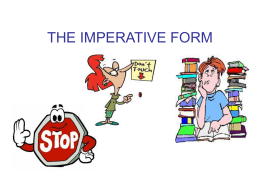La montagna sotto la neve Domenico A. Cassiano LA MONTAGNA SOTTO LA NEVE Romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright © 2014 Domenico A. Cassiano Tutti i diritti riservati Alla memoria di mia madre Jeno Maria Teresa e di mio padre contadino. Duro, zëmer, duro Sa duroj malji me borë (Resisti, cuore, e pazienta Quanto la montagna sotto la neve). Girolamo dè Rada, Milosao, XV Parte Prima 1 Don Francesco Marchese aveva l’età di ottant’anni, nel 1921, quando gli squadristi della Disperata, con Giangorgo, Iasparro e don Maurino, di notte, dal vicino paese di monte Calliano, venivano a cantare, nei dintorni del suo palazzo, la filastrocca di contumelie, associando il suo nome a quello del deputato socialista della provincia. In una girandola di Eia! Eia! e Alalà!, inserivano strofette improvvisate all’indirizzo di Don Francesco: A mezza notte in punto È passato un aeroplano. Di sotto c’era scritto: Mancini è un ruffiano. Misiani va in carrozza, Mancini fa il vetturino, al posto del somaro ci mettiamo Don Franceschino. Oppure, con allusione alla sua lunga barba bianca, vi aggiungevano la variante: Con la barba di Don Franceschino ci faremo spazzolini. Il vecchio, però, non si faceva intimidire. Era ancora pieno di impeto e passioni giovanili. Gli squadristi si tenevano alla larga dal palazzo; sapevano, per passata esperienza, che, se si fossero avvicinati al portone, gli uomini che lavoravano alle di11 pendenze dell’anziano socialista gliele avrebbero suonate. Come era successo la prima volta quando la squadraccia le aveva prese di santa ragione ed era stata costretta a darsela alle gambe, leccandosi le ferite. Marchese era uno strano socialista, uno di quei socialisti umanitari della fine dell’Ottocento. Il suo essere socialista, in Matermara, dove tutti lo chiamavano il Patriarca o il vecchio Garibaldino, era, in verità, uno scandalo. Non si era mai visto da quelle parti un galantuomo, un grande proprietario come lui, professare il socialismo e, soprattutto, rispettare i propri dipendenti, non trattandoli come servitori, come usavano tutti gli altri signori. Don Franceschino non era, per questo, ben visto da quel gruppetto di signorotti che erano e si consideravano essi stessi, con le poche tomolate di terra che avevano, difensori del capitalismo ed i padroni non solo di buona parte dei terreni, ma anche del destino dei contadini e dei braccianti del luogo. A differenza degli altri, che s’erano spartiti quei pochi terreni residuati al Comune, distruggendo anche le carte nell’archivio, egli – come consigliere di minoranza – s’era battuto per salvaguardare gli usi civici e l’interesse generale. Quando il sindaco don Momo aveva transatto la lite antica, cedendo in cambio di pochi spiccioli i diritti della collettività sulla montagna, don Franceschino aveva protestato, fatto innumerevoli ricorsi, alzato la voce nel Consiglio Comunale e tenuto infuocati comizi. Tutto inutilmente. Contro la coalizione degli interessi dei signori, protetti dalla regia Prefettura, era impotente ogni voce di dissenso. Sin dalle prime avvisaglie del fascismo, che veniva promosso dai proprietari della Valle del Crati, don Franceschino costituì naturalmente l’eccezione. Aveva compreso per tempo, quasi per istinto, che non era quella la strada del rinnovamento e della democrazia. Nel dicembre del 1922, i signori di Matermara consegnarono ufficialmente il municipio alla squadraccia di S. Demetrio, comandata da don Spiridione Bellusci. Ricevettero i fascisti, tra spari ed applausi e con la banda musicale, all’ingresso del paese e li guidarono fino alla porta del municipio, che i fascisti non vollero aprire con la chiave, offerta dal sindaco don Momo, ma sfondare con un lungo palo di legno. Volevano, così, 12 dimostrare che essi avevano conquistato il Comune con la forza. Ma nel Comune le cose rimasero come prima. Don Momo, il sindaco, divenne podestà e fu nominato segretario della sezione fascista; gli altri signori ne costituirono il direttivo. La tanto decantata rivoluzione si risolse nel cambiamento dei nomi; nella sostanza nulla mutò nell’assetto istituzionale. Quei quattro signori del paese continuarono, come prima, a fare i padroni. Ai loro inservienti posero in testa il fez e li vestirono con la camicia nera; così costituirono quella squadra della milizia fascista che, in effetti, era il loro corpo di guardia. Con quella attaccarono e distrussero la sezione del Partito Popolare. Fu agevole impresa perché i popolari, anche se tra le loro fila contavano molti giovani, non opposero alcuna resistenza per loro scelta politica, disdegnando di compromettersi con atti di violenza. Don Teodosio, il giovane diacono di rito greco, che era la mente e l’anima dei popolari e fiero oppositore dei fascisti e dei signori locali, li aveva vivamente invitati a rifiutare la violenza, anche a costo di subirla. Solo il vecchio contadino Cosmantonio si era sporto dalla finestra della sua abitazione, posta nei pressi della sezione dei popolari, agitando una croce e gridando all’indirizzo dei fascisti: “Questa è la croce di Karavak che vi distruggerà. Risorgeremo”. Non ci fecero caso, perché pensarono che il vecchio fosse ubriaco o, più verosimilmente, non compresero il significato delle parole di Cosmantonio. Dopo quell’episodio, la croce fu nascosta in campagna, nel fabbricato rurale di Comesse. Un ventennio dopo, alla caduta del fascismo, verrà riportata alla luce dai figli di Cosmantonio. Ed i socialisti disseppelliranno la loro bandiera dal nascondiglio di Ambolo, dov’era stata nascosta per non farla cadere nelle mani dei fascisti al momento dell’assalto alla sezione socialista. Impadronirsi della sezione socialista non fu facile. Un primo assalto, di notte, ebbe esito negativo: un gruppo di militanti socialisti, armati di fucili, prevedendolo, passava la notte nella sezione. Alle prime fucilate, i fascisti se la diedero a gambe. Si sparse la voce che fosse stato ferito ad un braccio il capo delle 13 camicie nere. Ed effettivamente, per una quindicina di giorni, non si vide in circolazione. Neppure un successivo assalto, tentato alcuni mesi dopo, ebbe esito positivo. La sezione socialista sarà chiusa dalla dittatura quando tutti i partiti ed i sindacati saranno dichiarati fuori legge. Nel frattempo, il capo dei militi fascisti, che andava braveggiando per il paese, ebbe una dura lezione. Una delle sue gratuite bravate consisteva nel recarsi, di notte, con la squadraccia, nei pressi della casa del giovane avvocato socialista don Vincenzo, lanciando al suo indirizzo le ingiurie più oscene e gli improperi, che aveva nel suo modesto vocabolario, per poi allontanarsi. Era evidente che il tutto era predisposto per provocare una qualche reazione dell’avvocato. Che non ci fu mai, perché don Vincenzo li lasciava sfogare, restando perfettamente indifferente. Anzi, sembrava che neppure se ne accorgesse di quanto avveniva per strada. Mai si era aperto uno spiraglio di una finestra o di un balcone. Questo comportamento di perfetta indifferenza destava ancora di più l’odio dei fascisti, che avrebbero voluto lasciare il segno dei loro manganelli sul corpo dell’avvocato o, almeno, fargli provare l’olio di ricino. Era stato impossibile sorprenderlo: di giorno, quando si recava in Pretura o quando passeggiava per le strade del paese, non era consigliabile aggredirlo alla vista di tutti. E, poi, non era neppure cosa facile: come angeli custodi, lo accompagnavano immancabilmente Pietro e Miloscino, due robusti giovanotti socialisti che, più volte, avevano costretto alla fuga i fascisti. Non restava che il tentativo di farlo uscire di casa, di notte, per poterlo bastonare. Solo allora avrebbero potuto riscuotere il premio di cento lire che il circolo dei signori aveva promesso di dare. Non avevano messo nel conto e neppure potuto immaginare che l’ostentata indifferenza dell’avvocato sarebbe stato un ostacolo insormontabile. Continuarono, così, gli schiamazzi notturni per qualche tempo ancora fino a quando Pietro e Miloscino non ne decisero la fine. Una sera, sul tardi, alla vigilia della festa grande dei Santi Anargiri, quando il capo con la squadraccia stava sbucando dalla strettoia del vicolo che dà sotto i balconi della casa dell’avvocato, Pietro e Miloscino, appostati nel pianerottolo di una casa disabitata nei pressi, con un palo, colpirono in testa il 14 capo fascista mentre cantava a squarciagola All’armi! Siam fascisti. Non ebbe neppure il tempo di finire la prima strofa – rimase al siam – che cadde bocconi per terra tramortito, in una pozza di sangue. Gli altri compagni della squadraccia scapparono, lasciandolo per terra. Solo il più fidato, Lero, si recò dai regi carabinieri per chiedere soccorso. Pietro e Miloscino disparvero nella notte. Qualche tempo dopo, emigrarono in America. Solo dopo la liberazione, al loro rientro in Italia per una breve visita ai parenti, si seppe che erano stati gli autori della sonora lezione al capo fascista: una ben visibile cicatrice ne segnò permanentemente il volto. Dopo l’accaduto, cessarono le molestie all’avvocato socialista e gli assalti alla sezione, che fu chiusa con l’inizio della dittatura quando tutte le organizzazioni politiche non fasciste furono dichiarate illegali. 15 2 Don Francesco Marchese, per il fatto di essere uno dei grandi proprietari terrieri del circondario, era in qualche modo rispettato dai fascisti ed anche sopportato, pur se non mancavano di motteggiarlo, perché ritenevano che, per la sua condizione sociale, alla fine non avrebbe potuto che aderire al fascio. Egli, che non era mai stato un militante socialista attivo, pur partecipando sporadicamente alle riunioni di partito, nella mutata situazione politica, avvertiva, però, la necessità di dimostrare concretamente la sua solidarietà, non facendo mancare il sostegno economico e prendendo aperta posizione nella campagna elettorale del 1924. Accolse nella sua casa il deputato socialista che era venuto nel Katund per tenervi un comizio. Lo accompagnò in piazza e salì con lui sul palco. Alle prime parole dell’oratore, i fascisti incominciarono a scalpitare a provocare ed aggredire i socialisti, determinando visibile fastidio e preoccupazione tra la folla, accorsa numerosa per la fama del deputato. Ma i tafferugli continuarono alla presenza dei reali carabinieri, che non osarono intervenire per fermare alcuni scalmanati fascisti, intenzionati a fare fallire il comizio. Non si contavano gli abbasso! Abbasso! e le contumelie contro il deputato, costretto al silenzio. Ad un certo momento, don Francesco prese la parola gridando ai fascisti: non volete farci parlare perché avete paura della libertà. Ma i fascisti continuarono ancora di più a rumoreggiare e, questa volta, a dileggiare anche don Francesco. I reali carabinieri, il cui intervento fu inutilmente invocato dal deputato socialista perché gli fosse garantita la libertà di parlare, non si mossero; anzi, ordinarono lo scioglimento del comizio. 16 In questo clima di sopraffazione e di illegalità manifesta, si arrivò al giorno delle votazioni. Sin dalla sera precedente, al piano-terra del Comune era stato approntato l’unico seggio elettorale, dove gli elettori avrebbero dovuto recarsi l’indomani per esprimere il voto a cominciare dalle ore otto. I quattro militi fascisti, armati di pistole e di pugnali, pretesero di occupare il locale, ove passarono la notte gozzovigliando. Don Vitaliano, l’anziano e saggio segretario comunale, si oppose energicamente, contestando espressamente la pretesa dei fascisti di impadronirsi del seggio elettorale. A nulla valsero le sue proteste. Nel corso della notte, sopravvenne un altro gruppo di militi che procedette all’arresto di tutte le persone ritenute avversarie del governo e che avrebbero potuto votare per i socialisti. La mattina, i militi nominarono il presidente del seggio e due scrutatori, scegliendoli tra i fascisti locali. Don Vitaliano non ne poté più: a fronte di tanto scempio, si recò nella Caserma dei Regi Carabinieri per denunziare tutte le illegalità consumate. Il maresciallo lo accolse benevolmente, ma gli fece capire che non sarebbe intervenuto, non avrebbe mosso un dito. «Don Vitalià, è tutto vero quello che dite, ma ora così vanno le cose. Non dovete pretendere che io perda il pane o venga trasferito in Sardegna. I fascisti sono i padroni del momento; fanno come vogliono al ministero dell’Interno; sono i padroni della Prefettura di Cosenza. Che volete? Che mi metta io a contrastarli per fare votare regolarmente un paio di centinaia di persone?» Don Vitaliano depositò la sua puntuale denunzia. Prima dell’apertura del seggio, i militi fascisti votarono in sostituzione delle settantacinque persone arrestate nella notte. Poi aprirono il seggio; chiamavano per nome i signori ed i loro servitori, che già aspettavano nella piazza antistante al seggio elettorale. Chiamarono, per prima, il sindaco, don Momo: scattò sull’attenti, gridò con voce sonora “presente”! E fece il saluto al gagliardetto della milizia. Entrò nel seggio e fece vedere come si doveva votare: avuta la scheda elettorale, vi tracciò un segno 17 a x sopra il listone fascista e diede il voto di preferenza a Michelino Bianchi. Don Ambrosino era il segretario del fascio: entrò pomposamente nel seggio, facendo il solito saluto al gagliardetto e acclamando “viva il duce”! Seguirono gli altri signori in attesa, tutti col cappello in mano. Poi fu la volta del gruppo dei servitori che, disciplinatamente, uno alla volta, votarono seguendo le indicazioni dei militi, sotto la sorveglianza attenta dei carabinieri. Fino alle ore quattordici, nessuno si affacciò al seggio. I fascisti erano convinti che oramai i giuochi erano fatti. Secondo i loro calcoli, s’erano accaparrati il voto della maggiore parte degli elettori iscritti nella lista elettorale. Ma non era proprio così. Damiano Macrì, che nella mattinata aveva assistito alle operazioni elettorali ed alla protesta di don Vitaliano che usciva ed entrava dal municipio senza darsi pace, esclamando tra sé e sé: «ma dove siamo arrivati? La legge viene messa sotto i piedi!» fece il giro belle botteghe artigiane e dei campi, per riferire quanto era accaduto e di cui era stato testimone. Si recò anche nella casa del diacono di rito greco, don Attanasio, notoriamente schierato contro i fascisti, seguace di don Carlo De Cardona, aveva fondato nel paese una piccola banca di credito cooperativo. Il diacono lo interrogò minuziosamente e, resosi conto della gravità del fatto, organizzò la contromossa per il pomeriggio: per protesta e per solidarietà, tutti i voti degli antifascisti sarebbero confluiti nella lista socialista. Don Francesco Marchese, accompagnato dal fedele Antonino, verso le tre pomeridiane, si recò al seggio. Nella piazza lo attendevano Don Attanasio con gli artigiani ed i contadini, che avevano fondato la banca cooperativa, i due maestri elementari del luogo e numerose altre persone, certe che l’anziano garibaldino non si sarebbe assoggettato ai fascisti ed avrebbe disobbedito alle loro imposizioni. Nel frattempo, era anche giunto al seggio don Maurino Bellushi, il capo dei fascisti, la cui famiglia, da oltre mezzo secolo, era in contrasto con don Francesco Marchese perché ritenuto usurpatore di parte del loro esteso e ricco patrimonio terriero. I due si guardarono in cagnesco come se fossero pronti a venire alle mani. Don Francesco votò la scheda e la infilò nella 18 apposita cassetta. Andandosene, disse di avere votato come sempre, cioè, per il partito socialista e di avere dato la preferenza al deputato Pietro Mancini. A questo punto, i militi tentarono di percuoterlo; egli li tenne a distanza difendendosi col bastone, che portava. Don Maurino, con aria di superiorità, quasi pregustandosi la vittoria ch’era già nelle urne, ordinò ai suoi di stare calmi per il momento, la sera avrebbero festeggiato. Quanto a don Francesco, lo lasciava andare per rispetto alla sua barba bianca. La scaramuccia portò un po’ di scompiglio, ma le votazioni continuarono. Don Attanasio ed i suoi amici non si mossero dal seggio, pronti ad intervenire nel caso di tentativi di imbroglio. Turi Minisci, dopo avere allertato e fatto affluire al seggio tutti quelli della sezione comunista, s’era piazzato in un angolo della stanza, circondato dai più fidi compagni, quasi tutti armati di pistole. Il clima era teso, ma ancora più tese le persone. Sarebbe bastato un nonnulla per arrivare a vie di fatto. Fortunatamente la presenza di don Attanasio era una garanzia perché era rispettato da tutti e la sua parola contava. Prima dello spoglio delle schede, i signori se ne andarono seguiti dai loro servitori. Non avrebbero voluto trovarsi coinvolti in qualche zuffa o, peggio, in qualche fatto di sangue. Nella sala restarono don Attanasio con i suoi, il gruppo dei comunisti e quello dei socialisti. I cinque militi fascisti si guardarono tra di loro: era evidente che avevano paura; non erano più spavaldi e prepotenti come nella mattinata. La sorpresa venne dallo scrutinio. La lista fascista rimase in minoranza; ebbe solo un terzo dei voti. La maggioranza fu dei socialisti. Com’era potuto accadere? La violenza, esercitata contro i socialisti nella notte precedente, la manipolazione delle schede, l’arroganza dei militi fascisti, l’arrivo del capo fascista, don Maurino, un riccone disistimato che aveva la pretesa di imporsi all’opinione pubblica, furono tutti fatti che determinarono una spontanea solidarietà verso i socialisti. La faccia di don Maurino era diventata gialla come quella dell’icona bizantina nella chiesa greca. Non sapeva che fare. Ad un certo punto, se la prese con i militi, gridando: coglioni, non sapete fare niente! Sapete solo rubare e menare le mani! Rivolto ai presenti, minacciò di vendicarsi: questi me la pagheranno! Per la ma19 donna, se me la pagheranno. Quando pronunziava queste parole, Turi che gli si era avvicinato e gli stava alle spalle, gli puntò la pistola che teneva nascosta sotto il mantello e gli intimò di uscire. Lo accompagnò nei pressi del Santuario del Carmelo, dove aveva lasciato il cavallo, lo disarmò e gli intimò di partire, prendendo la scorciatoia, accompagnandolo per un tratto per sincerarsi che non facesse marcia indietro. Al ritorno, Turi trovò che, nel seggio, i suoi compagni avevano disarmato e immobilizzato i cinque militi fascisti. Qualcuno voleva picchiarli. Non mancavano le ragioni di private vendette. Ma Don Attanasio si oppose fermamente: che se ne andassero ai loro paesi; che li accompagnassero fino alla strada. E così fecero. Zepa non riuscì a farsi vendetta su Giangordo della manganellata data al padre, perché non s’era tolto il cappello davanti al gagliardetto fascista. La sonora lezione ebbe una divertita risonanza nel circondario. Don Francesco Marchese – anche per mettere in cattiva luce il suo nemico e parente don Maurino – scrisse e pubblicò sul Monitore di Cosenza un racconto, pieno di lazzi e frizzi, intitolato I pifferi della montagna, che erano andati per suonare e rimasero suonati. Soprattutto ne usciva a pezzi la figura politica di don Maurino Bellushi, che s’era messo a capo dei fascisti del circondario e, candidato al Consiglio Provinciale di Cosenza, faceva promesse strabilianti, promettendo il ristabilimento dell’ordine, la costruzione di acquedotti, fognature, edifici scolastici per ogni paese, facendosi forte dell’appoggio del popolino: ma, in verità, Marchese parlava di marmaglia incosciente di sua sorte. Ma al segretario comunale, il vecchio e buon Don Vitaliano, i fascisti locali resero la vita difficile perché lo licenziarono dal servizio, privandolo conseguentemente dell’esiguo stipendio, senza assicurargli la pensione. Con la scusa dell’età avanzata ne deliberarono la “dispensa dal servizio” perché “non può più dare quel rendimento che l’Ufficio comunale ha bisognio” – lasciarono scritto nella rozza e sgrammaticata deliberazione – aggiungendo “e visto che cerca anche di ostacolare in buon andamento del regime fascista, come fece nel aprile 1924 in occasione delle elezioni politiche, col denunziare i componenti dell’intiero seggio elettorale, ed i militi fascisti, alla autorità giu20 diziaria per le volute minaccie e brogli elettorale. Nel mentre si deprola il fatto essendosi rivelato un falso fascista, gli dà un voto di sfiducia e adun’animità delibera di dispensarlo dal servizio”. 21 3 Tra la famiglia di don Maurino Bellushi ed il Patriarca v’erano ragioni antiche di grave dissenso. Da parte dei Bellushi, solo da pochi anni erano cessate le ostilità: precisamente da quando, nel 1920, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale che riconosceva la validità del testamento olografo, col quale Donna Eufrasia Bellushi aveva nominato suo erede universale il cognato don Francesco Marchese. Si trattava di una ricchezza fondiaria immensa che, anche in passato, era stata oggetto di contesa tra don Flaminio Tocci, i suoi eredi e la famiglia Bellushi, accusata di essersene impossessata con l’inganno e con la frode. La storia del complesso immobiliare, di cui il Patriarca era diventato l’ultimo proprietario, era complicata assai ed anche collegata a numerose vicende storiche. Nel 1790, il monastero dei monaci greci di S. Adriano fu soppresso per ordine del re di Napoli. Tutti i suoi beni furono assegnati al Collegio italo-greco, del quale era presidente il vescovo greco Francesco Bugliari. Fino a quando era durata l’amministrazione dei monaci, i terreni – che costituivano un grande feudo, esteso per migliaia di ettari – erano stati liberamente usurpati. Poche famiglie vi avevano costruito grandi fortune economiche, successivamente opportunamente nascoste da titoli nobiliari inventati. Il Vescovo, che aveva la necessità di mantenere la scuola, di pagare i professori, gli inservienti e tutto il personale dipendente, fece la ricognizione dei beni, constatò le avvenute usurpazioni e diede inizio all’azione di recupero. Apriti cielo! Gli usurpatori si allarmarono, si allearono tra di loro e vi coinvolsero anche il popolo minuto, facendogli crede22 re che il Vescovo era il nuovo barone oppressore. I più tenaci oppositori, assidui e astuti nel creare e tessere la ragnatela delle insinuazioni, delle maldicenze, che tenevano vivo il fuoco delle diffamazioni e delle calunnie, erano i due cugini Flaminio Tocci e Gianmarcello Lopes. Ma il Vescovo non gli diede molto peso e tirò dritto per la strada intrapresa, avviando le azioni giudiziarie di rivendicazione. Nel tardo pomeriggio del 21 novembre 1794, giorno in cui il Vescovo aveva presieduto alla celebrazione della festa in onore della Madonna Mesosporita, Gianmarcello Lopes per intimidirlo, d’accordo col cugino, spedì dal Vescovo la sua compagnia di sgherri. Maurizio e Arcangelo Jeno, Demetrio Kopidiri, Coltellazzo e Pastillera, gli ultimi tre armati di fucile e pugnali, bussarono alla porta del Collegio. L’inserviente, da dentro, chiese chi era e che voleva. «Sono don Arcangelo Jeno. Voglio parlare con Monsignore.» «Un momento!» Bisulco, il portinaio, corse dal Vescovo, che si trovava nello studio, per riferire e chiedere il da farsi. «Fallo entrare» disse il Vescovo. Aperto il portone, tutti e cinque entrarono con sorpresa di Bisulco che, per precauzione, prese il suo fucile e contemporaneamente chiamò in portineria gli altri dipendenti, Martino Strigari, Giuseppe Brunetti ed il figlio, per ogni evenienza. Dalla stanza del Vescovo si sentiva la voce di Arcangelo Jeno: «Monsignore, anche a nome di don Marcello e di don Flaminio, vi chiedo di volere desistere dalle pretese sui fondi S. Basilio, Santa Agata, Civetteria, Saline e Frasciro, che sono posseduti da oltre trent’anni e sono stati trasformati in uliveti, agrumeti, gelseti e seminativi. Questo per la pace di tutti. Se voi non desisterete, ci costringete a correre ai ripari perché con le vostre azioni rovinerete le nostre famiglie.» Il Vescovo, senza scomporsi, rispose: «Non credete di farmi paura con le vostre minacce. I fondi sono stati usurpati ai monaci ed io li debbo recuperare perché servono al mantenimento della scuola. Io non ho niente contro di voi né contro don Flaminio e don Marcello. Non posso tralasciare i miei obblighi nell’interesse del Collegio e della Chiesa.» 23 La conversazione finì così bruscamente in un nulla di fatto. Seguirono, da parte degli usurpatori, non pochi atti di molestia e di tentativi di impossessamento di altri quozienti di terreno, di pascoli abusivi, di deviazione delle acque, tutti prontamente respinti dai dipendenti del Collegio, che erano stati autorizzati dal Vescovo ad opporsi e respingere ogni atto di violenza e di modifica dello stato dei luoghi. Nel corso del 1797, don Francesco Saverio Lopes, che era il capo reale degli usurpatori e la loro mente direttiva, convocò il fratello Gianmarcello, i cugini don Flaminio e don Leonardo Tocci e l’altro cugino don Filippo Chinigò per concordare una comune linea di azione contro il Vescovo, che si dimostrava deciso ed irremovibile nella difesa del patrimonio immobiliare del Collegio italo-greco. Si stabilì di sperimentare una nuova modalità di attacco per saggiare la reale capacità di resistenza del Vescovo. Nello stesso giorno, i foresi degli usurpatori menarono al pascolo gli animali nelle terre del Collegio, devastandone le coltivazioni. Greggi di ovini e suini e troie con i porcellini dilagarono a Serra di Stracco, Valle palma, Santa Agata. Accorsero i guardiani, procedettero al sequestro degli animali. Attraverso tali atti, i nemici del Vescovo maturarono la determinazione di attaccarlo per via politica sostenendo che era un giacobino e, quindi, non meritevole di tenere la direzione del Collegio. Lo scopo evidente era quello di allontanarlo dal Collegio e di metterlo nella impossibilità di nuocere, facendosi forte della documentazione, custodita nell’archivio, che inequivocabilmente attestava la proprietà delle terre del Collegio e, nello stesso tempo, evidenziava le usurpazioni consumate. Ma la via politica si dimostrò subito inefficace ed inconcludente. Il Vescovo godeva della fiducia del re di Napoli che, su segnalazione di Giuseppe Maria Galanti, lo aveva nominato Presidente della Società patriottica per la Calabria Citeriore con sede a Cosenza. Ed era inattaccabile dal punto di vista religioso per essere abbastanza conosciuto e famoso per la sua opera Dissertatio teologico-historico-critica, pubblicata a Napoli nel 1791. Quando il cardinale Fabrizio Ruffo, nel 1799, sollevò il contadiname calabrese contro la Repubblica Napoletana, i fratelli 24 Lopes e Tocci ritennero finalmente giunto il momento di fare fuori il Vescovo, vestendosi dei panni sanfedisti. Nel febbraio del 1799, profittando del disordine, fecero un primo assaggio: ordinarono ai foresi di porci e di pecore di condurre gli animali nelle terre del Collegio, riservate a pascolo invernale. Vi pascolarono in lungo ed in largo per tutta la giornata, distruggendo il pascolo, senza che i guardiani del Collegio potessero intervenire a causa dei disordini e del caos in atto. Non si sapeva più chi comandasse: se gli organi della Repubblica o gli emissari del cardinale Ruffo. A San Demetrio, nella pubblica piazza, era stato innalzato l’albero della libertà. La Repubblica giacobina vi era rappresentata dalle personalità più ragguardevoli della borghesia rurale, emersa dalle rovine del feudo: don Salvatore Marini, don Vincenzo Chiodi, capitano della Guardia Civica, don Domenicantonio Lopez, fratello dell’arciprete Don Trifone, il notaio don Giovanni Brunetti, don Giuseppe Mazziotti ed il figlio don Nicola, don Angelo Aiello, don Martino Strigaro, Angelo Travaglione e molti altri, costituivano l’ossatura e la forza del locale governo democratico. A loro si opponeva lo schieramento, ormai apertamente sanfedista, che faceva capo a Francesco Saverio e Gianmarcello Lopes, che poteva contare sul numeroso popolino nullatenente. Il 7 febbraio 1799, il cardinale Ruffo era sbarcato a Punta del Pezzo nei pressi di Villa S. Giovanni. L’incendio della controrivoluzione sanfedista divampò in tutta la Calabria. Il popolino credeva erroneamente di fare la sua rivoluzione contro la classe proprietaria per rovesciare i rapporti sociali: a lu suonu de li tummarelli so risorte li puverelli. Si trattava di una tragica sollevazione, in cui si mescolavano vecchi rancori, private vendette, una vaga aspirazione al riscatto sociale, che la dirigenza sfruttò per distruggere la Repubblica, facendo scaricare tutto il malessere ed il disagio sociale contro i “giacobini” – che costituivano ed erano il reale movimento riformatore –, rappresentati come “ricchi” e, quindi, da abbattere: chi tene pane e vine 25 ha da esse giacubine. Alle prime notizie che i sanfedisti stavano per arrivare a Cosenza, nella nottata del primo marzo 1799, nella sua casa posta a Mormorico, in cima al paese, don Francesco Saverio Lopes riunì i capi del sanfedismo locale, proponendo di preparare l’assalto ed il saccheggio del Collegio per distruggere l’archivio e fare a pezzi l’odiato Vescovo. Bisognava distruggere S. Adriano perché covo di giacobini ed “ivi anche Cristo è giacobino”. Qualche sera dopo, i Lopes riunirono, nei vasti magazzini della casa, posti al piano-terra, i loro servi, i dipendenti, i loro debitori: Arcangelo, Coltellaccio, Demetruzzo, Pastillera, Fruschi, Piscuzzo, Andreuzzo, Pietrodimiglio, Gimillo, Gnazio, Caccaturo, Patracco, Maurizio. Tutti costoro, insieme ai Lopes, si prepararono all’assalto del Collegio con la cattura e uccisione del Vescovo per la notte del sabato 16 marzo 1799, che precedeva la domenica delle Palme. Pietrodimiglio e Coltellaccio, alcuni giorni dopo, trovandosi a bere nella cantina di Rino Ponte, a Marzile, tra i fumi del vino, accennarono alla riunione, alla promessa ricompensa di denaro per il “colpo”, ormai prossimo. Giunse, sia pure in ritardo, la soffiata a Giuseppe Brunetti. Questi con i tre fidati amici, Martino Strigaro, il figlio di costui Giuseppe e Angelo Travaglione, all’imbrunire, per vie diverse, raggiunsero il Collegio. Il Vescovo fu fatto scappare e si rifugiò in S. Sofia, presso i suoi parenti. I quattro, armati di fucile, si appostarono lungo la via, nelle immediate adiacenze del Collegio, nascondendosi nella folta boscaglia. Al calare delle tenebre, arrivano i Lopes con la loro masnada. Fioccarono le fucilate. Presi alla sprovvista, nel buio della notte fonda, gli assalitori se la diedero alle gambe. Ma fallito il tentativo notturno, Francesco Saverio Lopes detto Pettolone, il fratello Gianmarcello, il cugino Francesco Saverio detto Pisciamuro, e gli altri capi sanfedisti Stanislao Jeno, Maurizio Lopes, fratello di Pisciamuro, Demetrio Lopes, fratello di Pettolone, Vattasarri Archiopoli e Arcangelo Jeno, seguiti da una massa di popolani, tra cui si distinguevano i facinorosi e noti ladroni Di Miglio, Coltellazzo, Pastillera, Dimitruzzi, Nicolgianigli, Caccaturo, Petracco, Frusci e Criegaduri, il giorno seguente, Domenica delle Palme, abbatterono l’albero della li26 bertà e vi innalzarono la croce sanfedista. Al grido di morte ai giacobini! assaltarono il Collegio, uomini e donne, armati di fucili, scure e coltelli, facendo man bassa di tutto ciò che trovavano: vesti, letti, grano, farina, vino, olio, lardi, formaggi, soppressate, libri, argenteria: portavano via nelle loro case e ritornavano per rubare ancora. Rubarono la mitra del Vescovo, il pastorale, i calici e gli altri arredi sacri. Irruppero nella chiesa bestemmiando e dicendo: distruggiamo tutto. Qui anche Cristo è giacobino. I Lopes si precipitarono nell’archivio e vi trafugarono carte e documenti, ritenendo, così, di avere distrutto i titoli di proprietà del Collegio, loro vera ed unica preoccupazione. Di tutte le carte fecero un gran falò nel cortile. Non avendo trovato il Vescovo che si era salvato, rifugiandosi nottetempo in S. Sofia, pugnalarono con più colpi il suo grande ritratto ad olio, appeso alla parete dello studio. 27 4 Diciotto mesi dopo il saccheggio, nel settembre del 1800, Monsignor Bugliari riebbe la presidenza del Collegio. Il Cardinale Ruffo ne aveva affidato l’amministrazione provvisoria a don Saverio Cofone della vicina Acri ed all’Alfiere don Gianmarcello Lopes. Il Preside di Cosenza aveva disposto, con suo specifico provvedimento, che il Bugliari continuasse nella carica di presidente a “riceverci i soliti Collegiali e alunni secondo le forze del luogo onde sotto la di Lei vigilante cura possa rimettersi e prosperare a seconda delle Sovrane benefiche intenzioni”. A don Saverio Cofone e a don Gianmarcello Lopes veniva ordinato di “passare in potere” del Vescovo “quanto siasi finora ricuperato di mobili e suppellettili saccheggiati e tutti i beni semoventi e frutti appartenenti al medesimo Real Collegio da loro amministrati e percepiti”. Era una ulteriore sconfitta per i nemici del Vescovo: don Gianmarcello, amministratore provvisorio dopo il saccheggio, che forse aveva nutrito qualche speranza di potere disporre del Real Collegio e, soprattutto, dei suoi beni da padrone assoluto, dovette riconsegnare l’amministrazione proprio all’odiato nemico. Ma i Lopes non desistettero: fecero lanciare contro il Bugliari, dai loro partigiani, la terribile accusa di lesa Maestà e di reità di Stato che, tra l’altro, comportava la decadenza da tutte le cariche pubbliche ed, invece, egli continuava “a godere la reale munificenza, gli onori e gli utili delle reali rendite” – esponeva alla “Sacra Reale Maestà” il Governatore di S. Demetrio e suo Casale di Macchia – “abusando della Vostra Real Clemenza nell’averlo arricchito non solamente colla Badìa di S. Benedetto Ullano in annui ducati 1.000, ma ben che coll’altra Badìa dè PP. Basiliani in S. Demetrio in annui ducati 8.000 per sostener se stesso ed elevar giovani utili allo Stato ed alla Chiesa”. 28 Il Bugliari – continuava lo scritto – invece di “corrispondere alle reali aspettative, fu piuttosto per quel Collegio nocivo che utile, tanto vero che ora si trova dimesso affatto, e le rendite si consumano da lui e da un suo procuratore. E quel che è più scandaloso, che trovandosi processato per reità di Stato con altri 13 di què Signori che consumano la robba del Collegio suddetto”, non è stato neppure dichiarato decaduto dalla carica. E, quindi, si invocava “destinarsi un presidente benemerito allo Stato e attaccato alla Religione”. Anche questo tentativo fallì. Monsignor Bugliari, benché parteggiasse per il movimento riformatore e progressista, aveva avuto l’accortezza e la precauzione di non esporsi mai personalmente, tenendo un comportamento prudente ed adeguato alla sua funzione di vescovo greco. Ebbe buon giuoco nel difendersi, non potendogli essere imputato alcun atto concreto di sovversione. Nella sua memoria difensiva, attacca i suoi nemici, sostenendo che, da quando fu nominato vescovo e presidente del Collegio, non è mai venuto meno ai suoi doveri di educazione – “retta e cristiana” – della gioventù e di difesa del Collegio greco e dei suoi “diritti”. Tale condotta, apprezzata dai “buoni”, aveva “irritato l’animo di alcuni torbidi ed ambiziosi prepotenti di S. Demetrio e di S. Cosmo, che per l’addietro avevano, a manfranca, fatto varie occupazioni nei fondi appartenenti al Collegio, fra i quali i più acerbi sono stati e sono i fratelli D. Giovanni Marcello e D. Francesco Saverio Lopes, D. Leonardo e D. Flaminio Tocci, appunto perché D. Guglielmo Tocci, fratello germano degli ultimi e cugino dei primi, essendo concorso col supplicante nel detto presidentato, è stato posposto: cosa che nell’animo ambizioso di costoro ha cagionato un gratuito livore che il supplicante medesimo, con tutte le sue dolci maniere, non è arrivato ad estinguere”. Il Bugliari espone dei dati di fatto ineccepibili, perché veri, che denotano e caratterizzano il comportamento dei fratelli Tocci e dei fratelli Lopes, in concorso fra di loro, finalizzato alla “rovina” del Vescovo. “Primieramente, incominciando con le parole, hanno cercato di disastrare la buona fama del supplicante con cacciar voci detraenti la sua acquistata stima. Quindi replicatamene con gente 29 armata mandarono i suddetti a devastare d’inverno alcuni erbaggi, riserbati ab immemorabili per le pecore del fu monastero, per cui pendono le querele in Regio Consiglio, dove il medesimo ricorse per altri vari litigi. Ma sviluppando passo passo i delitti complottati, il loro reo disegno, han cercato di subornare il popolo col dargli a intendere che buona parte delle prestazioni, le quali dal medesimo si corrispondevano al Collegio, non erano dovute; ma tutte erano ingiuste usurpazioni. Nel mese di febbraio, abusandosi gli espressati prepotenti del disordine in cui tutto il Regno si trovava, con molta gente armata sono andati a devastare gli erbaggi tutti del sopradetto Collegio. Ma bisognò che il supplicante, cedendo al tempo, soffrisse pazientemente tali guasti, non avendo a chi e dove dirigere le sue querele”. Passa alla ricostruzione del saccheggio del Collegio e del progetto di omicidio: “Previdero quei malvagi uomini che, sistemata la Monarchia ed i Dicasteri, avrebbero pagato il fio dei loro trascorsi. Quindi, accorrendo alle loro diaboliche arti, degnarono d’uccidere il supplicante Prelato, di mettere a sacco e guasto questa casa d’educazione e di bruciare l’archivio, dove conservansi tanti Diplomi antichi, scritture e Decretali dei Supremi Tribunali a favore di questa S. Casa, per non essere così chi a loro resistesse, né più esistessero documenti od intraprese. Nel dì 16 marzo adunque di detto anno 1799, complottati i sopradetti, col favore dei loro congiunti, amici, debitori e dipendenti, avendo raunato molte persone facinorose, hanno assaltato il mentovato Collegio, circa le due della notte; ma dopo molte schioppettate, non essendo loro riuscito di guadagnare la porta, se ne andarono via. Non però desisterono dall’iniquo concepito disegno; finchè la mattina seguente, Domenica delle Palme, si unirono con maggior numero di gente per ritornar all’assalto; ed il perseguitato supplicante, essendo stato fatto conscio da alcune persone di morigerata coscienza che i suoi nemici volevano assassinarlo, se ne scappò per vie incognite in S. Sofia, sua con vicina Patria. Detta gente però, unita, assaltò effettivamente questo Collegio, ed ha involato tutto quanto vi era e ciò che apparteneva al supplicante, non escluse le lettere e carte tutte, perché il medesimo appena potè scappare con una veste di camera; ciò che ap- 30 parteneva ai Collegiali, ai Lettori ed ai serventi, ed anche gli arredi sacri della Chiesa”. Questi i nudi fatti, esposti dal Vescovo in modo semplice e concreto. Anche nel rifugio di S. Sofia non mancarono le insidie e le minacce, che costrinsero il Vescovo a recarsi a Cosenza da Don Pietro Gualtieri, nominato Commissario dal cardinale Ruffo, per mettere in salvo la propria vita ed illustragli le modalità del saccheggio del Reale Collegio. A questo punto, “i complottati sopradetti, per colorire l’orrendo sacrilego misfatto, investendo il carattere di realisti, hanno cercato di arrivare per mezzo della calunnia là dove non erasi giunto con la forza delle armi… Sparsero la voce che il supplicante era reo di Stato, e per animare alcuni, poco più circospetti, han dato a sentire che, se non era tale, lo farebbero con le loro voci; e non ebbero orrore di fare proporre l’accusa da uno del loro complotto, col disegno che gli altri complottati e rei di sacrilego saccheggio si prestassero con lo spergiuro a servire da testimoni; come infatti hanno praticato, per quanto si sente, in presenza del sig. Consigliere De Fiore, con produrre testimoni per lo più rei di tutto saccheggio e di altri enormi delitti, commessi in quell’infelice tempo di anarchia”. Francesco Bugliari fu reintegrato nella presidenza del Collegio: del saccheggio fu accusato Francesco Lopes, figlio di Nicola Lopes, condannato a rispondere dei danni in via civile, non essendovi stato spargimento di sangue. Assolto dalla commissione di delitti, penalmente rilevanti, fu rimesso in libertà. Naturalmente il tribunale borbonico volle essere molto benevolo ed accondiscendente: non accusò gli organizzatori dell’assalto che, invece, avrebbero dovuto essere gli imputati principali; preferì scaricare tutta la responsabilità dell’accaduto su un protagonista secondario della vicenda, evidentemente per ridurre il tutto ad un’azione di risarcimento dei danni con esclusione di delitti di sangue, la cui sussistenza avrebbe comportato ben altra sanzione. Eppure, delitti ce ne furono. Baldassarre Archiopoli, detto Vatassarri, che era della banda degli assalitori, si diede al saccheggio di case private, consumando anche alcuni stupri. E non poche furono le persone, uccise a colpi di fucile. 31 5 L’assassinio del Vescovo era solo rimandato. I Lopes ed i loro amici erano in attesa di un’occasione opportuna qualunque fosse. Il susseguirsi precipitoso, in quel tempo, degli avvenimenti politici con i rapidi cambiamenti ed il mutamento delle fortune personali che comportavano, di lì a qualche anno, con lo scatenarsi del brigantaggio filoborbonico, in particolare, nella zona pre-silana, offriva quella opportunità che i Lopes ed i loro cugini Giambattista e Stefano Chinigò attendevano con la speranza di colpire a morte il Vescovo, additato come giacobino e, dunque, nemico da abbattere senza ulteriori ripensamenti. Il 9 ottobre 1805, il re di Napoli sottoscriveva con Napoleone il trattato di Parigi, in forza del quale le truppe francesi sarebbero state sgomberate da Napoli; il regno delle Due Sicilie sarebbe stato neutrale ed il porto di Napoli non avrebbe dovuto accogliere navi di potenze nemiche della Francia. In contemporanea, però, il re di Napoli, Ferdinando, sottoscriveva l’alleanza con i tradizionali nemici di Napoleone, Austria, Russia e Inghilterra. Questo doppiogiochismo costò la fine del regno, decretata da Napoleone col proclama di Schoenbrunn del 27 dicembre 1805. Il 15 febbraio 1806, il maresciallo Andrea Massena, Giuseppe Bonaparte ed i generali Reynier e Verdier entravano in Napoli. Re Ferdinando con tutta la corte, già ai primi di gennaio, era sbarcato in Sicilia, a Palermo, da dove alimentava l’opposizione antifrancese – vivace nella Calabria – affidandosi soprattutto ai capi di bande brigantesche che, nel 1799, anche se si erano battuti con accanimento, garantiti efficacemente dal cardinale Ruffo, ora saranno costretti a soccombere per la mancanza di unità e di coordinamento. 32 L’obiettivo delle truppe francesi era, dunque, la conquista della Calabria. Il 9 marzo 1806, a Campotenese, il generale Reynier sconfisse i borbonici, raggiungendo il 16 successivo la città di Cosenza ed il 20 Reggio. Giuseppe Bonaparte scese in Calabria: il 30 marzo, a Scigliano, gli fu recapitato il decreto napoleonico che lo nominava re di Napoli e di Sicilia. Visitò la Calabria e la Puglia, ai primi del maggio 1806, rientrò nella capitale. Fece importanti, utili ed efficaci riforme di riorganizzazione amministrativa del regno sul modello francese ed emanò la legge eversiva della feudalità, dando attuazione nel Mezzogiorno d’Italia alle idee di ispirazione liberale, sostenuto e coadiuvato da quegli intellettuali, scampati agli eccidi borbonici del 1799, che avevano decapitato il Mezzogiorno delle più eccelse intelligenze. *** L’opposizione antifrancese in Calabria, alimentata dalla corte dalla Sicilia attraverso suoi fanatici emissari con promesse varie di premi alla fine dell’insurrezione, trovava una sua specifica spiegazione sia nelle condizioni oggettive di miseria, di superstizione, di analfabetismo in cui versava la popolazione, sia nell’azione pratica dei Francesi per i tanti oneri, scaricati sulle popolazioni, per la diversità di cultura, di lingua, per la necessità di cercare in loco i viveri per la truppa. Non rare volte, poi, si dovettero registrare atti di violenza di singoli militari francesi nei confronti di donne o di gruppi di cittadini o di interi paesi, messi a ferro e fuoco, come, per esempio, nel caso del saccheggio di Morano; tutti fatti che suscitavano naturalmente la reazione armata e la vendetta che si concretizzavano nella costituzione di bande. Il clero – regolare e secolare – che esercitava tanta influenza soprattutto nelle campagne, supportava ed incoraggiava il sentimento antifrancese in forza dell’antico pregiudizio secondo cui i Francesi ed i loro alleati andavano combattuti ed abbattuti perché erano contro Dio e contro la religione e la famiglia. Venivano, così, rappresentati come il male assoluto, che si era 33 abbattuto sulla Calabria per seminarvi il caos, il disordine ed, in definitiva, disgregare la società civile. L’insurrezione generale della Calabria costrinse i due generali francesi Verdier e Reynier ad un momentaneo ritiro: Verdier, da Cosenza, ai primi del mese di luglio, si ritirò a Cassano, ma da lì, per precauzione, partì addirittura per la Puglia; Reynier, da Catanzaro passò a Crotone per, poi, arrivare a Rossano, benevolmente accolto dalla popolazione. Ma, quando chiese a Corigliano i viveri per l’esercito, gli furono rifiutati. I borbonici locali, le cui file erano ingrossate da insorti provenienti da Longobucco, Acri, S. Demetrio, S. Giorgio, riuscirono a respingere le truppe del Reynier, che finsero di scappare indietreggiando verso un terreno più conveniente alla battaglia in campo aperto. Così, i coriglianesi e gli altri insorti, loro alleati, furono vinti con conseguente saccheggio del paese. Molti palazzi e case furono bruciati e fu fatta “strage – annota melanconicamente un cronista dell’epoca – di centinaia di persone e tutt’altro di male che può in questi casi concepirsi, ma non esprimersi”. Il capomassa coriglianese Domenico Della Cananea, rientrato dalla Sicilia, ch’era stato uno dei fautori dell’insurrezione, fu catturato nelle campagne di Corigliano, in località S. Marco, dai francesi e immediatamente fucilato con altri cinquanta suoi sodali. Il fratello, l’arciprete Giovanni Vincenzo Della Cananea riuscì, invece, a salvarsi scappando in Sicilia. L’altro capomassa Domenico Cundari fu giudicato in contumacia dalla Commissione Militare e condannato a morte per i suoi numerosi crimini; successivamente catturato, fu impiccato. Riuscì a salvarsi con la fuga solo Salvatore Pugliese; lasciò la famiglia in miseria a Corigliano e, per tutto il Decennio, ramingò per l’Italia. Dopo la Restaurazione, fu nominato da re Ferdinando colonnello e destinato a Castellammare. Il sandemetrese Salvatore Marini – che aveva difeso il Vescovo Bugliari e che ora svolgeva le funzioni di commissario di polizia a Cosenza – indirizza allarmate relazioni al ministro dell’Interno per evidenziare che gli insorti mettono in pericolo la tranquillità pubblica nella provincia. S. Giovanni in Fiore è addirittura occupata da una masnada di briganti, che avevano trucidato molte persone oneste ed altre costrette alla fuga. 34 Scene non meno efferate sono avvenute nella zona tirrenica, a Belmonte Calabro, dove sono state massacrate diverse persone, ritenute filo-francesi. Nelle altre zone del versante tirrenico, dove stazionavano alcune navi inglesi, i pubblici funzionari erano impossibilitati a svolgere le proprie funzioni per paura. Le bande hanno la possibilità di consumare numerosi misfatti, fidando sulla protezione inglese. A Bisignano – ad un tiro di schioppo dal Collegio greco – la Guardia Civica non sempre è in grado di opporre la dovuta resistenza agli attacchi briganteschi ai centri abitati, in cui i briganti contano molti amici e alleati che li riforniscono di viveri e di armi. La provincia di Cosenza è percorsa da bande brigantesche, alcune delle quali, nel settembre 1806, riescono addirittura a penetrare nel Castello ducale di Corigliano Calabro, massacrando due soldati francesi. Il capo della Guardia Civica di S. Sofia, l’indomito Giorgio Ferriolo, con una forza di sessanta persone riesce a tenere testa ai briganti, riportando qualche successo. A S. Cosmo ne ha catturati due ed uccisi quattro. Ma la tranquillità pubblica e la sicurezza dei cittadini non sono sufficientemente garantiti, nonostante le continue esecuzioni delle sentenze di condanna alla pena capitale, emesse dalla Commissione Militare. Nella fascia dei paesi albanesi, posta tra Acri e Corigliano, in cui è ricompresso il Collegio greco, i più attivi borbonici sono i fratelli Minisci di S. Giorgio, particolarmente il capomassa Giorgio, conosciuto col soprannome di Michelicchio. Si tiene in continuo e diretto contatto con la corte borbonica di Palermo e si muove con estrema facilità tra la Calabria e la Sicilia. Agli inizi della sollevazione della Calabria, appositamente rientrato dalla Sicilia con abbondante denaro e proclami incendiari, aveva addirittura tentato di occupare Corigliano senza riuscirvi per la scoperta della congiura. Tentò – anche qui inutilmente – la presa del suo paese; la sua banda fu costretta alla fuga dalla popolazione. Passò, quindi, a Vaccarizzo e S. Cosmo, dove, sul campanile delle rispettive chiese matrici, fece sventolare la bandiera borbonica. Fu la vittoria di un giorno; costretto a scappare, sequestrò tre cittadini di San Cosmo, Domenicantonio Marchese, Vincenzo Marchese e Giuseppe Maria Tocci, che spedì in Sicilia. 35 Di loro non si ebbero più notizie. Passò, quindi, a S. Demetrio, rifugiandosi dai Lopes, con i quali raggiunse il feroce re Coremme in Acri per convincerlo a scendere in S. Giorgio con la sua masnada per consumarvi col saccheggio una tremenda rappresaglia. Quivi i partigiani di Michelicchio, di notte, avevano bollato col sigillo brigantesco le porte delle case, che dovevano essere risparmiate dal saccheggio. Come l’angelo della morte passava oltre le case degli Ebrei le cui porte erano segnate dal sangue degli agnelli, così i briganti avrebbero risparmiato le case dei borbonici. Calò su S. Giorgio re Coremme con la sua orda di qualche migliaia di briganti; mise il paese a ferro e fuoco, risparmiando solo le case in precedenza segnalate. Il successivo intervento del generale Verdier trova il paese semidistrutto con gli abitanti alla disperazione: ordina e fa eseguire la demolizione del palazzotto di Michelicchio. Su quel suolo sarà costruita la casa municipale. Il brigante Antonio Santoro di Longobucco si faceva chiamare re Coremme. Si vantava di avere corrispondenza con la regina e di essere stato nominato tenente colonnello dalla corte borbonica. Dopo qualche tempo, si autoproclama generale con mille uomini al suo comando. Dopo essere sfuggito alla custodia della Guardia Civica di S. Sofia, ritorna in Longobucco, umiliato, abbattuto nel fisico e nel morale. Viene ricevuto dai longobucchesi con spari, al suono delle campane e con altri segni di giubilo. Gli fanno visita paesani e forestieri per augurargli salute e prosperità. In poco tempo, cresce il numero delle persone che si mettono a sua disposizione. Egli accoglie tutti e crea un simulacro di corte, un consiglio di guerra, tutta una gerarchia di gradi, delle bandiere, dei tamburi e dei pifferi. Nomina dei capitani nelle persone di suoi stretti parenti o amici fidatissimi, tutti pastori come lui: Serafino e Pietro Santoro, Antonio Marincolo, il Ciamotaro, Giuseppe Falcone e Domenico Capalbo. Tutti costoro formano il consiglio di guerra. Nel giro di poco tempo, riesce – forte di mille uomini – ad esercitare una egemonia esclusiva anche nei paesi vicini: i Comuni di Cropalati, Campana, Paludi, Caloveto, Crosia, Scala, Cariati e Bocchigliero sono da lui governati attraverso i suoi 36 uomini ed attraverso quegli altri del luogo, che si erano aggregati alla sua banda. Ordinava arresti, saccheggi, persecuzioni; seminava fuoco e sangue; disponeva in dispense di matrimonio, divorzi, promozione di benefici e di parrocchie. Sembrava che Longobucco fosse il centro del potere, piazza d’armi, quartiere generale, tribunale: un piccolo Stato che aveva un pastore sul trono. Si proclama difensore della fede e della religione cristiana. Nell’ottobre 1806, dopo essere rientrato a Longobucco, avendo avuto notizia dell’approssimarsi del generale Verdier, si recò processionalmente in chiesa, dove armò le statue dei santi: chi di una spada, chi di un pugnale, chi di una picca, chi di un trombone, perché, così bardati, combattessero per lui contro i francesi. Ovunque passa lascia il segno della sua crudeltà e della sua ferocia. Prima del saccheggio di S. Giorgio, uno dei suoi orribili gesti fu l’assassinio di uno sventurato giovane di Crosia, che, per ripugnanza, aveva declinato l’invito di fargli da segretario: gli fece tagliare la testa, l’appiccò ad un palo e con questo orribile trofeo continuò la sua marcia per i paesi del basso Jonio. Ignorante, ma perfetto reazionario, aveva capito che il nemico da combattere era rappresentato dalla cultura perché i giacobini passavano per uomini colti. Così, Coremme – come nazista anzi tempo – aveva la mania, oltre che di uccidere le persone, di sequestrare i libri e di farne dei grandi falò di gioia nelle piazze dei paesi. 37 6 In questo contesto fu eseguito l’assassinio del Vescovo. Giungevano, intanto, da Acri nei paesi albanesi voci insistenti di una terribile, imminente rivolta delle masse, che il sacerdote don Antonio Rossa Cozza preparava segretamente per distruggere il partito contrario. Ma la cosa non doveva essere, poi, tanto segreta se ne parlavano venditori ambulanti acresi o altre persone che trasportavano e vendevano la lana e la seta alle filande che, in Acri, erano numerose. Mastro Ottorino Filla raccontava, al ritorno da Acri, che il governo del Comune era composto dal sindaco don Saverio Cofone e dai due eletti, il farmacista don Antonio Capalbo ed il medico don Francesco Sammarro, ma che i galantuomini, quasi tutti giacobini e filofrancesi, ora che il distaccamento dell’esercito francese aveva abbandonato Bisignano, correvano un grosso pericolo con le loro famiglie. Le voci si diffondevano rapidamente. La gente ne parlava nelle campagne, nella pausa del lavoro; nelle botteghe dei calzolai, dei sarti o dei mastri forgiari, facendo le previsioni più disparate, non nascondendo la preoccupazione che l’asprezza del conflitto in Acri avrebbe potuto avere sciagurate conseguenze nei paesi albanesi, anche se in essi la maggioranza della popolazione parteggiava per il nuovo governo. Era, però, pur vero che i filoborbonici erano combattivi e potevano chiedere aiuto ad una o a più delle bande brigantesche, che circolavano desiderose di bottino e di saccheggio. Don Flaminio Tocci, i Lopes ed i loro cugini Chinigò stavano in agguato; studiavano attentamente la situazione per cercare di cogliere il momento opportuno per inserirsi nel nuovo tentativo di sollevazione antifrancese. Il loro principale obiettivo era l’eliminazione fisica del Vescovo. Erano pervenuti a tale con38 clusione estrema dopo avere tentato tutte le vie per farlo destituire dalla presidenza del Collegio greco. Avevano inutilmente reiterato la pericolosa denunzia di reità di Stato. Non c’era stato niente da fare. Evidentemente il Vescovo aveva un grande prestigio e godeva di considerazione anche presso i rappresentanti governativi. Bisognava eliminarlo e farla finita una volta per sempre. Il Vescovo si era ritirato nel suo paese, in S. Sofia, per la chiusura provvisoria del Collegio a causa dei rivolgimenti calabresi. Bisognava tentare il colpo a S. Sofia, provocandone il saccheggio e mettendola a ferro e fuoco da parte degli insorti realisti. Nel caos che ne sarebbe derivato, l’assassinio del Bugliari sarebbe apparso e passato come la soppressione di un giacobino e, cioè, di un nemico del re e della religione. La causa della morte, nel corso di un saccheggio del paese da parte delle bande filoborboniche, sarebbe necessariamente passata come un fatto politico, escludendo personali responsabilità di privata rappresaglia e vendetta. Acri era terra ricca e industriosa con numerose filande e botteghe artigianali, posta su di un colle, pochi chilometri lontana da S. Demetrio e dagli altri paesi dell’Arberia, con circa quindicimila abitanti: un ristretto gruppo di galantuomini, che governa la municipalità e detiene buona parte della ricchezza; un medio ceto benestante di artigiani, commercianti e di massari; la stragrande maggioranza di contadini, foresi, braccianti, guardiani di migliaia di capi di bestiame di vario genere. Si tratta, in genere, di una moltitudine di nullatenenti al servizio della locale borghesia rurale i quali, se perdono il padrone e diventano spaturnati, si sentono sfortunati e come smarriti. Essi vivono sparsi nel vasto territorio oppure raggruppati in pochi villaggetti tra S. Giacomo, Muccone, Vallone cupo e Serricella od in casette isolate, vere e proprie capanne, costituite da un unico vano a piano terreno e costruito con frasche intrecciate e impastate con terra rossa. Niente strade, se non modesti ed impervi sentieri pedonali; niente servizi igienici; niente istruzione. Per secoli, tutta questa povera e degradata umanità non aveva conosciuto che il feudatario attraverso i suoi fattori o gli altri signori attraverso i loro guardiani, pa- 39 droni di tutto il ben di dio ed anche – quando lo desideravano – dello loro donne, figlie e giovani spose. Rientrava nella normalità delle cose e della consuetudine di vita che, quando un signore s’incapricciava di qualche ragazza, la richiedeva alla madre che mandava la figlia nella casa di campagna del padrone. Se la madre non obbediva, provvedevano i guardiani a sequestrare la giovane, che di solito non opponeva che trascurabile resistenza. Fu una eccezione il caso di Pettoruta che, sequestrata dai guardiani, inutilmente per giornate e nottate intere riuscì a non cedere alle voglie dell’anziano don Giacomino. Lasciata sola, alla fine, disperata e distrutta dalla rabbia e dalla vergogna, fu presa dal padrone. Ogni tanto, nelle feste principali, a Natale e Pasqua, nella chiesetta – costruita dal signore in adiacenza alla casa padronale – si faceva vivo un altro signore, vestito di nero, che celebrava una frettolosa funzione in una lingua sconosciuta ed incompresa e predicava facendo gesti strani con le mani; egli parlava di sacrifici e di dolore da sopportare per amore del Cristo crocefisso e per sfuggire alle fiamme dell’inferno. Alla fine della cerimonia, raccoglieva qualche dono in natura – uova, galli, formaggi – e se ne ritornava in Acri in groppa ad un asino così com’era venuto. Tutta questa popolazione menava una vita di stenti, aspra e selvaggia e, salvo il battesimo – come si diceva – quasi simile a quella delle bestie, che custodiva per conto dei signori. Tra inenarrabili stenti e disagi di ogni genere, riusciva, tuttavia, a sopravvivere. All’apparenza, era gente buona e mansueta; non aveva mai tentato una ribellione collettiva. Aveva solo espresso, per vendicarsi dei soprusi, singole e sanguinose contestazioni, sfociate in omicidi, estorsioni e sequestri. Per uscire dal dominio dell’ingiustizia, bisognava farsi brigante, scegliendo, così, una strada senza ritorno e anch’essa frutto di violenza. 40 7 Per comprendere le terribili giornate di violenza collettiva che furono le stragi di Acri, che costituirono anche l’occasione per l’assassinio del Vescovo Francesco Bugliari, occorre guardare alla nudità e crudità delle oggettive condizioni di vita contadina. Tutta questa popolazione contadina – che aveva ritenuto di ribellarsi contro “i ricchi” seguendo il cardinale Ruffo – aveva soltanto due modelli, tutt’e due, però, del tutto diseducanti: il signore, padrone delle terre, che sembrava godere di ogni privilegio; oppure il prete, dedito ad accumulare denaro, nient’affatto cristianamente chino ad alleviare le miserie degli umili, dei cristi in carne ed ossa, che erano costretti a patire le ingiustizie e le umiliazioni. Ricconi e reverendi, con la loro condotta di vita, offrivano al popolo basso delle genti minori esempi tutt’altro che edificanti e virtuosi. L’assenza assoluta di virtù civile e di educazione religiosa lasciava la comunità sociale popolare in una fase arcaica e bloccata, abbandonata all’analfabetismo ed alla superstizione, del tutto trascurata dai gruppi dirigenti cittadini, compresi gli intellettuali illuministi. Non v’è da meravigliarsi se consistenti gruppi popolari, già vittime dell’oscurantismo, lo furono successivamente del sanfedismo, manifestandosi in quello scoppio di odio e di vendette sanguinose, che le stragi di Acri hanno rivelato. Il 14 agosto 1806, i galantuomini di Acri, alla notizia che i francesi avevano rioccupato Cosenza, si rimpadronirono del Comune. Con imprudenza, sapendo che le masse brigantesche occupavano le alture silane, procedettero all’arresto del capomassa longobucchese Luca, cieco da un occhio, e di un corriere che da S. Giovanni in Fiore andava nell’accampamento dei 41 briganti in Cassano. Ci furono altri numerosi arresti di persone sospette, poi rimesse in libertà, compresa la druda di Giacomo Pisano, detto Francatrippa, capomassa di Pedace. I fratelli Fucilari – Tommaso e Carmine Fuscaldo – riferirono la cosa a Francatrippa, che si trovava in montagna con altri trenta briganti. Questi aggregò altri trenta torrieri di Là Moccone, ai quali si unirono altri numerosi torrieri di Vallone cupo, condotti dall’acrese Natale Baldini, e numerosi altri chiamati a raccolta dal prete Antonio Rosa Cozza e seguaci. Con questi elementi, all’indomani, sarebbe piombato improvvisamente nella cittadina, per eseguirvi una severa rappresaglia. La notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto 1806 non si vedeva anima viva per le strade di Acri. Con l’arrivo dei francesi a Cosenza, si era nella convinzione che il pericolo era cessato e che ormai regnavano l’ordine e la tranquillità, dopo qualche mese di caos, trascorso nell’apprensione e nell’angoscia e nel timore delle violenze della plebe e del partito borbonico, sostenuto dal prete don Antonio Rosa Cozza e supportato dalla massa di Francatrippa. Si dormiva tranquillamente. Quasi a presagio dell’orribile strage, la notte era tetra e scura; tutto il giorno una tempesta di vento s’era abbattuta su Acri e numerosi vortici di vento e di polvere – cosa mai vista in passato – s’innalzavano nella piazza dell’Annunziata e, poi, ricadevano e nuovamente e rapidamente si rialzavano, tra la meraviglia degli abitanti, ivi richiamati dall’insolito spettacolo della natura. Alle sette del mattino di Ferragosto, un improvviso stridore di voci e di reiterati colpi di fucile sorprese gli acresi. Si pensò che fosse arrivata la banda di Pane di grano, alla quale erano state rifiutate le quattromila razioni di viveri. Ci fu un fuggifuggi generale. Ognuno scappò per salvarsi in campagna o nello stesso paese presso amici e, comunque, in un luogo ritenuto sicuro. I primi ad essere passati per le armi furono gli sfortunati fratelli Angelo, Pietrantonio, Gaetano e Vincenzo Fusari, uccisi a fucilate in piazza. La medesima mattina subirono la stessa sorte don Matteo Capalbo, Antonio Capalbo, il figlio Raffaele, il notaio Antonio Padula e il medico Saverio Cofone, sorpreso in campagna. La strage continuò anche nei giorni seguenti fino al 42 30 agosto, quando finalmente arrivarono i francesi al comando del generale Verdier. I corpi dei fucilati venivano ammassati in piazza e dati alle fiamme con un gran falò. Il popolo assisteva all’orribile spettacolo. Un tal Jaccapitta o Spaccapitta, mentre i cadaveri bruciavano, intingeva nel grasso una focaccia e la mangiava. Al terrore sanfedista, dopo l’arrivo del Verdier, seguì quello borghese con numerose esecuzioni capitali, compresa quella dello Spaccapitta, che fu menato vivo tra le fiamme. Erano giunte in Acri, chiamate da Francatrippa, orde da Corigliano, da Longobucco, dai Casali; vi arrivò fortunosamente lo stesso re Coremme. Costui fu battuto e volto alla fuga mentre assaliva S. Basile, sopra Castrovillari, per il tempestivo intervento di un reparto polacco al comando del Malacowsky. Rifugiatosi in Santa Sofia, venne catturato con i suoi compagni dalla Guardia Civica al comando di Giorgio Ferraiolo e trattenuto in carcere il tempo necessario per predisporre il suo trasferimento a Cosenza per essere giudicato dalla Commissione Militare. Non si sa bene come fece a scappare: secondo la voce corrente avrebbe corrotto uno dei custodi. Il che pare assai improbabile. Ma, secondo una fonte scritta dell’epoca, di notevole rilievo per la storia del Decennio, per sfuggire alla custodia si gettò da una finestra. I suoi cinque compagni furono fucilati dalla Guardia Civica mentre tentavano di scappare durante il viaggio di trasferimento alle carceri di Cosenza per essere giudicati dalla Commissione Militare. Coremme, arrivato in Acri malmesso nel fisico, segnato dai lividi e dalla battiture ricevute dai militi della Guardia Civica, era naturalmente gonfio di odio e smanioso di vendicarsi, mettendo a ferro e fuoco Santa Sofia. Fece presto a ricostituire la sua banda, scegliendo il personale tra le mille e più persone, accorse in Acri, armate chi di fucile, chi di ronche e scuri e baionette, conficcate in lunghe aste. 43 8 La progettata vendetta di Coremme era l’occasione opportuna, attesa dai nemici del Vescovo. Gianmarcello Lopes, i cugini Chinigò Stefano e Giambattista, Francesco D’Amico e Baldassarre Archiopoli si uniscono ai briganti nell’assalto a Santa Sofia col segreto proposito di uccidere l’odiato nemico. Calava da Acri l’orda di Coremme. Gli abitanti di S. Sofia cercavano riparo nelle campagne o nei paesi vicini. Anche la famiglia Masci, stretta parente del Vescovo, era partita per Spezzano. Don Paolo Masci lo aveva inutilmente scongiurato di seguirli. Ma il Vescovo fu irremovibile: non volle scappare. Probabilmente non percepiva l’imminenza del pericolo di vita proprio per la sua persona. Egli riteneva che, essendo anziano, nessuno avrebbe portato offesa alla sua persona. Evidentemente non aveva messo nel conto che raramente l’odio inveterato scema col passare del tempo. Particolarmente, quando è causato dall’interesse economico. I briganti si diedero al saccheggio, appiccando fuoco alle abitazioni. Una parte si diresse verso la casa di Giorgio Ferriolo, gravemente colpevole dell’arresto del Coremme al comando della Guardia Civica, per catturarlo e consumare una atroce vendetta. Ma il Ferriolo non fu trovato: la casa era vuota. Essa fu saccheggiata e data alle fiamme. Praticamente, l’operazione si poteva considerare completata col saccheggio generale del paese e l’incendio della casa del Ferriolo. Gianmarcello ed il suo gruppo, travestiti da briganti, cercavano affannosamente il Vescovo e non riuscivano a trovarlo. Sembrava scomparso. Girovagò in lungo ed in largo per il paese, ispezionò i catòi ed i bassi, s’inoltrò nella campagne in prossimità dell’abitato; tornò nuovamente in paese, passando 44 mentalmente in rassegna le abitazioni dove il Vescovo avrebbe potuto essere accolto e protetto. In casa Bugliari c’era rimasto solo il vecchio fratello del Vescovo, Domenico Antonio; tutti gli altri, il giorno antecedente, avevano raggiunto i loro parenti a Spezzano. In casa dei Masci, cugini dei Bugliari, non c’era nessuno. Così pure in quella degli altri parenti, i Baffa. Erano tutti scappati da S. Sofia per rifugiarsi chi nelle campagne, chi negli altri paesi dell’Arberia, nel timore che, essendo notoriamente partigiani del governo filo-francese, facilmente avrebbero potuto ricevere del male nel corso del saccheggio. Il Vescovo non era a casa sua; Gianmarcello l’aveva rovistata, passando per tutti i locali, financo le stalle ed i magazzini, ma il Vescovo non c’era. Il fratello Domenico Antonio, maltrattato e strattonato, non seppe dire ove mai si trovasse Monsignore. Gianmarcello ordinò a Baldassarre Archiopoli, che aveva conoscenze in Santa Sofia, di mettersi un po’ in giro per il paese nel tentativo di avere qualche notizia sul possibile rifugio. Egli stesso si mise alla ricerca di qualche persona conosciuta per venire a capo di quel che veramente lo interessava in quel momento. Passò e ripassò dai luoghi delle abitazioni delle famiglie più in vista di Santa Sofia; niente da fare. Anche le case dei Becci, dei Pizzi e dei Miracco di Sopra erano vuote; nei loro pressi non si vedeva anima viva; solo dal palazzotto di Giorgio Ferriolo si levavano alte le fiamme nel cielo. Tutto bruciava dai piani bassi su su fino al terzo piano, i mobili, la travatura in legno di rovere. Alla fine, forse anche la muratura sarebbe crollata. Anche qui sembrava che non ci fosse alcuno. Il Lopes s’era fermato con Ciccio D’Amico, che l’accompagnava, a vedere bruciare e rovinare la casa del Ferriolo, suo acerrimo nemico, col quale più volte s’era scontrato. «Ma dove può essersi nascosto questo Vescovo maledetto?» chiese ad un tratto Gianmarcello al D’Amico, ch’era suo fedele servitore e da più anni al suo servizio. «Eccellenza, ho girato per tutte le case del paese, sono andato per tutti i vicoli, le stalle, perfino a controllare nei pollai, e non ne ho trovato traccia» rispose D’Amico. «Forse non è vero che è rimasto a Santa Sofia» proseguì il servitore «altrimenti lo avremmo trovato. I caseggiati non sono 45 molti e li abbiamo tutti visitati. Il fratello del Vescovo non dice il vero: ha fatto capire che il fratello è in paese per non rivelarVi il luogo dove s’è rifugiato. Il Vescovo sarà certamente fuori Santa Sofia e qui, nella casa, sarà rimasto solo l’anziano fratello, che non ha nulla da farsi perdonare.» Mentre i due continuavano a discutere sulla presenza del Vescovo in paese ed a fare congetture sul possibile rifugio, dal vicolo che dava sul piazzale antistante la casa Ferriolo compare Donna Andronica Brunetti, figlia del notaio Giuseppe di S. Demetrio e vedova di don Terenzio Fasanella, donna che conservava ancora i tratti della bellezza giovanile, dal portamento altero e dotata di forte carattere. L’accompagnavano l’anziana domestica e i due guardiani armati. Era venuta per rendersi conto di persona dello stato di devastazione dell’edificio di Giorgio Ferriolo, cugino del defunto marito. La signora e gli accompagnatori rimasero sorpresi di trovare sul posto due briganti. Almeno tali sembravano dai vestiti indossati. I guardiani avevano posto mano sui fucili, pronti a sparare sui due alla prima mossa. Donna Andronica, ch’era di S. Demetrio e vi conosceva persone e cose, guardando attentamente i due, vi riconobbe immediatamente don Gianmarcello ed il suo fido servitore, Ciccio D’Amico. Uno dei Lopes, nemici di suo padre, era diventato brigante ed aveva dato fuoco alla casa Ferriolo. «Don Gianmarcello, siete arrivato così in basso da fare il brigante e per odio distruggere la casa di un galantuomo?» disse la donna al Lopes. «Io non ho dato fuoco alla casa. Sono qui per difendere il nostro Re Ferdinando, per combattere per la riconquista del Regno» rispose Gianmarcello, accusando all’evidenza un certo imbarazzo, ben consapevole che quella non era tutta la verità e che ciò che nascondeva doveva restare un segreto. Ma Donna Andronica, appartenendo ad una delle principali famiglie giacobine sandemetresi, conosceva perfettamente i profondi motivi di odio dei Lopes contro il Vescovo Bugliari, lo apostrofò con durezza: «Tu e la tua famiglia non difendete né Re Ferdinando e neppure la religione, come volete fare credere al popolino che avete ingannato. Voi difendete soltanto le terre che avete usur46 pato ai monaci di S. Adriano. Il vostro scopo è solo quello di fare fuori il Vescovo Bugliari per impadronirvi del Collegio greco e della sua amministrazione. Più volte avete attentato alla vita del Vescovo ed alla sua onorabilità, dal 1799, facendo assaltare il Collegio, di notte, dalla plebaglia al vostro servizio e successivamente tentando con false denunzie di farlo destituire.» «Donna giacobina, tu non sai quello che dici.» Punto sul vivo, Giamarcello stava per continuare il discorso, quando tutto trafelato arrivò Vatassarri Archiopoli, che gli disse qualcosa di urgente all’orecchio. Tutti e tre – Gianmarcello ed i due servitori – se ne andarono in tutta fretta. Dov’erano diretti? Vatassarri, nel suo giro per l’abitato ormai devastato e dato alle fiamme, aveva intravisto sotto l’ombra di una quercia una donna, che se ne stava sola. Gli era sembrato di conoscerla. Le si avvicinò e «Oh! Bertina, che fai da sola? Perché non sei scappata?» l’apostrofò. In effetti, era Bertina, originaria di S. Demetrio, ma che, da alcuni anni, era a servizio nella famiglia di don Cristofaro Scini di Santa Sofia. Tutta la famiglia s’era messa in salvo nella masseria di Serra di Zot, scappando al primo crepitìo degli spari degli assalitori. Non aveva fatto in tempo a seguire i padroni perché era fuori casa per un servizio. Ora era indecisa se andare o aspettare il loro ritorno. Nel frattempo, s’era rifugiata nel bosco di querce e, per la verità, ad ogni crepitare di foglie secche, era costretta a sobbalzare di paura. Bertina raccontò a Vatassarri della paura per i briganti, della fuga precipitosa la mattina presto degli abitanti rimasti dal paese con carri, asini, cavalli, birocci, a piedi, di corsa, verso le campagne ed i boschi. Molte famiglie erano scappate alcuni giorni prima e, per come si diceva, si erano rifugiate presso parenti o amici a Spezzano e a Strigàri, qualcuna anche a Macchia, ospitata nella casa di don Michele Rada. Ma – aggiunse Bertina – Monsignor Bugliari non aveva avuto paura: era rimasto in paese col fratello. Vatassari, fingendo disinteresse, ma molto attento alle parole di Bertina, osservò che anche il Vescovo probabilmente era 47 scappato nella campagna perché per il paese non si vedeva anima viva. «No» disse Bertina, «il Vescovo non è scappato. È certamente in paese perché, stamattina, mentre tutti scappavano, l’ho visto entrare nella casa di Bettina Miracco, che si trova a fianco a quella di don Cristofaro, dove sto io.» L’Archiopoli aveva avuto la notizia che cercava. Salutò Bertina, scusandosi di non potere intrattenersi oltre. In fretta e furia, corse per tutto il paese, finché non trovò il padrone per riferirgli la cosa. Fecero presto tutti e tre a trovare la casa di Bettina Miracco. Abitava Bettina in una casupola a due piani sovrapposti ed una soffitta, alla quale si accedeva attraverso una scala in legno che si trovava dietro la porta d’ingresso. Il primo piano era, in effetti, il piano seminterrato ed allo stesso si accedeva tramite una botola, posta ad un angolo con un’imposta di chiusura in legno del vano d’ingresso. Che era poi l’unica stanza abitata e fungeva da cucina, da soggiorno e da camera da pranzo. Il vano sottostante seminterrato serviva per la conservazione del grano e delle altre provviste. Bettina, che andava per la cinquantina, era vedova, senza figli, abbastanza sveglia ed in amicizia con le famiglie più elevate di Santa Sofia. Di mestiere faceva la pettinatrice, che esercitava da quanto era ragazza e che aveva appreso dalla madre, e consisteva nella cura, con cadenza settimanale, della pettinatura e della complicata acconciatura della capigliatura delle signore albanesi. Viveva dei proventi di questo mestiere: riusciva ad avere l’olio, il grano, il vino, la carne di maiale. L’esercizio del mestiere la portava ad avere rapporti amichevoli con le signore del luogo, nelle cui abitazioni ella si recava per eseguire le prestazioni. Conosceva il Vescovo da quando era stato parroco di Santa Sofia; aveva anche modo di vederlo e riverirlo, in questi ultimi tempi, quando si recava, per l’acconciatura dei capelli, nella casa della nipote, donna Maria, in cui era solito dimorare quando ritornava in paese. La mattina del diciotto agosto, nella confusione generale prodotta dal continuo ed, invero, insolito viavai di gente, era uscita sull’uscio della porta di casa, indecisa se restare o scappare nella campagna. 48 In quel momento, vide passare Monsignore che aveva bussato al portone di casa Masci, ma non aveva risposto nessuno; ritornava, quindi, alla sua casa, non curandosi del trambusto in atto. Dalla parte superiore del paese, si sentivano provenire numerosi spari di fucile. Se Monsignore avesse proseguito il cammino, probabilmente si sarebbe incontrato con la banda dei briganti. Bettina istintivamente pensò di invitare il Vescovo nella sua abitazione, magari per nasconderlo fino a che la malora non si fosse acquietata. «Eccellenza, dove andate? Non sentite che i briganti sono vicini? Entrate un momento nella mia povera casa» disse Bettina al Vescovo. «Bettina, non ti preoccupare. I briganti non hanno che farmi. E, poi, perché dovrebbero farmi del male?» rispose Monsignore. Ma Bettina quasi lo spinse all’interno dell’unica stanza, sicura che la povera abitazione non poteva essere un obiettivo per la banda. E, poi, chi avrebbe potuto pensare che il Vescovo si trovava nella casa di una umile popolana? Bettina nulla sapeva degli intrighi e degli attentati pregressi dei Lopes. Chiusa a chiave la porta di casa, si attardava nei pressi dell’abitazione, nel tentativo di capire se qualcuno della banda ce l’avesse con il Vescovo. Subito dopo, passò un gruppo di briganti; uno di loro diceva in albanese “Peshku neng ish te shpia” (il vescovo non era in casa). Capì allora che Monsignore era in pericolo. Di tutta fretta rientrò in casa; riferì a Monsignore le parole ascoltate. Lo pregò di scendere, attraverso la botola, nel piano sottostante. Sulla chiusura stese un rudimentale tappetino per nasconderla alla vista. Aprì di nuovo la porta di casa per non destare sospetti; di tanto in tanto si affacciava sull’uscio. Quando arrivarono Gianmarcello, Vatassarri e Ciccio D’Amico, trovarono la porta aperta ed entrarono come delle furie. «Dov’è il Vescovo?» gridò Gianmarcello. «Qui non c’è nessun vescovo. Che ci faceva un Vescovo nella casa di una miserabile?» rispose Bettina, imperturbabile. Vatassarri indicò la scala a Gianmarcello, come per invitarlo a salire. Anzi, salì egli stesso per ridiscendere subito dopo, evi49 dentemente deluso. A questo punto, il Lopes non sapeva che fare: si era trattato di una falsa o non esatta informazione. Quella misera casa non nascondeva nulla. Tanto meno un vescovo. Non restava che andarsene. Anche questa volta il Bugliari si era sottratto alla sua vendetta. D’Amico notò il rustico tappetino e lo scostò con un piede. Vide la chiusura in legno della botola e l’aprì. Scese lungo la scaletta e ritornò subito dopo con gli occhi iniettati di sangue. «Ah! Puttana, ci avevi gabbati. Il Vescovo è qua sotto» disse. Scesero nel vano sottostante: Gianmarcello in testa. Bettina si inginocchiò davanti all’immagine di S. Attanasio invocandone la protezione per Monsignore. Gianmarcello non credeva ai suoi occhi. Finalmente poteva soddisfare la vendetta, da tanti anni attesa. Col pugnale, colpì reiteratamente il Vescovo gridando “Morte al giacobino!”. Il Bugliari, mentre veniva colpito gli diceva: «Figlio, che ti ho fatto, perché mi uccidi? Giacché vuoi consumare il sacrificio della mia povera vita, ti benedico e ti perdono.» Vatassarri e D’Amico portarono il cadavere fuori e lo lasciarono per strada. Ma le parole di perdono del Vescovo dovettero colpire nel profondo il Lopes. Bettina, inginocchiata davanti al cadavere, lo sentì urlare mentre si allontanava con gli altri due: «Oh! Miei disperati pensieri, ove mi guidaste?» *** Il popolo pianse il suo Vescovo ricordandolo nel vajtim – canto funebre – che risuonò a lungo tra le colline e le soleggiate e popolose vallate di Santa Sofia. “Ascoltate, o buona gente, e piangete; piangete se le lacrime non sono ancora inaridite negli occhi vostri, dopo tanto pianto e cordoglio. Gemeranno col vento e cogli alberi, nelle notti di luna, i luoghi che videro fiorire la cima d’oro dei paesi albanesi, donde aquile volavano per il mondo i suoi figli.” S’erano messi in salvo i Sofioti nelle campagne, e avevano baciato la mano ed erano stati benedetti dal Santo Vescovo. 50 Fuggi, fuggi, gli aveva detto la voce dell’Angelo custode, fuggi, mettiti in salvo a Spezzano. «Maria, Maria» il Santo Vescovo chiamò la nipote scarmigliata, «Maria, porta ai parenti di Spezzano la mia benedizione e con te porta il mio affetto.» Partì la nipote carissima, accompagnata dalla Madonna. Il Santo Vescovo rimase e la furia dell’inferno si scatenò sopra Santa Sofia. Cento, mille, duemila diavoli, tutti i diavoli dell’inferno si scatenarono furibondi sopra Santa Sofia. Vennero i briganti di S. Benedetto, i briganti di S. Demetrio, i briganti di Longobucco e di Acri, tutti i briganti della terra. Re Coremme, re dell’inferno, era alla loro testa. Un urlo s’elevò dalle caverne dell’inferno, e ne fu scossa la terra. Fumava il palazzo del santo Vescovo, ventidue case erano una fornace ardente. Boati di sotterra: l’aria scoppiettava e tuonava. Correvano di qua, di là, più rossi delle fiamme, correvano, si sbracciavano, urlavano, bestemmiavano il nome santo di Dio, i briganti. Incendiavano, distruggevano tutto. «Il Vescovo, il Vescovo, dov’è il Vescovo?» urlavano le furie dell’inferno, e si guardavano, bestemmiavano, correvano in cerca del Vescovo, che era il bottino voluto dall’inferno. Lo trovarono pregando. Ristettero atterriti, guardandolo. Il santo Vescovo era circonfuso di luce e bontà e pregava per i suoi persecutori e li benediceva. Ristettero atterriti i briganti; alla fine il demonio armò le loro mani, li spinse… i pugnali lampeggiarono tutti; ventidue pugnalate finirono il santo Vescovo, che pregava e benediceva. Un grande urlo, un urlo d’orrore e di maledizione risuonò nell’aria. L’aria, gli alberi, gli uccelli ripeterono la triste notizia e la portarono per il mondo. 51 9 Dopo avere consumato il saccheggio di Santa Sofia, re Coremme con la sua masnada, Gianmarcello ed i suoi sgherri ritornarono in Acri. Domenico Antonio Bugliari, fratello del Vescovo e vecchio ottantenne, era uscito di casa in cerca del fratello. Lungo la strada, nella piazza a lato della chiesa matrice, incontrò Coremme e gli altri della compagnia. Riconosciuto dal Lopes, fu sequestrato da Vatassarri e D’Amico. Con le mani, legate dietro la schiena con una fune, fu portato in Acri e condotto nella piazza ove i briganti eseguivano le fucilazioni. Vi venne subito fucilato ed il suo corpo fu lanciato, come un tronco di legno, nel falò, tra spari e applausi dei presenti. Il parroco di S. Maria Maggiore ne annotò la morte violenta nel libro dei morti, non mancando di sottolineare che il suo corpo era stato bruciato: ejus corpus combustum fuit. Francatrippa, accecato dall’orribile strage degli innocenti del 18 agosto, conclusa con l’assassinio del vecchio Bugliari, pensò bene di attaccare e conquistare la vicina Bisignano. Incontrò la resistenza della guarnigione francese, ma anche dei patrioti del posto e di quelli di Acri, che ivi si erano precedentemente rifugiati. In più, in capo a pochi giorni, il 30 agosto, sopravvenne, da Cosenza, il corpo militare al comando del generale Verdier. La massa brigantesca fu sbaragliata: i briganti scapparono alla spicciolata precipitosamente per nascondersi tra i monti della Sila. Francatrippa, ferito a Spezzano Grande, riuscì a riunirsi alla banda di re Coremme, in Longobucco. In Acri, il Verdier fece processare e condannare alla pena capitale dalla Commissione Militare tutte le persone accusate di atti di brigantaggio che riuscì a catturare. Furono tutte fucilate ed i briganti più in vista ebbero tagliata la testa, esposta al 52 pubblico per ammonimento. Il feroce Jaccapitta, per i suoi atti di cannibalismo, fu bruciato vivo. Fu ricostituita l’Amministrazione Comunale e si ricompose la Guardia Civica. Regio Governatore fu nominato il giacobino di S. Demetrio Nicola Mazziotti. Ma gli animi erano inquieti; la pacificazione era soltanto apparente. Al terrore popolare del 18 agosto era seguito quello successivo dei galantuomini all’arrivo delle truppe francesi. Il fuoco era sotto cenere: dai borbonici acresi partivano messaggi pressanti e quasi giornalieri per re Coremme e Francatrippa invocandone l’intervento, da Longobucco. Domenico Ofrias e Tommaso Padula, sorpresi in possesso di simile corrispondenza, furono fucilati a Bisignano, i loro corpi fatti a pezzi e su due asini furono inviati a Acri. Quivi, la situazione diventava nuovamente pericolosa: alla difesa della cittadina furono lasciate solo alcune centinaia di soldati francesi che, insieme al corpo della locale Guardia Civica, non erano in grado di resistere all’urto di migliaia di briganti, provenienti dalla Sila e da Longobucco. La mattina del 14 ottobre 1806, le sentinelle che la Guardia Civica al comando del tenente Giuseppe Ferrari aveva dislocato sulle alture, immediatamente sopra la cittadina, sparano alcuni colpi di fucile: questo era il segnale che una banda di briganti stava per invadere la città. Al segnale, si chiusero le porte del palazzo Sanseverino, ov’erano i soldati della guarnigione e la Guardia Civica. Il predetto edificio era strutturato come una vera e propria piazzaforte. Vi si rifugiarono anche alcuni cittadini; altri che non fecero in tempo a scappare o che furono sorpresi per strada, caddero sotto i colpi dei briganti. E furono almeno in venticinque. Era arrivato re Coremme con una massa di quattromila briganti, che erano stati disposti in più punti sopra le colline di Acri in modo da essere pronti all’assalto. Egli si era fatto precedere dalla grande bandiera, dalla grancassa, dai pifferi e dai tamburi nei dintorni del palazzo baronale. Fu inutilmente intimata la resa: il tenente Ferrari si mise a tessere una paziente tela diplomatica col capomassa Coremme non tanto per raggiungere un accordo con lo stesso, bensì al fine di prendere tempo in attesa dell’arrivo dei soldati francesi da Bisignano 53 che, prestandosi meglio di Acri, per la posizione geografica, ad essere difesa, era stata scelta come sede del corpo militare francese. Pervenne la notizia a Bisignano: il comandante del presidio francese inviò messaggi al Comando in Cosenza ed egli stesso, con elementi della Guardia Civica, alcuni cittadini di Acri e di Bisignano, partì immediatamente per Acri per soccorrere gli assediati di palazzo Sanseverino, presso cui riuscì ad arrivare nonostante le replicate fucilate dei briganti. A questo punto, la massa si diede alla fuga, ritenendo che dietro al manipolo di soldati e guardia civica stesse per arrivare una forza più consistente. Alcuni altri briganti, che erano appostati sulle alture di Acri, la richiamarono, assicurando che altri corpi di soldati non erano in cammino e che, di conseguenza, il piccolo numero, accorso in difesa degli assediati, era addirittura entrato nel palazzo per non essere sopraffatto. Ritornarono, quindi, i briganti ad occupare Acri; con loro vi erano pure i borbonici di S. Demetrio, che dimostrarono non minore ferocia e determinazione degli acresi nel partecipare alla strage di patrioti. Il sandemetrese guardiano di porci, Vincenzo Mendicini, detto Coltellazzo, seguace del Lopes sin dall’assalto e saccheggio del Collegio greco, non andava per il sottile nelle esecuzioni capitali: tagliava la testa ai malcapitati. L’anno seguente (1807), sarà egli stesso condannato a morte dalla Commissione Militare di Cosenza per avere reciso con un coltello la testa del Governatore di Acri, Nicola Mazziotti, e per averla mostrata al pubblico col dire che così voleva fare con tutti i giacobini. Francatrippa, a causa della ferita riportata a Spezzano Grande, era stato costretto a restare in Longobucco. Re Coremme avrebbe voluto lasciare una parte dei suoi uomini in Acri e muovere verso Bisignano per occuparla e, poi, unirsi ad altre masse brigantesche, per occupare Cosenza. Non riuscì a mettere in atto tale proposito per l’arrivo del generale Verdier con un reparto dell’esercito. I briganti, contando sul numero e sulle posizioni occupate, resistettero ostinatamente per qualche ora. Alla fine si dispersero per la Sila, ma i più ritornarono a Longobucco con Co54 remme. Il generale Verdier li inseguì nel tentativo di sorprenderli e distruggerli nella stessa Longobucco. I briganti, impauriti dall’imminente arrivo dell’esercito francese, lasciarono Longobucco. Si rifugiarono parte nelle campagne del Marchesato di Crotone e parte nelle montagne silane, nascondendosi nei folti boschi di abeti. Alla fine, Coremme e Francatrippa scapparono in Sicilia. In Acri, la Guardia Civica organizzò la caccia ai briganti nelle campagne: furono catturati e passati per le armi Antonio Bonvenuto e cinque suoi compagni. Il prete Antonio Rosa Cozza fu catturato nella Sila dal generale Verdier e condannato a morte per impiccagione dal tribunale di guerra. In Bisignano, dove si erano nascosti, furono fucilati il fratello Giuseppe Rosa Cozza, soprannominato il Tedesco, e Nunziato Adimari, detto Riverito. Dov’era finito Don Gianmarcello Lopes con i suoi sgherri? Il Coltellazzo fu arrestato, menato nelle carceri di Cosenza, dove fu eseguita la condanna a morte, decisa dalla Commissione Militare. Lopes, Vatassarri e D’Amico, da Longobucco, dove avevano seguito Coremme, scapparono per rifugiarsi tra i monti della Sila e da qui raggiunsero Amantea, sul Tirreno, che, assediata, opponeva strenua resistenza ai francesi. Alla fine, il colonnello realista Rodolfo Mirabelli dovette prendere atto che la resistenza antifrancese non era più possibile. Nel febbraio 1807, chiese la resa che i francesi accordarono a condizioni onorevoli, con il riconoscimento della condotta generosa dei difensori e dello stesso Comandante, che furono lasciati liberi e – per chi lo desiderasse – anche con la facoltà di andare in Sicilia. Tra i difensori s’erano create due fazioni: una proponeva la resa onorevole; l’altra, invece, la resistenza ad oltranza. Don Gianmarcello era per la difesa ad oltranza: venne, per questo, in contrasto violento col Mirabelli; percorse le strade di Amantea per incitare la popolazione a non arrendersi, ricorrendo anche a minacce e violenze verbali nei confronti di chi non condivideva la sua tesi. Tutti i difensori, che si erano opposti alla resa, cercarono inutilmente di salvarsi con la fuga. Furono tutti presi, compresi Gianmarcello e gli altri due compagni. Rinchiusi nel carcere di Cosenza, furono giudicati dalla Commisione Militare e con55 dannati alla pena capitale. Per il Lopes, D’Amico e l’Archiopoli, la sentenza di condanna alla pena capitale fu pronunziata il 18 febbraio 1807 ed eseguita entro le 24 ore successive. Don Francesco Saverio Lopes e don Flaminio Tocci furono pure arrestati nel 1807 e detenuti nel carcere di Cosenza. Naturalmente anche loro correvano il grave rischio di subire una condanna a morte per i trascorsi atti di violenza e di ribellione in combutta con le masse brigantesche. Il pericolo era reale e non solo ipotizzato. Solo che, non essendosi eccessivamente esposti come don Gianmarcello, potevano sperare di avere una condanna più mite, dimostrando alla Commissione, attraverso testimonianze compiacenti, di non essere colpevoli. Né a loro mancavano i mezzi economici, le aderenze, i comparaggi per potere sostenere e supportare la loro estraneità ai fatti di cui erano accusati. Don Flaminio Tocci e don Francesco Saverio Lopes potevano fare affidamento sulle testimonianze dei loro numerosi dipendenti, amici e parenti. Le loro rispettive famiglie avevano profonde radici, da almeno due secoli, nel territorio; coinvolte in diverse vicende, tristi e liete, in sconfitte e vittorie nelle lotte antifeudali, non solo per la ricchezza acquisita, ma anche attraverso l’esercizio di professioni liberali, potevano contare, a Cosenza e provincia, su aderenze rilevanti ed influenti. Per don Gianmarcello non era stato possibile muovere qualche influente amicizia per evitargli la condanna a morte, perché colto in flagrante con le armi in pugno e per essersi fattivamente opposto alla resa di Amantea e ribellato allo stesso comandante Rodolfo Mirabelli, che già aveva dato la sua parola d’onore e concordato con i francesi il giorno e l’ora della resa. Col suo comportamento intransigente, di fatto, il Lopes aveva fortemente indispettito le autorità militari francesi e gli stessi moderati del partito borbonico, precludendosi ogni possibile via di salvezza. Per gli altri, il tentativo era possibile; bisogna ritenere che fu positivamente ed autorevolmente posto in essere. Fu lo stesso Sostituto Regio Procuratore Generale che chiese la rimessione in libertà di don Flaminio e di don Francesco Saverio. Il 30 agosto del 1811, nel carcere di Cosenza, Don Flaminio aveva fatto donazione di tutti i suoi beni a don Francesco Bel56 lushi, fornitore dell’esercito francese. Nel marzo successivo, riacquistò la libertà. Don Francesco Saverio era stato scarcerato nel corso del 1811. Anch’egli si spogliò di tutti i suoi beni in favore delle tre figlie, di cui la prima aveva sposato Angelo Bellushi, fratello di Francesco. Visse fino al 1830, senza letto e senza tetto, povero e misero, accolto nella casa del cugino Luigi Antonio. 57 10 Don Francesco Bellushi non lasciò passare tempo per prendere possesso dei beni che gli erano pervenuti con la donazione fatta in suo favore, nel carcere di Cosenza, da don Flaminio il 30 agosto del 1811. Dalla collina della Presila fino a lambire la pianura di Sibari si estendeva il grande patrimonio terriero donatogli con i vasti uliveti, i vigneti, i gelseti, i frutteti, i seminativi e i pascoli di Bardara, Milaino, Casino, Corvino, Campanaro, Frasciro, Cicirello, ed il trappeto e la grande casa palazzata con l’annesso villino di palme, che troneggiava in mezzo all’abitato. Si trattava di centinaia di ettari di terreno fertile, in cui lavoravano diverse famiglie di contadini, che risiedevano sul posto. Ogni fondo aveva la sua modesta casa colonica, fatta di due stanze, con nei pressi il porcile per l’allevamento dei suini neri, la stalla per il ricovero dell’asino e dei buoi aratori, l’ovile per capre e pecore. Ogni componente della famiglia aveva la sua mansione: i ragazzi erano addetti al pascolo degli animali minuti; i grandi, chi alla semina, chi alla cura del frutteto o del vigneto. Il gelseto serviva per l’allevamento del baco da seta, destinato ad essere raffinato nelle filande di Acri. I guardiani controllavano l’andamento dei singoli lavori ed erano anche i gelosi custodi della roba del padrone, sorvegliando sull’integrità dei confini dei fondi. Essi costituivano un gruppo di dieci persone che, giorno per giorno, dopo avere ricevuto le disposizioni padronali, partiva per le varie proprietà rurali. La sera, al ritorno, aspettavano, nell’atrio del palazzo padronale, di essere ricevuti uno ad uno per fare al signor padrone la relazione quotidiana e riferire, anche nei minimi particolari, gli accadimenti della giornata. 58 Nel periodo ottobre-marzo e, a volte, con l’appendice di aprile, entrava in funzione il grande trappeto per la produzione dell’olio di oliva. Venivano lavorati migliaia di quintali di olive che squadre di donne raccoglievano e la sera, alla fine del lavoro, caricavano sulle spalle come bestie da soma e trasportavano nell’olivaio padronale, percorrendo chilometri di sentieri con la pioggia, il vento, le intemperie e col fango. La loro retribuzione era in natura: consisteva in un quinto del prodotto raccolto nella giornata. Di tanta ricchezza, prodotta da centinaia di persone, uomini, donne e bambini, che lavoravano come formiche nei tenimenti padronali, sotto la sorveglianza quasi sempre arcigna del guardiano, Don Francesco Bellushi era il padrone geloso che, accumulava tanto ben di dio e, poiché il denaro bene impiegato produce altra ricchezza, estendeva, di anno in anno, i confini delle sue terre, acquistandone delle altre. Si era, così, venuto ingrandendo a dismisura, accorpando alle sue terre, in fasi successive, buona parte di quelle quote di terreno che il governo aveva tolto ai soppressi enti ecclesiastici ed assegnato a contadini poveri senza terra. Costoro, infatti, lasciati senza un iniziale sostegno che gli consentisse una concreta trasformazione agraria, come pure sarebbe stato necessario, in prosieguo di tempo, si erano indebitati a dismisura con i grandi proprietari, ai quali, alla fine, erano stati costretti a cedere le terre. In Matermara o Arberia, com’era anche chiamato il paese nella lingua locale, don Francesco era diventato senz’altro il più ricco dei proprietari. Il catasto dei terreni, fatto compilare dal governo, sotto il suo nome, contava pagine e pagine elencandone tutti i fondi posseduti, la località, l’estensione, la qualità, le colture praticate. Ed erano alcune centinaia di ettari con numerosi fabbricati rurali, nei quali si svolgevano tutte le attività agricole e quelle connesse della zona: l’uliveto, il vigneto, il ficheto, il frutteto, la semina del grano, dell’orzo e dell’avena, la bachicoltura, l’allevamento degli animali ovini, suini e bovini, la molitura delle olive. Don Francesco, che prima di trasferirsi in Arberia per prendere possesso del patrimonio terriero donatogli da don Flaminio, era stato partigiano e vivandiere dell’esercito francese, ac59 compagnandolo nei vari accampamenti nella Calabria Citeriore, certamente non aveva smesso di sventolare la bandiera francese. Ma, ora, non in nome degli immortali principi, bensì, più volgarmente, in difesa del proprio patrimonio fondiario e del sacro diritto di proprietà, consacrato anche nel codice civile e nelle leggi, che, però, un sottoproletariato affamato metteva concretamente in discussione con l’aggressione e l’estorsione dei proprietari e con mille altri modi selvaggi fino all’assassinio. Don Francesco non correva pericolo alcuno, difeso com’era dai suoi guardiani, che costituivano una vera e propria guardia del corpo e non lo lasciavano mai solo: neppure in casa sia durante il giorno che la notte. Il suo corpo di guardia gli consentiva di muoversi liberamente nel territorio e di arrivare fino a Cosenza per badare ai suoi affari. A Cosenza, poteva contare su diverse entrature, dentro gli stessi uffici della Intendenza e nel Tribunale, dove suoi parenti ed amici erano impiegati. Era egli, si può dire, non solo in sintonia con i dirigenti della pubblica amministrazione, ma a contatto diretto sia per il pregresso e prezioso servizio, prestato nell’esercito francese, sia perché suoi stretti parenti facevano parte della nuova burocrazia del Decennio ed erano tra gli importanti nel capoluogo della provincia e, quindi, in grado di aprire tutte le porte e di intervenire efficacemente presso i detentori del potere politico del momento. Aveva chiesto ed ottenuto il monopolio della vendita dell’olio in città. Si trattava di un affare che gli fruttava particolarmente fior di quattrini. Due volte al mese, faceva i trasporti dell’olio a Cosenza. Caricava su due traini animali, tirati da muli, numerosi fusti di olio. La mattina, sul fare del giorno, partivano da Matermara, scortati da uomini armati di tutto punto per prevenire gli assalti dei briganti. Attraverso viottoli e stradelle, buone per bande armate, facevano un viaggio tormentato, con alcune soste al bivio di Bisignano ed a Montalto, per arrivare a Cosenza la sera. La sera del giorno seguente erano di ritorno. Nell’arco di alcuni anni, don Francesco riuscì a consolidare il suo potere economico in Matermara/Arberia, accorto com’era nell’amministrazione e nella gestione del vasto patri60 monio fondiario e assai abile nelle intraprese commerciali. In breve tempo, risultò, di conseguenza, che anche la sua posizione sociale ne guadagnò. Nessuno ricordava più la sua umile origine, la pregressa mansione di distributore di vivande ai soldati francesi negli accampamenti e nelle caserme. Ora, il suo nome era riverito, stimato e considerato. Egli ormai si era collocato al vertice della nuova gerarchia sociale, che s’era venuta costituendo con il nuovo assetto politico e amministrativo del regno di Napoli, dopo la conquista francese. Anche le bande di briganti, che si aggiravano tra i folti boschi della zona, lo rispettavano o, più verosimilmente, riusciva a tenerle al largo dal palazzo e dalle sue masserie mediante dazioni di viveri e di denaro, che naturalmente in segreto corrispondeva loro o faceva pervenire tramite i suoi fidatissimi guardiani. Non era raro il caso che comitive di malfattori, in numero di quindici-venti, in pieno giorno penetrassero in Arberia e assalissero il palazzo di qualche galantuomo: i più ne restavano fuori a guardia e protezione dei tre o quattro che vi entravano, facevano man bassa di viveri e denaro e poi scappavano per nascondersi nella boscaglia, inutilmente inseguiti dalla guardia urbana. Tali azioni banditesche non erano eccezionali, ma si ripetevano nel tempo ed evidentemente dovevano fare affidamento anche sulla cooperazione e sul comportamento omertoso della maggioranza della popolazione, delusa nelle aspettative di riscatto sociale. L’eversione della feudalità l’aveva sciolta dai vincoli e dalle prestazioni personali nei confronti dei feudatari grandi e piccoli, laici od ecclesiastici. Però, il numeroso sottoproletariato di foresi, pastori, garzoni, contadini senza terra, guardiani di pecore, di suini, di bovi, e degli altri nullatenenti senza speranza, era rimasto nella condizione di prima. Al feudatario di prima, ora si era sostituito un padrone più esoso che era costituito dai gruppi di proprietari, arricchitisi con rapine e usurpazioni nel corso del Settecento, che il nuovo regime largamente favoriva con la legittimazione dei pregressi possedimenti fondiari. Questa gente costituiva la categoria sociale dei nuovi signori. A questi altri se ne aggiungevano, di recentissima for61 mazione: i coloni ed i massari benestanti, diventati proprietari delle terre, anche per acquisti successivi, erano promossi nel novero dei civili e, cioè, dei signori riveriti e rispettati. Paolo Rada era un massaro che conduceva i terreni baronali, posti tra Campanaro e Corvino. Con la moglie Dìela Petta e poi, quando vennero i figli, con tutta la famiglia, seminava il grano, i ceci, le fave, coltivava il terreno irriguo, aveva impiantato un uliveto ed un vigneto, allevava una mandria di pecore. Pagava la decima al barone, ma nel tempo di una generazione, disponeva di una discreta ricchezza. Un suo nipote, Michelangelo, ebbe la possibilità di studiare nel Collegio greco; divenne sacerdote e, poi, parroco di Maki, riscattando la famiglia dalla primitiva condizione sociale, collocandosi nel ceto dei civili. Tutta questa gente fece la rivoluzione sociale in Arberia, piantando – prima – nella piazza del paese l’albero della libertà, schierandosi, poi, con la Repubblica di Napoli e con i francesi. Pagò pure il suo tributo di sangue nel corso della reazione borbonica, tuttavia, seppe resistere alla repressione. Divenne classe dirigente nel Decennio, mantenendo la propria egemonia anche in seguito; nel corso della Restaurazione, con i suoi intellettuali, fu promotrice del movimento liberale ed anche di generose utopie. Ma tra contadini poveri e braccianti senza terra o possessori di piccoli quozienti di terreno, restati esclusi dai benefici dell’eversione della feudalità, e la borghesia rurale ovvero il ceto civile benestante, che deteneva anche il potere politico nel municipio, non vi fu mai vera intesa e collaborazione. Le condizioni di miseria e di precarietà nei ceti subalterni, la fame di terra, l’ignoranza, la superstizione, già nel periodo francese, alimentavano forme di brigantaggio: gruppi di persone si associavano per operare sequestri, estorsioni, furti, rapine. Don Angelo Bellushi, fratello di don Francesco, che aveva sposato una Lopes e stava a San Demetrio nel vecchio palazzo che una volta era di don Gianmarcello, si era recato in Acri dal notaio Zanfini. Al ritorno, quando attraversava i boschi di Calamia e S. Angelo, nel tardo pomeriggio del 18 giugno 1815, fu assalito dalla banda di Friddizza, depredato del denaro e assassinato. 62 Don Francesco, che non aveva figli, ne adottò il figlio minore, Alessandro, che si trasferì in Matermara, nel palazzo dello zio. 63 11 Quando fu rimesso in libertà, nel pomeriggio del 18 marzo 1811, don Flaminio era atteso alla porta del carcere di Cosenza dal fratello don Leonardo. I due, dal colle Triglio, attraversarono la stradina stretta che li portò a valle, a ridosso del Busento, nella locanda del Bersagliere, ove pernottarono, per poi partire di buon’ora, nella mattinata seguente, a bordo del calesse di famiglia. Nel tardo pomeriggio contavano di giungere in Arberia. Il viaggio era pieno di pericoli; bisognava fare molta attenzione nella scelta del percorso. Giunti alla taverna di Mocciaro, nei pressi di Montalto Uffugo, alla riva sinistra del Crati, attraversarono il varco di Finita, la pianura di Luzzi e, dopo avere costeggiato l’abitato di Bisignano, si inerpicarono per la collina che conduceva a Gaudio e Grottile di S. Sofia. Da qui passarono nelle terre del Collegio greco, raggiunsero Macchia dell’Orto ed i sottostanti Due Mulini, dove sostarono per fare riposare i cavalli e per rifocillarsi. In quel luogo, si sentivano ed, in effetti, erano al sicuro per essere, da più tempo, in amicizia con Tagliuzzo, il mugnaio proprietario dei due mulini ad acqua, posti su di un costone nei pressi di un affluente del fiume Mezofato. Tagliuzzo che, come al solito, si trovava quasi sempre sul posto a ragione del suo lavoro, accolse amichevolmente i due fratelli, li ospitò nel locale, posto a lato dei mulini, li aiutò a sistemare i cavalli alla mangiatoia e apparecchiò sul suo umile desco pane, formaggio, salsiccia e vino. I due fratelli si rifocillarono, contenti di essersi fermati in luogo conosciuto e di avervi trovato un vecchio amico, che li aveva affabilmente accolti. Dopo qualche ora, ripartirono per l’Arberia; scavalcata la salita ripida e malagevole di Sughereto, 64 piegarono per Campanaro e da qui scesero per il torrente, che costeggia Ambolo. Era ancora giorno quando vi arrivarono; ancora, per i campi, si vedevano gruppi di operai al lavoro, i foresi con i greggi di capre e di pecore al pascolo e, qua e là, i guardiani. Ambolo, Corvino, Campanaro e tutti gli altri terreni che attraversavano, Comesse, Bardara, Gramano, Serracavallo, Turibolo, Casino, con le vigne e gli oliveti in piena produzione, prima della maledetta donazione erano tutti suoi. Da orridi boschi di querce, lecci, eriche ed innumerevoli altre piante selvatiche, sparse tra dirupi ed anfratti, nell’arco di un trentennio, li aveva bonificati, trasformandoli in terreni altamente produttivi, costruendovi anche casette rurali, ripari e mulini e gualchiere nei pressi delle fiumare di Pisciacane e Mezofato. Ora, tutto questo patrimonio non era più suo. L’aveva dovuto donare a don Francesco Bellushi per sfuggire alla prigione e, forse, alla condanna alla pena capitale. Attraversava triste e mesto, con un groppo alla gola, il vasto territorio, che fino a mesi addietro era come il suo feudo, senza che nessuno lo salutasse e lo riverisse come una volta. I guardiani di don Francesco lo vedevano passare mostrando una visibile indifferenza, come a volere dire: chi è costui? Non s’era mai visto uno, liberato dalla prigione, triste e disperato come don Flaminio. Un cane battuto sembrava. E lo era veramente: perdute tutte le sue ricchezze, non era più un uomo: perché non era libero. Neppure era nella condizione fisica di potere rifare la strada, recuperando i suoi beni, facendo rivivere i tempi felici. Tutto era passato; della ricchezza di una volta gli era rimasto solo l’inutile “don” accanto al nome. Ritornava in Arberia, non come una volta, pieno di forza e di vitalità, ma – ora – come un prigioniero, tenuto da invisibili e, però, pesantissime ed inestricabili catene. Anche il palazzo aveva perduto. L’aveva costruito pietra su pietra, mattone su mattone, accanto a quello paterno, dotandolo di tutti i conforti. Nel vasto spiazzale, antistante al palazzo, aveva costruito un altro ampio fabbricato; nel piano terreno vi aveva sistemato il trappeto e, nel piano soprastante, l’olivaio. Dall’autunno inoltrato e per tutto l’inverno e, talvolta, fino alla metà di aprile, macinava, trasformandole in olio, le olive dei 65 suoi oliveti, che le donne del paese facevano a gara a raccogliere per procurarsi il fabbisogno di olio per l’annata. La vista di un luogo e di una qualunque cosa che, prima, gli erano appartenute, lo metteva in agitazione. Non riusciva ad accettare questa nuova situazione di non essere padrone di nulla, che pure lui aveva determinato con la sottoscrizione dell’atto notarile di donazione. Forse, al momento dell’apposizione della firma, non si era perfettamente reso conto di essere passato, da un momento all’altro, nella condizione di nullatenente; sopraffatto dall’idea di sfuggire ad un lungo periodo di carcerazione, smanioso di superare, in qualunque modo, il brutto periodo in cui era incappato e l’inferno in cui era caduto, non aveva considerato quale sarebbe stato il resto della sua vita. Don Francesco – come se l’avesse fatto di proposito – nulla aveva trascurato per rendergli tragicamente traumatico il passaggio alla nuova condizione di vita. Immediatamente dopo la donazione, si era astutamente impossessato di tutti i beni, passando ad abitare stabilmente nel palazzo e sostituendo il personale dipendente con uomini e donne di sua stretta fiducia, temendo che, per qualche cavillo di avvocati, don Flaminio, una volta liberato, avrebbe potuto rientrare nel possesso dei beni. Don Leonardo, nel corso del viaggio, gli aveva spiegato minuziosamente tutti gli intervenuti mutamenti; una cosa, però, è il sentire ed altra è il constatare con i propri occhi la gravità della situazione. Quando, col calesse, attraversarono la strada che quasi rasentava la bella casa del Casino e l’aia antistante ed il rigoglioso uliveto ed il vigneto, trasalì improvvisamente per l’emozione: vide, sul pianerottolo della casa, persone che egli non conosceva e che neppure lo salutarono e, così, nell’aia, bambini si rincorrevano e giocavano vociando, ma non erano i figli del suo colono. In quella casa, che era ampia e spaziosa, composta di numerosi locali ed in cui don Flaminio di tanto in tanto andava a fare bisboccia con i suoi amici ed incontrava le sue arrendevoli amanti contadine, don Francesco vi aveva sistemato il proprio figlio naturale, Gaetano Cozza, con la famiglia. Gaetano era anche il capo dei nuovi guardiani e sovrintendeva ai lavori in 66 tutti i fondi, che ispezionava in modo continuativo ed accurato. Il nuovo padrone imponeva una nuova legge. «Quando mi hanno riferito che, nel tuo palazzo, c’era venuto un signore che nessuno conosceva, con altre persone al suo seguito, sono subito accorso per vedere che cosa era accaduto» – disse don Leonardo al fratello e continuò: «quel signore fu molto gentile con me: mi disse come si chiamava, da dove veniva, che cosa era venuto a fare. Mi mostrò un atto pubblico di donazione, rogato dal notaio Casini di Cosenza in virtù del quale era diventato il nuovo proprietario e che si era obbligato nei tuoi confronti a garantirti il vitto e l’alloggio. Naturalmente, rimasi interdetto e non seppi che pensare. In pochi mesi, Don Francesco sostituì tutto il personale dipendente ed i vari coloni con persone di sua fiducia, molte delle quali non sono del luogo. Ma chi ti ha indotto a tale pazzia?» concluse Don Leonardo. «Fratello mio, chiuso nel carcere del Castello di Cosenza, senza potere vedere un volto amico, ero alla disperazione. Quando seppi da uno dei carcerieri che nostro cugino Gianmarcello Lopes ed i suoi due amici Baldassarre Archiopoli e Francesco D’Amico erano stati condannati a morte e subito dopo fucilati, ho avuto paura di fare la stessa fine perché anche io ero accusato di brigantaggio. Ti confesso che assai mi dispiaceva di morire. Mi arrovellavo di potere trovare una via di scampo, ma non sapevo che fare e come muovermi.» «Ma non avevi un avvocato?» chiese don Leonardo. «L’avvocato Mario Gabriele, al quale promisi un lauto compenso se almeno mi avesse aiutato a scampare alla fucilazione, mi fece toccare con mano la gravità della situazione. Mi riferì che ero accusato di azioni di brigantaggio, concorrendo negli omicidi di Lucia Braiotta, di Francesco Pace, di Vincenzo Candreva, del vescovo Bugliari e di avere aiutato i fratelli Minisci nell’occupazione di Matermara con l’innalzamento della bandiera borbonica, consentendo anche che fosse bruciato vivo nel campanile della chiesa Francesco Saverio Stringalo. Secondo l’avvocato, il numero e la gravità delle accuse non lasciavano sperare bene. Ed io ad implorarlo di trovarmi una qualche via di salvezza. Allora egli mi riferì che chissà, forse i fratelli Don Angelo e Don Francesco Bellushi avrebbero potuto aiutarmi. Avevano molte entrature e amicizie con gli ufficiali 67 dell’esercito francese, essendone i vivandieri e potevano contare su loro stretti parenti, impiegati nel tribunale e nell’amministrazione. Forse avrebbero potuto darmi una mano per sfuggire alla pena capitale. Egli, se io lo autorizzavo, avrebbe chiesto ai Bellushi di visitarmi nel carcere. Così, avrei potuto parlare direttamente con loro.» «Oh, santo Iddio! E non l’hai subito autorizzato?» «Sì, l’ho autorizzato. Effettivamente, dopo qualche settimana, una sera, Don Angelo e Don Francesco Bellushi mi fecero visita. Io li implorai di aiutarmi, che almeno avessi salva la vita. Mi dissero, senza nulla promettermi, che avrebbero dovuto prima rendersi conto di com’era la mia situazione per, poi, considerare se e come intervenire. Mi chiesero – ed io nulla nascosi – se e che beni avevo, quale era la mia disponibilità economica, perché si trattava di elementi e di condizioni da prendere in considerazione. Probabilmente, anzi certamente, nell’ipotesi che fosse stato necessario ungere le ruote. Almeno questo mi sembrò il senso. Ci salutammo: mi dissero che si sarebbero fatti vivi loro, senza che io insistessi a chiamarli.» «Sventurato fratello» disse Don Leonardo asciugandosi le lacrime che gli rigavano il viso «solo io ti sono rimasto, che non sono stato in grado di fare nulla per te. Gli altri fratelli, che avrebbero potuto aiutarti, sono scomparsi anzitempo: l’ultimo, Guglielmo, pochi anni prima della tua disgrazia. Una tempesta infernale ti ha allontanato da noi, da Donato, da Terenzio, da Guglielmo, tutti fiori di intelligenza e di cultura, e da me, che pure ti avevo consigliato di separare il tuo destino da quello di Gianmarcello Lopes. Ah, se avessi potuto immaginare l’abisso in cui ti sei calato, che cosa non avrei fatto per distoglierti dalla strada intrapresa.» Ora, Don Leonardo piangeva a calde lacrime per il dolore morale e per il rimorso di non avere fatto tutti i tentativi possibili per fare desistere il fratello e per distoglierlo dalle azioni criminali, poste in atto non per fede politica sanfedista e borbonica, ma per seguire Gianmarcello. Sarebbe stato sufficiente che Don Flaminio si fosse ritirato dopo l’assalto al Collegio greco, nel 1799, per salvarsi. A nulla erano valse le esortazioni del fratello Guglielmo, canonico della Cattedrale di Rossano ed eminente teologo, di Terenzio e di Donato, che studiavano a 68 Napoli; tutti e tre lontani dal sanfedismo, che ritenevano impastato di superstizione e di peccato, e schierati, invece, con le avanguardie intellettuali riformatrici meridionali. Donato aveva sacrificato la sua giovane vita in difesa della Repubblica, ucciso dai lazzari che lo trascinarono, per le vie di Napoli, legato alla coda di un cavallo. Non c’era stato nulla da fare. Don Flaminio era come preso da un istinto cieco, irrefrenabile, che lo dominava in modo assoluto e lo portava, a suo piacimento, sulla via del delitto, la cui iniziativa non aveva mai fatto capo a lui, ma ad altri. Così, era successo per l’assalto a Santa Sofia e così anche per l’occupazione di Matermara, durata tre giorni. Don Flaminio si era unito alla banda dei fratelli Minisci Michelicchio, che avevano innalzato nel municipio il vessillo borbonico ed avevano dato fuoco al campanile della Chiesa, dove s’era rifugiato don Francesco Saverio Stringalo, che nessuno poté soccorrere e fu sacrificato tra le fiamme del campanile. Nel frattempo, i due erano arrivati nel palazzo di Don Leonardo, posto nel dorsale della Conicella, in mezzo a piante d’ulivo, di fichi e di gelso, circondato da una fitta siepe di arbusti e di acacie, con un’ampia cancellata in ferro battuto che dava sul viale. «Dopo qualche settimana» riprese a dire Don Flaminio, stando ancora in piedi e poi sedendosi sulla poltrona davanti al focolare «venne nel carcere il solo Don Francesco: mi disse che, considerata la gravità dei fatti attribuitimi, occorreva una forte somma per tentare di portare buon fine la cosa. Egli, comunque, non era in grado di garantire nulla, data la delicatezza dell’affare. Non mi ci volle molto per capire che bussava a denaro. Gli dissi che, al momento, non ne disponevo; se fossi stato posto in libertà, lo avrei lautamente ricompensato. Notai che aveva fatto una smorfia: non accettava promesse, voleva il denaro in contanti. Egli stesso, però, mi suggerì la soluzione: avrei dovuto fargli donazione di tutti i miei beni, riservandomi il vitto e l’alloggio vita natural durante, come pegno e garanzia della promessa di ricompensarlo. Così, dopo la mia liberazione, io gli avrei consegnato il denaro e, contemporaneamente, avremmo annullato l’atto di donazione. Questi i patti che mi furono imposti. Dopo qualche giorno, Don Francesco venne in 69 carcere, accompagnato dal notaio Casini, che mi fece sottoscrivere l’atto di donazione. Firmai, senza frapporre ostacoli, nella convinzione che, se fossi stato rimesso in libertà, in poco tempo, avrei estinto il debito. Se la cosa non fosse andata a buon fine per una mia condanna, io stesso o i miei eredi avremmo potuto chiedere l’annullamento dell’atto di donazione perché mi era stato estorto in carcere.» «Allora, non tutto è ancora perduto» sottolineò Don Leonardo. «Bisogna assolutamente andare da Don Francesco per mettere in chiaro le cose. Domani mattina andremo da lui, di prim’ora.» La vecchia Viatrigia Buscia aveva, intanto, preparato la cena. I due fratelli cenarono, quasi senza parlare, ambedue pensosi e assorti per quel che sarebbe successo l’indomani. Quella notte, Don Flaminio non prese sonno. Non ricordava più dopo quanti anni era tornato a dormire nella casa, costruita dal padre, Don Giovanni Andrea, che era anche il parroco di rito greco in Matermara. Affluivano nella sua mente i primi ricordi dell’infanzia felice e dei giochi con i fratelli sotto gli occhi amorosi della madre previtera, Donna Dìela Lopes. Tutti, ora erano scomparsi: anche i fratelli, di lui più giovani. Solo lui e Leonardo erano sopravvissuti. Ricordava i primi screzi col padre, che gli consigliava prudenza e cercava di distoglierlo dalla solidarietà stretta col cugino Gianmarcello. Non era necessario provocare il Vescovo del Collegio greco più di tanto – gli diceva. Che bisogno c’era di rovinargli i pascoli, di incendiargli alcuni fondi, di diffamarlo propalando notizie non vere con il solo scopo di mettergli contro la popolazione? Non era nel loro interesse seminare la zizzania tra la popolazione. Loro avevano un considerevole patrimonio fondiario, che gli consentiva di vivere bene, di studiare e di progredire. Non v’era veramente alcun serio motivo di rivalsa nei confronti del Vescovo. Lasciasse stare i Lopes: essi erano spinti soprattutto da rivalità politica. «Per noi» spiegava pacatamente Don Giovanni Andrea «la condotta del Vescovo è una benedizione del Signore: ci accoglie nel Collegio, ci istruisce, ci fa veri uomini. Aiuta la popolazione a progredire, facendola uscire dall’ignoranza. Bisogna lasciarlo fare perché è una delle personalità eminenti della Calabria Citeriore ed è in grado di agire nell’interesse ge70 nerale. Dicono che è giacobino? Ma la gente neanche sa che significa giacobino. Egli predica la solidarietà evangelica e la attua nell’educare la gioventù. Predica la fratellanza e la libertà, che sono le fondamenta del Santo Vangelo. Accoglie i poveri ed ha predisposto una mensa giornaliera per loro. Questo vuol dire essere veri cristiani e non distruttori della religione, come vanno dicendo i suoi detrattori. Non può permettere che il Collegio greco sia spogliato delle sue terre perché, senza il ricavato dei terreni, non potrebbe pagare i professori e dovrebbe chiudere la scuola.» Riviveva i vari momenti, in cui il padre gli aveva fatto questi ragionamenti, che, adesso, gli sembravano chiari e veritieri, ma, all’epoca, non convincenti. Il rimorso di non avere creduto al padre si faceva più pungente quando passava a considerare la condotta di vita, dopo l’abbandono della casa paterna. Un pugno di vento ne era stato il risultato. Il suo ciclo s’era concluso nel carcere di Cosenza. 71 12 Si alzò di buon mattino. Attese che si alzasse anche il fratello per andare a fare i conti con Don Francesco Bellushi. Trovarono Don Francesco nell’atrio del palazzo che parlava con due suoi guardiani. Come vide i due, si affrettò ad andare loro incontro: tese la mano per salutare, prima, Don Flaminio come avviene quando si incontra un vecchio amico, che si rivede dopo molto tempo. «Beh, è tutto a posto? Come stai? Quando sei venuto?» disse a Don Flaminio e continuò: «come s’è visto, l’affare è riuscito. Ho fatto quel che potevo fare, mettendoci tutto il mio impegno e spendendo tutte le amicizie, che ho a Cosenza. E, come hai potuto capire, non solo le amicizie; c’è voluto ben altro ed un bel po’.» Così dicendo, li accompagnò nel salottino. Era abbastanza chiaro il discorso di Don Francesco: voleva dire che aveva dovuto sborsare una rilevante somma per la liberazione di Don Flaminio, di fatto, comprando la sua libertà da giudici corrotti. Era sottinteso che l’atto di donazione rappresentava nient’altro che il corrispettivo della sua prestazione o, meglio, della intermediazione. Perciò, legittimamente si era immesso nel possesso dei beni, dei quali era diventato proprietario come se li avesse acquistati, pagando quella somma, che Don Flaminio non aveva, a chi sapeva lui e di cui naturalmente non poteva rivelare il nome. Don Leonardo ascoltava attentamente per rendersi esattamente conto di com’erano effettivamente andate le cose. Aveva, però, capito che l’affare era frutto di un disegno assai contorto e complicato, certamente opera di più persone associate che, comprando o pagando salatamene la complicità di qualche giudice e di altri pubblici funzionari, realizzavano non indifferenti profitti. Era, quindi, difficile, se non impossibile, venire a 72 capo di questo intrico di corruzione e di associazione a delinquere, che aveva il suo pezzo forte nel cuore del potere nel capoluogo della provincia: una vera e propria rete di malaffare, resa possibile dalla scelta affrettata e non sempre oculata del personale preposto ai vari uffici. Sembrava – ed era certamente vero – a Don Leonardo, persona esperta e di estrema prudenza, nient’affatto istintivo come il fratello, che da come aveva raccontato le cose don Francesco, nella vicenda, erano occorse la complicità e la connivenza di più persone, che ricoprivano cariche pubbliche e che esercitavano pubbliche funzioni: principalmente, il notaio, il procuratore del re presso il tribunale del luogo ed altri più modesti funzionari. Una catena di fango che univa gli uni agli altri col doppio filo del peculato, delle malversazioni, estorsioni, usure, dei furti e ne determinava la solidarietà attiva. Da qui la nessuna possibilità di fare rispettare e trionfare anche un minimo di giustizia. Don Flaminio, istintivo com’era e tutto impulsi e passioni, lì per lì stava per sbottare e dare in escandescenze, chiedendo la restituzione dei beni. Don Leonardo lo trattenne con un braccio mentre chiedeva a Don Francesco: «Il patto con Flaminio prevedeva che, dopo la liberazione, gli avreste restituito i beni ed egli vi avrebbe convenientemente ricompensato. Ora gradiremmo stabilire di comune accordo l’ammontare del compenso, anche eventualmente con la corresponsione degli interessi. Il palazzo e le terre li dovete restituire.» Don Francesco, senza apparentemente scomodarsi, finse di cadere dalle nuvole e, manifestando sorpresa e stupore per la richiesta di restituzione, rispose: «Egregio Don Leonardo, poco fa, vi ho spiegato come si sono svolti i fatti. Voi che siete persona esperta e istruita, certamente sapete come vanno queste cose. Io ho assunto l’alea e l’impegno, a mio esclusivo rischio e pericolo, di fare scarcerare il vostro signor fratello. Ho dovuto preventivamente disimpegnarmi con chi so io e che non posso rendere noto, ma voi comprenderete anche la discrezione in un affare così delicato, considerando le accuse a carico di vostro fratello ed il mio è stato un impegno altamente rischioso e altrettanto costoso. Se 73 l’affare non fosse andato in porto, chi mi avrebbe ricompensato? Io avrei inutilmente giocato d’azzardo con le mie fortune? La mia ricompensa è l’atto di donazione, che mi fu fatto, appunto, per gratitudine, per riconoscenza e per remunerazione dell’assistenza e dell’aiuto, prestati a Don Flaminio. Il quale si è riservato il vitto e l’alloggio per la durata della sua vita. Io non ho rubato niente» e alzò la voce come a sottolineare quest’ultima espressione. «Non sto dicendo che voi state rubando o che avete rubato» riprese Don Leonardo con pazienza e sangue freddo. «Debbo pure credere a mio fratello, il quale mi ha riferito che la donazione serviva come pegno e garanzia di un suo sostanzioso obbligo economico in vostro favore. Egli non ha inteso affatto spogliarsi di tutto e ridursi in povertà. Era inimmaginabile che avesse potuto cadere in un così grave errore. Senza, poi, considerare che, astretto nella buia cella del carcere, solo, sentendosi perduto, la sua libertà era menomata.» Don Francesco, punto nel vivo e nell’onore perché rimproverato di non mantenere la parola rispettando i patti intercorsi, fece finta di irritarsi. «Per chi mi prendete?» esclamò. «Io sono un uomo d’onore e posso farlo attestare da galantuomini» e qui chiamò a testimoni due furfanti, suoi complici, il notaio Casini e l’avvocato Gabriele. Per decenza e per prudenza non gli era consentito di fare il nome di chi stava più in alto. «Sono pronto» proseguì, giurando e spergiurando sul suo onore e su quello della propria famiglia «di fare fronte agli obblighi derivanti dalla donazione, corrispondendo a Don Flaminio il vitto e l’alloggio. Ho già predisposto per questo» così dicendo, chiamò Dianora Toccia, la vecchia domestica che aveva appositamente assunto per badare a Don Flaminio: «è vero che ti ho dato l’ordine di tenere pulita la stanza, posta all’ingresso del palazzo, a disposizione di Don Flaminio?» «Sì, è vero zoti patrùn (signor padrone); è già tutto a posto. Quando vuol venire Don Flaminio sarà il benvenuto e il mio padrone» rispose Dianora, andandosene subito dopo. Don Flaminio, che fino allora aveva ascoltato in silenzio, in obbedienza alle raccomandazioni del fratello, ebbe uno scatto improvviso d’ira e stava per aggredire Don Francesco. Fu prontamente bloccato da Don Leonardo, che lo fulminò con 74 un’occhiata severa a mo’ di rimprovero e come per dirgli di non complicare ulteriormente le cose con gesti inconsulti che non sarebbero serviti a nulla. Don Leonardo, che era diacono della chiesa di rito greco e godeva di prestigio e di autorevolezza morale in Matermara, prima di accomiatarsi, tentò di convincere Don Francesco di arrivare almeno ad un compromesso e gli propose: «Mio fratello si obbliga di darvi, in due soluzioni, a titolo di compenso per le vostre prestazioni, la metà del valore di mercato di tutto il patrimonio immobiliare, terre e fabbricati, che è sicuramente una somma considerevole e che dovrebbe risarcirvi di ogni vostro incomodo.» Don Francesco non prese in alcuna considerazione l’offerta; ribadì che era giusto l’atto notarile di donazione e che alle sue disposizioni intendeva conformarsi; reiterava, pertanto, l’offerta a Don Flaminio del vitto e dell’alloggio. «Ma si tratta di un’ingiustizia» replicò Don Leonardo, questa volta alzando la voce «che grida vendetta agli occhi di nostro Signore. Voi avete profittato della disgrazia di mio fratello per carpirgli i suoi beni. Questa è la nuda e cruda verità, anche se nascosta dall’atto notarile nella sua parvenza formale di conformità alla legge scritta. Ma, egregio Don Francesco, la legge morale viene prima di quella scritta, e vi dovrebbe obbligare a non rubare. Ricordatevi che il Signore non paga il sabato.» A questo punto, i due fratelli salutarono e si ritirarono nel loro palazzo, pensoso sul da farsi Don Leonardo, furioso ed iracondo Don Flaminio. 75 13 Due giorni dopo, Don Francesco inviò da Don Flaminio, come messaggero, Muricchio Pisarra per invitarlo a venire a stare nel palazzo: era stata già preparata e pulita la stanza a lui destinata. Il padrone aveva pure designata al suo servizio la serva Dianora Toccia. Naturalmente Don Flaminio, ferito nel suo orgoglio, riempì di improperi l’incolpevole Muricchio e, declinando l’invito, replicò: «Di’ al tuo padrone che per entrare nel mio palazzo non ho bisogno di chiedere l’autorizzazione a nessuno e tanto meno ad un ladro e spergiuro.» Era abbastanza evidente che Don Francesco stava predisponendosi la prova di avere provveduto all’offerta del vitto e dell’alloggio, come previsto nell’atto di divisione, ricevendone il netto rifiuto da Don Flaminio. Muricchio Pisarra gli avrebbe fatto da testimone nella causa. Era ormai chiaro che don Flaminio avrebbe reagito, evocandolo in giudizio per l’annullamento della donazione. La eventuale mancata offerta del vitto e dell’alloggio avrebbe potuto costituire argomento per la revoca per ingratitudine della donazione. Don Francesco ed i fratelli, fino all’arrivo delle truppe francesi, erano vissuti di espedienti, facendo i venditori ambulanti di minutaglie varie, pettini, pezzi di stoffa, veleno per i topi, specchi. Giravano in continuazione per i paesi della Presila, visitandoli uno per uno ed intrattenendovisi almeno per un giorno in ognuno. S’erano, così, creata una loro particolare clientela che, col tempo, gli aveva consentito di racimolare anche qualche modesto risparmio. A Luzzi, avevano conosciuto il generale Verdier; se l’erano fatto amico con l’indicargli i percorsi, di solito praticati da alcune bande, in particolare di quelle di Panedigrano e di Carnegrossa, che non solo saccheggiavano, ma 76 alimentavano la guerriglia antifrancese con i massisti borbonici. Richiesti di servire nelle truppe francesi distribuendo le vivande ai soldati negli accampamenti tra Cosenza, Castrovillari, Cassano, Acri, Rossano e Longobucco, accettarono, trovandovi una discreta convenienza economica, anche se il nuovo mestiere non era esente da rischi. Il modesto e sempre incerto peculio di venditori ambulanti non era neppure raffrontabile con quel che guadagnavano da vivandieri e con gli ovvi vantaggi, che ne derivavano. Tra il 1806 ed il 1810, accumularono, così, una discreta fortuna. Non solo: con le amicizie conseguite, sistemarono fratelli e nipoti nei vari uffici dell’Intendenza di Cosenza e presso il tribunale della stessa città. Di fatto, col mutamento delle fortune economiche, mutò anche la loro posizione sociale: divennero civili, collocandosi tra le famiglie più in vista, a cui ci si rivolgeva per una raccomandazione o per il disbrigo di qualche pratica. Nel miglioramento progressivo delle acquisite posizioni, i fratelli Bellushi, come anche altri, furono oggettivamente agevolati dalla circostanza che i francesi ed il nuovo governo nella provincia della Calabria Citra avevano estremo bisogno di farsi dei proseliti, in un momento in cui, tra la popolazione calabrese, era scemato il primitivo entusiasmo per essere stata delusa nelle aspettative di sgravi fiscali, cessazione dei soprusi e di giustizia sociale. Ed i partigiani del vecchio regime avevano, in definitiva, spianata la strada per mantenere vivo il malcontento e la promessa che solo con la sollevazione generale era, ormai possibile, vendicarsi dei torti subiti, sottrarsi alla miseria e cambiare fortuna. La provincia, che sembrava florida ed opulenta, ora offriva un quadro di tristezza e di miseria. La desolazione regnava nelle campagne, tenute sotto il tiro delle bande brigantesche. Anche i partigiani del nuovo governo si assottigliavano perché erano costretti a subire le ruberie, le offese, le sventure e gli oltraggi da parte dei briganti. Particolarmente, nei casali della Sila, ribolliva la rivolta. In tale contesto, ebbero buon gioco i profittatori senza scrupoli, come i Bellushi e tutti gli intriganti e gli avventurieri che, 77 barcamenandosi nel caos, seppero e riuscirono a sfruttare la loro posizione al servizio dei francesi per permettersi un uso scellerato e criminale della forza; fingendosi depositari dei poteri pubblici, si arricchirono in poco tempo con l’esercizio della forza e della violenza, passando sopra ad ogni principio di morale e di legalità, facendo, così, prevalere la ricerca e la soddisfazione spregiudicata del proprio interesse. A fronte della massa dei profittatori, i cittadini onesti nulla o pochissimo poterono operare per preservare la legalità. Cessata la situazione di estremo disordine, non pochi furono coloro che riuscirono a conservare il maltolto ed, anzi, a consolidare le loro fortune economiche, che erano poi il presupposto anche per il loro avanzamento sociale nella categoria dei galantuomini. I due fratelli Bellushi erano un esempio di tale percorso sociale: dalla umile condizione di venditori ambulanti transitarono a quella di vivandieri dell’esercito francese per, infine, collocarsi nei galantuomini, di recentissima formazione, forti per il consistente patrimonio immobiliare, che garantiva redditi rilevanti, influenti per le amicizie acquisite anche attraverso l’affiliazione alle logge massoniche filofrancesi, abbastanza diffuse nel territorio provinciale. E Don Francesco era membro influente della Acherontea dei Bruzi di Cosenza. *** Per Don Flaminio, fatto di impeto e di passione, v’era un unico modo per riappropriarsi dei suoi beni: organizzare, come aveva più volte fatto in passato, un gruppo di persone fedeli e armate e procedere alla riconquista violenta del suo patrimonio. Ma era, adesso, possibile un colpo di forza, proprio ora che lo stato di guerra sembrava affievolirsi ed il governo andava punendo severamente gli autori del disordine? Tentò di organizzare l’impresa con un gruppo di facinorosi, che si nascondevano nei boschi intorno a Matermara: Antonio Malagrinò, che era stato tamburino di una banda; Andrea Busa e Giuseppe Elmo, in precedenza implicati in saccheggi; Tocci Alessio Costantino, che aveva manifestato per i Borbone; Cosmo Tocci e 78 Giovanni Elmo, che avevano partecipato alla sollevazione ed il pastore Saverio Marchionne, che non vedeva l’ora di menare le mani contro i filo-francesi, come aveva fatto negli anni precedenti. Riuscì a mettere insieme tutti costoro, con i quali si riunì, sul tardi, dopo il tramonto, in un casolare nella campagna di Matermara. Tutti si dissero disposti ad aiutarlo. Era con vero piacere che si impegnavano a sequestrare quell’arrogante di Don Francesco, in una delle prossime notti, sbaraccando anche il palazzo di tutte le persone forestiere e rendendolo nella disponibilità di Don Flaminio. Del proposito segretissimo, Don Flaminio non fece parola col fratello. Costui, però, alieno per principio da ogni atto di violenza, nei giorni precedenti, aveva mandato a Rossano Vincenzo Filla dall’avvocato Nicola Scura per chiedergli di fissargli un appuntamento: avrebbe voluto consultarlo per affidargli la causa civile per l’annullamento della donazione. L’appuntamento gli era stato fissato per la mattinata del 20 aprile 1811. La sera prima, raccomandò al fratello di alzarsi di buon’ora perché il giorno seguente sarebbero stati ricevuti dall’avvocato, nel suo studio in Rossano. Con due cavalli, arrivarono a Rossano dopo tre ore di viaggio. Presa cognizione di ogni circostanza, l’avvocato spiegò che la donazione era frutto di un raggiro e di circonvenzione di persona, impedita nell’espressione della sua libera volontà, per le condizioni in cui s’era venuta a trovare. Questo era il dato oggettivo, «Però» aggiunse l’avvocato Scura «la causa si presta ai cavilli, ma, soprattutto, Don Francesco Bellushi è persona ricca e molto influente, legata a filo doppio, al potere politico. E questo, temo, è il nostro punto debole. L’esperienza mi suggerisce di non fare solo affidamento sul trionfo della giustizia. Non sempre la vera giustizia è impersonata dai giudici, che sono persone influenzabili, con le loro amicizie, le loro debolezze, simpatie e antipatie.» «Ma non tutti i giudici possono stare o stanno dalle parte dei prepotenti» esclamò Don Leonardo «altrimenti non si renderebbe mai giustizia. C’è sempre un prepotente di turno con le sue amicizie e con la sua capacità di corruzione con le sue entrature, tuttavia, non sempre riesce ad avere ragione.» 79 «Il più delle volte, però, ci riesce» aggiunse l’avvocato «in modo particolare, nei nostri tempi tristi, l’esperienza ci insegna che la regola è la sopraffazione; che i potenti del momento, in un modo o nell’altro, riescono ad uscirne indenni. Del resto, voi avete una dimostrazione in famiglia: Don Flaminio, accusato di gravi reati, è stato prontamente scarcerato subito dopo l’intervento di Don Francesco. Ecco perché tengo a sottolineare che la causa civile potrebbe non sortire l’effetto positivo e giusto, da noi sperato. C’è da aspettarsi che il nostro avversario farà pesare tutta l’influenza, di cui è capace, che, per mia conoscenza, non è di poco conto.» «Avvocato, ma allora ci sta dicendo che dobbiamo ritirarci ed accettare il torto?» riprese Don Leonardo. «Nient’affatto» rispose l’avvocato Scura «se ho detto quel che ho detto, l’ho fatto per non celarvi quell’insidia che il processo nasconde; ma io difenderò con le unghie e con i denti le buone ragioni di Don Flaminio.» E così l’avvocato Nicola Scura accettò di perorare la causa di Don Flaminio, consapevole della delicatezza del caso e della gravezza a cui si sottoponeva, del resto, volentieri, abituato a prodigarsi in difesa dei più deboli ed a parlare alto e forte nell’aula del tribunale, anche se, qualche volta, riteneva non disdicevole riverire un cavallo di Caligola elevato a senatore. Ma Don Flaminio non era del tutto fiducioso nel buon esito dell’iniziativa giudiziaria. L’istinto lo portava a risolvere da sé – come aveva fatto in passato – le questioni che lo riguardavano, eliminando l’avversario o rendendolo comunque innocuo. Voleva farsi giustizia con le sue mani, chiudendo l’affare in poco tempo. E certamente l’avrebbe fatto se Leonardo non l’avesse fermato in tempo, manifestandogli tutta la sua ferma contrarietà all’uso della violenza e minacciandolo che l’avrebbe abbandonato al proprio destino se non avesse usato gli strumenti che la legge del tempo consentiva. Don Leonardo era destinato a succedere come Economo della Chiesa greca di Matermara all’ormai anziano zio. Nel corso dei suoi studi filosofici e religiosi, aveva maturato la consapevolezza che vivere da buon cristiano equivaleva anche vivere da buon cittadino e che ogni civile consorzio si regge se tutti osservano le regole e agiscono di conseguenza. Egli era pruden80 temente fiducioso nella giustizia degli uomini, che, di per sé, era fallibile perché il male, con le sue profonde radici, costantemente insidia le azioni umane. Se la causa fosse andata male, era pur sempre possibile rimediare, ricorrendo in appello a giudici superiori. Ma nessun ricorso alla violenza individuale era giustificabile. «Quando riavrò la mia roba? Le mie proprietà? La mia casa?» andava brontolando Don Flaminio. «L’avrai» gli replicava il fratello «quando quello che è tuo ti sarà dato. Ma che cosa è veramente tuo, costruito giorno dopo giorno col sudore e con la fatica? Ricordati come avevi accumulato le tue ricchezze: non è forse vero che hai fatto ad altri ciò Don Francesco ha fatto a te? Perciò attendiamo il corso della giustizia e affidiamoci alla volontà del Signore. Finalmente, cerca di vivere in pace con te stesso.» La causa, intanto, era stata avviata. Il presidente del tribunale di Cosenza l’aveva assegnata ad uno dei giudici. Una dopo l’altra seguivano le udienze, a distanza di diversi mesi l’una dall’altra. Tra cavilli, eccezioni, deduzioni, la soluzione finale andava procrastinandosi in tempi lunghi, anzi, lunghissimi, data l’instabilità politica del regno, nel quale sembrava prossima la restaurazione di Ferdinando di Borbone, che in effetti si realizzò nel 1815. L’aspettativa era, per Don Flaminio, una lenta tortura. Il passare del tempo lo immalinconiva; non riusciva a reagire vedendo che l’usurpatore aveva consolidato il suo potere e allargato le amicizie e la sua influenza in Matermara e dintorni. Aveva sperato nel mutamento di regime. In Matermara ci fu qualche tafferuglio tra partigiani del partito borbonico, che rialzarono la cresta, ed i partigiani murattiani. Non successe nulla di traumatico, com’era, invece, avvenuto al crollo della Repubblica. Il periodo di transizione da un regime all’altro – durante il quale Don Flaminio si prefiggeva di profittarne per ritornare in possesso del patrimonio – non determinò sommovimenti sociali, caos o disordine; non ci fu l’occasione – com’era avvenuto in passato – per colpi di mano e per cangiamenti di fortune da far passare come atti politici, eseguiti sotto l’insegna borbonica o francese. 81 Di fatto, le cose rimasero come prima: gli stessi Comuni continuarono ad essere amministrati dagli ex murattiani; le autorità civili e militari furono confermate. Restava poco o niente da sperare. Doveva convenire col fratello: ogni azione personale contro Don Francesco, pure possibile, sarebbe passata come un delitto, determinato da spirito di vendetta, e sarebbe stato perseguito, portandolo nuovamente nel carcere. Avrebbe potuto unirsi a qualche banda di briganti per organizzare una severa e sanguinosa vendetta. Ma, così, si metteva al bando della società: egli era sempre un civile, ancora in qualche modo riverito, che conservava il “don” grazie al prestigio della famiglia e dei fratelli. Ogni giorno cercava una soluzione al suo problema, che non riusciva a trovare perché la soluzione che egli desiderava e, cioè, rimpossessarsi del suo patrimonio, non c’era. Non avrebbe potuto riuscirci neppure con il delitto, dato che ora la situazione politica generale sembrava normalizzarsi o, quanto meno, non rendeva più possibile quelle sollevazioni di popolo, in cui infiltrarsi per fare il proprio comodo e cinicamente perseguire i propri fini particolari. Questa strada Don Flaminio aveva percorso nel recente passato, arricchendosi con spogliazioni ai danni dei giacobini, rivestendo per l’occasione i panni del sanfedista e, successivamente, quelli del partigiano di re Ferdinando, scappato in Sicilia, collegandosi con le masse brigantesche e di queste servendosi per terrorizzare le persone che resistevano ai suoi appetiti e, a volte, col delitto, costringendole alla resa. Era passato, di fatto, nell’opinione pubblica, come un attaccato alla difesa della causa borbonica, senza esserlo. Perché la politica o le sorti della casa regnante o quelle degli invasori francesi e dei patrioti, loro alleati, gli erano perfettamente indifferenti. Per lui, quella situazione, così come s’era determinata, andava benissimo perché gli consentiva di arricchirsi con ogni mezzo, passando sopra a tutte le morali e a tutti gli ideali. Il suo scopo era uno soltanto: aumentare il suo patrimonio con tutti i mezzi, senza guardare in faccia nessuno. Don Leonardo, il mite fratello, per questa sua condotta, aveva molto sofferto; non era riuscito a dissuaderlo riportandolo 82 sulla strada della rettitudine. Don Flaminio non l’ascoltava e non prestava attenzione alcuna agli ammonimenti del fratello. Ora, severamente provato, qualche dubbio gli si insinuava nella ancora ottusa coscienza. La nuda realtà lo costringeva a prendere atto che anche Don Francesco Bellushi ed il fratello e tanti altri come loro, che s’erano messi dalla parte dei francesi o si erano trovati per caso da quella parte, portati dalle circostanze, avevano agito come lui e si erano comportati allo stesso modo, nel tentativo di arricchirsi, ad alcuni riuscito e ad altri no. E, così, incominciava a comprendere come tante fortune erano state create nel recente periodo delle rivoluzioni e del caos: con le estorsioni, con il furto, con l’omicidio, ricattando, usurando, corrompendo, truffando, usando i poteri pubblici nel proprio interesse. Da tutto questo fango erano usciti tanti miserabili e poveri cristi, che oggi, con l’acquisita ricchezza, sembravano fiori di galantuomini. Questa – e non altra – era l’origine di molte delle famiglie, anche in Matermara, che ora primeggiavano ed i cui beni immobili, improvvisamente, come per un miracolo, riempivano pagine e pagine del catasto dei terreni e dei fabbricati. E prima dov’erano quei terreni e quei fabbricati? Di chi erano? Piano piano s’apriva in Don Flaminio uno spiraglio sulla sua condizione di carnefice e, nello stesso tempo, di vittima. La sua mente era come in un carcere profondo, dove non v’era raggio di sole né aria, né spirava alito di vento. Tutto era avvolto come in una fitta oscurità, ma una cosa gli era chiara: egli aveva fatto come Don Francesco: aveva spogliato altri dei loro beni e se n’era impossessato, mettendo tutto a tacere con la violenza. Anche Don Francesco aveva fatto la stessa cosa con lui, usando la frode, cioè, una violenza più sottile e pericolosa. Come altri erano stati sue vittime, egli era stato vittima di Don Francesco. Così vanno le cose degli uomini. Mai, prima d’ora, aveva preso in considerazione l’origine di quella che era stata la sua ricchezza. Tutto gli era sembrato dovuto. Adesso che l’aveva perduta per essergli stata estorta in carcere lo riteneva una grave ingiustizia. Ma, raffrontando la sua precedente condotta a quella di Don Francesco, gli si insinuava come chiodo fisso, nella mente, che differenza non v’era. 83 Gli si apriva il baratro, nelle cui oscure profondità, pareva precipitare. «Oh, santa Madonna di Costantinopoli» invocava la patrona di Matermara «liberami da questi crudi affanni. Piango giorno e notte, ma la tempesta si gonfia sulla mia vita e mi coprono interamente le tenebre. Non vedo più con gli occhi la luce che mi arriva quando spunta il mattino. Tutti i miei sogni e le mie speranze andarono perduti. Che faccio più in questa vita? L’oggi mi infosca e il domani m’annerisce. Il giorno mi amareggia e la notte mi uccide.» Non riusciva più a dormire. La notte era un tormento, piena di sogni spaventosi: gli apparivano morti che urlavano contro di lui, che lo chiamavano; donne che lo maledicevano; il campanile della chiesa che bruciava e Don Francesco Saverio, tra le fiamme, con gli occhi spalancati che lo chiamava: Flaminio, Flaminio, non ti ho fatto niente, perché non corri in mio aiuto? Perché non mi salvi da queste fiamme? La notte di Natale del 1820, uscì di casa e si recò alla Venosa, nel rigoglioso uliveto, ch’era stato suo e che egli aveva impiantato e curato amorosamente. Pianse lacrime amare; salì su di una pianta, si passò una corda al collo, lanciandosi nel vuoto. Il giorno seguente, le raccoglitrici trovarono il suo corpo penzoloni con gli occhi e la lingua di fuori; nelle mani stringeva un pugno di terra. *** Dieci anni dopo, alla vigilia di Natale del 1830, ad un’ora di notte, Don Francesco Bellushi, proveniente da Acri, preceduto dal fido guardiano Gaetano Cozza, attraversava il bosco di Gammarossa: un colpo d’archibugio lo fece stramazzare dal cavallo, tagliandogli anche la lingua. Non si seppe mai in seguito il nome di chi aveva sparato. Due giorni durò la sua agonia. L’Economo della Chiesa greca, Don Leonardo, annotò, tra l’altro, nel libro dei morti: “morì dopo due giorni e non si è potuto comunicare perché non poteva inghiottire mentre avea tagliata la lingua”. 84 14 Don Francesco, da qualche anno, aveva scritto il testamento e l’aveva depositato nello studio del notaio Don Matteo Capalbo di Acri. Diffusasi rapidamente la notizia dell’assassinio e venuta naturalmente a conoscenza del notaio, questi provvide senza indugio alla convocazione degli eredi per l’apertura e la pubblicazione del testamento. Presso lo studio notarile, nella tarda mattinata del 15 gennaio 1831, convennero il giovane Don Alessandro ed il fratello, Don Martino. Il notaio Capalbo lesse il testamento, assai breve e stringato, nel quale era semplicemente scritto: “nomino erede universale di tutti i miei beni, mobili ed immobili, il mio carissimo nipote Alessandro”. Grave ed evidente fu il disappunto di Don Martino perché, secondo le sue aspettative, l’intero patrimonio del fratello doveva essere assegnato a lui soltanto, che si considerava il capo della famiglia. La delusione determinò un sordo rancore e odio nei riguardi del fratello, che era diventato ricchissimo. Da allora Don Martino tentò con qualsiasi mezzo a sua disposizione – ma inutilmente – di venire in possesso del patrimonio, lasciato dallo zio, o, comunque, di poterne disporre anche attraverso altre persone. Stava in vigile attesa dell’occasione propizia per mettere in atto il suo progetto. Don Alessandro, che era stato educato nel Collegio greco, vi aveva maturato una formazione ultraliberale, democratica e repubblicana. Quella scuola, anche se presieduta dal vescovo greco, aveva mantenuta, difesa e perpetuata, la sua tradizione legata alla cultura illuministica e progressista meridionale. Si era salvata nel tracollo della Repubblica, nel 1799, era sopravvissuta al caos ed alle tragedie del 1806. Nel corso della Restaurazione, era stata affidata ad altro vescovo, scampato 85 all’eccidio borbonico del 1799, notoriamente – anche se prudentemente – di ispirazione liberale. Il giovane Don Alessandro si è ben presto trovato coinvolto nelle congiure e nelle cospirazioni, la cui organizzazione faceva capo ai patrioti della comunità arbreshe della Calabria Citeriore, alcuni dei quali erano suoi stretti parenti. Dal carcere di Cosenza, dov’era detenuto per ragioni politiche, il cugino Domenico, inviava le sue poesie patriottiche, incitanti alla riscossa, che circolavano tra gli studenti e gli intellettuali, come il sonetto famoso, in cui scriveva che, se avesse potuto volare, sarebbe salito al cielo per esprimere a Dio lo sdegno per le condizioni della patria: Mi innalzerei colà dove s’aggira L’eterna danza dè Celesti, e anch’io, tolta in mano d’un angelo la lira, tal trarrei dalle corde un tintinnìo, come mi detta la pietade e l’ira, che Italia tornerebbe in mente a Dio. Lo studio degli autori classici, latini e greci, dell’Alfieri, del Foscolo e del Byron, il desiderio di imitarli nella lotta contro il tiranno, la venerazione per i protagonisti della rivoluzione francese e per quella recente di Napoli, l’incitamento che veniva dai moti e dalle sollevazioni antiborboniche, i cui autori o erano incarcerati o già condannati chi alla pena capitale e chi a lunghi periodi di carcerazione, alimentavano nella gioventù studiosa, educata nel Collegio greco, romantica e democraticorepubblicana, l’ansia di partecipazione per rendere un servizio alla collettività, anche col rischio di sacrificarsi al bene comune. In questo clima di eccitazione politica e di aspettativa indistinta delle novità, visse la sua giovinezza il nostro Don Alessandro. Egli come, in genere, la nuova generazione, ossia i figli della borghesia rurale, formatasi nel decennio francese, furono i tessitori ed i protagonisti delle rivoluzioni e delle congiure, ma anche i suscitatori di movimenti popolari antiborbonici nella 86 Calabria Citeriore. Essi intravedevano nella rivoluzione un avvenire, pieno di fortune e di benedizioni con l’instaurazione di una società più giusta e umana. Ed ognuno di loro, nel suo ambiente, non mancò di farsi portatore delle novità politiche, cercando l’appoggio dei gruppi sociali più evoluti e di quei contadini senza terra, desiderosi di contendere ai baroni le terre pubbliche. Don Alessandro, nel marzo del 1848, dopo la concessione dello Statuto, organizzò la rivoluzione in Arberia, mettendosi alla testa del ceto medio e dei contadini poveri. Lo slogan Abbasso i retrogradi! Abbasso i regressisti! racchiudeva tutto il suo programma: si impossessò dell’amministrazione comunale; guidò i contadini alla occupazione dei terreni pubblici, che assegnò per quota a singole famiglie. Il movimento divenne impetuoso particolarmente tra il maggio ed il giugno del 1848, dopo il colpo di Stato di re Ferdinando. Il governo provvisorio, insediatosi a Cosenza, subiva la pressione di diverse migliaia di contadini poveri dell’agro silano e presilano, che contestavano le abusive occupazioni dei baroni del tempo e chiedevano terre da coltivare per sfamare le proprie famiglie. Nello stesso tempo, era costretto ad organizzare la difesa contro il governo centrale, che aveva disposto l’invio dell’esercito. In Matermara, la rivoluzione – fino a che non fu schiacciata dalla feroce repressione poliziesca – non si limitò alla declamazione di slogan. Nell’aprile, con bandiera rivoluzionaria spiegata, una moltitudine di contadini, guidata da don Alessandro occupò anche il vasto podere del barone Compagna; ne scacciò i guardiani. Fu diviso in quote e assegnato alle famiglie più povere. Fu organizzato il processo contro il re spergiuro, ritornato all’assolutismo. La statua del sovrano fu rimossa dall’ufficio del Giudicato regio; le venne legata una corda al collo e fu trascinata per le vie di Arberia tra gli sberleffi e i lazzi dei cittadini. Successivamente, nella piazza, Andrea Potta e Marcello Valacca furono i pubblici ministeri che sostennero l’accusa di tradimento e chiesero la condanna alla pena capitale mediante fucilazione. La statua fu ridotta a pezzi a fucilate tra grida e acclamazioni di Viva la Repubblica! Abbasso il tiranno!. 87 Alessandro partecipò con i volontari di Arberia alla difesa militare del governo provvisorio, combattendo a Spezzano, Cassano, Castrovillari ed a Campotenese. Fu qui che il fratello minore, Vincenzo Maria, insieme ad altri volontari Francesco Saverio Tocci, Demetrio Chiodi, organizzarono la cattura del generale borbonico Lanza, che sostava a Rotonda, in attesa di sferrare il suo attacco alla parte del Pollino. Spiati da un contadino del posto che ne riferì alla polizia, nei pressi di Rotonda, furono circondati da soldati e massacrati a colpi di baionetta: i loro corpi furono trascinati a coda di cavallo per le strade di Rotonda. Dopo il fallimento della rivoluzione calabrese, seguirono gli arresti e le condanne della Gran Corte Criminale di Cosenza. Alessandro, condannato ai ferri per anni ventiquattro, non fu mai preso. Visse da latitante fino al 1860, nascondendosi nelle campagne di Matermara, protetto dai contadini, in attesa del cugino Domenico che, con un corpo di volontari greci e albanesi, si aspettava che sbarcasse di giorno in giorno, per riprendere la guerriglia. Questa nuova avventura non fu possibile realizzarla per sopravvenute complicazioni internazionali. *** Alessandro e Francesco Marchese si trovarono insieme, per la prima volta, il primo settembre del 1860, a Spezzano, ivi accorsi per attendere l’arrivo di Garibaldi. Il Generale era partito da Cosenza, nella prima mattinata, in compagnia di Bertani, del Cosenz e del Canzio. Viaggiavano in carrozza aperta; costeggiarono, per più ore, la media valle del Crati che, allora, era luogo inospitale, paludoso e costellato di boscaglie fitte, rifugio di animali selvatici e di briganti. Dopo circa sette ore di viaggio, arrivarono ai piedi della salita per Tarsia. Garibaldi lasciò la carrozza e proseguì a cavallo per Tarsia; la carrozza seguiva. Alle prime case del paese, s’imbattè in una donna che, al vederlo, grida Evviva! Ma evviva chi? Chiede il Generale! Evviva Garlumbandu! Rispose la donna. Dal che capì di essere giunto in un paese amico. Nel quale 88 fu bene accolto. Nel pomeriggio, partiva in carrozza per Spezzano, dove trovò una folla entusiasta ad accoglierlo. Una lunga fila di donne albanesi con gli sgargianti vestiti lo aspettava fuori dell’abitato e l’accompagnò fino al municipio, intonando il tradizionale canto della vallja, con versi improvvisati in cui si esaltava l’eroe, come ai tempi della Grecia classica. La guardia nazionale gli rese gli onori militari e l’arciprete, accorso con tutto il clero locale, gli indirizzò un fervido saluto patriottico. Garibaldi, commosso nel vedersi accolto con tanto entusiasmo, esclamò: questa è la vera rivoluzione. La “vera rivoluzione” attendevano quelle masse di contadini che, da Matermara e dagli altri paesi, avevano seguito a Spezzano Don Alessandro e Don Francesco Marchese. Avevano essi infisso alla punta di ferro delle picche di legno colorate, una supplica a Garibaldi per la concessione di terre da lavorare; nella loro mente, la liberazione e l’indipendenza dell’Italia coincidevano con il riconoscimento del loro diritto alla concessione delle terre pubbliche, ormai privatizzate ed occupate dai baroni calabresi. Schiere di giovani volontari dell’Arberia avevano fatto la strada per Spezzano intonando il canto della liberazione: Gharibaldi çe me sit Dorrokopsen tiranit. Kure shpaten pra m’e nxier Me se pik lambson e shqier. Nani pret te prasmen her Te na benj ndutu t’ljefter. (Garibaldi col semplice sguardo Atterrisce i tiranni. Quando la spada poi snuda Più che fulmine lampeggia e lacera. Adesso aspetta per l’ultima volta Di farci completamente liberi). Don Alessandro e Don Francesco, con centinaia di altri volontari, si arruolarono tra i garibaldini, partecipando a tutte le battaglie. Si distinsero particolarmente al Volturno, richia89 mando l’attenzione di Garibaldi che, nell’occasione, rivolgendosi al generale Domenico Damis – pure arbresh che era partito con lui da Quarto – gli espresse la sua meraviglia: questi tuoi albanesi sono degli eroi! Il corpo dei volontari, cessate le ostilità, si sciolse: ognuno ritornò malinconicamente alle proprie occupazioni. Essi, invero, avrebbero voluto continuare fino a Roma per proclamarvi la Repubblica. Don Alessandro Bellushi e Don Francesco Marchese rifiutarono di essere aggregati come ufficiali nell’esercito sabaudo. Anche loro fecero ritorno in Matermara per dedicarsi alla coltivazione delle loro terre. Domenico, il cugino di Alessandro, già deputato nel 1848 e che era stato condannato dal tribunale borbonico di Cosenza alla pena capitale, preferì restare a Napoli per continuare, con gli scritti, le sue battaglie politiche; andava esternando sulle pagine de Il Popolo d’Italia, la delusione per la sconfitta della rivoluzione con l’instaurazione del regno dei Faraoni. La rivoluzione era stata tradita: quando, da Marsala giunse al Volturno, il popolo italiano non disse che ella aveva terminato la sua missione. Perché le diede un altro nome e la chiamò Plebiscito, trasformandola e spingendola a nuove battaglie. La rivoluzione dei Mille diventava quella di ventisei milioni di italiani. La rivoluzione, governata dall’idea progressiva, può sedere anche su di un trono, se questo è quello di un Codro che per il suo popolo sacrifica la vita, ma essa passa inesorabile sul capo dei Capeti. Con queste idee, dopo l’unità, era destinato all’isolamento. Ed, infatti, morì solo a Firenze, circondato da pochi amici. 90 15 Le fortune e le vicende della famiglia di Francesco Marchese hanno pure origine nel decennio francese e si intersecano con gli avvenimenti successivi della Restaurazione e del Risorgimento. Il padre, Don Leopoldo, aveva avuto in concessione le terre dai monaci a Makipuzzo ed a Santa Gada e pagava la decima al monastero. Nel decennio, si poteva considerare un discreto proprietario di molte tomolate di oliveto, di vigneto, di terreni seminativi e boscosi; aveva i suoi coloni che accudivano anche il gregge di capre, pecore e di maiali neri. Aveva raggiunto una posizione sociale di tutto rispetto, collocandosi tra i civili o bulari, come venivano chiamati dagli arbresh, e fregiandosi del “Don” per distinguersi dal resto della popolazione. Altri consistenti quozienti di terreno gli aveva portato in dote la moglie, Dinescia, figlia dell’Economo greco della Chiesa di Maki, Michele Rada, che aveva donato alla sposa la metà del podere nella Shureza. Famiglie siffatte erano naturalmente egemoni, nei piccoli paesi, per il potere economico acquisito, ma ne costituivano anche i gruppi dirigenti. Ed esse, in generale, si dimostrarono previdenti ed accorte. Non si accontentarono, infatti, del solo patrimonio immobiliare ed agrario, ma saggiamente investirono nella cultura, facendo istruire i loro rampolli nel Collegio greco per, poi, continuare gli studi nell’Università di Napoli, così, avviandoli alle professioni liberali ed all’insegnamento. Sicché, nell’arco di tempo di una generazione, si videro i frutti copiosi e fecondi, perché ne venne fuori, insieme alla mobilità sociale, un progresso generale di incivilimento. Le vecchie e rozze forme di vita e di rapporti sociali furono superate e messe tra parentesi da una più moderna sensibilità. 91 Si trattava di un processo originale, come in nessuna parte del Mezzogiorno era avvenuto, che fece di quella comunità alloglotta o, meglio, dei suoi giovani intellettuali, un punto di riferimento per la gioventù romantica dell’epoca, che aspirava alle novità nel campo della cultura e, di riflesso, nella organizzazione della vita civile e della politica. I giovani rampolli delle famiglie benestanti trovavano, nel Collegio greco, quella istruzione e moderna educazione, scevra da pregiudizi e dogmatismi, aperta alle novità della cultura europea, che li conduceva al romanticismo in letteratura ed alla visione democratica del vivere civile. Ed essi furono, in effetti, romantici in letteratura e democratici in politica. Tali furono Don Alessandro, ma anche Don Francesco Marchese ed il fratello, Domenico Antonio. Il più sfortunato dei tre fu proprio quest’ultimo. Nel corso degli studi curriculari nel Collegio, era entrato in amicizia con l’altro collegiale di S. Benedetto Ullano, Agesilao Milano. Esaltato dal mito della rivoluzione francese e dall’odio verso tutti i tiranni, Agesilao aveva combattuto, come Don Alessandro, in difesa della rivoluzione calabrese, a Spezzano ed al monte S. Angelo, ne pressi di Castrovillari. Amareggiato dalla sconfitta, aveva concepito il segreto progetto di assassinare il tiranno Ferdinando di Borbone per avere prima concesso e poi abrogato lo Statuto. Si era fatto arruolare nell’esercito napoletano e, l’8 dicembre 1856, nel Campo di Marte, a Napoli, mentre Ferdinando passava in rassegna le truppe, più rapido di un fulmine, si avventò contro il re, attingendolo due volte con la baionetta, ma ferendolo leggermente perché la corazza smorzò i colpi. Tuttavia, Ferdinando ebbe la convinzione che la punta della baionetta fosse avvelenata. Portava perennemente come antidoto una pietruzza, donatagli dalla veggente di Altomonte, Maria La Petra, che diceva di ricevere messaggi da S. Francesco di Paola ed era diventata confidente di Ferdinando. Anche in punto di morte, non mancò di chiedere al medico che l’assisteva di controllare se la cicatrice residuata fosse venuta in suppurazione. Agesilao fu prontamente bloccato, arrestato ed in pochi giorni, dopo avere subito indicibili torture, formalmente processato dal tribunale militare e condannato alla pena capitale 92 per impiccagione, eseguita al Largo del Cavalcatolo, in Napoli, nella mattinata del 13 dicembre 1856. Fu l’esecuzione più orrenda mai avvenuta fino allora. Secondo un cronista dell’epoca, per accelerarne la morte, il tirapiedi, con tutto il peso del suo corpo, si attaccò all’estremità del condannato, abbandonandosi a pendolo nel vuoto. Poiché la morte tardava, il boia gli montò sulle spalle per sollecitare la pressione del nodo scorsoio. Gli spettatori inorridirono di fronte all’immondo spettacolo dei due vivi, aggrappati ad un moribondo, che insieme oscillavano. La polizia pensò ad un complotto, in verità, inesistente. Agesilao fu fatto interrogare anche dal generale albanese Demetrio Lecca, comandante del Reggimento Real Macedone, perché suo amico, nella speranza che avrebbe potuto rivelare i nomi dei complici. Quando Agesilao ribadì di avere agito da solo, il Lecca lo rimproverò chiamandolo “assassino” e “traditore”. Al che reagì con forza, sottolineando di avere voluto liberare il regno da un tiranno oppressore, orgogliosamente aggiungendo: «Tu, mercenario al servizio del tiranno, disonori l’Albania, non io che muoio per la felicità del popolo.» Furono arrestati tutti gli amici e conoscenti di Agesilao, sia residenti a Napoli che nella provincia di Cosenza, e rinchiusi nel carcere napoletano di S. Maria Apparente. Ogni sera, a gruppi, dal carcere, posto sulle colline di Napoli, i detenuti in manette venivano portati in questura per essere interrogati da una apposita Commissione, alla ricerca di validi indizi per suffragare la fragile tesi del complotto. Domenico Antonio Marchese fu vittima di questo pregiudizio. Era amico di Agesilao, col quale intratteneva anche rapporti epistolari. Rinvenute alcune sue lettere tra le carte di Agesilao, subito dopo l’esecuzione della condanna a morte, Domenico Antonio fu tratto in arresto mentre si trovava a Cosenza. Era il sedici dicembre 1856. Aveva vent’anni. Portato davanti alla Commissione, gli fu chiesto, tra l’altro, a che ora fosse uscito di casa il giorno dell’attentato; rispose tranquillamente di avere studiato per tutta la mattinata e di essere uscito a passeggiare nel pomeriggio. La Commissione gli gridò in coro come se avesse trovato la prova che cercava: Dunque, non avete sentito 93 la Santa Messa neanche il giorno dell’Immacolata. Ecco i nemici del Re che si riconoscono nei nemici di Dio. Scontò quattro anni di carcerazione preventiva. Liberato, nell’autunno del 1860, con la caduta del regime borbonico, dopo alcuni mesi, morì per le sofferenze patite. Francesco Marchese, nel 1856, studiava nel Collegio greco. La polizia lo giudicò “testardo, insubordinato e irreligioso”; ne fu allontanato perché “fratello del detenuto politico Domenico Antonio”. *** Conclusa la stagione risorgimentale, Don Alessandro fece ritorno in Matermara. Era solo e triste nel suo grande palazzo, ma anche alquanto malmesso in salute: i lunghi anni della pregressa latitanza, per l’esattezza un dodicennio, dal luglio 1848 all’agosto 1860, l’avanzare dell’età, avevano lasciato il segno. Tuttavia, aveva in progetto di farsi una famiglia e di vivere in pace il resto della vita. Anche se aveva raggiunto e superato ormai l’età di quarant’anni, riteneva che o in Matermara oppure nei paesi della Valle del Crati e della Piana di Sibari, non gli sarebbe stato difficile trovare una nobildonna confacente alla sua posizione sociale. E certamente il progetto di matrimonio rientrava nella normalità delle cose della vita e, quindi, avrebbe potuto essere realizzato con sua piena soddisfazione. Non era vecchio, era ricchissimo, era famoso per la sua partecipazione ai moti risorgimentali. Nulla gli mancava per potere degnamente ed onorevolmente aspirare ad impalmare una nobildonna arbreshe, albanese, o litira, italiana, del circondario o del paese. Così, si mise alla ricerca della sposa fortunata. Un primo tentativo fu fatto presso la nobile famiglia Rende di Terranova. Un suo amico, che l’aveva protetto durante il periodo della latitanza, gli aveva proposto la giovane Donna Angelina Rende. L’aveva appositamente invitato per vederla in occasione della celebrazione delle cerimonie della Settimana Santa, quando la giovane era solita frequentare la chiesa dei padri Cappuccini. 94 Ne aveva tratto una buona impressione. Si decise a richiederne formalmente la mano ai genitori o, meglio, al padre, come si usava, attraverso un messaggero, all’uopo incaricato. Il padre della ragazza dimostrò di gradire la proposta; chiedeva un po’ di tempo per il consiglio di famiglia. Ma la risposta fu inspiegabilmente ed inaspettatamente negativa. Fu fatto un secondo tentativo presso il nobiluomo Carlo De Vulcanis di Corigliano, al quale fu richiesta in sposa una delle due giovani figlie da marito. Anche in questo caso, all’inizio, tutto sembrava mettersi per il meglio. A Bua Gervasio Protasio, che Don Alessandro aveva inviato come messaggero e suo uomo di fiducia, il magnifico Don Carlo De Vulcanis aveva risposto di sentirsi onorato della proposta; che conosceva per fama Don Alessandro e sapeva anche della sua solida e fortunata posizione economica e che, personalmente, non aveva motivi di contrarietà. Prima di una decisione definitiva, doveva, però, parlare con la sua signora moglie. Era questa la procedura che, allora, si seguiva per maritare una figlia. Il tutto veniva concordato tra le due famiglie o, meglio, tra i due capifamiglia, i quali stabilivano l’ammontare della dote, le eventuali modalità ed i tempi della sua corresponsione, la data del matrimonio. Il tutto veniva consacrato nei capitoli matrimoniali, solennemente rogati da un notaio. Come se si trattasse di un affare patrimoniale, concluso tra due famiglie, in cui la futura sposa non contava niente, non aveva voce in capitolo. La famiglia – ma, di fatto, il padre – decidevano il destino di una ragazza senza badare ai suoi desideri ed ai suoi sentimenti. Sicché l’ideale, per le ragazze di buona famiglia, era quello di un matrimonio con un buon patrimonio con riferimento al futuro marito. La convinzione era che l’amore non contava perché sarebbe nato dopo le nozze. Non rare volte accadeva che una povera ragazza venisse barattata secondo l’interesse ed il volere dei genitori. Quando il magnifico Carlo De Vulcanis, dopo qualche tempo, comunicò a Bua Gervasio Protasio di non potere accettare la proposta matrimoniale senza specificarne in dettaglio i motivi, Don Alessandro non seppe che pensare, restò quasi offeso nella sua onorabilità. 95 «Ma come ti ha detto esattamente De Vulcanis?» chiese con stizza a Gervasio Protasio. «Zoti Patrùn, Signor Padrone,» rispose quest’ultimo «m’è sembrato un vero signore, si è dimostrato gentilissimo, Vi ha mandato anche i suoi ossequi, mi ha detto di riferirVi che, suo malgrado, gli dispiaceva molto di essere nell’impossibilità di accettare la Vostra proposta. Io, çiot si jam, ignorante come sono, ho capito che gatta ci cova.» «Spiegami: che vuol dire “gatta ci cova”?» «Si kapirta u, ka t’jet ndonjerì çe neng mund te shoh te martuar, come io ho capito, ci dev’essere qualcuno che ha interesse contrario al tuo matrimonio. Quando sono andato a trovare il magnifico De Vulcanis, nella sua villa, al Baraccone, al solo sentire il Vostro nome, egli non stava dalla gioia, dimostrando una contentezza che, anche a me, è sembrata eccessiva. Per questo, ero convinto che la cosa sarebbe riuscita. Se così non è stato, debbo pensare che sia successo qualcosa, che ha impedito la decisione favorevole. Anche perché, ora che ci penso, De Vulcanis mi è sembrato uno che avrebbe voluto dire di sì, ma era costretto a dire di no. Quindi, la mia conclusione è che c’è qualcuno o qualcosa che, in segreto, agisce contro di Voi. Siete sicuro che non sia qualcuna di queste puttanone, che stanno nel palazzo, che semina zizzania?» «Escludo quest’ultima ipotesi. Le tue considerazioni mi convincono. Un sospetto ce l’ho. Prima di rivelartelo, birmi nj’eter fjale me zotin Kinigò, facciamo un altro tentativo con Don Chinigò, che ha delle figlie da maritare.» Particolarmente una delle figlie di Don Damiano Chinigò, Roda, era ben messa fisicamente, di solida bellezza da surclassare tutte le altre ragazze di Matermara; brillante ed esuberante, dotata anche di sensibilità artistica, faceva valere queste sue qualità quando si tenevano le vallje, i balli con canti, in primavera. Allora, con le sgargianti gonne multicolori, volteggiava leggera negli shesh, nelle piazze principali di Arberia, e con la sua voce melodiosa, che si diffondeva tra i vicoli ed entrava nelle case, intonava il canto della nostalgia e del rimpianto per l’antica patria perduta: “o mia bella Morea, / da quando ti ho lasciata / non ti ho più veduta / Là ho lasciato il signor mio padre / 96 Là ho lasciato la signora mia madre / Là ho lasciato anche mio fratello / tutti sepolti sotto terra / O mia bella Morea”. La famiglia Chinigò era una delle più antiche famiglie di Arberia; vi risiedeva da quattro secoli, probabilmente era emigrata dal Peloponneso, dall’antica Morea, per stabilirsi in Calabria, sfuggendo agli Ottomani invasori insieme ad altre migliaia di famiglie. Tutte insieme, dopo un viaggio rischioso, erano sbarcate alla foce del Crati, nei pressi di Sibari, ed inoltratesi verso la collina, ebbero la straordinaria fortuna di imbattersi nei monaci italo-greci, che li accolsero come fratelli e gli consentirono di stabilirsi nelle terre del cenobio. Qui costruirono le case che, inizialmente, erano nient’altro che piccole casupole fatte con paglia e frasche, impastate con la terra rossa del luogo e che, in seguito, divennero case e palazzi ed il villaggio una cittadina. Non si fecero assimilare dalla popolazione indigena; difesero il loro rito greco e mantennero la lingua e, con la lingua, la memoria del luogo di origine. Ma la loro patria era, ormai, quella italiana, per il cui risorgimento furono all’avanguardia in Calabria. Don Damiano Chinigò, un signore austero e riservato, era l’ultimo rampollo di questi antichi cavalieri; aveva una discreta fortuna e viveva nel vecchio palazzo paterno, in fondo al paese, insieme al fratello Don Cosmo, Lettore nella Chiesa greca di Matermara. In un pomeriggio della fine dell’aprile del 1863, Don Alessandro, che si trovava a Casino, lo vide passare a cavallo e capì che si recava nella sua masseria di Santa Rosa. Lo attese al ritorno per potergli parlare. Sapeva che Don Damiano, prima dell’imbrunire, era solito rientrare a casa. Don Damiano Chinigò fu sorpreso e incuriosito quando fu pregato da Don Alessandro di fermarsi un momento, anzi, di entrare nel Casino, perché gli doveva parlare. Non aveva mai avuto a che fare con lui o col fratello Don Martino. Con loro i rapporti non erano mai stati confidenziali. I Bellushi erano circondati da un alone di mistero per l’origine della loro proprietà; su di loro correvano, nell’opinione pubblica, leggende e dicerie che li faceva passare alla stregua dei giocatori di tarocchi in cui ognuno cerca di prendere all’altro le carte di maggiore valore. 97 Quale non fu la sorpresa di Don Damiano al sentirsi chiedere in sposa la figlia Roda. Lì per lì non sapeva cosa rispondere anche perché una voce corrente dava per certo che Don Alessandro, sia per l’età che per gli acciacchi dovuti alla latitanza, aveva detto addìo al matrimonio. Lo ringraziò, dicendogli di sentirsi onorato della richiesta ed aggiunse: «Mia figlia è troppo giovane per Voi; assai notevole è la differenza di età. E, poi, non vorrei mettermi contro il Vostro potentissimo fratello Don Martino, il quale si considera come unico titolare del patrimonio della Vostra famiglia. DandoVi mia figlia in moglie, rischierei di rovinarle l’avvenire perché, probabilmente, chissà, in un domani, potrebbe trovarsi aggrovigliata nel ginepraio dei contrasti in seno alla Vostra famiglia.» Don Alessandro veramente non aspettava una simile risposta. Soprattutto rimase sconcertato dalle dicerie che circolavano su di lui. Anche se Damiano Chinigò aveva parlato con discrezione e non ne aveva fatto il nome, tuttavia, dal contesto della conversazione, emergeva con sufficiente chiarezza che la fonte delle voci, messe in giro, non avrebbe potuto essere che il fratello o persone a lui assai vicine. Chi avrebbe potuto essere, del resto, a conoscenza delle pretese del fratello e del suo stato di salute, se non uno della sua stessa famiglia, che ne aveva parlato proprio al fine di diffonderle per impedire il suo matrimonio? Solo il fratello era interessato, in quanto un eventuale matrimonio gli avrebbe tolto ogni speranza di venire in possesso del patrimonio, lasciato dallo zio ad Alessandro. In conclusione, non restava che prendere atto che Don Martino era il vero ed unico dissuasore occulto; aveva intessuto una così abile trama per potere impedire il suo matrimonio. Si imponeva con urgenza un chiarimento col fratello. 98 16 Il giorno dopo, Don Alessandro andò alla ricerca del fratello. Non lo trovò a casa; la cognata, Donna Nescia Marchianò, gli riferì che, sin dalla prima mattinata, era partito per la campagna. Don Alessandro fece un rapido giro per le contrade; lo trovò a Montemoro. «Quale buon vento ti porta?» disse Martino al fratello, per nulla immaginando la fiera tempesta che lo tormentava. «Non è il vento, ma la tempesta che tu stesso hai suscitato» lo investì Alessandro, intenzionato di venire subito al dunque. «Ma perché vai propalando e insinuando che il patrimonio, lasciatomi dallo zio Francesco, non mi appartiene? Che sono anziano e minato dalle malattie?» Punto sul vivo e toccato nella corda della proprietà, Martino reagì vivacemente: «Te l’ho sempre detto, anche al momento dell’apertura del testamento, che il patrimonio era ed è unico, anche se amministrato da persone diverse. Questi erano i patti tra nostro padre e lo zio: ognuno di loro amministrava un patrimonio che, solo fittiziamente, era intestato diversamente. Dopo la morte di nostro padre, lo zio Francesco è venuto meno al patto di famiglia, forse pensando che noi non ne fossimo a conoscenza.» «Questa è solo una tua opinione: non c’è alcun documento che la provi. Se le cose fossero come tu dici, lo zio Francesco, morendo, avrebbe lasciato il patrimonio a noi tutti in parti uguali.» «Ma hai veramente la testa dura» riprese Martino. «Quando vennero in possesso dei beni, che appartenevano a due distinte famiglie di Matermara, nostro padre e lo zio non ritennero, per prudenza, di farli intestare cumulativamente a tutt’e due; su consiglio dell’avvocato, si fece ricorso a due distinte donazioni 99 per evitare eventuali contestazioni ed impugnazioni. Questo è anche il motivo per cui, dopo la morte di nostro padre, lo zio ti prese con sé, volendo significare che manteneva fermo il patto di unicità dei patrimoni e dello stretto collegamento tra le due famiglie.» «Queste cose le affermi solo tu» fece Alessandro «perché vuoi diventare padrone di tutto. Cerchi di frapporre ostacoli al mio matrimonio nella speranza che, alla mia morte, non lasciando eredi legittimi, potrai soddisfare la tua brama di possesso.» Martino protestò, dicendo che non aveva alcun personale interesse, ma che lo faceva al solo fine di fare rispettare l’antico patto di famiglia. «Non c’è alcun patto di famiglia» ribadì Alessandro «altrimenti lo zio lo avrebbe rispettato. Non solo: al momento dell’apertura del testamento, tu non l’ha fatto presente. Il patto di famiglia è un’invenzione tua.» «Ma, per la Madonna, che vuoi? Che adesso ci scanniamo tra fratelli? Scanniamoci pure. Io sono pronto» disse Martino col sangue agli occhi. Don Alessandro, vedendo il fratello talmente esagitato, temendo che il discorso potesse andare oltre il giusto limite delle contestazioni verbali per cadere nelle vie di fatto, montò sul cavallo e se ne andò. Si sfogò con Bua Gervasio Protasio, che era il suo confidente; gli disse delle pretese del fratello e degli ostacoli al matrimonio e delle minacce proferite. Gli chiese se fosse disponibile a mettersi in azione per trovare una possibilità di accordo onorevole col fratello. Il giorno dopo, Bua andò a trovare Don Martino, il quale, non appena lo vide, sapendo che lavorava per il fratello, gli disse: «Ti ha mandato mio fratello? Con lui debbo chiudere i conti. Ieri m’è venuto a trovare a Montemoro, però se n’è andato via subito e, quindi, il chiarimento non c’è stato.» «Egregio Don Martino, tra fratelli si deve tentare di risolvere qualsiasi problema. Tutto è risolubile e rimediabile. Ci deve pur essere una via di mezzo tra le vostre pretese e la posizione di vostro fratello. Perché voi pretendete che egli non si sposi?» 100 Don Martino spiattellò chiaro e tondo che era contro il suo interesse perché avrebbe spezzato l’unità del patrimonio immobiliare. Gervasio Protasio gli obiettò: «Ma così Voi impedite o cercate di impedire qualsiasi matrimonio di vostro fratello. Come potrebbe venirvi incontro, sposandosi e, nello stesso tempo, senza ledere il vostro interesse? Solo sposando una vostra figlia, che è, poi, sua nipote.» «Beh, potrebbe anche essere così» fece Don Martino. Gervasio Protasio pensava di non avere bene compreso e gli chiese: «Ma quale delle vostre figliuole?» «Eufrasia» rispose Don Martino «perché, l’altra, Kalìa, è già promessa a Francesco Marchese.» «Posso riferire quanto m’avete detto a vostro fratello?» Don Martino annuì. Egli era, quindi, disposto a sacrificare una delle giovani figlie, dandola in sposa al fratello, pensando evidentemente che, con questo stratagemma, avrebbe potuto – attraverso o per mezzo della figlia – avere il controllo del patrimonio immobiliare del fratello. In ogni caso, data l’età non più giovane, Don Alessandro sarebbe deceduto ben presto ed il patrimonio sarebbe passato in eredità alla moglie-nipote e, per conseguenza, alla famiglia. Lo stesso giorno, Bua Gervasio Protasio si affrettò a riferire il contenuto della conversazione a Don Alessandro. Lo trovò nel palazzo, nel primo pomeriggio. «Che novità mi porti?» gli chiese Don Alessandro, appena lo vide arrivare. «Zoti Patrùn, Signor Padrone, Vi porto delle novità veramente grosse, che non potete neppure immaginare» rispose e spiegò, per filo e per segno, il discorso che, nella mattinata, gli aveva fatto Don Martino e come e perché egli si sentiva appagato e disposto a cessare le ostilità alla condizione che Don Alessandro sposasse la nipote Eufrasia, di una trentina d’anni più giovane. «Oh, benedetto il Signore!» esclamò Don Alessandro «com’è stato possibile che mio fratello sia stato accecato da tale violenta rapacità da perdere il senno e fare simile proposta? Come potrei sposare una mia nipote?» 101 Questo interrogativo lo angosciò per giorni e notti. Il fedele servitore, Bua Gervasio Protasio, faceva la spola tra il palazzo di Don Alessandro e quello del fratello nel tentativo di ammorbidire le pretese di Don Martino e di rappacificare i due fratelli. Fino a quando non ce la fece più in questo viavai. In conclusione a Don Alessandro non restava che o cedere i beni al fratello oppure accettare la sua proposta. Altrimenti poteva finire in una tragedia. Che egli voleva assolutamente evitare. Facendosi un bel coraggio decise di sposare la nipote. Il matrimonio tra Don Alessandro e la nipote Eufrasia fu celebrato da Don Leonardo, nella Chiesa di Matermara, il 10 settembre 1865. Lo sposo aveva quarantanove anni; diciannove ne aveva la sposa. Nel dicembre dell’anno seguente, Don Francesco Marchese sposò Kalìa Bellushi, sorella di Eufrasia. Ambedue i matrimoni, se non proprio infelici, furono di breve durata. Kalìa era di carattere instabile, violenta e lussuriosa. Era sufficiente un minimo pretesto per prendersela col marito; così la convivenza pacifica andava a rotoli. Dopo qualche giorno di escandescenze e di scenate immotivate, che costringevano il marito ad allontanarsi di casa, subentrava d’improvviso il pentimento. Richiamava in casa il marito: gli chiedeva perdono, giurava e spergiurava che, d’ora in avanti, si sarebbe comportata correttamente. Ma la trafila subito dopo rincominciava e giù maledizioni, ingiurie e minacce contro il marito incolpevole, che aveva sempre pazientemente sopportato. Un giorno, però, a Don Francesco per poco non gli cadde la casa addosso. Rovistando nel comò, fu costretto ad aprire gli occhi: Kalìa s’era accesa di un vecchio amore con Scanderbeco Stamato. La corrispondenza amorosa tra i due, in costanza di matrimonio, trovata nel comò, per caso, da Don Francesco, era argomento inoppugnabile del tradimento. Trovava, così, una sua spiegazione l’instabilità della condotta di Kalìa. Questa volta, Francesco Marchese andò dall’avvocato; chiese la separazione giudiziale per colpa della moglie. Tre anni era durato il matrimonio. Eufrasia – Zonja, la Signora, come comunemente era chiamata in Matermara – era manifestamente contenta nella casa 102 dello zio-marito, ma gioiva soprattutto per essersi liberata dal fosco ambiente della famiglia originaria, dominata dalla personalità del padre, soggetto brutale e senza scrupoli, capace di passare sopra ad ogni sentimento per avidità di beni. La canagliata paterna che l’aveva sacrificata, imponendole il matrimonio con l’anziano zio, passava in secondo piano rispetto alla conquistata libertà: paradossalmente era vista e vissuta come liberazione, come conquista di una nuova dimensione. Insomma, ora aveva cominciato a vivere davvero. A mano a mano che si affezionava al suo liberatore, all’anziano zio-marito, si allontanava dalla famiglia; si venivano allentando tutti i vincoli fino alla definitiva rottura di ogni rapporto. Con grave disappunto e con terribile scorno del padre, che aveva fatto affidamento sul legame con la figlia per venire in possesso dei beni del fratello. Ma proprio per avere compreso di essere stata un semplice mezzo nelle mani del padre, Eufrasia, giorno dopo giorno, visibilmente e tangibilmente, accentuava il distacco dai genitori e dai fratelli, dai quali, col matrimonio, era, in effetti, fuggita inorridita per le sofferenze morali che le erano state inferte. Morirono i genitori e la morte travolse uomini e cose. Eufrasia non si incontrò mai più con nessuno della sua odiosa e odiata famiglia. Nel 1892 morì il padre, ma ella non volle rivederlo e nemmeno sentirne parlare. Quattro anni dopo il matrimonio, nel gennaio 1869, morì Don Alessandro. Con testamento olografo, istituì sua erede universale la moglie Eufrasia. Nuova violenta arrabbiatura del padre: era ancora persuaso che si era consumata una nuova spoliazione in suo danno. Questa rozza persuasione lo accompagnerà fino alla morte. La ricorderà perfino nel testamento, nel quale scriverà di non dovere lasciare nulla alla figlia Eufrasia “non avendo bisogno di ricchezze di che è ben fornita a danno dei veri e naturali aventi diritto, e di tanto danno arrecatomi anche l’assolvo”. Tanto tenace e forte era il rimpianto dell’altrui ricchezza da lasciare il segno anche nell’atto di ultima volontà, dove la stessa espressione di perdono non riesce a dissimulare la tragica devastazione morale. 103 17 Accade, a volte, che uno strano, inspiegabile ed imprevedibile destino predisponga l’incontro tra due persone, tra due storie individuali, che fino allora avevano fatto percorsi diversi. Due persone che, per proprio conto e per la loro condizione di vita, hanno bevuto o, meglio, sono state costrette a bere fino in fondo il calice della infelicità, incontrandosi, nella comunanza di vita, ritrovano la felicità perduta ed ognuna di loro sembra riprendere a vivere, definitivamente sconfiggendo lo stadio dell’angoscia e della depressione. Don Francesco ed Eufrasia avevano percorso vie diverse, che probabilmente non si sarebbero mai incontrate se il padre di Eufrasia non fosse stato divorato da quella febbre e da quella bramosia delle ricchezze altrui che lo portavano a subordinare tutto – anche i sentimenti e gli affetti famigliari – a tale insana, irrefrenabile e devastante passione. C’è sempre un “se” che si frappone al destino degli altri e riesce ad elevare muri al libero esplicarsi della personalità. Non sempre, però, i muri restano insormontabili. Don Martino, ostacolando con particolare e sottile astuzia i tentativi di matrimonio del fratello, era riuscito nel suo perverso proposito di sacrificare la figlia sull’altare dei suoi insani desideri. Non aveva calcolato che il malriuscito matrimonio dell’altra figlia, Kalìa, o, quanto meno, la sua instabilità di carattere, avrebbero potuto negativamente influenzare o, addirittura, annullare, il suo progetto. Don Francesco Marchese, naufrago dal matrimonio con la rissosa Kalìa, ma giovane e prestante, incontra la cognata Eufrasia, giovane vedova di ventitrè anni, e le presta soccorso nel preciso momento del bisogno, quando si trova ad affrontare e respingere le pretese paterne. 104 Marchese, dopo che era stato depositato alla cancelleria del Tribunale il ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie, si era allontanato da Matermara. Eufrasia si trovava in villeggiatura a Castellammare, dove soleva andare ogni anno col defunto marito. Il padre ed i fratelli sparsero e fecero circolare la voce che i due erano insieme a consumare l’adulterio. La finalità era evidente: avrebbero fatto perseguire Marchese per adulterio, isolando Eufrasia. Quando, alcuni giorni dopo, Don Francesco ritornò, il suocero, coadiuvato dai figli e da alcuni servitori, col pretesto di agire per una questione d’onore, lo aggredì rumorosamente nella sua casa in Matermara. Così, messo fuori gioco Marchese, svillaneggiata col pubblico disonore Eufrasia, costei, rimasta sola, priva di un consistente sostegno, sarebbe ritornata in seno alla famiglia, ponendosi sotto la protezione paterna. Ma il progetto fallì per la fiera e dura reazione di Eufrasia. A questo punto, Don Martino abbandona le maniere violente e rozze, ripiegando, pur di raggiungere l’obiettivo, sull’impiego di una strategia di avvicinamento, sull’uso di buone maniere e di persuasione. Dopo qualche mese dall’atto di aggressione nei confronti di Marchese, va a fare visita a Eufrasia, che era a letto per i postumi di una febbre influenzale. Erano le ore dieci. Seduto nella stanza da letto c’era Carlo Mileti, vecchio amico di famiglia che, con Don Alessandro, aveva un consolidato e lungo rapporto d’amicizia, contratta al tempo della rivoluzione calabrese del 1848. Era venuto a fare visita alla Signora e stava con lei intrattenendosi quando, improvvisamente, entra Don Martino. Si leggevano in volto alla Signora il disappunto, la meraviglia ed anche la rabbia per la visita inattesa e non gradita del padre. Immediata fu la reazione quando il padre, già alle prime battute del discorso, fece capire che intendeva conciliarsi. «Ma come, dopo avermi ripetutamente diffamato col propalare voci calunniose di una mia gravidanza, dopo avere assalito vostro genero e mio cognato Francesco, e dopo avermi fatto tutto il male possibile, tentando di deturparmi quando avevo appena quattordici anni, dopo avermi costretta a sposare lo zio Alessandro, ora ve ne venite col ramoscello d’ulivo? Siete un villano, un infame, un assassino, indegno di entrare nella mia 105 casa. Nulla voglio avere a che fare con voi. Non so veramente che farmene della vostra offerta di conciliazione.» Queste dure espressioni troncavano evidentemente ogni possibilità di dialogo col padre, che non chiamò mai con questo appellativo, usando a bella posta il voi per rimarcare la distanza, come se si rivolgesse a persona estranea e nemica, introdottasi furtivamente nella casa. Al bruciante e terribile rimprovero della figlia, Don Martino, forse preso alla sprovvista, restò per un momento come ammutolito, seduto sulla sedia. Improvvisamente, si alzò imprecando contro la figlia, aggredendola a pugni. Il pronto intervento di Carlo Mileti valse a scongiurare il peggio. L’accaduto era di tale gravità da interrompere ogni rapporto tra padre e figlia. Tuttavia non passarono che alcuni mesi per un altro tentativo di avvicinamento. Questa volta l’approccio avvenne tramite la zia materna Erina, la quale fece visita alla nipote. Con modi appropriati e delicati, l’esortò a non rompere definitivamente le relazioni con i suoi. «Cara zia, ciò che tu mi proponi e che è normale per ogni famiglia» rispose Eufrasia «io non posso neppure prenderlo in considerazione. Tu parli così perché sei all’oscuro di tutta la reale vicenda.» «Si tratta di malintesi, che avvengono in ogni famiglia» riprese la zia «e che non possono portare all’odio eterno e alla guerra continua col proprio sangue.» Eufrasia fu costretta, questa volta, a ricordare alla zia tutti i gravi torti e le passate sofferenze, che la inducevano a non mutare atteggiamento nei riguardi del padre e dei fratelli. «Fu il mio indegnissimo padre» disse «che con mia sorella ed i miei fratelli sparsero la voce calunniosa del mio presunto adulterio. Fu mio padre che con i miei fratelli aggredì e ferì mio cognato; quel padre che sin dai miei quattordici anni tentò di deturparmi. Lo tentò nuovamente quando ero diventata moglie del fratello. Durante la vedovanza, fui costretta, un giorno, a piantarlo in asso vicino al balcone che dà sul giardino ed esso a dirmi: non uscire perché se ne accorgono”.» La zia Erina rimase senza parole. La rivelazione di simili segreti le faceva vedere sotto altra luce il marito della sorella. 106 «Io ho sopportato per troppo tempo, cara zia,» continuò Eufrasia «anche perché non avevo a chi rivolgermi; ero ancora una ragazza, non sapevo come reagire. Quello per me non era un padre. Quando fui costretta ad accettare il matrimonio con lo zio, quel padre mi accusò di avere avuto contatti con mio marito prima del matrimonio; mi insultò alla morte di mio marito quando il cadavere giaceva ancora caldo nella bara. Continuò successivamente a torturarmi, per un anno e mezzo nella vedovanza, con lettere, con atti e con parole, dicendomi che mi concedeva uno dei figli a patto della cessione di una parte dei miei beni. Per questo fui costretta a rompere ogni relazione. Che vuoi che ti dica ancora? Servirebbe solo a rinnovare la mia pena.» La povera zia Erina restò attonita ed esterrefatta. Salutò affettuosamente la nipote e se ne tornò a casa. Non si è mai saputo se ebbe il coraggio di riferire alla famiglia di Don Martino tutto ciò che le aveva detto la nipote. *** Questo della zia Erina fu l’ultimo tentativo di conciliazione. Da allora le due famiglie si ignorarono. Eufrasia, pur di cancellare anche il ricordo della famiglia d’origine, avviò la pratica per cambiare il cognome da Bellushi in quello di D’Alessandro, che rammentava il marito defunto. Non l’ottenne. Lo adottò ugualmente per suo conto, firmando Eufrasia D’Alessandro ed usando un apposito sigillo con le tre lettere iniziali E.D.A. Con tale disposizione d’animo verso i parenti, ovviamente, non prese più parte né alle gioie e né ai dolori della famiglia. Indifferente la lasciarono la celebrazione delle nozze di un fratello e la morte del padre. La convivenza armoniosa e pacifica con Don Francesco Marchese ininterrottamente proseguì fino alla morte di Eufrasia, nel 1901. Con testamento segreto, nominò erede universale di tutti i suoi beni, mobili ed immobili, Don Francesco. Quel grande patrimonio, che era passato da Don Flaminio a Don Francesco Bellushi e, da questo, al nipote Don Alessandro ed, infine, alla moglie-nipote Eufrasia, pervenne tutt’intero e 107 con gli accrescimenti, nel tempo, di altri poderi, a Don Francesco Marchese, il patriarca di Matermara, ormai avanzato d’età e senza figli, ma che conservava un qual piglio giovanile e l’ideale di un socialismo umanitario. 108 18 Don Francesco Marchese si era sempre differenziato dagli altri signori. Questi menavano una vita parassitaria, di redditieri. Ai loro affari ed alla coltivazione delle terre badava il fattore, che, poi, di volta in volta, comunicava loro l’ammontare della raccolta delle olive nell’anno, il numero di animali venduti, la quantità di grano prodotta, il numero delle giornate lavorative impiegate. Era, insomma, il fattore che, alla fine di ogni anno, rendeva noto il bilancio dell’azienda agricola. Il signore ne era il proprietario che campava, con la sua famiglia, con le rendite. Era naturalmente riverito dalla moltitudine dei braccianti. Ogni tanto qualcuno del ceto medio, piccolo proprietario o artigiano, si permetteva di mettere in dubbio l’esistenza dei titoli nobiliari, sostenendo che la pretesa nobiltà si fondava esclusivamente sulla ricchezza posseduta e prodotta da altri: per questo motivo, i signori di Matermara avevano a cuore le sorti del capitalismo. Qualche spirito mordace osava anche prendersi delle licenze eccessive. Nicodemo Parlavascio, ch’era un piccolo proprietario e gran lavoratore in proprio, nella locale parlata aveva coniato il proverbio, diffusosi rapidamente, secondo il quale “nde se bitha kishe solde ajò ishe zonja bithe” (se il c. avesse denaro bisognerebbe chiamarlo don c…”). Questo stava ovviamente a significare che, nei gruppi più attivi ed intraprendenti della popolazione, la classe dei signori veniva messa in discussione ed i privilegi di fatto, di cui godeva, erano subìti, ma non accettati ed i pretesi titoli nobiliari ridicolizzati. Ma Don Francesco, benché fosse il più ricco, non rientrava in questa categoria. Egli personalmente sovrintendeva ai lavori ed alle coltivazioni stagionali; ne curava la contabilità; pagava puntualmente i numerosi dipendenti. Aveva introdotto i meto109 di più moderni nella produzione dell’olio di oliva, che addirittura esportava all’estero, con somma invidia dei galantuomini locali, ai quali non era naturalmente simpatico. Anche per la ragione che Don Francesco era un socialista umanitario e dava confidenza al popolino, non disdegnando di aiutare i più deboli e non facendo pesare la differenza di classe. Non era molto attivamente impegnato nella politica, anche se partecipava alle riunioni di zona con i dirigenti provinciali socialisti, ai primi del novecento. Lo ricorderà, nelle sue memorie, il fondatore del partito socialista nella provincia. Era, però, molto largo nella concessione di contributi in denaro: mai aveva opposto un rifiuto alle reiterate richieste di sussidio. Il suo essere socialista, se appagava una sua aspirazione ideale, gli procurava non pochi fastidi nella vita pratica: piccoli dispetti da parte del Municipio, esclusivo monopolio dei signori, e nel quale non era andato oltre la rappresentanza della minoranza. Alla costituzione del primo nucleo di fascisti locali, egli con l’avvocato socialista, Don Vincenzo, furono dei bersagli naturali. Per la verità, più Don Vincenzo che Don Francesco Marchese per il fatto che, da costui, ci si poteva aspettare qualche severa reazione, potendo fare affidamento sui numerosi dipendenti. Contro di lui, ma mai in sua presenza, i fascisti locali – ancora di numero assai ridotto – si limitarono al canto di una improvvisata canzoncina, in cui si ironizzava sulla sua lunga barba bianca in concomitanza con altre espressioni ingiuriose nei confronti di deputati socialisti. Quando, nel dicembre del 1922, accompagnata da squilli di tromba e da schioppettate, faceva ingresso nel paese, aspettata da tutti i signori con il Sindaco in prima fila, la squadraccia di Don Spiridione Bellushi per occupare il Municipio, si trattò, in effetti di una messinscena e di una occupazione simbolica. I signori, che erano i padroni del municipio, erano già fascisti; anzi, lo erano sempre stati. Essi ritenevano di appartenere ad un ceto sociale superiore, destinato naturalmente a comandare sul resto della popolazione. In effetti, i signori avevano deciso di passare in massa nel partito fascista perché era il padrone del momento, dal quale speravano di essere ulteriormente garantiti nella difesa del sacro diritto di proprietà. Essi erano sempre stati nel passato dal110 la parte dei governanti, senza distinzione di fedi politiche o di ideologie, proprio per conservare la loro posizione sociale ed economica. I fascisti furono i benvenuti perché finalmente mettevano a tacere le pretese dei contadini, preservando e conservando l’antico ordine. Perciò Don Momo e gli altri signori, addirittura prima che Don Spiridione avesse deciso di fare un salto con la sua squadraccia, avevano in cuor loro già aderito al fascismo ed erano già ben disposti a consegnare il Comune; aspettavano i nuovi padroni. Quando questi arrivarono, si limitarono alla messa in scena dell’occupazione. Quel pomeriggio, Don Momo e gli altri signori e Don Spiridione ed i suoi militi fascisti festeggiarono fino a tardi nell’aula del Consiglio Comunale. Due militi furono posti di guardia alla porta del Comune. Fu costituita la sezione del fascio e lo stesso Don Momo fu nominato segretario politico. Così aggiungeva alla carica di Sindaco anche quella di segretario della sezione fascista, della quale poi menava vanto col dire di avere servito lo Stato per vent’anni: quindici come sindaco e cinque come segretario del fascio. Verso mezzanotte, Don Spiridione con la sua squadra levò le tende. Nella piazza deserta, prima della partenza, gli squadristi spararono in aria ripetuti colpi di fucile per poi intonare il loro canto tradizionale di All’armi! Siam fascisti Terror dei comunisti Se non ci conoscete guardateci all’occhiello noi siamo squadristi contro la falce e il martello. Bombe a man e colpi di pugnal. La cosa non passò inosservata. Protestò il vecchio segretario comunale, don Vitaliano, per la gravità del fatto, ma alle sue proteste il Sindaco non diede importanza alcuna. Altra cosa fu la manifestazione organizzata dalla Camera del Lavoro la sera del giorno dopo con grande partecipazione di popolo. Al comizio presero parte l’avvocato Don Vincenzo, i due diaconi greci, 111 don Teodosio e don Attanasio; ostentò la sua presenza in piazza anche il Patriarca. Furono espressi dagli oratori, tra applausi ed evviva, severi giudizi di condanna sul comportamento del Sindaco, che aveva permesso che il Comune fosse occupato dai fascisti, in perfetta violazione della legge in vigore. Ma, ormai, alla legalità i signori non facevano più caso: essa si identificava col partito fascista. Anche le forze dell’ordine dimostravano una evidente compiacenza con l’operato delle squadre fasciste e chiudevano tutt’e due gli occhi davanti ai loro misfatti, mentre erano severe nel perseguire le proteste o gli atti di reazione alla prepotenza fascista sia ad opera di singoli che in forma associata. Gervasio, che aveva osato avvicinarsi all’ingresso del Comune per protestare la sera dell’occupazione, ne ebbe come risposta una coltellata al viso da uno dei militi. Recatosi nella caserma dei regi carabinieri per denunziare il fatto, fu convinto di non sporgere alcuna denunzia; tanto non ne avrebbe ricavato nulla – gli dissero. Dopo l’occupazione del Municipio, gli squadristi locali divennero più burbanzosi ed arroganti; non risparmiavano i manganelli contro chi non salutava la bandiera, contro chi non si toglieva il cappello al loro passaggio. Ma il loro bersaglio preferito era l’avvocato Don Vincenzo. Si era nel 1923. Nelle elezioni politiche dell’anno seguente, il trionfo dei fascisti non ci fu. L’uso della violenza non produsse i suoi frutti. La squadraccia, come si è visto, fu addirittura umiliata. Il Vecchio Garibaldino, ormai ultraottantenne, ma ancora vigoroso e pieno di impeti e di giovanile passione, ebbe il coraggio di sfidare apertamente i fascisti, nello stesso seggio elettorale, mostrando di votare per i socialisti. Rispose per le rime al capo della squadraccia, rivendicando la sua dignità di uomo libero col dirgli: «Tu sei uno sconfitto perché, per avere ragione, devi usare la forza contro un popolo di pecoroni. Io sto dove sono sempre stato: dalla parte della libertà che, alla fine, finita questa sbornia di violenza, sicuramente trionferà. Anche se forse, per la mia età, non ne vedrò il trionfo. Ma tu non potrai vivere sicuro e con la coscienza tranquilla con tutti questi straccioni, che ti abbandoneranno al primo mutare di vento.» 112 *** Il vecchio segretario comunale, Don Vitaliano, che non aveva mancato di fare sentire la sua voce di protesta, ne ebbe la peggio. Tutte le sue denunce contro i brogli elettorali, le violenze e le sopraffazioni, caddero nel vuoto. Ed egli perse il posto. Un solo consigliere di minoranza, Cosimo Parlavascio, prese la parola in difesa di Don Vitaliano per sostenere la fondatezza delle sue ragioni in difesa delle pubbliche istituzioni; denunciò – una per una – tutte le azioni di violenza, perpetrate dagli squadristi ed i grossolani brogli nel seggio elettorale per sottolineare l’onesta condotta e la dirittura morale di Don Vitaliano. Molti in privato gli manifestarono solidarietà, ma in pubblico sembrò prevalere l’indifferenza. Si avvertiva che incominciava il regime con la mano pesante contro i dissenzienti. Ogni atto di imprudenza avrebbe potuto avere conseguenze funeste. Don Momo e gli altri suoi amici, che oramai s’erano dati al fascismo nella speranza di ricevere dei benefici, come avveniva nel passato sistema liberale, sicuri di avere in pugno il Comune e di potere esercitare un incontrastato potere, erano intenti alla ricerca di un modo come arrivare addirittura ad attirare l’attenzione del duce ed entrare nelle sue simpatie. Si trattava naturalmente di un proposito, privo di possibilità di riuscita, frutto di menti rozze e servili, parto paradossale della loro ingenua ignoranza. Tuttavia, lo portarono ad effetto: proclamarono il duce cittadino onorario del paese con grande baldoria, limitata al solo gruppo di fascisti. La stessa deliberazione con la quale si attribuiva la cittadinanza onoraria al duce non fu unanime; oltre un terzo dei consiglieri non si presentò nella seduta consiliare. La cosa, però, si prestò ad un gioco crudele a danno dei fascisti, che ne uscirono ridicolizzati per tutto il circondario. Il diacono Don Teodosio, che ormai era stato ordinato sacerdote di rito greco, si trovava a Roma, dove insegnava nel seminario. I suoi amici – alcuni sospettarono l’avvocato socialista e Don Fancesco Marchese – gli riferirono della deliberazione del consiglio comunale. Don Teodosio era uno dei più colti sacerdoti dell’Eparchia greca di Lungro, universalmente stimato, che poteva contare 113 su importanti amicizie nella capitale, dove il vescovo lo aveva mandato forse per placare la sua passione politica, anche in considerazione ed in prospettiva del mutamento dei rapporti tra la Chiesa ed il fascismo. Il periodo di insegnamento nel seminario greco di Roma certamente lo avrebbe distolto dall’interesse politico ed avrebbe evitato di comprometterlo pericolosamente di fronte alle autorità civili ed anche a talune ecclesiastiche, entusiasticamente schierate col fascismo. A Don Teodosio non fu difficile procurarsi busta e foglio con l’intestazione della Presidenza del Consiglio. Vi scrisse a macchina poche parole per annunziare a Don Momo la prossima visita del duce nel paese; si preparasse, quindi, a riceverlo nel modo dovuto. L’annunzio proveniva dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Passò qualche settimana e la lettera fu recapitata a Don Momo. Che cosa non passò per la testa del pover’uomo! Divenne improvvisamente euforico, non riusciva a dormire dalla contentezza per avere raggiunto il suo scopo: finalmente era arrivato al duce; anzi, era il duce che veniva a trovarlo. Era diventato improvvisamente importante. La preannunciata visita del duce lo collocava tra gli esponenti più in vista del fascio. Per alcuni giorni tenne segreta la notizia: la cosa era così straordinaria che quasi quasi neanche lui ci credeva. Ma non poteva essere falsa od un’invenzione o, peggio, una burla degli oppositori. Leggeva e rileggeva la lettera, ne esaminava il bollo di provenienza che, indubbiamente, portava scritto “Roma”; dunque, la conclusione non poteva che essere una: la lettera era vera ed anche vero il suo contenuto. D’altra parte, riteneva che nessuno dei suoi locali avversari aveva la possibilità di fabbricare un falso di questo genere: non l’avvocato socialista, che era costantemente sorvegliato, e neppure Don Teodosio, che la gerarchia ecclesiastica aveva, in qualche modo, punito, cacciandolo dal paese proprio per non nuocere al nascente regime e relegandolo in qualche seminario a fare il professore. Forte di queste considerazioni e della certezza della prossima visita del duce, riunì il direttivo del fascio e comunicò ufficialmente la notizia. Nessuno manifestò od ebbe il minimo 114 dubbio sulla sua fondatezza. Don Michelicchio, che sapeva sì e no solo scrivere la sua firma, rimase a bocca aperta. Don Pietro, che era del tutto analfabeta, propose di festeggiare con una bella bevuta in onore del duce. Il medico condotto si strinse sulle spalle, raccomandando di preparare un’accoglienza coi fiocchi. L’altro componente del direttivo, il maestro di scuola, Don Finuzzo, volle prendere la lettera tra le mani e, dopo averla riletta, «0h, Dio mio, che grande onore» esclamò. Ormai, la notizia era diventata ufficiale: tutto il paese ne era a conoscenza. Ma, per la verità, vi credevano solo i fascisti. Gli altri si limitavano a sorridere come se presentissero la burla e ci scherzavano su. Il Vecchio Garibaldino si fece vedere, una mattina, nella piazza affollata, dove regnava un insolito fervore. C’erano i muratori, che mettevano a nuovo l’intonaco della facciata della casa comunale; c’erano alcuni imbianchini che provvedevano alla pitturazione delle mura delle case vicine e di tutte le case che davano sul corso principale. Lo spazzino puliva le vie pubbliche. Bighellonava nei pressi il vecchio Dimitri, vestito di stracci, come al solito. E Don Francesco gli chiese: «Dimiter, ma che ci diamo a Mussolini?» Dimitri prontamente rispose, saltellando, con il suo accento blèso: «Zoti Patrù, signor Padrone, gli diamo confetti e ciaffè.» Il fervore, dovuto all’aspettativa della visita, durò qualche settimana, poi andò scemando. Il duce non si faceva vivo. Don Momo si sentiva chiedere con insistenza dal suo dipendente Minichicchio: «Patrù, kur vjen Mussulini?» (Padrone, quando verrà Mussolini?). Non sapeva che rispondere; tergiversava e trovava qualche scusa plausibile, ma nel suo intimo soffriva. Era, intanto, passato più di un mese. I preparativi erano stati fatti, le pareti delle case imbiancate, le donne dei fascisti avevano preparato per la festa grandi quantitativi di taralli, biscotti, mostaccioli. Tutto era, dunque, pronto per ricevere il duce, ma della visita non si avevano notizie. Il direttivo della sezione fascista chiese udienza al federale di Cosenza, che in quel periodo era Don Maurino Bellushi. Il giorno, stabilito per l’udienza, la mattina presto, Don Momo e gli altri fascisti si recarono alla stazione di Sibari, a cavallo degli asini, per prendere il trenino per Cosenza. 115 Quivi giunti, impiegarono pochi minuti per raggiungere la federazione del fascio, in piazza della Vittoria. Il federale Don Maurino era tutto gallonato, vestito con una splendida divisa nera e relativi stivaloni neri lucidi. Don Momo e gli altri, introdotti al cospetto del federale, salutarono con la mano alzata e attesero che Don Maurino desse l’ordine di sedersi. «Beh, come mai questa visita?» chiese il federale. Don Momo spiegò il motivo della visita e porse al federale la lettera che gli era pervenuta da Roma. Il federale leggeva la lettera e sorrideva. Don Momo e gli altri si guardarono quasi per interrogarsi con lo sguardo. Ad un certo punto, il federale si fece serio e sbottò: «Ma siete proprio fessi. Che motivo aveva S.E. di venire nella vostra piccola Matermara? Non ve lo siete proprio chiesto? Siete degli autentici coglioni.» «Ma noi veramente pensavamo che il duce volesse ringraziarci del conferimento della cittadinanza onoraria» ardì rispondere Don Momo. «Non c’è stato paese o città che in questi tempi non abbia conferito la cittadinanza onoraria a S.E.. Perché avrebbe dovuto scegliere proprio la vostra Matermara, che si trova nel deserto, senza strade, senza acqua e senza niente, dove non avrebbe neppure come venirci? E, poi, se fosse vero il preannuncio della visita di S.E., la segreteria del duce l’avrebbe preventivamente comunicato alle Autorità governative ed al partito. Questa è carta straccia» continuò il federale, restituendo la lettera a Don Momo «qualche bello spirito ha voluto prendervi i giro, facendovi uno scherzo da prete. Prima di venire da me a rompermi i coglioni, dovevate almeno immaginare che si trattava di uno scherzo. E di uno scherzo feroce, che ha fatto vedere la vostra dabbenaggine, buttando il ridicolo sul nostro Partito.» Nell’occasione, il federale fece un annunzio che per Don Momo segnava anche la fine della sua carriera politica. «Tornate a casa» disse «e badate a rafforzare il partito. Fra un mese tutte le Amministrazioni comunali saranno sciolte e saranno rette da un podestà.» I poveri uomini, annichiliti dalla vergogna, mogi mogi ritornarono in Matermara. Ma si seppe dello scherzo e della lavata di testa, fatta dal federale alla dirigenza fascista locale. Nelle 116 botteghe artigiane, in piazza, nelle riunioni nelle gjitonie, nei vicinati, per diversi giorni si rise a crepapelle. Don Francesco incontrò Don Momo in piazza e davanti a molte persone, con sottile ironia, gli chiese: «Il duce quando ci fa l’onore della sua visita o ha voluto prendersi gioco di noi?» «Siamo in attesa» rispose Don Momo, stringendosi sulle spalle ed allontanandosi con una scusa. 117 19 La sera del 13 dicembre del 1926, l’avvocato socialista, Don Vincenzo, stava tranquillamente cenando con la famiglia. Verso le ore 20, una pattuglia dei Reali Carabinieri bussò alla sua porta: era venuta ad arrestarlo in esecuzione del provvedimento della Commissione Provinciale. Era stato condannato a tre anni di confino perché ritenuto attivo propagandista socialista in stretto collegamento col deputato socialista del circondario. Fu portato per scontare gli anni di confino a Miglionico. Pietro, il suo principale collaboratore, ed alcuni altri della sezione, erano già emigrati negli Stati Uniti ormai da quasi un anno. Avevano lasciato il paese malvolentieri; anzi, v’erano stati costretti. Non ci si poteva più vivere perché si sentivano come soffocati ed oppressi, stranieri e nemici nella propria patria. Ed, in effetti, come tali erano trattati. I signori non gli davano più una giornata di lavoro. E tanto valeva a convincerli ad andarsene: almeno in America sarebbero stati liberi ed avrebbero trovato lavoro. Ma lasciavano in Matermara i loro affetti, i parenti, gli amici, gli altri compagni della sezione, il ricordo delle tante battaglie sostenute. Ora, tutto sembrava perduto: il loro mondo era crollato. Il primo maggio del 1925 avevano fatto l’ultimo gesto di libertà: avevano fatto trovare nella piazza issata la bandiera rossa con la scritta W il martire Matteotti e la libertà. Erano stati anche processati, ma assolti da un giudice coraggioso perché il fatto non costituiva reato. Partirono, di notte, la mattina verso le quattro, per potere raggiungere a piedi, in tempo, la stazione ferroviaria di Sibari per prendere il treno per Napoli. Qui si sarebbero imbarcati nel piroscafo per l’America. Il viaggio a piedi, per viottoli e tratturi, almeno fino a quando si raggiungeva la strada nazio118 nale, richiedeva alcune ore ed era pieno di pericoli lungo la pianura paludosa, dominata dalla zanzara anofele che vi diffondeva la malaria, mietendo numerose vittime fra contadini, pastori e braccianti. Chi non aveva potuto emigrare ed era rimasto in Matermara aveva dovuto, in qualche modo, piegarsi al nuovo regime ed ai nuovi riti della vita quotidiana, almeno in apparenza, pur continuando a mantenere le proprie convinzioni. Fu allora che, nelle classi popolari, incominciò a diffondersi il detto, di cui non si è saputo mai l’autore K’misha e zez, k’misha e zez / ben e vemi beza bez (la camicia nera, la camicia nera / ci fa camminare carponi). Il vecchio Cosmantonio aveva nascosto, nella soffitta della casetta rurale di Comesse, la Croce di Karavak, lasciandola, così, in eredità ai due figli, che adesso lavoravano alla costruzione di linee ferroviarie in America. La bandiera socialista, dopo l’ultima apparizione del primo maggio 1925, era stata chiusa in un bauletto e messa al sicuro nella masseria di Pietrangelo, ad Ambolo. Neppure il Fascio locale aveva molta voce in capitolo per il fatto che i suoi dirigenti erano, perlopiù, gente rozza ed incolta, in grado soltanto di scrivere meccanicamente il proprio nome e cognome. I nuovi dirigenti erano forestieri: il podestà Don Luchino ed i due maestri elementari, Sinibaldo ed Argante, che sempre vestiti in camicia nera, curavano l’organizzazione della gioventù e delle attività sportive. Le loro signore erano addette al tesseramento delle donne negli organismi del regime. I nuovi arrivati convocavano nella sezione i non tesserati e li inducevano, più propriamente, li costringevano a prendere la tessera. Pochi riuscirono a non farsi incastrare. Qualcuno, convocato in sezione, come il giovane Alfonso, che proveniva dalla vicina Acri, ebbe anche il coraggio di reagire. Si dice che al podestà, che gli imponeva di tesserarsi, rispondesse con fierezza di essere e di sentirsi un uomo libero. «Non accetto questa imposizione» ripose. «Allora, sei contro il Fascio?» fece il podestà. Non sono neppure tenuto a dire con chi sono e con chi non sono. Sono affari miei. 119 Lo deferirono alla Commissione Provinciale, denunciandolo per disfattista ed antifascista. Ma il giovane operaio, che pure era comunista, ebbe l’accortezza di non fare trapelare la sua militanza politica e – questa volta – scampò al confino. Se la cavò con un’ammonizione. Un altro giovane, Francesco, disoccupato e vinto dalla disperazione perché non riusciva a trovare lavoro per sfamare se stesso e la propria famiglia, con un gesto coraggioso, portò alla luce del sole quella che era la situazione economica reale della maggiore parte della popolazione. Una domenica mattina, davanti ai signori ed al podestà che passeggiavano, scrisse sui muri del municipio Vogliamo lavoro! Abbasso il duce affamatore del popolo!. Immediata fu la reazione. Il podestà chiamò i carabinieri che lo arrestarono. Mentre veniva prelevato dai carabinieri, davanti ad una piccola folla che si era nel frattempo formata, gridò la sua disperazione di disoccupato, che era poi quella di tutti. «Questo volevo» disse «almeno, nel carcere, mi dovete dare da mangiare. Dite al vostro duce che abbiamo bisogno di lavoro.» Il gesto clamoroso destò enorme impressione e lasciò un segno duraturo perché, di voce in voce, si diffuse anche nei dintorni e fu commentato e discusso con apprezzamenti non certamente favorevoli al governo. Esso fu anche di incitamento per altri atti, ritenuti allora sovversivi e pericolosi per l’ordine pubblico. Il calzolaio mastro Peppino Stringalo si presentò all’ufficio dello stato civile del Comune per denunziare la nascita del primo figlio, al quale disse di volere dare il nome di Lenin. L’impiegato dello stato civile tentò inutilmente di dissuaderlo. Ma siccome insisteva nella sua richiesta, fu arrestato e deferito al Tribunale Speciale. Nell’occasione della visita del principe Umberto alla duchessa Bovino, i capi fascisti si recarono ad omaggiarlo, portandovi anche le loro donne, vestite con gli sfarzosi costumi arbresh, albanesi. Si insinuò tra la folla anche il maestro muratore Salvatore Cortese, che, mentre il principe salutava gli intervenuti, gli gridò: «Stasera, verremo a salutarVi al Castello per dirvi che qui si muore di fame.» Ne ebbe cinque anni di confino. 120 Dopo questi fatti, non ci furono più colpi di testa e proteste clamorose. Ma non cessò il dissenso soprattutto tra gli artigiani, i braccianti ed i piccoli proprietari. Turi Minisci, che si era allontanato da Matermara, trasferendosi nella vicina S. Giacomo per esercitarvi il mestiere di calzolaio, ogni tanto vi faceva una capatina per tenere le fila dell’organizzazione clandestina comunista. Nel laboratorio di falegnameria di Crisostomo, aveva costituito una cellula con tre persone fidate: lo stesso Crisostomo, Cosimo Vangieri e Damiano Deitenori. Il giorno venti di ogni mese, nella tarda mattinata, un corriere misterioso depositava in una grotta della contrada Gammarossa, il giornale del partito, L’Unità, con altro materiale di propaganda. Il giorno dopo, Cucchia, la moglie di Damiano Deitenori, vi si recava con il pretesto di trovare frasche e legna e prelevava il materiale, che naturalmente passava al marito, il quale, a sua volta, lo trasmetteva agli altri dell’organizzazione clandestina. Così passavano i giorni e gli anni, gli uni sempre simili agli altri. Il popolo minuto, quello dei braccianti senza terra, quello degli artigiani e dei piccoli proprietari, viveva faticando e facendo finta di aderire al regime. Tutto era rimasto come prima: d’autunno e d’inverno, le donne raccoglievano le ulive e le portavano, a loro spese, ai trappeti dei signori, ricevendone in cambio un quinto del prodotto raccolto. E questa era tutta la loro mercede, che non prevedeva neppure il versamento dei contributi per la pensione. I signori gironzolavano per il paese oppure passavano il tempo nel circolo giocando a carte. Essi non vi lasciarono alcun segno del loro passaggio terreno; neppure l’affossatura in una poltrona perché nel circolo vi erano solo vecchie sedie sgangherate. *** Il Patriarca, ormai anziano, sentendosi mancare progressivamente le forze, decise – com’era nel suo stile – di fare un atto fuori dell’ordinario, disponendo con testamento pubblico, del ricchissimo patrimonio, a beneficio della futura fondazione, che doveva essere intitolata al suo nome ed a quello della Zonja 121 Eufrasia, con l’eccezione di alcuni beni, case e fabbricati, che donava ai dipendenti come buonuscita. Fece venire nel palazzo il diacono greco Don Attanasio per spiegargli il progetto, da eseguirsi, dopo la sua morte: aveva intenzione di costituire la fondazione, alla quale lasciava quasi tutto il patrimonio, il palazzo come sede, il trappeto e l’olivaio per la produzione dell’olio. Esecutore testamentario Don Attanasio, coadiuvato da un consiglio di amministrazione di quattro contadini, da eleggere tra i contadini di Matermara. La fondazione aveva il compito di coltivare le terre e curare la produzione, assumendo la manodopera del luogo e remunerandola adeguatamente. Ogni anno andava redatto il bilancio. Un quarto del profitto, tolte le spese di coltivazione, ammodernamento e manutenzione del trappeto e dei fabbricati, tasse e quant’altro necessario, doveva servire per aiuto agli anziani ed agli studenti bisognosi e meritevoli del luogo. Nessun limite di tempo era stabilito per la fondazione. Avuto l’assenso di Don Attanasio di accettazione dell’incarico sia di esecutore testamentario che di presidente, Don Francesco chiamò il notaio Nicola Zanfini, il quale raccolse il testamento pubblico con la costituzione ed il regolamento della fondazione, la quale veniva nominata erede universale. A Duca Brescia ed alla moglie Porzia donò il fondo ulivetato di Gramano e la casa di via Pietro Shini; a Murana de Ligori, la casa di via Krojnusevet, da godere vita natural durante; a Marcello Valatta ed alla moglie Maria Pisarra, il fondo Zertine; a Dimitri Floco ed alla moglie Sandra Kandreva, l’appartamento di via Pokfili. Il 1933, il Patriarca morì, nel compianto generale. La Fondazione raccolse il suo patrimonio. Gli eresse una tomba monumentale. *** Poi vennero le guerre. La prima fu la guerra civile spagnola. Contro i “rossi” di Spagna non v’era domenica che il parroco non tralasciasse di mandare le sue maledizioni dall’altare, invocando l’aiuto del Signore per il trionfo della civiltà cristiana. 122 Alcuni poveracci, allettati dalla retribuzione promessa, si arruolarono nella milizia fascista e furono spediti come volontari in Spagna. Ritornarono dopo qualche anno più poveri di prima. La cosiddetta conquista dell’impero lasciò insensibile la maggiore parte della popolazione, salvo – naturalmente – i dirigenti del fascio, che si diedero da fare per celebrare l’avvenimento. Andavamo in Africa per portare la civiltà, per costruire strade, scuole, acquedotti. Ma qui, in Matermara, in tutto il circondario, in Calabria ed in tutto il Mezzogiorno d’Italia, queste opere non c’erano. Molti se lo chiedevano tra di loro senza tuttavia manifestare apertamente la propria opinione perché non si poteva. Nella sartoria di Cosmo, dove si recava la sera l’avvocato socialista, ridotto al silenzio dopo il ritorno dal confino di polizia, in modo guardingo, con estrema cautela, la conversazione era vivace ed irrispettosa per il regime. Lo stesso avveniva, quasi ogni sera, nella falegnameria di mieshter Zepa (mastro Giuseppe). Vi si riunivano quelli che, prima della dittatura, avevano parteggiato per il partito di Don Sturzo. Erano in pochi e discutevano a lungo per cercare di capire come andavano le cose. Problema assai difficile, anzi impossibile, da sciogliere per chi – come loro – poteva fare affidamento solo sulla propria esperienza di vita e non aveva alcuna informazione vera sugli avvenimenti se non i vaghi riferimenti della propaganda. Cosmantonio – quello che, in attesa della fine del fascismo, aveva nascosto la croce di Karavak – non mancava di sottolineare il dato oggettivo, che era sotto gli occhi di tutti. «Noi non abbiamo» diceva «l’acqua nelle case, le fognature, le strade; che andiamo a fare in Africa? Perché non si pensa di costruire qui le strade e le altre opere di civiltà? Sarebbe questo il modo anche come dare lavoro alle nostre maestranze ed ai nostri operai e rendere un lodevole e prezioso servizio alle popolazioni.» Nessuno pensava di emigrare nei deserti dell’Etiopia per lavoro. La mèta dell’emigrazione restavano le terre dell’America del Nord e del Sud. Da quelle terre, del resto, provenivano sostanziose rimesse degli emigrati che contribuivano ad alleviare le condizioni assai precarie della vita quotidiana. 123 Il parroco ed il segretario del Fascio non si stancavano di esaltare l’impresa imperiale; organizzavano riunioni, alle quali imponevano ai cittadini di partecipare per manifestare soddisfazione e per osannare al capo del governo. Ma la realtà portava in altra direzione e si vendicava sulla occasionale retorica. Era sufficiente dare uno sguardo ai ragazzi scalzi, ai giovani ed anziani malvestiti, al paese senza acqua, senza fognature, senza strade, senza luce elettrica, perché svanisse e cadesse nel ridicolo la retorica di piazza. Erano queste le considerazioni che si facevano nelle riunioni clandestine della cellula comunista, che si tenevano di notte in un casale diroccato della contrada Frasciro, che poi andavano diffondendosi tra la popolazione senza che si potesse venire a capo dei propalatori reali. Fece un tentativo il segretario del Fascio: convocò in sezione, separatamente, Artemisio, Deodato, Martino, Gallinazzo, che riteneva tra quelli maggiormente sospettati. Ma il tentativo si rivelò assolutamente inutile. Ognuno dei convocati, benchè minacciati di gravi pene, negò di essere a conoscenza delle critiche reiterate e persistenti al fascismo. In quell’occasione un brutto momento lo passò mastro Costantino Minisci. Ricevette una lettera raccomandata di convocazione dal Federale di Cosenza per il giorno 15 marzo 1937. Si vide perduto ed ormai destinato a qualche anno di confino perché effettivamente era solito sparlare del regime. La mattina, per tempo, partì di casa per raggiungere la stazione di Sibari per prendere il treno per Cosenza. Lasciò la moglie nella disperazione. «Ti abbraccio e ti saluto, moglie mia, perché probabilmente non ritornerò da Cosenza. Kush e dìe çe me token e ka me sbattirnjin ktà fashistra (Chissà che destino sarà il mio e dove mi sbatteranno questi fascisti).» Durante il viaggio, tentava di fare una rassegna mentale la più minuziosa possibile per ricordarsi con chi aveva parlato o avuto a che fare nel corso dell’ultimo anno, per potere individuare il probabile delatore e la natura dell’accusa. Cercava, così, almeno di preparare una qualche difesa od una qualche giustificazione. La situazione gli sembrava disperata. Troppe volte aveva sparlato del regime ed incautamente con più persone. La cosa che più lo preoccupava erano le sue visite all’avvocato so124 cialista. Come avrebbe potuto difendersi dall’accusa di avere a che fare con un sovversivo? Avrebbe sempre potuto discolparsi giustificandosi che, in casa dell’avvocato, andava per motivi di lavoro: per ripararvi porte, finestre, armadi malandati col tempo. Ma gli avrebbero creduto? Bisognava provare le sue affermazioni; ma le dichiarazioni di un sovversivo sicuramente non sarebbero state ritenute valide. E, allora, come fare? Si dibatteva in questo grave imbarazzo quando il commesso lo chiamò e lo introdusse nella stanza del Federale. Salutò romanamente ed il Federale rispose al saluto. Ma il cuore gli batteva forte. In quel momento avrebbe voluto sprofondarsi pur di non sentire la sua condanna dalla voce del gerarca. Perché mai costui si era scomodato a convocare un misero falegname se non per rimproverargli i suoi peccati contro il governo? All’impiedi, tutto compunto, stava davanti alla scrivania del Federale. «Camerata Minisci, avete un figlio?» A questo punto non aveva veramente che pensare. Forse, il figlio Sandrino, che era studente liceale a Core, aveva fatto qualche sbadataggine, compromettendosi gravemente? «Sì, eccellenza, ho un figlio che mantengo allo studio con tanti sacrifici miei e della famiglia; è un bravo ragazzo che non mi ha mai dato finora alcuna preoccupazione» aggiunse a giustificazione di qualche eventuale marachella del figlio. «No, non si tratta di questo» rispose il Federale. Mastro Costantino non ci raccapezzava più nulla se non erano in discussione né la sua condotta politica e neppure quella del figlio. «Perché non volete che vostro figlio giuochi nella quadra di calcio di Core?» continuò il Federale. «Eccellenza, questo è tutto?» «Sì, questo è tutto. Perché c’è dell’altro?» rispose il Federale. «Oh, no, no. Che giuochi, Eccellenza, che giuochi.» «Ve ne potete andare.» «Grazie, eccellenza, grazie.» Mastro Costantino non aveva come ringraziare il Federale. Si sentiva liberato da un grave peso. 125 Non si era trattato di uno scherzo. Era accaduto che Sandrino era una valida ed abile ala sinistra e, all’insaputa del padre, giocava nella squadra di calcio di Core. Quando il padre ne era venuto a conoscenza, glielo aveva severamente proibito nel timore che ne avrebbe sofferto il profitto scolastico. Per costringere mastro Costantino a prestare ufficialmente il suo assenso, il Segretario del Fascio di Core, pressato dai dirigenti della squadra, era ricorso allo stratagemma di farlo convocare dal Federale di Cosenza. *** Per la dichiarazione di guerra il 10 giugno del 1940, il Segretario del Fascio ed il podestà, tra pugnali, bandiere e moschetti, esposero al balcone del municipio un apparecchio radio e disposero la convocazione in piazza della popolazione. Andrea, il figlio di Cosmantonio, dovette interrompere il lavoro a Proi Vrika e tornare in paese per essere presente in piazza. Cambiò d’abito, prese per mano il figlioletto di alcuni anni e s’avviò verso la piazza. Vi giunse quando già dalla radio proveniva una voce strìdula che proclamava la necessità della guerra e la ormai irrevocabile decisione di dichiararla. Ad ogni pausa della voce urlante, i gerarchi locali ed i ragazzi delle scuole applaudivano. E poi la voce continuava ancora ad urlare e di nuovo seguivano le pause e gli applausi fino a che la riunione si sciolse ed ognuno mestamente prese la via di casa. ‘Ntoni Andropulo si accompagnò ad Andrea; ambedue, ragazzi diciottenni, erano stati arruolati nel 1916. Avevano partecipato a tante battaglie, all’Isonzo, al S. Michele, alla Bainsizza, al Piave, ed erano stati anche feriti. Avevano ancora vivo il ricordo della terribile vita di trincea, immersi quasi sempre nel fango. Andrea ne portava ancora il segno nella propria carne; oltre ad essere ferito alla gamba sinistra, aveva contratto una devastante emicrania che, di tanto in tanto, lo colpiva e non v’erano farmaci che potessero attutirla. Dopo la guerra, i due erano emigrati, prima in Argentina e poi negli Stati Uniti. Avevano faticato molto per guadagnare un po’ di denaro, bastevole per l’acquisto di alcuni poderi. Ora vi126 vevano in pace con le loro famiglie col reddito che traevano dalla vendita delle olive, dei fichi, del vino e del grano. Ma la guerra, che conoscevano per esperienza diretta, sentivano che questa volta che si pretendeva combatterla contro tutto il mondo, avrebbe causato maggiori lutti, rovine, morti e fame. I due, mentre proseguivano in direzione della casa di Andrea, facevano tali considerazioni. Proprio in prossimità della casa, si fermarono. ‘Ntoni si appoggiò con la spalla destra al muro; Andrea stava di fronte a lui. Il bambino, il figlio di Andrea, guardava i due, che gli sembravano due giganti e che parlavano e si accaloravano nella conversazione, fatta sempre a bassa voce ed in modo da evitare che estranei, passando, potessero percepirne il significato. Neppure il bambino capiva quello che i due si dicevano. Rimase turbato quando si accorse che, ad un certo momento, il padre e l’amico piangevano. Perché piangevano se, in piazza, poco prima v’era stata come una festa, conclusa allegramente tra evviva, canti ed applausi? Il contrasto tra questo pianto e l’allegria collettiva della piazza era troppo evidente. Ne rimase profondamente turbato, non riuscendo a darsi una qualche giustificazione. Anche negli anni successivi, rivisse mentalmente quella scena ed il suo turbamento. Quando ormai la guerra era finita da alcuni anni ed era stata anche proclamata la Repubblica, egli non era più il bambino di allora; era cresciuto, aveva studiato, soprattutto aveva letto molto ed aveva conseguito la licenza media. Gli era chiara, ormai, la ragione di quel pianto. Nell’estate del 1949, aiutava il padre nei lavori al podere vicino al paese. La sera, padre e figlio facevano lunghe conversazioni che toccavano gli argomenti più disparati. Il ragazzo chiese al padre se ricordava l’episodio del pianto con l’amico che l’aveva accompagnato fino a casa. «E tu come fai a ricordarti? Eri proprio piccolo» rispose meravigliato il padre. «Quella scena mi si è stampata nella memoria e non mi ha mai abbandonato» rispose il figlio. «Solo da grandicello ho intuito la ragione del pianto. Ma voglio da te la conferma.» «È vero, io ed il compare ‘Ntoni, ancora quasi ragazzi, eravamo stati sbattuti al fronte nella prima guerra mondiale. 127 Quella sera, in piazza, eravamo stati convocati dal Segretario del Fascio per sentire dalla radio la dichiarazione di guerra del duce. Sapevamo che rovine e morti avrebbe inevitabilmente portato la guerra. Abbiamo pianto dalla disperazione. Non avevamo con chi sfogare la nostra rabbia. Se mostravi di essere contro il Fascio, ti arrestavano. Bisognava, quindi, fingere di approvare. Non si poteva fare altro. In famiglia» continuò il padre «il nonno ci aveva educati a non ricorrere mai alla violenza.» «Ma i fascisti esercitarono la violenza contro di voi. Perché non avete reagito?» «Non si poteva, figlio. Avevi contro il Municipio, i carabinieri, la polizia, il parroco, lo Stato, tutto era contro il cittadino senza difesa. In gioventù, ritornato dal fronte, avevo seguito Don Sturzo. Non avevo mai partecipato agli scontri tra fascisti e socialisti.» «Perché?» chiese il figlio. «Rifuggivo dalla violenza. Mi piaceva vivere in pace, lavorare in campagna, fare un po’ di denaro per accasarmi, non seminare odio, che si tramanda, dalle nostre parti, di generazione in generazione.» «Ma, allora, con questo atteggiamento, si favoriva la vittoria del fascismo» fece il figlio. «No. Il Fascismo fu voluto e favorito dall’alto, dalla monarchia e da chi aveva le chiavi del potere in Italia. Fu imposto non facendo osservare le regole della democrazia. A quel punto, soltanto una insurrezione generale della popolazione giustificava il ricorso alla violenza. Ma così non fu. Il singolo atto di protesta ti poteva solo portare al carcere od al confino. Del resto, proteste singole o singole manifestazioni di opposizione non hanno fatto crollare il Fascismo.» «Così, niente hai fatto contro chi ti opprimeva.» «Non è vero. Nulla potevo fare di appariscente. Preferivo sopportare in silenzio. Sarebbe arrivato il giorno, com’è poi accaduto, della liberazione. L’arroganza non paga.» «Ma i fascisti ti privarono della libertà e tu non hai reagito» fece il figlio. «Mi privarono momentaneamente della libertà di parola, ma io sono sempre stato e mi sono sempre sentito un uomo libero. 128 Lo stesso Segretario del Fascio ed il Podestà mi hanno ritenuto un avversario tenace, ma che non offriva alcun appiglio per essere perseguitato. Ti ricordi che mai ti fu dato un giocattolo od un qualche regalo durante la distribuzione dei doni della Befana?» Allora, il figlio passò in rassegna mentalmente quegli anni trascorsi e dovette convenire col padre. Effettivamente, ogni anno, alla festa della befana fascista, il ragazzo si presentava in piazza nella speranza di ricevere anche lui uno di quei doni che venivano distribuiti. Attendeva speranzoso fino alla fine della cerimonia, ma non ricevette mai nulla. Ritornava a casa triste e silenzioso. «Alla fine» concluse il padre «con pazienza e con tenacia, io e tanti altri milioni di italiani, nella modestia della nostra condizione sociale, soffrendo in silenzio, siamo riusciti a resistere alla dittatura. Il 25 luglio del 1943, i fascisti sparirono. Il podestà, il Segretario del Fascio scapparono dal paese e si nascosero non so dove per la vergogna e la paura. Noi risorgemmo come dalle nostre ceneri, ma non eravamo mai morti veramente. La dittatura aveva erroneamente creduto di avere fatto piazza pulita di tutti i nemici. Non era così. Perché, ricordati, figlio mio, che la libertà non può mai morire. Allora, finalmente, potei disseppellire dalla soffitta della casetta di campagna quella Croce di Karavak, che il nonno aveva tenuto nascosta nel periodo della dittatura e con la quale aveva preannunziato alla squadraccia fascista una non lieta fine.» 129 20 Nell’orto, dietro la chiesa, all’ombra degli ulivi, quasi tutti i giorni nei caldi pomeriggi dell’estate del 1943, una frotta di ragazzi, di uomini e di sfollati provenienti da Paola, si davano appuntamento per assistere ai bombardamenti sulla stazione ferroviaria di Sibari, posta ad un tiro di schioppo, in pianura. La pianura di Sibari, circondata da una parte dai monti del Pollino e dall’altra dalle colline della Presila con i paesi albanesi, è come un immenso e grandioso anfiteatro. Nell’estate del 1943, in questo anfiteatro, lo spettacolo tragico era costituito dalle ondate di aeroplani inglesi ed americani che sbucavano o dal Pollino o dalla Sila per sganciare le micidiali bombe sulla stazione ferroviaria sibarita. Di tanto in tanto, si levava in volo qualche aereo tedesco per contrastare i bombardamenti. La lotta era naturalmente impari. Si sentivano i colpi delle mitragliatrici che sibilavano nel cielo e si vedeva l’aereo tedesco ritirarsi oltre i monti della Sila, ma quando era colpito lo si vedeva roteare e cadere fragorosamente, tra le fiamme, nella grande pianura, attraversata dal Crati e dal Coscile. Ormai, da quando la radio aveva comunicato che gli Americani erano sbarcati in Sicilia, i fascisti in Matermara erano sbandati; non organizzavano più adunate; avevano all’evidenza abbassato la cresta. Da un giorno all’altro, si aspettava il cambiamento radicale. In questo clima si diffuse rapidamente la notizia che il re aveva fatto arrestare il duce e che il fascismo non c’era più. La popolazione era presa da una grande eccitazione; si riversò in piazza per festeggiare. Fu invasa e saccheggiata la sede del Fascio, le carte ed i gagliardetti furono bruciati. Mastro Natalino strappò l’insegna sopra la porta della sezione fascista; la legò 130 ad un grosso filo di ferro e la trascinò per tutti i rioni del paese, seguìto da una piccola folla di ragazzi e adulti. Mastro Giannice si impossessò di un grande ritratto del duce, lo portò in piazza e, davanti a tutti, ci cacò sopra. Mastro Finuzzo andò ad Ambolo a riprendere, nella masseria di Pietrangelo, dov’era stata nascosta, la bandiera socialista con la falce ed il libro per portarla in paese, rione per rione, facendola sventolare in segno di vittoria, mentre una improvvisata folla di paesani applaudiva e gridava Evviva il Socialismo! Evviva la libertà! Evviva Matteotti! La mattina del giorno dopo, in tutti i vicoletti adiacenti alla piazza, si accalcò una moltitudine di uomini, donne e giovani, armati di bastoni, roncole, coltelli. Ad un certo momento, verso le otto, un fischio risuonò e tutta la gente, al segnale convenuto, assediò il municipio, ammassandosi sul grande portone d’ingresso che, nel frattempo, era stato chiuso, tempestandolo di pietre e bastonate, forzandolo in tutti i modi nel tentativo di aprirlo; tentativo non riuscito. «Via i fascisti dal Comune» era il grido unanime. L’assalto al municipio era stato organizzato per destituire e cacciare dal Comune il cavalier Cosimo Osmano, impiegato allo stato civile, uno dei dirigenti fascisti locali, accusato dalla voce pubblica di essere l’autore di varie segnalazioni e denunzie di avversari, a causa delle quali avevano avuto non poche noie. Non si è mai saputo se la voce propalata fosse vera o no. La furia popolare, in quel momento, era incontenibile. Il malcapitato riuscì a salvarsi, uscendo da una porticina secondaria e rifugiandosi in casa di amici. L’arrivo dei carabinieri non intimorì la folla; anzi, essi furono disarmati e dovettero fare aprire il portone del municipio. Il Segretario del fascio era scomparso dalla circolazione. Per molti mesi, e fino a quando non cessò la bufera, non si fece vedere. Si era rifugiato in una masseria nei pressi di Doria. Aveva lasciato uno scritto nel quale dichiarava di “non essere mai stato fascista” e che scappava per evitare di essere ammazzato dai comunisti. In paese non fece più ritorno. Neanche da morto. Circolava la voce che stava sempre tappato in casa per la paura dei comunisti. 131 All’indomani del 25 luglio, di mattina presto, il Podestà caricò tutte le sue masserizie su un mulo e si diresse verso la stazione ferroviaria di Sibari per raggiungere il suo paese, nei pressi di Taranto. Non se ne ebbe più alcuna notizia. Donna Erminia, che era stata la responsabile delle donne rurali, non rimase sconvolta dalla scomparsa del fascismo. Per lei l’organizzazione delle donne era alla stregua di una qualsiasi occupazione, che non aveva niente di politico. Era un modo come stare insieme, fare delle feste ed organizzare dei balli. Si disfece rapidamente del materiale propagandistico in suo possesso, facendone un falò nello spiazzo davanti alla propria abitazione con gran divertimento dei bambini che razzolavano lì intorno. Il maestro elementare, Don Rodolfino, un uomo bassino e mingherlino, che aveva creduto ciecamente nel fascismo e continuava a crederci, dismise la sua divisa e gli stivaloni; in cuor suo, era ancora convinto che il duce alla fine avrebbe vinto ed avrebbe imposto la sua volontà a Hitler. «Vedrete» diceva con calore nel Circolo dei galantuomini «che il duce non è ancora finito. Il nostro alleato tedesco sta costruendo un’arma micidiale che ci farà vincere la guerra.» Gli altri signori o non sapevano che dire o manifestavano scetticismo. Erano troppe le sconfitte dei nazisti e dei fascisti per potere credere ad una loro ripresa vittoriosa. In Italia erano sbarcati gli alleati e mezza Italia s’era liberata dal fascismo. Gli alleati erano sbarcati in Normandia; sembrava veramente difficile impedire la loro marcia tanto più che ovunque in Europa la Resistenza faceva egregiamente la sua parte contro l’occupazione nazifascista. Ma, nel Circolo dei signori, alla Resistenza ed, in particolare, ai partigiani italiani, non si dava alcuna importanza. Questi erano considerati degli irregolari, degli straccioni, che andavano all’assalto dello Stato per il loro personale tornaconto. Soprattutto, nella Resistenza, primeggiavano gli odiati rossi, che avrebbero portato al potere i socialisti ed i comunisti. Parole come “libertà”, “democrazia”, “uguaglianza” e simili, nel vocabolario della borghesia terriera meridionale, ormai da tempo, avevano assunto un unico significato: quello di socialismo, a 132 cui, ora, si aggiungeva il comunismo ed, in una parola, la temuta e odiata sinistra. La Resistenza era, dunque, percepita dai galantuomini come un reale pericolo perché, ove mai fosse giunta al potere, avrebbe messo in discussione l’assetto sociale tradizionale soprattutto perché, con il pretesto della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, avrebbe riscattato i villani, i contadini, i cafoni, dalla sudditanza. In questo modo, avrebbe sortito l’effetto di minare le loro fortune economiche, basate sullo sfruttamento del contadiname. La tendenza prevalente era quella di non compromettersi per il momento, di spiare l’orizzonte in attesa dell’affermazione di una formazione politica, antagonista ai rossi, alla quale aggrapparsi perché nulla potesse veramente cambiare. Poteva anche andare bene il richiamo a parole ad un generico antifascismo purché si fermasse alle pure e semplici declamazioni. Se il maestro Don Rodolfino ed il Parroco parteggiavano ancora per i fascisti, gli altri signori del Circolo nicchiavano, attendendo che le situazioni si chiarissero perché fiutavano i mutamenti, ma non sapevano in che direzione si sarebbero svolti. Al Municipio, il podestà scappato di notte, ma ormai decaduto, era stato sostituito da un commissario, nominato dal prefetto socialista, famoso per i suoi comizi infuocati. Questa volta, però, aveva preso un grosso abbaglio: credeva di avere nominato a commissario un socialista o un simpatizzante per i socialisti ed, invece, aveva fatto cadere imprudentemente la nomina su uno dei signori locali, don Arturo, che fingeva di essere socialista. Naturalmente enorme fu la delusione: cambiavano le persone, ma non il blocco sociale che stava al governo. Si constatò subito che don Arturo continuava a suonare la stessa musica di prima; favoriva gli speculatori; privilegiava i suoi amici nella distribuzione delle tessere del pane; addirittura scese tanto in basso da pestare un piede ad un contadino, che portava le scarpe nuove. La Camera del lavoro raccolse un centinaio di firme nella petizione al Prefetto per la sua destituzione. La richiesta non andò ad effetto perché inspiegabilmente la petizione non giunse 133 mai al Prefetto. Ci fu chi insinuò che don Arturo aveva un infiltrato nel direttivo della Camera del lavoro, che si era adoperato per non fare pervenire in Prefettura l’esposto. *** Finalmente arrivarono in zona gli Alleati e insediarono la sede del Comando a Core. Gli ex-gerarchi furono arrestati e rinchiusi in carcere per essere, poi, subito dopo liberati. In un tardo e nebbioso pomeriggio di novembre, una camionetta, dalla pianura, salì in Matermara, percorrendo quella stradina stretta e tortuosa che, di solito, i paesani facevano a piedi o con l’asino, pochi con la bicicletta. Portavano i liberatori che arrivavano carichi di biscotti, gallette, carne in scatola, caramelle, sigarette. Fecero con la jeep il giro del paese, marciando a passo d’uomo; i ragazzi facevano a gara per acchiappare quante più caramelle possibile ed i grandi, che seguivano come in processione la jeep, le sigarette e le altre merci che venivano lanciate alla folla dalla camionetta. Anche gli exgerarchetti ed i signori seguivano i liberatori che, senza fermarsi, proseguirono per altri paesi. Ercolino, tra caramelle, biscotti e cioccolato, si trovò tra le mani un grosso sigaro, che portò a shen Lisendri (sant’Alessandro), un anziano che veniva così chiamato per la sua religiosità e per la pratica devozionale. Tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944, ritornavano, alla spicciolata, a piedi, o con biciclette o con altri mezzi di fortuna, i soldati, che erano stati abbandonati dal re e da Badoglio in Grecia, in Albania, in Africa ed in tutte le parti dell’Europa o dell’Africa, dove la follia del duce e dei suoi accoliti li avevano portati ad ammazzare e ad essere ammazzati. In pochi erano tornati, per la verità: si trattava di quei pochi che si erano trovati in Italia dopo lo sbandamento e che fortunosamente riuscirono a raggiungere le proprie famiglie ed i propri paesi. I più, sbattuti in Russia, in Grecia od in Africa, erano stati fatti prigionieri dai tedeschi o dagli angloamericani; ci vorrà la fine della guerra per il loro ritorno. 134 Qualcuno era ritornato senza un braccio, qualche altro senza una gamba; di alcuni altri giovani si diceva che erano annegati con la nave che li trasportava dall’Albania nel mare Jonio; di altri ancora si era saputo che erano rimasti in Albania, protetti da qualche buona famiglia. Ma le notizie che arrivavano da quel paese non lasciavano sperare nulla di buono. Il potente protettore dei paesani, che nei tempi belli era stato ministro e, dopo l’annessione italiana, presidente della Camera delle Corporazioni, era caduto in disgrazia. Quando i Partigiani erano arrivati a Tirana, lo avevano arrestato e si erano insediati nella sua sontuosa villa. Ora veniva processato con grande clamore con l’accusa di alto tradimento davanti al Tribunale del Popolo, che teneva le sue sedute nel teatro Aurora. Egli si difendeva vigorosamente, respingendo l’infamante accusa e rivendicando i suoi meriti in favore del riconoscimento dell’indipendenza albanese, al cui perseguimento – diceva – aveva dedicato la sua vita, lasciando, dopo la laurea, il paese e l’Italia per trasferirsi in Albania, dalla quale provenivano i suoi antenati, vera e propria patria di un sogno realizzato, ma naufragato nella tragedia. L’ingenua voce pubblica dei paesani lo giudicava non colpevole. Ed egli stesso riteneva di avere bene operato e di non temere, per questo, l’arrivo, ormai imminente, dei Partigiani. In Matermara, la sua sorte costituiva l’argomento principale delle serali conversazioni nel Circolo, nelle botteghe artigiane e nelle cantine. Si sottolineava che egli, pur potendo, non aveva voluto scappare, come avevano fatti altri gerarchi, palesemente compromessi col nazifascismo. Aveva mandato a Roma la moglie e le figlie, ma egli era rimasto al suo posto, fiducioso che la rivoluzione lo avrebbe risparmiato. Ma così non fu. Il 20 aprile del 1945, nel tardo pomeriggio, a lungo, suonarono a morto le campane della Chiesa di S. Pietro; un suono triste che metteva mestizia nei paesani. In un baleno si sparse la voce che l’ex ministro era stato condannato a morte e fucilato. I vicoli si animarono: donne e uomini uscirono di casa per commentare la notizia. In piazza si formarono dei capannelli. Alcuni passavano da un gruppo all’altro nel tentativo di cono- 135 scere elementi più dettagliati. Ma nessuno era in grado di fornirli; neppure i parenti dell’ex ministro. Incominciò la processione verso la casa paterna del morto per esprimere le condoglianze. Nelle occasioni solenni, morti, matrimoni, nascite, la solidarietà è spontanea e sincera; cadono i muri delle inimicizie e delle divisioni politiche. La gente, che era entrata nella casa o quella che si accalcava lungo le scale o lungo lo stretto corridoio, trovò il vecchio genitore con l’anziana badante, solo e affranto dal dolore, che piangeva e gridava: «Me vrane! Me vrane! Me l’hanno ammazzato! Me l’hanno ammazzato.» 136 21 La previtera era la moglie del parroco di rito greco; il suo nome era Dìela Barcia, ma tutti la conoscevano come la previtera e così la chiamavano. Né destava scandalo il fatto che il prete era contemporaneamente sacerdote e marito. I canoni e le regole della chiesa orientale consentivano e consentono tuttora il matrimonio. Fino a quando ci furono i fascisti, la previtera era stata alquanto in ombra; partecipava alle riunioni delle donne fasciste senza avere incarichi nelle organizzazioni femminili, forse perché la surclassavano le signore del podestà e del segretario politico del fascio o, più realisticamente, bisogna osservare ch’era una sua precisa scelta mantenersi un po’ in disparte, in seconda fila, per conservare, all’occorrenza, una autonoma libertà di manovre nelle vicende paesane. Senza figli, con il passare del tempo si era mano a mano come inaridita; anche fisicamente, dava l’impressione di un albero in via di essiccazione. Nel suo piccolo, la funzione del marito sacerdote gli aveva consentito di allargare la rete delle sue relazioni sociali con tutti gli strati del piccolo mondo paesano. Alla caduta del fascismo, molti erano gli orfani che non riuscivano a trovare un punto di riferimento. Il terremoto politico aveva prodotto un generale sbandamento. Lo si toccava con mano, ogni sera, nelle riunioni del Circolo dei Signori. Don Ferdinando si lamentava che non c’era più legge; don Michele che non v’era più rispetto per i superiori perché i contadini pretendevano una paga giornaliera spropositata ed esigevano il pronto pagamento; don Carlino ce l’aveva con gli straccioni e con gli scalzagambe della Camera del Lavoro; don Sepantonio osservava che si preparavano tempi assai tristi per 137 i grandi proprietari perché, ormai apertamente, i contadini reclamavano la riforma agraria ed il ministro comunista sosteneva le loro pretese. Nulla di buono v’era, dunque, da sperare. Nel Circolo, da prima in modo guardingo, perché sottoposti alla procedura di epurazione, e, dopo l’assoluzione da parte della Commissione circondariale, pubblicamente e con fare sprezzante, gli ex dirigenti del fascio erano diventati frequentatori assidui, tenuti in molta considerazione. Vi era ricevuto con tutti gli onori il maresciallo dei regi carabinieri, ritenuto a ragione uomo forte e protettore dei proprietari. Ogni tanto, vi compariva il Procuratore del re presso il tribunale del circondario: i signori, tutti in silenzio, pendevano dalla sua bocca. Egli li rassicurava sulla consistenza della forza dello Stato ed affermava che avrebbe perseguito severamente ogni tentativo dei rossi di mettere in discussione i diritti dei proprietari. Si ricomponeva, così, quel blocco sociale che sembrava disintegrato con la fine della guerra. Il parroco, non potendo più benedire i gagliardetti dei fascisti, aveva trovato un altro fronte di combattimento: ogni domenica ed in tutte le altre possibili occasioni, tuonava dall’altare contro i comunisti ed i socialisti, negatori di Dio, distruttori della famiglia, simbolo vivente di tutto il male del mondo, che si proponevano di distruggere la religione in nome del materialismo. Si trattava di vuote parole, che astraevano del tutto dalla situazione reale perché i furori oratori del parroco, nei fatti, si esercitavano contro quel popolino di pastori, di contadini, di braccianti, di raccoglitrici di ulive, che frequentava la chiesa, cantava la messa, partecipava alle funzioni religiose con trasporto e con passione, che organizzava le feste religiose e trasportava a spalla nelle processioni le statue dei numerosi santi. I signori se ne stavano a casa la domenica o andavano a caccia. Neppure vivevano da cristiani, dando il buon esempio perché avevano le amanti o stavano pubblicamente con le concubine, dopo avere abbandonato la famiglia. «Il popolo di Dio siamo noi» gli gridò una domenica mattina, all’uscita dalla chiesa, dopo la messa, Ferdinando «eppure tu dimostri di ignorarci e di ignorare gli stessi insegnamenti 138 del Vangelo che proclamano l’uguaglianza, la giustizia, che dicono “beati i poveri” e “guai ai ricchi”.» Il parroco non raccolse la provocazione; farfugliò, come al solito, qualche frase imbarazzata ed, in fretta, prese la via di casa. Ormai, il ghiaccio era rotto ed il mistero della chiesa, che si schierava apertamente con i ricchi, che non praticavano la religione se non a parole, era stato svelato dal coraggio di Ferdinando. Ma non pochi cristiani rimasero turbati e lo furono maggiormente in occasione della visita pastorale del vescovo, nell’estate del 1945. Venne costui bardato dei ricchi paramenti del rito greco. A riceverlo, in prima fila, i signori con le consorti e con le concubine e gli ex dirigenti del fascio e, naturalmente, il parroco. Nell’omelia, parlò di fede, di carità, dell’amore per il prossimo e, brandendo la croce come scudo, scagliò innumerevoli maledizioni contro i comunisti, i socialisti ed i loro alleati perché colpevoli di volere distruggere la religione. Benedisse i fedeli ed a pranzo fu invitato, insieme al parroco ed alla previtera, nel palazzo di don Carrocciolo. Anche i figli di Cosmantonio, Nico e Andrea, rimasero non poco turbati e dubbiosi e abbastanza delusi. All’indomani della visita del vescovo, si ritrovarono nelle Comesse per i lavori all’uliveto. Andrea manifestò al fratello Nico tutto il suo disappunto e la delusione amara di avere fatto un buco nell’acqua, opponendosi alla dittatura se, ora, continuavano, di fatto, a tenere le redini in mano le stesse persone e gli stessi gruppi sociali che avevano fatto nascere e foraggiato il fascismo. Andrea non vedeva i segnali del cambiamento sperato. Tutto era rimasto e continuava come prima. Per braccianti, contadini, artigiani e tutta la bassa gente, il lavoro e la fatica da “sole a sole”, come si diceva, cioè, dal sorgere fino al tramonto del sole; per i galantuomini, vivere a sbafo, passando la giornata al gioco delle carte, bighellonando di qua e di là, attentando all’onore delle contadine. Naturalmente, per quei gruppi, che si erano coscientemente battuti contro il passato regime, era questo un boccone assai amaro da ingoiare. Soprattutto perché, stando a come si erano messe le cose, ne traevano la conclu- 139 sione di non potere uscire vincitori nella prossima tornata elettorale. Il popolo dei braccianti e dei nullatenenti era saldamente controllato dai galantuomini che ne coartavano la volontà al momento del voto, ricattandoli: se non avessero votato per chi dicevano loro, non li avrebbero fatti più lavorare nei loro poderi. E, senza lavoro, essi non avrebbero potuto neppure soddisfare il bisogno fisiologico del pane quotidiano. Perciò, la necessità detta legge. Un proverbio dell’epoca rispecchiava l’opinione, diffusa nelle classi popolari: chiamo padre chi mi dà da mangiare e da vivere. La convinzione corrente era che l’assetto sociale non poteva in nessun modo essere modificato. Cosmo Zaccheo lo andava sempre ripetendo ad Andrea di Cosmantonio, il quale, ormai pubblicamente, andava sostenendo nelle discussioni, che si facevano in piazza, nelle cantine, nelle botteghe artigiane, che bisognava tagliare le gambe ai padroni parassitari con la riforma agraria, costituendo delle medie aziende agricole. «Ma spiegami» chiedeva insistentemente Cosmo Zaccheo «come potremo vivere noi senza padroni? Sono loro che ci danno il lavoro.» Per il popolo della gente minuta, la repubblica, la riforma agraria e tutte le altre riforme servivano soltanto a sconvolgere le cose, a rendere precaria ed insicura l’esistenza. Nel dubbio, forse, era meglio continuare a vivere come prima. Si vide in seguito, però, che questa era l’opinione dei più sprovveduti. Seguirono alcuni mesi di grande fervore politico. La previtera riuscì nel suo intento di mettere d’accordo un buon gruppo di persone per costituire un partito politico dal nome nuovo, ma che, in effetti, inglobava tutti i vecchi arnesi della ex dirigenza fascista ed i galantuomini nullafacenti, tutti i giorni vestiti con l’abito nuovo e che il popolino una volta riteneva potenti ed in grado di aprire tutte le porte. L’operazione fu ufficializzata e tenuta a battesimo da don Carlo De Marinis, un prete venuto appositamente da Cosenza, che allora godeva di discreta fama in provincia e vi esercitava una notevole influenza. 140 Mano a mano, gli animi si infervoravano e lo si constatava nei comizi in piazza, dove si alternavano gli oratori in vista del referendum per la scelta tra repubblica e monarchia. Un giorno il blocco dei signori parve spaccarsi per un momento, per poi subito dopo ricomporsi. Candidata alla Costituente per il partito della falce e martello con stella era donna Giuseppina Avellis, moglie di un signore assai noto nel comprensorio. Era giovane e bella e conosciuta. Una folla di donne l’attese all’ingresso del paese per, poi, accompagnarla fino alla piazza, dove dal balcone del palazzo Avellis tenne il suo comizio, parlando di giustizia sociale, di riforma agraria e dei diritti delle donne. La cosa fece molto scalpore e destò una positiva impressione perché era ormai assai chiaro che, anche tra i signori più moderni ed evoluti, si erano insinuate ed avanzavano, sia pure faticosamente, le idee di progresso ed una nuova visione dei rapporti sociali. Nel frattempo, scandita dal ritmo solito, la vita continuava con le fatiche quotidiane ed anche con le feste che, ad intervalli, ne caratterizzavano lo svolgimento, come lo sviluppo graduale di un programma che si attuava nel tempo. A S. Gaetano, a S. Sebastiano, a S. Attanasio, i contadini, dieci giorni prima della celebrazione della festa, portavano in processione dalla casa del signore in chiesa, la statua del santo. Proprio così, perché quelle statue di santi erano custodite, come tenute sotto sequestro per il resto dell’anno, in un’apposita nicchia nelle case padronali per esserne estratte solo in occasione della relativa festa, nel corso della quale il detentore della statua distribuiva vino, pane, biscotti, taralli e alti generi alimentari, apparentemente con un gesto di generosità e di amore verso il prossimo. Quando, nel primo pomeriggio, la statua era portata fuori dalla casa padronale, contemporaneamente avveniva la distribuzione dei viveri. Ne seguiva l’inevitabile zuffa tra i tanti che tentavano di accaparrarsi quante più porzioni potevano. Poi seguiva la processione fino alla chiesa, allietata dalla locale banda musicale, formata da tre elementi soltanto: Angelino che batteva ininterrottamente l’uno contro l’altro i piattelli di bronzo; Francesco che percuoteva la grancassa, il grande 141 tamburo e Demetrio che furoreggiava col tamburino, battendo freneticamente sulla membrana con le apposite bacchette. Tutti i coloni ed i mezzadri e le persone che servivano nel palazzo trasportavano a spalla la statua del santo, scambiandosi vicendevolmente il posto per distribuire equamente il peso. Ma il padrone e la padrona restavano in casa, dove aspettavano che, dopo la cerimonia, venisse il fattore che gli faceva una minuziosa relazione sulle persone presenti, sul loro comportamento, su chi si era prodigato di più e con più accuratezza nel trasporto della statua ed, in genere, su tutto l’accaduto. I padroni appuntavano i dati raccolti, sia quelli positivi che quelli negativi. Alla fine della festa, in una riunione separata, davano riconoscimenti e rimproveri, che erano accettati con rispetto e trepidazione, come espressione dell’affetto e della benevolenza dei padroni. Dopo il novenario, veniva il giorno della grande festa, preceduta dal fuoco d’artificio della sera prima. Nell’occasione, i padroni indossavano l’abito buono ed andavano in chiesa, dove nel corso dell’anno non erano mai andati. Si sedevano in prima fila per fare pesare la loro presenza e per sottolineare soprattutto che erano loro i padroni della festa. Il parroco li benediceva, li ringraziava della beneficenza che facevano alla chiesa ed a tutto il popolo di dio ed invocava ad alta voce il padreterno perché manifestasse tutta la sua benevolenza nei loro confronti: “Benedici, Signore, la famiglia del nostro benefattore Don Aristide e proteggila da tutti i mali; concedi ad essa le tue grazie e preservala dalle tentazioni”. A queste parole, dette dal parroco con enfasi, con gli occhi rivolti al cielo e con le mani giunte, il padrone e la signora si esaltavano e si commuovevano e gli occhi gli si inumidivano fino alle lacrime. Finita la messa, seguiva la processione, alla quale non partecipavano né il padrone e neppure la signora. La statua del santo veniva portata a spalla, per le vie del paese, dai coloni e dai mezzadri e dalle altre persone di servizio, sotto il controllo del fattore. A tarda sera, la festa si concludeva col trasporto della statua nella casa del padrone; veniva fatta passare attraverso l’ampio portone per essere, infine, riposta nell’apposita nicchia e chiusa a chiave. 142 Ma le feste, che scandivano il corso delle stagioni, erano numerose perché ogni signore teneva in casa la statua di un santo. La memoria collettiva, col passare delle generazioni, aveva smarrito il significato di tali feste che erano quasi private, cioè, non predisposte dalla chiesa locale, anche se naturalmente venivano celebrate con la partecipazione del parroco. Forse neppure i signori delle nuove generazioni ne conoscevano le origini reali. Qualche traccia era, però, rimasta nelle vecchie carte risalenti ad alcuni secoli orsono. Ivi si può ancora leggere che, nella comunità, vi erano tante cappelle, oratori o edicole, incorporate alla chiesa, ciascuna dedicata ad un santo ed ognuna delle quali era proprietaria di vasti appezzamenti di terreno con colture varie, ficheti, oliveti, vigneti, terreni irrigui o seminatori, alla cui amministrazione sovrintendeva un procuratore, che aveva l’obbligo di rendere, ogni anno, il conto alla comunità. Col tempo, particolarmente nel primo quindicennio dell’Ottocento, durante la dominazione francese nel Mezzogiorno, le cappelle come d’incanto sparirono; i loro possedimenti diventarono proprietà dei procuratori, che s’appropriarono anche delle statue dei santi custodendole nelle loro case. Così, i procuratori divennero proprietari dei terreni, intestandoli a loro nome nel catasto, e delle stesse statue dei santi; con il possesso della proprietà terriera, assursero anche al grado sociale di magnifici e di signori, ed, in seguito, si inventarono una qualche ascendenza nobiliare. La vantata “nobiltà” del ceto parassitario dei galantuomini traeva la sua origine, perlopiù, dal fraudolento e, non poche volte violento, impossessamento delle terre pubbliche o della chiesa. Le feste che annualmente facevano celebrare in onore dei santi, le cui statue tenevano chiuse nelle loro case, erano il segno evidente della coscienza infelice dei signori che, in tal modo, facevano opera di riparazione postuma nel tentativo di purificarsi delle passate usurpazioni. Ma una parte della popolazione, quella più evoluta e vivace, che conosceva le vecchie carte o che ne aveva sentito parlare dagli anziani, manteneva viva la memoria delle pregresse occupazioni di terreni, sulle quali si basavano la fortuna dei si143 gnori e, di conseguenza, anche il loro potere attuale. Da qui nasceva un conflitto, rimasto latente per molto tempo, ma che era destinato ad acuirsi nell’immediato dopoguerra. Durante il ventennio fascista, i galantuomini che si erano accaparrati le cariche politiche di Segretario del fascio e di podestà o che, comunque, riuscivano a controllarle, avevano dominato in lungo ed in largo. Nel dopo fascismo, non mollarono il potere comunale anche se furono costretti a cercare l’alleanza con la chiesa ed a ricorrere, ognuno, ad un discreto numero di guardiani sia per essere protetti nella persona e negli averi e sia per incutere timore ai “rossi”, che erano non soltanto, comunisti e socialisti, ma tutti quelli che non la pensavano come loro. Né mancarono le reiterate provocazioni, che, attraverso i guardiani, posero in atto gratuitamente per creare un clima di violenza e per terrorizzare singole persone e le loro famiglie, ritenute responsabili di chissà quali preparativi di sovversione. Mastro Cosmo si vide aggredito nel buio di una notte dell’inverno del 1946, mentre dormiva a casa sua, dalla squadra dei guardiani di don Serafino che gli gridavano: “esci fuori, sporco comunista” e gli insultavano la moglie. Non raccolse la provocazione, ma sparò in alto due colpi di rivoltella, mettendo, così, in fuga gli aggressori. La mattina del giorno seguente, si presentarono nella sua bottega di falegname il maresciallo ed un carabiniere che lo portarono in caserma e lo arrestarono con l’accusa di avere tentato di uccidere il capo dei guardiani. E inutili furono tutte le sue proteste d’innocenza e la spiegazione di come i fatti s’erano veramente svolti. Scontò un mese di carcere preventivo per poi essere assolto dal tribunale. Venne il momento di preparare le liste per le elezioni comunali. I signori erano assai preoccupati di perdere il potere; temevano che al Comune andassero i rappresentanti della Camera del Lavoro e della Cooperativa dei braccianti, che certamente avrebbero fatto la ricognizione dei beni comunali, ormai in mano degli usurpatori per poi chiederne l’assegnazione alla lega dei braccianti. Era già accaduto che la Cooperativa “La Proletaria” aveva inoltrato apposita istanza alla Commissione per l’assegnazione 144 delle terre incolte, che era stata costituita presso il Tribunale di Rossano, e don Paolantonio era stato condannato a cedere una parte consistente del fondo “Margliuglie”. A nulla erano valse le amicizie altolocate e la stessa parentela con il procuratore del re. Aveva alzato la voce davanti alla Commissione per rivendicare il suo diritto di proprietà, per dimostrare che il fondo era coltivato, che quelli della Cooperativa avevano un fatto personale con lui e volevano vendicarsi. Ma tutti gli sforzi e le pressioni non erano valse a bloccare l’assegnazione. Naturalmente, questa prima vittoria dei contadini fece clamore, ma aumentò l’allarme e le preoccupazioni nei galantuomini, che si coalizzarono per le elezioni comunali e si strinsero intorno alla previtera per fare fronte comune nelle elezioni imminenti. Andrea di Cosmantonio rifiutò recisamente di fare parte della lista perché riteneva – come, del resto, era vero – che essa costituiva un ritorno al passato, un tentativo inutile di bloccare il processo di evoluzione civile e sociale. Vinsero i galantuomini; ma fu l’ultima volta. Sindaco fu eletto il vecchio podestà ed assessori gli ex segretari del fascio. 145 22 Per alcuni secoli, dall’epoca della fondazione del Katund, del paese, i contadini così come tutta la popolazione minuta di braccianti e artigiani, erano rimasti sonnacchiosi nelle loro povere abitazioni, fatte di paglia e frasche impastate con la terra rossa, senza mai avventurarsi in durature occupazioni delle terre feudali, limitandosi all’esercizio dell’uso del pascolo e del legnare. Del resto, anche volendo, essi erano nell’impossibilità di occupare e possedere un qualche consistente quoziente di terreno per la occhiuta sorveglianza degli agenti del feudatario, che prontamente intervenivano e carceravano i malcapitati. Solo per alcuni si faceva eccezione: questi pochi potevano liberamente occupare le terre pubbliche per seminarvi, per pascolare e per impiantarvi oliveti, gelseti, ficheti ed altri alberi. Essi erano protetti dal feudatario perché si erano posti al suo servizio oppure erano in combutta con gli agenti del feudatario, i quali, se chiudevano magari tutt’e due gli occhi, lo facevano anche per un loro preciso tornaconto perché venivano convenientemente ricompensati. Col passare del tempo, quei pochi poterono accumulare grosse fortune, diventando ricchi e potenti tanto da contrapporsi allo stesso feudatario. Ma la maggioranza della popolazione continuò a vivere precariamente in miseri abituri, nella promiscuità, dividendo la capanna od il tugurio, scavato in grotte, con gli animali, capre, buoi e maiali. Né v’era la speranza di potere uscire da tale situazione, dalla quale si poteva venire fuori solo attraverso la conquista della terra. Ma se questa era del feudatario o di quei pochi che erano con lui conniventi od al suo servizio, ai più era preclusa ogni via d’uscita dallo stato di povertà. Dai primi del Cinquecento, e cioè, da quando erano venuti dalla Morea o dall’Albania meridionale, i più erano rimasti in 146 tale stato di precarietà fino all’epoca della eversione della feudalità. Ma, abbattuto il feudo e tolto di mezzo il feudatario con tutte le sue dipendenze e le relative gerarchie, il numeroso popolo dei braccianti nullatenenti era ugualmente rimasto senza terra da coltivare. Al posto dei feudatari si era sostituita la ristretta cerchia dei civili e dei magnifici, detti anche galantuomini, i quali, a volte con la violenza ed a volte con la frode, riuscirono ad intestarsi le più estese e le più fertili proprietà immobiliari. Al popolo dei braccianti non rimase che il continuare a mettere le proprie braccia a disposizione dei nuovi padroni ed a prestare il proprio lavoro nelle terre dei recenti signori. Nel corso del Risorgimento, ci furono momenti esaltanti, come nel 1848, in cui sembrava che le rivendicazioni contadine avessero trovato finalmente validi sostenitori. A Cosenza, Domenico Mauro, che faceva parte del Governo Provvisorio, consentiva con le occupazioni delle terre ed accoglieva benevolmente i contadini che vi accorrevano per chiedere la divisione e l’assegnazione del vasto patrimonio terriero demaniale, occupato dai galantuomini. Per chi gli chiedeva cosa volevano tutti quei contadini, aveva una sola risposta: vengono qui per chiedere e per riprendersi ciò che a loro spetta. Ma la rivoluzione fu sopraffatta dall’esercito borbonico, prontamente accorso da Napoli. A Campotenese, tra i monti del Pollino, Mauro con i volontari, venuti in massa dai paesi, con contadini, studenti, professori ed intellettuali, non riuscì a fermare l’esercito; fu costretto a sciogliere il corpo dei volontari. Molti furono fatti prigionieri e lasciati languire nelle carceri, per lunghi anni, certuni fino all’arrivo di Garibaldi. Alcuni, invero pochi, si resero latitanti, riuscendo a sfuggire alla polizia, che non riuscì mai a catturarli, nascosti tra i boschi e nelle capanne, protetti e aiutati dai contadini. Don Antonio, il prete di Maki, professore di letteratura greca nel Collegio greco, che aveva guidato i contadini all’occupazione e spartizione del feudo baronale e, poi, insieme agli studenti, li aveva condotti a Campotenese, fu arrestato nella campagna di Pokfili, dove si era rifugiato. La condanna fu di vent’anni di carcere duro. Domenico Mauro, condannato a morte in contumacia, errò per i paesi del Mediterraneo; i suoi seguaci aspettavano che, da 147 un giorno all’altro, sarebbe sbarcato nella spiaggia di Sibari o di Corigliano o di Rossano con un esercito di volontari greci e albanesi per continuare la rivoluzione. Ma ciò non sarebbe potuto accadere perché, nel regno di Napoli, il popolo passava lento dalla vita materiale e oscura alla vita intellettuale ed il tempo della rivoluzione non era ancora maturo. Solo la nuova generazione vi era pronta, ma essa non era sufficiente. Infatti, i suoi moti rivoluzionari erano tutti falliti; erano come rumori lontani e fiochi che si ripetevano di distanza in distanza e che morivano in un deserto. Questa nuova generazione si aggirava come straniera in mezzo al popolo. Non era intesa, non era amata, era derisa e ritenuta pericolosa; prometteva al popolo sofferente che lo avrebbe reso libero; e il popolo tendeva l’orecchio, ascoltava, ma non comprendeva. L’arrivo dei piemontesi peggio che peggio. Le proprietà rimasero saldamente in mano di chi le aveva sempre avute. Anzi fu ancora di più rafforzato il potere dei galantuomini perché solo ad essi fu riconosciuto il diritto di voto e, così, poterono diventare anche i padroni dei Comuni e delle amministrazioni provinciali. Neanche la protesta era consentita: chi protestava contro le ingiustizie era qualificato brigante, nemico dello stato, da abbattere con tutti i mezzi. Per domare e reprimere la protesta contadina, selvaggia e forte, fu mandato un potente esercito che attraversò le montagne della Sila, dell’Aspromonte e dell’Appennino, mettendo a ferro e fuoco i villaggi, dove si era rivelata la protesta ed anche quelli semplicemente sospettati di appoggiarla. Solo i ricchi ebbero il diritto di votare; i poveri ne vennero esclusi. La conseguenza fu che i padroni restarono sempre gli stessi di prima, poi i loro discendenti e, così continuando, i discendenti dei discendenti. Né si intravedeva una qualche possibilità di cambiamento. Anche la speranza era preclusa. Alcuni reagirono imitando gli antichi briganti della Sila, di cui era ancora viva la tradizione orale, che toglievano ai ricchi per dare ai poveri. Morirono tutti poveri e massacrati dall’esercito, venuto dal Nord. Fecero ricchi quegli stessi signori manutengoli che incassarono buona parte delle somme pagate a titolo di riscatto. 148 Non pochi altri scapparono per tentare la fortuna soprattutto nell’America del Sud. Anche Zepa, il giovane poeta, si avventurò nelle terre dell’Argentina. Ritornò due anni dopo più povero di prima, senza speranza e senza vigore, con il veleno nel petto. Il suo vagare per pianure, foreste e burroni l’aveva irrimediabilmente colpito nel fisico e nella mente. Restò inquieto e triste in preda ad un misterioso affanno, che lo torturava, vagando senza riposo come un’onda marina. Non passò tempo e riprese la via dell’emigrazione. Si recò negli Stati Uniti: vi visse per qualche anno senza riuscire a trovare una stabile occupazione. Evidentemente la poesia non gli procurava il pane. Ritornò di nuovo nel Katund, dove si fermò per alcuni anni vivendo come pietra di fiume senza, però, abbandonare il suo sogno di costruire il proprio nido in terre lontane. Ritentò, così, l’avventura dell’emigrazione questa volta nel Brasile, che era diventato la mèta di migliaia di contadini meridionali. Fu l’ultimo viaggio: trovò precarie occupazioni. Per qualche anno, fece il maestro di scuola ai figli degli emigrati italiani in una stamberga, alla periferia di S. Paolo. Continuava a scrivere delicate poesie nella sua lingua arbreshe per esprimere il profondo disagio psicologico, il disappunto e la delusione per la caduta dei suoi sogni. La ragazza amata era morta e tristezza cupa lo compenetrava. La solitudine l’assaliva con oscuri desideri. Né il sentimento religioso rappresentava più un sicuro approdo. Non gli era giovata la fede nella Vergine Maria ed i suoi giorni si facevano sempre più bui; speranze e sogni erano andati delusi, facendolo cadere sempre più nel baratro profondo. L’oggi diventava fosco, tetro il domani, la miseria incalzava, facendolo ingoiare da un mare di sofferenza e dolore. Una mattina della primavera del 1901, i compaesani lo trovarono al mercato di S. Paolo, tutto agitato, con una mobilità di strana luce agli occhi; batteva i pugni sul muro e gridava ed inveiva contro il re e la regina d’Italia. Poi stramazzò al suolo: fu raccolto cadavere dalla pietà dei compaesani. Era veramente scomparso come una meteora. 149 *** Innumerevoli altri giovani contadini, figli di piccoli proprietari, partirono nel primo decennio del Novecento alla volta dell’America del Nord. La sera, prima della partenza, salutavano amici e parenti in un banchetto improvvisato. Tra i fumi del vino dolce delle colline albanesi, intonavano delicate canzoni di saluto al paese ed all’amata, come quella che Marzio improvvisò: I bukuri Katund, je me se hena. Doj, te t’ghodhirnja nge m’lereu fertuna. E dolla te ki rahj sa t’shtinja nj’vjesh T’e gjegjnj malli im, oj ka do ish. Penxo, malli im, penxo, sa mot u bora. Sa te t’amarnja u utull neng bera. (*Paese mio, sei più bello della luna. *Volevo goderti, ma il destino non volle. *Uscii sul colle per cantare uno stornello *rivolto all’amor mio, dovunque fosse.* Pensa, amor mio, al tempo che ho sprecato. * Tanto ti ho amata e sempre inutilmente). Poi si imbarcavano sui bastimenti dal porto di Napoli e certuni dal porto di Genova con pochi soldi. Dopo un lungo viaggio della durata di un mese circa, sbarcavano a Nuova Yorka con tutta la roba che portavano per sé e per gli amici e parenti. Superata la visita sanitaria ed il periodo di isolamento, si disperdevano nella grande e rumorosa metropoli, accolti nelle case di amici o parenti o fortunosamente accasati in qualche pensioncina, in attesa di trovare una qualsiasi occupazione. Ne avevano estremo bisogno per potere sopravvivere, ma anche per pagare il debito che avevano contratto in patria per pagarsi il prezzo del viaggio. Così essi erano disponibili e pronti anche per i lavori più umili e pesanti, trattati con arroganza e disprezzo. In buona parte resistettero: superata la violenza del primo impatto, si ambientarono nel nuovo grande paese, dove il lavoro non mancava e ce n’era per tutti. Col tempo accumularono 150 una discreta fortuna tanto da inviare denaro alla famiglia in Italia, che veniva impiegato per lo più nell’acquisto di terreni, che sarebbero serviti per vivere una volta ritornati per accasarsi e fare la propria famiglia. Un americano, che aveva costruito o comperato la casa e dei poderi con uliveto, vigneto, ficheto e terreno seminativo, al ritorno al paese, era considerato un benestante, e diventava un partito appetibile per le donne da marito. I più non pensarono affatto al ritorno ed archiviarono anche il sentimento struggente di nostalgia. L’emigrazione divenne definitiva. Tutt’al più, quelli che avevano lasciato la fidanzata nel paese, la sposarono per procura e le fecero il richiamo in America. Non ritornarono più; si dispersero nella popolazione di Broccolino, di Nuova Yorka o della California e di altre parti dell’America. Conservarono la lingua di Matermara che parlavano in famiglia e con i compaesani, con i quali rinnovarono e mantennero in vita la festa religiosa principale del paese, quella dei santi anargiri Cosma e Damiano, che celebravano nello stesso giorno in cui si celebrava nel paese. Naturalmente era un surrogato della festa paesana. Venuto il mese di settembre, il paese si animava come se entrasse in fibrillazione: ogni famiglia si preparava, come meglio poteva, per il grande ed unico evento dell’anno. Si pulivano le case e se ne rinnovava la tinteggiatura. Si preparava l’abito nuovo: i sarti avevano un gran daffare nel provare e riprovare i vestiti. Ogni famiglia faceva, in casa i dolci, biscotti, taralli, mustacciuoli; chi pochi, chi assai, secondo le proprie disponibilità di farina, olio, miele, zucchero, mandorle, fichi secchi, uva passa e mosto cotto. Finalmente arrivava il grande novenario e tutto il paese si riversava nel santuario. Anche dai paesi vicini accorrevano numerosi i devoti. Quelli che chiedevano una grazia particolare ai Santi facevano tutto il percorso a piedi nudi e, prima di entrare in chiesa, mille genuflessioni e, poi, in ginocchio si trascinavano per raggiungere le statue dei Santi. Qualcuno che aveva già ricevuto la grazia o che ne implorava una straordinaria, come entrava in chiesa si metteva con mani e ginocchia per terra e con la lingua strisciava lungo il pavimento fin sotto le due statue benedette. Chi proclamava di ave151 re avuto un miracolo indossava l’abito dei Santi e portava le sue offerte che deponeva ai piedi delle statue. Immancabilmente, poveri e ricchi, affiggevano con una spilla le monete di carta alle statue che, alla fine della novena, lasciavano trasparire solo la testa con la corona d’oro lucente. E poi incominciavano i canti, accompagnati dall’organo, che Zaccheo suonava e contemporaneamente guidava il coro di uomini e donne di tutte le età. Era un canto a squarciagola che rintronava tra le navate della chiesa e fuori le mura, confondendosi con i canti improvvisati al suono della fisarmonica e della zampogna di altri gruppi di fedeli che sostavano nel piazzale antistante, intrecciando balli vorticosi. Il predicatore, dal pulpito, ogni sera, concludeva la novena. Anche la predica faceva parte del rito e della festa come i fuochi d’artificio e la banda musicale. Poco o, piuttosto, nullo era l’interesse per il contenuto religioso delle prediche; tutti erano presi dall’euforia di fare festa, almeno in quei giorni dell’anno, quando in ogni famiglia si faceva di tutto perché non mancassero in tavola almeno la carne e la pasta ed il vino. Alla vigilia, nel tardo pomeriggio e sul fare della sera, frotte di pellegrini accorrevano al santuario da tutte le vie che portavano al paese: i più a piedi scalzi, altri a dorso di asini, muli e cavalli; altri trasportati da birocci e da traini tirati da buoi. E tutti, nella nottata, bivaccavano, mangiavano e dormivano e bevevano all’interno della chiesa, alternando al sonno i canti di devozione, accompagnati da cornamuse e fisarmoniche. Alla spicciolata, sacerdoti tra la folla distribuivano benedizioni o recitavano preghiere per conto di pellegrini e incassavano le offerte. Nel pomeriggio del giorno seguente, la festa aveva fine. Terminata la grande processione, i pellegrini riprendevano frettolosamente la via del ritorno; i paesani si aggiravano tra le bancarelle ancora per un po’ e poi si ritiravano nelle loro case. Tutto ritornava come prima: dopo la breve parentesi, riprendeva la vita di sempre. Nello spiazzale intorno al santuario, il vento di ponente sollevava, disperdendoli nei paraggi tra gli uliveti e le vigne, i cumuli di carte e di stracci. 152 *** Agli inizi del 1949, si diffondevano le notizie di numerose occupazioni di terre incolte e di vasti latifondi, di proprietà dei baroni e dei grandi agrari, nella valle del Crati. Dai paesi della Sila, da S. Giovani in Fiore, da Bisignano, Corigliano, Rossano, Cariati, dai paesi dell’alto Jonio, isolati e chiusi tra densi boschi e fiumare rovinose, correva la voce e passava di paese in paese, sempre più ingrandita dal tam-tam dei contadini, che numerose schiere di nullatenenti si erano mosse ed avevano occupato i terreni dei signori. Si raccontava che un signore del Marchesato di Crotone aveva chiamato la polizia e che un reparto della Celere aveva addirittura sparato sugli occupanti, che tuttavia non si erano arresi. La sera, i due locali della Camera del Lavoro erano sempre strapieni di contadini e di braccianti, pronti ormai anch’essi ad intraprendere l’occupazione di tutti quei terreni, che si sapevano o si dicevano essere comunali, a Campanaro, Bardara, Mortilla e Tenimento, ma che erano tenuti dai signori. Sarebbe bastato che fosse dato l’ordine e tutti sarebbero partiti per l’occupazione. Ma Damiano, Cozzarrano e quell’altro giovanotto, che tutti chiamavano Terracini, i capi della Camera del Lavoro, erano assai prudenti: essi sapevano che non era sufficiente il solo entusiasmo per la riuscita dell’impresa perché occorreva che ne fosse predisposta l’organizzazione. Si mossero per gradi: dapprima ritennero opportuno richiedere alla speciale Commissione presso il Tribunale l’assegnazione alla Cooperativa delle terre incolte o malcoltivate delle località Vallone Grande, Occhio di Lupo e Campanaro. Avrebbero, così, avuto la possibilità di valutare la reazione degli agrari, conoscere su quali appoggi essi potevano fare affidamento e, contemporaneamente, sondare anche la capacità di resistenza e di tenuta dei contadini. In un pomeriggio piovoso del mese di novembre del 1949, arrivò da Cosenza, a bordo di una vecchia Balilla, il compagno Paolo. Portava le carte per farle sottoscrivere ai soci della cooperativa La Proletaria, da inoltrare alla Commissione Speciale presso il Tribunale. Il giorno dopo, Damiano depositò l’istanza con tutta la documentazione alla Cancelleria del Tribunale. 153 Furono, una quindicina di giorni dopo, convocate le parti, i rappresentanti della cooperativa ed i signori, proprietari dei terreni. Essi giurarono e spergiurarono che i terreni non erano incolti; sostennero che, se venissero spogliati dei terreni, avrebbero avuto un grave pregiudizio economico; invocarono la solidarietà degli altri signori della Commissione. I loro avvocati si richiamarono al sacro diritto di proprietà, che non poteva essere violato e leso senza il pericolo di scardinare le fondamenta della società e dello Stato di diritto. Da parte sua, Damiano, in rappresentanza della cooperativa, illustrò senza scomporsi le ragioni dei richiedenti. Nel tardo pomeriggio, fu comunicata la decisione della Commissione: i signori, accompagnati dai guardiani, rientrarono mogi mogi. La sera, alla Camera del Lavoro, la vittoria fu celebrata tra applausi e bevute di vino. L’occupazione delle terre fu preparata in gran segreto di modo che fosse una sorpresa per i Carabinieri e per i padroni, i cui guardiani s’erano messi in movimento e si davano un gran daffare per carpire i nomi degli organizzatori, di quelli che s’erano dichiarati disposti a parteciparvi, l’ora ed il giorno dell’occupazione. Se ne fossero venuti a conoscenza, avrebbero potuto riferire il tutto ai padroni e questi, a loro volta, al maresciallo dei Carabinieri, per bloccare sul nascere il movimento con le intimidazioni e le minacce. Lo studente Pietro Lascaris, figlio di Andrea Lacaris, bighellonava, intrattenendosi con altri ragazzi nella piazza, dov’era il Circolo dei signori. Aveva assunto l’incarico dalla Camera del Lavoro di riferire quanto succedeva nel Circolo. Per tutta la mattinata, vi aveva notato un continuo viavai di guardiani. Verso le ore undici, era arrivato anche il maresciallo dei Carabinieri, che si era intrattenuto per qualche tempo. Dalla finestra a piano-terra si vedeva che particolarmente agitato era don Giacomino, agitava nervosamente le braccia mentre si rivolgeva al maresciallo. Forse lo sollecitava a fare una qualche irruzione nella Camera del Lavoro per incutere timore ai dirigenti e così tentare di prevenire e di bloccare sul nascere l’occupazione delle terre. Non si seppe cosa avesse detto il maresciallo, il quale se ne andò, dopo avere salutato i galantuomi- 154 ni presenti. Pietro percepì chiaramente che, sulla porta, mentre usciva, il maresciallo disse: «Allora, chiamatemi.» Evidentemente, il semplice sospetto dell’occupazione imminente aveva allarmato i signori da indurli a chiamare il maresciallo. Pietro riferì tutto quanto aveva osservato e sentito alla Camera del Lavoro. L’occupazione venne differita di una settimana con inizio alle ore cinque e mezza del mattino. La mattina del 10 marzo del 1950, all’orario prestabilito, più di cento persone, uomini e donne, giovani e anziani, con gli arnesi da lavoro, zappe, pale, picconi, falci, si trovarono al Calvario. Con la bandiera rossa spiegata, partirono in direzione delle terre da occupare, dividendosi a gruppi. Alcuni si diressero a Campanaro, altri a Occhio di Lupo, altri a Busciacca ed altri a Valletravo. Vi piantarono le bandiere, vi lasciarono dei manifesti con le scritte – preparate in precedenza – Terra ai contadini!, Riforma Agraria!, Terra del Popolo!. Era il significato assai chiaro: si invocava la riforma agraria, sempre promessa, ma che mai arrivava. Terra del popolo! Era l’avvertimento ai padroni che quelle terre, in origine, erano pubbliche, erano veramente “del popolo”, che liberamente vi pascolava gli animali, vi seminava, vi tagliava la legna. Solo successivamente i galantuomini, impadronitisi dei municipi, distrutti i documenti d’archivio, le avevano occupate con la violenza e con l’inganno, costituendo, così, quel ceto proprietario che, sorto dal fango, s’era venuto rafforzando col denaro, l’usura ed il furto ed aveva nobilitato le proprie origini rifacendosi ad ascendenze nobiliari, inventate di sana pianta. Alle sette e mezza, completata l’operazione, i contadini erano di ritorno. Nelle vicinanze del paese, incontrarono il maresciallo con i Carabinieri che evidentemente era diretto verso le località delle occupazioni. Fece una smorfia di chiaro disappunto per essere stato giocato sull’orario dai contadini; anticipando l’orario dell’occupazione, avevano evitato di essere sorpresi sul fatto dal maresciallo. Seguirono le querele dai proprietari depositate in caserma. Nel successivo processo, davanti al Tribunale, i contadini non negarono di essersi recati nei terreni, ammettendo di averli picchettati e di avervi apposto la scritta Terra ai contadini. 155 Il pubblico accusatore, ch’era uno dei grandi proprietari del circondario, tuonò e chiese pene severe contro i contadini comunisti, considerati eversori e sovvertitori del diritto di proprietà e che addirittura attentavano alla sicurezza dello Stato. In precedenza il tribunale aveva sempre accolto le richieste del pubblico ministero. Questa volta la composizione del tribunale era mutata: i due giovani giudici, che affiancavano l’anziano presidente, non condivisero la tesi accusatoria; assolsero tutti perché l’avere picchettato i terreni coll’apporvi la scritta Terra ai contadini, non era un delitto, ma una protesta, una manifestazione politica per richiedere la riforma agraria. La sera, nella Camera del Lavoro, si festeggiò la vittoria con abbondanti bevute. Vi partecipò, per manifestare la propria solidarietà, anche il diacono Don Attanasio, ormai anziano, ma che ancora presiedeva con mano ferma e con successo la fondazione, costituita dal Patriarca. Ormai, i contadini, che erano la grande massa della popolazione, s’erano mossi; come gli uccelli che, al fare del giorno, volavano dai nidi. Sarebbe stata difficile impresa farveli ritornare e riproporre la passiva accettazione delle primitive condizioni di vita. Finalmente era entrato in gioco anche il popolo senza storia. La speranza di tutti era che, forse, d’ora in avanti, non sarebbe stato più possibile a pochi privilegiati consumare la vita degli altri. Tuttavia bisognava stare in guardia perché la grande proprietà, i grossi agrari, erano decisi a resistere e potevano ancora contare su molti e potenti alleati. 156 Parte Seconda 1 Don Ferdinando, corrucciato più del solito col passare degli anni, dall’interno del Circolo dei Galantuomini ascoltava l’inutile chiacchierata degli altri signori e, contemporaneamente, dalla porta aperta che dava sulla via Mark Botzaris, osservava uno per uno i paesani che vedeva passare. Per ognuno aveva sempre avuto, in passato, da fare un commento. Ora, nella fase dell’età veloce, quando aveva ormai passato la sessantina, i commenti si facevano vieppiù sempre più pungenti e risentiti. Scaricava sugli altri tutta la rabbia che aveva in corpo. Era costretto a constatare che, anche nella piccola Matermara, da qualche tempo a questa parte, soprattutto dopo l’occupazione delle terre, stava rapidamente maturando il mutamento nell’assetto sociale; classi nuove apparivano minacciose all’orizzonte; nel ceto dei contadini e dei braccianti e dei piccoli proprietari, per secoli subalterni, ora si agitava qualcosa di nuovo, che ancora non aveva assunto forma precisa e restava per il momento indefinibile. Però, tutti costoro che avevano da quando erano ancora ragazzi lavorato le sue terre e quelle degli altri signori, dal sorgere al tramonto del sole, com’era l’usanza da sole a sole, quasi gratuitamente, senza pretese eccessive, salvo qualche mormorazione, ora si stavano trasformando: si davano alle intraprese commerciali più varie, acquistavano terreni, se li affittavano, si spostavano a lavorare e trafficare nella pianura di Sibari. Quivi i terreni erano di prima qualità, di ottima resa, tenuti a pascolo dal vecchio barone che se la godeva a Napoli. Bastava condurre in affitto o in mezzadria anche una piccola estensione di terreno per liberarsi dalla fame. Meglio ancora se si riusciva ad acquistarlo. Si vedeva e si toccava con mano il pro159 gresso economico dei popolani che, qualche anno prima, appena finita la seconda guerra mondiale, ancora li vedevi la mattina sostare nella piazza del paese in attesa che passasse il guardiano del signore per scegliere quelli o quello che, quel giorno o per pochi giorni, doveva andare a lavorare per il padrone. Il guardiano era un aspetto fondamentale dell’organizzazione sociale perché, di fatto, disponeva della vita dei braccianti e delle loro famiglie; di chi doveva lavorare per guadagnare quel poco per potere sopravvivere o di chi, invece, era condannato all’emarginazione per i motivi più vari, molte volte, per piccole e meschine vendette, perché non lo aveva salutato o non aveva lavorato gratis per coltivare il suo piccolo quoziente di terreno o, semplicemente, perché non gli era simpatico. Ma certi braccianti erano come lavoratori fissi: essi venivano sempre chiamati e scelti perché “erano bravi” – diceva il guardiano. Forse non era veramente così. La voce pubblica mormorava e ne dava un’altra versione che faceva presto a diffondersi ed a diventare l’oggetto prediletto del pettegolezzo paesano nelle botteghe e nelle riunioni serali della gjitonia, del vicinato. Erano, a seconda dei casi, le mogli, le sorelle o le madri dei braccianti, che avevano conquistato il guardiano o il suo padrone che, poi, in quel piccolo mondo, si sentiva il padrone di tutti, ma forse lo era veramente perché possedeva i terreni, era di conseguenza il più ricco in assoluto e tutti dipendevano da lui. Prima di tutto, il Municipio era come una sua proprietà. Durante il fascismo, con gli altri signori, con il parroco ed il maresciallo dei carabinieri, disponeva direttamente degli affari del Comune, che, poi, si riducevano a poca cosa: l’assunzione della guardia municipale, dell’impiegato dell’anagrafe, il pagamento di qualche spesuccia per l’acquisto degli stampati, qualche piccolo intervento per riparare la fontana pubblica e nient’altro. I signori bighellonavano tutto il giorno. Neppure il giornale leggevano quei pochi che sapevano leggere. Il cerchio della loro esistenza si esauriva nell’esercizio della caccia, la sera nel giocare alle carte nel circolo ed in qualche furto d’amore in danno di contadine di cui si incapricciavano. Non avevano, del resto, altro da fare: alle terre badavano i guardiani. L’ordine pubblico 160 era garantito dai carabinieri. Ma, poi, in una società cosiffatta non succedeva mai nulla e neppure avrebbe potuto mai succedere. Nessuno si azzardava a mettere in discussione l’assetto sociale. E chi mai l’avrebbe potuto fare? Non c’erano partiti o altre associazioni. C’erano stati per il passato, ma i signori avevano giustamente provveduto affidandosi al fascio. Sicché, ora tutto era a posto o, per lo meno, sembrava esserlo. Lor signori erano riusciti a fare tacere qualche voce di dissenso anche nella chiesa. Il diacono della chiesa greca, don Nicodemo, che aveva fondato una piccola banca cooperativa per venire in soccorso ad artigiani e piccoli coltivatori, era stato ridotto al silenzio e costretto a scappare. Avevano messo in giro la voce che era un eretico, un filo protestante. Il vescovo della diocesi greca, che non si muoveva tra i fedeli e passava le sue giornate in preghiera e le nottate – dicevano i maligni – a scrutare il cielo col suo cannocchiale, era caduto nella trappola: si era sempre rifiutato di conferire l’ordine sacerdotale al diacono. Così, una possibile voce di dissenso, che avrebbe potuto aprire gli occhi alla comunità era stata eliminata. Don Nicodemo non si diede per vinto: si rivolse al vescovo della diocesi latina che lo ordinò sacerdote. Ma dovette andare via dal paese: fu destinato all’insegnamento presso il seminario di Catanzaro. Dei vecchi dirigenti socialisti non c’era più nessuno. Con l’inizio della dittatura, ridotti al silenzio, perseguitati e chiusa la sezione, i più attivi erano emigrati: alcuni in Francia ed i più negli Stati Uniti, dove erano stati seguiti anche dalle fidanzate, sposate per procura. Il legame col paese s’era spezzato o rotto del tutto: anche se, naturalmente, restavano il ricordo e la nostalgia struggente. L’esiguo gruppo dei popolari, costituito per lo più da piccoli coltivatori diretti, seguaci di don Carlo De Cardona, con l’allontanamento forzato di don Nicodemo e la chiusura della cassa rurale e della cooperativa, non dava alcuna preoccupazione ai signori. Anche se in silenzio, la loro opposizione era paziente e dura e andava consolidandosi col tempo. Voleva dire pur qualcosa il fatto che il vecchio Cosmantonio Lascaris aveva nascosto, nella casa del suo podere di Comesse, 161 la Croce di Karavak ed aveva raccomandato ai suoi due figli, nel caso che egli fosse morto, di disseppellirla alla caduta della dittatura. Con quella croce di ferro che egli considerava un potente talismano contro tutti i mali e che chiamava di Karavak, come un vecchio patriarca, brandendola dalla finestra della sua casa, aveva maledetto la squadraccia fascista, che entrava nel paese, pronunziando parole, accolte lì per lì col sorriso ironico dei vincitori, ma che si riveleranno profetiche: poco tempo durerà la vostra violenza. Questa croce vi abbatterà! Non si poteva bloccare la storia e immobilizzare la vita delle persone, degli uomini e delle donne in carne ed ossa. Cosmantonio – che aveva avuto una vita travagliata lavorando, per lunghi anni, insieme ai negri a Nuova-Yorkca e, poi, ritornato in Matermara, s’era rotto le ossa insieme ai giovani figli a disboscare i terreni acquistati, a dissodarli per impiantarvi uliveti, ficheti, vigneti, gelseti e creando terreni seminativi ed irrigui, aveva capito che, se pure è possibile per determinati periodi, fissare il ritmo della vita entro certi schemi da farla sembrare immobile, tuttavia, prima o poi, le cose si sarebbero rimesse in movimento. Com’era a lui successo che a vent’anni, sentendosi soffocare fino a morire nel luogo in cui era nato, s’era perfino ribellato al padre ed era partito per l’America, dov’era arrivato a bordo d’un vecchio piroscafo, povero come un uccello, con in tasca solo quaranta lire, nel lontano 1885. Aveva duramente faticato e sofferto come la montagna sotto la neve. Alla fine, però, aveva vinto. Era ritornato a Matermara con i due figli e la moglie ad abitare nella casa paterna, ma anche con un discreto gruzzoletto grazie al quale aveva potuto acquistare quei terreni che, trasformati e coltivati, gli garantivano una discreta agiatezza. I successivi avvenimenti diedero ragione a Cosmantonio, nel frattempo, deceduto. In effetti, subito dopo la caduta del regime sopportato, la vita riprese. Incominciarono a vedersi le novità e non solo in politica, dove la cosa era scontata. La fuga del podestà e del segretario del fascio che, nei tempi belli, attillati come galletti, con gli stivaloni lucidi, si dimenavano per i rioni, senza acquedotto, senza fognature, con le strade in terra battuta, fangose d’inverno e polverose d’estate, mettevano in fibrillazione la popolazione; si sentiva e si toccava con mano 162 che iniziava un nuovo cammino con la segreta e collettiva speranza del miglioramento delle condizioni di vita. L’aspettativa del nuovo era prevalente rispetto al desiderio di vendetta dei torti subiti nel Ventennio, anche se pure non ne mancavano fondate ragioni personali. Spontaneamente, prima, la grande massa di contadini andava aggregandosi per reclamare terre da coltivare, destando naturalmente sospetto e preoccupazione nel ceto proprietario, particolarmente dopo la pubblicazione della legge sulla assegnazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate. Fu allora che le aspirazioni contadine presero maggiore consistenza organizzandosi nella camera del lavoro. Don Ferdinando e gli altri galantuomini del Circolo sembrarono spiazzati. Ora c’era una legge che riconosceva ai contadini il diritto di avere assegnati i terreni incolti o non perfettamente coltivati. Anche nel Tribunale era stata costituita una apposita Commissione, che doveva provvedere sulle istanze dei contadini. Si riuniva ogni quindici del mese ed immancabilmente era quasi forzata ad accoglieva le richieste dei contadini, magari dopo avere ordinato ed eseguita una perizia sui terreni, che erano, perlopiù, abbandonati dagli agrari parassitari. Don Ferdinando e gli altri galantuomini ce l’avevano con la Camera del Lavoro, strumento di perversione dei contadini – dicevano. Ma le cose non stavano veramente in questi termini. Mentre era immerso in questi tristi pensieri, ecco che vede passare due giovanotti – Damiano, giovane dirigente della Camera del Lavoro, e Pietro, lo studente povero e orfano, nipote di Cosmantonio; «Tiènili cari questi due!» disse al suo vicino di sedia, volendogli significare che quei due rappresentavano un potenziale pericolo sociale per il notabilato locale. 163 2 La Camera del Lavoro non era la fucina del diavolo, come ritenevano i benpensanti del Katund. Era stata riaperta subito dopo la caduta del fascismo; alcuni artigiani e braccianti, ormai anziani, che non avevano piegato la schiena ai fascisti, che erano, poi, gli stessi signorotti locali, avevano dissotterrato le vecchie bandiere e ripreso l’attività sindacale. Anche i due figli del vecchio Cosmantonio, Nico e Andrea, avevano tolto dal nascondiglio e messo a lucido quella Croce di Karavak con la quale l’anziano genitore, agitandola dalla finestra, aveva lanciato le sue maledizioni alla squadraccia fascista che passava tutta armata di pugnali, pistole e baionette, tra urli e schiamazzi e grida di alalà! Noi siam fascisti, terror dei comunisti. Sulle prime e, cioè, nei primi anni fino a dopo la proclamazione della Repubblica col referendum del 2 giugno del ‘46, l’organizzazione non incontrò ostilità eccessive da parte del ceto proprietario, probabilmente perché in attesa di trovare il proprio punto di riferimento, ora che il fascismo non c’era più, riteneva prudente fare ricorso ad una equivoca ambivalenza. Apparentemente sembrava che i rappresentanti della Camera del Lavoro venissero ossequiati e bene accolti. Ma non era veramente così. La mera apparenza nascondeva una profonda ostilità, che era, del resto, reciproca, destinata a scoppiare in un breve arco di tempo, al momento delle domande di concessione delle terre incolte e della successiva ondata delle occupazioni, vera e propria epopea contadina, conclusasi con la delusione; il grandioso movimento di popolo non era riuscito nell’impresa di mutamento della situazione sociale reale della società calabrese e degli equilibri di potere. Ma il fatto che finalmente tanta gente s’era mossa e che s’erano create spontanee alleanze, già di per sé, assumeva no164 tevole rilevanza, come i successivi avvenimenti avrebbero dimostrato. La Camera del Lavoro diventava, così, il punto centrale di riferimento dell’attività sociale nel Katund, una agenzia di formazione e di autoeducazione, vera e propria metafora del rinnovamento radicale, che richiamava una varia umanità di braccianti, contadini, artigiani, piccoli proprietari, ma anche di studenti e di intellettuali. Damiano Markut era stato eletto presidente. Era un muratore che lavorava sodo per allevare la sua famiglia numerosa. Negli anni passati e prima della guerra, aveva lavorato in Albania, a Tirana, con imprese italiane. L’armistizio dell’otto settembre ‘43 l’aveva bloccato in Albania e, per qualche tempo, non si erano avute sue notizie. Aveva assistito all’entrata dei partigiani albanesi a Tirana ed al successivo arresto e processo nei confronti del compaesano che, diventato cittadino di quel paese, aveva avuto l’ingenuità di accettare un importante incarico nel governo fascista. Ora il pubblico accusatore del Tribunale del Popolo gliene faceva colpa e ne chiedeva la condanna alla pena capitale con l’accusa di alto tradimento. Damiano aveva assistito alle varie fasi del processo. Raccontava come il compaesano si era difeso rivendicando benemerenze per essersi battuto per l’indipendenza; ricordava il suo passato di repubblicano mazziniano e rigettava l’accusa per avere agito nell’interesse nazionale e per salvare il salvabile dall’occupazione italiana del 1939. Tragica fu la fine. Nessuno gli credette. Cadde, nell’aprile del 1945, sotto i colpi del plotone di esecuzione, alla periferia di Tirana. Questa, ormai, era una pagina definitivamente chiusa, ma il suo racconto, nei frequenti conversari nei locali della Camera del Lavoro, suscitava e teneva vive le discussioni politiche che, non di rado, poi, sfociavano in altri argomenti. Francesco Converti si trovava nel Katund dal periodo della guerra. Era emigrato da Acri; con la moglie ed i dieci figli, faceva il colono nel fondo Sciurzat di don Spiridione, nei cui fabbricati abitava. Accudiva il fondo, vi seminana, allevava gli animali vaccini, suini e caprini ed aveva diritto ad un terzo del prodotto. Tre giorni alla settimana, uno dei figli portava con l’asino al palazzo del padrone immancabilmente le uova fre165 sche, qualche galletto ruspante e, secondo la stagione, frutta e ortaggi. Con tutto questo ben di Dio e con il resto che gli portavano gli altri coloni, don Spiridione poteva condurre vita spensierata, dilettarsi con l’esercizio della caccia, passare la serata al Circolo al giuoco delle carte, magari cicalando del più e del meno tra una partita e l’altra. Quando venne a conoscenza che il colono era stato in gioventù un attivo socialista nel suo paese d’origine e che, di tanto in tanto, sia lui che i figli più grandi erano stati visti, di sera, alla Camera del Lavoro, allertò il guardiano perché esercitasse una sorveglianza stretta, ma discreta. Non si può mai sapere che cosa passa per la testa di un bifolco nullatenente, specialmente se istigato o fomentato a frodare la roba del padrone. Ma don Spiridione – a differenza degli altri suoi simili – forse avvertendo odor di tempi nuovi, con astuzia tutta paesana, incominciò a parlare bene dei socialisti. Un giorno, per dare prova concreta della sua modernità, invitò al palazzo, a casa sua, un avvocato di Cosenza, che aveva tenuto un comizio in piazza. La preoccupazione di potere perdere ciò che gli era stato graziosamente lasciato o di dovere cedere qualche fondo alla cooperativa di contadini lo induceva a manifestare quella che non era veramente la sua opinione. La verità si appalesò tutta intera, nuda e cruda, davanti alla Commissione speciale per la concessione delle terre incolte, quando protestò vigorosamente, elevando alte grida contro i contadini “ladri” che avevano richiesto l’assegnazione di alcuni suoi terreni. La Camera del Lavoro era, ormai, diventato il luogo dove risuonavano gli accadimenti della vita quotidiana, pubblici e privati, che poi andavano soggetti ai commenti più disparati e si diffondevano fuori – magari esagerati – dando corpo e voce all’opinione di quel popolo minimo, che non aveva mai avuto voce, era stato sempre silente. Luigi Mamone e Alfonso Borresci, braccianti senza beni di fortuna che vivevano solo del proprio lavoro, in gioventù erano stati socialisti, s’erano più volte scontrati con i fascisti costringendoli alla fuga. Una volta, al Scescio, li avevano imbottigliati lungo la strettoia e li costrinsero a chiedere perdono in ginoc166 chio per la manganellata, data al vecchio Cardalano, che non s’era tolto il cappello al passaggio della squadraccia. Erano, ora, assidui alla Camera del Lavoro e, nonostante l’età matura, l’antica passione politica traspariva dai loro atteggiamenti. Carmine di Vascio – anche lui giovane agli inizi del fascismo – aveva aderito alla scissione comunista e, da allora, intrattenuto rapporti con Fausto Gullo, che, al momento, era ministro dell’Agricoltura. Non amava le spacconate, ma non era eccessivamente ottimista. Quando prendeva la parola nelle improvvisate assemblee, non mancava di avvertire i presenti che il cammino verso le riforme sarebbe stato irto di difficoltà. “Il movimento popolare – era solito dire – è come il fiume Pisciacane in piena, che è in grado di travolgere tutto, però, può essere deviato in altra direzione se non trova il letto libero da ostacoli”. Il calzolaio Ninuzzo Barci non prestava ascolto a tali avvertimenti. Riteneva Carmine un brontolone che, con i suoi discorsi, non portava un contributo positivo. Bisognava, invece, sempre ed in ogni occasione, suscitare entusiasmo per mantenere sempre vivi gli ideali. Pasqualino Candreva non si complicava la vita con discussioni. Bracciante senza figli e con la sola moglie a carico, manifestava i suoi ideali politici col canto. La sera, dopo avere tracannato alcuni bicchieri di vino nello spaccio della Camera del Lavoro, a notte inoltrata, prendeva la strada di casa cantando Bandiera rossa la trionferà e se non è oggi sarà domani, taglierem la testa ai pescecani. La sua voce con un contrappunto di forza e di malinconia, nella notte, attraversava i vicoli e le vie, entrava dalle finestre nelle case e nei palazzi, nel cui spiazzo di solito sostava per riprendere forza e vigore. Nessun vigile urbano e nessun carabiniere lo fermarono mai. Come, invece, era accaduto – circa un secolo prima – a Bua Protasio che, nella notte di Natale del 1849, inneggiava alla Repubblica italiana, impersonata dall’esule compaesano Domenico Mauro, sbeffeggiando il potere politico e quello religioso. 167 Abbasso Napoli! Abbasso Roma! Viva re Mauro Con la corona. La guardia urbana l’aveva arrestato e portato al carcere di Cosenza. Dopo un anno, fu rimesso in libertà perché – sentenziarono i severi giudici di quella Gran Corte Criminale – quel canto notturno non poteva costituire un attentato alle istituzioni. Pasqualino non ebbe la ventura di entrare nella storia politica e giudiziaria della provincia come il suo omologo ottocentesco. Il suo erratico notturno cantare, però, echeggia ancora nei vicoli del Katund, come per affermare l’eresia vecchia e sempre nuova dell’aspettazione di un mondo e di una vita più umani. Di tanto in tanto, faceva capolino nei locali della Camera del Lavoro don Bebecco, ormai assai malridotto in salute per i patimenti fisici – e, soprattutto, morali – subìti durante il fascismo tra fermi, arresti, confino, carcere e vessazioni innumerevoli. Il suo forte fisico era stato piegato; viveva in solitudine la malattia e, di fatto, si era allontanato dalla politica anche se non trascurava di essere presente nelle assemblee più importanti e nei comizi. Ma aveva perduto quella parola lucida e suasiva che andava al fondo delle questioni e faceva restare stupefatti e affascinati coloro che l’ascoltavano. Spesso l’accompagnava Turi Memisci, incorreggibile internazionalista e gran sognatore di utopie politiche e sociali: i due, nel lontano 1936, quando il dittatore proclamava l’impero, avevano fondato una cellula del partito comunista, facendo opera di efficace proselitismo nel circondario. Ora, l’avvocato don Bebecco, una volta così brillante e così vivace, non era più lui. Giovanni Araldi godeva di unanime stima ed aveva grande autorevolezza. Discendeva da una vecchia famiglia del Katund che si era battuta contro il regime borbonico nel Risorgimento e contava tra i suoi antenati un personaggio, implicato nell’attentato a Ferdinando II, portato a compimento da Agesilao Milano. Era una famiglia di repubblicani che, più che a 168 Mazzini, si ispiravano alle idee socialiste di Carlo Pisacane. Giovanni, in gioventù, era stato socialista, ma poi, nel 1921, era stato tra i fondatori del partito comunista nel congresso di Livorno. Durante il ventennio fascista, era vissuto a Napoli, più volte imprigionato e confinato. Nel 1925, quando la dittatura ormai spadroneggiava con le sue squadracce, si trovava ancora a Matermara. Forse pensava di potere organizzare una qualche opposizione. Per festeggiare il 1° Maggio di quell’anno, aveva dato appuntamento agli operai ed ai contadini nel suo fondo rustico della contrada Montemoro. Ivi avrebbero celebrato privatamente la Festa dei Lavoratori. Naturalmente la cosa venne alle orecchie degli squadristi locali, che indussero i Carabinieri ad intervenire. Così squadristi e Carabinieri si recarono sul posto per sciogliere la riunione e procedere agli arresti. Gli operai ed i contadini, che naturalmente erano abbastanza numerosi e soverchiavano gli squadristi ed i Carabinieri, avrebbero voluto e potuto opporsi vittoriosamente. Ma Giovanni li dissuase con fermezza dal reagire; protestò, però, opponendo l’illegittimità degli arresti e dell’intervento dei Carabinieri perché la pacifica sagra del 1° Maggio si svolgeva non in luogo pubblico, ma nella sua proprietà privata. Non ci fu nulla da fare. In fila per due, come prigionieri di guerra, contadini e operai con in testa Giovanni, sotto la minaccia delle armi, furono costretti, scortati da fascisti e carabinieri, a riprendere la via del ritorno a Matermara, ove giunsero all’imbrunire. Nel frattempo, sparsasi la notizie, mogli, figlie e madri degli arrestati, li attesero al Calvario. Grida, pianti, strilli e lamenti non servirono a commuovere fascisti e Carabinieri. Tutti gli arrestati furono tradotti nelle carceri di Rossano e Castrovillari. Successivamente, la maggior parte fu condannata al carcere ed al confino. Per Giovanni, incominciava il calvario. Dopo il carcere, fu spedito nella colonia di Ustica. Nel 1943, si era ritirato nel Katund. Quando la radio annunziò la fine del fascismo e la gente incominciò a festeggiare, Giovanni poté constatare quanto era amato e stimato dalla popolazione. Quando percorreva la strada che, lungo il corso principale del paese conduce alla piazza, la gente usciva di ca169 sa per salutarlo. Molti – che durante il regime lo avevano evitato – ora gli si avvicinavano e, in silenzio, come per scusarsi, gli stringevano calorosamente la mano. Rifuggiva dalle cariche politiche; preferiva stare tra la gente, particolarmente tra i giovani, ai quali metteva a disposizione la sua cultura ed aveva aperto la sua ricca biblioteca. Era diventato l’idolo della gioventù, il punto di riferimento di tutte le persone in difficoltà, che a lui ricorrevano per un consiglio, per un chiarimento o per essere rassicurate. Don Teodosio che, da giovane quando era ancora diacono e studiava nel Collegio greco, a via del Babbuino, a Roma, ed aveva manifestato aperta ostilità contro i fascisti, era ormai un uomo maturo. Ordinato sacerdote di rito greco, probabilmente per non farlo ritornare nel Katund, dov’era stato un segno di contraddizione per essersi schierato in difesa dei deboli, gli era stata assegnata una lontana parrocchia, a Villa Badessa, vicino Pescara. Ma non aveva interrotto i rapporti col suo paese d’origine; i suoi amici non tralasciavano di informarlo minuziosamente su quanto accadeva. Quando aveva saputo della riapertura della Camera del Lavoro e dei preparativi che si facevano per richiedere la concessione delle terre, si fece presente inviando una lettera, da leggere pubblicamente perché diretta a tutto il popolo, con la quale plaudiva ed incoraggiava l’iniziativa e denunziava le disuguaglianze e le ingiustizie. Richiamandosi al Vangelo ed ai Padri della Chiesa d’Oriente, affermava la necessità dell’uguaglianza e della fratellanza, esponendo la sua convinzione, tratta dal Vangelo, che “il Signore non giudicherà ciascun uomo secondo la sua posizione sociale e secondo le sue ricchezze, ma secondo i suoi meriti”. Tutti capivano quel che voleva dire e mentalmente ne facevano applicazione alla situazione locale. Gli applausi scrosciavano. Aumentarono d’intensità, mano a mano che Damiano leggeva gli altri passaggi della lettera in cui sosteneva che la ricchezza era frutto di frode e di delitto e che la terra era di tutti e del suo godimento nessuno poteva essere privato. Dio non creò i poveri ed i ricchi e né, al momento della creazione, ad alcuni soltanto concesse molti tesori e niente agli al170 tri. A tutti, invece, lasciò la terra perché la coltivassero e ne traessero i frutti. Ora, non trova giustificazione che alcuni pochi possiedono centinaia, se non migliaia, di ettari di terreno e tutti gli altri non ne possiedono neanche un palmo per coricarsi. I privilegiati dovrebbero sapere che la loro ricchezza attuale non trova giustificazione neppure nei lasciti ereditari da padre in figlio. Se si indaga, risalendo fino alle origini, si troverà che questa fortuna proviene originariamente dall’ingiustizia e dalla violenza o dalla frode. La riforma agraria era perciò necessaria perché, sia pure in parte, riparava alle ingiustizie. Il Signore ha ripartito tra noi, come tra veri fratelli, tutte le cose: la terra, l’aria, il sole, l’acqua, il cielo, il mare, la luce, gli astri. Ci ha dato gli stessi occhi, lo stesso corpo, una stessa anima e identiche facoltà. I conflitti sorgono quando qualcuno tenta di appropriarsi di una cosa o, peggio ancora, quando se ne appropria privatamente, giustificandosi col dire “questo è mio” e “questo è tuo”. Allora sorgono le lotte fratricide, le invidie ed i rancori. Don Teodosio augurava la pace, la solidarietà, con il necessario miglioramento delle condizioni di vita per tutti. In fondo, se la riforma agraria poteva certamente contribuire al benessere collettivo o, perlomeno, ad alleviare la miseria dei più, non intaccava in modo sensibile la ricchezza dei pochi. Alcuni ettari di terreno in meno non mettevano in crisi la ricchezza dei grandi proprietari. In un baleno si diffuse la notizia della lettera e della clamorosa pubblica lettura. Generalmente il suo contenuto venne accolto e positivamente commentato nell’ambiente popolare. Ma il momento era politicamente assai difficile: Don Teodosio appariva come il prete che si era apertamente schierato dalla parte dei comunisti e, quindi, contro la Chiesa. Gli inviati di tutti i giornali nazionali, che giravano in lungo ed in largo attraverso le zone ed i luoghi della riforma agraria, non mancarono di sottolineare l’avvenimento, riportando, in modo particolare, la reazione negativa dei galantuomini, che espressero naturalmente giudizi pesanti sul prete, che si era schierato con i contadini, che era stato sempre comunista, poco o nient’affatto rispettoso della gerarchia ecclesiastica, che 171 finalmente era ora di sbatterlo fuori dalla Chiesa così non avrebbe fatto ulteriori danni e non avrebbe più rotto le scatole; che cosa aspettava ancora il vescovo per intervenire e farlo tacere definitivamente? Le pressioni sul Vescovo erano di carattere politico perché sottolineavano gli effetti politici della lettera di Don Teodosio, trascurando del tutto il suo contenuto che non era sicuramente in contrasto con la dottrina della Chiesa. Avvenne, così, che la figura del sacerdote mise in subbuglio l’intera Diocesi e costrinse il clero a prendere posizione. Soverchiante era il numero dei nemici di Don Teodosio nello stesso clero. Quei preti che, durante la dittatura, avevano osannato al fascismo, benedetto le sue guerre, ed indifferenti ed impassibili avevano assistito all’isolamento e, poi, all’allontanamento di Don Teodosio, attendevano adesso la sua fine. La pratica cristiana, il richiamo costante al Vangelo ed alle dottrine dei Padri, la stessa scelta di vita di Don Teodosio lo distinguevano dalla generale ignavia dei confratelli, schiene curve davanti al potere, incapaci di alzare almeno la voce contro le ingiustizie evidenti, in difesa di quei poveri che, invece, il Vangelo privilegiava, attaccati alle piccole miserie della vita quotidiana ed interessati ad aumentare il gruzzolo di denaro che li aveva immiseriti nell’animo e declassati a impiegati della Chiesa, avidi e attenti nel trarre profitto da tutte le occasioni favorevoli per sé e per la loro parentela. Veri e propri pidocchi di Cristo, li definiva il vecchio avvocato anticlericale, Don Ciccio, che esercitava nella vicina Hora ed ogni tanto, faceva una capatina a Matermara. Il Vescovo, dopo averci pensato a lungo, convocò alla Curia Don Teodosio per sentire le sue giustificazioni. Lo rimproverò aspramente per avere scritto la lettera ai contadini e per averne autorizzato la lettura pubblica. La risposta di Don Teodosio fu ferma e decisa: «Eccellenza, ho giurato obbedienza alla Gerarchia e sono pronto e disposto ad ottemperare a tutte le Sue disposizioni senza discuterle. I contadini sono miei fratelli in Cristo. Trovo conforme al mio dovere di cristiano e di sacerdote dare una mano a chi soffre e lotta per i suoi diritti. Nello scrivere la lettera non ho fatto altro che manifestare il mio sentimento di solidarietà verso i miei fratelli, rifacendomi alla omelia dodicesima di S. Giovanni Cri172 sostomo.» Il Vescovo trasecolò. Ricordava vagamente che S. Giovanni Crisostomo era stato patriarca di Costantinopoli, era vissuto tra il quarto ed il quinto secolo, ed aveva denunziato le disuguaglianze economiche fra gli uomini, aspramente contestando la proprietà privata come offensiva del piano divino. Cercò le parole più opportune per dare una risposta plausibile alle parole del sacerdote. Ricordava, intanto, che effettivamente il patriarca Crisostomo aveva pronunziato e lasciate scritte parole di fuoco contro le ineguaglianze umane: “la terra con tutto quello che vi è in essa non appartiene al Signore? Se dunque le nostre possessioni appartengono ad un signore comune, anche esse apparterranno a coloro che come noi Lo servono, ogni volta che i beni del Signore si spartiscono in parti uguali tra i suoi servitori…come si spiega, ora, che essendo la terra di tutti, tu tieni tanti iugeri, mentre il prossimo tuo non possiede nemmeno un palmo di terra?” Sembrava il Vescovo prigioniero dei suoi pensieri, non riuscendo a trovare, al momento, una giustificazione congrua alla condotta del sacerdote, che gli aveva opposto il forte richiamo alla dottrina egualitaria dei Vangeli, esemplificata nella interpretazione dei Padri della Chiesa. «Ma tu ti sei schierato solo con una parte, facendo opera di divisione tra fratelli» soggiunse alla fine, di fatto giustificandolo sotto l’aspetto della dottrina, non potendo mettere in dubbio le affermazioni di S. Giovanni Crisostomo. «Schierandomi dalla parte dei poveri, che sono la maggioranza della popolazione,» replicò il sacerdote «non volevo e non potevo seminare la zizzania tra fratelli.» «Ma con la lettera, hai dimostrato di stare dalla parte dei comunisti.» «Monsignore» riprese il sacerdote «io sono sempre stato, e Lei lo sa bene, col popolo di Dio, con le persone reali e bisognevoli senza badare alle ideologie. Le persone sono privilegiate dal Signore ed esse vanno sempre aiutate e soccorse nei bisogni. Mi sono sempre battuto contro le prepotenze e le ingiustizie. Anche contro il passato regime. Quei galantuomini che mi accusano di comunismo si sbagliano: confondono il comunismo con la rivendicazione del diritto di una persona a vivere 173 in libertà e ad avere una occupazione; confondono la religione con l’ossequio formale alla Chiesa. Essi non vivono come cristiani: non lavorano, ma vivono sfruttando il lavoro degli altri; i poveri gli fanno le semine, gli raccolgono i prodotti, gli eseguono tutti i lavori della campagna senza ricevere la giusta mercede.» La discussione tra i due andò infervorandosi progressivamente. Alla fine, il Vescovo – che già ben conosceva Don Teodosio – si limitò a consigliargli maggiore prudenza per non esporre le Gerarchie alle critiche dei giornali. La mancata punizione canonica di Don Teodosio fu l’oggetto di lunghi conversari serali nel Circolo dei galantuomini. Per quei signori ingenui, il cui unico scopo nella vita era quello di accumulare ricchezze e denaro, non era neppure concepibile che Cristo potesse stare dalla parte dei poveri, tra i miserabili, nei tuguri. Il Vescovo era, perciò, sicuramente caduto in errore oppure era stato abbindolato da quella volpe di Don Teodosio. Ma tra i giovani del partito cattolico, schierati per il rinnovamento nella democrazia, la lezione di Don Teodosio gettò un seme destinato a germogliare. 174 3 Quell’anno, il 1952, la raccolta delle olive si presentava abbondante. Andrea Lascaris di Cosmantonio riteneva di potere finalmente, dopo alcuni anni di magra che lo avevano ridotto a mal partito, rifarsi delle perdite degli anni precedenti e migliorare, così, le condizioni della famiglia, abbastanza numerosa, con sei figli da sfamare, vestire, mandare a scuola, assicurare loro un sia pure modesto tenore di vita, al limite della sopravvivenza. Aveva sì le terre con vigna, oliveto, ficheto e parti lasciate per le semine, ma il ricavato non bastava più; i bisogni della famiglia erano aumentati. I figli erano tutti piccoli e non in grado di svolgere un qualche utile lavoro. Il maggiore dei figli, Pietro, non potendolo mantenere negli studi, l’aveva convinto ad entrare nel seminario greco, che si trovava in un paese a ridosso del Pollino. Il ragazzo, che manifestava una viva passione per lo studio, aveva accettato di buon grado. Così, nella prima mattinata della fine dell’ottobre del 1946, padre e figlio intrapresero il viaggio per la stazione ferroviaria di Sibari. Vi dovettero attendere il tardo pomeriggio per prendere la littorina, che conduceva a Castrovillari. Vi arrivarono che era già buio, dopo un percorso tortuoso tra i vari paesini ai piedi del Pollino. La mattina del giorno seguente, con la corriera, finalmente raggiunsero il seminario, posto fuori dal paese, in una collina pianeggiante, circondata da oliveti e vigneti, da cui si vedeva, come da una balconata, la pianura di Sibari con tutta la cerchia dei paesetti intorno, a oriente ed a occidente. Ad occhio nudo, nelle belle giornate quando non v’erano nebbia o foschia, si vedeva anche il Katund, il paese chiamato Matermara. Pietro, quando si sentiva solo, nei non rari momenti di malin175 conia, appoggiato al lato della finestra dello studio, guardava il Katund, pensava al padre al lavoro in campagna, ai fratelli che giocavano e mettevano sottosopra la casa, alla madre sempre indaffarata nelle faccende di casa, a fare il pane, lavare, cucire, rappezzare; agli altri ragazzi della gjitonia, del vicinato, con i quali aveva giocato negli anni passati, correndo per le viuzze del paese, arrampicandosi agli alberi alla ricerca di nidi e che, ora, un po’ più grandi, incominciavano ad apprendere i mestieri nelle botteghe degli artigiani oppure seguivano i genitori nei lavori faticosi dei campi che non finivano mai. La nostalgia durava un momento. Egli riteneva di essere stato fortunato a trovarsi in quel posto, dove aveva la possibilità di studiare e – chissà – di diventare qualcuno, ma comunque di essere scampato alla vita rude e faticosa e, in fondo, infelice del contadino, come suo padre che, ogni giorno, la mattina presto, partiva col cavallo per i campi e tornava la sera, dopo l’imbrunire. Da notte a notte, era la giornata di lavoro del padre. Ricordava quando diceva al padre: “ma tu non fai mai festa”? ed il padre lo guardava e sorrideva. Ora Pietro studiava intensamente e prendeva gusto nello studio del greco, del latino e di tutte le altre materie, con soddisfazione dei genitori. Nel tempo libero, leggeva romanzi di avventura, di cappa e spada e di briganti nella Sila e tutto ciò che gli capitava, oltre naturalmente il nuovo Testamento. Non era molto attratto dalle pratiche religiose, anche se vi adempiva con scrupolo. Avvertiva, però, la ristrettezza e la piccineria di quell’ambiente, ma non sapeva che fare. Scappare? Non poteva: non sapeva dove andare e, poi, significava indiscutibilmente troncare gli studi. Bisognava, dunque, soffrire, soffrire e resistere con pazienza e tenacia: almeno fino a quando non avesse intravisto la possibilità di continuare gli studi in altra modo e senza carichi per la famiglia. Per il momento, ogni soluzione sembrava preclusa. Agli inizi del terzo anno, era diventato irrequieto e manifestava segni di insofferenza per quel tenore di vita, chiuso, controllato, soffocante, oppressivo della propria identità, ogni giorno lo stesso. Alzata, la mattina alle sei; pulizia e preghiera. Studio e colazione; pulizia dei locali. Lezioni dalle otto e trenta 176 alle tredici. Preghiera e pranzo. Un’ora di ricreazione. Dalle quindici alle diciannove e trenta, studio con un intervallo di mezz’ora di ricreazione. Ancora preghiera e, poi, cena. Di nuovo, preghiera. Alle ventuno e trenta, a letto nella camerata comune. Questa volta, sentiva che prima o poi sarebbe scappato dal seminario, succedesse quel che doveva succedere. Pur di essere libero, era ormai disposto a qualsiasi sacrificio. Il pomeriggio di una bella giornata di novembre, mise in atto la fuga: alla chetichella, non visto da alcuno, si inoltrò per un sentiero del bosco, che era sotto il seminario e che portava in un torrente. Da qui avrebbe dovuto risalire per raggiungere Castrovillari, dove pensava di trovare il modo come raggiungere il Katund. Nel bosco, si smarrì in un punto in cui il sentiero si perdeva. Girovagò per qualche ora e, intanto, si approssimava il tramonto del sole. In lontananza, sentiva delle voci che lo chiamavano «Pietro! Pietro! Rispondi, dove sei?» Il personale del seminario s’era messo evidentemente alla sua ricerca. Egli non rispose mai alle chiamate reiterate. Non sapendo come riprendere il sentiero smarrito, si lasciò prendere e riportare nel seminario. Non lo mandarono via, lo riaccolsero benevolmente anche se qualcuno non mancò di ironizzare sulla avventura di Pinocchio. Il Padre Superiore intuì che qualcosa che, nel ragazzo, doveva essere successo. Egli si era dimostrato sempre studioso, obbediente, vocato alla carriera religiosa. Come si spiegava questo improvviso colpo di testa? Lo sottopose ad un vero e proprio interrogatorio. Pietro, che aveva appreso l’arte della dissimulazione, fu così abile da nascondere il venire meno della vocazione e da fare capire che egli voleva continuare a stare nel seminario. Era orgoglioso e non voleva farsi espellere, ma andare via nel momento che successivamente avrebbe scelto. Per adesso, occorreva resistere, almeno alcuni altri mesi fino al conseguimento della licenza media. Era consapevole che il padre, con tutti quei figli da mantenere, era nell’impossibilità di pagargli un professore privato e – peggio ancora – di tenerlo a pensione per la frequenza della scuola superiore. Passò un duro inverno, durante il quale Pietro aveva intensamente studiato, ma aveva anche deciso che, in primavera, 177 avrebbe abbandonato definitivamente il seminario. La sera del 30 marzo 1949, era a casa. Spiegò ai genitori che non ce la faceva più a resistere oltre in quell’ambiente oppressivo e, quindi, se n’era andato. Non si preoccupassero dei suoi studi perché sentiva che ce l’avrebbe fatto da solo. Cosa assai improbabile per il padre che, da uomo navigato e di sano realismo, nutriva dubbi seri e fondati. Come sarebbe stato possibile studiare senza la guida di un professore? Quattro ragazzi del paese, tra cui lo stesso suo nipote, frequentavano il ginnasio di S. Adriano, mantenuti con tanti sacrifici della famiglia, eppure, alla fine dell’anno scolastico, restava sempre qualche materia da riparare a settembre. Il ragazzo non sapeva come fare per vincere lo scetticismo paterno. «Comprami i libri» gli disse un giorno con orgoglio «e ti farò vedere come, da solo, riuscirò a studiare e superare l’esame.» Il padre glieli acquistò. Parlò anche al vecchio don Alessandro, che sapeva di greco e di latino più di un professore del ginnasio, perché ogni tanto controllasse il grado di preparazione del ragazzo. Pietro si procurò il programma di studio che in quell’anno veniva svolto nella scuola di S. Adriano. Molti di quegli argomenti li aveva già studiati in seminario. Preparò un proprio calendario, materia per materia, e si mise all’opera, senza perdere ulteriore tempo. Studiava otto ore al giorno: quattro nella mattinata e quattro nel pomeriggio. La sera usciva a passeggiare con Damiano della Camera del Lavoro, al quale spiegava quel che aveva studiato nella giornata. Al ritorno a casa, a letto, leggeva fino a notte inoltrata i romanzi che gli capitava di trovare, che erano perlopiù di autori russi, francesi e inglesi. Ogni tanto si faceva controllare la versione latina, la traduzione del classico latino o un tema da don Alessandro, che possedeva una straordinaria cultura, oltre ad avere una conoscenza specifica della lingua e della letteratura latina e di quella greca. Non s’era mai laureato: gli mancava una sola materia per la laurea in giurisprudenza. Aveva manoscritta la tesi di laurea sulle circolari amministrative. La prima guerra mondiale gli aveva fatto interrompere gli studi. Viveva con una piccola pensione di invalido di guerra nel palazzo paterno: una vecchia casa vicino alla Chiesa matrice, circondata da un orto di mandor178 li e di olivi, di fronte al mare Jonio, dove, nelle belle giornate, si sedeva all’ombra di un grande ulivo, e leggeva – direttamente in latino o in greco – l’Eneide di Virgilio, l’Iliade o l’Odissea di Omero, le odi di Pindaro, le storie di Tacito o di Tucidide ed, a volte, il nuovo testamento in greco, che annotava accuratamente. La casa era piena di testi latini, greci, di filosofia, di storia e di diritto con un vecchio mappamondo che evidentemente serviva per seguire gli avvenimenti internazionali. Don Alessandro era veramente un saggio, buono, rispettoso e prudente. A suo modo era anche religioso, ma di una religione particolare che era un misto di cristianesimo, di paganesimo e di superstizione. Credeva nell’esistenza del principio del bene e del male. Anche in certe parole, vedeva impersonato il male. Se si imbatteva, per esempio, nella lettura, di thànatos o mors, segnava i termini con un segno di croce. Se il libro era di altri, chiedeva l’autorizzazione e poi tracciava il segno della croce delicatamente sulla pagina. Contemporaneamente si segnava anche lui ed invitava l’interlocutore a fare altrettanto. Possedeva una capra che gli serviva per il latte quotidiano, che accudiva e personalmente portava al pascolo nel suo podere denominato Purgatorio, il più delle volte con le Georgiche o con le Ecloghe, che leggeva e rileggeva e poi spiegava ai contadini del luogo, raramente ai signori perché li qualificava ignoranti e allergici alla cultura. La sera faceva una frugale cena e poi usciva per fermarsi per una mezz’ora nel locale di Blushi, a due passi di casa sua, per farsi un quarto di vino rosso e quattro chiacchiere con gli amici. Al ritorno, si fermava nella sartoria di Gaetanino, dove, a quell’ora della sera, di solito, bighellonavano studenti, con i quali don Lisander scambiava opinioni, talora anche appassionate, nel campo della letteratura e raramente in politica. Manteneva una prudente distanza dalla politica perché – diceva – che era il regno dei mediocri e degli arruffoni, espressi da una popolazione non ancora del tutto matura per scegliere con raziocinio e buonsenso i suoi rappresentanti. E per avvalorare la sua testi, ricorreva all’esempio del suo compagno di liceo, Costantino Mortati, uno dei celebri costituzionalisti italiani, che aveva dato un rilevante contributo alla formulazione dei prin179 cipi della costituzione italiana, ma che non era stato più rieletto perché posposto al demagogo di turno. Il suo sentimento religioso si nutriva di pochi principi: niente dogmi e intolleranze. Il Padreterno può essere onorato e pregato in modi diversi, anche fuori dalla chiesa ufficiale e dagli schemi consolidati; ogni creatura va rispettata ed amata. Non frequentava le funzioni religiose da quando il parroco l’aveva fatto arrestare, ritenendosi oltraggiato dalla interruzione di don Lisander, intervenuto nel corso della celebrazione della Messa per correggere la traduzione del brano iniziale del Vangelo di Giovanni. A lui ricorrevano, per la traduzione dal greco, gli alunni del liceo classico. Per conto di uno di questi aveva tradotto tutti i brani del libro di testo, dal quale il professore sceglieva la versione che valeva come compito in classe. Per compenso aveva ricevuto un prosciutto. Le prime prove di traduzione dal greco si rivelarono perfette. Il professore non sapeva come spiegarsi l’improvviso miglioramento fino a quando non riuscì a venire in possesso, nel corso di una esercitazione, del quaderno delle traduzioni di don Lisander, sequestrato ad un improvvido alunno. Prima degli esami, don Lisander sondò la preparazione di Pietro. Fu una sorta di esame preventivo, condotto per alcuni giorni. Un giorno intero fu impiegato per il ripasso dei classici latini e della sintassi. Altri due giorni per le restanti materie. Don Lisander concluse che era in grado di affrontare la prova; gli raccomandò di invocare – prima di ogni prova – lo Spirito Santo, recitando il Veni Creator Spiritus. Effettivamente l’esito fu abbastanza soddisfacente. Pietro aveva vinto la scommessa col padre. Anche negli anni successivi, Pietro continuò la sua carriera scolastica da autodidatta fino al conseguimento della maturità classica. 180 4 Ma il padre Andrea non ebbe la fortuna di vedere completare al figlio la carriera scolastica, così tenacemente e orgogliosamente intrapresa dal ragazzo, da solo, tra tante difficoltà. Allo scetticismo iniziale, mano a mano che il ragazzo progrediva nello studio come se corresse, il padre si sollevava d’animo. Al superamento – anche con voti al di sopra della media – degli esami di quinta ginnasio, Andrea s’era convinto che ormai questo figliuolo era in grado di sbrigarsela da sé. In più occasioni, l’aveva manifestato alla moglie. «Di Pietro» le diceva «non mi preoccupo: sa farsi strada da solo.» Altrettanto orgogliosa del figlio era la madre Serafina. Costei non tralasciava occasione di ricordare alle donne del vicinato ed alla parentela che il figlio, quand’era bambino, l’aveva “preso la Madonna” (e muari Shen Meria) e, quindi, aveva qualcosa in più rispetto agli altri bambini perché l’aveva benedetto la Madonna. La leggenda aveva avuto origine da un episodio reale, accaduto in campagna quando il figlio era un bambino di tre anni. Mentre i genitori erano ambedue intenti alla estirpazione delle piante di ceci a Comesse, nell’estate del 1938, il bambino si divertiva ad inseguire grilli e farfalle. Si venne, così, a trovare dalla parte del podere opposta a quella dov’erano i genitori senza avvertire alcun senso di smarrimento e di disorientamento, conoscendo bene il luogo per esservi stato, in precedenza, molte altre volte. I genitori, non vedendo il bambino lì intorno, non ci fecero caso, ritenendo che si fosse recato, come altre volte, nel podere limitrofo di zio Michele, un loro vecchio parente senza figli. Perciò non si preoccuparono e continuarono nel loro lavoro. Ad un certo momento, chiamarono a voce alta il vecchio per chiedergli di riaccompagnare il bambino: 181 «Lale Michè, bite vinj diali (zio Michele fai venire il bambino).» «Diali neng esht ketu (il bambino non è qui).» «Ku esht diali; u buari diali? (dov’è il bambino; s’è perduto il bambino?).» A questo punto, lo zio Michele, che si trovava su una collinetta soprastante, col suo vocione incominciò a chiamare Pietro: «Pieter, ku jè? Mbidu te lale Mikelli (Pietro, dove sei? Ritorna dallo zio Michele).» Più volte, il grido di zio Michele che oscillava tra il dolore e lo spavento, risuonò inutilmente nella valle. Il bambino lo aveva sentito, ma occupato nel gioco, non aveva risposto. Quando sentì che anche i genitori lo chiamavano, prese la via del ritorno, percorrendo il fosso di scolo che attraversava l’intero podere. Il padre, la madre, lo zio Michele e la moglie Rachele lo chiamavano e lo cercavano lungo tutto il podere e non lo vedevano e né lo potevano vedere perché il fosso di scolo era più alto del bambino e attraversava la parte superiore del terreno. Avevano cercato sotto l’uliveto, nella vigna, nel ficheto; avevano passato in rassegna pianta per pianta, guardando e cercando tra i rami e le foglie ove mai il bambino si fosse arrampicato a qualche pianta e non potesse discendervi. Niente di niente. Il bambino sembrava sparito, rapito da qualche fata maligna che lo aveva reso invisibile. Le urla, i pianti di disperazione e di rabbia salivano al cielo. Avevano richiamato nel podere i contadini che lavoravano nelle vicinanze. Ognuno si dava da fare, perlustrando anche i terreni limitrofi, senza risultato alcuno. Quando ormai una piccola folla s’era fatta davanti alla casa colonica, dalla parte terminale del fosso di scolo, vicino alle piante dei fichidindia, lo zio Michele vide spuntare il bambino, allegro e sorridente. Fu una liberazione per tutti. Ringraziarono la Madonna e i santi Cosma e Damiano e gli Angeli e gli Arcangeli per il ritrovamento. Sì, perché ognuno in cuor suo ritenne che il bambino era stato rapito da una non bene individuata divinità e poi liberato per le invocazioni dei genitori. Fu Donna Netta, anima pia e religiosa, che, dopo avere parlato col bambino, stabilì definitivamente che era stato “preso dalla Madonna”. Donna Netta abitava nel suo grande palazzo con una sorella 182 e una donna di servizio. Sufficientemente ricca e dotata da costituire un buon partito per qualche signorotto locale o dei dintorni, aveva rifiutato tutte le richieste di matrimonio per scegliere una pratica di vita religiosa, dedicata alle preghiere, ma anche alle opere di solidarietà sociale. Come veniva a conoscenza delle tante povertà nascoste, non faceva mancare il suo aiuto senza che ne fosse richiesta: a chi faceva avere la farina o il grano per il pane quotidiano; a chi somme di denaro. Visitava ed assisteva gli ammalati; per tutti i bisognosi aveva parole di consolazione. Questa donna pia, tutta casa e chiesa, costituiva l’eccezione nella sua famiglia di miscredenti che, però, non l’ostacolavano e rispettavano la sua scelta di vita. Ella, dopo avere stabilito che il bambino era stato “preso dalla Madonna” e poi liberato, ne dedusse che questo fatto era il segno evidente della protezione della Madonna. Bisognava, quindi, ringraziarla facendo celebrare una messa solenne da don Giovanni, il nuovo parroco del paese. L’indomani mattina, tutti in chiesa, donna Netta in testa e, al seguito, i genitori del bambino, lo zio Michele, la moglie, le comari e tutte le altre donne e i ragazzi della gjthonia (vicinato). Al ritorno a casa, il bambino veniva interrogato. «È vero che la Madonna portava un manto nero?» «Sì,» rispondeva il bambino. «Ti ha baciato? Ti ha preso per mano?» Invariabilmente il bambino rispondeva di sì. E le donne piangevano per la commozione. Decisero, così, di recarsi sul posto per farsi indicare e descrivere dal bambino ogni minimo particolare. Vi si recarono tutte le donne del vicinato. Donna Netta non vi andò; non ne sentiva veramente il bisogno. Ella aveva ormai la certezza dell’apparizione miracolosa. Quando arrivarono al podere, lo percorsero in lungo e in largo col bambino, che tempestavano di domande. «Qui era la Madonna?» «Sì, rispondeva il bambino.» «Poi, come ha fatto a andarsene? È volata?» Ed il bambino rispondeva di sì, indicando una pianta d’ulivo, ch’era vicino alla casetta colonica, come se volesse dire che la 183 Madonna era salita su quella pianta, scomparendo e dileguandosi nell’aria. Ormai, il miracolo era avvenuto. La voce si diffuse per il paese e tutti vi credevano. Se qualcuno accennava ad un dubbio, si trovava sempre un altro, pronto a giurare sulla verità del fatto per averlo personalmente constatato o per averlo sentito raccontare dallo stesso bambino. Con gli anni, la memoria del fatto miracoloso andò man mano scemando fino ad essere del tutto dimenticato e non più ricordato. Ma nella cerchia della parentela, nessuno dimenticò mai che quello era il “bambino preso dalla Madonna” e, dunque, doveva essere superiore ad altri per intelligenza e per doti umane. Quando c’era da sciogliere qualche dubbio, chiedere una spiegazione oppure un parere, i parenti si rivolgevano all’ex bambino, ormai giovane ed uomo fatto. Alla vecchia zia Mariantonia, una vita intera tutta casa e chiesa, l’atterraggio sul suolo lunare pose un grave problema teologico che, secondo lei, solo il nipote istruito era in grado di dipanare. Più volte gli inviò messaggi per dirgli che lo voleva vedere al più presto. Finalmente, in un tardo pomeriggio dell’ottobre 1969, Pietro si recò dalla zia. La trovò indaffarata, come al solito, nel disbrigo delle faccende domestiche; aveva sempre qualche cosa da fare: togliere un po’ di polvere, posata sul vecchio comò, rammendare uno strappo od un buco sulla tendina della finestra, rassettare la stanza ove avevano giocato le nipoti. L’improvvisa comparsa del nipote la mise come in allegria; l’abbracciò calorosamente significandogli che l’aspettava. Gli offrì il solito rosolio riversandolo sul bicchierino dalla bottiglia che teneva bene in vista esposta nell’angoliera del salottino. Gli pose subito la domanda se veramente era stato effettuato il viaggio sulla luna. Il nipote pazientemente le espose le modalità della sbarco lunare e del viaggio di andata e ritorno dalla luna. Ma l’anziana zia non era veramente interessata alla conoscenza della verità sull’allunaggio. Aveva sempre saputo che Nostro Signore, gli Angeli e gli Arcangeli hanno dall’eternità la loro naturale dimora su, nel cielo, sopra di noi, sopra la terra. Il Padreterno – come appariva nelle sacre raffigurazioni – dal cielo incombeva sulla terra con la sua barba bianca. E lei ci 184 aveva sempre fermamente creduto sin da quando aveva frequentato, da bambina, le lezioni di catechismo. Il fatto che si faceva un gran parlare sul viaggio lunare e nulla si diceva sul Padreterno che sicuramente abitava nel cielo, l’aveva messa in agitazione perché scuoteva dalle fondamenta la sua fede. Com’era possibile che alcuni uomini erano stati capaci di volare in lungo ed in largo per il cielo, per alcuni giorni, senza incontrare Nostro Signore o, almeno, uno dei numerosi Angeli? La domanda successiva metteva in chiaro il dubbio terribile dell’anziana zia: e paan t’Yne Zot (l’hanno visto il Nostro Signore)? Se gli astronauti avevano attraversato il cielo sopra di noi, essi hanno necessariamente raggiunto il regno di Dio ed hanno dovuto vederlo. L’hanno visto o no? La risposta negativa significava di conseguenza che Dio non c’era. In questo caso, la fede della zia era destinata a crollare. Il nipote doveva aiutarla a capire che cosa era veramente successo. Pietro salvò la credenza della zia, spiegando che gli astronauti non hanno potuto vedere il Signore per il troppo buio che c’era in cielo e rassicurando la zia che nostro Signore è così potente che si manifesta solo a coloro ai quali piace manifestarsi. Così non si era manifestato agli astronauti e s’era circondato da nere nubi per non farsi vedere per sua scelta misteriosa e imperscrutabile dalla mente degli uomini. Ma Egli è il creatore e il padrone del mondo infinito che non può essere messo in discussione. La zia riacquistò la serenità e la sicurezza solita e consolidata nella fede dell’esistenza del Padreterno con una lunga barba bianca che sta nel cielo stellato, avvolto tra le nuvole, continuando a governare saldamente il destino dei poveri uomini. Tale e quale appariva nelle oleografie popolari e nel grande dipinto sulla parete destra della chiesa 185 5 La notte del 10 gennaio del 1952, la disgrazia si abbatté sulla famiglia di Pietro. Non la distrusse, ma la fece patire per lunghi anni. Una famiglia numerosa di sei figli, di cui il più piccolo era di cinque mesi ed il più grande di sedici anni. Era, a suo modo, felice la famiglia di Andrea Lascaris: di quella felicità fatta di poche e semplici cose come il pane fatto in casa e cotto ogni quindici giorni nel forno domestico con grande festa di piccoli e grandi e di tutto il vicinato che divoravano, assaporandole, le bianche focacce, appena uscite dalla bocca del forno e imbevute d’olio di oliva. I ragazzi sciamavano felici per le vie ed i viottoli e le piazze del paese, una volta usciti da scuola. Nelle serate invernali, attorno al focolare, o d’estate, nello spazio della gjitonia, appollaiati attorno agli anziani, non perdevano una parola delle lunghe e complicate romanze in cui si narravano i fatti ed i misfatti dei briganti della Sila, gli amori, le vendette, i sequestri, e le astuzie messe in atto per sfuggire alla legge o la triste storia di Costantino e Garentina, che commuoveva fino alle lacrime. Garentina era la decima figlia di una signora assai nobile, inutilmente corteggiata da molti giovani signori, che andavano e venivano dalla sua casa per chiederla in sposa. Un giorno, arrivò un giovane da un paese lontano. La madre ed i fratelli erano contrari al matrimonio perché la ragazza avrebbe dovuto allontanarsi troppo dalla famiglia. Solo Costantino insisteva perché la madre acconsentisse al matrimonio. «Madre mia, fai sposare Garentina.» «Ma che discorso è il tuo, Costantino, figlio mio,» rispondeva la madre «come posso permettere che tua sorella vada così lontano? Chi me la riporterà più in casa quando io la vorrò o 186 per una festa o per un lutto? Non potrò più vederla quando ne avrò il desiderio.» «Non preoccuparti, mamma,» assicurò Costantino, «ogni volta che tu lo vorrai, basta dirmelo ed io andrò a prendere Garentina.» Così, il matrimonio fu celebrato e Garentina partì con il suo sposo. Avvenne che una guerra terribile e distruttrice, dopo qualche tempo, fu combattuta in quella contrada. I nove figli maschi della nobile signora caddero in combattimento. Grande e profondo fu il suo dolore. Si chiuse nel suo palazzo, si vestì in gramaglie; solo il sabato dei morti si recava nella chiesa, dov’erano le sepolture dei figli. Accendeva una candela sulla tomba di ognuno, versandovi calde lacrime. Sopra quella di Costantino ne accese due e, come se parlasse col figlio, ad alta voce si lamentava che non aveva mantenuto la promessa di riportarle Garentina: «Costantino, figlio mio, dov’è andata a finire la promessa di farmi vedere Garentina? È sotterrata con te.» Ma, all’imbrunire, al lume delle candele, quando ormai la chiesa era chiusa, Costantino si alzò dal sepolcro; la pietra che lo copriva si trasformò in brioso cavallo con una nera gualdrappa ricamata; l’anello che manteneva la pietra sepolcrale divenne briglia d’argento. Costantino montò sul cavallo scalpitante; per monti, per valli e attraversando pianure, in una corsa forsennata per tutta la notte, finalmente, al mattino seguente, arrivò davanti al palazzo della sorella. Trovò i figli che giocavano nello spiazzale antistante e chiese: «Dov’è la vostra signora madre?» «È nella ridda, nel ballo tondo, in giro per la città» risposero. Erano molti i balli tondi che, con danze, suoni e canti, facevano il giro delle vie cittadine. Costantino si mise alla ricerca della sorella, che non tardò a trovare. Come lo vide Garentina fu piacevolmente sorpresa e gridò dalla gioia: «Oh, Costantino, fratello mio!» «Non perdere tempo» rispose Costantino «vieni con me perché dobbiamo andare a casa, da nostra madre.» «Ma come vengo, così come sono vestita; dimmi almeno per quale motivo debbo venire, se per lutto o per gioia in modo da indossare l’abito adatto.» 187 «Vieni come sei vestita; l’abito non è importante; importante è che tu venga con me.» E così la pose in groppa al cavallo. Come se il cavallo andasse con le ali di vento, rifecero in silenzio il viaggio di ritorno. Garentina osservava attentamente il fratello. Ad un certo punto, ruppe il silenzio: «Costantino, fratello mio, noto in te un segno funesto: le tue spalle larghe sono come ammuffite.» «Sorella mia, il fumo dei fucili mi ha annerito le spalle. Non preoccupartene più di tanto.» «Ma» riprese Garentina «anche i ciuffi dei tuoi bei capelli non mi sembrano quelli di una volta. Mi paiono come se fossero sfatti, consunti e cadenti come polvere.» «I tuoi occhi t’ingannano, sorella mia. È la polvere della strada che li fa vedere così. Ho viaggiato tutta la notte con questo cavallo che sembrava volare. Ne ho presa di polvere.» Giunti ormai nella periferia della città, Garentina ebbe un ulteriore elemento di sospetto, non vedendo nessuno dei più stretti parenti che l’aspettava, come di solito avveniva. «Costantino, non vedo venirci incontro né i miei fratelli e neppure alcuno dei nostri cugini.» «Sorella mia, abbi pazienza. Siamo giunti di sera e, per quest’ora, non ci aspettavano più; essi saranno in giro per la città a divertirsi.» Avvicinandosi al palazzo, Garentina colse un altro segnale infausto: tutte le finestre erano chiuse, mentre di solito erano sempre aperte. «Vedo le finestre della nostra casa serrate. Debbono esserlo da più tempo perché vi è cresciuta l’erba.» «Le hanno dovuto chiudere» la rassicurò Costantino «perché spira un forte vento di tramontana che spezza le ossa. Qui ancora imperversa l’inverno.» Arrivati nei pressi della chiesa, Costantino disse alla sorella di avviarsi verso casa perché egli si fermava un momento in chiesa per pregare. Garentina entrò in casa, salì la rampa della scala e, ad alta voce, chiamò la madre: «Apri la porta, mamma!» «Chi sei tu che bussi alla mia porta?» disse la madre. «Signora madre, sono tua figlia Garentina.» 188 «Vattene, tu sei l’insaziabile morte che già mi rapisti i miei nove giovani figli. Ora, con la voce di mia figlia, sei venuta a rapire anche me.» «Ma aprimi, signora madre, io sono veramente tua figlia Garentina» «Ma chi ti ha condotta fin qui?» «Mi ha portato mio fratello Costantino.» «E Costantino dov’è?» «È entrato un momento in chiesa per pregare.» A questo punto, la madre spalancò la porta e apparve sulla soglia vestita di nero, gridando: «Ma Costantino mio è morto!» La madre abbracciò la figlia e la figlia si strinse alla madre; così abbracciate, stretta l’una all’altra, spirarono tutt’e due. A volte, a gara, donne e uomini, intonavano melanconiche canzoni d’amore o di dispetto oppure il canto della nostalgia della bella Morea, tramandata dalla tradizione orale, in cui struggente era il ricordo del signor padre, della signora madre, sepolti sotto terra, e mai più visti dopo l’abbandono della patria da parte degli antenati ormai cinquecento anni fa. Fortunata poteva dirsi, nella povertà generale, la famiglia di un contadino, piccolo o medio proprietario. Possedeva le terre seminative con uliveti, ficheti, vigna e numerosi alberi da frutta: mele, pere, fichi d’India, pesche. Allevava uno o due maiali, uccisi nel periodo invernale. La provvista di carne per tutto l’anno era assicurata. La carne veniva trasformata in salsicce, prosciutti e soppressate, ben conservate per essere consumate nella primavera-estate successiva. Il capofamiglia col suo diuturno lavoro, sempre affaccendato, partiva la mattina, all’alba, con l’asino o col cavallo, per recarsi nel podere e badare alle varie coltura. Ritornava a sera, dopo l’imbrunire, con un’ora di notte. Raramente faceva festa, se non nei giorni comandati. Egli era, dunque, il motore della casa. La moglie provvedeva alle faccende di casa: cucinava, badava ai figli ed agli anziani della famiglia, faceva il pane ed il bucato, teneva anche e gelosamente la contabilità di casa, una piccola manager domestica che riusciva a fare quadrare le spese della famiglia con le entrate. 189 Ma per chi non aveva niente ed era costretto a vivere solo col lavoro delle sue braccia, in precarie e sporadiche occupazioni, erano veramente dolori riuscire a sbarcare il lunario. Era questo il popolo minimo, perlopiù costituito da poveri cristi, analfabeti e perennemente affamati, che vivevano ammassati in promiscuità in un catoio affumicato o in una sola stanza, esposti al caldo d’estate ed al freddo d’inverno, di fatto emarginati. Nel gradino più elevato della scala sociale, spiccavano le poche grandi famiglie dei signori, padroni di buona parte delle terre, coltivate dalle famiglie dei coloni; vivevano nel palazzo, da tutti riveriti e serviti, facevano la passeggiata nel pomeriggio e la sera giocavano a carte nel circolo dei galantuomini. Il guardiano sovrintendeva ai lavori dei terreni; ogni sera, gli faceva il resoconto della giornata, non trascurando di aggiornare il padrone su fatti del paese e sui pettegolezzi del momento. Questi signori ritenevano di avere ascendenze nobiliari risalenti a secoli addietro; non trascuravano occasione per esibire diplomi e titoli, in effetti, falsi e abilmente fabbricati, che costituivano il loro pennacchio ed in cui si esaurivano tutta la loro paesana nobiltà e l’alterigia di classe, invero non accettate passivamente da esponenti del ceto medio che, più volte, le avevano ridicolizzate. Tuttavia, i signori per alcuni secoli rimasero signori; le tante contestazioni non valsero a diminuire il loro potere. Essi si schieravano sempre con i partiti di maggioranza del momento e ne seguivano le sorti, pronti a saltare sul carro del vincitore non appena intuivano che il vecchio loro padrone stava per tirare le cuoia. Prima con i Borbone, poi con i Savoia, con i fascisti e, da ultimo, con i potenti capi democristiani della provincia, padroni delle banche, dei consorzi di bonifica e delle più importanti istituzioni pubbliche. Razza infelice, ora estinta, costretta alla separatezza: si sposavano tra di loro avendo di mira l’unione di più patrimoni, da trasmettere successivamente al figlio maggiore, condannando gli altri al sacerdozio, se maschi, alla monacazione, se femmine, oppure ad una ipocrita vita celibataria. Ognuno di questi forzati zerbinotti si faceva la sua casa piccola, in cui teneva l’amante popolana che sfornava numerosa figliolanza, non riconosciuta e destinata a tirare alla meno peggio. 190 Fortunate le femmine se trovavano o, meglio, se a loro veniva scelto dal padre, per sposo un altro possidente o un professionista, allettato da una dote considerevole. Altrimenti, dovevano arrangiarsi con amori clandestini, non rare volte assai pericolosi se scoperti dai famigliari. Come accadde ad una povera fanciulla, innamorata del giovane e vigoroso pastore del padre. Dopo qualche tempo, fu scoperta l’innocente relazione, ritenuta naturalmente disonorevole e non confacente al rango sociale. I guardiani del padrepadrone tesero al pastore un tranello: gli fecero sapere che l’amata l’attendeva nell’orto di casa ad una certa ora di notte. L’ingenuo giovane vi si recò. Sequestrato dai guardiani, la mattina seguente fu trovato impiccato ad una quercia. Autrice del delitto fu ritenuta la ragazza! Ma, sulla famiglia Lascaris, quella notte del 10 gennaio 1952, un fulmine improvviso si abbatté. Dopo mezzanotte, forse verso le due, Pietro nel sonno sentì la voce della madre che invocava aiuto. Balzò improvvisamente dal letto e corse nella stanza dei genitori. Vide che il padre farfugliava e si muoveva nel letto e la madre all’impedì era come inebetita. Vestitosi in fretta e furia, di corsa, raggiunse la casa del medico di famiglia, che abitava non lontano. Bussò fragorosamente al portone e quasi subito il medico sporse il capo dalla finestra e vide il ragazzo che gli chiedeva di correre in aiuto del padre. Pochi minuti passarono ed il medico don Filippo era al capezzale dell’ammalato. Ma nulla poté fare se non constatarne la morte. 191 6 Era la tragedia. Restavano, soli e senza alcuna protezione, la vedova con i sette figliuoli. Il più piccolo aveva cinque mesi ed il più grande sedici anni. Sembrava che non vi fosse alcuna speranza di sopravvivere. Non mancò la solidarietà sincera dei paesani. Anche dopo i funerali, le persone amiche e più vicine alla famiglia non trascurarono di fare visita e di portare le buone parole di consolazione. Alla vedova che si disperava, la vecchia Betta «Oh, comare mia» le diceva «vedrai che, col tempo, le cose si aggiusteranno. Il Signore ti ha chiuso una finestra, ma ti ha aperto sette porte. Questi sette figliuoli cresceranno, avranno un avvenire e saranno la luce dei tuoi occhi.» Una mattina arrivò col pullman la vecchia nonna materna, carica di ogni ben di Dio, pasta di varia qualità, pane, legumi, carne di maiale. Almeno, nell’immediato, era garantito il pane quotidiano. Se i ragazzi più piccoli sembravano non rendersi abbastanza conto dell’accaduto, il ragazzo più grande, Pietro, era ammutolito e sconfortato, pareva una quercia abbattuta. Non vedeva come avrebbe potuto continuare gli studi. Quale sarebbe stato il suo avvenire? E quello dei suoi fratelli? Come avrebbero potuto uscire dall’abisso, dov’erano improvvisamente piombati, sani e salvi per costruirsi un avvenire soddisfacente? Nel momento della disperazione, il buio è assoluto. Si tratta, però, soltanto di un breve momento perché la vita non si ferma. Le cose continuano come prima, indifferenti alla morte, al dolore ed alla disperazione. Ad un certo momento come se ti svegliassi da un lungo sonno, benché ancora stordito, incominci a renderti conto che devi darti da fare. Una qualunque cosa, anche la prima che ti capiti, per ritornare a vivere. 192 Pietro non perse tempo. Riprese a studiare con più intensità di prima. Ore e ore di studio. Solo la sera usciva per qualche ora; passeggiava con Damiano; fumava una mezza alfa che l’amico gli passava. E poi, al ritorno a casa, andava direttamente a letto e leggeva, leggeva appassionatamente tutto quel che gli capitava per mano e tutti i libri che riusciva a procurarsi: romanzi russi, francesi e italiani e le poesie dei poeti antichi e moderni. E il giorno dopo riprendeva lo studio dei testi scolastici per sostenere, da privatista autodidatta, gli esami al liceo. Perché il suo programma, nell’immediato, era il conseguimento della maturità classica. Poi, avrebbe considerato l’altro da farsi. Ma i signori avevano già sentenziato che il ragazzo, alla fine, avrebbe dovuto arrendersi per le gravi ed insormontabili difficoltà dello studio. Un giorno o l’altro sarebbe stato costretto a smettere. Ma essi non sapevano, non conoscendo se non superficialmente il ragazzo, che egli aveva una volontà di ferro e che s’era prefisso di arrivare, a tutti i costi, alla mèta, affrontando tutti i sacrifici e le inconvenienze ed anche le momentanee cadute e gli eventuali arresti del caso. Certo che gli costava studiare, studiare, sempre studiare, mentre altri ragazzi si divertivano, giocavano a carte, frequentavano le associazioni giovanili, scorrazzavano per le vie del paese, facevano le serenate alla ragazze. Pietro, però, resisteva; soltanto la stanchezza qualche volta lo vinceva e faceva esplodere una crisi momentanea. Buttava i libri per aria e le pagine, come tante foglie portate dal vento, si disperdevano per la stanza. La madre, vera mater dolorosa, con una santa pazienza, raccoglieva, ad una ad una, le pagine e le posava sulla scrivania. Così la vita riprendeva con i suoi alti e bassi. Il ragazzo, ormai s’era fatto un giovanotto, passata la crisi momentanea, con rinnovato vigore, ritornava allo studio delle varie discipline. Era tale il fervore che sembrava che i libri li divorasse. Non v’era testo di cui non conoscesse anche le note. I mesi di aprile e maggio erano dedicati alla ripetizione delle materie in cui gli sembrava di avere qualche lacuna o qualche residua difficoltà nell’espressione. Teatro delle ripetizioni era l’uliveto secolare di Comesse, a qualche chilometro dal paese. Vi si recava nelle bel193 le giornate di sole, al mattino, con una frugale colazione per ritornare a casa sull’imbrunire. Per tutto il giorno ripeteva ad alta voce tutti gli argomenti studiati senza trascurare alcun particolare. Perché, gli esami che sosteneva ogni anno da privatista, non si accontentava di superarli: almeno nelle materie principali doveva farcela conseguendo una votazione alta. Come, puntualmente, del resto, accadeva. Ripeteva e continuava a ripetere, passeggiando tra le piante, gli argomenti di studio. Lasciava solo quando aveva raggiunto la sicurezza di conoscerli a menadito e la consapevolezza di potere affrontare vittoriosamente la prova d’esame. Oh, se quei vecchi ulivi di Comesse potessero parlare, ripeterebbero tutte quelle nozioni che erano stati costretti ad ascoltare per giorni e giorni. Tutti i versi dei classici greci e latini e le teorie dei vari filosofi ed i fatti e gli avvenimenti della storia moderna e contemporanea! Pietro aveva fatto un patto con se stesso; si comportava come se avesse lanciato una sfida alla comunità paesana. Non doveva fallire. Il fallimento sarebbe stato la sua rovina. La morte del sogno lungamente accarezzato di promozione sociale, sua e della famiglia, dei fratelli e delle sorelle, poveri ragazzi rimasti senza padre, soggetti a tutte le umiliazioni, della madre derelitta che, nonostante tutto, non si scoraggiava e portava avanti la famiglia come meglio poteva. La riuscita del primo figlio l’avrebbe almeno ricompensata di tutti i pesanti sacrifici, sopportati nel silenzio e nella solitudine. A tutti i costi doveva riuscire a conseguire la maturità classica e laurearsi, superando tutti gli ostacoli, le non poche difficoltà di ogni ordine, facendo qualsiasi sacrificio. In tale prospettiva, forte del suo amor proprio e animato dall’orgoglio, aveva educato la sua volontà a seguire la logica ferrea di questo imperativo per evitare distrazioni e perdite di tempo. Non avrebbe potuto mai immaginare, dedito com’era tutto allo studio e quasi estraneo alla vita paesana ed ai suoi pettegolezzi, che in quel piccolo ambiente qualcheduno era come roso dal tarlo dell’invidia per il suo successo scolastico e ne soffriva tanto da escogitare un qualche marchingegno per poterlo fermare. Eppure tre omiciattoli da quattro soldi si presero la briga da recarsi da alcuni professori, in prossimità della sessione 194 degli esami, per sollecitare la bocciatura di Pietro. Egli ne venne a conoscenza solo alcuni anni dopo. Uno di quei professori, col quale nel frattempo era diventato amico, gli confessò che, anni addietro, tre paesani avevano contattato lui ed altri due professori nel tentativo di bloccare con la bocciatura la carriera scolastica di Pietro. Quei tre spregevoli omiciattoli ritenevano che il giovane andava punito con la bocciatura perché “era contro il governo” e – reato più grave – “era comunista”. Nella loro rozza piccineria e nell’ignoranza di cui erano vittime, evidentemente pensavano che ovunque era come nel paese: c’erano soltanto, da una parte, quelli che comandavano, i signori, il parroco ed il maresciallo dei carabinieri, e, dall’altra, quelli che dovevano solo obbedire senza fiatare. I professori non avrebbero potuto essere che dalla parte di chi comandava. Ma la realtà era diversa. E andava, di giorno in giorno, modificandosi e migliorandosi e ammodernandosi diventando la società – anche nella piccola Matermara – più libera e plurale. «Quando costui,» alludendo a Pietro, «diventerà grande e riuscirà a laurearsi» aveva sentenziato nel circolo dei galantuomini don Gelsomino «potrà essere la nostra rovina.» Capivano i signori che la diffusione della cultura sarebbe stata una rivoluzione; avrebbe inevitabilmente fatto alzare la testa a chi aveva sempre solo obbedito e lavorato le terre dei signori con salari di fame e senza alcun diritto. Questo processo andava fermato perché il suo sviluppo avrebbe determinato la caduta dei signori. Ma Pietro non si rendeva conto di essere anche un pericolo. 195 7 Il duro inverno per la famiglia Lascaris era veramente lungo; sembrava che non dovesse mai finire. Ogni giorno si presentava un problema, che bisognava comunque risolvere, nonostante le ristrettezze economiche e le scarse risorse a disposizione. La madre, sempre premurosa, previdente e attenta, sapeva convenientemente ripartire le assai scarse rendite dei fondi rustici, distribuendole e destinandole alla soddisfazione dei bisogni essenziali di ogni giorno: il pane, il vestire, alimenti e qualche altra insopprimibile necessità. Il pane lo cuoceva nel forno di casa e, nell’occasione, faceva anche le pizze ed i taralli. Quanto al vestire era instancabile nel rammendare, confezionare vesti e pantaloni con le sue mani, non rare volte, adottando le stoffe di altri vestiti. I ragazzi – che, ormai, si avviavano a diventare grandicelli – s’arrabattavano per come era nelle loro possibilità, facendo qualche lavoretto nei campi, eseguendo qualche prestazione lavorativa per conto di altri e, così, realizzando qualche modesto guadagno; si trattava di assai poca cosa, ma anche quel poco era pur sempre un utile aiuto alla famiglia. Pietro, oltre a dovere studiare per suo conto, dedicava le ore libere della giornata ad impartire lezioni private nelle materie letterarie, ricavandone quel guadagno che, in parte serviva per la prosecuzione dei suoi studi, ed in parte era ovviamente destinato alle necessità della famiglia. Ma non era ancora finita la notte ed aspro era ancora il cammino da fare. Restava, però, la speranza che, alla fine, quel duro destino, che lo faceva assai soffrire, con la costanza nell’impegno quotidiano sarebbe stato vinto. Era bello sperarlo, ma naturalmente arrivare a concludere il tutto con onore e soddisfazione personale, era ben altra cosa. Passavano gli anni ed i giorni e si 196 succedevano sempre uguali; mai una novità. Si ripetevano le stesse cose: la mamma faceva seminare il grano, i ceci e le fave ed accumulava le provviste per l’anno seguente. Aiutata dai figli, raccoglieva le olive, conservava il fabbisogno dell’olio per la famiglia per l’anno ed il resto lo vendeva o barattava per sopperire ad altre necessità famigliari. Cresceva anche un maiale che, macellato nell’inverno, la sua carne – trasformata in salsicce, soppressate e prosciutto – costituiva, particolarmente nel periodo invernale, un alimento fondamentale. Non mancava la provvista di sottaceti, di fichi secchi ed infornati, assai dolci con il miele che producevano, che immancabilmente costituivano, insieme al pane di casa, la colazione anche per la scuola. E, così, il tempo passava, i ragazzi crescevano, le ristrettezze si facevano sentire e mordevano amaro, ma Pietro progrediva sicuro per la sua strada. La madre ed i fratelli stravedevano per lui; pendevano da lui. Nella sua riuscita avevano riposto ogni speranza di salvezza. La stessa sua persona, benché ancora assai giovane, emanava come un fluido, trasmettendoti sicurezza e voglia di reagire e di fare. Egli, laureandosi e conquistandosi così una posizione sociale, poteva diventare qualcuno nella società. Di sicuro non si sarebbe mai dimenticato dei fratelli; li avrebbe fatti uscire dalla situazione di precarietà, nella quale erano piombati con la morte prematura del padre, uomo buono, dal cuore d’oro e dagli affetti tenaci. E Pietro l’aveva promesso ai fratelli. Non aveva mai parlato di un sogno premonitore. Erano passati tanti anni dalla morte del padre ed egli non l’aveva mai sognato. In una di quelle notti invernali di vento e pioggia che sembrava scuotere le imposte e faceva ballare i vetri come tamburini, gli venne in sogno il padre. Sembrava proprio lui, in carne ed ossa, com’egli lo ricordava, col sorriso sulle labbra. La sua immagine, nitida e naturale, si stagliava nella vigna e faceva il percorso tra le piante d’ulivo e di melo di Prorroi Vrika, il loro fondo dove tante volte i ragazzi l’avevano aiutato a trasportare i fichi raccolti o l’uva. Scendeva lungo il viottolo, che attraversava il terreno, diretto al luogo, dove Pietro e due dei suoi fratelli – i più grandicelli – stanchi e fiaccati dalla calura, s’erano sdraiati a riposare all’ombra di un grande albero d’olivo. Avvicinatosi ai tre, nulla disse. Fece solo un gesto: sol197 levò i tre, uno per volta, per poi allontanarsi in silenzio e svanire tra gli alberi del fondo. Il sogno era stato bello e commovente. Col suo gesto che sollevava i tre fratelli, porgendo l’aiuto per farli rialzare come a dovere riprendere il lavoro, l’ombra del padre voleva significare che no, non li aveva abbandonati, gli era sempre vicino; li incoraggiava a resistere ad ogni ostacolo. Alla fine, sarebbero usciti vincitori ed avrebbero sconfitto il destino amaro e crudele. “Su, alzatevi, o figli, non abbattetevi”, voleva significare col gesto di sollevarli dalla nuda terra, dove essi giacevano come esausti. I sogni non sono veri; essi sono come un’opera d’arte, costruiti da noi stessi perché esprimono i nostri desideri e le nostre aspettative in circostanze particolari della vita. Quel sogno – l’unica volta in cui vide l’immagine paterna – Pietro non lo dimenticò mai. Gli sembrava di avere ricevuto quel conforto che lo gratificava, lo faceva stare bene. Esso era come un incoraggiamento continuo nel deserto degli affetti in cui trascorreva le giornate, tra lo studio e le lezioni private, come arrampicato ed appeso al suo amore proprio, che lo guidava fortemente verso la mèta che si era prefissa. Se si guadava intorno, gli sembrava che anche gli uomini erano come le cose, gli oggetti, le pietre, la montagna che incombeva sul paese, senza alcun sentimento di solidarietà, di simpatia e di amore. Un destino tragico aveva condannato uomini e cose e la natura e si divertiva a disporre di loro a casaccio, senza finalità alcuna, senza distinzione tra buoni e cattivi, tra credenti e non credenti nell’esistenza di una provvidenza. Nessuno aveva avuto pietà e amore per gli orfani. Solo il vecchio Parroco, il buon don Giovanni, si ricordava di loro e non mancava di aiutarli per come poteva, incoraggiandoli e bonariamente ricordando che immancabilmente alla notte – anche alla più fonda ed oscura – è sempre seguito il giorno. Con Pietro era paterno: gli aveva messo a disposizione la sua biblioteca, particolarmente ricca di libri di autori della letteratura contemporanea, la cui lettura appagava la sete di conoscenza del ragazzo e lo arricchiva sempre più culturalmente. Anche Francesco, in più occorrenze, attestò a Pietro un’amicizia sincera ed un genuino sentimento di solidarietà. Particolarmente quando doveva raggiungere l’Università di 198 Napoli per sostenervi gli esami della sessione. Gli prestava sempre la somma di denaro occorrente, che ovviamente gli veniva restituita a distanza di mesi, senza interessi, sempre rifiutati. Era un atto di grande, reale e disinteressata amicizia. A differenza di quella di don Serafino – al quale ingenuamente si era rivolta la madre di Pietro per un piccolo prestito, sempre per le esigenze universitarie del figlio – che si limitò a dire: «Vieni in banca che ti faccio avere il denaro.» Fu più di uno schiaffo. Per Pietro, la difficoltà del corso universitario era soltanto economica e, cioè, della ricerca del denaro occorrente per i viaggi, la permanenza nella città, il vitto e l’alloggio. Bisognava sopravvivere, facendo una stretta economia, almeno per un mese circa, il tempo necessario per sostenere almeno due-tre esami. Alla fine, attraverso acrobazie economiche, peripezie varie e considerevoli sacrifici, anche questa difficoltà – che sembrava oggettivamente un ostacolo insormontabile – fu superata: a volte il denaro non era sufficiente, allora si sopravviveva consumando un solo pasto al giorno ed un bicchiere di latte la sera. Pietro, al ritorno a casa, sembrava essersi sottoposto ad una cura dimagrante. Ma, quando tutto finisce in gloria, si dilegua o si rimuove il ricordo delle giornate amare del passato. In una delle tante permanenze a Napoli, Pietro ebbe come una illuminazione. Una voce interiore gli suggeriva ricorrentemente di recarsi presso la sede del Consolato americano di Napoli per sapere se ai figli di genitori, nati negli U.S.A., era riconosciuto qualche diritto. Una mattinata, si recò presso il Consolato, spiegò in portineria quel che voleva, fu pregato di attendere nella sala di attesa. Dopo circa un quarto d’ora, fu introdotto nell’ufficio dell’impiegato addetto, il quale gli spiegò che il figlio di persona, nata negli U.S.A. purché non avesse compiuto la maggiore età e fosse nato in Italia prima del 1940, aveva il diritto di chiedere ed ottenere la cittadinanza americana. In questa ipotesi rientrava egli stesso e due dei suoi fratelli, nati prima della dichiarazione di guerra, nel 1940, da padre che era nato a New-York nel 1898. 199 Almeno per due dei fratelli si apriva una grande ed inaspettata opportunità: avrebbero potuto ottenere la cittadinanza americana e subito il relativo passaporto. Non perdette tempo: compilò il formulario, che gli era stato dato rispondendo a tutte le domande, allegandovi anche la richiesta documentazione amministrativa; spedì il tutto con raccomandata al Consolato americano. La cosa l’aveva messo in allegria perché aveva trovato una soluzione per la sistemazione dei fratelli. Tutti a casa ne furono contenti. Particolarmente la madre. Aveva ragione la vecchia comare Maria che, nei giorni di lutto, la consolava e le diceva di non disperare: “il Signore è grande, se ti ha chiuso una porta, te ne aprirà altre sette, una per ognuno dei figliuoli. Essi cresceranno e tutti troveranno la loro strada”. Qualche mese dopo l’invio della raccomandata, pervenne la risposta del Consolato che assicurava che ai due fratelli era riconosciuto il diritto di cittadinanza ed erano, pertanto, invitati a presentarsi, alla data indicata, nell’apposito ufficio consolare per prestare il giuramento e per la consegna del passaporto. Finalmente ed improvvisamente, nell’arco di pochi mesi, si era aperta una prospettiva reale di cambiamento ed una via d’uscita di benessere. I due ragazzi, uno di quindici e l’altro di diciassette anni, non vedevano l’ora di partire per Brooklyn, dove li avrebbe momentaneamente ospitati la zia Giovanna, sorella della madre, emigrata col marito sin dal 1934. La sera prima del giorno, fissato per il giuramento, dalla stazione ferroviaria di Sibari, si prese il treno per Napoli per giungervi la mattina del giorno dopo. Tutta la notte durò il viaggio fra innumerevoli fermate e lo sbuffare della locomotiva. La mattina, si era finalmente a Napoli. Una lavata di faccia, un caffelatte e subito, di corsa, al Consolato americano in via Caracciolo. Il giorno dopo, Pietro ed i due fratelli, ormai diventati cittadini degli Stati Uniti con tanto di passaporto, rientrarono in paese. 200 8 Ma, adesso, dove trovare almeno cinquecentomila lire per pagare il viaggio negli Stai Uniti? Il sogno americano e tutto quello che era ad esso collegato dipendeva da tale somma di denaro, che la famiglia non possedeva né vi erano privati che potessero dargliela a mutuo. Tutto sembrava diventare nuovamente impossibile. Quest’ultima, enorme difficoltà a Pietro sembrava come un grande masso, caduto improvvisamente sulla strada da impedire il passaggio. Pietro, per più giorni, rimase disturbato assai e pensieroso. Al trasferimento in America dei due fratelli era legato il loro avvenire, ma anche un qualche sostegno economico alla famiglia, una volta che i due si fossero messi a lavorare. E, allora, che fare? L’unica possibilità era un mutuo bancario. Ma, poi, come lo avrebbero pagato? La banca voleva le garanzie, pigliava le ipoteche e, se non pagavi alla scadenza pattuita, ti vendeva la casa o il terreno. Come, in paese, era successo a tanti poveri diavoli. Vendere il piccolo podere non era prudente: se le cose non fossero andate per il verso giusto, sarebbero tutti rimasti proprio senza nulla, veramente poveri e nudi come uccelli. Tutte le ipotesi che Pietro passava in rassegna sembravano da scartare. E se riuscisse ad ottenere un mutuo personale? Non restava che provare. Un bel mattino si fece coraggio, tutto quel coraggio che uno può darsi a vent’anni, prese la corriera per Cora e si presentò al direttore della locale banca. Gli espose la nuda e cruda situazione della famiglia, privata del capofamiglia, composta da sette orfani, con scarse risorse. Due dei sette ragazzi avevano ottenuto la cittadinanza americana, ma non potevano partire perché non avevano il denaro per il viaggio. Occorreva la somma di cinquecentomila. Se si potesse avere un mutuo dalla banca, i due fratelli, una volta messisi a 201 lavorare, con la rimessa di poche centinaia di dollari, avrebbero fatto presto ad estinguere il debito. Si trattava di salvare due ragazzi. La banca, in ogni caso, non avrebbe dato il denaro a fondo perduto. Pietro stesso e la madre si impegnavano alla restituzione. Non erano proprio nullatenenti. Quel poco che avevano copriva abbondantemente il mutuo richiesto. Il direttore fece alcune domande, si informò sugli studi di Pietro. Non disse di sì, ma neanche di no. Gli occorreva un po’ di tempo per decidere. Evidentemente doveva consultarsi con i superiori. Comunque, gli assicurò che, massimo per la settimana prossima, l’avrebbe convocato con raccomandata. Pietro ringraziò, tornò a rinnovare al direttore la preghiera di fargli avere quel mutuo, che avrebbe salvato due giovani e sarebbe stato anche di grande aiuto per la famiglia in condizioni precarie. Pietro ritornò a casa con la corriera, nel primo pomeriggio. Era pensieroso e pieno di dubbi. Quel giorno non riuscì neppure a consumare il frugale pasto, preparato dalla madre sempre premurosa. La preoccupazione era forte assai e non dava spazio ad altri pensieri. Non riusciva a prendere libro. Eppure doveva studiare per gli esami universitari. E se il mutuo non fosse stato concesso, dove si sarebbe andato a sbattere? A quale altro stratagemma avrebbe potuto ricorrere? L’ansia gli faceva fumare molte sigarette come mai, prima, era avvenuto. Passò una settimana senza ricevere la lettera di convocazione del direttore della banca. Ma, all’inizio della nuova settimana, il postino recapita la lettera tanto attesa. Senza porre tempo in mezzo, Pietro si precipitò nell’Istituto di credito. Il direttore, persona sui sessant’anni, poco incline ai complimenti, lo fece entrare nel suo ufficio e gli disse: “Caro ragazzo, la sincerità con la quale mi hai esposto la necessità per la tua famiglia di avere il mutuo, mi ha convinto a concederlo. Ne ho informato anche la direzione, che mi ha anche autorizzato. Non farmi fare brutta figura con i superiori. Faccio soprattutto affidamento su di te per la restituzione della somma”. Qualche giorno dopo, fu conclusa l’operazione bancaria. Finalmente, arrivò il giorno per la partenza per gli Stati Uniti, fissato verso la fine del mese di settembre, dal porto di Napoli, col piroscafo Conte Biancamano. 202 La madre, per tempo, preparò gli effetti personali dei ragazzi, predisponendo due capienti valigie, i doni per i parenti che particolarmente gradivano salami, salsicce e soppressate, e formaggio, in quelle forme particolari, confezionate dalle nostre parti, che da lontano facevano sentire una inconfondibile fragranza. Alla vigilia della partenza, la casa si riempì di amici, conoscenti, parenti, che venivano a salutare i due fratelli. Innumerevoli abbracci si scambiavano e ricordavano fatti particolari e avvenimenti antichi e recenti. I più anziani ricordavano il povero padre dei due giovani, sfortunato da morire ancora giovane senza avere avuto la soddisfazione di vedere crescere i figliuoli. Ne esaltavano la bontà d’animo, la capacità di lavoro, il suo passato d’emigrante in Argentina, prima, e negli Stati Uniti, dov’era nato, dopo. Ma prim’ancora, quasi ragazzo, aveva combattuto quella guerra dei contadini del 1914-18, uscendone indenne dall’inferno. Con enormi sacrifici, in tanti anni all’estero, aveva accumulato quei pochi risparmi, impiegati nell’acquisto di alcuni fondi rustici che gli avevano consentito di raggiungere una discreta posizione economica. Ed ora, i due figliuoli, ancora ragazzi, ripercorrevano il cammino del padre. «Ah, destino ingrato e amaro» concludeva il suo dire Cola Chidichimo, ch’era stato amico del padre, e imprecava contro quella “porca e cieca fortuna” che sembrava privilegiare solo certuni ed accanirsi contro molti altri. Il passato ed il presente si intrecciavano e si confondevano negli improvvisati discorsi dei convenuti tra i bicchieri di vino, dolci e taralli che la padrona di casa offriva in abbondanza per festeggiare la partenza dei figli; chi sa se fosse stata così fortunata da rivedere i figli, che andavano così lontano. All’apparenza sembrava partecipare alla festa, ma sapeva lei che pena grande aveva nel profondo del cuore. Il figlio grande ne seguiva i movimenti; con l’occhio della mente vedeva le lacrime invisibili che le solcavano quel volto, fatto aspro e glabro per le sofferenze morali. Vera mater dolorosa, costretta a fingere di essere allegra e di apparire gioiosa per non intristire l’imminente partenza dei figliuoli che – pensava – da soli e ancora ragazzi vanno incontro al loro destino in terre e popoli sconosciuti, chissà a quali difficoltà andavano incontro, se la203 crime o gioia avrebbero conosciuto nella lontana America, per lei irraggiungibile. In questi casi, a mezzanotte, la festa finiva con un canto a più voci, intonato da chi partiva e dagli amici. Di solito era un canto d’addio al paese o alla fidanzata o anche a tutt’e due. Così avvenne che gli amici dei partenti e questi stessi, usciti alla loggetta della casa, improvvisarono, nella parlata locale, un commosso canto d’addìo: Rri mire, vasheze, rri mire nde det vete menat, Ka zemra jote nxirme; Mbi detit tek rri e strati tek fie, T’e thashe kete primavere kem te le. Oi bukuri katund ce je me se hena, Sat te godirnja u se dishe furtuna (Addio, ragazza, addio, domani andrò per mare, toglimi dal tuo cuore; ma dal mare e dal letto dove dormo, ti ho detto che in primavera ti doveva lasciare. Oh, mio paese bello, più bello della luna, la fortuna non ha voluto che io ti godessi). Era l’addio alla ragazza, ma soprattutto l’addio al paesello, al quale – nel bene e nel male – si sentivano legati e dal quale una sorte avversa li staccava. Il canto notturno, struggente di malinconia, si disperse per i vicoli ed i vicinati, lasciando un segno di commozione per i due giovani che l’indomani, di presta mattina, si sarebbero apprestati ad andare per mare. Arrivarono a Napoli nella mattinata. Si recarono alla compagnia di navigazione per la consegna dei documenti per l’imbarco. Il tempo di mandare giù un boccone ed alle 14,30 i tre fratelli si trovarono puntualmente nel porto di Napoli, nella zona dove, nella parte di mare antistante, era già ormeggiato il grande transatlantico Conte Biancamano. Trovarono la folla degli emigranti e dei loro accompagnatori che avevano preso posto nelle panchine con i voluminosi bagagli. Altri ancora venivano e la folla si faceva più fitta. Erano emigranti del suditalia ed, in genere, di tutte le regioni meri204 dionali, ma soprattutto giovani: un vero popolo in cammino alla ricerca disperata di pane e lavoro. Scappavano dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Molise e dalla Basilicata, lasciavano le loro case, magari i loro vecchi, i loro affetti, per andare nella America – tante volta sognata – dove, magari aiutati da amici, parenti, conoscenti, pensavano o speravano di trovare un lavoro ed un pezzo di pane, come dalla fine dell’Ottocento avevano fatto i loro antenati, affrontando un viaggio per mare veramente pieno di brividi e di paure. Si era sempre partiti o, meglio, costretti a partire dal Sud per spargersi in tutte le patrie del mondo Ora, Pietro ed i suoi fratelli, assiepati insieme alle altre centinaia di emigranti, attendevano di essere chiamati per l’imbarco. E venne anche il loro momento. I tre si salutarono e abbracciarono in un lungo abbraccio collettivo come mai avevano fatto. Erano profondamente commossi. Il più piccolo – mentre s’allontanava per entrare nella nave seguendo il fratello – scoppiò in un pianto dirotto. Il fratello più grande, più coraggioso e più consapevole, quasi a rimproverarlo, gli disse di affrettarsi e di smetterla dal piangere: «Non stiamo andando a morire ed alla mercé della fortuna. Noi siamo cittadini americani e tenteremo di farci un avvenire. Se le cose non dovessero andare bene, ritorneremo in Italia.» I due fratelli entrarono, dunque, nel grande transatlantico, disperdendosi nella folla. Pietro non li vide più o, meglio, non riuscì a distinguerli. Quando la nave incominciò a muoversi, a Pietro sembrò di riconoscerli in mezzo a quanti, dalla nave, salutavano parenti o amici agitando le braccia o dei fazzoletti. La nave impiegò poco tempo per allontanarsi dal porto. Pietro rimase solo, come di pietra, a guardarla fino a quando non la vide sparire completamente dall’orizzonte. Improvvisamente, due lacrime gli rigarono il volto e gli scesero nelle guance. Gli si appannarono gli occhiali. Avvertì un improvviso venir meno delle forze e fece in tempo a sedersi su di una panchina. Il tempo necessario di riprendersi e di riannodare il filo dei suoi pensieri. Un’ora dopo, s’avviò a piedi verso la ferrovia: tanto per sgranchirsi un po’ e per distrarsi. Più tardi, prese il treno per il ritorno a casa. Per tutta la notte – contrariamente a quel che 205 avveniva nei tanti viaggi di ritorno dall’Università – non riuscì a prendere sonno. Era ancora troppo agitato. Aveva nascosto alla madre ed ai fratelli il suo stress per evitare di introdurre motivi di turbamento nella famiglia, ma ora che i fratelli erano per mare, tutta la sua tensione nervosa era caduta e non riusciva più a contenerla. Egli si era assunto una grave responsabilità morale, mandando in America i due fratelli ancora minorenni. Ma che cosa avrebbe potuto fare? Certamente non poteva trascurare – egli che era il fratello maggiore – di fare tutto il possibile per tutti i suoi fratelli. Per i due, ai quali aveva fatto riconoscere la cittadinanza americana, riteneva di avere operato bene e nel loro interesse. Per tutti gli altri, la questione sarebbe stata affrontata in seguito. Nonostante che non doveva rimproverarsi di alcuna colpa, l’angoscia lo tormentava ogni volta che lo prendeva il pensiero di una eventuale non riuscita dei fratelli. Egli assumeva su di sé, invero irrazionalmente, tale eventualità. Allora, solo con i suoi pensieri, rivedeva e passava in rassegna tutte le immagini di un passato prossimo. Si rivedeva, nella valle, con i suoi fratelli rincorrersi lungo gli alberi da frutta o andare alla ricerca di nidi sotto lo sguardo benevolo del padre, che ivi aveva buttato sudori nello spaccare il terreno per trasformarlo in produttivo oppure mentre attraversano – padre e figli – il Mezofato che, d’inverno, si trasformava in fiumara insidiosa. Il pensiero ritornava alla casa paterna, con le foto ingiallite degli antenati che, ora, era diventata come un nido, riempito dal calore materno, ma mancante di due uccellini. Passarono i giorni e, finalmente, arrivò una cartolina da Lisbona con i saluti e l’assicurazione che tutto “andava bene”. Ai primi di ottobre, finalmente, sbarcarono a New-York, attesi nel porto dalla zia e dai cugini. L’impatto col nuovo mondo non fu traumatico; la compagnia dei cugini li aiutò ad inserirsi e ad ambientarsi, ad apprendere la lingua e a trovare, quasi immediatamente, un lavoro. Mese per mese, inviarono quei dollari necessari che servirono a Pietro a onorare con la banca il debito contratto. Nel frattempo, anche Pietro si laureava. Finalmente si respirava. La scommessa era stata vinta. 206 9 A Matermara, per il 19, era fissata la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Per il passato era stata sempre una pura e semplice formalità. Nel periodo della monarchia e dei liberali, gli elettori erano soltanto i galantuomini e che si sceglievano, quindi, tra di loro. Si succedevano nella maggioranza e lasciavano l’opposizione ad un altro galantuomo che, di solito, veniva emarginato perché, per ragioni varie, con lui non correva buon sangue: era ritenuto un intruso in quel ceto. Ma era fatto sempre della stessa pasta di proprietario terriero nullafacente che – come gli altri suoi simili – passava il tempo bighellonando, giocando a carte, e insidiando qualche bella contadinotta, quando gli si presentava l’occasione. Per tutta la durata del Regno d’Italia non è successo niente a Matermara, salvo il naturale passaggio di generazioni. I signori rimasero sempre signori e i contadini rimasero sempre attaccati alla terra dei signori fino a quando, verso il 1880, non incominciarono le emigrazioni oltreoceano che portarono masse di contadini, compresi non pochi di Matermara, a lavorare e buttare il sangue per altri signori delle Americhe, del Sud e del Nord. Però, il paese rimase sempre lo stesso, anzi diminuì di popolazione a causa della emigrazione. I ceti sociali restarono sempre gli stessi: il popolino di contadini e braccianti, da una parte, e qualche decina di galantuomini, dall’altra, proprietari di buona parte dei terreni fertili, che, in difesa della loro posizione sociale ed economica, si erano sempre schierati col potere governativo indifferentemente. Fino all’immediato secondo dopoguerra, almeno fino al 1950, i galantuomini, in Calabria e nel Mezzogiorno in genere, posse- 207 devano quasi la totalità dei terreni, la cui proprietà il più delle volte era frutto di rapina. Ora, considerando che buona parte della popolazione calabrese, era costretta a vivere – o, meglio, a sopravvivere – di agricoltura, si spiega il fatto che, col mutamento delle condizioni storico-politiche, dopo il fascismo, inevitabilmente, il contenuto essenziale del confronto politico e del vero e proprio scontro di classe doveva riguardare il possesso delle terre. La riforma agraria diventava inevitabile, quando, dalla fine degli anni ‘40 del secolo scorso, enormi masse di contadini si sollevarono con l’obiettivo immediato di “pane e lavoro”. A quel punto, anche rappresentanti responsabili del potere politico centrale, furono costretti ad avvertire gli agrari calabresi di non dimenticare le origini delle loro proprietà. Nel suo piccolo la situazione sociale e politica di Matermara non faceva che rispecchiare quella generale del Mezzogiorno italiano. Anche nel Consiglio Comunale erano rispecchiate le due anime politiche del paese: comunisti e socialisti, sempre all’opposizione, espressione delle masse popolari; galantuomini che detenevano saldamente la maggioranza e che costituivano il tradizionale blocco agrario clerico-conservatore, in parte ancora d’ispirazione fascista. La Chiesa, impersonata dall’anziano don Antonio Argondizza, che aveva per moglie la previtera donna Maria Pisarra, ufficialmente era schierata – salvo singoli credenti – in difesa del vecchio per la paura dei comunisti e dei socialisti, i quali, nella realtà, erano gli unici a frequentare la chiesa nelle domeniche e nelle altre festività. I galantuomini non frequentavano la chiesa neppure nelle feste comandate. La religione viveva nel popolo. Era la chiesa ufficiale che non se ne accorgeva o non se ne voleva accorgere e faceva finta di niente. Quando lo stesso vescovo andava in visita al paese, veniva invitato a pranzo dai signori. Non andava a trovare i numerosi poveri che tiravano alla men peggio e vivevano ammassati nei catòi, nei tuguri. Questa contraddizione oggettiva tra la chiesa ufficiale ed il popolo dei lavoratori era naturalmente destinata a scoppiare, con lacerazioni e scontri, in un non lontano avvenire, non appena, cioè, l’avrebbero reso pos- 208 sibile e attuale, le condizioni storiche e lo sviluppo della dialettica politica. Anche dopo la seconda guerra mondiale sembrava che, a Matermara, nulla dovesse mutare nell’assetto politico e amministrativo. Un gruppo di cosiddetti galantuomini, decisamente avverso ad ogni e qualsiasi apertura, teneva ben strette nelle sue mani le chiavi del Comune e stavano bene attenti a non farsele sfuggire. Si seppe, poi, che in certi registri comunali, dov’erano annotate le terre pubbliche, mancavano molte pagine. Era questo ristretto gruppo di persone che, molte volte, non si esponeva direttamente, ma di fatto, attraverso l’interposizione di asserviti, determinava il corso della vita locale e della miserevole conduzione amministrativa. Che la cosa funzionasse in questo modo lo si toccava con mano in certi particolari momenti. Quando, per esempio, c’era da prendere una qualche decisione o assumere una determinata deliberazione nel Consiglio Comunale, in contrasto con l’interesse o il volere di lor signori, accadeva che i consiglieri comunali di maggioranza, uno alla volta, venivano convocati dal galantuomo nella sua casa, immediatamente prima che si tenesse la seduta consiliare per essere adeguatamente indirizzati nel modo di esprimere il voto. Inevitabilmente, il voto era dettato da uno o più dei “don” del paese. E se qualcuno voleva resistere? Ci lasciava le penne e qualcos’altro. Com’era accaduto al segretario del partito, sostenuto dal blocco moderato, che aveva dovuto amaramente constatare che i consiglieri espressi da quel partito, lo avevano clamorosamente sconfessato. Il potere vero stava, in effetti, altrove, nel blocco moderato e non in chi apparentemente lo rappresentava, ma non contava nulla. Questo lo avevano ben capito dei giovani cattolici, che o non militavano nel partito ufficiale o ne costituivano una esigua minoranza, messa a tacere perché si trattava di “comunistelli di sacrestia”. Essi avevano ormai maturato la consapevolezza che bisognava rompere con quel blocco clerico-conservatore e collegarsi alle forze vive del paese. Per intanto, attendevano l’occasione propizia. 209 Quando mancavano ancora dei mesi dalle elezioni, si aveva la sensazione netta – e tutti l’avvertivano, chi più chi meno – che, questa volta, le cose sarebbero cambiate. Pietro s’era laureato vincendo tutte le avversità economiche. Intorno a lui, s’era formato un gruppo di giovani studenti e non che manifestava scontentezza per il presente ed una vaga aspirazione al nuovo. Né mancava chi apertamente sollecitava questi giovani a prendere in mano il Comune. Don Beniamino Strigari, l’anziano e scapolo avvocato che, da Venezia, immancabilmente ogni primavera passava qualche mese in paese, amava intrattenersi e passeggiare con quei giovani; li invogliava a fare qualcosa, ad impegnarsi per fare tutte quelle opere di civiltà che, nel territorio comunale mancavano: l’acquedotto, le fognature, le strade, l’edificio scolastico, la pubblica illuminazione, la cui carenza rendeva veramente disagevole il viverci. «Non vi rendete conto» diceva l’avvocato «che qui c’è l’Africa? Come potete permettere e sopportare tali condizioni di arretratezza e di inciviltà che si riflettono inevitabilmente in modo negativo nella vita reale di ogni giorno? Il futuro è nelle vostre mani» continuava l’avvocato «e dovete voi farvene carico. Non aspettate la manna dal cielo, come si è sempre fatto per il passato.» Questa lezione civile, ardita e forte, che era ricorrente nelle lunghe passeggiate, che si facevano in compagnia dell’avvocato per i viottoli e le stradelle di campagna, cadeva in un terreno fertile. Quei giovani, in effetti, pensavano la stessa cosa ed erano abbastanza acculturati; essi avevano letto – sia pure confusamente, un po’ di Gramsci, di Gobetti, Salvemini, Sturzo, ma soprattutto il “Cristo” di Carlo Levi, acquisendo quel minimo di consapevolezza che era necessario ormai rimuovere i residui di un passato che ancora tardava a scomparire, rappresentato da quel blocco di potere che sembrava inossidabile. Tra quei giovani vi erano anche iscritti e dirigenti della Camera del Lavoro. Vi era tra di loro comunione di cultura e di idee, se non proprio di appartenenza politica. Anche se erano ancora in fase di formazione culturale, tutti avvertivano la puzza insopportabile di un passato morto e l’ingiustizia del presente, che occorreva porre definitivamente tra parentesi. 210 Stranamente, questa volta, ancora molto in anticipo dalla data delle elezioni, i numerosi servitori dei galantuomini erano tutti già mobilitati. Ma i più solerti, intraprendenti e spregiudicati erano Marcello Valacca e la moglie Nescia Diavoliza, che non trascuravano famiglia, vicinato, bottega artigiana, i residenti delle contrada, andavano ovunque e mettevano il paese sottosopra, raccomandando di votare bene, di lasciare stare le chiacchiere di ragazzi, che ancora non erano maturi e non sapevano quel che dicevano. Non si potrebbe mai pensare che quattro ragazzi, senza appoggi in alto, accompagnati da qualche smidollato, possano valere più di don Cosimino, che ha tante conoscenze a Cosenza ed a lui si aprono tutte le porte della prefettura, di onorevoli e di ministri. Era veramente uno spasso sentire quei discorsi. Ma nel popolino ed in certi esponenti del ceto medio albergava ancora una sorta di preoccupazione e di paura per la presunta potenza dei signori, che li tratteneva a non prendere posizione ed a rifugiarsi nel proprio io; se ne scusavano ricorrendo al vecchio e comodo proverbio calabrese: “chiamo padre chi mi dà da mangiare”. Prima avveniva che i galantuomini convocavano nelle loro case o nel Circolo, per mezzo del servitorame, le persone che volevano candidare nella lisa della “croce”, la cui vittoria era assicurata da uno scarto considerevole di voti da tutte le altre liste. Ora, se assai per tempo, i galantuomini s’erano messi in movimento ed avevano sguinzagliato i loro servitori più fedeli, più zelanti e più affidabili, voleva pure dire qualcosa. Avevano sicuramente capito che il clima stava cambiando e, dunque, subodoravano che potesse accadere l’irreparabile, ciò che non era mai accaduto e non doveva accadere. «Mai e poi mai» gridava la previtera donna Maria Pisarra, moglie del parroco di rito greco, «la bandiera rossa al Comune.» Ma quei giovani che si accompagnavano a Pietro e che parlavano una lingua sconosciuta ai galantuomini, di solito ignoranti e solo capaci di aumentare il loro scrigno, e con loro si accodavano quelli pericolosissimi della Camera del Lavoro, erano non solo inavvicinabili, ma costituivano un pericolo reale. Sempre a frequentare la Camera del Lavoro, familiarizzavano col popolino, trattavano alla pari quei quattro pezzenti; an211 dava a finire che ne avrebbero sposato la causa. E, allora, la frittata era bell’e fatta. Senza l’apporto del ceto medio dei piccoli proprietari, i galantuomini non potevano vincere. Era questo ceto medio di piccoli proprietari che si sentiva tradizionalmente attratto dai galantuomini e tendeva piuttosto ad imitarli. Ed era con esso che i galantuomini avevano avuto sempre quella alleanza che, nel suo insieme, costituiva il blocco conservatore, un blocco sociale di classe, che racchiudeva tutti i clerico-reazionari, fascisti compresi, che avevano all’evidenza l’interesse a stroncare ogni iniziativa che potesse costituire una minaccia all’ordine sociale costituito, che era stato costretto a subire un primo colpo con la legge sulla concessione delle terre incolte e con la conseguente formazione di un movimento che aveva un bersaglio preciso nel notabilato agrario parassitario. In passato, durante il ventennio fascista, erano riusciti a fare allontanare dal paese Don Teodosio che, ormai anziano e trasferitosi definitivamente a Roma, non costituiva più un pericolo di sovversione sociale. Ma ora, ognuno di quei giovani studenti, palesemente d’accordo in tutto con i giovani della Camera del Lavoro, con a capofila Damiano Cau, con in testa strane idee di rinnovamento a tutti i costi, occorreva fermare e neutralizzare: ognuno di loro, infatti, lasciato libero e non fermato per tempo con qualche marchingegno – come la paura di non potere avere un posto in avvenire – sarebbe stato in grado di turbare la quiete pubblica. Con simili ragionamenti, facendo balenare quella che, allora, era una minaccia reale e, cioè, di potere essere discriminati perché apparivano o erano socialisti o comunisti, ritenevano di bloccare le idealità della gioventù studiosa, che francamente se ne infischiava. Qualche rampollo del notabilato, più ingenuo, spiattellava la cosa, in modo assai rozzo, che in fondo rappresentava l’opinione vera di quei galantuomini, poveri di spirito e di cultura. Un giorno, in piazza, a Pietro che, discutendo con altri, sosteneva la necessità che il governo del Comune andasse alle forze politiche progressiste, uno di questi rampolli, più volte bocciato agli esami d’ammissione, glielo disse chiaro e tondo: «Non metterti contro di noi perché hai da perdere. Potresti sempre avere bisogno di noi e, allora, troverai le porte chiuse.» 212 Pietro, pur di natura riflessivo, reagì prontamente e fieramente: «Anche se dovessi avere un giorno bisogno, certamente non mi rivolgerei mai a voi. Ma ti dico e ricordati bene che, un domani, sarete voi ad avere bisogno di me. Io sono laureato, sarò un professionista, mentre sarete quelli che siete oggi, cioè, nessuno.» La lezione, terribile e spietata, fece il giro del paese, suscitando unanimi consensi e plauso per il modo in cui Pietro aveva reagito alla inutile provocazione. Da prima, attraverso il servitorame, i galantuomini tastarono l’umore del loro elettorato tradizionale per vedere come rispondeva. Dovettero registrare che, questa volta, era, però, possibile un fiasco. A quel punto ricorsero alle buone maniere, seguite da sottili minacce, nel tentativo di ricatturare il consenso, facevano intravedere futuri benefici e sicure e solide raccomandazioni con i potentati politici del momento per ottenere posti di lavoro nella provincia, presso l’Opera Sila ed altri enti del sottogoverno clientelare, che, di solito, servivano per sistemazioni di comodo di amici, parenti e clienti dei politici governativi. Non lasciarono nulla d’intentato lor signori: scomodarono tutte le amicizie che avevano, fuori del paese, per questa attività di convincimento e di recupero di quella parte del loro elettorato, che non ritenevano sicuro, del quale, insomma, non si potevano più fidare. Si videro girare per le vie del paese persone mai viste fino allora; si mossero dirigenti di importanti uffici pubblici, quegli uffici con cui i cittadini hanno più a che fare, il direttore della cassa mutua, del registro, delle imposte. Li si vedevano nel Circolo dei signori. La semplice loro presenza avrebbe dovuto servire per fare capire l’importanza e la potenza dei signori. Quello che, di solito, la sera girava per le case dei contadini era un dipendente dell’ente di Riforma agraria che faceva innumerevoli promesse di futuri favori. Fu tutto inutile. Non c’era nulla da fare: la ruota stava girando dall’altra parte. Le migliaia di promesse, le pressioni psicologiche, a volte insistenti, asfissianti ed astute, non avevano più valore. L’uso reiterato e l’abuso le avevano ridotte a carta straccia. 213 Erano le giovani generazioni, i nuovi elettori, maschi e femmine, che avevano rotto le catene del legame servile col blocco agrario, coinvolgendo anche le loro famiglie, che opponevano a tutti i persuasori un rifiuto reciso e deciso. Rimase proverbiale la risposta gelida e pepata che uno di quei giovani diede a Dimitri Floco, anziano servitore di don Muricchio Pisarra, che lo sollecitava a non perdere la benefica protezione del padrone, il quale gli poteva garantire e fare avere grosse raccomandazioni. «Tu sei così giovane, ancora devi trovarti una sistemazione: solo don Muricchio ti potrà essere di grande aiuto.» Il giovane gli diede una risposta che lo gelò, perché vera e fondata sulla constatazione di fatto: «Il tuo padrone non ha fatto nulla per te che, vecchio, ancora sei costretto a guadagnarti la giornata e per i tuoi figli disoccupati, che gironzolano per il paese tutto il giorno. Figuriamoci che potrebbe fare per me.» 214 10 Tali episodi, in sé magari insignificanti, avevano una rapida divulgazione nel piccolo mondo paesano. Erano oggetto di salaci conversazioni soprattutto nelle botteghe dei calzolai e dei sarti, che fungevano anche da piccoli circoli, ove si incontrava tutto l’inclito ambiente politico del paese. Di essi inevitabilmente si appropriavano gli scolastici del malo conversare, che pure abbondavano, che viepiù li divulgavano e li raccontavano nei locali pubblici e nei conversari dei vicinati, magari con l’aggiunta di altri elementi, con eventuali esagerazioni e osservazioni, condite di lazzi e frizzi, che contribuivano a ridicolizzare i padroni ed il loro servitorame. E, così, i paesani si divertivano alle spalle dei signori e dei loro guardaportoni, ma prendevano anche coraggio e rivelavano altri fatti accaduti, che mettevano in cattiva luce quei padroni che, una volta, lo stesso popolino era solito riverire e chiamare addirittura “Eccellenza”. «Eh, caro mio,» diceva don Cola Lopes al suo amico don Andrea Potta, nel Circolo dei galantuomini, «siamo caduti troppo in basso. Non c’è più rispetto per i superiori. Questi pezzenti non ti salutano più: sono diventati arroganti da quando quel poco di buono comunista, Fausto Gullo, ha fatto approvare quelle maledette leggi in loro favore. E penso, caro don Andrea, che ancora ne vedremo delle belle.» La china era veramente inarrestabile. La matassa si scioglieva gradualmente e ne veniva fuori il mosaico di piccole astuzie, ruberie, truffe e ricatti, che avevano caratterizzato e contraddistinto le relazioni tra contadini e padroni dei terreni. E non era veramente “il buon tempo antico” e quel mondo idilliaco, evocato da certuni non si sa se in buona o malafede. Ora, finalmente, si incominciò a svelare il segreto, su cui poggiava il po215 tere padronale e di tutti quei voti dati, ad ogni elezione, alla loro lista. Intere famiglie venivano ricattate e costrette a votare sotto la minaccia che, in caso contrario, lor signori non li avrebbero fatto lavorare nei loro poderi e nella raccolta delle olive e non gli avrebbero più versato quel minimo di contributi assistenziali e previdenziali. Il danno minacciato e, non rare volte, portato ad effetto, era grave assai; senza contributi neppure avrebbero potuto usufruire delle varie indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità, da parte dell’ente pubblico di presidenza ed assistenza. Che erano poca cosa – è vero – ma che alimentava l’economia di sopravvivenza di quelle famiglie e ne costituiva una fonte notevole di ricchezza. L’alternativa era veramente drammatica per chi, a Matermara, non aveva che le proprie braccia per lavorare e continuare a vivere una vita comunque di stenti. Non per nulla mastro Scanderbecco Stamato, assai preoccupato, chiedeva a Pietro, che predicava in piazza, una società libera e senza padroni: “ma, dimmi, come si può vivere senza padroni, che ci danno il lavoro”? E, nel proverbio popolare calabrese, il “senza padrone”, lo spaturnatu, era sinonimo di infelice, misero. I signori erano padroni di tutto: di buona parte dei terreni fertili e dei boschi, avevano grosse mandrie di ovini, caprini, suini e bovini, dei terreni irrigui, finanche dei mulini ad acqua, costruiti anticamente sulle rive dei fiumi, del Mezofato, del Sabatino e del Catenazzo. Erano anche medici, avvocati, giudici, oltre che sindaci e consiglieri provinciali e deputati. Un povero contadino, in ogni evenienza, non poteva che rivolgersi alla loro benevolenza. A voglia che, nei tribunali stava solennemente scritto che la “legge è uguale per tutti”. Era una bugia. Non v’era precetto borghese più maltrattato di questo. Se eri un galantuomo tutto ti era lecito; se, invece, eri un povero diavolo di contadino dovevi stare bene attento a dove poggiavi i piedi. Sembrava tutto lecito e legittimo contro il povero diavolo. Se, poi, costui era sospettato di essere un socialista, o un anarchico, insomma, un sovversivo, tutto era lecito contro di lui; tanto le leggi le avevano fatte e le amministravano lor signori. Se non ti chiamavano a lavorare, nulla potevi fare. Era meglio dare il voto e tenerseli buoni, i galantuomini. Dovevi emi216 grare, andare nella piana di Sibari, a fare il mandriano di porci, buttare il sangue per altri signori per, poi, crepare di malaria. Uno scapolo poteva preferire andare via dal paese e magari lavorare presso una masseria di Terranova o di Corigliano. Ma chi aveva moglie e figli, da sfamare e sostenere col quotidiano lavoro, ci pensava due volte prima di dire di no al servitore del signore, che gli imponeva come e per chi votare in tutte le consultazioni elettorali. Non solo in quelle comunali, nelle quali i signori erano direttamente interessati e badavano al mantenimento della loro egemonia ed alla conservazione del potere locale. Nelle altre elezioni curavano i rapporti e le relazioni con i potentati politici della provincia, veri e propri clans affamati, in linea di massima, con i singoli esponenti del potere governativo, ai quali procuravano migliaia e miglia di preferenze. A loro volta, in cambio, ne ricevevano i favori con la concessione di contributi, agevolazioni, raccomandazioni varie in tutte le occasioni, favoritismi sfacciati e particolari attraverso i consorzi ed altri enti pubblici. Era veramente come una catena di fango, che aveva alla sua base la moltitudine di contadini e braccianti, veri cristi in carne ed ossa, razza sventurata che, in genere, era prigioniera di quel sistema e non riusciva a staccarsene. Il signore rappresentava il politico nel mondo contadino ed interloquiva direttamente con i potenti del tempo, ricavandone notevoli benefici. Chi nulla riceveva era il bracciante o il contadino, che, viceversa, aveva tutto contro: il potere nei Comuni, la Chiesa, la forza pubblica. Sulla carta aveva tutti i diritti, ma solo sulla carta. Quando gruppi di braccianti e di contadini senza terra incominciarono, anche per protesta reclamando la riforma agraria, l’occupazione delle terre – che, per la maggior parte, erano terre pubbliche privatizzate – i carabinieri li arrestarono ed i giudici – ancora controllati dall’esecutivo – li condannarono considerandoli eversori delle pubbliche istituzioni. Neanche con lo stralcio di riforma agraria, fu riconosciuta la dignità del contadino di potere vivere una vita almeno decente. Poche tomolate di terra, assegnate al contadino, non erano sufficienti a garantirgli né il diritto al lavoro e neppure quello all’eguaglianza, che pure erano diritti che la Costituzione re217 pubblicana aveva solennemente sancito per tutti i cittadini. Per giustificare l’inadempienza fu inventata la favola – non vera, come in seguito fu dimostrato – che quelle norme costituzionali erano affermazioni generali, per la cui attuazione occorreva una ulteriore legge. Va detto, inoltre, che i centri di riforma erano diventati strumenti del partito al potere, la cui pressione diventava ossessiva particolarmente in periodo elettorale. In tale contesto, pur operando in un ambiente di difficoltà oggettiva, dovuta alla generale arretratezza, quel gruppo di giovani, a Matermara, era riuscito ad accendere un lumicino. Inizialmente, nessuno sembrò accorgersi; pochi altri se ne accorsero nell’immediato, ma che, anche per effetto di alcune fortunate circostanze, giorno dopo giorno, un po’ alla volta, con pazienza e costanza, andava ingrandendosi fino a diventare un sole, destinato a determinare – e per sempre – la caduta della supremazia di lor signori. Era come se il grande fiume della storia stesse per attraversare anche queste regioni e località periferiche, travolgendole e determinandone un diverso assetto e mutamento nei rapporti sociali e nelle relazioni intersubbiettive tradizionali. Questa grande fiume non si poteva fermare. Bisognava soltanto prenderne atto e seguirne il corso, facendo ognuno la sua parte. Quanto al resto, all’esito finale e definitivo era fuori dalle nostre previsioni e dal nostro potere. Iniziò all’interno dello stesso blocco conservatore tradizionale la crisi che lo travolse. Veniva indicato candidato alla carica di sindaco don Giorgino, il giovane rampollo di don Bartolo Brunetta e donna Mariantonia Dramisa. Fino ad allora, questa era stata la prassi tradizionale: colui che veniva designato alla carica era stato automaticamente sempre da tutti accettato senza veruna contestazione. Questa volta non fu così. Pasqualino ed altri giovani insorsero per contestare il preteso diritto di un gruppo ristretto di persone di imporre alla maggioranza e, quindi, all’intera popolazione l’elezione del designato, escludendone altri con una evidente ed inammissibile discriminazione. Le riunioni si susseguivano, ma quei giovani tenevano duro, sostenendo apertamente che occorreva un radicale mutamento; che i tempi erano maturi per sostituire tutta la vecchia gerarchia e la vecchia politica. Un partito, che proclamava di ri218 chiamarsi alle sue origini popolari, avrebbe dovuto essere conseguente e favorire il ricambio ed il pluralismo. La questione, che suscitava infuocati dibattiti, si protraeva senza trovare una qualche soluzione. I tempi, intanto, stringevano: bisognava compilare la lista dei candidati, che comunque non si poteva fare senza che si fosse raggiunto l’accordo sul nome della persona, che doveva essere sindaco e che, quindi, la doveva capeggiare come capolista. E qui stava il principio di contraddizione. Nel fatto irresolubile, come inequivocabilmente dimostrarono le successive evenienze. Perché non si trattava di semplice contrarietà verso una persona, per antipatia o per pregressa inimicizia, ma di un contrasto sociale, di una contrapposizione oggettiva tra interessi ed idealità contrastanti. E quei giovani, sostenuti anche dalle loro famiglie e dalla pubblica opinione, avevano sollevato la questione rendendosi ben conto di interpretare e di rappresentare la volontà ferma e decisa della parte, che si faceva carico del rinnovamento e, quindi, del superamento del governo paternalistico di lor signori. Avevano ben capito che si giocava la partita decisiva tra il nuovo che avanzava impetuosamente ed il vecchio, ancora fermo a concezioni e rapporti sociali inadeguati ai tempi. E ciò aveva scatenato la rabbiosa reazione di una dirigenza anchilosata, non più rappresentativa, che era ovviamente restìa a lasciare i privilegi goduti e niente affatto rassegnata a mettersi da parte, dando lo spazio dovuto alle nuove generazioni, naturalmente portatrici di altri ideali, ispirati al moderno vivere civile; in una parola, alla Costituzione, vera bestia nera di tutti i conservatori, quali che fossero i loro ideali, perché ritenuta espressione della odiata sinistra, comunisti e socialisti. D’altra parte, per le aspettative di rinnovamento e per le rinate speranze suscitate nell’opinione pubblica, l’iniziale modesto gruppo di rinnovatori si veniva allargando ed ingrossando, conquistando il consenso – da prima tacito e, poi, esplicito – di numerose famiglie di piccoli proprietari e di numerosi artigiani. Ovviamente, il gruppo dei rinnovatori aveva un naturale e spontaneo alleato nei giovani della Camera del Lavoro perché, insieme, superando le ristrettezze o la settarietà delle appartenenze politiche, avrebbero potuto, finalmente, dare corpo nel 219 paese a quel blocco sociale unitario di braccianti, intellettuali, piccoli proprietari e artigiani, che, di fatto, costituivano la stragrande maggioranza della popolazione, ma, solo per la loro divisione, venivano sempre sconfitti. Solo la consapevolezza della unità e della sua urgenza e necessità, avrebbe potuto portare ad una lista unitaria – come mai era avvenuto nel passato – risultato certamente eclatante ed altamente positivo, se non rivoluzionario nello stesso territorio regionale. Metodo nuovo per affrontare e risolvere i piccoli e grandi problemi di un paese, ma che evidenziava anche che, ove ci fosse disponibilità e buona volontà di andare in tale direzione, anche in Calabria c’erano le forze e le intelligenze per un rinnovamento reale. Quando ormai la corda stava per spezzarsi, i dirigenti del partito conservatore avevano la sensazione netta di essere isolati nell’opinione pubblica; sembrava che avevano perduto tutti gli amici d’un tempo, i quali non partecipavano più alle riunioni, non si facevano vedere nel Circolo. Tutti – come se l’avessero concordato – conservavano il più rigoroso silenzio. «Ma perché non partecipi più alle riunioni? Prima eri sempre presente ed ora che c’è bisogno di una persona come te per pacificare gli animi, non ti fai vedere?» chiedeva don Martino Belluccio a don Giulio Cumano. «Ma non vedi in che garbuglio ci siamo messi?» rispondeva quest’ultimo, con un certo fastidio, aggiungendo: «È difficile uscirne perché non è più in ballo questa o quella persona, ma uno scontro tra noi e loro. Finirà che una delle parti dovrà cedere; altrimenti, le cose peggioreranno. Non me la sento di intervenire perché avverto un grande disagio. L’altra parte forse esagererà un poco, però, noi non possiamo chiuderci nel nostro egoismo, rischiando una botta tremenda, dalla quale sarà assai difficile risollevarci.» Don Martino restò senza parole e pensieroso. Nel suo intimo, pensò – ma non lo espresse – che don Giulio ormai pendeva dall’altra parte. La dirigenza dei conservatori sollecitò la direzione provinciale di intervenire per fare un estremo tentativo di conciliazione. Una sera del mese di settembre fu convocata l’assemblea con la presenza di un pezzo grosso della provincia. Questi era una specie di fanfarone, borioso e saccente, conosciuto per le sue qualità di intrallazzatore. La sua presenza, in quel momen220 to ed in quella assemblea, era la meno indicata. Anzi, essa di per sé suscitava aperta antipatia perché la si riteneva pregiudizialmente contraria ai rinnovatori. La discussione fu lunga, animata ed aspra. Volarono anche parole grosse, insulti e roba del genere. Quando, l’inviato dell’organismo provinciale ribadì di condividere la validità della candidatura di don Giorgino, l’assemblea finì con lo sciogliersi tra tumulti e tafferugli. Il dirigente politico provinciale, ridicolizzato, tra fischi ed urla, se ne tornò a Cosenza senza averci raccapezzato nulla o, piuttosto, non aveva voluto capire nulla. Eppure non era difficile capire che non si trattava di rivalità personali, di beghe paesane o di scontro tra grandi uomini del villaggio, perché la materia del contendere appariva con tutta la sua evidenza. La questione era di principio, di modi opposti di porsi davanti alla soluzione dei problemi e degli interessi generali e collettivi. I fatti personali, le invidiuzze e le meschine ambizioni sbagliate, alla fine, trovano e si risolvono anche con compromessi rattoppati. Le questioni di principio no: esse portano direttamente alla scissione se ad esse non si concede uno sfogo ragionevole e serio. Il blocco sociale della paesana conservazione, già pieno di interne lacerazioni, non avendo né uniformità di interessi e con idealità trapassate, si sarebbe dissolto da tempo se non avesse trovato collocazione e buono stare all’interno del cosiddetto partito cattolico, ivi trovando protettori e collegamenti. In altre parole, il notabilato agrario parassitario calabrese e meridionale, compresi alcuni stracci umani residuati del fascismo, riuscirono a sopravvivere, trovando spazio – con il pretesto dell’anticomunismo – nel partito cattolico, ricostituendo con leggere modificazioni, al servizio dei potentati politici dell’epoca, le vecchie stratificazioni clientelari, facendogli perdere, di fatto, l’originaria ispirazione rinnovatrice. Questa e nient’altro era il motore che aveva fatto nascere, spingeva ed alimentava quel gruppo di giovani idealisti, che l’avevano resa popolare nel paese. Il partito dei signori era il vecchio, il passato. Non aveva più avvenire. Proprio perché erano giovani e colti, erano anche idealisti e, a loro modo, rivoluzionari. Se tale indirizzo fosse stato seguito nel Mezzogiorno, non avrebbero avuto spazio le clientele consolidate, la pubblica 221 amministrazione non sarebbe stata ridotta a pascolo delle correnti politiche, non si sarebbe creata la ragnatela degli interessi illeciti, della corruzione e dei collegamenti con le organizzazioni delittuose. Naturalmente, una formazione politica, quale che ne sia la sua ispirazione, se non riconosce nei fatti e non agevola la formazione spontanea di gruppi sociali, finisce col diventare una pura e semplice oligarchia ed anche se periodicamente si sottopone al giudizio elettorale, non fa che riprodurre se stessa, bloccando, già sul nascere, ogni possibilità di rinnovamento democratico. Quel nostro gruppo di giovani idealisti e disinteressati fu – è vero – un fatto isolato, una sorta di profezia politica, che rivelava, però, ciò che veramente ribolliva nelle viscere della società civile dell’epoca, della quale essi si resero interpreti e della cui innegabile rilevanza generale, oltre il confine del piccolo Comune, non ne ebbero consapevolezza le dirigenze politiche del momento. Le clientele politiche precostituite, invece, mortificavano la libertà della formazione di gruppi e di movimenti politici al loro interno, che, invece, avrebbero dovuto incoraggiare ed alimentare perché era da essi che avrebbe dovuto nascere un nuovo gruppo dirigente e, per conseguenza, il ricambio generazionale negli organismi con ovvie ripercussioni positive nel rinnovamento delle rappresentanze. Solo così sarebbe stato garantito che queste ultime non si riducessero a rappresentanze oligarchiche in danno, com’è ovvio, della democrazia reale. Quei giovani, nonostante le avversità incontrate e le tante trappole tese, si spendevano per i loro ideali con intelligenza, passione e disinteresse; seppero, così, collegarsi con quella realtà viva che non aspettava che di essere espressa e rappresentata. 222 11 Al tempo degli avvenimenti qui narrati, Matermara è uno di quei paesini calabresi, nella lingua locale detto katund, posto tra boschi e valli della zona presilana, il cui territorio si estende fino alla pianura, quasi a lambire la piana di Sibari, coltivato prevalentemente ad oliveto, vigneto e ficheto, per la più parte ripartito fra una decina di grandi famiglie, che non hanno ascendenze nobiliari, ma se le sono create soprattutto nel corso del secolo XVIII fabbricando carte false. Il resto della popolazione vive – una piccola parte – lavorando i propri terreni, estesi ognuno, sì e no, fino a tre o quattro ettari. È faticosa e laboriosa la vita di questi piccoli proprietari: partono, la mattina, di notte, con l’asino o col cavallo o col mulo, e vanno a lavorare i propri terreni per fare ritorno a casa a qualche ora di notte. La restante parte della popolazione è di braccianti, che per la gran parte lavoravano, per poche giornate all’anno, molte volte senza il versamento di alcun contributo previdenziale, le terre dei signori, se andavano d’accordo con i loro guardiani. Altrimenti dovevano andare a cercarsi, per sbarcare il lunario, una qualche occupazione come giornalieri, guardiani di porci e di vacche, nella grande pianura, infestata dalla malaria. Dormivano nei pagliai o nelle stalle, a fianco agli animali ed ogni quindicina tornavano a casa. I pochi artigiani – che si potevano contare sulla punta delle dita – tiravano a campare arrangiandosi come potevano; di solito, le loro prestazioni erano compensate col baratto: per esempio, un’annata col barbiere, tanti litri d’olio; col sarto, tanti tomoli di grano; col calzolaio altrettanto, come anche col fabbro-ferraro. 223 Quella della donna del popolo era la condizione più pesante, quasi a livello della schiavitù. Addetta, oltre che alla custodia della casa, provvede, facendo più d’un viaggio al giorno dalla casa alle due fontanine – distanti qualche chilometro dall’abitato – alla provvista dell’acqua, perché il paese non è provvisto di acquedotto; a lavare i panni nel torrente che costeggia il paese; a fare il pane nel forno di casa o in quello della vicina; all’allevamento del maiale; alla raccolta della legna e della frasca, che servono per il fuoco e per cucinare; ad accudire i figli, di solito, numerosi, cucendone o rammendandone i vestiti, curando la loro igiene. Sicché una povera donna, quand’è ancora sui trent’anni, sembra una vecchia. D’inverno, nel periodo da ottobre a marzo, la donna del popolo provvede alla raccolta delle olive nei vasti oliveti dei signori “a quinto” e, nella migliore delle ipotesi, “a quarto”, cioè, ricevendo un compenso in natura pari ad un quinto o ad un quarto del prodotto raccolto nella giornata. Proprio una miseria, se si tiene conto che, oltre che alla raccolta, era obbligata al trasporto del frutto raccolto in giornata al frantoio del signore, che la donna eseguiva caricandolo sulle sue spalle. Fatica veramente inumana, da schiavi, aggravata dal fatto che non v’erano strade rurali, ma viottoli pedonali, ripidi e tortuosi, su terreni argillosi che, particolarmente nei periodi di pioggia, rendevano un’avventura, già lo stesso passaggio a piedi. Il paese era, di fatto, isolato: servito da una sola stradina provinciale, costruita verso la fine dell’Ottocento, era ormai come una mulattiera, piena di buche che, dalla pianura, si inerpicava, attraverso una serie di curve pericolose, verso la collina perseguendo, fino ad un certo punto, fino alla montagna, ai cui piedi terminava, dopo un percorso faticoso, pieno di brividi e di paure, una volta regno tranquillo di bande di briganti. Non v’erano fognature né edificio scolastico per le scuole elementari e neppure un qualche rudimentale acquedotto. Le donne facevano i loro bisogni fisiologici nei càntari che svuotavano, di notte, scaricandone gli escrementi lungo certe strade – anche centrali, dette brigne – . E da qui, a volte improvvisamente, un lezzo esalava e si espandeva, particolarmente 224 d’estate, anche verso la piazza costringendo la gente ad allontanarsi. Gli uomini svuotavano la pancia all’aria aperta, col vento e con la pioggia, inoltrandosi in un boschetto di querce, di cisti e di ginestre, fuori dall’abitato o dietro la chiesa, riparandosi sotto l’albero. Le scuole erano ubicate in locali adattati, naturalmente senza bagni e senza acqua e senza riscaldamento. Non erano, però, frequentate da tutti i ragazzi obbligati perché, per le necessità famigliari, alcuni venivano “messi sotto padrone” in cambio di un misero gruzzoletto de denaro, alla fine del mese, destinati come garzoni alle dipendenze dei massari; altri al servizio dei signori, adibiti ai servizi domestici ed all’approvvigionamento dell’acqua potabile che, a spalle, trasportavano con orciuoli dalle fontanine pubbliche. È una misera umanità, costituita da due gruppi contrapposti, ma che si odiano e si disprezzano vicendevolmente, anche se tali sentimenti non sempre appaiono e sono, per lo più, tenuti segreti. Da una parte, contadini, piccoli e medi proprietari e braccianti nullatenenti e artigiani; dall’altra, i signori della borghesia rurale, orgogliosi e gelosi custodi dei terreni, pervenuti loro per successione ereditaria, che si limitano solo allo sfruttamento delle terre nell’intento di aumentare la propria ricchezza. Si tratta di un mondo chiuso ed immobile, non raramente attraversato da silenziosi e profondi rancori, che potevano anche sfociare, in determinate occasioni, in delitti atroci. Tra queste classi e categorie di persone vi era un muro invisibile ed invalicabile, costruito in secoli di reciproca diffidenza. Eppure non era stato sempre così. Il paese era stato fondato da profughi che, partiti avventurosamente dal Peloponneso o dalle isole greche del Mare Jonio, a bordo di barconi e di navi malsicure, dopo un viaggio periglioso, erano approdati alla foce del fiume Crati, verso la fine del Quattrocento. Da qui si erano inoltrati nelle ricche terre di Pietro Sanseverino, ricchissimo principe di Bisignano e duca di S. Mauro e Corigliano. Vagando tra le foreste, i canneti e gli acquitrini della pianura di Sibari e sorpresi dalle guardie del principe, furono usati 225 come manodopera, impiegati a fare i guardiani di animali, di buoi e di cavalli nelle terre intorno al castello ducale di S. Mauro. Parificati nella disgrazia per essere stati costretti dall’invasione turca a lasciare la patria, uguagliati nella miseria e nel dolore della condizione attuale, per il principe, erano una manna dal cielo perché costituivano manodopera fresca da impiegare nei campi in tempi di difficoltà,in cui la manodopera locale era al lumicino per carestie, per pesti e per terremoti. Dopo qualche tempo, per la verità, non troppo breve, un gruppo più ardimentoso scappò dalla pianura malarica per rifugiarsi, una trentina di chilometri più a monte, nelle terre – allora, in gran parte, deserte – dei monaci basiliani, che speravano più benevoli e misericordiosi. Il padre Paolo, il Superiore del cenobio, li accolse come fratelli, acconsentendo che si stanziassero nelle terre che – allora – costituivano un vasto comprensorio di boschi, vallate, ruscelli e fiumi, mai toccato dalla mano dell’uomo. Gli permise di lavorarle, di disboscarle, di coltivarle, di allevarvi animali, in cambio del decimo del prodotto al monastero, e di costruirvi anche le case. Da questi profughi, tutti equiparati nella stessa amara sorte e tutti poveri come uccelli, ebbe origine Matermara. Essi vivevano, inizialmente, in comunità, tutti dediti al disboscamento per ricavarne terreni da coltivare ed all’allevamento di animali suini, vaccini e pecorini. Con il lavoro di alcune generazioni trasformarono gli aridi boschi in uliveti, vigneti e seminativi ed irrigui; lungo le sponde del Mezofato e del Pisciacane, due fiumare impetuose, costruirono mulini ad acqua e gualchiere e, nelle prossimità dei fiumi, trasformarono i terreni sterili in irrigui, destinandoli all’impianto di alberi fruttiferi e ad ortaggi, nei quali portavano l’acqua attraverso condotte di argilla, cotta al sole. Le loro precarie abitazioni, all’origine, non altro erano che capanne, fatte di frasche imbastite da argilla e di terra rossa. Avevano come guida il prete, chiamato pàpas, il quale, a sua volta, era un prete-contadino che viveva, come gli altri, in una capanna con la moglie ed i figli e coltivava pure il suo quoziente di terreno per sostenersi con la famiglia. La domenica e nelle altre ricorrenze, celebrava la messa all’aperto su di un altare improvvisato sopra un grosso masso. Il pàpas che con la mo226 glie previtera costituiva una chiesa domestica, svolgeva anche le funzioni di assistente sociale e dava i primi rudimenti del sapere. Passò qualche secolo, prima che i nipoti dei primitivi profughi potessero godere i frutti del lavoro, duro e intenso, dei loro antenati. Molti e non tutti ebbero la possibilità di costruirsi una modesta casa, fatta di due vani, uno soprastante l’altro, con scala di accesso e con loggetta, con tutt’intorno un orticello per impiantarvi un fico o un piede di gelso. Con ogni probabilità, all’epoca della costruzione delle prime casette, può farsi risalire l’inizio della differenziazione in classi sociali: i più ricchi o i più ardimentosi, che avevano accumulato qualche fortuna, avevano la possibilità di costruirsi case “de calce et de arena”, gli altri, i meno fortunati, i più poveri, restarono nelle capanne per molto tempo ancora. La differenziazione si accentuò nel corso del Settecento, quando i più intraprendenti ed i più furbi, anche attraverso delitti, incominciarono una sistematica occupazione delle terre dei monaci, creando per le loro famiglie immense fortune economiche, grazie alle quali poterono mantenere agli studi i figliuoli presso l’Università di Napoli. Alcuni fabbricarono titoli nobiliari per inventarsi una inesistente origine aristocratica, ostentandola come pennacchio della pretesa superiorità sociale. Il governo francese del Decennio abolì la feudalità e legittimò le usurpazioni avvenute. Sicché nei catasti di quel periodo, questa nuova classe di ricchi proprietari terrieri, derivante da famiglie di massari, per pagine e pagine, poté figurare come detentrice di rilevanti compendi immobiliari. Allora, veniva consacrata ed ufficialmente riconosciuta questa nuova borghesia rurale, che si distingueva e distanziava – anche nel modo di vita – dalla grande massa dei braccianti senza terra e dei contadini. Ai primi dell’Ottocento, la divisione di classe era, ormai, avvenuta e consolidata e riconosciuta dal codice francese che difendeva la proprietà. Baroni e borghesi usurparono e mai rilasciarono le terre pubbliche. Inutili furono le aspettative contadine ed i tentativi, messi in atto soprattutto nel periodo 1847-48, per avere un pezzo di terra da coltivare. Anche le promesse garibaldine sva227 nirono nel nulla, com’era logico prevedere, dato che la campagna garibaldina, in Calabria, era stata finanziata dalla grande proprietà. Inutile ogni speranza nei Savoia, che addirittura arrivarono al punto di prendere a cannonate il popolo che protestava per la fame. Ai contadini non restava che a sperare nella Repubblica. Ma sembrò che, nella Repubblica, ancora comandassero lor signori. E, allora, che fare? Non restava che l’emigrazione; andare via, scappare da uno Stato che aveva usato le masse contadine solo come carne da cannone in inutili e micidiali guerre. L’astratto diritto di uguaglianza, nella realtà, si dimostrava bugiardo. 228 12 Erano queste, in effetti, le considerazioni che avevano convinto quei nostri giovani a romperla col cosiddetto partito cattolico perché lo si riteneva – e tale era nei fatti – lo strumento di quella borghesia rurale paesana, pecuniosa, parassitaria ed immobilista, nella realtà non cristiana, pervenuta al benessere ed alla ricchezza non proprio col sudore e con la propria fatica. Ad essa andava addebitata la responsabilità dell’arretratezza sociale ed economica del Mezzogiorno, come, del resto, le stesse condizioni di vita della piccola Matermara indubbiamente attestavano. Ed erano lì, davanti a tutti: le si poteva toccare con mano. Sembrava che fosse possibile una spontanea intesa ed alleanza tra questo gruppo di giovani ed altri giovani esponenti della Camera del Lavoro e progressisti indipendenti. Comuni innegabilmente erano gli obiettivi immediati: mettere insieme una forza popolare, senza rinunziare alle proprie identità, al fine di fare uscire il paese dai residui di feudalesimo, rinnovandone lo stesso vivere sociale e delle relazioni fra le persone, oltre ovviamente facendo realizzare almeno le più impellenti opere di civiltà. I conservatori si resero subito conto della difficoltà o, forse, dell’impossibilità di trovare un punto di incontro con quei giovani che non facevano nulla per nascondere la propria intransigenza morale. Fino a quando si era avuto a che fare con i padri, tutto era filato liscio: con i figli, istruiti e acculturati, con mille idee di novità che gli frullavano per la testa, era tutto un altro mondo rovesciato, che parlava un linguaggio incomprensibile per i signori. Diedero, così, per conclusa l’alleanza degli esponenti progressisti per la conquista del Comune. 229 Attraverso scribacchini assoldati, fu iniziata una campagna di stampa per denunziare lo scandalo di una innaturale alleanza nelle elezioni comunali, menando alti lamenti per le casse comunali che sarebbero state dissestate, rimarcando come vera una circostanza non vera: che il comune sarebbe stato consegnato ai comunisti. Questo al fine di esercitare una pressione psicologica sulle famiglie di contadini, da cui provenivano quei giovani, pure così intelligenti, ma, peccato! che erano comunisti. I signori che, per la evidente scarsa cultura ed informazione, non riuscivano a vedere le differenze nelle impostazioni ideologiche, riducevano tutto all’essenziale: chi era contro di loro, era comunista e basta. Il pregiudizio dell’anticomunismo e dell’antisocialismo era strumento di discriminazione. Per qualche tempo, su certi periodici provinciali, quei giovani furono variamente criticati con l’attribuzione di epiteti vari e ridicoli, di rivoluzionari, rossi, eretici. Il risultato fu uguale allo zero. Il Parroco, che probabilmente non aveva condiviso tale campagna di stampa per la sua evidente grossolanità e che conosceva e stimava quei giovani, ritenne di non avere alcun motivo di agitarsi. Non v’erano pericoli in vista per la religione. Incomincia il bombardamento anche contro il povero Parroco; se non si è mosso vuol dire che è comunista. Questa volta è un quotidiano nazionale che divulga la notizia del parroco di un paese della Calabria che si è schierato con i comunisti per le elezioni comunali. Il Parroco se la prese a ridere. Qualcuno insinuò che l’inutile spreco di articoli, peraltro, scritti assai pedestremente, in periodici della provincia, serviva, in effetti, ai suoi ispiratori e promotori per una sorta di auto incoraggiamento e per dare la sensazione, all’esterno, che essi esistevano ed avevano ancora voce in capitolo. Questa bagarre non era ancora terminata quando gli esponenti del rinnovamento stabilirono di riunirsi per definire i termini del patto e per determinare le finalità e le modalità esecutive. La riunione definitiva fu tenuta una sera, alla presenza dei delegati di tutte le parti, nella bottega di falegnameria di mastro Giorgio Brancaccio. Praticamente si scelsero i nominativi dei candidati e si stilò un succinto programma, consistente soprattutto nelle opere pubbliche da realizzare con urgenza prioritaria: acquedotto, rete fognaria, pavimentazione 230 dell’abitato, illuminazione, strade interpoderali. In buona sostanza, una intelligente amministrazione per dare nuova vita al Comune e speranze all’intera cittadinanza. L’impresa – che appariva razionale e chiara ai giovani rinnovatori – non era così facile e senza rischio. L’avversario, oltre che forte del potere economico e di quello politico consolidato, in un ambiente arretrato ancora dominato da superstizioni e pregiudizi, era agguerrito e deciso a giocare le carte a disposizione – lecite ed illecite – pur di non cedere. Tutti gli onorevoli della provincia, i due sottosegretari di Stato, il baldanzoso presidente dell’amministrazione provinciale, si mossero per tenere il loro bravo comizio, sfoggiando la smagliante eloquenza contro i comunisti atei e contro la famiglia e la proprietà; sarebbe stata una vera rovina mandarli al governo del Comune. Promisero mari e monti: solo loro che avevano il potere avrebbero veramente potuto venire incontro ai bisogni del paese. Mentre parlava il sottosegretario all’agricoltura ed esponeva le sue brave promesse e ne faceva intravedere la rapida realizzazione, ci fu una parentesi di ilarità. Don Giovanni Serbiscia alzò improvvisamente la mano destra e lo fermò col dirgli: «Sì, onorevole, tutto bene quel che dite, ma finora dov’eravate? Perché non le avete realizzate negli anni passati tutte queste opere di cui parlate? Spiegateci, invece, perché, adesso, vi dobbiamo credere.» Generale fu lo scoppio di ilarità. Il sottosegretario continuò per un’altra decina di minuti, poi terminò il discorso col pistolotto finale in difesa della religione e della famiglia. L’effetto fu di un gelo desolante, che certamente evidenziava gli umori reali dell’opinione pubblica ed il repentino cangiamento di clima. Don Giovanni Serbiscia, uomo semplice, ma serio, che non aveva mai parteggiato per nessuno, evidentemente poteva essere considerato come una specie di parametro della pubblica opinione. Quei giovani, uno per sera, nella piazza del paese, rispondevano per le rime. Spiegavano in modo semplice, chiaro e convincente, che non si trattava di fare un referendum sul regime comunista, ma se, invece, al governo del Comune, si dovevano ancora mantenere i signori ed i loro dipendenti oppure se, viceversa, sarebbe stato più utile e nell’interesse di tutti, avere al 231 Comune degli uomini liberi, istruiti e colti. I signori esercitavano il potere da qualche secolo ed il risultato fallimentare era drammaticamente sotto gli occhi di tutti: un paese senza strade, senza acquedotto, senza fognature, senza edificio scolastico; praticamente mancante di tutto ciò che caratterizza il moderno vivere civile. L’altro dente dolente era quello delle imposte comunali, nella distribuzione delle quali, campeggiavano il favoritismo e la discriminazione. Quei giovani, con dati alla mano, nelle lunghe serate di maggio, davanti ad un pubblico numeroso di contadini, artigiani e braccianti, dimostravano come e perché almeno buona parte delle imposte gravava sui ceti più poveri. I galantuomini, invece, padroni della maggior parte dei terreni e, quindi, possessori della più grossa fetta della ricchezza fondiaria e mobiliare, erano tassati in modo inadeguato, non proporzionale ed ingiusto. Si facevano pubblicamente i confronti con tanto di nomi e cognomi, così ognuno era posto in grado di verificare la realtà dei fatti e come era vero che il contadino Pietro Vascia, così come altri piccoli proprietari, ognuno pagava, in proporzione, somme superiori a quelle, imposte ai singoli grandi proprietari. La conclusione era assai evidente: se gli elettori, i contadini, piccoli e medi proprietari ed i braccianti, volevano che la percentuale maggiore delle imposte gravasse sui ceti più deboli economicamente, continuassero pure a votare per lor signori, sapendo che votavano contro i loro interessi e contro l’avvenire dei propri figli. Alla fine, gli applausi scrosciarono per più minuti. Quei giovani avevano colpito nel cuore del problema. Ognuno, da tempo, avrebbe voluto sentirsi dire quelle parole e fare quei raffronti, con semplicità e badando ai dati reali. Perché avvertivano di essere vittime di ingiustizie, però non sapevano come ribellarsi e come farle cessare. Il discorso aveva prodotto i suoi effetti pure nel campo avverso. Anche qualche galantuomo, ingiustamente tartassato, che aveva reiteratamente proposto ricorsi su ricorsi, tutti regolarmente sempre respinti, si dissociava privatamente dal coro dei signori; faceva recapitare a Pietro Lascaris una lettera di congratulazione, consigliandogli di insistere sulla manifesta disparità nella imposizione delle tasse comunali, di cui egli 232 stesso si proclamava vittima. Era assai chiaro che il movimento rinnovatore aveva aperto una breccia, destinata ad allargarsi, in quel blocco di galantuomini, che erroneamente finora si erano ritenuti tutti uguali. Invece, la realtà smentiva il pregiudizio. Proprio un galantuomo, come don Cola Chidichimo, persona istruita e colta, ma vessata ed isolata dagli altri signori, era dalla parte dei giovani e scommetteva sulla loro vittoria. Ma l’avversario non demordeva: voleva vincere con tutti i mezzi. Incominciavano le visite notturne nelle case dei braccianti e delle raccoglitrici d’olive, da parte dei guardiani e dei servitori dei signori. Una povera umanità che si prestava a carpire il voto, per conto altrui, di altri poveri cristi, sotto la minaccia che, se non avessero votato la lista dei signori, il padrone non li avrebbe fatti più lavorare nei suoi terreni. Non si trattava solo di una minaccia a vuoto: ad ogni elettore veniva consegnato un fac-simile della lista da votare con degli accorgimenti particolari, per esempio, il più ricorrente era data dalla successione delle preferenze. Nome e cognome venivano annotati in un quaderno al fine del controllo successivo, al momento dello spoglio. In caso di mancata corrispondenza tra i dati del facsimile consegnato e quelli della scheda scrutinata, vi era la prova che il voto, magari promesso sotto la minaccia e la violenza, non era stato dato. Sarebbe, quindi, seguita la messa in atto della misura minacciata. La pressione psicologica, particolarmente sui braccianti e le raccoglitrici, era enorme e seria e di raffinata violenza: si trattava di scegliere tra chi ti minacciava di toglierti il lavoro ed il pane per i figliuoli e chi sentivi in dovere di votare, come per spontanea vocazione, perché naturalmente era dalla tua parte e ti rappresentava e ti era sempre vicino nelle occorrenze più varie. Il dilemma era traumatico. Fortunatamente solo poche famiglie soggiacquero alla violenza. La maggioranza – come rivelò l’esito elettorale – pur se a parole aveva garantito il voto, non ce la fece a votare in modo contrario alla propria volontà ed alla propria coscienza. «Ma come avrei potuto guardarmi allo specchio» rivelò Cosmo Ranfredi dopo lo scrutinio «se avessi votato per i signori?» Il bracciante Luigi Brescia e la moglie raccoglitrice Dianora Toccia rivelarono il marchingegno di pressione e costrizione 233 elettorale, in una affollata assemblea della Camera del Lavoro, facendo capire che, nelle notti precedenti, molte famiglie erano state “visitate” e minacciate, con la consegna del fac-simile sul cui modello esprimere il voto. Immediatamente scattarono le misure di prevenzione da parte dei Dirigenti. Fu contattato ogni iscritto e simpatizzante per dissuaderlo dall’accettazione dei segni di riconoscimento del voto e di vera e propria violenta costrizione della coscienza. Molti consegnarono i facsimili ricevuti. In un’assemblea generale, Damiano ed il dirigente provinciale Elio rassicurarono gli iscritti di votare tranquillamente senza paura di rappresaglie e di repressioni. Il voto era segreto e la violazione della segretezza era severamente punita. La Camera del Lavoro tenne in piazza un pubblico comizio per denunziare il tentativo di inquinamento della libertà del voto, promettendo che, col proprio ufficio legale, avrebbe agito contro chiunque avesse posto in essere tentativi di carpire il voto con la violenza o la minaccia. La pronta e determinata risposta della Camera del Lavoro fu una botta dura per l’avversario ed un efficace incoraggiamento a resistere dalla parte popolare, che avvertiva di non essere sola ed abbandonata alle ammiccanti tentazioni padronali. La campagna elettorale – già di per sé caratterizzata da un duro scontro – si accendeva e, a volte, si esasperava. Qualche volta non mancava di dare adito anche a episodi risibili e curiosi. Come quando il ragazzo Venturino andava per il paese, distribuendo alle famiglie un opuscoletto di propaganda che portava sul frontespizio “Una battaglia per la democrazia”. Sentendo dalla voce di Venturino gridare la parola “democrazia”, nella errata convinzione che era propaganda del suo partito, donna Soga Canadè si affrettò a chiederne una copia. Avutala e visto che, nel frontespizio portava il nome degli autori, Pietro e Pasqualino, rincorse, in fretta e furia, il ragazzo e gliela buttò in faccia col dirgli: «Che mi hai dato a fare questa robaccia? Riportala a chi te l’ha data.» Come nel 1825, i soldati russi che, sollecitati dai rivoluzionari, acclamavano alla “Costituzione”, ritenendo che fosse la moglie dello zar Costantino, donna Soga, nella sua beata e innocente ignoranza, forse pensava che la “democrazia” era la sua persona di servizio. 234 *** Gli emigrati all’estero, in Svizzera, Germania e Francia, erano stati tutti telefonicamente contattati e mobilitati alla partecipazione al voto dagli organismi esteri del sindacato. Quelli del paese erano pochi, ma tutti avevano assicurato la loro presenza che avrebbe potuto anche essere determinante per l’esito finale. All’antivigilia del giorno, fissato per le elezioni, nel tardo pomeriggio, arrivarono in paese, a bordo di un grosso pullman, tappezzato da bandiere rosse e tricolori. Era un avvenimento mai verificatosi per il passato, veramente eccezionale, di grande efficacia propagandistica e psicologica per quelle zone grigie e titubanti dell’elettorato, che vennero indotte a sciogliere ogni dubbio. Altro fatto significativo fu che la mattina, all’apertura dei seggi elettorali, tutte le donne – giovani ed anziane – dei quartieri popolari, con in testa l’anziana Viatrigia, vecchia ed infaticabile combattente, si trovarono – prime – ad esprimere il loro suffragio. L’organizzazione elettorale avversaria sembrava balbettare. Tra i voti vaganti, riuscì letteralmente a “catturare” quello di mastro Natale Criegaduri, un povero diavolo che fu ingessato ai piedi ed accompagnato al seggio. Si assistette al penoso spettacolo che, mentre veniva condotto a votare, Criegaduri, pur in mezzo a due servitori, strepitava ed a gesti ed a parole, faceva capire a chi lo sgridava per essersi fatto abbindolare che il suo voto era per la lista popolare. Questo miserevole spettacolo era veramente il simbolo di quanto accaduto in passato. Tra il popolo ed i signori non v’era mai stata vera amicizia, nonostante le apparenze, gli ossequi e le riverenze. Tra i due gruppi sociali era sempre corso un odio sotterraneo e tenace, che ribolliva nelle viscere del popolo, ma che solo in rarissime occasioni, si era appalesato, come nel 1848, quando venne occupato il municipio e le terre comunali privatizzate al grido di “abbasso i regressisti”. Il triste episodio di Criegaduro stava a significare due cose e, cioè, il popolino solo se catturato e “ingessato” era costretto alla sottomissione, ma, anche in tale stato, riusciva comunque a manifestare evidenti segni di dissenso, 235 che erano, poi, altrettanti segnali che malsopportava tale stato di soggezione morale ed economica. All’inizio dello scrutinio, sembrò che le due liste si controbilanciassero. Ma, poi, iniziò una vera e propria fuga della lista popolare che non si arrestò che alla fine delle operazioni elettorali. Scoppiarono spontanei i festeggiamenti, prima, nelle piazzette dei vicinati e dei vicoli, con balli, canti e suoni. Festeggiò la vittoria anche don Cola Chididimo e la moglie donna Callia Ligori: erano stati sempre tartassati e vessati dai balzelli comunali; ora si erano vendicati schierandosi nell’urna con i ceti popolari. Anche loro si erano liberati; i servi di una volta avevano saputo conquistare la libertà anche per i padroni. Era giusto che anche loro festeggiassero gli inizi dei tempi nuovi con la fine di ogni e qualsiasi oppressione. Invitarono nella loro grande casa tutti i vicini per brindare alla vittoria. Nell’arco di una mezzoretta, dalle contrade e dai vicinati, una massa ingente di popolo, con la bandiera rossa spiegata, spontaneamente convenne, come se obbedisse ad un ordine, e si accalcò nella piazza principale del paese, riempiendo anche i vicoli adiacenti. Si formò, così, una vera e propria processione che, fra canti, evviva!, hurrà!, lacrime di gioia e applausi ad improvvisati oratori, percorse le vie principali del paese, ovunque accolta festevolmente con lancio di fiori. Sembrava che la gente avesse aspettato questo momento e vi si era preparata e finalmente poteva scatenarsi. Ormai il miracolo – per l’opera di quei giovani intellettuali intraprendenti – era avvenuto. Il popolo senza storia aveva rotto gli argini e, dopo sofferenze ed umiliazioni, si era liberato dalle invisibili catene e scendeva prepotentemente in campo, diventando protagonista del proprio destino. Anche nel piccolo e chiuso mondo paesano si incominciava a respirare; si metteva una croce sul passato ed iniziava quel mutamento reale che nessuno avrebbe più potuto frenare. 236 13 Il difficile incominciava proprio adesso. La vittoria elettorale, non seguita almeno di parte delle opere pubbliche promesse e propagandate, avrebbe potuto tramutarsi in un vero e proprio boomerang. Enorme era la mole dei problemi da risolvere. Le promesse per una tempestiva risoluzione forse sfioravano l’azzardo; tuttavia, non mancò l’impegno totale e quotidiano da parte di tutti. Furono portati a termine rapidamente i primi e necessari adempimenti del Consiglio Comunale. Naturalmente i nuovi amministratori si vollero rendere prima conto dei problemi al tappeto e dello stato delle pratiche amministrative: un vero e proprio disastro. Provvidero a stilare una lista delle priorità in funzione dei bisogni pubblici ai quali provvedere. Anche bisognava provvedere alla soluzione di una miriade di problemi e soddisfare istanze che giorno per giorno si accumulavano, alcune problematiche erano assolutamente prioritarie: fognatura, acquedotto con la pavimentazione dell’abitato e la sistemazione delle strade interne, rivestivano il carattere della particolare urgenza. Piano stradale per le campagne, elettrificazione rurale, edificio scolastico, strada di collegamento con la pianura, ammodernamento e adeguamento alle nuove esigenze del traffico dell’unica rotabile esistente, ridottasi di fatto ormai a mulattiera, costituivano un complesso di altrettanti problemi di non facile e rapida soluzione. Si individuarono e si scelsero i tecnici, ai quali affidare le varie progettazioni e si adottarono le numerose deliberazioni consiliari e di giunta per le approvazioni dei singoli progetti. Fu un lavoro stressante e minuzioso, gratuitamente reso perché, allora, per gli amministratori non era previsto compenso 237 alcuno. E, così, incominciò anche la sequela dei tanti viaggi a Cosenza, presso gli uffici della prefettura e del genio civile, ed a Catanzaro, presso il provveditorato alle opere pubbliche. Bisognava seguire o, quasi, inseguire l’iter burocratico delle varie pratiche per sollecitarne l’approvazione ed il finanziamento e sapersi muovere nei meandri della burocrazia: tanto più che un’Amministrazione, considerata di opposizione al governo, era trascurata, se non discriminata. Nel caso specifico, un certo presidente dell’Amministrazione Provinciale, nel suo comizio nella piazza del paese, durante la campagna elettorale, con la sua boriosa e tonitruante retorica, aveva minacciato che, col voto ai comunisti, il Comune non avrebbe mai avuto alcun finanziamento. E non era una minaccia a vuoto: un Comune della zona l’aveva esperimentata sulla sua pelle: finché durò nella carica quel presidente, il completamento della strada di collegamento rimase un sogno. Il tempo naturalmente passava per i controlli e le normali lungaggini burocratiche che comportavano problemi di ogni genere ed un oggettivo contrasto tra gli Amministratori che pressavano per arrivare al più presto alla realizzazione delle opere e le gerarchie burocratiche che, al contrario, avevano i loro tempi lunghi, che si esaurivano tra timbri, supervisioni, autorizzazioni e quant’altro. Ma gli Amministratori non lasciavano passare mese senza inoltrare alle autorità preposte un pressante sollecito. Non era stata ancora data attuazione al principio costituzionale dell’autonomia, per cui, negli uffici della prefettura, si scaricavano le sollecitazioni e lo scontento dei Comuni i quali, attraverso gli organi prefettizi, erano direttamente controllati dal governo centrale, che vigilava, in modo particolare, su bilancio e, in genere, su tutte le attività inviandovi ispettori occhiuti e non proprio benevoli, se non maldisposti, nel caso di amministrazioni tenute dall’opposizione. Per la verità, gli Amministratori di Matermara, con tutto il loro idealismo, non perdevano tempo nel ricordare e sottolineare, sia all’interno degli organismi locali che in esposti ufficiali, che la prefettura era un residuato fascista, un organo incostituzionale, e sollecitavano che, proprio a causa di tale permanente anomalia, l’uso 238 del potere pubblico dovesse essere trasparente, senza privilegiare – come pure avveniva – questa o quella parte politica. In questa direzione erano aiutati da Zepa Aleana, che era consigliere provinciale, eletto nel partito comunista, e consigliere del Comune. Zepa apparteneva anche a quel gruppo di giovani idealisti, un po’ romantici e rinnovatori, che avevano dato inizio a quel grosso avvenimento politico, che aveva piuttosto tenuto conto della unità nel perseguire l’interesse generale e non le singole ideologie politiche o religiose. Quei giovani erano convinti che l’azione politica deve mirare al perseguimento degli interessi generali e comuni della cittadinanza. Essi, quasi tutti acculturati e studiosi, che pure avevano le loro particolari visioni ideologiche, partivano dal presupposto che l’esercizio della prassi politica non è un dibattito filosofico o teologico e, quindi, non è uno scontro ideologico, bensì uno scontro di interessi concreti e pone al centro la soluzione di tali problemi concreti. Il punto di unione di questi interessi era la piattaforma ed il fondamento di quel patto che li legava. Esso era costituito dalla civiltà contadina, dall’unione dei piccoli e medi proprietari e dei braccianti e degli artigiani, che, nell’insieme, costituivano un mondo di valori, che resisteva da secoli e che andava salvaguardato e, magari, potenziato e sviluppato con il sostegno pubblico di tante piccole e medie aziende. Il mondo dei contadini del Sud non era affatto il mondo dei barbari perché era semplicemente una civiltà diversa e non inferiore ad altre. Quegli stessi giovani, avviati all’esercizio delle professioni, avevano le radici ben piantate nella civiltà contadina. Questa constatazione, fatta alla luce della storia, naturalmente era al di sopra – anzi, superava – le singole appartenenze politiche e le scelte o le visioni ideologiche singole e dava origine e corpo ad una organizzazione unitaria di base, che si poneva, come contraltare, a tutto il tradizionale notabilato agrario, il quale aveva dimostrato per il passato e lo si poteva constatare per il presente che il suo unico scopo era la conservazione del potere economico, sotto qualunque governo nazionale, del quale erano il supporto e dal quale, in cambio, avevano la garanzia del mantenimento dei privilegi ed, in buona sostanza, del potere locale. 239 In tale contesto intricato meridionale, fatto da due gruppi contrapposti – popolo contadino e borghesia agraria – i contadini non avevano mai avuto voce in capitolo; essi erano semplicemente invisibili, costituivano un popolo a parte, che faticava, pagava le tasse, faceva il servizio militare e, talvolta, si faceva massacrare, ma sempre in silenzio. Quel gruppo di nostri giovani intellettuali aveva capito che quel mondo di contadini, dal quale essi provenivano e del quale erano e si sentivano fare parte, avrebbe potuto essere uno strumento efficace per un reale cambiamento se fosse diventato protagonista nella lotta politica. La sua solo entrata attiva, attraverso propri dirigenti, nella politica e nella storia civile era già di per sé una vera e propria rivoluzione, con conseguenze certamente positive nello sviluppo della storia meridionale. Questo sogno riuscì a Matermara: esso diede luogo ad un nuovo modello politico, rivelatosi funzionale e fecondo per gli interessi di tutta la collettività perché quel mondo contadino seppe assurgere a classe generale, facendosi carico dei bisogni collettivi e dimostrando di saperli governare con legalità e senza punte di discriminazione. Zepa era pure figlio di contadini, come tutti gli altri giovani. Egli era, però, convinto che solo attraverso il Partito Comunista si poteva avere uno strumento per operare il cambiamento. Perciò era piuttosto propenso a considerare il movimento contadino come momentanea espressione di quel partito. Vale a dire che i contadini, in quel dato momento storico, rappresentavano un punto della dialettica della lotta di classe. Pietro, in questo, manifestava i suoi dubbi, affermando di non essere d’accordo. Da qui scaturivano interminabili discussioni tra i due, che si protraevano fino a notte inoltrata, passeggiando per le vie del paese, per poi fermarsi a bere un bicchiere di birra nel bar di Francesco. Pietro insisteva soprattutto nel sottolineare che la ricchezza del mondo contadino consisteva nella sua libertà che garantiva la coesistenza di posizioni e di atteggiamenti anche differenti. L’organizzazione interna del partito comunista portava all’accentramento ed alla supremazia di una sola tesi, di fatto, annullando tutte le altre con la semplice finzione del centralismo, che non era per nulla “democratico”. Invece, tutte le sin240 gole culture andavano salvaguardate con la garanzia della piena libertà di espressione e di manifestazione, perché ognuna di loro portava il suo contributo e – diciamo – suonava un proprio strumento; ed erano i tanti strumenti che, nel loro insieme, creavano l’armonia. Il mondo contadino andava visto come quell’Italia di minoranza, che costituiva una ricchezza ed un patrimonio di civiltà, che aveva enormi potenzialità. Invece – aggiungeva Pietro – il pensiero unico, già come tale, di per se stesso, esprimeva una imposizione, la sottomissione delle altre culture. Né più e né meno che un credo religioso, un dogma, che pur fingendo di lasciare spazio ad altre opinioni, alla fine si impone. Si trattava di una discussione accademica fra i due giovani, di uno scambio di idee sempre piacevole ed istruttivo per chi ascoltava e per chi si accompagnava a loro nelle lunghe passeggiate che, particolarmente di domenica, avvenivano per le stradine ed i viottoli della verde campagna e, puntualmente, terminavano nella casa rurale di Cosmo, a Vallepalma, che immancabilmente offriva un bicchiere di vino, prosciutto e formaggio e provava piacere intrattenersi in compagnia di quei giovani. Il dialogo e la discussione tra i due erano continui ed andava sempre più intensificandosi nel tempo perché tutt’e due erano animati e come posseduti dalla passione politica, alimentata anche dalla instancabile lettura di giornali e riviste e di testi della letteratura del tempo e di saggi soprattutto storicopolitici. La sola differenza fra di loro era che, mentre Zepa riportava tutto invariabilmente al partito ed alla sua ideologia, considerati come il sole che illumina ogni cosa, Pietro non nascondeva il suo scetticismo, ricordando che non esistono un pensiero ed una filosofia perenni, validi per tutti i tempi storici e per tutte le situazioni. Poi – aggiungeva – le scelte dei partiti tendono ad impoverire gli ideali e, talvolta, a snaturare l’essenza della realtà, che non sempre sanno o riescono ad interpretare esattamente. Come nel nostro caso. «Tutti i partiti – con qualche rara eccezione – hanno considerato la civiltà contadina come qualcosa di arretrato da distruggere per portare l’industria nel Mezzogiorno. Questa posizione è errata, antisto- 241 rica e vedrai che non passerà tempo per rivelarsi in tutta la sua negatività, dopo avere causato disastri.» «Ma» rispondeva Zepa «tutto questo timore che tu manifesti, non ha ragione d’essere per il Partito Comunista: il centralismo democratico garantisce il dibattito libero, lo scambio delle idee, il manifestarsi anche dei contrapposti punti di vista ed il loro ricomporsi, dopo scontri magari assai vivaci.» «Non avviene proprio così» la risposta di Pietro «perché, in realtà, trionfa – sarebbe meglio dire è imposta – solo l’opinione di chi dirige. Le discussioni avvengono, ma non servono a niente. Nel caso della civiltà contadina si è partiti dal presupposto che si trattava di un mondo inferiore, fatto di passività sociale, di vecchie superstizioni e di obbedienza servile, che bisognava eliminare solo con l’industrializzazione. La realtà probabilmente era anche questa, ma non solo questa, come noi sappiamo.» Anche Zepa condivideva l’opinione che la gestione amministrativa doveva essere separata dall’esercizio del potere politico, al quale competeva tracciare l’indirizzo politicoamministrativo. Solo in questo modo si poteva tentare di porre un freno al malcostume ed alla corruzione. Particolarmente in Calabria, ma un po’ in tutt’Italia, perché la politica tendeva a diventare un mestiere, una professione, che si trasmetteva per successione da padre in figlio, di generazioni in generazione, «Ma noi comunisti siamo un partito diverso» diceva Zepa. «Mica tanto» replicava Pietro «non è sufficiente l’affermazione teorica di una diversità, che, nella esperienza pratica, non esiste, essendo prevalente il conformismo. Andando di questo passo, è ragionevole temere che, nel nostro paese, ci si avvii verso un’oligarchia, data l’organizzazione accentrata dei partiti e lo scarso controllo dal basso. Se il popolo è per buona parte ancora analfabeta, se si leggono pochi giornali e pochi libri, come si può partecipare alla vita politica? E senza partecipazione, vi può essere democrazia?» Questi nostri giovani avevano molte cose in comune, al momento, però, passava pure tra di loro una leggera linea di divisione su alcuni concetti fondamentali che, col tempo, si sarebbero chiariti ed avrebbero anche definito e caratterizzato la personalità di ciascuno. Su di un punto erano tutti d’accordo: 242 sul fatto, cioè, che le masse contadine costituivano la sola classe che, nel Mezzogiorno, avrebbe potuto dare luogo alla rivoluzione. Essi, impegnati negli studi e colti, a vent’anni, non potevano che sognare e sperare nella rivoluzione, pur restando legati alla tradizione contadina. Ed era proprio Zepa che, in certi suoi delicati versi, ricordava con nostalgia di essere nato e cresciuto tra le montagne spaccate dal sudore degli avi e di essersi arrotolato tra la terra e la polvere delle valli scoscese, dove i padri avevano costruito le case al riparo dalle fiumare tempestose. I signori, quando partivano, non tornavano più. I contadini, invece, erano sempre partiti per il Nord ed in ogni direzione; avevano attraversato l’oceano, erano sempre pronti a partire, erano emigranti nel pensiero, ma erano sempre ritornati, in pochi od in molti, nei paesi d’origine. Anche nei luoghi, dove si erano trapiantati, vi avevano portato le proprie tradizioni, le feste ed i riti del paese. Anche Paolo Reda era della compagnia; vi era entrato a fare parte sin dalle fasi iniziali della sua formazione che avvenne per gradi. Egli, figlio di un sarto, quando ancora frequentava le classi ginnasiali, sotto l’influenza di un amico di famiglia, era entrato nel gruppo giovanile neofascista. Fece una breve esperienza, della quale in seguito, progredendo nelle cognizioni, si vergognò; scherzando con gli amici, diceva di avere fatto come Pinocchio che, alla fine della sua avventura, era costretto a riconoscere com’era brutto quando era burattino. Il progresso negli studi e l’intelligenza valsero a riscattarlo. Certamente quell’ambiente chiuso favoriva – anzi facilitava – gli iniziali sbandamenti. Il processo di autocorrezione spontaneamente avveniva mano a mano che si procedeva negli studi e si approfondivano gli argomenti che interessavano aprendosi anche al confronto con gli altri. Carlino Dighira era figlio di un contadino più agiato. Il padre addirittura – per non farlo distrarre – lo teneva nel Convitto Nazionale di Cosenza, che allora comportava una bella spesa. Il padre, Demetrio, in gioventù, era stato col partito di Don Luigi Sturzo. Lo ricordava sempre quelle volte che gli capitava di parlare con quel gruppo di giovani. Avveniva ogni tanto, di domenica, quando restava in paese a riposare. Era sempre occupato ed indaffarato nella coltivazione dei suoi terreni. Nei 243 periodi di più intenso lavoro, si faceva aiutare da alcuni braccianti. La mattina presto, con la pioggia o col vento, in groppa al suo cavallo, si recava nel suo fondo; sul fare della sera, ritornava a casa. Tutti questi giovani avevano trovato il loro comune punto di intesa e di incontro nella prospettiva di conquistare il Comune per portarvi aria nuova, sostituendone il vecchio gruppo dirigente con la nuova forza, espressione del mondo contadino, creando, di fatto, un raggruppamento politico che sembrava indefinibile, non rientrando in alcuna delle forze politiche in campo. Aveva, però, un preciso e ben determinato punto di riferimento, costituito dal mondo contadino, che, insieme agli artigiani, era una forza sociale popolare reale: l’unica che, nell’intuizione di quei giovani intellettuali, invero, ancora un po’ asprigni, avrebbe potuto realizzare nel Mezzogiorno quella rivoluzione e quel sogno di libertà, invano atteso da secoli, come non mancherà di sottolineare la storiografia successiva. Per tale motivo, i dirigenti politici provinciali dei partiti, con una certa aria di superiorità, manifestamente li snobbavano: i dirigenti socialisti e comunisti ironizzavano sui giovani “rivoluzionari”; quelli del cosiddetto partito cattolico li definivano semplicemente comunisti. Ma tutt’insieme dimostravano evidentemente di non avere capito nulla della realtà meridionale. Aperto fastidio verso di loro evidenziavano quei funzionari della prefettura e del genio civile ogni volta se li vedevano d’attorno aggirarsi per i vari uffici, venuti a sollecitare il disbrigo di questa o quella pratica del Comune. A Pietro capitò addirittura di avere uno scontro verbale con lo stesso prefetto nel corso di una riunione di sindaci, appositamente convocata in un Comune della Sibaritide. In tali occasioni, l’esercizio della retorica si sprecava e si esauriva in espressioni di ossequio verso l’autorità. Pietro, venuto il suo turno di parlare, senza mezzi termini e salamelecchi, entrò subito in discorso, parlando delle condizioni di arretratezza generale ed, in particolare, del suo Comune, puntando l’indice sulla responsabilità dei vari governi, fino allora succedutisi, per avere lasciato le popolazioni meridionali nell’abbandono, senza acqua, senza fognature, senza edifici scolastici, senza strade, senza igiene pubblica e senza ospedali e senza istruzione. Disse 244 al prefetto che il Comune aveva presentato vari progetti per opere pubbliche, enumerandole una per una ed indicandone anche il relativo numero di protocollo. Concludendo, disse che era venuto non per ossequiare una autorità, ormai non più costituzionale, ma in rappresentanza e come eletto dal voto popolare per protestare per il ritardo nell’approvazione dei progetti presentati e per i troppi abusi perpetrati nei confronti delle popolazioni meridionali. L’anziano segretario comunale, che era seduto vicino a Pietro, sempre timoroso e ossequiente verso l’autorità governativa, terrorizzato per quel che il giovane andava dicendo, non cessava di tirarlo per la giacca per farlo smettere. Dopo il discorso, quasi a rimprovero, gli disse: «Ma tu sei pazzo. In questi termini parli al prefetto? Hai visto che nessuno ha parlato come te.» «Io sono stato eletto dalla popolazione per parlare in nome e nell’interesse della stessa. Il prefetto è un funzionario dello Stato che deve fare l’interesse pubblico e perciò è tenuto a dare ascolto ai bisogni della gente.» Al fermo, duro e ardito discorso del giovane, l’assemblea rimase muta e come di ghiaccio, evidentemente inorridita, in attesa della replica del prefetto. Pietro aveva colpito nel segno. Il prefetto incassò le critiche al governo ed agli organi amministrativi provinciali e non pronunziò verbo, ringraziò tutti gli intervenuti e sciolse l’assemblea verso le ore 14. Non trascorsero che pochi mesi che al Comune pervennero le comunicazioni che tutti i progetti di opere pubbliche erano stati approvati e che si poteva procedere ai relativi bandi per l’appalto. Così, in un breve arco di tempo, il paese divenne un cantiere. 245 14 Incominciava, nel frattempo, in tutto il Mezzogiorno, l’emigrazione che determinava lo sconvolgimento del suo tessuto sociale. Il che, all’evidenza, stava a significare che la forza contadina, i braccianti ed i piccoli artigiani, un po’ alla volta, erano costretti allo sradicamento dagli antichi insediamenti. I giovani amministratori assistevano con sgomento a questo fenomeno, che erodeva sistematicamente la forza sociale, che costituiva il fondamento del Comune democratico, che essi avevano costruito, immaginando l’inveramento di quella rivoluzione meridionale, da molti attesa ed auspicata. Invece, gli avvenimenti andavano – sarebbe meglio dire, li facevano andare – per il verso opposto. Non ci voleva molto a capire che i gruppi dirigenti nazionali, dopo alcune elezioni negative per i partiti di governo, non si fidarono del movimento contadino, venne fuori allora – e presto divenne dominante – la strana ipotesi, del tutto storicamente infondata, che la civiltà contadina era un complesso di arcaiche tradizioni e di arretratezze, che andavano superate attraverso un processo di industrializzazione diffusa, fondata su cosiddetti poli di sviluppo. Si voleva cambiare, con un’operazione spericolata – criticata da molti studiosi – la storia meridionale con lo sostituire l’industria all’agricoltura. Il che, in costi umani, significava l’espulsione dalle terre di intere famiglie contadine e lo smantellamento delle loro piccole e medie aziende. Tutt’al contrario di quello che, invece, avrebbe dovuto avvenire. Pietro Lascaris pose ufficialmente la questione all’attenzione del Consiglio comunale, sostenendo che, ancora una volta, invece dell’attuazione di una seria riforma agraria, che avrebbe dovuto incrementare e sostenere convenientemente le piccole e medie aziende agricole, ben radicate nel territorio, le forze po246 litiche – comprese quelle di opposizione – avevano preferito scegliere un percorso dannoso, il cui esito principale sarebbe stata la neutralizzazione del movimento contadino e la sua conseguente emarginazione. Parole pesanti, ma vere, condivise anche da Zepa Aleana, profondamente legato a quel mondo ed ai suoi valori, distinguendosi anche questa volta per la sua libertà di pensiero. «È vero» egli disse «è stato un errore lasciare cadere e non perseguire quel progetto di alleanza tra contadini del Sud e operai del Nord. Siamo andati alla ricerca delle nuvole e l’abbiamo chiamata politica di allargamento delle alleanze. Per fare che cosa? Invero, per non fare nulla; solo forse per non turbare il realismo politico dell’equilibrio delle forze politiche, ma lasciando cadere una occasione storica di riscatto reale delle popolazioni meridionali.» Anche il vecchio Cosimo Miceli, uno degli storici fondatori della Camera del Lavoro, intervenne con dure espressioni per manifestare tutto il suo disappunto. Rafforzò le affermazioni di Zepa, denunziando un improvviso cambiamento di rotta, nel partito, come si poteva dedurre, senza ombra di dubbio, dalla sostituzione, alla segreteria regionale, del “Ministro dei contadini” con un “redento” dal fascismo, che aveva vissuto la gioventù come rampante intellettuale fascista, trasformatosi ora in rigido funzionario di partito. «È un errore» disse Miceli «ripiegare su di una politica di ricerca di nuove alleanze, che sono già quelle consolidatesi nel movimento contadino in tutti questi anni. Non si riesce a capire a quali altri soggetti sociali si vuole veramente alludere. Non possiamo certamente fare confluire nel nostro movimento quegli elementi della piccola borghesia, finora espressione del ceto agrario, che erano stati e sono i veri rappresentanti del trasformismo meridionale.» Si sentiva e si toccava con mano che il disagio era diffuso e generava crisi di coscienza, particolarmente tra coloro che erano stati i protagonisti delle prime lotte agrarie ed avevano duramente pagato di persona subendo condanne penali e, talvolta, il carcere, dopo essere stati fatti passare ammanettati per le vie dei paesi, ove più vivace era il movimento. 247 Anche i nostri giovani idealisti erano costretti, da tali affermazioni, a sbattere il muso sulla dura realtà della politica ed a cogliere l’aspetto paradossale derivante da nuove alleanze. «Non vedo altre forze sociali con cui allearci» disse prendendo, a sua volta, la parola il giovane maestro elementare Gennaro Maida «se non gli artigiani, i gruppi intellettuali e piccoli proprietari, con i quali già insieme ci muoviamo. A meno che non si voglia alludere a quei galantuomini, i quali – non rare volte – sono stati essi stessi gli usurpatori delle terre pubbliche, contro i quali hanno lottato i contadini, scontrandosi duramente. Essi avevano amministrato o amministravano i beni dei baroni e li avevano seguiti e consigliati, come avvocati e notai, nelle azioni di spoliazione delle popolazioni. Essi hanno sempre amministrato i Comuni e abusato del loro potere per occupare – come nel nostro Comune – le terre pubbliche privatizzandole. Sarebbe, oltre che paradossale, un’alleanza con soggetti simili, anche fuorviante, che avrebbe potuto svuotare di contenuto le lotte contadine.» Martino Papadà, che studiava medicina a Bologna, rincarò la dose, ma volle commemorare la morte tragica del contadino Gaetano Greco, trovato morto, sfracellato nella valle di Catenazzo, ricordando con parole elevate e commosse che era stato pianto solo dal cane da guardia che l’accompagnava. Ne ricordò la dura esistenza come – disse – «quella del padre e del nonno e del nonno dei nonni, ai quali addirittura erano state negate anche le scarpe, costretti a subire passivamente mille ingiustizie sin dalla prima età, diventati vecchi anzitempo. Voglio salutare questo contadino – continuò – come glorioso combattente civile e ricordarlo per le mille opere di pace: l’innesto amaro agli ulivi selvatici, il tenero bacio delle gemme sui tralci, il suo colpo sonante nella roccia perché l’acqua fluisse, il sorriso dei ciliegi, la bocca rossa delle mele granate: tutto ciò fu opera della sua civiltà contadina. Chi vuole pattuire con noi» proseguì quasi liricamente Papadà «ci troverà sulle aie, tra le messi, nelle botteghe artigiane, tra l’autogeno e le colate di fuoco. Ma venga con le mani libere e non tenga la destra armata dietro la schiena.» La decisione era sta già presa. A nulla valsero le proteste, quasi sempre vivaci, della periferia. Di esse ci si sbarazzò con 248 qualche battuta. L’Italia – si assumeva – deve diventare una nazione europea ed ha, quindi, necessità di favorire lo sviluppo industriale del Nord con la conseguenza di fare pagare un duro prezzo al Meridione. Il quale doveva essere sottoposto “dall’alto” ad un nuovo processo produttivo di tipo industriale, al posto di quello agricolo, tradizionale, che andava distrutto, considerato arcaico o addirittura barbaro. Si dimenticava che i contadini costituivano una civiltà autonoma, legata alle più antiche tradizioni nazionali, con cultura propria ed un sistema di vita che aveva i suoi valori universali. Essi, poi, nel loro campo di attività, avevano dimostrato – quelli non emigrati – capacità imprenditoriali autonome creando imprese agricole e migliaia di aziende artigianali, medie e piccole, evidenziando, così, anche una autonoma energia. Tutti i cantori del De profundis della civiltà contadina saranno costretti, nell’arco di qualche ventennio, a dovere prendere amaramente atto del grave errore commesso e del danno enorme di avere contribuito ad un vero e proprio genocidio di una civiltà diversa, ma certamente non inferiore a quella consumistica. Perché non era affatto vero che in essa non vi fossero capacità imprenditoriali e valori universali, potenzialmente in grado di promuoverne uno sviluppo autonomo. Sicuramente preferibile a quella che giustamente fu detta “industrializzazione senza sviluppo”, foriera – come anche all’epoca era facile intuire – di incalcolabili danni all’assetto territoriale ed alla salute delle popolazioni. Al fallimento dell’industrializzazione, restarono i paesi svuotati con le case disabitate, le montagne, le colline e le campagne deserte a causa dell’esodo biblico; la rottura degli equilibri sociali; le discriminazioni e l’asservimento clientelare, entrato nel costume della società civile; l’occupazione del potere pubblico da parte di esponenti politici, per lo più incompetenti, se non disonesti, che hanno privilegiato con massicce elargizioni del denaro pubblico le loro clientele; la corruzione e decadenza progressiva dei grandi partiti politici tanto grave da minare le stesse basi della democrazia; infine, l’aggirarsi e l’infiltrarsi, tra le smagliature del potere clientelare di gruppi criminali, che hanno tessuto, col tempo, una ragnatela di fango a scapito del249 la correttezza delle pubbliche istituzioni fino ad arrivare al punto che chi riesce a fare applicare la legge sembra avere compiuto un atto eroico, più che il proprio dovere. Ad un tiro di schioppo da Matermara, il Sottosegretario socialista, nella furia ed infatuazione della industrializzazione, presenziò solennemente, con banda musicale, applausi e fuochi d’artificio, alla posa in opera, accompagnato da un manager di Stato, della prima pietra di una grande acciaieria, che avrebbe dovuto essere una delle più grandi del Mezzogiorno, che avrebbe comportato l’impiego di migliaia di persone, facendo addirittura sparire la disoccupazione nella grande pianura di Sibari. In quel periodo, il Sottosegretario capitò nel Comune ed ebbe modo di affacciarsi dal balcone, aperto sulla grande piana. «Ecco» disse «un giorno e fra non molto tempo, questa grande pianura sarà coperta da tante piccole e grandi fabbriche. Questo vostro ridente paese collinare diventerà un centro residenziale e ne riceverà tanti benefici. Perché la gente preferirà vivere in un paese accogliente, come il vostro, piuttosto che nel trambusto delle fabbriche, dove si recherà solo per lavorare.» Si faceva credere – forse ingenuamente – che Sibari sarebbe diventata una nuova California. Damiano, che era in disparte, seduto in un angolo del salone, destò l’attenzione del Sottosegretario forse perché gli sembrava alquanto scettico. «Perché non devi credere? Io non parlo per suonare il tamburo a me stesso; garantisco che l’industrializzazione della piana è nei programmi del nostro governo.» Passarono giorni ed anni, dell’acciaieria si persero le tracce. Non se ne parlò più. Non rimase neppure la prima pietra ed il suo ricordo. Il poeta socialista – che era stato uno dei protagonisti delle lotte contadine contro il notabilato agrario nella piana di Sibari – capitò a Matermara, dove aveva molti amici; vi tenne un affollato comizio, destando l’entusiasmo popolare perché – finalmente! – la Sibari del petrolio col suo cuore antico risorgeva in una nuova città con un grande porto, frequentato dalle grandi petroliere che trasportavano il combustibile per alimentare gli impianti industriali. 250 Tutta la pianura e le colline circostanti che la facevano sembrare un grandioso anfiteatro, come per un miracolo, improvvisamente, sarebbero diventati luoghi benedetti dal Signore e dalla fortuna, non più devastati dalla malaria e dalla disoccupazione. Ognuno vi avrebbe trovato il posto di lavoro confacente in una fabbrica, in un ufficio, nel porto o nelle attività connesse che inevitabilmente sarebbero sorte. Erano favole? Promesse a vuoto di comizianti? né le une e né le altre. Il nostro poeta socialista era veramente convinto di quanto andava dicendo: la trasformazione industriale della zona non solo avrebbe dato pane a lavoro a quanti ne avevano bisogno, ma creando una comunità moderna, avrebbe finalmente tagliato le grinfie all’agrario parassitario. Egli, nella sua immaginazione, vedeva già la realizzazione di un così profondo e fascinoso programma di totale rinnovamento e di trasformazione sociale, economica, politica e civile. E riusciva a comunicarlo ed a farlo credere come possibile col suo eloquio liricheggiante ed accattivante. Assicurava che non v’erano dubbi sulla sua fattibilità. Si trattava di un intervento urgente che il governo centrale aveva incluso e previsto nella Agenda delle opere da realizzare col carattere della priorità. Poi, anche Sibari rimase col suo cuore antico, ancora sepolto sotto il Crati ed il Coscile, ma senza petrolio e senza industrie. Quei nostri giovani non credevano nelle chiacchiere dei politicanti perché si informavano dai testi degli storici e degli economisti meridionalisti; sostenevano ben altre ipotesi sulla soluzione della questione meridionale. Essi, agevolati dall’ausilio di tali studi, erano posti in grado di “leggere” l’azione politica, che si veniva dispiegando nel Mezzogiorno, e di capire che, la Calabria in particolare, era destinata al sottosviluppo. La costruzione, infatti, nella pianura di Sibari di una centrale termonucleare, a basso assorbimento di manodopera e altamente inquinante, con circa diecimila o più emigrati, con colture intensive e specializzate, era quanto di meno adatto a dare lavoro a tante migliaia di persone. Al contrario, sarebbe stato necessario incentivare piccole e medie industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, non inquinanti, che si conciliavano con 251 l’ambiente e richiedevano un apporto considerevole di manodopera. Zepa, Pietro e gli altri giovani discutevano e si infervoravano a queste problematiche che ovviamente riguardavano anche l’avvenire del Comune amministrato. Ma chi avrebbe potuto prestare ascolto a questo gruppo di giovani? Essi, in effetti, erano isolati. Invitarono, d volta in volta, famosi meridionalisti e ci furono dibattiti e lunghe discussioni. Solo Carlo Levi disse chiaro e tondo, facendo capire a tutti con linguaggio semplice che le alte sfere della politica, di tutta la politica, avevano deciso la fine della civiltà contadina e l’industrializzazione ad ogni costo. Rispondendo ad una domanda di Zepa, spiegò come i meridionali erano stati grossolanamente ingannati. «Essi misero a disposizione degli imprenditori turistici settentrionali chilometri e chilometri di spiagge, i terreni, lo splendido paesaggio, in pura perdita, tutto gratuitamente, senza ricevere nulla in cambio se non l’assunzione stagionale di lavapiatti. Così, pochi spregiudicati hanno incassato miliardi solo in benefici e contributi e incentivi.» Levi, a conclusione del suo intervento, sottolineò che «l’industrializzazione senza sviluppo aveva lasciato rovine nell’ambiente, generato corruzione e malaffare. Non aveva neppure creato i presupposti per la nascita di una classe operaia.» «È stato tutto, dunque,» riprendeva Zepa «veramente un grande imbroglio. Anche per la sinistra. Altra avrebbe dovuto essere la soluzione: una moderna agricoltura, fatta da tante piccole e medie aziende, bene inserite nell’ambiente e nella storia locale, accompagnate da imprese artigiane e turistiche.» Quei giovani, arroccati nel Comune, di fronte ai guasti evidenti di una scelta politica errata, erano costretti a mordere il freno, però non cedevano. Essi appartenevano a “quella minoranza combattiva”, che non si rassegnava, non tralasciava occasione di criticare gli errori, i favoritismi e le discriminazioni. Il più impaziente era Zepa, che era anche il più esposto politicamente ed in qualche modo obbligato, in ossequio al centralismo, a seguire la linea del Partito Comunista, nel quale militava. Che veramente non si sapeva quale effettivamente fosse: se – come appariva – di radicale opposizione o di cauta e criti252 ca adesione all’industrializzazione. V’era, in effetti, quella incertezza che ingenerava dubbi e indecisioni. Ma una cosa era certa: l’abbandono del programma di unità tra operai del Nord e contadini del Sud con l’opzione per l’industrializzazione in considerazione dell’arcaicità della struttura sociale del Mezzogiorno con tutto quel che ne era seguito. A Zepa, impaziente di riprendersi la propria libertà per esternare tutto il suo malcontento ed il dissenso determinato e deciso, Pietro consigliava, con realismo, di tentare di fare valere i suoi argomenti negli organismi di partito: «Non v’è altra soluzione. Non ci si può abbandonare all’estremismo sterile. Dobbiamo essere concreti e dimostrare che sappiamo proporre soluzioni concrete.» Si lasciarono i due giovani con un disappunto di amarezza reciproca. 253 15 La realtà premeva: seguiva inesorabilmente il suo corso. Gli impegni comunali diventavano assillanti ed assorbenti ed aumentavano anche le riunioni politiche che agli amministratori, schierati col partito, non lasciavano molto tempo ed imponevano la loro presenza perché, insieme al malcontento contadino, veniva fuori anche un certo malessere per la progressiva burocratizzazione della dirigenza. Di fronte all’appressarsi del Sessantotto, alla consunzione del comunismo reale, all’esaurirsi della prospettiva di rinnovamento, nell’immaginario di quei giovani il mito contadino resisteva e riemergeva come quello di un popolo oppresso. Aldo era intervenuto nella discussione con la forza della sua poesia per chiamare all’unità. «Una nuova sconfitta» egli diceva «avverrà per la stessa mano e sarà repressione di popolo, fame, vergogna, emigrazione, crollare di paesi; sarà la fine del vostro avvenire e di quello delle vostre ragazze, che ora vagano nella tristezza di una casa mancata.» «Non bisogna cedere» continuava Aldo «abbiamo fatto tante lotte in questo nostro Sud, abbiamo creato grovigli di forze per infrangere le antiche barriere tenute alte dal potere dei padroni. Sì, è vero, qualcuno di noi è caduto e se ne potrebbero fare i nomi ed indicare i paesi, da quelli bianchi di Puglia, tinti di calce, lungo le marine, a quelli arroccati come fortezze nei cieli della Lucania, fino ai nostri paesi di Calabria, che vanno come alla deriva morsi dal fango. La nostra coscienza non deve essere appagata. Non dobbiamo dimenticare le sconfitte; anzi, le dobbiamo tenere inchiodate, come canestri, sui muri delle nostre case. Al primo lampo di un nuovo giorno, ci attendono altre lotte. In questo momento difficile, voglio lanciarvi e lasciarvi, io che sono ormai anziano, il mio messaggio di fratellanza 254 perché si possa correre verso stagioni migliori ed andare lontano per raccogliere le speranze della gente.» Erano belle e commoventi le espressioni di Aldo, che lasciarono il segno sugli astanti. L’epopea delle lotte e delle storie contadine aveva trovato in lui il suo cantore. L’ormai anziano medico, reduce dalle tante battaglie, non tralasciò neppure di ricordare i tempi delle tristi giornate delle tante emigrazioni che avevano disperso i contadini in terre straniere e quelli della guerra civile spagnola che li videro trafitti per una vile mercede e, successivamente, la guerra ed il dopoguerra, quando i baroni, che si dissero cristiani, ma erano solo fascisti, fecero sparare sui contadini che occupavano le terre incolte; fino alla strage di Portella della Ginestra, quando mafia e clerico fascismo rinnovarono l’antico patto sulla pelle dei poveri. Un certo sommovimento sotterraneo, accompagnato da mugugni e mormorii nei confronti della burocrazia di partito lo si toccava con mano; non veniva, però, fuori organizzandosi in una qualunque forma. Il timore di sfasciare tutto e di non approdare a nulla era un freno potente, che tratteneva i più consapevoli, lasciandoli nel limbo delle incertezze, costringendoli, talvolta, a rivedere le proprie posizioni, in una sorta di autoemarginazione. Pietro e gli altri giovani, concentrati nell’esercizio dell’attività amministrativa, non avevano di simili problemi che, alla fine, non intaccavano l’andamento amministrativo. Essi erano spettatori di quanto avveniva all’interno del partito alleato nel Comune, ma non avevano titolo per intervenirvi. L’Amministrazione andava a gonfie vele, riscuotendo l’appoggio della stragrande maggioranza della popolazione, fondata com’era, ormai saldamente, sui contadini, sui braccianti, piccoli e medi proprietari ed artigiani e che aveva ed esercitava una propria autonoma forza di attrazione verso altri gruppi sociali, che spontaneamente vi si aggregavano, rendendola più solida, sicura ed inattaccabile. Essa dava – come non mancava di sostenere quel gruppo di giovani – la dimostrazione che il popolo dei contadini, solo se in qualche modo aiutato, aveva in se stesso la forza di emanciparsi e di diventare classe dirigente; aveva nel proprio seno anche i tanti piccoli imprenditori, che avrebbero potuto costituire il motore del rinnova255 mento. Nel territorio comunale, infatti, non appena furono realizzate le strade interpoderali e l’elettrificazione delle campagne, i contadini si trasformarono in tanti piccoli imprenditori, dando vita ad aziende agricole con colture intensive e differenziate, lavorate con trattori ed altri mezzi meccanici, così sviluppando, come per uno spontaneo processo, un’attività complessiva, che creò altri posti di lavoro. Le potenzialità del mondo contadino furono – purtroppo! – intuite da quattro giovani inesperti di agricoltura, ma gonfi di studi classici, storici e filosofici, non furono capite o, se capite dalle alte sfere della politica, esse furono disattese, ritenendo la civiltà contadina non tale, ma solo una serie di arretratezze sociali e politiche da estirpare. Solo molto tardi, dopo molti anni che il nuovo forzato esodo dalle campagne era diventato irreversibile, i cosiddetti dotti si resero conto dell’errore. Zepa, invece, che vedeva e identificava piuttosto poeticamente il mondo contadino come il mito del popolo, che rivendica i suoi diritti, seppe reagire al riflusso ed alla progressiva disgregazione del comunismo reale: poco alla volta si allontanò dalla politica attiva, per dedicarsi all’insegnamento ed alla poesia. E proprio in alcuni suoi versi, si coglie un certo senso di impotenza e di scetticismo di fronte ad un quadro di disgregazione generale, che egli scorgeva dal suo osservatorio periferico; e la periferia diventava, così, metafora del malessere universale. E tanto lo portava a vedere la terra di Calabria spoglia, brulla, non più ricoperta da uliveti e da agrumeti, come terra maledetta, terrorizzata dall’ombra sinistra del malaffare e della delinquenza organizzata: le città diventate una bolgia, dominate da belve assatanate in cerca di denaro, non raramente intrallazzate con i nuovi politicanti. Le piccole cittadine della costa sono diventate l’immagine della solitudine e dell’abbandono con i loro vecchi e morti binari di treni, che non passano più, in un quadro aggravato dal proliferare delle associazioni malavitose che impongono il pagamento di tangenti. I nuovi padroni del Sud con in mano le attività economiche, impongono altri modelli di vita, oltre le tasse ed i balzelli. In questa terra – è la conclusione amara – è rimasta solo gramigna. Al popolo, la sola certezza di dover emigrare. Al pensatore solitario, che aveva sognato la trasfor256 mazione radicale della società col comunismo, dopo la dissoluzione di questa sorta di vero e proprio mito operativo, non restava che l’utopia: il sogno di una città migliore. Quanto diverso era Zepa da Aldo, che non aveva abbandonato la speranza in un avvenire di nuove lotte per la civiltà e la democrazia, perché la montagna si tramuti in cantiere operoso, che l’acqua dia luce amica, che brillino mine sulle rocce, che passi l’urto sui tuguri del popolo, che passino l’aratro e il trattore per dare lavoro e pane a tutti. Zepa con votazione plebiscitaria era stato eletto al Consiglio Provinciale. Ivi, i suoi interventi erano sempre di vibrante oratoria ogni volta che toccava la questione contadina e la necessità di una radicale riforma agraria, a mezzo della quale la terra fosse ripartita tra i contadini veri e non – come avveniva – per dare una focaccia per placare il malcontento giustificato delle classi popolari. Nel Consiglio Provinciale incominciarono a sorgere le prime delusioni e lì a sollevare i primi dubbi sulle reali intenzioni dei gruppi dominanti e delle stesse burocrazie di partito per non farlo trasbordare dalla linea, prefissata dall’alto. L’unità di operai e contadini restava solo sulla carta, ormai un mito inoperoso. Così, Zepa – ancora prima del sessantotto – aveva aperto gli occhi sulla realtà di un partito del tutto burocratizzato. Non nascose le ragioni della sua profonda dissonanza, della sua sfiducia e della sua delusione, pur senza distaccarsene, perché egli aveva vissuto il suo impegno politico, oltre che passionalmente, anche con dedizione totale. Ed il distacco dai sogni della sua vita non avrebbe mai potuto avvenire che non con gradualità ed in fasi successive di amarezza. Pietro e gli altri giovani, impegnati nel governo del Comune, capivano e giustificavano e vivevano la crisi intellettuale dell’amico. Ma come intervenire? Essa si dispiegava al di fuori dell’Amministrazione Comunale, la quale naturalmente nulla poteva opporre ad un così sconvolgente avvenimento di carattere internazionale, ma che indubbiamente aveva i suoi innegabili riflessi nelle coscienze individuali di milioni di uomini. L’avventura intellettuale di Zepa restava, così, una sua questione privata. Egli aveva vissuto fino in fondo, profondendo passione vivida ed impegno costante, la questione contadina con le sue aspirazioni alla rinascita ed al riscatto, aveva credu257 to nella rivoluzione socialista e nella trasformazione radicale della società. All’interno di questo processo, vedeva anche la rinascita della civiltà contadina. Il graduale obnubilamento dell’aspettativa socialista, il serpeggiare del riflusso e, poi, la restaurazione della conservazione, gli lasciarono l’ultimo mito a cui aggrapparsi: il mito del popolo che lotta per la sua liberazione in ogni parte del mondo, ma che era qualcosa di indefinibile, un intrico aggrovigliato che forse era un richiamo alla sua estrazione contadina ed una lontana e crepuscolare reminiscenza delle pregresse battaglie politiche. Più che di un politico egli aveva l’anima candida del poeta, che non riusciva a dominare una realtà cangiante, a capire la durezza del realismo politico e contro la quale avvertiva di essere indifeso. O, più semplicemente, con la caduta dei miti della illusa gioventù, avvertiva un senso di vuoto e di solitudine. E da qui la rivolta ed il ripudio. Da allora, gli amici ed i suoi compagni lo vedevano sempre più chiuso in se stesso, affogato negli studi amati come se, in essi, cercasse le sue radici e le risposte che non gli venivano da una quotidianità sfuggente ed amara. Incominciò a viaggiare per l’Italia e per l’Europa. Non lo si vedeva per lunghi periodi. Ogni tanto spediva, da qualche paese europeo o dagli Stati Uniti, ai suoi amici una cartolina di saluti. Aveva, ormai definitivamente, abbandonato la politica attiva; però, nelle manifestazioni di popolo, era sempre presente, quando si trovava in paese, particolarmente nella festa del Primo Maggio, che l’Amministrazione Comunale aveva deliberato di celebrare ufficialmente e che era diventata un appuntamento fisso per tutti i paesi della zona. Gli altri amici e fondatori del Comune democratico non abbandonarono il campo ed i giovanili ideali, anche se, con l’età, com’era del resto naturale impararono, a loro spese, ad essere più realisti e più accorti. Ma riuscirono a resistere, maturando una sicura consapevolezza politica ed un realismo politico, che rendevano più spedita l’attività amministrativa e sempre più aderente ai bisogni generali, facendo diventare il Comune un modello da imitare. Dopo alcuni lustri di impegno gratuito, speso per la comunità, ognuno prese la sua strada. Pietro andò ad insegnare storia nel liceo, continuando a coltivare i suoi 258 studi sulla realtà contadina della zona; Pasqualino si diede all’avvocatura e Damiano, da medio contadino, si trasformò in piccolo imprenditore agricolo, gestendo direttamente la sua azienda. Egli sarà anche il primo sindaco-contadino nella piccola storia e negli annali del paese; anzi, il primo sindacocontadino di tutta la zona presilana. Poi, venne il diluvio della distruzione delle piccole comunità rurali con lo spopolamento delle campagne – di collina e di pianura – e con il decremento della popolazione. Ma il nostro Comune, sia pure toccato dal fenomeno, lo fu come di striscio. La ragione fu dovuto al fatto che il collegamento e l’alleanza tra contadini, braccianti, artigiani e ceti popolari, aveva anche liberato e fatto crescere una capacità di aggregazione, da cui si sprigionò una energia nuova. Liberati dalla soggezione alla grande proprietà parassitaria e dalla soggezione psicologica nei confronti dei grandi uomini del villaggio, i piccoli e medi contadini si diedero da fare, mutando rapidamente metodi di coltivazione, ingrandendo le loro aziende, acquistando a rate le attrezzature agricole adeguate e, così, meccanizzando l’agricoltura, agevolati anche in questo dall’attività amministrativa del Comune che, nel frattempo, oltre che provvedere all’elettrificazione, aveva sostituito ai vecchi viottoli campestri, una rete di efficienti strade interpoderali che, tra di loro collegate, raggiungevano tutto il territorio, in collina ed in pianura. La scomparsa dell’arcaico ciuco fu il segno evidente di una nuova vita. Ormai il contadino s’era emancipato: per recarsi nei suoi poderi aveva gli automezzi. Erano scomparse anche altre odiose ed inumane costumanze. Non si videro più quelle fila di raccoglitrici d’ulive che, col vento o con la pioggia, sul loro dorso trasportavano, sottoponendosi ad una non lieve fatica, le olive fino al trappeto del signore. Non erano scomparse le raccoglitrici, ma era mutato il modo della raccolta attraverso l’uso di tende. Ma quel tipo di trasporto era definitivamente tramontato. Anche perché, nel cambiamento generale, anche i signori avevano finito di fare i signori. Chi di costoro era sopravvissuto nella mutata realtà sociale, ormai, se voleva campare, era stato costretto dalla forza travolgente degli avvenimenti, a fare l’imprenditore agricolo. 259 Né più e nemmeno come gli altri ex contadini, dai quali, una volta e pochi anni prima, era riverito e ossequiato, ritenuto di chissà quali doti e virtù fosse in possesso. Anche lo spagnolesco “don”, tipico appellativo dei galantuomini, era scomparso o, comunque, svalutato. Quei nostri giovani, dunque, non erano soltanto idealisti. Essi avevano i piedi ben piantati per terra; avevano intuito ed individuato nel mondo contadino in collegamento con quello bracciantile e dell’artigianato la sola forza sociale nuova, che avrebbe potuto trasformare la misera realtà meridionale, riducendo il potere del notabilato agrario. Come si era verificato nel nostro piccolo Comune. Aveva ragione il vecchio Sepantonio Petta che, mentre fumava tranquillamente la sua pipa, aveva detto a Pietro Lascaris: «Caro compare, solo l’unione dei contadini con le altre classi popolari, potrà scalzare i signori dal loro potere. Ricordatelo sempre: questa è la prima condizione. Poi, è inutile che vi sognate industrie; qui basta una buona agricoltura con tante piccole aziende e con piccole manifatture per la trasformazione del prodotto e per la sua commercializzazione. Così si lavora e si produce e si crea altro lavoro.» Questa semplice verità che, per un contadino semianalfabeta era lapalissiana, non fu presa in alcuna considerazione. Si inseguì il miraggio dell’industrializzazione per spendere un mare di miliardi di pubblico denaro, finito nelle mani degli affaristi ed in quelle delle clientele di ogni genere. Fu distrutta una civiltà millenaria, come quella contadina, imperniata sull’autonomia del Comune rurale, invece di aiutarla ad evolversi verso forme moderne, sostituendola col nulla o, meglio, lasciando un sottosviluppo pericoloso, in cui la fa da padrona la criminalità organizzata. Si è ignorato – o si è voluto ignorare – che la stessa civiltà meridionale, come provano i grandi intellettuali del Sud, da Verga a Ignazio Silone, a Benedetto Croce, Giustino Fortunato fino ad Antonio Gramsci, era espressione o, comunque, legata strettamente alle radici contadine, oltre che europee. 260 Indice La montagna sotto la neve Parte Prima Capitolo 1 .................................................................................. 11 Capitolo 2 .................................................................................. 16 Capitolo 3 .................................................................................. 22 Capitolo 4 .................................................................................. 28 Capitolo 5 .................................................................................. 32 Capitolo 6 .................................................................................. 38 Capitolo 7 .................................................................................. 41 Capitolo 8 .................................................................................. 44 Capitolo 9 .................................................................................. 52 Capitolo 10 ................................................................................ 58 Capitolo 11 ................................................................................ 64 Capitolo 12 ................................................................................ 72 Capitolo 13 ................................................................................ 76 Capitolo 14 ................................................................................ 85 Capitolo 15 ................................................................................ 91 Capitolo 16 ................................................................................ 99 Capitolo 17 .............................................................................. 104 Capitolo 18 .............................................................................. 109 Capitolo 19 .............................................................................. 118 Capitolo 20 .............................................................................. 130 Capitolo 21 .............................................................................. 137 Capitolo 22 .............................................................................. 146 Parte Seconda Capitolo 1 ................................................................................ 159 Capitolo 2 ................................................................................ 164 Capitolo 3 ................................................................................ 175 Capitolo 4 ................................................................................ 181 Capitolo 5 ................................................................................ 186 Capitolo 6 ................................................................................ 192 Capitolo 7 ................................................................................ 196 Capitolo 8 ................................................................................ 201 Capitolo 9 ................................................................................ 207 Capitolo 10 .............................................................................. 215 Capitolo 11 .............................................................................. 223 Capitolo 12 .............................................................................. 229 Capitolo 13 .............................................................................. 237 Capitolo 14 .............................................................................. 246 Capitolo 15 .............................................................................. 254 Finito di stampare nel mese di luglio 2014 BookSprint Edizioni www.booksprintedizioni.it
Scarica