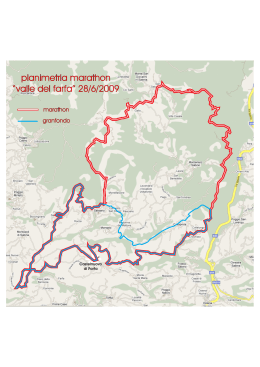Francesco Di Geronimo Francesco Di Geronimo (e su Santomenna, Laviano, Caposele, Buccino, Auletta, ed altri luoghi dell’Alto Sele) Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo è nato a Castelnuovo di Conza (Salerno) nel 1945. Docente di Italiano e Storia, si è laureato all’Università di Salerno con una tesi sul concetto di egemonia in Gramsci e specializzato in Scienze dell’Educazione all‘Università di Torino con una tesi sulla presenza degli handicappati nella scuola e nella società. È stato presidente del Consiglio provinciale di Salerno, ed è assessore della Città di Fisciano. Nel 1993 ha pubblicato La speculazione Menotti sulla stampa e nelle sentenze della magistratura. Nel 2010 ha pubblicato Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’ - Fotografie e parole del paese di una volta. Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Presentazione di Ruggiero Jannuzzelli e Francesco Custode Con un disegno di Pietro Lista ISBN 978-88-96554-11-1 € 25,00 iva inclusa Nella ricerca storica su Castelnuovo di Conza ho potuto avvalermi del prezioso contributo di diverse persone, che è doveroso evidenziare. Grazie a: Dott. Marco Grilli (Archivio Segreto Vaticano), dott.ssa Manuela Cacioli (Archivio Storico della Presidenza della Repubblica), dott.ssa Imma Ascione (Archivio di Stato di Napoli), dott.ssa Fernanda Volpe (Archivio di Stato di Salerno), dott. Nino Gallicchio (Archivio Diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi), Pietro Lista, Diego Landi, Rosamaria Guarino, Rosetta Berardinelli, Elio Venutolo, Maria Di Filippo, Ausilia Mondino, Francesco Custode, Onidia Ciriello, Pierdonato Iannuzzelli, Orazio Guarino, Emio Liloia, Teresina Pitoia, Luca Zarra. Stampa Tipografia Gutenberg S.rl. Fisciano (SA) Impaginazione e grafica Enzo Ricciardi 2013 © Copyright by Gutenberg Edizioni ISBN 978-88-7554-064-7 Proprietà letteraria riservata. Vietata la riproduzione anche parziale. Francesco Di Geronimo Notizie storiche su Castelnuovo di Conza (e su Santomenna, Laviano, Caposele, Buccino, Auletta, ed altri luoghi dell’Alto Sele) Presentazione di Ruggiero Jannuzzelli e Francesco Custode Con un disegno di Pietro Lista Ho accettato con piacere di scrivere la presentazione di questa ricerca di Francesco Di Geronimo su Castelnuovo di Conza non solo perché si tratta del luogo a tutti noi carissimo, ma anche per aver trovato in ogni frase e ogni parola dell’autore lo stesso amore che nutriamo tanti di noi che il paese l’abbiamo vissuto pienamente negli anni della nostra infanzia. Le Notizie storiche su Castelnuovo di Conza scoprono e valorizzano non solamente le radici e la cultura di tutti noi, ma anche eventi e temi che hanno coinvolto i nostri antenati e il loro vivere quotidiano con tutte le sfaccettature spesso piacevoli e semplici, ma a volte anche drammatiche. A volte si ha la sensazione di conoscere a fondo una persona, un luogo solo per alcune notizie che le riguardano, in modo più o meno completo, da qualche tradizione o notizia. Ciò implica una conoscenza “per sentito dire” e l’immaginazione diventa, a nostro giudizio, la realtà. Poi leggi le puntigliose e oneste ricerche fatte da Francesco Di Geronimo e ti chiedi: com’è e come è stato veramente il tuo paese? Il grande merito di questa ricerca è proprio quello di raccontare storie ed episodi poco noti, ma significativi della vita di questo luogo che permettono di scoprire fatti a volte miserabili, ma speso eroici della vita di un piccolo popolo che improvvisamente passa dalla lotta per un po’ di legna secca alla emigrazione con mezzi di fortuna in paesi lontani e sconosciuti, a inventarsi lavori e attività sorprendenti. Francesco Di Geronimo, innamorato anche lui di queste pietre, del suo passato e del suo territorio, si è dimostrato la persona più adeguata, con le sue pagine, a farci trascorrere bellissimi momenti alla ricerca delle nostra radici. Dopo aver scavato nelle origini, Di Geronimo ci racconta una generazione che passa e una che arriva; un feudatario che si succede all’altro come se fossero suoi coetanei nella immutabilità del paesaggio. Non si lascia scomporre dal senso di panico quando gli abitanti di questo piccolo borgo si dipartono alla conquista di una nuova vita in lontani paesi. Tutti col proposito di tornare, ma ne tornano solo alcuni. Ci accompagna per mano attraverso la puntigliosa descrizione della lotta per il diritto di portarsi a casa un po’ di legna secca al fenomeno dell’emigrazione ed al successo dei castelnuovesi “corallari”, in ogni parte del mondo. Ci dice che qualcuno non si spiegava le doti dei castelnuovesi, doti che non avevano 5 quelli dei paesi limitrofi, ma ci fa capire che quelle doti erano scaturite proprio dalle miserie e dai sacrifici affrontati per tante generazioni, per il vivere arroccati su uno sperone roccioso a combattere duramente per un po’ di fuoco. C’è in Francesco Di Geronimo la lettura di una società povera che cerca di riscattarsi dalla miseria e che ci riesce, prima strappando al feudatario una serie di diritti sulla terra e sul raccolto, poi combattendo con successo la guerra del fuoco e poi con la grande “piaga” dell’emigrazione che non vede tornare che pochi dei suoi compaesani. Di Geronimo evidenzia pure come a Castelnuovo, nelle amministrazioni comunali di fine ottocento, si manifestino le tendenze della “Sinistra storica” e come queste prevalgano sulle tendenze conservatrici. La puntuale ricostruzione storica, accompagnata alla grande capacità di raccontare di Francesco Di Geronimo, ci propone episodi visti da angolature che pochi sanno avere e che danno alla storia il sapore di una gustosissima sequenza di scoperte. Attraverso una ricerca capillare di eventi ed episodi sconosciuti e curiosi della vita di questa popolazione, ma significativi, l’autore ci fa scoprire un volto nuovo di ogni castelnuovese del passato, ma forse anche del presente. Io voglio approfittare dell’occasione e denunciare la completa distruzione di tutto quanto anche il terremoto aveva rispettato (casa mia, per esempio, dove aveva ceduto solo il tetto che era caduto per lo spostamento di una trave di colmo). Più del terremoto Castelnuovo fu distrutto dalle mani rapaci di speculatori, imprese ancora una volta venute dal nord e politici, fu abbattuto col consenso delle autorità all’unico scopo di relizzare metri cubi di macerie che arricchirono le imprese e, ancora una volta, le tasche dei governanti. Voglio rammentare a tutti quel detto romano, tramandato nei secoli: “quello che non poterono i barbari, poterono i Barberini” alludendosi alla distruzione della città eterna da parte della potentissima famiglia Barberini, di cui faceva parte Urbano VIII. A me viene spontaneo, avendo visto Castelnuovo il giorno dopo il terremoto e dopo le demolizioni, dire “a distruggere Castelnuovo più che il terremoto furono gli avvoltoi”, che a fini di lucro si avventarono sulla storia cancellandola e riducendo in macerie anche ciò che poteva non essere demolito. Anche la ricostruzione non è stata fedele, casa mia è stata ricostruita due metri più stretta. Questa mia è una denuncia dei mali di cui ha sofferto e soffre non solo il nostro paese, ma tutto il sud d’Italia fin dalla “Unità”. Come allora i piemontesi svuo6 tarono le banche e le industrie del “Regno”, in occasione del terremoto vi furono imprese che, partite da Verona, si avventarono sulle nostre pietre. E’ facile immaginare, se avessero salvato delle cose, come sarebbe bello oggi avere un museo con gli altari della chiesa della Petrara. Uno di questi, nella navata di sinistra vicino al battistero, l’aveva fatto costruire mia nonna in granito rosso e marmo di Carrara in memoria di una sua figlia morta a 22 anni in un convento di clausura a Portici. O anche il movimento meccanico in bronzo dell’ottocento, o le travi in rovere del sottopassaggio all’inizio di Via Roma, o la chianga che affacciava sulla piazza e che serviva a noi bambini per giocare; e tante altre mille cose, come la scalinata interna di casa di Attilio Sessa al castello, in porfido rosso; ed ancora… Nonostante questo è doveroso un plauso a tutti quelli che hanno ricostruito passando da sconfitte e vittorie, e che nonostante tutto ci fanno comunque amare questo sperone di roccia. Ruggiero Jannuzzelli Presidente d’Onore Camuzzi International S.p.A. 7 Vi racconterò qualcosa che non troverete nel libro. Francesco Di Geronimo è un mio caro amico e come tale mi sono accompagnato a lui nella fatica, nella gioia della scoperta, nella costruzione lenta e affascinante dell’opera “Notizie storiche su Castelnuovo di Conza”. Un giorno, durante una delle nostre lunghe e piacevoli chiacchierate, mi ha detto: “quasi tutti i paesi hanno un testo con la loro storia, e Castelnuovo no” e, come un padre che non fa mancare nulla ai suoi figli, si è messo al lavoro. Da quel momento non è passato giorno in cui non ci siamo sentiti per commentare la scoperta di un documento che proveniva dall’Archivio di Stato di Salerno o di Napoli, piuttosto che dall’Archivio Vaticano o dalla Curia di Sant’Angelo dei Lombardi. Francesco ha lavorato sin dal primo momento con l’entusiasmo candido di un fanciullo e la saggezza di un uomo che ha conosciuto il mondo ma non ha mai perso il legame con il suo paese natio. E nel lavoro di ricostruire gli avvenimenti storici della nostra terra ci ha messo la passione ma anche la serietà dello studioso, la perseveranza del ricercatore, la razionalità dello storico. Ora, grazie a Francesco Di Geronimo, anche il nostro paese ha un libro che raccoglie la sua storia. Ma io mi permetto di dire che quello di Francesco non è il solito libro di storia locale. Francesco Di Geronimo con il testo “Notizie storiche di Castelnuovo di Conza” ricostruisce anche frammenti mai approfonditi della storia generale. Una rigorosa analisi del territorio, la riflessione sui toponimi, il racconto dello storico bizantino Agazia, che Di Geronimo va a leggere ed analizzare nel testo greco originale, lo portano a ipotizzare l’edificazione nel 554 da parte del generale bizantino Narsete di una chiesa a San Menna, che ha poi dato il nome all’abitato di Santomenna. Derivandone - di conseguenza - l’esistenza di Castelnuovo in quello stesso tempo. La lettera del 1200 di papa Innocenzo III al vescovo di Conza, Pantaleone, perché elimini residui di culto bizantino a Buccino, Auletta e Vietri è un’assoluta scoperta di Francesco Di Geronimo, che l’ha tirata fuori dall’Archivio Segreto Vaticano. Lettera che non risulta conosciuta ed analizzata prima di lui da altri storici che si sono occupati di Conza e della sua diocesi. Così come è assolutamente puntuale la sua ricostruzione della scomparsa nel 1580 della chiesa di S. Menna a Santomenna, che 9 Donatantonio Castellano, nella sua Cronista Conzana, presenta in maniera “deformata”, mentre Di Geronimo va direttamente alla fonte e ci fa sapere che quella chiesa fu fatta demolire dall’Arcivescovo di Conza Marco Antonio Pescara, che era anche il barone di Santomenna. Francesco Di Geronimo sa anche toccare la sensibilità del lettore, ricostruendo la storia romantica e tragica dei due amanti Maria D’Avalos e Fabrizio Carafa, uccisi dal marito di lei, il geniale musicista Carlo Gesualdo, principe di Venosa e signore di Buoninventre. La ricomposizione storica di quella che l’autore definisce “la guerra del fuoco”, ridà a Castelnuovo di Conza la consapevolezza di un aspro conflitto per la legna da ardere portato al successo dopo quasi un secolo di alterne vicende. All’interno di quel conflitto splende l’operato di generosi ed eroici castelnuovesi, dal sacerdote Vincenzo Di Domenico, condannato a sette anni di ferri, al sindaco facente funzioni Francesco Di Donato, anch’egli carcerato dopo i fatti del 1848, ai carbonari del 1828 Vitantonio Di Geronimo, Vincenzo Di Donato, Luigi Iannuzzelli e Francesco Ricciulli, ospiti anche loro delle carceri borboniche. Estremamente interessante è lo spaccato sociale e culturale che l’autore evidenzia nel capitolo Castelnuovo, l’Africa e l’epopea del corallo e che fa di questo paese un “fenomeno commerciale”, con alcuni protagonisti, viaggiatori commercianti di corallo, coinvolti nel 1861 nell’affondamento del piroscafo Ercole che portava verso Napoli il poeta garibaldino Ippolito Nievo e i documenti contabili della spedizione dei Mille. Che la cultura sia importante Di Geronimo lo dimostra attraverso il resoconto dell’azione di Gennaro Venutolo e delle sue ricerche e scoperte archeologiche. Allora forse la vera risorsa sta sotto i nostri piedi e non siamo in grado di vederla e quindi si può sostenere che l’Italia crescerà solo con la cultura che, come la formazione, la ricerca, l’ambiente, è la nostra risorsa naturale. Castelnuovo di Conza, piccolo centro dell’entroterra, nell’opera storica di Francesco Di Geronimo, è protagonista assoluto di una storia fatta di grandi personaggi, o di uomini meno noti (almeno fino a prima della scrittura del libro) coinvolti in eventi significativi della storia collettiva e della nostra identità. E’ una storia che ripercorre i fatti, i personaggi, i luoghi, senza necessariamente sentir l’obbligo di riempiere vuoti di un racconto sincrono ad una canonica e sistematica linea del tempo (dalla preistoria ai nostri giorni). Per questo è bello e piacevole leggere il libro 10 di Francesco, ogni capitolo ha una vita a sé, è un racconto concluso, che ti appassiona dalle prime battute e ti trascina nel linguaggio morbido e limpido dell’autore fino alla scoperta di “come andrà a finire?” E’ il racconto di un patrimonio di idee e di cultura, ma soprattutto di quello spirito castelnuovese che ormai sembra conformarsi in una sopravvivenza sedentaria e senza impulsi, tipica dell’età moderna. Il libro di Francesco Di Geronimo ci spinge a riflettere. Non possiamo fare a meno di pensare al valore della storia come racconto della trama del tempo, ma anche come identificazione di una civiltà, al valore della cultura e del ruolo che oggi per noi assume. Certo la cultura non è un bene materiale, e oggi più che mai sembra che se ne possa fare a meno. Eppure la cultura per noi italiani è la risorsa più importante, cultura è “creatività, competitività, crescita, libertà”. L’amministrazione di un paese, il suo sindaco, la politica in generale, non possono esimersi dal valorizzare tutte quelle iniziative che hanno una valenza culturale. Non è sempre indispensabile costruire, edificare, fabbricare con le pietre o il cemento, anche ciò che è immateriale fa un paese. Oggi posso dire grazie a Francesco Di Geronimo a nome di tutti i nostri conterranei, ma anche di quelli che sono il futuro di Castelnuovo, per aver costruito, edificato, fabbricato cultura. Francesco Custode Sindaco di Castelnuovo di Conza 11 Capitolo I Antichità di Castelnuovo di Conza 1.1 L’antichità di Castelnuovo Quanto è antica Castelnuovo di Conza? Il grande geografo del diciottesimo secolo, Lorenzo Giustiniani, così scrive in proposito: CASTELNUOVO DI CONZA, terra in Principato citra, in diocesi della città di Conza, dalla quale ne dista miglia 4. La medesima non ha altra antichità, che quella di circa quattro secoli1. Aggiunge lo studioso: L’aria che vi si respira è buona stando situata in luogo eminente. Il territorio produce varie specie di vettovaglie, che sopravanzano al bisogno de’ cittadini. Inoggi i medesimi ascendono al numero di 1200 incirca, quasi tutti addetti alla sola agricoltura. Gli abitanti nel 1532 furono tassati per fuochi (famiglie) 35, nel 1545 per 57, nel 1561 per 71, nel 1595 per 83, nel 1648 per 50, e nel 1669 per 26. Inoggi si possiede dalla famiglia Mirelli de’ principi di Teora. Attilio Zaccagnini-Orlandini, nel 1861, compila un Dizionario dei Comuni dello stato unitario. Alla voce Castelnuovo di Conza scrive: Nella distanza di miglia 4 dalla città di Conza siede questa borgata che appartenne ai Mirelli di Teora e che fu costruita sul cadere del secolo XIV. Popolazione 17242. Ma è veramente così? Veramente Castelnuovo fu costruita alla fine del quattordicesimo secolo? E, prima, cosa c’era? Quando e perché fu costruito il castello che dà il nome al paese? Una risposta certa a queste domande, ovviamente, non la abbiamo e non può averla nessuno. Tuttavia, sulla base di fatti storici, con lo studio del territorio dell’alto Temete e attraverso l’interpretazione delle tracce che i nomi dei luoghi si portano dietro, è possibile fissare l’esistenza di Castelnuovo a quasi mille anni prima di quanto ci hanno detto Giustiniani e Zaccagnini-Orlandini. Le ricerche, e le riflessioni, di cui diamo conto in seguito attestano l’esistenza di Castelnuovo già nel sesto secolo dopo Cristo, e precisamente nell’anno 554. Vediamo come e perché. Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Napoli, 1797. Attilio Zaccagnini-Orlandini, Dizionario topografico dei Comuni compresi entro i confini naturali dell’Italia, Firenze, 1861. 1 2 13 1.2 Il 554 dopo Cristo e la guerra greco-gotica Il terremoto del 23 novembre 1980 ha buttato giù la parte più antica di Castelnuovo di Conza, quella edificata sullo sperone, con alla sommità il castello, da dove si spazia con la vista in ogni direzione e si controlla l’alta valle del Temete. Lo sperone con i resti del castello La ricostruzione, che pure ha interessato una parte del centro storico (quella dal Serrone a Piazza Umberto I° - Lu Chianieddh’) conservando il primitivo impianto, si è dovuta fermare subito dopo l’arco che dalla piazza 14 portava alla vecchia Via Roma fino alla chiesa della Petrara. Quest’area è stata oggetto di un intervento, fermatosi purtroppo a metà, di recupero del vecchio impianto urbanistico per tirar fuori dalle macerie le vecchie strade e far tornare alla luce la pianta del paese com’era prima del terremoto, quasi a riscoprire una novella Pompei. E’ perciò possibile oggi ripercorrere le strade di una parte del vecchio abitato, a partire dal pavimento e dal muro perimetrale della chiesa di San Nicola. La pianta dell’antica chiesa di San Nicola Di questa antichissima chiesa si vedono i gradini d’ingresso, insieme al sedile in pietra prima dell’entrata, lo scalino dell’altare, la base della campanella e quella dell’orologio. Più avanti, percorrendo quella che una volta 15 era Via San Nicola, si può osservare come i muri delle vecchie abitazioni si innestavano su piccole cavità scavate nella roccia, sulle quali erano successivamente poggiati, su travi di legno, i solai dei piani superiori. Alcune fotografie che pubblichiamo in queste pagine rendono plasticamente evidente quelle che sono le lontane origini di Castelnuovo. Grotte scavate nella roccia di Castelnuovo di Conza Ma quando sono state scavate le cavità e le grotte su cui si è edificato l’antico borgo di Castelnuovo? Quando è stato edificato il castello? Questo non possiamo saperlo; potremmo però capire quando già c’era il castello, e cioè che il castello c’era nell’anno 554 dopo Cristo. Secondo la nostra ipotesi, che sviluppiamo nelle pagine seguenti, ha a che vedere con Castelnuovo di Conza ed il territorio dell’alto Temete un grande imperatore dell’Impero Romano d’Oriente, Giustiniano (nato nel 482 d.C.; imperatore dal 527 fino alla morte avvenuta nel 565)3. Giustiniano ha a che vedere con l’Italia, che riporta sotto il potere imperiale, ed anche con il territorio dell’alto Temete interessato dalla presenza dell’esercito bizantino agli ordini di Narsete negli anni 554 e 555. 3 16 Ravenna, Basilica di San Vitale, Giustiniano e il suo seguito Parliamo di quell’anima beata che Dante Alighieri colloca nel cielo di Mercurio tra gli spiriti attivi, ed alla quale, nel VI canto del Paradiso, il sommo poeta fa dire: Poscia che Costantin l’aquila volse contr’al corso del ciel, ch’ella seguio dietro a l’antico che Lavina tolse, cento e cent’anni e più l’uccel di Dio ne lo stremo d’Europa si ritenne, vicino a’ monti de’ quai prima uscìo, e sotto l’ombra de le sacre penne governò ’l mondo lì di mano in mano, e, sì cangiando, in su la mia pervenne. Cesare fui e son Iustinïano, che, per voler del primo amor ch’i’ sento, d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano… 17 Giustiniano è principalmente ricordato per il suo Corpus Iuris Civilis, come colui cioè che, togliendo il troppo e il vano, mette ordine nella legislazione romana che, fra leggi e giurisprudenza, aveva accumulato nel corso dei secoli una mole immane di norme. Ma Giustiniano è anche l’ultimo imperatore che, da Costantinopoli, tenta di riportare sotto il dominio de l’uccel di Dio, l’aquila che è il simbolo dell’impero, il nord dell’Africa e la penisola italica, che nel sesto secolo dopo Cristo sono dominate rispettivamente dai Vandali e dai Goti. E’ l’ideale della renovatio imperii, la ricostituzione dell’impero romano, che Giustiniano persegue tenacemente con l’obiettivo di riportare lo stato entro i vecchi confini geografici, e farne rivivere l’assetto amministrativo, religioso e culturale, per arrivare, in definitiva, ad uno stato, una legge, una chiesa. Il sovrano si affida perciò a Belisario, generale al quale -per dirla ancora con Dante- commendò l’arme, delegandogli la direzione militare delle imprese. Belisario riporta ben presto sotto il dominio di Bisanzio l’Africa del nord, e successivamente viene inviato in Italia che, dall’anno 493 (Teodorico re d’Italia), è governata dai Goti. 1.3 La guerra greco-gotica (535-555). Giustiniano si riprende l’Italia La guerra gotica, come la chiama lo storico ufficiale di quegli eventi, Procopio da Cesarea, inizia nell’anno 535 con lo sbarco in Sicilia di diecimila 18 soldati bizantini al comando del generale Belisario, con i poteri straordinari di strategos autokrator. La guerra si protrae con alterne vicende, senza però che Belisario riesca a riportare la penisola sotto l’autorità dell’impero. Nell’anno 552 Giustiniano, che aveva già richiamato Belisario, invia in Italia un nuovo condottiero ed abile diplomatico, Narsete, al quale parimenti affida i pieni poteri, con l’intento di chiudere definitivamente la partita con i Goti. Narsete capovolge la strategia militare: laddove Belisario amava temporeggiare ed evitare lo scontro frontale con l’esercito nemico, il nuovo generale cerca la battaglia a tutto campo e fa valere la migliore organizzazione e capacità di manovra dell’esercito bizantino. Ed in effetti risolverà la partita con i Goti in due sole battaglie, quella di Busta Gallorum (Gualdo Tadino) e quella dei monti Lattari, nei pressi dell’odierna Angri in provincia di Salerno. Da Costantinopoli Narsete raggiunge l’Italia con un forte esercito risalendo la penisola balcanica, attraversa la Dalmazia e l’Istria e giunge ad Aquileia. A questo punto si aprono di fronte a lui due strade per raggiungere Ravenna (capitale del regno italogotico): una lungo la costa ed attraverso la laguna veneziana, l’altra –interna- che passa per Treviso. La strada interna, certamente più rapida, è però molto pericolosa, perché ottimamente presidiata dai Goti, e così Narsete decide di Ravenna, Basilica di San Vitale, Narsete rivolgersi ai veneziani4 chiedendo (accanto a Giustiniano) Secondo la Cronaca Altinate del decimo secolo, il primo insediamento a Venezia sulla Riva Alta (Rialto) risale al 25 marzo dell’anno 421 con la consacrazione della chiesa di San Giacomo sulle rive dell’attuale Canal Grande. I bizantini con il termine Venezia marittima intendevano tutta la fascia costiera da Chioggia a Grado; per veneziani sono dunque da intendere tutti gli abitanti della fascia costiera. 4 19 il loro aiuto per il passaggio delle truppe. L’aiuto viene concesso, i veneziani mettono a disposizione del generale bizantino le loro imbarcazioni e Narsete percorre la via costiera, poiché, quando l’esercito venisse a trovarsi sullo sbocco dei fiumi, formando con quelle barche un ponte sulla fiumana, più facilmente e con minor travaglio potesse passare5. La tradizione vuole che durante la fase preparatoria il generale Narsete si fermi a Rialto ed esprima un voto: in caso di vittoria nella guerra contro i Goti tornerà e farà erigere due chiese6; Gli Storici Veneti raccontano, che trovandosi questo Generale a Venezia fece voto fabbricarvi due chiese, se riportava da’ nemici la vittoria, come testificano la tradizione antica, la testimonianza delle stesse chiese e l’elogio seguente7. L’elogio seguente è quello dello storico Paolo Diacono che, nella Historia Longobardorum, così descrive il generale e diplomatico bizantino: Erat autem vir piissimus, in religione catholicus, in pauperes munificus, in recuperandis basilicis satis studiosus, vigiliis et orationibus in tantum studens, ut plus supplicationibus ad Deum profusis quam armis bellicis victoriam obtineret8. Narsete, ci dice Paolo Diacono, era un uomo molto pio, fervente cattolico, generoso con i poveri, zelante nella costruzione di chiese, tanto portato alle veglie e alle orazioni che otteneva la vittoria più con le suppliche a Dio che con le armi della guerra. Nella guerra dei bizantini contro i Goti è presente una componente di carattere religioso: i Goti, anche se tolleranti ed aperti alla libertà di culto per i latini, sono seguaci dell’eresia ariana9; che un vir piissimus quale Narsete sicuramente ritiene di dover combattere. Il condottiero, cioè, agisce con due riferimenti ugualmente importanti, uno politico-militare, l’altro religioso-devozionale. Procopio di Cesarea, La guerra gotica, libro IV, capitolo XXVI. Lebeau e Crevier, Storia degli imperatori romani, Napoli, 1847 - “Dicesi che Narsete, passando vicino alla laguna di Venezia, si fermasse all’isola di Rialto per farvi quivi le sue preghiere, e che facesse voto di fabbricare due chiese, se otteneva la vittoria”. 7 Marcus Wesler, Lo Squitinio della libertà originaria di Venezia, con un discorso di Luigi Helian Ambasciatore di Francia, contro i Veneziani, tradotto del Latino, e con note storiche, In Colonia, Appresso Pietro del Martello, 1681. 8 Paolo Diacono, Historia Longobardorum, Libro II, capitolo III. 9 L’arianesimo è il nome con cui è conosciuta la dottrina sulla natura di Cristo elaborata dal monaco e teologo cristiano Ario (256-336). Sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio. Ario non negava la Trinità ma subordinava il Figlio al Padre. Fu condannato dal Concilio di Nicea del 325. 5 6 20 Non ci soffermiamo sulle imprese militari di Narsete, dal voto fatto a Rialto fino alla battaglia decisiva che si combatte in Campania nel 553; lo scontro con l’ultimo re dei Goti -Teia- avviene vicino al fiume Sarno. I due schieramenti si fronteggiano per più di due mesi, ma il tradimento del comandante della flotta gotica, che si vende ai bizantini, priva i Goti dei rifornimenti, costringendoli a prendere l’iniziativa. In un primo momento Teia si dirige su per i monti Lattari alla ricerca di alimenti per i suoi soldati e di foraggio per i cavalli, ma non ne trova a sufficienza, anzi i soldati soffrono la fame, e allora decide di scatenare la battaglia sorprendendo con la sua azione fulminea le truppe bizantine. Alexander Zick (1845-1907), La battaglia dei monti Lattari (la figura centrale in nero è Teia) Ci sono due giorni di scontri durissimi durante i quali i Goti subiscono gravi perdite, ma le sorti della battaglia sono ancora incerte; il re Teia si batte come un leone ma, essendo il suo scudo pieno di dardi, se ne fa passare un altro. Durante il cambio rimasegli per un istante scoperto il petto; ed il caso fece che un dardo lo colpì per modo che subito ne venne a morte10. I 10 Procopio di Cesarea, La guerra gotica, libro IV, capitolo XXXV. 21 bizantini gli spiccano la testa dal collo e, infilzatola su una lancia, la vanno mostrando ai combattenti dell’esercito goto. Questi, anche se privi del loro re, combattono coraggiosamente fino a notte, ed ancora per un altro giorno. Alla fine, però, accettano le condizioni di Narsete: deporre le armi, cedere il cospicuo bottino saccheggiato e conservato nel castello di Cuma, ritornare oltralpe con le proprie famiglie. E’ questa l’ultima battaglia di Narsete? Di fatto la guerra dell’Impero Romano d’Oriente contro i Goti in Italia finisce qui; lo stesso Procopio chiude la sua opera con la descrizione della battaglia dei monti Lattari. 1.4 L’ultimo episodio della guerra greco-gotica. L’assedio di Conza Però Narsete deve continuare a combattere. Prima contro bande di FrancoAlamanni guidati dai fratelli Leutari e Bucelino, che sconfigge rispettivamente a Pesaro e a Capua. Poi l’ultimo episodio, quello che secondo la nostra ipotesi interessa Castelnuovo di Conza; ce lo racconta un altro storico bizantino, Agazia11: settemila Goti superstiti, alcuni scampati alla battaglia dei monti Lattari ed altri raccoltisi da varie parti d’Italia, si rifugiano nella fortezza di Conza. Il loro capo è un guerriero unno di nome Ràgnari. Vito Acocella, nella sua Storia di Conza, ricorda che presso i Goti la valle superiore dell’Ofanto, dominata dall’arx di Conza, fu reputata un vasto accampamento trincerato. In quella s’era sicuri di non esser sorpresi quando i monti che la chiudevano fossero ben muniti di castelli, -e all’uopo v’erano rocche inespugnabili e forti di sbarramento,- mentre si poteva invadere, per mezzo di numerose vie, le regioni confinanti, ed impedire, nello stesso tempo, al nemico le più facili e rapidi comunicazioni. Acocella ricorda anche che Conza fu occupata dai Goti verso il 534, e divenne , per la sua posizione militare, valido centro di difesa, una vera piazzaforte, τὸ φρούριον ἀνεχώρουν,- come la Agazia nacque a Myrina nel 536 circa, studiò legge in Egitto, ad Alessandria, per poi tornare a Bisanzio per terminare la sua istruzione e praticare come avvocato (scholasticus) nei tribunali. Malgrado ciò la letteratura era la sua ambizione. Scrisse un gran numero di brevi poemi d’amore in metro epico. Dopo la morte di Giustiniano, alcuni amici lo persuasero a scrivere una storia dei loro tempi. Questa opera in cinque libri, Sul regno di Giustiniano, continua la storia di Procopio da Cesarea, e costituisce la principale fonte per gli anni tra il 552 e il 558. Gli argomenti centrali dell’opera di Agazia sono le guerre combattute dall’esercito imperiale, agli ordini di Narsete, contro i Goti, i Vandali, i Franchi. 11 22 chiama lo storico bizantino di quel secolo, Agazia, -conservando la potenza e l’autorità che aveva come municipium romano. Conza –sottolinea ancora l’Acocella- fu una delle poche città che, con tutta la guarnigione, rimase fedele ai Goti e fu difesa non solo dalla milizia gotica ma anche da quella cittadina, non volendo questa soggiacere al dominio dei bizantini12. Dopo Pesaro e Capua, Narsete è a Roma dove i suoi soldati festeggiano le ultime vittorie su Leutari e Bucelino (Carico dell’immenso bottino dei vinti che componevasi delle ricchezze rapite a tutta Italia, l’esercito di Narsete tornava a Roma; e le vie della città erano liete dello strepito dell’ultima pompa trionfale della cui vista godessero i Romani. I guerrieri vincitori or davansi in braccio al piacere, e alleggerita la fronte dall’elmo, e deposto lo scudo pesante, gioivano fra le tazze e i suoni della lira…13), ma deve ancora una volta muovere l’esercito e prepararsi a combattere. Gli studiosi Franco Celetta e Michele Carluccio ritengono che i residui Goti avessero raggiunto Conza venuti su dalla valle del Sele, e che i bizantini avessero, da una parte, provveduto a bloccare quella via di fuga e, dall’altra, percorso la via Appia e i tutti i suoi diverticoli irpini così da chiudere il cerchio intorno ai ribelli14. La ricostruzione di Celetta e Carluccio circa le operazioni militari di Narsete individua i due siti che oggi corrispondono a Castelnuovo di Conza e a Santomenna (…) l’uno come anello del sistema difensivo (dei Goti) e sentinella verso sud (…), l’altro come base di operazioni verso il primo posto difensivo di cui è necessario impadronirsi15. Infatti, dopo aver risalito il Sele ed il Temete, i bizantini per raggiungere la città di Conza devono superare il varco appenninico e scendere nell’alta valle dell’Ofanto. Ma, prima della sella di Conza (varco appenninico), incontrano un complesso strategico-militare costituito da una castrum alla sommità di uno sperone (ad est) e da una torre collocata su un monticello (ad ovest), poste a controllo del tratturo Solofrana, parte finale della via che in epoca romana univa Volcei a Compsa. La conformazione del terreno è tale che un pugno Vito Acocella, Storia di Conza, Benevento, 1927. Ferdinando Gregorovius, Storia della Città di Roma nel Medio Evo, Venezia e Torino, 1866. 14 Franco Celetta e Michele Carluccio, Santomenna Città dei Vescovi, Salerno, 2004. 15 Franco Celetta e Michele Carluccio, Santomenna Città dei Vescovi, Salerno, 2004. 12 13 23 Castelnuovo di Conza, i resti del castello (in primo piano) ed il monte di Torricella (a destra nella foto) Ruderi di Torricella in primo piano e Castelnuovo sullo sfondo. L’esercito di Narsete doveva passare in mezzo 24 di armati nella roccaforte (Castelnuovo), in collegamento con altri armati nella torre (Torricella), possono impensierire anche un potente esercito nel passaggio verso Conza. Lo studioso del territorio dell’alta valle del Sele, Nicola Filippone, così intende la funzione di Torricella: Un punto fondamentale per il controllo di tutta la valle del Temete, come delle vie di accesso ad essa, è costituito da un monte fittamente arborato, situato esattamente al centro della valle, dal quale si domina sia l’accesso dalla valle del Sele, che il Valico di Conza (…). La località, indicata col toponimo Bosco Torretta o Torricella, è citata per la prima volta in fonti del XII secolo16. Filippone, che ha studiato sul posto le rovine di Torricella, così descrive quanto ne rimane: sulla sommità del monte sopravvivono i resti di un insediamento fortificato, costituiti da ruderi di una cinta muraria e quelli attribuibili ad una torre. La torre, situata sul lato Est delle mura, è a pianta quadrata, ed occupa il punto più elevato del colle. I ruderi affiorano mediamente per 60 cm. dal piano di calpestio interno –mentre è quasi completamente interrato l’esterno-, fatta eccezione per un consistente brano murario sul lato Est della costruzione. Le dimensioni della torre –che non presenta tracce di aperture- in pianta sono di m. 5,10 x 5,30 (rispettivamente i lati Sud ed Est, dato che gli altri due non sono completamente misurabili per l’interramento). Gli spessori murari di questa costruzione sono mediamente di m. 2. E’ difficile attribuirne i resti ad una determinata tipologia costruttiva: i muri sono in pietra calcarea locale adoperata allo stato grezzo, dalle dimensioni incostanti; sono poco evidenti i piani di posa, diseguale lo spessore dei giunti di malta. La robustezza della costruzione era evidentemente giocata sugli spessori delle murature e sulla buona qualità della malta (…) La fortificazione era posta a ridosso della strada –della quale resta ancora qualche traccia di selciato-, che provenendo dall’alte valle del Sele (lungo l’antico percorso della Volcei-Compsa), attraversava il Temete presso il ponte omonimo, non seguiva l’attuale percorso che conduce alla Sella di Conza attraverso il fondovalle, bensì preferiva un tracciato che svolgeva lungo la dorsale tra il Temete ed il torrente Casolaro, più al sicuro da imboscate e protetto dalla postazione militare…17. In merito alla datazione delle strutture murarie di Torricella vanno segnalati i saggi effettuati nel 1986 da W. Johannowskj. Il soprintendente ai beni archeologici, sull’impulso dato alle ricerche dallo studioso castelnuovese Gennaro 16 17 Nicola Filippone, L’alta valle del Sele tra tardo Antico ed Alto Medioevo, Napoli, 1993. Nicola Filippone, L’alta valle del Sele tra tardo Antico ed Alto Medioevo, Napoli, 1993. 25 Venutolo, attesta resti di insediamenti sannitici del IV secolo a.C. nelle contrade di Cupone e Sant’Ilarione. Qui, oltre ad un’enorme quantità di tegole frantumate e mura megalitiche, il saggio di scavo ha evidenziato terreno combusto nella paleo superficie raggiunta (circa un metro dal piano di campagna)18. La puntuale descrizione che Nicola Filippone fa di Torricella, frutto di un attento studio del territorio avviato con l’Università di Salerno, al quale è auspicabile faccia seguito una mirata campagna di scavi, va accompagnata da una riflessione più ampia sull’intero teatro dell’alta valle del Temete, compresi i siti di Castelnuovo di Conza e Santomenna. 1.5 I bizantini a Santomenna. I Goti a Castenuovo e Torricella La funzione difensivo-militare di Torricella messa in luce da Filippone va infatti completata con l’identificazione di un’analoga funzione del castrum impiantato sullo sperone; le due fortificazioni, che insieme controllano il passaggio verso Conza, spiegano l’utilità del sito di Santomenna quale postazione di accampamento e di attesa. Avanziamo perciò un’ipotesi basata sulla lettura degli elementi materiali sul territorio dell’alta valle del Temete e degli avvenimenti di cui furono protagonisti l’esercito bizantino di Narsete e gli ultimi Goti in armi ancora presenti in Italia, così come li racconta Agazia. Conza vista dal varco appenninico in territorio di Castelnuovo (in fondo Cairano) La Torricella, pubblicazione trimestrale di cultura e attualità, anno 1°, numero 0, Castelnuovo di Conza, 1988. 18 26 Facciamo parlare lo storico bizantino: Subito Narsete avanzò contro di loro (i Goti a Conza) con tutto l’esercito ma poiché non gli era possibile avvicinarsi al villaggio con un attacco di sorpresa (ἐπειδὴ αὐτῷ οὐχ οἷόν τε ἦν ἐξ ἐπιδρομῆς τῷ φρουρίῳ πελάζειν) e correre dei rischi in un luogo impervio, si dispose all’assedio e stava in guardia da ogni parte (πάντοθεν ἐφρούρει) affinché nulla fosse introdotto a quelli che erano all’interno né andassero facilmente dove avessero voluto (μηδέ γε ἐκεῖνοι ἀδεῶς ᾗ βούλοιντο ἴοιεν)19. E’ l’anno 554 dopo Cristo. Qui Agazia dice esplicitamente che a Narsete non è possibile avvicinarsi a Conza con un attacco di sorpresa; e, inoltre, che cosa significa che Narsete stava in guardia da ogni parte affinché nulla fosse introdotto? E che cosa significa che Narsete era attento a che gli assediati non andassero facilmente dove avessero voluto? Queste due annotazioni di Agazia risulterebbero pleonastiche nell’ipotesi di un assedio tradizionale, e cioè con tutto l’esercito bizantino schierato immediatamente a circondare la collinetta di Conza; in un caso del genere è chiaro che niente può essere introdotto e che gli assediati non possono andare da nessuna parte. Esse invece hanno senso se l’assedio di Narsete non è alla collinetta tout court, ma consiste nel controllo a più ampio raggio del territorio circostante la cittadella di Conza. Conza ed il territorio circostante 19 Agazia, De bello Gothorum, II, 13, 4. 27 Non dimentichiamo che Conza, come già osservato dallo storico Vito Acocella, costituiva un vasto accampamento trincerato nel quale si era sicuri di non essere sorpresi, quando i monti che la chiudevano fossero ben muniti di castelli, etc.20. Per castelli di Conza bisogna intendere le difese naturali che, scelte su vette di rupi tagliate a picco, la chiudono in un ampio circuito –con raggio di circa sei chilometri- di una serie di fortezze, quali Calitri, Pescopagano, Montecalvo, Cairano, Morra, Teora, e Castelnuovo di Conza, castrum certamente importante perché, insieme con Torricella, controlla la strada che dal Tirreno porta all’Adriatico. Conza, quale complesso militare difensivo, è così descritta anche da Giuseppe Gargano: Essa, posta a cavaliere dell’alta valle dell’Ofanto, fra una corona di alture, sulle quali erano, vigili scolte, i castelli di Calitri, Cairano, Pescopagano, Castelnuovo di Conza, Viario, castello ora distrutto presso Teora, era una vera fortezza naturale e, costituendo il nodo delle vie provenienti dall’Apulia, lungo l’Ofanto, dalla Lucania, lungo il Sele, e da Benevento, lungo il Calore, fu per gl’Irpini, per i Romani e poi per i Goti, i Greci e infine per i Longobardi un importante posto militare21. Consideriamo, allora, quanto scrive Agazia circa il comportamento dei Goti assediati: Tuttavia, sdegnandosi per il blocco dei Romani (i bizantini) e considerando una vergogna essere fermati e catturati se avessero indugiato un po’ di più nel piccolo spazio circostante (εἰ μέλλοιεν οὕτω δὴ ἐπὶ πολὺ ἐν περιβόλῳ μετρίῳ), facevano frequentemente delle cariche contro i nemici nel tentativo di respingerli, ma non compivano nessuna azione degna di ricordo22. Che cos’è il piccolo spazio circostante, nel quale i Goti avrebbero potuto essere fermati e catturati dai bizantini se avessero indugiato un po’ di più, se non il territorio tra la collinetta di Conza ed il sistema dei castelli che la circondano? Se avessero indugiato un po’ di più indica, poi, con estrema chiarezza una situazione spaziale per la quale i Goti assediati non sono immediatamente visibili dai bizantini assedianti; che però non sono nemmeno tanto lontani da non poterli raggiungere e catturare se avessero indugiato… All’interno di quello che possiamo definire sistema Conza, anche l’identi- Vito Acocella, Storia di Conza, Benevento, 1927. Giuseppe Gargano, Ricerche storiche su Conza antica, Avellino, 1934. 22 Agazia, De bello Gothorum, II, 13, 6. 20 21 28 ficazione fisica del rifugio dei settemila Goti è oggetto di interpretazione. Gli irriducibili guerrieri, ci dice Agazia, si rifugiano nella fortezza di Conza (αὐτίκα οἵ γε ἐς Κάμψας τὸ φρούριον ἀνεχώρουν23, ovvero, in latino: in Compsas propugnaculum sese receperunt). Francesco Paolo Laviano ritiene, come l’Acocella, che per fortezze di Conza bisogna intendere non solamente quelle esistenti nella città, ma ancora le difese naturali (nativa praedia) che ne formano (in un raggio di sei chilometri) tutto il circuito ed individua nella descrizione che lo storico bizantino fa del sito24 in cui i Goti sono asserragliati non già la Conza vera e propria, bensì il castrum di Pescopagano, in tal modo argomentando: se non fosse così, dove andremmo a cercare la parte tagliata a picco della città di Conza che guarda il fiume Ofanto da rendersi inaccessibile coi suoi dirupi?25. A Pescopagano l’interpretazione che Francesco Paolo Laviano dà delle parole di Agazia è apparsa tanto convincente da trovare luogo in una epigrafe dettata da Luca Araneo, nella quale sono sintetizzati i fatti salienti della millenaria storia di quella città. L’episodio della guerra greco-gotica è così scolpito: POSTREMO SEPTEM MILIA GOTHORUM TARTARO RAGNARI DUCENTE NARSES HIC DEBELLAVIT ANNO 555 AGAZIA ADAMUSSIM DESCRIBENTE CASTRUM HISTORIA DE BELLO GOTHORUM26 Quali che siano le modalità dell’assedio che Narsete stringe intorno a Conza, e comunque si configuri il Compsas propugnaculum (ovvero: sia che lo si faccia coincidere con la cittadina di Conza, sia che lo si voglia individuare Agazia, De bello Gothorum, II, 13, 1. Citato in latino dal Laviano: in arduo monte situm erat, et in ipso jugo abrupte omni ex parte petrae extarent ac protenderetur, ita ut difficilem hosti aditum praeberet – nell’originale greco: τῷ ἐν ὄρει κεῖσθαι ἀνάντει καὶ πρὸς αὐτῇ δήπου τῇ ἀκρωνυχίᾳ πέτρας τε ἀποτόμους πάντοθεν ἀνέχειν καὶ παρατετάσθαι, ὡς μὴπολεμίοις εὐέφοδον εἶναι. 25 Francesco Paolo Laviano, La vecchia Conza e il castello di Pescopagano, Trani, 1926. 26 Per come esattamente Agazia descrive il castello nella Storia della guerra gotica, è qui che Narsete nel 555 sconfisse definitivamente i settemila Goti comandati dall’unno Ràgnari. 23 24 29 L’epigrafe di Luca Araneo a Pescopagano nel castello di Pescopagano), il versante meridionale della collina che, oltre il torrente Pisciolo, fronteggia Castelnuovo è sito ideale per acquartierare una parte dell’esercito bizantino, come ritengono Celetta e Carluccio (… antico nucleo di Santomenna, dapprima semplice insediamento rurale, cresciuto poi come accampamento militare bizantino al tempo della guerra gotica…)27. 27 Franco Celetta e Michele Carluccio, Santomenna Città dei Vescovi, Salerno, 2004. 30 La collina di fronte a Castelnuovo (il paese di Santomenna è dietro) Utilizzando questo sito per l’accampamento, Narsete evita di esporsi ai nemici forzando il passaggio tra Castelnuovo e Torricella, in attesa di trovare la chiave risolutiva dell’assedio. Il luogo è ameno e soleggiato, al riparo dal vento di tramontana e facile da proteggere, il generale bizantino non ha fretta, il tempo è suo alleato. L’abitato di Santomenna nel 1924 (Castelnuovo è dall’altra parte, oltre il torrente Pisciolo) 31 La strategia dell’attesa consente a Narsete di vincere l’ultima battaglia senza nemmeno combatterla. Egli, infatti, lascia trascorrere tutto l’inverno, finché sopraggiunta la primavera dell’anno seguente (555), Ràgnari domandò un abboccamento con Narsete e vennevi con pochi tra le mura e il campo; ma perché egli voleva dettar condizioni, e Narsete non le acconsentiva, si partivano. Come fu Ràgnari su pel dirupo accosto a sue mura, tolto l’arco, ne scoccò una saetta in giù contro a Narsete. Diede in fallo; e sendogli risposto subito dalle saette greche, cadde egli ferito a morte, e, riportato addentro, morì due giorni appresso. Allora gli assediati si resero a patto di vita salva, e Narsete, entrato nel castello, li mandò tutti, affinché più non turbassero Italia, a Costantinopoli28. Tale è la versione ufficiale della vicenda; raccontata, come sempre, dai vincitori. E’ però più facile credere che Narsete, il quale era indubbiamente superiore dal punto di vista militare, non riuscendo a superare agevolmente il blocco a cui era costretto dai Goti, e volendo evitare ulteriori spargimenti di sangue, abbia attirato Ràgnari in un tranello facendogli balenare una qualche possibilità di accordo. E che poi lo abbia fatto colpire a tradimento dai suoi arcieri. Non vorremmo peccar di presunzione nel sottoporre a critica un testo storico vecchio di quasi millecinquecento anni; ma appare evidente a tutti la sproporzione tra un assedio di parecchi mesi di un esercito fortissimo, ormai padrone dell’Italia, e l’esito determinato dall’arroganza di Ràgnari (voleva dettar condizioni) e da un suo gesto del tutto illogico (scoccò una saetta in giù contro a Narsete). Ci affidiamo perciò alla saggezza di Procopio da Cesarea quando afferma che il chiamarsi un fatto glorioso o inglorioso dipende dal suo successo, ed è usanza che s’applaudano i vincitori senza investigare in che modo abbiano vinto. Certo è che Ràgnari viene ucciso da un dardo bizantino e che Conza ed il suo sistema di castelli, a seguito della morte del capo degli ultimi settemila Goti, sono presi senza combattere. E’ l’anno 555 dalla nascita di Cristo. 1.6 Narsete e la chiesa di San Menna a Venezia Conclusa definitivamente la campagna d’Italia, a Narsete non resta che tornare a Rialto e mantenere fede al voto: erigere le due chiese. Ludovico Antonio Muratori nel suo monumentale Annali d’Italia, all’anno 557 annota: L’Italia intanto si godeva buona pace. Narsete ne era Governato28 Agazia, De bello Gothorum, II, 14. 32 re, e a Narsete non mancava Pietà, Giustizia e Prudenza per ben governare i Popoli alla sua cura commessi. Secondo che abbiamo da Andrea Dandolo29, la tradizione di Venezia era, ch’egli ito colà fabbricasse nell’isola di Rialto due Chiese, l’una in onore di San Teodoro Martire, e l’altra di San Menna, e San Geminiano Vescovo di Modena30. Il senatore veneziano Flaminio Corner così scrive: Avendo stabilito l’Imperator Giustiniano di muover guerra a Totila fiero Re de’ Goti, consegnò il comando del suo esercito al valoroso Narsete, acciocché cacciasse quel Barbaro dagli usurpati stati d’Italia. Disceso il Generale nella Provincia chiamò in soccorso dell’armi Greche gli abitanti della Venezia marittima, con le forze marittime de’ quali poté ricuperare Ravenna, ed agevolarsi altre non meno importanti imprese. Portatosi dopo ciò nell’Isole delle Lagune, dopo aver colmato di lodi, e ringraziamenti il valore de’ Veneziani, promise di fabbricar in Rialto due Chiese, tostoché avesse sterminata interamente la potenza de’ Goti. Vinti dunque in battaglia campale l’un dopo l’altro Totila, e Teia di lui successore, e dissipate le reliquie de’ loro eserciti, adempì poscia l’impegno, facendo fabbricare nell’anno 554 (in realtà è il 557 come ben dimostra il Muratori, n.d.r.) due Chiese in Rialto: l’una dedicata al Martire San Teodoro, nel sito ove ora vedesi la Ducale Basilica di San Marco, e l’altra decorata dal doppio titolo di San Geminiano Vescovo, e di San Menna Martire, posta a fronte dell’altra assai ristretta piazza, da cui dividevasi la Chiesa per uno stretto Canale, che trascorreva per mezzo31. Due chiese fa erigere Narsete a Venezia per tre santi. San Teodoro: un soldato, San Menna: un soldato, San Gimignano vescovo di Modena, combattente contro l’eresia ariana, e che nel 390 era stato a Costantinopoli, chiamato dall’imperatore Gioviano per far guarire la figlia gravemente ammalata. Dai tre santi scelti da Narsete per le chiese di Venezia possiamo capire molto del suo modo di essere e di pensare, che abbiamo già appreso da Paolo Diacono: piissimo, cattolico, edificatore di chiese, portato alla preghiera. Forse Narsete ha anche in mente quello che ha già fatto il suo imperatore nella capitale: E numerando Procopio gli edifici di Giustiniano Imperatore, descrive ne’ Borghi di Costantinopoli le Chiese di S. Teodoro, e di SS. Menna, e Meneo. Il che mi fa credere, che Narsete abbia voluto imitare la devozione del suo Padrone, a che pare che fosse allettato per la somiglianza nella Doge di Venezia dal 1343 al 1354, autore di una Cronaca estesa sulla storia della città lagunare. 30 Ludovico Antonio Muratori, Annali d’Italia, Roma, 1786. 31 Flaminio Corner, Notizie storiche delle Chiese e Monasteri di Venezia, Padova, 1758. 29 33 sua professione, almeno con S. Teodoro, e S. Menna, ch’erano stati soldati…32 Oggi a Venezia la chiesa dedicata a San Menna e San Geminiano non esiste più, abbattuta dai francesi di Napoleone nel 1807, quando San Menna era già stato quasi del tutto dimenticato e permaneva unicamente il culto del vescovo modenese. Anche la chiesa di San Teodoro nemmeno esiste più dacché questo santo, primo patrono di Venezia, è stato sostituito da San Marco33 con la sua basilica eretta proprio in luogo del primitivo tempio. Della chiesa di San Menna e San Geminiano resta una stampa di CanalettoVisentini raffigurante Piazza San Marco con in fondo il tempio poi abbattuto dai francesi, una pala del quindicesimo secolo, opera di Bernardino da Murano34, raffigurante Sant’Elena con ai lati San Geminiano vescovo e Canaletto-Visentini: Piazza S. Marco con la chiesa di San Geminiano Marcus Wesler, Lo Squitinio della libertà originaria di Venezia, con un discorso di Luigi Helian Ambasciatore di Francia, contro i Veneziani, tradotto del Latino, e con note storiche, In Colonia, Appresso Pietro del Martello, 1681. 33 Nell’anno 827 due mercanti veneziani trafugano da Alessandria d’Egitto le spoglie del santo Evangelista e le portano trionfalmente a Venezia. Il doge Giustiniano “decretò che dove allora sorgeva il tempio di san Teodoro, uno se ne piantasse magnifico e sorprendente, intitolato a san Marco” (Giuseppe Cappelletti, Storia della Repubblica di Venezia, Venezia, 1850). Con l’affermarsi dell’indipendenza, Venezia si libera dai residui di tutela bizantina (rappresentata dal patronato di San Teodoro) e si affida a San Marco. 34 E’ conservata a Vienna nella Galleria dell’Accademia. 32 34 San Menna soldato, ed una portella laterale dell’organo con un bellissimo dipinto di San Menna, raffigurato nelle vesti di cavaliere rinascimentale, opera di Paolo Veronese35. 1.7 Narsete e la chiesa di San Menna a Santomenna Se Narsete ha edificato a Rialto una chiesa a San Menna per ringraziare i veneziani dell’aiuto prestatogli, cosa ci impedisce di ipotizzare che anche in occasione dell’assedio alla fortezza di Conza, nel lunghissimo inverno tra il 554 e il 555, trascorso in gran Bernardino da Murano, Pala dalla chiesa di San Menna e parte nel campo San Geminiano a Venezia impiantato alle spalle della collina che guarda Castelnuovo e la Torricella, il piissimo generale bizantino abbia fatto erigere una piccola chiesa a San Menna, nella quale trascorrere ripetute veglie di preghiera al santo soldato affinché lo aiutasse a vincere l’ultima battaglia contro Ràgnari? Quello che è sicuro è che su quel sito, davanti a Castelnuovo di Conza, sul versante meridionale della collina che fronteggia il castello, al di là del torrente Pisciolo, c’è un abitato con la sua comunità che mantiene ancor oggi vivo il culto di San Menna, il quale ha dato anche il nome Il San Menna di Paolo Veronese (1528-1588) nella chiesa di Venezia al paese di Santomenna36. La portella si trova oggi presso la Galleria Estense di Modena. In questa forma con il Regio Decreto n. 125 del 13 marzo 1881, Articolo unico: Il comune di Santa Menna, nella provincia di Salerno, cambierà l’attuale sua denominazione in quella di Santomenna a datare dal 1° aprile 1881. 35 36 35 San Menna Martire, Patrono di Santomenna (SA) Anche se, come è successo per Venezia, non c’è più la chiesa di San Menna a Santomenna, essa è esistita e lo attestano: 1) Donatanonio Castellano37, che nella Cronista Conzana richiama un istrumentum originale in pergameno della compra del territorio di S. Mennaio fatta per dom Giovanni, Abbate del monastero di S. Mennaio, dell’anno 893; 2) il Privilegio di Papa Innocenzo III dell’11 novembre 120038, che nomina l’ecclesiam Sanctae Mennae39 tra le competenze dell’arcivescovo di Conza, Pantaleone. Nel 1580 la chiesa di San Menna è oggetto, insieme alle altre chiese del paese, della visita pastorale che il vescovo di Conza Marco Antonio Pescara effettua dal 14 al 16 ottobre. Dopo aver praticato oltre centottanta cresime a bambini Donatantonio Castellano, Cronista conzana, 1691. In Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, Venezia, 1721. 39 Santa Menna, al femminile nella trascrizione dell’Ughelli del documento papale da lui consultato presso la diocesi di Conza. Oggi il Privilegio non è presso l’Archivio Segreto Vaticano e nemmeno presso l’Archivio diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi. 37 38 36 Relazione sulla visita pastorale a Santomenna del 1580 di entrambi i sessi, il vescovo, accompagnato dal vicario generale, dal padre teologo e dal clero, inerpicandosi su una cavalcatura per una strada sterrata, raggiunge l’antichissima chiesa di San Menna (devenit ad venerabilem ecclesiam sub vocabulo Sancti Mennae ab antiquissimo et immemorabili tempore … constructam). Mons. Pescara recita le consuete orazioni, ma si accorge che l’edificio è malmesso nella sua parte occidentale (invenit quod eadem Ecclesia occidentem versus diruta erat) e “autorizza” i cittadini a demolirla completamente (a civibus de licentia ipsius Ill.mi et Rev.mi Domini demolita fuerat). Non manca però l’Illustrissimus et Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Marcus Antonius Piscara Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Consanus, che è anche il Barone ed Utile Signore della Terra di San Menna, di confidare sulla bontà, la devozione e la generosità dell’Università (benché oppressa dalle tasse) affinché non permetta che la chiesa del suo santo patrono rimanga “incompleta”(non patietur tanti devotissimi Sancti Patroni sui Ecclesiam incompletam remanere)40. Relazione sulla visita pastorale di Mons. Pescara a Santomenna del 14 ottobre 1580, in Archivio storico della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia. 40 37 Lo stato della chiesa di San Menna nella relazione del 1580 Donatantonio Castellano, nella sua Cronista Conzana, tace la distruzione della millenaria chiesa, ed offre una versione edulcorata dell’accaduto: io ritrovo la chiesa di questo monasterio di San Menna, descritta nella visita di Pescara nel foglio 239, che era quasi diruta e n’haveva pensiero l’università, che si langhiava (lamentava) non poserla restaurare a causa che steva oppressa de’ fiscali e non vi remaso altro se non che il buon’animo de’ cittadini de volerla restaurare. Il cronista del 1691 sovrappone alla distruzione della chiesa un altro evento religioso consistente nella venuta da Salerno di alcuni frati cappuccini, inviati a Santomenna per prendere possesso e ricostruire il vecchio convento benedettino, impresa realizzata con le offerte di benemeriti cittadini e che vide il risorgere in qualche modo dell’antica chiesa, poi dedicata a San Menna e a San Francesco d’Assisi41. Il culto di San Menna (285-309) è molto antico ed egli è il santo più venerato dai cristiani d’Egitto. Menna era un soldato di origine egiziana che combatteva per l’esercito romano. Convertitosi al cristianesimo, si ritirò Cfr. Padre Mariano da Calitri, I frati minori cappuccini nella Lucania e nel salernitano, Salerno, 1948. 41 38 Altare della chiesa di San Menna e San Francesco nei ruderi del Convento (foto del 1980) come eremita nel deserto. Un giorno recatosi presso Kottyaion in Frigia (nell’odierna Turchia) predicò il Vangelo alla folla raccolta in un anfiteatro. Fu arrestato immediatamente e condannato a morte per decapitazione. Si narra che le sue reliquie furono portate in Egitto, secondo la volontà espressa dallo stesso Menna in punto di morte42. Il culto del santo-soldato si diffuse in ogni luogo d’Oriente ed in suo onore, sulle riva del lago Mareotis, presso Alessandria, fu eretto un santuario che ben presto divenne meta di grandi flussi di pellegrini, fino all’invasione araba del VII secolo. Agli inizi del XX secolo furono eseguiti degli scavi che riportarono alla luce le rovine della basilica di Mareotis, del suo monastero e delle sue terme. Vennero rinvenute le Ampolle di San Mènas, recipienti usati per prendere l’acqua da un pozzo vicino al reliquiario, con inciso il nome del santo. Anche in Sicilia sono conservati, tra gli oggetti che testimoniano la presenza bizantina, piccole ampolle di san Menas, che i pellegrini portavano con sé tornando da Alessandria, con un po’ d’olio santificato dal contatto della tomba del santo43. 42 43 Pietro Ribadeneira, Flos sanctorum cioè vite de’ santi, Venezia, 1763. Andrè Guillon - Filippo Burgarella, L’Italia bizantina, Torino, 1988. 39 La figura di San Menna d’Egitto non va confusa con quella dell’omonimo eremita del VI secolo, venerato a Vitulano, presso Benevento, e a Sant’Agata dei Goti. Quello venerato a Santomenna è il santo-soldato egiziano; oltre le argomentazioni già svolte circa il ruolo di Narsete e dei bizantini, l’iconografia raffigura il patrono di Santomenna come un militare con la spada in pugno, come si vede nell’immaginetta religiosa e nello stemma del Comune di Santomenna. Donatantonio Castellano nella Cronista conzana in merito al toponimo S. Menna riporta anche un’altra ipotesi: Vogliono alcuni che, siccome di tal sito desse titulo a questa Terra, perché in essa vi facesse romitaggio S. Menna…; ma aggiunge subito dopo: Vi è dubbio, però, chi fusse questo S. Menna; mentre nella Rosa del Martirologio ritrovo che in questo giorno 11 di novembre, la S. Chiesa fa commemorazione di due S. Menna, l’uno di nazione egittiana, martirizzato sotto Diocleziano imperatore, ch’era famoso soldato, la cui testa l’ho vista con l’occhi propri in Roma nella chiesa di S. Pietro44. L’altro, che fusse stato solitario, seu romito, nella Provincia de’ sanniti, del quale S. Gregorio Papa ne fa mentione… In realtà San Gregorio Magno, nel capitolo 26 dei Dialoghi, tratta del Venerabile Mena solitario45 e ne racconta alcuni miracoli, ma non aggiunge alcunché sulle località frequentate dal santo. L’orafo Antonio Gentili realizzò in occasione del giubileo del 1600 una teca argentea con il capo di S. Menna che andò a far parte del Tesoro di S. Pietro. 45 Le notizie pervenutaci su questo santo eremita vengono infatti da S. Gregorio Magno, il quale era contemporaneo e quindi, essendo l’unico testimone, è anche il più autorevole e veritiero; altre notizie successive provengono da Leone Marsicano. Nativo di Vitulano nel beneventano, di nobili origini, Menna fu eremita o “solitario” sui monti del Sannio, conducendo una vita poverissima, piena di aspre penitenze e meditazioni, alloggiando in una grotta. Morì verso il 3 novembre del 583, data in cui il suo corpo fu portato nella città di S. Agata dei Goti, dove subito divenne oggetto di culto generale. Della sua vita poco si sa, ma doveva essere molto conosciuto dagli abitanti dei paesi nei dintorni del monte dove stava; secondo la ‘Vita’ di Leone Marsicano nel 1094 il suo corpo fu trasferito nella città di Caiazzo; sulle alture di Vitulano esiste ancora un antichissimo oratorio sorto sul luogo della sua morte, meta di pellegrinaggi. Anche a S. Agata dei Goti esisteva un’antica chiesa intitolata al suo nome e quando nel 1114 per interessamento di Roberto il Normanno fu completata e consacrata la cattedrale da papa Pasquale II, essa fu intitolata oltre al Salvatore, alla Madonna e ai SS. Pietro e Paolo anche a San Menna confessore. Nel 1705 il vescovo di S. Agata dei Goti Filippo Albini, nobile cultore delle arti, rinnovò nella diocesi il culto di San Menna elevandolo a “santo protettore meno principale” dedicandogli nel Duomo una cappella con altare e facendo dipingere una pala che lo raffigura in meditazione, dal pittore Tommaso Giaquinto. E’ anche patrono della città di Vitulano. 44 40 Non ammette dubbi, invece, l’emblema della Terra di San Menna, pure inserita dal Castellano nella Cronista Conzana, che nello spazio centrale, tra la Madonna delle Grazie e la rappresentazione elementare dell’abitato, raffigura il santo soldato con la spada e la palma. Va comunque segnalato che quella che per Castellano è solo una delle due possibilità (peraltro palesemente smentita dall’icona) diventa invece una certezza per Ferdinando Ughelli, che nella sua monumentale Italia Sacra46 così scrive a proposito del nome di Santomenna: Nomenclaturam huius oppidi induxit frequens habitatio Sancti Mennae monachi solitarii… Stemma della Terra di San Menna inserito L’errore di uno storico dello spesnella Cronista Conzana sore di Ughelli circa l’identità del santo si può spiegare con la “rimozione”, operata dalla chiesa cattolica, della cultura e della religiosità orientale che interviene, come avremo modo di vedere per i “greci” di Buccino, Auletta e Vietri, in seguito alla rottura del 1054 tra il vescovo di Roma (papa Leone IX) ed il patriarca di Costantinopoli (Michele Cerulario)47. Ma il popolo di Santomenna ha conservato, insieme al nome, anche la corretta immagine del suo santo, fatta propria dalla istituzione civile, Universitas prima e Comune poi. Così nell’alta valle del Temete, a quasi millecinquecento anni dalla guerra greco-gotica, resta vivo il nome ed il culto del santo guerriero egiziano. 46 Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, Venezia, 1721. 47 La rottura che dà origine al Grande Scisma (o Scisma d’Oriente) ha per oggetto il mancato riconoscimento da parte di Bisanzio del primato del vescovo di Roma sugli altri patriarchi. Sul piano dottrinario la Chiesa d’Oriente si oppone all’aggiunta del Filioque nel Credo Niceno. Con questa aggiunta lo Spirito Santo procede anche dal Figlio e non più soltanto dal Padre. 41 Il gonfalone del Comune di Santomenna con l’immagine del santo soldato E sono proprio il nome ed il culto di San Menna, i quali (a differenza di ogni elemento di documentazione materiale) hanno resistito per quindici secoli, a dare credibilità all’ipotesi che Narsete con il suo esercito abbia stazionato proprio lì, alle spalle di quella collina posta davanti al castrum novum, oltre il torrente Pisciolo. 1.8 Castelnuovo di Conza esiste nel 554 Ma questo significa anche che nell’anno 554 dopo Cristo esiste48 Castelnuovo, se non proprio come paese quale possiamo intenderlo oggi, sicuramente come castrum, avamposto militare dell’antica Compsa, a guardia -insieme alla Torricella- dell’alta valle del Sele. Ovviamente, asserire l’esistenza di Castelnuovo nell’anno 554 dopo Cristo non vuol dire che prima di allora non vi fosse niente. Quella del 554 è, però, una data certa, per le considerazioni avanzate in precedenza, dell’esistenza della rocca e della sua funzione militare. Sicuramente è possibile andare ancora indietro nel tempo. Una siffatta ricerca esula dal presente lavoro; ma non vi è dubbio che, proprio per la funzione strategico-militare del sito su cui sorge il castrum novum, si può ritenerne l’esistenza in consonanza con l’affermazione di Conza come civitas significativa nel sistema civile e militare irpino-lucano. 48 42 Qui Narsete si ferma soltanto per alcuni mesi. Dopo la sua partenza e con i bizantini ormai padroni incontrastati di tutta la penisola, vi rimangono alcuni addetti agli edifici sacri (monaci basiliani) e, come avviene con tutti gli eserciti, anche un certo numero di ex soldati che si mischiano alla gente del luogo. Intorno alla chiesa fatta erigere da Narsete in onore di San Menna, ed ai monaci basiliani49 che se ne prendono cura e vi aggiungono un monastero50, si aggregano altri nuclei di popolazione così da strutturare il paese di Santomenna (che si può pertanto ritenere fondato da Narsete, condottiero bizantino). A Castelnuovo, tenuto dai Goti San Nicola, protettore di insieme a Conza e a tutto il sisteCastelnuovo di Conza (SA) ma dei castella che le fa da corona, dopo la morte di Ràgnari e la deportazione degli ultimi combattenti a Costantinopoli, i bizantini si impossessano del castrum e, come hanno già fatto con San Menna, introducono il culto di santi orientali. Anche in Castelnuovo di Conza è presente il culto di un santo orientale: San Nicola di Myra. San Nicola nacque a Pàtara di Licia (oggi Turchia), probabilmente nell’anno 270. Si narra che Nicola, venuto a sapere che un ricco uomo decaduto voleva avviare le sue tre figlie alla prostituzione perché non poteva farle maritare decorosamente, abbia gettato nella casa dell’uomo in tre notti consecutive dei sacchetti di denaro, in modo che le tre figlie avessero la dote per il matrimonio. Anche per questo episodio San Nicola è venerato come protettore dei bambini e dei fanciulli. Cfr. Amato Grisi, L’alta valle del Sele, Salerno, 1987: Pare che la prima ondata di questi monaci basiliani si sia concretizzata appresso alle armate condotte da Belisario e da Narsete, i quali, in fin dei conti, conducevano una guerra definibile anche religiosa... 50 Poi benedettino e successivamente francescano. Sul punto si segnala la ricostruzione delle vicende del monastero operata da Franco Celetta e Michele Carluccio in Santomenna città dei vescovi, Salerno, 2004. 49 43 A Castelnuovo le mamme cantano una ninna-nanna che fa: Sant’ Nicola p’ lu munn’ jia Tutt’ r’ criatur’ r’addurmìa Sant’ Nicola nun vulìa menna Vulìa cart’, calamar’ e penna Sant’ Nicola nun vulìa canzun’ Vulìa pater nostri e razìun’ Duorm’ n’nnill’ mij nun vogl’ chiant’ T’addurmisc’ Dij e tutt’ li sant’…51 E gli emigranti, al momento di partire: Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’ Viat’ a chi ng’ ven’ ad abitan’ Ij ng’ so’ inda e m’ n’eggia assì E Sant’ Nicola m’edd’ accumpagnan’…52 In seguito Nicola lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra dove venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo di Myra. Imprigionato ed esiliato nel 305 durante le persecuzioni di Diocleziano, fu poi liberato dall’imperatore Costantino nel 313, anno dell’editto di Milano, e riprese l’attività apostolica. Avrebbe partecipato al concilio di Nicea condannando duramente l’arianesimo e, secondo la tradizione, in un momento d’impeto avrebbe preso a schiaffi Ario. Morì a Myra il 6 dicembre del 343. San Nicola ha una caratteristica in comune con San Geminiano: inflessibile nella lotta contro l’eresia ariana, ed è possibile che Narsete, anticipando quello che avrebbe fatto a Venezia per il vescovo di Modena, abbia anche edificato di fronte al castrum novum una chiesa per San Nicola. San Nicola di Myra è il patrono di Castelnuovo di Conza e viene festeggiato solennemente il 6 dicembre di ogni anno. Anche a Torricella i bizantini, dopo la conquista, fabbricano una cappella ed introducono il culto di un santo orientale, Sant’Ilarione53. Superata la In Francesco Di Geronimo, Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil…, Fisciano (Salerno), 2010. In Francesco Di Geronimo, Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil…, Fisciano (Salerno), 2010. 53 Sant’Ilarione di Gaza, nato nel 291 e morto nel 371 fu il patriarca ed il fondatore del monachesimo palestinese. San Girolamo scrive addirittura la Vita Hilarionis . “Prima di S. Ilarione - dice Girolamo - non si conoscevano monaci in Siria. Egli fu là il fondatore della vita monastica e il maestro di quelli che l’abbracciarono. Il Signore Gesù aveva Antonio in Egitto e Ilarione in Palestina, il primo carico di anni e l’altro ancora giovane”. 51 52 44 Torricella, proseguendo verso Nord, sul versante settentrionale del colle, a poche centinaia di metri dalla fortificazione, esisteva fino a qualche anno fa una cappella dedicata a Sant’Ilarione, dalla quale prendeva nome anche la zona…54. Amato Grisi, nel suo lavoro sull’alta valle del Sele, trattando di Torricella e Sant’Ilarione, riporta come alle falde del colle, in direzione di Conza, la strada campestre si biforca dando luogo ad un bivio: una viuzza scavata nel tufo e poco più larga di un tratturo, sale sulla Torre agevolmente. Sui margini dell’altro ramo, che mena verso Buoninventre, si incontrano le rovine della chiesetta di S. Ilarione, dai nativi detta “La Cappelluzza”. Questo grande eremita orientale fiorì verso la fine del IV secolo d.C.; ebbe culto presso i monaci basiliani del VII e VIII secolo. Presumibilmente intorno a tale epoca sorse colà una laura basiliana55. Lo studioso castelnuovese Enzo Di Ruggiero, in un saggio su Santa Maria della Petrara56, riporta quanto ci riferì il defunto ing. Francesco Di Domenico, di Castelnuovo di Conza: nell’angolo sinistro appena dopo l’entrata principale della chiesa, era collocata distesa sul pavimento la statua di San Ilarione (monaco orientale, protettore dei terremoti, che evangelizzò le popolazioni dell’Egitto e del vicino Oriente). Nelle carte d’archivio abbiamo trovato l’indicazione di una “cappeddhuzza” dedicata a S. Ilarione e sita nel bosco omonimo. 1.9 Il culto greco nella diocesi di Conza. La seconda lettera di Innocenzo III a Pantaleone La chiesa di San Menna, la cappella di Sant’Ilarione, il culto di San Nicola a Castelnuovo non sono le sole testimonianze dell’influsso bizantino nel territorio dell’arcidiocesi di Conza. Indagare in profondità una siffatta presenza culturale e religiosa nella zona dell’alto Sele-Tanagro non entra nell’orizzonte del presente lavoro, che è limitato a ricostruire le tracce storiche di Castelnuovo di Conza. Tuttavia non vanno taciuti alcuni elementi, a cominciare dalla chiesa della Madonna della Sperlonga a Palomonte, la cui struttura architettonica, pur avendo subito varie e pro- Nicola Filippone, L’alta valle del Sele tra tardo Antico ed Alto Medioevo, Napoli, 1993. Amato Grisi, L’alta valle del Sele, Salerno, 1987. 56 Alto Sele, Bollettino di informazione culturale, Trimestrale 1,2,3, Castelnuovo di Conza, 1989. 54 55 45 fonde modifiche nel corso dei secoli, manifesta –a giudizio di Amato Grisi57– l’impronta caratteristica dell’arte bizantina. E l’influenza della cultura bizantina, con i monaci basiliani che lì hanno fondato il santuario dedicato a Maria, è ancor più testimoniata dagli affreschi riemersi durante i lavori di restauro dell’antica chiesa tra il 1997 ed il 2004. Anna De Martino, che ha curato l’elegante pubblicazione sugli affreschi bizantini, li data alla fine del decimo secolo, o alla prima metà dell’undicesimo, ma ritiene anche che, prima della edificazione del monastero e della chiesa, esistesse su quel sito una laura monastica di rito greco che viveva i suoi momenti di ritiro e preghiera nelle grotte presenti sul territorio. Anche per la De Martino l’inizio della religiosità di rito bizantino nella zona risale al sesto secolo, quando erano cominciati ad arrivare in Italia meridionale monaci provenienti dall’Oriente cristiano al seguito delle armate di Belisario e Narsete58. Amato Grisi, L’alta valle del Sele, Salerno, 1987 Anna De Martino (a cura di), Gli affreschi bizantini della Chiesa di S. Maria della Sperlonga a Palomonte, Salerno, 2008. 57 58 46 Affresco di San Nicola di Myra nella chiesa della Sperlonga L’ordinarietà del rito bizantino, e la sua coesistenza con il rito latino, nel territorio della diocesi conzana è attestato da un istrumentum in pergameno59 risalente all’anno 1043, con il quale Guidone, duca longobardo di Conza, garantisce a Daniele, monaco ed abate di rito greco (cum sit idem abbas de genere graecorum) del monastero di Santa Maria della Sperlonga, alcuni diritti sul territorio circostante e sui boschi ed i pascoli limitrofi. Il documento attesta anche la competenza dell’arcivescovo di Conza a nominare il successore dell’abate Daniele dopo la morte di costui. Grisi ritiene anche che San Nilo, famoso basilano, abbia fatto tappa alla Sperlonga nel 980, quando si rifugiò a Roma per sfuggire ai saraceni, e richiama la chiesetta di San Giovanni Demaniale situata ad oriente della Sperlonga, verso Buccino, sulla strada oggi inesistente che menava a Ponte San Cono, dove i basiliani avevano un’altra piccola stazione. Lo storico Il documento è richiamato negli atti della visita del Pescara e poi da Donatantonio Castellano nella Cronista Conzana. 59 47 cita anche il tempietto di S. Nicolò dei Goti, situato sulla stessa strada in posizione più orientale, e ritiene che sia stato edificato dai monaci di San Basilio per essere dedicato a San Nicola, la cui devozione era grande tra i bizantini. Questa chiesetta era ancora in piedi nel 1200 perché è nominata (come S. Nicolai de Cirioto) nel Privilegio di Innocenzo III. Una ulteriore testimonianza si trova nel territorio di Buccino dove, lungo via Egito, un terrazzamento su tre livelli nel corso del VI-VII secolo d.C. fu trasformato in un insediamento rupestre simile ai sassi di Matera. Nel costone roccioso fu scavato un sistema di grotte, che, trovando confronti con gli insediamenti eremitici della Calabria, suggerisce alla Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta la possibilità di interpretare il complesso come romitaggio, legato a presenze orientali-bizantine. Quanto in profondità abbia inciso l’opera dei monaci basiliani al seguito delle armate di Narsete è, infine, dimostrato dal fatto che, ancora quasi settecento anni dopo l’impresa del generale di Giustiniano, il culto “greco” è significativamente e consistentemente presente nel territorio del SeleTanagro. Tanto presente da indurre, agli inizi del XIII secolo, il papa Innocenzo III ad emettere un allarmato documento rivolto a Pantaleone, arcivescovo di Conza. Un precedente documento di provenienza papale è ampiamente noto60: si tratta del Privilegio dell’11 novembre 1200 con il quale l’arcivescovo Pantaleone viene confermato nell’esercizio pastorale dell’ampia arcidiocesi di Conza, con la puntigliosa elencazione di tutte le chiese, abbazie, terre di sua competenza. Con esso viene concesso a Pantaleone l’uso del pallio61 da portare in determinate occasioni solenni. Vi si prescrivono i compiti assegnati all’arcivescovo; è sottoscritto dal pontefice e da altri quattordici cardinali. Il secondo documento, che non ci risulta prima d’ora riportato dalla storiografia su Conza e la sua arcidiocesi, e che ci è stato messo a disposizione dall’Archivio Segreto Vaticano, è una allarmata lettera62 di Innocenzo III a E’ integralmente riportato in Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, Venezia, 1721; vi compaiono i nomi di Castelnuovo, Torricella e Malinventre. 61 È insegna liturgica d’onore e di giurisdizione, riservata al papa e agli arcivescovi metropoliti. Entro 3 mesi dalla sua consacrazione o conferma, il metropolita deve domandare al papa il pallio; questo obbligo data dalla seconda metà del sec. IX. 62 Lettera Pantaleoni Consano Archiepiscopo del 23 novembre 1200, Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 5, f. 13v. 60 48 Pantaleone (Pantaleoni Consano Archiepiscopo), indirizzatagli pochi giorni dopo e con la quale il pontefice impartisce severe disposizioni perché le forme greche del culto cristiano, ancora praticate nel territorio dell’arcidiocesi conzana, vengano energicamente eliminate. Lo scisma tra la chiesa grecoortodossa e la chiesa latina si è consumato da poco più di un secolo con scomuniche reciproche scambiate tra Roma e Costantinopoli. La presenza in territorio italico di comunità ecclesiali di rito orientale non è più accettabile. Innocenzo III, il papa della teoria e della pratica teocratica, il papa della lotta spietata alle eresie e della crociata contro gli albigesi, il detentore di un potere che oscura quello dell’impero, l’autorità da cui i diversi pretendenti al trono imperiale attendono, pavidi, il responso, viene informato che a Buccino, Auletta e Vietri (di Potenza) i fedeli di rito greco e quelli di rito latino vivono la religione da separati in casa, ognuno dei due gruppi non accettando di mescolarsi con l’altro. E così il sommo pontefice indirizza il severo richiamo all’arcivescovo di Conza, Pantaleone. La lettera di Innocenzo III a Pantaleone (Archivio Segreto Vaticano) La premessa utilizza il linguaggio evangelico, e richiama la recente nomina di Pantaleone a contadino di una vigna della quale erano andati perduti i frutti: Ne si semen verbi dominici quod mitteris seminare ceciderit inter spinas fructu careat exobtato, decet te, inter agricolas vinee domini sabaoth, utinam autem illos assumptum quibus male prius perditis malis vineam suam 49 dominus legitur locavisse, de messe dominica tribulos extirpare et litis materiam amovere a subditis ut tanto libentius audiant et exaudiant verba tua quanto quetioris mentis et animi placatioris existent (Affinché il seme della parola del Signore, se cade tra le spine, non sia privo del frutto desiderato è opportuno che tu –che sei stato assunto tra gli agricoltori della vigna del Signore degli eserciti celesti, o meglio tra quelli ai quali si dice che il Signore, essendosi prima malamente perduti i suoi frutti, abbia affidato la sua vigna– estirpi le spine dal raccolto del Signore ed elimini il motivo della contesa tra i fedeli a te affidati affinché tanto più volentieri ascoltino ed intendano le tue parole quanto più diventino tranquilli nella mente e pacificati nell’animo). Il fatto che allarma papa Innocenzo è così sintetizzato: Sane ad audientiam apostolatus nostri pervenit quod in castro Pulcini, Aulettae et Vetri inter latinos et grecos scisma non modicum est subortum, nolentibus alteris interesse officiis alterorum. Dum et greci grecos et latini latinos presertim diebus sollempnibis audire desiderant sacerdotes. Quod in eadem ecclesia de levi posse fieri non videtur (In verità è giunto all’attenzioPapa Innocenzo III ne del nostro apostolato che nel castello di Buccino, ad Auletta ed a Vietri, è sorto uno scisma di non poco conto tra latini e greci in quanto gli uni non vogliono partecipare alle celebrazioni degli altri. Giacché nelle occasioni solenni i greci vogliono ascoltare sacerdoti greci, ed i latini sacerdoti latini. Il che non si vede come possa accadere senza problemi nella stessa chiesa). 50 L’ordine impartito da tanto pontefice è severo e terribile: Ad tollendam igitur huius dissentionis materiam et pacis inter eos federa reformanda, praesentium tibi auctoritate concedimus ut cum duobus vel tribus suffraganeis tuis accedens ad locum de ipsorum consilio id inter discordantes constituas quod secundum Deum fuerit statuendum. In hoc sine personalis acceptione procedens cum non sit distinctio iudei ac greci, sed in omni gente qui facit iustitiam acceptus sit Deo (Dunque per eliminare il fondamento di questa divisione e per ristabilire gli accordi di pace tra di loro, con l’autorità della presente concediamo che tu, con due o tre tuoi suffraganei, recandoti sul luogo con la loro collaborazione, stabilisca tra coloro che sono in discordia quello che dovrà essere stabilito secondo la volontà di Dio. E proceda in quest’opera senza riguardo per le persone, non essendovi distinzione tra giudei e greci, ma dovunque sia gradito a Dio chi fa giustizia). A Papa Innocenzo è sufficiente ricordare a Pantaleone che non deve esserci distinzione tra giudei e greci; i giudei sono considerati colpevoli della morte di Gesù, per loro non vi è posto nella comunità dei cristiani e Pantaleone è incaricato di eliminare le spine dalla vigna del Signore. Qualche anno dopo, con la bolla Etsi Iudaeos del 1205, Innocenzo elabora giuridicamente la teoria della “perpetua servitù” degli ebrei (poi riaffermata da Gregorio IX nel 1234) con queste parole: Furono condannati dal Signore, alla morte del quale contribuirono, come servi; almeno si riconoscano servi di coloro che la morte di Cristo fece liberi, rendendo loro servi. Secondo il papa gli ebrei sono come Caino il fratricida e contro di loro grida il sangue di Gesù Cristo; non devono essere uccisi ma condannati a errare sulla terra come infelici vagabondi, finché non si siano ravveduti e abbiano cercato il Salvatore. Gli ebrei sono inoltre esclusi dall’agricoltura e dalle corporazioni e non resta loro che dedicarsi al commercio e all’artigianato. In una lettera inviata al conte di Nevers nel 1208, il pontefice scrive: affinché Caino potesse aggirarsi come un fuggitivo sulla terra senza essere però ucciso da alcuno, il signore lo marchiò facendogli tremare la testa. Lo stesso vale per gli ebrei, per i quali il sangue di Cristo è stato versato invano; e sebbene meritassero la morte, essi sono stati dispersi sulla terra e costretti a vagare senza meta, sino a quando, con il volto acceso dall’onta, non avessero invocato il nome del loro Signore Gesù Cristo. Ancora, nel 1215 Papa Innocenzo III stabilisce, nel IV Concilio Lateranense, che gli ebrei devono portare sugli abiti un distintivo di riconoscimento (una rotella gialla o rossa, un cappello giallo, un mantello di particolare colore..). Trattare i fedeli cristiani di rito greco (che a Buccino, Auletta, Vietri, e forse anche in qualche altra comunità dell’arcidiocesi, erano rimasti attaccati alle forme 51 di culto introdotte dai monaci basiliani al seguito dell’esercito di Narsete nel VI secolo) alla stregua degli ebrei, applicando nei loro confronti le disposizioni della Bolla Etsi Iudaeos e del Concilio Lateranense, significa cancellare ogni residua testimonianza della presenza bizantina. Ed in effetti scompaiono le comunità di rito orientale, rimanendo di esse unicamente tracce nei nomi e in poche strutture materiali. Anche il culto di San Menna viene di fatto oscurato; quanto ne è giunto fino a noi (il toponimo e l’immagine del soldato egiziano) è dovuto più alla omogeneità della piccola comunità che lo ha mantenuto, nel santo identificando se stessa, che non ad un consenso formale e convinto dell’autorità ecclesiastica. Di San Menna, nella cultura ufficiale, si perde finanche l’esatta cognizione, se è vero che in molti documenti del XIII secolo (ed anche più avanti, fino al Regio Decreto n. 125 del 13 marzo 1881) si opera addirittura un cambiamento di genere: San Menna, che era stato un soldato, diventa Santa Menna. 1.10 Considerazioni conclusive sulle origini di Castelnuovo e Santomenna Da quanto abbiamo visto fin qui si può affermare che quando c’è Conza come centro politico-militare con il suo sistema di difesa c’è anche Castelnuovo di Conza. Inizialmente è soltanto un castello, una rocca piantata Castelnuovo di Conza, aggregato sullo sperone intorno al castello 52 per difesa e sorveglianza sulla punta dello sperone, successivamente attorno al presidio militare sorgono le abitazioni. Mentre il paese di Castelnuovo nasce intorno al castrum, il paese di Santomenna nasce intorno alla chiesa di San Menna e ad una laura basiliana (che poi cede il passo ad un cenobio benedettino). Castelnuovo diventa poi un feudo, per così dire, civile/militare; Santomenna un feudo ecclesiastico. Il barone di Castelnuovo è un signore spesso guerriero, il feudatario di Santomenna è il vescovo di Conza. La struttura, la collocazione territoriale, l’organizzazione urbanistica di Castelnuovo di Conza e di Santomenna evidenziano visivamente le diverse funzioni intorno alle quali i due paesi sono nati: avvistamento e difesa (con Torricella) l’uno; accampamento bizantino e culto di San Menna l’altro. Il castello protegge e difende Castelnuovo; la chiesa, la laura basiliana63, il convento (prima benedettino e poi francescano), il vescovado proteggono Santomenna, aggregato sul fianco della collina intorno al campo bizantino e alla chiesa di San Menna Franco Celetta e Michele Carluccio, Santomenna Città dei Vescovi, Salerno, 2004 (I monaci orientali, stanziatisi un po’ più a monte del piccolo insediamento rurale –dove in pratica sono ubicati oggi i ruderi del Convento dei Cappucini- iniziarono una attività di dissodamento e di coltivazione che fu facilitata anche dalla presenza, non trascurabile, di acqua. In questo modo, come spesso accadeva, essi furono il perno intorno al quale si sviluppò il piccolo centro, in quanto la loro attività, allargata ai laici che si stabilivano nelle pertinenze della dimora monastica, consentiva la sopravvivenza di ampie fasce di popolazione, in un periodo 63 53 e difendono Santomenna. Ci dice l’Ughelli64 che il feudo di Santo Menna unito alla mensa arcivescovile trae origine da un ex monastero dell’ordine cassinense una volta sito in un luogo elevato (…) gli abitanti dei luoghi vicini, per la salubrità dell’aria, vennero a fissarvi la loro dimora. In conclusione: una molteplicità di elementi, materiali ed immateriali, presenti sul territorio dell’alta valle del Temete (l’esistenza e la collocazione spaziale del paese di Santomenna che conserva il nome ed il culto del santo-soldato egiziano, il toponimo di Sant’Ilarione, il culto di San Nicola, i resti di Torricella, l’importanza della Sella di Conza quale snodo viario, etc.) depongano per l’esercizio di una funzione strategico-militare del castrum novum di Conza, al tempo della guerra greco-gotica e dell’ultimo episodio, protagonista Narsete, degli anni 554 e 555 dopo Cristo. 1.11 Il settimo secolo e le incursioni slave; il nono secolo e i saraceni Circa il significato dei toponimi, che resistono anche quando si sono persi e dimenticati gli eventi che hanno dato loro origine, per quanto riguarda Castelnuovo, va fatta una riflessione anche sul Varco dello Schiavo. Vito Acocella dedica un capitolo della sua Storia di Conza alle vicende legate alle incursioni degli Slavi nelle regioni della Puglia, della Lucania e della Campania: Mentre i Longobardi di Benevento s’affermavano ovunque, nel Mezzogiorno d’Italia, consolidando i loro domini, un’orda barbarica, devastando ed incendiando quanto incontrava nel suo cammino, s’avanzava dall’alto Adriatico (…) Schiere feroci di Slavi o Schiavoni si danno a scorazzare per le contrade di Puglia e per le regioni limitrofe, già conquistate dai Longobardi…65. I territori occupati dagli Slavi vengono ripresi nel 643 dai longobardi Aione, duca di Benevento e figlio di Arechi, e dal suo fratello adottivo Radoaldo. Della breve presenza degli Slavi nelle nostre contrade restano unicamente tracce nelle parole: toponimi e cognomi. Donatantonio Castellano nella sua Cronista Conzana ci parla di un casale di Scavoni (Schiavoni) nei confini della terra di Calitri e di Pescopagano. L’Acocella identifica il sito descritto da Castellano con un casale denomiin cui fame e miseria erano all’ordine del giorno. Il modello proprio dei basiliani fu in pratica ripreso dai benedettini, il cui fondatore aveva ampiamente attinto agli scritti di San Basilio e alla pratica di vita dei suoi seguaci.). 64 Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, Venezia, 1721. 65 Vito Acocella, Storia di Conza, Benevento, 1927. 54 nato San Filippo degli Schiavoni, che fu abbandonato verso il Mille, e i cui abitanti emigrarono a Calitri, e fa osservare la frequenza di cognomi, come Schiavone, Schiavoni, Schiavino, Scoca, diffusi a Calitri, a Cairano, a Conza e negli altri paesi limitrofi. Alle suddette tracce della presenza degli Slavi nelle nostre contrade possiamo ben aggiungere il Varco dello Schiavo, località in territorio di Castelnuovo di Conza. Questo significa anche che alla metà del VII secolo (cento anni dopo il passaggio dell’esercito bizantino) c’è qualcuno a Castelnuovo di Conza che ha dato a quella località il nome che la comunità ha adottato e che generazioni successive hanno fatto giungere fino ai giorni nostri. Abbiamo visto gli effetti su Castelnuovo di Conza del terremoto del 23 novembre 1980. Le grotte scavate nella roccia friabile, così come sono drammaticamente riapparse dopo il sisma, sembrano la rappresentazione plastica di quanto scrive Amato Grisi: E’ proprio in questo periodo che gli abitanti, ormai decimati, cercano disperato rifugio sui monti, insediandosi su rupi scoscese, ove i punti di accesso, estremamente difficoltosi, erano ridotti al minimo indispensabile66. L’epoca cui si riferisce il Grisi è quella che va dalla metà del nono alla metà del decimo secolo dopo Cristo, allorquando le zone interne della Campania sono oggetto di ripetute incursioni dei saraceni. E’ forse in questa, o in altre simili occasioni, che anche quei contadini più restii ad allontanarsi dai campi sono indotti, per usare ancora le parole di Grisi, a trovare un certo margine di sicurezza solo sui picchi o sulle rupi, su alcuni dei quali o nelle prossime adiacenze già secoli prima sparuti abitanti avevano cercato tranquillità e pace. Ed è forse nella medesima occasione che anche la struttura militare di Torricella diventa utile per assicurare protezione a piccoli gruppi di contadini. Alla tendenza spontanea dei lavoratori della terra a rifugiarsi sulle cime inaccessibili dell’appennino si accompagna, infatti, la corrispondente tendenza degli uomini d’arme ad edificare o ad utilizzare preesistenti dimore fortificate e di facile difesa, intorno alle quali si radunano i villici in cerca di sicurezza. Si opera in tal modo un elementare scambio: l’uomo d’arme difende i contadini, i contadini sostentano l’uomo d’arme (ed il corrispondente apparato difensivo); è la sostanza del sistema feudale. Le antiche fortificazioni di Torricella e di Castenuovo diventano così gli elementi di base per il dominio dei nuovi signori feudali. 66 Amato Grisi, L’alta valle del Sele, Salerno, 1987. 55 Capitolo II Castelnuovo e Buoninventre in epoca feudale 2.1 Il Catalogo dei Baroni Normanni E’ il Catalogo dei Baroni Normanni del 1140 il documento più antico in cui compare scritto il nome di Castelnuovo. Non da solo, però: Castelnuovo compare “legato” a Buoninventre1 (che in quel tempo si chiamava Malinventre) nell’Elenco dei feudi e feudatari compresi nella circoscrizione militare della “Comestabulia” di Gilberto di Balvano; a cui fanno seguito i feudi intestati a Gionata di Balvano, conte di Conza, e i suffeudi da lui dipendenti2. Ivi si legge: Malum Ventre cum Castello Novo est feudum militum quator… (Malinventre con Castelnuovo è un feudo che fornisce quattro militi…). Il numero dei militi che il feudo fornisce ci dice qualcosa sul numero degli abitanti che doveva essere al massimo di 160 famiglie, se è vero che nel catalogo dei Baroni Normanni 36 o 40 villani costituiscono il feudo di un milite3. Cessato il pericolo delle incursioni saracene, la maggior parte delle famiglie dovevano essere sistemate nelle campagne, e ciò spiegherebbe la collocazione di Malinventre a precedere Castelnuovo. Circa Malum Ventre, e come e perché è poi diventato Buon in Ventre, Donatantonio Castellano, scrivendo di tre terre che nel 1691 non esistono più come paesi, ma restano feudi rustici, Pietra Boiara, Torricella e Malinventre, così assume: L’altro feudo che anticamente era terra sta notata nel conservatorio di Conza, ed era in essere nell’anno 1200, è la terra di Maliventre, così nominata in detto Conservatorio, forse perché li cittadini havevano ivi poco che magnare, ma oggidì ch’è feudo rustico si dimanda Buon’inventre, perché è buon erbaggio per vacche e sta anco sotto il dominio del Barone di Caposele Il toponimo Buoninventre si riferisce, come avremo modo di osservare più avanti, ad una vasta fascia di territorio, a cavallo del torrente Casolaro, che oggi si colloca tra i comuni di Castelnuovo di Conza e Caposele. 2 Il Catalogo dei Baroni Normanni è riportato in: Giuseppe Del Re, Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna, Napoli, 1845. 3 Bartolomeo Capasso, Sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle provincie napoletane sotto la dominazione normanna, Napoli, 1870. 1 57 che ne riceve grossa rendita dalli coltivatori e pascolanti in detto feudo; però poch’edifici si conoscono dell’antica terra ch’ivi era e qualcheduno che si ritrova è sotterrato e sia questo feudo e quello di Castelnuovo stanno a vista di S. Menna4. Non è, però, questa di Castellano l’unica spiegazione del significato di Malum Ventre. C’è un’altra versione che parte dalla donazione che nell’anno 774 il principe di Benevento, Arechi II, effettua in favore del monastero di Santa Sofia di Benevento, da lui stesso fondato. Tra le numerosissime proprietà che il principe longobardo dona al monastero figura anche il Gualdo in fine Consina qui vocatur ad Monumenta cum integris finibus suis (bosco in territorio di Conza che si chiama ad Monumenta in tutta la sua estensione). Nicola Filippone, appoggiandosi al Di Meo5, ritiene che la località ad Monumenta corrisponda a Malum Ventre, diventato successivamente Buoninventre. Non è infatti convinto che la connotazione negativa insita in Malum Ventre possa conciliarsi con la naturale predisposizione del sito alla coltivazione ed al pascolo, ed immagina che Malinventre possa derivare da una evoluzione del toponimo ad Monumenta. Circa il toponimo originario, Filippone ipotizza che possa riferirsi ad uno o più monumenti in senso stretto, così come ad un luogo di sepoltura che segnalerebbe la presenza di un antico insediamento rurale di epoca romana. Pare improbabile – aggiunge Nicola Filippone- che un sito così fertile sfuggisse alla colonizzazione ed alla messa a coltura, peraltro diffusa nel resto della valle, quand’anche si rifletta sulla contiguità del medesimo, dal punto di vista della morfologia e della vocazione agraria, all’altro versante dello spartiacque, verso l’Ofanto, ed alla propinquità alla principale arteria di traffico della regione6. Lo studioso poggia la sua ipotesi sul ritrovamento, in località Santa Cecilia, nei pressi della sorgente omonima, quasi sul crinale, di alcune sepolture terragne, coperte da cumuli di pietre, con elementare corredo di brocchette in ceramica acroma, riconoscibili come prodotto della tarda cultura romana. Una terza ipotesi, che qui avanziamo e che ci appare molto convincente, potrebbe spiegare il toponimo con la più semplice ed immediata derivazio- Donatantonio Castellano, Cronista conzana, 1691. Alessandro Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli, Napoli, 1795. 6 Nicola Filippone, L’alta valle del Sele tra tardo Antico ed Alto Medioevo, Napoli, 1993. 4 5 58 ne da malum ventum (cattivo vento), come per l’isolotto di fronte alla faccia occidentale della Sardegna (oggi isola di Mal di Ventre, in sardo Malu entu, cattivo vento) o per il più celebre Maleventum nel Sannio (diventato Beneventum dopo la vittoria dei romani su Pirro). Ed in effetti la località, in particolare la dorsale che delimita il torrente Casolaro, è battuta da forti venti. Nel 1231 Federico II di Svevia ordina che vengano sottoposti a riparazione le fortezze di Sicignano e di Campagna; gli uomini di Castelnuovo e di Malinventre sono precettati per i lavori sul castello di Campagna7. Nel 1375 il nostro feudo rustico si chiama ancora Malinventre e viene assegnato dalla regina Giovanna al conte Giacomo Arcuccia insieme a decine di altri possedimenti tra i quali …Calabritto, Tegora, Oppido, Montefalcone in Principato ultra…8. Il nome Bono Invento compare nel 1458 allorchè Ferrante I d’Aragona concede a Luigi Gesualdo II l’investitura di molti feudi che gli spettano per successione del padre, tra cui Buoninventre, insieme alla città di Conza ed alle terre di Auletta, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, Castiglione, Palo, Pietrabuiara, Salvia, Salvitella, Santa Menna (sic!), Santa Maria in Elice, Sant’Andrea, Santangelo le fratte e Teora9. Re Ferrante concede anche la sovrana approvazione al legato che in beneficio di una cappella faceva Luigi Gesualdo sopra la terra di Buoninventre. Nel Libro singolare d’intrade feudali de diversi Contati de diverse Provincie del Regno de Baroni ribelli del anno La regina Giovanna d’Angiò Carlo Carucci, Codice diplomatico salernitano del XIII secolo, Subiaco, 1931 (Castrum Campaniae debet reparari per homines eiusdem terrae, Senerclae, Balvae, Coliani, Contursi; et potest reparari per homines Calabricti, Caput Sileris, Pali, Alcini, Balsiniani, S. Nicandri, Speloncae, S. Magni, Castelli novi, Malli in Ventre et per homines Laviani). 8 Camillo Tutini, Della varietà della fortuna, Napoli, 1643. 9 Erasmo Ricca, La nobiltà del regno delle due Sicilie, Napoli, 1859. 7 59 1494, che riporta le rendite dei feudi tolti ai baroni ribelli e devolute al regio fisco, tra le pertinenze del contado di Conza, è nominato Bonojnvento casale disabitato10. Nel Catalogo dei Baroni Normanni è nominato anche il feudo di Torricella: Philippus Turricella dixit, quod tenet Turricella, quae, sicut dixit, est feudum unius militis… (Filippo Torricella … possiede Torricella, che è un feudo che fornisce un solo milite…). Nell’anno 1200, nel già richiamato documento prodotto da papa Innocenzo III, il Privilegio con cui il sommo pontefice circoscrive i termini dell’archidiocesi di Conza affidata all’arcivescovo Pantaleone, si menzionano Torricella (Turricellum), Malinventre (Male in ventre) e Castelnuovo (Castellum novum)11. Torricella, ad un certo punto, è abbandonata dagli abitanti, infatti così la descrive Donatantonio Castellano nel 1691: Turricella era una terra della quale hoggidì se ne conoscono vestigi che sta posta nella difesola di Buon Inventre e hoggi è del Barone di Castelnuovo che andava compreso con i feudi di Caposele, che volgarmente si chiama la TORRA nella quale vi si conoscono in atto i vestigi delle case, fontane et altro, che dicono che l’habitanti di detta terra quando abbandonarono detto luogo, parte rimasero nella terra di S. Menna e parte nelle terre di Caposele e Teora12. Una leggenda ancora viva a Castelnuovo vuole che gli abitanti di Torricella abbandonassero il sito per la gran quantità di serpenti e che venissero ad abitare in paese. 2.2 I primi castelnuovesi Il conte di Conza Gionata di Balvano è il primo signore di Castelnuovo di cui abbiamo notizia (anche se resta sconosciuto il nome del suffeudatario), e Castelnuovo è unito a Malinventre, mentre Torricella è un feudo a sé stante. Il primo castelnuovese non nobile di cui abbiamo cognizione storica è il notaio Giuseppe di Salvatore, che attesta la veridicità dell’atto del primo febbraio 1160 con cui Gionata di Balvano dona la chiesa di S. Andrea (tra Conza e Pescopagano), con tutti gli abitanti e i terreni circostanti, alla Erasmo Ricca, La nobiltà del regno delle due Sicilie, Napoli, 1859. Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, Venezia, 1721. 12 Donatantonio Castellano, Cronista conzana, 1691. 10 11 60 chiesa di Santa Maria dell’episcopio di Conza13. Un altro signore di Castelnuovo di cui abbiamo notizia è, dopo Gilberto di Balvano, Filippo di Acerno. Il regno meridionale è nel frattempo passato dai Normanni nelle mani della dinastia Sveva, in seguito al matrimonio dell’imperatore Enrico VI con Costanza d’Altavilla, figlia di re Ruggiero. Filippo è un feudatario dall’imperatore Federico II, re di Sicilia, dal quale nel 1239 riceve in custodia uno degli ostaggi delle città guelfe di Lombardia, Anselmo Trivulzio Milanese. E’ dunque uno dei baroni più fidati del grande Svevo e, come tale, subisce le conseguenze della scomunica che il papa scaglia contro Federico II. Ciò nonostante, dopo la morte dell’imGionata di Balvano peratore, Filippo viene confermato nel possesso dei suoi feudi dal papa Innocenzo IV. La conferma da parte del Pontefice gli giunge, secondo Carlo Carucci14, con una lettera del 17 agosto 1254. Ecco il testo integrale del documento: Nobili viro Philippo de Acerno spiritum consilii sanioris. Cum, sicut ex parte tua fuit propositum coram nobis, ad devotionem matris Ecclesie redire proponas, nos tuum laudabile propositum multiplice commendantes, ac volentes ex hoc statum tuum congruis munire favoribus et condignis gratiis adaugere, tuis supplicationis inclinati, civitatem de Acerno et roccam eius, ac de Rotunde, de Castronovo, de Viario castra, medietatem Vetri cum rocca ipsius, ac feuda et possessiones, que in de Gifono et de Campania castris, Consane, Salernitanane et Acernensis diocesum, cum omnibus iuribus, honoribus, hominibus et pertinentiis eorundem, et ommnia alia bona, que ad presens tenes et possides, tibi ad devotionem ipsius ecclesie redeunti ac persistenti in ea, tuisque heredibus in perpetuum auctoritate apostolica confirmemus etc. Data Anagne XVI Kalendas Septembris Anno Il documento si chiude così: Ego Notarius Ioseph de Salvatore Terrae Castrinovi incola in Terra Oliveti rogatus et requisitus signavi… . 14 Carlo Carucci, Codice diplomatico salernitano del XIII secolo, Subiaco, 1934. 13 61 XII15 (Al nobile uomo Filippo d’Acerno invio l’auspicio di un più ragionevole proposito. Giacché, come fu promesso da parte tua davanti a Noi, ti proponi di ritornare alla devozione della madre Chiesa, Noi, rendendo variamente illustre il tuo lodevole proposito e volendo perciò rafforzare la tua posizione con appropriate concessioni e accrescerlo con degni favori, ben disposti alle tue preghiere, confermeremmo in perpetuo con l’autorità apostolica a te, che stai per tornare alla devozione della Chiesa e persistere in essa, e ai tuoi eredi la città di Acerno e la sua rocca, i castelli di Rotonda, di Castelnuovo, di Viario, la metà di Vietri con la rocca, e i feudi e possedimenti nei castelli di Giffoni e di Campagna, nelle diocesi di Conza, di Salerno e di Acerno, con tutti i diritti, funzioni, uomini e pertinenze, e tutti gli altri beni che al presente tieni e possiedi. Data ad Anagni il 17 agosto, anno dodicesimo del pontificato). A questo documento fa seguito, dopo meno di due mesi, un’altra lettera papale pure indirizzata a Filippo d’Acerno: Nobili viro domino de Acerno fideli nostro Philippo. Devotionem tuam quam ad nos et Romanam habes ecclesiam propensius attendentes, civitatem Acerni et roccam et castrum Rotunde, castrum Viarii, Castrum novum, medietatem Vetri cum rocca eius nec non possessiones et feuda quae tenes in Gifono et Campania, prout ea et alia omnia iuste possides et quiete, tibi et successoribus tuis in devotionem sedis apostolicae persistentibus auctoritate apostolica confirmamus (…) Data Neapoli II Kalendas Novembris anno XII. Archiepiscopis Salernitanis datum et confirmatum16 (Al nobile uomo signore di Acerno, nostro fedele Filippo. Considerando più favorevolmente la tua devozione che manifesti verso di noi e verso la chiesa romana, confermiamo con l’autorità apostolica a te e ai tuoi eredi che persisteranno nella devozione verso la sede apostolica la città di Acerno e la rocca e il castello di Rotonda, il castello di Viario, Castelnuovo, la metà di Vietri con la sua rocca, e possedimenti e i feudi che tieni a Giffoni e a Campagna, dal momento che questi e tutti gli altri giustamente e pacificamente li possiedi (...) Data a Napoli il 31 ottobre dell’anno dodicesimo del pontificato. Data e confermata agli arcivescovi salernitani). In proposito Carlo Carucci ritiene che la seconda lettera in parte contraddica la prima, giacchè non dà più per scomunicato Filippo d’Acerno. A nostro giudizio non vi è contraddizione tra le due lettere in quanto la prima è 15 16 Archivio Segreto Vaticano, 164 r. Archivio Segreto Vaticano, 185 v. 62 soltanto la promessa del papa di confermare nel possesso feudale un barone che, per parte sua, è già sul punto di ritornare alla devozione della Madre Chiesa. Ma è soltanto con la seconda lettera che si concretizza la effettiva investitura. Già le differenti intestazioni delle due lettere lo lasciano chiaramente intendere. La prima lettera è indirizzata semplicemente a Filippo d’Acerno e con l’auspicio di un più ragionevole proposito. La seconda lettera, invece, è indirizzata al signore di Acerno, nostro fedele Filippo. La circostanza, poi, che la seconda lettera è stata data a Napoli fa immaginare che nella capitale del regno meridionale ci sia stato un incontro con Innocenzo IV e che il barone Filippo abbia giurato fedeltà alla Chiesa nelle mani del pontefice ricevendone, soltanto dopo l’atto di sottomissione, la conferma nel possesso dei suoi feudi. Inoltre, la prima lettera indica quasi un rapporto esclusivo tra il papa ed il feudatario, mentre la seconda è data, diremmo per conoscenza, anche agli arcivescovi salernitani perché la tengano nel conto dovuto. Nel 1272, siamo in epoca angioina, alcuni storici danno come signore di Castelnuovo di Conza un fedelissimo di Carlo d’Angiò, Guido (o Guidone) d’Alemagna. Tra costoro c’è Amato Grisi, il quale si basa su due passi dei Registri della Cancelleria Angioina. Ci sono però dubbi che il Castrum Novum di cui il d’Alemagna è fatto signore (Guidoni de Alemagna militi, donat Rex terram Castri Novi) sia proprio il nostro Castelnuovo di Conza. Lo storico Pietro Ebner17 ritiene che Guido sia barone di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. Ma anche Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, è considerato appartenuto a Guidone18. Il fatto è che il toponimo castrum novum, da solo, non identifica univocamente un paese. E’ proprio un altro documento trascritto nei Registri della Cancelleria Angioina che escluderebbe essere Castelnuovo di Conza un feudo di Guidone; nel 1272 il re Carlo d’Angiò concede al suo primogenito, futuro Carlo II, il Principato di Salerno, con l’elenco delle varie Terre e dei baroni cui sono assegnate. In questo elenco si trovano, tra gli altri, i baroni Adenasius de TaPietro Ebner, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma, 1982 (Vi è pure notizia di una lettera di re Carlo al vice-ammiraglio Guido d’Alemagna e signore di Castelnuovo Cilento…). 18 Casimiro di S. Maria Maddalena, Cronaca della Provincia de’ Minori Osservanti Scalzi di San Pietro d’Alcantara nel Regno di Napoli, Napoli, 1729 (trattando di Castelluccio degli Schiavi, oggi Castelnuovo della Daunia, scrive: Nell’anno 1273 Carlo I d’Angiò Re di Napoli diede Castelnuovo con altre Terre a Guido d’Alemagna….). 17 63 rascono pro castris Acerni et Castellinovi, Riccardus de Marzano pro Castronovo, Guillelmus de Laviano pro castro Laviani, Guido de Alemania pro Castronovo. Ma non ci possono essere contemporaneamente tre baroni per un solo Castelnuovo, e nemmeno si trova in territorio del nostro Castelnuovo, come ritiene Grisi, una località denominata Iscla de Ponticello per la quale insorse una lite tra Guidone e il Priore di San Giovanni Gerosolimitano in Capua19. L’equivoco può essere provocato dall’esistenza nel territorio di Castelnuovo di Isca di Tufarella (registrata nei documenti del secolo XIX come una parte del bosco di Buoninventre). Guido d’Alemagna è invece nel 1269 sicuramente signore di Senerchia, Colliano, Trentinara e Campagna (Giudoni de Alemania militi donat Rex castra Senercle, Luculliani, Trentinarie et Campanie, per mortem Ugoni de Susa)20. Riteniamo che non Guido d’Alemagna, dunque, ma Adenasio (o Dalmasio) di Tarascona sia nominato da Carlo I d’Angiò barone di Acerno e del nostro Castelnuovo; la conferma è in un documento del 1275, allorquando insorge una contesa tra Guglielmo di Melum, feudatario di Conza, con Dalmasio di Tarascona, signore di Castelnuovo, e Rinaldo di Poncelly, signore di Pescopagano e Andretta, circa i confini fra i tre feudi. Il re Carlo ordina al Giustiziere di principato di chiamare i feudatari delle tre terre e, definiti i confini, apporre i termini lapidei21. Secondo Ferrante della Marra, autore dei Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non, comprese ne’ seggi di Napoli, imparentati colla casa della Marra, questo Dalmasio, che di cognome faceva Belcadro (perchè Tarascona dovea essere la patria) successivamente si fa chiamare d’Acerno dal nome della terra da lui posseduta. Sposa Alistasia del Balzo, sorella di Bertrando Conte di Avellino, che gli dà un figlio, Giovanni d’Acerno. Costui, essendo ancor giovinetto viene mandato in Sicilia, e dato in man d’Aragonesi l’anno 1291 per ostaggio in cambio di Ramondo del Balzo primogenito del Conte Bertrando, e suo cugino: per la qual cosa il governo dello Stato d’esso Giovanni fu dato da Re Carlo II (durante la sua prigionia) a Bonforzato di Castellana. Consistea lo Stato, oltre Castelnuovo, in Acerno, Vietri, Cucullo, Tortorella, e Corsiaco. Ma in processo di tempo tornato libero Amato Grisi, L’alta valle del Sele, Salerno, 1987, cita in proposito i Registri della Cancelleria Angioina (Mandat ut provideat de iustitia in lite inter Guidonem de Alamania militum et Priorem S. Ihoannis Ierosolimitani in Capua, super territorio vocato Iscla de Ponticello in pertinentiis Castrinovi). 20 Registri della Cancelleria Angioina. 21 Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, 22, fol. 57. 19 64 anch’egli Giovanni in Regno, tolse per moglie Iacopa della Marra, figliuola di Rifone, la quale nell’anno 1302 vedova di lui, e per l’antefatto Signora di Castelnuovo, si rimarita ad Ugone del Balzo Gran Sinescalco del regno, e del Piemonte. Questo autore, sempre trattando della famiglia d’Acerno, aggiunge che non fece Iacopa altrimenti alla casa di Belcadro figliuoli: ond’ella ebbe per successore nel dominio di Castelnuovo Guglielmo di Sabrano Conte d’Apici22. La signoria su Castelnuovo di Iacopa della Marra, appartenente all’antica e potente famiglia normanna, trova conferma nella Cronista Conzana, dove è menzionata per lo scorporo del territorio di Santomenna da quello di Castelnuovo su richiesta di Dionigi di Valva, vescovo di Conza23, attestato da un Istrumentum in pergameno divitiones territorij S. Mennae a territorij Castellinovi in anno 1306 factum a domina Iacopa de Marra, uxore militi Ragoni de Bautio, Domina Castellinovi24. Questo significa che fino al 1306 nel feudo di Castelnuovo è compreso anche l’abitato di Santomenna. Di tale unità è traccia in una lite intervenuta nel 1620 tra le Università di S. Menna e Castelnuovo circa il diritto dei santomennesi di pascolare, acquare, legnare, pernottare con corte di pecore et altre opere con la franchigia del pagamento della piazza ed altri pagamenti in detta terra di Castellonovo. Donatantonio Castellano nella sua Cronista Conzana descrive le origini del contrasto tra le due comunità; emergono, all’interno di una indubbia semplificazione dello storico seicentesco, la categoria dell’incuria riferita a Santomenna e quella della potenza riferita a Castelnuovo, che avrebbero determinato la situazione di fatto: Essendo la Terra di S. Menna circa mezzo miglio distante dalla Terra di Castel Novo, dicono che le dette Terre erano comune d’acqua, pascolo e legne, e per incuria di Cittadini di S. Menna, et potenza di quelli di Castelnovo col braccio del quondam Consigliere di Martino, Padre del Barone d’essa Terra di Castelnovo, non so come si sia usurpato di prohibire a’ detti di S. Menna la detta comunità25. Quel diritto viene riconosciuto l’8 agosto 1621 dalla Regia Camera in virtù di communità assoluta per il passato fra le dette due Terre. D’altro canto va Ferrante della Marra, Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non, comprese ne’ seggi di Napoli, imparentati colla casa della Marra, Napoli 1641 (voce Della Famiglia d’Acerno o Belcadro). 23 Lo definisce tale il Castellano. Non è riportato quale vescovo di Conza dall’Ughelli, mentre il Gargano lo considera vicario capitolare dal 1308 al 1327. 24 Donatantonio Castellano, Cronista Conzana, 1691. 25 Donatantonio Castellano, Cronista Conzana, 1691. 22 65 ricordato che il papa Innocenzo III, nel Privilegio dell’anno 1200, nomina la chiesa (e non la Terra) di San Menna e che, ancora nel 1498, il re Federico d’Aragona dona al Gran Capitano Consalvo Ferrandez de Corduba la città di Conza con i suoi casali di Sant’Andrea e San Menna (civitatem Consae de provintia Principatus Ultra cum suis casalibus videlicet Casali Sancti Andreae provintiae Principatus Ultra et Casali Sancti Mennai provintiae Principatus Citra…)26. Quanto agli altri signori di Castelnuovo, Biagio Aldimari, nelle Memorie Historiche di diverse famiglie nobili, così napoletane, come forastiere27, trattando della famiglia Grillo di Salerno menziona un Roberto, Milite, nel 1346 marito di Filippella Vaccara, Signora di Acerno e Castelvetere, e nel 1381 Signore di Castelnuovo. Seguono, dal 1400 in avanti, altri feudatari di Castelnuovo appartenenti alla potente famiglia Orsini, e poi ancora altri, tutti riportati nell’elenco che segue28, fino al 1806. Già dopo Gionata di Balvano i destini di Castelnuovo e Buoninventre si separano in quanto i due feudi sono attribuiti a differenti signori. Boninventre nel sistema feudale è per diversi secoli aggregato a Conza, mentre Castelnuovo è per molto tempo feudo degli Orsini, aggregato con Nola e Forino, e poi donato dal re, o venduto separatamente da un signore all’altro. Castelnuovo e Buoninventre si ricongiungono dopo cinquecento anni, nel diciassettesimo secolo allorquando vengono acquisiti entrambi dal napoletano, dottore utriusqe iuris, Domenico de Martino. Le tracce più antiche di Castelnuovo che si trovano negli archivi sono per lo più legate ai signori ai quali di volta in volta il borgo viene affidato dal sovrano (o che gli stessi signori vendono e comprano). Ovviamente la storia dei signori feudali non è la storia di Castelnuovo. Alcuni di loro, che possedevano Castelnuovo insieme ad altre decine di feudi, probabilmente non vi misero mai piede; pur tuttavia alcuni dei signori di Castelnuovo e di Buoninventre hanno Erasmo Ricca, La nobiltà del regno delle due Sicilie, Napoli, 1859. Biagio Aldimari, Memorie Historiche di diverse famiglie nobili, così napoletane, come forastiere, Napoli, 1691 (voce Della Famiglia Grillo). 28 Le signorie su Castelnuovo di Raimondo, Daniele e Roberto Orsini, e di Luigi Gesualdo III, sono attestate da Erasmo Ricca, La nobiltà del regno delle due Sicilie, Napoli, 1859; le signorie di Orso e Giulio Orsini, e poi da quella di Baldassarre Pappacoda in avanti sono attestate dai Cedolari presso la Regia Camera della Sommaria, Archivio di Stato di Napoli. 26 27 66 conquistato di per se stessi un posto di rilievo nella storia d’Italia, e peccheremmo di prevenzione se di loro non dessimo conto sol perché appartenevano alla classe dei feudatari, che vivevano e prosperavano sul sudore e le sofferenze di migliaia di contadini. E’ significativo, in proposito, un passaggio di Francesco Paolo Laviano che, circa il dominio della famiglia Gesualdo a Pescopagano, così annota: …diedero tanto filo da torcere ai poveri vassalli di Pescopagano, che, coi continui piati giudiziari, stancarono il S. R. Consiglio. Basta ricordare qui i nomi di Michele e Fabio Gesualdo per compendiare tutti gli abusi e le violenze che si commettevano in quell’epoca funesta del feudalesimo; dove ogni arbitrio restava impunito; e, per colmo, contaminare il letto nuziale e attentare alla vita e alla proprietà dei pacifici cittadini era permesso29. 2.3 I signori di Castelnuovo e Buoninventre Ecco l’elenco che abbiamo ricostruito dei signori di Castelnuovo e Buoninventre (che coincidono all’inizio, nell’anno 1140, e alla fine del feudalesimo, nell’anno 1806): A) Signori di Castelnuovo di Conza 1. Gionata di Balvano, conte di Conza - 1140 - Castelnuovo e Malinventre. 2. Guidone d’Acerno - 1187 - manda in Terrasanta per una parte d’Acerno, e altri feudi che possedeva in Giffoni, sei soldati a cavallo e cinquanta fanti. 3. Filippo d’Acerno - 1239, poi confermato da papa Innocenzo IV nel 1254, possiede Acerno Rotonda, Viario, Castelnuovo, la metà di Vietri, ed altri feudi a Giffoni e Campagna. 4. Guido d’Alemagna (?) - 1271 (Die XVI februarii XIV ind. apud Capuam Guidoni de Alamania et heredibus donatur Castrum novum in Principatu pro uncii XXXX). 5. Dalmasio di Tarascona, poi d’Acerno - 1272 - possiede Acerno e Castelnuovo. 6. Benforzato di Castellana - (reggente per Giovanni d’Acerno). 29 Francesco Paolo Laviano, La vecchia Conza e il castello di Pescopagano, Trani, 1926. 67 7. Giovanni d’Acerno - figlio di Dalmasio di Tarascona, sposa Iacopa della Marra. 8. Iacopa della Marra - diventa Signora di Castelnuovo alla morte di Giovanni d’Acerno, e si risposa nel 1302 con Ugone, o Ragone, del Balzo. 9. Guglielmo di Sabrano - succede alla morte di Iacopa della Marra. 10. Roberto Grillo di Salerno - nel 1346 e nel 1381 è signore di Castelnuovo, Acerno e Calabritto. 11. Raimondo Orsini - è signore di Castelnuovo dal 1400 fino al 1412, quando il re Ladislao confisca agli Orsini tutti i feudi. 12. Raimondo Orsini - nel 1416 sono restituiti i feudi agli Orsini, e Raimondo è nuovamente Conte di Nola, Lauro, Avella, Palma, Ottaviano, Cicala, Atripalda, Monteforte, Montefredano, Castelnuovo e Forino. 13. Daniele Orsini - succede al padre Raimondo, ma si schiera con gli angioini e viene privato dei feudi dal re Ferrante d’Aragona. 14. Orso Orsini - il 18 gennaio 1462 riceve la Terra di Castelnuovo dal re Ferrante d’Aragona insieme alla contea di Nola, Atripalda, la signoria di Baiano, Lauro, Palma, Avella, Ottaviano, Monteforte e Forino. 15. Roberto Orsini - secondogenito di Orso, nel 1479 succede al padre nei feudi di Forino e Castelnuovo. Roberto partecipa ad una nuova congiura contro Ferrante d’Aragona e il 9 luglio 1485 il re lo fa imprigionare insieme al fratello primogenito Raimondo ordinando la confisca dei feudi. 16. Giulio Orsini - nel 1486 riceve dal re Ferrante d’Aragona la Terra di Castelnuovo, la città di Ascoli, il feudo di Fontanafura, e le terre di Forino, Collefegato e Poggio di Valle. Nel 1496 Giulio Orsini si schiera con gli avversari del re, che gli confisca i beni concessigli in precedenza (poi ci sarà la riconciliazione e, con essa, la restituzione dei feudi). 17. Luigi Gesualdo III - il 21 settembre 1496 il Re Ferrante II d’Aragona gli concede molti feudi, tra cui Buoninventre e Castelnuovo, con Auletta, Boiaro, Caggiano, Cairano, Calitri, Campagna, Caposele, Conza con i suoi casali, Frigento con la Baronia, Gesualdo, Palo, Salvia, Salvitella, Santa Menna (sic!), Santa Maria in Elice, Sant’Andrea, Sant’Angelo le fratte e Teora; resosi nuovamente ribelle Luigi Gesualdo, i suoi feudi passano al Fisco. 68 18. Baldassarre Pappacoda - nell’anno 1500 possiede Castelnuovo. Baldassarre è Cavallerizzo Maggiore e Consigliere del re Federico d’Aragona, il quale poi, nel 1501, lo nomina feudatario di Lacedonia. Fa parte dell’ambasceria che il Vicerè di Napoli, Raimondo di Cardona, invia nel 1519 nelle Fiandre presso il neo imperatore Carlo V. L’evento è così riportato da Francesco Ceva Grimaldi ne Le memorie storiche della Città di Napoli del 1857: I nobili patrizi di Napoli sempre onorevoli e distinti mandarono a Carlo V una deputazione per prestargli gli omaggi di obbedienza e di fedeltà. Tale messaggio fu diretto al sovrano sin nelle Fiandre; fu celebre per la magnificenza e per i soggetti che la componevano; e la storia ne ricorda i nomi. Questi furono il dott. Cecco Loffredo (anche lui poi signore di Castelnuovo) pel sedile Capuano, Paolo Brancaccio pel sedile Nilo, Galeazzo Ciciniello pel sedile di Montagna, Baldassarre Pappacoda pel sedile di Porto, il dott. Gattola pel sedile Portanova, e Cola Francesco Folliero per quello del popolo. 19. Giulio Orsini - nell’anno 1504 nuovamente possiede Castelnuovo. 20. Cicco Loffredo - nel 1508 acquista la Terra di Castello nuovo da Giulio Orsini. Lo storico Pietro Giannone nella sua Istoria civile del Regno di Napoli del 1753 così ne parla: Rilusse il famoso Cicco Loffredo, già rinomato Avvocato, e poi nell’anno 1512 creato Regio Consigliere. Per la sua grande abilità fu inviato Oratore in Fiandra a Rè Carlo dalla Città a prestargli in suo nome ubbidienza, ed a cercargli la conferma de’ suoi privilegj. Fù dapoi nel 1522 innalzato al supremo onore di Presidente del Sacro Consiglio che l’esercitò infino all’anno 1539, nel qual anno passò nel Consiglio Collaterale, dove fu fatto Reggente. Morì in Napoli nel 1547 e fù prima seppellito nel Duomo di questa Città nella sua Cappella Tiziano, Ritratto di Carlo V gentilizia; ma dapoi Ferdinando Loffredo Marchese di Trivico suo figliolo, trasferì le sue ossa nella Chiesa di S. Spirito da lui fondata, dove si vede la sua tomba con iscrizione; e da questo famoso Giureconsulto discendono i presenti Marchesi di Trivico. 69 21. Guglielmo Silvio -1544 - acquista la Terra di Castello nuovo da Cicco Loffredo. 22. Antonio Silvio - 1556 - succede a suo padre Guglielmo (Nel Registro significatoriarum releviorum, XI fol. 147, è registrata la significatoria di ducati 272, grana 84, e tarì 10 spedita il 3 Giugno 1557 contro Antonio Silvio per lo relievo per esso debito alla Regia Corte per morte di Guglielmo Silvio suo padre seguita a 29 Maggio 1556 per l’entrate feudali della terra di Castel nuovo della Provincia di Principato Citra). 23. Guglielmo Silvio - 1558 - riceve in dono la Terra di Castello nuovo dal padre Antonio. 24. Fabio Gesualdo - 1571 - acquista da Guglielmo Silvio la Terra di Castello nuovo. 25. Antonio Maria Gesualdo - 1574 - succede a Fabio Gesualdo. (Nel Registro significatoriarum releviorum, XX fol. 117, è registrata la significatoria di ducati 1849 e grana 17 spedita il 22 febbraio 1576 contro Antonio Maria Gesualdo per lo relevio per esso debito alla regia corte per morte di Fabio suo padre seguita a 6 Gennaio 1574 per le entrate feudali delle terre di Pescopagano, Santo Stefano, e sua Baronia, Ruvo e Castello nuovo). 26. Giovanni Geronimo Gesualdo - 1577 - succede a suo fratello Antonio Maria Gesualdo. 27. Fabio Gesualdo - 1591 - succede a suo padre Giovanni Geronimo Gesualdo. 28. Francesco Gesualdo - 1608 - succede a Fabio Gesualdo suo padre. 29. Fabio Bavosa - 1619 - nell’anno 1619, a’ 23 marzo Don Fabio comprò da Don Francesco Gesualdo, per intermedia persona di Cesare Gesualdo suo curatore, la Terra di Castelnuovo nel Vallo di Conza della Provincia di Principato citra per Ducati 6.00030. 30. Giuseppe Bavosa - succede a Fabio Bavosa suo padre. 31. Fabio Bavosa jr - 1655 - succede a Giuseppe Bavosa suo padre. 32. Camilla Felice Bavosa de Rossi - 1668 - succede a suo fratello Fabio Bavosa jr (e sposa Domenico de Martino, Cronista Conzana: la Terra di Castelnuovo, che volgarmente viene dimandata Castellonuovo di Conza, che come vogliono anticamente fusse stata casale di Conza; era anti30 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Cedolari, volume 90. 70 camente sotto il dominio del Signor Principe Francesco Giesualdo, da chi fu venduta dal detto Don Francesco al Don Fabio Bavosa della Terra di Pescopagano, suo vassallo, il quale havendo procreato Isabella Bavosa sua figlia questa contrasse matrimonio con il Dottor Domenico de Martino31, il quale in atto è il Barone di detta Terra). Lo stesso D. Domenicus di Martino, de Neapoli, Doctor Utriusque Iuris, il 6 luglio dell’anno 1674 acquista da Giovanni Battista Ludovisio Principe di Venosa, il feudo di Buoninventre col suo Bosco di S. Ilarione sito in Provincia di Principato Ultra, giusta li beni della Terra di Laviano, Terra di Castelnuovo, il fiume Tormite, lo Vallone, e stada pubblica, sin come detto Illustre Principe lo possedeva con giurisdizione separata. Dal 1674 Castelnuovo e Buoninventre sono di nuovo uniti sotto la stessa famiglia feudale. 33. Nicola Maria de Martino - 1676 - succede alla madre Camilla Felice Bavosa de Rossi (Registro significatoriarum 77, al foglio 139 e seguenti esiste la liquidazione del relevio dovuto alla Regia Corte da Nicola Maria de Martino per morte di Camilla Felice Bavosa de Rossi sua madre seguita nell’anno 1676, quale liquidazione seguì nell’anno 1679). 34. Domenico de Martino - 1691 - secondo la Cronista conzana è in atto il barone di Castelnuovo; succede al padre Nicola Maria de Martino. 35. Francesco Maria Mirelli Carafa Principe di Teora - con Gabriela Pallavicini, Principessa di Teora sua moglie, il 14 maggio 1722 in Napoli acquista da Domenico di Martino i feudi di S. Ilarione e Buoninventre unitamente colla Terra di Castelnuovo del Vallo di Conza, posta in Provincia di Principato Citra con li loro corpi, raggioni, giurisdizioni, e beni burgensatici, e feudali. 36. Giuseppe Mirelli - figlio di Francesco Maria e Gabriella Pallavicino, succede nel 1763. 37. Francesco Maria Mirelli - figlio di Giuseppe e Maria Arduino d’Alcontres, succede succede al padre nel 1774 ed è l’ultimo signore feuE’ possibile che l’autore della Cronista Conzana abbia identificato nella stessa persona due Domenico de Martino (nonno e nipote), così come può aver deformato il nome Camilla in Isabella (comunque nipote di un Fabio Bavosa). Anche nel caso di Fabio Bavosa il Castellano fonde in una stessa persona nonno e nipote: il Fabio Bavosa che acquista Castelnuovo da Francesco Gesualdo è il nonno di Fabio Bavosa jr, fratello di Camilla, o Isabella. 31 71 dale di Castelnuovo fino a quando, nel 1806, viene abolita la feudalità. Rimane comunque proprietario delle tenute boscose di S. Ilarione e Boninventre32. B) Signori di Buoninventre 1. Gionata di Balvano, conte di Conza - 1140 - Malinventre e Castelnuovo. 2. Conte Giacomo Arcuccia, Gran Camerario della regina Giovanna - 1374 - è signore di Malinventre insieme a decine di altri possedimenti tra i quali Calabritto, Tegora, Oppido, Montefalcone in Principato ultra. 3. (non abbiamo trovato notizie certe fino al 1458, ma è possibile che dal 1381 Buoninventre sia stato assegnato, insieme a Conza, alla famiglia Gesualdo; pertanto i signori sarebbero stati Luigi Gesualdo I, Antonello Gesualdo, Sansone Gesualdo I, fino a Luigi Gesualdo II). 4. Luigi Gesualdo II - il 6 agosto 1458 Re Ferrante d’Aragona gli concede l’investitura di molti feudi che gli spettavano per successine paterna: i quali furono la città di Conza, e le terre di Buoninventre e Pietrabuiara, insieme ad Auletta, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, Castiglione, Palo, Salvia, Salvitelle, Santa Menna (sic!), Santa Maria in Elice, Sant’Andrea, Santangelo in Fratte e Teora. 5. Sansone Gesualdo II - 1452 primo conte di Conza. Nel 1452 i Gesualdo diventano conti di Conza, nel 1480 vestono l’abito dell’Ordine di Malta e nel 1561 sono decorati principi di Venosa dal re Filippo II d’Asburgo-Spagna. 6. Niccolò II - 1471. 7. Luigi Gesualdo III - 1480 - Barone ribelle al re. Nel 1494 è devoluto al fisco, tra gli altri, il feudo di Bonojnvento casale disabitato. Successivamente Giuseppe Maria Cappetti il 10 Dicembre 1807 acquista dal principe di Teora Francesco Maria Mirelli (non più Signore di Castelnuovo) le due tenute boscose di S. Ilarione e Beninventre nelle pertinenze di Caposele attaccati alla Terra di Castelnuovo di Conza (colla servitù di dover far legnare a secco e selvaggio l’Università di Castelnuovo). Nel 1811 la proprietà passa ad Emilia Cappetti (destinataria della causa intentata dal Comune per la rivendica dei boschi Pantano magno, Macchioni e Pianello). Nel 1818 i beni passano a Don Romualdo Cassitti (marito di Emilia Cappetti) ed il Comune di Castelnuovo di Conza (Sindaco Donato Di Domenico) riprende la causa perché Romualdo Cassitti vuol far tagliare gli alberi. 32 72 8. Luigi Gesualdo III - (il 23 aprile 1495 il re Carlo VIII, con diploma dato nel castello di Capuana nella città di Napoli, conferma in favore di Luigi Gesualdo, civitatem Consae cum titulo comitatus, terras Calitri, Cayrani, Tegorae, Capitsileris cum territorio Pasani et terram Pali cum castris etc. –nec non casalia Sancti Mennai, Sancti Andreae, Sanctae Mariae in Elice et Salviae cum hominibus etc.; Terras Boniventri et Serralongae, Petrae de Boyano et Castiglionis inabitatas cum territorio pascuis etc; Terras Cagiani, Aulectae, Sancti Angeli de fractis, Silvitellarum cum pheudo suo; Gesualdi, Frigenti, Paterni, Fontanae rosae, Cossani, Taurasi et Castri veteris in Baroniam cum hominibus, vaxallis etc…). 9. Luigi Gesualdo III - il 21 settembre 1496 il Re Ferrante II d’Aragona gli concede molti feudi, tra cui Buoninventre e Castelnuovo, con Auletta, Boiaro, Caggiano, Cairano, Calitri, Campagna, Caposele, Conza con i suoi casali, Frigento con la Baronia, Gesualdo, Palo, Salvia, Salvitella, Santa Menna (sic!), Santa Maria in Elice, Sant’Andrea, Sant’Angelo le fratte e Teora. 10. Nel 1498 Luigi Gesualdo III è di nuovo ribelle ed i feudi ritornano al Fisco (Conza con i suoi casali Sant’Andrea e San Menna vanno al gran Capitano Consalvo Ferrandez de Corduba). 11. Luigi Gesualdo III - 1506 - ancora una volta gli sono restituiti i suoi precedenti feudi; non però Castelnuovo che viene nuovamente affidato a Giulio Orsini. Luigi Gesualdo III sposa Giovanna Sanseverino, sorella del Principe di Salerno, Antonello. 12. Fabrizio I - figlio di Luigi e Giovanna Sanseverino. Il 4 dicembre 1518 il Vicerè Raimondo de Cardona gli accorda l’investitura della città di Conza cum titulo et honore Comitatus, della città di Frigento, delle terre di Auletta, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, Castelvetere, Castiglione col suo territorio, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Palo, Paterno, Salvitelle con certo suo feudo, Santa Menna (sic!), Sant’Andrea, Santangelolefratte, Taurasi e Teora; de’ feudi di Buoninventre e di Pietraboiara; e delle terre di Salvia, Santa Maria in Elice e Villamaina ma con la sola giurisdizione criminale. Le summenzionate concessioni vengono confermate dall’imperatore Carlo V il 10 aprile 1520. 13. Luigi Gesualdo IV - dopo la morte del padre avvenuta il 14 giugno 1545, gli succede con l’investitura del Vicerè Pietro di Toledo del 30 73 settembre 1546. Sposa Isabella Ferrello e genera, tra gli altri, Fabrizio e Alfonso, che diventa Cardinale di Napoli nel 1596. Nel 1561 è nominato principe di Venosa. 14. Fabrizio Gesualdo II Conte di Conza e Principe di Venosa - succede alla morte di Luigi IV il 17 maggio 1584. E’ consigliere del re Filippo II di Spagna che gli conferma l’investitura del contado di Conza e della città di Venosa col titolo di principe. Sposa Geronima Borromeo, sorella del cardinale (poi sanIl re di Spagna Filippo II to) Carlo Borromeo. 15. Carlo Gesualdo Conte di Conza e Principe di Venosa33 - succede al padre Fabrizio che muore nel 1591. Nella Provincia di Principato Citra possiede Buoninventre con Caposele, Auletta, Palo, Caggiano, Sant’Angelo delle fratte, Salvitelle, Castiglione, Salvia, giurisdizione delle seconde cause su Salvia, diritti fiscali su Caposele e Cairano, Contursi. 16. Isabella Gesualdo Principessa di Venosa - all’età di due anni, dopo la morte del padre Carlo Gesualdo (8 settembre 1613), eredita Buoninventre insieme -per la Provincia di principato citra- a Caposele, Auletta, Palo, Caggiano, Sant’Angelo delle fratte, Salvitelle, Castiglione, Salvia, Contursi. Ad undici anni sposa Niccolò Ludovisio, duca di Zagarolo e nipote di papa Gregorio XV. Hanno una figlia di nome Lavinia. 17. Lavinia Gesualdo Ludovisio Principessa di Venosa - l’8 maggio 1629, alla morte di Isabella, eredita i feudi della madre: Conza, Venosa, ed altre decine di feudi tra cui Buoninventre. 18. Niccolò Ludovisio Principe di Venosa - 1636. Lavinia muore senza legittimi eredi ed il complesso dei feudi ritorna al re, che lo vende al padre di Lavinia: in tempo della Maestà di Filippo IV di felice memoria essendo devoluto alla Regia Corte lo Stato di Venosa per la morte di Don33 E’ il grande musicista-assassino della sposa di cui parleremo più avanti. 74 Feudi di Carlo Gesualdo, principe di Venosa (Archivio di Stato di Napoli) na Lavinia Gesualdo senza successori ne i feudali, fu quello precedente apprezzo esposto venale dal Vicerè di quel tempo, e mediante pubblico Istromento stipulato in data de 16 maggio 1636 fu venduto a benefizio dell’Illustre Principe di Piombino Don Nicolò Ludovisio… 19. Giovanni Battista Ludovisio - succede al principe di Venosa Don Niccolò Ludovisio, che muore nell’anno 1664 a Cagliari essendo il vicerè di Sardegna. 20. Domenico de Martino - 1674. Don Giovanni Battista Ludovisio per molti debiti, che s’erano contratti sopra detto stato, tanto da D. Nicolò, quanto da suoi predecessori vendè a 6 luglio dell’anno 1674 a Don Domenico de Martino il feudo di Buoninventre col suo Bosco di S. 75 Ilarione sito in Provincia di Principato Ultra, giusta li beni della Terra di Laviano, Terra di Castelnuovo, il fiume Tormite, lo Vallone, e stada pubblica, sin come detto Illustre Principe lo possedeva con giurisdizione separata. 21. Nicola Maria de Martino - 1676. Succede alla madre Camilla Felice Bavosa de Rossi (Nel Registro significatoriarum 77, al foglio 139 e seguenti esiste la liquidazione del relevio dovuto alla Regia Corte da Nicola Maria de Martino per morte di Camilla Felice Bavosa de Rossi sua madre seguita nell’anno 1676, quale liquidazione seguì nell’anno 1679). 22. Domenico de Martino - 1691, secondo la Cronista conzana è in atto il barone di Castelnuovo; succede al padre Nicola Maria de Martino. 23. Francesco Maria Mirelli Carafa, Principe di Teora - Il 14 maggio 1722 in Napoli Domenico di Martino vende alla Signora Donna Gabriela Pallavicino Principessa di Teora li feudi di S. Ilarione e Buoninventre unitamente colla Terra di Castelnuovo del Vallo di Conza, posta in Provincia di Principato Citra con li loro corpi, raggioni, giurisdizioni, e beni burgensatici, e feudali ed insieme loro stati tramite il Signor Don Francesco Maria Mirelli Carafa Prencipe di Teora messo, ed internunzio come dice, della Signora Donna Gabriela Pallavicini Principessa di Teora sua Moglie interveniente similmente alle cose infrascritte in nome, e parte di detta Sig.ra Principessa e per l’Eredi, e Successori della medesima… 24. Giuseppe Mirelli - figlio di Francesco Maria e Gabriella Pallavicino, succede nel 1763. 25. Francesco Maria Mirelli - figlio di Giuseppe e Maria Arduino d’Alcontres, succede al padre nel 1774 ed è l’ultimo signore feudale di Buoninventre fino a quando, nel 1806, viene abolita la feudalità. Rimane comunque proprietario delle tenute boscose di S. Ilarione e Buoninventre. 2.3 Personaggi di rilievo. Raimondo Orsini Guardando dentro le antiche carte che documentano le vicende dei signori, ma che comunque a Castelnuovo si riferiscono, è possibile trovare notizie che, seppure in modo indiretto, forniscono interessanti indicazioni su persone, famiglie, rapporti sociali, etc., come anche è interessante notare che alcuni dei signori di Castelnuovo e Boninventre hanno conquistato 76 una posizione di rilievo nella storia d’Italia. In particolare hanno avuto a che fare con Castelnuovo e Buoninventre, tra il Quattocento ed il Cinquecento Raimondo, Orso e Giulio Orsini34 e, alla fine del Cinquecento Carlo Gesualdo, principe di Venosa. Vediamoli uno alla volta, partendo dai documenti che ne attestano il legame con Castelnuovo e Buoninventre. Castelnuovo nel 1400, insieme a Forino, Lauro, Avella, Palma, Ottviano, Cicala, Atripalda, Monteforte, Montefredano, appartiene al Conte di Nola Raimondo Orsini35. Raimondo Orsini, a giudizio unanime degli storici, è stato il più brillante, colto e sagace conte di Nola. Molto abile nei maneggi politici ed espertissimo nell’arte della guerra, con una condotta intelligente, cauta, ma talvolta anche spregiudicata, dopo la perdita di tutte le terre su cui avevano esercitato il dominio i suoi avi, riuscì, sfruttando antiche e potenti amicizie, ad avvicinarsi agli Angioini prima, agli Aragonesi dopo; a ritornare, quindi, in possesso dei domini paterni ed inoltre essere riconosciuto Grande Giustiziere del Regno e duca di Amalfi (…) Durante la signoria di Raimondo la città di Nola si arricchì di grandiosi monumenti marmorei e di affreschi in diverse chiese: in quella di santa Chiara, nel convento di san Francesco, nel convento di sant’Angelo in Palco, dove egli volle essere sepolto, e nel Duomo di Nola dove sorge la celebre colonnina che ricorda il suo matrimonio Il cereo nella cattedrale di Nola con Isabella Caracciolo36. Quest’illustre Famiglia (fra le più famose ed antiche d’Europa) era già residente in Nola agli inizi del XIII secolo; e la città, fin dal 1290, fu posseduta in Contea degli Orsini, rimanendo sotto il loro dominio fino al 1529. 35 Erasmo Ricca, La nobiltà del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1859. 36 Luigi Ammirati, Il cereo quattrocentesco della Cattedrale di Nola, in Raccolta rassegna storica del Comuni, Istituto di studi atellani, 1969. 34 77 La Cattedrale di Nola incepta est a Raymundo Ursino finita ab Urso, atque Episcopio. Non avendo avuto figli legittimi, istituisce eredi i tre figli naturali: Felice, Conte di Nola e Principe di Salerno, nonché Duca di Ascoli e Signore di Lauro; Daniele Signore di Forino e Castelnuovo; Giordano Conte di Atripalda. Il Re Ferdinando d’Aragona, per legare a sé Felice gli dà in sposa la figlia naturale Maria, ma ciò non gli serve a nulla poiché Felice, in breve tempo, passa alla parte angioina. Gli altri due fratelli, per non essere da meno, tradiscono anche loro gli Aragonesi e per la loro condotta, dopo la battaglia di Troia, sono spogliati dei loro beni, che passano ad Orso Orsini. 2.4 Personaggi di rilievo. Orso Orsini Nel cedolario37 di registrazione della “proprietà” di Castelnuovo in capo a Camilla Felice Bavosa de’ Rossi, redatto in Napoli presso la Regia Camera della Sommaria il 20 settembre 1674 troviamo attestato: In anno 1462 il Serenissimo Re Ferdinando dona inter alia ad Urso Ursino la Terra di Castelnuovo, e Forino nella Provincia di Principato Ultra, con suoi vassalli, feudi, giurisdizioni et attioni, con mero, et misto Imperio, Bagliva, cognitione di prime cause, Portolania, mercatura di pesi, e misure in pheudalibus, ut in q.n 2.o al 33 iuxta la copia predetta, extracta dalli Regij Quinternioni 38. Di Orso Orsini si sa che è l’ideatore e costruttore Busto del re di Napoli Ferdinando I (Ferrante), della omonima Reggia Parigi, Louvre Registro nel quale era iscritta la tassa stabilita sul reddito del feudo, o adoa, e ne era riportata l’esazione. 38 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Cedolari, Volume 90. 37 78 in Nola, costruita con blocchi di marmo provenienti da antiche costruzioni romane. Figlio illegittimo di Gentile Orsini serve Alfonso d’Aragona che lo nomina Gran Cancelliere del Regno. Passa al servizio di Francesco Sforza e dei Visconti di Milano; ma Orso, dopo la morte di Alfonso I nel 1458, si ribella al Re Ferrante. Segue Giovanni d’Angiò ed ha una parte importante nella vittoriosa battaglia di Sarno (1460). Successivamente, il 7 gennaio 1462, innalza di nuovo la bandiera regia sulle mura di Nola e il 14 gennaio ottiene dal Re Ferrante d’Aragona la Contea di Nola, Atripalda, la Signoria di Baiano, Lauro, Palma, Avella, Ottaiano, Monteforte e Forino, insieme come si è visto, a Castelnuovo. Dopo aver combattuto ancora per Ferdinando, nella battaglia di Troia, il 18 agosto 1462, ha da quel momento delicati incarichi dal re, fra i quali, quello di assistere per oltre 15 anni il duca di Calabria. Nel 1478, nominato luogotenente dal duca, va con lui in Toscana per una missione di guerra. Muore nel 1479. Scrive anche d’arte militare, dedicando a Ferrante d’Aragona il trattato Governo et exercitio de la militia (1476), nel quale teorizza nuovi principi di tattica militare evidenziando l’importanza della fortificazione campale e delle artiglierie leggere. Di Orso è il figlio naturale, il secondogenito Roberto Orsini, legittimato con Decreto Reale il 10 febbraio 1480, che succede al padre nei feudi di Forino e Castelnuovo di Conza. Ma ha vita travagliata, poiché Alfonso d’Aragona, avuto sentore che qualcosa si stesse tramando contro di lui, piomba personalmente in Nola ed, il 9 luglio 1485, fa tradurre in prigione a Napoli, sia Roberto che la vedova di Orso, Donna Paola, insieme all’altro figlio Raimondo (che ha ereditato il grosso dei possedimenti paterni, tra cui Ascoli e Nola), ordinandone la confisca dei beni39. 2.5 Personaggi di rilevo. Giulio Orsini Tra i beni confiscati al giovane Roberto c’è anche Castelnuovo, tanto che nel medesimo documento del 1674 si trova più avanti: In anno 1486 il detto Serenissimo Re Ferdinando dona a’ Giulio Ursino diverse Terre, e fra’ Gli Orsini possedevano, oltre alla reggia di Nola, oggi Tribunale, uno splendido palazzo in Napoli eretto nel 1470, oggi chiesa di Santa Maria del Rifugio e annesso Conservatorio creato nella seconda metà del 1500 per ospitare le fanciulle. Sull’architrave vi è ancora, quasi illeggibile, tra due rose la seguente scritta: HEC ROSA MAGNANIMI DEFENDITUR UNGUIBUS URSI – HINC GENUS URSINUM ROMA VETUSTA TRAMIT. ANNO DOMINI MCCCCLXXI (Questa rosa è difesa dalle unghie del magnanimo Orso. Da qui l’antica Roma fa discendere la famiglia Orsini. Anno del Signore 1471). 39 79 esse la Terra di Forino, e Castel nuovo in Principato Ultra con vassalli, Bagliva, e intestationi, et attioni ad esse spettanti, Banco della Giustizia, cognitione di prime e seconde cause, conforme quelle che possedeva il quondam Urso Ursino in pheudalibus40. E’ da osservare che, sia nella prima che nella seconda donazione di re Ferrante d’Aragona, Castelnuovo viene collocato, insieme a Forino, in Principato Ultra (l’odierna provincia di Avellino). La circostanza è rilevata e, per così dire, spiegata nello stesso documento del 1674, laddove si legge: che nelle due concessioni del 1462 et 1486 si nomina detta Terra di Castel nuovo in Principato Ultra, e di poi nell’altre vendite, e successioni riferite, si dice Principato Citra, che saria diversità, però dalla parte si dice, che questo, o fu errore, perché in Principato Ultra non vi è Terra di Castello nuovo, ma in Principato Citra, o’ pure in quel tempo le Province fussero state in altro modo divise, e si vede chiaro che la successione va bene per Castello nuovo41. In altre parole, è vero che nelle donazioni del 1462 e 1486 si dice Castelnuovo in Principato Ultra, ma è pur vero che quello stesso Castelnuovo, allora “collocato” in Principato Ultra, è in seguito descritto come appartenente al Principato Citra quando passa ai successivi feudatari. Stemma in pietra degli Orsini a Napoli La biografia di Giulio Orsini è ancor più ricca di quella di Orso. Giulio è fondamentalmente un capitano di ventura, e partecipa in pratica a tutti gli avvenimenti militari di rilievo che si determinano in Italia tra la fine del quattrocento e gli inizi del cinquecento. Sono gli anni, 40 41 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Cedolari, Volume 90. Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Cedolari, Volume 90. 80 per capirci, di papa Alessandro VI e di Cesare Borgia, della venuta in Italia dei Francesi, prima con Carlo VIII e poi con Luigi XII, e successivamente dell’Italia contesa tra francesi e spagnoli. Nel 1482, al servizio del re di Napoli, Giulio Orsini combatte i veneziani. Nel 1485 lotta contro i Colonna. Successivamente, nel 1485, viene assoldato sia dai fiorentini che dai milanesi con il compito di affiancare gli aragonesi contro i pontifici. Nel 1486, con l’espugnazione Stemma della famiglia Orsini del ponte Nomentano a Roma da parte del San Severino, si accorda con il papa Innocenzo VIII contro la volontà degli altri suoi familiari. E’ in quest’anno che il re di Napoli lo investe del ducato di Ascoli Satriano, con i feudi di Fontanafura in Puglia, le terre di Forino e Castelnuovo, di Collefegato e di Poggio d’Abruzzo42. Nel 1492 è inviato dal papa Alessandro VI con Niccolò Orsini, Pietro Colonna ed Antonello Savelli in aiuto di Fermo contro Ascoli Piceno. A dicembre è a Roma, ove ha il compito con altri nobili di ricevere il principe di Altamura, Federico d’Aragona, in visita alla città. Nel 1493, al servizio del papa Alessandro VI, assiste alle nozze di Lucrezia Borgia con Giovanni Sforza. L’anno seguente prende parte alla conquista della rocca di Ostia ai danni Il privilegio del Re Ferrante del 4 dicembre 1486 così recita: Advertentes adgrata plurimun fructuosa et accepta servitia que nobis prestitit Magnificus Vir Iulius de Ursinis Consiliarus Noster fidelis dilectus hoc maxime bellorum turbine eiusmodique fuerunt: Quod status Noster sine dubio stabilior factus est que ab eodem in factum speramus de bono in melius continuazione laudabili eidem Magnifico Iulio suisque heredibus et successoribus ex suo corpore legitime discendentibus natis iam et in antea nascituris in perpetuum Civitatem Asculi et Pheudum Funtane Fure in provincia Capitanate nec non Terram Forini et Castellum Novum provinciae Principatus Ultra, Castrum Collis Fecati et Castrum Podii de Valle Provinciae Apritii cum casalibus etc. pro ut illas et illa melius et utilius tenebat Illustris quondam Ursus de Ursinis Dux Asculi tamquam rem Nostram propriam et ad Nos et Curiam Nostram legitime et pleno iure spectantem et pertinentem damus tradimus atque concedimus (Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Quinternione VII, fogli 149-150). 42 81 del cardinale Giuliano della Rovere (il futuro papa Giulio II). Nel 1496 su incarico di Cesare Borgia, il figlio secondogenito di papa Alessandro VI, celebrato da Machiavelli come il principe ideale in un progetto di costituzione dello stato nazionale in Italia, si unisce con Paolo Orsini per indurre a più miti consigli Bandino da Castel della Pieve, che minaccia Orvieto. Giulio però non si associa con gli altri Orsini che nel 1502, come racconta Machiavelli, avvedutisi tardi che la grandezza del duca era la loro ruina, fecero una dieta alla Magione, nel Perugino 43. La dieta altro non è che una congiura tentata ai danni del duca Valentino (Cesare Borgia), il quale, per usare ancora le parole di Machiavelli, si volse agli inganni, e tanto seppe dissimulare l’animo suo che li Orsini, mediante el signor Paulo si riconciliarono seco; con il quale el duca non mancò di ogni ragione di offizio per assicurarlo, dandoli danaro, veste e cavalli; tanto che la semplicità loro li condusse a Sinigallia tra le sue mani44. Qui, a Senigallia, il 31 dicembre 1502, Cesare Borgia, dopo averli fatti ben mangiare e bere a volontà, li fa arrestare e poi strangolare. Tra gli ingenui Orsini eliminati non c’è Giulio, il quale non partecipa alla congiura e firma un accordo con il duca Valentino ed il papa. Con la morte di Alessandro VI, dopo il breve interregno di Pio III, assurge al soglio pontificio il cardinale Giuliano della Rovere con il nome di Giulio II, il quale diffida di Giulio Orsini. Questi si volge al servizio della Spagna, poi di Venezia ed, infine, nuovamente della Chiesa, tanto che è presente a Roma nell’aprile del 1513, con 50 cavalli, all’incoronazione di Leone X. Muore nel 1517. E’ ricordato come valoroso, intelligente, bello di corpo. 2.6 Personaggi di rilevo. Carlo Gesualdo principe di Venosa Il quarto personaggio illustre che ha a che fare con Castelnuovo, più precisamente con Buoninventre, è Carlo Gesualdo, principe di Venosa. Nel documento che lo attesta così si legge: In cedulario ab anno 1610 et per totum anno 1614 (…) notatur taxatus Don Carolus Iesualdus Princeps Venusis (…) Pheudis Beneventre et Petre Borraye45. Insieme a Buoninventre e Pietra Niccolò Machiavelli, Il Principe, capitolo VII De principatibus novis qui alienis armi et fortuna acquiruntur. 44 Niccolò Machiavelli, Il Principe, capitolo VII De principatibus novis qui alienis armi et fortuna acquiruntur. 45 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Cedolari, vol. 88 43 82 Borraia sono elencati altri possedimenti del Principe di Venosa: Caposele, Auletta, Palo, Caggiano, Sant’Angelo delle fratte, Selvitelle, Castiglione, Salvia, Cairano, Contursi. Franco Battiato nel 1995 ha inciso una bellissima canzone su Carlo Gesualdo. Eccone il testo, scritto dal filosofo siciliano Manlio Sgalambro: Io, contemporaneo della fine del mondo non vedo il bagliore, né il buio che segue, né lo schianto, né il piagnisteo ma la verità da miliardi di anni farsi lampo. Concerto n° 4 in do minore per archi di Baldassarre Galuppi (te, piccolo, minutissimo mazzetto di fiori di campo). La settima frase di Ornithology, l’ultima, prima della cadenza e dal da capo via, il noto balzo da uccello, sull’ultima nota di Charlie... (Pensiero causale Imperativo categorico Ferma distinzione dell’uomo dall’animale Teorema adiabatico!) I madrigali di Gesualdo, principe di Venosa, musicista assassino della sposa cosa importa? Scocca la sua nota, dolce come rosa. “Musicista, assassino della sposa”. In queste due annotazioni è sintetizzata la vicenda di Carlo Gesualdo, noto come Gesualdo da Venosa. Di lui scrive Scipione Cerreto, musicologo del diciassettesimo secolo: É un raro suonatore di molti strumenti e del liuto in special modo. Nelle composizioni è superiore a tutti i musici suoi contemporanei. Tiene a sue spese molti suonatori e compositori e cantanti. Se questo signore fosse vissuto all’epoca 83 dei Greci, gli avrebbero fatto una statua di marmo e d’oro46. Per Massimo Mila, critico musicale del novecento, Carlo Gesualdo … protagonista di una fosca tragedia coniugale e assassino per gelosia, sembra aver portato nell’insaziata febbre cromatica della sua musica lo smisurato disordine delle sue passioni. Da Marenzio a Gesualdo si assiste al trapasso dall’ordinata euritmia del Rinascimento alla convulsa interiorità del barocco (…) il suo eccesso di dissonanze, l’abuso del cromatismo, i suoi Stemma della famiglia Gesualdo capricci armonici sfociano ad una piena anarchia tonale, specchio d’uno stato d’animo tormentato e patetico, per il quale vien fatto di pensare al romanticismo avanti lettera d’un Caravaggio47. Massimo Privitera, nel saggio Madrigali malinconici48, ritiene che negli ultimi madrigali di Gesualdo il cromatismo pervade ogni strato compositivo: si presenta sia nella dimensione lineare dei soggetti, sia in sequenze di accordi che tolgono al discorso musicale ogni discrezionalità logica, lasciando l’ascoltatore sospeso nella cupa contemplazione del doloroso abisso. Della vita del principe compositore ci offre una compiuta descrizione il musicologo Pietro Misuraca49. Il trisavolo di Carlo, Luigi III, che –come abbiamo visto nell’elenco dei feudatari di Buoninventre- è stato protagonista delle rivolte baronali contro la corona aragonese, finisce la sua vita a Conza nel 1517. Il bisnonno Fabrizio I diviene importante riferimento per la corona spagnola, tanto Scipione Cerreto, Della prattica musica vocale, et strumentale, Napoli, 1601. Massimo Mila, Breve storia della musica, Torino, 2005. 48 In Enciclopedia della musica – La musica europea dal gregoriano a Bach -, Torino, 2004. 49 Pietro Misuraca, Carlo Gesualdo principe di Venosa, Palermo, 1962. 46 47 84 da essere elevato da Carlo V alla dignità di Grande di Spagna. Il nonno di Carlo, Luigi IV, succeduto nel 1545, ha un ruolo ancora più decisivo nell’ascesa dei Gesualdo. Intimo consigliere e collaboratore del re di Spagna, viene infatti compensato per i suoi servigi con nuovi feudi e immense ricchezze. Amante delle lettere e delle arti, dà avvio al mecenatismo di casa Gesualdo: Bernardo Tasso, il padre di Torquato, è tra coloro che beneficiano della sua protezione e amicizia. Intanto, ad accrescere Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, Signore di Buoninventre la potenza della casata dei Gesualdo, in un’epoca in cui logiche economiche e di potere governano le politiche matrimoniali, vengono le accorte scelte che imparentarono i Gesualdo con gli Orsini, i Carafa, i d’Avalos, i Caracciolo. In questo senso tra i figli di Luigi IV è Alfonso, cardinale, a fare un autentico capolavoro, portando a buon fine il matrimonio di suo fratello Fabrizio II50 –futuro padre di Carlo- con Geronima Borromeo, nipote del papa. Potente per autorità e prestigio, celebre per liberalità e generosità, il cardinale Alfonso Gesualdo, zio di Carlo, partecipa a sette conclavi. Tra i pochi cardinali a risiedere in Vaticano, a Roma promuove la costruzione della chiesa di S. Andrea della Valle, quella del primo atto della Tosca; come arcivescovo di Napoli, poi, istituisce per i poveri il Monte della Mise- Come si è visto nell’elenco dei feudatari di Buoninventre, Fabrizio è consigliere del re di Spagna Filippo II ed ottiene l’investitura del contado di Conza e della città di Venosa col titolo di principe. 50 85 ricordia. La futura madre di Carlo, figlia di Margherita de’ Medici, è infatti nipote di Papa Pio IV, al secolo Giovan Angelo de’ Medici, (il papa della conclusione dei lavori del Concilio di Trento), sorella del cardinale Carlo Borromeo – il San Carlo dei teatri di Napoli e Lisbona – e cugina di Federico Borromeo di manzoniana memoria (il cardinale che nei “Promessi sposi” induce la conversione dell’Innominato). Carlo Gesualdo nasce a Venosa l’8 marzo del 1566 da Fabrizio II e Geronima Borromeo. Vive la sua giovinezza a Napoli dove, nel palazzo di Torre Maggiore di proprietà del duca di Sangro, il padre, amante delle lettere e delle arti, ha creato un cenacolo intellettuale, al cui interno illustri musici provvedono alla formazione musicale del giovane Carlo. Egli, La copertina del disco di Battiato con la dedica a Sgalambro infatti, sin da giovanissimo ha rivelato un talento sbalorditivo, tanto da avviarsi alla composizione; la musica cessa ben presto di essere per lui un gradevole passatempo sino a diventare la sua stessa ragione di vita. Lo si educa, al contempo, in un clima di religiosità penitenziale, con rigorosa disciplina, e con gli Exercitia spiritualia di Ignazio di Loyola come pane quotidiano, che inculcano nell’animo sensibile e fragile del giovane profondi sensi di colpa e che ne segneranno sino all’ultimo la sfortunata e tragica vicenda umana. Già destinato, come figlio cadetto, alla carriera ecclesiastica, si trova di colpo nel ruolo di erede a causa dell’improvvisa morte del fratello maggiore. Si deve allora subito pensare a trovargli una moglie, e la scelta cade su sua cugina, la bellissima Maria d’Avalos. In seguito alle nozze, gli sposi prendono alloggio nel palazzo napoletano di Torre Maggiore, mentre i genitori di 86 Carlo si ritirano nei loro feudi. Pochi anni dopo nasce l’erede, Emanuele. Poi l’episodio che sconvolge la vita di Carlo. Maria durante una festa da ballo conosce Fabrizio Carafa, duca d’Andria, cavaliere forse il più avvenente e valoroso della città, che non avea compiuto il suo sesto lustro51 e se ne innamora follemente. Ben presto i due giovani diventano amanti e prendono ad incontrarsi, prima nella ombre dei giardini di Don Garzia di Toledo e nelle stanze remote di quel palazzo, ma poi una giovane cameriera di Donna Maria osò d’introdurre persino il duca nella stanza nuziale. La relazione rimane segreta per qualche tempo fin quando l’eco degli appassionati e segreti colloqui non giunge all’orecchio di Don Giulio Gesualdo, zio del principe Carlo, il quale essendosi fieramente invaghito della stessa Donna Maria, obbliando che fosse la consorte di suo nipote, non avea lasciato mezzo e modo per sedurla. Don Giulio viene respinto dalla bella Maria e, per vendicarsi, informa della tresca il marito di lei. Carlo non vuol credere a quanto gli viene riferito, ma poi prende a spiare i passi dei due amanti e, assicuratosi dei lor privati trattenimenti, fè con gran segretezza smuovere e guastar le serrature delle porte che menavano al suo appartamento, acciò la Donna Maria non si fosse desta al minimo rumore, e sparse ad arte la voce di voler andare a caccia secondo il solito, annunziando che la sera non sarebbe tornato a casa, bensì la dimane. E’ la trappola, neanche tanto originale, nella quale cadono i due folli ed ingenui innamorati. Infatti, saputosi dal Duca d’Andria che il Gesualdo era andato agli Astroni, e che non tornava la sera, alle ore quattro della notte subito si condusse al convegno, ed accolto col solito affetto da Donna Maria, spogliatisi entrambi, entrarono in letto. E’ l’ultima notte, quella tra il 26 ed il 27 ottobre 1590, per Maria e Fabrizio; notte di amore e di morte. Andato a buon fine il primo punto del diabolico piano, il principe di Venosa può mettere in atto la vendetta; e così sulla mezzanotte corse al palazzo il Don Carlo seguito da una mano di servi tutti armati, ed introdottosi nel suo appartamento volò come un demone alla camera della consorte, innanzi al cui uscio stava alla vedetta la fida cameriera mezzo addormentata sopra un lettino. Atterrata la porta della camera, Don Carlo vi entrò furibondo, ed i due amanti furono in un punto trucidati. Carmine Modestino, Della dimora di Torquato Tasso in Napoli, Napoli, 1863 (tutte le successive citazioni su Fabrizio e Maria sono tratte da questo testo). 51 87 Viene avviata dalle autorità una formale istruttoria circa il fatto di sangue, e viene finanche redatta una Informatione, una sorta di immediato rapporto di polizia compilato dai consiglieri e giudici criminali della Gran Corte della Vicaria, entrati per il sopralluogo nella camera da letto del palazzo di Don Carlo Gesualdo. In essa si legge che il detto Duca d’Andria era tutto insanguinato, e ferito di più ferite, e di un’archibugiata al braccio sinistro che gli pasDante Gabriel Rossetti, Maria d’Avalos sava il cubito dall’una parte all’altra, e passava ancora il petto; e la manica della sopraddetta camiscia era abbruciata, e teneva più e diverse ferite in petto di ferri acuti, e nella braccia, in testa, ed in faccia: un’altra archibugiata alle tempie e sopra l’occhio, dove era una gran lava di sangue; e che dentro detto letto si è trovata morta la suddetta Donna Maria d’Avalos, quale era morta uccisa, che teneva tagliati li cannarini, una ferita in testa dalla parte della tempia dritta, una pugnalata in faccia, e più pugnalate sulla mano e braccio dritto, e nel petto e fianco teneva due altre ferite di punta52. L’Informatione si dilunga su altri particolari e raccoglie diverse testimonianze; ma del tutto inutilmente, giacché ad essa non si dà seguito alcuno per ordine del Vicerè, Conte di Miranda, sia perché estimò giusto il motivo da cui fu mosso Don Carlo a togliersi quell’onta, sia perché volle usar riguardo al figlio di un principe, al pronipote di un pontefice, ed al nipote di due cardinali, cioè Carlo Borromeo ed Alfonso Gesualdo; quindi l’inquisizione del magistrato arrestossi e non ebbe corso, rimanendo impuniti anche gli sgherri ch’avevano consumato il misfatto53. Il Vicerè, inoltre, esorta Carlo ad allontanarsi da Informatione Die 27 octobris 1590, in quo habitat D. Carolus Gesualdus, in Carmine Modestino, Della dimora di Torquato Tasso in Napoli, Napoli, 1863. 53 Carmine Modestino, Della dimora di Torquato Tasso in Napoli, Napoli, 1863. 52 88 Maria e Fabrizio in un disegno di Pietro Lista Napoli non per sfuggire alla legge, ma per non esasperare il risentimento delle famiglie degli uccisi. Il caso suscita grande scalpore e sul tragico destino degli amanti i poeti si scatenano in una gara in versi. Da Roma, appena qualche settimana dopo il delitto, Torquato Tasso scrive: Piangi, Napoli mesta, in bruno ammanto Di beltà, di virtù l’oscuro occaso E in lutto l’armonia rivolga il canto. I cantastorie vanno raccontando la storia d’amore e di morte di Maria e Fabrizio, che ben presto diventa leggenda. L’opinione pubblica sul tragico fatto di sangue si divide tra chi giustifica l’azione di Carlo e coloro che fanno prevalere la pietà per l’infelice sorte dei due giovani amanti, ritenendo l’adulterio indotto dalla potenza dell’amore, forza primordiale alla quale non è possibile opporsi. Al partito della pietà appartiene, come abbiamo già visto, Torquato Tasso che, con una immagine retorica propria del tempo, rivolgendosi al ferro dei pugnali che hanno trafitto Maria e Fabrizio lo equipara all’amore; con la differenza che l’amore unì le vite e i corpi degli sfortunati amanti, ma il ferro ne unì, e per sempre, le anime: 89 Ferro, in ferir pietoso D’ambo gli amanti il core, Ferro, che in ferir fosti emul d’amore; Concorso doloroso, Che concordi ed unite Tu le morti tenesti, egli le vite; Anzi tue fur le palme, Che amore i corpi unì, tu unisti l’alme! Per il Tasso i due giovani assassinati sono in Paradiso, nel terzo cielo che è il cielo di Venere, il cielo dell’amore: D’immortale splendor nel terzo giro Già fiammeggiate (…) Anzi è di vostra colpa il Cielo adorno, Se pure è colpa in due cortesi amanti. Maria viene così elevata ad eroina dell’amore ed assimilata alle figure mitiche di Francesca da Rimini, della regina di Saba, di Didone, di Ginevra, di Isotta… L’attualità, dopo più di quattrocento anni, della tragica vicenda napoletana è testimoniata dal dramma teatrale di Franco Chimenti54, La notte dei madrigali, laddove si mette in luce che quella di Maria e Fabrizio non è tanto la storia di un adulterio, quanto il racconto di un amore che si conclude con la morte. Per il critico Enzo Cocco l’interpretazione che Chimenti dà della vicenda lo pone dalla parte di Maria e di Fabrizio, lo fa apparire partigiano dell’amore e non della legge, dei codici civili, delle norme sociali, dei vincoli stabiliti dal matrimonio. L’amore di Maria e Fabrizio lo commuove, per ciò che di puro e drammatico, di grande e di tragico, è in esso. Un amore votato all’estremo sacrificio di sé, pur di affermare il più proprio del sé. Ad appena 24 anni, Carlo, ormai circondato da una fama sinistra, per un anno intero si rinchiude in un turbato isolamento nel feudo irpino di Gesualdo. Con propositi espiatori vi fa costruire due conventi, uno per i Domenicani con la chiesa del SS. Rosario, ed uno per i Cappuccini con la chiesa di Santa Maria delle Grazie; una lapide all’ingresso del chiostro Franco Chimenti, La notte dei madrigali, a cura del Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, 2007. 54 90 riporta il nome di Carlo Gesualdo (Dominus Carolus Gesualdus, Compsae Comes VIII, Venusii Princeps III) ed attesta che il convento è completato nel 1592. Nel 1594 Carlo si trasferisce a Ferrara, ove nello stesso anno appaiono i primi due libri di madrigali, e dove sono celebrate sfarzosamente le sue seconde nozze con Eleonora d’Este, nipote del duca Alfonso II. Qui crea, intona, compone ardite nuove musiche, suona il liuto e la chitarra spagnola, illuminato dalla vivacissima atmosfera culturale della corte ferrarese. Ben presto si allontana da Ferrara per un lungo viaggio: a Venezia, città che gli piace moltissimo, immerso nella composizione, insofferente dei doveri che gli derivano dal rango principesco, cerca per quanto gli è possibile di sottrarsi agli incontri di circostanza con le autorità della Serenissima; gli preme molto di più l’incontro con il più grande compositore Un disco di madrigali di Carlo Gesualdo veneziano dell’epoca, Giovanni Gabrieli: solo nel discorrere di musica la sua conversazione si anima, come sempre. Il ritorno a Ferrara, dopo una assenza durata sette mesi, segna una svolta nella vita culturale della città: con la presenza a corte del principe musico si assiste a un momento di gloria dell’accademia ferrarese, che influenzerà anche musicisti del calibro di Marenzio e Monteverdi. Nel marzo del 1596 Carlo lascia definitivamente Ferrara, per trascorrere gli ultimi diciassette anni della sua vita in ritiro dal mondo, nella prediletta dimora di Gesualdo; sono anni punteggiati da malesseri psicofisici e fissazioni religiose, tra malattie e lutti: la grave malattia della moglie, la perdita dei due figli, il piccolo Alfonsino e il ventenne Emanuele, e dello zio Alfonso, l’arcivescovo di Napoli. 91 Durante questo lungo periodo il paese di Gesualdo beneficia della presenza del principe. Il castello perde il rude aspetto di fortezza e diventa una bellissima dimora capace di accogliere una fastosa corte canora nel tentativo di emulare quella di Ferrara. Carlo fa realizzare un teatro per la rappresentazione delle sue opere ed una stamperia per la pubblicazione dei testi musicali. Per lo zio Carlo, il San Carlo Borromeo, fratello di sua madre Geronima, egli nutre una vera e propria venerazione. Ne resta traccia nella grande pala della chiesa di Santa Maria delle Grazie del convento dei cappuccini in Gesualdo, eseguita nel 1609 da Giovanni Balducci, dove San Carlo è raffigurato nell’atto di intercedere per il nipote, ritratto accanto a lui in palandrana nera e collare di pizzo mentre chiede il perdono dei suoi peccati a Cristo benedicente. In questo contesto di sofferta contrizione, egli crea gli ultimi capolavori di musica sacra, i Responsoria per la settimana santa, insieme agli ultimi due libri, il quinto e il sesto, di madrigali. A Carlo Gesualdo non sopravvivono eredi maschi; poco dopo la tragica morte del figlio Emanuele per una caduta da cavallo, anche il principe compositore muore, o si lascia morire, a soli 47 anni, l’8 settembre Giovanni Balducci, Il perdono di Gesualdo, 1609 1613. Viene sepolto a Napoli, nella chiesa del Gesù Nuovo, ai piedi dell’altare di Sant’Ignazio di Loyola. Sul monumento funebre è posta questa iscrizione: 92 Carolus Gesualdus Compsae Comes Venusiae Princeps Sancti Caroli Borromaei sorore genitus coelesti clarior cognatione quam regum sanguine Northmannorum sepulcrali sub hac ara sibi suisque erecta cognatos cineres cinere fovet suo donec una secum animentur ad vitam. Societas Jesu sibi superstes ac postera integrae pietatis oculata semper testis memor posuit.55 Oggi Carlo Gesualdo è considerato come uno dei più inquietanti e geniali personaggi della storia della musica. A lui si sono ispirati anche Wagner e Stravinsky. 2.7 Il “ritorno” di Buoninventre con Castelnuovo Morto Carlo Gesualdo, i suoi beni passano alla nipote Isabella, figlia dello sfortunato Emanuele, la quale alla morte del nonno ha soltanto due anni. Nel 1622 Isabella, appena undicenne, viene data in sposa al futuro principe di Piombino, Niccolò Ludovisi, il quale nel 1629, alla morte della giovane moglie (che ha fatto in tempo a generare Lavinia), contrastando le aspirazioni di un diverso ramo dei Gesualdo a subentrare nella linea ereditaria, ottiene (mediante il pagamento di 42.000 scudi alla Regia Camera di Napoli) l’investitura del principato di Venosa, con il feudo di Buoninventre, per sé, i suoi eredi e i successori. Al detto Principe Nicolò Ludovisi, che muore nell’anno 1664, succede Giovanni Battista suo figlio, il quale per molti debiti, che s’erano contratti sopra detto stato, tanto da Don Nicolò, quanto da suoi predecessori vendè a 6 luglio dell’anno 1674 mediante la persona Stefano Petrucci suo agente, e Procuratore generale a Don Domenico de Carlo Gesualdo, Conte di Conza, Principe di Venosa, nato dalla sorella di San Carlo Borromeo, più illustre per la santa parentela che per la discendenza dai re normanni, sotto questo altare sepolcrale eretto per sé e per i suoi, protegge con le proprie ceneri quelle dei suoi parenti sino a quando insieme risorgeranno. In seguito la Compagnia di Gesù, a piena testimonianza della sua grande devozione verso di lei, in ricordo pose. 55 93 Martino salvo Regio assenso impetrando il feudo di Buoninventre col suo Bosco di S. Ilarione sito in Provincia di Principato Ultra, giusta li beni della Terra di Laviano, Terra di Castelnuovo, il fiume Tormite, lo Vallone, e stada pubblica, sin come detto Illustre Principe lo possedeva con giurisdizione separata56. Domenico de Martino è marito di Camilla Bavosa de Rossi, signora di Castelnuovo, alla quale succede il figlio, suo e di Domenico, Nicola Maria de Martino, e così -nella seconda metà del seicento- Castelnuovo e Buoninventre tornano ad essere uniti nelle mani della stessa famiglia feudale. Nel 1722 la famiglia de Martino vende tutto (Castelnuovo con Buoninventre e Sant’Ilarione) alla principessa di Teora Gabriella Pallavicino: Costitituito in presenza nostra il Signor Don Domenico di Martino, il quale non potendo essere di persona alle cose infrascritte, perciò fà, e costituisce suo Procuratore il Signor Don Nicola Maria di Martino suo figlio, acciò possa, anco in nome d’esso Signor Don Domenico vendere, ed alienare liberamente, e senzo patto alcuno di ricomprare a’ beneficio della Signora Donna Gabriela Pallavicino Principessa di Teora li feudi di S. Ilarione e Buoninventre unitamente colla Terra di Castelnuovo del Vallo di Conza, posta in Provincia di Principato citra con li loro corpi, raggioni, giurisdizioni, e beni burgensatici, e feudali ed insieme loro stati…. Marito della principessa è Don Francesco Maria Mirelli Carafa, dunque Principe di Teora, e perciò nuovo signore di Castelnuovo con Buoninventre e Sant’Ilarione. Nell’istrumento del 14 maggio 1722, rogato in Napoli57, colui che vende è in effetti Nicola Maria de Martino, figlio di Don Domenico e da questi delegato, chi acquista è il principe di Teora Francesco Mirelli (in nome e per conto della principessa Pallavicino). Il contratto è interessante in quanto in esso si trova una descrizione minuta (e sicuramente anche per formula) di tutto l’oggetto del trasferimento: la suddetta Terra di Castelnuovo del vallo di Conza, ed il suddetto feudo di Buoninvente, e suo Bosco di S. Ilarione, siti in questo regno di Napoli, nella Provincia di Principato Citra, una ancora col Palazzo Baronale esistente in detta Terra di Castelnuovo, e con tutti Uomini, Vassalli di qualunque setta, grado, e conditione, che siano, renArchivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Refuta dei Quaternioni, Vol. 216. 57 L’atto di vendita è stipulato Die decima quarta mensis Maij Millesimo Septincentesimo vigesimo secundo Neapoli et proprie in appartamento habitationis Domini Don Nicolai Pepe in Palatio Infrascriptorum de Martino, sito Contra Ecclesia Sancti Antonij de Padua extra ianuam medinam hora prima noctis pulsata tribus luminibus accensis. 56 94 dite de Vassalli, angarij, perangarij, servitij reali, e personali, feudi, suffeudi, feudatarij, suffeudatarij, quaternati, e non quaternati, Adhoi, Relevij, frutti, cenzi, entrade, raggioni, e rendite qualsivogliano, tanto in denaro, grano, o vettuagli, quanto altrimenti consistenti edificij, Massarie, Casalini, orti, Giardini, osterie, Starze, oliveti, Trappeti, Forni, Montagne, Vigne, arbusti, Terre coltivate, ed incolte, decime, servitij, e raggioni di pascolare, Gabelle, Dogane, Dazij, Collette, Scandaggi, raggioni di Uscitura, e Portolania, Zecca de pesi, e misure, fiere, Mercati, Ponti, Pedaggi, Passaggi, raggioni di piazze, boschi, ghiandaggi, Erbaggi, Pascoli, Prati, Arbori Cerqueti, Castagneti, selve, fide, diffide, Franchizie, Immonità, onori, Privilegij, Prerogative, Presenti, grazie, acque, decorsi, e condotti d’acque, rivi, fiumi, Paduli, Pantani, Fonti, Molini, Serrie, Caccie de Peli, e Penna, Laggi, Pescaggioni, e beni vacanti, Mortitij, difese, foreste, Monti, Valle, Campesi, Jus di Patronati di Chiesa, e Badie, et Jus di presentare, e nominare in quelle, ed altre raggioni qualsivogliano, si qui, vel si qua, aut si qua ex predictis sunt, ed a’ detta Terra di Castelnuovo, et successive ad esso Signor Don Nicola Maria, come Utile Padrone di quella spettano, ed appartengono, e possono spettare, ed appartenere in qualunque modo in futuro in vigor di Privilegij, che ne’ alliga, ed il suo tenore è come siegue cioè Inseratur apparono, ed in altro qualunque modo, raggione, prescrizione, consuetudine, e Causa qualsivoglia, anco de facto, e coll’intero suo Stato. Et signater col Banco della giustizia, ed omnimoda giurisdittione, e cognizione di prime, e seconde Cause, Civili, Criminali, e Miste, Mero e Misto Imperio, e potestà del gladio, quattro lettere arbitrarie, e di componere delitti, e commutare le pene da corporali in pecuniarie, e rimetterle, in tutto, o parte, sodisfatta prima la parte offesa, e con i proventi, emolumenti di detta giuridittione, ed intero suo stato. Ed anco signater con l’infrascritti altri Corpi, e beni sotto la parola signater espressi: Il Castello, seu Palazzo Baronale, la Mastro d’Attia, la Bagliva, la Zecca da pesi, e misure affittata all’Università per annui docati venti, la Portolania, anco affittata all’Università per annui docati venti, la difesa, chiamata La Redeta, la Vigna della Corte, il Pasteno della Corte, l’Orto della Corte, le Padule della Corte, il Molino solito affittarsi tomola cento venti di grano, l’Erbaggio d’Està, l’Erbaggio d’Inverno, alcuni cenzi de particolari in somma d’annui docati sette, e tari uno, cioè: da Giovanni Custode annui Carlini nove, da Angela Pezzuto Carlini diece, da Giovanni de Martino Carlini venti, da Giovanni Giacomo dell’Annecchiarica Carlini trenta, la semenza del grano che s’esigge dal Territorio vicino la Taverna diruta, annui docati cinquantaquattro, e tari tre di fiscali posseduti da detto Signor Don Nicola Maria 95 sopra detta Terra di Castelnuovo. E più anno asserito, che esso Signor Don Domenico de Martino ha, tiene, e possiede giustamente come utile Signore, e Padrone immediate, ed in capite della Regia Corte in feudo la difesa detta di Buoninventre, con il suo Bosco detto di Santo Ilarione, li quali si ritrovano attaccati a detta Terra di Castelnuovo del Vallo di Conza per esso Signor Don Domenico comprati detti Feudo, e Bosco dal quondam Signor Prencipe di Venosa, e Piombino Don Giovan Battista Ludovisio in vigor d’Istromento stipulato per il quondam Notar Stefano de Angelis di Napoli a sei Luglio mille seicento settanta quattro. L’atto di vendita del 1722 è accompagnato da una Nota delle robbe esistenti nel Palazzo di Castelnuovo. Ecco l’elenco: Tre cantarani58 di radica d’oliva, e pero; Tre scanzi grandi di noce scorniciate colli suoi piedi tornati; Uno inginocchiatoio di noce scorniciato; Uno cascione di noce scorniciato, e lavorato; Due altre cascie di noce, ordinaria; Due altri cascioni di abete; Due boffette59 di noce colli suoi foderi; Uno scrittorio di noce con dodeci foderi, e le sue portelle; Due scrittorij d’ebano, colli suoi piedi tornati; Quattro boffetti di noce grandi; Tre armieri, uno con il suo stipo grande; Due baulli col suo armaggio60 per un letto da’ campagna; Uno armaggio di tranacca61 colla sua capizziera, posso dire nuovo, che costò 500 docati, quando si casò62 suo Padre; Due altri armaggi di tranacche indorati, più ordinarij; Due altri di noce, uno de’ quali è noce, et oro; Sei quadri: cioè quattro d’historie, e due con due Madonne con cornice di pero di 4 e 3 (palmi); Ventiquattro se non erro mezzi busti di ritratti antichi de’ Re’ et Imperatori d’ottima mano; Non si ricorda il numero de’ quadri di belle prospettive con cornici indorate: ma sono assai belli di 4 e 5 (palmi); Quattro quadri di 4 e 3 palmi di fiori et uccelli; Tre quadri di Santi con cornice di pero di due e mezzo e due (palmi); Se non erro son dodici altri con diverse figure, cioè uno Bacco, certi paesi, ed altro tutti apparati e si ricorda anche d’altri: ma non sa’ il numero e qualità; Uno specchio a’ otto angoli ed altre cose di servitio di casa più tenui. La Nota si conclude con l’inventario degli arredi sacri esistenti all’interno della Cantarano è un cassettone in uso dal 500 fino ai primi anni del 700. Di impostazione massiccia, ben costruito con ottimi materiali, il cantarano è oggi uno dei mobili più ambiti da collezionisti ed intenditori. 59 Boffetta=tavolino (francesismo). 60 Armaggio=ossatura, scheletro di sostegno di un qualunque oggetto lavorato a mano (Antonio Salzano, Vocabolario napoletano-italiano, Napoli, 1979). 61 Tranacca=letto di legno, scolpito e talvolta indorato con colonne, padiglione e cortine (Antonio Salzano, Vocabolario napoletano-italiano, Napoli, 1979). 62 Si casò=si accasò, si sposò (spagnolismo). 58 96 cappella baronale dedicata a San Giovanni Battista: Nella cappella vi è uno famosissimo quadro di ottima mano ma’ considerabile di sei, o cinque e quattro (palmi), con S. Giuseppe, S. Giovanni, la Beata Vergine e Nostro Signore; Due pianete di damasco, una bianca con frangia di seta, et oro, e l’altra di più colori, e la fodera de’ morti gallonata, con il panno di altare, simile, e coscini, tovaglie, e camise; La campana di molto peso. Cantarano del ‘600 Questo elenco ci dice che nel 1722 il castello, ovvero il palazzo baronale, è usato come una delle abitazioni del feudatario. Il riferimento all’armaggio di tranacca colla sua capizziera, posso dire nuovo, che costò 500 docati, quando si casò suo Padre attesta l’uso del castello in occasione delle nozze del barone. Il riferimento alla cappella, con il quadro raffigurante S. Giuseppe, S. Giovanni, la Beata Vergine e Nostro Signore e la campana di molto peso, concorda con la descrizione di Donatantonio Castellano: In detta Terra (di Castelnuovo) vi è uno semplice beneficio sotto il titolo di San Giovanni Battista in patronato del Signor Barone, che tiene poche entrade, e sta posto nel cortile del Castello di detto Barone. 97 2.8 Castelnuovo nelle visite pastorali del vescovo Pescara del 1576 e 1580 Risalta la ricchezza degli arredi nel 1722 a confronto delle condizioni della cappella nel 1580, quando viene visitata dal vicario generale del vescovo di Conza. In questa occasione l’oratorio del castello è in stato di completo abbandono, ricettacolo di cani randagi che vi stazionano notte e giorno; il vicario non la prende affatto bene: sotto pena di scomunica ordina al camerario, cioè all’amministratore del barone, di non far celebrare messa senza il pemesso del vescovo, di chiudere a chiave il locale e di liberarlo dai cani (Intus castrum dictae Terrae est oratorium nudum Sanctissimo Ioanni Baptistae dicatum. Apertum erat et canes in eo pernoctanter et in die. Mandavit in eo non celebrari absque licentia Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi, precepitque Marcantonio Andreocciae Camerario domini Baronis presenti, sub pena excomunicationem, quod ipsum clave clausum teneat, et ab eo canes asceat). Diligentemente il vicario annota anche che sul tetto dell’oratorio c’è una campanella (Supra tectum et campanula). Prima pagina della relazione di Pescara su Castelnuovo del 1580 (Archivio Diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi) 98 Il brano sopra riportato è tratto dalla relazione della visita pastorale del vescovo di Conza Marco Antonio Pescara effettuata a Castelnuovo dal 10 al 12 dicembre 1580, che è conservata, insieme a quelle delle visite pastorali a Castelnuovo del 1576 e 1658, presso l’archivio storico della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia. Le visite pastorali dei vescovi alle comunità delle loro diocesi vengono intensificate dopo il Concilio di Trento, ed hanno l’obiettivo di conformare le forme del culto e della religiosità ai canoni sanciti dal Concilio. Il Concilio di Trento, che inizia nel 1545 e si conclude nel 1563, è la risposta che la Chiesa cattolica oppone alla riforma protestante di Martin Lutero. Con una serie di decreti vengono fissati rigidamente i canoni entro i quali si deve esplicare la pratica religiosa; circa l’eucarestia, ad esempio, la Chiesa ribadisce la dottrina della presenza reale rifiutando l’opinione luterana, secondo cui non si deve adorare il Cristo nell’eucarestia, né onorarlo con feste, condurlo in processione o portarlo agli ammalati. Importanti per le sue conseguenze sociali sono anche le decisioni del Concilio in materia matrimoniale. Viene introdotto l’obbligo di celebrare il matrimonio alla presenza del parroco e dei testimoni, dopo le relative pub- Il Concilio di Trento 99 blicazioni. Si impone la registrazione del matrimonio favorendo l’eliminazione di abusi e ingiustizie nel diritto di famiglia. Viene fissata l’età al di sotto della quale la mancanza di consenso dei genitori o dei tutori invalida il matrimonio. Con il Concilio la Chiesa tende a ricondurre l’autorità ai vescovi in ambito più propriamente spirituale e pastorale. Di grande rilievo, anche dal punto di vista storico, è l’istituzione obbligatoria delle anagrafi parrocchiali. I parroci sono obbligati a tenere regolarmente i registri dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e dei defunti. Si costituisce così un vero e proprio status animarum, ancora oggi di importanza fondamentale. Al clero viene gradualmente imposto l’abito talare, viene richiesta una vita irreprensibile, un costume meno secolare improntato a gravità e modestia. La stessa figura del papa cambia, tendendo a perdere la caratteristica del principe mondano, del mecenate e del politico, per un’immagine più sobria e dignitosa, caratterizzata dalla purezza dottrinale e morale, degna di colui che è il custode supremo dell’ortodossia e del Vangelo. Esemplare, da questo punto di vista, è il modo in cui Gregorio XIII vive e fa vivere il giubileo del 1575: il papa proibisce il carnevale, fa allontanare da Roma le prostitute, fissa il giusto prezzo delle vivande, impone rigide norme per l’accoglienza dei pellegrini, che non devono essere occasione di arricchimento per gli affittuari di alloggi. Egli stesso guida le processioni camminando a piedi scalzi per le strade di Roma. La diocesi di Conza partecipa al giubileo del 1575 con una folta delegazione guidata dal vescovo Marco Antonio Pescara e dal cardinale Alfonso Gesualdo. Del gruppo fanno parte anche i fedeli di Venosa63 con il principe Luigi Antoine Lafréry, Giubileo del 1575 Cfr. Angelo Pientini, Le pie narrationi dell’opere più memorabili fatte in Roma l’anno del giubileo 1575, Viterbo, 1577. 63 100 Gesualdo, che è anche conte di Conza. A Roma in quell’anno ha una funzione di primo piano nell’organizzazione dell’evento il cardinale di Milano Carlo Borromeo, il futuro santo. E c’è anche Fabrizio Gesualdo, padre di Carlo il musicista, e marito di Geronima Borromeo, dunque cognato del cardinale, che però non lo incontra perché Carlo Borromeo deve tornare a Milano un giorno o due prima di quaresima, come egli stesso gli scrive scusandosi di non poterlo visitare personalBalducci, Alfonso Gesualdo protetto da San Gennaro, mente64. Cattedrale di Napoli Dopo l’anno del giubileo la prima visita pastorale di mons. Marco Antonio Pescara è a Castelnuovo. Il giorno 26 marzo 1576 a Conza il vescovo celebra una messa per il papa Gregorio XIII alla quale assistono più di quattrocento fedeli giunti in processione da Colliano (plus quam quadringenti utriusque sexus devoti Christi fideles qui ex tertia die a Terra Coliani, pro Sanctissimo Iubilaeo conseguendo, processionali venerunt), visita quattro chiese cittadine, e cioè la Metropolitana e quelle di Santa Sofia, di San Leone e di Santa Maria della pietà e poi, accompagnato dal vicario generale Sagliocca e da tre assistenti a cavallo, si avvia verso Castelnuovo (et a Reverendissimo Donno Rainaldo Sagliocca Archidiacono et Vicario Generali Consano et tribus familiaribus equestribus associatus Castrum 64 Aristide Sala, Documenti circa la vita e le gesta di San Carlo Borromeo, Milano, 1841. 101 Novum versus, celebato itinerario, iter accepit). Al vescovo ed al suo seguito si fanno incontro il popolo e le autorità di Castelnuovo: il sindaco Donato de Minico, gli eletti Guglielmo de Natale, Minico de Angelo e Giovanni Domenico de Pascarello, l’arciprete Nicola de Gregorio con il suo assistente don Antonio Nicola de Guglielmo, i quali inginocchiatisi lo accolgono con gioia ed allegria (et cum prope esset ad Terram predictam accurrentes ob viam ei Sindycus et Electi ac homines illius una cum venerabile donno Nicolao de Gregorio Archipresbitero, et donno Antonio Nicolai de Gulielmo qui, genibus flexis facta reverentia, hilari fronte eum cum gaudio receperunt). Il vescovo benedice tutti; dopo di che, preceduto dal prete e dai chierici che cantano inni, muovendosi ora a piedi perchè così impone lo stato dei luoghi (cum id locus exigat), giungono alla chiesa madre (ad Venerabilem Ecclesiam maiorem gloriosissimae Virgini dicatam, osculata Cruce et pedester et toto populo comitante, dictis quisdam Archipresbiteri et Clericis precedentibus et hymnos cantantibus, sub Pallio pervexit). E’ significativo che il corteo, del quale fanno parte anche anche cavalieri, debba proseguire a piedi. Alla chiesa si può accedere attraverso una strada tanto ripida ed accidentata che un cavallo non la può percorrere in modo sicuro per il cavaliere. Dopo le consuete orazioni e benedizioni, il vescovo, indossati il piviale e la stola viola, con la mitria semplice, compie un giro intorno alla chiesa ed al sottostante cimitero Timbro della chiesa di per impartire l’assoluzione alle Santa Maria della Petrara anime dei fedeli defunti (cum pluviali et stola violacea indutus, cum mitra simplici, circumiens dictam Ecclesiam et Coemeterium, ad absolutione hanimarum fidelium defunctorum devenit). Successivamente iniziano le pratiche proprie della visita pastorale; il vescovo domanda all’arciprete chi detenga la chiave della custodia del Santissimo Sacramento. Don Nicola de Gregorio gli risponde che la 102 chiave è sempre in suo possesso e che, quando è necessario, la tiene il suo socio Don Antonio. I due vengono severamente ammoniti a non affidare per alcun motivo la chiave a bambini, a servitori, né a qualsivoglia laico (nec pueris nec domesticis, aut cuicumque layco qualibet ex causa nullo pacto admittarit). Il vescovo interroga poi su come l’eucarestia venga portata ai malati. Gli viene risposto che due ostie consacrate vengono recate in un calice sopra un piatto coperti da un velo sottile. Osserva il vescovo che questa modalità non è accettabile, anche a causa delle strade del paese piene di sassi e quasi impraticabili (propter saxosas et quasi incalcabiles vias) ed il sindaco e gli eletti promettono di fornire entro due mesi una pisside d’argento che consenta di recare la comunione agli ammalati in modo rispettoso, comodo e sicuro. Nel terzo giorno della visita pastorale, il 29 marzo 1576, il vescovo, in corteo con sindaco, eletti e popolo di Castelnuovo, si reca nella chiesa maggiore e lì celebra una messa solenne (comitantibus cum Sindico et Electis ac Incolis Castrinovi, Ecclesiam maiorem adivit et, asperso ipso cum populo aqua benedicta, facta reverentia et oratione, missalibus indumentis decoratus, missam maximam cum predicti populi letitia et exultatione ac devotione celebravit). Qui emerge la notizia di un fatto di sangue accaduto a Castelnuovo: la morte violenta di Cesare Ciuonti; il vescovo viene infatti supplicato di “riconciliare” il cimitero che era stato profanato a causa di quella morte cruenta. Indossata nuovamente il piviale e la stola viola, con la mitria semplice, ed appoggiandosi al bastone pastorale, Monsignor Marco Antonio Pescara procede alla riconsacrazione del cimitero (missarum solemniis peractis, Cruce erecta precedente, Pluviali ac stola violaceis imbutus mitraque simplici decoratus, baculo pastorali se regens, ad reconciliationem predicti Coemeterii, pro ut ipse hesterna die supplicatum fuerat, pervenit -violatum enim fuerat morte cruenta cuiusdam Caesaris Ciuonti de Castronovo- et cum populo astante servatis servandis pie Coemeterium ipsum reconciliavit). E’ questo il tempo in cui –a dirla col Foscolo- i sassi sepolcrali a’ templi fean pavimento; i defunti vengono seppelliti nei sotterranei delle chiese, ed i morti di Castelnuovo trovano riposo sotto la chiesa della Petrara e quella di San Nicola. Più avanti, nella stessa relazione del 1576, si può leggere che da tempo immemorabile la Mensa Arcivescovile di Conza percepisce a Castelnuovo una tassa sui defunti, detta ius sepeliendi, nella misura di un tarì per ogni defunto fino a dieci anni, e di due tarì per ogni morto di età maggiore dei dieci anni (Mensa Archiepiscopalis Consana percipit ius sepeliendi ab immemorabili tempore solvi consuetum, ut quo pro quolibet de103 functo aetatis decim annorum infra tarenum unum, et a maioribus dictae aetati tarenos duos). Dopo la riconsacrazione del cimitero, sindaco, eletti e popolo di Castelnuovo ringraziano vivamente il vescovo (de quo Sindicus et Electi predicti cum toto populo ingentissimas gratias ipsi Illustrissimi et Reverendissimi Predicti Domini redditere). Per riconsacrare il cimitero il vescovo è sceso nei sotterranei della chiesa; e se la discesa è stata agevole non altrettanto è la risalita, specialmente per una persona anziana qual è Mons. Pescara. Il vescovo osserva che gli scalini che riportano in superficie sono mal fatti e rendono difficile l’ingresso alla chiesa; ordina perciò di sistemare la faccenda entro un mese, così che vi si possa comodamente accedere (reconciliatione huismodi completa, cum Ecclesiam ipsam ingredi voluisset, animadvertit gradus per quos ascenditur portam difficilem et male compositum ascensum praebere. Mandavit quod infra mensem aptetur itaque commode ad eam ingredi possit). Come si sa, della chiesa di Santa Maria della Petrara a Castelnuovo non è rimasto niente. A differenza di San Nicola, nemmeno della struttura è rimasta traccia. E non solo per il terremoto. Ancora nel 2006 era però visibile, tra le macerie nel sito corrispondente, un tratto di volta a mattoni innestato su una cavità naturale. Se si mettono insieme la relazione di Pescara con la volta sulla grotta, ben si può ritenere che quelle scale difficili e mal fatte mettessero Tratto di volta in corrispondenza della chiesa della Petrara in comunicazione la (foto di ottobre 2006) 104 chiesa con una o più grotte sotterranee utilizzate per seppellire i morti. Più avanti la relazione riferisce di tre sepulture, che potrebbero indicare, appunto, tre grotte. Rientrato in chiesa il vescovo passa a visitare la cappella di Santa Maria del Loreto, di patronato della confraternita castelnuovese, il cui priore Donato de Ferraro mostra le bolle, che risultano in regola con i sacri canoni (et cum ingressus esset visitavit Cappella sub vocabulo Sancta Maria de Loreto quam dixerunt esse de jure patronatus societatis et confratium ipsius. Comparuit Donatus de Ferraro prior predicate societatis et ostendit bullas quae inventae fuerunt canonice ac legalite expeditae). Della chiesa madre e della cappella del Loreto il vescovo chiede che entro un mese si compili e gli si faccia avere l’inventario di tutti i beni immobili posseduti con i relativi confini e gli atti notarili (mandavit predicto Archipresbitero presenti quod infra mensem conficiat inventarium pubblicum bonis stabilibus cum confinibus et iuribus ac instrumentibus tam dictae Ecclesiae quam predictae Cappellae, et copiam autenticam trasmittat). La diffusione delle Confraternite in Italia si fa risalire al XII secolo in coincidenza con l’affermazione del Comune e con lo spirito associativo delle varie categorie artigiane e professionali. Sin dall’inizio associazioni di laici pii, esse hanno una vocazione assistenziale e sono poste sotto la protezione di un santo (o della Madonna). Ma le Confraternite –come notano Vincenzo e Mariarosaria Orlando- sono anche strumento di promozione umana e danno una prima risposta ai problemi di povertà e di emarginazione, allora del tutto ignorati dal potere civile. Nella Confraternita il partecipante trova una promozione, oltre che spirituale, anche sociale ed umana: contadino, artigiano, Raffaello, Madonna del Loreto salariato o bracciante che sia, ec105 colo inserito in una associazione nella quale le consuete, precedenti gerarchie non hanno più valore. Rimangono, certo, le situazioni di miseria: carestie, pestilenze ed altre disgrazie contro le quali nessuna istituzione in quanto tale può offrire protezione; c’è l’emarginazione che deriva dalla nascita, dalla ineludibile condizione della vita quotidiana. Ma ecco che nella Confraternita egli trova gli altri, apprende lo stare insieme, il vivere in condivisione con i propri simili dai quali è possibile ricevere conforto, ed ai quali si è pronti ad offrirlo quando è necessario65. Il Concilio di Trento, nella sessione del 1547, si è occupato dei sacramenti, definendone la esatta natura e le modalità di somministrazione: il sacrosanto Concilio Tridentino generale ed ecumenico legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della Sede Apostolica, per eliminare gli errori ed estirpare le eresie (…) attenendosi alla dottrina delle sacre scritture, alle tradizioni apostoliche e all’unanime pensiero degli altri concili e dei padri, ha creduto bene di stabilire e di proporre i presenti canoni… Il canone che riguarda il battesimo fissa quali debbano esserne la materia e la forma: materia o elemento di questo sacramento è ogni genere di acqua naturale, sia di mare sia di fiume, palude, pozzo o fonte: quella che suol dirsi acqua, senza aggettivi specificativi. E poiché si offrono innumerevoli circostanze nelle quali è necessario che il battesimo sia amministrato da gente del popolo, spessissimo anche da donne che assistono le partorienti, occorre che si conosca bene quanto si riferisce alla forma di questo sacramento. Chi lo impartisce deve, con parole chiare e accessibili a tutti, dire: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. A Castelnuovo in quel periodo vi sono due levatrici: Seva de Donato e Cecca de Marchese. A causa della elevata mortalità infantile accade spesso che il battesimo debba essere impartito proprio da loro. Ma sono a conoscenza della giusta forma stabilita dal Concilio Tridentino? E ciò che il vescovo Pescara deve accertare; fa chiamare le due ostetriche e le interroga (Soeva de Donato de Ricciullo et Cecca de Marchese de terra Castrinovi obstetrices quae demandatae Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi vocatae fuerunt, in ibi presentes et coram ipso Illustrissimo et Reverendissimo Domino personaliter constitutae interrogatae de forma baptismatis ab eis tempore necessitatis prestari solita). Le due donne nulla sanno di questioni dottrinarie Vincenzo e Mariarosaria Orlando, La congregazione di Santa Caterina nell’antica terra di Angri, Salerno, 1993. 65 106 Pagina della relazione Pescara del 1576 con l’interrogatorio delle due levatrici e rispondono in modo errato alle domande del vescovo; per cui vengono interdette dalla pratica ostetrica fino a quando non apprendano, in chiesa dall’arciprete o da Don Antonio, la giusta forma del battesimo; dovranno 107 anche confessarsi dei loro peccati (quaedam inania verba proferebant nihil ad formam ipsam facientia: fuit eisdem interdictum hocmodum obstetricii exercitium donec ipsam formam non didicerint et monitae quod ad Archipresbiterum vel ad Dominum Antonium in Ecclesia accedant: quibus presentibus fuit mandatum quod illas formam predictam baptisimalem doceant sub pena arbitrio ipsis Illistrissimi Domini infligenda. Monuitque eas quod ut sanctissimum Iubilaeum nonnulam pretermittant, et peccata sua confiteantur). Le due levatrici praticano anche la medicina popolare per scacciare il mal di testa e mal di pancia dei bambini, come ancora fa qualche anziana donna di Castelnuovo che “guarisce” con l’affasc’n’66 e cioè recitando formule e strofinando il pollice sulla fronte del bambino (in molti casi è l’effetto psicologico della cantilena e delle carezze ad attenuare il dolore). Seva e Cecca vengono interrogate su tali pratiche, che non hanno difficoltà ad ammettere davanti al vescovo al quale rivelano anche le parole “magiche” utilizzate. Il vescovo minaccia di scomunica non solo le due ostetriche ma anche tutto il popolo e le donne di Castelnuovo, ordinando loro di astenersi da tali pratiche superstiziose da cui –assicura- nascono i nemici del genere umano. Piuttosto preghino in chiesa per la guarigione dei malati perché le loro preghiere saranno esaudite ed otterranno la salute dei bambini da Nostro Signore Gesù Cristo, che è la vita e la salvezza del mondo (Mandavitque eiusdem presentibus quod de cetero a dictis verbis et remendiis superstitiosis sub pena excomunicationis abstineant: monitas eas, populum et mulieres ibidem existentes, quod quando pueri eorum infirmantur, superstitiones abhorreant cum fiant ex superstitione hostis humani generis, et ad Ecclesiam devote pergant in ibique genibus flexis coram Sanctissimo Sacramento pro infirmorum salute devotas orationes fundant, et sic eis preces exaudentur et salutem pueri infirmi a Domino Nostro Iesu Christo qui est mundi salus et vita consequentur). Le castelnuovesi Seva e Cecca possono dirsi fortunate perché l’Europa del cinquecento e del seicento è piena di guaritrici, spesso proprio levatrici, messe al rogo come streghe. Il vescovo Pescara ritiene Castelnuovo un paese primitivo e selvaggio, gran parte del popolo che lo abita è senza guida, la vita dei fanciulli rivolta al male; Affasc’n’ (fascinazione), dal latino fascinare=incantare, ammaliare, stregare. Al giorno d’oggi l’uso più comune della parola fascino rimanda al potere di attrazione e di suggestione in senso lato. La derivazione latina del termine dialettale affasc’n’ è indice delle radici millenarie delle pratiche di medicina popolare. 66 108 ed allora prescrive che nei giorni festivi l’arciprete e Don Antonio non si limitino a suonare le campane per invitare alla messa. Essi dovranno girare per tutto il paese ad acchiappare i ragazzi e trascinarli in chiesa per istruirli nella dottrina cristiana, la preghiera domenicale, la salvezza angelica, i dodici articoli di fede, i dieci comandamenti (Cumque locus ipse rudis sit et in eo Deo prestante populus copiosus sine preceptore et puerorum aetas pronasit ad malum, mandavit predictis Archipresbiteri et Donno Antonio presentibus quod in diebus festivis, ultra signum in Ecclesia pulsandum, predictam terram incedant et quos invenerint pueros ad Ecclesiam asportent et, cum in ibi congregati fuerint, eos doctrinam Christianam instruarunt, et presertim orationem dominicam, salvationem angelicam, duodecem articulos fidei, decem precepta legis). C’è un’altra prescrizione del vescovo a Don Nicola e Don Antonio: erigere croci di legno nelle tre chiese dirute di San Felice, di Sant’Elena e di Sant’Angelo (Mandavit predicto Archipresbitero praesenti nec non Domino Antonio similiter praesenti quod infra mensem erigant Cruces ligneas in Ecclesiis dirutis Sancti Felicis, Sanctae Helenae et Sancti Angeli). Di queste tre antiche chiese che nel 1576 erano già in rovina non c’è oggi a Castelnuovo alcun ricordo, ed è ignoto dove fossero ubicate; restano però i toponimi di San Felice e Sant’Angelo. Elena, madre dell’imperatore Costantino, secondo la tradizione, salita sul Golgota per purificare il sacro luogo dagli edifici pagani fattivi costruire dai romani, scoprì la vera Croce di Cristo e trovò gli strumenti della Passione, che sono custoditi e venerati nella Basilica di Santa Croce in Sant’Elena e l’imperatore Costantino 109 Gerusalemme, che fece innalzare dopo l’eccezionale scoperta. Si vuole che trovasse anche il titulus crucis (il cartiglio originario infisso sopra la Croce), la croce di uno dei due ladroni, la spugna imbevuta d’aceto, un chiodo e parte della corona di spine. Elena morì a circa 80 anni nel 329, assistita dal figlio, in un luogo non identificato; il suo corpo fu trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana. Non è da escludere che il suo culto sia stato introdotto a Castelnuovo dai bizantini. La vita del prete Felice ci è narrata da San Paolino di Nola. Nato a Nola nel III secolo da un ricco padre di origini orientali, aveva sofferto le persecuzioni ed era stato imprigionato, torturato e poi liberato miracolosamente da un angelo che lo condusse in un luogo deserto. Grazie alla conversione al cristianesimo dell’imperatore Costantino, Felice era potuto rientrare nella sua Nola. Qui, pur essendo stato indicato come successore dal vescovo Massimo, alla morte di questi rifiutò l’elezione e visse in povertà fino alla fine dei suoi giorni. Fu sepolto in uno dei più importanti complessi paleocristiani a sei chilometri da Nola, sorto in luogo di una preesistente necropoli pagana, vicino alla quale i primi cristiani della zona seppellirono i loro morti in un coemeterium, termine da cui deriva il toponimo di Cimitile. Il vescovo di Conza visita poi la chiesa di San Nicola, posta all’ingresso del paese, con il tetto crollato che il sindaco e gli eletti si impegnano a far aggiustare entro il termine del loro mandato (Visitavit deinde Ecclesiam Sancti Nicolai qua est in ingressu predictae terrae, et tectum erat collapsum: ad exhortationem Ill.mi ac Rev.mi Domini promisit supradictus Sindicus cum suis Electis hoc tempore sui sindicatus illum reparare). Passa poi a controllare l’oratorio di San Giovanni posto all’interno del castello e che manca di quadri e tovaglie; ordina di non celebrarvi messa prima di aver provveduto a mettervi un quadro del Battista e di aver accomodatolo lo sgabello davanti all’altare (Visitavit Cappellam sub vocabulo Sancti Ioannis constructam intus arcem predictae terrae et indiget pictura et tobaleis. Mandavit in ea non celebretur donec imago ad honorem predicti Santi in ibi depictandi fuerit, et scabellum ante dictum Altare non fuerit accomodatum). Ma noi già sappiamo che nulla di ciò verrà eseguito se, come si è visto all’inizio di questo paragrafo, quattro anni più tardi l’oratorio è alla mercè dei cani randagi. Mettendo a confronto le due visite pastorali effettuate Castelnuovo, a breve distanza una dall’altra nel 1576 e 1580, si nota che i compiti che il vescovo 110 assegna all’arciprete e all’Università (il Comune di allora) vengono eseguiti. Vedremo in seguito che si ripara il tetto della chiesa di San Nicola, si fornisce la pisside d’argento per portare la comunione agli ammalati, si dotano di croci lignee le chiede dirute, si compila l’inventario dei beni mobili ed immobili della chiesa della Petrara e della cappella del Loreto. Il barone, al contrario, se ne strafotte completamente e non caccia nemmeno un ducato per sistemare decorosamente il piccolo oratorio nel castello, benché appartenga alla famiglia Gesualdo che annovera uno dei più potenti cardinali dell’epoca (Alfonso Gesualdo), che è imparentata con il papa e con il cardinale di Milano Carlo Borromeo, che dispone di potere e ricchezze enormi. La relazione della successiva visita pastorale ci mostra, infatti, una realtà che nel complesso è alquanto mutata. A Castelnuovo giunge il 10 dicembre 1580, in una giornata di vento e pioggia (non sine ventorum et turbinorum ac pluviarum infestazione) il Vicario generale Augusto Gamillo accolto dai soliti Don Nicola e Don Antonio (terram predicti Castrinovi intulit et in castro predictae terrae hilari animo a Domino Nicolao de Gregorio Archipresbitero et domino Antonio de Gulielmo receptus et hospitatus). Immediatamente il vicario si porta a visitare la chiesa maggiore (Eadem die supradictus Magnificus et Reverendissimum Dominus Generalis Vicarius et Visitator devenit ad visitationem venerabilis Ecclesiae maioris). Qui il vicario trova, alla destra dell’altare maggiore, un’apertura nel muro che però è attraversata dall’impeto dei venti, ed ordina all’arciprete di farvi mettere una imposta di legno che possa ben chiudersi e non disturbare la celebrazione della messa durante il maltempo (Ubi facta sanctissimo Eucharestiae Sacramento profunda reverentia et oratione, invenit portam quae est in angulo seu cornu epistolae67 altaris maioris a ventorum improbitate satis infestari: et mandavit predicto Archipresbitero quod infra mensem apponi faciat in specula predicta portam ligneam quae tali infesto tempore claudi possit, et missae celebrationem non impediri). L’altare maggiore è coperto con tre tovaglie ed un parato di seta con scritte di colore giallo zafferano e sopra c’è la custodia del Santissimo Sacramento coperta anch’essa di seta (Altare Maius erat copertum tribus tobaleis et parato sericeo crocei et paginali colori et de supra erat custodia Sanctissimi Sacramenti cooperta veste sericea). Sopra c’è la statua della gloriosa Vergine Maria, che il popolo di Guardando verso l’altare il cornu evangeli definisce la parte sinistra (il luogo dove si legge il vangelo); il cornu epistolae quello di destra (il luogo dove si legge l’epistola). 67 111 Castelnuovo chiama Santa Maria della Petrara. Vi si celebra con l’altare portatile68 e vi sono due cuscini lavorati di seta e due grandi candelabri di legno (Supra quondam altare est imago gloriosae Virginae Mariae vulgariter noncupata Sancta Maria de la petrara. Celebratur in eo cum altari portatili, et sunt ibi duo pulvinaria serico laborata et duo candelabra magna lignea)69. La Madonna della Petrara nella sua nicchia, a sinistra dietro la sposa L’altare portatile è una pietra consacrata di forma quadrata e di piccole dimensioni, incastrata nel piano dell’altare, che copre in genere una sottostante reliquia. 69 E’ questo del 1580 il documento più antico in cui compare la denominazione della Petrara riferita alla Madonna di Castelnuovo. La leggenda è nota: un giorno la Madonna chiese ad un abitante di Santomenna un pezzo di pane che le fu negato; giunta a Castelnuovo fece la stessa domanda ad una donna del posto la quale prese dall’impastapane un pezzo di pasta lievitata e glielo diede. La Madonna volle perciò essere collocata nella chiesa con lu cr’scent’ (la pasta lievitata) in mano e le spalle rivolte al paese di Santomenna. La leggenda rielabora la rivalità con il vicino borgo attraverso la nascita della chiesa dedicata a Maria in un luogo ricco di grotte,“la petrara”. La scultura di Castelnuovo, scolpita in un unico pezzo di pietra, raffigurava una Madonna in trono, nell’atto di reggere nella destra quello che la fantasia popolare immaginava fosse un pane lievitato, mentre con la sinistra reggeva il bambino. Insieme al monolite raffigurante la Madonna della Petrara, 68 112 La descrizione degli arredi della chiesa dimostra che dal 1576 molto è stato fatto per abbellire ed impreziosire il tempio: l’ombrello per proteggere il santissimo sacramento da portare agli ammalati è di seta colorata di giallo, rosso e verde. La chiesa è illuminata da una lampada ad olio fornito dal Comune, che arde notte e giorno ed il sindaco Giovanni de Martino è esortato a non far mancare il prezioso combustibile (Pallium pro asportando Sanctissimo Sacramento ad Infirmos habet sericeum Crocei rubei et viridis colorum. Pendet etiam lampas ardens quae elemosynaliter ardet. Atque Universitas compatitur et semper de oleo providet. Iohannes de Martino Sindicus erat ibi presente et fuit hortatus quod non deficiat). Il pallio a protezione del Santissimo Sacramento che nonostante accurate ricerche non è stata mai recuperata dalle macerie del terremoto, nella sacrestia della chiesa era collocata una vasca di calcare bianco con l’immagine in bassorilievo di un sileno. La presenza della vasca con il sileno accanto alla statua litea della Madonna depone per una possibile utilizzazione, nella edificazione della chiesa, di preesistenti manufatti di epoca pagana, probabilmente ritrovati in sito, o nelle vicinanze. Non va dimenticato, in proposito, che nel territorio di Castelnuovo di Conza sarebbe stato collocato il tempio di Giove Vicilino, citato da Tito Livio per il fragore notturno di armi percepito in occasione del passaggio per la sella di Conza dell’esercito di Annibale. 113 I lavori devono essere ancora in corso se la chiesa in rovina di Sant’Angelo è utilizzata come deposito di pietre da trasferire alla chiesa della Petrara. Vi si conserva una croce di legno e l’arciprete afferma essere di sua competenza. Possiede una vigna che è tutto intorno ad essa (Ecclesia diruta Sancti Angeli quae lapides transferantur ad fabricam maioris Ecclesiae et in ea manutentur Crux lignea erecta: Dicit Archipresbiter esse annexam Archipresbiterali dignitati: Et habet Vineam circum circa). Il portale del 1584, ad opera di Vincenzo de Ianuzo, della porta minore della chiesa della Petrara Il portale con la data del 1584, ad opera di Vincenzo de Januzio, certamente il sindaco di quell’anno, potrebbe avere utilizzato le pietre provenienti da Sant’Angelo, e fissa il tempo della conclusione dei lavori. Il motto non dir di me se di te non sai, pensa di te e poi di me dirai attesta lo spirito “laico” dell’autore e dimostra il patronato comunale sulla chiesa della Petrara. Il vescovo Pescara trova la cappella di Santa Maria del Loreto nelle medesime condizioni della visita precedente. Il nuovo priore è Bernardino de Laurenza e, come era stato chiesto quattro anni prima, vengono forniti gli elenchi dei beni mobili ed immobili appartenenti alla confraternita. L’elenco è scritto in volgare e lo riportiamo integralmente. I beni mobili consistono in Un Crucifisso portatile; Un Confalone de taffetà rosso coll’Immagine della Madon114 na da portare nelle processioni; Trentadoi pecore dentro le pecore de Rogieri de Bactista de Castelnuovo. I beni immobili (Bona Stabilia) consistono in numerosi appezzamenti di terreno nel territorio di Castelnuovo: Un pezzo de terra sotto Padula Piana (…) de tomola uno iuxta le Cerze della ecclesia, et li boni de Gregorio de Dominico; Un pezzo de terra de tomolo uno e mezzo sopra Padula Piana, con cerque dentro, iuxta li boni de Donato de Giovanfrancesco et la terra de Giovanni Margiacco; La metà della terricella della quarta in circa ubi dicitur A Boccale Strettole iuxta la vigna de Sterlicchio e Minico de Pitoya; Un pezzo de terra dove si dice La Cerza de tomole tre iuxta li beni de Salvatore de Sciviccaro et la via pubblica; Un pezzo de terra ibidem de tomola doi iuxta li beni de Ettore de Linardiello et la via che va a Preta Longa; Un pezzo de terra a quella banda del Vallone de San Felice de tomola tre in circa iuxta li boni de Antonio de Petruzzo, ed Ettore de Linardiello; Un pezzo de terra alla Matina de tomola quattro in circa iuxta li boni de Donato de Pitoya, et li boni de Berardino de Rogieri; Un pezzo de terra alla Serra de Donato Infante de tomola quattro e mezza alla grotta iuxta li boni de Pascarello de Belardo, Berardino de Roggieri et lo Vallone de Via Campagna; Un terricello de un tumulo allo Pennino iuxta li boni de Gioanni Monaco, lo vallone de Manni, la via che vene da Santo Mennaio, e la via che vene da Piedi la terra. La chiesa della Petrara, invece, come ci dice l’Inventarium bonorum mobilium Venereabilis Maioris Ecclesiae Terrae Castrinovi, possiede soltanto i beni mobili occorrenti alle pratiche di culto: In ea est uno piviale de damasco carmosino con lo scudo de tela d’oro, quattro pianete, una de damasco carmosino, una de velluto verde, una de damasco pagonazzo et una altra de giallo; Una croce posta d’oro, ma dentro est de rame; Una croce de rame antica. Tre calici con le coppe e patene70 d’argento indorate e piedi de rame; Diece tovaglie lavorate de bammace ed alcune schette; Uno turibolo71 d’ottone antico; Un tabernacolo de rame sopra indorato. Un baldacchino de damasco de diversi colori con i fiocchi pendenti; Due vestimenta per celebrar messa ed una pianeta de tela bambacina; Uno messale moderno, due lenzola vecchie serveno per parati; Un paro de ferri per hostie. La relazione pastorale continua con il riferimento ai sepolcri sotto la chiesa, che sono tre e che comportano lo ius sepeliendi a favore della Mensa Ar- 70 71 Piatti per l’ostia. Incensiere. 115 civescovile di Conza (Intus predictam Ecclesiam maiorem sunt tres sepulturae in quibus solvit ius sepeliendi devolutum Mensae Archiepiscopalae Consanae). C’è una nuova (?) levatrice, che si chiama Seva de Melfi, esercita da tre anni e conosce bene materia e forma del battesimo; viene ammonita a confessarsi almeno una volta al mese e a non praticare l’affasc’n’, che peraltro nega di conoscere (Soeva de Melfi obstetrica a triennio obstetricavit: Et interrogata recte respondevit de forma et materia baptisimi: fuit monita quod saltem semel in mense confiteat et communicet, abstineat ab incantationibus et superstitiones fugiat; quas omnino scire negavit). Lo stato della cappella baronale di San Giovanni invasa dai cani l’abbiamo già riportato all’inizio di questo paragrafo. Dopo averla visitata, in un percorso ascendente, il vicario conzano arriva alla chiesa di San Nicola, che nel frattempo è stata riparata a cura di Donato de Giovanfrancesco con i proventi delle elemosine e che è ben custodita, vi si celebra con l’altare portatile a beneficio di tutto il popolo ed è fornita di campanella (Ecclesia Sancti Nicolai Episcopi et Confessoris ex elemosynis reparata fuit et clave clausa tenetur et celebrantur in ea cum altari portatili coram omnibus. Donatus de Ioannefrancisco de predicta reparatione curam habuit. Supra tectum est Campanula). C’è però ancora da perfezionare il lavoro: sul tetto vicino alla porta occorre ancora coprire; le tegole ci sono e Donato viene esortato a completare il lodevole lavoro già fatto; anche la porta va accomodata in tutto o in parte (In tecto prope porta est copriendum aliquantum: adsunt imbrices fuit hortatus predictus Donatus quod inceptum prium et laudabile opus compleat et portam resarcire faciat in omnibus seu partibus). La chiesa di San Nicola è stata anche arricchita con un nuovo altare dedicato a Sant’Antonio abate, detto anche di Vienna, che però è eccessivamente ingombrante e posto al centro della chiesa: si ordina perciò di trasferire il tutto con un nuovo altare vicino al muro (In predicta Ecclesia est altare ad honorem Sancti Antonii Abbati, de Vienna vulgariter nuncupati, quod Ecclesiam predictam summopere occupat, mandavit transferri in pariete cum novo altari). Finisce così la prima giornata a Castelnuovo del Vicario Generale del vescovo di Conza, Augusto Gamillo. Il giorno successivo, 11 dicembre 1580, passa a visitare l’ospedale72 consistente in due vani sottani e due soprani. E’ abbisognevole di tutto e specialmente della serratura. Viene invitato il sindaco a provvedere almeno per i materassi e le chiavi alla porta (Magnificus et Reverendisimus Dominus Generalis Vicarius et Visitator qui supra 72 Per ospedale deve intendersi un luogo di ricovero per indigenti. 116 visitavit Hospitale consistens in duobis stabilis sub et supra. Indiget omnibus et praesertim clausura: fuit hortatus syndicus ut provideat saltim de pagliaritio et clavibus in portis). Il vicario visita la chiesa in rovina di Sant’Elena, dove si conserva la croce di legno, e la cappella di Santa Lucia, anch’essa in rovina ma che dovrebbe essere riparata: vi sono infatti mucchi di pietre per lo scopo ed il sindaco viene sollecitato ad accelerare i lavori (Ecclesia Sanctae Helenae, manuteneantur in ea Crux lignea. Cappella Sanctae Luciae diruta: iam preparati fuerunt acervui lapidei; circa illam et illius reparationem fuit hortatus Syndicus quod predictam reparationem quantum primum acceleret). Infine si prescrive che la carta-gloria73 venga collocata adeguatamente e che, nel celebrare la messa, tre tocchi di campana si battano mentre si dice Sanctus ed altrettanti quando si sollevano l’ostia ed il calice (Carta de gloria apponeatur in tabella et in columnis custodie. Dum dicitur Sanctus in Missa Maiori pulsetur tribus ictibus campana et totidem dum elevantur Hostia et calix). Sul far della sera di questa seconda giornata, salendo dalla sua città di Santomenna, si presenta a Castelnuovo con due accompagnatori il vescovo in persona. Qui, essendo l’ora tarda e non avendo potuto salire prima a causa della pioggia mista a neve e dei venti impetuosi, Monsignor Pescara benedice la chiesa della Petrara e concede l’assoluzione alle anime dei defunti (Ex oppido suo Sancti Menna Illustrissimus et Reverendissimus Dominus ascendit duobus tantummodo cum suis visitatoribus ad dictam Terram Castrinovi, ubi cum hora tarda esset nec antea per pluvias nivibus mixtas non sine ventorum quassationibus venire potuisset, facto signo in Venerabilis Maiori Ecclesia, servata forma Pontificalis, absolutionem animarum fidelium defunctorum fecit, in Castrumnovum deo dante sacramenta visitatoris). E così si conclude anche la seconda giornata della visita pastorale. Il terzo giorno, 12 dicembre 1580, il vescovo celebra la messa nella chiesa della Madonna della Petrara e poi procede a tutte le verifiche sulla custodia dei sacramenti, sulle modalità di trasporto dell’ostia consacrata per la comunione degli ammalati, visita la fonte battesimale che trova pulita e fornita di ciborio ligneo. Mancano, però, i vasi di stagno per il trasporto dell’olio sacramentale da Conza a Castelnuovo (non habeat vasa stannea pro asportandis sacramentorum oleis a venerabile metropolitana Ecclesia consana). Il vescovo prescrive che il contenitore dell’olio per l’estrema unzione venga custodito con gli altri vasi nel ciborio (Vas olei estremae unctionis reLa carta-gloria permetteva al celebrante di leggere particolari preghiere fisse che venivano ospitate entro cornici più o meno artistiche appoggiate alla mensa eucaristica 73 117 ponatur et detineatur cum aliis vasibus sacramentis intus predictum Ciborium fontis baptisimalis). Il vescovo ordina, poi, di sollevare di un palmo l’altare maggiore nel termine di sei mesi (Mandavit quod altare maius alzetur palmo uno infra sex menses); dà atto che don Nicola ha istituito il registro delle nascite e dei matrimoni e lo invita a continuare (Habeat archiprebister librum baptisatorum et matrimoniorum: Monitus quod pertenere). Viene interrogata l’altra levatrice74 la quale risponde correttamente sulla forma e la materia del battesimo (Cecca de Mucciaccio obsterix interrogata: recte respondit de materia et forma baptisimi). Per finire il vescovo affronta due questioni che hanno a che vedere con la materialità della vita ecclesiale: ricorda all’arciprete la regola di pretendere la quarta parte dei beni di coloro che muoiono senza testamento (ab intestato), da devolvere ad pias causas a favore della mensa arcivescovile conzana. Era antica consuetudine che i vescovi, o in loro vece, i parroci potessero disporre per l’anima di un morto ab intestato quei suffragi che essi ritenevano più convenienti. Quando, cioè un testatore, volutamente ovvero Ciborio del 1531, per dimenticanza, ometteva di lasciare Palazzo Comunale, Roma. un tanto al mese per messe da celebrarsi per la sua anima, il vescovo (o il parroco) aveva il potere di prelevare dall’eredità una quota, di norma corrispondente alla terza parte del valore, per la celebrazione di messe, che per questo veniva detta ad pias causas. Infine l’Illustrissimus et Magnificus Domunus Archiepiscopus Marcus Antonius Piscara impone che nel giro di tre mesi l’inventario dei beni immobili Le due levatrici del 1576, quelle che praticano l’affasc’n’ si chiamano Seva e Cecca. Quelle del 1580, ben preparate su forma e materia del battesimo, si chiamano pure loro Seva e Cecca. Cambiano i cognomi; sono altre o sono le stesse donne che si presentano con differenti identità? 74 118 della chiesa e della cappella di Santa Maria del Loreto vengano prodotti in forma autenticata e resi pubblici al fine della registrazione (Inventarium bonorum stabilium predictae Venerabilis Maioris Ecclesiae et Cappellae cum confinibus infra tres menses autenticatur et pubblicum conficeatur illius copiam autenticam transmittant ut registrari possit). 2.9 Castelnuovo (e la peste) nella visita pastorale del vescovo Campana del 1658 La successiva visita pastorale di cui abbiamo trovato traccia nell’archivio diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi è quella, molto rapida, del vescovo Fabrizio Campana che si tiene in una sola giornata, il 17 aprile del 1658. Essa è condizionata dagli effetti ancora molto vivi della epidemia di peste che è si sviluppata, a partire da Napoli, per tutto l’anno 1656. Sono pochi i castelnuovesi che si aggiungono all’economo Vincenzo de Martino ad accogliere il vescovo (pauci cives cum Reverendissimo Oeconomo Prima pagina della relazione di Campana su Castelnuovo del 1658 119 dictae terrae eundem Illuustrissimum Dominum salutantes). La chiesa di San Nicola non viene visitata perché i cadaveri dei morti di peste, sepolti lì dentro, ne impediscono l’ingresso (Ecclesia Sancti Nicolai non fuit visitata quia in ea erant sepulta aliqua cadavera mortuorum ex contagio et non ad huc expurgata erat). Il terribile flagello, che in quegli anni colpisce prima la città di Napoli e poi molti luoghi del regno, a Castelnuovo si riverbera sulla già povera economia agricola tanto che Paulus Furst, Il medico della peste l’economo lamenta al vescovo i pochi mezzi che la comunità gli mette a disposizione adesso che le gente sono morte per il passato contagio. Le chiavi della chiesa maggiore, quella della Petrara, sono in possesso dell’economo, e non dell’arciprete che non esiste. L’assenza del sacerdote a Castelnuovo è il segno più tangibile della devastazione operata dalla peste. In un’epoca in cui non difettano le vocazioni sacerdotali, lasciare un paese intero senza il prete è indice dell’enorme numero di vite umane perdute a seguito della peste in tutta l’area della diocesi di Conza. La peste nel regno di Napoli, mai chiamata con questo nome ma sempre definita morbo o contagio, ha il suo culmine tra la primavera e l’inverno del 1656. Si è calcolato che i morti in tutto il regno, esclusa la capitale, andassero da un minimo di 400.000 a un massimo di 900.000, vale a dire da un decimo a quasi un quinto della popolazione, calcolando che prima della peste gli abitanti del Mezzogiorno erano quattro milioni o al massimo quattro milioni e mezzo, mentre a Napoli città il conto dei morti andrebbe da un minimo di 200.000 a un massimo di 600.000 individui75. Idamaria Fusco, La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli. Densità abitativa, diversità territoriale e mortalità differenziale. 75 120 Pagina della relazione di Campana del 1658 relativa alla chiesa di San Nicola La pur frettolosa relazione di Campana mostra cosa è cambiato dal 1580 nel sistema ecclesiale di Castelnuovo. In primo luogo, le chiese di Sant’Angelo, Sant’Elena e di Santa Lucia, che allora erano in rovina, dopo poco meno di ottanta anni sono del tutto scomparse. L’oratorio del castello, 121 Domenico Gargiulo, Piazza Mercatello durante la peste del 1656, Museo di San Martino a Napoli invece, quello che nel 1580 era ricettacolo di cani randagi, adesso è funzionante per il culto, ed il vescovo lo trova fornito di tutto l’occorrente per la celebrazione eucaristica (visitavit altare minus in eo existens, quod omnibus ad celebrandum requisitis decenter ornatum invenit ac calicem albam planetas et omnia pro missae sacrificio necessaria, bene disposita, ita quod nihil demandandum putavit, et laudavit). La relazione ricorda che l’altare è di patronato del barone e che il suo rettore è il cittadino di Santomenna, Giuseppe Voza (altare quondum est de iure particolare Domini Baronis dictae Terrae, Rector est civis Ioseph Voza Terrae Sancti Menae). I Bavosa, nuovi feudatari di Castelnuovo si dimostrano, per questo aspetto, molto più civili dei Gesualdo. Quello che, però, emerge nettamente è la dimensione nuova della chiesa della Petrara. Essa è non solo più ricca di altari e di arredi sacri; ma si è anche fisicamente ingrandita. Vediamo come è strutturata nel 1658, seguendo la relazione del vescovo. La prima visita nella chiesa madre è al Santissimo Sacramento (Visitatio SS.mi), custodito in due pissidi; una d’argento decorata all’interno e protetta da un palliolo di seta, usata per recare la comunione agli infermi, l’altra più piccola di colore nero (invenit in duobus pixidibus una pede elevata 122 in cuppa argentea intus decorata, ac suo palliolo serico operta qua utunt tempore delationis ad infirmos, altera nero pauca sine pede). La cappella è perennemente illuminata da una lampada ad olio e non mancano il pallio, le lanterne e tutto il resto per il trasporto (Adest lampas semper ardens sumptibus Cappella Sanctissimi Sacramenti, …adsunt pallium sericum, lanternas et cetera pro Sanctissimi asportaur ad infirmos necessaria). Poi il vescovo passa a visitare la fonte battesimale (Visitatio fontis baptisimalis). Qui abbiamo notizia che ora la chiesa ha due porte: la fonte battesimale è posta a levante della porta più grande (accessit ad visitandum fontem baptisimalem posita in ingressu Ecclesiae ad levam ianuae maioris). Si capisce che la chiesa è ben organizzata perché ha il ciborio di legno munito di due serrature e protetto con una tela cerata; lì vicino c’è il sacrario anch’esso munito di serratura (Supra dictum fontem adest ciborium lignum duobis seris munitum et tela cerulean copertum. Prope dictum fontem in pariete adest sacrarium bene dispositum et sera decenter munitum). La successiva ispezione è ai confessionili (Visitatio sedium confessionalium) che trova forniti del sommario della bolla della confessione (Visitavit sedes confessionales in quibus invenit … sommarium bullae … affixas, ita quod nihil in eis demandandum invenit, et laudavit). Passa poi all’altare maggiore (che non è più quello della Madonna della Petrara!) che viene trovato ben curato e dotato di tutti i requisiti per la celebrazione (visitavit altare maius quod omnibus ad celebrandum requisitis decenter ornatum invenit et nihil in eo demandandum putavit). L’altare successivo è quello della Madonna del Loreto, che il vescovo Campana trova dotato di tutti i requisiti canonici, per cui non ha domande da fare e si compiace (Deinde Reverendissimus Illustrissimus Dominus visitavit altare Sanctae Mariae de’ Laureto quod omnibus requisitis ad celebrandum decenter ornatum invenit, ita quod nihil in eo demandandum invenit, Dominus laudavit). E’, come già sappiamo, l’altare della Confraternita che porta il nome della Vergine. I confratelli portano il saio e cappucci bianchi quando intervengono alle processioni; ogni anno eleggono il priore che, al momento, è Leonardo Masullo, al quale il vescovo raccomanda di comportarsi come si deve e di fornire, a tempo debito, alla curia conzana il resoconto della sua amministrazione (In dicto altare adest erecta Confraternitas sub titulo eiusdem Virginis. Confrates utunt sais et capputiis albis et interveniunt in pubblicis processionibus. Prior singulis annis eligitur ab eisdem confratribus et ad presens est Leonardus Masullus qui comparuit. Eis 123 Dominus mandavit quod bene se gerat et computa redat suae administrationis coram Rationali Curiae Archiepiscopalis tempore suo). Poi c’è l’altare della Madonna del Rosario (Altare Sanctissimi Rosariis) e quello di Santa Maria di Costantinopoli. L’altare della Madonna della Petrara con la statua della Vergine continua a dare il nome alla chiesa; ma non ha redditi né oneri ed è, adesso, in posizione marginale, (In altero latere Ecclesiae adest aliud altare sub titulo Sanctae Mariae de’ Petrara cum statua eiusdem Virginis qua est Ecclesiae titulus estque omnibus demandata et nullos habet reditus, nec onera). Si è talmente ingrandita la chiesa di Castelnuovo che ha perfino il coro e la sacrestia (posteriori Altaris Maioris adest locus pro choro et sacristia). La relazione del vescovo Campana si sofferma anche sulla struttura architettonica della chiesa di cui attesta che il tetto, il pavimento e le pareti non abbisognano di alcuna riparazione; sulle sepulture il vescovo ordina di osservare i decreti della Sacra Congregazione e le costituzioni sinodali (Visitavit corpus Ecclesiae in qua tectum, parietes et pavimentum nulla indigent reparatione. Tamen circa sepulturas mandavit servari Decretos Sacrae Congregationis et Synodales Constitutiones). E poi il riferimento chiaro alle due porte: la più piccola si chiude dal retro e le chiavi sono tenute dall’economo perché non vi sono sacerdoti né chierici (Adsunt duae ianuae quam minori claudit a parte posteriori et clavis servantur penes oeconomus cum nullus alius adsit sacerdos nec clerici). Sulla porta maggiore sono poste due campanelle (Supra dictam ianuam maiorem sub quondam arculo adsunt due campanule in quibus nihil demandandum Ill.mus Rev.mus putavit). Le due porte del 1658 configurano la struttura della chiesa della Petrara come è arrivata fino al 23 novembre 1980. Non compaiono nella relazione del 1658 il sindaco e gli eletti, che nelle occasioni precedenti erano in prima fila insieme al popolo festante ad accogliere il pastore. E nemmeno c’è traccia del popolo, salvo i pauci cives dell’inizio. Evidentemente la peste ha mietuto tra le vittime anche il sindaco; e non c’è stata la nuova elezione perché il timore di nuovi contagi sconsiglia di tenere l’assemblea cittadina; i pochi castelnuovesi sopravvissuti stanno attenti ad evitare gli affollamenti. O, forse, è il vescovo che preferisce evitare il più possibile i contatti con sconosciuti. Conclusa la frettolosa ispezione, il vescovo Fabrizio Campana saluta e convoca l’economo per il successivo 20 aprile 1658, sabato santo, nel suo palazzo di Santomenna per sottoporlo alla visitatio personalis. 124 Puntualmente in quel giorno gli si presenta il reverendo economo don Vincenzo de Martino da Castelnuovo, di anni 38, che viene interrogato sugli ammalati di peste e sui redditi e gli oneri della chiesa (Die 20 mensis aprilis 1658 Reverendissimus Illustrissimus Dominus Dominus Archiepiscopus expeditus a visitatione pulcesiana devenit ad visitationem personalem et fuit curatus et comparuit Reverendus Dominus Vincentius de Martino Economus dictae Terrae Castri Novi, etatis suae annorun 38, qui interrogatus supra Infectis respondit ut infra, et de reditibus et oneribus Archipresbyteratis suae Ecclesiae dixit). Quello che dice don Vincenzo l’economo, lo dice nella lingua volgare e queste sono le sue parole: Io ho circa diciassette tomola di grano dalle decime sacramentali, uno rendito di mezzo pari di vino di sopra una vigna, e queste sono l’entrate certe adesso che le gente sono morte per il passato contagio. Di più ci sono molti beneficiis et alberi di ghiande di cerque quali non si trovano ad affittare per niente. Di più ho carlini dieci per qualsiasi matrimonio; e le candele seu torriette che portano li sposi, carlini dodici per qualsiasi morto, e due libre di candele, ma dalle femmine ne ho carlini undici e mezzo e due libre di candele, e dalle scomuniche ne ho due carlini per pubblicazione e cinque grana per revelatione, e due carlini li ho per qualsiasi fede delli libri parochiali; e queste sono tutte l’entrate dell’Arcipretato. In quanto poi alli pesi io sono obbligato pagare ogn’anno al R. Seminario carlini 18 in danari e tomola tre e mezzo e due mezzetti di grano alla Mensa Arcivescovile; pago carlini dieci otto l’anno per l’encennio et per il spoglio pago ogni anno carlini 19 e tre grana, e per ultimo ho il peso delle candele per la Chiesa che credo importano circa ducato quattro l’anno e questi sono li pesi et entrate che ho dalla Chiesa, la quale non ha niente altro, né vi sono altri Preti. Poi il vescovo sottopone l’economo ad un fuoco di fila di domande: se ricava altri benefici; e risponde di no; se insegna la dottrina ai bambini, se dice messa tutti i giorni di festa, se benedice le ceneri e le palme, e le abitazioni in tempo di Pasqua, se le vedove e le donne non maritate frequentano la messa, e risponde di si. Lo interroga sulle modalità di somministrazione di tutti i sacramenti. Circa l’estrema unzione il vescovo chiede all’economo come e quando la somministra agli appestati; alla risposta dell’economo che lui osserva la forma rituale e la dà al momento giusto, il vescovo gli ordina di non attendere che il moribondo sia del tutto privo dei sensi (Interrogatus de morbidibus asportationis illius et de tempore, dixit illud asportatur servata forma ritualis, et tempore quo notatur, et Ill.mus Dominus ei mandavit ut in futurum non expectetur tempus quo infirmus est omnino sensibus 125 destitutus). Rassegnate, infine, alcune raccomandazioni a don Vincenzo, il vescovo Fabrizio Campana dispone che si celebri una messa cantata il 29 maggio di ogni anno per l’anniversario della sua consacrazione, e che un’altra se ne dica il 13 febbraio per l’anima del suo predecessore, Ercole Rangone (Nec non mandavit quod in die 29 maiis singulis annis celebret missam cantatam Consecrationis Archiepiscopi, et in die 13 februarii celebret anniversarium pro anima Nostri Predecessoris). Il verbale si chiude con l’indicazione della data e del luogo: Datum in Terra Sancti Mennae in Nostro Palatio Archiepiscopali die 20 aprilis 1658. Qualche anno più tardi, passata la peste e la paura, nei paesi dell’alta valle del Sele si elevano croci lapidee per ringraziare dello scampato pericolo. Questo è il significato che Gerardo Monteverde assegna alla Croce dell’Angiolo collocata all’ingresso del paese di Caposele (come l’epidemia scema, per ringraziare il Signore che ha inviato l’Angelo Salvatore viene realizzata una croce viaria in pietra)76. La croce di Caposele è pressoché identica a quella di Castelnuovo, probabilmente entrambe dovute alla mano dello stesso artigiano. La croce di Caposele e quella di Castelnuovo 76 Gerardo Monteverde, Terra di Caposele, Caposele, 2012. 126 2.10 Castelnuovo e i conflitti con i signori feudali A partire dai primi del cinquecento, come abbiamo visto, la terra di Castelnuovo, da sola o insieme ad altri feudi, passa da un signore all’altro, o per concessione regia, o in seguito ad un semplice atto di compravendita. I signori sono spesso napoletani più o meno illustri77 che da Castelnuovo traggono rendite parassitarie. Ma il rapporto degli abitanti di Castelnuovo con il signore feudale non è di passiva accondiscendenza. Nel 1557 è aperto davanti al Sacro Regio Consiglio un conflitto che riguarda la titolarità delle terre possedute da alcuni castelnuovesi. E’ stato il barone Guglielmo Silvio a denunciare i castelnuovesi che illegittimamente e senza diritto detengono terreni strappati al feudo ed a chiederne il reintegro e la nuova incorporazione. Ma la causa non si tiene perché le parti giungono ad un accordo di reciproca soddisfazione. Al di là della forma, che appare ossequiosa nei confronti del barone, i cittadini di Castenuovo strappano al feudatario la conferma nel possesso delle terre, oltre a nuove e più vantaggiose condizioni. Infatti l’11 novembre 1557, davanti al sindaco di quell’anno Nicola di Guglielmo, al notaio Giovanni Cappella, ed a diversi testimoni si costituiscono, da una parte, il barone Magnificus excellens dominus Antonius Silvius de Neapoli78 e, dall’altra, i cittadini di Castelnuovo di Conza Nicola di Monaca, Minico di Donato, Matteo Vellele, Giovanni di Guglielmo, Celillo di Pietro, Andrea de Santoro, Giacomo di Pietro di Angelillo, Paolo di Giovanni Pistoia, Nicola di Pietro, Gennaro de Madrari, Giovanni Pitoia, Antonio de Mardiese, Matteo Monaco, Paolo de Luca, Martino Petrolino, Ferdinando Vinto, Vincenzo di Nicola Covella, Nicola de Bernardino, il venerabile don Lorenzo de Petrulio, il venerabile don Gabriele de Viridiario. Entrambe le parti dichiarano di agire per se stessi e per i loro eredi e successori universali e particolari. Barone e cittadini, desiderando e volendo essi suddetti che convenga risparmiare sulle spese e sui costi, e per evitare liti, contese, odi e rancori e molti altri mali che solitamente nascono dalle liti, si accordano nel senso che i castelnuovesi all’istante rinunziano trasferiscono e ritengono tutti i territori predetti feudali allo stesso Come Baldassarre Pappacoda, Cavallerizzo Maggiore e Consigliere del re Federico d’Aragona, e Cicco Loffredo, rinomato Avvocato, e poi nell’anno 1512 Regio Consigliere. 78 E’ il figlio ed erede di Guglielmo Silvio (che ha comprato Castelnuovo da Cicco Loffredo nel 1544). 77 127 signor Barone, ed il feudatario riconosce nuovi patti e condizioni molto più favorevoli ai cives et homines particulares dictae terrae Castrinovi. Tra l’altro si conviene tutti i territori feudali come sopra da essi ceduti, uniti ed incorporati al demanio ed al feudo predetto che tenevano e coltivavano, quelli (i castelnuovesi, n.d.r.) possono tenere e coltivare, arare e seminare e rategricare. I castelnuovesi così, al di là del riconoscimento formale in favore del barone, rimangono in possesso dei terreni contesi e passano, per di più, da una forma di mezzadria unilaterale (al feudatario la metà del prodotto) ad una sorta di affitto (un undicesimo al feudatario, il resto ai contadini): come in detto territorio e feudo di Castelnuovo è solito e costumasi pagare alla baronal Corte per terraggio79 de ogni due tomola uno, che, non obstante tal solito e costumato, se abbia da pagare de ogni undece uno tomolo, uno varro di grano come de olgio, fave, lino et ogni altra sorte de victuvaglie et legume con quello non lle possa luvare… Una seconda clausola favorevole ai castelnuovesi stabilisce che quando non possono essi cultivare dicti territorii pheudali hanno la facoltà di concederli ad altri a coltivarli, rimanendo l’obbligo di pagare al barone l’affitto come sopra (un undicesimo del prodotto). In più i cittadini di Castelnuovo che volessero per loro commodo concedere, donare, cedere, dare in dote, conservare alcuno tomolo delle terre predicte per rendite usi e redditizie ut supra, lo possa, con grazia del signor barone et sua licentia in scriptis obtenta, quella in parte o in tucto vendere et dare in dote tantum ut supra et ancora la baronal corte ne le possa conseguire la decima del prodotto… Inoltre i cittadini di Castelnuovo potranno recintare i terreni paludosi ed i pascoli posseduti per uso dei loro boij (buoi) e pagare quello che è solito per ciascheduno anno. Quelli che, invece, non hanno già prati e palude antique et hanno necessario di fare fieno per uso de loro boij, potranno recintare quattro tomola per qualsivoglia capo de casa seu maxaro (capofamiglia o massaro) senza pagare cosa alcuna… Vengono confermati nel possesso quelli che foro lle mura di Castello novo tenono grotte case80, pagliare81, vigne, ortere et è solito Corrispettivo in natura dovuto al feudatario, o al Comune, per l’uso civico di coltivare nel terreno demaniale. 80 Sono la grotte-case da cui è partito questo libro. E’ da osservare che sono “fuori le mura”, ma nella roccia; infatti le mura delimitavano una parte soltanto dello sperone (dalla chiesa di San Nicola al castello). 81 Pagliai, abitazioni monolocali con muretto perimetrale in pietra a secco e copertura di legno e paglia, in uso nelle campagne di Castelnuovo fino al ventesimo secolo. 79 128 pagarsi delle grotte case grana cinque per ciascuno et delle altre soleno pagare siccome sta annotato in libro de lo feodo in danari per ciascun anno…Quelli che tengono vigne, orti, grotte, pagliai senza pagare le potranno tenere per un pretio justo et conducente et tanto in dicte vignie como in lle dicte altre vignie de dicta terra de Castello novo possano tenere dintro ad decte vignie uno tumulo de terreno vacuo et si alcuno volesse far vignie de nuovo non lle possa fare, senza licentia in scriptis obtenta et pagare il justo ut supra finchè sarrà tenuta et cultivata per vignie et non ad altro uso et si intendono concessi ceterum in feudum. Per quanto riguarda gli alberi, premesso che in dicto territorio e demanio de dicto phoeudo ngesò (ci sono) multi et bona quantità de arbori fructiferi, come sono cerri cerque, etc., si conviene che quelli che li hanno tenuti potranno continuare a tenerli e che il possessore possa continuare a goderne dei frutti pagando alla baronal corte ciascuno anno secondo sta annotato in lo libro antiquo predicto de li feudi. Se poi si volesse far tagliare gli alberi e far seminare il terreno disboscato, si dovrà pagare siccome tutti li altri territorj de undici una ut supra… I cittadini di Castelnuovo ottengono poi che, per quanto attiene gli altri territori feudali che non sono stati oggetto della contesa (atteso dicta corte tene et possede tutti li altri territorj pheudali quali mai sono stati separati né dissoniti dal demanio et pheudo predetto), anch’essi possano essere posti a coltura con il solito pagamento de ogni undece uno. Per ultimo viene registrato un atto spontaneo di generosità dei castelnuovesi verso il feudatario, una salma di paglia per ogni allevatore di buoi che pascolano nei territori: dicti citatini et homini de dicta terra de Castello novo, ultra de dicto terragio, sponte promettono et ciascauno di loro promette per sui heredi et successori che coltiveranno dicto territorio overo faranno coltivare ut supra, per ogni anno a la baronale Corte dare una salma di paglia per ciascuno maxaro che fa campo in dicto territorio con boij sui et nende (niente) vi semina o zappa, o coi boij a pagamento et quelli non siano tenuti de dare dicta salma de paglia. In conclusione dell’atto notarile vengono registrati i confini del territorio di Castelnuovo. Le parti affirmano et declarano tutto lo territorio essere pheudale et demanio de dicto pheudo circondato et confinato dalle infrascritte confine. Le infrascritte confine sono così riportate: Incommenzando dal Varco del Casolaro, ed esce al Varco dello Schiavo, et saglie lo Vallone ad alto, et esce a lo Varco de li Cesi nomine Redognica, et sale sempre Vallone Vallone per si al 129 Il territorio di Castelnuovo in una mappa catastale del 1901 Varco della confine di Buoninventre, et saglie lo Valloncello ad alto nominato la confina, et esce al loco nominato la Seta di Conza, et spacca la terra, che si dice la logia de Serracchio, secondo appare per uno titolo, et preta piatta feccata in Terra, et poi piglia la Strata in suso, come penne acqua, e tira la Seta ad alto, et va a lo lemmete che si dice de Linardo de Chirico, ed esce alla fontanella de dicto Linardo, et tira per lo limite de piedi per lo limite traverso di Pescopagano, dov’è una fontanella, se dice la logia de Donato Petrolino, e tutto lo soprascritto è confinato con lo territorio de Consa, tira per la Serra, che confina con Pescopagano, et se nomina la Serra delle confine, et tira per la Serra ad alto quanno penne acqua, che va alla aira della Serra della confine, et esce allo lemite della noce, et va sopra la fossa della Carcara, si esce all’aira de Pietro de la Genestra, et tira la serra ad alto quanno penne acqua, et va a lo puzzo fore de Petrella con lo monte se dice de Petrella, et tira lo Vallone abascio et esce la via della Poina secondo appare per uno lemmete, et cala con Vallone abascio et va alla Fontana de lo scalo et tira per lo Vallone abascio et per lo Vallone de la defesa de la Redeta, quale Vallone confina con lo territorio di Santo Mendai, et corre lo Vallone abascio, et esce a lo Varco de Sollemato, et scende a lo Pisciolo calando a lo Vallone de lo Pennino, et cala a lo Varco de 130 lo Molino de Santo Mendai confinato con lo territorio di Laviano, et va come corre lo Fiume de Temmete abascio, quale sparte lo territorio di Castelnuovo, et Laviano scendendo sì a bascio a lo predetto Vallone de Casolaro, et confine de Bono inventre primo confinato ut supra. Si chiarisce comunque che i confini riportati definiscono tutto il complesso feudale e demaniale, ma che quanto a quelli che teneno ad cultura et lavorano dicto territorio restano lle confine tra loro chi cultivano et hanno cultivato dicti territorj. Nel 1585, dopo che il feudo di Castelnuovo è stato venduto dalla famiglia Silvio alla famiglia Gesualdo, i castelnuovesi avviano una causa avente ad oggetto le limitazioni imposte dal barone ai cittadini. Nel Grande Archivio di Napoli si trova il processo contro il barone Fabio Gesualdo (Universitatis et hominum Terrae Castrinovi cum Magnifico Domino Fabio Gesualdo eius Barone et aliis super…). L’Universitas (il Comune di allora) e gli uomini di Castelnuovo, attraverso l’esposizione facta per Excellentem Militem Utriusqe Iuris Doctorem Dominum Cesarem Vitellum, avanzano una serie di gravamina (opposizioni) alle prepotenze del feudatario. In sostanza si chiede al potere regio di far sì che il barone la smetta di proibire ai cittadini la possibilità di edificare nelle loro terre (il signor Barone proibisce et vole prohibire che li citatini non habino a fabricare nelle loro possessioni). Il barone poi vole prohibire che non vadano a fare legna nel bosco della Redeta contro l’antiquo solito et consueto, e i castelnuovesi chiedono che loro sia licito de andare a fare legna in detto bosco. Per di più, siccome il barone, se ritrova alcuno fare danno in detto bosco, li fa pagare la pena più del danno contro la forma della Regia Prammatica, l’Università di Castelnuovo chiede provvedersi quod poena non excedat damnum (che il pagamento non sia maggiore del danno). Analoga richiesta viene avanzata per i danni eventualmente arrecati al feudatario dagli animali dei castelnuovesi. La successiva opposizione riguarda il tentativo messo in atto dal barone di usurpare li boschi che sono dentro la terra tanto del demanio dell’Università, quanto dei territori appatronati contro la volontà dell’Università e delli padroni. Anche per questo si domanda che il barone la smetta (provvedersi quod abstineat). Una delle fonti di rendita per i feudatario è il pagamento imposto ai castelnuovesi per la macinazione del grano e degli altri cereali presso i mulini del barone. Con lo stesso atto dell’avvocato Cesare Vitello, l’Università di Castelnuovo si oppone, e chiede che i castelnuovesi possano macinare dove meglio credono: acteso il barone vole che li cetatini non possono andare a macinare in altre moline che nelle moline della Corte, et da questo li cittadini 131 ne sentono grande interesse sì per lo pagamento come che non se spediscono così presto, supplica perciò provvedersi quod abstineat et che sia licito alli cittadini andare dove loro piace ad loro arbitrio et voluntà. Analoga opposizione viene avanzata per l’obbligo di servirsi del forno del barone: Item grava acteso vole prohibire che li cittatini non possono fare forna nelli loro lochi et case et vole che tutti vadano a cocere il pane nelle forne della Corte, supplica provvedersi quod abstineat et che sia licito alli citatini fare forna et andare a cocere dove loro piace. Il barone paga i lavoratori a giornata meno del dovuto e l’Università di Castelnuovo si oppone: acteso mentre comanda li citatini che vadano a zappare la vigna della Corte o fare altri servitii dentro del territorio non le paga come se pagano fra li citatini, supplica provvedersi quod intus territorium solvatur salarium prout inter cives (in tutto il territorio si paghi lo stesso salario come si paga tra i cittadini). Il barone utilizza i castelnuovesi per far portare a Napoli quanto gli occorre anche dalle altre Terre, e l’Università di Castelnuovo si oppone chiedendo che il servizio di trasporto si divida tra tutti i feudi di Fabio Gesualdo in ragione del numero delle famiglie: acteso avendo detto signor Barone più terre, mentre occorre comandare così a portare carriaggi in Napoli come per altri servitii fuor del territorio, comanda et fa comandare solo li homini et hanimali de essa terra de Castelnovo et non delle altre terre, supplica provvedersi quod servitia distribuantur et dividantur per tutte le terre secundum numerum focularium a fine che ogni uno porti il peso giusto. Il barone tende a risparmiare il più possibile sui trasporti perché paga solo il viaggio per Napoli e non anche per il ritorno, e l’Università di Castelnuovo si oppone: Item se grava acteso molte volte occorre che mentre se comandano animali, li fa ritornare carrichi ancora nel ritorno et non le vole pagare se non per l’accesso, supplica provvedersi che quando ritornano carrichi sia tenuto pagarli ancora il recesso. Anche sulla pratica baronale di far deportare fuori da Castelnuovo i carcerati, l’Università si oppone: Item grava acteso fa extrahere li carcerati fuori de la terra predetta et lle manda carcerati in altri luochi contro la forma della Regia Prammatica, supplica provvedersi quod abstineat, et quod carcerati non extrahuntur extra territorium. Una delle opposizioni dell’Università di Castelnuovo riguarda l’uso baronale dei balivi, funzionari istituiti dal re Ruggero II nel 1140 che devono svolgere compiti di polizia urbana e rurale, riscuotere vari diritti, comminare multe ai proprietari di animali che arrechino danni ai fondi altrui o a quanti facciano uso di falsi pesi e misure, ma che il feudatario impiega come privati camerieri: Item grava acteso costrenge li baglivi a fare altri servitii che quelli 132 spectanteno alla Corte et vole che lo servano ancora alli servitii domestici di casa sua, osa pure la moletura et altre cose che non spectano allo baglivo, supplica provvedersi quod abstineat quod non teneantur nisi ad servitia Curiae. E’ avido il barone che affitta tutti i pascoli ai forestieri e lascia morire di fame gli animali dei castelnuovesi; anche per questo l’Università si oppone: Item grava acteso fida tanti animali nel territorio che alli cittatini non loro resta l’uso et li loro animali non hanno come pascolare et se moreno, supplica provvedersi quod abstineat et che non impedisca l’uso delli citatini. 2.11 Un conflitto che si trascina nei secoli Il conflitto tra i castelnuovesi ed i feudatari non cessa con gli accordi del 1557, se è vero che ancora nel 1722, all’atto della vendita di Castelnuovo (con Buoninventre e Sant’Ilarione) da parte della famiglia de Martino al principe Mirelli, i contraenti devono precisare che gli antichi feudatari pretesero che tutto il territorio di detta Terra fusse feudale, e pretesero esiggere la Decima dalli Possessori82 di detto Territorio, e parimente fu’ preteso aver il Jus proibendi del forno, e che non si potesse fare dall’Università e fu’ aggiunta lunga lite nel Sacro Consiglio, dal quale fu’ promulgato sentenza, che si dovessero li cenzi dalli Possessori di detti Territorij, e per rispetto del Forno fu’ detto capiatur informatio83, e per la lunghezza del tempo si è trascurato d’esiggere, e la Decima, ed i cenzi. L’atto rappresenta che i venditori de Martino hanno rinovato il giudizio, facendo istanza astringersi li possessori de Territorij saltem (almeno) alla corresponzione de cenzi, anco servata la forma della Sentenza del Sacro Consiglio ottenuta a’ favor d’essi possessori84, e pende ancora il litiggio, così rispetto alle decime, come rispetto al forno. Ovviamente gli acquirenti, principe e principessa di Teora, non pagano per quanto non viene loro trasferito e così i contraenti dichiarano a verbale (ed a futura memoria) che queste pretenzioni contro i possessori del territorio di detta Terra di Castelnuovo, e contro detta Università non vanno comprese in detto prezzo, ma essi Signori di Martino si riservano la facoltà di esperimentare le loro raggioni conto i Possessori di detti Territorij, ed Università, sincome I possessori dei territori sono i castelnuovesi. Si prendano informazioni, ossia si prosegua l’istruttoria. 84 I castelnuovesi –in effetti- non pagavano al feudatario nemmeno nella misura limitata che erano riusciti a stappare. 82 83 133 potevano fare prima della presente vendita. Nel caso, molto improbabile –possiamo ritenere-, che i venditori riuscissero a recuperare il pagamento di quanto preteso dai cittadini di Castelnuovo, allora potranno ricevere dagli acquirenti il corrispettivo: (quando) ricuperato avranno detti Signori di Martino, li sodetti cenzi, o decime, ed avranno a’ loro beneficio il pacifico possesso dell’esattione di detti cenzi, e del Jus proibendi del forno, senza veruna opposizione incontrario, all’ora si debbia liquidare il prezzo di detti corpi, e rendite, quale liquidatione si debbia fare dall’istessa loro rendita, cioè essendo feudali alla raggione di carlini venti sette per cento, ed essendo burgensatici alla raggione del quattro per cento, e secondo detta liquidazione sia tenuta detta Signora Principessa pagare il prezzo a detti Signori di Martino, senza interesse alcuno fra’ questo mentre. 2.12 Le rendite feudali e comunali Ma a quanto ammontano le rendite parassitarie che il barone ricava da Castelnuovo? Ce lo dicono i relevii, e cioè le presentazioni dell’omaggio al re nella investitura del feudo, o nei vari passaggi che avvengono per successione. In siffatte occasioni il feudatario, all’atto delle nuova investitura, comunica i redditi del feudo e viene assoggettato ad una corrispondente tassazione. I signori feudali traggono consistenti rendite parassitarie facendosi pagare (o cercando di farsi pagare) tutto il possibile ed immaginabile; accanto alle consuete entrate sul mulino, sul forno, sulla taverna, sui boschi, sui campi e sulle vigne, il barone lucra perfino sulle donne di Castelnuovo che si maritano con un forestiero. In occasione della morte del barone Guglielmo Silvio, il figlio Antonio dichiara nell’anno 1557 i seguenti redditi: Lista introitum Castrinovi perceptorum tempore mortis Magnifici predicti Guglielmi est ita videlicet. In primis la defensa nominata la Redita, Ducati 18. La bagliva Ducati 12. Lo furno Ducati 12. Li censi seu rediti sono Ducati 6 però (in quanto) dapoi la morte de dicto magnifico Guglielmo et avante per causa de la lite ne sono esatti Ducati 6. Lo molino rende tomola 30 de grano, non macina l’estate85, tomola 30. Li terraggi di grano tomola 20, de orgio tomola 6, de altra leguma tomola 2, de lino fasci 8. La taverna Ducati 12 et poi sua morte non è stata fatta, né affittata e pertanto non se n’è avuta 85 E’ un mulino sul torrente Pisciolo, secco d’estate. 134 cosa alcuna86. La vigna botte napoletane 4 e mezza. Le cerque per ghianda Ducati 6. Li filetti carlini 4. Quando le donne se maritano et escono fora de dicto castello carlini 5 sono esatti per una Ducati 0, 2, 10. Di più lo predicto magnifico Guglielmo comprò annui Ducati 51 sopra le entrate di Rapolla de la magnifica Beatrice Malda Ducati 51. Comprò dall’illustre Conte di Sant’Angelo sopra le intrate di Morra Carbonara et de Lioni con patto retrovendendi Ducati 430. Se ne deve deducere quanto si despende a recogliere dette entrate et quanto si spende a putare, governare et vendegnare le predette vigne e tutte altre cose di giustizia si devono dedurre. Nel 1575, invece, Antonio Maria Gesualdo a seguito della morte del padre Fabio dichiara: L’intrata de Castello novo. In primis per lo affitto de lo herbaggio et ghianda de lo bosco della Rideta secondo apparisce per libro de lo Camerlingo Ducati 30. Item per lo affitto delle bagliva Ducati 25. Item per lo affitto de lo forno cum jure prohibendi Ducati 21, 2, 10. Item per lo affitto de la casa de la Corte Ducati 1, 1. Item per lo affitto de l’orto Ducati 2, 10. Item per lo affitto di un altro orto a piede de lo Castello Ducati 4. Item per li frutti de la vigna et fronde de celso Ducati 2, 2, 5. Item per lo affitto de la molina cum jure prohibendi tomola 54 e mezzo. Item ricevuto da li terraggi tomola 61 e mezzo de grano. Cecerchia et fave tomolo uno. Item de semenze de lino tre matide. Item de lino quattro sarcine da le quale se ne può cavare una decina in circa de lino. Item de paglia esatta da li massari che sono tenuti quolibet anno ogni massaro donare gratis a la baronal Corte lenzuola 27 che in danaro sono Ducati 1, 1, 15. Item para 32 de vino e 14 mezze quarte et mezza a la napoletana. Nel 1577 muore Antonio Maria Gesualdo ed il feudo passa al figlio Giovanni Geronimo Gesualdo che dichiara: Castelnuovo de la Provincia de Principato Citra possede le infrascritte intrate. In primis se li ponono per introito Ducati 28 per la vendita de li erbaggi de la difesa et bosco de la Rideta Ducati 28. Item Ducati 22 e mezzo per lo affitto del furno de la Corte, qual tiene in detto Castello cum jure prohibendi dico Ducati 22, 2, 10. Item Ducati 35 per l’affitto del herbaggio di detto territorio di detto Castello. Item Ducati 5 per vendita dell’herbaggio del vacantale de la viga de la Corte. Item carlini 14 esatti da diverse persone per piazza. Item carlini 5 per vendita de le cerase Ne deduciamo che la famosa Taverna (il cui toponimo ancora sopravvive), e che successivamente troviamo nominata come Taverna diruta, aveva funzionato e prodotto reddito feudale fino al 1557. 86 135 de la vigna de la Corte. Item Ducati 2 per vendita de la ghianda de de le cerze de la Corte Ducati 2. Item Ducati 3 e tarì 3 per vendita de sei decine de lino per conto del terraggio. Item Ducati 5 per l’alloghiero de la stalla de la Corte. Item ducati 2 et mezzo per alloghiero de la casa de la Corte. Item se ben sono perceputi dalli vini et moscatello Ducati 24 in circa come che alle vigne ci è andata maggior spesa, con putare, zappare, rescotere, legare, vendegnare et spese alli operaji, non se cacciano. Item tomola 53 de grano recevuto dal terraggio a compimento di tomola 50 circa de le due remanente si pagano a li baglivi che matorno li terraggi che a carlino 4 lo tomolo sono Ducati 21 et doi carlini, de li quali defalcato un Ducato per carriare da l’aira restano Ducati 20, 2. Item tomola 16 de orgio receputi dal terraggio de la Corte a carlini 3 il tomolo sono Ducati 4, 4. Item per lo affitto del molino tomola 55 che a la detta ratione sono Ducati 22 da li quali dedotto Ducati 2 et tarì 4 et grana 8 spesi a far la sacettola al molino, acconcio del ferro de dicto molino et tina e imbrici restano Ducati 19, 0, 12. Nel 1679 Nicola Maria de Martino, a seguito delle morte della madre Camilla Felice Bavosa de’ Rossi, dichiara alla Regia Corte: la zecca denunciata in rendita Ducati 20 et la portulania che si possiede dall’università, e ne paga l’Adhoe Ducati 20. Bagliva e Piazza Ducati 17. Mastrodattia Ducati 12. La vigna non tutta baronale Ducati 15. La difesa della Redita 40, 2, 1 e 2/3. Il territorio d’estate e d’inverno Ducati 60. Il molino Ducati 29, 3, 10 e ½. Da Lorenzo Ricciullo per li terraggi seu territorii grano tomola 2 e ½ a carlini 7 e mezzo Ducati 1, 4, 7 e 1/2. Dall’orto de la Corte tomola uno d’orgio. Dal detto Ricciullo per terraggio di orgio tomola 1. Il 15 gennaio 1740 il sindaco, due eletti ed il cancelliere dell’Universitas di Castelnuovo attestano per il catasto i beni posseduti dal barone: Per obedire agli ordini dell’illustrissimo sig. Preside di Salerno, noi qui sottoscritti e crocesegnati di questa Terra di Castelnuovo Sindaco ed Eletti facciamo fede vera regale giurata et sotto pena di falso, come dall’illustre Principe di Teora, Barone della medesima, si posseggono li sottoscritti beni feudali. Videlicet: la Defesa di Bonomente con Bosco di S. Ilarione, Bagliva, Zecca, Taglio e Portolania, Mastridattia, la Defesa della Redita, Uno molino posto nel loco detto lo Vurvo di una macina. Beni burgensatici dubbj: Una vigna con territorio nel loco detto lo Cenuso, Un palazzo d’abitazione con giardino, Un altro territorio di tomolo 1 nel loco detto lo Cupone. Ed in fede del vero n’abbiamo fatto la presente sottoscritta e crocesegnata di nostre proprie mani, et monita col suggello di questa Università. Castelnuovo 15 gennajo 1740. Segno di croce di Nicola dell’Anicchiarica Sindaco – Io Nicola Ricciullo Capo Eletto – Segno di croce di Vincenzo di Donato Eletto – Nicolaus Iannuzza M. Cancellarius. 136 Accanto alle rendite feudali ci sono le più modeste rendite dell’Università ovvero del Comune. Nel 1627 il Vicerè Antonio Alvarez di Toledo, duca d’Alba, dispone che venga effettuato una sorta di ricognizione delle rendite dei Comuni del regno ed affida al Marchese di Belmonte Carlo Tappia, Reggente della regia Cancelleria, l’incarico di formare gli stati delle entrate. Tra gli stati formati dal Reggente Tappia vi è quello del Comune di Castelnuovo di Conza, dove si legge tra l’altro per le entrate: lo territorio detto lo cenoso Ducati 13, 1, 13. Un altro poco di territorio Ducati 8. Si aggiunge all’introito la decima del grano che si esigge alla scogna. E nell’esito (le uscite del Comune) si legge: al Barone per Zecca Ducati 30. Nel 1741 la Regia Camera forma lo stato del Comune di Castelnuovo de Conza e nella rubrica dell’introito si releva tra l’altro il seguente: Dall’affitto del territorio denominato lo Cenuso annui Ducati 6. Dall’affitto del forno annui Ducati 40. E nella rubrica del’esito si descrive fra l’altro quanto siegue. All’illustre Principe Mirelli per fiscali annui Ducati 54, 3. Fu provista questa partita juxta librectum realis patrimonii. All’illustre Principe Mirelli per Zecca e taglio di bosco87 e portolania annui Ducati 70. Per questa partita vi è la solita decretazione di continuarsi il pagamento purché sia in possesso di esiggere, o per l’esibizione dei documenti fra tre mesi, qual termine elasso l’Università non paghi, ma ne faccia deposito presso il Regio Percettore provinciale. Nel successivo stato formato dalla Regia Camera nel 1785, nella rubrica dell’introito, si legge tra l’altro: Dall’affitto del Cenuso Ducati 10; dall’affitto del forno Ducati 30, 70; dal jus prohibendi della bottega Ducati 2, 80. Nella rubrica dell’esito si descrive tra l’altro il seguente: All’illustre Principe Mirelli per fiscali Ducati 162, 84. Al detto illustre Principe Mirelli per taglio, zecca e portolania Ducati 70. All’illustre Principe per l’erba vernotica Ducati 13, 5. 2.13 Fine del feudalesimo Come abbiamo visto Francesco Maria Mirelli, Principe di Teora, è l’ultimo feudatario. La ritrovata unità territoriale ed amministrativa di Castelnuovo e Buoninventre con il suo Bosco di Sant’Ilarione dura fino al 1806, anno della promulgazione della legislazione eversiva della feudalità. L’Università di Castelnuovo deve pagare il barone per gli usi civici sui boschi di Boninventre e Sant’Ilarione ma, come si afferma poco più avanti, occorre che il barone, entro tre mesi, esibisca i documenti. E’ la base di tutte le successive controversie tra il Comune e i proprietari dei boschi. 87 137 Giuseppe Bonaparte re di Napoli dal 1806 al 1808 Nel Regno di Napoli il regime feudale, che fa coincidere la proprietà delle città, dei feudi e delle terre con l’esercizio di funzioni amministrative, di giustizia, di fiscalità, rimane in piedi fino all’abolizione ad opera di Giuseppe Bonaparte, re di Napoli e fratello di Napoleone. Egli elimina così l’ultimo retaggio della feudalità nell’Europa occidentale, anche se ormai la spinta rivoluzionaria giacobina è da tempo attenuata. In tal senso emana, come primo atto di rottura rispetto alle istituzioni del vecchio regime, la legge n. 130 del 2 agosto 1806, il cui primo articolo recita: La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili. Tale provvedimento risponde ad una effettiva esigenza di rinnovamento delle antiche strutture socio-politiche, anche per il mutato clima, benché non tutte le innovazioni si rivelino completamente positive e per il fatto che in molti casi muta la forma, ma non la sostanza, 138 del vecchio potere baronale. E’ innanzi tutto necessaria la ricognizione dei beni del demanio, molti dei quali sono stati usurpati nel corso dei secoli. Altro grande problema è che sui beni feudali coesistono antichi diritti delle popolazioni locali, in base al principio ubi feuda ibi demania e che portano al riconoscimento degli usi civici. La serie dei provvedimenti prosegue con la legge del 1° settembre 1806, ed il Real Decreto del 3 dicembre 1808, che affida agli Intendenti di ciascuna provincia il compito di determinare i diritti residui degli antichi baroni. E’ istituita anche una magistratura speciale, la Commissione feudale per dirimere l’enorme contenzioso tra i baroni e le Università. Il ritorno al potere dei Borboni di Napoli nel 1815 non cambia la legislazione. La feudalità resta abolita e le leggi di Giuseppe Bonaparte, considerate di elevata modernità, sono riprese dal legislatore italiano oltre un secolo dopo e poste alla base della vigente Legge n. 1766 del 1927 per regolare la liquidazione degli usi civici. Vengono nominati i cosiddetti Commissari ripartitori, che devono regolare le conseguenze dell’abolizione del regime feudale (i vecchi baroni perdono le funzioni amministrative ma restano proprietari delle terre). La vecchia Universitas (che già assolveva a limitate funzioni amministrative con il beneplacito del feudatario) diventa il moderno Comune con i suoi organi elettivi. E’ in questo passaggio che si apre la controversia legale circa gli usi civici esercitati dai cittadini di Castelnuovo di Conza sulle tenute ex feudali di Boninventre e Sant’Ilarione e per la restituzione delle terre usurpate, controversia che vede il Comune impegnato davanti ai Tribunali per quasi un secolo. 139 Capitolo III La guerra del fuoco – parte prima (il diritto di legnare nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione) 3.1 Il fuoco e la vita Un antico proverbio di Castelnuovo così dice: Chi t’nija r’ fuoch’ campagh’ e chi t’nija r’ pan’ murigh’ (chi ebbe il fuoco visse e chi ebbe il pane morì). L’azione di andare a raccoglier legna è fondamentale nella vita quotidiana del popolo castelnuovese, e trova spazio nei canti popolari: E tu t’ vaij avandann’ Ca la tien’ na bella fucagna Si li vuoij mett’ fuoch’ Ejia ji a leun’ a la muntagna.1 Per quasi un intero secolo, l’ottocento, amministratori e popolazione di Castelnuovo sono occupati a combattere la guerra del fuoco per conservare il diritto di legnare, cioè di attingere la legna dai boschi di Buoninventre e di Sant’Ilarione. E’ una guerra che si combatte a colpi di antichissimi documenti, più o meno pertinenti, di carte bollate, di ricorsi, di appelli nelle aule di tribunale. Ma è una guerra che si combatte principalmente sul campo, ed ogni giorno, con gli uomini e, molto spesso, le donne di Castelnuovo che vanno a fare legna ed i guardaboschi padronali che lo vogliono impedire. E’ una guerra che in qualche occasione utilizza armi vere, fucili che sparano da una parte e dall’altra. In una della tantissime petizioni che gli amministratori e la popolazione di Castelnuovo indirizzano al Prefetto di Salerno per difendere quel diritto si legge: Non voglia permettere che si consumi sotto il predominio di una cieca fatalità, lo spoglio non solo di una popolazione poverissima, ma che resti essa condannata anche alla privazione del fuoco, elemento il più necessario per trascinare una semplicissima esistenza sulla vetta di un sassoso e gelidissimo monte di questa Provincia. In un altro documento è scritto: La popolazione di Castelnuovo ha terre sufficienti per lavorare, quello di cui ha necessarissimo bisogno si è del combustibile bisognevole a tutti gli usi della vita nel clima abbastanza rigido di questo abitato. Tu ti vanti di avere un bel focolare, ma se ci vuoi mettere fuoco devi andare a raccogliere legna alla montagna, in Francesco Di Geronimo, Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil…, Fisciano (Salerno), 2010. 1 141 L’esistenza nei secoli della comunità di Castelnuovo, al di là della edificazione del castello quale postazione di avvistamento e difesa in funzione della sicurezza dell’antica Conza, è assicurata da due elementi della geomorfologia del sito: il torrente Pisciolo che fornisce l’energia per i mulini, ed i boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione che, con la legna da ardere di cui sono ricchi, assicurano la sopravvivenza nei gelidi inverni dell’appennino meridionale. Con le leggi eversive della feudalità del 1806 si apre nella storia di Castelnuovo di Conza un nuovo capitolo in gran parte incentrato sulla rivendicazione dell’uso civico2 di fare legna alla montagna e sulla contesa giudiziaria per ottenere la restituzione delle terre demaniali usurpate dai baroni. 3.2 Buoninventre e Sant’Ilarione negli atti notarili dal 1636 al 1807 Nel capitolo precedente abbiamo già visto alcuni passaggi di proprietà feudali. Per quello che interessa Buoninventre, e per definire sulla base degli atti notarili che cosa si intende con questo toponimo, occorre andare al 1636, allorché il principe di Piombino, Nicola Ludovisi, acquista per 42.000 ducati dalla Regia Corte i feudi già appartenuti alla famiglia Gesualdo3. Nicola Ludovisi L’uso civico su un fondo di proprietà feudale o demaniale è il diritto, di origine altomedievale, in capo alla collettività di utilizzarlo per una particolare utilità: raccogliere la legna da ardere, consumare l’erba per il pascolo, cacciare, seminare, etc. 3 In primis in Provincia Principatus Ultra la Terra di Taurati Casal di Sant’Angelo Alesca, la Terra di Fontanarosa, la Terra di Cossano, la Città di Frigento con suo Casale detto lo Sturno, la Terra di Calitro, Castiglione, feudo disabitato, la Terra di Cairano, la Terra di Patierno, la Terra di Tegora, Castelvetere, Montefredano, Montefuscolo con li seguenti Casali: Santa Paulina, Calvi, Sant’Agnese, Torre della Nocella, Santo Pietro in Delicato, Santo Angelo a Canciello. In Provincia Principatus Citra la Terra di Caposele, la Città di Conza, la Terra di Cangiano con la Pertosa, la Terra dell’Auletta, la Terra di Palo, la Terra di Contursi, la Terra di Salvia, la Terra di Salvitella, la Terra di Sant’Angelo de la Fratta. Et in Provincia Basilicatae la Città di Venosa et Maschito, Casale di detta Città. 2 142 Tra essi c’è la Terra di Caposele, con Sant’Ilarione e Buoninventre. L’atto notarile del 1636 è integrato da una valutazione (“apprezzo”) della Terra di Caposele effettuato dal Regio Ingegnere Tavolario4 Onofrio Tango. In questo documento, oltre alla descrizione di Caposele e delle rendite da esso derivanti, si trovano valutati alcuni beni particolari; tra essi figurano: 1. il feudo di Buon’Inventre; 2. la difesa5 di Buon’Inventre; 3. il bosco di Santo Hilarione. Ecco come Onofrio Tango descrive le tre entità: 1. Erbaggio del feudo di Buon’Inventre contiguo alla difesa infrascritta, territorio macchioso seminatorio et piano, e parte penninoso di capacità di mogia 1500, e l’altre macchiose iusta li beni di Tegora, Conza, il demaniale di Caposele, ed altri confini, del quale ogn’anno li massari che coltivano detto feudo, che ci va compreso la mità del frutto, ed herba del bosco Santo Hilarione, conforme l’antico stile, e si dirà a suo luoco, oltre che detti massari ne pagano il compasso di quello che seminano ogni anno… 2.La difesa di detto feudo di Buon’Inventre con alberi di cerque, e cerri, et altri selvaggi, bosco parte redutto seminatorio, e parte boscoso per loco di pascolo di capacità di miglia due di circuito iusta li beni della terra de Laviano, Castellonovo, lo bagno, il fiume Termite, lo vallone e strada pubblica; s’affitta in denari ancorché ce si semina per lo pascolo… 3.Il bosco di Santo Hilarione di capacità de un miglio e mezzo di circuito, boscoso et penninoso con cerque, et cerri iuxta li beni di Castelnuovo, s’affitta in denari, et la mittà di detto affitto spetta alli massari di Buon’Inventre, che pagano conforme si è accennato di sopra, et per l’erbaggi, e frutti ne spetta alla principal corte la mettà… Il tavolario è un tecnico (ingegnere e architetto) che nel regno di Napoli è incaricato di redigere mappe accurate del territorio; i tavolari possono essere considerati i padri del catasto. 5 La difesa è un territorio recintato. Nel regno di Napoli ha un senso vario. Alcune volte comporta una chiusura per tutto l’anno; altre volte una chiusura temporanea. In alcuni altri casi la difesa è chiusa tutto l’anno per il pascolo, e non lo è per la legna necessaria al fuoco o per gli usi agrari dei cittadini (Ministeriale del 5 settembre 1810). In Niccolò Jeno de’ Coronei, Dizionario demaniale-amministrativo per lo Regno delle due Sicilie, Bari, 1847. 4 143 Panoramica di Castelnuovo oggi con i boschi di Sant’Ilarione e Buoninventre (Torretta) sullo sfondo La valutazione fatta dal tavolario Tango in termini di rendita è di ducati 190 annui per l’erbaggio e di ducati 593 per il grano del compasso provenienti dal feudo di Buon’Inventre, di ducati 287 annui dalla difesa di Buon’Inventre, e di ducati 36 annui dal bosco di Santo Hilarione. Il 6 luglio 1674 il principe di Piombino e Venosa Giambattista Ludovisi vende6 al napoletano Domenico de Martino le tenute di S. Ilarione e Buoninventre nell’agro di Caposele: qualmente il detto Eccellentissimo Principe si ritrova debitore al detto signor Domenico in ducati 2200 (…) e non avendo esso signor Principe denaro pro mainibus per soddisfare detto signor Domenico di detti ducati 2200, conforme è tenuto, sono venuti a convenzione (…) di volerli liberamente vendere infrascritti due corpi feudali, cioè la difesa del pascolo di Buoninventre sita nel territorio di Caposele juxta li beni della Terra di Laviano, Castelnuovo, lo Bagno, il fiume Termite, lo Vallone, e Strada pubblica, (e) il Bosco di S. Ilarione sito nel detto territorio e pertinenze del feudo di Caposele, juxta li beni di Castelnuovo, ad corpus et non ad mensuram (…) sul quale Bosco di S. Ilarione vi è il peso di far legnare i cittadini et abitanti in S. Andrea a legnare morto e selvatico, col pagamento di annui ducati 25 da farsi per detta Università di S. Andrea… Due anni più tardi, il 12 febbraio 1676, il principe di Piombino e Venosa vende ad Indico Rota la Terra di Caposele senza le tenute di Buoninventre e S. Ilarione, ma con il Feudo nominato Buono in Ventre. Spesso nella vendita da un feudatario all’altro, motivo ricorrente sono i molti debiti accumulati dal venditore. E’ quasi una costante: la famiglia che era così ricca da poter comprare il feudo, nel giro di qualche generazione, si riduce a doverlo vendere per far fronte ai debiti. Accade alla famiglia del principe Ludovisi che vende a de Martino Buoninventre e Sant’Ilarione (1674), accade al barone de Martino che vende tutto a Mirelli (1722), accade al principe Mirelli che vende Buoninventre e Sant’Ilarione a Cappetti (1807, poi Cassitti); accadrà alla famiglia Cassitti che verrà espropriata dai creditori (1874). 6 144 Nel 1722 la famiglia de Martino vende al principe di Teora Mirelli la Terra di Castelnuovo del vallo di Conza, ed il suddetto feudo di Buoninvente, e suo Bosco di S. Ilarione, siti in questo regno di Napoli, nella Provincia di Principato Citra. Il 10 dicembre 1807 si stipula in Napoli l’Istrumento col quale i Mirelli vendono a Don Giuseppe Cappetti di Teora le tenute di Sant’Ilarione e Buoninventre. Per la famiglia Mirelli si costituiscono per vendere Don Giosuè Starace, ministro economico dell’illustre Principe di Teora don Francesco Maria Mirelli (…) con la facoltà di poter alienare gli effetti della casa di detto illustre Principe per togliere debiti vantaggiosi e mettere alla meglio in regola gl’interessi della medesima (…) e l’illustre signor Conte di Conza Don Giuseppe Maria Mirelli figlio di esso Principe Don Francesco Maria, emancipato e sciolto dalla patria potestà, ben anche in questa città di Napoli, li quali in solidum aggono ed intervengono alle cose infrascritte (…). Dall’altra parte acquista il signor Giuseppe Carelli figlio di Don Nicola Felice, procuratore di Don Giuseppe Cappetti della Terra di Teora in provincia di Principato Citra. La consistenza delle due tenute è fatta misurare dal perito Pietro Schioppa, Tavolario del Sacro Consiglio, che in Napoli il 16 novembre 1807 così attesta a Giosuè Starace che gli ha conferito l’incarico: Avendo Vostra Signoria deliberato di devenire all’alienazione delle due tenute boscose di S. Ilarione e Buoninventre colli territorii adiacenti che l’illustre Principe di Teora possiede in tenimento della Terra di Caposele, situata in provincia di Salerno per indi col prezzo di esse soddisfare taluni creditori di detta illustre famiglia; stimò espediente (…) commetterne la ricognizione a me sottoscritto. Oggetto della compravendita sono le due tenute ex feudali e di natura boscose con territorii lavoratorii adjacenti nelle pertinenze di Caposele denominate Sant’Ilarione e Buoninventre (…) quelle stesse tenute che come feudali et in capite a Regia Curia a 10 maggio 1722 acquistò la fu illustre Principessa di Teora… La relazione del tavolario Schioppa inizia con la descrizione del viaggio da Napoli a Caposele: Per esecuzione di un tal venerato incarico nel dì 12 dello scorso mese di ottobre partii da questa capitale e facendo dimora nella sera di quel dì nella città di Salerno, e nella sera del dì susseguente nella Terra di Valva, percorrendo sempre la strada nuova rotabile e propriamente quella che conduce alla città di Matera, nel dì 14 con cavalcatura mi condussi nel collegio dei RR. PP. Missionari di Mater Domini che mi fu additato per luogo di residenza, ed ivi, per dar principio al disimpegno, prescelsi due periti compassatori uno della Terra di Pescopagano nominato Don Marco Masini, l’altro 145 della Terra di Teora per nome Pasquale Ferraro, e dippiù chiamai due periti di campagna cioè Pietro Salandra e Giovan Battista Carluccio entrambi della Terra di S. Menna. La relazione così prosegue: Nel susseguente giorno poi 15 mi conferii nelle prefate tenute, e colà con i nominati periti e compassatori cominciai a praticare quelle operazioni ed esami che convenivano, in modo che fattasi l’ora tarda, conoscendo più lungo e disagevole il ritorno a Mater Domini, mi ritirai nel convento dei RR. PP. Cappuccini di S. Menna… Quanto alla descrizione e misura delle due tenute, il tavolario così scrive: Le medesime abbenché contenghino due differenti denominazioni come sopra spiegate, pur nondimeno formano una sola estensione di fondo, del quale la sua generale situazione osservasi disposta tutta montuosa con avvallati di tratto in tratto, riponi impraticabili, e con molte e diverse partite di superficie quasi piana nelle parti intermedie. In essa si distingue per Buoninventre quella porzione di detto fondo che resta inferiore al medesimo e propriamente nel lato meridionale, giacché all’opposto chiamasi tenuta di S. Ilarione l’altra porzione che resta nella parte superiore del fondo stesso, e con l’aspetto a settentrione, avvertendo che le denominazioni di sopra marcate nelle tenute riferite provengono dai boschi che nell’una e nell’altra si contengono, ed in tal modo nominati. Generalmente parlando un siffatto fondo comprende li due accennati boschi nei suoi estremi con piante di cerri e querce che producono la ghianda e nelle parti intermedie osservasi in parte destinato Castelnuovo oggi con il bosco di Buoninventre (Torretta) e Calabritto sullo sfondo 146 per difesa, e nel dippiiù adatto alla semina di grani, grano d’India, orzi ed avene, particolarmente in quella parte della tenuta inferiore, a motivo dello sboscamento colà da poco avvenuto, soggiungendo in questo luogo che gli alberi del primo di essi boschi nella qualità e dispostezza sono più ragguardevoli del secondo, e che il terreno di difesa nella tenuta superiore è di qualità alquanto più ferace del rimanente. I confini delle due tenute sono così definiti: In riguardo alla sua confinazione è da sapersi che la nominata tenuta inferiore detta Buoninventre dalla parte di mezzogiorno confina col vallone e ponte della Tempeta che di sopra ho marcato, dalla parte di levante con un vallone che intercede tra questo fondo e quello dell’illustre Duca di Laviano con un molino del medesimo Duca, con un terreno di Don Donato Garippo di S. Menna nel locale detto la Canna delle frasche. Dalla parte di ponente confina col vallone Casolaro, che si frappone tra questo fondo ed alcuni territorii lavorantini di pertinenza dell’illustre Principe di Caposele; e finalmente dalla parte di settentrione confina con la tenuta suddetta con altro vallone a traverso di essa. L’altra tenuta poi di S. Ilarione di sopra espressata confina da mezzogiorno col valloncino riferito, da ponente col medesimo vallone Casolaro, a lato del quale vi sono egualmente i simili terreni lavorantini posseduti dall’illustre Principe di Caposele, e che intercede con li terreni di Don Giuseppe Cappetti e Don Vincenzo Fiore nei tenimenti di Conza e Teora, e finalmente dalla parte di levante con i terreni Castelnuovo oggi con il bosco di Sant’Ilarione e la sella di Conza 147 demaniali dell’Università di Castelnuovo e col podere dei magnifici di Castello (nuovo) nel locale detto Serra delle Chianche. Quanto all’estensione l’insieme delle due tenute è misurato in tomole 1831 e passitelli 217. Si contano in Buoninventre 6500 cerri grandi, 415 cerri mezzani, 2750 querce da frutto. Nel bosco detto l’Isca sotto la Tufarella, che è parte di Buoninventre, altri 2500 cerri grandi già marcati per il taglio, 400 cerri piccoli e 100 querce grandi. Nella tenuta superiore di Sant’Ilarione si contano 3750 querce grandi e 1400 mezzane; 6100 cerri grandi e 1700 mezzani. Totale alberi 25615. La valutazione delle tenute ex feudali di Buonivente e Sant’Ilarione tiene conto della strutture agropastorali che vi insistono; così relaziona Schioppa al ministro Storace: Devo inoltre rappresentarle che in servizio di un siffatto fondo nel contenuto del medesimo, e propriamente in quella parte chiamata Buoninventre vi esiste un ben esteso scariaggio e pannizzo che serve per ricetto degli animali che vanno colà a pascolare. Nella parte superiore detta S. Ilarione vi esiste una pila ossia vasca d’acqua perenne che serve per comodo degli animali, meritevole però di essere accomodata, e dippiù ad un lato un casamento di grandezza di palmi 45 per 18 nel locale denominato la pila consistente in due bassi terranei con due stanze sopra e gradetta risaltata. Non si manca di segnalare che nel terratico dell’intera difesa di entrambe le tenute riferite, erano suscettibili di semina soltanto all’incirca tomolate 500, non ostante la situazione alpestre, e la situazione di alcuni siti pietrosa e sassosa. In conclusione della sua relazione il tavolario Schioppa fissa il prezzo: ritiene che resta netto il capital valore delle due divisate tenute di S. Ilarione e Buoninventre, depurato anche del diritto della ricompra, nella somma di ducati 26.042 e grana 80. 3.3 L’uso civico di legnare nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione Nell’Istrumento del 10 dicembre 1807 si precisa che nella vendita sono compresi gli annui ducati 40 che si pagano dall’Università di Castelnuovo per il preteso diritto di legnare al secco e boscoso di dette due tenute ut infra, quatenus (se) un tal diritto alla stessa compete. Ma si aggiunge che trattasi di un diritto non riconosciuto dai Mirelli, i quali hanno istituito un giudizio nel Sacro Regio Consiglio per la libertà delle tenute medesime e quindi danno e concedono al cennato signor Don Giuseppe compratore l’omnimoda facultà di poter il giudizio stesso proseguire, e far dichiarare di non appartenere all’Università di Castelnuovo il preteso diritto di legnare in dette due tenute. 148 Il 17 maggio 1810 la Commissione Feudale, riunita in Napoli definisce il rapporto tra Il Comune di Castelnuovo e l’ex feudatario per quanto riguarda l’uso civico di raccogliere la legna nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione. Ecco il documento: Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e grande Ammiraglio dell’Impero Francese La Suprema Commissione Feudale ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra il Comune di Castelnuovo di Conza patrocinato dal Signor Felice Santangelo e il Principe di Teora patrocinato dal Signor Michele Tonoli. Sul rapporto del Signor Giudice Mertuni. Il Comune di Castelnuovo di Conza ha domandato in Commissione contro il Principe di Teora gli usi di legnare al secco e morto senz’alcuna retribuzione ne’ boschi chiamati S. Ilarione e Boninventre. La Commissione, le parti e il Regio Procuratore Generale intesi, attesocché costa in fatto, che i boschi in quistione sono fuori del tenimento di Castelnuovo. Che quindi gli abitanti di questo Comune non possono godervi, che i diritti acquisiti per convenzione. Considerando che il Feudatario non disconviene degli usi accordati su’ due boschi, sotto la prestazione annua di ducati quaranta. Ma che s’è chiaro che gli usi sono convenuti per effetto d’una prestazione; non è evidente che quella prestazione sia di ducati quaranta come il feudatario assume. Confrontando anzi la partita di ducati 70 che il Comune portò in debito tanto nello stato di Tappia del 1627, che nello stato discusso del 1785 per zecca, taglio di bosco, e portolania col relevio del 1679 si ha che Gioacchino Murat, re di Napoli 149 la bagliva, e zecca erano stimati in rendita per ducati quaranta, ciocché fa che la prestazione convenuta per l’uso ne’ boschi si riduce a ducati trenta. Che perciò è caso di definire la somma fissa che il Comune seguirà a corrispondere per conservare gli usi riclamati. Dichiara Che segua il Comune di Castelnuovo di Conza a godere degli usi di legnare al secco, e morto ne’ boschi chiamati S. Ilarione, e Boninventre sotto la prestazione fissa di ducati trenta annui a favore del Feudatario. Il Comune di Castelnuovo solleva però due eccezioni a questa decisione: 1. Che il diritto dei castelnuovesi a raccogliere la legna nei due boschi non deve essere limitato “al secco e morto” ma deve estendersi altresì al selvaggio ed al verde; 2. Che erano terreni demaniali, e quindi devono tornare al Comune, il bosco denominato il Pantano Magno con i terreni ridotti a coltura chiamati li Macchioni e Pianelli, ingiustamente occupati dai feudatari e compresi nella vendita da Mirelli a Cappetti del 1807. Avanza perciò alla Commissione Feudale le due osservazioni con richiesta di rivedere la decisione del 17 maggio. La Commissione risponde il 29 agosto 1810 ribadendo la primitiva decisione circa gli usi civici e demanda alla giurisdizione ordinaria la competenza sulla denunziata usurpazione di fondi demaniali. In merito agli usi civici (che devono essere liquidati) con ordinanza del 3 agosto 1811 il Commissario ripartitore, Paolo Giampaolo, li valuta in Ducati 2181,60 ed ordina che dai boschi di Buoninventre e S. Ilarione sia ritagliata, nella parte prossima all’abitato, una porzione di terreno corrispondente al detto valore da trasferire in piena proprietà al Comune, quale compenso degli usi medesimi. Ne segue che l’11 ottobre 1811, in esecuzione dell’ordinanza, i periti effettuano il distacco (la riseca) di moggia 31 e ½ sul bosco di basso detto Beninventre tutti arborati di cerri e querce. Con successiva ordinanza di Giampaolo del 13 novembre 1811 viene approvato il distacco a favore del Comune di Castelnuovo. Il Comune però non dà seguito agli atti di Giampaolo (di fatto non li riconosce) ed i castelnuovesi continuano ad esercitare il diritto di fare legna nei boschi di Sant’Ilarione e Buoninventre. In effetti ai castelnuovesi non giovano alcune tomola di terreno, magari da rendere coltivabili: quello di cui gli abitanti hanno assoluta necessità è la possibilità di rifornirsi di legna, avere cioè garantito il diritto al fuoco. 150 3.4 L’azione legale per ottenere la restituzione dei fondi usurpati Quanto all’usurpazione, il 20 dicembre 1810 il sindaco di Castelnuovo, Vincenzo Cozzarelli, dà notizia al decurionato7 (corrispondente all’attuale consiglio comunale) di una lettera dell’Intendente del 12 Dicembre 1810, colla quale mi fa sapere d’essersi osservato da quel Consiglio d’Intendenza l’allegazione in istampa, e le carte colla medesima annesse per la lite verso dell’usurpazione del Demanio di questo Comune detto Pantano Magno, Serro, e Pianello, fatta dall’ex Barone, come pure la sentenza della Commissione Feudale, che disse eseguirsi la sentenza emanata sotto del dì 17 maggio in riguardo al legnare, ma in riguardo all’usurpazione del detto Demanio resta a questo Comune il dritto di vedersela presso del Giudice competente, onde come ci sono in atti, carte, ed Istromenti a nostro favore, così speriamo averne buoni esiti da detta causa. Il sindaco propone di individuare il modo ed i mezzi accessorij per sostenere la lite davanti al Tribunale di Salerno, al fine di ritornare in possesso dei fondi demaniali Pantano Magno, Serro e Pianello usurpati dai baroni, giacché solo docati cinquanta sonosi lasciati per le liti nel Budjet del venturo anno 1811. Il decurionato, vista e ben intesa la proposta del sindaco, delibera di accedere ad un prestito rinviandone l’esazione sui cittadini di Castelnuovo all’agosto dell’anno successivo, tempo in cui ogni particolare cittadino può pagare stante l’introito, o sia scogna de’ generi che da ogn’uno si fa in detto mese. E’ significativa la motivazione che l’assemblea cittadina pone alla base della decisione di avviare l’azione legale: il Popolo intiero esclama, e vuole assolutamente che si faccia il detto litigio, conoscendo il danno, che apporta ora l’usurpazione di tal Demanio, ed il vantaggio, che ne può avere, e tutti vogliono pagare qualunque danaro, ma come in questi mesi non sono tutti in stato di poter cacciare danaro, così ad Agosto ogn’un può, e deve pagare, onde si faccia tutto ciò presente al Sig. Intendente per darci il suo beneplacito8. La guerra del fuoco è acclamata e finanziata dai cittadini di Castelnuovo, disposti a privarsi di una parte del raccolto pur di conservare il diritto alla legna. Tra le carte osservate dal Consiglio d’Intendenza, che a dicembre 1810 suggerisce al Comune di Castelnuovo di I Decurioni sono: Pasquale Iannuzzelli, Lorenzo Di Ruggiero, Arcangelo Iannuzzelli, Francesco Pugliese, Orazio Rosania, Lorenzo Annicchiarico, Antonio Pacillo, Giuseppe Nicola Turi; il Cancelliere è Vincenzo Di Donato. 8 Deliberazione del 20 dicembre 1810, Archivio di Stato di Salerno, Atti Demaniali. Come tutti i documenti successivamente citati. 7 151 esperire la giustizia ordinaria per rivendicare i fondi usurpati, l’allegazione in istampa è una memoria a firma Raffaele Volpicelli, datata Napoli 21 agosto 1810 con la quale si richiamano alcuni atti per dimostrare essere il diritto di legnare nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione non limitato al secco e morto, ma esteso altresì al verde e selvaggio. Con la stessa memoria si fa riferimento ad alcuni documenti per dimostrare l’usurpazione dei fondi demaniali, da esibire in giudizio. In proposito Raffaele Volpicelli richiama un Istromento stipulato il 1° Aprile 1557 tra il Comune di Castelnuovo col Possessore di allora Gio:Antonio Carafa, nel quale si enuncia che l’Università possedendo il cennato Bosco denominato il Pantano di Castelnuovo suo demaniale, e volendo tutto, o parte del medesimo, così il piano, come il monte ridurre a coltura, e volendo col Possessore Carafa amichevolmente procedere, si devenne alla seguente convenzione, mediante la quale l’Università si obbligò corrispondere al Possessore annui ducati 18 ratione forsan competendi juris pascendi, pernocticandi, aquandi, terraticandi, seu exigere terragium seu quolibet alio jure quomodolibet spectante, et competente, seu competituro, et de futuro, et presenti. La memoria di Volpicelli assume che il Possessore Carafa all’incontro (per parte sua) rifiutò e rinunciò (trasferì) all’Università di Castelnuovo, e suoi Cittadini ogni dritto su detto bosco, anzi con patto espresso fu stabilito, che volendo detta Universitò cacciare, seu roncare, etiam coltivare per l’avvenire la Montagna dove si dice li Pianelli, et dove si dice li Macchiuni, e altre parte, che possa liberamente fare coltivare dette parte absque metu (senza timore), et periculo di terraticare, e pascere nelli modi, e qualità sopra menzionati… Volpicelli commenta anche le parti citate dell’atto notarile del 1° aprile 1557: Da tal istrumento dunque chiaramente raccogliesi, che il Bosco del Pantano era di pertinenza dell’Università, e suo demaniale, e perché col ridursi a coltura veniva il Possessore a privarsi del diritto di pascere che godeva come primo Cittadino, perciò l’Università si obbligò corrispondere al medesimo annui ducati 18 ad oggetto di esimere il suo fondo demaniale da tal servitù, e di poterlo tutto, o parte ridurre a coltura. Infine il Volpicelli asserisce che con altro istrumento poi stipolato a 7 Febraro 1570 la stessa Università di Castelnuovo dà in fitto al Possessore medesimo Gio:Antonio Carafa il mentovato Bosco, seu Pantano magno suo demaniale per anni nove, pel convenuto estaglio di ducati 118. Vengono richiamati, nella memoria Volpicelli a sostegno della vertenza per i fondi usurpati, altri documenti che poi saranno alla base del giudizio 152 davanti alla magistratura ordinaria, giudizio che si concluderà, dopo oltre settanta anni, con l’attribuzione al Comune di Castelnuovo di Conza della tenuta denominata Torretta. Gli altri documenti sono l’atto notarile dell’11 novembre 1557 tra alcuni cittadini col possessore (il barone Antonio Silvio) nel quale vengono descritti i confini di Castelnuovo, l’atto notarile del 1674 con cui il principe di Piombino vende a de Martino le due tenute boscose di S. Ilarione e Buoninventre, lo stato del reggente Tappia del 1627 e l’atto di vendita del 1807 dal principe Mirelli a Giuseppe Cappetti. Si tratta di documenti tutti riferiti a Castelnuovo di Conza, alcuni dei quali abbiamo già incontrato in questo libro, e che incontreremo più avanti. L’atto notarile del 1° aprile 1557, invece, non si riferisce a Castelnuovo di Conza. Per il semplice fatto che Giovanni Antonio Carafa non è barone di Castelnuovo di Conza. L’Istromento stipulato il 1 Aprile 1557 tra il Comune di Castelnuovo col Possessore di allora Gio:Antonio Carafa potrebbe, invece, riferirsi a Castelnuovo Cilento. Sul piano storico nulla cambia. La titolarità della comunità di Castelnuovo di Conza sui boschi in contestazione con possessori ed ex feudatari derivava da una sorta di diritto naturale a disporre dei beni essenziali alla vita e alla sopravvivenza. Va capovolto il ragionamento: piuttosto i baroni avrebbero dovuto dimostrare su quali basi legali si fondavano i loro possedimenti, il loro dominio e la loro prepotenza. Non le carte ammuffite dal tempo, ma la storia ce lo dice, ed in modo chiaro: è il sovrano (sia esso normanno, svevo, angioino, aragonese, spagnolo) che di volta in volta si impadronisce del regno di Napoli a graziosamente donare ai suoi seguaci più valorosi e fidati pezzi del territorio conquistato, città, paesi e campagne, insieme a tutti gli uomini e le donne che in quel territorio vivono. E’ la natura del sistema feudale. Che però finisce con la rivoluzione francese e, nel regno di Napoli, con le leggi eversive di Giuseppe Bonaparte del 1806. La guerra del fuoco, condotta per quasi un secolo dai castelnuovesi, non è affatto sminuita se a fondamento della battaglia giudiziaria viene prodotto (anche) un documento non pertinente. Abbiamo visto la decisione del Decurionato del 20 dicembre 1810 di avviare l’azione legale. Con una successiva delibera del Comune di Castelnuovo di Conza del 5 agosto 1811 viene ribadita la decisone di muovere causa presso il Tribunale di Salerno, per la reintegra de’ locali detti Pantano Magno, Macchione e Pianello usurparpati a questa Comune dall’ex feudatarij e per 153 obbligare gli possessori, e gli ex feudatarij alla restituzione di detti locali, una con gli frutti dal tempo dell’usurpazione ed il 31 agosto successivo si procede a nominare per avvocato il Sig. Matteo Iovale di Cava, e per Patrocinatore, il Sig. Vito Antonio Iovane della stessa, essendo questi persone di gran talento, cognizione, ed onestà. Il Consiglio d’Intendenza il 27 settembre 1811 autorizza il Comune di Castelnuovo a fare il litigio in codesto Tribunale Civile col possessore de Boschi Signora Emilia Cappetta, per la rivindica dell’istessi. Passano sette anni perché, come scrive il sindaco Donato Di Domenico il 6 aprile 1818, la controversia si è trattenuto a causa che Don Romualdo Cassitti marito di detta Donna Emilia Cappetta voleva fare l’accomodo con questo Comune, e ci ha fatto stare nel pacifico possesso di legnare ne’ detti boschi. Ma il possessore ora ci ha impedito nel diritto, e vuole incidere gli arbori ivi esistenti vendendoseli, e questo Comune andrebbe a perire per la mancanza della legna, e perciò il sindaco chiede al Sig. Intendente autorizzarci di poter spendere pel proseguimento di tal litigio, non solo gli ducati quindici lasciati nello stato corrente, ma anche gli ducati cinquanta lasciati nello stato dello scorso anno 1817, a tal’uopo. 3.5 La prima sentenza del Tribunale La guerra del fuoco, sopita sotto le ceneri per sette anni, si riaccende quando Cassitti vuole far tagliare gli alberi, e materialmente privare della legna i castelnuovesi. Si arriva così, dopo tre anni e sulla base della documentazione della memoria Volpicelli, alla prima pronunzia giurisdizionale sulla materia. Il 14 marzo 1821 si esprime il Tribunale Civile di Principato Citra, in Salerno. La sentenza è emessa in nome di Ferdinando primo, per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme ed Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana. Attore è la Comune di Castelnuovo di Conza, rappresentata dal suo attual Sindaco Don Francesco Ricciulli. Convenuti sono Don Romualdo Cassitti, nonché il Principe di Teora Don Giuseppe Maria Mirelli, entrambi però non comparenti. La causa si svolge, cioè, in assenza della controparte. Il Tribunale non decide nel merito della questione, ma pronunziando interlocutoriamente, dà atto della contumacia di Cassitti e Mirelli, e prima di giudicare sul merito della dimanda di essa Comune ordina che si proceda ad una relazione di Periti da eseguirsi da Don Gaetano Forte e Don Raffaele Pannaini Tavolarj di Salerno che il Tribunale 154 nomina di officio e dal Sig. Giovanni Colajacono di Laviano i quali dopo che avranno prestato il giuramento nelle mani del Giudice del Circondario di Laviano, che delega a tal’effetto, si recheranno sulla faccia dei Luoghi in controversia, e tenendo presenti gli Istromenti degli primo Aprile 1557, sette Febbrajo 1570 e sei Luglio 1674 certificheranno: 1.Confini antichi e nuovi del Territorio di Castelnuovo e con distinzione quelli dei locali in contesa Pantano Magno, Pianelli e Macchioni, come pure confini antichi e nuovi delle suddette due tenute ex Feudali Sant’Ilarione e Buoninventre. 2. Quale di queste due tenute attacca col Territorio di Castelnuovo e da quale e per quanta parte. 3. Lo stato attuale così dei suddetti Pantano Magno, Macchioni e Pianelli, che delle tenute Sant’Ilarione e Buoninventre. 4. L’estensione antica di tali tenute e l’estensione attuale delle medesime. 5.Infine di quanto si sono estese dette tenute ex Feudali dallo stato di loro antica confinazione e dove trovansi attualmente compresi i locali suddetti Pantano Magno, Macchioni e Pianelli. E’ il 1821, Ferdinando I di Borbone è (per poco ancora) re costituzionale, la sentenza del Tribunale di Salerno è interlocutoria. Tanto interlocutoria che dovranno passare cinquantaquattro anni, tre altri re Borbone, l’impresa di Garibaldi e l’Unità d’Italia per arrivare, sotto il regno di Vittorio Emanuele II, il 24 maggio 1875, alla decisione di merito, in primo grado di giudizio, emessa dal Tribunale Civile di Salerno. Nel frattempo la guerra del fuoco non si spegne; al contrario ogni occasione è buona per ravvivarne le fiamme. La nuova legge forestale del 21 agosto 1826 istituisce una Direzione Generale Forestale con organi provinciali retti da soprintendenti, che hanno alle dipendenze sottointendenti e guardie generali. Alla custodia dei boschi del regno delle due Sicilie sono addetti dieci brigadieri e 50 guardie forestali; si istituiscono anche delle brigate mobili di guardie forestali a cavallo, ciascuna composta da un brigadiere e tre o quattro guardie. Essa distingue i boschi in statali, comunali, di altri enti, e dei privati. Per i boschi di proprietà comunale o di enti morali la sorveglianza viene esercitata da guardaboschi nominati dagli intendenti, su proposta dei rispettivi amministratori, e dietro autorizzazione del Ministero della polizia. Brigadieri, guardie forestali e guardaboschi sono tenuti a vestire le prescritte uniformi ed hanno facoltà di procedere ad arresti e alla traduzione davanti al magistrato di coloro che si rendano colpevoli di 155 reati. La nuova legge sancisce anche che chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque nei boschi tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi o traendone resina sarà punito con un’ammenda uguale al danno o con la prigionia. Questa legge è occasione per una solenne dichiarazione del Comune di Castelnuovo. Eccola: L’anno 1827 il giorno 11 Gennaio in Castelnuovo. In esecuzione della nuova Legge Forestale de’ 21 Agosto ultimo a N° 77 – Noi qui sottoscritti Sindaco e Decurioni del Comune di Castelnuovo di Conza, siamo venuti a dichiarare i nostri diritti di uso legittimamente posseduti ed esercitati da secoli dietro, e da tempo immemorabile, e consistenti fin’ora, e che attualmente si stanno esercitando ne’ boschi denominati S. Ilarione, e Buoninventre in tenimento di questo Comune, sono, il diritto di legnare sul secco, morto e selvaggio su gli alberi di cerro, querce ed altri volgarmente detti Perazzi, Melazzi e Crognali, de’ quali vengono alberati detti boschi di estensione di tomola ottocento circa, e sono detti alberi, chi di alto e chi di basso fusto, e questi sono addetti a pascolo col fitto de’ frutti, e colla fida annuale di animali, di Cittadini e Forestieri. Tali boschi erano anticamente comunali, che poi dagli antichi Baroni furono usurpati per prepotenza ed ora si verte per la revindica di detti boschi nel Tribunale Civile di Salerno ad istanza, e dimanda di questo medesimo Comune, ed a causa di tal usurpazione oggi si usufruttano il Signor Don Romualdo Cassitti di Bonito in Provincia di Avellino, qual erede del fu Don Giuseppe Cappetta di Teora che acquistati avea dal Principe di Teora Signor Mirelli, e Barone di Castelnuovo. Nel passato anno 1825, il citato Signor Cassitti tentato avea d’impedire a questi Cittadini l’esercizio dei citati diritti, cioè di legnare a secco, morto e selvaggio, ma non li riuscì sì perché non avea documenti in contrario, sì anche perché questi Cittadini hanno esercitato tali diritti da tempo immemorabile senza prestazione alcuna né ad esso Signor Cassitti, e né agli Baroni. La dichiarazione è firmata dal Sindaco Donato Del Vecchio e dai Decurioni Erberto Annicchiarico, Vincenzo Pezzuto, Antonio Venutolo, Saverio Turi, Nicola Mastrodomenico, Giovanni Giacomo Rosania. A questo punto, nel 1828, la guerra del fuoco, destinata a protrarsi per ancora più di cinquant’anni, incrocia eventi che si sviluppano a Castelnuovo (ed a Laviano) e che fanno parte di un processo storico che investe il napoletano, l’irpinia e la provincia di Salerno con epicentro il Cilento. La vicenda di alcuni carbonari castelnuovesi finiti in carcere si intreccia con la guerra del fuoco perché è uno dei guardaboschi di Cassitti che denunzia e fa incarcerare i castelnuovesi. E’ il 29 luglio 1828 e negli uffici del Regio Giudice di Laviano è presente Giuseppe Ciliberti figlio del fu Felice Antonio, 156 di San Menna, d’anni sessanta, Guardiano di Boschi e di Tenute. Ciliberti così dichiara a verbale9: Signore, in occasione di essere io Guardiano del Bosco e delle tenute di Don Romualdo Cassitti, che son site nel tenimento della Comune di Castelnuovo, convicino alla mia Patria di S. Menna, avendo dovuto ben spesso praticare per causa di interessi nella medesima Comune di Castelnuovo; ho spesse volte osservato senza ricordarmi le giornate precise, che molti carbonari sotto l’aperto cielo si riunivano nella contrada detta il Pianello luogo spazioso dentro l’abitato di Castelnuovo; tra questi ho veduto e distinto Francesco Ricciulli, il Cancelliere Vincenzo di Donato, un tal Francesco Manziano, e qualche volta il medico Don Francesco Di Donato prima del dì dieci di Giugno, e dopo di tal epoca pur anche (…) debbo supporre, che si parlasse di affari politici, e contro del Governo, poiché tra essi non si immischiavano quelli del Partito del Re, ma la unione vedevasi tra loro soli tutti carbonari. Il guardaboschi di Cassitti, anche se il suo lavoro non ha a che fare con l’abitato di Castelnuovo, dimostra di essere molto bene informato su che cosa succede nella piazza e addirittura conosce gli orientamenti politici dei singoli cittadini. Ma ecco il resto della sua deposizione: circa li diciotto, in diciannove di luglio ultimo intesi raccontar dagli Urbani di Castelnuovo, non ricordandomi bene la giornata, Michele Conte ed Antonio Di Ruggiero, in occasione di avergli incontrati per la strada, che conduce in S. Menna mia Patria, che taluni senza palesarmi il nome, deridendosi de’ fucili, che si avevano comprato, gli dissero le seguenti espressioni: “Li volite tenè assai sti fucili, da qui a un’altra quindicina di giorni avete da vedè”. Queste parole per quanto mi pare, son tutte rivoluzionarie contro del Governo del Re, volendo dimostrare che la rivoluzione doveva essere imminente, ma molto più meglio, Signore, potete informarvi anche da un tal Angiolo Maria Di Martino mio paesano, poiché ho rilevato che mio figlio Nicola Ciliberti nel principio di questo mese, discorrendo col medesimo nella mia casa in S. Menna, senza ricordarmi del giorno preciso, allorché si sentivano varj arresti di settarj, egli mi raccontò, che nel bosco di S. Ilarione un tale Angiolo Maria Di Martino, custode di pecore insieme con mio figlio di pertinenza di Francescantonio Giannini di Barletta, li aveva confidato che Vitantonio Di Geronimo di Castelnuovo nel domandarli se apparteneva alla Guardia Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828 9 157 Urbana, nel dirli di no, li soggiunse con queste espressioni: “e chi sa da qua a quattro altri giorni hai da vedè lo mundo rivoltato”. Essendosi intese in seguito diverse carcerazioni di settarj che tentavano la rivoluzione, considerai che quelle espressioni del Di Geronimo fussero sediziose e rivoluzionarie, e che egli fosse inteso assolutamente di qualche sedizione, e pur che di altri nemici del re, Nostro Signore, avesse egli penetrato qualche movimento di rivoluzione, tanto più che egli è un settario, e tratta con settarj. A Ciliberti vengono chieste anche informazione circa i carbonari di Castelnuovo Ricciulli, Di Donato, Del Duca, Di Majo (di Santomenna), Pugliese, Manziano, Di Geronimo, ed in particolare se sono settarj antichi, oppure del novimestre. Questa è la risposta del guardiano di boschi e di tenute: Signore tutti credo, che siano antichi settarj, poiché nella disfatta costituzione comparivano festeggianti in faccia del pubblico, e specialmente il medico Di Donato, e Don Luigi Di Majo, poiché furono graduati nel Battaglione de Militi. Il verbale dell’interrogatorio non è firmato da Ciliberti, per non saper scrivere. Un analfabeta che però sa bene cosa sono il novimestre, la costituzione e l’ordinamento militare di otto anni prima. E’ del tutto credibile che la deposizione del guardaboschi sia stata concordata col suo padrone Don Romualdo Cassiti, in guerra con Castelnuovo per Buoninventre e Sant’Ilarione. Dopo qualche settimana sono arrestati Vitantonio Di Geronimo, Vincenzo Di Donato, Giuseppe e Luigi Iannuzzelli. Ma questa è materia del capitolo seguente. 158 Capitolo IV La guerra del fuoco - parte seconda (guardaboschi, carbonari, e castelnuovesi carcerati nel 1828) 4.1 I moti del 1820 nel regno delle due Sicilie e la Costituzione Abbiamo appena visto che il 29 luglio 1828 il Regio Giudice di Laviano chiede a Giuseppe Ciliberti, alias Scibbone, guardaboschi di Giovanni Cassitti, se Francesco Ricciulli, Vincenzo Di Donato, Antonino Del Duca, Luigi Di Majo, Fedele Pugliese, Francesco Manziano e Vitantonio Di Geronimo, tutti di Castelnuovo di Conza, salvo Di Majo, sono settarj antichi, oppure del novimestre. Per meglio inquadrare questo interrogatorio dobbiamo leggermente allargare l’orizzonte nello spazio e nel tempo. Per lo spazio occorre considerare quello che accade nelle stesse settimane nel Cilento, e per il tempo dobbiamo andare ad otto anni prima, al 1820 e alla Costituzione, richiesta dai settari della Carboneria e concessa dal re Ferdinando I; Costituzione che resta in vita per nove mesi appena, un novimestre. Il Cilento nel 1828 è teatro di un tentativo di insurrezione, promosso da aderenti alla società segreta dei Filadelfi, avente per obbiettivo la concessione della costituzione francese e la riduzione del prezzo del sale1. E’ un episodio unico nella storia d’Italia di quell’anno; mentre i moti del 1820 nel regno meridionale si inquadrano in un più vasto movimento che parte dalla rivolta di Cadice in Spagna e sono seguiti dai moti del Piemonte e della Grecia del 1821, quanto accade nel 1828 è limitato al Cilento, con riflessi in Irpinia e nel salernitano (ed a Castelnuovo e Laviano). E’ una pagina tragica e nobile della vicenda meridionale che non trova spazio nei testi scolastici, e che un coraggioso scrittore ed editore cilentano, Giuseppe Galzerano, da anni è impegnato a riportare all’attenzione e alla consapevolezza delle nuove generazioni. Quanto accade nel regno di Napoli otto anni prima, nel 1820, è ampiamente noto. Sulla scia dell’ammutinamento a Cadice dei soldati spagnoli che si rifiutano di partire per il Sudamerica a reprimere la ribellione di quei popoli, alcuni reparti dell’esercito borbonico di stanza a Nola, nella notte 1 Proclama di Palinuro del 28 giugno 1828, Archivio di Stato di Salerno. 159 tra il 1° e il 2 luglio, guidati dai sottotenenti Michele Morelli e Giuseppe Silvati, insorgono e al grido di “Viva Dio, Re, Costituzione” marciano, con una ventina di settari guidati dal prete-carbonaro Luigi Menichini, su Avellino. Ben presto lo spirito costituzionale, ampiamente diffuso dalla Carboneria, si propaga pressoché a tutto l’esercito fino alle più alte sfere. Il generale Guglielmo Pepe, che dovrebbe fermare gli insorti, fa causa comune con i rivoluzionari, l’entusiasmo popolare è alle stelle. Il prete-carbonaro Menichini con gli insorti Lo storico (e militare egli stesso, già generale murattiano) Pietro Colletta così racconta le ore decisive della rivoluzione, che convulsamente si consumano nel palazzo reale di Napoli: Ed allora cinque settari andarono agli appartamenti del re, dicendo scopertamente ai custodi ed alle guardie essere ambasciatori di causa pubblica venuti a parlare col re2. E’ l’una di notte del 6 luglio, in altre circostanze i cinque sarebbero immediatamente arrestati ma, stante l’agitazione popolare, Il Generale carbonaro Guglielmo Pepe Pietro Colletta, Storia del Reame di Napoli, Canton Ticino, 1834; sue sono anche le citazioni che seguono. 2 160 vengono ricevuti dall’assistente del re, il duca d’Ascoli, al quale ingiungono: Siamo delegati per dire al re che la quiete della città non può serbarsi (né si vorrebbe) se Sua Maestà non concede la bramata costituzione. E settari e soldati e cittadini sono in armi, la setta è adunata, tutti attendono, per provvedere ai nostri casi, la risposta del re. La risposta reale non si fa attendere: Sua Maestà, visto il desiderio dei sudditi, avendo già deciso di concedere una costituzione, ora coi suoi ministri ne consulta i termini per pubblicarla. I settari gli danno due ore di tempo, allo scadere delle quali il re emette il seguente editto: Essendosi manifestato il voto generale della nazione del regno delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena nostra volontà consentiamo, e promettiamo nel corso di otto giorni di pubblicarne le basi (…). L’innesto dei motivi costituzionali sulla monarchia borbonica è evidenziato dal tricolore carbonaro (nero, rosso e turchino) che, nelle parate militari, si aggiunge al bianco dello stendardo borbonico. Le stesse principesse reali confezionano i nastri “tricolorati” per le truppe che sfilano. Il tricolore della Carboneria ed il vessillo borbonico appaiati Il 13 luglio il re solennemente giura: Io Ferdinando Borbone, per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia napoletana, re, col nome di Ferdinando I, del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e di sopra i santi Evangeli che difenderò e conserverò… Il 22 luglio sono indette le elezioni per il parlamento napoletano, composto da 72 deputati, che si riunisce per la prima volta il 1° ottobre. Intanto in Sicilia scoppiano moti separatisti che vengono sedati dall’esercito costituzionale napoletano. Ma se per il regno borbonico la costituzione ed un largo consenso potrebbero costituire un’occasione di radicamento3, le potenze della Santa Alleanza non gradiCome fa intendere, falsamente, il vicario figlio di Ferdinando, futuro Francesco I, quando dichiara: Sua Maestà il re, la nazione, noi tutti dobbiamo gratitudine all’esercito costituzionale (…) il trono non era saldo; ora è saldissimo, ché poggia sulle volontà e gli interessi del popolo. 3 161 scono i mutamenti e convocano il re Ferdinando a Lubiana. Originale certamente, forse unica, la rivoluzione napoletana del 1820 che non prodotta da povertà o disperazione, non compagna di delitti, non cagione di danni, lasciando illese le proprietà, la civiltà, le religioni, era solamente un bene scevro di mali, una libertà nuova, facile, innocente4. Tanto bella da sembrare un fiaba, e tanto facilmente cresciuta che, senza le adeguate radici, altrettanto facilmente di lì a poco sarebbe stata spazzata via5. Il parlamento napoletano, diviso e confuso, concede al re di partire, ricevuta l’assicurazione che a Lubiana il sovrano avrebbe sostenuto la causa della costituzione. Invece il Borbone chiede ed ottiene l’intervento militare per riportare l’assolutismo nel regno del sud. Il governo costituzionale prepara le difese nella paradossale situazione di Antodroco 1821, la prima battaglia del Risorgimento uno stato retto dal figlio del re, il quale si appresta a combattere l’esercito mandato dal re padre (il nostro sistema di guerra è difensivo, scrive il reggente principe Francesco ai militari). Ma tant’è; il comando militare dell’esercito costituzionale, diviso tra i generali Carascosa e Pepe, aumenta l’incertezza ed il 7 marzo 1821 il primo impatto con l’armata austriaca, inopinatamente scelto in campo aperto ad Antrodoco, presso Rieti, da Guglielmo Pepe, si risolve in una disfatta, e Pietro Colletta, Storia del Reame di Napoli, Canton Ticino, 1834. Niccolò Machiavelli, Il Principe, capitolo VII (…li stati che vengano subito, come tutte l’altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe e correspondenzie loro in modo, che ‘l primo tempo avverso le spenga…). 4 5 162 per l’armata tedesca è aperta la strada verso Napoli. Gli austriaci sono nella capitale il 24 marzo. Il sogno costituzionale è durato appena nove mesi (il novimestre costituzionale). Ferdinando, che rientra poco dopo, ordina la rappresaglia. Si compongono le Giunte di scrutinio, destinate a verificare la vita di tutti gli ufficiali dello stato e dei più alti e noti cittadini nel corso del novimestre. Il risultato sono centiL’esecuzione di Morelli e Silvati naia di arresti e condanne a morte, poi commutate nel carcere a vita, tranne che per i due sottotenenti Morelli e Silvati i quali vengono impiccati il 22 settembre 1822. 4.2 Il tentativo di rivincita del 1828. I moti del Cilento e la repressione militare Otto anni più tardi, nel 1828, i rivoluzionari tentano la rivincita. La setta dei Filadelfi, attiva nel napoletano, nel salernitano, in Irpinia e nel Cilento, prepara l’insurrezione per ottenere dal re (ora Francesco I, figlio del traditore Ferdinando) la costituzione francese. Pochissimo si sa dei Filadelfi, se non che il nome della setta è preso dall’esperienza francese di fine settecento e che di fatto essa è una quache forma di articolazione o prosecuzione dalla carboneria. Lo storico Francesco Michitelli6 ci dice che la nuova setta 6 Francesco Michitelli, Storia delle rivoluzioni ne’ reami delle due Sicilie, Italia, 1860. 163 sorge a Napoli dopo la carboneria del 1820. Guidata da Luciano Bonaparte, è capeggiata a Napoli dal negoziante Antonio Migliorati, e nel salernitano dal canonico Antonio De Luca, di Celle, ex deputato del parlamento del 1820. In uno dei periodi più tristi del dominio borbonico –annota Matteo Mazziotti7 nella prefazione al suo libro sulla rivolta del Cilento- alcuni modesti borghesi, in massima parte piccoli possidenti, legali, medici e poveri preti di provincia, immaginarono una grande sommossa. Non li trattenne la mancanza di armi, di denaro, di larghe aderenze tra le plebi. I più, vecchi carbonari, testimoni della rivoluzione del 1820 avvenuta quasi in un attimo, come una lieta sorpresa, erano nella falsa credenza che la costituzione del 1820 fosse caduta contro i propositi del re e che il nuovo principe fosse proclive a ristabilirla, sol che un largo movimento l’avesse richiesta. L’ingenua illusione dei congiurati che il nuovo re sia disponibile a concedere la costituzione si accompagna, nell’analisi di Mazziotti, all’ipotesi che –al contrario- i carbonari salernitani cadano in una trappola preparata ad arte dalla polizia borbonica: Questa sollevazione apparve così temeraria che molti la ritennero per lungo tempo provocata ad arte dal governo, per disfarsi di antichi e pertinaci settari8. Mazziotti non fa propria questa ipotesi, che invece è sostenuta dal francese Charles Didier, ed evidenzia come il processo risorgimentale sia punteggiato di tentativi visionari, come quello del 1828: Essi divinarono l’avvenire, perché, a preparare la coscienza popolare per la meravigliosa rivoluzione del 1860, contribuirono prepotentemente quei tentativi, ciascuno dei quali va accuratamente studiato, affinché si possa, raccolto tutto questo materiale prezioso, assorgere ad una storia vera del risorgimento nazionale. Tra i capi della congiura cilentana vi è il canonico Antonio Maria De Luca, che è stato deputato al Parlamento napoletano nel breve periodo costituMatteo Mazziotti, La rivolta del Cilento del 1828 narrata su documenti inediti, RomaMilano, 1906. Il lavoro di Mazziotti è stato ripubblicato nel 1994 dall’editore e storico cilentano Giuseppe Galzerano. 8 Diversi elementi che emergono dal processo Riunioni settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828, istruito a tamburo battente dal 5 giugno al 17 settembre 1828 dal Regio Giudice del Circondario di Laviano Raffaele Passarelli, mostrano come i settari di Laviano, Castelnuovo di Conza e Santomenna, pressoché tutti vecchi sostenitori del movimento costituzionale del 1820, fossero tenuti sotto stretto controllo da più di un anno. Il processo sembra istruito proprio per disfarsi degli antichi e pertinaci settari dell’alto Temete. Nelle carte del processo c’è anche la prova di un tradimento. 7 164 zionale. Aderiscono alla sommossa, che dovrebbe scoppiare il 13 giugno, elementi della carboneria e anche i famosi fratelli Capozzoli, che nel Cilento sono già alla macchia, un po’ per reati comuni, un po’ per odio verso il regime borbonico. Uno dei capi della rivolta, Antonio Galotti, però, il 7 maggio ne confida i segreti ad un tale Carlo Iovine, che scambia per un appartenente all’organizzazione rivoluzionaria. Il risultato è che le autorità borboniche, che già sono sull’avviso, procedono ad una serie di arresti preventivi in tutta l’area del napoletano e del salernitano, e l’insurrezione sfuma. Nel Cilento, tuttavia, il canonico De Luca avvia ugualmente l’azione e nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1828 Antonio Galotti e la banda Capozzoli disarmano le guardie comunali di Centola e si fanno accompagnare nel forte di Palinuro, che assaltano, e dove dovrebbero essere custoditi 1500 fucili, dodici cannoni e abbondanti munizioni; il bottino è invece di pochi moschetti e scarsa polvere da sparo rovinata dall’umidità. Nonostante il deludente inizio, le forze ribelli ottengono l’adesione di nuovi simpatizzanti e sono accolti con entusiasmo in numerose località, e soprattutto a Bosco dove il sindaco fa preparare cinquecento razioni di cibo per i rivoltosi. Il re Francesco I affida al maresciallo Francesco Saverio Del Carretto, già carbonaro e capo di stato maggiore nell’esercito costituzionale di Guglielmo Pepe, l’incarico di stroncare la rivolta. Il 1° luglio 1828 gli insorti, informati che Del Carretto sta marciando contro di loro alla testa di 8.000 soldati, consapevoli della mancanza di risorse necessarie per organizzare la difesa, decidono di sciogliersi. Nonostante la ritirata dei rivoltosi, Del Carretto fa incendiare e poi radere al suolo la cittadina di Bosco, colpevole di aver fornito vettovaglie agli insorti, fa eseguire ventitré condanne a morte e fa esporre le teste tagliate ai Il canonico Antonio De Luca fucilati in varie località della zona. Non essendo riuscito a catturare il canonico De Luca, Del Carretto minaccia di distruggere Celle di Bulgheria, come ha già fatto con Bosco. De Luca, per evitare al proprio paese natale una sorte spaventosa, si costituisce assieme al nipote Giovanni De Luca, anch’egli 165 sacerdote, e ad altri otto insorti. Dopo un processo sommario vengono tutti condannati a morte: gli otto laici fucilati all’alba del 19 luglio 1828; i due religiosi il 24 luglio, dopo una scomunica prontamente emessa dall’arcivescovo di Salerno Camillo Alleva. Il 19 settembre 2011 la Città di Salerno -sindaco Vincenzo De Luca- ha posto questa lapide nella Via a lui intitolata: ANTONIO MARIA DE LUCA TEOLOGO CANONICO PENITENZIERE ED ESAMINATORE SINODALE DELLA CATTEDRALE DI POLICASTRO NACQUE IN CELLE DI BULGHERIA IL 21 OTTOBRE 1764 DEPUTATO AL PARLAMENTO NAPOLETANO DEL 1820 ANIMATORE DEI MOTI CILENTANI ANTICIPO’ IL PENSIERO DI UNITARIA LIBERTA’ IL 24 LUGLIO DEL 1828 FU FUCILATO A SALERNO AL GRIDO DI VIVA LA LIBERTA’ RIPOSA IN SAN PIETRO IN VINCULIS A PORTANOVA LA CITTA’ MEMORE NEL CENTOCINQUANTESIMO ANNO DELL’UNITA’ D’ITALIA A RICORDO POSE Galotti, i Capozzoli e pochi altri riescono a fuggire in Corsica. Ritornati nel Cilento l’anno successivo, i Capozzoli sono arrestati in un conflitto a fuoco e successivamente fucilati nel forte di Palinuro dopo un processo sommario. Galotti dalla Corsica viene consegnato alla polizia borbonica, ma per le proteste dell’opinione pubblica francese, guidate da La Fayette, Francesco I è costretto a liberarlo e farlo tornare in Francia. Ecco come il giornalista francese Charles Didier racconta le barbarie di quei giorni: Il lutto e il terrore regnavano; tutti gli agenti di polizia erano in movimento; i gendarmi coprivano i paesi, le guardie urbane erano sotto le armi, la costernazione nelle famiglie, e la libertà individuale veniva oltraggiata (…) Le prigioni di Vallo erano piene, e ad ogni istante io sentivo le catene di un nuovo prigioniero che passava sotto la mia finestra. Gli abitanti non vi badavano più: ne passavano tanti! Allo scopo di intimidire per il futuro, il governo aveva 166 attuato una raffinata barbarie, che non appartiene al nostro secolo. Tutte le teste recise sul patibolo erano state esposte in gabbie di ferro, in modo che le donne e i bambini avevano sotto i loro occhi le teste sanguinanti dei loro mariti e dei loro padri (…) Vallo della Lucania ha parecchi di questi terIl sindaco di Salerno Vincenzo De Luca rificanti trofei. Ve ne sono in tutti i paesi e persino sul poetico promontorio di Palinuro. Ho visto la testa di un vecchio i cui capelli bianchi macchiati di sangue sventolavano dall’alto del palo su cui era piantata davanti alla sua abitazione9. Lo storico del risorgimento Francesco Michitelli racconta come il maresciallo Del Carretto, prima di ritornare a Napoli a rassegnare i poteri eccezionali che il re gli aveva conferito, volle lasciar in Palinuro e in altri comuni del Vallo memorie ferali di membra umane recise e depezzate sui patiboli e teste rotte da soldatesche, palle, messe in cima a muri, torri, e pali in gabbie di ferro a terrore e vista di parenti ed amici10. Questi macabri spettacoli rimarranno in essere fino alla venuta di Garibaldi nel 1860! Giuseppe Galzerano, editore e scrittore egli stesso, mantiene vivo il ricordo di una pagina gloriosa del nostro passato. Sull’argomento ha ripubblicato nel 1994 il libro di Matteo Mazziotti, La rivolta del Cilento nel 1828, e nel 1998 ha dato alle stampe, per la prima volta in italiano, le Memorie di Antonio Galotti. Ne consigliamo vivamente la lettura, e facciamo nostra una riflessione di Galzerano: Tutt’altro che figure mute gli uomini e le donne del 1828! Ancora oggi parlano ai cuori, ai sentimenti e alle coscienze degli 9 Charles Didier, Les Capozzoli et la police napolitaine, Parigi, 1831. Francesco Michitelli, Storia delle rivoluzioni ne’ reami delle due Sicilie, Italia, 1860. 10 167 uomini e delle donne, che in ogni parte del mondo si battono contro l’arroganza e la crudeltà del potere11. Potremmo aggiungere che la libertà e il benessere di cui oggi godiamo sono anche il frutto delle lotte di generazioni di generosi “visionari”, quali furono gli ingenui rivoltosi del 1828. Quella della società segreta (carboneria, massoneria, Filadelfi…) è la forma prevalente di partecipazione ai processi di liberazione nazionale nell’Europa della Restaurazione dopo il Congresso di Vienna del 1815. Fallita tragicamente l’avventura napoleonica, che pure ha esportato le idee e i valori della rivoluzione francese, tornati al potere i vecchi regimi assolutistici, ogni opinione dissonante è proibita e sono le associazioni segrete, le sette, a mantenere in vita la speranza di una libertà da riconquistare, insieme all’affermazione dei più elementari diritti civili, la libertà di pensiero e di espressione, la libertà di associazione, la costituzione. Tra gli animatori delle prime società segrete è il rivoluzionario italiano, poi naturalizzato francese, collaboratore prima di Robespierre e poi, insieme a Babeuf, realizzatore del progetto della Congiura degli Eguali, Filippo Buonarroti. Ma, nel regno delle due Sicilie, le sette sono anche il cruccio principale della occhiuta polizia borbonica, più che mai attenta dopo la parentesi del decennio francese ed i nove mesi del 1820. La rete dei carbonari che programma l’insurrezione per il mese di giu- Giuseppe Galzerano, Le “memorie” di Antonio Galotti, Casalvelino Scalo (Salerno), 1998. 11 168 gno del 1828 è ampia e diffusa in diversi luoghi della Campania, e se quella del Cilento è la pagina più drammatica con la repressione manu militari del maresciallo Del Carretto e le orrende esecuzioni, non mancano episodi che riguardano altre cellule dell’organizzazione settaria, ugualmente pronte ad una insurrezione generale (che non avviene) ed ugualmente improntate ad una utopistica fiducia nell’imminente riscatto. Filippo Buonarroti 4.3 I settari di Castelnuovo e Laviano e l’intreccio con la guerra del fuoco. Gli arresti e la caccia a Ruggiero Gibboni A Castelnuovo di Conza, ai primi di settembre del 1828, vengono arrestati Vitantonio Di Geronimo, Vincenzo Di Donato12 e Luigi Iannuzzelli. I primi due sono accusati di aver diffuso voci allarmanti contro il real governo, il terzo di aver dato ospitalità nella sua casa di Castelnuovo a Don Ruggiero Gibboni di Laviano ricercato dalla polizia, inseguito da un ordine di cattura con l’accusa di aver scritto alcune lettere di contenuto eversivo. Determinante per gli arresti è la delazione del guardaboschi di Romualdo Cassitti, Giuseppe Ciliberti, che riferisce al Regio Giudice di Laviano le voci allarmanti diffuse da Vitantonio Di Geronimo (e chi sa da qua a quattro altri giorni hai da vedè lo mundo rivoltato) e gli sfottò alle guardie urbane di Castelnuovo (li volite tenè assai sti fucili, da qui a un’altra quindicina di giorni avete da vedè). Il quadro generale, tratteggiato nella sintesi degli atti processuali13, è che molti carbonari di Castelnuovo contiI cognomi sono trascritti nella loro forma attuale (con il Di maiuscolo laddove in quell’epoca si usava il di minuscolo) e con la correzione delle non infrequenti deformazioni. 13 Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 12 169 nuamente si son riuniti, nel mese di Maggio, Giugno e Luglio ultimi in un luogo spazioso di quel Comune così detto il Pianello; che questi sono per lo appunto Francesco Ricciulli, Vincenzo Di Donato il Cancelliere Comunale, Fedele Pugliese, Francesco Manziano, il medico Don Francesco Di Donato, Antonio Del Duca; che con questi vedevasi ben spesso Don Luigi Di Majo della convicina Comune di S. Menna; che l’oggetto di questi continui congressi non si è potuto penetrare se egli fusse criminoso, se non che alcuni testimonj intesi nel corso delle indagini opinano di esser punibile l’adunanza in quanto che tra i congregati settarj non vedavasi alcuno, che fusse del partito del Re (Nostro Signore). L’azione del Regio Giudice di Laviano Raffaele Passarelli si avvia il 5 giugno 1828 con la deposizione di un suo uomo incaricato di sorvegliare i carbonari di Laviano e Castelnuovo, ben noti per la loro partecipazione al movimento costituzionale del 1820. La spia è il comandante della Guardia urbana di Laviano che così dichiara a verbale: Signore, dietro Vostro incarico di dover sorvegliare la classe di coloro, che son sospetti al Governo non ho perduto di mira quei carbonari che esistono in questo Comune, e mi è riuscito di osservare che taluni di essi Don Domenico Gibboni cioè, Don Celestino Robertiello, Don Antonio Gibboni, Don Vincenzo Felice Robertiello, Raffaele Porcelli ed altri si raccolgono nelle cantine private; e delle volte vi si trattengono a porte chiuse; che nel primo del corrente (mese) si portarono nel pagliaro di Giuseppe Salandra nelle vicinanze di questo paese, in contrada la fontana, e che ivi mangiarono insieme, e si veggono uniti fuor del solito con maggior entusiasmo. Aggiunge la spia che nel fine di Febbraio ultimo Don Ruggiero Gibboni consegnò in Salerno due lettere ad un tal Giuseppe Trevisano di questo Comune per ricapitarne una a Don Domenico Gibboni, dentro del quale eravene un’altra, che diriggevasi a Don Giovanni Pelosi, che Don Domenico dopo aver letta la sua lettera montò in ira, la ridusse in pezzi, e la gettò nel fuoco, poicchè quella lettera offriva le notizie, che il Governo del re Nostro Signore sarebbe caduto, e finito dopo due altri mesi. Infine, la spia segnala al giudice i carbonari, che si ritrovano in Castelnuovo, e che sono Francesco Di Donato, e Francesco Ricciulli, questi si uniscono con Don Luigi Di Majo di S. Menna in un luogo pubblico di Castelnuovo medesimo. Informato immediatamente della situazione, il Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Salerno dispone che una forza imponente si conferisca in cotesta residenza per eseguire le di lei disposizioni di arresto contro degl’incolpati. Attendiamo poi da lei continui rapporti sullo sviluppo dell’affare, conclude il Procuratore nella lettera a Passarelli del 7 giugno 1828. 170 Alla ricerca di elementi contro i carbonari di Castelnuovo, forte dell’incoraggiamento dei superiori, dopo aver praticato la pista di Laviano, l’11 agosto 1828 il Regio Giudice Passarelli, sulla base della delazione di Giuseppe Ciliberti, guardaboschi di Cassitti, convoca il pastore di Santomenna Angiolo Maria Di Martino, e gli domanda: Sapete, se si siano sparse da alcuno, voci allarmanti contra del Real Governo: ditemi, chi sia l’autore di questa voci, ed in quale luogo le ascoltaste, ed in qual tempo? Ed ecco la risposta: Mi ricordo, che tempo il mese di Giugno già scorso, a circa le ore venti, del giorno, che non mi sovviene, ritrovandomi io a custodire il gregge di pecore, di pertinenza di Francescantonio Giannini di Barletta, nel Bosco detto di Sant’Ilarione, nel tenimento di Castelnuovo di Conza, luogo soggetto a questa Vostra giurisdizione; m’incontrai con Vitantonio Di Geronimo, mio paesano, ed in questa occasione mi domandò, se mi avevano arruolato nella Guardia Urbana di San Menna: allora fu che io gli risposi, di non appartenervi, per esser sempre occupato nella custodia delle pecore, e per esser nella maggior parte dell’anno trattenuto da questo mio mestiere nelle Puglie per il pascolo di questi armenti, poiché vivo con quest’arte, per esser sprovvisto di beni di fortuna: in questo incontro il suddetto Di Geronimo mi soggiunse, con dico con queste espressioni “E chi sa da qua a quattro altri giorni hai da vedè lo munno rivoltato”. A tale proposizione io rispondendogli, che il Re, nostro Signore, era ben fortificato con le Sue Truppe, e che perciò a quest’oggetto Egli aveva ordinato di farsi le Guardie Urbane; allora non parlò più, e se ne andieva. Ed io, signor Giudice, debbo assicurarvi, che restai sorpreso, ed attonito da questo discorso del Di Geronimo; ed immaginai, ch’egli era inteso di qualche mossa, che si macchinava contra del Real Governo. Lo scrupoloso magistrato di Laviano si informa poi presso il pastore circa le idee politiche di Vitantonio Di Geronimo; chiede infatti: Conoscete voi gli andamenti del detto Di Geronimo, e specialmente prima e dopo delle carcerazioni14 seguite in Salerno? La risposta: Niente mi consta di quanto mi domandate: solamente posso dirvi, per quanto ho inteso, che lo stesso Di Geronimo sia stato un settario antico. Ed altro non so15. Tanto basta a Raffaele Passarelli Giudice Regio del Circondario di Laviano, e per Vitantonio Di Geronimo si aprono le porte del carcere. Il riferimento è agli arresti preventivi operati nel maggio a Salerno con la scoperta della progettata insurrezione. 15 Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 14 171 Ecco il documento dell’arresto: Processo verbale per costare l’arresto eseguito in persona di Vitantonio Di Geronimo del Comune di Castelnuovo, imputato di voci allarmanti sparse contro del Real Governo. Oggi, che sono li due del mese di Settembre anno 1828 verso le ore dodici in Castelnuovo Noi Domenico Rocco Caporale e Gendarmi qui sottonotati tutti della suddetta Brigata previo mandato di arresto spedito dal Signor Regio Giudice di questo Circondario in data del primo settembre corrente anno a carico di Vitantonio Di Geronimo imputato come sopra, praticando delle più accurate ricerche, ci è riuscito rinvenirlo nel luogo detto San Angelo di detto Comune, ed avendoci fatto lettura di detto mandato di cui noi eravamo in carricati (sic!) in nome del Re (D.G.)16 l’abbiamo arrestato, e tradotto in queste prigioni lasciandolo a disposizione del detto Giudice per l’uso conveniente17. Il detenuto viene tradotto a Campagna, al cospetto del Giudice Istruttore, il quale però in data 6 Settembre 1828 così si rivolge al collega di Laviano: Signore, è arrivato in queste prigioni il detenuto Vitantonio Di Geronimo del Comune di Castelnuovo. Il reato di voci allarmanti contro il Real Governo mi è del tutto nuovo. Mi dirà dunque l’occorrente distintamente e subito, e tutto ciò che è praticato sull’oggetto18. Il meccanismo dello zelante giudice di Laviano è lo stesso anche nei confronti di Vincenzo Di Donato, cancelliere comunale di Castelnuovo, noto carbonaro. Il 3 settembre viene interrogato un componente della guardia urbana, al quale si rivolge la solita domanda: Siete voi informato delle voci allarmanti, e sediziose contra del Real Governo sparse nella vostra Patria nel mese di luglio scorso, potete manifestarne gli autori? Ed ecco la risposta: Signore su di quanto mi dimandate posso assicurarvi, che Francesco Di Donato giovane di circa venti anni, essendo stato ricevuto nella Guardia urbana di Castelnuovo volle comprarsi il fucile; fu perciò a diciannove luglio ultimo gravemente ripreso dal Padre il Cancelliere Comunale Vincenzo Di Donato, lascandosi uscir di bocca in mia presenza questa espressione: “Lasciate andar su chiatarulo (che significa fucile, nota del verbalizzante) che qua a quattro giorni che avete da vedè”, espressioni significanti, voD.G. sta per Dio Guardi; è formula usata nei documenti ufficiali ogni qualvolta si fa riferimento al re. 17 Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 18 Ibidem. 16 172 lendo intendere a parer mio, che la rivoluzione sarebbe stata imminente e il Regio Governo sarebbe finito; e questa è la verità19. Poteva essere notorio che il cancelliere comunale Vincenzo Di Donato appartenesse alla carboneria, probabilmente era uno dei capi della vendita castelnuovese, ma soltanto un arido burocrate quale il giudice di Laviano, preteso dotto e fine giurista, introduttore nel codice borbonico di nuove figure di reato, sicuramente ignorante del nostro dialetto, poteva non cogliere la bonaria ironia e lo sfottò nelle parole dell’anziano padre che degrada il fucile pomposamente ostentato dal giovane figlio ad inoffensivo iatarulo (soffiatoio, da iato, fiato) utile per ravvivare il fuoco, ma poco più che un giocattolo nelle mani inesperte della nuova guardia urbana. Giudice privo di ironia ma feroce persecutore di carbonari: paragonare il fucile allo iatarulo è grave indizio di colpevolezza e così il 4 settembre 1828 Passarelli emette l’ordine di cattura: Considerando, che gli indizj raccolti convingono il Magistrato sulle voci allarmanti contro il Real Governo, di cui viene imputato Don Vincenzo Di Donato di Castelnuovo, Visto l’articolo 104 del Codice di Procedura Penale (…) Ordiniamo e Comandiamo alla Gendarmeria, a ogni altro Depositario della Forza Pubblica di arrestarsi Don Vincenzo Di Donato di Castelnuovo, e di tradurlo innanzi a Noi per esser subito interrogato20. Sfottere le guardie urbane che si erano dotate di nuovi fucili doveva però essere a Castelnuovo usanza piuttosto diffusa e non limitata al cancelliere Di Donato, stando a quest’altra testimonianza: Signore su di quanto mi domandate debbo dichiararvi che circa otto giorni in dietro non ricordandomi il giorno preciso, essendomi incontrato con i due miei paesani Michele Conte ed Antonio Di Ruggiero Guardie Urbane, poiché ambedue si sono provveduti dei rispettivi fucili di ottima qualità, mi han confidato con dispiacere, come Realisti, di esserli detto da taluni, de’ quali non mi palesarono il nome, queste espressioni: “Li vulite tene’ assai sti fucili, da qui a un altra quindicina di giorni avete da vedè”. Immancabile, anche in questo caso, la richiesta del giudice al testimone di fornire la valutazione politica delle circostanze dedotte, ed il testimone ritiene che: tutte tendono a far supporre la prossima caduta del Regio Governo, però potete meglio informarvi dalli suddetti Conte e Di Ruggiero, poiché questi ancor aggiungevano che queste voci abbiano potuto uscire dal palazzo del PrinArchivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 20 Ibidem. 19 173 cipe in Castelnuovo, conforme anche mi assicurò Giuseppe Giliberti21 alias Scibbone della Comune di S. Menna circa otto giorni in dietro, poiché nel Palazzo medesimo mi soggiunse il Giliberti con gli stessi Conte, e Di Ruggiero, di avervi veduto entrare taluni di S. Menna, locale che si custodisce da Vitantonio Di Geronimo mio Paesano, anche uomo sospetto settario effervescente nel tempo della costituzione, tanto che è sempre unito con settarij22. Per il cancelliere Di Donato è già in piedi un processo per supposti reati comuni: l’accusa rivoltagli è di aver falsificato la firma del sindaco di Castelnuovo su una richiesta al sottointendente per il rilascio della carta di sicurezza a Francesco Ricciulli (in pratica il passaporto) per recarsi in provincia di Avellino; nonché su un mandato di pagamento a sé medesimo di dieci carlini per spese di scrittojo; modestissima somma, peraltro dovuta al Di Donato. Entrambe le accuse sono mosse nel mese di luglio 1828 ad un soggetto notoriamente schierato dalla parte dei carbonari, come anche appartenente alla setta è Francesco Ricciulli (si ritrovano entrambi tra i congregati settarj del Pianello). Naturalmente anche il Ricciulli è gettato in carcere. I due chiederanno di essere presto condotti davanti alla Gran Corte Criminale di Salerno e, dietro la garanzia di venti ducati ciascuno, sotto la “tutela” del castelnuovese Nicola Iannuzzelli di Lorenzo, potranno attendere il giudizio fuori dalla prigione. Allo scopo il garante Iannuzzelli deve produrre lo stato patrimoniale; e dall’estratto catastale risulta essere proprietario di due mulini in località Pisciolo23, insieme a due orti in località S. Angelo24 e ad un orto al Pisciolo, un seminato ai Marzi, alcuni fabbricati al Serrone e a San Nicola, una vigna a Carrara della botte, per una rendita complessiva di ducati 75. La maggior parte della rendita, 50 ducati, deriva dai due mulini al Pisciolo. Quanto al terzo castelnuovese arrestato, Luigi Iannuzzelli, l’accusa nei suoi confronti è di aver accolto in casa sua Don Ruggiero Gibboni di Laviano. Gli sbirri alla ricerca del Gibboni piombano in Castelnuovo e danno l’assedio alla casa di Iannuzzelli ma arrivano tardi. Non trovando gli adulti E’ il Guardiano del Bosco e delle tenute di Don Romualdo Cassitti. Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 23 Sono i mulini a ripresa studiati e descritti da Onidia Ciriello, in: Francesco Di Geronimo, Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’…, Fisciano (Salerno), 2010. 24 Oggi è la Via S. Angelo, sotto Lu Chianieddh’. 21 22 174 prendono un ragazzo di sedici anni, Giuseppe Iannuzzelli, fratello di Luigi e lo portano davanti al Regio Giudice del Circondario di Laviano. Nel verbale dell’interrogatorio del 4 settembre 1828, il ragazzo è così descritto: Statura bassa, corporatura robusta, viso regolare, ed olivastro, imberbe, un poco offeso dal vaiolo, occhi, e capelli castagni, bocca grande, mento rotondo, naso grosso, di anni sedici. Il giudice Passarelli gli domanda: Qual è Mulino a ripresa sul torrente Pisciolo il vostro nome, cognome, Patria, Padre, età, condizione? Quello risponde: Mi chiamo Giuseppe Iannuzzelli del fu Erberto di anni sedici, bracciale di Castelnuovo, ove domicilio. Poi il capolavoro, il giudice chiede al ragazzo: Sapete lo oggetto della vostra convocazione? E quello risponde: Signore, nella notte del primo del corrente (mese) essendo stata assediata la casa di mio fratello Luigi Iannuzzelli di Castelnuovo dalla Forza Pubblica per arrestarsi Don Ruggiero Gibboni, che si diceva essersi ivi tenuto di nascosto da mio fratello suddetto, poiché non fu rinvenuto, né si trovò anche lo stesso mio fratello Luigi, il Capo Urbano di Castelnuovo volle ingiustamente arrestarmi, senza considerarsi, che io vivo separatamente dallo stesso mio fratello in altra casa di abitazione con mia madre solamente Maria Torsiello. So per altro, per la pubblica voce, che corre in Castelnuovo, che il detto mio fratello abbia rifuggiato lo stesso Gibbone, ma non so in qual luogo, e lo abbia dato da mangiare, e so anche, come anche pubblicamente si è detto dalla maggior 175 parte della gente, che Vincenzo Ricciulli mio paesano sia stato quello il quale lo abbia fatto venire in Castelnuovo, ed avesse incaricato mio fratello a tenerlo occultato. Dunque, Signor Giudice io di niente son colpevole: e questa è la verità. Alla fine, tanto per non sbagliare, che fa il giudice Passarelli? Lettura data al dichiarante l’ha confermata, e non sapendo scrivere, abbiamo sottoscritto noi solamente col nostro Cancelliere; quindi abbiamo ordinato di tradursi in carcere, e di ritenersi a disposizione de’ Magistrati Supremi25. Ed i Magistrati Supremi si attivano in tutta fretta per difendere l’ordine e la sicurezza del regno borbonico dal pericoloso adolescente castelnuovese, che porta su di sé i segni del vaiolo. Anche se il Giudice Istruttore di Campagna26, in data 12 settembre, ha disposto la escarcerazione del giovane Iannuzzelli laddove non riceverà ordini diversi dal Signor Procuratore Generale del Re, puntualmente, il 17 settembre, dalla Procura Generale del Re Presso la Gran Corte Criminale Salerno parte l’ordine per il Sig. Giudice Regio di Laviano: Signore, per l’arresto di Giuseppe Iannuzzelli di Castelnuovo Ella deve dipendere dalle disposizioni del Signor Maresciallo di Campo Del Carretto27. La caccia di Passarelli a Ruggiero Gibboni si trova puntigliosamente descritta in un rapporto in data 9 settembre 1828 che il giudice di Laviano invia al Procuratore Generale in Salerno. Ecco il documento: Signore, fin dal punto in cui si allontanò da questa Comune Don Ruggiero Gibboni, è stato egli di mio ordine dalla Forza Pubblica continuamente perseguitato. Mi dò l’onore intanto di farle conoscere che nella notte de’ cinque Luglio, dopo di essere già assicurato che egli ritrovavasi in Peschiopagano in casa di Don Giuseppe Nicola Pelosi in Provincia di Basilicata, ben presto mi risolvei di spedirvi una forza imponente guidata da questo Capo Urbano, e dal Caporale de’ Gendarmi di quel tempo Raffaele Morena. Fu aggredita ed assediata in tutti i punti la casa del medesimo. Non si rinvenne. Che nella notte de’ 28 di quel mese istesso fu puranche visitata da quest’ottimo sott’ufficiale Rocco, e dall’intiera sua Brigata col mio personale intervento per tutti gli angoli li più segreti l’abitazione del figlio Don Domenico Gibboni di qui e neppure si Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 26 Accanto alla ottusità del giudice Passarelli va segnalato, per contrasto, il comportamento del giudice istruttore di Campagna improntato in qualche modo ad elementi di garantismo. 27 Il feroce uomo di fiducia di Francesco I, che nel Cilento ha già fucilato decine di patrioti, le cui teste tagliate e fatte esporre grondano ancora sangue. 25 176 trovò. Che successivamente nell’altra notte del 1° del corrente con questo stesso Caporale Rocco, e con i suoi Gendarmi credei di ancor perquisire la casa di Donna Orsola d’Amato, ove mi fu riferito, che giaceva il Gibboni annidato nel fieno del più secreto nascondiglio sotto la base di uno stipo: neppure si rinvenne. Che verso le ore quattro di quella stessa notte sul punto, in cui erano già terminate le perquisizioni nella casa di essa Donna Orsola, con suo uffizio di quel medesimo giorno il Supplente di questo Regio Giudicato Don Felice Chiara di S. Menna, uomo attaccatissimo al Real Trono, in continuazione de’ suoi rapporti orali per l’arresto del Gibboni, m’informò di aver fatto assediare la casa di un tal Luigi Iannuzzelli, alias il Zoppo in Castelnuovo, ove il Don Ruggiero era nascosto, a denunzia di un tale Antonio Venutolo e del Capo Urbano di quel Comune. Finalmente in quel momento istesso mi deliberai di spedir questo medesimo Sott’uffiziale Rocco coi i suoi Gendarmi in Castelnuovo, per così render più facile nella di lui avvedutezza l’arresto del Gibboni, anche pel riflesso che il Signor Chiara assicurò di non esser la Forza bastante da lui spedita. Il rapporto intanto di questo Caporale di Brigata circoscritto nel verbale esibitomi, mi offre, che il Iannuzzelli avea dato asilo al Gibboni, prese la fuga in quella notte de’ due del corrente; ch’egli lo riteneva occultato in una grotta vicina, ove, visitata dalla Gendarmeria, si rinvennero diverse scorze di ovi, varie spighe fresche di granodindia, una lettiera di paglia, ove il Gibboni riposava. Finalmente il verbale fa conoscere, che la Guardia Urbana di Castelnuovo avendo prima aggredita la casa del ricettatore Iannuzzelli, e non la grotta28, il Gibboni perché avvertito della persecuzione, ebbe libero il piede di darsi in fuga; che malgrado di essersi visitati in quella stessa notte tutti i ricoveri, i casini di campagna di Castelnuovo, malgrado, che anche si fosse la intiera Forza ripartita in quattro punti diversi, e si fossero trincerate tutte le vie che aprono il cammino verso la Provincia limitrofa di Principato Ulteriore, si rese inutile qualunque sforzo. In seguito di tutti questi dati debbe conchiudersi, che Il compleso casa-grotta è elemento costitutivo dell’antico borgo di Castelnuovo. Dove fosse ubicata la casa di Luigi Iannuzzelli lo sappiamo dalla testimonianza resa da un’altra spia, Giuseppe Carbutti, che così dichiara al giudice Passarelli: Signore come Don Ruggiero Gibboni occultamente trattenevasi in casa del Iannuzzelli; così niuno pubblicamente vi andava, e vi compariva: e ognuno, credo, che con segretezza doveva trattarlo; so molto bene per averlo più volte io veduto, che trovandosi la casa del Iannuzzelli fuori del Paese in contrada così detta sopra al giardino, la via della fontana, per quella stessa contrada più volte si siano veduti di intorno Francesco Ricciulli, e Don Luigi Di Majo di S. Menna, forse per abboccarsi collo stesso Don Ruggiero Gibboni. 28 177 in quella istessa notte si decise definitivamente il Gibboni, per sottrarsi dalla viva persecuzione che da me si li dava, di prender la fuga scortato dallo stesso Iannuzzelli, e di presentarsi. Quante volte fosse vera la di lui presentazione si compiaccia di disporre, che fosse subito qui tradotto per essere interrogato, e per così acquistarsi maggior lume di talune circostanze, che potrebbero meglio svilupparsi nel corso delle istruzioni, che sono già vicine al termine29. Effettivamente Don Ruggiero Gibboni si consegna a Salerno, ed il Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale così scrive a Passarelli: Signore, Ruggiero Gibboni si è presentato. Faccia ella pervenire in questa Procura Generale il processo sul di lui conto, perché l’interrogatorio si riceverà in questa Gran Corte. E’ il 17 settembre 1828. Nemmeno questo ordine proveniente dai Magistrati Supremi ferma la crociata di Passarelli che, a corto di prove concrete, il giorno dopo è a Castelnuovo a misurare il Pianello per dimostrare che è sufficientemente spazioso da consentire la segretezza delle conversazioni dei settari che lì si incontrano. Ordina infatti di misurare le dimensioni dello spazio aperto e, alla sua presenza coll’assistenza e con l’intervento di un Commesso Giurato, due maestri fabbricatori, e un Compassatore, che ne formano il disegno, la piazza viene trovata sufficientemente ampia: una linea nella longitudine è di palmi trecentoventicinque 325, giacché la latitudine, compreso il parallelogrammo, fu reclutato per palmi centotrenta 130; e furono perciò del parere i Periti, che i congregati abbiano comodamente potuto parlar di affari politici, e di far qualunque muta operazione senza accorgimento di alcuno. La figura del Pianello è segnata con quattro lettere A, B, C, e D con queste indicazioni: A) Dalla parte di Settentrione, dalla casa di Nicola Annicchiarico; B) Da Levante, fuori dal muro di D. Emmanuele Annicchiarico; C) Dalla parte verso Mezzogiorno, a termine fin alla casa di Donato Custode, camminando verso il Palazzo30; D) Ponente Strada da sotto. Procede ancora ad interrogatori fino a quando il 24 settembre non gli arriva dal Procuratore Generale un secondo ordine di consegnare le carte a Salerno: Signore, Ella rimetterà direttamente a questa Procura Generale del Re gli atti a carico di Ruggiero Gibboni, dando contemporaneamente conoscenza al Giudice Istruttore di tale invio. Nemmeno si ferma; il giorno seguente, non essendo riuArchivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 30 Il castello, palazzo baronale. 29 178 La pianta del Pianello fatto misurare dal giudice Passarelli scito a catturare Ruggiero Gibboni, ordina l’arresto del figlio, considerando che gli indizj raccolti, ed altri elementi di prove che gravitano sul conto di Don Antonio Gibboni, apertamente lo convingono del reato di Stato in complicità del Padre Don Ruggiero Gibboni. Siamo al 25 settembre 1828. Passarelli procede ancora con alcuni interrogatori, prima di Antonio Gibboni e poi di alcuni lavianesi per verificare le dichiarazioni dell’arrestato. Arriva così al 28 settembre. In questa data compare negli atti del processo un certificato a firma del cancelliere Luigi Tremante relativo alla estrazione dal carteggio riservato colla Polizia, per mettersi in veduta il carattere di effervescenza, i gradi e le dignità, che occuparono nell’epoca costituzionale gl’imputati, di cui si fa 179 particolar menzione nelle copie estratte dal suddetto volume, tranne per altro soltanto due individui, che non si veggono imputati nel presente processo, che sono Don Emanuele Marcelli, e Don Francesco Marcelli31. Si tratta delle relazioni di polizia che vedremo appena più avanti e che Passarelli fa inserire nel fascicolo, nella consapevolezza che il risultato della sua frenetica attività è pressoché nullo: l’unica certezza su Gibboni ed i carbonari di Laviano, Castelnuovo e Santomenna è che essi sono stati effervescenti settarj nei nove mesi della costituzione del 1820. Ma questo era già noto da otto anni. 4.4 La trappola e i traditori Gli arresti dei carbonari di Castelnuovo, come si è visto, vanno inseriti in un quadro più ampio che riguarda anche fatti e persone di Laviano. Qui il giudice Passarelli è informato che da Salerno è giunta a Don Domenico Gibboni una lettera spedita dal padre, Don Ruggiero. Cosa fosse scritto in quella lettera la spia borbonica non sa dirlo, se non che il destinatario l’ha fatta a pezzi e gettata nel fuoco con queste parole: “Ma papà vuo’ fa passà nu guaio a qualcheduno…”. Il Giudice è anche informato che alcuni settari di Laviano si riuniscono nella cantine o in un pagliaio e che altri di Castelnuovo si incontrano nel Pianello. Si tratta di meri pretesti per effettuare gli arresti. I settari di Castelnuovo e Laviano sono ben noti alle autorità borboniche per il semplice fatto che hanno partecipato, anche in ruoli significativi, agli eventi del 1820. Sono, infatti, agli atti del processo tre rapporti di polizia32 a firma del sottointendente di Campagna inviati tra febbraio e marzo 1827 al giudice Passarelli con l’invito a tenere sotto sorveglianza gli esponenti più in vista dell’organizzazione carbonara. Il funzionario borbonico segnala quali Membri della Gran Dieta33 Francesco Di Donato di Castelnuovo di Conza e Luigi Di Majo di San Menna; quali Uffiziali delle abolite Legioni lo stesso Francesco Di Donato, Domenico Gibboni di Laviano, col grado di capitani e Ferdinando Gaudiosi e Felice Ruggiero di Colliano col grado I fratelli Marcelli di Valva sono carbonari che tradiscono l’organizzazione; le loro “schede” sono mantenute riservate e non allegate agli atti del processo. 32 E’ il carteggio riservato colla Polizia inserito il 28 settembre. 33 La Gran Dieta è il più alto organo rappresentativo della Carboneria salernitana; la base territoriale, corrispondente alla provincia di Principato Citra, nel linguaggio carbonaro si definisce Lucania Occidentale. 31 180 di tenenti; ed infine quali Uffiziali degli ex Militi Ruggiero Gibboni di Laviano col grado di capitano e Angiolo Maria Tuccaro di San Menna col grado di tenente34; la segnalazione è accompagnata da queste parole: Ella li sottoporrà tutti ad una stretta sorveglianza, facendomi ogni venti giorni, sotto la sua personale responsabilità a fronte del Governo, un rapporto sulla loro condotta, non senza proporre delle misure repressive, in caso che taluno di essi trascorresse in dette credenze. Curi inoltre sotto la stessa Sua responsabilità, che i Membri della Gran Dieta non escano dal tenimento del proprio Comune, senza un espresso permesso del Signor Intendente. Mi attendo il primo rapporto a’ 20 di questo mese. Un secondo rapporto, in data 19 febbraio 1827 segnala al regio giudice di Laviano Francesco Marcelli, Emanuele Marcelli e Giovanni Domenico Marcelli di Valva e Francesco Di Donato, Antonio Del Duca e Francesco Ricciulli35 di Castelnuovo perché Il Sig. Intendente della Provincia, con foglio de’ 17 corrente ha ordinato, che fra gl’Individui sottoposti alla sorveglianza della Polizia, quelli che Le descrivo al margine, meritano più di tutti di essere strettamente sorvegliati ne’ loro andamenti, e contatti, che avessero con de’ settarj. Ella dunque per le citate disposizioni resta incaricata di sottoporli a questa misura e di farmene conoscere gli andamenti di ogni dì 28 di ciascun mese, senza permettere loro che si assentino dal proprio domicilio senza preventivo permesso del lodato Sig. Intendente, avendo egli così disposto. Una particolare attenzione si dovrà avere per don Luigi Di Majo di Santomenna. In data 28 marzo 1827 il sottointendente di Campagna fa sapere al giudice Passarelli che dalle informazioni raccolte sul conto di Luigi di Majo, del Comune di San Menna, si rileva che lo stesso si è ripigliato in salute, poiché negl’ultimi giorni di Carnevale si è veduto giocare al caciocavallo nella sua patria; e per quanto mi è stato riferito, di sera avanzata sta continuamente fumando nella pubblica piazza del suo Comune: oltre a ciò in questi ultimi giorni è andato a tener discorso nel Monistero de’ Cappuccini, con Don Tiberio Luciano Gran Maestro del Comune di Teora in Principato Ultra, colà spedito per misura disciplinari da Monsignore Arcivescovo di Conza; motivo che io ho cercato, e cerco d’indagare gli di loro trattamenti, e sono dispiaciuto di non averli potuti prima indagare. Sono coloro che hanno fatto parte dell’esercito costituzionale del 1820. Arrestato, come abbiamo visto, per il tentativo del cancelliere Di Donato di fargli ottenere il “passaporto”. 34 35 181 Ecco il resto del documento che riguarda Di Majo: L’individuo, di cui è parola ha avuto sempre sentimenti contro la Religione, e perciò dal dopo l’epoca del novimestre continuando nel suo sistema sentimentale, non ha soddisfatto il precetto Pasquale, tranne l’anno 1822, in cui forse lo adempì nell’idea di appagare il mondo, e nell’anno già passato, come non ha adempito il Precetto Pasquale, così nemmeno ha profittato del S. Giubileo. Ha seminato quest’uomo continuamente sentimenti contro la Religione, ma dopo l’epoca del novilunio (sic! voleva dire novimestre), temendo, senza forse, la circostanza del tempo, ha manifestato silenzio, mentre d’altronde ha dichiarato la pertinacia ne’ sentimenti avversi alla Religione coll’inadempimento al già detto Precetto Pasquale, col non profittare dell’indulgenza plenaria del S. Giubileo, e col sostenere le solite pubbliche scandalose pratiche, sprezzando totalmente l’offerta, che con questi fatti suoi andava ad occasione al pubblico pudore, che giunse anni dietro a dare ad una delle figlie sue naturali, la quale è vivente, il nome di Giulia, in commemorazione di un suo zio premorto. Si dice, che l’individuo istesso avesse continuamente letti libri proibiti, e particolarmente le opere di Lutero, e Calvino, ma su questo niente posso dirle con accerto. Esercitava lo stesso le funzioni di Presidente della Commissione Amministrativa di Beneficienza di detto Comune di S. Menna sua Patria, e vergognosamente ne fu esonerato nel 1824, in appoggio della pruova acquistata, di aver’esso profittato, ed involato a quel Pio Stabilimento del SS. Sagramento il prezzo ritratto dalla vendita di una quantità di capre, che poi venne obbligato a restituire. Se volessi far parola de’ profitti illeciti dall’istesso commessi, sarebbe il caso di non mai finirla. Nell’occasione del disarmo Sovranamente ordinato nel 1821 non esitò (non consegnò) egli tre fucili, che ha tenuti, e non può non tenere nascosti, uno, cioè paesano, acquistato dal fu Don Francesco Carbutti di S. Menna; altro con una canna Militare, mondato (montato) alla paesana; ed una carabina Militare, che seco portò nel partire per le bocche di Antrodoca36 contro l’armata Tedesca, e che seco lui anche riportò in Patria, reduce da detto luogo. Mi si è detto, poi, che uno di detti fucili l’abbia tenuto a sua disposizione nascosto in una pagliaja, sita nel luogo detto Sotto L’Ortone, ov’è stato, ed è solito andare giornalmente a passeggiare; ma non mi è riuscito acquistare su questo fatto lumi sufficienti. L’esternazione niente posso dire, poiché il soggetto in disputa è profondo assai, e la sua malvaggità non si è conosciuta mai dal detto, bensì sempre dal fatto. In punto di fatto, non ha avuto mai contatto amichevole con gli Amici Antrodoco, il luogo della sfortunata prima battaglia del risorgimento italiano dove, come abbiamo visto, Guglielmo Pepe fu sconfitto dall’esercitro austriaco. 36 182 di Sua Maestà; ed è stato sempre attaccato a’ settarj. Siccome i primi ad ascriversi nella vendita di S. Menna furono Giuseppe Calabrese, e Michele Scudese, Michele Ferrari, Vito Nicola Vigilante, e Giuseppe Figurelli, quali tutti conosciuti per ladri di strada, ed imputati con lui nella Gran Corte Criminale di più assassinj; così con scandalo si è veduto, e si vede, che mentre il di Majo esercita in S. Menna la carica di Supplente Giudiziario, carica da Lui acquistata fin dal 1819, per il favore della Carboneria, sieno gli stessi correi assassini li suoi mecenati. Impone egli ne’ settarj di S. Menna impone pure in quella Popolazione, perché conosciuto per sanguinario. Ha tenuto col suo germano Alessio di Majo guarda bollo, e suggelli, non che Gran Maestro Onorario della Vendita di S. Menna, corrispondenza finanche quando era nelle bocche di Antrodoca, nel fine di sostenere la causa contro Sua Maestà; cosicchè dopo l’entrata dell’arme Tedesche, il detto Maestro di Majo gli scrisse, ch’egli conservati avea gli statuti penali di detta Vendita, mentre per effetto delle soverchia debolezza del Gran Maestro del ridetto Comune, si erano bruggiate (bruciate) tutte le carte, e la lettera relativa all’oggetto, dietro la sorpresa fattagli, fu quella riconosciuta. Nel corso del 1821, e dopo l’entrata de’ Tedeschi in S. Menna, si disse, che il di Majo andava armato in compagnia di altri Carbonari, e che tenea corrispondenza colla Basilicata, sperando, che que’ settarj avessero fatta nuova rivoluzione. Finisco col dire, che di Majo concorse alla rivoluzione in compagnia di Macchiarola, ed altri: che nella rivolta di Salerno essendosi colà trovato il Sindaco di S. Menna con più militi, che portò per scorta de’ coscritti, profittò de’ fucili di Militi medesimi, e gl’impegnò contro la causa del Re: che essendosi il Sindaco stesso risentito, fu questo in quella triste circostanza nel pericolo di essere ammazzato, e che il soggetto in disputa fu quello, che venne a portare la bandiera tricolorata in Laviano, ed in quello di Evoli (Eboli). Su questi dati intanto potrà Ella basare l’informo a prendere, tenendo presente, che i Carbonari di S. Menna, e degli altri Comuni vicini, per essere il di Majo fondatore di più vendite, e per aver funzionato da Consigliere del Dicastero, non possono non avere incoraggiamento ne’ di loro sentimenti liberali dalla di lui persona, e quindi farmi chiaramente conoscere, se costui fosse attualmente punibile, ovvero, se esistono eccedenze attuali nella sua condotta, sotto tutti gli aspetti, e particolarmente sulla politica, spiegandomi, se sia il de Majo Supplente Giudiziario. Potrà anche praticare nella di lui casa una visita domiciliare37. Archivio di Stato di Salerno, Istruzione del processo relativo alle riunioni Settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828. 37 183 Questi documenti, agli atti del processo, evidenziano come, più di un anno prima della rivolta del Cilento, l’apparato repressivo borbonico, certamente avvisato di quanto si andava preparando, intensificasse il controllo sui carbonari. Danno, inoltre, consistenza all’ipotesi, riportata da Matteo Mazziotti, che i filadelfi salernitani cadano in una trappola preparata ad arte dalla polizia. Tra i settari sottoposti al rigido controllo della polizia borbonica, come abbiamo visto, ci sono anche i tre fratelli Marcelli di Valva, i quali però non verranno imputati di alcunché; essi sono diventati collaboratori direttamente del Ministro della Polizia Generale, al quale fanno pervenire una lettera mandata da Ruggiero Gibboni al sacerdote Giandomenico verso la fine di maggio 1828. La circostanza della lettera di Gibboni a Giandomenico Marcelli viene riferita al giudice Passarelli attraverso una denunzia riservata (attenzione, riservata, non anonima) come si evince dal seguente documento agli atti del processo: Certifico io qui sottoscritto Commesso Giudiziario che questo Regio Giudicato del Circondario di Laviano, qualmente oggi li venti luglio si è riservatamente dinunziato a questo Signor Giudice che Don Ruggiero Gibboni nel tempo della sua dimora in questo Comune di Laviano verso il fine di Maggio ultimo nel principio di Giugno anche ultimo si arrischiò a dirigere una lettera al Reverendo Don Giandomenico Marcelli di Valva tutta sospetta, e sediziosa per Real Governo. Perché costi dagli atti d’ordine dello stesso Signor Giudice ho formato il presente da me sottoscritto, e dal medesimo vidimato. L’autore della denunzia potrebbe essere un personaggio di alto rango nella geografia dei settari dell’alto Temete, che diventa delatore per evitare il carcere e patteggia l’anonimato, rimanendo sconosciuto38. Il giudice Passarelli, all’indomani della delazione, convoca Giandomenico Marcelli al quale domanda: Riceveste voi qualche lettera dal ridetto Gibboni, e nell’affermativo, ditemi ove si trovi Anche l’indicazione al giudice Passarelli delle persone a conoscenza del rifugio di Ruggiero Gibboni a Castelnuovo presso Luigi Iannuzzelli è fornita in forma riservata, come attesta questo documento del 7 settembre 1828, agli atti del processo: Certifico io qui sottoscritto Cancelliere del Regio Giudicato del Circondario di Laviano, qualmente oggi sette di questo mese di Settembre si è fatto riservatamente conoscere al Signor Giudice, che il ricettatore di Don Ruggiero Gibboni, e il conduttore nella fuga sia stato Luigi Iannuzzelli di Castelnuovo; che i testimonj da sentirsi del denunciante, che non ha voluto manifestarsi e da lui designati sono Antonio Venutolo, Giuseppe Carbutti, Vincenzo Chirichella, Donato Russo, Giuseppemaria Carlucci, Francesco Carlucci, Pasquale Di Ruggiero, Vincenzo Cozzarelli. 38 184 questa lettera e qual ne fu il tenore. Ecco la rispostra del Marcelli: Signore. La lettera di cui mi chiedete ed ogni altro andamento del suddetto Gibboni di cui io ebbi scienza fu tutto passato a conoscenza di Sua Eccellenza il Ministro della Polizia Generale presso di cui si trova la cennata lettera da me spedita fin dall’epoca dell’avvenimento; che forse fu, se mal non ricordo verso i primi giorni del caduto Giugno, ovvero alla fine del passato Maggio. Mi astengo dal confidarvi il tenore della divisata lettera essendo, come dietro ho detto, tutto a cognizione della suddetta Eccellenza il Ministro della Polizia Generale, il quale quando gli detterà colla sua innata saggezza di spedirne innanzi l’istruzione su tal proposito l’ordinerà senza dubbio. Anche la reticenza del sacerdote traditore sul contenuto della lettera di Gibboni, con la chiamata in causa del potente ministro della polizia, davanti a cui l’eroico giudice Passarelli (che non ha esitato a gettare in carcere un povero ragazzo di Castelnuovo) si deve fermare, indica che c’è un’altra partita tutta giocata ai piani alti del potere borbonico e dell’organizzazione carbonara. Comunque Passarelli si trasferisce a Valva e qui, il 3 agosto 1828, sottopone ad interrogatorio l’altro fratello Marcelli al quale ugualmente chiede: E’ a vostra conoscenza, se il nominato Don Ruggiero Gibboni, allorchè nel mese di maggio scorso si trattenne in Laviano, avesse scritto qualche lettera a persone qui in Valva, designate la persona, a cui si scrisse, ed il tenore della lettera, se mai vi fu noto? Emmanuele Marcelli risponde: E’ vero, che Don Ruggiero Gibboni di Laviano, senza ricordarmi del giorno preciso, nel mese di Maggio ultimo diriggè una lettera a mio Fratello Sacerdote Don Giandomenico Marcelli, allorché egli ritrovavasi in quel Comune; che questa lettera, per quanto generalmente mi venne manifestato dal detto mio Fratello, era rivestita di un sentimento sospetto, e criminoso contro del Governo: che perciò lo stesso mio Fratello stimò espediente di farla presentare a Sua Eccellenza il Ministro della Polizia Generale in Napoli per mezzo dell’altro mio Fratello, ivi di permanenza, Monsignor Don Francesco Maria Marcelli. Ed ecco la lettera-denunzia del sacerdote Giandomenico Marcelli al fratello Monsignor Francesco Maria Marcelli in Napoli. La lettera è datata Valva, 1° Giugno 1828, e dice: Caro Fratello, ieri l’altro ebbi una chiamata da Ruggiero Gibboni ex Capitano dei nostri militi con sua lettera, che conservo, in cui mi dice di andare colà senza far comprendere l’oggetto di mia venuta. Io non volli andarci né rispondere alla sua lettera, sospettai però sulle prime, che fosse stato un tale invito per mediazioni con suo figlio per li loro interessi, ma dopo considerando bene l’affare mi è giunto in mente il sospetto che non fosse altro 185 scopo la mia chiamata, specialmente nelle cose attuali. Quindi se credete per bene del governo, che io vi andassi, e ne spiegassi l’oggetto, parlatene prima a S.E., e fatevene ancor dare segreto permesso, mentre io non voglio compromettermi, e molto ppiù lo temo, perché venne col calesse apposta in Laviano, nel mentre voi sapete che le sue finanze sono strettissime. Nulla farò senza il vostro oracolo, e sarebbe ancor buono di passare in Bagnoli, ed altri luoghi di Principato Ultra, ove tengo delle conoscenze. Fate dare ulteriori ordini all’Intendente per la trasmissione delle carte dell’arresto di Luigi poiché di già il Comm.o ha riferito all’Intendente. La chiusura della lettera di Giandomenico Marcelli, con il riferimento ad ordini che dovranno giungere (dal Ministro di Polizia) all’Intendente in merito all’arresto di Luigi, anche se non chiarisce di quale Luigi e di quale arresto si tratti, lascia intendere di un qualche provvedimento restrittivo predisposto e poi congelato nei confronti di un importante personaggio della galassia settaria, poi diventato collaborante. 4.5 L’indagine di Passarelli sulle opinioni e la religiosità dei settari L’intensa attività istruttoria del regio giudice Passarelli non deve aver prodotto moltissimo se lo stesso deve ricorrere a nuove testimonianze, non su fatti ma sulle opinioni e sul comportamento dei carbonari al tempo della costituzione di otto anni prima. Così, infatti, scrive ai sindaci di Castelnuovo, Laviano e Santomenna: Signor Sindaco, debbo premurarla perché si compiaccia di indicarmi quattro persone probe, e distinte per morale, per attaccamento e per Religione che non abbiano alcun rapporto di parentela con….(sono aggiunti, comune per comune, i nomi dei sospettati). Ottenute le indicazioni delle persone probe di Castelnuovo, il giudice le convoca e chiede ad ognuno: Siete parente con Francesco Ricciulli, Vincenzo Di Donato, il medico Don Francesco Di Donato, Vitantonio Di Geronimo, Vincenzo Ricciulli, Francesco Manziano, Fedele Pugliese e Antonino Del Duca vostri paesani? Alla risposta negativa segue la successiva domanda: Siete voi informato delle qualità morali, religiose e politiche delle suddette persone, e se nel tempo della costituzione, e dopo si mostrarono nemiche dell’attuale governo del re, nostro Signore? Ed ecco la prima risposta: Signore, in tempo della Costituzione tra le persone indicate molte di esse, è noto a tutti, che diedero segni di allegrezza per la nuova forma di Governo, tanto che fecero uso di fasce tricolorate, e di altre esternazioni. Circa la morale e la religione, so che frequentano la Chiesa, né sono dediti alle scostumatezze. Un altro testimone 186 afferma: Signore, in tempo della Costituzione mi ricordo di aver una volta osservato in tempo di Domenica le indicate persone adornate di fasce, e di segni costituzionali, ad eccezione del solo Antonino Del Duca, che non mi sovviene abbia usato di questi segni. Un terzo teste fa mettere a verbale: Le indicate persone furono riscaldate, e diedero segni di attaccamento al Governo Costituzionale, mentre tutti si abbellivano di fasce tricolorate, e festeggiavano allora la nuova forma di Governo; ad eccezione però di Antonino Del Duca… Anche per il quarto teste la deposizione è identica. Per don Luigi Di Majo il giudice Passarelli scomoda l’arciprete di Santomenna, facendogli la solita domanda, ed il religioso così gli risponde il 16 settembre 1828: Signore, riscontrando il suo venerato foglio del 14 andante anno 8 porto alla di Lei conoscenza, che il mio filiano D. Luigi Di Majo, per quanto mi vado ricordando dall’anno mille ottocento venti 1820 a questa parte non ha adempiuto al precetto pasquale, se non una sol volta lacchè fu nell’anno mille ottocento ventitre 1823 in occasione della S. Missione, però in alcuni anni da detta epoca, lo stesso si è semplicemente presentato per la confessione. 4.6 L’ergastolo a Ruggiero Gibboni. La conclusione del processo. Il buco nell’acqua di Passarelli Ruggiero Gibboni, sfuggito come abbiamo visto alla caccia di Passarelli a Pescopagano ed a Castelnuovo, si consegna a Salerno il 17 settembre 1828. Qui, nelle carceri di Sant’Antonio, si trova un detenuto per reati comuni (ha ucciso il marito della sua amante), già condannato a morte con sentenza della Corte criminale di Potenza ed in attesa di un secondo giudizio dopo che il primo è stato cassato dalla Suprema Corte. Si tratta di Tommaso Giansante un irrequieto e pertinace agitatore, come lo definisce Matteo Mazziotti39. Seguiamone il racconto: Egli attendeva il novello giudizio, cui era stato rinviato, quando il 10 luglio 1828 la polizia scovriva nelle carceri di Potenza che vari detenuti d’accordo con il Giansante e con altri carcerati in Salerno si erano ascritti ad una setta ed avevano insieme stabilito di fuggire da le prigioni e di promuovere una rivolta nel giorno del Corpus Domini. La setta, chiamata dapprima dei Pellegrini bianchi, aveva di poi assunto il nome Matteo Mazziotti, La rivolta del Cilento del 1828 narrata su documenti inediti, RomaMilano, 1906. 39 187 di Beati Paoli. Per Tommaso Giansante la Procura generale di Potenza suggerisce di affrettare il giudizio per il reato di cospirazione: forse un pronto esempio potrebbe reprimere la perversità di tanti malintenzionati e la Gran Corte criminale resterebbe alleviata da non poco lavoro ed una inutile spesa si risparmierebbe al Real Tesoro. E’ un invito a nozze per il feroce Del Carretto che lo manda davanti alla Commisione Militare e, già che ci sono, vi manda anche un’altra decina di detenuti tra i quali Ruggiero Gibboni. La sentenza è del L’ex carcere di S. Antonio nel centro storico di Salerno 1° ottobre 1828: Tommaso Giansante è condannato a morte e fucilato il giorno seguente; Ruggiero Gibboni alla pena dell’ergastolo; sono anche condannati a 30 anni di ferri Giuseppe Torres di Napoli; a 25 anni di ferri Gabriele Jannotti di Vallo, Raffaele Sparano di Salerno, Serafina Apicella Galotti di Cetara; a 19 anni di ferri Celestino Torres di Napoli, Vincenzo Celentano di Fisciano, Pasquale Apicella di Cetara, Luigi Manzella di Polla; a 10 anni di ferri Prospero Landulfo di Rodio, Francesco Giuliani e Mattia Armenante di Cava, e Gregorio De Lisa di Napoli. E così Don Ruggiero Gibboni di Laviano, reo di aver scritto due lettere gettate nel fuoco dal figlio e una lettera al prete Marcelli, poi finita nelle mani del Ministro di Polizia senza che se ne sia conosciuto il contenuto40, colpevole di essersi sottratto agli sbirri di Passarelli rifugiandosi prima La circostanza della lettera di Gibboni fatta giungere al Ministro di Polizia, paradossalmente, scompare dalla requisitoria del Procuratore Generale. Ma si capisce perché: in tal modo si è mantenuto il riserbo sul ruolo dei fratelli Marcelli, carbonari traditori. 40 188 a Pescopagano e poi Castelnuovo nella casa di Luigi Iannuzzelli e, poi, consegnandosi al Procuratore Generale in Salerno, non torna più alla sua famiglia ed al suo paese. Muore in carcere qualche anno dopo. Egli è condannato all’ergastolo da un tribunale speciale per il reato di cospirazione contro lo stato, sulla base del processo istruito da Passarelli e che al suo interno non contiene uno straccio di prova. Al fascicolo, diligentemente formato dal Regio Giudice di Laviano e trasferito alla Gran Corte Criminale di Salerno, è semplicemente aggiunto il foglio 296, nel quale si legge: Certifico io qui sottoscritto qualmente Don Ruggiero Gibboni per imputazione di Cospirazione contro lo Stato in data del primo ottobre corrente anno 1828 fu condannato dalla Commissione Militare Straordinaria alla pena dell’ergastolo, e nel dì 25 detto mese fu spedito pel suo destino. Salerno sei novembre 1828. Benedetto Boffardi Commesso. La Commissione Militare Straordinaria era stata istituita con decreto del 24 maggio 1826 per regolare i giudizi per i reati di setta e per gli attentati contro la sicurezza interna dello stato. L’articolo 9 ne stabiliva la competenza quante volte l’incolpato sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato o quando viene perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso con gli effetti, con le armi, con gli strumenti, con carte, con emblemi e con qualsivogliano altri oggetti che facciano presumere essere egli l’autore od il complice. Lo stesso decreto prescriveva procedure abbreviate, le sentenza non soggette a gravame, le condanne da eseguirsi immediatamente. Il Del Carretto, in aggiunta, aveva ordinato che i processi si concludessero nello spazio di 24 ore. Ma anche queste norme disumane vengono travolte dalla furia della repressione borbonica: Don Ruggiero Gibboni non è arrestato in flagranza di reato, né viene sorpreso con armi, strumenti carte o emblemi; egli si è presentato spontaneamente alla giustizia borbonica e viene vigliaccamente mandato al carcere a vita. La conclusione del processo sulle Riunioni settarie e voci allarmanti contra il Real Governo, avvenute nei Comuni di Laviano e Castelnuovo in Febbraio, Maggio e Giugno 1828, per quella parte che ha camminato sui binari della giustizia ordinaria, è che il 20 gennaio 1829 il Procuratore Generale del Re presso la Commissione Suprema per i reati di Stato, il famigerato Domenico Girolami, quello che otto anni prima ha chiesto ed ottenuto la condanna a morte di Morelli e Silvati, smonta punto per punto l’architettura accusatoria di Passarelli e chiede l’archiviazione. Ecco il documento: 189 Il Procuratore Generale del Re Presso la Commissione Suprema per i reati di Stato Visti gli atti a carico dei detenuti Ruggiero ed Antonio Gibboni, Celestino Robertiello, Vitantonio Di Geronimo, non che degli assenti Domenico Gibboni, Vincenzo Felice Robertiello, Vincenzo Di Donato, Luigi Iannuzzelli, ed altri prevenuti rispettivamente di Riunioni settarie, di lettere e parole allarmanti, e di ricettazione data al detto Ruggiero Gibboni, imputato in materia di Stato Sulle riunioni Settarie Osserva, che quelle avvenute nelle Cantine non ebbero altro oggetto, che di mangiare e bere, secondo il costume del paese, anche perché vi erano pure delle persone attaccate al Governo. Osserva, che di quella avvenuta nel giardino di Giuseppe Salandra non se ne conosce l’oggetto, avendo gl’imputati discorso fra loro per una mezz’ora nel momento in cui furono presenti il detto Salandra e sua moglie. Osserva che neppure si è potuto liquidare l’oggetto delle riunioni avvenute nel luogo detto il Pianello, ed alcuni testimoni soltanto opinano, che fossero state criminose quelle adunanze, sol perché tra i congregati non vedevasi alcuno che fosse stato attaccato al Governo. Osserva infine, che la venuta in Laviano di Don Rocco Scoyno, trattato in casa dei Gibboni, non ebbe altro scopo, che per consultarlo sulla malattia di una donna di questa famiglia. Sulle lettere criminose Osserva, che per detto solamente di Giuseppe Trevisano, dal quale lo seppero i conjugi Francesco Bellini e Angiola M. Porcelli, si sa che Ruggiero Gibboni, stando in Salerno, li consegnò due lettere, una diretta al di costui figlio Antonio, e l’altra ad un tale Giovanni Pelosi; che il Trevisano consegnò tutte le due lettere ad Antonio; che costui lesse quella diretta a lui; indi la lacerò, e gittolla nel fuoco unitamente all’altra diretta al Pelosi, dicendo che si sarebbe costui turbato nel leggerla, il che fece dopo essersi segretamente abboccato con suo fratello Domenico Gibboni, il quale soggiunse in quel momento “Papà vo fa passà qualche guajo a qualcheduno”; che finalmente lo stesso Domenico parlando con la propria moglie disse che tutto era finito tra due altri mesi, e che avendone costei mostrato del dispiacere, soggiunse “Che ne vuoi fare d’inquietarti, chisti so affare nuoste”. Osserva, che oltre l’unicità del testimone, tutto quanto ha il medesimo asserito non è sufficiente a far credere criminose le lettere, di cui è parola. 190 Sulle voci allarmanti Osserva, che l’espressione proferita da Vincenzo Felice Robertiello, e quelle avanzate da Vincenzo Di Donato, e dal detenuto Vitantonio Di Geronimo non sono tali da poterli tradurre in giudizio, non essendo chiaro il sentimento da essi espresso. Sulla ricettazione41 data all’imputato in materia di Stato Osserva che questo reato a carico del solo Luigi Iannuzzelli non entra nella competenza della Suprema Commissione. In generale Osserva che gl’imputati furono effervescenti settari nel novimestre. Osserva che gli atti sono muniti di giuramenti e completi. Osserva infine, che da un certificato esistente al f. “296” appare, che l’imputato Ruggiero Gibboni è stato condannato alla pena dell’Ergastolo dalla Commissione Militare estraordinaria per reato di cospirazione contro lo Stato. Chiede, che la Suprema Commissione, dichiarando la presente causa di sua competenza, tranne per la ricettazione, come sopra, decida consegnarsi gli atti in Archivio per tutti i sopracennati reati in materia di Stato, fino alla sopravvenienza di nuovi lumi, abilitandosi provvisoriamente i detenuti sopranominati Gibboni, Robertiello e Di Geronimo col restare a disposizione della Polizia Generale e rimettendo gli atti medesimi per reati comuni al Giudice ordinario competente. Napoli, 20 Gennaio 1829 Domenico Girolami Dopo una settimana, il 27 gennaio, la Suprema Commissione accoglie la richiesta del Procuratore Generale e decide per l’archiviazione. Così tutta la costruzione del Regio Giudice di Laviano Raffaele Passarelli è smontata. Ma Don Ruggiero Gibboni è già stato condannato dalla Commissione Militare alla pena dell’ergastolo e spedito pel suo destino. Più “fortunati” sono Vitantonio Di Geronimo, Luigi Iannuzzelli, Vincenzo Di Donato e Francesco Ricciulli di Castelnuovo e Celestino Robertiello di Laviano che, ugualmente senza uno straccio di prova, il carcere di Sua Maestà Francesco I di Borbone (Dio Guardi) lo assaggiano “soltanto” per alcuni mesi, o al massimo per qualche anno. E’ l’ospitalità offerta da Luigi Iannuzzelli a Ruggiero Gibboni nella sua casa di Castelnuovo. 41 191 Capitolo V La guerra del fuoco - parte terza (fucilate ed occupazione dei boschi nel 1848, altri carcerati, ma poi Castelnuovo vince) 5.1 Riprende il confronto duro con Cassitti Gli arresti e le carcerazioni dei carbonari di Castelnuovo, seguite alla delazione del guardaboschi Giuseppe Ciliberti, alias Scibbone, ed il generale clima di repressione dopo il fallimento del tentativo rivoluzionario del 1828, ringalluzziscono i Cassitti, che ora si sentono padroni assoluti. Il 10 dicembre 1831 il sindaco di Castelnuovo, Francesco Mastrodomenico, si rivolge al Sott’Intendente del Distretto di Campagna per denunciare i maltrattamenti e gli abusi dei guardaboschi agli ordini del padrone di Buoninventre e Sant’Ilarione. Così scrive il sindaco: Signore, moltissimi miei Cittadini ed Amministrati giornalmente si dolgono presso di me del perché andando a legnare sul secco nelli Boschi denominati S. Ilarione e Buonimmente, siti nel tenimento di questo Comune, vengono continuamente maltrattati con gridi e bastonate dal Signor Don Giovanni Cassitti di Bonito, dimorante in Teora, qual Proprietario di detti Boschi, nonostante che questo Comune da molti secoli dietro ha avuto, come attualmente ha, il diritto di legnare sul secco, morto e selvaggio nelli citati Boschi, ed oltre i maltrattamenti che giornalmente si fanno a questi Cittadini dal succennato Signor Cassitti, vi è un suo Guardabosco particolare1, il quale leva i legni a questi cittadini, che vanno a legnare sul secco, che è di loro diritto, e seco li porta senza darne parte alla giustizia locale, forma ancora i processi verbali di autorità propria, senza atti generici e senza l’autorità del luogo, e fa conoscere che le legne recise sono verde e non già secche, perché li forma a suo piacimento, che perciò dietro dibattimento fatto davanti al Signor Regio Giudice del Circondario vengono i poveri Cittadini condannati alla refusa del danno, ed alle spese del giudizio; per evitare quindi tal’inconveniente, ed oppressione ne rapporto ad Ella, acciò si benigna dare le Sue disposizioni all’uopo, e li fa conoscere anche di questa aggressione che si fa ne sia data parte anche al Signor Intendente2. La guerra Il nome non è fatto; ma può ben ritenersi che si tratti di Giuseppe Ciliberti. Questa delibera, come tutti gli altri documenti del capitolo riguardanti Castelnuovo, è presso l’Archivio di Stato di Salerno, Atti Demaniali. 1 2 193 del fuoco è anche guerra di parole e di scritti. E Cassitti sa bene usare la penna e le sottili argomentazioni giuridiche. Così scrive all’Intendente: Signore, Giovanni Cassitti domiciliato in Teora, possidente delle tenute ex feudali di S. Ilarione e Boninventre site nel Circondario di Laviano, Distretto di Campagna, ossequiosamente espone di aver preinteso che il Sindaco del Comune limitrofo di Castelnuovo di Conza siasi fatto lecito di proporre a Lei la nomina di un Guardaboschi per la custodia delle tenute suddette, che si appartengono in piena proprietà, e legale dominio all’esponente. Questo inconcepibile eccesso per parte di un funzionario pubblico costituisce il colpevole attentato di usurpazione al particolare la libera facoltà di disporre dei beni che l’appartengono, ed il dritto assoluto di goderne, violando gli articoli 462 e 469 delle L.L. C.C.; perlocché merita di venire represso, e punito esemplarmente sotto l’egida del più giusto de’ Re. Cassitti passa all’attacco ed eccepisce che, con il distacco del 1811 in favore del Comune di Castelnuovo di una parte di Buoninventre in compensazione degli usi civici, il Sindaco non abbia null’altro a pretendere: Dietro Decisione formale dell’abolita Commissione feudale, con solenne ordinanza del già Commissario del Re Consigliere Giampaolo, furono compensati definitivamente gli usi di legnare sul secco, e morto che il detto Comune di Castelnuovo vantava su i fondi in parola, col distacco di circa trenta moggi di terreno, com’Ella potrà verificare dagli atti della divisione dei Demanj esistenti nell’Archivio di codesta Intendenza. Ciò posto, se il Sindaco vuole un Guardaboschi e limitare le funzioni tassativamente ai trenta moggi suddetti che s’appartengono al Comune da Lui amministrato, nommai chiederlo arbitrariamente nelle cose aliene, che sono sotto la sola guardia della Legge. In conclusione la minaccia di Cassitti al sindaco di Castelnuovo: Quindi il sottoscritto riserbandosi contro il Sindaco indicato le azioni competenti in linea civile, e penale, si attende dalla di Lei imparziale giustizia le solite provvidenze, onde il medesimo rientrando ne’ suoi doveri, ritratti l’abusiva proposta e risponda di qualunque guasto avvenuto. Lo avrà. Un alleato Cassitti lo trova nel Sottintendente di Campagna che, in una relazione richiestagli dall’Intendente, il 21 gennaio 1832 così scrive: Signor Intendente, in esecuzione del suo pregiato foglio segnato in margine, mi sono occupato a verificare il dedotto dal già Sindaco di Castelnuovo che qui le ritorno ed ho notato quanto segue: Pria che il fu Don Giuseppe Cappetti di Teora cui è succeduto il nipote Signor Don Giovanni Cassitti fusse addiventato proprietario de’ boschi siti nella tenuta del suddetto Comune di Castelnuovo sotto la denominazione di S. Ilarione e Buoninventre solevano que’ Naturali 194 legnare il secco, morto e selvaggio, pagandosi dal Comune annui Ducati 40 per godere di un tal beneficio. Il Sottintendente maliziosamente osserva che gli usi civici non esistono più perché il Comune di Castelnuovo ha ricevuto in cambio una parte dei boschi: Dietro però lo stabilimento delle Commissioni feudali, questo uso civico fu liquidato con una decisione emessa a quell’epoca dall’ex Consigliere di Stato Signor Giampaolo e la proprietà de’ boschi suddetti rimaneva libera ed immune da ogni peso. Ciò può meglio verificarsi dalla copia di detta decisione che vengo assicurato ritrovasi presso l’Archivio di codesta Intendenza. Cassitti è dipinto dal Sottintendente di Campagna come un benefattore che, bontà sua, ha permesso la raccolta di legna fino a quando i cattivi castelnuovesi non hanno esagerato: Ciò malgrado il Signor Cassitti, che nella citata contrada possiede delle vaste tenute le quali si tengono a colonia da quasi tutti i naturali di Castelnuovo, ha tollerato che i suoi Coloni avessero usufruito, senza alcun compenso, del suo morto e selvaggio de’ suoi bifolchi. Questa generosità per dono è degenerata spesso in abuso, poiché i Castelnovesi hanno ardito sovente recidere degli alberi vegeti, e non selvaggi ed anche di alto fusto con grave danno del proprietario, e dell’amministrazione delle Acque e Foreste. La nuova legge forestale è da applicare per difendere la proprietà privata ed impedire l’accesso ai castelnuovesi: Da questo inconveniente scende la necessità di stabilire alla custodia de’ citati boschi un Guardabosco particolare, approvato dal Ministero della Polizia Generale, e da codesta Intendenza ne’ modi regolari ed a termini dell’art. 183 della Legge forestale de’ 21 Agosto 1826 sui quali verbali compilati dal detto Guardabosco a carico di que’ Naturali contravventori e presentati regolarmente al Regio Giudicato, non si è osservata alterazione alcuna, che anzi sono stati confessi rimettendosi alla generosità del Cassitti. Infine, l’attacco personale al sindaco: E qui cade in acconcio osservarle che il ricorrente ex Sindaco trovasi anche prevenuto di delitto forestale commesso negli enunciati boschi del Signor Cassitti, per cui il suo esposto è velenoso e mendace. Dall’esposto di sopra Ella si avvedrà che quant’altro si deduce nel citato ricorso non lascia di essere effimero e inconcludente. 5.2 La guerra del fuoco (e il comunismo a Castelnuovo ed Auletta) nel 1848 Ma la guerra del fuoco non si nutre solo di parole, di azioni legali, di vendette consumate attraverso la delazione; c’è un tempo ed una occasione nella quale la secolare contesa per la legna diventa guerra vera, con le campane che chiamano il popolo a raccolta, l’occupazione dei boschi, i fucili che 195 sparano, i castelnuovesi prigionieri gettati nelle carceri di Salerno. Il tempo è il 1848; l’occasione sono le nuove idee che infiammano l’Europa. Il 1848 è l’anno che incendia l’Europa, con le rivoluzioni che dilagano in tutto il continente. L’assetto sancito dal Congresso di Vienna, già scosso dai moti degli anni venti e trenta, riceve un altro durissimo colpo. Tutto inizia nel regno delle due Sicilie, il 12 gennaio, con l’insurrezione dei popolani di Palermo contro il malgoverno borbonico. Ma è a Parigi che il 22 febbraio scoppia la rivolta popolare più significativa: quella contro il Il Congresso di Vienna (1814-1815) governo di Guizot e la monarchia di Luigi Filippo d’Orleans. Dopo tre giorni di combattimenti per le strade della capitale, con la Guardia Nazionale che spesso si unisce agli insorti, il re abdica ed abbandona la città. Il 26 febbraio il parlamento proclama la repubblica ed insedia un governo provvisorio nel quale sono presenti moderati, repubblicani, socialisti e persino un vero operaio, Alexandre Martin, detto Albert. La fiammata si propaga alla Confederazione germanica e allo stesso Impero austo-ungarico. Ai primi di marzo si verificano moti a Monaco e a Lipsia; il 13 la rivolta investe Vienna e Budapest, il 18 marzo il re di Prussia Federico Guglielmo IV scende a patti con i berlinesi che hanno preso le armi. A Milano prendono il via le gloriose cinque giornate, mentre Venezia si è ribellata il giorno prima ed il 22 si costituisce in repubblica sotto la guida di Daniele Manin. Alexandre Martin, In giugno anche Praga si solleva. l’operaio Albert 196 In Italia il primo sovrano a cedere è il Borbone Ferdinando II che l’11 febbraio promulga una costituzione analoga a quella francese del 1830. Viene seguito da Leopoldo II di Toscana, Carlo Alberto e papa Pio IX che promulgano i cosiddetti staLe cinque giornate di Milano tuti. Quello piemontese, lo statuto albertino, sarà successivamente la legge fondamentale dello stato unitario italiano dal 1861 fino al 1946. Il 21 febbraio a Londra viene pubblicato il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels; esso inizia con le famose parole: Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro: il papa e lo zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi… I due filosofi chiariscono però che è ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del partito stesso. A Castelnuovo nel 1848 si compie un atto concreto di rivoluzione. Gran parte della popolazione, guidata dagli amministratori e dai sacerdoti, con fucili e altre armi improprie, si reca in massa ad occupare i boschi rivendicati. Si verifiFrancesco Hayez, La meditazione cano scontri a fuoco con i guardaboschi dell’Italia nel 1848 197 ed altri sostenitori di Cassitti. Il racconto minuzioso degli eventi, nel linguaggio burocratico dell’apparato repressivo borbonico, si trova nel rapporto redatto in data 4 maggio 1848 dal capitano Corona della Guardia Nazionale di Teora e trasmesso all’Intendente della Provincia di Marx ed Engels Principato Ulteriore in Avellino: Signor Intendente –scrive il capitano Corona- dubitando che le diverse voci del seguente avvenimento che ebbe qui luogo il giorno di ieri non le potessero giungere cambiate ed alterate come suol succedere, mi dò l’onore di darlene minuto dettaglio ne’ puri sensi del vero, in discarico del mio dovere. Buona parte della popolazione di Castelnuovo in Provincia di Principato Citeriore, a questo Comune limitrofo, guidata da circa quaranta persone armate di fucili disarmarono e maltrattarono gravemente i Guardaboschi di Don Giovanni Cassitto di qui che custodivano la di costui estesa proprietà boschiva denominata S. Ilarione. Commisero molti guasti al fabbricato ed alle piante ed abusando della forza cercarono per via di fatto prender possesso de’ dritti comunali che essi asseriscono senza alcun fondamento vantare sulla proprietà medesima. Il Signor Cassitti accompagnato da quasi tutti i Galantuomini del Paese, e da molta gente armata che si offrirono spontaneamente alla vista di uno spoglio indoveroso e violento, si spinse sopra luogo per calmare gli animi e far loro intendere che se diritto vi avessero vantato potevano sperimentarlo in modi regolari e voluti dalla Legge, senza ricorrere ai mezzi tumultuosi ed alla forza. Ma non appena furono da quelli esternati vennero provocati da ben dirette fucilate. Cassitti non sparò un colpo, ma indignata la scorta di tale ospite in corrispondenza corrispose fuori tiro, con altrettanti colpi, gli arroganti aggressori che non cessarono tener 198 fuoco per più ore3. Una battaglia vera, a colpi di armi da fuoco, nel bosco di Sant’Ilarione, tra autorità e popolo di Castelnuovo, da una parte, e Cassitti ed i suoi guardaspalle, dall’altra. Il capitano Corona, pur adempiendo al dovere di stilare il rapporto sugli scontri tra i castelnuovesi e gli uomini di Cassitti, ne attenua la valenza e sottolinea in chiusura la conclusione incruenta: Sopraggiunto però nuovo rinforzo in favore della giustizia, e della santità della cosa, i primi si restituirono nelle proprie mura convinti del torto che li rifletteva. Intanto né dall’una, né dall’altra parte accadde verun sinistro, e la calma fu ridonata ad ambi i Comuni. Il 13 maggio, però, il Procuratore Generale di Salerno dà conto di quanto accaduto al Ministro di Grazia e Giustizia in termini più allarmati, mettendo in evidenza il ruolo di Francesco Di Donato, sindaco di fatto e capo della Guardia nazionale di Castelnuovo di Conza. Ecco cosa scrive il Procuratore: Eccellenza, certo Don Francesco Di Donato 2° Eletto ed anche Capo della Guardia Nazionale di Castelnuovo di Conza nel giorno 2 di questo mese, alla testa di molta gente armata impadronivasi di due muli carichi di legna raccolta in un bosco posseduto da Don Giovanni Cassitti di Teora, pel quale vanta de’ dritti lo Comune di Laviano, e dopo di aver sbaragliato e percosso coloro che qui avevano gli animali concertarono di commuovere l’indomani l’intera popolazione ad impadronirsi violentemente tanto del predetto bosco, quanto di un altro denominato S. Ilarione; all’uopo s’introdusse colla medesima comitiva nella Chiesa dove fece predicare dal Sacerdote Don Vincenzo Di Domenico che nel mattino appresso la popolazione era invitata a prendere possesso degli indicati boschi. In effetti nel giorno seguente il suono delle campane a stormo fece insorgere gli abitanti, che armati di ogni specie di armi proprie ed improprie e sempre sotto la direzione del 2° Eletto Capo della Guardia Nazionale Don Francesco Di Donato irruppero nei boschi controversi disarmando i Guardia Forestali, respinsero Guardiani, Coloni, ed ogni altro oppositore, s’impossessarono de’ boschi, devastarono le terre, radendo alberi, disperdendo un gregge di circa mille pecore, e spararono circa 400 fucilate piuttosto a spavento, incluse quelle sparate dagli aggressori. Il Procuratore segnala altresì l’infruttuoso tentativo di avviare, attraverso il rappresentante periferico, un minimo di istruttoria sui fatti del tre maggio: Informato di tale vandalismo il supplente di Laviano Don Felice De Chiara, fu sollecito 3 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero di polizia, fascio 3141, volume 8. 199 di dar mano alle prime indagini, dirigendo un uffizio4 per taluni testimonij al Sindaco di Castelnuovo, il quale uffizio cadde sventuratamente nelle mani del principale colpevole Don Francesco Di Donato, che nella qualità di 2° Eletto funzionante da Sindaco, o piuttosto funzionar volle appunto col proponimento di offendere con la risposta il Supplente di Laviano. A questo punto il ministro riporta la nota che FranceGendarmi della polizia borbonica sco Di Donato, nella qualità di sindaco facente funzioni, indirizza al supplente di Laviano, inviato ad indagare sugli avvenimenti. Francesco Di Donato si assume per intero la responsabilità di aver guidato l’occupazione dei boschi e disconosce la legittimità del supplente De Chiara, perché “anticostituzionale”: Amministazione Comunale Castelnuovo di Conza - senza data Al Signor Supplente anticostituzionale di Laviano Signore, Francesco Sibilia è ammalato e Vincenzo Pacillo è impedito, qual servente di affari pubblici, ma senza che s’incomodi di esaminarli, gli dico io l’avverantesi, io il Sindaco fummo quelli che fecimo emanare bandi, perché questi cittadini si avessero andati a prendere le legna del cerro tagliato nel bosco di basso5, ch’è di proprietà del Comune, come da sentenza diffinitiva del Tribunale, e che fu reciso da Santomennesi senza alcun diritto. Egli intanto come persecutore di Carbonari e Patriotti, per cui anticostituzionale, non sarà più inteso. Pel Sindaco assente - Il 2° Eletto Francesco Di Donato6 E’ la richiesta di ascoltare alcuni testimoni rivolta al sindaco di Castelnuovo. E’ il bosco di Buoninventre, o Torretta, oggetto della rivendicazione. 6 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero di polizia, fascio 3141, volume 8. 4 5 200 Il rapporto del ministro di Giustizia viene immediatamente girato al Ministro dell’Interno con la denunzia del doppio ruolo di Francesco Di Donato: Secondo Eletto funzionante da Sindaco e, nello stesso tempo, Capo della Guardia Nazionale di Castelnuovo: Se gli uffiziali pubblici, Signor Eccellentissimo, e specialmente il Comandante della Guardia Nazionale incaricati della sicurezza privata e pubblica; e di proteggere l’esecuzione delle Leggi, tradiscono i proprij doveri e piuttosto contro le Autorità competenti; e se tutto ciò debba succedere non solo impunemente, ma ben mentre rimanendo i colpevoli nelle rispettive loro cariche, io non saprei più conoscere l’oggetto di questa Magistratura Criminale; né lo stato in cui verrebbe a cadere la società. Dopo di aver quindi disposto che il Giudice Istruttore incaricato del processo, con facoltà di arrestare anche sopra luogo ed altre istruzioni, spedisca questo mandato di arresto contro del predetto Don Francesco Di Donato, supplico l’E.V. d’informare l’Eccellentisimo Ministro dell’Interno degli atti criminosi di un individuo che trovasi investito così bene del doppio carattere di 2° Eletto, e di Capo della Guardia Nazionale del Comune di Castelnuovo di Conza. Richiamo l’attenzione dell’E.V. sulla bisogna che prego di emettere all’uopo quei provvedimenti che l’urgenza del caso esige; e che Ella troverà opportuni nella sua saggezza. Intanto ho ingiunto al detto Procuratore Generale di spingere con zelo ed alacrità la istruzione del processo contro il 2° Eletto7. L’accorato appello del ministro della giustizia non sortisce subito l’effetto, se nel 1849 è Giovanni Cassitto, il padrone dei boschi di Sant’Ilarione e Buoninventre, a produrre una memoria al Ministro dell’Interno per lamentare che i capi della rivolta continuino indisturbati a godere della libertà nonostante il giudizio in corso, ed in particolare Francesco Di Donato: Giovan Antonio Cassitto del Comune di Teora in Principato Ulteriore, Supplente al Regio Giudicato di quel Circondario, e Capo Plotone delle Guardie d’Onore di quella Provincia, con umili suppliche rassegna a V.E., come nel 3 maggio dell’anno scorso la popolazione di Castelnuovo in Principato Citra, eccitata e guidata da tutte quelle Autorità Comunali, si permise per effetto di spirito rivoluzionario abusivamente recarsi a mano armata nelle di lui proprietà boscose site in tenimento di quel Comune per impossessarsene, distruggendo infinite piante fruttifere, scassinando i fabbricati, rubando degli oggetti campestri, e commettendo mille altri eccessi, fino a far fuoco con centinaia di armati sopra lo esponente, che fu salvo miracolosamente per della buona gente ivi spontaneamente accorsa. 7 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero di polizia, fascio 3141, volume 8. 201 Questi atti di alto criminale furon presi in considerazione dalla giustizia, perloché istruitosene analogo processo, venne uno degli imputati, (il solo presente) dietro pubblica discussione condannato dalla Gran Corte Criminale di Salerno con sua decisione alla pena di sette anni di ferri8, condanna, che fu rispettata dalla Corte Suprema di Giustizia in conseguenza di ricorso del condannato, essendo gli altri correi colpiti da mandato di arresto, e tuttavia giudicabili. Or non ostante la pendenza de’ mandati accennati, si veggono essi imputati passeggiare impavidi nella lor patria, scorrer la campagna a mano armata, e quel Capitano della Guardia Nazionale, singolarmente in funzioni della carica, dalla quale avrebbe dovuto da tanto tempo essere esonerato. Ed intanto convinti del proprio fatto, scevri di motivi legittimi di difesa, ricorrono a delle private protezioni, e per via di ecclesiastici, e per via di particolari ed anche per via di autorità, onde inorpellare (coprire con orpelli) la forza della verità e della Legge, lusingandosi uscire impuniti da’ loro criminali eccessi; tanto ciò vero, che essendosi giorni dietro da questa Prefettura di Polizia arrestato Don Donato di Donato del suddetto Comune di Castelnuovo, imputato de’ menzionati reati, si rinvenne presso di lui una lettera del suo cognato Capitano di colà, con la quale se gli scriveva, che il Sig. Romaldo già Sottintendente in Campagna, avea vantaggiosamente rapportato a V.E. certamente sopra i fatti de’ quali erano accusati, che erano stati richiamati i mandati; cosa che l’E.V. potrà liquidare, se si degni di chieder conto dalla Prefettura della lettera medesima, offrendo la stessa chiaro argomento di privata corrispondenza tra esso Sottintendente funzionante e gl’imputati, ciò che per altro è ben noto in Provincia, non ignoto al ragguardevole Generale Sig. Palma in Salerno, impegnato per l’assicurazione de’ rei. In tale stato essendo vera la rappresentanza di quell’autorità presso la lodata E.V. relativamente ai fatti in parola, si vede bene la deferenza e la pendenza del funzionario in favore de’ rivoluzionari di Castelnuovo, soprattutto se si considera alla spontaneità del suo rapporto che versa sopra fatti da un tempo sottoposti alla cognizione del Tribunale competente; e quindi è che il supplicante La prega tener presenti tali circostanze nella valutazione del dedotto, nel mentre La scongiura a dichiararlo meritevole di una sollecita e completa giustizia, sol perché è stato oppresso come attaccatissimo a Sua Maestà. E l’avrà9. Ed effettivamente Giovanni Cassitto, che è attaccatissimo a Sua Maestà (mentre a Castelnuovo nel 1848, come nel 1828, fioriscono i rivoluzionari), ottiene la carcerazione di Francesco Di Donato e di altri dodici castelnuovesi 8 9 E’ il sacerdote Vincenzo Di Domenico. Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero di polizia, fascio 3141, volume 8. 202 che hanno capeggiato l’occupazione. Può, dunque, tornare alla carica per far tagliare i boschi. E’ l’intera popolazione di Castelnuovo che il 20 novembre 1849 rivolge una petizione all’Intendente con la quale si denunzia il tentativo di Cassitti: Signor Intendente, Don Giovanni Cassitto del Comune di Teora, non pago d’aver con suoi intrighi e false addebbitazioni strappato dal seno di questa infelice Popolazione e l’innocente cura spirituale, che temporale cioè l’Arciprete Sacerdote Don Vincenzo Di Domenico, e gl’impiegati tutti, e menati i quali nelle prigioni centrali di Salerno per eterna vergogna di detto Comune: e ciò ad uso dell’antico Baronaggio; cerca ora avverare un taglio nelle tenute boscose site nel tenimento del medesimo Comune; ed in cui la popolazione oltre che vi ha sempre esercitato il diritto di morto, secco e selvaggio, qual diritto esisteva in faccia al Comune istesso, hannovi ancor sostenuto da circa tre secoli il litiggio per la proprietà degli antichi Baroni usurpata mediante gli affitti dal Comune agli stessi fatti da novennio in novennio. A qual riguardo ha il signor Cassitto fatte venire persone napolitane a siggillare degli alberi di querce e di cerri. Signor Intendente, aggiungono i cittadini di Castelnuovo, cosa dovrebbe fare il Comune? Rinunziare ai suoi diritti, cedendo alle oppressioni ed ingiustizie; o esercitando le sue proprie forze dovrebbe tutto menarsi a precipizio col pericolo della vita per la difesa dei suoi dritti? La prepotenza di Cassitti, che ha fatto carcerare il sacerdote Di Domenico, riuscirà a serrare a questo Comune ogni giustizia e finanche le porte del Paradiso?10 Salerno, l’ex carcere di Sant’Antonio 10 Archivio di Stato di Salerno, Atti demaniali. 203 Nessun esito ottiene la petizione, se nel febbraio del 1850 i rivoluzionari castelnuovesi sono nella carceri di Sant’Antonio, da dove sottoscrivono una richiesta di grazia, che non è un cedimento né una viltà, ma una pagina di dignità e di fierezza nella riaffermazione del diritto della comunità di disporre di un diritto elementare: quello di raccogliere la legna nei boschi di S. Ilarione e Buoninventre. Ecco la lettera dei carcerati all’Intendente della provincia di Salerno: Eccellenza, Gerardantonio Pugliese, Don Francesco e Don Donato Di Donato, Fedele Pugliese, Michele, Pasquale e Giuseppe Turi, Michele Pezzuto, Pasquale Di Ruggiero, Michele Tavarone, Donato, Giuseppe, e il Sacerdote Don Vincenzo Di Domenico, tutti del Comune di Castelnuovo di Conza in Distretto di Campagna, detenuti in queste prigioni centrali di Salerno, i primi giudicabili, e l’ultimo condannato a sette anni di ferri, umilmente espongono all’E.V., qualmente da circa sette mesi sono stati gittati in queste prigioni, perché imputati da Don Giovanni Cassitti di Teora di trasgressioni forestali. Il fatto è bastantemente noto alla Vostra giustizia, come pure le annose vertenze civili tra il Comune di Castelnuovo, ed il Signor suddetto Cassitti, avendo il Comune medesimo ne’ giorni passati riportata da questo Tribunale Civile una sentenza favorevolissima per la proprietà dei Boschi in quistione. Oltre la pendenza per la proprietà, il Comune da epoca remotissima sta esercitando il diritto di legnare nei detti Boschi, qual diritto fu convalidato da una decisione di Giampaolo. Intanto tutti i cittadini inaspriti per i continui insulti, maltrattamenti, e ricatti, che ricevevano dagl’ingordi Guardaboschi, che tuttodì li molestavano nello esercizio di legnare e per profitto e per farli dimenticare a poco a poco de’ propri diritti, nel giorno tre Maggio 1848 si portarono tutti in massa ad esercitare un tale diritto ne’ prefati boschi. L’avere quindi usato de’ propri diritti, che costituisce un fatto semplicissimo, si è elevato ad un reato di alto criminale, essendosi tutto ritenuto per usurpazione violenta; mentre è risaputo sì dalle pagine della romana sapienza, che dalla giurisprudenza Francese, e nostre leggi attuali, che dove v’è diritto anche malformato non vi è usurpazione. I carcerati di Castelnuovo hanno tutta intera la consapevolezza che il loro non è stato un mero atto di rabbia né di cieca ribellione; la loro azione si inserisce in un secolare processo di rivendicazione delle terre usurpate dai feudatari: Eccellenza, sono circa tre secoli che il povero Comune si è dispendiato per sostenere un giudizio, quanto strepitoso, altrettanto giusto, in modo che nello Archivio Generale di Napoli sonosi impolverati dieci voluminosi processi, spediti da questo Tribunale Civile fin dal 1826. Ed infine per la prepotenza della controparte il risultato del litiggio è stata la rovina di 204 tante disgraziate Famiglie. Eccellenza, le pene, le prigioni, i ferri sono fatti per i malvaggi, per i figli del delitto. Gli oratori sono le persone le più probe, ed oneste del paese, che nel corso della loro vita non si sono macchiati nemmeno di una controvenzione di polizia. Il male si è già fabbricato a danno degl’infelici, e non veggono altro scampo, che quello di ricorrere all’alta Vostra pietà e giustizia, che con la interposizione de’ buoni uffizi presso il Clementissimo Sovrano (D.G.) può certamente implorare la regia parola del perdono, che sarà l’inesplicabile conforto ad una malmenata popolazione, d’inaspettato sollievo a tante desolate famiglie, e d’impareggiabile gloria a Vostro nome. Colui che paga il prezzo più alto per aver guidato la popolazione di Castelnuovo all’occupazione dei boschi è un sacerdote, Don Vincenzo Di Domenico, condannato a sette anni di ferri. Egli non è l’unico sacerdote della provincia di Salerno a schierarsi dalla parte dei rivoluzionari. Pasquale Villani, nel saggio Aspetti della partecipazione del clero salernitano ai moti del ‘4811 ricorda i preti della provincia che hanno subito condanne: insieme al Di Domenico da Castelnuovo vi sono Inverso Toribio da Piano di Orria; De Mattia Luigi da Pisciotta, La Bruna Ferdinando da Massa; Del Buono Francesco da Tremiti; Farro Matteo da Bellosguardo; Parrilli Vincenzo da Gioi; Desio Nicola da Olevano; Serino Ovidio da Carifi di San Severino; De Angelis Pompeo da Castellabate. In tutto il regno gli ecclesiastici condannati sono 74. A giudizio di Villani il fenomeno si spiega con la particolare funzione che Vincenzo Gioberti aveva assegnato al papato e con l’importanza che il mito neoguelfo ebbe nell’opinione pubblica italiana, ragioni per le quali il clero fu sollecitato ad interessarsi alle vicende politiche degli anni intorno al ’48 ed a partecipare a quegli avvenimenti in misura maggiore che non in altri momenti del Risorgimento italiano. L’ampiezza del fenomeno, però, è maggiore di quanto si può ricavare dalle fonti archivistiche civili. Pasquale Villani lamenta che non si siano conservate le raccolte di prediche di quel tempo, ma ritiene che in alcuni comuni i sacerdoti giungessero a predicare la comunione dei beni e suggerisce di dedicare attenzione agli archivi vescovili ove dovrebbe esistere un materiale notevolissimo; la corrispondenza tra parroci e vescovi, e tra questi e le autorità secolari, farebbe certamente luce su alcune situazioni che i documenti degli Archivi di Stato lasciano soltanto intravedere. 11 In Rassegna Storica Salernitana, Gennaio-Dicembre 1948. 205 E’ il caso del processo ecclesiastico a carico di un prete di Auletta, Francescantonio de Amato, che, come il castelnuovese Di Domenico, benedice ed in qualche modo legalizza l’occupazione delle terre. In questo processo compare, anche se in modo deformato, la consapevolezza di contenuti comunistici nelle rivolte contadine del 1848 in provincia di Salerno. Ad oltre un anno di distanza dallo svolgimento dei fatti, in pieno clima di restaurazione, il vescovo di Conza ordina: Si diano cinque giorni Vincenzo Gioberti all’Arciprete di Auletta don Francesco Antonio de Amato per recarsi a Napoli ad audiendum verbum Archiepiscopi; passati i cinque giorni rimanga ipso facto sospeso a divinis usque ad novum ordinem, intimandogli il ritiro di un mese tra i Liguorini di Caposele. Così recita l’imperioso atto di convocazione emesso in Napoli il 12 agosto del 1849 dall’Arcivescovo di Conza Monsignor Giuseppe Pappalardo12. Ubbidisce il parroco di Auletta, ed arrivato a Napoli il 21 di agosto si presentò umilmente al suo Pastore, il quale vedutolo cominciò a caricarlo delle più villane ignominie, e prendendolo per il collo l’obligò alla rinunzia della sua cura Parrocchiale (...) poiché presentatogli innanzi un foglio di carta lo costrinse a scrivere di sua mano l’atto di rinunzia dettandone egli le parole troppo degradanti in un documento da mettersi a notizia del pubblico. E’ consacrato arcivescovo di Conza il 10 giugno 1849 ma, saputo che l’arcidiocesi era una contrada selvaggia e piena di briganti, rinuncia all’incarico il 30 maggio 1850 senza mai uscire di casa. Si veda Giuseppe Gargano, Ricerche storiche su Conza antica, Avellino, 1934. 12 206 Auletta I brani sopra riportati sono tratti da un opuscoletto a stampa dal titolo Ragioni di diritto e di fatto a favore del Reverendo Parroco di Auletta don Francescantonio de Amato contro l’estortagli rinunzia dell’Arcivescovo di Conza contenente sottili argomentazioni giuridiche per dimostrare la nullità dell’ estorta rinunzia con una copiosa documentazione di testimonianze a discarico, datato Napoli 19 ottobre 1849. Di che cosa è accusato il reverendo parroco di Auletta? Nientemeno che di ...aver predicato il Comunismo! Accade, anche ad Auletta come in tanti altri luoghi della provincia di Salerno, che addì 8 maggio 1848 il popolo prenda possesso di alcuni fondi rustici appartenenti a grandi proprietari terrieri del paese; tra gli occupanti c’è il parroco don Francescantonio. In precedenza un gruppo di rivoltosi si è recato in chiesa per richiedere la presenza all’atto di esproprio del sacerdote “quale primaria Autorità” che in qualche modo valga a legittimare la presa di possesso. Il religioso si porta con i rivoltosi presso le terre da occupare, ed entra in un fondo con un coltello da caccia alla cintola. Le testimonianze a discarico dell’Arciprete di cui è fatto cenno nell’opuscoletto non negano i fatti, ma li presentano come costrizioni subite dal prete. La prima testimonianza è di Alfonso Carusi di don Nicola, presente ai fatti ed anch’egli partecipe: forzato da numeroso ed armato popolo ad andare in loro unione alla serra S. Giacomo, per ivi impossessarsi di alcuni fondi 207 del signor don Gerardo Isoldi creduti dalla massa di terrazzani usurpati alla comune… E’ però proprio Alfonso Carusi, sedicente spettatore ed insieme popolazione, ad armare il sacerdote, ovviamente -nella testimonianza a discarico- solo per gioco: per scherzo mi feci lecito levare da dosso ad un certo maestro nominato Francesco Altilio una cortella da caccia lunga circa un palmo, e colle mie proprie mani la cinsi al fianco del detto Arciprete, al quale fatto il rispettabile Curato atteso l’amicizia che fra noi passava, e penetrato dell’innocenza del fatto, non ricusò tenerla al fianco per quel po’ di tempo che ivi ci fermammo, consegnandola poi al sopra indicato maestro, appena da quel luogo ci muovemmo. La stessa partecipazione del parroco al corteo e all’occupazione delle terre è presentata, nelle testimonianze a discarico, come non volontaria, ma, al contrario, imposta con la violenza. Il Sottodirettore dell’Officina Postale, Baldassarre di Matteo dichiara che lo stesso signor Arciprete nel dì 8 Maggio mentre stava in confessionile gli fu spedita una Commissione del popolo la quale con minacce lo condusse a prendere possesso illegale di vari fondi. Un collega di don Francescantonio, il sacerdote Giuseppe Muccioli dichiara che la mattina de’ 8 Maggio 1848, trovandomi in Chiesa verso le ore 10 d’Italia vidi entrare una moltitudine di gente armata, che estrasse dal confessionile il detto Arciprete, e gl’imposero seguirla, in caso che non volesse rimanere vittima del furore popolano. Vittorio Muccioli di don Andrea, “per coscienza e verità del fatto” dichiara che nel giorno otto maggio 1848 gran parte di un popolo sfrenato ed armato, si portò nella Chiesa, ove trovato l’arciprete nel Confessionile, con parole ingiuriose, e minacciose l’obbligarono ad abbandonare detto luogo, e seguirlo nella rivindica de’ suoi diritti, su i fondi, che la sfrenata passione alla rapina, li faceva credere abusivamente posseduti dal Marchese di Auletta ed altri proprietari, supponendo che l’Arciprete come prima autorità, legalizzava la sua operazione, nell’impossessarsene. Dichiaro pure -aggiunge il Muccioli- per quanto mi costa in coscienza di non aver mai inteso predicare dall’Arciprete il Comunismo, anzi colla sua parola ha insinuato sempre fedeltà al Re Nostro Signore (Dio Guardi) ed adesione all’ordine pubblico. Giuseppe e Raimondo Mari attestano di non averlo giammai veduto armato di schioppo, non che predicare in favore del Comunismo. Dieci Sacerdoti del Clero di Auletta dichiarano tutti insieme qualmente la condotta del Reverendo nostro Arciprete D. Francescantonio de Amato è stata sempre lodevole, ed attaccata al real trono del nostro Sovrano, ed infatti nel 1847, allo scoppio della rivoluzione di Calabria dopo celebrato un 208 triduo di preghiere, ordinate da Monsignor Arcivescovo D. Leone Ciampa per ottenere la quiete del Regno, l’Arciprete suddetto tenne un discorso al Popolo col quale insinuava ubbidienza e fedeltà al prelodato nostro Sovrano (D.G.) dimostrando d’essere il di lui governo somigliante al Governo di Dio. Certifichiamo ancora -aggiungono i dieci sacerdoti particolarmente edotti circa le funzioni celebrate da don Francescantonio- che nel giorno 5 dello scorso Agosto (1849) assegnato a ringraziare l’Altissimo per averci concesso la pace generale, il medesimo Arciprete tenne una predica, colla quale dimostrò al popolo che la ribellione è il più tremendo de’ mali, e per evitarlo è sempre necessario prestare fedeltà, amore, ed ubbidienza al Sovrano, come a colui, che ne rappresenta le veci di Dio nell’ordine civile. Attestiamo ancora che nelle sue prediche dette sull’Altare, non ha mai parlato del Comunismo, né parola alcuna abbia proferito in discapito della Augustissima persona di Sua Maestà, e del Ministro, o altro in particolare... . Non mancano testimonianze di gente del popolo che, accanto all’immancabile non ha mai predicato il comunismo, si soffermano sull’uniforme del curato: non è andato mai armato di schioppo o di altro ferro, né vestito di giacca. Firmato Francesco Altilio (quello della cortella da caccia?). Chi è veramente Francescantonio de Amato? Furbo e pericoloso eversore comunista, o calunniato sostenitore della proprietà privata e della monarchia di diritto divino? O, più verosimilmente, un donabbondio nostrano propenso a piegarsi e ad adattarsi al mutevole corso degli eventi? Certo é che negli stessi giorni in cui uno spettro si aggira per l’Europa, anche ad Auletta13, Archidiocesi di Conza, Provincia di Principato Citra, Regno delle Due Sicilie, qualche spiritello il sonno e la quiete dei custodi del governo simigliante al Governo di Dio pure li disturba. Perché, come sostiene Leopoldo Cassese14, le vicende demaniali del 1848 nei paesi del salernitano hanno tutte una esasperante uniformità: Da un lato uno o due grossi proprietari terrieri che avevano costituito i loro latifondi in gran parte a spese del demanio comunale; dall’altro canto una massa grigia di povera gente abituata da secoli al diritto “in comune” degli usi civici sui terreni cittadini, e che, mediante i raggiri di gente senza scrupolo, si vede- Come a Castelnuovo e in tanti altri paesi del salernitano. Leopoldo Cassese, Contadini e operai del salernitano nei moti del quarantotto, in Rassegna Storica Salernitana, Gennaio-Dicembre 1948. 13 14 209 va d’un tratto privata della possibilità di trarre un magro alimento dalla terra di tutti, o “terra comune”: denominazione questa che fece chiamare “comunisti” tutti quei cittadini la cui vita economica era regolata da quelle norme consuetudinarie; di contro c’erano i “demanisti”, signorotti locali i quali tendevano a ridurre le terre a demani feudali, cioè ad appropriarsi dei fondi comuni allo scopo di monopolizzare la proprietà terriera. Per Cassese il comunismo Leopoldo Cassese quarantottesco nel salernitano, come in tutto il mezzogiorno, non fu un’utopia perché trasse origine non da un complesso di dati metafisici o da una ideologia, ma da concreti rapporti sociali che avevano una lunga storia, da effettivi bisogni e da costatazioni di fatto (…) in esso fermentavano idee profonde di uguaglianza, di fratellanza e di libertà (…) fermentavano istinti libertari, e ad essi si abbandonavano le masse di sfruttati chiedendo giustizia, perché nei loro riguardi l’ingiustizia era stata elevata a sistema… Cassese mette anche in evidenza come, nella maggior parte dei casi, le occupazioni delle terre si verificarono con sorprendente disciplina. I contadini spesso si sforzarono di dare forma legale ai loro gesti, oppure trovarono il modo di fare un’occupazione simbolica, dandone poi pubblicità mediante bandi, ed esternando la loro gioia con canti e con spari. Essi erano presentati dai proprietari usurpatori e retrivi come masse vandaliche che distruggevano e ammazzavano, ma –evidenzia Cassese- i contadini ed i braccianti, invece, contestavano da anni quel diritto di proprietà, affermavano che erano stati essi, i padroni, a commettere dapprima ruberie, che avevano poi legalizzate mediante i raggiri e la connivenza dei potenti; e perciò ora intendevano rivendicare i loro imprescrittibili diritti, e rientrare in possesso delle terre che erano state ad essi rubate. 210 5.3 La pace dopo la guerra? La guerra del fuoco, come tutte le guerre, contempla anche momenti di tregua, o di armistizio. Dopo la fiammata rivoluzionaria del 1848, con le speranza suscitate a Castelnuovo, come in tutta l’Italia e l’Europa, si deve registrare la battuta d’arresto delle istanze popolari. Il rivoluzionario Francesco Di Donato, che ha retto la carica di sindaco, è nelle carceri di Salerno insieme al sacerdote Vincenzo Di Domenico ed altri coraggiosi castelnuovesi. Ed anche il decurionato deve in qualche modo adeguarsi, e far risuonare la parola pace. Il 4 agosto 1850 il sindaco Gianvincenzo Annicchiarico così esordisce: Signori Decurioni qui radunati in numero opportuno, il rispettabilissimo Signor Intendente della Provincia onde far diffinire lo strepitoso litigio iniziato da questo Comune fin dai secoli remoti per la giusta rivindica delle usurpate tenute boscose Santo Ilarione e Buoninventre con i corrispondenti locali Pantano Magno, Macchioni e Pianelli; e volendo pure fare restituire la pace a questo Comune non poco sconvolto ed agitato per vedersi strappato dalla prepotenza de’ Baroni le avite proprietà che sono il raggio animatore delle assolute nostre speranze, ed il sollievo alla spaventevole miseria di esso Comune, cerca da Voi rischiarimenti su le seguenti interessanti dimande. L’Intendente vuole sapere dal Comune se negli anni 1557 e 1570 il feudatario di Castelnuovo di Conza era il Signor Don Giovanni Antonio Carafa oppure altro, chiede poi lumi sull’entità della numerazione e valutazione degli alberi fatta eseguire dal Commissario Giampaolo, e sui fondi Pantano Magno, Macchioni e Pianelli. Per tutta risposta il Decurionato, intesa la volontà del Signor Intendente, ed udita la proposta del Sindaco rispondendo al primo quesito osserva che trattandosi di epoche sì rimote, e non avendo a tal uopo documenti, ignora se il Signor Carafa sia stato feudatario di questo Comune. Suggerisce a sua volta, per dirimere pertanto la quistione fin da suoi veri primordi e per vantaggio dell’opera, che il Signor Intendente si compiaccia, giacché ne viene caldamente pregato, chiamare dal Grande Archivio di Napoli dieci ampi processi ed altri titoli ivi inviati dalla Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno fin dal 1826. Il Decurionato soggiunge che vana, inutile e gratuita è la pretensione de’ feudatari in aver voluto sostenere che il denominato Pantano Magno con le corrispondenti contrade Pianelli e Macchioni non siano compresi nei boschi S. Ilarione e Boninventre, ma che siano due fondi tra loro separati e distinti, messi nel territorio dell’ex feudatario di Caposele, e non facienti parte de’ boschi e per conseguenza non compresi nella tenuta di questo Comune; mentre 211 dalla pianta rilevasi il contrario, e da isperimento di fatto e di vista si conosce a chiare note che i suddetti locali sono il tronco ed i boschi le braccia15; se pure non si voglia rimandare a tante deliberazioni esistenti in questo archivio da cui emerge incontestabilmente una tal verità, ed alla soda e costante tradizione che in tal fatto devesi riputare come cosa evidente ed innegabile. Essa in ogni tempo ha riguardato questi fondi come spettanti al Comune e perciò da reintegrarsi perché usurpati da’ Baroni. Infine il Decurionato prospetta un’argomentazione storica che dovrebbe chiudere definitivamente la querelle: l’antica origine di Castelnuovo che, secondo la leggenda giunta fino ai nostri giorni, derivava dall’insediamento nel bosco (Torretta), poi abbandonato a causa dell’abbondanza dei serpenti: Dippiù qual dubbio fondato può mai sorgere che detti locali non siano nel territorio di questo Comune, mentre (…) da dirute abitazioni e macerie esistenti ancora nel bosco di basso e da altri monumenti sparsi in tutta quella contrada, come a dire la Chiesa (la cappella di S. Ilarione) e sepolture, levasi che ivi i nostri avi ebbero la culla, ivi giacciono le loro fredde ceneri, che da lì quai novelli angeli al temuto trono dell’Onnipotente dimandano vendetta su gli usurpatori. Cassitti torna alla carica perché vuole far tagliare gli alberi ed il Decurionato nuovamente si oppone, e chiarisce perché la riseca del 1811 (che avrebbe dovuto compensare gli usi civici) non è stata accettata; gli alberi, conteggiati nelle due tenute in numero di 10.222, erano in realtà 30.600, di cui 12.950 nel bosco di Sant’Ilarione: L’anno 1851 il giorno 16 Febraro in Castelnuovo di Conza. Il Decurionato riunito nella casa Comunale in numero opportuno, e presieduto dal Sindaco, in ordine al taglio che intende fare il Signor Cassitti nel Bosco denominato S. Ilarione è venuto a deliberare a voti unanimi quanto segue: Il Commissario Ripartitore Paolo Giampaolo (…) valutò gli usi civici di legnare ne’ Boschi S. Ilarione e Buoninventre per ducati duemila centoottantuno e grana sessanta in conformità dell’articolo 26 delle Reali Istruzioni del 10 Marzo 1810. Siffatta valuta fu desunta dal numero degli alberi portati dai periti erroneamente e fraudolentemente per diecimila duecentoventidue, mentre il numero effettivo degli alberi è di gran lunga superiore, come dallo stesso istrumento di tali Boschi fatto dal Principe Mirelli al Signor Cappetti, di cui il Signor Cassitti n’è l’erede, rogato per mano di Notar Saverio Epifania di Napoli il dì 10 Dicembre 1807, il numero totale degli alberi ammonta a trentamila e seicento, e particolarmente nel Bosco S. Ilarione ammonta a dodicimila novecentocinquanta. 15 Cioè stanno in mezzo tra il bosco di Sant’Ilarione (a nord) ed il bosco di Buoninventre (a sud). 212 5.4 Altri due fronti di guerra A questo punto nella guerra del fuoco si aprono altri due fronti, dei quali si deve dare conto anche se sommariamente. Da una parte le fortune della famiglia Cassitti vanno calando, tanto che le tenute di Buoninventre e Sant’Ilarione sono oggetto di richiesta di esproprio avanzata dai creditori; e questo è il primo fronte. Il Comune di Castelnuovo eccepisce in Tribunale che Buoninventre e Sant’Ilarione sono gravate dalle richieste avanzate nel 1818, per le quali è in corso il giudizio, e chiede che sia impedito l’esproprio. Si tengono vari giudizi che si concludono con la sentenza della Gran Corte Civile dell’11 gennaio 1860 la quale stabilisce non doversi impedire l’azione dei creditori finalizzata all’esproprio (e alla messa all’asta) dei beni della famiglia Cassitti, salvo però il diritto del Comune di Castelnuovo di far valere le sue pretese come per legge e contro chi sarà di ragione. Sul secondo fronte, la famiglia Cassitti (ora guidata da Teresa Carelli, vedova di Giovanni) tenta, ancora una volta, di far tagliare i boschi per venderne la legna; e riesce anche ad ottenere alcuni permessi amministrativi. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 18 settembre 1861 (siamo nell’Italia unita) così scrive al Governatore (non più Intendente) della Provincia di Salerno: La Signora Teresa Carelli vedova del Cav. Giovanni Cassitti si fece a chiedere la dissodazione del suo fondo detto S. Ilarione sito nel territorio di Castelnuovo di Conza. Il Consiglio Forestale tenuto presente il verbale di verificazione redatto dalla Commissione creata a norma dell’art. 18 della legge forestale in vigore, con deliberazione del 13 p.p. mese, ha portato avviso di potersi permettere, giusta la proposta della detta Commissione, il dissodamento e disboscamento delle seguenti cinque partite di terreno, le quali complessivamente formano la estensione di tomola 150 pari a moggia legali 882 circa. Delle tomola 10 (m.l. 58,80) nella contrada Acqua di Antonio inclinate gradi 6 ad 8 Delle tomola 30 (m.l. 176,40) sull’alto piano inclinate gradi 2 a 4 Delle tomola 10 (m.l. 58,80) nella contrada sopra la Pila inclinate gradi 2 a 4 Delle tomola 60 (m.l. 362,80) nella contrada Pila di sopra e di sotto inclinate gradi 4 ad 8 Delle tomola 40 (m.l. 236,80) nella contrada Serra di Palumbo inclinate gradi 4 a 6 a condizioni che il terreno sia ridotto a scaloni fatti con ogni regola d’arte, e che dette quote di terreno a dissodarsi sieno misurate e circoscritte con termini 213 lapidei inalterabili, dal rimanente del fondo stesso da lasciarsi saldo boscoso; restando alla Superiore Autorità decidere quello che meglio creda nella contesa di proprietà. Richiesto il Consiglio Amministrativo a dare il suo parere, lo stesso adottando quello del Consiglio forestale ha espresso il voto che possa autorizzarsi il dissodamento in parola nelle cinque partite di terreno descritte nella deliberazione del Consiglio forestale del 13 Agosto ultimo ne’ modi e sotto le condizioni notate nella stessa, e salvo lo sperimento delle ragioni che possano competere ai terzi sul fondo di cui fan parte le cinque partite in quistione da usare come per legge. In forza di poteri concessi con Decreto del 6 Ottobre 1860 approva il chiesto dissodamento in conformità degli avvisi resi dal Consiglio forestale, ed amministrativo e sotto l’espressa condizione di restar saldi i dritti e lo sperimento delle ragioni che possono i terzi far valere presso chi e come per legge. Nel darle comunicazione della presente risoluzione le fo rilevare ch’essendo interessato nella contesa il Comune anzidetto per asseriti dritti di uso civico di legnare ella procederà alla liquidazione de’ dritti del Comune pria che il taglio delle piante ed il dissodamento si avveri, giacché facendo altrimenti il dritto di legnare verrebbe caducato quando le piante fossero preventivamente abbattute e il terreno dissodato, colla ingiunzione a Lei di prevenire di ciò anche il Commissario dimaniale. Forte di tale approvazione la vedova Cassitti affida il taglio del bosco a tale Pasquale Scafidi, ma il Comune di Castelnuovo si oppone e si rivolge al Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Il risultato è che dal Ministero si ordina che sia sospeso ogni procedimento in sino a che sarà chiarito il dritto che sostiene il Comune. Viene così salvato il bosco di Sant’Ilarione da un vero e proprio scempio, forse la totale distruzione, non soltanto per il richiesto taglio degli alberi, quanto per il dissodamento ed il terrazzamento (la riduzione a scaloni) di gran parte della montagna. Il Comune di Castelnuovo vince su entrambi questi altri due fronti, per così dire, secondari. 5.5 La fine della guerra del fuoco. Castelnuovo vince anche sul fronte principale L’azione dei creditori di Cassitti per ottenere l’esproprio di Buoninventre e Sant’Ilarione si conclude il 17 aprile 1874 con la messa all’asta delle due tenute e l’aggiudicazione provvisoria al sacerdote Vito Di Geronimo. Nel 214 termine di legge si rende sovraimponente di sesto a detta aggiudicazione provvisoria per ambedue le tenute l’avvocato Francesco Frieri. Il 29 maggio 1874 si procede all’incanto in grado di sesto e l’avvocato Frieri si aggiudica due lotti (il bosco di sotto Buoninventre o Torretta, e la parte centrale a coltura); il terzo lotto (bosco di sopra o Sant’Ilarione) è aggiudicato a Vito Di Geronimo. Machioni, Pianelli e Pantano Magno ricadono nei due lotti aggiudicati al Frieri. Il 5 dicembre 1879, poi, Vito Di Geronimo vende Sant’Ilarione ai suoi fratelli Girolamo, Pasquale, Vincenzo, Antonio e Valentino. Effettuato l’esproprio e la vendita all’asta di Buoninventre e Sant’Ilarione, l’azione giudiziaria del Comune di Castelnuovo per la rivendica di Machioni, Pianelli e Pantano Magno, avviata nel 1818, subisce una accelerazione. Finalmente si concretizza la perizia ordinata dal Tribunale di Salerno nel 1821, ed il 24 maggio 1875 viene pronunciata la sentenza di primo grado che fa proprie le ragioni del Comune ed ordina la restituzione dei fondi usurpati. Ecco il dispositivo della sentenza: il Tribunale, intesi i Procuratori comparsi, pronunziando in contumacia dei signori Romualdo, Saverio, Salvatore, Alberto, Amalia e Virginia Cassitti ed Olimpia Cassitti autorizzata dal marito Signor Arcangelo Corona, Silvia Cassitti autorizzata dal marito Signor Giacomo Magnoliverio, ed Emilia Cassitti autorizzata dal marito Alessio Perna, (…) condanna essi Signori Cassitti a rilasciare al Comune di Castelnuovo di Conza la controversa tenuta Torretta o Torricella colle località Pantano Magno, Pianelli e Macchioni nella circoscrizione e confinazione riconosciuta dai periti Massanova, Cerimele e Mastrocinque con la relazione del 24 settembre 1874, ed al pagamento dei frutti percepiti dal dì della domanda spiegata col libello del 18 Giugno 1818 fino all’effettivo rilascio, da liquidarsi mercé specifica. La ricostruzione storica della complessa vicenda giudiziaria della “guerra del fuoco” non può che limitarsi a riportare la decisione del Tribunale, escludendo l’analisi delle ragioni formali su cui si regge il giudicato. Va, in ogni caso, sintetizzato il ragionamento che è alla base del convincimento dei giudici del Tribunale di Salerno. I legali del Comune di Castelnuovo sostengono che Pantano Magno, Macchioni e Pianelli altro non sono che denominazioni di parti che tutte insieme corrispondono alla tenuta Torretta; e dimostrano, inoltre, che la denominazione Buoninventre si riferisce ad altri fondi siti in Caposele. Più esplicitamente, gli avvocati del Comune di Castelnuovo sostengono che il toponimo Buoninventre non si riferisce al bosco in contestazione. Ed il Tribunale accoglie questa argomentazione. 215 Lo stesso assunto è fatto proprio dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza dell’8 maggio 1876, rigetta tanto le domande e deduzioni dell’interventore Prattico, quanto gli appelli dei signori Prattico e Cassitti contro la sentenza del 24 maggio 1875, pubblicata addì 31 detto, e confermandola ordina che si esegua. Accoglie poi l’appello per incidente del Comune, modifica il capo della sentenza relativo ai frutti e condanna i signori Cassitti a restituire i frutti medesimi da agosto 1810 sino al rilascio dei fondi. E’ la vittoria piena del Comune di Castelnuovo, al quale viene riconosciuto il diritto alla restituzione dei frutti non già dal 1818, data dell’inizio della vertenza, ma dal 1810, data della decisione della Commissione feudale, contestata come abbiamo visto. Questa sentenza, però, non diventa mai esecutiva. Ad essa si oppongono alcuni creditori di Cassitti, e la Corte di Appello di Napoli, con altra sentenza del 16 marzo 1877, ordina la ripetizione della perizia sui fondi in contestazione. Questa sentenza, su ricorso del Comune, il 13 giugno 1878 viene annullata dalla Corte di Cassazione, che ordina un nuovo giudizio. Ma il 18 aprile 1879 una diversa sezione della Corte d’Appello conferma la sentenza del 16 marzo 1877 che ordinava la ripetizione della perizia. Nuovo ricorso del Comune, e nuova decisione della Cassazione, che il 3 luglio 1880, a sezioni riunite, annulla anche la sentenza del 18 aprile 1879 e passa nuovamente la palla alla Corte d’Appello. E allora? A questo punto il Comune di Castelnuovo sceglie un’altra strada. E’ l’intuizione del nuovo sindaco Girolamo Di Geronimo, alla guida dell’amministrazione cittadina da appena due anni: giungere ad una transazione con i creditori di Cassitti. Pagare loro qualcosa ed entrare in possesso, dopo oltre settanta anni di guerra del fuoco, dei fondi contesi, evitando per di più una pericolosa ripetizione della perizia (che avrebbe potuto essere non più favorevole a Castelnuovo). E così l’anno 1881, il giorno 12 di febbraio, Girolamo Di Geronimo riunisce il Consiglio comunale. Sono presenti oltre al sindaco, i consiglieri Antonio Di Geronimo; Pasquale Di Geronimo; Pasquale Turi; Antonio Cozzarelli; Francesco Ricciullli; Erberto Venutolo; Francesco Di Guglielmo; Vincenzo Di Donato; Vincenzo Iannuzzelli. Sono assenti Giovanni Annicchiarico, emigrato; Francesco Rosania; Valentino Di Geronimo; Vito Ricciulli; Giovanni Tavarone. Il verbale della seduta così inizia: Il Sindaco presidente è lieto di annunziare la mai tanto sospirata e giusta novella della rivendicazione della tenuta Comunale Torretta che costò duri sacrifici a queste Comunali sostanze per opera di antiche pre216 potenze e di malintesi indipendenti santuario di umane coscienze. La Dio mercè, l’intemerata giustizia, compenetrandosi e convintasi della pienezza delle ragioni del Comune, emise il suo verdetto di piena giustizia e riconfermò nei modi e termini di legge i reclamati suoi diritti; ma per mettere una diga a possibili ulteriori cavillosi procedimenti, che intralciar potessero il retto andamento di questa Comunale Amministrazione, e per fare del pari una buona volta finita questa causa di amari saGirolamo Di Geronimo crifici, a cui contro ogni sua volontà e principio di giustizia dové soggiacere il Comune medesimo nel sostenere le sue ragioni da remote epoche e potersi immettere nel legittimo possesso del suo Demanio suddetto, sottomette al Consiglio la sua proposta di transazione. Questi sono i termini della proposta: 1. I creditori rinunziano formalmente ai gravami di opposizione e di rivocazione, avvanzate (…) riconoscendosi da essi denunzianti come proprietà demaniale del detto Comune di Castelnuovo di Conza la enunciata tenuta Torretta nei suoi confini, siccome fu dichiarato con le sopraddette sentenze del 31 maggio 1875 e 12 maggio 1876, consentendo perciò essi rinunzianti suddetti che il Comune di Castelnuovo di Conza proceda immediatamente alla presa di possesso della tenuta rivendicata Torretta nei confini descritti nella ripetuta sentenza del 31 maggio 1875 e nella perizia del 24 settembre 1874 eseguita dagli ingegneri Cerimele, Mastrocinque e Massanova. 217 2. Il Comune di Castelnuovo di Conza, stante la detta rinunzia, abbandona a favore di essi rinunzianti la somma di Lire cinquemila (…) All’uopo il Sig. Girolamo Di Geronimo e quale Sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza, ed in proprio nome si obbliga depositare fra mesi due dalla presa di possesso suddetta nella Cassa dei Depositi e Prestiti la detta somma di Lire cinquemila a favore della massa dei creditori. 3. Il Comune medesimo rinunzia totalmente a qualunque possibile suo diritto di rivalsa per spese e compensi dell’intero giudizio (…). 4. Della presente transazione, dopo accettata con deliberazione del Consiglio Municipale di Castelnuovo di Conza, debitamente approvata dalla Deputazione Provinciale di Salerno, le parti transigenti si obbligano provocarne la omologazione, con conclusioni uniformi, dalla terza Sezione della Corte di Appello di Napoli presso di cui la causa transatta è pendente in grado di nuovo rinvio della Corte di Cassazione di Napoli. Il Consiglio, vista la proposta del Signor Sindaco tendente a concretizzare nei più ampi modi di legge la transazione con gli opponenti di terzo accennati nella sua lodevole proposta, a voti unanimi approva la proposta istessa in tutte le sue parti niuna esclusa od eccettuata, e ciò al solo fine di risparmiare, come per spirito patriottico lodevolmente si è proposto dal Sindaco stesso, questo Comune da ulteriori e cavillosi giudizi civili. Prega vivamente l’Onorevole Deputazione Provinciale di Salerno a voler approvare al più presto possibile il presente deliberato, onde por fine ad una lite secolare e mettere il Comune in stato florido. Infine il Consiglio stesso sente per spontaneo affetto e vera riconoscenza l’indeclinabile dovere di ringraziare l’Egregio Signor Sindaco Girolamo Di Geronimo per aversi dato quell’interesse e premura che non ha pari nell’attuare e compiere, sia come onesto cittadino, che come Sindaco di questo Comune, i sacrosanti diritti da tanto tempo reclamati da questa popolazione sulla rivendicata tenuta Torretta o Torricella, e ripone altresì in lui tutta quella divozione e quella fede di onesto patriota di questo paese, che a suo onore e benemerenza gli affidava i destini. Trascorre meno di un anno (il tempo per l’omologazione della transazione presso la Corte d’Appello di Napoli) ed ecco che il 24 Gennaio 1882, il sindaco Girolamo Di Geronimo può finalmente scrivere al Prefetto della Provincia di Salerno nei termini del bollettino finale di una guerra vittoriosa: Son lieto di manifestare alla S.V. Ill.ma che nel giorno 22 volgente la Corte di Appello di Napoli omologava la transazione della lite circa la rivindica della vasta tenuta Torretta per la quale da secoli si sostenne strepitoso litigio con 218 Il bosco di Buoninventre che, col nome di tenuta Torretta, diventa di proprietà comunale gli eredi Cassitti di Teora e poscia con gli opponenti di terzo al numero di 36; cagionando gravi dispendi ed amari sacrifici alle sostanze di questa Azienda Comunale, ed ora, la Dio mercè, ogni ambagia e minaccia di miseria è svanita da questa Cittadinanza che, all’annunzio di questa finale vittoria e della presa di possesso ordinata dalla stessa Corte e che avrà luogo fra pochi altri giorni, è tutta esultante e ricolma di gioia, ed io finalmente oggi più che mai son felice per aver raggiunto questo scopo, di vedere cioè questa mia amministrazione fatto riconquistare il pingue patrimonio usurpato a questo Comune nei tempi del feudalismo. Tanto partecipo alla S.V. Ill.ma, consapevole quanto possa tornarle grata questa novella esprimendo miglioramento morale e civile di questa Amministrazione Comunale e della pubblica finanza del Paese. 5.6 Il distacco in compensazione degli usi civici. Un ulteriore fondo passa al Comune Ottenuto il bosco di basso, detto Buoninventre o Torretta, al Comune spetta ancora una porzione di terreno corrispondente al valore di Ducati 2181,60 come stabilito con con l’ordinanza del 3 agosto 1811 dal Com219 missario ripartitore, Paolo Giampaolo. In effetti, come abbiamo visto, nel 1811 si era anche proceduto al distacco nella parte prossima all’abitato, di moggia 31 e ½ sul bosco di basso detto Beninventre tutti arborati di cerri e querce, distacco però mai riconosciuto ed accettato dal Comune, impegnato prioritariamente a vedere riconosciuto il diritto di piena proprietà sui fondi usurpati. Il Consiglio comunale si riunisce il 15 giugno 1882 ed il sindaco Girolamo Di Geronimo legge una nota del sottoprefetto che così recita: La S.V. è autorizzata a convocare in seduta straordinaria codesta Rappresentanza Comunale per deliberare sulla convenienza o meno di eseguirsi il distacco della reseca al Comune conceduta dal Commissario Ripartitore Signor Giampaolo con ordinanza 3 agosto 1811, mediante assegno a farsi dai creditori istanti della famiglia Cassitti e dello intero Lotto, che prima fu aggiudicato a Francesco Frieri, ed ora si appartiene a detti creditori, confinante col Demanio Comunale Torretta. Il Consiglio comunale, ammirandosi sempre più lo zelo e la continua cura del Sindaco Girolamo Di Geronimo nella realizzazione del patrimonio Comunale, delibera unanimemente un voto di lode e della più viva e sentita riconoscenza in nome del Paese. Quanto al merito, delibera altresì accettarsi che il Comune per le tomola 31 e ½ pari ad ettari 10 ed are 71, cui ha dritto per l’ordinanza del 3 Agosto 1811 e per la sentenza del 1855, si faccia assegnare il restante terreno Buoninventre o Torretta nello stato in cui presentemente trovasi delimitato dalle confinazioni dei comproprietari del Demanio Comunale. Nei giorni dal 10 al 13 maggio 1883, in Castelnuovo di Conza e sulle tenute Buoninventre e Sant’Ilarione, l’agente demaniale Giuseppe Congedo, delegato dal Prefetto di Salerno nella sua qualità di Regio Commissario Ripartitore, procede al distacco in favore del Comune. Nel verbale delle operazioni di distacco si legge: Ci siamo recati sulla tenuta Buoninventre e Sant’Ilarione in unione dei detti periti e dell’indicatore Sig. Erberto Rimardi. Ivi giunti, abbiamo rinvenuti sul luogo il Signor Francesco Di Guglielmo Consigliere Comunale delegato a rappresentare il Comune ed il Signor Vincenzo Dottor Di Geronimo, i quali hanno dato i loro rilievi a voce chiedendo che la riseca fosse attuata sulla restante parte aggiudicata al secondo lotto al Signor Frieri, non essendo giusto che i Sigg.ri Di Geronimo soffrano un gravissimo danno dal vedersi spogliati di una proprietà acquistata a carissimo prezzo per espropriazione forzata, mentre il Sig. Frieri non si oppone al rilascio del restante terreno del secondo lotto essendo aggiudicatario inadempiente. Le operazioni di distacco del fondo da trasferire al Comune così proseguono: Innanzitutto abbiamo esattamente accertato nei suoi confini ed estensione il demanio reintegrato al Comune, detto Buoninventre e Torretta, giusta la 220 perizia del 24 settembre 1874, eseguita dai Signori Massanova, Ceriniola e Mastrocinque, la quale zona comprende tutto il primo lotto e parte del secondo dell’intera tenuta espropriata ai Signori Cassitti come di sopra si è detto. Successivamente abbiamo portato l’esame tanto sul restante terreno del secondo lotto aggiudicato al Sig. Francesco Frieri ed amministrato dal Sig. Vito Nicola Di Geronimo, quanto sul terzo lotto posseduto dai fratelli Di Geronimo nella contrada Sant’Ilarione. Poi abbiamo considerato che non è giusto ed equo eseguire il distacco sul terzo lotto posseduto dai Signori Di Geronimo nella contrada Sant’Ilarione perché costoro ne hanno fatto acquisto dal fratello Vito Nicola, e questi per espropriazione forzata pagandone prontamente il prezzo aumentato in grado di sesto a Lire 81.40016 quandoché dai periti dell’espropriazione fu valutato per Lire 29.712,70 e stante l’insolvibilità dei debitori espropriati, non avrebbero essi Di Geronimo come rivalersi dell’ingente somma sborsata. Oltre a ciò hanno essi eseguito delle positive migliorie permanenti su quel terreno, edificando un comprensorio di case di campagna con varie camere per proprio uso e dei massari, con stalle, ovili, pagliare, pozzi, depositi di cereali ecc. con piantagioni di viti, con alberi fruttiferi e boschivi. Il “casone” di Sant’Ilarione in un disegno di Pasquale D’Elia La tenuta di S. Ilarione è acquistata, con ogni probabilità, con i profitti provenienti dal commercio dei coralli praticato dai fratelli Di Geronimo (Valentino, Girolamo, Giuseppe, Pasquale) nei diversi continenti. 16 221 L’agente demaniale Congedo motiva ulteriormente la scelta del fondo da distaccare: Invece eseguendosi il distacco sulla restante zona del secondo lotto nella contrada detta Costa dei Laghi e Piano della Quercia si ha un terreno in buona parte seminatorio, più vicino al paese ed in adiacenza del Demanio Comunale detto Torretta reintegrato dal Comune; di guisa che la zona del secondo lotto incorporata al Demanio Comunale Torretta formando una sola tenuta offre il vantaggio di potersi quotizzare a pro’ dei miseri proletari del Comune con maggior facilità e minore spesa. Da ultimo trattandosi di un terreno, il cui valore non è stato soddisfatto dall’aggiudicatario Signor Frieri (onde trovasi attualmente posseduto dall’amministratore giudiziario nell’interesse della massa dei creditori), non vi è, né vi può essere, opposizione di sorta da parte di costoro. Epperò ragionevolmente il Municipio di Castelnuovo di Conza con le su cennate deliberazioni del 15 giugno 1882 e dell’11 maggio 1883 ha dimandato che il distacco sia da noi eseguito sul terreno del secondo lotto aggiudicato al Sig. Francesco Frieri. La conclusione è che: unanimemente abbiamo creduto di escludere dal distacco il terreno del terzo lotto posseduto dai Signori Di Geronimo, ed invece distaccare la zona spettante al Comune di Castelnuovo di Conza sul terreno del secondo lotto aggiudicato al Signor Francesco Frieri giusta la suddetta sentenza del 15 giugno 1874. Il risultato delle operazioni di distacco è riportato sulla piantina redatta in data 13 maggio 1883 e sottoscritta dall’agente demaniale Congedo e dai periti Gerardo Vetromile e Michele Trimarco. Alla conclusione di una vertenza secolare il Comune di Castelnuovo entra in possesso di tutto il bosco di Buoninventre, sotto il nome di tenuta Torretta, nonché di un ulteriore fondo adiacente al bosco di tomola 31 e ½ pari ad ettari 10 ed are 71. Meglio di così non poteva andare. 5.7 Partiti e schieramenti a Castelnuovo di fine Ottocento Il risultato ottenuto dall’amministrazione Di Geronimo non è però condiviso da alcuni cittadini di Castelnuovo i quali producono diversi ricorsi in materia. Essi vorrebbero che il distacco del fondo in compensazione degli usi civici fosse praticato sulla tenuta di Sant’Ilarione acquistata, come abbiamo visto, dai fratelli Di Geronimo. Il Prefetto di Salerno, però, con ordinanza del 13 Ottobre 1885, approva il verbale dell’Agente Demaniale e conseguentemente l’eseguito distacco. Ciò nonostante, quaranta cittadini chiedono l’annullamento delle operazioni demaniali effettuate dall’agente Congedo. Il Consiglio comunale di Castelnuovo il 30 gennaio 1888 222 Pianta di Buoninventre e Sant’Ilarione con il distacco del 1883 223 Il fondo distaccato nel 1883 a favore del Comune in compensazione degli usi civici, che si aggiunge alla tenuta Torretta ottenura a conclusione della contesa giudiziaria. respinge questo ricorso, ed i quaranta cittadini chiedono l’annullamento della delibera del Consiglio. Ma nella seduta del 12 aprile 1888 il Consiglio di Prefettura approva la delibera del Comune. Il ricorso contro il distacco operato dall’agente demaniale Congedo ed altre iniziative contro l’amministrazione comunale guidata da Girolamo Di Geronimo trovano spiegazione nell’accesa contrapposizione tra gli opposti schieramenti politici di Castelnuovo. E’ una relazione del Regio Delegato Straordinario Giuseppe Provaroni, il quale a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale regge per alcuni mesi le sorti di Castelnuovo, a gettare luce sugli schieramenti che si fronteggiano, e ad inquadrarli nella situazione politica dell’Italia post-risorgimentale. Come si sa, l’atto finale del processo di unificazione italiana è la breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, che sancisce l’annessione di Roma allo stato italiano e la fine del potere temporale del Papa. Ma Porta Pia è anche una ferita profonda nei rapporti tra Stato e Chiesa. Pio IX si ritira sdegnosamente in Castel Sant’Angelo e dopo qualche giorno emana l’enciclica Respicientes ea con la quale dichiara ingiusta, violenta, nulla e invalida l’occupazione di Roma. Nel 1874 emana il Non expedit (non conviene) con cui proibisce ai cattolici italiani la partecipazione alle elezioni ed alla vita politica. L’Italia è governata dal 1876 dalla cosiddetta Sinistra Storica, di 224 matrice ideologica liberale e progressista, improntata alle idee mazziniane e garibaldine. Essa ha come suoi esponenti di spicco prima Agostino Depretis e poi Francesco Crispi. A Castelnuovo, nel 1878 si registra nell’amministrazione comunale l’affermazione dello schieramento che si richiama alla Sinistra. Il nuovo sindaco, di appena 31 anni, è Girolamo Di Geronimo che, salvo qualche breve interruzione, guiderà il Comune fino al nuovo secolo. L’accesa polemica tra gli opposti schieramenti che si contendono la guida del Comune porta allo scioglimento del Consiglio comunale con Decreto del re del 31 luglio 1887 e la nomina del Regio Delegato Straordinario Giuseppe Provaroni. Si tengono nuove elezioni amministrative per il nuovo Consiglio comunale, che risulta così composto: Girolamo Di Geronimo, Antonio Del Vecchio, Antonio Di Geronimo, Valentino Di Geronimo, Pasquale Di Geronimo, Giuseppe Ricciulli, Francesco Sibilia, Antonio Cozzarelli, Francesco Di Guglielmo, Donato Di Donato, Michele Mariano, Luca Turi, Vincenzo Di Donato, Vito Del Vecchio e Vincenzo Rosania. Il 10 dicembre 1887 si insedia il nuovo consiglio comunale davanti al quale il professor Provaroni presenta il resoconto della sua attività. In questa occasione si lascia andare ad una illuminante analisi sulla dialettica politica del tempo ed individua due partiti: il partito di sotto di matrice clericale, ed il partito di sopra di ispirazione liberale e progressista. Ecco cosa evidenzia il Regio Commissario17: Anche in questo, come in quasi tutti i Comuni, esistono due partiti; in ciascun luogo hanno diverse origini, a seconda delle diverse cause che li generano. Qui, il germe dei partiti, anzitutto ha una lieve parte nella politica: l’uno risente più dell’altro delle vecchie istituzioni, si mantiene più devoto al Clericalismo Francesco Crispi (che in ogni più remoto angolo d’Italia Giuseppe Provaroni, Relazione letta al Consiglio Comunale di Castelnuovo di Conza nella seduta del suo insediamento, addì 10 dicembre 1887, Napoli, Stabilimento Tipografico A. Tocco e C., 1888. 17 225 I bersaglieri italiani entrano a Roma il 20 settembre 1870 fa capolino), e lascia che nel suo focolare soffi sempre il fanatismo del prete, questo si distingue col nome di Partito di Sotto. L’altro, meglio ispirato ai principi di libertà e di progresso, più devoto alle attuali istituzioni, si nomina Partito di Sopra. Pel resto, quel germe ha la sua gran parte nelle discordie locali, generate da ambizioni di potere, da interessi privati e comuni, nonché da invidie per posizioni sociali e finanziarie. Questi partiti rimontano ad epoca abbastanza lontana, ma il loro accentuarsi risale a quella in cui un Sindaco, facendosi scudo della legge 6 luglio 1871, modificante quella del 1865 sulla Pubblica Sicurezza, a scopo di private vendette, faceva ammonire tutti quei cittadini che non la pensassero a modo suo, che si ribellassero al dispotismo cui dava prova, che fossero stati invisi alle eccleLa relazione Provaroni del 1887 226 siastiche autorità locali, e che non si arruolassero, con giuramento, nelle file del suo partito. Pur sapendo che quei cittadini erano onesti e probi, oltreché essere fra i meglio censiti del paese. Fece dippiù, ordì trame, per fare instruire processi penali che poi sfumarono, fece sequestrare lauree, da lui sognate false, ordinò arresti, insomma terrorizzò addirittura questa popolazione. Così accentuandosi le lotte dei due partiti qui nacque assolutamente un caos. E dallo dibattersi di un partito morente, ed ormai esecrato da chi aveva ancora sangue nelle vene, e dallo svilupparsi e crescere dell’altro, nel Consiglio Comunale di allora, trovaronsi diversi ed eterogenei elementi, e nel 1877, il Re pose riparo a tale baraonda, con lo scioglierlo. Le elezioni generali del 26 agosto 1877, sortirono un effetto che poco giovò, a tutta prima, per calmare la burrasca, tantoché, su 15 consiglieri, riuscirono eletti solo 5 del secondo partito, per effetto di falsificazione di atti più tardi punita, e dall’intromissione clericale, nella lotta. Ma, nella coscienza di alcuni degli altri 10 eletti, presto subentrò la ragione e la rettitudine tanto da sdegnare le false e calunniose insinuazioni loiolesche18 del proprio partito, e dopo poche sedute, passarono nelle file della minoranza, costituendola maggioranza. Fu proprio allora, che il Governo del Re, nominò fra questa nuova maggioranza, con Decreto del dì 10 marzo 1878, il SindaUmberto I, Museo d’arte della città di Ravenna co, in persona del signor Girolamo Di Geronimo19. Da quell’epoca ad oggi, il crescente e progressivo sviluppo della coscienza nazionale del popolo, fece sì che al primo partito non fosse più dato quartiere nelle ingerenze della Casa Comunale. Il Regio Commissario Provaroni ricostruLoiolesche=gesuitiche, in senso dispregiativo. La Legge Comunale e Provinciale del 1865, all’art. 98 prevede che la nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere. 18 19 227 isce la genesi dello scioglimento del Consiglio comunale e riporta quanto accaduto il giorno delle elezioni. Pure il soccombente partito, sperò in un nato morto sistema che tutto trasformava, ritrovare una via a rivivere, e di bel nuovo imbaldanzito, per sognate conciliazioni, scosso dal suo letargo, ritornò a far capolino. Saputo come una strepitosa lite civile20, che durava da circa un secolo, era stata definita, e con esito felice, dai nuovi venuti alla pubblica Azienda, e mal tollerando che questi ne riscuotessero il meritato plauso, con le sue vecchie armi gesuitiche intorbidò le acque. Fece credere a’ gonzi ed alle genti zotiche, che i capitani di quel vincente avverso partito, ne avessero tratto vantaggio, coll’usurparsi parte delle terre, in quella lite riscattate dal comune. E poco stentò nel trovare chi, balordamente, vi credesse. E, per sempreppiù ingrossare le sue file, si mise a parteggiare persino in favore di colui che pretendeva un compenso di oltre CENTOMILA LIRE, per la difesa del Comune in quella lite, e che dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e Salerno venne ridotto a sole lire 34950,36, che pure la disciolta amministrazione –sentito il parere di Illustri Giureconsulti- riteneva esagerato, ed offriva sole lire 16000, mentre dal partito di sotto si cercò sempre, a danno del Comune, di animare il pretendente, a resistere tenacemente facendogli sperare tempi migliori. Così aumentate le sue file, e trovato in un licenziato Segretario Comunale il braccio forte per fare redigere lunghi memoriali, e male, o meglio, a suo talento, informare le Superiori Autorità, vide sciolto il Consiglio, e sognò il ritorno al potere. Ma, avendo coscienza che il calmo ragionare, per quanto lungamente avesse atteso a preparare terreno, a nulla gli sarebbe giovato, pensò, all’ultim’ora, e proprio nel giorno delle elezioni generali, ricorrere alla violenza. Difatti, mentre si apriva questa residenza comunale per dare adito agli Elettori, che qui convenivano in Comizio, quel partito promosse un ammutinamento di popolo, per la più parte rappresentato ridicolamente da donnicciole, con alla testa la bandiera della società di mutuo soccorso, di cui il Di Deo è il Direttore, tentando di fare invadere appunto questa residenza. Trovata la resistenza, prima in me che a quella masnada barricai del mio petto la porta, pur lasciandola aperta agli elettori che tranquilli e dignitosi si recavano alle urne, poi negli agenti della pubblica forza, chiamati a custodirla, con strepiti assordanti, con grida di evviva e morte, con minacce ecc., si tentò –come in principio vi dissi- di intimidire il Corpo Elettorale, onde avesse votato in suo favore. Ma la coscienza della maggioranza E’ la vertenza per la proprietà del bosco di Buoninventre (Torretta) felicemente portata a compimento dall’amministrazione di Castelnuovo. 20 228 degli Elettori si ribellò a quelle inqualificabili e ridicole sommosse, e dall’urna riuscì vittoriosa la MORALITA’. Degna risposta ai mestatori e fanatici figli dei tempi che furono!... E’ inutile v’intrattenga più a lungo in narrarvi le gesta dei partiti; voi meglio di me le conoscete, ed io stimo meglio opportuno parlarvi della mia gestione e del come trovai la cosa pubblica, di come ve la rendo, e di quanto a voi spetta di fare, onde migliorarla. Il Regio Commissario dà poi conto del suo operato nei diversi settori dell’amministrazione, e segnala al nuovo Consiglio alcune questioni da affrontare e risolvere. Ecco alcuni stralci del suo discorso per i diversi settori: Casa comunale. Anche in questo come in molti altri comuni si ha il disdoro di vedersi a casa a pigione, e meno male se il paese offrisse un locale ove, con necessaria comodità e voluta decenza, potesse venir posta la residenza del Comune, che per essere la casa di tutti, bene a ragione reclamerebbe e la comodità e la decenza, ma qui non abbiamo che un abituro qualunque che, per tutto vantaggio ci viene affumicato, come tana da volpe, dagli abitanti del piano sottostante tanto da vedere ogni carta resa lurida e poco meno che illeggibile. E pure, date le circostanze locali, devesi o bere o affogare. A me fu assolutamente impossibile migliorare, come avrei voluto, tali condizioni, perché affatto privo dei necessari mezzi, e perfino del Bilancio ove cercare, se possibile fosse stato, un qualche articolo strornabile all’uopo. A voi raccomando di fare quanto è in voi possibile per rimuovere tale sconcezza. Sanità pubblica. Per quanto anormali sien corsi, in fatto di pubblica sanità i mesi estivi ed autunnali di quest’anno in varie provincie e specialmente in questa e nella limitrofa di Avellino, pure mercè una straordinaria pulizia di vie, piazze, case e stalle, da me e dalla Commissione di Sanità Municipale, rigorosamente sorvegliata, mediante anche il rigore spiegato nel sorvegliare che ogni commestibile ed ogni bevanda, e più specialmente la frutta, messa in vendita in questo Comune, fossero state fresche e sane; aggiuntovi lo zelo, le assidue cure, le caritatevoli premure, in ogni circostanza spiegate da questo Medico Chirurgo Sig. Vincenzo Dottor Di Geronimo, posso assicurarvi, con vanto, che appunto in questo Comune, la pubblica salute si mantiene pienamente soddisfacente. 229 Istruzione pubblica. Nella maggior parte di tempo della mia dimora tra voi, le pubbliche scuole si tennero chiuse, per le vacanze autunnali. Il 15 ottobre, giusta quanto prescrive il Regolamento in vigore, furono riaperte le iscrizioni e gli esami di riparazione ed ammissione, e per quelli di classificazione. Da circa un mese sono riprese le lezioni regolari. Tanto il Maestro che la Maestra vanno a gara onde impartire, per quanto è loro dato, la più sana istruzione della mente e del cuore, nei loro rispettivi alunni. Mentre mi è gradito farvi qui un meritato elogio degli insegnanti signori Nicola Sica e Pasqualina Cesaro, mi duole assaissimo portare a vostra conoscenza, come le scuole sieno quasi del tutto sfornite degli arredi necessarii, che tanta parte hanno nel mantenimento della disciplina e per le esplicazioni didattiche. Io, per quanto mi è stato possibile, ho iniziato un provvedimento, ora sta a voi il completare l’opera da me iniziata. Lavori pubblici. Alcuni dei più urgenti lavori furono da me fatti eseguire, assistei pure con assiduità alla costruzione della via rotabile che, dalla Consortile mette al Centro di quest’abitato. Tale via è pressoché al termine della costruzione. Molti lavori restano a farsi, ma mancatimi i mezzi necessarii mi è stato impossibile eseguirli. Il Regio Commissario rivolge alcune raccomandazioni ai Consiglieri neo eletti, segnalando le questioni più urgenti da affrontare. Molti ed urgenti sono i lavori pubblici che restano a farsi, e dirò i più importanti come il riattare e rendere possibili molte delle vie interne, ora ridotte in fossi; la condotta dell’acqua potabile in paese, di che ora è affatto sfornito; la costruzione di un pubblico lavatoio, di cui assolutamente si difetta; la costruzione di qualche pubblica latrina, per non vedere più imbrattato ogni angolo del paese; l’apposizione di più orinatoi, per la stessa ragione; l’obbligare i proprietari delle case a farvi costruire i cessi ed i lavandini, acciò termini una buona volta il getto delle acque immonde e delle materie fecali nelle pubbliche vie; la costruzione di più cunicoli ove è possibile, e di pozzi neri in altri punti, perché ivi possano essere raccolte e condotte le materie escrementizie, onde poi trasportarle lontano dall’abitato in certe date epoche: finalmente la costruzione della casa comunale e scolastica, e così risanare il vostro paese dal lato materiale. Provaroni suggerisce anche l’istituzione di un asilo infantile (successivamente realizzato per opera del benefattore Vincenzo Rosania). 230 Anche dal lato morale a voi spetta risanare il paese, e questo potete specialmente farlo, con migliorando le condizioni delle pubbliche scuole; con lo esortate le famiglie a proseguire, nel loro seno, la propaganda educativa che i figli loro apprendono dai maestri; e specialmente coll’aprire una scuola infantile mista, dove raccogliere tutti i fanciulli compresi fra i tre e i sei anni, ove beverebbero – per così dire- col latte, i principii di sana e morale educazione, uscendone poi, per entrare nelle rispettive scuole, già avviati Vincenzo Rosania in un dipinto presso il Comune di Castelnuovo alla disciplina scolastica, e non affatto digiuni dell’Alfabeto e dell’Abbaco. In conclusione il prof. Giuseppe Provaroni è proclamato, con voto unanime del Consiglio, Cittadino Benemerito di Castelnuovo di Conza. 231 Capitolo VI Castelnuovo, l’Africa e l’epopea del corallo Consultando l’archivio dello stato civile del Comune di Castelnuovo, nei documenti della metà dell’ottocento alla voce “professione” si trova un termine nuovo; fino ad allora la parola più ricorrente è “bracciale”, cioè bracciante, lavoratore con le braccia, seguita da negoziante, commerciante, proprietario o possidente, qualche cancelliere, notaio, legale, dottore fisico, eccetera. La voce che irrompe è quella di coralliere o corallaro. Il primo anno in cui appare la nuova professione è il 1859. E’ Donato Di Donato, di professione corallaro, che il 18 giugno 1859 compare come testimone in un atto dello stato civile. Se si verifica la professione di Donato Di Donato negli anni precedenti il 1859 si trova riportata quella di pezzaro. La circostanza è comune con altri castelnuovesi che, nel giro di pochi anni intorno al 1859, passano alla nuova professione di corallaro. Accade per Vincenzo Di Guglielmo, Gennaro Berardinelli, Giuseppe Di Domenico, Michele De Rullis, Domenico De Rogatis, Francesco Ricciulli. Come e perché in un piccolo paese di montagna, arroccato su uno sperone dell’appennino meridionale, si affacci una nuova attività che ha piuttosto a che vedere col mare e i marinai, è domanda destinata a rimanere senza risposta. E’ però lecito pensare che i commercianti di stoffe, nel loro girovagare, abbiano colto al volo la nuova opportunità ed abbiano introdotto a Castelnuovo la professione del corallaro. 233 Negli anni immediatamente dopo il 1859 a Castelnuovo c’è il boom della nuova attività. Oltre i pezzari riconvertiti, la esercitano ancora in pochi nel 1860: Pietro Mastrodomenico, Luigi Di Ruggiero, Vincenzo Annicchiarico. Nel 1861 si aggiungono Lorenzo Ricciulli e Vincenzo Iannuzzelli. Nel 1862 troviamo Antonio Di Ruggiero, Vito Del Vecchio, Luca Conte, Giovanni Rosania, Francesco Mastrodomenico, Vito Annicchiarico, Vitale Di Ruggiero, Francesco Venutolo, Francesco Pugliese, Nicola, Francesco e Giovanni Rosania, Antonio e Nicola Cozzarelli, Gennaro Annicchiarico, Nicola Pugliese, Vincenzo Del Vecchio, Gaetano Manziano. Nel 1863, oltre tutti quelli già nominati, troviamo Pasquale Di Geronimo, Giuseppe Iannuzzelli, Salvadore Aurigemma, Giuseppe Turi, Giuseppe Pugliese, Nicola Conte, Michele Del Vecchio, Donato Di Domenico, Vitale Iannuzzelli, Giuseppe e Giovanni Custode, Erberto Conte, Giuseppe Annicchiarico, Erberto Pezzuti, Giuseppe Di Donato, Vito Rosania, Guglielmo Ciuonti, Donato Forcella, Nicola Conte, Giuseppe Pugliese, Antonio Cozzarelli, Antonio Tavarone, Antonio Pizza. Nel 1864 compaiono Nicola Cozzarelli, Antonio e Vito Ricciulli, Giuseppe Rosania, Vitonicola Berardinelli, Giovanni Fabbricatore. Nel 1865 si aggiungono Giovanni Porreca, Michele Del Vecchio, Antonio Di Domenico e Pasquale Infantozzi. In tutto 63 addetti1 su una popolazione di circa 1500 abitanti; all’incirca una famiglia su cinque di Castelnuovo vive sul corallo. L’eccezionalità del “caso Castelnuovo” impronta un articolo comparso nel 1901 sul Bollettino della Società Africana d’Italia, rivista mensile edita a Napoli. L’articolo ha per titolo “Il fenomeno commerciale di Castelnuovo di Conza” ed è firmato dall’ing. G. Buonomo. Il giornalista così inizia: E’ degno di essere segnalato il caso veramente tipico di un piccolo comune, nel fondo della provincia di Salerno, Castelnuovo di Conza, i cui abitanti, con indomito ardire e con straordinario spirito di avventura, s’inoltrano in paesi nuovi nella qualità di commercianti e merciai girovaghi. Data una sommaria descrizione del paese (Castelnuovo di Conza è fabbricato su di una prominenza rocciosa che domina la valle del Sele; dista cinque chilometri dalla stazione ferroviaria di Conza sulla linea Avellino-Ponte S. Venere), l’autore così prosegue: E’ questo paese lontano dal mare, e direi quasi lontano dal consorzio umano, che per virtù dei suoi figli finisce per essere il più diffusamente noto nel… globo terraqueo. A coloro che compaiono nei registri dello stato civile vanno aggiunte le due vittime del naufragio del 4 marzo 1861, Francesco Turi e Vito Pezzuti. 1 234 Tale affermazione non è punto esagerata -aggiunge il Buonomo- poiché non vi è plaga in cui sia possibile uno scambio commerciale in cui non sia stato un cittadino di Castelnuovo. Se Castelnuovo avesse il suo istoriografo, risulterebbe che nell’ultima metà del secolo scorso cittadini di Castelnuovo, nella qualità di negozianti di corallo, penetrarono nell’India, a Borneo, nel Siam. I lavori del canale di Panama videro castelnovesi nella qualità di fornitori di merci; ed i pellegrini maomettani a Gedda potettero rifornirsi dai merciai di Castelnuovo. Caduta Ondurnam, i primi a penetrare nel Sudan furono due di Castelnuovo, e nel Brasile e nell’Argentina quei di Castelnuovo credono di essere come a casa loro. Uno spirito innato di avventura fa perdere pregio, agli occhi dei nostri coraggiosi pionieri, ai paesi di facile accesso; e quell’Algeria, Turchia e Grecia, che esercitarono un fascino 30 anni fa (intorno al 1870) oggi non allettano nessuno. I paesi in voga oggi, ove di preferenza si rivolgono i nostri soggetti, sono quelli dell’Africa occidentale. E qui l’autore incomincia a fare nomi di castelnuovesi: L’anno scorso a Bolama nella Guinea Portoghese il viaggiatore Leonardo Fea s’incontrò in Nicola e Francesco Mariano, Donato Di Ruggiero, Michele Annicchiarico, Vincenzo Ricciulli, Vito Gatti, tutti di Castelnuovo, ed agenti commerciali del nostro (della Società Africana d’Italia, n.d.r.) socio Valentino Di Geronimo. Altri tre mercanti di Castelnuovo lo stesso Fea incontrò a Farim a 220 miglia da Bolama. Durante la costruzione della ferrovia del Congo i nostri pionieri commerciali giravano pei cantieri con le loro merci. (…) Lo stesso Di Geronimo tiene in questo momento agenti nel Congo Portoghese, nel vecchio e nuovo Calabar e sulla Costa d’Oro. Per conto di altre ditte, sempre di Castelnuovo, sono agenti commerciali a Zanzibar, nel Madagascar, nella colonia del Capo, ad Angola, nel Senegal, all’isola Principe, alla Riunione, alla costa dell’Avorio, nel Mozambico, ecc.. 235 Ai nomi dei castelnuovesi riportati nell’articolo dell’ing. Buonomo possiamo aggiungerne altri che compaiono in un documento, parimenti del 1901, conservato dalla famiglia Di Geronimo. Si tratta di un contratto stipulato a Napoli il 18 marzo 1901 con il quale si stabilisce che, acquistata merce per lire 206.623 con capitale di Girolamo Di Geronimo e Gennaro Ricciulli, detta merce è mandata a vendere in Africa dai signori: 1° Francesco Di Geronimo di Girolamo, 2° Pasqualino Di Geronimo di Girolamo, 3° Vito Rosania fu Nicola, 4° Erberto Venutolo fu Michelangelo, 5° Michele Conte fu Nicola, 6° Erberto Conte fu Nicola, 7° Antonio Sessa fu Gennaro Ricciulli Vito, 8° Giovanni Borzone fu Pasquale, 9° Francesco Custode fu Michele, 10 Vincenzo d’Antona fu Stefano e Nicola Carchio di Pasquale, i primi dieci di Castelnuovo di Conza e quest’ultimo di Laviano. Nel contratto, oltre ai patti e le condizioni di divisione del guadagno tra i partecipanti alla società costituita tra i Di Geronimo ed il Ricciulli, si fa anche riferimento a crediti da esigere in Africa, nelle due isole di St. Vincent di Capoverde e di San Thomè, al largo della Guinea nell’Oceano Atlantico: Il Di Geronimo Francesco deve raggiungere la cifra del capitale che si porta versato come sua quarta parte lire diecimila che disse di dover ricevere a S. Vincenzo Capoverde per fronteggiare ai diritti doga- Girolamo Di Geronimo e la sua famiglia a fine ottocento 236 nali, come pure il Di Geronimo Francesco esigendo altri suoi crediti che tiene a S. Thomè, questa cifra verrà rimessa a parte. L’iniziativa dei mercanti castelnuovesi si inserisce nel macrofenomeno storico della colonizzazione del continente nero operata dagli europei nella seconda metà dell’ottocento, allorquando un flusso di esploratori si riversò nell’interno dell’Africa. Essi erano, soggettivamente, mossi da disparati interessi, scientifici, geografici, religiosi ed anche commerciali, quando non esplicitamente finalizzati alla conquista militare di nuove Henry Morton Stanley terre a vantaggio delle potenze del vecchio continente. Tra l’umanitarismo di un Livingstone, che si proponeva di contribuire allo sviluppo civile e morale dell’Africa, ed il dichiarato fine imperialistico di un Rhodes, il contributo dei castelnuovesi si può collocare nella scia di Henry Morton Stanley, per il quale numerose ed amichevoli tribù insediate lungo il corso del fiume Congo volentieri avrebbero accolto i mercanti europei scambiando i loro ricchi prodotti con i tessuti di Manchester, perle veneziane, fili di rame, chincaglierie ed altre simili merci. Questo fatto –aggiungeva Stanley- ci aiuterà molto nello stabilire con loro un legittimo commercio e nell’aprire il vasto cuore dell’Africa, con i suoi prodotti vari, all’iniziativa degli europei. Ma quanti erano, all’epoca, i cittadini di Castelnuovo impegnati nei commerci all’estero? L’articolista del 1901 prova a dare qualche numero: In complesso attualmente sono disseminati nella qualità di agenti commerciali nell’Africa e nell’India e nell’America più di duecento cittadini di Castelnuovo: cifra davvero straordinaria se si tiene conto che, giusta il penultimo censimento, Castelnuovo contava 1661 abitanti, e giusta i conti fatti in base ai registri dello stato civile municipale, oggi appena raggiunge i duemila abitanti. Ritiene l’ing. Buonomo che tolti i vecchi e i fanciulli più della metà della 237 popolazione maschile nel vigore degli anni si dedica alla pericolosa ed avventurosa vita dell’agente commerciale in paesi semi inciviliti. Questa singolare condizione di dimezzamento della popolazione maschile in età riproduttiva trova eco in uno stornello popolare che contrappone l’innovazione tecnologica del lume a gas collocato nel mezzo del “Pianello” al “disagio” delle giovani fanciulle, che “fanno fracasso” perché non ci sono ragazzi: Mmiezz’ a lu chianieddh’ Ngenn’ mist’ lu lum’ a gas R’ guagliott’ fann’ fracass’ Ca guagliun’ nu ng’ n’ son’. Lu chianieddh’ con il lume a gas ai primi del novecento E’ da osservare che proprio nel 1901 la popolazione di Castelnuovo di Conza raggiunge il suo massimo storico nei centocinquanta anni dell’unità d’Italia, a dimostrazione evidente di una fase di crescita economica e di espansione urbanistica. I palazzi signorili sorti lungo la strada oggi intestata a Federico Di Donato e risalenti a quel periodo sono sicuri indicatori di un solido benessere, conseguito fondamentalmente con le attività commerciali e l’emigrazione. Lo spirito di intraprendenza dei cittadini di 238 Evoluzione demografica di Castelnuovo di Conza dal 1861 al 2011 Castelnuovo risalta ancor di più se si considera, come fa l’autore, che non la borghesia poteva fornire tale numero di agenti, ma i più sono sottratti alla vanga, ed hanno la cultura che è possibile in un comune di duemila abitanti, con un solo maestro elementare di grado inferiore, anche se a rialzare le sorti della cultura concorrono i cittadini, che a proprie spese mantengono due maestri di grado superiore. Racconta l’ing. Buonomo che tutto inizia verso la metà dell’Ottocento quando le condizioni finanziarie della popolazione di Castelnuovo erano tutt’altro che liete, e le campagne, per quanto ridenti ed affidate alle cure di forti e laboriosi coltivatori, non erano sufficienti a rialzare le condizioni economiche del paese. Colà nulla penetrava del mondo esteriore, ed i primi ad affacciarsi fuori i limiti del comune furono i cenciajuoli Francesco Berardinelli ed Erberto Conte ed alcuni ciabattini girovaghi che si spinsero fino nella provincia di Foggia e di Bari. Costruendosi la ferrovia Eboli-Potenza cominciò a circolare un po’ di danaro, ed i cenciajuoli assursero a venditori di corallo spingendosi fin nelle Romagne2. I primi negozianti di corallo di Castelnuovo furono Francesco Turi e Vito Pezzuti che Una ulteriore testimonianza del commercio dei castelnuovesi verso la Romagna è dato da un passaggio dell’orazione funebre tenuta in occasione della morte, nel 1919, di Girolamo Di Geronimo, fratello di Valentino e che fu sindaco di Castelnuovo dal 1878 al 1900. La sua carriera commerciale è così sintetizzata: Lo troviamo un piccolo negoziante nelle Romagne; di poi, cresciuto il capitale mediante privazioni e lavoro, da uomo che dedica al progresso tutta la sua esistenza, lo vediamo spingersi a commerciare prima nella Spagna; poi 2 239 nel 1862 morirono miseramente annegati nella traversata da Palermo a Napoli. I buoni risultati conseguiti dai primi mercanti di corallo invogliarono altri a seguirne le orme, e fu Pietro Mastrodomenico il primo che si spinse fino sulla costa nord dell’Africa. Nuovi orizzonti al commercio del corallo aprirono i fratelli Di Geronimo, i quali andarono nelle Americhe, nelle Indie, nella Cina, nel Giappone, nell’Australia e nell’Africa Occidentale ed Orientale. Ma essi non si limitarono al solo corallo, e passarono al commercio delle conterie, dei tessuti di lana, di seta, di cotone, ai filati ed alle mercerie. Ampliatosi il campo di azione e come mercato e come generi, altri molti seguirono le orme dei fratelli Di Geronimo fino a giungere al giorno d’oggi, in cui la maggior parte della popolazione maschile di Castelnuovo di Conza è occupata nel commercio in lontane contrade. Circa l’anno dell’annegamento di Francesco Turi e Vito Pezzuti il giornalista commette un piccolo errore. I due corallieri castelnuovesi non morirono nel 1862, ma nella notte tra il quattro ed il cinque marzo 1861 nell’affondamento del piroscafo “Ercole”. Nell’archivio del Comune di Castelnuovo c’è il documento che attesta la scomparsa di Francesco Turi. Eccolo: Provincia di Principato Citeriore - Comune di Castelnuovo di Conza Atto di morte di Francesco Turi L’anno milleottocentosessantadue, il dì ventotto del mese di marzo, alle ore sedici Noi Giuseppe Nicola Di Donato Sindaco ed Uffiziale dello stato civile del suddetto Comune, Distretto di Campagna, dichiariamo che Francesco Turi figlio del fu Luca Turi di anni cinquanta di professione coralliere domiciliato in Castelnuovo si moriva nel mese di marzo milleottocentosessantuno pel naufragio del Piroscafo l’Ercole giusta la decisione del Tribunale civile sedente in Salerno in data del ventisei febbraio corrente anno milleottocentosessantadue, registrata a Salerno li ventisette detto mese ed anno al libro terzo, volume 444, folio 99, casella seconda, numero 2725. Epperò abbiamo inscritto l’atto di morte di Francesco Turi fu Luca ne’ presenti registri per disposizione del Tribunale civile contenuta nella sù citata disposizione. in Turchia ed in altre remotissime regioni dell’Oriente; indi lo vediamo commerciare nell’America del Nord, dove una fra le primarie banche di New York metteva a sua disposizione ogni qualsiasi somma; in ultimo, commerciato in Europa, in Asia e nelle Americhe, si spinse anche nell’Africa, che, ai suoi tempi, era inabitabile e inospitale, poiché la Civiltà non ancora aveva potuto penetrare in que’ luoghi selvaggi. 240 L’Ercole è il piroscafo sul quale a Palermo il 4 marzo 1861 si imbarcò per Napoli lo scrittore e poeta Ippolito Nievo, che aveva partecipato al seguito di Garibaldi alla spedizione dei Mille con il ruolo di vice intendente (colui cioè che teneva i conti economici dell’impresa). Ippolito Nievo portava con sé una cassa di documenti che ricostruivano tutti i passaggi di denaro e che gli erano stati richiesti dal governo piemontese, presumibilmente per porre freno alle polemiche insorte tra i seguaci di Cavour e quelli di Garibaldi sul costo ed i finanziamenti della spedizione. Come è noto Ippolito Nievo ed i suoi documenti non arrivarono mai a Torino perché l’Ercole nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1861, dodici giorni prima della nascita ufficiale del Regno d’Italia, scomparve prima di arrivare a Napoli con tutti gli uomini a bordo, una ventina di marinai ed una sessantina di passeggeri. Compresi i due commercianti di corallo di Castelnuovo Francesco Turi e Vito Pezzuto. Stranamente passarono undici giorni prima che partissero le ricerche del piroscafo e soltanto il 17 marzo 1861 venne data la notizia sul giornale Omnibus: “L’Ercole, battello a vapore della Compagnia Calabro-Sicula, è affondato a mezzavia tra Palermo e Napoli per un colpo di mare. Incerto il numero dei 241 naufraghi”. Le ricerche non diedero esito alcuno: non si trovò niente, nessun relitto, nessun corpo. Critiche alla versione ufficiale vennero avanzate, più di cento anni dopo, dal pronipote del poeta Stanislao Nievo nel libro “Il prato in fondo al mare” che, nel 1975, fece dire a Pier Paolo Pasolini: “Si trattò di un giallo politico, cioè della storia della prima, sospetta, “strage” decisa e attuata dagli uomini del potere: “strage” con cui si sarebbe aperta la storia dello Stato italiano”. Il tragico episodio del misterioso naufragio dell’Ercole viene evocato nel libro di Umberto Eco, Il cimitero di Praga3. Nel capitolo otto, Eco riprende e rappresenta in forma romanzata quella lettura in chiave complottista dell’evento, che è avanzata da un filone della storiografia risorgimentale: il naufragio del piroscafo Ercole non sarebbe un incidente dovuto a fattori naturali, ma sarebbe stato provocato ad arte per far scomparire la contabilità dell’onesto ed ingenuo poeta padovano, contabilità che avrebbe dimostrato come la sconfitta dell’esercito borbonico fosse stata ampiamente “agevolata” da consistenti elargizioni di denaro ai generali traditori di Francesco II, denaro peraltro proveniente da ambienti massonici dell’Inghilterra. Se l’ing. Buonomo data il commercio dei coralli al 1861, un documento conservato dalla famiglia Di Geronimo ne conferma sostanzialmente l’epoca, e fornisce altre informazioni circa il quando e il dove delle iniziative commerciali dei castelnuovesi. L’anno è il 1872, il luogo è Callao, il più grande ed importante porto del Perù. Al Vice Consolato d’Italia di questa città affacciata sull’oceano Pacifico si presentano, il 13 aprile 1872, Giuseppe Di Geronimo e Francesco Mastrodomenico. Alla presenza del Vice Console Bentamoni il primo consegna all’altro, perché ne faccia vendita, oggetti di corallo lavorato per il valore di 550 franchi. La firma di Mastrodomenico in calce alla ricevuta è autenticata dal funzionario del governo italiano. Era successo che i rapporti tra i due, che erano cognati, si fossero guastati e che Giuseppe Di Geronimo rimproverasse l’altro di non operare con diligenza. Infatti il 22 aprile successivo a Giuseppe Di Geronimo, che ha perduto le tracce del cognato (e dei 550 franchi di coralli), viene rilasciato il seguente certificato: -Vice Consolato d’Italia in CallaoIl sottoscritto Vice Console d’Italia in Callao certifica per onore del vero che intervenuti personalmente nel Vice Consolato d’Italia in Callao i nominati Giuseppe Di Geronimo e Francesco Mastrodomenico proposero di venire ad un 3 Umberto Eco, Il cimitero di Praga, Milano, 2011. 242 accomodamento fra loro per le differenze sopravvenute tra essi. Riconobbe il Mastrodomenico Francesco che egli era venuto dall’Italia con il Di Geronimo ed altri suoi fratelli con lo scopo di facilitare lo smercio di coralli lavorati di spettanza dei Di Geronimo e che egli riceveva una commissione per la vendita che ne operava. Il Di Geronimo Giuseppe convenne che il Mastrodomenico Francesco si occupava della vendita di detti coralli e ne riceveva un compenso, ma atteso che la condotta di lui non era punto lodevole e che sprecava malamente non solo i guadagni ma anche il capitale affidatogli, quindi chiese che venisse fortemente rimproverato e tornasse a miglior sentimento. Osservò che il Mastrodomenico era ammogliato con una sua sorella e che era opera di carità quella che egli faceva di condurlo seco e di farlo partecipare al beneficio della rivendita coralli poiché gli era d’inciampo più che di altro. Dopo diverbii sostenuti vennero ad un componimento che cioè il Di Geronimo avrebbe di nuovo tentato di affidare 550 o 600 franchi di merce di corallo al Mastrodomenico onde li vendesse e gliene desse conto più tardi, ma che non realizzandosi la speranza di vederlo tornare a buoni sentimenti, lo avrebbe abbandonato a se stesso e non gli avrebbe affidato altrimenti altri coralli lavorati, essendo alla vigilia di partire per altra destinazione e non potendo pel capriccio del Mastrodomenico indugiare e ritardare le sue operazioni di vendita. Certifica altresì il Sottoscritto Vice Console che il Mastrodomenico ricevette, come risulta da ricevuta apposita esibita a questo Consolato, la quantità di coralli promessa e che al giorno d’oggi non ha questo Ufficio saputo più nulla di lui. E perché ne consti si è rilasciato al Di Geronimo che lo richiese il presente Certificato. 243 Il documento del Vice-Consolato d’Italia a Callao (fronte) 244 Il retro del documento con il timbro del Vice-Consolato e la data del 22 aprile 1872 Non sappiamo come andò a finire la contesa tra i due cognati, se non che nel primo documento del 13 aprile Francesco Mastrodomenico dichiarava che le pendenze anteriori, che fra il suddetto Signor Giuseppe Di Geronimo e me vertono ancora, rimangono sospese insino al che ci sia dato di riunirci col comune cognato e fratello Girolamo Di Geronimo, che trovasi in Italia e conosce appieno i dettagli ed i particolari dei nostri affari. Sono degni di nota l’anno, il 1872, ed il luogo, il Perù ed il suo porto principale per il commercio sull’oceano Pacifico, che attestano la presenza e l’azione dei corallieri castelnuovesi. Emerge anche la figura di Girolamo Di Geronimo, allora giovane venticinquenne e futuro sindaco di Castelnuovo, che nel 1890 il re Umberto I nominerà Cavaliere della Corona d’Italia. Torniamo a quanto scrive nel 1901 l’ing. Buonomo a proposito di Castelnuovo. L’articolista osserva che le fortune commerciali dei pionieri generano ulteriori attività, sicché coloro i quali giunti ad una certa età e ad una agiata posizione economica si ritirano in paese, a loro volta inviano agenti 245 per conto loro. Buone sono le condizioni che si fanno agli agenti commerciali. Essi hanno tutte le spese pagate ed una metà degli utili, che dopo campagne fortunate raggiungono cifre ragguardevoli. L’effetto è che naturalmente data tanta attività ed energia, ed il numero dei cittadini di Castelnuovo addetti alla proficua ed avventurosa carriera, le condizioni economiche del paese sono più che buone; addirittura i fortunati risultati ottenuti dai Castelnovesi dovevano esercitare il loro influsso sui paesi vicini, e da Santomenna, Teora, Conza, S. Andrea di Conza e Castelgrande non sono mancati gli imitatori; ma nel complesso può dirsi che la fortuna loro non ha arriso, e nessuna ditta del genere esiste in quei paesi, ma solo qualche agente è colà reclutato. A questo punto l’estensore dell’articolo si domanda da che cosa possa dipendere tanta intraprendenza e coraggio nei cittadini di Castelnuovo e, in sintonia con la dominante cultura positivistica dell’epoca, ritiene che sarebbe degno di studio indagare l’origine di Castelnuovo, tanto per assodare se ci troviamo di fronte ad una specialità etnica o ad una tendenza sviluppatasi per causa accidentale. Quasi certamente il Buonomo non conosceva la Cronista conzana, opera del 1691 di Donatantonio Castellano. La Cronista attesta un’antica tradizione commerciale, se già allora il Castellano, a proposito di Castelnuovo, poteva annotare: In questa Terra nel presente anno 1691 vi sono 342 anime, li cittadini di essa si esercitano nell’arte del merciaro, tengono buono pascolo, vi è forte abbondanza di grano, e li cittadini sono tutti industriosi al lucro del denaro e la Terra, benché angusta di habitanti, è forte”. Ovviamente su un terreno “etnico” non era possibile andare lontano, cosicché l’ing. Buonomo ritorna ad occuparsi dei dati oggettivi e ci fornisce un’illuminante spaccato sociologico della vita di allora: La sottrazione di tanti uomini dai campi, parte perché all’estero, e parte perché per le mutate condizioni economiche disdegnanti del lavoro manuale ha prodotto come conseguenza che l’agro castelnovese sarebbe incolto, se non venissero a dissodarlo contadini dai paesi finitimi ed è importante notare che quei contadini che a Teora, Conza ed in altri paesi vicini percepiscono la paga giornaliera di lire 1.20 ed una semplice minestra, allorché lavorano nell’agro di Castelnuovo percepiscono lire 1.70, una minestra, due litri di vino e companatico. E, più avanti: Castelnuovo ha un carattere speciale che lo rende dissimile dai comunelli vicini. La conversazione nei ritrovi è delle più attraenti e variate, e ciò si comprende trovandosi di fronte ad uomini che hanno visitate le più dissimili contrade e sono stati attori o spettatori di avventure straordinarie. A 246 Castelnuovo possonsi sentire parlare tutte le lingue europee e non poche lingue dell’Africa. Quello che a Castelnuovo assolutamente manca, per buona ventura, è quella classe di uomini che, non essendo abbastanza poveri per dedicarsi ad un lavoro manuale e non abbastanza colti per procacciarsi una occupazione decorosa, costituiscono la vera peste dei comuni rurali dell’Italia meridionale. Al contrario, come già visto, a Castelnuovo i cittadini a proprie spese mantengono due maestri di grado superiore. Giuseppe Ricciulli in Africa a bordo di una Fiat Torpedo Nel nostro mondo globalizzato del terzo millennio le distanze fisiche tra i Paesi si percorrono con poche ore di aereo, ed anche andare nelle zone interne non comporta eccessivi rischi. Non dobbiamo però dimenticare che nell’Ottocento molte parti dell’Africa erano assolutamente sconosciute ed inesplorate, e perciò estremamente pericolose. Ce lo sottolinea opportunamente l’ing. Buonomo: Ma non bisogna credere che sia facile il compito che si assumono gli agenti commerciali di Castelnuovo, poiché essi hanno da debellare non pochi nemici. Prima di tutto dovunque vadano non sono bene accolti, rappresentando essi dei molesti concorrenti ai commercianti della nazione di cui il paese è colonia. Essi raramente trovano un console italiano; eppoi non sono malcontenti di non incontrarlo, poiché per tutto appoggio ricevono sempre il consiglio amichevole di non internarsi, se pure il consiglio non si muta in violenza. (…) Nel 1880 Valentino Di Geronimo dovette ricorrere 247 a mille espedienti per essere autorizzato dal ministro Scovasso4 a partire con una carovana da Tangeri a Fez; e fu quella la prima carovana italiana. Ma oltre alle difficoltà dell’ambiente, l’agente commerciale è costretto a vivere alla maniera degl’indigeni e non sempre può nutrirsi come vuole: è costretto a servirsi dei mezzi di trasporto più primitivi, carovane, canotti, sambuchi, ed a sentire certi racconti di pericoli non si sa se ammirarne il coraggio o l’incoscienza. Non tutte le vie sono sicure ed i depredati non sono pochi. Lo scorso giugno l’agente Alfonso Caruso in Angola sulla via tra Benguella e Catumbella è scomparso, senza che di lui si sia trovata traccia. In fine essi devono lottare con il clima quasi sempre malsano, e la moria fra gli agenti è grande. Ve ne sono seppelliti sotto gli argini della ferrovia del Congo; e non meno di 15 lasciarono la vita nel Panama. Lunga sarebbe la lista dei morti lontani dalla patria, e non pochi, contratto il germe del male, vengono a morire in seno alle famiglie5; e nel solo anno scorso tre morirono a Castelnuovo reduci dalla Guinea Francese. Un altro documento della famiglia Di Geronimo ci racconta della solidarietà tra i commercianti di corallo e della signorilità e corretStefano Scovasso, Ministro plenipotenziario tezza nei rapporti di affari, avviati sulla base di della sola parola tra d’Italia in Marocco Stefano Scovasso, ministro plenipotenziario d’Italia in Marocco, accreditato presso il Sultano Mulay al Hassan. Lo scrittore Edmondo de Amicis, all’epoca giovane inviato del giornale La Nazione, ed autore nel 1877 di un reportage di viaggio “Marocco”, scrive di lui: Dei due amici che avevo interrogato prima di partire, uno m’aveva assicurato che era un uomo capace di andare da Tangeri a Tumbuctù senz’altra compagnia che di un paio di pistole; l’altro aveva biasimato la sua pessima abitudine di rischiare la propria vita per salvare quella degli altri. 5 Nello numero della rivista è pubblicato il necrologio del medico Giuseppe Di Geronimo, deceduto a seguito di un morbo contratto in Africa. Eccone il testo: Giovanissimo, appena conseguita la laurea in medicina, spinto dall’esempio paterno, s’imbarca per l’Africa Occidentale, ove la sua famiglia possiede numerose fattorie, e con lo scopo preciso di studiare 4 248 uomini (una società d’affari tra castelnuovesi e lavianesi costituita “verbalmente”). Dopo la scomparsa in Africa di Alfonso Caruso, in data 30 marzo 1901, Girolamo Di Geronimo salda agli eredi dello sfortunato coralliere la quota spettante al loro congiunto. Ecco il documento: I signori Cav. Girolamo Di Geronimo fu Francesco domiciliato in Castelnuovo di Conza da una parte, l’avv. Caruso Pasquale di Michele, Carchio Raffaela fu Pasquale, vedova Caruso, Caruso Teodoro fu Francesco, sia in nome proprio che per autorizzare sua moglie Caruso Elisabetta, Caruso Archimede, Elisabetta, Carmela fu Pasquale; la Carchio tanto in nome proprio che quale legittima rappresentante dei propri figli minori Caruso Carmine e Vincenza, dall’altra, sono addivenuti alle seguenti dichiarazioni e convenzioni. Costituitasi verbalmente nel 1899 una associazione in partecipazione tra i Sig.ri Girolamo Di Geronimo, Francesco e Pasquale Di Geronimo di Girolamo, Erberto Conte fu Nicola, Carchio Nicola fu Pasquale, Caruso Alfonso fu Pasquale, tutti, meno il Cav. Di Geronimo, si recarono in Africa, nelle colonie Portoghesi, per negoziare la merce formante l’oggetto dell’associazione. Sventura volle che nel giugno 1900 si perdette ogni traccia dell’associato Alfonso Caruso fu Pasquale, né in seguito se n’è più avuto notizia alcuna. E poiché, rimpatriati i soci, si è definitivamente liquidata l’associazione in parola, preme sia al Di Geronimo che agli eredi di Alfonso Caruso di regolarizzare reciprocamente i loro diritti e doveri come segue. Questo documento ci dà l’entità del guadagno del povero Caruso per la spedizione in Africa, e ci dice come la somma fu corrisposta agli eredi: La quota di lucro netto toccante ad Alfonso Caruso è di lire undicimilaseicento. Di essa cinquemilasettecentotrentaquattro furono consegnate dal Cav. Girolamo Di Geronimo a Raffaela Carchio per estinguere, come infatti vennero estinte, alcune obbligazioni di famiglia. E ciò a seguito di ordine scritto, sotto l’aspetto fisico quelle regioni e di esservi di conforto e di ajuto al personale dipendente della Ditta paterna sparso nella Guinea Superiore e a Loanda. Appena giunto in Guinea si ammala di perniciosa africana che lo riduce in fin di vita. In S. Thomè ospite di un ricco negoziante portoghese migliora. Trasportato a respirare aure migliori in una piantagione di cacao appartenente allo stesso, si fa amministrare una siringa endovenosa di chinino –secondo il ritrovato del nostro Baccelli- che gli permise d’imbarcarsi per l’Europa dopo circa un mese. Giunto a Napoli, nel porre piede a terra e vedersi tra i suoi esclama: Sono in Napoli tra i miei, vicino ai miei professori, ho fede che guarirò. Ma purtroppo quando gli stessi suoi maestri lo rassicuravano, riesce appena al suo addolorato genitore che lo vegliava di raccoglierne l’ultimo anelito. Ai suoi fratelli in Africa che ignorano ancora la sorte toccata al loro germano, al padre suo Valentino, nostro caro Socio – le condoglianze più sentite della nostra Società. 249 comunicato dal Caruso sia a sua madre che al Cav. Di Geronimo. Lire tremilaottocentoventicinque, vennero ritenute dal Governo Portoghese per liquidarle diplomaticamente come percezione di Alfonso Caruso in testa al quale erano depositate presso la Banca Nazionale Oltre Marina in Benguella e furono consegnate agli eredi del detto Caruso a mezzo del Ministro degli Esteri e della Procura Generale. Lire ottocentoquindici sono ancora da esigersi nella colonia ave fu esercitato il negozio e spettano al Caruso come sua quota sul credito di 1950 perse portafogli non ancora riscosse. Ne segue che al Caruso spettano ancora altre lire milleduecentoventisei per completare il lucro di lire undicimilaseicento (11600,00). Ciò premesso e salvo a rimborsare agli eredi del Caruso la somma di lire ottocentoquindici, se verrà riscossa, il Di Geronimo si è mostrato pronto a versare nelle mani degli eredi del Caruso la ripetuta somma di lire milleduecentoventisei Francesco Di Geronimo in Africa (1226,00) che effetti(St. Vincent di Capo Verde) nel 1899 all’età di 22 anni vamente in carte bancarie correnti nel regno è stata pagata nelle mani dei Signori Carchio Raffaela, Caruso Elisabetta, Carmela e Archimede fu Pasquale. L’ultimo documento dell’archivio Di Geronimo, utile a definire ulteriori coordinate della presenza sullo scacchiere internazionale dei corallieri castelnuovesi, è una dichiarazione resa a Napoli in data 8 dicembre 1905 da 250 Gennaro Ricciulli fu Giuseppe il quale riconosce che la metà del fabbricato sito all’Isola di San Thomè, Colonia Portoghese, Africa Occidentale, intestata al Sig. Francesco Di Geronimo di Girolamo, è di esclusiva proprietà del medesimo, senza che la società nostra abbia diritto su di essa, avendo il Sig. Francesco Di Geronimo conferito e conteggiato nella società stessa il valore o la spesa della detta metà del fabbricato. Per quanto attiene l’altra metà del fabbricato, il Ricciulli precisa che si è detto la metà del fabbricato perché questo fu comprato dal Di Geronimo Francesco e Di Geronimo Giuseppe di Valentino e questi (ed ora i suoi eredi) è il proprietario dell’altra metà. Un segno dell’importanza del commercio e dei viaggi intercontinentali per gli intraprendenti castelnuovesi dell’ottocento, quasi un’icona simbolica dell’epopea del corallo, è costituito da un ritratto ad olio su tela. Vi è raffigurato un giovane di ventitre anni, elegante, barba alla Giosuè Carducci, i capelli spartiti da una riga al centro, riccamente vestito ed ingioiellato, che reca nella mano sinistra una carta geografica con i cinque continenti, quasi a suggerire la strada del coraggio e dell’avventura. Sul retro del dipinto, sull’asse di legno che regge la tela, è inciso: Valentino Di Geronimo di Francesco – nato il 12 maggio 1852 – Dipinto nel mese di gennaio 1875. L’attività in Africa dei commercianti di Castelnuovo prosegue e si intensifica nel nuovo secolo. E nel nuovo secolo si registrano nuove vittime. E’ il caso di Ruggiero Jannuzzelli che muore in Congo Belga di Valentino Di Geronimo febbre gialla all’età 251 Castelnuovesi a Warri in Nigeria nel 1919 festeggiano la vittoria nella prima guerra mondiale. Giuseppe Ricciulli con la bandiera italiana e Giuseppe Iannuzzelli, secondo da destra Ruggiero e Marianna Jannuzzelli in viaggio di nozze ad Amalfi nel 1910 252 di ventinove anni. I castelnuovesi presenti nella regione accorrono a rendergli l’estremo saluto. Un eccezionale documento fotografico mostra i commercianti di Castelnuovo Giuseppe Ricciulli, Vito Piserchia, Antonio Di Donato, Girolamo Di Geronimo, Vincenzo Di Ruggiero e Donato Conte in raccoglimento, insieme all’officiante, appena prima della inumazione del loro amico e compaesano. Il continente nero non è soltanto luogo delle avventure dei castelnuovesi commercianti. C’è anche il soldato Antonio Turi che il 26 Gennaio 1887 si trova a Dogali, piccolissimo villaggio dell’E- ritrea orientale, impegnato in una delle operazioni militari della prima guerra coloniale italiana. In quella occasione una colonna avanzata di 548 soldati italiani, guidati dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, viene affrontata e distrutta dalla truppe abissine. Si tratta di un vero e proprio eccidio, periscono quasi tutti, ma non il castelnuovese Antonio Turi. Gli italiani morti sono 430; un centinaio di feriti, dati per morti e abbandonati dal nemico sul campo, vengono salvati il giorno dopo da altre truppe italiane giunte in soccorso. Tra Congo Belga, 1919. L’inumazione di Ruggiero Jannuzzelli questi c’è anche Antonio Turi. Al quale, appena rientrato in Italia, sono decretate numerose attestazioni di stima, tra cui quella dell’Associazione dei Volontari Reduci dalle Patrie Battaglie di Reggio Calabria. Michele Cammarano, la battaglia di Dogali 253 L’onorificenza ad Antonio Turi Turi riceve anche l’onorificenza della Medaglia d’Argento al Valore Militare, col relativo soprassoldo di lire 100 annue per la splendida prova di valore data nel combattimento di Dogali. Per tutto il novecento l’attività del commercio di coralli è portata avanti dalla seconda e dalla terza generazione dei Di Geronimo: prima Francesco e Pasqualino, figli di Girolamo, che abbiamo visto giovanissimi inviati in Africa sul finire dell’ottocento; poi altri due Girolamo, figli di Francesco e Pa254 Pasquale e Francesco Di Geronimo (al centro) in una foto di gruppo con Enrico De Nicola (il secondo da sinistra) squalino. La famiglia Di Geronimo si colloca tra Castelnuovo, Napoli e Torre del Greco. Qui, a Torre del Greco, Francesco e Pasquale Di Geronimo hanno modo di coltivare l’amicizia con un giovane brillante avvocato, Enrico De Nicola, futuro primo Presidente della Repubblica Italiana. De Nicola viene anche a Castelnuovo in un paio di occasioni, ospite dell’amico e coetaneo Francesco Di Geronimo. Dall’ufficio postale di Castelnuovo di Conza il 1° luglio 1946, in occasione della sua elezione alla carica di Capo provvisorio dello Stato, parte un telegramma di congratulazioni a firma di Pasquale Di Geronimo. Il primogenito di Francesco, Girolamo, inizia ad interessarsi al commercio del corallo sin dalla sua giovane età. Dopo il servizio militare, intorno al 1930, appena ventenne, è inviato dal padre in Nigeria. Lì viaggia dal sud al nord del paese (Lagos - Port Harcourt - Kano) anche in condizioni e con mezzi di trasporto precari ed avventurosi. Occorrono diversi giorni di viaggio in treno per attraversare il Paese da Lagos a Kano. Poi bisogna proseguire in auto, o in corriera, verso le cit255 tà più piccole da raggiungere. Spesso è costretto, soprattutto per l’insicurezza delle strade, a viaggiare armato, soprattutto quando deve raggiungere i villaggi all’interno del Paese, e talvolta deve farsi scortare nel timore di possibili assalti dei Dignitari nigeriani nei costumi tradizionali con coralli banditi. Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo coglie lì in Nigeria dove, per il solo fatto di essere di nazionalità italiana, è preso prigioniero dagli inglesi e deportato in Giamaica. Torna in Italia solo alla conclusione del conflitto, e ricostruisce ripartendo da zero l’attività che la guerra aveva interrotto. Svolge, prima, diversi lavori a Castelnuovo, tra cui anche il manovale nella ricostruzione delle strade distrutte dai bombardamenti, e nel contempo, con un piccola quantità di corallo lasciata dal padre, e grazie alle amicizie ed alle conoscenze acquisite in Africa, inizia a ricontattare i vecchi clienti, riuscendo lentamente a riprendere l’attività commerciale. Agisce tra Castelnuovo e Torre del Greco fino al 1982, anno della sua morte. Per circa un anno e mezzo continua a seguire l’attività il figlio Francesco, fino alla liquidazione di un’attività commerciale che in buona parte era basata sulla profonda conoscenza personale di quel lontano mercato e sulla personale reputazione acquisite durante l’arco di tutta una vita, nella quale spiccano i rapporti di amicizia con l’ambasciatore della Nigeria in Italia, avendo annoverato tra i suoi clienti ministri e alte personalità dell’economia del paese africano. Anche un altro Girolamo Di Geronimo (detto Boby), figlio di Pasquale, prosegue nell’attività di famiglia. Lo troviamo in Nigeria con la Missione economica italiana svoltasi tra il 30 novembre ed il 18 dicembre 1958. Su Africa, Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, è pubblicata, a cura del dott. Teobaldo Filesi, Capo 256 Nobile fanciulla nigeriana ornata con gioielli di corallo 257 dell’Ufficio studi dell’Istituto Italiano per l’Africa, la relazione sulla missione. In questa relazione, a proposito delle attività degli italiani presenti in Nigeria, si legge: Gli italiani presenti oggi (1958) in Nigeria sono calcolati tra i 500 e i 600, cioè il doppio di quelli presenti qualche anno addietro. Di essi oltre 200 Francobollo celebrativo della lavorazione del corallo risiedono a Lagos e il ria Torre del Greco manente a Kano, Ibadan, Kaduna, Enugu, Jos, Zaria (…). Nel campo delle rappresentanze commerciali agiscono la GETEX e l’AMECO, in quello dell’abbigliamento per uomo e signora la DANASIL, in quello della vendita e distribuzione di gas liquidi la NIDOGAS, in quello dell’esportazione di legnami la POLETTI Bros. e la ROGNONI, in quello L’ambasciatore della Nigeria in Italia con Girolamo Di Geronimo alle nozze del figlio Francesco (1973) 258 Boby Di Geronimo con la delegazione italiana ed il ministro nigeriano delle finanze nel 1958 dell’esportazione di pelli la AMBROSINI Ltd., in quello dei coralli e bigiotteria DI GERONIMO. Nel 1982, con la morte di Girolamo Di Geronimo fu Francesco, dopo più di un secolo, termina definitivamente l’epopea del corallo dei coraggiosi commercianti castelnuovesi. 259 Capitolo VII Castelnuovo nei secoli XX e XXI 7.1 Il nuovo secolo e l’espansione urbanistica di Castelnuovo Il secolo XIX si chiude mentre Castelnuovo attraversa una fase di sviluppo economico e di espansione urbanistica. Le chiavi di volta dei portali in pietra delle abitazioni lungo il corso Regina Elena e dei palazzi signorili in Via Federico Di Donato recano quasi tutte una data tra il 1880 ed il 1900. La foto qui riprodotta mostra uno scorcio di Castelnuovo prima del 1926 (è infatti libero lo spazio del monumento ai caduL’espansione urbanistica di Castelnuovo ai primi del novecento ti della prima guerra mondiale, realizzato appunto in quell’anno). Il cimitero presenta le prime cinque cappelle nel lato meridionale. I nuovi palazzi che si costruiscono dopo La Croce hanno caratteristiche nuove rispetto alla consueta tipologia delle abitazioni del centro storico, e di quelle della prima espansione (corso Regina Elena, Via Serrone, Via del Sole). Sono a pianta rettangolare, a due piani sopraelevati, con ampi 261 locali terranei. Dimostrano una disponibilità economica del tutto nuova; la ricchezza si legge nelle facciate esterne, negli elementi decorativi delle modanature e nei cornicioni, nei portali e nei cantonali realizzati dallo scalpellino. Questa espansione edilizia, fine ottocento - inizio novecento, interessa l’attuale via Federico Di Donato. Gli edifici, tutti di ottima fattura, presentano la stessa tipologia, a blocco compatto, non aggregato. Essi si conformano come palazzi gentilizi, ma senza corte interna, ingresso diretto dallo spazio pubblico, con scala interna centrale che disimpegna gli ambienti. L’abitazione si distribuisce su due o più livelli: il primo piano destinato a residenza, il piano terra a depositi e magazzini. La copertura è a padiglione. Nelle facciate sono presenti portali in pietra, finemente lavorati, a superficie bocciardata o liscia, con concio di chiave decorato con motivi floreali o naturalistici. Presentano ampie aperture con imbotti in pietra calcarea, distribuite con ordine ed equilibrio, restituendo l’idea di una facciata semplice ed armoniosa. Chiave di volta del palazzo Urcioli del 1897 Chiave di volta del 1894 con le iniziali di Gennaro Ricciulli Al nuovo secolo appartiene anche la realizzazione della torre dell’orologio che viene edificata a ridosso dell’antica chiesa di San Nicola. Questa torre è indubbio segno di un nuovo orgoglio civico cementato con lo spirito di 262 intraprendenza e di laicità; quasi il manifesto ideologico di una espansione che dalla sfera commerciale si trasferisce alla sfera economica e poi a quella urbanistica e civile. Espansione destinata ad essere drammaticamente interrotta dalla prima guerra mondiale e da tutto quello che ne segue. Nel 1899 il sindaco Girolamo Di Geronimo affida l’incarico dello studio e della progettazione all’ing. Francesco Bianculli di Napoli. Motivo dell’incarico è quello di voler collocare per uso del pubblico un orologio, che visibile nelle ore del giorno dalla piazza del paese, lo sia, per meccanismo ed illuminazione, anche in quelle della notte; mentre per la posizione elevata, in cui dovrebbe trovar posto, sarebbe udito da tutte le abitazioni dei cittadini, comunque situate. Il tecnico individua il sito più adatto: in conseguenza si è ben prescelta la Chiesa di San Nicola, sul cui tetto tutti i cennati requisiti vengono a riscontrarsi; ma osserva anche che la medesima Chiesa, una delle poche che il paese si possiede, è assolutamente angusta e disadatta pei servizi del culto e pei bisogni della popolazione. A cavallo dei due secoli Castelnuovo vive il periodo di suo massimo splendore: ricco per le capacità e l’intraprendenza dei suoi abitanti, che non temono di avventurarsi nelle più remote contrade del pianeta, dalle Americhe, all’Asia, fino al cuore della inesplorata Africa, a praticare diversi commerci tra i quali spicca quello del corallo; in questi anni il paese tocca il culmine dello sviluppo demografico raggiungendo i duemila abitanti. E’ per questo che l’ing. Bianculli, mentre elabora il Progetto del Campanile della Cappella di S. Nicola per collocarvi l’orologio municipale, immagina anche che in un non lontano avvenire si dovrà pur pensare al suo1 migliore ampliamento e sistemazione. Per intanto il campanile nel quale l’orologio troverà posto -scrive il tecnico nella relazione- è stato ubicato nell’estremo orientale della facciata che guarda verso la piazza, ché ivi collocandosi il quadrante, nel sito più alto, sarà visibile dalla piazza medesima, ed il suono delle campanine, udibile da tutti i punti dell’abitato; la progettata torre per l’orologio e per le campane sarà impiantata sulla solida fondazione rocciosa, nella parte posteriore della Cappella di S. Nicola, ché ivi la rupe, a livello del suolo, non darà luogo a spese di murature dentro terra, opportunamente spianando e sistemando il masso. 1 Della chiesa di San Nicola. 263 L’ing. Bianculli precisa poi che è stato necessario, nel creare ex novo il campanile, servirsi dello spazio di suolo che resta fuori dal perimetro dell’attuale Cappella di San Nicola, per non restringere maggiormente la già per sé stessa insufficiente area attuale. Quanto alle dimensioni della nuova costruzione il progetto prevede che l’altezza della nuova opera sarà di m. 13,85, oltre il tetto che si eleverà per altri m. 2,00; essendo che solo sotto il piano di posa dell’orologio sono occorsi metri otto, per avere la profondità necessaria per tendere i relativi pesi. Tre dei muri Il complesso chiesa - torre in una foto del 1949 perimetrali saranno interamente di nuova costruzione, ché il quarto, per circa metri nove di altezza, sarà quello attuale della chiesa, e per il dippiù impiantato su di esso. In effetti il tetto non viene realizzato e le campanelle dell’orologio vengono situate sul solaio-terrazzo. Non raggiunge gli ottant’anni di vita la torre campanaria di C a s t e l n u ovo. E’ il terremoto del 23 novembre 1980 che se la porta via insieme a mezzo paese e a 86 persone. 264 7.2 Istruzione e cultura a Castelnuovo nel XX secolo Uno dei nuovi fabbricati dell’espansione urbanistica del primo novecento è quello fatto edificare da Vincenzo Rosania e poi donato per collocarvi l’asilo infantile. Abbiamo già visto la sensibilità esistente a Castelnuovo sulle questioni dell’istruzione. Il giornalista del 1901, che scrive del fenomeno commerciale di Castelnuovo di Conza, segnala che i cittadini a proprie spese mantengono due maestri di grado superiore. Quasi a raccogliere l’invito che il regio commissario Provaroni aveva rivolto al consiglio comunale di Castelnuovo nel 1887, Vincenzo Rosania, nato a Castelnuovo di Conza il 10 dicembre 1878, figlio di Vitale e Annicchiarico Rosaria e coniugato con Conte Ermelinda, su impulso del parroco don Gerardo Chirichella, dona un fabbricato destinato ad asilo infantile che inizia a funzionare regolarmente il 30 settembre 1936. Successivamente, con Decreto del 29 luglio 1938, su domanda del vescovo di Campagna mons. Giuseppe Maria Palatucci, si costituisce l’Ente morale Asilo Infantile “Vincenzo Rosania”, con sede in Castelnuovo di Conza, e dotato di un patrimonio valutato in Lire 291.700. Suore dell’Asilo “Vincenzo Rosania”; in secondo piano il busto del fondatore Lo Statuto dell’Ente richiama la donazione contenuta nello strumento del 9 giugno 1936 per Notar Federico Denza, fatta dal benefattore Cav. Rosania Vincenzo fu Vitale al Vescovo di Campagna Pietro Capizzi, quale rappresen265 tante e amministratore della Mensa Vescovile, e istituisce l’Asilo infantile, a nome del fondatore “Vincenzo Rosania” in un ampio e igienico locale che risponde a tutte le esigenze didattiche. Esso ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini di ambo i sessi, dall’età di tre a sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro età. Sono ammessi prioritariamente i bambini delle famiglie meno abbienti perché solo rimanendo posti liberi, dopo l’ammissione dei poveri, verso il pagamento di una retta, possono essere ammessi anche i bambini non poveri. Che potranno rimanervi non oltre il principio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati a ricevere l’istruzione elementare. Ai bambini dell’Asilo è somministrata la refezione quotidiana. Nel caso di deficienza di posti, salvo la preferenza dovuta agli orfani di tutte le categorie di caduti nelle varie guerre ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, sono preferiti i bambini che non abbiano persone che possano convenientemente vigilarli, perché impedite dalle loro occupazioni o da altre cause. Il primo consiglio di amministrazione è così composto: Presidente Mons. Gerardo Chirichella; componenti Giuseppe De Santis, Giuseppe Barbirotti, Francesco Rosania e Cav. Francesco Di Domenico. Nella percezione popolare l’Asilo infantile è un evento straordinario: la sua grandiosità risalta a fronte delle condizioni generali del paese, per come lo racconta un’anziana donna di Castelnuovo: Lu ’36 fu la prima vota c’aprigh’ l’asil’; prima nun g’era nisciun’ cunt’. Lu preut’ lu mannagh’ a chiamà e s’ m’ttigh’n’ d’accord’ ca vulia fa’ l’asil’. Vincenz’ Rosalia fec’ nu cuntratt’ ca s’ la v’dia tutt’iss’ da la prima preta a l’u’t’m’ seggiolin’. M’ ricord’ quann’ fec’r’ l’ fundament’, mamma mia quanta sold’ spicc’ ng’ m’namm’: tann’ s’ dicia ca purtav’ furtuna. Fu ’na grande cosa: era varament’, varament’ bell’; nun g’ nn’er’n’ accussì da qua ’ttuorn’: n’gera cucina, vetrat’ fierr’ battut’ (Il ’36 fu la prima volta che aprì l’asilo; prima non c’era niente. Il prete lo mandò a chiamare e si misero d’accordo che voleva fare l’asilo. Vincenzo Rosania fece un contratto che se la vedeva tutto lui, dalla prima pietra all’ultimo seggiolino. Mi ricordo quando fecero le fondamenta, mamma mia quanti soldi spiccioli ci buttammo; allora si diceva che portava fortuna. Fu una cosa veramente bella; non ce n’erano così qui intorno: c’era cucina, vetrate, ferri battuti)2. Ben presto però l’Asilo espande il campo dei suoi interventi: è anche propulsore di istruzione professionale con un laboratorio per giovani fanciulle 2 In Tina Terralavoro, Castelnuovo, paese di emigranti, Materdomini, 2004. 266 che vi apprendono il ricamo ed il taglio e cucito. L’Asilo è anche centro di aggregazione giovanile, con Suor Patrizia che suona l’organo, gestisce la Schola cantorum e prepara le recite. Insomma, una parte consistente della vita di Castelnuovo ruota intorno a questa nuova ed attesa istituzione. L’Asilo ospita anche le riunioni dell’Azione cattolica, con il gruppo donne, giovani e bambini. Presidente del gruppo donne è Rosa Di Geronimo, delle ragazze Carlotta D’Acunto; le catechiste sono Rachele Ricciulli, Maria Di Filippo, Alfonsina Greco, Maria Di Ruggiero. Le suore, appartenenti all’Ordine del Sacro Cuore di Ragusa, non percepiscono alcunché per la loro preziosa attività. E’ la popolazione che si fa carico del loro sostentamento con offerte in natura. Alcune suore sono rimaste a Castelnuovo per un lungo periodo. Suor Enrica per quarant’anni. L’Asilo, come istituzione, sopravvive al terremoto e funziona in locali di fortuna fino al 1995, quando le suore vengono trasferite altrove, un po’ per la diminuzione delle vocazioni, ed un po’ per la diminuzione dei bambini. Hanno lasciato un bellissimo ricordo nella gente di Castelnuovo. L’iniziativa filantropico-pedagogica di Vincenzo Rosania si innesta nella scia del pensiero e dell’opera di un altro castelnuovese illustre, Federico Di 267 Il laboratorio nell’Asilo di Castelnuovo Donato, maestro elementare, direttore didattico, giornalista. Egli nasce a Castelnuovo di Conza il 10 febbraio 1855 e muore a Roma il 30 novembre 1919. A Roma lo ha portato una brillante carriera di uomo di scuola ed educatore. Un bel profilo di Federico Di Donato è tracciato nella rivista I Diritti della Scuola, che lo ricorda all’indomani della sua scomparsa: A Roma egli era conosciuto da tutti: dagli uomini più noti ed autorevoli della città che s’erano trovati a cooperare con lui in tante istituzioni benefiche, e dalla folla degli umili che di quelle istituzioni avevano profittato per sé e per i propri figli. Nel quartiere dov’è la scuola “Pestalozzi”, di cui egli era stato direttore per molti anni, la sua popolarità è durata fino agli ultimi giorni. A Roma era venuto giovanissimo, dopo aver insegnato per alcuni anni nelle campagne della sua provincia. E s’era fatto subito notare per l’ingegno pronto e nutrito di sana coltura, per l’operosità e lo spirito d’iniziativa, e sopra tutto per un grande amore per la scuola. Egli ebbe veramente un culto per l’educazione del fanciullo; vide in essa il più sacro dei doveri sociali, l’unico mezzo per conseguire l’elevazione del popolo e un ben ordinato progresso civile. Ne sentì tutta la poesia, ne fece lo scopo supremo della sua vita. E non parendogli sufficiente l’opera, che pure compiva con tanto zelo, nell’interno della scuola, egli la estese in mezzo alle famiglie, nelle associazioni, nella stampa, con un così armonico collegamento che nulla ne andava perduto per il fine che si proponeva. 268 Recite nell’auditorium dell’Asilo Da direttore della “Pestalozzi” Di Donato si rende ben presto conto che l’azione educativa non può limitarsi alle poche ore del mattino, specialmente per i bambini delle classi disagiate, che non possono contare su un am269 biente familiare accogliente e stimolante. Ha perciò, con grande anticipo sui tempi, l’idea di una scuola a tempo pieno. Il suo Educatorio assicura a quegli alunni la possibilità di trascorrere il resto della giornata, dopo le lezioni, in un ambiente sano e suggestivo, assistiti, nutriti, provveduti degli indumenti e degli oggetti scolastici più necessari. Dietro il suo esempio anche altre scuole della capitale adottano l’idea, che Di Donato riesce a far condividere a facoltosi finanziatori. Collabora, nel frattempo, al giornale La Libertà, fondato nel 1870 dal garibaldino Edoardo Arbib, Federico Di Donato poi deputato e senatore, autore dell’opera Cinquant’anni di storia parlamentare del Regno d’Italia (1898). Questa esperienza gli è utile quando poi l’attività di giornalista diventa per lui prevalente, come corrispondente de Il Risveglio educativo e poi de I Diritti della Scuola. E’ anche collaboratore di Ruggero Bonghi quando vuole fondare ad Anagni un collegio per le orfane dei maestri. Rappresenta l’Italia al congresso pedagogico internazionale che si tiene a Parigi nel 1900 in occasione dell’Expo. E’ tra i fondatori del Patronato scolastico di Roma, di cui è anche autorevole consigliere. In questa veste Federico Di Donato trova l’occasione per realizzare le Colonie estive per gli alunni delle scuole comunali di Roma allo scopo di promuovere con la cura climatica in montagna e con quella dei bagni marini, con la buona nutrizione e con la ginnastica, il benessere fisico e morale degli alunni, di migliorarne la costituzione organica e prevenire le malattie, in particolare la tubercolosi. La rivista I Diritti della Scuola fornisce alcune cifre: si cominciò col mandare per un mese al monte o al mare un centinaio di fanciulli, scelti con rigoroso criterio tra i più poveri e bisognosi di cure; nel 1917 si era già arrivati a mandarne 1272, i più deboli anche per due mesi; nel 1918, 1503; quest’anno ven270 nero mandati al mare, a Formia, Nettuno, Ladispoli, Santa Marinella, 1069 fanciulli; in collina a Monteporzio e a Cingoli, altri 434; ne furono consegnati alla Croce Rossa, che li raccolse alla Quercia, presso Viterbo, altri 113. Il vero miracolo di Federico Di Donato consiste nel trovare i finanziamenti per far funzionare le Colonie, che vivono di anno in anno delle offerte dei privati, dei proventi delle feste promosse dalle scuole, dalle elargizioni di enti, del Bambini in colonia Patronato scolastico, del Comune di Roma, dei ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione, e perfino della Casa reale. Federico Di Donato può anche contare sul lavoro volontario che viene prestato da amministratori e medici. La sua rivista lo saluta con queste parole: Uomini come Federico Di Donato si possono considerare gli antesignani di un’umanità migliore. E ci sembra che non ci sia alcuna retorica. Castelnuovo di Conza gli ha dedicato questa lapide: Federico Di Donato Che Educatore dei figli del Popolo Nella Capitale d’Italia Con perseverante animo d’Apostolo Le profonde energie di Bene Della sua Gente natia Signorilmente profuse In opere durature di carità Per l’Infanzia Bisognosa II Comune di Castelnuovo di Conza A perenne ricordo XXIII – IX - MCMXXVI 271 Nel 2007 si opera una sorta di gemellaggio tra gli alunni delle scuola elementare di Castelnuovo e quelli della scuola elementare nel quartiere Esquilino di Roma intitolata a Federico Di Donato. Il progetto è incardinato sulla riscoperta del grande pedagogista. Dell’iniziativa fa un resoconto il sacerdote don Antonio Pisani, poeta ed artista di Contursi, il quale dà alle stampe un volumetto contenente anche disegni dei bambini delle due scuole. Don Antonio Pisani sottolinea l’incontro tra due realtà così diverse: quella castelnuovese fatta di emigrazione e di attaccamento alle proprie radici e tradizioni, e quella del quartiere Esquilino caratterizzata dall’immigrazione e dalla multiculturalità. Seguiamone il racconto: il 30 marzo 2007 gli alunni di Castelnuovo e Santomenna sono andati a Roma a visitare la scuola di Federico Di Donato. Tutti felici hanno ricevuto una calorosa accoglienza e sono restati stupiti nel vedere ragazzi orientali con gli occhi a mandorla. Si sono divertiti, hanno pranzato insieme ai ragazzi della scuola, hanno fatto amicizia, hanno ricevuto dei regali (…); il 22 maggio 2007 i ragazzi di Roma sono venuti a Castelnuovo di Conza, c’è stata una grande accoglienza. I bambini di Castelnuovo e Santomenna in costume d’epoca, inizio novecento, La scuola romana “Federico Di Donato” 272 facendo due ali sulle scalinate davanti alla scuola, hanno accolto gli amici di Roma con applausi, danze e tarantelle suonate con l’organetto… Una grande sensibilità pedagogica si trova nelle “Cronaca di vita della scuola – Osservazioni sugli alunni” redatte a cavallo degli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso dai maestri Linda Tomay e Guido Di Geronimo e che offrono uno spaccato della vita a Castelnuovo all’indomani della seconda guerra mondiale. Vi si possono leggere valori di solidarietà, giustizia, libertà, responsabilità, che sono alla base della funzione docente dei due maestri. Alle spalle di tutti c’è la tragica avventura della partecipazione italiana alla guerra. Per Castelnuovo la fase espansiva di fine ottocento si è esaurita anche per le mutate condizioni internazionali: le attività commerciali degli italiani non sono ben viste nei paesi controllati dagli alleati anglo-americani. I castelnuovesi continuano a viaggiare, ma si tratta ora di viaggi della speranza, con la valigia di cartone verso le Americhe, l’Australia, la Svizzera, il Belgio. E’ la seconda grande ondata migratoria, dopo quella altrettanto massiccia degli inizi del secolo. L’emigrazione trova spazio nelle cronache scolastiche della maestra Linda che, nell’imminenza del Natale 1949, così annota nel registro : Diversi alunni hanno il loro padre in lontane terre ed a tutti farò inviare il loro pensiero tenero ed affettuoso ed il loro augurio al genitore lontano che è lì per sacrificarsi, per lavorare incessantemente per procurare alla sua famiglia un avvenire migliore e sicuro. Lo spirito di sacrificio che ha il popolo di Castelnuovo è da ammirare. Uomini, donne e bambini sono pronti a sacrificarsi, a vivere lontano, soffrendo disagi anche i più duri per farsi un avvenire. Dal nulla diventano ricchi. Tutti espatriano, vanno nelle lontane Americhe La maestra Linda Tomay 273 e lì tutti trovano lavoro perché sono volenterosi e pronti a qualsiasi sacrificio. Quindi ammiriamo questi genitori ed amiamo questi cari figlioletti che vivono lontano dal loro caro papà, privi di tante tenerezze e di tanti baci. La scuola elementare di Castelnuovo è ubicata in alcune stanze di una casa malridotta, nei pressi della chiesa della Petrara. Manca il riscaldamento, e quando fa freddo i bambini soffrono, o non vanno proprio a scuola. A marzo così scrive la maestra: Il freddo è ancora intenso, diversi alunni oggi sono assenti perché piove e tira vento. Speriamo che presto venga il bel tempo in modo che tutti siano presenti. Il freddo è il vero nemico della scuola, come La sede della vecchia scuola in una foto degli anni ‘70 scrive il maestro Guido a gennaio 1951: Quest’anno, come del resto tutti gli anni d’inverno, siamo messi veramente a dura prova per il freddo. Infatti l’aula lascia completamente a desiderare. Vero è che tutte le aule di questa scuola sono in uno stato pietoso e per riscaldamento e per arredamento. Ci viene dato per riscaldarci un poco di carbonella, che è addirittura una ironia con questo freddo. L’aula nostra, poi, sopraelevata ed esposta a tutti i venti, è addirittura un frigorifero. E’ doloroso, molto doloroso, dover constatare, purtroppo, che ci sono ancora, in Italia, scuole in un tale stato di 274 abbandono. Io personalmente, e con tutta franchezza, devo dire che mi stupisco proprio come, mentre (e giustamente) si pretende tanto dall’insegnante per la sua preparazione, niente si fa nella scuola per il locale, per il riscaldamento, per tutto quanto, insomma, forma e deve formare quell’ambiente sereno, sano e confortevole, in cui l’alunno entri con gioia e che tanto coadiuva l’opera infaticabile del maestro. Guido Di Geronimo ritorna sulla questione in modo più organico: Secondo argomento da trattare è quello delle condizioni delle aule scolastiche. E’ questo un argomento veramente doloroso, scottante. Sono due anni che insegno in questa scuola e si va di male in peggio. In quest’inverno tanto inclemente, fatto di venti impetuosi e piogge torrenziali, a volte, entrando nella scuola la mattina, mi si stringe il cuore. Che desolazione, che squallore! Aule invase dalle acque filtranti da finestre sconnesse e dagli stessi muri umidissimi; vento che soffia attraverso le sconnessure a suo maggior piacimento. Ed a questo poi si deve aggiungere la solita ironia del riscaldamento, consistente in quel braciere (o meglio vecchia bacinella) con un po’ di carbonella quasi spenta, che serve solo a rendere l’aria irrespirabile. E’ in una atmosfera tanto desolate che assisto, a volte, all’arrivo degli alunni, e mi si gonfia il cuore, specie per quei ragazzetti di prima classe, i più dei quali, macilenti per le note condizioni locali di grande miseria, arrivano mal coperti dai loro miseri panni e con le scarpe rotte. Vanno a pigliare posto, intanto, nel loro banco, muti e tremanti, e spesso, è terribile a dirsi, quei piedini nelle Il maestro Guido Di Geronimo 275 scarpe rotte poggiano nell’acqua. Qualche volta non ho potuto fare a meno di dire a loro: -Ragazzi, se avete almeno un buon fuoco a casa, ritornatevi e riscaldatevi. Domani, se il tempo sarà migliore, ritornerete a scuola-. E li dovevo, così, rimandare a casa se non volevo che si buscassero un serio malanno. Dalla constatazione di condizioni materiali inaccettabili il maestro Guido trae spunto per una riflessione più ampia: Ora, mi dico, è concepibile tutto questo? E’ concepibile che la scuola sia quasi uno spauracchio per il bambino, che non vi trova se non umidità, freddo e squallore? Molto di più di quanto non ne possa trovare nella sua stessa povera casa? A ben ragione la collega della prima classe ha definito la sua aula “il carcere dello Spielberg”. Oh! Come sarebbe bello, tanto più bello invece, che questi fanciulletti, venendo dalle loro misere case, trovassero a scuola il loro posticino al caldo, in una bella aula arredata, confortevole, festante di luci e di colori; ed infine, dopo la scuola, la provvidenziale refezione! Quella refezione che esiste nei centri più grandi, ma che tanto difficilmente si ottiene in questi piccoli paesi dimenticati. E’ vero che i poveri sono di più nei centri più grandi, ma forse questi non sono poveri lo stesso per non avere diritto proprio a niente? Quando poi, in proporzione, i poveri sono qui in maggior numero. Infatti, se si considerano gli alunni di prima classe, qui ne abbiamo circa il 50%. Ora, come si può in tanto deleterie condizioni pretendere da questi ragazzetti assiduità e profitto, anche con tutta la buona volontà e la capacità del maestro? La sensibilità del maestro Guido e la denuncia delle ingiustizie sociali si accompagna ad una concezione pedagogica della funzione del maestro che ha nella libertà e nella sintonia con gli allievi i cardini fondamentali della pratica docente: Terzo argomento che tratterò è quello dell’uso del quaderno con la lezione giornaliera per la cosiddetta preparazione prossima. Io insegno da tre anni e devo dire sinceramente che non avevo mai provveduto all’uso di questo quaderno. Ciononostante mi sono sempre sentito soddisfatto del mio insegnamento. Vero è che tocca ai nostri superiori giudicare sul nostro rendimento, però indubbiamente anche noi stessi possiamo e dobbiamo accorgerci se le nostre lezioni sono proficue; se rendono; se sono assimilate e quindi se possiamo essere soddisfatti. Intanto, pur essendomi trovato sempre bene senza quaderno, quest’anno, per tassative disposizioni, ho dovuto anch’io impiantare il quaderno della classe. L’ho impiantato con tutta la mia buona volontà e con pieno spirito di ottemperanza alle superiori disposizioni. Ma, ahimè, ho sentito di averne avuto solamente un forte svantaggio! Qui mi si potrà dire che una simile dichiarazione è addirittura grave per un maestro; che ciò non può verificarsi, se si fa con buona volontà ed ordine, se si lavora con coscienza, serietà, 276 e tante altre cose. Ora davanti ad un fatto che può essere giudicato grave dai miei superiori, io debbo cercare di fissare in questa cronaca tutte le considerazioni, i riflessi che sono scaturiti da quest’uso impossibile per me. Prima d’ogni altro bisogna chiarire un punto: qual è lo scopo dell’uso di questo quaderno? Dovrebbe essere quello di permettere al maestro di ripartire razionalmente le varie lezioni della giornata, in modo che non siano improvvisate, e nello stesso tempo costringerlo a non potersi sottrarre allo svolgimento di quanto preparato. Quindi avrebbe il quaderno anche una funzione di controllo. A quest’ultima ipotesi voglio però credere poco, perché mi sembrerebbe poco edificante per noi educatori essere sottoposti ad un controllo che ci negasse, a priori, quella fiducia che in noi penso sia riposta per la nostra coscienziosa opera educatrice. E poi il controllo potrebbe essere anche effimero, in quanto si potrebbe preparare sul quaderno tutte le più belle lezioni e poi svolgere il tutto superficialmente. Quindi, trascurata o quasi scartata questa ipotesi, rimane quella che ci fa supporre l’uso del quaderno a scopo di ausilio didattico, nel senso dell’ordine e della razionalità. Ed è su questo punto che debbo fermarmi a trarre le mie maggiori considerazioni e ad esporre tutto il mio modo non dico di vedere (perché non voglio né posso fare questione di opinione personale quello che è un ordine superiore) ma dico di sentire lo svantaggio e quindi la impossibilità di servirmi di un tale sistema. E dicendo sentire, anziché vedere, io voglio significare che anche se avessi potuto convincermene con favorevoli argomentazioni teoriche, in pratica non ho potuto che avere un effetto contrario. Ed ora dirò, senza più preamboli, quello che ho sentito. Ho sentito che questo quaderno che vuole preordinare, definire, calcolare la mia lezione, non fa altro che toglierle il respiro, imprigionarla, strozzarla, rendendola sommamente arida. Io, mi si creda o no, questo ho sentito giorno per giorno. E poiché questo non è piccola disgrazia per la mia povera lezione, a cui tengo tanto, ma tanto, allora, con la licenza dei miei superiori, io butto all’aria il quaderno. Dico con la licenza dei miei superiori, perché se ad una visita, dopo che avrò tentato di giustificarmi, esprimendo non il mio punto di vista, ripeto, ma tutto quanto di male ho sentito di aver ricevuto dall’uso di questo quaderno, per la mia lezione; dico se ad una visita avrò torto, dovrò ripigliare il quaderno e ritentare. L’insegnamento nella scuola elementare non è quello che si può fare in una scuola media, dove tutta la lezione si può svolgere preordinata e calcolata nel tempo. Nella nostra scuola la lezione deve essere comunicativa, viva, palpitante. E’ questa una grande verità pedagogica, che io ho compreso subito nei miei studi e di cui mi vado sempre più convincendo nella pratica di ogni giorno. E perché sia possibile, la lezione non può essere preordinata, calcolata, limitata nel tempo. 277 I maestri Linda e Guido con gli alunni Guido Di Geronimo contesta in radice, e si rifiuta di applicare le aride regole della burocrazia scolastica che vorrebbero ingabbiare la libertà e la creatività dell’insegnante nel rapporto con gli alunni: Siamo d’accordo che è necessario avere un orario delle lezioni ed un piano mensile (ed io non sono mai venuto meno a questo dovere), ma non bisogna andare più in là di ciò, cioè non si può avere un piano giornaliero. L’orario deve avere, come ha sempre avuto per me, un carattere puramente orientativo nella giornata, senza creare la preoccupazione di doversi attenere scrupolosamente, se non si vuole, per la fretta, per la paura di non far tutto, cadere nell’aridità e nella superficialità. A volte capita che gli argomenti delle varie materie segnate nell’orario si presentino piani e facili, tanto che si possono trattare in un tempo anche prestabilito, senza che ne venga compromessa la riuscita della lezione. Ma quante altre volte, invece, questi argomenti si presentano troppo importanti ed interessanti per non poter essere trattati alla stessa stregua degli altri, senza che ne escano rachitici, direi, nella loro trattazione, e senza perciò che riescano ad interessare e ad essere assimilati per dare i loro buoni frutti! Io ricordo che un giorno ho speso oltre un’ora e mezza per una lettura. Ad un profano potrebbe sembrare 278 esagerato, potrebbe sembrare che il maestro sia indolente e perda tempo attardandosi per oltre un’ora e mezza per una lettura. Ma a noi che conosciamo di che cosa è fatta la vera lezione, che cosa significhi scuola viva, ciò certo non può né deve meravigliare. La lettura di quel giorno era un racconto di una povera mamma che aveva dato per il figlio tutto: dal suo latte al lavoro delle sue braccia, dalle lacrime copiose versate in silenzio senza che questi gliene fosse grato, sino al punto di abbandonarla. Ed allora, consumata dalla fatica e dal dolore, la povera mamma dette anche la sua vita e morì benedicendolo. Era una bella lettura, piena di sentimento, ricca d’insegnamenti morali; era la lettura dell’affetto più grande e più puro: quello di una mamma! Potevamo noi leggerla così, semplicemente, come esercizio di lettura con un breve commento, come avevamo fatto con altre letture? No, certamente. Ed allora ecco che parlammo tanto (dico parlammo, perché c’era piena comunicativa tra me maestro e loro alunni) di quell’affetto incommensurabile, ci commuovemmo sinceramente, ne traemmo l’insegnamento per noi, citammo esempi; insomma facemmo sì che quella lettura lasciasse la sua orma incancellabile nel nostro animo, sulla grandezza dell’affetto materno, sul sacrosanto dovere dei figli di onorare chi ha dato loro la vita. Oh! Io sono sicuro che quel giorno tutti diventammo un poco più buoni. Quindi la lezione aveva raggiunto lo scopo, era riuscita. E questo per me era certo più importante della preoccupazione, magari, di aver rubato un’ora ad altra materia, la quale certo non venne trascurata, perché fu trattata in altro tempo e pienamente. Questo della lettura è un esempio che ho voluto citare, ma in tutte le materie io credo di essere riuscito nella piena, libera, palpitante trattazione, ad interessare gli alunni e perciò a far loro assimilare completamente. Anche nella trattazione dell’arida aritmetica, in quelle lezioni che più si presentano difficili e pesanti, noi piano piano (senza alcun assillo a far presto per passare ad altro) siamo riusciti ad interessarli, a fare tante piccole utili scoperte sui numeri, quasi come fossimo i primi a farle, tanto da riuscire cara e simpatica anche l’aritmetica. A giudizio di Tina Terralavoro3 queste cronache dei due maestri veicolano un’idea di scuola e di educazione ammirevole, a cui oggi (dopo oltre 50 anni di politiche spesso distruttive in campo educativo) si sta finalmente e faticosamente cercando di ritornare. Il maestro Guido e la maestra Linda con serietà e coscienza sentivano la responsabilità del loro ruolo di educatori. Ci parlano 3 Lu Chianieddh’, Rivista bimestrale castelnovese, n. 3 del 2007. 279 di ferma disciplina, di studi seri, di passione per lo studio, di letture morali; e, ancora, riconoscono come un male fatto agli alunni la promozione di massa. Rivendicano la libertà sancita dalla Costituzione di ogni insegnate di esercitare la propria professione come ritenga più opportuno; e con almeno 20 anni di anticipo rispetto ai primi interventi legislativi, reclamano autonomia rispetto ai rigidi programmi imposti dai vertici. Nel quadro dei maestri a Castelnuovo negli anni quaranta e cinquanta un posto di rilievo spetta ad un’altra figura di insegnate, al di fuori della scuola ufficiale ma non per questo meno Il maestro Vito Liloia e la sua famiglia importante: il maestro Vito. Vito Liloia è una sorta di maestro di sostegno, nel senso che nella sua casa al Serrone si ritrovano frotte di ragazzini che vanno al doposcuola. Ed assolve anche ad una funzione sociale impartendo i rudimenti della lettura e della scrittura agli aspiranti emigranti, che devono almeno imparare a mettere la firma. Mantiene la corrispondenza tra vecchi genitori analfabeti e i figli nelle lontane Americhe. Il maestro Vito è anche uno stimato amministratore del Comune di Castelnuovo. 7.3 La “missione” del 1955 nella campagne di Castelnuovo, a Buoninventre e Sant’Ilarione Le cronache scolastiche di Linda Tomay e Guido Di Geronimo offrono un quadro delle difficili condizioni di vita a Castelnuovo negli anni del secondo dopoguerra. Altro illuminante documento è il diario della missione promossa dall’Azione Cattolica di Castelnuovo nella settimana di Pasqua del 1955. Missione è termine che nella storia della chiesa cattolica 280 ordinariamente si associa a viaggi avventurosi di religiosi, in paesi lontani ed esotici di cultura e religione non cristiana, allo scopo di predicare il Vangelo e di convertirne le popolazioni. Missione è anche un termine che, ancora al nostro tempo, si riferisce a cicli di predicazioni in chiesa tenute da religiosi esterni alla comunità, che si esaurisce in pochi giorni. Nel caso della “settimana campestre” dell’Azione Cattolica tenutasi a Castelnuovo di Conza dal 17 al 24 aprile 1955 le due accezioni semantiche di missione quasi si uniscono e si fondono. Non perché le campagne di Castelnuovo a quel tempo siano lontane ed esotiche, ma per il fatto che le condizioni materiali di vita degli abitanti dei pagliari li collocano lontanissimi nella storia, in un tempo immobile e sempre uguale a se stesso. Castelnuovo di Conza, anni ’50, insediamento a li pagliar’ Il tutto parte dal fatto che molti cittadini di Castelnuovo che abitano nelle zone “Bosco” e “Varco appenninico”, e cioè a Buoninventre o Torretta e a Sant’Ilarione, di fatto, non hanno pressoché alcun rapporto con la religione a causa della mancanza fisica del luogo di riferimento, la chiesa. Non che non operino le due chiese storiche di Castelnuovo, quella antichissima di San Nicola e quella della Madonna della Petrara, ma per il fatto che, né culturalmente, né fisicamente, esse sono percepite come raggiungibili 281 da quelle genti. Le condizioni di vita, poi, sono insostenibili e coloro che non trovano sbocco nell’emigrazione sono di fatto abbandonati a se stessi. E così le autorità religiose di Castelnuovo organizzano la “missione”. Un prezioso album di fotografie e di scritti conservato religiosamente (mai termine più appropriato) da Maria Di Filippo ci permette di dare conto di quella singolare iniziativa. Facciamo parlare i due sacerdoti “missionari”, autori delle illuminanti relazioni. La prima relazione riguarda la zona del Varco appenninico ed è stesa dal Rev.mo P.D. Benedetto Tortora, Direttore della Missione. La Parrocchia consta di 1400 anime: buona parte è dislocata in campagna, ove si è svolta la missione, anche perché al paese era stata tenuta la predicazione della settimana santa. Partecipanti alla missione con i bambini dei pagliai Sabato 16 aprile. Nelle ore pomeridiane arriva da Campagna il Missionario e direttore P.D. Benedetto M. Tortora, della Abbazia di Montevergine, accompagnato dal delegato Vescovile per l’A.C.D. Giuseppe D’Amato. All’ingresso del paese si fanno trovare Arciprete, Sindaco, Suore, Associazioni con bandiere: ac282 colgono il Missionario con prolungata ovazione. Al canto di inni si va in Chiesa Parrocchiale, ove il Molto Reverendo Arciprete Don Nicola D’Acunto dà il saluto al Missionario, il quale rispondendo assicura tutta l’attività dei Missionari per il bene delle anime, ed il Delegato porta la benedizione di S. Ecc. Mons. Vescovo, infermo gravemente, ma che segue lo sviluppo della Missione, la prima in diocesi. Si dà lettura di un telegramma da inviare al S. Padre: “Sua Santità. Città del Vaticano. Iniziando Missione Campestre Clero Missionari Autorità popolo Castelnuovo Conza elevando voti Vostra Santità implorano particolare benedizione Apostolica amato Vescovo Palatucci infermo Campagna”. Segue la Benedizione Eucaristica. Domenica. All’alba il Parroco celebra la S. Messa, segue la processione con la bellissima statua della Madonna delle Grazie, venerata nei paesi e nei dintorni fino al centro della Missione, distante circa 5 Km (Varco Appennino o Sella di Conza). Qui nella cappella improvvisata nella casa cantoniera messa gentilmente a disposizione dal capo compartimento dell’Anas di Napoli, comm. Foglia Domenico, si celebra la S. Messa del Missionario, il quale rivolge la sua parola a tutti, dando il programma e l’orario dello svolgimento della Missione. Più tardi con altra processione con una statua della Madonna Immacolata, portata giù dal paese, si va all’altro centro Missione “Bosco” ove il Missionario celebra altra Messa, in assenza del secondo Missionario, il Rev. Don Nicola D’Archi, il quale verrà in serata e raggiungerà questa sede. E’ presente una sola propagandista da Cerignola, mentre l’altra da Corleto viene meno e sarà supplita durante la settimana dalla signorina Ada Figurelli, dirigente Diocesana di Campagna, molto adatta e capace. La settimana si svolge con molto zelo e corrispondenza da parte dei fedeli: accostamento delle persone, benedizione pasquale delle case: si è fatto di meglio per le varie categorie. Tutti hanno potuto fare il precetto pasquale. Al centro Missione al giovedì una riuscita Ingresso di un pagliaio 283 ora di Adorazione; Via Crucis predicata nelle due Missioni; Rosario intero predicato con l’aiuto del Reverendo Arciprete D’Acunto e di due Sacerdoti di S. Andrea di Conza e del Giudice Addesso presidente diocesano della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) di Campagna. I centri missione sono stati meta di continuo pellegrinaggio da parte dei fedeli del paese e delle parrocchie limitrofe. Molte prime comunioni dai 12 anni in su. Domenica 24. Messa a mezzanotte al Centro Missione per i soli Uomini. La chiusura è stata un vero trionfo. Dopo la benedizione della Croce di ferro a ricordo si è ripetuta la processione per il ritorno al paese: oltre 1500 erano i fedeli con l’aggiunta di altri di paesi vicini. La S. Messa è stata celebrata in piazza dal venerato Arciprete D’Acunto, mentre il P.D. Benedetto commentava la S. Messa. Erano presenti il delegato Vescovile, Don Gibboni e Don Amato. Indi chiusura con la lettura del telegramma del S. Padre: “Parroco Castelnuovo di Conza. Città Vaticano. PaternaLa croce in ferro collocata sulla sella di Conza mente augurando la iniziata Missione Campestre durevoli preziosi frutti cristiano rinnovamento Sua Santità invoca larga protezione divini lumi ed aiuti, mentre volentieri conforta persone e propositi con implorata particolare benedizione. Dell’Acqua Sostituto”. Il Delegato Vescovile Don Amato legge un messaggio di S. Ecc. Mons. Vescovo. Osservazioni: 1. Si prende atto della completa e perfetta preparazione della Missione sia dal lato spirituale che dal lato tecnico e logistico. Preparazione spirituale: abbiamo ammirato l’impegno della Gioventù Femminile locale con la frequenza ai Sacramenti e nella vita interiore in tutte. La preparazione 284 Interno di un pagliaio 2. 3. 4. 5. tecnica e logistica: a tutto si è provveduto e a tutto si provvedeva anche nella cose impreviste e suggerite: tanto si sono prodigati Dirigenti e soci con sacrifici non indifferenti. Il plauso particolare all’ottimo Arciprete e alla sua degna nipote signorina Carlotta D’Acunto, Presidente dell’Associazione Femminile di Azione Cattolica. Si prende atto della gentilezza usata da parte della Direzione Compartimentale di Napoli della Azienda Nazionale Autostrade (sic!) Statale (Anas), che ha messo a disposizione della Missione la casa cantoniera al Varco Appenino (S.S. 91) locale adibito per cappella e per abitazione dei missionari. Si fa voto che la medesima direzione Compartimentale metta a disposizione dell’Autorità Ecclesiastica il predetto locale, perché alla domenica vi si possa celebrare la S. Messa nelle ore pomeridiane. Data la lontananza dei paesi si consiglia la creazione di una Cappella al posto più adatto e si prende atto della donazione del suolo fatta da un cittadino di Castelnuovo di Conza per detta erezione. Finché non sarà eretta l’attesa Cappella in loco per l’assistenza religiosa si raccomanda all’Associazione G. F. e alle benemerite Suore di fare delle puntatine domenicali per il Catechismo Parrocchiale e l’assistenza alle numerose giovani e all’infanzia, tanto desiderose d’istruirsi nelle cose religiose. 285 6. Si prenda nota dello stato particolare di miseria in cui versano le famiglie della località “Bosco”. Stato veramente pietoso e che merita l’attenzione delle autorità non solo religiose ma soprattutto amministrative e politiche. E’ gente che vive per tutto l’anno in veri pagliai, e nei pagliai vivono insieme agli animali. Povertà nera sotto tutti i punti di vista e l’opera assistenziale non si esaurisce con una minestra amministrata qualche volta né con qualche occasionale sussidio; il problema deve essere studiato in pieno, e prima di tutto si pensi alla “casetta” se vogliamo che quella popolazione buona e semplice abbia fiducia ancora nei valori spirituali ed umani. Perché non interessarne anche la P.O.A. (Pontificia Opera Assistenza). La seconda relazione, più cruda e diretta nelle osservazioni, è relativa alla zona Bosco, ed è stesa dal Missionario Arciprete Don Nicola D’Archi. La Missione si è svolta in due zone, una sull’importante snodo stradale detto Varco Appennino, dove confluivano feCoabitazione nel pagliaio deli della provincia di Avellino e di Salerno, limite anche di Diocesi diverse, e l’altra nella frazione Bosco, per i soli fedeli della campagna di Castelnuovo. Della prima missione vedere la relazione dell’altro Padre Missionario, della seconda eccone brevemente il resoconto: Abitanti della zona circa duecento; percentuale dei partecipanti il cento per cento; tutti si sono accostati ai SS. Sacramenti, eccetto uno, la cui posizione matrimoniale è un po’ imbrogliata, perché lui sta quasi sempre fuori casa in convivenza con un’altra donna (pur avendo moglie e figli) e nei giorni della Missione è stato assente, altrimenti avremmo pure fatto il possibile per tenerlo più legato alla propria famiglia. Particolare commovente: i genitori di costui alla fine piangevano come bambini, perché solo il loro figliuolo non s’era accostato ai sacramenti. 286 Detti genitori sono considerati quasi come i nonni di tutta la contrada essendo i più vecchi e quasi i capostipiti di tutti gli abitanti della zona. Quell’uomo, però, c’è da sperare ritorni all’ovile, mediante l’opera dello zelante Arciprete locale Don Nicola D’Acunto. Detta Missione è stata una delle vere Missioni Campestri, sotto tutti i riguardi. Difatti la cappella provvisoria della Missione è stata adattata in un pagliaio che abitualmente serve di abitazione per quei buoni villici, che nel suo misticismo sembrava la grotta delle tre fonIgiene personale nel pagliaio tane di Roma, nella quale grotta si sono svolte tutte le funzioni proprie della settimana campestre, ed a ricordo è stata piantata una grande croce sulla collina più alta della zona, per ricordare il grande avvenimento. La chiusura della Missione si è svolta con una solenne processione dalle due zone missionarie al centro paese dove si è celebrata la Messa all’aperto in presenza di numerosissimo popolo e delle autorità ecclesiastiche diocesane. Un particolare pietoso che vorremmo far presente al centro Nazionale e per Suo mezzo alle autorità governative. Quei villici vivono completamente isolati dal centro abitato, per accedere al quale debbono fare delle vie disastrose, essendo la rotabile molto tortuosa e lunga, e vivono nella più squallida miseria. Le abitazioni sono veramente singolari, ed io che ho fatto moltissime missioni rurali, è la prima volta che trovo delle zone così depresse. In un pagliaio, per lo più coperto di paglia, vivono assieme alle loro bestie famiglie con diversi figli, esposte a tutte le intemperie e col continuo pericolo di morire bruciati. Fortunatamente sono tutti d’indole naturalmente buona, ma esposti ai pericoli del comunismo e del protestantesimo4, che pullulano nelle vicinanze a brevissima distanza. Si auspica che a mezzo della P.O.A. quella zona sia molto assistita ed aiutata e 4 Nell’alta valle del Sele c’è una tradizionale presenza di nuclei di evangelisti. 287 che s’interessi anche il governo per la costruzione di casette più sicure e da poter far vivere in un modo più umano. Eppure la provincia di Salerno vanta di essere una delle provincie più belle e più ricche d’Italia e si è fatto tanto a sollievo dei sinistrati dell’alluvione, mentre coloro che vivono in detta zona sono degli eterni sinistrati, sprovvisti delle cose più necessarie. Vorrei che queste note siano prese in considerazione e ci si metta a contatto con il parroco locale, anche per la costruzione di una cappellina, dove elementi di Azione Cattolica locale potrebbero spesso recarsi per la necessaria istruzione religiosa, e dove spesso si potrebbe pure celebrare qualche Messa Vespertina e che si mandi presto qualche elemento del centro, anche da parte del governo, per constatare che quello che è stato scritto è non altro che la cruda realtà. Non posso chiudere questa breve relazione senza fare un elogio al parroco locale, Don Nicola D’Acunto ed alla sua nipote signorina Carlotta D’Acunto, ottimo elemento di Azione Cattolica, che se la Missione è riuscita efficacissima, è stato proprio perché l’hanno molto bene preparata ed assistita, anche da parte delle Suore locali e della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Va, infine, riportato il messaggio del Vescovo di Campagna, Mons. Giuseppe Maria Palatucci, gravemente ammalato in quei giorni: Dilettissimi figli e figlie in Gesù Cristo, sparsi nelle zone rurali di Castelnuovo di Conza, potete immaginare con quanto desiderio io abbia atteso la settimana campestre per venire in mezzo a voi a rivolgervi la mia paterna parola, ad impartirvi la mia pastorale benedizione, e insieme a constatare il fervido entusiasmo con il quale avete accolto i missionari e le propagandiste, ascoltando le loro esortazioni e avvicinandovi in questi giorni a Gesù Cristo. Ma non ho potuto per le mie condizioni di salute, come avete già saputo sono immobilizzato a letto. Com’è vero che non sempre il Signore, nei suoi amorosissimi disegni, permette che i nostri desideri, anche santi, siano appagati! Tuttavia non ho voluto che mancasse a voi, nel momento così bello della chiusura di questa santa iniziativa, la mia calda esortazione a continuare sulla via della fedeltà alla legge di Dio, che i Missionari e le propagandiste vi hanno additata. Vi assicuro innanzitutto che voi siete più vicini al mio cuore di Vescovo, perché siete più vicini al Cuore di Gesù, essendo voi più bisognosi materialmente e spiritualmente. Ho saputo, infatti, che voi vivete in condizioni disperate in povere casette5 lontano dal Il vescovo utilizza il termine casetta. Ma quella gente vive propriamente nei pagliai. La casetta è, invece, proprio l’obiettivo che i missionari prefigurano nei loro rapporti e che segnalano alle autorità religiose e civili. 5 288 centro impegnati a lavorare terreni ristretti e poco fertili; che i nemici di Dio, politici e religiosi, spesso profittando di queste condizioni di miseria tentano di strapparvi la vera fede in Gesù Cristo, ed insinuarvi la sfiducia e l’avversione alla Chiesa Cattolica, al Papa e ai Sacerdoti. Vi esorto, pertanto, a non lamentarvi mai della Provvidenza, per il vostro stato di disagio, ma ad aumentare la vostra fiducia in Dio, ad essere fedeli nell’osservanza dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa, per assicurarvi l’assistenza e la benedizione sulle vostre famiglie e sui vostri lavori. Ricordate le parole dello Spirito Santo: il peccato rende miseri i popoli; togliete quindi il peccato dalla vostra vita, individuale e familiare e il Signore vi farà migliorare anche nelle condizioni materiali. Desidero sapere dai dirigenti della settimana campestre le possibilità di venirvi incontro in qualunque maniera perché desidero di aiutarvi nelle vostre necessità spirituali e temporali. Vi assicuro, frattanto, che già ho dato disposizioni, perché sul posto, proprio vicino alla casetta cantoniera, venga costruita una chiesetta, intitolata a S. Michele e all’Immacolata, al grande Trionfatore e alla gloriosa Debellatrice di Satana, nemico del genere umano. Con questi sentimenti, nella speranza di vedervi presto di persona, ma già ora spiritualmente in mezzo a voi tutti, direttissimi figli e figlie in Gesù Cristo, vi benedico con tutta l’effusione del mio cuore di Vescovo, insieme ai Missionari, alle propagandiste, all’arciprete, alle Suore e alle varie organizzazioni di Azione Cattolica che tutte e tutti meravigliosamente hanno preparato e svolto la settimana campestre. Il ricordo del vescovo Palatucci è ancora vivo nelle comunità dell’Alto Sele. Il 31 Marzo 2011 è stato commemorato nel 50° anniversario della sua scomparsa nell’aula consiliare “S. Pertini” del palazzo di Città di Campagna dal sindaco Biagio Luongo, dal prof. Antonio Di Domenico e da Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. Egli è anche ricordato per la sua azione a favore degli ebrei internati a Campagna tra il 1940 ed il 1944. Per il suo Il vescovo Giuseppe Maria Palatucci 289 coraggio mons. Palatucci ha ricevuto la medaglia d’oro al merito civile, concessagli alla memoria dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con questa motivazione: Vescovo di elevate qualità umane e civili, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, si prodigava con eroico coraggio e preclara virtù civica nell’assistenza morale e materiale degli ebrei internati a Campagna, riuscendo a salvarne circa mille dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Fulgido esempio di coerenza, di solidarietà umana e di rigore morale fondato sui più alti valori cristiani e intensa condivisione delle altrui sofferenze. 7.4 Cultura e ricerca archeologica a Castelnuovo: gli anni ‘80 Negli anni immediatamente dopo il terremoto Castelnuovo vive una fase di grande fermento culturale, con iniziative e momenti di approfondimento storico ed archeologico che partono da due figure straordinarie di studiosi quali Gennaro Venutolo ed Enzo Di Ruggiero, ma che interessano e coinvolgono una nuova generazione di giovani intellettuali. Le iniziative dei due vulcanici ricercatori producono un interessante Convegno culturale che si tiene a Castelnuovo il 12 luglio 1986. E’ organizzato dalla sezione locale dell’Archeoclub, ed è accompagnato da una mostra fotografica, allestita da Gennaro Venutolo, di reperti archeologici rinvenuti nel territorio castelnuovese. Vi partecipano il Soprintendente archeologico, prof. Werner Johannowsky, i consiglieri nazionali dell’Archeoclub Reale e Speranza, il sindaco Alberto Venutolo. Il Convegno del 12 luglio 1986 290 Nella sua relazione il prof. Werner Johannowsky traccia il quadro delle ricerche archeologiche in atto: Tre sono i siti ove stiamo procedendo allo scavo: 1) S. Ilarione, 2) Cupone, 3) Aulecina, a monte del Cupone. Detti siti sono tutti di un’epoca che va dal V all’inizio del III secolo a.C. Le strutture sono precarie, solo la base risulta in pietra mentre le coperture dovevano essere in legno od argilla; strutture che per la loro fragilità sono state sconvolte da terremoti e frane. S. Ilarione = si nota uno strato riferibile, chiaramente, ad un incendio; Gennaro Venutolo 291 due corpi di fabbrica divisi da intercapedini. Si riscontra la povertà di strutture, caratteristiche del Sannio; anche a Castelvolturno i resti sono in un contesto di incendio. S. Ilarione si trova a sud di un tratturo che si svolgeva, forse, lungo la valle del Sele, sino ad Eburnum, Buccino. Si prevedono, se saranno rinvenuti, resti ceramici di uso. Al convegno intervengono, ovviamente, Venutolo e Di Ruggiero che illustrano lo stato delle loro ricerche. Di Ruggiero, che ha già pubblicato uno studio su Conza romana e il Varco del Temete, svolge una relazione su Torricella. Dopo il convegno Gennaro Venutolo intensifica le ricerche ed i suoi ritrovamenti archeologici trovano eco sulla stampa. Ecco come Onorato Volzone, su Il Mattino del 16 febbraio 1987, ne dà conto in un articolo dal titolo Le selci preistoriche scoperte a Castelnuovo da Gennaro Venutolo Scoperti nell’Alto Sele oggetti dell’età della pietra: Per adesso i manufatti venuti alla luce sono due, ma già sufficienti per immaginare la trama di presenze antichissime, addirittura dell’età della pietra. L’euforia della scoperta del piccolo centro dell’Alto Sele, incamminato sulla strada della piena ripresa dopo i colpi tremendi del terremoto, ha preso un po’ tutti. Ad innescarla è stato il dott. Gennaro Venutolo Campiglio, ispettore onorario della Soprintendenza archeologica. Ha trovato due manufatti litici di probabile era paleolitica, quando cioè veniva 292 forgiata la pietra per ricavarne gli strumenti utili alla sopravvivenza. (…) La scoperta del dott. Gennaro Venutolo Campiglio è solo un tassello di un mosaico che dovrà essere realizzato per gradi, attivando in tempi brevi le opportune ricerche e quindi le catalogazioni, gli approfondimenti. Sono passati tre anni da quando il Consiglio comunale presieduto dal dott. Alberto Venutolo, ritagliando uno spazio adeguato anche ad un capitolo diverso da quello assorbente la ricostruzione, chiese un finanziamento di circa 200 milioni per portare alla luce i tesori custoditi dal ventre della terra. Non sono mai arrivati. Un peccato. Ma adesso i due oggetti dell’età della pietra dovrebbero mettere le ali ai piedi per “darci dentro”, prima che anche le ruspe facciano la loro parte nel rendere difficilmente proponibile la ricerca nel cuore della preistoria. Campagna di scavi al Cupone Gennaro Venutolo, che è anche ispettore onorario della Soprintendenza, promuove due campagne di scavi, nel 1987 e 1988, in località Cupone di Castelnuovo, che portano al ritrovamento di una fattoria sannitica, databile al V-IV secolo a.C. insieme a diversi manufatti. Questi materiali, non essendosi concretizzato l’auspicato antiquarium a Castelnuovo, sono oggi in mostra presso il Museo archeologico di Conza, che così li presenta: La ceramica a vernice nera, usata come ceramica da mensa, è rappresentata da 293 vari tipi di piatti e scodelle, da boccali (skyphos) per bere e da una grossa brocca. Si tratta, tranne in un caso, di materiale riferibile ad una sola area produttiva. Infatti tutti i pezzi sono omogeneamente realizzati con argilla calcarea e sono ricoperti da una caratteristica vernice matta o talvolta semilucida, poco coprente. La cultura formale è vicina, da un lato, al mondo lucano, dall’altro a quello più propriamente sannitico delle aree interne. Allo stesso modo la grande olla, verosimilmente usata come contenitore da dispensa, che originariamente era provvista di una decorazione sub-geometrica, con fasce, linee concentriche e punti, ricorda sia oggetti simili rinvenuti in contesti lucani sia la cosiddetta ceramica ellenistica a bande prodotta dalle popolazioni sannitiche dell’interno. Circa la fattoria sannitica individuata da Gennaro Venutolo così è scritto nel Museo archeologico di Conza: Il centro di Castelnuovo è situato a pochi km ad occidente di Conza, dalla parte opposta del passo della Sella di Conza, sull’Alta Valle del Sele. Ci troviamo in un’area culturalmente irpina, anche se di estrema frontiera; In età antica certamente si trattava di territorio controllato da Compsani. La località Cupotii (o Cupone, in alcuni documenti) è sita a nordovest dell’abitato moderno, sulle pendici meridionali della Cresta della Cesina (…) Si tratta di una struttura rustica posta su di un breve terrazzo che incide in alto un pendio piuttosto scosceso nei pressi di una fonte che forma un breve corso d’acqua sul lato meridionale dell’insediamento. Le strutture erano in pietre di calcare giustapposte di piatto e allettate su strati di argilla. Non è possibile stabilire se queste strutture fossero parte delle mura dell’edificio, collassate, oppure rappresentassero soltanto lo zoccolo di base per un alzato ligneo o di argilla cruda. La copertura, molto probabilmente a doppio spiovente, era realizzata con tegole e coppi in terracotta. La struttura era probabilmente formata da un solo edificio, probabilmente con più fasi costruttive, gravitante attorno ad un focolare delimitato da pietre. L’edificio sembra essere stato abbandonato in modo traumatico dopo un incendio, alla fine del IV secolo avanti Cristo, o nei primi anni del secolo successivo (…) Il rinvenimento della fattoria di Cupone a Castelnuovo è molto importante perché rappresenta un raro esempio, l’unico in territorio irpino, di insediamento rurale, un tipo di insediamento che pare fosse tipico del modo di abitare di questi popoli, che erano “usi vivere nelle campagne”, come ci informano alcuni autori antichi. Questo sistema di insediamento sparso, noto nelle fonti, non ha trovato sinora molti risconti diretti dal punto di vista archeologico. Resta deluso chi si attende di leggere un elogio all’intuito ed alla capacità che Venutolo ha dimostrato nel portare al successo un progetto di ricerca intorno al quale è riuscito a coinvolgere la Soprintendenza e l’Archeoclub, insieme a decine di giovani. Invece la supponenza di un qualche burocrate, oltre a tace294 Ceramiche della fattoria sannitica scoperte da Gennaro Venutolo ed esposte nel Museo archeologico di Conza re il nome del ricercatore, ritiene di sminuirlo definendolo dilettante e poco esperto. Ecco cosa c’è scritto nella restante parte della didascalia: La prima parte dello scavo purtroppo è stata eseguita con modalità non scientifiche, alla metà degli anni 80, da un gruppo di archeologi dilettanti, volenterosi ma poco esperti, e proprio in quella occasione furono trovati i materiali qui esposti. Dopo quel primo intervento furono eseguite altre campagne di scavo, questa volta sotto il controllo del competente ufficio della Soprintendenza Archeologica, ma con scarsi risultati. L’unica pianta che abbiamo, estremamente schematica,è stata pubblicata su una rivista dattiloscritta6, ed è la pianta che qui riproponiamo elaborata. C’è di che rimanere allibiti! Peraltro non ci risulta che fosse un archeologo laureato il grande Heinrich Schliemann, colui che, basandosi unicamente sui testi omerici, nel 1872 riporta alla luce la mitica città di Troia ed il tesoro di Priamo. Vogliamo pensare che si sia trattato di un mero infortunio e che le autorità di Conza vi porranno rimedio, dando il giusto risalto al ruolo di Gennaro Venutolo. Anche perché non si comprende quale sarebbe il vulnus derivante dalle asserite modalità non scientifiche, che però produ- 6 Si tratta di Alto Sele del 1989. 295 Heinrich Schliemann teressato un insediamento sannitico, che si pone in un periodo tra il V ed il IV secolo a.C. nel territorio di Castelnuovo di Conza, nella contrada Cupone. L’intervento è consistito nella ripulitura e nel rilevamento topografico e fotografico del sito, alle quali operazioni sono stati aggiunti alcuni saggi programmati dalla Soprintendenza (…) I risultati di questo campo di ricerca si devono ritenere sicuramente molto positivi, sia per la perfetta riuscita tecnica dello stesso, dovuta peraltro ad un’ottima organizzazione locale sostenuta da tutti i soci, e sia per l’assistenza tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologica di Salerno-Avellino-Benevento. 296 cono i brillanti risultati messi in mostra. E comunque le ricerche di Venutolo avvengono in sintonia con la Soprintendenza, di cui è Ispettore onorario. Ecco la relazione all’Archeoclub nazionale sul campo di ricerca in località Cupone dal 1° al 22 agosto 1988: Hanno partecipato dieci soci per un totale di 560 ore lavorative. I campisti sono stati: Venutolo Gennaro Campiglio, Guarino Orazio, Sepe Cristina, Berardinelli Vito, Di Filippo Giuseppe, Custode Francesco, Di Ruggiero Enzo, Guarino Rosa Maria, Berardinelli Rosa Maria e Guarino Pietro. I lavori hanno in- Gioielli del Tesoro di Priamo indossati da Sophia Schliemann Un compendio dell’intensa attività culturale e di ricerca degli anni 80 a Castelnuovo si trova in un trimestrale informazione culturale dal titolo Alto Sele, diretto da Orazio Guarino e pubblicato nel 1989. In esso si trovano scritti di Orazio Guarino sulle attività dell’Archeoclub, sul campo di ricerche e sul Centro sociale, di Gennaro Venutolo sulle ricerche della statua litea della Madonna della Petrara, sul sito di Serroni e su Castelnuovo nella Cronista Conzana, di Luca Zarra sulla necessità di un catalogo dei beni culturali, di Enzo Di Ruggiero sulla chiesa della Petrara e su Torricella, di Rosamaria Guarino sui canti popolari, di Salvatore Bagarozza sulla processione del Corpus Domini, e di Nino Terralavoro sul redigendo piano di recupero. 7.5 Le due chiese di Castelnuovo: la Petrara e San Nicola Tra gli scritti di Alto Sele due sono riferiti alla chiesa della Petrara: uno di Gennaro Venutolo, l’altro di Enzo Di Ruggiero. Gennaro Venutolo fa la cronaca di due giornate di scavi, organizzate il 18 e 19 giugno 1988 dall’Archeoclub e portate avanti con la collaborazione di numerosi volontari, sul sito della chiesa alla ricerca della statua in pietra della Madonna. Gennaro dirige le operazioni con grande passione e professionalità, individuando esattamente tra le macerie il punto corrispondente alla collocazione della Madonna. Si trova un po’ di tutto (pezzi del confessionile, una parte della testa di San Rocco, una catenina d’oro con crocifisso, alcuni candelabri, pezzi in calcare rossastro della balaustra che divideva il transetto dall’altare maggiore, il cancelletto in ferro battuto ed i pezzi del gradino e della base dell’altare, tutti in calcare grigio). Sotto il muro della sacrestia Gennaro Venutolo rinviene una vasca di calcare con un 297 Vasca con bassorilievo di sileno recuperata da Gennaro Venutolo tra le macerie della Petrara bassorilievo di sileno sulla faccia anteriore con un tubo in bocca per la fuoriuscita dell’acqua7. Ma della Madonna tanto cara ai castelnuovesi, nessuna traccia. Venutolo non manca di criticare in modo netto l’azione sconsiderata delle ruspe che hanno distrutto e cancellato quello che il terremoto aveva risparmiato: Sono necessarie delle riflessioni alla luce dei ritrovamenti fatti e delle strutture della chiesa messe in evidenza al fine di indirizzare le future ricerche. Abbiamo constatato che le strutture della chiesa sono state completamente distrutte, e così anche gli altari e che tutto quello che era all’interno dell’edificio è stato completamente polverizzato. La distruzione di tutto o quasi tutto è stata opera non tanto del terremoto quanto delle mani dei castelnovesi vuoi per le necessità dell’immediato post calamità vuoi, in massima parte, per la loro negligenza. Di quello che era rimasto molto fu distrutto dalle ruspe e le macerie trasportate altrove per altre necessità. Così la maggior parte dei marmi e gli altri materiali, e forse tra quelli anche la statua della Madonna della Petrara, ora si trovano a bonificare la palude di Piano Voglino8. 7 8 Essa è ora conservata presso il Comune di Castelnuovo. Se non sono finiti proprio sotto l’impianto di compostaggio! 298 Non si può che condividere l’appassionato richiamo del medico castelnuovese, aggiungendo che non vi erano stati morti nel crollo della chiesa e che, di conseguenza, non c’era alcuna necessità di azionare le ruspe in modo dissennato come purtroppo avvenne. Venutolo redige anche una pianta della chiesa che qui riportiamo. 299 Anche Enzo Di Ruggiero si occupa della chiesa della Petrara sotto il profilo storico, a lui congeniale. Di Ruggiero avanza l’ipotesi che la configurazione recente della chiesa risultasse dall’ampliamento di una più antica struttura con la statua litea murata nella parete sud; ed elabora una piantina che illustra l’unione delle due strutture. Va detto che le relazioni delle visite 300 pastorali degli anni 1576, 1580 e 1658, trattate nel capitolo II, danno sostanza documentale all’ipotesi di Di Ruggiero. Più antica della Petrara è la chiesa di San Nicola. Essa è collocata sulla dorsale dello sperone, in asse con la rocca e immediatamente di fronte ad essa, al servizio del castello e delle prime abitazioni che si formarono intorno al presidio militare. L’orientamento è nella direzione sud-nord, con l’ingresso 301 proprio di fronte al castello, a meno di cento metri. L’edificio sacro ha contribuito all’unità formale ed alla caratterizzazione del paese, nettamente 302 emergente nel paesaggio circostante, ben leggibile in tutta l’ampia vallata dominata. La Cronista Conzana del 1691 attesta come quella di San Nicola anticamente fusse stata la chiesa maggiore. E questa chiesa ha costituito anche il limite del piccolo borgo. Nel 1576 il vescovo di Conza Marco Antonio Pescara effettua la visita pastorale a Castelnuovo e registra che la chiesa di San Nicola è posta all’ingresso del paese (Visitavit deinde Ecclesiam Sancti Nicolai qua est in ingressu predictae terrae…). Documenti notarili del settecento attestano un luogo ubi vulgariter dicitur la torricella della porta di capo (…) sotto S. Nicola. La porta di capo (con la torricella), cui si affiancava l’altra porta detta di piedi, immetteva all’interno della mura che circoscrivevano l’abitato. Così come è attestato, in un atto notarile del 1718 di richiesta al barone del permesso di costruire, che Lu Chianieddh’ fosse ubicato fuori le mura (come desiderando essi segnati cittadini di detta Terra fabbricare alcune case ogn’uno per loro habitatione fuori il recinto di detta Terra nello luogo chiamato lo Pianello…). Anche la pianta del Pianello (che abbiamo visto nel capitolo IV) fatta disegnare nel 1828 dal giudice di Laviano, che lo colloca verso il fine dell’a- La prima immagine di Castelnuovo in una stampa del ‘600 303 bitato di questa Comune di Castelnuovo di Conza, si incastra al limite della chiesa di San Nicola al posto dell’arco9 che collegava il successivo Pianello con la vecchia Via Roma. L’attuale Chianieddh’ è successivo e contiguo al precedente, realizzato, in parte con il riempimento di un avvallamento, nella seconda metà dell’ottocento. Quella che forse è l’immagine più antica di Castelnuovo è una stampa; essa si trova nel libro di Giovan Battista Pacichelli Il Regno di Napoli in prospettiva pubblicato postumo a Napoli nel 1703. Nonostante alcune imprecisioni nel testo scritto, in particolare nell’attribuzione di Castelnuovo al barone Fulvio Atenolfo di Cava10, la stampa, databile alla seconda metà del seicento, mostra molto verosimilmente come si è configurato il borgo nello spazio di molti secoli. Tutto ruota intorno ai tre cardini collocati in asse sulla dorsale dello sperone: il castello, la torre e la chiesa di San Nicola. La stampa corrisponde alla descrizione che di Castelnuovo fa Donatantonio Castellano (in detta Terra di Castelnuovo vi è un comodo e forte Castello posto in luogo ameno per uso del Barone di detta Terra ed è munito di forte Torre)11. La torre, della cui esistenza si è persa memoria, compare tra il castello e la chiesa, ed è richiamata nello stemma collocato nella parte alta a destra della stampa; lo stemma seicentesco, con l’aggiunta del doppio leone della famiglia Gesualdo, è quello che ancor oggi caratLo stemma di Castelnuovo di Conza oggi Segno che il fabbricato soprastante fu costruito in uno spazio comune e che l’arco servì a collegare i due versanti dello sperone. 10 L’equivoco si può spiegare per il titolo di marchesi di Castelnuovo (che non è Castelnuovo di Conza) posseduto dalla famiglia Atenolfi di Cava. 11 Donatantonio Castellano, Cronista Conzana, 1691. 9 304 terizza il Comune di Castelnuovo di Conza. La stampa riporta le mura che circondavano il piccolo abitato, la “costa”, la strada per Santomenna che scendeva a guadare il torrente Pisciolo, e lo stesso torrente definito con il nome del fiume a cui alla fine affluisce: Silento (cioè Sele). A seguito del terremoto del 23 novembre 1980 la piccola chiesa di San Nicola, che comunque era rimasta in piedi, fu abbattuta e di essa restano le mura perimetrali ed il pavimento. Si vedono i gradini d’ingresso, insieme al sedile in pietra prima dell’entrata, lo scalino dell’altare, la base della campanella e quella dell’orologio. Il pavimento, di mattonelle esagonali bicolori, è della prima metà del novecento; alcuni saggi recentemente praticati hanno evidenziato una preesistente pavimentazione in opus caementicium, materiale costituito da una mescolanza di malta e pietre grezze, o frammenti di pietra spezzati o ghiaia, utilizzato dai Romani per le costruzioni a partire dal II secolo a.C. L’assenza di cementizio sotto le mattonelle nella parte iniziale della chiesetta, nei pressi dell’ingresso, depone per un possibile ampliamento (un allungamento della consistenza di qualche metro) dell’edificio primitivo. Tale ampliamento potrebbe risalire all’anno 1725; data che appare nella iscrizione sulla pietra del sedile, murata a lato dell’ingresso della chiesa. La pietra murata nel sedile al lato dell’ingresso Vi è inciso: DFA. 1725 9 OP(us) f(ecit). D. M. S.D. P.P. 305 Il terremoto del 1980 ha cancellato pressoché tutto delle strutture materiali. Restano però il ricordo e la consapevolezza del passato, e restano le basi della chiesa e della torre, auspicabili punti di avvio di una non impossibile ricostruzione. Il Piano di Recupero adottato dal Comune consente la ricostruzione in sito della chiesa. E sarebbe bello che si riuscisse a farla tornare come prima del sisma. Esistono, infatti, le tecniche per ricostruire in sicurezza la chiesa e la torre dell’orologio, lì dov’erano e com’erano. A dicembre del 2012 l’idea è stata sottoposta al Soprintendente per i beni architettonici di Salerno e Avellino, Gennaro Miccio che è venuto a Castelnuovo insieme al docente di Costruzioni in zona sismica dell’Università di Salerno, prof. Luigi Petti. I due si sono intrattenuti prima al municipio e poi hanno effettuato un sopralluogo sui resti del castello e della chiesa. Il sindaco Francesco Custode è convinto che si possa realizzare un sogno. Ecco il suo pensiero: Affacciato al mio balcone, guardando i ruderi della Chiesa di San Nicola e della Torre dell’Orologio, mi sono spesso chiesto perché non fu mai recuperata. Eppure ricordo che era ancora lì in piedi dopo il terremoto del 1980, il crollo del campanile aveva sfondato solo la porzione di tetto sull’altare, il resto era tutto in piedi, come documentano le foto scattate subito dopo l’evento sismico. Eppure la Chiesa di San Nicola non fu mai recuperata o ricostruita. Sono trascorsi trentadue anni, i sogni si assopiscono ma difficilmente ti abbandonano. Oggi, questa idea di ricostruirla, insieme alla torre dell’orologio, dov’era e com’era e riportarla alle sua antica funzione nasce dall’esigenza di riconsegnare un luogo significativo ad un centro storico già oggetto di lavori di riqualificazione e riportare la gente di Castelnuovo nella sua antica Chiesa Patronale. Quando ho verificato la fattibilità della ricostruzione, mi è bastato parlarne con Onidia Ciriello e con un gruppo di amici (Francesco Di Geronimo, Filodemo Iannuzzelli, Ruggero Iannuzzelli, Pietro Lista, Michele Iannuzzelli, Dino D’Elia) per alimentare un grande entusiasmo; con grande spirito di volontariato tutti si sono resi disponibili a dare un contributo tecnico e condividere il sogno. Ho poi sottoposto l’idea alla sensibilità del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, Gennaro Miccio, che mi ha onorato subito di una sua visita a Castelnuovo, coinvolgendo l’Università di Salerno e il prof. Luigi Petti della Facoltà d’Ingegneria, Docente di Costruzioni in zona sismica: il sogno mi sembra già realizzato. Nonostante il particolare momento storico di crisi nazionale, quando dietro un’idea c’è la condivisione, la fede negli stessi valori, anche i sogni diventano realtà, e si può 306 La chiesa di San Nicola dopo il 23 novembre 1980: risparmiata dal sisma, abbattuta dalle ruspe restituire al paesaggio dell’Alta Valle del Sele un’icona mancante e al popolo un elemento di identificazione. Voglio pensare che se l’Italia si identifica con i campanili forse è proprio da li che si parte per risorgere più forti di prima. E’ veramente singolare che, con tutti i miliardi spesi nel dopo sisma, nessuno abbia pensato di ricostruire la chiesa di San Nicola. Non vi sono, infatti, 307 ostacoli di natura formale: il Piano di Recupero ha previsto la ricostruzione della chiesa; e poi, al di là di qualunque cavillo, non c’è chi non veda come a pochi metri dall’antichissimo tempio è stato fabbricato un orribile casermone, che non c’entra niente con le tipologie tradizionali del paese, e che cade in rovina non essendo mai stato abitato, tranne che per un solo caso. Il casermone evidenzia, però, che non ci sono ostacoli di natura sismica per l’edificazione in quel sito. E se il sindaco sogna di rivedere in piedi la chiesa di San Nicola, l’autore di queste note ha un sogno più radicale: ricostruire san Nicola, assegnare un nuovo alloggio all’unico coraggioso abitante di quel mostro, ed abbatterlo senza pietà. Per far risaltare, in una rinnovata sky-line, la sagoma del tempio del santo protettore di Castelnuovo. 308 Dicembre 2012. Il soprintendente Miccio ed il prof. Petti sulla chiesa di San Nicola 309 Luglio 2013. San Nicola ed il popolo di Castelnuovo ritornano nella chiesa millenaria 310 Luglio 2013. Si celebra nell’antico tempio Luglio 2013. Fedeli nella chiesa di San Nicola. In fondo la sagoma dei resti del castello 311 7.6 A trent’anni dal sisma Scrivere compiutamente del terremoto del 1980 e dei suoi effetti, non solo materiali, su Castelnuovo richiederebbe un libro a parte. Da quel drammatico 23 novembre quasi tutto è cambiato, e gli effetti del sisma continuano a farsi sentire. Tutto il paese antico, quello originario, arroccato sullo sperone intorno al castello ed alla chiesa di San Nicola, spazzato via in un attimo. Ma insieme alle persone, insieme alle abitazioni, si è perduto un intero mondo fatto di luci, di suoni, di odori. Si è perso il sapore del paese, della comunità. Pierdonato Iannuzzelli esprime la deprivazione in termini poetici. Lasciamogli la parola. Via Risorgimento, a sinistra è la lunga scalinata che porta alla Torricella e più avanti la parete nord della chiesa di San Nicola che poggia su una vistosa roccia muscosa; a destra qualche negozio e qualche altra casa. Poi, dopo un breve tratto in salita, i pochi scalini verso il forno. Un forno di pietre mal messe ed annerite dal tempo e dal fumo, ma tanto profumo di pane fresco che da lontano mi sembra di sentire ancora. …Ora non c’è più. Sopra il forno, delle case, e fra queste quella di Rosina; una donna instancabile. Chissà quanti barili di acqua ha portato nelle case! E quante ore di attesa per riempirli sotto il misero getto, quasi gocciolante dell’unico rubinetto alla “Fontana”! La rividi un anno fa; il suo viso rugoso e lo sguardo serio erano rimasti uguali; solo dalla lenta camminatura capii che i suoi anni non erano più gli stessi. …Ora non c’è più. Dalla piazza, dopo pochi scalini in giù, a due passi uno dall’altro, ed il passaggio sotto l’arco, è già via Roma. Da un lato una strettoia verso la Torricella e case alte, dall’altro, un po’ più avanti, l’inizio di via Pennino e la casa di zia Rosa. Il portone, due battenti blu, non ne ricordo altri di quel colore, sempre aperti e sostituiti, nei periodi freddi, da due porticelle vetrate. Rosinella, come tutti la chiamano, è viva per miracolo; lei stessa mi dice: “Ho cercato di mettere in salvo solo la mia anima affidandola al Signore, quando mi è sembrato che era la fine”. Continuando si arriva alla farmacia, dove era una volta, poi si passa davanti ad altre case e portoni vari ed a l’arco di Tavarone, attraverso il quale si scorge, verso valle, il ponte del Pennino. Più avanti la casa di Ruccia. Ruccia una donna inconfondibile, dalla riccia capigliatura, dallo sguardo sereno e dal viso sorridente. ...Ora non c’è più. 312 Subito dopo è la nostra casa; qui, mi dicono, sono nato. Tre camere e tre finestre che si aprono sugli orti con i mandorli, i primi a fiorire con il ritorno della primavera. Più in giù, il vallone con i resti di un vecchio mulino, la strada per Santomenna che scompare dopo un’ampia curva e più lontano, di fronte, la montagna di Laviano, la prima ad imbiancarsi con l’avvicinarsi dell’inverno. Ai suoi piedi, verso ponente, la vetta della torre con l’orologio ed i pochi tetti delle case più alte che affiorano dalle cime degli alberi e più in là un’ampia gola con il monte Cervialto. E’ l’alta valle del Sele. Che spettacolo da quelle finestre! Quanti canti melodiosi di uccelli! Quanto sole! Quanta aria buona! Quante corse per quelle campagne! E quanti ricordi di quella nostra casa! Un’ampia cucina con il camino di pietre scolpite, dove i ceppi, accostati uno a l’altro, ardevano, con noi intorno, fino a notte nelle giornate rigide. La sala, con il tavolo nel mezzo e la libreria stile “800”. E poi, tante, tante indimenticabili altre cose di quella casa ! ...Ora non c’è più. Quasi attaccata alla nostra, la casa dello zio “Cavaliere”. Pavimenti piastrellati, scale di marmo, pareti decorate a bassorilievo ed una grande veranda, sono le cose che spesso ricordo. ...Ora non c’è più. Poi, via Roma , la strada principale che dalla piazza va fino alla chiesa Madre passando in mezzo al paese, continua e comincia a scendere. Le due lunghe file di case, da un lato e dall’altro, sono interrotte ogni tanto da gradinate che salgono o che scendono. E’ la strada più lunga, è la più percorsa, è la strada degli incontri e dei giuochi dei ragazzi, è la strada dove gli anziani, seduti sull’uscio, prendono i caldi raggi del sole nelle giornate fredde. ...Ora non c’è più. Dalla via Roma, verso il castello, ancora strade e tante case, tutte unite tra esse; chi basse e chi alte, chi con balcone e chi senza; sono le case che in cartolina emergono e formano il profilo del paese. Le ricordo quasi tutte e la gente in esse, come pure quella nelle case di via Roma. Tanta gente semplice! Tanta gente buona! E tanta, tanta. ...Ora non c’è più. I castelnuovesi hanno saputo rialzarsi dalla tremenda botta e riprendere il cammino che da secoli le diverse generazioni hanno portato avanti. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 21 novembre 2005, ha conferito a Castelnuovo di Conza la medaglia d’oro al merito civile con questa motivazione: In occasione di un disastroso terremoto, con grande digni313 tà, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del proprio tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore civico ed altissimo senso di abnegazione. Sisma Il presidente Carlo Azeglio Ciampi consegna la medaglia d’oro al sindaco Terralavoro 23 novembre 1980. La medaglia è stata ritirata dal sindaco Carmine Terralavoro, dall’assessore Rosamaria Guarino e dal vigile urbano Emidio Liloia. Emio Liloia, Nino Terralavoro e Rosamaria Guarino davanti al Quirinale con il diploma e la medaglia d’oro 314 Castelnuovo ha voluto ricordare degnamente i suoi figli strappati via dalla furia della natura nei pochi, interminabili, secondi delle scosse. Ed ha voluto farlo collocando nel luogo simbolo del paese, Lu Chianieddh’, una scultura di Pietro Lista con i nomi di tutte le vittime. Ecco come il sindaco Francesco Custode ha presentato l’opera il 23 novembre del 2010: Sono trascorsi 10957 giorni, trent’anni dal terremoto, eppure sembra ieri per tutti quelli che hanno vissuto questo tragico evento. Molti di noi eravamo solo dei bambini, tanti altri avevano un’età matura, ma certamente quella sera di domenica 23 novembre 1980 è un momento indimenticabile, tragico che ci ha segnato e cambiato la vita. A noi l’ha cambiata, ma siamo qui per fortuna o per una semplice casualità per testimoniare quel momento. Questa sera siamo qui per commemorare le nostre 85 persone care che non sono state fortunate, perché quella maledetta sera è stata l’ultima della loro vita. Il terremoto ci ha colto di sorpresa in quelle case che erano il luogo del calore familiare, della Pietro Lista, studio per la scultura a Castelnuovo 315 sicurezza, sono crollate determinando vittime e devastazione. Le case a trent’anni hanno ripreso forma anche più comode e confortevoli, ma di tutti i bambini e le bambine, le donne e uomini che hanno perso la vita sotto le macerie non ci resta che un ricordo. Il loro ricordo trascritto nei nostri cuori, il maestro Pietro Lista lo ha inciso su una “porta” di acciaio corten, un materiale forte, resistente, arrugginito a significare la forza della loro vita. Il maestro Pietro Lista dice “Era giusto, quindi esprimere il ricordo delle vittime nella figura della “porta”, dove si compie il “passaggio” dalla condizione terrena a quella celeste; era giusto, inoltre, che la porta fosse semiaperta, indicandosi in ciò lo spiraglio della fede quale luce di un orizzonte eterno. A quella stessa luce la “porta” espone il racconto delle virtù e dei vizi degli uomini, ed è un racconto nascosto nei nomi delle vittime: nomi che incidono l’immobile sostanza simbolica, che ritagliano la consistenza metallica e rugginosa”. Si è pensato di collocare l’opera in questa Piazza che è parte stessa del monumento, è il luogo dove quasi tutti i corpi furono portati per essere riconosciuti e pianti. Il monumento voluto dalla nostra giovane amministrazione e da tutti i cittadini di Castelnuovo è il segno di una volontà forte per NON DIMENTICARE. Le attuali e future generazioni dovranno guardare a quest’opera pensando che le terre che tremano creano ferite indelebili e che solo con la memoria storica sempre vigile quelle vittime forse non sono state vane. La posa dell’opera di Lista 316 7.7 La celebrazione dei 150 anni dell’Italia unita Castelnuovo ha celebrato i centocinquanta anni dello Stato nazionale con un incontro presso l’aula consiliare. L’occasione è stata utile per ricordare i due corallieri castelnuovesi, Francesco Turi e Vito Pezzuto, morti insieme ad Ippolito Nievo il 4 marzo 1861 nell’affondamento del piroscafo Ercole. Il Comune di Castelnuovo ha pubblicato un opuscolo sulla celebrazione dell’Unità d’Italia, che è stato inviato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 317 Momenti della celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia 318 Guido Di Geronimo ed Emilio Gallo recitano il Contrasto sull’orgoglio di essere italiani 319 La pubblicazione inviata al presidente della Repubblica 320 La risposta del presidente Napolitano con i saluti a tutta la cittadinanza 321 Capitolo VIII Frammenti di storia di Castelnuovo che passano per la sua piazza, Lu Chianieddh’ La traccia più antica della piazza di Castelnuovo (Lu Chianieddh’, ovvero il Pianello) è la pianta, che abbiamo visto nel capitolo quarto, e che fu fatta redigere nel 1828 dal giudice borbonico Passarelli per dimostrare che era sufficientemente spaziosa da permettere ai carbonari castelnuovesi di parlare in segreto tra di loro. 323 La fotografia più antica della piazza è dei primi del novecento. Vi compaiono, oltre il lume a gas, quattro persone che in qualche modo rappresentano lo spaccato sociale del tempo. Quello all’estrema sinistra è sicuramente un “galantuomo”: spiccano le scarpe nere lucidate, il colletto bianco, l’elegante cappotto indossato, il copricapo nuovo. La persona a lui vicina sembra essere un suo subalterno, forse un massaro: le scarpe non brillano, il cappotto è poggiato sulle spalle, indossa un panciotto trasandato, il collo cinto da un ampio fazzoletto colorato. Dalla parte di destra, seduti, uno che potrebbe essere un impiegato; ed un vecchio barbone con una mazza per bastone, entrambi con le scarpe infangate. Ai balconi panni stesi ad asciugare, e a quelli di destra vasi di fiori e di basilico. Lu Chianieddh’ è da poco stato ampliato, con i due muri di contenimento. Gli scoli per l’acqua piovana sono bianchissimi perché recenti. Gli alberi ancora non sono stati piantati. 324 La funzione commerciale de Lu Chianieddh’. Un gruppo di persone (tutti maschi) in posa accanto ad un venditore di stoffe (pezzaro). Tutta la merce è contenuta in una cassa di legno che funge anche da espositore. Molta biancheria è poggiata sulla ringhiera e sui pezzi di pietra della piazza. Ancora non vi sono gli alberi. 325 326 Una processione con San Nicola e la Madonna delle Grazie, la grande bandiera ed il gonfalone delle gerardine. La piazza è ancora senza alberi, ma con il lume a gas. La banda musicale è quella dei carabinieri. Nella piazza il palco per il concerto, le bancarelle con nocelle e torrone, un traìno, festoni colorati, una donna con bambina affacciata al balcone, piante fiorite ai davanzali. 327 Anni venti del novecento. Gruppo con alcune fanciulle, eleganti e sorridenti, ognuna un fiore in petto. L’unico militare è un carabiniere, ma due persone, anche se in abiti borghesi, indossano la camicia nera. 328 Anni venti del novecento. Della piazza si riconosce il lume a gas. Una giovanissima fervente fascista, guanti bianchi e coccarda tricolore in petto, arringa il popolo. Bene in mostra la bandiera italiana con il fascio littorio. 329 Il fascismo trionfante. Al centro del gruppo Raffaele Ricciulli con i baffi neri. Due le bandiere tricolori, una con lo stemma sabaudo al centro, l’altra con il fascio littorio. Nelle prime file bambini elegantemente vestiti. Molte camicie nere, medaglie sui petti. Un solo anziano reduce con la divisa dell’esercito regio, in ultima fila. 330 Sono gli anni della pienezza del regime. Davanti a San Nicola è schierato lo stato maggiore del potere fascista. Raffaele Ricciulli incanutito, altri gerarchi in camicia nera, compare il fez. In secondo piano, davanti ai musicanti, un giovane Ciccantonio, e dall’altra parte donne con scialli e bambini in braccio. Sul balcone della casa d’angolo, le insegne della sezione del Partito Nazionale Fascista e del Dopolavoro “Armando Casalini”. Sugli altri balconi numerose donne a capo scoperto. 331 Sono sempre i fascisti a dominare la scena. Immancabile Raffaele Ricciulli. Al centro della foto, con la fascia tricolore in vita, il podestà. Gli alberi sono stati piantati e sono anche abbastanza cresciuti. 332 E’ febbraio del 1941. Funerali della guardia campestre di Castelnuovo, Michele Jannuzzelli e del falegname di Santomenna Rocco Somma. I due si sono aggregati come volontari ai carabinieri di Laviano nella caccia ai commandos inglesi paracadutati per minare un ponte sul torrente Tragino, nel comune di Calitri. L’obiettivo degli inglesi, con l’operazione Colossus, è di sabotare l’acquedotto pugliese, lasciare quella regione senz’acqua e dimostrare di poter colpire nel modo più inatteso, a migliaia di kilometri dai loro confini. Jannuzzelli e Somma restano uccisi in uno scontro a fuoco con un i paracadutisti, che a loro volta sono fatti prigionieri. Sul retro della foto-cartolina si legge: Funerali dei Fascisti M. Jannuzzelli e R. Somma eroicamente caduti il 12 febbraio 1941 XIX durante il rastrellamento dei paracadutisti inglesi in Castelnuovo di Conza (Salerno). 333 Un particolare della giornata. Si commentano gli eventi. Un gruppo di gerarchi fascisti. Il podestà in primo piano. Sempre presente Raffaele Ricciulli. Alcuni giovani ed un ragazzo assistono, inorgogliti di sfiorare i potenti. 334 La guerra è finita, l’Italia è Repubblica. Sono le feste di settembre con la Madonna, San Rocco e San Vito. Dove c’era la sezione fascista adesso c’è la DC. Il sindaco è eletto dal popolo. Qualcuno, che stava in prima fila con la camicia nera, continua a stare in prima fila con la camicia bianca. Ricompaiono i carabinieri. 335 E’ il 1949, il funerale di una persona illustre. Don Nicola rende omaggio alla salma. Più corone di fiori. Un gruppo di bambini sul muretto si girano verso il fotografo. 336 E’ il Corpus Domini. In piazza è stato preparato un classico altarino. I bambini hanno raccolto petali di fiori per comporre la scritta W Gesù. Il profumo è intenso ed inebriante. 337 Un matrimonio nei primi anni cinquanta. La sposa è accompagnata dal compare d’anello. Lo sposo è in seconda fila. Un cane segue il piccolo corteo. Il traìno di Pepp’ d’ Pappanes’ è parcheggiato in fondo. La casa d’angolo è sempre sezione della DC. Gli alberi sono un poco più ombrosi. 338 Un altro matrimonio. Lo sposo è venuto dall’America, dove farà ritorno con la moglie italiana. Parenti ed amici schierati. Raffaele Ricciulli a destra nella foto. In fondo, donne che osservano l’evento. 339 Ancora gli anni cinquanta. Con Don Nicola D’Acunto, Gesù Bambino portato dai bambini. Altri bambini accuditi da Maria Di Filippo. 340 Inverno anni cinquanta. Sotto il manto di neve risalta il fascino misterioso de Lu Chianieddh’. 341 1955. Si è conclusa la settimana campestre e con essa la missione presso gli abitanti dei pagliari di Sant’Ilarione e Buoninventre. Si celebra messa a Lu Chianieddh’. Balconi affollati. Gli uomini in piazza, le donne in fondo alla sinistra del celebrante. Graziose bambinette con eleganti cappellini bianchi dall’altra parte. 342 L’ordito a quadrati in pietra della piazza viene ricoperto con l’asfalto. Una malintesa idea di modernità seppellisce un’opera ammirevole di architettura urbana. Donna con il barile sperimenta il nuovo fondo stradale. 343 Vicienz’ lu musc’, padrone incontrastato della piazza in un assolato pomeriggio estivo. In fondo una donna ed alcuni bambini. Pubblicità del Campari. 344 Anni sessanta. La fotografia è a colori. La piazza è piena di gente e di auto parcheggiate. Due ragazzi in motorino. Una mamma con bambino. Il macellaio al centro domina scena. 345 1969. Lu Chianieddh’ centro di gravità e di socialità. Anziani chiacchierano al tiepido sole. Ciccantonio in primo piano. Qualcuno ha una pratica da sbrigare al Municipio. E’ aperta la bottega di Matteo e Francesca (e dei loro gatti giganteschi). Col barile in equilibrio sulla testa si va ad attingere l’acqua alla fontana. Due donne in nero scrutano. 346 1977. Continua la tradizione del corteo nuziale. E’ la forza della vita che attraversa Lu Chianieddh. 347 1978. Due anziani discutono, a segni e a parole. In secondo piano la scritta VINO della cantina. 348 1978. La torre dell’orologio in piedi ancora per poco. 349 1980. Qui si raccolgono i morti del terremoto. Tre bare aspettano di essere riempite. 350 1980. Le pietre buttate giù dal sisma ingombrano le strade. Si sfida il pericolo per recuperare il possibile nelle case crollate. 351 1981. La piazza è deserta. Il terremoto ha fatto cadere anche un tratto dei pezzi in pietra. Ma l’ombra degli alberi ed un richiamo forte invitano a sedersi lì. Significa che quel luogo non deve morire. 352 2005. Sulla piazza si affacciano gli antichi palazzi rimessi a nuovo. Splendono i colori, ma non c’è vita. I castelnuovesi stanno da un’altra parte. 353 2008. La piazza torna a vivere. Francesco Di Geronimo e Francesco Custode presentano la prima Mostra fotografica. 354 “Le parole sono pietre, diceva Carlo Levi, intellettuale piemontese innamoratosi delle nostre terre oltre Eboli. Ma anche le pietre sono parole, esse parlano la storia (grande o piccola che sia). Quando però le pietre non ci sono più perché la forza della natura le ha divelte e fatte saltare, in un impeto di distruzione e morte (come è accaduto il 23 novembre del 1980 per Castelnuovo di Conza), che cosa se non qualche immagine sbiadita dal tempo e sepolta per decenni in un vecchio album può ancora sostenere il ricordo di case, strade, vicoli, delle due chiese (di San Nicola e della Madonna della Petrara), della torre dell’orologio?” “Siamo andati alla ricerca di queste foto attraverso un passaparola, diversi hanno contribuito a questa raccolta anche dall’estero, ma il nostro progetto è ancora più grande: costituire un archivio storico di immagini della Castelnuovo di prima del terremoto, così da permettere anche alle future generazioni di scoprire, anche se solo attraverso la stampa, com’è stato Castelnuovo. Forse riusciremo nell’intento di comunicare il senso di protezione di quelle vecchie case, i percorsi in quei vicoli pavimentati con pietre sconnesse, insomma il nostro passato che è un patrimonio da tutelare, anche se oggi è solo un ricordo.” 355 2008. Onidia Ciriello presenta il libro di Franco Arminio Vento forte tra Lacedonia e Candela. E’ notte, ed i colori pastello della piazza aggiungono poesia a poesia. 356 2010, 23 novembre. Si inaugura il monumento alle vittime del terremoto. Mario Porreca, moglie e tre figli morti sotto le macerie, scopre la scultura. Di spalle il sindaco Francesco Custode ed il maestro Pietro Lista, autore dell’opera. 357 2010. La processione delle feste di settembre torna a Lu Chianieddh’. Si pesano i bambini secondo l’antica consuetudine. 358 Agosto 2011. A Lu Chianieddh’ per la festa dell’emigrante. Si balla, si mangia, si prende il fresco. Elio Venutolo con i libri di Castelnuovo. 359 360 2013. Nelle fotografie di Francesco Del Vecchio la piazza rinnovata con la scultura di Lista risplende di luci e colori. 361 Indice Capitolo I Antichità di Castelnuovo di Conza 1.1 L’antichità di Castelnuovo............................................................pag.13. 13 1.2 Il 554 dopo Cristo e la guerra greco-gotica..................................... »14 1.3 La guerra greco-gotica (535-555). Giustiniano si riprende l’Italia...... »18 1.4 L’ultimo episodio della guerra greco-gotica. L’assedio di Conza...... »22 1.5 I bizantini a Santomenna. I Goti a Castenuovo e Torricella............ »26 1.6 Narsete e la chiesa di San Menna a Venezia.................................... »32 1.7 Narsete e la chiesa di San Menna a Santomenna............................. »35 1.8 Castelnuovo di Conza esiste nel 554.............................................. »42 1.9 Il culto greco nella diocesi di Conza. La seconda lettera di Innocenzo III a Pantaleone.................................. »45 1.10 Considerazioni conclusive sulle origini di Castelnuovo e Santomenna.............................................................. »52 1.11 Il settimo secolo e le incursioni slave; il nono secolo e i saraceni...... »54 Capitolo II Castelnuovo e Buoninventre in epoca feudale 2.1 Il Catalogo dei Baroni Normanni................................................... »57 2.2 I primi castelnuovesi...................................................................... »60 2.3 I signori di Castelnuovo e Buoninventre......................................... »76 2.4 Personaggi di rilievo. Raimondo Orsini.......................................... »78 2.5 Personaggi di rilevo. Giulio Orsini................................................. »79 363 2.6 Personaggi di rilevo. Carlo Gesualdo principe di Venosa................. »82 2.7 Il “ritorno” di Buoninventre con Castelnuovo ............................... »93 2.8 Castelnuovo nelle visite pastorali del vescovo Pescara del 1576 e 1580.....»98 2.9 Castelnuovo (e la peste)nella visita pastorale del vescovo Campana del 1658 ............................................................ »119 2.10 Castelnuovo e i conflitti con i signori feudali................................ »127 2.11 Un conflitto che si trascina nei secoli............................................ »133 2.12 Le rendite feudali e comunali....................................................... »134 2.13 Fine del feudalesimo..................................................................... »137 Capitolo III La guerra del fuoco Parte prima (il diritto di legnare nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione) 3.1 Il fuoco e la vita.............................................................................. »141 3.2 Buoninventre e Sant’Ilarione negli atti notarili dal 1636 al 1807....... »142 3.3 L’uso civico di legnare nei boschi di Buoninventre e Sant’Ilarione..... »148 3.4 L’azione legale per ottenere la restituzione dei fondi usurpati.......... »151 3.5 La prima sentenza del Tribunale..................................................... »154 Capitolo IV La guerra del fuoco Parte seconda (guardaboschi, carbonari, e castelnuovesi carcerati nel 1828) 4.1 I moti del 1820 nel regno delle due Sicilie e la Costituzione........... »159 4.2 Il tentativo di rivincita del 1828. I moti del Cilento e la repressione militare........................................................................ »163 4.3 I settari di Castelnuovo e Laviano e l’intreccio con la guerra del fuoco. Gli arresti e la caccia a Ruggiero Gibboni............................................. »169 4.4 La trappola e i traditori.................................................................. »180 4.5 L’indagine di Passarelli sulle opinioni e la religiosità dei settari........ »186 364 4.6 L’ergastolo a Ruggiero Gibboni. La conclusione del processo. Il buco nell’acqua di Passarelli.............................................................. »187 Capitolo V La guerra del fuoco Parte terza (fucilate ed occupazione dei boschi nel 1848, altri carcerati, ma poi Castelnuovo vince) 5.1 Riprende il confronto duro con Cassitti......................................... »193 5.2 La guerra del fuoco (e il comunismo a Castelnuovo e Auletta) nel 1848.......................................................................................»195 5.3 La pace dopo la guerra?.................................................................. »211 5.4 Altri due fronti di guerra................................................................ »213 5.5 La fine della guerra del fuoco. Castelnuovo vince anche sul fronte principale............................................................................. »214 5.6 Il distacco in compensazione degli usi civici. Un ulteriore fondo passa al Comune.................................................... »219 5.7 Partiti e schieramenti a Castelnuovo di fine Ottocento................... »222 Capitolo VI Castelnuovo, l’Africa e l’epopea del corallo..................................... »233 Capitolo VII Castelnuovo nei secoli XX e XXI 7.1 Il nuovo secolo e l’espansione urbanistica di Castelnuovo............... »261 7.2 Istruzione e cultura a Castelnuovo nel XX secolo............................ »265 7.3 La “missione” del 1955 nella campagne di Castelnuovo, a Buoninventre e Sant’Ilarione............................................................. »280 7.4 Cultura e ricerca archeologica a Castelnuovo: gli anni ‘80.............. »290 365 7.5 Le due chiese di Castelnuovo: la Petrara e San Nicola..................... »297 7.6 A trent’anni dal sisma..................................................................... »312 7.7 La celebrazione dei 150 anni dell’Italia unita.................................. »317 Capitolo VIII Frammenti di storia di Castelnuovo che passano per la sua piazza, Lu Chianieddh’...................................................... »323 366 Finito si stampare nel mese di luglio 2013 presso la Tipografia Gutenberg S.r.l. Via Giovanni Paolo II, 5 - Fisciano (SA) Tel. e Fax 089.891385 - [email protected] Francesco Di Geronimo Francesco Di Geronimo (e su Santomenna, Laviano, Caposele, Buccino, Auletta, ed altri luoghi dell’Alto Sele) Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo è nato a Castelnuovo di Conza (Salerno) nel 1945. Docente di Italiano e Storia, si è laureato all’Università di Salerno con una tesi sul concetto di egemonia in Gramsci e specializzato in Scienze dell’Educazione all‘Università di Torino con una tesi sulla presenza degli handicappati nella scuola e nella società. È stato presidente del Consiglio provinciale di Salerno, ed è assessore della Città di Fisciano. Nel 1993 ha pubblicato La speculazione Menotti sulla stampa e nelle sentenze della magistratura. Nel 2010 ha pubblicato Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’ - Fotografie e parole del paese di una volta. Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Presentazione di Ruggiero Jannuzzelli e Francesco Custode Con un disegno di Pietro Lista ISBN 978-88-96554-11-1 € 25,00 iva inclusa Francesco Di Geronimo Francesco Di Geronimo (e su Santomenna, Laviano, Caposele, Buccino, Auletta, ed altri luoghi dell’Alto Sele) Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo è nato a Castelnuovo di Conza (Salerno) nel 1945. Docente di Italiano e Storia, si è laureato all’Università di Salerno con una tesi sul concetto di egemonia in Gramsci e specializzato in Scienze dell’Educazione all‘Università di Torino con una tesi sulla presenza degli handicappati nella scuola e nella società. È stato presidente del Consiglio provinciale di Salerno, ed è assessore della Città di Fisciano. Nel 1993 ha pubblicato La speculazione Menotti sulla stampa e nelle sentenze della magistratura. Nel 2010 ha pubblicato Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’ - Fotografie e parole del paese di una volta. Notizie storiche su Castelnuovo di Conza Presentazione di Ruggiero Jannuzzelli e Francesco Custode Con un disegno di Pietro Lista ISBN 978-88-96554-11-1 € 25,00 iva inclusa
Scarica