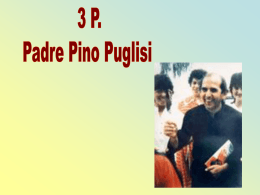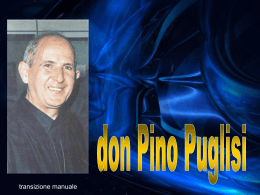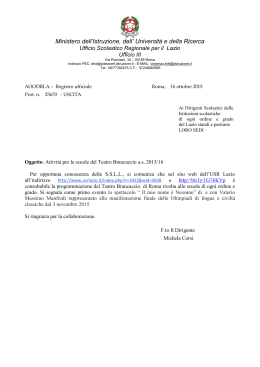Don Puglisi, un eroe solitario Incontro con BIANCA STANCANELLI 16 aprile 2005 BIANCA STANCANELLI Buongiorno a tutti; grazie di essere qui. Ringrazio la professoressa Soletti dell’invito. Sono molto curiosa e spero che vengano da voi anche molte domande. Mi dicono che parecchi di voi hanno visto il film, altri hanno letto il libro e alcuni invece non hanno la più pallida idea o hanno un’idea estremamente vaga di chi potesse essere don Puglisi, in quello sperduto angolo di mondo chiamato Brancaccio, nella città di Palermo. Il contesto come, con parola eminentemente sciasciana, il dottor Fulvetti ha voluto illustrare il retroterra di questa storia, vi è stato ampiamente raccontato e a me resta da dirvi chi era don Puglisi, perché ci importa di lui, perché ci ho scritto su un libro, perché qualcuno ha ritenuto di farci su un film e perché voi tutti oggi siete qui con la voglia, spero, di saperne di più. Vorrei fare una minuscola premessa, da siciliana quale sono: la società italiana ha un curioso atteggiamento nei confronti della mafia. Alterna fasi, purtroppo brevi, di grandissima emozione, che normalmente succedono alle stragi - più eclatante è la strage, più forte è l’emozione, più breve il tempo in cui si consuma - a fasi di grandissima indifferenza e di silenzio. Oggi attraversiamo una stagione d’indifferenza. Per questo è particolarmente bello che qualcuno voglia rompere questo silenzio, come appunto la prof. Soletti. Della mafia, delle storie di mafia normalmente si pensa: tutto questo è successo in Sicilia, in quella grande piattaforma sospesa nel Mediterraneo, quell’isola a forma di sfinge. E non si riesce a sentire tutto questo vicino a sé. Ora vorrei dirvi che proprio la vicenda di don Puglisi dimostra il contrario: questa storia è passata anche da qui, a poca distanza da voi. Nell’estate in cui da Brancaccio qualcuno telefonava a Giuseppe e Filippo Graviano, i capi mafiosi del quartiere, e li avvertiva che c’era questo “parrino”, come si dice in Sicilia, che «rompeva le scatole» (per usare il linguaggio dei collaboratori di giustizia) i fratelli Graviano erano in Versilia. Avevano preso in affitto una villetta con le loro fidanzate e non solo perché a entrambi piaceva la bella vita, ma perché dovevano sorvegliare il territorio. Come ricordava il dott. Fulvetti, la mafia è una forma di criminalità particolare. Una delle sue particolarità consiste in un controllo strenuo del territorio, in Sicilia ma, se occorre, anche fuori. E i fratelli Graviano, nell’estate 1993, si trovavano in Versilia perché preparavano la strage di via dei Georgofili, a Firenze. Nella stagione delle stragi, dalla Toscana passa un filo di questa misteriosa vicenda che unisce Roma, Firenze, Milano, i luoghi degli attentati. Sia i camion con l’esplosivo che verrà utilizzato a Firenze, sia gli uomini che arrivano in Toscana per studiare dove piazzare l’esplosivo, e come e quando, partono da Brancaccio. Partono, cioè, dal rione palermitano, dalla periferia dove si compiono gli ultimi tre anni della storia di don Pino Puglisi, proprio il periodo che ho raccontato nel libro. E adesso parliamo di don Puglisi. Nel film di Faenza lo impersona l’attore Luca Zingaretti. Ma dovete sapere che il vero Pino Puglisi è un personaggio fisicamente molto diverso. Immaginate un prete molto piccolo, molto minuto, molto sottile, molto mite, che attraversa la vita sorridendo: questo è abbastanza raro in generale, ed è raro soprattutto a Palermo. Un uomo che parla con una voce molto bassa. Io non l’ho conosciuto; l’ho visto in un filmato, quando ho curato un documentario per la Rai, a dieci anni dall’assassinio. Il filmato era stato realizzato per una festicciola a Brancaccio, il giorno dell’Epifania 1993. Vedendolo, mi ha impressionato il tono della voce di don Pino: la dolcezza di questa voce, la sua timidezza. Allora, questo sacerdote arriva nel quartiere di Brancaccio, dove peraltro è nato, nell’ottobre del 1990, in una fase di grande silenzio sulla questione mafiosa, come quella che oggi attraversiamo. Tutto tace a Palermo, tutto è tranquillo. E’ una condizione che normalmente tende a rassicurare l’opinione comune, ma per chi si occupa della materia, è un elemento di grande inquietudine. Perché la mafia è quieta e sta tranquilla quando è grassa e sta facendo i suoi affari. Le stragi non sono un segno della potenza della mafia, come potrebbe sembrare a un primo sguardo, sono la manifestazione della sua difficoltà. L’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 1992, poi le stragi del ‘93 non sono il sintomo di una mafia al culmine della sua potenza, ma piuttosto l’indizio di una mafia all’apice del terrore, perché nel 1993 la mafia ha temuto di perdere una fetta consistente del proprio potere. Tra la quiete del 1990 e la tempesta del 1993 si svolge l’avventura di don Puglisi a Brancaccio. Don Puglisi va a Brancaccio perché ce lo manda il cardinale Salvatore Pappalardo, che lo conosce da anni, lo stima, lo apprezza. Ci va perché non c’è nessuno che voglia andare nel quartiere a tenere aperta la piccola parrocchia di San Gaetano e a dire messa. E non ci vuole andare nessuno perché Brancaccio è una sorta di quartiere dannato. E’ ritenuto pericoloso. Provate a immaginare Palermo, questa città sul mare: Brancaccio è un quartiere orientale. Si trova all’ingresso della città, dove sbocca l’autostrada da Messina e da Catania. E’ un quartiere storico della mafia, una enorme piazzaforte dove moltissimi uomini d’onore, come Cosa nostra ama definire i propri membri, hanno casa e bottega. E’ un quartiere strategico: si trova a tre chilometri e mezzo dal municipio di Palermo, in periferia, ma non un’estrema periferia, una landa desolata. E ha l’aspetto come di un bozzolo, perché è isolato da due passaggi a livello. Così, per andare a Brancaccio, se si trova il passaggio a livello chiuso, bisogna aspettare anche dieci minuti, un quarto d’ora. Questo fa di Brancaccio un mondo chiuso, sottoposto alla dittatura mafiosa. Nei primi anni ‘80 si è scatenata a Palermo una guerra di mafia impressionante: la fazione corleonese prese il potere e si fece strada a forza di assassinii. Almeno mille morti, mafiosi prevalentemente. Parallelamente alla guerra interna alle cosche, si è scatenato un attacco alle istituzioni. Brancaccio, per il fatto di essere una roccaforte storica di mafia, era piena di uomini d’onore ostili ai corleonesi. E poiché, man mano che la caccia andava avanti, i cacciati tentavano di nascondersi, i corleonesi inventarono una tattica che è passata alla storia come vendetta trasversale. Per esempio, volevano prendere Totuccio Contorno, che era allora un killer famoso ed è stato poi un famoso collaboratore di giustizia dopo Tommaso Buscetta. Per stanare Contorno, gli ammazzavano il suocero, il cugino, lo zio, la cognata; non risparmiavano donne, non risparmiavano bambini. La mafia ha creato su di sé una leggenda di cavalleria, sostenendo di non aver mai ucciso le donne e i bambini. Non è assolutamente vero. Nel quartiere di Brancaccio, che conta 8000 abitanti, ci furono, nel giro di un paio d’anni, 150 morti. Ce n’era abbastanza per farlo giudicare un quartiere pericoloso. Tra il 1990 e il 1993 i boss mafiosi sono i fratelli Graviano: giovani ma già nel cuore di Totò Riina, il capo di Cosa nostra. I due fratelli sono inseriti in strutture segrete della mafia. Sono estremamente violenti, estremamente prepotenti, estremamente pericolosi. E’ su questo sfondo che don Puglisi va a Brancaccio, come parroco della chiesa di San Gaetano. Mi incuriosiva del personaggio l’idea che avesse accettato l’incarico, come dire, per ragioni di cuore, perché Brancaccio è il luogo dove è nato, dove è cresciuto. Quando accetta di tornarci, don Pino è un uomo di 53 anni, che ha un mucchio di cose da fare, perché ha compiuto una bella carriera ecclesiastica: è direttore del Centro diocesiano vocazioni, ha un incarico nazionale nel Centro delle vocazioni, è insegnante di religione in un liceo del centro della città, si occupa della Fuci, sempre per incarico del cardinale Pappalardo. Chi lo ha conosciuto, mi racconta che viveva giornate frenetiche. Usciva di casa alle sei della mattina, non aveva un telefonino - era povero, l’unico suo introito era lo stipendio di insegnante di religione, - rientrava a casa tardissimo, si nutriva di scatolette perché non aveva mai il tempo di sedersi a tavola per mangiare e correva da una parte all’altra di Palermo. Ma quel che distingueva don Puglisi era che, pur in queste giornate frenetiche, se qualcuno lo fermava perché gli voleva parlare, lui si fermava e ascoltava. La prima dote che colpiva in don Puglisi era la sua capacità enorme di ascolto. Questo faceva la forza del suo rapporto con i ragazzi. Per esempio, il giovane che andrà a Brancaccio a fare il “viceparroco”, come scherzosamente diceva don Puglisi, don Gregorio Porcaro mi raccontava d’aver incontrato un giorno don Pino quando ancora non aveva deciso di fare il sacerdote. Gregorio aveva vent’anni, attraversava una fase di particolare sbandamento, di incertezza. Dunque, questo ragazzo va da don Puglisi, comincia a parlare e non si ferma più. A un certo punto si rende conto che la luce è cambiata, guarda l’orologio e si accorge che sono passate cinque ore. E don Puglisi è ancora là e lo ascolta con tutta l’attenzione possibile. Gregorio Porcaro sobbalza e dice: «Ma, don Pino, sono cinque ore che parlo!». E don Puglisi risponde: «Che c’è, ti sei stancato?». Questo vi dice di un uomo interessato agli altri esseri umani, vi fa capire perché accetta di andare nella desolazione di Brancaccio per occuparsi di quel quartiere. Uno dei mali del nostro tempo è l’indifferenza, il nostro sentirci estranei a quasi ogni cosa che succede intorno a noi, il nostro non voler essere interpellati dal bisogno degli altri, dai sentimenti degli altri. Don Puglisi è diverso, e il suo andare a Brancaccio lo dimostra. Badate bene, lui non va lì per combattere la mafia. E’ un moderato, in qualche modo persino un conservatore. Non va a Brancaccio con l’intento di fare prediche antimafia, di sconfiggere l’idea stessa della mafia nella popolazione. Va lì per occuparsi dei parrocchiani, delle persone. Ma andandoci, scopre che il quartiere, in cui pure è nato e del quale ha ricordi infantili, è diventato una sorta di «luogo senza». In una relazione don Puglisi scrive: «Si fa prima a dire il poco che c’è, perché il tutto resto manca». Testimonia Gregorio Porcaro: «Non c’era neppure la cabina del telefono, non c’era nulla». “Nulla” significa che non ci sono i servizi sociali, gli ambulatori e non c’è soprattutto una scuola media. La prima cosa che don Puglisi mette a fuoco è che a Brancaccio, ogni anno, circa 250 ragazzini escono dalla quinta elementare e dovrebbero andare nelle medie, ma la scuola media non c’è. Così vengono dispersi nei più disparati plessi scolastici di Palermo. Per un po’ frequentano, ma dopo le vacanze di Natale, la maggioranza non torna più a scuola. I ragazzi restano nelle strade del quartiere, dove li attende un duplice destino: una parte viene arruolata nel lavoro nero e comincia a conoscere all’età di dieci, undici anni la sopraffazione, lo sfruttamento, l’illegalità; un’altra parte, i più svegli, vengono adocchiati dai numerosi uomini d’onore che presidiano il quartiere di Brancaccio e, come lì si dice, vengono allevati. Questo significa che vengono inseriti in un circuito in cui si parte con la consegna di una bustina di droga, poi si cominciano a trasportare armi da un capo all’altro della città; poi, se si dimostra di saperci fare, si viene usati per fare gli attentati, anche perché a Brancaccio il pizzo, l’estorsione, ha una diffusione capillare. Col tempo questi ragazzini vengono inseriti dentro l’organizzazione, si consegnano completamente a Cosa Nostra. Il pegno dell’inserimento è l’assassinio, l’incarico di uccidere una persona. E questi ragazzi ne sono fieri, perché vuol dire che sono arrivati. Don Puglisi mette a fuoco questo processo. Capisce che Brancaccio è una sorta di laboratorio all’aria aperta in cui la mafia riproduce se stessa, utilizzando un meccanismo di selezione che screma il meglio delle energie del quartiere e le volge al servizio di Cosa Nostra. Comprende che questo processo si alimenta della povertà e del degrado del quartiere: che la mafia e la miseria di Brancaccio, dove, come scrive, il primo dei problemi per molta gente è riuscire a mangiare, sono le due facce della medesima medaglia. Riflettete un attimo: mafia e miseria cominciano con la stessa consonante, finiscono con la stessa vocale, sostanzialmente sono la stessa cosa. Ogni tanto, a Palermo ma non solo, si alza qualche bella testa italiana – per ultimo, un noto filosofo - e comincia a dire che la mafia è l’unica forma di economia possibile per la Sicilia; che la mafia è l’unica possibile borghesia siciliana e che alla mafia bisogna guardare con occhio attento perché produce sviluppo e mette in movimento ricchezza. Don Puglisi capisce invece che la mafia è la ragione del sottosviluppo siciliano: non una manifestazione di quel sottosviluppo, ma la sua stessa radice e che combattere la miseria del quartiere di Brancaccio significa combattere la mafia, questa forma di dittatura che controlla l’economia, attraverso il pizzo; controlla la società, attraverso il reclutamento dei giovani e l’intimidazione degli adulti, e controlla la politica. Da questa consapevolezza comincia l’impegno di don Puglisi, soprattutto fra i ragazzini di Brancaccio. Il parroco ha chiara una cosa che pochi hanno chiara: che la mafia è una cultura, capace di utilizzare una serie di valori fortissimi nella società siciliana: il rispetto, l’onore, l’orgoglio, l’amicizia, la fedeltà, anche la religione, come vi ha detto splendidamente il dottor Fulvetti. E così i mafiosi sono gli uomini di rispetto; gli appartenenti ai clan si chiamano uomini d’onore. C’è in questo un fascino pericoloso, potente. Avrete sentito parlare del Padrino, l’avrete forse anche visto: raccontata come nel Padrino, Cosa nostra riesce perfino ad essere affascinante, ad esercitare una seduttività estremamente intensa. L’antimafia ha cominciato solo di recente a produrre, come dire, i suoi miti. Io non so quanti di voi abbiano visto i Cento passi, un film bellissimo su Peppino Impastato, ucciso dai mafiosi di don Tano Badalamenti. Nella produzione di miti l’antimafia è più debole, la mafia è forte. Don Puglisi capisce il fascino della mafia e decide di combatterla sul suo stesso terreno, di sfidarla sulla capacità di esercitare attrazione. Vedete, non è per ragioni biologiche o genetiche che alcuni siciliani diventano mafiosi. Intanto non capita a tutti e, comunque, anche quelli che lo diventano, “diventano” mafiosi, non “nascono” mafiosi. Perché succede? A Brancaccio, forse, è possibile leggere questi processi meglio che altrove. Ognuno di noi ha bisogno di valere. Ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto come una persona che vale. Ognuno di noi, in una fase della propria vita, ha bisogno che qualcuno investa su di lui, che lo aiuti a tirar fuori le sue capacità, le sue potenzialità. La cosa orribile del quartiere di Brancaccio è che a investire sui bambini è la mafia. Sono bambini infelici, figli di famiglie disgregate, abituati a vivere per strada. Non avendo giocattoli - chi ha visto il film di Faenza ricorderà queste scene - giocano con i gatti, strappano loro gli occhi, li danno da sbranare ai cani, prendono i cani e li portano agli adulti che li usano nei combattimenti clandestini. Sono bambini disperati. Me lo disse benissimo suor Carolina, una delle tre suore chiamate a Brancaccio da don Puglisi: “Questi bambini vogliono solo distruggere perché sono distrutti dentro, sono spezzati, sono rotti”. In un quartiere come Brancaccio, chi guarda questi bambini con attenzione? Non la Repubblica Italiana, che li lascia senza scuola media. Chi investe su questi bambini? Non i loro padri e le loro madri, che li mandano a rubare fidando nel fatto che sotto i 14 anni non sono punibili e che se spaccano un finestrino per rubare un’autoradio, a loro non succede niente. Chi investe su di loro, fino all’arrivo di don Puglisi, è solo e soltanto la mafia. La mafia che li osserva, sceglie i più svegli, li coltiva, dà loro la sensazione di valere, di poter camminare a testa alta (da qui il titolo del libro) in un quartiere dove la massima parte della gente deve camminare a testa bassa perché è minacciata, non deve vedere quello che vede, non deve sapere quello che sa, non deve pensare quello che pensa. E’ questa la sfida che don Puglisi accetta di combattere. Lo fa anche tentando il recupero di alcuni ragazzi di Brancaccio. Penso a uno di loro in particolare, Giuseppe Carini, un universitario ventenne tentato dalla mafia. Viene da una famiglia spaccata in due: padre onestissimo, impiegato nelle Ferrovie, un uomo gentile, vinto, sconfitto, e una madre che appartiene a una famiglia legata a Cosa Nostra. A vent’anni Giuseppe Carini si trova a dovere scegliere che fare della propria vita avendo davanti agli occhi l’immagine di un padre per bene, sconfitto e sottomesso, e di uno zio mafioso, uomo d’onore, uomo di rispetto. Giuseppe è diviso, ma è a suo zio che vuole assomigliare, non a suo padre. Nessuno a vent’anni vuole essere un vinto. Don Puglisi incontra questo ragazzo e non gli chiede nulla, capisce con uno sguardo che cosa gli va accadendo, gli chiede di lavorare con i bambini di Brancaccio, di farli giocare a calcio. Nel racconto di Giuseppe Carini, mi colpì moltissimo il suo primo incontro con questi bambini, che chiamava i diavoli di Brancaccio. Mi disse che la difficoltà più grande nel farli giocare stava nel fatto che le partite finivano a bastonate. Succede negli stadi di Milano e di Roma, figuriamoci che cosa doveva essere una partita di calcio fra i diavoli di Brancaccio! La cosa bellissima è che, man mano che Giuseppe Carini insegnava a questi ragazzini come giocare secondo le regole (vince chi è più bravo, non chi spranga meglio; vince chi ha più fiato, non chi mena più forte), si compiva una metamorfosi dell’allenatore e dei ragazzini. Sulle prime Giuseppe Carini aveva accettato l’incarico con l’aria un po’ annoiata, perché a Palermo non puoi dire di no a un parrino. E l’aveva accettato riservandosi di dedicare ai diavoli il poco tempo libero che gli restava dall’Università. Poi ha finito con l’appassionarsi all’idea di incidere sulla vita di questi bambini, di riuscire a trasformarli. Mi ha raccontato l’approccio con i ragazzini, la loro incapacità di esprimere la loro simpatia per lui, il loro affetto nelle forme che noi tutti conosciamo: dal “ciao, come stai” a una carezza, una pacca sulle spalle. I diavoli di Brancaccio non ne sono capaci: tirano pugni, lanciano pietre al loro allenatore, pur provando per lui gratitudine…Voi sapete che anche i sentimenti vanno educati, anche la gentilezza va coltivata. Non è facile essere gentili per bambini che sono abituati al linguaggio della violenza: a vedere violenza, a praticare violenza, a credere che non ci sia niente oltre la violenza. E l’educazione di questi bambini sul campetto di calcio è anche un’educazione a riconoscere la parte gentile di sé, quella che ha bisogno di affetto, di coccole. Così, man mano che giocano con Carini, i bambini di Brancaccio scoprono la possibilità di dire “grazie”, “prego”; di parlare in italiano, invece che in dialetto; di andare a prendere il loro allenatore a casa suonando e dicendo educatamente a chi apre: «Buongiorno, vorrei parlare con Giuseppe». E Giuseppe, in parallelo, scopre che c’è un modo di affermare il proprio valore nel mondo che è sostanzialmente diverso dalla mafiosità; c’è un modo di camminare a testa alta che consiste nel fare qualcosa per gli altri, nel battersi per cambiare insieme la propria vita e quella degli altri. Nella metamorfosi parallela dei diavoli di Brancaccio, che riescono - non vorrei esagerare - a scoprire la propria parte angelica, e di questo ragazzo di vent’anni, così sedotto dall’idea che la mafia ti dia potere, prestigio, e che scopre che ti puoi sentire qualcuno perché fai delle cose belle, interessanti, perché riesci a tirare fuori da un piccolo selvaggio un essere umano…in questa metamorfosi parallela c’è la storia di don Puglisi a Brancaccio e la ragione del pericolo grandissimo che il parroco rappresenta per la mafia. Il perno del lavoro del parroco è il Centro Paternostro, che fonda in un locale di fronte alla parrocchia. Nel Centro chiama le suore, comincia un rapporto intensissimo con le istituzioni di Palermo. L’idea di don Puglisi è che un passo decisivo per cambiare Brancaccio sia costruire questa benedetta scuola media, togliere i ragazzi dalla strada, farli studiare. E pensa di poter collocare la scuola negli scantinati di un orribile condominio in via Hazon, dove si svolgono i traffici peggiori della mafia di Brancaccio. Negli scantinati succede di tutto. E’ il luogo dove i rapinatori di Tir del quartiere nascondono la merce rubata agli automezzi che entrano a Palermo dall’autostrada. Ma in quei locali ci sono anche fenomeni di prostituzione minorile, lì vengono seppellite cataste di armi, lì sostanzialmente la mafia ha il suo santuario. Per questo don Puglisi decide che la scuola media va fatta là dentro. Comincia a parlarne con tutti: si rivolge al Consiglio di quartiere, al Municipio, alla Prefettura, all’ Assessorato regionale alla sanità, ecc. ecc. E trova un muro di gomma invalicabile, sperimenta una condizione di difficoltà estrema, di fatica che segnerà i suoi anni a Brancaccio. Non riesce ad avere alcuna risposta. Dovete considerare che la scuola media a Brancaccio è stata costruita sette anni dopo l’assassinio e inaugurata dal Presidente della Repubblica. Come capite, è assolutamente fuori dalla norma che un capo della Stato vada a inaugurare una scuola media e davvero io non so se, in assenza dell’assassinio, quella scuola media sarebbe stata costruita, e in quali tempi. Adesso, comunque, la scuola c’è, fa un bellissimo lavoro e, per quanto sia grande, tuttavia non riesce ad accogliere tutti i ragazzi che chiedono di frequentarla. Quanto agli scantinati di via Hazon, sono rimasti murati per moltissimo tempo, poi sono stati sfondati e utilizzati per i vecchi traffici. Adesso, finalmente, il Comune di Palermo ne ha concluso l’acquisizione. Voi capite che i tempi della politica sono colpevolmente lunghi rispetto alle necessità. Gli anni di don Puglisi a Brancaccio vengono scanditi da questa duplice battaglia: la scuola media, la chiusura degli scantinati di via Hazon. Nell’uno e nell’altro caso il parroco viene sconfitto. Sconfitto dalla politica, dalla cattiva politica. Ma vittorioso, e questo è importante, nella società di Brancaccio, dove il parroco diventa un punto di riferimento importante, fino a rappresentare una minaccia per il potere dei fratelli Graviano. Una minaccia tanto più forte perché si inscrive in una stagione di grandissimo cambiamento. Nel 1992, dopo l’assassinio dei giudici Falcone e Borsellino, la società italiana reagisce massicciamente, lo Stato comincia una attività intensissima contro la mafia. Il punto più spettacolare è la cattura di Totò Riina, il capo di Cosa nostra, ma gli arresti di latitanti sono continui, il fronte mafioso si disgrega, si moltiplicano i pentiti. Si arriva a un punto in cui i latitanti appena catturati, decidono di collaborare con la giustizia già sulla macchina della polizia o dei carabinieri che sta per condurli in carcere. Saranno pure pentimenti di comodo, ma rappresentano il segno di uno sgretolamento dell’organizzazione. Viene introdotto nella legislazione italiana il 41 bis, il carcere duro. Per un mafioso l’idea di potere andare in galera, di poterci restare, è pressoché insopportabile e - vi prego di credere, perché voi siete giovani - era assolutamente fuori dall’orizzonte fino al maxi processo, cominciato nel 1986 e concluso un anno dopo. Una delle più accreditate interpretazioni dell’assassinio di Giovanni Falcone lo spiega come una reazione alla sentenza della Corte di Cassazione che, nel gennaio 1992, rese definitivi gli ergastoli del maxiprocesso. Prima di allora, la mafia era abituata a una impunità insistita, di massa, apparentemente inscalfibile, certificata dalle assoluzioni per insufficienza di prove. Voi avete la fortuna di vivere in una Italia in cui le sentenze contro i mafiosi vengono pronunciate e i mafiosi, non tutti purtroppo, stanno in galera. Torniamo al 1993, quando i continui pentimenti, gli arresti, i sequestri di patrimoni mettono in tremendo allarme Cosa Nostra. La frastorna anche la vigorosa pronuncia del Papa. Nel maggio 1993, in visita in Sicilia, Giovanni Paolo II, nella Valle dei Templi di Agrigento, grida davanti a una folla immensa: ” Mafiosi, convertitevi!” E’ una parola, “convertitevi”, sulla quale vi invito a riflettere, perché, usandola, il Papa nega la religiosità dei mafiosi. La mafia si fa un vanto di essere religiosa: i riti di iniziazione si fanno bruciando immaginette sacre. Quando Totò Riina viene arrestato, il 15 gennaio del ’93, ha nel portafoglio l’immaginetta di S. Rosalia, la patrona di Palermo. I fratelli Graviano, prima di sedersi a tavola, fanno il segno della croce. Questa esibizione di devozione è per il mafioso un punto di forza. Anche in questo caso la mafia si appropria di valori forti della cultura siciliana per costruire le proprie radici nella società. Dicevamo che il 1993 segna un’enorme crisi dell’organizzazione. Con il 41 bis, costretti all’isolamento, i boss non possono più comandare dal carcere, come erano abituati a fare. Ferita, la mafia reagisce con le stragi: per costringere lo Stato a trattare, per imporsi come soggetto ancora forte. Ma reagisce in quel modo, state bene attenti, perché è debole, non perché è forte. Su questo sfondo, la ferita di Brancaccio è uno degli aspetti a cui l’Italia intera bada poco o niente, ma la mafia dei Graviano bada assai. Nel quartiere è in corso una sfida forte. Nell’anniversario dell’assassinio di Borsellino, don Puglisi inventa una manifestazione festosa, chiama i bambini a correre per strada in gare di bicicletta, riesce a portare il quartiere in piazza davanti a un palco dal quale parla anche Rita Borsellino - che anche voi avete conosciuto - sorella di Paolo, il magistrato ucciso. Portare nel quartiere di Brancaccio, roccaforte della mafia, Rita Borsellino è un gesto estremamente forte. La mafia è attentissima ai simboli. E il fatto che nonostante l’isolamento di Brancaccio, nonostante la vigilanza strettissima esercitata da una mafia che abita lì, nelle strade dove i latitanti passeggiano, il sacerdote sia riuscito a portare decine di famiglie in piazza, dietro uno striscione con scritto: «Brancaccio dice sì alla vita e no alla mafia» è una rottura formidabile. Soprattutto, è il segno di una possibile crisi di consenso, proprio nel momento in cui Cosa nostra sente il terreno mancarle sotto i piedi. Dopo le stragi del 1992-93, a Palermo succede una cosa straordinaria: su iniziativa di un gruppo di donne, vengono appesi in città dei lenzuoli bianchi con grandi scritte contro la mafia. Ma fino all’assassinio di don Puglisi, non un lenzuolo viene steso ai balconi di Brancaccio, perché nel quartiere non deve succedere nulla. Ecco che, per i mafiosi, la folla che don Pino Puglisi riesce a portare in piazza rappresenta un oltraggio, una sfida altissima. Da qui la decisione dell’assassinio. Ma che cosa rende possibile quell’assassinio? C’è una frase di Falcone, bellissima, in Cose di Cosa Nostra: «Si muore perché si è soli». Ma di che tipo di solitudine è morto don Puglisi? Nel quartiere il parroco non è isolato. Anzi, in quel mondo, è riuscito a operare rotture estremamente forti. La solitudine di don Puglisi è un isolamento creato dalle istituzioni. La solitudine di quelli che vengono uccisi, penso anche al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è una solitudine rispetto al tessuto naturale di alleanze che dovrebbe sorreggere un’operazione di cambiamento. A lasciare solo don Puglisi è il Comune, che non si occupa di fare la scuola media; è la Prefettura, che perde tempo nel requisire gli scantinati di via Hazon; è l’Assessore alla Sanità della Regione, che non apre l’ambulatorio; è il Consiglio di quartiere, spaventato dall’opera di questo sacerdote, dal suo fascino. Anche la Chiesa, alla fine, lo lascia solo. Numerosi collaboratori di giustizia hanno dichiarato che il rimprovero di Leoluca Bagarella, cognato di Riina, ai mafiosi di Brancaccio suonava così: “Avete consentito a questo parrino di diventare un personaggio”. Ciò che spaventa Cosa Nostra è il seguito di don Puglisi, la sua capacità di attrazione, la sua abilità nel trasmettere un messaggio radicalmente diverso al quartiere. Penso, per esempio, alla sua battaglia contro l’utile. A Brancaccio, dove la gente non ha i soldi per mangiare, le famiglie sono ossessionate dal guadagno. Uno ha 5 figli? Li manda a rubare. E s’industria da sé a rubare: la luce, l’acqua. La parrocchia distribuisce pane, pasta, vestiti? Arrivano queste madri Erinni, si fanno dare i vestiti, li mettono addosso ai figli: quando sono sporchi, non li lavano, buttano tutto e chiedono altri abiti. Contro l’ossessione dell’utile don Puglisi dice: «Noi, io, le suore, il Centro, i volontari, dobbiamo offrire la dimensione del gratuito. Far capire che facciamo le cose non perché ce ne viene qualcosa in tasca, ma per amore, per simpatia; lo facciamo perché ci importa di questa gente». Tutto questo la mafia vuole uccidere, nel momento in cui uccide don Puglisi. Tutto questo fa l’utilità paradossale del lavoro del parroco di Brancaccio. Ve lo dico perché ogni tanto, quando vado nelle scuole per parlare di questo libro, di questa figura, i ragazzi mi dicono:” E’ una bella storia, però don Puglisi è stato ucciso, quindi sostanzialmente ha perso”. Lui stesso aveva messo in conto di poter essere ucciso. E’ un rischio incontro al quale è andato consapevolmente. Ma l’avere perso la vita non fa di lui uno sconfitto. Se ci riflettete, sono assai più perdenti i fratelli Graviano nella loro miserabilità, nel loro essere due poveracci che al momento stanno in una cella e voglio sperare che non abbiano l’occasione per uscire. Gli uomini come Falcone, Borsellino, don Puglisi non sono sconfitti perché sono stati uccisi: hanno scommesso la loro vita su un impegno, su un modo forte di affrontare l’esistenza, di attraversarla, di lasciare un segno. L’ultima cosa che vi volevo dire è la singolarità assoluta del personaggio di don Pino nel martirologio, diciamo così, delle vittime di mafia. Tra il 1979 e il 1993, molti sono stati i caduti per mano di Cosa nostra. Per anni si è detto: si ammazzano fra loro. Una parte dell’indifferenza alla questione mafiosa si alimentava di questa convinzione. Ma dal 1979 la mafia inaugura una massiccia campagna di aggressione alle istituzioni: muoiono magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti. Muore anche un medico legale, Giaccone, ucciso perché aveva fatto una perizia su un’ impronta digitale che incastrava un certo mafioso. Gli fu chiesto di cambiare la perizia, si rifiutò e venne assassinato. Queste decine di vittime avevano un potere contro la mafia: i magistrati possono fare le inchieste, mandare in galera, processare, condannare, ordinare il sequestro di patrimoni; i poliziotti e i carabinieri arrestano, indagano; i giornalisti scrivono, denunciano, come Mario Francese; Giaccone fa la perizia… Insomma tutti avevano la facoltà di nuocere alla mafia nelle due cose cui tiene di più: l’impunità e i soldi, potere e ricchezza. Don Puglisi poteva solo parlare. Parlare e agire conseguentemente alle parole dette. Anche questo è fondamentale del personaggio: l’impegno a non tradire mai con i gesti, con i comportamenti le proprie parole. Uccidendo don Puglisi, la mafia dimostra di avere paura della parola. L’assassinio viene commesso contro un uomo disarmato. Vanno in quattro: quattro bestioni di mafia contro un uomo piccolino, mite, sorridente e disarmato. Gli tendono un aggguato al buio, arrivandogli alle spalle. Non hanno neppure il coraggio di affrontarlo faccia a faccia. E lo affrontano con una menzogna. Il mafioso che sta alla destra del parroco dice: “Questa è una rapina” per distrarlo, mentre da sinistra il killer Salvatore Grigoli gli spara. Anche nel momento in cui muore, il parroco sorride. E quel sorriso turba così potentemente il suo assassino da trasformarlo in un collaboratore di giustizia. Vi invito a riflettere su quest’aspetto della storia: l’assassinio di un uomo disarmato, che ha solo il potere della parola, per concludere che tutta l’avventura finale di don Puglisi a Brancaccio è nel segno della libertà. Il parroco vuole liberare i bambini, i ragazzini da un destino che per loro è già scritto: allevati nella ferocia, e senza riconoscere in sé altro che la ferocia, sono destinati a diventare mafiosi. La storia di don Puglisi dimostra limpidamente che la questione della mafia è una questione di libertà. Nessun paese può dirsi libero se consente che in alcune porzioni del proprio territorio la libertà sia messa radicalmente in discussione, fino al punto che viene uccisa con un proiettile alla nuca la libertà di parola. Questo è tutto. Vorrei le vostre domande. Grazie. LE DOMANDE A BIANCA STANCANELLI Domanda 1. Non ha paura della mafia per il libro che ha scritto? No, non ho paura, anzi ho una forma di speranza. E ve lo spiego. Qualche anno fa nella mafia è corso un passaparola a proposito di una strategia per chiudere i conti con lo Stato, una strategia che aveva nome “dissociazione”. Si trattava di replicare quanto è stato fatto con il terrorismo, nel senso che i mafiosi pretendevano di cavarsela dicendo “vabbè, ero mafioso, però mi dissocio” e riconquistare la libertà. Dovete pensare che, grazie al fortissimo intervento repressivo dello Stato tra il 1993 e il 1995, ci sono dietro le sbarre generazioni intere di mafiosi, anche giovani che non vedono l’ora di uscire. I Graviano hanno adesso poco più di 40 anni. Sono stati talmente bravi da riuscire ad avere due figli maschi con la fecondazione artificiale, facendo uscire, non si è mai capito come, il loro seme dal carcere in un regime di 41 bis. Oggi Filippo e Giuseppe Graviano hanno un maschio ciascuno, chiamato Michele in onore di papà, il capostipite mafioso. E naturalmente, non vedono l’ora di uscire. Ora, se il libro ha l’effetto di rendere consapevole una parte della società italiana di chi siano i fratelli Graviano, e quindi rende loro impossibile uscire di galera a buon mercato, io sono assolutamente fiera. Questo per dirti che non ho paura, ho anzi la speranza che il libro contribuisca a tenere i Graviano in una condizione per loro intollerabile, perché mi pare che se lo meritino. Domanda 2. Il Centro Padrenostro, poi, è stato portato avanti? E’ un discorso difficile: il Centro esiste tuttora, ma in una forma del tutto diversa da quella che don Pino Puglisi prevedeva. Una delle battaglie di don Pino fu quella per non avere i contributi pubblici. In Sicilia è estremamente semplice, perché la Regione è molto generosa e lo è in particolare con tutto ciò che si muove intorno alla Chiesa. Suor Carolina Giavazzo, che era una delle tre suore al lavoro nel Centro Padrenostro, mi raccontò d’aver chiesto diverse volte a don Pino:”Ma perché non ci facciamo dare dei contributi?”. Don Puglisi, che era un uomo assolutamente rigoroso, temeva che, se si fossero avuti i finanziamenti pubblici, si sarebbe perso lo spirito del volontariato; si sarebbe assoggettato il Centro Padrenostro a logiche clientelari, che non dovevano avere cittadinanza là dentro. Il parroco voleva trasformare gli abitanti di Brancaccio, portarli da una condizione di sudditi a una condizione di cittadini. Un suo discorso molto bello a un gruppo di parrocchiani si concludeva con l’invito:” Non chiedete come favore ciò che è vostro diritto ottenere”. Per ottenere questo, il parroco credeva che bisognasse dimostrarsi assolutamente rigorosi e, quindi, non sollecitare contributi. Adesso invece il Centro Padrenostro è, come alcuni dicono, un “progettificio”, cioè una fabbrica di progetti che ricevono tutti finanziamenti pubblici: e questo è estremamente spiacevole. Domanda 3. Cosa avrebbe potuto fare don Puglisi per salvarsi? Cosa, quali iniziative, chi avrebbe potuto muovere qualche cosa in quel dato momento, nell’estate del ’93? Che cosa avrebbe potuto fare? Me lo disse efficacemente il suo successore, don Mario Golesano: ”Poteva chiedere tre mesi di esercizi spirituali e si sarebbe salvato la vita”. Sostanzialmente, si poteva eclissare. Io sono assolutamente persuasa che don Puglisi seppe perfettamente a che cosa stava andando incontro, ce ne sono tracce visibili nell’ultima parte della sua vita. Se i Graviano fossero riusciti a farlo sloggiare, avrebbero potuto vantare quel risultato sulla piazza di Brancaccio e, forse, se ne sarebbero appagati. Questo però sarebbe stato in contrasto con il rigore del parroco, la sua serietà. Una delle intenzioni del libro - non so se riesce in questo - è dare il senso di che cosa significa vivere in un quartiere di mafia. Io ho abitato otto anni a Palermo, quando succedeva di tutto, ammazzavano in continuazione, scioglievano la gente nell’acido, eccetera, ma, nelle zone in cui io abitavo, al centro di Palermo, non avevi la percezione fisica della tensione, della mattanza. In otto anni sono andata una sola volta a Brancaccio, come ho raccontato nel post scriptum: nel 1983, quando, finita la guerra di mafia, la Repubblica Italiana aprì un Commissariato di Polizia e alla vigilia dell’inaugurazione, la mafia lo fece saltare in aria. Lavoravo per L’Ora, un piccolo giornale molto celebre. Andai a Brancaccio per raccontare l’attentato ed era la prima volta che ci mettevo piede. Ricordo la tensione, una sensazione fisica di intimidazione: era nelle facce che incontravi, nella bruttezza dei palazzi; nel grigiore, nello squallore si avvertiva una dimensione di minaccia. Una cosa è combattere la mafia a Lucca, o anche a Palermo in una via elegante come via Libertà, un’altra cosa è farlo a Brancaccio. Perché lì i mafiosi li vedi, incontri i latitanti per strada. I fratelli Graviano abitavano a cento metri dalla parrocchia, erano stati battezzati in quella parrocchia. Dunque, se tu chiedi alla gente che vive lì di impegnarsi e di vivere quotidianamente il proprio impegno, non puoi filartela all’ultimo momento. Così don Puglisi rimase e andò incontro al suo destino, conoscendolo in anticipo, perché ebbe molte più minacce di quanto ci è dato sapere. Ma c’è una seconda parte della domanda: a quali condizioni la storia di don Puglisi avrebbe potuto finire in maniera diversa? Avrebbe potuto se ci fosse stata la politica. E quando dico politica, non intendo il singolo personaggio politico, il singolo onorevole, il singolo sindaco; intendo le istituzioni, l’attenzione delle istituzioni. Se le delegazioni di Brancaccio avessero trovato udienza, se la Prefettura, il Comune, la Regione si fossero sintonizzate sulla necessità di un quartiere che aveva trovato finalmente nel parroco la via per uscire dal proprio degrado, se il movimento di uomini e donne che don Puglisi era riuscito a suscitare avesse trovato udienza, e quindi si fosse fatta la scuola media, si fossero sequestrati gli scantinati ecc. ecc., allora certo la storia sarebbe stata diversa. Se intorno a don Puglisi si fossero schierate le istituzioni, non sarebbe stato ucciso, ma qui entriamo nel problema della solitudine di cui parlava Falcone. GIANLUCA FULVETTI Su questo vorrei aggiungere un piccolo particolare. Oltre che la solitudine nei confronti delle istituzioni, come accennavi anche prima nell’intervento, c’è anche un capitolo sofferto che riguarda la solitudine per quello che riguarda la Chiesa siciliana. Noi siamo abituati a pensare a parroci che, se hanno situazioni di difficoltà nelle attività che portano avanti, si rivolgono ai loro colleghi, cercano di stabilire contatti, relazioni. Tutta la parabola di don Puglisi si gioca con lui all’interno di Brancaccio, con Gregorio Porcaro che gli dà una mano, con dei rapporti che non sono proprio così trasparenti nemmeno con il cardinale. C’è un inciso nel libro, al quale fa riferimento. Io ricordo nel ’98-‘99 di essere stato a Palermo e di avere fatto proprio una domanda a quello che allora era il Preside della Facoltà teologica di Palermo, e che poi è diventato vescovo, chiedendogli se gli altri parroci sapevano di questa attività di don Pugliesi, della sua difficoltà, della sua situazione. La risposta, sofferta, è stata un “Non abbiamo capito per tanto tempo quella che era la presenza e la pericolosità della mafia, quando l’abbiamo capito molti di noi hanno avuto paura”. Quella del ‘92-’93 è forse una fase in cui la Chiesa di Sicilia comincia a capire, ma nella stragrande maggioranza dei suoi esponenti ha ancora paura di quello che significa andare a Brancaccio a fare il sacerdote. Domanda 4. Che tipo di lavoro è stato necessario per raccogliere informazioni sull’organizzazione mafiosa, sulla vicenda di don Puglisi? Il mio punto di partenza fu la sentenza di condanna del primo gruppo di esecutori e mandanti dell’assassinio. Poi ho rintracciato una per una le persone che con don Puglisi avevano lavorato. Mi sono fatta raccontare il personaggio don Puglisi, perché io non l’ho conosciuto. Tra tutti questi incontri, il più suggestivo è stato quello con Giuseppe Carini. Dopo la morte di don Puglisi, Carini riuscì a persuadere un ragazzo di Brancaccio a testimoniare su un assassinio mafioso e poi dovette fuggire da Brancaccio. Un destino veramente terribile: testimone di giustizia (non collaboratore, perché non era mafioso), Giuseppe è stato ripudiato dalla sua famiglia, estromesso dal quartiere, costretto a interrompere gli studi in medicina e a fuggire qua e là cambiando identità, con tutte le difficoltà, anche normative, che esistono a fare tutto ciò in un paese relativamente piccolo come l’Italia. Lo raggiunsi per telefono tramite una persona che mi mise in contatto con lui, lo incontrai alla stazione di Firenze (perché viveva in Toscana, non ho mai saputo dove), con un appuntamento un po’ da spie, veramente suggestivo. Una domenica presi il treno prestissimo da Roma, arrivai alla stazione di Firenze, pioveva a dirotto, ci facemmo uno squillo con i telefonini e ce ne andammo al Bar delle Giubbe rosse. Giuseppe mi raccontò delle cose molto belle, tra cui quella da cui ho tratto il titolo del libro: l’ essere il mondo di Brancaccio diviso in due, tra una maggioranza di persone oneste, costrette però a camminare rasente i muri a testa bassa, perché non dovevano neppure sfidare con uno sguardo i mafiosi e la minoranza arrogante degli uomini d’onore, che camminavano a testa alta, sfidando il mondo. Concludendo, ho raccolto le testimonianze dirette di tutti quelli che avevano lavorato con don Puglisi, ho letto gli atti giudiziari e studiato quel po’ di documentazione lasciata da don Puglisi, le sue relazioni, gli interventi a convegni. Domanda 5. La scuola media del Brancaccio, per la quale ha lottato don Puglisi, continua lo stesso a mantenere il suo messaggio e l’ha capito? Se sì, come fa a continuare? La scuola è stata intitolata a don Puglisi. Costruita al fondo di via Hazon, il cuore dell’inferno di Brancaccio, è una bellissima scuola, in cui non si registrano atti vandalici, per fortuna. Anche fisicamente è bella: tutto l’atrio, che è molto vasto, è stato dipinto dagli studenti. Il preside mi ha spiegato che non riesce, però, ad assorbire tutti i ragazzini di Brancaccio, perché poi ci vanno anche da altre scuole. Gli alunni fanno una serie di attività collaterali. Direi che la bellezza del lavoro di don Puglisi non si è persa. Anche se lo stesso preside sostiene che ci vorranno generazioni per cambiare davvero le cose. Lo stesso don Puglisi su questo non si faceva illusioni. Non pensava di poter trasformare Brancaccio in un Eden. La sua formula, che adesso è incisa accanto al portone della chiesa di San Gaetano, era: Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Anche le persone che più seriamente e strenuamente si sono impegnate contro la mafia fino a perdere la vita in questo impegno, non lo facevano perché erano degli illusi che pensavano di poter cambiare il mondo in un baleno. Erano persone perfettamente consapevoli della difficoltà del loro impegno, ma consapevoli che, se si invocano le difficoltà per rinunciare, nessun processo di cambiamento è possibile. Domanda 6. Come si comporta il parroco attuale di Brancaccio? Purtroppo non è una figura luminosa. Il suo ingresso in scena - perché sta lì dall’’assassinio di don Puglisi - è segnato da una frase che mi impressionò molto. Arriva questo sacerdote, per altro da una zona molto vicina a Brancaccio, e incontra, ancora spaurite, le persone che erano più vicine a don Puglisi e che vivono il suo assassinio anche sentendosi in colpa. Si sentono in colpa perché, dopo la sua morte, capiscono che il parroco per molto tempo, in perfetta solitudine, si è allontanato dalle persone che lo circondavano per ridurre il pericolo nei loro confronti e si è avviato da solo verso il centro del mirino. Dunque il nuovo parroco, don Mario Golesano, incontra queste persone e dice: «Per prima cosa togliamoci tutti dalla testa questo cadavere», che non è esattamente il modo migliore per raccogliere l’eredità di don Puglisi… Ma qui torniamo alle difficoltà nel rapporto tra Chiesa e mafia di cui vi ha parlato il dottor Fulvetti. Domanda 7. Che reazioni ha suscitato prima il libro e poi il film a Palermo, e particolarmente a Brancaccio? Non so se a Brancaccio c’è un cinema. No, nel suo essere un quartiere totalmente “senza”, non c’è un cinema. Sono andata a presentare il libro in una scuola vicina a Brancaccio, un Istituto professionale. Mi ha colpito che alcuni ragazzi di Brancaccio, che avevano detto ai loro insegnanti che sarebbero venuti, alla fine non si sono presentati. Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il racconto di un’insegnante:aveva proposto di adottare per A testa alta quella pratica curiosa che consiste nell’abbandonare un libro su una panchina o sul sedile di un treno perché altri lo trovino, lo leggano. Aveva proposto ai ragazzi di lasciare il libro a Brancaccio, ben in vista, e le era stato risposto: «Professoressa, ma è pazza?». Ma alcuni ragazzi di Brancaccio che hanno letto il libro, ci si sono pienamente riconosciuti. E questo è bello. L’altro racconto che mi ha molto divertito è che, a un certo momento, questo libro è arrivato in una famiglia di Brancaccio, non so bene quale, in fotocopia (io trovo che i libri costino un po’ troppo e per persone di Brancaccio costano particolarmente). Una donna casualmente ne legge qualche pagina, decide che lo vuole comprare, domanda dove si comprano i libri, perché non aveva la più pallida idea che esattamente come ci sono le pescherie per vendere il pesce ci sono le librerie per vendere i libri. Sul film non ti so dire, perché non abito più a Palermo. So che ci sono state molte proiezioni pubbliche, ma a Brancaccio non lo so, non credo. Faenza racconta di avere avuto delle difficoltà quando si presentò lì. Domanda 8. Quali reazioni ci sono state da parte degli ambienti mafiosi? La mafia non è così incauta da reagire. Un proverbio siciliano recita: Calati iunco che passa la china. Ovvero, Piegati giunco, perché passa la piena. E’ un tipico proverbio mafioso, un invito alla flessibilità. Voglio raccontarvi un episodio significativo. 1983: congresso della DC siciliana ad Agrigento. E’ una DC nella quale un personaggio fondamentale è Vito Ciancimino, uno dei simboli delle collusioni fra politica e mafia, ex sindaco di Palermo, ma soprattutto assessore ai Lavori Pubblici nel tempo del sacco di Palermo. Nel settembre del 1982 viene ammazzato a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto antimafia. Era stato un eroe nazionale della lotta contro il terrorismo, così l’Italia intera reagì potentemente: si varò finalmente una legislazione antimafia. Anche la DC nazionale venne investita da questa reazione, capì di dover prendere le distanze dai personaggi più compromessi. Dunque, in Sicilia si celebra il Congresso di Agrigento, io vengo mandata lì come cronista. E lì, con grandissimo mio stupore, vedo che chiunque va al microfono, pronuncia parole spietate contro la mafia. Non c’è andato Ciancimino, ma tutti quelli che si sapeva essere in odor di mafia andarono alla tribuna e pronunciarono la loro ferma condanna della mafia. Abbiamo appreso successivamente, dalle ricostruzioni dei collaboratori di giustizia, che l’organizzazione aveva dato quest’ordine: professarsi antimafiosi. Calati junco, appunto. Non credo che la mafia possa avere reazioni sul film, sul libro. Ma questa domanda mi dà la possibilità di aggiungere un’osservazione sulla storia di don Puglisi. Brancaccio era zona di reclutamento per Cosa nostra. La mafia è fatta di numerosissimi insospettabili. Lo dimostrano i processi in corso: riguardano professionisti, medici, perfino ufficiali dei carabinieri che lavoravano fianco a fianco con uomini simbolo dell’antimafia. L’innervamento della mafia nella parte “buona” della società è potentissimo. Ma tutta questa impalcatura si regge su una struttura militare forte, formata da giovani come gli ex ragazzini di Brancaccio, che poi diventano soldati dell’organizzazione, disposti a morire e a uccidere per l’organizzazione. Se togli la forza militare, l’intera Cosa nostra si affloscia. Il 1993 significa una crisi di reclutamento mostruosa. Nella squadra che partecipa all’assassinio di don Puglisi, ci sono ex rapinatori. Quell’anno, per coprire gli organici decimati dagli arresti, la mafia è costretta ad arruolare una quantità di persone che non sono state allevate, selezionate per diventare uomini d’onore. Uno dei terrori dell’organizzazione di fronte all’azione di don Puglisi è che la crisi di reclutamento, in un quartiere decisivo come Brancaccio, possa essere accelerata: da qui la decisione di reagire. Ma al semplice parolaio antimafia, la mafia non fa assolutamente nulla. Gli può lasciar dire tutto quello che vuole; se agisce, è perché la ferita è dura, profonda. Domanda 9. Lei ha sentito come un dovere personale di scrivere questo libro su don Puglisi e sul suo messaggio? Sì. A Palermo c’è una bellissima rivista, si chiama Segno. La pubblicano i Padri Redentoristi, ma ci scrivono moltissimi laici. Nel settembre del 1998 Segno, che è un mensile, ha dedicato un intero numero alla sentenza di condanna del primo squadrone della morte mandato contro don Puglisi. Devo premettere che, quando don Puglisi venne ucciso, io ero già a Panorama, a Roma, chiesi al giornale di andare a Palermo per occuparmi di questa storia, seguivo allora la mafia. Mi risposero che era una storia piccola. Poi lessi la sentenza su Segno e mi appassionai al personaggio. Mi sembrò che, pur nella prosa faticosa di una sentenza, emergessero i contorni di una storia bellissima e tremenda. Ora, io sono assolutamente persuasa che anche la lotta alla mafia ha bisogno di costruire i propri miti, i propri simboli, un proprio patrimonio simbolico. E la storia di don Puglisi era una storia perfetta per questo, esattamente come risulta suggestiva e bella la storia di Peppino Impastato. Prima del film i Cento passi era una storia dimenticata, benché a Palermo ci sia un Centro Impastato che produce anche dei materiali molto belli sulla mafia. Per don Puglisi, leggendo quella sentenza, sentii il bisogno di restituire la storia alla sua bellezza, alla sua forza. Spero di esserci riuscita. Sì, il libro da questo nasce da questo. Grazie a voi. Buon ritorno a casa, spero non sotto la pioggia.
Scaricare