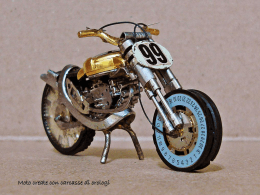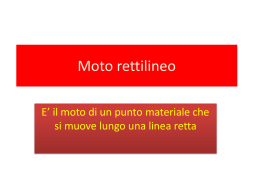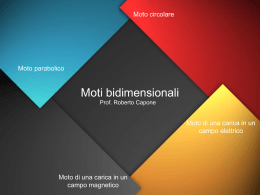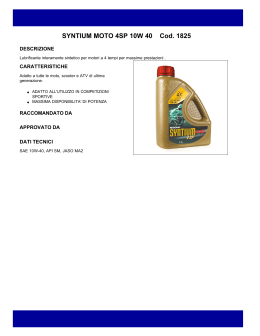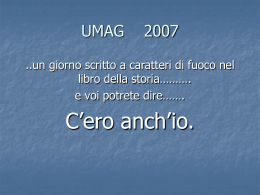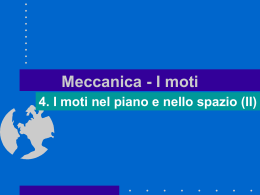QUESTONE DI MILLIMETRI: SECONDA PARTE DELLA DESCRIZIONE TECNICA DI TUTTI I PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO LA GEOMETRIA DELLA MOTO. Proseguiamo nella scoperta degli aspetti che caratterizzano la geometria di un Motociclo, affrontando due ulteriori elementi determinanti per la riuscita di un progetto: l'influenza dell'interasse sulla distribuzione dei pesi e il trasferimento di carico in fase di accelerazione e La distribuzione dei pesi tra ruota anteriore e ruota posteriore in una moto è uno dei parametri fondamentali per determinarne la manovrabilità. Stabilire esattamente la ripartizione dei carichi in fase di. progettazione, anche se coadiuvati da programmi di simulazione al computer, resta tuttavia uno dei passaggi più critici. Per questo, l'abilità di un progettista consiste nell'impostare il proprio lavoro lasciando possibili margini di intervento ai colleghi del reparto prove, così da permettere gli opportuni miglioramenti in corso d'opera. Per sottolineare quali difficoltà possano incontrare i tecnici, giova ricordare ciò che durante il Campionato Mondiale di Formula 1 del 1998, quando, a metà stagione, squadre di esperienza come Ferrari, Williams e Jordan furono costrette ad allungare Il passo del 5% (Circa 150 mm!) per ritrovare il giusto equilibrio della vettura. In questo disegno sono evidenziati i punti attraverso i quali il pilota scarica il proprio peso sulla moto. I tecnici prestano molta attenzione alla definizione di questo triangolo, risultante dall’unione dei punti rappresentati manurio, sella e pedane. In effetti, il modo più semplice per variare la distribuzione dei pesi sulle monoposto è proprio quello di intervenire sul passo, ovvero sulla distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle ruote posteriori. Se si desidera aumentare il peso sull’avantreno si dovrà spostare indietro l'asse delle ruote posteriori, interponendo, in genere, un stanziale calibrato fra motore e cambio se, viceversa, si vuole caricare maggiormente il retrotreno, si dovrà spostare in avanti l'asse delle ruote anteriori, montando triangoli delle sospensioni anteriori più angolati Ritornando alle "due ruote", il modo più semplice per variare l'interasse della nostra moto è quello di sfruttare l'asola di registro relativo alla tensione della catena, che solitamente consente variazioni di 35 o 40 mm, avendo sempre cura di ripristinare, dopo ogni intervento, il corretto gioco della stessa. Portando la ruota posteriore tutta in avanti avvicinandola cioè al baricentro, si carica maggiormente il retrotreno; viceversa, spostandola indietro si carica l'avantreno. In quest'ultimo caso, diventa più difficile eseguire le manovre a bassa velocità, mentre aumenta la stabilità dell'avantreno in fase di accelerazione e alle alte velocità. Al contrario, è facile dedurre che un avantreno Ieggero renda difficoltoso il controllo del veicolo a velocità sostenute. Per sperimentare questi effetti, potete programmare una gita in bicicletta (possibilmente non in Corso Buenos Aires a Milano) e, a media velocità, provare a togliere le mani dal manubrio, spostando il vostro corpo sulla sella prima avanti, poi indietro. In questa figura sono evidenziati tre diversi schemi di motore e relativo alloggiamento all’interno della struttura de telaio. Nel disegno A è rappresentata una moto sportiva di concezione moderna, col motore corto ed alto. Questa soluzione consente, a parità di interasse del veicolo, di usare un forcellone più lungo. Notare il triangolo generato dall’unione degli assi dell’albero motore, del primario e del secondario del cambio, come risulta essere compatto. Nel disegno B è rappresentato lo schema, originale, adottato dai tecnici della Benelli, mentre nel disegno C è raffigurato l’ormai noto schema Ducati. Noterete come in quest'ultima posizione la ruota anteriore diventi più instabile e sensibile a ogni minima irregolarità del terreno. Un'altra possibilità per variare la distribuzione dei carichi in un motociclo consiste nell'alzare il retrotreno, sempre che l'ammortizzatore lo permetta, di una decina di mm; questo è il sistema più diffuso ed economico per caricare maggiormente la ruota anteriore e apprezzarne i benefici nella guida sportiva. Se consideriamo il peso di un motociclista medio attorno ai 75 Kg ed il peso (compresi tutti i liquidi) di una moto sportiva di grossa cilindrata attorno ai 220 Kg, è facile calcolare che il rapporto tra i due è di circa 1 a 3, così come è facile comprendere quanto sia fondamentale il modo in cui si posiziona il pilota sul veicolo per la distribuzione dei carichi. Tutti sappiamo quanta attenzione dedichino molti piloti di velocità nel ricercare la posizione di guida ideale lavorando su altezza e avanzamento di pedane, manubri e sella. Sulle moto da Cross, invece, il pilota deve essere libero di effettuare ampi spostamenti sulla sella, in modo da equilibrare con il proprio i, peso, assumendo talvolta posizioni funamboliche, il sistema moto pilota durante salti, impennate e derapate. Se provate a sistemare la vostra moto su due bilance, in modo che gli assi delle ruote risultino ben centrati ai piani dello strumento, potete facilmente verificarne la ripartizione dei pesi e, con l'aiuto di un amico, salire sulla stessa e notare quanto siano sensibili le bilance ad ogni vostro minimo spostamento (ad es. se state sulla moto in posizione eretta oppure in posizione aerodinamica). Schema relativo alla pesata della moto. Dopo avere rilevato contemporaneamente i pesi sulle 2 ruote si può calcolare il peso totale e la ripartizione in percentuale dei carichi. Un altro elemento fondamentale nella distribuzione dei carichi, esaminato sotto un duplice aspetto, è il motore. Considerando sempre una moto sportiva di grossa cilindrata, il peso del motore è circa 1/3 , del peso totale della moto: il suo posizionamento nell'insieme veicolo i risulta perciò essere fortemente determinante. D'altra parte, la forma dello stesso è in grado di facilitare o meno il suo alloggiamento nel telaio Per citare un esempio pratico, prendiamo come riferimento la classica architettura a "L" dei motori Ducati, dove la testa del cilindro orizzontale, già vicinissima alla ruota anteriore, impedisce di fatto l'avanzamento del motore. Ecco perché, per mantenere un interasse accettabile, i tecnici della casa bolognese sono costretti a usare un forcellone che risulta essere il più corto della categoria. I motori sportivi dell'ultima generazione sono invece più compatti nella zona del cambio in modo da mantenere invariato l'interasse, avanzare il motore e allungare quindi il forcellone, con conseguente sul bilanciamento della moto e sul modo di lavorare della sospensione posteriore. Un'ulteriore modalità di intervento in fase progettuale sulla ripartizione dei pesi è quella adottata dai tecnici della Benelli sulla Tornado 900, che spostando il radiatore sotto la sella, hanno liberato la zona precedentemente occupata tra motore e ruota anteriore. Questo consente, pur mantenendo una configurazione "classica" del motore, di avanzare la sua posizione e di allungare il forcellone. Abbiamo finora parlato del peso della moto e della sua distribuzione tra i due assi; occorre ora, per proseguire nella nostra trattazione, introdurre il concetto di baricentro o Centro di Gravità (CG). Il CG è quel punto, presente in ogni corpo, attraverso il quale possiamo considerare concentrata tutta la massa. Per una figura geometrica semplice, la determinazione del CG è abbastanza intuitiva: ad esempio, per trovare il CG della rivista che state leggendo, basta immaginare il punto di intersezione dei segmenti che uniscono i vertici opposti, mentre il CG di una sfera è il centro della stessa. Nel caso di una motocicletta, a calcolo di questo punto misterioso risulta più complicato. D'altra parte, la conoscenza della posizione del CG, sia in lunghezza che in altezza, si rivela fondamentale per la progettazione di un veicolo, in quanto da esso dipende la manovrabilità del mezzo e l'entità del trasferimento di carico. Vediamo come individuare tale punto. Posizionando un dito della mano lungo l’asse passante per il centro di gravità (CG), sarete in grado di sostenere in perfetto equilibrio qualsiasi oggetto. Esistono due metodi per farlo: uno più complicato, ma senza dubbio più preciso e uno molto più semplice da comprendere, ma assolutamente poco pratico. Per semplificare le cose, senza tirare in ballo strane formule, faremo riferimento al secondo. Questo metodo consiste nel sollevare la moto tramite apposite cinghie, come illustrato in figura. Si procede con l'agganciare la moto per il manubrio e, dopo averla sollevata da terra, si provvede a tracciare sulla carenatura, con l'ausilio di un filo a piombo e di un nastro adesivo, il prolungamento della cinghia in modo che esso risulti perpendicolare al terreno. In questo caso è illustrato graficamente che una moto con centro di gravità alto (CGa), nei cambi di traiettoria sfrutta un braccio più lungo rispetto ad una moto con centro di gravità basso (CGb). Questo riduce lo sforzo del pilota richiesto per manovrare il veicolo. Ricordando che il CG è quel punto in cui possiamo considerare concentrata la massa dell'intero veicolo, sappiamo con esattezza che su quell'asse da noi tracciato passa A CG. Poiché un solo asse non è tuttavia sufficiente a individuarne il posizionamento occorre quindi passare a un'operazione successiva che consiste nel sollevare la moto utilizzando un diverso sistema di fissaggio, ad esempio il cerchio anteriore. Ciò consente di tracciare sulla carenatura della moto un'altra linea, prolungamento anch'essa della cinghia, perpendicolare al terreno. Il punto di incrocio delle due linee da noi tracciate rappresenta il CG. Individuata la posizione dei CG, passiamo ora a considerare quali siano i suoi effetti principali sulla dinamica del veicolo. Iniziamo con l'affrontare il problema dei trasferimento di carico in fase di accelerazione. Applicando una forza motrice al punto di contatto tra la ruota posteriore e il terrei-io, si genera un progressivo alleggerimento della ruota anteriore e a un corrispondente aumento di carico sulla ruota posteriore. Il trasferimento di carico è proporzionale alla massa della moto, all'altezza del CG e alla forza motrice applicata. E' viceversa inversamente proporzionale all'interasse. Nei disegni vediamo un metodo empirico per misurare l’altezza del baricentro. In realtà è possibile calcolare tale valore anche attraverso una formula matematica. Vale la pena ricordare, a questo punto, che la condizione di massima accelerazione si ottiene quando il pneumatico riesce a trasferire a terra tutta la potenza disponibile. Posizionando quindi il CG in alto, si aumenta il trasferimento di carico in fase di accelerazione ed il peso sulla ruota posteriore, migliorando così la trazione del veicolo. Non è tuttavia opportuno superare l'altezza limite del CG, altrimenti il trasferimento diventa eccessivo e si verifica la condizione di ribaltamento. Gli stessi concetti valgono per il trasferimento di carico in frenata: in questo caso la forza coinvolta non sarà quella motrice sulla ruota posteriore, ma quella frenante sull'anteriore. Per la guida della nostra moto l'altezza del CG è peraltro determinante nei cambi di direzione; essa, infatti, è in grado di influenzare la rapidità di "piegare la moto". Cerchiamo ora di capirne il motivo: poiché la forza peso si può considerare concentrata nel baricentro, è facile dedurre che più essa è distante dal punto di contatto della ruota con il terreno, maggiore sarà il braccio della forza applicata, così come minore sarà lo sforzo ed il tempo necessario per far "cadere" la moto. Si tratta dello stesso principio per cui se provassimo a flettere il ramo di una pianta aggrappandoci, ovvero applicando ad esso la nostra forza peso, sarebbe più facile riuscire nell'intento tanto più saremo lontani dal tronco. Questo concetto può creare un po' di confusione nei lettori: tutti hanno infatti presente gli sforzi dei tecnici automobilistici per abbassare il più possibile il baricentro delle loro vetture, ma, fortuna loro, le auto non devono "piegare" per curvare. In conclusione, volendo riassumere i concetti sopra elencati, potremmo dire che una moto con interasse corto e baricentro alto risulterebbe agilissima in uno slalom, ma sempre scomposta in frenata ed accelerazione; per contro una moto con interasse lungo e baricentro basso sarebbe stabilissima nelle staccate violente e nelle brusche accelerazioni, ma risulterebbe lenta e pesante nelle curve ad esse Come per qualsiasi altra scelta tecnica, il progettista è sempre costretto a scendere a compromessi, considerando, volta per volta, la tipologia del veicolo, l'uso a cui è destinato e i possibili utenti a cui è rivolto. Antonello Maino
Scarica