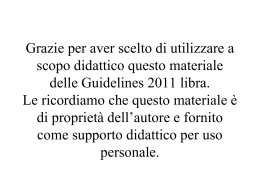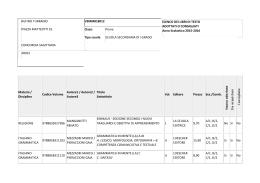a c e t o Bibli e n i l on Classe prima Per divertirsi Bianca Pitzorno Emily Rodda Oscar Wilde Luis Sepúlveda Ascolta il mio cuore, p. 2 Le foreste del silenzio, p. 6 Il fantasma di Canterville, p. 10 Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, p. 13 Vai 왘왘왘 Vai 왘왘왘 Vai 왘왘왘 l l l l Il meraviglioso mago di Oz, p. 15 Pollyanna, p. 20 Piccole donne, p. 24 La freccia nera, p. 29 Vai Vai Vai Vai 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 l l l l l l La fabbrica di cioccolato, p. 32 La fattoria degli animali, p. 34 L’anello di Re Salomone, p. 36 Quando Hitler rubò il coniglio rosa, p. 38 Sotto il burqa, p. 41 Il piccolo principe, p. 44 Vai Vai Vai Vai Vai Vai 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 왘왘왘 l l l l Vai 왘왘왘 Classici da non perdere Lyman Frank Baum Eleanor Hodgman Porter Louisa May Alcott Robert Louis Stevenson Per riflettere Roald Dahl George Orwell Konrad Lorenz Judith Kerr Deborah Ellis Antoine de Saint-Exupéry 2 Biblioteca on line Per divertirsi Bianca Pitzorno Ascolta il mio cuore L’autrice Bianca Pitzorno, nata nel 1942, è una scrittrice italiana. Dopo la laurea insegnò greco e latino in un liceo di Sassari, la sua città; poi si trasferì a Milano, dove iniziò una lunga collaborazione con la RAI nell’ambito delle trasmissioni per bambini e ragazzi; infine, è diventata scrittrice a tempo pieno e attualmente è molto conosciuta e amata, in particolare dai giovani. La sua produzione spazia tra molti generi diversi: ha scritto infatti romanzi storici, di fantascienza, fantastici e polizieschi, guardando sempre con attenzione, delicatezza e umorismo a bambini e ragazzi. Tra i suoi titoli più noti troviamo L’amazzone di Alessandro Magno, la saga di Lorrai, ambientata nella Sardegna degli anni Cinquanta, Tornatràs, Polissena del Porcello, L’incredibile storia di Lavinia, La bambinaia francese e, naturalmente, Ascolta il mio cuore. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Il romanzo Ascolta il mio cuore racconta le vicende di un anno scolastico: la quarta elementare femminile di una scuola sarda, negli anni Cinquanta. La protagonista, Prisca Puntoni, è una ragazzina vivace e fantasiosa, amante della scrittura e dotata di uno spiccato senso della giustizia, che la porta a scontrarsi con la terribile maestra Argia Sforza, esperta di ingiustizie e favoritismi. Prisca non è sola nella battaglia: vicino a lei ci sono Elisa e Rosalba, le sue amiche del cuore, che non esiteranno a rischiare punizioni e castighi pur di sostenere l’intrepida protagonista. Il brano che puoi leggere di seguito descrive l’inizio dell’anno scolastico e mostra le dinamiche di rivalità e amicizie tra compagne e maestra che si svilupperanno nel corso della storia. 1. martingala: cintura fissata posteriormente. «Sei emozionata?» chiese a Elisa la nonna Mariuccia mentre varcavano il cancello ed entravano nel cortile affollato della scuola. «Vedrai che andrà tutto bene». «Tu adesso però vattene!» rispose la nipote, che si vergognava di arrivare a scuola accompagnata come una piccola di prima. «Guarda! C’è Prisca! Vado a raggiungerla». «Vengo anch’io, così saluto la signora Puntoni». Prisca, oltre a non avere il fiocco regolamentare, aveva i ricci bruni spettinati, il colletto bianco di traverso, la martingala1 del grembiule penzoloni su un fianco, e nel brevissimo tratto da casa a scuola aveva trovato il tempo di farsi uno sbaffo d’inchiostro sul naso. 2. tailleur: completo da donna costituito da giacca e gonna fatte con lo stesso tessuto. 3. Kammamuri: insieme a Yanez e a Tremal Naik, citati più avanti, è tra i personaggi principali dei romanzi di Emilio Salgari, imperniati sulle avventure di Sandokan, la Tigre della Malesia. 4. tata: bambinaia. 5. bancata: fila di banchi. Sua madre invece era elegantissima, come al solito, senza un capello fuori posto, il rossetto senza sbavature, i guanti, le scarpe, la borsetta e il cappellino di paglia intonati al tailleur2 di lino rosa. Salutò la nonna Mariuccia e disse in tono di scusa: «Mi creda, signora Maffei, quando è uscita di casa mia figlia non era così in disordine. Ma le bastano pochi minuti per ridursi come una monella di strada. Io non so più cosa fare. Mi vergogno di uscire con lei». «Puoi sempre camminare a due passi di distanza e far finta di non conoscermi», suggerì Prisca. «La sente! Fa anche la spiritosa. Speriamo che questa nuova maestra non sia una mollacciona come la signorina Sole e riesca a metterla in riga». “Speriamo di no”, pensò Elisa. Prisca le piaceva esattamente così com’era. Era la sua amica del cuore e non l’avrebbe cambiata con nessun’altra. Neppure con Rosalba, che era buona, simpatica, affettuosa e fedele, tanto che lo zio Casimiro l’aveva ribattezzata “il fido Kammamuri3”. Prisca naturalmente era Sandokan, ed Elisa aveva esitato a lungo fra Yanez e Tremal Naik, decidendosi infine per quest’ultimo solo a causa della tigre Darma. Quanto a Darma, la parte toccava a Ciccio, il gatto della tata4, che era vecchio e grasso e aveva paura persino delle mosche. Se si fosse trovato davvero nella giungla nera, sarebbe saltato in braccio ad Elisa e si sarebbe rifiutato di scendere. La folla di bambini e genitori le spingeva su per la scalinata di marmo, verso il grande portone. «Su, nonna, vattene adesso!» supplicò Elisa impaziente. «Vado, vado», disse la nonna Mariuccia un po’ offesa. «Me lo racconterai a pranzo com’è questa nuova maestra. E, mi raccomando, al ritorno dritta a casa, senza fermarti a giocare per la strada». La signora Puntoni seguì le due bambine nell’atrio, facendosi strada a fatica tra la calca. Gli scolari galoppavano per i corridoi alla ricerca delle proprie aule, urtandosi, ridendo e chiamandosi a gran voce. «Guarda! C’è Marcella! Ecco Viviana e Fernanda! Ciao, Giulia!» strillava Prisca riconoscendo le compagne degli anni passati. Era bello rivedere le compagne dopo le vacanze. Anche quelle meno simpatiche, come Sveva e Alessandra. Anzi, sembrava che l’estate avesse cancellato tutti i litigi, i dispetti, le rivalità, tutti i difetti delle “nemiche”. Sì, perché fin dalla prima elementare c’era stata guerra tra la bancata5 centrale e quella di destra. Al centro sedevano Prisca, Elisa, Rosalba ed altre bambine loro amiche, tutte brave scolare, ma alcune così vivaci e rumorose che la maestra Sole, con una sfumatura di tenerezza, le chiamava “i miei Maschiacci”, nome che poi era rimasto a indicare tutta la bancata. A destra i banchi erano equamente divisi fra quelle che Prisca e Rosalba avevano battezzato “Gattemorte” e “Leccapiedi”, sempre impegnate, senza distinzione, a formare 3 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per divertirsi Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 4 Biblioteca on line 6. ostentatamente: in modo evidente e sfacciato. gruppi e gruppetti rivali, a darsi delle arie, a rompere i segreti, a fare la spia. Tutte, tranne la terribile Sveva Lopez del Rio, che era troppo superba per ricorrere a questi espedienti, ma in compenso era violenta e prepotente, e sedeva nel primo banco insieme a Emilia Damiani, che era la sua vittima e aveva sempre le braccia blu per i pizzichi e le gomitate. La bancata di sinistra, che non era così omogenea e non aveva capi riconosciuti, di solito si manteneva neutrale ed era perciò denominata “la Conigliera”. Ma nei momenti più accesi della guerra si schierava col centro. Non bisogna credere però che questo soccorso portasse un grande vantaggio alla bancata amica, perché quella di destra poteva contare all’occorrenza su un’alleata ancora più potente nella persona della maestra, ingannata dal comportamento subdolo delle Gattemorte e delle Leccapiedi. La maestra, quella vecchia s’intende, la signorina Sole, non prendeva sul serio le ostilità e le scaramucce tra le sue alunne. Pensava che fossero una cosa normale, e da parte sua si sforzava di essere giusta perché era affezionata a tutte quante. «Sono fortunata», diceva alle colleghe. «Ho una bella classe. Tutte bambine per bene, educate, seguite dalle famiglie. Non mi danno alcun problema». Nonostante qualcuna delle bambine fosse di famiglia molto modesta, come Luisella, ch’era figlia di una sartina a ore, o come Anna, che era figlia del bidello, a mezzogiorno andavano tutte a mangiare a casa, e nessuna frequentava la Refezione offerta agli alunni più poveri dal Patronato Scolastico. Il che per la maestra era un bel vantaggio, perché non doveva fare alcun turno di sorveglianza nel seminterrato rimbombante dalle urla e maleodorante di cattiva cucina. Non c’era da meravigliarsi se la D godeva fama di essere la migliore sezione femminile della scuola, e si diceva in giro che la nuova maestra avesse accettato il trasferimento dalla Ascensione solo a patto di avere quella e non un’altra quarta. Oggi, tra la folla, le alunne della IV D si distinguevano fra tutti gli altri scolari per via del fiocco rosa a pallini celesti. Ma ce n’erano quattro o cinque che, come Prisca, avevano il collo nudo. Molte erano accompagnate come lei dalla madre, e alcune portavano un mazzo di fiori nella mano libera dalla cartella. “Ecco le Leccapiedi che si preparano a corteggiare la nuova maestra”, pensò Prisca, e si rese conto che non era cambiato niente, che l’impressione di pace provata un attimo prima era apparente e illusoria, e che le ostilità stavano per ricominciare. Tanto valeva che fosse lei ad aprire la guerra. «Leccapiedi!» ripeté a voce alta in tono di disprezzo, guardando ostentatamente6 dalla loro parte. Una delle madri la sentì e disse alla figlia: «Che bambina maleducata! Chi è?» Per divertirsi 5 La signora Puntoni arrossì. «Belle figure mi fai fare! Lo sai chi è quella? La moglie del giudice Panaro! Tuo padre ha una causa importantissima con suo marito». Prisca incassò lo scappellotto senza fiatare, perché Ursula la stava guardando e lei non voleva dare a quella Gattamorta la soddisfazione di vederla soffrire. Però, nonostante la sua spavalderia, era emozionatissima. Man mano che si avvicinavano all’aula sentiva il cuore accelerare i suoi battiti. Prese la mano di Elisa e se la poggiò sul petto. Elisa sentì BUM BUM BUM... «Smettila! Lo fai apposta per farmi spaventare», protestò. «Certo che per essere la nipote di un cardiologo sei proprio ignorante», rispose l’amica. «Non ti ricordi che la signorina Sole ci ha spiegato che i movimenti del cuore, come quelli dei polmoni e dello stomaco, sono involontari? Non è possibile farlo apposta». A quel punto arrivò di corsa Rosalba, inseguita da un vecchietto in camice grigio che le teneva la cartella, e che non era suo nonno, come pensavano in molti, ma il magazziniere di suo padre e si chiamava signor Piras. «Ha visto che sono arrivata in tempo?! Se ne vada in negozio, adesso», disse ansimando Rosalba che, come Elisa, detestava farsi vedere accompagnata. Il signor Piras non si fece pregare. Mollò a terra la cartella e girò sui tacchi, perché doveva ancora spazzare il negozio con la segatura prima di sollevare la saracinesca. Le tre amiche si salutarono con entusiasmo, come se fosse un secolo che non si vedevano, e invece erano state insieme a giocare da Elisa solo due giorni prima. Svoltarono l’angolo ed ecco, in fondo al corridoio, sulla porta della loro vecchia aula, la nuova maestra che le aspettava. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino (B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Milano, A. Mondadori, 1991) 6 Biblioteca on line Emily Rodda Le foreste del silenzio L’autrice Jennifer Rowe è una scrittrice australiana nata nel 1948. Scrive romanzi polizieschi – non tradotti in italiano – e libri per ragazzi con lo pseudonimo di Emily Rodda. In Australia ha vinto molti premi letterari, e la sua saga imperniata sul magico mondo di Deltora ha avuto un successo internazionale. “Deltora” è un acronimo, cioè una parola formata con alcune iniziali; in questo caso, si tratta di sette pietre – diamante, smeraldo (emerald in inglese), lapislazzulo, topazio, opale, rubino e ametista – che formano una cintura magica il cui compito è proteggere il regno di Deltora dal malvagio Signore dell’Ombra. La saga si compone di tre cicli: Il magico mondo di Deltora, Ritorno a Deltora e Il segreto di Deltora. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Le foreste del silenzio è il primo romanzo del primo ciclo: rappresenta dunque il punto di partenza indispensabile per chi desidera entrare nel magico mondo di Deltora. Tutto ha inizio quando il re di Deltora muore improvvisamente. Gli succede il figlio Endon, giovanissimo. All’incoronazione assiste Jarred, amico fraterno di Endon, che rimane abbagliato, come tutti i presenti, dalla sfolgorante Cintura di Deltora indossata dal giovane re al momento dell’incoronazione. Jarred non conosce la storia della cintura, ma è certo che custodisca un segreto, ed è ben intenzionato a scoprirlo. Non sa ancora che la sua ricerca sarà molto, molto lunga, perché nel frattempo il malvagio Signore dell’Ombra si prepara a sferrare un attacco decisivo contro Deltora... Il brano che ti presentiamo rappresenta l’inizio del romanzo. 1. gremiva: riempiva. Era mezzanotte. Jarred aspettava, appoggiato a una colonna di marmo, fra la folla che gremiva1 il salone. Quando le urla e le campane l’avevano svegliato, si era vestito in fretta per unirsi ai nobili che affluivano verso la sala principale della reggia. «Il re è morto», mormorava la gente. «E ora incoroneranno il principino». Alton, il sovrano di Deltora, era morto per la febbre misteriosa che già da qualche settimana lo costringeva a letto. Era morto, come sua moglie prima di lui. E adesso... “Adesso sarà Endon il nuovo re”, pensò Jarred, scrollando incredulo il capo. Era amico del principe fin da bambino, nonostante Endon fosse il principe ereditario di Deltora, e lui solo il figlio di un servo, morto quando Jarred aveva appena quattro anni. Era stato assegnato a Endon come compagno di giochi perché il piccolo principe non soffrisse di solitudine, e così erano cresciuti insieme, come fratelli. 2. si forgia: si modella, si plasma. Studiavano insieme e insieme giocavamo tutti i giorni nell’immenso parco. Gli altri bambini della reggia avevano alloggi e porzioni di giardino separate. Era usanza di palazzo che Endon e Jarred non li incontrassero mai, tranne che nel salone durante le feste. Ciò nonostante, i due ragazzi ce la mettevano tutta per divertirsi. Avevano un rifugio segreto, un enorme albero cavo accanto al cancello. Vi si nascondevano per sfuggire al controllo di Min, la governante, esigente e pignola, e per evitare Prandius, il primo consigliere del re, un tipo alto, magro e acido che entrambi i ragazzi detestavano. Si esercitavano al tiro con l’arco, e giocavano a “mira alto”, in cui vinceva chi riusciva a infilare una freccia nella biforcazione più alta dell’albero cavo. Inoltre avevano inventato un codice segreto per passarsi messaggi senza che nessuno se ne accorgesse. Per esempio, quando Jarred si nascondeva nell’albero cavo perché Min voleva fargli bere una buona dose di olio di fegato di merluzzo, Endon passava di là e lasciava cadere un biglietto in un punto che l’amico potesse facilmente raggiungere. Sembravano parole insensate, del tutto incomprensibili agli estranei a cui capitasse in mano il foglietto. Eppure era un codice banale. Per decifrare il messaggio bastava scrivere le lettere tutte in fila, tralasciando gli “el”: NEL ONEL AN ELDAREEL INELCU CIEL NAEL CEMEL INEL. Infine raggruppare le lettere in parole che avessero un senso: NON ANDARE IN CUCINA. C’È MIN. Crescendo, però, Endon e Jarred ebbero sempre meno occasioni per giocare. Le loro giornate erano occupate da compiti più seri. Passavano quasi tutto il tempo a imparare la Regola, cioè le migliaia di leggi e usanze che la famiglia reale doveva rispettare. La Regola governava le loro vite. Endon, paziente e accomodante, e Jarred, più recalcitrante, accettavano che i loro lunghi capelli fossero intrecciati con fili d’oro, e passavano ore a imparare come si forgia2 il metallo in spade e scudi. Il primo re di Deltora era stato fabbro, e la Regola imponeva il rispetto della tradizione. Nel pomeriggio potevano godere di un’ora di ricreazione, durante la quale gli unici divieti erano scalare il muraglione che circondava il parco e uscire dal cancello che dava sulla città. Il principe di Deltora non poteva mischiarsi alla gente comune, come non potevano farlo il re e la regina. Era uno degli articoli più importanti della Regola, un obbligo che ogni tanto Jarred era tentato di infrangere. E ogni volta Endon lo implorava di non scavalcare il muro. «È proibito», ripeteva. «Jarred, lo sai... già Prandius sospetta che tu 7 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per divertirsi Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 8 Biblioteca on line 3. drappo: tessuto pregiato. 4. teca: contenitore, custodia. abbia un’influenza negativa su di me. L’ha detto anche a mio padre. Se infrangi la Regola ti manderanno via. E io non voglio». Jarred non voleva andarsene. Endon gli sarebbe mancato tantissimo. E poi, dove avrebbe potuto andare, fuori dal palazzo? Lo squillo delle trombe di cristallo interruppe il filo dei suoi pensieri. Si girò, come tutti, verso il fondo del salone. Endon stava entrando tra due file di guardie che indossavano le classiche uniformi azzurre bordate d’oro. “Endon”, pensò Jarred, “quanto deve soffrire per la morte del padre”. Avrebbe voluto stare al fianco dell’amico per consolarlo, ma non l’avevano nemmeno convocato. Al suo posto, alla destra di Endon, c’era il primo consigliere Prandius. Jarred lo guardò disgustato. Sembrava ancora più alto e magro del solito. Portava una lunga tunica viola e reggeva una scatola coperta da un drappo dorato, la testa protesa in avanti, come un rapace a caccia di prede. Lo sguardo di Endon era velato di tristezza. Era così piccolo e pallido, con quella giacca d’argento e quello scomodo colletto tempestato di pietre preziose... Era tutta la vita che si preparava a quel momento. «Quando io morirò, tu diventerai re, figlio mio», gli aveva ripetuto tante volte suo padre. «Dovrai dimostrarti all’altezza». «Lo farò, padre», gli aveva sempre risposto Endon, ubbidiente e rispettoso. «Farò quel che devo, quando verrà il momento». Nessuno immaginava che quel momento sarebbe giunto tanto presto. Il re era così forte e sano che sembrava poter vivere in eterno. Endon stava salendo i gradini del palco. Una volta arrivato, si girò verso il mare di occhi che lo scrutava. «Com’è giovane», sussurrò alla vicina una donna in piedi accanto a Jarred. Le trombe di cristallo squillarono di nuovo e un brusio eccitato si diffuse fra la folla. Prandius posò la scatola accanto al trono, tolse il drappo3 dorato che copriva la teca4 di vetro e ne estrasse un oggetto splendente. Era la magica Cintura di Deltora. Dalla folla si levò un oooh di stupore, e Jarred rimase senza fiato. Sapeva da sempre dell’esistenza della Cintura, ma non l’aveva mai vista. Eccolo lì, in tutta la sua misteriosa bellezza, l’antico talismano che da migliaia di anni proteggeva Deltora dall’invasione del malvagio Signore dell’Ombra, che regnava al di là delle Montagne. Appesa alle dita scheletriche di Prandius, la Cintura appariva delicata come un merletto, e le Sette Pietre scintillavano sotto la luce. Jarred sapeva che era fatta con l’acciaio più robusto e che ogni pietra aveva un ruolo speciale nel proteggere Deltora. C’erano il topazio, simbolo della fedeltà, dorato come il sole al tramonto, e l’ametista, simbolo della verità, color delle viole che cresce- vano sulle sponde del fiume Del. Per la purezza e la forza c’era il diamante, limpido e lucente come il ghiaccio, per l’onore lo smeraldo, verde come l’erba alta, poi il lapislazzuli, pietra celestiale, blu come il cielo notturno con punti luminosi come le stelle, il rubino, rosso come il sangue, per la felicità, e l’opale, simbolo della speranza, luminescente di tutti i colori dell’arcobaleno. La folla parve trattenere il respiro mentre Prandius si chinava per cingere la vita di Endon con la Cintura. Sembrava impaurito. Jarred si chiese il motivo di quel timore. La fibbia si chiuse di scatto, e la sua domanda trovò risposta. Prandius spiccò un balzo all’indietro. Si udì un rumore secco, poi la Cintura parve esplodere di luce. Le gemme brillavano come tanti fuochi, illuminando il salone. Dalla folla si levò un grido e tutti distolsero lo sguardo, schermandosi gli occhi. Endon rimase con le braccia in alto, nascosto dal lampo accecante che scaturiva dal magico gioiello. Non era più il ragazzetto gli occhi tristi. La Cintura l’aveva riconosciuto come il vero erede del trono di Deltora. I fuochi delle gemme si estinsero lentamente. Il giovane re restituì la Cintura a Prandius, che la ripose nella teca di vetro, con il sorriso sottile. Jarred sapeva cosa sarebbe successo di lì a poco. La Regola stabiliva che la Cintura fosse riportata nella stanza più alta della torre, la cui porta sarebbe stata chiusa con tre lucchetti d’oro e presidiata da tre guardie in uniforme. E poi... poi la vita sarebbe ricominciata come prima. Prandius e gli altri funzionari avrebbero preso ogni decisione. Il re avrebbe presenziato alle cerimonie e ai banchetti e si sarebbe esercitato nel tiro con l’arco. Sarebbe rimasto seduto immobile per ore mentre gli intrecciavano i capelli, e un giorno anche la barba. Avrebbe firmato infiniti documenti imprimendo il sigillo reale con il suo anello. Avrebbe seguito la Regola, in tutto e per tutto. Nel giro di qualche anno avrebbe sposato una fanciulla scelta per lui da Prandius. Avrebbero avuto un bambino destinato a prendere il posto di Endon alla sua morte. E quel bambino avrebbe indossato la Cintura una volta soltanto, prima che venisse di nuovo riposta sotto chiave. Per la prima volta in vita sua Jarred si chiese se tutto ciò fosse giusto, per la prima volta si domandò perché fosse stata realizzata la Cintura e dubitò che fosse sensato tenerla rinchiusa in una torre, mentre il regno che doveva proteggere restava fuori, irraggiungibile. Inosservato, scivolò fuori dal salone e salì di corsa le scale che portavano alla biblioteca. Era la prima volta che ci andava. Studiare non gli era mai piaciuto. Ma aveva bisogno di informazioni e quello era l’unico posto dove poteva trovarle. (Emily Rodda, Le foreste del silenzio, trad. it. G. Carlotti, Casale Monferrato, Piemme, 2001) 9 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per divertirsi 10 Biblioteca on line Oscar Wilde Il fantasma di Canterville L’autore Oscar Wilde (1854-1900), irlandese nato a Dublino, fu uno dei protagonisti della vita culturale e mondana dell’Inghilterra del suo tempo. Elogiato e ammirato per i suoi scritti, per le sue brillanti commedie e per il suo stile di vita raffinato, venne poi abbandonato da ammiratori e amici quando la sua relazione con il giovane aristocratico Alfred Douglas diventò di pubblico dominio. Processato e condannato per omosessualità, Wilde scontò due anni di lavori forzati e morì di lì a poco, solo e in miseria. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Il fantasma di Canterville è una parodia, cioè una presa in giro delle classiche storie del terrore. La vicenda è ambientata in un antico castello inglese abitato da un fantasma spaventoso, vecchio di parecchi secoli. Il castello viene acquistato dal signor Otis, un ricco americano che vi si trasferisce con tutta la famiglia: moglie e quattro figli, tra i quali due terribili gemelli esperti di scherzi e tranelli. Così, il tranquillo tran tran del fantasma, fatto di terrificanti apparizioni e rumore di catene, viene sconvolto per sempre. Il brano che ti presentiamo è un divertente esempio di come i nuovi arrivati comincino sin dalla loro prima notte nel castello a tormentare il povero fantasma. 1. Fanny Davenport: celebre attrice statunitense di origini inglesi (1850-98). 2. Sarah Bernhardt: attrice teatrale francese (18441923), considerata una delle più grandi attrici dell’Ottocento. 3. sorgo: un cereale. Il giorno era stato caldo e soleggiato e quando, verso sera, l’aria rinfrescò, la famiglia Otis uscì in massa per una scarrozzata. Non rincasarono che alle nove, e consumarono un pasto leggero. Durante la conversazione non fu fatto il benché minimo accenno a spettri e fantasmi, di modo che mancavano anche quelle condizioni primarie di attesa ricettiva che spesso precedono il verificarsi di fenomeni psichici. Come mi narrò in seguito il signor Otis, il discorso cadde su quegli argomenti che formano di solito il nocciolo della conversazione tra gli americani colti delle classi superiori, come ad esempio l’enorme superiorità, quale attrice, della signorina Fanny Davenport1 al confronto di Sarah Bernhardt2; la difficoltà di trovare granturco acerbo, focacce di sorgo3 e pannocchie bollite nel latte anche nelle migliori case inglesi; l’importanza di Boston sullo sviluppo dell’anima universale; i vantaggi del bagaglio assicurato nei viaggi per ferrovia, e la dolcezza dell’accento di New York in paragone alla pronuncia strascicata dei londinesi. Non si parlò neppur lontanamente di cose soprannaturali e tanto meno fu fatta alcuna allusione a sir Simon de Canterville. Alle undici la famiglia si ritirò e alle undici e mezzo tutte le luci erano già spente. Poco tempo dopo il signor Otis venne però risvegliato da un curioso rumore che proveniva dal corridoio, proprio davanti all’uscio di camera sua. Risuonava come uno stridor di metallo che pareva farsi sempre più vicino a ogni istante. Il ministro si alzò senza indugi, accese un fiammifero e guardò l’o- 4. esangue: pallida. 5. foggia: stile. 6. ad hoc: apposite, adatte all’argomento. rologio. Era l’una esatta. Si sentiva calmissimo, e si tastò il polso per accertarsi di non essere febbricitante. Lo strano rumore continuava, accompagnato ora da un distinto strascicare di passi. Il ministro s’infilò le pantofole, tolse dal cassetto del tavolino da notte una minuscola fiala di forma oblunga, e aprì la porta. Diritto dinnanzi a sé vide ergersi, nell’esangue4 luce lunare, un uomo dall’aspetto spaventoso. Aveva gli occhi rossi come due carboni ardenti, lunghi capelli grigi gli ricadevano per le spalle in ciocche incolte, e le vesti, di foggia5 antica, erano tutte lacere e imbrattate; dai polsi e dalle caviglie, infine, gli pendevano pesanti manette e rugginosi ceppi. «Egregio signore», incominciò il signor Otis, «sono costretto a pregarla di oliare un po’ come si deve quelle sue catene, e le ho portato a questo scopo una bottiglietta di Lubrificante Solare Tammany. Me lo hanno garantito efficacissimo sin dalla prima applicazione, e potrà leggere parecchie testimonianze ad hoc6, riportate sul foglietto di propaganda, da parte di alcuni tra i nostri più eminenti teologi. Glielo lascio qui per suo uso accanto alle candele della camera da letto, e sarò felicissimo di fornirgliene dell’altro, qualora ne avesse bisogno». Con queste parole il ministro degli Stati Uniti posò la bottiglietta su un tavolo di marmo, chiuse la porta e si ritirò a riposare. Per un attimo il fantasma di Canterville rimase letteralmente paralizzato dallo sdegno; quindi, dopo aver gettato con violenza la fiala sul lucido pavimento, svolazzò per il corridoio gemendo cupamente ed emanando una verde luce spettrale. Ma proprio nel momento in cui giungeva al sommo della grande scalinata di quercia, ecco che un uscio si spalancò lasciando intravvedere sulla soglia due figurette biancovestite, e un grosso guanciale passò sibilando a un pelo della sua testa. Non c’era evidentemente tempo da perdere; perciò adottando in tutta fretta la quarta dimensione come unica via di scampo, lo spettro svanì attraverso il rivestimento di legno della parete, restituendo alla casa quiete e silenzio. Come ebbe raggiunta una piccola stanza segreta, nell’ala sinistra del castello, si appoggiò a un raggio di luna onde riprender fiato e incominciò a riflettere sulla propria situazione. Mai, mai, nella sua brillante e ininterrotta carriera tricentenaria, egli era stato così grossolanamente insultato. Ripensò alla vecchia duchessa da lui spaventata al punto di farla cadere in un attacco isterico, mentre si ammirava davanti allo specchio nei suoi pizzi e nei suoi diamanti; pensò alle quattro cameriere che egli aveva fatto uscire di senno, semplicemente sghignazzando alle loro spalle da dietro alle tendine del guardaroba; ripensò al Rettore della parrocchia al quale aveva spento la candela una notte che usciva tardi dalla biblioteca, e che da quella volta aveva dovuto essere affidato alle cure di sir William Gull, divenuto com’era un misero essere, sempre in preda a turbe nervose gravissime. E che dire della vecchia signora de Trémouillac la quale, essendosi svegliata presto un mattino e avendo veduto uno scheletro seduto in poltrona accanto al caminet- 11 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per divertirsi 12 Biblioteca on line 7. da tregenda: allucinante, spaventosa. 8. egotismo: tendenza a parlare molto di sé e a sopravvalutarsi. to, intento a leggere il suo diario, era stata costretta a letto per ben sei settimane da un attacco di febbre cerebrale, e non appena ristabilita si era riconciliata con la Chiesa e aveva rotto ogni rapporto con quel noto scettico che era il signor de Voltaire. Ripensò alla notte da tregenda7 in cui il malvagio lord Canterville fu trovato rantolante nel proprio spogliatoio, con il fante di quadri mezzo infilato nella gola, e confessò sul punto di morire di aver sottratto a Charles James Fox 50.000 sterline al Casinò di Crockford, precisamente grazie a quella carta, e giurò che era stato il fantasma a fargliela ingoiare. Tutte le sue grandi imprese gli tornarono alla mente, dal maggiordomo che si era ucciso nella dispensa con un colpo di pistola per aver veduto una mano verde battere contro i vetri della finestra, alla bellissima lady Stutfield, costretta a portare sempre annodato al collo un nastro di velluto nero per nascondervi l’impronta che cinque dita di fuoco le avevano lasciato sulla pelle candida, e che alla fine si era annegata nello stagno delle carpe, in fondo al Viale del Re. Con l’egotismo8 entusiastico dell’artista nato, riandò col pensiero alle sue trasformazioni più famose e sorrise amaramente tra sé, rammentando la sua ultima apparizione sotto le spoglie di “Ruben il Rosso”, ovvero “L’Infante Strangolato”, il suo debut nella personificazione di “Gibeone l’allampanato”, e il furore che aveva suscitato in una languida sera di giugno limitandosi a giocare a birilli con le proprie ossa sul terreno del campo di tennis. Ebbene, dopo tutte queste gesta, dovevano venire quattro miserabili americani moderni a offrirgli del Lubrificante Solare e a buttargli dei cuscini in testa! Era una situazione assolutamente insopportabile. D’altronde nessun fantasma mai, nel corso della storia, era stato trattato a quel modo. Decise pertanto di vendicarsi adeguatamente, e rimase immerso sino allo spuntare del giorno in un atteggiamento di profonda meditazione. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino (O. Wilde, Il fantasma di Canterville, in Racconti, trad. it. M. Gallone, Milano, Rizzoli, 1982) Per divertirsi 13 Luis Sepúlveda Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare L’autore Luis Sepúlveda, nato nel 1949, è uno scrittore cileno. Fin da giovanissimo ha unito la passione per la letteratura e per la scrittura a un impegno politico pagato a caro prezzo: durante la dittatura militare del generale Pinochet, infatti, è stato imprigionato, torturato e condannato a morte, condanna poi commutata in esilio. Trasferitosi in Europa, ha unito l’attività di giornalista a quella di sostenitore dell’organizzazione ambientalista Greenpeace. Tra i suoi romanzi, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Incontro d’amore in un paese in guerra, Il potere dei sogni, La lampada di Aladino e altri racconti per vincere l’oblio. Il romanzo Il gatto nero grande e grosso prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì, a pancia all’aria sotto quei raggi tiepidi, con tutte e quattro le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone. Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali. «Non è stato un atterraggio molto elegante», miagolò. «Mi dispiace. Non ho potuto evitarlo», ammise la gabbiana. «Senti, sembri ridotta malissimo. Cos’è quella roba che hai addosso? E come puzzi!» miagolò Zorba. «Sono stata raggiunta da un’onda nera. Dalla peste nera. La maledizione dei mari. Morirò», stridette accorata la gabbiana. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è una fiaba moderna ambientata ad Amburgo. Protagonisti sono alcuni animali, tra cui una gabbianella che deve imparare a volare, un gatto che dovrebbe farle da maestro, e un poeta sognatore. Durante un volo sull’oceano la gabbiana Kengah finisce su una grande macchia di petrolio, da cui riesce a liberarsi a stento. Appesantita dalla sostanza, compie un ultimo disperato volo alla ricerca di un approdo e finisce su un balcone, dove Zorba, un grosso gatto nero, sta prendendo il sole. Il gatto comprende subito che la gabbiana ha poche speranze, e tuttavia non immagina ancora quale promessa stravagante lei stia per strappargli... Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 14 Biblioteca on line «Morire? Non dire così. Sei solo stanca e sporca. Tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano e là hanno veterinari che potranno aiutarti», miagolò Zorba. «Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo», stridette la gabbiana con voce quasi impercettibile e chiuse gli occhi. «Non morire! Riposati un po’ e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un po’ del mio cibo, ma non morire», pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva anche un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo notò che la respirazione dell’uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando in direzione dell’ippocastano quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Vuoi che ti lasci un po’ del mio cibo?» suggerì, leggermente sollevato. «Voglio deporre un uovo. Con le ultime forze che mi restano voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi tre promesse. Mi accontenterai?» stridette agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. «Ti prometto tutto quello che vuoi. Ma ora riposa», miagolò impietosito. «Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l’uovo», stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mi mangerò l’uovo», ripeté Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo», stridette sollevando il capo. «Prometto che avrò cura dell’uovo finché non sarà nato il piccolo». «E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. «Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca di aiuto», miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto. Kengah guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l’avevano accompagnata e, proprio mentre esalava l’ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio. (L. Sepúlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, trad. it. I. Carmignani, Milano, Salani, 1996) Classici da non perdere 15 Classici da non perdere Lyman Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz L’autore Lyman Frank Baum (1856-1919) nacque nello stato di New York. Dopo un’infanzia dorata passata nella grande villa di famiglia, frequentò per due anni un’accademia militare, dimostrando di non avere alcuna propensione per le armi e per la rigida disciplina di quegli ambienti. Tornato a casa, si dedicò alle sue grandi passioni: la scrittura e il teatro. Dalla prima ebbe notevoli soddisfazioni, legate soprattutto all’enorme successo del romanzo Il meraviglioso mago di Oz (1900), cui seguirono altre storie ambientate nello stesso fantastico mondo. Con il teatro fu meno fortunato, tanto che più volte, nel corso della vita, si trovò sull’orlo della bancarotta per aver finanziato spettacoli fallimentari; dovette perfino vendere i diritti del Mago di Oz per poter pagare tutti i debiti. Il meraviglioso mago di Oz ottenne da subito grande successo, diventando in breve un vero bestseller tradotto in 50 lingue. Fu lo stesso autore, nel 1902, a curarne una prima riduzione per il teatro, cui ne seguirono molte altre. Nel 1939 Il mago di Oz divenne un musical cinematografico, con la diva Judy Garland nella parte della protagonista. La storia inizia in una povera fattoria del Kansas, dove la piccola Dorothy vive insieme con gli zii. Un giorno si scatena una violenta tempesta. Dorothy e il cagnolino Toto non fanno in tempo a rifugiarsi in cantina, sicché restano in casa proprio nel momento in cui un ciclone la solleva dal suolo, trasportandola sempre più in alto. Mentre Toto, impazzito dalla paura, abbaia furiosamente, Dorothy resta stranamente tranquilla, sentendosi cullata dal vento come da una mano gentile: infine si addormenta nel suo lettino, finché un sobbalzo improvviso la avverte che, finalmente, il volo è terminato. La casa è atterrata da qualche parte, ma dove? Ben presto, Dorothy scopre di essere arrivata nel posto più strano del mondo... già, ma quale mondo? È l’inizio di un’avventura che porterà Dorothy a percorrere in lungo e in largo il mondo incantato di Oz, dove sono in agguato molti pericoli, ma dove esistono anche amici sinceri. Dorothy si svegliò per un colpo così forte e improvviso che, se non fosse stata sdraiata sul suo lettino morbido, avrebbe potuto farsi male. Per fortuna, invece, non fece altro che trattenere il respiro per la paura e si chiese cosa mai fosse accaduto, mentre Toto le strofinava sul viso il suo musetto umido lamentandosi penosamente. Dorothy si alzò e si Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 16 Biblioteca on line 1. strambe: strane. 2. bizzarramente: in modo stravagante, originale. 3. falda: la parte sporgente del cappello. accorse che la casa non si muoveva più e non era neanche più buio perché il sole brillava attraverso la finestra inondando la stanza di luce. Dorothy balzò dal letto e, con Toto alle calcagna, corse ad aprire la porta. Allora la bambina diede un grido di stupore e si guardò attorno, con gli occhi spalancati alla vista di tante meraviglie. L’uragano aveva deposto la casetta – che pensiero gentile per un uragano! – in mezzo a un paese di straordinaria bellezza. C’erano delle belle aiuole verdi con alberi giganteschi carichi di frutti deliziosamente profumati. Da ogni parte spiccavano macchie di fiori rigogliosi, e uccelli rari dalle penne variopinte cantavano e svolazzavano sugli alberi e sui cespugli. Poco più in là un ruscelletto scorreva scintillando tra le sue verdi sponde con un gorgoglio armonioso che giungeva molto gradito all’orecchio della piccola Dorothy, vissuta tanto tempo sulle aride e grigie praterie del Kansas. Mentre fissava intenta queste cose strane e meravigliose, vide venire alla sua volta un gruppo delle più strambe1 persone che avesse mai immaginato. Quella gente non era alta come tutte le altre persone grandi, ma non era nemmeno molto piccola. Insomma aveva press’a poco la statura di Dorothy, benché, a giudicare dall’aspetto, dimostrasse molti anni più di lei. Erano tre uomini e una donna, tutti bizzarramente2 vestiti. Portavano cappelli a pan di zucchero, alti due spanne più della testa, con tanti campanellini appesi tutt’attorno alla falda3 che tintinnavano dolcemente quando si muovevano. I cappelli degli uomini erano azzurri e quello della donnina era bianco; bianco era pure il manto che le ricadeva a piegoni giù dalle spalle, e tutto cosparso di stelle che rilucevano al sole come brillanti. Gli ometti erano vestiti di azzurro, lo stesso colore dei cappelli, e portavano stivali lucidissimi con le punte rivolte all’insù. Dorothy pensò che dovevano avere press’a poco la stessa età dello zio Enrico, dato che due di loro avevano la barba. Ma senza dubbio la donnina era molto più vecchia: aveva il viso coperto di rughe, i capelli bianchi come l’argento e l’andatura piuttosto rigida. Avvicinandosi alla soglia della casa di Dorothy, si fermarono bisbigliando fra loro qualcosa, quasi avessero paura di farsi avanti. Soltanto la vecchietta si accostò alla bambina inchinandosi profondamente dinanzi a lei. «Sii benvenuta, fata nobilissima», disse con voce dolce, «nel paese dei Succhialimoni. Noi ti siamo infinitamente grati per aver ucciso la Perfida Strega dell’Est e per aver liberato il nostro popolo dalla schiavitù». Dorothy ascoltava a bocca aperta questo discorso. Che diavolo voleva intendere la donnina chiamandola fata e dicendole che aveva ucciso la Perfida Strega dell’Est? Dorothy era una bambina ingenua e innocente che un ciclone aveva portato molte miglia lontano da casa, e che non aveva mai ucciso nessuno in vita sua. Ma era evidente che la donnina aspettava da lei una risposta, e allora Dorothy disse esitando: «Tu sei molto gentile, ma temo che sia un errore. Io non ho ucciso nessuno». «Ma la tua casa sì», ribatté la donnina ridendo, «che è poi lo stesso. Guarda!» continuò, indicando l’angolo della casa. «Non vedi che i piedi le spuntano ancora sotto quel pezzo di legno?» Dorothy guardò e diede in un piccolo grido di spavento. In realtà, sotto l’angolo del grosso trave su cui poggiava la casa, spuntavano due piedi calzati di scarpe d’argento appuntite. «Oh poveri noi!» esclamò Dorothy giungendo le mani con fare disperato. «Ma allora la casa le è caduta sopra! Cosa facciamo adesso?» «Non c’è nulla da fare», rispose calma la donnina. «Ma chi era?» tornò a chiedere Dorothy. «Ti ho già detto che era la Perfida Strega dell’Est», rispose la donnina. «È lei che ha tenuto i Succhialimoni sotto il suo potere per molti anni, obbligandoli a lavorare come schiavi per lei, notte e giorno. Ora il popolo è liberato, e ti è grato per la grazia che gli hai concesso». «Ma chi sono i Succhialimoni?» domandò Dorothy. «La gente che vive in questo paese dell’Est, dove regnava la Perfida Strega». «E tu, sei una Succhialimoni anche tu?» chiese la bimba. «No, ma sono loro amica, benché io abiti nel paese del Nord. Quando videro che la Strega dell’Est era morta, i Succhialimoni mi inviarono un messaggero volante, e io accorsi subito. Io sono la Strega del Nord». «Oh, mio Dio!» esclamò Dorothy spaventata. «Sei una vera Strega?» «Ma certo», rispose la donnina. «Ma io sono una strega buona e tutti mi vogliono bene. Però io non sono potente come la Perfida Strega che governava questo paese, altrimenti avrei liberato io questa gente». «Ma io credevo che tutte le Streghe fossero cattive», disse Dorothy un po’ atterrita all’idea di trovarsi faccia a faccia con una vera e propria strega. «Ah, no, questo è un grande errore. C’erano soltanto quattro streghe in tutto il regno di Oz e due di loro, quelle che vivono nel Nord e nel Sud, sono streghe buone, cioè fate. E questo è certamente vero, perché io sono proprio una di loro e non posso sbagliarmi. Invece quelle che vivevano nell’Est e nell’Ovest erano, è vero, streghe cattive; ma adesso che tu ne hai uccisa una, in tutto il regno di Oz non resta più che un’unica strega malvagia, la Strega dell’Ovest». «Ma», obiettò Dorothy dopo un momento di riflessione, «la zia Emma mi ha detto che le Streghe sono morte tutte, tanti e tanti anni fa». «Chi è la zia Emma?» domandò la donnina. «È la mia zia che vive nel Kansas, il mio paese». La Strega del Nord sembrò riflettere un momento col capo chino e gli occhi fissi al suolo. Ma poi sollevò lo sguardo e disse: «Io non so dove 17 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Classici da non perdere Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 18 Biblioteca on line sia il Kansas, perché mai prima di adesso ne ho sentito parlare. Ma dimmi, è un paese civile?» «Certo!» rispose Dorothy. «Allora mi spiego. Credo infatti che nei paesi civili non ci siano più streghe, né stregoni, né maghi, né fate. Ma, vedi, il regno di Oz non ha mai potuto diventar civile, perché noi siamo tagliati fuori da tutto il resto del mondo. Per questo ci sono ancora streghe e maghi qui da noi». «Quali sono i maghi?» chiese Dorothy. «Oz in persona è il Grande Mago», rispose la strega, abbassando il tono della sua voce a un bisbiglio. «È più potente di tutte noi altre messe insieme. E abita nella Città degli Smeraldi». Dorothy stava per fare un’altra domanda, quando i Succhialimoni, rimasti zitti ad ascoltare fino a quel momento, emisero un altro grido indicando l’angolo della casa dove giaceva prima la strega. «Che c’è?» domandò la vecchietta. Poi guardò anche lei e si mise a ridere. I piedi della strega morta erano scomparsi completamente e non erano rimaste che le scarpette d’argento. «Era così vecchia», spiegò la Strega del Nord, «che il sole ha impiegato poco tempo a disseccarla completamente. Così è finita anche lei. Ma le scarpette d’argento sono tue, e tu dovrai portarle». Si chinò a raccattare le scarpe che porse a Dorothy, dopo averne scosso la polvere. «La Strega dell’Est era orgogliosa di quelle pantofoline d’argento», disse uno dei Succhialimoni, «e si tratta certo di pantofoline incantate, ma quale sia il loro incantesimo non siamo mai riusciti a saperlo». Dorothy portò le scarpette in casa e le mise sul tavolo. Poi tornò fuori dai Succhialimoni e disse loro: «Io voglio tornare dai miei zii perché sono sicura che stanno in pena per me. Potete aiutarmi a trovare la strada?» I Succhialimoni e la Strega si guardarono dapprima fra di loro, poi guardarono la bimba e infine scossero tutti il capo. «Nell’Est, non molto lontano da qui», disse uno di loro, «c’è un grande deserto e nessuno al mondo sarebbe in grado di attraversarlo». «Lo stesso è al Sud», disse un altro. «Io ci sono stato e l’ho veduto. Il Sud è il Paese dei Gingillini». «Mi risulta», intervenne il terzo omino, «che lo stesso è all’Ovest. E quel paese, abitato dai Martufi, è governato dalla perfida Strega dell’Ovest che ti farebbe sua schiava se tu mettessi piede nel suo territorio». «Quanto al Nord, è il mio paese», disse la vecchietta, «ed esso confina con lo stesso sterminato deserto che circonda il regno di Oz. Temo, cara, che dovrai restare con noi per sempre». Dorothy a quelle parole si mise a singhiozzare, perché si sentiva sola in mezzo a tutte quelle strane persone. Forse le sue lacrime intenerirono i cuori dei bravi Succhialimoni, perché anche loro estrassero i loro fazzolettini e cominciarono a piangere. La donnina, invece, si tolse il cappello a cono e ne tenne in equilibrio la punta sul suo naso, mentre con voce solenne contava: «Uno, due, tre». D’un tratto il cappello si trasformò in un pezzo d’ardesia che portava scritto a grandi caratteri bianchi, tracciati col gesso: «CHE DOROTHY VADA ALLA CITTÀ DEGLI SMERALDI». La vecchietta si tolse il cappello dal naso e, dopo averne lette le parole, chiese: «Ti chiami Dorothy, cara?» «Sì», rispose la bambina levando lo sguardo verso di lei e asciugandosi gli occhi. «Allora devi andare nella Città degli Smeraldi. Forse il mago di Oz ti aiuterà». «Dove si trova questa città?» domandò la bimba. «Esattamente nel centro del regno, ed è governata da Oz, il Grande Mago di cui ti ho parlato». «È buono?» interrogò ansiosa Dorothy. «Sì, è un buon mago; ma non posso dirti se sia un uomo o no perché non l’ho mai veduto». «Come posso arrivare fin là?» chiese nuovamente la bambina. «Devi andare a piedi. È un viaggio molto lungo, attraverso un paese a volte bellissimo, a volte oscuro e terribile. Ma io farò uso di tutte le magie che conosco per tenerti lontana dai pericoli». «Non vuoi venire con me?» supplicò Dorothy, che cominciava a considerare la vecchietta la sua unica amica. «No, non posso», rispose quella. «Ma ti darò un bacio, e nessuno oserà far del male a chi è stato baciato dalla Strega del Nord». Si avvicinò a Dorothy e la baciò delicatamente sulla fronte: nel punto in cui le sue labbra l’avevano sfiorata rimase un’impronta rotonda e splendente, e presto anche Dorothy se ne accorse. «La strada per giungere alla Città degli Smeraldi è pavimentata di mattoni gialli», disse la Strega, «così non puoi sbagliare. Quando arriverai dal Mago, non avere paura di lui, ma raccontagli la tua storia e chiedigli di aiutarti. Addio, cara». I tre Succhialimoni le fecero un profondo inchino augurandole buon viaggio; dopo di che si incamminarono nel bosco. La Strega fece un’affettuosa carezza alla piccola Dorothy, girò tre volte sul tallone sinistro e sparì improvvisamente, con grande sorpresa del piccolo Toto che le abbaiò dietro furiosamente vedendola dileguare. Ma Dorothy, che sapeva con chi aveva a che fare, non si sorprese affatto di quella sparizione. (L. F. Baum, Il mago di Oz, trad. it. N. Agosti Castellani, Milano, RCS, 1978) 19 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Classici da non perdere 20 Biblioteca on line Eleanor Hodgman Porter Pollyanna L’autrice Eleanor Hodgman Porter fu una scrittrice statunitense (1868-1920). Nata nel New Hampshire (nel nord-est degli USA), da ragazza studiò canto, ma in seguito decise di dedicarsi alla letteratura per ragazzi. Scrisse numerosi romanzi, tra cui i celebri Pollyanna e Pollyanna cresce. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Pollyanna, romanzo uscito nel 1913, narra la storia di una ragazzina di undici anni, Pollyanna, che dopo essere rimasta orfana viene accolta dalla zia materna, l’inflessibile Miss Polly Harrington, assai poco lieta di dover rivestire i panni della tutrice. L’arrivo di Pollyanna porta un discreto scompiglio nell’ordinato tran-tran di casa Harrington e, più in generale, in tutto il villaggio. Pollyanna, infatti, è vivace e chiacchierona, ama conoscere le persone e, se può, rendersi utile agli altri. Così, senza volerlo, la ragazzina viene a conoscenza di antichi segreti che tutti, e in particolare Miss Polly, avrebbero voluto seppellire per sempre... Il romanzo comincia così. Quella mattina di giugno, quando entrò in cucina Miss Polly Harrington dava l’impressione d’avere fretta. Di solito i suoi movimenti non erano mai precipitosi; anzi, il suo vanto maggiore era di conservare in ogni occasione la calma. Oggi, invece, Miss Polly aveva davvero fretta. Nancy, che in quel momento era all’acquaio, la guardò sorpresa; anche se era al suo servizio soltanto da due mesi aveva già capito che Miss Polly non era solita affrettarsi. «Nancy!» «Sì, signora», rispose Nancy di buon umore, sempre continuando ad asciugare la brocca che aveva in mano. «Nancy», la voce di Miss Polly si era fatta dura. «Quando ti rivolgo la parola, desidero che tu smetta quel che stai facendo e che presti attenzione a quanto ti dico». Nancy arrossì; posò immediatamente la brocca e l’asciugapiatti accanto ad essa, e per poco non la rovesciava: ciò che la mise ancora più a disagio. «Sì, signora; ho capito, signora», farfugliò, riprendendo in mano la brocca e girandosi in fretta. «Cercavo di sbrigarmi perché stamattina mi aveva detto di non metter troppo tempo a riordinare la cucina». Miss Polly si fece ancora più severa. «Basta, Nancy. Non ti ho chiesto spiegazioni; voglio solo che tu stia ad ascoltarmi». «Sì, signora». Nancy represse un sospiro, chiedendosi se sarebbe mai riuscita ad accontentarla in qualche modo. Nancy non era mai stata a servizio, ma la malattia della madre, che era rimasta vedova da un giorno all’altro, con tre figli da allevare ancora più giovani di lei, l’aveva obbligata – lei, la maggiore – a cercarsi un lavoro per dare un aiuto in casa. Era stata veramente contenta quando aveva trovato il posto nella cucina della grande casa sulla collina: Nancy veniva dalla contrada “The Corners” a sei miglia da lì, e conosceva Miss Polly Harrington soltanto come proprietaria della vecchia tenuta Harrington, che apparteneva a una delle più ricche famiglie della zona. Questo era quanto sapeva due mesi prima. Adesso apprendeva anche che Miss Polly era una donna rigida dallo sguardo duro che si accigliava se una posata cadeva per terra, o se una porta sbatteva, né mai sorrideva per alcuna ragione. «Quando avrai finito il tuo solito lavoro, questa mattina», Miss Polly ora le diceva, «dovrai sgomberare la stanzetta del sottotetto e fare il letto della brandina. Naturalmente farai pulizia nella stanza, dopo averla liberata dai bauli e dagli scatoloni». «Sì, signora. E dove devo mettere tutta la roba che devo sgomberare?» «Nel sottotetto che dà verso il giardino». Un attimo di esitazione, quindi Miss Polly proseguì: «Tanto vale che te lo dica subito, Nancy. Mia nipote, Miss Pollyanna Whittier, verrà a stare con me. Ha undici anni e dormirà nella stanza che ti ho detto». «Una bambina verrà qui, Miss Harrington? Che bello!» esclamò Nancy, ricordando le sue sorelline e l’allegria che suscitavano in casa. «Bello? Non mi sembra la parola adatta», disse Miss Polly asciutta. «In ogni modo ho intenzione di fare il possibile perché tutto vada per il meglio. Sono una persona come si deve, voglio credere, e conosco i miei doveri». Nancy si fece rossa di fuoco. «Certo, signora. Pensavo che una ragazzina in questa casa... avrebbe portato un po’ d’allegria», farfugliò. «Grazie», disse Miss Polly con durezza. «Non posso dire, però, che ce ne sia proprio bisogno urgente». «Ma», azzardò Nancy, «certo che lei la vuole, la bambina di sua sorella». Vagamente sentiva che in qualche modo doveva preparare a quella piccola sconosciuta un’atmosfera più accogliente. Miss Polly s’irrigidì ancor più. «Veramente, Nancy, per il fatto di avere avuto una sorella tanto sciocca da finire per sposarsi e mettere al mondo altri bambini quando già ce ne sono tanti, non vedo perché dovrei desiderare in modo particolare di allevarne io stessa e di prendermene cura. Ad ogni modo, come ho detto, spero di sapere qual è il mio dovere. Mi raccomando di pulire bene negli angoli, Nancy», concluse poi con la solita durezza nel lasciare la stanza. «Sì, signora», disse Nancy, tornando alla brocca che nel frattempo si era asciugata da sola. 21 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Classici da non perdere 22 Biblioteca on line Rientrata in camera sua, Miss Polly riprese in mano la lettera che aveva ricevuto due giorni prima da una lontana città del West e che era stata per lei una sorpresa tanto sgradita. La lettera era indirizzata a “Miss Polly Harrington, Beldingsville, Vermont”, e diceva testualmente: Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino “Gentile signora, ho il dolore di informarla che il Reverendo Jokn Whittier è morto due settimane fa, lasciando una figlia, una ragazzina di undici anni. A parte alcuni libri non ha lasciato altro, in quanto, come lei certamente saprà, egli era il Pastore di questa piccola parrocchia e viveva di un ben misero stipendio. Se non sbaglio, aveva sposato la sua defunta sorella, ma mi aveva lasciato capire che i rapporti fra le due famiglie non erano troppo cordiali. Egli riteneva, tuttavia, che per amore di sua sorella lei avrebbe desiderato la bambina presso di sé per allevarla tra i suoi nell’Est, ed è per questo motivo che le scrivo. Quando riceverà questa lettera, la bambina sarà già pronta a partire e, se lei accetta di accoglierla, le sarò molto grato se me lo farà sapere in modo che possa farla partire immediatamente, dal momento che qui c’è una certa persona che con la moglie verrà tra breve nell’Est. Prenderebbero con loro la bambina fino a Boston, dove la farebbero salire sul treno per Beldingsville. Naturalmente sarà informata in quale giorno e su quale treno viaggerà la piccola Pollyanna. Con la speranza di avere presto una sua risposta affermativa, le invio i migliori saluti. Rev. Jeremiah O. White» Con la fronte sempre aggrottata, Miss Polly ripiegò la lettera e la infilò di nuovo nella busta. Aveva già risposto il giorno prima, scrivendo che avrebbe accolto la bambina, naturalmente. Per quanto le riuscisse poco gradito, sapeva bene qual era il suo dovere! Mentre era lì seduta con la lettera in mano, tornava con il pensiero a sua sorella Jennie, che era stata la madre di questa bambina, quando Jennie appena ventenne aveva superato l’opposizione della famiglia ed era riuscita a sposare il Reverendo. Anche un altro uomo molto benestante l’avrebbe sposata, e la famiglia l’avrebbe senz’altro preferito al Pastore; ma non Jennie. L’uomo ricco disposto a sposarla aveva a suo favore qualche anno in più e più denaro, mentre il giovane ministro aveva soltanto la testa piena di ideali giovanili, tanto entusiasmo, e un cuore molto grande. Jennie aveva preferito queste qualità, con molta ingenuità, forse, così aveva sposato il Pastore, e se ne era andata con lui al Sud, come moglie di ministro di una casa missionaria. Fu allora che si era verificata la rottura. Miss Polly se lo ricordava bene, anche se all’epoca aveva solo quindici anni, essendo la più giovane. La famiglia aveva avuto sempre più rari contatti con la moglie del missionario. Jennie aveva scritto per un certo tempo e aveva informato di aver chiamato la sua ultima bambina Pollyanna, dal nome delle sue due sorelle, Polly e Anna; gli altri bambini le erano tutti morti. Fu l’ultima volta che Jennie aveva dato sue notizie. Poi, qualche anno più tardi, si era saputo della sua morte, annunciata in una breve ma straziante lettera del ministro stesso e inviata da un piccolo centro del West. Classici da non perdere 23 Nel frattempo la vita non si era fermata nella grande casa in cima alla collina. Fissando lo sguardo sulla valle, Miss Polly pensava ai cambiamenti che quei venticinque anni avevano portato. Adesso era giunta ai quarant’anni ed era sola al mondo. Papà, mamma e le sorelle erano tutti morti. Da vari anni era unica padrona della casa e di quanto il padre le aveva lasciato. C’era gente che l’aveva compatita per quella sua vita di solitudine, mentre la spingeva a trovarsi chi stesse con lei, ma lei non aveva gradito né la loro preoccupazione, né i loro consigli. Non si sentiva sola, diceva. Le piaceva vivere così. Preferiva la tranquillità. Ma ora... Miss Polly si alzò con un’espressione pensierosa e le labbra strette. Era contenta, naturalmente, di essere una persona per bene che non soltanto conosceva il suo dovere, ma che era anche dotata di carattere sufficiente per dimostrarlo. Però... “Pollyanna”, che nome ridicolo! Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino (E. H. Porter, Pollyanna, trad. it. O. Bonato, Novara, De Agostini, 1994) 24 Biblioteca on line Louisa May Alcott Piccole donne L’autrice Louisa May Alcott (1832-1888) ebbe un’infanzia fuori dall’ordinario. Il padre era un filosofo che contava tra le proprie amicizie intellettuali e scrittori, alcuni dei quali, come il famoso Nathaniel Hawthorne, furono anche insegnanti privati di Louisa e delle sue tre sorelle. La famiglia trascorse alcuni anni in una comunità chiamata Fruitlands, dove si praticava uno stile di vita improntato alla condivisione dei beni e alla solidarietà; l’esperimento però fallì, e gli Alcott si trovarono in precarie condizioni economiche finché, grazie a un’eredità della madre, riuscirono ad acquistare una casa nel Massachusetts. Louisa iniziò a lavorare presto per contribuire al magro bilancio familiare: fece la sarta, la governante, l’insegnante e l’infermiera. Più tardi riuscì a vendere alcuni suoi racconti, che vennero pubblicati da varie riviste. Il vero successo come scrittrice arrivò nel 1868 con il romanzo Piccole donne, cui seguirono altri tre titoli della stessa serie: Piccole donne crescono, Piccoli uomini e I figli di Jo. In ognuno di questi romanzi vi sono molti riferimenti autobiografici: le quattro sorelle di Piccole donne, infatti, sono ispirate alla stessa Louisa e alle sue sorelle, mentre per le vicende di Piccoli uomini e I figli di Jo la scrittrice prese spunto dai numerosi nipoti che vivevano con lei nella casa di famiglia. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Il romanzo La storia di Piccole donne è ambientata durante la guerra di secessione americana, tra il 1861 e il 1865. La famiglia March vive in ristrettezze economiche, a causa di un passato rovescio di fortuna, ma serenamente, finché il signor March è richiamato alle armi e mandato a combattere a Sud. Le sue quattro figlie – Meg, Jo, Beth e Amy, rispettivamente di sedici, quindici, tredici e dodici anni – promettono al papà lontano di essere laboriose, gentili e sempre pronte ad aiutare il prossimo: insomma, a diventare delle “piccole donne”, come dice il titolo del romanzo. I buoni propositi, però, si scontrano spesso con la realtà dei fatti, e come tutte le ragazze di questo mondo anche alle quattro ragazze March capita di litigare, di invidiare le ricchezze altrui e di desiderare di vivere nell’ozio: il romanzo si snoda dunque raccontando le loro piccole storie di formazione, le amicizie, i primi corteggiamenti, la felicità e i dolori che accompagnano la vita delle adolescenti, ieri come oggi. Ecco come comincia la storia. 1. indispettita: irritata. «Un Natale senza regali non è un vero Natale», borbottò Jo, stesa sul tappeto. «Che disgrazia essere poveri!» sospirò Meg, guardando sconsolata il vecchio vestito che indossava. «È una vera ingiustizia che ci siano delle ragazze che hanno un sacco di belle cose, mentre altre non hanno proprio niente!» aggiunse la piccola Amy, tirando su col naso con aria indispettita1. «In fondo, però, siamo insieme, e abbiamo il papà e la mamma», disse Beth in tono tranquillo, dal suo angolino. 2. superflue: non necessarie. Rasserenati da quell’osservazione, i quattro visetti apparvero d’improvviso più splendenti, alla luce del focolare, ma subito tornarono a rabbuiarsi quando Jo disse in tono triste: «Veramente il papà non è con noi, e non lo sarà per molto tempo». Non aggiunse «forse mai più», ma ognuna di loro, in cuor suo, lo pensò, volando con la mente al padre lontano, impegnato sul fronte. Per qualche minuto, rimasero in silenzio. Poi, improvvisamente eccitata, Meg disse: «Sapete anche voi che la mamma ha proposto di non comprare nessun regalo per Natale perché l’inverno sarà duro per tutti, e secondo lei non è giusto spendere dei soldi per cose superflue2 quando i nostri uomini stanno soffrendo in guerra. Non possiamo fare molto, ma quei pochi sacrifici che ci vengono richiesti dovremmo farli con piacere. Però... però io non credo di essere così brava». Meg scosse la testa, pensando dispiaciuta a tutte le belle cose che desiderava. «Comunque, non credo che quel poco che abbiamo possa servire a qualcuno. Ci tocca un dollaro a testa, e se anche lo regalassimo all’esercito, non se ne farebbe molto. Mi va benissimo non farmi regalare niente da voi e dalla mamma, però mi piacerebbe tanto comprarmi Ondina e Sintram. È tanto di quel tempo che lo desidero!» esclamò Jo, che era una lettrice appassionata. «Io avevo pensato di spendere il mio dollaro per acquistare dei nuovi spartiti di musica», disse Beth lasciandosi scappare un sospiro così leggero che lo udirono solo lo scopino del caminetto e il gancio del bollitore. «Io mi comprerò una bella scatola di matite colorate Faber. Mi servono davvero», disse Amy, decisa. «La mamma non ha parlato dei nostri soldi, e di sicuro non vuole che rinunciamo proprio a tutto. Facciamo così: ognuna di noi si compra quello che vuole, almeno avrà una piccola consolazione, no? Visto che sgobbiamo parecchio, direi che ce lo meritiamo proprio!» esclamò Jo, fissandosi i tacchi delle scarpe con fare maschile. «Be’, questo è poco ma sicuro!» concordò Meg riprendendo il tono lamentoso di poco prima. «Con tutte le ore che mi tocca passare a far lezione a quei mocciosi quando avrei voglia di starmene a casa a divertirmi!» «Guarda che in confronto a me tu te la passi proprio bene», le fece notare Jo. «Cosa ne diresti di startene tappata in casa per delle ore insieme a una vecchietta pignola e irritabile che ti fa trottare su e giù in continuazione, non è mai contenta e ti tortura a tal punto che ti viene voglia di buttarti dalla finestra o di metterti a urlare?» «Lo so, è brutto essere tormentati così, ma ti dirò che per me lavare i piatti e tenere in ordine la casa è il lavoro peggiore del mondo. Divento di cattivo umore, e in più mi si irrigidiscono le mani, tanto che non riesco a suonare come vorrei», disse Beth guardandosi le mani ruvide con un sospiro che, questa volta, risultò udibile a tutte. 25 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Classici da non perdere Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 26 Biblioteca on line 3. impertinenti: sfacciate, maleducate. 4. cricca: compagnia. 5. riprovazione: critica, condanna. 6. moine e smancerie: comportamenti sdolcinati e affettuosi. 7. concitate: agitate per l’emozione. 8. ramanzina: rimprovero. 9. chignon: capelli raccolti sulla nuca. «Nessuna di voi soffre quanto me!» esclamò Amy. «Non siete mica costrette ad andare a scuola con delle ragazze impertinenti3, che se non sai la lezione ti mettono in croce, ti prendono in giro per i vestiti che ti metti e in più sfamano tuo padre perché non è ricco e ti offendono perché non hai un bel naso». «Veramente sarebbe meglio dire diffamano, se è questo che intendi: mica danno da mangiare a papà, le tue amate compagne!» osservò Jo, ridendo. «So benissimo cosa intendo dire, e non c’è nessun bisogno di essere così istrionica. È giusto usare parole ricercate e migliorare il proprio vocabulario», ribatté Amy con aria offesa. «Smettetela di beccarvi, ragazze. Non ti piacerebbe che avessimo ancora i soldi che il papà ha perso quando eravamo piccole, eh, Jo? Oh, come sarebbe bello non avere tutte queste preoccupazioni!» disse Meg, che ricordava tempi migliori. «Veramente l’altro giorno hai detto che secondo te eravamo ben più felici noi dei figli della signora King, che nonostante tutti i loro soldi non fanno altro che litigare e tormentarsi a vicenda». «È vero, Beth, hai ragione. In effetti, anche se dobbiamo lavorare, ci divertiamo, e tutto sommato siamo una cricca4 abbastanza allegra, come direbbe Jo». «Jo usa delle parole terribilmente poco fini», osservò Amy, gettando un’occhiata di riprovazione5 all’alta figura stesa sul tappeto. Jo si alzò immediatamente a sedere, infilò le mani in tasca e si mise a fischiettare. «Smettila, Jo! È da maschiacci!» «È proprio per questo che lo faccio». «Non sopporto le ragazze sgarbate e poco fini!» «E io odio le mocciose tutte moine e smancerie6!» «Nei loro nidi gli uccellini van d’accordo...», canterellò Beth la pacificatrice, con un’espressione talmente buffa sul faccino che le voci concitate7 delle due sorelle si trasformarono in una risata, e per quella volta il litigio finì lì. «Veramente, ragazze, avete torto tutte e due», sentenziò Meg, iniziando la ramanzina8 con il suo tono da sorella più grande. «Tu, Josephine, sei grande abbastanza da smetterla con quei modi da maschiaccio e iniziare a comportarti meglio. Quando eri piccola, si poteva chiudere un occhio, ma adesso che sei così alta e ti tiri su i capelli dovresti ricordarti che sei una signorina». «Non è vero! E se tirarmi su i capelli significa che devo comportarmi da signorina, mi farò le trecce fino a vent’anni!» gridò Jo, strappandosi dalla testa la retina che reggeva lo chignon9 e scuotendo la criniera castana. «Non voglio essere costretta a crescere e a diventare la signorina March, portare gonne lunghe ed essere delicata come un fiore raro! È già un tormento sufficiente essere nata femmina, quando invece mi piacciono i giochi da maschi, i mestieri da maschi e i modi da 10. affettata: poco naturale. maschi! Non riesco proprio a mandar giù il fatto di non essere un ragazzo, e adesso più che mai, dato che muoio dalla voglia di essere al fronte con il papà, invece di starmene a casa a lavorare a maglia come una vecchietta ingobbita!» concluse Jo scuotendo il calzettone blu a cui stava lavorando finché i ferri da calza non si misero a tintinnare come nacchere e il gomitolo di lana non rotolò in mezzo alla stanza. «Povera Jo! È triste, lo so, ma non c’è niente da fare. E dunque devi accontentarti di usare il tuo diminutivo, che assomiglia a un nome maschile, e far finta di essere una specie di fratello con noi sorelle», disse Beth, accarezzando la testa spettinata accanto al suo ginocchio con una mano che niente al mondo, nemmeno ore e ore di fatiche domestiche, avrebbe potuto rendere meno dolce e affettuosa. «Quanto a te, Amy», continuò Meg, «sei davvero troppo schizzinosa e affettata10. Per adesso sei soltanto buffa, ma stai attenta: se continuerai così, tra poco diventerai un’oca piena di smancerie. A me piacciono i tuoi modi gentili e raffinati, quando non ti sforzi di essere elegante, però: le parole assurde che inventi ogni tanto sono quasi peggio delle espressioni che usa Jo». «Se Jo è un ragazzaccio e Amy un’oca, mi dici cosa sono io?» chiese Beth, pronta a sorbirsi la sua parte di ramanzina. «Tu sei un tesoro e nient’altro», rispose Meg affettuosamente, e nessuno la contraddisse, poiché “Topolino” era la beniamina di tutta la famiglia. Dato che ai giovani lettori interessa sempre conoscere l’aspetto dei personaggi, approfitteremo del quadretto familiare per tracciare un piccolo schizzo delle quattro sorelle, sedute a lavorare a maglia nella luce del crepuscolo, mentre fuori cadeva silenziosa la neve di dicembre e in casa il fuoco crepitava allegro nel camino. La stanza era vecchia ma confortevole, sebbene il tappeto fosse piuttosto scolorito e il mobilio molto semplice. Alle pareti erano appesi un paio di bei quadri, e sui numerosi scaffali che riempivano le nicchie erano allineati molti libri. Sui davanzali fiorivano crisantemi e stelle di Natale, e tutta la sala era pervasa da una piacevole atmosfera di pace domestica. Margaret, la maggiore delle quattro sorelle, aveva sedici anni ed era molto graziosa: paffuta e chiara di carnagione, occhi grandi, folti capelli morbidi e castani, la bocca graziosa e mani bianchissime, di cui andava piuttosto fiera. Jo, quindici anni, era molto alta e slanciata, e scura di carnagione; somigliava un po’ a una puledra, perché dava sempre l’impressione di non sapere che cosa fare delle sue lunghe gambe, che la impacciavano di continuo. Aveva la bocca decisa, un naso piuttosto buffo e gli occhi grigi e penetranti, che sembravano vedere tutto ed erano ora fieri, ora divertiti e ora assorti. I capelli, lunghi e folti, erano la sua unica bellezza, ma di solito li portava raccolti in una retina, in modo che non le fossero d’impaccio. Jo aveva le spalle larghe e mani e piedi grandi, non si 27 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Classici da non perdere 28 Biblioteca on line curava molto dei suoi vestiti e aveva in generale l’aspetto sgraziato di una ragazza che sta rapidamente sbocciando in una donna ma non sa accettare la trasformazione. Elizabeth – o Beth, come la chiamavano tutti – era una ragazzina di tredici anni dalla pelle rosea, i capelli morbidi e gli occhi scintillanti. Era piuttosto riservata e aveva una vocina timida e un’espressione serena che ben poche cose potevano turbare. Suo padre la chiamava “Piccola Tranquillità” e il soprannome le stava a pennello: sembrava infatti che vivesse in un mondo felice e tutto suo, avventurandosi all’esterno solo per incontrare quelle poche persone che amava e in cui riponeva la sua fiducia. Amy, pur essendo la più giovane, era una persona molto importante, per lo meno a suo avviso. Pareva fatta di neve, con gli occhi azzurri e i capelli biondissimi che le si arricciavano sulle spalle, pallida e minuta, sempre attenta a muoversi con la grazia propria di una damigella dalle buone maniere. Quanto al carattere delle quattro sorelle, lasceremo ai lettori il compito di scoprirlo strada facendo. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino (M. L. Alcott, Piccole donne, trad. it. L. Cangemi, Casale Monferrato, Piemme, 1997) Classici da non perdere 29 Robert Louis Stevenson La freccia nera L’autore Robert Louis Stevenson (1850-94) nacque a Edimburgo, in Inghilterra. Fu un adolescente ribelle e inquieto, in aperta polemica con il padre che l’aveva destinato alla professione di avvocato. In effetti, si laureò in giurisprudenza ma non esercitò mai, preferendo scrivere e viaggiare. Per Stevenson viaggiare era una passione, legata al suo temperamento curioso e avventuroso, ma anche una necessità, dal momento che era malato di tubercolosi e aveva bisogno di soggiornare a lungo in luoghi dove il clima fosse mite. A partire dal 1891, infatti, si stabilì definitivamente nelle isole Samoa, dove visse circondato dall’affetto e dal rispetto degli indigeni fino alla morte. Stevenson scrisse numerosi romanzi e racconti, molti dei quali di genere fantastico e avventuroso: tra i più famosi vi sono La freccia nera, L’isola del tesoro, Il signore di Ballantrae e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hide; scrisse anche numerosi diari di viaggio, tra cui I mari del Sud. Il romanzo 1. tassi: grandi alberi dalla chioma verde scuro che producono bacche rosse. In un pomeriggio di tarda primavera, ad ora inconsueta, la campana del castello di Tunstall prese a suonare. Dappertutto, vicino e lontano, nella foresta e nei campi lungo il fiume, la gente, lasciato il lavoro, si affrettò verso la sorgente del suono, e nel villaggio di Tunstall si formò un gruppetto di contadini che si chiedevano il perché dell’appello. Il villaggio di Tunstall non era a quell’epoca, sotto il vecchio re Enrico VI, molto diverso da oggi: una ventina di case o poco più, con massicce strutture di quercia, sparse in una valle lunga e verde che scendeva al fiume. Qui c’era un ponte, superato il quale la strada risaliva la sponda opposta, fino a scomparire nella foresta, in direzione del Castello e dell’Abbazia di Holywood. A mezzo del villaggio sorgeva la chiesa, circondata da tassi1. Gli alberi della foresta incorniciavano da ambo i lati la valle. Proprio vicino al ponte, su di un monticello, sorgeva una croce di pietra, e qui si raccolse il gruppetto di gente del villaggio – che poi si riduceva a una mezza dozzina di donne e a un uomo d’alta statura in camiciotto di tela grezza – a discutere su ciò che la campana poteva significare. Mezz’ora prima un corriere era passato per il villaggio, fer- Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino La freccia nera (scritto nel 1883) è ambientato in Inghilterra nel XV secolo, all’epoca della Guerra delle Due Rose, quando le casate degli York e dei Lancaster, rispettivamente simboleggiate da una rosa bianca e da una rosa rossa, si contesero a lungo il trono, dissanguandosi a vicenda. Protagonisti sono due giovani: Richard Shelton (detto Dick) e Joanna Sedley, coinvolti loro malgrado in una girandola di intrighi, rapimenti e fughe, secondo la migliore tradizione del romanzo d’avventura. Il romanzo comincia così. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 30 Biblioteca on line 2. alabarda: lunga lancia con una lama a forma di scure. 3. Candelora: festa che cade il 2 febbraio, durante la quale vengono benedette le candele. mandosi a bere un boccale di birra senza neppure scendere di sella, tanta era la fretta; ma non aveva da raccontare alcuna novità; aveva soltanto delle lettere sigillate di Sir Daniel Brackley da consegnare a Sir Oliver Oates, il parroco che occupava il castello in assenza del signore. Ed ecco, all’improvviso, il suono di un cavallo al galoppo che sbuca dalla foresta e attraversa rombando il ponte: in sella c’è Master Richard Shelton, il giovane pupillo di Sir Daniel. Dick qualcosa doveva pur sapere! Lo salutarono, dunque, e gli andarono incontro per chiedergli delle spiegazioni. Dick fu abbastanza pronto a tirare le redini. Era un ragazzo di neppure diciott’anni, abbronzato dal sole, occhi grigi, giubbotto di pelle di daino con collo di velluto nero, cappuccio verde in testa e balestra d’acciaio a tracolla. Il corriere, a quanto pareva, aveva portato delle grosse novità. C’era puzza di battaglia. Sir Daniel ordinava che chiunque sapesse tirar d’arco o portare alabarda2 si recasse in gran fretta a Kettley se non voleva incorrere nella sua severità; ma per chi o che cosa si dovesse combattere, e dove, questo Dick non lo sapeva. Fra poco sarebbe arrivato Sir Oliver in persona; proprio in quel momento, infine, Bennet Hatch si stava armando, poiché era lui la persona che doveva comandare il drappello. «È la rovina di questa dolce terra!» disse una donna. «Quando i signori si fanno la guerra, i contadini sono costretti a mangiare radici». «Macché», disse Dick, «tutti quelli che ci seguiranno riceveranno sei pence al giorno, dodici gli arcieri». «Se salvano la pelle», ribatté la donna, «sarà come dite voi; ma se muoiono, padron mio?» «Cosa c’è di meglio che morire per il proprio signore naturale?» disse Dick. «Signore naturale per voi, non per me», intervenne l’uomo in camiciotto. «Io ho seguito i Walsingham; tutti lo abbiamo fatto da Brierly in giù, finché non è venuta la Candelora3. E adesso dovrei mettermi dalla parte di Brackley! Quello è mio signore per legge, non per natura. Io, con tutto il rispetto per Sir Daniel e per Sir Oliver, il quale conosce meglio la legge che l’onestà, non ho altro signore naturale che il povero re Enrico Sesto, Dio lo benedica quell’innocente che non sa distinguere la sua mano destra dalla sinistra!» «Non è una buona lingua la tua, amico», rispose Dick, «se metti nello stesso mazzo il tuo buon padrone e il signore mio Re. Intanto, però, re Enrico è guarito, siano lodati tutti i Santi, e metterà a posto pacificamente ogni cosa. Quanto a Sir Daniel, ti senti un leone quando parli dietro le sue spalle, eh! Ma io non sono uno che va a riferire i pettegolezzi, e tanto basti». «Di voi non dico alcun male, Master Richard», ribatté il contadino. «Voi siete un ragazzo; ma quando sarete un uomo vi troverete le tasche vuote. Non aggiungo altro: che i Santi aiutino chi sta vicino a Sir Daniel e che la Santa Vergine protegga i suoi scudieri». Classici da non perdere «Clipsby», lo interruppe Richard, «dici cose che per me non è onorevole ascoltare. Sir Daniel è il mio buon padrone e protettore». «Lasciamo andare», ribatté Clipsby. «Volete piuttosto sciogliermi un indovinello? Da quale parte tiene Sir Daniel?» «Non lo so», rispose Dick arrossendo lievemente; il suo protettore, infatti, non aveva fatto che passare da una parte all’altra, in quel periodo turbato, traendo da ogni cambiamento qualche beneficio. «Non lo sapete, no», disse Clipsby, «né voi né altri, perché costui è davvero uno che va a letto Lancaster e si alza York». In quel momento il ponte rimbombò sotto i ferri d’un cavallo; il gruppetto di gente si volse e vide Bennet Hatch che arrivava al galoppo, arsa la faccia, brizzolati4 i capelli, pesante la mano, arcigno5 l’aspetto, armato di spada e di lancia, la testa protetta da un casco d’acciaio e il corpo da un giaco6 di cuoio. Era un grand’uomo, da quelle parti, braccio destro di Sir Daniel in pace e in guerra e, per volere di costui, balivo7 dei cento. «Clipsby», gridò Bennet, «svelto, al castello, e fai andare su tutti gli altri poltroni, tutti alla pusterla8, che Bowyer gli darà giaco e casco. Si parte prima del coprifuoco. Bada: l’ultimo a presentarsi alla pusterla avrà da Sir Daniel il premio che merita! Su, datti da fare subito! Che sei un buono a nulla lo so. Ehi, Nance!» riprese, volgendosi a una delle donne, «è in paese il vecchio Appleyard?» «Ve lo garantisco», rispose la donna, «è certamente nel suo campo». Così il gruppetto si sciolse e, mentre Clipsby attraversava il ponte senza fretta, Bennet e il giovane Shelton ripresero insieme il cammino su per la strada del villaggio oltre la chiesa. (R. L. Stevenson, La freccia nera, trad. it. Q. Maffi, Milano, A. Mondadori, 1972) Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 4. brizzolati: che cominciano a diventare bianchi. 5. arcigno: severo e duro. 6. giaco: maglia, di ferro o di cuoio, che si usava in battaglia per proteggere il corpo. 7. balivo: governatore con ampi poteri. 8. pusterla: piccola porta, a volte segreta, che nelle antiche fortificazioni fungeva da passaggio di emergenza. 31 32 Biblioteca on line Per riflettere Roald Dahl La fabbrica di cioccolato L’autore Lo scrittore britannico Roald Dahl (1916-90) è stato uno dei più popolari autori per ragazzi, genere che ha saputo rinnovare profondamente con trovate e personaggi fantastici, grotteschi o addirittura ripugnanti. Tra i suoi romanzi ricordiamo, oltre a La fabbrica di cioccolato, Matilde, Gli sporcelli, Il grande ascensore di cristallo, La pesca gigante. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Nella periferia di una imprecisata città inglese c’è la grande e misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, un signore che da anni nessuno ha più visto, come a nessuno è stato concesso di visitare l’interno della fabbrica, da cui emanano fumo, ronzii, rumori e, soprattutto, un meraviglioso profumo di cioccolato. Finalmente l’occasione per svelare il mistero è offerta da un concorso indetto da Willy Wonka: i cinque ragazzi che troveranno un Biglietto d’oro in una delle tavolette di cioccolato potranno entrare nella fabbrica e visitarla per un giorno. Le avventure dei cinque vincitori all’interno della fabbrica rappresentano un’occasione di divertimento, ma anche di riflessione, perché i ragazzini riproducono dei prototipi di comportamento, dal protagonista Charlie Bucket, un ragazzino timido e riflessivo, ad Augustus Gloop, interessato solo a mangiare, alla viziata e capricciosa Veruca Salt, alla masticatrice di gomma Violetta Beauregarde e al teledipendente Mike Tivú. Ogni mattina, quando andava a scuola, Charlie scorgeva le grandi pile di tavolette di cioccolato accatastate nelle vetrine dei negozi, si fermava e le fissava col naso schiacciato contro il vetro e l’acquolina in bocca. Molte volte al giorno vedeva altri bambini sfilarsi di tasca delle belle stecche di cioccolato cremoso e sgranocchiarsele avidamente e questo, per lui, era un vero e proprio tormento. Solo una volta all’anno, in occasione del suo compleanno, a Charlie Bucket era dato assaggiare un po’ di cioccolato. Tutta la famiglia metteva da parte i soldi per quella speciale occasione e quando il grande giorno finalmente arrivava, gli regalavano sempre una tavoletta di cioccolato che Charlie poteva mangiare tutto da solo. Ogni volta che ne riceveva una, nel meraviglioso giorno del suo compleanno, la riponeva con cura in una scatolina di legno e ne faceva tesoro come se si trattasse di un lingotto di oro fino; nei giorni seguenti si permetteva soltanto di guardarla, senza neanche sfiorarla. Infine, quando proprio non ce la faceva più, ne scartava un angolino, scopriva una porzione piccola piccola di cioccolato e ne addentava un minuscolo pezzetto – appena appena abbastanza da permettere al dolce sapore del cioccolato di spandersi deliziosamente su tutta la lingua. Il giorno dopo dava un altro piccolo morso e così via, giorno dopo giorno. E così Charlie faceva in modo che una tavoletta di cioccolato da pochi soldi gli durasse più di un mese. Ma ancora non vi ho detto qual era la tortura tremenda che tormentava il povero Charlie, così amante del cioccolato, più di qualsiasi altra cosa al mondo. Molto, ma molto peggiore che vedere mucchi di tavolette di cioccolato nelle vetrine dei negozi o guardare gli altri bambini sgranocchiarsi le loro belle stecche proprio davanti a lui. Insomma, era la più terribile tortura che si possa immaginare. Si trattava di questo: nella sua stessa città, addirittura in vista della casa in cui abitava Charlie, c’era... pensate un po’... un’ENORME FABBRICA DI CIOCCOLATO! Provate a immaginare una cosa del genere! E non si trattava nemmeno di un’enorme fabbrica di cioccolato qualsiasi. Era la più grande e la più famosa fabbrica di cioccolato del mondo! Era la FABBRICA WONKA, di proprietà del signor Willy Wonka, il più grande inventore e fabbricante di dolciumi e cioccolatini che sia mai esistito. E che formidabile e meravigliosa fabbrica era quella! L’ingresso era sbarrato da enormi cancelli di ferro e tutta la fabbrica era circondata da un altissimo muro di cinta; dalle ciminiere sgorgava fumo e dalle profondità della fabbrica provenivano strani sibili e ronzii. E tutt’intorno, nel raggio di almeno mezzo miglio, l’aria era intrisa del forte e ricco aroma del cioccolato fondente! Due volte al giorno, quando andava e quando tornava da scuola, il piccolo Charlie Bucket doveva passare proprio davanti ai cancelli della fabbrica. E ogni volta che passava di lì cominciava a camminare sempre più piano e, volgendo il naso in alto, inspirava profondamente il profumo di cioccolato che lo circondava. Oh, quanto gli piaceva quel profumo! E, oh, come desiderava poter entrare in quella fabbrica e vedere com’era fatta! (R. Dahl, La fabbrica di cioccolato, trad. it. R. Duranti, Milano, Salani, 1994) 33 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per riflettere 34 Biblioteca on line George Orwell La fattoria degli animali L’autore George Orwell è lo pseudonimo di Eric Arthur Blair (1903-50), scrittore e giornalista inglese. Nato in India da una famiglia di origini scozzesi, dopo gli studi svolse lavori di vario genere e partecipò come volontario alla guerra di Spagna. Il suo impegno civile si riversò anche nella letteratura e ne La fattoria degli animali scrisse una satira pungente del comunismo e della dittatura staliniana. La sua critica al totalitarismo ispirò il romanzo 1984. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Che cosa succederebbe se un giorno gli animali si ribellassero e decidessero di non servire più gli uomini? Riuscirebbero a costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutti? A questi interrogativi offre una possibile risposta La fattoria degli animali, scritto nel 1945; in questo celebre romanzo Orwell immagina che gli animali prendano il potere, dopo aver cacciato il proprietario della fattoria in cui vivono. Ecco un “assaggio” della prima parte del romanzo. 1. stallo: scomparto di una stalla. Il signor Jones, della Fattoria padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma, ubriaco com’era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna che danzava da una parte all’altra attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa, da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando. Non appena la luce nella stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un’agitazione, uno sbatter d’ali. Durante il giorno era corsa voce che il Vecchio Maggiore, il maiale maschio Biancocostato premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero riuniti nel grande granaio, non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il Vecchio Maggiore (così era chiamato, benché fosse stato esposto con il nome di Orgoglio di Willingdon) godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un’ora di sonno per sentire quello che egli aveva da dire. [...] Tutti gli animali erano ora presenti, eccetto Mosè, il corvo domestico, che dormiva su un trespolo dietro la porta d’entrata. Quando vide che tutti si erano bene accomodati e aspettavano attenti, il Vecchio Maggiore si rischiarò la gola le cominciò: «Compagni, già sapete dello strano sogno che ho fatto la notte scorsa, ma di ciò parlerò più tardi. Ho avuto una vita lunga, ho avuto molto tempo per pensare mentre me ne stavo solo, sdraiato nel mio stallo1, Per riflettere 35 e credo di poter dire d’aver compreso, meglio di ogni animale vivente, la natura della vita su questa terra. Di questo desidero parlarvi. «Ora, compagni, di qual natura è la nostra vita? Guardiamola: la nostra vita è misera, faticosa e breve. Si nasce e ci vien dato quel cibo appena sufficiente per tenerci in piedi, e quelli di noi che ne sono capaci sono forzati a lavorare fino all’estremo delle loro forze; e, nello stesso istante in cui ciò che si può trarre da noi ha un termine, siamo scannati con orrenda crudeltà. Non vi è animale di Inghilterra che, dopo il primo anno di vita, sappia che cosa siano la felicità e il riposo. Non vi è animale in Inghilterra che sia libero. La vita di un animale è miseria e schiavitù: questa è la cruda verità. «Fa forse ciò parte dell’ordine della natura? Forse questa nostra terra è tanto povera da non poter dare una vita passabile a chi l’abita? No, compagni, mille volte no! Il suolo dell’Inghilterra è fertile, il suo clima è buono, e può dar cibo in abbondanza a un numero d’animali enormemente superiore a quello che ora l’abita. Solo questa nostra fattoria potrebbe sostentare una dozzina di cavalli, venti mucche, centinaia di pecore, e a tutti potrebbe assicurare un agio e una dignità di vita che vanno oltre ogni immaginazione. Perché allora dobbiamo continuare in questa misera condizione? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dall’uomo. Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. Essa si assomma in una sola parola: uomo. L’uomo è il solo, vero nemico che abbiamo. Si tolga l’uomo dalla scena e sarà tolta per sempre la causa della fame e della fatica». Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino (G. Orwell, La fattoria degli animali, trad. it. B. Tasso, Milano, A. Mondadori, 1980) 36 Biblioteca on line Konrad Lorenz L’anello di Re Salomone L’autore Il viennese Konrad Lorenz (1903-89) è considerato il fondatore dell’etologia scientifica, scienza da lui definita “ricerca comparata” sul comportamento animale e umano. Nel 1973 ricevette il premio Nobel per la medicina e la fisiologia per gli studi sulle componenti innate del comportamento delle oche selvatiche e in particolare sul fenomeno dell’imprinting, ossia l’apprendimento per imitazione che avviene nei nuovi nati a partire dal contatto con i genitori. Dai suoi studi Lorenz ha tratto diverse opere di divulgazione scientifica, che gli hanno dato notevole popolarità. Il testo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino La scelta del titolo L’Anello di Re Salomone si richiama alla leggenda secondo la quale il re biblico Salomone avrebbe avuto un anello che gli permetteva di capire il linguaggio degli animali e di parlare con loro. Convinto che gli animali comunicassero attraverso il loro comportamento, Lorenz si dedicò allo studio di uccelli, pesci e mammiferi, dedicando particolare attenzione alle oche selvatiche, che divennero le protagoniste del libro in cui sono riportate le sue osservazioni. 1. cacatua: pappagallo di media grandezza, con un ciuffo eretto sulla testa. 2. Altenberg: cittadina austriaca in cui Lorenz ha trascorso parte della sua vita. 3. anelano: aspirano a, ricercano. Perché incomincio proprio dal lato più sgradevole della nostra convivenza con gli animali? Perché il nostro amore per loro si misura proprio dai sacrifici che siamo disposti a sobbarcarci. Sarò eternamente grato ai miei pazienti genitori che si limitavano a scuotere il capo o a sospirare rassegnati quando, scolaretto o giovane studente, portavo a casa un ennesimo coabitante, prevedibilmente turbolento. E che cosa non ha sopportato mia moglie nel corso degli anni! Chi mai oserebbe infatti imporre alla consorte di lasciar circolare liberamente per casa un ratto domestico, che coi denti strappa tanti bei pezzettini dalle lenzuola per tappezzare la tana; o di permettere a un cacatua1 di beccar via tutti i bottoni dalla biancheria stesa in giardino; o di accogliere, per la notte, in camera da letto, un’oca selvatica addomesticata, per lasciarla poi volar via dalla finestra al mattino? (Sia detto qui per inciso che le oche selvatiche non sono minimamente educabili per quanto riguarda la pulizia!) [...] Ad Altenberg2 le gabbie e le reti avevano una funzione opposta a quella che hanno di solito: dovevano cioè impedire che gli animali entrassero in casa o in giardino. Ad essi era inoltre severamente vietato di trattenersi all’interno del reticolato che circondava le nostre belle aiuole. Ma, come avviene coi bambini, così anche gli animali più intelligenti sono magicamente affascinati da tutte le cose proibite. E per di più le oche selvatiche, con il loro splendido attaccamento all’uomo, anelano3 sempre alla sua compagnia. Così ogni momento, in men che non si dica, Per riflettere ci trovavamo circondati da venti o trenta oche selvatiche che venivano a pascolare sulle aiuole, o, ancor peggio, che facevano irruzione sulla veranda salutandoci con forti schiamazzi. E purtroppo è estremamente difficile tener lontano da un dato luogo un uccello capace di volare, ma privo di qualsiasi timore nei confronti dell’uomo; a nulla servono le grida più selvagge, i più energici movimenti con le braccia. L’unico mezzo intimidatorio4 di una certa efficacia era un enorme ombrellone rosso scarlatto: simile a un cavaliere con lancia in resta, mia moglie, l’ombrello chiuso sotto il braccio, piombava sulle oche che avevano ripreso a pascolare sull’aiuola appena seminata e, gettando un grido bellicoso, l’apriva con mossa repentina. Questo era troppo perfino per le nostre oche, che si levavano in aria starnazzando. (K. Lorenz, L’anello di Re Salomone, trad. it. L. Schwarz, Milano, Adelphi, 2006) Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 4. intimidatorio: che ha lo scopo di spaventare. 37 38 Biblioteca on line Judith Kerr Quando Hitler rubò il coniglio rosa L’autrice Judith Kerr è una scrittrice di origine tedesca, naturalizzata inglese. Nata a Berlino nel 1923, visse in Germania fino al 1933, quando in seguito all’ascesa al potere di Hitler la sua famiglia, di origine ebree, fu costretta a fuggire, stabilendosi infine in Inghilterra. È conosciuta per i suoi libri per bambini, alcuni dei quali illustrati da lei stessa, e per il romanzo autobiografico Quando Hitler rubò il coniglio rosa. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Berlino, 1933. Anna è una bambina felice: vive in una bella casa con i genitori e il fratello maggiore; va a scuola, ha molte amiche e adora disegnare. La vita, però, sta per cambiare: i suoi genitori sono ebrei, e per giunta il padre è un oppositore del nazismo. Quando Adolf Hitler prende il potere, non resta che scappare, di notte, con il cuore in gola e con il timore di essere scoperti... quando finirà la fuga? Quando Anna potrà sentirsi di nuovo al sicuro? Anna tornava da scuola e camminava verso casa con Elsbeth, una sua compagna di classe. Quell’inverno a Berlino era caduta un sacco di neve. Non si scioglieva e così gli spazzini l’avevano ammucchiata sul bordo della strada e lì era rimasta per settimane, triste e grigia. Adesso, in febbraio, la neve si era trasformata in fanghiglia e c’erano pozzanghere dappertutto. Anna ed Elsbeth le saltavano, con gli stivali ben allacciati ai piedi. Indossavano tutte e due cappotti pesanti e berretti di lana per tenere calde le orecchie e Anna aveva anche una sciarpa. Aveva nove anni, ma era piccola per la sua età e le code della sciarpa le pendevano quasi fino alle ginocchia. La sciarpa le copriva anche la bocca e il naso, e così le si vedevano soltanto gli occhi che erano verdi e una ciocca di capelli neri. Camminava in fretta perché voleva comprare delle matite dal cartolaio ed era quasi l’ora di pranzo. Ma era senza fiato e fu contenta quando Elsbeth si fermò davanti a un grande manifesto rosso. «Un’altra foto di quell’uomo», commentò Elsbeth. «La mia sorellina ne ha vista un’altra ieri e credeva che fosse Charlie Chaplin». Anna osservò gli occhi che la fissavano minacciosi. «Non assomiglia per niente a Charlie Chaplin, se non per i baffi», notò. Lessero lentamente il nome sotto la foto. Adolf Hitler. «Vuole che tutti gli diano il voto alle elezioni e poi arresterà tutti gli ebrei», aggiunse Elsbeth. «Credi che arresterà Rachel Lowenstein?» «Nessuno può arrestare Rachel Lowenstein», rispose Anna. «È capo squadra. Forse arresterà me. Anch’io sono ebrea». «Ma va’!» «Sì, davvero! Mio padre ce lo diceva proprio la settimana scorsa. Ha detto che noi siamo ebrei e, qualsiasi cosa succeda, non dobbiamo mai dimenticarlo». «Ma tu al sabato non vai in una chiesa speciale come Rachel Lowenstein». «Perché non siamo religiosi. Non andiamo per niente in chiesa». «Vorrei che neanche mio padre fosse religioso», sospirò Elsbeth. «Dobbiamo andarci tutte le domeniche e mi vengono i crampi al sedere». Gettò un’occhiata curiosa ad Anna. «Mi pareva che gli ebrei avessero tutti il naso con la gobba, ma il tuo non ce l’ha. E tuo fratello ce l’ha?» «No», rispose Anna. «L’unica persona in casa nostra con una gobba sul naso è Bertha, la cameriera, ma se l’è fatta cadendo dal tram». Elsbeth si spazientì. «Be’, se sei come tutti gli altri e non vai in una chiesa speciale, come fai a sapere che sei ebrea? Come fai a esserne sicura?» Ci fu una pausa. «Forse... forse perché mia madre e mio padre sono ebrei, e mi pare che anche i loro genitori fossero ebrei. Io non ci avevo mai pensato fino alla settimana scorsa, quando il babbo ha cominciato a parlarne». «Be’, è una stupidaggine!» esclamò Elsbeth. «Tutta questa storia di Adolf Hitler, degli ebrei e il resto!» E si mise a correre, seguita da Anna. Non si fermarono, finché non arrivarono dal cartolaio. Qualcuno stava parlando all’uomo dietro il bancone e Anna trasalì, riconoscendo la vecchia signorina Lambeck, che abitava nei dintorni. La signorina Lambeck aveva proprio una faccia da pesce morto, mentre diceva: «Ah, che tempi terribili!» e scuoteva la testa, agitando all’impazzata gli orecchini. Il cartolaio aggiunse: «Il 1931 è stato brutto, il 1932 ancor peggio, ma si ricordi quel che le dico, il 1933 sarà il peggiore di tutti». Poi, vedendo Anna ed Elsbeth, domandò: «Cosa volete, piccole?» Anna stava rispondendo che voleva delle matite, quando la signorina Lambeck la scorse. «Ma è la piccola Anna!» gridò. «Come stai, carina? E come sta il tuo caro papà? Che uomo meraviglioso! Io leggo tutto quello che scrive. Ho tutti i suoi libri e l’ascolto sempre quando parla alla radio. Ma questa settimana non ha scritto niente sul giornale... Spero stia bene. Forse è via per qualche conferenza. Oh, abbiamo proprio bisogno di lui in questi tempi terribili, terribili!» Anna aspettò che la signorina finisse e quindi rispose: «Ha l’influenza». La frase provocò una nuova esplosione. Pareva che qualche vicino parente della Lambeck fosse sul letto di morte. La donna scuoteva continuamente la testa, finché gli orecchini presero a tintinnare furiosamente. Suggeriva medicine, raccomandava dottori. Non si fermò fin- 39 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per riflettere Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 40 Biblioteca on line ché Anna non le promise di portare al babbo i migliori auguri per una pronta guarigione da parte sua. Anzi, sulla soglia si fermò e voltandosi aggiunse: «Cara piccola, non dire “dalla signorina Lambeck”, di’ soltanto “da un’ammiratrice”», e finalmente scomparve. Anna comprò in fretta le matite. Uscì e si fermò al freddo con Elsbeth, davanti alla vetrina del cartolaio. Era qui che di solito si separavano, ma Elsbeth indugiava. Da tempo voleva chiedere qualcosa ad Anna, e questo pareva il momento buono. «È bello, Anna, avere un padre famoso?» «Non proprio, quando ti capita tra i piedi qualcuno tipo la Lambeck», rispose Anna distrattamente, incamminandosi verso casa, seguita da Elsbeth, anche lei assorta. «Ma a parte la Lambeck?» «Direi di sì. Intanto il babbo lavora a casa, e così lo vediamo spesso. E poi qualche volta abbiamo i biglietti del teatro in omaggio. E una volta un giornale ci ha intervistato, e ci hanno chiesto che libri ci piacevano, e mio fratello ha detto Zane Grey e il giorno dopo ci è arrivata tutta la collana di libri in regalo!» «Vorrei che anche mio padre fosse famoso! Ma non ci riuscirà mai, perché lavora in un ufficio postale, e con questo tipo di lavoro uno non diventa mai famoso». «Se non riesce tuo padre, puoi diventare famosa tu. Vedi, il brutto di avere un padre famoso è che quasi mai diventi famoso tu stesso». «E perché no?» «Non so. Ma difficilmente capita di sentire di due persone famose nella stessa famiglia. E questo a volte mi rende triste», sospirò Anna. Intanto erano arrivate al cancello bianco della casa di Anna. Elsbeth era tutta agitata all’idea di potere un giorno diventare famosa, per chissà quale misterioso motivo, quand’ecco che Heimpi, avendole viste dalla finestra, aprì la porta d’ingresso. «Accidenti, ho fatto tardi!» gridò Elsbeth e scappò via. «Tu e quell’Elsbeth», brontolò Heimpi, mentre Anna entrava in casa, «voi due parlereste anche con la bocca cucita!» (J. Kerr, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, trad. it. M. Buitoni Duca, Milano, RCS, 1981) Per riflettere 41 Deborah Ellis Sotto il burqa L’autrice Deborah Ellis, nata in Canada nel 1960, è scrittrice e assistente sociale. Ha lavorato in varie parti del mondo nell’ambito di progetti umanitari e da queste esperienze ha tratto materiali e ispirazioni per i suoi romanzi: Cercando X, Verso il paradiso e la trilogia del burqa: Sotto il burqa, Il viaggio di Parvana e Città di fango. Il romanzo 1. chador: indumento di origine iraniana simile a un mantello o a un foulard semicircolare che ricopre capo e spalle lasciando scoperto il viso. 2. talebani: integralisti islamici che governarono l’Afghanistan dal 1996 al 2001; essi repressero ferocemente ogni opposizione e causarono un pesante arretramento della condizione femminile. «Sono capace di leggere quella lettera come il Papà», sussurrò Parvana tra le pieghe del chador1. «O almeno quasi». Non osò pronunciare quelle parole ad alta voce. L’uomo seduto accanto a suo padre non voleva certo sentirla parlare. E così nessun altro al mercato di Kabul. Parvana si trovava lì solo per aiutare il Papà a camminare fino al mercato, e poi di nuovo a casa dopo il lavoro. Sedeva un po’ indietro sulla coperta, il capo e gran parte del viso coperti dal chador. In realtà non avrebbe neppure dovuto essere lì. I talebani2 avevano ordinato a tutte le donne e le ragazze afghane di rimanere chiuse in casa. Avevano persino proibito alle ragazze di frequentare la scuola. Parvana era stata costretta a interrompere il suo sesto anno e a sua sorella Nooria non era permesso di frequentare le superiori. La loro mamma, redattrice in una radio di Kabul, era stata licenziata. Da più di un anno, ormai, vivevano barricate in una stanza, insieme con la sorellina Maryam di cinque anni e il fratellino Ali di due. Parvana usciva per qualche ora quasi tutti i giorni, per aiutare suo padre a camminare. Era sempre molto contenta di uscire, anche se questo significava restare seduta per ore su una coperta distesa a terra nel mercato. Se non altro era qualcosa da fare. Aveva perfino imparato a restare in silenzio e a nascondere il viso. Era piccola per i suoi undici anni: per questo di solito riusciva ad andare in giro senza essere fermata. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino La protagonista di Sotto il burqa, Parvana, ha undici anni, e da quando è nata il suo Paese, l’Afghanistan, è sempre stato in guerra. La sua famiglia, un tempo benestante, non possiede più nulla: per sopravvivere, il padre va al mercato a leggere e a scrivere lettere. In sua compagnia c’è sempre Parvana, che però deve stare nascosta dietro al chador e non può assolutamente dire che anche lei sa leggere, attività proibita alle donne dal regime talebano. Sembra che non possa andare peggio di così, e invece sì: quando il padre verrà arrestato, Parvana comprenderà che solo lei può aiutare la madre e i suoi tre fratelli e, con grande coraggio, si trasformerà in un’altra persona... Ecco come comincia il romanzo. Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino 42 Biblioteca on line 3. samovar: recipiente di origine russa per far bollire l’acqua per il tè. «Questa ragazza mi aiuta a camminare», spiegava il Papà additando la propria gamba a chi chiedeva spiegazioni. Aveva perso la gamba quando la scuola superiore in cui insegnava era stata bombardata. E forse aveva subito anche qualche altro danno non visibile: spesso era così stanco. «Il mio unico figlio maschio ha solo due anni», aggiungeva. Parvana si ritraeva un po’ più indietro sulla coperta e cercava di farsi piccola piccola. Aveva paura di guardare i soldati. Aveva visto cosa facevano, soprattutto alle donne, come frustavano e picchiavano chiunque secondo loro meritasse una punizione. Aveva visto molte cose, stando seduta al mercato, giorno dopo giorno. Quando i talebani erano nelle vicinanze, avrebbe voluto essere invisibile. Un cliente stava chiedendo a suo padre di rileggere una lettera. «Leggila piano, così riesco a ricordarmela e a raccontarla alla famiglia». A Parvana sarebbe piaciuto ricevere una lettera. Il servizio postale in Afghanistan era ripreso solo di recente, dopo anni di interruzione a causa della guerra. Molti dei suoi amici avevano lasciato il paese con le loro famiglie. Probabilmente erano in Pakistan, ma non ne era sicura e quindi non poteva scrivergli. Anche la sua famiglia aveva traslocato così spesso a causa dei bombardamenti che i suoi amici non sapevano più dove viveva. «Gli afghani sono sparpagliati sulla Terra come le stelle nel cielo», diceva spesso il Papà. Suo padre finì di leggere la lettera per la seconda volta. Il cliente lo ringraziò e pagò. «Ti cercherò quando dovrò rispondere». La maggior parte della popolazione in Afghanistan non sapeva leggere né scrivere. Parvana era una delle poche fortunate. Entrambi i suoi genitori erano stati all’università, e credevano che tutti, comprese le donne, avessero diritto a ricevere un’istruzione. Nel viavai dei clienti, il pomeriggio passò lentamente. La maggior parte di loro parlava Dari, la lingua che Parvana conosceva meglio. Quando un cliente parlava Pashtu, lei riusciva a capire la maggior parte delle parole, ma non tutto. I suoi genitori sapevano anche l’inglese. Suo padre aveva frequentato l’università in Inghilterra, ma era stato tanto tempo fa. Il mercato era un luogo molto movimentato. Gli uomini facevano la spesa per le loro famiglie e i venditori ambulanti vendevano per la strada quello che potevano offrire. Alcuni, come il negozio del tè, avevano una propria bancarella. Con il suo grande samovar3 e molti vassoi colmi di tazze, doveva stare in un posto fisso. I ragazzi correvano avanti e indietro per il labirinto del mercato, portando il tè ai clienti che non potevano lasciare i loro negozi, e riportando indietro le tazze vuote. «Potrei farlo anch’io», disse Parvana a bassa voce. Avrebbe voluto correre per il mercato e conoscere le sue stradine tortuose come le quattro pareti di casa sua. Suo padre si voltò a guardarla. «Preferirei vederti correre nel cortile di una scuola». Poi si voltò di nuovo per chiamare gli uomini che passavano di lì. «Qui si legge e si scrive! Pashtu e Dari! Bellissimi articoli in vendita!» Parvana s’incupì. Non era colpa sua se non poteva andare a scuola! Avrebbe preferito essere là invece che stare seduta su questa scomoda coperta, con la schiena che le faceva male. Le mancavano i suoi amici, la sua divisa bianca e blu, fare nuove cose ogni giorno. Storia era la sua materia preferita, soprattutto la storia afghana. Tutti erano venuti in Afghanistan. I Persiani c’erano arrivati quattromila anni fa. Era arrivato anche Alessandro Magno, seguito dai Greci, dagli Arabi, dai Turchi, dagli Inglesi e alla fine dai Sovietici. Un conquistatore, Tamerlano da Samarcanda, aveva decapitato i suoi nemici e impalato le loro teste una sopra l’altra, come meloni su una bancarella di frutta. Tutti questi popoli erano arrivati nel bellissimo paese di Parvana con l’intento di conquistarlo, ma gli Afghani erano sempre riusciti a scacciarli. Adesso però il Paese era governato dai soldati talebani. Erano afghani e avevano idee molto rigide su come le cose dovevano essere gestite. Quando per la prima volta occuparono la capitale Kabul e proibirono alle ragazze di frequentare la scuola, Parvana non ne fu particolarmente dispiaciuta. Aveva un compito di matematica che si avvicinava e per il quale non si era preparata, ed era finita nei guai per aver di nuovo chiacchierato durante la lezione. L’insegnante stava per darle una nota quando i talebani avevano preso il comando. «Perché piangi?» aveva chiesto a Nooria, che non la smetteva di singhiozzare. «Per me una vacanza è proprio quello che ci vuole». Parvana era sicura che i talebani avrebbero dato a tutti il permesso di tornare a scuola nel giro di qualche giorno; e allora il suo insegnante si sarebbe dimenticato di mandare quella nota a sua madre. «Sei solo una stupida!» aveva urlato Nooria. «Lasciami in pace!» Quando un’intera famiglia vive in una sola stanza, è davvero impossibile lasciare in pace gli altri. Dovunque andasse Nooria, c’era Parvana. E dovunque andasse Parvana, c’era Nooria. Entrambi i genitori di Parvana venivano da antiche e rispettabili famiglie afghane. Grazie all’istruzione che avevano ricevuto, erano stati in grado di guadagnare ottimi stipendi. Avevano abitato in una grande casa con il cortile, e avevano due domestici, la televisione, il frigorifero e l’automobile. Nooria aveva una camera tutta per sé e Parvana divideva la sua con Maryam, la sorellina piccola. Maryam parlava sempre tanto, ma adorava Parvana. Era stato certo piacevole poter sfuggire a Nooria qualche volta. La loro casa era stata distrutta da una bomba. Da allora avevano traslocato diverse volte. Ogni volta in un posto sempre più piccolo. Durante ogni bombardamento perdevano un po’ delle loro cose. A ogni bomba diventavano più poveri. Ora vivevano tutti insieme in una piccola stanza. Da più di vent’anni ormai, il doppio dell’età di Parvana, in Afghanistan c’era sempre stata una guerra. (D. Ellis, Sotto il burqa, trad. it. C. Manzolelli, Milano, RCS, 2003) 43 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Per riflettere 44 Biblioteca on line Antoine de Saint-Exupéry Il piccolo principe L’autore Lo scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry (1900-44) fu anche pilota in una linea commerciale; a questa esperienza si ispirarono i suoi primi libri, Corriere del Sud e Volo di notte. Nel 1939 si arruolò nell’aeronautica militare francese, in una squadriglia di ricognizione aerea, e scrisse Pilota di guerra. In piena seconda guerra mondiale, nel 1943, furono gli americani a pubblicare, per primi e in inglese, Il piccolo principe, romanzo in forma di fiaba che ebbe un successo internazionale. Saint-Exupéry morì nel cielo della Corsica, quando il suo aereo fu abbattuto dalla Luftwaffe, l’aviazione militare tedesca. Per molti anni, però, la sua morte rimase misteriosa, alimentando leggende su una scomparsa che sembrava presentare singolari coincidenze con le avventure narrate nel Piccolo principe. Solo di recente il ritrovamento dei resti dell’aereo guidato da Saint-Exupéry ha permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente e della morte. Il romanzo Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino Il piccolo principe è un vero caso letterario: è stato infatti tradotto in 180 lingue e ha venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo. In breve, si tratta di uno dei libri più letti e amati del XX secolo. È una fiaba moderna, che con toni delicatamente umoristici affronta temi importanti come l’amicizia e il senso della vita. Racconta la storia di un aviatore che, in seguito a un incidente, è costretto a un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara, dove incontra uno strano personaggio, un piccolo principe originario dell’asteroide B612 desideroso di raccontare ciò che ha visto e scoperto visitando dapprima altri asteroidi, e infine la terra. Il romanzo comincia così. Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell’atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C’era scritto: “I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede”. Meditai a lungo sulle avventure della jungla. E a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno. Era così: Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: «Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?» Il mio disegno non era il Per riflettere 45 Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all’aritmetica e alla grammatica. Fu così che a sei anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero uno e del mio disegno numero due mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un’altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po’ sopra tutto il mondo: e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d’occhio posso distinguere la Cina dall’Arizona, e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino. Ma l’opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l’esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva. Ma, chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva: «È un cappello». E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di avere incontrato un uomo tanto sensibile. (A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, trad. it. N. Bompiani Bregoli, Milano, RCS, 1994) Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © 2009 Loescher Editore - Torino disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos’era, disegnai l’interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. Il mio disegno numero due si presentava così:
Scarica