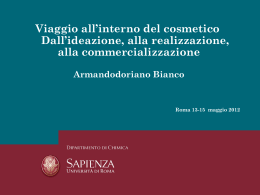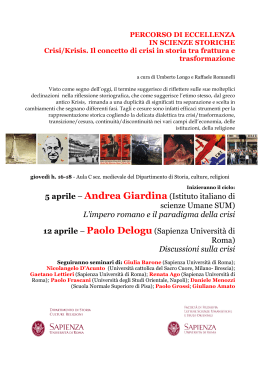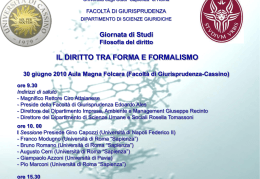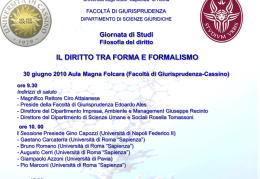Conoscenza e sapienza nella
Bibbia
di Marvin Olasky*
Il cattivo uso dell’intelligenza
Abbiamo bisogno di capire quale significato attribuisca la Bibbia alla ragione e alla
sua relazione con la fede, partendo dalla rivelazione divina. La ragione umana diventa intelligibile solamente se la si considera nel contesto della creazione. «Facciamo l’uomo a nostra
immagine» (Gn 1,26) è la premessa per comprendere come possiamo giungere alla conoscenza di qualsiasi cosa. I molti passi biblici che esaltano la saggezza e la conoscenza di
Dio chiariscono il significato di quella “immagine”, perchè ci insegnano che, essendo Dio
un essere che pensa, che ragiona, che conosce, Egli è la sorgente dell’intelligenza nelle sole
creature che ha creato a sua immagine.
La caduta dell’umanità nel peccato mostra i due modi in cui si è fatto cattivo uso dell’intelligenza. Il primo, nel terzo capitolo della Genesi, mostra la ragione in azione, con l’umanità che si pensa autonoma, capace di giudicare tra Dio e Satana. Il secondo, sempre
nello stesso passo, fornisce un modello per capire cosa succede quando la ragione esce dalla
propria sfera di azione. Esaminiamo più da vicino cosa è accaduto.
Dio: «Voi potrete mangiare liberamente di qualsiasi albero nel giardino, con una sola eccezione: se voi mangerete dell’albero della conoscenza del bene e del male, morirete».
Il serpente: «Dio ha detto che c’era un albero dal quale non avreste potuto mangiare?».
Eva: «Dio ha detto che noi non avremmo potuto mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male o saremmo morti».
Il serpente: «Voi non morirete. Dio ha detto ciò perché Egli sa che se voi mangerete
sarete come Lui, conoscitori del bene e del male»1.
*Marvin Olasky è
Docente di
Giornalismo,
University of Texas.
Così finisce il dialogo, seguito poi dalla disobbedienza di Eva, che mangia il frutto
proibito. L’interpretazione comune di questo brano considera la tentazione centrata sul soddisfacimento di desideri fisici, ma la lezione del passaggio è diversa, perché la tentazione è
stata, nella sua essenza, di tipo intellettuale. Guardiamo a ciò che è accaduto nell’intervallo tra la promessa del serpente e il momento in cui Eva mangia realmente il frutto: «La
donna ha visto che il frutto di quell’albero era buono da mangiare e piacevole agli occhi, e
33
Conoscenza e sapienza nella Bibbia
di Mar vin Olasky
anche desiderabile per acquistare la sapienza» (Gn 3,6).
Il frutto era certamente buono da mangiare e costituiva una delizia per gli occhi, ma
la vera tentazione sembrerebbe la sapienza (nel Giardino c’era una gran quantità di cibo che
era permesso prendere, né era proibito ammirare l’albero). Eva ha ascoltato la promessa del
serpente: sarebbe diventata saggia senza Dio, e con questa nuova saggezza sarebbe stata
veramente come Dio. La somiglianza promessa dal serpente non riguardava la forza di Dio o
la sua bontà o qualche suo altro attributo, ma soltanto la sua sapienza.
La tentazione intellettuale
La tentazione, dunque, è stata primariamente verso un compimento intellettuale,
staccato dalla grazia e dal favore di Dio. Ogni qualvolta pensiamo che la ragione umana sia
sufficiente da sola a capire le cose ultime della vita («Sarete come Dio e conoscerete il bene
e il male»), noi ci smarriamo. La Bibbia mostra che il peccato non riguarda solamente la
nostra vita morale e spirituale, ma anche la nostra vita intellettuale. In questo modo si afferma che Cristo è Signore non solamente dello “spirituale”, in senso stretto, ma di ogni cosa,
inclusa anche la mente.
La componente intellettuale dell’autonomia umana è evidente anche nell’episodio
della Torre di Babele (Gn 11,1-9): qui la ribellione contro Dio parte da una unità di linguaggio e quindi di pensiero e di scopo. La risposta di Dio si attua confondendo la capacità
dei costruttori di comunicare tra loro: «Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro».
Dio ha però sempre comunicato in modo chiaro e ragionevole con coloro che Egli ha
scelto. Uno degli esempi più illuminanti dell’uso della ragione da parte di Dio si trova nel
terzo libro dell’Esodo, quando Dio dice a Mosè che egli avrebbe condotto Israele fuori dalla
schiavitù e verso la libertà promessa. Ascoltiamo il dialogo:
Mosè: «Io non sono l’uomo giusto. Io non ho ciò che tu pretendi».
Dio: «Questo non è importante, perché io sono con te, e ti darò un segno che verrà
dimostrato nei fatti».
Mosè: «Se mi chiedono chi mi ha mandato, che cosa risponderò?».
Dio: «Di’: “Io-sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi ha mandato a voi”».
Mosè: «Ma essi non mi crederanno».
Dio: «I miracoli che compirò, li convinceranno».
Mosè: «Manda qualcun’altro».
Dio: «Io manderò tuo fratello Aronne con te e sarà il tuo portavoce».
Questa la fine del dialogo, un dialogo appunto, non semplicemente una serie di
comandi. Dio mostra a Mosè il più grande rispetto per i suoi argomenti, nel senso che li
accoglie e indica la Sua soluzione a ogni obiezione. Mosè dunque deve decidere se essere
obbediente o ribelle. Nel momento in cui Mosè dice: «Manda qualcun altro» si passa su un
altro terreno, da quello della ragione al primo mormorio di ribellione. L’ubbidire a Dio, e
34
Conoscenza e sapienza nella Bibbia
di Mar vin Olasky
non la continua indecisione, è un segno principale di fede. Occorre tenere lo sguardo fisso
sul confine tra ragione e ribellione, che è anche quello tra la mera conoscenza e la saggezza che dà la vita.
Le radici della vera sapienza
Al suo inizio, il libro dei Proverbi spiega il fine per cui è stato scritto, una spiegazione che contiene un alto «elogio della conoscenza». Il libro è utile «per conoscere la sapienza e la disciplina, per capire i detti profondi, per acquistare un’istruzione illuminata, equità,
giustizia e rettitudine, per dare agli inesperti l’accortezza, ai giovani conoscenza e riflessione. Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l’uomo accorto acquisterà il dono del consiglio,
per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi» (Pr 1,2-6).
Abbiamo bisogno, però, del versetto successivo per inserire queste righe nel loro contesto: «Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e
l’istruzione».
Il risvolto è che nei Proverbi l’esaltazione della sapienza dipende dal profondo radicamento della conoscenza nel timore del Signore. I Proverbi mettono in guardia dall’affidarsi
troppo alla ragione umana (Pr 3,5), perché tale tipo di ragionamento spesso si sottrae al
timore di Dio, divenendo insensato. La mente è abbandonata a se stessa, diventa il veicolo
dell’arroganza e della distruzione finale. I Proverbi affermano, punto di fondamentale importanza, che la sapienza ci è data dalla libera grazia di Dio. Essa non è ottenuta semplicemente con un lavoro diligente: «Perché è il Signore che dà la sapienza, dalla sua bocca esce
scienza e prudenza» (Pr 2,6). Quelli che riceveranno il dono devono desiderarlo, devono
«invocare l’intelligenza e chiedere ad alta voce la conoscenza» (Pr 2,3). Devono essere pronti ad accettare le istruzioni, i comandi e i consigli: lo sciocco è saggio ai suoi propri occhi,
ma il saggio sa che la sua saggezza è piccola cosa in confronto a quella di Dio.
Durante l’epoca dei profeti, Isaia (29,14) e Geremia (8,8) hanno criticato aspramente i saggi ai loro propri occhi. Il brano di Isaia è particolarmente pertinente, perché pone in
questa prospettiva l’universale accettazione dell’attributo della sapienza: Dio estirperà «la
sapienza del sapiente» e «l’intelligenza dell’intelligente». Questo significa che la falsa
sapienza di chi si pensa autonomo, un giorno apparirà per quello che in realtà è, cioè insensatezza. È per questo motivo che i Proverbi consigliano (Pr 3,5): «Confida nel Signore con
tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza». La Bibbia, però, non è con chi considera l’ignoranza come una virtù, perchè Dio dice: «Perisce il mio popolo per mancanza di
conoscenza»2 (Os 4,6).
La storia di Daniele può aiutare a capire meglio l’utilizzo della ragione umana nel contesto dell’obbedienza a Dio. Come si narra nel libro di Daniele, il re Nabucodonosor stava
cercando i migliori tra gli ebrei, quelli che dimostravano particolare attitudine ad apprendere, per porli al suo servizio, e i suoi servi avevano l’incarico di educare i ragazzi prescelti nel
linguaggio e nella letteratura babilonese (Dn 1,4).
Daniele si trova di fronte a una situazione che ha messo in difficoltà tanti cristiani
durante i secoli e che dura tuttora. Da un lato c’è la tentazione di cedere alla cultura della
35
Conoscenza e sapienza nella Bibbia
di Mar vin Olasky
società in cui si è inseriti, per dirla con Paolo, conformandosi al mondo (Rm 12,2).
Dall’altro, il rischio di ghettizzazione, il timore del conformarsi al mondo spinge il popolo di
Dio ai margini, incapace di giocare un proprio ruolo nella cultura.
Daniele ha deciso di non essere travolto dalla cultura pagana in cui vive: dato che ai
quei tempi la condivisione dei pasti assumeva il significato di un’alleanza, Daniele e i suoi
tre amici convincono i servi del re a permettergli di astenersi dalla mensa reale, ma non consentono che questo li releghi ai margini della società. Né lo consente Dio, che premia la loro
fedeltà, dando loro la capacità di «conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza»
(Dn 1,17). Quando il re parla con loro «in qualunque affare di sapienza e intelligenza li trovò
dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi che c’erano in tutto il suo regno» (Dn 1,19-21).
In Daniele, la pietà unita alla conoscenza costituiscono la sapienza. Questa sapienza
ha un impatto sia culturale che evangelico su Nabucodonosor, che dice a Daniele: «Certo il
vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei misteri, perché tu hai potuto
svelare questo mistero» (Dn 2,47).
La ragione nel Nuovo Testamento
Il Nuovo Testamento spiega ulteriormente il concetto di ragione dell’Antico
Testamento. Quando uno scriba interroga Gesù chiedendogli quale fosse il più grande
comandamento, Cristo risponde: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il più grande comandamento» (Mt
22,37). “Con tutta la tua mente”. Apparentemente c’è qualcosa nel modo in cui la mente
ama Dio, che è diverso dal modo di amare del cuore e dell’anima.
Gli Atti degli Apostoli (At 17,16-34) mostrano bene la combinazione di pietà e di
ragione di Paolo. Arrivando ad Atene, Paolo «aveva provato grande sofferenza nel vedere che
la città era piena di idoli». Piuttosto che attaccare, Paolo «discuteva nella sinagoga con i
Giudei e i Greci credenti in Dio, come pure nella piazza del mercato, giorno dopo giorno, con
coloro che incontrava». Così, Paolo viene convocato nell’Areopago, di fronte ai leader culturali e intellettuali di Atene.
I successivi tre passaggi sono cruciali. Primo. Parlando ai principali filosofi della città,
Paolo crea un punto di contatto: «Passando e osservando i monumenti del vostro culto, ho
trovato anche un’ara con l’iscrizione: “Al Dio ignoto”. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio» (At 17,23). Secondo. Egli mostra la sua conoscenza degli ateniesi citando i loro poeti, così da non essere preso per un ignorante. Terzo, e più importante
passaggio. Paolo non cerca un compromesso teologico, ma afferma chiaramente che Dio
«ora ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi» (At 17,30), e parla di risurrezione dei morti, anche se ciò suscita lo scherno di alcuni e provoca la fine dell’incontro.
Quell’incontro è stato un fallimento? Niente affatto. «Alcuni aderirono a lui e divennero credenti» (At 17,34). Paolo, ad Atene, non ha disprezzato Atene per mostrare la sua
fedeltà a Gerusalemme. Egli ha predicato ciò che praticava e ha messo in guardia contro la
seduzione dell’intelligenza del mondo (1Cor 1,2), delle cattive tradizioni umane che si
appoggiano a «filosofia e vuoto inganno» (Col 2,8), delle «contraddizioni di ciò che è falsa-
36
Conoscenza e sapienza nella Bibbia
di Mar vin Olasky
mente chiamata conoscenza» (1Tm 6,20). Non ha tuttavia ignorato la ragione, a causa del
suo frequente abuso: ha usato la ragione correttamente. Paolo ha scritto che un cristiano
deve servire Dio: «trasformatevi rinnovando la vostra mente» (Rm 12,2). Egli ha anche scritto «rendendo ogni intelligenza soggetta all’obbedienza a Cristo» (2Cor 10,5): così Paolo ha
messo in guardia i Corinti dalla sapienza del mondo, ma li ha anche invitati a giudicare da
soli quanto egli diceva, perché erano persone sensate (1Cor 10,15).
Dare ragione di ciò in cui si crede
Anche altri apostoli sono stati difensori della fede, cioè sono stati pronti ad argomentare. L’ammonizione di Pietro: «pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi» (1Pt 3,15), ha lo stesso intento apologetico, quello cioè di produrre argomenti per sostenere la fede cristiana. L’accento posto sulla capacità di ogni cristiano di dare ragione della propria fede porta a un altro importante punto: spesso le descrizioni della ragione enfatizzano gli aspetti intellettuali, portando così fuori strada. Siamo portati a pensare che la parola intellettuale si riferisca soltanto al mondo universitario: questo
approccio accademico alla storia intellettuale fa pensare alle grandi figure di Platone,
Cartesio, Spinoza, Voltaire, rischiando di farci ritenere che la gente normale non vi sia coinvolta.
L’insegnamento biblico, è invece diverso: in un certo senso, ogni cristiano è un intellettuale, perché ogni cristiano deve pensare e credere, non solo celebrare determinati riti.
La faccia dell’Europa, e anche delle sue colonie, è stata cambiata proprio da questo: i bravi
preti nelle loro omelie non solo comandavano ai loro parrocchiani di essere buoni, ma si confrontavano con loro e lo facevano all’interno della Rivelazione.
Ciò vale anche oggi, quando parliamo delle applicazioni pratiche dei principi della
Bibbia. Applicare con profitto la Bibbia non richiede un particolare intelletto, ma si impara
a essere fedeli obbedendo alla Parola di Dio e capendo che la Bibbia non insegna solo cosa
si debba e non si debba fare, ma ci offre anche una struttura di comprensione, una visione
del mondo.
Non potremmo aspettarci altro messaggio, perché quando Dio è apparso in forma
umana, Egli lo ha fatto sotto questo nome: il Verbo. Di più, il brano che ci informa di questa buona novella, afferma che la Parola esisteva ancora prima della creazione (Gv 1,1). Dio
dice che dobbiamo conoscerlo nella sua essenza e come azione, ma anche come Verbo, che
è qualcosa che deve essere afferrato dall’intelletto e capito.
Inoltre, la speciale rivelazione che ci è stata affidata è venuta in forma di parole. Uno
dei titoli con i quali Gesù era conosciuto, è Maestro e i Vangeli sono composti largamente
da insegnamenti di Cristo. Se la cristianità americana ha compiuto meno di quello che
avrebbe potuto, è in parte perché abbiamo ignorato il chiaro messaggio di Cristo di amare
Dio con tutta la nostra mente, come con tutto il nostro cuore e la nostra anima. Non abbiamo utilizzato gli strumenti che sono esclusivamente nostri, ma abbiamo provato ad usare
idee di seconda mano di ideologie sempre più logore, che dominano il mondo accademico e
i principali media.
37
XQ SDUWQHU GLIIHUHQWH
WHDP VHUYLFH
PROWR SL GHO VROLWR IRUQLWRUH
6('(
5RPD
3LD]]D $WWLOLR 3HFLOH 4EAM 3ERVICE NON á
UN SEMPLICE FORNITORE
³ UN VERO E PROPRIO PARTNER DELLAZIENDA IN GRADO
DI AFFIANCARLA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI
,A CAPACITÜ DI PROPORRE
LA FORZA DI INNOVARE
5NA DELLE PECULIARITÜ DI 4EAM 3ERVICE á LA COSTANTE
RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE DA PROPORRE AL
CLIENTE PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO RIDUCENDO
TEMPI E COSTI
5NA REALTÜ CHE ANCHE I NUMERI
AIUTANO A CAPIRE
5N VOLUME DI AFFARI DI OLTRE MILIONI DI EURO
0IÂ DI PERSONE IMPIEGATE
7HO 4EAM 3ERVICE NON á UNA
SEMPLICE SOCIETÜ DI SERVIZI
³ UNA SOCIETÜ CONSORTILE E LA DIFFERENZA
á FONDAMENTALE
5NA SINGOLA SOCIETÜ NON PUÒ GARANTIRE LO STESSO
LIVELLO DI COMPETENZA IN TANTI CAMPI DIVERSI
,E PERSONE GIUSTE
AL MOMENTO GIUSTO
#ON 4EAM 3ERVICE IL CLIENTE DISPONE DI TUTTE LE
RISORSE CHE GLI SERVONO NEL LUOGO E NEL MOMENTO
IN CUI GLI SERVONO
)D[ ZZZ WHDPVHUYLFHLW
),/,$/, ,1 ,7$/,$
0LODQR
7RULQR
*HQRYD
9HURQD
8GLQH
%RORJQD
WHDP VHUYLFH
DG RJQL ULFKLHVWD OD ULVSRVWD JLXVWD
!REA
)GIENE !MBIENTALE
0ULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI
3ANIFICAZIONE AMBIENTALE
$ERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
&ACCHINAGGIO E TRASPORTI
-ANUTENZIONE AREE VERDI
!REA 'ESTIONE %NTRATE E
"ANCHE $ATI
/RGANIZZAZIONE E GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA
BANCA DATI TRIBUTARIA INTEGRATA
2IORDINO AGGIORNAMENTO E MATCHING
DEGLI ARCHIVI DISPONIBILI
!REA
&ORMAZIONE 0ROFESSIONALE
&ORMAZIONE PROFESSIONALE
2IQUALIFICAZIONE
!GGIORNAMENTO
!REA
,OGISTICA
'ESTIONE MAGAZZINI E PIATTAFORME
!SSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
#ONSULENZA LOGISTICA
4RASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
)LUHQ]H
3HUXJLD
3HVFDUD
$QFRQD
!REA
'ESTIONE 2ISORSE 5MANE
2ICERCA E SELEZIONE
3TAFF LEASING
/UTSOURCING DELLA GESTIONE HR
!REA
3ERVIZI 3ANITARI
'ESTIONE 23!
'ESTIONE GLOBALE CASE DI RIPOSO E RESIDENZE PROTETTE
!SSISTENZA DOMICILIARE
'ESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
!REA
3ERVIZI #ONGRESSUALI
3EGRETERIA
)MPIANTI TECNICI
3ERVIZI MULTIMEDIALI
!REA
2ISTORAZIONE
,VHUQLD
1DSROL
&RVHQ]D
%DUL
&DJOLDUL
3DOHUPR
),/,$/, 1(/ 021'2
%XFDUHVW
0DGULG
/LVERQD
6DR 3DXOR
6DQWLDJR GHO &KLOH
'ESTIONE DI BAR E MENSE
0ROGETTAZIONE LOCALI
2EALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E ARREDI
!REA
2ECEPTION
#ENTRALINO MULTIFUNZIONALE
#ONTROLLO INFORMATIZZATO DEGLI ACCESSI
(OSTESSING PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
3TUDIO E ORGANIZZAZIONE DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE
W H D P
V H U Y L F H
Conoscenza e sapienza nella Bibbia
di Mar vin Olasky
La Cristianità non è una esperienza “significativa” o altamente estetica. È piuttosto
una questione di verità, di credere e dire cose che sono in accordo con la realtà esterna. È
questo il motivo per cui Paolo scrive ai Corinzi che non sarebbe stata accettabile nessuna
confortante dottrina spiritualizzata della risurrezione. O Cristo era effettivamente risorto dalla
morte, come cinquecento testimoni erano pronti a testimoniare, oppure la loro speranza era
vana (1Cor 15). C.S. Lewis scrisse che la cristianità non è come un farmaco che si prende
perché fa bene. Se non fosse vero, allora nessuna persona onesta vorrebbe avere a che farci.
Ragione e rivelazione sono in armonia
L’uso corretto della nostra ragione è possibile quando, all’interno della nostra visione
del mondo, capiamo che Dio ci ha creati. Non essendo al Suo stesso livello, dobbiamo usare
la nostra ragione nei termini di Dio, non perché Egli è un dittatore (anche se Dio è onnipotente), ma perché i Suoi termini sono gli unici veramente ragionevoli. Nient’altro ha senso,
perché nessun altro apparato argomentativo è in sintonia con il modo con cui il mondo veramente funziona. Ogni tentativo di elevare la nostra ragione al livello di quella di Dio, è irragionevole. Noi possiamo ragionare, perché Dio ci ha creato a Sua immagine: la ragione è una
caratteristica di Dio e Lui ci dà qualcosa di analogo al Suo potere di ragionare. Questo è
parte di ciò che si intende con «essere creati a immagine di Dio».
Quando Paolo mette in guardia i Corinzi contro la sapienza di questo mondo, spiega
che prende questa posizione, perché quella “sapienza” in realtà è insensatezza e li consiglia di dare ascolto alla vera sapienza. L’avvertimento di Paolo a Timoteo non è contro la
conoscenza, ma contro ciò che è «falsamente chiamato conoscenza» (1Tim 6,20). Perciò
non è giusto opporre ragione a rivelazione, perchè la vera ragione e la Rivelazione sono in
armonia. Quando la nostra mente ci porta ad abbracciare la falsa sapienza, ci getta nella
schiavitù delle illusioni della nostra epoca. In contrasto con questa schiavitù, Dio ci invita:
«Venite, ragioniamo insieme» (Is 1,18). Noi possiamo ragionare con Dio solamente quando
capiamo che la nostra ragione è un riflesso del fatto che siamo stati creati a immagine di
Dio (Gn 1,26).
La ragione non è uno strumento dell’autonomia dell’uomo, né un’arma con cui opporsi a Dio. Quando noi comprendiamo la maestà di Dio e mettiamo la nostra ragione al Suo
servizio, Dio ci consente di dialogare con Lui, e solo in forza di ciò noi possiamo dare il
nostro pieno contributo al Regno di Dio.
Note e indicazioni bibliografiche
1 Gn 2,16-17; 3,1-5. Abbiamo un po’ schematizzato la discussione per mostrare la relazione tra i discorsi. Vale la pena
notare che Eva è una reporter imprecisa, poiché riferisce anche al serpente che Dio aveva ordinato di non toccare l’albero, mentre non vi è nessuna traccia di questa affermazione.
2 Dio dice anche: «Perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti» (Is 5,13). Geremia (4,22) nota
che i figli di Israele «non mi conoscono, sono figli insipienti, senza intelligenza; sono esperti nel fare il male, ma non
sanno compiere il bene».
39
Scarica