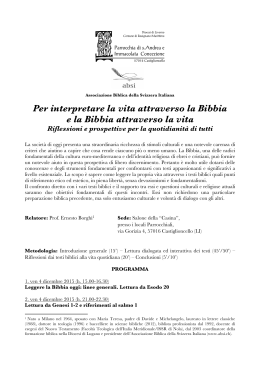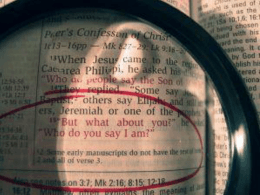Master Antropologia e Bibbia lezioni 2009 Appunti per le lezioni su Bibbia e Letteratura Alessandro Ratti 1. La Bibbia è letteratura George Santayana (1863 – 1952), filosofo spagnolo:«La Bibbia è letteratura, non dogma». (dall’Introduzione all’Etica di Spinoza) «Io non sapevo che la Bibbia fosse poesia! Pensavo che non fosse altro che religione!» (Sinclair Lewis) «Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile agli uomini» (Cost. Dei Verbum, 13). «..tutti interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti … hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture». (Cost. Dei Verbum, 11). Dalla Bibbia, che è essa stessa fenomeno letterario, è nata fin dall’inizio una progenie di libri e di forme letterarie figlie. Pensiamo ai libri della florida letteratura apocrifa dell’Antico e del Nuovo Testamento, che amplifica e interpreta narrativamente i passaggi sintetici degli scritti canonici (Si veda il Protovangelo di Giacomo [midrash cristiano scritto intorno al 200 dC.] e il suo influsso sulla stessa Chiesa e le festività dei Santi Giocchino e Anna, della presentazione della Madre di Dio al Tempio….nonostante già nel 405 condannato da Papa Innocenzo I. Dice C. Mazzucco che in realtà «è possibile riconoscere che lo scritto risponde a questioni di questo tipo e ha una chiara impronta apologetica», «un’apologia in forma di racconto, in cui l’elemento teologico è inserito nella narrazione. In risposta alle critiche e ai dubbi circolanti»). Pensiamo allo stesso libro santo dell’Islam, il Corano, che in senso letterario è certamente figlio della rivelazione ebraico-cristiana e prodotto partendo dal materiale biblico1. Tutta la letteratura di commento del Primo Testamento, sorta e diffussasi in campo ebraico (Talmud, Mishna… fino ai Midrashim e alla produzione moderna dei Hassidim2) manifesta la permanenza dell’immaginario biblico al fondo della costruzione culturale giudaica. Ma anche in campo cristiano, sia occidentale che orientale, l’eredità biblica è stata messa a profitto e fatta letterariamente fruttificare. I padri Orientali greci e i padri Latini, che chiudono le grandi stagioni della letteratura nelle lingue del mondo antico (la cosiddetta “letteratura cristiana antica”), sono in massima parte autori di commenti ai libri biblici (Basilio, Giovanni Crisostomo, Agostino, Gerolamo… fino ai medievali predicatori e poeti: Francesco d’Assisi, Iacopone, Dante, Bernardino da Siena…). L’influenza della letteratura biblica sulla cultura giudeo-cristiana-musulmana è difficilmente sopravvalutabile. Le radici bibliche della letteratura del nostro continente, insieme a quelle grecoromane, sono palesi a chiunque non disdegni ideologicamente di vederle. Tanto fu l’influsso della Bibbia sulla letteratura e sulla stessa lingua tardo antica, quando il mondo greco-romano si svegliò cristiano, che anche Giacomo Leopardi ne scriverà, lamentandosi, nel suo Zibaldone: 1 2 Cf. CHERUBINO MARIO GUAZZETTI, Bibbia e Corano: un confronto sinottico, San Paolo 1995. Cf. le opere di Martin Buber sul fenomeno hassidico. 1 E se vogliamo vedere l’influenza straniera sulla lingua greca, e come subito la corruppe, per incorruttibile che paia, come abbiamo dimostrato; sebbene è difficile trovar cosa straniera in detta letteratura, consideriamo l’unico (si può dir) libro straniero che introdotto in Grecia (o ne’ paesi greci) abbia influito sopra i suoi scrittori, e che sia stato ai greci oggetto di studio. Lasciamo l’influenza del latino nel greco dopo Costantino, influenza che tardò molto a propagarsi e a guastare definitamente la lingua, perché si esercitò piuttosto sul parlato che sullo scritto, e dal parlato arrivò solo dentro lungo spazio, alla letteratura. Io voglio parlare della Bibbia. Esaminiamo i padri greci da’ primi fino agli ultimi, e vi troveremo immediatamente una visibilissima e sostanziale corruzione di lingua e di stile, derivata dagli ebraismi, dall’uso dello stile profetico, salmistico, apostolico, dalla brutta e barbara e spesso continua imitazione della scrittura, dal misticismo della Religion Cristiana. Corruttela che è comune anche agli scrittori cristiani che non avevano punto che fare colla Palestina, o con altri paesi, dove la lingua greca volgare fosse guasta da mescolanza di ebraico, o d’altro dialetto propagato fra’ giudei ec.; non erano giudei di stirpe, ec. ec. Ma erano stranieri di setta, e quindi anche barbari di gusto. Lascio la traduzione dei Settanta, e il Nuovo Testamento. Le stesse cause di corruzione influirono pure sulla lingua e sullo stile de’ padri latini. Ma da queste, com’è naturale, si preservarono gli scrittori profani contemporanei, sì greci che latini, e non pochi degli stessi scrittori cristiani, o trattando materie profane, o anche più volte nelle stesse materie ecclesiastiche, secondo la coltura, gli studi e l’eleganza degli scrittori. (27 Maggio 1821)3. Con il passaggio alla prima letteratura in volgare in Italia, assistiamo alla specializzazione di due settori della letteratura (secondo il De Sanctis nel cap. VI, dedicato al Trecento, della sua Storia della Letteratura italiana): La letteratura volgare in senso prettamente religioso si stende per due secoli da Francesco di Assisi e Iacopone sino a Caterina. L’Allegoria dell’anima, la rappresentazione del Giovane monaco, l’Introduzione alle virtù, la Commedia dell’anima sono in forma letteraria la teoria di questo mistero, che nelle lettere di Caterina raggiunge la sua perfezione dottrinale, ed acquista la sua individuazione o realtà storica ne’ Fioretti, nelle leggende e nelle visioni del Cavalca e del Passavanti…. Ma questa letteratura era senza eco nella classe colta da cui esce l’impulso della vita intellettuale. Dante spregiava il latino della Bibbia, come privo di dolcezza e di armonia. Quello scrivere così alla buona e come si parla era tenuto barbarie e rozzezza. Vagheggiavano una forma di dire illustre e nobile, prossima alla maestà del latino, della quale Dante die’ nel Convito un saggio poco felice. Nè potea piacere quella semplicità di ragionamento con tanta scarsezza di dottrina ad uomini che uscivano dalle scuole con tanta filosofia in capo, con tanta erudizione sacra e profana. Ma se aveano in poco conto quella letteratura, giudicata povera e rozza, non era diverso il concetto che essi avevano della vita. I teologi filosofavano e i filosofi teologizzavano. In questi due secoli abbiamo due letterature quasi parallele, e persistenti l’una accanto all’altra: una schiettamente religiosa, chiusa nella vita contemplativa, circoscritta alla Bibbia e a’ santi Padri, e che ha per risultato inni e cantici e laude, rappresentazioni, leggende, visioni, e l’altra che vi tira entro tutto lo scibile e lo riduce a sistema filosofico, e abbraccia i vari aspetti della vita, e dà per risultato somme, enciclopedie, trattati, cronache e storie, sonetti e canzoni. Tra queste due letterature erra la novella e il romanzo, eco della cavalleria, rimasti senza seguito e senza sviluppo, quasi cosa profana e frivola. …La letteratura popolare va a finire nelle lettere dottrinali e monotone di Caterina: il suo difetto ingenito è l’astrazione dell’ascetismo. La letteratura dotta va a finire nelle sottigliezze 3 GIACOMO LEOPARDI, Zibaldone, pp. 1095-1096; in Tutte le opere, a cura di Walter Binni con la collaborazione di Enrico Ghidetti, vol. II, Sansoni, Firenze 1969. 2 scolastiche del Convito: il suo difetto intrinseco è l’astrazione della scienza. Tutte e due hanno una malattia comune, l’astrazione, e la sua conseguenza letteraria, l’allegoria4. 2. L’immaginazione plasmata dalla Bibbia e lasciata in dote culturale (dimenticata) alle letterature nate dalle sue radici5 Da Dante a Bach, da Cervantes a Oscar Wilde, da Thomas Mann a Bulgakov, da Michelangelo a Chagall, la presenza della Bibbia nella cultura occidentale è talmente pervasiva da risultare addirittura invisibile; sembra un paradosso, ma è così. Il mondo del Vecchio e del Nuovo Testamento, che ha dato vita, personaggi, simboli e strutture narrative a duemila anni di storia dell’arte spesso viene dato per scontato, considerato ovvio e di fatto ignorato. Anche - o forse, soprattutto - nei suoi capolavori. Difficile trovare un’opera di Shakespeare, per fare un esempio tra i tanti possibili, priva di riferimenti biblici: Lady Macbeth è un personaggio tratto da una leggenda scozzese, ma le sue parole riecheggiano quelle della regina Gezabele nel primo libro dei Re, mentre la Tempesta attinge a piene mani al libro della Genesi. Si potrebbe, senza ingannarsi di molto, affermare che ai tempi di Shakespeare di tutte le possibili fonti per la composizione di un dramma o di una commedia il Nuovo e l’Antico Testamento rappresentassero l’unico testo davvero comune, alla portata di un pubblico vasto e composito: chiunque, potenzialmente, avrebbe potuto coglierne, a livelli diversi, gli sviluppi tematici e narrativi. Difficile immaginare una fonte testuale più comoda da usare per un autore teatrale dell’epoca, come dimostra Naseeb Shaheen nella sua opera sulle occorrenze bibliche nelle opere del Bardo. L’indifferenza per la Sacra Scrittura non è un sintomo di buona salute per la repubblica delle lettere; se l’argomento è percepito come “specialistico” è perché la letteratura è diventata un divertissement tanto superficiale quanto irrilevante e non parla più - se non raramente - dei destini dell’uomo, della lettura del cosmo, del senso del vivere, e anche la Bibbia non è più percepita come l’epica di un popolo, una storia di infedeltà e tradimenti ma anche di visioni, profezia, dialogo e “duello” con Dio quale è stata per generazioni. Un immenso serbatoio di storie e di memoria condivisa ….. Un debito enorme. «Nel Vecchio Testamento ci sono storie, fatti, personaggi grandiosi; impossibile trovare qualcosa di simile nella letteratura greca» diceva il filologo classico Nietzsche. Nella modernità è prevalsa una lettura della Bibbia come testo unitario, e come tale ha influenzato l’immaginazione dell’Occidente. Il grande debito che la cultura occidentale in tutte le sue forme ha contratto nei confronti della Bibbia negli ultimi due secoli, Ottocento e Novecento, non è ancora stato riconosciuto in forma adeguata; ecco perché il master cerca le fonti bibliche della cultura europea, e le scoperte sono davvero tante e stupefacenti: scoprire quanto devono alla Scrittura le grandi opere musicali, letterarie, artistiche, teatrali, filmiche, giuridiche, filosofiche che l’uomo d’oggi considera alimenti quotidiani della propria cultura. Le radici giudaico-cristiane della cultura europea, in realtà possono essere viste – almeno dal punto di vista della letteratura e delle arti – come radici che affondano nell’humus biblico L’obiettivo che ci si può porre, in dialogo con letteratura laica, soprattutto di matrice italiana, è quindi rendere più consapevole e profonda la conoscenza spesso “subliminale” e superficiale della Sacra Scrittura. 4 F. DE SANCTIS, Storia della Letteratura Italiana, a cura di Giorgio Luti e Giuliano Innamorati, Sansoni, Firenze 1960. Questo paragrafo è ripreso in gran parte da: SILVIA GUIDI ,Quella Musa dimenticata che ha generato la cultura europea, in «L’Osservatore Romano», 20 agosto 2008. 5 3 L’opinione comunemente vulgata che la Bibbia sia irrilevante nella cultura della modernità non si giustifica se non per una mancanza di riflessione mirata, che impedisce di constatare la situazione reale, ossia la pervasività dell’azione ispiratrice che ha fatto della Bibbia il «grande codice dell’Occidente», secondo la felice espressione di Northrop Frye, per la sua capacità di offrire una struttura immaginativa, narrativa e legislativa, che va dal giardino dell’Eden, alle tavole della Legge sul Sinai, alla conquista della Terra promessa, alla forza vitale del Vangelo che fa nascere la comunità dei credenti, alla Gerusalemme celeste che discende dal cielo. Le radici lontane dell’eclissi della Scrittura dalla cultura Il malinteso culturale è dovuto all’indebita separazione tra fede e ragione perseguita dall’illuminismo, per cui al «credere» veniva riservato lo spazio della soggettività svalutata, irrilevante storicamente; il malinteso cade di fronte ai dati dell’evidenza, documentata dalle ricerche in tutti i campi, a cominciare da quello politico-sociale, dove la normatività della legge e l’insistenza sull’eguaglianza degli uomini hanno mostrato di avere le loro radici nei libri della Sacra Scrittura. Come vedremo, per l’ambiente cattolico, il problema dell’eclissi della Bibbia dalla letteratura viva e popolare ha tra le sue origini anche il movimento della Controriforma della fine del ‘500 e del ‘600. Il movimento Cattolico di opposizione e resistenza all’incipiente Luteranesimo e Calvinismo ricorse a mezzi drastici per impedire il dilagare della lettura protestante della Bibbia. La Bibbia non doveva essere tradotta. il divieto di traduzione della Bibbia (in opposizione alla traduzione tedesca di Lutero) è di Papa Paolo IV (1559) reiterato da Clemente VIII (1596). Non poteva darsi lettura privata, perché questo poteva essere sempre frainteso per “libero esame” della Scrittura. La Bibbia viene quindi fatta uscire dai circuiti di normale fruizione culturale. I temi della predicazione popolare cambiano: dall’interpretazione dei passi e delle storie bibliche, fino al ‘500 patrimonio comune dell’intera popolazione europea, diventano (pur senza generalizzare), in casa cattolica, sempre più sermoni morali, panegirici di santi, esortazioni parenetiche o elucidazioni dogmatiche e catechistiche che sorvolano sulle origini bibliche delle loro argomentazioni. L’accentuazione protestante della Sola Scriptura genera un movimento cattolico uguale e contrario di spinta sul Solo Magistero. L’eclissi della letteratura biblica ha comportato nei secoli seguenti un impoverimento da cui ancora la cultura italiana stenta a uscire. Diceva Carlo Ossola (intervistato sul Corriere della Sera, 5 marzo 1998, pag. 31: Bibbia. Il ritorno del libro assente di Polese Ranieri): E’ pur vero che nell’età tridentina e barocca, alla sottrazione della Bibbia supplì un grande programma - iconografico e musicale - di apologetica degli “affetti”; ma è anche vero che questa “religiosità degli affetti”, dopo sant’Alfonso Maria de Liguori, si è piuttosto stemperata. Non abbiamo più oggi una rigogliosa “arte sacra”, in nessun settore. Sono prevalsi, dall’Ottocento in poi, i segni (e i santi) delle opere sociali: alacri “benefattori”, come don Bosco, ai quali la Chiesa si affida soprattutto quando, al nascere della moderna civiltà industriale, essa si propone come infermiera della società, supplente delle istituzioni civili. Nè la santità, nè l’arte sacra, in Italia, sono state in grado, dall’Ottocento in poi, di esprimere forme di “memoria collettiva” e di fascinazione paragonabili a quelle suscitate in Francia da Giovanna d’Arco. Anche nella letteratura italiana quest’assenza ha pesato? “In modo determinante. Prendiamo direttamente il romanzo italiano per eccellenza, quello della “morale cattolica” e della «Provvidenza», i Promessi Sposi. Ecco, nei Promessi Sposi ci sono frati, monache, 4 vescovi, santi; e c’è don Abbondio: anch’egli s’interroga, ma su Carneade. C’è la filosofia, e il “sugo” della storia, ma non c’è la Bibbia. Per trovare un tracciato biblico in Manzoni, bisogna guardare agli Inni sacri, che sono tuttavia dedicati alla liturgia per annum, cioè al tempo della Chiesa più che alla testualità biblica”. Bisognerà attendere nuove arti, come il cinema, per ritrovare il respiro universale del testo biblico”. In che modo, e perchè? “Perchè il cinema è un’arte in grado di cogliere l’epico movimento di un popolo in esodo e insieme i silenzi e lo sguardo dell’interiorità. Per questo possono nascere opere come quelle di Rossellini, Pasolini, Bunuel, una linea di essenzialità (e una preferenza per il pauperismo evangelico) che non ha nulla a che vedere con le sfilate di paramenti liturgici della Roma di Fellini. Ma la radicalità delle interrogazioni ultime resta soprattutto nella cinematografia di Dreyer, di Bresson, di Bergman”. “Oggi comunque, dopo la secolarizzazione, e senza più l’obbligo di pensare al Libro come corollario del culto, è tornato un interesse per la Bibbia”, prosegue Ossola. “I lettori cercano la Bibbia perchè essa presenta ragioni di vita e di morte, modi di abitare e di rifiutare il mondo. Perchè essa, con Giobbe, interroga, e con Il Cantico dei Cantici ha sete di unione. Ciò non toglie, purtroppo, che i guasti di una lunga assenza lascino lacune ancora molto profonde. Nella stessa critica, nella capacità di rinnovamento delle metodologie. I più fecondi impulsi sono venuti in effetti dall’esegesi biblica, dalla tensione che il testo biblico impone, nel suo obbligare ad un tempo alla letteralità e all’interpretazione, alla fedeltà e al rischio ermeneutico. Questo è altrettanto importante per la critica che per la filologia, perchè la filologia, non nutrita dal fervere di un testo vivente, si restringe a mera restituzione, riconsegna di un testo al suo immoto passato. In Paesi a tradizione riformata, come la Germania, la presenza del testo biblico (che è insieme passato e attuale) ha nutrito i solchi dell’esegesi letteraria. Un’esegesi vivente: si pensi ai saggi di Blumenberg o di Ohly; una traslazione (metafora) in viaggio verso il presente di chi legge”. Un’immagine molto negativa della situazione italiana degli studi critici, della letteratura... “È un fatto che il parametro portante su cui hanno ragionato critici e docenti del secondo Novecento è stato quello della “rappresentazione della società”, del ruolo in essa degli intellettuali, dei loro compiti e tradimenti. Un titolo sintomatico: Scrittori e popolo di Asor Rosa. Ma nulla che assomigli a Mimesis di Auerbach (1946). Non abbiamo avuto nè il grande realismo, nè il grande paradosso del carnevale (Bachtin); abbiamo ceti, borgate, quartieri, non destini del mondo. È vero tuttavia che l’esistenzialismo ha aperto la strada a un “pensiero interrogante” al quale la matrice biblica ha offerto orizzonti, lessico, imagerie”. A chi pensa? “A Mario Luzi, al suo teatro di parola e ai suoi saggi, al Montale gnomico, a Giovanni Giudici, a filosofi come Cacciari, alla scrittura di Cristina Campo, Guido Ceronetti, Claudio Magris, Ezio Raimondi”. Un ritorno alla Bibbia, secondo molti osservatori, dovrebbe passare anche attraverso la scuola, per esempio grazie a un uso diverso dell’ora di religione. “Ha ragione: l’uso sciagurato dell’ora di religione nelle nostre scuole è il dolente retaggio di secoli di abbandono della lettura del testo biblico. Quando va bene, l’ora viene impiegata come un ventaglio di varia eticità; e invece si potrebbe leggere quello che Northrop Frye ha definito Il Grande Codice: parole, quelle delle Scritture, che si presentano come modello e come evento, in cui è contenuta la memoria collettiva dell’Occidente. La Bibbia è il pattern originario di generi narrativi ed epici, lirici, aforistici, mistici, senza conoscere i quali siamo ciechi davanti alle pitture, sordi davanti alla musica. Se ne può fare un’antologia, di quattrocento pagine o poco più, che comprenda i libri delle “fondazioni letterarie”: Genesi, Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe, Salmi, uno dei profeti (Giona ad esempio), un Vangelo sinottico, Apocalisse, un vangelo apocrifo della Natività. È ciò che praticava Northrop Frye che, nei suoi seminari preliminari per lo studio nella multietnica Università di Toronto, proponeva agli studenti proprio quel canone di figure e “luoghi” biblici. 5 Carmine di Sante sostiene alcuni punti interessanti in una sua intervista: La realtà culturale italiana ha veramente una visione così miope del testo biblico? Si può cogliere il segno di questa schizofrenia, di una concezione così miope, nella collocazione dell’ora di religione nella scuola. Lo stato laico ritiene che la bibbia non sia un grande testo letterario da insegnare agli studenti come Omero, Sofocle, Eschilo, Euripide, Dante, Shakespeare o i Veda, ecc. e lascia alla chiesa l’onere del suo studio e della sua divulgazione. La chiesa, da parte sua, in quanto custode del sapere religioso, ritiene di essere l’unica deputata a questo insegnamento. Ma al di là di una colpevole ignoranza, c’è da dire che la bibbia non appare proprio un testo di facile e immediata comprensione? Certo, per accostarsi alla bibbia si richiede, come per ogni testo, preparazione e conoscenza. Per questo è necessario insegnarla nelle scuole. E’ vero che essa produce inizialmente una sensazione di estraneità - la percezione di essere in un altro mondo - non soltanto per il suo linguaggio, per le sue metafore, per la sua simbolica, ma soprattutto per la sua logica narrativa inversa a quella tipicamente occidentale. Ma in questo è anche il suo grande fascino. Ovvero? La letteratura occidentale mira a sedurre il lettore, deve co-involgerlo e renderlo connivente. Èquesta connivenza che si crea tra il lettore e l’autore che è alla base di ogni lettura. Nella bibbia, invece, accade un procedimento contrario, una forma di estraniamento o estraneità, come dicevo prima. La bibbia ebraica è il racconto di un popolo in esodo alla ricerca di una terra promessa attraverso il deserto e la salita su un monte. Ora, il lettore che si accinge a leggerla è come se lui stesso si trovasse metaforicamente ad attraversare un deserto o a scalare una montagna, un paesaggio mai conosciuto: inizialmente si sente spaesato, sperduto, senza riferimenti, in un deserto, appunto, e sulle vie impervie di un monte. Però, insieme con questi sentimenti di estraniamento, dopo le prime diffidenze e i primi ostacoli ecco che ne avverte la fascinazione, la sorpresa e la gioia per la scoperta di paesaggi nuovi, di un mondo altro. 3. La frattura italiana fra letteratura laica e letteratura religiosa. Dove è finita la Bibbia? Verso la fine della censura Scrive Clementina Mazzucco a proposito dello studio e della conoscenza della Bibbia oggi, in particolare dell’assenza della Bibbia dalla scuola: Più di un secolo fa era lo storico della letteratura Francesco De Sanctis ad affermare: «Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetrata un’antologia biblica, attissima a tener vivo il sentimento religioso, ch’è lo stesso sentimento morale nel suo senso più elevato»6.E per parte sua spiegava il grande effetto che provò lui e provarono i suoi allievi quando, volendo trattare della lirica, affrontò da profano («Non avevo mai letto la Bibbia, e i giovani neppure») anche la lirica ebraica (il libro di Giobbe, il cantico di Mosè, i salmi, i profeti): «Rimasi atterrito. Non trovavo nella mia erudizione classica niente di comparabile a quella grandezza». Più recentemente (1989) il semiologo Umberto Eco si è domandato sulle pagine di un periodico popolare: «Perché i ragazzi debbono sapere tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si capisce Dante)?»7. Qualche anno fa (1993) è stato pubblicato un libro, risultato di un 6 F. DE SANCTIS, La giovinezza, Milano, Garzanti, 1981, p. 193. Il testo fu pubblicato postumo e De Sanctis morì nel 1883. 7 Su «L’Espresso» del 10 settembre 1989. Gli fa eco R. UGLIONE, in L’insegnamento della Letteratura cristiana antica nella Scuola media superiore, in AA.VV., Per una cultura dell’Europa unita. Lo studio dei Padri della Chiesa oggi. Atti dei Colloqui di Torino e Roma, 30-31 ottobre 1991, Torino, Sei, 1992, pp. 20-21: «È mai ammissibile che ci siano docenti di latino e greco che sanno tutto sulla questione omerica e nulla sulla questione sinottica? Ben consci che i 6 convegno precedente, a cura del Comitato Bibbia Cultura Scuola, dal titolo emblematico: Bibbia: il libro assente (ed. Marietti). Brunetto Salvarani ha scritto, richiamandosi a quel volume, A scuola con la Bibbia. Dal libro assente al libro ritrovato (Bologna, EMI, 2001), in cui, nonostante il nuovo titolo, si sostiene che la Bibbia è ancora troppo assente nella cultura italiana, specialmente scolastica, e si suggeriscono idee per illustrare l’importanza della Bibbia in tanti ambiti culturali moderni. Ha suscitato scalpore la dichiarazione del ministro dell’istruzione, Tullio De Mauro, fatta in un’intervista al periodico Famiglia cristiana e pubblicata il 10 settembre 2000. Egli manifesta il desiderio di imporre la Bibbia come libro di testo nelle scuole e, all’obiezione dell’intervistatore: «Ma come, lei, ministro ‘comunista’ ...», giustifica tale proposta dicendo: «Dal punto di vista didattico la Bibbia è una bomba conoscitiva. Non si capisce la nostra storia, né l’arte, senza Bibbia». Alla successiva domanda: «Dovrebbe essere il libro di testo dell’ora di religione?», risponde: «E perché no? L’ho detto anche al cardinale Ruini e ai suoi collaboratori esperti di problemi di scuola ... E il discorso è finito sull’insegnamento delle religioni». Osserva inoltre che in base a una verifica fatta dal ministero sull’ora di religione risulta che «quell’ora non è occupata al meglio». Commentando la battuta del ministro, una studiosa ebrea, esperta e divulgatrice di cultura ebraica, Elena Loewenthal (su La Stampa del 12 settembre 2000) ha di nuovo rilevato la contraddizione insita nel fatto che «il corpus della letteratura biblica sta alla base della civiltà europea non meno della cultura classica. Eppure la Bibbia è il libro assente per eccellenza nei piani educativi nazionali». Giustamente poi ella nota che «il fatto che gli studenti liceali abbiano tanta - e benedetta - dimestichezza con la levità dei lirici e il carico esistenziale dei tragici greci, senza nulla sospettare del fatto che nella lingua di aoristi e spiriti molesti s’esprimono anche gli abissi apocalittici di Giovanni e il ritmo lento e primitivo dei Vangeli sinottici, ha profonde radici storiche e culturali». E richiama il fatto che in Italia, a differenza dell’Inghilterra e della Germania, è mancata una traduzione in lingua corrente del testo sacro, al di fuori di quella di G. Diodati (1607), che era un calvinista proveniente da una famiglia italiana esule a Ginevra: per questi motivi la sua traduzione non ebbe vasta diffusione al di fuori dell’ambito protestante e non contribuì a diffondere la lettura della Bibbia nella popolazione. In Italia «nella formazione religiosa comune si è badato sempre più al dogma che alla conoscenza, alla catechesi piuttosto che al racconto e alla ricerca dentro il testo sacro». Solo le minoranze religiose, ebrei e protestanti, posseggono una certa familiarità con la Parola sacra. Proseguendo la sua analisi la prof.ssa Mazzucco arriva alla conclusione: la marginalità della Bibbia nella cultura contemporanea Allargando ulteriormente lo sguardo, potremmo rilevare che la divaricazione e la separazione tra cultura religiosa e cultura laica si verificano anche nei campi dell’editoria (una stampa cattolica distinta), delle librerie, ecc. Si direbbe che la religione sia concepita come una faccenda per «addetti ai lavori», per una élite di appassionati e che la Bibbia e i testi della tradizione cristiana siano cose «da preti» e basta. La conseguenza è che nella cultura comune contemporanea, a tutti i livelli, l’aspetto religioso risulta alquanto marginale, ed è venuta meno la conoscenza dei fondamenti della religione cristiana, e in specie della Bibbia, che precedentemente era invece patrimonio comune e alimento di tutta la poemi omerici non sono dei poemi scritti a tavolino nell’VIII secolo a.C. da un poeta chiamato Omero, e nel contempo convinti, invece, che i Vangeli siano la vita di Gesù scritta a tavolino da quattro biografi di nome Marco, Matteo, Luca, Giovanni?». 7 produzione culturale, dalle arti figurative (pittura, miniatura, scultura, ecc.)8, alla letteratura, al teatro, alla musica, ma anche alla filosofia, al diritto, ecc9. C’è chi fa notare che ignorare la Bibbia significa non rendersi conto dell’enorme debito che tutto il pensiero del nostro mondo occidentale ha verso di essa; per citare solo alcuni aspetti: la centralità della storia, l’idea di progresso, la secolarizzazione, il pluralismo culturale, che ci appaiono caratteristici della modernità, hanno radici nella Bibbia e nel cristianesimo, e non nel mondo classico. Il saggio famoso di un critico nordamericano, Northrop Frye, intitolato Il grande codice (trad. ital., Torino, Einaudi, 1986) ha sottolineato come siano di derivazione biblica i modelli e gli archetipi del mondo di immagini, miti e metafore che è l’essenza della letteratura anglosassone (ma non solo di quella letteratura). Un interessante contributo di Fortunato Pasqualino, uscito nell’ottobre ‘98 sulla rivista Studi cattolici, segnala come nelle opere di Verga si registri «un numero di metafore e di modi di dire biblici maggiore» che in Manzoni. [Goethe non aveva esitazione nel considerare la Bibbia come «la lingua materna dell’Europa». Lo è stato e lo è tuttora in forme anche semplici e quotidiane, attraverso quella spontaneità lessicale che si esprime in locuzioni che attingono al dettato e all’immaginario della Parola sacra]. Ignorare la Bibbia fa perdere perfino il senso di numerosi modi di dire che ne derivano, come, «essere il beniamino», «folgorato sulla via di Damasco», «vendersi per un piatto di lenticchie», «il vitello d’oro», «una babele», «sepolcri imbiancati», [«fare da Marta e Maria», «la pazienza di Giobbe», «andare da Erode a Pilato», «lavarsene le mani», «essere una colomba», «essere uomo di poca fede», «aspettare la manna dal cielo», «il figlio prodigo», «le cipolle d’Egitto», «essere un Cristo in croce», «chi semina vento raccoglie tempesta», «chi trova un amico, trova un tesoro» «nessuno è profeta in patria», «fare un’ira di Dio», un’«apocalisse» e così via]. Il linguaggio delle generazioni passate, soprattutto a livello popolare, ne era più fortemente impregnato di quanto non avvenga oggi, grazie alla mediazione della liturgia ecclesiale (che oggi è diventata evanescente rispetto all’influsso della televisione): di un bel saggio di G. L. Beccaria ne ha illustrato la ricchezza e la complessità10. Eppure tracce del patrimonio biblico sopravvivono ancora nella comunicazione corrente, come indicano espressioni usuali nel linguaggio giornalistico e perfino certi vezzi di politici, che cercano di nobilitarsi con reminiscenze bibliche. Anche qui, come già avveniva nei tempi passati, non di rado i riferimenti si intrecciano alle deformazioni. Parafrasando un detto famoso di Benedetto Croce («non possiamo non dirci cristiani»), potremmo dire: «non possiamo non dirci eredi della Bibbia», ma siamo eredi che non conoscono, o conoscono poco, la loro eredità e, per il fatto di non conoscerla abbastanza, la stanno dilapidando. Possiamo dissentire dalle affermazioni seguenti nel loro giudizio sul valore della comunicazione popolare cinematografica delle storie bibliche: Perso il contatto con le fonti autentiche, che cosa dànno al pubblico comune oggi i mezzi di comunicazione di massa, quando càpita che inseriscano nel loro tritatutto anche materiale biblico? Attraverso i film e gli sceneggiati televisivi, la cui fiumana non accenna ad esaurirsi (ne sono continuamente programmati su Gesù), filtra un mondo biblico hollywoodiano e mistificante, in cui i personaggi della storia sacra (Abramo, Salomone, Davide, ecc.) sono raffigurati in modo non 8 Sul Supplemento a «Il Sole 24 ore» di domenica 3.10.1999 veniva riportato il testo di una conferenza del critico d’arte Federico Zeri, in cui si raccontava il caso curioso di un quadro attribuito al Botticelli e intitolato La derelitta. Con fatica venne scoperto che si tratta in realtà di una figura maschile che appartiene alla storia di Ester e Assuero, narrata nel libro biblico di Ester. Solo la famigliarità con la Bibbia permette di comprendere la stragrande maggioranza dei dipinti della nostra tradizione. 9 Per una panoramica sulla presenza della Bibbia nelle varie espressioni culturali del mondo contemporaneo, si veda Le monde contemporain et la Bible, a cura di C. SAVART e J.-M. ALETTI, nella collana «Bible de tous les temps» 8, Paris, Beauchesne, 1985, con saggi sull’arte, sulla musica, sul cinema. I curatori constatano una scarsa presenza della Bibbia, soprattutto nella cultura di massa e nelle conoscenze dell’uomo comune. 10 Cfr. G. L. BECCARIA, Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell’italiano e nei dialetti, Milano, Garzanti, 1999. 8 molto diverso dai vari Rambo, Indiana Jones, e così via, in un enorme pastiche che tutto appiattisce, fatto per solleticare curiosità superficiali e per soddisfare grossolanamente il gusto dell’avventuroso e del fantastico. La pubblicità ricorre a episodi e frasi bibliche facendo di Dio e di Gesù dei testimonial commerciali: estrema e beffarda degenerazione di una familiarità perduta nella sua serietà11. Adesso la moda porta in auge nella produzione libraria i romanzi del filone fanta-biblico, di cui l’insuperato campione è Il codice da Vinci di Dan Brown, bestseller del 2004 che continua a rimanere nei primi posti delle classifiche di vendita, nonostante i numerosi tentativi di smascherare le falsità di cui è intriso. Il recupero dello studio dell’influenza della Bibbia sulla cultura e sulla letteratura è documentato dall’ampia ricerca proposta dall’Università di Venezia (Italianistica e filologia romanza): Riscritture del sacro: Echi e motivi biblici e cristiani nella letteratura italiana moderna. E’ disponibile un abstract e una bibliografia su questa ricerca: http://www.cristinacampo.it/public/informazioni%20sul%20programma%20di%20ricerca%20sulle% 20riscritture%20de%E2%80%A6.pdf 4. La Bibbia, Grande Codice: un tutto narrativo da Genesi ad Apocalisse, nata e cresciuta con una certa forma non è casuale, ma struttura “portante” del suo significato e della sua rilevanza per le culture che affondano le loro radici nell’immaginario delle storie bibliche e da esse nutrite. Il linguaggio simbolico e narrativo è il linguaggio della Bibbia. Non è un linguaggio analitico quello impiegato dagli scrittori sacri per narrare le vicende di un popolo il cui Dio interviene continuamente negli avvenimenti umani. La storia della salvezza è raccontata e raccontabile. I “generi letterari” e la forma stessa della letteratura biblica sono essenziali per coglierne la portata rivelativa religiosa. Non si può prescindere dalla forma della Bibbia per ricavarne il significato. Scrive mons. Gianfranco Ravasi: Per la Bibbia è possibile dire Dio in modo figurativo, in forma letteraria bella e in linguaggio giusto. Attraverso il simbolo si respinge un’ineffabilità e un aniconismo che ha colpito alcune religioni, almeno in certi ambiti: pensiamo alla proibizione delle immagini nell’ebraismo e nell’islam. Un atteggiamento che ha lambito anche il cristianesimo nel periodo dell’iconoclasmo o in qualche fase della Riforma protestante. Il simbolo, però, permette anche di rigettare la rappresentazione idolatrica che spesso è condannata dalla Bibbia e che è talora affiorata anche nella storia successiva. Il linguaggio simbolico e ciò che esso genera a livello artistico permette di conservare in equilibrio il mistero, l’Altro e l’Oltre di Dio con la sua rivelazione, la sua effabilità, il suo comunicarsi storico all’umanità. Con la sua ricchezza simbolica la Bibbia è stata, quindi, il grande codice della cultura, in particolare dell’arte, e dell’immaginario popolare ma è stata anche la presentazione di una fede che unisce in sé trascendenza e immanenza. L’arte ha cercato di cogliere la carnalità, cioè la storicità di quella rivelazione, ora esaltandola, ora trasformandola, ma ha anche saputo quasi sempre salvaguardarne la dimensione di segno, di mistero, di infinito e di eterno12. 11 E. BENEDETTO, in un articolo dal titolo Dio? ora fa il testimonial, su «La Stampa» del 19.10.1997, p. 22, che a sua volta commentava la pubblicazione di un volume di R. WALBAUM e J. COTTIN, Dieu et la pub, Cerf-Pbu, mostrava che gli episodi più citati nella pubblicità risultano quelli della creazione dell’uomo, del Paradiso terrestre, del frutto proibito (la mela). Per quanto riguarda le frasi di Gesù, chi non ricorda il «Chi mi ama mi segua» della Jesus jeans? Ma notevole è anche il «Venite, tutto è pronto», che era l’invito del padrone di casa nella parabola del banchetto e divenne lo slogan delle Olimpiadi di Atlanta. Da citare la campagna «Beati i citroënisti», che sfruttava la formula delle Beatitudini evangeliche. Sull’argomento dell’attualità del linguaggio biblico-evagelico e sul rapporto tra spiritualità e mezzi di comunicazione di massa si è svolto nel settembre 1998, a Roma, un convegno internazionale dal titolo «Dio è morto in televisione», con la partecipazione di esperti dei media, di cinema, di linguistica. 12 G. RAVASI, La Bibbia come “Il grande codice” dell’occidente, in «L’Osservatore Romano» 17 febbraio 2008. 9 5. La lettura tipologica della Bibbia cristiana: l’intertestualità teologica La Bibbia di cui parliamo, quella che ha influenza sull’Occidente, è la Bibbia Cristiana, letta fin dall’inizio, nella sua totalità, secondo il principio della tipologia (che sul piano della critica letteraria corrisponde all’intertestualità: la dipendenza di un testo dai suoi predecessori testuali). Tutto l’Antico Testamento, nella lettura cristiana, punta verso Cristo e prefigura a venuta di Cristo [nella lettura ebraica: il Messia non ancora giunto]. Tutto il Nuovo Testamento rappresenta un compimento dell’Antico e delle sue figure. L’Antico dice il vero perché è confermato dagli eventi accaduti e raccontati nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è vero perché già profetizzato dai sapienti dell’Antico Testamento. S. Agostino: “Novum in vetere latet et vetus in novo patet”. La tradizione della lettura tipologica della Bibbia ci insegna: a) Che la Bibbia Cristiana ha un centro: i vangeli con il racconto della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù. b) Questo fatto centrale e questo personaggio è la misura di quanto accaduto e raccontato prima e dopo di lui (Atti e Apocalisse). c) È il termine di riferimento e di punto focale di coerenza di ogni lettura particolare della Bibbia in senso Cristiano. La sua storia diventa il paradigma della più ampia storia. Questo criterio di lettura è già presente negli stessi racconti evangelici, per es. Lc 24,27: (i discepoli di Emmaus): E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui… 24,44ss: Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Anche Paolo conferma la lettura tipologica come corrente e coerente approccio alla letteratura biblica per il cristiano: 1Cor 10,11: haec autem omnia in figura (τυπικως ) contingebant illis scripta sunt autem ad correptionem nostram …. La lettura tipologica sta in equilibrio instabile fra lettura letterale del testo e lettura allegorica. Infatti un evento completo in se stesso, avente un proprio significato, viene scoperto nel suo “senso più pieno” (sensus plenior) quale figura dell’evento Cristico. Teologicamente la tipologia è interpretabile non solo nella relazione di figura-realtà, ma anche in quella di promessa-compimento, secondo il versetto di Geremia 31,31ss.: «Ecco verranno giorni dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova… dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo». Secondo un asse temporale quindi la promessa aspetta e si verifica nel suo compimento. Secondo un asse letterario il tipo disvela l’antitipo. Questa lettura “spirituale” e profetica dell’Antico Testamento è fondata, comunque, sulla lettura letterale del racconto evangelico. Su questo c’è un unanime consenso già nell’antichità cristiana. Il racconto evangelico non è una metafora; la vicenda terrena di Gesù, i suoi detti fatti, morte e risurrezione vanno accolti come sono raccontati nel quadriforme vangelo. Certo, d’altra parte, il metodo storico-critico ci mostra come la fissazione letteraria del materiale nato in forma orale delle gesta e dei detti di Gesù, sia plasmato a partire dai richiami testuali veterotestamentari. Ma la passione e la morte del Messia, sfuggono comunque alla coscienza giudaica del tempo di Gesù, tanto quanto la sua risurrezione. Questa è – come minimo – la novità 10 inaudita nell’ambiente ebraico che diventa metro di giudizio e anche cartina di tornasole per scoprire la forma dell’intervento divino nella storia umana. Un movimento che continua La letteratura post biblica, antica, moderna e contemporanea, continua il flusso della tipologia, creando continuamente storie, situazioni e personaggi che si ispirano tipologicamente alle grandi figure e narrazioni anticotestamentarie ed evangeliche. Il tipo dell’Antico Testamento si svela nell’antitipo neotestamentario: Cristo. Questo, a sua volta, si presenta come il prototipo di una serie di figure che ad esso si ispirano e continuano la tradizione precedente, ormai pienamente svelata e tuttavia bisognosa di essere ancora raccontata ed attualizzata. Le storie che ripresentano le figure cristiche, di cui parleremo in seguito, ci mostrano come il movimento della tipologia biblica continua anche nel tempo post-biblico, e permane nella letteratura e nelle altre arti, fino ai nostri giorni. 6. La Bibbia e la letteratura. Percorsi di creazione, sub-creazione e rivelazione Gianfranco Ravasi, in Italia, è certamente uno dei principali studiosi e divulgatori del collegament profondo tra Bibbia e lettereratura. Seguiamone il pensiero. La Bibbia si apre sul libro della Genesi: Dio crea il mondo con la sua Parola. Il logos divino dà forma e significato alla realtà. La parola è la radice della creazione ove espleta una funzione «ontologica». Infatti, si può quasi affermare che entrambi i Testamenti si aprono con la Parola divina che squarcia il silenzio del nulla. Bereshît... wajjômer ‘elohîm; jehî ‘ôr, Wajjehî ‘ôr, «In principio, Dio disse: Sia la luce! E la luce fu» (Genesi, 1, 1.3). Così si schiude la prima pagina dell’Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento l’ideale apertura potrebbe essere quella del celebre inno che funge da prologo al Vangelo di Giovanni: En archè en ho Lògos, «In principio c’era la Parola» (1, 1). L’essere creato non nasce, perciò, da una lotta teogonica, come insegnava la mitologia babilonese (pensiamo all’Enuma Elish), bensì da un evento sonoro efficace, una Parola che vince il nulla e crea l’essere. Canta il Salmista: «Dalla Parola del Signore furono creati i cieli, dal soffio della sua bocca tutto il loro esercito... perché egli ha parlato e tutto fu, ha ordinato e tutto esistette» (Salmo 33, 6.9). La Parola divina è, però, anche alla radice della storia, come sorgente di vita e di morte: «Mandò la sua Parola e li guarì, li scampò dalla fossa (...). Egli invia la sua Parola e li fa perire (...). Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua onnipotente Parola dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si slanciò (...) portando, come spada affilata, il tuo ordine inesorabile» (Salmi, 107, 20; 147, 18; Sapienza, 18, 14-15). Ma la Parola si cristallizza anche nel Libro per eccellenza, la Bibbia. È così che il Nuovo Testamento ama l’espressione graphè/graphài per indicare la Parola di Dio. Si ha qui una puntualizzazione del complesso rapporto tra infinito e contingente, tra Lògos e sàrx. La Parola, infatti, deve comprimersi nello stampo freddo e limitato dei vocaboli, delle regole grammaticali e sintattiche, deve adattarsi alla redazione di autori umani. È l’esperienza che tutti i poeti vivono nella sua drammaticità e tensione. Goethe nel Faust confessa che «sì, la parola muore già sotto la penna». E nel suo Flauto di vertebre Majakowski ribadisce: «Sulla carta sono crocifisso coi chiodi delle parole», mentre Borges più generalmente riconosce che el universo es fluido y cambiante, el lenguaje rigido. Eppure questa rigidità non riesce a raggelare e a spegnere l’incandescenza della Parola. Esemplare è il caso del profeta Geremia che «prende un rotolo per scrivere e scrive» su ordine divino gli oracoli del Signore (36, 2). Ma dopo che il re Ioiakim, leggendo quel rotolo, ne «aveva lacerato col temperino da scriba e aveva gettato nel fuoco» le colonne di quel testo (36, 23), il profeta non avrà esitazione su comando divino a far rinascere gli stessi oracoli mostrando così che 11 — come dichiarava Isaia (40, 8) — «secca l’erba, appassisce il flore, ma la Parola del nostro Dio dura in eterno». È anche questa un’esperienza che il poeta analogamente vive, convinto com’è che, una volta detta, la parola autentica non muore ma proprio allora comincia a vivere: «A word is dead/ when it is said, / some say./ I say it just/ begins to live/ that day» (così la poetessa americana Emily Dickinson). È la forza «performativa» e non meramente «informativa» della Parola che ovviamente nella poesia celebra il suo trionfo e che ha il suo apice nella Scrittura Sacra. La Bibbia ci racconta che Dio dunque è un grande autore, un poeta che dipinge il mondo con la Parola, una parola che fa essere ciò che immagina e viene pronunziato. La letteratura allora, l’arte della parola umana, è – biblicamente intesa - una partecipazione umana alla creazione. L’uomo creato ad immagine di Dio, crea anch’esso, con lo strumento principe della parola, che condivide con Dio. L’uomo crea mondi e storie (le cosiddette subcreazioni tolkieniane), condividendo con Dio la capacità di donare senso e ordine alla realtà caotica che vi è fuori e dentro l’uomo stesso. Solo creando questi “mondi secondari” attraverso la produzione di miti e racconti l’uomo, esercitando il suo essere a somiglianza del Dio creatore, nonostante possa cadere in errore nei significati che inserisce nelle sue creazioni, può catturare e riflettere delle scintille della luce eterna da cui proviene e che si esprime attraverso di lui. Già i padri della Chiesa vedevano nei miti greci, prima forma della letteratura dell’Occidente, un riflesso annebbiato della rivelazione che Dio stava elargendo all’umanità attraverso l’Uomo capace di accoglierla. I sapienti greci sono nel campo pagano quello che la compiuta profezia biblica è nella linea della rivelazione biblica, la rivelazione che si compie e prende coscienza di sé e del suo rapporto privilegiato con Dio. La rivelazione si fissa in scrittura, in letteratura. La parola umana ricettacolo della Parola divina. L’immaginazione umana capace di Dio. 7. La dimensione mitica della Bibbia e il recupero della forma narrativa della verità Qui c’è uno snodo importante fra l’arte della Parola Biblica e della letteratura contemporanea. Mentre, per gli antichi, la storia e il racconto non possono che essere l’interpretazione autorevole e divina della realtà, dischiudendo attraverso il logos il significato profondo degli eventi, e in tal modo comunicando narrativamente i valori morali che costruiscono la società e gli individui, tutto questo, nell’accezione contemporanea della letteratura, è andato perso. La letteratura - come anche l’arte visiva, nel mondo postmoderno - ha perduto la sua funzione di incarnare e applicare le meta narrazioni, credute e continuamente bisognose di essere ridette e rivissute. La letteratura contemporanea si ritira nel soggettivo del privato, dell’esplorazione interiore dei sentimenti e dei flussi di coscienza, del divertimento; cerca di lasciare il campo del mitico – per il quale si sente ormai inadeguata - , non si sente più capace dell’espressione narrativa della verità. Se non c’è più una verità, come si fa a raccontarla? Ma è poi davvero possibile questo sforzo? Eppure non possiamo non chiederci se l’essere umano possa, senza contraccolpi, ritrovarsi privato delle metanarrazioni o dei miti a cui conformare le proprie credenze personali e sociali? (e si badi non solo credenze religiose, ma le proprie convinzioni su ciò che ha valore e su ciò che non ne ha, su ciò che conta e su ciò che non conta, su che senso ha il mondo….cf. a questo proposito R. BARTHES, Miti d’oggi [or. 1957]). Anche Northrop Frye utilizza la categoria di “mito” e la applica alla Bibbia nel suo studio capitale intitolato Il grande Codice. (questa sezione è riassunta, con integrazioni, da JONATHAN HART, Northrop Frye: The Theoretical Imagination, Routledge, London 1994, pp. 125-136.) 12 Per prima cosa dobbiamo cogliere che per Frye tutta la letteratura è un’”estensione” della mitologia. Ogni società umana possiede una mitologia che è ereditata, trasmessa e diversificata attraverso la letteratura (Cf. Words with power, XIII). Mitologia e letteratura abitano e funzionano secondo lo stesso mondo immaginativo, governato dalle sue proprie convenzioni, modi, simboli e miti. Il critico letterario deve operare all’interno di questa sfera dell’immaginazione e resistere al cercare un principio organizzatore del tutto nell’ideologia. Fare questo, afferma Frye «trascurerebbe i principi strutturali centrali secondo cui la letteratura deriva dal mito, principi che dà alla letteratura il suo potere comunicativo attraverso i secoli e i mutamenti di ideologie» (Words with Power, XIII). Il mito offre perciò la sua struttura alla letteratura semplicemente perché la letteratura, in senso generale, è una “mitologia trasferita” (displaced mythology). Per Frye, insomma, è il racconto, non l’argomentazione, il centro della letteratura e della società. La base della società è mitica e narrativa e non ideologica e dialettica. Come parte fondamentale della nostra “tradizione immaginativa”, la Bibbia ci dice qualcosa su ciò che Frye chiama “universo mitologico”, un corpo di assiomi e credenze che sorgono da interessi/problemi esistenziali degli esseri umani, i quali non vivono immersi nella natura come invece gli animali. L’universo mitologico è – per la maggior parte – posseduto inconsciamente. Questo significa che la nostra immaginazione può riconoscere elementi di esso, quando le vengono presentati dall’arte o dalla letteratura, anche senza capire consciamente che cosa è ciò che viene riconosciuto. Praticamente tutto ciò che possiamo vedere di questo corpo di interessi è socialmente condizionato ed ereditato culturalmente. Al di sotto dell’eredità culturale deve esserci una comune eredità psicologica, altrimenti forme di cultura e immaginazione al di fuori della propria tradizione non sarebbero intelligibili. Ma per Frye si può dubitare che si possa raggiungere direttamente questa comune eredità, bypassando le qualità distintive che fanno parte di una cultura specifica. Una delle funzioni pratiche della critica, nome che designa l’organizzare coscientemente la tradizione culturale, è – possiamo ritenere - di renderci più consapevoli dei nostri condizionamenti mitologici. Frye si rende conto di quale carica emotiva è portatore il discorso biblico e afferma che l’obiettivo accademico non è di accettare o rigettare tale discorso, ma di vedere che cosa significhi. Egli è convinto che il rifiuto di credere significhi ben poco in termini di cambiamento dei nostri processi mentali, mentre invece le categorie “primitive” della metafora, del mito e della tipologia siano coinvolte in parecchie interferenze dei modi di pensare. Frye punta all’introspezione (insight). La conclusione centrale di Frye, nell’analisi linguistica della Bibbia, è che: «il mito è il veicolo linguistico del kerygma, e “demitizzare” qualunque parte della Bibbia equivale a distruggerla» (N. FRYE, The Great Code, p. 30). Per Frye, la Bibbia è una narrazione e perciò un mito. Egli si riferisce al seguente uso del termine “mito”: storie che hanno un significato preciso e rilevante, che dicono alla società ciò che è importante da sapere. Queste storie sono sacre, o rivelative, in opposizione alle storie profane, che sono raccontate per intrattenere o per scopi di importanza marginale. In questo senso (che va oltre il significato comune della parola), mito viene a significare: “essere carico di una speciale serietà”, non meramente: “esser frutto di fantasia, fuori della realtà”. In questo senso è il mito, non la storicità, la forza motivante della Bibbia. Per es., la struttura mitica del libro dei Giudici, visto come una sineddoche per l’intera Bibbia, mostra come le storie siano plasmate, attraverso l’opera redazionale, per formare un mito di Israele. Gli scrittori/redattori dei Vangeli danno forma alle loro storie per mezzo della tipologia, mettendo in relazione i loro miti con quelli dell’Antico Testamento. Gli studiosi della Bibbia sanno da tempo che “la Bibbia porterà solo 13 confusione ed esasperazione allo storico che tenta di trattarla come fosse Storia”: la prova a favore del Gesù storico rimane sigillata nel Nuovo Testamento. Il mito redime la Storia. Frye approfondisce questo punto controverso (che potrebbe essere solo una forma di delusione ideologica, per cui i popoli oppressi possono trovare sollievo nel mito e ignorare il cambiamento storico) dicendo che dovremmo imparare a vedere l’illusione nel reale e il reale nell’illusione. Da questo punto di vista, il mito della liberazione nella Bibbia è quello centrale, qualcosa che, per le sue implicazioni, mette insieme l’illusione reale e la realtà illusoria. Nel distinguere natura e cultura, ciò che è e ciò che è costruzione umana, Frye nota anche che “non ci sono nobili selvaggi, nel senso di uomini puramente naturali, per i quali il rivestimento della cultura sia sparito”. La storia, insomma, esiste in quanto già interpretata e raccontata, e non può esistere in altra forma, se non come serie di dati sconnessi. L’immaginazione umana vede, attraverso la visione mitica, il senso della storia. Frye sostiene che la narrazione nella Bibbia sia una divina commedia, e abbia una struttura a forma di U, una storia in cui l’umanità «perde l’albero e l’acqua della vita all’inizio della Genesi e li riceve nuovamente alla fine dell’Apocalisse» (Frye 1982b:169). Tutto ciò che c’è in mezzo riguarda il racconto di Israele, che è «una serie di declini nelle mani di regni pagani: Egitto, Filistea, Babilonia, Siria, Roma, ciascun declino seguito da un innalzamento a un breve momento di relativa indipendenza» (169). Il racconto del disastro e del ristabilimento di Giobbe, le parabole di Gesù sul Figlio prodigo utilizzano anch’esse una forma narrativa ad U. Frye isola sette cadute e sette ascese. Tutti i punti alti e bassi si relazionano metaforicamente gli uni gli altri: Cioè: il giardino dell’Eden, la terra promessa, Gerusalemme, il Monte Sion, sono sinonimi intercambiabili per casa e anima, e nell’immaginario cristiano sono tutti identici, nella loro forma spirituale, con il Regno di Dio di cui parla Gesù. In modo simile, Egitto, Babilonia e Roma sono tutti spiritualmente lo stesso luogo, e il Faraone dell’Esodo, Nabucodonosor, Antioco Epifane, e Nerone sono spiritualmente la stessa persona. E i liberatori di Israele: Abramo, Mosè e Giosuè, i giudici, Davide e Salomone, sono tutti prototipi del Messia, il liberatore finale (171). Il racconto biblico diventa una serie di alti e bassi, in cui il popolo di Dio periodicamente cade in catene e poi viene salvato da un leader, mentre i grandi imperi pagani sorgono e cadono secondo un ritmo opposto a quello di Israele. A un certo punto questa prospettiva viene capovolta, e ciò che vediamo è qualcosa di simile ad un eroe epico o romantico che discende in un mondo inferiore per salvare chi, allo stesso tempo, è una singola sposa e una ampia moltitudine di uomini e donne. In questa prospettiva, la sequenza di cattività e redenzioni sparisce e lascia il posto ad un unico atto di discesa e ritorno. Ma questo atto, sebbene in se stesso unico, ha molte concretizzazioni simboliche (Frye 1982b:192-3). Il libro di Giobbe per Frye è un riassunto di tutta la Bibbia: è una commedia, perché a lieto fine, ma è insieme una tragedia nel suo andamento, che niente fa sperare positivo sino all’ultimo. Ha un tipico andamento a U con una curva improvvisa. “Arriva ad una visione finale della presenza e della certezza che, in mezzo alla morte, siamo nella vita” (197). Giobbe è liberato dalla sua storia quanto non c’è più bisogno ulteriore di tempo, e così Gesù è liberato, nel racconto della Passione, ecco l’aspetto profetico della struttura mitico-narrativa ad U. II parte: Saggi di lettura * La Genesi e il peccato originale: paradigma della storia, e di ogni storia che si risolve solo alla fine (vangeli e apocalisse) 14 * Abramo e il momento culmine del Sacrificio di Isacco (altro andamento a U) Abramo l’uomo che spera contro ogni speranza (un figlio, la terra), ha fede contro ogni fiducia. Lettera agli Ebrei cap 11: 1La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. … 8Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 9 Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 11 Per fede anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. 12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. 7 Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio, 18del quale era stato detto: In Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. 19Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe e fu come un simbolo. * L’Esodo (uscita dall’Egitto) e l’andamento a U (l’esilio a Babilonia e il ritorno – con i tre giovani nella fornace come storia nella storia, cammeo parabolico di Daniele). La splendida parabola del Profeta Giona. Meditazione israelitica sulla misericordia di Dio per l’umanità: la grande U non è solo per Israele. Satana, il grande personaggio per immaginare il male. L’incarnazione dell’avversario necessario 1. Ravasi e i modelli dell’influsso biblico sulla letteratura: 1) reinterpretativo, 2) degenerativo, 3) trasfigurativo (Cf. G. RAVASI, Il grande Codice culturale dell’Occidente in “Vita Pastorale”, 11 nov. 2007, sezione Dossier, qui online) 1) La Bibbia reinterpretata, è quanto provano a fare i lavori letterari (o cinematografici) basati sul racconto biblico letterale, mettendolo in scena “in costume”, interpretando attraverso la rinarrazione attualizzata la stessa storia originariamente affidata alla Scrittura Sacra. Si rischia sempre il romanzo-biblico13 (vedi: Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann; Per amore solo per amore di P. Festa Campanile, ma anche, in un certo senso, il Quo vadis di H. Sienkiewicz) o la sacra rappresentazione. 2) La degenerazione, non è solo la parodia, ma lo stravolgimento di racconti, significati e personaggi biblici per dire altro, un’interpretazione di opposizione e di decostruzione religiosa, dettata o da pregiudizi ideologici, o da vera e propria contestazione del significato biblico, fino allo sgomento o inquietudine. Scrive Ravasi nel suo saggio: “Nella stessa storia della teologia e dell’esegesi si sono verificate spesso deviazioni e deformazioni interpretative. Il testo sacro si trasforma in un pretesto per parlare d’altro (allegoria) o persino per ribaltarne il senso originario. Così accade anche nella storia della cultura. Prendiamo ancora come emblema il libro di Giobbe. La tradizione, infatti, ignorando l’altissimo poema che costituisce la sostanza dell’opera, si è attestata quasi esclusivamente sul prologo e sull’epilogo (capitoli 1-2 e 42). Qui 13 Anche nell’Italia del ‘600 ebbe una certa fortuna questo genere letterario, pur non trovando una stabilità e una linea organica. Cf. C. JANNACO - M. CAPUCCI - A. BALDUINO (Edd.), Storia letteraria d'Italia - Il Seicento, Piccin, Padova 1986, p. 651. 15 Giobbe appare solo come l’uomo paziente che supera la prova ed è alla fine ricompensato da Dio. In realtà il corpo centrale dell’opera presenta, invece, il dramma della fede posta di fronte al mistero di Dio e del male. L’approdo di una ricerca lacerata e acre è in quella professione di fede che sigilla realmente l’intero scritto: “Io ti conoscevo per sentito dire; ora i miei occhi ti vedono” (42, 5).”…. Leopardi, (secondo GIUSEPPE BORTONE s.j., Presenza biblica nella poesia e cultura di Leopardi, in «Gesù Nuovo», 2-3/2006 ) sarebbe una grande eccezione all’assenza biblica nella Letteratura dell’800. Leopardi, leggeva la Bibbia in ebraico e greco e la riecheggiava, sia pure a volte adulterandola, nei suoi scritti: dallo Zibaldone ai Canti, alle Operette Morali la Bibbia, è presente, benché adattata al proprio pensiero, stato d’animo o ribellione interna (ma questo fa probabilmente parte della sua teoria sulla libera imitazione). Leopardi da giovane studia ebraico e greco, legge la Bibbia in ebraico, in greco, in latino. Ecco alcuni esempi di distorsione biblica in Leopardi: egli mutua il “Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas” del Qohelet, ma tace sul punto fermo proclamato dall’Ecclesiaste: Dio. Invece il Kempis ha capito l’insieme dell’opera e l’ha sintetizzato nel celebre aforisma: “Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas, praeter amare Deum et illi soli servire” (De Imitatione Christi I,1). Ugualmente Leopardi dà continuo risalto alle domande angoscianti di Giobbe, ma riferisce poco o niente delle risposte di Dio (Giobbe 38-41) e soprattutto tace l’intervento provvidenziale di Dio, con cui si conclude il libro. Allo stesso modo non si capisce bene il senso dato a Giovanni 3,19, posto come esergo alla Ginestra: «E gli uomini vollero piuttosto le tenebre, che la luce». Ha un senso pessimistico, senza cogliere che nel testo originale le tenebre sono lo sfondo oscuro per la vittoria della luce. Su questa linea va rilevato un altro abbaglio: Leopardi usa l’opposizione radicale di S.Giovanni evangelista tra Cristo ed il mondo per maledire la società, la storia civile, il mondo e gli uomini, pur sentendosi cristiano. Ma Giovanni usa la parola “mondo” come equivalente di “male morale, corruzione, peccato”: invece Leopardi usa “mondo” come equivalente di “società, storia, uomini” (cfr Zibaldone 112 e Pensiero LXXXIV). Dal numero 395 al 401 dello Zibaldone, Leopardi disquisisce ampiamente sui primi capitoli della Genesi e in particolare sul “Peccato Originale”, affermando che esso consiste nell’uso eccessivo della ragione: l’uomo non seppe contentarsi delle cognizioni raggiungibili con la mente propria e la Rivelazione, ma volle superare ogni limite, nell’intento di apprendere tutta la scienza del bene e del male, anzi apprenderla solo con la ragione; da ciò Leopardi deriva che la ragione e la scienza sono fonti di infelicità. In questo modo egli si oppone all’Illuminismo, che riponeva una fiducia totale nella ragione e nella scienza. Come si vede Leopardi non solo legge la Bibbia, ma ne disquisisce con interessanti meditazioni. Soprattutto in Giobbe Leopardi adombra la propria tragedia: giustamente Carducci definì Leopardi “il Giobbe della letteratura e del pensiero italiani” (cfr. Opere-Ediz. Nazionale, vol. XX, pag. 221, ed. Zanichelli, 1937). A Giobbe Leopardi ha dedicato un frammento poetico dalla data incerta e oggi riportato in Poesie e Prose, vol. 1, pag. 600, Mondadori, 1994. Divo Barsotti, nel volume La religione di Leopardi (ed. Morcelliana, Brescia), dedica l’intero capitolo 14 al rapporto tra Bibbia e Leopardi, sottolineando la vasta presenza nella sua opera di Giobbe e Qohelet, attribuito da Leopardi a Salomone. Ugualmente ritorna la Genesi nella “Storia del genere umano”, primo dialogo delle Operette Morali e nell’Inno ai Patriarchi del luglio 1822. 16 Un maestro dell’uso degenerativo consapevole è Dan Brown del Codice da Vinci. Mescolando dati biblici e dati inventati si toglie credibilità al tutto, minando la coerenza del materiale originale, che viene sempre letto con il sospetto acquisito a partire dal dubbio instillato dal romanzo pseudoscientifico. Si tratta quindi di un uso materiale di segni, nomi e racconti biblici opportunamente trasformati per dire altro da ciò che, nel loro contesto e nell’intenzione biblica, significano. 3) Il modello trasfigurativo è il più sottile e interessante dei possibili modelli di influsso della Bibbia sulla letteratura. Scrive Ravasi nel suo saggio citato: «L’arte riesce spesso a far vibrare le risonanze segrete del testo sacro, a ritrascriverlo in tutta la sua purezza, a far germogliare potenzialità che l’esegesi scientifica solo a fatica conquista e talora del tutto ignora. È ciò che Paul Klee affermava in senso generale quando nella sua Teoria della forma e della figurazione scriveva che “l’arte non ripete le cose visibili ma rende visibile ciò che spesso non lo è”.»…« Il risultato trasfigurativo è proprio, comunque, di tutte le grandi opere d’arte e di letteratura.» Possiamo dire a questo riguardo che la Bibbia si può RAPPRESENTARE oppure RIPRESENTARE: Tolkien rientra nella seconda categoria, seppure in modo inconscio. Nella sua arte c’è una trasfigurazione delle tematiche bibliche da lui assimilate. Lewis, che cerca di produrre un’opera religiosa consciamente, non riesce se non a mettere in scena, con vestiti diversi, un’allegoria, comunque godibile e interessante, della storia biblica-evangelica. La trasfigurazione si riferisce alle opere spirituali, in cui non sono presenti, in modo riconoscibile, storie o personaggi biblici, ma che sono rette da strutture e significati profondamente consonanti e ispirati alla rivelazione biblica. a) Tolkien: antropologia biblica riscritta e rivissuta. La trasfigurazione della Bibbia nell’arte (Ravasi) L’arte e la letteratura possono fungere, dunque, da “ermeneutica trasfigurativa” del testo biblico, non ripresentandolo nella sua materialità o vicenda, ma riscrivendolo e rinarrandolo in storie e situazioni originali che, tuttavia, lo riecheggiano profondamente e – a volte – addirittura inconsapevolmente14. L’arte e le varie espressioni culturali possono, quindi, rivelarsi ripetutamente animate dall’immaginario e dall’ideologia biblica. Contemporaneamente la tradizione culturale diventa chiave di interpretazione - ora libera, ora corretta, ora deviata - della stessa Scrittura tant’è vero che un teologo come Marie-Dominique Chenu nel suo volume sulla Teologia nel XII secolo confessava: “Se dovessi rifare quest’opera darei un’attenzione molto maggiore alla storia delle arti, sia letterarie sia plastiche, perché esse non sono soltanto delle illustrazioni estetiche ma dei veri luoghi teologici”. Tutto questo è giustificato anche dal fatto che la Bibbia, pur essendo un testo teologico nella sua finalità ultima, è anche un’opera letteraria, dotata di una sua straordinaria forza espressiva. Essa si manifesta in forme molteplici ma soprattutto ha una via privilegiata di formulazione - come si ha già avuto l’occasione di sottolineare - proprio nel simbolo15. Tolkien afferma nel suo epistolario che Il Signore degli Anelli è un’opera fondamentalmente religiosa e cattolica, all’inizio lo era “inconsciamente”, ma nel momento della revisione del testo lo divenne “consciamente”, ma “l’elemento religioso è assorbito nella storia e nel simbolismo”. 14 15 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 142 (pp. 195-196). G. RAVASI, La Bibbia come “Il grande codice” dell’occidente, in “L’Osservatore Romano” 17 febbraio 2008. 17 La “mitopoiesi”, per Tolkien, fa parte dell’essere umani: la definisce “sub-creazione”. L’uomo crea perché a sua volta è creato. Anzi, dice Tolkien, è creato ad immagine e somiglianza di un Creatore: non può – quindi – non imitarlo. Digressione su Tolkien e la sua Opera (da Paolo Giulisano): Tolkien ha riproposto, in pieno ventesimo secolo, il genere letterario epico, ridando dignità letteraria all’antichissimo genere della narrativa dell’immaginario, nonostante il cinismo di una cultura dominante che, come Brecht insegnava, doveva fare a meno dei valori, in particolare dell’eroismo. Il professore di Oxford è divenuto così un maestro, un punto di riferimento esistenziale per generazioni di giovani lettori che si sono commosse ed esaltate alla lettura delle sue pagine epiche così lontane dal realismo spesso squallido che ha imperato a lungo in letteratura- che narravano giustappunto di eroi, di regni perduti da restaurare, di signori del male contrapposti ad elfi, cavalieri e piccole gentili creature, pronte però a ogni sacrificio per il trionfo del bene: gli Hobbit, personaggi peculiarmente e assolutamente tolkieniani. Nato in Sudafrica nel 1892 da genitori inglesi ivi trasferitisi per lavoro, ritornato in Inghilterra a quattro anni dopo la morte del padre, dopo la morte della madre avvenuta nel 1904 fu allevato dal proprio tutore, il sacerdote oratoriano padre Francis Morgan. Studiò a Oxford dove ottenne il titolo di baccellierato e di Master of Arts. Nello stesso prestigioso ateneo fu docente per oltre vent’anni di Lingua e letteratura anglosassone, collaborando all’Oxford English Dictionary. La sua fama mondiale è tuttavia legata, come si è detto, alle opere di fantasia (o per meglio dire di epica fantastica e mitologica) che ebbero enorme successo: Lo Hobbit (1937), Il Signore degli Anelli, Il Silmarillion uscito postumo nel 1977 a cura del figlio Christopher dopo la sua morte avvenuta nel 1973. Tolkien possiede addirittura quella che potremmo definire una visione teologica della storia, attraverso la quale giudica, con l’autorevolezza di un filosofo o di un profeta, le vicende umane e con esse le brutture e gli errori della modernità. Una lettura che non è ideologica ma, al contrario, realistica; non nasce, cioè, da un idea di mondo, o da un progetto più o meno utopico su di esso, ma dalla constatazione della natura e della condizione umana, segnata indelebilmente dalla Caduta (in termini cristiani dal Peccato Originale), talchè il Nemico da battere è sì l’avversario malvagio (come i personaggi del Signore degli Anelli Sauron o Saruman) ma è soprattutto il male che si annida infido in ciascuno di noi. Il ritorno al Bello e al Vero auspicato dallo scrittore di Oxford venne realizzato da lui attraverso il ricorso e il ritorno al Mito, per ridare sanità e santità all’uomo moderno. “ Il mito è qualcosa di vivo nel suo insieme e in tutte le sue parti, e che muore prima di poter essere dissezionato”, disse Tolkien parlando ai suoi studenti di una delle sue opere preferite, il Beowulf. Il mito è necessario perché la realtà è molto più grande della razionalità. Il mito è visione, è nostalgia per l’eternità, come dice Clyde Kilby, studioso dell’opera tolkieniana. Il mito è simbolo, ossia segno che rimanda a un significato ultimo che l’uomo deve riconoscere e interpretare. Il mito, nella storia dell’umanità, non è mai stato contrapposto, come avviene oggi, alla realtà; il mito è sempre stato per sua stessa natura vero, espressione della verità delle cose. Nel mito si veniva a contatto con qualcosa di vero che si era pienamente manifestato nella storia, e questa manifestazione poteva fondare sia una struttura del reale che un comportamento umano. Il mito è un mezzo per dare risposte a questioni fondamentali come l’origine dell’uomo, il bene, il male, l’amore, la morte e per dare spiegazioni ai fenomeni della natura. 18 Se il mito è il nesso, il legame che l’uomo ha sempre cercato con il senso della vita, esso non può quindi che essere considerato un’espressione naturale ed antichissima del senso religioso che vive nel cuore dell’uomo. L’elemento religioso è radicato nelle storie di Tolkien e nel loro simbolismo. La sua stessa passione per il narrare nasce dal desiderio di comunicare la Verità, attraverso simboli e visioni. “Il Vangelo – spiegava - è la più grande Fiaba, e produce quella sensazione fondamentale: la gioia cristiana che provoca le lacrime perchè qualitativamente è simile al dolore, perchè proviene da quei luoghi dove gioia e dolore sono una cosa sola, riuniti, così come egoismo e altruismo si perdono nell’Amore”. In questa intensità epica e spirituale dell’opera di Tolkien sta il segreto della straordinaria attualità di questo autore di narrativa fantastica che si fa veicolo di valori immutabili, profondamente connaturati col cuore dell’uomo, i suoi sogni, le sue speranze. - Allegoria e rifiuto dell’allegoria (L’esempio di C.S. Lewis delle Cronache di Narnia) Più e più volte Tolkien torna sul suo rifiuto della lettura allegorica della sua opera. Non è stata scritta con questa intenzione. Non è un’opera didattica accuratamente pianificata. È un’opera d’arte scaturita dall’immaginazione produttiva, non dalla razionalità che deve “dipingere concetti”. In questo possiamo vedere la forma che chiamiamo parabolica: una storia coerente in se stessa e artisticamente compiuta, ma non affatto chiusa alla dimensione metaforica, all’apertura a significati ulteriori. Tolkien predilige la forma biblica per la sua narrazione (la struttura e i valori della storia evangelica informano il suo romanzo) piuttosto che un CONTENUTO biblico, da mettere in scena in forme originali. Questo lo si vede nella dimensione parabolica: un simbolo in movimento. Il simbolo non rimanda fuori di sé ad un significato altro, ma contiene in se stesso quello che intende mostrare e far esperire. Mentre l’allegoria è prescrittiva e chiusa, la storia parabolica, che ha una morale, è però nelle mani del lettore, che può farne quello che vuole o quello che riesce. Nel caso di Tolkien, leggendo il libro, la narrazione appare consistente, legata e sviluppantesi naturalmente dalle premesse. Invece, nel caso di Lewis tutta la costruzione narrativa del ciclo di Narnia, il susseguirsi dei libri sono dirette a riprodurre i temi biblici dalla creazione all’apocalisse. In particolare il sacrificio di Aslan, e la sua risurrezione è una puntuale allegoria, riconoscibilissima, della morte e risurrezione di Cristo, una messa in scena del concetto di Redenzione (sulla linea dell’interpretazione Anselmiana), più che la narrazione di un fatto verosimile – pur nel regno del Fantasy – come è la caduta di Gandalf nel Signore degli Anelli. Scrivendo a un bambino della classe quinta, Lewis mette l’accento sul suo più ampio scopo artistico: “Non mi sono detto, ‘Rappresentiamo Gesù come è realmente nel nostro mondo per mezzo di un Leone nel mondo di Narnia’. Mi dicevo: ‘Supponiamo che ci sia una terra come Narnia e che il Figlio di Dio, come è divenuto uomo nel nostro mondo, così là diventi un leone, e poi immaginiamo che cosa succederebbe’”16. Per Lewis la scelta di utilizzare il linguaggio del Fantasy per esprimere nuovamente la storia evangelica è comunque esplicito e voluto17. La fantasmagoria mitologica diventa rivestimento per un messaggio didattico e morale inteso in quanto tale. 16 R.H. BELL, Inside the Wardrobe: Is ‘Narnia’ a Christian Allegory?, in “Commonweal”, Vol. 132, n. 22 (16 Dicembre 2005), p. 12ss. 17 Come intuisce anche CHARLES MOORMAN nel suo contributo (“Now Entertain Conjecture of a Time”- The Fictive Worlds of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien) al libro di M.R. HILLEGAS (ed.), Shadows of Imagination: The Fantasies of C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, and Charles Williams, Southern Illinois University Press, 1979, p. 60: «Although beginning with images which developed into a literary form, the seven books became rather deliberately, if not allegories, then at least deliberate expositions of the great articles of the Christian faith, the Trinity, the Creation of the world through the agency of the Son, Original Sin, the Atonement, Repentance and Rebirth, the Second Coming, the Final Judgment - all are presented, stripped “of their stained-glass and Sunday school associations,” in the tales of Aslan and the Pevensie children, who themselves represent the various sorts and conditions of Christian men: capable, honourable Peter, 19 Le storie di Tolkien, che arrivano senza iniziale pianificazione a condensarsi nel Signore degli Anelli, non sono nate per insegnare qualcosa, quanto piuttosto si rivelano un recupero di una “chiara visione” sulla vita stessa, espressa nella subcreazione artistica. Charles Moorman addirittura è convinto che la differenza sostanziale tra il libro di Lewis e quello di Tolkien risiede nel fatto che il primo sia apertamente cristiano, mentre il secondo sarebbe eroicopagano. Il fatto che non ci sia una divinità scopertamente attiva e presente, coinvolta nella trama, fa dubitare il critico dell’ispirazione cristiana dell’opera di Tolkien. Egli non sa leggere la metafora, si ferma alla similitudine. Questo accade spesso con la lettura delle due opere da parte di critici protestanti, che non colgono l’importante lezione cattolica di Tolkien, per cui le cause seconde manifestano la grazia e portano a compimento la volontà di Dio che nella vita quotidiana non appare come personaggio sul palcoscenico del mondo (reale o fantastico che sia). In realtà Tolkien mostra come il male non è stato ancora completamente annullato, benché sia stato privato del suo potere più grande. Eppure la volontà corrotta può sempre seguirlo e farlo riemergere: le ére che si succedono nei racconti tolkieniani sono riproposizioni dell’andamento biblico di alleanza-peccato-esilio-perdono-ritorno che si riprone ciclicamente (Adamo; Noè, Babele, Giuseppe, Israele in Egitto, Esilio di Babilonia…). Non è ancora venuta la fine del tempo. Anche la distruzione dell’anello non rappresenta la fine delle guerre, è una tappa centrale della lotta, ma l’orizzonte escatologico non è raggiunto (come invece cerca di mostrare l’ultimo libro delle Cronache di Narnia: Battaglia finale). Tolkien – come notato precedentemente – tiene molto alla parola Mito, e come Lewis, vede in esso un appello primario all’immaginazione, non alla comprensione razionale: «Ma ab initio una passione per me fondamentale è stata quella per il mito (non l’allegoria!) e per le storie fantastiche, e soprattutto per le leggende eroiche a metà fra la fiaba e la storia…Ero studente quando il pensiero e l’esperienza mi rivelarono che questi interessi non sono contrastanti – i poli opposti di scienza e romanzo – ma intimamente connessi…. Il mito e la fiaba devono, come tutte le forme artistiche, riflettere e contenere - fusi insieme elementi di verità morale e religiosa (o di errore), ma non esplicitamente, non nella forma conosciuta dal mondo “reale”, primario»18. .L’allegoria si muove verso una corrispondenza uno ad uno dei riferimenti testuali con concetti esterni al testo; il mito invece è primariamente una storia che sta in piedi da se stessa, non ha bisogno – di per sé- di essere decodificata su un altro piano per essere comprensibile e significativa, ma questo non vuol dire che non possa (o non debba) avere degli ulteriori piani di lettura, in senso metaforico. Siamo nel campo della parabola, un campo totalmente e perfettamente consono alla rivelazione biblica. Tolkien non rifà la Bibbia, ma, potremmo dire fa come la Bibbia. Per Lewis, con la venuta di Cristo: “il mito divenne un fatto”. Il mito presentato e raccontato dai vangeli funziona come ogni altro mito. Ma ha una enorme differenza: che questo mito è realmente accaduto. Tolkien ridice il mito fondamentale della cultura biblica senza utilizzare gli stessi personaggi o materiali letterari, ma inventando una sua personale storia che, tuttavia, ripropone la verità e le tematiche della grande storia che gli sta a cuore in altra forma. «Nella cosmogonia c’è una caduta: una caduta di Angeli dovremmo dire. Benchè del tutto diversa, nella forma, naturalmente, da quella del mito cristiano. Queste storie sono nuove, non derivano direttamente da altri miti e da altre leggende, ma inevitabilmente finiscono per contenere in larga misura motivi o elementi anticamente molto diffusi. Dopo tutto, io credo che le leggende e i miti siano in gran parte fatti di “verità”, e in realtà presentino aspetti feminine Susan, self-centered Edmund, and saintly Lucy. Such a clearly didactic purpose and method appear never to have occurred to Tolkien. Quite the opposite, in fact. ». 18 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 131 (pp. 164-165). 20 della verità che possono essere recepiti solamente sotto questa forma; e certe verità furono scoperte molto tempo fa e ritornano sempre. Non ci può essere una “storia” senza una caduta: tutte le storie in definitiva riguardano una caduta, per lo meno per la mente umana come noi la conosciamo e di cui siamo dotati».19 Un punto centrale che Tolkien mette in scena e che prende dalla teologia neotestamentaria è la cosiddetta eucatastrofe, così tipica della letteratura di matrice cristiana. - Il concetto di eucatastrofe20: con questo termine si intende uno sconvolgimento improvviso e violento, un evento tragico, che però porta un effetto benefico, porta al bene ed è un segno che nella sua drammatica storia l’uomo non è abbandonato a sé stesso, ma è accompagnato sempre dalla luce della grazia di Dio (Andrea Monda). Lo vediamo esemplificato in due punti, due “climax” della narrazione del Signore degli Anelli. La lotta di Gandalf con il Balrog e la sua conseguente morte fino al suo inaspettato ritorno, e il fallimento della missione di Frodo nelle viscere di Monte Fato, che tuttavia viene compiuta per la provvidenziale presenza del traditore Gollum, misericordiosamente risparmiato in precedenza proprio da Frodo. Nel saggio On the Fairy-stories (1939 pubblicato nel 1947) Tolkien scrive: “I would venture to say that approaching the Christian story from this perspective [la prospettiva del mito, della storia fantastica], it has long been my feeling (a joyous feeling) that God redeemed the corrupt making-creatures, men, in a way fitting to this aspect, as to others, of their strange nature. The Gospels contain a fairy-story, or a story of a larger kind which embraces all the essence of fairy-stories. ...and among its marvels is the greatest and most complete conceivable eucatastrophe. The Birth of Christ is the eucatastrophe of Man’s history. The Resurrection is the eucatastrophe of the story of the Incarnation.” Non bisogna confondere il concetto di eucatastofe con quello di Deus-ex-machina. Tutti e due, letterariamente, servono per risolvere una situazione finale ormai destinata alla tragedia. La differenza è che l’eucatastrofe non introduce un nuovo personaggio, o una forza o una qualche ragione esterna alla narrazione e senza riferimenti al racconto fin lì sviluppatosi, ma nasce dall’interno della trama della storia stessa e delle scelte passate dei personaggi. L’evento eucatastrofico è inaspettato, ma non completamente imprevedibile o fuori della trama, come invece è l’apparizione del Deus-ex-machina (un famoso uso contemporaneo di Deus ex machina lo troviamo nella Guerra dei Mondi di Horson Wells, dove i terribili alieni sono all’improvviso e inaspettatamente sconfitti dai batteri terrestri). Il senso di provvidenza che pervade il cammino della Compagnia dipana sotto i nostri occhi una “teologia della storia” in cui Tolkien crede e che plasma il suo mondo (come il mondo reale) e le 19 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 131 (pp. 168-169). J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 86 (pp. 116-117): «Ho coniato la parola “eucatastrofe”: l’improvviso lieto fine di una storia che ti trafigge con una gioia tale da farti venire le lacrime agli occhi (che io argomentavo essere il sommo risultato che una fiaba possa produrre). E nel saggio esprimo l’opinione che produce questo effetto particolare perché è un’improvvisa visione della Verità, il tuo intero essere legato alla catena di causa ed effetto, la catena della morte, prova un sollievo improvviso come se un anello di quella catena saltasse….La Risurrezione è la più grande “eucatastrofe” possibile nella più grande fiaba, e produce quella sensazione fondamentale: la gioia cristiana che provoca le lacrime perché qualitativamente è simile al dolore, perché proviene da quei luoghi dove gioia e dolore sono una cosa sola, riuniti, così come egoismo e altruismo si perdono nell’Amore. Naturalmente non voglio dire che i Vangeli raccontano solo fiabe; ma sostengo con forza che raccontano una fiaba: la più grande. L’uomo narratore, deve essere redento in modo consono alla sua natura: da una storia commovente. Ma dato che il suo autore è l’artista supremo e l’autore di tutta la realtà, questa storia è stata fatta esistere per essere vera anche al primo livello [quello della realtà esistente; il secondo livello è quello del racconto immaginativo, ndr.]» 20 21 storie raccontate. Lewis invece cerca di rivestire la Storia della salvezza, raccontandola con elementi che la facciano apparire appetibile e digeribile. C’è chi ha parlato di una strategia di Tolkien nel “ri-paganizzare” il tessuto narrativo della sua opera a fine apologetico21; in realtà, come più volte spiegato da Tolkien stesso, la mitologia paganonordica è il linguaggio che egli usa, ma il contenuto del mito che va plasmando usa quel linguaggio ma per dire altro: non è un poema eroico-nordico quello raccontato nella trilogia del Signore degli Anelli. Le convinzioni evangeliche che Tolkien non nega mai, anzi, di cui si renderà conto personalmente nella rilettura del testo, si trasfondono nell’organizzazione morale della storia in modo non intenzionale (eppur reale), perché l’autore non desiderava primariamente metterle in scena mascherate da attori, quanto presentare dei veri e propri personaggi in un mondo guidato da regole che egli sentiva vere e coerenti con il suo credo22. Dice P. Giulisano nel suo saggio Tolkien, mitologia e teologia della storia: Diceva Chesterton a proposito della finalità dei racconti, e lo stesso Tolkien lo riprende nei suoi scritti, che i bambini sono innocenti e amano la giustizia, mentre la maggior parte di noi è malvagia e naturalmente preferisce il perdono. Per questo i primi - e con loro tutti coloro che hanno un cuore puro da bambino - amano che le storie si concludano con un “lieto fine”. A tale proposito, Tolkien introduce il concetto di “eucatastrofe”: il racconto eucatastrofico, contenente cioè un giudizio morale sugli avvenimenti e una conclusione appropriata, è la vera forma di fiaba e ne costituisce la suprema funzione. Quando in un racconto fantastico abbiamo a trovare un “capovolgimento”, un’interruzione del corso negativo degli eventi, un ribaltamento dell’inesorabile, opprimente realtà, abbiamo anche una stupefacente visione della gioia, dell’aspirazione del cuore che per un istante travalica i limiti del racconto, lacera la ragnatela della vicenda, permette che un bagliore la trapassi. “Gioia acuta come un dolore” dice Tolkien, presente nonostante le sconfitte e i fallimenti, poichè smentisce l’universale sconfitta finale, a dispetto delle molte apparenze contrarie evidenti nel tempo presente. La gioia che Tolkien ha posto a segno del vero racconto fantastico merita una più attenta considerazione; l’“eucatastrofe”, che è ben più del cosiddetto “lieto fine” delle fiabe tradizionali, rappresenta un lontano barlume, un’eco dell’Evangelium nel mondo reale. Nel saggio sui racconti fantastici Tolkien scriveva: “Mi azzarderei ad affermare che, accostandomi alla Vicenda Cristiana sotto questa angolazione, a lungo ho avuto la sensazione (una sensazione gioiosa) che Dio abbia redento le corrotte creature produttrici, gli uomini, in maniera adatta a questo come pure ad altri aspetti della loro singolare natura. I Vangeli contengono una favola o meglio una vicenda di un genere più ampio che include l’intera essenza delle fiabe. I Vangeli contengono molte meraviglie, di un’artisticità particolare, belle e commoventi, “mitiche” nel loro significato perfetto, in sé conchiuso: e tra le meraviglie c’è l’eucatastrofe massima e più completa che si possa concepire. Solo che 21 «It appears that The Lord of the Rings has also been partly “re-paganized” by its author with a special purpose. That “purpose” is related to what might be called an apologetic “strategy.” Tolkien is at once committed to certain insights of traditional Christian belief and aware of the modern man’s skepticism about many of those insights. Therefore, “repaganization”.» in M.R. HILLEGAS (ed.), Shadows of Imagination: The Fantasies of C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, and Charles Williams, Southern Illinois University Press, Carbondale(IL), 1979, p. 106. 22 «The Lord of the Rings, then, although it presents no ”God,” no “Christ,” and no “Christians,” embodies much of Tolkien’s “real religion” and is a profoundly Christian work. No “God” is required in this story; it is enough if it suggests the kind of pattern in history which the Christian tradition has ascribed to the providence of God. Gandalf and Aragorn need not turn our thoughts to the Christ of Christian faith; but they persuade us that if we are to have hope in our lives and in our history it must be hope for the kind of power and authority revealed in Aragorn the king and on the basis of the kind of power revealed in Gandalf’s “miracles” and in his rising from the dead. What Frodo does and undergoes speaks to us of what a man’s responsibility, according to the Christian faith, must always be: to renounce the kind of power which would enslave others and ourselves and to submit to that power which frees us to be all we are capable of being», Ibid. p. 107. 22 questa vicenda ha penetrato di sé la Storia e il mondo primario; il desiderio e l’anelito alla subcreazione sono stati elevati al compimento della Creazione. La nascita del Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo; la Resurrezione, l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa vicenda si inizia e si conclude in gioia, e mostra in maniera inequivocabile la “intima consistenza della realtà”. Non c’è racconto mai narrato che gli uomini possano trovare più vero di questo, e nessun racconto che tanti scettici abbiano accettato come vero per i suoi propri meriti. Perché l’Arte di esso ha il tono, supremamente convincente, dell’Arte Primaria, vale a dire della Creazione. E rifiutarla porta o alla tristezza o all’iracondia.” Tolkien ci introduce al significato della gioia cristiana, il cui nome è Gloria: “L’arte ha avuto la verifica. Dio è il Signore degli angeli, degli uomini – e degli elfi. Leggenda e Storia si sono incontrate e fuse”. Il Vangelo non ha abrogato le leggende, dice il professore di Oxford, ma le ha santificate. “Il cristiano deve ancora operare, con la mente come con il corpo, soffrire, sperare, morire; ma ora può rendersi conto che tutte le sue inclinazioni e facoltà hanno uno scopo, il quale può essere redento. Tanto grande è la liberalità onde è stato fatto oggetto, che ora può forse permettersi a ragion veduta di ritenere che con la Fantasia può assistere effettivamente al dispiegarsi e al molteplice arricchimento della creazione. Tutte le narrazioni si possono avverare; pure alla fine, redente, possono risultare non meno simili e insieme dissimili dalle forme da noi date loro, di quanto l’Uomo, finalmente redento, sarà simile e dissimile, insieme, all’uomo caduto a noi noto”. Si deve parlare quindi di Tolkien come scrittore religioso, dunque, e più precisamente si può rintracciare la fonte della sua visione religiosa nella fede cattolica intensamente vissuta. Tolkien era stato ricevuto nella Chiesa di Roma a nove anni, dopo la conversione della madre. La Chiesa cattolica in Inghilterra all’inizio del ‘900 era una comunità povera, composta in gran parte di immigrati irlandesi, con alle spalle tre secoli di persecuzioni. La città di Birmingham, dove la famiglia Tolkien viveva, era stata tuttavia illuminata in quegli anni dalla presenza di quel grande genio cristiano che fu John Henry Newman. Il volto magro e solcato di rughe profonde in cui splendevano due occhi intrisi di ideale scrutarono per anni in quella difficile Inghilterra. Elevato alla porpora cardinalizia da Leone XIII alla soglia degli ottant’anni, nominato Fellow onorario del Trinity College di Oxford (era dai tempi della Riforma, tre secoli prima, che un tale riconoscimento del massimo istituto accademico inglese non veniva più dato a un cattolico) si spense a Birmingham nel 1890, mentre i Tolkien si trasferivano in Sudafrica. Sicuramente Mabel ebbe a respirare quel clima spirituale che Newman aveva diffuso. Sulla sua tomba il grande convertito aveva voluto che fossero incise queste parole: Ex umbris et imaginibus ad veritatem (“Andiamo verso la verità passando attraverso ombre e immagini”). La saggezza di Tolkien è affidata alle parole di Gandalf, nella conclusione del Signore degli Anelli, ove dice: “Altri mali potranno sopraggiungere, perchè Sauron stesso non è che un servo o un emissario. Ma non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Ma il tempo che avranno non dipende da noi”. È questo il manifesto dell’umano realismo, profondamente cristiano, opposto agli incubi di tutte le utopie, con le loro promesse ingannatrici e illusorie. L’eucatastrofe non nega, anzi deve sorgere dagli eventi disastrosi che la storia non ha timore di raccontare. La gioia improvvisa e insperata deve conseguire alla più nera situazione. L’evento finale 23 deve produrre una vera liberazione, che doveva essere invocata proprio nel sentire tutta l’oscurità o la tragicità della sua mancanza. L’impossibilità di produrre il cambiamento desiderato, o l’incapacità comprovata di salvarsi con le proprie forze è anche questo un tema assolutamente centrale della panoplia biblica, soprattutto neotestamentaria. Scrive a proposito Tolkien, in modo assolutamente limpido: «Io sono cristiano, e cattolico romano, e quindi non mi aspetto che la “storia” sia qualcosa di diverso da una “lunga sconfitta” – benché contenga (e in una leggenda in modo ancora più chiaro e toccante) alcuni esempi e intuizioni della vittoria finale»23. Questa teologia narrativa la troviamo inscritta anche poeticamente nel paradosso della FELICE COLPA attribuito a sant’Agostino, ma in realtà presente nel Preconio Pasquale O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà: per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore! O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem! La forma dell’eucatastrofe evangelica della morte e risurrezione di Cristo, la troviamo già in nuce, potremmo dire in germe, in altri episodi che anticipano e preparano la grande conclusione della storia di Cristo. Per es. all’inizio del vangelo di Giovanni, nella scena delle nozze di Cana (Giovanni 2,1-11) Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Finisce il vino alla festa matrimoniale. Non solo un incidente, una vera e propria disgrazia per la famiglia, una vergogna per gli sposi. Maria, la madre di Gesù, ha il dono di accorgersi della situazione, ha l’occhio per vedere le necessità degli altri, ma non può risolverle. Gesù sembra quasi contrariato, in realtà rivela: “non è ancora venuta la mia ora”. L’ora di Gesù è l’ora della sua morte e risurrezione, l’ora della rivelazione finale. Qui egli anticipa simbolicamente la sua ora, traendo dall’acqua della morte il vino della vita e della gioia. È una simbolica risurrezione, ottenuta dalla fede incrollabile di Maria, contro ogni evidenza razionale e relazionale, e dall’obbedienza dei servi (“fate quello che vi dirà”, dice Maria ai servi). Nessuno è testimone o sa come è mutata l’acqua in vino. Solo i servi ne sono testimoni, quelli che non contano, quelli la cui parola non sarebbe creduta. 23 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 195 (p. 289). 24 -- Altro esempio di capovolgimento e simbolo di risurrezione lo troviamo nei racconti della moltiplicazione dei pani, unito all’offerta sacrificale: Gesù compie il miracolo, ma parte dal dono minimo, che non può certo ragionevolmente bastare, per sfamare la folla dei cinquemila. La situazione sembra disperata per i discepoli (duecento denari di pane non basterebbero a nulla). Non c’è niente da fare. Eppure la fede di Pietro e la generosità di un ragazzo che rinuncia al suo pranzo nelle mani di Cristo sfamano la moltitudine e ne avanza. Segno messianico ben codificato dal popolo che cerca di fare re Gesù. Il quale si sottrae, perché non è quello il vero successo. Giovanni 6,4-15: Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 7Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Il recupero dello sguardo Le storie fantastiche permettono di recuperare uno sguardo più profondo sulla realtà a cui siamo troppo abituati. Anche sulla storia divina a cui rischiamo di assuefarci. Dice Tolkien, che possiamo recuperare una chiara visione, liberata dalla eccessiva familiarità, dall’esser una verità trita e ritrita. Lo sguardo di meraviglia favorito dalla storia fantastica24, ci fa cogliere appieno quella verità che un tempo abbiamo acquisito, posseduto e messo al sicuro in uno scrigno, senza poi guardarla più, come facciamo sempre con gli oggetti preziosi che desideriamo (Cf. On fairy-stories, p. 146) Proprio come diamo per scontata la bellezza dei volti di chi ci è familiare, avendoli visti e rivisti, così arriviamo a convincerci falsamente di aver raggiunto una piena conoscenza di essi. Invece, quando ci capita di osservare questi volti in uno strano riflesso, rispecchiati sull’acqua o in un vetro, arriviamo a notare qualcosa di nuovo. Vediamo ciò che ci è già familiare in un modo nuovo e unico (Cf. JEFFREY L. MORROW, J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis in Light of Hans Urs Von Balthasar, in «Renascence: Essays on Values in Literature», 56(2004) 18ss.). La Teologia è preziosa per comprendere l’opera di Tolkien, anzi, la sua opera è anche una teologia applicata alla narrazione (o meglio una teologia che sorge dalla narrazione), una teologia narrativa nello stile di precedenti illustri (per es. i quattro vangeli!). La stessa forza delle parabole, la forza delle fiabe, la quale ha senso – è Tolkien che lo ricorda – solo perché ciò è successo veramente nella Storia, non quella scritta, ma quella vissuta25. 24 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 165 (pp. 249): «Penso che la cosiddetta “storia fantastica” sia una delle più alte forme di letteratura». 25 Cf. FRANCO MANNI, Introduzione a Tolkien, Simonelli, Milano 2002, p. 28. 25 Il lettore accorto, nel Signore degli Anelli, può discernere a vari livelli, reminescenze e richiami letterari e culturali: l’anello di Gige della Repubblica di Platone, l’anello dei Nibelunghi della saga wagneriana; il ciclo arturiano, la letteratura fantastica ottocentesca… Ma il lettore accorto discernerà soprattutto i libri dell’Antico Testamento e le parabole evangeliche; richiami teologici dei Padri della Chiesa, di Tommaso e del Card. Newman. «La prima cosa, però, che colpisce il lettore di questo libro non è la cultura, ma l’arte narrativa; la complessa vicenda della trama è organizzata con un ritmo tale da avvincere lungo tutte le 1300 pagine dell’opera. La varietas degli argomenti, degli scenari e della situazioni psicologiche dei personaggi è molto grande ed è associata, in ciascun caso, a uno stile che adeguatamente varia.Ammirevoli, inoltre, l’ampiezza lessicale, il ritmo interno di ciascun capitolo, la miscela tra discorso del narratore e discorsi dei personaggi, l’incarnazione in azioni e dialoghi del messaggio “filosofico” dell’autore»26. Personaggi e Christ-like figures. Gandalf e Frodo sono i due personaggi su cui puntiamo l’attenzione. Molti commentatori hanno visto in essi due cosiddette figure Cristiche, (o Christ-like figures). Ma se è facile scoprire la figura Cristica celata sotto la pelle del leone di Narnia, non è così univoco e altrettanto indiscutibile percepire nei personaggi complessi dell’universo tolkieniano le stesse caratteristiche. Possiamo convenire per quanto riguarda Gandalf e il suo sacrificio nella lotta con il Balrog e la sua successiva risurrezione, che questo episodio è certamente esemplificato sulla reminescenza delle narrazioni evangeliche. Si metta per esempio a confronto l’apparizione di Gandalf, ormai diventato “il bianco”, e i racconti evangelici della risurrezione, della trasfigurazione di Cristo e dell’apparizione del Figlio dell’Uomo nell’Apocalisse. Nel Signore degli Anelli il ripresentarsi di Gandalf ai compagni è così descritto: I suoi capelli erano bianchi come neve al sole; bianco splendente era il suo manto; gli occhi, sotto i suoi profondi sopraccigli erano luminosi, penetranti come i raggi del sole; la forza era nella sua mano. Tra stupore, gioia e paura ristettero e non trovarono una parola da dire. His hair was white as snow in the sunshine; and gleaming white was his robe; the eyes under his deep brows were bright, piercing as the rays of the sun; power was in his hand. Between wonder, joy, and fear they stood and found no words to say. (II, 98) La morte e il ritorno di Gandalf è normato sulla morte e risurrezione di Gesù, con riferimenti testuali che a Tolkien erano certamente coscienti27: Il Balrog cadde indietro e la sua spada volò in mille pezzi. Gandalf oscillò sul ponte, fece un passo indietro e rimase immobile come prima. “Non puoi passare”, disse. D’impeto il Balrog balzò in 26 F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 28. J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 156 (p. 229-230): «Solo Gandalf supera la prova… Perché nelle sue condizioni per lui era un sacrificio morire sul Ponte per difendere i suoi compagni, minore forse rispetto a quello di un uomo mortale o di uno hobbit, dato che lui aveva un potere interiore più grande di loro; ma anche maggiore, dato che si trattava del sacrificio di se stesso in conformità agli Ordini: per quanto ne sapeva lui in quel momento era lui l’unica persona che potesse dirigere con speranza di successo la resistenza nei confronti di Sauron, e l’intera sua missione era vana. Stava passando le consegne all’Autorità che aveva stabilito gli Ordini, e rinunciando alle sue personali speranze di successo… Gandalf si sacrifica, il suo sacrificio viene accettato, e fa ritorno più forte». Vedi anche la lettera 181 (p. 268). 27 26 pieno sul ponte. La frusta turbinava sibilando. Ma in quel momento Gandalf drizzò il bastone, e gridando con voce piena di autorità colpì il ponte innanzi a sé. Il bastone si frantumò e gli cadde di mano. Avvampò abbacinante una parete di fiamme bianche. Il ponte si ruppe sotto i piedi del Balrog mentre il resto rimase come una lingua di roccia nel vuoto. Con un urlo terribile il Balrog precipitò giù, ma, mentre cadeva, diede con la frusta una sferzata e le code si avvinghiarono intorno alle ginocchia del vecchio trascinandolo sull’orlo della voragine: Gandalf vacillò, cadde, cercò un appiglio, guardò gli amici: “Fuggite, sciocchi!”, gridò, e scomparve poi nella buia profondità. La Compagnia da lui salvata, appena fuori da Moria, lo pianse a lungo. Poi proseguì il suo viaggio. Solo dopo mesi accadde ad Aragorn, Legolas e Gimli, mentre camminavano nella foresta di Fangorn, di vedere un vecchietto curvo sotto un manto grigio; credevano che fosse lo stregone Saruman travestitosi per spiare, ma il manto cadde, e davanti a loro apparve Gandalf in candide vesti, Bianco e non più Grigio, oramai diventato lui il maestro del suo Ordine, perché solo lui era rimasto fedele. E Aragorn allora ripetè le antiche parole dei discepoli di Emmaus: “Qual velo copriva i nostri occhi, e non riconoscevamo il nostro maestro Gandalf, al dà di ogni speranza tu torni nel momento del bisogno!”.28 Nella quarta sezione dei Racconti incompiuti ci vengono fornite informazioni ulteriori su Gandalf inserito nell’ordine degli Istari. Le caratteristiche di questi “spiriti minori” (Maiar), esseri angelici inviati dai Valar sulla Terra di mezzo - come li definisce spesso Tolkien nel suo epistolario gettano ulteriore luce sulla loro funzione e sulle analogie cristiche del personaggio Gandalf: E così con il consenso di Eru [i Valar] inviarono membri del loro stesso alto ordine, però sotto la specie di uomini in carne e ossa, soggetti alle paure, ai dolori e alle stanchezze della terra, suscettibili di provare fame, sete e di essere uccisi; sebbene, a causa dei loro nobili spiriti, gli emissari non morissero, e se invecchiavano era solo per le cure e le fatiche di molti lunghi anni. E i Valar lo fecero indotti dal desiderio di riparare gli errori di un tempo, soprattutto il tentativo che avevano compiuto di salvaguardare e isolare gli Eldar [gli Elfi n.d.r.] rivelando pienamente tutta la loro potenza e gloria; laddove adesso ai loro emissari era fatto divieto di rivelarsi in forme di maestà o di cercare di governare la volontà di Uomini o Elfi facendo sfoggio di potere; presentandosi invece in aspetto debole e dimesso, dovevano consigliare e persuadere Uomini e Elfi al bene e provarsi a unire nell’amore e nella comprensione tutti coloro che Sauron, se fosse tornato, avrebbe cercato di dominare e di corrompere29. Non è forse una densa riproposizione letteraria della kenosi cristica dell’incarnazione? L’evitare il potere e lavorare per l’unità che allontana il male, pur nella debolezza e nell’essere esposto alla sofferenza è un richiamo potente all’opera di Cristo, trasfusa e trasfigurata nel lavoro di immaginazione dell’autore della Terra di Mezzo. Tolkien stesso si riferisce alla favola (o fantasy) come a ciò che possiede tre facce: «la Mistica, rivolta al soprannaturale; La Magica, rivolta alla Natura; e lo Specchio del disprezzo e della pietà, verso l’Uomo. La faccia essenziale per la storia fantastica è la seconda, quella magica. Ma la misura in cui le altre facce appaiono (se appaiono) è variabile, e può essere deciso dal singolo autore». (Cf. Tolkien, On Fairy-Stories, p. 53.) Altra figura cristica, (ma sempre in senso parziale, cioè secondo alcune caratteristiche e tematiche che coinvolgono il personaggio, senza connotarlo allegoricamente): Aragorn, il Re nascosto che torna. 28 29 F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p.63-64. Cit. in F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 36. 27 Frodo, l’Anello e la dinamica del Potere La storia narrata da Tolkien riguarda il potere, un potere intrinsecamente malvagio, perché è il potere sopra le volontà e la libertà altrui30. Cercare questo potere, simboleggiato dall’anello, anche a fin di bene, in realtà fa diventare da possessori, posseduti dall’anello stesso e da colui che l’ha forgiato. Non rimane che un’unica scelta: ripudiare totalmente quel potere che irretisce chi prova a dominarlo e distruggere il veicolo stesso di quel potere, l’Unico anello, nel fuoco dove è stato creato. Non c’è dubbio che nel forgiare l’anello del potere nella sua immaginazione Tolkien sia stato influenzato – anche inconsapevolmente – dal mito platonico dell’anello di Gige (narrato nel II libro della Repubblica). L’anello che ritrovato per caso nella caverna, dona al suo padrone l’invisibilità. Godendo di questo potere Gige entra a servizio del Re, ne seduce la moglie, lo tradisce e ne prende il posto. La tentazione del potere avvince il pastore Gige: qualunque potere possa essere esercitato impunemente, commenta Glaucone, dato all’ingiusto o al giusto, li farà agire allo stesso modo, per i propri interessi. Servirà sempre una forza esterna per imporre una legge nella sfera pubblica. Una visione pessimistica dell’essere umano, già rifiutata da Platone, ma comunque sempre in agguato, e con la quale anche Tolkien mette alla prova i suoi personaggi, vedendo come alcuni (molti) soccombano, altri, pochi, resistano. Non si può usare l’anello a fin di bene, non si può costringere la libertà altrui. Se si elimina il tiranno, si prenderà il suo posto. È l’insegnamento che viene dalle tentazioni di Cristo in San Matteo (4,9-11): Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». La tentazione del potere per perseguire i propri scopi, sostituendo la propria volontà a quella divina. È il peccato originale: essere come Dio. Gesù pur essendo Dio, rinuncia alla sua uguaglianza, al suo potere, spezzando, come uomo, la catena dell’idolatria di se stesso. In The History of Middle Earth, il nono volume è Sauron Defeat. In esso troviamo le varianti relative all’ultima parte del Signore degli Anelli. Nella voragine del monte Fato Frodo non vuole gettare l’anello perché sente una voce, profonda, lenta ma urgentemente persuasiva, che gli parla e gli offre vita, pace, onore, una ricca ricompensa, una signoria, e infine la condivisione del Grande Potere – se egli aspetterà e tornerà a Baradur con uno Schiavo dell’Anello. Ciò terrorizza Frodo. Egli rimane immobilizzato nella scelta tra la resistenza e il cedimento, tormentato, gli sembra un periodo lunghissimo e senza tempo. Poi a un tratto gli venne un pensiero nuovo – non dal di fuori – un pensiero nato dentro se stesso: egli avrebbe tenuto l’Anello per sé, e sarebbe diventato padrone di tutto. Frodo Re dei Re. Gli Hobbit avrebbero dominato (naturalmente egli non si sarebbe dimenticato dei suoi amici) ed egli avrebbe dominato gli Hobbit. Egli avrebbe composto grandi poemi e modulato grandi canzoni e tutta la terra avrebbe dovuto fiorire, e tutti avrebbero dovuto essere invitati alle sue feste. E così Frodo si arroga l’Anello!31 30 Tolkien comunque afferma che questa tematica così evidente è in realtà la cornice, il pretesto, non il vero nocciolo tematico del Signore degli Anelli: «Il tema centrale per me riguarda qualcosa di molto più eterno e difficile: morte e immortalità: il mistero dell’amore per il mondo in una razza destinata a lasciarlo e apparentemente a perderlo (uomini); l’angoscia nei cuori di una razza destinata a non lasciarlo, finchè il suo intero ciclo nato dal male sia completo (elfi)» J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 186 (p.278-279). Vedi anche il finale della lettera 211, (p. 320). 31 Cf. F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 37. 28 «Il diavolo condusse Gesù in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: “Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo» (Luca 4,5-7) L’analogia tra questa citazione e la tentazione dell’anello è notevole. Il vero messaggio che manda l’anello, però, è più complesso. Il fatto che l’anello non possa essere utilizzato contro il Nemico è un chiaro rimando all’impossibilità di subordinare i mezzi ai fini: mezzi malvagi non potranno portare ad altro che a fini malvagi, indipendentemente dalle intenzioni iniziali. Scrive Tolkien nel suo epistolario «Nella mia storia Sauron rappresenta quanto di più vicino esista alla totale malvagità. Ha percorso la stessa strada di tutti i tiranni, cominciando bene, in quanto pur desiderano un ordine che rispondesse alla sua conoscenza, dapprima considerava anche il benessere (economico) degli altri abitanti della Terra. Ma andò più lontano dei tiranni umani per quanto riguarda l’orgoglio e la brama di dominio». Inoltre, «Si può fare dell’Anello un’allegoria della nostra epoca, volendo: un’allegoria dell’inevitabile fine cui vanno incontro tutti i tentativi di sconfiggere il potere del male con un potere analogo»32. Gandalf aveva reagito all’offerta di Frodo di cedergli l’anello e aveva rifiutato così: «No! Con quel potere, il mio diverrebbe troppo grande e terribile. E su di me l’Anello acquisterebbe un potere ancora più spaventoso e diabolico. Non mi tentare! Non desidero eguagliare l’Oscuro Signore. Se il mio cuore lo desidera, è solo per pietà, pietà per i deboli, e bisogno di forza per compiere il bene. Ma non mi tentare! Non oso prenderlo, nemmeno per custodirlo senza adoperarlo. Ne avrei tanto bisogno: grandi pericoli mi attendono»33. La saggezza dei “saggi” di Tolkien è dunque astenersi dal dare sfogo a certi istinti, rifiutare la seduzione del potere34. L’unica cosa che Satana/Sauron non contempla, né lo potrebbe fare, è il sacrificio volontario e la rinuncia all’uso del potere per trionfare. Come dice Gandalf mandando Frodo alla pazza avventura di portare l’Anello verso il monte Fato: «Che la follia sia il nostro manto, un velo di fronte agli occhi del Nemico! Egli è molto saggio, e soppesa ogni cosa con estrema accuratezza sulla bilancia della sua malvagità». Ma il nemico non sospetta che coloro che custodiscono l’Anello si rifiutino di utilizzarlo o addirittura vogliano distruggerlo35. Sentiamo nella scelta narrativa tutta la potenza dell’eco delle parole della Prima lettera di Paolo ai Corinti: «Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. […] Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono» (1Cor 1,25.27-29). Il fallimento di Frodo. 32 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, p. 275; p. 140. Cit. in P. GIULISANO, Tolkien il mito e la grazia, Milano, Àncora, 2001, p. 96-97. 34 F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 87-88. 35 Cf. S. CALDECOTT, Il fuoco segreto. La ricerca spirituale di J.R.R. Tolkien, Lindau, Torino 2009, p. 52. 33 29 Il fallimento di Frodo appare un fatto incontestabile, riconosciuto dallo stesso Tolkien. Frodo fallisce allorchè, giunto sul Monte Fato, nell’attimo supremo in cui solo poteva decidere le sorti dell’intera Terra di Mezzo, rifiuta quell’azione che sembrava scontata, obbligata, l’unica apparentemente possibile e per compiere la quale tanto aveva patito sino a quel momento. Eccolo esclamare: «Ma ora non scelgo di fare ciò per cui sono venuto. Non compirò quest’atto, l’Anello è mio!»36, e infilarsi l’Anello al dito, così scomparendo alla vista del compagno Samvise. L’esito finale è ugualmente felice, per l’intervento inconsapevole di Gollum, il quale, strappando letteralmente l’Anello a Frodo, dopo una violenta lotta, finisce però col mettere un piede in fallo, precipitando nei fuochi degli abissi, con la conseguente distruzione dell’Anello. Ciò che è importante, però, nella lettura del significato del passo, è il valore simbolico che la ribellione finale di Frodo assume, in riferimento all’intera opera. È da dire innanzitutto che quanto accaduto sul Monte Fato deriva, come commentò lo stesso Tolkien, dalla logica del racconto fino a quel punto. Frodo, accettando di divenire Portatore dell’Anello, si era esposto ad un potere tremendo, al di sopra delle sue possibilità di resistenza; un potere che già si era manifestato e che aumentava man mano che l’Unico si avvicinava al Monte Fato. Del resto, ad illustrare l’enorme potere dell’Anello, basti pensare alla sua nefasta influenza sullo sciagurato Gollum, letteralmente consumato, fino all’autodistruzione, dalla brama del suo possesso e disposto a tutto pur di conseguirlo, o alla sventura di Boromir, il quale, anch’egli accecato dal desiderio dell’Unico, non esitò ad aggredire Frodo pur di impadronirsene Tolkien afferma conseguentemente l’impossibilità per Frodo, per di più indebolito e sofferente, di distruggere volontariamente l’Anello, una volta giunto sul Monte Fato, ma nel contempo si preoccupa di sottolineare la centralità che la soluzione narrativa data all’episodio riveste nello spiegare la sua concezione della vera nobiltà e dell’eroismo (Cf. lettera37 a Mrs. Eileen Elgar – abbozzi- settembre ‘63). Pertanto, con simili premesse, Frodo non poteva, in un modo o nell’altro, non fallire, a meno che Tolkien non avesse voluto trasformarlo in qualcosa di diverso, in un eroe “popolare”, senza incertezze e debolezze, di “sword and sorcery”, per così dire, la cui azione fosse proceduta per tutta la storia in un crescendo continuo fino alla catastrofe finale; ma questo, come visto, non era di certo il suo intendimento, come si evince anche da altre lettere alle quali è opportuno rifarsi. Tolkien precisa, (lettera ad Amy Ronald del luglio ‘56), che il fallimento di Frodo «seguendo la logica della trama, era un avvenimento chiaramente inevitabile. E di sicuro è un episodio molto più significativo e reale del finale di una fiaba in cui l’eroe vince sempre»38. In un’altra lettera del ‘56 Tolkien afferma l’impossibilità per Frodo di cedere l’Anello, specialmente nel momento in cui, per essere sul Monte Fato, esso aveva il massimo potere. Tolkien offre poi una spiegazione in chiave religiosa, citando, sono parole sue: «l’ultima misteriosa richiesta del Padre Nostro: “non indurci in tentazione, ma liberaci dal male”. Una richiesta di qualcosa che non può succedere è senza significato. Esiste la possibilità che la tentazione vada al di là del potere del singolo». Se l’adesione al progetto salvifico è infatti libera e affidata alla personale responsabilità di ciascuno, esistono tuttavia situazioni che superano le forze e le possibilità di un individuo; esistono cioè persone che cedono alla tentazione, respingendo la possibilità di salvezza e redenzione. Ecco allora la ragione dell’invocazione contenuta nel Padre Nostro, ad un Dio che è infinita ed imperscrutabile misericordia: così, se una vita di scelleratezze può essere riscattata da un’unica azione, o da una conversione in extremis, a Lui solamente nota, pure un’azione scellerata può essere perdonata, in grazia di una generale santità e di virtù preziose agli occhi di Dio; da una parte troviamo il caso di Gollum (Giuda), che pur avendo avuto la 36 J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, Rusconi, Milano 1977, parte III, p. 1129. J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 246 (pp. 366-369). 38 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 192 (p 286). 37 30 possibilità di pentirsi e redimersi, aveva fallito, dall’altra Frodo (più simile a Pietro che a Giuda, nell’ultimo frangente). Dunque Frodo cede alla tentazione, ma era inevitabile, ed in ciò fallisce, non è perciò eroico secondo i canoni più superficiali; ma se egli fallisce personalmente, come creatura dotata di libero arbitrio, ugualmente l’Anello viene distrutto. Vince dunque la causa, non già l’eroe; l’eroe ha solo “mediato”, facendosi veicolo di poteri più grandi ed in certo modo misteriosi, praticando – ecco il mezzo – pietà, compassione e perdono delle offese. Prosegue Tolkien nella lettera sopra citata: «Abbiamo la certezza che bisogna essere straordinariamente generosi, se si vuole sperare in una straordinaria generosità che ci permetta di sfuggire alle conseguenze dei nostri errori e delle nostre follie». Frodo era stato eroico fino a quel punto, ma eroico in senso cristiano, in quanto eminentemente cristiane sono le virtù da lui dispiegate nel corso della vicenda39. Ed ecco le virtù di Frodo: la principale è sicuramente la sua misericordia verso il traditore Gollum. Solo questa misericordia, che era stata prima ancora anche di Bilbo, assicurerà alla fine l’esito positivo della vicenda e la distruzione dell’Anello ad opera del suo servo più fedele. «Frodo (e la Causa) vennero salvati dalla pietà: grazie al valore supremo e all’efficacia della compassione e della capacità di perdonare le offese»40. La Pietà o meglio la Misericordia di Frodo: Frodo ebbe profonda compassione per Gollum, nonostante i fastidi e i guai da questi provocati, non prestando ascolto allo stesso Sam, suo compagno e amico, che insisteva nel volersene liberare. Il senso di pietà fa di Frodo un “giusto”, cristianamente (o meglio: evangelicamente) inteso. Frodo avverte inoltre che anche Gollum, alla luce di un disegno superiore, riveste un ruolo ben preciso nella storia; Frodo considera quindi Gollum una creatura da compatire e in ogni caso meritevole di rispetto, alla luce di un fine sovrapersonale, trascendente la sua capacità di comprensione41 La pietà e la misericordia usata in anticipo a Gollum anche da Bilbo42 (e poi da Gandalf, dagli elfi, da Frodo, persino da Sam!) equivale a un giudizio di perdono possibile per Frodo nel momento in cui lui divenga come Gollum – anzi, peggio – arrogandosi l’Anello! Qui si verifica quello che è espresso nella frase della preghiera del Padre Nostro: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Frodo aveva perdonato a Gollum, anche a lui viene perdonato lo stesso male, come anche – all’inverso – nella parabola evangelica del debitore e creditore (Mt 18,23-24): perdonato dal Padrone per un debito di 10 mila talenti non scusa il suo compagno che gli deve 100 denari e per questo viene gettato in mano agli aguzzini finché non avesse restituito il dovuto… perché non aveva a sua volta avuto pietà di chi lo pregava43. Obbedienza e fedeltà fino alla fine, ma niente pelagianesimo. A proposito del fallimento di Frodo, Tolkien aveva scritto (Lettera 191) che esso rifletteva il dato di fatto secondo cui la forza del male non può essere sconfitta dall’uomo da solo, per quanti sforzi di “bontà” cerchi di compiere. Tolkien è semplicemente realistico nel constatare l’insufficienza di ogni visione pelagiana di una salvezza ottenuta con le proprie forze44. Ciò non toglie, però, che obbedienza e fedeltà agli impegni assunti e alla parola data diventino atteggiamenti paradigmatici della missione di Frodo. Nonostante l’angoscia e la paura lo attanagliassero, Frodo affronta con il massimo senso del dovere e abnegazione estrema le prove e le 39 FRANCO MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 68-69. J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 191 (p. 285). 41 FRANCO MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 70. 42 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, Bompiani, Milano 2001, lett. 153 (p. 217 ): «E’ la pietà di Bilbo e in seguito di Frodo che alla fine permette alla ricerca di essere portata a compimento». 43 F.MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 95. 44 Cf. S. CALDECOTT, Il fuoco segreto. La ricerca spirituale di J.R.R. Tolkien, Lindau, Torino 2009, p. 56. 40 31 sofferenze che incontra lungo il cammino, senza mai per questo volerlo abbandonare, sottraendosi al compito assegnatogli. Frodo è un protagonista vibrante di umanità, che trema come il Cristo nell’Orto degli ulivi al pensiero della richiesta finale della sua via crucis. Frodo si dimostra un eroe della “rinuncia”, conferendo alla “quest”, ed alla realtà da essa simbolicamente sottesa, un sapore evangelico, anche se non esplicito. Significative sono finanche le parole dette a Sam, alla fine: «Ho tentato di salvare la Contea, ed è stata salvata, ma non per merito mio. Accade sovente così, Sam, quando le cose sono in pericolo: qualcuno deve rinunciare, perderle, affinché altri possano conservarle». E’ affermazione evangelicamente conforme al: «chi perderà la propria vita la salverà». Al termine della missione, cioè della prova, Frodo entra nella gloria, meritata, perché ha impiegato ogni sua risorsa fisica e mentale, arrivando con grande coraggio fino al punto stabilito e oltre. Tolkien precisa, non alludendo a se stesso, che «a quel punto prese il sopravvento l’altro potere: lo Scrittore della Storia; l’unica persona sempre presente che non è mai assente e mai viene nominata» nel Signore degli Anelli. Un esplicito riferimento alla Provvidenza di manzoniana memoria. Ora, lo Scrittore della Storia – è che sia Eru (il Dio del Silmarillion) non pare vi sia ombra di dubbio, anche al di là di esplicite dichiarazioni di principio di Tolkien, fra tutte quella contenuta in una lettera del 1953 indirizzata a Padre R. Murray, nella quale affermava che il Signore degli Anelli è fondamentalmente un’opera religiosa e cattolica – è presente ed opera nella Storia attraverso la Provvidenza, vale a dire secondo un disegno preordinato ad un certo fine, sovente imperscrutabile per gli uomini. Il Signore degli Anelli non è opera agnostica o indifferente sul piano religioso, per il solo fatto che in esso non si parla di religione o divinità; e se le creature (uomini o altro) si disinteressano di Dio e della religione, non vale sicuramente l’opposto, per il lettore che sia anche credente: Dio si preoccupa sempre delle proprie creature, pur rispettandone l’arbitrio45. Frodo inizialmente aveva pensato di poter distruggere lui l’Anello… ed esso fu distrutto, ma contro e al di là del suo volere; pensava di salvare la Contea… ed essa venne salvata, ma non da lui. Frodo voleva davvero distruggere l’Anello, ma non credeva che ci sarebbe riuscito davvero, non si immaginava neanche come avrebbe fatto! Di certo pensava di essere stato scelto, ma s’ingannava su quello che gli era chiesto: non un’azione eroica e impossibile, ma solo quello che era in suo potere fare, portare l’Anello più avanti di chiunque altro sarebbe riuscito a fare, e poi lasciar operare l’unico motore che avesse il potere di risolvere tutta la vicenda dell’Anello alla sua radice: la grazia, l’oppositrice per eccellenza del male, della tentazione, del peccato46. Gollum e Giuda Il “Giuda” del Signore degli Anelli è sicuramente Smeagol/Gollum, l’hobbit consumato da secoli di possesso dell’Anello, ottenuto fin dall’inizio uccidendo il suo migliore amico in una situazione alla Caino e Abele. Come Gesù aveva chiamato amico Giuda, proprio mentre egli metteva in atto il suo tradimento, allo stesso modo Frodo dice a Sam che si lamenta della ferita inferta da Gollum al suo padrone47: «Ma ricordi le parole di Gandalf: Persino Gollum potrebbe avere ancora qualcosa da fare? Se non fosse stato per lui, Sam, non avrei distrutto l’Anello. La Missione sarebbe stata vana, proprio alla fine. Quindi perdoniamolo! La Missione è compiuta, e tutto è passato. Sono felice che tu sia qui con me. Qui alla fine di ogni cosa, Sam»48 45 Cf. F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 71. Cf. F.MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 75. 47 F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 79. 48 J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, Rusconi, Milano 1997, p. 1131. 46 32 Alla fine della storia, dunque, Frodo riconosce la verità inscritta nelle parole di Gandalf tanto tempo prima pronunciate proprio al suo indirizzo: «Fu la Pietà a fermare la mano [di Bilbo]. Pietà e Misericordia: egli non volle colpire senza necessità. E fu ben ricompensato di questo suo gesto, Frodo. Stai pur certo che se è stato grandemente risparmiato dal male, riuscendo infine a scappare e a trarsi in salvo, è proprio perché all’inizio del suo possesso dell’Anello vi era stato un atto di Pietà». (E infatti l’unico che cede volontariamente l’Anello è e rimane solo Bilbo). Frodo, all’inizio, udendo quest’idea, aveva ribattuto che, in ogni caso, Gollum avrebbe meritato la morte. Al che lo stregone grigio, Gandlf, aveva replicato: «Se la merita! E come! Molti tra i vivi meritano la morte. E parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di dargliela? E allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi: sappi che nemmeno i più saggi possono vedere tutte le conseguenze. Ho poca speranza che Gollum riesca a essere curato e a guarire prima di morire. Ma c’è una possibilità. Egli è legato al destino dell’Anello. Il cuore mi dice che prima della fine di questa storia l’aspetta un’ultima parte da recitare, malvagia o benigna che sia; e quando l’ora giungerà, la pietà di Bilbo potrebbe cambiare il corso di molti destini, e soprattutto il tuo». E noi sappiamo che, in effetti, il gesto originario di Bilbo si tradurrà, in modo incredibile a dirsi, nella salvezza di Frodo: una salvezza magari non cercata consapevolmente e frutto di un’ultima lotta, eppure non meno vera e totale. Il dito mozzato rimane pero come “stimmata” della lotta finale con Gollum49. Il personaggio Saruman: l’attrazione del potere e il servire a due padroni: Saruman è il capo dell’Ordine degli stregoni, a cui appartiene anche Gandalf. Personalità sagge e studiose, ma tentate – a fin di bene – di usare mezzi che non sono congrui al fine buono: «Abbiamo bisogno di potere – dice Saruman a Gandalf – potere per ordinare tutte le cose secondo la nostra volontà, in funzione di quel bene che soltanto i saggi conoscono… Se potessimo comandare [l’Anello] la Potenza passerebbe nelle nostre mani… Si tratterebbe soltanto di aspettare, di custodire in cuore i nostri pensieri, deplorando forse il male commesso cammin facendo, ma plaudendo all’alta meta prefissa: Sapienza, Governo, Ordine». In sostanza, Sarumam propone a Gandalf di allearsi temporaneamente al Nemico, per poi rivolgere l’Anello contro di lui e dare inizio a una nuova epoca. Ma Gandalf gli risponde agitando la propria idea di libertà: «Ho udito prima d’oggi discorsi dello stesso genere, ma soltanto in bocca di emissari inviati da Mordor per ingannare gli ingenui… Una mano sola alla volta può adoperare l’Unico, e lo sai bene; non darti dunque pena di dire noi!… Ebbene, la scelta era di sottomettersi a Sauron, o a te. Non accetto né l’una né l’altra»50. È ben difficile non vedere, dietro queste parole, l’eco della convinzione di Tolkien, secondo cui “l’occupazione più inadatta a qualsiasi uomo… è governare altri uomini”. Parimenti, la replica di Gandalf riecheggia molto da vicino le parole evangeliche: “Nessuno può servire a due padroni: o 49 50 Cf. F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 82. J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, Rusconi, Milano 1997, p. 327-328. 33 odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire Dio e a mammona” (Mt 6,24). Nel momento in cui Saruman accetta di subordinare i mezzi ai fini, egli diventa – consapevolmente o no – un altro Oscuro Signore o, meglio, un giocattolo nelle mani di Sauron. Accecato dalla propria brama, egli non si rende conto che il Nemico lo muove come una pedina, concedendogli l’illusione di essere potente e forte ma pronto a schiacciarlo senza pietà e senza fatica alla bisogna. Scive Tolkien nel suo epistolario (lett. 81 al figlio Christopher): «Non puoi combattere il Nemico con il suo Anello senza trasformarti anche tu in un Nemico; ma sfortunatamente la saggezza di Gandalf sembra sia sparita insieme a lui nel lontano e genuino Occidente.» Anche dopo la propria caduta miseranda per mano di Gandalf, Saruman riesce ancora a fare del male: prendendo il potere nella Contea, per vendicarsi di coloro che ritiene la causa del proprio disastro51. E’ il colpo di coda del nemico sconfitto, una citazione implicita degli avvenimenti descritti dal libro dell’Apocalisse dopo la sconfitta del Drago che non si dà per vinto: «Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli…. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù». (Ap 12,7-9.17) b) L’erede attuale della letteratura fantastica di Tolkien e Lewis: J. K. Rowling La saga del giovane mago Harry Potter si sviluppa in 7 volumi (1997-2007) che ripercorrono gli anni della formazione presso la scuola di Magia di Hogwarts dell’unico sopravvissuto alla potenza distruttrice del nefando e oscuro Voldemort. La parabola di Harry parte dal ragazzino orfano undicenne, sopportato dai suoi zii, e arriva al maturo diciottenne che salva il mondo dei maghi con il suo coraggio e la sua dedizione agli amici e alle responsabilità. Il professore americano di Letteratura classica John Granger, autore di Looking for God in Harry Potter, iniziando con molti pregiudizi una lettura preventiva dei libri della Rowling per poter spiegare ai suoi bambini perché non dovevano leggerli è giunto, alla fine, a ben diverse conclusioni rispetto alle sue premesse: a) I romanzi di Harry Potter sono da prendere in seria considerazione come letteratura. b) La “magia” di cui si parla nei romanzi non ha niente a che vedere con la stregoneria condannata dalla Bibbia perché allontana dall’unico Dio, è invece un elemento del mondo fantastico. c) La trama, i temi e i simboli presentati dai libri di Harry Potter sono in consonanza con la visione del mondo cristiana, e sicuramente in opposizione alle posizioni materialistiche e naturalistiche oggi prevalenti. d) Gli scritti della Rowling sono diventati così popolari proprio perché toccano, come i lavori di Tolkien e Lewis, il nostro desiderio interiore per un particolare genere di storie, che richiamano la grande storia raccontata dalla Bibbia e ne riflettono le risposte alle grandi domande della vita. 51 F. MANNI, Introduzione a Tolkien, p. 89. 34 Granger è convinto che i libri di Harry Potter parlino a ciò che è profondamente insito nel cuore umano: “Tutti gli esseri umani vibrano in risonanza con le storie che riflettono la più grande storia mai raccontata, la storia di Dio che diventa uomo”. Secondo Granger questi romanzi toccano il nostro cuore perché contengono temi, immagini e storie coinvolgenti che riflettono quella grande storia a cui siamo predisposti a rispondere. In tal senso la Rowling è sulle orme di un C. S. Lewis, anche nell’uso del tema della magia, per mettere in evidenza esperienze umane archetipe che sono in stretta relazione con la storia salvifica come è compresa dai cristiani. L’autrice di Harry Potter si descrive, in verità, come cristiana credente, e in più occasioni ha ribadito è stata profondamente influenzata dalle storie fantasy di Lewis. Anche i suoi libri perciò possono essere visti come tentativi di far passare idee religiose, e specificamente cristiane, transitando sotto lo “sguardo attento dei draghi” di cui parla lo stesso Lewis nella sua riflessione sul ruolo della magia nelle favole. Perciò si possono interpretare i romanzi di Harry Potter come prove post-moderne di articolare i temi base del mistero cristiano in modi freschi e originali, benché fedeli alla verità evangelica. A partire dalla pubblicazione dell’ultimo volume della serie, la Rowling ha parlato apertamente della tematica cristiana dei suoi libri, affermando che a lei i paralleli religiosi erano sempre: “apparsi ovvi. Ma non ne avevo voluto parlare troppo esplicitamente perché pensavo che ciò avrebbe potuto rivelare ai lettori, che volevano solo seguire la storia, dove in realtà si stava andando a finire”52. Il tema della morte53 Il mondo fantastico della Rowling è significativo quanto quello delle altre favole che si sono fatte strada nella nostra memoria culturale. E come le favole, non è solo qualcosa di adatto ai bambini. La saga di Harry Potter è prima di tutto una storia esistenziale, sia in senso letterario che filosofico. La serie porta a riflettere sulla vita e sulla morte, pur rimanendo ben ancorata al mondo naturale con le regole che lo caratterizzano. Nel personaggio Harry vengono personificate le tappe verso la maturità che ogni persona deve raggiungere nel suo inevitabile cammino verso la morte. L’ultimo libro della serie: Harry Potter e i doni della morte, esplora in modo profondo questa preoccupazione. In modo interessante, la maturità e la saggezza che Harry raggiunge nella sua avventura sono connesse e utili per la sua esistenza terrena, non in vista di una vita al di là del mondo naturale. Il tema della morte è certamente il tema più esistenziale di tutti. C’è un evidente contrasto fra la raggiunta consapevolezza di Harry di poter affrontare la morte per amore dei suoi amici e la ricerca spasmodica del suo avversario riguardo l’immortalità, che lo porta a compiere ogni nefandezza e ogni violazione delle stesse leggi della natura (pur del mondo magico): il mago nemico farà a pezzi la propria anima per nasconderla in vari oggetti e assicurandosi così una sopravvivenza indefinita. L’anima di Harry è unificata, intera, basata sull’amore degli altri che la preserva come tale. Voldemort, (= will of death, desiderio di morte), il nemico, non può capire l’amore che arriva al sacrificio di sé. Egli, atterrito dalla morte, ha cercato l’immortalità a costo di sacrificare se stesso per sé: la divisione della sua anima in 7 oggetti per assicurarsi un’immortalità a prezzo della distruzione della sua umanità e del prossimo ne è il simbolo. Harry non cede all’uso del potere (ecco la magia nera) in modo corrotto, come fa il suo oppositore, pur di giungere ai suoi scopi. Non è divorato dal desiderio e dalla volontà di potere (invece da giovane, anche il suo idolo, il prof. Silente era caduto in questa tentazione, benché poi si redima: 52 Cf. LEONIE CALDECOTT, A Wizard’s Mission: Christian Themes in Harry Potter, in «The Christian Century» vol. 125/ 1, January 15, 2008, 24ss. 53 Cf. FRASER LOS, Harry Potter and the Nature of Death: Maturity, Mystique and Most of All Mortality Dominate This Wildly Popular Septet. in «Alternatives Journal» 34/1. January-February 2008, 32ss. 35 sulla sua tomba troveremo il passo evangelico di Mt: “Dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore”.). Harry preferisce la morte (che comporterà la distruzione della parte di anima del malvagio che è entrata involontariamente in lui da bambino), piuttosto che la distruzione dei suoi cari o il passaggio al campo avverso dove potrebbe diventare potente e invincibile. Nel confronto finale Harry marcerà verso il suo avversario, accompagnato da una schiera di amici defunti: accetta la propria morte come inevitabile nello scontro che avverrà. Questa è la sua maturità, il superamento della paura con l’amore, secondo le parole del suo mentore, Albus Silente: «È l’ignoto che noi temiamo quanto temiamo la morte, nulla più». A quanti accusano ancora la Rowling di aver giocato troppo con magia e stregoneria, costruendo una storia diseducativa e addirittura un inno alle facili soluzioni stregonesche, bisognerebbe ricordare, alla luce dell’ultimo volume della saga, che una storia che gira attorno alle scelte che ogni individuo deve fare per schierarsi dalla parte della vita piuttosto che con la morte , e che fa comprendere come l’apparente trionfo del maligno dev’essere sopportato nell’amore e nell’obbedienza, non può certo essere ridotta a una festicciola neopagana. Propugnatori New Age della cultura della morte e della gratificazione istantanea non rischierebbero mai con un posscriptum, potenzialmente meschino, in cui l’ideale di felicità non è la celebrazione di poteri occulti o l’ego umano, ma l’ordinaria vita familiare. - Harry Potter e i “bagliori di Vangelo” in alcune tematiche ed episodi della storia. (Cf. CONNIE NEAL, Il Vangelo secondo Harry Potter, Gribaudi, Milano 2003) Il sacrificio di sé per amore: è l’unica magia che fa superare la morte (la mamma di Harry aveva fin dall’inizio della storia affrontato il suo sacrificio per amore del figlio e ciò ha spezzato la magia mortale del più grande e perfido stregone, che non sa spiegarsi questo mistero) Anche in Harry Potter, la pietà o meglio la misericordia ha un ruolo importante, eco biblico e insieme letterario dei modelli più cari all’autrice, tra cui – per sua stessa ammissione – C.S. Lewis. Harry non vuole sia ucciso il traditore dei suoi genitori, un Giuda che ha consegnato il segreto del loro rifugio nelle mani del Nemico. A distanza di anni Peter, il nome del traditore, è finalmente nelle mani dei suoi alleati di un tempo, coloro che conoscono tutta la storia, è vogliono eliminarlo. Harry lo risparmia, perché questo – egli sente – avrebbero fatto i suoi cari. Il tema della cicatrice di Harry Potter, quella cicatrice a forma di lampo che gli percorre la fronte ed è l’unico segno che gli rimane della potente maledizione scagliata su di lui e poi rimbalzata su chi lo voleva uccidere. La cicatrice fa male ad Harry quando si avvicina il malvagio, brucia. Nel primo capitolo del primo libro di Harry Potter (la pietra filosofale), la professoressa McGrannit chiede al preside della scuola magica Silente se non potesse fare qualcosa per quella cicatrice…sottointendendo farla sparire. Silente risponde: “Non lo farei anche se potessi, le cicatrici a volte possono essere utili”. La cicatrice ricorda l’identità, il passato. È una testimonianza, come le piaghe sul corpo di Gesù risorto che non scompaiono, ma sono anzi il modo per far riconoscere il Risorto a Tommaso e agli altri apostoli: “Guarda le mie mani e i miei piedi…” (Gv. La parabola della fede del Binario 9 e ¾ “Vedere per credere” o “credere per vedere” Nel primo libro c’è un simbolo davvero potente e immaginativamente accattivante: il treno magico per raggiungere la scuola di stregoneria parte dalla stazione “umana” di King’s Cross a Londra, ma dall’improbabile “binario 9 e ¾”. Un binario nascosto, che solo chi “vede” con gli occhi della magia sa trovare, lanciandosi di corsa contro il pilastro che divide il binario 9 dal 10. E’ un simbolo delle cose che stanno sotto gli occhi di chi vi crede e si possono vedere solo con gli occhi della fede. 36 Per entrare nel mondo magico, della realtà più reale (o soprannaturale), c’è bisogno di esercitare l’occhio della fede, che biblicamente è «fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono» (Eb 11,1). c) E in Italia? Il caso Pinocchio. Il grande esempio italiano di letteratura popolare per l’infanzia dal chiaro riferimento biblico è sent’altro Pinocchio di Collodi. Uno dei best seller di tutti i tempi, amato da generazioni di bambini. Non c’è dubbio che risenta della sua “nascita” ottocentesca, trasuda di morale e di “buoni insegnamenti”, oltre che di mirabolanti e surreali avventure, così accattivanti per l’immaginazione infantile e non. Ma quello che ci interessa è la sua sapiente struttura, potremmo dire: il successo di una metanarrazione nascosta. Il Card. Giacomo Biffi, autore di vari studi sulla teologia del testo delle Avventure di Pinocchio così si esprime: «Quella di Pinocchio è la sintesi dell’avventura umana. Comincia con un artigiano che costruisce un burattino di legno chiamandolo subito, sorprendentemente, figlio. E finisce con il burattino che figlio lo diventa per davvero. Tra i due estremi c’è la storia del libro. Che è identica, nella struttura, alla storia sacra: c’è una fuga dal padre, c’è un tormentato e accidentato ritorno al padre, c’è un destino ultimo che è partecipazione alla vita del padre. Il tutto grazie a una salvezza data per superare la distanza incolmabile, con le sole forze del burattino, tra il punto di partenza e l’arrivo. Pinocchio è una fiaba. Ma racconta la vera storia dell’uomo, che è la storia cristiana della salvezza». Alle critiche letterarie che invece propongono visioni ben diverse della struttura del libro, rifacendosi ad ogni sorta di ideologia e a letture perfino marxiste e psicanalitiche, Biffi rispondeva: «La struttura oggettiva del racconto è sotto gli occhi di tutti ed è perfettamente conforme alla vicenda salvifica proposta dal cristianesimo. Giudicare di questa conformità spetta ai maestri di fede (ed è l’arte mia); certo non ai critici letterari, o agli storici sociali e politici, o agli storici delle idee». Sempre Biffi scriveva, ancora nel 1977: «Il Collodi aveva un cuore più grande delle sue persuasioni, una carisma profetico più alto della sua militanza politica. Così poté porsi in comunione forse ignara con la fede dei suoi padri e con la vera filosofia del suo popolo. L’ortodossia, che non avrebbe potuto superare con le proprie vesti gli sbarramenti censori della dittatura culturale dell’epoca e della stessa coscienza esplicita dello scrittore, travestita da fiaba eruppe dal profondo dello spirito e risonò apertamente. In quella fiaba gli italiani di istinto riconobbero la loro canzone di sempre e gli uomini di tutti i paesi avvertirono inconsciamente la presenza cifrata di un messaggio universale»54 . Pinocchio sarebbe insomma la verità biblica che erompe travestita da fiaba. E in questo modo riesce a superare le censure della dittatura culturale dell’epoca. Pinocchio, non dimentichiamolo, esce nel 1881, in pieno regime culturale dichiaratamente anticlericale e massonico. Collodi, Carlo Lorenzini, aveva studiato in seminario, poi dai padri scolopi. Visse sempre con la madre, religiosissima. Fu attratto dalle idee mazziniane e combatté nel 1848 come volontario a Curtatone e Montanara e poi nel 1859 con i Savoia. Ma ne uscì deluso. “In questo mondo tutto è bugia: dall’Ippogrifo a Mazzini”, scrisse già nel 1860 sulla “Nazione”. Gli studiosi sono oggi sempre più concordi nell’avvalorare la svolta nella vita di Collodi, la sua perdita di fiducia in 54 G. BIFFI, Contro Maestro Ciliegia, Mondadori, Milano 1997 (ed. or. 1977), pp. 16-17. 37 Mazzini e nelle ideologie risorgimentali. Fu dopo questa crisi che egli si dedicò a scrivere per i ragazzi. E fu così che riscoprì l’anima profonda dell’Italia. Il nocciolo del problema, per il Biffi, si riduce ad accertare se ci sia o non ci sia una correlazione tra il racconto collodiano, come è in se stesso a prescindere dagli intenti dell’estensore, e la storia della salvezza, come è contenuta e proclamata nell’annuncio evangelico. Le analogie metanarrative proposte da Biffi, sono: 1. La prima corrispondenza che si impone riguarda la concezione della storia del mondo e dell’uomo. C’è un avvio (creazione e fuga dal creatore) che è la premessa indispensabile e il senso di tutto ciò che poi avviene: c’è lo sviluppo di un dramma in cui si determina la scelta tra due opposti destini (quello di Pinocchio e quello di Lucignolo); c’è una “escatologia” conclusiva (ritorno al Padre e trasnaturazione). Vale a dire, qui c’è esattamente la prospettiva cristiana espressa dal racconto biblico di creazione, caduta, ritorni e conversioni parziali, redenzione, e apocalittica salvezza oltre la morte. 2. Pinocchio all’origine è “costruito”: c’è dunque una eterogeneità di natura col “costruttore”. Ma il “costruttore” lo chiama subito “figlio”. Il Creatore misteriosamente vuol essere anche “padre”, in questo modo viene immessa nella creatura l’aspirazione a oltrepassare l’alterità e a elevarsi ontologicamente. È un modo letterario di esprimere la verità della “vocazione soprannaturale”: colui che è stato fatto dal niente è destinato a partecipare nella vita di grazia alla natura divina. 3. La nostra libertà è una libertà ferita. Pinocchio in tutte le occasioni capisce sempre qual è la cosa giusta da fare e la vorrebbe, ma sceglie infallibilmente la cosa sbagliata. È l’incapacità dell’uomo a operare secondo giustizia in virtù del solo libero arbitrio, come è denunciata da san Paolo: «Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 7,29). 4. La drammaticità della nostra condizione è accresciuta per la presenza attiva di forze estranee che spingono al male. Esse sono raffigurate primariamente dal Gatto e la Volpe, ma raggiungono la migliore e più efficace rappresentazione nell’Omino, corruttore mellifluo che conduce i ragazzi al Paese dei Balocchi. Non c’è in tutta la letteratura della cristianità immagine del demonio più intelligentemente effigiata. Tenero in apparenza, perfido nella realtà, è il nostro insonne nemico: “Tutti la notte dormono, e io non dormo mai” (Pinocchio cap. 31). 5. L’ideologia illuminista aveva diffuso l’orgogliosa affermazione di una possibile “autoredenzione” dell’uomo. Ebbene, tutta la seconda parte del libro (dal capitolo 16 alla fine) parrebbe costruita proprio per smentire questa che è l’illusione dominante della cultura della modernità occidentale. Pinocchio, interiormente svigorito, esteriormente insidiato da esseri maligni più astuti di lui, non può assolutamente raggiungere la salvezza nonostante la sincerità dei suoi sforzi, se non interviene un aiuto superiore, che alla fine riesce a compiere il prodigio di riconciliarlo al padre, di riportarlo a casa, di dargli una nuova natura. Lo straordinario personaggio della Fata dai capelli turchini manifesta appunto questa necessaria mediazione salvifica, che secondo la fede cristiana narrata dal vangelo è svolta dal Figlio di Dio fatto uomo, il quale prolunga la sua azione nella storia per mezzo della Chiesa (cf. il libro degli Atti degli Apostoli). Il seguente ultimo contributo è ripreso dall’Introduzione (curata dal Card. Biffi) all’edizione artistica delle Avventure di Pinocchio, illustrata Mario Ceroli (Art’è, Bologna), questo testo è ripubblicato come: Il mistero di Pinocchio, LDC, Leumann (TO) 2002. 38 “Laicità” di Pinocchio Si può allora parlare di una “laicità” di Pinocchio? Si può e si deve, se con ciò si intende sottolineare l’assenza nel libro di ogni elemento ecclesiastico e cultuale nonché di ogni esplicito riferimento alle tematiche religiose. E non è certo una latitanza casuale: descrivere nell’Italia dell’Ottocento le borgate, il paesaggio, la vita associata, senza che nel racconto compaia mai nemmeno incidentalmente un campanile, un parroco, un rito, non poteva che essere il risultato di una intenzionalità. L’unico cenno di religiosità si trova - ripetuto alla lettera due volte - nel comportamento dei pescatori che assistono alla scomparsa in mare prima di Geppetto e poi del burattino: “Brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornare alle loro case” (cap. XXIII). Ma il particolare ha motivazioni puramente artistiche, per la concretezza della scena rappresentata. A parte ciò, non c’è traccia di qualche estrinseca utilizzazione del “divino” o del “religioso”: del “surnaturel plaqué”, come dicevano un tempo i teologi francesi. In questo senso la “laicità” di Pinocchio è incontestabile. Ma è una “laicità” analoga, per intenderci, a quella del racconto evangelico del “figlio prodigo”, dove (a differenza di quel che avviene in altre parabole di Gesù) non si ricordano né Abramo né Mosé né i profeti né i sacerdoti né il tempio. O alla “laicità” del Cantico dei Cantici, che pure ha nutrito la letteratura mistica di ogni tempo. “Cattolicità” di Pinocchio Pinocchio è un libro “cattolico”? Se con questo termine si intende alludere alla letteratura edificante o apologetica o catechetica che così viene talvolta denominata, bisogna rispondere senza esitazione di no. Per altri due aspetti si può dare invece un giudizio positivo. In primo luogo, se ci si rifa all’origine del nome: “cattolico” significa etimologicamente “secondo il tutto” (kath’olon). Si può quindi intendere con questo aggettivo una visione delle cose, una mentalità, una proposta di comportamento e di vita che rifugga per quanto è possibile da ogni parzialità e da ogni selezione arbitraria tra le “verità sostanziali”. Pinocchio è “cattolico” perché in esso coesistono e reciprocamente si integrano e si equilibrano il realismo disincantato nel valutare le tristi situazioni di fatto che inevitabilmente si incontrano e la fiducia nella possibilità di raggiungere un destino di gioia; la consapevolezza della debolezza umana e la speranza di un aiuto decisivo dall’alto; il senso della giustizia e il primato della misericordia; il coraggio tanto di guardare in faccia al male quanto di credere nella vittoria finale del bene. E così via. Ma in un senso ancora più rigoroso questo libro può essere considerato “cattolico”, ed è per la perfetta corrispondenza tra il racconto collodiano e la storia della salvezza come è proclamata nell’annuncio evangelico, tra la struttura della sua vicenda e la struttura intrinseca all’ortodossia, tra le “verità sostanziali” che esso propone e i caposaldi dell’insegnamento della Chiesa. Conclusione Gesù ha detto: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). Queste cose: cioè i misteri del Regno di Dio, dell’uomo e del suo destino. Proprio nel decennio in cui nascevano Le avventure di Pinocchio uomini straordinariamente dotti e perspicaci elaboravano e facevano conoscere le loro dottrine: Friedrich Nietzsche pubblicava le sue opere più importanti ed enunciava l’ideologia del “superuomo” e della “volontà di potenza”; uscivano i volumi di “Das Kapital” di Karl Marx; Sigmund Freud portava a termine il suo percorso accademico. In quegli anni venivano così poste dai “sapienti” e dagli “intelligenti” le premesse del mare di lacrime che nel secolo ventesimo avrebbe irrigato la terra. All’opposto, in Carlo Lorenzini si è in modo singolare pienamente avverata un’altra parola profetica 39 del Signore: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18,3). Il Collodi si è fatto piccolo coi piccoli, e in tal modo ha potuto diventare annunciatore del Regno, maestro di vita, seminatore di consolazione e di gioia. BIBLIOGRAFIA PER LE LEZIONI DI BIBBIA E LETTERATURA N. FRYE, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino, 1986 N. FRYE, Il potere delle parole. Nuovi studi su Bibbia e letteratura, La Nuova Italia, Firenze 1994 R. ALTER, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia, 1990 J. COSTA, La Bibbia raccontata con il Midrash, Paoline, Milano 2008. P. GIBELLINI – N. DI NINO, La Bibbia nella letteratura italiana. Vol. I - Dall'Illuminismo al Decadentismo, Morcelliana, Brescia 2009. KATIA CAPPELLINI - LORENZO GERI (ed), Il mito nel testo. Gli antichi e la Bibbia nella letteratura italiana, a cura di, Bulzoni, Roma 2007. CLARA LERI, Bibbia e letteratura. Rassegna di un trentennio di studi. (1965-1995), «Lettere Italiane», XXXXIX (1997), 2, pp. 295-345. G. BARBLAN (ed.), Dante e la Bibbia, Olschki, Firenze 1988. LODOVICO CARDELLINO, Dante e la Bibbia, Sardini, Brescia 2007. ANTONIO SPADARO,«APOCALISSI». Risposte alla Bibbia come testo letterario, in La Civiltà Cattolica III/2007, 494-501, quaderno 3774. Su Tolkien e la sua opera di sub-creazione: P. GIULISANO, Tolkien il mito e la grazia, Milano, Àncora, 2001 F. MANNI (ed.), Introduzione a Tolkien, Simonelli, Milano 2002. I. FERNÁNDEZ, La spiritualità del Signore degli Anelli, Leumann (TO), Elledici, 2003 S. CALDECOTT, Il fuoco segreto. La ricerca spirituale di J.R.R Tolkien, Lindau, Torino 2009. F. CASTELLI, Tolkien, Signore della Fantasia, in La Civiltà Cattolica II/2002, 432-444, (quaderno 3647) Su C.S. Lewis e la saga di Narnia: P. GIULISANO, C.S. Lewis - tra Fantasy e Vangelo, Milano, Àncora, 2005 40 F. CASTELLI, Il ritorno di C. S. Lewis, in La Civiltà Cattolica II/2004, 334-347, (quaderno 3694) Su Pinocchio G. BIFFI, Contro Maestro Ciliegia. Commento teologico a «Le avventure di Pinocchio», Jaca Book, Milano 2009 (ed. or. 1977). G. BIFFI, Pinocchio, Peppone, l'Anticristo e altre divagazioni, Cantagalli, Siena 2005. 41
Scarica