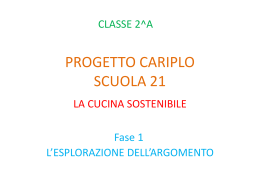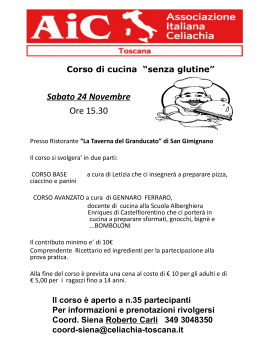CuoChi Un grazie speciale a Matteo Tambini che in questi anni è stato l’anima del “Teatro dei Cuochi”, un progetto al quale ha lavorato sempre con talento e passione. Cuochi ottobre 2012 Idea e progetto a cura di Giorgio Melandri Testi Alessandra Meldolesi Illustrazioni Francesca Ballarini Progetto grafico ed impaginazione Simone Savini - Ph5 La copertina di questo libro è un omaggio a Ferran Adrià. Edito da Enologica Salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia-Romagna www.enologica.org EnologICa® è un marchio registrato Cuochi Testi di Alessandra Meldolesi a cura di Giorgio Melandri Cuochi, il racconto di una comunità. C’è una intera comunità che ruota intorno ad Enologica ed è una comunità importante perché raccoglie i custodi della nostra identità, i testimoni di tutto quello che siamo in termini di cultura e valore simbolico del cibo di territorio. Questa comunità è quella dei cuochi, dai cuochi che lavorano nelle grandi trattorie della regione fino ai cuochi della creatività e dell’avanguardia. E forse tra queste due figure non c’è la grande differenza che pensiamo perché, come abbiamo già avuto modo di scrivere, la nostalgia è una trappola spietata che scatta sull’unica vera certezza che la nostra identità del cibo ci consegna: innovazione e tradizione sono la stessa cosa. Se per un momento provate a far saltare il vincolo del presente e immaginate il tempo come uno spazio completamente praticabile vi accorgerete che la tradizione è la cosa più innovativa che abbiamo tra le mani, un processo che ha ogni volta digerito il nuovo per farlo diventare quello che siamo. È la rielaborazione del nuovo che segna la cultura, la nostalgia non serve, è perdente. Noi preferiamo parlare di conoscenza, perché solo con la consapevolezza di quello che siamo potremo difendere la nostra identità e renderla moderna. Enologica è il grande laboratorio di questo presente, un crocevia di relazioni dentro al quale succede sempre qualcosa, e in questi anni abbiamo cercato di raccontarne i protagonisti attraverso i testi di Alessandra Meldolesi, dei testi sempre pieni di immagini, suggestioni, storie, invenzioni. Con questo libro li abbiamo raccolti tutti perché ci siamo accorti che erano una straordinaria memoria collettiva, radici che ogni anno sono andate sempre più in profondità. A questi testi abbiamo affiancato le immagini di Francesca Ballarini sui grandi prodotti dell’EmiliaRomagna, un omaggio alla filiera che in nessun posto al mondo ha lo spessore che trova in Italia. Giorgio Melandri Curatore Enologica Proteggere la tradizione. Ci sono tanti temi in comune tra il lavoro di Partesa Emilia-Romagna per il Vino e questo volume: l’amore per il proprio mestiere, la capacità di una testimonianza forte e, soprattutto, il tema della specializzazione. È un tema ricorrente, fondamentale, è la nostra direzione. Per questo abbiamo deciso di essere partner di questo progetto, il racconto dei cuochi eccellenti dell’Emilia-Romagna fatto attraverso il lavoro di Enologica e i testi di Alessandra Meldolesi. Noi, come i ristoratori che lavorano con una proposta di qualità, abbiamo scelto di interpretare il nostro lavoro con un coinvolgimento totale, con continuità e precisione. Abbiamo scelto di curare i dettagli e di stare sempre a fianco dei nostri clienti con una presenza rivoluzionaria e tradizionale. Partesa Emilia-Romagna per il Vino nasce nel 1988 con un progetto assolutamente all’avanguardia per la distribuzione del vino di qualità, applicando un concetto da sempre utilizzato dalla maggior parte dei paesi Europei. Le basi di questo lavoro sono quelle di un’offerta che coniuga un listino esclusivo, un servizio di logistica straordinario e una specializzazione della rete vendita. L’obiettivo è un rapporto con il cliente che garantisce qualità dalla scelta dei vini alla consegna. Moderni, ma molto legati ai contenuti della tradizione del vino italiano. Per questo sempre più aziende importanti si affidano a noi in esclusiva. Enologica è il grande laboratorio di idee dell’enogastronomia regionale, il crocevia di tante esperienze che qui si scambiano contenuti e progettano il futuro. Noi con la nostra presenza abbiamo rivendicato un ruolo in questa comunità per essere coinvolti in quel processo di consapevolezza che disegna l’architettura essenziale di quello che saremo. Vogliamo essere in prima fila in questo mondo, vicini alle tradizioni con gli strumenti moderni che servono a difenderle e a promuoverle. Siamo specializzati e vogliamo esserlo in modo sempre più leggibile. Alessandro Rossi Responsabile Progetto Vino Partesa Emilia-Romagna edizione 2012 Possiamo essere rivoluzionari e tradizionali allo stesso tempo. Michel SerreS, 2010 Teatro dei Cuochi il Tema 2012 «La gastronomia ha rindossato le calosce per scendere nelle trincee del prodotto. Rivoluzionario e avanguardista anche quando indossa la tuta mimetica di un piatto di polenta.» Alessandra Meldolesi 10 Filiera Ogni numero di magia è composto da tre parti o atti. La prima parte è chiamata “La Promessa”. L’illusionista vi mostra qualcosa di ordinario: un mazzo di carte, un uccellino, o un uomo. Vi mostra questo oggetto. Magari vi chiede di ispezionarlo, di controllare se sia davvero reale, sia inalterato, normale. Ma ovviamente... è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato “La Svolta”. L’illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora voi state cercando il segreto... ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati. Ma ancora non applaudite. Perché far sparire qualcosa non è sufficiente; bisogna anche farla riapparire. Per questo ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua, la parte che chiamiamo “Il Prestigio”. The Prestige, Christopher Nolan (2006) “L’artista studia amorosamente la sua materia, la scruta sino in fondo, ne spia il comportamento e le reazioni; la interroga per poterla comandare, la interpreta per poterla domare, le obbedisce per poterla piegare; la approfondisce perché riveli possibilità latenti e adatte alle sue intenzioni; la scava perché essa stessa suggerisca nuove e inedite possibilità da tentare; la segue perché i suoi naturali sviluppi possano coincidere con le esigenze dell’opera da fare; indaga i modi in cui una lunga tradizione ha insegnato a manipolarla per farne germogliare di inediti e originali, o per prolungarli in nuovi svolgimenti; e se la tradizione di cui la materia è carica sembra comprometterne la duttilità e renderla greve e tarda e opaca, egli cerca di recuperarne una vergine freschezza, che sia tanto più feconda quanto più inesplorata; e se la materia è nuova egli non si lascerà spaventare dall’audacia di certi suggerimenti che sembrano spontaneamente uscirne e non si rifiuterà 11 enologica edizione 2012 Le geografie variabili di una machina memorialis trasformista di Fregoli. La standardizzazione dei selezionatori della grande ristorazione, la stessa materia a qualsiasi latitudine e per qualsiasi interprete; il culto della griffe trasversale, paravento dorato per la mancanza di idee; per non parlare del contrabbando di pesci e crostacei di provenienza oscura, o delle denominazioni chimeriche con le loro miracolose moltiplicazioni delle cause e degli effetti. Roba senza la carta d’identità di un contrassegno, clandestina come le norme de iure condito che legano le mani del selezionatore verace. Per questo, innanzitutto, la filiera è una machina memorialis. Esercizio attraverso il quale il cuoco detective parte in cerca della storia del prodotto, per poi leggervi in filigrana le strutture formali che gli detteranno la ricetta. L’alimentazione di un volatile, che ne informa la consistenza e il profilo aromatico, come la sua storia di vita. Fra le sbarre di una gabbia, sul tapis roulant del mangime, le zampe che raspano la ghiaia del cortile sotto il sole oppure il fondo sintetico di un parallelepipedo iniettato di luce. E sul piano filogenetico l’archeologia di un seme, trasportato nel solco dal venticello dei secoli oppure rimbalzato sui vetrini del microscopio. Le razze autoctone e il al coraggio di certi tentativi ma nemmeno si sottrarrà al duro dovere di penetrarla per meglio individuarne le possibilità”. È il romanzo amoroso di una semiosi insaziabile, quello descritto dall’estetologo Luigi Pareyson. A testimonianza di un’arte tutta che, come la cucina, non germoglia dall’ispirazione idealistica ma si disegna nelle nervature delle cose. Fibre che dipanano le loro fughe parallele, stratificazioni a matrioska che covano l’uovo del big bang vitalistico, close up serrati su tessiture preziose, dove la natura trascolora in astrazione e forse persino in segno. Strutture che guidano la mano senza troppe esitazioni. Osservare. Interrogarsi. Obbedire. Ascoltare. Nel massimo silenzio possibile. Oggi più che mai il cuoco lungi dal formare è formato, domato, educato dal magistero del prodotto. Dominus incontrastato del gioco culinario. L’ossessione prende le vesti di un’anamnesi incalzante. “Ricordo” che compone una biografia dell’ingrediente ab origine. È questa la filiera, da un produttore al successivo, a ritroso sin dove si può, e poi fino in casseruola. Filo di Arianna sporco di terra e di letame che trae in salvo il cuoco smarrito nei gomiti del gastrocircus, minacciato da un minotauro non meno 12 gemelle di saldare il conto. Ed è proprio in quel momento che Simonide viene avvisato della presenza di due giovani che vanno in cerca di lui ed egli esce ad incontrarli. Grande è la sua sorpresa quando non trova nessuno, più grande ancora quella cagionata dal trambusto della sala del banchetto, che si accartoccia su se stessa sotto il peso del tetto. Il debito delle divinità è saldato con la vita; diversa è la sorte del re e dei suoi cortigiani, schiantati sul colpo. Anzi disintegrati dal crollo, tanto che i familiari accorsi non arrivano a riconoscerne l’identità. Ed è allora che vede la luce la mnemotecnica: Simonide rammenta dove stesse seduto il re, e dove coloro che alzavano le coppe, uno alla volta. Ed è un’intuizione fondativa. “Egli dedusse che persone desiderose di affinare questa facoltà devono scegliere alcuni luoghi e formare immagini mentali delle cose che desiderano ricordare, e collegare quelle immagini in quei luoghi, in modo che l’ordine dei luoghi garantisca l’ordine delle cose, le immagini delle cose denotino le cose stesse, e noi possiamo utilizzare i luoghi e le immagini rispettivamente come la tavoletta cerata e le lettere scritte su di essa”, commentò Cicerone, grande cultore 13 enologica edizione 2012 chilometro zero oppure il viaggio attorno a un mondo impacchettato da filiere lunghissime quanto stringenti e robuste. Gomitoli caldi pronti a tessere le loro tele sul piatto. La memoria: per millenni uomini privi di chiavette USB e Olivetti lettera 22, quando Gutenberg era di là da venire e i manoscritti rarità preziose, si sono arrovellati circa la strategia migliore per oliarla e potenziarla, renderla più agile e performante. Le rudimentali protesi hanno svolto i loro servigi da Cicerone a Quintiliano, fino a contaminare le grandi trattazioni di Giordano Bruno e Pietro Ramo. Anche se il loro fondatore si chiamava Simonide di Ceo, celebre poeta lirico greco del VI secolo a.C., di cui ci è giunta una manciata di epigrammi e qualche prezioso frammento. Ebbene ci troviamo in Tessaglia, presso la sontuosa dimora del re Skopas. Simonide attacca a cantare il suo componimento dedicandolo all’ospite preclaro, non fosse per un paio di versi in lode a Castore e Polluce, che però non sfuggono al committente. Il quale adirato lo ricompensa per metà del pattuito, demandando alle divinità che risvegliano la memoria dalla fase rem. Originando una scrittura sui generis, tridimensionale, labirintica, intessuta dei geroglifici spontanei del sonnambulismo. E una volta compiuto questo arredamento arbitrario, si trattava di intraprendere più e più volte lo stesso tour virtuale, impaginato con rigore ed aritmetica tranchant dalla coreografia dei passi ben cadenzati. Al fine di riceverne in cambio il messaggio. “Chi è quell’uomo che avanza lentamente nell’edificio solitario, e si ferma, a tratti, con espressione intenta? È uno studente di retorica che sta formandosi un sistema di loci della memoria”, descrive la storica Frances A. Yates (ipotizzando arditamente che la stessa Commedia dantesca non sia altro che uno svolgimento visionario del tema: le virtù e i vizi restituiti prontamente alla coscienza dal loro collocamento in una scenografia organizzata). O forse è un cuoco? In fondo è una ginnastica volontaristica, training basato sulla reiterazione emozionale e sulla percussione degli stimoli, volto a rendere più performanti i riflessi, più rotonde e muscolose le funzioni. È la potenza elementare, arcaica, quasi magica dei loci. “Quando facciamo ritorno in un luogo dopo qualche tempo, non di un’arte che rappresentava la quinta articolazione della retorica tutta. Al giorno d’oggi non c’è più memoria di quella memoria, donata agli uomini dai Dioscuri protettori delle Arti. Ne abbiamo perso le tracce per barattarla con qualche porta USB e un archivio di memory card. Eppure la vecchia storia di Simonide di Ceo, che suona così farraginosa ed improbabile ai nostri orecchi pragmatici, ha ancora qualcosa da raccontare ai cercatori e ai sognatori. Da allora e per diversi secoli ricordare è equivalso ad un turismo cerebrale che ricalca pedissequamente i suoi passi, sorta di coazione a ripestare orme che conducono al ricordo. Si trattava infatti di fingere nella propria mente serie ordinate di loci e di imagines. Edifici, spazi, ambienti artificiali, panorami presi in prestito dal mondo circostante oppure creati dal nulla, dove andare a depositare l’uovo fecondo di simboli pregnanti o di visioni ad effetto. Formae, notae, simulacra. Imagines agentes, le chiamava l’autore di Ad Herennium, unico testo esaustivo in materia pervenuto nelle nostre mani, capaci cioè di imprimere le loro caratteristiche ficcanti nella tavoletta cerata delle nostre associazioni. Generando urti emozionali 14 castelli, fiumi, laboratori e sinuosi fondali marini. Loci naturali e artificiali la cui cassa di risonanza carica di intensità le sue cose. Che poi il cuoco inanella nel proprio percorso manuale. Viatico della memoria materiale, ultima freccia della retorica vincente. Che poi Mnemosine era la madre delle Muse, la memoria progenitrice delle arti. E mentre la filiera disegna la sua cartografia sempre diversa, sempre personale, scorrendo fra i segni astratti della toponomastica come il filo aggira i chiodi del tombolo, l’arca della memoria si riempie dei tesori messi in salvo per quanti vorranno ri-cordare. È un patto, la filiera, un contratto fra il cuoco e il suo cliente siglato dal notaio del futuro. Oggi, è vero, molti di quei loci sono collassati al pari della reggia di Skopas. E i mattoni accumulati ai nostri piedi hanno offuscato torri e campanili millenari, lanciati nel loro assalto al cielo e sbriciolati in una perdita incresciosa. Simonide di Ceo, insieme a superstiti ed affini, probabilmente si sarebbe aggirato fra le macerie fumanti esercitando la rabdomanzia della sua ars memorandi, dono di eroi che salvano anche le identità e propiziano i riti. Ma sono i cuochi ad aiutarci a ri-vivere lo slancio delle scalere 15 enologica edizione 2012 solo ravvisiamo il luogo stesso, ma ricordiamo anche ciò che vi si fece, e tornano alla mente le persone, e talvolta anche i pensieri inespressi”, banalizza Quintiliano. Insieme a ciò che si produce e a quanto vi si mangia. La segnaletica con le sue frecce perentorie e le bandierine conficcate punta dritto alla forza del messaggio, alza il volume dell’eloquenza, connette le sinapsi delle associazioni, attacca adesivamente le tessere sparse di quanto vogliamo ri-membrare. Ri-vivere. Ri-cordare. Ovvero ri-passare dalle valvole del cuore. Ci piace fotografarli così, i nostri grandi cuochi dell’Emilia-Romagna, regione che ha saputo come nessun’altra conciliare eccellenza e grandi numeri, rigore e comunicazione, business e cultura, operosità, nicchia e spirito di squadra. Nell’atto di percorrere e ripercorrere coi passi e l’immaginazione il paesaggio mnemonico delle ricette, partendo sempre dai prodotti. Forme strategicamente riposte nelle cassette di sicurezza del territorio, blindate contro il furto della storia e del sapere ad opera della pirateria globalizzata. Paesi vicini e lontani, caseifici, allevamenti franchi come il piede delle vigne centenarie, famiglie e individui, case e casolari, in coraggio, l’orrore in bellezza, l’irrazionale in fantasia creatrice, l’anarchia incontrollabile della natura nella leibniziana, illuministica anarchia creatrice; il caos in logos, infine. Che è sempre il cammino della civiltà e della storia”. per il Parmigiano e la sospensione aerea nei solai del Balsamico, affinché possiamo ricostruirle esattamente come prima e probabilmente anche più in alto. Una fune robusta per risollevare la storia collettiva. “Tutti dovettero avere una grande superbia, un grande orgoglio, un alto senso di sé, di sé come individui e di sé come comunità, se subito dopo il terremoto vollero e seppero ricostruire miracolosamente quelle città, con quelle topografie, con quelle architetture barocche: scenografiche, ardite, abbaglianti concretizzazioni di sogni, realizzazioni di fantastiche utopie”, scriveva Vincenzo Consolo, ma io vedo quelle scalere e quelle magnifiche botticelle in volo. “Sembrano nei loro incredibili movimenti, nelle loro aeree, apparenti fragilità, una suprema provocazione, una sfida ad ogni futuro sommovimento della terra, ad ogni ulteriore terremoto; e sembrano insieme, le facciate di quelle chiese, di quei conventi, di quei palazzi pubblici e privati, nei loro movimenti, nel loro ondeggiare e traballare ‘a guisa di mare’, nel loro gonfiarsi e vibrare come vele al vento, la rappresentazione, la pietrificazione, l’immagine, apotropaica o scaramantica, del terremoto stesso: la distruzione volta in costruzione, la paura 16 Giovanna Guidetti “Quel che l’intelligenza ci restituisce sotto il nome di passato, non è tale. In realtà, come accade per le anime dei trapassati in certe leggende popolari, ogni ora della nostra vita, appena morta, s’incarna e si nasconde in qualche oggetto materiale. Essa vi resta prigioniera, prigioniera per sempre, a meno che noi non c’imbattiamo in quell’oggetto. Attraverso di esso noi la riconosciamo, la chiamiamo a noi e la rendiamo libera”. Apre i sapori come i vecchi cassetti delle sue credenze, giovanna guidetti della Fefa. Sicura che la magia di Marcel Proust sguscerà fuori insieme al profumo di amido dei tovaglioli e ai bagliori corruschi delle posate impilate. Dando nuova vita a quello che sembrava perduto in un rito al tempo stesso personale e collettivo. Fra le macerie di Finale Emilia, a metà strada fra la Torre dei Modenesi e il mastio del Castello Estense: cumuli rossastri indistinguibili sotto i quali è finita intrappolata la vitalità della Bassa. l’oro dei suoi nidi di tagliatelle e dei suoi ravioli sparpagliati sul piatto è qualcosa di più di una patina di comfort food sopra crepe troppo fresche. Assomiglia piuttosto allo stucco di una teodicea popolare, che chiude i dotti del rimpianto con il lenimento quotidiano di qualcosa di buono. In un viaggio che porta lontano, lungo quel Panaro che dagli ormeggi di fronte all’osteria un tempo conduceva a Ferrara e di qui ai fasti di Venezia, caricandosi dei colori e dei profumi delle spezie. Fra le mura miracolosamente intatte della sua Fefa, ancora calde di tante feste, mostre e concerti, ama definirsi una “razdora”. Ovvero la massaia di una metaforica famiglia contadina. Ma è reggitrice in senso lato, ben oltre le calorie e l’aritmetica: come una cariatide ingrembiulata che puntella le vestigia, siringa la storia di carbonio e imbraca la memoria sorridendo. E forse non è un caso che il ristorante abbia riaperto i battenti con un pranzo dedicato alla cultura ebraica; alla ricerca di una terra promessa irraggiungibile eppure quotidianamente sotto gli occhi, transennata dietro i nastri della protezione civile e le sirene della zona rossa. Alla sua tempra è andata una delle medaglie d’oro più splendenti di londra 2012, dove l’animo finalese è spirato da leggendarie paste ripiene e tournedos di maialino e zuppa inglese, passando un colpo di spugna magico sopra tre mesi di paura dentro i padiglioni gremiti di Casa Italia. Quali sono le tue origini? Vengo da una famiglia di Finale. Papà era ingegnere all’ufficio tecnico del Comune, poi industriale, ma veniva da una famiglia modesta. Siccome i miei nonni non avevano la possibilità di mantenerlo agli studi, prima che vincesse una borsa di studi, a pagargli la retta era stato lo zio Gino di Milano, che lavorava come farmacista 17 enologica edizione 2012 Osteria la fefa Via Trento Trieste 9/c - Finale Emilia (Modena) Tel +39 0535 780202 - www.osterialafefa.it all’Ospedale Fatebenefratelli e insegnava Farmacologia all’Università. Mia mamma invece era casalinga. Sono morti giovanissimi entrambi, nel giro di un anno; la mamma era già malata, ma se ne è andato per primo papà, forse per amore. Io ero la seconda di quattro figli e abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Ci siamo trovati a doverci occupare di un’azienda senza nessuna preparazione. Mio fratello, che si era appena laureato in ingegneria, appena finito il militare è stato catapultato a direttore generale senza sentirsi all’altezza. Per fortuna c’è stato un amico di mio padre che gli ha dato una mano. Mentre io mi sono occupata della famiglia e dell’azienda agricola. E non è stato facile. Avrei voluto fare il notaio, ma sono andata a lavorare in banca e ho avuto tante soddisfazioni, perché la Banca Commerciale Italiana mi ha fatto frequentare corsi e master per prepararmi alla carriera di funzionario, cosa che all’epoca non era scontata per una donna. Una formazione che poi mi è tornata utile nelle vesti di imprenditrice della ristorazione, perché un bilancio lo leggo in pochi secondi. Io però capivo che non faceva per me: è molto grigio fare il bancario. i grandi problemi della vita. Per cui mi sono impegnata a fargli da mangiare sempre: pranzo, cena, colazione. Invitavo tanti suoi amici per rendergli la vita più serena. Avevi imparato solo da tua madre? Chi mi ha influenzato di più è stata lei, che era bravissima. Poi sia mio padre che mia madre avevano il pallino di andare per grandi ristoranti. Il divertimento del fine settimana era quello, e a volte li accompagnavamo, quindi abbiamo sicuramente affinato il palato. Per esempio il giorno della mia laurea in giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Modena sono andata da gualtiero Marchesi a Milano con le mie amiche, i miei fratelli e i miei genitori. Oppure da Romano a Viareggio, da Santin alla Cascinetta di Lugagnano…. Ma io ho sempre cercato di mantenere i sapori, i profumi e i colori di casa, al fine di tramandarli. Perché mia mamma faceva tutto da sola: la sfoglia col mattarello, il pane, i maccheroni con il torchio. Io la aiutavo a preparare i dolci, le conserve, le marmellate. Come nelle vecchie famiglie contadine. Ricordo in particolare quando lavavamo le amarene nei mastelli e poi le snocciolavamo tutte. E anche qui al ristorante ogni anno facciamo la marmellata di amarene con i frutti delle piante del giardino e dell’azienda agricola. Produciamo inoltre la marmellata di pere, di mele cotogne, di prugne, la mostarda, la mostarda di mele campanine, di fichi e il “savor”, una particolare marmellata che si produce con il mosto dell’uva, le mele cotogne, le pere, le mele, la zucca, la barbabietola da zucchero e la buccia d’arancia. Mio fratello è cresciuto anche lui con un ottimo palato e mi è grato Com’è nato il tuo amore per la cucina? Quando siamo rimasti orfani avevo circa 30 anni, ma mio fratello minore ne aveva 11 di meno. Ho sentito che il mio scopo era proteggerlo utilizzando i sapori di casa, in modo che anche lui potesse conoscere la cucina della mamma, della nonna, della zia. Anche perché sono sempre stata convinta che mangiare bene aiuta a soddisfare la mente e il corpo, ma soprattutto aiuta a superare 18 Non c’è frase più azzeccata per quello che sta succedendo. Il sindaco di Finale Emilia ti ha permesso di riaprire affinché il paese ritrovi un senso di normalità. Sembra quasi che per te la cucina sia una tecnica di elaborazione del lutto. E io spero di riuscirci. Che si ritorni ad avere in paese un ristorante che pratichi la cucina tipica, partendo da prodotti di alta qualità. anche per traghettare questa tradizione al di là del terremoto. Fare capire che si può ripartire. Perché “nessuno può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene”, scriveva già Virginia Woolf. Lo stesso 20 maggio, giorno del terremoto, raggiunto il ristorante abbiamo aperto le porte a tutti, inizialmente abbiamo dato caffè, cappuccini, torte, biscotti, nocino e limoncello per superare la paura; poi abbiamo somministrato ai compaesani e ai giornalisti pane, salame, prosciutto e Lambrusco nei bicchieri di plastica. Come ti sei avvicinata alla cucina professionale? Nel 1996 mi sono ammalata di tumore al plesso brachiale, mi hanno curato benissimo all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ma sono rimasta alcuni mesi paralizzata al braccio e con la testa storta a sinistra. Quando mi sono ripresa ho deciso di cambiare vita. Voleva realizzare il mio sogno, dare sfogo alla mia passione per la cucina. Perché non avevo mai smesso di organizzare pranzi in famiglia e con gli amici. E avevo continuato a girare per ristoranti, abbinando magari un pranzo a una mostra. Arte e cucina. Quando sono tornata in banca dopo un’assenza così lunga mi sono sentita inadeguata, non mi piaceva più. Già prima facevo fatica, ma dopo era impossibile. Ed è così che sono andata a Panarea e ho avuto la folgorazione. Ero partita per fare immersioni subacquee insieme a mio figlio Edoardo, ad un’amica e ai suoi figli, Jacopo e Costanza, ma siamo rimasti bloccati sull’isola per giorni e giorni dal mare a forza 8. Spesso andavamo a mangiare in una trattoria sul porto che esiste ancora, si chiama Da Adelina. Il ristoratore era preoccupato perché nel mese di agosto non sarebbe arrivato l’aiuto cuoco che aveva scelto a Milano e io mi sono offerta come brava cuoca di casa, senza esperienze pregresse nella ristorazione. Lui mi ha detto che tante turiste dicevano così, poi non tornavano mai. “Se lei mi crede, porto a casa Edoardo e ritorno”. “Ma suo marito?”. “Decido io questa volta. Devo dare una svolta alla mia vita duramente colpita dalla malattia”. E così ho fatto. Appena il mare si è calmato ho riportato Edoardo a casa. Ho comunicato le mie intenzioni a mio marito, che non è stato per niente contento, non mi ha nemmeno accompagnato alla stazione il primo di agosto. La cosa che mi ha angosciato di più però è stato il pianto di Edoardo, che aveva solo 8 anni. Com’è stata l’esperienza? Sono partita dal basso, come gli sguatteri. Ho cominciato pulendo il pesce alle 8 di mattina e per quanto fosse fresco, mi veniva una nausea … andai pure dal dottore 19 enologica edizione 2012 di avergli fatto conoscere questi sapori. Sono tuttora convinta che mangiare bene aiuti a superare i traumi. dell’isola, che veniva solo il venerdì, mi disse che dovevo tornare a casa e mi ordinò le bustine ricostituenti di Polase. Perché non c’era altro, nessuna malattia. Ma ebbi un’idea geniale. Nel quaderno di mia madre, che avevo portato con me, c’era una torta di mandorle a base di ricotta di pura pecora emulsionata con lo zucchero, mandorle bianche e pasta frolla con farina di mandorle. Sicuramente una ricetta di derivazione siciliana. Chiesi al cuoco la possibilità di metterla in menu, mi rispose che non faceva investimenti. Allora proposi di farla a mie spese. Ordinai da un fornitore di lipari gli ingredienti per telefono e una mattina preparai dieci torte. Misi fuori un cartello sul molo: “Vendesi torta di mandorle”, a una cifra spropositata ma adeguata per l’isola, perché Panarea per i turisti era carissima. Feci queste torte che ebbero un successo clamoroso, perché all’epoca le barche potevano arrivare vicinissimo a terra, anche i grandi yacht. Alle 13 avevo già venduto tutto. alberghiera di Ferrara, al fine di acquisire i titoli per fare stage nei grandi ristoranti. E sono state esperienze bellissime, prima alla locanda San Lorenzo a Puos d’alpago, un posto delizioso con gente carina che mi ha molto aiutato. Certo hanno cercato di dissuadermi in tutti i modi, ma io non ho sentito ragioni. E ho imparato tanto, anzi tantissimo. Per esempio ho imparato a saltare la pasta, perché mi hanno messo davanti a un muro con una padella in mano, hanno versato all’interno un etto di riso e hanno detto: “Finché continua a uscire, non ti girare verso di noi”. In seguito sono rimasta per 6 mesi da Igles Corelli alle Tamerici, sono andata in Sicilia, dove ho familiarizzato con caponate e couscous, e in Toscana…. Quando hai aperto la Fefa? Nel 2001. Il locale era un’osteria con locanda sul fiume fin dal 1756, dove secondo gli storici si aggiustavano anche le barche. Nel primo portico c’è ancora l’occhiello dove venivano legate le corde delle chiatte, si salivano 3 gradini e si entrava. E anche qui c’è stato lo zampino della provvidenza. Perché io volevo intraprendere questa attività ma non trovavo un posto adeguato, stavo per comprare il pian terreno del palazzo di fronte, che adesso ospita una banca, ma capivo che non era il massimo. Mi sarebbe piaciuto entrare all’interno di questa osteria, ma i mediatori dicevano che non era in vendita. Ebbene, quel pomeriggio del 4 ottobre del 2000 sarei dovuta andare a Mantova a firmare il compromesso col proprietario del negozio, dove avrei ricavato una piccolissima osteria da 20 posti. Ma mi sembrava un acquisto incauto, così decisi di andare a parlare direttamente con i proprietari della Fefa Quindi c’è stato lo zampino di tua madre. Mi piace pensarlo. E da lì è nata la mia fortuna: sono salita di grado, non ho più pulito pesce, potevo andare al ristorante verso le 11, dopo essere stata un po’ al mare: l’importante era preparare queste 10 torte, che venivano vendute a fette al ristorante oppure intere da asporto. Ero diventata una piccola imprenditrice della torta di mandorle, insomma. Lo stage doveva essere a titolo gratuito, mi davano solo il viaggio e l’alloggio sopra il ristorante, invece sono tornata a casa con qualche soldo. Mio marito era ancora arrabbiatissimo, ma io gli ho detto che avevo deciso di fare la cuoca. Mi sono iscritta a un corso serale alla scuola 20 caparra. Avevo acquistato la mitica Osteria la Fefa! Quando sono uscita ero felicissima, ho ripreso fiato e ho telefonato alla notaia dove avevo fatto la pratica per comunicarle la novità. Lei mi ha risposto: “Ma che cosa hai fatto? Sei sicura? Hai già versato la caparra? Devi avere i dati catastali, vedere se l’immobile è ipotecato”. Entro mezzogiorno io però volevo chiudere il preliminare davanti al notaio, volevo un documento ufficiale che attestasse il mio acquisto. Così ho ottenuto di corsa la visura catastale ed era tutto in regola. Abbiamo fatto il compromesso e siamo andati al bar Mazzini a brindare. Mi sembrava di aver vinto alla lotteria. Il 4 ottobre del 2000 erano 12 anni che era morto mio padre, a cui ero legatissima, e questo evento mi sembrava un suo dono. Il rogito vero e proprio è stato firmato il 29 dicembre del 2000, la disponibilità del locale mi è stata data il 31 gennaio. Ero felice, anche se presto sono iniziati i problemi, perché la ristrutturazione è stata difficile, siamo partiti dalle fondamenta, il tetto è stato alleggerito e in parte rifatto ed è stato eseguito anche il cerchiaggio dei muri maestri. Forse è per questo che nel complesso ha tenuto. Ho inaugurato e dopo poco l’attività si è avviata. Ma come ho detto prima, le mie passioni, oltre alla cucina, sono l’arte e la musica. Così ho iniziato a organizzare concerti jazz e mostre, perché fare la cuoca è come rinchiudersi in convento, non si ha più tempo per nulla. Ho chiamato musicisti e artisti importanti come Emanuele Luzzati, che ha illustrato il mio libro A tavola con duchi e duchesse. 21 enologica edizione 2012 per un tentativo estremo. Entrai alle 7 di mattina, trovai la moglie del titolare e chiesi se era possibile incontrare il signor Francesco. “No, è a letto, arriva verso le 8 e mezzo. Mi lasci il telefono, quando si alza vediamo se le vuole parlare”. Così fu, lui mi chiamò e io chiesi di incontrarlo a quattr’occhi. Quando arrivai l’osteria era già piena di persone che giocavano a briscola. Lui mi fece accomodare nel retro bottega, dove attualmente abbiamo la dispensa. Mi chiese se mi volevo sedere e mi girò una cassetta da birra gialla. Pensavo al mio povero tailleur ma mi accomodai senza fiatare. “Mi dica cosa vuole”. “Vorrei comprare l’osteria della Fefa”. “Guardi l‘osteria della Fefa non è in vendita”. “Nella vita tutto si può comprare e tutto si può vendere, basta mettersi d’accordo”. “Nella mente io ho già un valore, ma sono talmente tanti milioni che è impossibile trovare un acquirente”. Non ricordo più l’importo, ma io dissi: “Va benissimo”. Mi ero sentita come un bambino dentro al negozio di giocattoli. Perché anche se l’osteria era fatiscente, e nessuno ci aveva messo mano da 60 anni, con l’occhio della sognatrice l’avevo già vista finita, con attaccate alle pareti le collezioni di tegami di rame, stampini da budino e da biscotti, che avevo raccolto fin da ragazza, pensando che un giorno avrei avuto un ristorante; sulle mensole dei mobili di famiglia i macinapepe e i barattoli da biscotti antichi. Quindi per me era bellissima. Abbiamo steso il compromesso su due piedi sopra un foglio di carta a quadretti, l’abbiamo firmato entrambi e ho versato con un assegno la Come eri entrata in contatto con Luzzati? dopo e, sapendo che sarebbe rimasto a Genova, gli chiesi un appuntamento. Mi ricevette a casa sua e nacque subito un sodalizio incredibile. Tornai da genova con le opere pronte per la mostra. E a tutte le mostre che ha inaugurato in seguito, mi ha sempre chiesto di accompagnarlo. Quando lui è morto, improvvisamente, il nostro libro era ancora allo stato di progetto. Gli eredi mi hanno contattato nel gennaio del 2011 per realizzarlo. Ho trascritto tutte le ricette, le ho fatte tradurre, mio marito le ha aggiustate, rendendo meno fredda la traduzione, e finalmente siamo usciti l’anno scorso a ottobre. La presentazione del libro al Museo Luzzati è stata curata da Mordillo. Il mio staff ed io abbiamo eseguito la prima cena al museo con offerta libera e abbiamo devoluto il ricavato in parte al museo stesso, in parte all’ospedale Pediatrico gaslini reparto oncologico. Ma di mostre ne ho organizzate tante altre: Marisa Carolina Occari, Erio Carnevali, Henri Hayden, Riccardo Biavati (con cui ho tenuto la cena delle 100 ciotole ispirata alle ceramiche estensi), Livio Ceschin, Rino Zapparoli... Con menu sempre sintonizzati sulle diverse suggestioni. Per caso. Nel 2002 organizzai un pranzo utilizzando prodotti kasher e ricette ebraiche in occasione della giornata Europea della Cultura Ebraica che si svolge la prima domenica di settembre. Andai a Modena in Comunità per comprare il Lambrusco kasher e mi fecero visitare la Sinagoga dove erano esposte sette coloratissime opere di Emanuele Luzzati illustranti le principali festività ebraiche. Mi chiesero se ero interessata all’acquisto o a fare una donazione in favore di una fondazione di Gerusalemme che si occupava di bambini in difficoltà, presieduta da Gabriella Luzzati, sorella dell’artista. Io feci un’offerta e me le diedero tutte. Mi consegnarono anche un biglietto con scritto: “Emanuele Luzzati, Via Caffaro 12 – Genova telefono 010 25120400”, dicendo che avrei potuto contattarlo per ottenere una dedica particolare. Io lo conservai a lungo. Una sera ero disperata, avevo deciso di chiudere il ristorante per sempre. Avevo avuto un incontro con i sindacati per liberarmi di un dipendente che rubava sia soldi che vini. Dopo essere stata a lungo nella penombra, mi dissi: “Basta piangere” e cercai qualcosa che mi potesse gratificare. Perché quando tocco il fondo trovo sempre un appiglio che mi aiuta a risalire. Mi venne in mente quel biglietto, telefonai, mi presentai e chiesi di poter organizzare a settembre una mostra delle sue opere. Era gennaio, lui mi rispose che ci doveva pensare perché non aveva mai esposto in un ristorante. Ma aggiunse che avevo un vantaggio, perché da giovane era stato indeciso se fare il cuoco o l’artista. Io con la mia irruenza gli chiesi cosa avrebbe fatto il giorno La locanda c’è sempre stata? No, l’ho aperta nel 2006. L’investimento iniziale era stato molto consistente, quindi ho aspettato che tutto funzionasse a pieno regime prima di affrontare nuove spese. Ho ricavato 6 camere e 2 mini appartamenti. Ma l’ultima avventura è stata la scuola, che doveva essere inaugurata pochi giorni dopo il terremoto. Quindi i nastri sono ancora da tagliare, perché l’ingresso dà su un vicolo chiuso. L’oggetto dei corsi sarà la cucina della tradizione: sfoglia, pane, paste 22 Com’è cambiato il ristorante in questi 10 anni? La mia cucina ovviamente è migliorata, ma continua a fondarsi sui classici modenesi che mi ha insegnato mia mamma. Perché la cucina emiliana, appena un po’ sgrassata, è davvero una grande cucina. La mia passione sono le torte: la torta di tagliatelle, la tenerina, i biscotti di frumentone con la farina gialla. Oppure la sfoglia, che facciamo io, Mirco, il mio secondo, o una sfoglina al matterello. Un uovo per ogni etto di farina, stesi a mano fino a ottenere una sfoglia sottile ma non troppo, soprattutto ruvida, con l’impronta della mano. Che intervento hai compiuto sulle ricette di tua madre? Molto circoscritto: cerco sempre di restare fedele ai sapori della tradizione, anche se talvolta li raggiungo percorrendo strade diverse. la coscia di anatra per esempio la cuocio confit, a bassa temperatura nel suo grasso, in modo che si ammorbidisca, ma gli aromi sono quelli di sempre perché deve assomigliare a un arrosto. In generale i secondi sono stati un po’ modificati, a parte gli umidi e i brasati; mentre i primi e i dolci sono rimasti tali e quali ai quaderni della mamma, dal ripieno del tortellino alla pasta e fagioli. Le specialità strettamente finalesi quali sono? Quella più tipica è la torta degli ebrei, una millefoglie salata con due strati di Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi e una pasta sfoglia a base di strutto, che originariamente veniva preparata con grassi vegetali. Quindi è un piatto abbastanza impegnativo e calorico, che viene consumato e venduto generalmente d’inverno, bollente. Una ricetta di sicure origini orientali, visto che ci sono torte simili in Grecia, Armenia, Israele ed Egitto, condite con formaggio fermentato e una specie di gorgonzola stagionato, carne o polpa di zucca. Era il vanto gastronomico della comunità ebraica di Finale Emilia, che si insediò in paese nel 1541 dopo la cacciata dalla Spagna. Il ducato estense di Ferrara l’accolse, ma presto il duca si rese conto che era troppo numerosa e ne trasferì una parte a Finale Emilia, dove aveva una residenza estiva. Ma quando nel 1861 Mandolino Rimini, figlio di Aronne, si fece cristiano al fine di sposare una bella finalese, l’ostracismo ebraico fu tale che decise di vendicarsi rivelando la ricetta della torta, che cominciò a produrre come cibo di strada. Cosa che avviene tuttora nei forni e nelle pasticcerie, dove è venduta 23 enologica edizione 2012 ripiene, arrosti, brasati, baccalà al latte (simile a quello alla vicentina), torte, dolci al cucchiaio … Accanto al cibo, credo che l’accoglienza sia stata una delle armi vincenti del locale, perché Finale è sempre stato un posto un po’ fuori dal mondo. La nostra clientela è affezionatissima, considera la serata al ristorante come la visita a un’amica. Un giornalista del Sole 24 ore mi ha illuminato quando ha scritto che mangiare alla Fefa è come andare a cena a casa di amici, ed è per questo che ci si presenta sempre con un regalo. Non so se provare gioia o imbarazzo quando i clienti arrivano con un pensiero, chi con un fiore, chi con una bottiglia di vino, oppure tanti libri. porzionata e avvolta nella carta paglia. L’abbinamento tipico dei nostri nonni era un bicchiere di Anicione, un liquore di anice secco tipico di Finale, la cui gradazione si aggira attorno ai 50 gradi. sia dalla presidentessa che da Luisa Modena. Una cultrice della materia che mi ha insegnato non solo le ricette, ma anche l’esecuzione e i sapori. Io mi sono limitata a porzionarle bene e presentarle come piatti da ristorante e non da casa. Per esempio l’anatra generalmente la decoro con petali di fiore, questa volta l’abbiamo fatta all’uva, l’anno scorso alla cannella, dipende dalle ricette che abbiamo voglia di eseguire. Poi ci sono le torte ebraiche, che sono tante. Quest’anno abbiamo scelto la torta di mele con salsa di albicocche, zenzero e mandorle tostate. Fa parte del pranzo ebraico che organizzi ogni anno? No, perché gli Ebrei di oggi non possono mangiarla se consumano anche carne, dato che contiene latticini. Non è kasher. Quindi il pranzo quest’anno è iniziato con i salumi di pura oca, prosciutto e salame. Una specialità tradizionale, visto che gli Ebrei a Finale avevano costituito grossi allevamenti di oche e di anatre, che purtroppo non esistono più. Poi abbiamo fatto il pane del sabato, a forma di treccia con i semi di papavero. Viene abbinato al pasticcio di fegato, che è simile a quello toscano, aromatizzato con salvia e rosmarino e poi battuto a coltello. Come primi piatti abbiamo offerto la zuppa di lenticchie o zuppa di Esaù, che viene speziata con la curcuma, e le ruote del faraone, tagliatelle condite con prosciutto d’oca leggermente affumicato, pinoli e uvetta. Commemorano la fuga d’Egitto, quando le acque si chiusero, le ruote ricordano quelle dei carri e i pezzetti di carne le testoline degli egiziani … C’è stata anche la coscia di anatra in dolce agro con salsa di uva e verdure agrodolci, poiché gli Ebrei facevano un grosso uso di aceto e di limone. C’è ancora la comunità ebraica a Finale? No, non c’è più nessuno. Il ghetto è abitato da gentili, e soprattutto non è più agibile. Però c’è un cimitero ebraico, il più bello della regione, con lapidi risalenti al 1500. Finale ha sempre aderito alla giornata Europea della Cultura Ebraica, almeno da quando ci sono io. Il tema cambia ogni anno, questa volta è l’umorismo, che non fa proprio al caso nostro… accanto ai pranzi, abbiamo sempre organizzato conferenze qui in giardino, per esempio due anni fa è venuto arrigo levi, che poi ha presentato il suo libro Un paese non basta, dove cita la Fefa. I Donati infatti, suoi antenati materni, erano proprietari dell’edificio dove attualmente hanno sede il ristorante e la locanda. Fu il primo palazzo che un ebreo poté acquistare al di fuori del ghetto, ed era proprio Donato Donati, che adibì il pian terreno a banca e gestione del dazio sul fiume. Nel 1600 Finale era un paese importantissimo dal punto di vista commerciale, grazie all’ubicazione strategica sul Panaro ed alla caratteristica intraprendenza. Ospitava l’università ebraica, che significa cosmopolitismo. Questi piatti però non si mangiavano in casa tua. no, l’unico era il pasticcio di fegatini, grazie a una zia che aveva sposato un toscano. Gli altri li ho imparati presso la comunità ebraica di Modena: quando mi sono affacciata al mondo della ristorazione, mi è stato chiesto se avevo voglia di imparare e sono stata accolta 24 Direi che sono partita da un impulso archeologico. avevo notato che la cucina di Finale era molto agrodolce, contrariamente al circondario. Per constatarlo basta spostarsi a San Felice, e mi chiedevo il perché. Penso al lesso con la marmellata di pere williams o la salsa di mele campanine (non piccanti, perché la senape era riservata alla mostarda del giorno di Natale). Un’altra stranezza era l’utilizzo di spezie: mia mamma nel ragù di carne metteva sempre un chiodo di garofano, sostenendo che toglieva il sapore del maiale, ma sicuramente era un retaggio del passato. Volendo trasmettere la cucina tradizionale di Finale, ho quindi ritenuto importante studiare l’importanza della cucina ebraica. Ho voluto capire le cause del fenomeno e soprattutto conoscere le ricette di quelle famiglie. Per me è stata una grande soddisfazione quando Arrigo levi, che è venuto spesso a mangiare qua, mi ha detto che la mia torta degli ebrei è identica a quella che preparava sua nonna all’inizio del 900. Agnizioni di questo genere sono la mia vittoria. Il tema di Enologica quest’anno è la filiera. Ed è un tema per me fondamentale. Durante le Olimpiadi mi hanno intervistato su RAI 1 e mi sono qualificata come razdora. A telecamere spente ho spiegato ciò che intendo, che la razdora era la reggitrice della casa, colei che aveva sempre tenuto l’economia domestica. Faceva da mangiare bene con i prodotti che aveva, le sue galline, il suo orto. Ecco: io mi sento questo, cerco di fare da mangiare bene con i prodotti che reperisco a Finale e nei dintorni. Già come mamma ero attenta alla provenienza del cibo di mio figlio, al contrario di tanti genitori. Volevo trasmettergli il senso della filiera, la qualità dei prodotti locali per quanto riguarda le verdure, la frutta, ma anche le carni. Al ristorante per esempio uso solo filetto di razza romagnola e pretendo che sia una bestia nata e cresciuta in Italia. Perché è un bovino eccellente. Come i salumi: uso solo quelli prodotti in zona, come il salame di San Felice, o i salumi di mora romagnola di Zocca. Quanto ti aiuta in questo sforzo l’azienda agricola? Mi aiuta per certi prodotti, ad esempio le pere e le zucche. Ma ne utilizziamo talmente tante che a volte devo rifornirmi dalla signora Sabrina, anche perché cambiano le varietà: secondo i periodi ci sono la zucca delica (la mia preferita), la violina, la coccarda. I nostri tortelloni sono una via di mezzo tra quelli di Ferrara e di Mantova, perché il ripieno è composto da zucca, Parmigiano e pochissima noce moscata, in modo che siano abbastanza neutri da potersi abbinare tanto al ragù che a un condimento di burro, mandorle e amaretti sbriciolati. Come ti sei costruita le tue reti? Pian piano, anche per una questione di comodità. Perché è più semplice se hai qualcuno che ti porta il maiale da San Felice, la signora che alleva le faraone e i capponi, l’allevatore delle quaglie in zona, oppure il produttore di uova… l’agnello no, lo faccio arrivare 25 enologica edizione 2012 Cosa ti affascina in una cultura che non è la tua? Il cibo come strumento di identificazione collettiva? dall’Alpago perché è troppo buono. E faccio eccezione anche per il foie gras e i salumi kasher di Jolanda De Colò. Il chilometro zero però è sempre stata la mia idea. L’ho sempre sostenuto, anche quando mi prendevano per pazza perché andavo controcorrente, sembrava che bisognasse comprare francese per fare qualità. Mentre io nella mia carta dei vini non ho nemmeno uno Champagne o un altro vino francese. In questa zona abbiamo prodotti ottimi, che vanno promossi attivamente, come il Parmigiano, che compro al caseificio Quattro Madonne, a 18 chilometri da qui. Quando sono partita avevo anche la mia acetaia di Balsamico, ma me l’hanno rubata; così adesso mi rivolgo ad acetaie della zona. Le farine arrivano dal Molino Ariani, a San Felice, o dal Molino Pivetti di Renazzo. Come nocino utilizzo per la maggior parte quello della distilleria Casoni, al pari degli altri liquori locali, l’Alchermes e l’Anicione. Perché bisogna fare territorio, filiera, gruppo. pochissimo tempo e io non potevo cucinare né a casa né al ristorante. Quindi siamo stati in giro per tanto tempo. Abbiamo vissuto da sfollati, mangiando piadine, panini, pizze, anche perché non ci veniva voglia di niente . Dormivamo lontano, ma ogni mattina volevamo tornare davanti a casa per una sorta di magnetismo, come dicono gli psicologi. Per 40 giorni non mi sono neppure avvicinata al ristorante, ma andavo dietro alla barriera più vicina e poi restavo lì a guardare. Quando sono entrata era tutto andato a male, con i tavoli ancora apparecchiati per il matrimonio del mattino successivo, le stoviglie a pezzi e un nauseabondo odore di vino fermentato. L’ottanta per cento delle bottiglie era in frantumi. Una sospensione surreale. Quanto è a rischio questo tessuto virtuoso dopo il terremoto? Direi che gli anelli della catena sono tutti deboli. Nel senso che le aziende fortunate, che non hanno avuto problemi, soffrono di una contrazione dei consumi che deriva in parte dalla crisi economica, in parte dal fatto che tanti ristoranti hanno chiuso, per crolli o per la mancanza di clienti. Senza dimenticare la siccità che ha dato il colpo di grazia. Un’ultima domanda. La Fefa sta riaprendo: quanto ti è mancata la cucina in questi mesi? Tanto, e soprattutto mi sono mancati i miei sapori. Perché il gas-metano nella zona rossa è stato riallacciato da 26 Laura e Matteo Morandi “Da mihi ubi consistam terramque moveabo”. Suona come una promessa la piroetta della porta di Giusti. Sorta di trottola su cui si riflettono i banconi lindi dei formaggi e le plastiche architetture dei salumi nel via vai di via Farini. La promessa di un punto di appoggio in cui affondare i rebbi a far volare il territorio. L’ubi consistam di un’identità senza compromessi, che getta il cuore oltre gli ostacoli di una contemporaneità mitridatizzata dalla grande distribuzione e dall’HACCP, con lo spauracchio della globalizzazione sullo sfondo. Il merito va in gran parte alla famiglia Morandi, che si affaccenda alacremente dietro il bel bancone in marmo chiaro, tutelato dalle Belle arti al pari delle piastrelle d’epoca e della graniglia rossa sul pavimento. In prima fila mamma Laura, caparbia e orgogliosa, gastronoma e cuoca, chioccia di Cecilia, esperta di formaggi, e di Matteo, addetto alla bottiglieria, più una nidiata di nipotini che proiettano le loro ombre guizzanti sul futuro dell’istituzione gastronomica. Una microstoria famigliare innestata sulla galoppata plurisecolare di plotoni di salsicce e prosciutti, nelle cui fila pare quasi di scorgere le andruglie in assetto di guerra di François Rabelais e i lombi poderosi del Mastro Presciutto della Secchia Rapita. In sottofondo un immaginario pêché de vieillesse composto da Gioacchino Rossini in onore di quella salsiccia fina così speciale, da farsela recapitare in giro per l’Europa. La salsiccia fina di Giusti. Transitata nelle curve a gomito degli ultimi tre decenni di storia della nostra cucina, dai francesismi della nouvelle cuisine alla deetnicizzazione forzata, dalla lumpen avantgarde degli anni 0 alle miserie del midcult televisivo, la discendenza è quella della robusta “Linea Italia”, il movimento di Franco Colombani e Peppino Cantarelli che negli anni ’80 si oppose al mainstream brandendo le armi demodé delle tradizioni regionali e dei prodotti del territorio, sotto il motto insuperato “Mai seguire le mode”. Carsica, e per ciò stesso profonda e inestinguibile, purificata dagli inabissamenti come dalle repentine risalite. Finalmente sbucata sotto il cielo variabile de nostri anni poco sereni. Perché il locale è polifunzionale, e nei pochi passi che separano le sue diverse anime dipana una piccola filiera a sé stante, nel senso più puro di un ganglio vitale di uomini e saperi che disegna una trincea di resistenza. “Il lavoro principale resta quello della salumeria con gastronomia, che condivide la cucina con il ristorante. Mentre al piano superiore c’è il laboratorio della pasta fresca, che è rigorosamente impastata a mano e tirata al matterello da me o dalla mia collega sfoglina”, racconta Laura. Di qua e di là gli universi 27 enologica edizione 2012 Hosteria Giusti Vicolo Squallore, 46 41121 Modena Tel +39 059 222533 - www.hosteriagiusti.it del turismo internazionale, dell’agroalimentare di qualità, dell’artigianalità e della memoria, elasticamente raggomitolati fra gli spigoli aguzzi dei vicoli di Modena. nel tempo una clientela medioalta, da sempre all’avanguardia nella ricerca esasperata della qualità e della tradizione. Chi era Nano? Era semplicemente un ragazzino che aveva finito la terza media dai Salesiani di Modena, non aveva molta voglia di studiare ed era portato per le attività manuali. Aveva tre fratelli maggiori e col più grande c’erano vent’anni di differenza, quindi esisteva quasi un rapporto genitoriale; fu proprio lui a trovargli un lavoro come garzone di bottega dal signor Giuseppe, che avrebbe affiancato e osservato per decenni. Perché non si trattava di un semplice titolare, ma di qualcuno che si rapportava quotidianamente con i clienti dietro il banco, ed era un artista delle decorazioni, che preparava di persona svariati piatti della gastronomia. Considerato che era nato nel 1911, per i suoi tempi aveva una professionalità rara, perché le gastronomie solevano tenere i prodotti in esposizione molto spartanamente, mentre lui aveva il culto del bello. Aveva imparato in casa, ma amando il suo lavoro non aveva smesso di coltivarsi e di tenersi aggiornato. E mio marito raccontava che la salumeria era frequentata da tanti attori, perché Modena ha sempre avuto un teatro di prosa importante. Venivano Ugo Tognazzi piuttosto che Vittorio Gassman, che erano golosi di amaretti o di qualcos’altro. La vostra insegna, anch’essa tutelata dalle Belle Arti, reca scritto il nome di Giuseppe Giusti. Chi era? La salumeria è sempre stata nelle mani della famiglia Giusti. Fin dalla fondazione attestata nel 1605, che ne fa il più antico esercizio del genere in Europa, quindi nel mondo; ma già nel 1589 un tale Giovanni Francesco Ziusti veniva annoverato nella lista dei lardaruoli e Salsicciari, una sorta di Camera di Commercio del settore, cui si veniva iscritti solo in base a requisiti precisi, come un capitale cospicuo. Tutta la documentazione è conservata presso la Biblioteca Estense. Di mano in mano, passando per svariati giuseppe, era quindi pervenuta nelle mani dell’ultimo discendente, chiamato anch’egli Giuseppe Giusti, il quale non avendo figli né eredi interessati, nel 1980 decise di cedere il negozio privo di marchio a mio marito Adriano Morandi, detto Nano, che era stato suo garzone di bottega sin dai 16 anni. Tenne invece per sé l’acetaia, che era meno faticosa da gestire e sarebbe poi passata agli eredi della moglie. Essendo cresciuto con la cultura e la mentalità di giuseppe giusti, nonostante il cambio di gestione mio marito è stato in grado di raccogliere il testimone, garantendo la continuità così preziosa per un’azienda plurisecolare, che era stata fornitrice ufficiale della Real Casa, quando il Duca da Ferrara si era trasferito qui davanti, in quella che oggi è la sede dell’Accademia Militare. Quindi una salumeria di grande prestigio, che aveva fidelizzato Il locale si presentava in questo modo? Credo che gli arredi attuali siano stati acquisiti all’inizio del secolo scorso. Per passaparola so che la Banca Popolare di Modena aveva cambiato mobilio; il padre del signor Giuseppe, che si chiamava giuseppe anche lui, trovandolo 28 Un dinamismo che fa riflettere. E che abbiamo cercato di tesaurizzare. Perché non è semplice portare avanti un negozio del genere in una realtà come quella attuale, dopo l’avvento della grande distribuzione, che in Emilia non è certo marginale. Noi abbiamo scelto di specializzarci sempre più nella ricerca della qualità, ma senza vendere fumo. Perché c’è ancora chi lavora bene, per quanto diventi sempre più faticoso scovarlo. Ma forse è la sfida più bella di questo lavoro: mi emoziona ancora scoprire un piccolo macellaio dell’Alto Adige che fa i wurstel o i carrè affumicati con tutti i crismi. Allora decido di fare arrivare i wurstel e i carrè da lui perché so di fornire un prodotto che io stessa ho assaggiato. Senza smettere nel tempo di controllare che la qualità resti costante. Tu hai sempre fatto questo lavoro? no, vengo da una storia molto diversa. Nel senso che sono arrivata a questa professione come moglie di Nano Morandi. Quando l’ho conosciuto avevo 17 anni, lui faceva già il garzone mentre io studiavo da ragioniera. Mia madre faceva la casalinga, più qualche lavoro saltuario a casa, e mio padre aveva un’officina meccanica ad alta precisione. Finita la scuola ho lavorato per 8-9 anni alla De Tommaso automobili, nel settore amministrativo. Poi, restando all’interno della stessa azienda, sono stata trasferita all’amministrazione dell’Hotel Canal Grande e del ristorante Secchia Rapita, dove ho avuto i primi contatti con l’horeca. Mi sono sposata, sono nati i miei figli, Matteo e Cecilia, poi mi sono licenziata dalla De Tommaso e sono andata a lavorare in banca, dove gli orari mi consentivano di dedicare più tempo alla famiglia. Quando i figli sono cresciuti, però, ho avuto voglia di essere più presente, perché mio marito nel frattempo aveva acquistato la salumeria; così mi sono licenziata anche dalla banca per curare l’amministrazione, visto che il mio mestiere era quello, oltre che per dare una mano. Mi è sempre piaciuto cucinare e mio marito mi stimolava moltissimo. Come mangiavate in casa? In modo molto curato. Non siamo mai stati per le cose troppo ricercate, ma per la maniacalità dell’esecuzione sì. Mio marito diceva sempre: “Io non ho problemi, mi va benissimo anche un uovo al tegamino, ma deve essere fatto a regola d’arte”. Lui cucinava in gastronomia? Sì, preparava piatti come la galantina e il polpettone di tacchino; ed era bravissimo nell’allestimento. Faceva tutto a memoria perché non esistevano ricette scritte, sono stata io a codificarle. A casa però cucinavo solo io. Erano tempi in cui gli uomini difficilmente contribuivano 29 enologica edizione 2012 consono volle acquistarlo e aggiunse in superficie le lastre di marmo su cui lavoriamo tuttora. In una delle due vetrine bombate, che invece fanno parte dell’architettura originale del negozio, il padre aveva già ricavato un impianto per una vasca destinata a pesci vivi, che poi ho trovato in vendita da un rigattiere. E tuttora nella vetrina di sinistra uscendo dal negozio si vedono le piastrelle forate con i pezzi di tubo per il ricambio dell’acqua. Non era geniale, considerati i tempi? alle faccende domestiche. Poi un giorno mio marito ebbe l’idea di aprire un ristorante in quello che era il nostro magazzino di stagionatura dei prosciutti. Perché noi selezionavamo le cosce appena macellate a Parma, le marchiavamo con il nostro nome, a 24 mesi le portavamo a Modena e le facevamo stagionare per altri 4 o 5 mesi, visto che nessun produttore si sarebbe mai accollato il calo. Le appendevamo proprio qui e spuntavamo su un calendario i capi che prelevavamo. Questo fino al 1980 circa. Quando abbiamo rilevato la salumeria i consumi però stavano cominciando a calare, anche per l’avvento della grande distribuzione. Così abbiamo dovuto porci il problema di come rilanciare gli incassi, studiando il mercato. più spedito le confezioni di Natale. Ma noi avevamo fatto i debiti per comprare il negozio e non potevamo certo rinunciare alle strenne, a costo di lavorare la domenica. Così mio marito scrisse un’altra lettera a tutti i clienti, sulla medesima carta intestata, per annunciare il cambio di gestione e presentarsi. Piano piano di comune accordo abbiamo provato a inserire qualche prodotto e qualche specialità in più. Il vitel tonné e la salsa verde sono rimasti quelli originali, ma io ho cominciato a fare la salsa cotta e le cipolle al Balsamico. Tante ricette della tradizione di mia suocera azzurra, che ho ripescato dall’oblio. Ho reintrodotto anche il tortellino, ma con la ricetta di casa. Tanto che non lo spedisco nelle strenne perché non contiene conservanti. E abbiamo continuato a produrre la salsiccia: avevamo un tavolo in marmo dove impastavamo 2 o 3 volte la settimana. Cos’è cambiato? Che selezioniamo e compriamo i prosciutti esattamente come prima, ma siccome i consumi si sono enormemente ridotti, quel poco che prendiamo lo facciamo stagionare sulle arcate del negozio. Ricordo che quando venivo qui al sabato il signor Danilo, che era il primo socio di mio marito, affettava 3-4 prosciutti al giorno: significava che c’era la fila fuori. Mentre adesso un prosciutto dura fino a 3 o 4 giorni. Molte persone non afferrano più le differenze qualitative, perché la grande distribuzione ha sottratto cultura. Nel piccolo esercizio c’era uno scambio di opinioni fra il bottegaio e il cliente, tutta una formazione che è venuta a mancare. Un’attività così polifunzionale può sopravvivere ai tempi dell’HACCP? È molto complicato. Io ho dei libroni alti così e nei vari ambienti mi trovo a dover gestire orari diversi. Se una mattina faccio i dolci, per esempio, non posso fare il salato. E non posso certo lasciare raffreddare il polpettone di tacchino nel suo brodo, coprendolo e basta, come faceva il signor Giuseppe. Ovviamente lo abbatto, perché i batteri di una volta non erano quelli di oggi. Poi ho dovuto smettere di fare le salsicce. Perché volevano una stanzina di 20 metri quadrati piastrellata e col lavandino solo per quello, ma con la vendita non mi sarei mai ripagata l’investimento. Così abbiamo trovato un macellaio il cui condimento è Avete cambiato anche l’offerta della gastronomia? Sì, perché il signor Giuseppe negli ultimi tempi l’aveva diminuita notevolmente, aveva persino spedito una lettera in cui annunciava che non avrebbe 30 Un’altra attività che ha dinamizzato l’offerta è stato il ristorante, cui accennavi pocanzi. Sì, ma ricordo che quando nel 1989 mio marito mi comunicò la sua intenzione, mi misi quasi a piangere. Perché a me piaceva cucinare, ma l’idea di farlo in modo professionale con il cliente al tavolo mi angosciava. Io non ho mai fatto scuole di cucina, sono completamente autodidatta, a parte una settimana passata come ospite da Franco Colombani al Sole di Maleo, nel settembre del 1989. A quei tempi era uno dei migliori ristoranti d’Italia, lui era presidente mondiale dei sommelier, quindi c’era molto da imparare. Mi sono messa a guardare quel che faceva Silvana con gli altri cuochi, ma non avrei mai potuto copiare, perché io ho una cucina di 20 metri quadrati, loro in uno spazio così ci facevano i gelati; poi avevano un’impronta piuttosto lombarda. Più che altro studiavo l’aspetto logistico del lavoro di Silvana, come si organizzava, cosa preparava prima e cosa sul momento. Mentre mio marito era in cantina con Franco. Quando poi ho aperto, il primo giorno c’erano già 23 persone. Sono andata nel panico più totale. Perché all’inizio tutta Modena si è mossa, mentre adesso su 4 tavoli al massimo ce n’è uno di italiani. In città ancora si cucina, ed è normale che molte persone preferiscano mangiare i tortellini della nonna a casa loro. Com’era la divisione del lavoro con Nano? Io mi occupavo della cucina e della creatività dei piatti, lui provava a darmi qualche suggerimento. E le degustazioni le faceva tutte lui, perché aveva un palato sopraffino, anche se fumava. Poi era molto psicologo. Ricordo che ogni tanto mi diceva: “Questo piatto è buonissimo, ma per la psicologia dei modenesi non può andare”. E non sbagliava mai. Come si presentava il locale? C’era ancora la terra battuta, con lo scolo del sangue in mezzo e i ganci in alto per attaccare le mezzene, perché fino ai primi del ‘900 era stato un macello; ma già il signor Giuseppe aveva smesso di usarlo e lo aveva riconvertito alle stagionature. Per cui c’erano le inferriate con le zanzariere ma non gli infissi, perché i salumi dovevano respirare. Fortunatamente non era vincolato, quindi abbiamo potuto mettere il cotto sopra a una gettata di ghiaia e abbiamo scelto mobili consoni dai rigattieri. Quando avete aperto il ristorante con questa idea della tradizione, stavano succedendo tante cose nella cucina italiana. In un certo senso avete precorso i tempi. Può darsi, perché mio marito era un po’ psicologo. Ricordo che diceva: “Io non riesco a capire come mai in una città come Modena, dove si è sempre mangiato bene anche a casa, non ci possa essere un ristorante che offre un buon tortellino fatto a mano o un piatto di tagliatelle tirate al matterello”. Ma se i tavoli fossero stati più numerosi, probabilmente gli avrei detto 31 enologica edizione 2012 abbastanza simile al nostro e abbiamo rimediato. È un campo in cui la concorrenza sui prezzi è troppo forte, ma non sai mai la verità sugli ingredienti. Mentre mia figlia è cresciuta a salsiccia cruda e io ero tranquillissima. di no. La richiesta di aprire la sera, un giorno variabile la settimana, o per gruppi con menu fisso è arrivata dopo. È un piatto che ho attinto dal passaparola, perché i miei suoceri Azzurra e Renzo ricordavano spesso il mangiare di una volta. Poi ho ricostruito la ricetta secondo la mia logica. Le dimensioni ridotte servivano a non uscire dal paradigma della cucina di casa? Sembra un piatto di recupero del cotechino avanzato. Forse, ma più che altro si trattava di tenere sotto controllo la fatica. E l’allure cambia, perché è un’esperienza rara. A un certo punto volevamo addirittura creare un’unica tavolata dell’amicizia con un menu fisso, come in una sala da pranzo con tanti ospiti. È probabile. Un’altra ricetta che mi viene in mente è la panna cotta, che servo con un “minestrone” di verdure crude tagliate a brunoise e macerate in uno sciroppo. Ma ogni anno tiriamo fuori qualcosa di nuovo. Per esempio già 9 anni fa avevamo in carta il ganascino brasato, che adesso fanno tutti. Io stimo molto chi lavora in un certo modo, fa le destrutturazioni o usa l’azoto; ma dobbiamo avere ben chiaro da dove arriviamo. Bottura per esempio lo ammiro moltissimo, lo conosco da sempre e adoro alcuni dei suoi piatti perché ha saputo interpretare in modo nuovo la modenesità. La mia intenzione però è un’altra: voglio passare il testimone della cucina tradizionale emiliana, che poi magari verrà reinterpretata oppure cambiata. La mia soddisfazione più grande è parlare con i clienti ai tavoli. Quando mi dicono che sono stati bene, hanno ritrovato dei sapori della memoria, o magari ne hanno scoperti di nuovi. la pasta in questo senso è emblematica. In giro vedo ancora troppi ristoranti in cui non viene fatta a mano. Ma è un pezzo di tradizione al quale non possiamo rinunciare. Personalmente faccio la sfoglia tutte le mattine, dalle 20 alle 25 uova, tanto per la salumeria che per il ristorante. Il modello che va di moda adesso in giro per l’Europa. Può darsi, perché come ripeto sempre mio marito era psicologo. Ma non c’è stato tempo perché lui è mancato e Matteo, che non aveva esperienza, non si è sentito in grado di assumere quel ruolo. La dimestichezza con i clienti che aveva suo padre non poteva certo inventarsela da un giorno all’altro. Perché ci sarebbe stato bisogno di creare un’atmosfera particolare fra i commensali e mio marito in questo era impagabile. Aveva una genialità che rasentava la follia; metteva a suo agio persone che arrivavano da tutto il mondo e finivano per conversare da un tavolo all’altro. Un risultato che sarebbe stato impossibile ottenere su dimensioni maggiori. La vostra carta è cambiata in questi anni? Qual è la ricetta più “creativa”? Forse il cotechino cotto, impanato e fritto con lo zabaione, che in realtà si faceva già nel 1400, quando andava di moda il Marsala. Io l’ho reinterpretato preparando lo zabaione con il Lambrusco di Sorbara, che con la sua acidità spegne la dolcezza. Che rapporti intercorrono fra i due esercizi? Un’osmosi totale, perché io vendo un unico tipo di Parmigiano, che compro da un caseificio di Concordia, ed 32 Il ristorante dal canto suo ha influenzato la salumeria? Sì, qualche influsso c’è stato. nel senso che lavorando molto sul turismo, grazie a 4 secoli di storia, quando i clienti escono passano dal negozio per comprare qualcosa, lo strolghino piuttosto che il Balsamico. Il terremoto in tutto questo? Come accennavo, il mio Parmigiano viene da Concordia. E le mie uova da Cavezzo. Sono paesi che hanno perso la loro identità, insieme ai loro monumenti. Ma anche su di noi c’è stato qualche effetto, perché il turismo è calato. Il Duomo per esempio è stato inaccessibile fino a settembre. E i modenesi che potevano hanno lasciato la città, che si è svuotata. Sotto il profilo delle forniture invece non ci sono stati grossi problemi, gli stessi produttori si sono industriati e se non avevano abbastanza merce, ce l’hanno procurata altrove, garantendo una qualità costante. Devo dare loro atto di grande serietà e determinazione. Il mio produttore di Parmigiano per esempio aveva 60 capi di bestiame, ma non poteva mandare a mungere gli operai perché mancava l’ok della protezione civile. Quindi ogni mattina è andato dentro a suo rischio e pericolo. “Se non ci vado non mangio”, diceva. E la produzione è proseguita. Il terremoto però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una crisi che già c’era. Da noi forse è arrivata un po’ più tardi perché il target è elevato. Ma se il numero degli scontrini è rimasto più o meno invariato, l’importo è sceso. Più nella salumeria che al ristorante, dove ho inserito apposta la mezza porzione. C’è chi storce il naso, ma io sono aperta solo a pranzo e voglio dare ai clienti l’opportunità di assaggiare più cose senza appesantirsi. Il tema di Enologica quest’anno è la filiera. E direi che è il succo del nostro lavoro, tanto in salumeria che al ristorante. Sia nel senso stretto del rapporto con i fornitori che in quello lato di quanto si tramanda. Le frittelle di minestrone per esempio sono un piatto di recupero che preparo da 23 anni. Mia suocera quando aveva un avanzo di maltagliati con i fagioli lo faceva addensare in frigorifero, il giorno dopo aggiungeva un uovo, un cucchiaio di farina e un po’ di Parmigiano, così otteneva un impasto semiliquido e lo friggeva a cucchiaiate in una padella di ferro. Erano deliziose. Tanto che io e mio marito ogni tanto ci dicevamo: “Il giorno che ci stanchiamo apriamo un chiosco in piazza: frittelle di minestrone e Champagne”. Dalla nostra conversazione invece evinco che non sei un’adepta del chilometro 0. Perché è difficile da realizzare e rischia di essere una forzatura. Come il biologico, che andrebbe rivisto con disciplinari e controlli più stringenti. C’è capitato con un riso: pensavamo fosse biologico perché aveva la certificazione, ma dei clienti ci hanno raccontato che veniva coltivato vicino a un’arteria di grande scorrimento. Ed 33 enologica edizione 2012 è quello che uso in cucina: un 24 mesi, perché abbiamo provato anche le stagionature estreme, ma al mio palato suonano un po’ forzate. Stesso discorso per il prosciutto cotto delle rosette. I prodotti sono gli stessi, senza semilavorati. E la cucina con le sue attrezzature non cambia. Quindi i canali cambiano, siete flessibili. è anche questo il bello, che dall’altra parte del bancone possono capitare dei maniaci, gente che oltre al feed-back ci fornisce pure il suo sapere. Sì, e la gente si fida della nostra selezione. Sa che tutto ciò che è in vendita è stato assaggiato preventivamente da noi e che la qualità delle forniture continua a essere monitorata: io e i miei figli siamo un piccolo panel di degustatori, ciascuno con il suo palato. Poi ogni anno organizziamo alla Corte dei Melograni un evento che si chiama “la giornata degli artisti”, dove invitiamo i fornitori a portare in degustazione alla clientela i prodotti. È una specie di piccola fiera con tanti stand. I clienti che vogliono partecipare pagano 20 o 30 euro, secondo gli espositori, che bevano Lambrusco o Champagne. In questo modo alla fine della giornata con qualche chiacchierata tastiamo il polso al mercato. Se un prodotto che non abbiamo mai trattato ha riscosso un successo particolare, magari lo prendiamo. Entrando nella salumeria il visitatore è colpito dalle dimensioni raccolte di un esercizio così famoso, e poi dall’offerta. Che sembra frutto di un lavoro in profondità piuttosto che di una vocazione enciclopedica alla Peck. Sì, c’è un lavoro in profondità su pochi prodotti, perché Modena non è Milano. Mio marito era molto amico degli Stoppani, e quello era un tempio. Ma qui sarebbe stato fuori posto. Noi abbiamo cercato la nostra strada personale, con l’appoggio della città, che sente Giusti come un bene comune. Siamo rimasti fedeli all’impronta originale, ma abbiamo cercato di dinamizzarla. Lo stesso signor giusti era uno che spaziava, e questo aspetto rappresenta la sua eredità più preziosa. Ricordo che vendeva una qualità di Marsala che mandava a prendere in Sicilia, insomma selezionava ad ampio raggio, senza smettere di privilegiare l’Emilia. Noi abbiamo la selezione di oli italiani, in natale vendiamo moltissimi formaggi francesi, perché il bancone è stagionale. Per il fossa ci affidiamo a un selezionatore di Longiano con cui lavoriamo da tanto tempo; per altri formaggi ci riforniamo dagli affinatori. Mentre i Gorgonzola panna verde li affiniamo noi. Li prendiamo in forme intere e li teniamo in una cella frigorifera del 1600, con i muri spessi e gli impianti moderni. Perché noi nella salumeria, che è tutta vincolata, non abbiamo banchi frigo; a mezzogiorno dobbiamo spostare tutto nella stanzina refrigerata a fianco con i carrelli. 34 Giuliana Saragoni Ci hanno insegnato che le parche sono tre e reggono i destini del mondo. Cloto che fila via la vita, Lachesi che ne stabilisce la durata, Atropo che inesorabile recide. Ma al Gambero Rosso di Bagno di Romagna, celebre trattoria ispirata a Collodi, sembra essere di casa un’altra Diva. Che riannoda i fili spenti con mosse di tombolo e polpastrelli agili sul telaio colorato della vita. giuliana Saragoni è tutto questo, dietro le striature del suo ombretto rosa, sulla divisa gli schizzi sgargianti di una vitalità dolcissima. Qualcuno potrebbe chiamarla autodidatta, ma è allieva di una rigorosa scuola al femminile. Dove il tirocinio dura tutta la vita, il master scatta ogni domenica e il diploma è scolpito nelle pieghe delle mani. ad accordarla sul la della tradizione è stato il diapason di mamma Diva. Una forcella assoluta nelle matasse interminabili dei tagliolini. Proust la chiamava “estasi metacronica”, l’ebbrezza della vittoria sul tempo regalata da un tozzo di pane tostato nel tè, che passando da Contre Sainte-Beuve alla Recherche si trasforma in madeleine senza perdere succosità lisergica. E Freud la indagò da par suo quale molla della creazione artistica, nella quale due esperienze, la presente e la passata, sono cucite insieme dalla penna o dal pennello; oggi anche dal mestolo di una cucina. Ma riesumare i sapori dell’infanzia è una sfida complicata. Perché il ricordo ha natura diversa dalle cose, il sogno fa danzare altre molecole spezzando le orbite dell’abitudine. Il cosiddetto “alleggerimento” diventa la sfida della rarefazione, il trampolino dello scarto, l’onirizzazione. Una cucina di testa che passa dal cuore, attivando i file della memoria al pari di un hacker delle emozioni. Sarebbe sbagliato pensare a un mero conservatorismo, quando è in atto questa rinascita costante. La cui protagonista è la stessa madre che gonfia il pane e regola le turbolenze dell’aceto. Enzimi di una tradizione organica che ribolle, freme e monta la contemporaneità secondo un canovaccio millenario. Prendiamo le erbe di campo, ingrediente feticcio e filo verde di cucina. Che si tratti della dadolata di pasta imperiale nella zuppa, della fonduta vellutata sul tortino o dell’omelette che farcisce il coniglio disossato, Giuliana fa loro impalmare in matrimoni interclassisti ingredienti nobili e grassi, quale veicolo aromatico che sancisce il loro riscatto. Con un approccio che risulta quasi algebrico nella sua pulsione minimalista. Come se la povertà della storia e dell’ingrediente inestimabile, senza prezzo nella vitalità che sporca crepe e rovi, recitasse fino in fondo la sua lezione estetica. Un’aurea brevitas contro l’inopia della globalizzazione. accanto a giuliana e al 35 enologica edizione 2012 Locanda al Gambero Rosso Via Giuseppe Verdi, 5 47021 Bagno di Romagna Forlì-Cesena Tel +39 0543 903405 - www.locandagamberorosso.it ha scritto che la cucina deve avere il sapore della terra da cui origina. Ma nessun ingrediente contiene più territorio di loro”. marito Moreno, la compagine famigliare annovera la figlia Michela, che ha chiuso nel cassetto la sua laurea per un diploma da sommelier professionista e lo scettro della sala; il genero Paolo Berardi, talent scout che nel fine settimana parte in cerca di eccellenze e maestro d’aceto insieme al papà Marco; nonché Maria Chiara, nipotina d’arte che armeggia con mattarellini e mazzetti d’erbe e fiori commestibili. Oltre alla figlioccia acquisita Alina, medico ucraino che interpreta come nessun altro il genius loci, forse in virtù di radici contadine che solcano i continenti sotto il manto castano della terra. Moreno raccoglie le erbe due volte alla settimana in posti che solo lui conosce, un po’ come i cercatori di tartufi e i fungaioli. E mentre sta chino sul ciglio della strada, può capitargli di scorgere con la coda dell’occhio un daino, oppure un capriolo mezzo sbranato dai lupi. Veste inoltre i panni dell’anfitrione con la clientela: “Entro in campo solo se c’è curiosità. Perché i nostri piatti possono sembrare un po’ strani, ma hanno dietro una storia e un’introduzione non guasta. A patto di non salire mai in cattedra o risultare invasivi. Poi c’è la ricerca dei prodotti sul territorio: l’ho iniziata io, in seguito è arrivato Paolo, che ha un suo lavoro ma è appassionato di cucina, tanto che è stato fiduciario Slow Food. È nato a San Mauro Pascoli, ma quando ha iniziato a frequentare questa zona, ha subito notato che c’erano parecchi giacimenti gastronomici. Noi del territorio abbiamo sempre fatto una bandiera, estremizzata se vuoi, perché fin dall’inizio abbiamo puntato su ingredienti e sapori inusuali, come le erbe spontanee. Tonino Guerra Come ha imparato a riconoscerle? M. Nell’infanzia, e sono cose che si sono risvegliate dentro di me grazie a Giuliana. Mi sono ritrovato bambino, quando raccoglievo le erbe che servivano per determinati piatti. Perché io sono nato a Bagno di Romagna, Giuliana a San Piero in Bagno e in casa mangiavamo più o meno le stesse cose. Mia nonna Palmira mi portava con sé nel campo vicino a casa, perché voleva tenermi sotto controllo. E io ero costretto malvolentieri ad aiutarla, ma col tempo mi ero anche appassionato. Era bello riconoscere ogni tipo di erba, sapere subito da lei che virtù medicamentose avesse… Poi tornando a casa lei faceva la sua mitica zuppa di erbe di campo. Per prima cosa le sceglieva in modo da ottenere un mix ben calibrato. Perché ogni varietà aveva le sue particolarità: era una specie di medicina popolare. Ricordo che imbottigliava una parte dell’acqua di cottura per bersela come tisana. Ebbene dopo decenni di oblio ho avuto l’opportunità di rivivere queste cose, che erano state negate da tutti. Tanto che quando ho ripreso questa pratica, mi vergognavo di farmi vedere e raccoglievo quasi di nascosto. Mentre oggi porto la mia nipotina Maria Chiara con me e le trasmetto il mio sapere. Sono piatti che avete sempre proposto? M. Sì, fin dagli esordi. Ma non era facile; in un contesto in cui la gente voleva funghi, tartufi e grigliate miste in abbondanza, sembrava che volessimo riportarla a un passato di miseria. Ai 36 G. Spesso davamo questi piatti gratuitamente, come stuzzichini, tanto per farli assaggiare. Il contrario della grande porzione che richiedeva il cliente medio. M. Cosicché magari alla fine la gente tornava e chiedeva se c’era ancora quell’assaggio, ma ne trovava uno diverso e lo provava. In questo modo pian pianino siamo riusciti a cambiare la percezione del passato, a riscattarlo. Perché venivamo da secoli in cui la gente si era interrogata su come fare da mangiare. Questa riflessione collettiva aveva fatto sì che certe innovazioni riuscite, come la nostra zuppa o la minestra di castagne coi fagioli, potessero stare alla pari con le creazioni dei grandi cuochi. Un’autentica miniera, ogni stagione con le sue peculiarità. Diva che ne pensava? G. Mi diceva che ero matta. “Ma tu devi farli mangiare. Vanno via con la fame, torna a fare come prima”. Perché i primi tempi alle 9 di sera io avrei potuto chiudere, tanto non arrivava più nessuno. Ma io aspettavo le 10 perché non se ne accorgessero i paesani. M. Sono sincero, anche io ho provato a dissuaderla, perché era uno stravolgimento totale. “Ci facciamo ridere dietro”, le dicevo. Giuliana però era molto determinata, non c’era modo di farle cambiare opinione. G. Perché ero partita con un progetto ben determinato. Volevo ripartire dai piatti che si mangiavano nelle case, dalla cosiddetta endocucina. E volevo fare assolutamente di testa mia. Anche se questo significava rompere con la ristorazione che si era affermata nella zona, compresa l’impostazione del locale di famiglia. Per un po’ di tempo ci siamo sentiti derisi. I clienti dei miei genitori non venivano più perché la mia proposta era diversa. E la gente del posto non capiva: “Ma questa qua cosa si crede di fare? Di fare risentire i sapori della sua infanzia?”. In questa operazione mia madre mi ha aiutato tantissimo, fino all’ultimo è stata lei a insegnarmi. Ma noi siamo andati anche a sentire altri anziani, era Moreno a intervistarli. Inoltre avevamo un’amica che insegnava alle elementari; fece sì che i bambini intervistassero i genitori e i nonni, procacciando altre ricette. Un lavoro quasi antropologico. In seguito che tipo di clienti è subentrato? M. Quelli che nel frattempo incominciavano a interessarsi di queste cose. Nonostante sia un fenomeno quasi concomitante, dobbiamo ringraziare Slow Food, che 37 enologica edizione 2012 tavoli per fare assaggiare la zuppa di erbe di campo occorreva fare un’opera di proselitismo. Mentre è un capolavoro che non lascerà mai la nostra carta. Bisogna considerare che fra il 1951, quando Cecco e Diva, i genitori di Giuliana, avevano fondato la trattoria, e il 1992, quando l’abbiamo rilevata noi, la cucina italiana era stata rovesciata come un calzino, dalla nouvelle cuisine, dal femminismo, dai traffici e dagli scambi di idee. I piatti della domenica erano diventati piatti quotidiani, deritualizzati, nel probabile tentativo di rimuovere una fame atavica. Mentre noi andavamo controcorrente, volevamo enucleare la sapienza delle specialità povere, l’ingegno di chi aveva saputo arrabattarsi con poco. abbiamo conosciuto nel 1996. Perché siamo figli della stessa temperie. Era l’aria che tirava. sua grande capacità. La passatina di ceci con gamberi è un esempio che si è ritrovato con una certa frequenza in molti ristoranti. Bella forza! Non compivate nessuna operazione su queste ricette? M. Sì, soprattutto di alleggerimento. Perché nella nostra società non prevalgono più il lavoro manuale e la fatica, quindi non c’è più la necessità di abbondare in grassi e alcol come carburante. Ma non ci siamo mai cimentati con le rivisitazioni, che non fanno parte del nostro approccio. Noi viviamo accanto a Paolo Teverini, un formidabile promotore del nostro territorio. assaggiate da lui, certe cose ci piacciono. Ma che senso avrebbero nel nostro contesto? E la separazione delle cotture? Le nuove tecnologie? In carta non ci sono piatti creativi? Con che grasso cucinate? M. Abbiamo sperimentato tecniche come il sottovuoto e le basse temperature con un ragazzo transitato per fornelli importanti. Perché è sempre giusto imparare. Ma se la succulenza, la testura e l’estetica ne traevano vantaggio, il gusto dei piatti non era più lo stesso, e i clienti se ne accorgevano. Quindi abbiamo calato il coperchio e siamo tornati a padelle e casseruole. G. Noi siamo passati quasi ovunque all’extravergine, ma un tempo dominava lo strutto, che noi adoperiamo saltuariamente. Per esempio nel basotto, il piatto più tipico di qui. Si tratta di tagliolini fatti in casa e cotti in brodo. Un tempo si preparavano quando si ammazzava il maiale, usando tagli grassi come la coda, che rendevano il brodo bello pesante, mentre io lo faccio molto più leggero, senza suino. Seguiva una cottura sul camino, con le braci sopra e sotto, mentre adesso si usa il forno. Lo strutto lo spalmo a velo sul fondo della teglia, per dare più sapore e reintrodurre in qualche modo il maiale. Poi ho sostituito il Parmigiano al pecorino. Insomma è più gentile. M. Sì. Per esempio i cappelletti all’uso di Romagna rivisti da giuliana, il cui ripieno è composto di ricotta e fiori di sambuco. Delicatissimo. Certo non è un piatto tradizionale, ma il cappelletto è tradizione e il fiore di sambuco immerso nella pastella e fritto da queste parti si è sempre usato. Quindi la Giuliana si è detta: perché non racchiudere i fiori nella pasta, anziché friggerli? La stessa operazione dei tortelli con ripieno di ricotta e fiori di acacia. Poi ci sono altri piatti, che sono leggermente rivisti. Cambiando un ingrediente, per esempio. C’è qualche furbetto in zona che ha già cominciato a copiarli, facendoli sembrare farina del suo sacco. Ecco una cosa che ci dispiace: i copiatori. Mia moglie ne parlava tempo addietro, quando ancora esercitava a San Vincenzo, con Fulvio Pierangelini, il quale si lamentava del fatto che colleghi senza scrupolo si impadronissero delle sue invenzioni, frutto di una ricerca approfondita e della M. È il piatto che identifica questa zona, perché è rimasto in uso solo qui, anche se probabilmente è nato in Romagna: l’ho ritrovato nei vecchi ricettari romagnoli sotto il nome di “bassotti”. Sono arrivato alla conclusione che fosse un piatto di recupero dei tagliolini in brodo avanzati. 38 Eppure lo stereotipo è quello. M. La cucina è un’espressione delle condizioni sociali di una comunità, lo hanno detto in tanti. Ma chi è che una volta poteva permettersi di mangiare certe cose, anziché venderle? Questa zona fino agli anni ’60 è stata classificata “depressa” perché era molto povera. Quando molte persone che non potevano permettersi il superfluo, ne hanno avuto la possibilità, hanno ritenuto che la cucina vera fosse quella. Ma secondo noi è un falso. Crediamo che la cucina vera sia quella basilare che siamo andati a recuperare. Ricordo che del tartufo mio nonno diceva “un sfama”. Perché i contadini non mangiavano tartufo. Mio nonno lo raccoglieva ma per venderlo, in modo magari da comprarsi l’olio. Ma da bambino non ricordo di averne mai mangiato. La prima volta fu nel ’58, quando era incipiente il boom, il capofamiglia dei nostri vicini, che era autista di camion, si era messo in proprio e aveva cominciato a guadagnare. Per mostrare il suo nuovo status una sera ci invitò a mangiare il tartufo. Me ne fece sentire una pallina e io, che non sapevo cosa fosse, la mangiai tutta intera, anche se non mi piaceva neanche molto. Lui si mise a ridere. A distanza di anni ho capito che il tartufo era il sogno proibito, se te lo potevi permettere significava che eri cresciuto socialmente e lo dovevi ostentare. Per questo se ne metteva così tanto, e anche Diva cominciò a cucinarlo, perché glielo chiedevano in tanti. In generale nacque quella falsa cucina che non aveva nulla a che fare con la storia dei luoghi. Era pura ostentazione del benessere. Mentre le erbe di campo non valevano più niente perché non costavano nulla ed erano in tutti i fossi. Quindi il vostro è un territorio più umano che naturale, emancipato dai suoi stessi giacimenti gastronomici. I tartufi, i funghi, la selvaggina. M. Sì, ed è un territorio frainteso, perché gli stranieri ci chiedono l’Aceto Balsamico, lo squacquerone, la piadina… Prima parlavi di selvaggina. Qui ce n’è tantissima anche perché con la caccia selettiva, se fai richiesta, puoi cucinare gli esemplari abbattuti. Eppure è pieno di locali che servono polpa congelata dell’Europa dell’est. 39 enologica edizione 2012 Perché un tempo si cucinava in abbondanza, ma la pasta avanzata, qualora cotta nuovamente in pentola, avrebbe perso qualsiasi consistenza. Mentre in questo modo, stesa in una teglia su un letto di strutto e pangrattato, con pochissimo brodo e una spolverata di formaggio, in superficie diventa croccante e sotto resta bella morbida, quasi sfogliata: cos’è la doppia consistenza, di cui tanti cuochi si riempiono la bocca, se non questa? Eppure è un piatto che appartiene alla vecchia cucina. Di festa perché all’uovo, ma pur sempre di recupero. Non faccio fatica a figurarmi la situazione. Quando si uccideva il maiale, un vero rito agricolo, la massaia si trovava in casa gente estranea, come il norcino e le altre persone specializzate, e non potendo fare cose banali serviva i tagliolini nel brodo delle ossa. Il basotto vero e proprio, mi è stato raccontato, è la ricottura nei giorni successivi, che nel tempo è diventata usuale. Ed è questa la tipicità per noi. Non certo le tagliatelle ai funghi o ai tartufi. Come ingrediente comunque non sarebbe nelle nostre corde, forse perché era il cibo dei signori, non certo un alimento popolare. Quando è il momento preferiamo l’agnello locale, che usiamo in interezza. Servito anche in umido secondo le ricette di mio suocero, che in materia era eccezionale perché aveva imparato da un altro ristoratore del paese. Ricordo ancora certe fricassee, o i pomodori spaccati sulla griglia… Ma il massimo lo dava quando cucinava per sé. Prendeva un po’ di brodo, ci metteva un po’ di pane e poi mangiava con noi. Era così appetitoso che doveva tornare a prepararlo per tutti. In quei momenti tendeva a ripescare un modo di mangiare all’antica, e Giuliana forse ha capito un’intenzione recondita e l’ha pubblicizzata. territorio allargato, che rappresenta un po’ una koinè. Per quello che possiamo, cerchiamo di supportare chi cerca di tornare ai prodotti di un tempo, gli artigiani volenterosi che reimpiantano le varietà tradizionali, chi opta per il biologico contro l’agricoltura intensiva. È importante anche in termini di sostenibilità. Perché la prossimità, il sostenibile erano la vita quotidiana di chi un tempo mangiava la zuppa di erbe di campo. Ci piace pensare di tornare alle origini con le cognizioni attuali, anziché comprare tutto dove costa meno, al costo di inquinare e distruggere i distretti alimentari secondo la logica del mercato. Parlando con voi le erbe spontanee spuntano sempre fuori, un po’ come nei campi. Quest’anno il tema di Enologica è la filiera. Come ci lavorate sopra? M. Sono alle origini degli ortaggi, perché il radicchio deriva dalla cicoria selvatica. Se le usiamo, è anche per fare capire alla gente che siamo partiti da lì. E non c’è km 0 più radicale di quello. M. Premetto che il nostro territorio, l’alta Valle del Savio, è un po’ speciale, situata com’è al crocevia fra Romagna, Toscana e Marche. Tanto che fino al 1923, quando Mussolini ci ha annesso alla Romagna, siamo stati provincia di Firenze. Questo comporta una certa elasticità, nel senso che possiamo dirigere la nostra filiera in diverse direzioni, pescando sempre il meglio. La cinta senese come la mora romagnola, la chianina o la romagnola. L’influenza toscana però resta dominante, perché i vini per esempio arrivavano dal Chianti e fra noi c’è un lessico famigliare anche in cucina. Per quanto riguarda le verdure, ogni tanto dobbiamo attingere al mercato della Romagna, perché ci sono pochi ortaggi; oppure approvvigionarci presso un’azienda biologica di Anghiari. Quindi a volte possiamo sconfinare, ma sempre all’interno di questo Queste erbe però hanno un gusto amaro, talvolta anche tannico, ferroso. Insomma sono amare due volte, perché ricordano la povertà, che va rimossa, e al palato. M. È vero, ma quando mia nonna cucinava la sua famosa zuppa, per prima cosa preparava una “cuvée” ben bilanciata, per esempio la cicoria selvatica e il tarassaco per l’amaro; le rosole, l’aspraggine e il crespigno, che da noi si chiama cicerbita, per addolcire. A me da piccolo non piaceva. Ma lei mi diceva: “Mangiala che fa bene”. E dietro quelle parole c’era un significato importante, distillato dall’esperienza nei secoli, magari a costo di qualche morto. La preparava 40 Nelle altre stagioni non si può preparare? M. Sì, ma in primavera è al suo massimo. Poi alla fine dell’estate, se inizia a piovere, per i radicchi scatta una seconda primavera. Nei campi dove vado io, a un certo punto fanno il fieno e non trovo più niente. Ma poi le erbe ricrescono. Questo modo di approvvigionarvi basta a definire il vostro stile di cucina? M. Direi di sì. Ci consideriamo una trattoria perché la nostra cucina nasce dal territorio e dai suoi prodotti. Spesso questa tipologia viene associata a una cucina minore, raffazzonata. Invece va interpretata come il tempio della cucina del posto, di contro al ristorante che è nato in albergo, quindi ha un’impronta internazionale. Noi cerchiamo di dimostrare che si può fare una grande cucina di trattoria con materie prime scelte e cotture giuste, compresi i prodotti bistrattati. La nostra neonata associazione delle Premiate Trattorie Italiane, che per il momento coinvolge cinque “Trattorie con la T maiuscola”sparse nel centronord, intende perseguire esattamente questo scopo. La vostra è anche una cucina prettamente femminile. M. Il primo a enfatizzarlo è stato Gianni Mura, con un pezzo sulla cucina delle donne: che soddisfazione è stata! Giuliana si definisce una cuoca domestica, ma per me assomiglia piuttosto a una massaia, che fa da mangiare per la famiglia, fra le altre cose. Perché la cuoca è connotata nel senso della professionalità. Per esempio pesa gli ingredienti, mentre Giuliana non misura niente, ha imparato da sua madre che faceva così. Adesso la chiamano spesso a fare la parte del contraltare alla cucina dei grandi autori, di solito maschi. Per esempio al salone del lusso di Verona con Pierangelini, Romito e lopriore ha servito quasi una provocazione: al posto di ostriche e culatelli, la polenta dolce di castagne con il maiale. Pierangelini l’ha ripresa tre volte. Oppure Marchesi alla serata dei 3 gamberi a Milano: anche lì un bis di zuppa di erbe. G. Poi la cuoca domestica non butta via niente, usa tutto. Comprese le foglie del sedano e le coste esterne più dure. Mia madre le faceva in umido e anche io a volte le servo con la carne. la gente non le riconosce e mi chiede: “Ma cos’è questa cosa buonissima?” Che ricordi avete di Diva in cucina? G. Mia madre aveva i suoi sapori… quelli che io cerco tuttora di proporre. E la presentazione del piatto era ricercata, combinava le verdure, i diversi colori. Inoltre era dolcissima, e anch’io in cucina non urlo mai. Se sbagliavo qualcosa me lo diceva sempre nel modo giusto. È stata una gran lavoratrice fino all’ultimo. Inarrestabile. La mattina, quando io arrivavo in cucina, aveva già pronta la sua “mise-en-place”. 41 enologica edizione 2012 soprattutto in primavera: dopo l’alimentazione invernale, composta di prodotti stagionati, formaggi, salumi, castagne secche, era il momento della freschezza e della depurazione. M. Era sempre presente: dal ’51 fino alla morte non si è mai spostata da qui. L’abbiamo portata una volta al mare e non è arrivata neanche in spiaggia. “Andiamo via, andiamo via, tira troppo vento”. Perché non lo aveva mai visto. Era una persona di una certa cultura, che leggeva, si confrontava con i clienti e gli ospiti dell’albergo, ma il suo mondo era questo. Come Giuliana, somigliava a un pittore naïf. Seguiva l’istinto, senza avere mai fatto scuole. E neanche giuliana le ha mai frequentate, in modo da restare all’interno dei saperi del territorio e non disperdersi. con me a Forlì ma loro non volevano venire. Così ho preso in gestione il Gambero, più che altro per ragioni affettive. Dopo 3 anni “in prova”, ho deciso di ristrutturare perché non ce la facevo più a stare in quell’ambiente. Perché, com’era prima? M. Uno di quei locali datati come se ne vedono in giro. Interamente rivestito da un finto pralinato in plastica di cui mio suocero andava molto fiero. Perché aveva fatto tutto lui, che era muratore, con un concetto di demolizione più che di recupero. Via il vecchio e su il nuovo, un po’ come in cucina. Giuliana ha voluto recuperare lo spirito originale del luogo. Abbiamo rimesso le travi e il cotto. E questi decori che vedi sulle pareti li ha fatti un signore del paese. Si chiamava Cecco, come il padre di Giuliana, abitava in un appartamento qui sopra e aveva fatto il decoratore a Firenze, nei palazzi signorili. Un’altra testimonianza dei saperi del territorio: non abbiamo importato qualcosa da fuori, ma ripristinato un pezzo di esperienza comune. Come compiva i suoi acquisti? G. Comprava molte cose dai contadini che avevano gli orti qui intorno: alcuni venivano la domenica a mangiare, altri li pagava. Mentre gli animali da cortile, i formaggi e le uova li acquistava. Il mercoledì c’era il mercato, molti venivano a bere un bicchiere di vino e nel frattempo portavano la roba. Qui di fronte a Palazzo Pesarini, dove oggi ha sede la Comunità Montana, vivevano tre fratelli celibi cui facevamo da mangiare, passando per l’entrata del personale. Ricordo che il mercoledì c’era la fila dei contadini che portavano la gallina, il coniglio, perché avevano tanti poderi. G. Me lo ricordavo da quando ero piccola e faceva le prove sui muri della sua abitazione. Quando andavo a giocare con sua figlia, vedevo i suoi disegni. Così, alla bella età di ottantadue anni, gli ho chiesto di decorare ogni stanza con una fantasia diversa. Mi ha decorato anche i sottopiatti, ma non li uso più. Perché, lavandoli, si è rovinato lo smalto e la gente pensa siano sporchi. Giuliana, la tua storia in tutto questo. G. Diciamo che al ristorante ho sempre aiutato e mi è sempre piaciuto. Ma qui le scuole non c’erano, così ho preso il diploma a Forlì, vivendo in collegio, poi sono andata a lavorare fuori. Sono stata prima maestra d’asilo poi impiegata, fino al ’92; ma continuavo a fare tante cene e tornavo ad aiutare nel fine settimana. Avevo 43 anni quando ho deciso di cambiare vita. Papà aveva dei problemi, io volevo portare lui e mamma E tutti questi oggetti? Le pendole, le sedie, i ricami? G. Sono stata io a sceglierli. Quando insegnavo a Selvapiana, siccome mi piacevano molto le cose antiche, cercavo di ottenerle 42 Il contesto cominciava a non essere propizio. M. Sì, la crisi era agli albori. E chissà come finirà. Non vorrei che a finirne vittima fosse proprio la filiera. Perché se la ristorazione entra in sofferenza, il rischio è che vengano contagiati gli altri anelli. Che agli artigiani manchi il mercato e la ricerca qualitativa perda slancio. Che contributo può dare la cucina in questo contesto? M. Credo che una cucina povera come la nostra abbia molto da insegnare. Perché significa sostenibilità, semplicità, sapienza popolare. Oltre a calmierare il food cost, nel quale pure bisogna includere i costi della mano d’opera. Purtroppo negli ultimi anni alcuni ristoratori della zona hanno “annusato” il vento e si sono messi sulle nostre tracce, convertendosi alla cucina di territorio e mantenendo, ad esempio, la pizzeria. Ecco una cosa dispiace: svilire una peculiarità per puri scopi di mercato. Non mi sembra giusto, ma per fortuna c’è anche qualcun altro che, capita la lezione, interpreta il tema seriamente e contribuisce all’impresa di Giuliana. Questo va detto per renderle merito e per riconoscerle, come dico io, la “primogenitura”. a proposito della crisi e della povertà, devo ricordare anche che io ho studiato all’Istituto Tecnico per Geometri a Forlì e fra i miei professori c’era Piero Camporesi. A volte accennava ai suoi studi paralleli, ma imbattendomi nell’edizione dell’artusi che porta il suo nome, non ho certo collegato le due cose: “Questo nome l’ho già sentito, sarà un omonimo”, mi sono detto. E mi si è aperto un mondo. Tanto che nel menu ho voluto fargli omaggio con una citazione discreta. Recita: “La povertà crea, l’abbondanza appiattisce”. Per troppo tempo abbiamo vissuto uno stravolgimento continuo: è venuto il momento di tornare indietro a recuperare ciò che abbiamo abbandonato. Che piatto porterete a Enologica? M. Prima ti ho raccontato che il nostro è un territorio bastardo, né romagnolo né toscano. Ebbene Giuliana farà lo spezzatino di maiale con le mele, un piatto del Casentino che si faceva anche qui, sebbene la carne con la frutta non rientri più nelle nostre abitudini. Le meline le colgo io sui vecchi alberi che restano nei poderi abbandonati. Magari accanto al sambuco, che fungeva da antiparassitario. I frutti più brutti, piccoli oppure bacati non finivano certo in tavola, ma nella mangiatoia dei maiali. Quindi il cerchio si chiudeva, il maiale tornava in tavola con il suo cibo. Di che maiale si tratta? M. Fino a poco tempo fa usavamo la mora romagnola, ma quando le mode si affermano spesso i prodotti soffrono un po’. La cinta senese nel Casentino non c’è mai stata. Per cui adesso usiamo il maiale grigio del Casentino, che è un incrocio fra mora romagnola oppure 43 enologica edizione 2012 facendo degli scambi. “Ma lei non vorrà mica questa cassapanca, signorina? Se proprio la vuole in cambio mi porti un mobile nuovo”. E con Moreno, che ai tempi aveva una 500, provvedevamo. I ricami delle applique e le tendine invece li abbiamo fatti io e mia madre. Poi nel 2006 abbiamo ristrutturato anche le camere. Radicalmente, perché andavano risanate. E il vino? cinta senese e maiale rosa. Con noi a Faenza ci sarà anche il produttore di Caprese Michelangelo, Bigiarini gianpaolo, dell’azienda agricola “Terra di Michelangelo”. M. Sebbene in zona il vino di riferimento sia ancora quello toscano (attirano molto i Brunelli o i Rossi di Montalcino, mentre un tempo prevalevano i Chianti aretini), la nostra carta è prevalentemente romagnola: come vedi, attingiamo ciò che più ci piace in qualsivoglia direzione. È un campo in cui dobbiamo molto a nostro genero Paolo Berardi. Girando come fiduciario, si è imbattuto nei produttori bio che poi si sono consorziati a Brisighella. Fanno bottiglie che sentiamo molto bene sui nostri piatti, perché ricordano i vini di una volta, i vini del contadino. Nel sapore come nelle tecniche di produzione, perché come mia nonna riconosceva le erbe, loro sono tornati alla sapienza delle fasi lunari. G. È una carne favolosa, perché l’animale cresce in libertà e ha i sapori e i profumi di ciò che mangia. Io utilizzo un po’ tutti i tagli: in carta ho lo spiedino, lo spezzatino e la lombatina; più la spalla per questa ricetta, con le meline acidule e semiselvatiche, che sono deliziose. “Sognare è possibile.” Culatello di Zibello 44 Elio, Samuele, Sauro e Sara Bison “Pas de grande poésie non plus sans de grands intervales de détente et de lenteur. Pas des grands poèmes sans silence. L’eau est aussi un modèle de calme et de silence. L’eau dormante est silencieuse, mais dans des paysages de lacs de champs. Près d’elle la gravité poétique s’approfondit. L’eau vit comme un grand silence materialisé. C’est auprès de la fontaine de Mélisande que Pelléas murmure. Il y a toujours un silence extraordinaire, on entendrait dormir l’eau. Il semble que pour bien comprendre le silence, notre âme ait besoin de voir quelque chose qui se taise. Pour bien être sure du repos, elle a besoin de sentir près d’elle un grand être naturel qui dorme.” Gaston Bachelard, L’eau et les rêves L’anguilla e la Zanzara: sembrerebbe un apologo di Esopo. Invece è una fiaba tutta da mangiare ambientata a Codigoro. In una casetta rosa sospesa sulla vita, ai due lati le porte sul panta rei dei lavorieri, di bora e di levante, dove un tempo si pescavano le anguille. Occhi sbarrati su una storia secolare, lunga e scivolosa come il pesce sirena. “Sott’acqua ci sono delle spine in legno. D’autunno ci si faceva scorrere attraverso un po’ di mare per attirare i pesci, che avvertivano il richiamo della riproduzione e venivano catturati con le reti”, ricorda Elio Bison, pater familias e carismatico patron del ristorante. Maestro di un fuoco che con l’eau dormante, lourde, morte lotta e frigge ogni giorno sulle braci. “On ne se guérit jamais d’avoir rêvé la nuit près d’une eau dormante”. In questa Venezia stracciona e avventurosa, ancora zuppa dei tonfi sordi delle fiocine e dei richiami dei guardiani, il paesaggio si disegna orizzontale e infinito. Specchi acquitrinosi infranti dagli svolazzi brevi delle folaghe, ciuffi di canne che stormiscono al primo refolo denso, casupole sparute su macchie ocra di sabbia e di mattoni. Costringendo il cuoco ad accorciare le distanze della vista, mettersi carponi per un corpo a corpo culinario, imbracciare i suoi arnesi ad alzo zero. Ripercorrere le distanze con i passi, il ventre, le mani. Una cucina all over. Una cucina d’azione. I precordi che strisciano per terra anziché lo sguardo algebrizzante sullo spazio. 45 enologica edizione 2012 Ristorante la Zanzara Via per Volano, 52 - Codigoro (FE) Tel +39 0533 355236 - www.ristorantelazanzara.com ha detto: “Io ho sempre anche dei nemici, o comunque anche qualcuno che critica, che non è contento, per forza di cose, altrimenti non farei una ricerca, altrimenti farei del marketing, produrrei quello che il mercato chiede”. Ammiro Scabin ma non ho il suo coraggio. Per me il cliente deve tornare: il mio scopo è quello. oggi questo lavoro è diventato meno divertente di un tempo, per una serie di motivi da non ricondurre forzatamente alla crisi. Penso a tutto ciò che gira intorno all’enogastronomia, che è puro marketing del cibo e soprattutto del territorio. Un giorno vorrei invitare i giornalisti ad andare a casa della gente che vive da queste parti, prendere quel che produce e portarmelo per cucinarlo. In qualsiasi stagione dell’anno. Che cosa mangeremmo? Una badilata di terra, forse. Arrivando hai forse visto mucche, capre, pecore? Qualcosa di commestibile a parte i pomodori della Valfrutta? “Je retrouve toujours la même mélancolie devant les eaux dormantes, une mélancolie très spéciale qui a la couleur d’une mare dans un forêt humide, une mélancolie sans oppression, songeuse, lente, calme”. Oggi che l’anguilla sta migrando per sempre, irretita dai miti brevi della civilizzazione, la sua risalita sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, fra i gorielli di melma di cui scriveva Montale, è anche lotta di una ristorazione controcorrente e “controsenso”. Indomabile carboneria del selvatico e del territorio volta a riportare anima verde laddove morde l’arsura della globalizzazione. La filiera è quella del Trigabolo: Sauro, figlio d’arte di Elio, tante cose le ha assorbite come una lingua madre, prima di affiancare Igles Corelli e Mauro Gualandi, tendendo le sue antenne mobili a captare i segnali nell’aria. Fra i ronzii e le evoluzioni di una Zanzara molesta quanto necessaria. In volo sulle anguille a caccia del sangue superstite del territorio. Le folaghe. Elio: Ce ne sono tante, è vero, ma sono protette. Possiamo mangiarle solo per autoconsumo, mentre al ristorante dovremmo utilizzare solo quelle che arrivano dai paesi dell’est e dalla Scozia. Cosicché molti ristoratori a inizio stagione comprano qualche esemplare da un distributore autorizzato per avere la bolla della caccia straniera da mostrare in caso di controlli. E nella carta infilano un foglio con i piatti di selvaggina, da sfilare lestamente alla bisogna. Come definireste La Zanzara: un ristorante? Perché molti colleghi con un pizzico di snobismo preferiscono classificarsi fra le trattorie o le osterie. Sauro: Mi sembra una distinzione nominalistica. Perché se si tratta di fare due servizi al giorno e sfamare le persone, non vedo una gran differenza. Poi si può spaccare il capello in quattro. Fare passare il discrimine per una serie di scelte: il ruolo del prodotto, la cucina più o meno d’autore, il rapporto con il territorio. Ma mi sembrano opzioni arbitrarie. Io per esempio metto tanto territorio, nel senso del km 0 fatto qui o altrove, sempre credibile in termini di filiera; e anche tanto prodotto. Ma la mia non la considero una cucina d’autore. Davide Scabin Voi avete mezzo ettaro di campo. Burocraticamente è altrettanto difficoltoso? Elio: Non cambia nulla. Teoricamente non potrei portare al ristorante la roba che produco. Ma tutti sappiamo quanto vada di moda l’orto dello chef. Diciamo che le autorità chiudono un occhio, i controlli sono blandi. 46 Sauro: No, è una stupidaggine. Perché andare con la macchina a prendere cinque chili di fagiolini dal contadino inquina molto di più che comprare quelli trasportati su un cargo dal Kenia o su un tir dalla Sicilia. Ed è proibito, perché anche in quel caso occorre la fattura, la tracciabilità. I fagiolini del contadino devono andare prima al mercato di Bologna, dove c’è un grossista che li acquista e li rivende. Ma non si tratta solo di sostenibilità; conta anche la freschezza dell’ingrediente. E secondo me c’è un discorso di coerenza estetica. Nel senso che tutto ciò che condivide le stesse origini può armonizzarsi naturalmente. Sauro: allora è un altro discorso. Importantissimo. Ma su tutto il cibo in Italia si fa troppa speculazione. Ci sono artigiani che lavorano benissimo, tenuti in vita da distributori benemeriti, che comprano l’intera produzione anche se non ne avrebbero bisogno. Il resto è pura propaganda. E in generale i prezzi di acquisto all’ingrosso sono troppo bassi. I datterini di Portopalo costano 3 euro e 75, ma il grossista li compra a 3 euro e 45. Com’è possibile vivere con ricarichi così bassi? E alla fine al povero contadino sono andati sì e no 45 centesimi. La qualità dovrebbe avere il suo prezzo, anche per conferirle il giusto valore in cucina. Io non mi lamento mai dei prezzi, se non in rapporto alla qualità. La speculazione di cui parlate colpisce tutte le categorie merceologiche? Elio: Certo. E voglio farti qualche esempio, perché ci sono troppe balle in circolazione. C’è un pastore da queste parti che ogni tanto ha degli agnelli, ma in tutta la provincia non c’è più un macello, forse perché c’era interesse a favorire qualcuno. Quindi per servire al ristorante uno dei suoi agnelli dovrei prendere un camion adibito al trasporto di animali vivi, con relativa documentazione, portarlo al macello, a Modena o nel Veneto, poi tornare a prenderlo con un camion frigorifero. Quindi la macellazione costerebbe come 100 capi. Se poi vuoi per forza quell’agnello, puoi fartelo macellare dal pastore nel cortile senza controlli veterinari e portartelo a casa. Col rischio di dover tirare fuori documenti inesistenti, nel caso succedesse qualcosa. Questa è la condizione del km 0: è illegale. Un’altra balla è quella del Bosco Eliceo: sono nato fra i filari di uva d’oro e so distinguerla facilmente dal fortana, perché una ha le foglie trilobate, l’altra quadrilobate e maturano in tempi diversi, a settembre e in ottobre. Quindi la denominazione andrebbe ritirata perché è fondata su un falso: quello di viti a piede franco che in realtà sono di uva d’oro. Ma è chiaro che non lo faranno mai, dati gli interessi in gioco. Il terzo caso da manuale riguarda la selvaggina. Si tratta di uno dei pochi prodotti di qualità che abbiamo ancora in abbondanza, ma non possiamo usarla, al di là dei problemi fiscali cui accennavo in precedenza, neppure quando è in sovrannumero. a gennaio, in occasione del rastrello delle folaghe, i selvatici vengono seppelliti in una buca, perché l’anno successivo si riprodurrebbero in modo esagerato e 47 enologica edizione 2012 Il marketing di cui parlate quindi è il chilometro zero. Non ci credete? morirebbero di fame. La stessa ASL non avrebbe una struttura veterinaria dove controllare i capi. Ma non interessa a nessuno, perché tutti continuano a riempirsi la bocca di territorio, poi la selvaggina si compra nei paesi dell’est, dove costa dieci volte di meno e magari è immangiabile. e di stoccaggio. C’è gente che si mette i guanti per non fare cambiare il colore della pelle. Cose che in Italia non si sono mai viste. Elio: E in ogni caso il tuo occhio deve essere in grado di discriminare. Anche all’asta ci può essere un pesce poco fresco, perché il giorno della pesca i prezzi erano troppo bassi e il pescatore ha preferito tenerselo da parte, o magari perché i pescherecci sono rimasti fuori tre giorni. Noi ci affidiamo a un signore per gli acquisti all’asta di Goro. Ha la professionalità, le conoscenze personali e il potere contrattuale necessari per farci risparmiare dei soldi, nonostante la provvigione che gli paghiamo. Sauro: oggi poi non c’è una grande richiesta di selvaggina, che invece rappresenterebbe un’ottima alternativa al pesce, sia in termini di sostenibilità che sotto il profilo nutrizionale. Nella clientela è maturato un certo tipo di sensibilità, poi ci sono fuori gli uccelli che svolazzano… Mentre nei miei ricordi resta indelebile l’immagine di Marco Pierre White con la doppietta fumante e il carniere delle prede. E le anguille? La filiera è un tema che vi interessa di più del km 0? Elio: L’anguilla migliore che puoi trovare in questo momento arriva dalla Francia. Non raccontiamoci le favole. Qui ormai ce n’è pochissima, siamo passati da 30mila a 30 quintali l’anno. E anche al mercato scarseggia, perché è troppo rara ed a catturarla sono rimasti quasi solo i pensionati, che possono venderla solo in nero. Sto parlando dell’anguilla di varietà europea, ovviamente, che paga le conseguenze di una politica sbagliata. Le valli di Comacchio non producono più nulla, non ci sono nemmeno i batteri nell’acqua. Sono morti anche loro. Una situazione che si è originata dalle bonifiche del dopoguerra. Il comprensorio vallivo, che oggi copre 10mila ettari, originariamente si estendeva su 33mila, ma le terre che sono state rese disponibili in questo modo sono scadenti e hanno mangiato lavoro anziché produrne. Con la riforma fondiaria sono state assegnate agli ex pescatori, ma contadini non ci si improvvisa, cosicché questi, appena finito di Sauro: È importantissima, ma bisognerebbe parlarne fuori dai denti, dire le cose come stanno. Fare un discorso realistico che consideri gli ostacoli che abbiamo tratteggiato e gli interessi commerciali che spesso puntellano le denominazioni fasulle. Poi a me interessa la qualità del prodotto in sé, a prescindere dalle sue origini. Nel senso che la filiera è importante, ma non per la sua lunghezza. Deve essere certa e controllata, questo sì. In generale quanta parte dei vostri prodotti è locale? Sauro: Il pesce intorno al 70%, in diminuzione però. Siamo costretti a usare anche prodotti di altri mari. E non lo dico con rammarico, perché quel che conta sono le caratteristiche della materia prima. Magari il pesce portoghese o neozelandese può essere più bello e più fresco del nostro, grazie alla logistica e ai protocolli di raffreddamento 48 Questo non spiega perché l’anguilla si stia estinguendo. Elio: È una storia lunga e complicata. In questo quadro di per sé preoccupante, il motivo scatenante è stato un altro. A causa del calo della produzione seguito alle bonifiche, qualcuno ha immesso in acqua anguille di ceppo indo-asiatico. Sono varietà così diverse che ormai non si incrociano neppure, anche se sembrano uguali e per distinguerle bisogna fare le radiografie e contare le vertebre. Si riproducono nella stessa area caraibica ma in periodi diversi, cosicché l’evoluzione nel corso dei millenni le ha separate per sempre. In questo modo però sono stati importati anche un sacco di problemi. Nuove malattie di tipo virale e soprattutto un parassita che nella varietà indo-asiatica si annida nell’intestino, mentre nella nostra attacca la vescica natatoria e la danneggia gravemente. Al punto che quando l’anguilla si deve inabissare per oltre 2000 metri al fine di deporre le uova, non ci riesce più. Praticamente è sterile. La piscicoltura può aiutare? Elio: Per il momento non siamo riusciti a combinare niente, anche se c’è stato un finanziamento consistente per esperimenti in corso a Cervia. Bombardando ormoni dai costi stratosferici, i ricercatori sono riusciti a fare deporre le uova per via chirurgica. Le larve che ne fuoriescono sono creature minuscole, che in natura vengono trasportate dalle correnti oceaniche e impiegano tre anni per rientrare in acqua dolce, dove si trasformano in avannotto. Un pesce che qui da noi non si è mai mangiato, nonostante fosse la zona più popolata al mondo. Perché le ceche andavano pescate e seminate nella valle; ancora adesso ci sono le peschiere dove venivano immesse, al riparo di una rete per evitare l’attacco degli uccelli, anche se non servono più a niente. Quindi la riproduzione è rocambolesca, ma la difficoltà è compensata dalla natura, visto che ogni anguilla depone circa dodici milioni di uova. Sembra incredibile, ma i ricercatori si sono fermati proprio a questo punto. Perché le ceche non si sa bene cosa mangino, cosicché muoiono di fame. Ma molto probabilmente il problema è meccanico, nel senso che muovendosi in natura riescono a ingurgitare il plancton attraverso il forellino che funge da bocca, nella vasca da ferme no. Le varietà sono davvero così diverse? Elio: Hanno gusti e consistenze diversi. Ma la massima variabilità è stagionale ed è legata all’età. Nel senso che in estate non ci sono anguille 49 enologica edizione 2012 riscattarle, le hanno vendute e oggi siamo tornati al latifondo. Tutte le terre che vedi qua intorno appartengono a tre proprietari. Invece le bonifiche fasciste erano state intelligenti, perché non erano state avviate su terre di pesca ma su acquitrini, che erano fonte solo di malaria. Distruggere le valli da pesca, togliendo lavoro a chi voleva fare il pescatore, è stata una violenza sciocca e costosa. Per appezzamenti del valore di 1 milione e mezzo l’ettaro è stato speso quasi il decuplo. Mentre la vocazione del territorio era sempre stata un’altra, fin dal 1200. Abbiamo trovato carte seicentesche dell’Archivio Pontificio che descrivono come la valle era organizzata per la pesca. sessualmente mature, stanno tutte deponendo le uova. Dopo i 10 anni poi, quando sono adulte, vivono in habitat diversi, dove cambiano alimentazione, quindi presentano caratteristiche variabili. All’inizio dell’accrescimento risalgono i fiumi fino alle colline. Poi avvicinandosi alla fase della riproduzione ridiscendono verso il mare, dove diventano più saporite e più grasse. Ingurgitano tutto quello che trovano perché hanno bisogno di accumulare grasso per affrontare il viaggio della riproduzione. Da quando partono infatti, per risparmiare tempo, chiudono la bocca e cessano di nutrirsi. Ma devono coprire 6mila chilometri a nuoto e produrre 12 milioni di uova che non hanno ancora in pancia, tutto con il grasso accumulato in precedenza, che non è concentrato sottopelle ma marezzato nella carne, che diventa biancastra. Quindi a seconda dei momenti sono pesci diversissimi. Oggi molti preferiscono l’anguilla giovane, magra e leggera, ma un tempo sarebbe stata una bestemmia perché si mangiava per nutrirsi. Un altro aspetto da considerare è che le valli chiuse, come quelle comacchiesi, hanno una sapidità diversa, che si riflette nelle carni rispetto a quelle aperte come Goro. E poi il clima: l’anguilla è molto sensibile alla temperatura esterna, quando è troppo bassa o troppo alta si infila nella sabbia anche per qualche metro e resta ferma lì finché la situazione in superficie non si è normalizzata. Quindi è impossibile pescarla. allora mi chiedo: come mai a nessuno è venuto in mente di andare a vedere come fanno? Anche per questo sono arrabbiato con la gestione delle Valli di Comacchio e i miei amici del Parco del Delta, che hanno decuplicato i costi e quasi azzerato la produzione. Persino il presidio Slow Food era stato sospeso perché l’anguilla era prodotta in Veneto e poi si proiettavano i filmini per turisti. Ma come si fa a spacciare per tradizionale un’anguilla marinata che non matura nelle zangole di legno per 3-4 mesi? Perché quella fatta nella latta è immangiabile, manca lo scambio ossidativo e resta aceto puro. È triste, se si pensa che era la prima industria conserviera d’Europa, la marinatura di Comacchio produceva 15mila quintali l’anno. Poi ci sono stati la guerra, le bonifiche, il progressivo degrado delle Valli, nonostante i miliardi che ci hanno buttato dentro, perché il sistema delle chiuse è saltato. Da una parte si è creata la frattura con il Volano, che con gli scarichi delle porcilaie del modenese è diventato una fogna; mentre con il Reno lo scambio è sempre stato insufficiente. A tutto questo si è aggiunto il parassitismo, perché la pesca non interessava a nessuno, meno pescavi più la regione sussidiava. Un quadro disastroso. Da chi hai imparato tutte queste cose sull’anguilla? Elio: Non certo in famiglia. I miei genitori erano contadini, non si occupavano di pesca. Erano originari del Veneto, come indica il cognome Bison, che è prettamente padovano. l’azienda agricola per la quale lavorava mio nonno, che era maniscalco, comprò della terra da queste parti e lui fu trasferito. Quindi quel che so l’ho imparato dai pescatori, Un’alternativa però c’è. Ed è l’anguilla francese di cui parlavi, purtroppo. Elio: In Camargue, presso la foce del Rodano, stanno producendo un’anguilla europea di qualità e di cattura, non di allevamento. È eccellente. E 50 reinterpretarle, andandomi a cercare sui libri la riproduzione dell’anguilla e aiutandomi con le nozioni di cucina. Le differenze fra un’anguilla e l’altra secondo l’età, l’habitat, l’uso migliore che se ne può fare…è stata tutta una mia elaborazione personale, che mi ha permesso di perfezionare le ricette. La ristorazione quando è arrivata? Elio: Nei primi anni ’80, prima a Casal Borsetti, poi alla Bassona, che era una spiaggia selvaggia, la più bella che abbia mai visto. In seguito abbiamo comprato un ristorante pizzeria qui al lido di Volano. Senza nessuna formazione. A quei tempi era ancora possibile: il mestiere era meno tecnico, si lavorava con turisti tedeschi che mangiavano di tutto. Poi la cuccagna del mare ha cominciato a scemare ed è nata l’esigenza di riconvertirci a una ristorazione diversa. Abbiamo conosciuto personaggi come Igles Corelli, che ho incontrato per un corso di cucina, ed è nata una grande amicizia, nonostante la diversità fra i nostri approcci. Io l’ho iniziato ai prodotti del territorio e lui mi ha sgrossato tecnicamente ai fondi, alle salse e alle tecniche professionali. I ragazzi sono cresciuti e si sono appassionati. Cosicché Sauro ha cominciato a girare con Igles, che continua a venir qui ogni tanto. Ma poi sai cosa mangia? Il mio salame. Il suo desiderio è quello. Che salame produci? Elio: È un salame all’aglio con una grana un po’ grossa, stagionato fino a due anni. La prima fase di asciugatura la facciamo qui al ristorante davanti al camino, durante le ferie di gennaio. Ha 51 enologica edizione 2012 che quando sono arrivato erano ancora numerosi. Sono rimasto affascinato dal loro mondo. Il vallante viveva dentro alla valle, perché nel periodo di pesca non poteva tornare a casa. Prima della guerra anzi poteva allontanarsi solo ogni due settimane e se veniva trovato in paese senza il permesso scritto perdeva il lavoro. Il pesce arrivava quando gli pareva, quindi tutta la notte bisognava aprire e chiudere le chiuse. Quando serviva il caporione svegliava i vallanti, che si alzavano dalle brande e tiravano fuori il pesce dai lavorieri. Uno di loro era addetto a cucinare e lo faceva nel camino che vedi là in fondo, perché questo edificio, prima che un ristorante, è stato un casotto. la nostra saletta privata era l’ufficio del caporione, dove si facevano le bolle e le paghe; e lo spazio dove friggiamo e grigliamo ospitava il forno a legna. Poi c’erano i guardiani, che vivevano qui anche loro. Quei seggioloni lì sono dell’epoca: ognuno aveva il suo, confezionato su misura. Li usavano perché intorno alle feste di Natale le anguille erano conservate dentro alle bolaghe, cestoni in vimini della capienza di 5 quintali, che erano disseminati sulla banchina. I pesci venivano conservati vivi in questo modo finché il prezzo non saliva. Ma con la fame che c’era allora non li potevi lasciare senza sorveglianza, perché non avresti trovato più nulla. Quindi bisognava vigilare. Parallelo a questo mondo c’era l’esercito dei fiocinini, che entravano di notte a rubare in valle con le fiocine. Ma spesso era tutta una farsa perché magari conoscevano i guardiani e convivevano pacificamente. Tutte le cose che ho imparato da queste persone, da cuoco ho voluto un’impronta veneta, perché ho imparato da mio padre, che d’inverno girava per ammazzare i maiali, e io lo accompagnavo. Ricordo ancora che il fegato veniva mangiato con le mani insanguinate, appena cotto sulle braci del fuoco usato per scuoiare l’animale. E il mio maiale è di quelli di una volta. Un esemplare di 3 quintali e 2-3 anni, allevato da un mio amico in compagnia del suo. La carne è matura, ha poca acqua, quindi in stagionatura il calo è contenuto e non si creano fessurazioni; anche i budelli sono quelli giusti, grandi e spessi, roba che ormai è difficile trovare. Perché in giro puoi trovare un buon prosciutto, non un salame di valore: l’industria non può permettersi scarti e stagionature e dati i prezzi usa solo rifilature, non l’animale intero come me; i budelli sono artificiali, perché standardizzati e resistenti, e i difetti della carne giovane sono corretti con gli addensanti. Dopo una giornata la consistenza è già quella del salame stagionato. La muffa è artificiale, di solito farina di riso, come l’aroma, che non si produce con la fermentazione ma viene addizionato. che viene commercializzata dopo le potature o se cade qualche albero. L’anguilla è sempre nostrana, quando c’è. Tradizionalmente si cuoceva intera solo se era molto giovane e aveva i grassi belli fluidi; era quella che chiamavano pistin, perché per impedire che si arrotolasse si batteva la spina con un mazzuolo di legno. In tutti gli altri casi veniva aperta a libro e privata della lisca, come facciamo anche noi. Veniamo alle verdure. Tu sei anche contadino. Elio: Sì, a casa ho un pezzetto di terra che apparteneva ai miei genitori. Ci sono animali da cortile, galline, oche, anatre, conigli, piccioni, tutti in piccole quantità, per l’autoconsumo; le verdure invece sono abbondanti e coprono buona parte del fabbisogno del ristorante. Il terreno è sabbioso, perché in epoca etrusca qui c’era il mare, quindi necessita di tanta acqua e di un generoso apporto organico, che ottengo nella concimaia con le pulizie dei pollai e gli scarti della verdura. La sabbia consente alle verdure di crescere bene perché la pressione è minore, tanto che i grossi produttori qui intorno hanno fatto incetta di terreni. Un’altra tua specialità è la griglia. Quando avete inaugurato la Zanzara? Elio: Sì, è tuttora mio appannaggio, ed è una cosa che imparavano a fare tutti qui in zona, fin da ragazzini. L’aspetto fondamentale sono le braci, che non si usano quasi più perché sono troppo scomode. Alcuni settori delle ASL stanno facendo i salti mortali per proibirle perché sarebbero cancerogene, come il forno a legna per le pizze. Ma sono cose che sono sempre esistite, ben prima che il cancro esplodesse. Per prepararle uso un po’ di carbonella e soprattutto tanta legna, quella di leccio del Bosco della Mesola, Elio: Nel marzo del 2009. I ragazzi, Sauro, Samuele e Sara, si sono affiancati a me e a mia moglie Vittoria in modo molto graduale. Hanno iniziato a collaborare quando facevano le medie, poi si sono appassionati e siamo entrati sempre più in sintonia. Oggi non so nemmeno cosa abbiamo in cantina, perché segue tutto Samuele, che ha studiato da sommelier come me 20 anni prima. Samuele: Io però sono arrivato dopo gli altri. Sara e Sauro sono sempre rimasti in famiglia. 52 E tu, Sauro? Sauro: A parte la famiglia, mi sono formato in un corso di pasticceria di una volta, poi con Mauro Gualandi, che ho affiancato nella pasticceria di Argenta. E la passione per i dolci non mi ha mai abbandonato. Da mio padre, come da Giacinto Rossetti, ho imparato tante cose. Sono persone lapidarie. Se chiedi loro: “E per il pesto?” Ti rispondono: “Ci vuole il basilico, quel tipo di basilico. Il resto è relativo. Altrimenti non lo fai”. È un modo di concepire le cose che è molto attinente alla realtà. Una cultura del prodotto e dei modi, che siano gentili o sgarbati. Cosa presenterete a Enologica? Elio: Salvo inconvenienti legati alla reperibilità, anguilla e selvaggina. Mi piacerebbe cominciare con l’anguilla arost en umad, un piatto di tradizione popolare che viene chiamato anche anguilla nella brusafiga. Si tratta di un arbusto che cresce nelle golene del Po e un tempo veniva usato sotto forma di bacchetti freschi per sostenere in forno il pesce, che era già cotto per metà sulle braci. In questo modo si aromatizzava, non friggeva nel suo unto e si sgrassava bene, cuocendo anche al cuore senza bruciare in superficie. Ma doveva essere un esemplare particolare, di pezzatura grande e di età media. Immagino che la doppia cottura servisse per conservare, perché l’alimento diventa meno deperibile. I pezzi avanzati poi venivano gettati nell’aceto, per fungere magari da colazione il mattino successivo. E la ricetta di selvaggina? Elio: Penso che sarà un risotto, probabilmente di folaga. Un selvatico che bisogna saper lavorare, perché il grasso e la pelle sono immangiabili e vanno scartati completamente, mentre il petto è squisito, più tenero e saporito di quello dell’anatra. Il risotto a mio giudizio è uno dei migliori in assoluto. Lo preparo con un fondo bruno di folaga, non buttando il volatile in acqua bollente come facevano le donne. Perché nessuno sapeva lavorare al coltello un animale così piccolo. Invece la folaga va spolpata, le carcasse arrostite con gli odori e sgrassate per il fondo bruno. Si usano anche le rigaglie, che sono buonissime. Dal punto di vista tecnico è una ricetta corretta dai suoi refusi, come direbbe Marchesi. Che per me è sempre stato un punto di riferimento, insieme al Pellaprat. 53 enologica edizione 2012 Io invece ho voluto trovare la mia strada e uscire dal contesto famigliare. Pur avendo studiato filosofia, ho trasformato la mia passione per l’informatica in una professione. Questo mi ha consentito di raggiungere una piena indipendenza, avere la mia macchina, la mia casa, la mia autonomia. Dopo la crisi della new economy, però, mi sono gradualmente riavvicinato alla famiglia e alla ristorazione. Ho avuto la fortuna di conoscere tante persone, fra cui Elena Pantaleoni e Marco Merighi, che mi ha iniziato al vino “naturale”; o più recentemente Andrea Bragagni e Gravner. Gente che è bellissimo visitare perché vive in oasi naturali. E sto continuando a imparare. Daniele Minarelli All’Osteria Bottega Via Santa Caterina, 51 - Bologna Tel +39 051 585111 Ci voleva la zampata canaglia di Daniele Minarelli per svegliare la bella addormentata della ristorazione nazionale. Bologna, preda ritrosa che Arcimboldo avrebbe ritratto incastrando nidi di tagliatelle e morbidi cuscinetti di lasagne, sulle gote rubizze uno schizzo di cosmetico friggione. Morbida e burrosa; dotta, grassa e generosa. Come l’Osteria Bottega, le quattro mura in via Santa Caterina che hanno rinchiuso nel perimetro di una sineddoche lo spirito del luogo. Fra la polifonia delle chiacchierate emulsionate dal grande mattatore, la percussione dei brindisi, il tintinnare delle forchette, l’euforia della festa. Il conflitto è il padre di tutte le cose, scriveva già Eraclito. Ed è col piglio di un consumato presocratico che Daniele, nelle vesti di patron ed eclettico regista, ha assemblato l’estetica del suo locale. Dove l’atmosfera vivace convive con la teca sacrale dei culatelli, quasi un tabernacolo profano cui inchinare le papille sopra l’altare vermiglio della Berkel; la carta gialla e cerata su cui riposa la chiffonnade dei salumi con l’irreprensibile calice Spiegelau, che abbraccia vini sempre a temperatura. Un po’ come il rustico involucro delle magie di Peppino e Mirella Cantarelli: Champagne e maialata, francesismi d’alta scuola fra i banconi stipati di uno spaccio di paese. Talento, sudore e tanta conoscenza fanno lo sgambetto ai sonnambulismi della tradizione. Perché Daniele fa il tagliando ai classici di sempre: tagliatelle, tortellini, lasagne, cotolette alla petroniana. Cominciando dalla lista degli ingredienti, che compila da talent scout della selezione, fino alla maniacalità delle elaborazioni, quella cuisson juste che ruba puntigliosità ai poeti. Sempre passando per l’alleggerimento e la ricerca della massima freschezza. Quasi una mediterraneizzazione senza apostasie che regala alla bella risvegliata forme più asciutte e un’agilità inusitata. “Mettiamo subito le cose in chiaro: Osteria Bottega. Bottega perché è aperta a tutti, nel senso della democratizzazione del buon cibo e del buon vino, che sono diritti universali. E la nostra clientela è trasversale, dagli studenti agli onorevoli. Osteria perché voglio riportare al centro la gioia di certe atmosfere e il cibo della tradizione. Mettendo a frutto le conoscenze acquisite ma senza formalismi. Un impatto caldo nel quale rientra un tocco di abbondanza, perché siamo a Bologna. E come si dice da queste parti: meglio fare schifo che compassione. Niente di fighetto, insomma”. Un’intervista alla Bottega, come i suoi menu, non può che esordire con i salumi. Sicuramente, perché sono la bottega. Il suo cuore, per la passione che fin da piccolo mi hanno trasmesso mio padre e la mia famiglia. In casa li facevamo anche, dal cotechino alla salsiccia passita, al salame, 54 Il piccione è locale? No, non sono un fanatico del km zero. Ma è di casa nella mia memoria. Perché ricordo che una volta veniva messo nel brodo dei ricchi, che dovevano sempre differenziarsi dai poveri. In campagna veniva aggiunto per dare al bimbo un nutrimento migliore. Quindi c’era, e io l’ho riportato in tavola. È un piatto che facciamo da 4 anni, perché la Bottega nasce pian piano e poi aggiusta il tiro. Il nostro menu vuole avere una sua impostazione, ma poi segue la stagionalità e le ispirazioni. La cotoletta alla bolognese invece è filologica. Sì, ed è un grande piatto di tradizione dimenticato. Il nostro intervento in questo caso riguarda gli ingredienti, perché come carne utilizziamo del vitello di fassona. Quindi una specialità tipica con una materia prima diversa. Ogniqualvolta è possibile facciamo piatti del territorio con prodotti del territorio, come le carni di cortile, il coniglio, la faraona, l’anatra muta, che qui erano sovrane. Ma la nostra non è una cultura delle carni rosse, e per questo mi permetto di spaziare. Sopra la costoletta di vitello mettiamo prosciutto Luppi 36 mesi e Parmigiano 30 mesi. Viene passata in padella come la milanese ma non finisce di cuocere fritta, bensì glassata con un goccio di brodo di cappone. Chi decide queste variazioni? La mente della cucina della Bottega sei tu? Diciamo che mi impegno anch’io. Ma quello della Bottega è un successo di squadra. Il mio chef attuale, Daniele Bendanti, è alla Bottega da 4 anni. I piatti nascono da un mio input, ma vengono messi a punto nel confronto tecnico con lui. Le sfoglie invece sono appannaggio delle mie due sfogline, Clara e Giovanna, autentiche rezdore, e sono sempre di giornata. Contengono quasi solo tuorli, con un filino di albume per legare, perché voglio una pasta ricca, gialla, solare. Anche mia mamma contribuisce: fa la mostarda quando dalla campagna arriva la frutta adatta, prugne scure, mele, pere. La serviamo con i formaggi. 55 enologica edizione 2012 sempre col suino pesante padano, che è il nostro maiale. Ormai praticamente un autoctono, come la mora in Romagna. Il piatto misto di salumi è uno dei grandi classici della cucina italiana. Il buongiorno che la Bottega vuole dare nel colore, nel profumo, nelle sensazioni olfattive e gustative. Ma per comporlo sono necessarie le eccellenze, quindi una forte passione nella ricerca. È l’incipit di un percorso che poi inanella le nostre sfoglie di giornata, le carni del cortile, in parte tradizionali e in parte rivisitate, come il piccione e l’anatra muta. Perché la Bottega vive in un contesto di tradizione, ma non chiude le porte alle novità, anzi è attenta ai dettagli e alle tecniche. Il piccione per esempio presenta cotture differenziate e un vero fondo alla francese: il petto è scaloppato, rosato e laccato, mentre le ali e le cosce sono croccanti. Si tratta di un prodotto della tradizione, perché è un piccione di nido, ma con elaborazioni contemporanee e colte, attraverso le quali vogliamo dimostrare che possiamo essere tradizionalisti e rivoluzionari nello stesso tempo. Il nome del locale evoca il connubio fra ristorazione e commercio di casa a Samboseto. Ti senti discepolo di Peppino Cantarelli? E poi c’erano i salumi, dicevi. Come tutte le famiglie della Bassa insaccavamo il maiale, più che altro per necessità, perché era fonte di vita; e fortunatamente io e mio padre, che adesso ha 86 anni, ci divertiamo tuttora a farlo. Conservo indelebile il ricordo meraviglioso di quel momento sacro: la festa dell’insaccatura del maiale. E la nostra emozione è rimasta tale e quale ad allora. le ricette sono quelle di mio padre, senza nessuna variazione. E lui a sua volta le aveva apprese dai vecchi. Perché una volta tutti andavano a insaccare il maiale, casa per casa. Ci si aiutava gli uni con gli altri, e da un’esigenza si imparava un’arte, quella del norcino. Da queste esperienze è nata la voglia spontanea di fare qualche cosa, dare gioia alle persone in quella casa di campagna con il camino acceso. La gioia del convivio. Il paragone mi lusinga, anche se non ci sono mai stato. Ma io non mi sento discepolo di nessuno, se non della mia storia, della mia famiglia, delle mie emozioni. La Bottega è nata dall’esperienza di una ristorazione di un certo tipo, più che decennale. Quella del Dandy di Minerbio, dove abbiamo avuto la stella Michelin dal 1994. Io e mia moglie Valeria siamo partiti da autodidatti totali. Io ero in sala; lei, che poi ha preferito la banchettistica nelle case, in cucina. Ed è stata un’esperienza bellissima, anche se durissima, perché in quegli anni non si parlava tanto di cucina e di vino. Mancava la cultura. Gestivamo una stuzzicheria con birreria in una casa di campagna e facevamo grandi incassi, perché c’era già un’offerta particolare, con la selezione delle birre crude e i crostini fatti in casa. Ciononostante nel 1990 abbiamo deciso di cominciare a fare ristorazione. Cosa che ci ha capovolto la vita anche sotto il profilo economico. In seguito ci siamo appoggiati ad alcuni professionisti in cucina, ma il timone è sempre rimasto nelle mani di Valeria. La ristorazione del Dandy com’era? Il primo aggettivo che mi viene in mente è “sentita”, perché il passaggio dalla stuzzicheria alla ristorazione è stato molto impegnativo. Un sacrificio notevolissimo per due autodidatti. La carta era molto più ampia di quella della Bottega, con tre menu: della tradizione, di terra e di mare. Per esempio siamo stati i primi in zona a servire il pesce crudo, con gli scampi e i gamberoni viola di Gallipoli; facevamo le quenelle e il foie gras. Poi c’era anche il tortellino, perché io non mi stanco mai di ripeterlo: non si può creare senza ricordare. Il Dandy ha curato in primis la tradizione, poi ha voluto arricchire il suo menu con piccole chicche non troppo elaborate, molto pulite, semplici, stagionali, tutte di grande materia prima. A me piace molto la cucina mediterranea. Come mai questa svolta? Perché fare ristorazione significa ristorare. L’impulso è stato il desiderio di stare in mezzo alla gente. E dietro c’era un’educazione famigliare forte. Perché la mia era una famiglia modesta, di gente semplice, papà muratore e mamma sarta; ma già c’era un “corteggiamento” di ristorazione, nel senso che c’era un via vai di gente, l’ospitalità era importante. Ci ritrovavamo per parlare di cibo e di vino. 56 Ma la mia operazione alla Bottega va nel senso della digeribilità. Perché è fondamentale che la cucina sia leggera, a differenza di 30 anni fa. Il ragù non può più essere sepolto da due dita di grasso; in dialetto si chiama “soffritto” e non può certo essere espresso, ma anziché 5 ore può cuocerne 3 e mezzo. Bisogna centrare le sue caratteristiche organolettiche con una maggiore attenzione per la salute, perché il cliente ritorna in funzione di come mangia e di come digerisce. D’estate poi facciamo piatti leggeri come i rifreddi e la galantina di galletto nostrano con la caponatina. Usiamo tanto olio, quello eccellente della nostra regione, accanto al burro della Normandia. Perché di grassi bisogna usarne pochi, ma buonissimi. Come mai l’esperienza del Dandy è finita? Perché il cerchio si è chiuso. Si ritorna sempre alla tradizione. Questo finale per me è un nuovo inizio: è bellissimo riportare sotto questi portici i profumi di sempre, il profumo di sfoglia, il profumo di ragù. Con tanto amore e curando i dettagli con la giusta attenzione. La tua traiettoria è esemplare di una tendenza più generale, dall’egemonia dell’alta cucina cosmopolita al revival del territorio. Sì, perché abbiamo abbandonato le spume e gli azoti, che erano indigeribili, tanto che la gente aveva smesso di mangiare. La spuma di mortadella possiamo darla agli inglesi, non ai bolognesi. Perché la mortadella va servita a fette. Bisogna valorizzare le consistenze. Le materie prime sono tuo appannaggio esclusivo. Come scegli i fornitori? alle spalle c’è una gavetta iniziata nel 1986, quindi parto da lontano. Ma è una conoscenza che non può mai essere esaustiva, quindi bisogna continuare a coltivare l’attenzione e la curiosità. La mia forza vuole essere proprio questa: ricercare sempre per mantenere viva una grande qualità e una grande materia prima, in modo da realizzare una cucina semplice ma corretta, fatta con esperienza e con gioia, che risvegli il ricordo dei sapori che ho in testa. La salsiccia per esempio deve essere quella che mangiavo da bambino, quando appena finito di insaccare nel budello mi arrampicavo sulla seggiola e dalla pertica con il coltello tagliavo un pezzo da mangiare crudo. Ma io prendo il mix di traculo, prosciutto, lombo, pancetta e coppone e lo rimacino due volte per migliorare la palatabilità, più una bella macinata di pepe, che è sempre stata la spezia della Bassa. Perché la cucina di tradizione è gioia. Mi piace molto scoprire i piccoli produttori, ma quando un prodotto diventa inflazionato mi rimetto alla ricerca della nicchia, per esempio ho scovato un piccolo allevamento allo stato brado di mora romagnola, dove uno svizzero produce anche fassona e romagnola. Bisogna avere sempre le antenne dritte 57 enologica edizione 2012 Il cliché della cucina bolognese però è antimediterraneo per definizione. La mente corre alle lunghe cotture con i loro colori spenti, alle materie prime esauste, a piatti robusti e invernali. perché la filiera è una catena che si costruisce da sola. E il cliente sfizioso può fornire molti stimoli in questo senso. i bambini che giocavano. la valorizzazione del portico significa vincere la prima battaglia contro il degrado del centro storico. È un modo per ripopolare, significa dare lustro alla città e ripulirla. In questi 7 anni ho rivoltato come un calzino via Santa Caterina, perché il gestore di un locale deve essere anche una sentinella di chi passa per la strada, come succedeva una volta. Ho fatto una battaglia di quartiere, ho ripavimentato l’esterno e i miei ragazzi tutte le sere lavano il portico. Le strade storiche come questa dovrebbero essere riportate alla tipicità di una cultura popolare ma bellissima, che unisce il sacro e il profano. Il muro qui davanti per esempio appartiene a un convento del 1300, ma intorno c’erano le prostitute, i casini e i preti che confessavano. Perché l’arte della confessione è quella che ti permette di peccare di nuovo. Due Ave Maria, un Padre Nostro e siamo già pronti per ripartire. C’erano anche i ladri di galline, ma era il furto per sopravvivenza, favorito dal fatto che molti giardini comunicavano fra di loro. Poi c’è la sala. Oltre a improntare la cucina e controllare le forniture, tu sei l’anima del servizio. E io mi sento soprattutto un oste, magari con qualche conoscenza in più. Il mio punto di partenza restano lo spuntino, la gioia di ricevere le persone e farle sorridere, con la stessa qualità di attenzione del ristorante stellato, dai bicchieri alle temperature di servizio. Perché i contorni sono più importanti della pietanza: il cotechino senza il purè non sarebbe mai diventato il cotechino. Per me l’oste resta una cosa meravigliosa. Ristorare, ospitare, sorriso e gentilezza. Perché la gente non va più fuori per mangiare, va fuori perché ha bisogno di essere curata. Il cibo è un veicolo di benessere. La cultura delle osterie è profondamente in crisi a Bologna. È vero, perché si lavora di microonde, molti hanno perso di vista cosa significa questo mestiere, dare un certo tipo di cibo e di vino. Ma io me la ricordo, la Bologna delle osterie, perché fin da ragazzo venivo solo qui la sera. Bologna storicamente è sempre stata la città dei biassanot, dove la gente andava fuori a mangiare fino a tardi. Adesso non riesci più a ordinare una pizza alle 10 e mezza, ti guardano male. Mentre io con la mia botteguccia vorrei ridare la gioia di un piatto di tagliatelle alle 11, dato che la nostra cucina è aperta fino alle 11 e mezza e garantiamo un servizio fino a tardi. In estate anche nel dehors, perché Bologna vive della cultura dei portici, dove una volta c’erano Nonostante il suo fascino, che trasmetti e interpreti alla perfezione, Bologna resta una piazza difficilissima per i ristoratori. È innegabile. La nostra cucina ha grandi qualità, una grande gioia, è straordinariamente buona quando è ben eseguita. Ma è stata un po’ rovinata dall’andamento delle fiere, perché l’afflusso che hanno generato ha portato a una disattenzione generale dovuta alla facilità di guadagno. Si è arrivati a fare la pasta precotta invece di curare una nicchia e dare all’ospite il fiore della tipicità. La ricerca della qualità è stata accantonata, anche e soprattutto per un 58 enologica edizione 2012 piatto semplice, in realtà estremamente complesso come la tagliatella. A Bologna è difficilissimo mangiare fuori un ottimo salume, persino l’emblema della nostra città, la mortadella, che in Pasquini e Brusiani ha il suo ultimo baluardo ribelle. Artigiani bolognesi che producono una mortadella bella, croccante, fatta ancora come una volta. Questa disattenzione è durata dai secondi anni ‘80 al 2000, nel senso di una ristorazione un po’ da corsa. Oggi poi c’è la crisi, ma noi dobbiamo combatterla restituendo gioia al consumatore. Una qualità genuina senza gli orpelli che hanno già stancato. Cosa porterete ad Enologica? L’anatra muta, perché, come dicevo, la nostra è una cultura di carni di cortile e l’anatra era il piatto della festa per antonomasia, che fosse arrosto o in umido. Ci serve per dimostrare che alla Bottega non si mangia solo la tagliatella, ma anche carni raffinate e difficili, e che abbiamo le qualità tecniche per elaborarle. Quindi una cottura lenta e confit nel suo grasso e un fondo vero alla francese. I volatili li compro nel Ferrarese. Sono allevati a terra, ruspanti ma in versione creativa, secondo la cifra della Bottega. E il vino? la nostra regione ci sta dando grandissime soddisfazioni, penso sia alla crescita prepotente del Sangiovese, nel bouquet, nella persistenza, nell’uso sapiente del legno, che al Lambrusco rifermentato in bottiglia e a certi Sorbara spettacolari. Vini che sposano naturalmente i nostri cibi. Per l’anatra abbiamo pensato a un Sangiovese Superiore Riserva Giovanna Madonia del 2007. 59 Remo Camurani Trattoria Di Strada Casale Via Strada Casale, 22 - Brisighella Tel +39 0546 88054 È una scultura sociale in piena regola, quella che prende forma ogni sera a Strada Casale. Convitato di pietra Joseph Beuys, l’artista tedesco che affondava il bisturi del talento nel tessuto economico, ecologico e relazionale delle sue opere. Fino a teorizzare il pasto come soziale Skulptur, appunto: ovvero un momento di convivialità che plasma i rapporti fra le persone, sublima la comunicazione in una cristallizzazione estemporanea, interagisce con l’ambiente, il paesaggio e le sue diverse vocazioni. Contribuisce insomma a modellare una società migliore. È una scultura sociale perché il piatto è il punto di confluenza di molteplici filiere, ricco collage di creazioni vegetali e animali covate nelle casupole che punteggiano le colline. Dove i solchi delle patate rovesciate dalla terra e i geroglifici delle galline che raspano il cortile trovano una sintesi nelle forme dei cibi e nei riti del consumo. Le macchie dove spuntano la misticanza di campo e la rucola selvatica; i contadini con i loro animali da cortile, galline, conigli, faraone; il leggendario ortolano “Pitano” e i capolini dei carciofi moretti; Pietro Cavina con il suo carniere di tartufi; Marino artista dei nocini e il chiosco delle piadine di Aldo; il vecchio mugnaio del mulino di Madonna dei Tre Fiumi; una compagine di piccoli vignaioli e olivicoltori. Gli eredi di una storia brisighellese consacrata dall’olio, prima Dop italiana, e dall’irriverenza aranciata dei pionieri Ronchi di Castelluccio. Era tempo che qualcuno andasse a tastare il corpaccione ipertrofico della cucina contemporanea alla ricerca di una qualche struttura. Lo scheletro, gli organi vitali, i significati contro la pletora delle superfetazioni e le adiposità della coazione a contaminare. È toccato a Remo Camurani e Daniela Pompili, rispettivamente alla guida della cucina e della sala della Trattoria con lo stesso understatement e una laconicità pari alla brevità dello stile. Trovandone con destrezza giunture, lische, fibre. architravi di resistenza al peso del superfluo che sfianca. Ma nella scultura sociale ci sono anche Giorgio Melandri e Giacinto Rossetti, ultimo dei Preraffaelliti e alter ego di Remo nell’ésprit de finesse contrapposto a decenni di geometria imperante, che dall’alta cucina ha curnonskyanamente deviato in direzione cuisine bourgeoise, la cucina di casa, origine e approdo di un professionismo intransigente. Storie contemporanee perché fuori dal tempo, quelle del Trigabolo e di una trattoria solitaria sulla SS 302, che da Faenza porta ai fasti di Firenze. “Ho voluto mettere insieme Remo e Giacinto in primo luogo perché sono due amici”, esordisce Giorgio. “E poi per una frase che una volta mi ha detto Giacinto. Ovvero che la cucina è uno strumento che gli uomini utilizzano come esercizio di sensibilità, nel quale si devono riconoscere, nel senso che un menu deve avere una trama narrativa. E io penso che su questo punto siano due persone che riescono a dialogare. C’è una profondità nella sensibilità che instaura una comunicazione fra loro attraverso il cibo, il quale funge da scusa. Quindi a me piace che a Enologica vengano insieme”. 60 M. Perché abbiamo un amico in comune. Grazie a lui pian piano ci siamo frequentati e conosciuti. Ma Giacinto non mi ha ancora autorizzato a dargli del lei, cosa che rappresenta il massimo grado dell’amicizia. Poi la storia di giacinto è molto intellettuale, ma anche molto pratica. Mentre da Remo io mangio tutte le settimane: questo per me è il posto in cui si sta meglio in assoluto. C’è una cucina di casa altissima, dove non ho mai visto una presunzione. Quella faraona probabilmente è sulle braci da 3 ore, quella lì e non un’altra. Perché Remo non è superficiale in nessuna delle cose che fa. Se c’è una cosa è perché è funzionale, lavora per sottrazione ma senza forzature. E ha una sensibilità straordinaria nell’interpretare il prodotto, può intrattenerti per ore sulle sfumature del rosmarino col trascorrere delle stagioni. R. Quando la cucina di casa fa sul serio, non ce n’è più per nessuno. I passatelli di Remo rispondono perfettamente a un piatto che per mille anni è stato fatto tutti i giorni, manifestano una tendenza all’assoluto. Non c’è nessun relativismo, di nessun genere. Senti il distacco fra i passatelli e il brodo, senti l’animalità del brodo, che è sporco, vero, pieno di energia. Ci vuole vocazione per fare una roba del genere. Rinunciare alla spettacolarità e al conformismo che fa parlare di sé. Quasi una forma di estasi, dove la cura maniacale del dettaglio è la dimostrazione che le cose semplici non esistono: esistono solo modi sempliciotti per fare cose complicate. È una sacralità che secondo me è destinata a entrare in conflitto con l’istituzione ristorante, perché le cose da vendere non valgono mai nulla. M. Questi passatelli sono una verità fuori dal tempo. Se ci pensi invece, i cuochi che hanno fatto? Hanno tirato i passatelli fuori dal brodo per servirli asciutti. E in questo modo hanno dovuto alterarli, perché ci hanno messo per forza un po’ di farina. Quindi un compromesso sul passatello a che scopo? Per spostarlo fuori dal brodo. Ma un piatto che ha attraversato i secoli avrà pure una sua ragion d’essere. Farsene custodi è un’operazione molto più interessante e raffinata che alterarlo per fare notizia ed entrare in cronaca. Questo non è un posto che va in cronaca. Poche persone in Emilia-Romagna hanno avuto il coraggio intellettuale di fare un passo indietro. Chi viene qui capisce che tradizione e innovazione sono la stessa cosa, se si prescinde dal vincolo del tempo; e quando l’innovazione non diventa tradizione, significa che c’è qualche problema. La stessa cosa vale per il mondo del vino. In Emilia-Romagna la più grande innovazione, da cui non si tornerà più indietro, è la vinificazione del Sorbara in purezza, da dieci anni a questa parte. Non è già una tradizione questa? E il formaggio: perché uno stagionato di mucca e pecora al posto del Parmigiano nell’impasto? R. Perché è la vera tradizione, che non è una cosa morta: siamo noi. Il passatello nelle case si è sempre fatto con quello che c’era, perché in fondo era un piatto di recupero. Mentre il Parmigiano era la “forma”, una roba da signori, il lusso vero. Significava la festa, l’incontro degli uomini, i bambini che facevano casino, la nonna vecchia in disparte. I comunisti e i cattolici erano già insieme al compromesso 61 enologica edizione 2012 A proposito di amicizia, tu e Giacinto come vi siete conosciuti? storico, contrariamente a quanto pensava Berlinguer, che era un sardo. La gastronomia e il compromesso storico sono andati di pari passo per vent’anni. Prendiamo anche la polpetta: è un passato con un po’ di futuro. Perché la tradizione è una cosa che deve ancora succedere. Ed è salata, perché i grandi cibi sono tutti sapidi e grassi. La finezza Remo non la va mai a cercare: le orchidee sono fini, ma le margherite sono bellissime. Remo è piuttosto un umile servitore delle materie prime. Un bravo cuoco, molto riflessivo. A dispetto delle apparenze la sua non è una cucina affettiva, ma il frutto di operazioni intellettuali. Allora lui che fa? Accorcia tutto utilizzando i prodotti del mercato: il chilometro zero lo pratica per primo, solo che lo chiama “cuisine du marché”. Al mercato compra un agnello e fa un piatto utilizzandolo tutto, le cervella, la lingua, il fegato; mentre i cuochi prima si limitavano al carrè. All’inizio è un po’ traumatico perché i tempi di cottura sono controversi, ma il pensiero è sano. Si lavora la verdura, si va verso il crudo, l’acido, il fermentato, l’amaro. Insomma c’è un’identità profonda che pone le basi per un nuovo umanesimo, perché si comincia a dar da mangiare alla gente, a chi magari in vita sua non aveva mai visto un salmone, abbassando anche i prezzi. Questa rivoluzione fortissima è arrivata lunga anche da noi. In Italia a quei tempi le materie prime non erano neanche prese in considerazione, i cuochi se ne stavano a casa, il macellaio portava loro un carré di vitello e facevano le cotolette. Ma il vitello ha delle razze, è buono solo se è grassissimo. È stato questo il contesto che abbiamo scompaginato. Io e Bruno Barbieri ogni mattina alle 4 andavamo al mercato piccolo, dove si trovavano le cose più straordinarie dell’orto. Tornavamo con la roba che c’era e avevamo già fatto il menu, che cambiava due volte al giorno. In questa realtà incredibile siamo incorsi in una specie di inerzia, forse per ambizioni sbagliate. E le cose sono andate come sono andate. Era questa la filosofia del Trigabolo? R. Se tu vuoi interpretare correttamente il Trigabolo, devi dimenticare che è stato un ristorante. Si è trattato piuttosto di un modo per interpretare la sua contemporaneità. Il tentativo in un mestiere di superare le difficoltà nel reperire materie prime nobili, comprese le più umili. Quello che abbiamo fatto noi per le materie prime non lo aveva mai fatto nessuno a livello mondiale, con la fortuna di avere il fuoco acceso della nouvelle cuisine. Come tutte le grandissime idee, il punto di partenza di quella rivoluzione planetaria è stata la capacità di risolvere i problemi del lavoro. Bocuse è stato bravissimo, ha messo insieme un ricettario che poteva essere eseguito nei tempi di lavoro previsti dalla legge, le 40 ore settimanali, mentre prima bisognava lavorarne 60. Siamo nella Francia del 1965-68, c’è il maggio, la gente vuole andare al ristorante ma anche al mare e vivere la sua socialità per intero, compresi i santuari gastronomici che erano riservati ai facoltosi. Eppure molti di noi immaginano la nouvelle cuisine come l’antefatto dell’avanguardia, per l’imperativo della creatività. Penso ai reiterati omaggi di Ferran Adrià o ai giapponismi dei Troisgros. Forse ha avuto polarità diverse. R. Secondo me è stata soprattutto una cucina di mercato, fatta per sterilizzare 62 caramellati, sono il frutto di una casualità ignorante. Abbiamo dato dei bignè a uno zotico per farlo stare un po’ zitto e quello, che invece aveva qualità e sapienza, ha detto: “Sono bignè, per farli diventare buoni bisognerebbe dare loro un sapore”. Solo un genio può partorire un’idea simile. Così Mauro Gualandi ha preso i bignè e li ha fritti, da bravo figlio del popolo. Li ha farciti e li ha serviti con una salsa ai mandarini. Ecco qua. M. Il Trigabolo per me era come un iceberg. La parte sommersa, il lavoro sulle materie prime, era di gran lunga la più importante. Quella visibile in fondo era una piccola parte, quanto affiorava di una storia iniziata ogni mattina all’alba. R. Come ho già detto, non era un ristorante, ma un modo di vivere, di interpretare la professione, il confine della perdizione. Il pensiero delle arti e dei mestieri in piena regola. Tanto che nell’ambiente se ne erano accorti tutti, i grandi cuochi del mondo erano sempre ad Argenta, Ferran Adrià per primo. L’unico che in seguito ha affrontato questo tema con il massimo silenzio dell’artista è stato Remo. Mentre i cuochi del Trigabolo hanno percorso altre strade, forse perché non hanno compreso il significato profondo del nutrimento intellettuale, che viene dalla possibilità di realizzare progetti che sono fuori di te, negli uomini. Oppure perché non hanno riconosciuto i loro limiti, che in fondo definiscono l’essenza, come insegna lo sport: se sei un pastaio formidabile, è ciò che devi fare. Poi il grande nemico è sempre lo stato, perché qualsiasi ristorante vero è totalmente fuorilegge. Se si ammazzano cento germani, che sono fra le cose più buone della terra, siamo costretti per 63 enologica edizione 2012 le 40 ore settimanali. E lì si è scoperto finalmente il fresco. Una vera rivoluzione. Quando noi abbiamo chiuso la partita del Trigabolo, è stato perché la materia prima era finita. non si trovava più niente da nessuna parte. I Francesi sono stati capaci di creare allevamenti di qualità, noi no. Per un pollo di qualità bisogna andare fino a Montrevel-enBresse. Mentre io compravo pesci che in un ristorante non si vedranno mai più. Per tutta l’estate quasi ogni sera andavo a Porto Garibaldi o a Marina di Ravenna e mi fermavo ad aspettare in una gelateria. Ti voglio raccontare un episodio eccezionale. Un giorno ero al mercato a Chioggia, dove mi recavo quasi tutti i giorni. C’era un signore mostruoso, uno di quei vecchi segnati dal vento, che calzano scarpe di gomma enormi. Lui è in piedi, davanti a sé ha degli scampi da 170-180 g bellissimi, che si muovono dentro alla cassetta. Io lo guardo e mi metto a ridere. E lui fa un mezzo sorriso. Arriva il figlio di un importante commerciante di Porto Garibaldi. Lo guarda e gli dice: “Quanto costano?”. Lui resta impassibile. “Quanto costano? Ti ho chiesto quanto costano”. Lui non risponde. l’altro si scalda e il vecchio si gira dall’altra parte. Lui che è un cretino gli va davanti e gli ripete la domanda. Al che il pescatore fa: “A te non te la do la roba perché sei un paesano”. Pensa, un uomo che non aveva fatto neanche la prima elementare. Ed è finita che li ho comprati io, ovviamente. Il Trigabolo era pieno di geni che avrebbero contaminato l’intero percorso degli anni ’80 e ’90, c’era più genialità ad argenta che in tutta l’Italia messa assieme. Geni anche ignoranti, visto che il più grande dolce del nostro tempo, che sono i bignè fritti legge a buttarli via. Dobbiamo andare avanti ancora molto tempo in questo modo? Le quaglie non si possono vendere, non si possono comprare, non si possono ammazzare… E per concepire gli studi di settore bisogna essere completamente matti. grande coniglio, un grande pollo, un grande pesce. E la padrona della cucina mondiale, che è la selvaggina. La selvaggina è sacra, quasi come il castrato, che però è invendibile, intrattabile, costa troppo ed è andato perduto. Un animale di 70 chili dal petto villoso, senza niente da mangiare, nemmeno le costolette, con le gambe secche e un grasso che sa naturalmente di ciccioli. Come avevi accumulato la tua formidabile conoscenza delle materie prime? R. Girando per il mondo, andando a conoscere la gente in bicicletta, suonando il campanello ai contadini. I miei maestri sono stati la curiosità, il tempo, la voglia di vedere. Ho cominciato a tenere da conto il vino, semplicemente perché mi piaceva, ho voluto conoscere i territori e poi di lì sono passato al cibo, che è molto più complesso e interessante. All’inizio c’è stato Columella, l’agronomo di Adriano; poi il mio grande amore per il Barolo mi ha portato oltralpe, perché il Piemonte è un pezzo di Francia. La matrice di questa cucina è femminile? R. Che problemone che poni… Sì, la matrice è totalmente femminile, i maschi non se ne sono mai curati. Un pochino al nord, sporadicamente. Ma ha cambiato sesso quando si è fatta complessa e si è passati dalla cucina di casa alla commercializzazione nei bordelli, dove si faceva da mangiare (da qui il vecchio detto che uno si è “chiavato la minestra”, nel senso che invece di mangiare è andato su perché aveva solo quei 10 baiocchi). Al Trigabolo eravamo tutti uomini, perché è un lavoro di sacrificio, ed è diverso gestirlo se la libertà è acquisita oppure è una conquista, come accade alle ragazze. Nel senso che il cuoco fa quel tot di ore poi smonta, sta fuori fino alle 4 e magari il giorno dopo arriva con un’ora di ritardo. Mentre la cuoca è castigata sul lavoro come a casa. E in questo modo non dura. Prima parlavi della nouvelle cuisine. La Francia ricorre spesso nelle tue parole. R. Perché la Francia è empirista. Non ha Dio, un bel vantaggio. Ed è un mondo senza puttanate. Poi i francesi hanno preso il volo con la roba di allevamento, hanno stracciato tutti. Ma non so se è la nostra strada. Noi dobbiamo percorrere la strada dei cibi veri, dove la gastronomia si intreccia alla scuola. Perché per fare da mangiare il pesce ci vuole il pesce. Scrivilo pure col sangue. Quindi parliamo di cose serie: il mare, la terra, i pesticidi, la valle. Tu, Remo, hai imparato a cucinare in casa, dalle donne della tua famiglia? C. Qualcosa sì, ma in generale sono autodidatta. Non ho mai fatto un corso, solo un paio di stage in cucina. Nella ristorazione ho cominciato dalla sala. Cucinavo solo a casa per gli amici, poi nel ’94 abbiamo aperto la Trattoria e Daniela Pompili, che prima era alla Grotta, ci ha seguito nel ’96. Nonostante le suggestioni francesi la cucina del Trigabolo era una cucina di territorio. R. Solo perché volevamo vivere le materie prime come andavano vissute, per avere un 64 Le ricette dove le hai imparate? C. Anche in casa, sebbene mia madre sia di origini abruzzesi. Ma qualcuna è inventata. Per esempio la crema di zucca con aglio, scalogni, mandorle e cannella, servita con un’altra crema di ricotta e ravaggiolo. È quasi un dessert tutto giocato sulla delicatezza, e se così non fosse occorrerebbe un contrasto scioccante. Il risultato è un sapore che conosciamo già e che non è neanche da spiegare. Il tuo lavoro però non è solo in cucina: il tema di Enologica è la filiera, tu fai la spesa e raccogli le erbe spontanee qui intorno. C. Direi che la cucina è la parte finale del lavoro, importante ai fini della gratificazione. Ma prima ci sono tante altre cose, che io non trovo affatto straordinarie. Per me è automatico, operando in una zona semirurale, raccogliere le erbe o i funghi, oppure avere amici contadini. Non è che una mattina mi sono alzato con la fantasia di cambiare il sistema di approvvigionamento: è qualcosa che è venuto da sé. Il nostro tipo di cucina è molto semplice, quasi casalingo, ma prevede materie prima di valore. Ed è sempre più complicato reperirle. Qua intorno ci sono due produttori di ortaggi importanti che stanno smettendo per ragioni anagrafiche. È in atto una forte mutazione. I prodotti che usi sono tutti locali? C. Quasi tutti. Poi non sempre la verdura migliore è quella del contadino dietro casa: se non è lui è un altro. L’importante è trovare il pomodoro buono, l’olio buono, la farina buona. Soprattutto riconoscerli. Qui è pieno di aglio ed è normale che col tempo abbia imparato qual è il migliore. Ma per fare un buon piatto con aglio e rosmarino, è importante che l’aglio sia buono, che il rosmarino non sia secco, che l’olio sia giusto. Ci sono quattro elementi contando la carne e devono essere tutti eccellenti. a quel punto diventa tutto più semplice, il secondo è fatto. avendo gli ingredienti in casa, buoni anche se forse un po’ cari, sarebbe quasi più complicato cercarli altrove. Ma non sono un selezionatore, perché uso ciò che ho vicino. E se questo diventa straordinario, vuol dire che la situazione è compromessa. Secondo me il futuro è nella produzione di nicchia, nei piccoli allevamenti rigorosi ma economicamente sostenibili. Il ruolo del cuoco, una volta scelti gli ingredienti, è di pura elaborazione tecnica. Non avrei neanche le capacità per fare una cucina diversa da questa. Come hai conosciuto Giacinto? C. La prima volta che l’ho visto è stato al Trigabolo, da semplice cliente. In quel periodo lavoravo al Gigiolé, ma credo di non averci neanche parlato. Ricordo uno dei migliori pasti che abbia mai fatto, veramente. Le canocchie aglio e prezzemolo, gelatinose dentro, appena scottate, con il loro condimento delicatissimo: tre elementi per un grandissimo piatto. Oppure i bignè fritti caramellati. Esempi di una cucina moderna, poco elaborata, dietro la quale si sentiva un discorso colto. Penso che 65 enologica edizione 2012 Ai fornelli ci sono approdato un po’ per stanchezza, non volendo gestire altre persone. E infatti mi sono trovato subito bene. Perché mi piace molto cucinare, mentre non sono portato per il contatto col pubblico. il regista sia sempre stato giacinto, tanto che i cuochi senza di lui hanno percorso strade diverse. Ma il Trigabolo, guido da Costigliole e Vissani restano i tre ristoranti dove ho mangiato meglio in assoluto. del ristoratore. Questo non è più un lavoro, è un’avventura insensata. Per gestire un ristorante si commettono in media un centinaio di reati civili e penali al mese. E si finisce per perdere soldi. La domanda di qualità non esiste, manca l’impresa. E in questi guai gli uomini di qualità non vogliono starci. Già al Trigabolo abbiamo pagato un prezzo troppo alto. Il Trigabolo però non esiste più. Tu che cosa hai fatto in seguito Giacinto? R. Sono andato a fare da mangiare per un privato, un industriale già cliente del Trigabolo, per le sue aziende e i suoi ospiti. Faccio tutto io, dalla spesa alla scelta del vino, e finalmente sono cibi che non sono da vendere e mi consentono di spaziare. In questo momento per esempio ho un fondo che sta cuocendo pian piano sul fuoco, speriamo non si asciughi troppo. Su una scala di questo genere i prodotti si trovano ancora. Pesce, verdura, ma anche tanta selvaggina. Perché a livello privato non ci sono leggi, e in questa forma di libertà si raggiungono livelli gastronomici molto alti, impossibili per un ristoratore. A cosa alludi? R. Alla nostra chiusura. Noi ci recavamo sempre in valle a prendere la roba, ma la selvaggina bisogna tenerla in penna, anche sottovuoto. È successo che è venuta l’USl, ha trovato dei germani in frigorifero e siccome sono vietati ha deciso la chiusura per una settimana, come fa sempre, ma con riapertura a norma. Un giochino da 500 milioni. Noi siamo andati avanti per qualche settimana, ma economicamente non ci stavamo più dentro. La chiusura però era già in corso, perché avevamo esaurito il nostro compito, avevamo appagato le nostre ambizioni. Quando negli anni ‘80 ripetevo che nel giro di una ventina d’anni avremmo fondato un vero ristorante, alludevo a qualcosa che è ancora da fare e che probabilmente in Italia non esisterà mai. Una vera, grande maison, che è tutta un’altra cosa. Il futuro della ristorazione è questo? R. Direi piuttosto che la ristorazione non ha futuro. l’unica speranza è che si abbandoni la gastronomia per vivere completamente nell’alveo delle leggi. Perché solo seguendole è possibile fare cose di alto livello morale, intellettuale, umano. Il compito del ristoratore è operare a norma di legge, come McDonald, altrimenti deve chiudere. È amaro constatarlo, ma lo stato ha distrutto i mestieri. Dentro qualsiasi ristorante ci sono 10 persone che lavorano fuori dalla legge. Ma sarà mai possibile? Per non parlare della tassazione abnorme, mentre il rischio d’impresa è tutto a carico Come giudichi la ristorazione contemporanea? R. Vedo tanto vecchiume, a prescindere dalle età anagrafiche. Vecchiume che per me è una forma di decadenza borghese, senza vita e senza futuro. La ripetitività di gesti conosciuti che hanno dato un risultato di perfezione. Ma quando una cosa è perfetta non bisogna più farla assolutamente. Non parlo della tagliatella, che è un piatto al di là del bene e del male, di cui facciamo parte noi stessi e in cui ci si può perdere, tanto è complicata. Ma della cucina 66 I camerieri del Trigabolo non sono passati alla storia come i cuochi. R. Ed è un peccato, perché erano bravissimi. Forse li ho un po’ uccisi io, avendo una personalità spiccata. Ma spesso erano persone di grande spessore, capaci di conversare nello stesso modo di Prost e di Proust. Perché la sensibilità è tutto. Per darti una ricetta dovrei raccontarti gli ultimi 30 anni della mia vita. Ti sembra mai possibile? Significa che l’eccellenza in cucina è una conquista della maturità? R. Come tutto ciò che vale. Anche l’amore non è un sentimento di gioventù. Il garbo, la riservatezza, la rinuncia sono conquiste tardive. La cucina risente molto di tutto questo, nella ricchezza di particolari, nella luce, nella trasparenza. È difficile da decifrare. Internet in tutto questo? R. È la rappresentazione intellettuale di un mutamento antropologico che la mia generazione stenta a comprendere, nel senso della primazia del virtuale e del visivo. Un aspetto che non siamo ancora in grado di valutare. Ma è utilissima, perché se ho bisogno di trovare del merluzzo nero polacco posso trovare le risposte che cerco, informazioni sui prodotti e sul lavoro della gente. Io sono un po’ come le donne romagnole... hanno un marito, un fidanzato, un amante e il cuore libero. Mi sento totalmente aperto. La cosa che mi interessa di più adesso sono le tecnologie che rivelano le temperature, perché la cottura è sensibilità pura. Non è un peccato che il frutto di queste ricerche non venga divulgato? R. Brava. Ci sei arrivata. Ma il concetto in cui ci si muove quando si diventa vecchi, e io ho 65 anni, è che pure a fare le carezze si ha paura di far male, come ha scritto De Andrè. C’è come una forma di prudenza, il tempo va troppo forte, le cose si consumano con rapidità eccessiva. Ti sembra di violare il più grande segreto della vita, che è l’intimità, la riservatezza. E allora scatta il meccanismo della paura, dovuto alla consapevolezza dell’amore per il proprio mestiere. Mia mamma Concetta, che è una cuoca bravissima, dice una verità che gli altri snobbano sempre un po’, come se fosse priva di importanza. Mentre io so con quale materialità faccia i conti rispetto al resto del mondo. Dice che la cucina è come un bambino piccolino di sei mesi, tu ti giri e lui si ammazza. Non puoi abbandonarla neanche un secondo. Se togli gli occhi di dosso alle cose, quelle non vanno mai bene. Il mio fondo sul fuoco come un ristorante o un’intera tradizione. Non fa paura una responsabilità del genere? 67 enologica edizione 2012 come un piatto di patatine fritte, magari ne mangi 1500 e sono tutte diverse, quindi arrivare alla perfezione è rarissimo. Ed è un bene, direi che è l’interesse della cosa, perché l’uomo cerca sempre la felicità in tutte le sue sfaccettature, ma è banale pensare di raggiungerla. La si cerca, come si cercano le cose che ti cercano. Ci vuole la sensibilità, l’arte, una roba dell’animo. La vocazione. Le cose sono davanti agli occhi ma non tutti le vedono. Come i grandi camerieri, che arrivano sempre qualche secondo prima che il cuoco impiatti. 68 edizione 2011 Nessuno è la patria, tutti insieme lo siamo. JOrGe lUiS BOrGeS Teatro dei Cuochi il Tema 2011 «150 anni di memoria condivisa.» Giorgio Melandri 70 “Il limite non è il punto in cui una cosa finisce ma, come sapevano i Greci, ciò a partire da cui una cosa inizia la sua essenza„ Martin Heidegger Ort, ovvero luogo. Che sia etimologia o paraetimologia, a detta di Martin Heidegger è la punta della lancia. “Tutte le parti della lancia convergono nella punta. L’Ort riunisce attirando su di sé in quanto punto più alto ed estremo. Ciò che riunisce trapassa e permea di sé tutto. L’Ort, come quel che riunisce, trae a sé, custodisce ciò che a sé ha tratto, non però al modo di uno scrigno, bensì in maniera da penetrarlo della sua stessa luce, dandogli così la possibilità di dispiegarsi nel suo vero essere”. Sembrerebbe un paradosso, quello di un lungo dinamico e puntato verso l’alto. Quasi fosse un magnete che aggrega e catalizza lungo parabole a venire. E invece rende il senso palmare di una parola sepolta dai detriti della storia, estratta dalle stratificazione pulviscolari del tempo e dalle macerie dell’antiretorica con un refolo di vita fra le labbra, complice l’alea dell’annuario, archeologi milioni di contemporanei. Vecchia di 150 anni, la parola “patria” si affaccia sotto il sole giaguaro del terzo millennio senza tracce di ruggine. E siccome ogni comunità ha 71 enologica edizione 2011 Patria nella ferma convinzione che come insegna persino Anton Ego, la ratatouille della mamma è ancora e sempre il cibo migliore, o perlomeno vince facile grazie alle sollecitazioni precordiali. Eccolo qua, allora, il fiume Alfeo della cucina italiana, la stessa dell’Artusi e prima ancora delle élites di una nazione ante litteram (giacché, notava Piero Camporesi, i gustemi del forlimpopolese hanno contribuito più degli stilemi e dei fonemi manzoniani alla costruzione della comune patria italiana, che comunque nel sentire e nelle consuetudini delle classi dirigenti già c’era). Fiume che dopo avere attraversato il mare magnum di ogni globalizzazione, è andato a riaffiorare proprio colà dove era nato. Le lingue franche avanguardiste, i pidgin dell’hôtellerie, le contaminazioni dell’industria alimentare, le voghe fusion, le colonizzazioni straniere – e poi la foce proprio fra le coordinate della sua sorgente. Un lavorio che il mito vuole invisibile e impenetrabile, miracoloso nella separazione di acque tenaci e immense, minuscole e cieche, adynaton di una riconquista che ha il gusto d’epos di una novella Odissea. Certo anche la patria ha i suoi rischi e i suoi cascami. Per esempio il kitsch. Etichetta che gli estetologi attaccano all’opera che per fare accettare la sua visione di stimolatrice di effetti, si pavoneggia con le spoglie il pleonasmo stratiforme di un feuilletage ben riuscito, i medesimi disegni stampati su ogni articolazione delle sue strutture, la lancia è lì per infilzarle una ad una. Fino alla superficie patriottarda dei fumi di cucina. Patria, dicevamo, o forse “patrie”. Giacché quella che ab origine era la terra dei padri, dove erano sepolti i loro resti e ospitati i sepolcri, ha poi stretto nel suo abbraccio semantico la grande patria e le piccole patrie, sovrapponendosi alla nazione, gonfiandosi nell’universalismo della patria-mondo o sbriciolandosi nei particolarismi comunitari. Tanto che se ciascuno ha la sua patria da camera, da lì si dipartono altre patrie più o meno maiuscole, più o meno catastali. Ciascuna con la sua cucina ben equipaggiata. “Siamo tutti penisole, per metà attaccate alla terraferma e per metà di fronte all’oceano”: l’incastro di Amos Oz scatta sonoramente in Italia, dove la penisola lascia cadere la metafora puntando il dito diritto alla cartina. È anche una questione di tempi, o meglio ancora di fisica newtoniana. Quella del principio di azione e reazione, per cui la costante spinta alla globalizzazione ha innescato un virulento ricorso a dimensioni sartoriali. Recherche tanto più evidente in cucina, dove la voga del terroir ha coniato gergo e pratiche del chilometro zero e della filiera cortissima, 72 respiro breve di un meccanismo destinato all’arresto. La cosiddetta morte termodinamica è in agguato. L’antidoto significa aprire le dighe dell’identità e sporcarsi il passaporto. La penisola di cui parlava Amos Oz, destino geografico della patria italiana, montata magari come métissage di patrie piccole e grandi, quale coperta rapsodica di tessuti personali. Sempre diversa ma dall’aria famigliare: bandiere di frattali multidimensionali con un lato saldamente sigillato; micropatrie frammentarie da ripiegare e infilare in valigia in vista della prossima peregrinazione. Come il corollario della globalizzazione surmoderna (luogo dell’eccesso di tempi, soggettività e soprattutto spazi, ricordiamolo quando apriamo il nostro frigo arabescato) è stato a lungo il ristorante non-luogo nell’accezione di Augé, il rinascimento della patria ha seminato locali connotati come luoghi antropologici, patrie bonsai cui si ormeggiano le identità individuali. “Se un luogo può definirsi come identitario, relazionale e storico, uno spazio che non può essere definito né identitario, né relazionale, né storico è un non-luogo”. Laddove la spersonalizzazione aveva ridotto sale e salette a meri luoghi di transito, interscambiabili, asettici, buoni tutt’al più ad essere fruiti 73 enologica edizione 2011 di esperienze altrui. Una malattia da cui nessuna tendenza è immune, ma che qui prende le forme del ruralismo posticcio e del nostalgismo pauperistico, di una costruzione ex post con materiali di recupero esausti e operai sfaccendati. “Per questo tutto ciò che viene propinato all’insegna del ‘tipico’, del ‘casalingo’ è quasi sempre kitsch alimentare, paccottiglia di rigatteria culinaria, che trova slancio e fortuna nella nostalgia del consumatore, orfano del passato, ignaro delle arbitrarie e cervellotiche mistificazioni perpetrate sopra il dolente e pungente desiderio di una mistica cucina ‘genuina’ confezionata dalle mani amorevoli di mamme e nonnine larvali e inafferrabili: anche a tavola il recupero del passato diventa operazione disperata al limite della necrofilia”, scriveva sempre Camporesi. È la ripetizione sclerotica di un sistema chiuso e perciò stesso destinato alla decadenza entropica. Incurante di quel principio della termodinamica che insegna come solo un principio esterno possa rimetterlo in moto: mentre la chiusura lo condanna fatalmente ad esaurire il potenziale accumulato, l’apertura gli restituisce la differenza, ed ogni motore, insegna Carnot, funziona proprio grazie ad essa. La patria murata e insulare ha il come bene di consumo da numeri primi senza comun denominatore, la nuova sfida è farsi luogo di condivisione capace di integrare vecchio e nuovo, “les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité” per dirla con Baudelaire, anticipatore degli sperimentalismi architettonici di Parigi. Ma c’è un però, al patriottismo testé resuscitato. Che l’arte è per sua natura straniamento, cioè tensione con una certa patria e la sua naturalità immediata. L’arte parla una lingua straniera, scriveva già Aristotele; dealgebrizza e semina il perturbante dell’ignoto. Ci strappa il cloroformio delle aspettative; sabota le pulegge delle sinapsi in pantofole; dipinge realtà allotrios anziché kyrion con lo sfavillio di vocaboli rari e peregrini (xenicon). Insomma rende altro, l’altro che è in noi: e così finisce la sua operazione galvanica sopra un concetto che occorre incessantemente rianimare. Che la temperatura delle nostre civiltà sia tornata a scendere, e il magma delle tradizioni a rapprendersi e cagliare, non significa necessariamente un rappel à l’ordre alimentare. Dalla forma gotica alla materia romanica, dall’Odissea individualista all’Iliade collettiva: un’altra ars nova è possibile su una patria che scaglia la sua lancia lontano. 74 Alberto Bettinii La poetica di Amerigo è tutta qua. Un concept così adamantino, da sparigliare i menu con serena evidenza. Il tomtom che guida il cliente affamato a inerpicarsi lungo le strade dell’appennino non è meno preciso del navigatore che orienta la sua cucina, capace di una localizzazione perentoria e centripeta, senza digressioni o scampagnate nell’esotismo. Mentre gli ingredienti sono teleguidati a piedi o dentro portabagagli polverosi, piuttosto che sulle ali della turbocucina cosmopolita. Classe 1961, come la Faema sul bancone e le lampade Castiglioni in saletta, fra vecchi legni non meno melodiosi di un concerto d’oboe, il patron Alberto Bettini canta la sua patria come un impiccato discetterebbe di nodi scorsoi, senza concessioni ai nostalgismi o alla querelle sciovinista. Il suo territorio è un’altra cosa: la tela alacre di una renaissance puntiforme, capace di risvegliare le materie prime da un’amnesia ventennale fatta di profitti selvaggi, standardizzazione e roundup. Invece no. In piena voga locavore, da consumato maieuta ha disseminato le colline di artigiani della gola, inaugurando la strada maestra di una pre-cucina celebrata anche a Eataly, fra i banconi del mercato e le facciate di chiese trecentesche ingoiate nei magazzini. Il seme del piatto germoglia sotto la vanga e fiorisce nella porcilaia. Porgerlo è l’ultimo atto di una storia collettiva che si affresca intorno a noi. Ed è una favola compiuta e perfetta, come vuole la Poetica che abbiamo tutti appreso a scuola. Ristoratore aristotelico per eccellenza, Bettini poeta la sua Savigno con aderenza in elastene ai dogmi della narrazione che fila. L’unità di tempo della stagionalità ortodossa e della contemporaneità condivisa, quasi che l’orologio fosse l’ultimo piatto da spartirsi a centrotavola; l’unità di spazio della sua Savigno, tenuta al guinzaglio di un chilometraggio implacabile; e l’unità di azione di una coerenza di ferro, che spalma il suo stile solido su tutti i piatti in carta, come un comfort food d’alta gamma. “Vedi, è questa la vera trattoria: un modo di intendere la cucina, piuttosto che un repertorio o una fascia di prezzi”, sbotta Giorgio Melandri, folgorato dal crostino con midollo e tartufo. “Hai ragione”, annuisce il peripatetico. “Perché la trattoria è l’interpretazione di un luogo. Un ristorante può fare ciò che vuole, anche usare i tartufi cinesi; ma una trattoria no, perché è l’ufficio informazioni, la proloco, il comune, la farmacia, il dottore e i carabinieri, tutto insieme. E cos’è Bottura, rispetto a tanti posti mediocri, se non una grande trattoria?”. Le norme del gioco aristotelico si accomodano sui vertici del quadrato semiotico come quattro commensali 75 enologica edizione 2011 Amerigo 1934 Via Marconi 16 - 40060 Savigno tel. 051 6708326 - www.amerigo1934.it tanto naturale non era. Il mio primo ricordo in assoluto è di essermi svegliato una mattina, verso i 4 anni, con questo odore di mosto. E sentivo gente che faceva rumore, perché sotto la mia stanza c’era la cantina, che oggi ospita da una parte i miei vini, dall’altra il laboratorio per la lavorazione delle carni. Ho aperto la finestra e mi è arrivata questa zaffata di uva pigiata. Una sensazione inebriante, che non mi ha più abbandonato. L’odore di mosto da allora mi colpisce sempre, e quando vado nelle cantine mi visita il ricordo. Il vino lo assaggiavo e mi piaceva già allora, perché non c’era il salutismo di adesso. O forse ce n’era anche di più, perché io sono nato in cantina e ho iniziato a bere con mio nonno, ma non mi sono mai ubriacato. Il mio compito principale era imbottigliare con la macchinetta manuale, mentre tappare mi piaceva poco, ed era anche pericoloso perché ogni tanto scoppiava qualche bottiglia. Mi piaceva molto anche filtrare e pigiare le vinacce per ricavare il torchiato, che era un vinello di seconda scelta per gli amici. In cucina c’erano mia nonna, mia madre e mia zia, perché a quei tempi era una professione esclusivamente femminile. Mai nessun uomo di campagna si sarebbe messo ai fornelli, non sarebbe stata considerata un’occupazione decorosa. All’inizio l’offerta era limitata: c’era quello che c’era. L’osteria fungeva prevalentemente da luogo di ritrovo per le persone del paese e coloro che venivano dalle campagne circostanti, perché Savigno è un comune molto vasto, che ha sempre rappresentato il centro commerciale dell’Alta Valle del Samoggia. La gente scendeva il sabato, la domenica o il martedì, che era giorno di mercato. Si ritrovava nell’osteria a bere e fare una partita a attorno al tavolo. Contrari il territorio e il cosmopolitismo, subcontrari il prodotto e la creatività. Cosicché la vicenda dell’istituzione trattoria scivola morbidamente sull’asse dei contraddittori, per abbracciare con una forchettata il territorio e la creatività. Mentre il ristorante, chiede il navigatore con insistenza, dov’è? Amerigo rappresenta da decenni un unicum agli occhi dei gourmet, per la sua capacità di coniugare istanze contrapposte in una sintesi che ha precorso i tempi e le mode. Come ci siete riusciti? La storia è quella nota. Di mio nonno Amerigo che nel 1934 ha deciso di fare lavorare mia nonna e di aprire l’osteria. Perché a quei tempi in campagna erano tutte osterie, non c’erano né trattorie né ristoranti. Visto che è morto nel ’74, me lo ricordo bene; e mia mamma dice sempre che gli assomiglio molto. Da quando ho memoria sono sempre stato in giro con lui. Tutte cose che un ragazzino sui dieci anni non vuole fare, perché di solito a quell’età preferirebbe andare al fiume in bicicletta oppure giocare a calcio. Quindi da un certo punto di vista non mi piaceva molto quando mi cercava, ma da un altro punto di vista era molto interessante. Per esempio già allora amavo stare in cantina, piuttosto che in cucina. Perché nel frattempo le osterie si erano metamorfosizzate in trattorie. Il nonno aveva origini contadine e il vino se lo faceva da solo, finché non è morto; comprava l’uva in giro dai suoi amici e poi vinificava. Era molto naturale, biologico ante litteram, se vuoi, con la fermentazione a tini aperti, i lieviti indigeni e la filtrazione con i sacchi; però i contadini tenevano la vigna come pareva a loro, quindi l’uva 76 Cosa ricordi degli insegnamenti di tuo nonno? Più che le parole o i gesti, la sua pignoleria. Forse per questo mia madre dice che sono come lui. Perché comunque era abbastanza esigente con i suoi uomini, quelli che lavoravano con lui, i 3 o 4 fidati. Dava anche tanto, ma quando c’era da lavorare, gli piaceva che tutto filasse liscio e ogni tanto si alterava. Le donne al suo fianco facevano una cucina molto basica, senza guide né libri di cucina. Mia madre preparava semplicemente ciò che le aveva insegnato sua madre. E cucinavano tutte esattamente nello stesso modo, anche se andavano a occhio e non c’era niente di scritto, le loro mani non si potevano distinguere. Per le ricorrenze c’era un menu speciale? Dopo la guerra sì, quando dalle città è iniziata ad arrivare un po’ di gente benestante, che il sabato e la domenica veniva in campagna per mangiare con le prime automobili. Ed era un pasto ricco, quindi tortellini e lasagne, mentre magari gli altri giorni c’erano solo due strichetti con un po’ di salsiccia. Un rito della domenica, che mi è rimasto ben impresso, erano le tigelle. Le facevamo sempre, ma la domenica pomeriggio tutta la gente del paese veniva a prenderle per mangiarle in giro o portarle a casa e le farciva con il pesto cotto, che era il condimento che andava per la maggiore. Adesso per assurdo non si fa quasi più, c’è solo il pesto crudo. Ma io mi sono divertito come Dispensa a ricrearlo nel vasetto. Gli ingredienti sono gli stessi: il lardo, il rosmarino e l’aglio che però vengono cotti, in modo che il grasso si scioglie, si alleggerisce un po’ e restano tanti cicciolini di carne aromatizzati. Più il Parmigiano grattugiato. Di queste me ne mangiavo un bel po’ anche io. Eravate l’unico locale del paese? No, ce n’erano tanti altri. Adesso sono 4 o 5, ma mi dicono sempre che un tempo ne esistevano il triplo, perché il paese era più abitato, c’erano 6000 abitanti rispetto ai 3000 di oggi. E la gente andava al bar o all’osteria perché comunque c’erano meno occasioni di uscire. Cos’è successo durante la guerra? Che si è proseguita l’attività con quello che c’era. Mio nonno, che era nato nel 1909, aveva già fatto il militare per alcuni anni, poi era rimasto a casa per un problema di salute. Ma a quei tempi gli incassi erano veramente ridotti, l’osteria era un mero punto di incontro per coloro che si trovavano ancora a Savigno. 77 enologica edizione 2011 carte e magari verso l’ora di pranzo mia nonna faceva uscire un piatto di lasagne, un coniglio arrosto o una cacciatora di galletto. Quello che mio nonno aveva trovato in giro. Perché di fianco all’osteria, dove adesso c’è la dispensa, si trovava la drogheria, dove vendevano prodotti di consumo, come la pasta, le farine e il sale, ma anche un po’ di vino e qualche animale da cortile raccattato in campagna. Quando mio nonno ne aveva in eccesso andava via la mattina per venderli a Bologna e tornava la sera. La dispensa è nata da questa idea, di mio nonno che raccoglieva prodotti e andava a venderli. Un po’ quello che mi piace fare adesso. Ti è stato raccontato dell’uso di succedanei, o degli effetti della battaglia del grano? preso per fargli fare l’aiutante del barbiere che rasava i capi. Poi appena i tedeschi scapparono tutti, lui corse a casa per chilometri a piedi. E dopo la guerra è iniziata la trasformazione in trattoria. Mi hanno sempre detto che erano costretti ad arrangiarsi. Ma essendo in campagna qualche maiale lo ammazzavano sempre e qualche gallina ci scappava fuori. Nei ricordi di mia madre Giuliana e di mia nonna Agnese, che è vissuta fino agli anni ’90, i succedanei erano legati a prodotti particolari, come il caffè. Non c’era un succedaneo della gallina che non fosse la gallina stessa, magari ce n’era solo una in meno. Oppure la povertà, le solite storie della saracca. Nelle case si trovavano a mangiare poche cose, e una polenta per venti persone veniva insaporita con un pesce secco. Ma erano esperienze che accomunavano tutti gli italiani in quegli anni. Com’è avvenuta? Subito, pianino pianino. La cucina è diventata un po’ più cucina ed è stata costruita l’abitazione sopra la bottega. Dove vivo io adesso, perché in casa mia la cucina non c’è. Il locale originario aveva un unico piano, ma nel ’53 mio nonno aggiunse il primo piano sopra, con una saletta TV come capitava in tanti locali a quei tempi. Era la prima del paese e i paesani venivano a bere e a guardare Lascia o Raddoppia. Poi nel ’59 costruì il secondo piano. Da una parte c’era la sua abitazione, dall’altra due camere della locanda per i primi villeggianti, che venivano da Bologna in estate per stare un po’ al fresco. Questi ospiti me li ricordo bene, perché erano sempre gli stessi, un po’ abitudinari. C’erano il maestro che veniva ad insegnare a Savigno ma non era locale, i carabinieri che erano privi di alloggio, le guardie forestali. Si piazzavano qui e diventavano un po’ persone di casa. Praticamente vivevano con noi, perché il bagno era in comune. Era un vero bed and breakfast. E la resistenza? Il fronte è rimasto fermo da queste parti, sulla linea gotica, dall’inverno del ‘44 alla primavera del ’45; c’erano i comandi tedeschi e la resistenza tutt’intorno. A me hanno raccontato le solite storie, legate a gente che spariva o partigiani che non si trovavano più. Soprattutto riguardo ai numerosi bombardamenti degli alleati scatenati alla fine. E mi dicevano che tutto sommato l’inverno era stato abbastanza tranquillo, a parte i movimenti partigiani. Il momento più critico fu quando i tedeschi cominciarono a capire che stavano arrivando gli americani; tutti erano sfollati dal paese, erano andati ad abitare fuori nelle frazioni e si nascondevano nei rifugi. E ci sono stati tanti morti. Il centro è stato molto colpito dagli attacchi aerei con lo sfondamento della linea gotica. Mio padre mi racconta sempre che quando aveva 12 anni i tedeschi l’avevano In cucina non aiutavi? Come no. Un altro dei compiti che mi affidava mio nonno era andare a prendere le trote, perché negli anni ’60-70 Savigno era famosa per la piscicoltura, poi la sorgente negli anni ’80 si è asciugata. Ma a quei tempi tutti facevano la trota a Savigno e c’era la famosa sagra della trota, che attirava un mare di gente. Mentre adesso non verrebbe più nessuno. L’allevamento si trovava a 500 metri dalla 78 Col senno di poi, come valuti quella cucina? Era una cucina di odori, di sapori, di cose vere, anche un po’ ingenua, ma forse bella per questo. Vado ancora a cercare locali così in giro ma non esistono più, e del resto non potrebbe più esistere questo modo di trattare gli alimenti, che era un po’ approssimativo. Credo che non si sia mai ammalato né avvelenato nessuno, ma adesso non sarebbe possibile. La cucina era minuscola, una decina di metri quadrati rispetto ai 25 che ho adesso. C’era un tavolo con la spianatoia sempre pronta dove si preparavano la sfoglia e le tigelle e altri due tavoli dove mangiavamo noi e i clienti delle camere, perché si accedeva dal retro. I fornelli erano a vista, con una vetrata in ferro di cui sto cercando le foto. Cos’è rimasto immutato della cucina delle origini? La tigella per esempio è cambiata? È sempre uguale, come tutte le ricette classiche, dalle lasagne al ragù, al ripieno dei tortellini e al brodo. Ma sono cambiate altre cose. Il sottovuoto per esempio è molto utile anche per fare tradizione, penso alla conservazione di una monoporzione di galletto alla cacciatora, che può essere rigenerata e servita come fresca. Mentre un tempo si cuocevano due galletti alla cacciatora e succedeva che al primo arrivava buono, al secondo troppo cotto e il giorno dopo era quello riscaldato. Adesso tutto questo non succede, ma la ricetta è ancora quella e i galletti sono solo migliorati. Ho fornitori locali molto bravi e gli animali da cortile vengono allevati per bene, non come facevano negli anni ’60-70, quando puntavano a ingrassarli in tutta fretta. Perché il mito dell’agricoltore mi piace, ma il contadino è anche un furbetto. Mi metto nei suoi panni: è stato sfruttato per millenni, è chiaro che adesso deve presentare il conto a qualcuno. Per questo è pericolosissimo come fornitore. Io per fortuna ho creato una rete di persone che sono affezionate alla terra, perché spesso hanno scelto di tornarvi, come io sono 79 enologica edizione 2011 trattoria, ai piedi di una discesina. Mio nonno si faceva sempre una piccola scorta, ma poi capitava che arrivasse più gente del previsto e le trote erano da prendere al volo. Allora io partivo con la bicicletta nera di mio nonno e la borsa di plastica traforata blu, suonavo in casa e mi davano il pesce. Tornavo e lo pulivo. Un’altra cosa che mi piaceva moltissimo era andare a rane. Quando era il periodo giusto partivo insieme a mio padre e altre persone di notte con le fiocine e le lampade ad acetilene, un altro di quegli odori che mi piacciono, “carburo” come si dice in dialetto. Tornavamo alle 2 di notte, che per un bimbo era un’avventura, con i cestini pieni di rane e la mattina dovevo pulirle tutte. Cosa che non mi piaceva un granché, soprattutto perché mi venivano i calli a forza di decapitarle con le forbici che non tagliavano. Nel menu della trattoria c’erano sempre, e le tengo ancora, ispirandomi alla ricetta di mia nonna. Che le friggeva infarinate e le ripassava in umido, un po’ alla livornese, per servirle con le tigelle da tocciare. Mentre io tutto questo l’ho trasformato in un sugo per condire gli strichetti. tornato alla trattoria. Quindi lavorano con consapevolezza e con criterio, in un clima di crescente attenzione sul cibo. Uno dei miei vecchi fornitori invece ha 90 anni, lavorava già con mio nonno e mi fa divertire moltissimo perché cerca sempre di fregarmi 100 lire. 2 o 3 maiali l’anno. Li cresceva con gli avanzi dell’osteria dietro il campo da bocce, negli spazi fino al fiume dove teneva l’orto, la porcilaia, i conigli e i galletti. Ho ancora il tavolo dove faceva i salumi, il numero 6 nella sala di sopra. Io gli davo una mano ma di malavoglia perché c’era troppa umidità. Preferivo il vino e col tempo ho iniziato a fare i corsi da sommelier, sull’onda dei ricordi. Mentre oggi se ci penso la mia passione principale sono i cibi e le materie prime, ed è una passione che è venuta dopo, con più consapevolezza. Le ricette che hai citato non erano condizionate dalla povertà? No, si componevano sempre degli ingredienti che occorrevano per farle bene, semplici ma giuste. Il ripieno del tortellino per esempio è sempre stato preparato con il maiale, il prosciutto, la mortadella e tutto quello che ci vuole. Che salumi faceva tuo nonno? Un po’ di tutto, mentre noi ci limitiamo alle salsicce e alla coppa di testa, visto che utilizziamo molti maialini e le teste avanzano. Lui macellava maiali rosa, mentre noi facciamo tutto con la mora romagnola di Cà Lumaco. Ed è una carne nettamente superiore, tratta da animali più difficili, grassi ma di grandissima qualità. Ho insistito molto qualche anno fa affinché Ferri iniziasse ad allevarli nei suoi 50 ettari di bosco e di prato. E secondo me i salumi sono strepitosi. La nostra norcineria in generale sarà povera dal punto di vista mediatico, ma regge il confronto con i prodotti top. Anche se costa cara, perché una mora partorisce 3 o 4 maialini anziché 12, una volta l’anno anziché 2 e la mortalità è elevata. E l’olio di oliva? Noi ce l’avevamo sempre, non era quello di Brisighella ma veniva dal Meridione, era abruzzese credo. Lo portavano i carabinieri o le guardie forestali, quando tornavano dalle licenze. E in cucina me lo ricordo da sempre, insieme a tanto burro del caseificio. Una delle nostre ricette più classiche, che ho rifatto per il 75mo anniversario della trattoria, è la trota intera impanata con le erbe e fritta in un extravergine verde scuro, così profumato che sovrastava anche il pesce. Ma era un piatto “tanto di tutto”, generoso. C’era una capacità di innovare, quindi, in questa cucina. È il classico caso in cui la gastronomia è cresciuta perché è cambiata la materia prima, e insieme ad essa la consapevolezza delle persone. L’autoproduzione non ti interessa? Certo l’olio era “fusion”, sebbene in origine fosse prodotto anche in zona, poi con le gelate del 1700 gli ulivi erano spariti e adesso li stanno ripiantando. Ma secondo me era un po’ un caso, nel senso che si ritrovavano la bottiglia in dispensa, mentre gli altri savignesi non ce l’avevano perché non avevano le camere. Mio nonno ammazzava anche Due anni fa ho rifatto l’orto un po’ per scherzo, piccolino però. Ma dall’anno prossimo l’idea è quella di ingrandirlo per bene. Quello di adesso è veramente casalingo, lo uso per il ristorante. Ma mi rifornisce 80 Il terreno conferisce caratteristiche particolari agli ortaggi? Non direi, sono buoni come altrove. Le altre verdure le compro dalla Sega, azienda agricola Battistini. Sono verdure biologiche al 100%, belle e di qualità, perché si tratta di contadini consapevoli, della mia età o anche più giovani, che hanno scelto questo mestiere. Compongono un piatto che propongo tutto l’anno, ma cambia ogni giorno; adesso l’ho trasportato sul fungo assemblando diverse varietà di stagione. Per il tartufo invece è un anno perso, ne arriverà un po’ prossimamente ma sarà scarso. E i tartufi che ho visto finora sono brutti e secchi perché sono cresciuti in un terreno troppo duro, la pioggia è penetrata solo di 1 cm e sotto è cuoio, quindi non si sono sviluppati bene. Profumano abbastanza ma non durano, perché il calore della terra li ha cotti e sono già vecchi. Un flashback sulla tua storia personale, a questo punto. Tu sei cresciuto con una memoria sensoriale importante, i riti e i tempi di una trattoria in simbiosi con la civiltà contadina. Sì, ma erano diventate abitudini, e come tutte le abitudini mi sono venute a noia. Quando hai 15 o 16 anni forse hai voglia di fare anche altro. La mia fortuna è stata quella di stancarmi. Quando facevo le superiori se c’era da dare una mano nel fine settimana lo facevo, non molto volentieri a dire il vero, perché preferivo la cantina piuttosto che stare dietro al bancone o fare il cameriere. Ma volevo conoscere il mondo e il militare doveva essere l’anno dei ripensamenti. Però è successa una cosa strana, anche per colpa di qualche disgraziato che ho incontrato. Si trattava di commilitoni più anziani, che avevano già fatto l’università. Abbiamo provato repulsione verso la cucina della caserma e abbiamo comprato la seconda guida dell’Espresso, quella del 1980. Così abbiamo girato tutti i ristoranti del Friuli Venezia Giulia con la mia macchina, mentre a pranzo mangiavamo le cose che ci portavamo da casa, formaggi, salumi, torte liguri. E siamo costati molto ai nostri genitori, mia madre continua a rimproverarmi di avere speso 5 milioni in ristoranti. Non sarà stata un’illuminazione, ma ho visto tanti locali, più o meno eleganti, e tanti di quelli semplici mi sembravano come il mio, ma con una professionalità appena superiore, uno spirito leggermente più culturale. Per esempio il menu scritto o la scelta dei vini. Lo constatavo quando in licenza tornavamo a Savigno e facevamo i paragoni con i ristoranti friulani. Questo l’ho messo in saccoccia, ho cominciato a metabolizzare e ad entrare in confidenza con una ristorazione che non era più solo casa e cucina, oltretutto in una zona di 81 enologica edizione 2011 in abbondanza, di zucchine e fagiolini me ne dà anche troppi. E quando butta butta. lo coltivo senza nulla, con meno acqua possibile per favorire la concentrazione. Le varietà sono locali, ma non ho fatto chissà quali selezioni. Perché è un orto di transizione, di allenamento per così dire. Ci stiamo dietro io e la mia compagna Marina. A me piace raccogliere, mentre lei preferisce zappare. Ed è molto divertente. Per gli animali invece non c’è abbastanza spazio. vini importanti. La cosa che mi dispiace è che non ho più quella guida, perché accanto alle insegne segnavamo il nostro punteggio, e talvolta mi accade di tornare in quei posti. Alla fine mi è passata la voglia di iscrivermi ad Architettura, ma non sapevo bene che fare. Ed è successo un altro incontro imprevisto. Quando non c’era niente da fare, mia madre il pomeriggio faceva la magliaia e una cosa che mi veniva bene era disegnare le maglie, scopiazzando i giornali. Compravo la lana, disegnavo, lei eseguiva e poi rifinivamo. Ne ho fatte 4 o 5 che portavo. Un giorno un signore che aveva un’azienda importante, il fondatore del marchio Carla G, lontano parente di mio zio, si è fermato da noi e mi ha chiesto che maglione fosse. “L’ho fatto io”. “Come l’hai fatto tu? Non ti piacerebbe lavorare con me nella moda?”. “Perché no?”. Così ho iniziato a fare il rappresentante in Veneto e in Trentino alto Adige. Scortato dalle guide, partivo il martedì e tornavo il venerdì. E ho cominciato a battere tutti i ristoranti, ma anche le osterie, che mi piacciono tuttora. Anche se è più difficile trovarne di buone, perché quelle che fanno la tagliatelle al ragù magari ci mettono la farina che viene dall’Ucraina, il pomodoro cinese e la carne congelata argentina. Quindi è una ricetta tradizionale ma le materie prime tradizionali non sono, ed è la cosa che mi scoccia di più. organizzare per loro la parte gastronomica. Così vendendo e comprando stracci è cresciuta la passione per il cibo. Fino a che mia nonna, mia madre e mia zia non hanno detto: “Noi alla fine del 1987 ci ritiriamo. Nessuno ha voglia di comprare, chiudiamo”. E ho cominciato a ragionarci. Allora avevo una fidanzata che faceva un lavoro che non le piaceva, la parrucchiera. Sua sorella era cuoca e abbiamo deciso di provarci. Siamo partiti in 3 e adesso siamo in 10 a gestire gli stessi coperti. Hai scelto la linea della continuità fin dall’inizio? Sì, solo ricette tradizionali, anche perché mia mamma e mia nonna continuavano a venire. I miei hanno chiuso a natale del 1987 e dopo qualche mese di lavori abbiamo riaperto, senza il bar al piano terra. Il primo giorno ho esordito con la carta dei Colli Bolognesi, che era veramente una carta, cioè un foglio con il nome di 20 etichette. Poi con la fama crescente della trattoria ho deciso di ampliare l’offerta dei vini. Dopo un paio d’anni di training ho capito che mi mancavano le materie prime, perché non ne avevo abbastanza e non su tutti i fronti. Quindi ho cominciato a convincere contadini e allevatori a lavorare in un certo modo. Erano cose che non mi aveva insegnato nessuno, ma le avevo captate frequentando i corsi, seguendo Slow Food o leggendo le riviste di cucina. Pian pianino sono riuscito a crearmi questa rete di fornitori, che mi hanno portato a una cucina localizzabile. Entrando in possesso di materie prime interessanti, nei primi anni ’90 sono arrivate anche le prime ricette creative, quasi un obbligo avendo certe cose per le mani. Come aprire il frigo e cucinare quel che trovi, senza escludere le tecniche moderne e giocando con gli accostamenti. Eravamo tutti autodidatti, ma senza Neanche le tue materie prime sono “tradizionali”, però. Sì, ma sono locali, ed è la cosa più importante. Per un certo tempo, comunque, ho portato avanti entrambi i discorsi, la moda e il cibo, con i titolari ho iniziato a girare per sfilate anche all’estero, da Parigi a Londra, a New York, e a 82 Vedi una relazione con la bistronomia contemporanea? Non direi. La bistronomia mi piace molto, a Parigi come a Londra è bello mangiare piatti semplici ma ricercati in un’atmosfera informale. Ma è un fenomeno metropolitano, che ha senso solo in un determinato contesto. Mentre il territorio è praticabile ovunque. Lo dimostra Eataly a Bologna, che si approvvigiona dai miei fornitori, dal mercato circostante e dai produttori dei presidi Slow Food. Il tuo orizzonte è apertissimo. Come mai non ti sei mai fatto contagiare dalla nouvelle cuisine o dall’avanguardia? Forse perché non ho mai avuto cuochi che mi istradassero in quella direzione. E non li ho mai cercati, come non ho mai cercato nulla. Sono molto fatalista in queste cose. Chissà cosa avrebbe potuto succedere, se fosse capitato da me un Bottura. Devo dire che ho sempre preferito lavorare con gente della zona, perché ho sempre creduto che chi viene a lavorare a Savigno da molto lontano, prima o poi si stancherà. Quindi la mia è una brigata stanziale e quello che sta più lontano, la mattina fa 15 chilometri. Poi con i cuochi della zona è più facile comunicare, perché c’è un codice del gusto comune con chi è cresciuto a tigelle e crescentine. Capisce quando una cosa è giusta o sbagliata molto prima di un giapponese. Preferisci lavorare con cuochi di sesso maschile o femminile? È indifferente, ma credo che in ogni brigata ci voglia una cuoca, perché serve a calmare gli animi, evitando che si crei un clima da caserma. E la sfoglia la fa ancora mia madre con altre 3 signore della stessa età, che mi diverto a mandare in giro per il mondo a fare le serate quando mi chiamano. Anziché andare a Lourdes vanno a Tokyo o a Zurigo. È una brigata acrobatica. Il tema di Enologica quest’anno è la patria. Faccio un po’ fatica a parlare di patria, perché è una parola che non mi appartiene; sebbene non mi sia mai spostato da Savigno, posso sentirmi a casa anche a New York e provare un sentimento di condivisione con gente che arriva da lontano. La patria non è un fatto geografico e non è necessariamente il luogo in cui sono nato, ma è un modo d’essere e rappresenta l’insieme nel quale mi riconosco, con le mie abitudini di pensiero, di comportamento, di stile di vita. La patria è lo stato interiore ed il paesaggio familiare che mi fa sentire a mio agio e a casa, ovunque nel mondo. E la patria in cucina cosa diventa? la cucina italiana non esiste assolutamente se non all’estero. Ci sono tanti piccoli territori che possono svilupparsi se gli uomini lo vogliono, a Savigno come altrove. Per quanto riguarda i 83 enologica edizione 2011 complessi. Perché non abbiamo mai mirato in alto, quello che è venuto è stato spontaneo, non lo abbiamo mica cercato. Compresa la stella Michelin, che per un certo tempo ha convissuto con il bib gourmand, cosa che all’epoca era un po’ un controsenso. Siamo stati il primo locale di questo tipo a essere premiato dalla guida rossa, credo. Quando mi arrivarono i telegrammi di Marchesi e di Gaja pensai subito a uno scherzo. vini, invece, sono fiero di avere lanciato i Colli Bolognesi, che oggi sono presenti nelle carte di tanti ristoranti. Anche se c’è un problema qualitativo, perché molti inseguono modelli anacronistici. Secondo me non hanno viaggiato, mentre il viaggio è importantissimo. Recentemente ci sono stati due eventi che mi hanno un po’ riconciliato con questo concetto. I 75 anni del ristorante, in occasione dei quali ho offerto un pasto a tutti i settantacinquenni nel teatro del paese. E “A cena con i rivoltosi”, un evento bellissimo che abbiamo tenuto in piazza il 15 agosto, in ricordo dei moti rivoluzionari della giovine Italia, con i droghieri e i macellai di Savigno. In seguito alla repressione del 15 agosto 1843, agli atti processuali sono stati trovate le testimonianze di 2 carabinieri pontifici presi in ostaggio, che hanno riportato giorno per giorno quello che avevano fatto durante la fuga sulle colline. Quindi abbiamo fatto un menu composto di quei piatti, che erano poi galletti, tagliatelle con il prosciutto rancido, pane e salame. sempre più consapevole. È un circolo virtuoso di cui Amerigo vuole rappresenta un anello. Però non sono così campanilista, da pensare che questo luogo sia migliore degli altri. La sua unicità è che è il nostro, perché il territorio lo fa l’uomo e allevare collaboratori è stato il lavoro più difficile in assoluto. Che piatti porterai a Faenza? Una selezione dei miei antipasti più classici: tigella mignon ripiena di gelato al Parmigiano, calzagatti avvolti nel lardo di mora romagnola e battuta di bianca modenese. Poi le lasagne con la zucca e la selvaggina, un piatto affatto tradizionale ma molto locale, che illustra bene la mia filosofia del territorio e il lavoro che porto avanti sulla filiera. Faccio fatica a parlare del chilometro zero, visto che lo faccio; e di solito a parlarne è chi non lo pratica. Dico solo che ciò che c’è qui è unico e può essere mangiato solo da noi, quindi per uno straniero vale moltissimo ed è un concetto su cui ragionare. Il senso vero della localizzazione. Altre cucine si fondano sulle tecniche e non sul prodotto, ed è una scelta legittima. Come quella di Ferran Adrià, del quale sono stato un cliente entusiasta. Con l’eccezione delle tagliatelle alla carbonara con estratto di sintesi di tartufo, che ho mandato indietro due volte. Gli altri piatti me li ricordo ancora, così come ho in testa un piatto di gnocchi con il capriolo che ho mangiato durante il militare nel Collio in una trattoria che aveva 12 ventesimi sulla guida dell’Espresso. Quindi per me Ferran Adrià vale come la più scarsa delle cuoche di campagna, che però azzecca un piatto e quello lì lo fa benissimo. Io sono laico, non mi interessano le bandiere. Una grande cipolla vale come un grande tartufo, una tagliatella giusta come un capolavoro d’avanguardia. Come potresti descrivere il tuo territorio? Direi che è molto bello, lo sto riscoprendo dal punto di vista paesaggistico, dopo le ricognizioni gastronomiche. Mi piace fare lunghe passeggiate a piedi, una volta alla settimana, per poterle riproporre agli ospiti della locanda. Ed è un paesaggio che cambia. Adesso c’è più verde, si sta rimboschendo, mentre nel dopoguerra era completamente brullo. Le case coloniche abbandonate sono di nuovo abitate. Gli animali stanno tornando: volpi, tassi, istrici che non avevo mai visto da bambino. gli agricoltori e gli allevatori stanno operando in modo 84 Carla Aradelli La patria? Una ricetta complicata. Carla Aradelli, chef del ristorante Riva di Ponte dell’Olio, rifugge dalle provocazioni senza vestire i panni della vestale. Nel Piacentino è nata all’anagrafe e alla ristorazione, ma le radici le ha gettate da sé, come la talea di una vite che da ramo tagliato si trasforma miracolosamente in pianta. Radici come creazione anziché mero presupposto, non per questo meno forti o ardite nel succhiare energie e rêveries dal territorio. Di innesti del resto ne avrà visti fare dal nonno Luigi, detto Gigiò. Quello carismatico che la portava bambina sul trattore e poi in mezzo ai filari. Cosicché per lei è stato infine naturale miscidare la memoria con i gallicismi di un altro père. Georges Cogny, che quest’anno ha riesumato con un omaggio evergreen. Il tortino di cipolle e tartufi parla con la forza elusiva dell’ellissi, chiudendo due parentesi robuste come dighe sullo spazio bianco della cucina. L’alfa della liliacea, umile incipit universale, e l’omega del tartufo, explicit di lusso. Nel mezzo infinite possibilità e i rebbi di una forchetta indaffarata, novella Proserpina fuggita dalla morsa ipogea. L’ellissi totale (o forse eclissi) come esito finale di ogni minimalismo del levare (e la gittata della nouvelle cuisine all’orizzonte si allontana). le parole di Carla hanno la stessa impazienza, un moto che cuce la conclusione addosso alla partenza. Ellittico, impulsivo, compresso come lo scarto di un puledro. Ma le sue mani sanno anche intrecciare storie e tradizioni. Ponte dell’olio al crocevia di Emilia, Lombardia, Piemonte e Liguria, mercato per barattare grano, vino, olio. Ponte dell’olio con i suoi tortelli sapientemente intrecciati, lascito della fantasia femminile a celebrazione del re. Un balletto dove i punti di appoggio si scambiano rapidamente di posto nell’incalzare delle coreografie. la villetta dove ha sede il ristorante è anche la sua casa: “Abitare qui è l’unico modo per conciliare lavoro e famiglia. Perché con me ci sono mio marito Maurizio, che guida la sala e la cantina, e le mie due bambine. È un angolo un po’ magico di Ponte dell’Olio, accanto a un castello del ‘200. L’arteria anni fa era trafficata perché ci passava un trenino e c’era un bar con licenza di trattoria, negozio di alimentari e tabaccheria. Tutto tranne un ristorante, ma io avevo il mio quadernetto e le mie fantasie di diciannovenne. E la famiglia di mia mamma aveva una trattoria, io ho cominciato da lì”. Ricominciamo dalle origini, allora. Sono nata e cresciuta a Ponte Dell’Olio. Mia nonna Teresa e mio nonno Luigi avevano un ristorante per banchetti e un’azienda agricola a Monte Santo, a 600 metri di altitudine, vicino a un altro 85 enologica edizione 2011 Riva Loc. Riva, 16 - Ponte dell’Olio (PC) tel. 0523.875193 - www.ristoranteriva.it piccolo castello. La passione per questo lavoro l’ho presa da loro. Perché a me della cucina piace la parte di natura, la semplicità delle cose. Detesto il contorno senza la sostanza. Cucino con la pancia e con il cuore, piuttosto che con l’intelletto. Il lavoro del contadino è un lavoro molto libero. Sei subordinato al tempo meteorologico e alle stagioni. Ma io ricordo mio nonno quando fumava il tabacco, queste cartine, c’erano dei tempi cadenzati, una forma di rispetto. Ecco, mi sono innamorata di questa parte del mestiere: le piccole autonomie. Quando avevamo fame, ma nessuno aveva tempo per noi, il pane abbrustolito sulla stufa a legna ci salvava. E mio nonno era una persona curiosa, perché oltre alle viti e al bestiame aveva le arachidi, il ribes, di tutto. Oggi fra i ristoratori va di moda avere l’orto, ma sono mestieri in cui non ci si improvvisa, occorre tanto tempo per capire. si occupava dei secondi. Eravamo molto diverse. Io avevo bisogno di avere metodo e ordine, di avere tutto organizzato; mentre lei stendeva e spandeva. Era un conflitto permanente. Con noi c’era personale vagante alla bisogna, oppure qualche parente, mia zia piuttosto che una cugina. Torniamo a tua nonna. Aveva messo su lei il ristorante? Mi stupisco sempre quando penso alla mia strada, perché io non avevo un progetto. Ho seguito quello di mia sorella, che poi ha deciso di svoltare. l’apertura è avvenuta nel 1987, appena ultimato il corso con Georges Cogny; Maurizio era già con noi. Cosa ti ha lasciato quel locale? Per me la cucina sono i ricordi della mia infanzia, come la vecchia bilancia con cui mi permettevano di pesare le cose. Mi facevano anche girare la manovella della pasta, mentre i bambini più lenti o dispettosi dovevano mettere a posto gli anolini sulle assi. Poi c’era la componente giocosa, la collana di anellini di pasta essiccata. Questo aspetto è andato un po’ perso nella cucina professionale, ma a me piace molto. Come sei arrivata qui a Riva? La famiglia di mia mamma ha sempre gestito questo posto, che era una locanda con camere. Allora non c’erano i congelatori, tutto veniva preparato praticamente all’ultimo momento. Le paste che si facevano erano sempre le stesse. Ma si partiva dalle materie prime grezze, che il contadino vendeva o barattava. C’era un equilibrio nelle cose. La cucina era quella della banchettistica di allora: i panzerotti, le lasagne, gli anolini, i tortelli, i pisarei. Le tagliatelle, i tagliolini, gli gnocchi. Quando hai conosciuto Georges Cogny? Nel 1984-85, in un corso biennale per addetti alla ristorazione. Ero insieme ad altri venti ragazzi ed è stato complicato, perché eravamo troppo diversi, alcuni avevano attività già avviate, altri un diploma e prospettive diverse. l’intenzione della regione era dare ai figli dei ristoratori l’opportunità di conoscere una cucina diversa. La mattina alla Cantoniera cucinavamo per noi stessi, apprendendo le basi ma soprattutto una Hai menzionato solo primi piatti. Perché è la parte cui mi sono sempre sentita più vicina, mentre mia mamma 86 Gli insegnamenti di Georges Cogny cozzavano con quelli famigliari? Sì, perché conoscere lui è stato come entrare in un nuovo mondo, ho capito che c’era qualcosa che mi piaceva al di là dell’esecuzione delle solite cose. Ed è scattata la passione. Georges era la parte di follia che mi allontanava dai problemi dell’adolescenza, quando si hanno troppi sogni e nessuna certezza. Ma in certi periodi sono arrivata persino a odiarlo, perché sentivo che mi aveva ingannata, nascondendomi la parte negativa di questo lavoro. Che è tanta. Ricordi qualche compagno di corso? Isa Mazzocchi della Palta, la Paolina (mia compagna di stanza), la Betty del Caffè Grande. Hai continuato a frequentare Cogny anche dopo il corso? Per tanti anni appena avevo un momento libero andavo da lui, finché non ho dovuto smettere a causa delle visite dell’ispettorato del lavoro. Più che un insegnante di cucina era un maestro e anche un padre, tanto che a un certo punto ho dovuto bilanciarlo, cercare un contrappeso. Ed è così che nel 1994 sono approdata in alto adige, dove ho incontrato un altro pazzo, innamorato della sua terra, che mi ha portato in una situazione completamente diversa, ma più vicina a come sono fatta io nelle mie viscere: Hans Baumgartner. Partendo dalle differenze fra noi, mi ha trasmesso la voglia di cercare la mia strada con coraggio. Come si è evoluta la tua cucina negli anni? all’inizio c’era un po’ di copiatura, perché attingevo spesso al quadernetto scritto su alla Cantoniera. Mentre le ricette di mia nonna non potevo usarle, perché Ponte dell’olio era una zona di ristoranti per banchetti, e non potevamo certo competere con chi faceva la stessa cosa da sempre. Ricordo che il primo giorno abbiamo fatto due coperti, senza il bar non si sbarcava il lunario. operai, rappresentanti, muratori: la gente veniva qua a mezzogiorno nella pausa di lavoro. Poi piano piano ha prevalso la voglia di una dimensione diversa. Ma non credo di essere cambiata. Personalmente amo la 87 enologica edizione 2011 filosofia della cucina. A volte george sceglieva qualcuno per dare una mano con i clienti; mentre il pomeriggio c’erano lezioni teoriche e il mercoledì, quando la Cantoniera era chiusa, andavamo a Piacenza o in giro per caseifici. Incontrare una persona come georges a 17 anni, quando non sapevo niente, è stato uno choc. Tanto per dare un’idea, prima dell’inizio noi corsisti abbiamo sostenuto un colloquio con uno psicologo e fra le domande c’era scritto: “Chi è il cuoco migliore che conosci?”. Io avevo indicato mia madre. Poi arrivo là in quella cucina un po’ sacrificata e lui prende in mano un coltello. Da restare a bocca aperta. Un anno mi mandò in stage da Franco Colombani al Sole di Maleo, che era un po’ il paradigma del locale storico del nord Italia, le radici territoriali rispetto alla sua creatività. Avevo un angoletto magico dove dormire e tutte le mattine passavo attraverso un orto, poi c’era la signora che raccoglieva le erbe spontanee, quella che lucidava i rami, un filare di kiwi, l’acetaia del Balsamico… creatività, ma detesto gli abbinamenti azzardati, sul piano del gusto sono un’abitudinaria. Ho sempre avuto il desiderio che i miei piatti rimanessero nella memoria delle persone, come io avevo nella memoria i sapori dei miei nonni. Amo la leggerezza perché sono una persona delicata e la mia cucina mi assomiglia. Negli anni ho sperimentato talmente tanto che per cambiare menu mi basta dare uno sguardo alla mia storia e fare qualche aggiustamento. Forse oggi mi manca un po’ la follia, la voglia di osare che avevo un tempo. Perché conosco troppe cose, so come vanno eseguite e soprattutto ho un forte senso di responsabilità nei confronti dei clienti, che sento di non poter deludere. Poi ci sono le mie figlie, che mi rubano una fetta di quel tempo che una volta era interamente consacrato ai miei piatti. sento un’attenzione, altrimenti sto a casa. Visto che qui ho trovato il mio equilibrio. Che ruolo ricopri in cucina? Non ho mai lavorato con una brigata vera. Chi viene qui impara a mandare avanti un locale da solo, e la musica che suona può essere solo la mia: un cuoco può partecipare, ma non può fare il fenomeno senza la mia approvazione. A parte una collaboratrice storica, Marilena, sono quasi tutti stranieri. I giapponesi mi hanno insegnato tanto, il rispetto ma anche la tecnica. Hanno un rigore e una determinazione ammirevoli; fare il cuoco per loro è una ragione di vita. Ormai fra di noi c’è un linguaggio anche implicito, tutto un metodo di lavoro. E se li correggo mi ringraziano. Se guardi alla ristorazione contemporanea, che sentimenti provi? Mi sento lontana dalla cucina contemporanea, perché la sua cerebralità non mi appartiene: piuttosto voglio trasmettere le mie emozioni, la mia personalità, i miei colori. E non mi interessano le mode, nemmeno il chilometro zero. Queste cose secondo me non hanno senso, perché una persona che ama la propria terra, quel che è di valore lo acquista sul posto, ma il resto deve cercarselo altrove. Noi per esempio prendiamo qui i capretti, gli agnelli, le uova, le verdure dell’orto, i funghi, i lamponi, il tartufo. Mentre altri prodotti li acquistiamo altrove. Non mi interessa praticare il chilometro zero per piacere alla stampa, farne un’ideologia. Piuttosto credo nel tempo e nella stagionalità. Poi occorre avere un maggiore senso di responsabilità nei confronti dei giovani cuochi, che vanno salvaguardati da modelli impossibili. Quindi basta con i piatti che non possono rientrare nei costi, perché danneggiano Come ti ha influenzato la maternità? Quando ho avuto le mie tatine ho scelto di non essere più soltanto una cuoca. I bambini con la loro spontaneità possono fare osservazioni che magari un adulto pensa e non dice, e questo mi ha indotto a una maggiore semplicità. Poi c’è stata la fase dello svezzamento con un pediatra naturale che mi ha introdotto a prodotti nuovi. E il successo? È arrivato molto presto, quando non avevo ancora trent’anni. Siamo entrati nei Giovani Ristoratori nel ’95 e due anni dopo è arrivata la stella Michelin. L’universo mediatico mi si è schiuso davanti, ma a me non piaceva. non percepivo un interesse vero per me, quanto piuttosto aspettative e proiezioni. Per cui mi sono un po’ rintanata. oggi vado solo nei posti in cui 88 Ad Enologica però hai deciso di venire. Cos’è l’italianità per te? Sapere come è fatta la pianta dei prodotti che uso; sapere da dove arrivano, restando magari in Italia. Sperimentare, ma senza farne una coazione. All’estero siamo ancora quelli di spaghetti e maccheroni, ed è importante non perdere anche quelli. Ho deciso di partecipare ad Enologica perché si svolge nella mia regione ed è la prima volta che qualcuno mi fa sentire che l’Emilia-Romagna esiste davvero. Come piatti porterò il tortino di cipolle di georges, per riallacciarmi alla mia storia personale, e come evergreen un raviolo di tacchinella con la pasta di castagna, la scorza di arancia e la frutta secca. Com’è riaffiorato in carta quel piatto di Cogny? Attraverso una mia cliente che l’ha mangiato per 15 anni. Ho trovato curioso che me lo chiedesse con tanta insistenza. Avevo la ricetta, che era una sorta di icona, perché a suo tempo l’avevo raccolta per i Giovani Ristoratori. Ma non mi sentivo di servire il piatto tal quale, perché mi sembrava sempre troppo povero; così aggiungevo le lumache, il baccalà, un uovo piuttosto che una cappella di porcino. O forse non mi sentivo di replicarlo a causa della venerazione che nutrivo per Georges. Mi hanno fatto notare che da poco ho cominciato a chiamarlo per nome, mentre prima era soltanto “il mio maestro”. Trovo che sia un piatto semplice ma completo, essenziale e tradizionale. È geniale che in un periodo di aragoste e foie gras lui abbia servito per 15 anni un tortino “povero” fatto di cipolle con un sospetto di pancetta, perché aveva sposato la Val nure, regno appunto di cipolle e salumi. Il risultato è senza tempo, un esempio della cucina cui aspiro. Anche Georges abitava nel suo ristorante, ed è morto dopo che l’hanno aggiustato, sventrando la sala per adattare l’abitazione ai suoi problemi. Il montacarichi trasformato in ascensore, le porte scorrevoli larghe come la carrozzina. Era come se si fosse rotto l’equilibrio fra la vita e il lavoro. Maurizio Rossi “Anch’io sono figlio d’arte: i miei avevano un locale a Genova, che da semplice bar divenne tavola fredda e poi tavola calda. Mia madre era una buona cuoca di pesce, tanto che spesso la nostra cucina di mare è ispirata ai ricordi delle sue ricette. Nel Piacentino restavano i miei nonni paterni, li visitavo ogni estate e alla fine degli studi mi sono trasferito. Certo sono due luoghi agli antipodi, ma non nutro nostalgie. nel 1987 con Carla e la sua famiglia abbiamo rilevato il bar trattoria di Riva. Per un po’ abbiamo tenuto il bar, poi abbiamo sistemato la cucina. Ma il salto di qualità l’abbiamo fatto nel ’92-’95, quando abbiamo chiuso il negozio (il bar esiste ancora, ma è al servizio del ristorante). Ricordo che all’inizio Carla era georges dipendente, per lei esisteva solo Georges. Poi c’è stato il periodo 89 enologica edizione 2011 soltanto la cucina. Meglio ricette semplici, economiche, ma con dentro un’idea. Perché i conti che tornano sono il fondamento di ogni autonomia. Chi ha avuto a che fare con persone come Georges o Gualtiero Marchesi, questa generazione di grandissimi cuochi, è come un primogenito. Esigente, per non dire viziato. altoatesino: chiudevamo in gennaio e lei trascorreva là tutto il mese. Da quelle parti sono completamente diversi, molto legati al territorio e ai suoi prodotti. Così Carla ha raggiunto l’equilibrio fra l’estro di Georges e il suo luogo. Andava da Hans Baumgartner, uno che utilizzava l’animale intero, non solo il filetto e lo scamone. Poi è stata dal fratello Karl e da Herbert Hintner. Ed è tornata con i piedi per terra. Passando per le Alpi è rientrata a casa. È difficile svolgere il tema della patria nel vino. Perché l’Italia è vastissima, abbiamo un patrimonio vitivinicolo sterminato e troppi vitigni diversissimi fra loro. La stessa Emilia è troppo grande, Piacenza è un’isola a sé, mentre la Romagna è più compatta. Quando siamo partiti la cantina del ristorante era consacrata ai vini piacentini, perché la cucina era locale. Mentre a casa mia avevo Barolo, Barbaresco, grandi Chianti e francesi. Con la crescita dell’offerta di cucina però abbiamo cominciato ad allargarci. Cosicché oggi come oggi di piacentino vendo poco, perché sono i miei clienti a non richiederlo. Tengo in carta due Gutturnio frizzante e il meglio (secondo me) della produzione locale, alcune chicche che mi divertono molto. Per esempio c’è chi in provincia fa qualcosa di diverso, come il Maiolo, un’azienda piccola con vigne di barbera, bonarda, cabernet e merlot. Le uve sono vinificate separatamente, il vino fa solo botte grande e l’assemblaggio è all’imbottigliamento. oppure l’azienda vitivinicola Marengoni, che ogni anno compie nuove sperimentazioni. In generale la Val Nure è molto interessante perché ci sono La Stoppa, La Tosa, Barattieri per il Vin Santo di Albarola, il Baraccone e altri ancora”. “In tutti i sensi.” Tortellino 90 Luca Marchini La patria: il problema è dirimente per chi cucina in quel di Modena, terra di totem gastronomici ingombranti. Luca Marchini lo fa da 8 anni negli spazi settecenteschi di palazzo Scarpinelli, nel cuore dell’area Pomposa, già ghetto ebraico, poi covo di malavita e di movida. Lì sono sparpagliati i suoi 30 coperti, sullo specchio di marmi le cui venature parlano di natura pictrix, sulle pareti l’intonaco di colla e sabbia a preannunciare opzioni letteralmente terroiristes, terragne, materiali. E lì aprirà a breve la sua scuola di cucina Amaltea, dedicata alla capra di Zeus il cui corno ha originato la cornucopia dell’abbondanza. Per luca la patria è un’entità da desiderare (cioè vagheggiare dalla distanza siderale delle stelle), anziché esserla spontaneamente. Ponendo fine alla comunione del neonato che non coglie la frattura fra l’io e l’ambiente, ma pensa il mondo come prosecuzione del suo corpo. Invece no: avviare le fasi dello specchio e l’identificazione dell’ego è il modo migliore per liberare anche la patria. Lontano dai pompierismi e dagli squilli di fanfara, slegata dai campanili per scorrazzare nell’immaginazione. Tanto che cinta com’è dai suoi confini, può farsi subliminale, cioè scendere sotto la soglia del gusto, sulla strada di un sublime minimalista e calibrato, sotterraneo come cunicoli che sfuggono al controllo. Sembra quasi di risentire le provocazioni di John Cage, quelle composizioni intessute di suoni non udibili che pescano nel fondo del subconscio sensoriale. Il risultato è uno sciame sismico di microsensazioni che scuotono le certezze del palato con caleidoscopica cangianza. Contrasti vibranti fra ingredienti quantici che compongono il gusto della patria come i pixel di una fotografia digitale. Dietro la finestrella sui fornelli si affaccendano un manipolo di cuochi, con Giulia in primo piano a confezionare i tagliolini al matterello. “In caso di grandi numeri, banqueting o catering, adoperiamo una macchina, ma poi finiamo la sfoglia sulla spianatoia, per conferire rugosità e dare calore. Si tratta di un utensile casalingo perché voglio che venga usato molto poco”. Fra i colleghi Luca si aggira come un jolly più che come un primus, preso in una supervisione che sa di impresa collettiva. “L’iter dei controlli all’Erba del re assomiglia a un imbuto, visto che prima c’è la brigata, poi il pass, cioè io, e infine il cameriere. ‘Secondo voi non è un po’ asciutto? Non vi siete scordati qualche cosa? Guardate che c’è un’ombra nel piatto’: ogni osservazione è benvenuta. Fino ai commenti del cliente, perché diverse ricette le ho corrette in base alle indicazioni ai tavoli. Se c’è una cosa che chiedo sempre, è cosa non è piaciuto oppure è piaciuto di meno”. Ci sono molte donne in brigata. È vero, e c’è anche Silvia Brunello, che cura la cantina 91 enologica edizione 2011 L’Erba del Re Via Castelmaraldo, 45 41100 Modena tel. 059 218188 - www.lerbadelre.it da un anno e mezzo. Non ho pregiudizi ma la mia cucina nel tempo si è evoluta nel senso della delicatezza, virando verso la femminilità. Quindi può esserci una maggiore sintonia. storici ha le fondamenta ben piantate nel Modenese, ma ha anche accenti “fusion” con la Toscana. Ed è il maialino da latte, che viene allevato a 12 chilometri dal centro storico di Modena. Si tratta di un prodotto speciale: ha solo 28 giorni e viene cresciuto interamente con il latte delle scrofe dell’allevamento, senza antibiotici o forzature, tenendo conto del benessere animale. Quindi omeopatia, prodotti naturali e gioco, in modo che l’animale non si stressi. Lo cuocio a bassa temperatura, mentre la cotenna è croccante come quella del porceddu sardo e della stessa porchetta toscana, con l’aroma di semi di finocchio che si usa da quelle parti, un gusto molto tipico e particolare. Il piatto quindi parte dall’Emilia, poi va in Toscana con i profumi e le consistenze, per ritornare infine alla base con lo scalogno al Lambrusco, che dà una sferzata agrodolce. Insomma andata e ritorno. Il bacino da cui attingo gli ingredienti tende a non oltrepassare il Mediterraneo, anche se ogni tanto uso lo zenzero o il lemon grass, che mi piace moltissimo. Sono ingredienti che instaurano un dialogo di territori con l’Emilia, perché la realtà dove abito è fondamentale. Tendenzialmente è sempre Modena con, o Modena versus un altrove. Che sensazioni prova uno chef quando vede i propri piatti interpretati da diversi cuochi? Direi che è salutare, nel senso che mi accorgo che ogni cuoco riesce a dare qualcosa in più. Di solito parto da un’idea, la propongo ai ragazzi, assaggiamo e mettiamo a punto la ricetta per poter andare fuori. Questo è l’iter grosso modo. Ma il giorno dopo potrebbe arrivare un’altra persona che prepara lo stesso piatto con la stessa ricetta e può darsi che si percepisca un cambiamento di mano. È un transito che non va mai indietro, ma apre a possibili progressi, perché parte da una codificazione rigorosa. E così il piatto vive. Nella carta del ristorante i miei classici sono corredati dalla data di inizio, che corrisponde alla loro creazione, e dalla data della versione attuale, scritte entrambe sulla carta. Servo l’ultima versione, con la consapevolezza che nessun inizio finisce lì, grazie agli input dell’intera brigata. Perché un cuoco non deve essere troppo sensibile, ma non può nemmeno fare l’operaio. Direi che è la seconda condizione per svolgere bene questa professione. La frase di Borges può significare anche che c’è stato un personalismo eccessivo nella cucina d’autore recente? Ti piace la frase di Borges scelta da Melandri? Cosa hai pensato quando l’hai letta? Può essere vero, ma la personalizzazione generalmente ha riguardato anch’essa un concetto del territorio. Con i rischi di ripetizione del caso: Parmigiano, Parmigiano, Parmigiano, Parmigiano, tanto per fare un esempio. Invece il territorio può esprimersi traendone una scaglia o una Che è possibile interpretare tutti i miei piatti in questa chiave. Perché alla fine quello che faccio sussume le sue basi dal territorio in cui mi trovo. La mia patria, visto che abito qui da 24 anni, pur essendo aretino di nascita e avendo vissuto in otto città. Uno dei miei piatti 92 Colleghi immediatamente la patria ai prodotti? E alla nostra cultura. Tutto ciò che facciamo fa parte della patria, che è innanzitutto vissuto. Qualcosa che si tramanda. Se il Parmigiano commuove è perché a monte c’è qualcosa. Sono percezioni che avverte anche un bambino, senza ancorarle al dogma di dovere mangiare quel formaggio sempre allo stesso modo, come lo ha sempre mangiato. Massimo Montanari scrive che le radici sono l’altro che è in noi. Certe operazioni di cui parli mi sembrano il tentativo di distanziare il territorio, in modo da poterlo guardare, non solo avvertire inconsapevolmente. Sì, è un modo per poterlo considerare dall’esterno. Straniarsi dalla quotidianità e poi tornare dentro con uno sguardo diverso è una bella palestra. Le esperienze all’estero ti portano a rivedere il territorio, a immaginare nuovi abbinamenti con quanto è locale, per fare un esempio banale. Con il risultato che la distanza non fa impigrire la patria. Perché il rischio della patria è la pigrizia. La standardizzazione. In questa operazione cerchi il gusto nuovo? Non obbligatoriamente. Cerco l’equilibrio, e l’emozione che può scaturire dagli elementi raccolti sul cucchiaio. Quello è un piatto che si ricorda, senza doverlo per forza descrivere o fotografare. Ma ci si arriva solo con una grande materia prima e una grande tecnica, unendo più elementi che si esaltano reciprocamente e facendo aggio sui ricordi atavici del commensale. Chi è nato a Modena, se nel piatto non vede né riconosce il Parmigiano o l’Aceto Balsamico, può percepire un equilibrio perché ha sentito dentro di sé inconsciamente quegli ingredienti, che gli danno piacevolezza, benessere, sensazioni, perché ricorda quello che ha sempre mangiato fin dall’infanzia. Una sorta di cavallo di Troia. Prendiamo il 93 enologica edizione 2011 crema, ma anche con elementi che danno un equilibrio, ci sono e non ci sono. Non sono essenziali a livello gustativo ma forniscono l’architrave per l’equilibrio generale del piatto. Ed è quello che sto cercando di fare, agendo sulle quantità e sulle reazioni di catalisi, anche se è più facile staccare una scaglia. Esisterà sempre il piatto in cui il territorio sarà protagonista in modo visibile, ma altrove sarà presente in altri modi, più evanescenti e smaterializzati. Se non ci fosse, si sentirebbe la differenza. Il rischio altrimenti è quello di cedere a un’altra forzatura, dopo che per anni la cucina è stata costretta a scimmiottare qualcosa che doveva essere per forza nuovo: il kitsch anni zero. È stato importante, essenziale, tuttora non ne paghiamo le conseguenza ma ne godiamo i benefici. Perché una rivoluzione giovane non può che essere scomposta, prima di trovare il suo equilibrio. Ma oggi si tratta di cogliere gli spunti che consentono di evitare le ripetizioni. Trovare sinonimi che non siano obbligatoriamente neologismi. A Enologica porterò entrambi i tipi di piatto. La visione nitida dei passatelli, che sono uno dei miei simboli, e quella sfocata della contemporaneità. C’è, non c’è, boh, non importa, mi piace perché se non ci fosse mi piacerebbe di meno. piatto Allenamenti sensoriali, elaborato con diverse tipologie e stagionature di Parmigiano Reggiano sottoposte a varie tecniche e abbinate nel modo più classico, con le pere, le noci, il Lambrusco, la noce moscata, l’Aceto Balsamico Tradizionale. Il sesto abbinamento, che nessuno riconosce, è quello con il crostino di pane. Quindi una piccola sfera impanata e fritta che restituisce il croccante del pane. Tutto questo porta a un’infilata di “mi ricordo mi ricordo mi ricordo mi ricordo, ho già assaggiato, ho capito, capisco”. Ma se tu lo guardi, non vedi il Parmigiano: è un piccolo gioco di concentrazione. Oppure la tartare fredda di pesce crudo con la spuma di mandorle tiepida e il brodo caldo di cipolla con poco Parmigiano, che solo un palato allenato magari riconosce. Quindi un gioco di contrasti fra temperature e consistenze, dove se togli il Parmigiano, tutto cade. in giro per ristoranti, posti semplici scelti da mio padre. Fino a pochi anni fa abbiamo tenuto anche un podere in Toscana che ci forniva l’alibi per tornare ogni tanto e rifornirci di prodotti. Ancora oggi a casa mia mangio solo pane toscano comprato là, ma non sono legami da scatola di cartone con lo scotch marrone e lo spago, sono legami più culturali. Cosa c’è di toscano nella tua cucina? Sicuramente l’olio, alcune influenze di questo genere, determinati formaggi; i salumi all’inizio, adesso un po’ meno. Il pane toscano insipido lo facciamo anche noi con il lievito madre, ma non sarà mai come quello locale, per mancanza di forni, acqua e clima. Cioè tutto. In generale la cucina toscana è più marcata, ha più sprint e più carattere, rispetto alla grassezza e alla tendenza dolce della cucina emiliana. Il prodotto è nudo, nel senso che ci sono meno elaborazioni e l’impronta è più contadina. Ma non parlerei di semplicità, perché una grande panzanella non ha niente di semplice. E se dovessi restare su un’isola deserta per un mese, mi porterei solo la panzanella. Questo confronto, che ha generato la cucina italiana nella codificazione artusiana, nei miei piatti è foriero di contrasti. Usare questi grandi prodotti come jolly ti serve per scrostare la banalità. Assolutamente sì, serve a vivificare la nostra relazione con il territorio. Perché prodotti come questi sono importantissimi ma non possono diventare una gabbia e neppure una routine. Tu però sei nato in Toscana. La mia famiglia è tutta toscana, a parte un nonno siciliano. Sono vissuto ad Arezzo fino a 3 anni, poi Lucca, Roma, Terni, Thiene, Piacenza, sempre per il lavoro di mio padre, che era un bancario. Quando avevo 21 anni abbiamo deciso di fermarci qui a Modena e di lasciargli fare il pendolare. Ma questa girandola di trasferimenti è stata bella e divertente, grazie alla forza della famiglia alle spalle. In casa cucinava mia madre, e cucinava toscano; poi si andava Come hai scoperto l’alta cucina? Intorno ai vent’anni, per conto mio. Per piacere personale andai in un ristorante che mi piacque moltissimo con la mia ex ragazza. La Noce di Montagnana, qui vicino. C’era una cuoca allieva di Paracucchi, una bella cantina, un servizio formale. “Aspetta un attimo, qui non c’è soltanto il centrino che devo scoprire”, 94 50mila lire: “Dammi 50mila lire, dai vecchio”. Ho iniziato pulendo l’insalata, poi credo di essere stato una pedina abbastanza importante. In tutto sono rimasto quasi due anni. Alle spalle avevo solo qualche corso di cucina presso scuole private: cucina del territorio, pasticceria, un corso di alta cucina dalla vecchia Petronilla, una brava cuoca altoatesina fortissima sui dolci. La prima infarinata. Ti sei buttato come un bambino che non sa nuotare. E ho imparato soltanto perché dovevo stare a galla. Massimo mi ha trasmesso l’entusiasmo e la voglia di fare bene senza esagerare. “Sogna luca, vai avanti con la tua testa, hai le tue idee e seguile, ma tieni i piedi ben piantati per terra”. È sensibile, pazzoide, ha tante caratteristiche ma sa tenerle a bada. È bravo tecnicamente, professionalmente e sotto il profilo umano. Non è il mio dio, lo sottolineo, perché spesso mi si accusa di essere esclusivamente un discepolo e lui il mio mentore. Ma come cuoco sono nato con lui, nel senso che non avrei iniziato questo lavoro senza la sua spinta, il suo trampolino. Con questo spirito ho cercato di captare ovunque il più possibile per restare a galla, con la mentalità di chi è pronto. Da lui come da Bruno Barbieri alla Solarola, dove mi sono fermato alcuni mesi. Prima di andare dal vecchio Dante a Bologna, dove ho fatto per la prima volta i passatelli, il mio primo vero piatto importante, per me tuttora un’icona di purezza, semplicità, schiettezza. È un connubio di Emilia e Romagna, perché la scorza che in Romagna profuma l’impasto diventa un’aria in 95 enologica edizione 2011 mi sono detto. Ma io ho passione per la cucina fin da quando avevo 12 o 13 anni e cucinavo in casa. Sono una bella forchetta, mi è sempre piaciuto mangiare e fin da piccolo se avevo voglia di un piatto e mamma non poteva farmelo subito le chiedevo di insegnarmi e lo preparavo da solo. Una delle mie prime ricette furono peperoni, melanzane e pomodori ripieni al forno, con latte, pane toscano, prezzemolo e la giusta (per lei) quantità di aglio. Ne andavo pazzo. Cucinavo per i miei genitori, per gli amici loro e per i miei; mia moglie l’ho conquistata con i sughi. Leggevo riviste, soprattutto la Cucina italiana, e libri: Oltre il fornello di Gualtiero Marchesi era la mia bibbia, lo so quasi a memoria da quante volte l’ho letto. Piano piano ho capito che c’è cucina e cucina e ho iniziato a frequentare qualche corso, ma senza pensare di farne un lavoro. Lo reputavo il mio hobby. Perché ho studiato ragioneria ed economia e commercio, ma nel week end lavoravo in un ristorante dove facevo lo gnocco e le crescentine, per me era una grande emozione ricoprire quel ruolo. Dopo il servizio civile alla Caritas avevo già preso contatti per fare il dottorato e diventare commercialista, ma mi ha un po’ imbrigliato quel mascalzone di Massimo. nel 1998 andavo in giro a cercare lavoro e lui dopo 15 giorni mi rispose: “Cerco una persona che venga qua, se ti piace veramente cucinare”… Ai tempi Massimo era diverso, sempre particolare, estroverso, estroso. Covava la provocazione, quella vena iconoclasta; e c’era già la passione per l’arte, i quadri alle pareti, la sua cultura. Ma si mangiava ancora con superficie, che dà brio con la sua nota acidula. La ricetta è quasi filologica, appena un cambiamento di proporzioni affinché i passatelli possano essere serviti asciutti, con un ragù di pollo, scalogno e alloro e una pioggia di uvetta che instaura un gioco rinascimentale soffuso, perché l’uvetta cilena è meno dolce. Non li ho mai tolti dalla carta. ristoranti di qualità in zona sono diversi e io consiglio sempre di visitarli. Un fuoriclasse educa la clientela e pungola i colleghi. Modena è forte perché sa fare sistema. Che ruolo hanno svolto i tuoi genitori in questa conversione? Quando ho annunciato loro le mie decisioni per la prima volta sono rimasti un po’ sorpresi, ma fondamentalmente sono sempre state accolte molto bene. Hanno sempre cercato di appoggiarmi, tentando solo di capire se era quello che volevo veramente o la pazzia del momento. Ma io sono sempre stato un tipo posato e riflessivo, non faccio colpi di testa. Oggi mio padre è socio dell’Erba del re e mi aiuta moltissimo. Tu e Bottura appartenete alla categoria dei cuochi non cuochi, più o meno autodidatti, che portano con sé un bagaglio culturale diverso dal consueto e fanno una cucina impura, miscidata. Sì, per me resta una figura di riferimento, ma non è un modello da imitare. Piuttosto è qualcuno da cui cogliere spunti di riflessione, allo stesso modo in cui Oltre il fornello di Gualtiero Marchesi continua a ispirarmi. Sono spunti, non ricette. Nonostante in passato mi si accusasse di avere poca personalità. Tua moglie e i tuoi bimbi, adesso. Tre figli possono essere un buon osservatorio su come si forma il gusto, in questa fase di primitivismo in cui i cuochi cercano il gusto originario. Sembra quasi una peculiarità dei cuochi emiliani, questa degli autodidatti colti. Massimo, tu, Fadiga. Mia moglie fa la farmacista e viene qui una volta ogni venti giorni. Direi che abbiamo un rapporto di consulenza esterna (ed è un bene), nel senso che mi fido molto del suo giudizio sui piatti, anche se a volte mi fa un po’ arrabbiare. Abbiamo tuttora la passione di andare per ristoranti, dove portiamo anche i bimbi, che hanno imparato a comportarsi a modo. Emanuele, sette anni, Chiara, cinque, e Niccolò, che è appena nato, mi hanno arricchito anche professionalmente. Tanto che sul menu c’è un ex ergo che evoca gli occhi innocenti dei bambini per esortare a dismettere i pregiudizi. Perché quando si va a tavola bisogna fare tabula rasa e giudicare soltanto alla fine. Emanuele per esempio assaggia il Sì è strano, nel senso che non abbiamo seguito l’impostazione famigliare. Se tutta la famiglia faceva una cosa, noi ne abbiamo fatta un’altra. Ci siamo staccati da iter forti e importanti, lineari. Con il correlato di una forte ambizione, non può essere altrimenti quando si cambia radicalmente strada. È la benzina per avviare la macchina. È difficile condividere il mercato con Massimo? Beh, è ovvio. Quando c’è un personaggio di questo rango per moda, piacevolezza e qualità oggettive la clientela tende ad andare da lui. Ma i 96 Quando hai aperto l’Erba del re e come lo hai impostato? Nel 2003. Ho allestito il locale senza appoggiarmi a un architetto perché volevo un’impronta spontanea, spazi organizzati in base alle nostre esigenze di lavoro. In modo che il ristorante avesse un clima e un profumo tutto suo, naturalmente. Perché mi considero un ristoratore prima che uno chef: significa che il cliente deve mettersi a sedere e stare bene. Se stende le gambe sotto il tavolo e si stira sulla sedia, significa che ho raggiunto il mio scopo. È come una spa, che offre servizi per il benessere delle persone. Anche le zampate però possono starci in cucina. Ma nelle spa fanno anche i massaggi, non stai tanto bene in quel momento però percepisci che la zampata può giovarti. Ed è lo stesso in cucina. Come si è evoluta la tua cucina in questi anni? È cambiata moltissimo. Oggi è molto più pulita, empatica, delicata, sfumata, grazie all’apporto misurato di tanti elementi. Sono partito con la volontà di dimostrare le mie capacità, poi sono passato al dubbio e al desiderio di rinnovarmi completamente. Fino a: “Basta, non mi interessa, questo è quello che sono in grado di fare”. Dopo una serie di bastonate sui denti mi sono accorto che non potevo cercare l’originalità e l’effetto a tutti i costi, per colpire la gente. Allora mi sono chiesto quali dei miei piatti mi piacevano di più e ho cercato di capire il motivo, per portare quel quid altrove. Col tempo mi sono affinato, nelle tecniche, nella manualità, nella mentalità, nel palato. Ogni tanto mi chiedo come ho potuto fare certi piatti. Ad esempio il capriolo semicrudo su crema di yogurt e basilico, con ostriche, piccoli budini di cipolle spruzzati di alcolico e alghe. Oggi magari non toglierei nulla ma perfezionerei l’insieme, non metterei più l’ostrica ma il profumo di ostrica, ad esempio. Perché ci si evolve, si cresce, si trova il proprio equilibrio. Senza rinnegare nulla perché gli “errori” e la generosità nell’esporsi sono i presupposti del mio essere qui. Consideri Gualtiero Marchesi il tuo maestro ideale? Ci ho mangiato tre volte, la seconda per la dichiarazione di matrimonio a mia moglie. Tra l’altro feci una figuraccia che ricorderò a vita. Partimmo con il giusto anticipo ma allora i navigatori non c’erano e arrivai alle 2 e 10… Molto emozionato chiesi scusa e lui mi disse: “Abbiamo solo alcune cose”. “Guardi, se non ci accetta non è un problema, torno la prossima volta”. Lui replicò: “Per carità, siete miei ospiti”. E di lì partì con un menu che scelse lui, straordinario. Grande ristoratore e grande chef. Grande maestro. Non ho mai avuto contatti diretti con lui ma è stato un ispiratore sotto tanti punti di vista. L’estetica e la semplicità, nella fase successiva la contaminazione con le arti visive. A metà anni ’80 ha fatto cose che sono diventate di moda 15 anni dopo. Il risotto con la foglia d’oro, la seppia al nero. Imperfettibili. 97 enologica edizione 2011 Puntinismo, lo guarda, lo annusa, gli piace e lo mangia tutto. Chiara guarda, annusa e poi dice: “non mi piace”. Ma l’importante è che usa l’olfatto, non c’è il rifiuto preventivo. Sei un cuoco tecnologico? buona e una straordinaria. Io le voglio tutte straordinarie. Se un maialino non va alzo la cornetta e mi spiego. Abbastanza. Mi sono aggiornato seguendo qualche corso, sul posto o nei congressi. Il Roner ce l’ho anch’io, ma tante tecnologie non le ho mai prese in considerazione. Penso al distillatore o al Pacojet; l’azoto liquido l’ho usato per un po’ ma preferisco il mantecatore tradizionale. Non è una questione di qualità perché ogni tecnica ha il suo apporto, dipende dal piatto. La tecnica è al servizio della ricetta. Stop. Il revival della patria è una reazione alla globalizzazione? Mi sembra una semplificazione. Da un certo punto di vista anch’io credo alla cucina globale. All’importanza di cogliere spunti, idee, prodotti, spezie. Che sono sempre arrivate da ogni parte del mondo. Quindi ben venga la globalizzazione, se solo riuscissimo a equilibrarla. Cogliere il territorio, stare alla finestra per andare oltre e quando capita fare un bel pick up. Senza cadere nei due eccessi: tutto dentro o tutto fuori. Preferisci il dolce o il salato? Tendenzialmente amo gli elementi dolci, non riesco a finire un pasto senza il dessert. E penso di essere più bravo nei dolci che nel salato. La molla è stata la volontà di migliorarmi: non amo fare i dolci, ma desidero mangiarli, quindi bisogna che ci metta più impegno. Conseguentemente c’è sempre una nota dolce anche nei piatti salati, ma difficilmente è stucchevole. È un contrasto raro ma presente tanto in Emilia che in Toscana, penso al cinghiale con le prugne o allo gnocco fritto con la marmellata. Anche se in Toscana poi bisogna usare il pepe, sennò non è un piatto. Mentre io preferisco il pepe bianco, e lo uso in modo molto lieve, femminile. Se l’alta ristorazione è in crisi, è perché non ha saputo farsi patria? Direi che è più campanile che patria, perché è parcellizzata. Ogni realtà è conosciuta solo nel suo piccolo entourage. L’alta ristorazione poi fa ancora più fatica, per ragioni politiche. Anche per questo, avendo iniziato la mia attività in anni brutti, seguo eventi esterni: catering, banqueting, cene in case private, che mi fanno conoscere e aiutano a coprire i costi del ristorante. La scuola Amaltea ha lo stesso scopo: divulgare. Con alcuni soci ho aperto un’enogastronomia con rosticceria che va moltissimo in centro storico. Perché la gente a volte ha bisogno di cose semplici, lo capisco bene. Per questo 4 anni fa ho deciso di separare la carta del ristorante in una pagina di sicurezza totale, il tortellino, la tagliatella, la frittata, il baccalà fritto, e nella sezione creativa. Mentre il menu degustazione è a sorpresa. Sei un talent scout del prodotto? Mi piace verificare di persona se mi segnalano un prodotto, anche se non sempre ci riesco per ragioni di tempo. La territorialità mi tranquillizza perché è più facile controllare che la qualità sia costante. Se è vero che noi facciamo appello ai piccoli artigiani, questi vanno “educati” alle richieste. Perché non possono darmi una patata 98 È inevitabile, perché se vai a vedere una mostra in un museo, magari qualcosa riaffiora, non subito ma dal subconscio. Perché è entrata a fare parte di te. Sono riuscito a creare certi piatti solo perché avevo una cultura legata ad altre sfere. Parto quasi sempre a tavolino, ho un’idea, un prodotto e con carta e penna schizzo il piatto. Dentro di me c’è un’enciclopedia di profumi per immaginare l’equilibrio finale, ma l’intenzione volontaristica non basta. Da lì bisogna andare molto avanti. E se riesce, fare qualcosa di buono che riesca a emozionare. L’italianità nel vino, per finire. Le eccellenze sono talmente tante… La nostra forza secondo me è l’umiltà di apprendere dagli altri, scriminando il grano dal loglio. Come in cucina, dove ci siamo fatti forti di un parterre di prodotti e know-how eccezionali. Da parte mia recentemente c’è stata la volontà di compiere un’ulteriore evoluzione specializzandomi sul versante transalpino. Ma ho sempre specificato che prima di andare oltre il confine volevo capire se era sufficiente il campionario italiano, che probabilmente non basterà mai ma secondo me può essere adeguato. “Oltre le nuvole.” Mortadella di Bologna 99 enologica edizione 2011 La patria della cucina, adesso. Quanto contano le contaminazioni con le altre discipline per te? Penso al tuo dessert Puntinismo. Al fatto che voi cuochi non cuochi tendete a una cucina che non gioca necessariamente in casa. Maria Grazia Soncini La Capanna di Eraclio Località per le Venezie, 21 - 44021 Codigoro (FE) tel. 0533 712154 - www.lacapannadieraclio.com Tappatevi il naso e tuffatevi. Perché poggiare i piedi su questo brandello di campagna attorno a Codigoro significa immergersi sei metri sotto il livello del mare e dodici sotto la piena del Po. Una liquidità immaginaria che pullula di fantasmi e risonanze, l’epica western della bonifica compiuta negli anni del fascismo, al posto degli indiani nuvole di zanzare, stormire di canne e gracidare di rane; mentre il Po qualche chilometro più in là ammonisce sulla precarietà della vittoria e all’orizzonte torna il mito. Sembrerebbe un panorama spoglio, cartesianamente ortogonale, con i suoi pioppi sparuti incastonati fra i canali e i campi pallidi; invece è un luogo magico. Una piccola patria che trova il suo punctum nella Capanna di Eraclio, il ristorante deliziosamente d’antan che ancora inalbera l’insegna di “Osteria con cucina”. Pochi locali in Italia potrebbero consentirsi tutto questo. Le tovaglie bianche profilate di merletto, le credenze di legno, le galline razzolanti nel dehors. E dietro le quinte la cappa e i mobiletti smaltati anni ’60 della cucina completa di camino, con la porta socchiusa sulla cameretta dentro la quale si intravvede un’anziana signora, intenta a preparare la maionese con il cucchiaio di legno che sbatte sulla ciotola. Sul pavimento il solco profondo di una crepa va e viene con le stagioni, segno di un terreno che respira e di muri simbiotici con la terra acquitrinosa. Il ritmo è quello scandito dagli orologi a pendolo delle salette: binario, inesorabile, eternamente ricorrente. E la nostalgia brilla come un lusso che altrove suonerebbe fesso, al pari del kitsch necrofilo e posticcio che cinge d’assedio la “cucina regionale”. Della memoria dell’acqua hanno discusso a lungo gli scienziati; ma nella liquidità delle narrazioni padane sguazza con innata padronanza la cuoca sirena Maria Grazia Soncini, con la complicità del fratello sommelier Pierluigi. Un’apnea nella storia che sa di avventura e lascia gli ospiti storditi e felici. Oltre che sazi. L’anguilla in umad, grigliata e poi finita al forno, ci sfida come un esercizio mnemotecnico dove l’eccellenza del prodotto getta l’amo della forchetta nel subconscio, rimescolando i precordi. Ma quel boccone non sarebbe lo stesso senza gli innumerevoli tasselli che ne puntellano il gusto. Dalla vestale canuta sullo sfondo, nient’altri che la mamma della cuoca, all’eponimo papà Eraclio, che curvato dal tempo e menomato nella vista risveglia reminescenze omeriche che credevamo sepolte. Dai rumori campestri dei trattori che si fanno strada fra le esalazioni dei canali alla patina del tempo, che si è posata sulle cose facendole più vere e più pesanti. anni luce dalle girandole post-moderne e virtuali che frullano l’ingrediente in un niente che nienta di heideggeriana memoria. “Quello che tu racconti e che tu vedi al ristorante in parte è il frutto della pigrizia, ma in parte ci piace, perché è 100 e l’osteria; ma loro chiedevano ai miei genitori se potevano cucinare qualche cosa per loro. E così è partito tutto. Quando poi è arrivato il boom economico, la gente cominciava ad avere la cinquecento o la seicento, e sai qual era la meta? Venivano qui a mangiare la domenica a pranzo. E si spostavano in gruppo, mica in coppia come adesso. Andavano a far ‘la magnà’. A quei tempi mio papà aveva le barche, perché lui era un pescatore, ovviamente di frodo. Le teneva nel canale qui davanti, che è un canale di irrigazione rivolto verso nord; poi c’è il canale di scolo, fatto durante la bonifica per drenare le acque. Ed erano corsi già pescosi, dove si potevano catturare le anguille, i pesci gatto, le tinche e anche i lucci, perché erano molto puliti. Con le sue reti al mattino tirava su la pescata e la domenica quando arrivava la gente gli faceva: ‘Ci fai la spadellatina di pesce?’. Perché le esigenze del cliente di allora, che non era poi così diverso da oggi, erano semplici. Il pesce più piccolo si friggeva, mentre le anguille o i pesci gatto si facevano alla griglia. C’era anche la selvaggina, perché mio papà era cacciatore. Soprattutto lepri e fagiani; non gli acquatici, che vivono verso le valli litoranee, a una ventina di chilometri da qui, dove si spingeva mio nonno. Allora mia mamma faceva la lepre in umido, le pappardelle o il fagiano arrosto. E questo era il menu. Quando il ristorante è decollato, però, abbiamo iniziato a fare un po’ di commercio, e sono arrivati i fischioni, le anatre e le folaghe. Abbiamo cominciato anche ad allevare i maiali per fare i nostri salami. 101 enologica edizione 2011 come una scarpa vecchia. Che ti piace, che è tua, che è modellata sul tuo corpo”, commenta Maria Grazia. In origine furono i nonni Luigin e Maria, pionieri di un avvincente “anguilla western”. Il primo edificò la casa negli anni ’20 sul terreno appena bonificato, di fronte a una strada trafficata da birocciai addetti al trasporto delle merci. Si trattava di un’osteria con negozio di alimentari dove si serviva solo vino, giacché l’istituzione ristorante era di là da venire. “Pan e gaban mai zmangari a ca’”, recitava la saggezza popolare, e di fatto il cibo lo si portava da casa. La sera c’era anche la musica, orchestrine del luogo, soprattutto fisarmoniche. Insomma quella casupola era un saloon vernacolare che fungeva da punto di ritrovo per tutto il circondario. nonno luigin era cacciatore e pescatore e stava via per giorni e giorni, così gravava tutto sulla nonna. E i figli da sfamare erano sette, tutti avviati su strade diverse, a parte Eraclio, che restò alla casa madre. Ma la ristorazione vera e propria arrivò solo nel 1962. “Mia mamma Vanda era molto brava a cucinare perché aveva lavorato in un’importante rosticceria di Bologna, dove facevano fino a 90 sfoglie al giorno per i tortellini. E ancora adesso alla Capanna stende la pasta al matterello. Aveva conosciuto mio papà perché veniva in vacanza dallo zio, fattore dell’azienda qui accanto. Ma mio nonno non voleva che si cucinasse, aveva messo il veto: ‘I sin fa preparar da so mujer’, ripeteva. Così abbiamo cominciato solo quando è morto. I primi clienti sono stati gli operai della linea elettrica, che qui è arrivata nel ‘60. Noi avevamo il salame, c’erano la salumeria Per le verdure c’era l’orto, perché vigeva l’autarchia. Si trovava dove adesso c’è il canneto, vicino all’acqua, e ci crescevano radicchio, sedano, carote, cipolle, pomodori, melanzane… Oggi va di moda avere l’orto, ma io non ci credo più di tanto, mi puzza un po’ di marketing e burocraticamente è complicato. Anche se oggettivamente non è facile trovare ortaggi eccellenti, perché specialmente in queste zone scarseggiano. Qui non c’è mai stata una vera tradizione, contrariamente al Veneto e alla Romagna, dove vige il culto della stagionalità e delle erbe spontanee. Personalmente so andare a radicchio, ci vado ancora e per me è uno dei cibi migliori che esistano, soprattutto spadellato. A crudo lo servo con la cipolla e l’aceto insieme al pesce alla griglia, come si è sempre fatto, ma la nostra cucina non si è mai basata più di tanto sul binomio pesce-verdure. Ovviamente poi c’erano i polli nel cortile, perché non puoi avere una corte in campagna senza le galline. Sono cosa fra le cose, come noi della famiglia. Ci sono tuttora, ma al ristorante non possiamo usare nemmeno le uova per la maionese o per la sfoglia. Se lo fai in Francia sei lodato, mentre qui da noi vai in galera”. Tu davi una mano da piccola? Io sono nata e cresciuta in questa casa. E se sei figlia di ristoratori, non c’è un momento preciso in cui inizi. Ricordo che al mattino prendevo l’autobus sulla strada per andare a scuola, o magari andavo al cinema, e al pomeriggio passavano a prendermi in città perché bisognava aiutare. Di lavoro ce n’era soprattutto il sabato sera e la domenica pomeriggio, quando la gente aveva la macchina e usciva. Mio papà faceva arrivare 3040 prosciutti da langhirano, li mettevamo in soffitta e li servivamo con i nostri salami. Io stavo soprattutto in sala, oppure prendevo i peperoni sottaceto dolci che si vendevano nelle latte, li tagliavo a falde e li condivo con l’aglio e il prezzemolo. Facevano parte dei vassoi di sottaceti, come usava allora, con le cipolline fatte in casa e la giardiniera. Quindi le mani in pasta le ho sempre messe, anche se era l’ultimo mestiere che avrei voluto fare, perché mi sembrava scontato. Così mi sono iscritta a medicina. Ma negli anni ’80 sono scoppiati il boom economico e quello della ristorazione. Sono nate le prime riviste, che mostravano le cose in una maniera diversa. I vini non erano più bianchi e rossi anonimi in caraffa, ma tanti tipi diversi con i loro abbinamenti. I nostri genitori hanno lasciato carta bianca a me e a mio fratello Pierluigi, soprattutto in cantina, e ho deciso di lasciare gli studi. Come è avvenuto il passaggio? non c’è stato un passaggio vero e proprio, diciamo che il menu si è ampliato. Perché prima c’erano il risotto di pesce o di caccia, le tagliatelle e nessun altro formato. Abbiamo cominciato a fare gli antipasti, cosa che prima non esisteva. Ricordo le cozze e le poveracce alla marinara, o le canocchie a vapore. Anche robe come le seppioline ripiene di insalata russa, che adesso mi sembrano talmente ingenue… Il pesce lo prendeva mio padre tutti i pomeriggi all’asta di Goro, dove i pescherecci fanno le 36 ore, cioè escono la notte e ritornano il giorno successivo al pomeriggio per vendere. 102 Sì, perché in quegli anni abbiamo avuto accesso mentale a cose che non conoscevamo, di cui non sospettavamo l’esistenza, e abbiamo visto improvvisamente tante sfaccettature nascoste. Le riviste svelavano un potenziale enorme da sviluppare. Ed era in corso la grande rivoluzione estetica di Gualtiero Marchesi, con il servizio al piatto. Ma la grande apertura mentale me l’ha data il Trigabolo di Corelli, un vero faro, che ha traghettato la ristorazione della zona dal risotto alla pescatora alla crema di crescione al midollo. Ci conoscevamo bene perché condividevamo l’acquisto di selvaggina. Giacinto Rossetti andava a caccia in Valle Sacchetta, ma quando c’era la cacciata la domenica bisognava prendere tutto il bottino della valle, perché il commercio non esisteva, e tanto meno i frigoriferi. Così ci spartivamo i selvatici. Anche mangiare da loro mi è piaciuto tantissimo. Il cibo non si riduceva a una cottura, ma era tutto un mondo di altre cose. Il Samsara. Unforgettable, nonostante tutte le differenze, perché io non cucinerò mai in quel modo. Ma è come una Ferrari, anche se non la guiderò mai, per me sarà sempre una bellissima macchina. Ricordo anche il Sambuco di Porto Garibaldi, che era molto elegante, aveva i fiori in tavola. Noi eravamo molto più poveri e allora usavo le bottigliette di Campari soda, quelle coniche, con dentro i fiori di campo. Erano gli anni in cui prendevano piede le prime manifestazioni, eventi dove sentivi spirare la grande gioia di condividere scoperte ed emozioni. Ed è lì che ho conosciuto Vissani, che sotto questo profilo è generosissimo, e altri colleghi che mi hanno arricchito. Questa fase quanto è durata? Perdura, nel senso che non c’è mai stata una soluzione di continuità. Anche se oggi c’è un ritorno alle cose naturali. E noi ci sguazziamo, perché abbiamo sempre fatto questo tipo di cucina, fondato sull’ingrediente. Se c’è stata un’evoluzione, è avvenuta nella consapevolezza tecnica delle cotture e nella grande volontà di servire la materia prima migliore. Perché il pesce buono si trova ancora, ma costa molto più caro e il cliente deve essere pronto ad accettarlo. C’è stato un periodo invece in cui mi sono sentita desueta, gli anni 2000, quando noi abbiamo continuato a modo nostro ma tutt’intorno la ristorazione vorticava. La grigliata per esempio è rimasta sempre la stessa, con la stessa mamma, lo stesso pesce e la stessa legna, i pioppi abbattuti qui davanti, i sarmenti di vite del pergolato e un po’ di carbone dolce scelto da noi. Nel 2001 abbiamo avuto un articolo di 5 pagine su Grand Gourmet, che per me rappresentava la consacrazione; ma in copertina c’era la carbonara di Adrià. Mi sono sentita come una canoa rispetto a un transatlantico. E non lo dico con risentimento, perché Ferran Adrià lo ammiro. All’inizio ero diffidente, mi sembrava quasi che non fosse un cuoco, ma i miei clienti hanno iniziato a descrivermi qualche piatto curioso. Poi l’ho visto sul palco di un congresso, ed ero molto prevenuta, ma quel che mi ha colpito sono stati la sua anima fanciullesca, il gioco, la meraviglia. Certo, qui alla Capanna è 103 enologica edizione 2011 Quindi tu, vestale della tradizione, sei stata sedotta dalla nouvelle cuisine? completamente diverso. È tutto molto casalingo, non esiste neanche una demarcazione netta fra il lavoro del ristorante e la vita famigliare. È come lavorare in un circo, anche se siamo stanziali. Tutte le sere dobbiamo montare lo spettacolo, tutte le mattine dobbiamo accudire gli animali. Quando mi metto la cuffia e la giacca prima del servizio, mi dico: “Ok, andiamo in scena. Comincia lo spettacolo”. E la vita privata segue. Il pesce che cucini è ancora quello di Goro? Prevalentemente sì, ma la flotta oggigiorno non è più così importante, per cui dobbiamo rivolgerci anche altrove, per esempio ad Ancona, sempre nell’Alto Adriatico. Mentre durante il fermo pesca andiamo a Porto Santo Stefano, sull’Argentario. Secondo la zona di pesca il gusto varia molto, perché la sapidità cambia. Per esempio le sogliole, i rombi e i soasi di Goro a mio giudizio sono i migliori, perché la bassa salinità si traduce in una maggiore finezza e lo iodato si smussa. Le anguille invece le prendiamo dalla Sacca di gorino, dove l’acqua del Po si mescola al mare, cosicché è corrente e pulita; i pesci si muovono molto e hanno una livrea grigio azzurra, per mimetizzarsi sul fondale. Mentre l’anguilla del canale ha un gusto palustre e una colorazione più scura. La patria sembra un po’ il filo conduttore di tutto il ristorante. Qui siamo in Emilia o in Romagna? Siamo in Emilia, e da Ravenna comincia la Romagna. C’è anche un forte influsso veneto. Perché non esiste una cucina ferrarese codificata del Delta del Po, ma la cucina polesana del Delta del Po esiste eccome, e andando oltre c’è quella più elegante di Venezia. Da queste parti, per fare qualche esempio, prepariamo le sarde in saor, la polenta bianca con il pesce, i risotti. Che un tempo si approntavano con il riso originario, come fa ancora qualche trattoria. Noi per affrancarci abbiamo provato il vialone, visto che mia mamma è mantovana, poi siamo approdati al carnaroli De Tacchi, che per me è top. Parlando in generale, credo che il concetto di patria nasca dalla lontananza. Nel senso che per me resta qualcosa di scontato, naturale, il mio modus vivendi, visto che non mi sono mai spostata. andando lontano invece si può sviluppare un concetto vero e proprio, probabilmente legato alle radici, ai genitori. Anche confrontarsi con uno straniero, per esempio un cuoco giapponese, porta a sviluppare una visione diversa. Però io mi sento molto patriota, se per patria intendi il luogo amato e decisivo per l’imprinting. Quello dove si desidera tornare dopo essere partiti. Può essere questo ristorante come il paese Italia, perché ci sono tanti altri luoghi come questo. [Passa un contadino e porta due cassette di pere: “Le vuoi?”. Maria Grazia e il contadino scaricano conversando in dialetto]. Vedi, anche questa è la patria: la condivisione di un territorio. Io voglio preservare le identità particolari per avere il privilegio di condividerle con gli altri attraverso il medium del cibo. Ritrovare altre persone che quando mi sposto possano darmi le stesse sensazioni. Nel ristorante insomma si fa la patria. Sì, perché si fa la storia di un luogo, la si condivide e si crea attorno ad essa un tessuto di relazioni con i fornitori e i clienti. Alla Capanna servo l’anguilla arrosto in umad, ma 104 In carta però ci sono anche piatti creativi, per esempio il crudo di pesce. Sì, e lo facciamo dal 1988. Perché è difficile individuare un confine catastale fra innovazione e tradizione. Noi abbiamo scelto di mantenere i piatti di sempre, come l’anguilla e i fritti, portandoli a una comunicazione più moderna. E abbiamo affiancato loro gli antipasti, che prima degli anni ’80 non faceva nessuno, il pesce crudo come la granseola alla veneziana, perché siamo un po’ veneti nell’anima. Adesso facciamo il calamaro scottato sulla padella di ferro di derivazione catalana, e io mi chiedo: il confine dov’è? Oppure ci confrontiamo con la patria degli altri, citando il cappon magro o elaborando i pomodorini del piennolo. Perché il chilometro zero secondo me è una forzatura. La sfida vera è un’altra: si tratta di mettere al passo le materie prime di sempre con le nostre conoscenze attuali. Per esempio uso un tonno che viene pescato secondo il sistema giapponese, cioè ucciso, eviscerato e privato delle branchie, per poi essere rimesso nell’acqua a sgrondare in navigazione. In questo modo resta rosso e sodo ma è privo di sangue, che ossidando diventerebbe scuro e amaro. Ammiro il rispetto per il pesce che hanno i giapponesi. Sono maestri nella dilatazione del particolare, nel senso che colgono in ogni cosa aspetti che possono essere ulteriormente sviluppati. E assemblano i piatti con una casualità misurata, che non è affatto casuale. Che piatti hai scelto di cucinare a Enologica? Porterò innanzitutto l’anguilla arrosto in umad, di cui ho già parlato, attualizzandola con una quenelle di pȃté del suo fegatino. È una ricetta concepita da un collega ristoratore già sindaco di Comacchio, che è stata ripresa anche da Igles. Ma la fonte non è scritta, così l’abbiamo personalizzata in modo un po’ diverso. Io per esempio al posto del brandy uso una spruzzata di Vin Santo e di Marsala e la servo con del pan brioche tostato. Il secondo piatto sarà il germano con cipolla e vino rosso, una ricetta tradizionale della zona, nella codificazione di mio nonno, che non ho voluto assolutamente rivedere. Il selvatico è rosolato interno in tegame con abbondante cipolla, fino a caramellizzazione, innaffiato di Fortana e lasciato stufare lungamente, in modo che si intenerisca ben bene e con la cipolla formi una crema dal gusto molto intenso. 105 enologica edizione 2011 dietro questa anguilla posso raccontare il mio luogo, la grande storia e le piccole storie che si intersecano tra loro. Se vado in Sicilia voglio mangiare le specialità locali per risalire a tante cose, ma qui servo l’anguilla arrosto in umad perché è l’anguilla della mia zona, quella che pescavano i pescatori, i cui ingredienti sono il grasso dell’anguilla, perché non c’era ancora l’olio, il rosmarino e l’aglio, che erano gli aromi tipici di qua. Magari perché l’aglio era un conservante naturale in zone così umide, chissà. È un piatto che ci identifica perché è una ricetta di goro, ed è una ricetta di mio nonno. L’anguilla viene tagliata a rocchi e cotta due volte. La prima scottata sulla griglia serve ad indurire la pelle, per raccogliere i succhi all’interno; poi si passa in forno dove il pesce cuoce nel suo stesso grasso. L’accompagnamento, anche questa volta, è la polenta bianca. I selvatici purtroppo non possono essere quelli della nostra Valle, anche se burocraticamente forse si sta aprendo qualche spiraglio per la certificazione e l’utilizzo nella ristorazione. Speriamo! Il vino, a questo punto. In origine c’erano solo il bianco e il rosso sfusi. Poi abbiamo iniziato con gli abbinamenti, soprattutto sui rossi. Anche dare due bicchieri è stata una rivoluzione. Abbiamo continuato ad aggiungere etichette fino agli anni ’90, quando c’è stato il massimo furore della cantina di mio fratello. Ma Tangentopoli ha segnato il crollo dei consumi di alta fascia. Così abbiamo dovuto fare damigiane e damigiane di aceto, perché nessuno comprava più quelle cose. Ricordo che mio padre versava le bottiglie nei recipienti e aggiungeva un po’ di madre. Ci abbiamo pulito la cucina e i piatti per anni, in modo da togliere l’odore del pesce. E sono fasti che non sono più tornati. interviene il paté di fegatino, che andrebbe a cozzare con un prodotto tannico, acidulo, frizzante. Meglio quindi l’Albana Progetti 1 di Leone Conti. Mentre il germano con cipolla e vino rosso, se annaffiato di Fortana, va accompagnato col medesimo vino secondo la regola aurea. Magari quello prodotto da Corte Madonnina, qui vicino, oppure da Mattarelli. Non bisogna comunque spacciare questi vini per chissà cosa, ma prenderli per quello che sono, in modo da goderne al massimo. Noi siamo anche un po’ veneti e un po’ emiliani. Ed ecco altre due mie passioni, il Lambrusco e il Soave. Invece non mi ha contagiato la voga dei vini naturali. Che come una sorta di madeleine al contrario mi ricordano i vini sfusi che servivamo quando ero piccino, con gli odori per me sgradevoli di cantina, bucce in fermentazione e lieviti. Pierluigi, come abbini la cucina della capanna e i piatti di Enologica? La cantina attualmente conta un centinaio di etichette, delle quali un decimo circa proviene dall’Emilia-Romagna. Copriamo un po’ tutte le fasce di prezzo e apriamo volentieri anche i grandi prodotti al bicchiere. Ma la tendenza che ho osservato nei clienti è quella di usare il vino non solo per degustare, ma anche per dissetarsi, a causa dell’etilometro e non solo. Quindi i prodotti tipici della zona, come il Fortana, tornano opportuni, anche perché in quanto a piacevolezza accompagnano in modo imbattibile tanto l’anguilla che i fritti. Nel caso dell’anguilla arrosto in umad però 106 Pierluigi Di Diego “Pasta pasta pasta pasta”. Per illustrare il suo concetto di patria Pierluigi Di Diego, chef del Don Giovanni a Ferrara, non può che ricorrere alla figura retorica dell’epizeusi. Tale è la pregnanza di un piatto che ha saputo farsi crocevia di grandi e piccole patrie, strumento privilegiato di quel bricolage con cui ciascuno di noi costruisce il proprio luogo ideale, per cacciavite un matterello e per chiave una rondella tagliapasta. Ed è così che la palatabilità spigolosa della sua piccola patria abruzzese (quegli angoli di chitarra che rimano le sferzate dei fonemi dialettali e le asprezze dei paesaggi scoscesi, anticipando la caratterialità dei condimenti) sposa le morbidezze dell’Emilia-Romagna, terra di sfoglie spesse e suadenti sui ripieni generosi, amniotiche come coltri di nebbia sulla bassa. Una palestra che diventa piacere ossimorico del nerbo che accarezza le sfumature e della soavità che tempera le punte. Contrasti mai completamente fusi al fine di stimolare i galvanismi del palato. Per un enigmista passare dalla patria alla pasta richiede appena qualche cambio di lettere. Un gioco da ragazzi che sganciandosi dell’ovvietà, può servire a costruire finalmente le coordinate di un’alta cucina renitente alle egemonie straniere. Da sempre apolide, quando non colonizzata, la gourmandise italiana ha fatto fatica a diventare patria. E forse per questo è così esposta alle bufere di ogni recessione. 150 anni dopo avere fatto l’Italia, è giunto il momento di fare gli (chef) italiani. Prendendo spunto dagli incipit senza svolgimento che hanno costellato la storia nostrana. Come il Trigabolo, primo ristorante no global, che ha tentato di sciogliere il nodo psichiatrico dell’identità italiana, romagnola, del Po. Uno zoom tanto deciso quanto instabile, sottoposto ad elastiche aperture sul mondo. Fantastici quegli anni: “Cucinavamo tutti gli uccelli che passavano di lì, i cacciatori li tiravano giù e li portavano ad Argenta; e il pesce lo prendevamo dove lo compro ancora io”, ricorda Pierluigi. Dove lo compri, allora? arriva adesso da Porto Garibaldi. Calamari, calamaretti, mazzancolle, rombi, soasi, sgombri, seppia nera, ricciola nostrana, granchi rosa… Quando arriva lo pulisco e lo assaggio un po’ a crudo, perché ogni giorno è diverso. Abbatto solo quello che servo crudo, perché oltre i 60 gradi non ha problemi. Il resto lo eviscero bene, lo libero dalle tracce di sangue e lo conservo a -1 o 0 gradi. Sottovuoto mai, perché se facciamo una prova della durata, con riferimento all’integrità dei sapori, il sottovuoto magari preserva altre cose ma non certo il gusto, e insieme all’aria estrae sempre 107 enologica edizione 2011 Il Don Giovanni Corso Ercole I D’Este, 1 - 44121 Ferrara tel. 0532 243363 - www.ildongiovanni.com dell’altro, per esempio un po’ d’acqua. Lascio anche la spina, perché non solo in cottura, anche prima preserva gli umori, mantiene un equilibrio. È come la carne attaccata all’osso, che è sempre migliore, per questo i fondi si fanno così. Sono prassi che ho tastato con mano, facendo dei test. Com’è il pesce di queste zone? Direi che è sempre meno e costa sempre di più, compreso il pesce azzurro e le vongole poveracce… Quello che 3 o 4 anni fa pagavo 500 euro adesso ne costa 900. Per esempio la cassa di canocchie da 6 chili che veniva 40 euro adesso è arrivata a 80. Perché le vogliono tutte; sono anni che faccio una terrina di canocchie crude, ma adesso tutti smaniano per le canocchie crude. Sotto il profilo qualitativo ci sono alcune cale speciali, per esempio la sacca di goro, dove c’è un mercato del pesce piccolino ma ottimo. Gli scampi, gli scampetti quando li trovi sono eccezionali, number one. Anche il pesce di Porto Garibaldi è buono, perché lo pescano comunque a poche miglia da qui. Ma non sempre il mare si sente, ci sono settimane in cui sa un po’ più di mare, altre settimane un po’ meno. Chissà da cosa dipende, dalle correnti, dal Po che comunque fa il suo danno, scarica di tutto e abbassa la sapidità con le sue acque dolci. Ferrara non è Santa Maria di Leuca, dove il pesce magari ha un altro sapore. Questa non è la tua patria anagrafica? Sono nato in Germania da genitori abruzzesi, papà operaio e mamma infermiera, ma ci sono rimasto solo 4 mesi. Mi definirei anche un po’ milanese, perché ho abitato nell’hinterland per moltissimi anni. In casa mia però si mangiava abruzzese: pasta, pesce, verdure. Una cucina molto mediterranea. Si può dire che a 10 anni già impastavo, perché dovevo stare dietro alle mie sorelline. E mia madre mi lasciava i foglietti: “questo fallo cuocere 10 minuti”… è stata lei a iniziarmi. Ricordo che fregavo il pezzo di pasta all’uovo, lo schiacciavo sul tavolo e lo mettevo sul fornello, sulla fiamma viva. Lo facevo bruciacchiare e lo mangiavo come una piadina. Mi piaceva quella sensazione di bruciato abbinata alla dolcezza della farina. Poi c’erano le nonne, ma stavano in Abruzzo. Andavo giù di testa quando mia nonna Lucia metteva su il sugo nel tegame di terracotta, con i rametti di prezzemolo intero e i pomodori appesarelli, che sono un po’ il nostro piennolo ma senza la goccia. lo lasciava scoppiettare per tutta la mattina e usciva fuori una pasta meravigliosa. Rigorosamente mezzemaniche, lei li chiamava gnoccun, e solo per mio nonno linguine, perché se gli serviva qualcos’altro si arrabbiava. Sembrava il vecchietto della birra Moretti, con gli stessi baffi, uguale. Con tutte queste suggestioni alla fine delle medie, quando hanno iniziato a chiedermi cosa volevo fare da grande, avevo già le idee chiare: il cuoco. Ho cominciato prestissimo e non ho mai fatto nient’altro: sono 28 anni che faccio questo mestiere. Lo senti un po’ come la tua patria, l’Abruzzo? Sì, sento che ogni tanto mi chiama. Che c’è qualcosa che tira. Prima o poi torneremo tutti alle origini. Il sangue è una roba troppo forte, sembra un magnete. I miei nonni erano contadini, avevano la 108 Cosa c’è di abruzzese nella tua cucina, a parte l’olio? gli spaghetti alla chitarra, ogni tanto qualche sugo, le basi come la pasta di semola Masciarelli della provincia dell’Aquila. E poi la mano e il senso del gusto. non tanto sul pesce, che è tanto ma non lo sanno fare, è sempre troppo cotto. Oltre agli insegnamenti famigliari, come ti sei formato professionalmente? Ho frequentato l’alberghiero a Milano, al CAPAC. Alle medie non ero stato bravo, ma lì primeggiavo. E intanto provavo a casa quel che imparavo a scuola. Uno dei primi piatti che ho voluto riproporre sono state le crespelle alla valdostana, con la Fontina, gli champignon e la besciamella. E mio padre mi fa: “Ma cos’è ‘sta roba?”. Perché era conservatore come lo sono spesso gli abruzzesi. Anche se adesso si è evoluto. La prima stagione l’ho fatta a Lipari, da Filippino. Poi non ho mai avuto un maestro vero e proprio, piuttosto ho lavorato con tanta gente valida, anche poco famosa, che so, Giuliani Paolo del Solaro tennis club di San Remo, bravo e molto umano. Un altro che mi è piaciuto molto, bello, tecnico, forte, simpatico è stato antonio ghilardi da Picci a Cavriago, che ha segnato il mio arrivo in regione. Poi Igles Corelli al Trigabolo dal ’92, quando Marcello Leoni ha lasciato. Dopo essere stato da Picci volevo cambiare e ho chiesto a ghilardi se conosceva qualcuno che cercasse in zona. Lui mi ha risposto: “guarda, c’è il Trigabolo ad Argenta, cercano uno ai primi”. Cosa ricordi di quel periodo? Avevo 25 anni, l’età in cui un cuoco si trova al giro di boa decisivo. Perché è confuso: o fa il cuoco di routine o cambia lavoro, oppure scatta la passione. Io avevo cominciato a lavorare a 14 anni e a 25 anni non capivo più la situazione, perché pensavo di essere un cuochetto bravo e invece sono andato in crisi. Allora il Trigabolo era ai vertici della ristorazione nazionale, se fosse rimasto aperto secondo me avrebbe preso anche la terza stella. Perché era una fucina. Giacinto Rossetti, che era il Trigabolo, ci trascinava con il suo entusiasmo per le materie prime; quando arrivava con una cassetta di roba, era come se portasse delle pepite d’oro. Ce le sbatteva lì e andavamo giù di testa. Un sentimento comune a tutti, dalla prima all’ultima ruota del carro la stessa emozione e il medesimo feeling. Me ne sono andato nel ‘95 perché ha chiuso per problemi finanziari. Ma avevo sbattuto il muso: le anguille, i germani, le alzavole, i beccaccini. “Cos’è ‘sta roba qui? Dove sono capitato?”. Per la prima volta ero entrato in un ristorante serio, con materie prime che all’Alberghiero non esistevano, soprattutto a causa dei costi. Perché portare un’anguilla a scuola ha dei costi esagerati, non è come sostituire la sella di vitello con quella di maiale e simulare. 109 enologica edizione 2011 terra e adesso i miei sono tornati giù e hanno preso in mano i campi di Lanciano. Mio padre non vedeva l’ora. adesso tutti i giorni coltiva l’orto e un uliveto da 150 alberi. Fa un olio mitico, che uso anch’io a crudo, perché è un fruttato da olive gentile con pochissimo leccino. Come ti ha influenzato questa esperienza? da qua. Sono partito molto tranquillamente, facendo molti errori, poi ho raddrizzato la barra. Perché tecnicamente non ero attento come oggi. Con me c’era Marco Merighi, che ancora oggi è il mio socio. L’avevo conosciuto ad Argenta, dove lavorava in sala. Sul piano della filosofia di cucina mi ha lasciato tanto. Penso al rispetto e alla conoscenza della materia prima. Perché prima di stabilire cosa fare devi conoscere il produttore e la morfologia del prodotto. La selvaggina da piuma o da pelo, per esempio, devi sapere cosa ha mangiato, da dove arriva, se è di passo, come è collocato il petto… Prima della cucina c’è la conoscenza, e prima ancora il rispetto. Come siete arrivati al Don Giovanni? Cucinare è un atto agricolo, per parafrasare Carlo Petrini. Direi piuttosto che cucinare è bello, e basta. Non mi sono mai pentito delle mie scelte perché questo lavoro ha significato viaggiare e conoscere tanta gente. Altro che sacrifici. Cosa ricordi del servizio del Trigabolo? Si respirava un’atmosfera di professionalità, ma con giacinto in sala… giacinto è uno che conosce tutte le materie prime, non solo il vino. La gente veniva apposta per fare due chiacchiere con lui. Quindi c’era un servizio attento, ma anche la battuta. Una bella atmosfera. Tanti ristoranti oggi hanno il problema della sala. A volte i ragazzi sono troppi tirati, non c’è un sorriso, spira quasi un’atmosfera militare. Invece devi capire il cliente, se è rilassato devi rilassarti anche tu. Puoi essere il cuoco più bravo del mondo, ma se intorno non c’è gente che crede in ciò che fai, è dura… Quando hai iniziato a fare una cucina tua? Dopo il Trigabolo nel ’98 ho aperto il ristorante di Marrara, una frazione a 17 chilometri nel 2003 sono venuti a cercarci e ci hanno proposto il locale. Noi avevamo già preso la stella Michelin in campagna, e lì stavo da Dio; lavoravo solo la sera, così riuscivo ad andare in piscina e a cercare i prodotti. Ma ci piaceva l’idea di aprire anche un wine bar, perché sono 70 coperti fra dentro e fuori più una ventina di sera nel ristorante gourmand. Un flusso che purtroppo non è più costante come un tempo. Come giudichi il percorso compiuto dal Don Giovanni in questi anni? È un periodo in cui l’alta ristorazione oggettivamente ha dei problemi. Credo che c’entri un po’ la sociologia, perché i liberi professionisti girano, un giorno sono qui, un giorno là. Mentre mio padre, che lavorava all’Alfa Romeo di Arese, prendeva il caffè ogni mattina nello stesso bar. Questa liquidità ha influito, eccome; e neanche il turismo basta. A Ferrara c’è un bel pubblico colto solo quando ci sono le mostre. Invece lavoriamo bene e con costanza al wine bar, che è più easy, veloce, informale. Tanta gente viene perché sa che siamo al ristorante ma poi va di là. Ci sono piatti seri a poco prezzo, un po’ un’aria di bistronomia. E un servizio diverso, con la tovaglietta. Ambiremmo a prendere la stella con la tovaglietta. Nel ristorante gourmand abbiamo 110 Se l’alta ristorazione italiana è in crisi, forse è perché non ha saputo attecchire nella cultura nazionale e farsi patria. È rimasta un po’ una schiuma in superficie. Credo sia vero, perché anche i ricchi dicono: ah ma è troppo caro… E la gente deve parlare bene affinché la macchina giri. È un discorso particolarmente vero per chi vuol fare avanguardia, perché deve trovare la clientela e in Italia non siamo ancora pronti. Penso a quei ristoranti che sembrano laboratori chimici con tutte le loro tecnologie, distillatori, Roner, estrattori… Parlando di patrie, non c’è un rischio di globalizzazione in tutto questo? È quello che dico anch’io, un pochino sì. Ma il cuoco non è questo. Il cuoco è il fuoco, anzi le braci. Il camino in cucina. Mi piacerebbe tornare a queste cose, un po’ alla Etxebarri, perché io amo stare sul fuoco. Adesso che il motto è “cook it raw” sei in controtendenza. Va bene “cuocere crudo”, ma ci vuole un po’ di fuoco. Il pesce crudo per esempio è buonissimo, ma se appena appena gli dai una scottata, basta! Io sono per le cose che si sentono sotto le mani, per le consistenze. I bocconi in cui senti il gusto, le estrazioni sono troppo complicati per me. La cucina abruzzese è una cucina di consistenze, anche troppo. Ci può essere anche una competizione fra le due componenti. Andoni Luis Aduriz sostiene che abbassando la soglia del gusto la testura risalta. Sì, ed è un rischio per entrambi. Personalmente sto salando sempre meno. Gli ingredienti hanno già il loro sapore, e comunque oggi si spinge meno sul pedale della concentrazione. Direi che la cucina è a schema libero. Forse perché, come dice Lopriore, da quando il fantasma di Ferran Adrià non si aggira più per la ristorazione, siamo tutti più sereni. Sì, ci sentiamo più liberi. anche se da queste parti non si è mai fatto vedere più di tanto. La Xantana per esempio ce l’ho, in certi casi aiuta ma bisogna andarci piano. Quando mi trovo in difficoltà su certe cose ne metto un pochino. Non le salse, che adesso vanno liquide, perché si cerca l’evanescenza. Ma se ho del vino rosso e voglio farlo coagulare leggermente senza perdere l’acidità e l’alcol, aggiungo un po’ di Xantana e il gioco è fatto. Così posso preparare una goccia di vino sul piatto che non scivola via. Anche il sifone qualche anno fa l’ho comprato, ma l’ho usato due volte. Ho fatto una spuma al Parmigiano e una spuma alla menta, basta. Perché queste cose, se non fanno parte delle origini, se non le senti, non sai usarle. Possono essere aiutini, piccole chicche. Ma non possono rappresentare la base perché noi siamo italiani. Dobbiamo essere quello che siamo, altrimenti la gente se ne accorge. 111 enologica edizione 2011 tolto il menu degustazione, perché non ci si può imporre più di tanto. A Marrara avevamo aperto con 3 opzioni: Tradizione, Dal mare e Dalla terra. Ma ora abbiamo solo una piccola carta su cui costruire insieme dei percorsi. Al Trigabolo sei entrato ai primi: una specializzazione che ti è rimasta addosso. Giorgio Melandri dice che sei un artista della pasta. Ho un rapporto estremo con la pasta, perché ci sono nato dentro. Penso alle donne della mia famiglia, anche se nei piatti che servo io ci sono sempre il maschile e il femminile, la memoria insieme alla grinta. Io non ho segreti: la pasta va rispettata. Devi sapere quanto glutine ha, ci vogliono esperienza e anche errori. Sono sfoglino e stendo la sfoglia al matterello in quattro modi diversi, con tecniche che metto in sequenza per ottenere uno spessore uniforme e ottimizzare la testura, a x, a semicerchio, come faceva mia mamma… è difficile spiegare. Già tanti anni fa facevo la pasta risottata, senza dirlo a nessuno: la scolavo al dente e la portavo a cottura nel sugo. Io la pasta la sento, la guardo e la faccio uscire solo quando so che è pronta. Ed è pronta quando il sugo si sposa bene con la pasta. Come un risotto all’onda. Scrivere o far vedere non basta. È una cosa che sta dentro, animale. Quindi per te la pasta è la patria. Una ricetta sentimentale. T’el dig. Mentre il pesce è più raffinato, e la carne mi fa venire l’acquolina in bocca. Poi ci sono i piatti rock. Per esempio ieri ho messo in carta dei fiori di zucca in carrozza con la mozzarella di bufala, l’acciuga e un agretto di pomodorini. Sembra una chitarra, con il fiore spampanato e fritto, e poi c’è della grinta. Ricette come queste partono dagli abbinamenti della tradizione con una spinta di freschezza, come si fa attualmente. Ma la cucina è un casino, fa parte dello stato d’animo di ognuno, in certi momenti il cuoco è più creativo, poi magari si rilassa. Non ha mai il diritto di cucinare male, però. Se non è professionale sta a casa. La patria in cantina Uomo degli abbinamenti eretici, Marco Merighi è il doppio letterario di Pierluigi Di Diego, in sala e in cantina. Anche per lui la patria è un’epizeusi: “autoctono autoctono autoctono autoctono”. Une percussione identitaria cha fa da basso continuo alle acrobazie dei mariages. Se ti dico vino italiano, che associazioni fai? La prima parola che mi viene in mente è autoctono autoctono autoctono autoctono, un patrimonio straordinario. Anche se questa non è terra di vino, ma di zucche e di pere. C’è il Bosco Eliceo, che è un po’ il nostro territorio, ma ha una sapidità povera, più da reflusso marino che da sottosuolo. Lo definirei un vino “da merenda”, a parte gli abbinamenti di tradizione con l’anguilla e la salama da sugo, che cuociamo a Natale. Trovarne una grande è davvero difficile, perché è ribelle. Ha variabili da stagionatura impressionanti, come il pecorino di fossa. A proposito di prodotti di carattere, quanto pesa la nostra forza sul fronte delle bottiglie naturali nella tua definizione di patria enoica? Penso al recupero delle anfore come ai bucciati. I vini naturali per noi sono i vini. Tutt’altro che un fattore moda. Per capirli bisogna allenare il palato alle sfumature e alla volubilità di quanto è suscettibile alle stagioni e all’atmosfera. Penso ai movimenti planetari come 112 Come si abbina la cucina del Don Giovanni? Voglio partire da una premessa: è difficile trovare pastaioli bravi come Pierluigi in Italia. Sembra un paradosso, ma in questo periodo di grande sperimentazione e attualità, si è un po’ dimenticata la pasta nella sua semplicità. C’è una corsa che mette la delusione dietro l’angolo a causa dei troppi artifici. Le consistenze di carattere, come quelle della nostra cucina e della pasta in particolare, si accompagnano bene ai vini naturali, che consentono abbinamenti strutturali, essendo ricchi di materia. Faccio un esempio un po’ estrinseco: le ostriche concave con un Rkatsiteli del Mar Nero, vinificato nelle anfore su macerazione. Quindi consistenza su consistenza, ossidazione sul metallo dell’ostrica, concentrazione minerale e iodica sulle radici di Rkatsiteli. Il risultato è la risacca marina in bocca. E un modo italiano di intendere la sala? Secondo me sì. C’è uno stile italiano, che si differenzia tantissimo nelle varie regioni. È connotato da grande calore e accoglienza, ma troppo spesso difetta di rigore. nelle nuove scuole invece il rigore eccessivo può inibire quelle sfumature romantiche cui accennavamo. Ma la combinazione di cuore e ragione è un fattore qualità. In questo mi sento discepolo del Trigabolo, pur avendo sviluppato negli anni un modo di lavorare personale. Esiste una gestione delle cantina “all’italiana”? Direi di no, sono prassi internazionali. Quello che si fa è incentrare molto l’offerta sulle produzioni locali, anche in Emilia-Romagna, una regione che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita straordinaria. 113 enologica edizione 2011 ai mutamenti energetici connessi ai cicli della natura, all’introspezione estiva seguita all’esplosione della primavera… Sono vini da ascoltare, un po’ come le persone e i prodotti. Materia prima complessa. anche se non tutto il vino naturale è buono, occorre stare attenti alle imitazioni di chi ha la mano pesante. Riccardo Agostini Il Piastrino via Parco Begni, 5 - 47864 Pennabilli (RN) tel. 0541 928106 - www.piastrino.it Quando i cuochi tornarono in cucina. Potrebbe essere questo il titolo sotto il quale catalogare tanti giovani talenti che negli ultimi anni, senza rinnegare le intemperanze delle avanguardie o il rigore dell’haute cuisine, hanno decretato il revival della cucina cucinata. Un po’ come i pittori che decisero di rintingere i pennelli nella tavolozza, piuttosto che appendere ruote e orinatoi, negli anni ruggenti e italianissimi della transavanguardia. la loro è una cucina che gioca nuovamente in casa, trovandovi pubblico e ragioni, contro l’esterofilia disciplinare dei métissage e quella geografica degli spagnolismi. La differenza con santini e sanctorum dei nostalgici sta nella pennellata gustativa sul piatto, dove un filetto o un gomitolo di spaghetti possono tornare protagonisti nella loro matericità, senza smettere di irradiare spirito contemporaneo. Non poteva esserci momento migliore, allora, per ridistendersi al sole giaguaro della patria. Grazie a un noto anniversario, ma anche per la coincidenza dei ritorni. Quello della cucina a cucina cucinata, per una mossa di yo-yo generazionale e sincronizzata; e quello di Riccardo e Claudia agostini nel paese natio, Pennabilli, dopo peregrinazioni professionali haut-de-gamme. la loro patria non è quella miniaturizzata delle scale cartografiche, ma si sbriciola in micron di soggettività impalpabile e corpuscolare. Prendere l’aereo per volare in Danimarca ha abbassato lo sguardo di Riccardo su un Montefeltro ad alzo zero. Dove pescano le radici delle erbe o dove volano brevemente i pollini, portati da un refolo di primavera. La patria del lievito madre, animato da microrganismi simili a un genius loci, e quella altrettanto invisibile e ficcante delle zolle di terra, serbatoio di mineralità che riproduce il DNA del territorio. Ed è da qui che ha preso il largo l’avventura del Piastrino. “Nel 2007, quando siamo arrivati, era una specie di agriturismo, con i servizi all’esterno; apriva sporadicamente, nella bella stagione o per il fine settimana. Ma lo conoscevamo già e ci era sempre piaciuto. Così quando la proloco di Pennabilli ci ha offerto questa opportunità, abbiamo subito accettato”. Nel cuore del Parco Begni, che lambisce tutto il paese, sono una trentina di coperti incartati nella pietra viva e nelle travi, scaldati in ogni saletta da un camino. Mentre la cucina interrata, dove una volta c’erano la mangiatoia e il fienile, fa take off via montacarichi. Subito fuori sta il giardino con uso cucina, un fitto via vai di cuochi a cogliere lavanda, timo, maggiorana, salvia, ma anche mirto, liquirizia, origano di vari tipi e issopo. Lo segue personalmente Riccardo, con l’aiuto del padre Tommaso. “Il contesto naturalistico mi piace molto. Razzolando nei prati mi imbatto in tanti possibili ingredienti: ortica, diversi tipi di erbette, senape, 114 Hai deciso di fare il cuoco vedendo l’esempio di tuo padre? Penso di sì. Anche mia madre era dell’ambiente, perché faceva la pizzaiola, e oggi ha un bar. Così ho sempre avuto questo pallino. Me lo ricordava un’amica, qualche tempo fa: “È da quando facevi la terza elementare che vai dicendo che vuoi fare lo chef. Hai visto che ci sei riuscito?”. Abitando qua però non è stato facile, anche come scuole. L’alberghiero ho dovuto frequentarlo a Rimini, da pendolare con il tram. Partivo alle 6 e un quarto di mattina e tornavo alle 2 e mezzo di pomeriggio. Come si mangiava a casa tua? Bene, ma i i miei genitori avevano degli orari un po’ particolari, quindi non sempre c’era il tempo per chissà cosa. Fondamentali invece sono state le nonne, che mi hanno trasmesso l’imprinting dei sapori, tutte e due. La domenica non era domenica se non andavamo in gita da loro, ma ci passavo anche periodi abbastanza lunghi. Vivevano nelle campagne qua intorno e da giugno a fine agosto giocavo al piccolo contadino con loro. È un altro mondo che ho respirato: la passione per gli animali da cortile, polli, anatre, faraone, tacchini; avevano anche un paio di bovini e mungevano, facevano la ricotta, il formaggino. Sono sapori che mi sono rimasti dentro. Se dovessi sintetizzare ciò che mi hanno lasciato, direi che non esiste filiera più corta della loro. Professavano veramente la stagionalità e il chilometro zero. D’inverno magari era la tagliatella con il ragù di rigaglia, poi d’estate si spaziava un po’ più nell’orto. Il pesce qui non c’era? Qualcosa di acqua dolce, ma non c’è mai stato un mercato. Seguendo questa traccia, quando ho aperto avevo chiare alcune scelte. Primo: non fare un ristorante alla moda, ma collocarlo bene nel suo ambiente. Perciò nei primi due anni abbiamo deciso di utilizzare solo prodotti locali, sia per gli ortaggi che per le carni. Poi abbiamo inserito un po’ di pesce, solo quello che si può trovare in collina, però. Quindi pesce di lago, pesce di fiume e conservato. Acciughe, storione, gamberi di fiume, baccalà. Anche per differenziarci da certi ristoranti, dove capita di mangiare il cervo in Sicilia e i gamberi rossi in Alto Adige. Ho preferito immedesimarmi nel territorio. 115 enologica edizione 2011 crescione. Li riconosco grazie a mia suocera Tina e alle signore che ci sono qua intorno. Mi piacerebbe anche codificarli, come Lucio Pompili, un maestro che riesce a creare misticanze magiche solo cercando nella sua campagna”. Della partita e della brigata fanno infatti parte gli appassionati genitori. “Mio padre faceva il fornaio. anche se il pane dopo 40 anni non vuole più farlo, continua a darci dei consigli, sulle dosi di madre piuttosto che sui tempi. Sicuramente nel suo forno ho respirato un mondo. L’arte bianca. A sentir lui da piccolo mi sono pure tuffato nelle marmellate, inciampando. lavorava di notte, una vita a sé come quella dei cuochi. Senza una famiglia vicino sarebbe difficile mandare avanti una struttura simile in momenti così particolari”. Che parte del fabbisogno riesci a coprire in loco? Buona parte. Più del 50% per gli ortaggi e le carni. Poi non voglio privarmi di tante cose. Mi piace il fegato grasso e lo uso. Anche i pesci arrivano da fuori. A casa abbiamo un piccolo orto con melanzane, pomodori, patate. Ci lavora prevalentemente mio padre, perché va curato quotidianamente. A chi ti rivolgi per riempire il paniere? Cerco di evitare la grande distribuzione per rifornirmi dal macellaio che magari il lunedì macella, in modo da avere il quinto quarto. E cerco anche di influenzarlo, se ci riesco. Sono gli stessi artigiani che riforniscono le famiglie, piuttosto che produttori per la ristorazione. Perché il tessuto qui è ancora vivo. Come si è svolto il tuo ingresso nella professione? Le mie prime esperienze le ho fatte in riviera, e sono state molto deludenti. Sfamifici dove si lavorava in catena. È il mercato che c’è in zona: diventi chef molto in fretta, ma uno chef apriscatole, che infila surgelati e conservati nel forno e tira fuori un menu. Dopo un anno o due di queste cose ho cominciato a stancarmi. Ho avuto la fortuna di appoggiarmi a un amico che era già un ottimo chef, Luigi Sartini della Taverna Righi di San Marino, dove sono rimasto per 2 anni e mezzo. Era appena uscito da Marchesi, quindi ricordo una cucina molto diversa da quella attuale. Concettuale nella creazione del piatto, nel colore, nell’abbinamento, mentre adesso siamo più attenti alla stagionalità e a tecniche nuove che mettano al centro il prodotto. È stata una bellissima esperienza, che mi ha permesso di conoscere tutte le partite, compresa la pasticceria. Mi sono innamorato del lavoro del ristorante ed è sorta la voglia di fare uno stage. Dove vai, dove non vai, salta fuori l’occasione di Vissani. Dovevano essere 8 mesi e sono diventati 10 anni. Un bel salto. Come sei riuscito a inserirti? La prima cosa che ti dicono al tuo arrivo è che devi dimenticare tutto ciò che hai fatto in precedenza. E infatti te lo fan dimenticare; se non riesci a inserirti nello staff di cucina, quando c’è il servizio finisci sempre a lavare le pentole. È stato così che piano piano ho conquistato la mia partita, è uscito fuori il mio stile e sono diventato souschef. Grazie anche alle mie esperienze di banchettistica, perché ero quello che si sapeva organizzare nelle situazioni più complicate. E alla capacità di fare gruppo: se le persone che hai intorno ti prendono come punto di riferimento, piano piano vai avanti. Caratterialmente come vi siete presi? Bene. Le persone eclettiche sono tutte un po’ sopra le righe; lui poi, che è un uomo di campagna, può essere molto colorito nelle espressioni, ma fondamentalmente è buonissimo. Pensa che dopo 10 anni a Baschi, quando ho voluto provare nuove strade, per non commuoversi nel momento del distacco è partito. Come si divideva i ruoli con i suoi famigliari? Tutto quel che si fa al ristorante passa per la sua idea o la sua autorizzazione, il singolo piatto come il dettaglio nel servizio. La moglie ha sempre seguito la messa in pratica, sia in sala che in cucina. Faceva le salse e la cottura delle carni, nonostante avesse imparato solo dal marito, e non è mai mancata in 10 anni. 116 Come ti spieghi che una persona così semplice possa avere un simile estro? Non lo so. A volte cercavo di capire perché facesse determinate scelte o determinati abbinamenti, ma lui è un istintivo. Oltre che un profondo conoscitore delle materie prime di tutt’Italia, roba che a volte rimani sbalordito. Quindi i prodotti te li ha insegnati lui? Sì, e lui è a tutto tondo. All’inizio, prima dell’esplosione televisiva, aveva più tempo e si dedicava interamente alla casa. Dopo il servizio, verso mezzanotte, partivamo per i mercati generali di Roma con un paio di ragazzi, aspettavamo le 3 davanti all’asta del pesce, poi andavamo a fare le verdure. Tornavamo alle 7-8 della mattina. Come trasmetteva il suo sapere, le ricette per esempio? Empiricamente. Bisognava capire il suo stile, entrare nel suo modo di pensare. lui lanciava l’idea, spesso al telefono: “Mi fai questa quaglia con lo spaghetto cacio e pepe?”. Io gli realizzavo il piatto e glielo facevo provare, poi lui faceva le sue osservazioni, aggiungiamo questo, togliamo quello, ci vuole un contrasto acido, eccetera. Ma lui non scriveva mai le ricette. Le scrivevamo io e la sorella pasticciera. Vederlo mangiare faceva un po’ ridere, perché crea piatti complessissimi, ma poi vuole mangiare le rigaglie di pollo o il piccione in umido cucinati dalla mamma. Cosa ti è rimasto dell’Umbria? Per me è un pezzo di vita, un pezzo di casa cui torno spesso. Mi sono rimasti i gusti, alcuni prodotti, la bontà dell’olio, che appena spremuto su certi piatti è ideale. Poi mi è piaciuto scoprire la cottura sotto la cenere, che è una bassa temperatura ancestrale. La massa di carboni a 150 °C, il calore che scema dolcissimo con un tocco affumicato. La tua cucina però è molto diversa da quella di Vissani, che è esuberante, barocca, manierista. E anche il tipo di ristorazione è agli antipodi, perché il locale di Baschi è molto lussuoso. Sì, ma la stagionalità e la cura della materia prima sono aspetti che devo a lui. E il locale quando sono arrivato sembrava un posto per camionisti: da una parte c’era Vissani, dall’altra la sala del padre, il Padrino, dove il cliente sceglieva il pesce di Anzio e glielo cucinavano. Anche l’immagine del piatto forse viene da lui, perché parto da uno spunto su cui poi faccio solo qualche prova. E il gusto va di pari passo con la presentazione. Qual è stato il passaggio successivo? Dopo un’esperienza così importante la mia esigenza era quella di mettermi alla prova, accantonando i vecchi menu, che pure amo collezionare. Così, non avendo ancora la possibilità o la maturità per partire da solo, mi sono affidato all’Osteria del Povero Diavolo, dove sono rimasto per 2 anni e mi sono fatto un po’ conoscere, grazie a giornalisti come 117 enologica edizione 2011 In sala oggi si è aggiunto il figlio Luca, che è cresciuto e sta mettendo molto di suo. garcia Santos e Paolo Marchi e ai proprietari, che sono ben inseriti. Immagino che tu volessi anche tornare a casa, riavvicinarti alle radici. Claudia ti aspettava qua? Forse mi mancava un po’ la campagna, la famiglia, per cui altre proposte, a Firenze come in Piemonte, le avevo lasciate cadere. Cercavo un altro locale famigliare, come era stato anche Vissani. Ma Claudia era già con me. Ci siamo fidanzati giovanissimi, nel 2001 ci siamo sposati e lei subito dopo si è trasferita in Umbria, dove abbiamo avuto la nostra prima bambina. Quindi era venuta per seguirmi, ma nel lavoro è entrata dalla porta principale e ha avuto un’ottima formazione. Era un foglio bianco e ha imparato ad abbinare le posate, a capire il cliente. Più tardi per passione ha frequentato anche i corsi da sommelier. L’amore per la cucina però ce l’ha sempre avuto, perché giravamo insieme per ristoranti. Un paio di scappate l’anno me le faccio sempre, con lei o in compagnia di colleghi: per me sono come uno stage, mi danno lo stimolo per innovare. Per esempio? L’ultimo è stato il Noma di Copenhagen, entusiasmante. Più bello e comprensibile di Ferran Adrià, che è un po’ un laboratorio, molto tecnico e gustativamente difficile. Mentre da Redzepi ho mangiato molta natura, piatti puliti e divertenti, nonostante le tecniche innovative. Tante verdure, qua e là un’ostrica o un filettino di pesce, comprimari anziché protagonisti in mezzo a creme, estrazioni vegetali, formaggi nordici e qualche sferzata agrodolce. Quando siamo tornati io e Giuseppe eravamo lì che assaggiavamo tutte le erbe, cercavamo il muschio croccante… Il prossimo viaggio sarà da Andoni ed Etxebarri. Perché una delle prime cose che ho voluto fare in cucina è stato il camino con la brace, per i profumi, l’affumicatura e con il cartoccio per finire le carni. Al Povero Diavolo hai iniziato a fare la tua cucina? Sì, ho avuto per la prima volta la possibilità di tradurre in pratica le mie idee e il mio stile, in modo più o meno consapevole. Ed è stata una bella palestra per familiarizzare con i prodotti del territorio e una ristorazione diversa. Ma è stato anche un salto nel vuoto, passare da una brigata di 15 persone a una cucina dove c’erano solo lo chef che lavava le pentole e un aiutante marocchino. Il primo giorno ho detto: “Claudia, io non so se ce la faccio a cucinare l’agnello alla piastra come le trattorie”. Perché lei non era con me, per un paio d’anni si era dedicata a fare la mamma. Pensavo di partire, poi dopo 3 o 4 giorni ho cambiato il menu, ho cominciato a fare quello che mi piaceva e siamo partiti. Sono stati due anni pieni di soddisfazioni, con qualche parentesi un po’ sciocca. Piatti simbolo di quel periodo? Non saprei, perché io non mi affeziono più di tanto. E anche lo stesso piatto, reinterpretato nella stagione successiva, cambia valenza, perché hai un altro pensiero o magari hai conosciuto una tecnica diversa. Così si evolve la tradizione che andiamo a cucinare. Quando sei tornato a Pennabilli, che tipo di locale avevi in mente? Come ti accennavo, siamo partiti con l’intenzione di tenere una fascia di prezzi molto 118 La tua tipologia di ristorazione assomiglia più ad una forma di “alta trattoria” che alla bistronomia. Sì, mi sento diverso da chef come Oldani o Aizpitarte, che operano in un contesto urbano. Io uso i prodotti stagionali, non solo quelli poveri. Non mi interessa cucinare qualsiasi cosa cada in una certa fascia di prezzo, per scelta ideologica, senza sapere da dove arriva e come è fatta. La trattoria dal canto suo è in uno stadio confusionale, dovrebbe svolgere un compito di conservazione di memorie e prodotti, civiltà gastronomica insomma, invece è diventata un fattore di omologazione. E forse è una missione di cui può farsi carico gente come me, quella di stimolare il territorio con la tradizione contemporanea. Perché alla fine è più tradizionale Massimo Bottura, con le sue tecniche applicate ai prodotti emiliani, di tanti locali che ormai vanno a rucola. È un discorso particolarmente vero oggi, quando il declino dell’egemonia spagnola ha rintuzzato l’esterofilia. Sì, per noi è un bellissimo momento, nonostante la sordità delle istituzioni. Perché alla fine le autorità vanno sempre a finire sul tagliere del salame. E questo è il rischio della patria, che si riduca tutto alla banalità, alla ripetizione. Ma la tradizione si evolve, quella di oggi è diversa da quella di un tempo, per una questione di stili di vita e non solo. Parliamo del tema della patria, allora. Cosa vi ha suggerito? L’unità d’Italia per come la intendo io è un’officina, nel senso che alla fine ognuno di noi ha il suo modo di praticarla, usando prodotti, esperienze e stimoli ad ampio raggio. I ragazzi che passano da qui diventano amici, poi magari si disperdono ed entro in contatto con altre zone d’Italia. I rapporti sono diversi da un tempo perché molte cose le scopriamo insieme, le basse temperature per esempio quando ho iniziato a fare il cuoco non c’erano. Sono tecnologie che hanno un po’ terremotato gli organigrammi di cucina. Come illustreresti il Montefeltro a uno di questi cuochi forestieri? La nostra cucina è un misto. L’influenza della Romagna è forte, nei prodotti come nelle preparazioni. La pasta fresca, all’uovo o senza, non manca mai nel menu. Ma 119 enologica edizione 2011 lineare, che valorizzasse con intelligenza le materie prime. Perché volevamo coinvolgere più persone possibili, compresi i giovani. Volevamo continuare a ricercare, mettendo a frutto le conoscenze acquisite, ma rendendole fruibili a persone meno avvezze. E devo dire che sta funzionando, è una vallata che risponde bene. Il pennese magari viene nel momento particolare, per festeggiare con gli amici. Mentre altra gente per fortuna ci premia e fa della strada per visitarci. Ma c’è ancora un forte timore, economico e non solo, verso la ristorazione. Sarà l’ambiente compassato, sarà il gusto nuovo rispetto al comfort food. I salumi e i formaggi selezionati che teniamo in carta per molti restano un’ancora di salvataggio. Mentre Tonino Guerra ama scoprire: “Cosa mi fai mangiare oggi?”, chiede ogni volta. le buone carni e gli animali da cortile forse provengono più dalla Toscana, che dista 4 chilometri, subito dietro la collina. Quindi è una zona fusion, e il sincretismo amplia lo spazio di manovra. A chi spedisce un curriculum consiglio sempre di farsi un giro a Pennabilli, perché è un posto particolare. C’è stato un brasiliano che non aveva mai visto la neve, era contentissimo. I genitori invece: “Scappa via! Hai il cibo?”. Perché l’inverno è molto rigido. Suggerirà anche una cucina particolare. Sì, quando viene il freddo si comincia con i prodotti del bosco, tartufi, funghi, castagne. Anche selvaggina, perché è un parco naturale e c’è l’abbattimento selettivo. Quindi caprioli, cervi e cinghiali. Ma gli ingredienti invernali sono difficili da stimolare, hanno la grevità di quanto stenta a crescere. Preferisco la primavera e l’autunno con i loro profumi. C’è un ingrediente che per te rappresenta Pennabilli? Una cosa che mi affascina molto è il fiore di sambuco, un profumo simile al Sauvignon, che ricorre spesso nella mia cucina. Da aprile a maggio è tutto uno sbocciare, ma io lo conservo anche essiccato. E sto scoprendo che non è un’invenzione personale, perché tradizionalmente veniva già utilizzato. Oppure il raveggiolo: lavoro molto con le cagliate, prendo il latte di capra o di vacca di un piccolo produttore e se lo aromatizzo con erba limoncina o melissa, diventa già interessante. Invece è impossibile importare il corbezzolo, la ciliegia selvatica autunnale dell’Umbria. Ci ho provato invano tantissime volte, mentre nel bosco di Civitella del lago rosseggiano centinaia di bacche. Il tuo pane è lievitato naturalmente. Da chi hai imparato? Piano piano, con alcuni amici. La mia madre, a base di mela, uva e farina macinata a pietra in un mulino vicino, ha 4 anni, l’età del locale. C’è un’amica pasticciera che è venuta a lavorare da me, aveva preso il lievito madre da Luca Montersino e ogni tanto ci confrontiamo, facciamo scambi, mescoliamo. al ristorante ci sta dietro giuseppe, che si dedica solo a questo: prepara l’impasto del giorno, il rinfresco, il nutrimento e il bagnetto in acqua e zucchero. Sono attività che richiedono empatia, come un tamagotchi. Un ragazzo giapponese che lavora con me era rimasto colpito da un maestro che aveva catturato i batteri dalla natura nel bosco, innescando la fermentazione. Un giorno l’ho visto con la sua bacinella sotto gli alberi, è riuscito a panificare ma il risultato era un po’ troppo strano… Che piatti porterai ad Enologica? Siamo in novembre, quindi ho pensato ai gamberi di fiume con finferli e bacche di bosco, sambuco, mirtillo e prugna selvatica. Tutti ingredienti locali, a volte presi dal giardino. nella creazione di un piatto parto sempre da un prodotto, in questo caso il fungo con la sua mineralità, che si abbina bene ai gamberi di fiume. Mentre i frutti acidi compensano la dolcezza e puliscono il palato grazie all’acidità e ai tannini. E l’infusione a freddo di finferli e carapaci di gamberi potenzia il corpo complessivo. Come 120 I tuoi piatti hanno sempre 3 ingredienti? Quasi sempre, al massimo 4. L’ultima volta che siamo stati da Vissani invece ho perso il filo, non riuscivo più a capire il perché di certe cose, perché è molto cambiato. Mentre io oggi come oggi preferisco avere pulizia e complicità fra gli ingredienti. Cerco soprattutto la linearità. Come la cipolla con succo d’uva di Redzepi, che è equilibrata, ti soddisfa, anche se non è fatta per il mercato che c’è qui. Sono suggestioni che magari tengo per me o per un altro menu. gli antipasti in generale li trovo meno complicati, mentre scampare alla banalità nei primi piatti è un’impresa: diventiamo tutti più esigenti, perché è il gusto italiano. Quindi c’è il rischio della banalità, e poi quello che l’innovazione sia inferiore al modello. Cantina Nelle amorevoli mani di Claudia, coadiuvata negli ultimi tempi da Vincenzo Donatiello, la cantina del Piastrino si è allargata per cerchi concentrici, partendo sempre dal territorio. Intorno a Pennabilli le prime vigne distano 30 chilometri, retaggio amaro di un’agricoltura abbandonata negli anni ruggenti del boom economico. Ma i territori del Montefeltro si dipartono con una fuga esaltante: Toscana, Emilia, Marche. autostrade lanciate verso culle ancor più blasonate. l’occhio di riguardo è per i vini naturali, biologici o biodinamici che siano. Una passerella fra i filari di vite e i fornelli di cucina, avvinti in un paradigma che parla di soggettività, territorio, riscoperta delle patria come suolo dei padri contro l’omologazione. Gli abbinamenti che ne conseguono vengono concordati fra Vincenzo e Riccardo in modo da completare il piatto con note sgargianti di creatività. “Con i gamberi proponiamo il MonteRè Ravenna Bianco IGT 2003 Vigne dei Boschi, da uve albana”, illustra Vincenzo. “Abbiamo infatti un piatto complesso, dai toni sapidi, con l’acidità e la tannicità delle bacche; allo stesso tempo il gambero di fiume ha una discreta tendenza dolce e grassezza. Queste sfaccettature chiamano un vino altrettanto eclettico, che cresca di sorso in sorso e possa sorprendere, senza sopraffare il piatto e senza farsi sopraffare dallo stesso. L’Albana 2003 di Paolo e Katia Babini è un vino particolarissimo, in un’epoca evolutiva molto interessante. Le note di maturità, con i primi sentori idrocarburici, aiutano ad accompagnare la persistenza gusto olfattiva. la questione palatale diventa un pelino più delicata, ma mentalmente stuzzicante. La sapidità di un Albana maturo crea contrasto con la tendenza dolce naturale dei crostacei; il giusto apporto pseudocalorico dell’alcol e un leggero residuo zuccherino ( presente solo in quest’annata) puliscono il palato dalle sensazioni acide e leggermente allappanti delle bacche ed allungano il sorso sull’infusione di funghi e carapaci, completando 121 enologica edizione 2011 piatto storico invece potrei portare la battuta di scottona della Val Marecchia con crema di pistacchi di Bronte e piccole perle fondenti di Parmigiano che esplodono in bocca. Un abbinamento abbastanza tradizionale, che non è mai uscito dalla carta. la chiusura di bocca. Per il battuto di vitellone invece abbiamo scelto il Borgo Stignani Ravenna Rosso IGT 2006 da uve malbo. Essendo il battuto uno dei piatti più rappresentativi del ristorante, ho pensato di chiedere al produttore quale fosse uno dei suoi prodotti più rappresentativi, in modo da creare, oltre ad un abbinamento gustoso e corretto, anche un filo logico nella mente di chi assaggia. Il battuto è un piatto caratterizzato dalla grassezza e dalla tendenza dolce della carne, alla quale si aggiunge quella della crema di pistacchi e delle perle di Parmigiano – grassezza che ci sposta anche verso una certa untuosità, data più che altro dalle consistenze. Il Malbo 2006 si muove su belle note rinfrescanti e possiede una leggera scia sapida capace di contrastare la grassezza e la tendenza dolce. La sua leggera tannicità spolvererà il palato dall’untuosità del Parmigiano fondente, e grazie al carattere decisamente morbido può accompagnare la complessità dell’assemblaggio di ingredienti”. “Tra terra e mare.” Pane Ferrarese 122 Massimo Spigaroli Odoardo Farnese che sotto il sole del 1636 esautora l’antica stirpe dei Pallavicino; l’empereur Napoleone Bonaparte che nel 1801 inghiotte il Ducato di Parma e di Piacenza, comprese le lische dello Stato Pallavicino; 37.250 teste parmigiane in festa, che il 24 maggio 1848 si iscrivono al Regno di Sardegna, e 427.512 patrioti emiliani, che l’11 marzo 1860 confermano di sentirsi sabaudi; Garibaldi che salpa da Quarto con le sue 1000 camicie rosse e Vittorio Emanuele II che il 17 marzo 1861 proclama la nascita del Regno d’Italia nel tripudio dei vessilli tricolori. E ancora Mussolini alla battaglia del grano su una rudimentale trebbiatrice, i partigiani e le truppe alleate che espugnano Parma il 26 aprile del 1945, De Gasperi al varo della sua timida riforma agraria e Bertolucci che accende le cineprese sul novecento allo scadere del secolo breve. Appesi come preziose stalattiti nell’antro amniotico della loro cantina, quasi una grottesca dalle decorazioni commestibili, i culatelli dell’antica Corte Pallavicina non si sono accorti dei clangori della storia che infuriava d’intorno. Il loro letargo dura imperterrito da 700 anni, frammisto ai sogni dei gourmet di tutto il mondo. Visto da fuori, nel paesaggio orizzontale della bassa, quasi una scacchiera di parcelle pallide e prive di elementi verticali, quel castelletto dei conti Pallavicino risalta come una piccola Mont Saint-Michel. Il Po dista pochi metri e le esondazioni non risparmiano di bussare al suo uscio. Serenamente sommersa e serenamente prosciugata, atlantide si lascia infine affettare sul tagliere dei salumi. E il coltello è nelle mani di Massimo Spigaroli, chef patron che ha scelto di puntare sulla mossa dell’alfiere, avanzando obliquo alla ricerca di un’evoluzione che tesaurizzi il territorio e la sua storia. “Nebulat ergo sum”, scrive Umberto Eco nella sua bella antologia dedicata all’incantesimo bianco; ed è una parafrasi calzante per il re dei salumi, che da queste parti si spoglia della vescica in cui stagiona per infilarsi sotto una cloche di guerardiana memoria, emblema di lusso e meraviglia che rievoca l’ascesa della cortina nebbiosa. Oppure avvolge e farcisce una faraona cotta nella creta del Po, circolo di umidità che entra ed esce dalle finestre, gonfia i salumi, inumidisce la terra sul greto e finisce per preservare la succulenza dell’animale da cortile. Imprese che ci piace immaginare come un sequel di Novecento: naufragata l’utopia comunista della bandiera rossa che sventola sulla bassa, il fattore Olmo (nient’altri che il gastrofanatico Gerard Depardieu, frequentatore assiduo del relais) alla conquista della corte dei signori, piegando le gerarchie classiste al materialismo delle casseruole e alle zaffate odorose sparate dalle buffe di cantina. Distante anni luce dalle devastazioni dell’agricoltura intensiva, la corte è introdotta 123 enologica edizione 2011 Antica Corte Pallavicina Strada Palazzo due Torri, 3 - 43010 Polesine Parmense (PR) tel. 0524 936539 - www.acpallavicina.com da un roseto, fra un petalo e l’altro i filari di un piccolo orto. Pomodorini e perini, melanzane, cespi di insalata, rape rosse e fagiolini in fiore; poco più in là erbe aromatiche, cipolle, carote, sedano e ancora un pergolato di vite. Tutti pronti al turn over invernale, quando saranno scalzati da cavoli e zucche. Tra i solchi, lavorati a mano o con i rastrelli, razzolano tacchini e pavoni, che in questi luoghi ci sono sempre stati “perché sono belli”. Ed è un pensiero del territorio dove rivivono mamma Enrica e papà Marcello, all’ombra del totem bronzeo di un maiale che emula la poularde di Georges Blanc. Nel ventre dell’edificio, dietro i chiavistelli rumorosi di una porticciola massiccia, si spalancano le cantine più antiche del mondo, portatrici di un’impronta digitale inconfondibile grazie ai bacilli delle muffe e al bacio subacqueo del Po. Al nostro arrivo sono 5000 i culatelli appesi a stagionare, suddivisi per annate come i grandi vini, fino a un massimo di 40 mesi, in gruppi che recano il nome prestigioso di chi li ha prenotati, da Alain Ducasse a Gualtiero Marchesi, da Troisgros a un altro Massimo (Bottura). Mentre nella parte semiinterrata riposano le forme di Parmigiano prodotte in pianura, collina o montagna con latte di vacche rosse, bianche e grigie. E non c’è igrometro che tenga, il sistema è ancora quello di una volta: ci vuole l’addestramento di uno Spigaroli per capire, appena varcata la soglia, se è il caso o meno di metter mano agli infissi. “La nostra famiglia era composta di mezzadri che portavano avanti un podere importante chiamato Piantador, uno dei tanti possedimenti del maestro Giuseppe Verdi, perché a quei tempi la terra rappresentava l’investimento più sicuro”, esordisce Massimo Spigaroli, avviando un lungo monologo. “D’inverno erano anche norcini e il cliente più importante era sempre lui, giuseppe Verdi, quindi tutti quei salumi che descrive come i suoi migliori compagni di viaggio erano passati in realtà per le mani dei miei avi. Il bisnonno si chiamava Carlo Spigaroli. La sua era una famiglia patriarcale con 11 figli da sfamare, e nel 1882 si mise alla ricerca di un nuovo sbocco, perché il vecchio podere gli andava stretto. Così arrivò qui all’Antica Corte Pallavicina. Si trattava del castello del paese, con una grande azienda agricola di 70 ettari. Perché il ramo dei Pallavicino, che seguiva una discendenza maschile, si era estinto con la morte dell’ultimo marchese nel 1731. La figlia aveva sposato un grosso proprietario terriero del Cremonese e si era trasferita da quelle parti. Dopo la conversione in caserma per i controlli fluviali, con la terra concessa ai contadini, intorno all’800 era sorta l’azienda agricola, che sarebbe finita appunto nelle mani della mia famiglia. Si trattava di un luogo speciale. Il palazzo era stato costruito attorno al 1300 proprio sulle sponde del Po, per ragioni strategiche. Il feudo dei Pallavicino arrivava oltre Salso Maggiore Terme, dove c’erano le saline. Quindi i marchesi erano gli unici produttori di sale della Pianura Padana, un aspetto importantissimo se si pensa ai salumi. L’ubicazione del paese e del palazzo tornava comoda perché rappresentava l’unico sbocco al fiume del territorio. Significava avere l’acqua e una via di comunicazione importante. Navigando si arrivava già alla città di Milano, e più tardi fino in Svizzera. Oppure prendendo l’Adriatico alla città 124 poi pian piano iniziarono a trasformare il latte in gelato e ad elaborare i prodotti della terra traendone spuntini e merende. Intorno agli anni ’50 fu la volta delle prime lasagne, poi vennero i polli arrosto, quelli allevati in campagna. In questo modo gli Spigaroli cominciarono a diventare osti o ristoratori. Ci fu solo una breve pausa dovuta alle vicende belliche: nel 1940 la corte fu abbandonata perché gli uomini andarono al fronte e le donne non poterono più gestire un podere così grande; anche le baracche in legno furono fermate perché il traghetto era stato affondato. Da quel momento la mia famiglia non ha più abitato qui, ma l’azienda agricola non si è fermata. Nel 1961 le baracche in legno furono finalmente smantellate e al loro posto sorse una costruzione in muratura che è il nostro ristorante di famiglia, il Cavallino bianco. Un locale guidato da mio fratello Luciano dove abbiamo sempre fatto una buona cucina del territorio usando i nostri prodotti, senza abbandonare le attività storiche di produzione di salumi e di vino. Dietro il suo nome c’è un aneddoto, perché il pittore Walter Madoi passando in zona si fermò per fare merenda e alla fine, siccome non aveva i soldi per pagare, si mise lì con il pennello ad affrescare una parete. Ed ecco questi cavalli bianchi sul Po. Nel 1990 poi la corte completa di terreni venne messa in vendita e noi siamo riusciti ad acquistarla. Era cadente, ma dentro c’era nato il nonno e si era svolta tutta la storia famigliare. Da allora fino al 2000 si è svolto un restauro importante per fare sì che questo posto si trasformasse in un piccolo relais di campagna. Il castello 125 enologica edizione 2011 di Venezia. Quindi era un punto intermedio per i Veneti quando si spostavano verso Milano, e il fiume era assai meno pericoloso della strada. Commerci, comunicazioni. Tutte le novità dell’Oriente arrivavano qui prima ancora che nell’entroterra. Al suo arrivo il bisnonno continuò a lavorare la terra. Ma trovò anche qualcosa di molto importante. Tutti i contadini e i signorotti che lavoravano sotto i Pallavicino non pagavano in denaro, ma attraverso la trasformazione delle cose, col plusvalore del lavoro. Poteva essere il formaggio elaborato dal latte, il vino dall’uva o il sale. E i due culatelli del maiale andavano di diritto al marchese. Quindi già in fase progettuale avevano stabilito l’edificazione di magazzini importanti dove stivare i beni del contado. E avevano ideato le cantine secondo le esigenze di prodotti specifici, che noi abbiamo continuato ad affinare negli stessi luoghi. Quando i marchesi sparirono, gli spazi vennero affittati a commercianti della zona e tutti i contadini d’estate continuarono a portare i loro salumi a stagionare, senza soluzione di continuità. Gli Spigaroli erano già reputati norcini eccelsi, grazie al lustro acquisito lavorando per giuseppe Verdi, e imbattendosi in queste cantine cominciarono a lavorarvi i loro salumi. Nel 1920 il nonno inaugurò un altro filone della nostra storia, mettendo un traghetto sul fiume. Si stabilì un bel passaggio di gente diretta alla sponda cremonese e furono costruite due piccole baracche di legno sulle rive opposte. Le donne della famiglia cominciarono ad affettare i salumi prodotti dagli uomini in inverno, era quasi dato per perso nei libri storici, invece siamo riusciti pian piano a farlo rinascere, affiancandogli un ristorante importante e sei piccole camere dove gli ospiti possono fermarsi in un territorio ancora molto naturale, come poteva esserlo qualche secolo fa. Il concetto è ancora quello di un tempo. Abbiamo i nostri orti dove prendiamo le verdure e il frutteto per la frutta, la carne viene dai nostri animali e le api fanno il miele sul tetto posteriore. Compriamo pochissimo e stiamo cercando di continuare questa tradizione importante, che ci permette di essere molto stagionali. l’anno scorso, ad appena un anno dall’apertura, abbiamo ottenuto una stella Michelin e stiamo andando avanti con il nostro concetto. Una cucina del territorio evoluta elaborata con prodotti propri, nell’involucro di restauri che hanno mantenuto ciò che era. Perché come in cucina, gli inserimenti moderni non precludono la lettura del passato. Abbiamo seguito il concetto in base al quale il castello era stato costruito. Quindi il piano nobile per la rappresentanza, le stanze sopra e le cantine in funzione, con gli stessi prodotti negli ambienti di sempre e l’aria che circola secondo percorsi studiati 700 anni fa, quando c’erano ancora i saperi. Anche i materiali provengono dalla nostra azienda agricola, ad esempio il rovere per gli infissi esterni, il pioppo per gli interni e persino il legno della copertina dei menu”. Cosa producete esattamente? attorno al castello pascolano bovini di razze antiche, come la bianca romagnola e la valpadana, che erano quasi scomparse. E razzolano gli animali da cortile, oche, anatre mute, germane e pezzate del Po; e ancora faraone, conigli, piccioni, tacchini parmigiani, polli a zampe blu e a zampe gialle, che danno uova antiche dal guscio bianco. Perché l’uovo italiano, che è sempre stato candido, negli anni ’60-70 è stato sostituito da quello a guscio rosso, frutto di incroci con galline inglesi o americane. E siccome non c’era la data, le massaie di un tempo riconoscevano la freschezza dal colore, che dal bianco virava verso il grigio. Poi c’è un grande orto chiamato ortaglia con tante colture stagionali, come fagiolini, verza, radicchio, sedano, carote, fagioli, pomodori, melanzane, zucchine, zucche, patate… Le utilizziamo nei nostri due ristoranti, e quel che avanza lo vendiamo al mercato dei contadini il sabato mattina a Parma; anch’io ci vado volentieri, quando posso. Il maiale è quello nero, appartenente a un’antica razza locale chiamata suino nero di Parma; d’estate pascolava fuori o nel cortile, e nei mesi autunnali passava nella porcilaia, dove veniva nutrito con un pastone di mais, mele e scarti dell’orto. In questo modo diventava bello grasso e da novembre a gennaio veniva macellato. Il metodo di allevamento del bestiame non è cambiato per niente? Direi che è cambiato molto per gli altri, quasi per niente per noi. Perché i salumi li facciamo ancora spostandoli dove c’è il clima giusto. All’antica. Dopo essere stati confezionati, vengono portati in una stanza dove si aprono le finestre d’inverno, se c’è un clima bello secco e freddo; poi sono appesi in una cantina a pian terreno rivolta verso nord e per finire a 6-7 mesi vengono trasferiti nelle cantine della corte, dove c’è più umidità, ma l’acqua comunque è già uscita. Anche il Parmigiano viene stagionato senza climatizzazione. Vediamo 126 Però non avete certificazioni. No, perché non le abbiamo richieste. Continuiamo a fare quello che è sempre stato fatto in famiglia. Anche quando tutto intorno cambiava, mio padre ripeteva che per produrre ciò che serviva andava bene proseguire così, e noi abbiamo mantenuto questa linea. Quando è nata Slow Food negli anni ’80 eravamo già nel suo solco, da sempre. E il vino? Produciamo un vino da uve fortana, con le caratteristiche di un tempo. Dalle stesse viti ricaviamo il Tamburen, un rosato che deve il suo nome al setaccio a forma di tamburo che serviva per separare le vinacce dal mosto, e un metodo classico, lo Strologo, nato guardando a quel che in Francia sanno ricavare dal pinot. “Perché non provare col fortana?”, mi sono chiesto. E ne è uscita una bottiglia importante. Vengono tutti prodotti qui in collina subito sopra Busseto, in società con un agricoltore del luogo. Il Rosso della Vigna invece è un vino secco e fermo, derivato da un uvaggio di lambrusco, scorzamara e fortana; lo produciamo a Villa Lenzo, nel vecchio podere dei genitori del maestro Giuseppe Verdi, dove questi aveva convogliato vitigni inviati da Ricasoli come da Cavour. Perché aveva cognizioni da tecnico. Quattro anni fa abbiamo piantato anche vitigni antichi e sconosciuti per il territorio, che stiamo classificando, ma è difficilissimo, e stiamo andando verso la prima vendemmia. Ci piace pensare che abbiamo nobilitato un territorio: è una soddisfazione grandissima. Molti cuochi si lamentano di lacci e laccioli all’autoproduzione. La burocrazia per loro è un ostacolo insormontabile. Noi non abbiamo problemi, ma bisogna seguire l’iter. I suini, il pollame e i bovini vengono allevati qua, ma li macelliamo al macello di Busseto. Riportiamo a casa le carcasse e le lavoriamo, abbiamo tutta la filiera per farlo. Per le uova basta fare un test ogni 40 giorni che certifichi l’assenza di salmonella, quindi niente di particolarmente complicato; come i test sui vini e sui salumi. Sono procedure care, certo, come strappare l’erba a mano anziché dare i diserbanti. Alla fine mi costerebbe meno comprare gli ingredienti che produrli, ma non sarebbe la stessa cosa. E il know how in famiglia lo abbiamo sempre avuto. Parecchi cuochi sostengono anche che il chilometro zero è impraticabile. Io non voglio parlarne, perché lo faccio. Punto e basta. Forse il chilometro zero è praticabile solo in contesti particolari, molto fortunati. Sicuramente non può essere osservato da chi vuole elaborare tutti i migliori prodotti del mondo. Ma il mio concetto è un altro. Anche 127 enologica edizione 2011 le forme che sudano, cacciano fuori tutta l’acqua che hanno dentro, il grasso si fonde e forma quel granellino così importante fra i denti. Per quanto riguarda gli animali, d’estate sono tutti fuori e a metà settembre passano all’interno. Mangiano solo alimenti di produzione aziendale, grano, mais, fave, orzo. I maiali come i bovini e il pollame. Quindi siamo autonomi. Questo comporta tanta manualità, perché non usiamo concimi chimici, ma letami aziendali di pollo, maiale o mucca. i pesci che cuciniamo sono nostri: la rana, lo storione, l’anguilla, la tinca. Non vengono pescati nel Po, ma si tratta pur sempre di acqua dolce. La tua storia personale in tutto questo. Sono nato in una famiglia di contadini, norcini e ristoratori dove c’erano concetti e saperi ben precisi. La ricerca spassionata sulla qualità del pollo e del maiale al fine di ottenere i migliori arrosti e salumi. Per essere belli e pimpanti, però, gli animali devono mangiare bene, quindi i cereali devono essere prodotti in un certo modo. Così questo concetto del buono è venuto avanti. Ma quando come cuoco ti arrivano questi animali e queste verdure, sai quanto hai tribolato per farli e sai che devi elaborarli nel modo migliore. È una questione di rispetto, ed è stata l’origine della mia passione. Fin da bambino, a 5 o 6 anni, quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande, rispondevo: il cuoco. Perché mi piaceva il lavoro della famiglia. Ricordo che quando si macellavano i maiali andavo la mattina presto con mio padre, era normale. Pulivo le anguille, i pesci gatto, le tinche e li lavavo. Se si faceva la pasta mettevo a posto i pezzi sul tagliere giocando, i tortelli erano i carri armati e gli anolini i soldati, mentre i miei fratelli magari andavano a giocare a pallone. oppure decoravo le torte con le ciliegine candite. Ho sempre avuto il mio orticello, il mio pollaietto di fianca a quello dei miei genitori, le mie galline, le mie anatre e le mie verze. Sono ricordi, con tutta la voglia che ne consegue di trasformare le basi in cose importanti. E del Po che ricordi hai? Ricordo le alluvioni, ma senza traumi. Abbiamo avuto l’acqua nelle cantine tante volte, ed è una cosa abbastanza normale, perché sai cosa fare. Nel 2000 per esempio siamo stati completamente sommersi, ma c’è stato il tempo di portare via tutto, anche i salumi. Adesso gli argini sono stati alzati, quindi c’è un po’ meno pericolo, ma il fiume può arrivare di nuovo. Il Po conferisce a queste terre un fascino incredibile, ma regala anche un microclima senza il quale la nostra norcineria sarebbe inconcepibile. La nebbia propizia la formazione delle muffe bianche, nobili e dolci, che sono utili anche all’uva per maturare dolcemente, un po’ come accade nel Sauternes. Prendono vita nel mese di ottobrenovembre, quando arriva l’umidità, e sui salumi comincia la fioritura, che è foriera di grandi profumi. Più nebbia c’è, migliore sarà il culatello. Come si è svolta la tua formazione? Il mio percorso è cominciato alla scuola alberghiera di Salsomaggiore. Le prime stagioni le ho fatte in alberghi di lusso, a Courmayeur, Venezia e Punta Ala. Poi sono andato un po’ in Francia, da Georges Blanc negli anni ‘80. Mi ha dato molto, non solo con riferimento al pollo, col quale ogni tanto gli rendo omaggio, o alle coscette di rana, che cuocio come lui. Quella zona della Francia, con la Dombes, ha tanta umidità, come qui. E c’è un nesso profondo, perché anche Verdi aveva importato i vitigni del Bordeaux per piantarli a Sant’Agata, come aveva fatto con il sangiovese per emulare il Chianti. Dai francesi ho imparato soprattutto la capacità di vendere la qualità e fare conoscere ciò che fanno. In questo sono maestri. In Francia il nostro formaggio era commercializzato in forme da 40 chili, mentre 128 Essendo un luogo di transito, immagino che questo sia sempre stato anche un luogo di contaminazioni. Tantissimo, nel bene e nel male. Visto che nel 1630, quando infuriava la peste, tutti scappavano, perché l’epidemia arrivava attraverso il Po da Milano. Ed è stato un posto in cui tanti hanno lasciato i loro saperi passando, le stesse razze animali sono più incrociate che altrove. Quindi io sono partito da questo luogo di contaminazioni, in cui si erano depositati tanti saperi, e mi sono lasciato contagiare in giro per il mondo. Ma girando ho capito quanto fosse importante il nostro territorio, e ho imparato ad approcciarlo con un sistema diverso, che si trattasse di cotture o di presentazioni. Perché uno chef come me, che conosce bene le sue radici, non deve cambiare i piatti della tradizione, ma deve portarli avanti, facendo anche da tramite. Con gli stessi prodotti può realizzare ricette del territorio, che in futuro potrebbero essere codificate. E sarebbe la massima delle ambizioni. Penso alla fiorentina di maiale nero, che viene cotta pian piano in una padella di rame con un contorno di verdure; al risotto col tosone, perché il formaggio fresco una volta non veniva utilizzato; alla cottura del pollo, scomposto e non intero, o ai carpacci di pollo, oca e maiale, con le loro marinature. Se dovessi sintetizzare il mio percorso, direi che sono partito dalla mia tradizione, che conosco perfettamente, con tutti gli aneddoti e le signore anziane che venivano a lavorare in cucina. Sapendo come si macella un pollo e come si trasforma un maiale. Sapendo anche come si fa il pane con la nostra farina e la lievitazione del nostro territorio. Oltre alla ricetta degli anolini e dei tortelli. E su queste basi ho cominciato a costruire il mio concetto di cucina, applicando talvolta nuove tecnologie e nuovi pensieri, che potevano arrivare dalla Francia come dalla ristorazione d’albergo. Quando sono tornato in Italia, sono stato chiamato spesso all’estero e ho potuto captare la cucina del luogo. In Argentina per esempio ho capito bene la cottura delle carni e i loro metodi di allevamenti, anche se non li ho fatti miei. Guardare fuori mi ha fatto capire che noi avevamo tantissima qualità e probabilmente non sapevamo di averla. Il lavoro poi mi ha messo in contatto con tanti personaggi importanti, da Ducasse a Troisgros, a Marchesi. Sono venuti qui e hanno confermato il mio pensiero. La nostra unicità, l’importanza dei nostri prodotti, la necessità di fare una cucina diretta, centrata sull’ingrediente, senza tanti fronzoli. Arrivando all’Antica Corte Pallavicina, ciò che colpisce è innanzitutto la cura del paesaggio, così diverso da quello circostante. Il podere era sempre stato mantenuto abbastanza bene, con parecchie piante, mentre molti vicini avevano abbattuto gli alberi perché non serviva più legna, da quando era arrivato il gas. Quello che abbiamo fatto noi è stato 129 enologica edizione 2011 loro vendevano i loro formaggetti da un etto tutti infiocchettati, con la rafia, le foglie o il legno, a un prezzo che era venti volte quello del Parmigiano Reggiano. È un sistema diverso di proporre il territorio. Non parlerei di marketing, quanto di una forma di personalizzazione. mantenere e incrementare ciò che c’era, ed era ancora bello vestito. Per esempio abbiamo rigenerato delle siepi e piantato dei filari di pioppi, in modo da rimodellare il paesaggio in base al concetto di quello che era, rifacendoci alle nostre memorie come alle vecchie foto. Il risultato attorno al castello è diventato armonioso, con le verdure di stagione sparse per il cortile. Tutti i vecchi frutti sono stati convogliati in un frutteto e anche all’interno abbiamo mantenuto gli arredi del territorio. Ricordo che una volta ogni campo aveva il suo filare di vite nel centro, poi a partire dagli anni ’60 sono stati tolti e trasferiti in collina, lasciando spazio alle grandi coltivazioni. Mentre prima era un territorio vitivinicolo perché il terreno si presta, è molto duro, tenace e tende a crepare via via che ci si allontana dal fiume. C’erano anche i salici, che tagliati fornivano i pali per gli impianti delle viti. Quindi era tutto vicino e fioriva il commercio con il Cremonese, dove il terreno è molto più sciolto e non c’è viticoltura. I cambiamenti climatici sono diventati un problema? Non direi, per il momento. Questo autunno è iniziato bene. C’è la giusta umidità e le nostre cantine sono fortificate contro gli agenti esterni, quindi la temperatura un po’ elevata non influisce più di tanto. Le finestre sono la nostra valvola di sfogo. In questo periodo le apriamo di notte e le chiudiamo di giorno; quando verrà il freddo apriremo anche di giorno ed eventualmente chiuderemo di notte. È vero che forse la nebbia è un po’ calata, ma io penso che alla fine si ricordino soprattutto gli eccessi, la grande nevicata come le macchine dai vetri appannati… Forse siamo dei privilegiati, ma per noi che abbiamo posti così importanti il pericolo scema. Vorrà dire che apriremo un po’ meno le finestre quando non serve. Il culatello non è un prodotto a rischio? Sicuramente sì, soprattutto quello di altissimo livello perché si deve difendere da tante imitazioni. L’industria si è impadronita di questo nome per fare business e confonde le acque. Ma produrre il culatello senza additivi o climatizzazioni è difficile, richiede saperi e manualità specializzate, perdendo i quali potrebbe scomparire oppure omologarsi, due esiti che ai miei occhi si equivalgono. La patria, a questo punto. Che piatti porterai ad Enologica? Ho fatto un piatto dove parto dalla mia storia, Giuseppe Verdi, il 1861, le narrazioni famigliari: è l’evoluzione della spalla cotta in snack. Verdi era amante della spalla cotta, che serviva con una salsa verde. Dopo l’unità d’Italia si diffuse una certa “goliardia dell’italianità”, gli uomini infilavano il fazzoletto verde nel taschino e alle finestre issavano lo stendardo italiano. Anche la cucina seguì questo momento di fermento, e lo stesso Verdi nei suoi banchetti iniziò a servire la spalla cotta con altre due salse, quella bianca al formaggio e vino bianco e quella rossa con conserva di pomodoro, zucchero e aceto, in modo da evocare la bandiera italiana con un contorno di torta fritta. Io ho portato avanti questo concetto. La torta fritta è diventato l’involucro, dentro a mo’ di lasagna ci sono la spalla cotta, le tre salse, la spalla cotta e il tosone che fonde tutt’intorno, con piccole quenelle di salsa a ribadire il tricolore. Quindi la spalla cotta diventa lo snack, che il maestro avrebbe potuto servire nel suo giardino di 130 Quindi l’Italia vista attraverso il buco nella serratura della piccola patria e delle sue specialità, i salumi e le paste ripiene. Sì. Ed è una tradizione che va verso l’evoluzione. Oggi in cucina vedo una grande confusione. Nella crisi dell’egemonia spagnola e francese facciamo fatica a trovare un’identità, perché non ci siamo mai sentiti patriottici, ma abbiamo sempre cercato di copiare gli altri. È la nostra cultura di disgregazione, forse perché siamo una nazione troppo giovane. Siamo avvantaggiati dalla possibilità di piaceri diversissimi che nascono da storie frammentarie, perché ogni piccolo territorio ha un’identità peculiare, quindi siamo più liberi. Ma c’è troppa confusione perché non so se è più importante l’idea di un cibo che sia per forza nuovo, oppure è meglio una cucina ben fatta che insiste con semplicità sul territorio. “Melancholia.” Piada di Romagna 131 enologica edizione 2011 Sant’Agata. In base agli stessi cromatismi, come secondo piatto ho pensato a una reinterpretazione dell’orto: dei ravioli di rapa rossa sparsi su una fonduta di patate insieme a un raviolo con ripieno liquido di prezzemolo, da spezzare nel centro come condimento. 132 edizione 2010 La tradizione non può essere ereditata, se la volete possedere dovete conquistarla con grande fatica. thOMaS StearnS eliOt, 1920 Teatro dei Cuochi il Tema 2010 «La tradizione è una forma di conoscenza.» Giorgio Melandri 134 Telefoni senza fili e cadaveri squisiti “Fa’ qualcosa di vecchio che sia assolutamente nuovo. Fa’ qualcosa di nuovo che sia assolutamente vecchio. Gli aspetti per noi più importanti delle cose sono nascosti dalla loro semplicità e quotidianità. (Non ce ne possiamo accorgere - perché li abbiamo sempre sotto gli occhi).” Ludwig Wittgenstein Siamo soliti ritornare eternamente all’eterno ritorno. Quello di stampo astrologico dell’anno platonico, al termine del quale tutte le cose sono destinate a ripetersi sotto forma immutata. Quello nicciano fondato sul principio algebrico che n oggetti ed eventi sono incapaci di infinite varianti (“Un numero finito di particelle non è suscettibile di infinite trasposizioni; in una durata eterna, tutti gli ordini e posizioni possibili avverranno un numero infinito di volte”, scrisse Hume – l’eterno ritorno del caso). Quello dei cicli simili ma non identici di Brahma, Seneca e Marco Aurelio, che rifiutano impossibili coincidenze totali. Dissolto il principio temporale, in tutti i casi, anche la novità è destinata a svaporare. E se ne possono trarre conseguenze enigmatiche quanto dirompenti: “Se i destini di Edgar Allan Poe, dei vichinghi, di Giuda Iscariota e del mio lettore sono segretamente lo stesso destino – l’unico destino possibile -, la storia universale è quella di un 135 enologica edizione 2010 la tradizione del presente solo uomo”, commenta Borges. La congettura “afferma semplicemente che il numero di percezioni, di emozioni, di pensieri, di vicissitudini umane, è limitato, e che prima della morte l’avremo esaurito”. L’eterno ritorno torna eternamente, dicevamo. Di recente ha fatto capolino anche in cucina, una disciplina dove la spinta tecnologica sembrava aver lanciato la sua sfida con la verticalità del propulsore di una navicella spaziale. Darwiniana. E invece no: anche quella retta ha ceduto alla forza di gravità della crisi economica, increspandosi in un’ipnotica voluta. Come sbalzata sul muro di gomma della globalizzazione, per una legge di azione e reazione che ha conservato ogni newton di forza in direzione passato, lasciando sul piatto rovine percorse da refoli bucolici e rimpianti. Quando il cerchio ha un raggio infinito, del resto, le sue pareti assomigliano a una retta. E forse quel progresso lineare e infinito non era che una lunghissima sinuosità destinata a irretirci. Adesso l’inversione è palese. La curva temporale in cui si muovono i cuochi si compone di nostalgie passatiste come di avanguardismi reazionari. Profuma di cucina della nonna, ostenta le certificazioni del tipico, scava nella memoria olfattiva alla ricerca di leve che risveglino stanchi moti di forchette. E ancora molto di più. Perché persino l’avanguardia nella capriola temporale ha acquisito lineamenti stranianti. Tanto da tornare sui suoi passi nel paradosso del suo eterno ritorno. Quello che sovrappone su un fotogramma impressionato due volte le goliardate futuriste e le provocazioni di Scabin, il cubismo culinario di Apollinaire e i coup de théâtre di Ferran Adrià. Le lettere di mortadella di Fillia e quelle in brodo gelatinato del Bulli, le sinestesie del torinese Santopalato e le sperimentazioni targate Sony al Fat duck. Passando per le rotture della nouvelle cuisine. Cucina cogitans e cucina extensa: l’eterno teatro dei fornelli. Ogni avanguardia sembra riprendere in mano i bandoli lasciati dalla precedente per dare loro svolgimenti fantasiosi, quasi fosse un cadavere squisito compilato da un manipolo di buontemponi su un foglio spiegazzato. Ma la tradizione può essere molte altre cose. Declinata al passato remoto, all’aoristo, all’imperfetto,oppure stirata in un futuro anteriore. Tessuta di ricordi infantili o di memorie sepolte nel 136 È la tradizione ipostasi di chi vive confinato nel provincialismo del tempo, mentre organicamente l’identità ricambia le sue cellule. (E anche questa è cucina molecolare). Cultura, natura: un solo participio futuro. Sempre avvenire rispetto alle capacità di previsione, oltre gli angusti limiti del nostro io. Un orizzonte che sta di fronte a noi, anziché alle nostre spalle. Ciò che nascerà e ciò che verrà coltivato. Un lavoro impegnativo per noi cittadini del presente. Alessandra Meldolesi 137 enologica edizione 2010 subconscio collettivo, fiume carsico di tic e idiosincrasie personali o enigmistico rompicapo di giochi metalinguistici. Invenzione, epos trascinante oppure scavo archeologico meticoloso. Un tapis roulant più o meno vischioso su cui scivola la vita collettiva, come piattini colorati sul nastro svelto di un sushi bar. Da quel coacervo di accezioni il cuoco è ormai costretto a fare la sua spesa, riponendo nel carrello ciò che più gli aggrada. La moneta è un lessico comune, una chiave passe-partout che segna distanza e vicinanze. Insiemistiche a sorpresa. Non è più tempo di querelle des anciens et des modernes. Singolare o plurale. Anche le tradizioni sono protagoniste di una spietata selezione darwiniana, e nei telefoni senza fili degli insegnamenti che si tramandano, il piatto a una cornetta e quello nelle nostre mani finiscono per assomigliarsi ben poco, che si tratti di errori cumulativi o della vita che preme. In illo tempore: il refrain dipinge una fonte unica e pura, che sia collocata su vette innevate, a un passo dal cielo, o in un pozzo artesiano di pulsioni inconsce e ventriloque. Franco Aliberti “Biografia di una tradizione” Osteria Francescana Via Stella, 22 41121 Modena Tel +39 059 210118 - www.osteriafrancescana.it le tradizioni sono una popolazione: nascono, muoiono, si ammalano, si fidanzano, si sposano e si riproducono, con innesti a sorpresa ed alberi genealogici ubertosi. Conoscono picchi demografici e contrazioni delle nascite, epidemie, pandemie e nuove speranze di vita. Questa demografia assai particolare, di cui scorgiamo solo il fotogramma finale, vive dentro le persone. neotradizioni, post tradizioni, pretradizioni. Sotto la scorza dell’ipostasi brulica un fermento incontenibile. Ne sa qualcosa Franco Aliberti, uno che nel distillatore del suo laboratorio, accanto alle spezie e ai frutti dimenticati, ha infilato una messe di esperienze personali che percorrono sinuosamente gli alambicchi. Dal sole della nativa Pompei, nei cui scavi ha imparato a dearcheologizzare e decriptare le vestigia del passato, al magistero dei più grandi cuochi e pasticcieri italiani. Una storia di genealogie che si allungano come gli orologi di Dalì, se è vero che un giovanissimo come Massimiliano Alajmo ha già trovato il tempo per formare i suoi allievi, trasmettendo loro in primo luogo il vizio del gioco. Quella risata pronta a seppellire gli eccessi sentimentali come la prosopopea di chi si prende troppo sul serio in questi tempi di cucina ipervitaminizzata. Poi c’è il perfezionismo, perché come diceva Mies Van Der Rohe God is in the details, Dio è nei dettagli. L’amore per ciò che è piccolo attiva un file che arriva direttamente da Goethe. Il filosofo tedesco rilevava come ciò che è piccolo, i bambini, i cuccioli, i virgulti, susciti in noi una particolare emozione estetica in quanto prossimo all’entelechia, ovvero all’essenza. Ed è così che anche per un calembour, la piccola pasticceria diventa lillipuziana, virtuosismo degno di un’alta oreficeria cucinaria. “Sono nato a Pompei e la prima tradizione per me, quella per così dire anagrafica, è rappresentata da mia mamma Angela, una che in casa metteva sempre le mani in pasta, a livello amatoriale ma con passione e costanza. Ha sempre amato fare dolci in casa e quando ero piccolo, i miei primi giochi erano con lei, che mi dava un po’ di impasto e mi faceva pasticciare. Poteva essere la pastiera, la pizza fatta in casa, il babà. Io giocavo, quindi il mio amore per i dolci è nato come divertimento e passatempo ludico. E lo è rimasto tuttora. Mi è piaciuto così tanto che mentre facevo la scuola media, la domenica andavo in bici in una pasticceria del paese, da Franco. Lì pirottinavo solamente i dolcini, migliaia e migliaia, e anziché pagarmi mi davano un vassoio da portare a casa, che a quei tempi era già qualcosa. Avevo anche modo di buttare l’occhio intorno a me e di vedere come funzionava un laboratorio. Quello che mi 138 Da noi la tradizione è più radicata. Ha saputo farsi popolare a partire da matrici diverse. Se non erro il babà è mezzo polacco e mezzo austriaco, abbiamo avuto i monsù, che erano francesi, e tante altre contaminazioni. Quindi una stratificazione di influenze che sono state metabolizzate e perfezionate fino a renderle proprie, per radicarsi in profondità presso tutte le famiglie. E la tradizione viene trasmessa anche ai giovani, perché da noi c’è ancora il costume di riunirsi a tavola il giorno di Pasqua e fare quel determinato dolce perché la tradizione lo prescrive. Direi che i dessert sono ancora più ritualizzati delle ricette salate, rappresentano qualcosa che lega le persone a tavola. La relazione. Un dessert come il babà è quasi un totem nel senso che incarna la comunità. Ma esito a prepararlo perché è un dolce da fare spesso per avere un buon esito, se mi cimentassi adesso sicuramente non sarei soddisfatto prima di parecchie prove. Al contrario i dolci reperibili nella maggior parte delle pasticcerie italiane da noi non sono molto apprezzati. Rappresentano una pasticceria senza una forte identità, con una base internazionale un po’ maccheronica ma standardizzata, mentre le preparazioni tipiche sono confinate nel ruolo di curiosità folcloristica. Direi che sono etnicizzate, mentre noi e i siciliani, anche grazie alle ondate migratorie, abbiamo avuto la forza di deetnicizzarci. Oggi ci sono pasticcieri campani che sono star mediatiche e chef stellati che nei loro ristoranti propongono dolci di altissimo livello. Sono riusciti a divulgare il nostro patrimonio al di fuori dei confini geografici. Con la conoscenza e la pubblicità ci siamo affacciati all’esterno senza perdere la nostra identità. Anche perché fuori dalla tradizione al sud non si lavora. Si tratta di un limite invalicabile, che mi fa amare anche il nord. La prima cosa che mi viene in mente pensando alla Campania è la pastiera, il profumo del grano. Mia madre lo lasciava rinvenire nel latte per tutta la mattina, alla vecchia maniera. E si sentiva il profumo che si spandeva dappertutto. oppure a livello di ingredienti i limoni, le noci, di nuovo il grano. Oltre ad essere un’ottima cuoca dilettante, mia madre era di famiglia contadina e ha sempre amato la terra. Un altro aspetto che mi ha aiutato 139 enologica edizione 2010 colpiva era la creatività, perché c’erano spesso le torte dei matrimoni, con i paesaggi in miniatura, le decorazioni figurative, gli animaletti. Mi piaceva, e se ci penso adesso, a livello popolare si facevano giochi che oggi sono di moda sulle tavole dei ristoranti avanzati. Curioso, no? Le cose piccine mi hanno sempre affascinato, i presepi li ho sempre fatti, ultimamente un po’ meno perché il tempo è poco. Quelli in marzapane e cioccolato, con le finestre piccoline, i mattoncini. Mi piace l’idea di potere creare sul momento un dolcino personalizzato, per trasmettere un’emozione al cliente. Perché da noi la domenica, anche se non è una festività particolare, la gente va in pasticceria a comprare il vassoio delle paste. a conoscere i prodotti. Un tempo aveva un orto per gli ortaggi, poi si è convertita alle piante ornamentali. Ma ricordo in modo indelebile che il pomeriggio ci portava in campagna, io giocavo con la terra e la aiutavo. Quando viene a trovarmi qua, visto che ho un piccolo orto, mi aiuta sempre e mi mette a posto le verdure. Dalla Campania però non faccio venire quasi più niente; solo qualcosa dalla Sicilia, le mandorle, gli agrumi, grazie a Corrado assenza che riesce a spedirmeli. la Sicilia rappresenta una tradizione che ho adottato soprattutto per il côté agrumato, insieme ad alcune influenze extraeuropee. A Seul ho fatto un concorso di pasticceria e ho conosciuto una miriade di prodotti che potrebbero essere valorizzati. Spezie e frutti che qui non ci sono. Le mie noci di Macadamia arrivano da Phuket, in Thailandia; ho conosciuto Atala che mi ha portato i tronchi delle palme e la pripioca, che per loro è tradizione mentre qui è ignota. Mi piace scoprire nuove cose, anche se come dice Ferran Adrià nel suo manifesto, gli stimoli e le contaminazioni vanno sempre ricondotti in un paradigma personale. Il piatto deve avere un’entità e un’identità. Deve trasmettere la filosofia di chi lo appronta, comprendere la propria chiave di lettura. Altrimenti è troppo freddo, non può comunicare il suo messaggio. Dopo la scuola media ho frequentato i primi due anni di scuola alberghiera a Nocera Inferiore; oltre alla pasticceria, che era la mia passione, mi interessavo di cucina salata. Però non ero soddisfatto, sentivo che in quella scuola non potevo crescere e realizzare i miei sogni. Così ho deciso di seguire mio fratello, che era andato al nord, all’alberghiero di Salsomaggiore. Era una scuola rinomata, dove la pasticceria campana era studiata e praticata, quindi ho potuto perfezionarla tecnicamente. Luis Stella è stato un ottimo professore di pasticceria e fra di noi c’era uno scambio vero sulle materie prime e le ricette tipiche. Mi chiedeva dei nostri ingredienti, voleva sapere. Lì ho conosciuto anche Massimo Spigaroli, che veniva a scuola a fare terziaria, cioè aggiornamenti. Io partecipavo ai suoi corsi e si è creato questo feeling, così il sabato e la domenica sono finito a lavorare da lui. lo aiutavo sia con il culatello che al ristorante e a poco a poco si è trasformato nel deus ex machina del mio tragitto professionale. Con lui ho avuto il mio battesimo, il primo approccio con la cucina vera e propria, la brigata. Ho iniziato con gli antipasti, poi i secondi e tutto il resto. Magari non sono un cuoco completo, ma conosco il salato ed è un background prezioso, perché ti fornisce cognizioni su materie prime che in pasticceria non sono mai state considerate. Per esempio, volendo fare un esempio estremo, i tagli della carne e i loro possibili abbinamenti con elementi dolci, oppure la conoscenza della pasta, delle spezie come il curry, la curcuma e il pepe. Un orizzonte un po’ più aperto. Anche se le premesse ci sono già nei piatti tradizionali come le melanzane al cioccolato, una ricetta così semplice che deve essere eseguita alla perfezione, senza sbavature di sorta. È un piatto che ho rifatto ma non ho riproposto o rivisitato, perché è giusto che certe cose rimangano così come sono e che vengano mangiate nel 140 Durante i mesi di chiusura della scuola ho fatto le mie stagioni, cominciando da un ristorante di Varese dove ho lavorato in tutti i reparti, perché la figura del pasticciere era ancora poco affermata. A quei tempi c’era lo chef che faceva la panna cotta, il crème caramel, quei dolci veloci da tenere pronti per il servizio. Poi ho fatto una stagione a Cattolica e anche lì mi sono un po’ perfezionato. Facevamo dei trucchi con lo zucchero tirato che ci sembrava fosse chissà cosa, e se ci penso adesso non è niente. La lampadina mi si è accesa in Francia in un ristorante di Ducasse, 59 Pointcaré. È stata un’esperienza un po’ traumatica perché parlavo male il francese, ma cucinavo carne e pesce e a fine servizio stavo sempre lì a osservare la pasticceria. Da allora in avanti mi sono consacrato esclusivamente al dolce, ma tutti questi passaggi sono stati ottimi osservatori. Finestre spalancate su altre tradizioni che mi hanno sempre arricchito. Quando sono arrivato qui quel che sentivo molto era il profumo della brioche, dei croissant. I lieviti. Mentre a Parigi ho imparato l’etica, il rispetto per la posizione, la divisione dei compiti, la dedizione. Preparavamo piccoli dolci in miniatura, come se fossero giocattoli di bambole eseguiti alla perfezione. Da lì sono tornato in Italia, in Svizzera, a lugano, e quando Marchesi ha aperto Alma mi sono fermato a Colorno. Io volevo studiare ma non avevo i soldi, Spigaroli riuscì a farmi entrare dietro le quinte per quasi due anni nelle vesti di assistente e così ho conosciuto persone come Corrado Assenza e Gino Fabbri, che professionalmente mi hanno segnato. È seguita la permanenza alle Calandre per quasi 4 anni. Ed è stato fra gli insegnamenti più importanti. La mentalità di Massimiliano si avvicina molto alla mia. Penso all’essenzialità del piatto, alla selezione delle materie prime, alla dimensione ludica, all’abnegazione rispetto al lavoro, al rigore. Ho potuto lavorare spalla a spalla con lui, conoscendolo e apprezzandolo anche personalmente. Nel laboratorio ho affiancato anche la mamma Rita, che Massimiliano considera un’artista, una scultrice di torte. Lei elabora spunti che poi Massimiliano perfeziona, mettendoci quel quid in più. Quando lei girava il risotto, si racconta, lui era già lì nel passeggino. Alla fine sono diventato capopartita. Ma uscendo da una bottega simile, il problema è che vieni sempre visto come un allievo, così diventa difficile trovare la propria autonomia, anche se forse è giusto così. A seguire ho fatto l’apertura del Marchesino. La pasticceria lombarda però non la sento, è troppo pesante. Eravamo io e Galileo Reposo, Marchesi lasciava cadere questi concetti rivolti al futuro come se fossero perle, Marchesi è un futurista… Due anni fa sono arrivato a Vite. In un ambiente in cui certe sostanze circolano eccome, magari per reggere ritmi e tempi di lavoro, per me è stata una sfida lavorare con i ragazzi della comunità, che comunque hanno tutti ricevuto una 141 enologica edizione 2010 loro contesto. È anche la cornice a creare l’emozione. formazione di alto livello grazie a corsi interni alla comunità con professionisti come Cammerucci e Corelli. Lo scambio con lo chef Fabio Rossi è costante e la condivisione assoluta. Adesso sto fortificando le fondamenta della mia tradizione personale, nel senso di un’impronta endogena, che nasce da me e muore nel piatto. Sto lavorando sul tema della natura, a contatto con gli artigiani. Per esempio ho in mente un dessert dal titolo emblematico, il Contadino contemporaneo, con le pere, il formaggio e una salsa di noci all’acqua. Dove la campagna sta negli ingredienti e la contemporaneità nelle tecniche di trasformazione, mentre l’acqua serve a disegnare ancora più nitidamente i sapori, senza interferenze di sorta, perché è il massimo della pulizia gustativa. Poi la sperimentazione sui distillatori, per carpire l’olfatto e isolarlo dalle altre componenti del piatto. C’è un frutto dimenticato che mi torna spesso in mente. Si chiama feijoa, una sorta di kiwi invernale approdato da noi negli anni ’80, con la buccia liscia e un fiorellino in cima. Mio nonno aveva delle piante in giardino e sono rimaste nel mio database. Ho risentito il profumo di quel frutto e mi sono ricordato di quando lo mangiavo. Lo sto cercando per lavorarci sopra, perché la tradizione è anche un’invenzione. E poi un menu moderatamente zuccherino, con oscillazioni gustative su un fil rouge semidolce. Il tema scelto da Melandri non è semplice, per capirlo ho voluto documentarmi. La frase di Eliot che ha scelto è un po’ polemica, include dei tranelli. Ma in quel saggio mi hanno colpito anche altri passaggi, che possono essere applicati alla cucina. Dice che alcune cose del passato sono importanti ma il presente può modificarle gettando la sua luce. Quindi ogni cuoco ha una responsabilità ben precisa, deve agire un po’ come un setaccio, che lascia passare certe cose, ne trattiene altre, agisce sulla tradizione di domani con un’azione di filtro. Io potrei proporre un classico di domani, o contribuire affinché il passato in futuro venga letto diversamente. Mi sto concentrando sui prodotti stagionali del territorio, ad esempio le castagne, per conoscerne l’utilizzo e fare capire alla gente che nel tempo ci sono stati cambiamenti e la riconoscibilità può essere salvaguardata apportando modifiche chirurgiche ad hoc. Ma questo comporta uno studio. Non essendo del luogo, devo avere rispetto e documentarmi. Alcuni dolci un tempo potevano essere presentati in un determinato modo perché in dispensa c’erano solo pochi ingredienti oppure mancavano gli strumenti di cottura. Per esempio ogni luogo ha un modo diverso di preparare il castagnaccio, devo trovare il mio filo conduttore. a volte posso essere conservatore. Prendiamo il carrello dei dolci, che sembrava così rétro e invece sta tornando in auge. Ne propongo una concezione nuova, con testure e temperature diversificate, rese possibili dalle tecniche a disposizione, come l’abbattitore. Insomma nuove torte per un nuovo carrello. E quei gelati estrusi dalla vecchia Carpigiani a mantecatura verticale: 142 anche l’avanguardia ha una sua tradizione. In Castagna e castagna il supporto del piatto è un quadrato di legno naturale di una vecchia trave che abbiamo scovato nella ex Jugoslavia. I camerieri invitano i clienti a passarvi i polpastrelli, per sottolineare la natura ruvida della castagna, che viene stemperata da una crema al rhum, ed evocare l’habitat boschivo dell’albero del pane. Un po’ come il tattilismo futurista. E poi ci sono ingredienti che portano dentro di sé una memoria: l’acqua (chissà), ma soprattutto l’olio, il vino, il lievito madre del laboratorio di panificazione. Ho imparato a fare il pane da Pier giorgio Parini del Povero Diavolo quando lavoravamo alle Calandre. In Campania ci sono le grandi pezzature, che consentono una lievitazione ottimale; ma a me piace usare il lievito anche in pasticceria per dei piccoli croissant, ad esempio in Colazione a Vite, un gioco su Colazione da Tiffany. È l’ironia di concludere il pasto con una colazione, sdrammatizzando le pulsioni regressive. Ad Enologica porterò il mio cavallo di battaglia, la sfoglia caramellata con la crema alla vaniglia. In qualsiasi ristorante è stato il mio biglietto da visita, come l’omelette nelle maison francesi, perché rappresenta la mia filosofia, la semplicità, la pulizia. È il palcoscenico degli ingredienti primari: la farina, l’acqua, il sale, il burro. Il tocco personale sta negli accorgimenti tecnici, perché il minimalismo è trasparenza e rigore. La sfoglia non è caramellata solo in superficie ma anche all’interno, perché viene tirata con lo zucchero e non con la farina, ed è preparata con un’acqua ad hoc, dal giusto residuo zuccherino; mentre la crema è fatta raffreddare e girata nella planetaria per vellutarla al massimo. Nella sua preparazione al posto dello zucchero utilizzo l’inulina, un derivato della cicoria con uno scarso potere dolcificante, che compensa la dolcezza della pasta. Insomma una ricetta tradizionale ringiovanita attraverso l’uso di tecniche nascoste, come va di moda di questi tempi. Poi ci sarà il piatto creativo. ogni dolce parte da un’idea, che sia la pioggia sulla vetrata o uno spunto dalla tradizione. Me lo appunto su un foglio volante, poi magari torna fuori quando meno me lo aspetto e lo sistemo. Una volta, due volte, tre volte. La gestazione può durare lungamente con cadenze annuali, quelle degli ingredienti stagionali. Alla fine lo disegno e stendo la ricetta dettagliata. Gli ingredienti fondamentali sono sempre 3 o 4, materie prime di eccellenza da lavorare il meno possibile. In questo caso ho provato 143 enologica edizione 2010 insuperabili, con buona pace degli apprendisti stregoni dell’idrogeno liquido. Altre volte la tradizione assume i connotati di uno scavo archeologico, che fa affiorare sotto il sole del terzo millennio sapori e ingredienti dimenticati. Come l’olio di oliva in pasticceria, un tempo utilizzato per castagnacci e ciambelloni, oggi imprescindibile per le sue virtù di digeribilità e quale fissatore di sapori. Perché le nuove conoscenze sanno scovare tesori sul fondo della storia. a immaginare la tradizione come le radici di un grande albero, quelle stesse radici che a ognuno di noi danno la possibilità di ambire a mete più lontane. Mete raggiungibili attraverso le proprie esperienze e le proprie basi, che durante la crescita si arricchiscono di nuovi valori e di nuove contaminazioni che ci permetteranno di spingerci più in là, nella ricerca di nuovi accostamenti e di nuove ricette. Le stesse che un giorno resteranno nel tempo o che andranno perdute. È proprio questo grande fogliame di ricette che ci distoglie da quel che è la tradizione, il tronco e le radici che hanno permesso la nascita dei frutti e delle foglie. Il mio pensiero è di non osservare la tradizione come punto d’inizio per sviluppare o reinterpretare le ricette che essa stessa ci offre, ma di considerarla come una grande finestra dalla quale possiamo ridarle valore, ripartendo dai prodotti e dalla materia prima. Solo attraverso forti radici la tradizione può essere ereditata e solo attraverso il nostro cammino di fatica può essere conquistata, secondo l’esortazione di Eliot. Ecco quindi le castagne in una duplice veste, come caldarroste e come evoluzione del castagnaccio, sotto forma di torta di castagne affumicate con gelato ai marroni e cremoso al cioccolato e al rum. È così che ho trovato la mia via personale al castagnaccio”. Quando questa intervista è stata rilasciata Franco Aliberti era pasticcere della Locanda Vite della Comunità di San Patrignano, Coriano di Rimini “Raccontami una storia.” Pere Abate Fetel (Pere dell’Emilia-Romagna IGP) 144 Gianni D’Amato “Nel ring del grande solista” Chi l’ha vista. L’alta cucina italiana potrebbe non essere mai esistita, impegnata com’era a ricalcare paradigmi in sedicesimo di nazioni straniere, dalla nouvelle cuisine transalpina all’avanguardia ispanofila. A fare le sue veci, uno sparuto manipolo di solisti più o meno brizzolati. Fulvio Pierangelini, Gianfranco Vissani, Igles Corelli, lucio Pompili. E Gianni D’Amato, chef patron del Rigoletto di Reggiolo. Fenomeni spontanei che hanno bucato la crosta del conformismo con una spontaneità primordiale, fatta di accostamenti prepotenti e intuizioni indiscutibili. Dentro l’ecosistema della ristorazione contemporanea, un giardino di geyser che ha fatto dell’eccezione l’unica regola possibile. Aggirarsi fra le loro tavole significa entrare in altrettante monadi prive di finestre, stagne, definitive, insofferenti a qualsivoglia paragone. Demiurgiche nel lavoro dell’ingrediente intero come nel forgiare una cucina ab ovo. le radici di gianni sono ad Aulla, ma la quadra si è compiuta altrove. La sua Emilia si presenta innanzitutto nella personificazione della moglie Fulvia, direttrice di sala e sommelier, la classica eminenza rosa che funge da cariatide delle sue architetture pindariche. Figura di prosopopea in senso stretto, giacché incarna alla perfezione tutto un sistema di pratiche e sapori. Nella sua memoria la corte di due famiglie, con oltre 60 bocche da sfamare, fra cui quella del padre, e persino il caseificio dentro il recinto di casa. Ma l’Emilia è anche la clientela, o meglio ancora il chiavistello per aprirla. E ovviamente i prodotti. Questione di testure morbide e di un’impronta gustativa a tendenza dolce, che per un peculiare fenomeno di osmosi dal menu del territorio ha contagiato la sua creatività. “La bassa ha sempre dato di più della montagna e della collina, compresa la selvaggina”, sentenzia Gianni, cui però piace portare i brividi degli strapiombi appenninici nel continuum orizzontale della pianura metafisica. La sua lunigiana, percorsa e ripercorsa da luigi Veronelli, era una terra genuina. Farine, castagne, ricotte da pazzi, salami a volte da toccare il cielo, a volte da buttare. Tutta una cultura della povertà a chilometri zero, come va di moda ultimamente, mentre lì, ben ovattata dal silenzio millenario della vita quotidiana, non è mai declinata. E anche di queste ultime tendenze, Gianni aspetta implacabile di scorgere il cadavere dal ciglio del laghetto di Reggiolo, nella porzione di Bassa ritagliata dal bastone dell’aruspice, dove secondo gli storici sarebbero stati inventati ripieni di cappelletti e tortellini. Il cuore insomma 145 enologica edizione 2010 Il Rigoletto Piazza Martiri, 29 - Reggiolo Reggio Emilia t. 0522 973520 - www.ilrigoletto.it della cucina emiliana. Oggi il Rigoletto è un due stelle, ma basta grattare sotto la scorza del Relais et Château per sentire battere una passione boxistica. E il ristorante diventa un agone, dove si celebrano le feste con le competizioni. l’ingrediente è un potenziale campione da addestrare, per tirare fuori con la socratica vena di un maieuta aggressività e carattere alla massima potenza, senza alterazioni che non siano l’elevazione di grado. E fra la tradizione e l’invenzione, il territorio e il mondo, il lusso e l’umiltà vinca il migliore. I palati contrattano le quotazioni per match nei quali non c’è nulla di scontato. ad Enologica se ne vedranno delle belle. Tartufo e tartufi ha la potenza ctonia della terra. Perché accanto all’umile tubero locale, che cresce senza tanto clamore lungo il Po e persino nel parco della villa, ci sono altre radici, la carota e lo zenzero, e un tartufo di mare, anch’esso ipogeo perché vive sotto la sabbia. Contrasti che non risparmiano le temperature, visto che il frutto di mare è avvolto nella tunica calda di una lamina di pane, prodotto anch’esso dalla terra attraverso il medium delle spighe. Mentre la capasanta in Emilia cita il topos delle paste con un raviolo non raviolo, fatto di mortadella dentro e fuori, più tre salse, bagnetto rosso, senape e Balsamico Tradizionale. Quasi fosse una parodia deluxe dell’hot dog. Altro classico emiliano il bollito, sorta di “carrello compattato”, forse contagiato dal paradigma della lasagna nella sua forma a millefoglie. Si compone di lamine sottilissime di testina, lingua e torchon di foie gras d’oca, passione dello chef qui in funzione di legante, più una giardiniera che assesta il suo potente gancio nella gola. Come insegna Maggie, struggente pugilatrice di Clint Eastwood, è arretrando di un passo che ci si prepara a sferrare il colpo fatale; ed è facendo aggio sull’appoggio sinistro che il pugno destro si scalda. Scaltro, ma anche sornione e ardito, Gianni ha imparato a schivare i cliché per un pasto che non conosce pause di riposo. La tua famiglia proviene dai métiers de la bouche. Sì, i miei bisnonni da parte di padre, che non ho mai conosciuto, avevano un’osteria ad Aulla. Che non è in Liguria, e neppure in Toscana, ma in Lunigiana. Una terra diversa da tutte le altre. Una terra di matti. La definirei una terra franca come Reggiolo, praticamente sul confine fra l’Emilia e Mantova. Sì, sono destinato ad abitare nelle terre di confine. Anche perché sono camaleontico, nel senso che riesco ad adattarmi al luogo in cui opero. Se dovessi lavorare in Sicilia, non avrei problemi a cucinare alla siciliana, e così in Piemonte. Ho cominciato con la cucina classica, che conoscevo a menadito, tutte le salse, le salse madri, i tagli, e da lì sono arrivato al mio stile personale. adesso non c’è più questa conoscenza, si fa qualche stage e si diventa subito chef. Ed è un peccato. Tornando all’osteria di Aulla, il bisnonno seguiva la cantina e la bisnonna cucinava qualche piatto con i prodotti che si potevano trovare, i testaroli, i panigacci. Perché erano tempi brutti. Poi c’è stata la guerra e i bombardamenti hanno distrutto tutto. La linea gotica passava proprio di lì. Gli inglesi hanno raso al suolo completamente il paese e i miei avi sono dovuti 146 suoi spaghettini, sfilettava il pesce… Anche noi facevamo queste cose al Rigoletto, fino a qualche tempo fa, perché mia moglie è addestrata. Ho ancora la passione di girare per ristoranti, una cosa innata che ho inoculato anche in mio figlio. Anche da Paracucchi? Paracucchi è una leggenda, ma non è riuscito a fondare una scuola, nel senso che la ristorazione ligure fa molta fatica. Certo, era vicino a noi, a Sarzana, e siamo andati diverse volte. A quei tempi non studiavo ancora da cuoco, ero un ragazzino. Ma ero incuriosito da quello che faceva. Probabilmente era il migliore ristorante in assoluto, completamente diverso da Marchesi perché in fondo lui era un gastronomo, molto edotto sugli aspetti scientifici della trasformazione della materia. Era partito come direttore di sala, perché gestiva il Motel dell’Agip a Sarzana, poi aprì la locanda dell’angelo, dove non si limitava a servire. Secondo me cucinava anche di notte, per le sue prove; poi faceva cucina di sala, con la lampada. Era molto bravo. Preparava i Quella di Paracucchi era una cucina all’olio di oliva? Certo, anche se io non faccio differenze. Per certi alimenti occorre l’olio, per altri il burro. A quei tempi nell’alta ristorazione non era scontato. Dipendeva dalla zona, perché in Liguria si è sempre usato. Il ristorante era moderno e spazioso, con un bel giardino e un grande prato con tutti gli ulivi; si entrava per una stradina interna e l’edificio aveva il tetto basso, con ampie vetrate all’inglese. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, ma non c’è stato modo. Il caso mi ha portato altrove. Bisogna considerare che anche lui era quasi in Toscana, e la liguria è una regione particolare. Il Ponente è ben diverso dal levante, dove c’è una cucina molto semplice, basata su pochi ingredienti poveri. Le acciughe, le patate, quei coniglietti piccoli piccoli, a misura dei loro spazi ristretti... Quindi trovi quasi solo locali alla mano e la ristorazione turistica, che è terribile. Dove hai fatto l’Alberghiero? A Lerici. La scuola era praticamente sul mare e ricordo che in primavera si stava spesso e volentieri sulla spiaggia. Lì ho 147 enologica edizione 2010 sfollare, arrangiandosi alla bell’e meglio con le castagne e quel che trovavano. Dell’osteria non è rimasto niente, neanche un bicchiere. Solo i ricordi e i racconti. I miei nonni e i miei genitori non hanno ripreso quel sentiero interrotto. Ma a mio nonno piaceva molto cucinare, e lo faceva anche bene. Aveva una forte passione e si cimentava spesso ai fornelli, soprattutto con il pesce. Da piccolo lo vedevo spadellare e cercavo di aiutarlo come potevo. Tanto che ho sempre saputo di voler fare il cuoco, fin da piccolissimo. Mi ricordo ancora i profumi del suo cibo, perché avevamo una casa con il cortile e mentre giocavo mi arrivavano addosso… Quindi volevo fare il cuoco, e ho fatto il cuoco. Avrà influito il racconto dell’osteria, avrà influito l’esempio di mio nonno. Per di più con la mia famiglia andavamo sempre a mangiare nei migliori ristoranti. La domenica, per le ricorrenze. conosciuto Fulvia, che studiava ricevimento. Frequentava la scuola di Salsomaggiore, perché è emiliana, ma lì mancavano il quarto e il quinto anno, quindi si era trasferita. Ho avuto un insegnante che mi ha fatto innamorare della professione, Gianfranco Ghegini. Anche il fratello Lucio era molto bravo, forse più raffinato perché aveva girato sulle navi di lusso. Insieme mi hanno aperto la strada della cucina. Ho girato in zona Versilia, in montagna a Madonna di Campiglio e in altre valli, per alberghi e ristoranti, in Inghilterra, a Londra e nel Kent, in Germania da Winkler… E poi ho mangiato quasi dappertutto. Ma non ho mai avuto un vero maestro, mi sono fatto da solo. Perché non ho mai voluto seguire un filone, come una pecorella nel gregge. Sono troppo anarchico per questo. La mia è una cucina molto personale, che non assomiglia a nessun’altra. In giro, in Germania come in Francia, raccoglievo stimoli, segreti, suggestioni tecniche, ingredienti, su cui poi mi divertivo a compiere le mie sperimentazioni; ma non certo uno stile. Ho sempre avuto la passione di fare bene e mi sembra che piano piano ci stiamo arrivando. Nel tempo si matura, un cuoco forma la sua idea e il suo concetto e li sviluppa come vuole. il pesce. Come i calamaretti ripieni di cipolla con tartufo e crema di patate al nero di seppia, un piatto storico che con qualche modifica servo anche qui. Poi la cacciagione, i funghi raccolti nei boschi, magari ne trovassi ancora di simili… Ci siamo restati 13 anni, ma il lavoro era quello che era, d’inverno si tribolava un po’ a causa della zona. Perché vi siete spostati proprio a Reggiolo? Avevo diverse opportunità. Ma al mare non volevo andare, perché mi sembrava una ristorazione troppo turistica, in cui era difficile emergere. Tramite alcuni clienti abbiamo saputo che c’era questa villa libera e siamo venuti a vederla. La telefonata la fece Fulvia. Era stata la dimora di un signorino ricco, che alla fine aveva sposato la sua governante. E lei l’aveva venduta a un ristorante, quindi c’era già la struttura della cucina. L’edificio è vincolato dalle Belle Arti e quando abbiamo rimaneggiato le camere per gli ospiti la Sovrintendenza ha messo parecchi paletti. Come mai vi è sembrato il vostro luogo? Fulvia è nata a 30 chilometri da qui, verso Parma, a Poviglio. La zona di Don Camillo e Peppone. Quindi era un rientro a casa. Poi il posto, con il parco per l’estate e il laghetto, ci piaceva moltissimo. Siamo nel centro del paese, ma sembra di stare in aperta campagna. Quando sei diventato chef e hai cominciato a fare la tua cucina? Ho aperto il mio primo ristorante a 24 anni, ad Aulla. Proponevo già una cucina d’autore e Fulvia, che è anche sommelier, lavorava in sala. Era uno dei migliori locali della provincia, forse il primo. Ricordo diversi piatti bandiera, ad esempio i testaroli, ma anche Che cosa ti ha mosso dentro questa location emiliana? L’impostazione non è cambiata: anche qui faccio una cucina mediterranea, ricca di colori e profumata dalle erbe aromatiche, tanto che molte ricette sono rimaste in carta, come il piccione. Ma 148 In tutto fanno 35 anni di cucina. Quindi hai attraversato la stagione della nouvelle cuisine come quella della cucina creativa. Ho sempre diffidato delle mode, anche se sono curioso delle novità. Perché non bisogna chiudersi a niente. Occorre scoprire, guardare e poi trovare la propria posizione. Ma non si può girare come una banderuola. Oggi c’è un ritorno al territorio, che mi sembra forzato. Non ci si può inventare terroiristes da un momento all’altro. anche io potrei cucinare a chilometro zero, perché qui intorno di materie prime ne trovo, dall’Aceto Balsamico Tradizionale alle zucche, ad alcuni tipi di verdura, al mio macellaio, ai cotechini e agli altri insaccati. Potrei tranquillamente accorciare la filiera, e difatti lo faccio nel menu del territorio, che ho iniziato a proporre molti anni prima che diventasse di moda nella ristorazione gourmand. Quindi non ho mai chiuso le finestre sul paesaggio circostante. Ma la mia carta non si limita a questo. Hai detto che adori la Francia. Sì, ci vado appena posso. Ma la mia è una cucina italiana. Adoro certi prodotti francesi e ancora di più le eccellenze nostrane. Tu sembri ancora affezionato e ispirato dal lusso, mentre oggigiorno va di moda l’ingrediente povero, il “lusso della semplicità”. Io adoro il lusso, navigherei in mezzo al lusso, anche se sono una persona molto semplice… Vedi che torniamo alle mode. Il lusso uno ce l’ha dentro, non se lo deve creare. Mica servono il maggiordomo con la tuba e il parcheggiatore. Poi anche un cotechino buono è un lusso. Ogni ingrediente ha la sua nobiltà, dal caviale alle costine di maiale. Perciò se un prodotto è veramente valido, io lo paragono agli altri prodotti e lo confronto sul piatto, dove deve dimostrare il suo carattere e tutta la sua grinta. A prescindere dal prezzo di mercato. Perché non è detto che un prodotto che costa 5000 euro al chilo sia migliore di uno che ne costa 3. Senza per 149 enologica edizione 2010 non ho mai voluto riproporre specialità lunigianesi; i testaroli li faccio solo per me e per la mia famiglia, mentre ad Aulla, per esempio, già mi facevo portare da mia suocera la zucca per i ravioli alla mantovana, ci andavo matto. I prodotti quindi li conoscevo già, e anche le ricette, grazie alla famiglia di Fulvia. Gli zii erano contadini e ho sempre visto il salame buono, il Parmigiano giusto, anche se la Lunigiana forse era più genuina, perché qui iniziava la food valley. Mi sono trovato facilitato nelle ricognizioni sul campo, alla ricerca di artigiani e fornitori, e ho battuto il terreno. La stessa frequentazione dei ristoranti regionali mi ha fatto gioco. L’Emilia mi ha stimolato nella determinazione di continuare a fare le mie cose. Perché ai clienti non darei mai un piatto che non piace a me. Non sarebbe una mia identità. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché non ho mai avuto l’aiuto di nessuno. anche quando sono arrivate le stelle, non mi sono montato la testa. Ho continuato a lavorare sodo, quindici o sedici ore al giorno, senza farmi vedere troppo in giro. Vi è piaciuta la frase scelta da Giorgio Melandri sulla tradizione come conquista? forza cadere nella forzatura ideologica opposta, per cui si cancellano i miti gastronomici. Dal basso o dall’alto, la qualità deve restare la stessa. lui è nato nella ristorazione: si trova nel suo liquido amniotico. È sempre venuto con noi al ristorante, fin da quando aveva 3 anni. Quindi ha avuto l’educazione giusta. Nelle maison importanti era molto obbediente, mentre nelle trattorie si scatenava… Ricordo una grana che piantò a Beaune, in Borgogna, dove voleva assolutamente il pesce ma senza troppe salse. Perché lui è più purista di me, un minimalista. Mentre io adoro le salse, se sono fatte bene. Ormai in giro ti servono lo stesso fondo con l’agnello, il vitello, il manzo, il piccione. Eh no! Molto, anche se non è immediato decriptarla. La tradizione è imprescindibile. Non si tratta solo di un menu degustazione, ma di capire il territorio, la gente del posto. nel senso che attraverso i piatti della tradizione è possibile anticipare le aspettative del cliente. Come il mercato: quando sono all’estero, per sentire dove sono finisco sempre fra le bancarelle. Ma una carta deve essere equilibrata: deve trovarvi posto il territorio, per chi viene da fuori, accanto alla personalità dello chef. Per un giovane poi quella frase è ancora più vera, perché le mamme cucinano poco, prendono i piatti pronti e certe identità si sono perse. Quindi il giovane, se non ha memoria del gusto, deve conquistarsela. Adesso si usano i piatti senza salsa. I piatti tradizionali della tua carta sono rivisitati? Perché ci sono costi maggiori, e tanti cuochi non sanno fare le salse. Non esiste più la figura del saucier. Ma le mie non sono salse alla francese, fungono piuttosto da accompagnamento, appena una goccia o una strisciata sul piatto. Non coprono nulla. Tornando a Federico, negli ultimi anni ha iniziato ad avere mansioni di responsabilità; si divide fra la cucina e la sala. Perché è giusto che chi lavora in sala conosca la cucina, e viceversa. Con questa simbiosi si riesce meglio nel lavoro. Senza mettere i cuochi in sala come fa Redzepi, perché sarebbe un disastro. A volte Federico fa le sue sperimentazioni e propone anche dei piatti, che possono essere accettati oppure no. Certo, nessuna ricetta è invariata, ma il gusto di un cotechino è difficile nasconderlo. Parto sempre dall’ingrediente del territorio e gioco secondo l’intuizione del momento. L’idea di base non la provo nemmeno; può essere un accostamento o qualsiasi altra cosa. Alla fine gli elementi sono spesso numerosi, perché assemblarli è una sfida esaltante per il cuoco, ben più impegnativa delle monografie vagheggiate da Marchesi. Ma non mi piace essere definito barocco, perché rispetto l’individualità del prodotto, che non voglio mai modificare più di tanto. Quando ti ha raggiunto tuo figlio Federico? 150 Isa Mazzocchi “Biotradizioni di una cuoca” “la tradizione è una conquista”, scrive T. S. Eliot. Conquista che sa farsi lungamente sudare prima che arrivi l’agognato happy end. Tanto che la parabola di Isa Mazzocchi, cuoca della Palta di Bilegno e bruciante pasionaria, assomiglia a una favola di Propp. Dove l’eroe (A, cioè Isa), istigato dal mandante (B e C, ovvero la madre e il padre) parte alla ricerca del bene agognato (D, la tradizione) e sulla sua strada si imbatte in fervidi aiutanti (E, Georges Cogny) e strenui antagonisti (F, la consuetudine), con il probabile sgambetto di insospettabili pseudo-eroi. Lo schema è universale e non conosce smentite. Dall’idillio iniziale alla complicazione, passando per una serie di peripezie che sul piatto sprigionano profumi inebrianti e volute palatali. Con un particolare rilievo sulle fasi numero 3 (Infrazione), 4 (Ricerche), 6 (Tranello)… Le funzioni canoniche sono 31 e non è dato sapere quale numero stia scritto a piè di pagina. Ah, la tradizione, la tradizione! “C’est bien plus que des recettes”. Isa lo sa sulla sua pelle, o meglio ancora la sua pelle lo sa. “Quando penso alla tradizione vedo alcuni gesti di mia madre, e mi accorgo di compierli nello stesso identico modo. Tagliare una cipolla, allacciarsi il grembiule, sistemarsi i capelli, oppure toccarsi il palmo delle mani, come faceva mio padre. Nonostante i ritmi, perché mia madre ad esempio è più lenta, misurata”. L’angolo di inclinazione del mestolo sul goniometro della genetica e dell’educazione sentimentale: la tradizione come corpo, in cucina più che mai. Insomma la verticalità di Roland Barthes, simile a un geyser che erompe dalla memoria biologica del cuoco: “È la voce decorativa di una carne sconosciuta e segreta; funziona come una Necessità, quasi che, in questa specie di crescita floreale, lo stile sia solo il termine di una metamorfosi, cieca e ostinata, la parte di un infralinguaggio che si elabora al limite della carne e del mondo”… Mentre sullo sfondo si staglia come un convitato di pietra il castelletto dove Isa e la sorella si recavano bambine a trovare le zie nubili. Senza manutenzione né coraggio, le rovine di una tradizione diroccata, facies hippocratica calata come una serranda sulle tiepide intermittenze del cuore. “Ricordo che avevano una grande stufa, quelle economiche di inizio ‘900, e sotto tante cassette rivestite di coperte. Quando le aprivano, partiva il pigolio di piccole anatre, faraone, tacchini, pulcini che chiedevano il cibo. Ogni cassetta ne era piena. Poi quando i volatili crescevano li lasciavano liberi di razzolare nel pollaio. Ma appena le zie si giravano, io e mia sorella ce li stringevamo al petto fin 151 enologica edizione 2010 Ristorante La Palta Via Bilegno, 1C - Borgonovo Val Tidone, Piacenza Tel +39 0523 862103 - www.lapalta.it quasi a soffocarli, tanto erano teneri. Erano i nostri peluche”. Ti è piaciuta la frase di Eliot scelta da Giorgio Melandri? Sì, mi è piaciuta. E quando l’ho letta mi è sembrato che fosse stata scritta per me. Se io penso a quello che sono io, è questo. Puro, nudo e crudo. Perché pur essendo figlia di osti, nessuno ha pensato che dovessi essere immediatamente accettata a causa degli insegnamenti trasmessi. Tutt’altro. In questi casi hai sempre addosso il problema di essere il figlio di un personaggio che ha fatto tanto e per acquisire credito devi darci dentro. Quindi la tradizione va coltivata, studiata e conquistata. Quando poi ho capito cosa fosse, l’ho odiata a tal punto che se fosse stato per me, avrei mollato tutto. Dopo essere sempre vissuta qui, sono partita da casa a 13 anni per andare a scuola e ho scoperto che esisteva un mondo diverso. Tornando mi sono sentita spaesata: “Ma io che cosa ci faccio qua?”, mi sono domandata. Quindi per te inizialmente la tradizione era la natura, nel senso che non poteva essere messa in discussione. Sì, prima che scoprissi la cucina professionale ero inconsapevole, non credevo esistesse nient’altro. Poi a scuola mi sono fermata e ho realizzato che non potevo continuare a fare per tutta la vita i pisarei e fasò e l’arrosto misto, perché sarei impazzita. Ho odiato la tradizione con tutte le mie forze perché mi sentivo in gabbia, da lì ho iniziato a lavorare, le grandi discussioni, l’inquietudine, la ribellione. Sentimenti che in fondo non sono tanto positivi. Se ci penso adesso però mi hanno dato modo di aprire la gabbia, quindi una loro utilità l’hanno avuta. Mi fai pensare a Edoardo de Filippo: Non mi piace ‘o presepe… Quanto è durato questo periodo “paleofobico”? Tutta l’adolescenza, fino ai 20 anni. Poi è stato fondamentale l’incontro con georges Cogny, che sembrava non fosse tradizionale, mentre forse era il più tradizionale di tutti. Ha cominciato ad usare i prodotti del territorio ed era curioso di conoscere le nostre tradizioni, come noi usavamo e approntavamo determinati cibi. Per poi prepararli e presentarli a modo suo, con la sua tecnica francese. Certe volte a dire il vero non li apprezzava un granché, li criticava tecnicamente, nella testura, nella presentazione. Ad esempio odiava la polenta. al ristorante preparava i panzerotti di crespella al forno o altre specialità tradizionali, che in realtà venivano cucinate dalle donne del luogo. Preferiva rifarsi alle tradizioni regionali della sua Francia, come insegnavano i comandamenti della nouvelle cuisine. Quindi i piedini di maiale al tartufo, che accompagnava con piatti piacentini quando c’era la festa della maialata. Ha agito un po’ da cerniera fra due parti di te in conflitto. Sì. Prima mi piacevano le cose più ardite, le espressioni più avanzate della nouvelle cuisine. Robe che magari non erano neanche così strane, ma rapportate a una ragazzina di 15 anni vissuta in campagna… Penso ai primi dessert al piatto, alle carni servite molto al sangue, a questi modi di cucinare diversi. Se mi 152 Uno psicoanalista direbbe che ti sei identificata nella figura di tua madre. Probabilmente è vero. Devo dire che mi ero già un po’ avvicinata al repertorio piacentino, perché nel momento in cui ho preso in mano le redini del ristorante e ho avuto carta bianca, c’era una clientela con determinate abitudini da accontentare. Quindi ho iniziato ad attualizzare i piatti della tradizione, ad alleggerirli eccetera. La prima prova è stata la picola di cavallo, con una cottura separata dei diversi ingredienti e una salsa al vino rosso. Qui non si usa tanto la bomba di riso, quanto il pasticcio di pasta frolla con amaretti, uovo crudo e una salsa di piccione a parte. Mi fece venire voglia di fare il piccione, un bel trait d’union con Georges Cogny. Mentre i tortelli per me restano un piatto imperfettibile, bello da vedere, buono da mangiare, ricco di aspetti moderni, le testure, la freschezza, l’acidità. Non ho mai voluto rivisitarli. Quando interpretavo questi piatti, però, non li assaggiavo mai. Anche se io in realtà non assaggio mai le novità, mi fido molto del palato di mia sorella e mio marito. Mi sembrerebbe quasi di divorare i miei figli. ad assaggiare riesco solo dopo un po’ di tempo. E tu come nutri i tuoi figli? Stai trasmettendo loro la tua tradizione? Mi sento di lasciarli crescere abbastanza liberi, non impongo loro nulla. Luigi, il maschio, è molto curioso. Mangia i broccoli crudi, i raperonzoli crudi, di tutto. Ed entrambi conoscono a menadito il repertorio piacentino. Nel tempo la tua apertura è durata? Sì, e sono anche maturata, nel senso che a volte ho proprio voglia di gusti che ricordino l’infanzia. Non so cosa darei per assaggiare di nuovo la fetta di pane spalmata di marmellata che mi faceva mia zia. Teneva i vasetti in quelle credenze a muro, con gli scaffali e le antine di legno. Quando aprivi sentivi quell’odore di umidità, ma il gusto era unico. Sono momenti che è impossibile rivivere, perché sono fatti di tante cose, atmosfere, emozioni. C’è bisogno che il panino sia fatto in quel determinato modo eccetera. Hai mai avuto la tentazione dell’iconoclastia, che poi è un tradimento 153 enologica edizione 2010 servivano un piatto di pisarei, nemmeno li assaggiavo. Non so se era un rifiuto o se proprio non mi piacevano, perché spesso mi avevano obbligato a mangiarli. Bisognava finire quel che era nel piatto, e comunque mio padre diceva sempre “Devi assaggiare”. Allora mi sembrava una violenza, mentre oggi lo considero un arricchimento, perché a un certo punto ho sentito l’urgenza impellente di quel cibo. La mia trasformazione è avvenuta con la maternità, che ha cambiato totalmente i miei gusti. Quando ero incinta ho avuto improvvisamente il desiderio di cibi che avevo sempre detestato, come il baccalà. In piena notte la voglia incontrollabile di un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino, che io mai nella mia vita… Oppure la zuppa con il latte. che tramanda, perché include il suo opposto? Credo che mi abbia sfiorato, nel senso che usavo i prodotti del territorio, ma li snaturavo molto, li massacravo perché mi piaceva provocare con un elemento tradizionale, portandolo all’eccesso. Tanto che spesso il risultato non era molto buono. Molti tentativi non sono mai entrati in carta. Da quel che racconti, sembra che la frase del poeta sia la tua biografia. Adesso che me lo dici, lo penso anch’io. Ma la tradizione per me non è una conquista compiuta, nel senso che c’è ancora molto da fare. Perché la tradizione è l’essenza. Un piatto cucinato da mia madre, non riuscirò mai a prepararlo come lei. Quindi il mio gioco sta nel portare l’essenza di quel piatto, che lei mi tramanda, avanti nella storia. ad Enologica ho pensato di proporre il merluzzo, cioè il baccalà, in umido con la polenta. Quindi un piatto tipico di qua e di altre zone, ancora preparato in molte case e in qualche trattoria, soprattutto il venerdì. Una tradizione cui mi sento molto legata. Oggi come oggi non potrei proporlo tal quale, per una serie di motivi. Il pesce veniva fritto nello strutto con la farina, in modo che risultasse croccante fuori e succoso dentro; per poi essere ripassato e servito in un intingolo di cipolla in umido con il pomodoro, che dava la giusta acidità. Quindi era un po’ greve; inoltre non è facile reperire il prodotto giusto e la lavorazione è abbastanza lunga, nel senso che ci sono tanti passaggi da fare: dissalare, friggere, preparare il condimento, cuocere la polenta, assemblare... Il mio baccalà è diventato un toast al mais con dentro il pesce marinato e una maionese alla cipolla, che rende il piatto un po’ più digeribile. Le conoscenze mi consentono di mantenere intatto il dna dell’originale, che è racchiuso nel toast; ma io non vado a snaturare la fibra del pesce con la frittura in padella. Piuttosto lo mantengo morbido all’interno del pane, dove si cuoce a puntino, sui 60-65 gradi, mentre il toast frigge alla francese come un croquemonsieur. Quindi le testure si invertono: la polenta diventa croccante e il baccalà resta morbido. E qui viene fuori l’altra mia tradizione, nel senso che c’è una strizzatina d’occhi a Georges Cogny. Mi sembra anche un piatto ironico. Quando si usano le forme del cibo popolare nell’alta cucina, il sorriso scatta sempre. Diventa una parodia affettuosa. A me sembra sempre di mettercela, l’ironia, anche se spesso non viene capita. Perché una volta che hai carpito quella che ti sembra l’essenza della tradizione, ci puoi pure giocare. Come faccio nella pizza di fichi affumicati con il foie gras e la quaglia. Una forma popolare e un caposaldo della cucina francese, la quaglia al foie gras. Con un tono fumé molto spinto per evocare la cottura a legna. Il baccalà è il piatto della tradizione oppure quello del ristorante? Lo presento come il piatto della tradizione. Quale specialità del ristorante voglio portare i pisarei e fasò, che sono tipici di Piacenza ma nel tempo hanno subito una fortissima evoluzione. Nel senso che la ricetta è attestata 154 Vedo una specie di chiasmo fra il piatto tradizionale e il piatto del ristorante, che si scambiano di posto. Come un minuetto. Sì. Per evidenziarlo mi piacerebbe portare mia madre sul palco, per cucinare i pisarei e il baccalà a modo suo. Avanti e indietro nel tempo. Io ho compiuto una ricerca per conoscere quel che in realtà è avvenuto e perché è stato fatto così; ad aiutarmi sono state lunghe chiacchierate con andrea Sinigaglia, mio amico e insegnante di storia della cucina all’Alma, sempre utilissimo per mettere ordine nelle investigazioni e scovare chicche riguardanti la tavola, piacentina e non solo. La nostra verità è questa. Ma la verità di mia madre è un’altra. In entrambi i casi c’è di mezzo una trasmissione e una tradizione. L’etimologia ci insegna che la tradizione e il tradimento hanno un’origine comune. La trasmissione contiene in nuce il germe della variazione. Eppure nell’immaginario collettivo la tradizione è conservazione. Mentre l’etimologia insegna esattamente il contrario. Con il tempo ci si rende conto di quanto sia innovativa la tradizione, e di quanta energia essa richieda. Un lavoro permanente. Sotto le sale eleganti della Palta c’è una trattoria che fa ristorazione veloce. Quindi una stratificazione di tradizioni. Esiste una osmosi fra queste realtà? Per noi la trattoria rappresenta una tradizione culturale piuttosto che cucinaria, nel senso che è la nostra storia. Sono stati i primi passi della Palta, che all’inizio era un’osteria con uso cucina, dove si mesceva il vino e gli avventori portavano il cibo da casa. È scritto sui nostri primi biglietti. Poi abbiamo cominciato a preparare qualche piatto caldo, l’inizio di una ristorazione di passaggio. Il battesimo della cucina tradizionale è avvenuto negli anni ‘70 durante il fine settimana, con il menu della festa, cioè i tortelli, gli arrosti misti, la picola di cavallo… L’utilità principale oggi riguarda le forniture, nel senso che la trattoria mi consente di utilizzare prodotti perfettamente freschi al ristorante. Gli avanzi e gli 155 enologica edizione 2010 fin dal 1100, quando è stata codificata. Ma qui a Piacenza mia mamma, al pari di tutti gli altri, la prepara con i fagioli borlotti e il sugo di pomodoro, quando nel 1100 Cristoforo Colombo era di là da venire, non esistevano né pomodori né borlotti ma solo fagioli dell’occhio. Quindi era una zuppa preparata con un soffritto di verdure, i legumi autoctoni e le cotiche, cotti pian piano nell’acqua. Verso la fine si aggiungevano gli gnocchetti di pane, che venivano preparati tali e quali. I fagioli e i pisarei diventavano quasi un tutt’uno, a causa della testura molto morbida. Mentre quando i fagioli vengono aggiunti al pomodoro, a causa dello choc termico che ferma la cottura la buccia si indurisce e diventa un isolante. Non c’è fusione fra i diversi elementi. Qual è allora la tradizione, il piatto di mia madre con il sugo di pomodoro o quello che ho scoperto e riproposto, senza nessuna variazione? scarti possono sempre essere rielaborati, e chi passa per uno spuntino veloce si ritrova nel piatto materie prime eccellenti a prezzi modici. Per esempio al ristorante cuocio un controfiletto a forma di parallelepipedo, e le parature vanno nel sugo o nelle polpette della trattoria. Ci tengo molto perché per me lo spreco è un’indecenza. Non a caso i pisarei si fanno da sempre con il pane raffermo. L’organizzazione fisica dello spazio di cucina è cambiata con il tuo stile? la cucina attuale risale a 5 anni fa, e ha già bisogno di cambiamenti, assolutamente. L’ho allestita per la prima volta a vent’anni, quando ho avuto carta bianca, anche se avevo poca esperienza. Quella di georges Cogny non poteva fungere da modello, perché lui lavorava in una vecchia casa cantoniera, quindi c’era una strettoia, una lingua di 2 metri con i fuochi alle pareti e dietro un banchetto. Però era magica, perché si era fatto mettere le lampade per scaldare appese al soffitto, che in realtà erano quelle per fare crescere i pulcini; le pentoline di rame francesi con i manici di ghisa alle pareti... Il forno era in fondo alla lingua e il pass all’inizio, quindi tutte le volte che bisognava prendere qualcosa era un problema. La cucina di un solista. No, perché tutti potevano andare a lavorare da lui. Ma ci voleva molta organizzazione. In quella cucina ha fatto crescere una scuola di venti alunni. E le tue cucine? La prima era concepita per due persone, perché c’erano ancora mia madre e mio padre. La seconda per tre persone. Adesso siamo in cinque e devo cambiare per forza, perché tre postazioni strategiche non bastano più, finisce che ci si pestano i piedi. Ma non è solo una questione di numeri. C’entra anche la tipologia di cucina. Nella prima non c’era neanche una piastra, la seconda aveva due piastre piccole, adesso c’è una piastra grandissima perché pratichiamo una cucina espressa e abbiamo bisogno di tantissimo spazio per tenere in caldo e cuocere al minuto. Vorrei più spazio per la finitura, la mise en place, un paio di punti di appoggio; e ci occorre un altro forno, perché quello che c’è viene monopolizzato dalla cottura del pane al mattino. Prima non avevamo nemmeno la salamandra, che adesso è indispensabile. Anche se per certi aspetti resto conservatrice, ad esempio non mi piace l’induzione. Io voglio fuoco e fiamme, la padella. All’inizio parlavamo dei gesti. Una cosa importantissima per me sono i gesti piccoli. Meno ti muovi, più sei efficace. Una specie di economia. Mi piace pensare che tutto sia talmente organizzato che posso lavorare senza spostarmi fisicamente, solo con le mani. Serve ad acuire la concentrazione. Stai conducendo ricerche particolari nel solco della tradizione? Vorrei lavorare sui frutti antichi e reinserirli nella cucina, ma è un lavoro difficile perché occorrono lunghe cotture, lunghe maturazioni. Ogni anno a gennaio macelliamo due maiali, la carne va a due norcini per gli insaccati, che vengono asciugati qui e stagionati nella cantina di una vecchia osteria. Tranne il lombo e i filetti per il ristorante. Ho provato a proporre i codini ma la gente 156 Le altre tradizioni ti interessano? Solo se sono radicate nelle mie esperienza. In questo momento ho in carta dei ravioli di porcini con il curry e il latte di cocco. Ma le spezie ci sono sempre state, e il cocco per me è un ricordo del venditore che passava sulla spiaggia in Romagna. Quindi ancora una volta una tradizione autobiografica. “La mano, il desiderio, il genio.” Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia 157 enologica edizione 2010 si impressiona; oggi con queste parti faccio la coppa di testa in varie versioni, con l’Aceto Balsamico, le spezie, le erbe aromatiche oppure affumicata. Il polmone un tempo si usava per fare il riso. Lessato, poi tagliato a pezzettini e ripassato in umido, come condimento. Mio padre lo adorava; è quasi insapore, ma la consistenza spugnosa non è male. Mentre io vado matta per le frittelle e le polpettine di sangue, che non si possono più preparare. Perché la tradizione oggi è scandalo, e anche illegalità. Italo Bassi “Bricolando Tradizioni” Enoteca Pinchiorri Via Ghibellina, 87 - Firenze Tel. 055 242757 - www.enotecapinchiorri.com Nella biga deluxe dell’Enoteca Pinchiorri, a tenere le redini non c’è un auriga ma quattro mani. Quelle di giorgio Pinchiorri ed Annie Féolde, trainati da puledri di razza che puntano dritti verso l’iperuranio. Il platonico cavallo bianco si chiama Riccardo Monco, 38 anni di cristallina riflessività cucinaria, mentre le pulsioni terragne e l’energia primordiale passano per i tendini nervosi e bruni di Italo Bassi. Così, schematizzando, si potrebbe interpretare un percorso che come pochi ha saputo scrostare dal conformismo tradizioni che erano in partenza plurali. Vino e tavola. Francia, Giappone e Italia. Diverse generazioni e filosofie del piacere. Un bel vaccino contro l’ipostasi della museificazione gastronomica in agguato. Ma con Italo non si può che cominciare dal principio. La fattoria di famiglia alle porte di Ravenna che ha covato la sua ruspante passionaccia di cuoco fra faraone che razzolavano in cortile, galline starnazzanti e nuvole di piume in guerra con la forza di gravità. La tradizione è come un respiro che entra ed esce dai piatti: comincia frugando nei cassonetti della storia per innescare un contrasto, e finisce per sbucare fatale come il ritorno di un rimosso freudiano, che lotta nella penombra del subconscio per guadagnarsi la scena. Lo specchio bianco di un collo di gallina farcito. “Sono di origini contadine, nato in Romagna e fiero di esserlo. Vengo da una famiglia numerosa, dove tutto veniva prodotto e lavorato in casa, dal pollame alle carni, ai formaggi. La nonna faceva le caciotte, la ricotta, il mascarpone, lo stracchino… Proprio vicino a Faenza, dove si terrà Enologica”. È quello il luogo della tradizione da cui si dipartono tutte le sue strade. Che sulle orme di Pellegrino artusi lo hanno portato dalla Romagna all’ombra della Cupola del Brunelleschi, nel cuore della koinè da cui partì la costruzione postrisorgimentale dell’identità cucinaria italiana. Che ricordi hai del cibo della tua infanzia? In cucina c’erano mia nonna Rosa e mia mamma Giovanna, Nina per i familiari. Le bocche da sfamare erano 24, quindi c’era quasi un’organizzazione professionale, nel senso che ciascuno aveva dei compiti prestabiliti, come in un ristorante. La nonna e la mamma erano molto esigenti, si svegliavano presto la mattina e lavoravano sodo per la colazione, il pranzo e la cena. La “brigata”, comprese le zie, contava 4 persone. C’era chi andava a raccogliere le verdure, mentre la mamma ad esempio faceva la pasta e i dolci. Approntavano anche un minimo di mise en place in casi eccezionali. Quel che dici è interessante perché storicamente i primi ristoranti femminili sono stati fondati da donne che hanno messo a frutto il background maturato organizzando il rinfresco delle grandi feste contadine. Specialmente 158 Tua nonna cucinava esattamente come tua madre? No, assolutamente. Mia mamma aveva una visione molto più leggera, anche per motivi salutistici, con meno grassi e più profumi, le erbe aromatiche, la salvia, il rosmarino; andava a raccogliere il radicchietto spontaneo nei campi. Mia nonna invece faceva una cucina arcaica, usava molti grassi e si doveva assolutamente utilizzare tutto. A noi piccolini toccava mangiare il collo della gallina, le zampettine, perché la coscia andava al poter familias, al nonno o al babbo. Se devo scegliere preferisco la cucina di mia mamma, la sento più vicina alle mie corde. Ma certe cose le faceva meglio la nonna, ad esempio il pancotto che preparava per me. Solo brodo e pane raffermo, con il Parmigiano alla fine. Già questa diversità di approccio fra generazioni problematizza il concetto di tradizione, e sfata il cliché della cucina femminile come conservazione. Il pesce si mangiava? Il venerdì c’era l’anguilla delle vicine valli di Comacchio. oppure il pesce azzurro, sgombri e vongole. Ma quelli bisognava comprarli. Capitava anche il mercoledì a dire il vero, che era giorno di mercato. Perché a quei tempi a Lugo di Romagna c’era il più grande mercato del nord Italia dove veniva battuta l’asta del bestiame, quindi ci andavano tutti i contadini. Vendevano tori, cavalli, mucche, galline; era una cosa bellissima da vedere. Poi hai deciso di fare l’alberghiero. Sì, a Riolo Terme. Sono stati anni bellissimi, la scuola era agli albori e c’era una gran voglia di fare. I professori erano bravi, ci hanno dato i primi rudimenti tecnici e ci hanno fatto partecipare a tantissime manifestazioni. nel periodo estivo ho cercato in tutte le maniere di introdurmi nelle cucine vere e ho fatto le mie stagioni 159 enologica edizione 2010 le afroamericane negli States. Tu partecipavi? Cercavo di mettere le mani in pasta, di aiutare mia mamma il più possibile, e forse è nata così la mia passione per questo lavoro. Non è che cucinassi veramente però, perché nemmeno adesso mi lasciano troppo fare… anche se a dire il vero io sono nato dopo, in un paesino accanto, più vicino alla città. Però andavo spesso nella fattoria, vi ho trascorso molte vacanze, ho respirato l’aria salutare della campagna e questa grande passione che accomunava un po’ tutti. Mio nonno era il bovaro della famiglia, si svegliava alle 4 di mattina per allattare i vitellini, preparare la stalla e mungere. Tutto veniva fatto in casa, compresi il burro e lo strutto, per cui l’olio di oliva praticamente non si usava, quando l’ho conosciuto avrò avuto 15 anni. La pasticceria di mia madre è a base di strutto, perché quando si ammazzava il maiale non si buttava via nulla, dopo tanti mesi di lavoro. È un bagaglio bellissimo che mi porto dietro, anche se in cucina oggi tendo a fare cose più leggere. E non mi impressiono neppure ripensando alla macellazione, perché allora mi sembrava naturale. Poi il piacere di staccare un pomodoro e mangiarlo, addentare una pesca scaldata dal sole… non c’erano tante varietà, erano quelle stagionali, ma erano talmente buone e abbondanti. per 5 anni al mare. Dopo il diploma mi chiedevo che fare. E casualmente lo IAL di Pinarella di Cervia, che organizzava corsi con grandi giornalisti come Luigi Mantovani, mi ha proposto di frequentare le lezioni, facendo stages in Francia, che ai tempi mi sembrava la Mecca, e in Italia. E visto che Fusignano era abbastanza vicino ad Argenta mi offrii subito di andare al Trigabolo, dove ho avuto la fortuna di conoscere Igles Corelli e la sua brigata. Di lui mi avevano parlato alcuni datori di lavoro bene informati dalle riviste e dai libri. Il Trigabolo mi interessa sotto un duplice profilo. Perché la tradizione era molto presente, seppure in modo peculiare, e perché rappresenta una delle colonne della tradizione della nuova cucina italiana. Penso che Igles Corelli sia stato l’anticipatore di tutta la cucina moderna italiana, era l’espressione più creativa che ci fosse in quel momento, in Italia e in Europa. Neanche il Bulli avrebbe potuto stare al suo passo. Ma c’era anche l’aspetto “tradizionale”, legato soprattutto alla ricerca delle materie prime del territorio, come la selvaggina più o meno nobile, le folaghe, i germani. E c’era la tradizione della pasta fatta in casa, nelle vesti della sfoglina Gianna. Quando sono arrivato sono stato accolto benissimo, perché l’atmosfera era amichevole, anche se durante il lavoro la tensione era forte. Avevo appena 18 anni e non è stato facile, perché per la prima volta ho avuto occasione di lavorare a certi livelli, dovevo ancora capire come funzionava. La cosa che mi ha colpito di più è che non esisteva mise en place; quando iniziava il servizio non c’era niente di pronto, a parte due acque calde per la pasta e le verdure. Servire 20 persone era come servirne 150. Magari si vedeva insieme la partita, poi quando la gente arrivava la turbina si metteva in moto. Il pesce e le verdure erano tutte di giornata e quel che avanzava andava al personale. Anche questo era nuovo per me. Oppure mangiare la cacciagione al sangue, che mi fece assaggiare Igles per la prima volta, mentre io ero scettico. “Adesso la cacciagione sarà sempre al sangue”. Ricordo che facemmo un banchetto presso il Castello Estense di Ferrara, dovevamo preparare una ricetta rinascimentale e pulimmo 100 chili di anguilla viva. Una cosa impressionante, sgusciavano via dappertutto. Cos’è rimasto del Trigabolo nella tua cucina? L’istinto e la spontaneità. Se qualcuno chiedeva qualcosa a Igles, improvvisava e metteva nel piatto delle cose eccezionali, veramente. Quanto tempo sei rimasto? Solo 4 mesi, purtroppo. Non c’era la possibilità di guadagnare e la brigata era già al completo, con Igles, Bruno Barbieri, Marcello Leoni e Mauro Gualandi. Io chiesi di restare ma mi risposero che non era possibile. Allora domandai un suggerimento su dove potevo andare. “Quest’anno siamo stati a mangiare all’Enoteca Pinchiorri e siamo stati benissimo”, fu la risposta. In precedenza avevo fatto il mio stage francese a Chartres, una piccola struttura a 100 chilometri da Parigi. Cominciai a mandare lettere in giro per vedere se c’era la possibilità di lavorare, e il signor Pinchiorri mi chiamò. Lui è di Modena ed è scoccata subito la scintilla. Mi ha preso in simpatia perché ha visto la mia forte determinazione. Tanto che mentre facevo il servizio militare a Firenze la sera lavoravo dalle 17 alle 23. 160 Ricordi una tua innovazione che fu accolta? Il metodo di lavorazione della pasta. Prima si faceva alla francese, si metteva sottovuoto per un giorno prima di lavorarla, certi ravioli erano addirittura precotti. Dal 30 dicembre 1991 è sempre stata preparata e cotta. Impasto fresco, cottura espressa, come al Trigabolo. Poi tutti avevano la possibilità di proporre un piatto, anche l’ultimo arrivato. Io ricordo un gamberone avvolto nella pancetta con zuppa di fagioli e farro, due elementi che erano già in carta separatamente e che ho avuto l’idea di accorpare. Ho fatto tutte le partite, commis alle carni, poi pesci, antipasti e pasta. Nel periodo del militare la pasticceria. Che impressione ti ha fatto l’Enoteca rispetto al Trigabolo? Mi ha messo in soggezione. Era una maison importante, c’era una grande brigata, molto più organizzata del Trigabolo, che aveva qualcosa di famigliare, ci si dava del tu. Qui invece c’erano gerarchie ben precise che andavano rispettate. La prima cosa che mi impressionò fu l’efficienza dei giapponesi al lavoro. E poi l’organizzazione in partite. La clientela internazionale. La scoperta del vino. Il signor Pinchiorri ha sempre fatto assaggiare i vini a tutti i dipendenti. Dopo Rosa e Nina, un’altra cucina femminile, quella della signora Féolde. Le materie prime com’erano, rispetto a quelle fra le quali eri cresciuto in campagna? Fantastiche ma diverse. Perché quelle di casa le raccoglievamo di persona, erano più spontanee, mentre qui era tutto organizzato, con gli ordini, i fornitori, vari passaggi di mani. La Féolde all’inizio arrivava con la macchina carica di prodotti francesi, ma mi ha insegnato anche l’olio di oliva, l’ingrediente che se dovessi scegliere, porterei con me su un’isola diversa. Col tempo ho trasmesso il mio background anche qui, quindi il discorso è un po’ cambiato. Una patata doveva essere una patata, buona, bella, uniforme. Quanti anni hai trascorso all’Enoteca? In tutto 21, più di metà della mia vita. Ma dopo il militare ho deciso di fare altre esperienze in Francia. Sono stato in stage da Chibois a Cannes, poi potevo andare da Franck Cerutti, quindi ho sfiorato Ducasse. In Italia mi sono fermato a Piacenza all’Antica Osteria del Teatro. Gente bellissima cui mi sento molto legato, nella mia Emilia-Romagna. Finché non è arrivata la proposta di lavorare nell’Enoteca in Giappone, alla fine del ’91. Sono rimasto un anno, e poi non mi sono più mosso da Firenze. Una pausa che mi è stata utile per ritrovarmi ancora più a casa. Il Giappone aveva già incuriosito i fratelli Troisgrois, ma la seconda ondata di japonisme, quella di Ferran Adrià, non era ancora partita. Che effetto ti ha fatto la cucina nipponica? In quel periodo per noi era quasi sconosciuta; la stessa apertura dell’Enoteca è stata pionieristica perché ai tempi a Tokyo c’era solo 161 enologica edizione 2010 avrei voluto girare, pensavo di trovarmi sulla casella di partenza, e invece ho iniziato ad avere le mie prime mansioni di responsabilità. la Tour d’Argent. Mi piaceva tantissimo il cibo di strada, che secondo me è il più popolare e il più tradizionale. Mi sconvolgevano la freschezza e la presentazione dei prodotti. L’impiattato al Trigabolo era molto interessante, geometrico, anche perché la compagna di Igles era una pittrice e lui si ispirava alle sue opere. In giappone, a parte i piatti bellissimi, anche quadrati quando da noi erano tutti rotondi, mi hanno colpito la tridimensionalità delle portate; nel sashimi per esempio il pesce aveva la coda verso l’alto, con la guarnizione, la fogliolina di verde accanto al daikon bianco, gli spazi vuoti. Un’estetica che per loro era naturale, ma per noi rappresentava un oggetto di studio. Di solito all’estero la cucina si etnicizza, ad esempio la proposta dei ristoranti italiani diventa più conservatrice, tende a museificarsi. La vostra è cambiata? No, è rimasta la stessa ma con uno studio sui prodotti locali. Se ad esempio il branzino non c’era, andavamo alla ricerca del pescato locale che gli somigliava di più. Si evitavano certi prodotti, perché all’inizio non si trovavano tutti i formaggi italiani. Era una specie di traduzione. Persino il sale era diverso. Poi col boom economico è arrivato di tutto. Questa esperienza come ti ha influenzato rientrando a Firenze? Quando sono tornato anche l’Enoteca era cambiata, perché c’era stato Carlo Cracco, che aveva organizzato molto rigorosamente la brigata. Quando lui è partito, sono stato catapultato sul proscenio, con tante difficoltà. Ero giovanissimo, l’ultimo arrivato, avevo pochissima esperienza e mi hanno messo al vertice. I collaboratori si sono scremati da soli. L’unico che è rimasto è stato Riccardo, che era già bravissimo, perché veniva da una grande casa francese. Ero impressionato da lui, mi sembrava che fosse molto più bravo di me. Mi raccontava della grande Francia, che era il mio mito. Ma il Giappone mi è rimasto dentro, cosa che ho espresso piano piano, nel tempo. Le cotture leggere, l’estetica della presentazione, le consistenze, certe attrezzature, il modo di sfilettare e tagliare i pesci che mi avevano insegnato i cuochi giapponesi a Tokyo. Per me era così straordinario che la mattina presto anziché dormire andavo al mercato del pesce. Una sorpresa continua. Come è maturato il tuo stile a Firenze? C’è voluto un po’ di tempo, prima di tutto la tranquillità. Dopo l’incendio l’atmosfera era poco serena, era difficile esprimersi creativamente. Anche perché all’inizio lavoravamo quasi solo per ristabilire la cantina. Avevamo appena conquistato la terza stella e la perdemmo nel ’94. È seguito un grande lavoro di consapevolezza. Il signor Pinchiorri e la signora Féolde ci hanno trasmesso una grande fiducia ed è cominciata la risalita. E nei piatti? la cucina all’inizio era più semplice; c’è stata una ricerca attenta sulle attrezzature e sulle tecniche. Di pari passo abbiamo approfondito la selezione delle materie prime, soprattutto piccoli produttori e ingredienti di nicchia. Il cliente deve avere la sensazione dell’unicità, come accade con determinati vini, che solo qui è sicuro di poter bere. Penso al cochinillo iberico, che abbiamo sostituito con un 162 Tu che sei nipote di un bovaro, che manzo hai scelto? È stato difficile trovarlo, perché qui a Firenze è un’istituzione. Ma noi in gruppo abbiamo optato per la razza piemontese, né chianina né romagnola, prendendo in considerazione il tipo di allevamento, l’alimentazione e anche la macellazione. Dall’Emilia-Romagna faccio arrivare il Parmigiano Reggiano, l’Aceto Balsamico Tradizionale, il formaggio di fossa, la frutta che conosco, quando posso. Il resto è difficile procacciarselo. Quali ricette hai scelto di portare ad Enologica? Come cavallo di battaglia il doppio raviolo farcito con stracotto di faraona e burrata, condito con salsa di Parmigiano, sugo d’arrosto e timo. Risale al 2004, appena presa la terza stella, e contiene tanti simbolismi. Per me lo stracotto di faraona ha un valore particolare perché a casa mia era il piatto della domenica, e la carne doveva essere letteralmente stracotta. Il doppio ripieno rappresenta me e Riccardo, i due approcci: il suo più delicato e fantasioso, e il mio un po’ più rustico e territoriale. Le due farce, dentro un unico raviolo, restano separate; solo addentando si amalgamano. Credo che nessuno ci avesse mai pensato prima. È un po’ la doppia cifra dell’Enoteca, questo sdoppiarsi con Riccardo, amico e collaboratore da sempre. Lavoriamo all’unisono con mentalità diverse. Una “coppia di fatto” che professionalmente funziona. E il secondo piatto? Un piatto della memoria, la minestrina di risoni in brodo di cappone. Si mangiava la domenica e mia nonna per rendermela più gradita ci metteva sempre un uovo sbattuto, un po’ di pancetta e del Parmigiano. Dell’originale restano il gusto e l’emozione, ma l’ho alleggerita e rivista nella tecnica di cottura, perché viene risottata e mantecata sempre con tuorlo, pancetta e un pepe giamaicano dai profumi particolarissimi di chiodo di garofano e cannella. Il gioco è anche aromatizzare un piatto nostro con una spezia esotica, che regala un tocco sensoriale fuori del comune, suscitando un effetto di straniamento. Perché secondo me il modo giusto di mangiare, dopo avere guardato, parte sempre dall’olfatto, che recupera la sua funzione nutriceutica. E poi c’è l’assaggio. In questo forse rientra in gioco il mio background contadino. L’enorme enciclopedia olfattiva nella quale mi sono mosso da bambino, nutrita di tutte le suggestioni archiviate in seguito, che possono riaffiorare all’improvviso. Sono spunti che prima incamero e poi esterno. Si toccano nel mio cervello e succede qualcosa. La tua tradizione assomiglia a un bricolage. Sono molto curioso. Quando vado all’estero cerco di mangiare sempre il cibo del luogo, quello più verace 163 enologica edizione 2010 maialino emiliano di razza mora romagnola, allevato appositamente per noi. L’allevatore controlla come si alimenta per I-phone. Quindi più tecnica e più campagna, cosa che mi ha consentito di rispolverare il mio background contadino. Nella tradizione di domani vedo l’innovazione di oggi, soprattutto sotto il profilo del prodotto biologico, che per me poi è mio nonno, biologico ante litteram. e popolare. Poi è chiaro che tornando a casa mia madre sa già che deve prepararmi i passatelli in brodo. Gli spaghetti con le cozze fritte e lo stracotto di coniglio sono nati leggendo un libro di cucina romana con Riccardo. Sentire un profumo, vedere un quadro: i ricordi sensoriali si combinano in modo creativo, perché sono un cuoco istintivo, come Igles. Esistono piatti intoccabili? no, le ricette classiche vanno conosciute, poi si possono sempre rielaborare. Quando un piatto è perfetto è il momento giusto per cambiarlo, nel senso che se piace a tutti vuol dire che ha perso la sua spinta propulsiva. È questa la linea mia e di Riccardo. Altrimenti ci si rinchiude nella staticità del repertorio. Ci sono aspetti sui quali ti senti conservatore? La costruzione del menu, che parte sempre da due antipasti di pesce, uno freddo e l’altro caldo; a seguire ci sono le paste, di cui una ripiena, e le carni. Mi sembra uno schema valido in particolare per la degustazione dei vini. Per quanto riguarda le ricette, il brodo di cappone lo preparo come faceva mia nonna, senza assolutamente sgrassarlo. Perché è insuperabile, come il pancotto. Mentre di mia mamma non dimenticherò mai i sughetti di mosto di trebbiano con l’anice, la farina e il pangrattato, preparati al momento della vendemmia. O i sabadoni, ravioli di pastafrolla allo strutto ripieni di castagne e fagioli. Sapori troppo etnici per l’Enoteca. tradizionale ma molto innovativo, per l’utilizzo di una parte di scarto. La tecnica è un po’ diversa da quella di mia nonna. Si tratta di galletti di razza autoctona del Valdarno che hanno la pelle molto sottile, quindi bisogna essere delicatissimi. I colli vengono farciti e cotti a bassa temperatura; poi finiscono sotto una salamandra dolcissima per sciogliere il grasso sottopelle, in modo da ottenere un risultato succulento. Ma se la pelle non fosse così sottile, sarebbero troppo rustici e pesanti. Oggi i clienti cercano gusti intensi, i piatti della memoria come questo. La tradizione del vino e quella della cucina sembrano avanzare a ritmi diversi. Vinum non facit saltus, si potrebbe chiosare. Tutto questo può suscitare un effetto di aritmia in tavola? Forse per questo alla fine il signor Pinchiorri ha acconsentito ad abbinare i nostri piatti con bevande diverse, come la birra, il sakè o i cocktail. Uscire dalla soggezione nei confronti del vino, per cui chi veniva in via Ghibellina lo faceva solo per stappare determinate bottiglie, è sempre stato un grosso problema. Perché è più facile decantare un grande Brunello che creare un piatto indimenticabile. Un piatto su cui stai lavorando? Mi viene in mente il collo di galletto farcito su una zuppa di lenticchie con trombette della morte fritte. Un piatto 164 Massimo Bottura “Il doppio cervello della tradizione” Massimo Bottura. Non è facile tenere il passo degli attraversamenti di colui che si è imposto a livello internazionale come il primo cuoco italiano. Attraversamenti spaziali. Attraversamenti temporali. Attraversamenti disciplinari. Attraversamenti espressivi, dall’elegia al concetto, alla schiarita ironica dopo lo sturm und drang delle emozioni. Un nomadismo stanziale, tanto si è fatto casa nella sua consuetudine al patchwork, senza mai divellere le proprie radici dal centro medioevale di Modena. Quel civico 22 di via Stella dove ha saputo diventare se stesso. Le peregrinazioni fisiche, dalle pagode asiatiche agli skyline newyorkesi, sono l’emergenza di una fibrillazione permanente. Energia che elettrifica i piatti fino a farsi dialogo di tradizioni: filo rosso di una miriade di piatti, viaggi intorno al mondo cucinario di un Jules Verne con la toque e gli occhialini. cucina attuale, estrema nell’ebbrezza quanto nel senno scrupoloso. Sono piatti che seducono con una doppia andatura, quella che fece scrivere a nietzsche che “una cultura superiore deve dare all’uomo un doppio cervello, qualcosa come due camere cerebrali, una per sentirci la scienza, un’altra per sentirci la non-scienza; che stiano una accanto all’altra, senza confusione, separate, isolabili: è questa un’esigenza di salute. /…/ Con illusioni, unilateralità e passioni bisogna riscaldare; con l’aiuto della scienza conoscitiva bisogna prevenire le cattive e pericolose conseguenze di un surriscaldamento”. Slanci artistici e provette. Schifano e la metilcellulosa. Il “grande stile” di cui parla il filosofo tedesco, ibridazione di istanze contrapposte sotto la regia di un’ottica binoculare, che sottopone l’arte alla scienza e la scienza all’arte, bombarda caldo e freddo in una doccia scozzese che non rinuncia alla passione né alla riflessività. Massimo Bottura è tante cose. L’amore proustiano per le croste di lasagna che correva ad agguantare da bambino, ma anche l’esattezza (calviniana e calvinista) con cui governa le trasformazioni della materia. Poeta e scienziato. L’incarnazione esemplare delle istanze bicefale che sembrano governare la l’incandescenza della tradizione, cui il fumo che leva le sue volute dal piatto regala una metafora calzante, è mitigata dal gioco metalinguistico, che ne fa materia prima per formule di secondo grado. Esercizi di stile che avanzano un surplus di identità e di riflessione. Ben oltre le soglie della destrutturazione e delle 165 enologica edizione 2010 Osteria Francescana Via Stella, 22 41121 Modena Tel +39 059 210118 - www.osteriafrancescana.it enigmistiche cucinarie. Ovvero schivando quella tradizione d’avanguardia che tanto facilmente assume lineamenti d’accademia. Nessuno meglio di Massimo Bottura sa assorbire e rilanciare la sfida della tradizione con un movimento freudiano di fort-da, avvicinamenti e allontanamenti di un rocchetto instancabile nella pulsione del gioco. Perché “l’uomo alla fine non trova null’altro nelle cose se non quello che egli stesso vi ha nascosto dentro: il ritrovare si chiama scienza, il nascondere dentro – arte, religione, amore, orgoglio”. la tradizione e la scienza si spartiscono il piatto di un’esperienza integrale. “Le mani sapienti.” Prosciutto di Parma 166 Pier Giorgio Parini “Fisiognomica della tradizione” Premiatissimo. Il 2010 è un anno da incorniciare e appendere al muro per il trentatreenne Pier giorgio Parini, nello spazio ormai angusto fra il premio per la creatività del Gambero Rosso e quello per il miglior giovane cuoco da parte dell’Espresso. Un successo maturato piano piano e lontano dalla ribalta, spontaneo come un tartufo e umbratile come i tesori del bosco che fanno la cifra della sua cucina. Finché qualcuno passando ha alzato per caso il sopracciglio e lo ha infilato nel paniere delle celebrità. Tutto è cambiato eppure nulla è cambiato, davanti al camino dove scoppietta il fuoco e si preparano le braci per le caldarroste a fine serata. Perché la fiamma sale dritta e senza scosse. Snella come il fuoco che per Bachelard rappresenta la rêverie di saggi e santi. Impassibile. Pier Giorgio, il patron Fausto Fratti e la consorte Stefania non si scompongono di fronte ai vagiti di una nuova fase. Ne parlano con Piero Meldini, già firma della “Gola” e romanziere, al loro fianco fin dagli anni delle ricerche storiche, grazie alle quali il Povero Diavolo iniziò a smarcarsi dalle notarili trattorie della zona. Una cucina archeologica piuttosto che dearcheologizzata. Le tradizioni come carote geologiche dove affondare bisturi, vanghe e forchette. Enologica sarà il palcoscenico per una singolare prosopopea. Ingredienti che parlano di una tradizione tutta personale, giacché Pier Giorgio, d’accordo con le recenti acquisizioni dell’antropologia culturale, ha deciso di destrutturare una nozione troppo spesso abusata a fini ideologici, per dimostrare che non esiste tradizione al di fuori della elaborazione che ne distilla ciascuno di noi. Utilizzando due ingredienti, il rognone e il fumo, tutt’altro che comuni da queste parti, in modo da distanziare le diverse equazioni e arrivare a un tessuto di metafore meno evidenti. Mentre il piatto del ristorante bricola la tecnica monocroma con quella del trompe-l’oeil, nascondendo l’evocazione di un filare di cipressi nelle sembianze vagamente ospedaliere di un riso in bianco immacolato. Contraddizione fra visivo e gustativo, complessità concettuale e tecniche luddiste, per un piatto che come ogni altro testo - insegna la semiotica di Umberto Eco - è capace di mentire. Vi è piaciuta la frase di Eliot? Meldini - È molto bella, anche se va contestualizzata. Nel senso che è stata scritta per la letteratura, che è qualcosa di diverso dalla cucina. Eliot probabilmente si riferiva al rapporto che c’era a quel tempo fra le avanguardie letterarie e la tradizione shakespeariana, un patrimonio difficile da possedere. Trasferendo la citazione in ambito gastronomico, io la intendo così: di non seguire pedissequamente la tradizione, 167 enologica edizione 2010 Ristorante Il Povero Diavolo Via Roma, 30 - Torriana Rimini Tel +39 0541 675060 - www.ristorantepoverodiavolo.com rispolverando i vecchi ricettari o facendo magari ricerca sul campo. Occorre piuttosto capire il sistema di sapori di un determinato territorio. La frase va calata nel contesto italiano, la cui ricchezza sta nel “mangiare geografico” (l’espressione è di Jean-Robert Pitte). Più di altri paesi, l’Italia dà l’opportunità di alimentarsi diversamente secondo i luoghi, grazie a microtradizioni di carattere municipale, più che regionale. Non si può parlare della cucina emiliano-romagnola, quando è già difficile circoscrivere la cucina romagnola tout court. Prendiamo la Valmarecchia, dove ci troviamo. Non ha un’unica cucina, ma almeno tre: nella bassa Valmarecchia la cucina è fondamentalmente romagnolo-riminese; nella media si mangia “marchignolo”, un ibrido fra la cucina romagnola e quella marchigiana pesarese; in alta Valmarecchia poi si pratica una cucina essenzialmente toscana. Questa è la ricchezza dell’Italia. Secondo me la cucina dovrebbe mantenere questi tratti di identità locale, non nel senso pedissequo di continuare a proporre i vecchi piatti o, peggio ancora, di “rivisitarli”, cioè riscriverli in bella eliminando le punte caratterizzanti, fino al sommo equivoco della destrutturazione, che è affascinante quanto una poesia ridotta all’elenco delle sue parole. La conquista della tradizione consiste piuttosto nel capire il sistema di sapori di un determinato territorio. Una cosa molto diversa dall’invenzione della tradizione. Si tratta di materie prime? M - C’è un problema di prodotti, in primo luogo, quindi una cucina di mercato o di raccolta degli ingredienti selvatici, che appartiene alla nostra tradizione. Si pensi alle misticanze. Se lasciavi mia mamma in un campo, quando ne usciva era come se ci fosse passato un gregge di pecore. Si era portata via tutto, fra le erbe che si lessano, quelle da insalata, quelle da sugo… Fausto - Donne così non ne esistono più in campagna. Ma era una cultura vera, sana. M - Adesso queste conoscenze si stanno in parte riformando. Ci sono associazioni come “I Radécc” che le stanno recuperando. Ma il sistema di sapori oltrepassa i prodotti. È un lavoro di tipo individuale, ogni chef ha la sua risposta individuale alla domanda sui rapporti fra i sapori in un determinato territorio. Grignaffini sostiene che semioticamente il tratto che meglio descrive l’identità emiliana è la continuità, anche a tavola. Si può individuare un’isotopia di questo genere in Romagna? M - La lettura di Grignaffini è corretta, anche se sottovaluta la frattura fra l’Emilia dei ducati e l’Emilia delle legazioni, cioè Bologna. Quanto poi alla Romagna, la sua identità gastronomica è fondamentalmente contadina. È in sostanza una cucina di terra; l’influenza del mare si esercitava solo sulla costa, e neppure nella sua totalità. Un tempo il pesce si mangiava soltanto il venerdì. Praticamente non esisteva una cultura del pesce. Bastava percorrere qualche chilometro verso l’interno e spariva. Rimini è una città in cui si coniugano maggiormente la cultura della terra e del mare. Gli ortolani erano la linea immediatamente successiva al bagnasciuga. Anche tu, Pier Giorgio, ti sei sentito coinvolto dalla frase di Eliot? Parini - Sì. Il mio pensiero è stato vicino a quello di Piero. 168 legati al mio vissuto. Sono convivialità, schiettezza, intraprendenza e sarcasmo. Questo secondo me è il romagnolo. Ad Enologica verrà distribuito un diagramma che ognuno potrà compilare, in modo da enucleare i tratti distintivi della sua tradizione, le corrispondenze con gli ingredienti e il piatto che ne deriva. M - In questi quattro caratteri vedrei un po’ lo stereotipo del romagnolo. È una mezza caricatura, ma il romagnolo è il primo a credere al proprio stereotipo. Il cliché si è formato nell’ambito del positivismo, ad opera di antropologi e criminologi come Ferrero, Ferri, Lombroso, Garofalo, in un periodo in cui era particolarmente forte la criminalità. Da un lato i romagnoli sarebbero teste calde, rissosi, ribelli, settari e mangiapreti, dall’altro cavallereschi, cortesi e gioviali. Chi ha letto Cuore, il racconto mensile Sangue romagnolo, ricorderà il ragazzino teppista, che quando la nonna viene aggredita si fa ammazzare per difenderla. Nel cliché del romagnolo rientra anche l’ingordigia di cibo, la scorpacciata da schiattare. I romagnoli, in effetti, partono dall’assunto che se la qualità è opinabile, la quantità non lo è. Quindi non puoi servigli un piattino di tagliatelle, ma gliene devi offrire una montagna. L’altra cosa è la ripetitività. Il romagnolo fondamentalmente vuole sempre lo stesso piatto. E il terzo elemento è il prezzo stracciato. Com’è la tua Romagna? Quindi fare un buon ristorante qui è un’impresa disperata. P - Alla fine tutto si riduce a un gioco. Ho fatto un piccolo schema a partire da 4 caratteri, strettamente M - Da suicidio, è l’idea più idiota che si possa avere. Essendo stato generalmente accontentato sulla ripetizione 169 enologica edizione 2010 Parlando di tradizione, molte persone hanno un’idea immobile, statica, passiva. Ma questo approccio non mi interessa; ho cercato di tracciare un’altra strada, pensando alla tradizione come un’entità, una persona, dandole ossa, capelli, mani, piedi. Se io avessi la Tradizione seduta al mio fianco, sarebbe interessante confrontarsi con lei. Poi chiedersi: Perché mi dici queste cose? La risposta che mi sono dato è che la Tradizione come entità può subire modifiche a seconda del luogo e del percorso compiuto. Quindi le ho conferito tratti distintivi che alla fine sono miei, quelli che io penso identifichino questa terra. Ho cercato gli aggettivi giusti e ho parlato con diverse persone, per verificare se la mia idea poteva corrispondere a un sentire comune. Partendo da questa fisiognomica si può arrivare a creare un piatto, che non è detto sia tradizionale in senso stretto. Si tratta di un’operazione soggettiva, perché a prescindere dai prodotti ognuno di noi ha ricevuto stimoli che hanno influenzato il suo concetto personale. I miei genitori per esempio sono nati in due paesi che distano 10 chilometri l’uno dall’altro, a Gambettola e a Longiano. Ma a casa di mia mamma si facevano cose che mio babbo non aveva mai visto né sentito. Possibile che in un ambito così ristretto ci fossero differenze così grandi? Poi le tradizioni con il matrimonio e il trasloco a San Mauro si sono mescolate creando un microcosmo unico che ci è stato tramandato, e io a mia volta l’ho modificato. e sulle quantità, il romagnolo è convinto che qui si mangi sempre bene; ne è convinto a tal punto che lo ha fatto credere anche agli altri. Tra riviera ed entroterra i locali sono migliaia e, quanto meno, garantiscono un buon rapporto qualità-prezzo, in genere migliore che altrove. F - Il Povero Diavolo non si regge sulla clientela romagnola, ma su gente che arriva da fuori. Poi c’è anche il gourmet romagnolo, ma è raro e di solito gira per tutti i locali importanti. Perché la nostra ristorazione sta vivendo un periodo d’oro, c’è fermento. Ma il riminese medio fa fatica. Stefania. Io la vedo così. La nostra ristorazione è stata fondata dalle ‘zdore, che dalle campagne sono andate al mare per mettere su chioschi, pensioni, alberghi, ristoranti, gestendoli in prima persona. Tutte attività a gestione famigliare che proponevano una cucina di casa. I romagnoli in questo modo hanno conosciuto una ristorazione improntata alla cucina di casa, e sentono quella professionale come aliena, distante, altezzosa. Il piatto della mamma è sempre più buono, e se ne è fatta un’industria che funziona. Anche se sono spariti i suoi fondamenti, perché è scomparsa la gestione famigliare, è rimasto questo retaggio nella forma mentis della gente. Che al ristorante vuole sentirsi rassicurata e mangiare le stesse cose che prepara in casa. F - Per poi dire: Ma le tagliatelle di mia mamma sono più buone… P - È vero, la tradizione “conquistata” è questa: la mamma che cucina meglio, la quantità… Ma la tradizione che voglio conquistare è un’altra: sono i miei 4 punti. La convivialità si spiega da sola. L’intraprendenza, perché all’inizio ho lavorato in un albergo a conduzione famigliare, e la cuoca era la mamma. Si svegliava, faceva la pasta, faceva il ragù. Come mia mamma. In questo modo dal nulla sono nate tante strutture. Le gente si è data da fare, non solo in cucina. Poi però si è fermata. Adesso occorre un’altra intraprendenza per crescere. Bisogna fare cose diverse perché il mondo cambia e la tradizione con lui. Mentre noi siamo rimasti al palo. La schiettezza, a questo punto. P - Significa sapori facili, riconoscibili, una caratteristica della mia cucina. E poi il sarcasmo, che collego a mio nonno. Ricordo che mi portava spesso al bar, quando ancora si fumava, si giocava a carte, si buttavano i lupini per terra, non si usava il posacenere. Magari arrivava qualcuno che non si era visto per un po’ e gli diceva: Non sei ancora morto? Quindi piatti ironici, a doppio taglio. M - Il nostro è un umorismo aggressivo che può diventare distruttivo. Prendiamo la nozione di “pataca” e “patacata”, che secondo Fellini ha 3000 significati. Uno dice: Sono andato al Povero Diavolo. – E cosa hai mangiato? – Delle patacate! P - Quello che ho cercato di fare in un secondo momento è stato tradurre ogni tratto distintivo in un diverso ingrediente. Secondo me il più sarcastico è il rognone, perché se lo ami è buonissimo, ma per tutti gli altri è quasi un dispetto. Ho legato l’intraprendenza alla terra, quindi alle verdure, pensando un po’ anche a mio padre. La convivialità è il fumo, per via del ricordo del bar dove tutti si trovavano. E la schiettezza è il tassello mancante. Un ingrediente che sta bene con tutti, ma da solo è già importante. Potrebbe essere il prosciutto, oppure un 170 Ma il rognone a casa tua si mangiava? P - Solo mio padre. Io provavo a mangiarlo, ma ho dovuto aspettare che il mio palato maturasse. P - Mi sembra una tecnica di creatività geniale. Io non so come facciano gli altri cuochi, ma l’idea di costruire un piatto a partire dai ricordi, dalle proprie esperienze personali, l’infanzia, il nonno al bar, il babbo che insegna a lavorare la terra… E il piatto del ristorante? P - Credo che porteremo il riso in bianco. F - È un piatto sconvolgente, anche se io sono di parte. Poi è versatile, perché può essere preparato con ingredienti diversi, adeguandolo alla stagionalità. Prima era a base di distillato di pomodoro, perché era estate, ora è fatto in un altro modo perché è arrivato l’autunno. Oltre che buono, è giocoso. M - È un piatto in controtendenza, perché è un lavoro di sottrazione, quando di solito il principio è l’aggiunta. Vengo dalla letteratura e so benissimo che qualsiasi cosa non sia stata scritta, non può essere sbagliata. Io lo chiamo “metodo Ford”. Quando veniva accusato di fare macchine troppo spartane, Ford rispondeva: Quello che non c’è non si rompe. La scrittura è l’arte del togliere. Un piatto marchesiano, quindi. P - Perché no. Si tratta di Rosa Marchetti, un antico riso della Lomellina semifino, semintegrale, completo di germe. Mi è piaciuto subito perché ogni chicco cuoce in modo diverso, addirittura ogni pacchetto riporta un tempo di cottura diverso. Il concetto è togliere il più possibile partendo dal colore, in modo da smentire l’aspettativa di un sapore scarso con un effetto di sorpresa. Il gusto, oltre che dal riso, viene dato dal cipresso, che rievoca la legna, il balsamico, sia al naso che al palato. È un’estrazione dalle foglie, per infusione nell’acqua di cottura, e dalla pigna, che viene spezzettata e coperta di burro, in modo che il grasso in mantecatura veicoli i profumi. Ci vedo un po’ di sarcasmo. La schiettezza invece sicuramente no. Le vostre ricerche sulla cucina storica, nei primi anni del locale, vi sono state utili per sviluppare un concetto così evoluto di tradizione? M - In quegli anni abbiamo compiuto un lavoro prezioso volto al recupero della tradizione del Montefeltro, un’area che appartiene a 4 province e 3 regioni. È una cucina di confine, capace di sommare e contaminare diversi sistemi di sapori, con una forte vocazione conservativa. A Pennabilli, molti anni fa, ho assaggiato in una casa privata un piatto di tagliatelle al cioccolato citate in un diario settecentesco. Sulla base delle ricerche compiute sono stati ripresi o inventati una serie di piatti che rispondevano sostanzialmente a quel sistema di sapori. Però bisogna chiarire che quando parliamo di tradizione, ci troviamo di fronte a un bivio. I ristoranti che servono i menufotocopia hanno selezionato i pochissimi piatti delle feste solenni, come il pranzo delle nozze, espungendo tutti i piatti della vera tradizione, quella quotidiana: le zuppe, 171 enologica edizione 2010 grande formaggio… Alla fine il rognone sarà affumicato, con una parte terrosa. le minestre, gli ingredienti selvatici - ciò cui ha sempre mirato la nostra azione di recupero. Tanto che il Povero Diavolo si distingueva già allora dai ristoranti dozzinali. Ma le fasi di questo esperimento sono state influenzate anche da chi c’era ai fornelli, prima le cuoche, poi gli chef. A una cuoca non puoi chiedere qualsiasi cosa, devi collegarti al suo sistema di sapori. F - Con Piero abbiamo ripreso un piatto storico, la faraona con le mandorle. L’abbiamo fatta l’8 settembre in Toscana e Pier giorgio l’ha un po’ rivista tecnicamente. M - Non bisogna neppure cadere nell’equivoco che la cucina femminile sia ripetizione pura. Qualsiasi famiglia vanta preparazioni tutte sue, che non si sa da dove siano arrivate. E nelle case si creava. Ogni buona massaia inventava qualche piatto, o lo “importava” da chissà dove. Mia madre non aveva alcuna tendenza a innovare, al pari di mia nonna, che era nata intorno al 1870. Eppure la nostra tavola era in parte diversa da quella dei vicini. Ricordo uno stoccafisso cosiddetto “all’anconetana”, che era buonissimo. Per preparare i cappelletti a casa mia, come nella maggior parte delle case di Rimini, si utilizzava uno stampino. Tutti pensano che sia un’innovazione recente, mentre in realtà un “ferro de cappelletti” è già attestato in un documento del Quattrocento. Quindi non serviva a velocizzare, ma a garantire un esito regolare, uniformando lo spessore della pasta. F - Noi chiudiamo i cappelletti a mano, a mo’ di tortellino, come ha iniziato a fare la nostra prima cuoca, Loredana. Ma personalmente preferisco quelli fatti con il ferro. Perché il ripieno è più buono della pasta, quindi la sfoglia deve essere sottilissima e il cerchietto praticamente identico alla noce di farcia. Da goloso quando mi capita ne mangio un tot anche a crudo. M - I dolci locali si contano sulle dita di una mano: la zambèla, il fiuchét, cioè le frappe, le castagnole, la zuppa inglese... E soprattutto le cantarelle. Nel periodo dell’olio appena franto nelle case dei contadini si preparavano crespelle di farina di frumento mista a farina gialla ed acqua, che venivano cotte sul testo e impilate. Si cospargevano di olio nuovo e zucchero, e quella in basso era la migliore perché raccoglieva il condimento. P - Mio padre è cintura nera di cantarelle. Il pancake di Romagna. M - Per cuocerle si usava, oltre al testo, la piastra della cucina economica. L’abbandono di questo strumento di cottura è stato una perdita secca: che attrezzo era! Sulla piastra superiore si potevano portare avanti cotture dolcissime, il forno era strepitoso e il cassettone di sotto fungeva da scaldavivande. Oppure ci si infilavano i piedi per scaldarsi. Le braci, alla fine, servivano per riscaldare il letto, e la cenere per ammollare i ceci. P - Mia mamma l’ha recuperata. E in giro ogni tanto si vede di nuovo. M - Le poveracce aperte sulla piastra erano squisite. Il poco liquido che usciva sfrigolava appena e si mangiavano calde al naturale, come quelle cotte al testo. Gli antropologi sostengono che ogni comunità per differenziarsi dalle altre elegge un alimento considerato universalmente incommestibile. Penso ai fagioli fermentati giapponesi o al peperoncino in Calabria. Esiste qualcosa di simile in Romagna? M - Direi le “pissotte”, il cui nome scientifico è non a caso mactra 172 La cucina romagnola è salata? F - Abbastanza. Lo rivela anche il lessico, perché di una persona stupida diciamo che è sciàp, cioè senza sale. Nelle case una volta c’era l’aringa appesa e se il figlio strofinava due volte la piadina il padre gli diceva: T’vò sc-iupè? (Vuoi scoppiare?) Eccolo qua il sarcasmo romagnolo. “Sulle spalle dei giganti.” Parmigiano-Reggiano 173 enologica edizione 2010 stultorum. Una conchiglia grossa e insapore. Oppure le “sponze”, in lingua italiana uovo di mare o tartufo di mare. All’aspetto ricorda una spugna, o meglio un grosso ciottolo di pietra pomice. Il guscio, di consistenza gommosa, va tagliato in due: si scopre allora una cavità cilindrica giallo vivo striato di rosso in cui una creatura primordiale emana violente zaffate di salmastro, jodio e acido fenico. Io, che pure da bambino ero inappetente e quasi anoressico, fino ai sette-otto anni sono cresciuto a ostriche e sponze. A me piacevano moltissimo. Nella cucina di terra l’equivalente è l’“andrugolo” o bartolaccio, un insaccato confezionato con le parti meno nobili e tutti i resti del maiale. Veniva servito soprattutto nelle osterie, perché, essendo molto salato, faceva vendere più vino. Paolo e Luca Raschi “Una cosmogonia da camera” Ristorante Guido Lungomare Spadazzi, 12 - Rimini Tel +39 0541 374612 - www.ristoranteguido.it Paolo e Luca Raschi sono doppelgaenger perfetti. Affiatati è dire poco per due fratelli che sembrano procedere con sincronismo perfetto nella lenta scalata verso le vette della ristorazione, regionale e non solo. Schivo e riflessivo il primo, cadenzato dallo stesso metronomo che regola inflessibile la misura dei suoi piatti; mentre Luca, maître e sommelier, rovescia il guanto svelando trame di ricami tutt’altro che banali con un eloquio avvolgente e finemente vernacolare. Leggermente alcolico nel calore dell’abbinamento che moltiplica, mette a fuoco, incapsula sensazioni già nitide. Davanti lo scenario di una liberazione: la spiaggia di Miramare in ottobre si offre allo sguardo selvaggia, fulva per l’umidità che impregna l’aria, sterminata da quando il condominio popolare degli ombrelloni è finito nelle soffitte dei bagnini. Sembra quasi di vedere il nonno guido guiducci, che nel 1946 inaugura il suo pionieristico capanno, con la nonna ai fornelli per capannelli di ghiotti turisti americani; le scene dei pescatori che tirano le reti cariche di pesci sul bagnasciuga fra le frotte degli spettatori; le famigliole che percorrono la riva chine alla ricerca dell’umile tesoro delle poveracce, le saporose vongole selvatiche della rivierTutto questo non è andato perduto, ed è il senso più profondo del ristorante Guido. Sembra anzi che esso viva di una sorta di mythos, un racconto fondativo che gli trasmette la febbre dell’universalità. Quello della conciliazione fra il mare e la campagna, una cosmogonia a ritroso che la colonizzazione della spiaggia nella stagione turistica smentisce con crudele sarcasmo. Eppure esso ha animato la storia della comunità riminese e percorso il libro dei ricordi famigliari, dalla discesa dei nonni dalle colline allo stravolgimento del dopoguerra; fino a ritirarsi nelle secche umbratili di un’endocucina che aveva tutti i connotati di un tesoro di iniziati, prima che i due fratelli nove anni fa iniziassero la loro amorevole azione di de-etnicizzazione. Più che di cucina regionale, allora, bisognerebbe parlare di cucina famigliare, perché ogni focolare ha il suo idioletto cucinario. In termini di ricette, ma soprattutto in termini di immaginario. “In casa nostra si mangiavano il cibo dei contadini e quello dei pescatori. Erano tempi in cui il pesce non si vendevRicordo che quando ero piccolo passavano le venditrici in bicicletta con i sacchi di juta e gridavano: ‘Puraze done!’, vongole signore. Era l’unico pesce che si affacciasse nelle case degli altri”, racconta Luca. Quando ho chiesto quale fosse il luogo della tradizione, non mi ha sorpreso la risposta 174 dicevano. Solo il nonno ebbe la lungimiranza di istallarsi in riva al mare, vicino alla rotonda”. E più che un paesaggio commestibile, il piatto finisce per comporre un’autobiografia famigliare. la clessidra rovesciata verso un età dell’oro di cui restano solo foto in bianco e nero. Che effetto vi ha fatto leggere la frase di Eliot scelta da Melandri, che problematizza il concetto di tradizione? P - L’abbiamo sentita nostra. Se mi dici che la tradizione non esiste, non ti seguo. Ma la frase va interpretata, bisogna ragionarci sopra. Abbiamo impiegato un certo tempo per mettere a fuoco cosa significasse in cucina. A quel punto abbiamo capito che rientra perfettamente nel nostro discorso. È proprio quello che stiamo facendo: la tradizione non esiste in quanto dogma immutabile, ma è il bagaglio culturale che ci portiamo appresso e che ci fa evolvere nelle cose. Secondo me c’è qualcosa di più. Nel senso che nel nostro immaginario la tradizione è qualcosa di passivo, mentre invece è azione. Qualcosa che noi creiamo, quindi una responsabilità del cuoco rispetto al passato e al futuro. L - Anche questo è un bel punto di vista. E rientra appieno in quel che stiamo facendo, nel senso che noi prendiamo la tradizione, la elaboriamo, la alleggeriamo, però comunque la conserviamo e la trasmettiamo. Come si fa anche con le attualizzazioni dei classici. 175 enologica edizione 2010 di Paolo: l’orto nella sabbia, un luogo utopico che ancora fa fantasticare, pensando alle passeggiate prima della guerra, quando dalla riva si vedevano i filari. “In cucina c’è un ragazzo il cui nonno fu uno dei primi a insediarsi a Miramare. E aveva creato l’orto al mare, dove adesso c’è solo cemento. Abbiamo voluto raccontare questa chimera in un piatto che si chiama ‘La costa d’inverno’, con un pesce di sabbia, la sogliola, e un prodotto dell’orto, il cavolo. In mezzo c’è una fila di spaghetti soffiati, che vengono prima lessati, poi fatti asciugare per perdere l’umidità e infine fritti come il riso. Diventa una cordigliera che simboleggia una frattura epocale, la falange degli alberghi alle nostre spalle. ancora adesso esistono vini di sabbia, oppure piante di aglio, cipolle, scalogni o carote che ricavano dalla rena più sapidità, come se il sale marino attraverso la sabbia le precucinasse. La rucola di sabbia poi è la più buona che esista, perché è più piccante e concentrata. Nelle spiagge libere si mescola a tantissime altre erbe aromatiche. Anche se gli ortaggi di sabbia si sono un po’ persi, sono dimenticati; esistono piccole realtà nella zona di Viserbella, diversi orti sul confine con il centro abitato, ma i quantitativi soddisfano al massimo il consumo personale. Sono appezzamenti grandi come questo ristorante”. “Quando dopo la guerra ci fu la divisione degli spazi chi veniva dalla campagna si istallò lontano dal mare”, aggiunge Luc“ ‘Tla sabia l’in fa gnenca al patede’, nella sabbia non crescono nemmeno le patate, Tutta la tradizione? Oppure la passate un po’ al vaglio? P - Non tutta la tradizione, perché comunque non saremmo in grado di abbracciarla interamente, credo che nessuno potrebbe farlo. Poi abbiamo lasciato perdere la carne, che da noi si mangiava, eccome, soprattutto il maiale. Ci limitiamo a citarla in una sorta di parodia, ricreando alcuni piatti di carne con il pesce, ad esempio la grigliata mistcostarelle di tonno, castrato di coda di rospo, salsicce di ricciola oppure salumi come la mortadella riproposti in chiave ittica. Un ingrediente che a volte usiamo è il prosciutto di mora romagnola. L - Geograficamente cerchiamo di ricomprendere la Romagna, e nello specifico di Rimini, quanto fa parte della nostra storia e del nostro passato. Con l’esclusione della cucina turistica che è una pseudotradizione. Quella degli spaghetti allo scoglio ed altre ricette che non si erano mai viste prima degli anni ’60. Ci sono aspetti della tradizione romagnola che invece non vi interessano, che magari interpretate come il portato di una condizione di povertà? L - Povertà assolutamente no, perché noi la povertà la andiamo a cercare. Anche perché la nostra zona prima della guerra non è che fosse ricchissima e questo non limitava il gioco; piuttosto aguzzava l’ingegno. Quando nelle case dei pescatori arrivavano i rombi, le sogliole, gli scampi e i gamberi, quelli finivano sul mercato. Loro mangiavano il resto, le cose che non voleva nessuno, che poi alla fine sono le più saporite. Ecco perché la vongola si chiama poveraccia. Qualche anno fa abbiamo fatto un piatto che si chiamava “Scampi versus canocchie”, per poi andare dal cliente a chiedere cosa fosse piaciuto di più. Nel 90% dei casi rispondevano la canocchia, che di solito viene bistrattata perché è difficile da mangiare. Non è anche una questione di food cost? P - No, perché io personalmente fra la saraghina e lo scampo scelgo la saraghina. Il food cost aiuta, certo, ma più che altro è un discorso di educazione. Che il pesce buono non è solo quello che ci hanno fatto conoscere, i rombi, gli astici e i branzini. Tenendo conto poi che ormai il pesce economico è quello allevato. La canocchia va sui 18-19 euro al chilo, un branzino di acquacoltura costa la metà degli sgombri. Il food cost può esserci sulla saraghina al limite, nemmeno sul pesce azzurro in generale. Ci sono momenti in cui vi sentite conservatori in senso stretto? P - Sì. Nel senso che certi piatti sono buoni in un certo modo e vanno conservati tal quali, per esempio il fondo di una buona zuppa di pesce, il sugo di vongole o la frittura come la faceva nostra nonna. Per me sono come dei dogmi, soprattutto gli aromi del soffritto che sono una sorta di impronta digitale. L - Però Paolo, un attimino di interpretazione ce la infili sempre, perché poi il piatto non è mai uguale. P - Diciamo che nella base di partenza mantengo questi parametri storici, poi magari il piatto anziché essere presentato in maniera 176 A proposito, cosa proporrete? P - Per Enologica ci sono stati chiesti due piatti, uno per la tradizione e l’altro tipico del ristorante, ma alla fine sono interscambiabili perché questo rapporto è al centro della nostra cucina. Cominceremo con le vongole con i ceci e il rosmarino, che è un piatto della nostra tradizione famigliare, dei contadini arrivati al mare che portavano i ceci e il rosmarino dalla campagna, raccoglievano le vongole sulla spiaggia e cucinavano questa minestra, in cui alcuni aggiungevano la pasta, i maltagliati. Anche i meno abbienti potevano permetterselo. Si faceva in primavera, e anche in inverno, quando si andavano a fare le raccolte sulla battigia. I nostri nonni tornavano a casa con questi sacchi, c’erano i ceci ammollati che cuocevano con il rosmarino e la cipolla. Si facevano aprire le poveracce e si aggiungeva la pasta battuta, cioè spezzata, con il rosmarino a legare tutti gli elementi. Il punto di partenza è stata la versione tradizionale del piatto povero, senza la pasta. Da questo concetto siamo arrivati alla ricetta attuale attraverso diversi passaggi, perché è un piatto che ci portiamo dietro dal 1989-1990, uno dei primi che ci recensirono. L - Fu Repubblica nel 1988, l’anno prima della mucillagine, uno spartiacque. È il classico abbinamento fra legumi e frutti di mare. Le proporzioni quali erano? L - Diciamo 50 e 50, noi abbiamo spostato il baricentro verso le vongole, 70 e 30, per dare più risalto al prodotto ittico. Quindi la vongola con il guscio appena aperta unita ai ceci già pronti, serviti in zuppa. In un secondo momento siamo passati alla vongola sgusciata, con sopra l’aria di acqua di vongole e rosmarino, una nuvola simile alla spuma del mare che abbiamo rapidamente abbandonato. Uno di quei passaggi che un po’ tutti hanno fatto, belli, innovativi, dei giochi… Tutto lì. L - In passato abbiamo preso qualche suggestione dalla nuova cucina spagnola, abbiamo sperimentato le loro tecniche e abbiamo imparato a usarle, poi ci siamo resi conto che non sono nelle nostre corde, e spesso nemmeno nelle corde di chi si siede a tavola. P - Sono belle da vedere e da fotografare, ma per il nostro gusto personale preferiamo una sostanza più concreta. la cucina di avanguardia italiana è più collegata alla tradizione, basta vedere quel che fanno Bottura e Scabin, mentre in Spagna c’è l’idea di partire da zero. Tornando al nostro piatto, il passo successivo è stata l’aggiunta di uno spaghetto soffiato al rosmarino. La parte decorativa e croccante del piatto. Lo abbiamo mantenuto anche nell’ultima versione, però abbiamo eliminato l’aria, abbiamo ridotto i ceci in una purea abbastanza consistente da servire in quenelle e mantenuto le vongole sgusciate nella loro zuppa 177 enologica edizione 2010 tradizionale, ad esempio il pesce con le lische, i crostacei con il guscio, viene servito con i filetti belli puliti o con un bastoncino di pesce come farò nel piatto di Enologica. ricca di olio e di sapore, in modo da separare i due elementi e differenziare le testure. Più questo spaghetto fritto sopra. Dal nostro punto di vista, un lavoro sul gusto, le consistenze e l’estetica. perché la nostra clientela è cambiata. Si tratta di un gioco, ma il bastoncino cotto a bassa temperatura, impanato e fritto trattiene tantissimo gli umori e i sapori del pesce, con la sapidità estrema della base della zuppa diventa un piatto di carattere. E il secondo piatto? P - È la zuppa di pesce di cui parlavamo prima. Viene preparata in maniera molto tradizionale nella base, in modo da avere alla fine quasi una doppia zuppa, solida e liquida. Perché abbiamo gli stessi pesci che si ripetono. Il fondo comprende tutti gli ingredienti tipici, scorfano, san pietro, canocchie, granchietti, mazzancolle; parlo di pesci interi con la polpa su una base di aglio, cipolla, peperoncino e aceto, come faceva nostra nonna. Viene cotto molto lentamente e poi filtrato, in modo da ottenere un succo bello denso. A parte, con gli stessi pesci della zuppa, si prepara una sorta di mattonella di filetti, code di crostacei e molluschi, che viene cotta a bassa temperatura e si lega grazie al collagene naturale. Una volta fredda è tagliata a bastoncini, che vengono passati nell’uovo, nel pangrattato e poi fritti. Quindi abbiamo lo specchio della zuppa di pesce e il bastoncino simil Findus un po’ ironico, che viene aggiunto all’ultimo momento per salvaguardare la consistenza croccante. Mentre la panatura fa anche le veci della bruschetta con la sua lieve aromatizzazione all’aglio. L - L’abbiamo chiamata Zuppa di pesce Findus e anche questa è una zuppa non zuppa, nel senso che c’è l’intingolo e il bastoncino viene solo appoggiato. L’avevamo proposta qualche anno fa e non veniva capita, mentre adesso piace molto, forse Mi sembra un caso di geminatio, la figura retorica della ripetizione. Se è vero che la ripresa, e persino la freudiana coazione a ripetere, sono costanti nell’arte. E dal raddoppiamento si sviluppa una forma di ironia che ha a che fare tanto con l’antifrasi che con la parodia, perché dice una cosa e il suo opposto, mentre mette in scena una cucina “avversaria”. Il surgelato industriale. L - Bisogna aggiungere che è stata un’evoluzione necessaria. Oggi a tavola la clientela deve trovare il pesce pulito; una zuppa di pesce com’era proposta una volta, con le lische e i gusci, non la prenderebbe più nessuno. Bisogna rendere più semplice possibile il compito del commensale. Quindi siamo passati attraverso una zuppa di pesce sfilettato cotto a bassa temperatura, poi si è trovata questa veste un po’ goliardica. Paolo si diverte, ci piace ridere e scherzare sui piatti con i nostri clienti. P - La tendenza è quella, anche se ogni tanto qualche cliente ci chiede la classica catalana, perché vuole lavorare con le mani. Ma dal mio punto di vista mangiare una canocchia o un sardoncino con le dita è tutta un’altra cosa. A Genova due anni fa ebbi una grandissima soddisfazione. Portai la canocchia riminese e davanti a 50 persone che stavano 178 Fra i due piatti vedo delle costanti. Il concetto è la separazione, e sono due zuppe alla fine. È un caso, oppure portano con sé l’immaginario corroborante del comfort food, il piatto fumante a centrotavola da cui tutti attingono a mestolate? Una cucina materna e una situazione ben determinata che le è correlata. L - Forse sì, anche se non ci avevo pensato. Il piatto di ceci e vongole poi è molto tirato, quasi asciutto. La definirei una minestra. Alcuni piatti della vostra carta, come la zuppa con i ceci, fanno pensare a uno studio archeologico. A una dearcheologizzazione. P - Ho letto tanto in passato su quelle che erano le abitudini dei marinai sulle barche, ciò che tiravano fuori dal pescato quotidiano, magari a partire dagli scarti, che non dovevano arrivare sulle tavole dei ricchi. Volevo scoprire cosa si mangiava alla fine dell’800, prima della guerra, anche parlando con le persone. Così ho imparato a utilizzare le frattaglie ittiche e l’acqua di mare; in inverno, quando è più pulita, la faccio bollire e la uso a freddo per pulire i pesci. Mi viene in mente anche un piatto di cui mi parlava il mio pescivendolo. I suoi nonni hanno iniziato a vendere pesce nel 1946, mentre nonno Guido iniziava a fare da mangiare, pensa che coincidenza. La sarda non poteva finire sui mercati, allora cosa facevano? I marinai usando il fornello a legna o a gas che avevano in barca buttavano in padella cipolla, aglio e peperoncino con un po’ d’olio e una spruzzata di aceto forte, di quello che si faceva una volta. Poi prendevano il pesce e lo gettavano dentro. Era un umido veloce che facevano spesso. Da qui è nato un piatto che è stato in carta per diverso tempo, la mattonella di saraghina cruda condita con una marinatura calda di aceto. Gli aromi erano quelli trasmessi da mia nonna e da mia mamma, l’aglio, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo. Quindi una cucina molto verace, molto marinara, molto rude. L - Oppure il cantarello, o cantarella, come si dice nel cervese, una preparazione che stava sparendo. È la piadina povera, una sorta di crêpe molto morbida che veniva preparata da chi aveva poco e poteva mettere meno farina nell’impasto. L’abbiamo recuperato e ogni tanto c’è qualche cliente che dice: ‘Ma questo me lo faceva la mia nonna’. Per questi aspetti ci siamo basati molto sui racconti dei nostri nonni, dei vecchi del paese con cui abbiamo a che fare, perché a volte non c’è nessuna documentazione. P - Era la merenda dei bambini; quando erano piccoli i nostri genitori mangiavano cantarello, olio di oliva e zucchero. L - Adesso con il cantarello Paolo sta facendo un piatto che è la rilettura della nostra storia. L’insalata, il cantarello 179 enologica edizione 2010 assaggiando dissi: ‘Se poi volete mangiarla anche con le mani’… Mi han dato abbastanza soddisfazione. Anche se noi i bastoncini Findus non li abbiamo mai mangiati, forse i Sofficini una volta. Finiamo sul più banale Big Mac, come i calzolai che girano con le scarpe rotte. e il pesce azzurro, nel nostro caso un’insalatina di campo fina fina, una cipolla addolcita con la cottura in padella e la saraghina in cima cotta solo su un lato, che rimane croccante sotto e sopra si scalda un po’ per induzione, quindi rimane bella morbida. P - Un altro piatto della tradizione che sono andato a ripescare è il pesce con le patate lesse, prezzemolo, olio e aceto; poteva essere moletto, mormora o merluzzo. Con la patata ho fatto un tortino, il condimento è diventato una maionese molto leggera che funge da specchio sul piatto. Mentre grazie alle nuove tecniche di cottura, bassa temperatura e quant’altro, sono riuscito a fare una barretta di pesce bianco. Ne è venuta fuori una serie di figure geometriche, con il piatto tondo, il triangolo di patate e la barretta di pesce. Su queste basi antiche sembra che innestiate sempre dei contrasti con una concezione di cucina contemporanea. P - Direi che cerchiamo di rendere le ricette attuali alleggerendole, applicando le nuove tecniche di cottura. Quando mia nonna metteva su il ragù c’erano sempre 4 dita di olio e 5 pezzi di aglio. Erano quelli i sapori che andavano a cercare. Mentre oggi la clientela vuole una cucina più leggera, veloce dal punto di vista nutrizionale e digeribile. Le quantità non sono più le stesse. C’è un punto sino al quale vi potete spingere nelle vostre rivisitazioni, dopo il quale alla tradizione subentra il tradimento, nel senso che l’originale non è più riconoscibile? L - Direi che la frontiera è l’evolversi della nostra clientela, che non è più quella turistica di un tempo o l’indotto riminese, ma da quando siamo sulle guide ha aspettative diverse, cerca le novità. P - Poi un piatto quando è perfetto devi smettere di toccarlo. Ogni ricetta ha una parabola, nasce da un concetto, ha uno sviluppo e continua a subire evoluzioni, nel senso che non riesco a tenerla ferma finché non è a posto. Solo la seppia con lo squacquerone, il carpaccio di cefalo e i cappelletti con le vongole sono rimasti tali e quali. Ma sono quei quattro o cinque capisaldi del locale… La vostra tradizione personale. P - Sicuramente. A livello più astratto, se dovessi compendiare le conquiste che abbiamo compiuto finora, direi che abbiamo imparato la separazione in cottura, la semplicità estrema, l’esaltazione della materia prima senza condimenti invasivi, la pulizia. L’unica tecnica che ritengo veramente essenziale in cucina è il rispetto del prodotto. Qualcosa di molto diverso dalla cucina romagnola, che è fatta di intingoli e di cotture lunghe. Forse questo è il tradimento che dicevi. Ci sono altre tradizioni cucinarie che vi interessano? L - Contaminazioni alla fine ce ne sono sempre, perché abbiamo imparato a usare dei prodotti che non avevamo mai considerato, come i ricci di mare. Da queste parti ci sono sempre stati, noi vedevamo i gusci sulla spiaggia ma pensavamo arrivassero dalla Croazia. Invece un signore 180 enologica edizione 2010 ha iniziato a pescarli con la muta e ogni tanto ce ne porta una cassa. Sono ricci più dolci di quelli pugliesi, che l’alga giapponese va un po’ a puntellare. Non è propriamente tradizione nostra ma il prodotto è di qui. Con il riscaldamento climatico inoltre si riscaldano anche le acque, quindi è comparsa la ricciola, un pesce che da noi mancava. P - Quest’estate ho visto persino dei pesci pappagallo, che sono pesci tropicali, tipici delle barriere coralline, con colori viola, azzurri, verdi, arancioni. Un pesce da acquario nelle maglie dei nostri pescatori. Quindi la tradizione cambia perché cambia il territorio e il modo di viverlo. L - E cambiano le leggi. Da quando l’Unione Europea ha fatto allargare le reti dei pescatori, di bianchetti non ne abbiamo più visti, al massimo qualche cassa di calamaretti. Ma non c’è più la quantità e la costanza sul mercato per giustificare un piatto in carta. P - Quello che hanno fatto è giusto perché c’era una pesca indiscriminata, per catturare un bianchetto, che è un pesciolino di 5 o 6 mm, si tirava su di tutto con delle maglie finissime. Gli altri pesci piccoli erano ributtati in acqua, chiaramente morti. Poi dispiace perché vengono meno dei prodotti, abbiamo dovuto cambiare le carte anche se sul mercato i bianchetti c’erano, quelli che arrivavano dall’estero però. 181 182 edizione 2009 In Emilia-Romagna il mangiare e bere vino sono inestricabilmente e sacralmente congiunti. MariO SOldati, aUtUnnO 1970 Teatro dei Cuochi il Tema 2009 «Selvatico. Cacciare, pescare, raccogliere.» Giorgio Melandri 184 il selvatico come dobbiamo registrare la rosellina? come dobbiamo registrare la rosellina qui vicino, fresca e rossoscura? noi non siamo venuti a cercarla ma quando venimmo, lei c’era. prima che ci fosse, nessuno l’aspettava. quando ci fu, nessuno le credette. cosa mai partita giunse alla meta. ma in verità non è sempre così? Bertolt Brecht Non ci sono selve nella bassa, né tantomeno sulla riviera romagnola, se non gli assembramenti di ombrelloni al culmine della stagione estiva, o certi skyline metropolitani. Ma la selva di cui vogliamo parlare è la metafora di un desiderio che attanaglia la cucina contemporanea. Voglia di natura, dopo le sbornie tecnologiche e i barocchismi degli ultimi dieci anni. C’è chi già parla di eco-cucina: una gastronomia a basso impatto ambientale, che estende il suo raggio d’azione dalle attrezzature ai rifornimenti di materie prime. Sostenibili, tracciabili, a portata di filiera. È la voga incontenibile dei chilometri zero, apoteosi del tipico e del terroir, che si proietta naturalmente in un’elaborazione meno tecnica e in un’estetica classica, rispettosa, epurata. L’agit prop ha fatto breccia un po’ ovunque, trovando il suo megafono negli anfratti umbratili di qualsiasi sottobosco, anche il più metropolitano. In Emilia-Romagna sono sei i paesaggi in cerca d’autore: i rivi ai piedi dei colli piacentini di Isa 185 enologica edizione 2009 una cucina naturante Mazzocchi, il boscoso Alto Savio di Paolo Teverini, l’amarissimo Adriatico di Paolo Raschi, la Modena glocal di Massimo Bottura, le colline panoramiche di Pier Giorgio Parini e le valli di Igles Corelli. Sei spaccati che si sparpagliano come tessere di un puzzle regionale. Incapaci forse di suggerire l’insieme, ma in grado di colpirci come frammenti dai profili acuminati. Il cuoco paesaggista trova le sue tinte più accese nel selvatico: l’azzurro della sarda, il bianco e nero del tartufo, il verde di tarassaco e borragine, il rosso e il bruno della selvaggina. Ognuno di essi è autentico, ovvero autos (etimologizzava Heidegger): semplicemente se stesso. Autoctono, autonomo, persino autobiografico. Altro da noi, se è vero che antropologicamente il selvaggio si definisce in opposizione a qualsiasi civiltà, e in cucina è quasi l’antitesi del cuoco. Altro da sé, altro dalla cucina. Un bagno rigeneratore nell’alterità. La cucina selvatica è una cucina scorbutica, spigolosa e antipatica. Leggera come il volo di un uccello, ficcante come il rostro di una beccaccia. I suoi confini sono ben più vasti di una riserva di caccia, senza limiti di stagione dal calendario venatorio. Dentro e fuori i confini della metafora, attraversa le sfumature di quanto è semi-selvatico, naturale, semplicemente diverso. Fino al selvatico del selvatico, la potenza del secondo grado: frattaglie ancora più aliene, umide e siderali. Maestra nel metamorfosizzare gli ammiratori in orsi, cervi e persino faraone, Artemide ha contagiato anche le tecniche di elaborazione culinarie. Il suo selvatico non è natura naturata, fissata nella sua datità; ma una natura naturans che produce instancabilmente natura, come la trama del suo arazzo. Insomma una cucina naturante, che prosegue la sua vita brulicando sul piatto. Prossima forse al putrido di Claude Lévi-Strauss, l’asse privilegiato del ritorno alla natura. Dove il passaggio dal crudo al cotto è svolto sempre meno per mezzo di cotture e sempre più attraverso i fenomeni naturali stessi, come (a proposito di cacciagione) faceva un tempo l’ancestrale frollatura. L’ingrediente si auto-cucina per via di tecniche avanzate, come insegna Massimo Bottura con la sua insolita tecnologia naturante. Ficcando il naso dietro le quinte, il selvatico è anche una pedagogia e un metodo di lavoro per il cuoco, costretto a rientrare dalle colonne d’Ercole dell’onnipotenza verso i lidi riottosi del prodotto. La poesia trova i suoi paletti nella meteorologia e nel calendario; la costrizione pungola e dirige 186 burocratico: la selvaggina e i funghi possono essere acquistati da rivenditori autorizzati all’abbattimento e alla commercializzazione, previo accurato controllo veterinario. Lo stesso abbattimento selettivo e professionale, con un colpo solo, contribuisce ad elevare la qualità, perché un animale cacciato con i cani, ferito, inseguito, trattiene sangue e carica batterica, diventando pericoloso, duro e coriaceo. Barriere che rischiano di frapporsi invalicabili fra il cuoco e il suo serbatoio naturale, trovando qualche spiraglio nel tentativo oggi in atto di istituire una filiera del selvatico tracciabile ed efficace, che metta a frutto il giacimento gastronomico mentre contribuisce a regolare l’ecosistema. Mentre il prodotto potrà salvarsi da un’endocucina che lo condanna al dilettantismo culinario: in casa sì, al ristorante no. L’intervento delle istituzioni è urgente. In campo enoico il selvatico si definisce come un poliedro affascinante ma un po’ zoppo, che perde fatalmente un suo lato. Profumi, metodi di elaborazione, caratterialità, suggestioni ancestrali, spigoli e artigli. Una metafora che sei sommelier interpretano ciascuno a modo proprio sulle tracce del bicchiere migliore. 187 enologica edizione 2009 la creatività come una metrica piovuta dal cielo. Riorganizzarsi è inevitabile: la prassi -dagli acquisti alla stesura della carta, all’impiattato- si ribalta. Caccia alla caccia, allora. Con lo sguardo del cacciatore, che è speciale. “Non crede di sapere da dove arriverà la preda. Non guarda tranquillamente in una direzione determinata, sicuro a priori che da quella verrà la selvaggina. Il cacciatore sa di non sapere ciò che accadrà e questa è una delle maggiori attrattive della sua occupazione. Di qui la necessità di approntare un tipo diverso e superiore di attenzione, che consiste nel non fissarsi in un presupposto, ma anzi nel non presumere proprio niente ed evitare al tempo stesso la disattenzione. È un’attenzione ‘universale’ che non si riferisce a nessun punto e procura di essere in tutti” (Ortega y Gasset, Discorso sulla caccia). Niente dogmi, tic o preclusioni. L’anacronismo è à la page; la novità ciò che abbiamo dimenticato; la tecnica il mirino più avanzato per centrare il dinamismo del prodotto. Lo stesso piacere è selvatico, mobile, ribelle. E il mito. Una cultura ormai naturalizzata che si nasconde nelle metropoli del pensiero cosciente, animandosi di vita propria. Ma c’è il deprecato lacciolo Isa Mazzocchi Ristorante La Palta Via Bilegno, 1C - Borgonovo Val Tidone, Piacenza Tel +39 0523 862103 - www.lapalta.it Nel paesaggio metafisico della bassa, una campagna algebrica dove il cielo equivale alla terra per una spiazzante equazione che rende gli animi inclini alla rêverie, la Palta delle sorelle Mazzocchi sviluppa la sua cucina come una carota geologica che accumula lentamente i suoi strati. Dall’osteria degli antenati al ristorante gastronomico, le ere geologiche svaniscono nelle nebbie di una terra franca, sospesa fra l’Emilia e la Lombardia. Il locale è una casa appoggiata sul nulla, dove lo spazio si fa tempo: sotto l’osteria, sopra i piatti di Isa, fra le cuoche più solide e originali del panorama italiano. Sulle sue pentole vegliano come angeli custodi papà Gino e Georges Cogny, Fitzcarraldo dell’haute cuisine in terra emiliana. La sorella Monica e il marito Marco officiano in sala; Roberto gazzola, consorte di Isa, in cantina. Al suo fianco in simbiotica unione da 10 anni c’è il souschef Andrea Molinelli. Ed è un’interpretazione femminile del selvatico: puro tatto senza eccessi tecnologici. Mentre i colleghi imbracciano doppietta e faretra, lei si avvia lungo i fossi alla ricerca di luppoli selvatici per i ravioli. “Non penserai anche tu, come Marchesi, che la creatività è dell’uomo?”. Mi viene in mente quel racconto di Perec, dove gli armadietti silenziosi di un cuoco nascondono il segreto del pensiero avanzato. En travesti. Il selvatico per Isa è un ricostituirsi naturale del microcosmo circostante nel piatto: la bassa è terra di agricoltura intensiva, ma a dispetto del nostro immaginario pullula di vita. Cercarla per il cuoco significa accettare la sfida di una cuisine impromptue, per dirla con Curnonsky: improvvisata con le verdure di giornata e il pesce che ha testé abboccato all’amo. E se Isa parla e scrive di una cucina trasversale -passaggio insensibile dal passato al futuro, dal concetto al manufatto, dall’io al mondo- ci piace immaginare che tenda proprio in quella direzione. Ascisse territorio, ordinata in libertà. Come il volo di una beccaccia. “Palta sta per l’appalto dei sali e tabacchi, visto che nasciamo come osteria”, attacca Isa. “Un tempo c’erano il bar, il negozio di alimentari e l’osteria, appunto. Una stanza con quattro tavoli dentro una casina piccola piccola a Bilegno, paesino di cento anime appena. la gente arrivava con il suo fagotto di roba da mangiare e prendeva una tazza di vino, qui lo chiamano ancora scodellino”. Di che epoca stai parlando? le nostre origini si perdono nella notte dei tempi. Uno zio di mia madre sposò la proprietaria della Palta, a vent’anni lei è andata con loro, poi è arrivato mio padre e adesso ci siamo noi. Ma credo che il locale esistesse da sempre. Nel 1989 il ristorante si è trasferito e nella Palta Vecchia ci abitiamo noi con i miei suoceri. È una casetta umile fatta con i sassi e il fango del Tidone; facendo gli scavi abbiamo trovato quattro strati di pavimento. 188 Come ti sei formata? Ho frequentato la scuola alberghiera a Salsomaggiore, ma i primi passi li ho mossi con mia madre Stefania. Mi ha dato un’impronta soprattutto nei piatti tradizionali, perché veniva da una famiglia di contadini, dalla tradizione di quelle donne che cucinavano alle feste e ai matrimoni. Mia madre ha un modo di muoversi in cucina che secondo me è unico, una meticolosità nel dosare gli ingredienti, persino nel regolare il fuoco. Quello che riesce a fare lei, non lo potrò mai uguagliare. Il sugo dei pisarei e fasò per esempio, non riesco a replicarlo, nonostante la osservi da quando avevo 0 anni. E da piccola lo vedevo fare ogni giorno. Bocuse sostiene che il modo in cui Troisgros spargeva i grani di sale non avesse uguali: uniformità perfetta dovuta alla ripetizione, come la mano di un pianista che si affina ripetendo gli accordi. È proprio così. Non è una questione di ricetta, perché le dosi sono uguali, ma di sensibilità. Arriva quasi alla perfezione. Lei ci aiuta ancora moltissimo: i sughi li prepara ancora lei quando ci sono da fare i piatti tipici. Ieri mattina per esempio ho fatto la piccola di cavallo, che è un piatto tipico di Piacenza. Lei è passata e mi ha detto: “La prossima volta ‘l fag me”. “Cos’è che non va?”, ho chiesto. Avevo sbagliato a metterci l’olio, avevo messo troppo poco burro, la cipolla tagliata così non andava bene, non l’avevo fatto rosolare a dovere… Poi l’ha assaggiato e ha detto: “È buono, però non ci hai messo il prezzemolo con l’aglio”. Che mansioni svolgevi al suo fianco? L’aiutavo sempre. Fin dall’età di 7-8 anni io e mia sorella ci mettevano vicino alla tavola degli anolini per metterli a posto nelle cassette. Erano ore e ore di lavoro al giorno. Poi piano piano ho iniziato a dare una mano in cucina, anche se non c’era molto spazio. Quindi io e mia sorella bene o male servivamo sempre ai tavoli. Non si può immaginare in che marasma fossimo, perché avevamo una sola lavastoviglie, dove comunque non riuscivamo a lavare i piatti durante il servizio. Quindi alla fine, andati via tutti, sparecchiavamo e cominciavamo a sciacquarli. Ma ormai era già ora di iniziare il servizio della sera. Non c’era nemmeno l’acqua potabile, era come vivere fuori dalla storia. Tuo padre cosa faceva? Mio padre Gino era un contadino. Era nato del ’29 e raccontava che da piccolo gli sparavano dietro i tedeschi, che viveva in una stalla… Poi ha sposato mia madre. Lui diceva sempre: Mi ha fregato, perché un giorno mi ha detto di mettere un po’ di sale nell’acqua della pasta. E io: “Ma non so quanto metterne”. –“Mettine un po’, e poi lo assaggi”. È stata la sua rovina perché non si è più fermato. Ha iniziato ad aiutarla, ha abbandonato l’azienda di famiglia ed è passato ai fornelli. 189 enologica edizione 2009 Per dire che è stata una continua evoluzione. Cinque anni fa abbiamo avviato la ristrutturazione, con il giardino estivo trasformato in salone, il giardino esterno per l’aperitivo e la terrazza. Abbiamo mantenuto il bar, ma non l’alimentari; e al piano inferiore l’osteria. Sono quelle cose che ci si porta dietro: qui sono nata e qui voglio restare. Si occupava di qualcosa in particolare? L’antropologia ha evidenziato che gli uomini sono addetti agli arrosti. Faceva quello che c’era bisogno di fare, ma è vero che era bravissimo con la carni e con la stagionatura dei salumi. Era un uomo di grandissimo carisma e aveva un palato insuperabile. Nell’88 feci un concorso rappresentando l’Italia, mi classificai terza e quando telefonai a casa per dirlo a mio padre, orgogliosa perché nessuno si aspettava niente da me, lui mi disse: “Dovevi prendere il pesce per la testa, non per la coda”. Sono arrivata a casa il sabato e lunedì mattina con mio zio era già andato dal geometra per costruire questa Palta. Forse aveva intuito che in me c’erano delle capacità che dovevano venire fuori e cercava di stimolarmi. Qualche aneddoto particolare? A quei tempi era tutto un aneddoto. Quando ho iniziato la scuola di georges Cogny mi sono iscritta di nascosto, perché avevo già fatto l’alberghiero e tornando si aspettavano che li avrei aiutati, visto che erano sempre in affanno. Invece mi sono iscritta e mi hanno scelto. Mio padre reagì male, ma alla fine era contento. Tutti gli stages successivi li ho fatti durante le ferie, oppure quando c’era un po’ di morto. E comunque ad ogni stage dovevo chiedere: “Posso andare?”. Perché all’inizio per loro era una coltellata. Professionalizzandoti avrai portato a casa una cucina diversa. Sì. Loro erano molto curiosi, ma c’erano spesso dei conflitti su come procedere, a partire dalle cose più semplici: come si fa il brodo, come si fa l’arrosto. “Guarda che il brodo si fa così!” – “Ma cosa dici? È una vita che faccio il brodo!”. Piano piano si sono resi conto che alcuni metodi erano migliori di quelli che mettevano in atto, perché li avevano ereditati o scoperti empiricamente. La prova regina era sempre l’assaggio. Non hai mai dubitato di voler fare la cuoca? No, l’ho sempre saputo, anche se l’ho scoperto col tempo. Era un destino di cui mi sono appropriata cercando una formazione indipendente. Come sei entrata in contatto con Cogny? Ho letto un trafilettino sul giornale, era un corso sperimentale a numero chiuso per 20 persone. L’ho incontrato e mi sono detta: “Non ce la farò mai”. Dire che era severo non basta: orso, burbero, durissimo. Lui invece mi aveva già individuato come una di quelle che secondo lui poteva farcela, perché ero l’unica che aveva il diploma alberghiero. Gli altri erano figli di osti piacentini, uno aveva fatto il geometra, l’altro aveva studiato economia. Ricordo che il lunedì mattina prendevamo la corriera che andava su alla Cantoniera, a 650 metri di altitudine sulle colline della Val Nure, e restavamo lì fino al mercoledì, perché avevamo lezione a Piacenza. Il giovedì mattina tornavamo su, ci fermavamo fino al venerdì e il sabato mattina avevamo un’altra lezione a Piacenza. Era un orario ritagliato sulle sue esigenze: il sabato e la domenica, che per lui erano i giorni clou, si dedicava interamente al ristorante, mentre il mercoledì era chiuso. A quei tempi ero ancora più selvatica, come diceva sempre mio padre. Mi dava fastidio che Georges mi avesse preso in simpatia e cercavo di 190 Se tu dovessi sintetizzare i suoi insegnamenti? Ha aperto i miei orizzonti e mi ha perfezionato tecnicamente. Poi quando vedi un uomo la cui passione oltrepassa qualsiasi cosa… è un po’ come se lui ti desse la scossa. Quando una persona che ha un talento così alto, ti fa capire che anche tu secondo lui hai talento, ti dà la chiave per aprirlo. Georges mi ha fatto credere in me stessa. Ti piace citarlo nei tuoi piatti? Non verbalmente. Spesso mi vengono delle ispirazioni pensando a lui e alla sua cucina, ma difficilmente lo scrivo sul menu. Ad esempio lui faceva una torta di cioccolato con una base di croccante di nocciole, che è stata copiatissima. Era uno dei suoi cavalli di battaglia. Noi abbiamo fatto una crostatina di pistacchi con il cioccolato e la crema di nocciole, quindi è un’ispirazione rivista, con un impiattato e una tecnica diversi. Accanto ai miei famigliari e a Georges, le persone fondamentali della mia vita sono stati Paolo Vai ed Herbert Hintner. Erano tutti accomunati da una gestualità sensibilissima. Georges aveva un modo di toccare la materia… era come se lui la accarezzasse. Io l’ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, ma aveva un modo così delicato, direi quasi femminile. Da Vai e Hintner hai svolto i tuoi stages? Sono stata anche all’osteria del Teatro con Filippo Chiappini Dattilo, quando georges non c’era più, da Mary Barale al Rododendro di Cuneo e alla Panoramica di Ivrea. Mi sono fatta una toccata e fuga da Marchesi, quando lo chef era Cracco, e da Vissani. Con Herbert mi sono fermata un pochino di più; durante le ferie invernali, anziché andare in vacanza, mi recavo da lui. Mi ha dato tantissimo perché mi sentivo confusa, fra la tradizione e la Francia, incollata qui a Bilegno. I ristoranti li sceglievo in base a quello che leggevo sui giornali o al passaparola. Erano quelli che mi interessava conoscere. Tanto per parlare delle esperienze più importanti, perché poi quando avevo 16 anni mi sono fatta pure una stagione a Gatteo in un “albergasso”… Quando hai iniziato a fare i tuoi piatti? Quando abbiamo aperto qui, venti anni fa, abbiamo iniziato a proporre qualcosa ma soltanto a voce, perché non avevamo nemmeno il menu. “Volendo, oltre ai tortelli, ai pisarei e agli anolini in brodo abbiamo una tagliatella di castagne con la lepre”, tanto per fare un esempio. Erano cose che potevano sembrare 191 enologica edizione 2009 mantenere un certo distacco. Visto che avevo fatto la scuola alberghiera con uno chef maschilista, che le femmine le metteva alla plonge, non volevo passare dall’altra parte. Ma quando ho finito la scuola siamo diventati molto più complici, molto più amici, molto più legati. Tant’è che prima di quel concorso andai da lui per chiedergli un po’ di supporto morale e lui mi disse: “Se ti danno le capesante, devi fare un gelato di capesante con la salsa del loro corallo”. Io l’ho guardato incredula. – “Se tu fai una cosa così, vedrai che li sbaragli tutti”. Adesso, se ci penso, per me era una roba sconvolgente, perché non sapevo neanche da che parte iniziare. A quei tempi nessuno parlava di gelati salati, credo. Non mi diedero le capesante e quel piatto non l’ho mai provato. Solo per dire quanto lui fosse avanti. tradizionali, ma per la Palta di allora erano sconvolgenti. A quei tempi non potevo permettermi di comprare il “pré salé”, innanzitutto per ragioni di approvvigionamento, quindi se mi andava di fare l’agnello cercavo un pastore della zona che avesse le pecore e potesse fornirmelo. In sostanza tentavo di adattare l’insegnamento che avevo ricevuto a quelli che erano i prodotti del luogo. Pensavo che non andasse bene, mentre adesso è la moda. Come ha reagito la clientela alle tue prime innovazioni? Molto bene, perché ho sempre fatto dei piccoli passi, anche negli accostamenti. Diversi clienti li abbiamo persi, ma quelli che sono rimasti hanno saputo capire. I miei genitori sembravano un po’ scettici, ma dopo un po’ mi hanno dato ragione, perché all’assaggio il gusto era quello tradizionale o comunque era riconoscibile. Non ti dico quanto foie gras ho buttato via per imparare, o perché non lo ordinavano, o perché non lo cuocevo bene. Da georges ne avevo visti tanti, ma quelle robe lì non le dava in mano a tutti. Noi facevamo il pandispagna, la pasta sfoglia, lui il foie gras. La prima volta che ho fatto una terrina, nemmeno con il flessibile saresti riuscito a tagliarla. Nel forno a bagnomaria, col pilotto al minimo, era uscito tutto il grasso e la parte magra si era pietrificata. È mai venuto a mangiare da te? Molte volte, e gli veniva quasi da piangere. Assaggiava, mi bastonava dove mi doveva bastonare, però quando era sulla porta mi diceva “Isa, ti è brava”, perché parlava un po’ in francese e un po’ in emiliano. Una lingua mista come la sua cucina. Che piatti aveva provato? Gli era piaciuto da matti un piccione che avevo fatto con il Campari. Essendo francese faceva una terrina di foie gras molto classica, semplice semplice, senza marmellate né frutta all’interno. Invece a me piace giocare, cose tipo il foie gras con le banane. Lui diceva: “No, no, no, te non pé fa chel roba ke. Il n’est pas possible. L’è mi bon”. E io rispondevo: “Proviamo a assaggiare, no?”. La prima volta che ho preparato la terrina di foie gras alternata con il cotechino, perché volevo un abbinamento con la nostra tradizione, gliene ho portata una intera, mi ha telefonato la sera stessa e mi fa: “Ma che schifessa! L’è mi bon, l’è mi bon”. – “Veramente Georges?”. Io non l’avevo ancora messa in carta perché aspettavo un parere. Poi si è sentito proprio che si è immagonito e mi ha detto: “No, è buonissimo”. Si era fatto contagiare dall’Emilia-Romagna? Più che altro dalla Val Nure. Era una situazione fuori dal mondo: lui e sua moglie in questa casa cantoniera spersi in mezzo al nulla. Riusciva a trovare una donna ogni tanto, ma poi doveva arrangiarsi come poteva. Non aveva mica un cameriere, in sala andava sua moglie, magari con le ciabatte, come se fosse una casa. Stendeva anche la pasta all’occorrenza, quando mancava la sfoglina. Ma lui ha avuto la stella nonostante quelle condizioni. In che senso si era lasciato contagiare? Dai prodotti; poi aveva reinterpretato alcuni piatti tipici, per esempio i panzerotti, presentandoli in modo carino, singolarmente, con degli abbinamenti diversi. 192 Cucinava spesso ingredienti selvatici? È stato uno dei primi a usare i prodotti che trovava in zona, anche se certe cose le prendeva da un distributore, perché era molto legato alla Francia. In Val Nure crescono spugnole meravigliose, profumatissime, e i porcini migliori in assoluto; non mancano la selvaggina, il pesce di fiume e le bacche. Cercava di usare tutto quello che gli veniva portato; assaggiava e anche se all’inizio non era convinto sperimentava, perché amava le novità. Un giorno un ragazzo pugliese all’osteria gli aveva fatto conoscere i lampascioni. –“Cosa sono? Valli a comprare”. Era arrivato con un sacco di “cipolle marce”… ma alla fine ha iniziato a usarli. Nonostante l’impronta francese, il gusto non mancava. La cucina della Cantoniera è stata una fusione fra quello che c’era prima e quello che è venuto dopo. Rimbalzava in Francia la notizia di quel che faceva in Italia? Secondo me no, forse per il suo carattere. Un giorno era al Four Seasons di Milano, tutti gli chef dovevano andare in conferenza stampa o comunque a salutare, un signore lo trovò in cucina e gli disse: “Devi andare sopra, non puoi stare qua”. E lui rispose: “Ma io non sono un attore, sono un cuoco”. Lui era per l’essere, non per l’apparire. Era molto infastidito dai colleghi che cominciavano ad andare in televisione. Che opinione aveva della cucina spagnola negli ultimi anni? La conosceva bene e gli piaceva molto. Perché era abbonato a tutte le riviste italiane e francesi, e se usciva un libro a Parigi, suo fratello glielo spediva. Aveva una biblioteca meravigliosa e quando andavamo a trovarlo, dopo che si era ritirato, lo trovavamo sempre davanti a un ricettario. La tua doppia formazione si biforcava di fronte al selvatico? Tuo padre e tua madre lo usavano in modo diverso da Cogny? Penso di sì. Nella cucina dei miei c’erano molte erbe spontanee, il tarassaco piuttosto che il radicchietto selvatico. Li coglieva mia madre, come faccio io quando arriva la primavera, lungo le rive del Tidone oppure nei campi, insieme ad Andrea. È una cucina tradizionale; mentre dall’altra parte c’era il tentativo di inserire il selvatico in una cucina moderna. Magari per creare dei contrasti, perché sono gusti fortissimi. Per esempio i bargnoli, quelle bacche blu che si usano per fare il bargnolino, sono astringenti in un modo impossibile, ma cuocendo diventano dolci e acquistano un gusto particolarissimo. Li uso in dolceforte, per esaltare il foie gras, perché con i tannini e l’acidità aiutano ad asciugare la grassezza. anche la delicatezza del pesce di fiume si esalta con un condimento agrodolce. Quali sono gli altri prodotti selvatici della Val Tidone? Qui intorno c’è una zona dove si raccolgono le nespole selvatiche. È un altro frutto incredibile: da acerbo è praticamente immangiabile, tannico e astringente come 193 enologica edizione 2009 Era uno che se c’era da fare la maialata, chiudeva e quel giorno lì faceva la festa per tutti i paesani tutto ciò che è selvatico. Bisogna aspettare che sia non dico marcio, ma almeno surmaturo per ricavarne una marmellata dal gusto unico, adatta ai dolci come al foie gras. Ti dicevo prima delle bacche, quindi i sambuchi. Quando arriva la stagione, il fiore puoi farlo tanto fritto che in infusione, come essenza per il gelato o la gelatina. A maturazione poi, forma delle piccole bacche che danno un’altra marmellata eccezionale. Per quanto riguarda le erbe spontanee, in primavera cresce il crescione d’acqua, di cui esistono due varietà, a fava e a prezzemolo. Il primo è buonissimo, dolce, con un sentore leggermente amarognolo; mentre il secondo assomiglia un po’ all’erba aromatica. Il selvatico di acqua dolce è un argomento difficile, perché c’è molto inquinamento, devi avere la certezza che il prodotto che usi sia sicuro e la disponibilità in ogni caso è limitata. Qui sopra c’è una diga bellissima, ogni tanto la svuotano per ripulirla e il pesce è abbastanza controllato. Ci sono moltissimi gamberi di fiume americani, che hanno soppiantato la razza autoctona; sono pregiati perché hanno più polpa, mentre i nostri talvolta sanno leggermente di fango. Perché non basta dire selvatico, se poi il prodotto non è buono. Che cosa vuoi proporre ad Enologica? Il boccalone, perché a fine novembre si riesce ancora a pescare, mentre le altre specie, come il luccio, si sono già ritirate in profondità per sfuggire al freddo. La stagione più propizia per il pesce d’acqua dolce è la primavera, ma il boccalone è sempre abbondante perché fa tantissime uova. Ha una carne molto fine, talvolta con note di melone. Me lo pesca un signore nella collina della Val Tidone, oltre la diga. L’anno scorso mi ha portato anche un temolo rosso che era cresciuto qui, non so come ci fosse arrivato: una cosa eccezionale. Cosa ti interessa nel pesce di acqua dolce? L’altro giorno il mio pescivendolo mi ha regalato un branzino pescato, allora ho detto: “Voglio proprio sentire la differenza”. Sembrava quasi che non sapesse di niente. È proprio il gusto che cambia: il pesce di mare ha una nota iodata un po’ monocorde, mentre quello di fiume sa di fiume, senti il profumo delle erbe. L’habitat è ristretto, quindi è più territoriale. Mangia tutto quel che trova nei paraggi, che siano bacche o erba, per purificarsi. Il Tidone non è il Mediterraneo. È proprio il gusto di questa terra. La tua ricetta? Il boccalone è cotto al naturale, con un filo d’olio, perché mi piace che si senta il suo gusto. Abbiamo preparato delle cialde di polenta con cui comporre un millefoglie e in abbinamento, ho pensato di rievocare un rito che mi piace molto, la grigliata dei pescatori sulla riva. Quindi ho affumicato delle uova con il legno del Tidone, gli arbusti con le loro bacche, i bargnoli, il ginepro e il sambuco. L’uovo, che comunque è poroso, assorbe il profumo; lo uso per preparare uno zabaione salato con un goccino d’acqua e un po’ di vino. Quando ho fatto la prova ho aggiunto qualche foglia secca di fico, perché affumicando rilascia un profumo di miele caramellato che con lo zabaione sta bene. Come contorno ci sono delle erbe spontanee spadellate con un fondo d’olio e uno spicchio d’aglio, per pulire la bocca con una nota amara. 194 Lo stesso che verrà servito in abbinamento, una bottiglia prodotta da mio marito in collaborazione con Torre Fornello, qui sui nostri colli. La botrytis ha attecchito su quattro parcelle di una vigna di malvasia vecchia quarant’anni, che è stata vendemmiata il 12 novembre 2007. Il piatto è stato studiato in funzione di questo abbinamento. Roberto: Assaggiando alcune basi di vini che Torre Fornello voleva produrre, ho provato questa strana Malvasia. Enrico Sgorbato aveva pensato a un muffato dolce, ma era tornato sui suoi passi perché la botrytis non fa parte del territorio; da queste parti l’appassimento ha regalato splendide espressioni. Io allora salto su e dico: “Tieni per me una barrique e falle fare tutta la fermentazione”. Da qui il nome di Una. Con quel corredo aromatico, avevo immaginato un vino secco, perché la malvasia di Candia, che ha origini greche, porta con sé i profumi e i colori del Mediterraneo. Pensavo a qualcosa di simile a uno zibibbo senza zuccheri residui. Man mano che l’assaggiavamo durante l’anno, intuivamo che si stava sviluppando una personalità interessante. Enrico ha deciso di proseguire l’esperimento con quattro barrique, poi ne abbiamo scelte ed assemblate tre, che sono state imbottigliate nella primavera del 2009. Un progetto che continua. Qual è il trait-d’union con il selvatico? la natura: in tutta la vigna soltanto queste quattro parcelle hanno sviluppato la muffa nobile. Il vecchio proprietario non pensava sarebbe stato possibile; ma probabilmente il microclima lo consente. Roberto: Poi non è un vino programmato, ma nasce da un evento naturale a sorpresa. I vecchi della zona dicevano che quell’uva non marciva mai: le condizioni climatiche della vigna consentivano una vendemmia tardiva. Ma la botrytis ha stupito un po’ tutti. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì: io uso il selvatico ma non potrei farlo per via degli intoppi burocratici. allora io dico: il selvatico fondamentalmente non esiste. La carne può essere pericolosa perché l’animale è malato, il fungo velenoso; ma nel momento in cui vado a raccogliere delle erbe spontanee, abbondanti in natura, e sono sicura, perché non posso usarle? A un certo punto mi ero fatta tante di quelle paranoie, non posso usare questo, non posso usare quello, non posso nemmeno coltivare l’orto, che la mia cucina si era ristretta fino a snaturarsi. Ma è proprio la bacca di sambuco a farmi la differenza, perché al contrario del mirtillo coltivato ha un sapore speciale. Quindi la cucina selvatica è un po’ una chimera, e laddove fosse intesa in senso stretto sarebbe pura improvvisazione, difficilmente praticabile nella ristorazione. Una chimera assoluta. Bisognerebbe cucinare solo quello che hai raccolto la mattina. Come la settimana scorsa: mi hanno portato 20 chili di chiodini, qua si chiamano gabareu perché crescono sotto le gabbe, cioè i pioppi. Il selvatico rappresenta la grande libertà di esprimersi facendo quello che hai. Ma spesso quello che hai non puoi usarlo. 195 enologica edizione 2009 Il selvatico passa negli attrezzi e nelle tecniche di cucina. Che vino usi per lo zabaione? Pier Giorgio Parini e Fausto Fratti Ristorante Il Povero Diavolo Via Roma, 30 - Torriana Rimini Tel +39 0541 675060 - www.ristorantepoverodiavolo.com Ci sono tante curve e tanti saliscendi sulla strada che porta al Povero Diavolo a Torriana. Le svolte di un’intelligenza sempre all’erta e di una cucina che si sposta per inquietudine interiore, tenendosi sempre ben lontana dal baratro delle mode del momento. Il paesaggio è quello delle colline sopra Rimini, mentre sullo sfondo, serafico, irenico, il mare continua a disegnare la sua retta come il muratore con la bolla. Paradigma di una natura che si sbizzarrisce incurante nei suoi mille capricci, fra i dirupi e le macchie che immaginiamo rigogliosi di fauna e flora selvatiche. a dare il la vent’anni orsono fu la cucina storica, prima passione di Fausto Fratti, alla ricerca puntigliosa degli archetipi gustativi della memoria collettiva, sorta di patron junghiano che accomoda il palato sul lettino. Poi il tuffo nella grande cucina di Pier Giorgio Parini, giovane chef di San Mauro Pascoli: libera, sregolata, rigorosamente ex novo… l’ingrediente selvatico come unico canovaccio possibile dell’improvvisazione; la novità quale frutto dell’oblio. È questo il fil rouge del ristorante. la ricetta per Enologica è un capolavoro di rispecchiamenti, che sposta l’accento dalle tecnologie alle tecniche narrative. Avvincente nella sua nostalgia della semplicità. Evanescente nella sua rusticità collinare, che svapora nel caleidoscopio delle inversioni. Il gioco è millimetrico: quale sia il latte e quale l’erba, quale l’ingrediente figurato e quale il letterale. Il selvatico vola via leggero come il frullare di un uccello dalla mattonella di borragine sul piatto. Il suo confine qui a Torriana sono la nostra identità e la nostra storia. Insomma un selvatico e contrario, appassionante frontiera di un western dove la civiltà gastronomica si sposta, avanza, arretra e finisce per innamorarsi degli indiani. La prima scorreria appartiene a Fausto: “Il Povero Diavolo? a Torriana esiste dal 1915, quando si trovava cinquanta metri più avanti sulla strada. I nipoti del fondatore erano miei coetanei e vi ho trascorso la mia infanzia. C’era una signora bravissima, che faceva una cucina di casa. Vent’anni fa ho recuperato quel nome per ragioni d’amarcord”. Come avevi deciso di fare il ristoratore? Fausto - Perché ero un grande frequentatore di ristoranti, nonostante i miei genitori non mi avessero mai portato. Per contro avevo una mamma che, come la mamma di ognuno di noi, era bravissima a cucinare. oltre a crescere quattro figli, il suo lavoro era quello. Avevamo un negozietto di generi alimentari, dove oggi è l’ingresso del ristorante. Era una bottega dove si poteva comprare di tutto, dal filo al bottone, dall’aringa al grano. Ma non era l’unica: attaccati l’uno all’altro, in questo piccolo paese c’erano quattro spacci che vendevano tutti le stesse 196 Quali sono i ristoranti che ti hanno segnato? F - Il primo è stato a Santa Sofia. Il cuoco aveva lavorato a casa agnelli, poi si era messo a fare l’artista. Un certo Paolini. Era una di quelle cucine davvero diverse per la zona, perché qui ancora oggi se vai in una certa fascia propongono tutti le stesse cose; di ristoranti importanti ce n’erano pochi e lui andava fuori dal seminato. Proponeva una cucina espressa, in largo anticipo sui tempi. Poi il ristorante dei fratelli Raccagni, Tarcisio e Nerio, la Grotta. A quei tempi cucinava Cammerucci, prima di spostarsi a Cesenatico al Bistrot Claridge, insieme ad altri due soci. E ancora Paolo Teverini, e poco dopo La Frasca. Erano loro che facevano la differenza, ma io non ero ancora pronto per questi posti. La mia intenzione era un’altra: creare un’osteria dove la qualità non si discutesse, ma l’atmosfera fosse molto più sciolta. Quei locali erano abbastanza “impiccati”, si pretendeva una certa etichetta, più alla Frasca che alla grotta, dove c’era una cameriera bravissima, Daniela. Persone come lei hanno fatto tanto per la ristorazione, ma nessuno se ne cura. Si parla sempre dei cuochi e si dimentica il resto. Il Povero Diavolo per esempio non è solo giorgio: c’è anche Walter che sta in sala. Quando hai aperto il tuo locale? F - Nel ’90 insieme a mio fratello, che aveva fatto l’alberghiero ed era maître di sala. Ma per cinque anni ho continuato a fare un altro lavoro, ero impiegato all’assessorato alla cultura del comune di Rimini e mi occupavo di logistica degli spettacoli. Abbiamo trovato una cuoca bravissima del posto, una signora che è stata con noi dodici anni, la Loredana affiancata da mia sorella Carmen. I nostri menu erano completamente diversi dal resto della ristorazione locale, basati su una vera ricerca di cucina. La carta era corredata da riferimenti storici precisi, dalle paste agli antipasti, ai secondi e ai dolci. Per esempio il pasticcio di carnevale con tutta la sua storia, che veniva prodotto dal Caffè Vecchi di piazza Cavour, dove la gente lo comprava come piatto da asporto e lo portava a teatro, per consumarlo fra un atto e l’altro. Oppure i piatti serviti durante le nozze di Elisabetta da Montefeltro e Roberto Malatesta. Ma a volte oltrepassavamo il territorio, ricordo un menu ispirato alle suore di Montefalco. Cercavamo di essere filologici in tutto, tenendo conto degli ingredienti che allora non c’erano, quindi 197 enologica edizione 2009 cose, con le difficoltà che ti puoi immaginare. Ricordo ancora bene che la gente negli anni ’60 barattava; chi dalla campagna veniva a fare la spesa portava un prodotto, che so, un formaggio. C’era una signora delle Fratte che aveva dei vaccini cremosi, completamente diversi dallo squacquerone; bucciavano leggermente, formavano una crosticina gialla e all’interno restavano belli liquidi. Col formaggio si portava via lo zucchero, oppure un’aringa. altre volte la gente segnava il dovuto sui libretti, poi quando prendeva lo stipendio pagava. Tutti i mesi c’era da discutere e si accumulavano conti anche lunghi. Per dire che i quattrini non c’erano e questi quattro negozi avevano sicuramente dei problemi a far quadrare i loro conti. andavano esclusi. Di questi aspetti si è sempre occupato gratuitamente Piero Meldini, che a mio parere resta uno dei migliori storici della cucina che abbiamo in Italia. È una fonte di sapere inesauribile, da quando era bambino vive piegato sui libri. Ogni anno sottoponevamo al suo vaglio i nostri otto menu, che conserviamo come un piccolo tesoro. Pier Giorgio ha la volontà di reinterpretare qualche piatto storico, e probabilmente lo faremo. Come mai avete cambiato registro? F - Ivan, che aveva sostituito loredana, dopo un certo numero di anni si è stancato di fare il cuoco. Peccato perché forse non era un compositore eccezionale, ma sicuramente un interprete di spicco. Dovevamo trovare un sostituto e nel 2004 è arrivato Riccardo agostini, che aveva lavorato da Vissani ma desiderava tornare a casa. Con lui abbiamo voltato completamente pagina rispetto agli anni precedenti. Il cambiamento ha spiazzato non poco la vecchia clientela, fidelizzata ad un clichè assimilato e rassicurante. Spiazzati dalle novità di forma e di sostanza, molti dei vecchi clienti si sono persi per strada, ma fortunatamente, soprattutto con l’arrivo di Pier giorgio, ne abbiamo acquisiti tanti altri. E Pier Giorgio? F - Cercavamo una figura di professionalità pari a quella di Riccardo, per consolidare la clientela recente. Allora ho chiesto informazioni a Massimiliano Alajmo, perché sapevo che Pier giorgio stava portando a termine la sua permanenza alle Calandre. La risposta è stata perentoria e molto elogiativa. Devo dire che da quando c’è lui, il Povero Diavolo ha subito una ulteriore evoluzione: facciamo una cucina giovane, fresca, avviata ad una compiuta personalizzazione. Lo vedo da come tratta il prodotto, dalla gestualità. Perché ogni cuoco ha una mano più o meno calda, più o meno creativa. Quando mangi i suoi piatti, sai con certezza che sono i suoi. Il racconto di Pier Giorgio, adesso. Pier Giorgio: Dopo l’alberghiero ho cominciato a fare le mie stagioni, ma al lavoro intorno a me vedevo troppo dogmatismo. C’era solo un modo giusto di fare le cose. Invece io ero curioso di vedere cosa sarebbe successo, tagliando la mela nel senso contrario. Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, fra cui Fabio Rossi dell’Acero Rosso e Massimiliano Alajmo, che mi ha assunto come pasticciere anche se in realtà sono un cuoco. Gli ho mandato un curriculum e quindici giorni dopo mi ha chiamato. Mi sono trovato davanti un ragazzo come me, che mi ha subito messo a mio agio. Mi ha trasmesso innanzitutto la curiosità, il fatto di non sentirsi appagati, di vedere le cose da un lato diverso, provarci per poi magari tornare indietro. Fausto l’ho conosciuto perché un’amica mi ha riconosciuto, quando mangiavo da lui, e gli ha parlato di me. Dopo l’esperienza con Massimiliano desideravo mettermi alla prova con una cucina che fosse tutta mia e Fausto me ne ha dato l’opportunità. Massimiliano è stato il tuo maestro? P - Qualche tempo fa avrei risposto di sì, ma oggi ho preso consapevolezza di certe cose e dico che è stato mio padre Pasquale, che fa il contadino e non il cuoco. Nel senso degli insegnamenti che mi ha trasmesso, ben oltre i cicli della natura e la 198 funghi: da un paio di anni non ne vedo di nostrani in quantità importanti. Magari viene un signore che ti porta dieci porcini, ma sul mercato arrivano funghi dei paesi dell’est, Romania, ex-Jugoslavia, Russia. Hanno almeno cinque giorni di vita. Sono un’altra cosa. Attraverso queste evoluzioni, il vostro rapporto col selvatico è cambiato? Noto che a dispetto del cliché della caccia, voi cuochi associate il selvatico ad altro. F - Direi che è stato sempre presente, perché determinati ingredienti qui sono a portata di mano. È più facile trovare delle lumache non di allevamento, perché c’è il tipo che le raccoglie a cinque metri da casa: “ T’ vò un sec ad lumeghi?”. Oppure la Pia, io la chiamo la donna dei boschi: “Ho trovato gli asparagi, vuoi gli asparagi?”. Un altro amico ci porta il tartufo nero da Montebello, che è già zona di raccolta; mentre per il tartufo bianco passano i tartufai oppure andiamo direttamente dai cavatori. Da quando è arrivato Giorgio, però, a me pare che il selvatico venga utilizzato quasi quotidianamente, a 360 gradi. Dalla verdura alla frutta, alle erbe, alle carni e ai pesci. Un po’ per come è lui, un po’ perché la cucina oggi ne ha particolarmente bisogno. Credo che la novità passi più per il selvatico che per i prodotti che tutti possono trovare ogni giorno su qualsiasi mercato. La cacciagione è in carta? P - No, perché è difficile trovarla, se non ti appoggi a determinate aziende specializzate; poi non hai mai la certezza di quello che veramente vai ad usare, le etichette possono essere attaccate e staccate a piacimento. Per la stessa ragione uso difficilmente i P - Sì, perché la selvaggina può essere allevata, mentre il pesce e le erbe sono la cosa più autentica che ci è rimasta. Le erbe, in particolare, sono fra gli ingredienti che mi stimolano di più. Questa è una zona vocata per le varietà meno bisognose di acqua; il clima torrido e la terra friabile, che non trattiene le precipitazioni, sono adatti alla borragine piuttosto che all’ortica o al crescione, che pure crescono a qualche chilometro di distanza. E la frutta? P - La signora Sonia ha messo su un impianto vecchio stile, dove le piante crescono a caso, non ci sono filari di alberi tutti dritti, tutti uguali. Ha un concetto un po’ naïf dell’agricoltura. Quando le chiedo determinati prodotti, lei mi risponde: “Andiamo a vedere se ci sono”. E non ti fa raccogliere i frutti se non sono pronti. Il selvatico è più impegnativo per un cuoco? P - Sì perché non lo puoi controllare, quindi sei tu che ti pieghi alle esigenze del prodotto. Devi sottostare a quel che fa. Se vuoi un’erba e ha grandinato, devi farne a meno per una settimana, dieci giorni e anche più. Ma non si tratta di limiti, 199 enologica edizione 2009 familiarità con la terra. Ha sempre lavorato da solo, non ha mai avuto aiutanti e ha sempre cercato di operare al meglio delle sue possibilità. Fornisce al ristorante il 90% del suo fabbisogno estivo, compresi i vegetali brutti ma buoni che il mercato finirebbe per scartare. piuttosto è un’opportunità. F - È come cucinare con quello che hai in casa, organizzare qualcosa di buono con gli avanzi trovati casualmente in frigorifero. Se vuoi determinate erbe o fiori, e non li trovi, devi ingegnarti per adeguare la tua idea al palinsesto. Ma non sarei troppo drastico, perché si parla di un selvatico che ha una stagionalità, gli asparagi selvatici per esempio sono reperibili dai primi di marzo a metà maggio e in quel periodo possono essere in carta. Magari c’è un clima siccitoso e non si trovano, se non hai la donnina che si infila nel bosco. C’è anche chi ricorre alle tecniche moderne, che secondo me vanno usate il meno possibile, in modo quotidiano e a breve raggio. Cosa fate quando un ingrediente manca? F - Abbiamo un menu con una cartella più grande, che contiene i piatti alla carta, un menu del territorio, un menu a sorpresa, chiamato “tipico terrestre”, e un menu a parte che riguarda il pesce. Perché non puoi trovare tutti i giorni le stesse varietà di pescato. Pier Giorgio ogni mattina va a fare la spesa come una casalinga, torna a casa, pulisce i suoi pesci, vede mia moglie Stefania e le comunica le variazioni del caso. L’intervento può essere dovuto tanto alla reperibilità che alle oscillazioni del prezzo, perché magari quei prodotti c’erano già ma non erano convenienti. Il discorso è relativamente più semplice nel campo delle carni. Oggi c’è la possibilità di andarsi a cercare piccioni splendidi, conigli fatti come devono essere fatti i conigli, galletti ruspanti. C’è gente che sta rimettendo in piedi le razze territoriali, ma non è semplicissimo avere questi prodotti ogni giorno. Anche il gusto dell’ingrediente selvatico è più variabile. P - È proprio lì il bello: percepire questo cambiamento anche minimo… Se raccogli un’erba quando è in fiore ha un sapore, se la raccogli prima ne ha un altro. Perché ogni pianta attraversa una seria di fasi: nasce, cresce, fiorisce, muore; e parallelamente cambia sapori, consistenze, tessiture, profumi. Mi viene in mente il meliloto, un’erbaccia che cresce in mezzo all’erba medica nei fossi: appena nata è molto tannica, crescendo comincia ad attenuare questa sensazione verde e amara, poi quando fiorisce raggiunge il massimo della sua espressione aromatica, con note di anice, liquirizia, erba bruciata. Io la uso soprattutto in infusione. Il caso della borragine è diverso. Tutti pensano che il momento migliore per usarla sia la primavera, quando è in fiore, anche perché diventa più visibile. Mentre dal punto di vista gustativo è il periodo peggiore, perché sta per morire, trasferisce tutta la sua forza ai fiori e le foglie cominciano a diventare coriacee, sviluppano un sapore molto intenso di verde, moltiplicano la fibra con poca polpa e poco succo. Da settembre a novembre, quando spunta, è migliore. L’ho scoperto perché me l’ha detto un contadino che va a raccoglierla per me. “Ma non la vuoi la borraggine?”. Eravamo intorno al 10 di ottobre, c’era stata una settimana di pioggia, poi era venuto fuori un gran sole e la borraggine cresceva dappertutto, quasi fossero spinaci. Mi ha spiegato che ha un ciclo vegetativo molto più lungo di quanto non si pensi. Spunta in settembre, d’inverno con le gelate molto spesso si secca e in primavera inoltrata ricresce. 200 P - La scuola alberghiera e molte cucina professionali; c’è il cliché che la migliore stagione per le erbe sia la primavera ma non si può schematizzare in questo modo. Qui attorno per esempio le erbe crescono più tardi che a valle. È una questione di maturazione… Ho conosciuto un ragazzo che alleva il pollame allo stato brado in dodici mesi, contro la consueta quarantina di giorni. Mi ha dato due polli da sentire, mi sono piaciuti ma non mi hanno colpito, perché mi aspettavo una carne molto più rustica e tenace. L’animale va ucciso quando è pronto, forse bisogna aspettare addirittura di più per trovarlo “maturo”. Si tratta comunque di un pollo allevato, non di un selvatico. P - Io lo chiamo pollo selvatico perché si trova sulla linea di confine, cresce in libertà, viene covato in mezzo all’erba alta un metro e mezzo e può essere mangiato da volpi, tassi, cani, gatti e cornacchie. Arrosto lo puoi usare come un mattone; meglio la bassa temperatura o una cottura accorta, che sia un tegame di coccio o di ghisa. Tutte cotture che ho provato. Quando svolgi questi esperimenti? P - La mattina, perché il ristorante è aperto solo a cena. Ho tantissimi quaderni dove da anni appunto le idee delle ricette, e tutto quello che mi passa per la testa. Fogli volanti, foglietti, quaderni lasciati a metà. Come nasce un piatto? P - Non so perché, difficilmente trovo subito la strada maestra. Di solito parto da un’idea di base, che può essere una casualità. Un giorno faccio una cosa, la lascio in sospeso, perché altrimenti mi stanco, poi magari mi torna in mente facendo qualcos’altro. Allora vado a leggere i miei quaderni. Può trattarsi di un processo razionale o di una razionalizzazione ex post, non ci sono regole. F - Quando cambia il menù compaiono venti piatti nuovi tutti insieme. È come una favola. Ed è anche una bella soddisfazione per me, visto che sono un goloso, questa è casa mia e tutti i giorni ceno al ristorante. Come si è sviluppata la ricetta per Enologica? P - Il punto di partenza è stata la ricotta di erbe. L’anno scorso in inverno la salsa di borragine è impazzita perché l’avevo scaldata troppo. Anche la clorofilla col calore coagula, ma in modo molto blando, mentre la borragine forma grumi che non si sciolgono più. Allora ho scritto sul quaderno: “Prova: scalda il frullato di borragine fino a farlo coagulare”. E non ci ho più pensato. Quando mi hanno invitato a Enologica mi è tornato in mente: facciamo il formaggio? Poi sono andato per esclusione. Visto che sto facendo un formaggio senza latte, con la stessa consistenza e la stessa tessitura di sapore, vado ad aggiungere quello che manca: il latte. A me piace moltissimo l’aringa, che in Romagna si è sempre mangiata; mi interessava per il sapore, perché il formaggio di borragine è evanescente, non per la testura, che nel piatto c’è già. Quindi mi serviva qualcosa che intrappolasse quel profumo: di nuovo il latte, dove si mettono a bagno le aringhe per eliminare l’eccesso 201 enologica edizione 2009 Chi ti aveva indotto a sbagliare? di sale e affumicato. Anche se di solito il latte si butta, mentre io faccio il contrario. Col fumo volevo anche rievocare le erbe ripassate, che sui bordi del tegame si sbruciacchiano un po’. Per finire ho aggiunto una salsa fatta come una crema inglese salata, con la funzione di trattenere gli aromi sul palato, fungendo da “arbitro” e legante fra i diversi elementi. Molta riflessione e poca tecnica. È una scelta? P - Per arrivare a questo risultato, secondo me non serve. La tecnica dipende dal mio scopo, perché in un posto posso arrivarci in macchina, in un altro magari con le scarpe da tennis. Non può mai essere un dogma. A proposito del vostro abbinamento, può esistere un vino selvatico? F - La mia filosofia dell’abbinamento non è schematica, segue la regola della piacevolezza. A proposito di vino selvatico, mi vengono in mente un paio di esempi. Andrea Bragagni fa dei bianchi che sono espressione della terra. Bevendoli avverti una sensazione di selvatico, perché riportano a com’era il vino 50 anni fa. Anche il rosso di Filippo Manetti, San Lorenzo Campiume, rievoca gli odori delle cantine dei contadini. Quindi associo il selvatico a un discorso della memoria. Se non selvatico, antico: ciò che ha preceduto l’evoluzione del vino, come ci hanno insegnato a bere, nel bene e nel male. “Le Città Invisibili.” Asparago Di Altedo 202 Igles Corelli Lo sguardo è lucidissimo: sul fluire di questo scampolo di Po come su passato, presente e futuro della cucina italiana. Con qualche rimpianto: le occasioni mancate, le intuizioni inascoltate. Dalla trattoria dei genitori ad Alfonsine all’alberghiero di Brisighella, poi le navi da crociera e la rivoluzione… la storia di Igles Corelli scorre via come un gioco. “Da piccolo, quando nessuno mi vedeva, costruivo le capanne con l’angolo del fuoco: già allora mi divertivo con il cibo”. Dal 1980 al 1995, il suo Trigabolo è un cenacolo insuperato e una fucina di invenzioni. Nei compagni d’avventura, Bruno Barbieri, Mauro Gualandi, Italo Bassi, Marcello Leoni, Pier Luigi Di Diego, si riconoscono i segni distintivi di un’affiliazione marchiante: la separazione delle cotture, l’impiego del sale grosso e delle erbe aromatiche, lo stile esuberante dell’impiattato. E se non erano mille, avevano la camicia rossa dei garibaldini. Lanciati contro l’ancien régime di una gastronomia renitente all’innovazione quanto incline all’esterofilia, facile terra di conquista per brigate straniere. Oggi come allora, “l’importante è trovare uno stile italiano che non c’è”, partendo inevitabilmente dai primi. Ad Enologica sfileranno le reinvenzioni del risotto e della pasta, citazione e sviluppo di due classici territoriali del Trigabolo, che continuano a far brillare la loro dinamite nel tempo. Più che tecnologia è tecnica avanzata, che per Igles significa radiografare il prodotto. L’anguilla buona, per esempio, è quella argentea, meglio se di Valle Nuova perché più grassa. Mentre diversi sono i cantieri di ricerca portati avanti sul confine col selvatico, che siano i frutti dimenticati di Tonino Guerra o il pollame di Monica Maggio. Produttori che si rivolgono a lui perché immetta gli ingredienti più arcaici nel flusso della contemporaneità. La precucina come gastronomia contropelo, sorta di viaggio à rebours nella materia. “La Locanda della Tamerice si trova nel preparco del delta del Po; sarebbe meglio della Camargue, se solo si volesse. le anguille arrivano attraverso i canali da Comacchio; poi cominciano due valli: la Val Giralda e la Val Sacchetta. Dentro qualche tino ancorato a filo d’acqua, il cacciatore sta chinato, mette giù gli stampi, fa il richiamo e quando vede il selvatico spara. Ma nel parco è assolutamente vietato. Qui non puoi usare neanche l’insetticida per le mosche”. L’ecocucina è una scelta obbligata, fin dal premio ricevuto nel 2004 dalle mani di Carlin Petrini per la raccolta differenziata e il riciclaggio. Quali piatti presenterai ad Enologica? Un risotto relativo alla caccia della valle, alzavola, fischione, moriglione, germano, moretta e folaga, e una tecnica di cottura della pasta con i funghi di stagione. 203 enologica edizione 2009 Ex Ristorante Locanda della Tamerice ora Atman Via Roma 4 - Pescia (Pt) Tel. +39 0572 1903678 - www.ristoranteatman.it Parlaci del risotto. Uso un riso Rondolino, che essendo invecchiato tre anni ha l’amido concentrato e non ha bisogno di tostatura. lo porto a cottura con il vino dealcolizzato, un brodo misto di carcasse e il ragù delle cosce. I petti a cubetti vengono incorporati all’ultimo momento, dopo essere stati saltati separatamente, perché i tempi di cottura variano, per esempio la moretta è più grassa del fischione e cuoce in fretta. Mentre in mantecatura utilizzo un burro aromatizzato, che ottengo in questo modo: tosto gli odori e le carcasse, aggiungo un blocco di burro lontano dal fuoco e quando si scioglie catturo le impurità; poi decanto, filtro, ripongo in frigorifero e in freezer. Perché più il burro è freddo, meglio si monta il riso. Bisogna andare piano piano, senza mai superare i 45 gradi. In finitura aggiungo Parmigiano, noce moscata, uno zabaione salato o un’aria di prezzemolo. Come mai hai scelto un risotto? Perché è un piatto problematico. Ci sono sempre quattro o cinque errori: tanto per cominciare la tostatura del riso con un grasso, che impermeabilizza il chicco, impedendogli di insaporirsi con l’intingolo; o il soffritto, che col riso rischia di bruciare. Se la tostatura salta, invece, occorre un grande riso, che abbia l’amido concentrato internamente, quindi la parte esterna dura come il cuore. Perché la tostatura serve a questo: indurire la superficie, in modo che l’amido non fuoriesca e la cremosità risulti solo dal burro. Il terzo errore è l’inserimento del vino. I migliori lo versano caldo, ma l’alcol va eliminato prima per la sua acidità. E poi la mantecatura: utilizzare un burro freddo e non ghiacciato, al naturale. In questo modo il riso alla fine sa di burro. Invece bisogna usare un burro aromatizzato, perché i grassi sono vettori del gusto. Ho scelto il riso perché con lui mi sono sempre scontrato. Il mix delle carni ha motivi precisi? Sì, perché portano note diverse. Per la pesciosità ci sono i rallidi, che mangiano in profondità, si cibano di alghe e sanno di pesce; parlo di folaga, fischione e codone. Il germano, la canapiglia e la moretta invece si nutrono di granaglie e hanno un gusto meno forte. Quindi taglio il pesante con il delicato. Facendo un risotto classico con una lunga cottura, avrei un blend finale, mentre qui sotto i denti trovi diversi gusti e consistenze. Tradizionalmente la folaga si mangiava da sola, ma era quasi cattiva. Fra la pelle e la carne ha un grasso giallo che è molto pescioso e prima dell’uso va del tutto scartato; si può anche sbianchire per eliminare il retrogusto. La scala è questa: il gabbiano, poi la gallinella e la folaga, con un sapore di pesce che si attenua. I selvatici che usi sono tutti territoriali? Sì, nel senso che ci sono e li ho conosciuti qui, da come si mangiavano in zona; però non posso usarli perché manca il macello. Quelli che mi porta il cacciatore, potrei servirli solo a lui, perché tutto quel che vola è proprietà dello stato. La situazione è paradossale; in certi periodi ci sono selvatici in quantità industriali, allora vengono soppressi e li ruspano, perché dentro ci sono il piombo e l’acciaio. È così da quando ero un cuoco esordiente. 204 Hai dedicato un libro alla cacciagione. Perché ti interessa così tanto? Il sapore mi intriga, sento la terra che pulsa. Non so se fa parte del mio dna, ma comunque è un ricordo d’infanzia; ho sempre mangiato selvaggina da piccolo. Poi bisogna aggiungere che è priva di colesterolo, è un’altra cosa importante. A casa tua si mangiava molto selvatico? Sì, privatamente. Mio nonno Antonio, cacciatore e fiocinino, era soprannominato Mingocc, perché a quei tempi l’unico divertimento era il bere e lui aveva l’abitudine di sorseggiare. In inverno, quando non poteva andare né a caccia né a pesca, si metteva alla finestra con le trappole per catturare i passerotti. Per la polenta mia nonna ricavava un intingolo buonissimo. Ma l’anguilla era lui a cucinarla, lo chiamavano in tutti i festival dell’Unità. Era un comunista sfegatato e aveva la barca rossa, anche se andava di frodo; nonostante fosse amico dei guardiani, ha fatto mesi di galera. Io però ho cacciato solo due volte, in Scozia e in Polonia. Ho centrato una volpe da dietro e i cani l’hanno sbranata, allora mi sono detto che non avrei più sparato a un animale. È stato impressionante. Ferran Adrià sostiene che la carne offre poche opportunità al cuoco creativo, a parte le frattaglie e la selvaggina, appunto. Non capisco perché. Io non darei mai il massimo punteggio a un ristorante che fa solo pesce, perché è troppo facile. Ma deve essere il motivo per cui adesso ha spostato la stagione di apertura ai mesi freddi. La selvaggina per un cuoco è molto complessa, perché ogni animale è un caso a sé. Ho amici che cacciano la grouse in Scozia. La cosa importante è che non venga starnata, perché mangia l’erica e i frutti di bosco, quindi il pasto dentro è profumatissimo. La lepre al contrario va starnata subito, e deve essere giovane, non vecchia. Tradizionalmente si è sempre cucinato il fagiano maschio, perché si fa in bellavista, eppure la carne della femmina è migliore. E così via. Quando ti arriva un selvatico, lo studi? È difficile spiegare, innanzitutto lo guardo bene per capire l’età. Poi c’è la stagione. Non uso mai la prima caccia degli anatidi, quella che arriva fra agosto e settembre, perché proviene dal Mar Rosso, quindi è bruciata dalla salsedine. Ed è magra. In seguito inizia a nutrirsi e cambia la penna, con spunzoni che rendono difficile la pulizia. Ma dopo un paio di mesi è già bella grassa e la piuma si stacca agevolmente. Quello è il momento migliore. La caccia della grande distribuzione è diversa? È allevata, quindi l’animale ha un gusto standardizzato. Ti faccio un esempio. Qui a valle è pieno di 205 enologica edizione 2009 adesso è passata la legge sugli ungulati dell’appennino, ma da noi non cambia niente. Il cuoco si trova davanti a un dilemma: o si standardizza con la grande distribuzione, oppure rischia di scivolare nell’illegalità. sambuchi, quello che hai visto all’ingresso lo utilizzo per le marmellate. È un arbusto come gli altri, ma le bacche sono più grosse e saporite delle altre, non so bene perché. Al momento della raccolta devo fare le lotte con gli storni, che arrivano a frotte. Nutrendosi in questo modo, saranno sicuramente migliori degli altri uccelli. Sono come i polli di Monica Maggio, che mangiano i germogli. Si possono definire polli semiselvatici? Sì. Intanto sono razze recuperate, oppure importate per determinati utilizzi, una per le uova, l’altra per l’arrosto o la griglia. Monica mi ha insegnato che ogni pollo ha la sua vocazione, come la selvaggina: ci sono cacce che vanno bene allo spiedo perché sono grasse, e cacce da cucinare con un supporto di grasso perché ne sono prive. L’ho conosciuta perché è venuta da me a fare un corso di cucina; lei è biologa e aveva preso un pezzo di terreno su una collinetta. Un giorno mi ha portato un pollo e su sua indicazione l’ho fatto arrosto. “Porca miseria se è buono ‘sto pollo”. “Li faccio io”. “Perché non produci qualcosa anche per me?”. Ho iniziato a comprarli io, poi Bruno Barberi, Alajmo, Marcattilii, Bottura… I prodotti semi-selvatici sono stagionali? Il pollo lo puoi avere tutto l’anno, ma logicamente lo devi programmare. Non è che Monica mette tot polli sotto la batteria; devi ordinarli in anticipo. Da lei prendo il muflone, la cornella, le faraone, che lascia volare libere. Hanno unghie lunghissime, ma la carne ha un sapore che avevo dimenticato. Perché quando ero al Trigabolo le prendevamo da Bucchi a Fusignano, ed erano strepitose, poi le avevo perse. Che vino abbini al riso? Flavio, il mio sommelier, vuole abbinare il Fortana. Vuole stare sul territorio, perché è autoctono come la selvaggina, e in certe zone è a piede franco. Anche se oggi gli manca l’ambientazione, perché le dune non esistono più. Un tempo lo proteggevano dal vento, ma adesso sono state rase al suolo. A parte la zona di Volano. Veniamo alla pasta: hai scelto un’altra ricetta selvatica. Sì. È uno spinosino, cioè un maccheroncino di Campofilone, portato a cottura con un brodo di funghi particolare. La pasta viene fritta in olio extravergine di oliva a 170 °C e bagnata con il brodo bollente. Grazie a questo scarto termico assorbe il liquido, ma nei primi minuti non va toccata perché essendo disidratata, si spaccherebbe. L’esperienza sta nell’aggiungere pian piano la giusta quantità di brodo, in modo che il risultato sia cremoso e non brodoso; e poi lo spinosino si sfila, non si impacca. Occorrono nove minuti anziché i soliti due, ma il gusto finale migliora del 50%. Dal capello d’angelo al tagliolino, alla Tamerice friggiamo e risottiamo tutte le paste secche. Lo facevo già negli anni ’80. Due piatti poco tecnologici ma molto italiani. Non è vero, perché c’è la tecnica di cottura, insieme alla ricerca della materia prima. Poi è difficile fare tecnologia su due primi. Penso anche al brodo di funghi, che è fatto con le radici, la terra. 206 Quali sono i funghi e gli altri prodotti selvatici di questa zona? A maggio ci sono le monachelle, una specie di spugnole; in autunno i pioppini, che qui sono buonissimi, le orecchie di elefante e le mazze di tamburo: tutte varietà della mia pasta. Poi le ortiche, che in primavera sono di una bontà incredibile, il tarassaco, il sambuco, la robinia. Nel fiume si pescano il luccioperca, qualche anguilla e il pesce gatto. Qui sa un po’ di canna, è difficile trovarlo buono; mentre il luccioperca lo puoi usare affumicato o marinato, gustativamente è neutro ma è un ingrediente da sfruttare. Fra i frutti la pesca Sant’anna, la pera volpina, il giuggiolo. Tutta roba che mi ha dato Tonino guerra, dal giardino dei frutti dimenticati. Il suo contadino si chiama Italo e ogni anno mi porta qualcosa; quest’anno il moro e l’uvaspina. Non sono prodotti selvatici in senso stretto, ma si abbinano bene alla cacciagione. Soprattutto la pera volpina, che ha una consistenza simile alla patata americana, è un po’ ruvida e non troppo dolce. Tu usi solo prodotti territoriali? No, io credo molto nella cucina garibaldina, che abbraccia tutta l’Italia. Il territorio mi interessa per quello che può darmi e che riesco a interpretare, ma se l’aglio di Sulmona e le patate di Avezzano sono migliori, le uso. Nel periodo dei funghi, siccome sono socio del club del cardoncello, me li faccio spedire. Adesso con il traco riesci ad avere anche l’ingrediente più fragile, puoi ordinare persino i ricci di mare. Non credi al chilometro zero? Solo per i prodotti tipici. Il chilometro zero è una questione di memoria più che di approvvigionamento. Tanti cuochi dicono di andare ogni mattina al mercato, ma al mercato non trovi certo la qualità. Hai dichiarato che il massimo della creatività, oggi, sta nella collaborazione fra il cuoco e il produttore. Vuol dire che spostandosi a monte, nella messa a punto del prodotto, l’intervento in cucina può diventare più soft? Certo. Tra l’altro più il 207 enologica edizione 2009 Io ritengo che sia la parte migliore, perché ha più sapore. Utilizzando i funghi delle Murge, un ecosistema incontaminato, non c’è nemmeno il problema dei metalli pesanti. Adesso Roca distilla la terra, ma noi la usavamo già al Trigabolo, su ispirazione di un amico giapponese. Eliminata la spugna, pelavamo il gambo del porcino e raccoglievamo tutta la parte del terreno sotto la radice. Questi scarti erano tostati con un po’ di odori, li raffreddavamo con il ghiaccio, incoperchiavamo e cucinavamo piano piano. Dopo un’oretta si filtrava con una calza, si raffreddava nell’abbattitore e si lasciava decantare tutta la notte. Il giorno dopo di nuovo stamina e decantazione. Ti posso garantire che quel brodo era dieci volte migliore del porcino. Ma la clientela non lo sapeva, che dentro c’era la terra. cuoco invecchia, più elimina i fronzoli. È la maturità. Quando mi sono diplomato, il professore mi ha detto in dialetto: “oh Igles, adess ti è un chef. L’impurtant è pastrucèr. Tutto il contrario del mio concetto di cucina. Buttare gli ingredienti a caso è la cosa più sbagliata: più ne butti, più devi rincorrere il gusto finale, senza che la gente ti segua. Ma una volta il piatto dello chef era l’assemblaggio dei rimasugli in frigorifero. cucinavo la selvaggina a lungo, adesso niente. Un germano al barbecue lo faccio in 6-7 minuti, con le cosce snervate e battute come farcia. Per quanto riguarda le salse, non amo quelle forti, a base di ginepro e vini rossi. Preferisco salse dolci per contrasto, a base di miele o marmellate. Com’era la cucina della selvaggina al Trigabolo? Le tecniche avanzate possono essere utili per fare una cucina naturale? Sì. Nella tecnologia ci ho sempre creduto. L’unica cosa che mi manca, perché preferisco la cottura ollare, è il Roner. La bassa temperatura fatta in quel modo non mi dà soddisfazione, questo gusto lo sento un po’ monocorde nei ristoranti in cui vado. Ho visto che in carta hai il menu di caccia. Lo proponi ogni anno? Sì, è composto di un antipasto a crudo, tipo tartare, un risotto e poi germano, fischione o moriglione. Tutti animali territoriali, di cui abbiamo già parlato. Potrei fare anche il capriolo o il cervo del Boscone, ma gli esemplari sono troppo pochi. Com’è cambiato il tuo modo di cucinare la selvaggina negli anni? Inizialmente marinavo molto, perché mi avevano insegnato che il selvatico non doveva sapere di selvatico. Oppure le frollature, adesso le utilizzo negli animali vecchi, ma raramente. A me piace che il selvatico sappia di selvatico, non che il gusto venga eliminato in favore di note fegatose. E poi i tempi di cottura: mentre prima Le cotture erano lunghe, ma la rivoluzione era già iniziata. Siamo partiti col risotto di folaghe, che era quello vallante. Allora c’era un riso meno importante, anche la tecnica era diversa. Ma il sapore c’era tutto, perché era roba sparata procurata da Giacinto Rossetti o da Gigino Basigli, i due patron. Come piatto era difficile, tanto più che a valle originariamente la folaga veniva tagliata col curchél, cioè il gabbiano, e condita con pecorini stravecchi, in modo da coprire i sapori, perché qui c’è sempre stata una comunità di sardi. Com’era organizzata la brigata del Trigabolo? l’unico cuoco vero ero io, gli altri erano talmente piccoli… Mauro, Italo e Marcello avevano 15 anni, Bruno 17 e mezzo. Erano tutti ragazzini che venivano dalla scuola alberghiera. Poi siamo cresciuti assieme, praticamente. l’aspetto vincente è stato avere tutti ragazzi di argenta, a parte Bruno di Medicina e Italo di lugo, a pochi chilometri da lì. Persino la sfoglina era di Argenta. Quindi non c’erano velleità di andare da un’altra parte. Avevamo le morose lì, avevamo gli amici lì. Man mano che i ragazzi crescevano, si andava a ballare assieme, giocavamo a tennis o a calcio al pomeriggio, ci scambiavamo le morose. Insomma era un gioco. 208 Sicuramente l’allegria, un senso di libertà e di liberazione da un’Italia vecchiotta. Quando in giro facevano le penne con la vodka, i tagliolini panna, prosciutto e salmone o i maccheroncini con la pancetta, la panna e l’uovo, noi avevamo in carta una crema con il pomodoro del peduncolo cotto a 65 °C e il gelato di Aceto Balsamico Tradizionale. Per dire la differenza. Se noi leggiamo il menu del Trigabolo, riconosciamo le ricette attuali. Avevamo già pensato con Marin a un tegame con il coperchio ad azoto… Dal tuo racconto trapela un senso scanzonato di anarchia. C’era anche questo. Fra i pazzi ricordo Ricci Gianni, l’assessore alla cultura di argenta, che era il nostro palato di riferimento. Dicevamo che non capiva niente, però l’invitavamo sempre ad assaggiare. Ci dava anche lezioni culturali, come Giacinto, che per noi è stato un padre. Non ho mai conosciuto nessuno che avesse una cultura paragonabile sul vino. Se eravamo liberi, prendevamo il pulmino a Lugo, uno di quei Volkswagen da otto-nove posti, mentre noi eravamo sempre in dieci o undici; andavamo ai concerti rock e poi mangiavamo in un grande ristorante. Era in quei momenti che nascevano i piatti. Quindi ci divertivamo, ma la cosa bella era che allo scoccare del coup de feu, l’arco era non tirato, di più. Era una cucina italiana? Territoriale, direi. Come quella dei Cantarelli. Io e Giacinto andavamo a mangiare da loro una volta al mese, mentre loro non si spostavano mai. Erano aperti sette giorni su sette, infatti Mirella è morta attaccata alla stufa, come gli attori in scena. Le prime volte mangiavo sempre le stesse cose, perché erano talmente buone… La mousse di cioccolato, la faraona ai carciofi, il savarin con la lingua salmistrata e i culatelli. Era una cucina tradizionale, però con un grande sapore e la forza dei ricordi d’infanzia. Dopo il pasto si faceva il giro delle porcilaie, che era lungo due chilometri, poi Giuseppe serviva un torbato. Mentre allora si beveva bianco e nero, non dico nemmeno bianco o rosso. Ricordo che all’ingresso c’era questo bancone con l’affettatrice per il culatello, la figlia handicappata, poverina, e poi dei portalibri con un Ligabue originale e i detersivi. Entravi dentro, lui indossava un maglioncino rosso e i pantaloni di velluto. C’era la stufa con il cannone che girava mezza sala e l’argenteria, la Fiandra, i cristalli. Ti portava la mousse di cioccolato in una coppa di peltro e sotto c’era il marchio della Coca-Cola. Parafrasando Claudio Meldolesi, autore di Fra Totò e Gadda: sei invenzioni sprecate del teatro italiano, si potrebbe parlare di Cantarelli e del Trigabolo come di clamorose occasioni mancate dalla nostra cucina. È davvero possibile una grande cucina italiana, se nei ristoranti che contano la pasta viene stesa a macchina? Me lo chiedo anch’io. E ti racconto una cosa: la gianna era la sfoglina del Trigabolo e 209 enologica edizione 2009 Se tu dovessi descrivere la cifra di quel locale, che ha lasciato così tanta nostalgia? È questo il ristorante del futuro? quando arrivava la comanda, partiva. Aveva l’impasto pronto e i ravioli li faceva espressi. La chiamavamo affettuosamente Giannina, perché era un po’ la nostra mamma e ci accudiva. Perché quell’esperienza è finita? Fra la prima e la seconda Repubblica, 2200 etichette ad Argenta… Già allora era dura, e lo sarà sempre di più. Il grande ristorante è un contenitore vecchio, perché la gente non ama più mangiare a prezzi esorbitanti sotto gli occhi dei camerieri, specie i giovani. Un locale che fa la ricevuta fiscale alle due e alle undici di sera, non può reggere i costi. Per sopravvivere deve rendere dieci ore al giorno. I posti con offerte diversificate, dalle colazioni ai pranzi, all’aperitivo sono quelli che funzionano. Il locale dove il cliente sta seduto tre o quattro ore secondo me interessa pochi, a meno che non sia di moda. Sì, piccolo e multifunzionale, con un alto tasso di interattività fra cuoco e clientela. Credo anche in un locale capace di offrire risposte diverse, a imitazione di una multisala, per abbattere i costi. Se tu fai 50 coperti, hai bisogno di almeno otto camerieri, almeno un sommelier e almeno una brigata di sette persone. Se fai una multisala e dividi il ristorante in quattro parti, con dodici posti ciascuna, te la puoi cavare con 5 camerieri e 5 cuochi. In questo modo hai sempre una serie di novità da proporre. Perché piace l’Ikea? Perché ha degli ambienti diversi, tu ti sposti e li vedi. Ma lì hai cucina contemporanea, cucina creativa, cucina a base di pesce, cucina di cacciagione e il cliente può scegliere ogni sera, come al cinema. Mentre tu abbatti i costi. 210 Massimo Bottura Nel suo Vocabolario estetico, Roger Caillois ha descritto l’artista con tratti che possono riguardare la cucina da vicino. “l’arte consiste spesso nel seguire al contempo indirizzi tra di loro in contrasto. L’artista somiglia sempre un po’ senza parere, a quegli atleti che eseguono con facilità e come per gioco movimenti in contrasto con la natura e con le nostre abitudini. Slanciano un braccio o una gamba in un senso e l’altra in quello opposto. Muovono una mano lentamente e l’altra rapidamente, e tutto in armonia. Chi tenta per la prima volta questi gesti bizzarramente combinati, si rivela sgraziato e ridicolo. Si direbbe quasi che abbia perso l’uso dei suoi arti”. Righe utili, ho pensato, per tratteggiare il ritratto di Massimo Bottura e della sua specificità sulla scena gastronomica contemporanea. Laddove infuria la battaglia fra il gusto e il concetto, la tradizione e l’avanguardia, la tecnica e la selva, il suo gesto acrobatico succhia energia da entrambi i campi sfoggiando una coordinazione esemplare. Nessuno fra i colleghi è capace di gesti tanto contrastanti, quanto arditi e necessari. Perché “è raro e difficile conciliare virtù che abitualmente si esaltano proprio nelle loro caratteristiche meno adatte ad essere accostate”. Soprattutto conciliarle con naturalezza e in ogni piatto del menu. A questo virtuosismo sincronistico, che fa la tenaglia ammaliatrice dei suoi piatti, Massimo non è arrivato senza sforzi, ma coltivando mondi in contrasto fra cui ha fatto tenacemente la spola. La sua formazione atipica gli ha regalato uno sguardo naturalmente straniante: cuoco e non cuoco mentre la cucina debordava in altri campi, e l’arte cercava, duchampianamente, la non arte. Una storia di reciproci sconfinamenti verso la terra franca su cui ha edificato la Francescana, mecca dei golosi ma anche punto di ritrovo per critici e galleristi di fama. Nel libro dei ricordi c’è la rezdora lidia Cristoni, che gli inoculò il virus della passione culinaria nell’osteria dove era partito patron, fuori dal seminato famigliare del business; e poi i maestri, Georges Cogny, Alain Ducasse, Ferran Adrià, sulle cui spalle è salpato all’avventura negli anni ruggenti dell’avanguardia, spari, polvere e allori. Dietro le quinte, la simbiosi con la moglie Lara è un innamoramento per l’arte contemporanea: sulle pareti dell’Osteria, dietro i battenti aperti nel 1996, si affastellano le opere d’arte e le passioni. Il selvatico è per Massimo un capolavoro di “cucina naturante”: selvatico come crudo, o meglio marinato, oppure elaborato sotto sale. Due evoluzioni del prodotto che fanno il paio con altre “tecniche spontanee”: le cotture lentissime, il sottovuoto, la bassa temperatura, alla ricerca di una prosecuzione dei processi naturali stessi. 211 enologica edizione 2009 Osteria Francescana Via Stella, 22 41121 Modena Tel +39 059 210118 - www.osteriafrancescana.it Inverano in chiave più o meno tecnologica il putrido di Claude Levi-Strauss, la trasformazione naturale dal crudo al cotto, che attraversa le sfumature della fermentazione fino a confinare col bollito. Quindi più che mai col sottovuoto, di cui Massimo è un cultore appassionato. Il prodotto sembra quasi elaborarsi autonomamente battendo cammini suoi propri. Poi c’è la metafora, il carbone per la griglia, i distillati per la polvere da sparo. Alcuni piatti di Massimo sono capolavori di metaforologia, sostituzioni millimetriche che sparigliano il giuoco espressivo e vi insufflano vita. Il selvatico può essere anche introdotto così: per la punta della penna o con una piuma che cade. Oggi la cucina di Massimo sembra scrollarsi di dosso le ultime tracce di qualsivoglia soggezione: alla modenesità, non più vissuta come un dogma o un destino; alle tecniche d’avanguardia, sempre più nascoste nel cassetto degli attrezzi; persino alle arti maggiori, citate con la disinvoltura di una messa in abisso. Libertà che parlano di una natura di ritorno. Come la lingua dedicata a Fontana, dove il taglio della materia, sorta di zolla primordiale, sembra quasi evocare la cesura metafisica di una bassa algebrica, equanimemente spartita fra cielo e terra dalla linea cieca del rispecchiamento. Quello del coltello è un gesto cosmogonico verso il bisenso delle lingue del mondo, sorta di Babele dove risuonano bollito, arrostito e brandelli di ricette planetarie: tutto quanto è cucina. “Zaratustra non vuole perdere nulla del passato dell’umanità, vuole gettare ogni cosa nel crogiolo”. Al suo fianco dal 2000 c’è Giuseppe Palmieri, più che un sommelier, un doppelgaenger di sala. I piatti della Francescana sono il frutto di un brain storming dove anche il vino è chiamato a dire la sua. Il selvatico è anacronistico, ma è anche attuale: oggi si parla di natura come nuovo verbo culinario. Nel campo dei prodotti, il tema del selvatico è vasto. Per esempio la mozzarella di bufala, dopo una masticazione prolungata, che tira fuori le note animali, esprime il gusto più selvatico che conosco. anche se non è cacciagione e non fa parte neppure del mio territorio. Il selvatico può essere una dimensione dell’artigianato gastronomico vero. Sei un talent scout di prodotti se non selvatici, quanto meno autentici. Dai capperi ai pomodori del piennolo, alla colatura di alici di Gabrio Bini. Stabilire dei rapporti di filiera che massimizzino la qualità delle materie prime è uno degli aspetti più importanti del lavoro di un cuoco. Ed è anche una responsabilità verso la comunità. Questo concetto di “artigianato applicato” è uno dei retaggi del mio apprendistato al fianco di Alain Ducasse. La coincidenza fra ciò che è buono e ciò che è giusto è fra i temi dominanti dell’attualità. L’ecocucina, ovvero una cucina a basso impatto ambientale, in simbiosi col contesto ti interessa? Sì, anche per questo amo a volte scegliere ingredienti come il pesce azzurro, buono, ma anche salutare, economico e sostenibile. Nella tua traiettoria di cuoco, hai imparato a cucinare il selvatico diversamente? L’anno scorso avevamo in carta un piccione selvatico con salsa di cioccolato amaro, gelato di polenta tostata e cereali soffiati e caramellati; quest’anno 212 Che ricetta hai scelto per Enologica? Non ho ancora scelto. Avessi avuto da svolgere il tema del mare avrei riproposto un piatto che ho creato quest’estate ragionando su una saraghina in salamoia prodotta dalla adler di Cesenatico. Mi è rimasta nel cuore. Lì volevo mettere a confronto il prodotto fresco con quello conservato, il massimo della testura con il massimo del sapore. Il pesciolino fresco viene aperto a libro, spinato, marinato per cinque minuti con sale e zucchero e sciacquato. Lo spennello con una passata di ricci di mare e olio al carbone, per spingere lo iodio ed evocare la griglia, poi inserisco del limone confit per pulire la bocca, un po’ di crescione piccante e copro con una pellicola ambrata di aceto di vino bianco e Aceto Balsamico, quindi alla fine sembra quasi un’aringa. La parte liquida del piatto è un’acqua di mare leggermente affumicata, ottenuta facendo scorrere sulla saraghina sotto sale dell’acqua affumicata con il carbone. Serve di nuovo ad evocare le grigliate, una specialità dell’Adriatico. Alla fine è un altro monocromo, per concentrare l’attenzione sul gusto bendando quasi il cliente. Ad Andalusia Sabor però abbiamo aggiunto qualche goccia di rapa rossa sui bordi del piatto, per evocare la corrida in omaggio a Siviglia. Scende piano piano fino a tingere il brodo. Sto cercando un piatto con quel carattere... il mare che ispira la terra. Il vino selvaggio, a questo punto. Giuseppe Palmieri: Sceglierò una volta che Massimo avrà messo a punto il piatto e lo farò seguendo una mia convinzione, che la grande cucina contemporanea cerca complementi, non gli abbinamenti come ci sono stati insegnati. I piatti sono già completi, con un equilibrio sottile che non va alterato. Penso anche che i grandi vini vadano lasciati alla fine, con un bel formaggio. Pasteggiando è meglio cercare bicchieri stretti e veloci, non invadenti o troppo aristocratici. E con la selvaggina? Con la selvaggina la pista giusta è la polvere da sparo... uguale zolfo... uguale Borgogna. È quasi fisiologico. la zona in cui queste note si esprimono al meglio è Meursault, un villaggio in cui lavorano quasi solo sullo chardonnay. Ma c’è un pazzo scatenato che si chiama Pierre Morey, fa viticoltura naturale e possiede una parcella vitata a pinot nero, dove produce un raro Meursault rosso di nome Les Durots. È un succo di polvere da sparo. Il 2004 poi è il prototipo del genere, con una mineralità quasi fuori controllo e uno zolfo straordinario. Questa è la risposta che mi viene naturale e questa sarà la pista che seguirò per scovare in regione un vino da abbinare alla selvaggina. Difficile, ma non impossibile, ci sono piccoli e straordinari produttori che possono stupire. 213 enologica edizione 2009 invece stiamo lavorando sull’idea della caccia, quindi la polvere da sparo e il sangue. Usiamo i prodotti di Monica Maggio o di altri fornitori; ci propongono le loro cose, noi le assaggiamo e magari andiamo a ripescare un’idea. Perché il concetto di selvatico c’è sempre, ci lavoriamo da tanto. E la base dei tagli, delle cotture non cambia. Paolo e Gianluca Raschi Ristorante Guido Lungomare Spadazzi, 12 - Rimini Tel +39 0541 374612 - www.ristoranteguido.it Questa è la storia di un ratto e di una liberazione: perché la cucina della riviera romagnola ha un’identità travagliata; serbatoi inesausti di ingredienti selvatici che sono stati lasciati addormentati, aspettando il cuoco giusto. Qui il selvatico è ancora più selvatico, privatistico, identitario, nel chiaroscuro di una ristorazione che parla un pidgin addomesticato. Sul fossato fra endocucina ed esocucina, mangiare pubblico e mangiare privato, le contaminazioni azzardano una fusion acrobatica. Come quella dei fratelli Gian Paolo e Gianluca Raschi, cuoco e maître di un’“osteria del mare” appoggiata sulla spiaggia di Rimini. Il fondatore eponimo, Guido, appena finita la guerra scese dalle colline di Mulazzano, dove era contadino, per aprire a Miramare un capanno di legno con la moglie Augusta, intuendo che l’incipiente movimento dei bagnanti poteva preludere ad un nuovo universo di opportunità. Fra le prime tende montate dai bagnini, faceva capolino qualche sparuto americano attorniato da famigliole emiliane in ferie. A loro era riservato quel chioschetto per i mangiari semplici e veloci: grigliata, spaghetti, risotto, brodetto… Ma il pesce a volte lo pescava di persona, e con un barbecue rudimentale ammanniva veraci spiedini di fortuna. Con la lentezza delle orbite astrali, mamma Tiziana affianca e sostituisce gradatamente i genitori. I suoi fornelli cambiano di poco: lo stretto necessario per ampliare un po’ la carta, seguendo le esigenze della clientela. È lei a coltivare ancora oggi l’orto a un chilometro dal ristorante, rifornendolo di ortaggi durante la stagione estiva, tutti di giornata: mare e collina sono i due bracci di un dna che continua la sua spirale nel tempo. In questo scenario gian Paolo ha mosso i primi passi da cuoco autodidatta, nato e cresciuto fra le sottane della mamma e della nonna. Una base di cucina femminile che si lascia avvertire nella dolcezza delle curve di sapore e nell’inclinazione all’amarcord. Dapprincipio ci sono i sacchi di patate da pelare, poi i panini e le piadine, e per finire le pizze. Fino alla metà degli anni ’90, quando inizia a manifestarsi il desiderio di valicare gli scogli immaginari di uno spaghetto che non c’è. Vongole con i ceci, strudel di branzino al forno, zuppetta di polpo con patate: gli stimoli arrivano leggendo, ma soprattutto a contatto col prodotto, visto che di stages non se ne parla, ad eccezione di un corso formativo all’alberghiero. È il 2002 quando con la ristrutturazione, le redini del locale passano nelle mani sue e di Gianluca, nel frattempo laureato sommelier. “Avevamo iniziato a frequentare un determinato tipo di locali, i vari Uliassi, Cedroni o l’acero rosso di Rimini, e volevamo fare il salto di qualità. C’era ancora mia madre in cucina, addetta a risotto, fritti e 214 Come descrivereste la cucina di Guido? Gian Paolo: La mia cucina è incentrata sul prodotto del territorio. Abbiamo un grandissimo patrimonio davanti, che è il pescato del mare, e un tesoro altrettanto importante alle spalle, il prodotto della collina di Rimini. I miei piatti sono molto legati alla tradizione, niente di spericolato. Perché conosco bene i miei prodotti, ma per azzardare dovrei avere uno scibile del mercato globale. Sono molto legato ai ricordi, ai sapori della memoria. Quelli di mia madre e della mia infanzia. Tanto per fare un esempio, la piadina con l’insalata, o il classico ragù di pesce che si usava una volta per fare il risotto. Non mi piace fare troppi voli pindarici per cadere magari su un errore banale. Il pesce cerco di lavorarlo pochissimo, le cotture sono molto delicate. In qualche preparazione uso tecniche moderne come la bassa temperatura e il sottovuoto, ad esempio per lo spiedino di calamari o la seppia e squacquerone. Ma cerco sempre di avere il massimo rispetto del prodotto, che si tratti di un’alice, un rombo o un cespo di insalata. lo stesso rispetto che pretendo dai fornitori. gianluca: Io parlerei di una cucina leggera, pulita, dai gusti nitidi, giocata su un numero ridotto di elementi, come si intuisce dalla sinteticità dei titoli. Per Gian Paolo è importante mantenere ben distinti i sapori. Usa pochissimi grassi, quasi tutti a crudo e quasi solo extravergine. Ma sa essere anche intuitivo e genialoide perché riesce a stupirti. Da piccoli siamo cresciuti nel selvatico. Nel casolare di Mulazzano, di fronte a San Patrignano, ogni fine settimana raccoglievamo le erbe. Quando arrivava settembre, o all’inizio della stagione, alle cinque e mezzo o alle sei di sera partivano i bagnini coi mosconi, facevano il cerchio e poi da riva si tirava su la pescata. Poi c’era il nonno cacciatore, che andava in Puglia piuttosto che in Jugoslavia, e portava a casa i fagiani e le quaglie. Mia mamma e mia nonna ci hanno sempre proposto cose naturali. Siamo cresciuti con questi input e cerchiamo di portarli con noi. Quali piatti avete scelto di proporre ad Enologica? GP - Per cominciare un piatto classico, i maltagliati con le canocchie e i fagioli bianchi, una variante della tradizione popolare italiana della pasta e fagioli che ho messo a punto cinque anni fa. C’è un brodo di canocchie preparato piano piano come si faceva una volta, che viene lasciato riposare tutto il giorno con le carcasse dentro per ottenere la massima estrazione. Poi un fondo di cipolla, fagioli e pomodori confit e la pasta cotta dentro. Alla fine si aggiunge fuori dalla fiamma la polpa di canocchia cruda per esaltare la fragranza. Il piatto selvatico è stato ideato appositamente per Enologica: uno spiedino di sarda, con un contorno di erbe spontanee e un sapore di mare un po’ deciso. I filetti sono infilzati nello spiedino, leggermente conditi con olio, sale e una spolverata di erbe aromatiche per dare un po’ di vivacità, una nota 215 enologica edizione 2009 grigliate. Una sorta di cucina a quattro mani”, racconta oggi Gian Paolo. La stella Michelin arriva nel 2007: una soddisfazione grandissima e del tutto inaspettata. dolce e fruttata. Vengono cotti in padella all’unilaterale, in modo da salvaguardare la pastosità della polpa. Sopra c’è una gelatina ottenuta dalle ossa di pesce, palamita e tonno, il gusto intenso del pesce azzurro con il sentore dell’ostrica, per spingere ancora di più verso il mare. Come erba abbiamo scelto di usare lo scarpigno, cioè il tarassaco, a crudo. Mia mamma lo coglie lungo i campi e nei giardini, perché cresce dappertutto. Vuol dire che prima di Enologica organizzeremo una scappata in campagna, per fare una bella raccolta. Mi sembra il trait d’union fra due ingredienti selvatici, di terra e di mare. L’assioma degli ingredienti autentici in affinità elettiva tra loro, come vero abbinamento di territorio. Poi c’è la fusione con la tradizione del ristorante, nella forma dello spiedino. Il confronto fra i due piatti è significativo di come vi siete evoluti? GP - Sì. Da una parte abbiamo dei sapori conosciuti, dall’altra l’estremismo gustativo della sarda, un prodotto un po’ aggressivo. Lavoro da anni sul concetto di selvatico, per il desiderio di tornare alle origini e fare conoscere determinati sapori che si stanno un po’ perdendo. E quando dico “selvatico” penso a qualcosa di difficile e caratteriale, perché di pesce allevato non ne uso proprio, tranne le ostriche e le cozze. Perché hai scelto la sarda? GP - Forse perché è il meno considerato dei pesci dell’Adriatico. Mia mamma e mia nonna al ristorante non la usavano: era cibo per i gatti, o la pastura con cui andare a pesca di sgombri e palamite. Ma a casa ci piaceva molto, fatta in padella o sulla griglia a carbone nel camino. Però non si poteva dare al ristorante. Il selvatico era qualcosa di privato, da mangiare in casa? GP - Era il mangiare dei riminesi, mentre la clientela veniva da fuori. Quando chiedevamo a mia madre: “Perché questa cosa non la facciamo al ristorante?”, lei rispondeva: “Queste cose non si vendono”, “Lin si vend”. Insomma esistevano una cucina di casa e una cucina per i turisti. a noi piaceva di più quella di casa, senza nulla togliere al ristorante. Ma negli anni ’80 era stata inventata tutta una linea di piatti, come gli spaghetti allo scoglio. E gli scogli a Rimini non ci sono mai stati. Il confine fra endocucina ed esocucina si è spostato? GP - Diciamo che il cliente è ancora un po’ titubante, per questo di solito propongo questo tipo di pesce sotto forma di piccole entrate, come offerta dopo l’ordinazione. Sto lavorando molto sulla saraghina, che è parente stretta della sarda, e sul cefalo, un altro pesce povero, un po’ scanzonato. Tutti dicono che sa di fango, ma scegliendo la ricetta e l’esemplare giusto si riesce comunque a tirare fuori delle belle cose. Sono 4 o 5 anni che lo propongo a crudo in carpaccio, e la gente di Rimini, che se lo aspetta sempre un po’ muschiato, non potrebbe mai riconoscerlo. Perché scelgo animali pescati al largo, con le carni belle chiare e sode, la livrea molto lucida, argentea e la macchiolina dorata sopra la guancia. Mentre quello pescato in zone paludose come le valli di Comacchio, nelle vicinanze dei fiumi e dei porti, ha una livrea verdastra, dovuta alle alghe e al fondale salmastro. Per quanto riguarda la sarda, deve essere rigida, soprattutto 216 Occorre una conversione della clientela? GP - La saraghina preparata sulla griglia, servita con il primo taglio del radicchio, quello molto tenero, la cipolla fresca e l’aceto fatto in casa è uno dei miei piatti preferiti, ma non è facile venderlo, forse perché bisogna trovare la forma giusta, il vestito più adeguato. Eppure battiamo questa pista da anni. Mi viene in mente un piatto del 2002-2003, dove ricorre il connubio fra il selvatico di mare e quello di collina: i cassoncini di piada con le rosole. Il papavero spontaneo viene pestato a crudo, condito per farlo spurgare, strizzato e addizionato di alici, che restano quasi crude all’interno, mentre la piada cuoce sopra il testo. È un piatto tipico di qui, da novembre fino alla fioritura del papavero, verso giugno, perché poi la rosola diventa tossica. A fornircela è Cristian Valloni, che ha un negozietto in via Oliveti. Lavora a contatto diretto con i raccoglitori, in particolare con una donna che va in campagna, sui bordi dei fiumi e dei fossi. Quindi una cassa ogni tanto si rimedia. Cosa significa per un cuoco lavorare con l’ingrediente selvatico? GP - Uno sforzo supplementare. Prima di tutto è necessario osservare la stagionalità; la carta deve essere duttile, con piatti estemporanei per ovviare ai capricci meteorologici. Poi il prodotto non è mai standardizzato, quindi occorre un’attenzione particolare e l’esito a sua volta non è standardizzabile. Le erbe e i prodotti della terra, raccolti in una giornata umida e piovosa, sono diversi da quelli di piena estate; ma anche il cefalo può variare secondo la zona di pesca. Come tutte le cose dove manca una programmazione, il prodotto selvatico un giorno ha un gusto e una forma, il giorno dopo ne ha altri. Bisogna sempre assaggiare. Dove comprate il pesce? GP - Usiamo solo pesce pescato, di conseguenza pesce selvaggio. Ci riforniamo nelle stesso negozio da tre generazioni; sono io a fare gli acquisti ogni mattina di buon’ora. Il pesce dell’alto adriatico è straordinario, uno dei più saporiti in assoluto. Il fatto che i fondali siano bassi aumenta la salinità e di conseguenza il gusto. Le pezzature sono ridotte, a parte una piccola zona verso Pesaro e Ancona chiamata Sprea, che sembra fosse il letto di un fiume preistorico quando l’adriatico non esisteva. È abbastanza rocciosa e ospita pesci più grossi, scorfani, dentici e quant’altro. Ma l’Adriatico è noto soprattutto per sogliole, canocchie, sarde, cefali, triglie di sabbia, ultimamente tante mazzancolle… Poi ci sono merluzzi, rigatine, palamite, il passaggio dei tonni nel periodo estivo, con qualche ricciola e qualche spada. Il pesce pescato è tutto ugualmente selvaggio? GP - Non credo che il metodo di cattura possa incidere, ma può influenzare la qualità del prodotto. E qui torno a quanto dicevo prima sul principio del rispetto, che deve reggere tutta la filiera. Ad esempio i due metodi di pesca in uso qui da noi: con la rete d’imbrocco, 217 enologica edizione 2009 nella zona del ventre, con un colore blu elettrico che spinge sul nero e le scaglie attaccate. Se ti si scioglie in mano, non è il caso. Deve essere di giornata, e il giorno dopo deve essere di giornata di nuovo. che viene stesa di notte in modo che il pesce si incastri, soprattutto durante il fermo pesca, oppure con lo strascico. Il secondo è più violento, ma dà un pesce migliore, perché non muore nella rete dopo essersi dimenato per ore, quindi resta bello tonico. la lenza e il parangallo sono ancora superiori, ma il quantitativo è insufficiente. GL - Poi conta il modo in cui si conserva il pescato. anche per questo il pesce d’inverno è più buono, perché se resta qualche ora sul ponte a 5 o 6 °C non si rovina. E le poveracce, sono vongole selvatiche? GP - Sì. La poveraccia, che in italiano si chiama lupino, è la vongola dell’Adriatico. nelle giornate invernali, dopo una bella mareggiata, se hai voglia di camminare un po’ e di spaccarti la schiena, riesci a raccoglierne anche un po’. Durante la bassa marea si vede proprio la vongolina affiorare dalla sabbia. Si chiamano poveracce perché nel dopoguerra i riminesi le raccoglievano sulle spiagge e quelle che pescavano i pescherecci non le voleva nessuno, finivano proprio ai contadini. Non costavano assolutamente niente, a quei tempi. GL - Nel menu abbiamo citato l’inizio di una poesia sul tema, firmata “il nonno della Valeria”: “Ogni Rimnes Rimnes, di burg o ned in piaza, us a da met in znoc daventi a la puraza, che senza des e pes, quasi in umiliazom, la a sfamè d’inverne miera ad generaziom”, cioè “ogni riminese, campagnolo o cittadino, deve mettersi in ginocchio davanti alla poveraccia, che senza darsi peso, restando un alimento umile, ha sfamato in inverno migliaia di generazioni”. Il suo gusto è estremamente sapido, perché viene fuori dall’acqua, con una bella consistenza. GP - La sapidità è più spiccata se viene pescata e consegnata. adesso purtroppo, con le nuove normative igienico-sanitarie che impongono controlli specifici, non può più essere acquistata direttamente, ma viene pulita a bagno nelle vasche, dove perde un po’ delle sue caratteristiche. Noi ci ricordiamo di nostro padre negli anni ’80, quando prendeva il moscone a remi, andava dal peschereccio, caricava i sacchi e li portava qui. Era tutto un altro mangiare. Non dovevi assolutamente salare la pasta perché il sale contenuto nella vongola era sufficiente per condire il piatto in modo quasi eccessivo. Le poveracce hanno una stagione? GP - Tutto l’anno, tranne il mese di giugno e luglio. Giugno è il periodo riproduttivo, quindi all’apertura sono piene di latte e il gusto cambia un po’; dopo c’è il fermo pesca, che viene fatto a rotazione nelle diverse zone. I mesi migliori sono quelli freddi, quando il mollusco è un po’ più grosso. Il sale può essere un prodotto selvatico? GP - Certo, anche se occorre l’intervento dell’uomo per raccoglierlo nelle saline. Da quando è uscito dai monopoli, uso solo ed esclusivamente sale di Cervia, sia il fiorsale che il sale grosso. Quello della Camillona, che è la riserva dove viene raccolto ancora a mano, senza macchine, come si faceva ai tempi dei Romani. Come mai la confezione all’ingresso è così rosa? GL - Forse dipende dal periodo in cui è stato fatto essiccare. Pensa che nel 2005, un’estate molto piovosa, non è stato prodotto perché non c’è stata 218 Quali sono le sue caratteristiche? GP - È un sale molto dolce, per nulla aggressivo, ha una bella sapidità e un profumo fresco di mare, iodato. Si può usare ovunque, ma io lo preferisco a secco sul piatto finito. GL - Dolce però non vuol dire zuccherino. Nella sua composizione mancano alcuni fosfati e solfati, caratteristici del retrogusto amaro del sale comune. Per questo in bocca non trasmette la voglia di bere. Non asciuga. Veniamo al vino: secondo voi può essere selvatico? GL - Selvatico è un termine un po’ generico. Nel vino non credo possa esistere. L’abbinamento col selvatico poi è altrettanto relativo, perché ogni cosa deve essere sposata con la bottiglia giusta. Nel mondo del vino si parla molto di naturale, di biodinamico, di biologico; ma non riesco a immaginare qualcosa di selvatico perché la vite ha sempre bisogno dell’uomo. massiccio del vignaiolo, che senza l’ausilio della chimica deve essere pronto a fronteggiare ogni piccola variazione climatica o ambientale per salvaguardare la vite e il vino. Per l’appuntamento di Enologica voglio coinvolgere la Tenuta Marmoreta, che ha sede sui nostri colli di Rimini. Al piatto selvatico va abbinato un vino abbastanza profumato, perché si tratta di tenere testa a ingredienti di carattere senza schiacciarli con un corpo eccessivo. Questa azienda produce il Pratogaio, un uvaggio a base principalmente di riesling e sauvignon; ha una buona dote di freschezza e aromaticità, le due componenti che ci servono per accompagnare il piatto. Rimanendo sullo stesso territorio ma con un’uva autoctona, sui maltagliati con le canocchie e i cannellini vedo bene una Rebola dei colli di Rimini. Meno freschezza e un corpo maggiore, per accompagnare la pastosità del fagiolo e della sfoglia all’uovo. I vini naturali però sembrano più vicini a questa dimensione, penso ai lieviti indigeni o alla fermentazione a temperatura non controllata. Sono vini lasciati a briglia sciolta e manifestano un temperamento più deciso. Anche se il vino selvatico resta probabilmente un ossimoro, possono esistere punti tangenziali. GL - Noterei piuttosto che per paradosso la naturalità richiede un intervento più 219 enologica edizione 2009 essiccazione al sole, un po’ come accade con i grandi vini. Il sale della Camillona cambia sempre. Anche il numero delle raccolte dipende dall’andamento climatico. Paolo Teverini Ristorante Hotel Tosco Romagnolo Piazza Dante Alighieri, 2 - Bagno di Romagna Tel +39 0543 911260 - www.paoloteverini.it Benvenuti in paradiso: secondo l’etimologia persiana, è l’abbondanza del selvatico a contraddistinguere il luogo degli eletti. Una definizione che calza a pennello all’alto Savio, sorta di tempio vivente di tutto quanto è autentico, vivo, naturale. Qui il selvatico è onnipresente: una tessitura di prodotti e sensazioni che avviluppa olisticamente il turista, prima ancora del cuoco. ne sa qualcosa Paolo Teverini, svezzato a latte e tartufi in questo spicchio di Appennino. Una messe di stimoli che ha convogliato felicemente in cucina, lui che aveva inizialmente studiato da impiegato ma non poteva stare chiuso fra quattro mura. Dopo l’Alberghiero ad Ascoli Piceno e a Rimini, nel 1971 per lui si schiudono le porte del ristorante dell’Hotel Tosco Romagnolo. È una cucina d’albergo senza troppe pretese, di matrice territoriale con sporadiche escursioni internazionali, i tavoli riservati ai clienti dell’hotel e i passaggi ad aspettare che si liberi un posto. Sono gli albori della grande ristorazione d’autore, e nei mesi invernali, quando il locale chiude, scattano gli stages in tandem con la moglie in sala. La Capannina del Boite di Cortina d’Ampezzo, al fianco di Piovesan, l’inventore del carpaccio, come il Cantunzen di Bologna. “Prendevo in mano la guida Michelin, scrivevo a 50 stellati e aspettavo la prima risposta”, racconta oggi Paolo. “Poi è arrivato Gualtiero Marchesi ed è stata una frustata per tutti. Vent’anni dopo Bonvesin de la Riva, l’ultimo stage l’ho fatto da Ferran Adrià: un’esperienza forte, scioccante, anche se l’approccio di cucina non è replicabile, perché opera nella terra di gaudì e Salvador Dalì, in un contesto di grande cultura ma diverso dal nostro”. la crescita è graduale e il premio inaspettato: stellato dal 1983, oggi Teverini conta fra i padri indiscussi della cucina dell’Emilia-Romagna; ma ne è pure l’enfant terrible, se è vero che il suo selvatico trova il giusto contrappeso nella tecnica avanzata; la personalità dei prodotti viene filtrata attraverso lenti tecnologiche che trascrivono fedelmente le curve di sapore, sorta di scrittura automatica à la Breton. Né manca il ludos, terzo vertice di un’equilateralità che bilancia il sentimento col rigore, l’amarcord con la telematica e l’ingegneria culinaria. La sua è una cucina a chilometro variabile, con il compasso della filiera regolato sul gusto. Del locale di famiglia, sontuosa cattedrale dai pinnacoli multisensoriali, si ha traccia fin dal 1550, quando era una posta con cambio cavalli di proprietà dei Marangoni, antenati della moglie, tuttora factotum e plenipotenziaria. Completano il team le figlie Gaia e Melita, rispettivamente alla spa e alla reception, allietate dalle incursioni di una torma di nipotini. La sommelier si chiama Rumina Arapi, una ragazza di origine albanese formata personalmente da Paolo, già degustatore e fiduciario Ais. Entusiasta e curiosissima, lo affianca da un anno e mezzo. 220 Una specie di rabdomanzia. Che ricordi hai dei tuoi cani? Vengo da una famiglia di raccoglitori di tartufi. Quando è morto mio nonno Gasparre, a 96 anni, il Resto del Carlino gli ha dedicato mezza pagina, rimpiangendo la scomparsa del “più grande raccoglitore di tartufi”. Era un falegname, costruiva anche violini e li vendeva. A settembre però chiudeva bottega e la riapriva a febbraio, perché andava a tartufi. Il lunedì mattina prendeva la corriera, andava a Ravenna col cane e ritornava il mercoledì mattina a piedi, raccogliendo i tuberi. Perché mercoledì c’è il mercato. Poi giovedì ripartiva, andava a Firenze in corriera e rientrava sempre attraversando il bosco. Quello cui ero più affezionato era Tom, un setter gordon che avevo addestrato personalmente, di un’intelligenza incredibile. Il cane da tartufi deve capire che se raccoglie il tartufo ha un premio; il suo era un tozzetto di pane secco, oppure una crosta di formaggio. All’inizio ci rendevamo conto che sentiva il profumo del tartufo, ma non lo segnalava, non scavava. Allora l’ho chiuso in una piccola stanza nell’orto e dopo 3 giorni ho aperto. L’ho preso con me e arrivati alla prima pastura (come vengono chiamati gli spazi dove crescono i tartufi), l’ho liberato e ha subito trovato. L’altro cane era Floc, un bastardo grasso e pigro, che dopo un po’ si metteva seduto, perché non aveva più voglia. Ma aveva un naso incredibile anche lui. Ricordo che ci alzavamo col buio per arrivare ai primi bagliori dell’alba, prima degli altri raccoglitori; stavamo in giro finché il cane aveva voglia di girare, cioè tutto il giorno. Chi gli aveva insegnato in quali luoghi cercare? Un po’ i suoi primi compagni, un po’ l’esperienza. Girando poi ne scopri sempre di nuovi. Un giorno ricordo che mi voleva portare in un posto e l’ho caricato sulla mia vespina, arriviamo a destinazione e mi fa: “Vedrai che dopo c’è un pero”. Il pero non c’era più, era stato tagliato, però io ho visto mio nonno trovare il tartufo dove il cane non l’aveva sentito. Non era questione di naso, ma di occhio. Io camminavo e mio nonno col bastone veniva più piano. “Paolo, vieni qui! Vieni qui! Scava qui che c’è”. “Guarda che non c’è. Il cane è lì”.”Scava”. Ho scavato e c’era davvero, seppure acerbo, quindi non aveva profumo e il cane non l’aveva sentito. Gli ho chiesto: “Come hai fatto a sapere che c’era?”. “Ma si vede, devi capire dal terreno”. Nessuno può sapere il punto esatto in cui scavare, però può percepire l’habitat, da com’è il muschio o dalle piante tutt’intorno. Dove si trovano i tartufi da queste parti? oltre il Savio, un po’ a macchia di leopardo. Le spore devono attaccarsi alle radici di una pianta, ma non tutte vanno bene. Arrivando da Piero in Bagno per esempio c’è un filare di tigli e sotto si raccolgono i tartufi. Il profumo cambia a seconda degli alberi? Certo. Da queste parti il tartufo cresce sotto i tigli, le querce, il biancospino, i noccioli, i pochi gelsi che restano, i salici e i pini, ma questi ultimi non sono tuberi pregiati; oppure sotto il ginepro… Ecco, per me il tartufo più bello è quello 221 enologica edizione 2009 Come ha avuto inizio il tuo apprendistato nel selvatico? che cresce sotto il ginepro, perché ha sempre una forma rotondeggiante, a causa della friabilità del terreno, che è reso sabbioso dalla caduta degli aghi; e poi ha un profumo… Anche il tartufo di quercia è molto profumato, cresce più in profondità ma è un po’ bitorzoluto, ha una forma irregolare. cottura lo guastava un po’, ma la patata prendeva un profumo… Adesso costerebbe una follia. Per merenda ricordo che prendevo una fetta di pane con un filo d’olio e aggiungevo qualche lamella di tartufo. Oggi che sei un professionista, qual è la tua filosofia del tartufo? L’origine dei tartufi viene annotata sul tuo menu? È impossibile, anche se mi piacerebbe. Non riusciamo a ricostruirla perché il raccoglitore porta i tuberi tutti insieme. Possiamo risalire alla pianta di origine per via induttiva, perché in degustazione si riconosce, ma la certezza manca. Com’è il tartufo di queste parti? Il classico tuber magnatum pico, lo stesso di Alba e Acqualagna. Poi c’è l’estivo o scorzone, e a fine settembre iniziano due varietà di nero. Si tratta dell’uncinato, un’evoluzione del nero estivo, più scuro dentro e prossimo olfattivamente al Norcia, e del brumale, che è una varietà ancora più vicina al nero di norcia, tipica di novembre e dicembre. Di Norcia ce n’è pochissimo, bisogna spostarsi di 30-40 chilometri, nella Valle del Tevere. Come veniva mangiato a casa tua? La mia era una famiglia modesta, l’unica ricchezza che avevamo era il tartufo, perché non riuscivamo neanche a venderlo. Quando ero piccolo nessuno lo comprava, solo un ristorante e il farmacista, due volte l’anno; perciò spesso veniva regalato. Mia mamma a casa faceva le tagliatelle, i tortelli di patate col tartufo, una teglia di patate a strati col tartufo, un goccio di latte, burro, sale e pepe. Forse la Il tartufo ha ingredienti con cui si sposa in maniera fantastica: i latticini, che siano panna, burro o formaggio; i farinacei, come la pasta, e le uova. Il massimo è la tagliatella, che racchiude tutti e tre, perché ci sono la farina, le uova, il burro e il parmigiano. Poi posso metterlo anche su un pezzo di carne, ma non è la stessa cosa. C’è sempre bisogno di fare una piccola salsa per sprigionare il profumo. Il mio cavallo di battaglia storico è un uovo ai tartufi: si tratta di uno zabaione salato servito nel guscio con fettine di tartufo e uno spruzzo di panna montata infilzata di lamelle, servito con una piccola misticanza e una bruschettina alla pancetta di cinta senese. I tuoi piatti sono sempre esuberanti. Spesso sul piatto ci sono molti elementi, ma gli ingredienti che uso sono relativamente pochi. Perché se faccio una salsa al prosciutto, deve sapere di prosciutto. I sapori devono restare nitidi e riconoscibili. Il nome deve corrispondere al piatto. Le mie ricette partono sempre dal gusto, prima di considerare la presentazione, i colori, le forme, l’innovazione. Come sono i tartufi quest’anno? Ho sempre detto e sperato che sarebbe stata un’annata bella, perché ha piovuto nei momenti giusti, a giugno e anche a luglio, poi è stato asciutto, come richiede il tartufo, e in agosto ha fatto ancora qualche 222 Altri prodotti selvatici di questa zona? Da piccolo ero un grandissimo pescatore di gamberi di fiume. Nel Savio non ci sono più, ma i ruscelli qui attorno sono tuttora popolatissimi, anche se è proibito pescarli. Devo ricorrere a quelli del Trasimeno e del lago di Massaciuccoli, che sono semi-selvatici perché vengono allevati in spazi aperti, un po’ come i salmoni dei fiordi norvegesi. Credo di essere stato per anni e anni il simbolo dei gamberi di fiume nella gastronomia italiana. Non è facile allevarli perché sono molto delicati, necessitano di un’acqua perfetta. Ancora adesso ho una vasca con acqua di fonte, il pozzo cinquecentesco dell’albergo, dove i gamberi si riproducono, mangiano quello che cade, escono e rientrano dentro. Li lascio lì per il piacere di guardarli ogni tanto. Ma i sette laghetti sul monte brulicano anche di trote, anguille, tinche e carpe. Abbiamo la fortuna di avere un parco nazionale delle foreste casentinesi, che inizia proprio qui. Tre quarti della sua superficie è compresa nel comune di Bagno. Qualsiasi raccolta è proibita, ma funge da polmone per l’ambiente circostante. Tutti i ruscelli che escono dal parco sono ricchissimi di una fauna incontaminata. Gli animali, appena arriva la prima neve, scendono in paese per cercare qualcosa da mangiare. C’è molta selvaggina? nel ‘400 qui c’era la riserva di caccia di Lorenzo il Magnifico; ed è rimasta ai Medici fino al 1800, quando è stata donata ai frati camaldolesi, che hanno fatto un lavoro enorme di reimpianto di alberi, prima della nazionalizzazione. Oltre ai classici, la lepre, il cinghiale, il capriolo, il cervo, adesso hanno introdotto nuovamente il daino. Il cinghiale è molto prolifico e crea danni incredibili, tanto che l’anno scorso hanno dovuto allungare la stagione di due mesi. Si caccia a squadre di una ventina di persone, singolarmente è quasi impossibile prenderlo perché è molto veloce. I cacciatori formano una lunga linea di appostamento, mentre i battitori dall’altra parte fanno baccano, lasciando fuggire gli animali verso i cacciatori e la linea dei fucili spianati. La selvaggina è stagionale? Il cinghiale, la lepre, il capriolo sono stanziali, ma anche la loro stagione comincia con l’autunno. A parte la burocrazia, sono migliori quando si preparano all’inverno, hanno superato il momento della riproduzione e accumulano grasso. Poi ci sono gli uccelli migratori; 223 enologica edizione 2009 acquazzone. Ma la raccolta del tartufo, come tutta la campagna, si è spostata. Mentre prima il culmine era ai primi di ottobre, adesso cade a novembre e dura di più, fino al gelo. Quando il terreno comincia ad arrivare a zero gradi o addirittura sotto zero, si chiude. Finito il bianco inizia il nero di norcia, che dura fino a febbraio-marzo. Lo spostamento è inferiore, perché è meno sensibile. Il primaverile o marzaiolo lo amo meno perché ricorda l’aglio e gli idrocarburi, è un po’ sgarbato. Mia mamma lo tritava e lo metteva nel minestrone, proprio per dare un tocco di agliaceo. Poi da metà aprile ai primi di giugno c’è un buco. Per questo i tartufi venivano in parte conservati, nella segatura, nella sabbia, nella crusca… nel riso no perché si seccano. E i funghi? la beccaccia per esempio inizia a ottobre. Vive nei paesi dell’est o in Inghilterra, poi durante l’inverno migra verso il caldo, di solito in Spagna o in Marocco. Bagno è sulla rotta dall’est, perché è un punto di passaggio abbastanza basso, il più basso dell’Appennino. Come qualsiasi animale, può essere malata, giovane o vecchia; può essere ferita o rovinata, con la carne sporca di sangue che inizia a fermentare; insomma va selezionata e uccisa in modo professionale. Tanti, e tante varietà. Oltre ai porcini ci sono gli ovoli, che stanno scomparendo, tutte le varietà delle russole, dalla verde alla marrone, alla rossa, che è leggermente tossica; e ancora trombette di morto, manine, galletti in tutte le loro varietà, mazze di tamburo, prataioli, spugnole e prugnoli, secondo me i migliori in assoluto… I nostri funghi sono buoni come altrove, con un unico atout. Che quando arrivano a Roma o a Milano hanno già una settimana di vita, quindi hanno perso la fragranza. Invece qui li raccolgono e ce li portano subito. Il carniere vegetale è altrettanto ricco? Sì, ci sono le castagne, i frutti dimenticati, dalle nespole alle sorbe, e poi tutte le bacche. Le more di rovo, le fragoline di bosco, che purtroppo durano pochissimo, i lamponi selvatici. L’offerta è copiosa, ma spesso non è facile trovare i raccoglitori. Credi alla voga dei chilometri zero? Ci sono ingredienti selvatici che si sono persi dalla tua infanzia? non riesco più a trovare le giuggiole selvatiche; ci sono quelle giapponesi, ma sono un’altra cosa. Anche le corniole sono sparite. È un frutto quasi trasparente, leggermente acidulo, che chi ci ha preceduto utilizzava per preparare salse da bollito o in marmellata con lo zucchero. Adesso è proibito raccogliere la carlina, una specie di carciofo selvatico a rischio di scomparsa. Cresce in terra, senza gambo, sopra gli 800 metri; ha una forma circolare con tante foglie spinose. Il frutto è il cuore di questa pianta, che è un po’ come un piccolo carciofo. Ha lo stesso gusto e si cucina in modo analogo. Lo conosco bene perché matura adesso, contemporaneamente ai tartufi. Quindi se vai per tuberi è pieno. Non mi convince perché è una cucina bugiarda. È impossibile prendere alla lettera il “chilometro zero”. Nel raggio di un chilometro facciamo fatica a uscire dal paese, quindi non possiamo cucinare niente. Quando salo l’acqua della pasta, se va bene mi rifornisco a Cervia. Ma se cuocio anche uno spaghetto, non sarà mai a chilometri zero perché l’azienda sarà a Parma o da un’altra parte. Se voglio fare il romantico, posso cucinare la carotina del mio orto; anch’io ho un pezzettino di terra per le erbe aromatiche. Uso il miele di un’azienda a due chilometri da qui, ma per il millefiori le arnie seguono le fioriture, fino a trenta chilometri di distanza. Il miele è un prodotto selvatico? Certo: l’uomo interviene per l’estrazione, ma l’animale che lo produce è libero. Quindi è selvatico al pari della melata di abete, che cola dalla pianta o da incisioni praticate dai raccoglitori, come lo sciroppo 224 Restano le erbe e i germogli. Mia mamma andava sempre a raccogliere il ramolaccio e il tarassaco per i tortelli; le vitalbe e gli asparagi selvatici. Anch’io lo faccio, così come spazzolo personalmente i tartufi, per il piacere di farlo. Amo molto la nepitella; anzi oggi devo andare a raccoglierla perché i ragazzi la vogliono. Cresce sul muro, lungo la strada a 100 metri da qui; è una delle 150 varietà classificate di menta ed è inscindibile dai funghi. Sento il suo profumo da lontano perché mi ricorda quando ero bambino, giocavo nel fiume e questo profumo era nell’aria: la mia madeleine. Con la mente ritorno a quando pescavo le ranocchie, le portavo a casa e le pulivo. Le mettevo in un cesto con l’ortica che gonfiava la carne, in modo che diventasse più tenera. Era il sapere dei nostri vecchi. A proposito di nepitella, quanta Toscana c’è nei tuoi piatti? Molta, perché dal 1400 al 1922 Bagno era in provincia di Firenze. Tutti i ragazzi della mia età ci andavano a scuola e il commercio andava in quella direzione. Lo stesso tortello di patate, il mio piatto simbolo, è tipico del Casentino. Alla Toscana ci accomunano il paesaggio e la cultura gastronomica. Perché il territorio non è definito dalla burocrazia o dalla politica, ma dalla cultura e dalle abitudini personali. La tua cucina è un laboratorio avanzatissimo. Quanta tecnica occorre per praticare una cucina selvaggia? Tanta. Il prodotto, specie se selvaggio, è il primum movens; poi c’è l’intervento dell’uomo, che può rappresentare anche un passo indietro, un’astensione per una forma di massimo rispetto. Ma se non tratta a dovere un prodotto eccellente, lo chef si riduce a un selezionatore. Il gioco è tutto lì: sistole e diastole della cucina. Nel cuoco c’è sempre stato il piacere di creare, l’amore per il gusto nuovo, le scoperte, la tecnologia. Fin dagli inizi sono stato additato come un rivoluzionario e voglio fare una cucina moderna, come innovazione o attualizzazione, perché un piatto di 50 anni fa sarà sempre anacronistico rispetto alle mode del momento. nella storia della cucina c’è sempre stato il Ferran Adrià della situazione. Prendiamo l’inventore del tortellino. Che cosa ha fatto? Ha ridotto le dimensioni di ciò che già si faceva, le torte, i pasticci. Adesso impazza il fingerfood, la miniatura di un piatto più grande, che è un po’ la stessa cosa. Perché il nostro piacere cambia continuamente e ciò che oggi è avanguardia, in parte diventerà tradizione, in parte sarà dimenticato. Ma sarà comunque stato utile per avanzare. Che piatto hai scelto di portare ad Enologica? Dei cubetti di pasta fresca con la lepre in dolceforte. Il formato nasce dalla voglia di preparare una pasta nuova, senza rinunciare alle radici. Sono partito dai grattatini, o manfrigole, che sono tipici delle zuppe qui in Romagna. La sfoglia è identica: uova, farina, Parmigiano e noce 225 enologica edizione 2009 d’acero. Io ce l’ho sempre, è un pochino più fluida e amarognola del miele ma l’uso non cambia. L’inizio dell’autunno è il momento migliore per raccoglierla. moscata. Per innovare l’ho stesa grossolanamente e ho preparato dei cubetti del lato di mezzo centimetro, che cucino come se fosse un comune risotto alla parmigiana. Si comportano in modo simile, rilasciando l’amido necessario per la mantecatura con burro e Parmigiano. Poi la lepre in dolceforte, un classico antichissimo. I pezzetti di carne sono rosolati, si aggiunge il soffritto, si copre di vino rosso e si profuma con ginepro, chiodi di garofano, erbe aromatiche e pepe. Tolgo la carne, setaccio la salsa, regolo il gusto, porto a ebollizione e unisco il cioccolato fondente, per dare gusto e lucentezza. Quindi metto a confronto due accezioni di selvatico, come materia prima (la nostra lepre e il nostro ginepro) e come dimensione della memoria, nella duplice forma di un hit popolare e di una ricetta della grande cucina che si contaminano fra loro. 226 Indice Capire Enologica Cuochi, il racconto di una comunità. Proteggere la tradizione Enologica 2012 Filiera. Giovanna Guidetti Laura e Matteo Morandi Giuliana Saragoni Elio, Samuele, Sauro e Sara Bison Daniele Minarelli Remo Camurani Enologica 2011 150 anni di memoria condivisa. Alberto Bellini Carla Aradelli Luca Marchini Maria Grazia Soncini Pierluigi Di Diego Riccardo Agostini Massimo Spigaroli Enologica 2010 La tradizione è una forma di conoscenza. Franco Aliberti Gianni D’Amato Isa Mazzocchi Italo Bassi Massimo Bottura Pier Giorgio Parini Paolo e Luca Raschi Enologica 2009 Selvatico. Cacciare, pescare, raccogliere. Isa Mazzocchi Pier Giorgio Parini e Fausto Fratti Igles Corelli Massimo Bottura Paolo e Luca Raschi Paolo Teverini pag.5 pag.7 pag. 9 pag.10 pag. 17 pag. 27 pag. 35 pag. 45 pag. 54 pag. 60 pag. 69 pag.70 pag. 75 pag. 85 pag. 91 pag. 100 pag. 107 pag. 114 pag. 123 pag. 133 pag.134 pag. 138 pag. 145 pag. 151 pag. 158 pag. 165 pag. 167 pag. 174 pag. 183 pag.184 pag. 188 pag. 196 pag. 203 pag. 211 pag. 214 pag. 220 COPIA DI: GLI AUTOGRAFI DEI CUOCHI
Scaricare