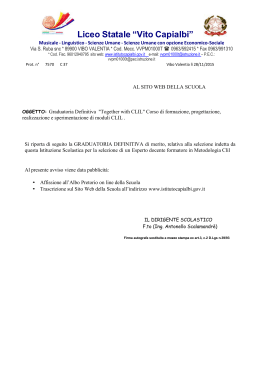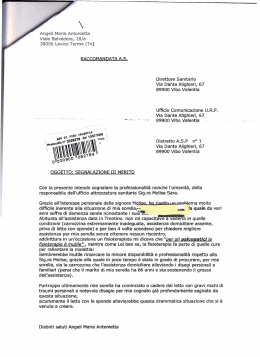Il direttore responsabile Enrico De Girolamo L a provincia vibonese custodisce un inestimabile patrimonio storico, testimoniato da un’identità millenaria che risale ai primi insediamenti greci, che fecero dell’antica Hipponium, l’attuale Vibo Valentia, un centro nevralgico della loro colonizzazione nel sud della Penisola. Ma quello ellenico rappresenta soltanto il primo livello di una stratificazione culturale che nel corso dei secoli ha ricoperto l’intero territorio, oggi disseminato di tracce e reperti archeologici di ogni tipo. Ecco perché nel secondo numero di Lìmen, rivista che ha tra i suoi obiettivi anche l’ambizione di offrire all’esterno della provincia una vetrina di questo territorio, abbiamo deciso di puntare i riflettori su uno dei più importanti “luoghi” vibonesi, la Certosa di Serra San Bruno. Nell’articolo dello storico Tonino Ceravolo il lettore potrà cogliere la straordinaria importanza di questo insediamento monastico che vanta circa 10 secoli di storia. Mille anni durante i quali la Certosa ha rappresentato il centro di una fittissima rete di rapporti che univa la Calabria all’Europa, ispirando con il suo profondo misticismo alcune delle maggiori figure storiche ed artistiche delle varie epoche che si sono succedute. Dall’entroterra boscoso alle spiagge assolate il tratto è breve, ma la storia molto più antica. Qui - dove tra Pizzo e Tropea, per le caratteristiche della costa, si realizzava in pieno il concetto greco di “viaggio”, come spiega Maria Teresa Iannelli nel suo articolo - le vestigia del passato sono custodite dal mare dell’antico porto romano di Valentia, a meno di dieci metri di profondità. Lo stesso mare sul quale scommette oggi il Porto di Vibo Marina per il suo atteso rilancio economico e commerciale. Un progetto che ogni giorno assume sempre maggiore concretezza e che vede l’Ente camerale in prima fila nel promuovere la rinascita dello scalo marittimo. Non manca in questo numero il resoconto dell’attività propria della Camera di Commercio, dalla pubblicazione del primo Bilancio sociale, all’approvazione del documento di previsione e programmazione dell’attività camerale nel 2007, dal quale emergono le priorità strategiche dell’Ente. E ancora: il progetto promosso dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, in collaborazione con la Camera di Commercio, per la creazione nella città capoluogo della sede meridionale dell’Icif, la prestigiosa scuola di cucina italiana per chef stranieri, fondata da Jhon Arena; l’analisi dei Sistemi turistici integrati, quale inevitabile evoluzione di un settore cruciale per le sorti di questo territorio; l’assegnazione a tre imprese vibonesi del Premio Ospitalità Italiana 2006, a rimarcare come la qualità sia di casa da queste parti. Su un piano squisitamente storiografico si attesta, invece, il contributo di Giacinto Namia, che con grande competenza ricostruisce il profilo e le vicende di un eroe risorgimentale, Michele Morelli. È storia anche il passato di un antico laboratorio artigianale vibonese, la Fonderia Scalamandrè, che per circa due secoli ha trasformato tonnellate di bronzo in bellissime campane che ancora svettano su molte chiese e basiliche italiane. Restando in tema di artigianato artistico, altrettanta rilevanza meritano le suggestive e dettagliate immagini della mostra cosentina “Argenti di Calabria”, che vede in esposizione anche bellissimi pezzi di origine vibonese. Arte pura, infine, è quella di Albino Lorenzo, il grande pittore di Tropea, capace di trasmettere come pochi il legame viscerale dell’uomo con la propria terra. gennaio / febbraio 2007 3 Il direttore editoriale Michele Lico Presidente Camera di Commercio di Vibo Valentia PRESIDENTE Michele Lico CONSIGLIO CAMERALE GIUNTA CAMERALE per il settore AGRICOLTURA Filoreto Fondacaro Ercole Massara Domenico Petrolo Paolo Pileggi Michele Vartuli Michele Lico - Presidente Francesco Gioghà - Vice Presidente Giuseppe Caffo Sergio Consolo Bruno Valeriano La Fortuna Ercole Massara Antonello Meddis Paolo Pileggi Giuseppe Rito per il settore ARTIGIANATO Rosario Carbone Francesco Gioghà Paolo Pecora REVISORI DEI CONTI per il settore COMMERCIO Sergio Consolo Mario Malfarà Sacchini Rita Tassone Antonino Tavella Michele Montagnese - Presidente Massimo Corso Francesco Schiumerini per il settore COOPERATIVE Antonello Meddis SEGRETARIO GENERALE F.F. Dr. Antonio Gallo Cantafio per i settori CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI ALLE IMPRESE Giuseppe Macrì Antonino Nicocia per il settore INDUSTRIA Giuseppe Caffo Antonio Gentile Michele Lico per il settore TURISMO Giuseppe Rito per i settori TRASPORTI E SPEDIZIONI Bruno Ruscio per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI Bruno Valeriano La Fortuna per le ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Luciano Prestia 4 gennaio / febbraio 2007 Q uando si pensa alle funzioni proprie della Camera di Commercio oggi, è necessario andare oltre la settorialità che potrebbe evocare la sua denominazione per considerarne invece il ruolo di soggetto funzionale e attivo nei più complessivi processi programmatori di sviluppo territoriale. La rappresentatività degli interessi economici generali del territorio e l’implementazione del mercato di cui si fa carico, vanno, infatti, inquadrati in una più ampia ottica di partenariato istituzionale in cui l’Ente camerale ha legittimazione a esplicitare istanze e necessità del sistema economico e produttivo che risultano, comunque, influenti e si intersecano con ogni azione preordinata ad amplificare parametri di crescita e competitività. Fondamentale, nelle relazioni istituzionali, è considerare le reciproche competenze senza apriorismi ad escludendum; occorre, invece, individuare convergenze che abbiano a presupposto una dialettica costante e propositiva e come obiettivo ultimo il benessere della collettività amministrata. Su questi principi abbiamo inteso costruire l’azione della Camera di Commercio di Vibo Valentia e in una visione ampia di economia e produttività comprensiva di tutte le espressioni identitarie e tipiche del territorio, di tutte le risorse di cui dispone, con una programmazione di valorizzazione e fruizione capace di innescare meccanismi moltiplicatori di quella redditività che ciascuna porta insita. È questa la chiave di lettura della pianificazione di interventi che abbiamo tracciato per l’anno 2007 e che proponiamo anche attraverso Lìmen per comunicare e partecipare il nostro essere e un modus agendi ispirato ai principi della sostenibilità, relazionalità, attrattività e fruibilità. A questi criteri, all’unisono con quelli di efficienza, efficacia ed economicità propri di una pubblica amministrazione, viene conformata l’erogazione dei servizi all’utenza, a questi le strategie operative per sostenere e promuovere imprese e territorio nelle fasi evolutive che interessano mercato e società. Con tali premesse non può destare meraviglia che una Camera di Commercio, e nello specifico quella di Vibo Valentia, segni il proprio percorso istituzionale di valorizzazione del sistema economico ed imprenditoriale locale puntando non solo su azioni a beneficio chiaramente diretto e immediato per i settori di competenza, quanto rivendicando ruoli e coinvolgimenti anche in ambiti che, solo apparentemente, potrebbero non sembrare di sua pertinenza. E così arte, cultura, archeologia, patrimonio storico e architettonico, ambiente, gastronomia investono l’interesse della Camera di Commercio nella loro dimensione di identità del territorio e beni fruibili, e come tali potenzialità di incrementi economici ed occupazionali per il territorio di riferimento. È necessario però intenderli in una logica di rete poiché nessuno di questi aspetti può essere considerato a sé stante nelle progettualità di sviluppo. Devono poter essere, invece, complessivamente interfacciati perché quanto ciascuno esprime in termini di stato e prospettive, necessariamente si riverbera sulle condizioni degli altri e il tutto, più complessivamente, sull’economia locale e sulle sue possibilità di inserirsi nei circuiti di quella globale. Questa ci sembra la strada giusta da percorrere, e Lìmen, coerente sintesi, è, per noi, uno degli strumenti per farlo. gennaio / febbraio 2007 5 SOMMARIO DIRETTORE EDITORIALE Michele Lico Presidente CCIAA DIRETTORE RESPONSABILE Enrico De Girolamo COMITATO SCIENTIFICO Tonino Ceravolo 8 Certosa, i luoghi dello spirito 36 Turismo, la rivoluzione dei sistemi integrati 14 Obiettivi e Strategie anno 2007 38 Cooperazione, rapporto sul trend vibonese 18 Avanti tutta verso il nuovo Porto 40 Rintocchi d’arte e tradizione 21 Greci e Romani approdavano qui 46 Chef Made in Vibo 24 Ecco Lìmen 50 Una rete provinciale per gli sportelli unici 26 Camera Comunica Camera 54 Michele Morelli un eroe vibonese 30 Quando la qualità fa la differenza 60 Frammenti di storia secolare negli argenti di Vibo Valentia 32 A Vibo Valentia le donne più intraprendenti 66 Albino Lorenzo viaggio nella memoria storico Francesco De Grano dirigente Regione Calabria Giuseppe Fiorillo arciprete Duomo di San Leoluca Silvestro Greco biologo Maria Teresa Iannelli direttrice Museo V. Capialbi Andrea Lanza economista Giampiero Monteleone notaio Giacinto Namia storico Vito Teti antropologo REDAZIONE Maurizio Caruso Frezza Rosanna De Lorenzo Raffaella Gigliotti Ernesto Matera Anselmo Pungitore PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE Francesco Romano STAMPA Romano Arti Grafiche Tropea (VV) FOTO © Archivio Romano Arti Grafiche © Studio Krom © Archivio C.C.I.A.A. Direzione e redazione Camera di Commercio di Vibo Valentia tel 0963.44011 - fax 0963.44090 [email protected] Registrazione Tribunale n° 3 del 2006 In copertina: La Certosa di Serra San Bruno 6 gennaio / febbraio 2007 CERTOSA i luoghi dello spirito di Tonino Ceravolo F Sin dalle origini, alla fine dell’XI secolo, il complesso monastico fondato da San Bruno ha rappresentato il centro di una rete di rapporti che univa la Calabria all’Europa. Ancora oggi, migliaia di pellegrini si recano annualmente in questo luogo ricco di spiritualità e tensione religiosa. in dalle sue origini, negli anni terminali dell’XI secolo, la Certosa di Serra San Bruno è stata “centro” e nucleo di una rete di rapporti che uniscono la Calabria all’Europa e l’Europa alla Calabria. Si pensi all’itinerario del suo fondatore, Bruno di Colonia: dalla Germania - dove era nato a Colonia intorno al 1030 in Francia, prima magister e scholasticus della famosa scuola cattedrale di Reims, successivamente iniziatore dell’insediamento monastico della Chartreuse sulle Alpi del Delfinato, nei pressi dell’attuale Grenoble. Pochi anni dopo in Italia: a Roma, consigliere di Papa Urbano II nella curia papale; quindi al seguito del medesimo pontefice nei suoi spostamenti da Roma verso l’Italia meridionale; infine di nuovo e definitivamente eremita a Santa Maria della Torre, vicino l’attuale Serra San Bruno, in un luogo solitario – come recitano le coeve carte di donazione – posto «tra Arena e Stilo». Si provi, adesso, a unire, come su un tracciato stradale, i punti di questo itinerario da Nord verso Sud: Germania, Francia e Italia; le nobili Colonia e Reims, le sperdute Santa Maria de Casalibus sulle Alpi francesi e Santa Maria della Torre nelle Serre calabresi. Si provi, inoltre, a comporre, contemporaneamente e per un momento, una mappa parziale della storia religiosa dell’Europa medievale nei decenni delle riforme monastiche: cluniacensi, certosini, cistercensi, vallombrosani, premostratensi, un “bianco mantello” di ordini, esperienze collettive e individuali, chiese, templi, comunità monastiche e nella mappa per ogni nuovo desertum solitudinis un punto, un piccolo segno per ricordarlo. Nomi di paesi e città molto noti agli occhi di chi si accosta all’Occidente medievale: Cluny, La Chaise-Dieu, Molesme, Grandmont, la Sauve-Majeure in Francia; Camaldoli, Fonte Avellana, Vallombrosa e la stessa Serra in Italia; Hirsau in Germania. Accanto ai luoghi, le persone: Roberto di Arbrissel a Fontevrault, Stefano di Muret a Grandmont, San Romualdo a Camaldoli, San Pier Damiani a Fonte Avellana, Giovanni Gualberto a Vallombrosa, Bruno di Colonia alla Chartreuse e in Calabria. Bruno di Colonia appare immediatamente come un personaggio centrale del suo tempo e gli eremi che ha iniziato in Francia e in Calabria si pongono, parallelamente, nel cuore della grande storia monastica d’Europa. Il discorso ci condurrebbe lontano, ma è il caso di compiere uno spostamento temporale in avanti di alcuni secoli, quando, agli inizi del Cinquecento, dopo oltre tre secoli di intermezzo cistercense, la Certosa di Calabria viene “recuperata” dall’Ordine certosino, sono ritrovate le reliquie di Bruno e hanno inizio i lavori per la costruzione delle fabbriche del monastero certosino sullo stesso luogo, a circa un chilometro dall’originaria fondazione di Santa Maria della Torre, dove, successivamente alla morte del santo, era stata edificata la Certosa di S. Stefano del Bosco. È un momento importante per la storia culturale e artistica del territorio. È un momento fondamentale per ritrovare altre tracce della centralità di un territorio solo in apparenza periferico. Nel corso di alcuni decenni, parallelamente con lo strutturarsi delle architetture del monastero, il “cantiere” certosino si arricchisce di non poche opere d’arte, per le quali i monaci affidano la committenza a importanti artisti italiani ed europei. Si pensi alle vicende del grande ciborio della chiesa conventuale certosina, che legheranno per sempre il nome del grande Cosimo Fanzago all’isolato mondo delle Serre cala- gennaio / febbraio 2007 9 bresi. Un artista, come scrive Silvana Savarese, che «[...] esercitò una rilevante e durevole influenza, nel Seicento ed oltre, in tutta l’Italia meridionale. Tra il 1619 e il ‘20 si recò personalmente a Barletta per lavorare alla decorazione dell’abside della Cattedrale; nel 1626 e nuovamente dopo il 1628, soggiornò a Montecassino per la ristrutturazione del coro e l’ammodernamento dell’altare maggiore e delle cappelle della chiesa dell’abbazia. Tra il ‘26 e il 28 visse a Pescocostanzo per i lavori al convento benedettino di S. Scolastica e, successivamente, intorno al 1630 per l’altare maggiore della chiesa di Gesù e Maria». Fondamentali furono i tre decenni (1623-1656) che lo videro impegnato a compiere i lavori di completamento della Certosa di San Martino in Napoli, per la quale l’artista bergamasco creò alcuni capolavori (come il mirabile San Brunone), pervenendo – secondo il giudizio di M. Mormone - ad «un momento di grande felicità inventiva e di radicale rinnovamento del linguaggio scultoreo». Di Napoli Fanzago inventò il «volto» barocco, rimanendo legato alla città fino alla morte, sopraggiunta il 13 febbraio del 1678. L’incarico per la realizzazione del grande Ciborio della Certosa di S. Stefano del Bosco venne affidato a Cosimo Fanzago nel 1631, durante il priorato di Dom Ambrogio Gasco e nell’esecuzione l’artista bergamasco si avvalse dell’aiuto dei fonditori S. Scioppi e Raffaele Matiniti o Materico detto il Fiammingo, nonché dell’opera dello scultore toscano Innocenzo A pag. 8, l’ingresso della Certosa di Serra San Bruno. A pag. 9, la statua di San Bruno nel laghetto della Certosa. Sopra, i ruderi dell’antica Certosa (foto Angelo Rizzo). A destra, un monaco contempla l’interno innevato della Certosa. 10 gennaio / febbraio 2007 Mangani, giunto a Serra proprio su invito dello stesso Fanzago. Capolavoro del barocco meridionale, il ciborio di Cosimo Fanzago è uno degli episodi artistici eminenti che collegano la storia culturale della Certosa ad altri fondamentali momenti e ad altre rilevanti figure delle vicende artistiche italiane ed europee. Ma altri fili è possibile annodare, altri episodi occorre richiamare brevemente per dire dei legami e dei rapporti che connettono la storia di questo territorio con altre storie riconosciute, invece, come centrali e “maggiori”. La relazione di una visita apostolica, compiuta nel 1629 dal vescovo di Venosa mons. Andrea Perbenedetti nella giurisdizione della Certosa, introduce a questi ulteriori episodi quando racconta come, sopra la porta della sagrestia, si potesse vedere una Coena Domini «a quondam Michäele Angelo Bonarota depicta, quae Roma fuit traslata». La notizia risulta al momento inverificabile su altre fonti, ma, anche a non considerare l’attendibilità del Perbenedetti – peraltro confermata dalle altre annotazioni relative alla sua visita - è comunque significativa nel quadro delle vicende che stiamo ricostruendo. In tale quadro, non si può certamente trascurare l’apporto che altri artisti di risonanza europea diedero al patrimonio culturale della Certosa. Ancora due esempi: lo scultore brandemburghese David Müller, il quale, su incarico del priore certosino Ludovico Suspechs, realizzò nel 1661 due statue marmoree raffiguranti la Vergine con il Bambino e San Bruno, nonché due pregevolissimi bassorilievi con una scena leggendaria della vita di San Bruno (l’apparizione del santo in sogno a Ruggero il Normanno durante l’assedio di Capua) e con la natività; Bernardino Poccetti, attivo nelle Certose di Firenze, Calci e Pontignano, che dipinse certamente il Martirio di S. Stefano (oggi nel coro della Chiesa Matrice di Serra) e del quale alcuni documenti archivistici attestano i rapporti con il monastero calabrese. La profonda attrazione che questa città monastica della preghiera ha esercitato è rilevabile pure da altre circostanze, alcune delle quali non sono da considerare alla stregua di semplici curiosità storiche, ma come segni del profondo interesse per la testimonianza spirituale che i monaci incarnano quotidianamente. Il 24 agosto 1923 giunse a visitare la Certosa, come riporta una Cronaca coeva, il principe ereditario Umberto II di Savoia, in compagnia del Contrammiraglio Bonaldi, del marchese della Rocchetta e di altri “tre signori” di cui la Cronaca in parola tace il nome. Il Principe partecipò alla Messa conventuale, visitò il monastero e alla fine ripartì. Nel marzo del 1953 entrarono nel monastero il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e sua moglie donna Francesca - fatto eccezionale, perché la clausura papale proibisce l’ingresso delle donne - presenti in Calabria per una visita di Stato in seguito ad una disastrosa alluvione. Questa visita era stata preceduta, due anni prima e a motivo della stessa alluvione, da quella del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e della moglie donna Ida. Il 5 ottobre 1984, durante un importante viaggio in Calabria e in occasione del nono centenario di fondazione dell’Ordine certosino, si trattenne per un’intera giornata prima a Serra e poi in Certosa Sua Santità Giovanni Paolo II. Molto significativi sono i due discorsi - ai monaci della Certosa e ai fedeli riuniti a Santa Maria del Bosco - che il Pontefice tenne in quell’occasione, non mancando di ricordare il particolare carisma dei monaci di San Bruno e l’efficacia spirituale della loro presenza, che pongono la Certosa come il “cuore di questa Regione”. «Il mio augurio è che da questo luogo - disse il Papa nel discorso rivolto alla comunità monastica - parta un mes- saggio verso il mondo e raggiunga specialmente i giovani, aprendo dinanzi ai loro occhi la prospettiva della vocazione contemplativa come dono di Dio [...]. Voi da questo monastero siete chiamati ad essere lampade che illuminano la via su cui camminano tanti fratelli e sorelle sparsi nel mondo; sappiate sempre aiutare chi ha bisogno della vostra preghiera e della vostra serenità». Sette anni dopo, nell’anniversario dell’arrivo di San Bruno in Calabria e della primitiva edificazione della fondazione calabrese, il Papa si rivolse nuovamente ai monaci della Certosa con una lettera indirizzata al priore dell’epoca Dom Gabriele Maria Lorenzi. «In questa ricorrenza - scrisse, tra l’altro, Giovanni Paolo II in quella circostanza - mi è gradito unirmi alla Comunità di Serra San Bruno ed a tutte le Chiese della Calabria per rendere grazie al Signore del dono fatto a codesta terra e, in particolare, della viva e fedele testimonianza che l’Ordine certosino continua ad offrire ai fedeli [...]. Auspico che codesta celebrazione giubilare possa servire anche a far conoscere meglio la spiritualità certosina, la quale esige che, anche quando si è presi dalle urgenti attività pastorali ed organizzative, l’ideale contemplativo rimanga sempre in cima alle aspirazioni di chi vuole raggiungere la perfezione cristiana. Esorto, pertanto, i monaci di Serra San Bruno a farsi costantemente interpreti presso Dio delle peculiari necessità della Chiesa nello spirito di vera comunione». Altre presenze ancora si potrebbero ricordare, ma basteranno, per tutti gli altri, ancora i nomi della regina del Belgio Paola Ruffo di Calabria, dell’attuale Ministro degli Esteri Massimo D’Alema e del patriarca di Costantinopoli Sua Santità Bartolomeo I. Ci si potrebbe, allora, chiedere cosa abbia di così particolare la vita dei monaci, tanto da attrarre, insieme con numerosissimi uomini e donne di ogni provenienza sociale, alcune tra le personalità maggiormente eminenti della propria epoca. La risposta da dare è semplice e complicata nel medesimo tempo. Solitudine, preghiera e silenzio, lode incessante a Dio, dialogo con l’Unico necessario, sono il “segreto” di questa vita. I tempi e gli spazi del monastero, la suddivisione della giornata del monaco, i ritmi e le scansioni dell’esistenza claustrale, ogni cosa è finalizzata all’incontro con il Signore. In estate e in inverno, in primavera e in autunno, la 12 gennaio / febbraio 2007 giornata dei certosini comincia quando quella di quasi tutti gli altri uomini finisce, intorno a mezzanotte per il Mattutino della Madonna e la preghiera personale nella cella. Successivamente, è il momento del Mattutino e delle Lodi nella chiesa conventuale, che possono durare – a seconda della lunghezza dell’Ufficio – sino alle due e mezza o anche sino alle tre e mezza della notte. Al termine, comincia un periodo di riposo a cui fa seguito il risveglio, con l’Ora liturgica di “prima” e un nuovo spazio di preghiera personale. Terza, sesta, nona, vespri e compieta sono le altre Ore del giorno che “segnano” la giornata del monaco. Tra l’una e l’altra, lo studio o il lavoro manuale, il pasto della mattina verso mezzogiorno e il pasto della sera al termine dei vespri. Tranne i momenti dedicati alle celebrazioni liturgiche nella chiesa (Mattutino e Lodi, Messa conventuale e vespri), la giornata trascorre in solitudine nella cella (chiamata anche, con linguaggio spiritualmente più suggestivo, eremo), perché la specificità della vocazione certosina è quella di sperimentare, insieme, tanto la dimensione della vita eremitica quanto la dimensione della vita comunitaria (nella durata temporale più ridotta rispetto all’altra). I certosini, come è stato detto, sono infatti una “comunità di solitari”, che, nella separazione dalla vita del mondo, testimonia quotidianamente la misteriosa fecondità della preghiera, nella quale è abbracciata l’umanità intera. Il laghetto all’interno del complesso monastico di Serra San Bruno. A destra, la sala della chiesa conventuale con il reliquiario di San Bruno (foto Angelo Rizzo). gennaio / febbraio 2007 13 di Raffaella Gigliotti N uova sede istituzionale e innovazione dell’Ente; studi economici e programmazione territoriale; valorizzazione e promozione delle tipicità della provincia di Vibo Valentia; pianificazione dei sistemi di sviluppo territoriale; sostegno allo sviluppo delle imprese; legalità: questi, in sintesi, i programmi e le priorità strategiche della Camera di Commercio di Vibo Valentia per il 2007, ampiamente articolati - poiché consoni ad una Pubblica Amministrazione trasparente - nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata all’unanimità dal Consiglio Camerale nella seduta del 31 ottobre 2006. Obiettivi ambiziosi quelli in programma per il 2007, soprattutto se proporzionati alle risorse umane di cui l’Ente dispone al suo interno – 14 gennaio / febbraio 2007 solo 19 unità lavorative – e alle quali gli organi camerali intendono dedicare particolare attenzione in termini di nuovo assetto organizzativo e professionalizzazione a 360 gradi. Obiettivi tra i quali svetta in particolare l’avvio delle procedure per dotarsi di una nuova sede istituzionale; una sede più dignitosa, più funzionale, più prestigiosa. Più dignitosa, in rispetto ad utenti e personale; più funzionale ai servizi erogati ed erogandi, non senza la previsione di spazi maggiormente fruibili per cittadini e imprese; più prestigiosa, per richiamare, anche formalmente e all’esterno dei propri confini territoriali, la rilevanza del ruolo e delle funzioni che l’Ente svolge ed intende consolidare sul territorio e per il territorio a servizio e vantaggio del sistema produttivo locale. Location d’eccezione, quella individuata quale nuova sede della Camera di Commercio di Vibo Valentia – il prestigioso edificio del Valentianum – patrimonio dell’Amministrazione Comunale della città capoluogo di provincia. Una nuova sede camerale, dunque, in tempi ragionevolmente brevi, ma anche un bene storico della città che si rivitalizza, divenendo fulcro dell’economia vibonese, in una coesistenza tra interesse pubblico ed utilizzo razionale, attuando una precisa prerogativa istituzionale dell’Ente camerale, che è quella di poter esercitare ruolo e funzioni anche per conservare e proteggere i valori e la memoria storica della città, attualizzandoli e rendendoli fruibili, così come richiede la coscienza civica dell’intera comunità. La nuova sede camerale è il principale dei programmi afferenti all’obiettivo dell’innovazione della Camera di Commercio di Vibo Valentia per il 2007, a cui si aggiunge una miriade di iniziative tese al miglioramento dell’efficienza e dell’orientamento ai clienti. Dal potenziamento e sviluppo di nuove funzionalità nella piattaforma dei Servizi e della comunicazione on line del Sistema Camerale e nella piattaforma locale di Customer Relationship Management (CRM), al miglioramento della comunicazione esterna dell’Ente, dalla creazione alla diffusione di strumenti di giustizia alternativa. Peso notevole nella programmazione delle attività camerali 2007 è dato dagli studi economici. È in essi che risiede l’obiettivo dell’Ente di realizzare approfondimenti su tematiche strategiche mirate allo sviluppo dell’economia locale. Conoscere il territorio per promuoverlo, indagare sulle esigenze reali delle imprese per meglio soddisfare i loro fabbisogni, analizzare l’andamento del tessuto imprenditoriale locale per tastarne periodicamente il polso: a tutto questo sono finalizzate le ricerche e gli studi programmati dalla Camera di Commercio per il 2007. In continuità con l’annualità precedente, l’Osservatorio Economico Provinciale, che fotografa l’economia della provincia con uno scatto sulle caratteristiche strutturali ed un focus sull’andamento congiunturale delle imprese vibonesi, a cui si aggiunge uno speciale approfondimento sulle imprese femminili. Ed ancora studi, con l’Osservatorio Turistico Provinciale, per il quale, anche per il 2007, è prevista una proficua collaborazione con istituti di ricerca e prestigiose università, al fine di analizzare le variabili ed i conseguenti mutamenti inerenti al settore del turismo. Programmati, altresì, uno studio sul sistema di trasporto provinciale, per individuare le esigenze di mobilità di mer- gennaio / febbraio 2007 15 ci e passeggeri del sistema produttivo locale, ma anche una analisi del trend cooperativo regionale ed una attività di monitoraggio e di studio finalizzata a supportare il processo decisionale della Regione Calabria in relazione alla definizione delle priorità strategiche del POR 2007-2013. Continua, inoltre, l’attenzione rivolta al Porto di Vibo Marina, con una pubblicazione che, corredata da fotografie e traduzione in lingua inglese, riguarderà lo studio prodotto dalla Camera nel 2002, aggiornato con quanto avvenuto e realizzato nel corso degli ultimi tre anni e con quanto prevedibile per il futuro, e che rappresenterà un utile strumento di marketing territoriale. Tra le pubblicazioni prosegue la programmazione di Lìmen, rivista di economia, arte e cultura, allo scopo di promuovere l’immagine di un Ente attivo e propositivo, aperto ai processi evolutivi del mercato in cui è contestualizzato il comparto economico che rappresenta e tutela. Per raggiungere l’obiettivo di incrementare il contributo allo sviluppo economico locale da parte dei settori correlati con le produzioni tipiche e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio, la Camera di Commercio di Vibo Valentia intende puntare con maggiore incisività sul settore turistico, anche sfruttando le sinergie possibili con le produzioni tipiche locali, l’artigianato, le produzioni artistiche, prevedendo una serie di iniziative e manifestazioni con ricaduta di promozione e valorizzazione del territorio a beneficio dell’economia locale. La Camera, dunque, prosegue le sue azioni in direzione delle certificazioni di prodotto e della qualità delle imprese, in particolare, nel settore turistico e agro-alimentare. Sul fronte della valorizzazione del patrimonio culturale 16 gennaio / febbraio 2007 Sopra, uno scorcio dell’interno del Valentianum, che ospiterà la nuova sede della Camera di Commercio. del territorio è prevista la realizzazione di un Catalogo degli Artisti Calabresi dell’800-900. Il catalogo mira a mettere in risalto la valenza del patrimonio artistico, al fine di creare attrattività verso un settore idoneo ad innescare meccanismi economici legati al turismo culturale, nuova frontiera di sviluppo. È il Porto di Vibo Marina al centro di una serie di iniziative che la Camera di Commercio ha programmato con attinenza alla pianificazione dei sistemi di sviluppo territoriali. Tale priorità intende focalizzare le energie della Camera sulla programmazione e realizzazione di un piano di sviluppo territoriale finalizzato a fare diventare il porto di Vibo Marina un riferimento importante per le attivi- tà economiche della provincia, sviluppando le aree industriali circostanti e la logistica dei trasporti connessa (intermodalità). L’obiettivo principale è quello di far diventare il porto di Vibo Marina elemento cardine sul quale costruire una linea strategica di sviluppo non solo della provincia vibonese ma dell’intera Regione, perché si possa configurare la “risorsa porto”, procedendo alla realizzazione di un progetto di riqualificazione dell’area portuale e del sistema economico dell’area circostante. A sostegno dello sviluppo delle imprese la Camera di Commercio di Vibo Valentia per il 2007 intende continuare a favorire la realizzazione di azioni legate all’accesso al credito - anche in considerazione dell’attuazione di Basilea II, ad attuare iniziative per l’internazionalizzazione - soprattutto mediante l’attivazione di desk di rappresentanza presso sedi estere, e continuare con le proprie attività a favore dell’alternanza scuola-lavoro. La Camera si propone altresì di favorire lo sviluppo delle imprese vibonesi sostenendole in questo particolare momento nella gestione dell’emergenza alluvionale, procedendo con il completamento di tutti gli adempimenti già avviati nell’anno 2006 e previsti dall’ordinanza del Commissario Delegato. Fare della legalità una leva competitiva per il territorio è altro importante obiettivo strategico che la Camera di Commercio di Vibo Valentia si è data per il 2007. L’Ente, infatti, intende svolgere con sempre più vigore il proprio ruolo di soggetto propulsore di iniziative volte a riaffermare i principi di giustizia, eticità e legalità nel territorio, in stretta collaborazione con le altre Istituzioni e con le associazioni locali. In tale direzione il progetto per la creazione di un codice etico per le imprese, da presentare e diffondere tra gli operatori economici, la predisposizione di un codice etico di regolamentazione e di disciplina delle Associazioni di Categoria e dei Consiglieri, che prevede norme di comportamento chiare e trasparenti, iniziative formative sulla Responsabilità Sociale (CSR), per diffondere la cultura dell’eticità dell’economia, nonché azioni di sostegno e rafforzamento di strumenti di tutela alle imprese vittime di atti criminosi, in particolare attraverso le Associazioni che già operano sul territorio, quali l’Antiracket e l’Antiusura. Un’azione a tutto campo, di grande respiro, quella programmata per il 2007 da una Camera di Commercio consapevole di essere protagonista dello sviluppo del territorio quando riesce nell’intento di far divenire protagonisti i soggetti economici che deve sostenere. E il documento di programmazione delle attività per il 2007, che delinea esigenze, strategie ed idee progettuali, che gli organi camerali hanno consegnato all’organizzazione interna dell’Ente, scaturisce da una piena condivisione con le Organizzazione di Categoria e da un confermato impegno collegiale in azioni a sostegno dell’economia della provincia. Iniziative promozionali, ma anche obiettivi di sistema: attrattività territoriale, verifica dei posizionamenti settoriali, competitività. È nel principio della coesione, per instaurare un clima di credibilità e fiducia, è nell’ottica della concertazione, per delineare strategie e perseguire progettualità condivise, che nasce il programma della Camera di Commercio di Vibo Valentia per il 2007, a significazione della necessità da parte delle Istituzioni e del mondo del lavoro di fare sistema. “La crescita economica” – affermava Benjamin Friedman, economista di Harvard – “è un processo al quale non possiamo rinunciare, perché lo sviluppo non produce solo futile benessere materiale, ma anche profondo valore politico e morale”. Dallo sviluppo economico, dunque, ad una società più aperta, tollerante e democratica. Un circolo virtuoso, quello generato da sviluppo ed etica in intrinseca complementarietà, che la Camera di Commercio di Vibo Valentia, con i suoi programmi per il 2007, intende considerare ambizioso traguardo. gennaio / febbraio 2007 17 di Maurizio Caruso Frezza Avanti tutta verso il nuovo PORTO Capitaneria e Camera di Commercio hanno impresso una forte accelerazione al piano di rilancio e valorizzazione dello scalo marittimo di Vibo Marina. N on si è perso nel vento e tra le acque blu profonde il roco richiamo del vecchio e potente rimorchiatore Strenuus. Il porto ha cominciato a risvegliarsi dal lungo torpore durato anni. La tabella di marcia - imposta inizialmente in tandem da Capitaneria di Porto di Vibo Marina e Camera di Commercio e poi in gruppo con Comune, Provincia, Regione, Consorzio Industriale e con referenti come Genio Opere Marittime, Anas, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Asl e Dogane - ha impresso in questi ultimi mesi una notevole accelerazione al processo di concertazione istituzionale volto a definire un piano operativo immediato per il rilancio del porto di Vibo Marina. 17 ottobre, 23 novembre, 12, 14 e 19 dicembre 2006 ed, ancora, 4, 8, 10, 13 e 16 gennaio 2007 sono le date che hanno scandito il nuovo percorso di una programmazione dal basso concreta ed efficace che ha portato a concordare il 1° 18 gennaio / febbraio 2007 febbraio scorso, nella conferenza di servizi clou, l’avvio ufficiale dei lavori per l’aggiornamento del piano regolatore portuale. E questa volta il processo si è portato in dote non più vaghe teorie o impegni ipotetici, ma idee chiare e una selezione ragionata e precisa di cosa si deve e si può fare. Le tappe per arrivare a questo risultato hanno esaltato l’elemento concertativo, con i diversi attori istituzionali impegnati a promuovere ed ospitare i vari incontri programmatici che si sono succeduti, passando per Capitaneria di Porto e Camera di Commercio, Comune e Provincia, Consorzio Industriale e imprese che operano e vivono nel porto, ascoltate direttamente per registrarne bisogni e aspettative. Ogni soggetto coinvolto ha contribuito ad arricchire il confronto, che è stato continuo, spontaneo ma non programmato. E questo è stato positivo, perché ognuno ha apportato il suo contributo e il suo punto di vista. E perché ognuno si è sentito parteci- pe e protagonista di un lavoro di gruppo, non dichiarato ma comunque condiviso e reale. Un approccio che testimonia un segno positivo di maturità istituzionale per un territorio che sconta ancora oggi numerosi ritardi. Ribadiamo: lo sviluppo salpa da qui. Dal porto di Vibo Marina. Oggi ne siamo ancora più convinti. Anche con un po’ di timore: perché fallire vorrebbe dire rinunciare irrimediabilmente ad un porto competitivo ed a ciò che il suo rilancio può significare per il territorio. Perché, avvertiamo, ancora nulla è raggiunto. Ma è anche vero che nulla è più fermo. Assolutamente fermo, come era quattro anni fa quando del porto nessuno si preoccupava. Oggi, invece, il vento sembra decisamente cambiato e lo si intuisce anche dall’entusiasmo che coinvolge gli attori istituzionali impegnati in questo ambizioso progetto. Un clima d’ottimismo consolidato dal fatto che finalmente si è cominciato a mettere giù qualche punto fermo. • Primo: il porto deve essere messo prima di ogni cosa in sicurezza. Questo vuol dire innanzitutto che la risacca, cioè il mare mosso che entra fino alla banchina Fiume quando il vento tira da nord-ovest, deve essere bloccata fuori. Questo lo si può fare, senza girarci troppo intorno, in un solo modo: prolungando il molo di sopraflutto, cioè il molo del faro verde. È un’opera impegnativa ma non proibitiva, né tecnicamente né finanziariamente. La si può realizzare gradualmente: prima la parte sommersa e poi quella in superficie. Velocizzando e suddividendo la spesa in un periodo più lungo senza per questo rinunciare a breve alla soluzione fondamentale che consentirebbe di recuperare a funzione economica tutto il quadrante sud del porto. Riuscire a fare questo consentirebbe di aggiungere 800 posti barca ai 400 esistenti. Assicurare il funzionamento 365 giorni su 365 delle banchine commerciali. Aggiungere un accosto all’attuale molo del faro rosso. In sintesi: più che raddoppiare la vita del porto. Delle imprese. Del business. Della città del fronte porto. • Secondo: il porto è polifunzionale. Ormai anche i più riluttanti nel credere alla necessità di rilancio dello scalo marittimo hanno preso atto che da Vibo Marina partono navi per tutto il mondo con prodotti di alta tecnologia metalmeccanica e petrolchimica; che di cemento ne può arrivare di più e, con i dovuti accorgimenti, partire anche; e che, in generale, il trasporto marittimo tradizionale può trovare dei vantaggi specifici a Vibo Marina oltre che a Gioia Tauro. Porto commerciale ma anche turistico, è questa la polifunzionalità da perseguire. • Terzo: si può lavorare per attrarre due tipologie nuove di traffico: le navi roll on - roll off per il trasporto di veicoli merci e auto sulla direttrice Nord-Sud (fattibile perché il mercato potenziale c’è, per Civitavecchia, Livorno o La Spezia lo si vedrà poi ma, nel frattempo, l’importante è che si possa prendere in considerazione anche questa opportunità); le navi da crociera, piccole sì (400-1000 passeggeri) ma comunque sempre navi da crociera e, quindi, importante volano turistico. Queste navi possono già oggi tecnicamente approdare come è successo a settembre con la Paloma I (vedi foto) che ha portato un migliaio di cicloturisti olandesi in escursione da Tropea a Vibo. • Quarto: il porto non è soltanto specchio di acqua ma è anche, e soprattutto, retroterra, collegato ed organizzato per assicurare un adeguato accesso ai quattro settori peculiari dell’economia portuale vibonese: cantieristica nautica e navale, commerciale, turistico, pesca e maricoltura. Da qui l’esigenza di aree di stoccaggio, di accessi dedicati terra-mare e mare-terra, di accessibilità porto-città e viceversa. Anche su queste problematiche si è lavorato per trovare le soluzioni “giuste”, quelle in grado di non stravolgere gli assetti attuali (e quindi più economiche) e di consentire la coesistenza “pacifica” tra esigenze funzionali differenziate. • Quinto: lo sviluppo del porto passa anche dalla necessità di dover affrontare, unitamente alle esigenze di messa in sicurezza e di delocalizzazione delle attività industriali presenti nelle aree coinvolte dall’evento alluIn alto a sinistra, la banchina “Bengasi” del Porto di Vibo Marina. Sopra, la nave da crociera “Paloma I”. gennaio / febbraio 2007 19 La strategia g della Capitaneria p di Porto di Maria Teresa Iannelli 20 Un porto dalle grandi potenzialità che può vivere di vita autonoma a condizione, però, che si proceda a una riorganizzazione razionale degli spazi e delle attività che in esso si svolgono. La Capitaneria di Porto ha deciso di affrontare subito questo problema. Lo ha fatto prima verificando spessore e problematiche degli operatori e poi radunando intorno al tavolo della conferenza di servizi i vari e diversi soggetti pubblici e privati con i quali disegnare una nuova strategia di sviluppo per lo scalo marittimo di Vibo Valentia Marina. Primo risultato di questa strategia è aver portato tutti a convincersi che per il rilancio del porto è fondamentale risolvere il problema della risacca che rende inutilizzabile le banchine interne e crea serie difficoltà nella gestione permanente del naviglio in stazionamento. Allungare il molo di sopraflutto è l’intervento-soluzione necessario e oggi non più differibile. Una volta realizzata questa opera, infatti, sarà possibile ampliare le possibilità offerte: dalla pesca alle attività mercantili, dalla valorizzazione del settore nautico-turistico all’utilizzo del porto per le attività istituzionali. Altra priorità individuata dalla Capitaneria di Porto e condivisa dai partner di questa intensa collaborazione, è costituita dal miglioramento della viabilità per l’accesso allo scalo marittimo, intervento da considerarsi essenziale per lo sviluppo commerciale. Altrettanto importante, infine, viene considerato il potenziamento dei servizi alle banchine: incremento ed ampliamento dei trasporti commerciali attuali, collegamenti veloci ro-ro e traffico crocieristico sono i punti sui quali attivarsi sin da subito. «La realizzazione di questi programmi - ha sottolineato recentemente il Comandante della Capitaneria, Domenico Napoli (al centro nella foto, durante la conferenza dei servizi) - consentirebbe di creare le condizioni utili allo sviluppo economico e commerciale del porto di Vibo e, giocoforza, dell’indotto legato alla sua attività». gennaio / febbraio 2007 vionale del 3 luglio 2006, i nodi dei depositi petroliferi e delle aree dismesse ed urbane irregolari. Una situazione che impone la ricerca di soluzioni per il recupero del “valore economico e sociale della città”. Il problema qui è serio ma i nuovi ragionamenti avviati per lo sviluppo del porto potrebbero introdurre elementi nuovi in grado di favorire la rimodulazione delle problematiche ambientali, urbanistiche ed economico-sociali del retroporto urbanizzato. Su tutti questi punti la discussione è andata avanti. Il confronto pure e alla fine è stata assicurata la convergenza delle diverse parti. Oggi alla Camera di Commercio il rilancio del porto è un obiettivo messo nitidamente a fuoco (non a caso rientra nelle linee stategiche prioritarie del programma di attività 2007), e così pure alla Provincia (porto inserito tra le infrastrutture di trasporto prioritarie), e al Consorzio Nucleo Industriale (la crescita dello scalo marittimo esprimerebbe conseguenze estremamente positive anche per l’area industriale di Portosalvo), al Comune (il Piano Strutturale Comunale contempla tra le priorità l’integrazione della città con il porto), alla Rfi (porto uguale nuova prospettiva per linee ferroviarie e stazioni dismesse), alla Regione (impiego efficiente e redditivo delle risorse regionali), a Vibo Sviluppo (il porto per la crescita del settore turistico). Ma è soprattutto alla Capitaneria di Porto che è più alta la mobilitazione su questo ambizioso progetto di riqualificazione e rilancio dello scalo marittimo (vedi riquadro a fianco). E così all’entusiasmo generale di “prima scoperta” che avevamo rilevato nel mese di febbraio 2006 (con i richiami fondamentali della Camera di Commercio e della Consulta economica portuale di Santa Venere), oggi si è aggiunto anche l’entusiasmo di quanti si rendono conto che la rinascita del porto è possibile. È vero, sono passati tre anni e mezzo da quando in questa provincia si è ricominciato, nel luglio del 2003, a parlare diffusamente ed ampiamente dello scalo di Vibo Marina. Non aver mollato, continuando a visualizzare gli effetti benefici che il rilancio del porto avrebbe sull’intera economia provinciale, comincia a dare i primi frutti, nella certezza che la vocazione ultramillenaria del porto di Vibo Marina, se assecondata, non ci tradirà. GRECI e ROMANI approdavano qui La costa vibonese custodisce sui propri fondali i resti di attracchi antichissimi. Il porto di Valentia costituiva l’unica possibilità di riparo lungo la costa tirrenica a sud di Napoli. È suggestivo pensare che il mare della costa tirrenica vibonese che oggi tanto attira il turista, abbia svolto, in passato, un ruolo ben diverso ed importantissimo nella vita degli indigeni e degli stessi Greci, che per suo tramite, intorno al VII sec a. C., sbarcarono in questi luoghi, spinti dall’oracolo divino. L’itinerario marittimo da Pizzo a Tropea, è quello che più si avvicina allo spirito ed alla mentalità Greca del viaggio, che veniva effettuato non per divertimento, ma per intima necessità. Ed eccoli i primi greci che ormeggiano le loro navicelle agli innumerevoli approdi presenti lungo questa costa; approdi che presto adattano alle esigenze dei loro traffici e delle comunicazioni; e che successivamente i Romani attrezzeranno di moli e solide strutture anche monumentali. Certamente non sognava il Lenormant, quando nel suo viaggio, al vecchio ed abbandonato Castello di Bivona, vide sotto l’acqua gli avanzi del porto di Valentia: considerevoli resti dei moli esterni e dei grossi piloni quadrati di costruzione romana, disposti a distanze regolari. La tradizione tramanda che l’arcata di mezzo, più larga delle altre, era costruita in marmo e portava scolpita la statua di Nettuno. Nonostante il trascorrere del tempo, ai giorni nostri, archeologi e geologi, hanno ritrovato proprio a Trainiti quelli che sembrano essere i ruderi del porto, visitato dal Lenormant alla fine del secolo scorso. Ma vedere i moli antichi del porto di Valentia è consentito anche al bagnante intraprendente e al sub non troppo esperto, dato che i manufatti sono a pochi metri dalla riva e a solo 4-8 metri di profondita’. Si tratta di un porto molto ampio, compreso tra il promontorio di S. Nicola, allora proteso più avanti nel mare, e Trainati; in quest’ ultima località ed alla Punta Buccarelli, sono stati rinvenuti due antemurali: quello maggiore, partendo dalla foce del Trainiti si spinge nel mare per circa 350 metri e si presenta come una sovrapposizione di ciottoli e grandi massi squadrati, che nel tratto iniziale, più vicino a terra, mostra due bracci distanti tra loro circa 10 metri; strutture queste che confluiscono in un unico elemento la cui larghezza varia da un minimo di 40 ad un massimo di 70 metri L’antemurale minore è ubicato in corrispondenza di Punta Buccarelli, ha direzione nord-est ed è anch’esso costituito da massi e ciottoli di dimensioni diverse; è in pessimo stato di conservazione poiché rimane solo il gennaio / febbraio 2007 21 fondale e le sue parti mostrano un’estrema dispersione di materiali. Le fonti classiche tramandano che Agatocle, intorno al III secolo a. C. aveva risistemato il porto di Hipponion, che poi, al tempo della guerre civili, (I secolo a. C.), fu base di Cesare e Ottaviano, contro Pompeo. Secondo notizie fornite dagli scrittori locali e i dati d’archivio, di recente oggetto di studio da parte di Antonio Montesanti, il porto di hipponion-Valentia era ancora attivo nel Medioevo e nel Rinascimento; in seguito venne distrutto per ordine dei Pontefici romani, per evitare che diventasse ricovero dei “barbari”. Verso l’interno il porto è limitato da un vecchio sistema di dune, sul quale, in età romana erano state costruite alcune ville, di cui una è stata in parte indagata al Castello di Bivona; qui sono visibili alcune strutture e un molo connesso al porto di Valentia; i manufatti rinvenuti, rappresentano la sistemazione, in età romana, di un’insenatura naturale già usata, come approdo, in età greca. In effetti il ruolo del porto è fondamentale sia per l’età greca che per quella romana, così come, per tutto il territorio in esame, esso diventa veicolo per il commercio e determina il fiorire di vasti complessi insediativi che specializzano e differenziano la loro produttività anche in funzione dell’esportazione a breve e forse anche a più ampio raggio. Val la pena di ricordare che il porto di Valentia costituisce l’unica possibilità di approdo lungo la costa tirrenica a sud di Napoli, quaA pag. 21, le vestigia sommerse del porto antico di Valentia. In alto, la costa di Pizzo Calabro. A destra, un tratto della costa vibonese in prossimità di Capo Vaticano. 22 gennaio / febbraio 2007 si tappa obbligata per le comunicazioni con la Sicilia. D’altra parte, non si deve dimenticare che la città di Valentia, cui si aggiunge il nome italicizzato di Vibona, ubicata com’è lungo le maggiori direttrici viarie, coagula e smista i prodotti locali anche per via terrestre e diventa il polo di riferimento economico e politico per tutto il territorio. A questo proposito grande impulso avrà il municipium ed il suo territorio, dalla costruzione della via Annia Popilia che assicurava il collegamento tra Roma e la Sicilia passando per il Bruzio. Negli itineraria romani, la città di Valentia è indicata come statio, cioè stazione di posta, dove ci si fermava a fare riposare cavalli e viaggiatori; essa viene definita con vari nomi e con qualche divergenza di distanze. La conferma archeologica che la via Popilia passava per Vibo Valentia è costituita dal miliario romano rinvenuto nel 1952, in modo fortuito, a S. Onofrio, nelle vicinanze dell’attuale centro, ora esposto al Museo Archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Secondo la ricostruzione topografica che fa G. Givigliano, la via si snoda dal fiume Angitola, attraverso l’attuale Piana degli Scrisi in comune di Maierato, e penetra nella città di Valentia tramite la porta nord, quindi la attraversa, secondo un percorso al momento non precisabile, e giunge fino al limite Sud-Ovest, dove si dirige verso l’attuale Gioia Tauro. Sempre in età romana e già a partire dal II sec. a. C., epoca di fondazione della colonia romana di Valentia che come abbiamo visto prima, nell’89 a.C. diventa municipium, su questa costa si diffonde il tipico insediamento in villa; si tratta di complessi rurali che molto spesso sorgono su speroni rocciosi costieri, protesi sul mare, ma talvolta, sono ubicati all’interno o sulla mezza costa, o anch’essi, su vasti pianori, tanto diffusi in questo territorio, da costituirne la principale caratteristica ed attrazione. In età imperiale, le ville, grazie alla presenza del mare e alla notevole bellezza naturale della zona, evolvono anche in senso residenziale, connettendo insieme, esigenze economiche e paesaggistiche. La costruzione di questi insediamenti era senz’altro finalizzata allo sfruttamento di un entroterra fertilissimo, di un’ottima posizione panoramica e di un’attività di esportazione collegata con il vicino porto di Valentia. Nell’antichità, l’attuale golfo lamentino, denominato anche hipponiate, era particolarmente rinomato anche per la quantità e l’alta qualità del tonno che vi si pescava, come testimoniano gli scrittori antichi Atheneo ed Aeliano. Lo studio e la ricerca archeologica su questo tratto di costa, hanno individuato due “tonnare” romane, di cui una alla Rocchetta di Briatico meno conservata, l’altra, in località S. Irene, molto monumentale e quasi intatta per la maggior parte. A Sant’Irene, in età romana, la pesca e la lavorazione del tonno si svolgeva secondo le modalità riferite dallo scrittore antico Columella, che, in un capitolo della sua opera, il De re rustica, descrive la pesca e la costruzione degli stabilimenti per la lavorazione del pesce. Dal promontorio di S. Irene, dove ora sono i resti di una torre quattrocentesca, il tonno veniva avvistato; e, mediante le barche ed un sapiente sistema di reti, opportunamente posizionate, il pesce che non era ucciso, veniva fatto entrare in un sistema di vasche, costruite sullo scoglio a mare e comunicanti, forse con un sistema di ponteggi di legno, con quelle costruite sulla spiaggia; qui, il pesce veniva conservato sotto sale; infine, in salsa (garum), o in pezzi salati, veniva stivato in contenitori di argilla (anfore), e trasportato e commerciato in varie località, attraverso imbarcazioni che dai porticcioli delle tonnare, arrivavano e venivano smistate nel vicino porto di Hipponion- Valentia. Del resto, la tradizione delle tonnare è rimasta viva su costa dove, fin dal ‘600, sono sorte diverse tonnare (fabbriche per la pesca e la lavorazione del tonno), documentate da atti d’ archivio (Bivona, Pizzo tonnara grande e piccola o “ delli Gurni, Briatico tonnara “delli Bracci” o “della Rocchetta”, S.Venere) delle quali, alcune sono state demolite; per fortuna, quella di Bivona è ben conservata e visitabile. Tuttora a Pizzo e Maierato sono attive due moderne fabbriche di produzione del tonno qui vengono lavorate le uova di tonno con la stessa procedura usata in antico; il prodotto, molto ricercato sul mercato, è chiamato con espressione dialettale “vatarico” che è chiaramente mediato dal greco taryxos, termine usato per indicare la salsa prodotta con le interiora delle sgombro. Ecco di Rosanna De Lorenzo LÌMEN Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria Giusppe Soluri e il docente universitario Mario Caligiuri hanno tenuto a battesimo la nostra rivista con interessanti interventi sulla comunicazione D ebutto ufficiale per Lìmen – Economia Arte Cultura, rivista bimestrale della Camera di Commercio di Vibo Valentia, sabato 16 dicembre scorso presso la Sala Riunioni dell’Ente camerale, con gli autorevoli interventi di Giuseppe Soluri - presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria - e di Mario Caligiuri, esperto in comunicazione, docente all’Università La Sapienza di Roma e all’Unical di Cosenza. «Lìmen è una rivista con anima che ha in sé e riesce a trasmettere positive sensazioni Una Rivista che, contrariamente a tante altre, non si sfoglia frettolosamente ma si ha il piacere di leggere e conservare», questo il giudizio di Giuseppe Soluri. E da Mario Caligiuri la consacrazione del messaggio sintetizzato nella testata: «Pertinente la scelta del nome Lìmen che tanto nell’accezione latina “soglia” quanto dal greco “porto”, induce a pensare a continui dinamismi». «Per noi è un progetto entusuiasmante», sostiene Michele Lico, presidente dell’Ente Camerale, consapevole di come sia stata accolta e condivisa la sua idea di una rivista istituzionale «autorevole e ricca nei contenuti, dinamica e accattivante nella grafica, che potesse diventare effettivamente strumento per comunicare l’Ente e valido contributo per determinare condizioni di competitività, sviluppo e benessere del territorio vibonese in una logica di partecipazione e condivisione». «A questi criteri sono stati improntati testi, aspetti grafici Sopra, un momento della presentazione di Lìmen, da destra Giuseppe Soluri, Mario Caligiuri, Michele Lico, Enrico De Girolamo e Franco Sammarco. 24 gennaio / febbraio 2007 e cromatici - precisa il direttore responsabile Enrico De Giorolamo - per veicolare appunto all’esterno, in modo interessante, l’attività e gli obiettivi programmatici dell’Ente, stimolando un ampio confronto sui temi cruciali dello sviluppo locale». Questo si è inteso fare con gli argomenti proposti nel primo numero: il Porto di Vibo Marina, il nuovo logo della Camera di Commercio, l’anagrafe imprese, i prodotti tipici, il Comitato Imprenditoria Femminile, il nuovo POR, i progetti di sviluppo, le eccellenze, la storia, la cultura, l’ambiente, l’arte di Enotrio; lo si è voluto fare anche parlando dell’alluvione del 3 luglio scorso, per rappresentare quel che è stato e come si sta operando per superare l’emergenza, e con le pagine riservate all’Amministrazione Provinciale e alla Vibo Sviluppo S.p.A., ringraziate dal presidente Lico per il loro importante contributo. GIUSEPPE SOLURI, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria «Lìmen è nel suo genere una rivista assolutamente originale, nel senso che raramente le istituzioni si dotano di strumenti di informazione e comunicazione così moderni ed accattivanti. Per la funzione che mi è propria, di rappresentare la categoria dei giornalisti calabresi, non posso, dunque, che esprimere soddisfazione tanto più ricordando che l’informazione e la comunicazione pubblica non solo rispondono all’esigenza dell’Ente di definire una precisa immagine di credibilità e affidabilità dando conto ai cittadini/utenti di progettualità e offerte di servizi ma costituiscono per lo stesso Ente un preciso dovere, anche di trasparenza nei confronti della col- lettività che ha il diritto di conoscere atti e situazioni di cui essa stessa è destinataria e rispetto a ai quali deve adeguare il proprio comportamento. E in un contesto di pluralismo istituzionale l’informazione e la comunicazione pubblica diventano modalità di partecipazione e condivisione, che poi risultano essere anche la mission che il presidente Lico ha dichiarato propria della rivista camerale e con la quale, la Camera di Commercio di Vibo Valentia associa, dunque, e in modo pregevole, il diritto/ dovere di informare al compito istituzionale di promuovere il territorio. E lo fa con un prodotto editoriale dai contenuti interessanti e piacevoli. Lìmen è una di quelle riviste che contrariamente a tante altre non si sfoglia frettolosamente ma si ha il piacere di leggere e conservare. Un raro esempio, soprattutto in Calabria, di prodotto istituzionale ben costruito in ragione degli obiettivi prefissati. Si può con certezza definire una rivista con anima, che ha in sé e trasmette positive sensazioni». MARIO CALIGIURI, esperto in Comunicazione «Lìmen rappresenta uno strumento importante per il territorio vibonese ed è un segno di cambiamento reale, perché ha giusti contenuti. Pertinente la scelta del nome che tanto dal latino “soglia” quanto nel greco “porto” induce a pensare a dinamismi che hanno punti di partenza e anche di arrivo. Di questo bisogna dare atto e merito alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, al suo presidente Michele Lico che, nel realizzare il progetto, facendo leva su risorse interne, è stato concreto e lungimirante. La comunicazione deve accompagnare ogni progettualità, tanto più quella delle istituzioni pubbliche che hanno il dovere di rendere noti programmi e azioni. E Lìmen va in questa direzione. Anzi va oltre proiettando l’immagine di un territorio vivo e attivo, per come effettivamente è. E la percezione di un territorio, della sua immagine, è sicuramente elemento non secondario nei processi di sviluppo economico. Certo l’immagine da sola non basta, non serve se non rappresenta coerenza di contenuti e di risorse, che qui, in questo territorio esistono; la strategia è ampliare i punti di forza rispetto a quelli già esistenti. Turismo, cultura, beni culturali, arte, tradizioni, gastronomia, ambiente, in altre parole il “buon vivere” che ci appartiene: è questo quello che dobbiamo valorizzare e comunicare. Per la provincia di Vibo Valentia costituiscono preziose risorse, così come risorsa è il Porto di Vibo Marina che il presidente Lico ha giustamente definito struttura strategica da potenziare e rilanciare. In tutto questo l’informazione e la comunicazione sono determinanti, devono diventare strategia. Una potenzialità spesso e generalmente sottodimensionata; un problema complessivo, non esclusivamente della Calabria che è solo il vagone di un treno che va a rilento. La rivista della Camera di Commercio di Vibo Valentia, può rappresentare, quindi, un punto d’incontro e utile strumento di tutte realtà positive e propositive del territorio. In quanto, poi, alle politiche di sviluppo, il concetto chiave è: pensare locale e agire globale. I nostri prodotti, le nostre risorse devono inserirsi e integrarsi in sistemi a carattere complessivo facendo rete a più livelli. È ora di ribaltare la tendenza dei media di indugiare su di noi solo per questioni non sempre esaltanti, che tra l’altro sono comuni ad altre realtà, e mostrare, invece, quanto di positivo, propositivo e costruttivo abbiamo e riusciamo ad esprimere. Stabiliamo una cosa: questo si può fare e si deve fare. E, mi pare, che il presidente Lico, questo percorso, non solo lo abbia chiaramente in mente, ma lo abbia già intrapreso in modo preciso». FRANCO SAMMARCO, Sindaco di Vibo Valentia «Do il benvenuto a Lìmen in un territorio orgoglioso di essere rappresentato da una rivista di tale caratura. Colori luminosi e bellissime foto che sono rappresentazione dei nostri luoghi, della nostra identità; testi interessanti e ben calibrati, impaginazione gradevole, tutti elementi esemplificativi delle capacità e delle raffinatezze che il nostro territorio sa esprimere. Economia, arte e cultura sono sapientemente considerate in un sistema di rete, un modalità che dobbiamo percorrere con capacità, sagacia e impegno. Condivido l’importanza di fare rete, come propone la Camera di Commercio anche con questa rivista, perchè è l’unica strada percorribile oggi per azioni credibili ed efficaci volte a valorizzare le risorse esistenti individuando priorità e strumenti finanziari. Con il presidente Lico abbiamo già avanzato proposte comuni e condivise, per esempio per dare identità al porto di Vibo Marina, rilanciando servizi commerciali e turistici di qualità. Per tutto questo il mio plauso a Lìmen e l’augurio di poter continuare a comunicare, come ha fatto in questo numero, un territorio che è realisticamente operoso, positivo e propositivo». gennaio / febbraio 2007 25 Camera di Raffaella Gigliotti COMUNICA Camera Pubblicato il primo bilancio sociale relativo al biennio 2004/2005 S i chiamano “stakeholder” - portatori di interessi - i destinatari del Bilancio Sociale che, per la prima volta, la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha realizzato, con riferimento al biennio 2004/2005, quale risposta concreta al dovere etico di rendere conto a tutti i suoi interlocutori del proprio operato. Ogni decisione maturata, ogni impegno assunto, ogni iniziativa intrapresa dalla Camera di Commercio si sviluppa nelle relazioni intessute dall’Ente con i suoi stakeholder (imprese, istituzioni, associazioni di categoria, risorse umane interne, fornitori, destinatari di servizi). Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle attività svolte, moderno, puntuale, trasparente. Missione, strategie perseguite, valori etici di riferimento: comunicati. Valore, competenze, prodotto dell’azione amministrativa – elementi fondamentali per la vita dell’Ente: esternati. Il documento è snello e sintetico, ma esaustivo delle scelte compiute nell’arco temporale di riferimento. Usa un linguaggio comunicativo estremamente efficace, di impatto per la scelta dei supporti figurativi che catturano l’attenzione visiva, e fruibile non solo al ristretto pubblico degli addetti ai lavori, per la leggerezza e semplicità dei contenuti testuali. Un Bilancio Sociale che mette in evidenza gli obiettivi raggiunti dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia nel corso del biennio 2004/2005. Obiettivi meritevoli di comunicazione, quali il miglioramento della qualità dei servizi amministrativi, l’incremento dei livelli di efficienza e tempestività nella loro erogazione, il potenziamento del ruolo dell’Ente nei diversi avvenimenti che regolano il mercato e stimolano la crescita del tessuto imprenditoriale della provincia. Il piano strategico della Camera di Commercio di Vibo Valentia, le cui linee fondamentali sono declinate nei documenti programmatici annuali e pluriennali, prevede interventi finalizzati alla crescita del sistema socioeconomico ed al miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dell’organizzazione interna. Il rinnovo degli organi direttivi, avvenuto nel corso del 2005, ha dato nuovo impulso al processo di programmazione dell’Ente, individuando un piano d’azione coerente con i mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le strategie individuate possono essere così sintetizzate: • migliorare la qualità dei servizi amministrativi, semplificando e velocizzando l’erogazione degli stessi; • potenziare il ruolo di ente regolatore del mercato, mediante la diffusione dei procedimenti di giustizia alternativa, il miglioramento della trasparenza del mercato e la tutela del consumatore; • consolidare la competitività del territorio e del sistema produttivo, promuovendo azioni di marketing territoriale e valorizzando, in particolare, i settori del turismo, dell’artigianato e dell’agroalimentare; • supportare la penetrazione delle imprese locali sui mercati esteri, mettendo a disposizione strutture in grado di garantire assistenza e informazione; • favorire l’orientamento al lavoro, sviluppando il rac- cordo tra il mondo della formazione ed il tessuto imprenditoriale; • promuovere la diffusione della cultura d’impresa, supportando le nuove iniziative imprenditoriali; • incrementare il livello degli investimenti delle Pmi, facilitandone l’accesso al credito; • promuovere l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, attraverso il monitoraggio dei fabbisogni tecnologici delle imprese e l’offerta di servizi informativi; • migliorare l’efficienza dell’organizzazione camerale, mediante l’adeguamento e la modernizzazione della struttura e la valorizzazione del personale; • rafforzare la centralità dell’utenza, attraverso la costruzione di relazioni di fiducia ed il miglioramento delle attività di comunicazione da parte dell’Ente. In linea con l’evoluzione economica e istituzionale dell’ultimo decennio, la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha aggiornato costantemente i propri servizi e la propria struttura operativa per meglio rispondere alle istanze del proprio territorio. In particolar modo, l’Ente camerale si è fatto interprete delle necessità del tessuto imprenditoriale della provincia, fondando la propria gestione su un sistema ben definito di valori, che sono stati recepiti anche nello Statuto: • l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, che spingono al miglioramento costante delle prestazioni da parte dell’Ente; • la trasparenza, in relazione alle procedure amministrative ed alla comunicazione, sia interna che esterna; • l’imparzialità, garantendo le medesime condizioni di gennaio / febbraio 2007 27 accesso ai servizi alle imprese ed agli utenti in generale; • la libera iniziativa economica, la libera concorrenza, l’autoregolamentazione del mercato, la tutela e la dignità del lavoro, al fine di garantire un’economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell’impresa e nel lavoro. A tali valori si affiancano alcuni principi derivanti da prassi e comportamenti consolidati negli anni, con i quali la Camera di Commercio risponde alle specifiche aspettative del sistema economico. In particolare, tali principi riguardano: • la “centralità” dell’utenza, per adeguare i servizi erogati alle effettive esigenze delle imprese e degli altri soggetti che si rivolgono agli uffici camerali; 28 gennaio / febbraio 2007 • l’orientamento all’innovazione, volto all’adeguamento costante dei modelli di gestione dell’organizzazione, di erogazione dei servizi e della dotazione tecnologica; • la capacità di operare in rete, che ispira la realizzazione di iniziative concertate e volte a promuovere l’interscambio di competenze e risorse. Ma il Bilancio Sociale non è solo un documento di descrizione dei programmi, delle strategie e dei valori espressi dall’Ente. Esso si traduce anche in uno strumento di analisi, poiché offre un resoconto completo dei progetti, delle attività realizzate, delle risorse allocate e delle ricadute sociali prodotte sul territorio e verso gli stakeholder. Il documento è stato realizzato applicando le migliori tecniche, i principi di redazione e le prassi professionali più evolute. È articolato in tre parti, seguendo le raccomandazioni delle metodologie prevalenti in letteratura. La prima parte è dedicata all’identità della Camera e descrive la missione, i valori, le strategie, la struttura organizzativa e fornisce un quadro del contesto socioeconomico della provincia. Nella seconda parte (relazione sociale) vengono individuate le principali categorie di stakeholder e illustrate le attività, i servizi e i progetti realizzati dall’Ente in termini di efficacia e di ricaduta sociale. La terza e ultima parte riguarda il Rendiconto Economico, che descrive la ricchezza prodotta e le modalità di distribuzione agli interlocutori sociali. Dal Bilancio Sociale la Camera di Commercio di Vibo Valentia vuol fare emergere “cosa si fa”, “come si fa” e, soprattutto “per chi si fa”. Come l’impresa risponde ai propri soci, così la Pubblica Amministrazione risponde alla società, che si traduce nel proprio “azionista” di riferimento. In tal senso si esplicita l’analogia tra impresa privata ed ente pubblico sotto il profilo della responsabilità sociale e si chiarisce perché anche il soggetto pubblico presenti il Bilancio Sociale. La Camera di Commercio di Vibo Valentia ha dimostrato una peculiare lungimiranza nell’adottare questa politica di comunicazione ed è stata tra le poche Pubbliche Amministrazioni in Calabria a confrontarsi con l’opinione pubblica. Non va tralasciato, inoltre, che l’intero lavoro è stato prodotto da un Gruppo di funzionari interni alla struttura, con l’assistenza tecnica di Retecamere; un lavoro, che ha reso possibile candidare la Camera di Commercio di Vibo Valentia all’ambìto premio “Oscar di Bilancio” per la categoria Organizzazioni Centrali e Territoriali delle Amministrazioni Pubbliche, ricevendo il plauso della Giuria. Scrive Gherarda Guastalla Lucchini (Segretario Generale del premio) nell’inviare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia l’attestato di partecipazione: «Desidero esprimere il nostro vivo apprezzamento per il livello qualitativo del Bilancio da voi presentato. Partecipare all’Oscar di Bilancio è di per sé indice di qualità della comunicazione e nelle relazioni con gli influenti». Con il Bilancio Sociale, dunque, la Camera di Commercio di Vibo Valentia “si racconta”, ma soprattutto, “si confronta”. La realizzazione del Bilancio Sociale vuol essere, infatti, anche una verifica della gestione e dell’organizzazione dell’Ente, affinché possa rendersi sempre più capace di corrispondere alle aspettative del sistema imprenditoriale locale, del quale è il punto di riferimento istituzionale. Così è stato pensato per dare slancio allo scambio dialettico ed alle valutazioni sull’operato dell’Ente, per meglio addivenire alla definizione di obiettivi di miglioramento sempre più condivisibili. gennaio / febbraio 2007 29 Quando la QUALITÀ fa la differenza di Rosanna De Lorenzo Tre imprese vibonesi impegnate nel settore turistico e della ristorazione si sono aggiudicate il Premio Ospitalità Italiana 2006. Il prestigioso riconoscimento è andato all’hotel Porto Pirgos di Parghelia, al pub Tato’s di Vibo Marina e al ristorante San Pietro di San Calogero. “P remio Nazionale Ospitalità Italiana”, quando l’ospitalità premia e la qualità fa la differenza. In questo slogan si può riassumere l’iniziativa promossa dall’ISNART (Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche), in partenariato con le Camere di Commercio, coinvolte e impegnate nella fase propedeutica e preselettiva di attribuzione del “Marchio di Qualità” alle strutture turistiche che si sono contraddistinte per l’adozione di elevati standard di qualità nell’erogazione dei servizi. Il Premio Ospitalità Italiana edizione 2006, celebrato a Bari lo scorso novembre, ha visto protagoniste, tra le dieci strutture decretate vincitrici da un’apposita Commissione Nazionale di esperti, tre imprese turistiche vibonesi, certificate così al top per la qualità dei servizi offerti e per il gradimento dei clienti. Il primo posto nella categoria “Hotel 5 stelle” è stato riconosciuto all’Hotel Porto Pirgos di Parghelia, premiati poi Tato’s di Vibo Marina e San Pietro di San Calogero per la categoria ristorante-pizzeria. Un primato esaltante per il nostro sistema turistico che in termini di accoglienza dà prova di professionalità e affidabilità, adeguandosi a sempre più elevati standard di qualità. La nostra provincia, poi, registra un alto tasso 30 gennaio / febbraio 2007 di strutture a cinque stelle, rafforzando questa tendenza. Il criterio della qualità nell’offerta dei servizi e dei prodotti turistici è indubbiamente un fattore di competitività, irrinunciabile quale garanzia per l’utente ed elemento di attrattività per un territorio capace di modulare la propria offerta ad una domanda sempre più puntuale ed esigente. Nell’ambito del progetto che la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha condiviso e sostenuto, l’attribuzione del Premio Nazionale “Ospitalità Italiana 2006” alle tre strutture della nostra provincia, non può che essere motivo di soddisfazione anche per l’ente camerale che fa della qualità fulcro della sua politica istituzionale. Al contempo, assume la duplice valenza di premialità per le strutture di eccellenza e di incentivo per una sana concorrenzialità nel sistema turistico locale verso quei parametri di eccellenza che si auspicano sempre più diffusi e omogenei, presupposti e moltiplicatori di sviluppo reale. A Bari, al Galà organizzato per la consegna dei premi erano presenti autorità istituzionali, rappresentanti del mondo economico, della moda e dello spettacolo, Sopra, la premiazione di Caterina Messina, direttrice dell’Hotel Porto Pirgos, sul palco con il presidente della Camera di Commercio Michele Lico a la soubrette Valeria Marini, madrina della manifestazione. tra questi ultimi Pippo Franco, Valeria Marini, Barbara Chiappini e Maurizio Mattioli. Alla serata di premiazione è intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia Michele Lico che ha voluto, anche in questa occasione, testimoniare la costante vicinanza e partecipazione dell’Ente camerale al comparto imprenditoriale vibonese. Michele Lico, poi, insieme a Valeria Marini ha consegnato il primo premio di categoria all’Hotel Porto Pirgos alla direttrice Caterina Messina. Il “Premio Ospitalità Italiana” è un’attestazione di alta qualità. Alla rosa delle strutture turistiche vincitrici si arriva attraverso un percorso di preventive verifiche basate su rigorosi criteri selettivi. Dal primo luglio al 31 agosto i clienti delle strutture italiane certificate con il “Marchio di qualità” hanno votato, appunto, la qualità del servizio ricevuto dalla struttura ospitante, assegnando un punteggio da 1 a 10, a seconda del livello di soddisfazione complessivamente raggiunto al termine della permanenza. Per la votazione previsti SMS, internet o l’apposito numero verde. L’Isnart ha poi contabilizzato le preferenze ricevute da ciascuna struttura, selezionando quelle con maggior numero di voti e quindi con punteggio più alto. Questo ha portato per ciascuna categoria – Alberghi: da 5 a 2 stelle; Ristoranti: gourmet, tipico regionale, internazionale, classico italiano, pizzeria, Agriturismo di qualità - alla selezione delle tre strutture più votate e quindi all’assegnazione del Premio Nazionale Ospitalità Italiana. La scelta della Camera di Commercio di Vibo Valentia di aderire al progetto dell’Isnart promuovendo il Marchio di Qualità nel settore Turistico muove da un obiettivo ben preciso che è quello di assicurare al territorio competitività attraverso l’emersione delle sue eccellenze, in un settore poi in cui l’accoglienza assume valenza poliedrica ed il gradimento è fattore indubbio di successo e di affezione. Il Marchio di qualità suggella il rigore nella valutazione e nella scelta degli operatori economici e delle strutture ricettive con caratteristiche confor- mi ai criteri della professionalità e dell’affidabilità, con la duplice funzione di conferire credibilità e visibilità a quanti concepiscono professionalmente l’attività turistica e al contempo diventa garanzia per l’utente all’atto della selezione di luoghi e strutture per un periodo di vacanza all’insegna della soddisfazione delle proprie aspettative. Già da diversi anni il sistema camerale si è attivato per moltiplicare le iniziative dei Marchi di Qualità con il coinvolgimento trasversale delle imprese dei vari comparti produttivi, dall’agroalimentare, al commercio, all’attività ricettiva e turistica in generale. Il Marchio di Qualità nel settore turistico, stante la specifica vocazione del nostro territorio, morfologicamente comprensivo di mare, monti e colline (le Serre Calabre con annesso Parco), oasi naturalistiche (Lago Angitola), altopiani (Monte Poro) con le tipicità ad ogni zona connesse, diventa elemento fortemente indicativo di elevati standard competitivi che tutela il turista proiettando un territorio contemporaneo e quindi capace di modulare la propria offerta ad una domanda sempre più puntuale ed esigente in termini di servizi turistici. Il Marchio di qualità così inteso vuol essere anche stimolo e incentivo per una sana concorrenzialità nel sistema turistico locale per uno spirito autopropulsivo verso criteri di alta qualità sempre più diffusi e omogenei su tutto il territorio provinciale. La Camera di Commercio con il Marchio di qualità delle imprese alberghiere, dei ristoranti, degli agriturismi e dei Bed & Breakfast della provincia di Vibo Valentia lancia questa sfida nell’ambito di una politica di filiera e di un’offerta turistica integrata. Ciò perchè la nostra terra possa essere vissuta per come e per quanto è capace di esprimere e perchè le bellezze naturali e paesaggistiche, storiche ed artistiche possano lasciare segno indelebile nella memoria del visitatore tanto quanto servizi turistici impeccabili e conformati alla più gradita ospitalità. Un momento della premiazione per il settore della ristorazione: primo a sinistra, l’imprenditore Salvatore Caliò di Tato’s. A Vibo Valentia le donne più INTRAPRENDENTI di Raffaella Gigliotti Pubblicato dalla Camera di Commercio il primo rapporto sull’imprenditoria femminile. La provincia di Vibo Valentia si attesta al primo posto nella graduatoria nazionale. D ictum Factum. Era stata preannunciata nelle pagine del primo numero di Lìmen dal Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, la realizzazione del Primo Rapporto sulle Imprese Femminili nella provincia. E con lo stesso amplificatore mediatico si è voluto dare notizia della sua pubblicazione, comunicandone tempestivamente i risultati. Risultati che non potevano essere più esaltanti di quelli che emergono da questo agile monitoraggio delle imprese femminili vibonesi, prodotto dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, con l’assistenza tecnica di Retecamere e la collaborazione del Comitato Imprenditorialità Femminile. Sì, perché, dalle statistiche snocciolate da questo primo rapporto in rosa risulta, a chiare cifre, che la provincia 32 gennaio / febbraio 2007 di Vibo Valentia è leader dell’imprenditoria femminile in Italia. A Vibo Valentia la voglia d’impresa a conduzione femminile si fa strada, tanto da conquistare, con un tasso pari al 4,3%, il primo posto nella graduatoria nazionale in termini di crescita tra il 2005 ed il 2006. La rilevazione al 30 giugno 2006, l’ultima in ordine temporale, ha infatti visto Vibo Valentia registrare il più elevato tasso di crescita a livello nazionale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato appare tanto più positivo se si considera che il trend di crescita delle imprese femminili della provincia nei due anni precedenti è stato uno dei più deboli di tutte le province della Calabria. Questo dato di Vibo Valentia al 30 giugno 2006 risulta supportato solo parzialmente dall’andamento regionale: la crescita piuttosto contenuta della Calabria (+0,3%) risente infatti di tre situazioni di eccellenza e di due di attenzione. Vibo Valentia è infatti seguita al secondo e terzo posto nella graduatoria provinciale, in base al tasso di crescita delle imprese femminili, da Crotone e Catanzaro; Reggio Calabria occupa una posizione centrale e Cosenza è all’ultimo posto con una performance addirittura negativa. In tutti i 7 semestri oggetto della rilevazione le imprese femminili di Vibo Valentia sono aumentate in termini assoluti passando dalle 2.840 del 30 giugno 2003 alle 3.127 del 30 giugno 2006 (+10,1%). Dal punto di vista della forma giuridica le imprenditrici vibonesi preferiscono le ditte individuali (85,34% nel 2005). L’altra quota consistente delle imprese femminili è quella delle società di persone (11,32%), che è la più elevata nel confronto con le altre province calabresi. A Vibo Valentia, invece, la percentuale più bassa (2,71%) delle imprese in forma di società di capitale. Sotto il profilo del settore di attività economica, la maggiore numerosità di cariche femminili si registra nel settore commercio, che rappresenta il 39,91% del totale provinciale. Forte incidenza delle imprenditrici si manifesta anche in agricoltura (21,72%). Seguono, il settore manifatturiero (9,51%), alberghi e ristoranti (8,95%), servizi (7,36%). Oltre che nella città capoluogo di provincia, in cui si registra la presenza di 726 unità, pari al 23,97% del totale, i Comuni in cui si concentrano le imprese al femminile Imprese femminili nelle province della Calabria: tassi di crescita giugno 2003-giugno 2006 var. % 2003-04 var. % 2004-05 var. % 2005-06 CATANZARO 4,1% 3,1% 3,7% COSENZA 3,3% 4,5% -4,1% CROTONE 5,1% 2,1% 4,1% REGGIO DI CALABRIA 5,0% 3,0% 1,5% VIBO VALENTIA 3,4% 2,1% 4,3% TOTALE 4,1% 3,4% 0,3% sono Tropea con 185 imprese (6,11%), Pizzo con 172 imprese (5,68%), Nicotera con 154 imprese (5,08%), Ricadi con 124 imprese (4,09%) e Serra San Bruno con 112 imprese (3,70%). Il presente Rapporto si è proposto, dunque, di presentare un quadro aggiornato dell’imprenditorialità femminile della provincia di Vibo Valentia al fine di monitorare e mappare la componente imprenditoriale femminile locale attraverso la quantificazione delle imprese ad essa appartenenti, l’analisi delle loro caratteristiche e dei trend in atto, e fornire un contributo conoscitivo funzionale alla progettazione ed alla realizzazione di politiche e di linee di attività, a supporto della competitività delle imprese femminili vibonesi. È una prima lettura di dati a cui dovranno seguire azioni specifiche - di sensibilizzazione e di informazione, di formazione e di affiancamento - mirate al rafforzamento ed alla valorizzazione delle skills manageriali già esistenti, da una parte, e alla riduzione delle criticità che ancora inficiano le performance aziendali delle imprese femminili, dall’altra. gennaio / febbraio 2007 33 Imprese femminili attive per provincia Classifica per variazione percentuale giugno 2006/giugno 2005 gennaio / febbraio 2007 VIBO VALENTIA CROTONE CATANZARO SASSARI MILANO PRATO NUORO ROMA BERGAMO CASERTA LECCE NAPOLI REGGIO EMILIA TERAMO VARESE SALERNO VERONA LA SPEZIA BENEVENTO COMO FROSINONE PISA MANTOVA RAGUSA ORISTANO CAGLIARI LATINA NOVARA PARMA CATANIA BRESCIA ASCOLI PICENO TARANTO MESSINA ALESSANDRIA TORINO MODENA CALTANISSETTA RIMINI LUCCA PERUGIA BARI PISTOIA PESCARA VICENZA REGGIO CALABRIA PALERMO SIRACUSA VENEZIA BELLUNO VERCELLI LECCO 30/06/2006 30/06/2005 Variazione % 06-05 3.127 3.621 7.044 10.646 68.463 6.278 6.617 57.916 16.782 21.013 15.443 58.822 9.020 8.463 13.449 25.569 18.609 4.881 10.714 8.502 12.888 8.501 7.876 7.284 3.262 15.620 13.019 6.369 8.069 21.157 22.029 9.682 11.487 11.663 11.699 46.923 13.389 5.974 7.418 8.759 16.234 30.762 6.510 7.971 15.324 12.011 19.600 7.851 16.081 3.506 3.747 4.846 2.998 3.479 6.795 10.299 66.302 6.090 6.425 56.241 16.313 20.476 15.059 57.368 8.807 8.269 13.142 24.989 18.188 4.771 10.474 8.324 12.619 8.324 7.713 7.134 3.195 15.300 12.753 6.240 7.916 20.761 21.619 9.504 11.276 11.455 11.497 46.121 13.164 5.874 7.296 8.616 15.977 30.278 6.408 7.849 15.090 11.835 19.331 7.746 15.867 3.460 3.699 4.784 4,3 4,1 3,7 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 PROVINCE PESARO E URBINO SONDRIO VITERBO LODI ANCONA GENOVA TRENTO PIACENZA CREMONA PAVIA FOGGIA CHIETI BOLOGNA L’AQUILA PADOVA MASSA CARRARA AREZZO AVELLINO TREVISO UDINE ROVIGO FIRENZE RIETI SIENA ENNA MACERATA FORLI’ - CESENA TRAPANI GROSSETO BRINDISI PORDENONE GORIZIA ASTI BOLZANO - BOZEN SAVONA CUNEO LIVORNO AOSTA MATERA AGRIGENTO IMPERIA BIELLA TRIESTE ISERNIA RAVENNA TERNI CAMPOBASSO FERRARA POTENZA VERBANO CUSIO OSSOLA COSENZA TOTALE 30/06/2006 30/06/2005 Variazione % 06-05 8.759 4.160 10.089 2.972 10.277 16.950 9.134 6.256 5.505 9.885 18.552 13.203 17.919 7.844 19.434 4.694 8.123 13.809 17.608 12.265 6.253 19.591 3.630 6.436 3.820 8.892 8.435 11.732 8.103 7.915 6.338 2.600 6.417 11.412 7.963 17.775 7.783 3.372 5.414 10.967 6.766 4.016 3.901 2.588 7.737 5.218 8.044 7.482 11.203 2.967 13.836 1.228.534 8.652 4.115 9.980 2.940 10.172 16.777 9.043 6.194 5.451 9.790 18.392 13.097 17.777 7.783 19.292 4.665 8.075 13.732 17.516 12.201 6.221 19.505 3.617 6.414 3.810 8.869 8.414 11.706 8.086 7.899 6.328 2.596 6.411 11.402 7.963 17.785 7.791 3.381 5.430 11.008 6.796 4.034 3.919 2.601 7.790 5.258 8.107 7.545 11.329 3.016 14.427 1.210.612 1,24 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -1,1 -1,6 -4,1 1,5 Imprese femminili attive per provincia Classifica per variazione percentuale giugno 2006/giugno 2005 34 PROVINCE gennaio / febbraio 2007 35 TURISMO di Anselmo Pungitore la rivoluzione dei sistemi integrati Il quadro normativo nazionale impone la valorizzazione ed il rilancio del settore attraverso un’offerta locale che integri beni culturali, ambientali ed enogastronomia per la creazione di un “marchio” univoco che la contraddistingua nel panorama nazionale ed internazionale. A prescindere dal tipo di soluzione normativa che la Regione Calabria deciderà di adottare, i Sistemi Turistici Locali rappresentano, per come già normati dalla legge nazionale di riordino del comparto turistico, l’idea centrale per rendere il turismo in tutte le sue sfumature, motore di sviluppo e prima industria per fatturato e numero di occupati del Sistema Italia. Ma non solo, intorno al concetto stesso di STL, si è costruita infatti la volontà 36 gennaio / febbraio 2007 di aggregare in maniera strutturata ed organizzata le risorse che, presenti in forma slegata nell’area, non hanno ancora provocato quel cambiamento, che è possibile definire strategico, per la creazione del “valore aggiunto” dell’offerta turistica. Nasce con questi presupposti, prima di tutto nella volontà del legislatore nazionale, una vera rivoluzione normativa tesa a colmare una pressante necessità di organizzare un settore cardine della nostra economia. L’ideazione dei Sistemi Turistici Locali vede protagonisti “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate” e rappresenta la chiave di volta per le realtà locali di divenire centri propulsivi di idee e progetti integrati di un territorio, promuovendo e valorizzando le specificità dell’offerta turistica. In questo contesto diviene evidente il ruolo, che in un territorio ricco di risorse non solo naturali, come quello vibonese, deve giocare la creazione di una catena del valore, ovvero di una rete delle risorse, fortemente coesa ed interdipendente. Al disegno strategico regionale e talvolta ultraregionale si sostituiscono dunque le volontà e gli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriali e la connessa possibilità di dotare un’area di una chiara identità, di un “marchio” che la possa collocare con successo nel panorama dei differenti e molteplici turismi. Ideare un marchio e perseguire le azioni tese al suo irrobustimento non è compito facile, ma rimane una delle poche vie per il rafforzamento di un’offerta turistica che ormai si trova a competere con aree altamente concorrenziali sul fronte dei costi e dei servizi dislocate in ogni area del mondo. Trasporti, filiera agroalimentare, tradizioni arte e cultura, artigianato sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il mix delle risorse da mettere in rete al pari della qualificazione delle strutture ricettive, della cultura dell’accoglienza, della qualità dell’ospitalità, della conservazione e del risanamento dei fattori ambientali, dell’effettiva fruizione dei beni archeologici ed artistici. Pubblico e privato in questo panorama si intersecano e si fondono producendo eccellenze, gli interessi diffusi e generali condivisi trovano riposte e divengono fattore di sviluppo endogeno. Così come le risorse economiche investite dagli operatori e attratte dall’area dispiegano un effetto moltiplicatore delle provvidenze nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo locale, creando una espansione economica A sinistra, uno scorcio di Capo Vaticano, una delle località più suggestive della costa vibonese. autopropulsiva. Una crescita territoriale capace di innescare fenomeni virtuosi di cogenerazione di iniziative che possono rendere, a loro volta, complessivamente più attrattivo ed appetibile il territorio. È sufficiente qualche valutazione di carattere generale per supportare quanto appena espresso. Finanza di progetto (project financing) e riqualificazione urbana costituiscono un esempio tangibile delle possibilità che vengono date ai soggetti pubblici e privati di costruire, nell’ambito di un sistema integrato, opportunità di crescita diffusa e duratura. Migliorare il rating dell’area diviene precondizione prioritaria ed essenziale per potenziare l’attrattività del territorio. Un miglioramento congiunto di numerose variabili che potremo riassumere sinteticamente con l’incremento dell’indice della qualità della vita. Lavorare alacremente ed in maniera determinata sul riposizionamento complessivo dell’indice della qualità della vita è la scommessa che il futuro o futuri STL dell’area vibonese dovranno saper cogliere. Ed è su questi temi che si gioca la partita più importante per la nostra area, migliore qualità della vita significa bloccare la fuga dei cervelli, instaurare un clima favorevole per l’insediamento di nuove attività economiche e restituire fiducia a quelle che già vi operano, produrre collaborazioni positive che adottino regole certe ed una carta di “valori” condivisi generata attorno al concetto stesso di appartenenza. Un master plan, una prova di concertazione che assume particolare significato alla luce della prossima programmazione comunitaria che mette a confronto due modi di progettare e programmare lo sviluppo, quello tradizionale, inefficace ed oramai obsoleto ed uno innovativo, permeato di saperi differenti e complementari, di interazione tra filiere turistiche integrate, di nuovi e più forti sistemi di relazioni che possono portare anche alla costituzione, se necessaria, di un’agenzia di sviluppo turistico intesa come officina di idee, di prodotti e di servizi. In definitiva, l’efficacia ed il successo dei Sistemi Turistici Locali oscilla fortemente tra la possibilità di essere anello debole della catena del valore che cede alla prova della programmazione collegiale o, come è certamente auspicabile, anello forte capace di creare il senso di appartenenza e di identità di un territorio e di un “sistema cha fa sistema” coinvolgendo le migliori risorse. gennaio / febbraio 2007 37 di Antonello Meddis COOPERAZIONE rapporto sul trend vibonese Confcooperative ha promosso due pubblicazioni che fotografano criticità ed eccellenze del settore locale al fine di calibrare gli interventi ottimali per lo sviluppo e la crescita di questo comparto. C onoscere il settore per calibrare gli interventi: è questa la filosofia alla base dell’azione che ha condotto alla realizzazione di due pubblicazioni che fotografano il trend del settore della cooperazione in provincia di Vibo Valentia, in riferimento al periodo 2002-2004 e all’implementazione relativa all’anno 2005. Questi due rapporti già realizzati e un terzo di prossima edizione, costituiscono un buon motivo di orgoglio per la Confcooperative di Vibo Valentia e per i partner (Camera di Commercio, Midia Scrl ed Elabora Calabria) che hanno voluto sostenere e contribuire a questa ricerca. I risultati prodotti rappresentano il frutto del lavoro comune portato avanti nel corso di questi anni e stanno a dimostrare come la collaborazione consenta di ottenere proficue sinergie, ancora da esprimere con pienezza nel nostro territorio. La costruzione del trend cooperativo è scaturita dall’osservazione delle unità operative nel settore che hanno depositato il bilancio di esercizio in tutti gli anni della serie storica analizzata (specificamente 2001-2004). Il fine è quello di valutare lo “stato di salute” e le potenzialità di sviluppo della realtà imprenditoriale “cadetta”. La raccolta e la successiva elaborazione dei dati inerenti le diverse società cooperative operanti nella provincia di Vibo Valentia ha consentito di esaminare il trend evo- 38 gennaio / febbraio 2007 lutivo del campione osservato, di individuarne i tratti distintivi cogliendone le trasformazioni e le tendenze in atto, nonché di osservare lo “stato di salute” di ciascuna iniziativa imprenditoriale, caratterizzata dall’appartenere ad un territorio in cui le fasi di sviluppo seguono alterne vicende. Il lavoro si struttura in quattro momenti fondamentali. Un primo momento è costituito da una rassegna degli elementi di carattere generale sulle società cooperative, anche in considerazione delle notevoli modifiche intervenute in materia con la riforma del diritto societario (elemento particolarmente accentuato nella prima edizione) e propone, inoltre, approfondimenti delle principali variazioni intercorse tra le due edizioni (istituzione da parte del Ministero delle Attività Produttive dell’Albo delle Cooperative). Il secondo momento è caratterizzato da un’analisi meramente quantitativa delle imprese cooperative (operanti nella provincia di Vibo Valentia) mirata all’osservazione, tra l’altro, della distribuzione per categoria. Nella seconda edizione, inoltre, è stato dato maggiore spazio all’analisi del profilo quantitativo della compagine societaria e della forza lavoro occupata. L’indagine prosegue con l’analisi, quantitativa e qualitativa, dei dati di bilancio. Nella terza parte sono stati esaminati i fat- tori quantitativi (trend assoluto, distribuzione provinciale, soci, addetti) del settore. Nell’ambito delle attività, a fronte di un deficit di elementi relativi ad alcuni degli aspetti quantitativi che si intendevano indagare - compagine sociale e forza lavoro occupata - l’analisi è suffragata da una verifica empirica sul campo che ha permesso di censire, in modo accurato e minuzioso, la distribuzione di soci e addetti per ciascuna cooperativa. Il quarto momento è relativo all’analisi dei dati di bilancio delle realtà oggetto di indagine, ossia all’analisi delle voci e all’elaborazione di indicatori di settore. L’azione è stata orientata a garantire l’uniformità della lettura tra le due edizioni; sono stati presi in considerazione gli aggregati oggetto del primo studio e arricchiti in funzione delle esigenze rilevate nell’attività di riesame delle attività realizzata tra le due pubblicazioni. Pertanto l’analisi della seconda edizione (analisi del trend 2001-2004) ha esaminato in dettaglio l’entità di 16 voci di bilancio a fronte delle 8 voci relative alla prima indagine. In merito alla rilevazione degli indicatori di settore si è proceduto all’accertamento della solidità patrimonia- La tabella riepiloga le voci delle due pubblicazioni promosse da Confcooperative I edizione Fatturato Capitale sociale Immobilizzazioni Attivo circolante Attivo di bilancio Debiti Patrimonio netto Risultato d’esercizio II Edizione Immobilizzazioni Crediti Attivo circolante Attivo di bilancio Patrimonio netto Capitale sociale Riserve Debiti Passivo di bilancio Valore della produzione Totale costi di produzione Reddito operativo Gestione finanziaria Totale valore delle rettifiche Gestione straordinaria Risultato di esercizio le attraverso il calcolo dei tassi di copertura delle immobilizzazioni con mezzi propri e di terzi e il grado di indipendenza da terzi; all’accertamento della liquidità attraverso il calcolo dell’indice di solvibilità e infine all’accertamento della redditività attraverso il calcolo del ROI e del ROE. Nella maggior parte delle osservazioni le performance si sono rivelate in contrapposizione evidenziando dinamiche eterogenee in relazione agli andamenti congiunturali dei settori di attività delle cooperative. L’analisi ha, comunque, messo in luce innumerevoli informazioni sullo stato di salute della realtà cooperativa della provincia. In particolare è stata rilevata una variabilità all’interno del campione di riferimento in relazione alla composizione annua. Nello specifico, nell’ultimo anno della serie storica considerata (2004) si assiste ad un calo del 13,21% del numero dei bilanci depositati. L’analisi di bilancio, condotta secondo un’ottica patrimoniale, finanziaria e reddituale, ha fatto emergere una situazione differenziata. Nello specifico, dal punto di vista patrimoniale gli indici hanno messo in luce una rilevante copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli e capitale proprio. Dal punto di vista finanziario emerge una sostanziale dipendenza da terzi ed un costante indice di solvibilità in linea con il valore soglia. Dal punto di vista della redditività il trend si presenta decisamente decrescente. I dati presentati nel lavoro costituiscono un’interessante chiave di lettura della realtà cooperativa interrelata con il territorio e l’economia locale. Si tratta comunque di un’analisi settoriale e territoriale che presenta i limiti insiti nella medesima sua natura: un’interpretazione intelligibile potrebbe scaturire da un confronto con il mondo “non cooperativo” vibonese e soprattutto con realtà cooperative di altre province. Un confronto del genere consentirebbe di contestualizzare e inserire gli andamenti settoriali e aggregati all’interno di un quadro macro-economico in grado di fornire maggiori spunti di riflessione. Questo studio sarà di certo un ottimo strumento di riferimento per lo svolgimento delle finalità istituzionali di Confcooperative Vibo Valentia, nonché apprezzabile punto di partenza per la realizzazione di importanti progetti di sviluppo locale che l’associazione ha in corso di attuazione. gennaio / febbraio 2007 39 d’arte e tradizione testi e foto di Francesco Gioghà La storia dell’antica fonderia Scalamandrè che per oltre due secoli ha rappresentato la massima espressione monteleonese nella realizzazione di campane destinate alla Calabria e all’Italia intera. C i sono manufatti e mestieri che, per quanto possono essere suscettibili all’evoluzione della scienza e della ricerca che la moderna terminologia post-industriale definisce “innovazione di processo e di prodotto”, non possono essere migliorati con nuovi cicli di lavorazione, in quanto strettamente connessi a tecniche antiche e insostituibili. La produzione di alcuni manufatti, infatti, non può essere minimamente pensata e sostituita con lavorazioni automatizzate in serie tipiche della produzione industriale. Alcuni manufatti, ancor oggi vengono fuori dalle mani dell’uomo, dalle mani d’eccellenti artigiani, seguendo le stesse tecniche di una volta, gelosamente tramandate di 40 gennaio / febbraio 2007 generazione in generazione. Ancor oggi tanti lavori artigianali sono capolavori artistici, unici e irripetibili, in cui difficoltà di realizzazione, lunghi tempi di lavorazione e preziosità del prodotto si “fondono” per dar vita ad un’ineguagliabile opera di gran valore, anche dal punto di vista commerciale. La linea di confine fra Artigiano e Arte diventa sottilissima, l’impronta dell’imprenditore si trasforma nel tocco sapiente dell’artista, cosicché dati statistici, esigenze di mercato, quantità prodotta e tempi di lavorazione passano in secondo piano di fronte al pregio e all’irripetibilità dell’opera. Questa sintesi d’operosità, cultura, estro creativo e conoscenza, necessita di un’ulteriore passaggio per consegnare alla storia il Mestiere e il Maestro, cioè quello che oggi definiamo “successione e trasmissione d’impresa” tramandandola di padre in figlio, affinché l’esperienza e il sapere dell’artista-artigiano non si disperda a causa di quelle che sono le vicessitudini della vita. La premessa era necessaria per onorare un importante capitolo di storia della nostra città, sconosciuto ai più, che per alcuni versi ha il valore di una scoperta. Il riferimento è all’antica Fonderia di Campane degli Scalamandrè di Monteleone di Calabria, in cui diverse generazioni di Monteleonesi si succedettero nella sua conduzione con pregevole maestria e lusinghieri risultati. In questa occasione ci cimenteremo poco nell’esaminare o illustrare tecniche e fasi di lavorazione di questa tipicissima produzione artistico-tradizionale, sebbene il trattato amanuense “Regole in pratica per fondere le Campane”, un bellissimo manuale che incorpora in sé il segreto della fusione delle campane, tramandatosi nei secoli e ricopiato per l’ultima volta nel 1901 da Raffaele Scalamandrè, di cui daremo traccia in seguito, farebbe impallidire qualsiasi disciplinare di certificazione di qualità Iso 9000 dei giorni nostri. Purtroppo l’assenza di studi dettagliati e approfonditi c’impedisce di collocare la peculiarità della fusione delle campane targata Scalamandrè nel più ampio scenario della storia e della tecnologia di questo particolare manufatto; tanto più è possibile introdurre un tentativo di confronto con una produzione di elevata specializzazione e con una tecnica posseduta da non più di una decina di fonderie in tutta la Penisola, o il rapporto di questa con altre attività metallurgiche nella cui tradizione certamente si iscrive. La ricerca è aperta e il campo di studio è ancora tutto da scoprire. Poche e frammentate le notizie di cui si dispone per ricostruire la storia di questa gloriosa fonderia: un breve capitolo (“Fonderia di Campane”) del libro di Mon. Francesco Albanese, intitolato “Vibo Valentia e la sua storia” (1962, Tipografia Carioti); alcune note su Raffaele Scalamandré (1887-1918) di Felice Muscaglione nel suo volume “Eroi, 1915-1918” (Casa Editrice Europa 3); e per ultimo uno scritto del 1908 di Federico Tarallo, dal titolo “Alcuni cenni storici sulla fonderia di Campane in Monteleone”, pubblicato in “Raccolta di Notizie e Documenti della Città di Monteleone” di Pietro Tarallo (1926, Tipografia La Badessa). Lo stesso Mons. Albanese, nella prefazione alla sua opera avverte: «Non lievi difficoltà ho incontrato nelle indagini: il succedersi d’invasioni, guerre, saccheggi e terremoti e l’incuria degli uomini hanno contribuito a disperdere tanti documenti del suo glorioso passato». Fondamentale, quindi, la testimonianza degli eredi diretti della famiglia Scalamandrè e, in particolare, degli ingegneri Antonello e Luigi Scalamandrè, che hanno messo a disposizione il materiale da loro accuratamente custodito. Si tratta di documenti originali, libri scritti a mano, stampi di vario tipo, calchi in gesso, matrici inverse, punzoni, tavole campanarie, riconoscimenti e onorificenze, che ci hanno permesso di ricostruire buona parte della storia della Fonderia di Monteleone. Proprio la detenzione di alcuni di questi reperti testimonia una continuità familiare che permette di affermare con quasi assoluta certezza e precisione che l’origine della Fonderia di Monteleone va fatta risalire al 1671, tempo in cui un certo Gerardo Olita da Vignola, fonditore di campane girovago, si fermò a Monteleone per assolvere le commesse che gli erano pervenute dai paesi e dalle province vicine. Qui, un suo figlio s’imparentò con la famiglia Bruno e di seguito un Gerardo Bruno e i suoi due figli Nicola e Gennaro tennero su la fonderia fino al 1815, data in cui pervenne in potere agli Scalamandrè. Raffaele Scalamandrè mantenne la fonderia per quasi sessanta anni passandola al figlio Fedele Nicola che, sempre secondo il Tarallo, fu il perfezionatore dell’arte di fondere le campane, tra i migliori delle province meridionali per il decoro a cesello e per la perfetta sonorità che riuscì ad imprimergli. Si stima che il numero delle sue fusioni supera le quattrocento di cui parecchie eccedenti il peso di 10, 19, 20 e 37 quintali e diffuse in tutta la regione, tra cui quelle eseguite per Maida, per il Duomo di San Leoluca, per la Cattedrale di Mileto, per Palmi, per Cosenza e altri siti. Nel 1902 inviò all’Esposizione Internazionale Campionaria di Marsiglia e all’Esposizione Campionaria di Roma una campana di 5 quintali che conseguì in entrambe le manifestazioni il “Gran Premio con Diploma d’Onore e Medaglia d’Oro” per la specialità campane in bronzo. Nicola Fedele Scalamandrè nella rappresentanza della Fonderia, al proprio nome aggiungeva quello dell’unico suo figlio Raffaele, anch’esso fonditore e dedito all’arte della plastica dei modelli, che si avvicendò nella conduzione della Fonderia dopo la morte del padre che avvenne nel principio del 1909. Il giovane Raffaele aveva gia dato prova di una promettente e splendida riuscita nell’arte paterna, in quanto terminati gli studi ginnasiali scelse di lavorare nella Fonderia di Monteleone che condusse fino al 1915, quando, scoppiata la Prima Guerra Mondiale, venne chiamato alla Fabbrica d’Armi di Terni per fondere i cannoni utilizzati nel conflitto. L’industria dell’artiglieria pesante, infatti, approfittò della tradizione e dell’esperienza dei fonditori campanari costringendoli a produrre cannoni, e il valore del bronzo diede origine al cosiddetto “diritto alle campane”: gli artiglieri e le loro compagnie ebbero le miglio- ri campane del paese conquistato e molte di queste, in occasione di guerre furono trasformate in pezzi di artiglieria; così come, all’opposto, alla fine della guerra il bronzo dei cannoni era rifuso per costruire campane. Le circostanze vollero che proprio questo fatto avrebbe condizionato la vita del giovane Raffaele Scalamandrè e la continuità della stessa Fonderia di Monteleone. A Terni, infatti, Scalamandrè si ammalò gravemente, contraendo l’influenza aviaria, la cosiddetta “Spagnola” che in quegli anni seminò morte in tutta Europa con milioni di vittime. Ritornato a casa, morì il 27 novembre 1918 all’età di appena 37 anni. Con la sua scomparsa ebbe fine l’Antica Fonderia di Campane rinomata in Italia e all’estero, nonostante la buona volontà e il tentativo di mantenere in vita la tradizione della fusione di campane da parte del cugino Vincenzo Scalamandrè che fuse alcune campane tra le quali quella del Municipio di Vibo Valentia e di Simbario. Ciò che si diceva in premessa sull’interruzione della catena della successione d’impresa, si manifesta in tutta la sua irriverenza nel causare la fine di un’appassionante esperienza che non poté avere continuità probabilmente per il sol fatto che alla morte di Raffaele Scalamandrè il suo primogenito Fedele Nicola aveva solo 4 anni. Di Raffaele Scalamandrè, ultimo fonditore di campane di Monteleone, non rimangono tracce nemmeno nel cimitero di Vibo Valentia. La lapide che così recitava ”qui giace Raffaele Scalamandrè fu Nicola che seguendo le orme dell’avo e del padre fu valente meccanico e fonditore di lavori in bronzo e che giovine ancora per morbo gennaio / febbraio 2007 43 stato in vita. Del primo Raffaele Scalamandrè fonditore troneggia sul campanile del Duomo di San Leoluca la grande campana fusa nel 1832, ricca d’incisioni, d’immagini di santi, di frasi celebrative con i nomi dei benefattori, dei parrocchiani, delle autorità religiose e politiche del tempo; e di converso si nota in maniera evidente lo sfregio che l’incuria del tempo e degli uomini nonché l’improprio uso di un battaglio esterno sta danneggiando irreparabilmente. 44 gennaio / febbraio 2007 - pag. 40, Antonello Scalamandrè vicino alla campana del Duomo di San Leoluca, Vibo Valentia. - pag. 41, antiche matrici per la realizzazione di fregi ornamentali che impreziosivano le campane. - pag. 42, antichi manuali per la realizzazione delle fusioni di bronzo. - pag. 43, la matrice della Fonderia Scalamandrè usata per firmare le opere realizzate. - a sinistra, contratti e documenti relativi alle commesse della Fonderia Scalamandrè. - in basso, le tavole tratte dai manuali rappresentati a pag. 48. - a destra, Raffaele Scalamandrè (1887-1918) e la medaglia d’oro di Marsiglia, prestigiosa onoreficenza che venne assegnata sua fonderia. L’aneddoto storico contratto servendo la patria in guerra perì fra l’atroce spasimo dei suoi cari le invocazioni di cinque tenere creature e l’unanime rimpianto della cittadinanza”, in ossequio al volere del figlio Nicola Fedele, morto nel 2006, fu divelta e i resti di Raffaele furono ricongiunti nella stessa bara per averlo in morte più vicino di quanto non lo fosse Federico Tarallo, nel suo volume “Scritti Vari” racconta: «Pervenuto il 1815, un caso inatteso indusse quest’ultimo Bruno (Gennaro) a smettere dalle assidue sue occupazioni. Il Bruno, teneva presso di sè da più tempo l’adolescente Raffaele Scalamandrè, figlio di una sua congiunta, per servirsi di lui nella formazione delle sagome bisognevoli alla costruzione dei modelli, essendo Raffaele avviato al mestiere del falegname. Or avvenne che dovendosi fondere una campana le cui dimensioni, superiori a quante altre mai finallora al Bruno erano state commesse, esigevano proporzioni diverse sì nelle curve, come nelle falde e nella corona. A ciò fare con tutta lena vi si accinse il nostro fonditore; ma per quanta attenzione ei vi avesse posta i risultati che ne otteneva erano ben lungi dal soddisfarlo. Ripetuto più volte un tal lavoro non ne veniva a capo, finché, infastidito d’una simile disdetta, divisò differirlo ad altro, e così fece. Lasciato in custodia l’opificio al nipote, si recò ad una sua tenuta di campagna per darsi svago, e ricorrendo in quel tempo la vendemmia, vi si trattenne finché questa non fu terminata. Sbollitogli frattanto il malumore in cui messo l’aveva la cattiva riuscita del suo modello, ritornato in città, sua prima cura fu quella di recarsi all’opificio per riprendere l’abbandonato lavoro; ma entratovi appena, qual fu la sua meraviglia nello scorgere sul gran tornio ove si girano i modelli, quello da lui tanto desiderato ed invano più volte rifatto? Il piccolo falegname, nei giorni di assenza del Bruno si era dato ad eseguire il modello e con tanta perfezione il condusse a termine, simmetria ed eleganza di parti, che quello, ammirato del nobile ardire del giovinetto, dopo averlo più volte abbracciato, gli chiese se, come pel modello gli dava l’animo di fonder la campana; ed avutane risposta affermativa, passò ad interrogarlo, ricevendone soddisfacente risposta. Lieto in cuor suo di aver senz’avvederselo trovato nell’adolescente Raffaele colui che a non lunga scadenza lo avrebbe surrogato, il Bruno tenne la sua promessa e fecegli fondere la campana, contentandosi di sorvegliarne la esecuzione, il cui esito tanto lo appagò che da quel giorno non fuvvi opera a lui commessa ch’egli non avesse interamente al nipote affidato, il quale, istradandosi sempreppiù in poco tempo sorpassò lo zio, siccome lo dimostrano le tante sue opere fino a tarda età eseguite, parti delle quali, e forse le ultime, sono a noi note, essendo Raffaele morto nel 1875 in età d’ottantasei anni…». Provincia di Vibo Valentia La Provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con la Camera di Commercio, promuove l’insediamento nella città capoluogo dell’Icif, la prestigiosa scuola di cucina italiana per cuochi stranieri fondata da Jhon Arena, uno dei maggiori ristoratori canadesi di origine calabrese. V ibo Valentia potrebbe presto ospitare la sede meridionale del prestigioso “Italian Culinary Institute for Foreigners” (Icif), la Scuola di cucina italiana per stranieri nata nel 1991 con lo scopo di tutelare e promuovere nel mondo l’enogastronomia del Bel Paese, formando gli chef ed i sommelier che operano all’estero. È questo l’ambizioso progetto a cui sta lavorando l’Amministrazione provinciale, in collaborazione con la Camera di Commercio, con l’obiettivo dichiarato di fare della città capoluogo un punto di riferimento internazionale nell’alta formazione culinaria. Padre tutelare dell’iniziativa è uno dei più famosi chef internazionali di origini calabresi, John Arena. Emigrato in Canada nel 1939, all’età di 15 anni, Arena gestisce oggi nove dei migliori ristoranti di Toronto ed ha alle spalle una lunga carriera durante la quale ha accumulato una serie incredibile di riconoscimenti e premi internazionali. I suoi piatti, tutti rigorosamente ispirati alla cucina mediterranea, hanno fatto storia nel continente americano, fino a renderlo notissimo nel jet set internazionale. Basti pensare che persino personaggi del calibro di Bob Kennedy e della Regina d’Inghilterra hanno avuto modo di gustare e apprezzare la cucina italiana proposta da Mr. Arena. Nel 1991 ha fondato, in Piemonte, l’Italian Culinary Institute for Foreigners, di cui oggi è presidente onorario, con l’obiettivo di formare nel nostro Paese chef e ristoratori stranieri interessati alla tradizione enogastronomica italiana. Una scelta vincente che, in pochi anni, ha fatto dell’Icif un punto di riferimento mondiale in questo settore di alta formazione professionale. Oggi, sedi dell’Icif sono presenti in 29 Paesi, divisi tra Europa, Asia, Oceania e Continente americano. Nel 2004, è stata inaugurata, ultima in ordine di tempo, la sede di Shanghai, in Cina, dove è stato realizzato il primo ed unico Centro di cucina, cultura ed enologia delle Regioni d’Italia, sostenuto dal Governo cinese e dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero (Ice). In questo prestigioso contesto si inserisce il progetto di realizzare a Vibo Valentia la seconda sede italiana dell’Icif (quella principale è in provincia di Asti). Secondo le intenzioni della Provincia, la nuova Scuola di formazione sarà ubicata all’interno di Palazzo Romei, monumentale edificio acquistato dall’Ente nel 2005. L’immobile, che rappresenta uno dei palazzi storici più suggestivi del capoluogo vibonese, necessità però di importanti interventi di restauro e ammodernamento. Ecco perché, nelle intenzioni dei promotori dell’iniziativa la nascita del nuovo istituto comporterà il contestuale e completo recupero di Palazzo Romei, che sarà così pienamente restituito alla città nel suo rinnovato splendore architettonico. «Il valore aggiunto di questo progetto sta proprio nel volontà di riportare agli antichi splendori architettonici un edificio storico, per farne la sede meridionale dell’Icif - sottolinea il presidente della Provincia Gaetano Ottavio Bruni -. Raramente, infatti, si ha la possibilità di mettere in cantiere iniziative di questo spessore, capaci di esprimere effetti benefici A sinistra, lezione sulla pasta italiana in un’aula dell’Icif, nella sede centrale in Piemonte (foto Luigi Bertello). A destra, l’entrada di Palazzo Romei a Vibo Valentia. gennaio / febbraio 2007 47 Provincia di Vibo Valentia La conferenza stampa di presentazione del progetto Icif. Da sinistra, Michele Lico, Paolo Barbieri, Jhon Arena e Gaetano Ottavio Bruni non soltanto sull’economia locale, ma anche sulla riqualificazione urbanistica del territorio. Senza contare le ricadute occupazionali e quelle legate alla crescita del comparto turistico vibonese, che chiede continuamente saldi punti di riferimento formativi per i propri addetti». Una strategia ribadita dall’assessore provinciale ai Lavori pubblici, Paolo Barbieri: «Da quando abbiamo acquistato Palazzo Romei c’è sempre stata l’intenzione di farne la sede dell’Icif. Adesso è arrivato il momento di lavorare per concretizzare questo progetto, che intendiamo realizzare facendo inserire nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 un articolato piano di recupero e restauro dell’immobile. Ma non vogliamo muoverci da soli, perché riteniamo che in iniziative di questo tenore vadano coinvolte anche le forze produttive e imprenditoriali, affinché ne condividano le finalità e contribuiscano attivamente al risultato finale». In occasione della presentazione alla stampa del progetto, Mr. Arena ha sottolineato i motivi che hanno spinto l’Icif a scegliere Vibo Valentia «che può vantare una posizione 48 gennaio / febbraio 2007 strategica e un patrimonio paesaggistico senza uguali». «Non di meno – ha continuato - il forte legame con questa Amministrazione provinciale e con il presidente Bruni, in particolare, ci hanno convinto a puntare sul Vibonese». Parole di grande apprezzamento per la storia umana e professionale di Arena sono venute anche da Michele Lico, che ha espresso la piena condivisione del progetto da parte della Camera di Commercio: «Una volta realizzata, attraverso questa scuola sarà possibile promuovere con maggiore incisività i prodotti tipici della tradizione locale, utilizzando questo canale anche per incrementare le esportazioni». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere provinciale Saverio Mancini, tra i maggiori imprenditori turistici del Vibonese, che ha partecipato anch’egli all’incontro con i giornalisti e con Mr Arena. In particolare, Mancini ha sottolineato come «la formazione professionale possa diventare anche uno straordinario volano per l’export e la valorizzazione dell’enogastronomia calabrese». Studenti dell’Icif a fine corso Italian Culinary Institute for Foreigners L’Icif è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1991 per tutelare e qualificare l’immagine della cucina e dei prodotti italiani presso i professionisti che operano nella ristorazione all’estero. Da allora organizza Master, Corsi Brevi (generici e tematici) e Corsi di Aggiornamento per gruppi di professionisti stranieri (chef, sommelier, ristoratori), che intendano acquisire una specializzazione italiana. In questi anni ha diplomato studenti provenienti da Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Corea, Filippine, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Israele, Libano, Messico, Perù, Russia, Stati Uniti, Singapore, Svezia, Tailandia, Taiwan, Venezuela, oltre ovviamente dall’Italia. Nel 1997 l’Icif ha inaugurato la sua nuova prestigiosa sede all’interno del medievale Castello di Costigliole d’Asti, stato restaurato in funzione dell’Istituto e delle sue attività di formazione, realizzando una struttura didattica in grado di permettere lo sviluppo di un programma di insegnamento a livello di Università di Cucina. Accanto alle aule attrezzate con i più sofisticati impianti per una moderna attività didattica sono state allestite un’enoteca ed un’elaioteca. Il corpo docente è formato da professionisti altamente qualificati, docenti di istituti alberghieri, giornalisti, tecnici ed esperti, chef e sommelier di fama internazionale. Per una maggiore conoscenza dei prodotti le lezioni sono affiancate da visite guidate ad aree produttive di particolare interesse e ad importanti aziende agroalimentari. Nel 2004 l’Icif ha compiuto un ulteriore passo ed ha ampliato le proprie attività all’estero, con l’apertura di due nuove sedi in Brasile ed in Cina, dove nel 2005 sono iniziati i primi corsi. La prima nel sud del Brasile, nella Regione di Rio Grande do Sul, a Flores da Cunha, la seconda a Shanghai, presso il campus universitario Shanghai Lingang Science and Technology School. gennaio / febbraio 2007 49 Una rete provinciale per gli sportelli UNICI Vibo Sviluppo S.p.A. è impegnata nella realizzazione di un network provinciale che consenta il coordinamento degli strumenti comunali deputati a facilitare e snellire i rapporti tra Pubblica amministrazione e imprese. A vviare un’impresa in Italia? Fino a ieri servivano mesi, da domani, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 gennaio 2007, dovrà essere realizzabile in un solo giorno. Fare impresa sarà, quindi, più facile dopo l’approvazione del “Pacchetto Bersani” che, focalizzando l’attenzione su svariati settori dell’economia, ha recepito il Disegno di legge Capezzone (Presidente della Commissione Attività produttive della Camera), attualmente all’esame in del Parlamento. Si tratta di un lungo elenco di novità che riguarda varie misure. Tre in particolare le misure di “liberalizzazione” relative alla semplificazione nei rapporti tra imprese e P.A., pensate dal ministro per le Riforme e l’innovazione della Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais ed ora contenute nel Disegno di legge: è previsto innanzitutto un rafforzamento dello Sportello unico per le Attività Produttive nel quale confluiranno tutte le pratiche degli imprenditori e delle amministrazioni pubbliche che diventa quindi lo snodo strategico dell’operazione. Detto Sportello Unico per le Attività Produttive è stato previsto dal D.Lgs n. 112 del 1998, il quale, in ottemperanza alle disposizioni della Legge-delega n. 59/1997 (cosiddetta “legge Bassanini”), ha operato il conferimento, alle Regioni ed agli Enti Locali, della maggior parte delle funzioni e dei compiti amministrativi spettanti allo Stato. Più specificatamente il D Lgs richiamato ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative alla 50 gennaio / febbraio 2007 realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. I Comuni devono, ai sensi del presente decreto, esercitare tali funzioni realizzando un’unica struttura responsabile dell’intero procedimento (Sportello Unico per le attività produttive). Tutto ciò al fine di garantire agli interessati l’accesso, anche in via telematica, a tutte le informazioni concernenti le domande d’autorizzazione ed il relativo iter procedurale, ed ancora lo svolgimento degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le notizie relative alla disponibilità di aree per i nuovi insediamenti, alla fruibilità o meno d’eventuali agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali e d’ambito locale. Tale servizio di Sportello Unico è previsto nell’ambito delle politiche di sviluppo delle attività produttive di beni e servizi ed ha lo scopo di dare certezza agli imprenditori sui tempi e sulle modalità di realizzazione delle strutture produttive e di concentrare su un unico soggetto le competenze di natura amministrativa, fino ad ora svolte da diversi Enti. Lo Sportello Unico opererà garantendo: • l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi; • la nomina di un Responsabile della Struttura unica, dello Sportello Unico e del procedimento unico; • l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un insie- me di archivi informatici e di servizi di informazione; • il rispetto e, ove possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti all'uso d'impresa. Lo Sportello Unico rappresenta un’importante occasione per orientare il modo di lavorare della Pubblica Amministrazione, dall’applicazione delle norme in quanto tali ad un loro utilizzo finalizzato al raggiungimento di risultati rilevanti per l’intera comunità, quali quello dello sviluppo economico ed occupazionale. Il consolidamento del ruolo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive sul territorio nazionale ha avuto una crescita disomogenea e con risultati differenti per efficacia ed efficienza: uno sviluppo “a macchia di leopardo” che ha visto nascere anche casi di eccellenza sul territorio. L’esperienza di questi anni ha evidenziato che solo le reti Suap consentono in questo panorama variegato di “fare massa critica” nel complesso percorso di sburocratizzazione del sistema amministrativo che vincola le imprese, coinvolgendo gli enti terzi in un cammino di emulazione virtuosa. Per questo le reti fra Suap restano l’unica strada percorribile per garantire il consolidamento diffuso della semplificazione a favore delle imprese. Il livello amministrativo comunale rappresenta il primo stadio del processo di semplificazione, ma mostra tutta la sua fragilità appena i nodi normativi da sciogliere richiedono decisioni a livelli superiori di programmazione e di reingegnerizzazione legislativa. Nella provincia di Vibo Valentia, sulla base del DPR n. 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, che ha disciplinato il procedimento unico e la struttura competente per la sua gestione, la Prefettura di Vibo Valentia, l’Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio, l’Assindustria e la Vibo Sviluppo SpA, nel 2003, hanno ritenuto importante fornire ai Comuni interessati il supporto di una struttura chiamata Sportello Unico d’Area, con il compito di coordinare il rapporto tra i loro Sportelli Unici e quelli comunali, e tutti gli Enti autorizzatori che intervengono nel procedimento, individuando nella Vibo Sviluppo Spa l’Ente cui affidare detto ruolo di coordinamento. L’ottimizzazione dei risultati avverrà introducendo modalità innovative nella gestione dei procedimenti, attraverso la loro completa automazione permettendo così alle imprese di avere una interfaccia unica e semplificata verso la P.A.. Tali modalità determineranno la predisposizione del “back office” che rappresenterà un punto fondamentale per la corretta organizzazione dello sportello unico nel rispetto dei termini indicati dal DPR n. 447/1998 per come modificato dal DPR 440/2000. La determinazione di dette modalità è oggetto dell’attività della Vibo Sviluppo SpA che ha proceduto alla predisposizione di un progetto, con la partnership del Formez e di Met Sviluppo Srl in concorso con i Comuni interessati e gli Enti autorizzatori, il quale prevede la costituzione dello Sportello Unico d’Area con funzioni di “servizio” nei confronti degli Sportelli Unici comunali, i quali manterranno la caratteristica, in ossequio alle citate disposizioni di legge, del “front-office” cioè di interfaccia con le imprese e con l’utenza in generale. Ciascuno degli Enti promotori, per quanto di propria competenza, ha assunto impegni precisi. L’Ufficio Territoriale del Governo, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di essere il promotore dell’integrazione dell’attività delle diverse amministrazioni, con particolare riferimento alle Amministrazioni periferiche dello Stato, si è impegnato a proseguire nell’attività fin qui svolta di stimolo alla collaborazione tra gli Enti locali e le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte, ai fini dell’attivazione degli Sportelli Unici. Tale ruolo è stato ulteriormente ribadito in sede di Conferenza Unificata, nell’ambito della quale si è espressamente richiamato l’invito, formulato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 59 del 22 maggio 1999, e rivolto alle Prefetture stesse, ad assumere ogni iniziativa idonea a gennaio / febbraio 2007 51 stimolare la collaborazione tra Enti locali ed altre amministrazioni coinvolte, ai fini dell’istituzione e dell’effettiva operatività degli Sportelli Unici. L’Amministrazione Provinciale si è impegnata nell’attività di promozione, di coordinamento e di sensibilizzazione presso i Comuni della provincia per la costituzione dello Sportello Unico d’Area attivando tutti gli strumenti ed i mezzi, anche finanziari, previsti dalla normativa vigente. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura si è impegnata a mettere a disposizione i servizi informativi di tipo normativo, economico e statistico, l’attività di promozione e di marketing territoriale e la fruizione della piattaforma telematica “SisterVibo” comprendente anche l’applicativo per gli Sportelli Unici. L’Assindustria si è impegnata a fornire informazioni consulenza ed assistenza in materia di localizzazione, delocalizzazione e insediamento di nuove attività pro- 52 gennaio / febbraio 2007 duttive; promozione e sviluppo di sistemi industriali; riposizionamento strategico del territorio; raccolta e gestione dei dati relativi alle aree, alle filiere ed ai distretti industriali; analisi congiunturali, strutturali e di competitività del territorio. Vibo Sviluppo SpA, invese, si è impegnata a predisporre il progetto di costituzione e messa in rete degli Sportelli Unici ed a coordinare e gestire le attività dello Sportello Unico in regime di “service” con gli Sportelli Unici singoli dei Comuni. Il progetto elaborato dalla Vibo Sviluppo prevede la costituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive in ogni Comune della provincia, a regime collegati in rete con il coordinamento provinciale Suapa creato presso la Vibo Sviluppo SpA. I pilastri del progetto di coordinamento provinciale Suapa sono: • Semplificazione amministrativa ed omogeneizzazio- ne procedure; • Sviluppo del sistema informativo; • Attività Formative e di supporto ai Suap Comunali. I principali compiti del coordinamento provinciale Suapa sono: • Favorire l’istituzione ed il sostegno alla crescita dei Suap comunali; • Creazione e consolidamento di una rete tra i Suap; • Coordinare le azioni dei Suap presenti sul territorio provinciale: • Ruolo forte di coordinamento dei Suap quale punto di riferimento per assistenza ai Comuni su materie specialistiche; • Nuova metodologia di lavoro basata sulla discussione ed analisi delle problematiche in seno al Tavolo di coordinamento il quale predisporrà dei documenti di sintesi che saranno diffusi a tutti i Suap comunali. Le attività del coordinamento provinciale sono dirette alla: • gestione informatica delle informazioni e dei procedimenti; • razionalizzazione e semplificazione amministrativa dei singoli procedimenti; • promozione delle opportunità economiche offerte dal territorio. Sono previste le seguenti aree di intervento: Informatica - è stata realizzata una piattaforma informatica destinata alla gestione dello Sportello Unico, la quale, oltre a mettere in rete i Comuni della provincia, attraverso una facile utilizzazione risponde alle esigenze di legge in materia di informazione sugli adempimenti necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni amministrative e di controllo delle singole pratiche da parte sia degli operatori che degli utenti; Amministrativa - prevede la creazione di un centro di coordinamento e controllo presso la Vibo Sviluppo Spa capace di coordinare ed ottimizzare le funzioni dei diversi Enti coinvolti nell’iter autorizzatorio con il metodo del “procedimento unico” cioè “unica domanda – unica risposta”; Promozione - prevede la capacità di promuovere le aree disponibili attraverso una politica di marketing territoriale che evidenzi le opportunità offerte anche dalle leggi di incentivazione a favore delle imprese. Questo progetto diventerà operativo con la presentazione ufficiale, che avverrà presumibilmente nel mese di febbraio, in cui verranno esposti sia il software applicativo che lo schema di articolazione dei rapporti tra Coordinamento provinciale, Suap comunali, Enti terzi ed Imprese. Il software, accessibile tramite rete internet, prevede la possibilità per gli utenti di accedere a diverse informazioni relative ai procedimenti autorizzativi, alla modulistica, alle agevolazioni, ai referenti per i singoli uffici della P.A. coinvolti, per aprire/modificare un’attività produttiva. Inoltre, detto software dà la possibilità alle imprese che attivano una procedura autorizzativa di verificare in tempo reale lo stato della propria pratica con il semplice accesso diretto dal proprio computer, senza doversi recare ai vari uffici coinvolti dal procedimento autorizzativo. Come è facilmente intuibile il progetto della Vibo Sviluppo sarà in progress, nel senso che il livello di informatizzazione della P.A. in tema di procedimento unico, avverrà per stati di avanzamento. L’obiettivo, ambizioso e pionieristico, è quello di portare in tre anni all’informatizzazione completa del procedimento autorizzativo, escludendo la forma cartacea sostituita a favore di progetti digitali. La complessità dell’intera operazione è rappresentata dallo stato attuale del livello di informatizzazione della P.A. sia in termini strutturali (dotazione informatica, disponibilità di linea ADSL …) che di risorse umane (conoscenza da parte degli operatori dei principali software applicativi) sia dalla vastità del territorio in termini di numero di Comuni che dovranno essere coinvolti. Da questo primo step di attività si passerà alla strutturazione sul territorio di questi modelli operativi attraverso le convenzioni tra il Coordinamento provinciale, i singoli Comuni e gli Enti autorizzatori, con una operazione graduale che partirà dal Comune capoluogo per estendersi a tutto il territorio provinciale. gennaio / febbraio 2007 53 di Giacinto Namia Michele MORELLI La vita di uno dei personaggi più evocativi della storia italiana, “primo martire del Risorgimento”. «E un eroe vibonese ra Morelli di giusta statura, bruno di volto, avea occhi e capelli nerissimi, estrema magrezza, muscoli d’acciaio: univa al rapido volo del pensiero i più rapidi movimenti della persona, mostrando in ogni atto, in ogni gesto, tutta la vivace petulanza della nobil razza calabrese. Ignaro di scienze e lettere, il bollente suo ingegno abbandonavasi agl’impeti d’indomita natura; ardito sino alla temerità, sprezzava i pericoli e si compiaceva di essi; generoso, umano, leale, vivea onorato fra uguali, carissimo ai subordinati». Così scriveva nel 1851 uno storico dei “Martiri della Libertà Italiana” disegnando un ritratto di Michele Morelli simpatetico e insieme ammirato. Lo storico, Giovanni La Cecilia, aveva conosciuto il Morelli e ne aveva condiviso certamente il progetto ideale e politico; il ritratto che ne dà trova conferma, per tacere di quanto si legge in testimonianze di amici e compagni di lotta politica, nel Foglio di sfratto - ossia di espulsione - redatto dall’ Imperiale Regio Capitanato Circolare di Ragusa; Ragusa è la città della Dalmazia meridionale che faceva parte dell’impero austriaco, 54 gennaio / febbraio 2007 dove Morelli era fuggito nel luglio del 1821 in seguito al fallimento dei moti napoletani del 1820-21. Michele Morelli nacque a Monteleone (l’attuale Vibo Valentia) il 12 gennaio 1792 da Giuseppe Maria Morelli, dottore in utroque iure (cioè in diritto civile e in diritto ecclesiastico), e da Maria Orsola Ceniti: una famiglia, dunque, della borghesia intellettuale. Frequentò molto probabilmente il Collegio monteleonese di Santo Spirito, retto allora dai Padri Basiliani, l’antenato dell’attuale Liceo Classico. Era in atto allora nella città una vivace controversia tra sostenitori della famiglia Pignatelli alla quale era stata infeudata la città fin dai primi del ‘500, e demanisti sostenitori dell’abolizione della feudalità. La controversia, che durava da decenni, si concluse nel 1806 con la legge sull’eversione della feudalità. Monteleone contava allora circa ottomila abitanti ed era un notevole centro agricolo e commerciale. Era attiva, inoltre, una discreta intellettualità che seguiva il grande dibattito politico-culturale promosso dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese, mediato e filtrato attraverso la fervida capitale del Regno borbo- nico; significativa a tal proposito la presenza di aderenti alla Massoneria e di giacobini, che nel 1799 innalzarono nella città l’albero della libertà e tentarono di opporsi alla marcia del cardinale Ruffo verso Napoli. Monteleone, dopo il fallimento della Rivoluzione napoletana del 1799, visse da vicino l’esperienza della lotta tra i “patrioti” giacobini e i sanfedisti del cardinale Ruffo, conclusasi con l’avvento nel Regno di Napoli dei napoleonidi Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e Gioacchino Murat (1808-1815), quest’ultimo assai caro ai monteleonesi. Nel 1806 la città fu eretta a capoluogo di provincia ed ebbe come intendenti uomini di spiccata capacità politica e culturale: Francesco Saverio de Rogatis, Giuseppe de Thomasis, il grande storico Pietro Colletta e Giacinto Martucci. In questo clima di particolare fervore, maturò la decisione di Michele Morelli di abbracciare la carriera militare. Si arruolò a sedici anni a Napoli come volontario nella Compagnia dei Veliti a cavallo, detti di Clary dal nome del comandante Mario Clary; la Compagnia faceva parte dell’esercito murattiano; altri giovani calabresi, come i fratelli Florestano e Guglielmo Pepe di Squillace, che avrebbero avuto molta parte nei moti carbonari del 1820, avevano scelto anch’essi la carriera militare. Morelli conseguì il grado di brigadiere nel 1809 e di maresciallo di alloggio nel 1811. Prese parte con le truppe napoletane alla campagna di Napoleone contro la Russia nel 1812; dopo la battaglia di Konigsberg fu nominato sottotenente per meriti di guerra; partecipò successivamente alla battaglia di Osmiana in Polonia. Con la battaglia di Lipsia dell’ottobre 1813, vinta dalla coalizione antinapoleonica, il sistema napoleonico entrò in crisi. Murat tentò disperatamente, in due successive campagne del 1814 e del 1815, di conservare e ampliare il Regno di Napoli prima accordandosi con gli Austriaci e poi combattendo contro di loro. Con la fucilazione a Pizzo il 13 ottobre 1815, il sogno murattiano ebbe miseramente fine e con esso anche il sogno di tanti patrioti meridionali, e non solo meridionali, che si erano illusi che Gioacchino potesse costituire un Regno d’Italia. Michele Morelli partecipò alle campagne murattiane distinguendosi per il suo valore, tanto che un suo compagno d’armi, Domenico Badolati, scrisse: «Nell’ultima campagna contro i Tedeschi [Michele Morelli] ha dato pruove di sommo coraggio, e particolarmente nell’attacco di Prato e sotto le mura di Fiorenza, a Tolentino, a Loreto, a Reganate e da per tutto ove combatteva Morelli era vittoria». Sulla base del nuovo assetto dato all’Italia al Congresso di Vienna (1814-1815), fu restaurato sul trono del Regno di Napoli, ora denominato Regno delle Due Sicilie, il re borbone Ferdinando IV col nome di Ferdinando I. Continuò tuttavia la permanenza di Morelli nella vita militare, ma non ne conosciamo le motivazioni; in ogni caso, negli anni 1816-1818, dopo la fine dell’avventura murattiana, egli approfondì i legami con le società segrete. Abbiamo già accennato alla vivace presenza a Monteleone della Massoneria negli ultimi anni del ‘700; da qualche anno aveva cominciato a diffondersi in tutto il Regno di Napoli e anche in Calabria la Carboneria, e le due Società spesso condividevano gli adepti. Particolarmente attiva era la Massoneria nell’aristocrazia e negli alti gradi dell’esercito, mentre la Carboneria trovava i suoi affiliati soprattutto nella borghesia e negli strati popolari. Inoltre la prima si fondava su una più vasta e solida base filosofica, la seconda mostrava una più specifica e pratica intenzionalità politica. All’interno della Carboneria, poi, era possibile distinguere un’ala più radicale che mirava all’abbattimento della tirannia politica e del trono del re-tiranno; e un ala moderata che perseguiva il rinnovamento delle istituzioni con l’instaurazione della monarchia costituzionale. Le due anime della Carboneria furono entrambe presenti e a volte in modo conflittuale nei moti napoletani del 1820. Nel decennio francese erano maturate, sopratutto nel campo militare idee e progetti di rinnovamento politico ai quali anche Morelli non rimase insensibile. Quando il 7 marzo del 1820 il re di Spagna Ferdinando VII fu costretto dalle truppe rivoluzionarie guidate dai due colonnelli Riego e Quiroga a concedere la Costituzione, il suo gesto ebbe ripercussioni pressoché immediate nel Regno delle Due Sicilie: la difficile congiuntura economica e le idealità perseguite nelle società segrete por- gennaio / febbraio 2007 55 tarono allo scoperto i fermenti rivoluzionari. In Campania i carbonari salernitani invitarono il calabrese (di Squillace) Guglielmo Pepe a prendere l’iniziativa della rivolta. Pepe inizialmente tergiversò, ma ruppe gli indugi quando il 1° luglio del 1820 i due sottufficiali Michele Morelli e Giuseppe Silvati, ai quali si unì un prete carbonaro, don Luigi Minichini, insorsero e marciarono con il loro squadrone di cavalleria. Un cronista dei moti, Biagio Gamboa, ci descrive così la figura di Morelli tra gli altri soldati: «Tra essi distinguevasi il giovane Morelli, calabrese di nobile spirito e di straordinario coraggio». Ma ben presto scoppiò un dissidio tra Morelli e Minichini, che rifletteva il più vasto conflitto fra le due anime della Carboneria alle quali si è accennato, nel quale l’elemento murattiano svolgeva un’utile funzione di freno rispetto alle tendenze di un giacobinismo intransigente. Morelli era decisamente orientato insieme a Pepe verso la prima prospettiva; Minichini propendeva con altrettanta decisione per la seconda. Quando il re Ferdinando, il 7 luglio del 1820, concesse furbescamente la Costituzione attraverso l’escamotage della nomina a vicario del figlio Francesco, il quale ebbe appunto l’incarico di proclamarla ufficialmente, le forze moderate della rivoluzione potevano sentirsi sostanzialmente appagate. È significativo dell’atteggiamento ideale e politico di Morelli quanto egli dichiarò nel corso della cerimonia del giuramento in seguito all’ingresso trionfale delle sue truppe ad Avellino, come riferisce lo storico Pietro Colletta: «Nella cerimonia del giuramento il Morelli dichiarò non essere sediziose le mosse, rimaner integri lo Stato, la famiglia regnante, gli ordini». Morelli partecipò alla successiva campagna di Sicilia (settembre-dicembre 1820), dove era scoppiata una rivolta a carattere accentuatamente sociale, ancora con uno squadrone di cavalleria che faceva parte del corpo di spedizione comandato dal generale Florestano Pepe, fratello di Guglielmo. La rivolta fu sedata in un primo momento dal generale con un compromesso con gli insorti; ma l’accordo non fu accolto dal governo costituzionale centrale che sostituì Pepe con Colletta. Morelli si comportò egregiamente nella campagna di Sicilia meritandosi l’elogio del generale Pepe che scrisse in un 56 gennaio / febbraio 2007 suo rapporto: «Lo squadrone comandato dal tenente Morelli ha giustificato in tutte le azioni lo spirito che lo distingue». Intanto, nel mese di ottobre, il decurionato di Monteleone si era espresso a favore del conferimento a Morelli da parte del governo centrale di un riconoscimento dei suoi meriti di combattente, e nell’adunanza parlamentare del 27 ottobre del 1820 si diede lettura di «un rapporto dell’Intendente di Catanzaro, che provoca la considerazione del Parlamento su di un atto decurionale di Monteleone, per coniarsi tre medaglie di oro ed erigersi una colonna di marmo in attestato di onore, che la Patria destina al benemerito Morelli»; il rapporto fu rimesso nelle mani della Commissione dei premi. Prendendo spunto dalla richiesta del decurionato di Monteleone, il governo insignì Morelli, al suo ritorno dalla Sicilia, della decorazione di Cavaliere dell’ordine di San Ferdinando con decreto reale del 10 novembre 1820. Intanto si andava consolidando a Napoli un Parlamento a maggioranza nettamente moderata. Ma l’evoluzione in senso costituzionale in Europa e in Italia era avversata dall’Austria che decise di intervenire. Il potente ministro austriaco Metternich si rifiutò di ricevere il nuovo ambasciatore napoletano che aveva giurato fedeltà alla Costituzione; fece ammassare truppe in Lombardia e nel Veneto e convocò un congresso a Troppau (ottobre-dicembre 1820) con l’obiettivo di ottenere il consenso delle altre potenze europee per un intervento militare a Napoli e l’abrogazione della Costituzione. Per un’attuazione pratica delle decisioni del congresso di Troppau fu convocato un apposito nuovo congresso a Lubiana, al quale fu invitato a partecipare anche Ferdinando I. Questi, ottenuta l’autorizzazione del Parlamento napoletano dopo essersi impegnato a difendere al Costituzione, si recò a Lubiana (gennaio 1821). Una volta giuntovi, con un cambiamento di fronte e uno scandaloso spergiuro, reclamò la restaurazione dei propri diritti sovrani e diede via libera all’intervento militare dell’Austria nel Regno delle Due Sicilie. Il tradinento del re portò a una forte resistenza da parte del Parlamento napoletano in difesa dell’assetto costitu- zionale del Regno e soprattutto determinò l’accentuarsi della linea dura dei carbonari nei confronti della maggioranza murattiana. I parlamentari respinsero qualsiasi proposta di ripiegare su una costituzione più moderata per un estremo tentativo di mediare nella difficile situazione, e decisero di difendere militarmente il Regno contro le truppe austriache comandate dal generale Frimont. Anche Morelli condivise questa volontà e azione di resistenza, e organizzò a Nola, nel febbraio del 1821, uno squadrone detto Squadrone sacro, cercando di coinvolgere altre forze per costituire un corpo franco. La rivolta contro il nemico ebbe luogo a Monteforte, dove Morelli si batté valorosamente. Ma ogni resistenza fu vana; le truppe austriache entrarono a Napoli il 24 marzo 1821. Poco dopo iniziò il processo di restaurazione e di repressione da parte del nuovo governo di ogni forma di libertà, e due mesi più tardi, il 15 maggio, re Ferdinando poté fare il suo rientro a Napoli accolto trionfalmente dalla folla. Particolarmente feroce fu l’opera persecutoria del principe di Canosa, ministro dell’Interno del Regno, nei confronti di quanti erano stati coinvolti nel precedente regime costituzionale. Ne seguì lo scioglimento delle varie formazioni militari e per alcuni dei capi carbonari anche l’esilio. Morelli e Silvati tentarono di raggiungere la Puglia e di imbarcarsi di là verso la penisola balcanica per trovarvi asilo. Trovarono rifugio nei pressi di Ragusa, come si è già ricordato, in territorio soggetto all’Austria; ma furono arrestati ed espulsi. Tornati in Italia sotto scorta in stato di arresto furono trasferiti prima a Foggia e poi a Napoli, dove furono essere processati da una Corte di Giustizia speciale con l’accusa di aver partecipato alla rivolta di Monteforte. Il processo durò a lungo e si concluse con la condanna a morte dei due ufficiali: del processo sono stati recuperati gli atti, e sono particolarmente interessanti i “constituti”, cioè gli interrogatori dei due ufficiali per la ricostruzione dei contenuti e delle fasi dell’azione politico-militare e per il percorso e la dinamica della fuga dall’Italia. Vi si scorge tra le righe anche l’indole sostanzialmente mite di Morelli e la moderazione sempre dimostrata nell’impostazione ideologica e nell’impegno politico. La condanna a morte fu fortemente voluta dal re per dare un esempio del modo in cui venivano trattati i promotori della rivoluzione e per far capire che in avvenire, di fronte a situazioni simili, egli non si sarebbe comportato diversamente. Morelli e Silvati furono condotti alla ghigliottina e decapitati (non impiccati, come generalmente si crede) a Napoli, in piazza del Mercato fuori Porta Capuana, il 12 settembre 1822. La notte antecedente Morelli aveva respinto con fermezza, contrariamente a Silvati, i conforti religiosi, in coerenza con la sua fede massonica. Poco meno di un anno prima, in data 4 dicembre 1821, aveva scritto dal carcere al padre una lettera che giova rileggere perché ci offre un sintetico ma efficacissimo autoritratto dell’uomo, del soldato e del patriota e insieme ce ne consegna il testamento spirituale: «[…] La mia causa sento che si farà ai principj dell’anno nuovo. Spero che la Clemenza di S. M. voglia esser quella di salvarmi di una punizione severa, attesa la mia illibata condotta che ho tenuto nelle passate vicende senza essermi profittato di niente come si rileva nelle attuali circostanze, che senza un soccorso della famiglia, mi saria perito dalla fame in queste prigioni. In tanto state di buon animo, ché tutti credono lo stesso perché io non dovessi esser punito aspramente, mentre non si puol [sic] negare che ho contribuito la maggior parte al buon ordine con la mia moderazione in una rivoluzione generale e replico che io sono stato di freno ai veri tumultuosi senza che fosse accaduto alcun disordine proporzionatamente a tutte le rivoluzioni. Infine, caro Sig. Padre, il vostro figlio non ha che rimproverarsi, e ora conosco quanta fermezza mi ha dato l’Ente Supremo a resistere a tante passioni che mi si presentarono nelli 9 mesi, perché miserabile ero prima e più lo sono al presente, e vi assicuro che l’unico sollievo che mi scema i miei tanti dispiaceri è di esser stato così onesto, ringraziandovi sempre di tali prinicipj d’educazione che mi avete ispirato, e chiedendovi la S. B., anche alla Sig. ra Madre, con abbracciare a tutta la famiglia vi bacio la mano. Il vostro aff.mo figlio Michele». gennaio / febbraio 2007 57 Maurizio Carnevali è lo scultore che nel 1991 ha realizzato la statua di Michele Morelli situata nel centro storico di Vibo Valentia. Carnevali nasce a Villa San Giovanni nel 1949, compie il suo primo ciclo di studi presso il Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria, per poi frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera. Intrattiene rapporti significativi oltre che con i suoi diretti maestri accademici, Cantatore e Messina, anche con Luciano Minguzzi. Durante la sua permanenza in Lombardia frequenta Renato Guttuso nella sua villastudio di Velate. Dal 1978 si occupa anche di scultura. Nel 1986 espone una mostra di dipinti “La donna di Calabria” alla Galleria S. Karl di Vienna, riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico. Fonda la Stamperia del Sileno, officina calcografica che darà alla luce numerosissime edizioni d’arte. La sua attività di scultore si esprime in tante opere monumentali sia sacre che civili, in marmo o in bronzo. Tra le più note, oltre al monumento a Morelli a Vibo Valentia, quelli a Leonida Repaci e Francesco Antonio Cardone a Palmi, il bassorilievo sulla sepoltura di Alarico presso il Credito Cooperativo di Cosenza, il Cristo Orante di Fuscaldo, la Madonna degli Emigrati a Toronto, il San Rocco ligneo a Sidney. Dal 1993 riprende intensamente la mai abbandonata attività pittorica (nella foto sotto, il quadro intitolato Bocca di Rosa), realizzando i grandi cicli dedicati a Frate Francesco di Paola, Petrushka, Omaggio a Fabrizio De Andrè (mostra inaugurata a Palazzo San Giorgio di Genova per ricordare il grande cantautore nel secondo anniversario della morte), Labirinthos, “L’uomo che ride” (omaggio a Victor Hugo), fino alle più recenti “Storie di Castelli, Principesse e Amori”, Omaggio a Pablo Neruda e, da ultimo, Omaggio a Ruggiero Leoncavallo. 17 Luglio 1991 La statua di Michele Morelli presente a Vibo Valentia, realizzata dallo scultore Maurizio Carnevali. 58 gennaio / febbraio 2007 È difficile, per me, esprimere adeguatamente quanta gratificazione ho ricevuto dall’incarico di realizzare questa opera, differente da altri per alcune valide ragioni: la prima nasce da una riflessione sull’uomo, quello di oggi, con la sua esistenza fatta di falso benessere ed autentica ingordigia, peculiarità queste, che se usate come diaframma per osservare la storia, quella lontana da noi, magari poco più di cento anni fa, ci dovrà apparire almeno strano che di quelle esperienze, di quei martiri, di quei grandi ideali tanto poco siamo riusciti a conservare. Oggi, commemorare Michele Morelli è un modo per affermare con forza quanto sia ancora importante avere coraggio, rifiutare l’ingiustizia per sé e per gli altri, lottare insieme a chi ha il diritto di non avere fame. Per quattro mesi – tanto è durato il mio lavoro – ho avuto ben presente questi sentimenti, spesso ho avuto la sensazione di trovarmi a confronto, nel laboratorio, con uomini di gesso che chiedevano di divenire vitali per compiere, ancora una volta, quel meraviglioso sforzo che si chiama solidarietà umana. Anche la scelta di scolpire nel gesso ha una ragione che va al di là degli aspetti tecnici. Infatti, la sofferenza che esprime una superficie tagliata dai ferri non è paragonabile, in termini di drammaticità, alla morbidezza di un modellato ottenuto nella creta. Il Pathos di corpi sopravvissuti alla battaglia e la volontà di portare ancora in alto la “bandiera” si configurano nel ritmo ascensionale dei personaggi, che a partire dalla figura posta più in basso, si fa sempre più aperto e più deciso verso l’apice. La bandiera è in questo caso l’artificio plastico attraverso il quale ho voluto esprimere il senso dello sforzo unanime di uomini che accomunati dallo stesso ideale riescono a costruire la dignità della stessa specie. Alle spalle del gruppo, quasi un monito: la nostra donna calabrese, tanto spesso madre di figli uccisi da una assurda quanto odiosa guerra mai dichiarata; accanto, una creatura che piange nella sua nudità disperata forse per la fame, forse per la paura. Non ho voluto indugiare in eccessive descrizioni anatomiche e di particolari convinto che l’essenzialità formale conferisca all’opera maggiore efficacia. L’opera è stata realizzata direttamente in acciaio e gesso d’alabastro, fusa in bronzo cavo a cera persa. Ha un peso di circa cinque tonnellate ed una altezza di metri 3, 40. Ringrazio gli Uomini che hanno reso possibile la realizzazione di tale monumento e voglio augurarmi che la profusione del mio impegno sia stata all’altezza della Nobiltà del Loro intento. Maurizio Carnevali tratto da “Michele Morelli - Primo martire del risorgimento italiano” Edizioni Mapograf 1992 “Bocca di Rosa” Frammenti di storia secolare negli di Vibo Valentia Tra le 180 opere in mostra a Cosenza fino al 30 aprile 2007 molte provengono dal Vibonese, a cominciare dallo splendido Turibolo cesellato alla fine del XV secolo, immagine simbolo dell’esposizione ospitata a Palazzo Arnone. di Francesco Piro A lcune erano già note al pubblico attento dei cultori di arte sacra, altre erano state gelosamente custodite negli armadi delle sacrestie, e per questo inedite: sono le preziose opere in argento messe saggiamente in mostra a Palazzo Arnone di Cosenza, a testimonianza di quel patrimonio artistico, della provincia di Vibo Valentia e della Calabria tutta, permeato di fede e di misticismo. È la luce promanata dall’argento a guidare il percorso di storia tracciato dalla sacralità delle opere esposte; argento finemente modellato dai maestri meridionali più prestigiosi, tra il XV ed il XIX secolo, per dare corpo e anima ai simboli del culto religioso calabrese. Centottanta le opere in mostra, enigmatiche e affascinanti. Frammenti speciali di storia secolare che narrano la stratificata identità culturale della regione. Croci e ostensori, calici e pissidi, reliquari e busti, turiboli e ferule, cartegloria e tronetti: capolavori argentei di cui sono custodi le diocesi della Calabria. Ed in questo mare magnum d’arte sacra Vibo Valentia emerge con i suoi splendidi tesori museali ed ecclesiastici. È patrimonio della provincia vibonese il logo della mostra “Argenti di Calabria”, lo straordinario Turibolo in argento sbalzato, inciso e cesellato alla fine del secolo XV proveniente dalla Cattedrale di Mileto, opera di argentieri meridionali. Il Turibolo è un contenitore di metallo a forma di coppa su piede, che contiene un piccolo braciere con carboni ardenti, su cui si dispongono i grani d’incenso. È chiuso da un coperchio intagliato a giorno per attivare la combustione e liberare il fumo profumato. Stile rigorosamente gotico che richiama le coeve costruzioni architettoniche, con torri, guglie e pinnacoli. Nessun punzone è impresso nell’opera per risalire puntualmente alla provenienza, ma per analogia con altri esemplari coevi, l’ambito elettivo sembra essere napoletano. Dal Museo della Cattedrale di Tropea, invece, proviene la Statua di Santa Domenica in argento sbalzato, inciso e cesellato, con cornici e figure in bronzo dorato, opera di Gaetano e Nicola Avellino, maestri napoletani. L’agiografia narra che la Santa, vergine romana che può identificarsi con la martire greca Ciriaca, in seguito la- tinizzata in Domenica, durante le persecuzioni di Diocleziano fu decapitata ed il suo corpo trasportato dagli angeli a Tropea, dove venne eletta protettrice e dove è venerata come martire locale. Di particolare pregio il diadema posto al centro della fronte della Santa, che lascia sottintendere le proprie origini patrizie. Nella mano sinistra regge un libro, la croce e la palma, simboli del suo martirio. In basso a sinistra è riprodotta in miniatuImmagini tratte dal catalogo della mostra “Argenti di Calabria” Nella foto grande, il Turibolo (Cattedrale di Mileto) Sopra, Santa Domenica (Museo della Cattedrale di Tropea) ra la città di Tropea, mentre a destra, due piccoli devoti lupi in bronzo dorato, alludenti a un episodio della sua vita, quando gettata ad essi in pasto, ne uscì indenne. A definire l’humus culturale ed artistico della Chiesa calabrese in età aragonese contribuisce il Riccio di bacolo pastorale – Cristo Consacrante un vescovo – della seconda metà del XV secolo, proveniente dalla Cattedrale di Tropea. Nel nodo, che riproduce una struttura architettonica esagonale con cupoletta dorata e decorata a scaglie, si aprono nicchie e archetti all’interno delle quali si delineano microsculture raffiguranti la vergine con il Bambino, i Santi Pietro e Paolo, un vescovo, Bartolomeo e Giacomo. Dal nodo si diparte il riccio sottolineato dal rincorrersi delle foglie d’acanto, sulle cui lamine argentee si disegna l’ordinato svolgersi di girali e foglie, a cinque, quattro e tre petali. Al centro del manufatto il Cristo in trono benedicente un vescovo, probabilmente Sigismondo Pappacoda, la cui prelatura intercorre tra gli anni 1499 e 1536. Le vicende critiche del bacolo di Tropea si sono da sempre intrecciate con quelle del più noto esemplare di Reggio Calabria del quale «non è certamente una fiacca copia, ma molto più probabilmente la ripetizione di un comune modello di bottega» (Lipinsky 1934). 62 gennaio / febbraio 2007 Faceva parte del corredo dello splendido busto argenteo di San Leoluca, patrono di Monteleone, oggi Vibo Valentia, la preziosa Mitria commissionata all’argentiere napoletano Mattia Condursi dai cittadini di Monteleone nel 1854, come ex voto a San Leoluca, patrono della città, per averli salvati dal colera. La Mitria, oggi custodita nel Museo d’Arte Sacra di Vibo Valentia, è in argento sbalzato e cesellato, ed è composta da due lamine sagomate, ornate con esuberanti motivi vegetali e ghirlande, alcune delle quali ulteriormente sottolineate dalla loro doratura. A completare la ricca decorazione, l’incastonatura di gemme ornamentali di vario colore. La Mitria, assieme alla base processionale, scampò al furto del busto di San Leoluca, trafugato nella notte del 17 gennaio del 1975. Altro notevole esempio dell’abilità dei maestri argentieri di scuola napoletana è l’Ostensorio raggiato con nodo figurato - San Tommaso d’Aquino - custodito nella Chiesa di San Domenico di Soriano Calabro. Realizzato con tecnica tipica del tardo barocco napoleIn altro, Navicella portaincenso (Cattedrale di Mileto) A destra, Riccio di bacolo pastorale Cristo Consacrante un Vescovo (Cattedrale di Tropea) tano, è finemente lavorato e decorato con pietre ornamentali. La base circolare, sostenuta da quattro piedini, è arricchita dalle due splendide statuine di angeli seduti alla destra e alla sinistra del corpo centrale che si erge verso il nodo. Gli angeli reggono in mano i simboli della passione di Cristo: la colonna ed i flagelli, quello a sinistra; la Veronica, con la definizione a rilievo del volto di Cristo incoronato dalle spine, quello a destra. Il nodo, costituito da un globo, sul quale sono incise a graffio le rappresentazioni del sole, della luna, delle stelle e dello zodiaco, è sorretto da testine di cherubini, ai lati delle quali partono due grappoli di melograni, simboli dell’Eucaristia. Sul nodo si poggia la figura di San Tommaso d’Aquino. L’Ostensorio si conclude con la teca a forma di sole e alla sua sommità spighe di grano fermate da un nastro. Tra le altre opere esposte, appartenenti al patrimonio di arte sacra della provincia di Vibo Valentia, spiccano: i busti di San Nicola e di San Fortunato di Mileto, la Croce astile di Pizzoni, le Pissidi di Serra San Bruno, le Serie di cartegloria di Nicotera e la navicella porta incenso di Mileto. Attraverso questa mostra, dunque, organizzata dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Calabria, e magistralmente curata dal Soprintendente Salvatore Abita, si dà conto delle molte e differenti declinazioni di quest’arte, a torto ritenuta “minore”, a tutt’oggi ancora poco studiata, e tendente ad essere confinata nell’ambito degli interessi specialistici. Di sicuro la mostra “Argenti di Calabria” ha realizzato una impresa di grande valore scientifico e culturale fino ad ora mai tentata: raccogliere in un’unica sede i manufatti più preziosi e significativi del patrimonio degli argenti della provincia di Vibo Valentia e dell’intera regione. Una prima assoluta, un debutto brillantemente riuscito, a cui si spera seguano nuove scoperte di scintillanti tesori sui quali puntare i riflettori. Una mostra che accende la luce negli occhi dei visitatori; quella luce riflessa dagli argenti di una Calabria traboccante di fede. A destra, Mitria di San Leoluca (Museo d’Arte Sacra di Vibo Valentia) A sinistra, Ostensorio raggiato con nodo figurato San Tommaso d’Aquino (Chiesa di San Domenico di Soriano Calabro). S e si ha la fortuna di avere un proprio universo, allora, quell’universo suggerisce il linguaggio attraverso cui esprimerlo. Per Albino Lorenzo quel linguaggio e quell’universo sono Tropea: il suo mondo e la sua genealogia. Un mondo dove rifugiarsi e ricrearsi, navigare o perdersi. Il fare dei contadini possenti, l’avanzare a passo pesante delle vaste mucche, le macchie degli sbattimenti solari: chiazze di terra e luce di «un pittore-pittore, autentico, innocente, istintivo, uno che dice pane al pane, che rimane pur sempre l’origine e la fine della pittura» (Michele Cascella, 1976). Albino Lorenzo nasce a Tropea il 19 gennaio del 1922. Apprende le prime nozioni di disegno dal padre, Saverio, suo grande maestro. Fino all’età di 18 anni frequenta l’Istituto magistrale di Palmi per poi essere assunto all’Ufficio imposte di Tropea. “Scena agreste” - 1988 “Lavandaie” 1989 di Michele Lico Albino LORENZO 66 Viaggio nel diario della memoria gennaio / febbraio 2007 Dal 1957 al 1960 insegna l’arte del disegno presso il Seminario vescovile e dal 1992 è docente di pittura presso l’Accademia “Fidia” di Vibo Valentia. Sposato con Luigia Capua, diventa padre di ben 18 figli. È dopo i 35 anni che si dedica alla pittura in maniera costante e compiuta. Nelle pennellate sfocate dal mosso lirico della calura mediterranea si accende il suo temperamento, che aderisce totalmente ai valori della civiltà che la sua pittura racchiude. Pennellate di luce accecante del sole e della salsedine della sua Tropea, sanguigna e nobile, ormai tòpos turistico per eccellenza della Calabria. In quel fortino, tra l’azzurro del mare ed il verde che lo circonda, Lorenzo riesce a cogliere i resti di una civiltà che non c’è più, e in un caleidoscopio di storie e di figure, cariche di “Mercato” 1980 sentimenti e passato, vive con entusiasmo nuovo il suo idillio con la memoria ed i suoi luoghi. E il filtro della memoria ch’egli attiva è una animazione di sequenze, di ombre, che di continuo ripassa, come un album di famiglia. «Dopo tanto girar di pagine, l’una uguale all’altra, nel librone del tempo, ora il battente della rilegatura sembra spiombare sull’ultima, trattenuto dal pittore che non rinuncia a disegnarvi le sue opere» (Maurizio Calvesi, 1991). Sganciata dallo spessore intellettualistico la sua arte pittorica, poco incline alle mode, modesta, lontana da ogni clamore, ma capace di trasmettere inequivocabilmente la sua instancabile e caparbia ricerca della memoria. 68 gennaio / febbraio 2007 I contadini al mercato – una delle scene più ricorrenti della sua produzione – par quasi che aprano un dialogo tra il pittore ed il suo interlocutore. In quelle figure solo accennate un dinamismo che sa di teatralità. In quei tratti sfumati la vibrazione della luce rende più vivo il contrasto delle masse. E se il messaggio di Lorenzo nasce dal rapporto viscerale tra il pittore e la propria terra, «non geografica è la sua pittura, ma ben più in là della Calabria approda, pur da essa partendo e senza essa mai tradire» (Lucio Barbera). Perché la pittura di Lorenzo esprime il disagio, il disappunto per una semplicità perduta, per dei valori smarriti; annota, denuncia, registra, riporta alla luce la precarietà dell’uomo, il bisogno dei ricordi, dell’amore che nutre la vita, di quegli attimi di occhieggiamento che si concludono in un ciclo alimentato da suggestioni, amori e patimenti, dall’attesa continua, dal vivere quotidiano. Una pittura di forte impatto affidata tutta al colore, all’impasto cromatico della materia, alla sfrangiatura della pennellata. Con una tavolozza-mortaio, in cui sembra pestare l’aria e il sole, la polvere e il fango, Lorenzo dipinge asinelli caricati di soma e bovari ingombranti, uomini carichi di un possente destino di vita, una natura forte, selvaggia e agreste. Fotogrammi ridotti all’essenziale nel viaggio tra appa- rizione e ricordo, i giorni captati da Lorenzo: flash attimali infilzati dalla memoria. Nelle storture delle sue forme l’”espressionismo” di Lorenzo: lo storpiarsi e contrarsi di molte figure, che accennano all’immagine di una umanità caricata dal peso dell’esistenza, ma pur nervosamente reattiva; questo espressivo continuo dar di spalle di uomini e donne, davanti ai panni stesi al sole o ad una fontana che scorre, su una bicicletta o nel raccogliere le olive nei campi. Espressionismo? Forse è meglio parlare di «dinamismo irrequieto - dice Maurizio Calvesi nel 1991 - inconcludibile ed inconcluso, nel friggere perpetuo di uno stimolo verso il movimento senza arresti né chiusura; con ac- gennaio / febbraio 2007 69 centi che mimando l’apparente goffaggine del povero ne esaltano l’autentica antica sapienza naturale di armonizzarsi con i movimenti della natura: dai tagli delle rocce, al rattorto spiegarsi degli olivi, al flettersi di un ramo nel vento, al tendersi del mare, o al sobbalzare di una groppa d’asinello». I ritratti, altro genere in cui Lorenzo esprime pienamente la sua arte: dal soggetto all’occhio, dall’occhio al dipinto, il suo dinamismo creativo, espressione o lettura del sentimento dell’artista. Lorenzo si schermiva dinanzi ai tanti apprezzamenti rivoltigli da artisti e critici di notoria fama. Diceva spesso: «Io sono solo me stesso. Per me la pittura è la vita. È uno stato d’animo». E quando gli domandavano cosa fosse per lui la pittura ribadiva: «La pittura è l’unica cosa sentitamente viva della mia vita, un ideale tangibile, un bisogno quasi fisico. Ho fatto del colore un castigo quotidiano ed una pena d’amore. Esiste in Calabria un mondo di gente con le mani ruvide, pieno di speranze, spesso tradite, deluse, eppure mai sopite; di uomini e donne che sanno cos’è l’attesa sotto il sole, vissuta senza dire parola o bestemmia, ma con la voce pronta a ringraziare per quel poco che è loro concesso, la fatica, la speranza e il sole. Noi, con molto distacco riteniamo questo mondo contadino tramontato, superato. Ecco, questo mondo ripreso per frammenti che appartengono all’esistente, è il mio mondo, è la mia pittura». A sinistra e sopra, ritratti di donna. gennaio / febbraio 2007 71 Gli Uffici della Camera di Commercio Sede Viale G. Matteotti 89900 Vibo Valentia centralino 0963.44011 fax 0963.44090 Presidenza tel. 0963.547630 Segreteria Affari Generali e Personale tel. 0963.547437 Registro delle Imprese tel. 0963.44011 Ragioneria Provveditorato Economato Diritto Annuale tel. 0963.547645 Area Servizi Sviluppo Imprese e Regolazione del Mercato tel. 0963.547646 Area Servizi Programmazione Territoriale tel. 0963.44703 Orario di Servizio al Pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Scarica