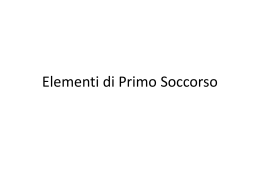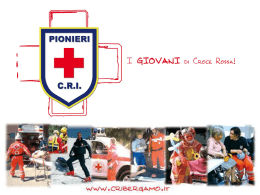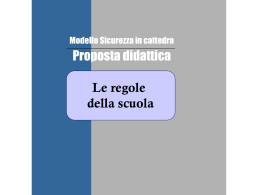ABSTRACT
BOOK
Presentazione II Congresso Nazionale FIMEUC
Roma, 2930 novembre 2013 Cecchignola Scuola Sanità Militare
I Professionisti della Emergenza quotidianamente sono impegnati a gestire il caos in ambito preOspedaliero ed
Ospedaliero. La instabilità geofisica della nostra nazione ci impone, inoltre, l’elaborazione di modelli organizzativi
Regionali e Nazionali in coerenza con i più recenti progetti Europei. I disastri, infatti sia di origine naturale che
antropica causano gravi ripercussioni sulla salute pubblica, sia in termini di vite umane che di interruzioni di
servizi essenziali per la popolazione colpita.
Diventa sempre più urgente, pertanto l’esigenza di garantire una uniforme gestione dei Disastri nel contesto della
Rete Nazionale della EmergenzaUrgenza.
Il Convegno Nazionale FIMEUC 2013 affronta in questa direzione il tema delle Maxiemergenze nei suoi aspetti di
Pianificazione, Gestione e Formazione.
Le Strutture Sanitarie appartengono al gruppo dei “First Responder” e sono chiamate a garantire la più efficace
risposta nell’ambito della “Rete della Emergenza”. Il Convegno nasce dall’esigenza di un confronto con tutte le
professionalità in campo: SSN, Istituzioni, Sanità Militare, Gruppo Operativo Interforze, Difesa Civile, Volontariato
per realizzare piani di “Continuità Operativa” in ambito sanitario e il passaggio dalla pianificazione al
coordinamento delle attività in corso di Disastri.
La formazione e l’addestramento del personale sanitario sono premessa indispensabile per garantire la piena
attuazione dei Piani di Emergenza.
La Task Force FIMEUC sulla gestione preospedaliera ed ospedaliera dei disastri (DiMFIT) si pone l’ obiettivo
specifico di definire “Linee di Indirizzo Nazionali” per l’elaborazione di piani di emergenza, con particolare
attenzione agli aspetti di coordinamento, comando, controllo, comunicazione, gestione delle risorse umane e
materiali, sicurezza, gestione del rischio clinico e formazione.
Il congresso sarà occasione di presentazione, discussione, confronto e condivisione delle linee di indirizzo
proposte.
Inoltre nel corso di formazione satellite, organizzato dalla Faculty FIMEUC, utilizzando gli ambienti, la tecnologia e
gli scenari messi a disposizione dalla Scuola di Sanità Militare, sarà possibile verificare alcuni degli aspetti di
pianificazione, simulando le fasi attuative e quella di coordinamento.
In questa prospettiva il Congresso vuole essere una occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nelle grandi
emergenze: Medici, Infermieri, Soccorritori, Volontari, Sanità Militare, per una partecipata e condivisa
elaborazione di “Linee di Indirizzo Nazionali” sulla preparazione alla gestione dei disastri.
Ci vediamo a Roma, con l’augurio di un incontro costruttivo e propositivo.
Coordinamento Nazionale FIMEUC e Disaster FIMEUC Task Force
Cinzia Barletta
CONTROL OF COURSE TEMPERATURE IN
MAJOR ORTHOPEDIC SURGERY AND
NEUROTRAUMATOLOGY IN GERIATRIC
PATIENTS USING LEVOBUPIVACAINE FOR
SPINAL ANESTHESIA.
1) B. Amarisse, 2) B. Ciammitti, 3) M. Emanuelli, 4) V. A,
Peduto ,5) D. Celleno
1) Department of Anaesthetics and Intensive Care,
University of Perugia ( Terni); 2) U.O.C. ( Multi – speciality
Department ) Anaesthetics and Intensive Care, University
of Perugia (Terni); 3) Departiment of Anaesthetics and
Intensive Care ,FBF Isola Tiberina Hospital Rome (Roma); 4)
U.O.C. ( Multi – speciality Department ) Anaesthetics and
Intensive Care, University of Perugia ( Perugia); 5) U.O.C. (
Multispeciality Department) Anesthetics intensive
Care,FBF Isola Tiberina Hospital Rome ( Roma).
A homogeneous sample of patients was selected for
a randomised study: age (80 ± 0.5 years old),health
status (ASA 1,2,3 ): Group A (n=25 patients men) was
subjected to active cutaneous warming (at 38° C) and
the infusion of liquid and/or blood heated to 37 °C.
Gruppo B (n=25 patients women) did not receive
either active cutaneous warming during the
ntervention or the infusion of the liquids or blood
intraoperationally. Monitoring of core temperature
was done through a rectal probe, which began before
subarachnoid anesthesia and was carried out
successively every 15 minutes until the end of the
operation, the thermometer bening calibrated with a
temperature range of between 30°C and 40°C, with
an accuracy of 0,1 °C. All procedures began at 8.00
a.m. and the operating theatre was maintained at
between 21 °C and 23 °C with a humidity rate of
between40% and 45%. The length of the operation
was almost identical in both groups, average length
being 75 minutes ± 10. No serious hypotensive events
were recorded. No substantial haematic loss
occurred .The central temperature decreased in both
groups but by varying amounts: in Group A the
average central temperature was 36 ° C; in Group
B, the average central temperature was 35,5°C.
Concerning the trend of central temperature in
both groups, it became clear that decrease in
temperature
was
directly
related
to
intraoperational warming, the length of the
intervention and haematic loss. It was highlighted
that the initial average temperature of patients in
both groups was stated at about 36,5°C, whereas
the end result was that of a decrease in the central
temperature to as little as 35,8 °C for Group A and as
little as 34,8 °C for Group B.
Suggested reading:
Sessler DI. Current Concepts: Mild Perioperative
Hypotermia. N Engl J Med June 1997; 336:173
L’ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI NELLE
STRUTTURE CAMPALI PER LE MAXI
EMERGENZE: L’ESPERIENZA DELL’ARES
1) C. Antinori, 2) E. Andreoli, 2) L.C. Calò, 3) S. Pacini, 4) M.
Troiani, 2) B. Gabrielli, 2) M. Caroli
1) Dipartimento Prov.le ARPAM di AnconaServizo rifiuti
suolo; 2) Ospedali Riuniti di Ancona Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza; 3) Ospedali Riuniti di Ancona
Clinica di Anestesia e Rianimazione; 4) Ospedale S.
Salvatore Tolentino Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
PPIPotes 118.
Secondo le raccomandazioni OMS le strutture
sanitarie campali in grado di fornire assistenza
medica d'emergenza sono utili solo se raggiungono il
luogo dell’evento nelle prime 24 ore dal disastro
(PAHOWHO, 2003).
Per tale realizzazione occorrono una notevole
quantità di attrezzatura logisticosanitaria ed una
tempistica elevata per preparazione, arrivo ed
installazione (2010/481/UE, Euratom).
Tali strutture devono partire entro 12 ore dalla
chiamata, quindi l’organizzazione deve essere
stabilita e condivisa in tempo di pace, sia per quanto
riguarda la planimetria esterna, che il materiale
utilizzato per allestire le tende. Quest’ultimo si
distingue in diverse tipologie, in relazione al
trattamento da effettuare e su questi presupposti
l’ARES (Associazione Regionale per le Emergenze
Sanitarie e Sociali)* ha ripreso la classificazione del
materiale sanitario secondo i criteri adottati a livello
internazionale dal D.M. 13/02/2001 (G.U. n. 81
6/04/2001) integrandola con ulteriori codicicolori
(Tabella 1).
Tabella 11: Materiale sanitario identificato da un
codice e un colore
La quantificazione del materiale è stata effettuata a
partire dalle indicazioni delle linee guida europee per
la gestione di 150 pazienti al giorno, di cui 50 gravi e
100 non gravi, per un’autonomia di 3 giorni.
Ogni tenda necessita di una specifica quantità e
tipologia di materiale, per cui è stato creato un
database su file Excel, dove è riportato il quantitativo
di ogni singolo materiale per ogni tenda.
Il materiale viene classificato attraverso nome,
codice/colore,
consumabilità,
scadenza
e
localizzazione nel deposito.
Il database viene costantemente aggiornato e
revisionato in base a scadenze del materiale
consumabile, innovazioni e modifiche alla struttura
campale (tipologia/destinazione tende).
La preparazione del materiale per la pronta partenza
consiste nell’inserimento in casse metalliche a tenuta
stagna modello Zarges 470 di diverse dimensioni
(Figura 1).
Figura 1: Alcuni modelli delle casse alluminio (da
sinistra piccola750x550x380, media750x550x580 e
grande1150x750x480)
Il quantitativo di materiale da inserire nelle casse è
standardizzato e suddiviso per tipologia. L’interno di
ogni cassa è stato ulteriormente suddiviso con
cassetti scorrevoli di più facile impiego (Figura 2).
Figura 2: casse pronte alla partenza e con cassetti
scorrevoli
Al fine di facilitare e velocizzare il posizionamento
delle singole casse all’interno della tenda ognuna
deve avere:
a. Un’etichetta esterna ed impermeabile con
indicato (Figura 3): logo di appartenenza; peso;
codice materiale; numero cassa (numerazione
crescente per ogni codice colore); destinazione
tenda.
Figura 3: etichetta esterna cassa
b. Una lista del materiale contenuto con indicato
(Figura 4):
tenda destinazione; numero cassa; tipologia
materiale (codice colore); nome materiale;
scadenza; quantità.
-
Fig. 41: lista materiale sanitario interno alle casse
*Per maggiori informazioni visitare il sito www.ares
italia.org
radiological images and a logic processor integrating
information on the casualty evolutionary progress.
This last part is responsible for calculating the
appropriate laboratory results and images according
to the clinical conditions of the simulated patients.
Integration with actors impersonating casualties is
done through radiofrequency identification (RFID)
tags which allows the system to know which casualty
reached which hospital in multihospital drills. The
imagining system includes both images and
radiologist report related to each image. They can be
produced automatically and a radiologist in the
emergency department, can review images provided
by the system and type in reports that then are
included in the system. Both the number of request
and the average turnaround time for each exam in
each hospital are calculated and logged. We tested
this system during a multiple hospital 100 casualties
real size drill lasting five hours.
Results: No usability issues arose from the user
evaluation. All the casualties were correctly admitted
to the proper hospital for exams request via RFID
tracking. Table 1 presents the number of exams
requested and the average turnaround time for each
exam.
Hospital 1
Hospital 2
Request
Request
Count: Time: Count: Time:
http://crimedim.med.unipmn.it
Name:
Complete Blood
Count
Clotting
Biochemistry
Cardiac markers
Arterial Blood Gas
Xray
CT Scan
Ultrasound
Electrocardiography
Intro: Radiological studies and basic emergency
laboratory test are of very high importance for the
management of hospital patients. However it is well
known that during mass casualty events and disasters
they can create a significant bottleneck to the
emergency department and hospital patient flow.
Methods: We designed and implemented an online
tool to be used during full scale hospital mass
casualty drills faithfully simulating an online radiology
and laboratory requests and results system called
Virtual Laboratory and Imaging (VLI). It is composed
of a basic user interface used to request and consult
laboratory exams and radiological studies, a database
containing all the casualty details and related
Table 1 legend: Aggregated count of laboratory and
radiology tests according to hospital and relative
execution time according to the relative number of
requests.
Conclusion: VLI resulted an easy to use, user friendly
virtual laboratory and imagining system. It allowed to
point out, in real time, bottlenecks during the
exercise, that could be explored in depth during the
debriefing. In particular the massive use of CT scan in
the hospitals resulted as the main bottleneck related
to imaging and laboratory during our exercise.
According to the number of CT requests and the
average time of execution, it is clear that many of
them were requested and queued but never
executed with possible detrimental effect for the
VIRTUAL RADIOLOGY AND LABORATORY: A
TOOL FOR HOSPITAL MASS CASUALTY
TRAINING
Carenzo L, Colombo D, Ingrassia PL, Ragazzoni L, Della
Corte F
CRIMEDIM Research Center in Disaster and Emergency
Medicine, Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"
Novara, Italy
4
4
4
1
1
15
23
2
0
30 min
45 min
35 min
35 min
3 min
7 min
38 min
7 min
1
2
2
2
2
5
5
0
0
25 min
40 min
35 min
35 min
5 min
5 min
29 min
casualties and thus lowering the overall simulation
performance. Moreover VLI increases the realism of
the exercise by offering a tool to simulate an aspect
of clinical practice that would otherwise be absent in
hospital based drills.
Scheda di Triage preospedalero PLS/SAP
attiva in paesi europei
IIb Trasporto prioritario
III Attesa possibile
IV Attesa necessaria (poiché la situazione al
momento non consente un trattamento
individuale standard mediante ricovero di
elezione)
La ripetizione del suddetto triage permette di
modificare i parametri di diagnosi e trattamento se
l’evoluzione lo indica.
x
x
x
G. Ciccone – già direttore PS AO di Lodi – membro
Commissione SIMEU per i rapporti con l’Europa
Il Trauma Maggiore o POLITRAUMA
*E’ utilizzata in casi di maxiemergenze e disastri
collettivi: in casi di attivazione di Grande Noria e
Piccola Noria, in particolare. Trattasi di un sistema di
identificazione delle vittime e della loro
documentazione medica sulla scena e lungo il
percorso
fino
al
ricovero.
PLS
ovvero
PatientenLeitSystem;
SAP
ovvero
Système
d’Acheminement des Patients.
*E’ in materiale plastico resistente all’acqua ed a
liquidi biologici. Presenta tre sezioni: la prima, la
maggiore, destinata all’ospedale di ricovero, è una
tasca contenente documentazione, la seconda e la
terza, staccabili, sono destinate alla polizia ed al team
della protezione civile. Sulle loro superfici vi sono
pittogrammi da utilizzare per rilievi clinici e per
provvedimenti; più precisamente la faccia anteriore è
dedicata ai rilievi clinici ed al triage, quella posteriore
al trattamento eseguito.
*Nella tasca sono allegati
1 una serie di etichette autoadesive con il numero di
riconoscimento del paziente: sono applicabili su ogni
sua pertinenza, anche su effetti personali;
2 – un cartoncino di colore rosa ove è possibile
trascrivere i dati del paziente (protocollo di
identificazione), dinamica dell’evento e quant’altro;
3 – un cartoncino giallo URGENT PRE-TRIAGE viene
utilizzato esclusivamente in caso di compromissione
dei parametri vitali con immediato pericolo di vita. In
tal caso l’urgenza è tale da esonerare da qualsiasi
approfondimento diagnostico sul luogo del disastro.
Viceversa viene utilizzata solo la PLS;
4 – un modulo di colore bianco può essere utilizzato
per il followup in itinere fino al ricovero
L’utilizzo del corredo 2 e 4 è facoltativo
*Le categorie di Triage indicate sulla faccia anteriore
del PLS:
x
x
I Trattamento immediato sul luogo dell’evento
IIa Trasporto immediato
G. Di Rosa, infermiere MCAU Ospedale Maggiore – Modica
ASP Ragusa.
Il Trauma Maggiore o Politrauma, nei paesi
occidentali è la principale causa di morte nei soggetti
di età inferiore ai 45 anni e causa di invalidità
permanente in un numero ancora maggiore di casi.
Costituisce un evento di frequente riscontro e di
grande impegno professionale, sia medico sia
infermieristico. Il lavoro di team implica il
coinvolgimento, nel trattamento del Paziente
traumatizzato, di molte figure professionali e la
gestione di un eventuale trasferimento del paziente
al trauma center di riferimento.
Obiettivo: questo lavoro vuole evidenziare la
flessibilità di modelli organizzativi possibili nella
gestione ottimale del paziente politraumatizzato e
quali siano i bisogni di formazione specifici per gli
operatori sanitari direttamente coinvolti.
Strumenti e metodi: lo studio è stato condotto
comparando linee guida e dati di letteratura relativi
al paziente traumatizzato ed i protocolli di gestione
messi in atto nel nostro presidio ospedaliero.
Risultati: questo lavoro termina con la proposta della
necessità/utilità che qualsiasi Pronto Soccorso si doti
di un Protocollo sulla gestione del Paziente
politraumatizzato, ponendo particolare attenzione
alla diffusione dello stesso al fine di realizzare una
maggiore collaborazione tra operatori sanitari
afferenti a U.O. diverse ma egualmente coinvolti, una
pianificazione
preventiva
che
consenta
nell’emergenza un coordinamento in parte
precostituito e sottolinea l’importanza della
formazione di tutti gli operatori, con particolare
attenzione al personale medicoinfermieristico e di
supporto del DEA.
IL BENCHMARKING E LA VALIDITA’ DEL
SAFETY WALK ROUND IN DIPARTIMENTO DI
EMERGENZA
V.R.Iulianella., Asl 1 Abruzzo –Avezzano –L’Aquila
Dipartimento di Emergenza Urgenza Ospedale S,Filippo e
Nicola Avezzano Pronto SoccorsoEmergency
Project Work
Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare ed applicare
il modello del Safety Walk Round come strumento di
Benchmarking sulla Unità Operativa Complessa o
Servizio ad alta complessità Assistenziale del
Dipartimento di Emergenza –EmergencyPronto
Soccorso.
IL Safety Walk Round(SWR) è ancora poco conosciuto
ed utilizzato in Italia. Sono state effettuate
sperimentazioni di applicazione del Safety Walk
Round in alcune Unita’ Operative di degenza
ospedaliera(Levati) ed ambiti di residenza
assistenziali territoriali(Perin D.), non sono riportate
in letteratura sperimentazioni in Emergency Pronto
Soccorso.
Il Ministero della Salute nell’anno 2012 ha emanato
Raccomandazioni e progettato seminari per la
divulgazione e l’analisi del confronto dei risultati sul
Safety Walk Round allo scopo di individuare
strumenti idonei di valutazione per i processi
assistenziali e per la prevenzione degli eventi avversi
in Sanità a garanzia della Sicurezza dei
pazienti(Albolino S.). Il Ministero della Salute ha
individuato il Safety Walk Round (SWR)come valido
metodo e strumento di applicazione per i Sistemi
Sanitari.(Dipartimento e Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della
Salute,2012.)
Le Regioni risultano con la riforma bis della Sanità
titolari della funzione legislativa ed amministrativa in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera in
particolare per le linee di Organizzazione dei Servizi
Sanitari. La Regione Abruzzo insiste, in uno dei Punti
della Mappa Strategica, sulla rimodulazione , sulla
razionalizzazione ed organizzazione dei processi
interni per migliorare la appropriatezza e sicurezza
dei processi produttivi tramite azioni, programmi e
progetti di studio sperimentali, orientati a definire le
caratteristiche e la sostenibilità di nuove forme
assistenziali(Carta dei Servizi Regione Abruzzo 2011
2013).
Il bisogno di nuove capacità organizzative indica nel
Benchmarking lo strumento per la innovazione ed il
miglioramento della organizzazione sanitaria per il
raggiungimento della maggiore BEST PRACTICE o
PERFORMANCESANITARIA.(SargiacomoM.)
Il
Benchmarking nella innovazione può avvalersi ed
utilizzare una Piattaforma di Appoggio di Sicurezza su
cui incamminarsi quale il SAFETY WALK ROUND.
Che cos’e il Safety Walk Round?
IL SAFETY WALK ROUND (SWR) è uno strumento
PROATTIVO di CONTROLLO che AGISCE sulle
ORGANIZZAZIONI AZIENDALI, MODULATO PER LA
OTTIMIZZAZIONE E LA IMPLEMENTAZIONE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI, SULLE ANALISI DEI RISCHI
DELLE
ORGANIZZAZIONI
SANITARIE
ED
INTRODUZIONE di CORRETTIVI E MIGLIORAMENTI
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DEI
COSTI ECONOMICI
Come si modula il Safety Walk Round?
Il Safety Walk Round(SWR) consiste in: GIRO per la
Sicurezza del paziente (GISO), Giro Interno Sicurezza
Organizzazione.
Il GISO e’ effettuato da un Gruppo o numero limitato
(massimo 5) di designati dirigenti sanitari. Il
Personale del GISO nel corso del Giro effettua
interviste agli operatori sanitari ed ai pazienti,
identifica i fattori di rischio presenti o futuri, che
potenzialmente potrebbero contribuire e palesare
eventi avversi ed individua misure da adottare per la
loro riduzione o eliminazione , effettua inoltre
supervisione con controllo, ed adotta misure
preventive ed operative, partecipando alla
risoluzione dei problemi.
Le interviste verranno effettuate agli operatori in
anonimato utlizzando domande secondo le categorie
e la tassonomia di Vincent.
Obiettivo del Safety Walk Round
L’obiettivo del SWR comporta un percorso di
sensibilizzazione, di introduzione e di inglobazione di
una cultura della responsabilizzazione della
PRODUZIONE , associata alla Educazione Formativa
che miri alla Qualità massima con meno risorse e
meno sprechi con raggiungimento dell’obiettivo
strategico del 2013 che riguarda lo Spending
review.(Atti di Indirizzo Ministero della Salute ,anno
2013) con la attuazione della Prevenzione e
ComunicazioneRilancio della Ricerca Sanitaria
Politiche Sanitarie InternazionaliPromozione della
Qualità della Assistenza SanitariaPolitiche per
l’Efficienza Gestionale –
L’EFFICIENZA GESTIONALE può impiegare il SWR nel
BENCHMARKING Interno
Il BENCHMARKING
Il Benchmarking interno si avvale del confronto tra
INDICATORI di PERFORMANCE e di PROCESSI per una
BEST PRACTICE; Permette un miglioramento continuo
ed una accurata misurazione dei processi
confrontando i processi interni di una organizzazione
con le pratiche di maggiore successo riscontrate.
Permette di confrontarsi con i punti di forza ed i punti
di debolezza o di minacce latenti o silenti. Il
Benchmarking ha utilità per la scelta delle STRATEGIE
AZIENDALI, LA REINGEGNERIZZAZIONE dei PROCESSI
AZIENDALE, LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
MIGLIORAMENTO AZIENDALI.
IN SANITÀ L’OUTCOME È L’INDICATORE DECISIVO
PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA’ COSTITUENDO
ANCHE UNA VERA SFIDA A CUI ARRIVARE PER UN
SISTEMA SANITARIO DI ECCELLENZA .
IL GISO
Il GISO attraverso il SAFETY WALK ROUND e’ un
METODO di SICUREZZA CHE OFFRE UNA
PIATTAFORMA SU CUI CAMMINARE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E PER LA
PIANIFICARE DEL LAVORO ALL’INTERNO DELLE
STRUTTURE SANITARIE. INDICATO ALTAMENTE COME
METODO di MINIMO COSTO MA CON VALENZA
PRODUTTIVA di ALTO LIVELLO CHE INDUCE LA STESSA
ORGANIZZAZIONE SANITARIA ALLA REINGEGNERIZZA
ZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, ADOTTANDO
METODI di CONTROLLO CHE INFLUISCONO SUL RISK
MANAGEMENT, CON RIDUZIONE DEI COSTI SANITARI
E MIGLIORE PERFORMANCE CON RISULTATO di
OUTCOME di QUALITA’, VERO OBIETTIVO DEL
SISTEMA SANITARIO , MIRANDO ALL’OBIETTIVO di
UN SISTEMA BLINDATO IN SICUREZZA PER IL
RISULTATO MASSIMO di PRODUZIONE ATTRAVERSO
LA SPENDING REVIEW.
La caratteristica del metodo consiste nel
coinvolgimento diretto degli operatori sanitari,
rafforzando il loro senso di appartenenza ad una
organizzazione sanitaria che miri ad una MISSION o
Vision comune , partecipata verso il centro comune
dell’oggetto di lavoro che rappresenta un Valore
intangibile, e che attraverso le forme di analisi nella
valutazione dei progetti in materia sanitaria come la
Cost effectiveness analysis o analisi costiefficacia e la
CostUtility analysis o analisi CostiUtilità per la salute
possa generare una nuova cultura di responsabilità
che generi valori economici utili per la visione globale
di una sana economia in un paese civile.
I valori intangibili sono quelle risorse costituite da
capitale
intellettuale,
organizzazione
e
posizionamento sul mercato che concorrono alla
efficienza del processo e non sono trasferibili ovvero
non vendibili autonomamente, equivale al Valore
Atteso dall’impiego delle risorse aziendali,
normalmente pari alla capitalizzazione dell’utile
sperato dall’impiego delle risorse intangibili,
indipendentemente dalla spesa sanitaria od in sua
aggiunta per acquistarle o usarle (D’Andreamatteo
A.Zappi A.)
La Cost Effectiveness Analysis consiste nel valutare
per ciascuna alternativa il rapporto tra unità di
prodotto ed i costi di produzione. Essa consente ad
esempio di determinare il numero di vite salvate da
un certo progetto per unità di capitale
investito.(Colantonio E.)
L’analisi CostiBenefici per beni privi di mercato come
l’allungamento della vita e la migliore qualità di essa,
potrebbero derivare da nuove tecnologie sanitarie od
anche dall’applicazione di un sistema rigido di
controllo con la verifica della Clinical Governance nei
processi assistenziali e la mitigazione di fattori
produttivi inefficaci , pericolosi o lesivi.
La maggiore domanda di salute in particolar modo
richiesta negli ultimi anni alle Strutture di Emergenza
Urgenza focalizza l’attenzione del Responsabile
tecnicogestionale e del Responsabile Politico sulla
valutazione della siffatta domanda di salute con la
reale attribuzione ad esso di un valore economico
come quello per beni o benefici privi di mercato che
si basano solitamente sulla conoscenza o la survey
della disponibilità a pagare dei singoli individui per
ottenere quel Bene(Willingness To Pay, WTP).
Poiché il paziente ed il bene Salute rappresentano gli
attori principali su cui ruota il meccanismo
organizzativo strutturale e clinico della Sanità,
l’obiettivo strategico del futuro sarà quello di creare
percorsi più efficienti intorno al paziente fulcro
dell’attività produttiva sanitaria. Il termine cliente –
utente ha sostituito quello di paziente con l’intento di
convalidare anche nominalmente la graduale
evoluzione di un rapporto istituzionale tra un Ente
erogatore di un servizio pubblico ed il cittadino
utente.La visione e la missione di una azienda
sanitaria moderna mira alla centralità della persona e
della dignità umana, eccellenza della professionalità,
rispetto dell’etica professionale, impegno per una
cultura di partecipazione nella organizzazione
sanitaria.
La Organizzazione viene considerata come sistema
sociotecnico dove aspetto tecnico e umano sono
interdipendenti e si influenzano, la efficacia della
Organizzazione è determinata dalla integrazione dei
suddetti sistemi (Zappi A.) La produttività è il
rapporto tra i fattori della produzione ovvero le
risorse utilizzate direttamente ed indirettamente ed i
risultati ottenuti.
Il risultato delle attività produttive iniziali ed
intermedie sono alla base del percorso assistenziale
di cura che porta all’OUTCOME, che comprende non
solo l’esito della malattia ma anche altri elementi
quali il recupero della funzionalità, la riabilitazione, e
la prevenzione degli esiti invalidanti od infausti.
L’OUTCOME RESEARCH, e’ in fase di studio ed è alla
base dei sistemi per il miglioramento continuo e la
ricerca della BestPractice attraverso il Benchmarking
che risponde ad una logica di programmazione e
controllo, che considera gli esiti derivanti dalla
misurazione
dell’outcome
come
un
ruolo
fondamentale nell’indirizzo manageriale della
Azienda Sanitaria. Basandosi sugli outputs derivanti
dal Benchmarking, delimitando i Gaps e fissando i
Benchmark, ci si può indirizzare e ci si proietta verso
livelli futuri di Perfomance.
L’Outcome nei servizi ad alta complessità
assistenziale quali i Pronto Soccorso Emergency,
derivano dalle varie fasi di attività produttiva ,
partendo dalla presa in carico del paziente nel primo
soccorso attraverso la Golden Hour , fino alla
stabilizzazione in emergenza. La principale finalità del
Servizio di Emergency è quella di garantire l’efficacia
e l’appropriatezza delle cure, utilizzando al meglio le
risorse disponibili, considerando peraltro che una
prestazione richiesta al Pronto Soccorso difficilmente
può essere considerata costituzionalmente a priori
non “essenziale” o non “urgente” (Rebba V.). La
Direttiva del Ministero della Salute 2013 tenta di
creare un Servizio Sanitario di Qualità e di Eccellenza
all’interno della Comunità Europea, tale da attirare la
utenza di altri stati membri per avere un ritorno
economico (in caso di cure inadeguate,di prestazioni
e prestatori di strutture o di tecnologie inadeguate,
non solo vi sarebbe un aumento di numero di reclami
o ricorsi con un danno emergente, ma anche un
passività economica da recuperare per la maggiore
richiesta di cure all’estero). Tra gli atti di indirizzo si
attua la Promozione della Qualità dell’assistenza
sanitaria ponendo rilievo a costi e fabbisogni
standard con l’azione di implementazione nel 2013 “
ai fini attuativi del Patto della Salute, nuovi indicatori
e strumenti innovativi per la ottimizzazione in termini
di costo/beneficio delle prestazioni sanitarie tramite
individuazione di Outcome esiti di cura delle malattie
al fine di effettuare un confronto tra le diverse
Regioni e di individuare un ulteriore macrolivello di
assistenza da inserire nella ripartizione del
fabbisogno di salute che sia strettamente legato alla
EmergenzaUrgenza da inserire tra le offerte di
assistenza ospedaliera e distrettuale.
A tale scopo e’ necessario costruire nell’ambito della
razionalizzazione della spesa sanitaria un processo
capace di creare modelli e diffondere le migliori
pratiche, sviluppando modelli organizzativi e
gestionali innovativi per il funzionamento delle
strutture e predisporre piani per il miglioramento dei
servizi erogati e per l’uso ottimale delle
risorse.(Ministero della Salute –Atti di indirizzo 2013)
In questo senso occorre una rivisitazione dei processi
clinico tecnico assistenziali utilizzando le risorse
disponibili per arrivare ad una Best Practice
attraverso il Benchmarking e la sperimentazione ed
applicazione del Modello Organizzativo Gestionale
del Safety WalkRound .
Il Safety Walk Round si presenta di basso costo e di
facile applicabilità , ma con il suo sistema di analisi e
di controllo con identificazione della vulnerabilità del
sistema si classifica il metodo proattivo migliore che
la organizzazione sanitaria possa intendere utilizzare
sul piano della Sicurezza e della qualità, soprattutto
nei sistemi ad alta complessità assistenziale quali il
Dipartimento di Emergenza Urgenza Pronto
Soccorso – Emergency
Bibliografia:
1) Albolino S., Toccafondi G., Tartaglia R., Safety walkround
esperienze regionali a confronto., Seminario. Ministero
della Salute, 2012
2) D’Andreamatteo A., La cultura organizzativa. I simboli e
le dinamiche culturali nel governo dell’azienda, Aracne,
2008
3) Levati A., Amato S., Adriario E., De Flaviis C., Delia C.,
Petrini F., Bevilacqua L., Safety Walkround as a risk
assessment tool: The first Italian experience Ig, Sanità
Pubbl. MayJune; 65(3):22740., 2009
4) Paris D., Il ruolo delle Regioni nell’organizzazione dei
servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del TitoloV;
ripartizioni delle competenze ed attuazione del principio di
sussidiaretà., Le Regioni, 983, ss., 2007
5) Perin D., Sperimentazione del Safety Walk Round per
l’identificazione dei rischi in RSA., 2008
6) Sargiacomo M., Benchmarking in Italy: The first case
study on personell motivation and satisfaction in a Health
Businnes., Total Quality Management., 13:4,489505.,
2002
7) Sharti., gruppo rischio clinico. Studio multicentrico
sull’impiego della tecnica del Safety Walk Round in terapia
intensive., 2007
Il ruolo del Medico di Medicina Generale
nelle Maxiemergenze: l’esempio del sisma
del 2012 nella “bassa modenese”.
1
2
3
4
C. Curatola , F. Giusti , R.De Gesu , V.M. Magro , L.De
5
3
3
3
3
Luca , C. Piancone , N. D’Autilia , D. Novi , N. Borelli , S.
6
Toscani
1
Medico in Formazione Specifica per la Medicina Generale,
2
Regione Emilia Romagna,
Medico d’Emergenza
3
4
Territoriale, MMG AUSL Modena, Medico formato in
5
Medicina Generale, Regione Lazio, Direttore Cure Primarie
6
AUSL Modena, Responsabile Pronto Soccorso Ospedale
Mirandola.
Introduzione. Il sisma del maggio 2012 ha interessato
l’EmiliaRomagna provocando 27 vittime, 350 feriti e
danni
ingenti
agli
ospedali
territoriali,
compromettendone l’agibilità. Il metodo di
decentramento delle cure ha visto i Medici di
Medicina Generale (MMG), quelli in Formazione
Specifica, la Continuità Assistenziale, i Pediatri di
Famiglia, i Medici di Emergenza Territoriale e gli
infermieri operanti in “Tende Mediche” allestite dalla
Protezione Civile ed attive H24 nei paesi
dell’epicentro. Materiali e Metodi. Sono stati
esaminati gli accessi alle Tende Mediche operanti nei
comuni di San Felice sul Panaro e Massa Finalese. Gli
accessi sono stati catalogati per patologia in
internistici,
traumatologici
e
psichiatrici e
ulteriormente suddivisi in medico, medico
infermieristico o infermieristico. Considerati a parte
gli interventi verso la popolazione pediatrica.
Risultati. Sono stati esaminati 1219 casi provenienti
da Massa Finalese (753) e da San Felice Sul Panaro
(466). La prevalenza delle patologie internistiche è
stata rispettivamente del 66% e 68%, con una
tipologia di intervento prevalentemente medica (66%
e 58%). Il 29% degli interventi classificati come
internistici ed il 13% di quelli traumatologici di Massa
Finalese riguardavano soggetti con età inferiore a 14
anni;lo stesso tipo di popolazione a San Felice sul
Panaro aveva richiesto il 21% degli accessi internistici
ed il 6% di quelli traumatologici. La percentuale di
pazienti inviati in Pronto Soccorso dalle Tende
Mediche di Massa Finalese e’ stata del 4,7%, inferiore
ad 1/20 degli accessi; la quota per quanto riguarda le
postazioni di Massa Finalese era del 9,8%, meno di
1/10 del totale degli accessi. Conclusioni. L'impegno
dei professionisti delle Cure Primarie nell'assistere la
popolazione colpita è stato massimo, rispondendo
alle esigenze di Salute secondo il modello “biopsico
sociale”. E’ stata anche svolta una funzione di filtro
per l'accesso alle cure di secondo livello: tale
compito, già evidenziatosi dopo il sisma in Abruzzo,
porta alla ridefinizione del ruolo del MMG nei
percorsi riguardanti le grandi emergenze, con
configurazione dei “Posti di Assistenza Socio
Sanitaria” (“PASS”, già istituzionalizzati da una
Direttiva del Consiglio dei Ministri emanata dopo il
terremoto
dell’Abruzzo),
consolidando
una
significativa connessione tra la figura del MMG e la
Protezione civile. Lo studio descritto esalta il ruolo ed
il grande impegno dei professionisti delle Cure
Primarie.
C.I.S.O.M (Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta) E MAXIEMERGENZE.
L’ESPRIENZA DEL GRUPPO DI MATERA.
Autori: 1) inf Salvatore Pellegrini; 2) dr C.Sinno; 3) dr
M.Maragno
1)Capo gruppo CISOMMATERA; 2)Direttore PSMatera;
3)Dir. Medico e responsabile OBIPSMatera.
Il C.I.S.O.M. nasce il 24 giugno 1970 e fonda le
proprie basi sul volontariato. Composto da più di 70
Gruppi, opera su tutto il territorio nazionale, per un
totale di circa 1800 volontari con a capo un Direttore
Nazionale, un Vice Direttore Nazionale e un
Segretario Nazionale. Suddiviso, solo per motivi
organizzativi, in tre grosse Aree: Nord, Centro e Sud.
Svolge, con proprio personale e con mezzi propri o
con mezzi posti a disposizione dalle autorità
competenti, attività di previsione, prevenzione,
soccorso ed assistenza per il ripristino delle normali
condizioni di vita nei periodi successivi ad eventi
calamitosi; Svolge attività di emergenza,di primo
soccorso e di pronto soccorso nel settore sanitario
avvalendosi di volontari medici, infermieri e
soccorritori; Istituisce posti di primo e pronto
soccorso sanitario, sia direttamente che per conto di
Enti pubblici o privati; Svolge attività informative e
formative rivolte ai propri aderenti e alla cittadinanza
sui temi di protezione civile in generale e su materie
specifiche;Svolge attività addestrative sia in relazione
alle proprie esigenze, sia nell’ambito delle
pianificazioni nazionali relative a particolari situazioni
di rischio.
Il gruppo di Matera è composto da un capogruppo,
da medici, infermieri,psicologi, un assistente
spirituale e soccorritori formati e addestrati all’uso
del BLSD e PBSLD. E’ intervenuto in supporto a
popolazioni colpite da calamità naturali: campi di San
Felice d’Ocre e Poggio Roio ( terremoto dell’Aquila);
ha garantito assistenza sanitaria (PMA), psicologica
dopo il terremoto di Haiti e ha effettuato attività
ambulatoriale, riabilitativa, interventi chirurgici
ortopedici e ginecologici gestendo l’ospedale da
campo con 12 posti letto nei campi di Loganne e
Darbonne; ha svolto attività di soccorso in mare a
Lampedusa; ha gestito un campo di extracomunitari a
Bonporto (Mo).
DISCUSSIONE
Grafico 1 maxincidente: si riporta solo parzialmente
la curva del triage che mostra l’arrivo dei 5 politraumi
20 min. dopo l’allertamento del PS da parte del 118.
La freccia nera (entrambi i grafici) alle ore +2, indica
la disattivazione del PEIMAF.
MAXIEMERGENZAOVERCROWDING
REGGIO EMILIA
1) F. Marino; 2) S. Badiali; 3) A. Gabrieli; 4) E. Vitali
1) Dipartimento Chirurgie Specialistiche Piastra
Operatoria AOUI S.Anna Ferrara; 2) Dipartimento
Emergenza AUSL Bologna; 3) Dipartimento di Anestesia
e Terapia Intensiva AOUI Verona; 4) Pronto Soccorso e
Med. d’Urgenza AOUI S.Anna Ferrara.
OBIETTIVO
Analizzare la risposta sanitaria, con attivazione
PEIMAF, del Pronto Soccorso della Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia per due eventi di
maxiemergenza: incidente stradale 2010 e
overcrowding 2012. Le risposte sono state
confrontate con la rispettiva attività media di base e
l’organizzazione PEIMAF per verificare se le soluzioni
adottate siano state coerenti alle circostanze.
MATERIALI E METODI
Revisione della letteratura internazionale su PubMed
per MeSH terms. Analisi retrospettiva per gli eventi.
Dati elaborati per 122 utenti (incidente) e 185
(overcrowding):
orari
di
triagetrattamento
dimissione; codici di priorità; dati di attività media
del Pronto Soccorso.
RISULTATI
1. Incidente stradale (grafico 1): PEIMAF livello 1 (4
cod rossi, 5 gialli). Dimostrato aumento delle
risorse per il trattamento dei politraumi; blocco
dei codici verdi in attesa; dimostrato aumento
delle dimissioni per diminuire il carico di lavoro
nell’area trattamento
2. Overcrowding: (grafico 2) PEIMAF livello 2 (6
cod rossi, 8 gialli) e impossibilità di ricovero per
mancanza di posti letto.
Dimostrato aumento delle dimissioni per
diminuire il carico di lavoro nell’area trattamento.
L’attivazione PEIMAF ha permesso il ripristino
della ricettività ospedaliera di reparto in circa due
ore, e la miglior assistenza ai codici rossi e gialli.
Il grafico 1 esprime chiaramente l’opposto
andamento tra il triage dei pazienti evento e il
trattamento: tutte le risorse sono state indirizzate
alle 2 shock room e il blocco della presa in carico dei
codici di gravità minore hanno determinato una netta
diminuzione del numero di pazienti trattati/tempo. Si
evidenzia piuttosto un aumento delle dimissioni, il cui
razionale è diminuire il carico assistenziale in
gestione.
Grafico 2 Overcrowding: il risultato più importante
dell’azione del PEIMAF, non si ritrova nella curva del
trattamento, che rimane stazionaria, piuttosto su
quella della dimissione, indice di un’azione mirata a
diminuire il carico di pazienti in trattamento, per
garantire più risorse ai codici ad alta priorità.
L’attivazione PEIMAF ha permesso il ripristino della
ricettività ospedaliera di reparto in circa due ore, e la
miglior assistenza ai codici rossi e gialli.
In entrambi i casi, la riorganizzazione delle risorse,
l’attivazione di personale reperibile e quanto stabilito
dal PEIMAF, in base al livello organizzativo e di
complessità di attivazione, determina una
concentrazione maggiore di risorse per i pazienti ad
alta criticità ed un modico ritardo per utenti a bassa e
media.
La strutturazione “plastica” di un Piano per Massiccio
Afflusso di Feriti (PEIMAF) e l’adeguata formazione
del personale sanitario, permette una risposta
assistenziale qualiquantitativa appropriata e
razionale all’evento destabilizzante.
NATIONWIDE PROGRAM OF EDUCATION
FOR UNDERGRADUATES IN THE FIELD OF
DISASTER MEDICINE: THE DEVELOPMENT OF
A BASIC CORE CURRICULUM CENTERED ON
BLENDED LEARNING AND SIMULATION
TOOLS.
1) L Ragazzoni, 1) PL Ingrassia, 1) M Tengattini, 1) L
Carenzo, 1) F Della Corte.
1) CRIMEDIM Research Center in Emergency and Disaster
Medicine. Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
– Novara – Italy.
In recent years, valid examples have been established
as effective models of disaster medicine curriculum
for medical school. However, only a small percentage
of medical schools worldwide have considered at
least some basic disaster medicine teaching in their
study program. In Italy, disaster medicine has not yet
been included in the medical school curriculum.
Perceiving the lack of a specific course on disaster
medicine, the Italian medical students' association,
contacted the research center CRIMEDIM with a
proposal for a nationwide program in this field. Six
modules (introduction to disaster medicine; pre
hospital disaster management; definition of triage;
characteristics of hospital disaster plans; treatment of
the health consequences of different disasters; and
presentation of past disasters) delivered using an e
learning platform and a 12hour classroom session,
which involved problembased learning activities,
tabletop exercises and a computerized simulation,
were designed as a framework for a basic disaster
medicine curriculum. From January 2011 to May
2013, 21 editions of the course in 21 different
medical schools were delivered and 524 students
attended the course. The blended approach and the
use of simulation tools were thoroughly appreciated
by all participants and successfully increased
participants’ knowledge and awareness of disaster
medicine. The authors reported on the designing
process and the initial outcomes with respect to
learners' achievements and satisfaction of a one
month educational course on the fundamentals of
disaster medicine. This experience might represent a
valid and innovative solution for a basic and lithe
disaster medicine curriculum for medical students,
easily deliverable by all medical schools.
EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF MOCK
VICTIM IN LIVE SIMULATION OF MASS
CASUALTY INCIDENT: THE PERCEPTION OF
MEDICAL STUDENTS.
1) L Ragazzoni, 1) PL Ingrassia, 1) L Carenzo, 1) F Della
Corte.
1) CRIMEDIM Research Center in Emergency and Disaster
Medicine. Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
– Novara – Italy.
Background: The live exercise is a well recognized
tool for educational, training and evaluative
purposes. It is a unique opportunity to evaluate
policies and guidelines; to train personnel in
emergency and crisis roles; and to test plans and
procedures and eventually improve them. Mock
victims play a key role having an impact on exercise’s
realism and its efficacy. Considering the event as an
educational purpose for mock victims, we ran a
complementary course for medical students about
live simulation of mass casualty incident (MCI) and
trained them in performing as smart victims. We
explored how medical students perceived their
knowledge of disaster management before and after
the simulation and their need in disaster education.
Selfevaluation of the educational module was also
carried out.
Methods: A 9items questionnaire rated on a 10
point Likert scale was delivered to medical students
before and after the live simulation. The survey
contained 3 demographic and 6 parallel items
designated to measure the perception of baseline
knowledge of the medical rescue chain in MCI, the
expectation for the efficacy in acquisition of disaster
management knowledge trough the participation as
smart victim and the confidence with the “learning by
doing” teaching methodology. Three additional
questions were included in the postevent
questionnaire to evaluate also participants’
satisfaction with the simulation and the whole
course. To assure confidentiality, students submitted
surveys anonymously. The data were analyzed for
statistical significance of preintervention to post
intervention change using the MannWhitney test.
Results: 112 and 102 medical students completed
preevent and postevent survey respectively.
Demographics are listed in Table 1. Before the
exercise, students scored their level of knowledge of
medical rescue chain in disaster and crises 6,05 [SD
1,69] and 7,07 [SD 1,25] (P < .001) after the live
simulation. The efficacy of participating in live
simulation to increase the knowledge of MCI
management was rated in the same way in pre and
postsimulation questionnaire (7,52 [SD 1,38], 7,64
[SD 1,31] respectively). The students perception of
importance of disaster medicine was graded
identically in pre and postsimulation questionnaire
(8,45 [SD 1,16], 8,43 [SD 1,04] respectively). There
were statistically significant changes in the student
comfort perception about their feeling as a mock
victim which increased from 7,61 [SD 1,53] to 8,08
[SD 1,33] (P < .05). The overall mean score of the
student satisfaction with the simulation was 7,19 [SD
1,48] and the appreciation of the entire learning
course was 8,48 (SD 1,14).
Conclusions: The live simulation appeared to have a
positive impact on medical students selfperception
to increase their knowledge in the medical
management of disasters. Students generally have
indicated very high expectations for the efficacy of
the participation as mock victims in a live simulation
in improving their disaster management knowledge.
These expectations also were met in practice as the
postevent survey confirmed. The students
considered disaster medicine relevant to their
professional worldviews and future related practices.
Finally the responders felt comfortable playing the
role of smart victims and they really appreciated
either the live simulation and the entire
complementary course.
COSTA CONCORDIA WRECKAGE JANUARY
2012: THE PREHOSPITAL PHASE OF LOCAL
MEDICAL RESPONSE.
1) PL Ingrassia, 2) L Ragazzoni, 2) G Sbrana, 3) V Chelli, 3) F
Ronchese, 2) P Aloia, 1) L Carenzo, 3) M Breggia, 1) F Della
Corte.
1) CRIMEDIM Research Center in Emergency and Disaster
Medicine. Università del Piemonte Orientale “A.
Avogadro”, Novara, Italy.; 2) Department of Anesthesia
and Intensive Care, Ospedale Della Misericordia, Grosseto,
Italy; 3) Emergency Department,
Misericordia, Grosseto, Italy.
Ospedale
Della
Costa Concordia was a cruise liner on duty in the
Mediterranean Sea since July 2006. It was able to
carry up to 3700 passengers and 1100 crew
members. On January 13th 2012 at 9.42 pm, Costa
Concordia, in calm seas and overcast weather, hit a
rock just a few meters from Isola del Giglio coastline
and stopped just in front of the small island. Isola del
Giglio is a small Italian island (25 km2) situated an
hour sail from Tuscany coastline, and is part of the
Province of Grosseto. During the first hour after the
impact, no rescue request arrived neither to EMS
dispatch center nor to coast guard. Only a few
citizens of the island called the Italian emergency
numbers speaking about "a boat in distress close to
the Isola del Giglio". Being worried about the "ship
accident" at 10.35 pm, about 60 minutes after the
incident, Grosseto dispatch center stopped a
secondary air medical transport from Grosseto
Hospital to Pisa University Hospital (about 40 minutes
flight) to keep available the only helicopter with
permission to fly over the sea. But it was only 25
minutes later, at 11.00 pm, about 1 hour and 20
minutes after the impact, that the severity of the
situation became clear, so the alarm was confirmed
and the local medical disaster plan was activated. As
soon as the Grosseto air medical crew landed on the
island, the first triage started according to the START
Triage method. It was immediately clear that the vast
majority of victims would have been tagged as
‘minor’, so the real challenge was precisely the
recognition of the few seriously injured patients
among the dramatic number of walking wounded. At
the beginning, the main objective of the medical
response was definitely the protection of all
shipwrecked victims from hypothermia. Two
advanced medical posts (AMP) were established on
the island using both a tent and a small first aid
station that is used during summer by EMS. These
AMPs served as a safety zone to perform triage and
as a warming area not only for critical patients who
were waiting for air medical evacuation, but also for a
lot of ‘minor’ victims. Four thousand and two
hundred persons disembarked from Costa Concordia,
307 of them requested medical care. One hundred
and ten, 3 T1, 16 T2 and 91 T3, were admitted to
Grosseto and Orbetello Hospital (a rural hospital on
the mainland in front of Isola del Giglio). T1 and T2
were transported by HEMS directly to Grosseto
Hospital. All T3 were transported to the nearest
harbour, Porto Santo Stefano, by a couple of
commercial ships where the third AMP was ready to
receive them. During the embarking from Giglio
Porto, all the casualties were retriaged by a couple
of nurses. As a consequence 2 T3 were reclassified to
T2 and evacuated by HEMS. At the AMP in Porto
Santo Stefano triage was performed again and all the
victims were confirmed T3. Most of them had small
trauma injuries, signs and symptoms of moderate
hypothermia or minor health problems. Fortyseven
were transferred to the Orbetello Hospital and 53 to
the Grosseto Hospital. On January 14th at 8.30 am,
the acute emergency phase was declared over. The
high probability to discover other victims inside the
ship, and the need to provide medical assistance to
all rescue technicians (mainly fire fighters and navy
special force SCUBA operators) imposed to leave on
the island a medical rescue team (1 emergency
physician and 1 nurse).
CONFRONTO TRA SCHEDA CARTACEA DI
RACCOLTA DATI E UN SISTEMA
INFORMATICO CON RFID E TRASMISSIONE
WIFI DURANTE UN INCIDENTE MAGGIORE.
IL TIPO DI RACCOLTA DATI INFLUISCE SUL
RISCHIO DI DISPERSIONE DELLE
INFORMAZIONI CLINICHE?
1) E. Vitali , 2) S. Badiali , 3) A. Cucchi
1) Azienda OspedalieraUniversitaria S.Anna –Ferrara, 2)
Azienda USL Citta di Bologna, 3)Università di Ferrara
Introduzione: La gestione di un grande numero di
feriti è una situazione ad elevato impatto emotivo
per i soccorritori. L'errata trasmissione di
informazioni attraverso le varie fasi del soccorso
aumenta il rischio clinico per le vittime. La scarsa
conoscenza del sistema di raccolta dati o le sue
particolari caratteristiche tecniche sono una della
cause .
Obiettivo: questo studio confronta due sistemi di
raccolta dati, uno cartaceo e uno informatizzato , e
valuta la dispersione delle informazioni rispetto ai
sistemi riceventi (personale sanitario che opera sul
luogo dell’evento, nel Posto Medico Avanzato e
negli ospedali di destinazione).
Metodi: abbiamo sviluppato uno studio caso
controllo che confronta il sistema cartaceo di Triage
usato dalla Protezione Civile e un sistema informatico
che utilizza come supporto un tablet 9 pollici con
software dedicato (SAT Triage @) completo di RFID,
touchscreen, con connessione WiFi. L'esercitazione
è stata preceduta da una fase di addestramento
all’utilizzo di entrambi i sistemi di raccolta dati
coinvolgendo un gruppo di medici e infermieri che
lavorano nel Servizio 118. I parametri utilizzati come
indicatori di rischio clinico sono state: esecuzione del
Triage, step di valutazione ABCDE secondo ATLS, e la
corretta destinazione delle vittime . I dati raccolti
sono stati analizzati utilizzando il test esatto di Fisher
con il 95% intervalli di confidenza .
Risultati: 61 vittime sono state assegnate in modo
casuale a due squadre: 30 per il sistema RFID con
tablet (Team RFID), 31 per il sistema cartaceo ( Team
Carta).
La valutazione di esecuzione Triage era
significativamente migliore per il Team RFID rispetto
al Team Carta (100% v / s 80,6, p <0,02). La stessa
connessione positiva è stata trovata per la
valutazione delle vie aeree ("Team RFID 100% v / s
64,5, p <0,0003), Attività respiratoria (" Team RFID
"86,6% v / s" Team Carta "61, 2, p <0,04) e Circolo
("Team RIFD" 80% v / s "Team Carta" 51,61%, p
<0,03). I dati relativi alla destinazione dei pazienti era
significativamente migliore ("Team RFID" 73,3% v / s
"Team Carta" 19,3%, p <0,001).
Conclusione: in una esercitazione con molti feriti,
l'uso di un supporto informatico
RFID con
trasmissione WiFi dei dati garantisce una minore
dispersione delle informazioni sanitarie, una
maggiore correttezza di trasmissione lungo la catena
del soccorso e consente una riduzione del rischio
clinico per le vittime.
RFID=radio frequency identification
ATLS=Advanced Traumatic Life Support
Dalla celeste Aida al rischio NBCR:
l’integrazione della tossicologia clinica nel
piano di maxiemergenza del DEA di Verona.
M. Zannoni, , A. Rigatelli, E. Vallaperta, G. Mazzone, F.
Rossi, S. Saronni, A. Rossignoli, A. Papini, G. Ricci
U.O. Pronto Soccorso Dipartimento di Emergenza
Urgenza, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona Verona (VR)
Sempre più di frequente, in particolar modo nelle
grandi città, si verificano eventi che aggregano un
elevato numero di persone. La gestione ottimale di
eventi di massa richiede adeguata conoscenza del
territorio ed analisi del rischio, la predisposizione
degli interventi di risposta con periodico
addestramento del personale coinvolto. Inoltre, per
gestire al meglio l’evento di massa si prediligono aree
servite da idonee vie di afflusso e deflusso dove
disporre adeguatamente mezzi e personale in base
all’evento. Un recente rischio per tali manifestazioni
è la possibilità che si verifichino eventi non
convenzionali anche intenzionali. Nel corso degli anni
gli eventi di massa che si svolgono in Verona sono
aumentati, associandosi all’annuale Festival Lirico
Areniano, e anch’essi tendono ad essere collocati
nell’anfiteatro romano di indiscusso pregio scenico
capace di contenere fino a 22.000 spettatori in pieno
centro storico. La nomea internazionale del festival
lirico richiama turisti ed appassionati che sempre più
spesso vengono solo per assistere all’opera
ripartendo subito dopo. La città di Verona, poi,
seppur non gravata da grandi aree ad elevato rischio
industriale, si collocata all’incrocio di importanti assi
stradale e ferroviario del nord Italia con elevato
rischio di incidenti con sostanze pericolose. Tali
peculiarità ci hanno indotto a prestare particolare
attenzione all’aspetto non convenzionale per la
stesura del piano d'emergenza per il massiccio
afflusso di feriti (P.E.I.M.A.F.). Abbiamo pertanto
integrato il piano coinvolgendo la Unità di
Tossicologia Clinica dell’A.O.U.I. – Verona che svolge
attività di consulenza tossicologica h 24 , 7 giorni su 7,
per presidi ospedalieri e 118 nella provincia di
Verona. L’unità è composta da personale con
formazione specifica in Tossicologia, e sostanze
pericolose (Hazardous Material), che anche opera
quotidianamente nel DEA. Riteniamo importante, in
caso di sospetto evento non convenzionale, che la
precoce disponibilità del consulente tossicologo
aumenti la sensibilità nel riconoscere le sindromi
tossicologiche evitando, come già accaduto in
passato, ritardi nell’ identificazione del tossico. Avere
a disposizione questo tipo di integrazione comporta
anche altri vantaggi. Contribuisce ad inquadrare la
tipologia dell’evento sin dalle fasi iniziali dell’allarme
quando spesso le informazioni giungono da quanti si
presentano al DEA nonostante gli sforzi per
contenere i pazienti nel luogo dell’evento. Altro
vantaggio è di sovrintendere la fase tossicologica
della risposta, momento delicato in cui il personale
adotta procedure particolari in una fase caotica. Non
bisogna scordare la fase terapeutica con ottimale
gestione della scorta antidotica nel DEA ma anche sul
luogo dell’evento. Punto di forza dell’integrazione
dell'Unità di Tossicologia Clinica nel PEIMAF è la
riduzione del rischio di contaminazione secondaria
del DEA grazie al riconoscimento precoce di quei
pazienti che, sfuggiti alla zona filtro, si recano
autonomamente al PS. La maxiemergenza è una
situazione in cui le normali capacità operative del
DEA ma anche di tutto l’ospedale cambiano
radicalmente ingenerando caos e ansia con facilità
all’errore. Un evento NBCR indubbiamente amplifica
questo disordine. La presenza, sul posto, di personale
con formazione tossicologica che anche conosce le
possibilità logistiche così come le modalità operative
del DEA offre l’indiscusso vantaggio, rispetto a
qualsiasi miglior consulenza tossicologica a distanza,
di migliorare la gestione dell’evento.
HOSPITAL EVAC: FORMAZIONE DI
PERSONALE SANITARIO SU PROCEDURE
SANITARIE, TECNICHE E MATERIALI IN CASO
DI EMERGENZA
1) M. Zannoni, 1) P. Tommasi, 1) F Di Prisco, 1) M. Manega,
1) R. Ronca, 1) M. Santamaria, 1) S. Sempreboni, 2) C.
Giuliari, 1) G. Zanetti, 1) C. Pistorelli
1) U.O. Pronto Soccorso Dipartimento di Emergenza
Urgenza, 2) Servizio di Prevenzione e Protezione, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Verona (VR)
L’evacuazione di un ospedale, per l’alta densità di
persone (pazienti, visitatori e personale) nonché le
particolari caratteristiche dei soggetti coinvolti spesso
non autosufficienti o non deambulanti richiede un
notevole impegno organizzativo. Il successo deriva da
pianificazione con analisi e riduzione del rischio,
mezzi di contenimento dell’evento e conoscenza dei
comportamenti in fase di emergenza cui
necessariamente segue la fase di formazione e
simulazione periodica. E’ però possibile che il
personale deputato all’evacuazione di pazienti ma
anche feriti, debba operare in un ambiente
gravemente evolutivo che non consenta l’uso di
barelle, letti o carrozzine e delle normali vie di fuga
ed evacuazione. Altra evenienza è che il personale
sanitario non possa intervenire se privo di particolari
dispositivi di protezione individuale (DPI). Ritenendo
quindi inderogabile un’adeguata formazione in tal
senso, dalla fine del 2011 è stato istituito, presso la
nostra azienda, il corso Hospital Evac. Scopo del
progetto è formare adeguatamente il personale, delle
unità di degenza e dei servizi, ad intervenire in
situazioni limite utilizzando particolari presidi di
trasporto e DPI idonei. Il corso, in collaborazione con
il Servizio di Prevenzione e Protezione e del
Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza
Aziendale ai sensi del D.Lgs 81/08, si articola su più
edizioni annuali ed è tenuto dal personale del Pronto
Soccorso. La didattica verte sulla conoscenza e
formazione all’utilizzo di procedure sanitarie,
tecniche, dispositivi e materiali da utilizzare in caso di
evacuazione sanitaria di emergenza. Lezioni frontali
illustrano il sistema di allarme aziendale ed i sistemi
di comunicazione radio, le tecniche di triage rapido
per eventi maggiori e le relative manovre di apertura
delle vie aeree e controllo delle emorragie, i DPI ed i
presidi di trasporto in caso di evacuazione. Segue la
fase di training all’impiego di quanto illustrato con
particolare enfasi al corretto utilizzo dei presidi. Gli
allievi hanno modo di familiarizzare ed imparare ad
usare
correttamente
attrezzature
come
ricetrasmittenti, tute di protezione, maschere facciali
con filtri chimici, giubbetti ad alta visibilità, teli
portaferiti, barelle cucchiaio, materassi a depressione
e sedie da evacuazione. Considerata la tipologia e
particolarità delle attrezzature, la fase di training
viene svolta con un rapporto istruttore/discenti
elevato (1:3, 1:4), questo per garantire che l’allievo
impari il corretto impiego ed utilizzo ma, cosa molto
più importante, i limiti di presidi e DPI. Il corso
prevede infine la simulazione real size, sempre con la
supervisione ed assistenza del tutor, di una
evacuazione: lo scenario riproduce un ambiente
gravemente evolutivo derivante da incendio o sisma
con rischio chimico relativo. Dall’inizio del progetto
ad ora abbiamo formato circa 100 dipendenti, medici
e non, di entrambi i poli aziendali con ritorno
entusiastico da parte dei discenti. Anche se
l’intervento in ambiente ostile spetta a personale
tecnico quali i Vigili del Fuoco, riteniamo importante
che il personale ospedaliero venga formato al
corretto utilizzo di presidi d’emergenza. Questo se da
un lato consente che il personale sanitario agisca con
l’adeguata sicurezza prevista dalla vigente normativa,
dall’altro permette di mantenere professionalità
dell’intervento e sicurezza del paziente pur operando
in presenza di eventi evolutivi complessi.
Scarica