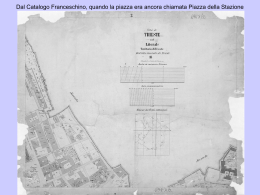La piazza dell’Isolotto dal 1954 al futuro per l’Assemblea della Comunità dell’8 settembre 2013 La vicenda Ina casa nel villaggio Isolotto a Firenze parte dalla legge Fanfani, cui seguono gli espropri dei terreni, ricchissimi di attività, gli orti, i campi, le discariche che davano lavoro a spazzaturai e cernitori, e di antichi manufatti rurali, l' avvio dei cantieri, fino alla consegna dei 1.600 nuovi alloggi (9 mila vani). Mentre dappertutto si puntava sui casermoni e, anche a Firenze, in seguito, prenderà piede un' architettura di tipo solo funzionale, all' Isolotto, ispirandosi piuttosto al modello delle new towns inglesi, si fanno case vernacolari, piccole, basse, aperte, diverse l' una dall' altra, che facilitano le relazioni, i contatti, e subito una piazza, una chiesa, un portico. Anche i materiali, i colori, e il verde che «cuce» le parti dell' edificato, richiamano l' antico paesaggio, e insomma l' immagine finale è quella di una «città nella città», dove, come diceva La Pira (e prevedeva lo stesso piano dell' Ina casa), «rapporti sociali e convivenza dovevano essere i primi risultati da ottenere». E se è vero che ancora per anni mancheranno servizi cruciali - bus, scuole - sarà proprio la forte mobilitazione per ottenerli, a cementare la coesione sociale, a tutt' oggi valore aggiunto dell' Isolotto. Dettaglio della planimetria di progetto della Piazza dell’Isolotto Centro del quartiere, la piazza è in prossimità dell'Arno e in corrispondenza con la Passerella, il ponte pedonale che porta alle Cascine. Su un lato ci sono i portici, con vari negozi; sull'altro la strada (Viale delle Magnolie) e al centro la pensilina sotto la quale si tengono il mercato e le celebrazioni della Comunità di Base dell'Isolotto. Dalla parte opposta al fiume si trova la chiesa. Confluiscono in piazza il Viale delle Magnolie (strada principale dell'Isolotto in direzione nord-sud) con il suo ideale proseguimento, la passerella; il Lungarno dei Pioppi e la parallela Via dei Ligustri; l'asse pedonale anch'esso parallelo all'Arno, costituito dal Viale dei Bambini e dal Viale dei Pini. Sul lato opposto ai portici (lato ovest) si ergono i cosiddetti "Grattacieli", edifici a 6 piani progettati da Fagnoni. Messa in piazza Messa in piazza Festa 1° maggio Incontro in piazza tra la Comunità dell’Isolotto e la Comunità Rom La piazza di fronte alla chiesa Il mercato quotidiano I portici La «piazza piccola» – parcheggio A piazza oggi, vista dall’alto 2003 – progetto dell’arch. Franca Vannoni 2003 – progetto dell’arch. Franca Vannoni 2003 – progetto dell’arch. Franca Vannoni Idee in Piazza – 15 luglio 2013 – primo incontro indetto dal Quartiere 4 e dal Comune di Firenze per raccogliere idee sulla riprogettazione della piazza dalla popolazione • Le piazze delle città italiane rappresentano i luoghi privilegiati per lo studio dello sviluppo urbano di un determinato centro, non solamente dal punto di vista urbanistico ma anche da quello economico, sociale, funzionale e rituale. Storicamente infatti la piazza è definibile come uno spazio d’uso pubblico e di significativa qualità architettonica e urbanistica, centro di convergenza o baricentro di un determinato territorio urbano. La piazza centrale o il sistema di piazze che costituiscono il cuore della città costituisce di per sè il luogo prescelto della rappresentazione della centralità della presenza delle pubbliche istituzioni, civili e religiose, perchè è delimitata dai principali monumenti cittadini in cui si incarnano le più significative memorie storiche e ogni privilegiata funzione pubblica. La piazza è luogo di riunioni, di spettacoli, di prediche, di cerimonie, di processioni, nonchè il luogo privilegiato dello scambio e dell’attività commerciale, del contatto della comunità con il mondo esterno, dell’informazione in quanto simbolo materializzato della storia pubblica di quella comunità. Pertanto dal punto di vista culturale storico, scientifico, le piazze prodotte nell’ambito della cultura urbana dell’Occidente costituiscono lo spazio formale della comunità insediata, il nucleo spaziale ove si realizza l’intersezione di storia civile, movimenti culturali, tendenze artistiche, cultura materiale, immaginazione collettiva, proiezioni simboliche, ritualità consolidate, tradizioni popolari e consuetudini comportamentali. (cfr. C. Dardi, Place d’Italie, in “Agorà”, n.1, Roma 1987). Per tutti questi motivi e per altri a questi intrecciati la piazza costituisce uno degli elementi focali all’interno della storia degli insediamenti nel loro complesso. La sconfinata campionatura e la variegata complessità delle piazze d’Europa, quale si è venuta configurando nel corso del suo ultimo millennio di storia, emerge in tutta evidenza quale significativa ed operante presenza strettamente interconnessa con la storia delle città europee e con la storia stessa d’Europa. • La piazza costituisce il nucleo stesso della civiltà urbana. Nel Rinascimento la piazza si sovrappone al tessuto urano, determinando ambiti geometrici che individuano un’immagine legata alla “nuova” civiltà. Mentre nei secoli XVIII e XIX il “decoro” e la ricerca dell’immagine tendono a sostituirsi alla funzione e la piazza assume il ruolo scenico di valorizzazione di un edificio laico o religioso, facendo prevalere la rappresentazione della scena urbana del concetto di socialità. Si tende cosi a riproporre la sovrapposizione individuata dalla piazza rinascimentale, accentuandone una spiccata ricerca scenografica, legata a vere e proprie sistemazioni estetiche della città. Nella seconda metà del secolo XIX compare, vicino alla componente estetica, la necessità di dare ordine al movimento dei veicoli che iniziano l’invasione dello spazio urbano. La piazza perde, allora, la sua funzione aggregatrice di vita collettiva per divenire centro e fulcro di direttrici di movimento, prodromo di gran parte dell’architettura del XX secolo. Ogni significato della piazza ha perso di univocità, come una strada, è una delle articolazioni possibili dello spazio pubblico e la ricerca di una vita sociale si trasforma generalmente in qualcosa di molto simile alla piazza-mercato, immagine di un centro di scambi e commercio, un luogo in cui si arriva, si parcheggia facilmente e all’interno del quale ci si muove per fare acquisti, guardare, divertirsi. Accanto a questo modello trovano una loro specificità altri tipi di piazza, come la piazza-giardino, dei quartieri residenziali e la piazzacelebrativa costruita intorno d un monumento o ad una funzione pubblica, ultimo baluardo di una concezione aulico-classica del secolo scorso
Scarica