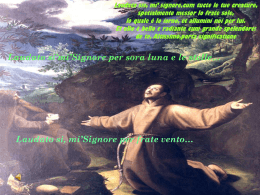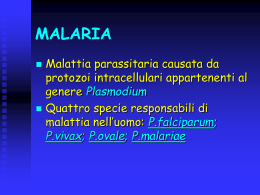Riflessioni sulla natura proposte alla classe 5^D figurativo per l’attività di discipline pittoriche e per il progetto “Barbiana è qui” dalla prof. Santina Tagliati come organismo vivente e luogo simbolico 6 – 10 – 17 – 20 – 26 – 32 Come proiezione del paesaggio interiore 9 – 19 - Come problema ecologico 7 – 8 – 13 – 14 – 21 – 29/30 NATURA Come riflessione sulla storia e sulla tecnologia 16 – 22 – 23/24/25 – 27/28 – come occasione per il ricordo come riflessione sulla vita e ritorno a Dio 5 – 15 –33 – 35 3 – 4 – 11/12 – 18 – 31 – 34 Trasaliscono i monti al soffio lieve Endecasillabi sciolti Trasaliscono i monti al soffio lieve del respiro serale, e rabbrividendo si velano d’un velo di viola che si vena d’un tremulo affiorare d’oro, nel verde argenteo del tuo cielo. 5 Dove tu stendi l’eccitata luce delle tue prospettive, ivi t’innalzo, dal mio segreto fremito, l’offerta di questo breve tempo della terra, ch’è il ritmo del mio petto, ove mi parli. 10 Dagli spazi lucenti, sulla soglia della notte, al fiorir delle tue stelle, trasaliscono i monti, in un respiro che rassomiglia al mio, nel dolce suono del tempo di quaggiù, che d’uomo ha il canto 15 e di terra la forma e la speranza. Arturo Onofri (1885 – 1928) 4 – 5 tutte le cose sembrano svanire nella pura melodia coloristica del cielo 6 – 7 la luce del tramonto allude a prospettive nuove, a spazi interinati 9 – 10 il ritmo vitale del mondo si raccoglie in quello del cuore umano, aperto alla voce di Dio Nel terreno umido delle rive Il salice grigio, tremulo, il pioppo ibrido, già bianco già nero, e più in là l’olmo minore, l’acero campestre e gelsi, cespugli. E più giù, di radice in radice, giungo alla radice di tutte le cose. E penso a come sacra è questa unione. E più su un diffondersi vivo nell’aria, un guardare in posizione d’ascolto. E, ascoltando, con lei vado che fa brillare di quiete le cose, che fa tornare allo splendore le distrutte. Vittorio Cozzoli La poesia è tratta dalla raccolta “La splendida luce” edita nel 1992 Vittorio Cozzoli ha lasciato l’insegnamento nel 1999 per dedicarsi all’attività di poeta e scrittore Traversando la Maremma toscana Dolce paese, onde portai conforme l’abito fiero e lo sdegnoso canto e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme, pur ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto. 1 Onde portai conforme: dal quale ho tratto simile a te 2 l’abito fiero… canto il carattere severo, l’ispirazione poetica che rifiuta ogni compromesso 3 il petto: il cuore;s’addorme: si addormenta 4 pur ancora 5 le usate forme le immagini consuete e familiari 7 in quelle riferito a forme Ben riconosco in te le usate forme con gli occhi incerti tra ‘l sorriso e il pianto, e in quelle seguo de’ miei sogni l’orme erranti dietro il giovanile incanto. Oh, quel che amai, quel che sognai, fu invano; e sempre corsi, e mai non giunsi il fine; e dimani cadrò. Ma di lontano pace dicono al cor le tue colline con le nebbie sfumanti e il verde piano ridente ne le piogge mattutine. Giosuè Carducci (1835 – 1907) 8 erranti… incanto erranti riferito a orme: i sogni del poeta inseguono le illusioni della giovinezza 10 giunsi raggiunsi 11 cadrò morirò 13 Nebbie sfumanti che sfumano all’alba verde piano la pianura Notturno [frammento 58D] Dormono le cime dei monti e gli abissi e le colline e le valli e tutte le stirpi degli animali che la nera terra nutre, e gli animali feroci che abitano sui monti e le api e i pesci nella profondità del mare di colore azzurro scuro; e gli uccelli dalle ampie ali. Alcmane VII sec. a. C. Trad. dal greco di B. Panebianco L’arca di Noè Un volo di gabbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte nella notte una stella d’acciaio confonde il marinaio; strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini, la luna è piena di bandiere senza vento, che fatica essere uomini! Partirà, la nave partirà dove arriverà, questo non si sa sarà come l’arca di Noè: il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia il suo cuore perde cherosene, a ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca; una città si è perduta nel deserto la casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini! Partirà, la nave partirà dove arriverà, questo non si sa sarà come l’arca di Noè: il cane, il gatto, io e te. Canzone di Sergio Endrigo presentata a Sanremo nel 1970 Chico I signori della morte hanno detto sì, l’albero più bello è stato abbattuto, Canzone dei NOMADI tratta dall’album “Le strade, gli amici, il concerto” del 1997 i signori della morte non vogliono capire, non si uccide la vita, la memoria resta. così l’albero cadendo, ha sparso i suoi semi e in ogni angolo del mondo, nasceranno foreste. ma salvare le foreste vuol dire salvare l’uomo, perché l’uomo non può vivere tra acciaio e cemento, non ci sarà mai pace, mai vero amore, finchè l’uomo non imparerà a rispettare la vita. per questo l’albero abbattuto non è caduto invano, cresceranno foreste e una nuova idea dell’uomo. Ma lunga sarà la strada e tanti gli alberi abbattuti, prima che l’idea trionfi, senza che nessuno muoia, forse un giorno uomo e foresta vivranno insieme, speriamo che quel giorno ci sia ancora. Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico morto per gli indios e la foresta, ricordati di Chico. La canzone ricorda la lotta contro l’abbattimento degli alberi nella foresta amazzonica e la morte del sindacalista Chico Mendes O falce di luna calante 1 falce di luna la luna all’ultimo quarto O falce di luna calante 2 su… deserte sulle acque senza imbarcazioni che brilli su l’acque deserte, 3 messe mietitura o falce d’argento, qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 5 aneliti respiri 6 sospiri profumi come fruscii 7 esalano al mare vanno verso il mare 10 il popol de’ vivi s’addorme tutti gli esseri viventi si addormentano Aneliti brevi di foglie, sospiri di fiori dal bosco esalano al mare: non canto non grido non suono pe ‘l vasto silenzio va. Oppresso d’amor, di piacere, il popol de’ vivi s’addorme… O falce calante, qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore qua giù Gabriele D’Annunzio da “Canto Novo” 1882 Corrispondenze È un tempio la Natura ove viventi pilastri a volte confuse parole mandano fuori; la attraversa l’uomo tra foreste di simboli dagli occhi familiari. I profumi e i colori e i suoni si rispondono come echi lunghi che di lontano si confondono in unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte ed il chiarore. Esistono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come gli oboi, e verdi come praterie; e degli altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l’espansione propria alle infinite cose, come l’incenso, l’ambra, il muschio, il benzoino, e cantano dei sensi e dell’anima i lunghi rapimenti. Charles Baudelaire da “I fiori del male” 1857 1-2 è un tempio…parole la Natura è un tempio e, agli occhi del poeta, gli alberi si trasformano in colonne, che lasciano intuire misteriose rivelazioni 3-5 la attraversa…familiari l’uomo vive ignaro in una realtà di cui è compartecipe ma che allude a qualcosa di misterioso 5-9 i profumi … chiarore fra le sensazioni esistono delle corrispondenze che, come echi che svaniscono lontano, si confondono e diventano una cosa sola 15 l’incenso… muschio l’incenso è una resina profumata, l’ambra è una sostanza animale utilizzata per i profumi, il muschio è una sostanza aromatica 16 benzoino è una pianta originaria della Malesia dalla quale si ottiene una resina balsamica nota come incenso di Giava Se la materia della terra, l’acqua, i soffi leggeri dei venti, i vapori brucianti del fuoco, la cui unione costituisce il nostro universo, sono tutti formati da una sostanza soggetta alla nascita e alla morte, bisogna ben pensare che lo stesso valga per l’insieme del mondo. Qualsiasi composto, di cui vediamo le parti e le membra formate da una sostanza soggetta a nascere e da elementi mortali, ci appare allo stesso modo sottomesso alle leggi della nascita e della morte. Quando, considerando le membra gigantesche e le parti di questo mondo, le vedo morire e nascere, non posso dubitare che anche il cielo e la terra non abbiano avuto la loro prima ora e non debbano soccombere un giorno. Non credere che io abbia snaturato i fatti a mio vantaggio, quando ho preteso che la terra e il fuoco sono di natura mortale, quando ho affermato con sicurezza che l’acqua e l’aria sono periture, e che queste stesse sostanze nascono e crescono di nuovo. In primo luogo, una parte non trascurabile della terra, calcinata dall’ardore incessante del sole, calpestata da infinite moltitudini, esala nugoli di polvere, nubi dal volo leggero, che il potente soffio del vento dissipa in tutta l’atmosfera. Un’altra parte delle zolle è diluita dalle piogge, e le rive dei corsi d’acqua sono rose dalla corrente che le leviga. Ogni corpo che la terra nutre e fa crescere, rende alla terra la parte ricevuta. Se sembra fuori dubbio ch’è insieme la madre di tutte le cose e la loro tomba comune, vedi dunque che volta per volta essa si esaurisce, si rinforza e cresce. Ma non è necessario dire che le nuove onde affluiscono senza tregua verso il mare, i fiumi, le sorgenti, che le acque sgorgano in un flusso inesauribile : l’immensa quantità di acque che cadono da ogni parte, lo prova a sufficienza. Le acque si sperdono nella misura della loro formazione, tanto che, nell’insieme, da nessuna parte l’elemento liquido trabocca. I venti, spazzando il mare col loro soffio potente, e il sole etereo, aspirando con i nuovi raggi, ne diminuiscono il volume; un’altra parte si distribuisce ovunque sotto terra dove si infiltra e deposita i suoi veleni, poi l’elemento liquido, ritornando sui suoi passi, risale verso la sorgente dei fiumi dove si riunisce; e di là il suo flutto, addolcito, scorre e cammina alla superficie del suolo, seguendo la via scavata un tempo, che scende lungo la marcia limpida delle onde. Passiamo all’aria, che in tutta la sua sostanza subisce a ogni istante innumerevoli mutamenti. Sempre ogni emanazione dei corpi è trasportata tutta intera nel vasto oceano dell’aria; e se questo non restituisse alle cose altri elementi per rimediare alle loro perdite, da molto tempo tutto sarebbe disciolto e convertito in aria. Essa non smette quindi di essere generata a spese dei corpi e di risolversi in essi: tutto – è chiaro – è in un flusso perpetuo. Periture: destinate a morire calcinata: sgretolata, come calce dissipa: disperde il sole etereo:secondo gli antichi gli astri erano immersi in uno spazio limpido e purissimo chiamato etere da Lucrezio “La natura” trad. di O. Cescatti, Milano, Garzanti 1975 Continua alla pagina seguente Allo stesso modo, questa grande sorgente della limpida luce, il sole etereo, bagna il cielo con un chiarore che rinasce senza sosta e alimenta la luce sempre nuova. Ognuno dei suoi raggi si perde, appena formato, in qualsiasi luogo cada. E infatti quando una nuvola viene a passare sotto il sole, interrompendo il cammino dei raggi luminosi, subito la parte inferiore di questo sparisce interamente, e la terra si copre d’ombra dovunque si porta la nuvola. Vedi così che le cose hanno continuamente bisogno di una nuova illuminazione che i getti di luce muoiono nella misura in cui si formano; sarebbe impossibile scorgere gli oggetti al chiarore del sole, se questo chiarore non fosse incessantemente rinnovato dalla sua stessa fonte. Anche le nostre luci notturne, che sono d’origine terrestre –queste lampade sospese, queste grosse torce, che mescolano al chiarore delle luci intermittenti nero e spesso fumo – si affrettano ugualmente con le risorse delle loro fiamme, a rinnovare senza tregua la luce; i fuochi tremanti si accalcano, e malgrado la loro intermittenza, la luce non smette di bagnare ogni luogo: tanto tutti i fuochi si affrettano a dissimulare la morte della vecchia fiamma con la nascita rapida di una nuova. Allo stesso modo – secondo noi – il sole, la luna, le stelle devono inviarci la loro luce, con emissioni incessantemente rinnovate; le loro fiamme devono perdersi senza tregua nella misura in cui si formano. Non supporre quindi in loro un vigore che nessuna violenza potrà distruggere. Non vedi le pietre stesse soccombere agli assalti del tempo, le alte torri crollare, le rocce cadere in polvere? Non vedi i templi e le statue degli dei fendersi per la stanchezza dell’età, e la potenza divina incapace di respingere i limiti del destino, di lottare contro le leggi della natura? Non vedi forse i monumenti degli eroi rovinare, e invecchiare i bronzi e le pietre? Non vedi cadere, strappate alle alte montagne, masse di roccia incapaci di resistere ancora ai potenti sforzi per un tempo anche assai breve? Non si strapperebbero per cadere in un sol colpo, se da tutta l’eternità avessero potuto sostenere imperterrite gli assalti dei secoli. Considera questo vasto insieme che, tutt’intorno e al di sopra di noi, avvolge tutta la terra nella sua vasta stretta: se – come si dice – esso procrea tutte le cose dalla sua stessa sostanza, e le riceve dopo la sua morte, è costituito tutto da una materia soggetta a nascere e a perire. Qualsiasi sostanza che fornisce ad altri corpi degli alimenti per la crescita, deve subire delle perdite, e riformarsi, quando i corpi vi fanno ritorno. Getti di luce: raggi luminosi mescolano…spesso fumo:le torce bruciavano sostanze grasse che producevano denso fumo questo vasto insieme: l’universo da Lucrezio “La natura” trad. di O. Cescatti, Milano, Garzanti 1975 da Finale di Partita di Samuel Beckett Clov spinge Nagg in fondo al bidone, abbassa il coperchio CLOV (tornando al suo posto accanto alla poltrona) Se i vecchi sapessero! HAMM Sieditici sopra. CLOV Non posso star seduto. HAMM Già. E io non posso stare in piedi. CLOV Così è. HAMM A ciascuno la sua specialità. [pausa] Nessuna telefonata? [pausa] Non ridi? CLOV [dopo aver riflettuto] Non ci tengo. HAMM [come sopra] Neanch’io [pausa] Clov. CLOV Sì. HAMM La natura ci ha dimenticati. CLOV Non c’è più natura. HAMM Più natura! Adesso esageri. CLOV Nei dintorni. HAMM Ma noi continuiamo a respirare, a cambiare! Perdiamo i capelli, i denti! La nostra freschezza! I nostri ideali! CLOV E allora non ci ha dimenticati. HAMM Ma tu dici che non esiste più. “Alcuni problemi di ordine ecologico derivano infatti dalle nostre concezioni sbagliate sul modo di vivere. L’uomo occidentale crede di essere superiore agli altri e di avere il predominio su tutta la natura. L’uomo primitivo, invece, dipendeva dai prodotti della terra e viveva in stretto contatto con essa. Il suo rispetto per i processi biologici era talmente grande che identificò con alcune divinità le forze della natura. Come si può ancora osservare in certe religioni orientali, egli non si pone in concorrenza con la natura. Infatti entrambi appartengono alla stessa biosfera. Prendono, ma danno anche qualcosa. L’uomo moderno si è illuso di poter dominare tutti gli altri esseri viventi. Siamo ormai giunti a un punto tale che dal nostro ambiente prendiamo a man bassa senza mai restituire nulla. Con le nostre azioni irresponsabili assomigliamo a quei parassiti che uccidono l’ospite presso cui si sono installati firmando così la propria condanna. Noi siamo ospiti del pianeta Terra e dobbiamo renderci conto, al più presto, che occorre restituire alla Terra quello che essa ci dà. Dobbiamo capire una volta per sempre che non ci possiamo permettere il lusso di distruggere con i nostri sprechi e i nostri rifiuti questo sistema vitale. Basta dare un’occhiata a una qualsiasi città moderna per convincerci che la strada da percorrere per ritrovare un contatto con l’equilibrio naturale è assai lunga” J.Y. Cousteau Temporale Un bubbolio lontano… Rosseggia l’orizzonte, come affocato, a mare; nero di pece, a monte, stracci di nubi chiare: tra il nero un casolare: un’ala di gabbiano. Il lampo E cielo e terra si mostrò qual era: la terra ansante, livida, in sussulto; il cielo ingombro, tragico, disfatto: bianca bianca nel tacito tumulto una casa apparì sparì d’un tratto; come un occhio, che, largo, esterrefatto, Giovanni Pascoli dalla raccolta Myricae 1894 s’aprì si chiuse, nella notte nera. Il pioppo di Karlsplatz Un pioppo c’è, sulla Karlsplatz, in mezzo a Berlino, città di rovine, e chi passa per la Karlsplatz vede quel verde gentile. Nell’inverno del Quarantasei gelavano gli uomini, la legna era rara e tanti mai alberi caddero e fu l’ultimo anno per loro. Ma sempre il pioppo sulla Karlsplatz quella sua foglia verde ci mostra: sia grazie a voi, gente della Karlsplatz, se ancora è nostra. Bertolt Brecht (trad. F. Fortini) Paesaggio Il campo di ulivi s’apre e si chiude come un ventaglio. Sull’oliveto c’è un cielo sommerso e una pioggia scura di freddi astri. Tremano giunco e penombra sulla riva del fiume. S’increspa il vento grigio. Gli ulivi sono carichi di gridi. Uno stormo d’uccelli prigionieri che agitano lunghissime code nel buio. Federico Garcia Lorca S’aprono come foglie i giorni, pallidi come tendaggi ad uno ad uno spinti dal vento, dalla luce che cresce dietro ad essi o al loro interno, leggeri e curvi solo per essere ammirati. Valerio Magrelli da Nature e venature 1987 Lieve offerta Vorrei che la mia anima ti fosse leggera come le estreme foglie dei pioppi, che s’accendono di sole in cima ai tronchi fasciati di nebbia – Vorrei condurti con le mie parole ANTONIA POZZI (1912 – 1938) per un deserto viale, segnato d’esili ombre – fino a una valle d’erboso silenzio, al lago – ove tinnisce per un fiato d’aria il canneto e le libellule si trastullano con l’acqua non profonda – Vorrei che la mia anima ti fosse leggera, che la mia poesia ti fosse un ponte, sottile e saldo, bianco – sulle oscure voragini della terra. Autunno Autunno. Già lo sentimmo venire Nel vento d’agosto, nelle pioggie di settembre torrenziali e piangenti, e un brivido percorse la terra che ora, nuda e triste, accoglie un sole smarrito. Ora passa e declina, in quest’autunno che incede con lentezza indicibile, il miglior tempo della nostra vita e lungamente ci dice addio. Vincenzo Cardarelli Versi liberi Al mare (o quasi) L’ultima cicala stride sulla scorza gialla dell’eucalipto i bambini raccolgono pinoli indispensabili per la galantina un cane alano urla dall’inferriata di una villa ormai disabitata le ville furono costruite dai padri ma i figli non le hanno volute ci sarebbe spazio per centomila terremotati di qui non si vede nemmeno la proda Chi vuole respirare a grandi zaffate la musa del nostro tempo la precarietà può passare di qui senza affrettarsi è il colpo secco quello che fa orrore non già l’evanescenza il dolce afflato del nulla Hic manebimus se vi piace non proprio ottimamente ma il meglio sarebbe troppo simile alla morte (e questa piace solo ai giovani) Eugenio Montale (1896 – 1981) se può chiamarsi così quell’ottanta per cento ceduta in uso ai bagnini e sarebbe eccessivo pretendervi una pace alcionica il mare è d’altronde infestato mentre i rifiuti in totale formano ondulate collinette plastiche esaurite le siepi hanno avuto lo sfratto i deliziosi figli della ruggine gli scriccioli o reatini come spesso li citano i poeti E c’è anche qualche boccio di magnolia l’etichetta d’un pediatra ma qui i bambini volano in bicicletta e non hanno bisogno delle sue cure In questa, che è una delle ultime liriche di Montale (1976 ripubblicata l’anno dopo in Quaderno di quattro anni), si delinea nettamente l’immagine del poeta prigioniero della storia; ma non più di quella violenta e atroce della guerra o delle dittature, bensì di quella del grigiore avvilente della civiltà consumistica, banalizzante, ma soprattutto negatrice integrale della cultura e quindi dell’umano. Ritornano in scena cose e luoghi della precedente poesia montaliana, con un gusto di autocitazione che rende più evidente il nulla della vita attuale: la cicala, l’eucalipto, la villa, il mare, la magnolia. Tutti divengono emblemi d’una civiltà perduta, irta di contraddizioni, ma pur sempre migliore della vacuità totale dell’oggi. Tutto qui si svolge nel segno del volgare, della sporcizia e della precarietà, della totale assenza di rispetto per la natura e il vivere civile. 10 la proda la riva 14 una pace alcionica il tempo di pace sul mare, in settembre, quando gli alcioni nidificano (è forse un ironico ricordo della poesia di D’Annunzio) 15 infestato inquinato 22 l’etichetta intendi “c’è anche la targa” 25-30 Qui, dunque, si può respirare il cattivo odore che manda la musa del nostro tempo, la precarietà, che non significa soltanto rinuncia ai valori per mediocri interessi effimeri, ma anche incapacità, o meglio, non volontà di costruire qualcosa di solido e duraturo nella vita associata. Ne è riprova lo scempio che si fa della natura, senza pensare alle immancabili conseguenze che certo saranno vicine nel tempo. Ma gli uomini hanno orrore del colpo secco, cioè della morte ( o magari della guerra), non della dissolvenza lenta, dell’evanescenza che è il respiro (la manifestazione) del nulla, ma che per loro è dolce, in quanto non assume volti minacciosi. Il poeta si sente come travolto da una stupidità colossale, che mozza il respiro. 30-32 Hic manebimus riecheggia la frase classica “Qui resteremo ottimamente”!, caduta ormai in proverbio, e lo fa con evidente ironia; ma il sarcasmo maggiore consiste nell’affermare che questa gente non vuole il meglio, in quanto segnerebbe il crollo di questi falsi valori e di questa falsa civiltà, perché comporterebbe vita, azione, responsabili scelte e crollo di basse ma comode certezze. Una morte del genere potrebbe piacere solo ai giovani, che qui paiono assenti, perché questo mondo di falsità e conformismo è vecchio, di là da ogni considerazione dell’età di chi lo accetta. I FIUMI Cotici il 16 agosto 1916 Mi tengo a quest’albero mutilato Abbandonato in questa dolina Che ha il languore Di un circo Prima o dopo lo spettacolo E guardo Il passaggio quieto Delle nuvole sulla luna Stamani mi sono disteso In un’urna d’acqua E come una reliquia Ho riposato L’Isonzo scorrendo Mi levigava Come un suo sasso Ho tirato su Le mie quattro ossa E me ne sono andato Come un acrobata Sull’acqua Mi sono accoccolato Vicino ai miei panni Sudici di guerra E come un beduino Mi sono chinato a ricevere Il sole Questo è l’Isonzo E qui meglio Mi sono riconosciuto Una docile fibra Dell’universo Questo è il Serchio Al quale hanno attinto Duemil’anni forse Di gente mia campagnola E mio padre e mia madre. Il mio supplizio È quando Non mi credo In armonia Questo è il Nilo Che mi ha visto Nascere e crescere E ardere d’inconsapevolezza Nelle distese pianure Ma quelle occulte Mani Che m’intridono Mi regalano La rara Felicità Ho ripassato Le epoche Della mia vita Questi sono I miei fiumi Questa è la Senna E in quel suo torbido Mi sono rimescolato E mi sono conosciuto Questi sono i miei fiumi Contati nell’Isonzo Questa è la mia nostalgia Che in ognuno Mi traspare Ora ch’è notte Che la mia vita mi pare Una corolla Di tenebre Giuseppe Ungaretti Dalla raccolta L’Allegria MALARIA E’ vi par di toccarla colle mani - come dalla terra grassa che fumi, là, dappertutto, torno torno alle montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello incappucciato di neve - stagnante nella pianura, a guisa dell’afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la Puddara, che sembra navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera, e l’estate arsa, e vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell’autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra le rive larghe e abbandonate, bianche, slabbrate, sparse di ciottoli; e in fondo il lago di Lentini, come uno stagno, colle sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto pascolano svogliatamente i buoi, rari, infangati sino al petto, col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio della mandra, nel gran silenzio, volan via le cutrettole, silenziose, e il pastore istesso, giallo di febbre, e bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpebre gonfie, levando il capo all’ombra dei giunchi secchi. È che la malaria v’entra nelle ossa col pane che mangiate, e se aprite bocca per parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite mancar le ginocchia, o vi accasciate sul basto della mula che va all’ambio, colla testa bassa. Invano Lentini, e Francofonte, e Paternò, cercano di arrampicarsi come pecore sbrancate sulle prime colline che scappano dalla pianura, e si circondano di aranceti, di vigne, di orti sempre verdi; la malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate, e li inchioda dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, tremanti di febbre sotto il pastrano, e con tutte le coperte del letto sulle spalle. Laggiù, nella pianura, le case sono rare e di aspetto malinconico, lungo le strade mangiate dal sole, fra due mucchi di concime fumante, appoggiate alle tettoie crollanti, dove aspettano coll’occhio spento, legati alla mangiatoia vuota, i cavalli di ricambio. - O sulla sponda del lago, colla frasca decrepita dell’osteria appesa all’uscio, le grandi stanzucce vuote, e l’oste che sonnecchia accoccolato sul limitare, colla testa stretta nel fazzoletto, spiando ad ogni svegliarsi, nella campagna deserta, se arriva un passeggiero assetato. Oppure come cassette di legno bianco, impennacchiate da quattro eucalipti magri e grigi, lungo la ferrovia che taglia in due la pianura come un colpo d’accetta, dove vola la macchina fischiando al pari di un vento d’autunno, e la notte corruscano scintille infuocate. O infine qua e là, sul limite dei poderi segnato da un pilastrino appena squadrato, coi tetti appuntellati dal di fuori, colle imposte sconquassate, dinanzi all’aia screpolata, all’ombra delle alte biche di paglia dove dormono le galline colla testa sotto l’ala, e l’asino lascia cascare il capo, colla bocca ancora piena di paglia, e il cane si rizza sospettoso, e abbaia roco al sasso che si stacca dall’intonaco, alla lucertola che striscia, alla foglia che si muove nella campagna inerte. La sera, appena cade il sole, si affacciano sull’uscio uomini arsi dal sole, sotto il cappellaccio di paglia e colle larghe mutande di tela, sbadigliando e stirandosi le braccia; e donne seminude, colle spalle nere, allattando dei bambini già pallidi e disfatti, che non si sa come si faranno grandi e neri, e come ruzzeranno sull’erba quando tornerà l’inverno, e l’aia diverrà verde un’altra volta, e il cielo azzurro e tutt’intorno la campagna riderà al sole. E non si sa neppure dove stia e perché ci stia tutta quella gente che alla domenica corre per la messa alle chiesuole solitarie, circondate dalle siepi dei fichidindia, a dieci miglia in giro, sin dove si ode squillare la campanella fessa nella pianura che non finisce mai. Però dov’è la malaria è terra benedetta da Dio. In giugno le spighe si coricano dal peso, e i solchi fumano quasi avessero sangue nelle vene appena c’entra il vomero in novembre. Allora bisogna pure che chi semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perchè il Signore ha detto: “Il pane che si mangia bisogna sudarlo”. Come il sudore della febbre lascia qualcheduno stecchito sul pagliericcio di granoturco, e non c’è più bisogno di solfato né di decotto d’eucalipto, lo si carica sulla carretta del fieno, o attraverso il basto dell’asino, o su di una scala, come si può, con un sacco sulla faccia, e si va a deporlo alla chiesuola solitaria, sotto i fichidindia spinosi di cui nessuno perciò mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio, e gli uomini stanno a guardare, fumando. continua Così s’erano portato il camparo di Valsavoia, che si chiamava massaro Croce, ed erano trent’anni che inghiottiva solfato e decotto d’eucalipto. In primavera stava meglio, ma d’autunno, come ripassavano le anitre, egli si metteva il fazzoletto in testa, e non si faceva più vedere sull’uscio che ogni due giorni; tanto che si era ridotto pelle ed ossa, e aveva una pancia grossa come un tamburo, che lo chiamavano il Rospo anche pel suo fare rozzo e selvatico, e perché gli erano diventati gli occhi smorti e a fior di testa. Egli diceva sempre prima di morire: - Non temete, che pei miei figli il padrone ci penserà! - E con quegli occhiacci attoniti guardava in faccia ad uno ad uno coloro che gli stavano attorno al letto, l’ultima sera, e gli mettevano la candela sotto il naso. Lo zio Menico, il capraio, che se ne intendeva, disse che doveva avere il fegato duro come un sasso e pesante un rotolo e mezzo. Qualcuno aggiungeva pure: - Adesso se ne impipa! ché s’è ingrassato e fatto ricco a spese del padrone, e i suoi figli non hanno bisogno di nessuno! Credete che l’abbia preso soltanto pei begli occhi del padrone tutto quel solfato e tutta quella malaria per trent’anni? – Compare Carmine, l’oste del lago, aveva persi allo stesso modo i suoi figliuoli tutt’e cinque, l’un dopo l’altro, tre maschi e due femmine. Pazienza le femmine! Ma i maschi morivano appunto quando erano grandi,nell’età di guadagnarsi il pane. Oramai egli lo sapeva; e come le febbri vincevano il ragazzo, dopo averlo travagliato due o tre anni, non spendeva più un soldo, né per solfato né per decotti, spillava del buon vino e si metteva ad ammanire tutti gli intingoli di pesce che sapeva, onde stuzzicare l’appetito al malato. Andava apposta colla barca a pescare la mattina, tornava carico di cefali, di anguille grosse come il braccio, e poi diceva al figliuolo, ritto dinanzi al letto e colle lagrime agli occhi: - Tè! mangia! - Il resto lo pigliava Nanni, il carrettiere per andare a venderlo in città. - Il lago vi dà e il lago vi piglia! - Gli diceva Nanni, vedendo piangere di nascosto compare Carmine. - Che volete farci, fratel mio? - Il lago gli aveva dato dei bei guadagni. E a Natale, quando le anguille si vendono bene, nella casa in riva al lago, cenavano allegramente dinanzi al fuoco, maccheroni, salsiccia e ogni ben di Dio, mentre il vento urlava di fuori come un lupo che abbia fame e freddo. In tal modo coloro che restavano si consolavano dei morti. Ma a poco a poco andavano assottigliandosi così che la madre divenne curva come un gancio dai crepacuori, e il padre che era grosso e grasso, stava sempre sull’uscio, onde non vedere quelle stanzacce vuote, dove prima cantavano e lavoravano i suoi ragazzi. L’ultimo rimasto non voleva morire assolutamente, e piangeva e si disperava allorché lo coglieva la febbre, e persino andò a buttarsi nel lago dalla paura della morte. Ma il padre che sapeva nuotare lo ripescò, e lo sgridava che quel bagno freddo gli avrebbe fatto tornare la febbre peggio di prima. - Ah! - singhiozzava il giovanetto colle mani nei capelli, - per me non c’è più speranza! per me non c’è più speranza! Tutto sua sorella Agata, che non voleva morire perché era sposa! - osservava compare Carmine di faccia a sua moglie, seduta accanto al letto; e lei, che non piangeva più da un pezzo, confermava col capo, curva al pari di un gancio. Lei, ridotta a quel modo, e suo marito grasso e grosso avevano il cuoio duro, e rimasero soli a guardar la casa. La malaria non ce l’ha contro di tutti. Alle volte uno vi campa cent’anni, come Cirino lo scimunito, il quale non aveva né re né regno, né arte né parte, né padre né madre, né casa per dormire, né pane da mangiare, e tutti lo conoscevano a quaranta miglia intorno, siccome andava da una fattoria all’altra, aiutando a governare i buoi, a trasportare il concime, a scorticare le bestie morte, a fare gli uffici vili; e pigliava delle pedate e un tozzo di pane; dormiva nei fossati, sul ciglione dei campi, a ridosso delle siepi, sotto le tettoie degli stallazzi; e viveva di carità, errando come un cane senza padrone, scamiciato e scalzo, con due lembi di mutande tenuti insieme da una funicella sulle gambe magre e nere; e andava cantando a squarciagola sotto il sole che gli martellava sulla testa nuda, giallo come lo zafferano. Egli non prendeva più né solfato, né medicine, né pigliava le febbri. Cento volte l’avevano raccolto disteso, quasi fosse morto, attraverso la strada; infine la malaria l’aveva lasciato, perché non sapeva più che farsene di lui. Dopo che gli aveva mangiato il cervello e la polpa delle gambe, e gli era entrata tutta nella pancia gonfia come un otre, l’aveva lasciato contento come una pasqua, a cantare al sole meglio di un grillo. Di preferenza lo scimunito soleva stare dinanzi lo stallatico di Valsavoia, perché ci passava della gente, ed egli correva loro dietro per delle miglia, gridando, uuh! uuh! finché gli buttavano due centesimi. continua L’oste gli prendeva i centesimi e lo teneva a dormire sotto la tettoia, sullo strame dei cavalli, che quando si tiravano dei calci, Cirino correva a svegliare il padrone gridando uuh! e la mattina li strigliava e li governava. Più tardi era stato attratto dalla ferrovia che costrussero lì vicino. I vetturali e i viandanti erano diventati più rari sulla strada, e lo scimunito non sapeva che pensare, guardando in aria delle ore le rondini che volavano, e batteva le palpebre al sole per capacitarsene. La prima volta, al vedere tutta quella gente insaccata nei carrozzoni che passavano dalla stazione, parve che indovinasse. E d’allora in poi ogni giorno aspettava il treno, senza sbagliare di un minuto, quasi avesse l’orologio in testa; e mentre gli fuggiva dinanzi, gettandogli contro la faccia il fumo e lo strepito, egli si dava a corrergli dietro, colle braccia in aria, urlando in tuono di collera e di minaccia: uuh! uuh!... L’oste, anche lui, ogni volta che da lontano vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, non diceva nulla, ma gli sputava contro il fatto suo scrollando il capo, davanti alla tettoia deserta e ai boccali vuoti. Prima gli affari andavano così bene che egli aveva preso quattro mogli, l’una dopo l’altra, tanto che lo chiamavano “Ammazzamogli” e dicevano che ci aveva fatto il callo, e tirava a pigliarsi la quinta, se la figlia di massaro Turi Oricchiazza non gli faceva rispondere: - Dio ne liberi! nemmeno se fosse d’oro, quel cristiano! Ei si mangia il prossimo suo come un coccodrillo! Ma non era vero che ci avesse fatto il callo, perché quando gli era morta comare Santa, ed era la terza, egli sino all’ora di colazione non ci aveva messo un boccone di pane in bocca, né un sorso d’acqua, e piangeva per davvero dietro il banco dell’osteria. - Stavolta voglio pigliarmi una che è avvezza alla malaria - aveva detto dopo quel fatto. - Non voglio più soffrirne di questi dispiaceri -. Le mogli gliele ammazzava la malaria, ad una ad una, ma lui lo lasciava tal quale, vecchio e grinzoso, che non avreste immaginato come quell’uomo lì ci avesse anche lui il suo bravo omicidio sulle spalle, quantunque tirasse a prendere la quarta moglie. Pure la moglie ogni volta la cercava giovane e appetitosa, ché senza moglie l’osteria non può andare, e per questo gli avventori s’erano diradati. Ora non restava altri che compare Mommu, il cantoniere della ferrovia lì vicino, un uomo che non parlava mai, e veniva a bere il suo bicchiere fra un treno e l’altro, mettendosi a sedere sulla panchetta accanto all’uscio, colle scarpe in mano, per lasciare riposare i piedi. - Questi qui non li coglie la malaria! - pensava “Ammazzamogli” senza aprir bocca nemmeno lui, ch se la malaria li avesse fatti cadere come le mosche non ci sarebbe stato chi facesse andare quella ferrovia là. Il poveraccio, dacché s’era levato dinanzi agli occhi il solo uomo che gli avvelenava l’esistenza, non ci aveva più che due nemici al mondo: la ferrovia che gli rubava gli avventori, e la malaria che gli portava via le mogli. Tutti gli altri nella pianura, sin dove arrivavano gli occhi, provavano un momento di contentezza, anche se nel lettuccio ci avevano qualcuno che se ne andava a poco a poco, o se la febbre li abbatteva sull’uscio, col fazzoletto in testa e il tabarro addosso. Si ricreavano guardando il seminato che veniva su prosperoso e verde come il velluto, o le biade che ondeggiavano al par di un mare, e ascoltavano la cantilena lunga dei mietitori, distesi come una fila di soldati, e in ogni viottolo si udiva la cornamusa, dietro la quale arrivavano dalla Calabria degli sciami di contadini per la messe, polverosi, curvi sotto la bisaccia pesante, gli uomini avanti e le donne in coda, zoppicanti e guardando la strada che si allungava con la faccia arsa e stanca. E sull’orlo di ogni fossato, dietro ogni macchia d’aloe, nell’ora in cui cala la sera come un velo grigio, fischiava lo zufolo del guardiano, in mezzo alle spighe mature che tacevano, immobili al cascare del vento, invase anch’esse dal silenzio della notte. - Ecco! - pensava “Ammazzamogli”. Tutta quella gente là se fa tanto di non lasciarci la pelle e di tornare a casa, ci torna con dei denari in tasca -. Ma lui no! lui non aspettava né la raccolta né altro, e non aveva animo di cantare. La sera calava tanto triste, nello stallazzo vuoto e nell’osteria buia. A quell’ora il treno passava da lontano fischiando, e compare Mommu stava accanto al suo casotto colla bandieruola in mano; ma fin lassù, dopo che il treno era svanito nelle tenebre, si udiva Cirino lo scimunito che gli correva dietro urlando, uuh!... E “Ammazzamogli” sulla porta dell’osteria buia e deserta pensava che per quelli lì la malaria non ci era. Giovanni Verga dalla raccolta Novelle rusticane 1883 SI', SI', COSI', L'AURORA SUL MARE giallo reboante Meraviglia dei grigi Tutte le perle dicono SI' 3 ombre corrosive contro Ragionamenti persuasivi verdazzurri delle rade adescanti l'ALBA i venti via via lavorando impastando il mare così muscoli e I lastroni lisci violacei del mare tremano di entusiasmo Un raggio rimbalza di roccia in roccia sangue per l'Aurora La meraviglia si mette a ridere nelle vene del mare EST luce gialla sghimbescia Rischio di una nuvola blu a perpendicolo sul mio capo Poi Tutti i prismatismi aguzzi delle onde impazziscono un verde diaccio Calamitazioni di rossi slittante Una vela accesa Poi scollina all'orizzonte che trema NORD un rosso strafottente ROMBO D'ORO rumore duro vitreo risucchio di tre ombre in quella rada mangiata dal sole Poi un grigio stupefatto Le nuvole rosee sono delizie lontane fanfare di carminio scoppi di scarlatto fievole NO grigio tamtam di azzurro - bocca denti sanguigni bave lunghe d'oro che beve il mare e addenta rocce SI' semplicemente SI' No Sì elasticamente NO pacatamente SI' COSI' sì ancora sì sì ANCORA SI' ANCORA SI' MEGLIO COSI' Filippo Tommaso Marinetti Quando tecnologia vs civiltà di Jànos Vargha L’evoluzione della vita negli ultimi quattro miliardi di anni è avvenuta grazie alla “tecnologia” degli acidi nucleici e delle proteine. Poi, di recente, una specie – l’Homo Sapiens – ha cominciato ad usare altre tecnologie di sua invenzione per acquisire vantaggi ecologici sui limiti dell’ambiente fisico, sulle altre specie della biosfera e, infine, per conquistare un potere militare nei confronti delle altre popolazioni umane. Per diecimila anni si è assistito al crescente incremento della popolazione umana, delle specie domestiche da essa scelte e di altre forme di vita – parassiti o specie che vivono in simbiosi con esse; a ciò si aggiunge una proliferazione di prodotti della tecnologia umana. Tutti questi elementi – esseri viventi e prodotti tecnologici – costituiscono un sistema: la cosiddetta tecnosfera. Oggi la tecnologia regola lo sviluppo e il comportamento della tecnosfera, perché fornisce il potere di “governare” la biosfera. Gli elementi biologici della tecnosfera devono dunque adeguarsi alle tecnologie: le forme di vita che non sono in grado di farlo sono in pericolo con la crescita della tecnosfera e anzi, si stanno estinguendo in numero sempre maggiore. Il fenomeno dell’estinzione è sempre stato un elemento naturale dell’evoluzione sin dalla comparsa della vita, ma oggi la realtà sembra molto diversa. L’evoluzione della biosfera prima della comparsa dell’uomo era il prodotto della competizione e della cooperazione tra gli esseri viventi e tutta la vita si basava sulla stessa “tecnologia” biologica. La nostra specie non avrebbe mai potuto dominare senza cogliere il frutto della conoscenza: questa fase ha rappresentato un taglio netto nel processo evolutivo e non la sua logica continuazione. Da quando abbiamo cominciato ad applicare tecnologie “estranee” abbiamo iniziato a separarci dalla comunità della biosfera. Abbiamo tagliato i fili della dipensenza con la stessa sconsiderata noncuranza con cui avremmo distrutto una ragnatela, ma questa particolare ragnatela è il risultato di miliardi di anni di evoluzione. La nostra esistenza è indissolubilmente legata a processi che durano ben più dell’esistenza di un essere umano, eppure questa consapevolezza non ha molti effetti sulle nostre attività. Interveniamo solo quando i nostri sensi, all’improvviso, si accorgono che qualcosa non funziona: di fronte ad un lago che muore siamo spinti ad agire solo quando ci dà fastidio l’odore. Finchè una calamità non sta alle porte non ci sforziamo di usare il nostro intelletto per analizzare e costruire una concezione del mondo che ci circonda, applicando la nostra creatività. Se vogliamo capire il rapporto che ci lega ai processi ecologici e non vogliamo distruggere la delicata ragnatela che costituisce la biosfera, dobbiamo guardare il mondo con occhi nuovi e andare oltre le percezioni limitate e miopi che i nostri sensi ci forniscono quotidianamente. Continua alla pagina seguente La Braun pubblicizza i suoi apparecchi con lo slogan “Per questa forma è stata progettata la mano dell’uomo”. A mio parere, questa frase è rivelatrice non tanto della conoscenza e saggezza che la nostra civiltà ha tratto dagli sviluppi tecnologici, quanto del nostro “distacco” dall’evoluzione. Essa rispecchia l’arroganza della tecnocrazia: la tecnologia è arrivata a un punto tale che non è al nostro servizio, ma ci usa. Jànos Vargha da “Il nuovo atlante di GAIA Bologna, Zanichelli, 1996, pag. 194 Lo scritto di J. Vargha, presidente dell’Istituto di ricerca ambientale dell’Europa orientale, ci fornisce, in sintesi, un quadro efficace dei problemi connessi allo sviluppo, in particolare mettendo in evidenza il rapporto fra tecnologie e livello di civiltà umana. Frate Leone e il Duemila di Giorgio Celli Il terzo millennio ci sovrasta, e come già accadde per il “mille e non più mille”, le profezie di catastrofi si moltiplicano, sempre più perentorie e minacciose. Mentre allora, però, queste apocalissi erano il risultato di una proiezione mistica, ora sono i computer, e non le sibille, a parlare e l’escatologia elettronica assume tutta la credibilità di un immediato futuribile che si presenti, e in gran parte si millanti, come scientifico. È sicuro che le circostanze fin de siècle militano tutte contro di noi: i mari stanno agonizzando, le acque interne si mutano in cloache […], nel suolo si accumulano intere costellazioni di molecole di sintesi, scarsamente biodegradabili, l’anidride carbonica è in crescita costante nell’atmosfera, sull’Antartide la fascia dell’ozono si è squarciata e c’è un buco, che non si sa come rammendare, grande quanto gli Stati Uniti. Di fronte al fantasma di un’estinzione prossima dell’umanità, che si sta, tra l’altro, riproducendo con una furia esponenziale – cinque miliardi di uomini popolano attualmente il pianeta! – noi adottiamo, insieme, i due meccanismi opposti, ma in fondo complementari, della consapevolezza disperata, che genera il cinismo e la tendenza a vivere alla giornata, o della rimozione, che presuppone la dimenticanza ma che evoca – il prezzo dell’oblio! – una inquietudine senza perché, un persistente malessere. Gli scienziati per fronteggiare l’emergenza e per formulare delle prognosi, se non delle terapie, hanno per solito adottato due approcci differenti. Un approccio, che potremmo definire, con una parola un po’ buffa, “biosferico” è costituito in un esame sistemico della situazione […]. L’approccio opposto, che potremmo definire “ecosistemico”, non parte dal particolare per capire l’universale, ma, al contrario, va dal particolare, gli ecosistemi, all’universale, la biosfera. […] Gli scienziati tentano, insomma, di darsi e di darci una ragione, ma, ahimé, è la tragedia del nostro tempo, proprio quella ragione a cui chiediamo la salvezza ha istituito una attiva intelligenza con il nemico. La ragione, attraverso la tecnologia, si è messa dalla parte della morte e congiura contro di noi. Il nostro cervello, che ha raddoppiato il suo volume in un milione di anni, sembra aver smarrito la sua funzione e lavora non più a favore della nostra sopravvivenza. Si è creato, così, un singolare e paradossale effetto boomerang: il cervello fabbrica le macchine infernali, i Frankestein inanimati che provocano la nostra (e la sua!) distruzione. […] Il tradimento della ragione ha consigliato molti di noi a sperare nei poteri benefici della natura. La natura, si sogna, ci salverà in extremis, mettendo in atto, sui confini dell’ultima spiaggia, i suoi antichissimi e sapienti meccanismi di sopravvivenza. Ma no, non ci si può proprio contare. La storia, la cultura sono troppo veloci perché l’evoluzione possa dar loro una mano. La storia e l’evoluzione marciano in due universi temporali enormemente sfasati dal punto di vista cronologico, e i tempi storici […] sono costantemente al di là dell’orizzonte dei tempi biologici. […] Se non possiamo sperare in una mutazione biologica, che ci aiuti a superare l’emergenza, non ci resta che sperare in una mutazione culturale, in altre parole, in un cambio di mentalità, se con questa espressione intendiamo una modificazione psicologica, che venga dal profondo, e che ponga i presupposti per un diverso stile di vita. Continua C’è qualche sintomo che una simile alchimia riparatrice sia in atto? O, per meglio dire, vediamo forse delinearsi il fantasma di un uomo nuovo, di un nuovo Adamo, riconciliato con la natura? Vediamo un po’ di partire dai mass media, gli interpreti migliori di quello che confusamente desidera l’uomo della strada. Sui giornali, alla televisione, nelle tribune politiche e anche (perché no?) in ambiti più rigorosamente scientifici, si sente menzionare, talora agitata come una bandiera, la qualità della vita, e la si presenta come un bene da conservare, da migliorare, da tenere presente per il futuro. Il consenso unanime di cui gode questa espressione non contribuisce a renderla di più facile comprensione. Taluni alludono a una passeggiata nel bosco, altri a un’aria più respirabile o a un’acqua più bevibile, altri ancora a un nuovo modo di vivere e di entrare in sintonia con il mondo. Alcuni sociologi americani, con il consueto empirismo, hanno deciso di intervistare un certo campione di persone, pregandole di rispondere a un questionario. I risultati sono stati,ahimé, e non poteva essere che così, piuttosto deludenti. L’unanimismo teorico si è risolto, nel concreto, in una galassia di punti di vista. Ma è chiaro: la qualità della vita è ancora ben lungi dall’essere un concetto, è piuttosto l’espressione verbale di uno stato d’animo. […] Sicuramente, chi ha detto la prima volta che il denaro non fa la felicità era ricco, ma nell’epoca dell’emergenza il proverbio svela una sua parte di verità. Difatti, parafrasando il Vangelo, a che scopo possedere tutti i beni della terra se perdiamo il pianeta? In vena di contaminare un po’ il misticismo e l’ecologismo ho riletto i Fioretti di San Francesco, un uomo che nel suo amore per la natura ha sfiorato per tutta la vita l’eresia. Il capitoletto in cui Francesco e frate Leone camminano, di notte, sotto la neve, verso un lontano monastero, mi ha suggerito alcune considerazioni. Cito a memoria. Durante la marcia penosa Francesco interroga frate Leone su che cosa sia, per lui, la perfetta letizia. Frate Leone non lo sa, ma il suo compagno di viaggio lo incalza. Immagina, gli dice, che siamo giunti al monastero: il padre guardiano non ci riconosce e ci lascia fuori nella notte, sotto la neve, affamati e intirizziti. Immagina ancora, continua, che alle nostre proteste egli esca e con un nodoso bastone ci fiacchi le ossa. Frate Leone è perplesso. Ma Francesco non gli dà tregua. Bene, lo ammonisce, se malgrado queste prove tu resti saldo in te e, aggiungo io, ti conservi dalla parte della neve e della notte, quella, frate Leone, è la perfetta letizia. Questa parabola, secolarizzata e spogliata di ogni enfasi mistica, non illustra, secondo il mio punto di vista, un semplice caso di masochismo reverenziale, è, invece, faccenda da samurai e suggerisce che le vie della felicità non solo sono infinite, ma imprevedibili. Non è vero, forse, che anche Albert Camus sostiene che si può, anzi si deve, supporre Sisifo felice? Sì, malgrado il masso che è condannato a portare, ogni giorno, in cima alla montagna, per vederlo sempre ricadere. Francesco e Camus ci suggeriscono che è necessario inventare, e non cercare, la felicità. Ci insegnano, così, la perfetta letizia del Duemila? Da Giorgio Celli “Le farfalle di Giano” Fertrinelli, Milano, 1989 Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue so le laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. A te solo, Altissimo, se confano e nullo omo è digno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, con tutte le tue creature, spezialmente messer lo frate Sole, lo qual è iorno, e allumini noi per lui. Ed ello è bello e radiante cun grande splendore: de te, Altissimo, porta significazione. Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle: in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato si, mi Signore, per frate Vento, e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo per lo quale a le tue creature dai sustentmento. Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. Laudato si, mi Signore, per frate Foco, per lo quale enn'allumini la nocte: ed ello è bello e iocundo e robustoso e forte. Laudato si, mi Signore, per nostra matre Terra, la quale ne sostenta e governa, e produce diversi fructi con colorati flori ed erba. Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che 'l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale da la quale nullo omo vivente pò scampare. Guai a quelli che morrano ne le peccata mortali! Beati quelli che trovarà ne le tue sanctissime voluntati ca la morte seconda no li farà male. Laudate e benedicite mi Signore, e rengraziate e serviteli cun grande umilitate. Cantico di Frate Sole (San Francesco 1225) Ecco mormorar l’onde Ecco mormorar l’onde e tremolar le fronde a l’aura mattutina e gli arboscelli, e sovra i verdi rami i vaghi augelli cantar soavemente e rider l’oriente: ecco già l’alba appare e si specchia nel mare, e rasserena il cielo e le campagne imperla il dolce gelo e gli alti monti indora. O bella e vaga Aurora, l’aura è tua messaggera, e tu de l’aura ch’ogni arso cor ristaura. Torquato Tasso (1544 – 1595) LE RICORDANZE Né mi diceva il cor che l'età verde Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea Sarei dannato a consumare in questo Tornare ancor per uso a contemplarvi Natio borgo selvaggio, intra una gente Sul paterno giardino scintillanti, Zotica, vil; cui nomi strani, e spesso E ragionar con voi dalle finestre Argomento di riso e di trastullo, Di questo albergo ove abitai fanciullo, Son dottrina e saper; che m'odia e fugge, E delle gioie mie vidi la fine. Per invidia non già, che non mi tiene Quante immagini un tempo, e quante fole Maggior di sé, ma perché tale estima Creommi nel pensier l'aspetto vostro Ch'io mi tenga in cor mio, sebben di fuori E delle luci a voi compagne! allora A persona giammai non ne fo segno. Che, tacito, seduto in verde zolla, Qui passo gli anni, abbandonato, occulto, Delle sere io solea passar gran parte Senz'amor, senza vita; ed aspro a forza Mirando il cielo, ed ascoltando il canto Tra lo stuol de' malevoli divengo: Della rana rimota alla campagna! Qui di pietà mi spoglio e di virtudi, E la lucciola errava appo le siepi E sprezzator degli uomini mi rendo, E in su l'aiuole, susurrando al vento Per la greggia ch'ho appresso: e intanto vola I viali odorati, ed i cipressi Il caro tempo giovanil; più caro Là nella selva; e sotto al patrio tetto Che la fama e l'allor, più che la pura Sonavan voci alterne, e le tranquille Luce del giorno, e lo spirar: ti perdo Opre de' servi. E che pensieri immensi, Senza un diletto, inutilmente, in questo Che dolci sogni mi spirò la vista Soggiorno disumano, intra gli affanni, Di quel lontano mar, quei monti azzurri, O dell'arida vita unico fiore. Che di qua scopro, e che varcare un giorno Viene il vento recando il suon dell'ora Io mi pensava, arcani mondi, arcana Dalla torre del borgo. Era conforto Felicità fingendo al viver mio! Questo suon, mi rimembra, alle mie notti, Ignaro del mio fato, e quante volte Quando fanciullo, nella buia stanza, Questa mia vita dolorosa e nuda Per assidui terrori io vigilava, Volentier con la morte avrei cangiato. Sospirando il mattin. Qui non è cosa Ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro Non torni, e un dolce rimembrar non sorga. Dolce per sé; ma con dolor sottentra Il pensier del presente, un van desio Del passato, ancor tristo, e il dire: io fui. Quella loggia colà, volta agli estremi Raggi del dì; queste dipinte mura, Quei figurati armenti, e il Sol che nasce Su romita campagna, agli ozi miei Porser mille diletti allor che al fianco M'era, parlando, il mio possente errore Sempre, ov'io fossi. In queste sale antiche, Al chiaror delle nevi, intorno a queste Ampie finestre sibilando il vento, Rimbombaro i sollazzi e le festose Mie voci al tempo che l'acerbo, indegno Mistero delle cose a noi si mostra Pien di dolcezza; indelibata, intera Il garzoncel, come inesperto amante, La sua vita ingannevole vagheggia, E celeste beltà fingendo ammira. O speranze, speranze; ameni inganni Della mia prima età! sempre, parlando, Ritorno a voi; che per andar di tempo, Per variar d'affetti e di pensieri, Obbliarvi non so. […] Giacomo Leopardi NATURA Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne accorgerei. […] NATURA Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. ISLANDESE Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? […] Giacomo Leopardi dal Dialogo della Natura e di un Islandese AVE in morte di g. p. Or che le nevi premono, lenzuol funereo, le terre e gli animi, e de la vita il fremito fioco per l’aura vernal disperdesi, tu passi, o dolce spirito: forse la nuvola ti accoglie pallida là per le solitudini del vespro e tenue teco dileguasi. Noi, quando a’ soli tepidi un desio languido ricerca l’anime e co’ i fiori che sbocciano torna Persefone da gli occhi ceruli, noi penseremo, o tenero, a te non reduce. Sotto la candida luna d’april trascorrere vedrem la imagine cara accennandone. Giosuè Carducci Il testo è tratto dalla raccolta Odi barbare del 1877; la poesia è scritta in ricordo della morte del figlio adolescente di Lina Cristofori Piva che fu legata al poeta da affettuosa amicizia
Scaricare