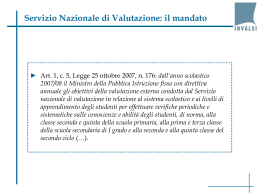I LAVORI ATIPICI DIRETTIVE n. 97/81 del 15.12.1997 sul part-time n. 99/70 del 28.6.1999 sul lavoro a tempo determinato n. 08/104 del 19.11.2008 sul lavoro tramite agenzia interinale Con le tre direttive e con le proposte che le hanno precedute si è progressivamente elaborato un modello di lavoro flessibile e «adattabile» tendente a: contemperare flessibilità per le imprese e sicurezza per i prestatori di lavoro, riconciliare le esigenze della vita lavorativa con i bisogni della vita familiare, rimuovere le discriminazioni di genere, ma anche quelle fra lavoratori standard e lavoratori flessibili promuovere la creazione di un lavoro flessibile di «qualità». Interventi normativi sui lavori flessibili e SEO Gli interventi sui lavori flessibili risultano trasversali a tre dei pilastri a cui si è ispirata la SEO a partire dal Consiglio di Lussemburgo del 1997: la promozione (1) dell'occupabilità, (2) dell'adattabilità e (3) delle pari opportunità. Le tre direttive assumono obiettivi tipici delle politiche occupazionali, quali per es. l'«aumento della intensità occupazionale » (quarto considerando dell'accordo allegato alla direttiva 97/81/CE). cfr. anche l‘undicesimo considerando della dir. 2008/104/CE per il quale «il lavoro interinale (…) contribuisce (…) alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato» IL METODO dell’intervento normativo interventi di armonizzazione legislativa di tipo hard nei quali l’impiego del «metodo comunitario classico è diluito nella sostanza per via della adozione di direttive soft nei contenuti («direttive quadro») Le direttive contengono disposizioni alquanto generiche, nonché, almeno prima facie, poco vincolanti, sul presupposto che le soluzioni siano da ricercare e da adattare flessibilmente in relazione alle diverse esigenze regolative dei singoli Stati membri LA PROCEDURA retrostante le due prime direttive sui lavori atipici: Dalla contrattazione collettiva istituzionale… … alle due direttive del Consiglio In particolare, l’applicazione degli artt. 154 e 155 del TFUE In tema di lavori atipici le parti sociali - previamente consultate dalla Commissione ai sensi dell’art. 154, comma 2 – hanno intrapreso il processo negoziale previsto dall’art. 155 e, come già avvenuto in materia di congedi parentali (dir. n. 96/34 di ricezione dell’accordo collettivo del 14.12.1995), hanno concluso due accordi, successivamente allegati dalla Commissione alle due proposte di direttive indirizzate al Consiglio e, allo stesso modo, annessi alle direttive che il Consiglio ha successivamente adottato. Gli accordi sul part-time e sul contratto a termine sono segno della “vitalità politica” della contrattazione collettiva comunitaria e della sua capacità di funzionare come strumento di integrazione tra gli Stati membri e come risorsa regolativa dell’Unione. I precedenti normativi sui lavori atipici Già all’inizio degli anni ottanta la Commissione aveva formulato due proposte di direttiva (a) sul lavoro volontario a tempo parziale e (b) sul lavoro temporaneo (1982) che rimasero, però, senza seguito: base giuridica art. 100 TCE ostilità delle organizzazioni imprenditoriali e veto del governo britannico Sono conseguenza dell’ impulso fornito alle politiche sociali della Comunità dalla Carta dei diritti sociali fondamentali, del 1989 (che ha auspicato, al paragrafo 7, il ravvicinamento delle condizioni di vita e di lavoro dei prestatori di lavoro nel progresso, anche per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale e il lavoro temporaneo) , le due proposte della Commissione sul parttime e sul lavoro temporaneo del 1990 e la proposta relativa alla (poi adottata) direttiva n. 91/383 ciò che all'epoca stava più a cuore alla Commissione era ancora il corretto funzionamento del mercato comune: «visto il notevole sviluppo e le forme assai disparate di contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato» occorreva, infatti, «predisporre un quadro per garantire un minimo di coerenza tra le varie forme di contratto», non solo, e non tanto, per garantire un miglioramento delle condizioni di vita dei prestatori, quanto per evitare «problemi in termini di dumping sociale, anzi di distorsioni di concorrenza» [Comunicazione della Commissione sul suo programma di azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori», COM (89) 568 def. del 5 dicembre 1989] La direttiva 91/383 sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori atipici Il numero rilevante di incidenti riguardanti lavoratori aventi un rapporto di lavoro temporaneo ha spinto la Commissione a presentare una specifica proposta, finalizzata a «contenere i rischi corsi dai lavoratori temporanei » Lungi dal dettare una compiuta regolamentazione del lavoro atipico, la direttiva contiene soltanto misure rivolte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo (a termine o interinale). sancendo il principio della parità di trattamento fra lavoratori temporanei e lavoratori standard «per quanto concerne le condizioni di lavoro relative alla protezione della sicurezza e della salute durante il lavoro, con particolare riguardo all’accesso alle attrezzature di protezione individuali» La direttiva resta dunque lontana da una disciplina del lavoro atipico indipendente dall’ambito tematico della salute e della sicurezza Base giuridica utilizzata per la proposta: art. 118 A TCE (ora 153) : adozione di direttive con maggioranza qualificata Il contenuto della dir. 91/383 - Esempi: 1) Per il lavoro interinale, responsabilità dell’impresa utilizzatrice per la sicurezza, l’igiene e la salute del lavoratore interinale, per tutta la durata della “missione”; 2) il diritto di informazione dei lavoratori temporanei sui rischi connessi all’esecuzione dell’opera al cui svolgimento è tenuto il lavoratore etc… Conseguenza… E’ scarsa, sino alla fine degli anni ’90, la comunitarizzazione degli ordinamenti nazionali in materia di lavori atipici Le direttive n. 97/81 e 99/70: nuovi contenuti e nuova “ispirazione di fondo” In ordine ai contenuti: le due direttive sono specificamente rivolte a disciplinare il part-time e il lavoro a termine (anche se la maggior parte delle prescrizioni sono formulate in modo programmatico) in tutti gli aspetti e non solo in quello relativo alla salute e alla sicurezza Le direttive n. 97/81 e 99/70: nuovi contenuti e nuova “ispirazione di fondo” In ordine alla “ispirazione di fondo”: Le direttive sono finalizzate al contemperamento di “flessibilità e sicurezza”, ovvero alla realizzazione della cd. “flessibilità mite” (o della flexicurity) La normativa in materia di lavori flessibili appare pervasa da una duplice anima: da una parte, perseguendo obiettivi di politica sociale, statuisce una rete di tutele e di diritti a favore dei lavoratori flessibili; dall’altra, ispirandosi a finalità occupazionali, favorisce un efficiente funzionamento del mercato del lavoro Significato necessità di contemperare l’esigenza del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori con quelle di competitività delle imprese e con il generale obiettivo dell’incremento dell’occupazione (tit. IX TFUE) Si ricorda che: promozione dell’occupazione e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro rientrano tra i nuovi obiettivi assegnati alla Comunità dall’APS allegato al Trattato di Maastricht del 1991 La direttiva n. 97/81 sul parttime… …e la sua implementazione nell’ordinamento italiano: il d. lgs. n. 61 del 2000 (cenni) Il d. lgs. n. 61 del 2000 E’ un esempio di comunitarizzazione diretta del nostro ordinamento del lavoro L’Italia, con legge comunitaria 5 febbraio 1999, n. 25, ha previsto il recepimento della direttiva mediante decreto legislativo, da emanarsi entro il 27 febbraio 2000 La tecnica di regolamentazione utilizzata nella direttiva La direttiva contiene per lo più principi generali; abbandona l’approccio regolativo di tipo dettagliato e formula prescrizioni di carattere prevalentemente programmatico. La funzione di armonizzazione risulta pertanto ridotta al minimo a favore della previsione di principi generali – più o meno vincolanti E’ un tipico esempio di direttiva soft di seconda generazione I contenuti: La direttiva può essere scomposta in quattro parti fondamentali: 1) 2) 3) 4) Le finalità generali Le definizioni e il campo di applicazione Il divieto di discriminazione e il principio di proporzionalità Le disposizioni relative alla attuazione della direttiva 1) Le 2 finalità generali (clausola 1) 1) Assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e migliorare la qualità del lavoro part-time 2) Facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro in modo da tenere conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori Rispetto alla seconda finalità... (facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale) …va sottolineato il contenuto della clausola 5.1 per la quale gli Stati membri dovrebbero individuare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di diffusione del part-time L’interazione fra il linguaggio della politica (occupazionale) e il linguaggio dei diritti In questo senso appaiono rilevanti alcuni “considerando” iniziali (in particolare, il 5° e l’11°) Il 5°: “considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen (…) hanno richiamato l’esigenza di adottare misure volte ad incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività”; l’11°:che fa riferimento allo “sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori”. 2) Definizione di part-time e campo di applicazione della direttiva Il lavoratore a tempo parziale è il salariato il cui orario di lavoro normale è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile Diversamente dalle due proposte di direttiva del 1990 – che richiedevano una soglia minima di orario (in media almeno otto ore settimanali) – la dir. n. 97/81 ammette part-time anche con orari minimi CONSEGUENZE: Non viene fissato un minimo di ore ( e di conseguente retribuzione) che debba essere comunque garantito al lavoratore part-time In compenso, non esistono soglie al di sotto delle quali le prestazioni di lavoro part-time sono irrilevanti per gli ordinamenti giuridici nazionali (salvo il caso dei soggetti che lavorano su base occasionale: clausola 2.2) Il part-time a zero ore o “secondo il fabbisogno” (nella legge italiana, «lavoro intermittente») La sentenza Wippel (CGCE 12 ottobre 2004, C-313/02, Nicole Wippel c. Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG) la sig.ra Wippel era parte di un contratto di lavoro “secondo il fabbisogno”; il contratto si caratterizzava per la mancata previsione di orari e di retribuzione fissi, dunque, esso non attribuiva alla sig.ra Wippel alcuna garanzia di salario minimo La sig.ra Wippel chiede che le sia riconosciuto il diritto alla differenza retributiva tra la somma dovuta per la durata massima di lavoro che avrebbe potuto esserle richiesta e l’importo dovuto per le ore effettivamente prestate. Sostiene di essere vittima di una discriminazione fondata sul sesso …segue: la decisione della CGCE Il lavoratore secondo il fabbisogno dell’ordinamento austriaco è lavoratore subordinato Per la prima volta la CGCE decide un caso di discriminazione indiretta di una lavoratrice part-time applicando la direttiva sul part-time, invece che quella sulla parità di trattamento fra uomini e donne La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 e gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207 debbono essere interpretati nel senso che «non ostano ad un contratto di lavoro a tempo parziale dei lavoratori (…), come quello oggetto della causa principale, in forza del quale la durata del lavoro settimanale e l’organizzazione dell’orario di lavoro non siano fisse, bensì siano correlate al fabbisogno di lavoro, determinato caso per caso, restando tali lavoratori liberi di scegliere se accettare o rifiutare il lavoro offerto». «In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui le due categorie di lavoratori non sono comparabili, un contratto di lavoro a tempo parziale in base al fabbisogno, il quale non fissi né una durata del lavoro settimanale né un’organizzazione dell’orario di lavoro, non costituisce una misura indirettamente discriminatoria». La sig.ra Wippel è una «speciale» lavoratrice a tempo parziale rientrante, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva sul parttime, cui, tuttavia, non è concretamente applicabile il principio di parità di trattamento ivi sancito, poiché non esistono lavoratori, né a tempo parziale, né a tempo pieno, che si trovino in una situazione comparabile alla sua La definizione di part-time nel d. lgs. n. 61 del 2000 Ai sensi dell’art. 1, si intende, per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati I “silenzi” della dir. n. 97/81 La direttiva non definisce le diverse tipologie di parttime (orizzontale, verticale, misto). Il decreto legislativo italiano sul part-time (d. lgs. n. 61/2000) contiene, per es., una definizione assai più dettagliata del part-time, specificando queste distinzioni. Non specifica neanche se debbano essere predeterminate in modo certo le modalità di distribuzione dell’orario (problema delle cdd. “clausole elastiche”). I “silenzi” della dir. n. 97/81 e le sue conseguenze La “volontarietà”, che la clausola 1, lett.b, qualifica come elemento caratterizzante dell’intero rapporto di lavoro a tempo parziale, fa pensare ad una necessità di consenso sulla dimensione temporale complessiva della prestazione di lavoro e sulle sue eventuali variazioni. La disciplina delle clausole “flessibili” ed “elastiche” nell’art. 3 del d. lgs. n. 61/2000: tra legittimità della flessibilità e garanzia della “volontarietà” del part-time flessibile e/o elastico per il lavoratore. Il consenso del lavoratore deve essere espresso attraverso specifico patto scritto …inoltre: …ex art. 3, c. 9, d. lgs. n. 61/2000: Il rifiuto del lavoratore di inserire nel contratto calusole elastiche o flessibili «non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento» Volontarietà del part-time e clausola 5.2 Il part-time come “tempo scelto” Illegittimità del licenziamento motivato dal rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro full-time a part-time, o viceversa (conf.art. 5 d.lgs. 61/2000) Il part-time come “tempo scelto” Necessità per i dat. di lav. di prendere in considerazione le richieste di conversione e di fornire informazioni sulle disponibilità in organico CLAUSOLA 5 Ambito di applicazione La possibile esclusione - da parte degli Stati membri, a condizione di una previa consultazione delle parti sociali e “per ragioni obiettive” - della prestazioni su base occasionale Indeterminatezza dell’espressione “ragioni obiettive” 3) Il divieto di discriminazione (clausola n. 4.1) I lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori comparabili a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive Finalità L’affermazione del principio – confermato anche dalla successiva direttiva sul contratto a termine – risponde all’esigenza di evitare il proliferare di statuti giuridici differenziati nei confronti dei lavoratori atipici, privilegiando, al contrario, la riconduzione delle pur diverse tipologie contrattuali ad un unico paradigma regolativo Il divieto di discriminazione: ratio Prevalente utilizzo del part-time da parte della manodopera femminile - per questo profilo, la direttiva sul p.t. va collocata nell’alveo della tutela del lavoro femminile e della promozione delle pari opportunità (art. 157 TFUE; dir. n. 75/117; n. 76/207; n. 79/7; 2002/73; 2006/54) L’indebolimento del divieto di discriminazione Sono possibili eccezioni al divieto Anche qui “per ragioni obiettive, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali (o le parti sociali, autonomamente), possono subordinare l’accesso a condizioni d’impiego particolari …ad una durata del lavoro (clausola 4.4) La direttiva contempla anche il principio di proporzionalità (o del “pro rata temporis”) “Ove opportuno” è applicabile ai lavoratori part-time la regola della riduzione proporzionale dei trattamenti. La regola del riproporzionamento come corollario dell’accezione positiva del principio di non discrimianzione, cioè della regola della parità di trattamento Come è stato trasposto, dal d. lgs. n. 61/2000 (art. 4), il divieto di discriminazione L’inderogabilità del divieto di discriminazione (anche ad opera delle parti collettive) Nessun riferimento è presente, nel d. lgs. n. 61/2000 alla possibilità di derogare al divieto di discriminazione per ragioni obiettive Le lett. a) e b) dell’art. 4 del d. lgs. n. 61/2000: Lett. a): l’applicazione ai lavoratori part-time dei medesimi trattamenti normativi previsti per il full-time (importo della retrib. oraria, durata del periodo di prova, ferie, periodo di comporto etc…) Lett.b): (il riproporzionamento dei soli trattamenti economici (retribuzione globale, retribuzione feriale, trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità) 4) Disposizioni relative all’attuazione della direttiva (clausola 6) Generale apertura verso integrazioni e adattamenti successivi della disciplina. Ciò rende ancora più soft l’intervento comunitario sul part-time In particolare: A) Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nella direttiva B) Le parti sociali - anche a livello europeo - possono concludere accordi che adattino o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate C) Le parti firmatarie, su richiesta di una di esse, potranno rivedere l’accordo e la direttiva sul part-time, dopo cinque anni dalla sua adozione da parte del Consiglio La novità sotto il profilo giuridico-istituzionale In modo del tutto innovativo, una direttiva del Consiglio legittimava le parti che hanno stipulato l’accordo retrostante ad avviare autonomamente la procedura di revisione dell’Accordo Valorizzazione della contrattazione collettiva europea Le parti sociali possono agire senza il previo input della Commissione. Viene, in tal modo, individuato uno spazio di intervento normativo riservato preliminarmente ratione materiae alla autonomia collettiva Direttiva 99/70/CE del 28.6.1999 sul contratto a termine I precedenti normativi comunitari sul contratto a termine Il progetto di direttiva avanzato dalla Commissione nel 1982 (conteneva una indicazione analitica dei casi in cui era legittima la stipulazione dei contratti a termine) L’art. 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali (impegnava gli Stati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori atipici e, tra questi, dei lavoratori a termine) La direttiva n. 99/70 segue lo stesso iter procedurale della direttiva sul part-time Già nel preambolo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale le parti (Unice,Ceep e Ces) avevano annunciato di considerare necessari simili accordi per altre forme di lavoro flessibile Le parti sociali, consultate dalla Commissione, hanno informato quest’ultima della loro volontà di avviare il procedimento previsto dall’art. 154 del Trattato. La Commissione ha acconsentito alla richiesta, assegnando alle parti sociali un termine per la conclusione delle trattative ...Segue Il 18 marzo 1999 le organizzazioni intercategoriali hanno sottoscritto l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ...hanno dunque trasmesso l’accordo alla Commissione chiedendo che ad esso venisse data attuazione con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell’art. 154, paragrafo 2 del Trattato Il Consiglio, su proposta della Commissione, ha, infine, adottato la direttiva 99/70, ai sensi della norma richiamata. Anche l’ispirazione di fondo della direttiva 99/70 è identica a quella della direttiva sul part-time Nel preambolo dell’accordo è espressamente enunciato il fondamentale ruolo delle parti sociali in ordine: a) alla attuazione della strategia europea per l’occupazione, adottata col vertice di Lussemburgo b) alla realizzazione dell’equilibrio tra “flessibilità e sicurezza” …Segue mentre fra i “considerando” iniziali della direttiva vengono richiamati gli orientamenti in materia di occupazione formulati dal Consiglio nel 1999 con i quali le parti sociali venivano invitate a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza Altre significative enunciazioni del preambolo 1) Si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro 2) Si escludono espressamente dall’ambito di applicazione dell’accordo (e, dunque,della direttiva) i rapporti di lavoro interinale (per i quali le parti sociali già pensavano ad un successivo specifico accordo) Segue… 3) Si prefigura, per i sindacati nazionali, un ruolo di primo piano nella attuazione della direttiva, richiamando la necessità che le parti sociali “siano consultate prima di qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro” (cfr. anche le clausole 2.2.; 4.3; 5.1; 5.2; 7.2; 8.1) I contenuti della direttiva 1) L’enunciazione delle sue finalità: A) Migliorare la qualità del lavoro dei contratti a tempo determinato, garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione B) Prevenire gli abusi derivanti dall’uso di successivi contratti a tempo determinato Alla rinuncia ad un approccio regolativo di tipo dettagliato consegue l’abbandono della tecnica normativa (presente nella proposta del 1982) fondata sulla individuazione delle ipotesi di liceità del termine (di difficile armonizzazione) I lavoratori a termine vengono piuttosto tutelati al momento del rinnovo (cfr., più in dettaglio, la clausola 5) Clausola 5 Propone 3 possibili soluzioni: a) la fissazione di esplicite ragioni obiettive per il rinnovo b) la fissazione della durata massima dei rapporti a termine successivi c) la fissazione del numero dei rinnovi CGCE – caso Impact (sent. 15.4.2008): la disposizione impone agli Stati l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure elencate in tale disposizione dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (conf. sent. Angelidaki 23.4.2009) La sentenza Adeneler (CGCE 4/7/2006) La sentenza Angelidaki (CGCE 23/4/2009) Adeneler: La Corte ha ritenuto contrastante con la direttiva la normativa greca che giustificava di diritto e senza ulteriore precisazione il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza stabilire «criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale» (punto 74). Abgelidaki: sfavore dell’ordinamento dell’U.E. verso successivi contratti a termine utilizzati per soddisfare “bisogni permanenti e durevoli” del datore di lavoro. La proroga del contratto a termine nell’ordinamento italiano (art. 4, d. lgs. 368/2001) La direttiva comunitaria 99/70: l’ esigenza di prevenire gli abusi derivanti dall’uso di successivi contratti a tempo determinato La proroga è ammessa: solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore ai tre anni una sola volta per ragioni obiettive con riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato originariamente stipulato (segue…) La proroga del contratto a termine (art. 4) In ogni caso la durata complessiva del rapporto a termine non potrà superare i tre anni Conseguente divieto di proroga per tutti i contratti il cui termine iniziale già oltrepassi il triennio La riforma legislativa del rapporto a termine in Italia (l. 247/07): 1. 2. Il ripristino del principio secondo cui il rapporto di lavoro si presume a tempo indeterminato (art. 1, comma 0, d. lgs. 368/01) In caso di successione di contratti a termine che superi i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), il contratto si considera a tempo indeterminato sin dall’inizio (art. 5, c. 4 bis, d. lgs. 368/01 come modificato dalla l. 247/07) 3. Così anche se due assunzioni a termine avvengano senza soluzione di continuità (e, cioè, senza far intercorrere tra il primo ed il secondo contratto un lasso temporale di 10 o 20 giorni) 2) La definizione di lavoratore a tempo determinato (clausola 3) E’ lavoratore a tempo determinato “una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di uno specifico compito o il verificarsi di un evento specifico” 3) Il campo di applicazione della direttiva (clausola 2) Sono possibili esclusioni ad opera degli Stati membri, previa consultazione della parti sociali a) per i rapporti di formazione professionale e di apprendistato; b) per i contratti definiti nel quadro di programmi specifici di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici 4) Il principio di non discriminazione (clausola 4) Diversa enunciazione rispetto alla proposta di direttiva del 1982: - quest’ultima assicurava ai lavoratori a termine una tutela pari a quella dei lavoratori a tempo indeterminato solo “nella misura del possibile”; - la direttiva n. 99/70, più decisamente, sancisce il principio della parità di trattamento, prevedendone l’applicazione a tutti gli aspetti del rapporto 4) Il principio di non discriminazione (segue) In maniera analoga alla direttiva sul part-time, l’enunciazione del principio è però attenuata: a) dalla possibilità che gli stati membri introducano eccezioni al divieto per ragioni obiettive b) dalla possibile applicazione del principio di proporzionalità (pro rata temporis) 5) La clausola di non regresso (clausola 8.3) gli Stati membri e le parti sociali "possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori, di quelle stabilite nel presente accordo", la cui applicazione peraltro “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori” Il contratto a termine e la CGCE Il caso Mangold (CGCE 22.11.2005) La legge tedesca del 2002: “Non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore all’inizio dell’accordo abbia già compiuto 58 anni. (…). Fino al 31 dicembre 2006 l’età di 58 anni indicata nella prima frase è sostituita con quella di 52 anni». in occasione della trasposizione della direttiva 1999/70, la legge tedesca ha abbassato l’età oltre la quale i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere conclusi senza restrizioni da 60 a 58 anni, prima, e da 58 a 52, poi. La sentenza Mangold della CGCE 1) La clausola 8, punto 3, dell’ accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) dev’essere interpretata nel senso che NON OSTA ad una normativa quale quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi con la necessità di promuovere l’occupazione e indipendentemente dall’applicazione del detto accordo, ha abbassato l’età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato. 2) Il diritto comunitario e, in particolare, l’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che OSTANO una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età di 52 anni. È compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione in ragione dell’età disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto. Le pronunce della CGCE (2006) Adeneler 4.7.2006; Marrosu e Sardino 7.9.2006; Vassallo 7.9.2006 La successione di contratti a termine nel pubblico impiego la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro si applicano anche ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico l'accordo quadro non osta, tuttavia, all'applicazione di una normativa nazionale che vieta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato L’art. 36 d. lgs. n. 165/01 (T.U.P.I.) Prevenzione degli abusi: Comma 3: Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile , le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure , rispettano principi di imparzialità e a trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio Comma 4: In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno Trib. Siena 27.9.2010 Ritiene implicitamente abrogato il comma 5 dell’art. 36 e dispone la conversione di più contratti a termine in contratto a tempo indeterminato, immettendo in ruolo la lavoratrice ricorrente 6) I doveri di informazione (clausole 6 e 7) L’informazione dei lavoratori a tempo determinato sui posti di lavoro disponibili nell’impresa. Non esiste, tuttavia, un diritto di precedenza L’informazione degli organismi di rappresentanza aziendali sul lavoro a tempo determinato nell’impresa 7) Disposizioni relative alla attuazione della direttiva (clausola 8) Del tutto analoghe a quelle contenute nella direttiva sul part-time A) Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nella direttiva ...Segue B) Le parti sociali - anche a livello europeo - possono concludere accordi che adattino o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate C) Le parti contraenti verificano l’applicazione dell’accordo entro cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso La direttiva sul contratto a termine: valutazioni conclusive Sul contenuto della direttiva I La direttiva non è nella logica della deregolazione neo-liberista del mercato del lavoro II Riconferma, piuttosto, la centralità dell’impiego stabile III Lo spazio che viene assegnato al lavoro a termine è soprattutto in vista dello sviluppo dell’occupazione Anche nella disciplina europea si afferma, dunque, la specialità del rapporto di lavoro a termine rispetto al prototipo standard del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ... il contratto a termine viene tuttavia considerato uno strumento di politica attiva del lavoro, ovvero uno strumento di flessibilità (in entrata) del mercato del lavoro
Scarica