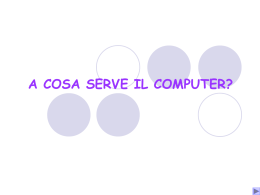STORIA DELLA LINGUA GRECA Laurea Triennale a.a. 2009-2010 Prof.ssa Paola Cotticelli, (36 ore) I dialetti greci storici tra il II e il I millennio a.C. [email protected] Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Programma 2008/2009 1. Collocazione del greco all'interno della famiglia i.e. 1.2. Isoglosse principali che danno il grado della parentela tra il greco e le altre lingue indoeuropee (fonetica, lessico, morfologia, sintassi) 1.3. Caratteristiche esclusive del greco (innovazioni rispetto alle altre lingue), fonetiche e morfologiche 2. Collocazione storica del greco. Inizio della tradizione scritta 2.1. Storia della scrittura 2.2. Storia del sillabario miceneo 2.3. Storia dell´alfabeto greco Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Programma/2 3. 3.1. 4. 5. 5.1. 6. 6.1. 7. 7.1. 7. Divisione dei dialetti greci Breve storia delle proposte delle suddivisioni dei dialetti greci Definizione della denominazione "greco“ Il greco miceneo Testi Il greco omerico Testi Il greco delle iscrizioni Testi Il BASP: esperimenti e testi Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Bibliografia consigliata Storia della lingua greca O. Hoffmann-A. Debrunner-A. Scherer, Storia della lingua greca, trad. it. Napoli, Macchiaroli, 1969. L.R. Palmer, The Greek Language, London, Faber, 1980. Per lo studio dei dialetti greci Y. Duhoux, Introduzione alla dialettologia greca antica, trad. it. Bari, Levante, 1986. A. C. Cassio, Storia delle lingue letterarie greche, Le Monnier, Firenze 2008 (Mondadori). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1. Collocazione del greco all´interno della famiglia indoeuropea 1.1. Il greco e l'indoeuropeo 1.1.1. Definizione dei concetti usati (ie.; ricostruzione; protolingua, periodo ricostruito a cui si fa riferimento etc.) 1.1.2. Definizione del ricostruibile e del ricostruito (concezione brugmanniana; neogrammatica; problema dell'ittito e delle laringali) 1.1.3. Collocazione della lingua all'interno della famiglia i.e.. Appartiene al gruppo „Kentum“. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1./2 L’indoeuropeo: una lingua o un insieme di dialetti?/2 1.1.4. Le concordanze sistematiche e le differenziazioni antiche. FENOMENI DI CONSERVAZIONE le opposizioni vocaliche a, e, o (con armeno e italo-celtico, e contro indoiranico e germanico) il significato ‘tonico’ e semantico (non intensivo né metrico) dell’accento (come in lituano, in serbo) il ritmo quantitativo (sillabe brevi e sillabe lunghe) 1.1.5. La non coscienza dell’unità originaria. Cultura indoeuropea. 1.1.6. La patria degli indoeuropei: localizzazione nelle steppe meridionali russe, dalle quali hanno preso le mosse progressive migrazioni da est a ovest, a sud, a nord. 1.1.7. La cronologia: l’indoeuropeo del terzo millennio (i metalli, l’agricoltura) e prime attestazioni linguistiche (anatolico) verso il XVII-XVI sec. a.C. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1./3 L’indoeuropeo: una lingua o un insieme di dialetti? 1.1.8. Formazione dei singoli gruppi e di singole lingue: Ogni lingua comune presuppone un’unità politica e culturale, anche se può sopravvivere al dissolversi di un’unità nazionale. Ogni lingua comune risulta dall’estendersi di una lingua predominante oltre i suoi confini (il diffondersi di una lingua è sempre il diffondersi di un tipo di cultura). Ogni lingua comune che diventa ‘imperiale’ tende nuovamente a differenziarsi in molte varietà dialettali. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.2. Isoglosse principali con le altre lingue indoeuropee 1.2.1. Il greco è imparentato con diverse altre lingue iee. tramite caratteristiche comuni: - sul piano del lessico con l'armeno - sul piano della fonologia con l'iranico - sul piano del sistema verbale con l'indiano - lo strato „egeo-anatolico“ Pelasgi (dalla Tessaglia a Creta: indoeuropei pre-greci per V. Georgiev, A.J. van Windekens), Lelegi (dalla Grecia centrale all’Asia Minore), Cari. Le popolazioni anatoliche (l’anatolico di P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen 1896) e il rapporto con il ceppo ittito-luvio e con le lingue caucasiche. Toponimi ‘anatolici’; antroponimi e teonimi. Case e ambienti, utensili e suppellettili, piante, animali, metalli, armi, mare, danza, sovranità. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.2. / 2 Isoglosse principali con le altre lingue indoeuropee 1.2.2. Modelli ricostruiti del paradigma nominale (declinazioni=temi; genere, numero, numero dei casi) 1.2.3. Modelli ricostruiti del paradigma verbale (coniugazioni, tempi, modi, aspetti, modi dell'azione, ingiuntivo, imperativo, desinenze) 1.2.4. Modelli ricostruiti del paradigma pronominale 1.2.5. Accenni di morfologia 1.2.6. Accenni di sintassi Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3. Caratteristiche esclusive del gruppo greco 1.3.1. Innovazioni A. Fonetica: il sistema consonantico il suono s, semivocali e sonanti; la generale tendenza all’assordimento e alla semplificazione - sostituzione di un /i/ iniziale tramite lo spirito aspro (=/h/) sostituzione sistematica di laringali anteconsonantiche tramite le vocali a/e/o , a seconda del tipo di laringale - trattamento dei gruppi "occlusiva + /i/ = /pi/ /bhi/ > /pt/ πτ Le cadute intervocaliche di |y|, |w| e |s| e gli incontri vocalici (N.B.: le contrazioni costituiscono una fase successiva al greco comune). L’indebolimento di -s- e la progressiva spirantizzazione delle occlusive dolci e aspirate (s > h, b > v, etc.). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./2 Caratteristiche esclusive del gruppo greco: innovazioni il sistema vocalico e i dittonghi (progressivamente scomparsi, prima nel beotico, poi nel greco, ma conservati in gran parte nel lituano) la caduta delle consonanti finali e l’uniformazione delle finali in vocale, dittongo, restrizione a sole tre possibilità di terminazione di parola n, r, s; le leggi dell’accento Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./3 Caratteristiche esclusive del gruppo greco: innovazioni B.1. Morfologia nominale La conservazione del sistema flessivo: temi e desinenze Le funzioni: numero, persona, maschile/ femminile/neutro, casi. La semplificazione progressiva Il crollo del sistema indoeuropeo delle radici semantiche Paradigma di flessione nominale (paradigma del contenuto): lo specifico sincretismo dei casi nel paradigma nominale Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./4 Caratteristiche esclusive del gruppo greco B.1.1. Paradigma di flessione nominale (paradigma dell'espressione): - sostituzione della desinenza ie. di loc. pl. *-su tramite -σι, in funzione di dat.-loc. pl. - il suffisso di superlativo -τατο - livellamento paradigmatico delle differenze nella flessione del pronome dimostrativo e relativo da una parte e, dall'altra, dei nomi con tema in -o e in -a lungo - il pronome dimostrativo ου)τοj, aυ)τοj, (ε))κεινοj Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./5 Caratteristiche esclusive del gruppo greco Semplificazione dei casi da 8 a 5 (l’eliminazione dei casi a valore concreto). Conservazione delle alternanze vocaliche e della caratterizzazione accentuativa dei casi nel sistema nominale. La semplificazione della declinazione dei dimostrativi. L’opposizione tra animato e inanimato, il neutro plurale (con l’accordo del verbo al singolare, come solo nelle Gāthā dell’Avesta), la progressiva scomparsa del duale (salvo che nell’attico). La varietà formale e l’unificazione della koinh/ (ma non ai livelli di monotonia del turco o del finnico). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./6 Caratteristiche esclusive del gruppo greco B. 2. Morfologia verbale la distinzione tra attivo/medio/passivo nell'aoristo e futuro Verbi radicali e verbi denominativi (-aω, -eω, -oω, -aζω, -iζω, -πτω, -σσω < ie. *t-yo), la coniugazione regolare (il paradigma), la progressiva crisi del perfetto, nomi radicali (zugon) e nomi derivati (zeugma). L’estensione (massima) del participio e dell’infinito (privo però di flessione prima dell’articolo), la limitazione dell’aggettivo verbale e delle forme perifrastiche (che invece abbondano in latino). L’opposizione aspettuale presente/aoristo/perfetto, modale indicativo/congiuntivo/ottativo (mantenuta solo dal vedico e dall’avestico), di diatesi attivo/medio/passivo. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./ 7 Caratteristiche esclusive del gruppo greco Greco come lingua unitaria o gruppo di dialetti greci? Le differenze dialettali sono tarde, tranne -μεν/-μες, τότε/τότα/τόκα, εij//αij, aν/κε (residui di una differenziazione originaria dopo un periodo di livellamento). Le divergenze tra A. Meillet e A. Scherer. La mancanza di una documentazione storica delle fasi di passaggio e delle ‘innovazioni’. Il greco lingua di conquista: relazioni e trasformazioni interne. Il processo ‘a fisarmonica’: la costruzione di nuove lingue comuni ‘interne’ al greco. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 1.3./ 8 Caratteristiche esclusive del gruppo greco C. Sintassi La libertà dell’ordine delle parole, che tendenzialmente è SOV, ma in poesia funzionale all’espressività e non alla grammatica. Posizione delle parole enclitiche (Posizione di Wackernagel) al II posto della frase) e gli stacchi espressivi. L’articolo e la sua funzione ‘associativa’, grammaticalizzato dal dimostrativo anaforico. Una lingua ‘intellettuale’: l’eliminazione degli elementi affettivi e concreti (nel verbo, i desiderativi, gli iterativi, i causativi, gli intensivi; nel nome, gli strumentali, i locativi, gli ablativi) L’esempio della comparazione (intensivi e distintivi diventano parimenti comparativi). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2. Collocazione storica del greco. Inizio della tradizione scritta • Età del Bronzo antico: 2800-1900 a.C. • Età del Bronzo medio: 1900-1600 a.C. • Età del Bronzo recente: 1600-1100 a.C. • Il periodo miceneo: tra 1450 e 1200 a.C. periodo oscuro, tra 1200 e 900 a.C. Il periodo anticoIl : dai primi documenti al 394 d.C. (la divisione dell’impero romano) - fase dialettale: fino alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) - fase ellenistica e romana: lo sviluppo della κοινZ Il periodo bizantino: dal 394 al 29 maggio 1453 (la conquista di Costantinopoli) Il periodo moderno: dal 1453 a oggi Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Collocazione storica/2 - Le prime ondate di popolazioni parlanti una lingua greca sono da collocarsi nel 2. millennio - 14.-13. sec. ha inizio la tradizione scritta del greco della lineare B sulle tavolette - 700 a.C. circa si colloca l'inizio dei poemi omerici e si data il Vaso di Dipilo di Atene cosí insieme quello della tradizione letteraria - nel periodo alessandrino si codifica la cosiddetta κοινή All'inizio della sua tradizione storica letteraria il greco non si presenta come lingua compatta bensì in forma di diversi dialetti (storici) a cui si aggiungono una serie di lingue letterarie artificiali, d'arte. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.1. Storia della scrittura Vedi i files relativi a: 2.2. Storia del sillabario miceneo 2.3. Sviluppo dell´alfabeto 2.3.1. Formazione dell´alfabeto Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.1.1. Dagli ideogrammi alle sillabe 1. Fase pittografica: il disegno della “stella” indica il cielo stellato in sumero. 2. Fase ideografica: il disegno della “stella” indica anche la “divinità” che ha sede nel “cielo stellato” 3. Fase logografica: il disegno della “stella” si legge AN in sumero e significa: “cielo stellato, stella, dio” Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.1.2. Dalle sillabe all’alfabeto • STRUTTURA SILLABICA: tipica del cuneiforme, del miceneo, del cipriota rappresenta lo sviluppo secondo il principio acrofonico dalla fase logografica. Esempi: •ka, ke, ki, ko, ku > kx = kx, a, e, i, o, u •STRUTTURA ALFABETICA: si sviluppa dal fatto che le lingue semitiche non notavano le vocali nelle prime sistemazioni alfabetiche dei testi di Ras Shamra (fenicio) • k + (a, e, i, o, u solo pronunciate) 2.2. Sillabario miceneo: Vedi file PDF Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.3. La formazione dell’alfabeto Le ‘matres lectionis’: ’aleph ()), yod (y), waw (w) Le vocali e l’aspirata: )>Α, y>Ι, w>Υ (e ), h>Ε, (>Ο, x>Η Le sonanti: l>Λ, m>Μ, n>Ν, r>Ρ Le occlusive: b>Β, g>Γ, d>Δ, p>Π, k>Κ, t>Τ, q> +>Θ Le sibilanti: c, s # > Σ (Ξ), z>Ζ Il primo risultato: Α Β Γ Δ Ε F Η Ζ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Q Ρ Σ Τ Υ Vedi anche il file PDF Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.3.1. Completamento dell’alfabeto a) ΠH > Φ ΚΗ/ Η > X b) L’alfabeto orientale L’alfabeto occidentale ΠΣ > Ψ ΚΣ/ Σ > Ξ (Φ = ph, Χ = kh, Ψ = ps, Ξ = ks) (Φ = ph, Χ = ks, Ψ = kh, Ξ = -) c) La psilosi e l’economia: Η = e lunga aperta (≠ Ē), Ω = o lungo aperto (≠ Ō) d) Il decreto ateniese Archino/Euclide (402/403 a.C.): ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.3.2. Alfabeti greci: diffusione Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.3.3. Links sugli alfabeti greci http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/ TITUS Didactica Greek Alphabets Map frame.mht TITUS Didactica Greek Dialects Map frame.mht Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 2.3.4. I quattro tipi principali di alfabeto Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3. Divisione dei dialetti greci Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3./2 Carta delle suddivisioni dialettali/2 Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1. Breve storia delle suddivisioni dialettali La distinzione dialettale si stabilizza a partire dall'11. secolo, dopo le invasioni doriche e la scomparsa del miceneo. I dialetti storici si possono suddividere nel seguente modo: 1. gruppo dorico-nord-occidentale (dorico in senso stretto) : Laconico con Taranto Cretese messenico melico, thera, cirenaico, rodio argico corinzio città doriche della Sicilia megarico 1.1. dorico della lingua d'arte è quello della lirica corale (Pindaro), delle parti corali della tragedia Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1./2 Breve storia delle suddivisioni dialettali/2 1.2. greco nord-occidentale: locrese Focese etolico Epirotico eniaco 1.3. I dialetti di Acaia ed Elide hanno grosse somoglianze con i dialetti nord-occidentali. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1./3 Breve storia delle suddivisioni dialettali/3 2. gruppo eolico: lesbico tessalico beotico 2.1. lesbico + lingua epica caratterizzano la lingua d'arte di Saffo e Alceo. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1./4 Breve storia delle suddivisioni dialettali/4 3. gruppo arcadico-cipriota: arcadico Cipriota 4. gruppo ionico-attico: ionico dell'Asia Minore ionico insulare dialetti dell'Eubea attico 4.1. La lingua epica è ionica con influssi eolici. Ionico è anche la lingua letteraria degli epigrammi, delle elegie e dei giambi, le parti dialogiche della tragedia. La lingua della prosa letteraria è lo ionico fino al 5./4. secolo, poi lo diventa l'attico. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1./5 Breve storia delle suddivisioni dialettali/5 5. il miceneo (tavolette da Cnosso, Pilo, Micene, Tebe 14./13. sec.) rimane per la sua arcaica attestazione difficilmente collacabile in un rapporto genealogico di filiazione con i dialetti tardi, la cui attestazione ha uno scarto di circa 500 anni. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 3.1. /6 Riflessioni sui dialetti greci: uno sguardo d’ insieme • Il miceneo e le sue filiazioni: l’arcadico, il cipriota e il panfilio (il problema dell’unitarietà del gruppo). • Oriente e Occidente: il gruppo ionico-attico (coesione) e il gruppo occidentale (frammentazione). • L’eolico e la sua natura mista: tre o quattro gruppi. Le tesi di O. Hoffmann, W. Porzig, E. Risch. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 4. Definizione della denominazione “greco” La continuità linguistica tra conservazione e innovazione (una lingua è continuo movimento) . Concordanze sistematiche tra le forme di diverse fasi storiche di una lingua e corrispondenze regolari tra le particolarità delle diverse parlate derivate da una preesistente unità linguistica. I cambiamenti, le regole determinate, la ‘simmetria del cambiamento’. Le parlate indoeuropee: consonanze fonetiche, morfologiche (la flessione) e lessicali, differenze nella flessione verbale e pronominale e nel lessico; i dialetti ‘interni’ all’indoeuropeo Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 4.1. Gli A)χαι=oi nel il Mediterraneo Le ‘innovazioni elleniche’ (fonetiche e grammaticali) e il tasso di ‘indoeuropeo’ nel lessico greco. Vestigia linguistiche ‘mediterranee’: l’‘etrusco’ di Lemno, eteocretesi ed eteocipri, i minoici. Lingue e grafie sconosciute: un problema di metodo (l’impossibilità di comprendere una lingua, la cui tradizione si sia interrotta, senza traduzioni in altra lingua conosciuta o senza forti somiglianze con altra lingua conosciuta; la decifrabilità di una lingua conosciuta ‘nascosta’ sotto una grafia ignota). Nomi propri (antroponimi, toponimi, teonimi: la cautela necessaria di fronte a questo materiale, variabile e ‘insensato’) e dati archeologici. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 4.2. Migrazioni e invasioni nel II millennio Gli Ittiti e i Luvi dal 2000 al 1200: strutture indoeuropee, lessico ‘nuovo’ (rapporti con gli Ahhijawâ). Gli Arya (le iscrizioni Hurriche del XIV sec. con divinità indoiraniche e i testi di ippologia: Indra, Nāsatya, Mitra, Varuna) e il regno di Māda (Mh`doi) tra XIV e XIII sec. a.C. Illiri, Macedoni, Traci, Frigi dalla parte settentrionale della penisola balcanica (XIII sec. ca.). Le altre popolazioni anatoliche: Lici (estese iscrizioni funebri), Lidi, Cari. Le popolazioni caucasiche. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 4.3. Ittiti e Luvii Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 5. Il greco miceneo Storia documentaria delle scoperte Immagini di testi su tavolette e reperti archeologici Vedi anche il file PDF Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Michael Ventris (12.7.1922-6.9.1956) Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Sir Arthur Evans (8.7.1851-11.7.1941) Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Heinrich Schliemann (6.1.1822-26.12.1890) Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Le tavolette cretesi Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Tavolette a foglia di palma Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Tavolette a piena pagina Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Scritture nel mondo miceneo: I ‘geroglifici’ Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Il disco di Festo Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 La lineare A Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 La lineare B Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Il segnario miceneo Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 La natura della grafia sillabica micenea Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Gli ideogrammi e il contesto Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 I numerali Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 I determinativi di A. Evans • i segni ‘categoriali’ (come le nostre maiuscole): CITTA’, NOMI, PIANTE; • il determinativo della ‘sovranità’: • il determinativo della ‘sacralità’: Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Segni ideografici Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Ipotesi sul rapporto tra lineare B e A 1) L’ortografia ‘reale-palaziale’ (A. Evans). 2) La stessa lingua in grafia ‘non gotica’ (G. Pugliese Carratelli). 3) L’adattamento di una grafia a un’altra lingua. • Le linee-guida e il sistema numerale. • Il ritrovamento di lineare B in altri siti. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Scritture sillabiche a Cipro e in Anatolia Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Il sillabario cipriota Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Sillabario cipriota e Lineare B Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Nuove scoperte • Carl Blegen e la scoperta di Pilo (1939: 600 tavolette). • Alan J.B. Wace e la scoperta delle tavolette di Micene (1952: 50 tavolette). • Le più recenti scoperte a Tebe, Orcomeno, Tirinto: la rivoluzione della cronologia (dal 1750 al 1200 a.C. ca.). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 I siti del Lineare B Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Testo del “tripode” Dalla lettera di Carl Blegen (maggio 1953): Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 La tavoletta dei pugnali •Un segno, settanta sillabe? (es. ka) • La riduzione delle possibilità. • Il contesto e gli ideogrammi. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Lingua micena: il greco del II millennio 1) Le sillabe: vocali (a, e, i, o, u, a2), dittonghi (a3/ai?), sillabe aperte (ra-, re-, ri-), sillabe a doppia consonante (dwo-, pte-); 2) Mancanza di quantità: ko-wa, po-me, i-jo-te, pa-te, ti-ri-po; 3) Dittonghi: po-me/koi-no, qo-u-ko-ro, a3-ku-pi-ti-jo, de-we-ro-; 4) Unica serie per le liquide (do-e-ro, ri-no) e per le occlusive (tranne d: da-mo, te-o-jo); Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Lingua micena: il greco del II millennio/2 5) Omissioni di: consonanti finali (pa-te, po-me), nasali e liquide davanti a occlusiva e in fine di parola (a-to-roqo, a-re-ka-sa-da-ra), sibilanti davanti a consonante e in fine di parola (pe-mo, koi-no; tranne m: de-so-mo); 6) ripetizione delle vocali nei nessi consonantici: wa-naka-(ke)-te, ku-su, re-po-to, ku-pe-se-ro, po-to-ri-jo [ptolio], po-ti-ni-ja, qi-si-pe-e wa-na-ka, po-mi-ni-jo, po-pi. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Lingua micenea : caratteristiche/ 3 1) mantenimento di ā: da-mo, a-ta-na; 2) forme non contratte: e-ke-e, do-e-ra; 3) sviluppo di una semivocale di passaggio: i-jo ( i-je-re-ja; ui > i: i-jo; 4) esiti delle sonanti: a-mo, pe-mo, pa-ro, a-pu, qe-to-ro-po-pi, to-pe-za, ma-ra-ku []; 5) j > h o z ( ze-u-ke-u-si), sorda + j > s (pa-sa-ro, pa-sa), sonora + j > z (pe-za), sj > j (gen. -oio da -osjo), ki/ke/gi/ge + vocale > z (o gutturale palatale) + vocale (su-za, ai-za), conservazione di w (wo-no); Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Lingua micenea: caratteristiche 6) sonore aspirate > sorde (e-ke), d per l (da-pu3-ri-to-jo), conservazione delle labiovelari (qe-to-ro-we, i-qi-ja), tranne che prima e dopo u (qo-u-ko-ro), mancato passaggio di m a n (e-me); 7) caduta della sibilante iniziale (e-me, e-qo-te, a2-te-ro), ti/thi > si (kori-si-jo), semplificazione dei nessi con sibilante (me-no, mhno-, lat. mēnsis); 8) varianti (a/o [ma/mo], a2/e [fialh/ fielh], a/u [da-ma-te/du-ma-te, damartej], e/i [dentale + -emi- > -imi-: a-ti-mi-te], e-pi/o-pi, o/u, u/i) e lingua scritta; Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: temi in -a sing. N. -a (do-e-ra, e-qe-ta). G. -a (di-wi-ja), -ao (qu-qo-ta-o). D. -a (po-ti-ni-ja, ra-wa-ge-ta). A. -a (ki-ti-ta). dual. N.A. -o (ko-to-no), -ae (e-qe-ta-e). G.D. -oi (wa-na/no-soi). pl. N. -a (e-qe-ta) G. -ao (e-re-ta-o). D. -ai (ku-na-ke-ta-i). A. -a. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: temi in -o sing. N. -o (do-e-ro) G. -ojo (di-wo-ni-so-jo). D. -o (da-mo). A. -o (ri-no). dual. N.A. -o (pa-sa-ro). G.D. -o. pl. N. -o (du-to-mo), -a. G. -o (a-ne-mo). D. -oi. A. -o (si-a2-ro, sialonj), -a (do-ra). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: temi in consonante sing. N. - (pa-te, ti-ri-po) G. -o (po-me-no, poimevnoj) D. -e (po-de, a-ti-mi-te), -i. A. -a. dual. N.A. -e (ti-ri-po-de). G.D. -oi. pl. N. -e (to-ra-ke), -a (ke-ra-a). G. -o? D. -si (pa-si). A. -e (a-ko-so-ne), -a (tu-we-a, quvea). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: temi in dittongo sing. N. -eu (ka-ke-u), G. -ewo (i-je-re-wo), D. -ewe (ka-ke-wi). A. -ewa? dual. N.A. -ewe (ke-ra-me-we). G.D. ?. pl. N. -ewe (ka-ke-we). G. ?. D. -eusi (ka-ke-u-si). A. -ewe?. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: comparativi, pronomi, numerali • Comparativi: me-u-jo, me-wi-jo, me-zo. • Pronomi: mi, pei (sfei, to-jo, to-to, jo/o, jo-qi (o(/ti). • Numerali: e-me, dwo, du-wo-u-pi, ti-ri-, qe-toro-, we-, e-ne-wo-, de-ko-to. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: verbi pres. att. e-ke, a-ke, pe-re, di-do-si, pa-si, e-ko-si, e-e-si. pres. med. di-do-to, i-je-to fut. do-se, do-so-si, a-ke-re-se aor. a-pe-do-ke; a-pu-do-ke, e-ra-se, wi-de, de-ka-sa-to, a-ke-re-se perf. e-pi-de-da-to imper. pres. e-e-to part. pres. att. e-o, e-ko-te, e-qo-te, o-pe-ro-sa pres. med.-pass. o-ro-me-no, re-qo-me-no, ki-ti-me-na fut. med. ze-so-me-no aor. a-ke-ra-te perf. a-ra-ru-ja, de-do-me-na, ke-ke-me-na inf. pres. att. e-ke-e, a-na-ke-e agg. verb. a-pi-ko-to, a-na-mo-to Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Morfologia: preposizioni, negazioni, congiunzioni • Preposizioni: a-pi, a-pu, e-ne-ka, e-pi, ku-su, meta (dat.), o-pi, pa-ro, pe-da (acc.), po-si, en-, an-, peri, po-ro, pos, u-pa. • Negazioni: o-u, o-u-qe. • Congiunzioni: -qe (-te), a-u-qe, -de, o-/ jo- . Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Una tavoletta di Pilo (PY Eb 297 = 140 DMG = 95 Palmer) Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 Una tavoletta di Pilo (PY Eb 297 = 140 DMG = 95 Palmer) i-je-re-ja e-ke-qe eu-ke-to-qe e-to-ni-jo e-ke-e te-o ko-to-no-o-ko-de ko-to-na-o ke-ke-mena-o o-na-ta e-ke-e «la sacerdotessa possiede e dichiara che il dio (la dea) possiede l’etonion, mentre i proprietari di terre (affermano) che possiede gli usufrutti delle terre pubbliche» Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 5. Aufstieg und Niedergang dei Micenei • Insediamento: parallelo a quello di Ittiti e Luvi, all’inizio del II millennio a.C. in Anatolia? • Le tavolette: a un passo dalla catastrofe (to-to we-to; il 1400 a Cnosso e il 1200-1150 altrove; l’esercito, i rematori, e il fronte di Pleurone; l’arrivo dei Dori?). • Termini della sovranità: wa-na-ka, ra-wa-ge-ta, te-re-ta-i, qa-si-re-e. • Religione: Zeus, Era, Posidone, Atena, Artemide, Dioniso, Enialio, po-tini-ja da-pu-ri-to-jo. • I metalli, l’oro, i manufatti elaborati, le armi. • L’allevamento, l’agricoltura, la lavorazione della lana, l’olio. • I rapporti ‘internazionali’ (es. l’Egitto, la Fenicia, Anatolia come dai testi ittiti datati 1200 a.C.) • Scomparsa del regno miceneo parallela a quello ittito (ca. 1100 a.C.). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. Il greco delle iscrizioni: Le fonti per lo studio dei dialetti • Le iscrizioni (pronuncia e forme grammaticali di una parlata locale): ma le iscrizioni arcaiche sono rare, mentre sono frequenti quelle a partire dal IV sec. (quando domina già la koinhv) e quelle in ionico-attico (che è il dialetto per cui ce ne sarebbe meno bisogno, perché ampiamente rappresentato a livello letterario). • Le lingue letterarie (che non corrispondono alle parlate locali se non in Attica, a Lesbo e in parte a Siracusa, ma danno informazioni sui modi di impiego dei vari mezzi di espressione. • I Greci non possiedono una letteraria unitaria – nemmeno la lingua di Omero – distinta dalle lingue parlate, ma le lingue letterarie non rispecchiano le differenze linguistiche diatopiche. •Le testimonianze lessicografiche e grammaticali (a partire dalla fine del IV sec. a.C.). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 1 Il paradosso dei dialetti greci • Ogni regione, ogni città, ogni genere letterario, ogni autore ha una varietà sua propria: il greco, con l’ittita e l’indoiranico, è la lingua ie. attestata più anticamente, ed è quella con la maggior varietà di parlate fin dall’inizio della sua tradizione. • Gli apparentamenti e le cartine ‘a macchia di leopardo’. • La storia delle stirpi e la geografia del mondo greco: il carattere misto e diacronico delle migrazioni (ultima quella dorica, prima – forse – quella ionico-‘achea’), le catene montuose, le isole e i bracci di mare. La complessa ripartizione dei dialetti rispecchia la complessa storia delle migrazioni indoeuropee nel Mediterraneo orientale (in gran parte sconosciuta) e la complessa storia della colonizzazione greca (in parte conosciuta). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 2 Il greco e i ‘greci’ • L’alfabeto (tranne a Cipro), la letteratura, la coscienza di parlare la stessa lingua, gli dèi e gli agoni panellenici. • Differenze dialettali antiche nette (-men/-mej, -men,-menai/, -nai/, -en, αij///εij, aν/κα, κεν), l’unificazione grafica e letteraria, la coscienza di parlare una stessa lingua. • Le sopravvivenze del fondo indoeuropeo, le innovazioni della fase comune, le innovazioni indipendenti, le innovazioni dovute a coesistenza posteriore, i prestiti (l’esempio di eijrhnh ionico), commistioni e sovrapposizioni dialettali (l’esempio dell’eolico nella ionica Chio, dell’arcadico-cipriota nella dorica Creta, di -ti > -si). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./3 Cartina della Grecia dialettale Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./ 4 Distribuzione dei dialetti greci Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./ 5 L’ Acheo tra realtà e mito: un gruppo discusso •Sin dai testi ittiti si nominano gli Ahhiyawa, forse un’ isoglossa di Achei, rappresentati da un gruppo non compatto, non esteso sino all’età storica, incapace di penetrazione culturale e linguistica. •La lingua degli Achei (II metà del II millennio a.C.). Le colonie peloponnesiache pre-doriche (Λακεδαiμων, Κερuνεια a Cipro e in Acaia) e i relitti del grande impero acheo (sin dal XIV sec. a.C.: Acaia, Creta, Rodi, Ftiotide, Ponto Eussino). • Le enclaves linguistiche: Arcadia, Cipro, Panfilia. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. /6 Gli Arcadi • La grande popolazione pre-dorica e il popolo di pastori. • La mancanza di una letteratura e le iscrizioni dal V al III sec. a.C. (mesoun, didumoiun). • I caratteri dell’arcadico: conservazione di ü e aspirazione, conservazione del gruppo –ns- acc. Pl., dat. sing. in -oi, estensione di -au ai femminili (oijkiau), des. medie in -toi. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. /7 Una parentela a distanza: Cipro e Arcadia •Unità arcadico-cipriota - Ti è assibilato > -si • A Cipro si è adottata una scrittura di tipo sillabico che rende difficilmente l’imperfetto adattamento al greco (es. po-to-li-se /ptolis/) a causa di un sistema di scrittura usato per un’altra lingua. • La mancanza di una letteratura, le iscrizioni a partire dal V/IV sec. a.C. (tranne un’iscrizione del 1050-950 ca. a.C. scoperta a Palepafo nel 1979), le glosse. • I caratteri del ciprio: in + acc = ion eij + acc.; infinito in –nai; si mantiene l´orginario –onsi/ onsa. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./ 8 Tra Greci e barbari: il panfilio • Aspendo (Aspendoj e le colonie di Argo achea -l’Argo omerica). • Le poche iscrizioni e glosse e il greco ‘lontanissimo’ ma imparentato con l’arca-dico e con il cipriota (malgrado Hoffmann-Debrunner-Scherer, che da ultimo lo considerano un dialetto a parte). • La mancanza dell’articolo. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 9 Lo ionico-attico • Contatti culturali e sintesi avanzate. • La geografia dello ionico: l’Eubea, le Cicladi (meno Tera, Melo, Coo, Cnido e Rodi), l’Asia Minore; la Calcidica, Italia (Cuma) e Sicilia, Massalia e Agde (non esiste una sola città ionica sul continente greco). • La sovrapposizione all’eolico (es. di Herodot. I 150 e della conquista di Smirne eolica da parte dei Colofonii), la ritirata di fronte al dorico (es. di Thuc. VI 4,6 e di Zancle sotto Anassila); la varietas dello ionico (rotacismo a Eretria di Eubea, la psilosi microasiatica); la lingua ‘comune’ nata dalla precoce civiltà mercantile ionica (l’eliminazione dei tratti locali). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./ 9 Caratteristiche ionico-attiche /2 •I tratti comuni allo ionico e all’attico: la chiusura di a (lunga) in h, mantenimento di a puro in attico dopo e,i,u,r; l’abbreviamento in iato (ew), le contrazioni e la precoce caduta di ü, il passaggio dei nomina agentis in -thr a -thj, eteroj per ateroj (da *sm-teros), le desinenze in -a~ e in -e~ aggiunte agli acc. e ai nom. dei pronomi personali, oi e ai per toi e tai, la 3 pers. pl. del passato in -san e il -n efelcistico, gli avverbi di luogo in -ου (oπου), le preposizioni non apocopate, an per ke. • I tratti distintivi: la pronunzia |ü| di υ ad Atene, ion. -rs- / att. -rr-, prhssw / prhttw (Eretria) / prattw, psilosi / aspirazione, / gen. -ew / gen. -ou (politew/politou), πoλιoς / πoλεως; ξεiνος / ξeνος; κοuρη / κoρη, att. meizwn e kreisswn. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 10 Il dialetto attico / 1 Il dialetto attico, a differenza del dialetto eolico e ionico d'Asia, non presenta la psilosi delle vocali o consonanti aspirate iniziali L'esito fonetico nell'evoluzione dei gruppi consonantici occlusiva+jod non passa al gruppo spirante -σσ-, bensì rimane come doppia occlusiva -ττesempi: *πραγ-yo- si evolve in πράττω, pratto -"faccio"- contro a dorico, eolico e koinè → πράσσω, prasso Questa caratteristica è estesa anche a gruppi -σσ- originari, vale a dire che θάλασσα, thalassa -"mare"- in attico è θάλαττα, thalatta ed è presente sia in Beozia che in Eubea. Il gruppo -ρσ- di altri dialetti si assimila in -ρρ- (scritto anche –ρ(spirito aspro) ρ (spirito dolce) - a descriverne l'esito fonetico) • esempi: in attico l'esclamazione-imperativo "coraggio!" è θάρρει (tharrei) mentre in altri dialetti è θάρσει (tharsei). Il digamma appoggiato a liquida e nasale ( -λF-vF -ρF ) sparendo non provoca allungamento di compenso nella vocale precedente.: Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 10 Il dialetto attico / 2 da un originario καλFός, kalwòs -"bello"- documentato in Beozia, l'attico produce κaλός con la breve ampiamente testimoniata dalla poesia drammatica, contro al normale esito κaλός documentato in Omero e in altri dialetti. 2. da un originario ξενFος, ξenFos, "straniero, ospite" (conservato nel dorico) mentre in ionico ed eolico risuta ξεiνος, ξeinos, in attico prevale ξένος 3. da un originario FορFος, worwos, "confine" documentato nel miceneo, che mentre in dorico diviene wρος e in ionico ed eolico οuρος, ma in attico resta oρος. alfa lunga originaria preceduta da ε, ι oppure ρ, (fenomeno definito tradizionalmente alfa puro) non passa ad η come di norma nei dialetti ionici Le eccezioni a tale fenomeno (κόρη, kòre "ragazza" e κόρρη, kòrre, "tempia", δέρη, dére, "collo") sono spiegabili con la concomitanza della lenizione di digamma. 1. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 10 Il dialetto attico / 3 Contrazione. In Attico, diversamente che in ionico la contrazione tra vocali è un fenomeno antico ed esteso, che non solo influenza la coniugazione, dittongando vocali che in Erodoto e altri autori ionici rimangono distinte, ma anche la declinazione nominale e pronominale (in particolare è documentato principalmente in attico il passaggio da heautouheautwn a hautou-hautwn e persino gli stessi confini di parola, come è il caso delle numerose crasi documentate nella letteratura drammatica e nella logografica. Morfologia Rispetto alle altre parlate ioniche l'attico è un dialetto caratterizzato da diversi fattori di conservazione: in particolare la persistenza di uso del duale anche in periodi in cui tutti gli altri dialetti lo avevano abbandonato da secoli. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6./ 11 Distribuzione delle stirpi: gli Eoli Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 11 L’eolico: i tre gruppi / 2 • La costa settentrionale dell’Asia Minore da Smirne alle colonie ioniche dell’Ellesponto (la lotta tra Eoli e Ioni d’Asia, a partire dal IX sec. a.C.: l’esempio di Chio, Eritre, Clazomene, Focea) e l’isola di Lesbo (il VI sec. di Saffo e Alceo, e le iscrizioni del IV sec.): la prevalenza (culturale) del lesbico e la lingua del IV-III sec. (l’es. della baritonesi). • La Tessaglia: l’isolazionismo, gli allevatori e i peri oikoi, la mancanza di unità politica, di una letteratura e di una lingua comune; la Tessaliotide (Farsalo e Ciero: i rapporti con il dorico) e la Pelasgiotide (Larissa). • La confederazione beotica e l’unitarietà; la scarsa penetrazione politicoculturale (gli esempi contrastanti di Pindaro e Corinna); la lingua unitaria (dall’età classica al II sec. a.C.) e le riforme del III sec. (oe per oi, ou per |u|, u per oi > |ü|, h per ai > |e|, ei per h). • La variegata geografia dell’eolico (eolismi ‘fuori sede’) e l’accezione (non letteraria, non antica) di dialetto eolico. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 11 Caratteristiche eoliche / 3 • L’evoluzione labiale delle labiovelari in inizio di parola. • Le desinenze del presente per il participio perfetto attivo. • L’evoluzione scura della sonante r (or, ro contro ar, ra). • Gli aggettivi patronimici (cf. il nuovo Posidippo, di Pella). •Una caratteristica interessante, sul piano delle consonanti, è il trattamento delle velari micenee kw e gw, che vengono mutate in π e β anche davanti ad ε: così abbiamo in eolico πέμπε e βελφίς, invece di πέντε e δελφίς. Questo fenomeno influenza anche l' arcado-cipriota. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 11 Caratteristiche eoliche/4 Flessione nominale Nella prima declinazione, il genitivo plurale è -αν, privo d'accento per la legge della baritonesi. Il dialetto eolico di Tessaglia e Beozia mantiene ancora, nella seconda declinazione, il genitivo -οιο, poi semplificato in -οι. Nella terza declinazione, il dialetto eolico ha un dativo plurale in εσσι, generalizzato dai temi in sibilante. Le tangenze fra il dialetto eolico e il cosiddetto dialetto ionico della lingua dell'epica di Omero, fanno sì che tale forma faccia capolino anche nello ionico letterario. Flessione verbale L'imperativo, in eolico, sia in Anatolia, sia in Tessaglia, mostra la desinenza, -ντον nella terza plurale: ad es.: δίδoντον (att. διδόντων). Nel verbo eolico si riscontra la tendenza ad estendere ai participi perfetti la declinazione dei participi presenti: così ad esempio, il participio perfetto di γίγνομαι, verbo che in eolico suona γίνυμαι (modellato analogicamente sui verbi atematici di seconda classe), si declina: γεγόνων γεγόνοντος. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 11 I rapporti tra i tre gruppi eolici / 5 • 1) Le concordanze lesbico-tessalico contro il beotico: e[mmi vs eijmi. •2) Le concordanze beotico-tessalico contro il lesbico: ginumai vs gignomai, ginomai •3) Le concordanze lesbico-beotico: strotoj, peda (corrisponde a meta). •4) La posizione del beotico e gli influssi nordoccidentali (da non sopravvalutare, malgrado Pisani, che considera il beotico un dialetto a parte, in coda ai dialetti dorici. •5) La posizione del lesbico e gli influssi ionici microasiatici: ti > si, proti > proj; en + acc. (non dat.); eol. e tess. on per ana; psilosi e baritonesi, scomparsa del F, mantenimento del suono sd, soluzione di ns panellenico nei gruppi -ais-, -eis, -ois-, coniugazione atematica dei verbi contratti, desinenze della 3 pers. pl. dell’imperativo in -nton. •6) La posizione intermedia del tessalico: pansa, gen. -oio. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 12 I Dori: l’ultima invasione indoeuropea • L’enorme estensione del gruppo occidentale: i pochi che governano sui molti (Thuc. IV 126) e la guerra come stile di vita (Plat. Leg. 625d). • Dori del nord (aperti e pacifici) e Dori del sud (chiusi e bellicosi). • I Dori distinti in 3 phylai: Illi, Dimani e i Pamfili ad Argo, Sicione, Corcira, Epidauro, Megara, Creta, Tera, Coo, Cirene, Agrigento: la quarta tribù locale) e la successiva costituzione spartiate di Licurgo. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 12 L’ultima invasione indoeuropea: i Dori /2 Dori furono una popolazione della Grecia antica, di origine indoeuropea. Il termine Dori viene tradotto combattenti con la lancia I Dori da alcuni non sono considerati stirpe ellenica, ma essi fecero del loro dio eponimo Doro un figlio (il quarto) di Elleno, il capostipite degli Elleni. Le genti doriche, rappresentanti dell'ultima ondata delle tribù che da nord e da est invasero la penisola e le isole greche, abitavano originariamente la regione danubiana per poi passare nella valle del Vardar. Penetrarono in Grecia parte attraverso l'Epiro e l'Illiria e parte attraverso la Macedonia Occidentale e la Tessaglia. Raggiunsero il Peloponneso distruggendo Micene e Tirinto. Alcune loro città (Corinto e Megara in particolare) presero parte al grande movimento colonizzatore che a partire dall'VIII secolo a.C. si sviluppò in tutto il Mediterraneo. Colonie doriche furono fondate in Asia Minore, a Cipro, in Africa settentrionale ed in Italia (Magna Grecia e Sicilia). Fra queste ultime vanno segnalate Ancona, Siracusa e Taranto, le più popolose e ricche città greche d'Italia prima della conquista romana. Nella tradizione antica questa migrazione è rappresentata dalla leggenda del ritorno degli Eraclidi. Secondo la testimonianza di Erodoto e Tucidide i discendenti di Eracle verso il 1200 a.C. si sarebbero spinti nel Peloponneso, in Laconia e nella Messenia. Alcuni studiosi hanno individuato nel racconto mitologico una prova della cosiddetta "invasione dorica", ultima responsabile della decadenza della civiltà micenea. Per tre secoli, a partire dal 1100 a.C. circa, la Grecia attraversò un periodo di assestamento, chiamato dagli storici Medioevo ellenico, caratterizzato da una commistione dei tratti peculiari della precedente cultura micenea e delle innovazioni doriche, quali l'introduzione dell'uso del ferro, dell'incinerazione dei morti e della costruzione dei primi templi. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 12 L’estensione del territorio dorico • Corinto, Argolide, Laconia e Messenia • Le Cicladi meridionali e le Sporadi (Melo, Tera, Càrpato, Coo, Rodi, Telo), Cnido e Alicarnasso, Citera e Creta • Le colonie megaresi del Ponto Eussino (Calcedonia e Bisanzio), Corcira, Cirene (630) • Magna Grecia (Sibari, Crotone, Metaponto, Poseidonia achee, Taranto laconica > Eraclea sul Siri [432]) • Sicilia (Siracusa calcidese [734] e Archia corinzio, Megara Iblea > Selinunte [650], Gela rodio-cretese [690] > Agrigento [580]). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 12 Documentazione del dorico / 2 • La letteratura dorica: la lirica corale e l’alta formalizzazione letteraria, i frammenti di Epicarmo e Sofrone, le mimesi aristofanee, la prosa dei Dissoi Logoi, il corpus teocriteo, gli scritti ‘regolarizzati’ di Archimede). • Le iscrizioni laconiche, argive, cirenee (oi/ /toi, ekassa/ekoisa), cretesi • La grande legge di Gortina e la koinh siracusana. • I patois dei signorotti feudali (l’es. di mikkiciddomenoi = mikizomenoi) versus la koinh ionica. • Il greco del NO e la sua parentela solo formale con il dorico: Focide (Delfi), Locride, Etolia, Acarnania, Epiro; la posizione singolare dell’eleese. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 • 6. / 12 Caratteristiche doriche / 3 •Non altera in η l'α lungo impuro, praticamente mai. Ciò rende particolarmente trasparente il confronto fra il dorico stesso e altre lingue indoeuropee, mentre determinati tratti originari nello ionico e nell'attico sono opacizzati. μάτηρ ("madre") e φάμα ("fama"), ionico-attico μήτηρ e φήμη. •Il dorico ha una α breve dove lo ionico-attico ha una ε o contrae in ι, come nell'aggettivo hiαρός, "sacro", che in attico è hiερός, e in Omero hiρός. •Il dorico conserva tracce più ampie della sonante lunga (o della coppia sonante+ laringale) tardo-indoeuropea: ad esempio πρaτος, "primo", da *prhtòs, al posto di πρwτος. •Il dorico contrae sempre in η le vocali di timbro E ed O. Inoltre, contrae in α i timbri A e O. Genitivo plurale di prima declinazione dorica suona an con accento circonflesso, mentre in attico è wν, Entrambe dal miceneo αων, ancora attestato nel dialetto omerico. •Allungamento di compenso e la contrazione in vocale lunga aperta, anziché in dittongo (il dittongo, o meglio, la vocale lunga chiusa, è un fenomeno tipico dello ionico-attico). Così le forme ionico-attiche εiμί, Paola Cotticelli - Storia dellaMwσα. hiππου, Mοuσα diventanoProf.ssa in dorico hμί, hiππω, lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 13 Caratteristiche doriche / 4 •Il futuro costituisce l'innovazione più tipica per cui il dorico si differenzia dagli altri dialetti greci. Il futuro dorico, presente occasionalmente in alcuni verbi di altri dialetti, ha il caratteristico suffisso -σέω, -σίω. Tale forma di futuro è particolarmente notevole per due ragioni: •si differenzia dagli altri futuri dei dialetti greci e dal futuro latino arcaico in -so, che derivano dal congiuntivo dell'aoristo indoeuropeo; •appare estremamente vicino al futuro indoario in -syāmi e al futuro lituano (tipo duosiu). Quest'ultimo dato ha fatto pensare a un futuro indoeuropeo in *-syō. In realtà, si tratta di una tarda innovazione che, partita da alcune aree dialettali del proto-indoiranico, ha influenzato alcune aree del proto-greco e del proto-balto-slavo, quando erano relativamente vicini nelle aree attigue all' Urheimat degli indoeuropei. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 12 Caratteristiche doriche / 5 Il dorico, come lo ionico-attico, perde il σ prevocalico e lo jod (semivocale palatale indoeuropea *y). A differenza dello ionico, è un dialetto non psilotico, cioè sostituisce la consonante scomparsa con un'aspirazione /h/, uno spirito aspro, che ha in comune con l'attico. Il dorico mantiene il digamma, scritto F, la semivocale labiovelare *w indoeuropea, ancora nel V secolo a.C., mentre lo ionico-attico la perde già alla fine del IX secolo a.C., in fase predocumentaria. Es. Fάναξ ("re" -il miceneo wa-na-ka), Fέργον ("lavoro", cfr. l'inglese work e il tedesco werk). In dorico, come abbiamo detto, la *t indoeuropea resta invariata davanti a vocale chiusa ι e υ: così abbiamo τύ, "tu", dove l'attico ha σύ; δίδωτι "egli dà" (cfr. il sanscrito didāti), dove l'attico ha δίδωσι. Inoltre, πότις, sposo, (indoeuropeo *potis, signore, marito), e Ποτειδάς, Poseidone (in Omero Ποσειδάων), letteralmente "Sposo della (madre) Terra, Δα-μάτηρ" (secondo il mito arcadico, e già miceneo, che influenza sotterraneamente i culti e le denominazioni di divinità nel Peloponneso). l'antico gruppo *tw si semplifica in τ, come in τέτορες "quattro". in dorico, il θ evolve in σ: ad es. σιwν, per θεwν, "degli dèi", in Alcmane. il dorico tende a sostituire la Ζ con il gruppo ΣΔ: ad esempio μελίσδεται per μελίζεται "risuona", attestato in Teocrito. Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010 6. / 13 Rapporti tra i dialetti Gruppo eolico: lesbico più vicino allo ion. att., e beotico e tessalico più vicini al gruppo occidentale. Gruppo acheo: arcadico più vicino allo ion. att., e cipriota e panfilio più vicini al gruppo occidentale. I rapporti tra panfilio, lesbico e dorico. • Ionico/eolico, attico/beotico, arcadico/laconico e argivo. • Delfi, i giochi olimpici, l’alfabeto. • La terra che divide, il mare che unisce: il dominio sul Mediterraneo orientale e kubernaw. • Dalla guerra alla ‘pace’: l’evoluzione di polij da ‘cittadella’, ‘piazzaforte’ (ai. pur, lit. pilis “castello”) a ‘città’, ‘stato’. • Apertura (gli Ioni: il ‘meticciato’) e chiusura (i Dori: il carattere di Sparta, l’involuzione di Creta, l’eccezione di Corinto e Siracusa). Prof.ssa Paola Cotticelli - Storia della lingua greca - aa. 2009-2010
Scarica