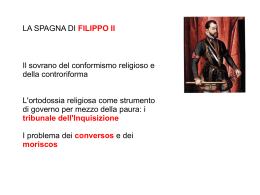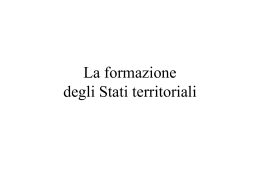Bibliografia: Vittorio Alfieri • Edizioni critiche (Centro Nazionale di Studi Alfieriani di Asti): Filippo, a cura di Carmine Jannaco (1952); Mirra, a cura di Martino Capucci (1974), Saul, a cura di C. Jannaco e Angelo Fabrizi (1982). • Ezio Raimondi, Le pietre del sogno. Il moderno dopo il sublime, Bologna, Il Mulino, 1985; Giuseppe Antonio Camerino, Alfieri e il linguaggio della tragedia, Napoli, Liguori, 1999. Suggestiva e fondamentale rimane la lettura di Giacomo Debenedetti, Vocazione di Vittorio Alfieri, Roma, Editori Riuniti, 1977. Bibliografia: Alessandro Manzoni • L’edizione critica del Conte di Carmagnola, a cura di G. Bardazzi, Milano 1985. Oggi si dispone anche di quella a cura di Giuseppe Sandrini, uscita nel 2004 a Milano, presso il Centro Nazionale di Studi Manzoniani, nell’ambito dell’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni. Tra le numerose edizioni economiche, si segnala quella a cura di Gilberto Lonardi, con note di Paola Azzolini, Venezia, Marsilio, 1989. • L’edizione critica dell’Adelchi, a cura di Isabella Becherucci, è uscita nel 1998, a Firenze, presso l’Accademia della Crusca. Anche in questo caso, tra le numerose versioni economiche disponibili, si suggerisce quella curata da G. Lonardi e annotata da P. Azzolini (Venezia, Marsilio, 2005 - I ed.1987). • Sulla drammaturgia manzoniana: G. Lonardi, Ermengarda e il Pirata, Bologna, Il Mulino, 1991; Carlo Annoni, Lo spettacolo dell’uomo interiore. Teoria e poesia del teatro manzoniano, Milano, Vita e Pensiero1997. Cronologia essenziale V. Alfieri • Filippo 1775-76 e 1780-82 • Saul 1782 (con correzioni fino al 1788) • Mirra 1784-87 A. Manzoni • Il Conte di Carmagnola 1816-20 • Adelchi 1820-22 Uno sguardo all’etimologia • Il sostantivo ‘teatro’ proviene dal latino theatrum, che a sua volta ricalca il greco théatron, derivante da theaomai, che significa ‘guardo’, ‘sono spettatore’ . • Il termine tragedia – tramite il latino tragoedia – deriva dal greco tragoidia, che significa letteralmente ‘canto del montone’ o ‘canto per il (in onore del) montone’, poiché – probabilmente – le prime tragedie vennero rappresentate in occasione delle feste in onore del dio Dioniso (o Bacco), ispiratore dell’arte drammatica, durante le quali venivano portati in corteo e sacrificati capri e montoni . La rinascita della tragedia (I) • 1514-15, Giangiorgio Trissino, Sofonisba (prima rappresentazione, in francese, nel 1554 a Blois, per volere di Caterina de’ Medici). • 1515, Giovanni Rucellai, Rosmunda • 1524, Alessandro de’ Pazzi, Dido in Cartagine (dopo avere tradotto in latino l’Elettra e l’Edipo, e in volgare lo stesso Edipo e l’Ifigenia in Aulide e il Ciclope). • 1522 ca. Luigi Alamanni, Antigone • 1525 ca. Ludovico Martelli, Tullia (ed. postuma 1533). La rinascita della tragedia (II) • 1541, Giambattista Giraldi Cinzio, Orbecche • 1542, Sperone Speroni, Canace • 1546, Pietro Aretino, Orazia • 1587, Torquato Tasso, Torrismondo Giraldi, Orbecche, III 2 (vv. 1104 e ss.) La mia figliuola, in cui sola avea posto tutta la speme mia, tutto il mio bene, per cui sola i’ sperava questo poco di viver che m’avanza esser contento, mostrato m’ha quanto sia stato folle il mio pensiero e quanto infide e ingrate siano le donne tutte e ch’al lor peggio s’appiglian sempre. Costei che poteva aver Selino, un de’ gran re del mondo, per suo marito, ha preso un che di vile sangue creato insin da’ suoi primi anni ne la mia corte s’è nodrito. [...] Avrò per figlia una che me da padre non tiene? E per fedele un che me ’nganna? Semplice ben sarei più d’ogni sciocco s’io mi lasciassi por questa su gli occhi e non mostrassi a l’uno e a l’altro quanto aver poco rispetto a un re sia grave. Vedrà quel traditor, vedrà la figlia (se figlia si dee dir femina tale) ciò che posson gli scettri e le corone e s’io saprò mostrare ad ambo loro (com’a molti ho mostrato) esser re vero. Sperone Speroni, Canace, vv. 616-658 […] ’l mio peccato, non malizia mortale, ma fu celeste forza che ogni nostra virtù vince et ammorza. […] Vili seco, io nol nego, e disoneste fur le opere mie; ma n’ebbi quel che non pur non sperai, ma mai non disiai. Spinse allor le mie membra non propria elezione, ma uno impeto fatal che intorno al core mi s’avolse in quel punto e in vece d’alma mosse il mio corpo frale e sforzollo a far cosa orribile a chi l’ode, a chi la fe’ odiosa. [...] Or vivo e con l’empiezza del mio grave peccato, che spense il nome e la ragion fraterna, do cagione a mio padre di divenir spietato, crudelmente extinguendo col sangue de’ suoi figli la sua pietà paterna. Orazi e Curiazi (da Livio, Hist., I 24-25) Cavalier d’Arpino, Combattimento tra gli Orazi e i Curiazi, Roma, Palazzo dei Conservatori, 1612 Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, Parigi. Louvre, 1785 Pietro Aretino, Orazia, III, vv. 1627 e ss. III, vv. 1627 e ss. Io vo’ inferir che pare orribil cosa l’avere Orazio la sorella uccisa, perché il velame de la crudeltade l’atto ricopre: che da ragion mosso fece ciò ch’egli ha fatto e ch’io farei contra me stesso, non che d’un mio figlio, quando che io in me medesmo ardissi ombrar col duolo il comun gaudio e solo. V, vv. 2438 ss. Ben sa de i sommi Dei la providenza che il tutto è intervenuto perché Celia gran cagion dienne a lui, giovane altiero. Devea la crudeltà, dal suo marito usata in tòr del mondo i fratei suoi, ispegner la pietà, ch’ella ebbe tanta de la morte di tale, e saria viva, e ’l cor proprio d’Orazio, che sospinto fu al giusto atto da reale sdegno. T. Tasso, Torrismondo, 1587 Situazione di partenza Re dei Goti → Alvida >< Rosmonda (scambio) ↓ Re di Svezia prende Alvida come figlia I movimento Re di Norvegia (Germondo) → Alvida ↓ Torrismondo (re dei Goti) ↔ Alvida II movimento Ipotesi di Torrismondo → Alvida >< Rosmonda (scambio) Scoperta della verità da parte di Torrismondo (Alvida è sua sorella) Conclusione Suicidio di Alvida e Torrismondo La tragedia secentesca • 1627-28, Federico della Valle, Reina di Scotia, Ester, Iudit • 1657, Carlo de’ Dottori, Aristodemo → la drammaturgia gesuitica Giuditta e Oloferne Caravaggio, 1599-1600 Artemisia Gentileschi, 1620 La tragedia del XVIII secolo • 1713, Scipione Maffei, Merope • 1744, Saverio Bettinelli, Gionata figlio di Saulle • 1779, Alessandro Verri, La congiura di Milano V. Alfieri, Del principe e delle lettere (1778-1786) I 8 “Leggono adunque veramente nel principato i pochi uomini rinchiusi nelle città; e fra questi, il minor numero di essi; cioè quei pochissimi che, non bisognosi di esercitare arte nessuna per campare, non desiderosi di cariche, non adescati dai piaceri, non traviati dai vizi, non invidiosi dei grandi, non vaghi di far pompa di dottrina, ma veramente pieni di una certa malinconia riflessiva, cercano ne’ libri un dolce pascolo all’anima e un breve compenso alle umane miserie; le quali forse assai più vivamente vengono sentite da chi il minor danno ne sopporta. […] Leggere, come io l’intendo, vuol dire profondamente pensare; pensare vuol dire starsi; e starsi vuol dire sopportare. […] Non nego però che a lungo andare lo spirito dei libri non s’incorpori, direi così, nello spirito dei popoli che nella loro lingua gli hanno; e penetra questo spirito in tutti gl’individui, o sia per tradizione o sua per lettura effettiva […] e penetra a tal segno che in capo a qualche secolo si trova poi mutata affatto l’opinione di tutti”. Il teatro tragico alfieriano • • • • 21 tragedie 1775-1790 Endecasillabi sciolti Intrecci brevi ed essenziali: pochi personaggi, sviluppo lineare, dialogo d’azione + monologo o soliloquio • Tema fondamentale: la tirannide (cioè la negazione della libertà) come causa suprema dell’infelicità umana (arbitrio >< pietà) • Rispetto delle tre ‘unità aristoteliche’ V. Alfieri, Vita (1790-1803), IV 4 “(I) Ideare dunque io chiamo il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginucce di prosaccia farne quasi l’estratto a scena per scena di quel che diranno e faranno. (II) Chiamo poi stendere, qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia accennata ne riempio le scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, senza punto badare el come. (III) Verseggiare finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, ma col riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle lungaggini del primo getto i migliori pensieri, ridurli a poesia, e leggibili. Segue poi come di ogni altro componimento, il dover successivamente limare, levare, mutare”. V. Alfieri, Vita, IV 2 “Noi Italiani non avendo altro verso che l’endecasillabo per ogni componimento eroico, bisognava creare una giacitura di parole, un rompere sempre variato di suono, un fraseggiare di brevità e di forza, che venissero a distinguere assolutamente il verso sciolto tragico da ogni verso sciolto e rimato sì epico che lirico” Encyclopédie, vol. V, ad vocem Elocution (1755) “Essere eloquenti […] significa comunicare rapidamente e imprimere con forza nell’animo altrui il sentimento profondo da cui si è penetrati. Questa definizione è tanto più giusta, in quanto si applica alla stessa eloquenza del silenzio e a quella del gesto”. Alfieri, Filippo • Tempi di composizione: 1775-76, 1780-81, 1785-87, 1789 • Fonte principale: César Vichard, Dom Carlos (1672) → alterazione dei fatti storici • Personaggi protagonisti: Filippo II re di Spagna, Elisabetta (seconda moglie di Filippo; Isabella nella tragedia di A.), Carlo (figlio di Filippo e Maria di Portogallo) Alfieri, Filippo • Tempi di composizione: 1775-76, 1780-81, 1785-87, 1789 • Fonte principale: César Vichard, Dom Carlos (1672) → alterazione dei fatti storici • Personaggi protagonisti: Filippo II re di Spagna, Elisabetta (seconda moglie di Filippo; Isabella nella tragedia di A.), Carlo (figlio di Filippo e Maria di Portogallo) I fatti storici • 1543 matrimonio tra Filippo II e Maria di Portogallo • 1545 nascita di Carlo e morte di Maria • 1554-1558 matrimonio tra Filippo e Maria I d’Inghilterra • 1559 pace di Cateau-Cambrésis, matrimonio tra Filippo e Elisabetta di Valois, figlia di Enrico II • 1568 ribellione dei Paesi Bassi capitanata da Guglielmo I d’Orange, e repressione spagnola; morte in carcere di Carlo accusato di avere ordito una congiura contro il padre. F. Schiller, Sul sublime, 1794-96 Il tratto distintivo dell’umanità è la volontà. […] Per questo non esiste nulla di più indegno per l’uomo che il subire violenza, giacché la violenza lo annienta. Chi usa violenza ci contende la nostra stessa umanità; chi la subisce vilmente abdica alla propria umanità. […] Questa è la condizione in cui si trova l’uomo. Circondato da infinite forze che gli sono tutte superiori, e che agiscono da dominatrici, l’uomo, in virtù della sua natura, reclama il diritto a non subire violenza alcuna. Verdi, Don Carlo (1865-86), IV 2 Elisabetta Giustizia, giustizia, Sire! Giustizia, giustizia! Ho fé nella lealtà del Re. Son nella Corte tua crudelmente trattata e da nemici oscuri incogniti oltraggiata. Lo scrigno ov’io chiudea, Sire, tutt’un tesor, i gioielli… altri oggetti a me più cari ancor, l’hanno rapito a me! Giustizia, giustizia! La reclamo da Vostra Maestà! Filippo Quello che voi cercate, eccolo! Elisabetta Ciel! Filippo A voi d’aprirlo piaccia... Ebben, io l’aprirò. Elisabetta Ah, mi sento morir! Filippo Il ritratto di Carlo! Non trovate parola? Il ritratto di Carlo! Elisabetta Sì Filippo Fra i vostri gioielli? Elisabetta Sì! Filippo Che! confessar l’osate a me? Elisabetta Io l’oso! Sì! Ben lo sapete, un dì promessa al figlio vostro fu la mia man! Or v’appartengo… a Dio sommessa, ma immacolata qual giglio son! Ed or si sospetta l’onor d’Elisabetta. Si dubita di me… e chi m’oltraggia è il Re! Filippo, I 2, 25-110 Le molteplici ‘ragioni’ di Carlo nel dialogo con Isabella • Primo livello: la corte austera e iniqua (34 e 38) • Secondo livello: “le mie angosce / principio han tutte dal funesto giorno, / che sposa in un data mi fosti, e tolta” (68-70) • Terzo livello: “Suddito, e figlio / di assoluto signor” ho sopportato tutto in silenzio; la volontà di Filippo è stata per me una legge (75 e ss.) • Quarto livello: Filippo, benché sia mio padre, mi odia e induce all’odio nei miei confronti (89 e ss.) → domanda: un padre può odiare suo figlio? • Quinto livello: “Qual havvi affetto, che pareggi, o vinca / quel dolce fremer di pietà?” (53 ss.) Filippo, I 2, 5-110: alcune parole chiave • Corte nemica (28), austera (38), empia e infame (96-97) • Padre signore (31), padre irato (62), quel padre (74), il cor del padre (88, 90), qual padre (95), si adira di essere padre (101-102) • Pietà (37, 51, 53, 55, 60) • Odio (28, 88, 90, 92, 100, 108: snaturato inaudito odio paterno) • Pianto (48, 59, 77, 86-87) • Destino: dura sorte (47-48), fortuna (57), dura necessità (64-65) La ‘posizione’ di Carlo (I 4) nel dialogo con Perez 193-196 Altro nemico / non ho, che il padre; che onorar di un tanto / nome i suoi vili non vogl’io, né il deggio. / Silenzio al padre, agli altri sprezzo oppongo. 204-210 Chiuso inaccessibil core / di ferro egli ha. Le mie difese lascia / alla innocenza; al ciel, che pur talvolta / degnarla suol di alcun benigno sguardo. / Intercessor, s’io fossi reo, te solo / non sdegnerei: qual di amistade prova / darti maggior poss’io? Filippo, II 2, 23-165 • Prima domanda di Filippo a Isabella: il dilemma tra paternità e regalità, tra “ragion di sangue” e “ragion di stato” • Seconda domanda di Filippo a Isabella: il suo ‘sentimento’ per Carlo → La (supposta) rivelazione del tradimento (60-117) • Terza domanda di Filippo a Isabella: quale sorte meriti un figlio colpevole (98) • Il consiglio di Isabella: (1) primato della paternità, (2) necessità di rigettare la logica del sospetto a favore di quella dell’ascolto, (3) possibilità di contemperare giustizia, ira e dolcezza Filippo, II 2, 23-165: la sincerità del re Stimo il tuo parere più di ogni altro (29-30) Voglio che tu sia giudice di mio figlio (58-59 e 98100) Chi più di me vorrebbe che Filippo non fosse colpevole? (107-108) Ascolto in me anche la voce del padre (117-118) Poiché tu credi Filippo innocente, sembra quasi tale anche a me (163-165) Filippo, II 2, 156-162 Oh trista Sorte dei re! Del proprio cor gli affetti, Non che seguir, né pur spiegar, ne lice. Spiegar? Che dico? Né accennar: tacerli, Dissimularli, le più volte è forza. – Ma, vien poi tempo, che diam loro il varco Libero, intero. – Assai, più che nol pensi, Chiara ogni cosa il tuo dir fammi… Lo sviluppo del dramma • II 4 Carlo ammette la sua ‘colpa’: 186-194 e 229-246 (“In cor pietade io sento / de’ lor mali”). Filippo promette il perdono (265-277) • II 5 Filippo e Gomez • III 1 7-18 e 29-34: Carlo sospetta una finzione da parte di Filippo, mentre Isabella lo rimprovera (“L’ira ti accieca; un odio in lui supponi, / che allignar non vi può”). • III 5 il consiglio notturno: Filippo, Gomez, Leonardo, Perez – Cfr. sptt. Il discorso di Perez (204-260) • IV 2 Carlo e Filippo: “Ma che fec’io? […] Ecco il mio sol misfatto: / sete hai di sangue” • IV 5 (202-234) Gomez e Isabella: l’unica colpa di Carlo è “esser figlio di un orribil padre”; lo “snaturato odio paterno” nasce da “vile invidia”. L’epilogo del dramma: il V atto • V 3 Filippo: “tutto io so: quella che voi d’amore, / me di furor consuma, orrida fiamma”; “vendetta vuolsi”; “mi giova intanto / goder qui di vostr’onta” → la colpa è un amore che Filippo interpreta come offesa, come violazione della dedizione assoluta che egli pretende per sé (cfr. v. 184: “geloso orgoglio”). • V 4 Morte di Perez e di Carlo; volontà di Filippo di tenere in vita Isabella (“Mi fia sollievo il tuo lungo dolore”); suicidio di Isabella; conclusione di Filippo (“Ma, felice son io?”). Sull’accusa di tentato parricidio Lettera di Ranieri Calzabigi, 20 agosto 1783 Avrei desiderato che fosse meglio sviluppata l’accusa del re contro il figlio d’averlo voluto trucidare. Non ben si rileva se l’attentato sia fondato sul vero, o se sia puro pretesto del padre per rendere il principe reo ed odioso. Sull’accusa di tentato parricidio Lettera di Vittorio Alfieri, 6 settembre 1783 Non ho voluto mai schiarire nel corso di quella tragedia l’accusa del parricidio dal padre apposto al figliuolo, per due ragioni: prima, perché dal totale carattere e di Carlo e di Filippo mi parea che troppo chiaramente risultasse ai leggitori e spettatori che Carlo era innocente di tale orribile misfatto: seconda, e a parer mio più forte, che volendo io a Filippo dare del feroce e cupo carattere del Tiberio di Tacito, non poteva io meglio il mio intento ottenere, che spandendo moltissima oscurità, dubbiezza, contraddizione apparente, e sconnessione di ordine di cose in tutta la condotta di Filippo. […] Tuttavia da questo disordine stesso ho voluto trane una delle pennellate più importanti del carattere di quell’inaudito padre, che mescendo il vero col falso, e valendosi del verisimile come vero, pervenne pure ad offuscar talmente l’intelletto de’ suoi contemporanei, che la morte violenta di Carlo da alcuni è negata, da altri stimata giusta e meritevole. V. Alfieri, Vita, IV 9 “Fin dal marzo di quell’anno [1782] mi era dato assai alla lettura della Bibbia, ma non però regolatamente con ordine. Bastò non dimeno perch’io m’infiammassi del molto poetico che si può trarre da cotesta lettura, e che non potessi più stare a segno s’io con una qualche composizione biblica non dava sfogo a quell’invasamento che n’avea ricevuto. Ideai dunque, e distesi, e tosto poi verseggiai il Saulle”. V. Alfieri, Parere sulle tragedie, 1789 Le antiche colte nazioni, o sia che fossero più religiose di noi, o che in paragone dell’altre stimassero maggiormente se stesse, fatto si è che quei loro soggetti, in cui era mista una forza soprannaturale, esse li reputavano i più atti a commuovere in teatro. […] Ma io benissimo so che quanto piacevano tali specie di tragedie a quei popoli altrettanto dispiacciono ai nostri. […] Il nostro secolo, niente poetico, e tanto ragionatore, non vuole queste bellezze in teatro. […] Saul, ammessa da noi la fatal punizione di Dio per aver egli disobbedito ai sacerdoti, si mostra, per quanto a me pare, quale esser dovea. Ma per chi anche non ammettesse questa mano di Dio, […] basterà l’osservare che Saul credendo d’essersi meritata l’ira di Dio, per questa sola sua opinione fortemente concepita e creduta, potea egli benissimo cadere in questo stato di turbazione. […] In questa tragedia l’autore ha sviluppata, o spinta assai più oltre che nell’altre sue, quella perplessità del cuore umano, […] per cui un uomo appassionato di due passioni fra loro contrarie, a vicenda vuole e disvuole una cosa stessa. C. Calcaterra, Il barocco in Arcadia e altri studi sul Settecento, Bologna, Zanichelli, 1950 “ Ardentissima era in Piemonte la discussione se il regime ebraico non fosse stato nulla più che un governo dispotico e tirannico, simile ad altri reggimenti orientali, come sostenevano il Boulanger e il Montesquieu, ovvero un governo teocratico, che avesse veramente attinto leggi e autorità da Dio. […] Da questa temperie di studi biblici [...] venne a lui l’idea centrale di rappresentare in Saul il terribile dramma umano, cui aveva dato luogo la forma di governo teocratico, già propria degli israeliti. Tutti gli studi biblici dei subalpini mettevano innanzi quel Re come una delle figure più drammatiche della storia ebraica. In lui era rappresentato il cozzo tra l’uomo e Dio” . Alfieri, Saul, II 2: “Piangete tutti” Cfr. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, red. 1817, II 19 (lettera da Ventimiglia, 19 e 20 febbraio) “Eccolo quel demonio mio persecutore; torna a incalzarmi, a premermi, a investirmi, e m’accieca l’intelletto, e mi ferma perfino le palpitazioni del cuore, e mi fa tutto ferocia, e vorrebbe il mondo finito con me. – Piangete tutti – e perché mi caccia fra le mani un pugnale, e mi precede, e si volge guardando se io lo sieguo, e mi addita dov’io devo ferire? Vieni tu dall’altissima vendetta del Cielo? E così nel mio furore e nelle mie superstizioni io mi prostendo su la polvere a scongiurare orrendamente un Dio che non conosco, che altre volte ho candidamente adorato, ch’io non offesi, di cui dubito sempre – e poi tremo, e l’adoro. Dov’io cerco aiuto? Non in me, non negli uomini: la Terra io la ho insanguinata, e il Sole è negro”. Alfieri, Saul, I 1: “Empio spirto” Cfr. Verdi, Macbeth, I 3 (libretto di F. M. Piave, 1847) Banco Oh, come s’empi costui d’orgoglio, Nella speranza d’un regio soglio! Ma spesso l’empio spirto d’Averno Parla, e c’inganna, veraci detti, E ne abbandona poi maledetti Su quell’abisso che ci scavò. Alfieri, Saul, III 4: “Di che pianger ora?” Cfr. Dante, Inferno, XXXIII 37-42 Quando fui desto innanzi la dimane, Pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli Ch’eran con meco, e dimandar del pane. Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli Pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; E se non piangi, di che pianger suoli? Saul, IV 3, 95-96 O ria di regno insaziabil sete, Che non fai tu? Per aver regno, uccide Il fratello il fratel; la madre i figlio; La consorte il marito; i figlio il padre… Virgilio, Eneide, III 56-57: Quid non mortalia pectora cogis, / Auri sacra fames! Marco 13,12: [Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno.] Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. E. Raimondi, Le pietre del sogno, 1985 “Il Saul è la strana interpretazione alfieriana di una crisi di identità, di una scissione dell’Io, dove sono compresenti paradossalmente Re Lear e Amleto, dove il personaggio dominante è drammaticamente conteso dal dubbio sulla perdita di se stesso, del suo ruolo di sovrano e del suo Io vivente. [...] Alfieri si rende conto che ci sono delle forze oscure, che la notte è dentro all’uomo, che distruzioni operano al suo interno”. Alfieri, Vita, IV 14 “Mi capitò alle mani nelle Metamorfosi di Ovidio quella caldissima e veramente divina allocuzione di Mirra alla di lei nutrice, la quale mi fece prorompere in lagrime, e quasi un subitaneo lampo mi destò l’idea di porla in tragedia; e mi parve che toccantissima ed originalissima tragedia potrebbe riuscire, ogni qual volta potesse venir fatto all’autore di maneggiarla in tal modo che lo spettatore scoprisse da sé stesso a poco a poco tutte le orribili tempeste del cuore infuocato ad un tempo e purissimo della più assai infelice che non colpevole Mirra, senza che ella neppure la metà ne accennasse, non confessando quasi a sé medesima, non che ad altra persona nessuna, un sì nefando amore. […] Sentii fin da quel punto l’immensa difficoltà ch’io incontrerei nel dover far durare questa scabrosissima fluttuazione dell’animo di Mirra per tutti gl’interi cinque atti, senza accidenti accattati d’altrove. E questa difficoltà che allora viepiù m’infiammò, e quindi poi nello stenderla, verseggiarla e stamparla sempre più mi fu sprone a tentare di vincerla, io tuttavia dopo averla fatta, la conosco e la temo quant’ella s’è” Ovidio, Metam. X 298-518 • Proemio • Monologo di Mirra: “sono soggetta a una perversa passione” (malus ardor – spes interdicta) • La scelta del pretendente (“uno simile a te”) • Il tentato suicidio e il dialogo con la nutrice (“Parla con me e lascia che ti aiuti” – “E’ un’infamia quella che vuoi conoscere… Beata te, o madre, per lo sposo che hai”) • La reiterata consumazione della colpa (“scellerato connubio”) • La scoperta del padre, la fuga di Mirra e la sua preghiera agli dei (“Perché io non contamini i vivi con la mia presenza e i defunti con la mia morte, scacciatemi dal regno degli uni e degli altri”) • La trasformazione in albero e la nascita di Adone Ovidio, Metam. X Proemio: “Sto per cantare un fatto atroce… una tale mostruosità… un obbrobrio tanto grande! … Perfino Cupido sostiene che non furono le sue frecce a ferirti, o Mirra, e rifiuta la responsabilità di aver scatenato codesto incendio criminoso. Fu una delle tre Furie che indirizzò verso di te il fumo di un tizzone Stigio e il fiato dei serpenti gonfi di veleno! Se è un delitto odiare il padre, questo tipo d’amore è delitto maggiore dell’odio”. Monologo di Mirra: “Dove mi trascina il mio pensiero? Che cosa sto meditando? Vi prego, o Dei, e tu Pietà e voi, leggi sacre degli avi, impedite questo misfatto, opponetevi al delitti (scelus) che voglio compiere… Ma non è vero che la Pietà condanni questo tipo di amore: gli altri animali si congiungono senza commettere colpa… La mentalità scrupolosa degli uomini ha imposto leggi restrittive e sono esse a vietare con cattiveria quello che la natura concede… Oh! Se anche lui provasse una folle passione simile (similis furor) alla mia! Ovidio, Metam. X La nutrice: “La prega di confidarle il suo tormento, qualunque esso sia… Mirra si sottrae alle sue preghiere gemendo… La nutrice finalmente capisce e un brivido di gelido terrore le penetra fin nelle ossa mentre i bianchi capelli le si rizzano in testa; pronuncia un diluvio di parole per tentare di dissuaderla dall’empia passione. La fanciulla riconosce che i suoi ammonimenti sono giusti, ma è decisa a morire se non otterrà l’oggetto dei suoi desideri [divorata da un fuoco indomabile… Mirra non riesce a immaginare altro mezzo per placare l’amore se non la morte]. Allora la nutrice si risolve a dire: ‘Vivi e avrai tuo…’ ma non osa pronunciare la parola ‘padre’, e si arresta lì, avvalorando la promessa con un giuramento”. Ovidio, Metam. X Verso la consumazione: “L’infelice fanciulla non riesce a gioire completamente; il suo spirito è in preda a un angoscioso presagio, ma non può nemmeno sottrarsi al giubilo: tanto grande è la confusione dei suoi sentimenti (Tanta est discordia mentis)… Quanto più si avvicina al compimento del suo delitto, tanto più ne ha orrore (Quoque suo propior sceleri est, magis horret) e si pente della sua audacia e vorrebbe poter tornare indietro senza essere riconosciuta. Ma la mano della vecchia la sostiene nella sua esitazione e l’accompagna”. Il mito di Mirra • Igino (I sec. aC-I sec. dC), Fabulae (LVII) l’ira di Afrodite è scatenata dalla madre di Mirra, che aveva sostenuto la figlia essere più bella della dea • Pseudo-Apollodoro (autore del I-II sec.), Bibliotheca (III 14.4) Smirna, figlia del re assiro Teia, viene punita da Afrodite per la sua scarsa devozione con una passione perversa per il padre Adelaide Ristori (1822-1906), Ricordi e studi artistici, 1887 Quel dover dimostrare gl’immani contrasti che si succedono senza tregua nell’anima di questa infelice, in perpetua lotta co’ suoi feroci martirii; quel dover dare a divedere che tutto ciò che è in lei di reo non è suo; ma sue sono bensì la virtù, la forza che sa trovare per strapparsi dal cuore quella rea passione, con l’incrudelire perfino contro se stessa, togliendosi la vita; e il dover far scoppiare, tratto tratto, il fuoco di questa fatale passione, rendendone terribili tanto gli effetti quanto gli impeti incompresi, mi sembrava cosa impossibile a riprodursi. F. De Sanctis, Janin e la Mirra (1855), poi in Saggi critici Mirra ama di un amore abbominevole e lo sa, e teme che una parola, uno sguardo, un gesto non la tradisca, e quanto più si sforza e meno riesce ad occultare la fiamma: ella muore nel momento stesso che il segreto le sfugge di bocca. La tragedia così è una lunga lotta interiore, una collisione straziante di cui solo Mirra ha coscienza, chiusa nella sua anima, e rivelantesi a quando a quando in un gesto, in uno sguardo. Abbiamo dunque innanzi una tragedia mimica in cui il gesto ha più valore della parola. Spesso la parola nega e il gesto afferma; essendo i gesti atti involontari, che denunciano inesorabilmente quello che abbiamo al di dentro anche a dispetto delle parole. I. Teotochi Albrizzi, Risposta all’abate Artega, 1799, in V. Alfieri, Tragedie, VI, 1803 La nostra compassione non è sempre risvegliata all’aspetto della sofferenza, e talvolta non è ella più viva, più sollecita, se ignoriamo la causa del dolore, che espresso vediamo nel volto o nella favella di alcuno? […] Osservisi ancora che l’Autore non ha voluto scoprirci la reità della fanciulla che dopo averci sommamente interessati per lei. I suoi mali, la sua costante virtù, i suoi nobili sentimenti, tutto ci conduce ad amare quella giovinettà in maniera che compassione, più assai che orrore, ci fa il suo delitto quando finalmente veniamo a saperlo. L’autore volle così favorirla che neppure un sol momento ha sofferto che la vedessimo rea, benché di reità, se così posso dirla, innocente. Ella non comincia a mostrarsi rea che quando la tragedia finisce. Mirra, I 2: monologo di Cecri • Idea (1784) Cecri: mezzo pentimento d’aver offeso Venere coll’estoller tanto la bellezza della figlia. • Stesura (1785) Cecri: Gli Dei, credo invidi della sorte nostra, quest’unica figlia, che di suo padre e di me la delizia era, come troppo bella e perfetta cosa invidiata ce l’hanno. Tu Venere, forse, di cui io nel baldanzoso affetto di madre, in quei teneri trasporti d’esultanza, osai in beltade agguagliartela, e non cederti allora, tu forse di mio ardire sdegnata in tale stato l’hai posta. Mirra, I 2: monologo di Cecri (175-85) Red. (A) I Numi invidi, credo, di nostra sorte, questa rara figlia del genitor letizia, e mia, ci vonno, ritor: ma perché darcela? Tu Dea di questa a te devota isola e sacra, Venere, tu di sua beltade forse sdegnata meco, a tal misero stato lei riduci; e la mia già forse troppo stolta di madre baldanzosa gioia or fai scontarmi in lagrime di sangue Red. (B) Di nostra sorte i Numi invidi forse, torre or ci von sì rara figlia, a entrambi i genitor solo conforto e speme? Era pur meglio il non darcela, o Numi. Venere, o tu sublime Dea di questa a te divota isola sacra, a sdegno la sua troppa beltà forse ti muove? Forse quindi al par d’essa in fero stato me pur riduci? Ah! la mia troppa e stolta di madre amante baldanzosa gioia, tu vuoi ch’io sconti in lagrime di sangue? Mirra, II 2: la proposta di matrimonio (201-204) • Idea (1784) Altro non desidera – Mirra, s’intende – che d’esser tratta fuori di Pafo • Stesura (1785) Mirra: oggi tua, purché domani le vele al vento si diano, e lungi da queste rive mi trasportino i venti per sempre. • Versificazione (1786-7) No; questo è il giorno; ed oggi / sarò tua sposa. – Ma doman le vele / daremo ai venti, e lascerem per sempre / dietro noi queste rive. Mirra, III 3: Ciniro a Cecri (261-269) • Stesura (1785) Ciniro: E se Venere è seco adirata, chi sa che nel core malgrado essa qualche indegna passione non l’ha inspirata, che così la martira ed a morte la mena? Chi sa se il volerci, il chiederci per grazia e per pietà di lasciarci non è il generoso sforzo dell’alto ed innocente suo animo, che per involversi in qualche malnato, represso e nascosto fuoco, a sì tosta e dura partita la sforza. Racine, Fedra (1677), prefazione trad. di G. Ungaretti “Fedra non è assolutamente colpevole né assolutamente innocente. È vincolata dal proprio destino e dalla collera degli Dei a una passione illegittima di cui lei per prima ha orrore. Compie tutti gli sforzi possibili per vincerla. Preferisce lasciarsi morire che dichiararla. E quando è costretta a rivelarla, e parla con una vergogna che indica bene come il suo crimine sia una punizione degli Dei e non un impulso espresso dalla sua volontà”. G. Debenedetti, Vocazione di Vittorio Alfieri “Il motivo, l’incentivo tragico è il segreto della protagonsita: la sua inconfessabilità, prima a se stessa, poi a tutti. Il tema della Mirra non è l’amor di Mirra per il padre, non è l’orrore dell’incesto temuto e paurosamente, irresistibilmente, selvaggiamente bramato: è la condanna, l’asfissia di dover ringhiottire proprio ciò che la fa così spaventosamente viva. Non è tanto la pena d’amore, quanto il grafico dello spaventoso travaglio di doverlo confinare al di sotto della coscienza. È l’agitazione folle, inane dell’individuo a cui è vietato di coincidere con la sua sostanza più vera e animatrice. È la paura di dichiararsi: e ogni gesto, ogni parola è un tradirsi per evitare di denunciarsi. Mirra non è la tragedia di un sentimento in conflitto con la realtà, con le leggi del mondo e dell’umano, è la modulazione di un senso di colpa”. G. Debenedetti, Vocazione di Vittorio Alfieri “Nella Mirra la sceneggiatura è il tema stesso della tragedia: è la continua elusione del gorgo tragico, è quello stesso movimento di fuga sa se stessa in cui consiste il dramma della protagonista, e nel quale il poeta di specchia, trasfonde la sua intima sostanza. [...] Mirra è una mera, pietosa menzogna, in cui l’Alfieri riesce a rendere irriconoscibili i propri dati interni nella loro identità, per così dire storica e reale. [...] Il rapporto che l’Alfieri ha proiettato in Mirra è un legame, un impeto d’amore a cui la realtà nega di manifestarsi, disconosce il diritto di esistere. La sua poetica arte di mentire, cioè di riconoscersi sotto mentite spoglie, inverte i dati: fa che il suo oscuro rapporto di figlio verso la madre, diventi un rapporto di figlia verso il padre. Di autentico è rimasta l’impossibilità, in un affetto ascendente, di varcare certi limiti [...], dove forse in lui la sola degenerazione era stata quella di arroventarsi, di disperarsi, di vedere qualche cosa di mostruoso in quell’affetto, solo perché gli era stato negato, represso dalle circostanze materiali, e dal particolare temperamento della donna alla quale era rivolto, la cui vocazione era più di sentirsi moglie che madre”. G. Debenedetti, Vocazione di Vittorio Alfieri “Queste forze [da cui il teatro alfieriano è nel complesso ispirato] son quelle di un figlio offeso nella’more. Diremo [...] che si potrebbe chiamare l’offesa del figliastro. E che l’offesa ci sia, è provato dal fatto che tutto il teatro alfieriano, eccettuata Mirra, e ne sappiamo il perché, è polemica ed invettiva; ma una invettiva che si conosce in certo modo sacrilega, tanto è vero che sente quasi sempre il bisogno di cercarsi un’espiazione nella morte. C’è come un dovere di morire. [...] Registrata nel fondo dell’essere un’offesa, un torto di cui non gli era possibile cercare o trovare diretta riparazione, abbia elaborato lentamente un ‘tipo’, contro cui appuntare questa sete di ritorsione, questo bisogno di liberazione dall’offesa. Quello che nell’inconfessato, inconfessabile romanzo familiare era stato l’usurpatore della madre, il patrigno, nel romanzo civile, nella segreta, arcaica equazione tra la madre e la patria, diventa l’usurpatore del comando, il tiranno. [...] Così il re, il principe, in quanto paralizza la libera esplicazione degli attivi e creativi affetti ascendenti che legano il cittadino alla patria, come figlio alla madre, diventa senz’altro, in una rigida tipologia, il tiranno”.
Scarica