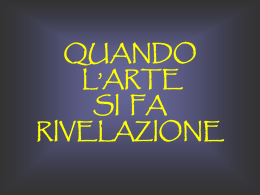I GIORNI DELLA COMUNE • La Comune di Parigi fu il primo Stato socialista della storia. La sua importanza consiste nell’aver creato il precedente storico degli stati socialisti diffusisi in tutto il XX secolo, ancor più che nell’aver conseguito obiettivi immediati (essa visse del resto per poco più di due mesi, dal 26 marzo al 27 maggio 1871). Quali sono le ragioni che hanno portato al suo fallimento? FRANCIA 1871 • L’inverno 1870-1871 vede la fine della guerra franco-prussiana. Nel settembre ‘70 la battaglia di Sedan ha segnato il tracollo francese: solo Parigi resiste, in una Francia allo stremo (cfr. Boule de suif di Maupassant), fino al 28 gennaio 1871. L’armistizio viene firmato nella stessa data a Versailles, dove dieci giorni prima era stato conferito a Guglielmo I il titolo di Kaiser della Germania unita. LA TERZA REPUBBLICA • Fin dal 4 settembre 1870, dopo la cattura di Naoleone III a Sedan e il conseguente vuoto di potere, è stato proclamato decaduto il Secondo Impero ed è nata la Terza Repubblica. I leader della resistenza contro i prussiani, Gambetta e Favre, istituiscono la Guardia Nazionale per la difesa a oltranza. A Bordeaux si costituisce un governo provvisorio, guidato dal Thiers, con lo scopo di porre presto fine alla guerra. PARIGI NELL’INVERNO 1870 • Nonostante la disfatta di Sedan, la resistenza prosegue per tutto l’inverno sui fronti ancora aperti: Digione, Metz e soprattutto Parigi. In realtà in tutto il resto del paese, specie nelle campagne, è ben più forte il desiderio di pace che l’orgoglio patriottico. A Parigi, sotto assedio, si trovano ormai solo i piccolo-borghesi e i proletari: la nobiltà è in salvo a Versailles. I PRELIMINARI DI PACE • Nonostante gli sforzi, il 28 gennaio Parigi capitola. L’8 febbraio si svolgono le elezioni dell’Assemblea Nazionale; la tendenza è “pace e monarchia”. I repubblicani, visti come dei guerrafondai, vincono solo a Parigi e nelle grandi città. Il 28 febbraio Thiers, capo dell’esecutivo, firma i preliminari di pace col Bismarck, a Versailles. A Parigi cresce il malcontento. LE CONDIZIONI DI PACE • 5 miliardi di franchi in oro (l’indennità di guerra più alta mai subita fino ad allora) • la cessione dell’Alsazia e della Lorena alla Prussia • l’occupazione dell’intero nord-est della Francia finchè l’indennità non fosse stata versata interamente. • la non restituzione dei prigionieri di guerra francesi. PARIGI SI OPPONE • E’ in questa occasione che il popolo parigino, dopo giorni di tensione col governo di Bordeaux, insorge. Affida il potere alla municipalità cittadina, accusando il Thiers di arrendevolezza, di connivenza col nemico e di nostalgie monarchiche (cfr. Brecht). La presenza in città di truppe prussiane acuisce la sensazione del tradimento, dopo una guerra mossa in difesa dei soli interessi borghesi. DAL 18 MARZO ALLA COMUNE • Nella notte tra il 17 e il 18 marzo Parigi proclama la propria autonomia dal governo repubblicano di Versailles, fucila i generali dell’esercito regolare, esautora i sindaci in carica e occupa il municipio. Le forze attive sono ancora in parte borghesi e in parte socialiste e proletarie, in attesa delle elezioni municipali indette per il 26. Il 26 le elezioni segnano il trionfo della parte socialista. E’ la nascita della Comune. LA REAZIONE • A Versailles crescono le ostilità per gli insorti parigini. Si prospetta la possibilità di una guerra civile, ma le forze governative sono in realtà molto scarse. In attesa degli sviluppi, una terza posizione cerca di stemperare gli estremismi dei monarchici e dei comunardi: sono uomini come Clemenceau, Hugo e Zola, che fino all’ultimo s’opporranno alla guerra civile. Scrive Zola: “Se un giorno la storia dirà che l’insurrezione ha spinto il paese nell’abisso, dovrà aggiungere che il potere legale ha fatto di tutto per rendere mortale la sua caduta”. LA GUERRA CIVILE • Il 2 aprile Thiers rompe gli indugi. Dopo una vera e propria gara di reciproche intransigenze incomincia la guerra civile, che vede le truppe comunarde opposte a quelle governative (prigionieri rilasciati dai Prussiani + volontari dalle campagne). A pesare sull’esito degli scontri sarà anche la disorganizzazione dell’esercito parigino, formato da “combattenti che da poco si sono scrollati di dosso la schiavitù delle fabbriche e non si lasciano comandare come fantocci” (Brecht) e indisciplinato. I DECRETI (I) • Abolizione della coscrizione obbligatoria • sostituzione all’esercito permanente di una Guardia Nazionale di tutti i cittadini (il “popolo armato”) • separazione ufficiale Chiesa-Stato; confisca delle proprietà ecclesiastiche e divieto di affissione di simboli religiosi in luoghi pubblici • revocabilità, in qualsiasi momento, dei funzionari pubblici e dei rappresentanti (a garantire il controllo del popolo sullo Stato) I DECRETI (II) • Fissazione degli stipendi dei funzionari statali alla cifra corrispondente al salario di un operaio specializzato; riduzione del personale statale (in opposizione al vecchio Stato burocratico) • diritto di sciopero e divieto del lavoro notturno • istruzione elementare gratuita, laica, pubblica (con incentivi all’insegnamento femminile) • collettivizzazione delle industrie abbandonate (date a cooperative operaie) IL RIFIUTO DELLA GUERRA • Il 13 aprile si decide la distruzione della Colonna Vendome, costruita nel periodo delle guerre napoleoniche. Il decreto è il seguente: “La colonna imperiale è un monumento alla barbarie, un simbolo di forza bruta e falsa gloria, un’affermazione del militarismo, una negazione del diritto internazionale, un insulto permanente dei vincitori ai vinti, un attentato perpetuo a uno dei tre grandi principi della Repubblica Francese: la Fraternità.” IL RUOLO DELLE DONNE • Se nelle rivoluzioni precedenti la presenza femminile aveva generalmente avuto un ruolo di supporto o tutt’al più di comparsa (cfr. il corteo del 5 ottobre 1789, da Parigi a Versailles), nella Comune, con la Costituzione dell’Unione delle Donne (11 aprile), esse rivendicano un proprio ambito specifico d’azione: non solo in seconda linea (vivandiere, infermiere…) ma come combattenti loro stesse: ricordiamo Louise Michel (la “Vergine rossa” di molte canzoni), Elisabeth Dimitrieff e Nathalie Lemel. LE LIBERTA’ • Durante la prima seduta del Consiglio municipale della Comune furono affissi i seguenti cartelli: • 1) diritto alla vita • 2) libertà individuale • 3) libertà di coscienza • 4) Diritto di unione e associazione • 5)Libertà di parola, stampa e qualunque manifestazione intellettuale • 6) Diritto di libere elezioni Erano i principi inderogabili della Comune. LA COMUNE E L’ARTE • Il 17 aprile viene eletto un “Comitato della Federazione degli Artisti”, per “garantire la libera espressione delle arti”. Tale comitato, che avrà per esponenti nomi illustri come Courbet, Corot, Daumier, Manet, otterrà tra l’altro la riapertura del Louvre, del Museo di Storia Naturale e dei saloni delle Tuileries; invano s’opporrà agli incendi che durante la Settimana di Sangue distrussero mezza Parigi per mano dei Comunardi stessi. LA COMUNE E LA RELIGIONE • Il più importante decreto della Comune sul rapporto Chiesa-Stato è il seguente: “Il primo principio della Repubblica è la libertà, e la libertà di coscienza è la prima di tutte; il clero è stato complice della monarchia nei delitti contro la libertà stessa; la Comune decreta: la Chiesa viene separata dallo Stato, inoltre il delegato alla pubblica istruzione darà disposizioni affinchè i maestri rimuovano crocefissi e oggetti simbolici dalle aule scolastiche”. Del resto, secondo lo storico Winoch, la guerra civile del ‘71 fu per molti aspetti anche una guerra di religione. LA COMUNE E IL “POPOLO” • L’esigenza più sentita dalla Comune, soprattutto nei primissimi tempi, è quella di porre la macchina statale al servizio e sotto il controllo diretto del “popolo” (nella sua interezza: ogni decisione è votata tramite suffragio universale). Da qui la removibilità dei funzionari in qualsiasi momento; la creazione del “Journal officiel”, che pubblica i verbali di tutte le sedute della Assemblea; l’autocritica dei politici, cui Brecht fa dire: “Non arroghiamoci pretese d’infallibilità: diamo pubblicità a tutti nostri discorsi e azioni. Mettiamo a parte il pubblico delle nostre manchevolezze”. LA COMUNE E LE CAMPAGNE • Il rapporto conflittuale tra città, Parigi in particolare, e campagna non è certo cosa nuova (cfr. la rivolta in Vandea del 1793). La diffidenza e ostilità tra ceto rurale e proletariato urbano si era nutrita anche del bonapartismo, su cui la Francia si era già spaccata. Quando Parigi vota per la guerra a oltranza, poi, le campagne esasperate si schierano con l’Assemblea Nazionale e con Thiers, che alimentando la pubblicità avversa ai comunardi fa dei contadini il suo punto di forza (anche nell’esercito). Vani tutti gli appelli al popolo rurale, tra cui quello famoso del 19 aprile. IL SOCIALISMO NEL 1871 • Quando si dice che la Comune fu il primo stato socialista non bisogna immaginarsi una vita politica senza dissidi. Innanzitutto erano gli anni in cui si passava da un socialismo “utopistico” a uno “scientifico”: gli anni in cui all’interno del movimento stesso convivevano i seguaci di Proudhon, di Lassalle, di Marx (che fu molto duro con il proudhonismo, giudicato inapplicabile e borghese) e in parte perfino gli anarchici di Bakunin: gli anni della Prima Internazionale. 1864-1876: LA PRIMA INTERNAZIONALE • Nel ‘64 a Londra nacque l’Associazione Internazionale dei Lavoratori, grazie ai frequenti contatti tra le società operaie inglesi e francesi. In principio in essa confluirono tutte le eterogenee matrici del pensiero operaio europeo (dallo spirito oweniano-cartista al mazzinianesimo); ma specie dopo la caduta della Comune fu l’elemento marxista a imporsi. Rispetto alla Comune essa non prese posizione: il suo mancato sostegno fu tra le molte cause del crollo finale della Comune stessa. IL CONSIGLIO MUNICIPALE • Questa molteplicità di posizioni è rispecchiata dal Consiglio municipale della Comune, che, pure di matrice socialista, è tutt’altro che unitario. In esso sono: • una maggioranza giacobino-blanquista, sostenitrice dell’azione rivoluzionaria • una minoranza operaia-internazionalista, ostile ad ogni autoritarismo e fortemente influenzata dal mutualismo anarchico e federale di Proudhon Con il passare del tempo le frizioni tra queste due anime si fanno insanabili. LA FASE “DITTATORIALE” • Una vera dittatura, in realtà, non vi fu mai. Ma è evidente che intorno ai primi di maggio qualcosa nell’attitudine libertaria della Comune è cambiato. Le pressioni dei nemici esterni, i contrasti sempre più profondi all’interno del Consiglio, il definitivo prevalere della fazione blanquista portano la Comune a quegli eccessi da cui, memore del Terrore del 1793, essa ha inizialmente tentato di astenersi. La vanità di questo tentativo è strutturale: una rivoluzione senza sangue, come parve in principio questa, forse non può esistere (cfr. Engels, Brecht, Winoch). QUALCOSA E’ CAMBIATO • Il 1° maggio viene istituito un Comitato di Salute Pubblica: con le truppe versagliesi alle porte, è facile tacciare i moderati e gli oppositori di connivenza col governo. 13 comunardi ostili al provvedimento vengono allontanati da Parigi. 30 testate giudicate “reazionarie” vengono chiuse, benchè la libertà di stampa fosse stata motivo di vanto nei primi tempi della Comune. Quando i versagliesi entreranno a Parigi, i comunardi cattureranno e fucileranno l’arcivescovo di Parigi, causando grave scandalo nella Francia e nell’Europa intera. LA FINE DELLA COMUNE • Con i Prussiani spettatori, il 21 maggio 1871 le truppe governative riescono a penetrare a Parigi dopo più di un mese d’assedio. Si combatte disperatamente tra le strade della capitale per tutta la “settimana di sangue” fino alla caduta della Comune, il 28 maggio. Gli edifici simbolo del potere (le Tuileries, l’Hotel de Ville…) vengono dati alle fiamme dai cittadini. UN BILANCIO SPAVENTOSO • • • • • I comunardi morti in combattimento: 4000 I governativi morti in combattimento: 877 I cittadini uccisi senza processo: 20000 I cittadini arrestati: 43522 I deportati in Nuova Caledonia: 3860. Tale durezza mosse a sdegno molti intellettuali del tempo. Tra questi, Ippolito Lissagaray, giornalista e pubblicista. Solo l’11/7/1880 avrà luogo l’amnistia. MOLTI PUNTI DI VISTA (I) • Com’è naturale i posteri hanno tratto dalla esperienza del 1871 lezioni differenti, e formulato i più disparati giudizi sulla Comune. Per Marx ed Engels essa fu la prima vera espressione di autocoscienza del proletariato europeo, con tutti i difetti e le manchevolezze di una “prima volta”, ma un immenso valore storico e simbolico. Disse Engels: “Guardate la Comune di Parigi: questa fu la dittatura del proletariato”. E l’anniversario della Comune era giorno di festa generale di tutto il proletariato. MOLTI PUNTI DI VISTA (II) • Henri Lefebvre, autore tra l’altro di una monumentale opera sulla rivoluzione francese, si concentra sulla portata innovatrice della Comune, valutando che essa fu “all’inizio un’immensa e grandiosa festa, una festa che il popolo parigino, essenza e simbolo del popolo francese e del popolo in generale, volle offrire a se stesso e al mondo”. MOLTI PUNTI DI VISTA (III) • Jaures, nella sua Histoire Socialiste, si riavvicina all’interpretazione prettamente socio-economica già data da Marx: “Fu nella sua essenza la prima grande battaglia campale tra Lavoro e Capitale. Fu soprattutto un repubblicanesimo che non era altro che un socialismo che si ignorava e che arrivava fino a minacciare le basi stesse del vecchio ordine sociale e ad evocare un ordine nuovo”. MOLTI PUNTI DI VISTA (III) • Jaures, nella sua Histoire Socialiste, si riavvicina all’interpretazione prettamente socio-economica già data da Marx: “Fu nella sua essenza la prima grande battaglia campale tra Lavoro e Capitale. Fu soprattutto un repubblicanesimo che non era altro che un socialismo che si ignorava e che arrivava fino a minacciare le basi stesse del vecchio ordine sociale e ad evocare un ordine nuovo”.
Scarica