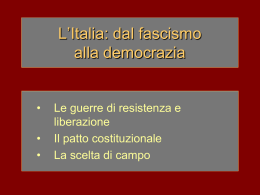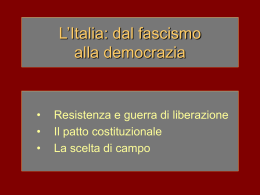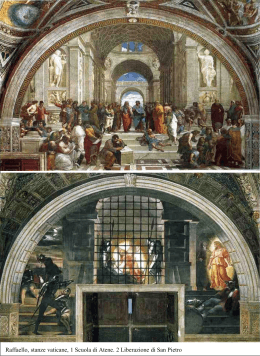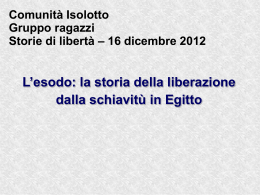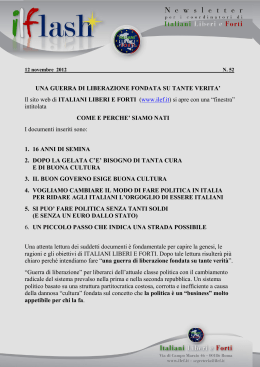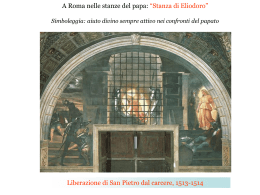IL MARGINE ISSN 2037-4240 IL MARGINE Giovanni Colombo 7 AGOSTO-SETTEMBRE 2012 3 Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna 5 Mensile dell’associazione culturale Oscar A. Romero Anno 32 (2012) n. 7 Il Gigante nella corazza Verità incomplete Urbano Tocci 13 Una questione di morale. Sulla politica tedesca dopo le elezioni regionali in Nordrhein-Westfalen Eugen Galasso 24 I pregiudizi nei confronti della teologia della liberazione Piergiorgio Cattani 28 Graffi sul muro Luigi Giorgi 31 Il tempo e la fine Case costruite sulla sabbia Giovanni Colombo IL GIGANTE NELLA CORAZZA Eugen Galasso Alberto Conci Paolo Grigolli Natalina Mosna I PREGIUDIZI NEI CONFRONTI DELLA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE VERITÀ INCOMPLETE Urbano Tocci Piergiorgio Cattani GRAFFI SUL MURO UNA QUESTIONE Luigi Giorgi DI MORALE IL TEMPO E LA FINE In Italia l’industria delle costruzioni è stata a lungo fonte di grande arricchimento per pochi soggetti che hanno spesso ignorato o forzato normative e buon senso, a danno (tra l’altro) della qualità del territorio e del paesaggio: i meccanismi che già Francesco Rosi aveva denunciato nel 1963 ne Le mani sulla città si sono estesi ben oltre la Napoli che fa da scenario del film. Da qualche mese arrivano però notizie che annunciano l’esplosione della bolla speculativa: degli infiniti metri cubi che sono stati edificati negli ultimi anni nessuno sa davvero che fare. Secondo i dati della Banca d’Italia a fine 2011 le banche risultavano esposte nei confronti dell’industria delle costruzioni per 172 miliardi di euro (Luca Martinelli, La casa è un paradosso, “Altreconomia”, giugno 2012, p. 29) e c’è il fondato timore che l’edificato non abbia il valore che si pretendeva avesse. Ora anche la grande stampa se ne sta accorgendo (http://espresso.repubblica.it/dettaglio/nessuno-si-compra-piu-casa/2190417, 5 settembre 2012). La crisi del mattone travolgerà non solo i costruttori ma anche tutti coloro che nell’edilizia trovano il loro lavoro e coloro che nella casa hanno la loro piccola ricchezza: speriamo che la politica non insegua soluzioni provvisorie, magari ancora a vantaggio degli interessi di pochi, ma colga invece l’occasione per ripensare il rapporto tra spazio antropizzato e ambiente in modo più lungimirante rispetto a quanto è stato fatto finora. (E.C.) Il Margine 32 (2012), n. 7 Il Gigante nella corazza GIOVANNI COLOMBO I l Cardinal Martini ha terminato la sua corsa terrena. Scompare dai nostri occhi uno dei personaggi principali della vita della chiesa nell’ultimo trentennio, un (quasi) Papa, molto letto, molto ascoltato dai media (anche se non è mai stato, a differenza di Wojtyla, l’uomo delle folle e del gesto). Se ne va il Gigante, il principale riferimento religioso, morale, intellettuale della mia giovinezza. L’ho seguito fin dal suo arrivo in diocesi, ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e di confidarmi con Lui come fosse mio padre. A lungo mi sono vantato di essere un “martiniano”, poi ho smesso, visto che lui stesso mi ripeteva: di Maestro ce n’è uno solo! Martini si è speso fino all’osso per farci conoscere la Parola. In principio la Parola è il titolo della sua più intensa lettera pastorale e ben sintetizza il cuore del suo magistero. «Leggi la Parola... sottolinea la Parola», quante volte l’ha ripetuto. La Parola che parla di Gesù è Gesù stesso, e come lui incessantemente in moto, senza fine nel movimento di dare tutto di se stessa. Se ascoltata e “ruminata”, susciterà in noi le parole giuste per quest’epoca di alto sbandamento, le parole gocciolanti in grado di “rimettere al mondo il mondo”. Con le sue parole intorno alla Parola, Martini mi ha cambiato Dio. Non più il Dio lombardo, cupo, controriformista, il Dio col vocione che produce l’inflazione del senso di colpa. Ormai Dio è vento sottile e sua volontà la nostra liberazione: la partenza da tutti i varchi, l’apertura di tutte le gabbie. Ah, le gabbie... In Martini ho visto da vicino la fatica di star dentro le tante costrizioni in cui s’infossa la vita della chiesa cattolica d’Occidente, sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista pastorale. Alla fatica si è presto aggiunta (metà degli anni ottanta) anche la viva preoccupazione di non apparire l’anti-Papa, l’anti-Wojtyla, e di riuscire a sottrarsi al continuo controllo vaticano. A mio avviso, era in battaglia continua, fuori e dentro di sé, con il marmo di sacra romana chiesa. Da un certo punto in poi il campo di questa 3 battaglia è diventato il suo stesso corpo, come se il tremolio parkinsoniano non foss’altro che la costante lotta tra la spinta ad essere se stesso e la controspinta a non esserlo, per non disobbedire all’autorità costituita. Alla fine il controllo estremo ha avuto il sopravvento e il Gigante si è trovato rinchiuso dentro una corazza. Ha dovuto rinunciare alla sua originalità, alla sua “martinità”. È stato bello, sì, molto bello conoscere e frequentare padre Carlo. E il modo migliore di ricordarlo sarà quello di seguire la strada che lui stesso aveva intravisto dal suo personale monte Nebo e di cui parlò tanti anni fa durante la messa esequiale di uno dei suoi più cari amici, don Luigi Serenthà: «procedere per una più grande scioltezza nella Chiesa, per una più grande libertà di spirito, per una più grande creatività, soltanto in questo modo si manifesta la vitalità della Parola, del mistero pasquale della morte e della risurrezione di Gesù». Aveva capito assai bene quant’è indispensabile alleggerire e, in tal senso, è riuscito a fare più di quanto lasciasse prevedere la sua estrazione alto borghese, la sua impostazione perfetta e il suo ruolo di “principe della Chiesa”. Oggi, finalmente sciolto da pesi obblighi dolori, è giunto «nella pienezza totale che non è cancellazione delle singole individualità ma affermazione piena dell’individualità di ciascuno in una perfetta armonia in Dio» (citazione dell’Inno all’universo di un altro gesuita, Teilhard de Chardin, che Martini stesso usava per spiegare come sarà in Cielo). Adesso tocca a noi, che restiamo per qualche giorno ancora su questa terra di terra e sassi, non farci frenare dalle pesantezze del vivere e volteggiare in libertà di spirito sopra ogni pietra tombale. (31 agosto 2012) 4 Il Margine 32 (2012), n. 7 Verità incomplete ALBERTO CONCI, PAOLO GRIGOLLI, NATALINA MOSNA C i sono periodi della nostra storia che sono rimasti aperti. Come ferite che non si rimarginano mai completamente, come braci sotto la cenere che basta poco a riattizzare. E anche solo avvicinarli, questi periodi, diventa un’impresa difficile e complessa, perché in qualunque modo ci si muova c’è sempre il rischio di urtare le sensibilità, di provocare reazioni imprevedibili, di ferire coloro la cui vita è rimasta impigliata per sempre negli eventi tragici di quel periodo. E se questo è vero per molte delle vicende degli anni Settanta, che non sono ancora alle nostre spalle, lo è ancora maggiormente per quei due anni e mezzo che vanno dal 12 dicembre 1969, quando l’esplosione della bomba di piazza Fontana causò la morte di 17 persone e il ferimento di oltre ottanta, al 17 maggio 1972 quando veniva ucciso il commissario Luigi Calabresi. La strage, la morte in circostanze mai completamente chiarite dell’anarchico Pino Pinelli, che avviene nella notte fra il 15 e il 16 dicembre 1969, e l’omicidio Calabresi sono tre episodi che hanno assunto un valore emblematico e non hanno perso con il passare degli anni la propria carica evocativa: non a caso la lettura di quei fatti è condizionata ancora oggi da opposte valutazioni, pesanti silenzi, colpevoli omissioni e, non di rado, da giudizi fortemente orientati sul piano ideologico. A rendere più complesso il quadro di riferimento contribuisce la collocazione storica degli eventi, all’interno di un quinquennio fra i più drammatici della storia repubblicana, insanguinato dalla successione di ben cinque stragi: piazza Fontana a Milano, nel dicembre 1969 con le sue diciassette vittime; Peteano, il 31 maggio 1972, dove trovarono la morte tre carabinieri per l’esplosione di un’autobomba collocata dai neofascisti Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicuttini; la questura di Milano – che causò l’uccisione di quattro persone e il ferimento di cinquantadue il 17 maggio 1973, nel primo anniversario dell’omicidio del commissario Calabresi – posta in essere da Gianfranco Bertoli, che si definì “anarchico stirneriano” e i cui rapporti con i servizi segreti vennero alla luce solo nel 2002; piazza della Loggia a Bre- 5 scia, il 28 maggio 1974, che colpì un’imponente manifestazione antifascista causando la morte di otto persone e oltre cento feriti, il cui iter giudiziario, dopo la sentenza di appello, rischia ormai di chiudersi senza individuare responsabili e mandanti; e infine il treno Italicus, che il 4 agosto 1974 provocò dodici vittime e quarantotto feriti. Cinque stragi in meno di cinque anni, che restano profondamente legate fra loro dalla matrice neofascista, dal coinvolgimento di settori deviati delle istituzioni, dalla quasi totale impunità per gli esecutori, dall’obiettivo eversivo, dalla mancanza di verità sui mandanti. Le testimonianze raccolte nelle pagine di A onor del vero. Piazza Fontana. E la vita dopo (Il Margine, Trento 2012) dai giovani dell’associazione Note a Margine si collocano all’interno di questo quadro. Un testo che ha richiesto loro un lungo lavoro di preparazione e che per la prima volta tiene assieme le voci di Francesca Dendena, Paolo Dendena e Carlo Arnoldi, che nella strage di piazza Fontana persero i padri, di Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, e di Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi. All’origine di quel lavoro sta il gesto di altissimo valore del Presidente della Repubblica che, nella cerimonia del 9 maggio 2009 in occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, volle fossero presenti al Quirinale Francesca Dendena, presidente dell’Associazione piazza Fontana 12 dicembre 1969, Licia Rognini e Gemma Capra, accomunando così, all’interno della stessa prospettiva storica, tre vicende cruciali per la comprensione degli anni di piombo. Un incontro tanto più significativo se si tiene conto delle parole pronunciate da Giorgio Napolitano in quell’occasione, pochi mesi prima del quarantennale di piazza Fontana, parole che costituiscono un punto di non ritorno nel dibattito su quegli anni in ragione dell’attenzione posta dal Quirinale sulle responsabilità di settori deviati dello Stato nell’occultamento della verità: «Ricordare quella strage – affermava il Capo dello Stato – e con essa l’avvio di un’oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire un’esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l’ispirazione politica, ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del Paese, componenti non secondarie di quella trama – in particolare “l’attività depista- 6 toria di una parte degli apparati dello Stato” (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) – rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo»1. L’idea di incontrare le protagoniste di una giornata tanto intensa e importante per la vita del Paese nacque proprio il 9 maggio 2009, quando i giovani autori dei dialoghi racchiusi nel libro Sedie Vuote furono invitati dal Presidente della Repubblica a raccontare la loro esperienza durante la cerimonia in Quirinale, dopo la quale ebbero modo di intrattenersi con Gemma Capra, Licia Rognini e Francesca Dendena nel suo studiolo. È stato quello il punto d’avvio di una serie di incontri dai quali sono scaturiti i tre dialoghi raccolti nel libro. Il primo con Francesca Dendena, che nella strage del 12 dicembre 1969 perse il padre: assieme a lei i giovani di Note a Margine hanno parlato con il fratello Paolo, la nipote Federica e con Carlo Arnoldi, figlio di un’altra delle vittime di piazza Fontana, realizzando così un dialogo a più voci. Successivamente è stata la volta del dialogo con Licia Rognini, moglie di Giuseppe Pinelli, l’anarchico che morì precipitando da una finestra della questura di Milano nella notte fra il 15 e il 16 dicembre 1969, ingiustamente sospettato di essere implicato nell’attentato di piazza Fontana. Un dialogo reso ancora più denso e significativo dalla presenza delle figlie di Pinelli, Silvia e Claudia, che hanno contribuito a rendere ulteriormente vivido il ricordo di quella tragica morte e degli anni che seguirono. Infine i ragazzi hanno incontrato Gemma Capra, moglie del commissario Luigi Calabresi, assassinato il 17 maggio 1972 dopo una dura campagna di stampa che lo dipinse come il responsabile della morte di Giuseppe Pinelli. Passato irrisolto Nei dialoghi sono emerse alcune questioni cui vale la pena fare brevemente riferimento per la rilevanza che vi hanno assunto anche come chiavi interpretative di un intero periodo storico. Un primo elemento riguarda la complessità, per molti aspetti ancora irrisolta, delle vicende affrontate e la percezione, come espresso dal Presidente della Repubblica, che tanta parte di ciò che rimane in ombra dipenda da 1 Giorgio Napolitano, Discorso pronunciato in occasione del secondo Giorno delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, 9 maggio 2009, http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1526. 7 settori deviati dello Stato che si sono adoperati affinché non si giungesse a una compiuta ricostruzione dei fatti. Con ciò non si vuol dire che ci troviamo di fronte a vicende delle quali non si sappia nulla o quasi nulla: ma se su taluni aspetti si è fatta luce sia sul piano storico che su quello giudiziario, restano ancora numerose questioni aperte che si prestano ad essere interpretate attraverso chiavi di lettura contrapposte. A differenza di altre vicende anche più recenti del nostro Paese, ormai consegnate definitivamente alla storia, quando si avvicina la strage di piazza Fontana, e più in generale al quinquennio 1969-1974, si toccano nervi scoperti e si deve fare i conti con approcci fortemente condizionati da atteggiamenti ideologicamente militanti. Insomma, come accennato in apertura, lungi dall’essere una vicenda chiusa, piazza Fontana rimane una ferita aperta che mantiene una straordinaria carica di simbolismo e che ancora oggi mobilita le coscienze e spinge a schierarsi come in pochi altri casi della storia italiana. E lo stesso si può dire degli altri episodi narrati nelle pagine di A onor del vero e della stagione costellata di stragi che da piazza Fontana prese avvio. In tale quadro non mancano, va ribadito, elementi di certezza storica, che vanno ulteriormente approfonditi e fatti conoscere perché costituiscono una fonte preziosa di informazione per ricostruire il contorno di quelle vicende. Tuttavia, l’impressione più diffusa che i giovani protagonisti di questi dialoghi hanno ricavato dagli incontri con i testimoni di quegli eventi e dai tanti incontri che ad essi sono seguiti è quella di aver a che fare con un mosaico nel quale manca sempre qualche tessera fondamentale. La sensazione di trovarsi di fronte a una verità incompleta ha profondamente condizionato la stesura delle domande e soprattutto l’andamento successivo dei dialoghi, al punto che l’esigenza di giungere a una verità piena ci è parsa, fin dall’inizio, come uno dei tratti peculiari delle tre storie qui accomunate. Questa sensazione di camminare troppo spesso in una penombra che non consente di distinguere i lineamenti e definire i contorni, continuando a garantire anonimato e impunità a chi ha tramato e agito contro la democrazia, rimane sullo sfondo di tutto il lavoro. Già nel corso della preparazione dei dialoghi era emerso chiaramente che una verità incompiuta da un lato non rende giustizia alle vittime della violenza e dall’altro rischia di inchiodare i familiari e il Paese a un passato che rimane incompleto non per fatalità, ma per la responsabilità precisa di chi ancora oggi ostacola la ricostruzione degli eventi. Se, prima di entrare nel vivo dei dialoghi, nel gruppo con il quale abbiamo lavorato era emersa la volontà di porre l’accento soprattutto sul futuro e sugli insegnamenti che questa storia lascia in eredità ai giova- 8 ni, la lettura dei documenti, l’incontro con i familiari delle vittime e molti dei riscontri che hanno seguito la pubblicazione hanno imposto un rovesciamento di prospettiva rendendo sempre più chiaro che avvicinare quel periodo comporti l’accettare il peso di un passato irrisolto, con tutto ciò che questo implica sul piano dell’esistenza personale dei sopravvissuti e su quello della vita pubblica. Ciò non ha coinciso con un abbandono della riflessione sul futuro, che rimane la dimensione portante di ogni società che intenda progettare il proprio domani; piuttosto in questo lavoro è divenuto sempre più evidente che le lacerazioni del passato rimangono insanabili se su di esse non si stende il balsamo della verità, e che un Paese che calpesta la verità commette un doppio crimine: nei confronti di coloro che, sopravvissuti alla tragedia, si sentono traditi da chi avrebbe dovuto dare loro giustizia, e nei confronti della vita collettiva, che non può fondarsi se non sulla trasparenza delle istituzioni e sul comune riconoscimento della verità. In altre parole il cinismo e l’indifferenza, accanto al vizio tragico di molti di non voler ammettere i disastri causati dall’abbracciare con disinvoltura ideologie distruttive, non inquinano solo la memoria ma, ostacolando lo sviluppo di una coscienza critica, compromettono la capacità di futuro dei singoli e della comunità sociale e politica. E come se non bastasse dobbiamo fare i conti anche con le complicità di coloro che, pur militando su fronti apparentemente opposti, avevano e hanno interesse a nascondere la verità e che ancora oggi si rifugiano per convenienza dietro il “tutti sappiamo ma non riusciamo a dire” o dietro l’inconfessabile convinzione che, per difendere la ragion di stato o altre più meschine ragioni, sia inopportuno che tutti sappiano tutto. Dobbiamo fare i conti, insomma, anche con un patto omertoso che mantiene volontariamente quelle zone d’ombra. Ciò che è in gioco, a questo livello, è ben più della ricostruzione del passato: «La memoria – ha scritto Claudio Magris – è anche una garanzia di libertà; non a caso le dittature cercano di cancellare la memoria storica, di alterarla o di distruggerla del tutto. Le tirannidi la deformano, i nazionalismi la falsificano e la violentano, il totalitarismo soft di tanti mezzi di comunicazione la cancella, con un’insidiosa violenza che scava paurosi abissi fra le generazioni»2. E tuttavia, i racconti contenuti in A onor del vero non cedono mai alla semplificazione e mantengono sempre viva la distinzione fra il valore delle 2 Claudio Magris, Livelli di guardia. Note civili (2006-2011), Garzanti, Milano 2011, pp. 119s. 9 istituzioni democratiche e le responsabilità di coloro che le hanno abitate e, in questo caso, le hanno tradite. Calpestando così le attese di verità e giustizia di un Paese che continua a vivere con un piede nel baratro di complotti, colpi di stato, logge massoniche, affossamento del senso delle istituzioni, abrogazione del futuro. In tutto ciò, il trascorrere del tempo non è un fattore secondario. La storia non è fatta di un eterno presente, e il susseguirsi dei decenni incide in profondità sulla possibilità di ricostruire il passato e sulla sua rielaborazione personale e collettiva. A quarant’anni di distanza da quella prima fase degli anni di piombo, dobbiamo fare i conti con la scomparsa di testimoni privilegiati e di molti di coloro che avrebbero potuto fornire preziose informazioni per ricostruire il quadro delle responsabilità. E, come se non bastasse, il tempo che passa induce spesso anche chi potrebbe sciogliere i nodi più intricati a scegliere il silenzioso ritrarsi nella vita privata, abdicando a un dovere civile di testimonianza e, non di rado, di assunzione di responsabilità. Accade così che si consolidi l’impressione in chi resta che, mentre il quadro generale si fa via via più chiaro (anche grazie a sentenze come quelle di Brescia, che hanno contribuito a chiarire molti aspetti relativamente al clima, al contesto, agli ambienti nei quali maturarono quegli atti criminosi), diventi impossibile l’individuazione delle singole responsabilità personali, soprattutto rispetto a coloro che di quella stagione di violenza furono gli scellerati mandanti. Ma non c’è solo questo, perché dobbiamo fare i conti anche con la morte di coloro che hanno atteso per una vita intera la verità. La scomparsa per un male incurabile di Francesca Dendena, avvenuta pochi mesi dopo l’incontro con i giovani di Note a Margine, assume da questo punto di vista un significato particolare, perché alla ricerca della verità Francesca aveva dedicato tutta la vita, con un impegno incessante all’interno dell’Associazione piazza Fontana 12 dicembre 1969. In realtà, è proprio l’incapacità di un Paese di consegnare la verità ai familiari delle vittime e più in generale a tutti i cittadini che rimane inaccettabile, non solo perché senza verità non è possibile nemmeno la rielaborazione del lutto, ma anche perché sul piano pubblico si consolida l’idea che il silenzio faccia ancora comodo a molti. Una ragione, questa, che ha spinto il Presidente della Repubblica a dedicare la giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il 9 maggio scorso, proprio a Francesca Dendena e a invitare nuovamente i ragazzi dell’associazione a presentare il loro lavoro, con la lettura dell’intervento che a nome di tutti ha pronunciato Anna Brugnolli. 10 A fare da sfondo ai dialoghi c’è, come già nel libro Sedie Vuote, l’incontro con il dolore, perché essi non contengono solo la tragedia delle vittime, ma tutto il dolore dei figli e delle figlie che rimangono senza un padre, delle madri che, improvvisamente sole, devono far fronte alle esigenze della famiglia, dei bambini che devono crescere portando sulle spalle non solo il peso della perdita, ma anche quello che viene dall’essere gettati improvvisamente all’interno di una vicenda pubblica. Eppure, in questo dolore così profondamente umano, ci sono anche tratti di una compostezza che appartengono forse a un’altra epoca storica e che esprimono una capacità di sostare nella sofferenza, un coraggio nel prendere in mano la vita della propria famiglia e una dignità che colpiscono nel profondo e che danno l’impressione che se in questo Paese la democrazia ha resistito è grazie a queste donne e a questi uomini che non hanno ceduto alle seduzioni della violenza e hanno continuato a credere, nonostante tutto, alla necessità di un impegno quotidiano per la difesa delle istituzioni democratiche. E tuttavia, accanto a questi elementi che accomunano tutti i dialoghi presenti in A onor del vero, non si deve dimenticare la specificità che le caratterizza. Esse rimangono profondamente diverse non solo nelle dinamiche che le hanno causate, ma anche nella lunga e complessa storia delle conseguenze che hanno avuto sullo sviluppo degli anni di piombo. Se la strage di piazza Fontana rappresenta il primo atto di una storia che da quel momento ha preso la direzione della violenza, l’intreccio di motivazioni e responsabilità che caratterizza ciascuno dei momenti successivi rimane ogni volta differente. Da questo punto di vista non si deve commettere l’errore di appiattire la storia successiva unicamente su piazza Fontana. La morte di Giuseppe Pinelli affonda le radici nella tragedia del 12 dicembre 1969, ma il fermo protratto dell’anarchico milanese e la sua tragica fine sono una storia a sé, attorno alla quale si assiste a un’imponente mobilitazione ideologica. Quei tre giorni che separano piazza Fontana dalla sua morte si dilatano enormemente e si affievolisce il legame con la strage mentre si sottolinea l’inaccettabilità della sua fine all’interno di un’istituzione il cui compito prioritario è quello di difendere l’integrità morale e fisica dei cittadini. Benché legata a corda doppia con la morte di Pinelli, anche quella di Calabresi acquisisce ben presto una sua specificità, inserendosi nella linea dello scontro politico che montava in quegli anni e che sarebbe poi sfociato nel terrorismo della seconda metà degli anni Settanta. È un destino singolare, quello di Pino Pinelli e di Luigi Calabresi: uniti dal fatto di appartenere alla stessa epoca, di vivere nello stesso clima culturale, ideologico e politico, ma poi 11 profondamente soli nella propria vicenda personale. Un paradosso che non deve stupire, perché ognuno è sempre contemporaneamente figlio di un tempo e assieme protagonista della sua storia, ma è proprio per questa ragione che quando si avvicinano le vicende che qui sono narrate si deve fare lo sforzo di comprendere, in uno sguardo unitario, ciò che le lega e ciò che le distingue, se non altro per non perdere di vista il valore delle persone, che non possono essere ridotte semplicemente a simboli di uno scontro annullandone in tal modo l’umanità unica e singolare. Unicamente un gruppo di ventenni poteva riuscire a raccogliere questi dialoghi. Non solo perché si tratta di giovani che, a differenza di troppi intellettuali di questo Paese, non hanno ombre nel proprio passato da nascondere, né scheletri negli armadi, né posizioni da difendere, né tantomeno imbarazzanti conversioni personali da celare e non hanno bisogno di dare lezioni a nessuno. Ma anche perché il loro sguardo diventa per questo più libero e penetrante, lontano anni luce da quello opaco di chi, da un pulpito televisivo e sfruttando la notorietà accattivante dell’intellettuale di sinistra, ha avuto la spudoratezza di affermare che «gli anni di piombo sono stati di piombo solo per gli idraulici»; e perciò è uno sguardo che cerca l’essenziale. Per costruire futuro. 12 Il Margine 32 (2012), n. 7 Una questione di morale La politica tedesca dopo le elezioni regionali in Nordrhein-Westfalen URBANO TOCCI1 C hiunque viva in Germania ha letto con stupore i commenti della stampa italiana ai risultati delle elezioni anticipate in Nordrhein-Westfalen del maggio scorso, riassunti da titoli come “La Merkel perde in casa” (L’Unità) o “Figura di Merkel” (Il Giornale, con la consueta sobrietà). Sono titoli che danno una rappresentazione completamente fuorviante sia dei risultati elettorali nel Land che della situazione politica tedesca nel suo complesso. Banalmente: dare un giudizio su avvenimenti di un’altra cultura è sempre un’operazione rischiosa. Farlo pretendendo di utilizzare le proprie categorie interpretative espone al pericolo di incorrere in errori marchiani. È un’indicazione di metodo così elementare che non dovrebbe essere sconosciuta neanche ai giornalisti di professione del nostro Paese. Sorge allora il sospetto che il non considerare il ben noto ruolo giocato dalla morale nella vita pubblica e politica dei Paesi di tradizione protestante non sia ignoranza ma parte di una più vasta operazione di disinformazione, nella quale si costruisce una Germania inesistente ad uso e consumo dell’elettore italiano2. In quest’opera si distingue Andrea Tarquini, corri- 1 I contenuti di quest’articolo riflettono unicamente posizioni e convinzioni personali dell’autore, e non possono in alcun modo essere ricondotte né all’Unione Europea né alla Direzione Generale Ricerca ed Innovazione. 2 L’operazione non è ovviamente nuova. Ricordo nella mia infanzia come veniva magnificato il modello giapponese, in cui il lavoratore, moralmente superiore al pigro occidentale occupato a protestare, si assumeva in prima persona la responsabilità di qualunque disfunzione e si sacrificava per la collettività. Poi il Giappone entrò misteriosamente in crisi ed iniziò ad uscire dalle pagine della nostra stampa. Da quando poi sorprendentemente l’attesa notizia dell’harakiri di massa dei dirigenti della compagnia elet- 13 spondente da Berlino di Repubblica, giornale che sta purtroppo sempre più assumendo il ruolo di Pravda del governo Monti. Se come italiani vogliamo dare un contributo alla crescita federale del nostro continente, è indispensabile restare aderenti alla realtà. Per questo tenterò di contrapporre all’operazione mediatica in atto una piccola operazione verità, smontando pezzo per pezzo alcune tesi propagandate nel nostro Paese. 1) La Merkel perde in casa. In realtà il Nordrhein-Westfalen è l’EmiliaRomagna della Germania, un Land governato dalla SPD3, spesso con maggioranza assoluta, dal 1966. Con l’unica eccezione del governo del democristiano Jürgen Rüttgers, salito al potere nel 2005 grazie al combinato disposto dello scandalo dei rifiuti4 e della politica liberista5 del cancelliere socialdemocratico Schröder. Sarebbe stata una notizia da prima pagina se la SPD avesse perso6, non una sua vittoria. 2) La Merkel perde tutte le elezioni. Non c’è un trend univoco7, a volte la CDU8 guadagna voti e consensi, a volte li perde, rappresentando comun- trica responsabile del disastro di Fukushima non è arrivata, del Giappone non si parla più, ed oggi il modello di disciplina per noi irraggiungibile è diventato la Germania. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (in gergo “die Rote”, i Rossi). Per gli italiani non è difficile leggere la politica tedesca, le famiglie politiche sono in gran parte quelle della nostra prima repubblica e non esiste partito tedesco per cui non ci sia stato o non ci sia equivalente nella storia politica italiana. Ben più difficile è per i tedeschi capire e relazionarsi col nostro sistema partitico, fattore che causa non poche incomprensioni fra le classi politiche dei due Paesi. I democristiani considerano quelli del PdL alla stregua di servi di un ra’is africano e non riescono a capacitarsi del servilismo di Casini nei confronti del Papa; i socialdemocratici guardano con estrema diffidenza ad un PD che contiene tutto ed il suo contrario senza un programma definito; liberali sono nello stesso gruppo politico al Parlamento Europeo con i dipietristi con cui hanno davvero poco a che spartire. Gli unici ad avere un riferimento stretto nella penisola sono i Verdi ed i Pirati, ma i Verdi italiani praticamente non esistono e 5 Stelle è appena nato. 4 A Colonia la SPD intascò 250.000 euro di fondi neri per autorizzare, dopo infinite polemiche con i Verdi, la costruzione di un termovalorizzatore. 5 Incarnata nell’Agenda 2000, il pacchetto di deregolamentazione del sistema sociale e del mercato del lavoro, che nella vulgata corrente ha posto le basi dell’attuale miracolo tedesco. Politica economica, ça va sans dire, sicuramente più a destra di quella della Merkel e che alienò al partito parte del voto operaio e portò alla nascita della Linke, “La Sinistra”, il partito di Oskar Lafontaine che si posiziona fra Rifondazione e SEL. 6 Come appunto accadde nel 2005, quando il risultato disastroso della Socialdemocrazia forzò le dimissioni di Schröder aprendo la strada all’era Merkel. 7 Il pericolo in effetti c’è stato: dopo Fukushima la Democrazia Cristiana sembrava non dovesse vincere neanche un’elezione di condominio. È stata la prontezza della Mer- 14 que sempre circa un terzo del corpo elettorale. Dalla composizione del Bundesrat9 traspare invece l’abilità politica della cancelliera, che grazie al suo prestigio personale ed alle lotte intestine della sinistra è riuscita a mantenere al governo un partito ed una destra minoritari nel Paese (insieme democristiani e liberali raggiungono il 40% dei consensi). L’Unione infatti non solo governa tutti i Länder tradizionalmente conservatori10, ma è al governo in ben sei Länder tradizionalmente di sinistra, in tre dei quali nominando addirittura il presidente appoggiandosi a una socialdemocrazia più interessata a una lotta fratricida che ad un reale cambio di governo. 3) È stato un voto contro la politica di austerità in Europa. La politica europea del governo non è stata un tema della campagna elettorale fino alla fine, quando il candidato CDU Norbert Röttgen, vistosi perso, non ha iniziato a “tirare per la giacchetta” la cancelliera11; la quale, da parte sua, prevedendo un esito non esaltante del voto, ha saggiamente preferito non farsi coinvolgere. Come ho già detto le elezioni sono state invece tutte giocate su due temi etico-morali. Innanzitutto la domanda, continuamente ripetuta a Röttgen, allora ministro dell’ambiente, se, in caso di sconfitta, sarebbe rimasto a dirigere l’opposizione a Düsseldorf o se ne sarebbe tornato a Berlino, piantando tutti in asso. Lo sventurato non rispose, cercando di mantenere il piede in due staffe e continuando a perdere irrimediabilmente consensi12. La kel (che la stampa estera normalmente dipinge come pavida, attendista ed irrisolta) nel decidere, contro i quadri del suo stesso partito, la svolta sul nucleare e riequilibrare così la situazione sfilando ai Verdi la loro carta migliore. 8 Christlich Demokratische Union Deutschlands, costituisce insieme al partito gemello-coltello bavarese CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) la Democrazia Cristiana tedesca. Collettivamente vengono spesso chiamati Unione, nome richiamato da Prodi nel 1995. Il modello di due partiti gemelli federati è quello cui s’ispira Cacciari quando auspica per la sinistra la nascita di un “partito del nord”. 9 La camera delle regioni che viene eletta in secondo grado dai parlamenti regionali e che è stata praticamente completamente rinnovata nello scorso biennio. 10 Baviera e Sassonia, con l’eccezione del Baden-Württemberg le cui elezioni si sono tenute poco dopo Fukushima. 11 Facendo così infuriare l’intero partito ed indebolendolo fino al punto che la Merkel ha potuto dimissionarlo senza problemi all’indomani della sconfitta elettorale. 12 È una situazione analoga a quella che si è creata a Parma, dove 5S continuava a chiedere a Bernazzoli perché non si fosse dimesso dalla carica di presidente provinciale e cosa avrebbe fatto dopo le elezioni. Solo che a Parma questo è stato un tema fra i tanti che hanno portato all’affermazione di Pizzarotti, mentre in Nordrhein-Westfalen è stato il tema. 15 seconda domanda, rivolta alla Linke, è stata se fosse un atteggiamento responsabile portare il Land ad elezioni anticipate invece di trovare un compromesso sul bilancio ed appoggiare il governo rosso-verde di minoranza. Sono temi che ai sudeuropei possono risultare di difficile comprensione quanto l’accanirsi dei media americani nel caso Lewinsky. E in fondo la matrice è la stessa, una concezione moralistica, in cui si chiede ai politici di non mentire agli elettori e di mettere gl’interessi del Paese al di sopra di quelli personali o di partito. La differenza fra la classe politica nord- e sudeuropea sta soprattutto in questa dinamica quasi di coppia che s’instaura fra elettore ed eletto13: non che i politici nordeuropei non provino a prendere in giro gli elettori, o che se non ci provano questo avvenga per una moralità superiore. Semplicemente sanno che “l’infedeltà coniugale” nei confronti degli elettori non paga, perché, se scoperta, porta a repentini divorzi. In una logica protestante l’elettore ha infatti il dovere morale del controllo della classe politica, e se non lo fa (come in Grecia) è connivente e coresponsabile (non nobilmente disinteressato) e dev’essere pronto a pagare le conseguenze della sua pigrizia14. 4) È possibile che l’anno prossimo due donne si sfidino per la cancelleria. Anche in questo caso la questione della coerenza morale si ripresenta potente impedendo una candidatura di Hannelore Kraft: la presidente SPD del Nordrhein-Westfalen ha preso l’impegno con gli elettori di guidare il Land per i prossimi cinque anni, se mollasse tutto per correre per la cancelleria non sarebbe più credibile15. In più non si capisce che interesse dovrebbe avere una politica giovane e promettente di scontrarsi con la popolarissima Merkel. Più prudente consolidare la propria base elettorale nel Land più popoloso della Germania e correre fra cinque anni (è stata la strada seguita da Schröder nel ‘98 in Bassa Sassonia). 5) La cancelliera esce chiaramente indebolita sul piano europeo. Sarebbe vero se queste elezioni cambiassero qualcosa nel Consiglio Europeo o se indebolissero la Merkel sul piano interno. In realtà ne esce rafforzata: 13 Mi piace ricordare in proposito quanto illuminanti furono le riflessioni su eros e politica della scuola della Rosa Bianca del 2007: L’amore conta: per una democrazia ad alta energia. 14 È il meccanismo per cui i tedeschi continuano a sentirsi colpevoli per il nazismo. 15 Invero se fosse a fine carriera potrebbe lasciare, come accade, con un diciotto mesi di anticipo per preparare la strada al suo successore. Ma tutti quanti le auguriamo una lunga carriera a Berlino, non di andare in pensione fra un paio di anni. 16 Röttgen16 non era «un pupillo della Merkel», come dice Tarquini. La Merkel non ha pupilli17. C’era tutta una serie di sedicenti principi ereditari, che ovviamente per ereditare avrebbero dovuto attendere o provocare la morte della regina, la quale però non aveva e non ha alcuna intenzione di farsi giubilare. Con Röttgen esce di scena l’ultimo dei dirigenti della CDU che potevano impensierirla per un cambio di potere18. Ed il più pericoloso di tutti, visto che è anche lui esponente di quell’ala sinistra e protestante largamente maggioritaria nel partito19 ed il promotore all’interno della democrazia cristiana di un’istanza di governo Schwarz-Grün20, alternativa a quella della Große Koalition tanto amata dalla cancelliera. Un secondo fattore che la rafforza è il nuovo successo dei Pirati, che rende quasi certo un loro ingresso nel Bundestag, ingresso che farebbe mancare i numeri ad una maggioranza RossoVerde a livello federale. 6) Se vorrà restare al potere, la cancelliera dovrà subire una Große Koalition. Nulla di più falso. Quella che viene spesso presentata dai giornali come una soluzione di ripiego cui la cancelliera si è dovuta e si ridovrà adattare per restare in carica è la sua formula di governo preferita: il suo primo mandato è stato la sua età dell’oro, e l’assonanza politica con i gemellini di pietra della Socialdemocrazia21 è stata ed è totale. Sia sul piano sociale22 che su quello economico, dove si trattava di consolidare e portare avanti le riforme contenute dell’Agenda 2010. Contro tutti i pronostici molto più problematica si è invece rivelata la convivenza con i liberali di Westerwelle, partito fortemente clientelare e dalla retorica populista, che per caratterizzarsi ed emergere sul mercato politico tiene una prassi molto più aggressiva nei confronti della cancelliera23 di quanto non abbia fatto una Socialdemocrazia, come in Italia sempre ansiosa di dar prova di responsabilità istituzionale. Che cosa cambia realmente, 1: la resurrezione dei Liberali Proprio dall’inaspettato successo degli alleati liberali, che erano oramai dati per spacciati e che costituiscono la vera sorpresa di questa tornata di elezioni regionali (hanno raggiunto un ragguardevole 8.6%, più del doppio della soglia di sopravvivenza del 4%, più dei Pirati, il cui successo era previsto dopo il “terremoto” di Berlino), che possono paradossalmente derivare i maggiori problemi alla Merkel. Abbandonata la campagna per una rivoluzione liberale condotta nel bel mezzo della crisi del liberalismo (campagna che aveva portato il partito dal 15% delle nazionali del 2009 al 2% dei sondaggi a livello federale d’inizio mese)24, la FDP si è rilanciata dando da una 16 Che viene a volte presentato come l’artefice dell’addio al nucleare, decisione che invece è stata presa dalla Merkel seguendo il suo metodo. 17 Come non ha padri: basta considerare la freddezza con cui scaricò Kohl (il leggendario padre della riunificazione tedesca, dell’euro ed artefice della sua carriera) nel frangente dello scandalo dei fondi neri alla Democrazia cristiana. Da allora il rapporto con lui e con il suo entourage (fra cui Michael Stürmer, ex consigliere di Kohl intervistato da Tarquini) è al limite dell’insulto pubblico. 18 Ursula Gertrud von der Leyen, già ministro della famiglia ed ora ministro del lavoro, da molti indicata come vera erede della Merkel, a 50 anni non ha fretta e non sarà certo lei a creare problemi alla cancelliera. 19 Malgrado la campagna di normalizzazione della Chiesa cattolica tedesca e della Democrazia cristiana perorata da Ratzinger. 20 Nero-verde: rispettivamente i colori dei democristiani e dei Verdi. L’uso in questi casi è mettere prima il partito più votato, quello che decide la carica più rappresentativa. 21 Peer Steinbrück e Frank Walter Steinmeier, “cava di pietra” ed “amministratore di pietra”: due dei tre possibili candidati socialdemocratici alla cancelleria che incarnano la continuità con la politica economica liberista dell’era Schröder. 22 La modernità della Germania è essenzialmente dovuta a questo profondissimo rinnovamento della CDU, accompagnato dalle Chiese tedesche, che ha assecondato la naturale evoluzione della società e del Paese. Così anche per i partiti conservatori gli immigrati da problema ed estranei sono diventati risorse da integrare con politiche adeguate; 17 l’islam in particolare, come ha detto l’ex presidente tedesco Wulff, «appartiene alla Germania come il cristianesimo e l’ebraismo»; le donne da regine della casa che si dovevano occupare dell’educazione dei figli diventano sempre più soggetti di diritti cui lo Stato deve fornire strumenti per un eguale accesso al mercato del lavoro; il riconoscimento dei diritti degli omosessuali non è stato osteggiato ma spesso il dibattito è stato se appoggiarlo o astenersi ecc. Ovviamente questo rinnovamento è avvenuto ed avviene fra strappi e polemiche, ma ha contribuito a conservare la competitività del sistema produttivo tedesco quanto se non più delle riforme del mercato del lavoro. 23 Dall’atteggiamento della FDP è scaturita una litigiosità continua all’interno della coalizione, ben riassunta dalla copertina dello Spiegel (n° 26/2010) che rivolgendosi ai partiti della coalizione e riassumendo gli umori dell’intero Paese tuonava un perentorio: Aufhören! (“Piantatela!”), come si fa con i bambini all’asilo. 24 Ideologia ormai sentita come tipicamente anglosassone, quindi straniera ed avulsa dalla tradizione della nazione tedesca, che si riconosce compatta nel suo modello di capitalismo renano, o economia sociale di mercato che dir si voglia. Per capire l’attaccamento dei tedeschi al loro modello basta osservare come l’intervista di Draghi (mai molto amato in Germania, checché ne dica Scalfari) al “Wall Street Journal”, nella quale il governatore della BCE affermava che l’economia sociale di mercato era morta, sia stata fatta passare completamente sotto silenzio dai media per evitare problemi per l’approvazione dei piani di salvataggio della Grecia. 18 parte risposta politica25 alla domanda di rappresentanza emergente dal preleghismo tedesco26, e dall’altro rivitalizzando la sua anima libertaria che chiede più diritti civili per il singolo cittadino27. Ed è proprio questo aspetto libertario su cui puntano i pontieri del partito per porre le basi di quel “semaforo”28 che rappresenta la più probabile opzione per mandare un giorno la CDU all’opposizione29. Nel più breve periodo, se il nazionalismo tedesco dovesse essere ulteriormente sollecitato a livello europeo, il partito potrebbe facilmente tornare al di sopra del 10% dei consensi, rendendo possibile una riedizione dell’attuale maggioranza, con grande dolore della cancelliera che, come nella scorsa legislatura, non potrebbe sottrarsi. Per capire gli umori dell’elettorato tedesco vale sicuramente la pena considerare come al pre-leghismo della FDP ed al successo riscosso da quest’offerta elettorale faccia da contraltare il processo di progressiva dissoluzione della Linke, che seguendo l’ideale “internazionalista” è schierata per una soluzione “solidaristica” della crisi finanziaria europea “senza se e senza ma”, per la nazionalizzazione della banche in stato di insolvenza e per l’emissione di eurobond a beneficio della Grecia come dell’Italia. Ovviamente il declino della Linke non si può ricondurre esclusivamente alla sua politica solidaristica: la litigiosità del partito a livello federale, la poca flessibilità mostrata nel far cadere il governo del Nordrhein-Westfalen e soprat- tutto lo spostamento a sinistra della SPD hanno giocato e giocano un ruolo determinante nella crisi del partito30. Che cosa cambia realmente, 2: la rinascita di una sinistra Ed è proprio il ritorno a sinistra della SPD la seconda grande novità di queste elezioni. La storia della Germania dal crepuscolo dell’era Schröder in poi deve anche essere letta come la storia di un Paese di sinistra regalato alla destra, grazie ad un tabù, analogo al fattore K italiano ed all’ostracismo verso i Verdi durato fino all’85, che precludeva ogni possibile alleanza a sinistra nell’ex Germania Ovest. La novità e la forza della Kraft è stata di riuscire a far uscire il proprio partito da uno stato di subordinazione intellettuale rispetto al centro, a convincerlo due anni fa a tornare al governo anche tramite un patto con gli ex-comunisti della Linke ed oggi a votare un programma dichiaratamente di sinistra: in Nordrhein-Westfalen, il Land dell’ala più conservatrice della SPD, governato per anni da quel Wolfgang Clement che pur di far un favore all’industria nucleare arrivò nel 2008 ad invitare a votare contro il suo stesso partito alle elezioni regionali in Assia, è nata una nuova socialdemocrazia capace di produrre leader e politiche a livello federale, leader in prospettiva capaci di vincere una mano a livello europeo nella lunga partita contro gli eredi della trimurti Blair-Schröder-D’Alema. 25 Da quando il referendum interno esteso a tutti gli iscritti del dicembre 2011 (strappato alla riluttante dirigenza del partito da Frank Schäffler), in cui si chiedeva se il partito dovesse votare a favore del meccanismo di salvataggio europeo o far cadere il governo, ha ottenuto ben il 45% dei voti (malgrado la campagna martellante e compatta di tutta la stampa nazionale e dell’attuale e passata dirigenza dal partito), la FDP ha iniziato coerentemente a posizionarsi contro ogni forma di eurobond e a esprimere fortissime perplessità, critiche e voti contrari di numerosi deputati sui “salvataggi” europei. 26 A livello federale. In Baviera anche questo mercato è saldamente in mano alla CSU. 27 Riuscendo abilmente a coniugare su questo tema cittadini genuinamente preoccupati per la pervasività del controllo informatico e vecchie clientele rese inquiete dalla possibilità di una lotta informatica all’evasione fiscale. 28 La metafora del semaforo si riferisce ai colori rosso, giallo e verde; rispettivamente della SPD, della FPD e dei Verdi. 29 E sbarazzarsi della Merkel. Ragione per cui quest’opzione viene vista di buon occhio dagli ambienti conservatori dell’Unione, che potrebbero finalmente provare a porre fine al controllo protestante e progressista del partito e si ritroverebbero nel comodo ruolo di opposizione quasi unica ad un governo ch’è facile prevedere estremamente litigioso. Dev’essere però chiaro che si tratta di una prospettiva lontana nel tempo. 19 Il “Metodo Merkel” Nel presente bisognerebbe però concentrare l’attenzione sulla possibile nascita di un leghismo tedesco31 le cui dirompenti conseguenze per la crisi italiana e per il futuro dell’Europa dovrebbero essere parte del dibattito politico e non solo un fantasma da esorcizzare. Affrontare questo tema permetterebbe di capire il ruolo fondamentale giocato dalla Merkel e dal suo meto- 30 Come detto dallo stesso Lafontaine, il fondatore del partito, la Linke esaurirà il suo ruolo quando la SPD smetterà di essere il partito delle banche e della grande industria e tornerà ad essere il partito dei lavoratori. 31 Magari mediante una mutazione genetica del partito liberale con una deriva simile a quella già subita dei liberali austriaci e da quelli sudtirolesi. 20 do per tentare di scongiurare tale pericolo32, che si concretizzerebbe se l’elettorato tedesco avesse per lungo tempo la sensazione di non essere adeguatamente difeso al tavolo europeo dagli attuali partiti. Sono convinto che in futuro proprio osservando come la cancelliera stia mediando fra la visione tedesca dell’Europa e le aspettative dei suoi partner nell’eurogruppo che la sua statura politica risulterà chiara a tutti gli europei. Le dichiarazioni di Hollande e di Monti sulla crescita ed i toni trionfalistici dei media delle rispettive nazioni non devono trarre in inganno: la Merkel applicherà anche con loro la tecnica dell’Entleerung, dello “svuotamento”, tecnica già testata numerose volte in patria con piena soddisfazione, da ultimo con la fuoriuscita dal nucleare. Dichiarandosi formalmente favorevole alla soluzione del problema perorata dalla controparte: «la crescita??? Ovviamente sono per la crescita, che domande!». Al momento dell’implementazione fra tutte le possibili strategie, onde evitare inutili attriti/spaccature/rinvii si sceglieranno solo quelle condivise da tutti, quindi solo quelle che rispecchiano le sue visioni politiche e/o gli interessi cui lei fa capo (salvataggio delle banche, magari facendo cadere la responsabilità sui socialdemocratici come accaduto nel Consiglio di giugno, suo grande capolavoro politico dove sono stati presi, con una sua opposizione di facciata, solo i provvedimenti da lei voluti). Altre misure, proposte dagli interlocutori, saranno rimandate alle calende greche («gli eurobond33? Si faranno appena ci saranno le condizioni e gli Stati membri saranno pronti»). Per un lungo periodo tutti saranno ufficialmente contenti sperando così di evitare la rinascita di un nazionalismo tedesco e salvare l’Europa. La Sehr Große Koalition e le sue conseguenze Ora, prescindendo da giudizi sulle politiche della Merkel, condivido il grido di allarme di sempre più ampî settori dei Verdi, che denunciano come il “metodo Merkel” comporti uno svuotamento non solo dei partiti alleati ed 32 Per comprendere quanto questo pericolo sia reale, basta considerare il successo dell’ultimo libro di Thilo Sarrazin, ex assessore socialdemocratico a Berlino ed ex membro del consiglio direttivo della Bundesbank: L’Europa non ha bisogno dell’Euro, dove in effetti dell’Europa importa veramente molto poco ed il problema viene affrontato in maniera germanocentrica. 33 Odiatissimi dai tedeschi, meno del 15% è favorevole ad una loro emissione. 21 avversari, ma dello stesso sistema dei partiti34, che diventano sempre meno distinguibili gli uni dagli altri dando lo stesso senso di democrazia bloccata che ritroviamo in Grecia ed Italia, e sia quindi una delle cause del successo dei Pirati/5 Stelle35. Dal dopoguerra ogni nuova generazione che si affacciava alla vita politica ha incarnato, anche inconsciamente, la necessità di adattamento della società alle mutate condizioni geopolitiche mondiali e portato un bisogno di rinnovamento che si è espresso in movimenti che a volte sono rimasti merî contenitori dello scontento ed a volte sono riusciti a maturare in partiti. Ma guardando l’evoluzione del panorama politico tedesco non si può che restare colpiti dall’accelerazione del fenomeno. I Verdi di Daniel Cohn-Bendit, pur originando da un movimento fortissimo come il ‘68 e detenendo il copyright di un tema importantissimo come l’ambiente, impiegarono 15 anni per arrivare in Parlamento e lottarono un altro decennio prima di diventare un partito stabile. I Pirati sono nati in Svezia nel 2006 ed entreranno nel Parlamento tedesco l’anno prossimo, in meno di metà del tempo e con un tema generazionale (si caratterizzano come il partito dei nativi digitali) che, probabilmente a causa della mia non più giovane età, non percepisco come così fondamentale. L’ultima legislatura è cominciata con l’esplosione dei liberali: hanno guadagnato il 5%, era sembrato un’enormità. Ma quasi il doppio dei voti sono passati ai Verdi nel giro di pochi mesi (+8%, toccando il 23% nel luglio 2011, mentre i liberali nel frattempo erano praticamente spariti); tali voti fluttuanti sono ulteriormente aumentati nel passaggio ai Pirati/5 Stelle (11% a livello nazionale, i Verdi sono scesi ai loro valori pre-Fukushima36). 34 E quindi, in un sistema basato sulle prerogative del parlamento come quello tedesco, della democrazia stessa del Paese. 35 In effetti, malgrado l’argomento sia considerato sconveniente all’interno degli stessi partiti e non venga quindi tematizzato, si può dire che dallo scorso febbraio (quando la Merkel, non avendo una maggioranza propria, ha dovuto accettare i voti dell’opposizione per far passare il secondo pacchetto di “aiuti alla Grecia”) la Germania è governata, sui temi economici e di politica europea, da una Sehr Große Koalition, un tacito accordo fra CDU, SPD e Verdi in cui gli ultimi due partiti per senso di responsabilità istituzionale non fanno mancare i loro voti alla cancelliera quando questa perde la maggioranza a causa della fronda di pezzi della sua coalizione e del suo stesso partito su argomenti di politica europea. È la stessa maggioranza che ha votato il liberal-conservatore Gauk, candidato ufficiale dei socialdemocratici, alla presidenza della repubblica. 36 Malgrado i Verdi tengano i loro voti storici, sono i veri sconfitti di questo periodo: appoggiando la Sehr Große Koalition sono visti come omologhi e non più alternativi all’Unione. 22 Il Margine 32 (2012), n. 7 Ovviamente non è detto che la storia finisca qui, ed anche se questi voti si fermassero sui Pirati, nessuno, neanche loro stessi, sa chi siano realmente37. Ciò che traspare è che tendono, come in Italia, a seguire le mode e gli umori dell’elettorato in modo un po’ inquietante. Ma la domanda di rappresentanza politica è reale, e salda inquietudini generazionali alla rivolta dei saperi contro il dominio del pensiero unico e dei manager-kapò su cui si appoggia: saranno le risposte alle richieste di questa generazione di superamento del pericolosissimo attuale blocco della democrazia che determineranno il futuro della Germania e di quell’insieme di isole e penisole che le stanno intorno e che vengono chiamate Europa. 37 Un dietrologo direbbe che, come i loro omologhi svedesi, sono la risposta della destra all’esplosione dei Verdi. Un po’ come i radicali italiani degli anni Settanta, solo che internet come mezzo di organizzazione e comunicazione è ben più efficiente delle radio libere. 23 I pregiudizi nei confronti della teologia della liberazione EUGEN GALASSO N el 1984 Lucio Colletti, pensatore già marxista, poi profondamente “revisionista” verso lo stesso pensiero di Marx, scrisse un saggio sul rapporto tra le teologie della liberazione e il marxismo, nato come complesso di risposte a domande di “Mondo operaio”, organo culturale del PSI, forse steso con la collaborazione del sociologo Luciano Pellicani1. Nel testo si inizia subito mettendo le carte in tavola: «Le teologie della liberazione non sono, a rigore, delle teologie vere e proprie; sono piuttosto una concezione escatologica della storia». Il filosofo afferma cioè subito, in modo apodittico, la distinzione, anzi la dicotomia, tra teologie vere e proprie (quelle tradizionali e “ammesse”, concezione curiosa per un filosofo laico) e della liberazione (dove, particolare non insignificante, è almeno da rilevare il riconoscimento della pluralità di esse, in luogo della reductio ad unum che da qualche parte si era avuta e tuttora si ha). Si noti, peraltro, che in tutto il saggio Colletti non distingue mai tra una teologia della liberazione e le altre, quasi ci fosse un common sense unificante e onnivoro. Il discrimine è, per Colletti, l’escatologia, che culminerebbe, per le teologie vere e proprie, nel «Regno di Dio», nella «comunità mistica degli eletti», nella «Gerusalemme celeste», comunque in una dimensione ultratemporale, collocata «al di là della storia stessa», mentre il fine, il tèlos delle teologie della liberazione sarebbe infra-storico («nelle teologie della liberazione l’approdo ultimo della storia cade nella storia stessa e si iscrive nel tempo»). Si tratta di una tesi rispetto alla quale si potrebbe avanzare qualche dubbio: molte teologie della liberazione non escludono affatto, anzi presuppondono il tèlos extra-mondano e ultrastorico. Senz’altro quest’argomentazione non vale o vale con riserva per Fernando Belo2; la maggioranza delle 1 Lucio Colletti, Le teologie della liberazione e il marxismo, in “Mondo operaio”, ottobre 1984, poi in Pagine di filosofia e di politica, Milano, Rizzoli, 1989, pp.167-175. 2 Fernando Belo, Per una lettura materialistica del Vangelo di Marco, Torino, Claudiana, 1973. 24 teologie (e dei teologi!) della liberazione non esclude la «redenzione», ma presuppone l’«emancipazione economico-sociale», per dirla ancora con Colletti. Ma Colletti (all’epoca ormai convertito politicamente e ideologicamente dal marxismo al socialismo craxiano) non era il solo a sostenere questa tesi, diffusa in gran parte dell’intelligentsia moderata italiana ed europea. Secondo tale tesi le teologie della liberazione sarebbero state protagoniste, rispetto alla teologia “tradizionale”, di un umanismo radicale, quasi di stampo prometeico: «nelle teologie della liberazione è la storia stessa che si fa Dio». Un umanismo così radicale che delegittimerebbe l’etica a questione meramente sociale e politica: «Le teologie della liberazione sposano, senza neppure, forse, rendersene conto, la soluzione che – come vide magistralmente Kant – è stata data da Rousseau al problema della teodicea. Il male viene dal di fuori. Ha origine dagli ordinamenti della società ... Il pessimismo cristiano, che esprime nell’idea del “peccato originale” è qui rovesciato da cima a fondo e sostituito da un ottimismo antropologico che sfida persino il senso comune». A parte l’arbitrio che ritiene tout court ottimistica la prospettiva di Rousseau e suoi successori (basterebbe esaminare le opere di Rousseau per scoprirvi tratti ben diversi), appare francamente esagerata l’affermazione “teologica”, a livello morale: in nessuna teologia della liberazione si nega il peccato originale, semmai se ne relativizza l’onnipervadenza, quale clavis universalis per spiegare tutto, fino a negare (excusatio non petita, ma talora anche petita) il “peccato sociale”. Anche qui vien da dire, non solo a Colletti ma a coloro che tuttora (anche nella Chiesa), argomentano in modo analogo: leggete i teologi della liberazione (ché, prima che di teologie, bisognerebbe dire anche dei loro autori). Ma non basta: secondo Colletti (e non solo lui) anche per varie altre comunità di base italiane ma anche e soprattutto europee (ricordo quella dell’Abbé Pierre), ma ancor di più mondiali (penso a Ernesto Cardenal e al suo straordinario Vangelo di Solentiname)3. Se è impossibile identificare teologie della liberazione e comunità di base, è d’altronde vero che nessun teologo della liberazione ha scritto le sue opere nella turris eburnea, nel sovrano distacco dalla e dalle comunità dei credenti. Se per l’opera citata può valere l’argomento della sua origine pastorale (le omelie tenute nell’isola di Solentiname) anche opere teoriche come per esempio quelle di Gustavo Gutierrez4 e di Ignacio Ellacuria e Jan Sobrino5 nascono sempre dal contatto con le persone e con le comunità cui queste afferiscono, cui esse si riferiscono, mai dalla “grigia teoria”. Le affermazioni di Colletti (ma il discorso, come dicevo, è estendibile ad altri autori e a semplificazioni giornalistiche presenti in riviste “culturali”) sono dunque il frutto di un atteggiamento snobistico di certa intelligentsia, e credo che in questo senso il testo collettiano sia emblematico. Oltremodo discutibile anche l’altra affermazione di Colletti, per cui «la loro [delle teologie della liberazione] stessa diffusione in America del Sud procede al passo con lo sviluppo (seppur relativo) di quei maggiori Paesi (Argentina e Brasile)». Per cominciare, bisognerebbe per lo meno parlare di “America Latina” (dove mettiamo altrimenti il Nicaragua dei fratelli Cardenal o il Messico di José Porfirio Miranda?). Ma il problema vero è quello dello “sviluppo” (desarrollo): Colletti scambia il “progresso” con il puro e semplice “sviluppo”, per riprendere la dicotomia pasoliniana. In Latinoamerica è la presa di coscienza del problema sociale e non il mero “sviluppo economico” ad essere la “causa” della teologia della liberazione. Ancora: riprendendo l’affermazione precedente, per cui le teologie della liberazione sarebbero mere escatologie storiche, anzi «storico-politiche», come le definisce poi Colletti, egli le colloca nell’alveo “stretto” del marxismo: «Le teologie della liberazione sono un portato della cosiddetta “secolarizzazione” ... Le teologie della liberazione non sono il frutto della tragica miseria di molte plaghe latino-americane. Non segnano un ritorno al “cristianesimo delle origini”. Sono, al contrario, un prodotto dell’Occidente industrializzato». Ora, prima di tutto non è vero che le teologie della liberazione siano frutto del weberiano “disincanto del mondo” e della “secolarizzazione”: partono da comunità di base di Paesi “in via di sviluppo” (come spesso ipocritamente vengono definiti) e da comunità, come quella romana di Oregina (dom Franzoni) e fiorentina dell’Isolotto (con lo scomparso don Enzo Mazzi) in cui non si può dire che sia prevalsa la secolarizzazione, anzi. Ciò vale 25 «Questo loro carattere conferma, da una parte, quanto profonda sia stata la fecondazione che esse hanno ricevuto dal marxismo; e spiega, dall’altra, come la vitalità di quest’ultimo, nell’età della “secolarizzazione”, si riduca al fatto di essere ormai solo un’escatologia storica, ovvero come il marxismo sia condannato a figliare, oggi, so- 3 Ernesto Cardenal, Il Vangelo a Solentiname, Brescia, Querinina, Claudiana, 1989. Gustavo Gutierrez, La teologia della liberazione, Brescia, Queriniana, 1972 5 Mysterium Liberationis, a cura di Ignacio Ellacuria e Jan Sobrino, Assisi, BorlaCittadella, 1993. 4 26 Il Margine 32 (2012), n. 7 prattutto nel campo spurio dell’utopismo sociale e del radicalismo ideologicoreligioso». Quest’ultima affermazione rivela il disprezzo verso Weltanschauungen definite “spurie” (vien da chiedersi quali siano invece quelle “pure” e “incorrotte”, vista l’acrimonia del tardo Colletti verso i sistemi filosofici nel suo complesso, con il suo parziale ritorno a Kant e all’Illuminismo). Ma, soprattutto, vien da chiedersi: sarebbe allora la secolarizzazione a relegare il marxismo in questo ruolo? Sarebbe la secolarizzazione la causa delle teologie della liberazione, figlie di un’escatologia marxista? Colletti critica poi i teologi della liberazione che vorrebbero servirsi del marxismo solo come “analisi scientifica della realtà”, mentre questo sarebbe un repertorio ormai patetico; essi sarebbero incapaci di considerare, secondo Colletti, «le società e i regimi che a quella dottrina si richiamano», come se in Porfirio Miranda, in Belo, in Cardenal, in Frei Betto, in Gutierrez, in Boff vi fosse alcuna pagina di anche solo velata apologia dell’URSS, della Repubblica Popolare Cinese o di Cuba. Il testo collettiano finisce dunque con il riconoscere il valore del documento contrario alle teologie della liberazione prodotto dall’allora cardinal Ratzinger in qualità di Prefetto della Congregazione per la Dottrina delle Fede. È evidente che il laico Colletti non poteva tout court inneggiare alla parte teologica (pur se il saggio citato è un’intromissione completa in questioni teologiche), ma ne esalta la presa di distanza da Marx e dal marxismo e dalla loro presunta “presa” (influenza, se vogliamo) sulle teologie della liberazione. Una presa di posizione, dunque, “ideologica” nell’accezione che deriva da Marx ed Engels e che sembra ormai corrente nel discorso filosofico, storico e sociologico, dove sarebbe più appropriato dire “strumentale”. Non vorrei infierire, ma mi vien da dire che, se Colletti fosse stato ancora marxista nel 1984, magari a denti stretti avrebbe osannato le teologie della liberazione o quantomeno il loro anti-imperialismo. Nessuna conclusione, da parte mia, limitandomi a quest’analisi: se è vero, come credo, che un disegno politicamente ed economicamente neo- e iper-liberista oggi “stritola” a livello editoriale e di comunicazione le teologie della liberazione, non sappiamo che cosa succederà in futuro, pur se non sembra del tutto condivisibile il messaggio spesso ripetuto da Gutierrez: «Se la teologia della liberazione è morta, non me n’ero accorto». Forse le recenti (e anche meno recenti...) evoluzioni economico-politiche contribuiscono a farla ammalare. Anche se non riescono però ad “ammazzarla” definitivamente. 27 Graffi sul muro PIERGIORGIO CATTANI N annetti Oreste Ferdinando: pochissimi lo hanno conosciuto in vita, quasi nessuno se ne ricorda. Eppure quest’uomo, “un matto vero”, diventa il protagonista della nuova fatica letteraria di Paolo Miorandi, psicoterapeuta e scrittore roveretano, capace, con una sensibilità fuori dal comune, di addentrarsi nelle situazioni limite, varcando con discrezione i confini fisici e mentali di quella che chiamiamo normalità. Come nel precedente libretto Ospiti in cui Miorandi, in 80 fulminanti terzine, superava la soglia delle case di riposo per raccogliere e fissare almeno un frammento di vite menomate e giunte al termine, così in Nannetti (questo il titolo del volume edito dalla casa editrice “Il Margine”) recupera e sublima la vicenda di un internato nel manicomio giudiziario di Volterra. Una vicenda perduta rinarrata attraverso le parole di un anziano infermiere, “l’Aldo” che a sua volta aveva decifrato e trascritto i graffiti che il Nannetti aveva vergato con la fibbia del gilet sui lunghi muri del cortile dell’istituto. Con uno stile letterario del tutto particolare, frutto di un quinquennale lavoro di taglio e di limatura, Miorandi propone una originale scrittura paratattica, senza punti, come in un flusso ininterrotto di pensieri che confonde e sovrappone le voci dei due protagonisti (i ricordi dell’Aldo e le parole, spesso deliranti, del Nannetti) con le impressioni di un narratore – l’autore stesso – che, in veste di “pellegrino”, sale verso le vestigia del manicomio, ora ridotto a un rudere in disfacimento, comunque testimone di una struttura che accoglieva fino a 5500 persone. L’istituto di Volterra era una vera e propria città, con i dormitori, le lavanderie, l’officina, le mense, gli orti, lo spaccio interno e persino con una moneta propria con cui venivano “retribuiti” i matti in grado di svolgere alcune mansioni. C’era anche il cimitero dove erano sepolti quei morti non reclamati da nessuno. Proprio questa, anche in vita, sembra essere stata la sorte di Nannetti. Così racconta l’Aldo: 28 «Era nato a Roma, quando è arrivato si sapeva poco sul suo conto, non si sapeva se i genitori fossero ancora in vita né se avesse parenti da qualche parte, sta di fatto che ce l’hanno consegnato, l’hanno portato al giudiziario, io ero di riposo quel giorno, e poi, per tutti i quindici anni che è stato qui, non si è mai fatto vivo nessuno a reclamarlo, nessuno ha mai chiesto di lui, come se non esistesse, nemmeno una lettera dal tribunale». (p. 19). E ancora: «Prima di arrivare da noi era stato due anni all’ospedale Forlanini a Roma, nel reparto di ortopedia, sembrerebbe per un problema alla spina dorsale, ma forse lo hanno tenuto tutto quel tempo perché nessuno sapeva dove metterlo, il Nannetti era una di quelle cose per cui non c’è posto al mondo» (p. 31). Sono frammenti incerti, recuperati per sentito dire, tessere sparse di un mosaico che nessuno potrà mai ricomporre: non c’è posto per i matti come Nannetti, non c’era posto 50 anni fa come oggi per chi guarda la realtà con occhi sicuramente stralunati, eccentrici e folli, ma proprio per questo capaci di penetrare un altro piano della percezione del mondo. Nelle scritte incise dal Nannetti ricorrono spesso accenni ai pianeti, alle stelle, a viaggi astrali, a prodigiose onde cosmiche trasmettenti segnali e informazioni direttamente al cervello “catodico” (aggettivo molto presente nei deliri dell’uomo) del Nannetti che poi doveva assolutamente riprodurre sul muro della Casa della Misericordia Mentale. «Loro mi hanno scelto, io sono il santo con la cellula fotoelettrica, sono moro, secco, naso a y, testa lunga, testa sottile e bocca stretta, sulla foto la tengo aperta anche se non si dovrebbe farlo, non è educazione tenere la bocca aperta» (p. 61). rare queste tracce; e altrettanta dedizione ce l’ha messa Paolo Miorandi, anch’egli instancabile traduttore. E per una coincidenza incredibile il manicomio di Volterra era dedicato a san Girolamo, il patrono dei traduttori, colui che aveva trasposto in latino la Bibbia ebraica. Anche recuperare le parole di un uomo derelitto, di cui non si conoscono origini e di cui si ignora la fine, diventano quasi un gesto sacro che risponde a una sorta di “appuntamento segreto” che l’autore aveva con Nannetti: un appuntamento, per usare un’immagine di Walter Benjamin (filosofo e critico molto amato da Miorandi), che rivela un indice segreto nascosto nelle pieghe del passato; un tempo trascorso da cui riemergono sussurri flebili, in cui si possono incontrare mani e ascoltare pensieri. «Il Ferri [così si chiamava il padiglione dove venivano ospitati gli internati giudiziari, ndr] adesso è un corpo svuotato, un ventre a cui hanno tolto sangue e viscere, la catena che tiene accostata la porta che dà sul cortile è lenta, posso passare tra la porta e lo stipite solo se trattengo il fiato, aspetto, gli occhi devono abituarsi all’oscurità dei lunghi corridoi e al chiarore improvviso delle finestre, qualcuno ne ha divelto gli scuri e gli ha utilizzati per fare il fuoco, per tenere lontano di qualche metro il gelo dell’inverno, per scaldarci un zuppa in scatola o abbrustolire una patata» (p. 89). Qualcuno però si muove ancora tra quei ruderi come il cieco Omero che, nel carme Dei Sepolcri di Foscolo, brancolando nel buio sfiora le pietre dell’antica Troia e sente le voci degli eroi, le grida dei combattimenti, l’eco della poesia; così Miorandi riporta in vita il suo antieroe che esce battuto dall’epica battaglia della vita. (“Trentino”, 20 giugno 2012) Questo il linguaggio a volte senza senso, a volte evocativo di luoghi e di persone mai esistite, a volte incredibilmente serio e folgorante che accompagna le pagine di un libretto che si legge tutto di un fiato. Nannetti diventa quindi un antieroe del tempo presente, un emarginato che assomiglia ai tanti rifiuti umani che questa società costringe al degrado e alla solitudine. Miorandi riporta in vita un’anima dolente e sconfitta ma pregna di una sensibilità fuori dal comune e desiderosa di scrivere, scrivere, scrivere (questa l’unica attività di un paziente che quasi non parlava) e di lasciare al mondo qualcosa di sé. Ci sono voluti la pazienza e l’amore dell’infermiere Aldo (che dice quasi trionfante: «sono l’unico traduttore del libro che il Nannetti ha scritto sul muro del manicomio», p. 14) per recupe- 29 30 Il Margine 32 (2012), n. 7 Giorgio Agamben ragiona sullo stesso problema e nella stessa linea, anche se sposta il piano prospettico dell’analisi. Scrive infatti che: Il tempo e la fine «Occorre sottolineare con forza questo punto, contro un’opinione che si sente spesso ripetere dai teologi, a proposito di un preteso “ritardo della parusia”. Secondo quest’opinione, che mi è sempre parsa blasfema, quando la comunità delle origini, che aspettava come imminenti il ritorno del messia e la fine dei tempi, si rese conto di avere a che fare con un ritardo di cui non riusciva più a venire a capo, avrebbe allora mutato il suo orientamento per darsi una stabile organizzazione istituzionale e giuridica. Ciò significa che essa avrebbe cessato di paroikenin, di soggiornare come straniera nel secolo, per cominciare a katoikein, ad abitarvi come cittadina, come qualsiasi altra istituzione mondana»5. LUIGI GIORGI «Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano. Noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza» (1Ts 5, 7-9). C’ è soltanto questa spiaggia fra noi e l’Onnipotente: così dice, più o meno, un soldato americano sbarcato in Normandia nel film di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan. Ciò mi spinge a una riflessione: quanto c’è fra noi e il ritorno del Cristo? Fra noi e la fine del tempo? Fra noi e il Regno? Fra noi e la salvezza? C’è una parte del saggio di Paolo Flores d’Arcais su Gesù1 nel quale l’autore affronta il tema della venuta del Regno e della salvezza, e lo fa seguendo un percorso storico interessante, ma che, a mio parere, resta sulla superficie del problema, se di “problema” si tratta (ma potremmo parlare più che altro di “mistero”). Flores d’Arcais, partendo dalla lettera di Paolo ai Tessalonicesi scrive: «il trionfo apocalittico del Regno avverrà nel corso della generazione stessa degli apostoli»2. Ma lo spazio dell’attesa si è dilatato e l’attesa, la speranza che non arriva, afferma Flores d’Arcais, «rende necessaria la fondazione della Chiesa»3. Ma se storicamente si può, anche se con qualche rischio di interpretazione, prendere alla lettera testi scritti molto dopo la morte e resurrezione di Gesù, cosa che Flores d’Arcais fa, tale approccio non riesce a fare il paio con la fede. Lo stesso studioso scrive infatti che: «La fede consente di dire tutto, naturalmente, come già sapeva San Paolo, che usa la parola moria (follia, stoltezza, comunque l’opposto della “ragione” nel senso greco del termine) a proposito della fede. La ricerca storica no»4. 1 Paolo Flores d’Arcais, Gesù. L’invenzione del Dio cristiano, add Editore, Torino 2011. Flores d’Arcais, Gesù, p. 21. 3 Flores d’Arcais, Gesù, p. 26. 4 Flores D’Arcais, Gesù, p. 35. 2 31 Agamben indica una diversa qualità e concezione del tempo: «il tempo del messia non designa, infatti, una durata cronologica ma, innanzitutto, una trasformazione qualitativa del tempo vissuto». Eppure il tempo si è dilatato, allungato nella storia. Storia che è un interim come scrive Agamben stesso ragionando su Schmitt e Peterson6. Ma il tempo sul quale ragioniamo è da noi determinabile o meno? Il “frattempo”, l’“interim” quanto dureranno? Agamben scrive che: «il messianico non è la fine del tempo, ma il tempo della fine»7, soprattutto quando ragiona sul fatto che fare esperienza del “tempo messianico” «implica una trasformazione integrale di noi stessi del nostro modo di vivere»8. Il tempo mes-sianico è l’unico nel quale la Chiesa può vivere, poiché essa, ricorda Agamben, «può vivere come istituzione soltanto mantenendosi in relazione immediata con la propria fine»9. 5 Giorgio Agamben, La Chiesa e il Regno, nottetempo, Roma 2010, p. 7. Cfr. Giorgio Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 19. Schmitt parla della Chiesa come di una complexio oppositorum: «Pare non possano darsi opposizioni che essa non riesca ad abbracciare […] Ma anche dal punto di vista teologico la complexio oppositorum domina ovunque. L’Antico e il Nuovo testamento valgono entrambi, l’uno accanto all’altro, e all’aut aut marcionita si risponde qui con un “sia sia”». Carl Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Il Mulino, Bologna 2010, p. 15 e p. 16. 7 Agamben, La Chiesa e il Regno, p. 8. 8 Agamben, La Chiesa e il Regno, p. 11. 9 Agamben, La Chiesa e il Regno, p. 18. 6 32 Ma il problema di che cosa fare nell’attesa, in questo fra-tempo, si pone in tutta la sua “tragicità”. Che cosa bisogna fare nel tempo datoci? Ecco la domanda angosciata dell’uomo… Scriveva Sergio Quinzio: «È assolutamente impossibile vivere e lavorare nel mondo per quasi tutte le ore del giorno e insieme “cercare il regno”; come sarebbe stato impossibile a Matteo seguire Gesù e insieme continuare a fare l’appaltatore d’imposte. Se, d’altra parte, soffrissimo adeguatamente questa impossibilità non potremmo continuare a vivere»10. Come attendere alle cose ultime e penultime? Scriveva Dietrich Bonhoeffer: «il penultimo va salvaguardato per amore dell’ultimo. Una sua distruzione arbitraria pregiudicherebbe gravemente l’ultimo»11. L’attesa diviene una “lotta”, quasi un “corpo a corpo” fra la natura umana e quella divina. Scrive Rita Fulco commentando le opere di Quinzio che «il fatto che si continui a morire, nella sua tragicità, non è l’unica pietra dello scandalo. Il “da farsi” nel continuare a vivere non lo è da meno»12. Per Quinzio, infatti, «Proprio perché l’imminenza dell’éscaton è vissuta come certa, l’attesa dell’evento risolutivo che si confida ogni giorno di vedere con i propri occhi diventa ogni giorno più difficile […]. Ogni volta che un credente muore con la sua speranza, la sua morte rimbomba come un masso caduto nell’abisso dell’assenza di Dio, risuona nel vuoto come una smentita della promessa, una smentita della fedeltà di Dio, una smentita di Dio»13. Comunque Quinzio non si rassegnava, come ha ricordato Giuseppe Cantarano: «Eppure, se Dio è stato sconfitto, l’attesa messianica non può convertirsi nell’evento apocalittico. Era quello che Quinzio pensava – ne soffriva – ma non cessava di credere. Credeva e non si rassegnava»14. E infatti Quinzio invitava, nell’attesa nel fra-tempo, alla preghiera, con tutta la sua “precarietà”15 alla conversione, con tutta la sua fatica16. 10 Sergio Quinzio, La fede sepolta, in Rita Fulco, Il tempo della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, Diabasis, Reggio Emilia 2007, p. 133. 11 Dietrich Bonhoeffer, Etica, Queriniana, Brescia 2010, p. 133. 12 Fulco, Il tempo della fine, p. 138. 13 Sergio Quinzio, Un commento alla Bibbia, in Fulco, Il tempo della fine, p. 138. 14 Giuseppe Cantarano, I giorni della vita, Ed. San Raffaele, Milano 2011, p. 216. 15 Cfr. Fulco, Il tempo della fine, p. 136. 16 Cfr. Fulco, Il tempo della fine, p. 134. 33 Di fronte all’angoscia dell’attesa, alla fatica del vivere mi viene alla mente il grido17 di Gesù sulla croce, che un po’ tutti ci accomuna. Gesù urla infatti il salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Non usa l’ebraico, ma la lingua del popolo minuto, l’aramaico. E questo perché egli è uomo fra gli uomini, dà corporeità alla sua divinità e lo fa con l’ultima “disperata” invocazione. Ha scritto Benedetto XVI che quello di Gesù «non è un qualsiasi grido d’abbandono. Gesù recita il grande Salmo dell’Israele sofferente e assume con sé tutto il tormento non solo d’Israele, ma di tutti gli uomini che soffrono in questo mondo per il nascondimento di Dio. Egli porta davanti al cuore di Dio stesso il grido d’angoscia del mondo tormentato dall’assenza di Dio. Si indentifica con l’Israele sofferente, con l’umanità che soffre a causa del «buio di Dio», assume in sé il suo grido, il suo tormento, tutto il suo bisogno di aiuto e con ciò, al contempo, li trasforma»18. Resta la speranza, la fiducia, la voglia, faticosa e piena di “tradimenti”, dell’incontro con il Cristo e con il Regno. Un’ultima suggestione. Nel Vangelo di Luca si narra dei discepoli di Emmaus: essi, pur non riconoscendo il Risorto, lo esortano a restare con loro perché la sera si avvicinava. La versione greca dice: «kai parabiasanto auton» cioè «e forzarono lui»19. Ecco forse una chiave, per quanto ardua, quando incontriamo, per pura Grazia, la voce del Signore, in attesa del suo ritorno: “forziamolo” a restare con noi, e “sforziamoci” di restare con lui, secondo la sua volontà20. 17 Sul gridare nel Vangelo mi sembra interessante il saggio di Matteo Prodi, “Gridare”: un verbo centrale per chi crede nel Vangelo, “Il Margine”, 32 (2012), n. 3, pp. 13-19. 18 J. Ratzinger Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione, Libreria Editrice Vaticana, p. 239. Ha scritto Umberto Curi che: «Proprio nell’abbandono, quando Cristo si sente completamente abbandonato, attraverso il grido egli esprime il momento della massima relazione. Nella croce coincidono il culmine dell’abbandono e il culmine della relazione. Si può allora comprendere perché, nella concezione cristiana, le due dimensioni – quella della vita e quella della morte – vadano letteralmente pensate insieme, non l’una come negazione dell’altra; perché dunque la vita stessa sia vista come qualcosa che ha in sé la morte, ma che alla morte non si arrende». Umberto Curi, Via di qua. Imparare a morire, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 225-226. 19 Vangeli e Atti degli apostoli, a cura di P. Beretta, San Paolo, Milano 2005, pp. 748-749. 20 Scrive Agamben: «Parousia significa in greco semplicemente: presenza (para-ousia, letteralmente: essere accanto; nel presente, l’essere sta, per così dire, accanto a se stesso)». G. Agamben, Il tempo che resta, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 70. 34 I IL MARGINE mensile dell’associazione culturale Oscar A. Romero http://www.ilmargine.it/it/rivista e-mail: [email protected] Direttore: Emanuele Curzel Vicedirettore: Francesco Ghia Amministrazione e diffusione: Luciano Gottardi [email protected] [email protected] Comitato di direzione: Celestina Antonacci, Monica Cianciullo, Giovanni Colombo, Francesco Comina, Alberto Conci, Fulvio De Giorgi, Marcello Farina, Guido Formigoni, Paolo Ghezzi (resp. a norma di legge), Giovanni Kessler, Roberto Lambertini, Paolo Marangon, Fabrizio Mattevi, Michele Nicoletti, Fabio Olivetti, Vincenzo Passerini, Pierangelo Santini, Grazia Villa, Silvano Zucal. Collaboratori: Carlo Ancona, Anita Bertoldi, Dario Betti, Stefano Bombace, Omar Brino, Vereno Brugiatelli, Luca Cristellon, Marco Dalbosco, Mirco Elena, Cornelia Dell’Eva, Michele Dorigatti, Michele Dossi, Claudio Fontanari, Eugen Galasso, Lucia Galvagni, Luigi Giorgi, Massimo Giuliani, Giancarlo Giupponi, Paolo Grigolli, Alberto Guasco, Tommaso La Rocca, Paolo Mantovan, Gino Mazzoli, Milena Mariani, Pierluigi Mele, Silvio Mengotto, Walter Nardon, Rocco Parolini, Lorenzo Perego, Nestore Pirillo, Gabriele Pirini, Emanuele Rossi, Flavio Santini, Angelo Scottini, Giorgio Tonini. Progetto grafico: G. Stefanati Una copia € 2,00 – abb. annuo € 20, + pdf euro 22, solo pdf euro 8, estero € 30, via aerea € 35. Versamenti: c.c.p. 10285385 intestato a: «Il Margine», c.p. 359 - 38122 Trento o c.c.b. Bancoposta (IBAN IT97 D076 0101 8000 0100 4299 887). Estero: BIC: BPPIITRRXXX. Autorizzazione Tribunale di Trento n. 326 del 10.1.1981. Codice fiscale e partita iva 01843950229. Redazione e amministrazione: «Il Margine», c.p. 359, 38122 Trento. Publistampa Arti Grafiche, Pergine Il Margine n. 7/2012 è stato chiuso in tipografia il 12 settembre 2012. «Il Margine» è in vendita a Trento presso: “Artigianelli”, via Santa Croce 35 - “Centro Paolino”, via Perini 153 “La Rivisteria” via San Vigilio 23 - “Benigni” via Belenzani 52 - a Rovereto presso “Libreria Rosmini”. n Macbeth il tema è, semplicemente, l’ambizione. E benché tutte le tragedie di Shakespeare possano essere trasposte in termini di contemporanea vita quotidiana, la storia di Macbeth mi appare fra tutte la più vicina all’esperienza comune. In piccolo e in modo relativamente innocuo, tutti si sono comportati talvolta, e con conseguenze simili, in modo abbastanza analogo a quello di Macbeth. Se volete, Macbeth è la storia di Hitler o di Napoleone. Ma è anche la storia di un qualsiasi impiegato di banca che falsifichi un assegno, di un qualunque funzionario che accetti una tangente, di qualunque essere umano, in realtà, che colga qualche meschina convenienza per sentirsi più importante e avvantaggiarsi un po’ sui propri colleghi. Ciò si fonda sull’illusoria convinzione umana che un’azione possa restare isolata – che si possa dire a se stessi: «Commetterò solo questo crimine per raggiungere il mio scopo, e subito dopo diventerò rispettabile». Ma in pratica, come scopre Macbeth, da un crimine ne nasce un altro, anche se non aumenta la malvagità di chi lo compie. George Orwell (1943) editore della rivista: A S S OC I A Z I ON E OS C A R R O M E R O Presidente: Piergiorgio Cattani [email protected] Vicepresidente: Leonardo Paris Segretaria: Veronica Salvetti Periodico mensile - Anno 32, n. 7, agosto-settembre 2012 - Poste Italiane S.P.A. spediz. in abb. postale - d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - taxe perçue. Redaz. e ammin.: 38122 Trento, cas. post. 359 – Una copia € 2,00 – abb. annuo € 20 http://www.il-margine.it/it/rivista
Scaricare