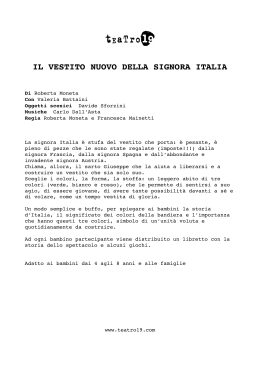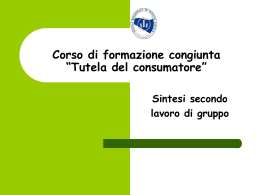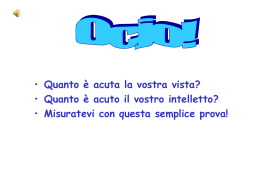Irène Némirovsky
SUITE FRANCESE
Suite française
Nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz,
Irène Némirovsky compose febbrilmente i primi due romanzi di una grande
"sinfonia in cinque movimenti" che doveva narrare, quasi in presa diretta, il
destino di una nazione, la Francia, sotto l'occupazione nazista: Tempesta in
giugno (che racconta la fuga in massa dei parigini alla vigilia dell'arrivo dei
tedeschi) e Dolce (il cui nucleo centrale è la passione, tanto più bruciante
quanto più soffocata, che lega una "sposa di guerra" a un ufficiale tedesco)
La pubblicazione, a sessant'anni di distanza, di Suite francese, il volume che
li riunisce, è stata in Francia un vero evento letterario. Non è difficile capire
perché: con Suite francese ci troviamo di fronte al grande "romanzo
popolare" nella sua accezione più nobile: un possente affresco, folto di
personaggi memorabili, denso di storie avvincenti, dotato di un ritmo
impeccabile, nel quale vediamo intrecciarsi i destini di una moltitudine di
individui travolti dalla Storia. Su tutti - il ricco banchiere e il giovane prete,
la grande cocotte e la contadina innamorata, lo scrittore vanesio e il ragazzo
che vuole andare al fronte e scopre invece le gioie della carne fra le braccia
generose di una donna di facili costumi: Irène Némirovsky posa uno
sguardo che è insieme lucidissimo e visionario, mostrandoci uno spettro
variegato di possibilità dell'uomo: il cinismo, la meschinità, la vigliaccheria,
l'arroganza e la vanità, ma anche l'eroismo, l'amore e la pietà. "La cosa più
importante, qui, e la più interessante" scriveva la Némirovsky due giorni
prima di essere arrestata "è che gli eventi storici, rivoluzionari, ecc. sono
appena sfiorati, mentre viene investigata la vita quotidiana, affettiva, e
soprattutto la commedia che questa mette in scena"
"Qua e là, davanti ai palazzi di boulevard Delessert si vedeva un gruppo
gesticolante di donne, vecchi e bambini che si sforzavano, dapprima con
calma, poi febbrilmente, quindi con un'eccitazione morbosa e folle, di far
entrare familiari e bagagli in una Renault, in una berlina, in una spider.
Nessuna luce alle finestre. Cominciavano a spuntare le stelle - stelle di
primavera dal riflesso argentato. Parigi aveva il suo profumo più dolce,
quello degli ippocastani in fiore e delle essenze volatili miste a granelli di
polvere che scricchiolano sotto i denti come grani di pepe. Nell'ombra, il
pericolo cresceva. Nell'aria, nel silenzio, si respirava l'angoscia. Neanche le
persone più fredde, quelle generalmente più tranquille, potevano evitare
quella confusa e mortale apprensione.
Ciascuno guardava la sua casa con una stretta al cuore e pensava:
"Domani sarà distrutta, domani non avrò più niente. Non abbiamo fatto del
male a nessuno. Perché?". E contemporaneamente si sentiva sopraffatto da
un'ondata di indifferenza: "Che importa! Sono solo pietre, legno, materia
inerte! L'essenziale è salvare la pelle!""
Composto fra il 1941 e il 1942, Suite francese è apparso nel 2004 e ha
subito suscitato un vastissimo consenso, tanto che, infrangendo regole
inveterate, i giurati del Prix Renaudot gli hanno assegnato il prestigioso
riconoscimento a titolo postumo. Di Irène Némirovsky (nata a Kiev nel
1903, rifugiatasi in Francia con la famiglia allo scoppio della rivoluzione
d'Ottobre, e morta ad Auschwitz nel 1942) Adelphi ha pubblicato Il ballo
(2005) e ha in preparazione altri romanzi.
INDICE
Temporale di giugno
Dolce
Appendice
I. Appunti di Irène Némirovsky
Il. Corrispondenza 1936-1945
Postfazione di Myriam Anassimov
"Sulle tracce di mia madre e di mio padre, per mia sorella Elisabeth
Gille, per i miei figli e i miei nipoti, questa Memoria da trasmettere, e per
tutti quelli che hanno conosciuto e ancora oggi conoscono il dramma
dell'intolleranza"
DENISE EPSTEIN
TEMPORALE DI GIUGNO
CAPITOLO 1.
LA GUERRA
Sarà dura, pensavano i parigini. Aria di primavera. Una notte di guerra,
l'allarme. Ma la notte svanisce, la guerra è lontana. Quelli che non
dormivano, i malati nei loro letti, le madri con un figlio al fronte, le donne
innamorate con gli occhi sciupati dal pianto, sentivano il primo soffio della
sirena, ancora solo un ansito profondo simile al sospiro che esce da un petto
oppresso. In pochi istanti il cielo tutto si sarebbe riempito di clamori. Che
venivano da lontano, dall'estrema linea dell'orizzonte - senza fretta si
sarebbe detto. Quelli che dormivano sognavano il mare che spinge davanti a
sé i ciottoli e le onde, la tempesta di marzo che scuote la foresta, una
mandria di buoi che galoppano pesanti facendo tremare il suolo con gli
zoccoli; ma il sogno finiva e socchiudendo appena gli occhi gli uomini
mormoravano: "É l'allarme?"
Le donne, più ansiose, più pronte, erano già in piedi. Alcune, dopo aver
chiuso imposte e finestre, tornavano a letto. Il giorno precedente, lunedì 3
giugno, per la prima volta dall'inizio della guerra, Parigi era stata
bombardata; ma la popolazione non si era fatta prendere dal panico, benché
le notizie fossero tutt'altro che buone. Nessuno riusciva a crederci. Così
come nessuno avrebbe creduto all'annuncio di una vittoria. "Chi ci capisce
qualcosa è bravo" diceva la gente. Le madri vestivano i bambini facendo
luce con una pila. Poi alzavano di peso i piccoli corpi inerti e tiepidi:
"Vieni, non aver paura, non piangere" E l'allarme. Si spegnevano tutte le
luci, ma sotto quel cielo di giugno dorato e trasparente ogni casa, ogni
strada era visibile. Mentre la Senna pareva concentrare in sé ogni sparso
chiarore per poi rifletterlo, centuplicato, come uno specchio sfaccettato: le
finestre non oscurate a sufficienza, i tetti che luccicavano nell'ombra
leggera, le guarnizioni di ferro delle porte su cui ogni sporgenza brillava
debolmente, qualche semaforo rosso che, chissà perché, durava più a lungo
degli altri - la Senna li attirava, li catturava e li faceva danzare nei suoi
flutti. Dall'alto, doveva sembrare un fiume di latte. Guida gli aerei nemici,
pensavano alcuni. Altri affermavano che era impossibile, In realtà nessuno
sapeva niente. "Me ne resto a letto," mormoravano voci assonnate "non ho
paura" "Basta una volta e siamo fritti" rispondevano voci più sagge.
Nei palazzi nuovi, attraverso le vetrate che proteggevano le scale di
servizio, si vedevano scendere una, due, tre fiammelle: gli inquilini del sesto
piano fuggivano da quelle altezze puntando davanti a sé le pile tenute
accese in barba ai regolamenti. "Preferisco non rompermi il collo sulle
scale, vieni, Emile?" Tutti, istintivamente, abbassavano la voce come se lo
spazio si fosse d'un tratto popolato di sguardi e di orecchie nemici. Si
sentivano sbattere le porte, che venivano richiuse una dopo l'altra. Nei
quartieri popolari metropolitane e rifugi - nei quali stagnava ormai un gran
lezzo di sporcizia - erano sempre affollati, mentre i ricchi si limitavano a
fermarsi nelle portinerie dei loro palazzi tendendo l'orecchio agli scoppi e
alle detonazioni che avrebbero annunciato la caduta delle bombe, attenti,
tesi come animali trepidanti acquattati nei boschi quando scende la notte
della caccia. Non è che i poveri fossero più impauriti dei ricchi o più
attaccati alla vita, ma avevano, più di loro, la tendenza a vivere in gruppo,
avevano bisogno gli uni degli altri e di sostenersi a vicenda, di piangere o di
ridere insieme. Stava per spuntare il giorno; un riflesso pervinca e argento
sfiorava le strade, i parapetti dei lungosenna, le torri di Notre-Dame. Sacchi
di sabbia coprivano fino a metà altezza gli edifici più importanti,
nascondevano le danzatrici di Carpeaux sulla facciata dell'Opera,
spegnevano il grido della Marsigliese sull'Arco di Trionfo.
In lontananza, echeggiavano colpi di cannone che via via si facevano più
vicini, e i vetri tremavano, in risposta. Bambini nascevano dentro camere
afose in cui le fessure delle finestre erano state sigillate per non lasciar
trapelare la luce, e i loro pianti facevano dimenticare alle donne il fragore
delle sirene e la guerra. Alle orecchie dei morenti le cannonate sembravano
deboli e insignificanti, un rumore in più nel sinistro e vago brusio che
accoglie l'agonizzante come un'onda. I piccoli, appiccicati al fianco caldo
della madre, dormivano placidamente, le boccucce aperte in uno schiocco
leggero, simile a quello dell'agnellino che succhia il latte. Abbandonati
durante l'allarme, carrettini di frutta e verdura rimanevano in strada con il
loro carico di fiori freschi.
Il sole, ancora tutto rosso, saliva in un cielo senza nuvole. Partì una
cannonata così vicina a Parigi che tutti gli uccelli volarono via dalla
sommità dei monumenti. Più in alto si libravano grandi uccelli neri, di solito
invisibili, spiegavano sotto il sole le ali di un rosa argenteo, poi venivano i
bei piccioni grassi che turbavano e le rondini, i passeri che saltellavano
tranquillamente nelle strade deserte. Su ogni pioppo dei lungosenna c'era un
nugolo di uccelletti scuri che cantavano frenetici. Nelle profondità dei rifugi
arrivò infine un segnale remoto, attutito dalla distanza, sorta di fanfara a tre
toni: il cessato allarme.
CAPITOLO 2.
I Pericand avevano ascoltato alla radio il bollettino della sera in un
silenzio sgomento, ma nessuno aveva commentato le notizie. Erano dei
benpensanti: le loro tradizioni, la forma mentis, un certo retaggio borghese e
cattolico, nonché i legami con la Chiesa (il figlio maggiore, Philippe
Pericand, era stato ordinato sacerdote), tutto li portava a considerare con
diffidenza il governo della Repubblica. Al tempo stesso, la posizione del
signor Pericand, soprintendente di un grande museo nazionale, li rendeva
partecipi di un regime che con i suoi servitori era prodigo di onori e
benefici.
Con grande cautela, un gatto teneva fra i denti aguzzi un brandello di
pesce pieno di spine: ingoiarlo gli faceva paura, sputarlo gli sarebbe
dispiaciuto un po’.
Tutto considerato, Charlotte Pericand riteneva che solo la mente maschile
potesse giudicare con serenità avvenimenti così strani e gravi. E al momento
né suo marito né il figlio maggiore si trovavano lì: il primo cenava in casa
di amici, il secondo non era a Parigi. La signora Pericand dirigeva con polso
fermo tutto ciò che atteneva alla vita quotidiana - dal governo della casa
all'educazione dei figli o alla carriera del marito - e non aveva bisogno di
chiedere il parere di nessuno. Ma questo era un ambito diverso, bisognava
che una voce autorizzata le dicesse preventivamente che cosa avrebbe
dovuto pensare. Una volta messa sulla buona strada, procedeva poi a tutto
vapore e non conosceva ostacoli. Se le si dimostrava, prove alla mano, che
la sua opinione era errata, rispondeva con un sorriso freddo e altezzoso:
"Me l'ha detto mio padre", oppure: "Mio marito è ben informato" E con la
mano guantata tracciava nell'aria un piccolo gesto perentorio.
La posizione del marito la lusingava (lei avrebbe preferito una vita più
casalinga, ma secondo l'esempio del nostro Divino Salvatore ciascuno di
noi, quaggiù, deve portare la sua croce!) Era rientrata in casa - un breve
intervallo tra una visita e l'altra - per controllare i compiti dei bambini, i
biberon del neonato, i lavori dei domestici, e non aveva ancora trovato il
tempo di togliersi tutta la bardatura. Nel ricordo dei figli Pericand, la madre
figurava sempre pronta per uscire di casa, cappello in testa e guanti bianchi
debitamente infilati. (Parsimoniosa com'era, i suoi guanti, spesso rinfrescati,
avevano un leggero odore di benzina, prova incontestabile del loro
passaggio in tintoria)
Anche quella sera era appena rientrata e stava in piedi nel salotto, davanti
alla radio. Tutta vestita di nero, portava un cappellino all'ultima moda, una
cosina deliziosa guarnita con tre fiori e un pompon di seta calcata sulla
fronte. Il suo volto era pallido e angosciato, e accusava più che mai i segni
dell'età e della stanchezza. La signora Pericand aveva quarantasette anni e
cinque figli. Era una donna alla quale di sicuro Dio aveva destinato una
capigliatura rossa. Lo provavano la pelle molto sottile, sciupata dagli anni, il
naso, forte e importante, spruzzato di efelidi, e gli occhi verdi che
lanciavano dardi penetranti, da gatto. Ma, all'ultimo minuto, la Provvidenza
doveva aver esitato o considerato che una capigliatura troppo accesa non si
sarebbe accordata né all'irreprensibile moralità della signora Pericand né al
suo rango, e l'aveva dotata di capelli di un castano spento che dopo la
nascita dell'ultimo figlio cadevano copiosamente. Il signor Pericand era un
tipo rigoroso: i suoi scrupoli religiosi gli impedivano di piegarsi a un buon
numero di desideri e, preoccupato com'era della propria reputazione, si
teneva alla larga da luoghi di malaffare. Perciò il più piccolo dei Pericand
aveva solo un anno, e fra il reverendo Philippe e l'ultimo nato si
susseguivano tre figli, tutti vivi, che la signora Pericand chiamava
pudicamente "tre incidenti" - senza contare il bambino portato quasi fino al
termine della gravidanza. Tre incidenti che l'avevano condotta tre volte
sull'orlo della tomba.
Il salotto, dove in quel momento echeggiava la voce della radio, era un
ampio locale di proporzioni armoniose, con quattro finestre che davano su
boulevard Delessert. Era arredato all'antica, con grandi poltrone e divani
giallo oro trapuntati a losanghe. Vicino al balcone c'era la sedia a rotelle del
vecchio signor Pericand, ora invalido, che l'età molto avanzata a volte
faceva tornare bambino; riacquistava piena lucidità solo quando si trattava
del suo ingente patrimonio (era un Pericand-Maltete, erede dei Maltête di
Lione) Ma la guerra e le sue vicissitudini non lo toccavano più; vi prestava
un orecchio distratto, scuotendo ritmicamente la bella barba d'argento.
Dietro la mater familias i figli erano disposti a semicerchio, compreso il più
piccolo in braccio alla bambinaia. Questa, madre di tre figli al fronte, aveva
portato lì il piccolino per la buonanotte alla famiglia e approfittava della
temporanea ammissione in salotto per ascoltare con angosciata
concentrazione le parole dello speaker.
Dietro la porta socchiusa la signora Pericand avvertì la presenza degli altri
domestici: la cameriera Madeleine, spinta dall'apprensione, si portò
addirittura fin sulla soglia, e alla signora Pericand questa infrazione alle
usanze parve un brutto segno: è così che, durante un naufragio, tutte le
classi sociali si ritrovano mescolate sul ponte. Ma il popolo mancava di
autocontrollo. "Come si lasciano andare" pensò con aria di biasimo. La
signora Pericand apparteneva a quel tipo di borghesi che hanno fiducia nel
popolo. "Non sono cattivi, basta saperli prendere" diceva con il tono
indulgente e un po’ sconsolato che avrebbe usato per parlare di una bestia in
gabbia. Si vantava di riuscire a tenere molto a lungo presso di sé i domestici
e si faceva un dovere di curarli personalmente quando si ammalavano. Una
volta Madeleine aveva avuto la tonsillite: le preparava i gargarismi con le
sue mani. Poiché durante la giornata non trovava un momento libero, lo
faceva alla sera, dopo il teatro. Madeleine, svegliata di soprassalto,
testimoniava la sua riconoscenza solo a posteriori e per di più in termini
alquanto freddi, pensava la signora Pericand. Ecco come sono quelli del
popolo, mai contenti - e più ci si dà da fare per loro, più si mostrano volubili
e ingrati. Ma la ricompensa la signora Pericand se l'aspettava solo dal Cielo.
Si voltò verso il vestibolo in ombra e disse con magnanimità: "Potete
ascoltare il notiziario, se volete"
"Grazie, signora" mormorarono alcune voci rispettose, e i domestici
entrarono circospetti nel salotto camminando in punta di piedi.
Madeleine, Marie, Auguste, il cameriere, e da ultima Maria, la cuoca, a
disagio per via delle mani che sapevano di pesce. Il notiziario, del resto, era
terminato. Ora seguivano i commenti: la situazione era "seria, certo, ma non
allarmante", così assicurava lo speaker. Parlava con una voce così rotonda,
così calma e rassicurante (ma che assumeva un tono squillante allorché
pronunciava parole come "Francia", "patria", "esercito") da infondere
ottimismo nei cuori di chi lo ascoltava. Aveva un modo tutto suo di dar
lettura del comunicato secondo il quale "il nemico continua a martellare
accanitamente le nostre posizioni scontrandosi con la vigorosa resistenza
delle nostre truppe" Leggeva la prima parte della frase con tono leggero,
ironico e sprezzante, quasi volesse dire: "Perlomeno è quello che cercano di
farci credere" In compenso sottolineava con forza ogni sillaba della seconda
parte, scandendo l'aggettivo "vigorosa" e le parole "le nostre truppe" con
tanta sicurezza che la gente non poteva fare a meno di pensare: "Non è
davvero il caso di preoccuparci più di tanto!"
La signora Pericand colse gli sguardi interrogativi e speranzosi fissi su di
lei e dichiarò con fermezza:
"Non mi sembra che la situazione sia poi così brutta!"
Non ne era affatto convinta, ma riteneva suo dovere risollevare il morale
delle persone che le stavano attorno.
Maria e Madeleine sospirarono.
"Lo crede davvero, signora?"
Solo Hubert, il secondogenito dei Pericand, un diciottenne paffuto e
roseo, sembrava in preda a disperazione e sgomento. Si tamponava
nervosamente il collo con il fazzoletto appallottolato ed esclamava con voce
acuta e a tratti rauca:
"Non è possibile! Guarda a che punto siamo arrivati! Ma insomma,
mamma, che cosa aspettano ad arruolare tutti? Dai sedici ai sessant'anni,
tutti gli uomini e subito! Questo dovrebbero fare, non credi, mamma?"
Corse fino allo studio, tornò con una grande carta geografica e la spiegò
sul tavolo, misurando febbrilmente le distanze fra vari punti.
"Siamo perduti, ti dico, perduti a meno che...".
La speranza tornava a sorridergli.
"Io l'ho capito quello che si deve fare" annunciò quindi con un largo
sorriso gioioso che gli scoprì i denti bianchi. "É molto chiaro: li lasceremo
venire avanti, sempre più avanti, e noi li aspetteremo lì, poi lì, capisci,
mamma! O anche...".
"Sì, sì" disse sua madre. "Su, va a lavarti le mani e sistemati quel ciuffo
che ti cade sugli occhi. Guarda cosa sembri...".
Furente, Hubert ripiegò la sua mappa. Solo Philippe lo prendeva sul serio,
solo Philippe gli parlava da pari a pari. "Famiglie, vi odio!" declamò tra sé
e, per vendicarsi, uscendo dal salotto sparpagliò qua e là con un gran calcio
i giocattoli del fratellino Bernard, che si mise a urlare. "Questo gli insegnerà
cos'è la vita" pensò Hubert. La bambinaia si affrettò a portar fuori Bernard e
Jacqueline, mentre il piccolo Emmanuel già dormiva sulla sua spalla.
Camminava a grandi passi, tenendo per mano Bernard e piangendo i suoi tre
figli che immaginava già morti. "Solo miseria e disgrazia, miseria e
disgrazia!" ripeteva sottovoce scuotendo la testa grigia. Aprì i rubinetti della
vasca, mise a scaldare gli accappatoi dei bambini e intanto continuava a
borbottare parole che le sembravano rappresentare non solo la situazione
politica ma anche, e soprattutto, la sua stessa esistenza: i lavori della terra in
gioventù, la vedovanza, il brutto carattere delle nuore e sedici anni di vita in
casa d'altri.
Auguste, il cameriere, ritornò in cucina a passi felpati. Sul suo volto
solenne e vacuo aleggiava un'espressione di grande disprezzo rivolta a
molte cose. La signora Pericand riguadagnò le sue stanze. Dedita a
un'attività frenetica, essa occupava il quarto d'ora libero fra il bagno dei
bambini e la cena facendo ripassare le lezioni a Jacqueline e a Bernard. Si
levarono voci tenere: "La Terra è una sfera che non poggia su niente...". In
salotto restarono solo il vecchio Pericand e il gatto Albert. Era una giornata
splendida. La luce della sera rischiarava dolcemente gli ippocastani
rigogliosi; Albert, un gatto grigio, non di razza, proprietà esclusiva dei
bambini, sembrava in preda a una gioiosa frenesia e si rotolava sul tappeto.
Poi balzò sul caminetto e da lì sopra una mensola, dove mordicchiò il bordo
di una peonia nel grande vaso blu notte decorato elegantemente con una
bocca di leone scolpita nel bronzo. Infine si appollaiò sulla poltrona del
vecchio e gli miagolò nell'orecchio. Pericand allungò verso di lui la sua
mano perennemente fredda, violacea e tremante. Il gatto si spaventò e
scappò via. La cena stava per essere servita. Apparve Auguste, che spinse in
sala da pranzo la sedia a rotelle dell'invalido. La famiglia era sul punto di
mettersi a tavola quando la padrona di casa si immobilizzò di colpo,
tenendo a mezz'aria il cucchiaio con cui stava somministrando lo sciroppo
ricostituente a Jacqueline.
"C'è vostro padre, bambini" disse udendo il rumore della chiave che
veniva girata nella serratura.
Era il signor Pericand, infatti: un ometto grassoccio, dall'aspetto bonario e
un po’ goffo. Il suo viso, abitualmente roseo, riposato e ben pasciuto, era
pallidissimo e sembrava non già spaventato o preoccupato bensì
estremamente stupito. Aveva la stessa espressione che si coglie in genere
sul volto di chi trova la morte in pochi secondi, in un incidente, senza aver
avuto il tempo di soffrire o di avere paura, chi leggeva un libro, o guardava
dal finestrino dell'auto, o pensava agli affari suoi, o stava andando al vagone
ristorante, e si trova di colpo all'inferno.
La signora Pericand si sollevò leggermente dalla sedia.
"Adrien?" esclamò in tono angosciato.
"Niente, niente" mormorò lui in fretta, indicando con lo sguardo i
bambini, suo padre e i domestici.
La signora Pericand capì. Fece segno di continuare a servire. Si sforzava
di mandar giù il cibo che aveva davanti, ma ogni boccone le sembrava duro
e insipido come una pietra e le si fermava in gola. Tuttavia continuava a
ripetere le parole che da trent'anni costituivano il rituale di tutte le sue cene.
"Non bere prima di aver cominciato a mangiare la minestra. Tieni bene il
coltello, piccolo mio...".
Intanto tagliava a pezzettini il filetto di sogliola del vecchio Pericand. A
quest'ultimo si riservavano cibi molto leggeri ed elaborati, e la signora
Pericand lo serviva sempre personalmente. Gli versava l'acqua, gli
imburrava il pane, gli annodava il tovagliolo intorno al collo perché, quando
vedeva comparire qualcosa che gli piaceva, il signor Pericand aveva
l'abitudine di sbavare. "Penso" diceva la signora agli amici "che a questi
poveri vecchi invalidi non piaccia affatto esser toccati dalle mani dei
domestici"
"Dobbiamo affrettarci a dimostrare tutto il nostro affetto al nonno,
bambini" tornò ancora una volta a esortare i figli, guardando il vegliardo
con una tenerezza raccapricciante.
Negli anni della maturità il signor Pericand aveva creato alcune opere pie,
delle quali una soprattutto gli stava a cuore: quella dei Piccoli Redenti del
XVI arrondissement, la mirabile istituzione che perseguiva lo scopo di
emendare minorenni traviati. Si dava per scontato che alla sua morte
avrebbe lasciato una certa somma a questa organizzazione, ma il vecchio
aveva un modo alquanto irritante di non precisarne mai l'ammontare.
Quando una pietanza non gli era piaciuta o i bambini facevano troppo
chiasso, usciva all'improvviso dal suo torpore e diceva con voce flebile ma
chiara:
"Lascerò cinque milioni ai Piccoli Redenti"
Seguiva un penoso silenzio.
In compenso, quando aveva mangiato di gusto e dormito bene nella sua
sedia a rotelle davanti alla finestra, al sole, levava verso la nuora i suoi
occhi pallidi, vacui e velati come quelli dei neonati o dei cuccioli.
Charlotte aveva molto tatto. Non esclamava, come avrebbe fatto un'altra:
"Saggia decisione, papà!", ma rispondeva con voce dolce: "Mio Dio, papà,
avete tutto il tempo per pensarci!"
Il patrimonio dei Pericand era ingente, e davvero non sarebbe stato giusto
accusarli di concupire l'eredità del vecchio. Non tenevano al denaro, no, era
il denaro che, in qualche modo, teneva a loro! Potevano contare su diversi
beni, fra l'altro sui "milioni dei Maltête di Lione" che non avrebbero mai
speso, che avrebbero tenuto da parte per i figli dei figli. Per tornare
all'istituzione dei Piccoli Redenti, i Pericand vi si interessavano al punto che
due volte all'anno la signora organizzava per quegli infelici un concerto di
musica classica. In tali occasioni lei suonava Tarpa, e sosteneva che durante
certi passaggi le arrivava, dall'ombra della sala, l'eco di qualche singhiozzo.
Il vecchio Pericand seguiva con sguardo attento le mani della nuora. Era
così distratta e turbata che dimenticò la salsa. La barba bianca del vegliardo
si agitò in modo allarmante e la signora Pericand, riacquistato il senso della
realtà, si affrettò a versare sulle carni eburnee del pesce il burro fuso
cosparso di prezzemolo tritato; ma solo quando ebbe aggiunto sul bordo del
piatto una fettina di limone il vecchio ritrovò la sua serenità.
Chinandosi verso il fratello, Hubert sussurrò:
"Le cose vanno male, vero?"
"Sì" confermò l'altro con il gesto e lo sguardo.
Hubert lasciò cadere sulle ginocchia le mani tremanti. La sua fantasia gli
prospettava drammatici scenari di battaglie e di vittorie. Era uno scout; lui e
i compagni avrebbero formato una brigata di volontari, di franchi tiratori
che avrebbero difeso il paese fino all'ultimo sangue. In un secondo
attraversò con la mente il tempo e lo spazio. Lui e i compagni: un pugno di
uomini uniti nel segno dell'onore e della fede. Si sarebbero battuti, si
sarebbero battuti di notte; avrebbero salvato Parigi bombardata, incendiata.
Che vita eccitante, meravigliosa! Il cuore gli balzò in petto. Eppure la
guerra era una cosa oscena e selvaggia. Hubert era inebriato da quelle
visioni. Strinse con tanta violenza il coltello che il pezzetto di roast beef
sotto la lama schizzò sul pavimento.
"Imbranato" sussurrò Bernard, suo vicino di tavola, facendogli le corna
sotto il tavolo.
Lui e Jacqueline erano due biondini di otto e di nove anni, smilzi, con il
nasino all'insù. Furono spediti a letto subito dopo il dessert e il vecchio
Pericand si addormentò al solito posto, vicino alla finestra aperta. La tenera
luce del giorno indugiava, non voleva morire. Ogni suo fremito era più lieve
e più incantevole del precedente, quasi un addio alla terra pieno di amore e
di rimpianto. Seduto sul davanzale della finestra, il gatto guardava con aria
nostalgica il verde cristallo dell'orizzonte. Il signor Pericand misurava a
grandi passi la stanza.
"Dopodomani, domani forse, i tedeschi saranno alle porte di Parigi. Pare
che l'Alto Comando sia deciso a combattere davanti, dentro e dietro Parigi.
Non si sa ancora niente di preciso, per fortuna, perché da qui a poche ore le
stazioni e le strade saranno prese d'assalto. Dovete partire domattina di
buonora, Charlotte, e andare da vostra madre in Borgogna. Quanto a me,"
continuò il signor Pericand, non senza una certa solennità "dividerò la sorte
dei tesori che mi sono stati affidati"
"Credevo che avessero sgombrato il museo già in settembre" disse
Hubert.
"Sì, ma il rifugio provvisorio scelto in Bretagna non andava bene, si è
rivelato umido come una cantina. Non ci capisco niente: avevamo
organizzato un comitato per la salvaguardia dei tesori nazionali diviso in tre
gruppi e sette sottogruppi, ciascuno dei quali doveva designare una
commissione di esperti incaricata del dislocamento delle opere artistiche
durante la guerra, ed ecco che il mese scorso un guardiano del museo
provvisorio ci segnala la comparsa di macchie sospette sui quadri. Proprio
così: un mirabile ritratto di Mignard aveva le mani corrose da una specie di
lebbra verde. Abbiamo subito fatto tornare a Parigi quelle casse preziose, e
adesso siamo in attesa di un ordine, che non può tardare, per spedirle più
lontano"
"Ma allora noi come viaggeremo? Soli?"
"Partirete tranquillamente domattina insieme ai bambini, con le due
macchine e tutti i mobili e i bagagli che potrete portare via, perché non
dobbiamo nasconderci che entro la fine della settimana Parigi può essere
distrutta, incendiata e per di più saccheggiata"
"Siete straordinario," esclamò Charlotte "parlate di tutto questo con una
calma!"
Il signor Pericand volse verso la moglie un viso che andava riprendendo a
poco a poco il suo colorito roseo, ma opaco come quello dei maiali appena
ammazzati.
"Il fatto è che non posso crederci" spiegò con dolcezza. "Parlo con voi, vi
ascolto, decidiamo di abbandonare la nostra casa, di metterci in fuga sulle
strade, ma non posso credere che questo sia reale, capite? Andate a
prepararvi, Charlotte, e fate in modo che tutto sia pronto domattina, potrete
arrivare da vostra madre per cena. Io vi raggiungerò appena possibile"
La signora Pericand aveva assunto l'aria tra l'acido e il rassegnato che
sfoggiava, insieme al camice da infermiera, quando i figli si ammalavano;
in genere facevano in modo di ammalarsi tutti nello stesso momento
seppure di malattie diverse. In quei giorni la signora Pericand usciva dalla
camera dei bambini brandendo il termometro come la palma del martirio e
tutto, in lei, era un solo grido: "Mio caro e buon Gesù, tu saprai chi
ricompensare nel giorno del Giudizio!" Ma si limitò a domandare:
"E Philippe?"
"Philippe non può allontanarsi da Parigi"
La signora Pericand uscì a testa alta. Non si sarebbe lasciata piegare dalle
difficoltà. Avrebbe fatto in modo che all'indomani la famiglia fosse pronta
per la partenza: il vecchio invalido, i quattro bambini, i domestici, il gatto,
l'argenteria, i pezzi più preziosi del servizio da tavola, le pellicce, le cose dei
bambini, le provviste di cibo e, non si sa mai, una scorta di medicinali.
Rabbrividì.
In salotto, Hubert supplicava il padre:
"Permettetemi di non andare. Resterò qui con Philippe. E... non burlatevi
di me, ma non credete che se andassi a cercare i miei compagni, giovani,
forti, pronti a tutto, potremmo formare una brigata di volontari...
Potremmo...".
Il signor Pericand lo guardò e disse solo: "Mio povero ragazzo!"
"É finita? Abbiamo perso la guerra?" balbettò Hubert. "É... è così?".
All'improvviso sentì con orrore che stava scoppiando in singhiozzi.
Piangeva come un bambino, come avrebbe fatto Bernard, la grande bocca
piegata in una smorfia, un torrente di lacrime che gli bagnava le guance.
Scendeva la notte, dolce e serena. Nell'aria già scura passò una rondine,
quasi rasente il balcone. Il gatto emise un piccolo verso di bramosia.
CAPITOLO 3.
Lo scrittore Gabriel Corte stava lavorando sulla sua terrazza, tra il bosco
frusciante e cupo e il tramonto verde oro che si spegneva sulla Senna. Che
calma tutt'intorno! Gli stavano accanto, creature familiari ben addestrate,
grandi cani bianchi che non dormivano ma giacevano immobili, il naso sulle
piastrelle fresche, gli occhi socchiusi. L'amante, ai suoi piedi, raccoglieva in
silenzio le pagine che lui lasciava cadere I domestici e la segretaria si
muovevano invisibili dietro i vetri scintillanti, nascosti da qualche parte
all'interno della casa, tra le quinte di una vita che lui voleva brillante,
fastosa e disciplinata come un balletto. Aveva cinquant'anni e sceglieva i
suoi ruoli secondo i giorni, il Signore dei Cieli o un povero autore gravato
da un'improba fatica. Sul tavolo da lavoro aveva fatto incidere: "Ci vorrebbe
la tua forza, o Sisifo, per sostenere un simile peso" I colleghi lo invidiavano
perché era ricco. Lui stesso raccontava con acredine che alla sua prima
candidatura all'Academie française uno degli elettori, sollecitato a votare
per lui, aveva risposto con una certa indignazione: "Ha tre linee
telefoniche!"
Era bello, aveva modi languidi e crudeli come quelli di un gatto, mani
morbide, espressive, e un volto da Cesare un po’ imbolsito. Solo Florence,
l'amante ufficiale, l'unica autorizzata a dividere il suo letto per tutta la notte
(le altre non dormivano mai con lui), avrebbe potuto dire sotto quante
maschere poteva nascondersi il vecchio seduttore con quelle borse livide
sotto gli occhi e le sopracciglia femminili, appuntite, troppo sottili.
Quella sera lavorava, come al solito, mezzo nudo. La casa di Saint-Cloud
era costruita in modo che nessuno sguardo indiscreto salisse fino alla
terrazza - grande, bellissima, adorna di cinerarie blu. Il blu era il colore
preferito da Gabriel Corte. Poteva scrivere solo se aveva accanto a sé una
piccola coppa di lapislazzuli di un azzurro intenso. A volte la contemplava e
la accarezzava quasi fosse un'amante. E del resto, quello che preferiva in
Florence, glielo aveva detto spesso, erano i suoi occhi dall'azzurro deciso,
che gli davano la stessa sensazione di freschezza della coppa. "I tuoi occhi
mi dissetano" sussurrava. Lei aveva un mento morbido, leggermente
appesantito, una voce da contralto ancora bella e qualcosa di bovino nello
sguardo, come diceva Gabriel Corte agli amici. É una cosa che mi piace.
Una donna deve assomigliare a una giovenca, dolce, pacifica e generosa,
con un corpo bianco come panna e la pelle delle vecchie attrici, avete
presente?, resa più elastica dai massaggi, impastata di ciprie e cosmetici.
Corte stirò le dita allungandole in aria e le fece schioccare come nacchere.
Florence gli porse un limone e lui vi affondò i denti, poi divorò un'arancia e
qualche fragola gelata; la quantità di frutta che riusciva a consumare aveva
del prodigioso. Lei lo guardò, quasi inginocchiata su un pouf di velluto,
nella posa adorante che gli piaceva (e del resto non ne avrebbe immaginata
un'altra!) Lui si sentiva stanco, ma di quella stanchezza buona che viene
dopo un lavoro ben riuscito, una stanchezza migliore di quella che segue
l'amore, come a volte dichiarava. Osservò l'amante con aria benevola.
"Be, credo proprio che funzioni. Vedi, il centro" e disegnò in aria un
triangolo indicandone il vertice "l'ho già superato"
Lei sapeva che cosa voleva dire. Sempre, a metà del romanzo,
l'ispirazione gli veniva meno. Corte, allora, penava come un cavallo che non
riesce a liberare dal fango il carro impantanato. La donna giunse le mani in
un grazioso gesto di ammirato stupore.
"Di già! Complimenti, tesoro. Adesso tutto filerà liscio, ne sono certa"
"Dio ti ascolti! Ma Lucienne mi dà qualche problema" mormorò lui con
aria pensosa.
"Lucienne?"
L'uomo la squadrò, e il suo era uno sguardo duro, freddo e sgradevole.
Quando lo vedeva di buon umore, Florence diceva: "Hai di nuovo i tuoi
occhi da basilisco", e lui ne rideva, lusingato, ma nel fuoco della creazione
non gli andava di scherzare.
Florence non si ricordava assolutamente del personaggio di Lucienne. E
mentì.
"Ma certo! Chissà dove avevo la testa!"
"Me lo domando anch'io" disse lui in tono amaro e offeso.
Florence aveva un'aria così triste e così umile che Gabriel ne ebbe pietà. E
si rabbonì.
"Te l'ho sempre detto, non dai abbastanza peso alle comparse. Un
romanzo deve somigliare a un viale pieno di sconosciuti, in cui passano solo
due o tre creature che conosciamo a fondo, non di più. Prendi certi scrittori,
come Proust: hanno saputo utilizzare le comparse. Se ne servono per
umiliare, per sminuire i personaggi principali. Niente di più salutare, in un
romanzo, di questa lezione di umiltà inflitta ai protagonisti. Pensa, in Guerra
e pace, alle contadinelle che attraversano la strada davanti alla carrozza del
principe André ridendo e la prima immagine che ne hanno è quella di lui
che parla con loro, alle loro orecchie; nello stesso tempo la visione del
lettore si allarga, non c'è più un singolo volto, una sola anima. Si scopre la
molteplicità delle forme. Aspetta, ti leggo il passo, è notevole. Accendi la
luce" le disse, giacché era scesa la notte.
"Aerei..." rispose Florence indicando il cielo.
Lui grugnì:
"Quand'è che mi lasceranno in pace?"
Odiava la guerra, che minacciava ben più della sua vita o del suo
benessere: distruggeva in ogni istante l'universo della creazione
romanzesca, l'unico in cui si sentisse felice, simile a uno squillo di tromba
discordante e terribile che facesse crollare le fragili muraglie di cristallo
erette con tanta fatica tra lui e il mondo esterno.
"Dio!" sospirò. "Che noia, che incubo!".
Ma era tornato con i piedi per terra.
"Hai i giornali?" domandò.
Lei glieli portò in silenzio. Lasciarono la terrazza. Gabriel diede una
scorsa alle pagine, scuro in volto.
"Insomma, niente di nuovo" disse.
Non voleva vedere, rimuoveva la realtà col gesto spaventato e infastidito
di chi dorme e viene svegliato nel bel mezzo di un sogno. Si fece perfino
schermo agli occhi con la mano, quasi a proteggersi da una luce troppo
forte.
Florence si avvicinò alla radio. Lui la fermò.
"No, no, lascia stare"
"Ma, Gabriel...".
"Non voglio sentire niente, ti dico" sbottò, pallido di rabbia. "Ci sarà
tempo domani. Le brutte notizie (e non possono che essere brutte con questi
stà al governo) in questo momento provocano la caduta della mia
ispirazione, la morte dello slancio creativo, e stanotte forse provocheranno
una crisi d'angoscia. Insomma, faresti meglio a chiamare la signorina Sudre,
credo che detterò qualche pagina!"
Florence si affrettò a ubbidire. Mentre tornava in salotto dopo aver
avvertito la segretaria squillò il telefono.
"Il signor Jules Blanc chiama dalla presidenza del Consiglio e chiede di
parlare con il signore" disse il cameriere.
Florence chiuse accuratamente tutte le porte affinché nessun rumore
arrivasse nella stanza dove Gabriel e la segretaria lavoravano. Nel frattempo
il cameriere preparava, come al solito, la cena fredda che avrebbe
soddisfatto il capriccio del padrone. Gabriel mangiava poco ai pasti, ma
spesso aveva fame di notte. C'erano un avanzo di pernice, delle pesche e
certi deliziosi pâté al formaggio che Florence ordinava personalmente in un
negozio della Rive gauche, il tutto accompagnato da una bottiglia di
Pommery. Dopo lunghi anni di riflessione e di ricerche, Gabriel era arrivato
alla conclusione che solo lo champagne si confaceva al suo mal di fegato.
Fu Florence a prendere la telefonata di Jules Blanc, la sua voce estenuata,
quasi afona; e nello stesso tempo coglieva tutti i suoni familiari della casa, il
leggero tintinnio di piatti e bicchieri, la voce stanca, roca e profonda di
Gabriel, e le sembrava di vivere in un sogno nebuloso. Riagganciò la
cornetta e chiamò il cameriere. Questi era da tempo al loro servizio e
conosceva perfettamente ciò che chiamava "la meccanica della casa", quella
sorta di inconsapevole imitazione del Grand Siecle che affascinava tanto
Gabriel.
"Cosa si può fare, Marcel? Il signor Jules Blanc ci consiglia di partire...".
"Partire? E per andare dove, signora?"
"In un posto qualsiasi. In Bretagna. Nel Midi. Pare che i tedeschi abbiano
già attraversato la Senna. Cosa si può fare?" ripeté.
"Non lo so proprio, signora" disse Marcel in tono gelido.
Era ora che gli chiedessero il suo parere. E pensava: "Per fare le cose per
bene avremmo dovuto essere già partiti. Che strazio vedere questa gente
ricca e famosa con meno sale in zucca degli animali! E almeno gli animali
lo fiutano, il pericolo!" Quanto a lui, i tedeschi non gli facevano paura. Li
aveva già visti nel '14. Adesso non aveva più l'età per essere richiamato e lo
avrebbero lasciato in pace. Ma gli sembrava francamente scandaloso che
non ci si fosse preoccupati per tempo della casa, dei mobili, dell'argenteria.
Si lasciò scappare un sospiro appena percettibile. Fosse dipeso da lui
avrebbe imballato ogni oggetto, nascosto tutto nelle casse, messo tutto al
riparo da un pezzo. Provava nei confronti dei suoi padroni una sorta di
affettuoso disprezzo, lo stesso che gli ispiravano quei levrieri bianchi, così
belli e così stupidi.
"La signora farebbe bene ad avvertire il signore" concluse.
Florence entrò in salotto ma, socchiusa la porta, subito le giunse la voce
di Gabriel: quella dei giorni peggiori, dei momenti di angoscia, una voce
lenta, rauca, interrotta a tratti da una tosse nervosa.
Diede qualche ordine a Marcel e alla cameriera, e pensò alle cose più
preziose, quelle che ci si porta dietro nella fuga, nel pericolo. Fece posare
sul letto una valigia leggera e solida, e vi nascose prima di tutto i gioielli
che, prudentemente, aveva già ritirato dalla cassetta di sicurezza. Vi mise
sopra qualche capo di biancheria, gli oggetti da toilette, due camicette di
ricambio, un abitino elegante da indossare per cena all'arrivo (bisognava
calcolare eventuali ritardi nel viaggio), vestaglia e pantofole, l'astuccio del
trucco (che occupava molto spazio) e naturalmente i manoscritti di Gabriel.
Tentò di chiudere la valigia. Impossibile. Spostò il cofanetto dei gioielli,
provò ancora. No, decisamente bisognava togliere qualcosa. Ma cosa? Tutto
era indispensabile. Appoggiò un ginocchio sulla valigia, premette, fece
forza sulla serratura. Inutile. Si innervosì e finì per chiamare la cameriera.
"Vedi un po’ tu, Julie, se riesci a chiuderla"
"É troppo piena, signora. É impossibile".
Per un attimo, Florence esitò fra l'astuccio del trucco e il manoscritto, poi
optò per il primo e chiuse la valigia.
Ficcheremo il manoscritto nella cappelliera, pensò. Oh, Dio, no! Lo
conosco, scoppi di collera, crisi di angoscia, digitalina per il cuore.
Vedremo domani, meglio preparare tutto questa notte e che lui non sappia
niente. Poi si vedrà...
CAPITOLO 4.
I Maltête di Lione avevano lasciato in eredità ai Pericand non solo il loro
patrimonio ma anche una certa predisposizione alla tubercolosi.
Malattia che stroncò prematuramente le giovani vite di due delle sorelle di
Adrien Pericand. Ne era stato colpito, qualche anno prima, anche Philippe,
ma un paio d'anni passati in montagna sembravano averlo guarito proprio
quando veniva finalmente ordinato sacerdote. Alla visita di leva, però,
risultò ancora debole di polmoni, e alla dichiarazione di guerra fu riformato.
Il suo aspetto, tuttavia, era quello di un uomo robusto. Aveva un bel
colorito, folte sopracciglia nere e un'aria sana, da campagnolo. Faceva il
parroco in un paesino dell'Auvergne. Quando si era manifestata la sua
vocazione, la signora Pericand lo aveva ceduto al Signore. In cambio,
avrebbe gradito un po’ di gloria mondana, come il vederlo destinato a
incarichi prestigiosi piuttosto che all'insegnamento del catechismo ai
contadinelli del Puy-de-Dôme. In mancanza di ruoli di prestigio in ambito
ecclesiastico, avrebbe preferito saperlo in un chiostro piuttosto che in quella
povera parrocchia. Sei sprecato, gli diceva con decisione. Sperperi i doni
che ti ha dato il buon Dio. Ma si consolava pensando che il clima rigido gli
si confaceva. L'aria di alta montagna che aveva respirato per due anni in
Svizzera sembrava essergli divenuta necessaria. A Parigi ritrovava le strade,
e le percorreva a grandi passi agili che facevano sorridere i passanti, perché
l'abito talare non si addiceva a quell'andatura.
Quella mattina si fermò davanti a una casa grigia ed entrò in un cortile
che puzzava di cavolo: l'Opera dei Piccoli Redenti del XVI occupava un
piccolo edificio costruito dietro una casa a molti piani dall'apparenza
borghese. Come scriveva la signora Pericand nella lettera annuale
indirizzata agli amici dell'opera (membro fondatore, 500 franchi l'anno;
sostenitore, 100 franchi; socio, 20 franchi), lì i ragazzi vivevano nelle
migliori condizioni materiali e morali, facendo il loro apprendistato nei
diversi mestieri e dedicandosi a una sana attività fisica. Vicino alla casa era
stata costruita una piccola rimessa a vetri che ospitava un laboratorio di
falegnameria e un banco da lavoro per calzolai. Attraverso le vetrate padre
Pericand vide le teste rotonde dei pupilli sollevarsi un attimo al rumore dei
suoi passi. In un'aiuola fra la scalinata esterna e la rimessa due ragazzi di
quindici e sedici anni stavano lavorando agli ordini di un sorvegliante. Non
indossavano l'uniforme. Non si era voluto perpetuare il ricordo dei
riformatori per i quali alcuni di loro erano già passati. Vestivano abiti
confezionati da persone caritatevoli che utilizzavano poi per sé i resti della
stoffa. Uno dei ragazzi portava un maglione verde mela che gli lasciava
scoperti i lunghi polsi magri e pelosi. Rivoltavano la terra, strappavano le
erbacce, trasferivano le piantine di fiori in un vaso nuovo, il tutto con la
medesima disciplina e in assoluto silenzio.
Salutarono padre Pericand, e lui rispose con un sorriso. Il volto del
sacerdote era calmo, l'espressione severa e un po’ triste. Ma il sorriso aveva
una grande dolcezza e una certa timidezza mista a mite rimprovero:
"Io vi amo, perché voi non mi amate?" sembrava dire. I ragazzi lo
guardavano e tacevano.
"Che bella giornata" mormorò.
"Sì, signor curato" risposero quelli con voci fredde e impacciate.
Philippe disse ancora qualcosa poi entrò nell'atrio. La casa era grigia e
pulita, la stanza, in cui si trovava quasi nuda, con due sedie impagliate quale
unico arredo. Era il parlatorio dove si andava a far visita ai pupilli - cosa
tollerata ma non incoraggiata. Del resto, i ragazzi erano per lo più orfani. Di
tanto in tanto qualche vicina che aveva conosciuto i genitori morti, qualche
sorella maggiore sistemata in provincia si ricordava di loro e otteneva il
permesso di una visita. Ma in quel parlatorio padre Pericand non aveva mai
incontrato un essere umano. L'ufficio del direttore si trovava sullo stesso
pianerottolo.
Il direttore era un ometto pallido dalle palpebre rosate, il naso aguzzo e
fremente come il muso di un animale che fiuta il cibo. I ragazzi lo
chiamavano "il topo" o "il tapiro" Tese a Philippe entrambe le mani, fredde
e umidicce.
"Non so come ringraziarla, signor curato, della cortesia che mi fa
accettando di occuparsi dei nostri pupilli"
Bisognava farli sfollare il giorno dopo, e lui era stato chiamato d'urgenza
nel Midi al capezzale della moglie ammalata...
"Il sorvegliante teme che l'impegno sia troppo gravoso e pensa di non
farcela, da solo, a trasferire trenta ragazzi"
"Sembrano molto docili" osservò Philippe.
"Ah, su questo può stare tranquillo. Qui li facciamo diventare remissivi,
teniamo a freno i più ribelli. Ma, non lo dico per vantarmi, sono io che
mando avanti tutto. I sorveglianti non hanno polso. Del resto, la guerra ci ha
privati di parecchi di loro...".
Fece una smorfia.
"Ottimi elementi se non li si priva delle loro abitudini, ma assolutamente
incapaci di una qualsiasi iniziativa. Gente che annegherebbe in un bicchier
d'acqua. Insomma, non sapevo a che santo votarmi per condurre felicemente
in porto questo sfollamento, quando suo padre mi ha detto che lei passava di
qui, diretto al suo paesello di montagna, e che non si sarebbe rifiutato di
aiutarci"
"Lo farò molto volentieri. Come pensa di far partire questi ragazzi?".
"Abbiamo potuto procurarci due camion e benzina in quantità sufficiente.
Il luogo di destinazione è a una cinquantina di chilometri dalla sua
parrocchia, quindi non sarà troppo fuori strada"
"Sono libero fino a giovedì" disse Philippe. "Mi sostituisce un fratello
della nostra comunità"
"Oh, il viaggio non durerà tanto! Suo padre mi ha detto che lei conosce la
casa messaci a disposizione da una delle nostre benefattrici. É un grande
edificio in mezzo ai boschi; la proprietaria l'ha ereditato l'anno scorso e tutto
l'arredamento, che era magnifico, è stato venduto poco prima della guerra. I
ragazzi potranno accamparsi nel parco. Con una così bella stagione per loro
sarà una festa! All'inizio della guerra hanno passato tre mesi in un altro
castello, nel Correze, che ci era stato offerto gentilmente da un'altra di
queste dame benefiche. E là non avevamo il riscaldamento; al mattino
bisognava spaccare il ghiaccio nelle brocche, ma i ragazzi non sono mai
stati meglio. Non è più tempo di comodità" disse il direttore. "Dobbiamo
dire addio agli agi della pace"
Philippe guardò l'ora.
"Mi farebbe l'onore di pranzare con me, signor curato?"
Il giovane rifiutò. Era arrivato a Parigi quella mattina dopo aver viaggiato
tutta la notte. Temeva un qualche colpo di testa da parte di Hubert ed era
venuto a prenderlo, ma la famiglia si metteva in viaggio per la Nievre quel
giorno stesso. Philippe contava di assistere alla partenza: avrebbe dato una
mano, e non sarebbe stato di troppo, pensò sorridendo.
"Vado ad annunciare ai ragazzi che lei mi sostituirà" disse il direttore.
"Forse vorrà rivolgere loro due parole per stabilire un primo contatto.
Pensavo di dire qualcosa io stesso al fine di innalzare i loro animi alla
consapevolezza delle guerre attraverso le quali è passata la patria, ma parto
alle quattro e...".
"Gli parlerò io" disse padre Pericand.
Abbassò lo sguardo, si posò sulle labbra la punta delle dita unite.
Un'espressione di severità e di tristezza gli si dipinse in volto, entrambe
dirette contro se stesso e le proprie inclinazioni. Non li amava, quegli
infelici. Li avvicinava con dolcezza, con tutta la buona volontà di cui era
capace, ma davanti a loro provava solo freddezza e ripugnanza, nessun
impulso d'amore, neanche l'ombra di quel palpito divino che persino i
peccatori più abietti ispirano quando implorano la grazia. C'era maggiore
umiltà nelle fanfaronate di un ateo impenitente, di un bestemmiatore
incallito che nelle parole o negli sguardi di quei ragazzi. La loro apparente
docilità era terrificante. Nonostante il battesimo, nonostante i sacramenti
della comunione e della confessione ricevuti, nessun raggio di salvezza
scendeva su di loro. Figli delle tenebre, non possedevano neppure la forza
spirituale per elevarsi fino a desiderare la luce; non la percepivano, non vi
anelavano, non ne avevano nostalgia. Padre Pericand pensò con tenerezza ai
suoi bravi bimbetti del catechismo. Oh, neanche su di loro si faceva troppe
illusioni. Sapeva già che in quelle giovani anime il male aveva radici
profonde, fortissime, ma quanta tenerezza vi sbocciava ogni tanto, quanta
grazia innocente, quanta pietà e orrore quando lui parlava del martirio di
Cristo. Aveva fretta di ritrovarli. Pensò alla cerimonia delle prime
comunioni fissata per la domenica successiva.
Intanto seguiva il direttore nella sala dove i pupilli erano stati convocati.
Nell'oscurità creata dalle imposte chiuse non si accorse di un gradino,
incespicò e, per non cadere, si aggrappò al braccio del direttore. Guardò i
ragazzi, aspettando, sperando in uno scoppio di risa soffocato. A volte, quel
buffo genere di incidente basta a rompere il ghiaccio fra allievi e maestri.
Ma no! Nessuno di loro fiatò. Pallidi, le labbra serrate, gli occhi bassi,
stavano in piedi in fondo alla stanza disposti a semicerchio, i più giovani in
prima fila. Questi avevano dagli undici ai quindici anni ed erano quasi tutti
bassi di statura per la loro età, e gracili. Dietro si trovavano gli adolescenti,
ragazzi dai quindici ai diciassette anni. Alcuni avevano la fronte bassa e
grosse mani da assassini. Di nuovo, non appena fu alla loro presenza,
Philippe provò uno strano sentimento di avversione, quasi di paura.
Doveva superarlo a ogni costo. Avanzò verso di loro, e quelli
indietreggiarono impercettibilmente come se volessero sprofondarsi nel
muro.
"Cari ragazzi, a partire da domani e fino alla fine del nostro viaggio
sostituirò il signor direttore" disse. "Sapete già che state per lasciare Parigi.
Solo Dio conosce la sorte riservata ai nostri soldati, alla nostra cara patria, e
Lui solo, nella sua infinita saggezza, conosce la sorte riservata a ciascuno di
noi nei giorni a venire.
Purtroppo è più che probabile che tutti noi patiremo una sofferenza
personale, perché le disgrazie pubbliche sono fatte di una moltitudine di
sofferenze private, ed è il solo caso in cui, poveri ciechi e ingrati che altro
non siamo, ci rendiamo conto della solidarietà che ci lega, noi membri di
uno stesso corpo. Quello che vorrei da voi è un atto di fiducia in Dio. Con le
labbra ripetiamo sempre: "Sia fatta la tua volontà", mentre dentro di noi
gridiamo: "Sia fatta la mia volontà, o Signore" Ma perché cerchiamo Dio?
Perché speriamo nella felicità: è nella natura stessa dell'uomo desiderare la
felicità, e questa felicità, se accettiamo la volontà di Dio, se facciamo nostra
la Sua volontà, Dio può darcela subito, senza aspettare la morte e la
resurrezione. Miei cari ragazzi, affidatevi a Dio. Rivolgetevi a Lui come a
un padre, mettete la vostra vita nelle Sue mani venerabili e la pace divina
scenderà su di voi"
Attese un istante, li guardò.
"Ora diremo insieme una breve preghiera" Trenta voci acute, indifferenti,
recitarono il Padrenostro, trenta volti magri attorniavano il sacerdote, e
quando lui tracciò sopra di loro il segno della croce le fronti si chinarono
con un movimento brusco e meccanico. Solo un ragazzino dalla bocca larga
e imbronciata volse lo sguardo verso la finestra e il raggio di sole che
filtrava tra le imposte chiuse illuminò una guancia delicata, spruzzata di
lentiggini, e un piccolo naso dalle narici contratte.
Nessuno di loro si mosse, nessuno rispose. Al fischio del sorvegliante si
misero in fila e uscirono dalla sala.
CAPITOLO 5.
Le vie erano deserte. I negozianti abbassavano le saracinesche. Nel
silenzio si udiva soltanto il loro rumore metallico, quel suono che nelle città
minacciate, all'alba di una sommossa o di una guerra, colpisce con violenza
l'orecchio.
Davanti a loro, lungo la strada, i Michaud videro dei camion pieni zeppi
in attesa alla porta dei ministeri. Scrollarono la testa. Come al solito, si
presero sottobraccio per attraversare avenue dell'Opera, di fronte all'ufficio,
benché il viale quella mattina fosse deserto. Erano entrambi impiegati di
banca e lavoravano nello stesso istituto di credito, ma il marito occupava da
quindici anni un posto di contabile mentre lei era stata assunta solo pochi
mesi prima "a titolo provvisorio per la durata della guerra" Maestra di canto,
in settembre aveva perso tutti i suoi allievi, rampolli di buona famiglia fatti
sfollare in provincia per timore dei bombardamenti. Lo stipendio del marito
non era mai bastato e l'unico figlio era sotto le armi. Grazie a quel posto di
segretaria fino a quel momento se l'erano cavata e, come diceva lei:
"Non bisogna pretendere l'impossibile, marito mio!" Avevano sempre
avuto una vita difficile fin dal giorno in cui erano scappati di casa per
sposarsi contro il volere dei genitori. Da allora era passato molto tempo, i
capelli erano grigi, ma il viso di lei recava ancora tracce di bellezza. L'uomo
era piuttosto basso di statura, aveva un'aria stanca e trascurata, ma ogni
tanto, quando si voltava verso di lei e la guardava, le sorrideva e gli si
accendeva negli occhi una piccola luce tenera e ironica - la stessa, pensava
la donna, sì, davvero, quasi la stessa di un tempo. Lui l'aiutò a salire sul
marciapiede e raccolse il guanto che le era caduto. Lei lo ringraziò
premendo appena le dita sulla mano che lui le porgeva. Altri impiegati si
affrettavano verso la porta aperta della banca, e uno di loro, passando vicino
ai Michaud, domandò:
"Allora, si parte?"
I Michaud non ne sapevano niente. Quel giorno era il 10 giugno, un
lunedì. Quando erano usciti dall'ufficio, due giorni prima, tutto sembrava
calmo. Azioni e obbligazioni erano state trasferite in provincia, ma per gli
impiegati non si era preso alcun provvedimento. La loro sorte veniva decisa
al primo piano, dove si trovavano gli uffici della direzione, dotati di due
grandi porte imbottite dipinte di verde davanti alle quali i Michaud
passarono in fretta e in silenzio. In fondo al corridoio si separarono, lui
saliva al reparto contabilità e lei restava al piano nobile: era la segretaria di
uno dei direttori, il signor Corbin, il vero capo di quell'istituto. L'altro
direttore, il conte de Furieres (sposato con una Salomon-Worms), si
occupava soprattutto dei rapporti esterni della banca, che poteva contare su
una clientela ristretta ma di alto livello. Vi si ammettevano solo grossi
proprietari terrieri e grandi nomi dell'industria, preferibilmente metallurgica.
Il signor Corbin sperava che il collega, conte de Furieres, avrebbe facilitato
la sua ammissione al Jochey e viveva in quell'attesa già da qualche anno.
Quanto al conte, riteneva che certi favori quali gli inviti alle sue cene e alle
sue partite di caccia compensassero largamente certe agevolazioni di cassa.
Alla sera la signora Michaud mimava per il marito i colloqui dei due
direttori, i loro sorrisi acidi, le smorfie di Corbin, gli sguardi del conte, e
questo dava un po’ di colore alla monotonia del lavoro quotidiano. Ma da
qualche tempo anche quella distrazione era venuta a mancare: il conte de
Furieres si trovava al fronte, sulle Alpi, e Corbin dirigeva la banca da solo.
La signora Michaud entrò con la posta in una piccola stanza attigua
all'ufficio del direttore. Nell'aria aleggiava un profumo leggero. Segno che
Corbin era occupato con la sua protetta: la signorina Ariette Corail, di
professione ballerina. A quanto si sapeva, aveva sempre avuto come amanti
delle ballerine. Non sembrava minimamente interessato a donne impegnate
in altri campi. Nessuna dattilografa, per quanto giovane e bella, era mai
riuscita a distoglierlo da quel pensiero fisso. Con tutte le sue impiegate,
belle o brutte, giovani o vecchie, si mostrava ugualmente astioso, rozzo e
avaro. Parlava con una strana vocina di testa che usciva da un corpaccio
tarchiato e ben pasciuto. Quando perdeva le staffe, la sua voce si faceva
acuta e vibrante come quella di una donna.
Quel suono pungente, ben noto alla signora Michaud, filtrava ora
attraverso le porte chiuse. Uno degli impiegati entrò e disse sottovoce:
"Si parte"
"Quando?"
"Domani"
Nel corridoio passavano delle ombre, ed era tutto un sussurrare. Gli
impiegati si riunivano nei vani delle finestre e sulla soglia dei rispettivi
uffici. Finalmente Corbin aprì la porta del suo e fece uscire la ballerina.
Questa indossava un completo di tela rosa confetto e un grande cappello di
paglia sui capelli tinti. Era slanciata e ben fatta, il volto duro e stanco sotto
il trucco. Le guance e la fronte erano cosparse di macchie rosse: era
visibilmente fuori di sé. La signora Michaud sentì dire:
"Vuoi che parta a piedi?"
"Dammi retta per una volta, torna subito al garage e non essere avara,
promettigli quello che vogliono e ti ripareranno la macchina"
"Ma se ti dico che è impossibile! Impossibile! In che lingua devo
spiegartelo?"
"E allora, mia cara, cosa vuoi che ti dica? I tedeschi sono alle porte di
Parigi e tu vuoi metterti sulla strada di Versailles? Perché, poi?
Parti con il treno"
"Ti rendi conto di quello che sta succedendo nelle stazioni?"
"Sulle strade non sarà meglio"
"Sei... sei un incosciente, ecco! Tu, però, parti, con le tue due
macchine...".
"Trasporto i documenti della banca e una parte del personale. Dove
cavolo vuoi che lo metta, il personale?"
"Non essere così volgare, per favore! Hai la macchina di tua moglie!"
"Vorresti salire nella macchina di mia moglie? Ma che bella idea!"
La ballerina gli voltò le spalle e con un fischio chiamò il cane, che le
balzò incontro. Lei gli allacciò il collare con mani tremanti di indignazione.
"E dire che ho sacrificato tutta la mia gioventù a un...".
"Su, su, poche storie. Ti telefonerò stasera, vedrò cosa si può fare...".
"No, no, lascia perdere. É chiaro, non mi resta che andare a morire in un
fosso sulla strada... Ah! taci, mi esasperi...".
Finalmente si accorsero che la segretaria li stava ascoltando.
Abbassarono la voce e Corbin, conducendo per il braccio l'amante, la
riaccompagnò fino alla porta. Quindi tornò e lanciò un'occhiata alla signora
Michaud la quale, trovandosi sul suo percorso, subì le prime manifestazioni
del suo malumore.
"Faccia convocare i capiservizio nella sala riunioni. Immediatamente, per
favore!"
La signora Michaud uscì per impartire gli ordini. Qualche istante dopo gli
impiegati entravano in una grande stanza dove campeggiavano, l'uno di
fronte all'altro, il ritratto a figura intera del presidente in carica, il signor
Auguste-Jean, affetto da qualche tempo da demenza senile, e un busto in
marmo del fondatore della banca.
Corbin li ricevette in piedi al di là del tavolo a forma di ellisse sul quale
nove sottomano segnavano i posti dei membri del consiglio
d'amministrazione.
"Signori, domattina alle otto partiamo per la nostra succursale di Tours.
Porto con me in macchina i documenti della direzione. Signora Michaud, lei
e suo marito mi accompagnerete. Quanto a coloro che dispongono di
un'automobile, passino a prendere i colleghi che ho designato e si trovino
alle sei davanti alla porta della banca. Per gli altri, vedrò di arrangiarmi,
altrimenti prenderanno il treno. É tutto, signori. Grazie".
Sparì, e immediatamente un brusio di voci preoccupate si diffuse nella
sala. Fino a due giorni prima Corbin aveva dichiarato che non ci sarebbe
stato alcun trasferimento, che le voci allarmistiche erano opera di disfattisti,
che la banca sarebbe rimasta al suo posto, lei, e avrebbe fatto il proprio
dovere, lei, a differenza di qualcun altro. Il fatto che il "ripiegamento",
come si diceva con un certo pudore, fosse stato deciso con tanta
precipitazione di sicuro significava che tutto era perduto! Alcune donne si
asciugarono le lacrime. Passando tra i vari gruppi di impiegati, i Michaud si
ricongiunsero. Pensavano tutti e due al figlio Jean-Marie. La sua ultima
lettera era datata 2 giugno. Solo otto giorni prima. E chissà cosa poteva
essere successo da allora, mio Dio! Angosciati com'erano, il solo conforto
possibile era quello della loro reciproca presenza.
"Che fortuna non doverci separare" gli sussurrò lei.
CAPITOLO 6.
Era quasi notte ma la macchina dei Pericand era ancora ferma davanti alla
porta: sul tetto era stato sistemato il morbido e alto materasso che da
ventotto anni guarniva il letto coniugale. Una carrozzina e una bicicletta
erano assicurate al bagagliaio. All'interno dell'abitacolo i Pericand
cercavano invano di sistemare tutte le borse, le valigie e i bauletti della
famiglia, nonché i cestini che contenevano i panini e il thermos per la
merenda, il latte dei bambini, il pollo freddo, il prosciutto, il pane, le scatole
di farina lattea del vecchio Pericand e la cesta del gatto. Il ritardo era dovuto
principalmente al fatto che il lavandaio non aveva consegnato la biancheria
e non si riusciva a raggiungerlo per telefono. Sembrava inconcepibile
abbandonare quelle grandi lenzuola ricamate che facevano parte del
patrimonio inalterabile dei Pericand allo stesso titolo dei gioielli,
dell'argenteria e della biblioteca. L'intera mattinata era stata spesa in
affannose ricerche; anche il lavandaio stava partendo e aveva finito per
restituire alla signora Pericand le preziose lenzuola sotto forma di fagotti
umidi e sgualciti. La signora aveva rinunciato alla colazione per badare
personalmente al loro imballaggio. Si era deciso che i domestici avrebbero
preso il treno, e così pure Hubert e Bernard. Ma in tutte le stazioni i cancelli
erano già chiusi e piantonati dai militari. La folla si aggrappava alle sbarre,
le scuoteva, poi rifluiva in modo tumultuoso nelle strade vicine. Donne con
i bambini in braccio correvano piangendo.
Qualcuno faceva segno agli ultimi taxi e offriva due o tremila franchi per
poter lasciare Parigi. "Solo fino a Orleans...". Ma gli autisti rifiutavano, non
avevano più benzina. I Pericand dovettero tornare a casa. Alla fine
riuscirono a procurarsi un camioncino che avrebbe trasportato Madeleine,
Maria e Auguste, e Bernard con il fratellino sulle ginocchia. Quanto a
Hubert, li avrebbe seguiti in bicicletta.
Qua e là, davanti ai palazzi di boulevard Delessert si vedeva un gruppo
gesticolante di donne, vecchi e bambini che si sforzavano, dapprima con
calma, poi febbrilmente, quindi con un'eccitazione morbosa e folle, di far
entrare familiari e bagagli in una Renault, in una berlina, in una spider.
Nessuna luce alle finestre. Cominciavano a spuntare le stelle - stelle di
primavera dal riflesso argentato. Parigi aveva il suo profumo più dolce,
quello degli ippocastani in fiore e delle essenze volatili miste a granelli di
polvere che scricchiolano sotto i denti come grani di pepe. Nell'ombra, il
pericolo cresceva. Nell'aria, nel silenzio, si respirava l'angoscia. Neanche le
persone più fredde, quelle generalmente più tranquille, potevano evitare
quella confusa e mortale apprensione.
Ciascuno guardava la sua casa con una stretta al cuore e pensava:
"Domani sarà distrutta, domani non avrò più niente. Non abbiamo fatto
del male a nessuno. Perché?". E contemporaneamente si sentiva sopraffatto
da un'ondata di indifferenza: "Che importa! Sono solo pietre, legno, materia
inerte! L'essenziale è salvare la pelle!" Chi pensava alla tragedia della
patria? Non loro, non quelli che partono stasera. Il panico annullava tutto
ciò che non era istinto, impulso animale, fremito della carne. Afferrare
quanto si aveva di più prezioso al mondo e poi...! E, quella notte, solo ciò
che viveva, ciò che respirava, piangeva, amava, valeva qualcosa! Erano
pochi coloro che pensavano con rimpianto alle ricchezze perdute:
l'importante era stringere fra le braccia una moglie o un figlio. Il resto non
contava, il resto poteva pure sprofondare tra le fiamme.
Tendendo l'orecchio, si riusciva a cogliere il rombo degli aerei che
passavano nel cielo. Francesi o nemici? Chissà. "Più svelti, più svelti"
diceva il signor Pericand. Ma ora ci si accorgeva di aver dimenticato il
cofanetto dei pizzi, ora mancava l'asse da stiro. Impossibile far intendere
ragione ai domestici. Erano terrorizzati, volevano partire, ma la forza
dell'abitudine superava la paura, e tenevano a che tutto si svolgesse secondo
i riti che regolavano le partenze per la villeggiatura. Tutto doveva essere
messo nelle valigie nell'ordine consueto. Non avevano capito realmente
quello che stava succedendo. Era come se agissero in due tempi, metà nel
presente e metà nel passato, quasi che gli eventi fossero penetrati solo in
una piccola zona della loro coscienza, la più superficiale, lasciando
addormentata e in pace tutta un'area profonda. La balia, con i capelli grigi
scarmigliati, le labbra strette, le palpebre arrossate dalle lacrime, piegava
con gesti straordinariamente vivaci e precisi i fazzoletti di Jacqueline
appena stirati. La signora Pericand, già seduta in macchina, la chiamava ma
l'anziana donna non rispondeva, non la sentiva neppure. Alla fine, Philippe
dovette salire a cercarla.
"Vieni, Tata, che cos'hai? Dobbiamo partire. Che cos'hai?" ripeté
dolcemente prendendole la mano.
"Ah, lasciami, piccolo mio!" gemette lei, dimenticando all'improvviso che
ormai lo chiamava solo "signor Philippe" o "signor curato", e ritrovando
istintivamente il tu di un tempo: "Lasciami stare, va. Tu sei buono ma noi
siamo perduti!"
"No, non disperarti così, mia povera vecchia, non badare ai fazzoletti,
vestiti e scendi subito, la mamma ti aspetta"
"Non rivedrò più i miei ragazzi, Philippe!"
"Ma sì, ma sì" diceva lui mentre le sistemava le ciocche disfatte e le
calcava sulla testa un cappello di paglia nero.
"Pregherai la santa Vergine per i miei ragazzi, vero?"
Le diede un bacio leggero sulla guancia.
"Sì, sì, te lo prometto. Va, adesso".
Sulla scala incrociarono l'autista e il portiere che salivano a prendere il
vecchio Pericand. Lo avevano lasciato lontano dal trambusto fino all'ultimo
momento. Auguste e l'infermiere lo aiutarono a vestirsi. Il vecchio era stato
operato qualche tempo prima e portava un complicato bendaggio, nonché,
in previsione dell'abbassamento della temperatura durante la notte, una
fascia di flanella così lunga e larga che il suo corpo appariva tutto bendato,
come quello di una mummia. Auguste gli abbottonò gli stivaletti all'antica,
gli infilò un golf caldo e leggero e la giacca. Il vecchio Pericand, che fino a
quel momento si era lasciato maneggiare senza dir niente, come un vecchio
bambolotto di legno, parve riemergere da un sogno e borbottò: "Gilet di
lana!"
"Il signore avrà troppo caldo" obiettò Auguste ritenendo chiusa la
questione.
Ma il padrone lo fissò con il suo sguardo pallido e vitreo e ripeté a voce
un po’ più alta:
"Gilet di lana!"
Glielo diedero. Gli infilarono quindi il lungo soprabito e gli arrotolarono
due volte intorno al collo la sciarpa, fermata sulle spalle con una spilla da
balia. Lo sistemarono sulla sedia a rotelle e gli fecero scendere i cinque
piani: la sedia non entrava nell'ascensore.
L'infermiere, un robusto alsaziano dai capelli rossi, prese le scale
procedendo a ritroso e reggendo con le braccia tese il prezioso fardello che
Auguste teneva rispettosamente dall'altro lato. A ogni pianerottolo i due
uomini si fermavano per asciugarsi il sudore che colava loro dalla fronte,
mentre il vecchio Pericand contemplava serafico il soffitto e scuoteva pian
piano la bella barba. Impossibile capire che cosa pensasse di quella partenza
precipitosa. Tuttavia, contrariamente a quanto si sarebbe potuto credere, non
ignorava affatto gli eventi recenti. Mentre lo vestivano aveva mormorato:
"Bella notte chiara... Non mi stupirebbe che...".
Poi sembrò che si fosse assopito e solo qualche istante dopo, sulla soglia,
aveva completato la frase:
"Non mi stupirebbe che ci bombardassero strada facendo!"
"Cosa va a pensare, signor Pericand!" aveva esclamato l'infermiere con
l'ottimismo proprio della sua professione.
Ma il vegliardo aveva già ripreso la solita aria di profonda indifferenza.
Finalmente la sedia a rotelle fu fatta uscire dal palazzo.
Il vecchio Pericand venne sistemato in macchina nell'angolo di destra, al
riparo dagli spifferi d'aria. La nuora stessa, con mani tremanti d'impazienza,
lo avvolse nello scialle scozzese di cui lui di solito si divertiva a intrecciare
le lunghe frange.
"Tutto a posto?" domandò Philippe. "Bene! Sbrigatevi a partire, adesso".
Sarà una vera fortuna se escono da Parigi prima di domattina, pensò.
"I guanti" disse il vecchio.
Gli infilarono i guanti. Ma il polso, ingrossato dai vari strati di lana,
rendeva difficile l'allacciarli. Il vecchio Pericand non fece grazia di un solo
bottone. Finalmente tutto era pronto. Emmanuel urlava in braccio alla
bambinaia. La signora Pericand baciò il marito e il figlio. Li strinse a sé,
senza piangere, ma entrambi sentivano il suo cuore battere all'impazzata
contro il loro petto. L'autista mise in moto. Hubert inforcò la bicicletta. Il
vecchio Pericand alzò la mano.
"Un momento" scandì con voce calma e flebile.
"Che cosa c'è, papà?"
Fece segno che non poteva dirlo alla nuora.
"Avete dimenticato qualcosa?"
Il vecchio annuì con il capo. L'automobile si fermò. Pallida per
l'esasperazione, la signora Pericand mise la testa fuori dal finestrino.
"Credo che papà abbia dimenticato qualcosa" gridò in direzione del
gruppetto fermo sul marciapiede e formato dal marito, da Philippe e
dall'infermiere.
La macchina tornò indietro e si arrestò davanti alla porta. Con un piccolo
gesto discreto, il vecchio chiamò l'infermiere e gli sussurrò qualcosa
all'orecchio.
"Ma cosa c'è? É pazzesco, saremo ancora qui domani!" esclamò la signora
Pericand. "Che cosa desiderate, papà?". Poi, rivolta all'infermiere:
"Cos'è che vuole?"
L'uomo abbassò gli occhi.
"Il signore vorrebbe che lo riportassimo su... per un bisognino...".
CAPITOLO 7.
Charles Langelet, in ginocchio sul pavimento del suo salotto spoglio,
imballava personalmente le sue porcellane. Era grasso e malato di cuore; il
respiro che gli usciva dal petto oppresso somigliava a un rantolo.
Era rimasto solo nell'appartamento deserto. Quella mattina, quando i
parigini si erano svegliati in mezzo a una nebbia artificiale che scendeva su
di loro come una pioggia di cenere, la coppia di domestici che lo serviva da
sette anni era stata presa dal panico: usciti di buonora per fare la spesa, i due
non erano più tornati. Il signor Langelet pensava amaramente al ricco
salario e alle generose gratifiche elargite loro da quando si trovavano da lui,
un trattamento che, senza alcun dubbio, aveva permesso alla coppia di
comprarsi una casetta tranquilla, o una piccola fattoria isolata, al paesello
natio.
Il signor Langelet avrebbe dovuto partire da un pezzo. Adesso lo
ammetteva anche lui, ma era terribilmente attaccato alle sue vecchie
abitudini. Puntiglioso, difficile, amava solo il suo appartamento e gli oggetti
sparpagliati ai suoi piedi sul pavimento: i tappeti erano stati arrotolati nella
naftalina e nascosti nello scantinato. Tutte le finestre erano ornate di lunghe
strisce di carta gommata rosa e celeste:
Langelet stesso, con le sue mani pallide e grassocce, le aveva disposte a
forma di stelle, di navi e di liocorni. Questa trovata suscitava l'ammirazione
degli amici, ma il fatto è che lui non poteva vivere in un ambiente banale o
volgare. In quell'appartamento, tutto ciò che costituiva il suo modo di vivere
era composto da schegge di bellezza a volte umili, a volte preziose, che
finivano per creargli intorno un'atmosfera particolare, morbida, luminosa la sola che fosse degna di una persona civile, pensava. A vent'anni portava
un anello all'interno del quale era incisa la scritta "This thing of Beauty is a
guilt for ever" Era una cosa puerile e lui, in seguito, non lo aveva più
portato (tra sé il signor Langelet parlava spesso in inglese: questa lingua,
per la sua poesia e la sua forza, ben si adattava a certi suoi stati d'animo),
aveva eliminato l'anello ma non aveva rinnegato il motto e gli era rimasto
fedele.
Si sollevò su un ginocchio e gettò intorno uno sguardo profondo e
desolato, che abbracciava ogni cosa: la Senna sotto le sue finestre, la linea
elegante che separava i due salotti, il caminetto con gli alari antichi, gli alti
soffitti dove fluttuava una luce limpida che per via delle tende color
mandorla sul balcone aveva il riflesso verde e la trasparenza dell'acqua.
Ogni tanto squillava il telefono. A Parigi c'erano ancora degli indecisi, dei
pazzi spaventati all'idea di mettersi in viaggio e che speravano in un qualche
miracolo. Lentamente, sospirando, il signor Langelet si portava all'orecchio
la cornetta. Parlava con voce nasale e tranquilla, con quel distacco,
quell'ironia che i suoi amici - una piccola cerchia molto chiusa, molto
parigina - chiamavano "tocco inimitabile" Sì, si era deciso a partire. No, non
è che temesse qualcosa. Nessuno avrebbe difeso Parigi, e altrove le cose
non sarebbero state molto diverse. Il pericolo era ovunque, ma non era dal
pericolo che lui fuggiva. "Ho visto due guerre" diceva. In realtà quella del
'14 l'aveva vissuta nella sua proprietà in Normandia perché, malato di cuore,
era stato esonerato dal servizio militare.
"Ho sessant'anni, cara amica, e la morte non mi fa certo paura!"
"Perché parte, allora?"
"Non posso sopportare questo disordine, queste esplosioni di odio, lo
spettacolo ripugnante della guerra. Me ne andrò in campagna, in un posto
tranquillo. Vivrò con i pochi soldi che mi restano, aspettando che gli uomini
riacquistino il senno"
Come risposta ebbe un leggero sogghigno: aveva fama di essere avaro e
prudente. Di lui si diceva: "Charlie? Si cuce monete d'oro in tutti i vestiti
vecchi" Fece un sorriso gelido e beffardo. Sapeva che gli invidiavano la sua
vita così soddisfacente, così agiata. L'amica esclamò:
"Oh, lei se la caverà bene, ma non tutti hanno la sua fortuna, ahimè!"
Charlie aggrottò le sopracciglia: quella donna mancava di tatto.
"Dove andrà?"
"Ho una casetta a Ciboure"
"Vicino al confine?" disse l'amica, oltrepassando ormai la misura.
Si salutarono freddamente. Charlie tornò a inginocchiarsi vicino alla cassa
riempita a metà, accarezzando attraverso la paglia e la carta velina le
porcellane, le tazze cinesi, il centrotavola di Wedgwood, i vasi di Sevres.
Da tutto questo non si sarebbe separato che a costo della vita. Ma il suo
cuore sanguinava: non gli sarebbe stato possibile portare con sé un certo
tavolino da toilette, un vero pezzo da museo in porcellana di Sassonia, e lo
specchio ornato di rose che si trovava in camera da letto. Abbandonati ai
cani randagi! Rimase immobile per un istante, accovacciato sul pavimento,
con il monocolo penzolante dal cordoncino nero che quasi toccava terra. Era
alto e robusto; sulla pelle delicata del cranio, pochi capelli leggeri erano
disposti con infinita cura. Il volto aveva di solito un'espressione melliflua e
diffidente, da vecchio gatto che fa le fusa in un cantuccio vicino al fuoco.
La fatica dell'ultimo giorno lo aveva profondamente segnato e la mascella,
dai muscoli rilassati, d'un tratto era pendula come quella di un morto. Che
cosa aveva detto, al telefono, quella smorfiosa? Aveva insinuato che lui
volesse fuggire all'estero. Povera scema! Immaginava di offenderlo, di farlo
arrossire! Ma certo che sarebbe partito. Gli bastava arrivare fino a Hendaye
e da lì avrebbe fatto in modo di passare il confine. Un breve soggiorno a
Lisbona e poi un addio all'Europa, a quell'Europa ripugnante che grondava
sangue. Se la figurò con gli occhi della mente, cadavere mezzo decomposto,
martoriato da mille ferite. Fremette. Non era fatto per lei. Non era fatto per
il mondo che sarebbe nato da quella carogna come un verme esce da una
tomba. Un mondo brutale in cui ci si sarebbe dovuti difendere dai morsi di
animali feroci. Si guardò le belle mani che non avevano mai lavorato ma
solo accarezzato statue, pezzi di oreficeria antica, rilegature preziose e
talvolta qualche mobile elisabettiano. Che cosa avrebbe fatto lui, Charles
Langelet, con la sua raffinatezza, i suoi scrupoli, e perfino quella superiorità
di cui era consapevole e che costituiva il fondo del suo carattere, in mezzo a
una folla demente? Lo avrebbero derubato, spogliato, assassinato come un
povero cane in balia dei lupi. Sorrise debolmente, con amarezza, e si pensò
in forma di cagnolino pechinese dal pelo dorato sperduto in una giungla.
Non assomigliava alla maggior parte degli uomini, lui. Le loro ambizioni, le
loro paure, le loro bassezze e i loro piagnistei gli erano estranei. Lui viveva
in un universo di pace e di luce. Destinato a essere odiato e ingannato da
tutti. A questo punto si ricordò dei suoi domestici e sogghignò. Era l'alba
dei tempi nuovi, un avvertimento e un presagio! Si alzò a fatica per via delle
articolazioni dolenti, premette le mani sull'incavo delle reni e andò nel
ripostiglio a prendere il martello e i chiodi per inchiodare la cassa. Poi la
trascinò giù lui stesso nella macchina: non era il caso che i portinai
vedessero quello che si portava via.
CAPITOLO 8.
I Michaud si erano alzati alle cinque del mattino per avere il tempo di
riordinare e pulire a fondo l'appartamento, prima di abbandonarlo.
Certo, era un po’ strano prendersi tanta cura di cose senza valore e
destinate con ogni probabilità a finire in pezzi sotto le prime bombe che
sarebbero cadute su Parigi. Ma, pensava la signora Michaud, forse che non
si lavano e si vestono i morti, che marciranno poi sottoterra? E un ultimo
omaggio, un'estrema prova d'amore a ciò che fu caro. E quel piccolo
appartamento era loro molto caro. Ci vivevano da sedici anni e non
avrebbero potuto trasportare altrove tutti i loro ricordi. Per quanto facessero,
i più belli sarebbero rimasti lì, fra quelle pareti modeste. In fondo a un
armadio sistemarono i libri e quelle piccole fotografie da dilettanti che ci si
ripromette sempre di incollare su un album e che restano poi accartocciate,
sbiadite, incastrate nella scanalatura di un cassetto. La foto di Jean-Marie
bambino l'avevano già messa in fondo alla valigia, fra le pieghe di un
vestito di ricambio; la banca aveva raccomandato caldamente di prendere
solo lo stretto necessario: qualche capo di biancheria e gli oggetti da toilette
indispensabili. Finalmente tutto fu pronto. Fecero colazione, poi la signora
Michaud coprì il letto con un grande lenzuolo per proteggere dalla polvere
la seta rosa un po’ scolorita che lo rivestiva.
"É ora di andare" disse il marito.
"Comincia a scendere, ti raggiungo subito" rispose lei con voce alterata.
Lui obbedì e la lasciò sola. La signora Michaud entrò nella camera di
Jean-Marie. Tutto era silenzioso, buio, funebre, dietro le imposte chiuse. Si
inginocchiò un attimo vicino al letto, disse a voce alta:
"Mio Dio, proteggilo", poi chiuse la porta e scese.
Il marito la aspettava sulla scala. L'attirò a sé e, senza una parola,
l'abbracciò forte, così forte che lei si lasciò sfuggire un gridolino di dolore.
"Oh! Maurice, mi fai male!"
"Non importa" mormorò lui con voce roca.
In banca gli impiegati, riuniti nel grande vestibolo, ciascuno con il suo
fagottino sulle ginocchia, si scambiavano sottovoce le ultime notizie.
Corbin non c'era. Il capo del personale assegnava progressivamente a
ognuno un numero, e ognuno, quando sentiva chiamare il proprio, doveva
salire sull'automobile che gli era stata destinata.
Fino a mezzogiorno, le partenze si svolsero in buon ordine e quasi in
silenzio. Alle dodici in punto entrò Corbin: andava di fretta e aveva un'aria
imbronciata. Scese nel caveau e risalì con un pacchetto tenuto seminascosto
sotto un soprabito. La signora Michaud sussurrò all'orecchio del marito:
"Sono i gioielli di Ariette. Quelli di sua moglie li ha presi l'altro ieri"
"Speriamo che non si dimentichi di noi" sospirò Maurice, ironico e
preoccupato a un tempo.
La signora Michaud si piazzò risolutamente sulla traiettoria di Corbin.
"É inteso che noi partiamo in macchina con lei, vero, signor direttore?"
Lui fece segno di sì e li invitò a seguirlo. Il signor Michaud afferrò la
valigia e tutti e tre uscirono. La macchina di Corbin era pronta, ma quando
le si accostarono Michaud, strizzando gli occhi miopi, disse con la sua voce
dolce e un po’ strascicata:
"A quel che vedo il nostro posto è già occupato"
Ariette Corail, il suo cane e le sue valigie occupavano il sedile posteriore.
La donna aprì la portiera e gridò furente:
"Pensavi forse di lasciarmi in mezzo alla strada?"
Scoppiò una bella lite di coppia. I Michaud, che si erano allontanati di
qualche passo, ne colsero tuttavia ogni parola.
"Ma a Tours devo raggiungere mia moglie" gridò alla fine Corbin
allungando una pedata al cane.
Il cane lanciò un ululato e si rifugiò tra le gonne di Ariette.
"Bruto!"
"Ma taci, per favore! Se l'altro ieri tu non fossi andata a zonzo con quegli
aviatori inglesi... altri due che vorrei vedere annegati...".
Lei continuava a ripetere: "Bruto! Bruto!" con voce sempre più stridula.
Poi, di colpo, annunciò con la massima calma:
"A Tours ho un amico. Di te non avrò più bisogno".
Corbin le scoccò un'occhiataccia ma sembrò decidersi. Si girò verso i
Michaud.
"Mi dispiace ma, come vedete, non ho posto per voi. La macchina della
signora Corail ha avuto un incidente e la signora mi prega di darle un
passaggio fino a Tours. Non posso rifiutare. Avete un treno fra un'ora.
Ci sarà ressa ma è un viaggio così breve... Comunque, fate in modo di
raggiungerci al più presto. Conto su di lei, signora Michaud, che è più
energica di suo marito. E lei, Michaud, dovrà mostrarsi più dinamico"
sillabò con forza la parola di-na-mi-co "di quanto lo è stato negli ultimi
tempi. Non tollererò più alcuna negligenza. Se lo tenga per detto, se vuole
conservare il posto. Trovatevi tutti e due a Tours dopodomani al più tardi.
Ho bisogno di avere il personale al completo".
Fece loro un piccolo cenno con la mano, salì vicino alla ballerina e la
macchina partì. I Michaud, fermi sul marciapiede, si guardarono in faccia.
"Ha trovato la formula giusta" disse Michaud con la sua voce un po’
indolente e alzando appena le spalle. "Strapazzare chi ha motivo di
lamentarsi di voi è sempre una buona tattica!"
Nonostante tutto, si misero a ridere.
"E adesso che facciamo?"
"Torniamo a casa a mangiare" disse la moglie con rabbia.
Il loro appartamento era fresco, trovarono la cucina con le tapparelle
abbassate, i mobili coperti da fodere. Tutto aveva un'aria intima, amichevole
e gentile, come se una voce sussurrasse nell'ombra: "Vi aspettavamo. É tutto
in ordine".
"Rimaniamo a Parigi" propose Maurice.
Erano seduti sul divano del salotto e lei, con gesto familiare, gli
accarezzava le tempie con le sue mani magre e delicate.
"É impossibile, mio povero caro, dobbiamo vivere, e sai bene che non ci è
rimasto un soldo da parte dopo la mia operazione. Mi restano solo
centosettantacinque franchi alla Cassa di Risparmio, e Corbin coglierà al
volo questa occasione per metterci alla porta. Vista la situazione, tutte le
aziende ridurranno il personale. Dobbiamo arrivare a Tours a ogni costo"
"Credo che sarà impossibile"
"Dobbiamo" ripeté lei.
Ed era già in piedi, si rimetteva il cappello e afferrava di nuovo la valigia.
Uscirono e si diressero alla volta della stazione.
Non riuscirono a entrare neanche nel grande atrio: le porte erano chiuse,
sprangate, e piantonate dall'esercito che teneva a bada la folla pigiata contro
le sbarre. Rimasero lì fino a sera lottando invano.
Intorno a loro tutti dicevano:
"Pazienza. Andremo a piedi".
Lo dicevano con una sorta di desolato stupore. Era chiaro che non ci
credevano. Si guardavano intorno e aspettavano il miracolo: una macchina,
un camion, un mezzo qualsiasi che li avrebbe presi a bordo. Ma niente di
tutto questo si presentava al loro sguardo. Allora si avviarono verso le porte
di Parigi, le varcarono trascinandosi dietro i bagagli nella polvere;
camminavano, si inoltravano nei sobborghi, poi nella campagna e
pensavano: "É un sogno!"
Come gli altri, anche i Michaud si erano messi in cammino. Era una calda
notte di giugno. Davanti a loro una donna con l'acconciatura da lutto tutta di
traverso sui capelli bianchi incespicava sulle pietre della strada e
gesticolando come una pazza borbottava: "Ringraziate il Cielo che la nostra
fuga non avviene d'inverno... Pregate... Pregate!".
CAPITOLO 9.
La notte dall'11 al 12 giugno Gabriel Corte e Florence la passarono in
macchina. Erano arrivati intorno alle sei di sera e l'albergo non disponeva
più che di due piccole stanze afose sotto i tetti. Gabriel le attraversò
entrambe a grandi passi furibondi, aprì violentemente le finestre, si sporse
un istante dal davanzale illuminato, si raddrizzò e disse conciso:
"Qui non ci resto"
"Non abbiamo nient'altro, signore, sono desolato. Pensi che con questa
folla di profughi facciamo dormire la gente sui tavoli da biliardo" disse il
direttore, pallido e sfinito. "É proprio per venirle incontro!"
"Qui non ci resto" ripeté Gabriel scandendo le parole con voce metallica,
quella che adottava per troncare le discussioni con gli editori quando, già
sulla porta, buttava là: "A queste condizioni, signore, non vedo alcuna
possibilità d'intesa!" L'editore allora cedeva e, da ottanta, saliva a centomila
franchi.
Ma il direttore si limitò a scuotere tristemente il capo.
"Non ho nient'altro, niente di niente"
"Ma lo sa chi sono io?" domandò Gabriel tutt'a un tratto minacciosamente
calmo. "Sono Gabriel Corte e la informo che preferisco dormire in
macchina che in questa trappola per topi"
"Quando uscirà di qui, signor Corte," ribatté il direttore, offeso "troverà
sul pianerottolo le dieci famiglie che mi stanno supplicando in ginocchio di
dar loro questa camera"
Corte scoppiò in una gran risata teatrale, gelida e sprezzante.
"Non gliela contenderò di certo. Addio, signore".
A nessuno, neppure a Florence che lo aspettava nella hall, avrebbe
confessato la vera ragione per cui aveva rifiutato quella camera.
Avvicinandosi alla finestra aveva visto lì vicino, nella notte trasparente di
giugno, un serbatoio di benzina e, un po’ più in là, qualcosa come dei carri
armati e delle autoblindo parcheggiati sulla piazza.
"Ci bombarderanno!" si era detto, e un tremito lo aveva scosso, così
profondo e violento da fargli pensare: "Mi sono ammalato, ho la febbre"
Era paura? Lui, Gabriel Corte? No, non poteva avere paura, lui. Suvvia!
E sorrise con disprezzo e commiserazione, come rispondendo a un
interlocutore invisibile. Certo che non aveva paura, ma quando si era sporto
ancora una volta dalla finestra e aveva visto quel cielo buio da cui il fuoco e
la morte potevano cadergli addosso da un momento all'altro aveva provato
di nuovo quella sensazione orrenda, dapprima quel tremito nelle ossa e poi
quella estenuazione, quella nausea, quel contrarsi delle viscere che precede
lo svenimento. Paura o no, che importava! Ma ora fuggiva da lì, seguito da
Florence e dalla cameriera.
"Dormiremo in macchina," disse "una notte passa in fretta!"
Più tardi pensò che avrebbero potuto scegliere un altro albergo, ma,
mentre ci rifletteva, era già troppo tardi: sulla strada da Parigi scorreva
lentamente un fiume di macchine, di camion, di barrocci, di biciclette e carri
di contadini che abbandonavano le loro fattorie e andavano verso sud
portandosi dietro greggi e bambini. A mezzanotte in tutta Orleans non c'era
una camera libera, non un letto. La gente dormiva per terra nelle sale dei
caffè, nelle strade, nelle stazioni, con la testa appoggiata alla valigia.
L'ingorgo era tale che uscire dalla città era diventato impossibile. Correva
voce che fosse stato creato uno sbarramento per lasciare la strada libera ai
soldati.
Senza rumore, a fari spenti, le macchine arrivavano una dietro l'altra,
piene zeppe, sovraccariche di bagagli e di mobili, di carrozzine e di gabbie
di uccelli, di casse e di ceste portabiancheria, ciascuna con il suo bravo
materasso solidamente fissato sul tetto. Erano come tante fragili impalcature
e sembravano avanzare fino alla piazza senza l'aiuto del motore, portate dal
proprio peso giù per le strade in pendenza.
Adesso bloccavano tutte le uscite e stavano pigiate le une contro le altre
come pesci presi in una nassa: e allo stesso modo pareva che tirando le reti
le si potesse raccogliere insieme e ributtare verso un'orrida riva. Non si
udivano pianti né grida, anche i bambini tacevano. Tutto era calmo. Ogni
tanto da un finestrino abbassato si sporgeva un viso che scrutava a lungo il
cielo. Da quell'assembramento saliva un rumore sordo e indistinto, un
insieme di respiri difficoltosi, di sospiri, di parole scambiate sottovoce come
per paura di essere ascoltati da un nemico in agguato. Qualcuno cercava di
dormire, la fronte contro lo spigolo di una valigia, le gambe indolenzite
sullo stretto sedile o la guancia bruciante premuta contro il vetro del
finestrino. Alcuni giovani e alcune donne si rivolgevano la parola da una
vettura all'altra, e qualche volta ridevano allegramente. Ma non appena una
macchia scura passava sul cielo scintillante di stelle tutti si facevano attenti
e le risate cessavano. Non era esattamente inquietudine ma una strana
tristezza che non aveva più niente di umano, perché non portava con sé né
coraggio né speranza: è così che gli animali aspettano la morte. Ed è così
che il pesce preso nelle maglie della rete vede passare e ripassare l'ombra
del pescatore.
L'aereo era spuntato all'improvviso sopra le loro teste, ne udivano il
rumore sommesso e stridente che ora si allontanava, si perdeva, ora tornava
a sovrastare i mille suoni della città lasciando tutti ansimanti e senza fiato. Il
fiume, il ponte di metallo, le rotaie della strada ferrata, la stazione, i camini
delle fabbriche brillavano debolmente: tanti "punti strategici", tanti bersagli
da colpire. E per quella folla silenziosa, altrettanti rischi! Gli ottimisti
dicevano: "Credo che sia francese!" Francese? Nemico? Nessuno lo sapeva.
Ma ecco che spariva. A volte si udiva un'esplosione in lontananza: "Non è
per noi" pensava la gente con un sospiro di sollievo: "Non è per noi, è
toccato agli altri.
Siamo fortunati!"
"Che notte! Che notte!" gemeva Florence.
Con voce quasi impercettibile, una sorta di sibilo che gli usciva dalle
labbra serrate, Gabriel, al modo in cui si getta un osso a un cane, le buttò lì:
"Forse che dormo, io? Fa come me"
"Ma insomma, l'avevamo pure una camera! Avevamo la fortuna inaudita
di avere una camera!"
"E la chiami una fortuna inaudita? Quel sordido abbaino che puzzava di
cimici e di risciacquatura di piatti! Non ti sei accorta che si trovava sopra le
cucine? Io là dentro? Mi ci vedi, là dentro?"
"Insomma, Gabriel, ne fai una questione di amor proprio"
"Ma lasciami in pace! L'ho sempre pensato... ci sono sfumature, ci
sono..." cercò le parole "... pudori che tu non avverti".
"Quello che avverto è un gran male al sedere" gridò Florence cancellando
di colpo gli ultimi cinque anni della sua vita, e con la mano ingioiellata si
dette una pacca sulla coscia con vigore plebeo. "Ne ho abbastanza, sai!"
Gabriel girò verso di lei il suo volto livido di rabbia e dalle narici
palpitanti. "Sparisci allora! Su, fuori dai piedi!".
In quel preciso istante una luce improvvisa e violenta illuminò la piazza.
Un missile partito da un aereo. A Gabriel le parole morirono sulle labbra. Il
missile si spense ma il cielo parve riempirsi di aerei.
Passavano e ripassavano sopra la piazza, senza fretta si sarebbe detto.
"E i nostri, dove sono?" brontolava la gente.
Alla sinistra di Corte c'era una piccola automobile malconcia che portava
sul tetto, oltre al solito materasso, un tavolino da salotto, rotondo, dai
pesanti e volgari fregi di bronzo. All'interno sedevano un uomo con il
berretto in testa e due donne, una che teneva sulle ginocchia un bambino e
l'altra una gabbia di uccelli. Dovevano aver avuto un incidente lungo la
strada. La carrozzeria era graffiata, il paraurti sfondato, e il donnone che
teneva stretta al petto la gabbia degli uccelli aveva la testa fasciata con
pezze di tela.
Gabriel vide alla sua destra un camioncino carico di quelle cassette in cui
i contadini trasportano il pollame nei giorni di mercato e che al momento
erano piene di stracci, e alla portiera dalla sua parte scorse la faccia di una
vecchia prostituta dai capelli arancione, scarmigliati, la fronte bassa e truce,
gli occhi bistrati. Lo fissava con insistenza masticando un tozzo di pane.
Gabriel rabbrividì.
"Quante brutture," mormorò "che volti ripugnanti!"
Profondamente depresso, si girò verso l'interno dell'auto e chiuse gli
occhi.
"Io ho fame," disse Florence "e tu?"
Gabriel fece segno di no.
Lei aprì la valigetta e tirò fuori qualche panino.
"Stasera non hai cenato. Dammi retta. Sii ragionevole".
"Non posso mangiare" disse lui. "Credo che non potrò più ingoiare un
boccone. Hai visto quell'orrenda vecchia dall'altra parte, con la sua gabbia
di uccelli e le pezze sporche di sangue?"
Florence prese un panino e divise gli altri fra la cameriera e l'autista.
Gabriel si mise le belle mani affusolate sulle orecchie per non sentire il
crocchiare del pane sotto i denti dei domestici.
CAPITOLO 10.
I Pericand erano in viaggio da circa una settimana: un tragitto irto di
ostacoli. Un guasto alla macchina li aveva bloccati per due giorni a Gien.
Più avanti, nei pressi di Nevers, in mezzo alla confusione e all'incredibile
calca, l'auto era andata a sbattere contro il camioncino che trasportava i
domestici e i bagagli. Fortunatamente per i Pericand quello non era un buco
di provincia in cui fosse impossibile trovare con facilità qualche amico o
qualche parente, gente che disponeva di grandi case, bei giardini e armadi
pieni di ogni ben di Dio. Un cugino del ramo Maltête di Lione li aveva
ospitati per quarantott'ore. Ma il panico cresceva, si diffondeva da una città
all'altra come un incendio.
L'automobile fu riparata alla meno peggio e i Pericand ripartirono. Ma il
sabato a mezzogiorno fu purtroppo chiaro che la macchina non avrebbe
potuto proseguire senza una vera riparazione. I Pericand si fermarono allora
in una cittadina un po’ fuori mano rispetto alla strada statale, dove
speravano di trovare una camera libera. Ma le strade già erano intasate da
ogni sorta di veicoli e nell'aria echeggiava lo stridore dei freni sottoposti a
dura prova. La piazza antistante al fiume sembrava un accampamento di
zingari: uomini esausti dormivano per terra, altri si lavavano sul prato. Una
giovane donna aveva fissato un piccolo specchio a un albero e, in piedi, si
truccava e si pettinava. Un'altra lavava alla fontana delle fasce per neonati.
Gli abitanti del posto erano usciti sulle soglie delle case e contemplavano
quello spettacolo con un'espressione di profondo stupore.
"Poveracci! Cosa ci tocca vedere!" dicevano compassionevoli ma con una
certa intima soddisfazione: quei profughi venivano da Parigi, da nord, da
est, da province destinate all'invasione e alla guerra. Ma loro, lì, potevano
stare tranquilli, i giorni sarebbero passati, i soldati avrebbero combattuto, e
intanto il negoziante di ferramenta del corso e la signorina Dubois, la
merciaia, avrebbero continuato a vendere rispettivamente pentole e nastri, a
mangiare la minestra calda in cucina e di sera a chiudere il cancelletto di
legno che separava il loro giardino dal resto del mondo.
Le automobili aspettavano che facesse giorno per rifornirsi di benzina,
che ormai scarseggiava. I residenti chiedevano notizie agli sfollati, lì non si
sapeva niente. Qualcuno dichiarò che "ci si aspettava di veder arrivare i
tedeschi sui monti del Morvan", parole accolte con un certo scetticismo.
"Ma via! Nel '14 non si sono spinti tanto lontano" disse il corpulento
farmacista scuotendo il capo, e tutti approvarono come se il sangue versato
nel '14 costituisse per sempre uno sbarramento mistico contro il nemico.
Arrivavano altre macchine, e altre ancora.
"Che aria stanca e accaldata hanno!" ripeteva la gente, ma nessuno
prendeva l'iniziativa di aprire la porta, di accogliere qualcuno di quegli
infelici, di farlo entrare in uno di quei piccoli paradisi ombreggiati che si
intravedevano vagamente dietro ogni casa, con la panca di legno sotto una
pergola, le piante di ribes e le rose. I profughi erano troppi. Troppi i volti
stanchi, lividi, sudati, troppi i bambini che piangevano, troppe le bocche
tremanti che chiedevano:
"Sapete dove si possa trovare una camera? un letto?", "Potrebbe indicarci
un ristorante, signora?" Tutto questo toglieva la voglia di mostrarsi
caritatevoli. Quella folla miserabile non aveva più niente di umano,
somigliava a un branco di animali in rotta. Una strana uniformità li
accomunava: i vestiti stazzonati, le facce sconvolte, le voci arrochite, tutto li
rendeva simili. Facevano gli stessi gesti, pronunciavano le stesse parole.
Scendendo dalla macchina vacillavano un po’, come ubriachi, e si
portavano le mani alla fronte e alle tempie doloranti. "Dio mio, che
viaggio!" dicevano sospirando. E con un sogghigno: "Siamo belli, vero?"
Poi, mostrando da sopra la spalla un punto invisibile, aggiungevano: "Pare
comunque che là le cose vadano meglio"
La signora Pericand fece fermare la sua carovana in un piccolo caffè nei
pressi della stazione. Là aprirono un cesto di provviste e ordinarono della
birra. A un tavolo accanto al loro un bel ragazzino vestito elegantemente ma
con il soprabito verde tutto spiegazzato stava mangiando con aria pacifica
una fetta di pane. Vicino a lui, in una cesta per la biancheria posata su una
sedia, un bambino piccolo urlava.
La signora Pericand, che aveva l'occhio esperto, si rese subito conto che
quei bambini erano di buona famiglia e che si poteva parlare con loro. Si
rivolse quindi con gentilezza al ragazzino e quando apparve sua madre
attaccò discorso anche con lei; era di Reims, e lanciò uno sguardo d'invidia
alla ricca merenda dei giovani Pericand.
"Vorrei pane e cioccolata, mamma" disse il ragazzino in verde.
"Non ne ho di cioccolata, povero tesoro" rispose la donna prendendo il
piccolino sulle ginocchia per cercare di calmarlo. "Non ho avuto il tempo di
andare a comprarla, ma stasera, dalla nonna, avrai un buon dessert"
"Mi permette di offrirle dei biscotti?"
"Oh, signora, lei è troppo gentile!"
"Ma prego...".
Parlavano nel tono più gaio e più cortese, con i gesti e i sorrisi dei tempi
normali quando si accetta o si rifiuta un pasticcino e una tazza di tè. Intanto
il piccolino urlava; nel caffè c'era un flusso continuo di profughi con i loro
figli, i loro bagagli, i loro cani. Uno di questi fiutò l'odore del gatto Albert che stava nella cesta - e si precipitò abbaiando festoso sotto il tavolo dei
Pericand, davanti al quale il ragazzino in verde mangiava imperturbabile i
suoi biscotti.
"Jacqueline, tu hai dei bastoncini di zucchero d'orzo nello zainetto" disse
la signora Pericand con un gesto discreto della mano e uno sguardo che
voleva dire: "Sai bene che bisogna dividere quello che abbiamo con chi non
ha niente e darsi aiuto a vicenda nella sventura. É il momento di mettere in
pratica quello che ti hanno insegnato al catechismo"
Il sentirsi così privilegiata, così ricca di risorse, e insieme così
caritatevole, la riempiva di intima soddisfazione. Questo faceva onore alla
sua lungimiranza e al suo buon cuore. E offrì i bastoncini di zucchero
d'orzo, oltre che al ragazzino, a una famiglia belga che era arrivata con un
camioncino carico di polli in gabbia. Aggiunse dei panini con l'uva per i
bambini. Poi si fece portare dell'acqua bollente e preparò un infuso leggero
per il vecchio Pericand. Hubert era andato a vedere se si trovavano delle
camere. La signora Pericand uscì e chiese la strada: cercava la chiesa, che si
trovava nel centro della città.
Intere famiglie erano accampate sui marciapiedi e sui gradini di pietra.
La chiesa era bianca, nuovissima, profumava ancora di pittura fresca. E
viveva, all'interno, di una duplice vita: il normale, pacifico tran-tran di ogni
giorno e un'altra esistenza insolita e febbrile. In un angolo, una suora
cambiava i fiori ai piedi della Vergine. Senza fretta, con un sorriso placido e
dolce, tagliava i gambi appassiti e faceva grossi mazzi di rose fresche; si
sentiva il colpo secco delle forbici e il suo passo tranquillo sui lastroni di
pietra. Poi si apprestò a togliere il moccolo alle candele. Un prete anziano si
avviava verso il confessionale; una vecchia dormiva su una sedia con il
rosario fra le dita. Davanti alla statua di Giovanna d'Arco c'erano molte
candele accese, e sotto tutto quel sole, nel bianco abbagliante dei muri, tutte
quelle fiammelle danzavano, pallide e trasparenti. Su una lastra di marmo
tra due finestre scintillavano le lettere d'oro che formavano i nomi dei caduti
del '14.
Nel frattempo, però, una folla sempre più grande prendeva d'assalto la
chiesa come un'ondata. Donne e bambini venivano a ringraziare Dio per
essere arrivati fin là o a implorare il suo favore per il resto del viaggio; chi
piangeva, chi era ferito e aveva la testa fasciata o un braccio bendato. I loro
volti erano cosparsi di chiazze rosse, e tutti avevano i vestiti sgualciti,
sporchi e strappati quasi che chi li indossava avesse dormito per diverse
notti senza spogliarsi. Su certe facce livide, grigie di polvere, grosse gocce
di sudore colavano come lacrime. Le donne entravano precipitosamente,
irrompevano nella chiesa come in un rifugio inviolabile. Sovreccitate e
febbrili, sembravano incapaci di stare ferme. Andavano da un
inginocchiatoio all'altro, si genuflettevano, si rialzavano, alcune urtavano
contro le sedie con aria timorosa e smarrita, simili a uccelli notturni in una
stanza piena di luce. Ma a poco a poco si calmavano, nascondevano il volto
nelle mani e, stremate e sfinite dal pianto, finalmente trovavano pace
davanti al grande crocifisso di legno nero.
Recitate le sue preghiere, la signora Pericand uscì dalla chiesa. Una volta
fuori pensò di impinguare la scorta di biscotti secchi fortemente intaccata
dalla sua prodigalità. Entrò in una grande drogheria.
"Non abbiamo più niente, signora" disse la commessa.
"Ma come! Neanche un biscotto, un po’ di pan pepato, niente?"
"Proprio così, signora. Tutto esaurito".
"Mi dia una libbra di tè, allora, di Ceylon naturalmente"
"Niente da fare, signora"
La signora Pericand si fece indicare altri negozi di alimentari, ma da
nessuna parte poté comprare qualcosa. Gli sfollati avevano saccheggiato la
città. Vicino al caffè, fu raggiunta da Hubert che non aveva trovato neanche
una camera libera.
"Non c'è niente da mangiare, i negozi sono vuoti!" esclamò la signora
Pericand.
"Io invece" disse Hubert "ne ho scoperti due ben forniti"
"Ah, sì? Davvero? E dove?"
Hubert rise di cuore.
"In uno si vendevano pianoforti e nell'altro articoli funerari!"
"Come sei stupido, ragazzo mio" disse la madre.
"Credo che, per come vanno le cose," osservò Hubert "anche le corone
mortuarie saranno molto richieste. Potremmo farne una scorta, non credi,
mamma?"
La signora Pericand si limitò a fare spallucce. Sulla porta del caffè vide
Jacqueline e Bernard che distribuivano a piene mani cioccolatini e
caramelle. La madre fece un balzo.
"Che cosa fate qui? Su, tornate dentro! Vi proibisco di avvicinarvi alle
provviste. Jacqueline, tu sarai punita. E quanto a te, Bernard, lo dirò a tuo
padre" ripeteva, ferma come una roccia, trascinando per mano i due
colpevoli stupefatti. La carità cristiana, la mitezza di secoli di civiltà le
cadevano di dosso come vani orpelli rivelando un'anima arida e nuda. Lei e
i suoi figli erano soli in un mondo ostile. Doveva nutrire e proteggere i suoi
piccoli. Il resto non contava più.
CAPITOLO 11.
Maurice e Jeanne Michaud camminavano l'uno dietro l'altro sulla strada
spaziosa costeggiata da un filare di pioppi, ed erano circondati, preceduti,
seguiti da una moltitudine di fuggiaschi. Quando arrivavano su uno dei
dossi che interrompevano a intervalli il percorso, vedevano all'orizzonte, fin
dove poteva arrivare lo sguardo, una massa confusa di gente che trascinava i
piedi nella polvere. I più fortunati possedevano una carriola, una carrozzina,
un carrello fatto di quattro assi montate su ruote sbilenche per trasportare i
loro bagagli, e procedevano curvi sotto il peso di sacchi, di stracci, di
bambini addormentati. Erano i poveri, gli sfortunati, i perdenti, quelli che
non sanno trarsi d'impiccio, quelli che vengono respinti dovunque, che
restano sempre in fondo, nell'ultima fila. E con loro alcuni indecisi, alcuni
avari che avevano recalcitrato fino all'ultimo istante, spaventati dal prezzo
del biglietto, dalle spese e dai rischi del viaggio. Ma che poi, all'improvviso,
erano stati presi dal panico come gli altri. Non sapevano perché fuggivano:
la Francia tutta era in fiamme, il pericolo ovunque. E certo non sapevano
dove stessero andando. Quando si lasciavano cadere a terra, dicevano che
non si sarebbero più rialzati, che sarebbero crepati lì, che morire per morire
tanto valeva starsene in pace. Ed erano i primi a scattare in piedi appena si
avvicinava un aereo. Fra loro vigeva un patto di solidarietà, un senso di
pietà, una simpatia attiva e vigile che la gente del popolo testimonia solo nei
confronti della propria classe, quella dei poveri, e anche questo solo in
momenti eccezionali di pericolo e di carestia. Già una decina di volte certe
robuste comari avevano offerto il braccio a Jeanne Michaud per aiutarla a
camminare. Lei stessa teneva per mano alcuni bambini mentre suo marito si
caricava sulle spalle ora un fagotto di biancheria, ora una cesta che
conteneva un coniglio vivo e delle patate, i soli beni terreni di una
vecchietta partita a piedi da Nanterre. Malgrado la stanchezza, la fame, la
preoccupazione, Maurice Michaud non si sentiva troppo infelice. Aveva una
struttura mentale particolare, non attribuiva molta importanza alla propria
persona: non era, ai suoi occhi, quella creatura rara e insostituibile che ogni
uomo vede quando pensa a se stesso. Per quei compagni di sventura
provava pietà, ma una pietà lucida e fredda. Dopo tutto, pensava, queste
grandi migrazioni umane sembrano governate da leggi naturali. Certi
periodici spostamenti di massa probabilmente sono necessari alle
popolazioni come la transumanza lo è per le greggi. E trovava in questo uno
strano conforto. Quella gente intorno a lui credeva che la sorte si accanisse
in particolare su di loro, sulla loro disgraziata generazione, ma lui ricordava
che gli esodi si erano sempre verificati, in ogni periodo. Quanti uomini
erano caduti su quella terra (come su tutte le terre del mondo) piangendo
lacrime di sangue, fuggendo il nemico, lasciando città in fiamme,
stringendosi al petto i figli... Eppure nessuno aveva mai pensato a tutti quei
morti con partecipazione affettuosa: per i loro discendenti non contavano
più di polli sgozzati. Immaginò le loro ombre dolenti materializzarsi davanti
a lui sulla strada e mormorargli all'orecchio:
"Abbiamo conosciuto tutto questo prima di te. Perché dovresti essere più
fortunato di noi?"
Vicino a lui, una grassa comare gemeva:
"Non si è mai visto un orrore simile!"
"Si è visto, signora, si è visto" rispose lui con dolcezza.
Camminavano da tre giorni quando videro i primi reggimenti in rotta. Nel
cuore dei francesi la fiducia era così totale e profonda che, scorgendo i
soldati, i profughi pensarono che ci si apprestasse a combattere, che il
Comando Supremo avesse dato ordine di far convergere verso il fronte, a
piccoli gruppi( per vie secondarie, le forze armate ancora incolumi.
Questa speranza li confortava. I soldati non si mostravano loquaci.
Quasi tutti erano cupi e pensierosi. Alcuni dormivano in fondo ai camion.
I carri armati avanzavano pesanti nella polvere, mimetizzati con frasche
leggere. Tra le foglie avvizzite dal sole rovente spuntavano volti pallidi,
sfiniti, sui quali si leggeva la rabbia e una stanchezza mortale.
La signora Michaud credeva continuamente di riconoscere in mezzo a
loro suo figlio. In realtà non vide mai il numero del suo reggimento, ma era
in preda a una sorta di allucinazione: ogni volto sconosciuto, ogni sguardo,
ogni voce giovane che le arrivava all'orecchio la faceva trasalire, tanto che
si fermava di colpo e si portava la mano al cuore mormorando debolmente:
"Oh, Maurice, non è...".
"Cosa?"
"No, niente...".
Ma lui aveva capito. Scuoteva il capo.
"Vedi tuo figlio dappertutto, mia povera Jeanne!"
Lei si limitava a sospirare.
"Ma gli assomiglia, non trovi?"
Dopo tutto, poteva anche capitare. Suo figlio, il suo JeanMarie sfuggito
alla morte, poteva apparire improvvisamente lì, vicino a lei, esclamando con
la sua voce tenera e allegra, quella voce maschia e dolce che le pareva
ancora di sentire: "Ma che cosa ci fate qui tutti e due?"
Oh, vederlo soltanto, stringerselo al cuore, sentire la sua guancia fresca e
ruvida, veder brillare da vicino i suoi begli occhi, quello sguardo vivo e
penetrante! Aveva occhi nocciola dalle lunghe ciglia femminili, che
vedevano tante cose! Gli aveva insegnato fin da bambino a cogliere il lato
comico e commovente del prossimo. A lei piaceva ridere e provava pietà
per gli altri - "il tuo lato dichensiano, mammina" diceva lui. Come si
capivano, loro due! Prendevano in giro allegramente, crudelmente a volte,
le persone di cui avevano motivo di lamentarsi; poi una parola, un gesto, un
sospiro li disarmava. Maurice era diverso: più sereno, più freddo. Lei amava
e ammirava Maurice, ma Jean-Marie era... oh, mio Dio, tutto quello che lei
avrebbe voluto essere, tutto quello che aveva sognato, e la parte migliore di
se stessa: era la sua gioia, la sua speranza... "Figlio mio, mio tesoro, mio
Jeannot" pensava, dandogli ancora il soprannome che aveva a cinque anni,
quando gli prendeva dolcemente le orecchie per baciarlo, rovesciandogli la
testa all'indietro e facendogli il solletico con le labbra mentre lui scoppiava
a ridere.
A mano a mano che procedeva lungo la strada i suoi pensieri si facevano
più febbrili e confusi. Era una buona camminatrice: ai tempi in cui lei e
Maurice erano più giovani passavano spesso le loro brevi vacanze
girovagando per la campagna zaino in spalla. Quando non avevano
abbastanza denaro per l'albergo, si mettevano in marcia a piedi con il sacco
a pelo e qualche provvista. Perciò sentiva la fatica meno dei suoi compagni
di sventura, ma quel caleidoscopio ininterrotto, quei volti sconosciuti che la
sorpassavano, che spuntavano di colpo, poi si allontanavano e sparivano le
provocavano una sensazione più dolorosa della stanchezza fisica. "Un
carosello in una trappola" pensava. In mezzo alla folla, le macchine
restavano imprigionate come quei fili d'erba che si vedono galleggiare
sull'acqua, trattenuti da lacci invisibili mentre il torrente scorre tutt'intorno.
Jeanne si voltava dall'altra parte per non vederle. Avvelenavano l'aria con
l'odore di benzina, assordavano i pedoni con il vano clamore dei clacson,
invocando un passaggio che era impossibile concedere loro. Lo spettacolo
della rabbia impotente dei conducenti o della loro cupa rassegnazione era un
balsamo per i profughi appiedati, che dicevano: "Non vanno più in fretta di
noi!", e il sentimento di una comune sventura confortava i loro cuori.
I fuggiaschi camminavano a piccoli gruppi. Il caso li aveva messi insieme
alle porte di Parigi e adesso non si separavano, anche se nessuno conosceva
il nome di chi gli camminava accanto. Con i Michaud c'era una donna alta e
magra che indossava un misero soprabito logoro e una gran quantità di
gioielli falsi. Jeanne si domandava vagamente quale impulso potesse
spingere qualcuno a fuggire portando alle orecchie due grosse perle finte
circondate da una miriade di brillantini, alle dita pietre verdi e rosse, e sulla
camicetta una spilla di strass adorna di piccoli topazi. Poi venivano una
portinaia e sua figlia, la madre piccola e pallida, la figlia tarchiata e robusta,
tutte e due vestite di nero. Camminavano portandosi dietro, nei loro bagagli,
la fotografia di un omone dai lunghi baffi neri: "Mio marito, guardiano del
cimitero" spiegava la donna. La accompagnava la sorella incinta che
spingeva una carrozzina con un bambino. Ed era giovane, quella! Anche lei,
a ogni convoglio di militari che passava, trasaliva e cercava qualcuno. "Mio
marito è laggiù" diceva. Laggiù o forse qui... tutto era possibile. E
Jeanne le confidava, forse per l'ennesima volta, sebbene ormai non
sapesse più esattamente quello che diceva: "Anche mio figlio, anche il
mio...".
Ancora non erano stati presi di mira dalle mitragliatrici. Quando accadde,
sulle prime non capirono niente. Sentirono il fragore di un'esplosione, poi di
un'altra, e delle grida: "Si salvi chi può! A terra! Giù, mettetevi giù!" Si
buttarono all'istante faccia a terra, e Jeanne pensava confusamente: "Come
dobbiamo essere grotteschi!" Non aveva paura, ma il cuore le batteva così
forte che se lo premeva, ansimante, con tutte e due le mani e lo teneva
appoggiato contro una pietra. Sentiva un filo d'erba con in cima una
campanula rosa sfiorarle la bocca, e in seguito si ricordò che mentre stavano
distesi lì una farfallina bianca volava senza fretta da un fiore all'altro.
Finalmente sentì una voce che le diceva all'orecchio: "É finita, se ne sono
andati" Si rialzò e si rassettò meccanicamente la gonna impolverata.
Nessuno, così almeno le parve, era stato colpito. Ma ripreso il cammino
videro i primi morti: due uomini e una donna. I loro corpi erano dilaniati,
ma stranamente i volti erano rimasti intatti, volti così scialbi, così banali,
con un'espressione meravigliata, compunta e stupida come se cercassero
invano di capire cosa gli stava succedendo - così poco all'altezza di una
morte guerriera, mio Dio, così poco all'altezza della morte. La donna, in
tutta la sua vita, doveva aver pronunciato solo frasi del tipo: "I porri sono
ancora aumentati di prezzo", oppure: "Chi è quel sudicione che ha sporcato i
miei vetri?"
Ma che ne posso sapere, disse Jeanne tra sé. Forse dietro quella fronte
bassa, sotto quei capelli spenti e scarmigliati c'erano tesori di intelligenza e
di tenerezza. E cos'altro siamo noi, io e Maurice, agli occhi della gente se
non una coppia di poveri impiegatucci? In un senso è vero, ma in un altro
siamo esseri preziosi e rari. So anche questo.
"Che scialo immondo" pensò ancora.
Si appoggiò alla spalla di Maurice, tremante e con le guance bagnate di
lacrime.
"Andiamo avanti" disse lui trascinandola con dolcezza.
Ma tutti e due pensavano: "Perché?" Non sarebbero mai arrivati a Tours.
La banca esisteva ancora? E chissà, forse Corbin era finito sotto le
macerie con i suoi documenti, i suoi titoli, la sua ballerina... e i gioielli di
sua moglie! Sarebbe troppo bello, pensò Jeanne con un guizzo di ferocia. E
tuttavia, pian pianino, zoppicando, lei e Maurice si rimettevano in marcia.
Non c'era altro da fare che camminare e affidarsi a Dio.
CAPITOLO 12.
Il gruppetto formato dai Michaud e dai loro compagni di strada fu
raccolto il venerdì sera. Un camion militare li prese a bordo.
Viaggiarono per il resto della notte distesi in mezzo alle casse e
arrivarono in una città di cui non avrebbero mai saputo il nome. I binari
della ferrovia erano stati risparmiati, dissero quegli uomini, così avrebbero
potuto arrivare direttamente a Tours. Alla periferia della città Jeanne entrò
nella prima casa che trovò sul suo cammino e chiese di potersi lavare. La
cucina era già affollata di fuggiaschi che sciacquavano i panni nell'acquaio,
ma Jeanne fu fatta entrare nel giardino, dove poté lavarsi azionando la
pompa dell'acqua. Maurice aveva comprato un piccolo specchio fissato a
una catenella; lo appese al ramo di un albero e si fece la barba. Dopodiché si
sentirono meglio, pronti ad affrontare la lunga attesa davanti alla porta della
caserma, dove veniva distribuito un piatto di minestra, e quella, ancora più
lunga, alla stazione, davanti alla biglietteria della terza classe. Dopo aver
mangiato, stavano attraversando la piazza della stazione quando cominciò il
bombardamento. Da tre giorni aerei nemici sorvolavano senza sosta la città.
L'allarme suonava di continuo. Si trattava di un vecchio segnalatore
d'incendio che fungeva da sirena in caso di incursione aerea; nel frastuono
delle automobili, in mezzo alle grida dei bambini e della folla impazzita,
quel debole e assurdo scampanellio lo si udiva a malapena. La gente che
scendeva dal treno domandava: "Ehi, è l'allarme?" "Ma no, è il cessato
allarme" rispondeva qualcuno, e passati cinque minuti il fioco tintinnio si
faceva sentire di nuovo.
Veniva da ridere. Là c'erano ancora negozi aperti, ragazzine che
giocavano a campana sul marciapiede, cani che scorrazzavano nella polvere
vicino all'antica cattedrale. Non ci si preoccupava neanche più degli aerei
italiani e tedeschi che planavano placidi sopra la città.
Alla fine, la gente ci si era abituata.
All'improvviso un veicolo si staccò dal cielo, scese in picchiata sulla folla.
Jeanne pensò: precipita! Poi: ma no, ci mitraglia, ci prende di mira, siamo
perduti... Istintivamente si portò le mani alla bocca per soffocare un grido.
Le bombe erano cadute sulla stazione e un po’ più in là, sulla strada ferrata.
La tettoia di vetro crollò in mille pezzi, che vennero proiettati sulla piazza
ferendo e uccidendo coloro che vi si trovavano. C'erano donne che, in preda
al panico, gettavano via i loro figli come pacchi ingombranti e scappavano.
Altre, invece, li afferravano e li stringevano a sé con tanta forza che
sembrava volessero farli tornare di nuovo nel loro grembo, come se quello
fosse l'unico rifugio sicuro. Un'infelice rotolò ai piedi di Jeanne: era la
donna dai gioielli falsi. Le scintillavano sul petto e sulle dita, e dalla testa
fracassata colava sangue. Quel sangue caldo era schizzato sul vestito di
Jeanne, sulle sue calze e sulle sue scarpe. Fortunatamente lei non ebbe il
tempo di contemplare i morti che aveva intorno. I feriti invocavano aiuto da
sotto le pietre e i vetri in frantumi. Jeanne si unì a Maurice e ad altri uomini
che cercavano di sgombrare le macerie. Ma era un lavoro troppo duro per
lei. Non ce la faceva. Allora pensò a quei poveri bambini che vagavano
sulla piazza cercando la madre. Li chiamò, li prese per mano, li raggruppò
in disparte, sotto il portico della cattedrale, poi tornò in mezzo alla folla e
quando vedeva una donna sconvolta, urlante, che correva come impazzita
da un punto all'altro, le annunciava con voce calma e forte, così calma e così
forte che lei stessa ne era stupita: "I bambini sono sulla porta della chiesa.
Andate a prenderli là. Chi ha perso i propri figli vada a prenderli in chiesa".
E le donne si lanciavano verso la cattedrale. Alcune piangevano, altre
scoppiavano a ridere, altre gettavano una specie di grido selvaggio,
strozzato, che non assomigliava a niente che si fosse udito prima. I bambini
erano molto più quieti. Le loro lacrime si asciugavano in fretta. Le madri se
li portavano via, stretti al cuore. Nessuna pensò a ringraziare Jeanne. Lei
tornò verso la piazza, dove le dissero che la città non aveva subito molti
danni ma che un convoglio sanitario era stato colpito dalle bombe proprio
mentre entrava in stazione. La linea di Tours, però, non era stata
danneggiata; il treno si stava formando in quel momento e sarebbe partito
da lì a un quarto d'ora. Già la gente, dimenticando morti e feriti, si
precipitava verso la stazione aggrappandosi alle valigie e alle cappelliere
come naufraghi ai salvagente. Ci si accapigliava per un posto. I Michaud
videro le prime barelle con i soldati feriti. La ressa era tale che non
riuscirono ad avvicinarsi né a vederli in faccia. Li caricavano su camion, su
macchine civili e militari requisite in tutta fretta. Jeanne vide un ufficiale
andare verso un camion pieno di ragazzi guidati da un prete.
"Mi dispiace molto, reverendo, ma sono costretto a prendere il camion.
Dobbiamo portare i feriti a Blois" sentì dire.
Il prete fece un cenno ai ragazzi che cominciarono a scendere.
L'ufficiale ripeté:
"Mi dispiace proprio, reverendo. É una scuola, vero?".
"Un orfanotrofio"
"Se trovo un po’ di benzina le rimando il camion"
I ragazzi, adolescenti dai quattordici ai diciotto anni, ciascuno con la sua
valigetta in mano, scesero e si raggrupparono intorno al prete.
Maurice si girò verso la moglie.
"Allora, vieni?"
"Sì. Aspetta un momento".
"Ma cosa c'è?"
Jeanne cercava tra le barelle che scorrevano l'una dopo l'altra fendendo la
folla. Ma la ressa era troppa e lei non riusciva a vedere niente. Al suo fianco
un'altra donna si alzava come lei sulla punta dei piedi.
Muoveva le labbra ma non ne usciva alcuna parola chiara e distinta:
pregava, forse, o ripeteva un nome. Guardò Jeanne e disse:
"Si spera sempre di vedere il proprio figlio, è così?"
Jeanne emise un lieve sospiro. Poteva essere benissimo il suo, piuttosto
che quello di un'altra, ad apparirle all'improvviso davanti agli occhi, suo
figlio, il suo amore. Chissà, forse è al riparo in un posto tranquillo. Le
battaglie più terribili lasciano sempre delle zone intatte, fra una cortina di
fiamme e l'altra.
Domandò alla donna che le stava vicino:
"Sa da dove veniva, questo treno?"
"No"
"Ci sono state molte vittime?"
"Pare che ci siano due vagoni pieni di morti"
Smise di opporsi a Maurice che la trascinava via. A fatica, si aprirono un
varco fino alla stazione. Qua e là scavalcarono mattoni, blocchi di pietra,
cumuli di vetri in frantumi. Giunsero finalmente alla terza banchina, intatta,
dove si stava formando il treno per Tours, un accelerato di provincia,
placido e nero, che sputava fumo.
CAPITOLO 13.
Jean-Marie era stato ferito due giorni prima, e si trovava sul treno
bombardato. Questa volta era stato risparmiato, ma il vagone aveva preso
fuoco e, nello sforzo di scendere dal suo posto per arrivare fino alla portiera
la ferita del ragazzo si era riaperta. Quando lo raccolsero e lo issarono sul
camion era semisvenuto. Stava disteso sulla barella, la testa gli era scivolata
di lato e a ogni sobbalzo urtava con tutto il suo peso contro una cassa vuota.
Tre camion pieni di soldati avanzavano lentamente, in fila, su una strada
mitragliata e a malapena carrozzabile. Sopra il convoglio passavano e
ripassavano gli aerei nemici. Jean-Marie emerse per un attimo dal suo
nebuloso delirio e pensò: "Quando vola lo sparviero, polli e galline devono
sentirsi come noi...".
Confusamente rivide la fattoria della sua balia dove, da bambino, lo
mandavano a passare le vacanze di Pasqua. Il cortile era pieno di sole: i
polli beccavano chicchi di grano e svolazzavano sul mucchio di cenere, la
grande mano ossuta della balia ne afferrava uno, gli legava le zampe, lo
portava via e, cinque minuti dopo... c'era quel rivolo di sangue che usciva
con un leggero e grottesco glu glu. Era la morte... E anch'io sono stato preso
e portato via, pensò... preso e portato via... e domani, nudo e stecchito,
gettato nella terra, non sarò meglio di un pollo...
La fronte urtò così forte contro la cassa che dalle labbra del ragazzo uscì
una sorta di flebile protesta: non aveva più la forza di gridare, ma il suo
lamento attirò l'attenzione del compagno disteso accanto a lui, ferito più
leggermente alla gamba.
"E allora, Michaud? Di, Michaud, va meglio?"
Dammi da bere, e sistemami la testa in modo che non sbatta, e cacciami
questa mosca dagli occhi, avrebbe voluto dire Jean-Marie, ma si limitò a
sospirare.
"No...".
E chiuse gli occhi.
"Ecco che ricominciano" brontolò il compagno.
Nello stesso istante alcune bombe caddero intorno al convoglio. Un
piccolo ponte fu distrutto e di conseguenza la strada per Blois restò
interrotta. Bisognava tornare indietro, aprirsi un varco in mezzo alla folla
dei profughi oppure passare per Vendôme, dove non si sarebbe arrivati
prima di notte.
Poveri ragazzi, pensò l'ufficiale medico guardando Michaud, che era il
più grave. Gli fece un'iniezione e ripartirono. I due camion che
trasportavano i feriti leggeri s'inerpicarono alla volta di Vendôme; quello in
cui si trovava Jean-Marie prese invece una strada secondaria che doveva
abbreviare il percorso di qualche chilometro. Poco dopo si fermò, a corto di
benzina. L'ufficiale medico si mise alla ricerca di una casa dove poter
sistemare i suoi uomini. Lì si era un po’ più lontani dal fuggi fuggi generale,
la marea delle macchine scorreva più in basso. Dalla collina dov'era arrivato
l'ufficiale si vedeva, attraverso quel crepuscolo di giugno tenero e
tranquillo, color pervinca, una massa nera da cui salivano i suoni discordi,
indistinti dei clacson, delle grida, dei richiami, un rumore sordo e sinistro
che stringeva il cuore.
L'ufficiale vide alcune fattorie, una accanto all'altra. Erano abitate, ma
solo da donne e bambini, poiché gli uomini si trovavano al fronte.
Proprio in una di queste venne trasportato Jean-Marie. Le case adiacenti
ospitarono altri soldati; l'ufficiale medico, invece, scovata una bicicletta da
donna, annunciò che sarebbe andato nella città più vicina a cercare aiuto,
benzina, camion, tutto quello che avrebbe potuto trovare...
"Se deve morire," pensava accomiatandosi da Michaud, sempre disteso
sulla barella nella grande cucina della fattoria intanto che le donne
preparavano e scaldavano il letto "se deve restarci, meglio che sia fra due
lenzuola pulite piuttosto che in mezzo a una strada...".
E si affrettò alla volta di Vendôme. Dopo aver pedalato tutta la notte stava
entrando in città quando cadde in mano ai tedeschi, che lo fecero
prigioniero. Le donne della fattoria, non vedendolo tornare, erano corse fino
al paese per avvertire comunque il dottore e le suore dell'ospedale.
L'ospedale era pieno zeppo perché vi avevano portato le vittime dell'ultimo
bombardamento. Così i soldati restarono al villaggio. Le donne si
lamentavano: con tutti gli uomini al fronte, avevano fin troppo da fare con i
lavori dei campi e la cura delle bestie per potersi occupare anche dei feriti
che si erano ritrovate in casa!
Jean-Marie, quando a fatica alzava le palpebre brucianti di febbre, vedeva
davanti al suo letto una vecchia dal lungo naso giallastro che lavorava a
maglia e guardandolo sospirava: "Se solo sapessi che il mio vecchio, là
dove si trova, pover'uomo, è curato come questo qui che per me non è
niente...". Nel suo sogno agitato Jean-Marie sentiva il ticchettio dei ferri da
calza; il gomitolo di lana saltellava sulla trapunta, e nel delirio gli sembrava
che avesse delle orecchie a punta e una coda, e allungava la mano per
accarezzarlo. Ogni tanto la figlia adottiva della fattoressa gli si accostava;
era giovane, lei, con un viso fresco di un bel colorito vivo, dai lineamenti un
po’ rozzi e gli occhi scuri, limpidi e vivaci. Un giorno portò a Jean-Marie un
mazzo di ciliegie e glielo mise vicino, sul guanciale. Gli era proibito
mangiarle, ma lui se le portava alle guance che bruciavano come fuoco e si
sentiva placato, quasi felice.
CAPITOLO 14.
I Corte avevano lasciato Orleans e proseguivano il viaggio verso
Bordeaux. Le cose erano complicate dal fatto che non sapevano esattamente
dove andare. Dapprima si erano diretti alla volta della Bretagna, poi
avevano deciso per il Midi e adesso Gabriel dichiarava di voler lasciare la
Francia.
"Usciremo da qui soltanto morti" diceva Florence.
Non era tanto stanchezza o paura quello che sentiva, quanto rabbia, una
rabbia cieca, folle, che saliva in lei e la soffocava. Le pareva che Gabriel
avesse sciolto il tacito contratto che li legava. Dopo tutto, fra un uomo e una
donna della loro condizione, della loro età, l'amore è un baratto. Lei gli si
era data perché sperava di ricevere in cambio una protezione non solo
materiale ma anche spirituale, e fino a quel momento l'aveva ricevuta sotto
forma di denaro e di prestigio - insomma, lui l'aveva pagata equamente. Ma
d'improvviso Gabriel le sembrava una creatura fragile e spregevole.
"Vuoi dirmi cosa faremo all'estero? Come vivremo? Tutto il tuo denaro è
qui, visto che hai fatto la sciocchezza di ritirarlo dalla banca di Londra... A
proposito, non ho mai saputo perché!".
"Perché credevo che l'Inghilterra fosse più in pericolo di noi. Scusa tanto
se ho avuto fiducia nel mio paese, nell'esercito del mio paese: non mi
rimprovererai anche questo, eh? E poi, di che cosa ti preoccupi?
Grazie a Dio, sono famoso dappertutto, credo!"
Si interruppe di colpo, sporse la testa dal finestrino e subito la ritrasse con
fare irritato.
"Che c'è ancora?" mormorò Florence alzando gli occhi al cielo.
"Guarda quelli...".
E indicò la macchina che li stava superando. Florence osservò gli
occupanti: avevano passato la notte a Orleans accanto a loro, sulla piazza.
La carrozzeria rovinata, la donna con il bambino sulle ginocchia, l'altra con
la testa fasciata, la gabbia degli uccelli e l'uomo con il berretto in testa li si
ricordava facilmente.
"E tu non guardarli" fece Florence esasperata.
Gabriel colpì istericamente, a più riprese, il piccolo necessaire da viaggio
con guarnizioni d'oro e avorio sul quale appoggiava i gomiti.
"Episodi dolorosi come una disfatta e un esodo che non siano nobilitati da
un po’ di dignità e di grandezza non meritano di essere ricordati!
Non ammetto che questi bottegai, questi portinai, questi pidocchiosi
sviliscano un clima da tragedia con il loro piagnucolio, le loro chiacchiere,
la loro volgarità. Ma guardali!... Guardali! Eccoli di nuovo. Parola mia, mi
esasperano!...".
E gridò all'autista:
"Henri, acceleri un po’, per favore! Non riesce a seminare questa gente?"
Henri non rispose nemmeno. L'automobile faceva tre metri e si fermava,
bloccata da un'incredibile confusione di veicoli, biciclette e pedoni.
Di nuovo, a due passi da lui, Gabriel vide la donna dalla testa fasciata.
Aveva folte sopracciglia scure, lunghi denti bianchi, scintillanti, serrati, e il
labbro superiore ombreggiato da una peluria.
La fasciatura era macchiata di sangue e ciocche di capelli neri erano
appiccicate sull'ovatta e sulle pezze. Gabriel rabbrividì di disgusto e girò la
testa dal lato opposto. La donna invece gli sorrise e cercò di attaccare
discorso.
"Si va piano, eh?" disse amabilmente attraverso il finestrino abbassato.
"Ma tutto sommato è una fortuna esser passati di qui. Se la sono vista
brutta, dall'altra parte, sotto le bombe! Tutti i castelli sulla Loira sono stati
colpiti, sa...".
Poi però colse lo sguardo fisso e gelido di Gabriel e tacque.
"Non capisci che non riesco a liberarmi di loro?"
"Non guardarli più!"
"Fosse così semplice! Che incubo! Oh, la bruttezza, la volgarità, l'orrenda
bassezza di questa torma!"
Erano quasi arrivati a Tours. Già da un po’ Gabriel sbadigliava: aveva
fame. Da quando avevano lasciato Orleans non aveva mangiato quasi
niente. Come Byron, così diceva, anche lui era di abitudini frugali, gli
bastava un po’ di verdura, della frutta e dell'acqua gassata. Una o due volte
alla settimana, però, gli ci voleva un buon pasto sostanzioso. E in quel
momento ne avvertiva l'esigenza. Stava immobile, silenzioso, con gli occhi
chiusi, il bel volto pallido devastato dall'espressione sofferta di quando
creava mentalmente le prime frasi scarne e nitide dei suoi libri (gli
piacevano così, leggere e fruscianti come cicale; dopo veniva il suono fondo
e appassionato, quello che lui chiamava "i miei violini" Facciamo cantare i
miei violini, diceva) Ma quella sera era occupato da altri pensieri. Rivedeva
con un'intensità straordinaria i panini che Florence gli aveva offerto a
Orleans: allora gli erano sembrati poco appetitosi, ammosciati com'erano
dal caldo. Si trattava di piccoli panini dolci ripieni di pâté de foie gras, o di
pane nero con una fettina di cetriolo e una foglia di lattuga che dovevano
avere un sapore gradevole, fresco, lievemente acido. Sbadigliò di nuovo,
aprì la valigetta, trovò solo un tovagliolo macchiato e un vasetto di sottaceti.
"Che cosa cerchi?" domandò Florence.
"Un panino"
"Non ce ne sono più"
"Ma come! Poco fa ce n'erano tre"
"La maionese si era sciolta, erano immangiabili e li ho buttati. Potremo
cenare a Tours, spero" aggiunse.
All'orizzonte si vedevano i sobborghi di Tours ma le macchine non
avanzavano più: a un incrocio era stato alzato uno sbarramento e bisognava
aspettare il proprio turno. Passò un'ora. Gabriel era sempre più pallido.
Adesso non sognava panini, ma minestrine calde e leggere, e certi piccoli
pâté fritti nel burro che aveva mangiato un giorno a Tours tornando da
Biarritz (in quell'occasione era con una donna, ma stranamente non ne
ricordava né il nome né il volto, gli erano rimasti in mente solo quei piccoli
pâté al burro che contenevano, chiusa nella pasta morbida e vellutata, una
mezzaluna di tartufo) Poi pensò alla carne: una grande fetta di roast beef al
sangue, con un ricciolo di burro che si scioglie pian piano sulla carne tenera,
che delizia... Sì, gli ci voleva proprio quello... una fetta di roast beef... una
bistecca una chateaubriand... anche solo una scaloppina o una costoletta
d'agnello. Sospirò profondamente.
Era una sera mite e dorata, senza un alito di vento, non troppo calda, la
fine di una giornata stupenda, e un'ombra deliziosa si allungava come un'ala
sui campi e sulle strade... Dal bosco vicino veniva un leggero profumo di
fragola. A tratti lo si coglieva nell'aria resa irrespirabile dalle esalazioni di
benzina e di fumo. Le macchine avanzavano di pochi centimetri alla volta.
A un certo punto passarono su un ponte, sotto il quale alcune donne
lavavano tranquillamente i panni nel fiume, e quelle immagini di pace
accentuavano, per contrasto, tutto l'orrore e l'anormalità degli eventi. In
lontananza un mulino faceva girare la sua ruota.
"Queste acque devono essere ricche di pesce" disse Gabriel con aria
sognante. Due anni prima, in Austria, sulle rive di un piccolo fiume che
scorreva limpido e impetuoso come quello, aveva mangiato delle trote al
bleu d'Auvergne. E quelle carni, sotto l'involucro madreperlaceo e azzurro
del formaggio, erano rosa come la pelle di un neonato. E le patate al
vapore... così semplici, classiche, con un po’ di burro crudo e di prezzemolo
tritato... Guardò speranzoso le mura di Tours. Stavano finalmente entrando
in città. Ma appena misero la testa fuori dal finestrino videro la fila degli
sfollati che aspettavano in piedi lungo la strada. La mensa dei poveri
distribuiva cibo agli affamati, così gli venne detto, ed era inutile andare
altrove, non c'era più niente da mangiare da nessun'altra parte.
Una donna ben vestita, che teneva per mano un bambino, si voltò verso
Gabriel e Florence:
"Siamo qui da quattro ore, e il bambino piange, è terribile! "É terribile"
ripeté Florence.
Dietro di loro comparve la donna dalla testa fasciata.
"Non serve aspettare. Stanno chiudendo. Non c'è più niente". E fece un
gesto reciso con la mano. "Niente di niente. Neanche una crosta di pane.
L'amica che è con me ha partorito tre settimane fa e non ha mangiato
niente da ieri, e sta allattando! E dopo vi vengono a dire: fate figli.
Proprio così, accidenti a loro! Mi fanno ridere!"
Dalla fila si levava un mormorio lugubre.
"Niente, non hanno più niente. "Tornate domani" dicono. Pare che i
tedeschi si avvicinino e che il reggimento levi le tende questa notte"
"Siete andati a vedere in città se per caso si trova qualcosa?"
"Figuriamoci! Scappano tutti, sembra una città morta. E stia pur certa che
c'è già chi ha immagazzinato delle scorte"
"É spaventoso" gemette di nuovo Florence.
Era così turbata che si rivolgeva agli occupanti dell'auto mezza sfasciata.
La donna con il bambino sulle ginocchia era pallida come una morta, l'altra
scuoteva il capo con aria desolata.
"Spaventoso, dice? Non si preoccupi, i ricchi hanno sempre tutto. Quello
che soffre è l'operaio"
"Cosa facciamo?" disse Florence voltandosi disperata verso Gabriel.
Con un cenno lui le ordinò di seguirlo. Camminava a grandi passi. Si era
alzata la luna e, grazie al suo chiarore, ci si poteva orientare facilmente nella
città dalle imposte chiuse, dalle porte sprangate, in cui non brillava una luce
e nessuno si affacciava alle finestre.
"Sono tutte storie..." andava dicendo Corte sottovoce. "É impossibile che
pagando non si trovi niente da mangiare. Dammi retta, c'è una massa fatta di
quelli che hanno perso la testa e ci sono i furbi che hanno accumulato scorte
in posti sicuri. Tutto sta nello scovarli".
Si fermò.
"Siamo a Paray-le-Monial, vero? Guarda, ecco quello che cercavo. Due
anni fa ho cenato in questo ristorante. Il padrone si ricorderà certo di me,
vedrai"
Bussò ripetutamente alla porta sprangata e chiamò con voce imperiosa:
"Apra, apra, la prego! Sono un amico!"
Ed ecco il miracolo! Si udirono dei passi, una chiave girò nella serratura e
apparve una faccia preoccupata.
"Dica un po’, mi riconosce, vero? Sono Corte, Gabriel Corte. Sto
morendo di fame, mio caro. Sì, sì, lo so, non c'è niente, ma per me...
cercando bene... Non le è rimasto qualcosa? Ah! Si ricorda, adesso?".
"Sono desolato, signore, ma non posso farla entrare nel ristorante,"
sussurrò l'uomo "sarei assediato! Ma vada fino all'angolo della strada e mi
aspetti. La raggiungerò lì. Desidero solo accontentarla, signor Corte, è che
siamo così sprovvisti di tutto, così disgraziati. Ma insomma, cercando
bene...".
"Appunto, cercando bene...".
"In ogni caso non lo dirà a nessuno, vero? Non può immaginare quello
che è successo oggi. Cose da pazzi, mia moglie non si è ancora riavuta.
Divorano tutto e se ne vanno senza pagare!"
"Conto su di lei, amico mio" disse Gabriel mettendogli in mano del
denaro.
Cinque minuti dopo lui e Florence tornavano verso la macchina portando
con aria misteriosa un cestino avvolto in un tovagliolo.
"Non so assolutamente cosa ci sia dentro" mormorò Gabriel con il tono
distaccato e sognante che assumeva per parlare alle donne, quelle concupite
e non ancora possedute. "No, non lo so proprio... Ma mi par di sentire un
profumo di foie gras...".
In quel preciso istante un'ombra guizzò fra Gabriel e Florence, li separò
con un pugno e arraffò il cesto che entrambi reggevano. Florence, in preda
al panico, si portò le mani al collo gridando: "La mia collana, la mia
collana!" Ma la collana era sempre al suo posto, come pure il cofanetto dei
gioielli che portavano con loro. Il ladro aveva preso solo le provviste.
Florence si ritrovò sana e salva vicino a Gabriel che si tamponava la
mascella e il naso dolorante.
"É una giungla, siamo incappati in una giungla..." continuava a ripetere
lui.
CAPITOLO 15.
"Non avresti dovuto farlo" sospirò la donna che teneva in braccio un
neonato.
Un Po di colore le stava riaffiorando sulle guance. Con un'abile manovra,
la vecchia Citroën mezzo sfondata era uscita dalla mischia e i suoi
occupanti ormai riposavano seduti sul muschio di un boschetto. Una luna
limpida e rotonda brillava in cielo, ma anche senza luna a illuminare la
scena sarebbe bastato il grande incendio che divampava all'orizzonte:
gruppi di gente sdraiata qua e là sotto i pini, automobili ferme e, accanto
alla giovane donna e all'uomo con il berretto in testa, il cesto delle provviste
aperto, mezzo vuoto, e il collo dorato di una bottiglia di champagne
stappata.
"No, non avresti dovuto... non mi piace, è brutto essere costretti a questo,
Jules!"
L'uomo, piccolo, gracile, la faccia piatta, tutta fronte e occhi, con una
bocca molle e un mento da faina, protestò:
"E allora? Dobbiamo crepare?"
"Lascialo stare, Aline, ha ragione lui. Insomma!" disse la donna dalla
testa fasciata. "Che cosa dovremmo fare? Quei due là, credimi, non
meritano di vivere!"
Restarono in silenzio. La donna era un'ex domestica; aveva sposato un
operaio che lavorava alla Renault. Durante i primi mesi di guerra erano
riusciti a farlo restare a Parigi, ma poi, in febbraio, era stato mandato al
fronte e in quel momento combatteva Dio sa dove. E sì che aveva fatto
anche l'altra guerra ed era il maggiore di quattro figli...
Niente da fare! I privilegi, l'esenzione dal servizio militare, le
raccomandazioni erano tutta roba per i borghesi. Nel profondo di quella
donna c'erano come degli strati di odio via via sedimentati che si
sovrapponevano senza confondersi: quello della contadina che detesta
istintivamente la gente di città, quello della domestica stanca e inasprita per
essere vissuta in casa d'altri, e infine quello dell'operaia, giacché negli ultimi
mesi aveva preso il posto del marito in fabbrica. E quel lavoro da uomo, al
quale non era abituata, le aveva indurito l'anima e il corpo.
"Li hai fregati per bene, Jules," disse al fratello "davvero non ti credevo
capace di tanto!"
"Quando ho visto Aline che stava per svenire, e quegli schifosi carichi di
bottiglie, di foie gras e di tutto il resto, non ci ho visto più"
Aline, che sembrava più timida e più dolce, azzardò: "Forse avremmo
potuto chiedere loro di darci qualcosa, non credi, Hortense?"
Il marito e la cognata sbottarono:
"Ma figurati! Tu non li conosci, ci lascerebbero crepare come cani, va là!
Io li conosco bene" disse Hortense. "Quelli sono i peggiori. Lui l'ho visto
dalla contessa Barrai du feu, una vecchia carampana; scrive libri e
commedie. Un pazzo, a quel che diceva il suo autista, e scemo da far pietà"
Mentre parlava, Hortense sistemava gli avanzi nel paniere. Le sue grosse
mani rosse avevano gesti straordinariamente abili e leggeri. Poi prese il
piccolino e gli tolse le fasce.
"Che viaggio, povero tesoro! Ha fatto presto a conoscere la vita, questo
qui! Forse è meglio. Qualche volta non mi dispiace di non essere cresciuta
negli agi: sapersi servire delle proprie mani, mica tutti possono vantarsene!
Ti ricordi, Jules, quando la mamma è morta io non avevo ancora tredici
anni, e andavo al lavatoio col bello e il brutto tempo, d'inverno dovevo
spaccare il ghiaccio e caricarmi chili di panni sulla schiena... Mi
nascondevo la faccia fra le mani tutte screpolate e piangevo. Ma sono cose
che mi hanno insegnato a sbrigarmela da sola e a non aver paura di niente"
"Ah, quanto a questo, è proprio vero che sei in gamba!" disse Aline con
ammirazione.
Quando il piccolino fu lavato, asciugato e cambiato, Aline si sbottonò la
camicetta e lo prese sul cuore. Gli altri due la guardavano sorridendo.
"Lui almeno potrà rimpinzarsi, povero piccolo!"
Lo champagne dava loro alla testa; avvertivano una dolce e confusa
euforia e, sprofondati in una sorta di ebetudine profonda, guardavano le
fiamme in lontananza. Ogni tanto dimenticavano perché si trovavano in
quel luogo strano, perché avevano abbandonato il loro piccolo appartamento
nei pressi della gare de Lyon e si erano precipitati sulle strade, perché
avevano attraversato la foresta di Fontainebleau, derubato Corte. Tutto
diventava oscuro e nebuloso, come in un sogno.
Avevano appeso la gabbia a un ramo basso e dettero da mangiare agli
uccelli: Hortense si era ricordata di prendere con sé un sacchetto di semi.
Tirò fuori di tasca qualche zolletta di zucchero che gettò in una tazza di
caffè bollente: il thermos non era stato danneggiato nell'incidente. E bevette
rumorosamente, sporgendo le grosse labbra e tenendo una mano sul petto
prosperoso per proteggerlo alle macchie.
All'improvviso tra i gruppi corse una voce: "I tedeschi sono entrati a
Parigi stamattina"
Hortense si lasciò sfuggire di mano la tazza quasi piena. La sua grossa
faccia si era fatta più rossa che mai. Chinò la testa e si mise a piangere.
"Questo mi fa un certo effetto... mi fa qualcosa qui" disse indicando il
cuore.
Le sue lacrime erano rade e brucianti, lacrime di una donna indurita che
difficilmente prova pietà per se stessa e per gli altri. La invadeva un
sentimento di rabbia, di dolore e di vergogna così violento da procurarle un
male fisico, acuto e lancinante, nella zona del cuore.
"Tu sai che voglio bene a mio marito... Povero Louis... Siamo noi due
soli, e lui lavora, non beve, non corre dietro alle donne, insomma ci
amiamo, non ho che lui, ma se mi dicessero: non lo rivedrai più, è morto,
ma abbiamo vinto la guerra... Be, preferirei così, sì, giuro, preferirei così!"
disse alla fine.
"Ah, sicuramente," disse Aline, cercando invano un'espressione più forte
"sicuramente siamo tutti dispiaciuti"
Jules taceva pensando al suo braccio semiparalizzato che gli aveva
permesso di evitare il servizio militare e la guerra. "Mi è andata di lusso"
diceva fra sé, ma al tempo stesso qualcosa lo turbava, non sapeva bene cosa,
una specie di rimorso.
"Insomma, è così. É così e non possiamo farci niente" disse alle due
donne con aria cupa.
Ripresero a parlare di Corte, ed erano profondamente soddisfatti
dell'ottima cena che avevano consumato al posto suo. Adesso, tuttavia, lo
giudicarono con maggiore indulgenza. Hortense, che in casa della contessa
Barrai du Jeu aveva visto passare scrittori, accademici e una volta perfino la
contessa de Noailles, li fece ridere di cuore raccontando ciò che sapeva di
quella gente.
"Non è che siano cattivi" disse Aline. "É che non conoscono la vita".
CAPITOLO 16.
I Pericand non avevano trovato posto in città ma in un borgo vicino, di
fronte alla chiesa, in una casa abitata da due anziane signorine in cui c'era
ancora una grande camera libera. I bambini, stanchi morti, furono messi a
letto vestiti. Jacqueline implorò con voce tremante che le mettessero vicino
la cesta del gatto. Era ossessionata dall'idea che sarebbe scappato, che si
sarebbe perso, che sarebbe morto di fame vagando randagio per le strade.
Infilò la mano fra le asticelle della cesta di vimini che formavano per il
gatto una piccola finestra attraverso la quale si vedevano uno sfolgorante
occhio verde e lunghi baffi irti di collera, e solo allora si calmò. Emmanuel
era spaventato da quella camera sconosciuta, immensa, e dalle due vecchie
zitelle che correvano di qua e di là come maggiolini impazziti gemendo:
"Cosa ci tocca di vedere, Gesummaria... Che strazio... Poveri innocenti...".
Bernard, disteso supino, le guardava senza batter ciglio con aria ebete e
grave succhiando una zolletta di zucchero che aveva tenuto per tre giorni in
fondo a una tasca dove il calore l'aveva impastata con una mina di matita,
un francobollo usato e un pezzetto di spago. L'altro letto della stanza era
occupato dal vecchio Pericand. La signora Pericand, Hubert e i domestici
avrebbero passato la notte sulle sedie della sala da pranzo.
Dalle finestre aperte si intravedeva un giardinetto illuminato dalla luna.
Una luce scintillante e tranquilla si riversava sui ciottoli d'argento del
vialetto, lungo il quale una gatta camminava adagio, e sui grappoli bianchi e
profumati dei lilla. Nella sala da pranzo sfollati e gente del posto
ascoltavano insieme i notiziari della radio. Le donne piangevano. Gli
uomini chinavano il capo in silenzio. Non provavano una vera e propria
disperazione; era piuttosto un rifiuto di comprendere, un attonito stupore del
tipo di quello che si prova dopo un brutto sogno, quando piano piano si
emerge dal sonno, si avverte che il giorno è vicino, tutto l'essere tende alla
luce e si pensa: "É un incubo, adesso mi sveglio" Stavano immobili, e
ciascuno si voltava dall'altra parte per evitare lo sguardo dei compagni.
Appena Hubert spense la radio tutti gli uomini se ne andarono, senza una
parola. Nella stanza rimasero solo le donne. Si sentivano i loro sussurri, i
loro sospiri; piangevano sulle sventure della patria che, nel loro
immaginario, aveva le care fattezze dei mariti e dei figli che combattevano
ancora. Il loro dolore era più animalesco di quello dei loro compagni, più
semplice anche, e più loquace; lo alleviavano con una sequela di
recriminazioni, di esclamazioni: "Ecco... Valeva proprio la pena!... Per
arrivare a questo punto... Che peccato... Siamo stati traditi, signora mia,
glielo assicuro... Ci hanno venduti, e adesso chi ha la peggio è la povera
gente...".
Hubert le ascoltava con i pugni stretti, fuori di sé per la rabbia. Che cosa
ci faceva lui lì? Con quelle vecchie pettegole... Oh, se avesse avuto solo due
anni di più! Nell'animo suo, fino a quel momento tenero e leggero, più
giovane della sua età, si destavano di colpo le passioni e i tormenti di un
uomo maturo: angoscia patriottica, brama di sacrificio, vergogna, dolore e
collera. Per la prima volta nella vita, pensava, un'avventura tanto grave
investiva la sua personale responsabilità. Non era il caso di piangere o
gridare al tradimento, era un uomo, lui; non aveva l'età richiesta per
combattere ma sapeva di essere più forte, più resistente alla fatica, più
capace, più furbo dei vecchi di trentacinque e quarant'anni mandati in
guerra, ed era libero, lui. Non c'era una famiglia, un amore, a trattenerlo!
"Voglio partire," mormorò "voglio partire!"
Si precipitò verso sua madre, la prese per mano, la trascinò in disparte.
"Mamma, dammi delle provviste, il maglione rosso che è nella tua
valigetta e... abbracciami. Parto" disse.
Soffocava. Le lacrime gli scorrevano sulle guance. La madre lo guardò e
capì.
"Ma via, bambino mio, sei pazzo...".
"Io parto, mamma. Non posso restarmene qui... Morirò, mi ucciderò se
devo rimanere con le mani in mano mentre... Non capisci che i tedeschi
arriveranno e arruoleranno a forza tutti i ragazzi, li obbligheranno a
combattere per loro? Non voglio! Lasciami andare"
Senza rendersene conto aveva alzato la voce e adesso gridava, non
riusciva a trattenersi. Era circondato da un gruppo terrorizzato di vecchie
tremanti e a lui si era unito un ragazzo, di poco più grande, il nipote delle
padrone di casa, biondo e roseo, con i capelli ricci e grandi occhi azzurri
innocenti, che ripeteva con lieve accento meridionale (figlio di statali, era
nato a Tarascona):
"Sicuro che dobbiamo partire, e questa notte stessa! Senti, non molto
lontano da qui, nei boschi della Sainte, ci sono i soldati... Non dobbiamo
fare altro che prendere le biciclette e filare...".
"René," piagnucolarono le zie aggrappandosi a lui "René, tesoro mio,
pensa a tua madre!"
"Lasciami, zia, queste non sono cose da donne" rispose respingendole, e il
suo bel viso arrossì di piacere, era compiaciuto di aver parlato così bene.
Guardò Hubert che si era asciugato le lacrime e stava in piedi davanti alla
finestra con aria tenebrosa e risoluta. Gli si avvicinò e gli sussurrò
all'orecchio:
"Si va?"
"Sì, naturalmente" rispose Hubert sottovoce.
Rifletté un attimo e aggiunse:
"Appuntamento a mezzanotte all'uscita dal paese"
Si strinsero la mano furtivi. Intorno a loro le donne parlavano tutte
insieme, scongiurandoli di rinunciare a un simile progetto, di preservare per
il futuro le loro vite così preziose, di pensare ai genitori. In quell'istante dal
piano superiore giunsero gli strilli disperati di Jacqueline.
"Mamma, mamma, vieni, presto! Albert è scappato!"
"Albert? L'altro suo figlio? Ah, mio Dio!" esclamarono le anziane
signorine.
"No, no, Albert è il gatto" disse la signora Pericand sull'orlo di una crisi
isterica.
Intanto, colpi sordi e cupi facevano tremare l'aria: in lontananza tuonava il
cannone e tutti loro erano in pericolo! La signora Pericand si lasciò cadere
su una sedia.
"Ascoltami bene, Hubert! In assenza di tuo padre, comando io! Sei un
bambino, hai solo diciassette anni e hai il dovere di preservarti per il
futuro...".
"Per la prossima guerra?"
"Per la prossima guerra" ripeté meccanicamente la signora Pericand. "Nel
frattempo devi solo tacere e ubbidirmi. Non partirai affatto! Se tu avessi un
po’ di cuore, un'idea così crudele e così stupida non ti avrebbe neppure
sfiorato! Non ti pare che io sia già abbastanza infelice? Ma ti rendi conto
che tutto è perduto? Che stanno arrivando i tedeschi e tu sarai ucciso o preso
prigioniero prima di aver fatto cento metri? Taci! Non voglio neanche
discutere con te, se vorrai uscire da qui dovrai passare sul mio corpo!"
"Mamma, mamma," strillava intanto Jacqueline "voglio Albert! Andate a
cercare Albert! Lo prenderanno i tedeschi! Finirà sotto le bombe, lo
ruberanno, si perderà! Albert! Albert! Albert!"
"Jacqueline, smettila, sveglierai i tuoi fratelli!"
Gridavano tutti contemporaneamente. Hubert, con le labbra che gli
tremavano, si allontanò da quel gruppo caotico di vecchie gesticolanti e
scarmigliate. Quelle donne non capivano niente... La vita era
shakespeariana, mirabile e tragica, e loro la sminuivano in modo insensato.
Un mondo stava crollando, non restavano che macerie e rovine, ma loro non
cambiavano. Creature inferiori, prive di eroismo e di grandezza, di fede e di
spirito di sacrificio... Sapevano solo rimpicciolire tutto quello che toccavano
e abbassarlo al loro livello.
Oh, Dio! Vedere un uomo, stringere la mano di un uomo! Anche di papà,
pensò, ma soprattutto del caro, del buono, del grande Philippe. Sentiva un
tale bisogno della presenza del fratello che gli tornarono le lacrime agli
occhi. Il rombo continuo del cannone lo allarmava e lo eccitava a un tempo,
il suo corpo era scosso da brividi e, come un giovane cavallo spaventato,
egli girava di scatto la testa a destra e a sinistra. Ma non aveva paura, no!
Non aveva paura! Accoglieva, vagheggiava l'idea della morte. Era bello
morire per quella causa persa. Ed era meglio che marcire nelle trincee come
nel '14. Adesso si combatteva a cielo aperto, sotto il bel sole di giugno o nel
luminoso chiaro di luna.
Sua madre era salita da Jacqueline ma aveva preso le sue precauzioni:
quando lui volle scendere in giardino, trovò la porta chiusa con il
catenaccio. La scrollò, le assestò dei colpi violenti. Le padrone di casa, che
si erano ritirate nella loro camera, protestarono:
"Lasci stare quella porta, giovanotto! É tardi. Siamo stanche e abbiamo
sonno. Ci lasci dormire".
E una di loro aggiunse:
"Vada a letto, ragazzo caro"
Hubert alzò le spalle furibondo.
""Ragazzo caro" Vecchia megera!"
Riapparve la madre.
"Jacqueline ha avuto un attacco di nervi" disse. "Per fortuna avevo nella
borsa una boccetta di fiori d'arancio. Non mangiarti le unghie!
Hubert, mi esasperi. Su, mettiti su questa poltrona e dormi".
"Non ho sonno"
"Non importa, dormi" disse lei con la voce imperiosa e impaziente che
avrebbe usato per parlare con Emmanuel.
L'anima in rivolta, Hubert si buttò su una vecchia poltrona foderata di
cretonne che gemette sotto il suo peso. La signora Pericand alzò gli occhi al
cielo.
"Come sei goffo, ragazzo mio! La sfascerai! Stai un po’ tranquillo"
"Sì, mamma" disse lui, mostrandosi remissivo.
"Hai pensato a tirar giù dalla macchina l'impermeabile?"
"No, mamma"
"Non pensi proprio a niente!"
"Ma non mi servirà. C'è bel tempo".
"Domani può piovere"
Estrasse dalla borsa il lavoro a maglia e i ferri cominciarono a ticchettare.
Quando Hubert era piccolo e prendeva lezioni di piano, lei gli si sedeva
accanto e sferruzzava. Il ragazzo chiuse gli occhi e finse di dormire. Dopo
un po’, anche lei si addormentò. Allora lui saltò dalla finestra aperta, corse
fino al capannone dove aveva lasciato la bicicletta e, socchiudendo il
cancello senza far rumore, scivolò fuori.
Tutti dormivano. Il rombo del cannone era cessato. Solo i gatti si
lamentavano sui tetti. Una bellissima chiesa, dalle vetrate di un azzurro
lunare, sorgeva in mezzo a un vecchio viale polveroso dove gli sfollati
avevano parcheggiato le macchine. Chi non aveva trovato posto nelle
abitazioni dormiva dentro l'auto o sull'erba. I volti pallidi che trasudavano
angoscia restavano tesi e spauriti anche nel sonno. Tuttavia tutti dormivano
pesantemente e niente li avrebbe svegliati prima dello spuntar del giorno.
Lo si vedeva benissimo. Avrebbero potuto passare dal sonno alla morte
senza neppure accorgersene.
Hubert avanzò in mezzo a loro, osservandoli con pietà e stupore. Non si
sentiva stanco. Il suo animo sovreccitato lo sosteneva, lo spingeva avanti.
Pensava alla famiglia che aveva abbandonato con dolore e con rimorso. Ma
dolore e rimorso non facevano che aumentare la sua esaltazione. Non si
lanciava nudo in quell'avventura; sacrificava al suo paese non solo la
propria vita ma quella di tutti i suoi cari. Andava incontro al suo destino
come un giovane dio carico di doni. Lui, perlomeno, si vedeva così. Uscì
dal paese, arrivò sotto il ciliegio e si gettò a terra sotto i rami.
All'improvviso, un'emozione dolcissima gli fece battere il cuore: pensava a
quel nuovo compagno che avrebbe diviso con lui pericoli e gloria. Quel
ragazzo dai capelli biondi gli era quasi sconosciuto, ma si sentiva legato a
lui con una violenza e una tenerezza straordinarie. Aveva sentito dire che
all'attraversamento di un ponte, nel Nord, un reggimento tedesco era dovuto
passare sui corpi dei compagni caduti, e lo aveva fatto cantando: "Avevo un
camerata...". Quel sentimento d'amore puro, quasi selvaggio, lui lo capiva.
Nel suo inconscio cercava di sostituire Philippe, che aveva tanto amato e
che si andava staccando da lui con implacabile dolcezza, troppo serio,
troppo santo, pensava Hubert, e senza altro amore e passione all'infuori di
Cristo.
Negli ultimi due anni Hubert si era effettivamente sentito molto solo e,
come per una spiacevole coincidenza, i suoi compagni di scuola erano
ragazzi o molto rozzi o molto snob. Inoltre, quasi inconsciamente, era
sensibile alla bellezza fisica, e quel René aveva un viso d'angelo.
Insomma, lo aspettava. A ogni minimo rumore trasaliva, alzava la testa.
Mezzanotte meno cinque. Ecco un cavallo, senza cavaliere. Passavano,
ogni tanto, visioni strane come questa, che ricordavano il disastro e la
guerra, ma per il resto tutto era tranquillo. Strappò un lungo filo d'erba e lo
mordicchiò, poi esaminò pezzo per pezzo il contenuto delle sue tasche: un
po’ di pane raffermo, una mela, delle nocciole, briciole di pan pepato, un
temperino, un gomitolo di spago e il piccolo taccuino rosso. Sulla prima
pagina scrisse: "Se vengo ucciso, avvertite mio padre, signor Pericand, 18
boulevard Delessert, Parigi, o mia madre..."
Aggiunse l'indirizzo di Nîmes. Poi pensò che non aveva detto le preghiere
della sera; si inginocchiò nell'erba e le recitò, con un Credo speciale per la
sua famiglia. Si rialzò con un sospiro profondo. Si sentiva in regola con gli
uomini e con Dio. Mentre pregava era suonata la mezzanotte. Adesso
occorreva essere pronti a partire. La luna illuminava la strada. Hubert non
vedeva arrivare nessuno. Attese pazientemente per una mezz'ora, poi fu
preso dall'ansia. Adagiò la bicicletta nel fossato e mosse verso il paese,
incontro a René, ma questi non si vedeva. Fece dietro front, tornò sotto il
ciliegio e si dispose ad aspettare passando in rassegna il contenuto dell'altra
tasca: qualche sigaretta un po’ ammaccata, qualche spicciolo. Fumò una
sigaretta, senza alcun piacere. Non si era ancora abituato al sapore del
tabacco. Gli tremavano le mani per l'agitazione. Strappò qualche fiore, li
gettò. Era l'una passata, possibile che René?... No, no... non si manca così
alla parola data... Certo era stato trattenuto, segregato dalle zie, ma lui,
Hubert, era pur riuscito a scappare nonostante le precauzioni di sua madre.
Sua madre. Probabilmente dormiva ancora, si sarebbe svegliata di lì a poco
e che cosa avrebbe fatto? Lo avrebbero cercato dappertutto; non poteva
restare lì, così vicino al paese. Ma se poi René arrivava? Lo avrebbe
aspettato fino all'alba, se ne sarebbe andato allo spuntar del sole.
I primi raggi illuminavano la strada quando Hubert finalmente si mosse e
si avviò verso il bosco della Sainte, su una collina. Si inerpicò cautamente
per la salita spingendo la bicicletta a mano e preparando le parole che
avrebbe rivolto ai soldati. Gli arrivarono delle voci, qualche risata, il nitrito
di un cavallo. Qualcuno gridò. Hubert si fermò trattenendo il respiro:
avevano parlato in tedesco. Si buttò dietro un albero, vide un'uniforme color
reseda a pochi passi da lui e, abbandonata la bicicletta, scappò via come una
lepre. Ai piedi della salita sbagliò direzione, corse dritto davanti a sé e
arrivò al villaggio, che non riconobbe. Tornò quindi sulla strada statale e
capitò in mezzo alle automobili degli sfollati. Che passavano a una velocità
pazzesca. Ne vide una (una grossa torpedo grigia) che aveva appena spinto
un camioncino nel fosso e filava via senza che il conducente avesse
rallentato neanche un istante. Più lui avanzava, più il fiume di macchine
scorreva veloce - come in una pellicola impazzita, pensò. Vide un camion
pieno di militari. Fece dei segni disperati; senza fermarsi, qualcuno gli tese
la mano e lo tirò su in mezzo a cannoni ancora mimetizzati con fogliame e
tra casse di munizioni.
"Volevo avvertirvi" disse Hubert ansimante "che in un bosco qui vicino
ho visto dei tedeschi"
"Ma sono dappertutto, ragazzo mio" rispose il soldato.
"Posso venire con voi?" domandò timidamente Hubert. "Vorrei" e la voce
gli s'incrinò per l'emozione "vorrei combattere"
Il soldato lo guardò e non disse niente. Nessuna parola, nessuno
spettacolo sembrava capace di stupire o di emozionare ancora quegli
uomini. Hubert venne a sapere che, strada facendo, avevano raccolto una
donna incinta, un bambino ferito e abbandonato durante un
bombardamento, o che forse si era perso, e un cane con una zampa rotta.
Riuscì inoltre a capire che la loro intenzione era quella di ritardare
l'avanzata nemica e possibilmente di impedire ai tedeschi la traversata del
fiume.
"Resto con loro" pensò Hubert. "É fatta, adesso ci sono dentro".
Il flusso sempre più grande dei profughi circondava il camion e ne
intralciava la marcia. A tratti era impossibile andare avanti. Allora i soldati
incrociavano le braccia e aspettavano che li lasciassero passare. Hubert era
seduto in fondo al camion, con le gambe penzoloni nel vuoto. Uno
straordinario tumulto, una confusione di idee e di passioni lo agitavano, ma
l'elemento dominante nel suo cuore era il disprezzo verso l'umanità tutta.
Un sentimento quasi fisico: qualche mese prima alcuni compagni lo
avevano fatto bere, per la prima volta in vita sua - e quel sapore orrendo di
fiele e di cenere che il vino cattivo lascia in bocca lo ritrovava adesso. Era
stato un bambino così buono! Ai suoi occhi il mondo era semplice e bello,
gli uomini degni di rispetto. Gli uomini... un branco di animali feroci e
vigliacchi. Quel René che lo aveva spinto alla fuga e che se n'era rimasto
poi a crogiolarsi nel letto mentre la Francia crollava... Quella gente che
rifiutava agli sfollati un bicchiere d'acqua, un letto, quelli che facevano
pagare le uova a peso d'oro, quelli che stipavano le loro macchine di valigie,
di pacchi, di provviste, perfino di mobili, e che alla donna stremata dalle
fatiche, ai bambini venuti a piedi da Parigi rispondevano: "Non possiamo
farvi salire... Vedete bene che non c'è posto...". Quelle valigie di cuoio
rossiccio e quelle donne imbellettate su un camion pieno di ufficiali, tutto
quell'egoismo, quella viltà, quella feroce e vana crudeltà lo nauseavano. E la
cosa più spaventosa era che non poteva ignorare né i sacrifici, né l'eroismo,
né la bontà di certi altri. Philippe, ad esempio, era un santo, e quei soldati,
che non avevano né mangiato né bevuto (l'ufficiale addetto
all'approvvigionamento, partito al mattino, non era tornato per tempo)
eppure si apprestavano a combattere per una causa disperata, erano degli
eroi. Sì, c'erano coraggio e abnegazione e amore fra gli uomini, ma anche
questo era atroce perché i buoni sembravano predestinati. Philippe lo
spiegava a modo suo. Quando parlava appariva fulgido e ardente insieme,
come illuminato da un purissimo braciere, ma Hubert attraversava un
momento di crisi religiosa e Philippe era lontano. Il mondo esterno,
incoerente e ripugnante, aveva i colori dell'inferno, un inferno in cui mai
Gesù sarebbe ridisceso, perché lo avrebbero fatto a pezzi, pensava Hubert.
Il convoglio fu mitragliato. La morte aleggiava nel cielo e all'improvviso
si tuffava, piombava dall'alto ad ali spiegate e becco d'acciaio dardeggiante
puntato su quella lunga fila tremante di insetti neri che strisciavano lungo la
strada. Tutti si buttavano a terra, le donne si stendevano sui figli per
proteggerli con il loro corpo. Quando il fuoco cessava, solchi profondi
restavano scavati nella folla, simili a spighe di grano piegate in un giorno di
tempesta o ad alberi abbattuti che formano strette e profonde trincee. Dopo
pochi istanti di silenzio gemiti e richiami si levavano, si rispondevano,
gemiti che nessuno ascoltava, richiami lanciati invano...
La gente risaliva nelle macchine ferme sul ciglio della strada e ripartiva,
ma alcune restavano lì abbandonate, con le portiere aperte e le valigie
ancora assicurate al tetto, a volte con una ruota nel fossato per la fretta del
conducente di fuggire e di mettersi al riparo. Ma invano: non sarebbe
tornato. Dentro la macchina, fra i bagagli dimenticati, capitava di vedere un
cane che strattonava il guinzaglio abbaiando o un gatto che miagolava
infuriato nel suo paniere.
CAPITOLO 17.
Riflessi condizionati di antica data si prendevano ancora gioco di Gabriel
Corte: se qualcuno gli faceva del male, la sua prima reazione era quella di
lamentarsi, e solo la seconda quella di difendersi.
Impaziente, trascinandosi dietro Florence, cercò in tutta Paray-le-Monial
il sindaco, i gendarmi, un deputato, un prefetto, un qualsiasi rappresentante
delle autorità che potesse fargli riavere la sua cena. Ma, che strano, le vie
erano deserte, le case mute. A un incrocio si scontrò con un gruppetto di
donne che sembravano vagare senza meta e che risposero alle sue domande.
"Non sappiamo, non siamo di qui. Siamo sfollate come voi" aggiunse una
del gruppo.
Portato dal dolce vento di giugno, un leggerissimo odore di fumo arrivava
fino a loro.
Dopo un po’ i due cominciarono a domandarsi dove fosse rimasta la
macchina. Florence credeva di averla lasciata vicino alla stazione.
Gabriel si ricordava di un ponte che avrebbe potuto servire come punto di
orientamento; la luna, splendida e pacifica, rischiarava i loro passi, ma le
strade di quella vecchia cittadina si somigliavano tutte.
Ovunque vetuste mura merlate, antichi paracarri, balconi inclinati di lato,
tenebrosi vicoli ciechi.
"Un brutto scenario da melodramma" mugugnò Corte.
Anche l'odore era quello che si respira dietro le quinte, dolciastro e
stantio, con un vago fetore di latrina. Faceva molto caldo e il sudore gli
colava dalla fronte. Sentiva le invocazioni di Florence che era rimasta
indietro e che gridava: "Aspettami! Fermati, vigliacco, farabutto! Dove sei,
Gabriel? Dove sei? Non ti vedo più, Gabriel.
Carogna!" Le sue grida si ripercuotevano sulle vecchie mura e l'eco le
rimandava come palle: "Carogna, vecchio mascalzone, vigliacco!"
Alla fine lo raggiunse vicino alla stazione e gli si gettò addosso, lo
picchiò, lo graffiò, gli sputò in faccia mentre lui si difendeva con grida
stridule. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la voce bassa ed
estenuata di Gabriel Corte celasse note così acute e vibranti, così femminili
e selvagge. La fame, la paura, lo sfinimento li avevano fatti uscir di senno.
Davanti all'avenue de la Gare completamente deserta avevano capito che la
città era stata evacuata per ordine superiore.
Gli altri erano già lontani, sul ponte illuminato dalla luna. Soldati esausti
sedevano per terra in piccoli gruppi. Uno di loro, un ragazzo giovanissimo,
pallido e dalle lenti spesse, si alzò faticosamente per separare Florence e
Corte.
"Suvvia, signore... E lei, signora! Non vi vergognate?".
"Dove sono le macchine?" gridò Corte.
"É stato dato l'ordine di portarle via"
"Ma chi l'ha dato? Perché? E i nostri bagagli? E i miei manoscritti?
Sono Gabriel Corte!"
"Buon Dio, li ritroverà i suoi manoscritti! E mi lasci dire che c'è gente che
ha perso molto di più!"
"Zoticone!"
"Può darsi, signore, però...".
"Chi ha dato quest'ordine idiota?"
"Quanto a ciò, signore... Devo ammettere che ne hanno dati molti altri che
non erano certo più intelligenti. Lei ritroverà la sua automobile e le sue
carte, stia sicuro. Nel frattempo non dovete restare qui. I tedeschi entreranno
in città da un momento all'altro, e abbiamo l'ordine di far saltare la stazione"
"Dove possiamo andare?" gemette Florence.
"Tornate in città"
"Ma dove alloggeremo?"
"Il posto non manca. Tutti tagliano la corda" disse uno dei soldati che si
era avvicinato e stava a pochi passi da Corte.
Il chiaro di luna diffondeva una tenue luce azzurrina. L'uomo aveva un
volto severo, massiccio: due pieghe verticali gli scavavano le guance piene.
Toccò Gabriel sulla spalla e, senza sforzo apparente, lo fece ruotare su se
stesso.
"Su, adesso basta! Toglietevi di mezzo, capito?"
Per un attimo Gabriel pensò che si sarebbe avventato su quell'uomo, ma la
pressione della mano ferrea sulla sua spalla lo fece desistere dal proposito e
indietreggiare invece di due passi.
"Siamo in viaggio da lunedì... e abbiamo fame...".
"Abbiamo fame" gli fece eco Florence con un sospiro.
"Aspettate fino a domattina. Se siamo ancora qui, vi daremo un piatto di
minestra"
Il soldato dalle lenti spesse ripeté con la sua dolce voce esausta:
"Non deve restare qui, signore... Su, si allontani" e prendeva Corte per
mano spingendolo leggermente, così come si fanno uscire i bambini dal
salotto per mandarli a dormire.
Riattraversarono la piazza, ma adesso camminavano l'uno accanto
all'altro, trascinando i piedi stanchi; la collera era svanita e con essa la forza
nervosa che li aveva sorretti. Ed erano così scoraggiati che non trovarono
neppure la forza di mettersi di nuovo alla ricerca di un ristorante. Bussarono
a porte che non si aprirono. Finirono per lasciarsi cadere su una panchina
nei pressi di una chiesa. Florence, con una smorfia di dolore, si tolse le
scarpe.
La notte avanzava e non succedeva niente. La stazione era sempre al suo
posto. Ogni tanto si sentivano dei soldati nella strada vicina. Una o due
volte alcuni uomini passarono davanti alla panchina senza neanche gettare
un'occhiata a Florence e a Corte, raggomitolati nell'ombra quieta, le teste
dolenti l'una accanto all'altra. Un odore di carne guasta salì fino a loro:
qualche mattatoio, nei sobborghi, era stato incendiato da una bomba. Si
assopirono e, quando si svegliarono, videro dei soldati che portavano delle
gamelle. Florence emise un flebile grido di desiderio e i soldati le diedero
una ciotola di brodo e un pezzo di pane. Con lo spuntar del giorno Gabriel
aveva ritrovato un po’ di rispetto umano: non osò disputare alla sua amante
quel po’ di zuppa e quel tozzo di pane. Florence sorbiva lentamente il
brodo. E tuttavia si fermò, tornò vicino a Gabriel.
"Prendi tu il resto" gli disse. Lui rifiutò.
"Ma no, ce n'è appena per te!"
Lei gli tese la scodella di metallo piena di un liquido tiepido che sapeva di
cavolo. L'uomo la afferrò con entrambe le mani tremanti, posò la bocca
sull'orlo e bevette a lunghi sorsi, fermandosi solo per prendere fiato, e
quando ebbe finito emise un sospiro di benessere.
"Va meglio?" domandò il soldato.
Era lo stesso che la sera prima li aveva cacciati dalla stazione, ma i raggi
del sole nascente addolcivano il suo volto da centurione truce.
Gabriel si ricordò di avere in tasca delle sigarette e gliele offrì. I due
uomini fumarono un momento in silenzio mentre Florence tentava invano di
infilarsi le scarpe.
"Se fossi in voi," disse poi il soldato "filerei più che velocemente: i
tedeschi stanno per arrivare. Anzi, è strano che non siano ancora qui.
Ma non hanno più bisogno di affrettarsi," aggiunse con amarezza "ormai
sarà solo una passeggiata fino a Bayonne...".
"Allora tutto è perduto?" gli domandò timidamente Florence.
Il soldato non rispose e si allontanò bruscamente. Si mossero anche loro,
un po’ traballanti, e andarono difilato verso i sobborghi. Nella città che era
sembrata deserta spuntavano via via da ogni parte piccoli gruppi di sfollati
carichi di bagagli. Si ritrovavano e si aggregavano gli uni agli altri come
bestie smarrite che dopo la tempesta si cercano e si raggruppano. Andavano
verso il ponte presidiato dai soldati, che li lasciavano passare. Anche i Corte
erano lì. Sopra di loro il cielo era di un azzurro puro e luminoso, senza una
nuvola, senza un aereo. Sotto scorreva un bel fiume luccicante. Di fronte si
aprivano la strada che portava verso sud e un giovane bosco dal fogliame
ombroso.
Improvvisamente il verde parve spostarsi e muovere avanti: camion e
cannoni tedeschi mimetizzati avanzavano verso di loro. Corte vide la gente
davanti a lui alzare le braccia e fare dietro front mettendosi a correre. In
quel preciso istante i francesi spararono e le mitragliatrici tedesche
risposero. Presi tra due fuochi gli sfollati correvano in tutte le direzioni,
alcuni giravano in tondo come impazziti; una donna scavalcò il parapetto e
si gettò nel fiume.
Florence afferrò il braccio di Corte e vi conficcò le unghie urlando:
"Torniamo indietro, vieni!"
"Ma il ponte salterà" gridò Gabriel.
La prese per mano spingendola avanti, e d'un tratto un pensiero gli
attraversò la mente, strano, bruciante e fulmineo a mo’ di lampo: stavano
correndo verso la morte. La attirò a sé piegandole con forza la testa, gliela
nascose sotto il suo soprabito - come si bendano gli occhi di un condannato
- e incespicando, ansimando, quasi portandola di peso, superò i pochi metri
che li separavano dall'altra riva. Benché il cuore gli martellasse in petto
come il battaglio di una campana, non aveva realmente paura. Desiderava
salvare la vita di Florence con un ardore selvaggio. Confidava in qualcosa
d'invisibile, in una mano tutelare posata su di lui, su di lui debole, misero,
piccolo, così piccolo da essere risparmiato dalla sorte come una pagliuzza
dalla tempesta.
Attraversarono il ponte, nella corsa sfiorarono i tedeschi, superarono le
mitragliatrici e le uniformi verde reseda. La strada era libera, la morte alle
loro spalle, e improvvisamente videro - sì, non si sbagliavano, l'avevano
riconosciuta -, lì, all'imbocco di un piccolo sentiero nella foresta, la loro
automobile, con i fedeli domestici che li aspettavano. Florence riuscì solo a
gemere: "Julie, Dio sia lodato.
Julie!" Le voci dell'autista e della cameriera giungevano alle orecchie di
Corte come quei suoni rochi e bizzarri che squarciano in parte le nebbie di
uno svenimento. Florence piangeva. Lentamente, ancora incredulo, con
sprazzi di ritrovata lucidità, penosamente, gradualmente Corte si rendeva
conto che la macchina gli era stata restituita, che gli erano stati restituiti i
suoi manoscritti, che aveva ritrovato la vita, e non sarebbe stato mai più un
uomo qualunque, sofferente, affamato, coraggioso e vile a un tempo, ma
una creatura privilegiata e preservata da ogni male - Gabriel Corte!!!
CAPITOLO 18.
Alla fine Hubert, unitosi agli uomini incontrati lungo la strada, era
arrivato sulle rive dell'Allier. Erano le dodici in punto di lunedì 17 giugno.
Nel frattempo ai soldati si erano aggiunti dei volontari - uomini della
guardia mobile, senegalesi, militari di compagnie sbandate che tentavano
invano di ricostituirsi e si aggrappavano con disperato coraggio a ogni sacca
di resistenza, ragazzi come Hubert Pericand separati dalla famiglia in fuga o
scappati di casa nottetempo "per raggiungere la truppa" Parole magiche che
erano corse di villaggio in villaggio, di fattoria in fattoria. "Vogliamo
raggiungere i soldati, fuggire dai tedeschi, ricompattarci al di là della Loira"
ripetevano bocche di sedicenni. Quasi tutti portavano in spalla un fagotto
(gli avanzi della merenda del giorno prima che una madre in lacrime aveva
avvolto in fretta e furia insieme a un maglione e a una camicia); avevano
volti rosei e paffuti, dita macchiate d'inchiostro, voci che stavano mutando.
Tre di loro erano accompagnati dai rispettivi padri, combattenti del '14, che
da settembre età, vecchie ferite e situazione familiare avevano tenuto
lontani dal conflitto. Il posto di comando fu installato sotto un ponte di
pietra vicino al passaggio a livello.
Hubert contò circa duecento uomini accampati sulla strada e lungo la riva.
Inesperto com'era credette che finalmente un esercito agguerrito facesse
fronte al nemico. Vide collocare sul ponte di pietra tonnellate di melinite,
ma ignorava che non si era riusciti a trovare la miccia per l'accensione. I
soldati si affaccendavano senza aprir bocca oppure dormivano sdraiati per
terra. Non avevano mangiato dal giorno prima.
Verso sera vennero distribuite delle bottiglie di birra. Hubert non aveva
fame, ma quella birra bionda con il suo sapore amaro e la schiuma che
lentamente svaniva gli procurò una sensazione di benessere. Era quel che gli
serviva per darsi un po’ di coraggio. In effetti, nessuno sembrava aver
bisogno di lui. Andava dall'uno all'altro offrendo timidamente i suoi servigi;
non gli rispondevano, non lo guardavano neppure. Vide due soldati che
trascinavano paglia e fascine verso il ponte e un altro che spingeva davanti a
sé una botte di catrame. Allora alzò un'enorme fascina, ma in modo così
maldestro che si ferì le mani con le spine e proruppe in un'esclamazione di
dolore. Poco dopo, pensando che nessuno lo avesse sentito, si sentì morire
di vergogna quando, gettato finalmente il suo carico davanti al ponte, uno
degli uomini gli gridò: "Ehi, tu, che cavolo ci fai qui? Non vedi che dai
fastidio?"
Col cuore ferito Hubert si allontanò. Poi, in piedi, immobile sulla strada di
Saint-Pourçain, davanti all'Allier, vide eseguire un lavoro che gli sembrava
incomprensibile: la paglia e le fascine, cosparse di catrame, venivano
collocate sul monte, vicino a un bidone di benzina da cinquanta litri. Era lo
sbarramento sul quale si contava per arrestare le forze nemiche mentre un
cannone da 75 avrebbe fatto esplodere la melinite.
Il resto della giornata passò così, e anche la notte e tutta la mattinata
seguente: ore vuote, stranite, incoerenti come la febbre. E sempre niente da
mangiare, niente da bere. Perfino i giovani contadini stavano perdendo i
loro bei colori: illividiti dalla fame, neri di polvere, i capelli scarmigliati, gli
occhi arrossati, sembravano improvvisamente più vecchi, più maturi, con
un'aria ostinata, dolente e dura.
Alle due apparvero sull'altra riva del fiume i primi tedeschi. Era la
colonna motorizzata che aveva attraversato Paray-le-Monial la mattina
stessa. A bocca aperta, Hubert li guardava avanzare sul ponte a tutta
velocità, come una selvaggia folgore di guerra che saettava nell'aria quieta
della campagna. Durò appena un istante: una cannonata fece saltare le botti
di melinite che facevano da sbarramento. Frammenti del ponte, mezzi
corazzati e uomini che vi stavano sopra caddero nell'Allier. Hubert vide
correre i soldati davanti a lui.
"Ci siamo! Andiamo all'assalto" pensò, e si sentì gelare, la gola gli si
seccò come quando era bambino e sentiva le prime note della fanfara
militare che passava per strada. Si lanciò in avanti e inciampò nella paglia e
nelle fascine cui veniva dato fuoco. Il fumo nero del catrame gli entrò nella
bocca e nel naso. Dietro quella cortina protettiva le mitragliatrici fermavano
i carri armati tedeschi. Tossendo, starnutendo e sentendosi soffocare, Hubert
indietreggiò di qualche passo, strisciando. Era disperato. Non aveva
un'arma. Non faceva niente. Gli altri si battevano e lui stava lì a braccia
conserte, inerte, inutile.
Si consolò un po’ vedendo che intorno a lui gli uomini si limitavano a
subire il fuoco nemico senza rispondere. Lo attribuì a sottili ragioni tattiche,
finché capì che in realtà le munizioni erano quasi completamente esaurite.
Tuttavia, pensò, visto che ci fanno restare qui, vuol dire che siamo
necessari, che serviamo a qualcosa, che stiamo proteggendo, chissà, il
grosso dell'esercito francese. Si aspettava di veder spuntare da un momento
all'altro delle truppe fresche che li avrebbero raggiunti a passo di carica
sulla strada di Saint-Pourçain gridando: "Siamo qui, ragazzi, non
preoccupatevi, li batteremo!" o altre frasi guerresche. Ma non arrivava
nessuno. Vide un uomo, lì vicino, con la testa insanguinata, che barcollava
come fosse ubriaco e che finì per cadere in un intrico di arbusti dove rimase
seduto in una posizione bizzarra e scomoda, il mento sul petto e le
ginocchia ripiegate sotto il corpo. Sentì un ufficiale gridare con rabbia:
"Niente medici, niente infermieri, niente lettighe! Che cosa possiamo fare?"
Qualcuno gli rispose:
"Ce n'è uno conciato male nel giardino del dazio"
"Che cosa ci posso fare, mio Dio?" ripeté l'ufficiale. "Lasciatelo lì".
Alcune granate avevano incendiato una parte del villaggio. Nella
splendida luce di giugno le fiamme avevano un colore trasparente e rosa; un
alto pennacchio di fumo si innalzava nel cielo, attraversato dai raggi dorati
del sole con riflessi di zolfo e di cenere.
"I ragazzi se ne vanno" disse un soldato a Hubert, mostrandogli i
mitraglieri che abbandonavano il ponte.
"Perché?" gridò Hubert costernato. "Vuol dire che rinunciano a
combattere?"
"E con che cosa?"
"É un disastro" sospirò Hubert. "Una sconfitta! Sto assistendo a una
grande sconfitta, è peggio di Waterloo. Non c'è scampo, siamo perduti, non
rivedrò più la mamma e nessuno dei miei. Morirò". Si sentiva perduto,
indifferente a tutto, in uno stato spaventoso di stanchezza e di disperazione.
Non capì neppure che veniva dato l'ordine di ritirarsi.
Vide gli uomini correre sotto le raffiche delle mitragliatrici, si lanciò,
saltò oltre la recinzione di un giardinetto nel quale i proprietari avevano
abbandonato una carrozzina. Ma la battaglia non era cessata. Senza carri
armati, senza artiglieria, senza munizioni, venivano ancora difesi pochi
metri quadrati di terreno, una testa di ponte, mentre da ogni parte i tedeschi
vincitori si riversavano sulla Francia. Hubert fu colto all'improvviso da
un'ondata di coraggio disperato, quasi di follia. Pensò che stava fuggendo
mentre il suo dovere era quello di ritornare verso il fuoco - verso quei fucili
mitragliatoli che continuavano a rispondere ostinati alle mitragliette
tedesche - e di morire con quegli uomini. Di nuovo rischiando a ogni istante
la morte, attraversò il giardinetto calpestando dei giocattoli sparpagliati.
Dov'erano gli abitanti di quella piccola casa? Erano scappati? Sotto una
pioggia di proiettili si arrampicò sulla recinzione metallica e ricadde, sano e
salvo, sulla strada, dove ricominciò a strisciare, con le mani e le ginocchia
sanguinanti, verso il fiume. Non ci arrivò mai. Era a metà strada quando
tutto tacque. A quel punto si accorse che era notte e capì che doveva essere
svenuto. Quel silenzio incredibile, improvviso, lo aveva fatto rinvenire. Si
sedette. Si sentiva stordito, con la testa vuota. Uno splendido chiaro di luna
rischiarava la strada, ma lui stava al riparo nella fascia d'ombra proiettata da
un albero. Il quartiere Villars continuava a bruciare, le armi tacevano tutte.
Hubert abbandonò la provinciale, lungo la quale temeva d'incontrare dei
tedeschi, e attraversò un boschetto. Ogni tanto si fermava e si chiedeva dove
stesse andando. Le colonne motorizzate che in cinque giorni avevano
occupato metà della Francia l'indomani sarebbero certamente arrivate ai
confini dell'Italia, della Svizzera, della Spagna. E lui non aveva scampo.
Dimenticava che non aveva addosso un'uniforme, e niente faceva supporre
che si fosse battuto. Lo avrebbero fatto prigioniero, ne era sicuro. Lo stesso
istinto che lo aveva portato sul campo di battaglia lo spingeva ora alla fuga,
lontano da quell'incendio, da quei ponti distrutti, da quei sogni in cui, per la
prima volta in vita sua, si era trovato a faccia a faccia con dei morti.
Calcolava febbrilmente la strada che i tedeschi avrebbero potuto percorrere
di lì al mattino seguente. Immaginava le città cadute l'una dopo l'altra, i
soldati vinti, le armi deposte, i camion abbandonati per mancanza di
benzina, e quei carri armati, quei cannoni anticarro di cui aveva ammirato le
riproduzioni, e tutto quel bottino finito nelle mani del nemico!
Tremava, piangeva avanzando carponi in quel campo illuminato dalla
luna, e tuttavia non credeva ancora alla sconfitta, così come una creatura
giovane e sana rimuove l'idea della morte. I soldati si sarebbero ritrovati un
po’ più avanti, si sarebbero raggruppati, avrebbero ricominciato a
combattere, e lui con loro. E lui... con loro... "Ma io che cosa ho fatto?"
pensò all'improvviso. "Non ho sparato neppure una fucilata!" Provò una tale
vergogna che cocenti lacrime di dolore gli sgorgarono nuovamente dagli
occhi. "Non è colpa mia, ero disarmato, avevo soltanto le mie mani"
Improvvisamente si rivide mentre tentava invano di trascinare quella fascina
verso il fiume. Già, non era stato neanche capace di fare quello, lui che
avrebbe voluto slanciarsi sul ponte attirando dietro di sé i soldati, gettarsi
contro i carri armati nemici, morire gridando: "Viva la Francia!" Era
ubriaco di stanchezza e di disperazione. Ogni tanto pensieri di un'insolita
maturità gli attraversavano la mente: pensava al disastro, alle sue cause
profonde, al futuro, alla morte. Poi si interrogava su se stesso, su quel che
ne sarebbe stato di lui, e a poco a poco riprendeva coscienza della realtà:
"Quante me ne dirà la mamma, accidenti!" mormorava, e il suo volto
pallido, teso, che sembrava essere invecchiato e smagrito in due giorni,
s'illuminava un attimo del suo bel sorriso aperto e schietto di bambino.
Fra due campi trovò una stradina che si inoltrava nel verde. Lì niente
parlava di guerra. Scorrevano acque di fonte, un usignolo cantava, una
campana batteva le ore, c'erano fiori su tutte le siepi, foglie giovani sugli
alberi. Si bagnò le mani e la faccia in un ruscello e bevette con le mani a
coppa, dopodiché si sentì meglio. Cercò disperatamente qualche frutto sui
rami. Sapeva che non era ancora la stagione, ma aveva l'età in cui si crede
nei miracoli. In fondo a quel sentiero si ritrovò sulla strada. Su un cippo
lesse: Cressange, ventidue chilometri, e si fermò perplesso; poi vide una
fattoria e alla fine, dopo aver esitato a lungo, bussò. Sentì un rumore di
passi all'interno della casa. Gli chiesero chi fosse. Rispose che si era perso e
aveva fame, e lo fecero entrare.
All'interno trovò tre soldati francesi addormentati. Li riconobbe: erano del
manipolo che aveva difeso il ponte di Moulins. Adesso russavano sdraiati
sulle panche e avevano volti sparuti e sporchi rovesciati all'indietro come
quelli dei morti. Li vegliava una donna che lavorava a maglia mentre il
gomitolo di lana rotolava sul pavimento inseguito dal gatto. Era uno
spettacolo così familiare e a un tempo così strano dopo tutto quello che
aveva visto negli ultimi otto giorni che Hubert cadde a sedere, sfinito. Sul
tavolo vide gli elmetti dei soldati, che erano stati ricoperti di foglie per
attutirne il riflesso al chiaro di luna.
Uno degli uomini si svegliò e si sollevò appoggiandosi a un gomito.
"Ne hai visti, ragazzo?" domandò con voce spenta e roca.
Hubert capì che alludeva ai tedeschi.
"No no" si affrettò a rispondere. "Neanche uno dopo Moulins". _
"Pare" disse il soldato "che non facciano neanche più prigionieri. Ce ne
sono troppi. Li disarmano e poi li mandano a farsi fottere".
"Pare" disse la donna.
Rimasero in silenzio. Hubert mangiò la minestra e il formaggio che gli
avevano messo davanti. Quando ebbe finito domandò al soldato:
"Adesso che cosa fate?"
Il compagno aveva aperto gli occhi. Si misero a discutere: uno voleva
raggiungere Cressange, l'altro ribatteva con aria afflitta:
"Perché? Sono dappertutto, dappertutto..." e gettava intorno sguardi
dolenti e spaventati da uccello stregato.
Gli sembrava davvero di vederli tutt'intorno, quei tedeschi pronti ad
acciuffarlo. A tratti se ne usciva in una sorta di risata nervosa e piena di
amarezza.
"Buon Dio! Aver fatto il '14 e vedere questo...".
La donna lavorava placidamente a maglia. Era molto vecchia. Portava una
cuffia bianca pieghettata.
"Io ho visto il '70. E allora..." borbottò.
Hubert li ascoltava, li osservava sgomento. Gli sembravano a malapena
reali, simili a fantasmi, a ombre dolenti uscite dalle pagine della Storia di
Francia. Mio Dio! Il presente e le sue rovine valevano più di quelle glorie
morte e di quell'odore di sangue che si levava dal passato. Hubert bevette
una tazza di caffè molto forte e molto caldo, un bicchierino di acquavite,
ringraziò la donna, salutò i soldati e si mise in cammino, deciso a
raggiungere Cressange nella mattinata. Da lì avrebbe forse potuto mettersi
in contatto con i suoi cari e rassicurarli sulla propria sorte. Camminò fino
alle otto e si trovò in un paesino a pochi chilometri da Cressange, davanti a
un albergo dal quale usciva un delizioso profumo di caffè e di pane fresco.
A quel punto si rese conto che non si reggeva in piedi dalla fatica e che non
ce l'avrebbe più fatta a proseguire. Entrò nella sala dell'albergo, che era
piena di sfollati, e domandò se sarebbe stato possibile avere una camera.
Nessuno era in grado di rispondergli. Gli dissero che la padrona era uscita
alla ricerca di cibo per quell'orda di affamati, e che sarebbe tornata di lì a
poco. Tornò in strada e, a una finestra del primo piano, vide una donna che
si stava truccando. Nel corso dell'operazione il rossetto le sfuggì di mano e
cadde ai piedi di Hubert, che si precipitò a raccoglierlo. La donna si affacciò
alla finestra, lo vide e gli sorrise.
"E adesso, come fare per recuperarlo?" domandò.
E lasciò penzolare fuori dalla finestra il braccio nudo, la mano
bianchissima. Le unghie dipinte scintillarono al sole mandando piccoli
bagliori agli occhi di Hubert. Quelle carni nivee, quei capelli rossi lo
colpirono come una luce troppo viva.
Abbassò precipitosamente lo sguardo e balbettò:
"Posso... posso riportarglielo io, signora".
"Oh, sì, per favore" disse lei.
E sorrise di nuovo. Hubert entrò nell'albergo, attraversò una sala, salì una
piccola scala scura e vide una porta aperta che dava su una camera tutta
rosa. Il sole passava infatti attraverso una misera tenda di cotone rosso e
riempiva la stanza di un'ombra calda, viva, cremisi come un cespuglio di
rose. La donna lo fece entrare; si stava lucidando le unghie. Prese il
bastoncino di rossetto, guardò il ragazzo: "Ma sta per svenire!" Hubert sentì
che lo prendeva per mano, lo aiutava a raggiungere una poltrona e gli
passava un cuscino sotto la testa. Non aveva perso i sensi, però, e il cuore
gli batteva molto forte. Tutto gli ballava intorno come per il mal di mare, e
grandi ondate gelide e brucianti lo attraversavano rincorrendosi.
Era intimidito ma piuttosto fiero di sé. Quando lei gli domandò: "Che
cos'è, mio povero ragazzo? Stanchezza? Fame?" lui accentuò il tremito della
voce per rispondere:
"Non è niente, ma... ho camminato da Moulins, dove abbiamo difeso il
ponte"
Lei lo guardò sorpresa.
"Ma quanti anni ha?"
"Diciotto"
"Non è stato richiamato?"
"No. Ero in viaggio con i miei familiari. Li ho lasciati e mi sono unito ai
combattenti"
"Ma che bravo" disse lei.
Aveva parlato con il tono di ammirazione che lui si aspettava, e ciò
nonostante, chissà perché, sotto il suo sguardo Hubert arrossì. Da vicino la
donna non sembrava giovane; sul suo volto sapientemente truccato si
vedevano piccole rughe. Ma era molto slanciata, molto elegante, e aveva
delle magnifiche gambe.
"Qual è il suo nome?"
"Hubert Pericand"
"Non c'è un Pericand soprintendente di un museo nazionale?"
"É mio padre, signora"
Mentre parlava, la donna si era alzata e gli versava del caffè. Lei aveva
appena fatto colazione, e il vassoio con la caffettiera piena a metà, il bricco
con la panna e le fette di pane tostato era ancora sulla tavola.
"Non è più molto caldo" disse "ma lo beva ugualmente, le farà bene"
Hubert ubbidì.
"C'è un tale pandemonio, giù, con tutti quegli sfollati, che potrei suonare
fino a domani e non salirebbe nessuno! Lei viene da Parigi, vero?"
"Sì, anche lei, signora?"
"Proprio così. Sono passata da Tours, e lì mi sono presa un bel
bombardamento! Adesso penso di raggiungere Bordeaux; suppongo che
l'Opera sia sfollata lì"
"Lei è un'attrice, signora?" domandò Hubert con rispetto.
"Ballerina. Ariette Corail".
Hubert non aveva mai visto una ballerina se non sul palcoscenico dello
Châtelet. Istintivamente il suo sguardo si posò con curiosità e desiderio sulle
caviglie eleganti e sui polpacci muscolosi, inguainati in calze di seta
lucente. Era terribilmente turbato. Una ciocca bionda gli cadde sugli occhi.
La donna gliela rialzò dolcemente con la mano.
"E adesso dove conta di andare?"
"Non lo so" confessò Hubert. "La mia famiglia si è fermata in un paesino
a circa trenta chilometri da qui. Andrei volentieri a raggiungerla ma ci
devono già essere i tedeschi"
"Li aspettano anche qui da un momento all'altro" "Qui?"
Ebbe un moto di spavento e si alzò come per fuggire. Lei lo trattenne
ridendo.
"Ma cosa vuole che facciano a un ragazzino come lei...". 'Però ho
combattuto" protestò lui, offeso. "Si, certo, ma nessuno andrà a dirglielo,
no?"
La donna rifletteva aggrottando leggermente le sopracciglia.
"Ascolti. Ecco cosa faremo. Io scenderò e chiederò una camera per lei.
Qui mi conoscono; è un piccolo albergo, ma la cucina è ottima e ci ho
passato qualche fine settimana. Le daranno la camera del figlio che è sotto
le armi. Si riposerà uno o due giorni poi potrà mettersi in contatto con i suoi
genitori"
"Non so come ringraziarla" mormorò Hubert.
Lei lo lasciò solo. Quando tornò, pochi minuti dopo, Hubert dormiva.
Volle tirargli su la testa e circondò con le braccia le spalle larghe del
ragazzo, il petto che si sollevava a ritmo lento. Lo guardò con attenzione,
sistemò di nuovo i capelli biondi che gli cadevano arruffati sulla fronte, lo
contemplò ancora una volta con l'aria ghiotta e sognante di una gatta che
fissa un uccellino e sospirò:
"Non è male, il giovanotto...".
CAPITOLO 19.
In paese si aspettavano i tedeschi. All'idea di vedere per la prima volta i
vincitori c'era chi provava un sentimento di disperata vergogna, chi si
sentiva stretto dall'angoscia, ma la maggioranza manifestava solo una
curiosità sgomenta, come all'annuncio di uno spettacolo inedito e
stupefacente. Il giorno prima i funzionari, le guardie, gli impiegati della
posta avevano ricevuto l'ordine di allontanarsi. Il sindaco, invece, restava al
suo posto. Era un vecchio contadino gottoso e flemmatico che niente
riusciva a scuotere. Se il paese fosse stato del tutto senza un capo, le cose
non sarebbero andate peggio! A mezzogiorno nella rumorosa sala da pranzo
dove Ariette Corail stava finendo di mangiare arrivò la notizia
dell'armistizio. Alcune donne scoppiarono in lacrime. La situazione era
confusa, si diceva, in certi posti i soldati opponevano ancora resistenza e
alcuni civili si erano uniti a loro.
Tutti erano d'accordo nel disapprovarli: era la fine, ormai, non restava che
arrendersi. E tutti parlavano contemporaneamente. L'aria era irrespirabile.
Ariette spinse da parte il piatto e uscì nel piccolo giardino dell'albergo
portando con sé le sigarette, una sdraio, un libro. Partita da Parigi una
settimana prima in uno stato di panico che rasentava la follia, si ritrovava
ora, dopo essere realmente passata attraverso pericoli mortali, perfettamente
calma e fredda. Per di più aveva acquisito la certezza di sapersela cavare
sempre e ovunque e di essere dotata di un grande talento per procurarsi in
ogni circostanza il massimo di comodità e di benessere. Quella elasticità
mentale, quella lucidità, quella imperturbabilità le erano enormemente
servite nella carriera e nella vita sentimentale, ma non sapeva, fino a quel
momento, che le sarebbero state ugualmente utili nella vita quotidiana o
nelle emergenze.
Adesso, quando ricordava di aver implorato la protezione di Corbin, le
spuntava sulle labbra un sorriso di commiserazione. Erano arrivati a Tours
giusto in tempo per subire il bombardamento; la valigia di Corbin che
conteneva gli effetti personali e i documenti della banca era rimasta sepolta
sotto le macerie, mentre lei era emersa da quel disastro senza aver perso un
solo fazzoletto, né una scatola di fard, né un paio di scarpe. Aveva visto
Corbin sconvolto dal terrore e pensava con piacere che in futuro non
avrebbe mancato di ricordargli quanto più spesso possibile quei momenti.
Poi rivide la mascella cascante di lui, simile a quella di un morto: veniva
voglia di mettergli un sottogola per sostenerla. Pietoso! Lo aveva piantato a
Tours nella confusione e nel tumulto spaventevole che regnavano in città,
aveva preso la macchina, si era procurata della benzina e se n'era andata. Da
due giorni si trovava in quel paesino dove aveva mangiato bene e dormito
saporitamente, mentre una massa di poveracci stava accampata in piazza o
nei fienili. E si era persino offerta il lusso della carità lasciando la sua
camera a quel ragazzo così carino, il piccolo Pericand... Pericand? Una
famiglia borghese, un po’ noiosa, rispettabile, molto ricca, che grazie alla
parentela con i Maltête di Lione aveva relazioni brillanti nel mondo
ufficiale, ministeriale e della grande industria... Relazioni brillanti... Emise
un piccolo sospiro di fastidio al pensiero di tutto quello che avrebbe dovuto
ormai modificare in quell'ordine di idee e a tutta la fatica che si era
sobbarcata qualche tempo prima per sedurre Gerard Salomon-Worms,
cognato del conte de Furieres. Conquista assolutamente inutile e che le era
costata tanto impegno e tanto tempo.
Aggrottando appena le sopracciglia, Ariette si guardò le unghie. La vista
di quei dieci specchietti scintillanti sembrava predisporla alle speculazioni
astratte. I suoi amanti sapevano che quando lei si contemplava le mani con
quell'aria pensosa e malevola finiva poi per esprimere un'opinione su cose
come la politica, l'arte, la letteratura e la moda; e la sua opinione era in
genere acuta e pertinente. Per qualche istante, in quel piccolo giardino
fiorito, mentre le ronzavano intorno i calabroni intenti a saccheggiare un
cespuglio di campanule amaranto, la ballerina provò a immaginarsi
l'avvenire. E arrivò alla conclusione che per lei niente sarebbe cambiato. Il
suo patrimonio consisteva in gioielli - e non potevano che aumentare di
valore - e in terreni (prima della guerra aveva fatto qualche acquisto oculato
nel Midi) Tutto ciò, d'altronde, era secondario. I beni principali di cui
disponeva erano le sue gambe, la sua figura, il suo gusto per l'intrigo, e
questi erano minacciati solo dal tempo. Ecco il punto dolente... Pensò alla
sua età e subito, così come per scongiurare la malasorte si toccò un amuleto,
tirò fuori uno specchietto dalla borsa e guardò attentamente il suo viso. Un
pensiero sgradevole le attraversò la mente: usava, per truccarsi, un fard
americano, insostituibile. D'ora in avanti non avrebbe potuto procurarselo
facilmente. Questo la mise di malumore. Bah! Le cose sarebbero cambiate
in superficie e il fondo sarebbe rimasto lo stesso!
Come sempre all'indomani di ogni catastrofe, ci sarebbero stati nuovi
ricchi, uomini pronti a comprare il piacere pagandolo a caro prezzo, perché
il loro era denaro facile, ottenuto senza fatica, e l'amore sarebbe stato
sempre lo stesso. Purché tutta quella confusione si placasse al più presto!
Che si stabilisse un modo di vivere, uno qualsiasi, giacché tutto quel
pandemonio, quella guerra, quelle rivoluzioni, quei grandi rivolgimenti
della storia potevano esaltare gli uomini, ma le donne... Ah, le donne ne
provavano solo fastidio! Ariette era assolutamente sicura che tutte la
pensassero come lei: quei paroloni, quei sentimenti solenni erano noiosi,
noiosi da morire! Gli uomini... chissà, difficile dire... Per certi versi quelle
creature semplici erano incomprensibili, ma le donne, loro, si erano liberate
per almeno cinquant'anni di tutto ciò che non era il quotidiano, il terra
terra... Alzò gli occhi e vide la padrona del piccolo albergo che, affacciata
alla finestra, stava guardando qualcosa.
"Che cosa c'è, signora Goulot?" domandò.
L'altra rispose con voce solenne e tremante:
"Sono loro, signorina... arrivano". "I tedeschi?".
"Sì"
La ballerina fece per alzarsi e andare al cancello da dove si vedeva la
strada, poi, temendo che in sua assenza qualcuno le occupasse la sdraio e il
posto all'ombra, rimase dov'era.
Non erano ancora i tedeschi ad arrivare, ma un tedesco: il primo. Dietro le
porte sprangate, dagli spiragli delle imposte socchiuse o dall'abbaino di un
solaio tutto il paese lo guardava avanzare. Il soldato fermò la motocicletta
sulla piazza deserta; portava i guanti, un'uniforme verde e un elmetto con
visiera sotto il quale, quando alzò la testa, apparve un volto roseo, magro,
quasi infantile. "Com'è giovane!" sussurrarono le donne. Inconsciamente si
aspettavano una qualche visione apocalittica, un qualche mostro orrendo. Il
tedesco scrutava tutt'intorno alla ricerca di qualcuno. Allora il tabaccaio, che
aveva fatto la campagna del '14 e sul risvolto della vecchia giacca grigia
portava una croce di guerra e la medaglia militare, si fece incontro al
nemico. Per un attimo i due uomini restarono immobili, l'uno di fronte
all'altro, senza parlare. Poi il tedesco mostrò la sigaretta che teneva in mano
e chiese del fuoco in cattivo francese. Il tabaccaio rispose in cattivo tedesco
giacché aveva preso parte all'occupazione di Mayence nel '18. Il silenzio era
tale (tutto il villaggio tratteneva il respiro) che si coglieva ogni loro parola.
Il tedesco domandò la strada.
Il francese rispose, poi, fattosi coraggio: "É stato firmato l'armistizio?"
Il tedesco allargò le braccia.
"Non lo sappiamo ancora. Speriamo" disse.
E la risonanza umana di quella parola, quel gesto, tutto l'insieme provava
in modo evidente che non ci si trovava di fronte a un mostro assetato di
sangue ma a un soldato come gli altri, e il ghiaccio fra il paese e il nemico,
fra il contadino e l'invasore si ruppe immediatamente.
"Non sembra cattivo" sussurrarono le donne.
Il tedesco portò la mano all'elmetto, ma senza irrigidirsi, sorridendo, con
un gesto indeciso e appena abbozzato, che non era un vero e proprio saluto
militare e nemmeno quello con cui i civili prendono congedo.
Lanciò alle finestre chiuse una rapida occhiata curiosa, mise in moto e
sparì. Allora, l'una dopo l'altra, le porte si aprirono, il paese al completo si
riversò sulla piazza e circondò il tabaccaio il quale, in piedi, immobile, le
mani in tasca, le sopracciglia aggrottate, guardava lontano. Gli si leggevano
in volto espressioni contraddittorie: sollievo che tutto fosse finito, tristezza e
collera che fosse finito a quel modo, ricordi del passato, paura del futuro. E
ognuno di quei sentimenti sembrava riflettersi sui volti degli altri. Le donne
si asciugarono gli occhi pieni di lacrime, gli uomini restarono in silenzio
con un'aria ostinata e severa. I bambini, per un attimo distolti dai loro
svaghi, erano tornati alle biglie e al gioco del mondo. Il cielo brillava di uno
splendore luminoso e argenteo; come spesso avviene a metà di una giornata
molto bella, e nell'aria aleggiava un impercettibile velo di vapore, tenero e
iridescente, che ravvivava tutti i freschi colori di giugno, rendendoli più
ricchi e più morbidi, quasi li si vedesse attraverso un prisma d'acqua.
Le ore passavano tranquille. Sulla strada c'erano meno automobili. Le
biciclette filavano ancora a tutta velocità come spinte dal vento impetuoso
che da una settimana soffiava da nordest e trascinava con sé tanti poveri
disgraziati. Un po’ più tardi - visione sorprendente - spuntarono alcune
macchine che andavano in senso contrario rispetto a quello seguito negli
ultimi otto giorni: tornavano verso Parigi. A quella vista ci fu chi pensò
davvero che tutto fosse finito. La gente rientrò nelle case. Si udì di nuovo
l'acciottolio delle stoviglie che le donne lavavano in cucina, il passo leggero
di una vecchierella che andava a portare l'erba ai conigli, e persino il canto
di una ragazzina che attingeva l'acqua con la pompa. Alcuni cani si
azzuffavano rotolando nella polvere.
Era sera - un crepuscolo delizioso, un'aria trasparente, un'ombra
azzurrina, un ultimo bagliore di tramonto che accarezzava le rose, la
campana della chiesa che invitava i fedeli alla preghiera - allorché si udì
sulla strada un rumore che andava crescendo e che non somigliava a quello
degli ultimi giorni: pesante, sicuro di sé, quel rimbombo sembrava farsi
strada senza fretta, in modo inesorabile. Dei camion avanzavano verso il
villaggio. Questa volta erano proprio i tedeschi.
Dai camion fermi sulla piazza scesero degli uomini; altri mezzi
giungevano dietro ai primi, poi altri, e altri ancora. In pochi istanti l'intera
vecchia piazza grigia, dalla chiesa al municipio, non fu più che una massa
immobile e oscura di camion color ferro sui quali si distingueva ancora
qualche ramo avvizzito, residuo della mimetizzazione.
Quanti uomini! La gente, uscita di nuovo sulla porta di casa, silenziosa e
attenta, li guardava, li ascoltava parlare, cercava invano di farsi un'idea di
quanti fossero. I tedeschi sbucavano da tutte le parti, riempivano strade e
piazze, e ne arrivavano continuamente altri. Da settembre il paese non era
più abituato a sentire passi, risate, voci giovani. Era stordito, sconcertato dal
rumore confuso che saliva da quella marea di uniformi verdi, da quell'odore
di uomini sani, di corpi giovani, e soprattutto dai suoni di quella lingua
straniera. I tedeschi si riversavano nelle case, nei negozi, nei caffè, le
mattonelle rosse delle cucine risuonavano sotto i loro stivali. Chiedevano da
mangiare, da bere. Passando accarezzavano i bambini. Gesticolavano,
cantavano, ridevano rivolti alle donne. Quell'aria felice, quell'ebbrezza da
conquistatori, quella febbre, quella follia, quell'esultanza mista a una sorta
d'incredulità, quasi essi stessi non riuscissero a credere alla loro avventura,
tutto questo era così tumultuoso, così eccitante che i vinti erano portati a
dimenticare per qualche istante la loro pena e il loro rancore. Li guardavano
a bocca aperta.
Nel piccolo albergo, sotto la camera in cui Hubert continuava a dormire,
la sala echeggiava di grida e di canti. I tedeschi avevano subito chiesto dello
champagne ("Sekt! Nahrung!") e facevano saltare i tappi.
Chi giocava a biliardo, chi entrava in cucina portando con sé una quantità
di rosee scaloppine crude che gettava sul fuoco, dove sfrigolavano
diffondendo un denso fumo. Alcuni soldati salivano dalla cantina con
diverse bottiglie di birra, scostando impazienti la cameriera che voleva
aiutarli; un giovanotto dalla faccia vermiglia e i capelli d'oro cuoceva delle
uova su un angolo del fornello, un altro, in giardino, raccoglieva le prime
fragole. Due ragazzi seminudi immergevano la testa in secchi d acqua
fredda attinta al pozzo. Si saziavano, si rimpinzavano di tutto il ben di Dio
della terra; erano scampati alla morte, erano giovani, vivi, e vincitori!
Manifestavano la loro gioia delirante con parole affrettate, precipitose,
parlavano in cattivo francese con chi voleva starli a sentire e mostravano i
loro stivali ripetendo: "Noi camminare, camminare, camerati cadere e noi
sempre camminare" Un clicchettio di armi> di cinturoni, di elmetti saliva
dalla sala. Hubert lo percepiva in sogno, lo confondeva con i ricordi del
giorno prima, rivedeva la battaglia sul ponte di Moulins. E si agitava,
sospirava; respingeva qualcuno d'invisibile. Si lamentava, soffriva. Alla fine
si svegliò in quella stanza sconosciuta. Aveva dormito tutto il giorno. Ora,
dalla finestra aperta, si vedeva brillare la luna piena. Ebbe un moto di
stupore, si stropicciò gli occhi e vide la ballerina, che era entrata mentre lui
dormiva.
Hubert balbettò qualcosa per scusarsi e per ringraziare.
"Adesso lei deve aver fame, vero?" domandò Ariette.
Sì, effettivamente moriva di fame.
"Forse è meglio mangiare in camera, sa? Giù è impossibile, è pieno di
soldati"
"Soldati!" esclamò lui slanciandosi verso la porta. "Che cosa dicono?
Com'è la situazione? Dove sono i tedeschi?"
"I tedeschi? Ma sono qui. Sono soldati tedeschi".
Hubert si scostò bruscamente da lei con un moto di stupore e di spavento
simile al balzo di una bestia braccata.
"Tedeschi? No, no, è uno scherzo?"
Cercò invano un'altra parola e ripeté con voce bassa e tremante: "É uno
scherzo?"
Lei aprì la porta; dalla sala si levò allora, insieme a un fumo denso e acre,
l'inconfondibile rumore prodotto da una turba di soldati vincitori: grida,
risate, canti, e lo scalpiccio degli stivali e il tonfo delle pesanti pistole
gettate sui tavoli di marmo, e il cozzare degli elmetti contro le piastre di
metallo dei cinturoni, e quel fragore festoso che sale da una folla felice,
fiera, inebriata dalla vittoria.
"Come una squadra di rugby dopo una partita vinta" pensò Hubert. E
trattenne a stento lacrime e ingiurie. Si precipitò alla finestra e guardò fuori.
Ora la strada cominciava a vuotarsi, ma quattro uomini camminavano a
fianco a fianco e, passando, picchiavano alle porte delle case: "Luce!
Spegnete tutto!" gridavano e, docilmente, una dopo l'altra, le luci delle
lampade si spegnevano. Restava solo il chiarore della luna che accendeva
tenui sprazzi azzurrini su elmetti e canne dei fucili.
Hubert afferrò la tenda con entrambe le mani, se la premette in modo
convulso sulla bocca e scoppiò in lacrime.
"Su, su, si calmi" diceva la donna, e gli accarezzava la spalla con delicata
compassione. "Tanto non possiamo farci niente... Che cosa potremmo fare?
Tutte le lacrime del mondo sarebbero inutili. Ci saranno giorni migliori, e
dobbiamo vivere per vederli, prima di tutto dobbiamo vivere... resistere...
Ma lei si è comportato coraggiosamente... fossero stati tutti così
coraggiosi... ed è tanto giovane! Quasi un bambino...".
Lui scosse la testa.
"No?" fece lei a voce ancora più bassa. "Un uomo?".
E tacque. Con dita un po’ tremanti affondò nervosamente le unghie nel
braccio del ragazzo come se ghermisse una giovane preda e la cincischiasse
fra le mani prima di portarsela alla bocca e saziare la sua fame.
Sommessamente, con voce alterata, disse: "Non deve piangere. I bambini
piangono. Lei è un uomo, e un uomo, quando è infelice, sa cosa cercare...".
Aspettò una risposta che non venne. Lui teneva le palpebre abbassate, la
bocca serrata in una piega amara, ma il naso gli si arricciava e le narici
fremevano. Allora lei disse con voce fioca: "L'amore...".
CAPITOLO 20.
Nella camera in cui dormivano i bambini Pericand il gatto Albert si era
fatto il suo giaciglio. Salito sul piumino che teneva caldi i piedi di
Jacqueline, aveva cominciato a ciancicarlo e a mordicchiare il cretonne
profumato di colla e di frutta, ma poi la balia lo aveva cacciato via.
Per tre volte di seguito, non appena lei girava le spalle, Albert aveva
riconquistato la sua postazione con un balzo silenzioso dalla grazia aerea,
ma alla fine aveva dovuto cedere e si era sdraiato sotto la vestaglia di
Jacqueline, nell'accogliente cavità di una poltrona. Nella stanza ogni cosa
era immersa nel sonno. I bambini riposavano tranquillamente e la balia si
era assopita recitando il rosario. Il gatto, immobile, lanciava dardi sui grani
della coroncina che brillavano al chiaro di luna con un occhio fisso e verde;
l'altro restava chiuso.
Il corpo era nascosto sotto la vestaglia di flanella rosa. Piano piano, con
estrema delicatezza, tirò fuori una zampa, poi l'altra, le allungò e le sentì
fremere dall'articolazione superiore, molla d acciaio ricoperta di morbida e
calda pelliccia, fino alle unghie dure e trasparenti. Prese lo slancio, saltò sul
letto della balia e la puntò a lungo senza muoversi, solo facendo vibrare
l'estremità dei baffi sottili. Spinse avanti la zampa e toccò i grani del
rosario; dapprima li agitò appena, poi prese gusto al contatto con le
minuscole sfere perfette che gli rotolavano lisce e fresche fra le unghie e
dette loro una scossa più forte. Il rosario cadde a terra. Il gatto si spaventò e
sparì sotto una poltrona.
Poco dopo Emmanuel si svegliò e si mise a strillare. Le finestre erano
aperte, e così pure le imposte. La luna illuminava i tetti del villaggio, le
tegole scintillavano come scaglie di pesce. Il giardino era profumato,
tranquillo, e quella luce argentea sembrava muoversi come un'acqua
trasparente, fluttuare e ricadere dolcemente sugli alberi da frutto.
Sollevando con il muso le frange della poltrona, Albert guardava quello
spettacolo con aria grave, stupita e sognante. Era un gatto molto giovane,
vissuto sempre in città, dove le notti di giugno si avvertono solo da lontano,
e solo a volte se ne può respirare una folata tiepida e inebriante. Ma lì il
profumo gli saliva fino ai baffi, lo avvolgeva, lo afferrava, lo penetrava, lo
stordiva. Con gli occhi socchiusi, si sentiva investire da ondate di odori
fortissimi e delicati, quello degli ultimi lilla con il loro leggero sentore di
decomposizione, quello della linfa che scorre negli alberi e quello della terra
tenebrosa e fresca, quello degli animali - uccelli, talpe, topi, quante prede! odore muschiato di peli, di pelle, odore di sangue... Sbadigliò di bramosia,
saltò sul davanzale della finestra e passeggiò lentamente lungo la grondaia.
Era lì che, due giorni prima, una mano robusta e decisa lo aveva afferrato e
lo aveva ributtato sul letto di una Jacqueline in lacrime. Ma ora non si
sarebbe lasciato prendere. Misurò con lo sguardo la distanza fra grondaia e
suolo: era un gioco, per lui, superare quello spazio, ma volle darsi
importanza esagerando la difficoltà di quel salto. Fece oscillare il treno
posteriore con aria feroce da vincitore, spazzò la grondaia con la lunga coda
nera e, con le orecchie appiattite all'indietro, si slanciò e si ritrovò sulla terra
smossa di recente.
Esitò un attimo, poi affondò il muso nel terreno; adesso era al centro, nel
cuore, nel grembo stesso della notte. Era nella terra che bisognava sentirla: i
profumi erano tutti lì, fra le radici e i sassi, non ancora evaporati, non
ancora svaniti nel cielo o diluiti nell'odore degli umani. Erano eloquenti,
segreti e caldi. Erano vivi. Da ciascuno di essi fuoriusciva una piccola vita
nascosta, felice, commestibile...
Maggiolini, topi campagnoli, strilli e la piccola ranocchia dalla voce piena
di lacrime cristalline Le lunghe orecchie del gatto, piccoli coni rosa dai li
d'argento, appuntiti e delicatamente arrotolati all'interno come un fiore di
convolvolo, si drizzarono: Albert ascoltava i rumori lievi delle tenebre, così
sommessi, così misteriosi e, solo per lui, così chiari - fruscio dei fuscelli di
paglia nei nidi in cui l'uccello veglia i suoi piccoli, frullare di piume
minuscoli colpi di becco sulla corteccia di un albero, fremito d'ali e di elitre,
zampe di topo che grattano piano la terra e perfino l'impercettibile esplodere
dei semi che germogliano. Occhi d'oro saettavano nell'oscurità, i passeri
addormentati sotto le foglie, il grosso merlo nero, la cinciallegra, la
femmina dell'usignolo; il maschio era ben sveglio, lui, cantava e le
rispondeva dalla foresta e dal fiume.
Ma si potevano cogliere altri suoni: una detonazione che a intervalli
regolari saliva, sbocciava come un fiore e moriva, e ogni volta tutti i vetri
del villaggio tremavano, le imposte sbattevano e venivano subito richiuse
nell'oscurità, e parole angosciate volavano nell'aria da una finestra all'altra.
Sulle prime il gatto sobbalzava a ogni colpo, la coda ritta: riflessi cangianti
correvano sulla sua pelliccia, la tensione gli irrigidiva i baffi. Poi si abituò a
quel fragore che si avvicinava sempre più e che lui probabilmente
scambiava per un tuono.
Fece qualche capriola in mezzo alle aiuole, sfogliò con le unghie una
rosa: era sbocciata completamente, le sarebbe bastato un soffio per disfarsi e
morire; i suoi petali bianchi si sarebbero sparpagliati a terra in una pioggia
languida e profumata. All'improvviso il gatto si arrampicò fin sulla cima di
un albero lacerandone la corteccia con le zampe; il suo balzo era rapido
quanto quello di uno scoiattolo. Alcuni uccelli spaventati volarono via.
All'estremità di un ramo Albert eseguì una danza selvaggia, guerriera,
insolente e ardita, sfidando il cielo e la terra, gli animali e la luna. A tratti
apriva la bocca stretta e profonda facendone uscire un miagolio stridulo, un
richiamo acuto e provocante rivolto a tutti i gatti del vicinato. Nel pollaio e
nella piccionaia gli animali si svegliarono tremanti, nascosero il capo sotto
l'ala, sentirono l'odore della pietra e della morte; una gallinella bianca salì
precipitosamente su un secchio di zinco, lo rovesciò e fuggì chioccando
disperatamente. Ma il gatto adesso era saltato tra l'erba e stava immobile, in
attesa. Gli occhi rotondi e dorati scintillavano nell'ombra; ci fu un fruscio di
foglie smosse e lui riapparve, portando in bocca un uccellino inerte e
leccando adagio il sangue che usciva dalla ferita. Beveva quel sangue caldo
con delizia, strizzando le palpebre. Aveva conficcato le unghie nel cuore
della bestiola, ora disserrandole, ora affondandole nelle carni tenere, negli
ossicini leggeri, con un movimento lento, ritmato, finché quel cuore non
cessò di battere. Mangiò l'uccello senza fretta, si pulì, si leccò la coda, la
punta della sua bella coda di pelliccia su cui l'umidità della notte aveva
lasciato una traccia bagnata e brillante. Ora si sentiva disposto alla
benevolenza: un toporagno gli passò fra le zampe senza che lui lo
afferrasse, poi si limitò ad assestare sulla testa di una talpa un colpo che le
insanguinò il muso e la lasciò mezzo morta; ma non si spinse oltre, la
osservò con un piccolo fremito sdegnoso delle narici e non la toccò. Un'altra
fame si destava in lui; le reni si inarcarono, alzò la testa e miagolò ancora
una volta, un miagolio che finì in un grido imperioso e rauco. Sul tetto del
pollaio, raggomitolata al chiaro di luna, era apparsa una vecchia gatta
rossiccia. La breve notte di giugno volgeva al termine, le stelle
impallidivano, l'aria aveva un odore di latte e di erba bagnata; la luna
seminascosta dietro la foresta mostrava solo una punta rosa che scompariva
nella nebbia, quando il gatto, stanco, trionfante, intriso di rugiada,
masticando un filo d'erba fra i denti, si infilò nella camera di Jacqueline, sul
suo letto, cercando il posto tiepido fra i piccoli piedi magri. Si mise a fare le
fusa, quel ron ron sembrava il suono di un bollitore. Qualche istante dopo la
polveriera saltò.
CAPITOLO 21.
La polveriera saltò e l'orribile eco dell'esplosione si era appena spenta (nel
paese c'era stato un forte spostamento d'aria; porte e finestre tremavano, e il
piccolo muro del cimitero era crollato) quando una lunga fiammata si levò
sibilando dal campanile. Il fragore della bomba incendiaria si era confuso
con lo scoppio della polveriera. In un attimo il paese andò a fuoco. Nei
depositi c'era fieno, nei solai paglia e tutto s'incendiò; i tetti crollarono, i
pavimenti si spaccarono a metà; la massa degli sfollati si precipitò in strada,
mentre gli abitanti correvano verso le stalle e le scuderie a mettere in salvo
le bestie. I cavalli nitrivano, s'impennavano, terrorizzati dal bagliore e dal
crepitare dell'incendio; si rifiutavano di uscire, sbattevano la testa e gli
zoccoli annaspanti contro i muri infuocati. Una mucca fuggì portando sulle
corna un carico di fieno che aveva preso fuoco e che lei scuoteva
furiosamente, lanciando muggiti di dolore e di terrore; i fuscelli
fiammeggianti volavano da ogni parte. Nel giardino gli alberi in fiore erano
rischiarati da una luce vermiglia come sangue. In tempi normali si sarebbero
organizzati i soccorsi. Passati i primi momenti di paura, gli abitanti
avrebbero ritrovato un po’ di sangue freddo, ma davanti a quella sciagura
che arrivava dopo altre sciagure ora perdevano la testa. Per di più sapevano
che tre giorni prima i pompieri avevano ricevuto l'ordine di partire con tutto
il loro armamentario. Si sentivano avviliti. "Se solo avessimo qui gli
uomini!" gridavano le contadine. Ma gli uomini erano lontani, e i ragazzini
che correvano, urlavano, si agitavano aumentavano la confusione. Gli
sfollati strillavano. In mezzo a loro i Pericand, mezzo svestiti, la faccia
annerita dal fumo, i capelli arruffati. Come già sulla strada dopo il
bombardamento, si levavano e si incrociavano i richiami, la gente gridava il villaggio era tutto un tumultuoso vociare: "Jean! Suzanne!
Mamma! Nonna!" - e chiamava all'unisono. Nessuno rispondeva. Alcuni
giovani che erano riusciti a tirar fuori le biciclette dalle rimesse in fiamme
le spingevano brutalmente in mezzo alla folla. Ma, fatto strano, la gente si
sentiva abbastanza padrona di sé, aveva l'impressione di comportarsi
esattamente come bisognava. La signora Pericand teneva in braccio
Emmanuel, mentre Jacqueline e Bernard le stavano attaccati alle gonne
(quando sua madre l'aveva tirata giù dal letto, Jacqueline era perfino riuscita
a ficcare il gatto nella cesta e la stringeva al cuore in modo convulso) La
signora Pericand ripeteva dentro di sé: "Grazie a Dio, le cose di maggior
valore sono salve!" Gioielli e denaro erano racchiusi in un taschino di
camoscio cucito all'interno della camicia, e li sentiva sbattere mentre
fuggiva. Ma aveva avuto la presenza di spirito di afferrare al volo la
pelliccia e la valigetta piena di argenteria che teneva prudentemente vicino
al letto. E i bambini erano lì con lei, i suoi tre bambini! A tratti, rapido e
penetrante come un lampo, il pensiero dei due figli maggiori, lontani e in
pericolo, le attraversava la mente: Philippe e quel pazzo di Hubert. La fuga
di Hubert l'aveva gettata nella disperazione, e tuttavia ne andava orgogliosa.
Era un atto impulsivo, ribelle, ma degno di un uomo. Per quei due, Philippe
e Hubert, non poteva far niente, ma i tre piccoli! I suoi tre piccoli li aveva
salvati! La sera prima l'istinto le aveva suggerito di metterli a letto senza
spogliarli del tutto. Jacqueline non aveva il vestito ma una giacchetta sulle
spalle nude, e non avrebbe avuto freddo; meglio così che in camicia da
notte. Il piccolino era avvolto in una coperta e Bernard aveva persino il
berretto in testa.
Quanto a lei, senza calze, i piedi nudi infilati nelle pantofole rosse,
stringendo i denti, cingendo febbrilmente con le braccia il piccolino che non
piangeva ma, spaventato, strabuzzava gli occhi, si apriva un varco fra la
folla in preda al panico, senza minimamente sapere dove stesse andando,
mentre nel cielo aerei che le sembravano innumerevoli (ce n'erano due!)
passavano e ripassavano con il loro minaccioso ronzio da calabroni.
"Purché non ci bombardino! Purché non ci bombardino più! Purché...".
Parole che continuava a ripetere dentro di sé mentre procedeva a testa
bassa. A voce alta, invece, diceva: "Non lasciarmi la mano, Jacqueline!
E tu, Bernard, smettila di piangere! Non sei una femminuccia! Su,
tesorino mio, non è niente, c'è qui la tua mamma!" Pronunciava quelle
parole meccanicamente e dentro di sé pregava senza sosta: "Signore, fa che
non ci bombardino più! Che bombardino gli altri, ma non noi! Ho tre
bambini! Voglio salvarli! Fa che non ci bombardino più!"
Alla fine, superato il villaggio, si trovò in aperta campagna: l'incendio era
ormai alle spalle e le fiamme si dispiegavano a ventaglio nel cielo. Solo
un'ora era trascorsa dall'alba, quando la granata era caduta sul campanile.
Sulla strada la lunga teoria di automobili in fuga da Parigi, da Digione, dalla
Normandia, dalla Lorena, da tutta la Francia procedeva ininterrottamente. A
bordo, i viaggiatori sonnecchiavano. A volte alzavano la testa e guardavano
con indifferenza l'orizzonte in fiamme. Ne avevano viste tante! La balia
camminava dietro la signora Pericand e il terrore sembrava averla
ammutolita; muoveva le labbra senza che ne uscisse alcun suono. Teneva in
mano la cuffia pieghettata appena stirata, dai lacci di mussola. La signora
Pericand le lanciò un'occhiata di riprovazione: "Ma insomma, Tata, non
avrebbe potuto trovare qualcosa un po' più utile da portar via?" L'anziana
donna fece uno sforzo sovrumano per articolare qualche parola. Diventò
violacea in volto e gli occhi le si riempirono di lacrime. "Oh, Signore,"
pensò la signora Pericand "questa è diventata pazza! Che ne sarà di me?"
Ma la voce severa della padrona aveva miracolosamente fatto riacquistare la
favella alla balia, che ritrovò il suo tono normale, deferente e aspro a un
tempo, per rispondere: "La signora non penserà che potevo lasciarla lì, la
mia cuffia! Con quello che costa!"
La faccenda della cuffia era il vero pomo della discordia fra le due donne,
perché la balia detestava il vezzoso copricapo che le veniva imposto "Stanno tanto bene, quelle cuffiette," pensava infatti la signora Pericand "e
sono tanto adatte alle domestiche!": lei riteneva che ogni categoria sociale
dovesse esibire un qualche segno della propria condizione onde evitare
spiacevoli errori di valutazione, così come in un negozio si espongono i
prezzi. "É chiaro che non è lei a lavare e stirare, la vecchia arpia!" si
sfogava la balia con gli altri domestici. Con mano tremante si posò quella
farfalla di pizzo sulla testa già coperta da una grande berretta da notte. La
signora Pericand la guardò e trovò qualcosa di strano nella donna, ma non
capì che cosa fosse. Tutto sembrava inaudito. Il mondo era un incubo
orrendo. Si lasciò cadere sul terrapieno, restituì Emmanuel alle braccia della
balia e proclamò con la massima energia: "Adesso dobbiamo tirarci fuori da
qui" rimanendo seduta in attesa del miracolo. Non ci fu alcun miracolo, ma
passò un carretto tirato da un asino; il conducente, gettata un'occhiata a lei e
ai suoi bambini, rallentò e allora la signora Pericand seguì il suo istinto,
quello che scaturisce dalla ricchezza e che sa dove e quando c'è qualcosa da
vendere.
"Fermo!" gridò. "Qual è la stazione più vicina?".
"Saint-Georges"
"Quanto ci vuole per arrivarci, con il suo carretto?"
"Be, quattro ore"
"Sa se i treni vanno?"
"Pare di sì"
"Salgo. Vieni, Bernard. Tata, prenda il piccolo". "Ma, signora, io non
andavo da quella parte e per fare andata e ritorno mi ci vorranno otto ore"
"La pagherò bene" disse la signora Pericand.
Salì sul carretto, calcolando che se i treni viaggiavano normalmente
sarebbe stata a Nîmes l'indomani mattina. Nîmes... la vecchia casa di sua
madre, la sua camera da letto, un bagno; a quel pensiero si sentì venir meno.
Avrebbe trovato posto sul treno? "Con tre bambini" disse fra sé "ci riuscirò
senz'altro" Come un'Altezza Reale, la signora Pericand, nella sua veste di
madre di famiglia numerosa, occupava ovunque e nel modo più naturale il
primo posto... e non era certo di quelle donne che permettono a chicchessia
di non rispettare i loro privilegi. Incrociò le braccia sul petto e contemplò la
campagna con aria da vincitore.
"Ma, signora... e l'auto?" gemette la balia.
"A quest'ora dev'essere ridotta in cenere" rispose la signora.
"E i bauli, la roba dei bambini?"
I bauli erano stati caricati sul camioncino dei domestici. Al momento del
disastro restavano solo tre valigie, tre valigie piene di biancheria...
"Li ho sacrificati" sospirò la signora Pericand con gli occhi al cielo,
rievocando tuttavia, come in un bel sogno, i grandi armadi di Nîmes con i
loro tesori di tele e di lini.
La balia, che aveva perso il suo grosso baule bordato di ferro e una
borsetta di finto cinghiale, si mise a piangere. Invano la signora Pericand
cercò di farle capire quanto fosse ingrata nei confronti della Provvidenza.
"Pensi solo che è scampata alla morte, mia povera Tata, cosa importa il
resto!" L'asino trottava. Il contadino prendeva tante piccole scorciatoie
brulicanti di sfollati. Alle undici arrivarono a Saint-Georges e la signora
Pericand riuscì a salire su un treno che andava in direzione di Nîmes. La
gente intorno a lei diceva che era stato firmato l'armistizio. Alcuni
affermavano che era impossibile; a ogni modo, il cannone taceva e le
bombe non cadevano più. "Che l'incubo sia finito?" pensò la signora
Pericand. Guardò ancora una volta tutto quello che era riuscita a portare con
sé, "tutto quello che aveva salvato!": i suoi figli, la sua valigetta. Toccò i
gioielli e il denaro nascosti sul petto. Sì, in quei terribili momenti aveva
agito con fermezza, coraggio e sangue freddo. Non aveva perso la testa...
Non aveva perso... Non aveva... Improvvisamente gettò un grido strozzato.
Si portò le mani al collo, si rovesciò all'indietro e dalla gola le uscì un
rantolo cupo, come se stesse soffocando. "Mio Dio, signora! La signora si
sente male!" esclamò la balia. Con voce fioca, la signora Pericand riuscì
finalmente a dire gemendo:
"Tata, mia povera Tata, abbiamo dimenticato...".
"Ma cosa? Cosa?"
"Abbiamo dimenticato mio suocero" disse la signora Pericand scoppiando
in lacrime.
CAPITOLO 22.
Charles Langelet aveva guidato per tutta la notte fra Parigi e Montargis,
prendendo così anche lui parte alla catastrofe generale. Ciò nonostante
mostrava una grande forza d'animo. Si fermò in una locanda per far
colazione, e poiché intorno a lui un gruppo di sfollati si lamentava delle
cose orribili che avvenivano lungo la strada e cercava di prenderlo a
testimone - "Non è vero, signore? Lo ha visto anche lei... Non si può dire
che stiamo esagerando!" - rispose in tono secco:
"Io non ho visto niente!"
"Ma come? Neanche un bombardamento?" chiese la padrona, stupita.
"Ma no, signora"
"Neanche un incendio?"
"Neanche un incidente d'auto"
"Meglio per lei, naturalmente" disse la donna dopo un attimo di
riflessione ma alzando le spalle con aria dubbiosa, come per dire: "Un bel
tipo, questo qui!"
Langelet sbocconcellò controvoglia l'omelette che gli avevano servito,
allontanò il piatto sussurrando "immangiabile", chiese il conto e ripartì.
Provava una soddisfazione perversa nell'aver negato a quelle anime belle il
piacere che si ripromettevano interpellandolo, perché loro, creature volgari,
credevano di provare compassione umana ma in realtà fremevano di bassa e
melodrammatica curiosità. * pazzesco quanta volgarità ci sia al mondo"
pensò Charlie Langelet con tristezza. Era sempre scandalizzato e afflitto
quando scopriva una realtà formata da infelici che non anno mai visto una
cattedrale, una statua, un quadro.
Del resto> accadeva che degli happy few, categoria alla quale si vantava
di appartenere, mostrassero, nei rovesci della sorte la stessa mollezza e la
stessa imbecillità degli umili. Dio! Chissà cosa ne avrebbero fatto, più
avanti, dell'"esodo", del "loro esodo"! Gli pareva già di sentirli; la vecchia
carampana che avrebbe detto in giro con voce lagnosa: "Non ho avuto paura
dei tedeschi, io; gli sono andata incontro e ho detto: "Signori, siete nella
casa della madre di un ufficiale francese" Non hanno fiatato" E quell'altra
che avrebbe raccontato: "Le pallottole mi piovevano intorno, ma è strano,
non mi facevano paura"
Tutti ben d'accordo nell'infarcire i loro racconti con scene di terrore.
Quanto a lui, avrebbe risposto: "E curioso, mi è sembrato tutto normale.
Molta gente sulle strade, niente di più" Immaginò il loro stupore e sorrise,
confortato. E aveva bisogno di conforto. Quando pensava al suo
appartamento di Parigi gli si spezzava il cuore. Ogni tanto si girava verso
l'interno dell'auto e guardava con tenerezza le casse che contenevano le
porcellane, i suoi tesori più cari. C'era un Capodimonte che lo preoccupava:
si domandava se lo avesse protetto con una quantità sufficiente di trucioli e
di carta velina. Verso la fine delle operazioni di imballaggio quest'ultima era
venuta a mancare. Si trattava di un centrotavola che rappresentava fanciulle
danzanti con amorini e cerbiatti. Charlie sospirò. Immaginava di essere un
antico romano in fuga dalla lava e dalla cenere di Pompei che, abbandonati
gli schiavi, la casa e il denaro, aveva avuto cura di portare con sé, nelle
pieghe della tunica, qualche statuina di terracotta, qualche vaso dalla forma
perfetta, qualche coppa modellata su un bel seno. Era consolante e al tempo
stesso amaro sentirsi tanto diverso dagli altri uomini. Li osservò con i suoi
occhi pallidi: il flusso di automobili scorreva ininterrotto e i volti, cupi e
ansiosi, si somigliavano tutti. Che triste genia! Di cosa si preoccupava
quella gente? Di quello che avrebbe mangiato, di quello che avrebbe
bevuto? Lui, invece, pensava alla cattedrale di Rouen, ai castelli della Loira,
al Louvre. Una sola di quelle sacre pietre valeva mille vite umane. Stava
avvicinandosi a Gien quando un puntino nero apparve nel cielo. Con la
rapidità del lampo, Charlie pensò che quella colonna di sfollati nei pressi
del passaggio a livello dovesse costituire un bersaglio molto allettante per
un aereo nemico, e imboccò immediatamente una scorciatoia. Quindici
minuti dopo, a pochi metri da lui, alcune automobili che avevano cercato
anch'esse di allontanarsi dalla strada si scontravano in seguito alla manovra
sbagliata di un conducente in preda al panico. E rimbalzavano di qua e di là
andando a finire addirittura nei campi e sparpagliando in giro valigie,
materassi, gabbie di uccelli, donne ferite. Charlie udì voci e rumori confusi
ma non si voltò; filava verso un fitto bosco. Raggiuntolo si fermò un attimo,
quindi ripartì attraverso i campi perché la strada nazionale era diventata
davvero pericolosa. Per qualche tempo smise di pensare ai rischi che la
cattedrale di Rouen stava correndo per figurarsi con precisione quello che
incombeva su di lui, Charles Langelet. Non avrebbe voluto attribuirvi
troppa importanza, ma il fatto è che gli si presentavano alla mente le
immagini più sgradevoli. Le sue mani grassocce e delicate, contratte sul
volante, tremavano un po’. Là dove si trovava c'erano poche macchine e
poche abitazioni, ma non si rendeva assolutamente conto in quale direzione
stesse andando. Non aveva mai avuto il senso dell'orientamento e non era
abituato a viaggiare senza autista. Vagò per qualche tempo intorno a Gien e
cominciò a innervosirsi, tanto più che temeva di restare senza benzina.
Scosse il capo sospirando. Lo aveva previsto: lui, Charlie, non era fatto per
quell'esistenza volgare. Le mille piccole insidie della vita quotidiana erano
troppo forti per lui. L'auto si fermò, non c'era più benzina. Con la mano
rivolse a se stesso un piccolo gesto di benevolenza, come quando ci si
inchina davanti al coraggio della disperazione. Niente da fare, avrebbe
dovuto passare la notte nei boschi.
"Ha mica un bidone di benzina da vendermi?" domandò a un
automobilista di passaggio.
Questi rifiutò e Charlie sorrise, un sorriso acido e malinconico.
"Eccoli, gli uomini! Razza egoista e spietata. Nessuno che nell'avversità
divida con il fratello un tozzo di pane, una bottiglia di birra, un maledetto
bidone di benzina" L'automobilista si girò per gridargli: "Ne troverà a dieci
chilometri da qui, nella frazione di...".
Il nome si perse nell'aria ma già l'uomo spariva attraverso il folto degli
alberi. A Charlie sembrò di distinguere in lontananza una o due case.
"E la macchina? Non posso abbandonarla!" disse fra sé, esasperato.
"Proviamo ancora" Non passava nessuno. La polvere lo copriva come
gesso. Finalmente ecco alcuni giovani, sembravano ubriachi e se ne stavano
agglutinati come mosche sui sedili, sul predellino e perfino sul tetto di una
macchina che avanzava a fatica.
"Che brutti ceffi" pensò Langelet rabbrividendo. Tuttavia si rivolse loro
con il tono più amabile.
"Signori, non avreste per caso un po’ di benzina? Sono bloccato"
Quelli si fermarono con un tremendo stridere di freni messi a dura prova.
Guardarono Charlie e sghignazzarono.
"Quant'è che paga?" disse alla fine uno di loro.
Charlie si rendeva perfettamente conto che avrebbe dovuto rispondere:
"Quello che volete!", ma era avaro e per di più temeva, mostrandosi
troppo ricco, di indurre in tentazione quei teppisti. E poi detestava essere
imbrogliato.
"Pagherò un prezzo ragionevole" rispose con alterigia.
"Non ce n'è" fece il tipo nella macchina tutta sobbalzi e cigolii. E ripartì
sul sabbioso sentiero boschivo mentre Langelet, costernato, agitava le
braccia e chiamava.
"Suvvia, aspetti! Si fermi! Mi dica almeno quanto vuole!"
Non gli risposero neanche. Restò solo, ma non per molto perché col calar
della sera altri sfollati invadevano a poco a poco la foresta. Non avendo
trovato posto negli alberghi ed essendo piene zeppe anche le case private,
avevano deciso di passare la notte nei boschi. Presto l'atmosfera ricordò
quella di un campeggio estivo a Elisabethville, pensò Langelet con un senso
di nausea: ragazzini che strillavano, giornali spiegazzati per terra, panni
sporchi e barattoli di conserva vuoti. Alcune donne piangevano, altre
gridavano o ridevano; orrendi bambini mal lavati si avvicinarono a Charlie
che li cacciò via senza alzare la voce perché non voleva storie con i genitori,
ma terrorizzandoli con occhiate feroci. "É la feccia di Belleville" mormorò
spaventato. "Dove sono finito?". Il caso aveva veramente riunito lì gli
abitanti di uno dei quartieri più malfamati di Parigi, oppure era la sua
immaginazione, fervida ed eccitata, a turbarlo? Gli pareva che tutti gli
uomini avessero un'aria da delinquenti e che le ragazze fossero tutte
prostitute e ladre. Presto fu notte fonda, e sotto quegli alberi folti l'ombra
leggera di giugno si trasformò in tenebra, interrotta qua e là da chiazze
bianche di luce di luna satinata. I rumori assumevano tutti una risonanza
particolare e sinistra: quegli aerei che volavano in cielo come uccelli
ritardatari, quelle detonazioni cupe che non si sapeva se fossero cannonate o
scoppi di pneumatici bucati. Un paio di volte qualcuno venne a
gironzolargli intorno e a fissarlo con insistenza. E coglieva frasi da far
venire i brividi. Lo stato d'animo del popolo non era quello che avrebbe
dovuto essere...
Parlavano molto di ricchi che scappavano per salvare la pelle e i soldi e
che ostruivano le strade mentre i poveri non avevano altro che le proprie
gambe per camminare e crepare. "Ma non sono anche loro in macchina?"
pensava Charlie, indignato. "Rubata, probabilmente!".
Provò un gran sollievo quando accanto a lui si fermò una piccola
automobile occupata da un giovane e da una ragazza di estrazione sociale
chiaramente più elevata di quella degli altri sfollati. Il giovanotto aveva un
braccio leggermente deforme e lo protendeva con una certa ostentazione
come se ci fosse scritto sopra a caratteri cubitali "esonerato dal servizio
militare" La donna era giovane e bella, molto pallida. Si divisero dei panini
e ben presto si addormentarono, seduti al volante, spalla a spalla, guancia a
guancia. Charlie cercò di fare altrettanto, ma la stanchezza, la
sovreccitazione e la paura lo tenevano sveglio. Passata un'ora, il giovane
aprì gli occhi e, svincolandosi piano piano dalla compagna, si accese una
sigaretta. Vide che neanche Langelet dormiva.
"Gran brutta situazione!" disse sottovoce sporgendosi verso di lui.
"Molto brutta, sì"
"Comunque, una notte passa presto. Spero di poter arrivare domani a
Beaugency prendendo delle scorciatoie, la strada, giù, è impraticabile"
"Davvero? E pare che ci siano stati dei bombardamenti a tappeto. E
fortunato a poter partire" disse Charlie. "Io non ho più una goccia di
benzina"
E, dopo un attimo di esitazione:
"Se non sono troppo indiscreto, le chiederei gentilmente di tener d'occhio
la mia macchina" ha davvero l'aria di un tipo onesto, pensò
"mentre io farei una scappata al villaggio vicino dove mi hanno detto che
se ne trova ancora"
Il giovanotto scosse il capo.
"Non ce n'è più, purtroppo. Ho preso gli ultimi bidoni, e a un prezzo
pazzesco. Ne avrò giusto per arrivare alla Loira e passare i ponti prima che
saltino" disse indicando i bidoni fissati al bagagliaio posteriore.
"Come sarebbe? Faranno saltare tutti i ponti?"
"Sì, così dicono tutti. Si combatterà sulla Loira".
"Allora lei pensa che non ci sia più benzina?"
"Oh, ne sono sicuro! Gliene avrei data volentieri un po’ ma ne ho solo
quanto basta per me. Devo portare la mia fidanzata al sicuro, dai suoi
genitori che abitano a Bergerac. Passata la Loira, potremo fare rifornimento.
Almeno spero".
"Ah, è la sua fidanzata?" disse Charlie, che stava pensando ad altro.
"Sì. Dovevamo sposarci il 14 giugno. Pensi, signore, era tutto pronto, gli
inviti spediti, gli anelli pronti, e l'abito da sposa doveva essere consegnato
proprio questa mattina"
E rimase assorto in una dolce fantasticheria.
"E solo rimandato, sarà per un'altra volta" disse gentilmente Charles
Langelet.
"Ahimè, signore! Chissà dove saremo domani... Per quel che mi riguarda,
non posso proprio lamentarmi. Avrei dovuto essere arruolato, ma con il mio
braccio... sì, un incidente in collegio... ma credo che in questa guerra i civili
corrano maggiori pericoli dei militari. Pare che certe città...".
Abbassò la voce.
" siano ridotte a rovine fumanti e piene di cadaveri, veri e propri carnai. E
mi hanno raccontato delle storie atroci. Lo sa che hanno aperto le prigioni, i
manicomi? Sissignore, i nostri governanti sono fuori di testa. Così, un
ergastolano gira per le strade senza sorveglianza. Mi hanno detto che il
direttore di una prigione è stato assassinato dai detenuti che per ordine
ricevuto stava facendo trasferire; è successo qui vicino. Ho visto con i miei
occhi città saccheggiate, buttate all'aria da cima a fondo. E quelli attaccano
gli sfollati, derubano gli automobilisti...".
"Ah! derubano gli...".
"Non si saprà mai tutto quello che è capitato durante l'esodo. Adesso ci
dicono: "Potevate restarvene a casa!" Grazie tante. Per farci massacrare a
domicilio dall'artiglieria e dagli aerei. Avevo preso in affitto una casetta a
Montfort-l'Amaury per passarci tranquillamente un mese dopo il
matrimonio, prima di raggiungere i miei suoceri. Ed è stata distrutta il 3
giugno!" disse con indignazione.
Parlava e parlava, febbrilmente, era come ubriaco di stanchezza. Con la
punta delle dita sfiorò affettuosamente la guancia della fidanzata
addormentata.
"Purché possa portare in salvo Solange!"
"Siete molto giovani tutti e due, vero?"
"Io ho ventidue anni e Solange venti"
La sua fidanzata sta molto scomoda così" disse all'improvviso Charles
Langelet con voce melliflua, una voce che non sapeva di avere, dolce come
il miele, mentre il cuore gli batteva all'impazzata nel petto.
"Perché non andate tutti e due a sdraiarvi sull'erba, un po’ più in là?"
"Ma... e la macchina?".
"Oh, farò io la guardia, non si preoccupi!" disse Charlie con una risatina
soffocata.
Il giovane esitava ancora.
"Il fatto è che vorrei ripartire il più presto possibile, e ho un sonno molto
pesante...".
"La sveglierò. A che ora vuole partire? Guardi, è appena mezzanotte"
disse dando un'occhiata all'orologio da polso. "La chiamerò alle quattro"
"Oh, signore, lei è troppo buono!"
"No, ma a ventidue anni anch'io sono stato innamorato...".
Il giovane fece un gesto vago.
"Dovevamo sposarci il 14 giugno" ripeté sospirando.
"Certo, certo... Viviamo in tempi terribili... Ma le assicuro che è assurdo
restare aggrappato così al volante. La sua fidanzata si sveglierà tutta
indolenzita. Ha una coperta?".
"Solange ha un ampio spolverino da viaggio"
"Si sta così bene sull'erba. Se non avessi paura di risvegliare i miei vecchi
reumatismi... Ah, giovanotto, com'è bello avere vent'anni!".
"Ventidue" corresse il fidanzato.
"Vedrete tempi migliori, voi, e ve la caverete sempre, mentre un povero
vecchio come me...".
E abbassò le palpebre come un gatto che fa le fusa. Poi indicò con la
mano una radura tutta erba che s'intravedeva vagamente in mezzo agli
alberi, sotto la luna.
"Come si deve star bene, lì... Si dimentica tutto".
Aspettò un attimo, poi sussurrò ancora con aria falsamente indifferente:
"Lo sente l'usignolo?" L'uccello cantava già da un po’, appollaiato su un
ramo alto, indifferente al rumore, agli schiamazzi degli sfollati, ai fuochi
che questi avevano acceso sull'erba per dissipare l'umidità.
Cantava e altri usignoli gli rispondevano dalla campagna. Il giovane
ascoltò l'uccello, la testa inclinata e il braccio che cingeva la fidanzata
addormentata. Passati alcuni istanti, le sussurrò qualcosa.
Lei aprì gli occhi. Lui le parlò ancor più da vicino, con tono insistente.
Charlie si voltò dall'altra parte e tuttavia colse alcune parole. "Visto che
questo signore si è offerto di far la guardia all'auto...". E: "Tu non mi ami,
Solange, no, davvero tu non mi ami...
Eppure tu...".
Charlie sbadigliò a lungo, con ostentazione, e disse a mezza voce senza
rivolgersi a qualcuno in particolare e con la naturalezza esagerata di un
cattivo attore:
"Credo proprio che farò un sonnellino...".
Allora Solange abbandonò ogni esitazione. Tra risatine nervose, rifiuti
subito messi a tacere, e baci, disse:
"Se ci vedesse la mamma... Oh, Bob, sei terribile!... Non me lo rinfaccerai
dopo, eh, Bob?"
E si allontanò al braccio del fidanzato. Charlie li vide passare sotto gli
alberi tenendosi per la vita e sbaciucchiandosi. Quindi sparirono.
Rimase in attesa. La mezz'ora che seguì gli parve la più lunga della sua
vita. Tuttavia non pensava, provava solo angoscia e una straordinaria
euforia. Le sue palpitazioni erano così violente e gli procuravano una tale
sofferenza che mormorò: "Questo povero cuore malato... non ce la farà!"
Ma sapeva di non aver mai conosciuto voluttà più grande. Il gatto che
dorme su cuscini di velluto e si nutre di petti di pollo, quando per caso si
ritrova in campagna, sul ramo secco di un albero lucente di rugiada, e mette
sotto i denti la carne sanguinante e palpitante di un uccello, deve provare lo
stesso terrore, la stessa gioia crudele, pensò.
Era troppo intelligente per non capire quello che stava avvenendo in lui.
Piano piano, facendo attenzione a non sbattere le portiere, salì nell'auto
della coppia, sganciò i bidoni (già che c'era prese anche dell'olio), svitò il
tappo del suo serbatoio ferendosi le mani, fece il pieno di benzina e,
approfittando del fatto che molte altre automobili venivano messe in moto,
partì.
Una volta uscito dalla foresta, si voltò indietro, contemplò sorridendo la
cima degli alberi di un verde argenteo al chiaro di luna e pensò:
"Dopo tutto lo hanno consumato, il loro matrimonio, il 14 giugno...".
CAPITOLO 23.
Il vecchio Pericand fu svegliato dai clamori che venivano dalla strada.
Aprì un occhio, uno solo, imbambolato, pallido carico di stupore e di
riprovazione. "Che cos'hanno da gridare così?" pensò. Aveva dimenticato il
viaggio, i tedeschi la guerra. Credeva di essere in casa di suo figlio, in
boulevard Delessert, benché la camera che stava fissando gli fosse ignota;
non ci capiva niente. Era nell'età in cui la visione del passato è più forte di
quella reale; immaginava le cortine verdi del suo letto parigino. Allungò le
dita tremanti sul tavolo dove ogni giorno, al suo risveglio, una mano solerte
collocava una porzione di porridge e i biscotti dietetici. Ma non c'era né il
piatto, né la tazza, e neppure il tavolo. Fu allora che udì il crepitare del
fuoco nelle case vicine, sentì l'odore del fumo e intuì quello che stava
succedendo. Aprì la bocca in una muta inspirazione, simile a un pesce tolto
dall'acqua, e svenne.
Tuttavia la casa non aveva preso fuoco; solo una parte del tetto era
crollata. Dopo aver provocato molta confusione e spavento, l'incendio si era
placato. Il fuoco covava ancora con un lieve sibilo sotto le macerie della
piazza, ma la locanda era intatta e, verso sera, qualcuno scoprì il vecchio
signor Pericand, solo nel suo letto. Borbottava parole confuse e
tranquillamente, senza opporsi, si lasciò portare all'ospizio.
"Meglio così, di occuparmene io non se ne parla nemmeno" disse la
padrona. "Tra gli sfollati, i tedeschi che arrivano, l'incendio e tutto il resto,
dove lo trovo il tempo?"
E non diceva quello che le stava più a cuore: l'assenza del marito e dei
due figli, tutti e tre partiti militari e dispersi... Tutti e tre in quella zona
incerta, mobile, spaventosamente vicina che chiamavano "la guerra"
L'ospizio era molto pulito, molto ben tenuto dalle suore del Santissimo
Sacramento. Il signor Pericand venne sistemando un buon letto vicino alla
finestra; di là dal vetro avrebbe potuto vedere i grandi alberi verdi di giugno
e, in quindici vecchi silenziosi e tranquilli nei loro letti dalle lenzuola
candide. Ma lui non vedeva niente. Continuava a credersi a casa. Ogni tanto
sembrava parlasse alle sue fragili mani violacee, incrociate sulla coperta
grigia. Rivolgeva loro parole smozzicate e severe, poi scuoteva il capo a
lungo e, esausto, chiudeva gli occhi. Non era stato neanche sfiorato dalle
fiamme, non era ferito, ma aveva una febbre da cavallo. Il medico si stava
occupando delle vittime di un bombardamento nella città vicina e riuscì a
visitare il signor Pericand solo a tarda sera. Non disse granché: era stanco
morto, non dormiva da quarantott'ore e gli erano passati tra le mani almeno
sessanta feriti. Gli fece una puntura e promise di tornare il giorno dopo. Per
le suore, la faccenda era chiara; abituate com'erano a vegliare gli
agonizzanti, sapevano riconoscere la morte da un sospiro, da un lamento, da
quelle perle di sudore freddo, da quelle dita inerti.
Mandarono a chiamare il curato che aveva accompagnato il dottore in
città e non aveva dormito molto più di lui. Questi diede comunque l'estrema
unzione al signor Pericand, che parve riprendere coscienza.
Uscendo dall'ospizio il curato disse alle suore che il povero vecchio era in
regola con Dio e che avrebbe concluso la vita da buon cristiano.
Una delle suore era piccola, magra, con profondi occhi azzurri, pieni di
malizia e di coraggio, che brillavano sotto la cuffia bianca; l'altra, dolce,
timida, dalle guance rosse, aveva un gran mal di denti e, mentre recitava il
rosario, appoggiava ogni tanto la mano alla gengiva dolente con un sorriso
umile, come se si vergognasse di portare una croce così leggera in quei
giorni di dolore. Fu a lei che il signor Pericand disse all'improvviso (era
mezzanotte passata e il tumulto del giorno si era placato, si udivano solo
gemere i gatti nel giardino del convento):
"Figlia mia, mi sento male... Mandate a chiamare il notaio".
L'aveva scambiata per la nuora, pur meravigliandosi, nel suo semidelirio,
che si fosse messa in testa una cuffia da monaca per curarlo - ma insomma
non poteva essere che lei! E ripeté piano piano, pazientemente:
"Maître Nogaretà notaio... ultime volontà...".
"Che facciamo, sorella?" chiese suor Marie del Santissimo Sacramento a
suor Marie dei Cherubini.
Le due cuffie inamidate si chinarono e quasi si congiunsero sopra il corpo
disteso.
"Il notaio non verrà certo a quest'ora, mio povero signore. Dorma,
adesso... Avrà tempo domani".
"No... Non c'è tempo..." disse la voce fioca. "Nogaret verrà...
Telefonate, per favore"
Di nuovo le due suore si consultarono sul da farsi e una di loro sparì,
tornando poi con un infuso bollente. Pericand cercò di mandar giù alcune
sorsate ma subito le vomitò facendole colare lungo la barba bianca.
Improvvisamente fu assalito da una grande agitazione; gemeva, dava
ordini:
"Ditegli di far presto... Mi aveva promesso che... non appena lo avessi
chiamato... Vi prego... sbrigatevi, Jeanne" (perché nella sua testa non era
più la nuora a trovarsi lì, al suo capezzale, ma la moglie, morta da
quarant'anni)
Una fitta particolarmente lancinante al dente malato tolse a suor Marie del
Santissimo Sacramento ogni possibilità di reazione. Fece "sì, sì" con il capo
e, tamponandosi la guancia con il fazzoletto, rimase immobile mentre la
compagna si alzava con fare deciso.
"Bisogna andare a chiamare il notaio, sorella"
Di temperamento ardente e combattivo, era esasperata dall'inoperosità
dell'altra. Avrebbe voluto seguire il dottore e il curato in città ma non poteva
abbandonare i quindici vecchi dell'ospizio (e non nutriva molta fiducia nello
spirito d'iniziativa di suor Marie del Santissimo Sacramento) Quando era
scoppiato l'incendio, si era subito allertata.
Dopo essere riuscita a spingere i quindici letti fuori dalla stanza, aveva
approntato personalmente scale, corde e secchi d'acqua, ma il fuoco non si
era propagato fino all'ospizio, che si trovava a due chilometri dalla chiesa
bombardata. Era quindi rimasta in attesa, rabbrividendo alle grida della folla
impaurita, all'odore del fumo e alla vista delle fiamme, ma restando
inchiodata al suo posto e pronta a tutto. Tuttavia non era successo niente. Le
vittime di quel disastro venivano curate all'ospedale civile, e a lei non
restava che preparare la minestra per i quindici vecchi. L'arrivo imprevisto
del signor Pericand aveva dato nuovo impulso a tutte le sue energie.
"Sì, bisogna andarci"
"Crede, sorella?"
"Forse ha delle importanti dichiarazioni da fare in punto di morte"
"Ma il notaio Charboeuf potrebbe non essere a casa...".
Suor Marie dei Cherubini si strinse nelle spalle.
"A mezzanotte e mezzo?"
"Non vorrà venire!"
"Vorrei vedere! É tenuto a farlo! Lo tirerò giù dal letto, se occorre"
dichiarò la giovane suora con aria indignata.
E uscì. Una volta fuori, esitò. La comunità era composta da quattro suore,
due delle quali, in ritiro spirituale nel convento di Paray-le-Monial dai primi
di giugno, non avevano ancora potuto rientrare in sede. L'ospizio possedeva
una bicicletta, ma fino a quel momento nessuna delle suore, temendo di
scandalizzare la gente, aveva osato servirsene e la stessa suor Marie dei
Cherubini diceva: "Dobbiamo aspettare che il buon Dio ci faccia la grazia di
un caso urgente. Ad esempio, un malato che sta per andarsene... Bisogna
andare a chiamare il medico e il curato! Ogni secondo è prezioso, salto sulla
mia bicicletta... La prima volta, la gente resterà senza parole, ma quella
successiva non ci troveranno più niente di strano!" Il caso urgente non si era
ancora presentato. Suor Marie dei Cherubini, però, moriva dalla voglia di
salire su quell'aggeggio! Ai tempi in cui non aveva ancora pronunciato i
voti, cinque anni prima, quante allegre scampagnate con le sorelle, quante
gite, quanti picnic! Gettò indietro il velo nero, disse a se stessa: "Adesso o
mai più" e, con il cuore in gola dall'eccitazione, afferrò il manubrio.
Pochi minuti dopo era in paese. Svegliare il notaio Charboeuf, che aveva
il sonno pesante, e soprattutto convincerlo a seguirla non fu cosa da poco. Il
notaio Charboeuf, che le ragazze del paese chiamavano "Bamboccione" per
via delle guance piene e rosee e delle labbra tumide, aveva un buon
carattere e una moglie che lo terrorizzava da sempre. Si vestì sospirando e si
diresse alla volta dell'ospizio, dove trovò il signor Pericand tutto arzillo,
molto rosso in faccia e con un gran febbrone.
"Ecco qui un notaio" annunciò la suora.
"Si sieda, si sieda" disse il vecchio. "Non perdiamo tempo".
Il notaio aveva preso come testimoni il giardiniere dell'istituto e i suoi tre
figli. Vedendo la fretta del signor Pericand, estrasse dalla borsa un foglio e
si accinse a scrivere.
"L'ascolto, signore. Mi favorisca prima di tutto le sue generalità".
"Ma allora non è Nogaret...".
Pericand riacquistò tutta la sua lucidità. Gettò uno sguardo alle pareti
della stanza, alla statua di gesso di san Giuseppe di fronte al suo letto, alle
due splendide rose rampicanti che suor Marie dei Cherubini aveva raccolto
affacciandosi alla finestra e messo in un sottile vaso azzurro. Cercò di
capire dove si trovasse e perché lo avessero lasciato solo, ma vi rinunciò.
Stava morendo, ecco tutto, e bisognava farlo secondo le regole. Quell'ultimo
atto, quella morte, quel testamento, quante volte se li era figurati come
brillante recita finale di un Pericand-Maltête sul palcoscenico del mondo.
Essere stato per dieci anni un povero vecchio impotente che non sa vestirsi
da solo e al quale si soffia il naso, e ritrovare d'un tratto tutta la propria
importanza!
Punire, ricompensare, deludere, appagare, dividere i propri beni secondo
la propria volontà. Dominare gli altri. Far sentire agli altri il proprio peso.
Essere protagonista. (Dopodiché ci sarebbe stata solo una cerimonia in cui
lui avrebbe occupato sì il primo posto, in una cassa nera, su un cavalletto, in
mezzo ai fiori, ma a puro titolo simbolico o come spirito alato, mentre lì,
ancora una volta, era vivo...).
"Lei come si chiama?" disse con voce bassa.
"Charboeuf" rispose umilmente il notaio.
"Be, non fa niente. Proceda".
E cominciò a dettare con lentezza, a fatica, come se gli leggesse frasi
scritte espressamente per lui e visibili a lui solo.
"Davanti a Maître Charboeuf... notaio a... alla presenza di..." (il notaio
mormorò i nomi dei testimoni) "si è presentato il signor Pericand...".
Fece un debole sforzo per amplificare, magnificare il nome. Poiché
doveva risparmiare il fiato e gli sarebbe stato impossibile proclamarne a
gran voce le prestigiose sillabe, le mani violacee danzarono per un attimo
sul lenzuolo come due marionette: immaginava di tracciare dei segni neri,
inarcati, su un foglio bianco, come faceva un tempo in calce ai documenti,
alle obbligazioni, ai contratti di vendita: Pericand... peri-cand, LouisAuguste.
"Abitante a?"
"89, boulevard Delessert, Parigi"
"Si è presentato al notaio e ai testimoni malato di corpo ma in pieno
possesso delle facoltà mentali" snocciolò Charoeuf alzando lo sguardo sul
malato con aria dubbiosa.
Ma quell'uomo morente lo incuriosiva. La sua clientela si componeva
essenzialmente di proprietari terrieri dei dintorni, e la sua esperienza gli
diceva che tutti i ricchi fanno testamento allo stesso modo. E questo era un
uomo ricco, non c'era dubbio; benché gli avessero messo addosso la ruvida
camicia dell'ospizio, doveva essere una persona importante! Il notaio
Charboeuf si sentiva lusingato di raccogliere le sue ultime volontà.
"Dunque, signore, lei desidera nominare suo figlio erede universale?"
"Sì, lascio tutti i miei beni mobili e immobili a Adrien Pericand, con
l'impegno, da parte sua, di versare immediatamente e senza indugio cinque
milioni all'Opera dei Piccoli Redenti del XVI arrondissement da me
fondata. L'Opera si impegna a far eseguire un mio ritratto a grandezza
naturale sul letto di morte, o un busto che riprodurrà i miei lineamenti e che
sarà commissionato a un artista famoso e collocato nell'atrio della suddetta
istituzione. Alla mia amata sorella Adele-Emilienne-Louise, per risarcirla
dei dissapori sorti fra noi a proposito dell'eredità della mia venerata madre,
Henriette Maltête, lascio le mie terre di Dunkerque acquistate nel 1912 con
tutti gli immobili che vi sono stati costruiti nonché la parte dei magazzini di
mia proprietà. Do a mio figlio l'incarico di far sì che questa promessa sia
integralmente realizzata. Stabilisco inoltre che il mio castello di Bleoville,
comune di Vorhange, nel Calvados, venga trasformato in ricovero per
grandi invalidi di guerra, scelti preferibilmente fra i paraplegici e quelli
colpiti da alienazione mentale. Desidero che una semplice targa rechi scritto
"Pia Fondazione Pericand-Maltête in memoria dei due figli caduti in
Champagne" Quando la guerra finirà...".
"Credo... credo che sia finita" azzardò timidamente il notaio.
Non sapeva che il signor Pericand era tornato con la mente all'altra
guerra, quella che gli aveva preso due figli e triplicato il suo patrimonio.
Pensava di essere nel settembre 1918, all'alba della vittoria, quando una
polmonite stava per portarlo all'altro mondo, e in presenza dell'intera
famiglia riunita al suo capezzale (compresi tutti i parenti collaterali del
Nord e del Midi accorsi alla notizia) aveva fatto quella che era una sorta di
prova generale del proprio decesso: la dettatura delle ultime volontà, che ora
ritrovava perfettamente chiare nella mente e alle quali dava libero corso.
"Quando la guerra finirà, voglio che venga eretto sulla piazza di Bleoville
un monumento ai caduti per il quale intendo stanziare la somma di tremila
franchi da defalcare dalla mia eredità. Per primi vengano incisi i nomi dei
miei due figli a grandi lettere d'oro, poi, dopo uno spazio...".
Chiuse gli occhi, esausto.
"dopo uno spazio, tutti gli altri a lettere più piccole...".
Dopodiché rimase in silenzio così a lungo che il notaio guardò le suore
preoccupato. Non era mica?... Era la fine? Ma suor Marie dei Cherubini
scosse la cuffia con aria serena. No, non era ancora morto. Stava riflettendo.
Nel suo corpo immobile la mente vagava in lungo e in largo nel tempo
percorrendo spazi immensi.
"La quasi totalità del mio patrimonio è composta da titoli americani che, a
quanto mi si diceva, avevano un buon rendimento. Credo che non sia più
così"
Scosse con aria lugubre la lunga barba.
"Sì, credo proprio che non sia più così. Desidero che mio figlio li cambi
immediatamente in franchi francesi. C'è anche dell'oro, non è più il caso di
tenerlo, adesso: lo si venda. Una copia del mio ritratto venga collocata
anche nel castello di Bleoville, nel salone del pianoterra. Al mio fedele
cameriere lascio una rendita annuale e vitalizia di mille franchi. A tutti i
miei futuri pronipoti venga dato il mio nome, Louis-Auguste, se sono
maschi, e Louise-Augustine se sono femmine"
"É tutto?" domandò Charboeuf.
La lunga barba, abbassandosi, fece segno di sì, era tutto. Per diversi
istanti, che al notaio, ai testimoni e alle suore parvero brevi, ma che in quel
preciso momento erano lunghi come un secolo, lunghi come il delirio,
lunghi come un sogno, il signor Pericand-Maltête rifece in senso inverso il
cammino che gli era stato dato di percorrere su questa terra: i pranzi di
famiglia in boulevard Delessert, le sieste in salotto, con il gatto Anatole
sulle ginocchia; l'ultimo colloquio con il fratello maggiore che si era
concluso nel modo più burrascoso (dopodiché lui aveva ricomprato
sottobanco le azioni dell'azienda) Jeanne, sua moglie, a Bleoville, curva,
tormentata dai reumatismi, allungata su una sdraio di paglia in giardino con
un ventaglio di carta tra le mani (sarebbe morta otto giorni dopo), e ancora
Jeanne a Bleoville, trentacinque anni prima, all'indomani delle nozze,
quando delle api erano entrate dalla finestra aperta e avevano preso a
suggere il nettare dai gigli del bouquet della sposa e dalla coroncina di fiori
d'arancio finita ai piedi del letto. E Jeanne si era rifugiata fra le sue braccia
ridendo...
Poi sentì forse arrivare la morte; ebbe il tempo di un piccolo gesto appena
abbozzato, stentato, di sgomento, quasi, come se cercasse di passare da una
porta troppo stretta per lui e dicesse: "No, prego, dopo di lei", e sui suoi
lineamenti si dipinse un'espressione di sorpresa.
"É dunque questo?" sembrava dire. "É proprio questo?".
Poi la sorpresa svanì, il volto si fece severo, scuro, e il notaio Charboeuf
si affrettò a scrivere:
" Presentatagli la penna per fargli apporre la firma sul presente
documento, il testatore ha fatto uno sforzo per sollevare la testa, senza
riuscirvi, e ha immediatamente reso l'ultimo respiro sotto gli occhi del
notaio e dei testimoni, i quali ciò nondimeno, letto il documento, vi hanno
apposto le loro firme per far valere quanto è sancito di diritto"
CAPITOLO 24.
Jean-Marie, piano piano, tornava in sé. Per quattro giorni aveva
sonnecchiato semi-incosciente e in preda alla febbre, ma ora si sentiva più
forte. Il giorno prima si era finalmente presentato un medico che gli aveva
rifatto la medicazione, e la febbre cominciava a scendere. Dal catafalco
dove lo avevano coricato Jean-Marie vedeva una grande cucina piuttosto
buia, la cuffia bianca di una vecchia seduta in un angolo, delle belle pentole
di rame che scintillavano appese al muro e un calendario dov'era raffigurato
un soldato francese, roseo e grassoccio, che teneva per la vita due giovani
alsaziane, ricordo dell'altra guerra.
Era strano notare come i ricordi del '14 fossero vivi qui. Al posto d'onore,
quattro fotografie di uomini in divisa, con un piccolo fiocco tricolore e una
minuscola coccarda in un angolo della cornice, e una raccolta di numeri
dell'"Illustration" dal 1914 al 1918, rilegata in nero e verde, messa vicino a
lui per aiutarlo a passare le ore della convalescenza.
Nelle conversazioni che poteva cogliere tornavano di continuo le parole
"Verdun", "Charleroi", "la Marna..." o frasi come: "Quando si è vista l'altra
guerra...", "Quando abbiamo occupato Mulhouse...". Di questa guerra,
invece, della sconfitta, si parlava poco, non era ancora ben penetrata negli
animi, avrebbe assunto la sua forma viva e terribile solo alcuni mesi più
tardi, forse alcuni anni, forse quando quei bambini dalla faccia sporca che
Jean-Marie vedeva sbucare al di sopra del piccolo steccato di legno davanti
alla porta sarebbero diventati uomini.
Con cappelli di paglia strappati, guance brune e rosa, lunghe bacchette
verdi in mano, intimiditi, curiosi, si sollevavano sulla punta degli zoccoli
per poter guardare, all'interno, il soldato ferito, e quando Jean-Marie faceva
un movimento scappavano via, sparivano come ranocchie che si tuffano in
acqua. A volte dal cancelletto lasciato aperto entrava una gallina, un
vecchio cane impettito, un tacchino gigantesco.
JeanMarie vedeva i suoi ospiti solo alle ore dei pasti; durante il giorno era
affidato alle cure della vecchia con la cuffia in testa. Al calar della sera due
ragazze venivano a sedersi vicino a lui. Una era chiamata la Cecile, l'altra la
Madeleine. Per qualche tempo credette che fossero sorelle. Ma no! La
Cecile era la figlia della padrona e la Madeleine una trovatella. Erano
ambedue di aspetto gradevole, non belle, ma fresche: Cecile aveva una
faccia piena, rossa, e vispi occhi scuri;
Madeleine era bionda, più fine, con guance vellutate e rosee come fiori di
melo.
Jean-Marie fu messo al corrente degli ultimi eventi dalle ragazze.
Uscendo dalle loro bocche, riportati in quella loro lingua un po’ aspra,
tutti quei fatti di così grande portata perdevano ogni consonanza tragica. "É
molto triste", e "non è bello vedere certe cose...", "Ah, signore, è un gran
brutto momento!" Jean-Marie si domandava se quello fosse il modo di
parlare della gente del posto o dipendesse da qualcosa di più profondo,
dall'animo stesso di quelle ragazze, dalla loro giovane età, dal sapere, per
istinto, che le guerre passano e l'invasore se ne va, che la vita, anche
deturpata, anche mutilata, continua. In fondo sua madre, lavorando a maglia
mentre la minestra si cuoceva sul fuoco, sospirava: "Il 1914? É l'anno in cui
ci siamo sposati, tuo padre e io.
Lo abbiamo finito male, è vero, ma l'inizio è stato meraviglioso"
Quell'anno funesto, infatti, era stato addolcito, ravvivato dal riflesso del
loro amore.
Allo stesso modo, per quelle ragazze l'estate del 1940 nonostante tutto
sarebbe rimasta la stagione dei loro vent'anni, pensava Jean-Marie. Ma non
avrebbe voluto pensare; il pensiero faceva più male del dolore fisico, ma
tutto gli tornava in mente, tutto gli si agitava senza tregua nella testa: la
revoca della licenza il 15 maggio, quei quattro giorni ad Angers con i treni
che non andavano, i soldati sdraiati sulle assi, divorati dagli insetti, e poi gli
allarmi, i bombardamenti, la battaglia di Rethel, la ritirata, la battaglia della
Somme e ancora la ritirata, la fuga di città in città per giorni e giorni, senza
comandanti, senza ordini, senza armi, e infine quel vagone in fiamme.
Allora Jean-Marie si agitava e si lamentava. Non sapeva più se quel suo
tormentoso arrovellarsi avvenisse nella realtà o in un sogno confuso causato
dalla sete e dalla febbre. Via, non era possibile... Ci sono cose che non sono
possibili... Qualcuno aveva parlato di Sedan? Era nel 1870, e la pagina del
libro di storia dalla copertina di tela rossiccia che gli sembrava di avere
ancora davanti agli occhi iniziava con queste parole che ora lui scandiva
lentamente: "Sedan, la sconfitta di Sedan... la disastrosa battaglia di Sedan
che decise della sorte della guerra...". Sulla parete, il calendario con
l'immagine del soldato roseo e ridente e delle due alsaziane dalle calze
bianche bene in mostra. Sì, questo era il sogno, il passato, e lui... Cominciò
a tremare e disse: "Grazie, ma non è niente, non occorre..." mentre qualcuno
gli infilava nel letto la borsa dell'acqua calda posandogliela sui piedi
irrigiditi.
"Sembra che stia meglio, stasera"
"Sì, mi sento meglio" rispose.
Chiese uno specchio, e la vista del suo mento ornato da una barbetta nera
alla Cavour gli strappò un sorriso.
"Domani dovrò radermi...".
"Se ne avrà la forza. Per chi vuol farsi bello?".
"Per voi"
Scoppiarono a ridere e si avvicinarono al letto. Erano curiose di sapere da
dove veniva, dov'era stato ferito. Ogni tanto, assalite da qualche scrupolo, si
interrompevano.
"Oh, non dovremmo chiacchierare tanto! La stancheremo... e poi
rischiamo di farci sgridare... Il suo nome è Michaud, vero?...
Jean-Marie?"
"Sì"
"É di Parigi? Che lavoro fa? L'operaio? No, no... lo vedo dalle mani.
Lei dev'essere un impiegato, forse un funzionario...".
"Sono solo uno studente"
"Ah! Lei studia... E perché?".
"Mah!" fece lui con l'aria di rifletterci su. "Me lo domando anch'io!".
Strano: lui e i suoi compagni avevano studiato, passato esami, ottenuto
diplomi pur sapendo che era inutile, che non sarebbe servito a niente dato
che ci sarebbe stata la guerra... Il loro futuro era già tracciato, la loro
carriera era scritta nel cielo, come si diceva una volta dei matrimoni. Era
nato nel 1915, in occasione di una licenza militare. Nato dalla guerra,
dunque, e (lo aveva sempre saputo) per la guerra. Non c'era niente di
morboso in questo, era un pensiero logico, ragionevole, condiviso da molti
ragazzi della sua età. Ma, pensò, dal momento che il peggio è passato, le
cose cambiano. C'è di nuovo un avvenire. La guerra è finita, terribile, turpe
fin che si vuole, ma è finita! E... c'è speranza...
"Volevo scrivere dei libri" disse timidamente, rivelando a quelle
contadine, a quelle sconosciute, un desiderio appena formulato tra sé, nel
segreto del suo cuore.
Poi volle sapere il nome della località, della fattoria in cui si trovava.
"É un posto isolato," disse la Cecile "sperduto. La vita non è molto
divertente, qui. A governare le bestie si diventa stupidi come le bestie, vero
Madeleine?"
"É qui da molto, signorina Madeleine?"
"Da quando avevo tre settimane. La madre di Cecile mi ha allevata
insieme a lei. Siamo sorelle di latte, noi due".
"Vedo che andate d'accordo"
"Non la pensiamo sempre allo stesso modo" disse Cecile. "Lei vorrebbe
farsi suora!"
"Mi capita, qualche volta..." disse Madeleine sorridendo.
Aveva un bel sorriso pacato e un po’ timido.
"Chissà da dove viene" si domandò Jean-Marie. Aveva mani rosse ma di
forma aggraziata, così come le gambe e le caviglie. Una trovatella...
Provò un po’ di curiosità, un po’ di pietà. Le era grato delle vaghe
fantasticherie che suscitava in lui. Questo lo distraeva, gli impediva di
pensare a se stesso e alla guerra. Peccato soltanto che si sentisse così
debole. Gli riusciva difficile ridere, scherzare con loro... Eppure era quello
che loro si aspettavano, probabilmente! In campagna, fra ragazze e ragazzi,
punzecchiature e canzonature sono di rigore... É conforme alle regole, è così
che si fa. E Cecile e Madeleine sarebbero rimaste deluse e sconcertate se lui
non avesse riso un po’ con loro.
Fece uno sforzo per sorridere.
"Arriverà un ragazzo che le farà cambiare idea, signorina Madeleine, e lei
non vorrà più farsi suora!"
"Ma ci penso solo ogni tanto!"
"Quando?"
"Oh, non so... Nei giorni tristi...".
"Non ce ne sono tanti, di ragazzi, da queste parti" disse Cecile. "Siamo
fuori dal mondo. E poi, i pochi che ci sono se li prende la guerra. E allora?
Ah, è una bella disgrazia essere femmina!"
"Di disgrazie ce n'è per tutti!" disse Madeleine.
Si era seduta vicino al ferito, e all'improvviso si alzò di scatto.
"Cecile! Non abbiamo lavato il pavimento"
"Tocca a te"
"Questa, poi! Hai una bella faccia tosta! É il tuo turno, invece!"
Bisticciarono un momento, poi sbrigarono il lavoro insieme. Erano
straordinariamente svelte ed efficienti; in pochi minuti le piastrelle rosse
scintillarono sotto un profluvio di acqua fresca. Dalla porta aperta veniva un
odore di erba, di latte, di menta selvatica. Jean-Marie stava con la guancia
appoggiata alla mano. Era curioso quel contrasto fra la pace assoluta che lo
circondava e il tumulto che ferveva in lui, perché l'infernale frastuono degli
ultimi sei giorni gli era rimasto nelle orecchie e gli bastava un attimo di
silenzio per risentirlo: un rumore di metallo accartocciato, i colpi simili a
martellate che si abbattevano sorde e lente su un'incudine enorme... Trasalì
e tutto il suo corpo si coprì di sudore... Era il rumore dei vagoni mitragliati,
l'esplodere di travi e di acciaio che copriva le grida degli uomini.
Disse a voce alta:
"Bisognerà comunque dimenticare tutto questo, vero?"
"Che cosa sta dicendo? Le occorre qualcosa?"
Non rispose. Non le riconosceva più, la Cecile e la Madeleine. Le ragazze
scossero il capo, avvilite.
"É la febbre che torna a salire"
"E poi lo hai fatto parlare troppo!"
"Ma figurati! Lui non diceva niente, eravamo sempre noi a parlare!"
"E questo lo ha stancato"
Madeleine si chinò su di lui. Jean-Marie vide vicinissima alla sua una
guancia rosea che sapeva di fragola. E la baciò! La ragazza si raddrizzò tutta
rossa, ridendo e aggiustandosi le ciocche scomposte dei capelli.
"Ah! Mi ha fatto paura... Non sta poi così male!".
Lui pensava: "Che cosa significa, che cos'è questa ragazza?" L'aveva
baciata come se si fosse portato alle labbra un bicchiere di acqua fresca.
Stava bruciando, sentiva la gola e l'interno della bocca come screpolati dal
calore, prosciugati da una fiamma. Quella pelle morbida e luminosa lo
dissetava. Nel contempo, la sua mente godeva di quella lucidità che è data
dall'insonnia e dalla febbre. Aveva dimenticato il nome delle due ragazze e
anche il proprio. Lo sforzo mentale necessario per comprendere la sua
condizione presente, in quei luoghi che non riconosceva più, gli costava
troppa fatica. Il tentativo di venirne a capo lo estenuò, ma in astratto il suo
spirito fluttuava sereno e leggero, come un pesce nell'acqua, come un
uccello sulle ali del vento.
Non vedeva se stesso, Jean-Marie Michaud, ma un altro, un soldato senza
nome, vinto, che non si rassegnava, un giovane ferito che non voleva
morire, un infelice che non abbandonava la speranza. "Bisognerà comunque
uscirne... Tirarsi fuori da tutto, da questo sangue, da questo fango che ci
sommerge... Non vorrai crepare qui... No, eh?... Sarebbe troppo stupido.
Bisogna aggrapparsi... aggrapparsi... aggrapparsi..." mormorò, e si ritrovò,
abbarbicato al guanciale, con gli occhi spalancati, in piedi sul letto a
guardare la notte di luna piena, la notte profumata, silente, la notte
scintillante, così deliziosa dopo la giornata calda e che, contrariamente al
solito, entrava nella fattoria dalle porte e dalle finestre aperte per recare al
ferito frescura e sollievo.
CAPITOLO 25.
Ritrovatosi sulla strada con i ragazzi, che portavano ciascuno una coperta
e un tascapane e lo seguivano strascicando i Piedi nella polvere, padre
Pericand si era diretto verso l'interno, allontanandosi dalla Loira che
riteneva piena di pericoli e inoltrandosi nei boschi. Ma già la truppa vi si era
accampata, e il sacerdote pensò che i soldati sarebbero stati presto avvistati
dagli aerei: dunque il pericolo era altrettanto grande lì nel bosco che lungo
le rive del fiume. Così, abbandonando la statale, imboccò un percorso
sassoso, quasi un sentiero, lasciando che l'istinto lo portasse a un qualche
abituro isolato, come quando, in montagna, guidava il suo gruppo di sciatori
verso un rifugio perduto nella nebbia o nella tormenta. Questa, invece, era
una splendida giornata di giugno, così calda e luminosa che i ragazzi ne
erano come inebriati. Rimasti in silenzio fino a quel momento, e buoni,
troppo buoni, ora si spintonavano, gridavano, e a padre Pericand arrivavano
risate e frammenti soffocati di canzoni. Tese l'orecchio e colse un ritornello
osceno sussurrato alle sue spalle, una sorta di bisbiglio a fior di labbra.
Allora propose loro di cantare in coro una marcetta. Fu lui a iniziare
scandendo vigorosamente le parole, ma solo qualche voce lo seguì. Pochi
istanti dopo tutti tacquero. A quel punto anche lui si mise a camminare in
silenzio, domandandosi quali oscuri desideri, quali sogni quell'improvvisa
libertà suscitasse nei poveri ragazzi. Uno dei piccoli si fermò di colpo e
gridò: "Oh, una lucertola! Una lucertola!
Guardate!" Fra due pietre al sole apparivano e sparivano agili code,
spuntavano piccole teste piatte, gole palpitanti pulsavano rapide per lo
spavento. I ragazzi guardavano affascinati. Qualcuno si era perfino
inginocchiato sul sentiero. Il prete pazientò per alcuni secondi, poi li esortò
a riprendere il cammino. Docili, i ragazzi si rimisero in piedi, ma nello
stesso istante dalle loro mani partirono, come proiettili, dei sassi, scagliati
con tanta abilità e una rapidità così sorprendente che due lucertole, le più
belle, le più grandi, di un grigio delicato quasi azzurro, restarono uccise sul
colpo.
"Perché lo avete fatto?" esclamò il prete in tono irritato.
Nessuno rispose.
"Perché? É un'azione vile!"
"Ma sono come le vipere, mordono" disse un ragazzo dalla faccia smorta
e stralunata e dal lungo naso a punta.
"Che sciocchezza! Le lucertole sono del tutto inoffensive"
"Ah! Noi non lo sapevamo, padre!" replicò quello con una voce da
teppista e una finta innocenza che non ingannarono il prete. Ma questi
pensò che non fosse né il luogo né il momento di rimproverarli; si limitò a
chinare brevemente il capo come fosse soddisfatto della risposta,
aggiungendo però: "Adesso lo sapete"
Li fece mettere in fila. Fino a quel momento li aveva lasciati camminare
in ordine sparso, ma all'improvviso si era trovato a pensare che qualcuno di
loro avrebbe potuto decidere di scappare. Gli obbedirono in modo così
impeccabile e meccanico - avvezzi com'erano ai comandi del fischietto, a
muoversi in fila docili e in silenzio - che gli si strinse il cuore. Lanciò
un'occhiata a tutti quei visi fattisi improvvisamente tetri, spenti, chiusi come
può esserlo una casa dalla porta sprangata, l'anima ripiegata in se stessa, o
assente o morta. E disse: "Dobbiamo sbrigarci se vogliamo trovare un
rifugio per la notte, ma non appena saprò dove dormiremo e non appena
avremo cenato (perché tra un po’ comincerete ad aver fame!) potremo
accendere dei falò e restare fuori finché ne avrete voglia"
Camminò in mezzo a loro, parlando dei suoi ragazzi dell'Auvergne, delle
gare di sci in montagna, sforzandosi di interessarli, di avvicinarli in qualche
modo a lui. Tutto inutile. Sembrava che neanche lo ascoltassero, e allora
capì che le parole che venivano loro rivolte: incoraggiamenti, rimproveri,
insegnamenti - non avrebbero mai potuto raggiungerli perché vi
opponevano un'anima chiusa, murata, sorda e muta.
"Se potessi tenerli con me più a lungo" pensò. Ma nel suo cuore sapeva di
non desiderarlo. Non desiderava che una cosa: liberarsi di loro al più presto,
sgravarsi di quella responsabilità e del senso di disagio che quei ragazzi gli
procuravano. La legge d'amore che fino a quel momento aveva ritenuto
quasi facile, tanto era grande in lui la grazia di Dio, si diceva umilmente,
ecco che non riusciva a rispettarla "proprio quando, forse per la prima volta,
ubbidire a quella legge sarebbe uno sforzo meritorio, un vero e proprio
sacrificio. Come sono debole!" Chiamò vicino a sé uno dei più piccoli, un
ragazzino che restava continuamente indietro.
"Sei stanco? Ti fanno male le scarpe?"
Sì, aveva indovinato: le sue scarpe erano troppo strette e lo facevano
soffrire. Lo prese per mano per aiutarlo a camminare, gli parlò con dolcezza
e, vedendogli le spalle e la schiena curve, gli strinse appena appena il collo
con due dita per obbligarlo a raddrizzarsi. Il ragazzino non si ribellò. Anzi,
con lo sguardo rivolto lontano e il viso indifferente, appoggiò il collo alla
mano del prete e quella pressione tacita, insistente, quella strana, quella
indefinibile carezza, o meglio quell'attesa di una carezza, fecero salire il
sangue al volto di padre Pericand. Allora alzò il mento del bambino e cercò
di guardarlo fisso negli occhi, ma, sotto le palpebre abbassate, quegli occhi
erano invisibili.
Affrettò il passo, provò a concentrarsi, come faceva sempre nei momenti
di tristezza, recitando una sorta di orazione interiore; non era una vera e
propria preghiera. Spesso non si trattava neppure di parole usate nel
linguaggio umano. Era una specie di contemplazione ineffabile dalla quale
usciva impregnato di gioia e di pace. Ma oggi entrambe gli restavano
inaccessibili. La pietà che provava era guastata da un'ombra di inquietudine
e di amarezza. A quelle povere creature mancava visibilmente la grazia: la
Sua grazia. Avrebbe voluto farla scendere su di loro a inondare di fede e
d'amore quegli aridi cuori. Certo, bastava un sospiro del Cristo crocifisso,
un battito d'ali di uno dei suoi angeli per compiere il miracolo, ma lui,
Philippe Pericand, non era stato forse designato da Dio ad addolcire, a
schiudere le anime per prepararle alla venuta di Dio? Esserne incapace lo
faceva soffrire. Gli erano stati risparmiati i momenti di dubbio e
quell'inaridirsi improvviso che assale il credente senza abbandonarlo del
tutto ai signori di questo mondo ma lasciandolo in qualche modo a metà
strada fra Dio e Satana, sprofondato nelle tenebre.
Altra era la tentazione, per lui: una sorta di sacra impazienza, il desiderio
di accumulare intorno a sé anime redente, un'urgenza frenetica che, una
volta conquistato un cuore a Dio, lo proiettava verso altre battaglie,
lasciandolo sempre frustrato, insoddisfatto, scontento di sé.
Non era abbastanza! No, Gesù, non era abbastanza! Quel vecchio
miscredente che si era confessato e in punto di morte aveva fatto la
comunione, quella peccatrice che aveva smesso di peccare, quell'ateo che
aveva chiesto il battesimo. Non era abbastanza, no, non era abbastanza!
Provava qualcosa di simile all'avidità dell'avaro che ammassa il suo oro.
Anzi no, non era esattamente così. Era un po’ come certe ore passate da
bambino sulle rive del fiume: un soprassalto di gioia a ogni pesce preso
(non capiva come avesse potuto amare quel gioco crudele, adesso non
riusciva neanche più a mangiare pesce a cuor leggero.
Verdura, latticini, pane fresco, castagne e la zuppa densa dei contadini
nella quale il cucchiaio resta in piedi gli bastavano) Ma da bambino era
stato un pescatore accanito e ricordava l'angoscia che lo afferrava quando il
sole scendeva sull'acqua, il bottino era scarso e il giorno di vacanza finito.
Per quegli scrupoli eccessivi lo avevano biasimato. Lui stesso temeva che
non gli venissero da Dio ma da un Altro... Comunque, non aveva mai
provato tutto ciò come lo provava ora lungo quella strada, sotto quel cielo in
cui scintillavano gli aerei assassini, in mezzo a quei ragazzi dei quali
avrebbe salvato solo i corpi...
Camminavano da un po’ quando scorsero le prime case di un villaggio.
Un villaggio minuscolo, intatto, deserto: gli abitanti erano fuggiti.
Tuttavia, prima di andarsene, avevano sprangato porte e finestre, preso
con sé cani, conigli e galline. Erano rimasti solo alcuni gatti, che dormivano
al sole nei vialetti dei giardini o passeggiavano sui tetti bassi con aria
pacifica e satolla. Era la stagione delle rose, e sopra ogni portico se ne
arrampicava qualcuna, pienamente sbocciata, ridente, che si lasciava
penetrare e mangiare il cuore da vespe e calabroni. Quel villaggio
abbandonato dagli uomini, dove non si udivano né passi né voci ed erano
assenti tutti i rumori della campagna - cigolio di carriole, tubare di piccioni,
pigolio di animali da cortile -, era diventato il regno degli uccelli, delle api e
dei calabroni. A Philippe sembrò di non aver mai sentito canti così vibranti
e gioiosi, né visto volare intorno a sé sciami così numerosi. Dai fuscelli di
fieno, dalle fragole, dal ribes, dai piccoli fiori profumati che contornavano
le aiuole, da ogni arboscello, da ogni ciuffo e da ogni filo d erba proveniva
un dolce ronzio da arcolaio. Quei piccoli giardini erano stati
opportunamente curati, con amore; in tutti c'era un archetto coperto di rose,
un pergolato con gli ultimi lilla, due sedie di ferro, una panca al sole. E l'uva
spina aveva frutti enormi, trasparenti e dorati.
"Stasera avremo un ottimo dessert" disse Philippe. "Gli uccelli dovranno
dividerlo con noi, ma non faremo torto a nessuno cogliendo questi frutti.
Avete tutti dei tascapane abbastanza ben forniti, non soffriremo la fame. Ma
non contate di dormire in un letto. Penso che la prospettiva di una notte
all'aperto non vi spaventi... Avete buone coperte. Vediamo un po’, che cosa
ci occorre? Un prato, una sorgente. Fienili e stalle non vi dicono niente,
credo! E neanche a me... Il tempo è così bello.
Su, mangiate qualche frutto per tirarvi su di morale e seguitemi, andiamo
a cercare una buona sistemazione per la notte"
Aspettò un quarto d'ora mentre i ragazzi si rimpinzavano di fragole; li
sorvegliava con attenzione per impedire che calpestassero fiori e ortaggi ma
non dovette intervenire neanche una volta, erano davvero dei bravi ragazzi.
Non usò neppure il fischietto, si limitò ad alzare la voce.
"Su, lasciatene un po’ per questa sera. Seguitemi. Se non ciondolerete per
strada, non vi costringerò a mettervi in fila"
Ancora una volta ubbidirono. Guardavano gli alberi, il cielo, i fiori, ma
Philippe non riusciva a capire che cosa pensassero... Quello che piaceva
loro, che parlava al loro cuore, così almeno sembrava, non era il mondo
visibile ma l'odore inebriante di aria pura e di libertà che respiravano per la
prima volta.
"Qualcuno di voi conosce la campagna?" domandò Philippe.
"No, padre, no signore, no" risposero l'uno dopo l'altro con una certa
flemma.
Philippe aveva già notato che da quei ragazzi otteneva una risposta solo
dopo alcuni secondi di silenzio, come se volessero imbastire una finzione,
una menzogna, o come se non capissero esattamente che cosa si voleva da
loro... Sempre quell'impressione di avere a che fare con delle creature... non
del tutto umane...
"Su, affrettiamoci" li esortò.
Usciti che furono dal villaggio, videro un grande parco, mal tenuto, un
bellissimo stagno profondo e trasparente e un edificio in cima a una collina.
Il castello, probabilmente, pensò Philippe. Suonò alla cancellata nella
speranza di trovare qualcuno, ma la guardiola del custode era chiusa e
nessuno si fece vivo.
"Comunque, ecco un prato che sembra fare al caso nostro" disse
indicando con la mano le rive dello stagno. "Che volete, ragazzi miei, qui
faremo meno danni che in quei giardinetti così ben tenuti, ci staremo meglio
che sulla strada e se dovesse scoppiare un temporale potremmo ripararci in
quelle piccole cabine...". Il parco era circondato da una semplice recinzione
di filo di ferro, che oltrepassarono senza difficoltà.
"Sia chiaro" continuò Philippe ridendo "che stiamo commettendo
un'effrazione; perciò pretendo da voi il rispetto più assoluto di questa
proprietà: non voglio vedere un ramo spezzato o una carta lasciata nell'erba,
un barattolo vuoto. Intesi? Se fate i bravi, domani vi lascerò fare il bagno
nello stagno"
L'erba era così alta che arrivava loro alle ginocchia. Camminavano
calpestando fiori. Philippe mostrò ai ragazzi i fiori della Vergine, stelle
bianche a sei petali, e quelli di san Giuseppe, di un lilla tenue, quasi rosa.
"Possiamo prenderli?"
"Sì, quanti ne volete, di questi. Basta un po’ di pioggia e di sole per farli
spuntare. Ecco invece qualcosa che ha richiesto molta cura e molto lavoro"
disse indicando le aiuole piantate intorno al castello. Uno dei ragazzi, in
piedi vicino a lui, levò la piccola faccia quadrata, pallida, dalle ossa
prominenti, verso le grandi finestre chiuse.
"Ce ne dev'essere di roba là dentro!"
Aveva parlato a voce bassa ma con una asprezza cupa che turbò il prete.
Poiché lui non rispondeva, il ragazzo insistette.
"Vero, padre, che ci dev'essere tanta roba là dentro?"
"Noi non ne abbiamo mai viste di case così" fece un altro.
"Di sicuro vi si trovano cose molto belle, mobili, quadri, statue... Ma
parecchi di questi proprietari sono finiti in rovina e non illudetevi di vedere
chissà quali meraviglie, sareste delusi" rispose allegramente Philippe.
"Penso che siano le provviste alimentari a interessarvi di più. Eppure la
gente di qui mi sembra molto previdente e deve aver portato via tutto. Del
resto, dato che in ogni modo non avremmo potuto metterci le mani perché
non è roba nostra, meglio non pensarci e arrangiarci con quello che
abbiamo. Formerò tre squadre: la prima raccoglierà gli sterpi, la seconda
attingerà l'acqua, la terza preparerà le gamelle"
Sotto la sua direzione, lavorarono in fretta e bene. Sulle rive dello stagno
fu acceso un gran fuoco e mangiarono, bevvero, raccolsero fragole di bosco.
Philippe volle organizzare dei giochi, ma i ragazzi si muovevano con aria
spenta e impacciata, senza grida, senza risate. Lo stagno non scintillava più
al sole ma riluceva debolmente e si sentivano le rane gracidare sulle rive. Le
fiamme illuminavano i ragazzi immobili, avvolti nelle coperte.
"Volete dormire?"
Nessuno rispose.
"Non avete freddo, vero?"
Ancora silenzio.
Eppure non saranno tutti addormentati, pensò il prete. Si alzò e prese a
camminare in mezzo a loro. Ogni tanto si chinava, copriva un corpo più
magro, più gracile degli altri, una testa dai capelli appiattiti, dalle orecchie a
sventola. I ragazzi tenevano gli occhi chiusi. O fingevano di dormire,
oppure erano realmente immersi nel sonno. Philippe tornò vicino al fuoco, a
leggere il suo breviario. Di tanto in tanto alzava gli occhi e guardava i
riflessi sull'acqua. Quei momenti di tacita meditazione lo compensavano di
tutte le sue fatiche, lo ripagavano di tutte le sue pene. Di nuovo l'amore
penetrava nel suo cuore come la pioggia in un terreno arido, dapprima a
goccia a goccia, aprendosi a stento una strada fra i sassi, poi, trovato il
cuore, in un lungo scorrere precipitoso.
Poveri ragazzi! Uno di loro stava sognando e nel sogno emetteva un
lungo lamento monotono. Il prete levò la mano nell'ombra, li benedisse,
mormorò una preghiera. "Pater amat vos" sussurrò. Lo diceva anche ai suoi
piccoli scolari del catechismo quando li esortava alla penitenza, alla
rassegnazione, alla preghiera. "Il Padre vi ama". Come aveva potuto credere
che a quegli infelici fosse negata la grazia? Forse lui stesso sarebbe stato
meno amato di loro, sarebbe stato trattato con minore indulgenza, minore
tenerezza celeste del più meschino, del più degenerato di quelli... Oh, Gesù,
perdonami! É stato un moto di orgoglio, un'insidia del demonio! Che cosa
sono io? Meno di niente, polvere sotto i tuoi piedi divini, Signore! Sì, certo,
a me che tu hai amato, protetto fin dall'infanzia, chiamato a te, puoi chiedere
qualsiasi cosa... Ma questi ragazzi... alcuni si salveranno... altri...
Li redimeranno i Santi... Sì, tutto è bene, tutto è buono, tutto è grazia.
Gesù, perdona la mia tristezza!
L'acqua palpitava dolcemente, la notte era solenne e tranquilla. Quella
presenza senza la quale non avrebbe potuto vivere, quel Soffio, quello
Sguardo, erano su di lui nell'ombra. Un bimbo addormentato nelle tenebre,
stretto al cuore della madre, non ha bisogno di luce per riconoscerne i
lineamenti cari, le mani, gli anelli! Ebbe persino un lieve riso di piacere.
"Gesù, sei qui, eccoti di nuovo. Restami vicino, adorabile Amico!" Una
lunga fiamma rosa, viva, sprizzò da un ceppo nero. Era tardi; la luna si
alzava ma lui non aveva sonno. Prese una coperta, si sdraiò nell'erba e restò
disteso, a occhi spalancati, sentendo un fiore sfiorargli la guancia. Tutto era
silenzio su quel lembo di terra.
Non udì, non vide niente, avvertì con una sorta di sesto senso la corsa
silenziosa di due ragazzi che sgattaiolavano verso il castello. La cosa fu così
rapida che sulle prime credette di aver sognato. Non volle chiamare né dare
così l'allarme agli altri ragazzi che dormivano. Si alzò, rassettò la sottana
alla quale erano rimasti attaccati fili d'erba e petali di fiori, e si diresse a sua
volta verso il castello. L'erba fitta attutiva il rumore dei suoi passi. Si
ricordò di aver notato che l'imposta di una delle finestre non era ben chiusa.
Sì, non si era ingannato! La luna illuminava la facciata. Uno dei ragazzi
spingeva, forzava la persiana. Philippe non ebbe il tempo di gridare, di
fermarli, e già una pietra spaccava il vetro mandandolo in frantumi. Con un
balzo felino, i due ragazzi sparirono all'interno.
"Ah, piccoli delinquenti, aspettatemi!" esclamò Philippe.
Sollevando la sottana fino alle ginocchia, li seguì e si trovò in un salone
dai mobili ricoperti di fodere, dal grande pavimento freddo, luccicante.
Brancolò per un attimo cercando tentoni l'interruttore della luce. Quando
ebbe acceso non vide nessuno. Esitò, si guardò intorno (i ragazzi si erano
nascosti o erano scappati): quei divani, quel pianoforte, quelle poltrone con
le loro fodere dalle pieghe svolazzanti, quelle tende di cretonne a fiori erano
altrettanti nascondigli. Avanzò verso il vano profondo di una finestra perché
aveva visto muoversi le cortine; le scostò bruscamente, uno dei ragazzi era
lì, uno dei più grandi, quasi un uomo, con una faccia nerastra, occhi
abbastanza belli, fronte bassa, mascella pesante.
"Che cosa siete venuti a fare qui?" disse il prete.
Sentì un rumore alle sue spalle e si voltò; dietro di lui c'era un altro
ragazzo. Anche questo poteva avere diciassette o diciotto anni: labbra
serrate, sprezzanti, viso giallastro, come se la bestialità gli fosse stata
iniettata sotto la pelle. Philippe stava in guardia ma loro furono troppo
rapidi per lui; in un baleno gli si avventarono contro e mentre uno lo buttava
a terra con uno sgambetto l'altro lo afferrava alla gola.
Ma silenziosamente, efficacemente, Philippe si dibatteva. Riuscì ad
afferrare uno dei ragazzi per il bavero, stringendo così forte che quello
dovette abbandonare la presa. Mentre si dimenava per liberarsi qualcosa gli
cadde dalle tasche e rotolò per terra: del denaro.
"Complimenti, hai fatto presto" disse Philippe senza fiato, seduto sul
pavimento. E pensava: prima di tutto, non prendere la cosa sul tragico, falli
uscire da qui, e ti seguiranno come cagnolini. Domani, si vedrà!
"Basta così! Adesso piantatela... e filate".
Aveva appena pronunciato quelle parole che di nuovo, con un balzo
silenzioso, selvaggio e disperato, i due si gettarono su di lui; uno lo morse a
sangue.
"Mi uccideranno" pensò Philippe con una sorta di stupore. Gli si
avvinghiavano addosso come lupi. Non voleva far loro del male ma era
costretto a difendersi; li respingeva a suon di pugni e di calci, e quelli
tornavano alla carica con maggiore accanimento, senza più niente di umano,
come dementi, come bestie... Philippe, nonostante tutto, sarebbe stato il più
forte, ma gli arrivò in testa un mobile, un tavolino dai piedi di bronzo.
Cadde e in quel mentre sentì uno dei ragazzi correre alla finestra e fare un
fischio. Di quello che successe dopo non vide niente: né i ventotto
adolescenti svegliati di colpo che attraversavano di corsa il prato e
scalavano la finestra, né l'assalto agli eleganti mobili del castello che
venivano sfasciati, saccheggiati, gettati dalla finestra. Erano ebbri,
danzavano intorno al prete disteso a terra, cantavano, gridavano. Uno dei
più piccoli, dal volto di fanciulla, saltava a piedi giunti su un divano
facendone gemere le vecchie molle. I più grandi avevano scoperto un
mobile bar: lo spinsero nel salone a pedate. Quando lo aprirono, videro che
era vuoto ma non avevano bisogno di alcolici per essere ubriachi: il
saccheggio era sufficiente, ne provavano una gioia atroce. Trascinarono
Philippe per i piedi, lo issarono sulla finestra e lo fecero cadere
pesantemente sul prato. Sempre trascinandolo, arrivarono sulla riva dello
stagno, lo afferrarono, lo fecero oscillare come un fagotto. "Oooh, issa! A
morte!" gridavano con le loro voci rauche, da castrati, alcune delle quali
avevano ancora un timbro infantile. Ma quando cadde in acqua era
comunque vivo. Un istinto di conservazione o un estremo soprassalto di
coraggio lo trattenne a riva; si afferrò con entrambe le mani a un ramo
d'albero e si sforzò di tenere la testa fuori dall'acqua. La faccia, massacrata
da pugni e calci, era paonazza, gonfia, grottesca e orribile a vedersi. Gli
gettarono delle pietre. In un primo momento tenne duro, aggrappandosi con
tutte le sue forze al ramo che oscillava, si scheggiava, cedeva. Cercò allora
di raggiungere l'altra riva ma le pietre gli piovevano addosso. Alla fine alzò
le braccia per coprirsi il volto, e i ragazzi lo videro inabissarsi, ritto in piedi,
nella sua sottana nera. Non annegò ma rimase imprigionato nella fanghiglia.
Morì così, nell'acqua fino alla cintola, la testa rovesciata all'indietro,
l'occhio maciullato da una pietra.
CAPITOLO 26.
Ogni anno a Nîmes, nella cattedrale di Notre-Dame, veniva celebrata una
messa per i defunti della famiglia Pericand-Maltete; ma poiché a Nîmes
abitava solo la madre della signora Pericand la funzione veniva di solito
sbrigata piuttosto celermente in una cappella laterale, alla presenza della
vecchia signora, obesa e quasi cieca, il cui respiro affannoso copriva la voce
dell'officiante, e di una cuoca che serviva in casa da trent'anni. La signora
Pericand era nata Craquant, ed era imparentata con la famiglia Craquant di
Marsiglia, arricchitasi con il commercio dell'olio. Un'origine che lei
giudicava più che rispettabile, certo (la sua dote era stata di due milioni, due
milioni d'anteguerra), ma che impallidiva davanti al lustro della nuova
parentela. Sua madre, la vecchia signora Craquant, la pensava allo stesso
modo e, ritiratasi a Nîmes, osservava scrupolosamente tutti i riti dei
Pericand, pregava per i loro morti e mandava ai vivi lettere di felicitazioni
in occasione di matrimoni e battesimi, come quegli inglesi delle colonie che
si ubriacavano in solitudine quando a Londra si festeggiava il compleanno
della regina.
Alla signora Craquant quella messa da requiem era particolarmente
gradita: dopo la funzione, rincasando dalla cattedrale, si fermava in una
pasticceria dove beveva una tazza di cioccolata e mangiava due croissant.
Poiché era molto grassa, il medico le faceva seguire una dieta alquanto
rigida, ma visto che in quelle occasioni si alzava prima del solito e doveva
attraversare tutta la cattedrale, dal grande portale scolpito fino al suo banco,
cosa che l'affaticava parecchio, si concedeva senza troppi rimorsi quei
dolciumi tanto corroboranti. A volte, quando la cuoca, che le incuteva un
certo timore, le voltava le spalle e rimaneva impettita e silenziosa vicino
alla porta del negozio con i due messali in mano e lo scialle nero della
padrona sul braccio, questa arrivava persino a impadronirsi di un vassoio
intero e a ingoiare con aria distratta ora un bignè alla crema, ora una
crostatina di ciliegie, ora tutti e due.
Fuori la carrozza, tirata da due vecchi cavalli e guidata da un cocchiere
quasi altrettanto grasso della signora Craquant, aspettava sotto il sole e le
mosche. Ma quell'anno portò un grande scompiglio e tutto andò
diversamente: i Pericand, riparatisi a Nîmes in seguito agli eventi di giugno,
vennero a sapere della morte del signor Pericand-Maltête e di quella di
Philippe. La notizia della scomparsa del vecchio era stata comunicata loro
dalle suore dell'ospizio dove il signor Pericand si era spento, una fine
"molto serena, molto consolante, molto cristiana", come scriveva suor
Marie del Santissimo Sacramento, e si era dimostrato così magnanimo nei
confronti dei suoi cari da preoccuparsi nei minimi dettagli del testamento,
che sarebbe stato trascritto al più presto.
La signora Pericand lesse e rilesse l'ultima frase, sospirò, e un'espressione
preoccupata le si diffuse in volto, subito sostituita dalla compunzione della
buona cristiana alla notizia che un essere amato ha reso l'ultimo respiro, in
pace con il buon Dio.
"Vostro nonno è vicino a Gesù Bambino, figli miei" disse. Due ore dopo
giungeva la seconda mazzata che colpiva la famiglia: il sindaco di un
piccolo villaggio del Loiret annunciava, senza entrare nei dettagli, che padre
Philippe Pericand era morto di morte accidentale e mandava i documenti
che ne certificavano l'identità in modo incontestabile. Quanto ai trenta
minori affidati alle sue cure, essi erano scomparsi. Poiché all'epoca metà
della Francia cercava l'altra metà, questo non stupì nessuno. Si parlava di un
camion caduto nel fiume, non lontano dal punto in cui Philippe aveva
trovato la morte, e i suoi genitori non ebbero dubbi: si trattava proprio di lui
e dei poveri orfani. Infine giunse la notizia che Hubert era stato ucciso nella
battaglia di Moulins. Questa volta la catastrofe era completa. La portata
della sventura strappò alla signora Pericand un grido di orgoglio disperato.
"Avevo dato alla luce un eroe e un santo" disse. "I nostri figli pagano per
quelli degli altri" mormorò poi cupamente guardando la cugina Craquant, il
cui unico figlio aveva trovato un posticino tranquillo a Tolosa, nella difesa
passiva. "Cara Odette, il mio cuore sanguina, tu sai che sono vissuta solo
per i miei figli, che sono stata madre, nient'altro che madre," (la signora
Craquant, che in gioventù era stata alquanto leggera, chinò la testa) "ma ti
giuro, l'orgoglio che provo allevia il mio lutto"
E dritta e fiera, piena di dignità, sentendosi già avviluppata in svolazzanti
veli neri, accompagnò alla porta la cugina che sospirava umilmente: "Oh!
Tu sì che sei una vera matrona romana"
"Una buona cittadina francese, semplicemente" rispose la signora
Pericand in tono secco voltandole le spalle.
Quelle parole avevano un po’ mitigato il suo dolore, che era vivo e
profondo. Aveva sempre rispettato Philippe e capito in qualche modo che
non era di questo mondo; sapeva che sognava di andare missionario e che,
se vi aveva rinunciato, era stato per un eccesso di umiltà che lo aveva
portato a scegliere, per servire Dio, quello che più gli pesava: l'assoggettarsi
agli umili doveri quotidiani. Era sicura che ora suo figlio fosse vicino a
Gesù. Quando lo aveva detto a proposito del suocero, era stato con
un'ombra di dubbio che subito si rimproverava, ma insomma... Ma per
Philippe era diverso. "Lo vedo come fossi lì!" pensava. Sì, poteva andar
fiera di Philippe e lo splendore di quell'anima ricadeva anche su di lei.
La cosa più strana, tuttavia, era la sua elaborazione interiore della figura
di Hubert: Hubert che mieteva zeri al liceo, che si rosicchiava le unghie,
Hubert dalle dita macchiate d'inchiostro, dalla cara faccia paffuta, dalla
larga bocca fresca, Hubert morto da eroe era... inconcepibile... Raccontava
agli amici commossi la partenza di Hubert ("Ho cercato di trattenerlo ma
sapevo che era impossibile. Era un bambino, ma un bambino coraggioso, ed
è caduto per l'onore della Francia. E, come dice Rostand, è tanto più bello
quando è inutile").
Insomma, ricreava il passato, le sembrava di aver effettivamente
pronunciato quelle nobili parole, di aver mandato suo figlio in guerra.
Nîmes, che fino a quel momento l'aveva considerata con una certa
acredine, ora manifestava a quella madre orbata una stima quasi affettuosa.
"Oggi avremo tutta la città" sospirò la vecchia signora Craquant con
malinconico compiacimento.
Era il 31 luglio. Alle dieci doveva essere celebrata la messa funebre al cui
elenco dei defunti si erano così tragicamente aggiunti tre nomi.
"Oh, mamma, che cosa importa?" rispose la figlia, e non si capì se quelle
parole si riferivano alla vanità di una simile consolazione o alla pessima
opinione che ella aveva dei suoi concittadini.
La città splendeva sotto un sole rovente. Nei quartieri più popolosi un
vento secco e sornione agitava le tende di perline colorate davanti alle porte.
Le mosche erano più fastidiose che mai e nell'aria si sentiva il temporale.
Nîmes, abitualmente morta in quell'epoca dell'anno, era affollatissima. I
profughi che l'avevano invasa vi indugiavano ancora, trattenuti dalla
mancanza di benzina e dalla chiusura provvisoria del confine sulla Loira.
Strade e piazze erano diventate altrettanti parcheggi per le automobili, e non
si trovava una sola camera libera.
Fino a quel momento la gente aveva dormito per strada, e una balla di
paglia, a mo’ di letto, diventava un lusso. Nîmes si vantava di aver fatto il
suo dovere, e anche di più, nei confronti degli sfollati; li aveva accolti a
braccia aperte, se li era stretti al cuore. Non c'era famiglia che non avesse
offerto ospitalità a quegli infelici. Peccato solo che quello stato di cose si
prolungasse più del dovuto. C'era il problema degli approvvigionamenti e
inoltre non bisognava dimenticare, dicevano i suoi abitanti, che quei poveri
rifugiati, estenuati com'erano dal viaggio, rischiavano di essere vittime delle
più tremende epidemie.
Così, a mezze parole, attraverso la stampa, e in modo meno velato, più
brutale, per bocca della gente del posto, li si pregava insistentemente e
quotidianamente di andarsene al più presto, cosa che fino a quel momento le
circostanze non avevano permesso.
La signora Craquant, che ospitava in casa tutta la famiglia e poteva quindi
rifiutare a testa alta di privarsi anche solo di due lenzuola, assaporava con
un certo piacere l'animazione che le arrivava alle orecchie attraverso le
persiane abbassate. Stava facendo la prima colazione, insieme ai piccoli
Pericand, prima di recarsi in chiesa. La signora Pericand li guardava
mangiare senza toccare cibo, e sì che a dispetto delle restrizioni quel che
veniva servito era molto appetitoso, grazie alle alle scorte di viveri
accumulate nei grandi armadi subito dopo la dichiarazione di guerra.
La signora Craquant, il tovagliolo candido come neve spiegato sul petto
prosperoso, stava terminando la terza fetta di pane tostato e imburrato, ma
sapeva che le sarebbe andata di traverso: l'occhio fisso e freddo della figlia
la turbava. Ogni tanto si fermava e guardava la signora Pericand con aria
timida.
"Non so davvero perché mangio, Charlotte," diceva "non mi va giù
niente!"
La signora Pericand rispondeva con glaciale ironia: "Devi sforzarti,
mamma"
E spingeva davanti alla madre il bricco della cioccolata.
"E sia! Versamene ancora una mezza tazza, Charlotte, ma non di più, mi
raccomando!"
"Lo sai che è la terza?"
Ma la signora Craquant sembrava improvvisamente colpita da sordità.
"Sì, sì" diceva con aria vaga scuotendo il capo. "Hai ragione, Charlotte,
bisogna ristorarsi prima della triste cerimonia" E con un sospiro sorbiva la
cioccolata schiumosa.
In quel momento si udì suonare e il domestico portò un pacchetto alla
signora Pericand: le fotografie di Philippe e di Hubert che lei aveva dato da
incorniciare. Charlotte le osservò a lungo, poi si alzò, le posò sulla mensola,
fece qualche passo indietro per giudicarne l'effetto, quindi andò nella sua
camera e tornò con due coccarde da lutto e due nastri tricolori che sistemò
intorno alle cornici. A quel punto si udirono i singhiozzi della balia che
stava in piedi sulla soglia con in braccio Emmanuel. Anche Jacqueline e
Bernard si misero a piangere. La signora Pericand prese ciascuno dei figli
per una mano, li costrinse dolcemente ad alzarsi e li condusse fino alla
mensola.
"Miei piccoli cari! Guardate bene i vostri due fratelli maggiori e chiedete
al buon Dio la grazia di somigliare a loro. Cercate di essere anche voi dei
bravi bambini, ubbidienti e studiosi. Sono stati dei figli così buoni" disse
con voce soffocata dal dolore "che non mi stupisco che Dio li abbia
ricompensati con la palma del martirio. Non dobbiamo piangere. Sono
vicini al buon Dio; ci vedono, ci proteggono e ci accoglieranno lassù.
Intanto noi, quaggiù, potremo andar fieri di loro, come cristiani e come
francesi"
Adesso piangevano tutti; persino la signora Craquant aveva lasciato
perdere la cioccolata e cercava il fazzoletto con mano tremante. La
fotografia di Philippe era straordinariamente somigliante; quello era proprio
il suo sguardo profondo e puro. Sembrava contemplare i suoi cari con il suo
dolce sorriso, spesso tenero e indulgente.
". E nelle vostre preghiere" concluse la signora Pericand "non dovete
dimenticare i piccoli sventurati che sono morti con lui"
"Forse non sono morti tutti"
"É possibile," fece distrattamente la signora Pericand "sì, è possibile.
Poveri piccoli... D'altra parte quell'opera pia non è un impegno da poco"
aggiunse, e tornò con la mente al testamento del suocero.
La signora Craquant si asciugò gli occhi.
"Il piccolo Hubertà così carino, così mattacchione. Mi ricordo che un
giorno, quando eravate venuti a trovarmi, dopo pranzo mi ero addormentata
in salotto, ed ecco che quel birichino strappa la carta moschicida attaccata al
lampadario e me la cala piano piano sulla testa.
Mi sono svegliata e ho gridato, e tu, Charlotte, gli hai dato una bella
lezione, quella volta"
"Non me lo ricordo" fece Charlotte seccamente. "Ma su, mamma, finisci
la tua cioccolata e sbrighiamoci. La carrozza è pronta e sono quasi le dieci"
Scesero in strada, la nonna per prima, greve e ansimante, appoggiata al
bastone, poi la signora Pericand con i suoi veli da lutto al vento, quindi i
due bambini in nero ed Emmanuel in bianco, e per ultimi alcuni domestici
in lutto stretto. La carrozza era in attesa; il cocchiere scese da cassetta per
aprire la portiera quando, all'improvviso, Emmanuel tese il ditino e indicò
qualcuno nella folla.
"Hubert, c'è Hubert!"
La balia si voltò meccanicamente verso la direzione indicata dal bambino,
impallidì e uscì in un grido strozzato.
"Gesummaria!"
Una sorta di urlo roco uscì dalle labbra della madre; gettato indietro il
velo nero, mosse due passi verso Hubert, scivolò sul marciapiede e crollò
nelle braccia del cocchiere accorso in tempo a sostenerla.
Era proprio Hubert, una ciocca sbarazzina sull'occhio, la pelle rosea e
dorata come una pesca, senza bagagli, senza bicicletta, senza ferite, che
veniva avanti con un largo sorriso raggiante.
"'giorno, mamma! 'giorno, nonna! Tutti bene?"
"Sei tu? Sei tu? Sei vivo!" esclamò la signora Craquant ridendo e
singhiozzando insieme. "Ah, mio piccolo Hubert, io lo sapevo che non eri
morto! Sei troppo birbante!"
La signora Pericand stava tornando in sé.
"Hubert? Sei proprio tu?" balbettò con voce fioca.
Hubert era felice e al tempo stesso imbarazzato per quell'accoglienza.
Fece due passi verso la madre, le porse le guance che lei baciò come in
trance, poi restò lì in piedi, dondolandosi alla sua presenza come quando
portava a casa uno zero nella versione di latino.
"Hubert" fece con un sospiro la signora Pericand e gli si gettò al collo,
aggrappandosi a lui e coprendolo di baci e di lacrime. Una piccola folla
commossa si stringeva intorno a loro. Hubert, che non sapeva come
comportarsi, dava dei colpetti sulla schiena della madre, come se le fosse
andato qualcosa di traverso.
"Non mi aspettavate?"
La donna fece segno di no.
"Stavate per uscire?"
"Piccolo sciagurato! Andavamo a celebrare una messa per la pace della
tua anima!"
Si staccò da lei bruscamente.
"No! Sul serio?"
"Ma insomma, dov'eri finito? Che cosa hai fatto in questi due mesi? Ci
avevano detto che eri stato ucciso a Moulins"
"Be, come vedete non era vero, dal momento che sono qui"
"Sei andato veramente a combattere? Hubert, non mentire! Avevi proprio
bisogno di andarti a cacciare nei pasticci, sciocchino... E la bicicletta? Dov'è
la bicicletta?"
"L'ho persa"
"Naturalmente! Questo ragazzo sarà la mia morte! Ma su, racconta, parla,
dov'eri?"
"Cercavo di raggiungervi"
"Avresti fatto meglio a non lasciarci" disse la signora Pericand con
severità. "Tuo padre, comunque, sarà molto felice quando lo saprà"
aggiunse poi con voce rotta dall'emozione.
E di colpo si mise a piangere disperatamente, a baciarlo ancora. Intanto il
tempo passava; si asciugò gli occhi ma le lacrime continuavano a scorrerle
sulle guance.
"Su, sali in casa, va a lavarti! Hai fame?"
"No, ho fatto un'ottima colazione, grazie"
"Prendi un fazzoletto pulito, una cravatta e lavati le mani. Cerca di avere
un aspetto decente, santo Dio! E sbrigati a raggiungerci in chiesa"
"Ma come? Siete sempre dell'idea di andarci? Dal momento che sono
vivo, non preferireste sostituire la messa da requiem con una bella
abbuffata?
Magari al ristorante, che ne dite?"
"Hubert!"
"Cosa? É perché ho detto "abbuffata"?"
"No, ma...". É spaventoso dirglielo così, in mezzo alla strada, pensò la
signora Pericand. Lo prese per mano e lo fece salire nella carrozza.
"Piccolo mio, abbiamo avuto due grandi disgrazie. É morto prima il
nonno, il vostro povero nonno, poi Philippe...".
Hubert accusò il colpo in modo strano. Due mesi prima sarebbe scoppiato
in lacrime, e grosse lacrime trasparenti e salate gli avrebbero bagnato le
guance rosee. Ora invece diventò pallidissimo, e il suo volto assunse
un'espressione che la madre non gli aveva mai visto, virile, quasi dura.
"Del nonno non m'importa" disse dopo un lungo silenzio. "Quanto a
Philippe...".
"Ma Hubert, sei pazzo?"
"No, lo confermo: non m'importa, e neanche a voi. Era molto vecchio e
malato. Che cosa avrebbe fatto in mezzo a questo caos?".
"Ma insomma!" protestò la signora Craquant, offesa.
Lui continuò senza ascoltarla.
"Quanto a Philippe... Ma prima di tutto, siete sicuri? Non sarà andata
come con me?"
"Ahimè no, siamo sicuri...".
"Philippe...".
La voce ebbe un tremito e gli si spezzò.
" non era di questo mondo, gli altri parlano sempre del cielo ma pensano
solo alla terra... Lui veniva da Dio e adesso dev'essere molto felice" Si
nascose il volto fra le mani e rimase a lungo immobile. A quel punto si
udirono le campane della cattedrale. La signora Pericand toccò il braccio del
figlio.
"Andiamo?"
Il ragazzo fece segno di sì. Anche gli altri salirono nella carrozza o in
quella che la seguiva. Nella cattedrale Hubert avanzò fra sua madre e sua
nonna, e si trovò fra loro anche quando prese posto sull'inginocchiatoio.
Qualcuno lo aveva riconosciuto; si udirono dei sussurri, delle esclamazioni
soffocate. La signora Craquant non si era ingannata: c'era l'intera città, e
tutti poterono vedere il sopravvissuto che veniva a rendere grazie a Dio di
essere rimasto incolume nel giorno stesso in cui si pregava per i morti della
sua famiglia. La gente era piuttosto soddisfatta: un bravo ragazzino come
Hubert scampato alle pallottole tedesche era una cosa che confortava il loro
senso della giustizia e la loro sete di miracoli. Ogni madre rimasta senza
notizie dal mese di maggio (ed erano tante!) sentiva il proprio cuore battere
di speranza. Ed era impossibile pensare con acredine, come avrebbero
potuto essere tentate di fare: "C'è chi ha troppa fortuna", dal momento che,
purtroppo, il povero Philippe (un ottimo prete, si diceva) aveva trovato la
morte.
Così, nonostante la sacralità del luogo, molte donne sorrisero a Hubert.
Ma lui non le guardava, non si era ancora riavuto dallo stupore che le
parole di sua madre gli avevano procurato. La morte di Philippe lo
straziava. Riviveva l'orribile stato d'animo del momento del disastro, prima
della difesa disperata e vana di Moulins. "Fossimo tutti uguali, tutti porci e
cagne," pensava osservando i presenti "sarebbe ancora comprensibile, ma
santi come Philippe, che cosa li si manda a fare quaggiù? Se è per noi, per
redimere i nostri peccati, è come offrire una perla in cambio di un sacco di
pietre"
Quelli che gli stavano intorno, la sua famiglia, gli amici, suscitavano in
lui un sentimento di vergogna e di furore. Li aveva visti sulla strada, quelli e
i loro simili, ricordava le macchine piene di ufficiali che scappavano con le
loro belle valigie gialle e le loro donne dipinte, i funzionari che
abbandonavano le loro sedi, i politici che in preda al panico seminavano per
strada fasci di documenti segreti, le ragazze che dopo aver versato qualche
lacrima di convenienza il giorno dell'armistizio ora si consolavano con i
tedeschi. "E dire che nessuno lo saprà, che ci sarà intorno a tutto questo una
tale rete di menzogne che arriveranno a farne una pagina gloriosa della
Storia di Francia. E quanto si daranno da fare per scovare atti di eroismo e
di abnegazione... Dio, cosa non ho visto! Porte che restavano chiuse a chi
bussava per un bicchier d'acqua, sfollati che saccheggiavano le case; in tutti,
ricchi o poveri che fossero, confusione, viltà, vanità, ignoranza! Un bel
popolo siamo!"
Tuttavia recitava l'uffizio a fior di labbra, il cuore stretto, pesante come un
macigno, tanto da fargli male fisicamente. A più riprese emise un sospiro
rauco che preoccupò sua madre. La signora Pericand si girò verso di lui con
occhi pieni di lacrime che luccicavano attraverso il velo da lutto. E sussurrò:
"Stai male?"
"No, mamma" rispose lui guardandola con una freddezza di cui provò
rammarico ma che non riuscì a occultare.
Giudicava la sua famiglia con amarezza e severità dolorose; non
formulava le proprie rimostranze in modo preciso, le raccoglieva in sé tutte
insieme sotto forma di immagini brevi e violente: suo padre che definiva la
Repubblica "un regime corrotto" e la sera stessa dava una cena di
ventiquattro coperti, con le tovaglie più belle, il miglior foie gras, i vini più
pregiati, in onore di un ex ministro che poteva essere nominato di nuovo e
di cui il signor Pericand sollecitava i favori. (Oh! la bocca di sua madre a
culo di gallina: "Mio caro presidente..."). E le automobili stracariche di
biancheria e di argenteria intrappolate tra la folla dei fuggiaschi, con sua
madre che, indicando le donne e i bambini che andavano a piedi con poche
cose annodate in un fazzoletto, diceva:
"Vedete com'è buono Gesù Bambino: avremmo potuto essere al posto di
quei poveretti!" Ipocriti! Sepolcri imbiancati! E lui stesso, che cosa ci
faceva lì? Con il cuore pieno di odio e di ribellione, fingeva di pregare per
Philippe! Ma Philippe era... Mio Dio! "Philippe, fratello mio adorato!"
sussurrò, e come se quelle parole avessero avuto un potere consolatorio
divino la morsa che gli attanagliava il cuore si allentò e lacrime calde e
impetuose gli bagnarono le guance. Si lasciò invadere da pensieri di
dolcezza e di perdono, che non venivano da lui ma dal di fuori, come se un
amico si fosse chinato al suo orecchio e avesse mormorato: "Una famiglia e
una razza che hanno prodotto Philippe non possono essere malvagie. Sei
troppo severo, hai guardato solo ai fatti esteriori e non conosci gli animi. Il
male è visibile, brucia, fa mostra di sé e se ne compiace agli occhi di tutti.
Uno solo ha contato i sacrifici, misurato il sangue versato e il pianto"
Guardò la lastra di marmo dov'erano incisi i nomi dei caduti in guerra...
l'altra guerra.
Fra loro c'erano dei Craquant e dei Pericand, zii e cugini che non aveva
conosciuto, ragazzi poco più grandi di lui, uccisi sulla Somme, nelle
Fiandre, a Verdun, uccisi due volte perché erano morti per niente. A poco a
poco da quel caos, da quei sentimenti contraddittori nacque in lui una
strana, un'amara consapevolezza. Aveva acquisito una ricca esperienza;
adesso sapeva, e non più in modo astratto, libresco, ma con i battiti folli del
suo cuore, con le mani scorticate nella difesa del ponte di Moulins, con le
labbra che avevano baciato una donna mentre i tedeschi festeggiavano la
vittoria. Sapeva che cosa significassero le parole pericolo, coraggio, paura,
amore... Sì, anche amore... Si sentiva bene, adesso, forte e sicuro di sé. Non
avrebbe mai più guardato con gli occhi degli altri, e ormai anche quello che
avrebbe amato e in cui avrebbe creduto sarebbe stato opera sua e non
ispirato da altri. Giunse lentamente le mani, chinò la testa e, finalmente,
pregò.
La messa ebbe termine. Sul sagrato tutti gli si fecero intorno, lo
abbracciarono, si congratularono con sua madre.
"E ha sempre quelle sue belle guance" dicevano le signore. "Dopo tanti
strapazzi è solo dimagrito un po’, non è cambiato, il nostro caro piccolo
Hubert...".
CAPITOLO 27.
I Corte arrivarono al Grand Hôtel alle sette del mattino, barcollanti dalla
stanchezza e con lo sguardo spaurito, come se si aspettassero, una volta
varcate le porte girevoli, di ripiombare in un universo assurdo e angoscioso
nel quale gli sfollati avrebbero dormito sul tappeto color crema del salottino
riservato alla corrispondenza, il portiere non li avrebbe riconosciuti e
avrebbe negato loro una camera, non ci sarebbe stata acqua calda per lavarsi
e le bombe sarebbero cadute nella hall.
Ma, grazie a Dio, la perla delle stazioni termali di Francia era rimasta
intatta e sul lago ferveva una vita rumorosa e febbrile ma tutto sommato
normale. Il personale era al suo posto. Il direttore, è vero, affermava che
mancava ogni cosa, tuttavia il caffè era squisito, le bibite al bar ben
ghiacciate e dai rubinetti usciva acqua fredda o bollente a volontà.
All'inizio ci si era preoccupati: l'atteggiamento ostile dell'Inghilterra
faceva temere il prolungarsi del blocco che avrebbe reso problematica la
fornitura di whisky, ma l'albergo era dotato di scorte ragguardevoli. Si
poteva aspettare. Già ai primi passi sul marmo della hall i Corte si sentirono
rinascere: tutto era tranquillo, tanto che si percepiva il lontano ronzio dei
grandi ascensori. Dalle vetrate aperte si scorgeva l'arcobaleno liquido e
tremolante dei getti d'acqua che innaffiavano i prati del parco. I Corte
furono riconosciuti e fatti oggetto di sollecita attenzione. Il direttore del
Grand Hôtel, dove Corte scendeva regolarmente da vent'anni, alzò le
braccia al cielo e disse che il mondo era crollato, che si sprofondava in un
abisso e che bisognava ripristinare nella gente il senso del dovere e della
grandeur; quindi rivelò loro che era atteso da un momento all'altro l'arrivo
del governo, che tutte le suite erano prenotate dal giorno prima, tanto che
l'ambasciatore della Bolivia dormiva su un tavolo da biliardo, ma che per
lui, per Gabriel Corte, avrebbe trovato una sistemazione. Più o meno quello
che usava raccontare al Normandy di Deauville nel periodo delle corse, al
tempo dei suoi esordi da vicedirettore!
Corte si passò stancamente la mano sulla fronte accigliata.
"Mio povero amico, faccia come vuole, mi metta anche un materasso in
un gabinetto!"
Tutto, intorno a lui, si svolgeva in modo discreto, ovattato, decoroso.
Non c'erano più donne che partorivano in un fosso, bambini che vagavano
sperduti, ponti che ricadevano in getti di fuoco, come missili, esplodendo
sotto una carica di melinite mal calcolata e polverizzando le case vicine.
Dove si trovava ora chiudevano una finestra per non fargli sentire la
corrente d'aria, aprivano le porte al suo passaggio e sentiva sotto i piedi
soffici tappeti.
"Ha tutti i suoi bagagli? Non ha perso niente? Che fortuna! C'è gente che
è arrivata qui senza un pigiama, senza uno spazzolino da denti. Un
poveraccio è stato completamente spogliato da un'esplosione e ha fatto il
viaggio da Tours tutto nudo, avvolto in una coperta e gravemente ferito"
"Io ho rischiato di perdere i miei manoscritti" disse Corte.
"Oh, mio Dio, che sciagura! Ma li ha ritrovati intatti, spero? Cosa ci tocca
di vedere! Cosa ci tocca di vedere! Prego, signore, mi scusi, signora, vi
precedo. Ecco la suite che vi posso assegnare, è al quarto piano purtroppo,
ma mi scuserete, vero?"
"Ah," mormorò Corte "tutto mi è indifferente ormai!"
"Capisco" disse il direttore piegando il capo di lato con aria triste.
"Un tale disastro... Io sono svizzero di nascita ma il mio cuore è francese.
Capisco" ripeté.
E rimase per qualche istante immobile, la fronte china come al cimitero
quando si è salutata la famiglia e non si osa precipitarsi all'uscita.
Da qualche giorno aveva assunto così spesso quell'atteggiamento che la
sua faccia simpatica e grassoccia si era completamente trasformata.
Aveva sempre avuto il passo leggero e la voce flautata che la sua
professione richiedeva; accentuando vieppiù queste disposizioni naturali era
arrivato a circolare silenziosamente, come in una camera mortuaria, e
quando disse a Corte: "Faccio portar su le colazioni?" lo fece con un tono
discreto e funebre, quasi gli domandasse, indicando il corpo di un caro
parente: "Posso dargli un ultimo bacio?"
"Le colazioni?" sospirò Corte, tornando faticosamente alla realtà
quotidiana e alle sue futili preoccupazioni. "Non mangio da ventiquattr'ore"
aggiunse con un pallido sorriso.
Il che, se era stato vero il giorno prima, non lo era più, perché
Gabriel aveva fatto un buon pasto quella mattina stessa, alle sei. Non
mentiva, comunque: aveva mangiato molto distrattamente per via
dell'estrema stanchezza e del turbamento in cui lo gettavano le sventure
della patria, e gli sembrava di essere ancora digiuno.
"Ma deve sforzarsi, signore! Mi dispiace vederla così, signor Corte.
Deve mettercela tutta, lei ha dei doveri verso l'umanità"
Corte fece con la testa un piccolo cenno disperato, come a dire che lo
sapeva, che non contestava i diritti dell'umanità nei suoi confronti, ma che,
nel caso specifico, non si poteva pretendere più coraggio da lui che
dall'ultimo dei cittadini.
"Amico mio," disse voltandosi per nascondere le lacrime "non è solo la
Francia che muore, è lo Spirito"
"Mai, finché ci sarà lei, signor Corte" rispose calorosamente il direttore
che, dopo la disfatta, aveva pronunciato quella frase un certo numero di
volte. Corte era, nell'ordine delle celebrità, la quattordicesima arrivata da
Parigi dopo i luttuosi avvenimenti, e il quinto scrittore venuto a rifugiarsi al
Grand Hôtel.
Corte sorrise debolmente e chiese che il caffè fosse ben caldo.
"Bollente" assicurò il direttore, che uscì dopo aver dato per telefono le
debite istruzioni.
Florence si era ritirata nella sua camera e, chiusa a chiave la porta, si
guardava allo specchio costernata. Il sudore copriva di uno strato lucido il
suo volto, abitualmente così sereno, così ben truccato, così riposato, che ora
non assorbiva più la cipria e la crema, ma le espelleva in grumi densi come
una maionese impazzita; le alette del naso erano contratte, gli occhi
infossati, la bocca molle e avvizzita. Si allontanò dallo specchio inorridita.
"Ho cinquant’anni" disse alla fidata cameriera.
Aveva espresso un'incontestabile verità, ma pronunciò quelle parole con
un tale accento di incredulità e di terrore che Julie le intese come andavano
intese, vale a dire come un'immagine, una metafora per designare
l'irrimediabile vecchiaia.
"Dopo quello che abbiamo passato, è più che comprensibile... Ma se la
signora fa un pisolino...".
"É impossibile... Appena chiudo gli occhi, sento le bombe, rivedo quel
ponte, quei morti...".
"Dimenticherà"
"Ah, no! Mai! Potrai dimenticarlo, tu?"
"Per me è diverso"
"Perché?"
"La signora ha tante altre cose a cui pensare!" disse Julie. "Devo tirarle
fuori il vestito verde?"
"Il vestito verde? Con la faccia che mi ritrovo?"
Florence si era lasciata andare contro lo schienale della sedia, con gli
occhi chiusi, ma di colpo raccolse tutte le sue energie come il condottiero
che, quantunque abbia bisogno di riposo, constatata l'inefficienza dei
subalterni riprende in mano il comando e, pur estenuato, si mette alla testa
dei suoi uomini sul campo di battaglia.
"Ascolta, Julie, senti quello che devi fare. Per prima cosa preparami,
insieme al bagno, una maschera per il viso, la numero tre dell'Istituto di
bellezza americano; poi telefona al parrucchiere dell'hotel e chiedi se c'è
sempre Luigi. Se c'è, fallo venire con la manicure fra tre quarti d'ora. Da
ultimo, tirami fuori il tailleurino grigio con la camicetta di lino rosa"
"Quella con il colletto così?" domandò Julie muovendo il dito a indicare
la forma dello scollo.
Florence esitò.
"Sì... no... sì, quella, e il cappellino nuovo con i fiordalisi. Sai Julie, ho
pensato davvero che non lo avrei mai messo, quel cappellino.
Ma insomma... Hai ragione tu, non dobbiamo più pensare a quelle cose,
c'è da impazzire... Mi domando se hanno ancora la cipria ocra, l'ultimo
tipo...".
"Vedremo... La signora farebbe bene a prenderne diverse scatole: veniva
dall'Inghilterra"
"Ah, lo so bene! Vedi, Julie, forse non ci rendiamo perfettamente conto di
quello che sta succedendo. Si tratta di avvenimenti di portata incalcolabile,
davvero incalcolabile... La vita della gente cambierà per generazioni. E
avremo fame, quest'inverno. Tirami fuori la borsetta di camoscio grigio con
la cerniera d'oro... Chissà che aspetto avrà Parigi" disse Florence entrando
in bagno, ma il rumore dell'acqua che Julie faceva scendere coprì le sue
parole.
Nel frattempo, pensieri meno frivoli occupavano la mente di Corte. Se ne
stava anche lui disteso nella vasca. Nei primi istanti aveva provato una gioia
tale, una pace campestre così profonda che gli erano tornate alla mente le
delizie dell'infanzia: la beatitudine di mangiare una meringa ghiacciata
imbottita di crema, di mettere i piedi in una sorgente fresca, di stringere al
cuore un giocattolo nuovo. Non aveva più desideri, rimpianti, angosce. La
sua testa era vuota e leggera.
Fluttuava in un elemento liquido, tiepido, che gli accarezzava e
solleticava la pelle, lavava via la polvere, il sudore, gli s'insinuava fra le dita
dei piedi, gli scivolava sotto le reni nel modo in cui una madre solleva un
bimbo addormentato. La stanza da bagno profumava di sapone al catrame,
di lozione per i capelli, di acqua di colonia e di lavanda. Corte sorrideva,
allungava le braccia, faceva scrocchiare le giunture delle lunghe dita pallide,
assaporava il divino e semplice piacere di essere al riparo dalle bombe e di
fare un bel bagno rinfrescante in una giornata torrida. Eppure,
all'improvviso, non avrebbe saputo dire in quale istante, l'amarezza penetrò
in lui come un coltello nella polpa di un frutto. Forse fu quando lo sguardo
gli cadde sulla valigia con i manoscritti posata su una sedia o quando,
cadutogli il sapone nell'acqua, dovette fare, per ripescarlo, uno sforzo che
offuscò la sua euforia: fatto sta che a un certo punto aggrottò la fronte, e il
suo viso che era sembrato più fresco, più levigato del solito, ringiovanito,
riassunse un'espressione cupa e preoccupata.
Che ne sarebbe stato di lui, Gabriel Corte? Dove stava andando il mondo?
Quale sarebbe stato lo spirito dei nuovi tempi? Forse la gente avrebbe
pensato solo a mangiare e non ci sarebbe più stato posto per l'arte, oppure,
come dopo ogni crisi, un nuovo ideale avrebbe conquistato il pubblico. Un
nuovo ideale? Cinico e annoiato, pensò: "Una nuova moda!".
Ma lui, Corte, era troppo vecchio per adeguarsi a un cambiamento di
gusti. Già nel 1920 aveva rinnovato il suo stile; impossibile farlo ancora una
volta. Si affannava a seguirlo, quel mondo nascituro. Ma come prevedere la
forma che avrebbe preso uscendo, come da uno stampo di bronzo, dalla
dura matrice della guerra, quell'universo di cui si coglievano i primi
sussulti? Poteva uscirne gigante o deforme - o entrambe le cose. Era
terribile tentare di penetrarlo... e non capirci niente. Perché non ci capiva
davvero niente. Pensò al suo romanzo, a quel manoscritto salvato dal fuoco
e dalle bombe che stava lì, su una sedia. E provò uno scoramento profondo.
Le passioni che vi descriveva, i suoi stati d'animo, i suoi scrupoli, quella
storia di una generazione, la sua, tutto questo era vecchio, inutile, superato.
Ripeté con disperazione: superato! E per la seconda volta il sapone, che
guizzava via come un pesce, sparì nell'acqua. Corte lanciò una bestemmia,
si alzò in piedi, suonò all'impazzata, il cameriere accorse.
"Fammi una frizione" sospirò infine con voce tremula.
Dopo una bella frizione alle gambe con il guanto di crine e l'acqua di
colonia si sentì meglio. Completamente nudo, prese a farsi la barba mentre
il cameriere gli preparava i vestiti: camicia di lino, completo di tweed
leggero, cravatta blu.
"C'è qualcuno che conosciamo?" domandò Corte.
"Non lo so, signore. Non ho ancora visto molta gente ma mi hanno detto
che la notte scorsa sono arrivate, ma solo di passaggio, parecchie macchine
dirette in Spagna. Tra gli altri, c'era il signor Jules Blanc, che andava in
Portogallo"
"Jules Blanc?"
Corte restò immobile, con la lama del rasoio coperta di sapone a
mezz'aria. Jules Blanc scappato in Portogallo! La notizia lo colpì
dolorosamente. Come tutti coloro che si danno da fare per trarre dalla vita il
massimo di comodità e di piaceri, Gabriel Corte si era assicurato la
devozione di un uomo politico. In cambio di cene squisite, di brillanti
ricevimenti, di piccoli favori accordati da Florence e di qualche articolo ben
piazzato, otteneva da Jules Blanc (titolare di un portafoglio in quasi tutte le
combinazioni ministeriali, due volte presidente del Consiglio, quattro volte
ministro della Guerra) un'infinità di privilegi che facilitavano la sua
esistenza. Grazie a Jules Blanc, per esempio, gli era stata commissionata la
serie degli "Amanti Celebri" che l'inverno precedente aveva curato per la
radio di Stato. Sempre per la radio, Jules Blanc lo aveva incaricato di tenere
allocuzioni patriottiche, sermoni trionfali o morali a seconda delle
circostanze. Ed era stato ancora Jules Blanc a insistere presso il direttore di
un grande quotidiano affinché il romanzo di Corte venisse pagato
centotrentamila franchi invece degli ottantamila precedentemente pattuiti. E
per finire gli aveva promesso il nastrino della Legion d'onore. Jules Blanc,
insomma, era un umile ma necessario ingranaggio nella meccanica della sua
carriera, perché neppure il genio può librarsi nell'alto dei cieli, anche lui
deve manovrare sulla terra.
Venuto a conoscenza della caduta in disgrazia dell'amico (doveva essersi
molto compromesso se aveva preso quella decisione disperata, lui che
amava ripetere che in politica la sconfitta prepara la vittoria), Corte si sentì
solo e abbandonato sull'orlo di un baratro. Di nuovo, con terribile violenza,
lo assalì il timore di un mondo diverso, a lui sconosciuto, di un mondo in
cui tutti sarebbero diventati per miracolo virtuosi, disinteressati, nutriti dei
più nobili ideali. Ma già quel mimetismo che è una forma dell'istinto di
conservazione per piante, animali e uomini gli faceva dire:
"Ah, è scappato? É finita l'epoca di quei gaudenti, di quei politicanti...".
E dopo un silenzio aggiunse:
"Povera Francia...".
Si infilò lentamente le calze blu. E in piedi, in calze e giarrettiere di seta
nera, il resto del corpo nudo, glabro e di un bianco levigato con riflessi
giallastri d'avorio, eseguì alcuni movimenti delle braccia e alcune flessioni
del tronco. Si guardò nello specchio con aria compiaciuta.
"Va decisamente meglio" disse rivolto al cameriere, come se pensasse di
fargli molto piacere con quelle parole.
Poi finì di vestirsi e scese al bar; era da poco passato mezzogiorno.
Nella hall si notava una certa agitazione, era evidente che stava
succedendo qualcosa di anomalo, che grandi catastrofi lontane scuotevano il
resto dell'universo; alcuni bagagli erano stati dimenticati, ammucchiati alla
rinfusa sulla pedana dove di solito si ballava. Dalle cucine provenivano
scoppi di voci; donne pallide, stravolte, vagavano nei corridoi alla ricerca di
una camera, gli ascensori erano guasti. Un vecchio piangeva davanti al
portiere che gli rifiutava un letto.
"Cerchi di capire, signore, non è cattiva volontà, ma è impossibile,
impossibile. Siamo sovraccarichi, signore".
"Solo un angolino" supplicava il poveretto. "Avevo dato appuntamento a
mia moglie qui. Ci siamo persi durante il bombardamento di Étampes. Mi
crederà morto. Ho settant’anni, signore, e lei sessantotto. Non ci siamo mai
lasciati"
Tirò fuori il portafoglio con mano tremante.
"Le darò mille franchi" disse.
Sulla sua faccia di francese medio, modesto e dabbene, si leggeva la
vergogna di dover offrire una specie di bustarella per la prima volta nella
sua vita, e anche il dispiacere di doversi separare dal suo denaro, ma il
portiere rifiutò la banconota che l'uomo gli porgeva.
"Le ripeto che è impossibile, signore. Cerchi in città".
"In città? Ma vengo proprio da lì! Ho bussato a tutte le porte fin dalle
cinque di stamani per vedermi cacciare come un cane! E non sono uno
qualunque, insegno fisica al liceo di Saint-Omer e sono stato insignito di
un'onorificenza accademica"
Poi, accortosi finalmente che il portiere non lo ascoltava da un pezzo e gli
aveva voltato le spalle, raccolse una piccola cappelliera che aveva lasciato
cadere a terra e che doveva contenere tutto il suo bagaglio, e se ne andò in
silenzio. Ora il portiere se la stava vedendo con quattro spagnole dal volto
incipriato e i capelli neri. Una di loro gli si aggrappava al braccio.
"Una volta nella vita, passi, ma due è troppo" sbraitava in cattivo francese
con voce rauca e forte. "Prima la guerra in Spagna, poi la fuga in Francia
per ritrovarmi in questo caos... É troppo!".
"Ma, signora, io che ci posso fare?"
"Può darmi una camera!"
"Impossibile, signora, impossibile"
La spagnola cercò una risposta sferzante, un'ingiuria, non ci riuscì,
boccheggiò un istante poi gli gettò in faccia: "Lei è un verme!"
"Io?" sbottò il portiere perdendo di colpo la sua impassibilità
professionale e fremendo di indignazione per l'oltraggio. "La smette
d'insultarmi? E poi lei è straniera, o sbaglio? Chiuda quella bocca o chiamo
la polizia" concluse più dignitosamente aprendo la porta e spingendo fuori
le quattro esagitate che vomitavano ingiurie in castigliano.
"Che giornate, signore, che notti" disse rivolto a Corte. "Il mondo è
impazzito!"
Corte imboccò un lungo corridoio fresco, silenzioso e scuro, e arrivò
all'ampio bar. Ogni agitazione si fermava sulla soglia di quel luogo
tranquillo. Le imposte chiuse delle grandi finestre lo proteggevano dalla
vampa di un sole foriero di tempesta, e vi si respirava un aroma ramato di
cuoio, di ottimi sigari e di acquavite stagionata. Il barman, un italiano,
vecchio amico di Corte, lo accolse con stile perfetto, testimoniandogli il suo
piacere nel rivederlo e la sua partecipazione alle sciagure della Francia in
modo così nobile, così pieno di tatto, senza mai dimenticare il riserbo
dettato dagli eventi né l'inferiorità della sua posizione nei confronti di Corte,
che quest'ultimo si sentì del tutto rincuorato.
"Mi fa piacere rivederla, vecchio mio" disse con riconoscenza.
"Il signore ha avuto difficoltà a lasciare Parigi?"
"Ah!" fece semplicemente Corte alzando gli occhi al cielo.
Il barman abbozzò un piccolo gesto pudico con la mano come a
respingere delle confidenze che avrebbero potuto risvegliare ricordi così
recenti e dolorosi e, con il tono del medico che dice al malato in piena crisi:
"Beva prima questo, poi mi esporrà il suo caso", mormorò
rispettosamente:
"Il solito martini?"
Con il bicchiere reso opaco dal ghiaccio posato davanti a lui fra due
piattini, uno con le olive, l'altro con le patatine, Corte rivolse allo scenario
familiare un pallido sorriso da convalescente, poi osservò gli uomini che
stavano entrando riconoscendoli via via l'uno dopo l'altro.
Ma sì, c'erano tutti, l'accademico ed ex ministro, il grande industriale,
l'editore, il direttore di giornale, il senatore, il drammaturgo e quello che
firmava Generale X quegli articoli così documentati, così seri, così tecnici
su un grande periodico parigino per il quale commentava gli eventi militari
e li faceva digerire alle masse aggiungendovi precisazioni sempre
ottimistiche ma alquanto vaghe (dicendo ad esempio: "Il prossimo teatro
delle operazioni militari sarà nell'Europa del Nord o nei Balcani o nella
Ruhr, o in queste tre zone contemporaneamente, oppure in un punto del
globo che è impossibile determinare") Sì, c'erano tutti e in perfetta salute.
Per un attimo Corte provò un certo stupore. Non avrebbe saputo dire perché,
ma per ventiquattr'ore gli era sembrato che il vecchio mondo fosse crollato e
che lui fosse rimasto solo in mezzo alle rovine. Che sollievo ineffabile
ritrovare quelle facce di amici famosi, di nemici così poco importanti per lui
oggi! Appartenevano allo stesso ambiente sociale, erano lì, tutti insieme! Si
dimostravano a vicenda che niente era cambiato, che tutto era rimasto
uguale, che non ci si trovava davanti a un qualche cataclisma straordinario,
alla fine del mondo come si era creduto, ma a una serie di eventi puramente
umani, limitati nel tempo e nello spazio, e che, tutto sommato, non
dovevano ripercuotersi che su gente estranea.
Ci si scambiarono frasi pessimiste, quasi desolate, ma con voce allegra.
Alcuni avevano tratto i massimi vantaggi dalla vita; erano nell'età in cui ci
si dice, guardando i giovani: "Che si arrangino!" Altri facevano
mentalmente un rapido inventario di tutte le pagine che avevano scritto, di
tutti i discorsi che avevano pronunciato, e che avrebbero potuto venire utili
con il nuovo regime (e poiché avevano tutti più o meno deplorato che la
Francia avesse perso il senso della grandeur, dell'avventura, e che avesse
smesso di fare figli, da quel lato stavano tranquilli!) Gli uomini politici, un
po’ più preoccupati perché alcuni di loro erano molto compromessi,
meditavano rovesciamenti di alleanze.
Il drammaturgo e Corte parlarono tra loro delle rispettive opere,
dimenticando il resto del mondo.
CAPITOLO 28.
I Michaud non erano mai arrivati a Tours. Un'esplosione aveva distrutto
la strada ferrata. Il treno si era fermato e gli sfollati si erano ritrovati sulla
strada insieme alle colonne tedesche. E lì ricevettero l'ordine di fare dietro
front. Tornati a Parigi, i Michaud trovarono la città semideserta. Si
avviarono verso casa a piedi; erano stati lontani per quindici giorni, ma
poiché quando si rientra da un lungo viaggio ci si aspetta di ritrovare tutto
sottosopra, avanzavano in quelle strade intatte e non potevano credere ai
loro occhi: tutto era a posto, un sole che pareva annunciare un temporale
illuminava le case dalle imposte chiuse, un'impennata di caldo aveva
bruciato le foglie dei platani che nessuno spazzava e che gli sfollati
calpestavano con i loro piedi stanchi. I negozi di alimentari sembravano
chiusi. Di tanto in tanto quella realtà desertica suscitava stupore; la città
pareva come svuotata dalla peste, e quando si stava per esclamare, con il
cuore stretto: "Ma sono tutti scappati o morti", ci si trovava
improvvisamente a faccia a faccia con una donna vestita e truccata per bene,
oppure, come capitò ai Michaud, si scorgeva, fra una macelleria e una
panetteria sprangate, il salone di un parrucchiere dove una signora stava
facendosi fare la permanente. Era proprio il parrucchiere della signora
Michaud, che lo chiamò; lui stesso, l'aiutante, la moglie e la cliente si
precipitarono alla porta ed esclamarono:
"Siete tornati a piedi?"
Lei mostrò le gambe senza calze, gli abiti stracciati, la faccia sporca di
sudore e di polvere.
"Come potete vedere! E a casa mia?" domandò con ansia.
"Tutto a posto! Sono passata anche oggi sotto le sue finestre" disse la
moglie del parrucchiere. "Non è stato toccato niente".
"E mio figlio? Jean-Marie? Qualcuno lo ha visto?"
"Come vuoi che lo abbiano visto, mia povera moglie" disse Maurice
facendosi avanti a sua volta. "Tu vaneggi!".
"E tu, con la tua calma, mi farai morire" ribatté lei prontamente. "Ma
forse la portinaia..." e già si slanciava verso casa.
"Lasci perdere, signora Michaud! Non si sa niente, l'ho chiesto passando,
e del resto la posta non arriva più!"
Jeanne cercò di nascondere la bruciante delusione sotto un sorriso.
"Bene, non c'è che da aspettare" disse, ma le tremavano le labbra.
Si sedette meccanicamente e mormorò: "Che fare adesso?"
"Fossi in lei," disse il parrucchiere, che era un ometto grasso dalla mite
faccia rotonda "comincerei col farmi uno shampoo, le schiarirà le idee, e
potremmo anche sistemare un po’ il signor Michaud... Nel frattempo, mia
moglie vi cucinerà qualcosa"
E così fu. Stavano frizionando la testa di Jeanne con una lozione alla
lavanda quando il figlio del parrucchiere piombò in negozio annunciando
che era stato firmato l'armistizio. Nello stato di prostrazione e di stanchezza
in cui si trovava, la signora Michaud colse a malapena l'importanza di
quella notizia, come quando al capezzale di un morente, dopo aver versato
tante lacrime, non ne restano più per il suo ultimo respiro. Maurice, invece,
ricordando la guerra del '14, le sue battaglie, le sue ferite, le sue sofferenze,
sentì salirgli in cuore un'ondata di amarezza. Ma non c'era più niente da
dire. E tacque.
Restarono più di un'ora nel negozio della signora Josse, poi si avviarono
verso casa loro. Correva voce che le perdite dell'esercito francese fossero
relativamente basse ma che il numero dei prigionieri arrivasse a due milioni.
Chissà, forse Jean-Marie si trovava fra questi... I Michaud non osavano
sperare di più. Si avvicinavano alla loro casa e, nonostante le assicurazioni
della signora Josse, non riuscivano a credere che fosse ancora in piedi e non
in cenere come le case incendiate di place du Martroi, a Orleans, che
avevano attraversato la settimana precedente. E invece ecco il portone, la
guardiola della portinaia, la casella delle lettere (vuota!), la chiave che li
aspettava e la portinaia in persona! Lazzaro, ritrovando le sorelle e la zuppa
sul fuoco dopo essere resuscitato, dovette provare un sentimento analogo,
un misto di stupore e di tacita fierezza: "Nonostante tutto siamo tornati,
siamo qui" pensavano. E subito, Jeanne:
"Ma a che pro? Se mio figlio...".
Guardò Maurice che le sorrise debolmente, poi disse a voce alta alla
portinaia:
"Buongiorno, signora Nonnain"
La portinaia era anziana e mezzo sorda. I Michaud abbreviarono quanto
più possibile i rispettivi resoconti dell'esodo: la signora Nonnain aveva
seguito la figlia, che faceva la lavandaia, fino alla porte d'Italie. Arrivata là,
aveva litigato con il genero e se n'era tornata a casa.
"Non sanno che fine ho fatto; mi crederanno morta" disse con una certa
soddisfazione "e penseranno già di mettere le mani sui miei risparmi.
Non è che sia cattiva," aggiunse alludendo alla figlia "ma è prepotente"
I Michaud le dissero che erano stanchi e salirono in casa. L'ascensore era
guasto.
"É la goccia che fa traboccare il vaso" gemette Jeanne, che comunque la
prendeva allegramente.
Mentre il marito saliva lento la scala, lei si slanciava avanti, ritrovando le
gambe e il fiato di quand'era ragazza. Mio Dio, quante volte aveva
imprecato contro quella scala buia, contro quell'appartamento che mancava
di armadi a muro, che non disponeva di un bagno (tanto che avevano dovuto
mettere una tinozza in cucina), per non parlare dei termosifoni che si
guastavano regolarmente in pieno inverno!
E ora quel piccolo universo chiuso, ovattato, dove lei era vissuta per
quindici anni e che racchiudeva fra le sue pareti ricordi così dolci, così
caldi, le veniva restituito. Si sporse dalla ringhiera delle scale, vide Maurice
sotto di lei, ancora distante. Era sola. Si chinò e posò le labbra sul legno
della porta, poi prese la chiave e aprì. Il suo appartamento, il suo rifugio.
Ecco la camera di Jean-Marie, ecco la cucina, ecco il salotto e il divanetto
su cui la sera, rientrando dalla banca, allungava i piedi stanchi.
Il ricordo della banca la fece sobbalzare di colpo. Erano otto giorni che
non ci pensava. Quando Maurice la raggiunse, vide che era preoccupata e
che la gioia del ritorno era svanita.
"Che cosa c'è?" domandò. "Jean-Marie?".
Lei ebbe una breve esitazione.
"No, la banca"
"Mio Dio, Jeanne, abbiamo fatto tutto quello che era umanamente
possibile, e anche di più, per arrivare a Tours. Non hanno niente da
rimproverarci"
"Non lo faranno se avranno l'intenzione di tenerci," ribatté lei "ma io ero
stata assunta solo ad interim dopo lo scoppio della guerra, e tu, mio povero
caro, non sei mai andato molto d'accordo con loro... Quindi, se vogliono
sbarazzarsi di noi, questa è l'occasione buona"
"Sì, ci ho pensato anch'io"
Come sempre quando lui non la contraddiceva e si dichiarava pienamente
d'accordo con lei, Jeanne cambiò subito parere.
"Comunque, se non sono delle sporche carogne...".
"Ma sono delle sporche carogne," disse Maurice con dolcezza "lo sai
anche tu. Ascolta, abbiamo avuto la nostra parte di guai, adesso siamo
insieme, siamo a casa nostra. Non pensiamo a nient'altro...".
Non parlarono di Jean-Marie, non potevano pronunciare il suo nome
senza scoppiare in lacrime e non volevano piangere. C'era sempre, in loro,
un'ardente aspirazione alla felicità; forse perché si erano molto amati,
avevano imparato a vivere alla giornata, a non pensare al domani.
Non avevano fame. Aprirono un vasetto di marmellata, una scatola di
biscotti, e Jeanne preparò con infinita cura un caffè, attingendo all'ultimo
etto o poco più di quel moca di prima qualità fino allora riservato alle grandi
occasioni.
"Ma quali occasioni più grandi ci saranno date?" disse Maurice.
"Nessuna di questo tipo, spero" rispose sua moglie. "Comunque, non
dobbiamo nasconderci che se la guerra continua un caffè così non lo
troveremo tanto presto"
"Gli dai quasi il sapore del peccato" disse Maurice aspirando il profumo
che usciva dalla caffettiera.
Dopo quello spuntino si accomodarono insieme davanti alla finestra
aperta. Avevano ciascuno un libro sulle ginocchia, ma non leggevano.
Alla fine si addormentarono, a fianco a fianco e con le dita intrecciate.
Trascorsero alcuni giorni abbastanza tranquilli. Poiché la posta non
funzionava, Jeanne e Maurice sapevano di non poter avere notizie, né buone
né cattive. Non c'era che da aspettare. All'inizio di luglio il signor de
Furieres tornò a Parigi. Il conte aveva fatto "una bella guerra", come si
diceva dopo l'armistizio del 1919: incurante del pericolo, si era comportato
eroicamente per qualche mese, poi aveva sposato una ragazza molto ricca.
A quel punto aveva avuto un po’ meno voglia di farsi ammazzare, il che era
abbastanza naturale! Sua moglie aveva relazioni brillanti ma lui non se ne
servì. Non andò più incontro al pericolo e neppure cercò di evitarlo. Finì la
guerra senza un graffio, soddisfatto di sé, del suo comportamento eroico in
battaglia, della fiducia in se stesso e della sua buona stella. Nel '39 la sua
posizione mondana era di primissimo ordine; sua moglie era una SalomonWorms, sua sorella aveva sposato il marchese de Maigle; era membro del
Jochey Club, le sue cene e le sue partite di caccia erano celebri e aveva due
figlie deliziose, la maggiore delle quali si era appena fidanzata. Certo, non
possedeva tanto denaro come nel 1920, ma era in grado molto meglio di
allora di farne a meno o di procurarsene alla prima occasione. E aveva
accettato il posto di direttore della Banca Corbin.
Corbin era solo un personaggio volgare, che aveva iniziato la carriera dal
basso, da una posizione quasi spregevole - si raccontava che avesse
cominciato a lavorare come fattorino in un istituto di credito di rue Trudaine
-, ma le sue competenze in ambito bancario erano tali che, tutto sommato,
lui e il conte andavano abbastanza d'accordo. Erano entrambi molto
intelligenti e capivano di essere utili l'uno all'altro; questo finiva per dar
luogo a una sorta di amicizia a base di cordiale disprezzo - come certi
liquori aspri e amari che, quando vengono mescolati, assumono un sapore
gradevole. "É identico a tutti i nobili: un degenerato" diceva Corbin. "Il
pover'uomo non sa stare a tavola" sospirava Furieres. Facendogli balenare il
miraggio di un'eventuale ammissione al Jochey, il conte otteneva da Corbin
tutto quello che voleva.
Furieres, insomma, si era organizzato una vita assai piacevole. Quando
scoppiò la seconda guerra mondiale, si sentì all'incirca come un bambino
che è stato bravo a scuola, che ha la coscienza tranquilla, che ora sta
giocando con passione e che qualcuno viene di nuovo a strappare ai suoi
svaghi. Quasi quasi avrebbe gridato: "Suvvia! Una volta passi, due è
troppo!" Ma come? Aveva già fatto il suo dovere, lui! Gli avevano preso
cinque anni della sua gioventù e adesso gli rubavano quelli della maturità,
così belli, così preziosi, anni in cui un uomo capisce quello che sta per
perdere e ha fretta di goderne.
"No, è davvero il colmo" disse sconfortato a Corbin congedandosi da lui
il giorno della mobilitazione generale. "Si vede che era scritto lassù che non
dovevo scamparla!"
Era un ufficiale di riserva e aveva l'obbligo di partire; certo, avrebbe
potuto arrangiarsi in qualche modo per evitarlo, ma ne fu trattenuto dalla
necessità di continuare ad avere stima di sé, necessità in lui molto forte e
che gli consentiva di assumere verso il resto del mondo un atteggiamento
ironico e severo. Partì. Il suo autista, che aveva la sua stessa età, diceva:
"Bisogna andarci e ci andiamo. Ma se quelli credono che sarà come nel
'14, si sbagliano," (dicendo "quelli" pensava a un qualche mitico areopago
di individui la cui funzione, e passione, era il mandare gli altri alla morte)
"se s'immaginano che faremo tanto così più del necessario, be se lo possono
pure scordare, glielo dico io"
Il conte de Furieres non avrebbe certo espresso a quel modo il suo
pensiero, ma esso aveva una certa analogia con quello del suo autista, che a
sua volta rispecchiava la mentalità di molti ex combattenti.
Parecchi uomini partirono animati da un sordo rancore o da una disperata
rivolta contro la sorte che giocava loro quel tiro mancino due volte nella
vita.
Nel corso della disfatta di giugno il reggimento di Furieres cadde nelle
mani del nemico quasi al completo. Quanto a lui, aveva una possibilità di
salvezza e la colse al volo. Nel '14 si sarebbe fatto uccidere per non
sopravvivere alla sconfitta. Nel '40 preferì vivere. Ritrovò la moglie che già
lo credeva morto, le sue graziose figlie, la maggiore delle quali aveva fatto
un gran bel matrimonio (si era sposata con un giovane ispettore delle
Finanze) e il suo castello di Furieres.
L'autista fu meno fortunato: venne rinchiuso nello stallaggio con il
numero 55.481.
Al suo ritorno il conte si mise subito in contatto con Corbin, che era
rimasto nella zona libera, e insieme si dettero da fare per riunire i vari
settori sparsi della banca. La contabilità era a Cahors, i titoli a Bayonne, la
segreteria, destinata a Tolosa, si era dissolta fra Nizza e Perpignan. E
nessuno sapeva dove fosse finita la gestione del portafoglio.
"E tutto un caos, un guazzabuglio, un disordine inconcepibile" continuava
a dire Corbin a Furieres la mattina del loro primo incontro.
Durante la notte aveva oltrepassato la linea di demarcazione e ora
riceveva Furieres in casa sua, nell'appartamento parigino abbandonato dalla
servitù durante l'esodo; Corbin sospettava i domestici del furto delle valigie
nuove di zecca nonché della marsina, il che gli rinfocolava il furore
patriottico:
"Lei mi conosce, non sono un tipo particolarmente emotivo, eppure sono
stato lì lì per piangere, mio caro, sì, piangere come un bambino quando ho
visto il primo tedesco al confine - molto corretto devo dire, non con
quell'aria disinvolta del francese, sa, l'aria di chi dice: "Abbiamo mangiato
nello stesso piatto" No, un tipo veramente a posto, saluto veloce,
atteggiamento fermo ma non rigido, uno veramente a posto... Ma cosa ne
dice lei di tutto questo, eh? Cosa ne dice? Bella roba, gli ufficiali!"
"Scusi tanto," disse Furieres in tono secco "ma non vedo proprio cosa si
possa rimproverare agli ufficiali. Cosa si può fare senza armi e con uomini
viziati, corrotti, che chiedono solo di essere lasciati in pace?
Dateci degli uomini, per cominciare"
"Ma loro dicono: "Ci hanno lasciati allo sbando, senza ordini!"" replicò
Corbin, felicissimo di umiliare Furieres. "E, detto fra noi, vecchio mio, ho
assistito a certi spettacoli... davvero pietosi...".
"Senza i civili, senza quei pusillanimi in preda al panico, senza quel fiume
di sfollati che ostruiva la strada, ci sarebbe stata una possibilità di salvezza"
"Ah, in questo ha ragione! Quel panico era spaventoso. La gente è
davvero strana. Per anni tutti si sono sentiti ripetere: "La guerra totale, la
guerra totale...". Avrebbero dovuto aspettarsela, invece no!
Subito il panico, il caos, la fuga, e perché poi? Lo chiedo a lei. É assurdo!
Io sono partito perché le banche avevano ricevuto l'ordine di partire.
Altrimenti...".
"É stato brutto, a Tours?"
"Terribile... Ma sempre per lo stesso motivo: la massa degli sfollati!
Non ho trovato una camera libera nei dintorni e ho dovuto dormire in
città, dove naturalmente siamo stati bombardati, incendiati, e tutto il resto"
disse Corbin pensando con indignazione a quel piccolo castello in
campagna dove si erano rifiutati di accoglierlo perché vi si ospitavano dei
rifugiati belgi. Non erano stati colpiti, quelli, mentre lui, Corbin, aveva
rischiato di finire sepolto sotto le macerie di Tours. "E tutto quel disordine,"
continuò "ciascuno che pensava solo a se stesso!
Quell'egoismo... Ah, questo vi dà una bella idea dell'uomo! Quanto ai
suoi impiegati, si sono comportati al di sotto di ogni previsione. Non uno si
è sognato di raggiungermi a Tours. Hanno perso i contatti fra loro, e sì che
avevo raccomandato a tutti i nostri settori di restare uniti. Figuriamoci!
Qualcuno sta a sud, qualcun altro a nord. Non si può contare su nessuno.
Eppure è proprio nei momenti di crisi che si giudica l'uomo, la sua
intraprendenza, la sua grinta, il suo coraggio. Delle pappamolle, glielo
assicuro, che pensano solo a salvarsi la pelle e non si preoccupano né della
banca né di me! E ce n'è qualcuno che sbatterei fuori volentieri, le do la mia
parola! Del resto, non prevedo un gran movimento d'affari per il momento"
La conversazione prese un taglio tecnico, il che restituì ai due uomini il
sentimento gratificante della propria importanza, alquanto affievolito dopo
gli ultimi avvenimenti.
"Un gruppo tedesco" disse Corbin "si appresta a ricomprare le Acciaierie
dell'Est. Non siamo in una posizione sfavorevole da quel lato. É vero che
l'affare dei docks di Rouen...".
Cambiò umore, si incupì. Furieres stava congedandosi. Volle
accompagnarlo e, nel salone dalle imposte chiuse, girò l'interruttore ma la
luce non si accese. Lanciò una bestemmia.
"Mi hanno tagliato la corrente, carogne!"
"Dio, com'è volgare quest'uomo!" pensò il conte. E gli consigliò:
"Faccia una telefonata, rimedieranno in fretta. Il telefono funziona".
"Ma lei non può immaginare quanto tutto sia disorganizzato in questa
casa" disse Corbin che moriva di rabbia. "I domestici hanno pensato bene di
svignarsela, caro mio! Tutti al completo! E mi stupirei se non avessero fatto
man bassa dell'argenteria. Mia moglie non c'è, e io sono perduto in mezzo a
tutto questo, io...".
"La signora Corbin è nella zona libera?"
"Sì" grugnì Corbin.
Tra lui e sua moglie c'era stata una bella scenata; nella confusione della
partenza precipitosa, o forse con intenzione maligna, la cameriera aveva
infilato nel necessaire della signora Corbin una cornicetta che apparteneva
al signor Corbin e che racchiudeva una fotografia di Ariette nuda. In sé
quella nudità non avrebbe forse contrariato la sposa legittima, che era
persona piena di buon senso, ma il fatto è che la ballerina sfoggiava un
magnifico collier. "Ti assicuro che è falso!" dichiarava il signor Corbin,
seccatissimo. Ma la moglie non gli aveva creduto. Quanto ad Ariette, non
dava più segni di vita. Pareva tuttavia che si trovasse a Bordeaux e che si
facesse vedere spesso in compagnia di ufficiali tedeschi. Questo pensiero
non fece che peggiorare l'umore di Corbin, che tirò furiosamente un
campanello.
Ho solo una dattilografa," disse "una ragazzina che ho colto a Nizza.
Scema come poche ma molto carina. Ecco" aggiunse bruscamente, rivolto
alla brunetta che stava entrando. "Mi hanno tolto la corrente, veda un po’ di
fare qualcosa. Telefoni, protesti, si arrangi, e poi mi porti la posta"
"Non l'hanno portata su la posta?"
"No, è in portineria. Alzi i tacchi, adesso, e me la porti. La pago forse per
far niente?"
"La lascio, Corbin, lei mi spaventa" disse Furieres.
A Corbin non sfuggì il sorriso leggermente sprezzante del conte e la sua
collera aumentò. Smorfioso e imbroglione, pensò.
Ma disse:
"Cosa posso farci? C'è da diventar matti"
Nella posta c'era una lettera dei Michaud. Si erano presentati alla sede
della banca, a Parigi, ma nessuno aveva dato loro direttive precise.
Avevano scritto a Nizza e la lettera era stata rispedita a Corbin.
Chiedevano istruzioni e denaro. Il malumore che affliggeva Corbin fino a
quel momento trovò finalmente un oggetto su cui fissarsi.
"Ah, questa è buona!" esclamò. "Non si scompongono, i signori! Non
fanno una piega! Noi corriamo, ci diamo da fare, ci facciamo ammazzare su
tutte le strade di Francia, e i signori Michaud passano a Parigi delle
piacevoli vacanze. E hanno anche la faccia tosta di chiedere del denaro.
Scriva, signorina, scriva" disse alla dattilografa terrorizzata.
Parigi, 25 luglio 1940
Sig. Maurice Michaud
23, rue Rousselet Paris VII.
Signore, l'11 giugno avevamo dato a lei e alla signora Michaud l'ordine di
raggiungere il vostro posto di lavoro nella sede in cui la Banca era sfollata,
vale a dire a Tours. Lei non può ignorare che in certi momenti decisivi ogni
impiegato di banca, e in particolare lei che ricopriva un incarico di fiducia, è
come un combattente. E sa che cosa significa in tempi come questi
l'abbandono del posto. Il risultato della latitanza di entrambi è stato la totale
disorganizzazione dei settori che vi erano stati affidati - la segreteria e la
contabilità. E non è l'unico rimprovero che dobbiamo rivolgerle. In
occasione delle gratifiche del 31 dicembre scorso, quando lei aveva chiesto
di portare la sua a tremila franchi, le era stato fatto notare che, nonostante la
mia buona volontà nei suoi confronti, mi era impossibile concederle questo
aumento dato il basso rendimento del suo settore se paragonato a quello
fornito dal suo predecessore. Stando così le cose, mentre deploriamo il
grande ritardo con cui lei si è messo in contatto con la direzione,
consideriamo l'assenza di notizie da parte sua fino a questo momento come
una presentazione di dimissioni, sue e della signora Michaud. Dimissioni
che, partendo solo da lei e non essendo state oggetto di alcun preavviso, ci
esimono dal corrisponderle una qualsiasi indennità.
Tuttavia, tenendo conto del suo lungo periodo di servizio presso la Banca
e considerando le particolari circostanze del momento, concediamo a
entrambi, a titolo eccezionale e per pura generosità, l'importo
corrispondente a due mesi di stipendio. Accludiamo dunque alla presente un
assegno non trasferibile di franchi... presso la Banca di Francia a Parigi.
Voglia debitamente accusarcene ricevuta e gradisca, signore, i nostri distinti
saluti.
Corbin
La lettera gettò i Michaud nella disperazione. I loro risparmi non
arrivavano a cinquemila franchi, perché gli studi di Jean-Marie erano costati
parecchio. Con i due mesi di stipendio e quel gruzzolo riuscivano a mala
pena a mettere insieme quindicimila franchi e per di più dovevano del
denaro all'esattore delle tasse. Trovare un altro posto, in quel momento,
appariva impossibile; il lavoro era poco e mal pagato. Per di più erano
sempre vissuti piuttosto isolati; non potevano contare su una famiglia, su
qualcuno cui chiedere aiuto. E ora si sentivano esausti per le fatiche del
viaggio e angosciati a proposito del figlio. Durante l'infanzia di JeanMarie,
anni segnati da numerose avversità, la signora Michaud aveva pensato
spesso: "Non appena avrà l'età di cavarsela da solo, niente potrà più farmi
paura" Allora si sentiva forte e in buona salute, piena di coraggio, e non
temeva niente per sé né per il marito con il quale aveva una perfetta
comunanza di idee.
Adesso Jean-Marie era un uomo. Ovunque fosse, se era vivo, non aveva
più bisogno di lei. Ma questo non la consolava. Prima di tutto non riusciva a
credere che il suo bambino potesse fare a meno di lei, e al tempo stesso
capiva che era lei adesso, ad aver bisogno di lui. Tutto il suo coraggio
l'aveva abbandonata; vedeva la fragilità di Maurice e si sentiva sola,
vecchia, malata. Come avrebbero fatto a trovare un lavoro?
Come sarebbero vissuti quando avrebbero dato fondo a quei quindicimila
franchi? Jeanne aveva qualche piccolo gioiello cui era molto affezionata.
Diceva sempre: "Non hanno un gran valore", ma in fondo al cuore non
poteva credere che quella bellissima spilla di perle, quel piccolo anello con
rubino, regali di Maurice al tempo della gioventù e che le piacevano tanto,
non potessero essere venduti con un buon ricavo.
Li offrì a un gioielliere vicino a casa, poi a una ditta importante di rue de
la Paix, ma in entrambi i casi vennero rifiutati: la spilla e l'anello erano di
lavorazione elegante ma a loro interessavano solo le pietre, e queste erano
così piccole che non valeva la pena acquistarle.
Nel suo animo la signora Michaud fu felice di poter conservare i suoi
gioielli, ma il fatto era che essi costituivano ormai l'unica risorsa.
Il mese di luglio era già passato e aveva intaccato non poco le loro
economie. In un primo tempo tutti e due avevano pensato di andare da
Corbin, spiegargli che avevano fatto tutto il possibile per arrivare a Tours e
che, se perseverava nella sua idea di licenziarli, doveva almeno pagare
l'indennità di legge. Ma lo conoscevano abbastanza, Corbin, per sapere che
non erano in grado di opporglisi. Non avevano i mezzi necessari per
intentare una causa contro di lui, e Corbin, del resto, non era uno che si
lasciasse intimidire con facilità. E poi erano profondamente riluttanti a
chiedere qualcosa a un uomo che detestavano e disprezzavano.
"Non posso farlo, Jeanne. Non domandarmelo, non posso" diceva
Maurice con la sua voce dolce e sommessa. "Credo che se mi trovassi
davanti a lui gli sputerei in faccia, e questo non migliorerebbe le cose"
"No, credo proprio di no," disse Jeanne, sorridendo suo malgrado "ma la
nostra situazione è disastrosa, mio povero caro. E come se avanzassimo
verso un baratro e vedessimo la distanza diminuire a ogni passo senza poter
evitare di cadervi dentro. É insopportabile".
"Ma bisognerà sopportarlo" rispose lui in tono pacato.
Con la stessa inflessione di voce le aveva detto, quando era stato ferito nel
1916 e l'avevano chiamata all'ospedale: "Penso che le mie probabilità di
guarigione siano dell'ordine di quattro su dieci" Aveva riflettuto un attimo,
poi, per scrupolo, aveva aggiunto: "Di tre e mezzo, per essere precisi"
Lei gli posò dolcemente, teneramente, la mano sulla fronte, pensando
disperata: "Ah, se Jean-Marie fosse qui ci proteggerebbe, ci salverebbe! É
giovane, lui, è forte...". In lei s'intrecciavano stranamente il bisogno di
proteggere della madre e quello di esser protetta della donna. "Dov'è il mio
povero bambino? É vivo? Soffre? Non è possibile, mio Dio, che sia morto!"
pensò, e sentì un gelo nel cuore al pensiero di come, al contrario, questo
fosse possibile. Le lacrime trattenute coraggiosamente da tanti giorni le
sgorgarono copiose. E insorse protestando:
"Ma perché a noi tocca sempre soffrire? Alla gente come noi, alla gente
comune, ai piccoli borghesi? Quando arriva una guerra, o il franco è in
ribasso, o ci sono disoccupazione, crisi e rivoluzioni, gli altri se la cavano
sempre. E siamo noi a pagare! Perché? Che cosa abbiamo fatto?
Paghiamo per gli errori di tutti. Certo, di noi nessuno ha paura! Gli operai
si difendono, i ricchi sono forti, ma noi, noi siamo quelli da spremere! Mi
spieghino perché! Com'è possibile? Non capisco. Tu, che sei un uomo,
dovresti capire" disse con rabbia a Maurice, non sapendo più con chi
prendersela per la rovina che minacciava di travolgerli. "Chi ha torto? Chi
ha ragione? Perché Corbin? Perché Jean-Marie? Perché noi?"
"Che cosa vuoi capire? Non c'è niente da capire" disse lui cercando di
calmarla. "Ci sono leggi che governano il mondo e che non sono fatte né
pro né contro di noi. Quando scoppia il temporale non te la prendi con
nessuno, sai che la folgore è prodotta da due polarità elettriche, le nuvole
non ti conoscono. Non puoi muovere loro alcun rimprovero. E del resto
sarebbe assurdo, non capirebbero"
"Ma non è la stessa cosa. Qui si tratta di fenomeni puramente umani".
"Solo in apparenza, Jeanne. Sembrano dovuti a questo o a quell'uomo, a
questa o a quella circostanza, ma è come nella natura: a un periodo di calma
segue la tempesta che ha il suo principio, il suo punto culminante, la sua
fine, e che è spazzata via da altri periodi di tranquillità più o meno lunghi!
Disgraziatamente, siamo nati in un secolo di tempeste, ecco tutto. Ma si
placheranno".
"D'accordo," fece lei, che però non lo seguiva su questo terreno astratto
"ma Corbin? Non è una forza della natura, Corbin, no?"
"É una specie nefasta come quella degli scorpioni, dei serpenti, dei funghi
velenosi. In fondo, è un po’ colpa nostra. Abbiamo sempre saputo chi era
Corbin. Perché siamo rimasti lì, da lui? Così come non tocchi un fungo
velenoso, devi guardarti dalle cattive compagnie. Ci sono state diverse
circostanze in cui, con un po’ di coraggio e di tenacia, avremmo potuto
trovare un altro posto. E ricordati che quando eravamo giovani e mi
avevano offerto quel lavoro di insegnante a San Paolo tu non hai voluto
lasciarmi partire"
"Be, è una storia vecchia" disse lei scrollando le spalle.
"No, dicevo solo che...".
"Sì, dicevi che non bisogna prendersela con gli uomini. Ma tu stesso hai
detto che se lo incontrassi, Corbin, gli sputeresti in faccia"
Continuarono a discutere, non tanto perché sperassero o desiderassero
convincersi l'un l'altro, ma perché parlando dimenticavano un po’ le loro
amarezze.
"A chi potremmo rivolgerci?" proruppe alla fine Jeanne.
"Non hai ancora capito che tutti se ne fregano di tutti?"
Lei lo guardò.
"Sei ben strano, Maurice. Li hai pur visti quei campioni di cinismo, di
scetticismo, e però non sei addolorato, addolorato nell'intimo voglio dire!
Mi sbaglio?"
"No"
"Ma allora, cos'è che ti conforta?"
"La certezza della mia libertà interiore," disse lui dopo aver riflettuto
"questo bene prezioso, inalterabile, e che dipende solo da me perdere o
conservare. La convinzione che le passioni spinte al parossismo come capita
ora finiscono poi per placarsi. Che tutto ciò che ha un inizio avrà una fine.
In poche parole, che le catastrofi passano e che bisogna cercare di non
andarsene prima di loro, ecco tutto. Perciò, prima di tutto vivere: Primum
vivere. Giorno per giorno. Resistere, attendere, sperare"
Jeanne lo aveva ascoltato in silenzio. Poi, all'improvviso, si alzò e afferrò
il cappello che aveva lasciato sulla mensola del caminetto.
Maurice la guardò stupito.
"Il mio motto, invece, è: "Aiutati che il Ciel t'aiuta"" disse lei.
"Perciò vado a trovare Furieres. É sempre stato molto gentile con me e ci
aiuterà, se non altro per far dispetto a Corbin"
Non si era sbagliata. Furieres la ricevette e promise a lei e al marito
un'indennità corrispondente a sei mesi dei rispettivi stipendi, il che portò il
loro capitale a circa sessantamila franchi.
"Hai visto? Mi sono data da fare e il cielo mi ha aiutata" disse Jeanne,
rientrando, al marito.
"E io ho sperato!" rispose lui sorridendo. "Avevamo ragione tutti e due!"
Erano molto soddisfatti del risultato di quel tentativo, ma sentivano che
adesso la loro mente, accantonate, almeno per l'immediato, le
preoccupazioni finanziarie, sarebbe stata interamente occupata dall'ansia per
il figlio.
CAPITOLO 29.
In autunno Charles Langelet tornò a casa. Le porcellane non avevano
subito danni durante il viaggio. Schiodò lui stesso le grandi casse, fremendo
di piacere ogni volta che sfiorava, sotto i trucioli e la carta velina, la
superficie levigata di una statuina di Sevres o di un vaso di porcellana
cinese. Non riusciva quasi a credere di essere a casa, di aver ritrovato i suoi
tesori. Di tanto in tanto alzava la testa e guardava, attraverso i vetri delle
finestre che portavano ancora tracce di carta gommata, la dolce curva della
Senna.
A mezzogiorno la portinaia salì a fare le pulizie perché Langelet non
aveva ancora assunto nuovi domestici. Gli eventi gravi, fasti o nefasti che
siano, non cambiano la natura di un uomo ma permettono di definirla
meglio, così come un colpo di vento, spazzando all'improvviso le foglie
morte, rivela la forma di un albero; mettono in luce quello che era rimasto
in ombra; danno allo spirito l'inclinazione che da lì in avanti lo
caratterizzerà. Charlie era sempre stato parsimonioso, attaccato al proprio
denaro. Al ritorno dall'esodo si scoprì avaro; risparmiare, quando era
possibile, diventò per lui un vero e proprio godimento, e ne aveva piena
consapevolezza perché, oltretutto, era diventato anche cinico, prima, non si
sarebbe mai sognato di mettere piede in una casa disorganizzata e piena di
polvere, né di andare al ristorante il giorno stesso del suo rientro. Ma adesso
ne aveva passate così tante che più niente gli faceva paura. Quando la
portinaia gli disse che in nessun modo avrebbe potuto finire le pulizie in
giornata, che il signore non si rendeva conto di tutto il lavoro che c'era,
Charlie rispose con voce dolce ma che non ammetteva repliche:
"Veda di farcela, signora Logre. Lavori un po’ più in fretta, ecco tutto"
"Presto e bene non vanno sempre insieme, signore!"
"Questa volta ci andranno, i tempi facili sono finiti" ribatté Charlie
severamente. "Rientrerò alle sei e spero che tutto sia in ordine" aggiunse.
E dopo un'occhiata maestosa alla portinaia, che tacque allibita masticando
amaro, e un ultimo sguardo innamorato alle porcellane, uscì.
Lungo le scale calcolò quello che avrebbe risparmiato: il pasto della
signora Logre, prima di tutto. Per qualche tempo si sarebbe occupata di lui
due ore al giorno; sbrigato il lavoro più grosso, l'appartamento non avrebbe
avuto bisogno che di un po’ di manutenzione. Nel frattempo lui avrebbe
cercato tranquillamente i domestici, una coppia probabilmente, come
sempre: cameriere e cuoca.
Andò a pranzo sul lungosenna, in un piccolo ristorante che conosceva.
Non mangiò male, tenuto conto delle circostanze. Del resto non era un
gran mangiatore, ma ebbe il piacere di gustare un ottimo vino. Il padrone gli
sussurrò all'orecchio che aveva ancora un po’ di caffè vero.
Charlie si accese un sigaro e trovò che la vita era bella. Cioè, no, non era
bella, non si poteva dimenticare la sconfitta della Francia e tutte le
sofferenze e le umiliazioni che ne derivavano, ma per lui, Charlie, la vita era
bella perché sapeva prendere le cose come venivano, non piagnucolava sul
passato e non aveva paura dell'avvenire.
"Sarà come sarà," pensò "me ne infischio altamente...". Scosse la cenere
del sigaro. Aveva depositato il suo denaro in America, fortunatamente, era
bloccato là; questo gli permetteva di pagare meno tasse o addirittura di non
pagarne affatto. Il franco sarebbe rimasto in ribasso a lungo, così il suo
capitale, quando avrebbe potuto riscuoterlo, si sarebbe automaticamente
decuplicato. Quanto alle spese correnti, aveva provveduto per tempo a
tenere da parte un fondo. Era proibito acquistare o vendere oro, che al
mercato nero aveva già raggiunto quotazioni folli.
Pensò con stupore all'aria che tirava intorno a lui (di vero e proprio
panico) allorché aveva considerato l'opportunità di lasciare la Francia per
andare a vivere in Portogallo o in Sudamerica. Alcuni suoi amici lo avevano
fatto, ma, grazie a Dio, lui non era né ebreo né massone, pensò con un
sorriso sprezzante. Non si era mai occupato di politica e non vedeva perché
non avrebbero dovuto lasciarlo in pace, un tipo così tranquillo, così
inoffensivo, un pover'uomo che non faceva male a una mosca e che amava
solo le sue porcellane. Più seriamente, pensò che proprio lì stava il segreto
della sua felicità pur in mezzo a tanto sconquasso: lui non amava niente,
quanto meno niente di vivo, di ciò che il tempo corrompe e che la morte
rapisce; aveva fatto bene a non sposarsi, a non avere figli... Tutti gli altri ci
erano cascati; solo lui era saggio.
Ma per tornare a quell'assurdo progetto di espatrio, si ricordò che gli era
stato ispirato dal pensiero bizzarro e quasi folle per cui il mondo, nel giro di
pochi giorni, si sarebbe trasformato, sarebbe diventato un inferno, un luogo
di orrori. Ed ecco... che tutto era rimasto uguale!
Ripensò alla Storia Sacra e alla descrizione della terra prima del Diluvio:
com'era? Ah, sì: gli uomini costruivano, si sposavano, mangiavano e
bevevano... Ebbene, il sacro testo era incompleto. Avrebbe dovuto dire: "Le
acque del Diluvio si ritirarono e gli uomini ricominciarono a costruire, a
sposarsi, a mangiare e a bere...". Del resto gli uomini non avevano molta
importanza. Quelle che bisognava preservare erano le opere d'arte, i musei,
le collezioni. La cosa terribile, nella guerra di Spagna, era che in quel paese
avevano lasciato andare in rovina i capolavori; ma in Francia l'essenziale
era stato salvato, con l'eccezione di alcuni castelli sulla Loira. Un fatto
davvero imperdonabile, ma il vino che aveva bevuto era così buono che
Charlie si sentiva incline all'ottimismo. Dopo tutto c'erano delle rovine,
delle bellissime rovine. Come a Chinon, ad esempio, con la mirabile sala
senza soffitto i cui muri, che avevano visto Giovanna d'Arco, ora ospitavano
nidi di uccelli e, in un angolo, un ciliegio selvatico.
Finito di pranzare, volle gironzolare un po’ per le strade, ma le trovò
tristi. Pochissime automobili, un silenzio strano, e grandi bandiere rosse con
la svastica che sventolavano ovunque. Davanti a una latteria alcune donne
facevano la coda; era la prima immagine di guerra che gli si presentava. La
folla aveva un'aria tetra. Charlie si affrettò a infilarsi nel metro, il solo
mezzo di locomozione possibile: voleva andare in un certo bar che
frequentava abitualmente all'una o alle sette di sera. Oasi di eleganza e
signorilità, quei bar! Costosi com'erano, la loro clientela era composta di
uomini ricchi e più che maturi, che la mobilitazione e la guerra avevano
risparmiato. Per un po’ Charlie restò solo, ma intorno alle sei e mezzo
arrivarono tutti, tutti i clienti di sempre, e tutti in ottima forma, sani e salvi,
l'aria fresca e radiosa, accompagnati da belle donne, ben truccate, ben
messe, con deliziosi cappellini. Ci fu un coro di esclamazioni:
"Ma è lui, è proprio Charlie? Allora, tutto bene? Di nuovo a Parigi?"
"Parigi è orrenda, vero?"
E quasi subito, come se si fossero ritrovati dopo la più tranquilla e la più
normale delle estati, diedero il via a quel genere di conversazione brillante e
leggera che sfiorava ogni argomento senza approfondirne alcuno, quel
genere di conversazione che Charlie definiva "sorvoliamo-miacarasorvoliamo" Fra le altre cose, venne a sapere della morte o della
prigionia di alcuni giovani.
"Oh, non è possibile! Ma guarda! Non lo avrei mai immaginato, è
terribile! Poveri ragazzi!" commentò.
Il marito di una delle signore era prigioniero in Germania.
"Ricevo sue notizie abbastanza regolarmente, non sta troppo male, ma la
seccatura, capisce? Spero di poterlo far liberare presto"
E sempre più, via via che chiacchierava e ascoltava, Charlie ritrovava la
serenità e il buon umore poco prima offuscati dal triste spettacolo delle
strade parigine; ma ciò che davvero gli risollevò il morale fu il cappellino di
una donna che era appena entrata. Erano tutte ben vestite, anche se
ostentavano una certa semplicità, come se dicessero: "Mettersi eleganti? Ma
figuriamoci! Prima di tutto non ci sono soldi e poi non è il momento...
Finisco di consumare i vestiti che ho...". Questa, invece, sfoggiava con
spavalderia, con coraggio, con gioia insolente un delizioso cappellino
nuovo, poco più grande di un anello portatovagliolo, due pelli di zibellino e
una veletta rossa che le copriva i capelli d'oro. Dopo aver visto quel
cappello Charlie si sentì del tutto rasserenato. Era tardi e voleva ancora
passare da casa prima di cena; avrebbe dovuto muoversi ma non si decideva
a lasciare gli amici. Qualcuno propose: "Se cenassimo insieme?".
"É un'ottima idea" disse Charlie con entusiasmo.
E suggerì il piccolo ristorante dove aveva pranzato così bene, perché era
d'indole simile a quella dei gatti, che si affezionano presto ai posti dove
sono stati trattati bene.
"Bisogna riprendere il metro! Che strazio, questo metro, ci avvelena la
vita" disse.
"Io sono riuscita ad avere un po’ di benzina e un permesso di
circolazione. Non le offro un passaggio perché ho promesso a Nadine di
aspettarla" disse la donna dal cappellino nuovo.
"Ma come ha fatto? É straordinario sapersi destreggiare così!"
"Già!" disse lei sorridendo.
"Allora d'accordo, appuntamento fra un'ora, un'ora e un quarto"
"Vuole che passi a prenderla?"
"No, grazie. Lei è molto gentile, ma da casa mia sono due passi".
"Faccia attenzione, c'è buio pesto. Su questo sono molto severi".
"Che buio!" pensò infatti Charlie piombando da quell'antro tiepido e
pieno di luce nelle tenebre della strada. Pioveva, era una sera d'autunno
parigino come quelle che tanto gli piacevano un tempo, ma allora
all'orizzonte indugiava un riflesso dorato. Adesso tutto era scuro e sinistro
come la gola di un pozzo.
Per fortuna l'ingresso del metro era vicino. A casa, Charlie vide la signora
Logre che non aveva ancora finito le pulizie e stava spazzando con aria
cupa e meditabonda. Il salotto però era in ordine. Sul tavolo Chippendale
dal piano splendente Charlie volle mettere una statuina di Sevres che
prediligeva fra tutte e che rappresentava una Venere allo specchio. La tirò
fuori dalla cassa, tolse la carta velina che l'avvolgeva, la contemplò
amorosamente e stava portandola verso il tavolo quando qualcuno suonò
alla porta.
"Vada a vedere chi è, signora Logre"
La signora Logre uscì e tornò dicendo:
"Avevo detto in giro che il signore cercava del personale e la portinaia del
6 manda questa signora che avrebbe giusto bisogno di trovar lavoro"
Poiché Charlie esitava, aggiunse:
"É una persona molto a posto, e ha fatto la cameriera in casa della
contessa Barrai du Jeu. Poi si è sposata e non voleva più andare a servizio,
ma il marito è stato fatto prigioniero e lei deve guadagnarsi da vivere. Il
signore può comunque vederla!".
"Va bene, la faccia entrare" disse Langelet posando la statuina su un
tavolino basso.
La donna si presentava bene, con la sua aria tranquilla e modesta: era
visibilmente desiderosa di piacere ma senza essere servile. Si capiva subito
che aveva classe e che aveva lavorato in case altolocate. Era robusta, cosa
che Charlie le rimproverò col pensiero; gli piacevano le cameriere minute e
magre, ma questa sembrava avere dai trentacinque ai quarant'anni, età
perfetta per una domestica, età in cui si è messa la testa a posto e si gode in
pari tempo di sufficiente salute e forza per assicurare un buon servizio.
Aveva una faccia larga, un bel paio di spalle, ed era vestita con semplicità
ma molto correttamente; di certo l'abito, il cappotto e il cappello erano scarti
di una ex padrona.
"Come si chiama?" domandò Charlie, cui la donna aveva fatto un'ottima
impressione.
"Hortense Gaillard, signore"
"Molto bene. Sta cercando un posto?".
"Diciamo, signore, che ho lasciato la contessa Barrai du Jeu due anni fa
per sposarmi. Non pensavo di tornare a servizio, ma mio marito, che era
sotto le armi, è stato fatto prigioniero e, come il signore comprenderà,
adesso devo guadagnarmi da vivere. Per di più, mio fratello è disoccupato
ed è a carico mio, con una moglie ammalata e un bambino piccolo"
"Capisco. Pensavo però di assumere una coppia...".
"Lo so, signore, ma forse potrei andarle bene ugualmente... Dalla signora
contessa sono stata capocameriera, ma in precedenza avevo lavorato in casa
della madre della signora contessa, e lì facevo la cuoca. Potrei occuparmi
della cucina e della casa".
"Sì, mi sembra interessante" mormorò Charlie trovando la combinazione
alquanto vantaggiosa.
Naturalmente c'era il problema del servire a tavola; spesso veniva gente,
ma per quell'inverno non contava di ricevere molto.
"Sa stirare bene la biancheria da uomo? A questo proposito sono molto
esigente, l'avverto"
"Stiravo io le camicie del signor conte"
"E per la cucina? Ceno spesso al ristorante e ho bisogno di una cucina
semplice ma curata"
"Se il signore vuole vedere le mie referenze...".
Le tirò fuori da una borsetta di finto cinghiale e gliele porse. Charlie le
lesse una per una; erano redatte nei termini più entusiasti: gran lavoratrice,
molta classe, onestà assoluta, esperta di cucina e persino di pasticceria.
"Sa fare anche i dolci? Perfetto! Credo proprio, Hortense, che potremo
metterci d'accordo. Per quanto tempo ha servito in casa della contessa
Barrai du Jeu?"
"Cinque anni, signore"
"E la contessa è a Parigi? Come può capire, preferisco avere informazioni
dirette"
"Capisco perfettamente, signore. La signora contessa è a Parigi. Se il
signore vuole il suo numero di telefono, è Auteuil 38 14"
"Grazie. Prenda nota, per favore, signora Logre. E per lo stipendio?
Quanto vuole?"
Hortense chiese seicento franchi. Lui ne offrì quattrocentocinquanta.
Hortense ci pensò su un momento. I suoi occhietti neri, vispi e penetranti,
avevano acutamente messo a nudo la natura di quel signore insolente e ben
nutrito. "Spilorcio e pignolo," concluse fra sé "ma me la caverò" E poi il
lavoro non si trovava a ogni angolo di strada.
Così, disse con decisione:
"A meno di cinquecentocinquanta non posso. Il signore deve capire.
Avevo qualche risparmio e vi ho dato fondo durante quell'orribile viaggio"
"Era andata via da Parigi?"
"Durante l'esodo, sì, signore. Bombardati e tutto il resto, senza contare
che abbiamo rischiato di morire di fame per strada. Il signore non può
sapere com'è stata dura"
"Lo so, invece, lo so" disse Charlie sospirando. "Quel viaggio l'ho fatto
anch'io. Che brutti momenti! Diciamo dunque cinquecentocinquanta.
Accetto perché credo che lei li valga. Sappia comunque che do la
massima importanza all'onestà"
"Oh, signore!" disse Hortense con tono vagamente scandalizzato come se
una simile precisazione avesse qualcosa di offensivo, e Charlie si affrettò a
farle capire, con un sorriso rassicurante, che lo diceva puramente per la
forma, che non metteva in dubbio neanche per un istante la sua rigorosa
onestà e che del resto l'idea stessa che vi venisse meno era per lui così
insopportabile che non poteva neanche sfiorargli la mente.
"Spero che lei sia abile e coscienziosa. Ho una collezione alla quale tengo
molto. Non permetto a nessuno di spolverare i pezzi più rari, ma questa
vetrina, ad esempio, la affiderò a lei"
Hortense, poiché sembrava che lui la invitasse a farlo, gettò uno sguardo
alle casse semiaperte con le preziose mercanzie ancora da sballare:
"Il signore ha delle belle cose. Prima di entrare a servizio dalla madre
della contessa ho lavorato in casa di un americano, il signor Mortimer
Shaw, che collezionava avori"
"Mortimer Shaw? Ma guarda! Lo conosco bene, è un famoso antiquario"
"All'epoca si era ritirato dagli affari, signore"
"E quanto tempo è rimasta da lui?"
"Quattro anni. Sono i soli posti dove ho lavorato".
Charlie si alzò, e accompagnando Hortense alla porta disse con fare
incoraggiante:
"Torni domani per una risposta definitiva. Se le informazioni orali sono
buone quanto le referenze scritte, cosa di cui non dubito affatto, l'assumo.
Potrebbe cominciare presto?".
"Già da lunedì, se il signore è d'accordo"
Uscita Hortense, Charlie si affrettò a cambiarsi collo e polsi della camicia
e a lavarsi le mani. Al bar aveva bevuto parecchio. Si sentiva
straordinariamente leggero e soddisfatto di sé. Non aspettò l'ascensore, che
era un arnese lento e antiquato, ma scese le scale col passo spedito di un
giovanotto. Stava per ritrovare degli amici simpatici, una donna
affascinante, e si rallegrava al pensiero di far loro conoscere il piccolo
ristorante sul lungosenna.
"Chissà se gli è rimasto un po’ di quel bourgogne bianco" pensò. Il grande
portone dai pannelli di legno con sirene e tritoni scolpiti (una meraviglia, un
pezzo artistico sotto il vincolo dei Beni culturali e dei monumenti storici di
Parigi) si aprì e si richiuse alle sue spalle con un gemito sordo. Varcata la
soglia, Charlie fu inghiottito di colpo dalle tenebre opache, ma, allegro e
spensierato com'era quella sera, non ci fece caso e attraversò la strada
diretto verso i lungosenna. Aveva dimenticato di prendere la pila tascabile,
"ma conosco ogni pietra del mio quartiere" disse fra sé. "Basta seguire la
Senna e attraversare il Pont-Marie. Non ci devono essere in giro molte
macchine". E nel momento stesso in cui pronunciava mentalmente queste
parole vide spuntare a due passi da lui un'auto che andava velocissima, con i
fari oscurati come da regolamento che diffondevano una luce lugubre e
incerta. Colto di sorpresa fece un balzo all'indietro, scivolò, sentì che stava
perdendo l'equilibrio, annaspò con le mani cercando un appiglio cui
aggrapparsi e, non trovando che il vuoto, cadde. L'auto fece una sbandata,
una voce di donna gridò angosciata: "Attento!" Troppo tardi.
"Sono perduto, sto per essere schiacciato! Aver superato tanti pericoli per
finire sotto una macchina, è troppo... è troppo stupido... Mi hanno preso in
giro... Qualcuno, da qualche parte, mi sta giocando questo tiro atroce e
volgare...". Come un uccello terrorizzato da uno sparo vola via dal nido e
sparisce, così questo estremo pensiero cosciente attraversò la mente di
Charlie e la abbandonò insieme alla vita. Era stato colpito violentemente
alla testa; il parafango dell'auto gli aveva spaccato la scatola cranica
mandandola in pezzi. Sangue e materia cerebrale sprizzarono con tanta
forza che alcune gocce caddero sulla donna che guidava, una bella donna,
con un cappellino non più grande di un anello portatovagliolo, con due pelli
di zibellino riunite e una veletta rossa svolazzante sui capelli d'oro. Ariette
Corail, che era rientrata da Bordeaux la settimana precedente e che adesso,
sconvolta, guardava il cadavere mormorando:
"Accidenti, che scalogna!"
Da donna previdente qual era, aveva con sé la pila tascabile. Osservò la
faccia, o almeno quello che ne restava, e riconobbe Charlie Langelet:
"Oh, poveraccio! Correvo un po’, è vero, ma non poteva stare attento, il
vecchio scemo? Che faccio adesso?"
Tuttavia si ricordò che assicurazione, patente, permesso di circolazione
erano in ordine, e che conosceva un tipo influente in grado di sistemare la
faccenda. Rasserenata ma ancora col batticuore, si sedette sul predellino
dell'auto, si riposò un attimo, accese una sigaretta, si diede un po’ di cipria
con mani tremanti e andò a cercare aiuto.
La signora Logre aveva finito le pulizie nello studio e nella biblioteca.
Tornò sui suoi passi per staccare l'aspirapolvere che era inserito in una presa
del salotto. Mentre si muoveva il manico dell'aspirapolvere urtò il tavolino
sul quale si trovava la Venere allo specchio. La signora Logre gettò un
grido: la statuina era sul pavimento, la testa della Venere in briciole.
La signora Logre si asciugò la fronte con il grembiule, esitò un istante,
poi, lasciando la statuina dov'era, con passo leggero e silenzioso,
impensabile in una persona così robusta, dopo aver messo a posto
l'aspirapolvere, si precipitò fuori dall'appartamento.
"Mah! Dirò che quando ho aperto la porta la corrente d'aria ha fatto
cadere la statua. É anche colpa sua: perché diavolo l'ha lasciata sull'orlo del
tavolino? E poi, che dica quello che vuole, e che vada all'inferno!" concluse
con rabbia.
CAPITOLO 30.
Se a Jean-Marie avessero detto che un giorno si sarebbe trovato in un
villaggio sperduto, lontano dal suo reggimento, senza denaro,
nell'impossibilità di comunicare con i genitori, senza sapere se fossero a
Parigi sani e salvi oppure, come tanti altri, sepolti nel cratere di una granata
sul ciglio di una strada, e soprattutto se gli avessero detto che, dopo la
sconfitta della Francia, lui avrebbe continuato a vivere e avrebbe perfino
conosciuto momenti felici, be, non ci avrebbe creduto. Eppure era così.
L'entità stessa del disastro, quel che vi era di irreparabile, conteneva un
rimedio, come certi veleni violenti forniscono il loro stesso antidoto, poiché
tutte le disgrazie che lo affliggevano erano irrimediabili. Non poteva
cancellare il fatto che la linea Maginot era stata aggirata o sfondata (non si
sapeva esattamente come fossero andate le cose), che due milioni di soldati
erano stati fatti prigionieri, che la Francia era stata sconfitta. Non poteva
utilizzare la posta, il telegrafo o il telefono, né procurarsi della benzina e
una macchina per arrivare alla stazione che si trovava a ventun chilometri di
distanza e dove, del resto, i treni non passavano più perché le rotaie erano
state bombardate. Non poteva andare a piedi fino a Parigi perché, ferito
gravemente com'era, cominciava solo ora ad alzarsi. E non poteva pagare
chi lo ospitava perché non aveva denaro né alcun mezzo per procurarsene.
Tutto questo era al di sopra delle sue forze; doveva dunque starsene
tranquillo là dov'era e aspettare.
Questa sensazione di dipendenza assoluta nei confronti del mondo esterno
gli procurava una sorta di pace interiore. Non possedeva neppure degli abiti
suoi: l'uniforme stracciata e bruciacchiata qua e là era inutilizzabile.
Indossava una camicia cachi e un paio di pantaloni di scorta di uno dei
ragazzi della fattoria. In paese comprò degli zoccoli.
Era anche riuscito a farsi smobilitare attraversando clandestinamente la
linea di demarcazione e dando un domicilio falso; in questo modo, non
rischiava di esser fatto prigioniero. Viveva sempre alla fattoria, ma da
quando era guarito non dormiva più nel catafalco in cucina; gli avevano
riservato una cameretta sopra il fienile. Da una finestrella rotonda vedeva
uno stupendo, idilliaco paesaggio di campi, terre fertili, boschi. La notte
sentiva correre i topi sopra la sua testa e tubare i colombi nella piccionaia.
Un'esistenza basata su angosce mortali è sopportabile solo a condizione di
vivere alla giornata e dirsi, quando scende la sera: "Altre ventiquattr'ore in
cui non è successo niente di particolarmente brutto, grazie a Dio!
Aspettiamo domani" Tutti coloro che stavano intorno a Jean-Marie la
pensavano così o quanto meno agivano come se pensassero così. Si
occupavano delle bestie, del fieno, del burro, e non parlavano mai
dell'indomani. Guardavano agli anni futuri, piantavano alberi che avrebbero
dato i loro frutti a distanza di cinque o sei stagioni; ingrassavano il maiale
che avrebbero mangiato di lì a due anni, ma non si soffermavano
sull'immediato futuro. Quando Jean-Marie domandava se il giorno dopo ci
sarebbe stato bel tempo (la classica frase banale del parigino in vacanza), "E
chi lo sa? Come si fa a saperlo?" dicevano. "Ci saranno dei frutti?" "Forse
qualcuno sì," rispondevano guardando con diffidenza le piccole pere dure e
verdi che crescevano sui rami tagliati a spalliera "ma non si può ancora
dire... Chissà... Vedremo quando sarà il momento...". Un'esperienza
ancestrale delle insidie della sorte - le gelate d'aprile, la grandine che
devasta i campi pronti per la mietitura, la siccità di luglio che brucia l'orto ispirava loro quella saggezza e quella flemma anche se tutti, comunque,
facevano tutti i giorni quello che andava fatto. Non erano simpatici ma
degni di stima, pensava Jean-Marie, che conosceva poco la campagna: i
Michaud erano cittadini da cinque generazioni. In quella frazione le persone
erano ospitali, affabili, gli uomini buoni parlatori, le ragazze graziose.
Quando si prendeva dimestichezza con loro si scoprivano elementi di
asprezza, di durezza, di cattiveria perfino, che lasciavano allibiti e che
potevano forse essere spiegati con oscure reminiscenze ataviche, con
rancori e terrori secolari trasmessi con il sangue da una generazione all'altra.
E allo stesso tempo erano persone generose. La fatto ressa non avrebbe mai
dato un uovo alla vicina e, se vendeva un pollo, non faceva grazia di un
soldo; ma quando Jean-Marie aveva annunciato di voler lasciare la fattoria
dicendo che non aveva denaro, che non intendeva essere a carico loro e che
avrebbe cercato di raggiungere Parigi a piedi, tutta la famiglia lo aveva
ascoltato in un silenzio costernato e la madre aveva detto, con inaspettata
dignità:
"Non deve parlare così, signore, ci offende...".
"Ma che fare allora?" disse Jean-Marie, che si sentiva ancora molto
debole e le stava seduto vicino, immobile, con la testa fra le mani.
"Niente. Non c'è niente da fare. Bisogna aspettare".
"Sì, certo, la posta tra poco funzionerà," mormorò il giovane "e se i miei
genitori sono a Parigi...".
"Vedremo allora il da farsi" disse la fattoressa.
In nessun altro luogo sarebbe stato altrettanto facile dimenticare il mondo.
Senza posta né giornali, l'unico legame con il resto dell'universo era la
radio, ma ai contadini avevano detto che i tedeschi avrebbero sequestrato gli
apparecchi, e loro li avevano nascosti nei fienili, nei vecchi armadi, o
sotterrati in campagna insieme ai fucili da caccia che non erano stati
consegnati al momento della requisizione.
Il villaggio si trovava nella zona occupata, vicino alla linea di
demarcazione, ma le truppe tedesche si limitavano ad attraversarlo senza
prendervi quartiere; comunque i soldati passavano solo per il paese e non
facevano mai i due chilometri di salita, sassosi e quasi impraticabili, che
portavano alla fattoria. Nelle città e in alcune circoscrizioni il cibo
cominciava a scarseggiare; lì in campagna ce n'era in abbondanza perché i
prodotti, non potendo essere trasportati, venivano consumati sul posto. JeanMarie non aveva mai mangiato in vita sua tanto burro, tanta panna, tanti
polli e tante pesche. Si stava riprendendo in fretta, cominciava perfino a
ingrassare, diceva la fatto ressa che, nella sua bontà verso Jean-Marie,
covava l'oscuro desiderio di mettersi d'accordo con il buon Dio, offrendogli
la salvezza di una vita in cambio di quella che Lui teneva nelle sue mani;
come dava chicchi di grano alle galline in cambio di uova, così cercava di
barattare Jean-Marie con il proprio figlio. Jean-Marie lo capiva benissimo,
ma questo non modificava per niente la sua gratitudine nei confronti
dell'anziana donna che lo aveva curato. Cercava di rendersi utile, faceva
piccoli lavori nella fattoria, curava il giardino.
Le donne qualche volta lo interrogavano sulla guerra, quella in corso, gli
uomini mai. Erano tutti ex combattenti, di giovani non se ne vedevano, li
avevano mandati tutti al fronte. I loro ricordi si fermavano al '14. Il passato
aveva avuto il tempo di essere filtrato, decantato, ripulito dalla sua feccia,
dal suo veleno, reso assimilabile agli animi, mentre gli avvenimenti recenti
restavano oscuri e nefasti.
Del resto, nel fondo del cuore, essi credevano che la colpa di tutto quello
che stava accadendo fosse dei giovani, che erano meno sani di loro, meno
pazienti e a scuola erano stati viziati. E poiché Jean-Marie era giovane, per
delicatezza evitavano di essere indotti a giudicarlo, lui e i suoi coetanei.
Così tutto concorreva a impigrire e a cullare il soldato per fargli ritrovare
forza e coraggio. Restava quasi sempre solo; era l'epoca dei grandi lavori
nei campi. Gli uomini uscivano di casa sul far del giorno.
Le donne si occupavano delle bestie o stavano al lavatoio. Jean-Marie si
era offerto di aiutare ma lo avevano mandato a quel paese. "É già tanto se si
regge in piedi, e parla di lavorare!" Allora usciva dalla stanza, attraversava
il cortile dove schiamazzavano i tacchini e scendeva fino a un piccolo prato
chiuso da uno steccato. Lì alcuni cavalli brucavano l'erba. C'era una
giumenta dal mantello bruno dorato con i suoi due puledrini color caffellatte
dalle corte e ruvide criniere nere. I cavallini andavano a strofinare il muso
sulle gambe della madre che continuava a brucare agitando con impazienza
la coda per scacciare le mosche. A volte uno dei puledri girava la testa verso
JeanMarie sdraiato vicino allo steccato, lo guardava con il suo occhio umido
e nero e nitriva giulivo. Jean-Marie non si stancava di contemplarli.
Avrebbe voluto scrivere la storia immaginaria di quei deliziosi puledrini,
raccontare quel giorno di luglio, quel villaggio, quella fattoria, quella gente,
la guerra, se stesso. Scriveva con un mozzicone di matita mezzo consumato
su un quadernetto da scolaro che nascondeva poi sul cuore. Scriveva in
fretta, qualcosa lo rendeva inquieto, bussava a una porta invisibile;
scrivendo, apriva quella porta, dava libero corso a ciò che desiderava essere
portato alla luce. Poi, di colpo, si scoraggiava, si sentiva stanco, nauseato.
Che pazzia buttar giù quelle stupide storielle, lasciarsi coccolare dalla
fattoressa mentre i suoi compagni erano in prigione, i suoi genitori disperati
lo credevano morto, l'avvenire era così incerto, il passato così funesto. Ma,
mentre si abbandonava a quei pensieri, ecco uno dei puledri correre
gioiosamente avanti, poi fermarsi, rotolarsi nell'erba, agitare in aria gli
zoccoli, strofinarsi contro il terreno e guardarlo con i suoi occhi brillanti di
tenerezza e di malizia. Lui tentava di descrivere quello sguardo, tentava con
curiosità, con impazienza, con un'ansia bizzarra e dolce. Non ci riusciva, ma
capiva quello che doveva provare il piccolo puledro - quanto era buona
l'erba, così fresca e croccante! Quanto erano insopportabili le mosche! E che
aria aveva quando alzava le froge e correva e scalciava libero e fiero.
Scriveva in fretta poche righe incomplete, goffe: ma non significavano
niente, non era quello l'essenziale, pazienza, ci sarebbe arrivato. Allora
chiudeva il quaderno e rimaneva immobile, con le mani aperte e gli occhi
chiusi, stanco e felice.
Una mattina, rientrando all'ora della zuppa, capì subito che durante la sua
assenza era successo qualcosa. Il garzone era andato in paese a prendere il
pane e aveva portato quattro belle pagnotte dorate a forma di corona infilate
nel manubrio della bicicletta; le donne gli si erano fatte intorno. Scorgendo
Jean-Marie, una delle ragazze gli gridò:
"Ehi, signor Michaud, sarà contento, la posta funziona"
"Davvero?" fece Jean-Marie. "Sei sicuro, ragazzo?".
"Sicurissimo. Ho visto la posta aperta e gente che leggeva delle lettere"
"Allora salgo a scrivere due righe per i miei genitori e corro in paese.
Mi presti la bicicletta, vero?"
In paese non solo imbucò la lettera ma comprò i giornali che erano
appena arrivati. Com'era strano tutto questo! Si sentiva simile a un naufrago
che ha ritrovato il paese natale, la civiltà, la società dei suoi simili. In piazza
la gente leggeva le lettere arrivate con la posta della sera; alcune donne
piangevano. Molti prigionieri davano notizie, ma comunicavano anche i
nomi dei compagni uccisi. Come gli avevano chiesto alla fattoria, JeanMarie domandò se qualcuno sapeva dove si trovasse Benoît, il figlio della
fattoressa.
"Ah, lei è il soldato che abita lì?" dissero le contadine. "No, non lo
sappiamo dove sta Benoît, ma adesso che le lettere arrivano, dove stanno i
nostri uomini lo sapremo presto!"
E una di quelle donne, una vecchia che per scendere in paese si era messa
un cappellino nero a punta con una rosa in cima, disse piangendo:
"Qualcuna lo saprà anche troppo presto. Preferirei non averla ricevuta
questa maledetta lettera. Mio figlio era marinaio sul Bretagne, dicono che è
disperso da quando gli inglesi hanno silurato la nave. Povera me, che
disgrazia!"
"Non deve disperarsi. Disperso non vuol dire morto. Magari è prigioniero
in Inghilterra!"
Ma a quelle parole di conforto la vecchia rispondeva solo scrollando la
testa, e a ogni movimento il fiore artificiale tremava sul suo stelo di fil di
ferro.
"No, no, è spacciato, il mio povero ragazzo! Che disgrazia...".
Jean-Marie si apprestò a far ritorno alla fattoria e lungo la strada si
imbatté in Cecile e in Madeleine che gli erano venute incontro e che
domandarono, parlando tutte e due insieme:
"Sa niente di mio fratello? Sa niente di Benoît?"
"No, ma non vuol dire. Vi rendete conto di quanta posta arretrata c'è da
smaltire?"
La madre, invece, non domandò nulla. Tenendo la mano gialla e ossuta
davanti agli occhi a mo’ di schermo, lo guardò; lui fece segno di no con la
testa. La minestra era in tavola, gli uomini stavano entrando, tutti
mangiarono. Dopo cena, e quando i piatti furono lavati e asciugati e la
stanza spazzata, Madeleine andò in giardino a raccogliere piselli.
Jean-Marie la seguì. Pensava che di lì a poco avrebbe abbandonato la
fattoria, e ogni cosa assumeva ai suoi occhi maggior bellezza e pace.
Da qualche giorno il caldo era torrido, e solo verso sera si respirava un
po’. A quell'ora il giardino era una delizia; il sole aveva bruciato le
margherite e i garofani bianchi che delimitavano l'orto, ma i rosai vicino al
pozzo erano un tripudio di fiori dischiusi, e un profumo di zucchero,
muschio e miele saliva da un'aiuola di roselline rosse accanto agli alveari.
La luna piena aveva il colore dell'ambra e il suo splendore era tale che il
cielo sembrava illuminato fino alle più inesplorate profondità da un chiarore
uniforme, sereno, di un verde tenero e trasparente.
"Che bella estate abbiamo avuto" disse Madeleine.
Aveva preso un cesto e si dirigeva verso i sostegni dei piselli rampicanti.
"Otto giorni di cattivo tempo all'inizio del mese e dopo neanche una
pioggerella, neanche una nuvola, tanto che se va avanti così possiamo dire
addio alle verdure... E il lavoro è faticoso con questo caldo; ma fa lo stesso,
è piacevole, come se il cielo volesse consolare questo povero mondo. Senta,
se vuole aiutarmi, non faccia complimenti" aggiunse.
"Che sta facendo la Cecile?"
"Cuce, la Cecile. Si fa un bel vestito da mettere domenica alla messa".
Le sue dita abili e forti si infilavano tra le foglie verdi e fresche dei piselli,
spezzavano in due il gambo, gettavano i baccelli nel cesto.
Lavorava tenendo il volto chino.
"Allora sta per lasciarci...".
"Devo farlo. Sarò felice di rivedere i miei genitori e bisogna che cerchi un
lavoro, ma...".
Tacquero tutti e due.
"Certo, non poteva restar qui tutta la vita" disse lei abbassando ancor più
la testa. "Si sa la vita com'è, ci si incontra, ci si lascia...".
"Ci si lascia" ripeté lui sottovoce.
"Insomma, adesso si è rimesso in forze, ha preso un bel colorito...".
"Grazie a lei che mi ha curato così bene"
Le dita si fermarono nel mezzo di una foglia.
"Le è piaciuto stare da noi?"
"Lo sa bene"
"Allora non dovrà lasciarci senza notizie, dovrà scriverci" disse la
ragazza, e lui vide, vicinissimi, i suoi occhi pieni di lacrime. Ma subito
Madeleine si voltò dall'altra parte.
"Certo che scriverò, lo prometto" fece Jean-Marie e, timidamente, le
toccò la mano.
"Oh, si dice sempre così... Noi qui, quando sarà partito, avremo tutto il
tempo per pensare a lei... Adesso è ancora la stagione del lavoro, siamo
occupati dalla mattina alla sera... Ma viene l'autunno, poi l'inverno, e c'è
solo da governare le bestie, il resto del tempo si sta a casa a guardar cadere
la pioggia, e dopo la neve. Qualche volta penso di andare a servizio in
città...".
"No, Madeleine, non lo faccia, me lo prometta. Qui sarà più felice".
"Crede?" mormorò lei con una voce bassa e strana.
E, afferrato il cesto, si allontanò da lui; il fogliame la nascose al suo
sguardo. Jean-Marie continuava a raccogliere meccanicamente i piselli.
"Pensa che potrò dimenticarmi di lei?" disse infine. "Crede che abbia dei
ricordi così belli da potermi permettere di trascurare questo? Pensi un po’!
La guerra, l'orrore, la guerra...".
"Ma prima? Non c'è stata sempre la guerra, no? Prima c'è stato...".
"Cosa?"
Lei non rispose.
"Intende dire donne, ragazze?"
"Be, direi!"
"Niente di molto interessante, mia piccola Madeleine"
"Ma lei se ne va" ribatté quella e, senza più riuscire a trattenere le lacrime,
le lasciò scorrere lungo le guance rotonde mentre con voce rotta diceva: "A
me, mi dispiace lasciarla. Non dovrei dirglielo, si burlerà di me, e Cecile
ancora di più... Ma non m'importa... Mi dispiace...".
"Madeleine...".
Lei alzò la testa, i loro sguardi si incontrarono. Lui le si avvicinò e la
prese dolcemente per la vita; quando volle baciarla, la ragazza lo respinse
con un sospiro.
"No, non è questo che voglio... É troppo facile...".
"Che cos'è che vuole, Madeleine? Che le prometta di non dimenticarla
mai? Libera di non credermi, ma è la verità, non la dimenticherò" disse lui,
e le prese la mano, la baciò; lei arrossì di piacere.
"É vero, Madeleine, che vuol farsi suora?"
"É vero, lo volevo prima, ma adesso... Non è che non amo più il buon
Dio, ma credo di non essere fatta per quella vita!"
"Certo che no! Lei è fatta per amare ed essere felice" Felice? Non so, ma
credo che sono fatta per avere un rito e dei figli, e se Benoît non è stato
ucciso, allora..." "Benoît? Non sapevo...".
"Sì ci eravamo parlati... Io non volevo. Avevo quell'idea ,. farmi suora.
Ma se torna... E un bravo ragazzo...".
"Non sapevo" ripeté lui.
Com'erano abbottonati quei contadini! Prudenti, diffidenti, chiusi a
doppia mandata... come i loro grandi armadi Era vissuto più di due mesi in
mezzo a loro e mai aveva sospettato che ci fosse qualcosa fra Madeleine e il
figlio dei fattori, anzi, ora che ci pensava, a quel Benoît avevano sempre
accennato solo di sfuggita... Non parlavano mai di niente. E nemmeno
stavano lì a pensarci.
Dalla soglia di casa la fattoressa chiamò Madeleine, e i due ragazzi
rientrarono.
Passarono alcuni giorni. Di Benoît nessuna notizia, JeanMarie invece
ricevette una lettera e del denaro dai suoi. Non gli era più capitato di
trovarsi a tu per tu con Madeleine: capiva che li tenevano d'occhio. Si
congedò da tutta la famiglia riunita sulla porta di casa. Era una mattina di
pioggia, la prima dopo tante settimane; un'aria fredda soffiava dalle colline.
Quando si fu allontanato la fattoressa rientrò in casa ma le due ragazze
restarono lì a lungo, ascoltando il rumore del carretto sulla strada.
"Be, non è un gran male!" esclamò con foga Cecile, come se si fosse
tenuta dentro a fatica un fiume di parole rabbiose. "Finalmente la signorina
si darà un po’ da fare... In questi ultimi tempi vivevi nel mondo della luna,
tutto il lavoro lo lasciavi fare a me...".
"Non sei certo tu che mi puoi rimproverare, tu che non facevi altro che
cucire e guardarti allo specchio... Sono stata io a mungere le vacche ieri, e
non spettava a me" replicò Madeleine irosamente.
"E io che c'entro? Te l'ha ordinato mia madre"
"Se l'ha fatto, so io chi è andata a metterle la pulce nell'orecchio"
"Pensa quello che vuoi!"
"Ipocrita!"
"Scostumata! E vuole anche farsi suora!"
"E perché tu, non gli giravi intorno anche tu? Ma lui se ne fregava alla
grande!"
"E di te, allora? Se n'è andato e non lo rivedrai più"
Si guardarono un attimo con occhi scintillanti di rabbia, e
improvvisamente un'espressione dolce e stupita passò sul volto di
Madeleine.
"Oh, Cecile! Eravamo come sorelle... Non avevamo mai litigato prima...
Su, non ne vale la pena! Non è né per me né per te, il ragazzo!"
Gettò le braccia al collo di Cecile che piangeva.
"Passerà, vedrai, passerà... Asciugati gli occhi. Tua madre vedrà che hai
pianto"
"Mia madre... Sa tutto ma non dice niente".
Si separarono; l'una si diresse alla stalla, l'altra alla casa. Era lunedì,
giorno di bucato, ed ebbero appena il tempo di scambiarsi qualche parola,
ma i loro sguardi, i sorrisi, dicevano che si erano rappacificate. Il vento
ricacciava verso la rimessa il fumo che si levava dalla bollitura del bucato.
Era uno di quei giorni burrascosi e cupi in cui nel pieno di agosto si
avvertono i primi soffi dell'autunno.
Occupata a insaponare, strizzare, sciacquare la biancheria, Madeleine non
aveva il modo di pensare e così metteva a tacere il suo dolore.
Quando alzava gli occhi vedeva il cielo grigio, gli alberi squassati dalla
tempesta.
"L'estate è proprio finita..." disse a un certo punto.
"Estate schifosa. Era ora" rispose la madre in tono astioso.
Madeleine la guardò allibita, ma subito dopo si ricordò della guerra,
dell'esodo, dell'assenza di Benoît, del dolore del mondo, di quella guerra
che continuava lontano, di tutti quei morti. E si rimise a lavorare in silenzio.
Quella stessa sera aveva appena rinchiuso le galline e stava attraversando
di corsa il cortile sotto la pioggia quando vide un uomo che si avvicinava a
grandi passi lungo il sentiero. Il cuore prese a batterle all'impazzata: pensò
che Jean-Marie fosse tornato. Una gioia selvaggia la assalì; corse verso
l'uomo e, giunta a due passi da lui, gettò un grido.
"Benoît?"
"Sì, sono io" fece lui.
"Ma come? Oh, che felicità per tua madre... L'hai fatta franca, allora?
Avevamo tanta paura di sapere che eri prigioniero"
Lui rise silenziosamente. Era un ragazzo ben piantato, dal viso largo e
abbronzato, l'occhio franco e chiaro.
"Lo sono stato, ma non per molto!"
"Sei scappato?"
"Sì"
"Come?"
"Be, con dei compagni"
E, rivedendolo, lei ritrovò di colpo la sua timidezza di contadina, quella
facoltà di soffrire e di amare in silenzio che Jean-Marie le aveva fatto
perdere. Non gli fece domande, gli camminò al fianco senza dire niente.
"E qui, tutto bene?" domandò lui.
"Tutto bene"
"Niente di nuovo?"
"No, niente" disse lei.
E superato il primo dei tre gradini della cucina entrò in casa e chiamò:
"Madre, presto! É tornato Benoît!"
CAPITOLO 31.
L'inverno precedente - il primo inverno di guerra - era stato lungo e duro.
Ma che dire di quello del 1940-1941? Freddo e neve cominciarono già alla
fine di novembre. Nevicava sulle case bombardate, sui ponti che venivano
ricostruiti, sulle strade di Parigi dove non passavano più né automobili né
autobus, dove camminavano donne impellicciate con cappucci di lana in
testa e dove altre donne, in coda davanti ai negozi, battevano i denti. La
neve cadeva sui binari della ferrovia, sui fili del telegrafo piegati e a volte
spezzati sotto il suo peso, sulle uniformi verdi dei soldati tedeschi di
sentinella davanti alle caserme, sulle bandiere rosse con la svastica che
sventolavano in cima ai monumenti. Negli appartamenti gelidi la neve
proiettava una luce livida e lugubre che accresceva la sensazione di freddo e
di disagio. I vecchi e i bambini delle famiglie povere rimanevano a letto per
settimane: solo in quel modo stavano un po’ al caldo.
La terrazza dei Corte, quell'inverno, era coperta da uno spesso strato di
neve in cui si metteva in fresco lo champagne. Corte scriveva vicino a un
fuoco di legna che non riusciva a sostituire il calore ormai inesistente dei
termosifoni. Aveva il naso bluastro e quasi piangeva per il freddo. Con una
mano stringeva al petto una borsa d'acqua calda, con l'altra scriveva.
A Natale il freddo si fece ancora più pungente; solo nei corridoi del metro
ci si sottraeva un po’ alla sua morsa. E la neve continuava a cadere
inesorabilmente, lenta e tenace, sugli alberi di boulevard Delessert dove i
Pericand erano tornati ad abitare - perché appartenevano a quell'alta
borghesia francese che preferisce vedere i propri figli privati di pane, di
carne e di aria piuttosto che di diplomi, e non bisognava a nessun costo
interrompere gli studi di Hubert, già tanto compromessi dagli eventi
dell'estate precedente, né quelli di Bernard, che era prossimo agli otto anni e
si era dimenticato di tutto quello che aveva imparato prima dell'esodo,
sicché la madre gli faceva recitare: "La Terra è una sfera che non poggia su
niente" manco avesse sette anni invece che otto (che disastro!)
Fiocchi di neve si impigliavano nei veli da lutto della signora Pericand
quando, superata fieramente la coda dei clienti davanti a un negozio, si
fermava sulla porta sventolando come un vessillo la tessera rilasciata alle
madri di famiglia numerosa che le dava diritto di precedenza.
Sotto la neve, Jeanne e Maurice Michaud aspettavano invece il loro turno,
appoggiandosi l'uno all'altro come cavalli stanchi prima di rimettersi in
cammino.
La neve ricopriva la tomba di Charlie Langelet al Pere Lachaise e il
cimitero delle automobili vicino al ponte di Gien - tutte le auto bombardate,
incendiate, abbandonate nel mese di giugno e che giacevano ai due lati della
strada, inclinate su una ruota o sul fianco, con le portiere spalancate o
ridotte a un ammasso contorto di rottami. La campagna era bianca,
immensa, muta; poi, per qualche giorno, la neve si scioglieva e i contadini
tiravano un sospiro di sollievo. "Fa bene al cuore vedere la terra" dicevano.
Ma all'indomani nevicava di nuovo, nel cielo gracchiavano i corvi. "Ce ne
sono tanti quest'anno" mormoravano i giovani pensando ai campi di
battaglia, alle città bombardate, ma i vecchi rispondevano: "Non più del
solito!" In campagna niente cambiava, si aspettava. Si aspettava la fine della
guerra, la fine dell'assedio, il ritorno dei prigionieri, la fine dell'inverno.
"Non ci sarà primavera quest'anno" sospiravano le donne vedendo passare
febbraio e i primi giorni di marzo senza che il clima si facesse più mite. La
neve era sparita ma la terra era grigia, dura, sonora come il ferro. Le patate
gelavano, le bestie non avevano più foraggio, avrebbero già dovuto
pascolare fuori, ma non era ancora spuntato un filo d'erba.
Alla fattoria dei Labarie i vecchi si tappavano in casa, dietro le grandi
porte di legno che la notte venivano sprangate. La famiglia si riuniva
intorno alla stufa e le donne lavoravano a maglia per i prigionieri senza
scambiarsi una parola. Madeleine e Cecile tagliavano lenzuola vecchie per
ricavarne camiciole e fasce: Madeleine aveva sposato Benoît in settembre e
aspettava un bambino. Quando un colpo di vento più forte degli altri
scuoteva la porta le vecchie dicevano:
"Gesù, Giuseppe e Maria, aiutateci voi!"
Nella fattoria vicina piangeva un bambinello nato poco prima di Natale e
il cui padre era prigioniero. La madre aveva altri tre figli. Era una contadina
lunga e magra, pudica, silenziosa, riservata, che non si lamentava mai.
Quando qualcuno le diceva: "Come farete a cavarvela, Louise, senza un
uomo in casa, con tutto questo lavoro, nessuno per aiutarla e quattro
bambini?", lei sorrideva debolmente mentre gli occhi restavano freddi e
tristi e rispondeva: "E che posso fare?" La sera, appena i piccoli si
addormentavano, la si vedeva comparire dai Labarie.
Si sedeva con il suo lavoro a maglia vicinissimo alla porta in modo da
sentire nel silenzio della notte le voci dei bambini, caso mai la chiamassero.
Quando nessuno la guardava, alzava furtivamente gli occhi e osservava
Madeleine con il suo giovane marito, senza invidia, senza malanimo, con
muta tristezza, poi si affrettava ad abbassare lo sguardo sul lavoro e un
quarto d'ora dopo si alzava, prendeva gli zoccoli e diceva sottovoce: "Ecco,
adesso devo andare. Buonanotte a tutti", e tornava a casa sua. Era una notte
di marzo e lei non riusciva a prender sonno. Quasi tutte le sue notti le
passava così, a cercare il sonno in quel letto freddo e vuoto. Aveva pensato
di mettere a dormire con sé il maggiore dei figli, ma era stata trattenuta da
una sorta di timore superstizioso: il posto doveva restare libero per l'assente.
Quella notte soffiava un vento rabbioso, una tempesta che dai monti del
Morvan investiva il paese. "Ancora neve, domani" avevano detto i
contadini. Nella grande casa silenziosa, che scricchiolava tutta come una
nave alla deriva, la donna per la prima volta si lasciava andare, si
abbandonava al pianto. Non lo aveva fatto quando il marito era stato
richiamato nel '39, né quando se ne andava dopo qualche breve licenza, né
quando aveva saputo che era stato fatto prigioniero, e neppure quando aveva
partorito senza di lui.
Ma adesso era allo stremo: tutto quel lavoro... il piccolino così esuberante
che la sfiniva con la sua voracità e le sue grida... la vacca che quasi non
dava più latte per via del freddo... le galline che non facevano più uova
perché non avevano mangime a sufficienza, e il ghiaccio da spaccare al
lavatoio... Era troppo... Non ne poteva più...
Era stremata, malata... Non voleva neanche più vivere... a che scopo
vivere? Non avrebbe più rivisto suo marito, sentivano troppo la mancanza
l'uno dell'altro, lui sarebbe morto in Germania. Che freddo in quel grande
letto: prese lo scaldino di ceramica che aveva infilato fra le lenzuola due ore
prima quando ancora scottava e che adesso non conservava più un briciolo
di calore, lo posò adagio sulle piastrelle del pavimento e, nel ritrarre la
mano, toccò per un istante le mattonelle gelate ed ebbe ancora più freddo,
fin nel profondo del cuore.
Era scossa dai singhiozzi. Che cosa si poteva dire per consolarla? "Non
sei la sola...". Sì, lo sapeva, ma altre erano più fortunate...
Madeleine Labarie, per esempio... Non le augurava del male, no... Ma era
troppo! C'era troppo dolore nel mondo. Il suo corpo magro era intirizzito.
Aveva un bel rannicchiarsi sotto la coperta, sotto il piumino, ma era come
se il freddo la penetrasse fin nelle ossa.
"Passerà," le dicevano "lui tornerà e la guerra finirà!" No! No! Non lo
credeva più, sarebbe durata e durata... E la primavera che non voleva
arrivare... Si era mai visto un tempo simile in marzo? Il mese volgeva alla
fine e la terra era gelata, ghiacciata sin nel profondo, come lei.
Che raffiche! Che furia! La tempesta avrebbe fatto sicuramente volar via
delle tegole. Si mise a sedere nel letto, rimase in ascolto per un attimo e
all'improvviso, sul volto afflitto e bagnato di lacrime, passò un'espressione
più dolce, incredula. Il vento si era placato; nato chissà come, se n'era
andato chissà dove. Nella sua furia cieca aveva spezzato rami, squassato
tetti; aveva disperso le ultime tracce di neve sulla collina, e adesso da un
cielo scuro e burrascoso cadeva la prima pioggia di primavera, fredda
ancora ma impetuosa, fitta, e si apriva un varco sino alle radici nascoste
degli alberi, sino al nero e profondo cuore della terra.
DOLCE
CAPITOLO 1.
In casa Angellier ci si affrettava a mettere sotto chiave i documenti,
l'argenteria e i libri: i tedeschi stavano entrando a Bussy. Il villaggio veniva
occupato per la terza volta dopo la disfatta. Era la domenica di Pasqua,
all'ora della messa solenne. Cadeva una pioggia fredda. Sul sagrato della
chiesa un piccolo pesco rosa, tutto fiorito, agitava tristemente i suoi rami. I
tedeschi, in tenuta da combattimento, con elmetti di ferro, marciavano in
file di otto. I volti avevano l'espressione impersonale e impenetrabile del
soldato in armi, ma gli occhi osservavano furtivi, con curiosità, le facciate
grigie del villaggio in cui si sarebbero insediati. Nessuno alle finestre.
Davanti alla chiesa udirono il suono dell'armonium e un brusio di preghiere,
ma un fedele terrorizzato corse a chiudere la porta. Non ci fu più che il
rimbombo degli stivali tedeschi. Passato il primo squadrone, si fece avanti
un ufficiale a cavallo. La bella bestia dal mantello pomellato, costretta a
un'andatura così lenta, sembrava furente; posava gli zoccoli sul suolo con
precauzione rabbiosa, fremeva, nitriva e scuoteva la nobile testa. Dietro,
martellando il selciato, avanzavano grandi carri armati grigi. Poi i cannoni,
sopra le loro piattaforme girevoli, su ciascuna delle quali stava allungato un
soldato con lo sguardo all'altezza dell'affusto. Erano così numerosi che una
sorta di tuono ininterrotto continuò a rimbombare sotto le volte della chiesa
per tutta la durata del sermone del curato. Le donne sospiravano nell'ombra.
Quando quel rimbombo ferrigno si allontanò apparvero i motociclisti, che
fiancheggiavano l'auto del comandante. Dietro, a debita distanza, camion
stracarichi di grosse pagnotte di pane nero fecero vibrare le vetrate.
La mascotte del reggimento - un cane lupo magro, silenzioso, addestrato
alla guerra - scortava i militari a cavallo che chiudevano il corteo.
Questi ultimi, o perché all'interno del reggimento formavano un gruppo
privilegiato, o perché si trovavano molto lontano dal comandante che non
poteva vederli, oppure per una qualche altra ragione che sfuggiva ai
francesi, si comportavano in modo più sciolto, più cordiale degli altri.
Parlavano fra loro, ridevano. Il tenente che li guidava guardò con un
sorriso l'umile pesco rosa che tremava sotto le raffiche rabbiose del vento e
ne staccò un ramo. Intorno a lui vedeva solo finestre sprangate.
Credeva di essere solo, ma dietro ogni imposta chiusa l'occhio di una
donna anziana, penetrante come un dardo, spiava il soldato vincitore.
Dal fondo di camere invisibili si levavano voci lamentose: "Cosa ci tocca
vedere...".
"Poveri noi, distruggono anche i nostri alberi da frutto!"
Una bocca sdentata sussurrò:
"Dicono che questi sono i più cattivi. Dicono che hanno fatto l'ira di Dio
prima di arrivare qui. Oh, poveri noi!".
"Si prenderanno le nostre lenzuola," diceva un'altra donna "le lenzuola
ereditate da mia madre, pensate! Vogliono il meglio, loro!"
Il tenente lanciò un ordine. Gli uomini sembravano tutti molto giovani,
avevano la carnagione rosea e i capelli d'oro, montavano splendidi cavalli,
grassi, ben nutriti, dalle larghe groppe lucenti. Li legarono sulla piazza,
intorno al monumento ai Caduti. Alt! "Rompete le righe!" i soldati si
sparsero per il paese con un gran fragore di stivali, di voci straniere, di
speroni tintinnanti e di armi. Nelle case borghesi le donne nascondevano la
biancheria più fine.
Le signore Angellier - la madre e la moglie di Gaston Angellier,
prigioniero in Germania - stavano finendo di mettere al riparo i loro beni.
La vecchia signora Angellier, una donna magra, pallida, fragile e severa,
chiudeva personalmente nella biblioteca ogni volume, dopo averne letto a
mezza voce il titolo e accarezzata devotamente la rilegatura con il palmo
della mano.
"I libri di mio figlio" mormorava "tra le grinfie di un tedesco!- Mai!
Preferirei bruciarli"
"E se vogliono la chiave della biblioteca?" domandò con voce lamentosa
la grossa cuoca.
"La dovranno chiedere a me!" rispose la signora Angellier e,
raddrizzandosi, batté leggermente la mano sulla tasca cucita all'interno della
gonna di lana nera facendo tintinnare il mazzo di chiavi che portava sempre
con sé. "E non me la chiederanno una seconda volta" concluse con aria
cupa.
Sotto la sua direzione la nuora Lucile tolse le suppellettili che stavano
sulla mensola del caminetto. Volle lasciarvi un portacenere. In un primo
momento, la vecchia signora vi si oppose.
"Ma butteranno la cenere sui tappeti" le fece osservare Lucile, e la signora
Angellier, con riluttanza, si arrese.
L'anziana donna aveva un viso così bianco e trasparente che sembrava
non aver più una goccia di sangue sotto la pelle, capelli candidi come la
neve, bocca a lama di coltello, di un rosa stinto, quasi violaceo. Un colletto
alto di mussola color lilla e di foggia antiquata, sostenuto da stecche di
balena, velava senza nasconderlo un collo dalle ossa sporgenti che
l'emozione faceva palpitare come la gola di una lucertola.
Quando, passando vicino alla finestra, la signora sentiva il passo o la voce
di un soldato tedesco, fremeva tutta, dalla punta del piccolo piede stretta in
uno stivaletto appuntito sino alla fronte incorniciata dall'aristocratica
acconciatura a bandeau.
"Presto, sbrigatevi, stanno arrivando" diceva.
Lasciarono nella stanza solo il necessario: non un fiore, non un cuscino,
non un quadro. Nascosero l'album di famiglia nel grande armadio della
biancheria, sotto una pila di lenzuola, per sottrarre agli sguardi sacrileghi
del nemico la foto della prozia Adelaïde nel giorno della sua prima
comunione e quella dello zio Jules a sei mesi, tutto nudo su un cuscino.
Tolsero perfino le decorazioni del caminetto, due vasi Luigi Filippo
raffiguranti dei pappagalli che tenevano nel becco una ghirlanda di rose,
dono di nozze di una parente che di tanto in tanto veniva a trovarli e che non
osavano offendere sbarazzandosi del suo regalo - sì, perfino quei due vasi
che avevano fatto dire a Gaston: "Se la domestica li rompe mentre pulisce la
stanza le aumento la paga", perfino quelli furono messi al riparo. Erano stati
donati da una mano francese, guardati da occhi francesi, spolverati da
piumini di Francia - non dovevano essere profanati dal contatto con il
tedesco. E il crocifisso!
Era nell'angolo della stanza, sopra il divano. La signora Angellier lo
staccò con le sue mani dalla parete e se lo mise in seno, sotto lo scialletto di
pizzo.
"Credo sia tutto" disse finalmente.
Fece una rapida ricapitolazione mentale: i mobili del salone grande erano
stati fatti sparire, le tende staccate, le provviste alimentari ammassate nel
capanno dove il giardiniere riponeva gli attrezzi - oh, i grandi prosciutti
affumicati coperti di cenere, le giare di burro fuso, di burro salato, di grasso
di maiale, il migliore, i grossi salami maculati, tutti i suoi beni, tutti i suoi
tesori... Il vino riposava, sotterrato in cantina, dal giorno in cui l'esercito
inglese si era reimbarcato a Dunkerque. Il pianoforte era chiuso a chiave, il
fucile da caccia di Gaston al sicuro in un nascondiglio inviolabile. Tutto a
posto, non restava che aspettare il conquistatore. Pallida e muta, con la
delicata mano tremante accostò le imposte, come nella camera di un morto,
e uscì seguita da Lucile.
Lucile era una giovane donna bionda con gli occhi neri, di grande
bellezza, ma silenziosa, riservata: ragione per cui la vecchia signora
Angellier le rimproverava di avere "l'aria assente" L'avevano accolta in
famiglia per la parentela che poteva vantare e per la dote che portava (era la
figlia di un grande proprietario terriero della regione), ma poi il padre aveva
fatto certe speculazioni sbagliate, messo in crisi le sue sostanze, ipotecato le
terre. Il matrimonio non era dunque dei più riusciti, e per giunta Lucile non
aveva figli.
Le due donne entrarono in sala da pranzo, dove la tavola era già
apparecchiata. Era mezzogiorno passato, ma solo per gli orologi della chiesa
e del municipio che, vincolati alle nuove leggi, segnavano l'ora tedesca; in
ogni casa francese, invece, gli orologi venivano mantenuti in ritardo di
sessanta minuti, per puntiglio. E ogni donna diceva con fare sprezzante: "A
casa nostra, non si vive all'ora dei tedeschi"
Questo lasciava qua e là nella giornata grandi spazi di tempo vuoti,
inutilizzati, come quello, mortalmente noioso, che la domenica andava dalla
fine della messa all'inizio del pranzo. Non c'era l'abitudine di leggere. La
vecchia signora Angellier, quando vedeva Lucile con un libro in mano, la
osservava con aria stupefatta e piena di rimprovero: "To, stai leggendo?"
Aveva una voce dolce e educata, sottile come il sospiro di un'arpa: "Non hai
niente da fare?" Non si lavorava perché era la domenica di Pasqua. E non si
parlava. Fra quelle due donne ogni argomento di conversazione somigliava
a un cespuglio di rovi al quale avvicinarsi con estrema prudenza per non
ferirsi. L'eco di ogni parola evocava nella signora Angellier un lutto, una lite
familiare, una vecchia ruggine che Lucile ignorava. Dopo ogni frase,
pronunciata a fior di labbra, si fermava e guardava la nuora con
un'espressione vaga, dolente e stupita, quasi pensasse: "Suo marito è
prigioniero dei tedeschi, e lei può respirare, muoversi, parlare, ridere? Che
strano...". Le pesava riconoscere che il problema, fra loro, fosse Gaston. Il
tono di Lucile non era mai quello che avrebbe dovuto essere.
A volte le sembrava troppo triste: parlava forse di un morto? D'altronde il
suo dovere di donna, di sposa francese, era quello di sopportare la
separazione con coraggio, come lei stessa l'aveva sopportata durante l'altra
guerra, all'indomani delle nozze o giù di lì. Ma quando Lucile mormorava
parole di conforto, di speranza, la madre pensava con acredine: "Ah, si vede
benissimo che non lo ha mai amato, l'ho sempre sospettato. Adesso lo vedo,
ne sono sicura... C'è un'inflessione, nella sua voce, che non inganna. É di
natura fredda e indifferente. Non manca di niente, lei, mentre mio figlio, il
mio povero ragazzo...". E immaginava il campo, il filo spinato, i carcerieri,
le sentinelle. Gli occhi le si riempivano di lacrime e con voce rotta
dall'emozione diceva:
"Non parliamo di lui...".
Prendeva dalla borsa un elegante fazzolettino pulito, sempre pronto nel
caso in cui si evocasse il ricordo di Gaston o quello delle sciagure della
Francia, e si asciugava delicatamente le palpebre: un gesto che faceva
pensare a quello di chi raccolga una macchia d'inchiostro con l'angolo di
una carta assorbente.
Così, immobili e mute, accanto al caminetto spento, le due donne
aspettavano.
CAPITOLO 2.
I tedeschi avevano preso possesso dei loro alloggi e cominciavano a
familiarizzarsi con il paese. Gli ufficiali, soli o in coppia, camminavano a
testa alta facendo risuonare gli stivali sul selciato; i soldati formavano
gruppi di sfaccendati che andavano su e giù lungo l'unica strada o si
ammassavano sulla piazza, davanti al vecchio crocifisso. Quando uno di
loro si fermava tutto il gruppo faceva altrettanto e la lunga fila di uniformi
verdi sbarrava il passaggio ai paesani. Questi, allora, si calcavano ancora di
più il berretto sulla fronte, cambiavano strada e, senza dare nell'occhio,
raggiungevano i campi prendendo certi sentieri tortuosi che si perdevano
nella campagna.
Sotto lo sguardo vigile di due sottufficiali la guardia campestre andava
incollando manifesti sui muri degli edifici principali. Tali manifesti erano di
vario tipo: alcuni raffiguravano un soldato tedesco dai capelli chiari e dal
largo sorriso che gli scopriva la dentatura perfetta, circondato da ragazzetti
francesi mentre distribuiva loro sostanziosi panini imbottiti. La scritta
diceva: "Popolazioni abbandonate, abbiate fiducia nei soldati del Reich!"
Altri illustravano, mediante grafici o caricature, la dominazione inglese nel
mondo e l'odiosa tirannia dell'ebreo. Ma la maggior parte di quei manifesti
cominciava con la parola "Verboten", proibito. Era proibito circolare nelle
strade dalle nove di sera alle cinque del mattino, proibito tenere in casa armi
da fuoco, dare "asilo, aiuto o protezione" a prigionieri evasi, a rifugiati di
paesi nemici della Germania, a militari inglesi, proibito ascoltare radio
straniere, proibito rifiutare il denaro tedesco. E sotto ogni manifesto, a
caratteri neri sottolineati due volte, c'era sempre lo stesso avvertimento:
"Pena la morte"
Nel frattempo, finita la messa, i commercianti aprivano i negozi. Nella
primavera del 1941, in provincia, le merci non scarseggiavano ancora:
c'erano provviste così abbondanti di stoffe, di calzature, di viveri che i
negozianti erano disposti a venderli senza troppe esitazioni. I tedeschi non
erano di gusti difficili, si potevano rifilare loro tutti i fondi di magazzino busti da donna che risalivano all'altra guerra, stivaletti d'inizio secolo,
biancheria con ricami di bandierine tricolori e piccole torri Eiffel (in origine
destinate agli inglesi), gli andava bene tutto.
Agli abitanti dei paesi occupati i tedeschi ispiravano paura, rispetto,
avversione, nonché la voglia maligna di bidonarli, di approfittare di loro, di
estorcergli denaro.
"É pur sempre il nostro... quello che ci hanno preso" pensava la droghiera
porgendo con il suo più bel sorriso una libbra di prugne secche marcite a un
soldato dell'esercito invasore e facendogliele pagare il doppio di quanto
valevano.
Il soldato esaminava la merce con aria diffidente e si vedeva che
subodorava la frode, ma, intimidito dall'espressione impenetrabile della
droghiera, stava zitto. Prima di allora il reggimento era stato acquartierato in
una cittadina del Nord, da tempo devastata e svuotata di tutti i suoi beni. In
quella ricca provincia del centro il soldato scopriva ancora qualcosa da
desiderare. Davanti a vetrine che evocavano le dolcezze della vita civile, a
quei mobili di mogano, a quegli abiti confezionati, a quei giocattoli, a quelle
vestine rosa, gli occhi gli si accendevano di desiderio. I militari andavano da
un negozio all'altro con aria grave, sognante, facendo tintinnare il denaro
nelle tasche.
Alle loro spalle, o sopra le loro teste, da una finestra all'altra i francesi si
scambiavano piccoli segni - occhi al cielo, cenni del capo, sorrisi, smorfie di
derisione e di sfida, tutta una mimica per significare che in simili avversità
bisognava ricorrere a Dio, ma che persino Dio...! Che si voleva restare
liberi, liberi nello spirito se non negli atti o nelle parole, che quei tedeschi
non erano poi molto furbi visto che prendevano per buoni i favori che gli si
facevano, che si era costretti a fargli perché, dopo tutto, i padroni erano
loro. "I nostri padroni" dicevano le donne guardando il nemico con una
sorta di concupiscenza piena di odio. (Nemici? Certo... Ma uomini, e
giovani...).
Quel che dava loro il massimo piacere era l'infinocchiarli. "Pensano di
esserci graditi, ma noi miriamo soltanto a ottenere dei lasciapassare, della
benzina, dei permessi" dicevano tra sé e sé quelle che avevano già avuto a
che fare con gli occupanti a Parigi o nelle grandi città di provincia, mentre
le ingenue campagnole, sotto gli sguardi dei tedeschi, abbassavano
timidamente gli occhi.
Quando entravano nei caffè, i soldati prima di tutto si slacciavano i
cinturoni, li lanciavano sui tavolini di marmo, poi si sedevano.
All'Hotel des Voyageurs, i sottufficiali si erano riservati per la loro mensa
la sala principale, un salone lungo e scuro da locanda di campagna. Sopra lo
specchio sul fondo due bandiere rosse con la svastica nascondevano amorini
e fiaccole sulla parte superiore della vecchia cornice dorata. Malgrado la
stagione, la stufa era ancora accesa; alcuni uomini avevano trascinato le
sedie vicino al fuoco e si scaldavano con aria pigra e beata. Ogni tanto dalla
grande stufa nera e vermiglia usciva un fumo acre, ma i tedeschi non ci
badavano. Anzi, vi si accostavano ancora di più; facevano asciugare vestiti
e stivali mentre con aria pensosa lanciavano intorno uno sguardo annoiato e
nel contempo vagamente ansioso che sembrava dire: "Ne abbiamo viste
tante... Vediamo come sarà questa...".
Così almeno si comportavano i più anziani, i più saggi. I giovani facevano
l'occhiolino alla servetta che alzava senza sosta la botola che portava in
cantina, si inoltrava nelle tenebre sotterranee e tornava alla luce reggendo
con una mano sola dodici birre e con l'altra un paniere pieno di bottiglie di
spumante ("Sekt!" reclamavano i tedeschi.
"Champagne francese, prego, mam'zelle! Sekt!'") La servetta - grassa,
rotonda e rosea - passava svelta fra i tavoli. I soldati le sorridevano e lei,
combattuta tra la voglia di sorridere a sua volta perché erano giovani, e la
paura di mettersi in cattiva luce perché erano nemici, aggrottava le
sopracciglia e stringeva severamente le labbra, senza poter nascondere le
due fossette sulle guance che tradivano la sua esultanza interiore. Tutti
quegli uomini, mio Dio! Tutti quegli uomini solo per lei, perché negli altri
locali erano le figlie dei padroni a servire, e i genitori le tenevano d'occhio,
mentre lei... Loro, guardandola, facevano schioccare le labbra come per un
bacio. Trattenuta da un residuo di pudore, lei fingeva di non udire quei
richiami e a volte rispondeva, senza rivolgersi a qualcuno in particolare:
"Ecco, ecco, arrivo! Quanta fretta!" I soldati le parlavano nella loro lingua, e
lei diceva con aria fiera:
"E chi lo capisce il vostro ostrogoto?"
Dalle porte aperte entrava un flusso continuo e sempre nuovo di uniformi
verdi, e lei si sentiva via via inebriata, vinta, senza più resistenza, e alle
sollecitazioni ardenti reagiva solo con qualche gridolino, oppure sbottando:
"Ma insomma, la volete piantare? Che razza di selvaggi!"
Altri soldati giocavano a biliardo attorno al tavolo ricoperto di panno
verde. Cinturoni, berretti, pistole e cartucciere erano disseminati sui
parapetti delle scale, sui davanzali delle finestre e sulle spalliere delle sedie.
Intanto le campane chiamavano i fedeli ai Vespri.
CAPITOLO 3.
Le signore Angellier stavano uscendo di casa per recarsi ai Vespri quando
si presentò l'ufficiale tedesco che doveva alloggiare da loro. Si incontrarono
sulla porta. L'ufficiale scattò sull'attenti battendo i tacchi e salutò. La
vecchia signora Angellier si fece ancora più pallida e gli concesse con un
certo sforzo un muto cenno del capo. Lucile alzò gli occhi, e per un attimo
lei e l'ufficiale si guardarono. Una ridda di pensieri attraversò in un secondo
la mente di Lucile: "Forse è lui che ha fatto prigioniero Gaston..." disse fra
sé e sé. "Mio Dio, quanti francesi avrà ucciso? Quante lacrime saranno state
versate a causa sua?
É anche vero, però, che se la guerra fosse andata in un altro modo oggi
forse sarebbe Gaston a entrare da padrone in una casa tedesca... É la guerra,
non è colpa di questo ragazzo"
Era giovane, magro, con belle mani e occhi grandi. Lucile notò la bellezza
delle mani perché lui le teneva aperta la porta di casa. Aveva all'anulare un
anello con una pietra lavorata, scura e opaca; un raggio di sole, spuntato fra
due nuvole, strappò al gioiello un bagliore purpureo, danzò sul volto dalla
pelle dorata per la prolungata esposizione all'aria aperta e coperta di una
leggera peluria come un bel frutto. Gli zigomi erano alti, decisi e ben
modellati, la bocca tagliente e fiera. Lucile rallentò il passo, suo malgrado:
non riusciva a staccare gli occhi da quella mano fine, dalle lunghe dita (la
immaginava mentre stringeva una pesante rivoltella nera, o un mitra, o una
granata, o una qualsiasi arma dispensatrice di morte), fissava quell'uniforme
verde (quanti francesi, nelle notti di veglia, avevano spiato nell'ombra del
sottobosco l'apparizione di un'uniforme simile...) e quegli stivali lustri... Le
tornarono in mente i soldati dell'esercito francese che, un anno prima,
sconfitti, nella loro fuga avevano attraversato il paese sporchi, stremati,
trascinando nella polvere i logori scarponi. Mio Dio, questa era la guerra...
Un soldato nemico non sembrava mai solo - un essere umano di fronte a un
altro -, ma era seguito, premuto da ogni parte da una massa innumerevole di
fantasmi, i fantasmi degli assenti e quelli dei morti. Non ci si rivolgeva a un
uomo bensì a una moltitudine invisibile; pertanto nessuna delle parole
pronunciate era detta semplicemente e semplicemente ascoltata; si aveva
sempre la strana sensazione di essere soltanto una bocca che parlava per
conto di tante altre, mute.
"E lui, che cosa pensa?" si domandò la giovane donna. "Che cosa prova
mettendo piede in questa casa francese il cui padrone è assente, fatto
prigioniero forse da lui o dai suoi camerati? Ci compiange? Ci odia?
Oppure entra qui come in una locanda, chiedendosi soltanto se il letto è
buono e se la serva è giovane?" Da un pezzo la porta si era chiusa alle spalle
dell'ufficiale; Lucile si era incamminata dietro la suocera; entrata in chiesa,
si era inginocchiata al suo banco, ma non poteva fare a meno di pensare al
soldato nemico. Adesso era solo in casa; occupava lo studio di Gaston, che
aveva un'uscita indipendente; avrebbe preso i pasti fuori e lei non lo avrebbe
visto; avrebbe sentito il suo passo, la sua voce, la sua risata. Ahimè, poteva
ridere, lui! Ne aveva il diritto.
Guardò la suocera, immobile, il volto nascosto fra le mani, e per la prima
volta quella donna che lei non amava le ispirò un senso di pietà e una vaga
tenerezza. Si chinò verso di lei e disse dolcemente:
"Recitiamolo per Gaston il nostro rosario, mamma"
La vecchia signora annuì con un cenno del capo. Lucile cominciò a
pregare con sincero fervore, ma a poco a poco la concentrazione venne
meno e i suoi pensieri tornarono a un passato al tempo stesso vicino e
remoto, probabilmente per via della tragica frattura provocata dalla guerra.
Rivedeva il marito, quell'uomo grasso e annoiato, interessato unicamente al
denaro, alle terre e alla politica locale; non lo aveva mai amato. Lo aveva
sposato per far piacere al padre. Nata e cresciuta in campagna, la sua
conoscenza del mondo si limitava ad alcuni brevi soggiorni a Parigi presso
un'anziana parente. In quelle province del centro la vita è opulenta e
selvatica: ciascuno vive in casa propria, sulle sue terre, intento a riempire i
granai e a contare i soldi.
Abbuffate senza fine e partite di caccia occupano il tempo libero. Quel
grosso borgo, con le sue case severe difese da grandi porte che facevano
pensare a una prigione, i suoi salotti pieni di mobili, sempre chiusi e gelati
per risparmiare la legna, era per Lucile l'immagine della civiltà. Quando
aveva lasciato la casa paterna sperduta in mezzo ai boschi aveva provato
un'eccitazione gioiosa all'idea di vivere in quel centro abitato, di avere
un'automobile, di andare qualche volta a pranzare a Vichy... Educata in
modo severo e castigato, da ragazza non si era sentita infelice perché il
giardino, i lavori domestici e la biblioteca di casa - immensa stanza umida
dove i libri ammuffivano e dove lei andava a curiosare di nascosto bastavano a distrarla. Poi si era sposata, ed era stata una moglie docile e
fredda. Al momento del matrimonio Gaston Angellier, nonostante fosse
appena venticinquenne, aveva l'aspetto precocemente maturo del
provinciale sedentario rimpinzato di cibi pesanti e prelibati, grande bevitore
e incapace di qualsiasi emozione viva e profonda. Una maturità
ingannevole, che riguardava solo le abitudini e il modo di pensare, mentre,
sotto sotto, il sangue caldo e ricco della gioventù continuava a pulsare in lui.
Nel corso di un viaggio d'affari a Digione, dove aveva compiuto gli studi,
Gaston Angellier ritrovò un'ex amante, una modista dalla quale si era poi
allontanato. Si innamorò di lei per la seconda volta, e più
appassionatamente; la mise incinta, le prese una casetta nei sobborghi della
città e fece in modo di passare metà del suo tempo a Digione.
Lucile sapeva tutto ma taceva, per timidezza, per disprezzo o per
indifferenza. Poi, la guerra...
E adesso, da un anno, Gaston era prigioniero. Povero ragazzo... Sta
soffrendo, pensava Lucile facendo scorrere meccanicamente i grani del
rosario fra le dita. Che cosa gli manca di più? Il suo buon letto, i lauti
pranzi, l'amante... Avrebbe voluto ridargli tutto quello che aveva perduto,
tutto quello che gli era stato tolto... Tutto, sì, anche quella donna... Da ciò,
dalla spontaneità e dalla sincerità di quel sentimento, Lucile misurò il vuoto
del suo cuore, mai colmato né dall'amore né da un odio dettato dalla gelosia.
A volte Gaston la trattava con durezza. Lei gli perdonava le infedeltà, lui
invece non aveva mai dimenticato le speculazioni sbagliate del suocero. Le
pareva ancora di sentire le parole che il marito aveva pronunciato più di una
volta e che le bruciavano come uno schiaffo: "Cosa credi? Se avessi saputo
prima che era al verde...".
Chinò il capo. Ma no! Non provava più alcun risentimento. Quello che di
sicuro Gaston aveva dovuto sopportare dopo la disfatta, gli ultimi scontri, la
fuga, la cattura da parte dei tedeschi e le marce forzate, il freddo, la fame, i
compagni di prigionia che gli morivano intorno e infine il campo in cui lo
avevano rinchiuso, be, questo cancellava tutto. "Chiedo solo che ritorni e
che ritrovi tutte le cose che ha amato: la sua camera, le sue pantofole
foderate di pelo, le passeggiate in giardino all'alba, le pesche appena colte
dall'albero, i manicaretti deliziosi, le belle fiammate nel camino, tutti i suoi
piaceri, quelli che ignoro e quelli che intuisco, voglio che li ritrovi tutti! Per
me non chiedo niente. Vorrei solo vederlo felice. E io?...".
Mentre fantasticava il rosario le sfuggì di mano; si accorse allora che tutti
erano in piedi, che i Vespri stavano finendo. Fuori, i tedeschi affollavano la
piazza. Le mostrine d'argento sulle uniformi, gli occhi chiari, le teste
bionde, le fibbie di metallo sui cinturoni brillavano al sole e davano allo
spiazzo polveroso davanti alla chiesa, chiuso fra alte mura (resti di antichi
bastioni), un'allegria, una luminosità, un'animazione nuova. Alcuni soldati
portavano in giro i cavalli, altri avevano organizzato una mensa all'aperto:
assi prese dalla bottega del falegname, destinate soprattutto alle bare,
formavano un tavolo e varie panche. Gli uomini mangiavano e osservavano
gli abitanti con un'espressione di divertita curiosità. Undici mesi di
occupazione non li avevano ancora resi indifferenti: guardavano i francesi
con lo stupore gioviale dei primi giorni, li trovavano buffi, strani, non si
erano abituati al loro rapido eloquio. Chissà, forse cercavano di capire se
erano odiati, tollerati, amati da quei vinti... Sorridevano da lontano alle
ragazze guardandole di sottecchi, e le ragazze passavano altere e sprezzanti
- era il primo giorno! Allora i tedeschi abbassavano lo sguardo sui ragazzini
che stavano loro intorno: tutti i bambini del paese erano lì, affascinati dalle
uniformi, dai cavalli e dagli alti stivali. Avevano un bel chiamarli, le madri:
tutto inutile! Con le dita sporche toccavano furtivamente il panno pesante
delle giacche. I tedeschi facevano segno di avvicinarsi e gli mettevano in
mano dolci e monete.
A ben guardare, comunque, nel borgo c'era la solita atmosfera di quiete
domenicale; i tedeschi aggiungevano all'insieme del quadro un tocco
anomalo, ma il fondo, pensava Lucile, restava lo stesso. C'erano stati, è
vero, momenti di tensione; alcune donne (madri di prigionieri come la
signora Angellier o vedove dell'altra guerra) erano rincasate in fretta e
avevano chiuso le finestre e abbassato le tende per non vedere i tedeschi.
Qualcuna, all'interno di piccole stanze scure, piangeva rileggendo vecchie
lettere, baciava fotografie ingiallite ornate di un nastrino nero e di una
coccarda tricolore... Ma le più giovani, come tutte le domeniche, si erano
fermate in piazza a chiacchierare. Non erano disposte a rinunciare, per via
dei tedeschi, a un pomeriggio di festa e a qualche svago; avevano messo un
cappellino nuovo: era la domenica di Pasqua. Gli uomini osservavano i
tedeschi con occhiate furtive; impossibile sapere che cosa pensassero: i volti
dei contadini sono impenetrabili. Un tedesco si avvicinò a un gruppo e
chiese del fuoco; gli accesero la sigaretta e risposero con aria assente al suo
saluto. Il soldato si allontanò e gli uomini ripresero a parlare del prezzo dei
buoi. Come tutte le domeniche, il notaio entrava nel caffè dell'Hotel des
Voyageurs per giocare ai tarocchi e alcune famiglie tornavano dalla visita
settimanale al cimitero, quasi una gita di piacere in quel paese che ignorava
i divertimenti: ci andavano in gruppo e raccoglievano mazzolini di fiori fra
le tombe. Le suore dell'oratorio uscivano dalla chiesa con i bambini e,
impassibili sotto le cuffie, si aprivano un varco in mezzo ai soldati.
"Resteranno molto tempo?" mormorò l'esattore all'orecchio dell'usciere
indicandogli i tedeschi.
"Tre mesi, pare" fece l'altro nello stesso tono.
L'esattore sospirò.
"Faranno salire i prezzi"
E con un gesto meccanico si strofinava la mano dilaniata nel 1915 dallo
scoppio di una granata. Poi parlarono d'altro. Le campane che avevano
battuto la fine dei Vespri ora tacevano; gli ultimi tenui rintocchi si
perdevano nell'aria della sera.
Per rincasare le signore Angellier seguivano una stradina tortuosa di cui
Lucile conosceva ogni pietra. Camminavano in silenzio, rispondendo ai
saluti dei contadini con cenni del capo. La signora Angellier non era amata
in paese, ma Lucile ispirava simpatia perché era giovane, con un marito
prigioniero, e per niente altezzosa. A volte le donne andavano a chiederle un
parere sull'educazione dei figli o su una camicetta nuova.
Oppure su come spedire un pacco in Germania. Tutti sapevano che
l'ufficiale tedesco avrebbe alloggiato da loro - le Angellier avevano la casa
più bella del paese - e, vedendole assoggettate alla legge comune, le
compativano.
"Siete sistemate per bene" sussurrò la sarta passando loro accanto.
"Speriamo che se ne vadano in fretta" disse la farmacista.
E una vecchietta che trotterellava dietro a una capra dal morbido pelo
bianco si alzò sulla punta dei piedi per sussurrare all'orecchio di Lucile:
"Dicono che sono molto cattivi, molto crudeli, che fanno del male a noi
poveretti"
La capra fece un balzo e prese a dare cornate al lungo mantello grigio di
un ufficiale tedesco. Lui si fermò, scoppiò a ridere e fece per accarezzarla.
Ma la bestia fuggì; la vecchietta, impaurita, si allontanò e le signore
Angellier si chiusero alle spalle la porta di casa.
CAPITOLO 4.
La casa, vecchia di cent'anni, era davvero la più bella del paese: lunga,
bassa, costruita con una pietra porosa, gialla, che al sole prendeva il colore
caldo e dorato del pane. Le finestre sulla strada (quelle delle stanze di
rappresentanza) erano accuratamente chiuse, con le imposte accostate, e
munite di inferriate contro i ladri; il piccolo occhio di bue del ripostiglio
(dove venivano nascosti i barattoli, gli orci, le damigiane che contenevano
le derrate proibite) era circondato da una fitta rete metallica dalle alte punte
a forma di giglio sulle quali i gatti randagi restavano infilzati. La porta,
dipinta di blu, aveva un catenaccio degno di una prigione e una chiave
enorme che cigolava lamentosamente nel silenzio. Il pianoterra esalava un
odore di chiuso, un odore freddo di casa disabitata malgrado la presenza
costante dei proprietari. L'aria e la luce vi erano bandite per non far sbiadire
i tendaggi e preservare i mobili. Dalle finestre dell'anticamera - vetri
colorati che sembravano cocci di bottiglia - filtrava una luce verdastra,
incerta, che inondava d'ombra le cassapanche, le corna di cervo appese alle
pareti e alcune vecchie piccole stampe scolorite dall'umidità.
Nella sala da pranzo (la stufa veniva accesa solo lì!) e nella stanza di
Lucile, che a volte, la sera, si concedeva una fiammata, si respirava il
gradevole aroma del fuoco di legna, una fragranza di fumo, di buccia di
castagna. Davanti alle portefinestre della sala si stendeva il giardino, che in
quella stagione aveva un aspetto tristissimo: i peri allungavano le loro
braccia martoriate sopra i fili di ferro, i meli potati a cordone erano rugosi e
tormentati, irti di rami simili ad artigli; della vigna non restavano che tralci
nudi. Ma ancora pochi giorni di sole e il piccolo pesco precoce sulla piazza
della chiesa non sarebbe stato l'unico a coprirsi di fiori: ogni albero sarebbe
fiorito. Dalla sua finestra, mentre si spazzolava i capelli prima di andare a
letto, Lucile guardava il giardino inondato dal chiaro di luna. Dal muretto si
levava il lamento dei gatti. Intorno al giardino si intravedeva tutto il paese,
si scorgevano minuscole valli fitte di boschi, una terra fertile, segreta, che
sotto la luna assumeva toni di un delicato grigio perla.
Nella sua camera ampia e vuota Lucile, la sera, si sentiva a disagio.
Una volta vi dormiva anche Gaston; si spogliava, brontolava, spostava
qualche mobile: era un compagno, una creatura umana. Da quasi un anno,
ormai, non c'era nessuno. Solo silenzio. Fuori tutto taceva.
Involontariamente tese l'orecchio a spiare un segno di vita nella stanza
vicina, dove dormiva l'ufficiale tedesco. Ma non sentì niente: forse non era
ancora rientrato... o i muri spessi smorzavano i suoni... o anche lui stava
immobile e silenzioso... Qualche istante dopo colse un fruscio, un sospiro,
poi un leggero fischiettare, e ne dedusse che lui era alla finestra e guardava
il giardino. Chissà a cosa pensava...
Lucile non riusciva a immaginarlo: suo malgrado non gli attribuiva
riflessioni e desideri propri di un uomo comune. Non poteva credere che
contemplasse il giardino con vero abbandono, che ammirasse il luccichio
del vivaio in cui guizzavano mute forme d'argento - le carpe per il pranzo
dell'indomani. "No," diceva tra sé "certamente esulta, ricorda le sue
battaglie, rivive i pericoli passati. Tra poco scriverà a casa, in Germania, a
sua moglie - no, non dev'essere sposato, è troppo giovane -, a sua madre, a
una fidanzata, a un'amante... Scriverà: "Abito in una casa francese; non
abbiamo sofferto, cara Amalia," (deve chiamarsi Amalia, o Cunegonda o
Gertrude)" pensò Lucile, cercando di proposito nomi poco armoniosi e
grotteschi ""non abbiamo sofferto perché abbiamo vinto""
Adesso non avvertiva più alcun rumore; lui stava immobile, tratteneva il
respiro. Nell'ombra si udì il gorgoglio di un rospo. Era come un sospiro
musicale basso e dolce, una nota tremula e pura, una bolla d'acqua che
scoppiava con un suono argentino. Lucile socchiuse gli occhi. Che quiete,
triste e profonda... Ogni tanto qualcosa si destava in lei, si ribellava,
reclamava rumore, movimento, gente. Vita, mio Dio, vita!
Quanto ancora sarebbe durata quella guerra? Per quanti anni bisognava
restare così, in quel cupo letargo, rassegnati, docili, tremanti come bestie
sotto la tempesta? Rimpiangeva il frastuono familiare della radio, ma
appena arrivati i tedeschi l'apparecchio era stato confinato in cantina. Si
diceva che li requisivano o li distruggevano. Lucile sorrise. "Deve trovare le
case francesi piuttosto squallide" pensò ricordando tutto quello che la
suocera aveva nascosto negli armadi e chiuso a chiave per sottrarlo al
nemico.
Mentre stavano cenando, l'attendente dell'ufficiale era entrato in sala da
pranzo portando un biglietto: Il tenente Bruno von Falk presenta i suoi
omaggi alle signore Angellier e le prega di voler consegnare al soldato
latore di questo messaggio la chiave del pianoforte e quella della biblioteca.
Il tenente si impegna sul suo onore a non portare via lo strumento e a non
strappare i libri.
Ma la signora Angellier non aveva apprezzato la battuta. Alzando gli
occhi al cielo e muovendo le labbra come se pronunciasse una breve
preghiera e si rimettesse alla volontà divina, aveva detto al soldato:
"La forza ha la meglio sul diritto, vero?" L'attendente, che non capiva il
francese, si era limitato a un "Jawohl" accompagnato da un largo sorriso
mentre scuoteva ripetutamente la testa dall'alto al basso.
"Dica al tenente von... von" farfugliò il nome con disprezzo "che il
padrone è lui"
Staccò dal mazzo le due chiavi richieste e le gettò sul tavolo. Poi, in un
sussurro tragico, disse alla nuora:
"Suonerà certamente la Wacht am Rhein...".
"Credo, mamma, che adesso il loro inno nazionale sia un altro"
Ma l'ufficiale non aveva affatto suonato. Nel silenzio più profondo, il
tonfo del portone che risuonava come un gong nella pace della sera fece
capire alle signore che il tenente era uscito (accompagnato dal loro sospiro
di sollievo)
Adesso, pensò Lucile, si è allontanato dalla finestra. Cammina su e giù
per la stanza. Gli stivali... Quel calpestio di stivali... Passerà.
L'occupazione finirà. Ci sarà la pace, la pace benedetta. La guerra e la
disfatta del 1940 saranno solo un ricordo, una pagina di storia, nomi di
battaglie e di trattati che gli studenti elencheranno faticosamente a scuola ma io, finché vivrò, ricorderò questo martellare sordo e cadenzato degli
stivali sul pavimento. E perché non va a letto? Perché la sera, in camera,
non si mette le pantofole, come un civile, come un francese? Sta bevendo.
(Aveva sentito sprizzare l'acqua di selz dal sifone, il fievole zzz, zzz di un
limone spremuto. Sua suocera avrebbe detto: "Ecco perché non abbiamo più
limoni. Ci prendono tutto!"). Adesso gira le pagine di un libro. Oh, è
insopportabile questo pensiero... Poi trasalì: lui aveva aperto il pianoforte;
lo indovinò dal colpo del coperchio che veniva alzato e dal cigolio dello
sgabello fatto ruotare.
Ma insomma, non si metterà a suonare in piena notte? É vero che erano le
nove e che forse, nel resto del mondo, la gente non andava a letto così
presto... Sì, suonava. Lei ascoltò, chinando la fronte, mordendosi
nervosamente le labbra. Non fu tanto un arpeggio quanto una sorta di
sospiro quello che saliva dalla tastiera, una serie di note palpitanti appena
sfiorate, quasi accarezzate, che finirono in un trillo leggero e rapido come il
canto di un uccello. Poi tutto tacque.
Lucile restò a lungo immobile, con il pettine in mano, i capelli sciolti
sulle spalle. Poi sospirò, pensò vagamente: "Peccato!". (Peccato che il
silenzio fosse così profondo? Peccato che quel ragazzo avesse smesso di
suonare? Peccato che lì ci fosse lui, l'invasore, il nemico, lui, e non un
altro?) Ebbe un piccolo movimento indispettito della mano, come se stesse
respingendo una coltre d'aria troppo pesante, irrespirabile.
Peccato... E si coricò nel grande letto vuoto.
CAPITOLO 5.
Madeleine Labarie era sola in casa e sedeva nella stanza dove Jean-Marie
era vissuto per diverse settimane. Ogni giorno la giovane rifaceva il letto in
cui lui aveva dormito. Questo irritava Cecile. "Ma lascia stare! Dal
momento che nessuno ci dorme mai, non occorre mica rifarlo con lenzuola
pulite come se tu aspettassi qualcuno. Aspetti forse qualcuno?"
Madeleine non rispondeva e ogni mattina continuava a sprimacciare il
grande materasso di piume.
Era felice di essere sola con il figlio che poppava con la guancia
appoggiata al suo seno nudo. Quando lo spostò sull'altro lato, vide che il
piccolo aveva una parte del faccino tutta umida, rossa e lucente come una
ciliegia, con l'impronta della mammella; lo baciò teneramente, pensando
ancora una volta: "Sono contenta che sia un maschio, gli uomini sono più
fortunati" Sonnecchiava guardando il fuoco: non dormiva mai abbastanza.
C'era così tanto da fare che non si andava a letto prima delle dieci o delle
undici, e qualche volta ci si alzava in piena notte per ascoltare la
trasmissione di radio Londra. Al mattino bisognava essere in piedi alle
cinque per strigliare le bestie. Era molto piacevole, quel giorno, fare una
breve siesta, con la cena sul fuoco, la tavola già apparecchiata, tutto in
ordine intorno a lei. La luce smorzata di una, primavera piovosa illuminava
il verde tenero dell'erba e il cielo grigio. Nel cortile le anatre sbattevano il
becco sotto la pioggia, mentre galline e tacchini, piccolo mucchio di piume
arruffate, si rifugiavano tristemente sotto la rimessa. Madeleine sentì il cane
abbaiare.
"Che stiano già rientrando?" si domandò. Benoît aveva portato la famiglia
in paese. Qualcuno attraversò il cortile, qualcuno che non calzava gli
zoccoli come Benoît. E ogni volta che lei sentiva un passo che non era
quello del marito o di uno degli abitanti della fattoria, ogni volta che
intravedeva in lontananza una figura insolita, immediatamente pensava:
"Non è Jean-Marie, non può essere lui, sono pazza; prima di tutto non
tornerà, e poi, anche se venisse, cosa cambierebbe, visto che ho sposato
Benoît? Non aspetto nessuno, anzi prego Iddio che Jean-Marie non torni
mai, perché un po’ alla volta mi abituerò a mio marito e sarò felice. Ma non
so più quel che vado farneticando, parola d'onore, sono fuori di testa. Io
sono felice". E proprio mentre pensava così, il suo cuore, che era meno
ragionevole di lei, cominciava a battere con tale violenza da soffocare tutti i
rumori esterni, tanto che non sentiva più la voce di Benoît, gli strilli del
bambino, il vento sotto la porta, e il tumulto del suo sangue la assordava
come quando ci si tuffa sotto un'onda. Era come se per qualche istante
perdesse conoscenza; poi tornava in sé e vedeva solo il postino che portava
un catalogo di sementi (e che quel giorno non aveva ai piedi le solite scarpe)
o il visconte di Montmort, il proprietario.
"Be, Madeleine, non saluti?" chiedeva stupita la suocera.
"Credo di averla svegliata" diceva il visitatore mentre lei si scusava
debolmente e mormorava:
"Sì, mi ha fatto paura...".
Svegliata? Da quale sogno?
Anche allora sentì dentro di sé quell'emozione, quel panico interiore
provocato dall'ignoto che entrava (o ritornava) nella sua vita. Si raddrizzò
sulla sedia, fissò gli occhi sulla porta. Un uomo? Un passo, un tossicchiare
d'uomo, un aroma di sigarette raffinate! Una mano maschile, bianca e
curata, sul chiavistello, ed ecco apparire un'uniforme tedesca. Come sempre
quando a comparirle davanti non era Jean-Marie, la delusione fu così grande
che Madeleine restò per un attimo come stordita; non pensò neppure ad
abbottonarsi la camicetta. Il tedesco, un giovane ufficiale appena ventenne,
il volto quasi incolore, con ciglia, capelli e baffetti ugualmente pallidi, di un
biondo chiarissimo e lucente, abbassò lo sguardo sul seno scoperto, sorrise e
s'inchinò con correttezza ostentata, quasi insolente. Certi tedeschi, quando
salutavano i francesi, mettevano nel loro saluto (o forse così sembrava al
vinto, inasprito, umiliato, pieno di rabbia) una cortesia eccessiva. Non era
più quella dovuta a un proprio simile, ma la deferenza che si deve a un
cadavere, come il "Presentatarm" davanti al corpo del giustiziato.
"Desidera, signore?" domandò finalmente Madeleine affrettandosi ad
abbottonare la camicetta.
"Mi è stata destinata come alloggio questa fattoria, signora" rispose il
giovane che parlava benissimo il francese. "Mi scuso per il disturbo, ma
voglia per favore mostrarmi la mia camera"
"Ci avevano detto che avremmo ospitato solo soldati semplici" obiettò
timidamente Madeleine.
"Sono tenente-interprete presso la Kommandantur"
"Qui sarà lontano dal paese e ho paura che la camera non sia all'altezza di
un ufficiale. Questa è una semplice fattoria, e non abbiamo né acqua
corrente, né elettricità, né quello che serve a un signore"
Il giovane guardò la stanza. Osservò le mattonelle del pavimento di un
rosso sbiadito, qua e là quasi rosa, il grande fornello al centro, il catafalco
nell'angolo, l'arcolaio (lo avevano portato giù dal solaio dov'era stato
confinato dopo l'altra guerra, e tutte le ragazze del paese avevano imparato a
filare la lana, da quando non se ne trovava più di pronta nei negozi) Il
tedesco esaminò ancora con attenzione le fotografie incorniciate appese alle
pareti, i diplomi ottenuti ai concorsi agricoli, la piccola nicchia vuota che un
tempo ospitava la statuina di una santa e l'elegante fregio dipinto,
semicancellato, che la contornava. Alla fine il suo sguardo tornò a posarsi
sulla giovane contadina che teneva in braccio il bambino.
"Non si preoccupi per me. Starò benissimo" disse il giovane con un
sorriso.
La voce aveva un timbro stranamente duro e vibrante che faceva pensare
allo sfregamento del metallo. Gli occhi grigio ferro, il profilo tagliente del
viso, la particolare tonalità chiarissima dei capelli biondi, lisci come un
casco, davano a quel giovane un aspetto sorprendente che colpiva
Madeleine; nel fisico di lui c'era qualcosa di perfetto, di preciso, di
scintillante che lo faceva somigliare, pensò, a una macchina più che a un
essere umano. Senza volerlo era affascinata dai suoi stivali e dalla fibbia del
cinturone: il cuoio e l'acciaio mandavano lampi.
"Spero che lei abbia un attendente, perché nessuno, qui, saprebbe lustrare
così i suoi stivali" disse.
"Non si preoccupi per me" ripeté lui ridendo.
Madeleine aveva messo a dormire il bambino. Per un attimo il riflesso del
tedesco balenò nello specchio inclinato appeso sopra il letto. Lei vide il suo
sguardo e il suo sorriso, e pensò con timore: "Che cosa dirà
Benoît se questo mi corre dietro?" Quel giovanotto non le piaceva e le
faceva un po’ paura, ma, suo malgrado, ne era attratta per una certa
somiglianza con Jean-Marie, non con Jean-Marie in quanto uomo, ma in
quanto borghese, in quanto signore. Tutti e due erano ben rasati, beneducati,
avevano mani bianche e carnagione delicata. Si rese conto che la presenza
di quel tedesco sarebbe stata doppiamente penosa per Benoît: perché era un
nemico, perché non era un contadino come lui, ma soprattutto perché il
marito detestava in Madeleine l'interesse e la curiosità che lei mostrava nei
confronti di una classe sociale di livello superiore, al punto che da qualche
tempo le strappava di mano le riviste di moda o diceva, quando lei gli
chiedeva di farsi la barba o di cambiarsi la camicia: "Devi metterti il cuore
in pace. Ti sei presa un uomo di campagna, un bifolco, non ho bei modi,
io..." con tanto rancore, con una gelosia così profonda che lei capiva subito
chi gli avesse messo la pulce nell'orecchio: Cecile, che di sicuro era andata a
raccontargli qualche cosa, e che del resto con lei non era più la stessa.
Sospirò.
Quante cose erano cambiate con quella maledetta guerra...
"Le faccio vedere la sua camera" disse alla fine.
Ma lui non volle; prese una sedia e si mise a sedere vicino alla stufa.
"Tra un po’, se permette. Facciamo prima conoscenza. Qual è il suo
nome?"
"Madeleine Labarie"
"Io mi chiamo Kurt Bonnet" disse lui pronunciando la t finale. "É un
nome francese, come vede. I miei antenati dovevano essere vostri
compatrioti, cacciati dalla Francia sotto Luigi XIV. C'è del sangue francese
in Germania, e ci sono parole francesi nella nostra lingua"
"Ah sì?" fece lei con indifferenza.
Avrebbe voluto rispondere: "C'è sangue tedesco in Francia, ma sotto terra
e dopo il 1914" Non osò dirlo: meglio tacere. Era strano: non odiava i
tedeschi; non odiava nessuno, ma la vista di quell'uniforme sembrava
renderla, lei fino a quel momento libera e fiera, una sorta di schiava, una
creatura astuta, prudente e timorosa, capace di fare moine al conquistatore
salvo poi borbottare dietro la porta chiusa: "Che crepino tutti!", come faceva
la suocera, che almeno non sapeva fingere né mostrarsi benevola con il
vincitore, pensò. Si vergognò di se stessa; aggrottò le sopracciglia, assunse
un'espressione gelida e spostò indietro la sedia per far capire al tedesco che
non desiderava più parlare con lui e che la sua presenza le pesava.
Lui invece la guardava con manifesto piacere. Al pari di molti
giovanissimi, sottoposti fin dall'infanzia a una severa disciplina, si era
abituato a rafforzare il suo io profondo con l'arroganza e la rigidezza
esteriore. Pensava che un uomo degno di questo nome dovesse essere di
ferro. E tale si era mostrato, del resto, in guerra, in Polonia e in Francia, e
nel corso dell'occupazione. Ma non obbediva tanto a determinati principi
quanto all'impulsività della gioventù.
(Madeleine, vedendolo, gli aveva dato vent'anni. In realtà ne aveva ancora
meno, ne aveva compiuti diciannove nei giorni della campagna di Francia)
Si mostrava benevolo o crudele a seconda dell'impressione, buona o cattiva,
che cose e persone suscitavano in lui. Se prendeva qualcuno in antipatia, si
adoperava per farlo soffrire il più possibile.
Quando, durante la ritirata dell'esercito francese, era stato incaricato di
scortare fino in Germania la misera torma dei prigionieri, in quelle giornate
terribili in cui l'ordine era di abbattere i più deboli, quelli che non
camminavano abbastanza in fretta, lui lo aveva messo in pratica senza
rimorsi e persino con un certo piacere nei confronti di chi non gli andava a
genio. Al contrario, si era mostrato infinitamente buono e pietoso verso certi
prigionieri che gli erano risultati simpatici: alcuni di loro gli dovevano la
vita. Era crudele, ma si trattava della crudeltà che è propria dell'adolescenza,
quella che nasce da un'immaginazione accesa e sottile, tutta rivolta a se
stessi, alla propria anima; non ci s'impietosisce per le sofferenze altrui: non
le si vede, si vede solo se stessi. In quella crudeltà vi era anche una certa
ostentazione dovuta sia all'età sia a una vaga inclinazione al sadismo.
Duro con gli uomini, mostrava grande sollecitudine verso gli animali; a
lui si doveva un'ordinanza della Kommandantur di Calais emanata qualche
mese prima. Bonnet aveva notato che i contadini, nei giorni di fiera,
portavano i polli legati per le zampe e a testa in giù. Da quel momento, "per
una questione di umanità", fu proibito portarli così. I contadini non ne
tennero minimamente conto, il che rafforzò l'avversione di Bonnet nei
confronti dei francesi, "barbari e frivoli", mentre i francesi, da parte loro,
erano profondamente indignati nel leggere un simile avviso sotto un altro in
cui si diceva che, come rappresaglia per un'azione di sabotaggio, otto
uomini erano stati giustiziati. Nella città del Nord in cui il suo reggimento si
era acquartierato, Bonnet aveva stretto amicizia solo con la donna presso la
quale alloggiava perché, un giorno in cui aveva l'influenza, costei si era
presa la briga di portargli la colazione a letto. Questo gli aveva ricordato sua
madre, gli anni dell'infanzia, e, con le lacrime agli occhi, aveva ringraziato
Madame Lili, ex tenutaria di una casa chiusa. Da allora in poi Bonnet si era
prodigato in ogni modo per lei, facendole avere permessi di tutti i tipi,
buonibenzina e così via, nonché passando le sue serate con quella vecchia
carampana perché, diceva, era sola, anziana, e si annoiava; inoltre le portava
da Parigi, dove si recava per servizio. Gingilli che gli costavano un occhio
della testa e sì che non era ricco! Queste simpatie nascevano a volte da
impressioni musicali o letterarie, oppure, come in quella mattina di
primavera in cui era entrato dai Labarie, pittoriche: Bonnet era molto colto e
dotato di grande sensibilità per tutte le arti. Nella fattoria dei Labarie, con
l'atmosfera un po’ umida e scura di quel giorno piovoso, con il rosso
sbiadito del pavimento con la piccola nicchia vuota dove immaginava una
statuina della Vergine rimossa durante l'ultima rivoluzione con il ramo di
ulivo benedetto sopra la culla e lo scaldino di rame che luccicava nella
penombra, aveva qualcosa che ricordava, pensò Bonnet, un "interno" di
scuola fiamminga.
Quella giovane donna seduta su una seggiola bassa con il bambino in
braccio e un delizioso seno nudo che splendeva nell'ombra, quel volto
incantevole dalle guance rosee, la fronte e il mento bianchissimi, valeva da
sola un quadro. Guardandola, ammirandola, gli sembrava quasi di trovarsi
in un museo di Monaco o di Dresda, solo, di fronte a uno dei capolavori che
gli davano ciò che più amava al mondo: un'ebbrezza sensuale e cerebrale a
un tempo. Quella donna avrebbe potuto mostrarsi fredda, addirittura ostile,
la cosa non lo avrebbe toccato; non se ne sarebbe neppure accorto. Ciò che
chiedeva, a lei come a tutto quanto le stava intorno, era soltanto di
continuare a procurargli dei benefici puramente artistici - di conservare
quelle luci da capolavoro, quella luminosità delle carni, quella morbidezza
degli sfondi.
Proprio allora il grande orologio batté il mezzogiorno. Bonnet rise, quasi
di piacere. Il suono grave, profondo, un po’ fesso che usciva dall'antiquato
aggeggio con la cassa dipinta era esattamente quello che lui sentiva quando
guardava le tele di certi pittori olandesi e gli pareva di cogliere l'odore di
aringhe fresche preparate dalla massaia o il rumore della strada intravista al
di là della finestra con i vetri dai riflessi verdi; c'era sempre, su quelle pareti
rivestite di legno scuro, un orologio di quel tipo.
Ora, però, voleva far parlare Madeleine: desiderava ascoltare ancora
quella voce fresca, un po’ cantilenante. "Abita sola, qui? Suo marito è
prigioniero?" "Ma no!" disse lei con una certa veemenza. E di nuovo,
pensando al fatto che Benoît era stato prigioniero dei tedeschi ed era
scappato, ebbe paura; temette improvvisamente che il tedesco lo avrebbe
indovinato e avrebbe arrestato il fuggitivo. "Come sono stupida" aggiunse
subito dopo e, istintivamente, prese un'aria più amabile, quella che
conveniva avere con il vincitore, e con voce innocente e rispettosa
domandò:
"Si tratterrà a lungo? C'è chi dice tre mesi...".
"Non lo sappiamo neanche noi" spiegò Bonnet. "La vita militare è così:
dipendiamo da un ordine, da un capriccio dei generali o dagli incerti della
guerra. Eravamo diretti in Iugoslavia, ma laggiù è finito tutto".
"Ah, è finito tutto?"
"Questione di giorni. A ogni modo, saremmo arrivati dopo la vittoria.
Penso che ci terranno qui tutta l'estate, a meno che non vogliano spedirci
in Africa o in Inghilterra"
"E... questo le piace?" fece Madeleine assumendo deliberatamente un'aria
ingenua, pur senza riuscire a nascondere un piccolo fremito di disgusto,
come se avesse chiesto a un cannibale: "É vero che le piace la carne
umana?"
"L'uomo è fatto per essere un guerriero, come la donna è fatta per il
piacere del guerriero" rispose Bonnet, e sorrise perché trovava divertente
citare Nietzsche alla bella contadina francese. "Suo marito, se è giovane,
deve pensarla così anche lui"
Madeleine non rispose. In fondo, benché fossero cresciuti insieme,
conosceva ben poco i pensieri di Benoît, che era taciturno e come chiuso in
una triplice corazza di pudore - maschile, contadino e francese. Non sapeva
cosa lui odiasse o amasse, ma solo che era capace di amore e di odio.
"Mio Dio," disse fra sé "purché non prenda questo tedesco in antipatia"
Lo ascoltava parlare, ma gli rispondeva appena, l'orecchio teso ai rumori
della strada; passavano i carretti, le campane delle chiese chiamavano i
fedeli ai Vespri e l'eco si diffondeva via via nella campagna; per prima
quella della piccola cappella di Montmort, leggera come un sonaglio
d'argento, poi il suono grave che veniva dal paese, e poi un tenue scampanio
frettoloso a Sainte-Marie, che si avvertiva solamente quando c'era brutto
tempo e il vento soffiava dall'alto delle colline.
"Gli altri non tarderanno" mormorò Madeleine, e aggiunse sulla tavola
apparecchiata un bricchetto di maiolica color crema pieno di
nontiscordardimé.
"Lei non mangerà qui, penso..." disse all'improvviso.
"No, no, per i pasti sto a pensione in paese. Le chiederò soltanto il
caffellatte del mattino" la rassicurò lui.
"Per quello non c'è problema"
Era una frase caratteristica del posto; veniva detta sorridendo e in tono
amabile; del resto, non significava proprio niente: era una semplice formula
di cortesia che non ingannava nessuno, non voleva necessariamente dire che
la richiesta sarebbe stata esaudita. Si trattava di pura cortesia e, qualora la
promessa non fosse stata mantenuta, c'era un'altra formula bell'e pronta,
pronunciata, questa, con un tono di rincrescimento e di scusa: "Ah,
purtroppo non si può fare sempre quello che si vuole" Sia come sia, il
tedesco ne fu incantato.
"Come siete tutti affabili in questo paese" disse ingenuamente.
"Lei trova, signore?"
"E mi porterà il caffè a letto, spero...".
"Questo si fa solo con gli ammalati" rispose Madeleine con aria
scherzosa.
Lui volle prenderle le mani; lei le ritrasse bruscamente.
"Ecco mio marito"
Non era ancora Benoît, ma sarebbe arrivato di lì a poco: Madeleine aveva
riconosciuto il trotto della cavalla. Uscì in cortile, sotto la pioggia.
La vecchia carrozza, che non era più servita dopo l'altra guerra e che
adesso sostituiva l'auto inutilizzabile, stava passando sotto il portone. Benoît
era a cassetta, mentre le donne sedevano reggendo gli ombrelli bagnati.
Madeleine si precipitò verso il marito e gli si gettò al collo:
"C'è un crucco" gli sussurrò all'orecchio.
"Abiterà da noi?"
"Sì"
"Maledizione!"
"Bah!" fece Cecile. "Non sono cattivi, basta saperli prendere. E poi,
pagano bene"
Benoît staccò la giumenta e la portò nella stalla. Cecile, intimidita dal
tedesco, ma consapevole di quanto le donassero il vestito della festa, il
cappello e le calze di seta, entrò tutta fiera nella stanza.
CAPITOLO 6.
Il reggimento passò sotto le finestre di Lucile. I soldati cantavano;
avevano voci molto belle, ma quel coro grave, minaccioso e triste, che
sembrava più religioso che guerriero, riempiva di stupore i francesi.
"Saranno le loro preghiere, queste?" si domandavano le donne.
I soldati rientravano dalle manovre; era così presto che in paese tutti
dormivano ancora. Alcune donne, svegliatesi di soprassalto, si affacciavano
alle finestre e ridevano. Che bella mattina, tenera e fresca! I galli lanciavano
le loro prime note, arrochite dal freddo della notte. L'aria serena aveva
riflessi rosa e argento, e quella luce innocente splendeva sui volti felici degli
uomini che sfilavano (come non essere felici con una primavera così bella?)
E le donne seguivano a lungo con lo sguardo quei ragazzi alti, ben fatti,
dalle facce maschie e dalle voci armoniose. Cominciavano a riconoscerne
qualcuno. Non formavano più quella massa anonima dei primi giorni, quella
marea di uniformi verdi in cui non c'era un tratto che si distinguesse dagli
altri, così come un'onda del mare non ha una fisionomia propria ma si
confonde con quelle che la precedono e quelle che la seguono. Adesso molti
soldati avevano un nome: "Ecco il biondino che alloggia dallo zoccolaio e
che i camerati chiamano Willy" dicevano gli abitanti. "E quell'altro, quello
di pelo rosso, è il tipo che ordina omelette di otto uova e tracanna uno dietro
l'altro diciotto bicchierini d'acquavite senza ubriacarsi e senza sentirsi male.
Il giovincello che sta così impettito è l'interprete, quello che alla
Kommandantur fa il bello e il cattivo tempo. Ed ecco il tedesco delle
Angellier".
Come in passato ai contadini si erano dati i nomi delle tenute in cui
vivevano, tanto che il postino, discendente dai mezzadri stabilitisi un tempo
sulle terre dei Montmort, ora si chiamava Auguste di Montmort, così i
tedeschi ereditavano in qualche modo lo stato civile di coloro presso i quali
alloggiavano. E si diceva: "Fritz dei Durand, Ewald dei La Forge, Bruno
delle Angellier"
Quest'ultimo cavalcava alla testa del suo reparto. I cavalli, ben nutriti e
focosi, caracollavano e guardavano la folla con il bellissimo occhio
impaziente e fiero, e suscitavano l'ammirazione dei contadini.
"Hai visto?" strillavano i ragazzini.
Il cavallo del tenente aveva un mantello bruno dorato dai riflessi di raso, e
come il suo padrone non sembrava insensibile alle esclamazioni, ai gridolini
estasiati delle donne. Lo splendido animale inarcava il collo, scuoteva con
furia il morso. L'ufficiale sorrideva leggermente e ogni tanto faceva con le
labbra un piccolo schiocco affettuoso che domava la bestia meglio del
frustino. Quando una ragazza, affacciata alla finestra, esclamò: "Però,
monta bene, il crucco!", lui si portò al berretto la mano inguantata e salutò
con aria compresa.
Alle spalle della ragazza si udì un sussurrare agitato.
"Ma sei pazza? Lo sai che non gli piace essere chiamati così"
"Be, e allora? L'ho dimenticato" si difese la ragazza, diventando rossa
come una ciliegia.
Sulla piazza il reparto si disperse. Con un gran fracasso di stivali e di
speroni gli uomini rientrarono nei rispettivi alloggi. Il sole splendeva, molto
caldo ormai, quasi estivo. Nei cortili i soldati si lavavano a torso nudo: i
loro corpi erano abbronzati dalla vita all'aria aperta e madidi di sudore. Un
soldato aveva fissato al tronco di un albero un piccolo specchio e si faceva
la barba. Un altro tuffava la testa e le braccia nude in un grande secchio di
acqua fresca. Un terzo esclamava, rivolto a una giovane donna:
"Bella giornata, signora!"
"To, parla la nostra lingua?"
"Un po’"
Si guardavano, si sorridevano. Le donne si avvicinavano ai pozzi e
srotolavano le lunghe catene cigolanti. Quando il secchio risaliva alla luce,
pieno di un'acqua ghiacciata, tremolante, in cui si rifletteva un cielo blu
scuro, c'era sempre un soldato che si precipitava a toglierlo dalle mani della
donna. Chi per dimostrare che anche i tedeschi sapevano essere educati,
altri per gentilezza innata, altri ancora perché la bella giornata e una sorta di
pienezza fisica generata dall'aria aperta, dalla sana fatica e dall'attesa del
riposo li mettevano in quello stato di esaltazione, di forza interiore in cui
l'uomo si sente tanto più generoso con i deboli quanto più propenso a
mostrarsi crudele con i forti (probabilmente lo stesso istinto che in
primavera spinge i maschi degli animali a battersi fra loro e a mordicchiare
l'erba, a giocare e a saltellare davanti alle femmine) Un giovane soldato
accompagnò una donna fino alla casa dove quella abitava, reggendo con
aria compunta due bottiglie di vino bianco che lei aveva tirato su dal pozzo.
Era un uomo giovanissimo con gli occhi chiari, il naso all'insù e un bel paio
di braccia robuste.
"Belle," disse guardando le gambe della donna "belle, signora...".
Lei si voltò mettendosi un dito sulle labbra.
"Sss... Mio marito...".
"Ah, marito, base... cattivo" esclamò lui facendo finta di avere molta
paura.
Dietro la porta chiusa il marito ascoltava e, poiché era assolutamente
sicuro di sua moglie, non provava rabbia, bensì una sorta di orgoglio:
"Visto? Abbiamo delle belle donne, noi!" pensava. E il suo primo vinello
bianco del mattino gli sembrava ancora più gustoso.
Alcuni soldati entrarono nella bottega dello zoccolaio, un mutilato di
guerra che stava lavorando chino sul suo banco. Nell'aria fluttuava un odore
vegetale e penetrante di legno fresco e da alcuni ceppi di pino appena
tagliati stillavano ancora gocce di resina. Sopra una mensola erano allineati
gli zoccoli già pronti, decorati con chimere, serpenti, teste di bue in rilievo.
A un paio era stata data la forma di grugnì di maiale. Uno dei tedeschi li
guardò ammirato.
"Un lavoro stupendo" disse.
Lo zoccolaio, un tipo malaticcio e taciturno, non rispose, ma la moglie,
che stava apparecchiando la tavola, non poté trattenersi dal domandare con
curiosità:
"Che cosa faceva in Germania?"
Il soldato non capì subito, poi disse che da civile faceva il fabbro. La
donna rifletté un attimo e sussurrò all'orecchio del marito:
"Dovremmo fargli vedere la chiave della credenza che si è rotta, magari
potrebbe aggiustarla...".
"Lascia perdere" fece il marito aggrottando le sopracciglia.
"Voi... pranzo?" continuò il soldato. E indicando il pane bianco che stava
in un piatto decorato a fiori: "Pane francese... leggero... Nello stomaco
niente..." aggiunse.
Intendeva dire che quel pane non gli sembrava nutriente, che non
riempiva lo stomaco, ma i francesi non potevano credere che qualcuno fosse
così pazzo da disconoscere la squisitezza di una delle loro specialità, e
soprattutto di quelle pagnotte dorate, di quei grandi pani a forma di corona
che presto sarebbero stati sostituiti, si diceva, da una miscela di crusca e
farina di qualità inferiore. Non potevano credere a un giudizio negativo sul
loro pane. Presero le parole del tedesco per un complimento e si sentirono
lusingati. Persino la fisionomia dello zoccolaio parve assumere
un'espressione meno arcigna.
Si mise a tavola con tutta la famiglia mentre i tedeschi sedevano un po’ in
disparte, sugli sgabelli.
"E il paese vi piace?" continuò la moglie dell'artigiano.
Era di carattere socievole e soffriva dei lunghi silenzi del marito.
"Oh, sì... bello...".
"E da voi com'è? Un po’ come da queste parti?" domandò all'altro
soldato.
Il volto dell'uomo denotò una forte agitazione; era chiaro che si ostinava a
cercare le parole per descrivere il proprio paese, i suoi campi di luppolo o le
sue folte e rigogliose foreste. Ma non riuscì a esprimersi, si accontentò di
allargare le braccia. "Grande... buona terra...".
E dopo una pausa sospirò.
"Lontano...".
"Ha famiglia?"
Il soldato fece segno di sì.
Ma lo zoccolaio disse alla moglie:
"Che bisogno hai di parlarci?"
La donna arrossì di vergogna e continuò ad affaccendarsi in silenzio,
versando il caffè, tagliando e imburrando le fette di pane per i bambini.
Dall'esterno saliva un allegro brusio. Le risa, il clangore delle armi, i passi e
le voci dei soldati creavano un suono festoso. Non si sapeva perché, ma ci si
sentiva il cuore leggero. Che fosse a causa del bel tempo? Quel cielo, così
azzurro, sembrava inclinarsi dolcemente verso l'orizzonte e accarezzare la
terra. Alcune galline accovacciate nella polvere ogni tanto agitavano le
penne con un sonnacchioso coccodè.
Nell'aria volavano fuscelli di paglia, lanugine, un polline impalpabile: era
la stagione dei nidi.
Da lungo tempo il paese mancava di uomini, cosicché perfino questi, gli
invasori, parevano al posto giusto. Loro lo intuivano e si crogiolavano
beatamente al sole; vedendoli, le madri dei prigionieri e dei soldati uccisi in
guerra invocavano sottovoce su di loro la maledizione del Cielo, ma le
ragazze se li mangiavano con gli occhi.
CAPITOLO 7.
In un'aula vuota della scuola le signore del paese e alcune importanti
fattoresse dei dintorni si erano riunite per la seduta mensile dedicata al
Pacco Viveri per i prigionieri. Il comune si era fatto carico dei trovatelli
abitanti nella regione prima della guerra e fatti poi prigionieri. Presidentessa
dell'ente era la viscontessa di Montmort. Una giovane donna timida e brutta,
che soffriva le pene dell'inferno ogniqualvolta doveva parlare in pubblico;
balbettava, le sudavano le mani, le tremavano le gambe; insomma, veniva
presa dal panico come chiunque altro. Ma lo considerava un dovere,
pensava di essere destinata per diritto di natura a illuminare quelle borghesi
e quelle contadine, a indicare loro la strada, a fare dei loro cuori un fertile
terreno in cui seminare la buona parola.
"Capite, Amarume," spiegava al marito "non posso credere che ci sia una
differenza essenziale fra me e loro. Anche se mi deludono continuamente
(sono così volgari, così meschine, sapeste!), io insisto nel cercare in loro
una luce... Sì," aggiungeva alzando su di lui gli occhi che si andavano
riempiendo di lacrime, giacché era facile al pianto "sì, Nostro Signore non
sarebbe morto per queste povere anime se non ci fosse stato qualcosa in
loro... Ma l'ignoranza, amico mio, l'ignoranza nella quale vivono è
spaventosa. Così, all'inizio di ogni riunione, faccio un breve discorso
affinché capiscano perché sono state punite dalla sorte, e (ridete pure,
Amaury) qualche volta ho visto spuntare su quelle facce grossolane un
lampo di comprensione. Rimpiango" concludeva pensosa la viscontessa "di
non aver seguito la mia vocazione: avrei voluto predicare il Vangelo in una
contrada deserta, essere il braccio destro di un missionario nella savana o
nella foresta vergine. Basta, non pensiamoci più. La nostra missione è là
dove il Signore ci ha mandato".
Adesso era in piedi su una piccola pedana nell'aula scolastica sgombrata
in fretta e furia di tutti i banchi; una dozzina di allieve, scelte fra le più
meritevoli, erano state ammesse ad ascoltare le parole della viscontessa. Le
ragazze sfregavano il pavimento con gli zoccoli e si guardavano intorno con
i loro occhioni pacifici "come tante vacche", pensò la viscontessa con una
certa irritazione. Decise comunque di rivolgersi specialmente a loro.
"Mie care ragazze," esordì "voi siete state precocemente colpite dai dolori
della Patria...".
Una delle ragazzine ascoltava con tanta attenzione che cadde a terra dallo
sgabello sul quale era seduta; le altre undici soffocarono la ridarella
nascondendo la faccia nei grembiuli. La viscontessa corrugò la fronte e
continuò con voce più forte.
"Vi dedicate ai giochi della vostra età, sembrate spensierate, ma il vostro
cuore è pieno di tristezza. Quante preghiere levate mane e sera a Dio
Onnipotente affinché abbia pietà delle sciagure della nostra cara Francia!"
Si interruppe e rivolse un saluto molto freddo alla maestra della scuola
elementare laica che stava entrando in quel momento: una donna che non
andava a messa e che aveva fatto seppellire il marito con il solo rito civile.
Le sue scolare aggiungevano addirittura che non era neanche stata
battezzata, il che sembrava, più che scandaloso, del tutto inverosimile, come
se si fosse detto di una creatura umana che era nata con una coda di pesce. Il
comportamento di quella persona era irreprensibile, e ciò faceva sì che la
viscontessa la odiasse ancora di più: "Capite," spiegava al visconte "se
bevesse o avesse degli amanti si potrebbe giustificarlo con la mancanza di
religione, ma rendetevi conto, Amaury, della confusione che può nascere
nella mente del popolo quando vede la virtù praticata da gente che la pensa
a quel modo" Poiché la presenza della maestra le riusciva odiosa, la
viscontessa mise in qualche modo nella sua voce un po’ del calore
appassionato che ci ispira la vista di un nemico, e continuò il suo discorso
con grande eloquenza:
"Ma le preghiere e le lacrime non bastano. Non lo dico solo per voi; lo
dico per le vostre madri. Dobbiamo praticare la carità. E invece, che cosa
vedo? Nessuno pratica la carità, nessuno si sacrifica per gli altri. Non vi
chiedo denaro; il denaro, ahimè, non può far molto di questi tempi" fece la
viscontessa con un sospiro, ricordando che aveva pagato ottocentocinquanta
franchi le scarpe che portava ai piedi (fortunatamente, il visconte era il
sindaco del paese e lei poteva avere tutte le tessere e i buoni che le
servivano per l'acquisto di calzature) "No, non è il denaro ciò che vi chiedo,
ma i prodotti alimentari di cui la campagna è così ricca e di cui vorrei
rifornire i pacchi per i nostri prigionieri. Ciascuna di voi pensa al proprio
marito, al proprio figlio, al fratello, al padre prigioniero, e per loro non ci
sono difficoltà; gli si manda burro, cioccolato, zucchero, tabacco: ma quelli
che non hanno una famiglia? Ah, signore, pensate, pensate a quegli infelici
che non ricevono mai né pacchi né notizie!
Vediamo un po’, cosa potete fare per loro? Accetto tutti i vostri doni, li
raccolgo, e poi li mando alla Croce Rossa, che li distribuirà nei diversi
campi di prigionia. A voi la parola, signore".
Seguì un gran silenzio; le contadine guardavano le borghesi, e queste
ultime, stringendo le labbra, osservavano le contadine.
"Allora comincio io" disse la viscontessa, tutta miele. "Ecco la mia idea:
nel prossimo pacco si potrebbe aggiungere una lettera scritta da una di
queste bambine. Una lettera in cui, con parole semplici e toccanti, la piccola
aprirà il suo cuore e esprimerà i suoi sentimenti patriottici e il suo dolore per
i mali della Francia. Pensate," continuò con voce vibrante "pensate alla
gioia del povero derelitto che leggerà quelle righe e vi sentirà palpitare
l'anima del paese, righe che gli ricorderanno gli uomini, le donne, i bambini,
gli alberi, le case della sua piccola patria, quella, come dice il poeta, che ci
fa amare di più la grande. E soprattutto, bambine mie, lasciate parlare il
cuore, non cercate il bello stile: taccia il talento epistolare e parli solo il
cuore. Ah, il cuore," disse socchiudendo gli occhi "niente di bello, niente di
grande si fa senza di lui. Potrete mettere nella lettera qualche piccolo fiore
di campo, una margheritina, una primula... Non penso sia proibito dai
regolamenti. Vi piace l'idea?" domandò inclinando appena il capo di lato
con un grazioso sorriso. "Ma via, ho parlato abbastanza. Ora tocca a voi".
La moglie del notaio, una virago baffuta, dai lineamenti severi, disse con
tono aspro:
"Non ci manca certo il desiderio di viziare i nostri cari prigionieri.
Ma che cosa possiamo fare, noi, poveri abitanti del borgo? Non abbiamo
niente. Né vaste tenute come lei, signora viscontessa, né ricche fattorie
come la gente di campagna. Abbiamo molta difficoltà anche a nutrire noi
stessi. Mia figlia, che ha appena partorito, non trova il latte che le serve per
il bambino. Le uova costano due franchi l'una e sono diventate una rarità"
"Vorrebbe forse insinuare che noialtre facciamo del mercato nero?"
domandò Cecile Labarie, che era presente alla riunione. Quando montava in
collera, il collo le si gonfiava come quello di un tacchino e il volto le
diventava violaceo.
"Non voglio dire questo, ma...".
"Signore, signore..." mormorò la viscontessa, e pensò scoraggiata: "Non
c'è niente da fare, decisamente non hanno alcuna sensibilità, non capiscono
niente, sono anime vili. Che dico? Anime? Sono ventri dotati di parola"
"É brutto sentire queste cose," continuò Cecile facendo spallucce "è brutto
vedere case dove c'è ogni ben di Dio e dove si piange miseria.
Suvvia, si sa benissimo che i borghesi hanno di tutto. Aprite le orecchie:
di tutto! Credete che non si sappia chi fa razzia di carne?
Raccolgono i tagliandi nelle diverse proprietà. É risaputo. Cento soldi la
tessera per la carne. Chi ha denaro, naturalmente, se lo può permettere, ma i
poveri...".
"Dobbiamo pur mangiare carne anche noi, signora" disse maestosamente
la moglie del notaio pensando con angoscia che l'avevano vista uscire dal
negozio del macellaio con un cosciotto di agnello (il secondo dall'inizio
della settimana) "Non uccidiamo il maiale, noi! Non abbiamo, nella nostra
cucina, prosciutti, pezzi di lardo e salsicce lasciate seccare e che si
preferisce veder andare a male piuttosto che regalarle ai poveri delle città"
"Signore, signore," supplicò la viscontessa "pensate alla Francia, elevate i
vostri cuori... Controllatevi! Mettete a tacere questi penosi dissensi. Pensate
alla situazione in cui ci troviamo! Rovinati, sconfitti... Con una sola
consolazione: il nostro caro Maresciallo... E voi parlate di uova, di latte e di
maiali! Che importa il cibo? Via, signore, tutto questo è volgare! Abbiamo
ben altri motivi di tristezza.
Di che si tratta, in fondo? Di un po’ di aiuto reciproco, di un po’ di
tolleranza. Stiamo unite, come lo erano i soldati del '14 nelle trincee, come
lo sono, di certo, i nostri cari prigionieri nei loro campi, dietro il filo
spinato...".
Strano. Fino a quel momento l'avevano ascoltata appena. Quelle sue
esortazioni erano un po’ come i sermoni del parroco che si ascoltano senza
capirli. Ma l'immagine del campo di prigionia tedesco, con gli uomini
rinchiusi e ammassati come bestie dietro il filo spinato, le commosse.
Laggiù ognuna di quelle forti e rudi creature aveva un essere caro; lavorava
per lui; risparmiava per lui; sotterrava del denaro per il suo ritorno, affinché
lui dicesse: "Hai mandato avanti bene la baracca, moglie mia. Brava".
Ciascuna rivide col pensiero l'assente, uno solo, il proprio; ciascuna
immaginò a suo modo il luogo in cui era prigioniero; chi pensava a foreste
di pini, chi a una stanza fredda, chi ai muri di una fortezza, ma tutte finivano
per avere davanti agli occhi l'immagine di quei chilometri di filo spinato che
segregava gli uomini e li separava dal resto del mondo. Borghesi e
contadine sentirono gli occhi riempirsi di lacrime.
"Le porterò qualcosa" disse una di loro.
"Troverò anch'io un po’ di roba da mangiare" sospirò un'altra.
"Vedrò cosa posso fare" promise la moglie del notaio.
La signora di Montmort si affrettava a prendere nota delle offerte.
Ognuna si alzava dal suo posto, andava verso la presidentessa e le
sussurrava qualcosa all'orecchio, perché adesso erano impietosite,
commosse, volevano dare, non solo ai figli e ai mariti, ma agli sconosciuti,
agli orfani del Patronato. Purtuttavia diffidavano della vicina; non volevano
sembrare più ricche di quanto fossero; temevano le denunce: in tutte le case
le cibarie più prelibate venivano nascoste; madre e figlia si spiavano e si
denunciavano a vicenda; le massaie chiudevano la porta della cucina al
momento dei pasti affinché l'odore non tradisse la presenza del lardo che
rosolava in padella, o della fetta di carne proibita, o del dolce fatto con fior
di farina. La signora di Montmort annotava:
"Signora Bracelet, fattoria delle Roches, due salsicce, un barattolo di
miele, uno di ciccioli... Signora Joseph, tenuta del Rouet, due faraone in
conserva, burro salato, cioccolato, caffè, zucchero...".
"Posso contarci, vero, signore?" disse ancora la viscontessa.
Le contadine la guardarono allibite: non si rimangiavano le promesse,
loro. Presero congedo tendendo alla nobildonna una mano rossa, screpolata
dal freddo, dalla cura delle bestie, dal bucato, e ogni volta la viscontessa
doveva fare un piccolo sforzo per stringere quelle dita il cui contatto le era
fisicamente sgradevole. Ma controllava quel sentimento contrario alla carità
cristiana sforzandosi anche, per spirito di mortificazione, di baciare i
bambini che accompagnavano le donne; bambini grassi e rosei, ben pasciuti
e con la faccia sporca come tanti maialini.
Alla fine l'aula restò vuota. La maestra aveva fatto uscire le ragazzine, le
contadine se n'erano andate. La viscontessa sospirò, non di stanchezza, ma
di disgusto. Com'era brutta e volgare l'umanità! Che fatica far palpitare una
piccola luce d'amore in quelle anime squallide... "Puah!" disse a voce alta,
ma, come la esortava a fare il suo direttore spirituale, offrì a Dio le fatiche e
le opere di quella giornata.
CAPITOLO 8.
"E cosa pensano i francesi dell'esito della guerra?" domandò Bonnet
rivolgendosi a Benoît.
Le donne si guardarono con un'espressione scandalizzata. Questo non
stava bene. Con un tedesco non si parlava della guerra, né di quella in corso
né dell'altra, né del maresciallo petain, né di Mers-el-Kebir, né della
divisione della Francia in due zone, né delle truppe di occupazione, né di
fatti importanti. C'era un solo atteggiamento possibile: manifestare una
fredda indifferenza - e proprio così Benoît rispose alzando il bicchiere pieno
fino all'orlo di vino rosso:
"Se ne fregano, signore"
Era sera. Il tramonto, puro e glaciale, annunciava una notte di gelo, ma
l'indomani probabilmente il tempo sarebbe stato splendido. Bonnet aveva
passato tutta la giornata in paese. Era appena rientrato e, prima di salire
nella sua camera, per una sorta di condiscendenza, o per gentilezza naturale,
desiderio di farsi benvolere o di scaldarsi un momento vicino al fuoco, si era
trattenuto nella sala comune. La cena era terminata; solo Benoît indugiava a
tavola; le donne, già in piedi, mettevano in ordine la stanza e rigovernavano.
Il tedesco osservò con curiosità il grande letto inutilizzato.
"Non ci dorme nessuno, vero? Non serve a niente... Che strano!".
"Qualche volta serve" disse Madeleine che aveva sempre in mente JeanMarie.
Credeva che nessuno le avrebbe letto nel pensiero, ma Benoît si fece
scuro in volto: ogni allusione agli eventi dell'estate precedente gli feriva il
cuore con la rapidità e la precisione di una freccia, ma era una faccenda
sua... solo sua. Rintuzzò con un'occhiata il piccolo sogghigno di Cecile e
con estrema cortesia rispose al tedesco:
"A volte, non si sa mai, potrebbe servirle, se per caso le succedesse
qualcosa (non che glielo auguri...). Ci mettiamo i morti, noi, su quei letti"
Bonnet lo guardò divertito, con un pizzico di quella sprezzante pietà che
si prova vedendo una bestia feroce digrignare i denti dietro le sbarre di una
gabbia. "Per fortuna," pensò "quest'uomo, preso dal suo lavoro, non sarà
spesso in casa... e le donne sono più alla mano".
"In tempo di guerra, nessuno di noi si aspetta di morire in un letto" disse
sorridendo.
Madeleine, intanto, era uscita in giardino; ne tornò con un fascio di fiori
per abbellire il caminetto. Erano i primi lillà, di un bianco niveo, con le
punte verdeggianti - piccole gemme compatte e ancora chiuse sopra
profumati grappoli già sbocciati. Bonnet affondò la faccia pallida nel mazzo
di fiori.
"Stupendo! E come sa disporli bene...".
Per un attimo i due rimasero in piedi, a fianco a fianco e senza parlare.
Benoît pensava che lei (sua moglie, la sua Madeleine) sembrava sempre a
proprio agio quando si dedicava a un'occupazione da signora - quando
coglieva dei fiori, o si lucidava le unghie, o si pettinava in un modo diverso
da quello delle donne del posto, quando parlava con un estraneo, quando
teneva fra le mani un libro...
"Non si dovrebbe prendere una trovatella, non si sa da dove viene" pensò
ancora una volta, sconsolato - e quando pensava: "non si sa da dove viene"
quello che immaginava e che temeva non era una qualche ascendenza da
alcolizzati o da ladri, ma un'eredità borghese che la faceva sospirare: "Ah,
che noia la campagna..." oppure: "Vorrei delle cose belle...", e che la legava,
secondo lui, in una oscura complicità a uno sconosciuto, a un nemico,
purché fosse un signore, purché avesse biancheria fine e mani bianche.
Spinse violentemente indietro la sedia e uscì. Era l'ora di far rientrare le
bestie. Indugiò qualche minuto nell'ombra e nel tepore della stalla. Una
mucca aveva figliato il giorno prima e leccava amorevolmente il vitellino
dalla grossa testa e dalle sottili zampe tremanti. Un'altra soffiava piano nel
suo angolo. Benoît ascoltò quei respiri calmi e profondi. Da dove si trovava
vedeva la porta di casa, aperta; un'ombra si stagliò sulla soglia. Qualcuno si
preoccupava della sua assenza, lo cercava. Sua madre o Madeleine? Sua
madre, certo... Solo sua madre, ahimè... Non si sarebbe mosso da lì finché il
tedesco non fosse entrato in camera. Lo avrebbe visto accendere la lampada.
Infatti, pochi istanti dopo, una luce brillò alla finestra del piano di sopra.
Nello stesso momento l'ombra in attesa sulla soglia di casa si mosse e
corse fino a lui, leggera. A Benoît si allargò il cuore, come se una mano
invisibile gli avesse improvvisamente tolto dal petto un peso che da tempo
lo opprimeva.
"Sei qui, Benoît?"
"Sì, sono qui"
"Che cosa fai? Avevo paura"
"Paura? E di che? Sei pazza"
"Non lo so. Vieni".
"Aspetta. Aspetta un momento".
La attirò a sé. Lei si dibatteva e faceva finta di ridere, ma lui sentiva, da
un certo irrigidirsi di tutto il corpo, che non aveva voglia di ridere, che non
lo trovava divertente, che non le piaceva essere spinta in mezzo al fieno e
rovesciata sulla paglia fresca, che non lo amava... No, non lo amava... Non
provava piacere con lui. E le disse piano, con voce sorda:
"Cos'è, non ti piace?"
"Sì che mi piace... Ma non qui, non così, Benoît. Mi vergogno".
"Di chi? Delle vacche che ti guardano?" disse lui in tono aspro. "Su,
vattene!"
Allora lei sbottò in quel lamento desolato che gli faceva venir voglia di
piangere e insieme di ucciderla.
"Come mi parli? Qualche volta si direbbe che ce l'hai con me. Perché? É
Cecile che...".
Le mise una mano sulla bocca, ma lei la scostò con violenza e finì la
frase:
"É lei che ti monta la testa"
"Nessuno mi monta la testa. Non vedo con gli occhi degli altri, io. So solo
che quando mi avvicino a te mi sento sempre dire: "Un momento.
Un'altra volta. Non adesso, il bambino mi ha stancata". Chi è che ti
aspetta?" ringhiò. "Per chi ti conservi? Allora?".
"Lasciami!" gridò lei cercando di liberare braccia e fianchi dalla sua
stretta convulsa. "Lasciami! Mi fai male".
La respinse con tanta violenza da farle sbattere la fronte contro la porta.
Si guardarono un momento in silenzio. Lui aveva preso un rastrello e
smuoveva rabbiosamente la paglia.
"Sbagli" disse infine Madeleine. E con voce tenera mormorò: "Benoît...
Mio povero piccolo Benoîtà Sbagli a farti certe idee... Sono la tua donna,
dai; se qualche volta ti sembro fredda è perché sono stanca per via del
bambino. Ecco tutto".
"Usciamo di qua" disse lui bruscamente. "Andiamo a dormire".
Attraversarono la sala vuota e scura. C'era ancora un po’ di luce, ma solo
nel cielo e sulle cime degli alberi. Il resto - la terra, la casa, i prati - era
immerso in una fresca oscurità. Si spogliarono e andarono a letto. Quella
notte lui non cercò di prenderla. Rimasero distesi, immobili, senza dormire,
ascoltando il respiro del tedesco e gli scricchiolii del suo letto sopra le loro
teste. Nelle tenebre Madeleine cercò la mano del marito e la strinse con
forza.
"Benoît!"
"Che c'è?"
"Benoît, mi è venuto in mente adesso... Devi nascondere il fucile. Hai
letto gli avvisi in paese?"
"Sì che li ho letti" disse lui con una certa ironia. "Verboten.
Verboten. Pena la morte... Hanno solo queste parole in bocca, quei
bestioni"
"Dove lo nascondiamo?"
"Lascialo stare, sta bene dove sta"
"Benoît, non essere testardo! E una cosa seria. Lo sai quanti ne hanno
fucilati per non aver consegnato le armi alla Kommandantur!"
"Vorresti che vada a consegnare il fucile? Ma solo i vigliacchi lo fanno!
Non ho paura di loro, io. Lo sai come sono scappato, l'estate scorsa? Ne ho
fatti fuori due. Non gli ho lasciato il tempo di aprir bocca! E ne ammazzerò
ancora" fece con rabbia, mostrando il pugno nell'ombra al tedesco
invisibile.
"Non ti dico di consegnarlo, ma di nasconderlo, di sotterrarlo... I
nascondigli non mancano"
"Impossibile"
"Ma perché?"
"Devo averlo sottomano. Non posso lasciare che volpi, faine e puzzole si
avvicinino alla casa... Il parco del castello, lassù, ne è pieno. Il visconte ha
troppa fifa. Se la fa addosso. Non ne farebbe fuori una, di quelle bestie. Lui
sì che ha consegnato il fucile alla Kommandantur, e con tanti
salamelecchi... "Prego, signori, vogliate farmi l'onore di...". Per fortuna io e
altri compagni perlustriamo il parco di notte, altrimenti sarebbe la rovina
per il paese"
"Non sentono gli spari?"
"Figurati! É grande come una foresta"
"Ci vai spesso?" disse Madeleine, incuriosita. "Non lo sapevo".
"Ci sono tante cose che non sai, ragazza mia... Andiamo a prendere le sue
piante di pomodori e di barbabietole, la sua frutta, tutto quello che non
vuole vendere. Il visconte...".
Tacque, restò pensoso un istante.
"Il visconte è uno dei peggiori..." aggiunse poi.
Da generazioni i Labarie erano mezzadri sulle terre dei Montmort. E da
generazioni li odiavano e ne erano odiati. I Labarie dicevano che i
Montmort erano spietati con i poveri, orgogliosi, subdoli, e i Montmort
accusavano i loro mezzadri di "malafede": espressione che pronunciavano
sottovoce, stringendosi nelle spalle e alzando gli occhi al cielo - ma che
significava più cose di quanto i Montmort stessi credessero. Era un modo di
concepire la povertà, la ricchezza, la pace, la guerra, la libertà, la proprietà,
che in sé non aveva nulla di meno ragionevole rispetto a quello dei
Montmort, eppure era antitetico al loro, come il fuoco all'acqua. Adesso,
poi, si erano aggiunti altri motivi di risentimento. Agli occhi del visconte,
Benoît era un soldato del '40; ed era proprio la mancanza di disciplina dei
soldati, il loro scarso patriottismo, la loro "malafede" insomma, la causa
della sconfitta, pensava, mentre Benoît vedeva in Montmort uno di quegli
eleganti ufficiali in ghette gialle che durante le giornate di giugno filavano
verso la frontiera spagnola, belli comodi nelle loro automobili, con le loro
mogli e le loro valigie. Per non parlare del "collaborazionismo"...
"E un leccapiedi dei tedeschi" disse cupamente Benoît.
"Sta attento" ribatté Madeleine. "Ti scopri troppo quando parli. E non
essere villano con il tedesco che abbiamo in casa...".
"Se prova a ronzarti intorno, io...".
"Ma sei pazzo!"
"Non sono cieco"
"Sei geloso anche di questo qui, adesso!" esclamò Madeleine.
Subito rimpianse le parole che le erano sfuggite: non bisognava dare
corpo, nome, alle fantasie del geloso. Ma, dopo tutto, a che pro tacere quello
che tutti e due sapevano?
"Per me, i due sono la stessa cosa" fu la risposta di Benoît.
Quel genere di uomini ben rasati, ben lavati, dalla parola pronta e facile,
quelli che le ragazze guardano... loro malgrado... perché sono lusingate di
essere scelte e ammirate da veri signori... Ecco quello che voleva dire
Benoît, pensò Madeleine. Se avesse saputo! Se avesse sospettato che lei
aveva amato Jean-Marie dal primo istante in cui lo aveva visto arrivare,
stanco, infangato, con l'uniforme insanguinata, disteso su una barella!
Amato. Sì. E nella notte, nel segreto del suo cuore, mille e mille volte
ripeté: "L'ho amato. Ecco. Lo amo ancora. Non c'è niente da fare"
Al primo canto rauco del gallo che squarciava l'alba, tutti e due si
alzarono senza aver dormito. Lei andò a scaldare il caffè, lui a strigliare le
bestie.
CAPITOLO 9.
Lucile Angellier, con un libro e un lavoro di cucito, si era seduta
all'ombra dei ciliegi. Era l'unico angolo del giardino in cui avevano lasciato
crescere liberamente alberi e piante senza preoccuparsi di ciò che avrebbero
potuto produrre; quei ciliegi, infatti, davano pochi frutti. Ma era la stagione
dei fiori. Sullo sfondo di un cielo di puro e inalterabile azzurro, l'azzurro
delle preziose porcellane di Sevres, insieme ricco e brillante, ondeggiavano
rami che sembravano coperti di neve; in quel giorno di maggio l'alito di
vento che li muoveva era ancora freddo, e i petali se ne difendevano
dolcemente, si accartocciavano con una sorta di grazia freddolosa, girando
verso il suolo i pistilli biondi del loro cuore. Il sole, infilandosi tra i rami,
rivelava un intreccio di venuzze delicate, visibili nel candore dei petali, che
alla fragilità, all'immaterialità del fiore aggiungevano qualcosa di vivo, di
quasi umano nel senso della debolezza e della resistenza che la parola
umana comporta. Il vento infatti poteva scuotere quelle incantevoli creature
senza distruggerle, senza neppure sgualcirle: esse si lasciavano dondolare
con aria sognante, sembravano sul punto di cadere, ma erano solidamente
attaccate ai loro rami sottili, lucenti e duri, rami che nell'aspetto avevano
qualcosa di metallico, come il tronco stesso, slanciato, levigato, uniforme,
dai riflessi grigi e purpurei. Fra i ciuffi bianchi apparivano piccole foglie
allungate; nell'ombra erano di un verde tenero, coperte da una peluria
d'argento; al sole, sembravano rosa. Il giardino costeggiava una strada
stretta, una viuzza di campagna lungo la quale sorgevano delle casette che i
tedeschi avevano adibito a deposito di esplosivi. Una sentinella andava su e
giù sotto il cartello rosso che recava scritto a lettere cubitali:
VERBOTEN E sotto, a caratteri più piccoli, in francese:
É PROIBITO AVVICINARSI, PENA LA MORTE
I soldati strigliavano i cavalli, fischiettando, e i cavalli mangiavano i
nuovi germogli degli alberi. In tutti i giardini ai lati della strada c'erano
uomini che lavoravano tranquillamente. In maniche di camicia, pantaloni di
velluto, cappello di paglia, vangavano, sfrondavano, innaffiavano,
seminavano, piantavano. A volte un soldato tedesco entrava dal cancelletto
di uno di quei giardini e chiedeva del fuoco per la pipa, o un uovo, o un
bicchiere di birra. L'uomo lo accontentava, poi, appoggiandosi alla vanga, lo
guardava allontanarsi con aria pensosa, e alla fine riprendeva il lavoro con
un'alzata di spalle che significava un'infinità di pensieri - così numerosi,
così profondi, così gravi e strani che lui non trovava le parole per
esprimerli.
Lucile aggiungeva qualche punto al suo ricamo, poi lo lasciava cadere in
grembo. Sopra la sua testa i fiori di ciliegio attiravano vespe e api; le si
vedeva andare e venire, volteggiare, penetrare nei calici e bere avidamente a
testa bassa, il corpo fremente in una sorta di spasmodica allegria, mentre un
grosso calabrone dorato, che sembrava farsi beffe di quelle solerti
lavoratrici, si dondolava sull'ala del vento come su un'amaca, muovendosi
appena e riempiendo l'aria del suo canto placido e solare.
Dalla sua postazione Lucile poteva vedere, a una finestra, l'ufficiale
tedesco che alloggiava da loro e che, da qualche giorno, aveva preso con sé
il cane lupo del reggimento. Stava seduto alla scrivania Luigi XIV nella
camera di Gaston; scuoteva la cenere della pipa in una tazza azzurra che la
vecchia signora Angellier un tempo usava per la tisana del figlio; col tacco
degli stivali dava piccoli colpi distratti ai fregi in bronzo dorato che
ornavano le gambe della scrivania. Il cane, con il muso appoggiato alla
gamba del tedesco, abbaiava e dava strattoni al guinzaglio. Allora l'ufficiale
gli diceva, in francese e a voce abbastanza alta perché Lucile lo sentisse
(nella quiete di quel giardino i suoni aleggiavano a lungo, come portati dalla
brezza tranquilla):
"No, Bubi, niente passeggiata. Mangeresti le insalate delle signore e loro
non sarebbero contente; direbbero che siamo dei soldatacci maleducati.
Dobbiamo starcene qui, Bubi, e accontentarci di guardare il bel giardino"
"Che tipo!" pensò Lucile, e non poté fare a meno di sorridere.
L'ufficiale continuò:
"Peccato, vero, Bubi? Ti piacerebbe fare dei buchi nella terra col naso,
immagino. Se in casa ci fosse un bambino, sarebbe possibile... Ci farebbe
segno di scendere. Siamo sempre andati d'accordo con i bambini, ma qui ci
sono solo due signore molto serie, molto silenziose e...
Meglio restare dove siamo, Bubi!"
Aspettò ancora un istante, e poiché Lucile taceva, parve deluso. Si sporse
di più dalla finestra, fece un grande inchino e domandò, cerimonioso:
"Avrebbe qualcosa in contrario, signora, a lasciarmi cogliere delle fragole
nelle sue aiuole?"
"Lei qui è a casa sua" disse Lucile con vivacità non priva d'ironia.
L'ufficiale si inchinò di nuovo.
"Non mi permetterei mai, mi creda, di chiederglielo per me, ma questo
cane va pazzo per le fragole. Tengo d'altronde a farle notare che si tratta di
un cane francese. É stato trovato in Normandia, in un villaggio abbandonato
durante la battaglia, e raccolto dai miei camerati. Non vorrà rifiutare le sue
fragole a un compatriota".
"Siamo due idioti" pensò Lucile, che rispose semplicemente:
"Venite pure, lei e il suo cane, e prendete quello che volete"
"Grazie, signora" esclamò allegramente l'ufficiale, e uscì subito, saltando
dalla finestra, seguito dal cane.
Si avvicinarono entrambi a Lucile; il tedesco sorrise.
"Sono molto indiscreto, signora, non me ne voglia, ma questo giardino,
questi ciliegi, sono un angolo di paradiso per un povero soldato"
"Ha passato l'inverno in Francia?" domandò Lucile.
"Sì, nel Nord, tra la caserma e il caffè per via del brutto tempo.
Abitavo presso una giovane donna; la poverina si era appena sposata e
due settimane dopo il marito era stato fatto prigioniero. Quando mi
incontrava nel corridoio scoppiava a piangere, e io mi sentivo un criminale.
Non era colpa mia... Avrei potuto dirle che anch'io ero sposato, e che la
guerra mi aveva separato da mia moglie"
"Lei è sposato?"
"Sì. La stupisce? Da quattro anni sposato e da quattro anni soldato".
"É così giovane!"
"Ho ventiquattro anni, signora"
Rimasero in silenzio. Lucile tornò al suo ricamo. L'ufficiale, con un
ginocchio piegato a terra, si mise a raccogliere fragole; le teneva nel cavo
della mano, dove Bubi le prendeva allungando il muso umido e nero.
"Vive sola qui con sua madre?"
"E la madre di mio marito; lui è prigioniero. Può farsi dare un piatto in
cucina per le sue fragole"
"Ah, molto bene... Grazie, signora".
Tornò qualche minuto dopo con un grande piatto azzurro e proseguì nella
raccolta. Poi offrì le fragole a Lucile che ne prese qualcuna e gli disse di
mangiare le altre. Stava in piedi davanti a lei, appoggiato al tronco di un
ciliegio.
"E bella la sua casa, signora"
Vapori leggeri velavano il cielo, e sotto quella luce smorzata la casa
aveva una tonalità ocra, quasi rosa, che ricordava il colore di certi gusci
d'uovo; Lucile, da bambina, le chiamava uova brune e le sembravano più
saporite delle altre, di quelle bianche deposte dalla maggior parte delle
galline. Quel ricordo la fece sorridere; guardò la casa, con il tetto di ardesia
grigioazzurra, le sedici finestre dalle imposte prudentemente accostate
affinché il sole primaverile non sbiadisse le tappezzerie e, nel frontone, la
grande campana arrugginita che non suonava più, con la tettoia di vetro su
cui si rifletteva il cielo.
Domandò:
"La trova bella?"
"Sembra la casa di un personaggio di Balzac. Deve averla fatta costruire
un ricco notaio di provincia che si è ritirato in campagna. Me lo vedo, la
notte, nella camera che occupo io, mentre conta i rotoli di luigi d'oro.
Doveva essere un libero pensatore, ma la moglie andava alla prima messa
del mattino, quella che sento suonare quando torno dalle manovre notturne.
E quella donna doveva essere bionda, rosea, e avere sulle spalle un grande
scialle di cachemire"
"Chiederò a mia suocera" disse Lucile "chi ha fatto costruire questa casa.
I genitori di mio marito erano proprietari terrieri, ma nell'Ottocento devono
esserci stati dei notai, degli avvocati, dei medici e, prima ancora, dei
contadini. So che centocinquant'anni fa qui c'era la loro fattoria"
"Deve chiederlo a sua suocera? Lei non lo sa? La cosa non le interessa,
signora?"
"Non saprei," disse Lucile "ma della casa in cui sono nata sì che potrei
dirle quando è stata costruita e da chi. Qui ci vivo, ma non ci sono nata"
"Dov'è nata?"
"Non molto lontano, ma in un'altra provincia. Una casa nei boschi...
Dove gli alberi crescono così vicini al salotto che d'estate tutto è immerso
in un'ombra verde, come in un acquario"
"Anche a casa mia ci sono delle foreste" disse l'ufficiale. "Grandi,
grandissime foreste. Dove si va a caccia tutto il giorno. Un acquario, ha
detto... Sì, proprio così" aggiunse dopo un attimo di riflessione.
"Gli specchi del salone sono tutti verdi e scuri, e torbidi come acqua.
Ci sono anche degli stagni: là diamo la caccia all'anatra selvatica"
"Tornerà presto a casa in licenza?" domandò Lucile.
Un lampo di gioia illuminò il volto dell'ufficiale.
"Parto fra dieci giorni, signora. Dall'inizio della guerra ho avuto solo una
breve licenza per Natale, meno di una settimana. Ah, signora, sapesse come
li aspettiamo, questi permessi! Come contiamo i giorni, come ci speriamo!
E poi arriviamo e ci accorgiamo di non parlare più la stessa lingua"
"Qualche volta è così" mormorò Lucile.
"Sempre"
"Ha ancora i genitori?"
"Sì. E in questo momento mia madre dev'essere seduta in giardino come
lei, con un libro e un lavoro di cucito"
"E sua moglie?"
"Mia moglie" disse "mi aspetta, o meglio aspetta qualcuno che è partito
per la prima volta quattro anni fa e che non tornerà mai... del tutto uguale.
L'assenza è un fenomeno ben strano!".
"Già" sospirò Lucile.
E pensò a Gaston Angellier. Ci sono quelle che aspettano lo stesso uomo,
e quelle che aspettano un uomo diverso da quello che è partito, disse fra sé,
e tutte restano deluse. Si sforzò di immaginare il marito, da un anno lontano
da lei, quale doveva essere in quel momento: sofferente, tormentato dalla
nostalgia (di sua moglie o della modista di Digione?)
Era ingiusta; Gaston viveva certo con dolore l'umiliazione della sconfitta,
la perdita di tanti beni... Improvvisamente la vista del tedesco (no, non del
tedesco in sé, ma della sua uniforme, di quel particolare verde mandorla
tendente al grigio, della sua giacca attillata, degli alti stivali lustri) le riuscì
penosa. Col pretesto di qualcosa da sbrigare in casa, rientrò. Dalla sua
camera lo vedeva andare su e giù lungo il vialetto, sotto i peri che
allargavano le loro braccia cariche di fiori. Che splendida giornata... La luce
calava a poco a poco e i rami dei ciliegi in fiore si facevano azzurrognoli e
leggeri come piumini pieni di cipria. Il cane camminava disciplinatamente
vicino all'ufficiale e ogni tanto posava il muso sulla mano del giovane, che
lo accarezzò più volte. Il tedesco era a capo scoperto e i suoi capelli dal
biondo metallico brillavano al sole. Lucile vide che stava guardando la casa.
"É intelligente e beneducato," pensò "ma sono contenta che parta presto;
la mia povera suocera non sopporta di vederlo occupare la camera di suo
figlio. Le creature passionali sono semplici" disse ancora fra sé. "Lei lo
odia, punto e basta. Beati quelli che possono amare e odiare davvero, senza
tante storie, senza sfumature, senza incertezze. Intanto, eccomi confinata in
camera con un tempo simile perché il signore ha voglia di passeggiare. Che
situazione assurda".
Chiuse la finestra, si gettò sul letto e riprese la lettura interrotta.
Andò avanti fino all'ora di cena, ma, affaticata dal caldo e dalla luce
abbagliante di quella giornata, ogni tanto si addormentava sul libro.
Quando entrò in sala da pranzo trovò la suocera già seduta al suo posto, di
fronte alla sedia vuota occupata un tempo da Gaston. Era così pallida, così
rigida, con gli occhi così arrossati dal pianto che Lucile, spaventata,
domandò:
"Cos'è successo?"
"Mi chiedo..." rispose la signora Angellier stringendo le mani l'una contro
l'altra con tanta violenza che Lucile vide le unghie diventare bianche. "Mi
chiedo perché hai sposato Gaston".
Niente è più costante, in un essere umano, del suo modo di esprimere la
collera; quello della signora Angellier era generalmente subdolo e sottile
come il sibilo della vipera, e Lucile non si era mai vista aggredire in modo
così aspro e diretto. Ne fu più addolorata che offesa; d'improvviso capì
quanto la suocera doveva soffrire. Le tornò in mente la gatta nera, sempre
querula, ipocrita e affettuosa, che mentre faceva le fusa dava unghiate
sornione. Una sola volta, però, era saltata agli occhi della cuoca quasi
accecandola; era il giorno in cui avevano annegato la sua cucciolata. Poi era
sparita.
"Che cosa ho fatto?" domandò Lucile sottovoce.
"Come hai potuto, qui, nella sua casa, sotto le sue finestre, con lui assente,
prigioniero, forse ammalato, maltrattato da questi bruti, come hai potuto
sorridere a un tedesco, parlare confidenzialmente con un tedesco? É
inconcepibile!"
"Mi ha chiesto il permesso di scendere in giardino a cogliere delle fragole.
Non potevo rifiutare. Lei dimentica, mamma, che in questo momento il
padrone è lui, ahimè... Ha conservato i gesti della buona educazione, ma
potrebbe prendere quello che gli piace, entrare dove vuole e perfino
cacciarci via. Esercita i suoi diritti di conquistatore con modi pieni di
riguardo. Non posso fargliene una colpa. Trovo che abbia ragione. Qui non
siamo in un campo di battaglia. Possiamo avere dentro tutti i sentimenti che
vogliamo, ma perché non essere educati e gentili, almeno esteriormente? C'è
qualcosa di disumano in questa situazione. Perché accentuarlo? Non è... non
è ragionevole, mamma" esclamò Lucile con una violenza di cui lei stessa
rimase stupita.
"Ragionevole!" ribatté vivamente la signora Angellier. "Ma ragazza mia,
questa parola, da sola, prova che tu non ami tuo marito, che non lo hai mai
amato e che non senti la sua mancanza! Pensi forse che ragioni, io?
Di questo ufficiale non sopporto neanche la vista! Vorrei strappargli gli
occhi! Vorrei vederlo morto. Non sarà giusto, né umano, né cristiano, ma
sono una madre, soffro d'esser privata di mio figlio, detesto quelli che me
l'hanno preso, e se tu fossi una vera moglie, non avresti potuto sopportare la
vicinanza di questo tedesco. Non avresti avuto paura di sembrare volgare,
maleducata, ridicola. Ti saresti alzata e, con o senza un pretesto, ti saresti
allontanata. Mio Dio, quell'uniforme, quegli stivali, quei capelli biondi,
quella voce, quell'aria sana, soddisfatta, mentre il mio povero Gaston...". Si
interruppe e scoppiò a piangere. "Via, mamma...".
Ma queste parole non fecero che rinfocolare l'ira della signora Angellier.
"Mi domando perché lo hai sposato!" sbottò di nuovo. "Per i soldi,
probabilmente, per le proprietà, ma allora...". "Non è vero! Sa bene che non
è vero! Mi sono sposata perché ero un'oca e perché mio padre mi aveva
detto: "E un bravo ragazzo. Ti farà felice". Non immaginavo che mi avrebbe
tradita l'indomani delle nozze con una modista di Digione!"
"Ma cosa dici? Che storia è questa?" "É la storia del mio matrimonio"
disse amaramente Lucile. "In questo momento, a Digione, c'è una donna che
sferruzza per Gaston, gli fa un maglione, gli prepara dei dolci, gli manda dei
pacchi e probabilmente gli scrive: "Mi manchi tanto, lupacchiotto mio, mi
sento sola, stanotte, nel nostro lettone""
"Una donna che lo ama" mormorò la signora Angellier, e le sue labbra
presero il colore dell'ortensia appassita e si fecero sottili e taglienti come
una lama.
"Adesso" pensò Lucile "le piacerebbe cacciarmi e mettere al mio posto la
modista" e, con la perfidia che è insita anche nella migliore delle donne,
insinuò:
"Sì, gli è cara... molto cara... Dia solo un'occhiata alle matrici del suo
libretto di assegni. L'ho trovato nello studio quando è partito".
"Gli costa del denaro?" esclamò la signora Angellier, inorridita.
"Sì, e non me ne importa niente"
Ci fu un lungo silenzio, rotto dai suoni familiari della sera: la radio del
vicino che mandava una serie di note monotone, lamentose e stridenti come
la musica araba o il frinire delle cicale: era la BBC di Londra, disturbata da
oscure interferenze nella notte, il misterioso mormorio di una fonte sperduta
nella campagna, il gorgoglio insistente di un rospo assetato che implorava la
pioggia. Nella sala da pranzo l'antico lampadario di ottone, strofinato e
lucidato da generazioni fino ad aver perso il suo splendore di oro rosso e
assunto un colore biondo e pallido da luna al primo quarto, illuminava la
tavola e le due donne. Lucile provava tristezza e rimorso.
"Che cosa mi ha preso?" pensava. "Avrei dovuto ascoltare i suoi
rimproveri e starmene zitta. Adesso si tormenterà di più, vorrà giustificare il
figlio, farci rappacificare... Dio, che noia!".
La cena si concluse senza che la signora Angellier aprisse bocca. Poi le
due donne passarono in salotto, dove la cuoca annunciò la visita della
viscontessa di Montmort. Questa signora, naturalmente, non frequentava i
borghesi del villaggio, né li invitava a casa più di quanto non invitasse i suoi
coloni, ma, quando aveva bisogno di un favore, non esitava ad andarlo a
chiedere a domicilio con una semplicità, un'ingenuità, un candore che
rivelavano i suoi alti natali. Arrivava dalle Angellier da buona vicina,
vestita come una domestica, in testa un cappellino rosso con una penna di
fagiano che aveva visto tempi migliori; i borghesi non si rendevano conto
che quell'assenza di ostentazione esprimeva meglio di quanto avrebbero
fatto una certa altezzosità o modi cerimoniosi il profondo disprezzo che
costei nutriva nei loro confronti: non era necessario mettersi elegante per
loro, così come non lo era per entrare di sfuggita in una fattoria a chiedere
un bicchiere di latte. Disarmati, i borghesi dicevano: "Non si dà arie", il che
non gli impediva, del resto, di accoglierla con insolita alterigia, altrettanto
inconsapevole della falsa semplicità della contessa.
La signora di Montmort entrò nel salotto delle Angellier a grandi passi, le
salutò cordialmente senza scusarsi per essere piombata lì a un'ora così tarda,
poi prese il libro di Lucile e ne lesse il titolo a voce alta: Conoscenza
dell'Est, di Claudel.
"Ma bene!" le disse con un sorriso incoraggiante, come se si
complimentasse con una delle ragazzine della scuola confessionale perché
leggeva, senza esservi costretta, la storia di Francia. "Le piacciono le letture
serie, è un'ottima cosa"
Si chinò a raccogliere il gomitolo di lana che la vecchia signora Angellier
aveva lasciato cadere a terra.
Come vedete, sembrava dire la viscontessa, sono stata educata nel rispetto
per le persone anziane; ai miei occhi non contano origine, educazione,
patrimonio: vedo solo i loro capelli bianchi. La signora Angellier, intanto,
con un freddo cenno del capo e schiudendo appena le labbra indicava una
sedia alla viscontessa, e tutto in lei gridava, per così dire, silenziosamente:
"Se crede che mi mostrerò lusingata della sua visita, si sbaglia di grosso. É
possibile che il mio trisnonno sia stato il fattore dei visconti di Montmort,
ma è storia vecchia e nessuno la conosce, mentre tutti sanno, signora
viscontessa, quanti ettari il suo defunto suocero, che aveva bisogno di
denaro, ha ceduto al mio defunto marito; il suo, comunque, ha fatto in modo
di tornarsene a casa dalla guerra, mentre mio figlio è prigioniero. Lei deve
rispettare in me una madre che soffre" Alle domande della viscontessa
rispose con voce flebile che sì, la salute era buona, e che aveva avuto notizie
recenti del figlio.
"Ha qualche speranza?" s'informò la viscontessa, intendendo "qualche
speranza di vederlo tornare presto"
La signora Angellier scosse il capo e alzò gli occhi al cielo.
"Che tristezza!" disse la viscontessa. "Siamo tutti molto provati"
aggiunse.
Diceva "siamo" spinta da quel senso di pudore che, davanti a un infelice,
ci induce a fingere sventure simili alle sue (ma l'egoismo deforma così
candidamente le nostre migliori intenzioni che a un tubercolotico all'ultimo
stadio diciamo in tutta innocenza: "La compiango, so cosa vuol dire, da tre
settimane ho un raffreddore di cui non riesco a liberarmi")
"Molto provati, sì, signora" mormorò la signora Angellier con freddezza e
malinconia. "Come lei sa" aggiunse indicando con un sorriso amaro la
camera vicina "abbiamo compagnia. Uno di quei signori... Ma certo ne
ospita qualcuno anche lei, vero?" chiese, benché le fosse giunto all'orecchio
che, grazie a certi rapporti personali del visconte, il castello era stato
preservato da presenze tedesche.
La viscontessa non rispose alla domanda ma proseguì in tono indignato:
"Non indovinerà mai quello che hanno avuto la sfrontatezza di
pretendere! L'accesso al lago per pescare e nuotare. E io, che passavo lì le
mie ore più belle, posso farci una croce sopra per tutta l'estate"
"Le proibiscono di andarci? Questa poi!" esclamò la signora Angellier,
vagamente consolata dall'umiliazione inflitta alla viscontessa.
"No, no," assicurò questa "al contrario, si sono mostrati molto corretti:
"Ci faccia sapere in quali ore possiamo andarci senza disturbarla" mi hanno
detto. Ma pensi a come mi sentirei trovandomi a faccia a faccia con uno di
quei signori in tenuta estiva... Lo sa che stanno mezzo nudi anche per
mangiare? Nel cortile della scuola che hanno occupato prendono i pasti a
torso e gambe nudi, solo con una specie di cache-sexe! Nella classe delle
grandi che dà proprio su quel cortile siamo costretti a tenere le imposte
chiuse per evitare che le bambine vedano... quello che non devono vedere. E
con questo caldo, pensi un po’ che delizia!"
Sospirò: situazione molto difficile, la sua. All'inizio della guerra aveva
mostrato un ardente patriottismo e un altrettanto ardente spirito antitedesco;
non che detestasse i tedeschi più degli altri stranieri (li inglobava tutti in uno
stesso sentimento di avversione, di diffidenza e di disprezzo), ma vi era nel
patriottismo e nella germanofobia, come del resto nell'antisemitismo e, più
tardi, nella devozione al maresciallo petain, qualcosa di teatrale che la
eccitava. Nel '39 alla scuola confessionale, davanti a un uditorio composto
da suore dell'ospedale, signore del paese e ricche fattoresse, aveva tenuto
una serie di conferenze aventi per tema la psicologia hitleriana nelle quali
designava tutti i tedeschi, senza eccezione, come pazzi, sadici e criminali.
Subito dopo la disfatta aveva perseverato in questo atteggiamento, perché,
per voltare gabbana in fretta, ci sarebbero volute una duttilità e un'agilità di
spirito di cui era del tutto sprovvista. A quell'epoca aveva battuto a
macchina di persona e distribuì in giro a diverse decine di esemplari le
famose predizioni di santa Odile che profetizzavano lo sterminio dei
tedeschi per la fine del 1940. Ma il tempo era passato, l'anno si era concluso
e i tedeschi erano sempre lì; per di più il visconte, nominato sindaco del
paese, si era trovato a essere un personaggio ufficiale, indotto, di
conseguenza, a seguire l'indirizzo del governo, ogni giorno più propenso a
una politica cosiddetta collaborazionista. Così, quando parlava della
situazione, la signora di Montmort si vedeva via via costretta ad annacquare
un po’ le sue opinioni. Anche stavolta si ricordò che non doveva esprimere
sentimenti ostili nei confronti del vincitore e disse facendo mostra di
tolleranza (del resto, Gesù Cristo non ci ordina forse di amare i nostri
nemici?):
"Posso d'altronde capire che dopo le loro faticose manovre si mettano un
po’ in libertà. Dopo tutto sono uomini come gli altri".
Ma la signora Angellier si rifiutò di seguirla su quel terreno.
"Sono creature malvagie, che ci detestano. Hanno detto che saranno
contenti solo quando vedranno i francesi mangiare erba"
"É abominevole" commentò la viscontessa, sinceramente indignata.
E poiché, dopo tutto, la politica collaborazionista era nata da pochi mesi,
mentre la germanofobia poteva vantare quasi un secolo di vita, la signora di
Montmort ritrovò istintivamente il linguaggio di un tempo.
"Il nostro povero paese... Saccheggiato, oppresso, perduto... E quanti
drammi! Guardi la famiglia del fabbro: tre figli, uno ucciso, l'altro
prigioniero, il terzo disperso a Mersel-Kebirà Dai berard della Montagne,"
continuò, facendo seguire, secondo l'uso del posto, al nome dei coloni
quello del fondo in cui abitavano "da quando il marito è prigioniero quella
povera donna è diventata pazza per la fatica e il dolore. E a portare avanti la
fattoria ci sono solo il vecchio e una ragazzina di tredici anni. Dai Clement,
la madre è morta praticamente sul lavoro e i quattro piccoli sono stati presi
da certi vicini. Quanti drammi... Povera Francia!".
La signora Angellier, le labbra pallide serrate, lavorava a maglia e
annuiva. Dopo un po’ lei e la viscontessa smisero di parlare delle disgrazie
altrui per concentrarsi sulle proprie seccature; lo facevano con un tono
vivace e appassionato che contrastava con il linguaggio lento, enfatico,
affettato che avevano usato per evocare i mali del prossimo. Proprio come
uno scolaro che recita con serietà, rispetto e noia l'episodio della morte di
Ippolito, che non lo tocca minimamente, e ritrova per miracolo forza di
persuasione e calore quando s'interrompe per denunciare al maestro che
qualcuno gli ha rubato le biglie.
"É una vergogna, una vergogna," diceva la signora Angellier "pago
mezzo chilo di burro ventisette franchi. Al mercato nero, naturalmente,
come tutto il resto. Le città devono vivere, d'accordo, ma...". "Ah, non me
ne parli, mi domando a che prezzo si vendano a Parigi i generi alimentari...
Va bene per chi può permetterselo, ma insomma, ci sono anche i poveri"
fece notare virtuosamente la viscontessa, assaporando il piacere di sentirsi
buona, di saper mostrare a tutti che non dimenticava i miserabili - piacere
acuito dalla consapevolezza che, grazie al suo ingente patrimonio, lei non si
sarebbe mai trovata nell'eventualità di esser compianta.
"Non si pensa abbastanza ai poveri" concluse.
Ma queste erano solo chiacchiere; era venuto il momento di affrontare
l'oggetto della sua visita: la viscontessa desiderava procurarsi del grano per i
suoi animali da cortile. Possedeva infatti un bellissimo pollaio, famoso in
paese. Nel 1941 tutto il grano veniva obbligatoriamente requisito; era
proibito, in linea di principio, darne ai polli, ma "proibizione" non
significava "impossibilità di superare l'ostacolo", semplicemente "difficoltà
nel farlo"; una questione di tatto, di fortuna e di mezzi finanziari. La
viscontessa aveva scritto un breve articolo che era stato pubblicato sul
giornale locale, un foglio benpensante che si avvaleva anche della
collaborazione del parroco. Il pezzo era intitolato: Tutto per il Maresciallo!
e cominciava così:
"Diciamolo! Ripetiamolo nelle capanne, durante le veglie intorno ai
fuochi che bruciano sotto la cenere: un francese degno di questo nome non
darà più ai suoi polli un solo chicco di grano, non lascerà al suo maiale una
sola patata; metterà da parte l'avena, la segale, l'orzo e la colza e, raccolti
questi frutti del suo lavoro e del suo sudore, li legherà in un fascio stretto da
un nastro tricolore, simbolo del suo patriottismo, e li deporrà ai piedi del
Venerabile Vegliardo che ci ha ridato la speranza!" Ma nel novero di quei
pollai in cui, secondo la viscontessa, non doveva più restare un solo chicco
di grano, non rientrava naturalmente il suo: quegli animali da cortile erano il
suo orgoglio e l'oggetto delle sue cure più amorevoli, e comprendevano
elementi rari, premiati in occasione di importanti concorsi agricoli in
Francia e all'estero. La viscontessa possedeva le più belle tenute del paese,
ma non osava rivolgersi ai contadini per una transazione così delicata: guai
a mettersi nelle mani dei proletari, le avrebbero fatto pagar cara ogni
complicità di quel tipo, mentre con la signora Angellier era tutt'altra cosa.
Ci si poteva sempre accordare, con lei. La signora Angellier sospirò
profondamente.
"Forse potrei... Uno o due sacchi... E lei, da parte sua, attraverso il signor
sindaco, non potrebbe farci avere un po’ di carbone? In linea di massima
non ne avremmo diritto, ma..." disse.
Lucile le lasciò e si avvicinò alla finestra. Il salotto dava sulla piazza: le
imposte non erano ancora chiuse e c'era una panchina, nell'ombra, davanti al
monumento ai caduti. Tutto sembrava immerso nel sonno. Era una
splendida notte di primavera, piena di stelle d'argento.
Nell'oscurità si vedevano brillare debolmente i tetti delle case vicine: la
fucina, dove un vecchio piangeva i tre figli morti, la piccola bottega del
ciabattino ucciso in guerra e che una povera donna e un ragazzino di sedici
anni sostituivano come meglio potevano. Tendendo l'orecchio, da ciascuna
di quelle case basse, scure, tranquille si sarebbe potuto cogliere un lamento,
pensava Lucile. Ma... cos'erano quei rumori? Dalle tenebre saliva una risata,
un fruscio di gonne. Poi una voce maschile, una voce straniera domandò:
"Come, in francese, questo? Bacio? Sì? Oh, bello...".
Poco più in là vagavano delle ombre; balenava il bianco di una camicetta,
un nastro tra capelli sciolti, il luccichio di uno stivale e di un cinturone. La
sentinella continuava a fare su e giù davanti al Lokal al quale era vietato
avvicinarsi pena la morte, ma i suoi camerati si godevano la bella notte e i
loro momenti di libertà. Due soldati, in mezzo a un gruppo di ragazze,
cantavano:
Trink 'mal nodi ein Trôpfchen! Ach! Suzanna...
e le ragazze riprendevano il motivo canticchiando in sordina.
Durante una pausa della conversazione, la signora Angellier e la
viscontessa colsero le ultime note della canzonetta.
"Chi può cantare a quest'ora?"
"Sono delle donne con i soldati tedeschi"
"Che orrore!" esclamò la viscontessa, e fece un gesto di raccapriccio e di
disgusto. "Vorrei proprio sapere chi sono quelle svergognate... Le segnalerò
al parroco"
Si chinò e scrutò avidamente nella notte.
"Non riesco a vederle. Non oserebbero farlo in pieno giorno... Ah, signore
mie, questo è peggio di tutto! Corrompono anche le donne francesi, adesso!
Pensate, i loro fratelli, i loro mariti sono prigionieri e loro se la spassano con
i tedeschi! Ma che cos'hanno in corpo, certe donne?" esclamò con veemenza
la viscontessa la cui indignazione nasceva da molteplici cause: patriottismo
ferito, senso delle convenienze, dubbi sull'efficacia del suo ruolo sociale (il
sabato sera teneva delle conferenze sul tema "La giovane cristiana", aveva
organizzato una biblioteca rurale e a volte invitava a casa sua i giovani del
paese a vedere film edificanti e istruttivi, quali Una giornata all'abbazia di
Solesmes o Dal bruco alla farfalla. E tutto questo, a che scopo? Per poi dare
al mondo una visione orrenda, avvilente della donna francese?), e infine
ardore di un temperamento che si sentiva turbato da certe immagini senza
poter sperare in un qualche appagamento da parte del visconte, poco
interessato alle donne in generale e alla propria moglie in particolare.
"É uno scandalo!" esclamò.
"É triste" disse Lucile pensando a tutte quelle ragazze la cui gioventù
veniva frustrata: gli uomini, prigionieri o morti, erano assenti e il nemico ne
prendeva il posto. Un fatto deplorevole, certo, ma nessuno lo avrebbe
saputo. Sarebbe stata una di quelle cose ignorate dalla posterità, o dalle
quali questa avrebbe distolto per pudore lo sguardo.
La signora Angellier suonò. La cuoca si affrettò a chiudere imposte e
finestre e tutto tornò nell'ombra: le canzoni, il rumore dei baci, il dolce
splendore delle stelle, il passo del conquistatore sul selciato e il sospiro del
rospo assetato che implorava invano un po’ d'acqua dal cielo.
CAPITOLO 10.
Il tedesco aveva incontrato un paio di volte Lucile nella penombra
dell'anticamera; quando lei prendeva il cappello di paglia che usava in
giardino, e che stava appeso a un corno di cervo, faceva tintinnare un piatto
di rame che ornava la parete proprio sotto l'attaccapanni. Il tedesco
sembrava spiare quel rumore leggero nel silenzio della casa; apriva la porta
e si faceva avanti per aiutare Lucile: le portava in giardino il cesto, le forbici
per potare, il libro, il lavoro di cucito e la sedia a sdraio, ma lei non gli
parlava più; si limitava a ringraziarlo con un cenno del capo e un sorriso
forzato, come se si sentisse addosso lo sguardo della vecchia signora
Angellier, appostata dietro una persiana. Il tedesco lo capì e non si fece più
vedere; partiva quasi ogni notte per le manovre alla testa del suo
reggimento, rientrava solo alle quattro del pomeriggio e si chiudeva in
camera con il suo cane. Verso sera, attraversando il villaggio, Lucile lo
vedeva qualche volta seduto a un caffè, solo, con un libro in mano e un
bicchiere di birra sul tavolino. Lui evitava di salutarla e si girava dall'altra
parte aggrottando le sopracciglia. Lei contava i giorni:
"Partirà lunedì" diceva fra sé. "Al suo rientro forse il reggimento non sarà
più qui. A ogni modo ha capito che non gli rivolgerò più la parola"'
Ogni mattina interrogava la cuoca:
"Il tedesco è ancora qui, Marthe?"
"Sì che c'è," rispondeva la cuoca "e non sembra cattivo: ha chiesto se alla
signora farebbe piacere avere della frutta. Ne offrirebbe volentieri un po’.
Hanno di tutto, quelli là, accidenti a loro! Casse intere di arance. Sono
molto rinfrescanti" aggiunse, combattuta fra una certa benevolenza nei
confronti dell'ufficiale che gliele offriva e che si mostrava sempre, come
diceva lei, "molto carino, molto gentile, uno che non fa paura", e un moto di
collera pensando a quella frutta di cui i francesi venivano privati.
Quest'ultimo pensiero dovette senz'altro prevalere, perché la donna
concluse con aria disgustata:
"Gran brutta razza, comunque! Io gli prendo tutto quello che posso,
all'ufficiale: il pane, lo zucchero, i dolci che riceve da casa (e sono fatti con
fior di farina, signora, glielo assicuro) e il tabacco, che mando al mio
prigioniero"
"Oh, non deve farlo, Marthe!"
Ma la vecchia cuoca alzò le spalle.
"Dal momento che ci prendono tutto, è il meno che possiamo fare...".
Una sera, mentre Lucile usciva dalla sala da pranzo, Marthe aprì la porta
della cucina e chiamò:
"Può venire un momento qui, signora? C'è qualcuno che desidera vederla"
Lucile entrò con il timore di essere colta di sorpresa dalla suocera, cui non
piaceva vedere una persona estranea in quel locale, né in quello dove
stavano le provviste. Non che sospettasse davvero Lucile di rubare la
marmellata - benché controllasse ostentatamente gli armadi in sua presenza
-, ma piuttosto perché provava l'intimo disagio e l'irritazione dell'artista
disturbato nel suo atelier o della mondana che sta iniziando a truccarsi: la
cucina era un ambito sacro che apparteneva a lei, a lei sola. Marthe era in
quella casa da ventisette anni, e da ventisette anni la signora Angellier
faceva di tutto perché Marthe non dimenticasse mai che non si trovava in
casa propria, ma in casa d'altri, e che poteva aspettarsi in ogni momento di
dover abbandonare i suoi piumini, le sue pentole, il suo focolare, così come
il fedele, secondo i riti della religione cristiana, deve ricordarsi
continuamente che i beni di questo mondo gli sono elargiti solo a titolo
temporaneo e possono essergli tolti da un giorno all'altro secondo il
capriccio del Creatore.
Marthe chiuse la porta alle spalle di Lucile.
"La signora è in chiesa" le disse con aria rassicurante.
La cucina era un locale vasto come una sala da ballo, con due grandi
finestre che davano sul giardino. Al tavolo stava seduto un uomo; sulla
tovaglia di tela cerata, fra una grande pagnotta dorata e una bottiglia di vino
mezzo vuota, c'era un magnifico luccio dal corpo d'argento ancora percorso
dagli ultimi fremiti dell'agonia. L'uomo alzò la testa e Lucile riconobbe
Benoît Labarie.
"Dove lo ha preso, Benoît?"
"Nello stagno del conte di Montmort"
"Un giorno o l'altro la scopriranno"
L'uomo non rispose. Prendendolo per le branchie, sollevò l'enorme pesce
che ancora respirava e faceva oscillare la coda trasparente.
"É un regalo?" domandò Marthe, la cuoca, che era una parente dei
Labarie.
"Se vi fa piacere"
"Dammelo pure, Benoît. Lo sa, signora, che ci diminuiscono ancora la
razione di carne? Sarà la morte e la fine del mondo" aggiunse alzando le
spalle e appendendo un grosso prosciutto a una trave del soffitto.
"Benoît, approfitta che non c'è la vecchia signora per dire alla signora
Lucile qual è il problema"
"Signora," disse Benoît "da noi c'è un tedesco che sta dietro a mia moglie.
É l'interprete della Kommandantur, un ragazzino di diciannove anni; è un
fatto che non posso più sopportare"
"Ma che cosa ci posso fare, io?"
"Uno dei suoi camerati abita qui...".
"Io non gli parlo mai"
"Non dica così" fece Benoît guardandola in faccia.
Si avvicinò al focolare e, meccanicamente, piegò fra le dita e raddrizzò
l'attizzatoio: aveva una forza fisica straordinaria.
"L'hanno vista parlare con lui in giardino, ridere e mangiare fragole.
Non glielo rimprovero, è affar suo, ma sono qui a supplicarla. Faccia in
modo che il vostro ospite convinca il suo camerata a cambiare alloggio"
"Che paese!" pensava intanto Lucile. "Qui i muri hanno occhi e orecchi".
In quel momento scoppiò il temporale che era nell'aria da diverse ore, e
dopo un solo tuono, breve e solenne, si udirono scrosci di pioggia impetuosa
e fredda. Il cielo si oscurò, le luci si spensero come succedeva nove volte su
dieci nei giorni di bufera, e Marthe disse con aria soddisfatta:
"Bene! Adesso la signora dovrà fermarsi in chiesa"
Ne approfittò per portare a Benoît una tazza di caffè caldo. I lampi
illuminavano la cucina; i vetri della finestra grondavano di un'acqua
scintillante che, in quella luce sulfurea, sembrava verde. La porta si aprì e
l'ufficiale tedesco, che il temporale aveva fatto uscire dalla sua camera,
entrò a chiedere due candele.
"Ah, lei è qui, signora?" aggiunse accorgendosi di Lucile. "Mi scusi, ma
con questo buio non l'avevo vista"
"Niente candele" disse Marthe in tono arcigno. "Non ci sono più candele
in Francia da quando ci siete voi"
Non le piaceva vedere l'ufficiale nella sua cucina; nelle altre stanze,
pazienza, era sopportabile, ma lì, tra il focolare e la dispensa, quella
presenza le sembrava scandalosa, quasi sacrilega: violava il cuore della
casa.
"Mi dia almeno un fiammifero" implorò l'ufficiale prendendo a bella
posta un'aria accorata per ammansire la cuoca. Ma lei scosse il capo.
"Non ci sono più neanche quelli"
Lucile si mise a ridere.
"Non le dia retta. I fiammiferi sono dietro di lei, sulla cappa. A proposito,
c'è qui una persona che vorrebbe parlarle, signore; ha delle rimostranze da
fare circa il comportamento di un soldato tedesco"
"Ah, sì? L'ascolto" disse l'ufficiale mostrando interesse. "A noi preme
molto che i soldati della Reichswehr siano estremamente corretti con gli
abitanti"
Benoît taceva e fu Marthe a prendere la parola.
"Corre dietro a sua moglie" dichiarò con un tono in cui era difficile capire
che cosa prevalesse in lei, se l'indignazione virtuosa o il rimpianto di non
essere più nell'età che ci espone a simili vicissitudini.
"Ma, ragazzo mio, lei sopravvaluta il potere dei capi nell'esercito tedesco;
posso sempre punire questo giovanotto se molesta sua moglie, ma se lei lo
trova di suo gusto...".
"Attento a come parla!" ringhiò Benoît facendo un passo verso l'ufficiale.
"Prego?"
"Attento a come parla, le dico. Ci mancavano anche questi sporchi...".
Lucile lanciò un grido d'angoscia e di avvertimento. Marthe dette una
gomitata a Benoît; aveva capito che stava per dire "crucchi", la parola
proibita che i tedeschi punivano con la prigione. Facendo uno sforzo, Benoît
tacque.
"Ci mancava anche di vedere voialtri correre dietro alle nostre donne"
"Ma, amico mio, dovevate difenderle prima, le vostre donne" disse piano
l'ufficiale.
Era arrossito violentemente e il suo volto aveva assunto un'espressione
altezzosa e sgradevole. Lucile intervenne.
"La prego," disse sottovoce "quest'uomo è geloso. Soffre. Non lo
esasperi"
"Come si chiama quel soldato?"
"Bonnet"
"L'interprete della Kommandantur? Ma non ho alcuna autorità su di lui;
ha il mio stesso grado. Mi è impossibile intervenire".
"Neanche a titolo amichevole?"
L'ufficiale si strinse nelle spalle.
"Impossibile. Le spiegherò perché".
La voce di Benoît, calma e aspra, lo interruppe.
"Non c'è niente da spiegare! A un soldato semplice, a un povero diavolo,
viene sempre proibito qualcosa. Verboten, come dite voi. Ma perché
contrastare i piaceri dei signori ufficiali? É così in tutti gli eserciti del
mondo"
"No, non gli parlerò, perché sarebbe stuzzicarlo, eccitarlo ancora di più, e
rendere a lei un cattivo servizio" rispose il tedesco e, voltando le spalle a
Benoît, si avvicinò alla tavola.
"Mi faccia un po’ di caffè, cara Marthe, esco fra un'ora"
"Ancora manovre! Tre notti di seguito!" esclamò Marthe che non riusciva
a definire i suoi sentimenti nei confronti del nemico, ora dicendo
soddisfatta, quando vedeva rientrare il reggimento all'alba: "Come sono
accaldati, come sono stanchi... Ben gli sta, sono contenta", ora
dimenticando che si trattava di tedeschi e sentendo nascere in lei una sorta
di materna pietà: "Però, poveri ragazzi, non è vita la loro...".
Per oscure ragioni fu quell'ondata di tenerezza femminile a prevalere in
lei quella sera.
"Su, glielo farò, il suo caffè. Si metta lì. Lo prende anche lei, vero,
signora?"
"No..." cominciò Lucile.
Nel frattempo, Benoît era uscito con un balzo silenzioso dalla finestra.
"Oh, la prego" sussurrò il tedesco. "Non la importunerò più per molto
tempo, ormai: parto dopodomani, e si parla di mandare il reggimento in
Africa, al mio ritorno. Non ci rivedremo mai più e mi consolerebbe pensare
che lei non mi odia"
"Io non la odio, ma...".
"Lo so, lo so. Non approfondiamo. Accetti solo di farmi compagnia...".
Intanto Marthe, con un sorriso intenerito, complice e scandalizzato, come
quando si dà di nascosto una fetta di pane imburrato a un bambino in
castigo, preparava la tavola. Posò su un canovaccio pulito due grandi tazze
di ceramica a fiori, la caffettiera bollente e una vecchia lampada a petrolio
che aveva alimentato e acceso dopo averla tirata fuori da un armadio. La
lieve fiamma gialla illuminava le pareti coperte di oggetti di rame che
l'ufficiale osservava con curiosità.
"Come si chiama quello, signora?"
"Quello è uno scaldaletto"
"E quell'altro?"
"É uno stampo per fare le cialde. Ha quasi cent'anni; non ce ne serviamo
più"
Marthe portò in tavola una zuccheriera monumentale che, con i suoi
piedini di bronzo e il coperchio scolpito, sembrava un'urna cineraria, e una
coppa di vetro lavorato che conteneva marmellata.
"Così, dopodomani a quest'ora" disse Lucile "lei prenderà una tazza di
caffè con sua moglie...".
"Lo spero tanto. Le parlerò di lei. Le descriverò la casa".
"Sua moglie non conosce la Francia?"
"No, signora"
Lucile avrebbe voluto sapere se al nemico piaceva la Francia, ma una
sorta di orgoglio pudico le fece morire le parole sulle labbra.
Continuarono a bere il caffè, in silenzio, senza guardarsi.
Poi il tedesco parlò del suo paese, dei grandi viali di Berlino, d'inverno,
sotto la neve, dell'aria viva e pungente che spazza le pianure dell'Europa
centrale, dei laghi profondi, dei boschi di abeti e delle cave di sabbia.
Marthe moriva dalla voglia di prendere parte alla conversazione.
"Durerà ancora tanto, questa guerra?" domandò.
"Non lo so" disse l'ufficiale sorridendo e stringendosi leggermente nelle
spalle.
"Ma lei cosa pensa?" chiese a sua volta Lucile.
"Signora, io sono un soldato. E i soldati non pensano. Mi dicono di andare
in un posto e ci vado. Di combattere, e combatto. Di farmi uccidere, e
muoio. L'esercizio del pensiero renderebbe la battaglia più difficile, e la
morte più terribile"
"Ma... l'entusiasmo...".
"Mi perdoni, signora, ma questa è una parola da donna. Un uomo fa il suo
dovere anche senza entusiasmo. E proprio da questo si riconosce l'uomo, il
vero uomo"
"Forse"
Si sentiva il leggero mormorio della pioggia in giardino; le ultime gocce
cadevano lentamente dai lillà; dal vivaio che andava riempiendosi d'acqua
saliva un pigro gorgoglio. La porta d'ingresso si aprì.
"Presto, scappate, c'è la signora!" fece Marthe, spaventatissima,
spingendo fuori l'ufficiale e Lucile.
"Passate dal giardino! Chissà che lavata di testa mi prenderò, Vergine
santa!"
Si affrettò a versare nell'acquaio il caffè rimasto, a nascondere le tazze e a
spegnere la lampada.
"Scappate, presto! Per fortuna è già buio!"
Si ritrovarono fuori tutti e due. L'ufficiale rideva. Lucile tremava un po’.
Nascosti nell'ombra, videro la signora Angellier attraversare la casa,
preceduta da Marthe che portava un lume; poi furono chiuse tutte le imposte
e vennero assicurate le sbarre di ferro. Sentendo il cigolio dei cardini, un
rumore di catenacci arrugginiti e il suono lugubre delle grandi porte
sprangate, il tedesco osservò:
"Sembra una prigione. Come torna dentro, signora?".
"Dalla porticina del ripostiglio. Marthe l'avrà lasciata aperta. E lei?"
"Oh, salterò il muro"
Infatti lo superò con un rapido balzo e disse sottovoce:
"Gute Nacht. Schiafen Sie wohl!".
"Gute Nacht" rispose lei.
Il suo accento fece ridere l'ufficiale. Ferma nell'ombra, Lucile ascoltò per
un istante quel riso che si allontanava. Un po’ di vento, agitando i rami
bagnati, fece cadere dei lillà sui suoi capelli. Si sentiva leggera e allegra;
rientrò di corsa.
CAPITOLO 11.
Ogni mese la signora Angellier faceva un giro d'ispezione nelle sue terre
e, per quella visita, sceglieva una domenica, giorno in cui avrebbe trovato in
casa la sua "gente" Questo esasperava i mezzadri che, non appena lei
compariva, si affrettavano a nascondere il caffè, lo zucchero e la grappa di
fine pranzo. La signora Angellier, infatti, apparteneva alla vecchia scuola:
considerava il cibo dei suoi contadini come sottratto a quanto sarebbe
spettato a lei, e muoveva aspri rimproveri a coloro che, dal macellaio,
sceglievano carne di prima qualità. Aveva, in paese, quella che chiamava la
sua "polizia", e licenziava quei mezzadri la cui moglie o figlia comprava
troppo spesso calze di seta, profumi, bustine di cipria o romanzi. La signora
di Montmort governava i suoi sudditi in base a principi analoghi, ma,
essendo aristocratica e più legata ai valori spirituali di quanto lo fosse quella
borghesia severa e materialista da cui proveniva la signora Angellier, si
preoccupava specialmente dell'aspetto religioso del problema; si informava
se tutti i bambini erano stati battezzati, se in famiglia si faceva la comunione
almeno due volte l'anno, se le donne andavano a messa (cosa impossibile da
ottenere dagli uomini, così dichiarava arrendendosi) Pertanto, delle due
famiglie che si dividevano il paese - i Montmort e gli Angellier -, la più
detestata era comunque la prima.
La signora Angellier si mise in viaggio in un'alba cupa. Dopo il temporale
del giorno prima il tempo era cambiato: cadeva una pioggia dirotta e gelida,
un vero diluvio. La macchina non era più in uso, perché non c'era benzina
né permesso di circolazione, ma la signora Angellier aveva fatto riesumare
da una rimessa, dove era stata lasciata dormire per trent'anni, una specie di
victoria che, attaccata a due robusti cavalli, era in grado di fare molta strada.
Tutta la gente di casa era in piedi per assistere alla partenza della vecchia
signora.
All'ultimo momento (e a malincuore), questa affidò le chiavi a Lucile.
Aprì quindi l'ombrello; l'acquazzone stava raddoppiando di forza.
"La signora farebbe meglio ad aspettare domani" disse la cuoca.
"Sono costretta a occuparmi di tutto, visto che il padrone di casa è
prigioniero di questi signori" rispose la signora Angellier in tono sarcastico
e a voce molto alta nell'intento di colpevolizzare due soldati tedeschi che
passavano di là.
E accompagnò le parole con uno sguardo simile a quelli di cui parla
Chateaubriand quando evocando il padre dice che "la pupilla scintillante
sembrava staccarsi e andare a colpire la gente come una pallottola"
Ma i soldati, che non capivano una parola di francese, presero
probabilmente quello sguardo per un omaggio alla loro bella corporatura,
alla loro prestanza, all'uniforme impeccabile, giacché sorrisero con timida
benevolenza. La signora Angellier chiuse gli occhi disgustata. La carrozza
partì mentre una raffica di vento scuoteva gli sportelli.
Un po’ più tardi nella mattinata Lucile si recò dalla sarta, una giovane
donna che, a quanto si diceva, se la spassava con i tedeschi. Le portava un
taglio di stoffa leggera da cui voleva ricavare una vestaglia. La sarta scosse
il capo:
"É fortunata ad avere ancora una seta così. A noi non è rimasto più
niente"
Lo diceva apparentemente senza invidia, quasi con rispetto, come se
riconoscesse alla borghesia non tanto un diritto di priorità, quanto una
specie di astuzia naturale che le consentiva di essere servita prima degli altri
- in qualche modo come l'abitante delle pianure dice del montanaro: "Non
c'è pericolo che perda la bussola, quello là! Bazzica le Alpi da quand'era
bambino" E probabilmente pensava pure che Lucile, per nascita, per un
dono atavico, fosse più capace di lei di infrangere le leggi, di aggirare i
regolamenti, perché strizzandole l'occhio con un bel sorriso disse:
"Si vede che sa cavarsela bene. Brava!".
A quel punto Lucile vide sul letto il cinturone slacciato di un soldato
tedesco. Gli occhi delle due donne s'incontrarono. Quelli della sarta
assunsero un'espressione astuta, attenta e implacabile; sembrava una gatta
che, davanti a chi le vuol togliere dalle unghie l'uccello che sta per uccidere,
alza il muso e miagola con arroganza, quasi dicesse: "Ma di un po’, è per
me o per te questo bocconcino?"
"Come può?" mormorò Lucile.
La sarta esitò fra diversi atteggiamenti. La sua faccia assunse in rapida
successione un'espressione insolente, stolida, bugiarda. Ma di colpo chinò il
capo.
"E allora? Tedesco o francese, amico o nemico, è prima di tutto un uomo,
e io sono una donna. E con me è affettuoso, tenero, pieno di attenzioni... E
un ragazzo di città, ben curato a differenza degli uomini di qui; ha una bella
pelle, denti bianchi. Quando bacia ha l'alito fresco, non sa di alcol come i
ragazzi di paese. A me basta. Non cerco altro. Ci complicano abbastanza la
vita con le guerre e tutto il resto. Fra un uomo e una donna sono cose che
non contano, queste. Fosse anche inglese o negro e lo trovassi di mio
gradimento, me lo prenderei, se potessi. La disgusto? Certo, lei è ricca, gode
di piaceri che io non ho...".
"Piaceri!" la interruppe Lucile con un'amarezza che le veniva dal cuore,
domandandosi che cosa la sarta potesse immaginare di piacevole in
un'esistenza come quella degli Angellier: visitare le proprie tenute, forse, e
investire il proprio denaro.
"Lei è istruita, vede gente. Per noi c'è solo lavoro e fatica. Se non ci fosse
l'amore, non resterebbe che andarsi a gettare nel pozzo. E quando dico
l'amore, non creda che pensi solo a quella cosa. Guardi, questo tedesco
l'altro giorno era a Moulins e mi ha comprato una borsetta di finto
coccodrillo; un'altra volta mi ha portato dei fiori, un mazzolino preso da un
fiorista di città, come a una signora. É una sciocchezza, visto che in
campagna non ci mancano i fiori, ma è un'attenzione, fa piacere. Io, fino a
oggi, gli uomini li frequentavo solo per il sesso.
Ma questo qui, non so come dirle, farei di tutto per lui, lo seguirei
ovunque. E lui, mi ama... Oh, ho abbastanza pratica di uomini per capire
quando uno è sincero. E allora, vede, dicano pure che è un tedesco, la cosa
non mi fa né caldo né freddo. É gente come noi".
"Sì, ma, ragazza mia, quando si dice "un tedesco" tutti sappiamo che è
solo un uomo, né migliore né peggiore di tutti gli altri, però la cosa
sottintesa, quella terribile, è che quest'uomo ha ucciso dei francesi, tiene
prigionieri i nostri cari, ci fa patire la fame...".
"Crede che non ci pensi? Qualche volta, quando sono distesa al suo
fianco, dico a me stessa: "Forse è stato suo padre a uccidere il mio"; lei sa
bene che mio padre è morto nell'altra guerra... Ci penso, ma poi, in fondo,
non me ne frega niente. Di qua ci siamo lui e io, di là quella gente. E quelli
non si curano di noi; ci bombardano e ci fanno soffrire, e ci ammazzano
come tanti conigli. Be, neanche noi ci curiamo di loro.
Vede, se si dovesse davvero fare solo quello che vogliono gli altri,
saremmo peggio delle bestie. In paese dicono che sono una cagna. No!
Cani sono quelli che stanno in branco e mordono se gli si ordina di
mordere. Io e Willy...".
Si interruppe, sospirò.
"Lo amo" disse poi.
"Ma il reggimento partirà"
"Lo so, signora, ma Willy ha detto che dopo la guerra vuole che lo
raggiunga in Germania"
"E lei ci crede?"
"Sì che ci credo" rispose la donna con aria di sfida.
"Lei è pazza," disse Lucile "la dimenticherà non appena sarà partito. I
suoi fratelli sono prigionieri; quando torneranno... Mi creda, stia attenta, è
molto pericoloso quello che sta facendo. Pericoloso e brutto" concluse.
"Quando torneranno...".
Si guardarono in silenzio. In quella stanza angusta, piena di pesanti mobili
rustici, Lucile respirava un odore profondo e segreto che la turbava e le
dava uno strano malessere.
Mentre usciva incrociò sulla scala dei marmocchi dalla faccia sporca che
scendevano i gradini a quattro a quattro.
"Dove correte così?" domandò Lucile.
"Andiamo a giocare nel giardino dei Perrin"
Si trattava di una ricca famiglia del paese che si era data alla fuga nel
giugno del '40; terrorizzati com'erano, i Perrin avevano lasciato la casa
aperta, tutte le porte spalancate, l'argenteria negli armadi, i vestiti nel
guardaroba; i tedeschi l'avevano saccheggiata, e anche il grande giardino,
abbandonato, devastato, calpestato, sembrava una giungla.
"I tedeschi vi permettono di andarci?"
I bambini non risposero e scapparono ridendo.
Lucile tornò a casa sotto la pioggia. Lungo la strada vide il giardino dei
Perrin; fra i rami, nonostante il gelido diluvio, passavano e ripassavano i
grembiulini azzurri e rosa dei bambini del paese. Qua e là si vedeva brillare
una guancia sporca e lucida bagnata dalla pioggia, che splendeva,
grondante, come una pesca. Alcuni bambini strappavano i fiori di ciliegio e
di lillà e giocavano a rincorrersi sui prati. Un ragazzino dai pantaloncini
rossi stava appollaiato sulla cima di un cedro e fischiava come un merlo.
Finivano di distruggere quello che restava del giardino un tempo così
ordinato, così amato, dove la famiglia Perrin non andava più a sedersi al
crepuscolo sulle sedie di ferro, gli uomini in giacca nera e le donne in
lunghi abiti fruscianti, a guardar maturare le fragole e i meloni. Un bimbetto
col grembiule rosa camminava lungo la cancellata di ferro tenendosi in
equilibrio fra le punte acuminate.
"Finirai per cadere, piccolo sciagurato" disse Lucile.
Il bambino la guardò fisso senza rispondere, e lei improvvisamente
invidiò quei ragazzini che si divertivano senza preoccuparsi del maltempo,
della guerra, della sventura. Le parve che, in mezzo a un popolo di schiavi,
solo loro fossero liberi - "E di una libertà vera" disse fra sé.
Tornò a malincuore verso la casa tetra, muta, flagellata dal nubifragio.
CAPITOLO 12.
Lucile si meravigliò nel vedere il postino che usciva dalla porta: riceveva
pochissime lettere. Sul tavolo dell'anticamera c'era un biglietto indirizzato a
lei.
Gentile signora, ricorda l'anziana coppia che ha ospitato in casa sua lo
scorso giugno? Da allora abbiamo pensato spesso a lei, alla sua gentile
accoglienza, a quella sosta nella sua casa durante quel viaggio maledetto.
Saremmo felici di avere sue notizie. Suo marito è tornato sano e salvo?
Quanto a noi, abbiamo avuto la grande gioia di ritrovare nostro figlio. La
preghiamo di gradire, signora, i nostri migliori saluti.
Jeanne e Maurice Michaud 23, rue Rousselet, Paris VII.
Il messaggio le fece piacere. Che brave persone... Erano più felici di lei...
Si amavano, avevano affrontato insieme tutti i pericoli...
Nascose il biglietto nel suo secretaire ed entrò in sala da pranzo.
Decisamente era una buona giornata nonostante il protrarsi
dell'acquazzone: sulla tavola c'era un solo coperto. Lucile si rallegrò
dell'assenza della signora Angellier; avrebbe potuto leggere mentre
mangiava. Pranzò molto in fretta, poi si avvicinò alla finestra e guardò la
pioggia che cadeva. La coda del temporale, come diceva la cuoca. In
quarantotto ore il tempo era cambiato al punto di fare della primavera più
radiosa una sorta di stagione incerta, crudele, bizzarra, in cui si
mescolavano l'ultima neve e i primi fiori; alcuni meli avevano perso in una
notte i loro mazzetti fioriti, i rosai erano neri e gelati, il vento aveva
fracassato i vasi di terra dove crescevano i gerani e i piselli odorosi. "Andrà
tutto in malora, possiamo dire addio alla frutta" si lamentava Marthe
sparecchiando. "Faccio un po’ di fuoco in salotto" aggiunse. "C'è un freddo
insopportabile. Il tedesco mi ha chiesto di accendergli il caminetto, ma non
è stato pulito e la camera si riempirà di fumo. Peggio per lui. Io gliel'ho
detto, ma non vuol sentir ragione, crede che sia cattiva volontà, come se,
dopo tutto quello che ci hanno preso, non potessimo dargli ancora due o tre
ceppi... Lo sente? Eccolo che tossisce! Santa Vergine! Che strazio dover
servire i crucchi. Vengo, vengo!" disse con astio. Lucile la udì aprire la
porta e rispondere al tedesco che parlava con voce irritata.
"Ha visto? Gliel'avevo detto! Se il caminetto non è stato pulito, il vento
ricaccia il fumo all'interno"
"Ma perché non è stato pulito, mein Gotti" esclamò il tedesco esasperato.
"Perché? Perché? Non ne so niente, io. Non sono la padrona. Crede che
con la vostra guerra possiamo fare quello che vogliamo?"
"Senta, buona donna, se lei pensa che resterò qui a lasciarmi affumicare
come un coniglio, si sbaglia! Dove sono le signore? Che mi sistemino in
salotto se non possono offrirmi una camera abitabile. Accenda il fuoco in
salotto"
"É impossibile, signore, mi dispiace" disse Lucile facendosi avanti.
"Nelle nostre case, qui in provincia, il salotto è un locale di
rappresentanza dove non si sta mai. Il caminetto è finto, come può
constatare"
"Cosa? Quel monumento in marmo bianco con gli amorini scolpiti che si
scaldano le dita...".
" non è mai servito per il fuoco" concluse Lucile sorridendo. "Ma, se
vuole, la invito in sala da pranzo, dove c'è la stufa accesa. La sua camera è
davvero in uno stato pietoso" aggiunse, vedendo gli sbuffi di fumo che ne
uscivano.
"Ah, signora, ho rischiato di morire asfissiato! Il mestiere del soldato è
decisamente pieno di pericoli! Ma non vorrei disturbarla per niente al
mondo. In paese ci sono dei caffè con sale da biliardo polverose dove l'aria
è offuscata da nuvole di gesso... Sua suocera...".
"Starà via tutto il giorno"
"Ah! Allora la ringrazio molto, signora. Non le darò fastidio. Ho del
lavoro urgente da finire" disse indicando una carta geografica e alcune
planimetrie.
Si mise al tavolo mentre Lucile sedeva in una poltrona vicino al fuoco
tendendo le mani alla fonte di calore e strofinandole ogni tanto l'una contro
l'altra con fare distratto. "Ho gesti da vecchia," pensò all'improvviso con
tristezza "gesti e vita da vecchia"
Lasciò cadere le mani sulle ginocchia. Alzando la testa, vide che
l'ufficiale aveva abbandonato le sue carte, si era avvicinato alla finestra e,
scostata la tenda, guardava i peri martoriati che si stagliavano come tante
croci contro il cielo grigio.
"Che paesaggio triste" mormorò.
"Che importanza può avere per lei?" rispose Lucile. "Visto che parte
domani"
"No," disse lui "non parto più"
"Ah, credevo...".
"Tutti i permessi sono revocati"
"Davvero? E perché?"
Lui si strinse leggermente nelle spalle.
"Non sappiamo. Revocati e basta. É la vita militare".
Lucile provò pena per lui: si era talmente rallegrato per quella licenza!
"É molto spiacevole," disse lei, mossa a compassione "ma sarà per
un'altra volta...".
"Fra tre mesi, sei mesi, forse mai... Mi dispiace soprattutto per mia madre.
E anziana e fragile. Una piccola vecchia signora con i capelli bianchi e il
cappello da giardino, che un soffio di vento farebbe cadere... Mi aspetta per
domani sera e avrà solo un telegramma".
"É figlio unico?"
"Avevo tre fratelli. Uno è stato ucciso durante la guerra in Polonia, un
altro un anno fa, proprio quando siamo entrati in Francia. Il terzo è in
Africa"
"É triste anche per sua moglie...".
"Oh, mia moglie... Mia moglie si consolerà. Ci siamo sposati
giovanissimi; eravamo quasi due bambini. Che cosa ne pensa, lei, di quelle
unioni concluse dopo quindici giorni di cameratismo, di vagabondaggi sui
laghi?"
"Non ne so niente! Non ci si sposa così in Francia"
"Non sarà comunque come una volta, quando ci si sposava dopo due
incontri in casa di amici di famiglia, come nel vostro Balzac?"
"Forse non proprio così, ma non c'è molta differenza, almeno in
provincia...".
"Mia madre me lo diceva, di non sposare Edith. Ma ero innamorato. Ach,
Liebe... Bisognerebbe poter crescere insieme, invecchiare insieme... Ma
arrivano la separazione, la guerra, le prove difficili, e uno si trova legato a
una ragazzina che ha sempre diciotto anni, mentre lui ne ha...".
Alzò le braccia, le lasciò ricadere.
" a volte dodici e a volte cento...".
"Lei esagera!"
"No, sotto certi aspetti il soldato resta bambino, e sotto altri è così
vecchio, così vecchio... Non ha età. É contemporaneo delle cose più antiche
che sono accadute sulla terra, dell'uccisione di Abele da parte di Caino, dei
banchetti dei cannibali, dell'età della pietra... Ma non parliamo più di
questo. Eccomi rinchiuso qui, in questo posto che è come una tomba... Che
dico!... Una tomba in un cimitero di campagna, pieno di fiori, di uccelli e di
ombre incantevoli, ma sempre una tomba... Come può vivere qui tutto
l'anno?"
"Prima della guerra, qualche volta uscivamo...".
"Eppure scommetto che non ha viaggiato, che non conosce né l'Italia, né
l'Europa centrale... solo un po’ Parigi... Pensi a tutto quello che adesso ci
manca... i musei, i teatri, i grandi concerti... Ah, è soprattutto la musica che
mi manca! E qui non ho che un misero strumento sul quale non oso neppure
suonare per paura di offendere le vostre legittime suscettibilità francesi"
disse con risentimento.
"Ma suoni pure tutto quello che vuole... Ecco, guardi, lei è triste, ma
neanch'io sono allegra! Si metta al piano e suoni. Dimenticheremo la
pioggia, l'assenza, le nostre disgrazie...".
"Lo vuole davvero? Io ho del lavoro da sbrigare" disse guardando le sue
planimetrie. "Bah! Prenda un ricamo o un libro, venga a sedersi vicino a me
e mi ascolti! Suono bene solo quando ho un pubblico. Sono molto... come
dite in Francia? Istrione? Proprio così!"
"Istrione, sì. Complimenti per la sua conoscenza della lingua...".
L'ufficiale sedette al pianoforte, la stufa dava calore e borbottava
sommessamente, emanando un gradevole odore di fumo e di caldarroste.
Grosse gocce di pioggia scorrevano lungo i vetri, come lacrime; la casa
era silenziosa e deserta, la cuoca era andata ai Vespri.
"Dovrei andarci anch'io," pensò Lucile "ma pazienza! Piove troppo"
Guardava scorrere sulla tastiera le mani magre e bianche. L'anello dalla
pietra rosso scuro che l'ufficiale portava al dito lo intralciava; se lo levò e,
meccanicamente, lo porse a Lucile. Lei lo prese e lo tenne un attimo in
mano, tiepido ancora delle sue dita, e lo fece scintillare alla pallida luce
grigia che cadeva dalla finestra. In trasparenza si distinguevano due lettere
gotiche e una data. Pensò a un pegno d'amore.
No! La data poteva essere 1775 o 1795, non si vedeva molto bene, senza
dubbio si trattava di un gioiello di famiglia. Lo posò delicatamente sul
tavolo. E si disse che forse lui suonava così, la sera, accanto a sua moglie...
Come si chiamava, a proposito? Edith? Come suonava bene! Lucile
riconosceva certi pezzi. Domandò timidamente:
"Bach, vero? Mozart?"
"Ma lei è una musicista...".
"No, no! Per niente! Suonavo un po’ prima di sposarmi, ma ho
dimenticato tutto! Amo la musica, e lei ha molto talento, signore!"
Lui la guardò e disse gravemente, con una tristezza che la sorprese:
"Sì, credo di avere talento"
Trasse dalla tastiera una serie di arpeggi leggeri e scherzosi.
"Adesso ascolti questo" disse poi.
E, mentre suonava, raccontava sottovoce:
"Ecco il tempo di pace, ecco il riso delle ragazze, gli echi gioiosi della
primavera, le prime rondini che tornano dal Sud... Siamo in una città della
Germania, è marzo, quando la neve comincia appena a sciogliersi. Ecco il
rumore di sorgente della neve che cola lungo antiche strade. E adesso la
pace è finita... Ecco i tamburi, i camion, i passi dei soldati... Lo sente? Lo
sente, questo scalpiccio lento, sordo, inesorabile? Un popolo in marcia... In
mezzo a quella gente il soldato è perduto... A questo punto dovrebbe esserci
un coro, una specie di inno religioso che è ancora incompiuto. Adesso,
ascolti! É il momento della battaglia...". La musica era grave, profonda,
terribile.
"Oh," disse piano Lucile "com'è bello!"
"Il soldato muore, e mentre muore sente di nuovo quel coro che non è più
terreno ma si leva dalle schiere divine... Così, ascolti... Dev'essere soave e
vibrante insieme. Sente le trombe celesti? Sente le sonorità di questi ottoni
che fanno crollare le muraglie? Ma ecco che tutto si allontana, si
affievolisce, cessa, sparisce." Il soldato è morto".
"Lo ha composto lei? É opera sua?"
"Sì! Volevo diventare musicista. E adesso tutto è finito".
"Perché? Ma la guerra...".
"La musica è un'amante esigente. Non la si può abbandonare per quattro
anni. Quando si torna da lei, lei non c'è più. A cosa sta pensando?" domandò
vedendo lo sguardo di Lucile fisso su di lui.
"Penso... che l'individuo non dovrebbe essere sacrificato così. Parlo per
tutti noi. Ci hanno preso tutto! Amore, famiglia... É troppo!".
"Ahimè, signora, è proprio questo - individuo o collettività - il problema
principale del nostro tempo, perché la guerra, vede, è opera collettiva per
eccellenza. Noi tedeschi crediamo nello spirito comunitario, così come si
dice che le api hanno lo spirito dell'alveare.
Gli dobbiamo tutto: nutrimento, splendore, profumi, amori... Ma sono
considerazioni troppo serie. Senta! Adesso le suono una sonata di Scarlatti.
La conosce?".
"No! Credo di no...".
E Lucile pensava: "Individuo o collettività? Dio mio, questa non è una
cosa nuova, non hanno inventato niente. I nostri due milioni di morti,
durante l'altra guerra, sono stati sacrificati anche loro allo "spirito
dell'alveare"! Loro sono morti... e venticinque anni dopo...
Che inganno! Che illusione! Ci sono leggi che regolano il destino degli
alveari e dei popoli, ecco tutto! L'anima stessa del popolo, probabilmente, è
governata da leggi che ci sfuggono, o da misteriosi capricci. Povero mondo,
così bello e così assurdo... Ma quel che è certo è che fra cinque, dieci o
vent'anni questo problema, che secondo lui è il problema del nostro tempo,
non esisterà più, sarà sostituito da altri... Mentre questa musica, questo
rumore della pioggia sui vetri, questo lugubre scricchiolio del cedro nel
giardino di fronte, questo momento così dolce, così strano in mezzo alla
guerra, questo non muterà... É eterno...".
All'improvviso lui smise di suonare.
"Ma lei piange..." disse guardandola.
Lucile si asciugò in fretta gli occhi pieni di lacrime.
"Le chiedo scusa. La musica è indiscreta. Forse la mia le ricorda... un
assente?"
Lei mormorò suo malgrado:
"No, nessuno! É per l'appunto questo che... Nessuno...".
Rimasero in silenzio. Il tedesco abbassò il coperchio sulla tastiera.
"Signora, dopo la guerra tornerò. Mi permetta di tornare. Tutti questi
problemi tra Francia e Germania saranno vecchi... superati... per quindici
anni almeno. Una sera suonerò alla porta. Lei mi aprirà e non mi
riconoscerà, perché sarò in borghese. Allora dirò: "Sono... l'ufficiale
tedesco... Ricorda? Adesso c'è la pace, la felicità, la libertà. La porto via con
me. Venga, partiamo insieme". Le farò visitare molti paesi. Io sarò un
compositore famoso, naturalmente, e lei sarà bella come adesso...".
"E di sua moglie e di mio marito, cosa ne facciamo?" disse lei sforzandosi
di ridere.
Lui fischiettò piano.
"Chissà dove saranno... e anche noi... Ma, signora, ho parlato seriamente.
Tornerò".
"Suoni ancora" disse lei dopo un breve silenzio.
"No, basta! Troppa musica ist gefahrlich... è pericoloso. Adesso, faccia la
signora di mondo e mi inviti a prendere il tè"
"Non c'è più tè in Francia, mein Herr. Le offro del vino di Frontignan e
dei biscotti. Gradisce?".
"Oh, sì! Ma per favore non chiami la domestica; mi permetta di aiutarla a
preparare la tavola. Dove stanno le tovaglie? In questo cassetto?
Lasci scegliere a me: sa bene che noi tedeschi siamo privi di tatto.
Vorrei quella rosa... No!... Meglio la bianca con i fiorellini ricamati...
Ricamati da lei?".
"Certo!"
"Per il resto, le lascio carta bianca"
"Meno male" disse lei ridendo. "Dov'è il suo cane? Non lo vedo più".
"É andato in licenza: appartiene a tutto il reggimento, a tutti i soldati. Uno
di loro, Bonnet, l'interprete, quello di cui il suo rustico amico ha avuto da
lagnarsi, lo ha preso con sé. Sono andati a Monaco tre giorni fa, ma le
nuove disposizioni li faranno tornare"
"A proposito di Bonnet, gli ha parlato?"
"Signora, il mio amico Bonnet non è un'anima semplice. In quello che è
stato fino a questo momento un gioco innocente, è capace, se il marito lo
esaspera, di mettere maggior passione, più Schadenfreude, capisce?
Può perfino innamorarsi sul serio, e se la giovane donna non è seria...".
"Questo è fuori discussione" disse Lucile.
"Ama quello zotico?"
"Certamente. Del resto, se certe ragazze di qui si lasciano corteggiare dai
vostri soldati, non creda per questo che siano tutte uguali.
Madeleine Labarie è una donna onesta e una buona francese"
"Ho capito" disse l'ufficiale chinando il capo.
Quindi aiutò Lucile a spostare vicino alla finestra il tavolino da gioco; lei
vi dispose dei bicchieri di cristallo antico sfaccettato, la caraffa dal tappo di
vermeil e vari piattini decorati a tema. Risalivano al Primo Impero e vi
erano raffigurate scene militari: Napoleone che passava in rassegna le
truppe, ussari dai galloni dorati che bivaccavano in verdi radure, una parata
al Campo di Marte. Il tedesco ne ammirò i freschi e ingenui colori.
"Che belle uniformi! E quanto mi piacerebbe avere una giacca a ricami
d'oro come questo ussaro!"
"Assaggi questi dolci, mein Herr! Sono fatti in casa"
L'ufficiale levò lo sguardo verso di lei e sorrise.
"Ha mai sentito parlare, signora, di quei cicloni che infuriano nei mari del
Sud? Se ho ben capito quello che ho letto, formano una specie di cerchio
costellato di tempeste lungo i bordi ma con un centro immobile, tanto che
un uccello o una farfalla che si trovassero nel cuore dell'uragano non ne
soffrirebbero affatto, le loro ali non ne riporterebbero il minimo danno,
mentre tutt'intorno si scatenerebbero le peggiori devastazioni. Guardi questa
casa! Guardi noi stessi mentre gustiamo vino di Frontignan e biscottini e
pensi a quello che sta succedendo nel mondo!"
"Preferisco non pensarci" disse Lucile con tristezza.
Tuttavia sentiva nell'animo una sorta di calore mai provato prima.
Perfino i suoi movimenti erano più leggeri, più disinvolti del solito, e la
sua voce le giungeva all'orecchio come quella di una sconosciuta: più bassa
del consueto, più profonda e vibrante; lei per prima non la riconosceva. Ma
la sensazione più squisita era quell'isolamento all'interno della casa ostile - e
quello strano senso di sicurezza: non sarebbe venuto nessuno, non ci
sarebbero state lettere, né visite, né telefonate. Perfino la pendola che al
mattino si era dimenticata di caricare (cosa che avrebbe fatto dire alla
signora Angellier:
"Naturalmente quando non ci sono io tutto va a rotoli"), quella pendola
dai rintocchi gravi e malinconici che la turbavano, si era fermata. Per di più
il temporale aveva danneggiato ancora una volta la centrale elettrica; il
paese era rimasto per qualche ora senza luce e senza radio. La radio muta...
Che pace... Impossibile cedere alla tentazione di cercare Parigi, Londra,
Berlino, Boston su quel quadrante buio. Non si sarebbero più sentite quelle
voci maledette, invisibili, funebri, parlare di navi colate a picco. di aerei
esplosi, di città distrutte, enumerare i morti, annunciare futuri massacri...
Beato oblio... Fino a sera, niente, il lento passare delle ore, una presenza
umana, un vino leggero e profumato, la musica, lunghi silenzi, la felicità...
CAPITOLO 13.
Un mese dopo, in un pomeriggio di pioggia simile a quello che il tedesco
e Lucile avevano passato insieme, Marthe annunciò una visita per le signore
Angellier e fece accomodare in salotto tre figure velate, chiuse in lunghi
soprabiti neri e con i cappelli da lutto. I veli che dalla sommità del capo
cadevano quasi fino a terra le isolavano in una sorta di gabbia funebre e
impenetrabile. Le Angellier non ricevevano molte visite; la cuoca,
emozionata com'era, si era dimenticata di prendere gli ombrelli delle
visitatrici, e ciascuna di loro teneva in mano il suo, semiaperto e svasato
come un calice, facendovi cadere dentro le ultime gocce di pioggia che
stillavano dai veli da lutto, come le prefiche versano lacrime nelle urne di
pietra sulle tombe degli eroi. Con un certo sforzo, la signora Angellier
riconobbe le tre sagome nere ed esclamò sorpresa:
"Ma sono le signore Perrin!"
La famiglia Perrin (titolare della bella proprietà saccheggiata dai tedeschi)
rappresentava "quel che c'era di meglio in paese" La signora
Angellier provava nei confronti di quella casata un sentimento simile a
quello che le persone di sangue reale nutrono le une per le altre: la serena
certezza di trovarsi fra gente della stessa razza con le stesse opinioni su
tutto; razza che può essere momentaneamente separata, certo, ma che resta
unita, malgrado le guerre o le malefatte di qualche ministro, legata da un
vincolo indissolubile, tanto che un trono non può crollare in Spagna senza
far vacillare quello di Svezia. Quando un notaio di Moulins era scappato
con il denaro che aveva in custodia, causando ai Perrin una perdita di
novecentomila franchi, gli Angellier avevano provato un fremito di orrore.
E quando la signora Angellier aveva acquistato per un tozzo di pane un
terreno appartenuto "da sempre" ai Montmort, i Perrin se n'erano rallegrati.
Cosa ben diversa da quella solidarietà di classe era il rancoroso rispetto che
i Montmort ispiravano ai borghesi.
Con affettuosa deferenza la signora Angellier invitò la signora Perrin, che
vedendola arrivare aveva fatto per alzarsi dalla sedia, a rimanere seduta.
Non provava quel brivido di disagio che l'assaliva quando compariva la
signora di Montmort: sapeva che agli occhi della signora Perrin il finto
caminetto, l'odore di cantina, le imposte socchiuse, i mobili coperti da
fodere, la tappezzeria color oliva con palme d'argento, tutto era accettabile e
corretto. Tra poco avrebbe offerto alle visitatrici aranciata e biscotti un po’
stantii, e la signora Perrin non si sarebbe scandalizzata per la grettezza di
quello spuntino; vi avrebbe visto invece un'altra prova della ricchezza degli
Angellier, perché più si è ricchi e più si è avari; vi avrebbe riconosciuto la
sua stessa inclinazione al risparmio e quella tendenza all'ascetismo che cova
nella borghesia francese e dà maggior gusto ai suoi piaceri segreti e
inconfessabili aggiungendovi un pizzico di amaro.
La signora Perrin parlò della morte eroica del figlio, ucciso in Normandia
nel corso dell'avanzata tedesca, e del permesso che le avevano dato di
andare a pregare sulla sua tomba. I Perrin abitavano a Lione; la signora si
lamentò a lungo del prezzo del viaggio e la signora Angellier assentì:
l'amore materno e il denaro erano due cose ben diverse.
"In città c'è molta miseria. Ho visto vendere dei corvi a quindici franchi
l'uno, e ci sono state madri che hanno nutrito i figli con brodo di cornacchia.
Non le parlo di operai! No, signora, ma di gente come lei e come me!"
La signora Angellier sospirò con aria afflitta; immaginò i suoi conoscenti,
la sua stessa famiglia che si dividevano un corvo per cena.
L'idea aveva qualcosa di grottesco, di infamante (mentre, se si fosse
trattato di operai, non ci sarebbe stato altro da dire che: "Poveracci!" e
passare oltre)
"Ma voi almeno siete libere! Non avete tedeschi in casa, mentre noi
dobbiamo ospitarne uno. Un ufficiale! Sì, signora, in questa casa, proprio
dietro questa parete" disse indicando la tappezzeria color oliva con le palme
d'argento.
"Lo sappiamo" ribatté la signora Perrin con un'ombra d imbarazzo. "Ne
siamo state informate dalla moglie del notaio che recentemente ha passato
la linea. Ed è proprio a questo proposito che siamo venute a farle visita"
Tutti gli sguardi, involontariamente, si appuntarono su Lucile.
"Vogliate spiegarvi, signore" disse fredda la vecchia Angellier.
"Questo ufficiale, a quanto mi è stato detto, si comporta molto
correttamente...".
"É così"
"Ed è stato anche visto parlarvi, in diverse circostanze, con molta
gentilezza...".
"A me non rivolge mai la parola" disse la signora Angellier con alterigia.
"Non lo sopporterei. Ammetto che questo mio atteggiamento non è
ragionevole," e calcò la voce su ragionevole "come mi è stato fatto
osservare, ma sono la madre di un prigioniero e, in quanto tale, non posso
fare a meno di considerare uno di questi signori come un nemico mortale.
Ma certe persone sono più... come dire... più accomodanti, più realiste,
forse... e mia nuora in particolare...".
"In effetti, quando mi parla, io gli rispondo" disse Lucile.
"Ma lei ha tutte le ragioni, mia cara!" esclamò la signora Perrin. "Ed è
proprio in lei che ripongo le mie speranze. Si tratta della nostra povera casa!
É in pessime condizioni, vero?"
"Ho visto solo il giardino... dal cancello...".
"Mia cara, non potrebbe farci restituire alcuni oggetti che vi si trovano e
ai quali teniamo in modo particolare?"
"Ma, signora... io...".
"Non dica di no! Lei non dovrebbe fare altro che andare a trovare quei
signori e intercedere in nostro favore. Forse tutto è distrutto, bruciato, ma
non posso credere che il vandalismo sia stato tale da rendere impossibile
ritrovare qualche fotografia, qualche lettera o qualche mobile che ha solo un
valore di ricordo...".
"Vada lei stessa, signora, dai tedeschi che occupano la casa e...".
"Mai!" disse la signora Perrin ergendosi in tutta la sua statura. "Mai
varcherò la soglia della mia casa finché vi si trova il nemico. É una
questione di dignità e anche di coscienza... Hanno ucciso mio figlio, un
figlio appena promosso al Politecnico fra i primi sei... Sarò fino a domani,
con le mie figlie, all'Hotel des Voyageurs. Se lei potesse fare in modo di
recuperare certi oggetti di cui le darò la lista, le sarò eternamente grata. Se
dovessi trovarmi a faccia a faccia con un tedesco (mi conosco!), sarei
capace di mettermi a cantare la Marsigliese" dichiarò la signora Perrin con
voce vibrante "e di farmi deportare in Prussia. Non sarebbe un disonore,
anzi, ma ho ancora delle figlie! Devo conservarmi per la mia famiglia.
Perciò la supplico, cara Lucile, di fare per me quello che può"
"Ecco la lista" disse una delle figlie Perrin.
Aprì il foglio e lesse: "Un catino e una brocca dell'acqua in porcellana,
con le nostre iniziali e un motivo di farfalle, uno sgocciolatoio per l'insalata,
il servizio da tè bianco e oro (ventotto pezzi, il coperchio della zuccheriera
era già andato rotto), due fotografie del nonno: 1) in braccio alla balia, 2)
sul letto di morte.
"Le corna di cervo che stanno in anticamera, ricordo dello zio Adolphe, il
piatto per le pappine della nonna (porcellana filettata d'argento), la dentiera
di ricambio che papà aveva dimenticato in bagno, il divano nero e rosa del
salotto. Inoltre, nel cassetto di sinistra della scrivania di cui ho qui la chiave:
"Il primo esercizio di scrittura di mio fratello, le lettere di papà alla
mamma durante la cura termale che papà faceva a Vittel nel 1924
(lettere legate con un nastrino rosa) e le fotografie di tutti noi"
La ragazza leggeva in un silenzio funebre. La signora Perrin piangeva
sommessa sotto i suoi veli.
"É dura, è dura vederci strappare cose che ci erano tanto care... La prego,
mia cara Lucile, non lasci nulla d'intentato. Sia convincente, abile...".
Lucile lanciò un'occhiata alla suocera.
"Questo... questo ufficiale" disse la signora Angellier pronunciando quella
parola con sforzo "non è ancora rientrato. Stasera non lo vedrai, Lucile, è
troppo tardi; ma potrai rivolgerti a lui già domattina e sollecitare il suo
intervento"
"D'accordo. Lo farò".
La signora Perrin tese le mani guantate di nero e attirò a sé Lucile.
"Grazie, grazie, mia cara! E adesso togliamo il disturbo"
"Non prima di aver bevuto qualcosa" disse la signora Angellier.
"Oh, signora, non si incomodi...". "Ma vuole scherzare?...".
E tutt'intorno alla caraffa di aranciata e ai biscotti che Marthe aveva
portato ci fu un sommesso e gentile ciangottio. Un po’ rasserenate, le
signore parlarono della guerra. Paventavano la vittoria tedesca, ma non
desideravano certo la vittoria inglese. In fondo auspicavano che nessuno
vincesse. Per loro la causa di tutti i mali era la mentalità godereccia che si
era diffusa fra il popolo. Poi la conversazione tornò di natura personale. La
signora Perrin e la signora Angellier parlarono dei loro malanni. La signora
Perrin si dilungò alquanto sull'ultimo attacco di reumatismi che l'aveva
colpita; la signora Angellier l'ascoltava con una certa impazienza e, non
appena la signora Perrin si fermava per riprender fiato, si affrettava a dire:
"Lo stesso per me..." e cominciava a parlare dei propri reumatismi.
Le figlie della signora Perrin mangiavano educatamente i loro biscotti.
Fuori continuava a piovere.
CAPITOLO 14.
L'indomani mattina non pioveva più. Il sole illuminava una terra calda,
umida e felice. Già di buonora Lucile, che aveva dormito poco, sedeva su
una panca del giardino e aspettava il passaggio del tedesco. Non appena lo
vide uscire gli andò incontro e gli fece la sua richiesta; tutti e due si
sentivano spiati dalla vecchia signora Angellier e dalla cuoca - senza
contare le vicine, ciascuna delle quali, dietro le imposte chiuse, osservava la
coppia in piedi nel mezzo del vialetto.
"Se è così gentile da accompagnarmi fino alla casa in questione," disse il
tedesco "farò cercare alla sua presenza gli oggetti che queste signore
richiedono. Ma molti dei nostri soldati si sono acquartierati in quella casa
abbandonata dai proprietari, e temo che essa abbia subito notevoli danni.
Andiamo a vedere".
Attraversarono il paese, a fianco a fianco, quasi senza parlare.
Dietro una finestra dell'Hotel des Voyageurs Lucile vide svolazzare il
velo nero della signora Perrin. La gente guardava Lucile e il suo compagno
con un'aria incuriosita ma complice e come di approvazione.
Tutti probabilmente sapevano che la giovane andava a strappare al
nemico una briciola delle sue conquiste (sotto forma di una dentiera, di un
servizio di porcellana e di altri oggetti di valore domestico o sentimentale)
Una vecchia, a cui bastava la vista di un'uniforme tedesca per sentirsi
terrorizzata, si avvicinò comunque a Lucile e le disse sottovoce:
"Brava!- Finalmente! Lei almeno non ha paura di loro." L'ufficiale
sorrise.
"La prendono per Giuditta che va ad affrontare Oloferne nella sua tenda.
Spero che lei non nutra propositi così truci! Eccoci arrivati. La prego,
entri, signora"
Aprì il pesante cancello facendo tintinnare un piccolo sonaglio
melanconico, quello che un tempo avvertiva i Perrin dell'arrivo di qualche
visitatore. Nel giro di un anno il giardino aveva assunto un aspetto
trascurato che in una giornata meno bella avrebbe stretto il cuore. Ma era
una mattina di maggio, all'indomani di un temporale.
L'erba scintillava, i viali traboccavano di margherite, di fiordalisi, di ogni
sorta di fiori stillanti e selvatici che brillavano al sole. Gli arbusti erano
cresciuti in modo disordinato e grappoli freschi di lillà schiaffeggiarono
dolcemente Lucile mentre passava. La casa era occupata da una decina di
giovani soldati e da tutti i bambini del paese che trascorrevano giornate
incantevoli nell'anticamera (come quella degli Angellier, anche questa era
buia, con un vago odore di muffa, vetri verdastri e trofei di caccia alle
pareti) Lucile riconobbe le due bambine del carrettiere, sedute sulle
ginocchia di un soldato biondo dalla larga bocca ridente, e il ragazzino del
falegname, che si divertiva ad andare a cavallo sulla schiena di un altro
soldato. Quattro marmocchi, dai due ai sei anni, figli illegittimi della sarta,
distesi sul pavimento, intrecciavano corone di nontiscordardimé e di quei
piccoli garofani bianchi e profumati che un tempo bordavano tanto
ordinatamente le aiuole.
I soldati scattarono in piedi e si irrigidirono sull'attenti, il mento alzato e
spinto in avanti, il corpo così teso che si vedevano le vene del collo pulsare
leggermente.
L'ufficiale disse a Lucile:
"Vuole favorirmi la sua lista? Cercheremo insieme"
La lesse e sorrise.
"Cominciamo dal divano, che dovrebbe trovarsi in salotto. Immagino che
il salotto sia qui..."
Aprì una porta ed entrò in una stanza molto grande, ingombra di mobili,
alcuni rovesciati, altri rotti, e di quadri allineati per terra lungo le pareti,
qualcuno sfondato a colpi di tacco. Sul pavimento erano rimaste pagine di
giornale, paglia (vestigia, probabilmente, della grande fuga nel giugno del
'40) e mozziconi di sigari lasciati dall'invasore. Su un piedistallo c'era
ancora un bulldog impagliato, con una corona di fiori appassiti e il muso
spaccato in due.
"Che spettacolo!" disse Lucile costernata.
Nonostante tutto c'era qualcosa di buffo in quella stanza e ancor più
nell'aria mortificata dei soldati e dell'ufficiale. Quest'ultimo colse lo sguardo
di Lucile e la sua espressione di rimprovero, e disse con una certa foga:
"I miei genitori possedevano una villa sul Reno; i vostri soldati, durante
l'altra guerra, l'hanno occupata e hanno sfasciato rari e preziosi strumenti
musicali che avevamo da duecento anni, e fatto a pezzi libri appartenuti a
Goethe"
Lucile non poté fare a meno di sorridere; l'ufficiale si difendeva con un
tono aspro e indispettito come un ragazzino che, accusato di una malefatta,
risponde indignato: "Ma, signora, sono stati gli altri a cominciare...".
Lucile provò un piacere tutto femminile, una sorta di dolcezza sensuale
nel vedere quell'aria fanciullesca su un volto che, dopo tutto, era quello di
un nemico implacabile, di uno spietato guerriero. "Non dobbiamo
nasconderci che siamo tutti nelle sue mani" pensò infatti. "Che siamo
indifesi. Se la nostra vita e i nostri beni sono salvi, è solo perché lui lo
permette" Ebbe quasi paura dei sentimenti che le nascevano dentro e che
somigliavano a quello che avrebbe provato accarezzando una bestia feroce,
qualcosa di aspro e di delizioso, un misto di tenerezza e di terrore.
Volle spingere oltre quel gioco. "Dovreste vergognarvi!" esclamò
aggrottando le sopracciglia. "Queste case disabitate erano sotto la
protezione dell'esercito tedesco, affidate al suo onore!"
L'ufficiale la ascoltava mentre con una bacchetta sferzava leggermente il
risvolto degli stivali. Poi si girò verso i soldati e li apostrofò con severità.
Lucile capì che ingiungeva loro di riordinare la casa, di aggiustare ciò che
era rotto e di pulire mobili e pavimenti. Quando parlava in tedesco, specie
con quel tono di comando, la sua voce assumeva una sonorità vibrante e
metallica che procurava all'udito di Lucile un piacere simile a quello di un
bacio un po’ brutale che finisce in un morso. Si portò piano le mani alle
guance brucianti e disse a se stessa: "Fermati! Allontana i tuoi pensieri da
lui, sei su una china pericolosa...".
Mosse qualche passo verso la porta.
"Torno a casa, non resto qui. Le ho dato la lista degli oggetti, dirà ai suoi
soldati di cercarli"
Lui la raggiunse con un balzo.
"La supplico, non vada via arrabbiata... Per quanto è possibile,
sistemeremo tutto, le do la mia parola. Ascolti! Lasciamoli cercare;
caricheranno il tutto su un carretto e andranno a deporlo ai piedi delle
signore Perrin, secondo i suoi ordini. Io verrò con lei per presentare le mie
scuse. Di più non posso fare. Nel frattempo, venga in giardino.
Passeggeremo un po’ e coglierò dei fiori per lei"
"No! Torno a casa!"
"Non può farlo! Ha promesso a quelle signore la restituzione dei loro
beni, e deve assicurarsi che i suoi ordini vengano eseguiti" disse
prendendola per il braccio.
Erano usciti dalla casa e si trovavano in un viale fiancheggiato da lillà in
fiore. Migliaia di api, calabroni e vespe svolazzavano tutto intorno,
penetrando nei fiori, succhiandone il polline e andando poi a posarsi sulle
braccia e sui capelli di Lucile, che non si sentiva per niente rassicurata e
rideva nervosamente.
"Allontaniamoci da qui. Sto passando da un pericolo all'altro".
"Venga più in là"
In fondo al giardino ritrovarono i bambini del villaggio. Alcuni giocavano
in mezzo alle aiuole, tra i fiori strappati, calpestati; altri, arrampicati sui
peri, ne spezzavano i rami.
"Piccoli vandali" disse Lucile. "Non ci saranno più frutti".
"Sì, ma i fiori sono così belli!"
Lui tese le braccia ai bambini che lanciarono loro mazzi di fiori dai teneri
petali.
"Li prenda, signora, saranno splendidi in una coppa al centro del tavolo"
"Non oserò mai attraversare il paese con dei rami di alberi da frutto..."
protestò Lucile ridendo. "Attenti, birbanti, a non farvi prendere dalla
guardia campestre!"
"Non c'è pericolo" disse una bambina in grembiule nero. Addentava una
fetta di pane e si arrampicava su un albero circondandone il tronco con le
gambette tutte sporche.
"Non c'è pericolo... I cruc... I tedeschi non la lasciano entrare la guardia"
Il prato, che l'estate precedente nessuno aveva falciato, era disseminato di
ranuncoli. L'ufficiale sedette nell'erba e gettò a terra il grande mantello
color mandorla tendente al grigio. I bambini li avevano seguiti; la bambina
dal grembiule nero coglieva delle primule; ne faceva grandi mazzi gialli, nei
quali affondava il naso senza staccare dai due adulti gli occhi neri, furbi e
innocenti insieme.
Fissava Lucile con curiosità e anche con un certo spirito critico: uno
sguardo da donna a donna. "Ha l'aria di aver paura" pensava. "Chissà
perché. Non è cattivo, l'ufficiale. Lo conosco, mi dà sempre delle monete e
una volta mi ha preso il pallone che era rimasto fra i rami del grande cedro.
Com'è bello questo ufficiale! Più bello di papà e di tutti i ragazzi del paese.
E che bel vestito ha la signora!".
Si avvicinò di soppiatto e toccò con il ditino sporco un volant dell'abito
leggero, semplice, di mussola grigia, guarnito solo dal colletto e dai polsini
di lino pieghettato. Tirò la stoffa piuttosto forte e Lucile si girò
bruscamente; la piccola fece un balzo indietro, ma Lucile la guardava con
grandi occhi spaventati come se non la riconoscesse. La bambina vide che
la signora era molto pallida e che le tremavano le labbra. Doveva aver paura
a trovarsi lì sola con il tedesco. Come se lui stesse per farle del male! Le
parlava molto gentilmente, però le teneva la mano così forte da toglierle la
voglia di scappare. La piccola pensò confusamente che i maschi, piccoli o
grandi, erano tutti uguali. Si divertivano a punzecchiare le femmine e a
spaventarle. Si sdraiò quant'era lunga nell'erba alta e vi sparì in mezzo. Si
sentiva piccola piccola e invisibile, e i fili d'erba le facevano il solletico sul
collo, sulle gambe, sulle palpebre... era delizioso!
Il tedesco e la signora parlavano sottovoce. Anche lui, adesso, era bianco
come un cencio lavato. Ogni tanto le arrivava la sua voce stridula,
trattenuta, quasi avesse voglia di gridare o di piangere e non osasse farlo.
Per la bambina le sue parole non avevano alcun senso. Capì vagamente che
stava parlando di sua moglie e del marito della signora.
Sentì che ripeteva più volte: "Almeno lei fosse felice... Ma so come vive...
So che è molto sola, che suo marito la trascurava... Ho fatto parlare la gente
del paese" Felice? Dunque non era felice, quella signora, con i suoi bei
vestiti, la sua bella casa? A ogni modo non ci teneva a essere compatita,
voleva andarsene. Gli ordinava di lasciarla andare e di tacere. In fin dei
conti non era più lei ad aver paura, ma lui piuttosto, nonostante i suoi stivali
e la sua aria superba, sì, era lui a sembrare intimidito. In quel momento una
coccinella si posò sulla mano della bambina, che la osservò per qualche
istante; aveva voglia di ucciderla ma sapeva che uccidere una bestiolina del
Buon Dio porta male.
Si limitò a soffiarvi sopra, dapprima piano, giusto per sollevarne le ali
sottili e trasparenti finemente lavorate, poi con tutte le sue forze - così che la
povera bestiola dovette sentirsi come un naufrago su una zattera in balia di
un mare in tempesta. Ma la coccinella volò via. "É sul suo braccio,
signora!" gridò la bambina. L'ufficiale e la signora si voltarono di nuovo e
guardarono verso di lei senza vederla. L'ufficiale, però, fece un gesto
impaziente con la mano come se scacciasse una mosca.
"No che non me ne vado!" disse la piccola fra sé con aria di sfida. "E poi,
che cosa ci fanno qui? Un signore e una signora potrebbero restarsene in
salotto!" Risentita, tese l'orecchio. Che cosa si dicevano? "Mai," affermava
l'ufficiale con voce bassa e rauca "mai la dimenticherò!"
Una grande nuvola coprì metà del cielo; i fiori, i freschi e brillanti colori
del prato, tutto si spense. La signora strappava i fiorellini viola dei trifogli e
li sbriciolava.
"É impossibile" disse, con voce che tremava di pianto.
"Che cosa è impossibile?" si domandò la bambina.
"Anch'io ho pensato... lo confesso, non parlo... d'amore... ma avrei voluto
avere un amico come lei... Non ho mai avuto un amico. Non ho nessuno!
Ma è impossibile"
"Per via della gente?" disse l'ufficiale con aria sprezzante.
Lei lo guardò con fierezza.
"La gente? Se dentro di me mi sentissi innocente... Ma no! Non ci può
essere niente fra noi"
"Ci sono già molte cose che lei non potrà mai dimenticare: la nostra
giornata sotto la pioggia, la musica, questa mattinata, le nostre passeggiate
nei boschi...".
"Ah, non avrei dovuto!"
"Ma è troppo tardi... Non può farci niente! Quel che è fatto...".
La bambina nascose il viso fra le braccia ripiegate e non sentì più che un
lontano mormorio, come il ronzio di un'ape. Quella grande nuvola, quegli
sprazzi di sole cocente annunciavano pioggia. Se all'improvviso si fosse
messo a piovere, come si sarebbero comportati la signora e l'ufficiale?
Sarebbe stato divertente vederli correre sotto l'acquazzone, lei con il
cappello di paglia e lui con quel bel mantello verde... Ma avrebbero potuto
nascondersi nel giardino. Se avessero consentito a seguirla, avrebbe
mostrato loro una pergola dove nessuno poteva vederli. "É mezzogiorno"
disse fra sé la bambina sentendo suonare l'Angelus. "Chissà se tornano a
casa per pranzo... Che cosa mangiano i ricchi? Formaggio molle come noi?
Pane? Patate? Caramelle? E se gli domandassi delle caramelle?" Già si
avvicinava alla coppia con l'intento di chiedere delle caramelle - non aveva
paura di niente la piccola Rose - quando vide i due alzarsi di scatto e
rimanere in piedi, tremanti. Proprio così, quel signore e quella signora
tremavano, come quando lei si era arrampicata sul ciliegio della scuola e, la
bocca ancora piena di ciliegie, aveva sentito la voce della maestra che le
ordinava: "Rose, piccola ladruncola, scendi immediatamente da lì!" Ma
davanti a quei due non c'era la maestra, bensì un soldato sull'attenti che
parlava molto in fretta in quella lingua incomprensibile; nella sua bocca le
parole facevano il rumore di un torrente su un letto di ciottoli.
L'ufficiale si scostò dalla signora pallida e sconvolta.
"Che cosa c'è? Cosa dice?" mormorò lei.
L'ufficiale sembrava altrettanto sgomento; ascoltava il soldato senza
capire. Poi il suo volto pallido si illuminò di un sorriso.
"Dice che è stato recuperato tutto... ma che la dentiera del vecchio signore
è andata rotta perché i bambini ci hanno giocato, volevano introdurla nella
bocca del bulldog impagliato"
Tutti e due - l'ufficiale e la signora - sembravano uscire a poco a poco da
una sorta di rituale magico e tornare sulla terra. Abbassarono lo sguardo
sulla piccola Rose e, questa volta, la videro. L'ufficiale le tirò l'orecchio.
"Che cosa avete fatto, birbanti?"
Ma la voce era incerta e nel riso della signora si coglieva un'eco vibrante
come un rumore soffocato di singhiozzi. Rideva come ride chi ha avuto
molta paura e, pur ridendo, non può ancora dimenticare di essere sfuggito a
un pericolo mortale. La piccola Rose, molto seccata, cercava invano di
scappare. "La dentiera... sissignore... volevamo vedere l'aria feroce del
bulldog con quei bei denti bianchi tutti nuovi...". Ma temeva la collera
dell'ufficiale (visto da vicino sembrava molto grande e terribile) e preferì
dire piagnucolando:
"Non abbiamo fatto niente... non l'abbiamo neanche vista la vostra
dentiera"
Da ogni parte, in un'allegra confusione di voci fresche e acute, arrivavano
gli altri bambini. La signora supplicò:
"No, no! Lasci stare! Non importa! É già bello aver trovato tutto il resto"
Un'ora dopo dal giardino dei Perrin usciva una frotta di bambini con i
grembiulini sporchi, nonché due soldati tedeschi che trasportavano un
carretto contenente un cesto pieno di tazze di porcellana, un divano con i
quattro piedi all'aria, di cui uno rotto, un album di peluche, la gabbia di un
canarino che i soldati avevano scambiato per lo sgocciolatoio richiesto dalle
proprietarie e diversi altri oggetti.
Chiudevano il corteo Lucile e l'ufficiale. Attraversarono tutto il paese
sotto gli sguardi incuriositi delle donne e fu notato che i due non si
parlavano, che neppure si guardavano e che erano di un pallore insolito;
l'ufficiale aveva un'aria gelida e impenetrabile. Le donne sussurrarono:
"Deve averglielo detto chiaro e tondo che è una vergogna ridurre una casa
in quello stato. Lui è infuriato. E ci credo! Non sono abituati che gli si tenga
testa! Ha fatto bene, brava. Non siamo bestie! É coraggiosa, la giovane
signora Angellier, non ha paura" dicevano le donne. Una di loro, che badava
a una capra (la stessa vecchierella che la domenica di Pasqua aveva detto
alle signore Angellier di ritorno dai Vespri: "Questi tedeschi sono molto
cattivi"), una donnina ingenua, dai capelli bianchi e gli occhi azzurri,
passando accanto a Lucile sussurrò addirittura:
"Coraggio, signora, gli faccia vedere che non abbiamo paura! Il suo
prigioniero sarebbe fiero di lei" e si mise a piangere, non perché qualcuno
dei suoi fosse prigioniero (da tempo aveva passato l'età per avere un marito
o un figlio in guerra), ma perché i pregiudizi sopravvivono alle passioni e
lei era patriota e sentimentale.
CAPITOLO 15.
Quando la vecchia signora Angellier e il tedesco si trovavano a faccia a
faccia arretravano entrambi istintivamente: un gesto che poteva passare, da
parte dell'ufficiale, per un'ostentazione di cortesia, per il desiderio di non
importunare con la propria presenza la padrona di casa, ma assomigliava
piuttosto allo scarto di un cavallo di razza appena vede una vipera tra gli
zoccoli; mentre la signora Angellier non si preoccupava nemmeno di
reprimere il brivido che l'attraversava, e rimaneva irrigidita dal terrore,
come chi abbia sfiorato una bestia pericolosa e immonda. Ma tutto questo
durava solo un istante: la buona educazione serve appunto a correggere le
reazioni istintive della natura umana. L'ufficiale stava ancora più impettito,
dava ai suoi lineamenti una fissità, una serietà da automa, piegava il capo e
batteva i tacchi (oh, quel saluto alla prussiana!, mormorava la signora
Angellier, senza pensare che da parte di un uomo nato nella Germania
orientale tale saluto era, in definitiva, quello che era naturale aspettarsi, più
del baciamano da parte di un arabo o dello shake-hand da parte di un
inglese) Quanto alla signora Angellier, incrociava le mani sul petto con un
gesto simile a quello di una suora che, dopo aver vegliato un morto, si alza
per salutare un membro della famiglia in odore di anticlericalismo, il che fa
passare sulla sua faccia ombre diverse: apparente rispetto ("Il padrone è
lei"), biasimo ("Ma non creda d'ingannarci, miscredente che non è altro!"),
sottomissione ("Offriamo al Signore le nostre ripugnanze") e infine uno
sprazzo di gioia feroce ("Aspetta, amico mio, brucerai all'inferno mentre io
riposerò sul cuore di Gesù") Nella mente della signora Angellier
quest'ultimo pensiero era sostituito da un auspicio da lei formulato tra sé e
sé ogni volta che si imbatteva in un membro dell'esercito occupante: "Spero
che tu finisca presto in fondo alla Manica" (dato che all'epoca si parlava di
un tentativo d'invasione dell'Inghilterra e ci si aspettava di vederlo messo in
atto da un giorno all'altro) Prendendo i suoi desideri per realtà, la signora
Angellier credeva perfino di vedere il tedesco già sotto forma di un livido e
gonfio annegato in balia delle onde, e solo questa immagine le consentiva di
riacquistare un'espressione normale, di lasciar errare sulle labbra un pallido
sorriso, come l'ultimo raggio di un astro che si spegne, e di rispondere
all'interlocutore che si informava della sua salute: "Sto bene, grazie, per
quanto è possibile", con una nota lugubre che risuonava nelle ultime parole
e che significava: "Per quanto è possibile dato lo stato disastroso della
Francia"
Dopo la signora Angellier arrivava Lucile, che era, in quei giorni, più
fredda, distratta e schiva del solito. Nell'accomiatarsi dal tedesco piegava
silenziosamente il capo. Nemmeno lui diceva niente, ma, credendo di non
esser visto, la seguiva con un lungo sguardo. La signora Angellier, però,
sembrava avere occhi anche dietro la testa e, senza girarsi, mormorava
irosamente a Lucile: "Non badargli. É ancora lì".
Tirava il fiato solo dopo che la porta si era richiusa alle loro spalle, e
allora lanciava alla nuora un'occhiata omicida: "Oggi hai cambiato
pettinatura..." oppure: "Vedo che hai messo il vestito nuovo..." e concludeva
seccamente: "Non ti sta bene"
E tuttavia, malgrado l'astio che a volte provava nei confronti di Lucile,
semplicemente perché lei era lì e suo figlio no, malgrado ciò che avrebbe
potuto fiutare, intuire, era mille miglia lontana dal pensare che fra sua nuora
e il tedesco potesse esistere un affetto. Dopo tutto, si giudicano gli altri solo
in base al proprio cuore: l'avaro vede sempre la gente spinta dall'interesse, il
lussurioso dall'ossessione del desiderio. Per la signora Angellier un tedesco
non era un uomo, era la personificazione della crudeltà, della perfidia e
dell'odio. Che qualcun altro potesse giudicare uno di loro diversamente le
sembrava impossibile, inverosimile... Né poteva figurarsi Lucile innamorata
di un tedesco più di quanto potesse immaginare l'accoppiamento di una
donna e di un mostro leggendario, come il liocorno, il drago o il serpente
marino. E neanche il tedesco poteva essere innamorato di Lucile, dato che
lei non gli riconosceva alcun sentimento umano. Pensava che, con i suoi
sguardi, l'ufficiale volesse profanare quella casa francese ancor più che con
la sua semplice presenza, che provasse un piacere brutale nel vedere la
madre e la moglie di un prigioniero francese ridotte alla sua mercé.
Soprattutto la irritava quella che chiamava "l'indifferenza" di Lucile:
"S'inventa altre pettinature, mette vestiti nuovi! Non capisce che il tedesco
penserà che lo faccia per lui! Che mancanza di dignità!" Avrebbe voluto
coprire la faccia di Lucile con una maschera, infagottarla in un sacco.
Vederla così bella e in buona salute la faceva soffrire. Il suo cuore
sanguinava: "E intanto mio figlio, il mio caro figlio...".
Una sera conobbe un attimo di gioia allorché lei e Lucile incrociarono il
tedesco nell'atrio e videro che era pallidissimo e aveva un braccio al collo
(con una certa ostentazione, sentenziò la signora Angellier)
Fu scandalizzata nell'udire Lucile che si affrettava a chiedere, quasi suo
malgrado:
"Che cosa le è successo, mein Herr?"
"Una caduta da cavallo... Una bestia difficile che montavo per la prima
volta"
"Ha una gran brutta cera" disse Lucile guardando la faccia stravolta del
tedesco. "Vada a sdraiarsi un pochino".
"Oh, no! É solo un graffio, e del resto...".
Le fece segno di ascoltare il reggimento che passava sotto le finestre.
"Manovre...".
"Come? Ancora?"
"Siamo in guerra" rispose lui.
Sorrise debolmente e, dopo un breve saluto, uscì.
"Ma cosa fai?" esclamò acida la signora Angellier.
Lucile aveva scostato la tenda e seguiva con lo sguardo i soldati che si
allontanavano.
"Non hai il senso della decenza. I tedeschi devono sfilare davanti a
finestre e imposte chiuse... come nel '70...".
"Certo, quando entrano per la prima volta in una città, ma dato che
passano nelle nostre strade quasi ogni giorno, se seguissimo le tradizioni
alla lettera saremmo condannati a un'oscurità perpetua" ribatté Lucile con
impazienza.
Minacciava un temporale: una luce sulfurea cadeva su quei volti levati in
alto, su quelle bocche aperte dalle quali usciva un canto cadenzato, diffuso a
mezza voce, come trattenuto e represso, ma che di lì a poco sarebbe esploso
in un coro cupo e magnifico. La gente del paese diceva:
"Hanno dei canti strani, trascinanti, sembrano preghiere"
Al tramonto un balenio rossastro sembrò tingere di sangue quelle teste
con l'elmetto e il sottogola, quelle uniformi verdi e l'ufficiale a cavallo che
comandava il reparto. Perfino la signora Angellier ne rimase colpita, e
mormorò:
"Speriamo che sia un presagio...".
Le manovre si conclusero a mezzanotte. Lucile sentì il rumore della porta
d'ingresso che veniva aperta e richiusa. Riconobbe il passo dell'ufficiale sul
pavimento dell'anticamera Sospirò. Non riusciva a dormire. Un'altra brutta
nottata! Si somigliavano tutte, ormai: dolorosa insonnia e incubi
incoerenti... Alle sei era già in piedi. Ma non serviva a niente. Non faceva
che rendere le giornate più lunghe, più vuote.
La cuoca informò le signore Angellier che l'ufficiale era rientrato
ammalato; il maggiore era venuto a fargli visita, lo aveva trovato
febbricitante e gli aveva ordinato di restare a letto. A mezzogiorno due
soldati tedeschi si presentarono con un pasto che il ferito si rifiutò di
consumare. Si era chiuso in camera ma non stava a letto. Lo si sentiva
andare su e giù per la stanza, e quel monotono scalpiccio irritava talmente la
signora Angellier che volle ritirarsi di sopra subito dopo pranzo,
contrariamente alle sue abitudini, perché di solito faceva i conti o lavorava a
maglia in sala da pranzo fino alle quattro, d'estate accanto alla finestra,
d'inverno accanto al fuoco. Solo dopo quell'ora saliva al primo piano, dove
si trovavano le sue stanze e dove nessun rumore poteva raggiungerla.
Lucile, allora, tirava il fiato finché non sentiva di nuovo un passo leggero
che scendeva la scala, vagava per le stanze come a caso, poi si perdeva nelle
profondità del primo piano. Si era domandata spesso che cosa facesse la
suocera lassù, al buio - giacché chiudeva imposte e finestre e non accendeva
la luce.
Dunque non leggeva. Del resto non leggeva mai. Forse continuava a
lavorare a maglia nell'oscurità. Faceva sciarpe per i prigionieri, lunghe
strisce dritte. Andava avanti senza guardare, con una sicurezza da cieca.
Forse pregava... Forse dormiva... Chissà. Fatto sta che scendeva alle sette
senza un capello fuori posto, diritta e muta nel suo vestito nero.
Quel giorno e i giorni seguenti Lucile la sentì chiudere la porta della sua
camera a chiave, poi non udì più niente; la casa sembrava morta, solo il
passo regolare del tedesco rompeva il silenzio, senza però arrivare alle
orecchie della vecchia signora, protetta dalle pareti spesse e dai tendaggi
che soffocavano i suoni. La sua era una stanza molto grande, scura e
ingombra di mobili. Appena entrava la signora Angellier la rendeva ancora
più buia chiudendo le imposte e tirando le tende, poi si metteva a sedere in
una grande poltrona dalla tappezzeria verde e incrociava sulle ginocchia le
mani trasparenti. Chiudeva gli occhi; talvolta sulle guance le scorrevano
lacrime rade e brillanti, quel pianto tipico dei vecchi che sembra uscire a
stento, controvoglia, come se l'età avesse finalmente riconosciuto l'inutilità,
la vanità di ogni lamento. Le asciugava via con un movimento quasi
selvaggio. Si raddrizzava, parlava fra sé a mezza voce. "Vieni, non sei
stanco? Ti sei ancora messo a correre dopo mangiato, in piena digestione;
sei tutto sudato. Su, vieni, Gaston, prendi il tuo sgabelletto e mettiti qui,
vicino alla mamma. Vieni, che ti faccio leggere. Ma puoi riposarti ancora un
momento, metti la tua testolina sulle ginocchia della mamma" diceva, e
lievemente, teneramente, accarezzava riccioli immaginari.
Non era delirio né un principio di follia; mai era stata più spietatamente
lucida e cosciente di sé: era una sorta di commedia volontaria, la sola che le
procurasse un po’ di sollievo - come può darne l'alcol o la morfina.
Nell'oscurità, nel silenzio, ricreava il passato; rievocava istanti che lei stessa
aveva creduto dimenticati per sempre; portava alla luce dei tesori; ritrovava
una determinata parola detta dal figlio, una determinata intonazione della
sua voce, un gesto delle piccole mani paffute che realmente, per un attimo,
cancellavano il tempo. Non si trattava più di immaginazione: la realtà stessa
le veniva restituita in ciò che aveva d'imperituro, perché niente poteva far sì
che tutto quello non fosse avvenuto. Né l'assenza né la morte riuscivano a
cancellare il passato; un grembiulino rosa che suo figlio aveva indossato, il
gesto con cui le aveva teso piangendo la mano punta da un'ortica erano
esistiti realmente, ed era in suo potere, per gli anni che le restavano, farli
esistere di nuovo. Occorrevano soltanto la solitudine, l'ombra e, intorno a
lei, quei mobili, quegli oggetti che il figlio aveva conosciuto. Variava a
piacere tali sue allucinazioni. Non si accontentava del passato, anticipava il
futuro! Cambiava il presente a suo piacimento: mentiva e ingannava se
stessa, ma poiché quelle menzogne erano opera sua le erano care. Per
qualche breve istante era felice. La sua felicità non aveva più limiti, non era
più condizionata dalla realtà. Tutto diventava possibile, alla sua portata.
Tanto per cominciare la guerra era finita: questo era il punto di partenza del
sogno, il trampolino da cui lanciarsi verso una felicità assoluta. La guerra
era finita... Un giorno come gli altri... Perché non domani? Lei non avrebbe
saputo niente fino all'ultimo momento: non leggeva più i giornali, non
ascoltava la radio. Sarebbe stata come un'esplosione, o come un colpo di
tuono. Una mattina, scendendo in cucina, avrebbe visto Marthe con gli
occhi fuori dalla testa: "Ha sentito, signora?" Ecco come aveva avuto
notizie sulla resa del re dei belgi, sull'occupazione di Parigi, sull'arrivo dei
tedeschi, sull'armistizio... E allora, perché non la pace? Perché non queste
parole: "Pare che sia finita, signora!
Non si combatte più, non c'è più la guerra, i prigionieri stanno per tornare
a casa!" Che la vittoria fosse degli inglesi o dei tedeschi, poco le importava!
Lei non pensava che a suo figlio. Pallida, con le labbra tremanti e gli occhi
chiusi, tracciava mentalmente il suo quadro con quella dovizia di particolari
che si trova nelle pitture dei pazzi.
Vedeva ogni minima ruga sul volto di Gaston, e i capelli, gli abiti, i lacci
degli scarponi militari; sentiva ogni inflessione della sua voce.
Tese le mani sussurrando: "Su, entra, non riconosci più la tua casa?"
Durante quei primi istanti in cui lui sarebbe appartenuto solo a lei, Lucile
sarebbe rimasta nell'ombra. Lei non avrebbe ecceduto in baci e lacrime; gli
avrebbe fatto preparare un buon pranzetto, un bagno. "Mi sono occupata dei
tuoi affari, sai. Quella proprietà che desideravi, vicino all'EtangNe–, l'ho
comprata, è tua. Ho acquistato anche il prato dei Montmort, quello che
confinava con il nostro e che il visconte non voleva assolutamente cederci.
Ho aspettato il momento favorevole e ho ottenuto quello che volevo. Sei
contento? Ho messo al sicuro il tuo oro, l'argenteria, i gioielli di famiglia.
Ho fatto tutto da sola, ho affrontato ogni difficoltà. Se avessimo dovuto
contare su tua moglie...
Non sono forse io la tua unica amica? La sola che ti capisce? Ma adesso
va, figlio mio! Va da tua moglie. Non aspettarti granché da lei. É una
creatura fredda e caparbia. Ma noi due, insieme, sapremo piegarla ai nostri
voleri più di quanto potessi farlo io da sola, quando lei mi sfuggiva con i
suoi lunghi silenzi. Ma tu, tu hai il diritto di chiederle: "A cosa pensi?" Tu
sei il padrone, tu puoi esigere una risposta. Va da lei, va! Prendile tutto
quello che ti appartiene: la sua bellezza, la sua gioventù... Mi è stato detto
che a Digione... Non sta bene, piccolo mio! Un'amante costa cara. Ma
questa lunga assenza ti avrà fatto amare di più la nostra vecchia casa... Oh,
quante belle, tranquille giornate passeremo insieme" mormorò subito dopo
la signora Angellier. Si era alzata e camminava adagio per la stanza. Nel
sogno teneva una mano immaginaria, si appoggiava a una spalla. "Vieni,
adesso scendiamo. Ho fatto preparare qualcosa da mangiare, sei dimagrito,
figlio mio. Devi rimetterti, vieni".
Aprì meccanicamente la porta, scese le scale. Sì, la sera sarebbe uscita
così dalla sua camera. Avrebbe fatto una sorpresa ai ragazzi. Avrebbe
trovato il figlio seduto in poltrona vicino alla finestra con la moglie accanto
intenta a leggergli qualcosa. Era suo dovere, spettava a lei curarlo, distrarlo.
Ai tempi della convalescenza di Gaston dopo una febbre tifoidale Lucile gli
leggeva i giornali. Aveva una voce dolce e molto gradevole all'ascolto, e lei
stessa a volte vi prestava orecchio con piacere. Una voce dolce e bassa...
Ma... Non la stava giusto ascoltando? No, era un sogno! Aveva spinto le sue
fantasticherie al di là dei limiti consentiti. Si irrigidì, fece qualche passo,
entrò nella sala e vide nella poltrona vicino alla finestra, con il braccio ferito
posato sul bracciolo, la pipa in bocca, i piedi sullo sgabello dove sedeva
Gaston bambino, vide, nella sua uniforme verde, l'invasore, il nemico, il
tedesco, e Lucile accanto a lui, che leggeva un libro ad alta voce.
Vi fu un attimo di silenzio. Tutti e due si alzarono in piedi. Lucile si
lasciò scappare di mano il libro che cadde a terra. L'ufficiale si precipitò a
raccoglierlo, lo posò sul tavolo e mormorò:
"Signora, sua nuora mi ha gentilmente autorizzato a tenerle compagnia
per qualche minuto"
La vecchia signora, pallidissima, inclinò leggermente il capo.
"Lei è il padrone, qui"
"E poiché da Parigi mi hanno mandato dei libri nuovi, mi sono permesso
di...".
"Lei qui è il padrone" ripeté la signora Angellier.
Fece dietro front e uscì. Lucile sentì che diceva alla cuoca:
"Non uscirò più dalla mia camera, Marthe. Mi porterai i pasti di sopra".
"Oggi, signora?"
"Oggi, domani, e finché questi signori saranno qui"
Quando si fu allontanata, e il rumore dei suoi passi svanì nelle profondità
della casa, il tedesco disse sottovoce:
"Sarà il paradiso"
CAPITOLO 16.
La viscontessa di Montmort soffriva d'insonnia; aveva un animo cosmico:
tutti i grandi problemi del momento trovavano un'eco nel suo cuore. Se
pensava al futuro della razza bianca, ai rapporti franco-tedeschi, al pericolo
massone e al comunismo, non riusciva a prendere sonno. Brividi freddi
l'attraversavano dalla testa ai piedi. Allora si alzava, si gettava addosso una
vecchia pelliccia tarlata e usciva nel parco. Non si curava dell'eleganza,
forse perché non sperava più di poter correggere con un bell'abito un fisico
alquanto sgradevole - naso lungo e rosso, figura quasi deforme, pelle
costellata di foruncoli -, forse per quella sorta di orgoglio congenito per cui
si crede nella superiorità del proprio valore e non si può immaginare che
resti nascosto agli occhi altrui, anche sotto un cappello sformato o un
cappotto lavorato a maglia (verde marcio e giallo canarino) che la sua cuoca
non avrebbe indossato per tutto l'oro del mondo, o forse per sprezzo delle
circostanze. "Che importanza avrà mai, amico mio?" diceva con dolcezza al
marito quando lui le rimproverava di presentarsi a tavola con una scarpa
diversa dall'altra. Ma se si trattava di strigliare i domestici o di badare ai
propri interessi scendeva di colpo da quelle sublimi altezze.
Nelle notti insonni passeggiava nel parco recitando poesie o si spingeva
fino al pollaio per controllare le tre enormi serrature che ne impedivano
l'accesso; teneva d'occhio le mucche che passavano la notte sui prati dove,
per via della guerra, non si coltivavano più fiori e, nel dolce chiarore lunare,
andava su e giù per l'orto e contava le pianticelle di mais. Sì, qualcuno la
derubava. Prima della guerra la coltivazione del mais era pressoché
sconosciuta in quella ricca contrada che nutriva gli animali da cortile con
grano e avena. Adesso, però, gli addetti alla requisizione perlustravano tutti
i granai per sequestrare i sacchi di grano, e le massaie non avevano più
niente da dare alle galline. Ci si era rivolti ai proprietari del castello per
ottenere qualche pianticella di mais, ma i Montmort le tenevano in serbo
prima di tutto per loro, poi per amici e conoscenti della zona. I contadini si
infuriavano. "Siamo disposti a pagare" dicevano. Non avrebbero pagato
niente, del resto, ma il punto non era quello, ed essi intuivano oscuramente
di cozzare contro una sorta di massoneria, una solidarietà di classe per cui
loro e il loro denaro passavano in secondo piano rispetto al piacere dei
Montmort di fare un favore al barone di Montrefaut o alla contessa di
Pignepoule. Non potendo comprare, i contadini prendevano. Al castello non
c'erano più guardiani; fatti prigionieri in guerra, non erano stati sostituiti
perché il paese mancava di uomini. Altrettanto impossibile era trovare
operai e materiale per rimettere in sesto i muri che cadevano in rovina. I
contadini si introducevano attraverso le brecce e cacciavano di frodo,
pescavano nello stagno, portavano via galline, pianticelle di pomodoro o di
mais, insomma arraffavano a piacimento. Il visconte di Montmort si trovava
in una posizione delicata. Da una parte, in quanto sindaco, non voleva
inimicarsi la cittadinanza, dall'altra era naturalmente molto attaccato ai
propri beni. Pur tuttavia avrebbe magari chiuso un occhio se non ci fosse
stata la moglie che, per principio, rifiutava qualsiasi compromesso, qualsiasi
segno di debolezza. "Voi cercate solo la pace" diceva irritata al marito.
"Perfino nostro Signore ha detto: "Non sono venuto a portare la pace, ma la
spada"" "Voi non siete Gesù Cristo" brontolava Amaury, ma da tempo, in
famiglia, si dava atto alla viscontessa di possedere uno zelo apostolico e una
lucidità chiaroveggente. Amaury era del resto incline a condividere le
opinioni della moglie, tanto più che era lei la detentrice del patrimonio
familiare ed era lei a tenere stretti i cordoni della borsa. La appoggiava
dunque lealmente e faceva una guerra accanita ai bracconieri, ai ladruncoli
di piante e granaglie, alla maestra che non andava a messa e all'impiegato
delle poste, sospettato di appartenere al Fronte Popolare benché avesse
ostentatamente attaccato sulla porta della cabina telefonica una fotografia
del maresciallo petain.
Una bella notte di giugno la viscontessa passeggiava nel parco del suo
castello e declamava i versi che voleva far recitare alle sue protette della
scuola confessionale in occasione della Festa della Madre. Avrebbe
desiderato comporli lei stessa, ma, pur essendo dotata per la prosa (quando
vi si cimentava, il flusso delle idee era in lei così possente da costringerla a
posare spesso la penna e immergere le mani nell'acqua fredda per far
defluire il sangue salito alla testa), lo era meno per la poesia. La costrizione
alla rima le riusciva insopportabile. Decise perciò di sostituire la poesia che
avrebbe voluto comporre in onore della Madre francese con una
invocazione in prosa; "O madre," avrebbe recitato una delle scolarette delle
elementari vestita di bianco e con un mazzolino di fiori di campo tra le mani
"o madre, poter vedere il tuo dolce viso chinato sul mio lettino mentre fuori
infuria la tempesta! Il cielo è nero sul mondo, ma un'alba radiosa sta per
levarsi. Sorridi, o tenera madre! Guarda: la tua bambina segue il
Maresciallo che tiene per mano la pace e la felicità. Entra anche tu nel
gioioso girotondo di tutti i bambini e di tutte le mamme di Francia intorno al
venerando Vegliardo che ci ridona la speranza!"
La signora di Montmort pronunciò solennemente quelle parole che
echeggiarono nel silenzio del parco. Quando le veniva l'ispirazione non era
più padrona di sé. Andava su e giù a grandi passi; poi si lasciò cadere sul
muschio umido e, stringendosi la pelliccia intorno alle spalle magre, prese a
meditare. La meditazione, in lei, assumeva presto la forma di rivendicazioni
appassionate. Perché, con tutte le sue doti, non percepiva intorno a sé calda
ammirazione o amore? Perché era stata presa in moglie per il suo denaro?
Perché era così impopolare? Quando passava per il paese i bambini
correvano a nascondersi o le sghignazzavano dietro. Sapeva che la
chiamavano "la Pazza". Era dura sentirsi detestata, malgrado si fosse data
tanto da fare per i suoi contadini... La biblioteca (ma quei libri scelti con
amore, tutte quelle buone letture che elevano lo spirito, li lasciavano freddi;
le ragazze reclamavano i romanzi di Maurice Dekobra - che generazione,
ahimè...), i film edificanti (anche quelli suscitavano scarso interesse), la
festa annuale nel parco con uno spettacolo realizzato dai bambini della
scuola confessionale... Ma a quel proposito le erano giunte all'orecchio
aspre critiche. La biasimavano perché aveva fatto disporre delle sedie
all'interno del garage in caso di maltempo, qualora non fosse stato possibile
festeggiare sotto gli alberi. Che cosa volevano quegli individui? Pensavano
forse che li avrebbe fatti entrare nel castello?
Sarebbero stati i primi a sentirsi a disagio. Ah, il nuovo spirito, il
deplorevole spirito che soffiava sulla Francia! Lei sola sapeva riconoscerlo
e dargli un nome. Il popolo stava diventando bolscevico. La signora di
Montmort aveva pensato che la sconfitta gli sarebbe stata salutare, lo
avrebbe distolto da una china pericolosa, lo avrebbe costretto di nuovo a
rispettare i capi: e invece no, era peggio che mai.
A volte lei, ardente patriota, arrivava addirittura al punto di rallegrarsi per
la presenza del nemico, pensò sentendo il passo delle sentinelle tedesche
sulla strada che costeggiava il parco. Perlustravano il paese per tutta la
notte, a squadre di quattro; si sentiva la suoneria dolce e familiare
dell'orologio della chiesa che cullava i sogni della gente, insieme al
martellare degli stivali sul selciato e al clicchettio delle armi, come nel
cortile di una prigione. Sì, la viscontessa di Montmort era arrivata a
domandarsi se non si dovesse ringraziare il Buon Dio per aver consentito
l'entrata dei tedeschi in Francia. Non che lei li amasse, per carità di Dio!
Non li poteva soffrire, ma senza di loro... Chissà?... Amaury aveva un bel
dirle:
"Comunisti, questi? Ma se sono più ricchi di voi...". Non era solo una
questione di denaro o di proprietà, ma anche, e soprattutto, di passione. Lei
lo avvertiva confusamente senza riuscire a spiegarselo.
Forse quella gente aveva un'idea approssimativa di cosa fosse realmente il
comunismo, ma certo quella dottrina assecondava la loro aspirazione
all'uguaglianza, aspirazione che il possesso di denaro e di terre esasperava
invece di soddisfare. A quelli non andava giù, secondo la loro espressione,
di possedere una fortuna in capi di bestiame, di poter pagare gli studi ai figli
e le calze di seta alle figlie, se poi si sentivano, nonostante tutto, inferiori ai
Montmort. Insomma, ritenevano di non essere mai trattati con sufficiente
riguardo, specie da quando il visconte era sindaco del paese... Il vecchio
contadino che lo aveva preceduto nell'incarico dava del tu a tutti, era avaro,
rozzo, duro, insultava i paesani... e quelli gli perdonavano ogni cosa! Ma al
visconte di Montmort rimproveravano di mostrarsi altezzoso, e questo non
poteva essere perdonato. Pensavano forse, quei contadini, che lui si sarebbe
alzato in piedi vedendoli entrare nella sala del municipio? Che li avrebbe
accompagnati fino alla porta o che altro? Non sopportavano nessun genere
di superiorità, né di nascita né di ricchezza. C'era poco da dire, i tedeschi
avevano dei pregi. Erano un popolo disciplinato, docile, pensò la signora di
Montmort ascoltando quasi con piacere il passo cadenzato che si
allontanava e la voce rauca che in lontananza gridava: "Achtung" Doveva
essere piacevole possedere grandi terre in Germania, mentre lì...
Questi pensieri la tormentavano. Intanto la notte avanzava e lei si
apprestava a rientrare, allorché vide - credette di vedere - un'ombra che
scivolava lungo il muro, si chinava e spariva in direzione dell'orto.
Finalmente avrebbe colto in flagrante uno dei ladri di mais.
Fremette di gioia. Neanche per un attimo ebbe paura. Amaury temeva i
colpi di mano, lei no! Il pericolo risvegliava la sua predisposizione alla
caccia. Seguì dunque l'ombra, celandosi dietro i tronchi degli alberi giacché
mentre ispezionava la base del muro aveva trovato un paio di zoccoli
nascosti dal muschio. Il ladro camminava scalzo per far meno rumore. La
viscontessa si mosse in modo da pararglisi davanti appena lui uscì dall'orto.
L'uomo fece un brusco movimento per fuggire, ma lei gli gridò con voce
sprezzante:
"Ho i tuoi zoccoli, amico. Le guardie faranno presto a scoprire a chi
appartengono"
L'uomo allora si fermò, tornò indietro, e lei riconobbe Benoît Labarie.
Restarono l'uno di fronte all'altro, in silenzio.
"Ma bravo!" disse infine la viscontessa con voce che tremava di odio.
Lo detestava. Era il più insolente, il più intrattabile di tutti i contadini; che
fosse per il fieno, per il bestiame, per i recinti, per una cosa qualsiasi, fra il
castello e la fattoria dei Labarie era in atto una sorda e incessante guerriglia.
La viscontessa disse con indignazione:
"Bene, ragazzo mio, adesso so chi è il ladro, vado subito ad avvertire il
sindaco. Non illuderti di farla franca!".
"Dica un po’, le do forse del tu, io? Se le prenda, le sue piante, eccole"
fece Benoît gettandole per terra, dove si sparpagliarono sotto i raggi della
luna. "Ci rifiutiamo forse di pagare? Pensate che non abbiamo abbastanza
soldi? É da un pezzo che vi chiediamo di farci questo favore... per quel che
vi costerebbe... Ma no! Preferite lasciarci crepare"
"Ladro, ladro, ladro!" continuava a gridare la viscontessa con quanto fiato
aveva in corpo. "Il sindaco...".
"Me ne frego del sindaco! Lo porti pure qui. Glielo dirò in faccia".
"Come osa parlarmi in questo tono...".
"Ne abbiamo abbastanza di voi, in paese, se vuol proprio saperlo! Avete
tutto e vi tenete stretto tutto! La vostra legna, la vostra frutta, i vostri pesci,
la selvaggina, i polli, non li vendete, non li cedete per tutto l'oro del mondo.
E il sindaco fa tanti bei discorsi sulla solidarietà, sull'aiuto reciproco! Ma
che vada a farsi fottere! Il vostro castello è pieno zeppo di roba, dalla
cantina alla soffitta, lo sappiamo, lo abbiamo visto. Forse che vi chiediamo
la carità? Ma è proprio questo che vi indispettisce, la carità in fondo la
fareste perché vi piace umiliare il povero, ma quando vi si viene a chiedere
un favore da pari a pari: "Pago e porto via", niente da fare. Perché non ha
voluto vendermi le sue piante di mais?"
"É affar mio, sono in casa mia, credo, insolente!"
"Quel mais non era per me, glielo giuro! Preferirei crepare che chiedere
qualcosa a gente come voi. Era per la Louise, che ha il marito prigioniero,
per farle un favore, perché li faccio i favori, io!"
"Rubando?"
"Ma che altro dobbiamo fare, con voi che siete così duri, e così tirchi
anche! Che altro dobbiamo fare?" ripeté con furore. "E non sono il solo a
rifornirmi da voi. Tutto quello che ci rifiutate, senza ragione, per pura
cattiveria, ce lo prendiamo. E non finisce qui. Vedrete in autunno, quando il
signor sindaco andrà a caccia con i tedeschi...".
"Non è vero! É una menzogna! Non è mai andato a caccia con i tedeschi"
Batteva il piede a terra con rabbia, era furibonda. Ancora quella stupida
calunnia! D'accordo, l'inverno passato i tedeschi li avevano invitati, tutti e
due, a una partita di caccia. Loro avevano rifiutato ma si erano sentiti in
dovere di partecipare al pranzo che concludeva la giornata. Volenti o
nolenti, bisognava seguire la politica del governo.
E poi, insomma, dopo tutto quegli ufficiali tedeschi erano persone molto
educate! Quello che divide o unisce gli individui non è la lingua, non sono
le leggi, i costumi, i principi, ma il modo di tenere le posate!
Benoît riprese:
"In autunno lui andrà a caccia con i tedeschi, ma io ci tornerò, nel vostro
parco, e non mi farò scrupolo né per le lepri né per le volpi.
Mettetemi pure alle calcagna l'amministratore, i guardiani e i cani! Non la
spunteranno con Benoît Labarie! Mi son corsi dietro tutto l'inverno senza
beccarmi!"
"Non chiamerò né l'amministratore né i guardiani, ma i tedeschi. Quelli le
fanno paura, eh? Fa tanto l'arrogante, ma quando vede una divisa tedesca
fila dritto!"
"Senta un po’, li ho visti da vicino, io, i crucchi, in Belgio e sulla Somme.
Non come suo marito! Dove l'ha fatta la guerra, lui? Imboscato in un ufficio
a rompere le scatole alla gente!"
"Villanzone!"
"É stato a Chalon-sur-Saône, suo marito, da settembre a quando sono
arrivati i tedeschi. Allora se l'è filata, eccola la sua guerra!".
"Lei è... lei è un essere abominevole! Se ne vada o grido. Se ne vada o
chiamo qualcuno!"
"Ecco, brava, chiami i crucchi! Le va bene che siano qui, eh? Fanno da
polizia, sorvegliano le sue proprietà. Preghi Iddio che ci restino a lungo,
perché il giorno che se ne andranno...".
Non terminò la frase. Afferrò repentinamente gli zoccoli che lei teneva in
mano come prova del reato, li calzò, saltò oltre il muro e sparì.
Quasi subito si udirono i passi delle sentinelle tedesche che si
avvicinavano.
"Oh, spero che l'abbiano preso! Che l'abbiano ucciso" diceva fra sé la
viscontessa correndo verso il castello. "Che razza d'individuo! Che
canaglia! Che gente abietta! Ma è proprio questo, il bolscevismo, è questo!
Mio Dio, cos'è diventato il popolo! Ai tempi di papà, un bracconiere che
veniva arrestato nei boschi piangeva, chiedeva perdono.
Naturalmente lo si perdonava. Papà, che era buono come il pane, gridava,
s'infuriava, e poi gli faceva dare un bicchiere di vino in cucina...
L'ho visto più di una volta nella mia infanzia! Ma allora i contadini erano
poveri. Da quando hanno i soldi, si direbbe che in loro si siano risvegliati gli
istinti peggiori. "Il vostro castello è pieno zeppo di roba, dalla cantina alla
soffitta"" ripeté con furore. "Be? E a casa sua? Ma se sono più ricchi di noi!
Che cosa vogliono? Si rodono d'invidia, sono imbevuti dei sentimenti più
ignobili. Questo Labarie è un uomo pericoloso. Si è vantato di venire a
cacciare nel nostro parco!
Dunque non ha consegnato il suo fucile! É capace di tutto. Se ne fa una
grossa, se per esempio uccide un tedesco, l'intero paese sarà ritenuto
responsabile di quell'attentato, e il sindaco per primo! Sono quelli come lui
la causa di ogni nostra disgrazia. Denunciarlo è un dovere. Lo farò capire ad
Amaury, e... se sarà necessario, andrò io stessa alla Kommandantur. Gira
per i boschi di notte sfidando i regolamenti, possiede un'arma da fuoco... ce
n'è abbastanza!".
Si precipitò in camera da letto, svegliò Amaury, gli raccontò quanto era
successo e concluse:
"Ecco a che punto siamo arrivati! Vengono a sfidarmi, a derubarmi, a
insultarmi a casa mia! Ma questo è niente! Possono forse toccarmi gli insulti
di un bifolco? Il fatto è che l'uomo è pericoloso. Pronto a tutto. Sono sicura
che se non avessi avuto la presenza di spirito di tacere, se avessi chiamato i
tedeschi che passavano per la strada, sarebbe stato capace di gettarsi su di
loro a suon di pugni, oppure...".
Lanciò un grido e impallidì.
"Aveva un coltello! Ho visto brillare la lama di un coltello, sono sicura!
Pensate a quello che sarebbe successo dopo... L'uccisione di un tedesco, di
notte, nel nostro parco... Andate a spiegarglielo che non c'entriamo niente...
Amaury, bisogna agire, è vostro dovere. Quest'uomo ha in casa delle armi,
visto che si è vantato di aver cacciato tutto l'inverno nel parco. Delle armi!
Dopo che i tedeschi hanno detto e ripetuto che non lo avrebbero tollerato! E
se le tiene in casa vuol dire che prepara una qualche azione criminale, di
sicuro un attentato! Ve ne rendete conto?"
Nella città vicina un soldato tedesco era stato ammazzato e tutti i notabili
(sindaco in testa) messi in prigione come ostaggi fino alla scoperta del
colpevole. In un piccolo paese, a undici chilometri da lì, un ragazzo di
sedici anni, ubriaco, aveva mollato un pugno alla sentinella che voleva
arrestarlo per mancata osservanza del coprifuoco.
Il ragazzo lo avevano fucilato, ma non si erano limitati a questo. Dopo
tutto, se avesse rispettato i regolamenti, non sarebbe successo niente, ma il
punto è che il sindaco, considerato responsabile dei suoi amministrati, per
poco non faceva anche lui la stessa fine.
"Un temperino" borbottò Amaury, ma lei non lo ascoltava.
"Comincio a pensare," disse Amaury vestendosi con mani tremanti (erano
quasi le otto) "comincio a pensare che non avrei dovuto accettarlo, questo
incarico"
"Andrete a sporgere denuncia alla gendarmeria, spero...".
"Alla gendarmeria? Ma siete impazzita? Avremmo tutto il paese contro.
Sapete bene che, per quella gente, prendere quello che ci rifiutiamo di
cedere in cambio di denaro contante non è un furto. É solo una beffa.
Ci renderebbero la vita impossibile. No, no, vado dritto filato alla
Kommandantur. Chiederò loro di tenere la faccenda segreta, cosa che
faranno sicuramente perché sono discreti e comprenderanno la situazione.
Andranno a fare una bella perquisizione dai Labarie e troveranno
certamente un'arma...".
"Siete sicuro che la troveranno? Guardate che quella gente...".
"Si credono molto furbi, ma i loro nascondigli io li conosco... Se ne
vantano al bar, quando hanno bevuto... Si tratta sempre del solaio, della
cantina o del porcile. Arresteranno Benoît, mi farò promettere dai tedeschi
che non sarà punito troppo severamente. Se la caverà con pochi mesi di
prigione, e ce lo saremo tolto dai piedi per un po’; dopodiché ti assicuro che
se ne starà buono. Li sanno domare, i tedeschi, i tipi come lui. Ma che
cos'hanno," esclamò improvvisamente il visconte, che in quel momento era
in camicia, i cui lembi ondeggiavano sui polpacci nudi "che cos'hanno in
corpo? Perché non possono starsene tranquilli? Che cosa gli si chiede, in
fondo? Di tacere e di starsene tranquilli. Ma no!
Loro protestano, trovano da ridire su tutto, fanno gli arroganti. E cosa ci
guadagnano, eh? Siamo stati sconfitti, no? E allora dobbiamo rigare dritto.
Sembra che lo facciano apposta per rompermi le scatole. E dire che ero
riuscito, con qualche sforzo, a essere in buoni rapporti con i tedeschi. Notate
che non abbiamo dovuto ospitarne uno solo qui da noi.
Ed è un grande favore. E poi il paese... Faccio quello che posso per questo
paese... Ci perdo il sonno... I tedeschi si comportano molto correttamente
con tutti. Salutano le donne, accarezzano i bambini.
Pagano in contanti. Ebbene, no! Non è ancora abbastanza! Ma che cosa
vogliono? Che ci restituiscano l'Alsazia e la Lorena? Che si freghino da soli
con una repubblica sotto la presidenza di Leon Blum? E poi?"
"Non arrabbiatevi, Amaury. Guardatemi, sono calma. Fate il vostro
dovere senza aspettarvi altra ricompensa se non quella del cielo. Credete a
me, Dio legge nei nostri cuori"
"Sì, sì, lo so, ma è dura lo stesso" sospirò amaramente il visconte.
E senza perdere tempo con la colazione (aveva la gola così stretta che non
ci sarebbe passata una briciola di pane, disse alla moglie), uscì e chiese di
essere ricevuto, in gran segreto, alla Kommandantur.
CAPITOLO 17.
I tedeschi avevano ordinato di requisire tutti i cavalli per il loro esercito;
all'epoca una cavalla valeva dai sessanta ai settantamila franchi: i tedeschi
ne pagavano (promettevano di pagarne) la metà. Si avvicinava il tempo dei
grandi lavori nei campi e i contadini, amareggiati, domandavano al sindaco
come avrebbero potuto cavarsela.
"A forza di braccia, vero? Senta invece cosa le diciamo: se non ci mettono
in condizione di lavorare, saranno le città a crepare di fame"
"Amici miei, non posso farci niente, io!" mormorava il sindaco.
I contadini sapevano benissimo che non poteva farci niente, ma, nel
segreto del loro cuore, se la prendevano con lui. "Se la caverà sempre, il
signor visconte, si arrangerà, nessuno glieli toccherà i suoi dannati cavalli!"
Tutto andava male. Dal giorno prima soffiava un vento di tempesta. I
giardini erano fradici di pioggia; la grandine aveva devastato i campi.
Quando Bruno, al mattino, partì a cavallo dalla casa delle Angellier diretto
alla città vicina, in cui doveva aver luogo la requisizione, vide un paesaggio
desolato, flagellato dall'acquazzone. I grandi tigli del viale, scossi con
violenza, gemevano e scricchiolavano come alberi di un vascello. Tuttavia
Bruno, galoppando lungo la strada, provava una sorta di allegria; l'aria
fredda, pungente e pura gli ricordava quella della sua Prussia orientale. Ah,
quando avrebbe rivisto quelle pianure, quelle distese di erba pallida, quelle
paludi... la straordinaria bellezza dei cieli di primavera... le primavere
tardive dei paesi del Nord... cielo d'ambra, nubi di madreperla, giunchi,
canne, radi boschetti di betulle? Quando avrebbe cacciato di nuovo l'airone
e il chiurlo? Strada facendo incrociò dei cavalli e i loro conducenti, che da
tutti i villaggi, da tutti i borghi, da tutte le tenute della regione si dirigevano
verso la città. "Bestie valide," pensò "ma tenute male. I francesi - come tutti
i civili, del resto - non capiscono niente di cavalli"
Si fermò un momento per lasciarli passare. Procedevano a zigzag e a
piccoli gruppi. Bruno osservava attentamente le bestie cercando fra quegli
esemplari i più adatti alla guerra. La maggior parte sarebbe finita in
Germania, destinata ai lavori dei campi, ma qualcuno di quei cavalli
avrebbe conosciuto le cariche travolgenti nelle sabbie d'Africa o nelle
coltivazioni di luppolo del Kent. Dio solo sapeva dove sarebbe soffiato
ormai il vento della guerra. Gli tornarono alla mente i nitriti dei cavalli
terrorizzati nella Rouen in fiamme. Cadeva la pioggia. I contadini
camminavano a testa bassa, e la alzavano appena quando scorgevano quel
cavaliere immobile avvolto nel mantello verde. Per un attimo i loro sguardi
si incrociavano. "Come sono lenti," pensava Bruno "come sono maldestri!
Arriveranno in città con due ore di ritardo, e chissà quando si potrà
pranzare... Bisognerà prima di tutto occuparsi dei cavalli. Ma su, avanti,
coraggio" mormorava battendo con impazienza il frustino sul risvolto degli
stivali, trattenendosi dal gridare ordini a gran voce come alle manovre. Gli
passavano davanti vecchi, bambini e perfino qualche donna; tutti gli abitanti
di un villaggio procedevano insieme. Seguiva un vuoto. Lo spazio, il
silenzio erano allora riempiti solo dall'infuriare del vento. Approfittando di
uno di quei tratti sgombri, Bruno lanciò il cavallo al galoppo in direzione
della città.
Dietro di lui si riformò una fila paziente. I contadini tacevano. I tedeschi
avevano preso gli uomini giovani; avevano preso il pane, il grano, la farina,
le patate; avevano preso la benzina e le automobili, adesso i cavalli. E
domani cos'altro? Alcuni di loro erano in cammino dalla mezzanotte.
Andavano a testa bassa, curvi, il volto impenetrabile.
Avevano avuto un bel dire al sindaco che era finita, che da loro non si
sarebbe cavato più niente, in realtà sapevano che i lavori dei campi
andavano conclusi, la raccolta portata a termine. Bisogna pur mangiare.
"E dire che eravamo così felici" pensavano. "I tedeschi... branco di
carogne... Però, dobbiamo anche essere giusti... É la guerra... Ma quanto
ancora durerà, mio Dio? Quanto?" mormoravano i contadini guardando quel
cielo tempestoso.
Uomini e cavalli erano passati per tutto il giorno sotto la finestra di
Lucile. Lei si tappava le orecchie per non sentirli. Non voleva sapere più
niente. Ne aveva abbastanza di quelle visioni di guerra, di quelle immagini
tristi! La turbavano, le straziavano il cuore, le impedivano di essere felice.
Felice, mio Dio! "Va bene, sì, c'è la guerra," diceva fra sé "ci sono i
prigionieri, le vedove, la miseria, la fame, l'occupazione. E allora? Non
faccio niente di male. É l'amico più rispettoso e ci siano libri, la musica, le
nostre lunghe conversazioni, e nostre passeggiate nei boschi della Maie... É
l'idea della guerra, di questa sciagura universale, che rende tutto questo
colpevole. Ma lui non ne è più responsabile di me! Non è colpa nostra.
Che ci lascino in pace... Che ci lascino stare!". A volte si spaventava e
persino si stupiva nel sentire dentro di sé una tale ribellione - contro il
marito, la suocera, l'opinione pubblica, quello "spirito dell'alveare" di cui
parlava Bruno. Sciame ronzante e maligno che obbedisce a ignote finalità...
Lei lo odiava... "Che vadano dove vogliono; quanto a me, farò quel che
vorrò. Voglio essere libera. Aspiro non tanto alla libertà esteriore, quella di
viaggiare, di lasciare questa casa (benché sarebbe già una felicità
inimmaginabile!), quanto a essere libera dentro, a scegliere la mia strada,
seguirla senza dover seguire lo sciame. Odio questo spirito comunitario di
cui ci riempiono le orecchie. Su una sola cosa tedeschi, francesi, gollisti la
pensano tutti allo stesso modo: bisogna vivere, pensare, amare con gli altri,
in funzione di uno Stato, di un paese, di un partito. Oh, mio Dio, non
voglio! Sono una povera donna inutile; non so niente, ma voglio essere
libera! Schiavi lo diventiamo," continuò "la guerra ci manda qua o là, ci
priva del benessere, ci toglie il pane di bocca; mi lascino almeno il diritto di
giudicare il mio destino, di farmene beffe, di sfidarlo, di sfuggirgli se posso.
Uno schiavo? Meglio questo di un cane che si crede libero quando trotta
dietro al padrone. Non sono neppure consapevoli della loro schiavitù,"
pensò ancora ascoltando il rumore degli uomini e dei cavalli che passavano
"e anch'io sarei come loro se la pietà, la solidarietà, lo "spirito dell'alveare"
mi obbligassero a sacrificare la felicità" Com'era dolce, mio Dio,
quell'amicizia fra lei e il tedesco, quel segreto rubato, quel mondo nascosto
nel cuore della casa ostile!
Allora lei si sentiva un essere umano, libero e fiero. Non permetteva a
nessuno di sconfinare in quella che era la sua sfera personale.
"Nessuno! Non riguarda nessuno! Si combattano, si detestino pure! Che
un tempo suo padre e il mio si siano trovati di fronte e si siano battuti, che
lui stesso abbia fatto prigioniero mio marito (pensiero che ossessiona la mia
infelice suocera!): cosa importa tutto questo? Io e lui siamo amici" Amici?
Attraversando l'anticamera immersa nell'ombra si avvicinò allo specchio
che stava sul cassettone, uno specchio dalla cornice di legno nero; guardò i
suoi occhi scuri, la bocca tremante e sorrise. "Amici? Lui mi ama" sussurrò.
Avvicinò le labbra allo specchio e, dolcemente, baciò la sua immagine. "Sì,
ti ama. A quel marito che ti ha ingannata, trascurata, non devi niente. Ma è
prigioniero, tuo marito è prigioniero e tu lasci che un tedesco si avvicini a
te, prenda il posto dell'assente? Ebbene, sì! E allora? L'assente, il
prigioniero, il marito, io non l'ho mai amato. Che muoia! Che sparisca!
Insomma, rifletti" continuò, la fronte appoggiata allo specchio, e le
sembrava davvero di parlare a una parte di sé sconosciuta fino a quel
momento, invisibile, e che le appariva per la prima volta, una donna dagli
occhi scuri, dalle sottili labbra frementi, dalle guance in fiamme, che era lei
e non del tutto lei... "Insomma, rifletti... La ragione... La voce della
ragione... Sei una francese ragionevole... A cosa ti porterà tutto questo? Lui
è un soldato, è sposato, partirà... Be, e anche se fosse solo un istante di
felicità? O meglio, neanche di felicità, di piacere?
Sai almeno che cos'è, il piacere?" La propria immagine nello specchio
l'affascinava; la attraeva e le faceva paura.
Sentì il passo della cuoca nel ripostiglio delle provviste vicino
all'anticamera; sussultò spaventata e prese a camminare senza meta per la
casa. Che immensa casa vuota, mio Dio! La suocera, come aveva
annunciato, non usciva più dalla sua camera; le portavano i pasti di sopra
ma, anche assente, a Lucile sembrava sempre di vederla. Quella casa era il
suo riflesso profondo, la parte più vera del suo essere, come la parte più
vera di Lucile era quell'esile giovane donna innamorata, ardita, allegra,
disperata che poco prima le sorrideva nello specchio dalla cornice nera (che
ora era sparita, lasciando al suo posto un pallido fantasma, quella Lucile
Angellier che vagava per le stanze, appoggiava la fronte ai vetri delle
finestre, rimetteva meccanicamente a posto gli oggetti brutti e inutili che
ornavano i caminetti) Che tempo!
L'aria era pesante, il cielo grigio. Raffiche di vento freddo scuotevano i
tigli in fiore. "Una camera, una casa tutta per me," pensava Lucile "una
camera perfetta, quasi spoglia, una bella lampada... Se qui chiudessi le
imposte, se accendessi la luce per non vedere questo tempo... Marthe
verrebbe a domandarmi se sto male; avvertirebbe mia suocera che farebbe
spegnere la luce e aprire le tende perché l'elettricità costa cara. E non posso
suonare il piano: sarebbe un'offesa all'assente. Mi piacerebbe andare nei
boschi anche sotto la pioggia, ma tutti verrebbero a saperlo e direbbero:
"Lucile Angellier è diventata pazza" Basta questo per far internare una
donna, in un paese come il nostro" Rise e si ricordò di una ragazza di cui le
avevano parlato: i genitori l'avevano rinchiusa in una casa di cura perché
nelle sere di luna scappava di casa e correva allo stagno. "Con un ragazzo,
si sarebbe anche potuto capire! Sarebbe stata soltanto una condotta
scandalosa... Ma da sola? Pura follia...". Lo stagno, la notte... Lo stagno
sotto quella pioggia torrenziale. Oh, in qualunque posto, lontano da qui...
Altrove... Quei cavalli, quegli uomini, quei poveri corpi curvi e rassegnati
sotto l'acquazzone! Si allontanò di scatto dalla finestra; pur dicendo a se
stessa: "Non ho niente in comune con loro!", sentiva la presenza di un
legame invisibile.
Entrò nella camera di Bruno. Più di una sera era entrata col batticuore
nella sua stanza. Lui era semisdraiato sul letto, tutto vestito; leggeva o
scriveva, e il biondo metallico dei suoi capelli brillava sotto la lampada. In
un angolo, su una poltrona, erano gettati il pesante cinturone con la borchia
che recava incise le parole "Gott mit uns", una rivoltella nera, un berretto da
ufficiale e un grande mantello verde mandorla; quel mantello lui lo
prendeva e lo posava sulle ginocchia di Lucile perché da una settimana, con
quei continui temporali, le notti erano fredde. Erano soli - credevano di
essere soli - nella grande casa addormentata. Non una confessione, non un
bacio, il silenzio... poi conversazioni febbrili e appassionate in cui parlavano
dei rispettivi paesi, delle loro famiglie, di musica, di libri... La strana felicità
che provavano... quell'urgenza di svelare il proprio cuore all'altro...
un'urgenza da amante che è già un dono, il primo, il dono dell'anima che
precede quello del corpo. "Guardami, conoscimi. Sono così. Ecco come
sono vissuta, ecco quello che mi piaceva. E tu? E tu, mio amato?". Ma fino
a quel momento nessuna parola d'amore. A che pro? Sono inutili, le parole,
quando la voce si altera, quando le bocche tremano, quando scendono quei
lunghi silenzi... Dolcemente, Lucile sfiorò i libri sul tavolo, libri tedeschi
dalle pagine fitte di quella scrittura gotica che sembra bizzarra - e
sgradevole. Tedeschi, tedeschi... Un francese non mi avrebbe mai lasciata
andar via senza altro gesto d'amore che baciarmi le mani e l'abito...
Sorrise, si strinse leggermente nelle spalle; sapeva che non si trattava né
di timidezza né di freddezza, ma di una profonda e tenace pazienza, tutta
tedesca, simile a quella della bestia feroce che aspetta il suo momento,
aspetta che la preda, affascinata, si lasci prendere spontaneamente. "In
guerra," diceva Bruno "ci capitava di stare ore e ore in agguato nella foresta
di Mouvre, e l'attesa, allora, aveva qualcosa di erotico...". Quella parola
l'aveva fatta ridere. Le sembrava meno assurda, adesso. Che cosa stava
facendo, lei, di diverso?
Aspettava. Lo aspettava. Si aggirava per quelle stanze senza vita.
Ancora due, tre ore. Poi la cena in solitudine. Poi il rumore della chiave
che chiudeva la porta della suocera. Poi Marthe che attraversava il giardino
con una lanterna per andare a sprangare il cancello. Poi di nuovo l'attesa,
bruciante, strana... e infine il nitrito del cavallo nella strada, un clicchettio di
armi, ordini dati al palafreniere che si allontana con la bestia. E quel rumore
di speroni sulla soglia... Poi la notte, e in quella notte tempestosa, con le
raffiche fredde del vento sui tigli e il brontolio lontano del tuono, lei gli
avrebbe detto finalmente - oh, non era ipocrita, glielo avrebbe detto in buon
francese, chiaro e netto - che la preda desiderata era lì, era sua. "E domani?
Domani?" mormorò, mentre un sorriso malizioso, spavaldo, voluttuoso la
trasfigurava di colpo come il riflesso di una fiamma illumina e trasforma un
volto. Nel bagliore di un incendio, i lineamenti più dolci assumono un'aria
diabolica che attrae e spaventa.
Silenziosamente, uscì dalla stanza.
CAPITOLO 18.
Qualcuno bussava alla porta della cucina, colpi leggeri e timidi, attutiti
dal rumore della pioggia. Ragazzini che cercano riparo dal temporale, pensò
la cuoca. Guardò e vide Madeleine Labarie, in piedi sulla soglia con in
mano l'ombrello grondante. Marthe la fissò per un attimo a bocca aperta;
quelli delle fattorie scendevano in città solo la domenica, per la messa
solenne.
"Che ti succede? Su, entra. Tutto bene a casa?".
"No! É capitata una grande disgrazia. Vorrei parlare subito con la
signora" disse Madeleine sottovoce.
"Gesù! Una disgrazia! Vuoi parlare con la signora Angellier o con la
signora Lucile?"
Madeleine esitò.
"Con la signora Lucile. Ma stia attenta... Che quel dannato tedesco non
sappia che sono qui"
"L'ufficiale? Non c'è, è andato dove portano i cavalli da requisire.
Mettiti vicino al fuoco, sei bagnata fradicia. Vado a chiamare la signora"
Lucile stava terminando il suo pranzo solitario. Davanti a lei, sulla
tovaglia, c'era un libro aperto. "Povera piccola," disse Marthe fra sé in un
improvviso lampo di lucidità. "Forse che è vita, la sua?... Senza marito da
due anni... E quest'altra... Cosa può esserle successo? Ancora un brutto tiro
dei tedeschi, c'è da giurarlo!"
Annunciò a Lucile che qualcuno chiedeva di vederla.
"É Madeleine Labarie, signora. Le è capitata una disgrazia... Ma non
vorrebbe essere vista"
"Falla entrare qui! Il tedesco... Il tenente von Falk è rientrato?".
"No, signora. Quando torna, sentirò certo il cavallo e la avvertirò".
"D'accordo. Vai pure".
Lucile rimase in attesa con il batticuore. Madeleine Labarie, livida e col
fiato grosso, entrò nella stanza. In lei, il pudore e la cautela tipici dei
contadini lottavano con l'emozione che la sconvolgeva.
Strinse la mano di Lucile e, dopo i convenevoli d'uso - "Spero di non
disturbarla" e "Tutto bene a casa?" - cominciò a parlare sottovoce, facendo
uno sforzo terribile per trattenere le lacrime, perché non si piange in
pubblico, tranne che al capezzale di un morto... In caso contrario bisogna
controllarsi, nascondere agli altri sia un dolore sia un piacere troppo
grande...
"Ah, signora Lucile! Cosa posso fare? Sono qui a chiederle consiglio
perché siamo perduti. Questa mattina i tedeschi sono venuti ad arrestare
Benoît"
Lucile proruppe in un'esclamazione.
"Ma perché?"
"Secondo loro aveva un fucile nascosto da qualche parte. Come tutti, può
immaginare... Però non sono andati da nessuno, solo da noi. Benoît gli ha
detto: "Cercate pure" Hanno cercato e hanno trovato. Stava sepolto sotto il
fieno, nella vecchia greppia delle vacche. Quando gli uomini della
Kommandantur sono tornati con il fucile e hanno detto a mio marito di
seguirli, il nostro tedesco, quello che avevamo in casa, era nella stanza. "Un
momento! Il fucile non è mio. Lo ha nascosto qui un vicino per poi
denunciarmi. Datemelo un attimo e ve lo dimostrerò". Parlava con tanta
naturalezza che gli uomini si sono fidati. Il mio Benoît prende l'arma, fa
finta di esaminarla e all'improvviso... Ah, signora Lucile, le due fucilate
sono partite quasi contemporaneamente. Con una ha ucciso Bonnet e con
l'altra Bubi, un grande cane lupo che stava con Bonnet...".
"Lo so, lo so" mormorò Lucile.
"Poi salta dalla finestra e sparisce, con i tedeschi dietro... Ma lui conosce i
posti meglio di loro, figuriamoci! Non l'hanno più trovato.
Per fortuna pioveva così forte che non si vedeva a un passo. E il Bonnet
steso lì, sul mio letto! Se trovano Benoît, lo fucileranno. Lo avrebbero
fucilato anche solo per l'arma nascosta! Ma lì ci sarebbe stata ancora
qualche speranza, mentre adesso sappiamo quello che lo aspetta, vero?"
"Perché ha ucciso Bonnet?"
"Perché è sicuramente Bonnet che lo ha denunciato, signora Lucile.
Viveva in casa nostra. Deve aver trovato il fucile. Sono tutti dei traditori,
questi tedeschi! E quello... mi faceva la corte, capisce...
Mio marito lo sapeva! Forse l'ha voluto punire, forse si è detto: "Così non
starà più a ronzare intorno a mia moglie quando io non ci sono"
Forse... E poi li detestava, signora, non vedeva l'ora di farne fuori uno"
"Lo avranno cercato per tutto il giorno... É sicura che non lo abbiano
ancora scoperto?"
"Sì, sono sicura" disse Madeleine dopo un attimo di silenzio.
"Lo ha visto?"
"Sì. É questione di vita o di morte, signora Lucile. Lei... lei non dirà
niente, vero?"
"Oh, Madeleine!"
"D'accordo! Si è nascosto in casa della nostra vicina, la Louise, quella che
ha il marito prigioniero"
"Ma batteranno le strade, frugheranno dappertutto...".
"Per fortuna oggi c'era la requisizione dei cavalli, e tutti gli ufficiali sono
partiti. I soldati aspettano ordini. Domani perlustreranno l'intero paese. Ma
nei fondi, signora Lucile, i nascondigli non mancano. Gliene abbiamo già
fatto passare sotto il naso un bel numero di prigionieri evasi. La Louise lo
nasconderebbe ancora, ma ci sono i bambini, e i bambini ci giocano, con i
tedeschi, non hanno paura, chiacchierano, e sono troppo piccoli per farli
ragionare. La Louise mi ha detto: "So quello che rischio. Lo faccio
volentieri per tuo marito come tu l'avresti fatto per il mio, ma a questo punto
sarebbe meglio trovare un'altra casa dove potranno tenerlo finché non
arriverà il momento buono per farlo uscire dal paese" Adesso, come può
figurarsi, tutte le strade saranno sorvegliate. Ma i tedeschi non staranno qui
per sempre! Quello che ci vorrebbe, è una casa grande dove non ci siano
bambini"
"Qui?" disse Lucile guardandola.
"Sì, avevo pensato qui...".
"Lo sa che abbiamo in casa un ufficiale tedesco?"
"Sono dappertutto. Ma non starà sempre in casa, l'ufficiale... E poi mi
hanno detto... Mi scusi, signora Lucile, mi hanno detto che è innamorato di
lei, e che lei può farne quello che vuole. Non l'ho offesa, vero?
Sono uomini anche loro, certo, e soffrono di nostalgia. Allora, se per
esempio gli dice: "Non voglio che qui i suoi soldati buttino tutto all'aria. É
assurdo. Sa bene che non nascondo nessuno. Prima di tutto, avrei troppa
paura...". Insomma, le cose che può dire una donna. E poi, in questa casa
così grande, così vuota, non è difficile trovare un angolino, un nascondiglio.
Sarebbe una possibilità di salvezza. La sola!
Lei mi può dire che se la scoprono rischia la prigione... Forse anche la
morte... Con questi bruti è possibile. Ma se non ci aiutiamo tra noi francesi,
chi ci aiuterà? La Louise ha dei bambini, ma non ha avuto paura. Lei invece
è sola".
"Non ho paura" disse Lucile lentamente.
E rifletteva: lì o altrove, per Benoît il pericolo sarebbe stato lo stesso. "E
per lei? Per me? Per la mia vita? Per quel che ne faccio" pensò con
involontaria disperazione. La cosa non aveva davvero importanza. Le
tornarono in mente all'improvviso le giornate del giugno del '40 (un anno
prima, esattamente un anno) Anche allora, nel tumulto, nel pericolo, non
aveva pensato a se stessa. Si era lasciata trascinare come dalla corrente
impetuosa di un fiume. Mormorò:
"C'è mia suocera, ma non esce più dalla sua camera. Non vedrà niente.
C'è Marthe"
"Oh, Marthe è di famiglia, signora. É una cugina di mio marito. Nessun
pericolo da quella parte. Tra noi c'è fiducia. Ma dove si può nasconderlo?"
"Ho pensato alla camera azzurra vicino al solaio, la vecchia stanza dei
giochi dove c'è una specie di alcova... E poi, mia povera Madeleine, non
deve farsi troppe illusioni. Se il destino ci è avverso, lo troveranno là come
altrove... Ma, se Dio lo vuole, si salverà. Dopo tutto, ci sono stati degli
attentati, in Francia, contro i soldati tedeschi e i responsabili non sono mai
stati scoperti. Faremo del nostro meglio per nasconderlo e... dobbiamo
sperare, vero?".
"Sì, signora, sperare..." disse Madeleine mentre le lacrime che non
riusciva più a trattenere le scorrevano lentamente sulle guance.
Lucile la abbracciò.
"Vada a prenderlo. Passate per il bosco della Maie. Piove ancora e fuori
non ci sarà nessuno. Diffidate di tutti, datemi retta, francesi o tedeschi che
siano. Vi aspetterò alla porticina del giardino. Intanto avvertirò Marthe"
"Grazie, signora" balbettò Madeleine.
"Su, vada. Faccia presto".
Madeleine aprì la porta senza rumore e si inoltrò nel giardino deserto,
bagnato, sotto gli alberi stillanti. Un'ora dopo Lucile faceva entrare Benoît
dalla porticina dipinta di verde che dava sui boschi della Maie.
Il temporale era cessato ma soffiava ancora un vento impetuoso.
CAPITOLO 19.
Dalla sua camera, la vecchia signora Angellier sentì la guardia campestre
gridare sulla piazza del Municipio:
"Attenzione! Ordine della Kommandantur!"
Alle finestre apparvero volti preoccupati: "Cos'avranno inventato
ancora?" pensava la gente con odio e paura. Erano tutti talmente terrorizzati
dai tedeschi che quando la Kommandantur, attraverso la voce della guardia
campestre, ordinava la disinfestazione dai topi o la vaccinazione
obbligatoria dei bambini, perfino allora riuscivano a sospirare di sollievo
solo molto tempo dopo l'ultimo rullo di tamburo - e dopo essersi fatti
ripetere da qualche persona istruita, come il farmacista, il notaio o il capo
delle guardie, quello che era stato ordinato.
"E tutto? É proprio tutto? Non ci prendono altro?" domandavano
ansiosamente. E fattisi via via più sicuri continuavano:
"Ah, bene! Allora va bene! Ma di che s'impicciano...".
Un miracolo se non aggiungevano:
"Sono i nostri topi e i nostri bambini. Con quale diritto pretendono di
distruggere gli uni e di vaccinare gli altri? Forse che la cosa li riguarda?"
I tedeschi che si trovavano in piazza commentavano gli ordini.
"Tutti in buona salute adesso, francesi e tedeschi...".
Con un'aria di finta sottomissione (oh, quei sorrisi servili!, pensava la
vecchia signora Angellier), i contadini si affrettavano ad assentire:
"Certo... Va benissimo... É nell'interesse generale... Lo comprendiamo"
E ognuno di loro, tornato a casa, gettava il topicida nel fuoco, poi correva
dal dottore a chiedergli di non vaccinare il bambino "perché si era appena
rimesso dagli orecchioni" o "perché era gracile e malnutrito" Altri dicevano
senza mezzi termini: "Preferiremmo averne uno o due ammalati, se questo
facesse andar via i crucchi!" I tedeschi, rimasti soli in piazza, si guardavano
intorno con aria benevola e pensavano che fra loro e i vinti a poco a poco si
stava rompendo il ghiaccio.
Ma quel giorno nessuno dei tedeschi sorrideva o parlava con la gente.
Stavano in piedi rigidi, un po’ pallidi, con lo sguardo truce e fisso.
La guardia campestre, visibilmente compiaciuta e consapevole
dell'importanza delle parole che stava per pronunciare (era un bell'uomo, del
Midi, sempre felice di richiamare l'attenzione delle donne), si era prodotta
in un ultimo rullo di tamburo e, dopo essersi infilato le due bacchette sotto il
braccio con grazia e abilità da prestigiatore, lesse con una bella voce
maschia, pastosa, che risuonava nel silenzio: Un membro dell'esercito
tedesco è stato vittima di un attentato: un ufficiale della Wehrmacht è stato
vigliaccamente assassinato da un certo labarie Benoît, domiciliato Alà nel
comune di Bussy.
Il criminale è riuscito a fuggire. Chiunque gli darà asilo, aiuto o
protezione o, conoscendo il suo nascondiglio, avrà omesso di comunicarlo
alla Kommandantur entro il termine massimo di quarantotto ore, incorrerà
nella stessa pena riservata all'assassino, e cioè sarà immediatamente
FUCILATO.
La signora Angellier aveva socchiuso la finestra; quando la guardia
campestre si fu allontanata si sporse a guardare la piazza. La gente
mormorava, sbalordita. Che dire? Il giorno prima si parlava solo della
requisizione dei cavalli, e adesso quella nuova sventura si aggiungeva
all'altra e suscitava in quelle torpide menti paesane una sorta di incredulità:
"Benoît! Benoît ha fatto una cosa simile? Non è possibile!" Il segreto era
stato ben difeso: gli abitanti del borgo ignoravano tutto quello che
succedeva nella campagna, in quei grandi fondi così gelosamente protetti. I
tedeschi, invece, erano più informati. Adesso era chiara la ragione di quel
trambusto, di quei fischi nella notte, della proibizione di uscire dopo le otto
scattata il giorno prima: "Dovevano portare via il corpo e non volevano che
lo vedessimo" Nei caffè i tedeschi parlavano fra loro sottovoce e provavano
anch'essi una sensazione di irrealtà e di orrore. Da tre mesi vivevano a tu
per tu con quei francesi senza far loro alcun male; anzi, a forza di attenzioni
e di abili mosse erano riusciti a stabilire rapporti umani con i vinti. Ed ecco
che il gesto di un pazzo rimetteva tutto in discussione. Non era tanto il
delitto in sé a colpirli quanto quella solidarietà, quella complicità che
avvertivano tutt'intorno (perché, insomma, se un uomo riesce a sfuggire a
un reggimento che lo insegue vuol dire che l'intero paese lo aiuta, lo
protegge, gli dà da mangiare, a meno che si sia rintanato nei boschi - ma li
avevano perlustrati a palmo a palmo durante la notte - o, cosa ancor più
verosimile, che abbia abbandonato la regione, ma questo, di nuovo, non
poteva verificarsi se non con l'aiuto attivo o passivo degli abitanti)
"E io, allora?" pensava ogni soldato. "Io che vengo accolto in casa, e mi
sorridono, mi fanno posto a tavola, mi lasciano prendere i bambini sulle
ginocchia... Se domani un francese mi ammazza non ci sarà nessuno a
compiangermi e tutti faranno a gara per proteggere l'assassino!" Quei
pacifici contadini dal volto impenetrabile, quelle donne che il giorno prima
sorridevano e parlavano con loro, e che adesso, incrociandoli, distoglievano
imbarazzate lo sguardo, erano tutti dei nemici! Stentavano a crederlo; si
trattava di così brava gente... Lo zoccolaio Lacombe, ad esempio, la
settimana precedente aveva offerto una bottiglia di vino bianco ad alcuni
tedeschi perché la figlia si era diplomata e lui non sapeva come esprimere la
sua gioia; e Georges, il mugnaio, combattente dell'altra guerra, aveva
proclamato: "Che ci sia presto la pace e che ciascuno se ne stia a casa
propria! É tutto quello che vogliamo, noialtri"; e le ragazze sempre pronte a
ridere, a cantare, a lasciarsi baciare di nascosto... Nonostante tutto, nemici
per sempre?
I francesi, per parte loro, dicevano: "Quel Willy che ha chiesto se poteva
abbracciare la mia bambina, dicendo che ne aveva una della stessa età in
Baviera, quel Fritz che mi ha aiutato a curare mio marito ammalato,
quell'Erwald che trova la Francia uno splendido paese, e quell'altro che si è
tolto il berretto davanti alla fotografia di papà, ucciso nel '15, se domani
riceve l'ordine di arrestarmi e di uccidermi, lo farà di suo pugno senza
rimorsi? La guerra... sì, sappiamo cos'è.
Ma l'occupazione, in un certo senso, è più terribile ancora, perché ci si
abitua alle persone; si dice: "Dopo tutto sono come noi", e invece
nossignore, non è vero. Siamo due specie diverse, inconciliabili,
eternamente nemiche"
La signora Angellier li conosceva così bene, i suoi contadini, che credeva
di leggergli in faccia quel che pensavano. Sogghignò. Non si era lasciata
abbindolare, lei! Non si era lasciata comprare! Perché tutti erano disposti a
vendersi, nel piccolo borgo di Bussy come nel resto della Francia.
I tedeschi offrivano denaro agli uni (quell'oste che faceva pagare cento
franchi una bottiglia di chablis ai soldati della Wehrmacht, quei contadini
che vendevano le uova a cinque franchi l'una) e agli altri, ai giovani e alle
donne, offrivano piacere... Da quando erano lì non ci si annoiava più.
Finalmente c'era qualcuno con cui parlare. Dio... persino sua nuora!
Socchiuse gli occhi e stese sulle palpebre abbassate una mano lunga e
trasparente, come se si rifiutasse di vedere un corpo nudo.
Sì, i tedeschi credevano di poter comprare in quel modo tolleranza e
oblio. E ci riuscivano. Con amarezza, la signora Angellier passò in rassegna
tutti i notabili della città: tutti avevano ceduto, tutti si erano lasciati
sedurre... I Montmort ricevevano i tedeschi: si sussurrava che nel parco del
visconte, intorno allo stagno, gli occupanti stessero organizzando una festa.
La signora di Montmort proclamava ai quattro venti che la cosa la
indignava, che avrebbe chiuso le finestre per non sentire la musica e non
vedere i fuochi artificiali sotto gli alberi. Ma quando il tenente von Falk e
l'interprete Bonnet erano andati da lei per farsi dare sedie, bicchieri e
tovaglie li aveva trattenuti per quasi due ore. La signora Angellier lo aveva
saputo dalla cuoca che lo aveva saputo dall'amministratore. Anche quei
nobili, in fin dei conti, erano mezzo stranieri. Forse che nelle loro vene non
scorreva sangue bavarese, prussiano (orrore!) o renano? Le famiglie nobili
s'imparentano fra loro senza badare alle frontiere, ma, a pensarci bene, non
è che i grandi borghesi siano meglio. Si sussurravano i nomi di quelli che
trafficavano con i tedeschi (e la radio inglese li faceva tutte le sere, quei
nomi), i Maltête di Lione, i Pericand di Parigi, la Banca Corbin... e altri
ancora... La signora Angellier finiva per sentirsi un'eccezione, feroce,
irriducibile come una fortezza - la sola fortezza che resistesse in Francia,
ahimè!, ma che niente avrebbe potuto abbattere o violare, perché i suoi
bastioni non erano fatti di pietra, e neppure, d'altronde, di carne o di sangue,
ma di ciò che c'era al mondo di più immateriale e insieme di più invincibile:
l'amore e l'odio.
Camminava rapida e silenziosa nella stanza mormorando: "Non serve a
niente chiudere gli occhi. Lucile sta per cadere nelle braccia del tedesco" E
che cosa poteva fare, lei? Gli uomini hanno le armi, sanno battersi; lei non
poteva che spiare, osservare, ascoltare, cercare di cogliere nel silenzio della
notte un rumore di passi, un sospiro, perché almeno questo non fosse
perdonato né dimenticato, perché Gaston, al suo ritorno... Trasalì di una
gioia feroce. Dio, come odiava Lucile! Quando in casa finalmente tutto
taceva, la vecchia signora faceva quella che chiamava la sua ronda. E niente
allora le sfuggiva. Contava nei portacenere i mozziconi di sigaretta con
tracce di rossetto; raccoglieva silenziosamente un fazzoletto sgualcito e
profumato, un fiore gettato, un libro rimasto aperto. Spesso sentiva le note
del pianoforte o la voce molto bassa e molto dolce del tedesco che
canticchiava, abbozzava un motivo. Quel pianoforte... Come si può amare la
musica? Ogni nota sembrava ferire i suoi nervi scoperti e le strappava un
gemito.
Preferiva semmai le loro lunghe conversazioni, di cui percepiva un'eco
smorzata affacciandosi alla finestra, proprio sopra quella dello studio che
nelle belle notti d'estate i due lasciavano aperta. E preferiva persino i silenzi
che cadevano fra loro o il riso di Lucile (ridere! Con un marito prigioniero!
Svergognata, malafemmina, anima vile!) Tutto era meglio della musica,
perché solo la musica abolisce le differenze di lingua o di abitudini fra due
esseri e tocca fibre sensibilissime.
Qualche volta la signora Angellier si era avvicinata alla camera del
tedesco; aveva ascoltato il suo respiro, la sua tosse leggera di fumatore. Poi
aveva attraversato l'anticamera dov'era appeso, sotto la testa impagliata del
cervo, il grande mantello da ufficiale e gli aveva infilato nella tasca qualche
rametto d'erica - porta male, dicevano. Lei non ci credeva, ma chissà, non si
sa mai...
Da qualche giorno, due per l'esattezza, l'atmosfera della casa sembrava
ancora più minacciosa. Il pianoforte taceva. La signora Angellier aveva
sentito Lucile e la cuoca parlottare a lungo sottovoce. (Anche quella mi
tradisce, certo!) Le campane cominciarono a suonare. (Ah, il funerale
dell'ufficiale ucciso...). Ecco i soldati armati di tutto punto, ecco la bara,
ecco le corone di fiori rossi... La chiesa era stata requisita, l'ingresso vietato
ai francesi. Dalla cappella della Vergine si levava un coro di voci
meravigliose che intonavano un inno religioso.
Quell'inverno i bambini del catechismo avevano rotto un vetro che non
era mai stato sostituito. Il canto fuoriusciva dall'antica finestrella aperta
dietro l'altare della Vergine e ombreggiata dal grande tiglio della piazza.
Come cantavano gioiosamente gli uccelli! Il loro garrulo cinguettio a tratti
quasi copriva l'inno dei tedeschi. La signora Angellier ignorava il nome e
l'età del morto. La Kommandantur aveva detto solo: "Un ufficiale della
Wehrmacht" Bastava quello. Certo era giovane. Erano tutti giovani. "Be,
per te è finita. Cosa vuoi farci? É la guerra" Sua madre lo capirà anche lei,
mormorava la signora Angellier giocherellando nervosamente con la sua
collana da lutto, quella collana di giaietto e di ebano che si era imposta alla
morte del marito.
Rimase immobile fino a sera, come inchiodata al suolo, seguendo con lo
sguardo tutti quelli che attraversavano la strada. Scese il buio... silenzio
assoluto. "Non si sente neanche il leggero scricchiolio del terzo gradino
della scala ad annunciare che Lucile è uscita dalla sua camera e scende in
giardino - perché le porte, complici, non scricchiolano, ma quel vecchio
gradino fedele sì, e mi avverte" pensa la signora Angellier. "No, non si sente
niente. Che siano già insieme? Che s'incontrino più tardi?"
La notte avanza. In preda a una irrefrenabile curiosità, la signora
Angellier esce piano dalla sua camera, va a origliare alla porta della sala da
pranzo. Niente. E nessun rumore esce dalla camera del tedesco.
La signora Angellier potrebbe pensare che non sia ancora rientrato se non
avesse sentito, un po’ prima, un passo d'uomo. Non si lascia ingannare, lei.
Qualsiasi presenza maschile che non sia quella del figlio è un oltraggio;
fiuta l'odore del tabacco straniero e impallidisce, si porta le mani alla fronte
come una donna che si senta svenire. Dov'è il tedesco? Più vicino del solito,
giacché il fumo entra dalla finestra aperta. Che stia ispezionando la casa? La
signora Angellier immagina che, sapendo di dover partire di lì a poco, lui
passi in rassegna i mobili per fare la sua scelta: la sua parte di bottino.
Forse che i prussiani, nel '70, non avevano rubato gli orologi a pendolo?
Quelli di oggi non devono essere molto diversi! Pensa a mani sacrileghe che
frugano il solaio, il ripostiglio delle provviste, la cantina! A pensarci bene è
soprattutto il pensiero della cantina che la fa tremare. Lei di vino non ne
beve; ricorda di aver assaggiato un sorso di champagne in occasione della
prima comunione di Gaston e del suo matrimonio. Ma il vino in qualche
modo fa parte dell'eredità e, a questo titolo, è sacro, come tutto ciò che è
destinato a durare dopo la nostra morte. Quello Château d'Yquem, quelà li
ha avuti in consegna da suo marito per trasmetterli a suo figlio. Le bottiglie
migliori sono state sotterrate nella sabbia, ma quel tedesco... Chissà?...
Magari guidato da Lucile... Andiamo un po’ a vedere... Ecco la cantina, la
porta rivestita di ferro come quella di una fortezza. Ecco il nascondiglio, che
lei sola sa riconoscere da un segno a forma di croce sul muro. No, anche qui
sembra tutto a posto. E tuttavia il cuore della signora Angellier batte
all'impazzata. Lucile dev'essere scesa in cantina da poco perché il suo
profumo aleggia ancora nell'aria. E seguendo le tracce di quel profumo la
signora Angellier sale di nuovo, attraversa la cucina, la sala da pranzo, e
sulla scala incrocia finalmente Lucile che sta scendendo con in mano un
piatto, un bicchiere e una bottiglia vuota. Ora è chiaro perché era andata in
cantina e nel ripostiglio delle provviste, dove alla signora Angellier era
sembrato di sentire un passo.
"Una cenetta da innamorati?" dice con voce bassa e sferzante come una
frustata.
"Per carità, stia zitta! Se sapesse...".
"Con un tedesco! Sotto il mio tetto! Nella casa di tuo marito,
sciagurata...".
"Ma taccia, le dico! Il tedesco non è rientrato, ma sarà qui da un minuto
all'altro. Mi lasci passare e rimettere a posto queste cose. E lei, intanto,
salga, apra la porta della vecchia camera dei giochi e guardi chi c'è... Poi,
quando avrà visto, mi raggiunga in sala da pranzo. Mi dirà quello che
intende fare. Ho avuto torto, torto marcio, ad agire a sua insaputa, non
avevo il diritto di mettere a rischio la sua vita...".
"Hai nascosto in casa mia quel contadino... accusato di un delitto?".
In quel momento si udì il rumore del reggimento che passava, le rauche
voci tedesche che gridavano degli ordini e subito dopo il passo del tedesco
sui gradini della scalinata esterna, un passo che non era possibile
confondere con quello di un francese per via del rimbombo degli stivali e
del tintinnio degli speroni - e soprattutto perché un simile passo non poteva
essere che quello di un vincitore, fiero di sé, che calpesta il selciato nemico,
che calca con gioia la terra conquistata.
La signora Angellier aprì la porta della sua camera, vi fece entrare Lucile,
la seguì e chiuse a chiave. Poi prese piatto e bicchiere dalle mani della
nuora, li lavò nella stanza da bagno, li asciugò accuratamente, ripose la
bottiglia non senza aver prima guardato l'etichetta. Vino comune? Sì, grazie
al cielo! "Rischierebbe tranquillamente la fucilazione" pensò Lucile "per
aver nascosto in casa l'uomo che ha ucciso un tedesco, ma non gli
sacrificherebbe una bottiglia pregiata di bourgogne. Per fortuna in cantina
era buio e il caso ha voluto che prendessi del normale rosso da pasto" In
silenzio, Lucile aspettava con viva curiosità le prime parole della signora
Angellier. Non avrebbe potuto nasconderle più a lungo una presenza
estranea: la vecchia signora sembrava sondare i muri con lo sguardo.
"Hai per caso supposto che avrei denunciato quell'uomo alla
Kommandantur?" domandò alla fine. Le narici contratte fremevano, gli
occhi brillavano. Pareva felice, esaltata, un po’ folle, come una vecchia
attrice che ha ritrovato la parte in cui un tempo primeggiava e le cui
intonazioni, i cui gesti le sono ormai familiari, quasi una seconda natura.
"É qui da molto?"
"Tre giorni"
"Perché non mi hai detto niente?"
Lucile non rispose.
"É una follia averlo nascosto nella camera azzurra. É qui che deve stare.
Visto che mi faccio portare i pasti in camera, non rischierai di essere
scoperta: avrai sempre la scusa pronta. Dormirà sul divano, nella stanza da
bagno"
"Ma rifletta, mamma! Se lo scoprono qui, lei rischia grosso. Mentre io
posso accollarmi tutta la responsabilità, dire di aver agito a sua insaputa, il
che, tutto sommato, è vero, mentre qui, nella sua camera...".
La signora Angellier scrollò le spalle.
"Raccontami" disse con una vivacità che Lucile non ricordava da tempo.
"Raccontami esattamente come sono andate le cose... Io so solo quello
che ha annunciato la guardia campestre. Chi ha ucciso? Un tedesco solo?
Non ne ha colpiti altri? Era almeno un graduato... un alto ufficiale?".
"Come si sente a suo agio," pensava Lucile "come "risponde" subito ai
richiami del delitto, del sangue... Madri e amanti, femmine feroci. Io che
non sono né madre né amante (Bruno? No... non devo pensare a Bruno
adesso, non devo...), non posso guardare a questa faccenda allo stesso
modo. Sono più distaccata, più fredda, più calma, più civile... almeno voglio
continuare a pensarlo. E poi... non posso credere che avremmo rischiato
davvero la testa tutti e tre... Sembra eccessivo, melodrammatico, e tuttavia
Bonnet è effettivamente morto... ucciso da questo contadino che alcuni
bolleranno d'infamia e che per altri sarà un eroe... E io? Devo decidere in un
senso o nell'altro. Anzi, ho già deciso... mio malgrado. E dire che credevo di
essere libera...".
"Chiederà lei stessa a Labarie come sono andate le cose, mamma" disse.
"Vado a prenderlo e glielo porto qui. Gli dica di non fumare; il tenente
potrebbe fiutare l'odore di un tabacco che non è il suo. É l'unico rischio,
penso; non perquisiranno la casa, e non credono neppure che qualcuno
abbia osato nascondere l'uomo proprio qui in paese. Faranno Piuttosto dei
controlli nelle fattorie. Però possiamo sempre essere denunciate" "I francesi
non si accusano tra loro" dichiarò fieramente la vecchia signora. "Lo hai
dimenticato, mia cara, da quando frequenti i tedeschi"
A Lucile tornò in mente una confidenza che le aveva fatto il tenente von
Falk: "Il giorno del nostro arrivo abbiamo trovato alla Kommandantur un
pacco di lettere anonime che ci aspettava. Le persone si accusavano
reciprocamente di propaganda inglese e gollista, di incetta di generi
alimentari, di spionaggio. Se avessimo dovuto tenerne conto, l'intero paese
sarebbe in prigione! Le ho fatte bruciare tutte. Gli uomini non valgono
granché, e la sconfitta risveglia il loro lato peggiore. Da noi è lo stesso" Ma
Lucile non disse niente e lasciò la suocera euforica, ringiovanita di
vent'anni, mentre si dava da fare con zelo per sistemare il divano della
stanza da bagno. Con il materasso adatto, il guanciale, le lenzuola più fini
preparava con amore il letto di Benoît Labarie.
CAPITOLO 20.
I tedeschi avevano preso da tempo tutte le misure per organizzare una
festa al castello di Montmort nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Era
l'anniversario del giorno in cui il reggimento era entrato a Parigi, ma nessun
francese avrebbe conosciuto la vera ragione di quella scelta poiché la parola
d'ordine data dai comandanti imponeva di non urtare l'orgoglio nazionale
dei vinti. I popoli sono ben consapevoli dei propri difetti; li conoscono
meglio di quanto può fare l'osservatore straniero più malevolo. Durante una
conversazione amichevole che Bruno von Falk aveva avuto negli ultimi
tempi con un giovane francese, quest'ultimo aveva detto:
"Noi dimentichiamo tutto molto in fretta, è la nostra debolezza e insieme
la nostra forza! Dopo il 1918 abbiamo dimenticato subito di avere vinto, ed
è stata la nostra rovina; adesso ci dimenticheremo di essere stati sconfitti, e
sarà forse la nostra salvezza!"
"Il nostro difetto nazionale" aveva ribattuto Bruno "e insieme la nostra
maggiore qualità è la mancanza di tatto o, in altre parole, la mancanza di
fantasia: siamo incapaci di metterci al posto di un altro, lo offendiamo
gratuitamente, ci facciamo odiare, ma questo ci permette di agire in modo
inflessibile e senza cedimenti"
Poiché i tedeschi stavano in guardia contro la propria mancanza di tatto,
erano molto attenti a come parlavano e pesavano ogni parola quando si
intrattenevano con la gente del posto, che di conseguenza li tacciava di
ipocrisia. E a Lucile, che gli domandava che cosa celebrassero con quella
festa, Bruno aveva risposto in modo evasivo che da loro c'era l'usanza di
riunirsi più o meno intorno al 24 giugno, la notte più corta dell'anno, ma
siccome per quella data erano state fissate delle grandi manovre avevano
dovuto anticipare la festa.
Tutto era pronto. Nel parco ci sarebbero stati dei tavoli apparecchiati e
agli abitanti era stato chiesto di dare in prestito per qualche ora le loro
tovaglie più belle. Con grande rispetto e infinita cura i soldati, sotto la
direzione personale di Bruno, avevano fatto una scelta fra pile di tovaglie
damascate che venivano tirate fuori dalle profondità degli armadi. Le
borghesi, levando gli occhi al cielo - come se si aspettassero, pensava
maliziosamente Bruno, di veder scendere da lassù santa Genoveffa in
persona per folgorare i tedeschi sacrileghi, colpevoli di profanare quei
preziosi tesori di famiglia con tanto di orli a giorno e monogrammi ricamati
a motivi di fiori e di uccelli -, montavano la guardia e contavano gli
asciugamani davanti ai tedeschi.
"Ne avevo quattro dozzine: quarantotto pezzi, signor tenente, e me ne
ritrovo solo quarantasette" "Mi permetta di contare insieme a lei, signora.
Sono sicuro che non le abbiamo preso niente, forse l'emozione la confonde.
Ecco il quarantottesimo asciugamano caduto ai suoi piedi, signora. Mi
consenta di raccoglierlo e consegnarglielo". "Ah, sì, è vero! Mi scusi,"
replicava la borghese con un sorriso acido "ma quando si butta tutto all'aria
così, se non ci si sta attenti la roba sparisce" Lui, tuttavia, aveva trovato il
modo di ammansire quelle signore e con un bell'inchino diceva:
"Naturalmente, non abbiamo alcun diritto di chiederle questo. É chiaro che
non rientra negli oneri di guerra...".
Insinuava addirittura che se il generale lo avesse saputo... "E così severo...
Potrebbe punirci per la nostra sfacciataggine--. Ma ci annoiamo talmente.
Vorremmo tanto avere una bella festa. É un favore che le chiediamo,
signora; liberissima di rifiutare" Parole magiche! Il volto più accigliato si
apriva immediatamente a una parvenza di sorriso (un pallido e avaro sole
d'inverno su una di quelle vecchie case opulente e decrepite, pensava
Bruno)
"Perché non farle un favore? Ma voi vi prenderete cura delle tovaglie che
ho ricevuto in dote, vero?"
"Signora, le prometto che le saranno restituite lavate, stirate, intatte...".
"No, no! Ridatemele così come sono, per carità! Non vorrete lavare le mie
tovaglie con il sapone! Non le diamo neanche al lavandaio, noi! La
domestica fa il bucato sotto i miei occhi e usa solo cenere fine...".
A quel punto non restava che dire con un dolce sorriso:
"Proprio come mia madre...".
"Ah, davvero? Anche sua madre? Ma guarda! Forse le servono anche dei
tovaglioli...".
"Non osavo domandarglielo, signora"
"Gliene metto qui due, tre, quattro dozzine. Vuole delle posate?".
Uscivano dalle case con le braccia cariche di biancheria fresca e
profumata, con sacchetti pieni di coltelli da dessert, qualche antica coppa da
punch, una caffettiera Impero dal manico ornato di tralci e portata
solennemente in mano come il Santissimo Sacramento. Tutta quella roba
stava ora nelle cucine del castello in attesa della festa.
Le ragazze interpellavano i soldati ridendo.
"Come farete a ballare senza donne?"
"Ci rassegneremo, signorine. E la guerra". I musicisti avrebbero suonato
nella serra. All'ingresso del parco erano state innalzate delle colonne e dei
pali coperti di ghirlande su cui sarebbero state fissate le bandiere: quella del
reggimento che aveva fatto le campagne di Polonia, Belgio e Francia ed era
entrato da vincitore in tre capitali, e lo stendardo con la svastica,
impregnato, avrebbe detto Lucile sottovoce, di tutto il sangue d'Europa.
Ahimè sì, dell'Europa intera, Germania compresa, il sangue più nobile, il
più giovane, il più ardente, quello che scorre per primo nei combattimenti e con quello che resta bisogna poi vivificare il mondo. Per questo i
dopoguerra sono così difficili...
Da Chalon-sur-Saône, da Moulins, da Nevers, da Parigi e da Epernay
arrivavano ogni giorno camion militari con casse di champagne. In
mancanza di donne, intorno allo stagno ci sarebbero stati almeno vino,
musica e fuochi d'artificio.
"Verremo a vedervi" avevano detto le giovani francesi. "Per quella notte
non rispetteremo il coprifuoco. Siamo d'accordo? Se voi ve la spassate, è
giusto che ci si diverta un po’ anche noi. É il minimo. Andremo sulla strada
vicino al parco e vi guarderemo mentre ballate"
E ridendo si provavano cappellini da cotillon, cuffie Direttorio in pizzo
d'argento, maschere, acconciature con fiori di carta. A quale festa erano stati
destinati? Un po’ sciupati, un po’ sbiaditi, qualcuno doveva averli già usati,
oppure facevano parte di una partita accantonata a Cannes o a Deauville dal
gestore di qualche locale notturno che, prima del settembre 1939, contava
sulle stagioni future.
"Come sarete buffi con questa roba in testa" dicevano le donne.
I soldati si pavoneggiavano facendo smorfie.
Champagne, musica, ballo, una ventata di vita e di piacere... C'era di che
dimenticare per qualche istante la guerra e il passare del tempo.
L'unica preoccupazione era l'eventualità di un temporale. Ma le notti
erano così serene... Ed ecco, di colpo, quella grande sciagura! Un camerata
ucciso, caduto senza gloria, colpito vigliaccamente da un qualsiasi
contadino ubriaco. Si era pensato di annullare la festa. Ma no! Lì regnava lo
spirito guerriero. Quello stesso che ammette tacitamente che appena siete
morto i camerati disporranno delle vostre camicie, dei vostri stivali, e
giocheranno a carte tutta la notte mentre voi riposerete in un angolo della
tenda... ammesso che abbiano ritrovato i vostri resti! Ma è anche lo spirito
che accetta la morte altrui come cosa naturale, come destino del soldato, e
rifiuta di sacrificarle il benché minimo divertimento. Del resto i graduati
dovevano pensare prima di tutto ai sottoposti, che era opportuno distogliere
al più presto da fantasticherie demoralizzanti sui pericoli futuri e sulla
brevità della vita. No, Bonnet era morto senza soffrire troppo. Gli avevano
fatto un bel funerale. Lui stesso non avrebbe voluto che per causa sua i
camerati rimanessero a bocca asciutta. La festa avrebbe avuto luogo il
giorno convenuto.
Bruno si abbandonava a quell'eccitazione puerile un po’ folle e nel
contempo quasi disperata che pervade i soldati durante una tregua della
battaglia e quando sperano in un diversivo alla noia quotidiana. Non voleva
pensare a Bonnet, né immaginare quello che si sussurrava dietro le imposte
chiuse di quelle case grigie, fredde, ostili. Aveva voglia di dire, come un
bambino al quale era stato promesso un pomeriggio al circo e che invece
rischia di rimanere a casa perché un'anziana e noiosa parente è gravemente
ammalata: "Ma non c'entra niente. Sono fatti vostri. Forse che la cosa mi
riguarda?". Forse che quanto era successo riguardava lui, Bruno von Falk?
Non era solo un soldato del Reich, lui.
Non era mosso soltanto dagli interessi del reggimento e della patria.
Era il più umano degli uomini. Pensò che anche lui cercava, come tutti, la
felicità, la possibilità di sviluppare liberamente le sue doti, e che (come
accadeva a tutti, ahimè, in quei tempi) quel desiderio legittimo veniva
costantemente ostacolato da una sorta di ragione di Stato che si chiamava
guerra, sicurezza pubblica, necessità di mantenere il prestigio di un esercito
vittorioso. Un po’ come i figli dei re che esistono unicamente in vista dei
disegni dei sovrani loro padri. Egli sentiva che un riflesso di quella regalità,
della grandezza del potere tedesco, si sprigionava da lui quando passava per
le strade di Bussy, quando attraversava a cavallo un villaggio, quando
faceva risuonare gli speroni sulla soglia di una casa francese. Ma ciò che i
francesi non avrebbero potuto capire è che lui non si sentiva orgoglioso né
arrogante, ma sinceramente umile, spaventato dall'enormità del suo
compito.
E soprattutto quel giorno non voleva pensarci. Preferiva gingillarsi con
l'idea del ballo o sognare cose irrealizzabili, una Lucile vicina a lui, ad
esempio, una Lucile che avrebbe potuto accompagnarlo alla festa...
"Sto delirando" disse fra sé sorridendo. "Bah! Pazienza! Dentro di me
sono libero" E, nella sua mente, disegnava un abito per Lucile, non un abito
alla moda, ma ispirato a una stampa d'epoca romantica: un vestito di
mussola bianca a grandi volant, con la gonna svasata come una corolla, così
che ballando con lei, tenendola fra le braccia, lui sentisse ogni tanto i suoi
pizzi spumeggianti sfiorargli le gambe.
Impallidì e si morse le labbra. Era così bella... Oh, averla vicina in una
notte come quella, nel parco di Montmort, con le fanfare e i fuochi
d'artificio sullo sfondo... Una donna che avrebbe capito, che avrebbe
condiviso quel brivido quasi religioso dell'anima, nato dalla solitudine, dalle
tenebre e dalla consapevolezza di quella scura e terribile moltitudine - il
reggimento, i soldati in lontananza, e più lontano ancora l'esercito che
soffriva e combatteva, e l'esercito vittorioso accampato nelle città
conquistate.
"Con quella donna a fianco, svilupperei il mio talento" continuò fra sé.
Aveva lavorato molto; viveva in una perpetua esaltazione creatrice pazzo per la musica, pensava ridendo. Sì, con quella donna e con un po’ di
libertà, un po’ di pace, avrebbe potuto fare grandi cose. "Peccato," sospirò
"peccato... Un giorno o l'altro arriverà l'ordine di partire, e di nuovo la
guerra, altra gente, altri paesi, una fatica fisica tale che non riuscirò mai a
chiudere con la mia vita di soldato. E lei chiede di essere accolta... E sulla
soglia si accalcano frasi musicali, accordi mirabili, sottili dissonanze...
Creature alate e selvagge che il rumore delle armi sgomenta. É un peccato,
ma Bonnet amava qualcos'altro oltre alla guerra? Lo ignoro. Non si conosce
mai completamente un individuo.
Ma se... se fosse così... lui, che è morto a diciannove anni, si è realizzato
più di me che sono ancora vivo"
Si fermò davanti all'abitazione delle Angellier. Era arrivato a casa. In quei
tre mesi si era abituato a considerare sua quella porta d'ingresso rivestita di
ferro, quella serratura da carcere, quell'anticamera con il suo odore di
cantina e il giardino sul retro - il giardino inondato di luna e i boschi in
lontananza. Era una sera di giugno di una dolcezza divina; le rose si
aprivano, ma il loro profumo era meno forte di quello di fieno e di fragole
che dal giorno prima aleggiava in paese: era l'epoca dei grandi lavori
campestri. Lungo la strada il tenente aveva incrociato carri pieni di fieno
appena tagliato, trainati da buoi perché mancavano i cavalli. Aveva
ammirato in silenzio il lento, maestoso avanzare delle bestie e i loro carichi
fragranti. Al suo passaggio i contadini si voltavano dall'altra parte; se n'era
accorto, certo... ma adesso si sentiva di nuovo di umore gaio e leggero.
Andò in cucina e chiese qualcosa da mangiare. La cuoca lo servì con fretta
inconsueta senza rispondere alle sue battute scherzose.
"Dov'è la signora?" domandò il tenente.
"Sono qui" fece Lucile.
Era entrata senza far rumore mentre lui finiva di divorare una tetta di
prosciutto crudo sopra un grosso pezzo di pane fresco. Alzò gli occhi su di
lei:
"Com'è pallida" disse con aria tenera e preoccupata. "Pallida? No. É che è
stato molto caldo tutto il giorno"
"Dov'è la signora madre?" si informò lui sorridendo. "Andiamo a fare una
passeggiata fuori. Venga a raggiungermi in giardino".
Poco dopo, mentre camminava lentamente lungo il grande viale, fra gli
alberi da frutto, la vide. Veniva verso di lui a capo chino. Giunta a pochi
passi, esitò, poi, come al solito, non appena il grande tiglio li nascose a tutti
gli sguardi, gli si avvicinò e gli prese il braccio.
Fecero qualche passo in silenzio.
"Hanno falciato i prati" disse lei.
Lui respirò quel profumo a occhi chiusi. La luna aveva il colore del miele,
nel firmamento velato, lattiginoso, attraversato da nubi leggere.
Il chiarore del giorno indugiava ancora.
"Avremo bel tempo, domani, per la nostra festa"
"É per domani? Credevo...".
Si interruppe.
"Perché no?" fece lui aggrottando le sopracciglia.
"Niente, credevo...".
Con la bacchetta che teneva in mano, Bruno sferzava nervosamente i
fiori.
"Che cosa si dice in paese?"
"A proposito di?"
"Lo sa benissimo. A proposito del delitto".
"Non saprei. Non ho visto nessuno".
"E lei, che cosa ne pensa?"
"Che è terribile, naturalmente"
"Terribile e incomprensibile. Insomma, che cosa gli abbiamo fatto, a
questa gente, in quanto uomini? Se qualche volta li mettiamo in difficoltà
non è colpa nostra, non facciamo che eseguire gli ordini: siamo soldati. E
sono convinto che il reggimento ha fatto il possibile per mostrarsi corretto,
umano, non è così?"
"Certo" disse Lucile.
"A un'altra non lo direi, è ovvio... Per un tacito accordo, noi soldati
evitiamo di impietosirci per la sorte di un camerata ucciso. É contrario allo
spirito militare, secondo il quale ciascuno di noi è considerato unicamente
in funzione di un tutto. Muoiano i soldati purché viva il reggimento! Per
questo non rimandiamo la festa di domani" continuò. "Ma a lei, Lucile,
posso dirlo. Se penso a quel ragazzo di diciannove anni assassinato, il mio
cuore sanguina. Eravamo lontani parenti. Le le nostre famiglie si
conoscevano... E poi c'è un'altra cosa, forse stupida, ma che mi indigna
profondamente. Perché è stato ucciso anche il cane, la nostra mascotte, il
povero Bubi? Se mai scoprirò quell'uomo, sarà per me un piacere
ammazzarlo con le mie stesse mani"
"É probabilmente quello che ha pensato anche lui per un pezzo!" disse
Lucile a voce bassa. "Se metto le mani su uno di questi tedeschi, o almeno
su uno dei loro cani, sarà una festa!"
Si guardarono costernati; a entrambi le parole erano uscite di bocca quasi
inconsapevolmente. Il silenzio le avrebbe solo aggravate.
"É sempre la solita, vecchia storia," disse Bruno sforzandosi di assumere
un tono leggero "es ist die alte Geschichte. Il vincitore non capisce perché
lo si guardi in cagnesco. Dopo il 1918 vi siete sforzati invano di convincerci
che avevamo un brutto carattere perché non potevamo dimenticare
l'affondamento della nostra flotta, la perdita delle nostre colonie, lo
smantellamento dell'Impero. Ma come paragonare il risentimento di un
grande popolo al cieco soprassalto d'odio di un contadino?"
Lucile colse qualche stelo di reseda, aspirò il profumo dei fiori, li
stropicciò nella mano.
"Lo hanno trovato?"
"No. Dev'essere lontano ormai. Nessuna di queste brave persone avrà
osato nasconderlo. Sanno troppo bene quello che rischiano e alla loro pelle
ci tengono, vero? Quasi quanto ai loro soldi...".
Con un leggero sorriso guardò tutte quelle case basse che circondavano da
ogni parte il giardino - tozze, segrete, addormentate nel crepuscolo.
Si capiva che le immaginava occupate da vecchie ciarliere e sentimentali,
da signore borghesi prudenti, pignole, avide, e più in là, nella campagna, da
contadini simili a bestie. Era quasi la verità - o almeno una parte della
verità. Ma il resto era quella zona d'ombra, di tenebre, di mistero
assolutamente impenetrabile sulla quale, pensò all'improvviso Lucile
ricordando una lettura di scuola, "il più fiero tiranno non avrà mai alcun
potere"
"Andiamo un po’ più in là" disse lui.
Una fila di gigli costeggiava il viale; i lunghi boccioli vellutati si erano
schiusi agli ultimi raggi del sole e adesso fiorivano orgogliosi, eretti,
profumati, si aprivano al vento della sera. Nei tre mesi della loro
conoscenza Lucile e il tedesco avevano fatto insieme molte passeggiate, mai
però con un tempo così bello, così propizio all'amore.
Di comune accordo, cercarono di dimenticare tutto ciò che era estraneo a
loro due. "Non ci riguarda, non è colpa nostra. Nel cuore di ogni uomo e di
ogni donna esiste una sorta di Eden dove non ci sono né morte né guerre,
dove bestie feroci e cerbiatti giocano pacificamente insieme.
Dobbiamo solo ritrovare quel Paradiso, chiudere gli occhi davanti a tutto
il resto. Siamo un uomo e una donna. E ci amiamo".
Dicevano a se stessi che la ragione e persino il cuore potevano renderli
nemici, ma c'era un'intesa dei sensi che niente avrebbe potuto spezzare - la
muta complicità che lega con pari desiderio l'uomo innamorato e la donna
consenziente. All'ombra di un ciliegio carico di frutti, vicino alla piccola
fontana dalla quale si levava il lamento assetato dei rospi, lui cercò di
prenderla. L'afferrò e la strinse fra le braccia con una brutalità che non
riusciva più a dominare, strappandole l'abito, premendole i seni. Lei gettò
un grido: "Mai, no, no! Mai!". Mai sarebbe stata sua. Aveva paura di lui.
Non desiderava più le sue carezze. Non era abbastanza depravata (troppo
giovane forse!) perché da quella paura stessa nascesse una qualche voluttà.
Quell'amore, che lei aveva accettato al punto di non volerlo giudicare
colpevole, le appariva all'improvviso come un abietto delirio. Mentiva; lo
tradiva. Si poteva chiamarlo amore, quello? Che cosa, allora? Una semplice
ora di piacere? Ma anche il piacere, lei era incapace di provarlo. Ciò che li
rendeva nemici non era né la ragione né il cuore ma erano quei moti oscuri
del sangue sui quali avevano contato perché li unissero, e sui quali non
avevano alcun potere. Lui la toccava con le belle mani affusolate, ma quelle
mani di cui lei aveva tanto desiderato le carezze ora non le sentiva
nemmeno, mentre la fredda fibbia del cinturone premuta contro il suo petto
la gelava sin nel profondo. Lui le sussurrava parole tedesche. Straniero!
Straniero! Nemico, nonostante tutto e per sempre nemico, con quella
uniforme verde, con i bei capelli di un biondo d'altri paesi e la bocca
fiduciosa. Improvvisamente fu lui a respingerla.
"Non la prenderò con la forza. Non sono un soldataccio ubriaco... Se ne
vada"
Ma la cintura di mussola dell'abito di lei si era impigliata nei bottoni di
metallo dell'ufficiale. Piano, con mani tremanti, lui la sciolse, mentre lei
guardava con angoscia in direzione della casa. Stavano accendendo le prime
lampade. Si sarebbe ricordata, la vecchia signora Angellier, di chiudere
bene le doppie tende per non rischiare che l'ombra del fuggitivo apparisse
dietro il vetro? Non si diffidava mai abbastanza di quei bei crepuscoli di
giugno! Rivelavano i segreti delle stanze indifese, dove entravano gli
sguardi. Nessuno faceva attenzione a niente: da una casa vicina si sentiva
distintamente radio Londra; il carro che passava sulla strada era carico di
merci di contrabbando; in ogni casa c'erano armi nascoste. A capo chino,
Bruno teneva fra le mani la lunga cintura svolazzante. Non osava più
muoversi né parlare. Alla fine disse con tristezza:
"Credevo...".
Si interruppe, esitò, riprese:
"Che lei provasse per me... un po’ di tenerezza...".
"Lo credevo anch'io"
"E invece no?"
"No. É impossibile".
Si staccò da lui e rimase in piedi a pochi passi di distanza. Per un attimo si
guardarono. Echeggiarono le note laceranti di una tromba: il coprifuoco. In
piazza i soldati tedeschi passavano fra la gente. "Su, andate a dormire!"
dicevano in tono bonario. Le donne protestavano e ridevano. La tromba
suonò per la seconda volta. Tutti gli abitanti rientrarono nelle case. I
tedeschi restavano padroni del campo e fino all'alba solo il rumore della loro
ronda monotona avrebbe turbato il sonno.
"Il coprifuoco" disse Lucile con voce atona. "Devo rientrare e chiudere
tutte le finestre. Ieri, alla Kommandantur, mi hanno detto che le luci del
salotto non erano abbastanza oscurate"
"Finché sono qui io non si preoccupi di niente. La lasceranno in pace".
Lei non rispose, gli tese la mano che lui baciò e si diresse verso la casa.
Molto dopo la mezzanotte, Bruno passeggiava ancora nel giardino e Lucile
tendeva l'orecchio ai brevi richiami monotoni delle sentinelle che passavano
nella strada e a quel passo lento e cadenzato da carceriere sotto le sue
finestre. A tratti si diceva: "Mi ama, non sospetta di niente", ma anche:
"Diffida, spia le nostre mosse, aspetta"
"Peccato" pensò improvvisamente in un brusco soprassalto di sincerità.
"Peccato, era una notte così bella... Fatta per l'amore... Non dovevo
lasciarla perdere. Il resto non ha importanza". Ma non si mosse, non si alzò
dal letto per avvicinarsi alla finestra. Incatenata, schiava, si sentiva solidale
con quel paese prigioniero che sospirava d'impazienza e sognava. E lasciò
passare così quella inutile notte.
CAPITOLO 21.
Fin dall'inizio del pomeriggio in paese si respirava un'aria di festa. I
soldati avevano guarnito di foglie e fiori i pali sulla piazza, e sul balcone del
municipio, sotto la bandiera con la svastica, sventolavano banderuole di
carta rosse e nere con iscrizioni in lettere gotiche. Il tempo era splendido.
Un vento fresco e leggero agitava nastri e stendardi. Due giovani soldati dal
colorito acceso spingevano un carretto pieno di rose.
"Sono per i tavoli?" domandavano le donne incuriosite.
"Sì" risposero i soldati, molto fieri. E uno di loro, scelto un bocciolo
appena schiuso, lo offrì con un cerimonioso inchino a una ragazza, che si
fece tutta rossa.
"Sarà una bella festa"
"Wir hoffen so. Speriamo. Ce la mettiamo tutta" risposero i soldati.
I cuochi lavoravano all'aperto preparando pâté e torte a più strati per la
cena. Si erano sistemati al riparo dalla polvere sotto i grandi tigli tutt'intorno
alla chiesa. Lo chef, in divisa ma con cappello e grembiule di un bianco
abbagliante a protezione della giacca, dava gli ultimi tocchi a una torta. La
decorava con arabeschi di crema e la guarniva con frutta candita. L'odore
dello zucchero si diffondeva nell'aria. I bambini lanciavano grida di gioia.
Lo chef, gonfio d'orgoglio ma attento a non darlo a vedere, aggrottava le
sopracciglia e diceva severamente:
"Su, fatevi in là, lasciatemi lavorare" All'inizio le donne avevano fatto
finta di disinteressarsi della torta: "Puah! Sarà pesante...
Non hanno la farina che ci vuole...". A poco a poco, però, si erano
avvicinate, dapprima timidamente, poi con sicurezza, e alla fine mettendosi
a dare consigli con tono insolente.
"Ehi, guardi che questa parte non è abbastanza decorata... Quello che le ci
vorrebbe è un po’ di angelica"
Così finirono per collaborare all'impresa. Spingendo indietro i bambini, si
affaccendavano intorno al tavolo insieme ai tedeschi; una tritava le
mandorle, l'altra polverizzava lo zucchero.
"É per gli ufficiali? O ne avranno un po’ anche i soldati?" domandavano.
"Ce n'è per tutti, tutti quanti"
Le donne sogghignavano.
"Tranne che per noi!"
Lo chef alzò il grande piatto di ceramica sul quale troneggiava l'enorme
torta e con un piccolo inchino lo presentò alla folla, che rise e applaudì. Poi
il dolce fu posato con infinita cautela su una lunga asse di legno tenuta da
due soldati (uno a un'estremità e l'altro a quella opposta) e prese la via del
castello. Nel frattempo, facendo ondeggiare i lunghi mantelli verdi,
arrivavano da ogni parte gli ufficiali dei reparti acquartierati nelle vicinanze
che erano stati invitati alla festa. I negozianti li aspettavano, tutti sorridenti,
sulla soglia delle botteghe. Fin dal mattino avevano tirato fuori dalle cantine
le ultime scorte: i tedeschi compravano tutto quello che potevano e
pagavano bene.
Un ufficiale si portò via le ultime bottiglie di benedictine, un altro comprò
biancheria femminile per milleduecento franchi; i soldati si accalcavano
davanti alle vetrine e guardavano con aria intenerita certi bavaglini rosa e
azzurri. Alla fine uno di loro non poté resistere e, non appena l'ufficiale si fu
allontanato, chiamò la commessa e le indicò un corredino per neonato: era
un soldato giovanissimo con gli occhi azzurri.
"Maschietto o femminuccia?" domandò la commessa.
"Non lo so" disse lui ingenuamente. "Me l'ha scritto mia moglie; è stato
all'ultima licenza, un mese fa"
Gli altri scoppiarono a ridere. Lui era diventato tutto rosso ma sembrava
molto contento. Gli fecero comprare un sonaglino e una vestina.
E attraversò la strada con aria trionfante.
L'orchestra provava sulla piazza, e vicino al cerchio formato da tamburi,
trombe e pifferi un altro cerchio si andava stringendo intorno all'ufficiale
addetto alla posta. I francesi guardavano la scena a bocca aperta, gli occhi
pieni di speranza, e scuotevano la testa con un'espressione cordiale e un po’
triste pensando: "Lo sappiamo com'è quando si aspettano notizie da casa...
Ci siamo passati tutti...". Nel frattempo un giovane tedesco dalla stazza
enorme, con certe cosce possenti e un sedere che sembrava lì lì per far
saltare le cuciture dei pantaloni da cavallerizzo aderenti come un guanto,
entrava per la terza volta all'Hotel des Voyageurs e chiedeva di consultare il
barometro.
L'apparecchio indicava sempre "bello stabile"
"Nessun pericolo. Niente temporali stasera. Gott mit uns" disse il tedesco,
raggiante.
"Già" annuì la servetta.
Quell'ingenua soddisfazione si trasmise anche al padrone dell'albergo
(peraltro di tendenze anglofile) e agli avventori; tutti si alzarono e si
avvicinarono al barometro: "Nessun pericolo! Niente. Buona cosa questa,
bella festa" dicevano, sforzandosi di parlare sgrammaticato per farsi capire
meglio dal tedesco, che dava a tutti delle gran pacche sulle spalle ripetendo
con un largo sorriso:
"Gott mit uns"
"Ma certo! Got mit uns, ha già trincato mica male, il crucco"
mormoravano alle sue spalle, con una certa simpatia. "Sappiamo com'è.
L'ha cominciata da ieri, la sua festa... Un bel fusto... E poi, insomma,
perché dovrebbero rinunciare a divertirsi? Sono uomini anche loro, in
fondo!"
Dopo aver creato con la sua apparizione e con le sue parole un clima di
simpatia, e vuotato l'una dopo l'altra tre bottiglie di birra, il tedesco, sempre
raggiante, se ne andò. Con il passar delle ore tutti gli abitanti cominciavano
a sentirsi a loro agio ed eccitati come se anche loro dovessero partecipare
alla festa. Nelle cucine, le ragazze risciacquavano languidamente i bicchieri
e si affacciavano ogni momento alla finestra per vedere i tedeschi salire a
gruppi verso il castello.
"Hai visto il sottotenente che alloggia in parrocchia? Com'è bello sbarbato
di fresco! E guarda il nuovo interprete della Kommandantur! Che età gli
dai? Per me, non ha più di vent'anni, quel ragazzo! Sono tutti molto giovani.
Oh, ecco il tenente delle Angellier. Farei pazzie per quell'uomo. Si vede che
è beneducato. E che bel cavallo! Che bei cavalli hanno, mio Dio"
sospiravano le ragazze.
Un vecchio appisolato vicino alla stufa commentava in tono aspro:
"Sono i nostri, perdiana!"
E sputava nella cenere borbottando imprecazioni che le ragazze non
sentivano, occupate com'erano a finire di lavare i piatti per andare a vedere i
tedeschi al castello. Lungo il parco correva un sentiero costeggiato di
acacie, di tigli e di bei pioppi dal tremulo fogliame costantemente mosso e
frusciante. Attraverso i rami si poteva scorgere il lago, il prato dove erano
stati apparecchiati i tavoli e, su un'altura, il castello con porte e finestre
aperte, dove avrebbe suonato l'orchestra del reggimento. Alle otto tutto il
paese era lì; le ragazze avevano trascinato i genitori e le giovani donne non
avevano voluto lasciare a casa i bambini, alcuni dei quali dormivano in
braccio alle madri, altri correvano, gridavano e giocavano con i ciottoli, e
altri ancora, scostando i teneri rami delle acacie, guardavano incuriositi lo
spettacolo: i musicisti sistemati sulla terrazza, gli ufficiali che se ne stavano
sdraiati sull'erba o passeggiavano lentamente fra gli alberi, i tavoli coperti di
bellissime tovaglie e di argenteria che brillava agli ultimi raggi del sole e,
dietro ogni sedia, un soldato immobile come alla parata: gli attendenti
incaricati del servizio. Infine l'orchestra attaccò un'aria particolarmente
allegra e briosa e gli ufficiali presero posto. Prima di sedersi quello che
stava a capotavola ("il posto d'onore... un generale", sussurravano i francesi)
e tutti gli ufficiali sull'attenti lanciarono un alto grido levando i bicchieri:
"Heil Hitler!"; il clamore echeggiò a lungo, vibrò nell'aria con una
sonorità metallica, selvaggia e pura. Poi si udì il vocio delle conversazioni,
il tintinnio delle posate e gli ultimi canti degli uccelli.
I francesi cercavano di riconoscere da lontano certe figure note.
Accanto al generale con i capelli bianchi, il volto sottile, il lungo naso
arcuato, sedevano gli ufficiali della Kommandantur.
"Quello a sinistra, guarda, è lui la carogna che mi ha preso la macchina!"
"Invece il biondino tutto roseo che gli sta vicino è gentile, parla bene il
francese" "Dov'è il tedesco delle Angellier? Si chiama Bruno...". "Un bel
nome..." "Peccato, (tra poco farà buio e non si vedrà più niente...".
Il crucco dello zoccolaio mi ha detto che accenderanno le torce!" "Oh,
mamma, come sarà bello! Restiamo fino a quel momento, vero?" "E chissà
cosa dicono i castellani...
stanotte non potranno dormire!" "Chi mangerà tutto quello che avanza,
eh, mamma? Il sindaco?" "Taci, sciocchino, con l'appetito che si ritrovano
non avanzerà niente!"
A poco a poco l'ombra invadeva il prato; si vedevano ancora brillare, ma
con una luminosità attutita, le decorazioni dorate delle uniformi, i capelli
biondi dei tedeschi, gli ottoni dei musicisti sulla terrazza.
Per un breve istante il chiarore del giorno, allontanandosi dalla terra,
sembrò rifugiarsi nel cielo: volute di nuvole rosa circondavano la luna piena
che si rifletteva nel lago e che aveva un colore strano, un verde pallido
come di sorbetto al pistacchio e una trasparenza come di ghiaccio. Nell'aria
aleggiavano profumi squisiti di erba, di fieno fresco e di fragole di bosco.
L'orchestra continuava a suonare.
All'improvviso si accesero le torce; erano tenute dai soldati e
illuminavano la tavola in disordine e i bicchieri vuoti, perché ormai gli
ufficiali si affollavano intorno al lago cantando e ridendo. Si sentivano
saltare i tappi di champagne con allegri scoppi.
"Ah, canaglie!" dicevano i francesi, ma senza troppo rancore perché
l'allegria è contagiosa e smorza l'odio. "E pensare che è il nostro vino quello
che bevono...".
I tedeschi, del resto, sembravano apprezzarlo talmente quello champagne
(e lo pagavano così caro!) che i francesi, sotto sotto, si sentivano lusingati
dal loro buon gusto.
"Si divertono, per fortuna non è sempre guerra. Non preoccuparti, ne
vedranno ancora delle belle... Dicono che quest'anno finirà tutto. Certo che
se vincono loro non ci sarà da stare allegri, ma non c'è niente da fare, in un
modo o nell'altro bisogna che la facciano finita... Nelle città è uno strazio...
E che ci rimandino a casa i nostri prigionieri".
Sulla strada le ragazze ballavano tenendosi per la vita, mentre la musica
proseguiva, vibrante e leggera. I tamburi e gli ottoni davano a quei valzer e
a quei motivi da operetta una sonorità scintillante, un che di vittorioso, di
gaio, di eroico e gioioso insieme che faceva battere i cuori; e a tratti un
sospiro basso, prolungato e possente, si levava all'improvviso tra quelle note
allegre, come l'eco di una tempesta lontana.
Quando la notte scese del tutto fu la volta dei cori. Gruppi di soldati si
rispondevano dalla terrazza al parco e dagli argini della riva fin sul lago
dove scivolavano barche ornate di fiori. I francesi ascoltavano, affascinati
loro malgrado.
Era quasi mezzanotte, ma nessuno pensava a lasciare la sua postazione
nell'erba alta, fra i rami.
Solo le torce e i fuochi artificiali illuminavano gli alberi, mentre quelle
voci mirabili riempivano la notte. All'improvviso un gran silenzio. Si videro
i tedeschi correre come ombre su quello sfondo di fiamme verdi e di
chiarore lunare.
"Adesso ci saranno i fuochi d'artificio! Sì che ci saranno, lo so, me
l'hanno detto i Fritz" gridò un bambino.
La sua vocina acuta attraversava il lago. La madre lo redarguì.
"Taci! Non devi chiamarli né Fritz né crucchi. Mai! Loro non vogliono.
Taci e guarda"
Ma si vedeva solo un andirivieni di ombre agitate. Qualcuno, dall'alto
della terrazza, gridò qualcosa di incomprensibile; gli rispose un lungo e
cupo clamore simile al brontolio del tuono.
"Che cosa gridano? Avete sentito? Dev'essere "Heil Hitler! Heil Goering!
Heil il Terzo Reich!", o qualcosa del genere. Adesso non si sente più
niente. Non dicono più niente. To, i musicisti sbaraccano. Che sia arrivata
una notizia importante? Chissà, magari sono sbarcati in Inghilterra...
Secondo me, fuori avevano freddo e continueranno la loro festa nel
castello" disse con aria suadente il farmacista che per via dei reumatismi
temeva l'umidità della sera. E prese sottobraccio la giovane moglie.
"Se rientrassimo anche noi, Linette?"
Ma la farmacista non ne voleva sapere.
"Oh, no, restiamo, aspetta un altro po’! Forse canteranno ancora, era così
bello"
I francesi aspettarono ma il canto non riprese. Alcuni soldati, simili a
moderni tedofori, correvano dal castello al parco come se trasmettessero
degli ordini. A tratti si udiva un richiamo secco. Sul lago le barche
oscillavano vuote al chiaro di luna; gli ufficiali erano tutti saltati a terra e
camminavano lungo la riva discutendo animatamente ad alta voce.
Si potevano sentire le loro parole, ma nessuno le capiva. Uno dopo l'altro
i fuochi si spensero. Gli spettatori cominciarono a sbadigliare.
"É tardi. Torniamo a casa. La festa è sicuramente finita".
Ripresero la via del ritorno a gruppetti, le ragazze tenendosi a braccetto, i
genitori dietro, i bambini insonnoliti che strascicavano i piedi. Davanti alla
prima casa un vecchio fumava la pipa seduto su una sedia di paglia sul
ciglio della strada.
"Allora?" domandò. "La festa è finita?".
"Sì, e si sono divertiti un mondo"
"Non si divertiranno più per un pezzo" replicò il vecchio in tono pacifico.
"Alla radio hanno appena annunciato che sono entrati in guerra anche con la
Russia"
Batté a più riprese la pipa contro il legno della sedia per farne cadere la
cenere e mormorò guardando il cielo:
"Ancora niente pioggia domani; finirà per far male alle piante, questo
tempo!"
CAPITOLO 22.
Se ne vanno!
Già da diversi giorni ci si aspettava di veder partire i tedeschi. Lo avevano
annunciato loro: li mandavano in Russia. Saputa la notizia, i francesi
avevano cominciato a osservarli con curiosità ("Sono contenti?
Preoccupati? Perderanno o vinceranno?") Quanto ai tedeschi, cercavano
di indovinare che cosa la gente pensava di loro: era felice di vederli andar
via? E nel segreto del cuore si augurava che morissero tutti?
Oppure qualcuno li compiangeva? Li avrebbero rimpianti? Non in quanto
tedeschi e in quanto conquistatori (non erano così ingenui da porsi il
problema), ma chissà, forse avrebbero rimpianto quel Paul, quel Siegfried,
quell'Oswald che era vissuto per tre mesi sotto il loro tetto, che aveva fatto
vedere le fotografie della moglie o della madre, che aveva bevuto con loro
più di una bottiglia di vino... Ma francesi e tedeschi restavano impenetrabili;
si scambiavano parole cortesi e ponderate - "É la guerra... Non ci possiamo
far niente, vero? Speriamo che non duri a lungo!" E si congedavano gli uni
dagli altri come passeggeri di una nave all'ultimo scalo. Si sarebbero scritti.
E rivisti, un giorno. E avrebbero sempre conservato un buon ricordo delle
settimane passate a fianco a fianco. Nell'ombra, più di un soldato mormorò
a una ragazza pensierosa: "Dopo la guerra tornerò" Dopo la guerra...
Com'era lontano!
Se ne andavano quel giorno, il 1ø luglio 1941. Quello che soprattutto
preoccupava i francesi era se avrebbero dovuto o no ospitarne altri; perché
allora, pensavano amaramente, non valeva la pena cambiare. Si erano
abituati a quelli, e magari nel cambio ci avrebbero perso...
Lucile si infilò svelta nella camera della signora Angellier per dirle che la
cosa era decisa, i tedeschi sarebbero partiti quella notte stessa. Prima di
vederne arrivare altri, si poteva ragionevolmente sperare in qualche ora di
tregua di cui approfittare per far evadere Benoît. Tenerlo nascosto fino alla
fine della guerra appariva impensabile, e ugualmente impossibile era
rimandarlo a casa con il paese ancora occupato. Non restava che una
speranza: passare la linea di demarcazione, peraltro rigidamente sorvegliata
e destinata a esserlo ancora di più finché fosse durato il movimento delle
truppe.
"É molto, molto pericoloso" sussurrò Lucile. Era pallida e sembrava
stanca: da diverse notti dormiva pochissimo. Guardò Benoît, in piedi di
fronte a lei; provava nei suoi confronti un sentimento oscuro, un misto di
timore, di estraneità e di invidia. La sua espressione imperturbabile, severa,
quasi dura, la intimidiva. Era un uomo alto, muscoloso, dal colorito acceso;
sotto le sopracciglia folte aveva occhi chiari dallo sguardo a tratti
insostenibile. Le mani abbronzate e grinzose erano mani di contadino e di
soldato che avevano dimestichezza sia con la terra sia con il sangue, pensò
Lucile. Ne era certa: né angoscia né rimorso turbavano il suo sonno, tutto
era semplice per quell'uomo.
"Ci ho pensato bene, signora Lucile" disse lui sottovoce.
Nonostante quei muri da fortezza e quelle porte chiuse, tutti e tre, quando
si riunivano, si sentivano spiati e dicevano quel che avevano da dire molto
in fretta e quasi mormorando.
"In questo momento nessuno mi farà attraversare la linea. Troppo
rischioso. Sì, devo andarmene, ma vorrei andare a Parigi".
"A Parigi?"
"Quando ero sotto le armi avevo dei compagni...".
Esitò un attimo.
"Siamo stati fatti prigionieri insieme e siamo evasi insieme. Lavorano a
Parigi. Se riesco a pescarli, mi aiuteranno, ce n'è uno che a quest'ora non
sarebbe vivo se io non...".
Si guardò le mani e tacque.
"Mi basterebbe arrivare a Parigi senza farmi beccare per strada e poi poter
contare su una persona sicura che mi tenesse un giorno o due finché non
trovo i compagni"
"A Parigi non conosco nessuno" mormorò Lucile. "Ma comunque le ci
vorranno dei documenti d'identità"
"Non appena avrò rintracciato gli amici avrò anche i documenti, signora"
"Ma come? Che lavoro fanno i suoi amici?"
"Fanno politica" rispose Benoît, conciso.
"Ah, comunisti!" disse piano Lucile, ricordando certe voci che correvano
in paese a proposito delle idee e dei comportamenti di Benoît. "Ma adesso i
comunisti saranno braccati. Lei rischia la vita".
"Non è la prima volta né l'ultima, signora Lucile" disse lui. "Ci si abitua"
"E come ci andrà a Parigi? In treno è impossibile; i suoi connotati sono
stati trasmessi ovunque"
"A piedi. In bicicletta. Quando sono evaso ho fatto tutta la strada a piedi,
non mi fa paura"
"Le guardie...".
"Quelli che mi hanno ospitato due anni fa mi riconosceranno e non
andranno certo a denunciarmi alle guardie. É più sicuro di qui, dove ci sono
tanti che mi detestano. Il paese è peggio di tutto. Altrove non mi amano e
non mi detestano. É più facile".
"Tanta strada, a piedi, da solo...".
La signora Angellier, che fino a quel momento non aveva aperto bocca e
che, in piedi vicino alla finestra, osservava con i suoi occhi pallidi
l'andirivieni dei tedeschi sulla piazza, alzò una mano in segno di
avvertimento.
"Sta salendo"
Rimasero in silenzio tutti e tre. Lucile si vergognava dei battiti del suo
cuore; erano così precipitosi e violenti da farle temere che gli altri due li
sentissero. La vecchia signora e il contadino restavano impassibili. Si
sentiva la voce di Bruno, giù, che cercava Lucile; aprì alcune porte e
domandò alla cuoca:
"Sa dov'è la signora giovane?"
"É uscita" rispose Marthe.
Lucile tirò il fiato.
"Meglio che scenda" disse. "Probabilmente mi sta cercando per salutarmi
prima di partire"
"Approfittane" fece di colpo la signora Angellier "per chiedergli un
buono-benzina e un permesso di circolazione. Prenderai la macchina
vecchia, quella che non è stata requisita. Dirai al tedesco che devi portare in
città uno dei tuoi mezzadri ammalato. Con un permesso della
Kommandantur nessuno vi fermerà e potrete arrivare tranquillamente a
Parigi"
"Oh!" disse Lucile con una certa ripugnanza. "Mentire così..-""Che altro fai da dieci giorni?"
"E una volta a Parigi, dove nasconderlo finché non trova i suoi amici?
Dove scovare gente tanto coraggiosa, tanto generosa? A meno che...".
Un ricordo le attraversò la mente.
"Ma sì," disse d'un tratto "è possibile... Comunque, bisogna tentare.
Ricorda quegli sfollati parigini che si sono fermati qui da noi nel giugno
del '40? Una coppia di impiegati di banca, già anziani, ma tanto coraggiosi e
forti. Ultimamente mi hanno scritto: ho il loro indirizzo.
Si chiamano Michaud. Sì, Jeanne e Maurice Michaud. Forse
accetteranno...
Ma sì, accetteranno di certo... Però bisognerebbe scrivere e aspettare la
risposta... Oppure rischiare il tutto per il tutto... Non so...".
"A ogni modo chiedi quel permesso" consigliò la signora Angellier. E con
un sorriso pallido e arguto soggiunse: "É la cosa più facile"
"Ci proverò" mormorò Lucile.
Paventava il momento in cui si sarebbe trovata sola con Bruno. Tuttavia si
affrettò a scendere. Tanto valeva farla finita. E se lui sospettava qualcosa?
Pazienza! Era la guerra. Avrebbe subito la legge della guerra.
Non aveva paura di niente. Anzi, la sua anima vuota e stanca desiderava
confusamente affrontare un grande pericolo.
Bussò alla porta del tedesco. Entrando fu sorpresa di non trovarlo solo.
Erano con lui il nuovo interprete della Kommandantur, un ragazzo magro
dai capelli rossi, il volto ossuto e duro, le ciglia bionde, e un giovanissimo
ufficiale, piccolo, grassottello e roseo, con uno sguardo e un sorriso
infantili. Tutti e tre scrivevano lettere e facevano pacchi: mandavano a casa
quegli oggetti di vario genere che ogni soldato compra quando sta per
qualche tempo nello stesso posto come per crearsi l'illusione di una casa
propria, e che lo impicciano quando parte per una nuova campagna:
portacenere, sveglie, stampe, e soprattutto libri.
Lucile fece per ritirarsi ma la pregarono di restare. Così si mise a sedere
su una poltrona che Bruno le avvicinò e restò a guardare i tre tedeschi che,
dopo essersi scusati, si rimisero al lavoro: "Vorremmo spedire tutto con il
corriere delle cinque" dissero.
Lucile vide un violino, una piccola lampada, un dizionario francotedesco, alcuni libri francesi, tedeschi e inglesi, e una bella stampa
romantica che raffigurava un veliero sul mare.
"L'ho trovata da un rigattiere a Autun" disse Bruno.
Poi, dopo aver esitato un momento:
"Ma no... Questa non la mando... Non ho l'imballaggio adatto e si
sciuperebbe. Vuole farmi il favore di accettarla, signora? Starà bene alle
pareti di questa stanza un po’ buia. Il soggetto è convenzionale.
Però osservi: c'è un tempo minaccioso, un cielo plumbeo, una nave che si
allontana... e più in là, all'orizzonte, una striscia di luce... una vaga,
pallidissima speranza... L'accetti, signora, in ricordo di un soldato che parte
e che non la rivedrà più"
"La terrò cara, mein Herr, per questa linea bianca all'orizzonte" disse
Lucile quasi in un sussurro.
Lui s'inchinò e riprese i preparativi. Sul tavolo c'era una candela accesa;
Bruno avvicinava la ceralacca alla fiamma, poneva un sigillo sul pacco
legato con lo spago e premeva sulla cera calda l'anello che si era levato dal
dito. Guardandolo Lucile si ricordò del giorno in cui aveva suonato il
pianoforte e le aveva dato da tenere quell'anello ancora tiepido del contatto
delle sue dita.
"Sì" disse lui alzando d'improvviso gli occhi. "La felicità è finita".
"Crede che questa nuova guerra durerà tanto?" domandò lei, e subito si
pentì di aver fatto quella domanda. Come se si chiedesse a un uomo se
pensa di vivere a lungo! Che cosa presagiva, che cosa annunciava quel
nuovo fronte? Una serie di vittorie fulminee, la disfatta, o una lunga lotta?
Chi poteva saperlo? Chi mai osava scrutare il futuro? Anche se tutti lo
facevano... E sempre invano...
Lui sembrò leggere nei suoi pensieri.
"A ogni modo ci saranno molta sofferenza, molta angoscia e molto
sangue" disse.
Come lui, i due camerati sistemavano le loro cose. L'ufficiale più giovane
imballava con cura meticolosa una racchetta da tennis, e l'interprete certi bei
libroni rilegati in pelle gialla: "Trattati di giardinaggio," spiegò a Lucile "da
civile" aggiunse in tono leggermente tronfio "faccio l'architetto di giardini
Luigi XIV"
In tutto il paese, nei caffè, nelle case che avevano occupato, quanti
tedeschi, in quel momento, stavano scrivendo alle mogli, alle fidanzate, e si
separavano dalle loro proprietà terrene come si fa prima di morire?
Lucile ne provò una profonda pietà. Vide passare per la strada i cavalli
che tornavano dalla bottega del maniscalco e del sellaio, probabilmente già
pronti per la partenza. Sembrava strano pensare a quei cavalli che erano
stati strappati ai lavori dei campi in Francia e che ora venivano mandati
all'altro capo del mondo. L'interprete, che aveva seguito il suo sguardo,
disse gravemente:
"Dove andiamo adesso, è un paese molto bello per i cavalli...".
Il giovane tenente fece una smorfia.
"Un po’ meno per gli uomini...".
Lucile pensò che l'idea di quella nuova guerra li riempiva, visibilmente, di
tristezza, ma proibì a se stessa di approfondire troppo i loro sentimenti: non
voleva cogliere sull'onda dell'emozione qualche sprazzo di ciò che si
sarebbe potuto chiamare "il morale del combattente" Era quasi un lavoro da
spia, e lei si sarebbe vergognata di compierlo. Del resto, adesso li conosceva
abbastanza per sapere che si sarebbero comunque battuti bene! Insomma,
disse fra sé, c'è un abisso fra il giovane che vedo qui e il guerriero di
domani. É risaputo che l'essere umano è complesso, molteplice, diviso,
misterioso, ma ci vogliono le guerre o i grandi rivolgimenti per constatarlo.
É lo spettacolo più appassionante e più terribile, pensò ancora; il più
terribile perché è il più vero: non ci si può illudere di conoscere il mare
senza averlo visto nella tempesta come nella bonaccia. Solo chi ha osservato
gli uomini e le donne in un periodo come questo può dire di conoscerli - e di
conoscere se stesso. Quando mai avrebbe potuto credersi capace di dire a
Bruno con quel tono naturale, candido, che aveva l'accento stesso della
sincerità:
"Ero venuta a chiederle un grande favore"
"Mi dica, signora, in cosa posso esserle utile?"
"Potrebbe raccomandarmi a un qualche funzionario della Kommandantur
per farmi ottenere urgentemente un permesso di circolazione e un buonobenzina? Devo portare a Parigi...".
Mentre parlava, rifletteva: "Se gli racconto di un mezzadro ammalato, si
meraviglierà: ci sono ottime cliniche nelle vicinanze, al Creusot, a Paray o a
Autun...".
"Devo portare a Parigi uno dei miei contadini. Sua figlia lavora lì, è
gravemente ammalata e vuole vederlo. Il treno farebbe perdere troppo
tempo a questo pover'uomo; ci sono i grandi lavori, adesso, in campagna.
Se lei mi accorderà quello che le chiedo, faremo andata e ritorno in
giornata"
"Non occorre che lei vada alla Kommandantur, signora Angellier" disse
prontamente il giovane ufficiale che le rivolgeva da lontano sguardi timidi e
pieni di ammirazione. "Ho io l'autorità di soddisfare la sua richiesta.
Quando vuole partire?".
"Domani"
"Ah, bene!" mormorò Bruno. "Domani... Allora sarà qui stasera quando
partiremo"
"A che ora è stata fissata la partenza?"
"Alle undici. Viaggiamo di notte per via dei bombardamenti. Sembra una
precauzione inutile perché la luna illumina la strada come in pieno giorno.
Ma il militare, si sa, vive di tradizioni".
"Adesso devo lasciarvi" disse Lucile dopo aver preso i due pezzi di carta
sui quali il tedesco aveva scarabocchiato in fretta qualcosa: probabilmente
la vita e la libertà di un uomo. Piegò i foglietti con calma e li infilò nella
cintura senza che la minima precipitazione tradisse il suo turbamento.
"Sarò qui per vedervi partire"
Bruno la guardò, e lei colse la sua muta preghiera:
"Verrà a salutarmi, Herr tenente? Adesso esco, ma sarò di ritorno alle sei"
I tre giovani si alzarono battendo i tacchi; un tempo aveva trovato comica
quella cortesia antiquata, un po’ affettata, dei soldati del Reich. Ora pensava
che avrebbe rimpianto quel leggero tintinnio di speroni, quei baciamano,
quella sorta di ammirazione che le testimoniavano quasi loro malgrado quei
soldati senza famiglia, senza donne (se non d'infima specie) Nel rispetto che
le dimostravano c'era un'ombra di commossa malinconia, come se
ritrovassero, grazie a lei, un po’ della vita di un tempo in cui la gentilezza,
la buona educazione, la cortesia nei confronti delle donne erano virtù più
apprezzate di quelle che consistono nel bere smodatamente o nel prendere
d'assalto una postazione nemica. Vi era riconoscenza e nostalgia nel loro
atteggiamento verso di lei; Lucile lo intuiva e ne era commossa.
Aspettava le otto con profonda apprensione. Che cosa le avrebbe detto
Bruno? Come si sarebbero lasciati? Fra loro c'era tutto un mondo di
sfumature ambigue, inespresse, qualcosa di fragile come un cristallo
prezioso che una parola sarebbe bastata a spezzare. Lo sentì probabilmente
anche lui, perché rimase a tu per tu con lei solo un breve istante. Si levò il
berretto da ufficiale (l'ultimo gesto da civile, forse, pensò Lucile con un
sentimento struggente di tenerezza e di pena), le prese le mani. Prima di
baciarle, vi appoggiò un istante la guancia con un movimento dolce e
imperioso insieme: una presa di possesso? Un tentativo di segnarla in modo
indelebile con la fiamma di un ricordo?
"Addio," le disse "addio. Non la dimenticherò mai".
Lei non rispose. Quando la guardò, lui vide che aveva gli occhi pieni di
lacrime. Distolse lo sguardo.
"Senta," le disse "voglio darle l'indirizzo di un mio zio, un von Falk come
me, fratello di mio padre. Ha fatto molta carriera e si trova a Parigi
presso...".
Pronunciò un nome tedesco molto lungo.
"Fino alla fine della guerra questo signore è il comandante della regione
parigina, una specie di viceré, insomma, e fa assegnamento per tutto su mio
zio. Gli ho parlato di lei e gli ho chiesto, se mai si trovasse in difficoltà
(siamo in guerra e Dio solo sa quello che ci potrà capitare ancora), di
aiutarla nella misura del possibile"
"Lei è molto buono, Bruno" disse Lucile sottovoce.
Non si vergognava di amarlo, in quel momento: il suo desiderio era morto
e provava per lui solo pietà e una profonda, quasi materna tenerezza. Si
sforzò di sorridere.
"Come quella madre cinese, che mandando il figlio in guerra gli
raccomandava di essere prudente "perché la guerra non è priva di pericoli",
così io la prego, in mia memoria, di aver cura per quanto possibile della sua
vita"
"Perché significa qualcosa per lei?" domandò lui ansiosamente.
"Sì. Perché significa qualcosa per me".
Si strinsero la mano, lentamente. Lucile lo accompagnò fino alla porta.
Lì un attendente stava in attesa tenendo per le redini il cavallo di Bruno.
Era tardi, ma nessuno pensava a dormire. Tutti volevano vedere la partenza
dei tedeschi. In quelle ultime ore una sorta di malinconia, di affetto legava
gli uni agli altri vincitori e vinti; il grosso Erwald dalle cosce possenti, gran
bevitore, così buffo e così massiccio, il piccolo Willy, agile e allegro, che
aveva imparato delle canzoni francesi (dicevano che da civile facesse il
clown), il povero Johann rimasto solo perché tutta la famiglia era morta in
un bombardamento - "tranne mia suocera, perché non ho mai avuto fortuna,
io!" diceva amaramente -, tutti stavano per andare incontro al fuoco, alle
pallottole, alla morte. Quanti di loro sarebbero stati sepolti nelle pianure
russe? Per quanto rapidamente e felicemente potesse concludersi la guerra,
quanti poveri infelici non avrebbero mai visto quella fine benedetta, quel
giorno di resurrezione? Era una notte splendida, pura, illuminata dalla luna,
senza un alito di vento. Ed era la stagione in cui si tagliano i rami dei tigli:
gli uomini e i ragazzi si arrampicano su quei begli alberi dal denso fogliame
e li spogliano dei loro rami; sotto, le donne e le bambine strappano da quelle
bracciate profumate i fiori che resteranno a seccare per tutta l'estate nei
granai della provincia e che, d'inverno, serviranno â fare le tisane. Un
profumo delizioso, inebriante, aleggiava nell'aria. Come tutto era bello,
come tutto era tranquillo! I bambini giocavano a rincorrersi; salivano i
gradini dell'antico calvario e guardavano la strada.
"Si vedono?" domandavano le madri.
"Non ancora"
L'adunata era stata fissata davanti al castello e il reggimento sarebbe
sfilato per il paese in ordine di marcia. Qua e là, nell'ombra di una porta, si
udiva un sussurro, un rumore di baci... degli addii più teneri di altri. I soldati
erano in tenuta da combattimento, con elmetti pesanti e maschere antigas
sul petto. Finalmente si udì un breve rullo di tamburo ed essi apparvero.
Marciavano in file di otto e, a mano a mano che avanzavano, i ritardatari,
dopo un ultimo addio, un bacio mandato a fior di labbra, si affrettavano a
prendere il loro posto, stabilito in anticipo, il posto in cui avrebbero
incontrato il loro destino. Ci fu ancora qualche risata e qualche battuta
scherzosa scambiata tra i soldati e la folla, ma ben presto tutto tacque.
Comparve il generale, a cavallo, e si portò alla testa del reggimento; salutò
brevemente la truppa, salutò anche i francesi e si avviò. Dietro di lui
venivano gli ufficiali, quindi i motociclisti che scortavano un'automobile
grigia in cui stavano gli uomini della Kommandantur. Poi passò l'artiglieria,
i cannoni sulle loro piattaforme girevoli, su ciascuna delle quali stava
allungato un soldato con lo sguardo all'altezza dell'affusto, poi i mitraglieri
e tutti quegli ordigni leggeri e micidiali che la gente aveva visto passare
durante le manovre, che si era abituata a considerare senza paura, con
indifferenza, e che improvvisamente non poteva più guardare senza
rabbrividire, e i cannoni della contraerea puntati contro il cielo. E ancora: il
camion stracarico di grosse pagnotte di pane nero, appena uscite dal forno e
profumate, le ambulanze della Croce Rossa, ancora vuote... E la cucina da
campo, che saltellava a chiusura del corteo come una pignatta attaccata alla
coda di un cane. Gli uomini si misero a cantare, un canto lento e grave che
si perdeva nella notte. Poco dopo, sulla strada, al posto del reggimento
tedesco non restò che un po’ di polvere.
IL MANOSCRITTO DI SUITE FRANCESE:
Irène Némirovsky riservava la pagina di destra alla stesura del romanzo,
quella di sinistra ad appunti e al diario (IMEC, Fonds Irène Némirovsky)
APPENDICE
APPUNTI DI IRENE NÉMIROVSKY
sullo stato della Francia e sul suo progetto.
Suite française tratti dal suo diario.
Mio Dio, cosa mi combina questo paese? Dal momento che mi respinge,
osserviamolo freddamente, guardiamolo mentre perde l'onore e la vita. E gli
altri, come considerarli? Gli imperi muoiono. Niente ha importanza. Che le
si osservi dal punto di vista mistico o da quello personale, le cose non
cambiano - è un tutt'uno. Manteniamo la mente fredda. Tempriamo il nostro
cuore. Aspettiamo.
21 giugno. Conversazione con Pied-de-Marmite. La Francia marcerà
mano nella mano con la Germania. Tra poco qui gli uomini saranno
chiamati alle armi, "ma solo i giovani" Questo viene detto di sicuro per
riguardo a Michel. Un esercito attraversa la Russia, l'altro viene dall'Africa.
Suez è occupata. Il Giappone con la sua formidabile flotta batte l'America.
L'Inghilterra chiede grazia.
25 giugno. Caldo pazzesco. Il giardino sfoggia tutti i colori di giugno azzurro, verde chiaro e rosa. Ho perso la mia stilografica. E ho ben altre
preoccupazioni, come la minaccia del campo di concentramento, lo statuto
degli ebrei, ecc. Domenica indimenticabile. Il fulmine a ciel sereno della
Russia si abbatte sui nostri amici dopo la "folle notte" sulle rive del lago. E
per fare che? Anche gli altri sono tutti ubriachi. Chissà se un giorno lo
descriverò...
28 giugno. Se ne vanno. Per ventiquattro ore sembravano depressi, adesso
sono allegri, soprattutto quando stanno insieme. Il piccolino simpatico dice
tristemente che "i tempi felici sono passati" Mandano a casa i loro pacchi.
Sono sovreccitati, è evidente. Grande disciplina, e in fondo al cuore nessuna
ribellione, credo. Giuro qui di non riversare mai più il mio rancore, per
quanto giustificato, su una collettività di uomini, quali che siano la razza, la
religione, le convinzioni, i pregiudizi, gli errori. Compiango quei poveri
ragazzi. Ma non posso perdonare gli individui, quelli che mi respingono,
quelli che freddamente ci voltano le spalle, quelli che aspettano solo di
giocarti un tiro mancino. Quelli... vorrei averli tra le mani un giorno...
Quando finirà tutto ciò? I soldati che erano qui l'estate scorsa dicevano
"Natale", poi "luglio" Adesso "fine '41" Qui si parla di liberare il territorio,
tranne la zona proibita e le coste. Nella zona libera pare che la gente se ne
infischi della guerra. La rilettura attenta del "Journal officiel" mi fa ricadere
nello stato d'animo di qualche giorno fa.
Per sollevare un così grande peso ci vorrebbe la tua forza, o Sisifo.
Questa fatica non mi spaventa ma la meta è lontana e breve il tempo.
Le vin de solitude di Irène Némirovsky per Irène Némirovsky.
1942
I francesi erano stanchi della Repubblica come di una vecchia moglie. Per
loro la dittatura era un capriccio, una forma di adulterio. Volevano tradire la
moglie, certo, ma non intendevano assassinarla. Adesso la vedono morta, la
loro Repubblica, la loro libertà. E la piangono.
Da qualche anno tutto quello che si fa in Francia nell'ambito di una certa
classe sociale ha un solo movente: la paura. É stata la paura a provocare la
guerra, la sconfitta e la pace attuale. Il francese di questa casta non odia
nessuno; non nutre gelosia né ambizione delusa, né un vero desiderio di
vendetta. Ha una fifa blu. Chi gli farà meno male (non nel futuro, non in
senso astratto, ma subito e sotto forma di ceffoni e calci nel sedere)? I
tedeschi? Gli inglesi? I russi? I tedeschi lo hanno sconfitto, ma la punizione
è presto dimenticata e i tedeschi possono difenderlo. Per questo lui è "per i
tedeschi". A scuola, l'allievo più debole preferisce l'oppressione di un solo
individuo all'indipendenza; il tiranno lo tartassa ma impedisce agli altri di
rubargli le biglie, di picchiarlo. Se sfugge al tiranno, si ritrova solo, piantato
in asso in mezzo alla mischia.
Vi è un abisso fra la casta dei nostri attuali dirigenti e il resto della
nazione. Gli altri francesi, avendo ben poco da perdere, hanno meno paura.
Quando la vigliaccheria non soffoca più negli animi i buoni sentimenti,
questi (patriottismo, amore per la libertà, ecc.) possono fiorire. Certo, negli
ultimi tempi anche il popolo ha accumulato dei capitali, ma si tratta di
denaro svalutato che è impossibile trasformare in beni reali, terre, gioielli,
oro e così via. Il nostro macellaio, che ha guadagnato cinquecentomila
franchi di una moneta di cui conosce il tasso all'estero (esattamente zero),
tiene meno al suo denaro di quanto un Pericand, un Corbin tengano alle loro
proprietà, alle loro banche, ecc. Il mondo è sempre più diviso fra chi
possiede qualcosa e chi è nullatenente. I primi non vogliono mollare niente
e i secondi vogliono prendere tutto. Chi l'avrà vinta?
Gli uomini più odiati in Francia nel 1942:
Philippe Henriot e Pierre Laval. Il primo, noto come la Tigre, il secondo
come la Iena: intorno al primo si sente odore di sangue fresco, e puzza di
carogna intorno al secondo.
Mers-el-Kebir amaro stupore
Siria indifferenza
Madagascar indifferenza ancora più grande. Insomma, quello che conta è
il primo choc. Ci si abitua a tutto, a tutto quello che succede nella zona
occupata: i massacri, la persecuzione, il saccheggio organizzato sono come
frecce che si conficcano nel fango! Nel fango dei cuori.
Vogliono farci credere che siamo in un'epoca comunitaria in cui
l'individuo deve soccombere affinché viva la società, e non vogliamo vedere
che quella che soccombe è la società affinché vivano i tiranni.
Questa epoca che si crede "comunitaria" è più individualista di quella del
Rinascimento o di quella dei grandi feudatari. É come se nel mondo ci fosse
una quantità complessiva di libertà e di potere ripartita ora fra milioni di
individui, ora fra un singolo e milioni di individui. "Prendete i miei avanzi"
dicono i dittatori. Non mi vengano quindi a parlare dello spirito
comunitario. Se devo morire, voglio farlo da francese e da essere pensante,
voglio capire perché muoio, e io, JeanMarie Michaud, perché muoio per
Philippe Henriot e Pierre Laval e altri signori e padroni nel modo in cui
viene sgozzato un pollo per servirlo alla mensa di quei traditori. E sostengo,
io, che il pollo vale ben più di quelli che lo mangeranno. So di essere più
intelligente, migliore, più prezioso di quanto non sia il bene dei signori
succitati. Loro hanno la forza, ma una forza provvisoria e fallace, che gli
sarà tolta dal tempo, da una sconfitta, dalla malasorte, dalla malattia (com'è
stato per Napoleone) E allora il mondo si stupirà: Ma come?, dirà la gente, è
davanti a questi che abbiamo tremato? Ho davvero uno spirito comunitario
se difendo la mia parte, e quella di tutti gli altri, dalla voracità. L'individuo
vale solo se ha coscienza degli altri uomini, d'accordo. Ma che siano "gli
altri uomini" e non "un uomo". É grazie a questa confusione che nasce la
dittatura. Napoleone dice di volere solo la grandezza della Francia, ma grida
a Metternich: "Me ne frego della vita di milioni di uomini"
Hitler: "Non lavoro per me ma per l'Europa" (ha cominciato col dire "non
lavoro per il popolo tedesco") Il suo pensiero è uguale a quello di
Napoleone: "Me ne frego della vita e della morte di milioni di uomini"
PER "TEMPETE EN JUIN":
Ecco cosa dovrei procurarmi:
1) Una carta geografica della Francia molto dettagliata o una guida
Michelin.
2) La collezione completa di diversi giornali francesi e stranieri dal 10
giugno al 10 luglio.
3) Un trattato sulle porcellane.
4) I nomi degli uccelli di giugno e il loro canto.
5) Un libro mistico (quello del padrino), padre Brechard.
Osservazioni su quanto è già stato scritto:
1) Testamento - Lui parla troppo.
2) Morte del prete - Melodrammatica.
3) Nîmes? Perché non Tolosa, che conosco?
4) In generale, non c'è abbastanza semplicità!
[In russo, Irène Némirovsky ha aggiunto: "c'è un'abbondanza di
personaggi troppo altolocati"]
30 giugno 1941. Insistere sulle figure dei Michaud. Quelli che pagano
sempre per tutti e i soli che siano veramente nobili. Strano che la massa,
massa detestabile, sia per lo più formata da queste brave persone. Questo
non la rende migliore, né rende quelle peggiori.
Quali sono le scene che meritano di passare alla posterità?
1) Le code all'alba davanti ai negozi.
2) L'arrivo dei tedeschi.
3) Non tanto gli attentati e la fucilazione degli ostaggi quanto la profonda
indifferenza della gente.
4) Se voglio fare qualcosa che colpisca, non descriverò la miseria ma
piuttosto la metterò a confronto con la ricchezza.
5) Quando Hubert sfugge alla prigione in cui sono stati portati gli altri
sventurati, invece di descrivere la morte degli ostaggi devo mettere in risalto
la festa all'Opera, e fare un semplice accenno agli attacchini: uno di loro è
stato fucilato all'alba. Lo stesso dopo la guerra, senza insistere troppo su
Corbin. Sì, devo procedere a forza di contrapposizioni: una parola per la
miseria, dieci per l'egoismo, la vigliaccheria, la connivenza, il delitto. Sarà
formidabile! Ma è anche vero che quest'aria io la respiro. Una cosa facile da
immaginare: l'ossessione del cibo.
6) Pensare anche alla messa in rue de la Source, di prima mattina quando
è ancora buio. Contrapposizioni! C'è qualcosa, nelle contrapposizioni, che
può essere molto forte e molto nuovo. Perché me ne servo così poco in
Dolce? E allora, invece di insistere su Madeleine, potrei tagliare tutto il
capitolo Madeleine-Lucile, ridurlo a poche righe di spiegazione che
passerebbero nel capitolo signora Angellier-Lucile. In compenso, descrivere
minuziosamente i preparativi della festa tedesca. É forse an impression of
ironic contrast, to receive the force of the contrast. The reader has only to
see and hear.
Personaggi in ordine di apparizione (per quanto mi ricordi):
I Pericand - I Corte - I Michaud - I proprietari terrieri - Lucile - I teppisti?
- I contadini, ecc. - I tedeschi -I nobili.
Bene, bisognerebbe piazzare insieme fin dall'inizio: Hubert, Corte, Jules
Blanc, ma questo mi manderebbe all'aria l'unità di tono per Dolce.
Decisamente credo che si debba lasciare Dolce così com'è e in compenso
ritrovare tutti i personaggi di Tempête, ma fare in modo che abbiano tutti
un'influenza fatale su Lucile, Jean-Marie e gli altri (e sulla Francia)
Credo che (risultato pratico) Dolce debba essere breve. Infatti, contro le
ottanta pagine di Tempête, Dolce ne avrà probabilmente una sessantina, non
di più. Captivité, in compenso, dovrebbe arrivare a cento. Diciamo dunque:
tempête 80 pagine dolce 60 " captivité 100 "
Gli altri due 50
In tutto 390 pagine, mettiamo 400, moltiplicate per 4. Gesù! Farebbe
1600 pagine dattiloscritte! Well, well, if I live in it! Se poi il 14 luglio
arrivano quelli che hanno promesso di arrivare, questo comporterà, tra
l'altro, la soppressione di due parti, o almeno di una.
Effettivamente è un po’ come la musica in cui si sente a volte tutta
l'orchestra, a volte il violino solo. O almeno così dovrebbe essere. Legare
insieme [due parole illeggibili in russo] e i sentimenti individuali. É la storia
del mondo che mi interessa qui.
Attenzione, c'è un pericolo: dimenticare i cambiamenti dei caratteri.
Certo, il tempo trascorso è breve. Le prime tre parti, a ogni modo,
copriranno uno spazio di soli tre anni. Per le ultime due, lo sa il cielo e non
so cosa non darei per saperlo anch'io. Ma bisogna che l'intensità e la gravità
delle esperienze modifichino i caratteri dei personaggi...
La mia idea è che la vicenda si svolga come in un film, ma di tanto in
tanto la tentazione di far conoscere il mio punto di vista personale è forte, e
vi ho ceduto con brevi accenni o per esempio nell'episodio che viene dopo
la riunione nella scuola confessionale. Seguitare così a qualunque costo?
Meditare anche su: the famous "impersonality" of Flaubert and his kind
lies only in the greater fact with which they express their feelings dramatizing them, embodying them in living form, instead of stating them
directly?
Such... in certi casi non bisogna sapere quello che ha nel cuore Lucile, ma
mostrarla attraverso gli occhi di un altro.
Aprile 1942
Bisogna fare un seguito di Tempête, Dolce, Captivité. Sostituire la fattoria
Desjours con la fattoria dei Mounain. Avrei voglia di collocarla a
Montferroux - con un duplice vantaggio: si collega Tempête a Dolce e si
elimina quanto c'è di sgradevole nella famiglia Desjours. Bisogna fare
qualcosa di grande e smetterla di domandarsi a che pro.
Non farsi illusioni: non accadrà presto. E allora non bisogna trattenersi,
ma picchiare a tutta forza dove si vuole.
Per Captivité: Gli atteggiamenti successivi di Corte: rivoluzione
nazionale, necessità di un capo. Sacrificio (tutti d'accordo sulla necessità del
sacrificio, purché sia quello del prossimo), poi la frase lapidaria che gli
conferisce gloria, giacché all'inizio Corte è visto abbastanza in cattiva luce;
ha un comportamento troppo francese ma da certi piccoli segni minacciosi
ci si accorge che non è quello giusto. Sì, è un patriota ma poi: oggi il Reno
scorre sui monti Urali, ha un attimo di esitazione ma in fondo questo
corrisponde a tutte le fantasie geografiche che sono circolate in questi ultimi
anni - il confine inglese è sul Reno e per finire la linea Maginot e la linea
Sigfrido sono tutte e due in Russia, ultima invenzione di Horace (down him)
Dovrebbe essere lui perché è un farabutto. E di questi tempi un farabutto
vale più di un galantuomo.
1- Laval.
Captivité - niente leziosaggini, raccontare cosa ne è delle persone, punto e
basta.
Oggi, 24 aprile, un po’ di calma per la prima volta dopo tanto tempo;
lasciarsi permeare dalla convinzione che la serie delle Tempêtes, se così
posso dire, deve essere, è un capolavoro. Lavorarci strenuamente.
Corte è uno di quegli scrittori la cui utilità si rivelò in modo lampante
negli anni che seguirono la sconfitta; non aveva pari nel trovare formule
decenti che servissero ad abbellire realtà sgradevoli. Per esempio: l'esercito
francese non è indietreggiato, ha ripiegato! Leccare i piedi ai tedeschi vuol
dire avere il senso della realtà, e l'accaparramento di generi alimentari a
vantaggio esclusivo di pochi significa avere lo spirito comunitario.
Penso che dovrò sostituire le fragole con i nontiscordardimé. Sembra
impossibile situare nello stesso periodo i ciliegi in fiore e le fragole già
mature.
Trovare il modo di collegare Lucile a Tempête. Quando i Michaud si
riposano di notte sulla strada, quell'oasi e quella prima colazione e tutto
quello che deve sembrare bellissimo - sulla tavola le tazze di porcellana,
fitti bouquet di rose umide di rugiada (rose dal cuore nero), la caffettiera
avvolta da vapori azzurrognoli, ecc.
Stroncare i letterati. Per es. A. C, l'A. R. che ha scritto "la tristezza di
Olympio è un capolavoro?" Non c'è mai stata una vera stroncatura di certi
letterati tipo A. B. e compagni (lupo non mangia lupo)
In conclusione, i capitoli già fatti al 13 maggio 1942 sono: 1) L'arrivo - 2)
Madeleine - 3) Madeleine e suo marito - 4) I Vespri - 5) La casa - 6) I
tedeschi nel villaggio - 7) La scuola confessionale - 8) Il giardino e la visita
della viscontessa - 9) La cucina - 10) Uscita della signora Angellier. Primo
colpo d'occhio sul giardino Perrin - 11) Il giorno di pioggia.
DA FARE:
12) Il tedesco ammalato - 13) I boschi della Maie - 14) Le signore Perrin 15) Il giardino Perrin - 16) La famiglia di Madeleine - 17) La viscontessa e
Benoît - 18) La denuncia? - 19) La notte - 20) Il dramma in casa di Benoît 21) Madeleine da Lucile - 22) La festa sull'acqua - 23) Il ditale.
Restano da fare: 12, la metà di 13, 16, 17, e il seguito. Madeleine da
Lucile - Lucile dalla signora Angellier - Lucile con il tedesco - La festa
sull'acqua - La partenza.
PER "CAPTIVITÉ": PER IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO LA
BESTEMMIA DEGLI EBREI BATTEZZATI "MIO DIO PERDONA A
NOI I NOSTRI PECCATI COME NOI TI PERDONIAMO" - I martiri,
ovviamente, non lo avrebbero detto.
Per far bene le cose, ci vorrebbero cinque parti:
1) Tempête 2) Dolce 3) Captivité
4) Batailles?
5) La paix?
Titolo generale: Tempête o Tempêtes, e la prima parte potrebbe chiamarsi
Naufrage.
Nonostante tutto, quello che collega queste creature fra loro è l'epoca,
unicamente l'epoca. É abbastanza? Voglio dire: questo nesso si sente
abbastanza?
Dunque Benoît, dopo aver ucciso (o tentato di uccidere) Bonnet (devo
ancora vedere se per il seguito della storia non convenga lasciarlo vivere),
Benoît dunque scappa; si nasconde nei boschi della Maie, poi, dato che
Madeleine ha paura di essere seguita quando gli porta da mangiare, si
nasconde da Lucile. E infine a Parigi, dai Michaud, dove lo ha mandato
Lucile. Braccato, fugge in tempo, ma la Gestapo perquisisce l'appartamento
dei Michaud, trova delle note buttate giù da Jean-Marie per un libro che ha
in mente di scrivere, le scambia per volantini di propaganda politica e lo
arresta. In prigione Jean-Marie ritrova Hubert, che si è fatto beccare per
delle fesserie. Hubert potrebbe uscire tranquillamente, sotto l'egida della sua
potente famiglia che è collaborazionista all'unanimità, ma per una ragazzata,
per il gusto romantico dell'avventura, ecc, preferisce rischiare la morte
evadendo con Jean-Marie. Benoît e alcuni compagni li aiutano. Più tardi,
molto più tardi, perché nel frattempo bisogna che Jean-Marie e Lucile si
amino, ci sarà l'espatrio, l'evasione dalla Francia. Questo dovrebbe
concludere Captivité e, come ho detto:
- Benoît Comunista -Jean-Marie Borghese
Jean-Marie muore da eroe. Ma come? E che cos'è l'eroismo ai nostri
giorni? Parallelamente a questa morte bisognerebbe mostrare quella del
tedesco in Russia, entrambe dolorosamente nobili.
Adagio: Bisognerebbe trovare tutti questi termini musicali (presto,
prestissimo, adagio, andante, con amore, ecc)
Musica: Adagio dell'op. 106, l'immenso poema della solitudine - la XXa
variazione sul tema di Diabelli, questa sfinge dal cupo cipiglio che
contempla l'abisso - il Benedictus della Missa solemnis e le ultime scene del
Parsifal.
E dunque: quelli che si ameranno davvero sono Lucile e Jean-Marie. Che
fare di Hubert? Abbozzo vago: dopo aver ucciso Bonnet, Benoît scappa.
Viene nascosto in casa di Lucile. Dopo che i tedeschi se ne sono andati,
Lucile trova rischioso lasciarlo al villaggio e improvvisamente pensa ai
Michaud.
D'altra parte vorrei che J.-Marie e Hubert fossero arrestati e imprigionati
dai tedeschi per ragioni diverse. Così si potrebbe posticipare la morte del
tedesco. A Lucile potrebbe venire in mente di rivolgersi a lui per salvare J.Marie... Tutto questo è ancora molto vago. Ci penserò su.
Da una parte vorrei una sorta di idea generale. Dall'altra... Tolstoj per
esempio con un'idea rovina ogni cosa. Ci vogliono uomini, reazioni umane,
ecco tutto...
Accontentiamoci dei grandi uomini d'affari e degli scrittori famosi. Sono
loro i veri re, in fondo.
Per Dolce: una donna onesta può confessare senza vergogna "quelle
sorprese dei sensi che la ragione supera", come dirà Pauline (Corneille)
2 giugno 1942. Non dimenticare mai che la guerra finirà e che tutta la
parte storica sbiadirà. Cercare di mettere insieme il maggior numero di cose,
di argomenti... che possano interessare la gente nel 1952 o nel 2052.
Rileggere Tolstoj. Indispensabili le descrizioni, ma non storiche. Insistere su
questo. Per esempio in Dolce i tedeschi nel villaggio. In Captivité la prima
comunione di Jacqueline e la serata in casa di Ariette Corail.
2 giugno 1942. Cominciare a preoccuparmi della forma che avrà questo
romanzo una volta terminato! Considerare che non ho ancora finito la 2a
parte, che ho in mente la 3a ma che la 4a e la 5a sono ancora nel limbo, e
che limbo! Il futuro è davvero nelle mani degli dei, perché dipende da
quello che succederà. E gli dei possono divertirsi a fare un intervallo di
cento anni o di mille, come va di moda dire: e io sarò lontana. Ma gli dei
non mi faranno questo. Conto anche molto sulla profezia di Nostradamus.
1944. Oh, God!
La forma, dunque... ma dovrei dire piuttosto il ritmo: il ritmo in senso
cinematografico... collegamenti delle parti fra loro. Tempête, Dolce,
dolcezza e tragedia. Captivité. Qualcosa di smorzato, di soffocato, il più
possibile cattivo. Dopo non so.
L'importante - i rapporti fra le diverse parti dell'opera. Se conoscessi
meglio la musica, credo che questo potrebbe aiutarmi. In mancanza della
musica, quello che al cinema si chiama ritmo. Insomma, preoccuparsi da
una parte della varietà e dall'altra dell'armonia. Nel cinema un film deve
avere una unità, un tono, uno stile. Per es. quei film americani della strada
in cui si vedono sempre dei grattacieli, in cui s intuisce l'atmosfera calda,
pesante, appiccicosa, di una certa New York. Dunque unità per tutto il film
ma varietà fra le diverse parti. Inseguimento - gli innamorati - il riso, le
lacrime, ecc. E a questo genere di ritmo che vorrei arrivare.
Adesso un problema più terra terra e che non so risolvere: Non ci sarà il
rischio che da un libro all'altro ci si dimentichi dei personaggi? É appunto
per evitare questo inconveniente che vorrei fare non un'opera in diversi
volumi ma un grosso volume di 1000 pagine.
3 luglio '42. Decisamente [disperata], e a meno che le cose non perdurino
e non si complichino nel frattempo! Ma che almeno tutto finisca, bene o
male!
Ci vogliono solo 4 movimenti. Nel 3ø, Captivité, il destino collettivo e il
destino individuale sono strettamente legati. Nel 4ø, quale che sia il
risultato! (so a cosa alludo!), il destino individuale si libera dall'altro. Da
una parte il destino del popolo, dall'altra Jean-Marie e Lucile, il loro amore,
la musica del tedesco, ecc.
Adesso, ecco quello che ho immaginato:
1 ) Benoît viene ucciso nel corso di una rivoluzione o di un tafferuglio o
di un tentativo di rivolta a seconda di quella che sarà la situazione reale.
2) Corte. Credo che funzionerà. Corte, che ha avuto molta paura dei
bolscevichi, diventa violentemente collaborazionista ma, a seguito di un
attentato perpetrato ai danni del suo amico o per vanità frustrata, pensa che
ormai per i tedeschi non ci sia più scampo. E vuole dare garanzie ai
sinistrorsi! Pensa dapprima a Jules Blanc, ma dopo averlo incontrato lo
trova [parola russa illeggibile], e si orienta verso un gruppo di giovani molto
attivi che hanno fondato... [frase interrotta].
Per Captivité:
Cominciare con: Corte, Jules Blanc da Corte. Poi, in contrasto: forse
Lucile dai Michaud. Poi: i Pericand.
Il maggior numero possibile di riunioni, ma non storiche: folla, mondanità
o sommosse di strada o qualcosa di simile!
Arrivo Mattina Partenza
Tre episodi che devono essere messi in maggior risalto. Il valore di questo
libro deve essere dato dai movimenti di folla.
Della 4a parte so solo la morte del tedesco in Russia.
Sì, perché la cosa funzioni ci vorrebbero cinque parti di 200 pagine
ciascuna. Un libro di 1000 pagine. Mio Dio!
Nota. Il furto della cena di Corte da parte dei proletari deve influire
profondamente sul seguito. Corte di norma dovrebbe diventare
violentemente nazista, ma posso anche, se voglio, se mi serve, fare in modo
che dica a se stesso: "Non c'è da farsi illusioni: l'avvenire sarà questo, sarà
questa forza brutale che mi ha scippato il cibo. Dunque, due posizioni:
lottare contro di essa o, al contrario, mettersi da subito alla testa del
movimento. Lasciarsi portare dalla corrente, ma in prima linea? Meglio,
cercare di cavalcarla? Scrittore ufficiale del Partito. Il grand'uomo del
Partito, guarda guarda!" tanto più che la Germania è in buoni rapporti con
l'URSS e sempre più dovrà tollerarla. Finché dura la guerra, sarebbe
effettivamente una follia da parte della Germania, ecc. In seguito sarà
diverso... Ma in seguito si vedrà. Si correrà in aiuto del più forte. Un Corte
può avere idee così ciniche? Ma sì, in certi momenti. Quando ha bevuto
oppure quando ha fatto l'amore nel suo modo preferito, un modo di cui il
comune mortale non può avere che una pallida idea, e quand'anche l'avesse,
ne resterebbe sbigottito e terrorizzato. Il difficile, qui, è come sempre il lato
pratico della cosa. Un giornale, una specie di radio. Libertà, sovvenzione di
nascosto da parte dei tedeschi. Pensarci.
All action is a battle, the only business is peace.
Chissà se the pattern is less una ruota o un'onda che sale e scende, e sulla
cui cresta ora si trova un gabbiano, ora lo Spirito del Male e ora un topo
morto. Esattamente la realtà, la nostra realtà (non c'è da esserne orgogliosi!)
Il ritmo dev'essere dato dai movimenti di massa, tutti i punti in cui si vede
la folla nel 1ø volume, la fuga, i profughi, l'arrivo dei tedeschi nel villaggio.
In Dolce: l'arrivo dei tedeschi, ma deve essere rivisto, la mattina, la
partenza. In Captivité, la prima comunione, una manifestazione (quella
dell'11 novembre '41), una guerra? Da vedere. Non ci sono ancora e seguo il
dettato della realtà.
Se faccio vedere delle persone che "agiscono" su questi eventi prendo una
cantonata. Se invece le vedo agire, questo si avvicina senz'altro alla realtà,
ma a scapito dell'interesse. Tuttavia bisogna fermarsi lì.
E abbastanza giusto (e del resto banale, ma evviva la banalità) quello che
dice Percy - che le migliori scene storiche (vedi Guerra e pace) sono quelle
viste attraverso i personaggi. In Tempête ho cercato di fare la stessa cosa,
ma in Dolce tutto quello che si riferisce ai tedeschi può e deve essere a
parte.
Insomma, sarebbe bene (ma è fattibile?) mostrare sempre nelle scene non
viste attraverso i personaggi l'avanzata dell'esercito tedesco in Francia.
Bisognerebbe dunque cominciare Tempête con un'immagine di gente in
fuga.
Difficile.
Ciò che dà a Guerra e pace quella espansione di cui parla Forster credo
sia semplicemente il fatto che nella mente di Tolstoj Guerra e pace è solo un
primo volume cui avrebbe dovuto far seguito I decabristi, ma quello che lui
ha fatto inconsciamente (immagino, poiché io non ne so niente), insomma
ciò che ha fatto consapevolmente o no è molto importante farlo in un libro
come Tempête, ecc; anche se alcuni personaggi arrivano a una conclusione,
il libro in sé deve dare l'impressione di essere semplicemente un episodio...
com'è in realtà la nostra epoca, e indubbiamente tutte le epoche.
22 giugno '42. Già da qualche tempo ho scoperto una tecnica che mi ha
reso un ottimo servizio - il metodo indiretto. Ogni volta che nel trattare una
certa parte mi trovo in difficoltà, questo metodo mi salva, dà freschezza e
forza a tutta la storia. Me ne servo sempre in Dolce quando c'è in scena la
signora Angellier. Ma quel metodo di apparizione che non ho ancora
utilizzato può avere infiniti sviluppi.
10 luglio '42, per Captivité ho trovato questo:
Unificando e semplificando, il libro (nel suo complesso) deve sempre
risolversi in una lotta fra il destino individuale e il destino collettivo. Senza
doversi schierare.
La mia posizione: il regime borghese rappresentato dall'Inghilterra, e
disgraziatamente spacciato, vuole almeno essere rinnovato perché in fondo,
nella sua essenza, è immutabile; ma probabilmente si riprenderà solo dopo
la mia morte: restano dunque in campo due forme di socialismo. Non mi
entusiasmano né l'una né l'altra ma there are facts! Una di esse mi respinge,
dunque... la seconda... Ma la cosa è fuori questione. Come scrittore devo
porre correttamente il problema.
Questa lotta fra i due destini viene sempre fuori quando c'è un qualche
sovvertimento, non è cosa ragionata ma istintiva; credo che ci si lasci la
pelle, non per intero, ma in buona parte. Quello che ci salva è il fatto che in
genere il tempo che è riservato a noi è più lungo di quello riservato alla
crisi. Contrariamente a quanto si crede, ciò che è generale passa, il
particolare resta, il destino collettivo è più breve di quello del semplice
individuo (non è del tutto esatto. É una scala temporale diversa: ci
interessiamo solo alle scosse, e le scosse o ci uccidono o durano meno di
noi)
Tornando al punto: davanti a questa grande partita a scacchi J.-Marie ha
dapprima un atteggiamento cauto e distaccato. Naturalmente vorrebbe la
rivincita della Francia, ma si rende conto che quello non può essere
l'obiettivo finale, perché chi dice rivincita dice odio e vendetta, la guerra
eterna e il cristiano turbato dall'idea dell'inferno e dell'eterno castigo; quanto
a lui, sapere che ci sarà sempre chi è più forte e chi è più debole lo disturba
profondamente; si muove dunque nel senso dell'unificazione... Quello che
desidera, quello cui aspira davvero, è la concordia e la pace. Ma il
collaborazionismo come viene attualmente praticato lo disgusta, e dall'altra
parte vede il comunismo, che va bene a Benoît ma non a lui. Allora cerca di
vivere come se il grande e urgente problema comune non si ponesse, come
se dovesse risolvere solo i propri problemi personali. Ma ecco che viene a
sapere che Lucile ha amato e forse ama ancora un tedesco; di conseguenza
prende posizione perché l'astrazione ha assunto di colpo le sembianze
dell'odio. Odia un tedesco, e in lui, attraverso lui, odia o crede di odiare (che
è la stessa cosa) una forma mentis. In realtà quello che succede è che lui
dimentica il proprio destino e lo confonde con quello degli altri. Di fatto,
alla fine di Captivité, Lucile e J.-Marie si amano; un amore sofferto, tacito,
incompiuto, in piena lotta! J-Marie scappa per combattere contro i tedeschi posto che alla fine del '42 sia ancora possibile!
La 4a parte dovrebbe essere il ritorno, se non il trionfo, del capitolo in cui
comparirà J.-Marie. Non dimenticare mai che ai lettori piace che gli si
descriva la vita dei "ricchi"
In conclusione: lotta fra il destino individuale e il destino collettivo. Per
finire, porre l'accento sull'amore di Lucile e di Jean-Marie e sulla vita
eterna. Il capolavoro musicale del tedesco. Sarebbe inoltre opportuno un
richiamo a Philippe. Ciò che in definitiva corrisponderebbe alla mia
convinzione profonda. Punti fermi:
1 ) La nostra piccola vita quotidiana 2) L'arte 3) Dio
Bosco della Maie, 11 luglio '42.
I pini intorno a me. Sono seduta sul mio maglione blu come su una zattera
in mezzo a un oceano di foglie putride inzuppate dal temporale della notte
scorsa, con le gambe ripiegate sotto di me! Ho messo nella borsa il secondo
volume di Anna Karenina, Il Diario di K. M. e un'arancia. I miei amici
calabroni, insetti deliziosi, sembrano, contenti di sé e il loro ronzio ha note
gravi e profonde. Mi piacciono i toni bassi e gravi nelle voci e nella natura.
Lo stridulo "cip cip" degli uccellini sui rami mi irrita... Tra poco cercherò di
ritrovare quello stagno isolato.
Captivité:
1) Reazione di Corte.
2) Attentato compiuto dagli amici di Benoît e che spaventa Corte.
3) Corte viene a sapere attraverso quel chiacchierone di Hubert...
4) Attraverso Ariette Corail, ecc.
5) Le sue civetterie.
6) Denuncia. Hubert e J.-Marie vengono messi dentro insieme a molti
altri.
7) Grazie ai passi compiuti presso le autorità dalla sua ricca e benpensante
famiglia, Hubert viene rilasciato -J.-Marie condannato a morte?
8) Interviene Lucile, il tedesco. J.-Marie è graziato (qui un breve scorcio
della prigione o qualcosa del genere)
9) Benoît lo fa evadere. Evasione clamorosa.
10) Reazione di J.-Marie nei confronti della Germania e dei tedeschi.
11) Lui e Hubert: fuga in Inghilterra.
12) Morte di Benoît. Violenta e piena di speranza.
L'amore di Lucile per Jean-Marie deve passare attraverso tutto questo.
La cosa più importante qui, e la più interessante, è la seguente: i fatti
storici, rivoluzionari, ecc. devono essere solo sfiorati, mentre quella che
viene approfondita è la vita quotidiana, affettiva, e soprattutto la commedia
che è specchio della realtà di tutti i giorni.
CORRISPONDENZA 1936-1945
7 ottobre 1936 Irène Némirovsky a Albin Michel
La ringrazio per l'assegno di 4000 franchi. A questo proposito mi
permetto di ricordarle la visita che le ho fatto la primavera scorsa, in cui le
avevo chiesto se per l'avvenire non le sarebbe stato possibile prendere in
considerazione un accomodamento qualsiasi, perché adesso la situazione è
diventata molto difficile per me. In quell'occasione mi aveva risposto che
avrebbe fatto del suo meglio per venirmi incontro, e che dovevo avere piena
fiducia in lei. Sul momento non ha voluto dirmi in che modo si proponeva
di definire la cosa, ma mi ha promesso di precisarmelo entro due mesi al
massimo. Tuttavia, dopo quell'incontro che risale a quasi quattro mesi fa,
non ho ricevuto da lei nessun cenno al riguardo. Le chiedo dunque cosa
intenda fare, perché può capire quali siano ahimè le necessità della vita per
chi, come me, non possiede un patrimonio e vive solo di quello che
guadagna scrivendo.
10 ottobre 1938 Edizioni Genio (Milano) a Albin Michel
Vi preghiamo molto gentilmente di saperci dire se la signora I.
Némirovsky è di razza ebraica. In base alla legge italiana, non dev'essere
considerata di razza ebraica la persona che abbia uno dei genitori, il padre o
la madre, di razza ariana.
28 agosto 1939 Michel Epstein a Albin Michel
Attualmente mia moglie si trova a Hendaye (Villa Ene Exea, HendayePlage) con le bambine. In questi tempi difficili sono preoccupato per lei, che
in caso di bisogno non ha nessuno che le venga in aiuto. Posso contare sulla
sua amicizia per avere, se le è possibile, due righe di raccomandazione di
cui Irene potrebbe eventualmente servirsi presso le autorità e la stampa di
quella regione (Bassi Pirenei, Lande, Gironda)?
28 agosto 1939 Albin Michel a Michel Epstein
Il nome di Irène Némirovsky dovrebbe farle aprire tutte le porte! Ciò
nonostante, sarò felice di dare a sua moglie due righe di presentazione
presso certi giornali che conosco, ma per far questo mi servirebbero alcune
precisazioni che solo lei è in grado di fornirmi. Le chiedo dunque di passare
da me in serata.
28 settembre 1939 Robert Esmenard1 a Irène Némirovsky
Stiamo vivendo ore angosciose che da un giorno all'altro possono
diventare tragiche. Poiché lei è russa e ebrea, potrebbe darsi che chi non la
conosce - una minoranza di persone, comunque, data la sua fama di
scrittrice - possa procurarle delle noie. Quindi, dato che bisogna aspettarsi
di tutto, ho pensato che la mia testimonianza di editore potrebbe esserle
utile.
Sono quindi pronto a dichiarare che lei è una letterata di grande talento,
fatto del resto provato dal successo delle sue opere sia in Francia sia
all'estero, dove sono stati tradotti diversi suoi lavori.
Nota:
1. Direttore delle Éditions Albin Michel e genero di Albin Michel, che a
quell'epoca non sosteneva più da solo la gestione della casa editrice per
ragioni di salute.
Sono inoltre disposto a dichiarare che fin dall'ottobre 1933 - quando è
venuta da me dopo aver pubblicato presso il collega Grasset alcuni libri,
uno dei quali, David Golder, è stato una rivelazione clamorosa e ha dato
luogo a un film notevole - ho sempre mantenuto con lei e suo marito ottimi
rapporti di amicizia, oltre a quelli strettamente professionali.
21 dicembre 1939
Permesso di circolazione provvisorio dal 24 maggio al 23 agosto 1940 per
Irène Némirovsky Nazionalità: russa Autorizzata a recarsi a Issy-l'Évêque
Mezzo di locomozione autorizzato: ferrovia, Motivo: visita alle figlie
sfollate
12 luglio 1940 Irène Némirovsky a Robert Esmenard
Nel paesino in cui mi trovo il servizio postale è stato in qualche modo
ripristinato solo da due giorni. Le scrivo, a ogni buon conto, al suo indirizzo
parigino. Spero con tutto il cuore che lei abbia superato felicemente questi
terribili momenti e che non sia in ansia per alcuno dei suoi familiari. Per
quanto mi riguarda, le operazioni militari, che pure si sono svolte molto
vicino a noi, ci hanno risparmiati.
Attualmente il mio assillo più urgente è come procurarmi del denaro.
9 agosto 1940 Irène Némirovsky alla signorina Le Fur1
Spero le sia arrivata la lettera in cui le confermavo di aver ricevuto i
novemila franchi. Ma oggi mi rivolgo a lei per un altro motivo: su un
piccolo giornale della regione ho visto il seguente trafiletto:
"In base a una recente delibera, nessuno straniero potrà collaborare al
nuovo giornale"
Vorrei avere dei chiarimenti su questo provvedimento e ho pensato che lei
è forse in grado di darmene.
Crede che la cosa possa riguardare una straniera come me, che pure
risiede in Francia dal 1920? E questo vale per gli scrittori politici o anche
per i romanzieri?
Nota:
1: Segretaria di Robert Esmenard.
Lei sa che mi trovo del tutto isolata e tagliata fuori dal mondo e non so
niente dei provvedimenti adottati ultimamente nell'ambito della stampa.
Se ritiene che alcuni di questi potrebbero riguardarmi sia così gentile da
farmelo sapere. Non è tutto. Approfitto ancora di lei ricordando quanto è
gentile e premurosa: vorrei sapere quali sono gli scrittori che si trovano a
Parigi e la cui firma compare sui giornali che escono. Potrebbe dirmi se
"Gringoire", "Candide" e altre grandi riviste hanno intenzione di rientrare a
Parigi? E le case editrici? Quali pubblicano ancora?
8 settembre 1940 Irène Némirovsky alla signorina Le Fur
Per quel che mi riguarda, alcune voci che corrono con insistenza mi fanno
supporre che potremmo trovarci da un giorno all'altro in zona libera, e mi
domando allora come riscuoterò il mio mensile.
4 ottobre 1940 Legge sui cittadini stranieri di razza ebraica
A decorrere dalla promulgazione della presente legge i cittadini stranieri
di razza ebraica potranno essere internati in campi speciali su decisione del
prefetto del dipartimento di residenza.
Gli stranieri di razza ebraica potranno in qualsiasi momento vedersi
assegnare un domicilio coatto dal prefetto del dipartimento di residenza.
14 aprile 1941
Irène Némirovsky a Madeleine Cabour1 Adesso conosci tutte le difficoltà
che mi sono piovute addosso. Per di più da qualche giorno ospitiamo un
numero considerevole di quei signori. E la cosa si fa sentire da tutti i punti
di vista. Prenderei dunque in considerazione con piacere il paesino che tu
mi consigli, ma vorrei chiederti alcune informazioni.
1. Madeleine Cabour, nata Avot, era una grande amica di Irène
Némirovsky con la quale, da ragazza, aveva intrattenuto una fitta
corrispondenza. Suo fratello, René Avot, si occuperà di Elisabeth, la figlia
minore degli Epstein, quando la tutrice legale delle due sorelle ripartirà per
gli Stati Uniti. La bambina resterà in casa loro fino alla maggiore età.
1) Dimensioni di Jailly sotto il profilo abitanti e fornitori.
2) C'è un medico e un farmacista?
3) Ci sono truppe di occupazione?
4) Ci si può approvvigionare con una certa abbondanza? Avete burro,
carne? Adesso questo è molto importante per via delle bambine, una delle
quali ha appena subito l'operazione di cui ti avevo parlato.
10 maggio 1941 Irène Némirovsky a Robert Esmenard
Caro signore, certo ricorderà che, in base ai nostri accordi, il 30 giugno
dovrei riscuotere ventiquattromila franchi. Al momento non ho bisogno di
questo denaro, ma le confesso che le ultime disposizioni riguardanti gli
ebrei mi fanno pensare che potrebbero sorgere difficoltà per il pagamento di
questa somma, al quale mancano ancora sei settimane. Per me sarebbe un
vero disastro. Faccio dunque appello alla sua cortesia chiedendole di voler
anticipare tale pagamento con un assegno all'ordine di mio cognato, Paul
Epstein, al quale chiederò di telefonarle per accordarvi in proposito. Resta
inteso che la ricevuta che lui le firmerà varrà come quietanza da parte mia.
Sono desolata di darle questo ulteriore disturbo, ma sono certa che lei
comprenderà i motivi della mia preoccupazione. Spero abbia sempre le
migliori notizie di A. Michel.
17 maggio 1941 Irène Némirovsky a Robert Esmenard
Caro signor Esmenard, mio cognato mi ha fatto sapere di aver ricevuto da
lei i ventiquattromila franchi che dovevate versarmi il 30 giugno. La
ringrazio infinitamente della grande gentilezza che mi ha usato.
2 settembre 1941 Michel Epstein al viceprefetto di Autun '
Mi scrivono da Parigi che le persone equiparate agli ebrei non possono
allontanarsi dal comune di residenza senza l'autorizzazione del prefetto.
Poiché il dipartimento della Saône-et-Loire era diviso dalla linea di
demarcazione, il viceprefetto di Autun fungeva da prefetto della parte
occupata, in cui si trovava il comune di Issy-l'Évêque.
É il caso mio e di mia moglie, dal momento che, pur essendo cattolici,
siamo di origine ebraica. Mi permetto dunque di chiederle di voler
autorizzare mia moglie, nata Irène Némirovsky, e il sottoscritto a passare sei
settimane a Parigi - dove abbiamo un domicilio al 10 di avenue ConstantCoquelin durante il periodo dal 20 settembre al 5 novembre 1941.
La presente richiesta è motivata dal fatto che mia moglie si trova nella
necessità di regolare i rapporti con il suo editore, di sottoporsi a una visita
dall'oculista che l'ha in cura e di vedere i nostri medici di famiglia, il
professor Vallery-Radot e il professor Delafontaine. Contiamo di lasciare le
nostre due bambine di quattro e undici anni a Issy, e naturalmente
vorremmo essere sicuri che, una volta sbrigate le faccende parigine, non ci
saranno ostacoli al nostro ritorno a Issy.
Il dottore di Issy è A. Bendit-Gonin.
8 agosto 1941 Da "Le Progres de l'Allier", n. 200
Atto di comparizione obbligatoria per i cittadini residenti di nazionalità
sovietica, lituana, estone e lettone.
Tutti i cittadini residenti di sesso maschile dai 15 anni in su, di nazionalità
sovietica, lituana, estone e lettone, nonché gli apolidi che in precedenza
avevano nazionalità sovietica, lituana, estone e lettone, dovranno presentarsi
alla Kreiskommandantur della loro circoscrizione entro sabato 9 agosto
1941 (a mezzogiorno) muniti di un documento d'identità. Chi non si
presenterà sarà punito in base al decreto inerente a quest'ordine di
comparizione.
Il Feldkommandant.
9 settembre 1941 Irène Némirovsky a Madeleine Cabour
Ho finalmente preso in affitto la casa che desideravo: è comoda e ha un
bel giardino. Dovrei installarmici l'11 novembre se quei signori non ci
precedono, perché pare che stiano per arrivare di nuovo.
13 ottobre 1941 Irène Némirovsky a Robert Esmenard
Che gioia stamattina ricevere la sua lettera, non solo perché mi conferma
che lei farà tutto il possibile per aiutarmi, ma anche perché mi assicura che
qualcuno pensa a me, e questo è un grande confort. Come può immaginare,
la vita qui è piuttosto triste, e se non avessi il lavoro... Ma anche il lavoro
diventa difficile quando manca la certezza del domani.
14 ottobre 1941 Irène Némirovsky a André Sabatier1
Caro amico, la sua gentile lettera mi ha commosso. Non pensi neanche
per un attimo che non le sia grata della sua amicizia e di quella del signor
Esmenard; d'altra parte, conosco perfettamente le difficoltà della situazione.
Ho dato prova fino a oggi di tutta la pazienza e il coraggio che sono riuscita
a mettere insieme. Ma cosa vuol farci, nella vita ci sono momenti molto
difficili. La realtà è questa: impossibilità di lavorare e necessità di
provvedere all'esistenza di quattro persone. A ciò si aggiunge una serie di
stupide angherie - non posso andare a Parigi, non posso farmi mandare le
cose più indispensabili alla vita, come le coperte, i letti per le bambine, ecc,
né i miei libri. Tutti gli appartamenti abitati dai miei simili sono stati fatti
oggetto di una proibizione generale e assoluta. Non le racconto tutto questo
per impietosirla, ma per spiegarle che non posso far altro che vedere tutto
nero...
27 ottobre 1941 Robert Esmenard a Irène Némirovsky
Ho parlato della sua situazione a mio suocero e gli ho mostrato le sue
ultime lettere.
Come le ho già detto, il signor A. Michel, che vuole sinceramente venirle
incontro, mi ha pregato di offrirle per l'anno 1942 delle mensilità di 3000
franchi, corrispondenti a quanto le versava quando aveva la possibilità di
pubblicare le sue opere e effettuarne una vendita costante. Le sarei grato se
mi facesse sapere se è d'accordo.
Le devo tuttavia far presente che in conformità alle indicazioni molto
precise ricevute dal Sindacato degli Editori riguardo l'interpretazione delle
disposizioni impartite dall'ordinanza tedesca del 26 aprile, articolo 5, siamo
obbligati a versare tutti gli spettanti ad autori israeliti su un loro conto
bloccato" In base a questo principio, è detto che "gli editori devono pagare i
diritti d'autore agli autori israeliti versandoli in una banca dopo aver avuto
dalla stessa l'assicurazione che quel conto è bloccato"
Le rispedisco inoltre la lettera che lei ha ricevuto dalla Films GIBE (ne
conservo una copia) In base a informazioni che ho avuto da fonte sicura,
risulta che un'impresa del genere si può realizzare unicamente qualora
l'autore di un romanzo che può essere adattato allo schermo sia di origine
ariana, in questa zona come nell'altra. Non posso dunque trattare un simile
affare se l'autore dell'opera da portare sullo schermo non mi fornisce in
proposito le garanzie più puntuali.
30 ottobre 1941 Irène Némirovsky a Robert Esmenard
Ho ricevuto la sua lettera del 27 ottobre in cui mi si offrono 3000 franchi
al mese per l'anno 1942. Apprezzo molto l'atteggiamento del signor Michel
nei miei confronti e lo ringrazio caldamente, come ringrazio lei; la vostra
amicizia mi è altrettanto preziosa dell'aiuto materiale che volete offrirmi.
Comprenderete tuttavia che se questo denaro dovrà restare bloccato in una
banca non potrà essermi di alcuna utilità.
Mi domando se, stando così le cose, non sarebbe più semplice versare
questi importi mensili sul conto della mia amica, la signorina Dumot,1 che
abita con me ed è l'autrice del romanzo intitolato Les biens de ce monde, il
cui manoscritto è nelle mani del signor Sabatier...
La signorina Dumot è incontestabilmente ariana e può fornirvene tutte le
prove. La conosco fin dall'infanzia e se potesse mettersi d'accordo con voi
riguardo a queste mensilità se ne occuperebbe per mio conto...
13 luglio 1942
Telegramma di Michel Epstein a Robert Esmenard e André Sabatier
Irene trasferita oggi improvvisamente destinazione Pithiviers (Loiret)
Spero potrete intervenire d'urgenza. Cerco invano telefonare. Michel
Epstein
1. Irène Némirovsky e il marito Michel Epstein avevano fatto arrivare
Julie Dumot a Issy-l'Évêque nel caso fossero stati arrestati. La Dumot aveva
lavorato come dama di compagnia presso i nonni materni delle bambine.
luglio 1942
Telegramma di Robert Esmenard-André Sabatier a Michel Epstein
Ricevuto suo telegramma. Fatto subito passi in comune da Morand,
Grasset, Albin Michel. Saluti cordiali.
Le due ultime lettere di Irene nemirovsky1
Tolone S/Arroux 13 luglio 1942 - ore 5 [scritta a matita e non obliterata]
Amore mio, al momento mi trovo alla gendarmeria dove ho mangiato un
po’ di ribes aspettando che mi vengano a prendere. Soprattutto stai
tranquillo, sono certa che non sarà una faccenda lunga. Ho pensato che ci si
potrebbe rivolgere anche a Caillaux e al reverendo Dimnet. Che ne pensi?
Copro di baci le mie bambine adorate, e che la mia Denise faccia sempre
la brava... Ti stringo forte sul cuore insieme con Babet, che il buon Dio vi
protegga. Quanto a me, mi sento calma e forte.
Se poteste mandarmi qualcosa, credo che il secondo paio di occhiali sia
rimasto nell'altra valigia (nel portafoglio) Anche libri per favore, e se è
possibile un po’ di burro salato. Arrivederci amore mio!
Giovedì mattina - luglio '42 - Pithiviers [scritta a matita e non obliterata]
Mio amato, mie piccole adorate, credo che partiamo oggi. Coraggio e
speranza. Siete nel mio cuore, miei diletti. Che Dio ci aiuti tutti.
14 luglio 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Ho cercato invano di raggiungerla al telefono, così ho mandato un
telegramma a lei e al signor Esmenard. Ieri i gendarmi hanno portato via
mia moglie. Destinazione, pare, il campo di concentramento di Pithiviers
(Loiret) Motivazione: misura generale contro gli ebrei apolidi di età come
La prima è stata di certo generosamente inoltrata da un gendarme e seconda
da un viaggiatore incontrato alla stazione di Pithiviers. presa fra i 16 e i 45
anni. Mia moglie è cattolica e le nostre figlie sono francesi. Si può fare
qualcosa per lei?
Risposta di André Sabatier: In ogni caso ci vorranno diversi giorni. Suo
Sabatier
15 luglio 1942 André Sabatier a J. Benoist-mechin, segretario di Stato alla
vicepresidenza del Consiglio
La nostra autrice e amica I. Némirovsky è stata portata a Pithiviers da
Issy-l'Évêque dove abitava. Me lo ha appena comunicato il marito. Si tratta
di una russa bianca (ebrea, come sai) che non si è mai occupata di politica
ed è madre di due bambine di 5 e 10 anni; scrittrice di gran talento, ha
sempre fatto molto onore al suo paese di adozione. Ti supplico di fare tutto
quello che potrai. Grazie in anticipo. Sinceramente tuo.
16 luglio 1942 Telegramma di Michel Epstein a Robert Esmenard e
André Sabatier
Mia moglie probabilmente arrivata a Pithiviers. Credo utile intervenire
presso prefetto regionale Digione. Viceprefetto Autun e autorità Pithiviers.
Michel Epstein
16 luglio 1942 Telegramma di Michel Epstein a André Sabatier
Grazie caro amico. Confido in lei. Michel Epstein
17 luglio 1942 Telegramma di Michel Epstein a André Sabatier
Conto ricevere da lei notizie buone o cattive. Grazie caro amico.
17 luglio 1942
Telegramma di Lebrun1 da Pithiviers a Michel Epstein
Inutile mandare pacchi, non ho visto sua moglie. L. Intermediario presso
la Croce Rossa.
18 luglio 1942
Telegramma di Michel Epstein a André Sabatier
Nessuna notizia di mia moglie. Non so dove sia. Cerchi d'informarsi e di
telegrafarmi la verità. Può telefonarmi con preavviso a qualsiasi ora. 3ø
Issy-L'Eveque.
20 luglio 1942
Telegramma di zio Abraham Kalmanok a Michel Epstein
Mandare certificato medico per Irene. Bisogna farlo immediatamente.
Telegrafa.
22 luglio 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Ho ricevuto da mia moglie, dal campo di Pithiviers, una lettera in data di
giovedì scorso in cui mi annunciava la sua probabile partenza per una
destinazione ignota, che suppongo lontana. Ho telegrafato, con risposta
pagata, al comandante di quel campo, che però non si è fatto sentire. Forse
il suo amico potrebbe essere più fortunato e ottenere le informazioni che a
me non danno... Grazie per tutto quello che fa. Mi tenga al corrente, la
prego, anche delle cattive notizie. Molto cordialmente.
Risposta
Contattato personalmente il mio amico.1 Faremo l'impossibile.
Sabato 24 luglio 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Non le ho scritto prima perché, per il momento, non ho niente di preciso
da comunicarle e posso rivolgerle soltanto qualche parola di conforto alla
sua angoscia. Abbiamo fatto tutto il necessario. Ho rivisto il mio amico; mi
ha detto che ormai c'è solo da aspettare. Dopo aver ricevuto la sua prima
lettera, gli ho segnalato la nazionalità francese delle vostre due figlie e,
dopo la seconda, la possibile partenza dal campo del Loiret. Resto in attesa,
e la prego di credere che questa attesa è per me, in quanto amico, molto
dolorosa... come il tenore della lettera del 15 luglio fa pensare che si tratti di
Jacques Benoist-mechin.
vede, mi metto nei suoi panni! Spero di poterle dare presto buone e
precise notizie. Le sono sinceramente vicino.
26 luglio 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Forse, riguardo a mia moglie, sarebbe opportuno far presente che si tratta
di una russa bianca che non ha mai voluto prendere la nazionalità sovietica
e che, dopo molte vessazioni, è scappata dalla Russia con i genitori, che si
sono visti confiscare l'intero patrimonio. Anch'io mi trovo nella stessa
situazione e non credo di esagerare se affermo che quello che ci hanno
preso laggiù, a me e a mia moglie, ammonta a un centinaio di milioni di
franchi anteguerra. Mio padre era presidente del Sindacato delle Banche
russe e amministratore delegato di una delle più grandi banche di Russia, la
Banca Commerciale di Azov-Don. Le autorità competenti possono dunque
avere la certezza che non nutriamo la minima simpatia per l'attuale regime
russo. Mio fratello minore, Paul, era amico personale del granduca Dmitri, e
la famiglia imperiale che risiede in Francia è stata spesso ospite di mio
suocero, soprattutto i granduchi Alessandro e Boris. Le segnalo inoltre, se
già non gliel'ho detto, che i sottufficiali tedeschi che hanno alloggiato per
alcuni mesi in casa nostra, a Issy, mi hanno lasciato, al momento della
partenza, una dichiarazione che suona così:
"L. VII, '41
"Kameraden!
"Wir haben langere Zeit mit der Familie Epstein zusammengelebt und sie
als eine sehr anstandige und zuvorkommende Familie kennengelernt. Wir
bitten Euch daher, sie dementsprechend zu behandeln. Heil Hitler!
"Hammberger, Feldw. 23599 A.".!
Continuo a non sapere dove si trovi mia moglie. Le bambine stanno bene,
e io mi reggo ancora in piedi.
Grazie di tutto, caro amico. Forse sarebbe utile che lei parlasse di tutto
questo con il conte di Chambrun2 e con Morand. Cordialmente. Michel
Nota: 1. "Camerati! Abbiamo vissuto per qualche tempo con la famiglia
Epstein e abbiamo avuto modo di conoscerla come una famiglia assai
premurosa. Vi preghiamo pertanto di riservarle un trattamento adeguato.
Heil Hitler!"
2. Il conte René de Chambrun, avvocato, era il genero di Pierre Laval, di
cui aveva sposato l'unica figlia, Josée.
27 luglio 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Nell'opera di sua moglie, oltre a una scena in Vin de solitude, vi sono
brani di romanzi, racconti o articoli che possano essere segnalati come
decisamente antisovietici?
27 luglio 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Ho ricevuto stamane la sua lettera di sabato. Mille volte grazie per il suo
impegno. So che sta facendo e che farà tutto il possibile per aiutarmi. Sono
forte e paziente. Purché mia moglie abbia la forza fisica necessaria a
sopportare una simile prova! La cosa più grave è che dev'essere
terribilmente preoccupata per le bambine e per me, e che non ho modo di
comunicare con lei dato che non so neppure dove si trovi.
Le accludo una lettera che vorrei assolutamente far arrivare, con urgenza,
all'ambasciatore di Germania. Se lei potesse trovare qualcuno che sia in
grado di avvicinarlo personalmente e di consegnargliela (forse il conte di
Chambrun, che credo sia disposto a fare qualcosa per mia moglie), sarebbe
perfetto. Ma se non trova nessuno che possa recapitarla rapidamente, abbia
la gentilezza di farla portare all'ambasciata o, semplicemente, di imbucarla.
La ringrazio in anticipo. Naturalmente, se questa lettera dovesse intralciare i
passi già fatti, la strappi, in caso contrario vorrei tanto che arrivasse a
destinazione.
Mi aspetto di subire a mia volta un provvedimento simile. Per
fronteggiare i nostri problemi economici, potrebbe far mandare alla
signorina Dumot un anticipo sui compensi mensili del '43? Ho paura per le
bambine.
27 luglio 1942
Michel Epstein all'ambasciatore di Germania Otto Abetz
So che il fatto stesso di rivolgermi direttamente a lei è gesto alquanto
temerario. Tuttavia compio questo passo perché credo che lei solo possa
salvare mia moglie e ripongo in lei la mia ultima speranza.
Mi permetta di esporle quanto segue: prima di lasciare Issy, i soldati
tedeschi che la occupavano, riconoscenti per quanto abbiamo fatto per il
loro benessere, mi hanno lasciato una lettera così concepita:
"1. VII, '41
"Kameraden!
"Wir haben lângere Zeit mit der Familie Epstein zusammengelebt und sie
als eine sehr anstandige und zuvorkommende Familie kennengelernt. Wir
bitten Euch daher, sie dementsprechend zu behandeln. Heil Hitler!
"Hammberger, Feldw. 23599 A.".
Dunque, lunedì 13 luglio mia moglie è stata arrestata, portata al campo di
concentramento di Pithiviers (Loiret) e, da lì, avviata a una destinazione che
ignoro. Mi è stato detto che l'arresto era dovuto a disposizioni di ordine
generale date dalle autorità d'occupazione per quanto riguarda gli ebrei.
Mia moglie, la signora Epstein, è una scrittrice molto nota: I.
Némirovsky. I suoi romanzi sono stati tradotti in diversi paesi, e almeno due
di essi - David Golder e Le bai- anche in Germania. É nata a Kiev (Russia)
l'11 febbraio 1903. Suo padre era un banchiere importante. Il mio era
presidente del Comitato centrale delle Banche commerciali di Russia e
amministratore delegato della Banca di Azov sul Don. Le nostre due
famiglie hanno perso in Russia ingenti patrimoni; mio padre è stato
arrestato dai bolscevichi e imprigionato nella fortezza Santi Pietro e Paolo a
Pietroburgo. Con molte difficoltà siamo riusciti a scappare dalla Russia nel
1919 e ci siamo rifugiati in Francia da dove non ci siamo più mossi. Tutto
questo le garantisce che non possiamo che nutrire una profonda avversione
nei confronti del regime sovietico.
In Francia nessun membro della nostra famiglia si è mai occupato di
politica. Io ero procuratore di una banca, quanto a mia moglie è diventata
una rinomata scrittrice. In nessuno dei suoi libri (che del resto non sono stati
messi al bando dalle autorità d'occupazione) troverà una parola contro la
Germania, e benché sia di razza ebraica mia moglie scrive degli ebrei senza
alcuna simpatia. I nonni di mia moglie, così come i miei, erano di religione
israelita; i nostri genitori non professavano alcuna religione; quanto a noi,
siamo cattolici come le nostre bambine, che sono nate a Parigi e sono
francesi.
Mi permetto inoltre di segnalarle che mia moglie si è sempre tenuta
lontana da qualsiasi gruppo politico, che non ha mai beneficiato di alcun
favore da parte dei governi sia di destra sia di sinistra, e che il giornale al
quale collaborava come scrittrice di romanzi, "Gringoire", diretto da H. de
Carbuccia, non ha simpatie né per gli ebrei né per i comunisti.
Mia moglie, infine, soffre da anni di asma cronica (ne può far fede il suo
medico curante, professor Vallery-Radot), e l'internamento in un campo di
concentramento significherebbe per lei la morte.
Io so, signor ambasciatore, che lei è uno degli uomini di spicco del
governo del suo paese, e sono persuaso che sia anche un uomo giusto. E mi
pare ingiusto e illogico che i tedeschi mettano in prigione una donna che,
pur essendo di origine ebraica, non ha - come dimostrano tutti i suoi libri alcuna simpatia né per il giudaismo né per il regime bolscevico.
28 luglio 1942 André Sabatier al conte di Chambrun
Ricevo in questo momento una lettera del marito dell'autrice di David
Golder e mi permetto di inviarle in allegato una copia della stessa. Questa
lettera contiene alcune precisazioni che mi sembrano interessanti e che
spero le permettano di pervenire a un giudizio positivo. La ringrazio in
anticipo per tutto quello che potrà tentare per la nostra amica.
28 luglio 1942 André Sabatier alla signora Paul Morand
Ho scritto ieri al signor Epstein secondo quanto avevamo stabilito,
pensando che era meglio procedere così piuttosto che mandare un
telegramma. Questa mattina ho trovato fra la mia posta la copia, che
contiene incontestabilmente delle precisazioni interessanti.
28 luglio 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Spero che abbia ricevuto la mia lettera di ieri e che quella destinata
all'ambasciatore gli sia stata recapitata, da Chambrun o da qualcun altro,
oppure direttamente. Grazie in anticipo.
Rispondo alla sua richiesta di ieri: credo che, in David Golder, il capitolo
in cui David tratta con i bolscevichi la cessione di alcuni pozzi petroliferi
non susciti nei confronti di questi ultimi molta simpatia, ma non ho copie di
D. Golder qui, vuole controllare lei? Les échelles du levant, di cui avete il
manoscritto in casa editrice e che è uscito su "Gringoire", fornisce una
descrizione piuttosto feroce del protagonista, un medico ciarlatano di
origine levantina, ma non ricordo se mia moglie abbia specificato che si
trattava di un ebreo. Credo di sì.
Nel capitolo xxv della Vie de Tchékhov vedo la seguente frase: "La sala
n. 6 ha contribuito molto alla fama dello scrittore in Russia e ha fatto sì che
l'Unione Sovietica lo rivendicasse come suo autore e affermasse che, se
fosse vissuto, avrebbe aderito al partito marxista. La gloria postuma di uno
scrittore ci riserva di queste sorprese...". Purtroppo non trovo altro, e quanto
sopra è poco.
Davvero non c'è modo di sapere dalle autorità francesi se mia moglie è
ancora o no nel campo di Pithiviers? Dieci giorni fa ho telegrafato, con
risposta pagata, al comandante di quel campo, e non ho avuto risposta.
Chiedo solo di sapere dov'è, è possibile che anche questo sia proibito? Mi
hanno pur comunicato che mio fratello Paul è a Drancy, perché non mi
dicono dov'è mia moglie? Insomma...
Arrivederci, caro amico. Non so perché, ho fiducia nella mia lettera
all'ambasciatore. Michel
29 luglio 1942 André Sabatier alla signora Paul Morand
Ecco la lettera di cui le ho parlato al telefono. Credo che lei sia in grado
più di chiunque altro di valutare se è il caso di assegnarle la destinazione
voluta dal suo autore. Sull'insieme non posso pronunciarmi granché, quanto
al dettaglio certe frasi non mi sembrano molto felici.
29 luglio 1942 Mavlik1 a Michel Epstein
Mio caro, spero che tu abbia ricevuto le mie lettere ma ho paura che siano
andate perse perché ho scritto a Julie e la zia non aveva capito bene il suo
nome al telefono.
Nota: 1. La sorella di Michel Epstein, che sarà arrestata
contemporaneamente a lui e deportata ad Auschwitz, dove morirà insieme
al fratello nelle camere a gas.
Mio caro, ancora una volta ti supplico di tener duro, per Irene, per le
piccole, per gli altri. Non abbiamo il diritto di scoraggiarci poiché siamo
credenti. Ero terribilmente disperata ma mi sono ripresa e vado in giro tutto
il giorno a caccia di notizie parlando con quelli che si trovano nella stessa
situazione. Germainel è tornata l'altro ieri; partirà per Pithiviers non appena
avrà tutto quello che occorre. Pare che Sam sia a Beaune-la-Rolande, vicino
a Pithiviers, e lei vuole assolutamente riuscire a comunicare con lui e con
Irene. Non abbiamo notizie se non di Ania, che è a Drancy e chiede
biancheria e libri. Sono arrivate diverse lettere da Drancy e pare che lì la
gente sia trattata bene e abbia abbastanza da mangiare. Mio caro, ti
supplico, sii forte. Il denaro ha avuto un ritardo a causa del nome che non è
stato capito bene. Domani torno a trovare Josephine.2 Germaine ha
incontrato quel signore la cui domestica è a Pithiviers. Devo vedere anche
Germaine prima che parta. Ha ricevuto due righe da Sam, che però le ha
mandate quando era ancora a Drancy. Ti scriverò il giorno in cui lei partirà
ma vorrei ricevere tue notizie, mio caro. Quanto a me, reggo ancora, non so
come, e continuo a sperare. Abbraccio te e le bambine con tutta la mia
infinita tenerezza.
3 agosto 1942
Signora Rousseau (Croce Rossa francese)
a Michel Epstein
Il dottor Bazy3 è partito questa mattina per trattenersi qualche giorno
nella zona libera; si occuperà sul posto del caso della signora Epstein e farà
il possibile perché si intervenga in suo favore. Non avendo avuto il tempo di
risponderle prima di partire, mi ha incaricato di informarla di aver ricevuto
la sua lettera e di assicurarle che farà di tutto per esserle di aiuto.
Un'amica francese di Samuel Epstein, fratello maggiore di Michel.
Note: 2- Josephine era la cameriera di Irène Némirovsky..
3- Il presidente della Croce Rossa.
6 agosto 1942 Michel Epstein alla signora Rousseau
Ho appreso con sommo piacere che il dottor Bazy si sta muovendo in
favore di mia moglie. Mi domando se non sarebbe opportuno coordinare le
sue iniziative con quelle già intraprese da:
1) L'editore di mia moglie, il signor Albin Michel (la persona che si
occupa di Irene è il signor André Sabatier, uno dei direttori della casa
editrice)
2) La signora Paul Morand.
3) Henri de regnier.
4) Il conte di Chambrun.
Il signor Sabatier, cui mando copia della presente, potrà fornirle tutte le
informazioni che eventualmente le servissero (tel.: Dan 87 54). La cosa che
mi tormenta di più è non sapere dove sia mia moglie (giovedì 17 luglio si
trovava nel campo di Pithiviers - Loiret, ma da quel giorno non ho più avuto
sue notizie) Vorrei farle sapere che, fino a questo momento, né io né le
bambine siamo stati colpiti dalle recenti disposizioni e che stiamo tutti bene.
La Croce Rossa potrebbe farle arrivare questo messaggio? Ed è possibile
mandarle dei pacchi?
6 agosto 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Le accludo copia di una lettera che mando alla Croce Rossa. Continuo a
non aver notizie di mia moglie. É dura. Ha potuto contattare il signor Abetz
e fargli avere la mia lettera? Michel
P. S. Potrebbe darmi l'indirizzo del conte di Chambrun?
9 agosto 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Sono venuto a sapere da fonte attendibile che le donne (ma anche gli
uomini e i bambini) internate nel campo di Pithiviers sono state portate al
confine tedesco e, da lì, dirette a Est - Polonia o Russia, probabilmente.
Questo sarebbe avvenuto circa tre settimane fa.
Fino a oggi credevo che mia moglie si trovasse in un normale campo di
concentramento in Francia, sotto la sorveglianza di soldati francesi. Saperla
in un paese selvaggio, in condizioni probabilmente atroci, senza denaro né
generi di conforto, in mezzo a gente di cui non conosce neppure la lingua, è
intollerabile. Ormai non si tratta più di cercare di farla uscire più o meno
rapidamente da un campo ma di salvarle la vita.
Penso che abbia ricevuto il telegramma che le ho mandato ieri; le
segnalavo un libro di mia moglie, Les mouches d'automne, uscito prima da
Kra, in edizione di lusso, e successivamente da Grasset. Si tratta di un libro
decisamente antibolscevico e sono desolato di non averci pensato prima.
Spero che, presentando questa nuova prova, non sia troppo tardi per
esercitare delle pressioni sulle autorità tedesche.
So, caro amico, che lei fa tutto quello che può per salvarci, ma la
supplico, cerchi, inventi ancora qualcos'altro, parli di nuovo con Morand,
con Chambrun, con il suo amico e soprattutto con il dottor Bazy, presidente
della Croce Rossa, 12, rue Newton, tel.: KLE 84 05 (la sua segretaria
personale è la signora Rousseau, stesso indirizzo), segnalando loro questo
nuovo elemento che può scagionare mia moglie: Les mouches d'automne. É
comunque inconcepibile che noi che abbiamo perso tutto a causa dei
bolscevichi veniamo condannati a morte da quelli che li combattono!
Insomma, caro amico, questo è un appello in extremis. So di essere
imperdonabile abusando così di lei e degli amici che ancora ci restano, ma,
glielo ripeto, è questione di vita o di morte non solo per mia moglie ma
anche per le nostre figlie, per non parlare di me. La situazione è grave. Da
solo qui, con le bambine, quasi come un carcerato giacché mi proibiscono di
muovermi, non ho neppure la consolazione di poter agire. Non riesco più né
a dormire né a mangiare, e questo serva da scusa a una lettera così
incoerente.
10 agosto 1942
Il sottoscritto, conte W. Kokovtzoff, ex presidente del Consiglio, ministro
delle Finanze di Russia, dichiara con la presente di aver conosciuto il
defunto signor Efim Epstein, dirigente di banca in Russia, membro del
Comitato delle Banche attivo a Parigi sotto la presidenza del sottoscritto;
attesta inoltre che il succitato signor Epstein era noto come finanziere di
irreprensibile onorabilità, e che il suo operato e i suoi sentimenti erano
decisamente anticomunisti.
IL foglio autenticato dal commissariato di polizia]
12 agosto 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Ho ricevuto il suo telegramma e le sue lettere. Le rispondo prima di
recarmi per qualche settimana nei dintorni di Parigi. Se dovesse scrivermi
durante il periodo dal 15 agosto al 15 settembre indirizzi le sue lettere alla
casa editrice che ne prenderà subito visione, se occorre farà il necessario e
mi terrà sempre al corrente. Per il momento la situazione è questa: molte
iniziative e nessun risultato.
1) Nessuna risposta dal conte di Chambrun, al quale ho scritto. Poiché
non lo conosco, non posso insistere: il suo silenzio potrebbe indicare una
precisa volontà di non intervenire. Il suo indirizzo è: 6 bis, place du PalaisBourbon -VII.
2) In compenso, la signora Morand mostra un'incessante dedizione e
moltiplica le iniziative; ha ricevuto la sua lettera, e l'essenziale, insieme a un
certificato medico, dev'essere arrivato in questi giorni a chi di dovere
attraverso uno degli amici suoi e dell'Ambasciata. Les mouches d'automne,
che pure ha letto, non le sembra per niente corrispondere a quello che
cercava: antirivoluzionario, certo, ma non antibolscevico. La signora le
suggerisce di non intraprendere iniziative troppo disparate, inutili secondo
lei. L'unica porta a cui bussare, sempre a suo parere, è quella dell'Unione
israelita; la sola che, attraverso le sue ramificazioni, può indicarle il posto in
cui si trova sua moglie e forse fare in modo che Irene abbia notizie delle
bambine. Ecco l'indirizzo: 29, rue de la Bienfaisance, VIII.
3) Il mio amico mi ha fatto sapere con molta franchezza che tutte le
iniziative intraprese lo hanno portato alla constatazione della sua totale
impotenza.
4) Stessa risposta, non meno categorica, di mio padre dopo i suoi tentativi
presso alcune autorità regionali francesi.
5) Un amico ha parlato, su mia richiesta, con l'autore di Dieu est-il
français? (Friedrich Sieburg), il quale ha promesso di interessarsi, non tanto
in vista di un'eventuale liberazione, secondo lui assai poco probabile, ma
allo scopo di avere almeno qualche notizia.
6) Ieri ho telefonato alla Croce Rossa e ho parlato con la sostituta della
signora Rousseau, una persona molto gentile e al corrente del caso. Il dottor
Bazy si trova attualmente nella zona non occupata e cerca d'informarsi in
alto loco su quello che si potrebbe ottenere. Deve rientrare giovedì e gli
telefonerò prima di lasciare Parigi. Personalmente penso questo:
1) Il provvedimento che ha colpito sua moglie è di carattere generale
(solo qui, a Parigi, ha riguardato diverse migliaia di apolidi), e questo spiega
in parte l'impossibilità in cui ci troviamo di ottenere uno speciale
trattamento di favore, ma ci permette anche di sperare che niente di
particolare possa esserle capitato.
2) Il provvedimento è stato preso da alcune autorità tedesche che sono
onnipotenti in questo campo e presso le quali sia le altre autorità tedesche
militari o civili sia le autorità francesi, anche le più alte, non sembrano
avere grandi possibilità di intervento.
3) Secondo la signora Morand, la partenza per la Germania avviene
verosimilmente non già alla volta di campi di concentramento, ma verso
alcune città della Polonia dove vengono raggruppati gli apolidi.
Tutto questo è molto angoscioso, lo capisco fin troppo, caro signore. Il
suo solo dovere, adesso, è pensare alle bambine e tener duro per loro...
Consiglio facile da dare, lei mi dirà. Ahimè, ho fatto tutto quello che
potevo. Sempre fedelmente suo. André
14 agosto 1942 Michel Epstein alla signora Cabour
Purtroppo Irene è partita - per dove? Lo ignoro. Può immaginare la mia
angoscia. É stata portata via il 13 luglio e da allora non ho più avuto sue
notizie. Sono solo, qui, con le due piccole di cui si occupa Julie. Forse
ricorderà di averla vista in avenue du President-Wilson. Se dovessi ricevere
notizie di Irene, gliele trasmetterò subito. Lei si era offerta, cara signora, di
aiutarci: ne approfitto, senza sapere se quello che le chiedo rientra
nell'ambito delle cose fattibili. Potrebbe procurarci del filo e del cotone, e
dei fogli da macchina per scrivere? Ci farebbe un grandissimo favore.
20 agosto 1942 Michel Epstein alla signora Cabour
Irene è stata portata via il 13 luglio dalla gendarmeria in base agli ordini
della polizia tedesca, e condotta a Pithiviers in quanto apolide di razza
ebraica. Tutto ciò senza considerare il fatto che è cattolica, che le sue figlie
sono francesi e che lei si era rifugiata in Francia per sfuggire ai bolscevichi,
i quali si sono anche impadroniti dell'intero patrimonio dei suoi genitori. É
arrivata a Pithiviers il 15 luglio e, in base all'unica lettera che ho ricevuto da
lei, doveva ripartirne il 17 per destinazione ignota. Da allora, più niente.
Nessuna notizia, non so dove sia né se sia ancora viva. Poiché non ho il
permesso di muovermi da qui, ho chiesto l'intervento di diverse personalità,
finora senza alcun risultato. Se lei può fare qualcosa, qualsiasi cosa, la
faccia, la supplico, perché questa angoscia è insopportabile. Pensi che non
posso neanche mandarle qualcosa da mangiare, che non ha biancheria né
denaro... Fino a questo momento mi hanno lasciato stare perché ho più di
quarantacinque anni...
15 settembre 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Nessun segno di vita da Irene. Come mi aveva consigliato la signora
Paul,1 non ho preso nuove iniziative: faccio assegnamento solo su questa
signora. Non credo di poter vivere ancora a lungo in questo stato
d'incertezza. Lei mi aveva detto che aspettava notizie dal dottor Bazy; devo
pensare che neanche lui sia riuscito a sapere qualcosa? Se almeno la Croce
Rossa potesse far recapitare a Irene, prima dell'inverno, degli indumenti, del
denaro e dei viveri...
Se vede la signora Paul, abbia la cortesia di dirle che ho ricevuto un
biglietto da monsignor Ghika,2 il quale, sei mesi fa, era ancora a Bucarest in
buona salute.
17 settembre 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Appena tornato ho telefonato subito alla signora Paul; le ho fatto sapere
quanto lei le sia grato e le ho detto che aveva seguito il suo consiglio. Tutti i
suoi passi, compresi quelli presso l'alto personaggio al quale lei stesso
aveva scritto una lettera, non hanno dato ancora nessun risultato.
Note:
1. La moglie di Paul Morand: le misure di sicurezza consigliavano di non
citare i nomi per esteso.
2. Principe-vescovo rumeno che si recava molto spesso a trovare Irène
Némirovsky.
"É come sbattere contro un muro" mi ha detto. La signora Paul pensa che
per sapere qualcosa di preciso si debba aspettare che questo grande
trasferimento di persone venga regolato e in qualche modo stabilizzato.
19 settembre 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Le nostre lettere si sono incrociate. La ringrazio di avermi dato notizie,
anche se desolanti. Cerchi di sapere se sarebbe possibile che io e mia moglie
ci scambiassimo i posti - io potrei forse essere più utile al posto suo e lei
starebbe meglio qui. Se questo è impossibile, mi portino almeno vicino a lei
- insieme staremmo meglio. Naturalmente bisognerebbe che di tutto questo
potessi parlare con lei di persona.
23 settembre 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Fin dal 14 luglio mi sono detto che se un viaggio a Issy fosse stato
necessario, lo avrei intrapreso senza esitare. Non credo però che anche
adesso un nostro incontro ci potrebbe portare a una decisione precisa e utile.
Le dico subito perché.
Uno scambio di posti è attualmente impensabile. Comporterebbe solo un
internato in più, benché la ragione da lei invocata a questo proposito sia
assolutamente fondata. Quando sapremo con precisione dove si trova Irene,
vale a dire quando tutto questo sarà "organizzato", allora e solo allora potrà
forse essere utile porre la questione.
Insieme, in uno stesso campo!, neanche pensarci, dato che la separazione
fra uomini e donne è rigorosa e assoluta.
La Croce Rossa mi ha appena chiesto una precisazione che non ho e che a
mia volta, questa mattina, le ho chiesto di darmi con un telegramma. La
trasmetterò immediatamente. Speriamo che si apra uno spiraglio.
29 settembre 1942 Michel Epstein a André Sabatier
Le avevo promesso che l'avrei subissata di richieste, e mantengo la
promessa! Ecco di cosa si tratta. Devo rinnovare la mia carta d'identità di
straniero, valida fino al prossimo novembre. La pratica dipende dal prefetto
di Saone et-Loire, a Mâcon, e devo indirizzargli una richiesta di rinnovo
proprio in questi giorni. Non vorrei che questa domanda ci causasse nuove
difficoltà. Le chiedo perciò di intervenire presso il prefetto di Mâcon. Sono
perfettamente in regola sotto ogni punto di vista, ma le circostanze così
poco propizie alle persone della mia specie mi fanno temere eventuali
seccature burocratiche, ecc. Posso contare su di lei? Non mi muoverò prima
di avere la sua risposta, ma la cosa è urgente.
5 ottobre 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Ho ricevuto la sua lettera del 29. L'ho letta e l'ho fatta leggere. Nessun
dubbio, la mia risposta è netta: non faccia niente, ogni passo mi sembra
estremamente imprudente. Aspetto la visita del canonico Dimnet e sarò
felice di intrattenermi con lui.
12 ottobre 1942 André Sabatier a Michel Epstein
Questa mattina ho ricevuto il suo biglietto dell'8 e il duplicato della lettera
che lei ha mandato a Digione. Le scrivo per dirle questo:
La nostra amica era perfettamente in regola e ammetta che questo non ha
impedito il peggio.
Per quanto riguarda le bambine, dato che sono francesi, per usare la sua
stessa espressione, non credo che un cambiamento d'aria sia indispensabile,
ma è solo un modo di dire. Credo che su questo punto la Croce Rossa
sarebbe in grado di informarla con maggior precisione e sicurezza.
19 ottobre 1942
Michel Epstein a André Sabatier
(prigione di Creusot)
[lettera scritta a matita]
Mi trovo tuttora a Creusot, molto ben trattato e in ottima salute. Non so
quando riprenderemo il viaggio né dove ci porteranno. Conto sulla sua
amicizia per i miei cari. Ne avranno bisogno, e sono certo che lei si
occuperà di loro. A parte questo, non ho niente da dirle se non che mi faccio
coraggio e che le stringo le mani.
1ø ottobre 1944 Julie Dumot a Robert Esmenard
La presente per ringraziarla di continuare i versamenti mensili. Come ha
potuto capire, ho avuto qualche problema. Da sette mesi a questa parte ho
dovuto continuare a nasconderle in posti diversi. Adesso spero che l'incubo
sia finito. Sono andata a prendere le bambine per metterle in collegio. La
grande è in terza media e Babet in quarta elementare; sono felici di poter
essere finalmente libere, e Denise potrà studiare più tranquillamente: ne va
anche del suo avvenire.
10 ottobre 1944 Julie Dumot a André Sabatier
Ho ricevuto i 15.000 franchi. Dalla fine di febbraio sono stata molto in
ansia per le bambine: ho dovuto tenerle ancora nascoste. É sicuramente per
questo che suor Saint-Gabriel non le ha risposto. Da sette mesi le piccole
non hanno potuto seguire lezioni regolari. Adesso spero che staremo tutti
più tranquilli e che potranno studiare come si deve. Le ho riportate in
collegio. Denise è entrata in terza media e Babet in quarta elementare. Sono
molto contente di aver ritrovato le compagne e le buone suore che ci hanno
tanto aiutato nei momenti difficili. Spero che ormai più niente ci tormenterà
mentre aspettiamo il ritorno dei nostri esiliati. Adesso si possono mettere in
vendita le opere di tutti gli autori o la vendita non è ancora libera?
30 ottobre 1944 Robert Esmenard a Julie Dumot
La ringrazio per la sua lettera del 1ø ottobre. Vedo che ha dovuto superare
ancora momenti molto dolorosi e pieni di angoscia. Ora è finalmente
tranquilla circa la sorte delle bambine, che potranno proseguire negli studi
in tutta serenità; dobbiamo sperare che questo incubo spaventoso abbia
presto fine e che in un prossimo futuro lei possa ricevere notizie dei loro
genitori. É, come sa, uno dei miei più vivi desideri...
9 novembre 1944 André Sabatier ajulie Dumot
Ho appreso con viva partecipazione che recentemente ha avuto ancora
molto da temere per le bambine. Non posso che rallegrarmi di saperla
finalmente al riparo da tutti quei provvedimenti a cui allude. Non ci resta
che auspicare un ritorno non troppo lontano di coloro che ci sono stati
portati via.
Naturalmente il signor Esmenard ha dato le istruzioni necessarie per la
vendita delle copie rimaste dei libri della signora I. Némirovsky. Per parte
mia mi sono domandato se sia opportuno pubblicare adesso i due
manoscritti che abbiamo di lei, il romanzo Les biens de ce monde e la
biografia di Cechov. Il signor Esmenard e io stesso riteniamo che sia
preferibile soprassedere alla loro pubblicazione, perché potrebbe essere
pericoloso attirare l'attenzione in un momento in cui la situazione della
signora Némirovsky può esporla a eventuali rappresaglie.
27 dicembre 1944 Robert Esmenard a Julie Dumot
Che il 1945 ci porti finalmente la pace e le restituisca i suoi cari assenti.
1945
Albin Michel a Julie Dumot 9000 franchi (giugno - luglio - agosto 1945)
8 gennaio 1945 Risposta di Robert Esmenard a Raissa Adler
Ci è regolarmente pervenuto il certificato del 13 ottobre 1944 a nome di
Irène Némirovsky, ma purtroppo non abbiamo potuto inoltrarlo alla
destinataria. La signora Némirovsky, infatti, è stata arrestata il 13 luglio
1942 a Issy, dove viveva dal 1940, avviata al campo di concentramento di
Pithiviers e quindi deportata nello stesso mese. Il marito è stato arrestato
qualche settimana dopo e a sua volta deportato. Tutte le iniziative intraprese
in loro favore sono risultate vane e di entrambi non si è più saputo niente.
Le due bambine hanno potuto fortunatamente essere salvate grazie alla
dedizione di un'amica con la quale vivono in provincia. Ci dispiace
profondamente, mi creda, di darle queste notizie.
16 gennaio 1945 Risposta di Albin Michel a A. Shal La ringrazio del
biglietto del 6 novembre 1944 che ha gentilmente inviato alla signora I.
Némirovsky. Ma, ahimè, non ci sarà possibile spedire il suo messaggio
all'interessata perché la nostra autrice e amica è stata portata via nel corso
del 1942 e avviata verso non so quale campo di concentramento in Polonia.
Da allora, malgrado innumerevoli passi intrapresi, non abbiamo saputo più
niente di lei. La stessa sorte è toccata al marito qualche mese più tardi.
Quanto alle figlie, fortunatamente affidate ad amici di famiglia, adesso
stanno bene. Sono desolato di doverle dare notizie tanto tristi, ma
continuiamo a sperare...
5 aprile 1945
Marc Aldanov (Found for the Relief of Men of Letters and Scientists of
Russia, New York)
a Robert Esmenard
Siamo venuti a conoscenza, tramite la signora Raïssa Adler, della tragica
notizia riguardante Irène Némirovsky. La signora Adler ci ha inoltre fatto
sapere che le due figlie di I. Némirovsky sono state salvate da un'ex
infermiera del nonno. Costei, la signorina Dumot, è a detta di tutti persona
assolutamente degna di fiducia, ma essendo purtroppo sprovvista di mezzi
non è in grado di provvedere alla loro educazione.
A New York, gli amici e gli ammiratori della signora Némirovsky si sono
riuniti per trovare il modo di aiutare le bambine; ma non sono né molto
numerosi né ricchi. Quanto al nostro comitato, comprende a tutt'oggi un
centinaio di letterati e di scienziati. Non abbiamo potuto fare granché. Per
questo ci rivolgiamo a lei, caro signore, per chiederle se la signora
Némirovsky non godrebbe per caso di un credito presso i suoi editori
francesi (dovuto ai diritti d'autore) e se, in caso affermativo, non sarebbe
possibile, a lei e ai suoi colleghi, mettere una parte di questo denaro a
disposizione delle due bambine. Le faremmo avere, al caso, il loro
indirizzo.
11 maggio 1945 Risposta di Robert Esmenard a Marc Aldanov
La signora Némirovsky è stata effettivamente arrestata, ahimè, nel luglio
1942, avviata dapprima al campo di Pithiviers e poi deportata. Qualche
settimana dopo la stessa sorte è toccata al marito. Di loro non abbiamo più
saputo niente e ne siamo molto angosciati.
So che la signorina Dumot ha salvato le due bambine e se ne prende cura
nel migliore dei modi. Per consentirglielo, sappia che, dopo l'arresto di
Irène Némirovsky, ho versato alla signorina Dumot somme cospicue, un
totale di 151.000 franchi, e che tuttora le assicuro un importo mensile di
3000 franchi.
1ø giugno 1945 André Sabatier a Julie Dumot
Da quando i deportati e i prigionieri cominciano a tornare in Francia
penso molto a lei e alle bambine di cui si prende cura. Suppongo che fino a
questo momento non abbia potuto sapere niente, perché me lo avrebbe di
certo comunicato. Neanche da parte mia è stato possibile raccogliere la
benché minima informazione. Ho chiesto alla signora J.-J. Bernard,1 che
conosceva la signora Némirovsky e che attualmente presta servizio nella
Croce Rossa, di fare i passi necessari allo scopo di sapere qualcosa.
Naturalmente se dovesse arrivarmi una qualche notizia lei sarebbe la prima
a esserne informata. C'è una domanda che volevo farle: che fine hanno fatto
gli scritti che si trovavano a Issy al momento dell'arresto della signora
Némirovsky? Ho sentito dire che c'era un lungo racconto terminato. Ne
avrebbe il testo? Se sì, me lo confermi e forse potremmo pubblicarlo nella
nostra rivista "La nef"
16 luglio 1945 André Sabatier al reverendo Omer Englebert
Le scrivo per una questione del tutto imprevista. Ecco di cosa si tratta: lei
certo conoscerà di nome e di fama I. Némirovsky, una delle più brave
scrittrici che la Francia abbia avuto negli anni precedenti la guerra.
Nota: 1. Moglie dello scrittore Jean-Jacques Bernard, figlio di Tristan
Bernard.
Israelita e russa, nel 1942 la Némirovsky è stata deportata, come pure il
marito, quasi certamente in un campo di concentramento in Polonia, e non
siamo mai riusciti a sapere alcunché di loro. A tutt'oggi il silenzio è totale e
purtroppo abbiamo perso ogni speranza di ritrovarla viva.
In Francia, I. Némirovsky aveva affidato le sue bambine, Denise e
Elisabeth Epstein, alle cure di un'amica, che ho appena incontrato. Costei mi
ha raccontato di essere riuscita a far accettare le due bambine come interne
presso l'istituto delle suore di Sion. C'era stato un accordo, ma ecco che
all'ultimo momento la madre superiora è venuta meno all'impegno preso,
con il pretesto che non c'era più posto. Di conseguenza, delusione e forte
preoccupazione per la brava donna che si prende cura di queste due
creature. Le sarebbe possibile vedere come stanno esattamente le cose? E se
ha una qualche influenza su quelle suore, potrebbe esercitare delle pressioni
affinché quanto meno all'inizio dell'anno scolastico, in ottobre, Denise e
Elisabeth vengano ammesse nel loro collegio?
La sorte delle due ragazzine ci sta molto a cuore, come può immaginare;
in ogni caso, anche se non potesse far niente, grazie in anticipo per
l'attenzione che vorrà riservare a questa mia richiesta.
23 luglio 1945
Comunicazione telefonica: Chautard (Union Européenne Industrielle et
Financiere)
a André Sabatier
Il signor de mezieres dell'U. E.1 è disposto a fare qualcosa in favore delle
figlie di Irène Némirovsky, in collaborazione con la nostra società.
[nota manoscritta: aspettare che si metta in contatto con noi]
Sarebbero pronti a versare 3000 franchi al mese.
Hanno trovato un istituto religioso nei dintorni di Parigi a 2000 franchi al
mese per ciascuna bambina.
1. Banque de l'Union Européenne (ex Banque des Pays du Nord, l'istituto
presso il quale Michel Epstein aveva svolto l'incarico di procuratore)
7 agosto 1945 Omer Englebert a Robert Esmenard
Sono lieto di annunciarle che le ragazzine della scrittrice russa israelita
(ecco che non ricordo più il suo nome!) che le stanno a cuore, e che anche il
signor Sabatier mi aveva raccomandato, sono state ammesse all'istituto delle
suore di Sion a Grandbourg, direzione Evry-Petit-Bourg. La madre
superiora mi ha testé fatto sapere che potranno entrarvi alla prossima
riapertura dell'anno scolastico.
29 agosto 1945
Julie Dumot (46, rue Pasteur a Marmande)
a André Sabatier
Non so come ringraziarla per tanto generoso impegno. Sono molto felice
per le bambine, soprattutto per Babet che ha solo otto anni e tutto il ciclo
scolastico da compiere. Quanto a Denise, che adesso sta bene, potrà
perfezionare gli studi in questo istituto di prim'ordine, come desiderava la
sua mamma. Le sono dunque molto riconoscente di aver realizzato il
desiderio dei genitori. Se Denise non potrà continuare gli studi, dovrà
comunque avere un diploma per poter lavorare; vedremo tutto questo entro
pochi giorni. La sua gentile lettera mi ha raggiunta qui, dove faccio passare
le vacanze alle bambine. Denise è completamente guarita; le radiografie
hanno indicato che non c'è più traccia di pleurite. Quanto a Babet, la
settimana prossima sarà operata di tonsille e di adenoidi. Non abbiamo
potuto farlo prima perché il dottore era in vacanza, e questo ritarderà di otto
giorni il nostro rientro a Parigi.
Sì, signor Sabatier, la Société des Gens de Lettres si era effettivamente
impegnata a fare qualcosa per le bambine. Il signor Dreyfus, al quale avevo
fatto presente che non potevo farcela con i 3000 franchi al mese (con
Denise che ha dovuto esser curata per ben sei mesi), ne ha parlato con il suo
amico, il signor Robert. L'ho comunicato il giorno stesso al signor
Esmenard, che è al corrente. Per qualsiasi informazione su di me, Tristan
Bernard mi conosce da quando avevo sedici anni.
3 ottobre 1945 Edizioni Albin Michel a Julie Dumot
12.000 franchi: settembre - ottobre - novembre - dicembre 1945.
7 dicembre 1945 Robert Esmenard (nota per la signorina Le Fur)
Venerdì pomeriggio sono andato dalla signora Simone Saint-Clair,
membro di un comitato che ha lo scopo di aiutare le figlie di I. Némirovsky.
Alcune singole persone e alcuni gruppi verseranno una somma mensile a un
notaio designato a custodirla fino a che le due bambine non abbiano
conseguito il diploma di scuola superiore. Questo in linea di massima. Una
volta che la maggiore, Denise, avrà ottenuto il suddetto diploma penso che
potremmo rivedere i termini della questione.
Oltre a questo saranno raccolte delle donazioni che costituiranno per le
figlie di I. Némirovsky un capitale di cui potranno disporre alla maggiore
età. É già stata messa insieme una certa somma nella quale è compreso un
versamento della Banque des Pays du Nord, l'istituto in cui lavorava il
signor Epstein, qualcosa come 18.000 franchi, corrispondenti a 3000 franchi
di mensilità con effetto retroattivo.
La signorina Dumot potrà disporre immediatamente, attraverso il notaio,
di una somma X che la risarcirà delle spese sostenute, e poi, ogni mese, di
un importo stabilito. Per quanto riguarda la nostra casa editrice, ho disposto
che a partire dalla data dell'ultima mensilità, che ho fatto depositare il 3112-'45, sarà versata una somma mensile di 2000 franchi, senza che questo
tocchi, naturalmente, i diritti d'autore dovuti a I. Némirovsky. Inoltre, ai
diritti della signora Némirovsky aggiungo una somma di 2000 franchi al
mese a partire da quello in cui ho iniziato i versamenti mensili; in altre
parole, queste mensilità hanno effetto retroattivo a partire dal primo
versamento.
E faremo uscire ampi comunicati sulla stampa per promuovere le
donazioni.
24 dicembre 1945 W. Tideman a Irène Némirovsky
Sono un giornalista di un quotidiano di Leida (Olanda) al quale ho
proposto la traduzione di un romanzo o di un racconto francese da
pubblicare come feuilleton. La direzione mi ha risposto di essere d'accordo,
in linea di massima, su quello che consigliere loro. Ho fatto presente che ci
sarebbero da pagare dei diritti, che saranno certamente molto più alti per un
romanzo già pubblicato qui, in quanto gli editori esigerebbero la loro parte,
che non per un racconto mai uscito, originale, per il quale ci sarebbe da
trattare solo con l'autore. E ho pensato a lei, benché di lei conosca solo i
romanzi.
29 dicembre 1945 Risposta di Albin Michel a W. Tideman
Ho preso conoscenza della lettera indirizzata a I. Némirovsky presso la
mia casa editrice, non potendo ahimè trasmetterla alla sua destinataria.
La signora Némirovsky, infatti, è stata arrestata nel luglio 1942 e poi,
pare, deportata in Polonia. Dal giorno del suo arresto nessuno ha più saputo
niente di lei.
POSTFAZIONE DI MYRIAM ANASSIMOV
Nel 1929 Bernard Grasset, entusiasta di David Golder, un manoscritto
arrivato per posta, decise di pubblicarlo immediatamente. Ma al momento di
far firmare un contratto all'autore si accorse che quest'ultimo, forse nel
timore di un rifiuto, non aveva dato né nome né indirizzo, ma solo il numero
di casella postale. Perciò fece stampare un breve annuncio sui giornali per
invitare il misterioso scrittore a farsi vivo.
Quando pochi giorni dopo si presentò Irène Némirovsky, Grasset non
riusciva a capacitarsi che la giovane donna dall'apparenza allegra e serena,
che viveva in Francia da dieci anni soltanto, fosse proprio la persona che
aveva scritto quel libro brillante, crudele, audace, e soprattutto di così
notevole maestria. Un'opera assolutamente degna di uno scrittore maturo.
Pieno di ammirazione ma ancora dubbioso, l'editore la interrogò a lungo per
assicurarsi che la Némirovsky non stesse facendo da prestanome a un
qualche scrittore famoso che voleva restare nell'ombra.
Appena uscì, David Golder fu elogiato all'unanimità dalla critica, tanto
che Irène Némirovsky divenne subito celebre e fu lodata da scrittori di
diversa estrazione, come Joseph Kessel, un ebreo, e Robert Brasillach, un
monarchico di estrema destra e antisemita. Brasillach elogiò in particolare
la purezza della prosa di quella nuova arrivata nel mondo letterario parigino.
Irene era nata a Kiev, ma aveva imparato il francese dalla sua governante
fin dalla prima infanzia. Inoltre parlava correntemente il russo, il polacco,
l'inglese, il basco e il finlandese, e capiva lo yiddish, di cui si trovano tracce
in Les chiens et les loups, scritto nel 1940.
La Némirovsky non si montò la testa per il suo sensazionale ingresso nel
mondo letterario. Si meravigliò perfino che si attribuisse tanta importanza a
quel David Golder che lei stessa definiva, senza falsa modestia, "un
romanzetto" Il 22 gennaio 1930 scriveva a un'amica: "Come puoi credere
che possa dimenticare le mie vecchie amicizie a causa di un libro di cui ora
si parla, ma che tra una quindicina di giorni sarà già finito nel
dimenticatoio, come tutto a Parigi?"
Irène Némirovsky era nata l'11 febbraio 1903 a Kiev, in quello che oggi si
chiama yiddishland. Il padre, Leon Némirovsky (Arieh, in ebraico),
originario di una famiglia proveniente dalla città ucraina di Nemirov, uno
dei principali centri del movimento hassidico nel Settecento, aveva avuto la
sventura di nascere nel 1868 a Elisabethgrad, la città dalla quale doveva
dilagare, a partire dal 1881, la grande ondata di pogrom contro gli ebrei
russi, persecuzione che durerà molti anni. Leon Némirovsky, la cui famiglia
si era arricchita con il commercio di granaglie, aveva viaggiato parecchio
prima di farsi strada nel mondo della finanza e di diventare uno dei più
ricchi banchieri della Russia. Sul suo biglietto da visita si poteva leggere:
"Leon Némirovsky, presidente del consiglio della Banca Commerciale di
Voronej, amministratore delegato della Banca Unione di Mosca, membro
del consiglio della Banca Privata del Commercio di San Pietroburgo";
aveva acquistato una grande casa sulle alture della città, in una tranquilla
zona con viali di tigli e giardini.
Affidata alle attente cure della governante, Irene era stata educata da
ottimi precettori, ma lo scarso interesse dei genitori nei confronti della vita
familiare aveva fatto di lei una bambina molto infelice e solitaria. Il padre,
che Irene adorava e ammirava, preso dagli affari era quasi sempre in
viaggio o intento a giocare enormi somme al Casino. La madre, che si
faceva chiamare Fanny (dal suo nome ebraico Faiga), l'aveva messa al
mondo unicamente per compiacere il ricco marito: per lei la nascita di
quella figlia non rappresentava altro che il primo segno del declino della
propria femminilità, e aveva subito lasciato la bambina alle cure della balia.
Fanny Némirovsky (nata a Odessa nel 1887 e morta a Parigi nel 1989)
nutriva una sorta di avversione nei confronti della figlia, che non ricevette
mai da lei il minimo gesto d'amore. Passava invece ore e ore davanti allo
specchio a spiare la comparsa delle prime rughe, a truccarsi, a farsi
massaggiare, e il resto del tempo lo trascorreva fuori casa in cerca di
avventure extraconiugali. Vanitosissima e orgogliosa della propria bellezza,
era inorridita di vederla sfiorire: presto il tempo avrebbe fatto di lei una
donna costretta a ricorrere alla compagnia di qualche gigolot. E per
dimostrare a se stessa di essere ancora giovane si ostinò a voler vedere in
Irene, divenuta adolescente, un'eterna bambina, che obbligava a vestirsi e a
pettinarsi come una scolaretta.
Irene, abbandonata a se stessa durante le ore di libertà della governante, si
rifugiava nella lettura; cominciò a scrivere, e reagì alla disperazione
sviluppando a sua volta nei confronti della madre un odio feroce. Questa
violenza, l'anomalia nel rapporto madre-figlia occupano un posto centrale
nell'opera di Irène Némirovsky.
"Nel suo cuore, ella nutriva verso la madre uno strano odio che sembrava
crescere con lei" si può leggere ad esempio in Le vin de solitude. "Non
diceva mai "mamma" articolando chiaramente le due sillabe, che le
uscivano a fatica dalle labbra serrate; pronunciava "mani" in una sorta di
rapido borbottio che si strappava dal cuore con sforzo e con una punta di
sordo e subdolo dolore"
E ancora:
"Il volto della madre, contratto dall'ira, si avvicinò al suo, e lei vide
brillare gli occhi che odiava, le pupille dilatate dalla collera e dalla paura...
Dio ha detto: "Mia sarà la vendetta...". Ah, pazienza, non sono una santa,
non posso perdonarla! Aspetta, aspetta un po’ e vedrai! Ti farò piangere
come mi hai fatto piangere tu! Aspetta, aspetta, vecchia mia!"
E questa vendetta trovò il suo compimento nella pubblicazione di Le bai,
di Jézabel e di Le vin de solitude.
Le opere più significative di Irène Némirovsky hanno come sfondo il
mondo ebraico e russo. In Les chiens et les loups l'autrice descrive i
borghesi della prima Gilda dei mercanti, i soli che avessero il diritto di
abitare a Kiev, città altrimenti proibita agli ebrei per ordine di Nicola I.
Irène Némirovsky non rinnegava la civiltà ebraica dell'Europa orientale
nel cui ambito erano vissuti i suoi nonni (Yacov Margulis e Bella
Chtchedrovitch) e i suoi genitori - che una volta arricchitisi se n'erano
allontanati. Ma ai suoi occhi, e benché la sua esistenza sia stata sempre
quella di una ricca borghese, il maneggiare denaro e il conseguente
accumulo di beni avevano qualcosa di infamante.
Nel descrivere l'ascesa sociale degli ebrei la Némirovsky aderisce a ogni
sorta di pregiudizi antisemiti e utilizza tutti gli stereotipi negativi dell'epoca.
Nei suoi libri gli ebrei sono raffigurati nei modi più crudeli e peggiorativi, e
lei li osserva con una sorta di inorridita attrazione pur riconoscendo di
condividere con essi un destino comune - fatto di cui avrà conferma nel
corso dei tragici eventi successivi.
Quanto disprezzo di sé si può scoprire sotto la sua penna! In un
vertiginoso oscillare Irène Némirovsky adotta inizialmente l'idea in base
alla quale gli ebrei apparterrebbero alla "razza ebraica", razza inferiore i cui
tratti distintivi sarebbero facilmente riconoscibili - benché sia impossibile
parlare di razze nel senso che si dava a questa parola negli anni Trenta e che
sarà generalizzato nella Germania nazista. Ecco alcuni tratti specifici
attribuiti agli ebrei nella sua opera, alcune scelte lessicali utilizzate per
qualificarli, per farne un gruppo di individui dotati di caratteristiche
comuni: capelli crespi, naso adunco, mano molle, dita e unghie a uncino,
colorito scuro, giallo o olivastro, occhi neri, ravvicinati e melliflui,
corporatura gracile; e ancora: riccioletti neri e folti, guance livide, denti
irregolari, narici mobili; per non dimenticare la sete di guadagno, la
combattività, l'isteria, l'atavica abilità nel "vendere e comprare paccottiglia,
fare traffico di valuta, improvvisarsi commessi viaggiatori, rappresentanti di
finti merletti o munizioni di contrabbando...".
In Les chiens et les loups, dilaniando ripetutamente a parole quella
"gentaglia ebrea", scrive: "Come tutti gli ebrei, si scandalizzava più
vivamente e più dolorosamente di un cristiano per certi difetti
specificatamente ebraici. E quella energia tenace, quel bisogno quasi
selvaggio di ottenere le cose desiderate, quel disprezzo cieco per ciò che
possono pensare gli altri, tutto questo, nella sua mente, si collocava sotto
un'unica etichetta: "insolenza ebraica"" Paradossalmente, la Némirovsky
conclude questo romanzo con una sorta di tenerezza e di disperata
dichiarazione di appartenenza: "Sono questi, i miei; questa la mia famiglia"
E all'improvviso, in un nuovo rovesciamento di prospettiva, facendosi
portavoce di tutti gli ebrei, esclama: "Ah, come le odio le vostre moine di
europei! Quello che voi chiamate successo, vittoria, amore, odio, io lo
chiamo denaro! É un'altra parola per dire le stesse cose!"
Di fatto la Némirovsky ignorava completamente la spiritualità ebraica, la
ricchezza, la diversità della civiltà ebraica dell'Europa orientale. In
un'intervista concessa a "L'Univers israélite" del 5 luglio 1935 si dichiarava
orgogliosa di essere ebrea, e a chi la vedeva come una nemica del suo
popolo rispondeva di aver dipinto in David Golder non "gli ebrei francesi
stabilitisi nel paese da generazioni e per i quali, effettivamente, la questione
della razza non si pone, ma molti ebrei cosmopoliti nei quali la passione per
il denaro ha preso il posto di ogni altro sentimento"
David Golder, romanzo iniziato a Biarritz nel 1925 e concluso nel 1929,
racconta l'epopea di Golder, un ebreo di origine russa, magnate della
finanza internazionale: la sua ascesa, il punto di massimo splendore e infine
lo spettacolare tracollo della sua banca. Gloria la moglie che sta
invecchiando, notoriamente infedele e abituata ai fasti di un tenore di vita
altissimo, esige somme sempre più ingenti per mantenere il suo amante.
Rovinato, vinto, il vecchio Golder, un tempo terrore della Borsa, ridiventa il
piccolo ebreo che era stato in gioventù, a Odessa. D'un tratto, per amore
della figlia, peraltro frivola e ingrata, decide di ricostruire il suo patrimonio.
Dopo aver messo a segno un ultimo colpo, muore stremato su una nave
sbattuta da una furiosa tempesta, balbettando qualche parola di yiddish che
verrà raccolta da un immigrato ebreo, anche lui imbarcatosi a Simferopol
nella speranza di una vita migliore in Europa. Golder muore, per così dire,
in mezzo ai suoi simili.
In Russia i Némirovsky conducevano una vita lussuosa. Ogni estate
lasciavano l'Ucraina diretti in Crimea, o a Biarritz, a Saint-Jean-de-Luz, a
Hendaye o sulla Costa Azzurra. La madre di Irene scendeva in un albergo di
lusso, mentre la figlia veniva alloggiata, con la governante, in una pensione
a conduzione familiare.
Dopo la morte dell'istitutrice francese Irene, che all'epoca aveva
quattordici anni, cominciò a scrivere. Si installava su un divano con un
quaderno sulle ginocchia; aveva elaborato una tecnica che si ispirava a
quella di Ivan Turgenev: di un romanzo stendeva non solo la vicenda, ma
anche tutte le riflessioni che questa le ispirava, il tutto in un flusso libero,
senza cancellature o ripensamenti. E aveva un'idea molto chiara di ciascuno
dei suoi personaggi, anche di quelli di secondo piano: riempiva quaderni
interi per descrivere la fisionomia, il carattere, l'educazione, l'infanzia, le
tappe cronologiche della loro vita. Quando tutti i personaggi erano stati
minuziosamente delineati Irene, utilizzando due matite, una rossa e una blu,
sottolineava i tratti essenziali da conservare - a volte solo poche righe.
Passava quindi rapidamente alla composizione del romanzo, la
perfezionava, e infine redigeva la stesura definitiva.
Allo scoppio della rivoluzione di Ottobre i Némirovsky abitavano a San
Pietroburgo, in una grande e bella casa dove stavano dal 1914.
"L'appartamento... era disposto in modo che, dall'ingresso, lo sguardo
potesse spingersi sino alle stanze in fondo; grandi porte aperte lasciavano
intravedere un'infilata di salotti bianchi e oro" scrive Irene in Le vin de
solitude, romanzo in gran parte autobiografico. Per molti scrittori e poeti
russi San Pietroburgo è una città mitica, ma Irène Némirovsky ci vedeva
soltanto un susseguirsi di strade buie, coperte di neve, battute da un vento
gelido che saliva dalle acque putride e nauseabonde dei canali e della Neva.
Leon Némirovsky, che doveva recarsi spesso a Mosca per affari, aveva
preso in subaffitto un appartamento ammobiliato da un ufficiale della
Guardia imperiale all'epoca distaccato presso l'ambasciata di Russia a
Londra. Credendo di mettere al sicuro la famiglia, Némirovsky trasferì i
suoi a Mosca, ma fu proprio in quella città che nell'ottobre 1918 la
rivoluzione si scatenò con maggiore violenza. Mentre infuriavano gli scontri
di piazza, Irene andava alla scoperta della biblioteca di Des Esscintes,
l'ufficiale letterato. Vi scoprì Huysmans, Maupassant, Platone e Oscar
Wilde - Il ritratto di Dorian Gray era il suo libro preferito.
La casa, invisibile dalla strada, era incastrata fra altri edifici e circondata
da un cortile sul quale si affacciava un'altra casa più alta della prima. Poi
veniva un secondo cortile circolare, e di nuovo una casa. Quando non
vedeva nessuno in giro Irene scendeva di nascosto a raccogliere i bossoli
lasciati dai proiettili. Per cinque giorni la famiglia sopravvisse, chiusa
nell'appartamento, con un sacco di patate, alcune scatole di cioccolato e
altre di sardine come uniche provviste. Durante un momento di tregua i
Némirovsky tornarono a San Pietroburgo; poi i bolscevichi misero una
taglia sulla testa del padre di Irene, che fu costretto a entrare in
clandestinità. Nel dicembre 1918, approfittando del fatto che le frontiere
non erano ancora chiuse, Leon Némirovsky organizzò la fuga in Finlandia
dei suoi familiari, travestiti da contadini. E Irene trascorse un anno in una
minuscola frazione - tre case di legno in mezzo a una distesa di neve -,
sperando sempre di poter rientrare in Russia. Il padre, in attesa di ritornarci
definitivamente, si recava spesso in Russia in incognito per cercare di
salvare i suoi beni.
Per la prima volta Irene conosce un periodo di serenità e di pace; ormai
donna, comincia a scrivere poemi in prosa ispirati a Oscar Wilde. Poiché la
situazione in Russia si faceva sempre più critica e i bolscevichi si
avvicinavano pericolosamente, i Némirovsky, alla fine di un lungo viaggio,
ripararono in Svezia. Vissero tre mesi a Stoccolma, e di quel soggiorno
Irene conservò il ricordo dei lillà viola che a primavera fiorivano nei cortili
e nei giardini.
Nel mese di luglio del 1919 la famiglia si imbarcò su un piccolo
mercantile diretto a Rouen; rimasero a bordo dieci giorni, senza fare scalo,
in balia di una terribile tempesta (che ispirò poi l'ultima drammatica scena
di David Golder) A Parigi Leon Némirovsky assunse la direzione di una
succursale della sua banca e poté così ricostituire il suo patrimonio.
Irene si iscrisse alla facoltà di Lettere della Sorbona e ottenne la laurea
con lode. David Golder, il suo romanzo di esordio, non fu un primo
tentativo: l'autrice aveva già debuttato nel mondo letterario inviando quelli
che chiamava "raccontini ameni" al quindicinale illustrato "Fantasio", che
usciva il 1ø e il 15 di ogni mese e che glieli aveva pubblicati pagandoli
sessanta franchi ciascuno. Poi si era cimentata in un'impresa più ardua,
proponendo al "Matin" un racconto che fu accettato. Seguirono un altro
racconto e una novella che apparvero entrambi su "Oeuvres libres", e Le
malentendu, un primo romanzo, scritto nel 1923 all'età di diciotto anni. Un
anno dopo, nel febbraio del 1926, uscirà presso lo stesso editore L'enfant
genial, una novella che più tardi sarà intitolata Un enfant prodige.
É il racconto della tragica storia di Ismaël Baruch, un bambino ebreo nato
in una catapecchia di Odessa; le sue doti di poeta precoce e naïf incantano
un aristocratico, che lo toglie dalla strada e lo porta in un palazzo per
distrarre gli ozi della sua amante. Il bambino vive vezzeggiato,
costantemente in estasi ai piedi della principessa, che lo considera una
specie di scimmia ammaestrata.
Ormai adolescente Ismaël, dopo una lunga crisi, perde i talenti che
nell'infanzia gli avevano permesso di brillare e giudica poca cosa quei canti
e quei versi che erano stati all'origine della sua fortuna. Cerca l'ispirazione
nelle letture a cui si è dedicato, ma la cultura, lungi dal fare di lui un genio,
distrugge la sua originalità, la sua spontaneità. A quel punto la principessa
gli volta le spalle, se ne disfa come di un oggetto inutile, e a Ismaël non
resta che ritornare nel vecchio mondo: il ghetto di Odessa, con le sue
catapecchie e le sue bettole. Ma in quel giovane ormai assimilato nessuno
riconosce Ismaël: respinto dal suo ambiente, senza più legami con quel
mondo, il giovane si getta nelle putride acque del porto.
In Francia la vita di Irène Némirovsky prende una piega meno amara. La
famiglia si inserisce bene nella società parigina e conduce l'esistenza
brillante dei grandi borghesi: serate mondane, cene con champagne a
profusione, balli, villeggiature di lusso. Irene adora la vita movimentata, la
danza; corre da una festa all'altra, da un ricevimento all'altro. Come
confessa lei stessa, "fa baldoria". Ogni tanto gioca anche al Casino. Il 2
gennaio 1924 scrive a un'amica: "Ho passato una settimana di completa
follia: feste su feste, sono ancora un po’ ebbra e ho difficoltà a tornare sulla
retta via!"
E ancora, da Nizza: "Mi agito come una pazza, che vergogna! Non faccio
altro che ballare. Ogni giorno, nei vari alberghi, ci sono dei gala molto chic,
e poiché ho la fortuna di poter disporre di qualche gigolot, mi diverto
moltissimo"
Poi, di ritorno da quella città: "Non ho fatto la brava... tanto per
cambiare... Il giorno prima della partenza, al nostro albergo, il Negresco,
c'era una festa. Ho ballato e mi sono scatenata fino alle due del mattino;
dopo sono andata a flirtare bevendo champagne ghiacciato in mezzo a una
corrente d'aria fredda" Qualche giorno dopo: "É venuto a trovarmi Choura e
mi ha fatto una paternale di due ore: pare che io esageri con i flirt, e che sia
molto brutto far perdere la testa ai ragazzi in questo modo... Sappi che ho
sbolognato Henry, che l'altro giorno è venuto a trovarmi, pallido e con gli
occhi fuori dalla testa, l'aria cattiva e una rivoltella in tasca!"
Nel vortice di una di quelle serate, Irene incontra Michail, ovvero Michel
Epstein, "un brunetto dalla carnagione molto scura" che le fa subito la corte.
Ha una laurea in Ingegneria conseguita a San Pietroburgo, e lavora come
procuratore presso la Banque des Pays du Nord, in rue Gaillon. Irene lo
trova di suo gusto, ci amoreggia un po’ e lo sposa nel 1926.
La coppia si sistema al 10 di avenue Constant-Coquelin, in un
bell'appartamento le cui finestre danno sul grande giardino di un convento
della Rive Gauche. Nel 1929 nasce Denise, la primogenita. Quando viene a
sapere di essere diventata nonna, Fanny regala alla figlia un orso di peluche.
Una seconda bambina, Elisabeth, nascerà il 20 marzo 1937.
Gli Epstein ricevono diversi amici, come Tristan Bernard e l'attrice
Suzanne Devoyod, e frequentano la principessa Obolensky. Irene si cura
dell'asma che la affligge con soggiorni nelle stazioni termali. Una
produzione cinematografica acquista i diritti per l'adattamento di David
Golder, che sarà interpretato da Harry Baur in un film diretto da Julien
Duvivier.
Malgrado la notorietà, Irène Némirovsky, innamorata della Francia e della
buona società che lei e il marito frequentano, non otterrà mai la nazionalità
francese. Nella generale psicosi di guerra che caratterizza il 1939, e dopo un
decennio contrassegnato da un'esplosione di violento antisemitismo che
dipinge gli ebrei come perfidi invasori, avidi, bellicosi, assetati di potere,
guerrafondai, borghesi e rivoluzionari al tempo stesso, Irene decide di
convertirsi, insieme alle bambine, al cristianesimo. Viene battezzata all'alba
del 2 febbraio 1939 nella cappella Sainte-Marie de Paris da un amico di
famiglia, monsignor Ghika, principe-vescovo rumeno.
Il 1ø settembre 1939, alla vigilia della dichiarazione della seconda guerra
mondiale, Irene e Michel Epstein portano le due figliolette a Issy-l'Évêque,
nella Saône-et-Loire, con la bambinaia Cecile Michaud, originaria del
posto. Quest'ultima affida le piccole alle cure affettuose di sua madre, la
signora Mitaine. Irene e Michel Epstein tornano a Parigi e da quel momento
fino alla messa in opera della linea di demarcazione nel giugno 1940
faranno un continuo andirivieni per vedere le bambine.
Il primo statuto del 3 ottobre 1940 stabilisce per gli ebrei una condizione
di inferiorità sociale e giuridica che fa di loro dei veri e propri paria. E
soprattutto stabilisce, in base a criteri razziali, chi è ebreo agli occhi dello
Stato francese. Gli Epstein, che si dichiareranno ufficialmente ebrei nel
censimento del giugno 1941, sono anche stranieri. Michel non ha più diritto
di lavorare alla Banque des Pays du Nord e Irene non può più pubblicare i
suoi libri, perché le case editrici sottopongono a epurazione personale e
autori che non siano rigorosamente "ariani" I coniugi lasciano Parigi e
raggiungono le figlie all'Hotel des Voyageurs a Issy-l'Eveque, dove sono
acquartierati anche soldati e ufficiali della Wehrmacht.
Nell'ottobre 1940 viene promulgata una legge sui "cittadini stranieri di
razza ebraica" secondo la quale essi possono essere internati in campi di
concentramento o obbligati al domicilio coatto. Ma la legge del 2 giugno
1941, che sostituisce il primo statuto degli ebrei dell'ottobre 1940, rende la
loro situazione ancora più precaria, ed è il preludio all'arresto,
all'internamento e alla deportazione nei campi di sterminio nazisti.
Il certificato di battesimo non è di alcuna utilità agli Epstein. La piccola
Denise fa comunque la prima comunione. Quando diventa obbligatorio
portare il contrassegno ebraico, la bambina frequenta la scuola comunale
con la stella gialla e nera, ben visibile, cucita sul cappotto.
Dopo aver abitato per un anno in albergo, gli Epstein trovano finalmente
una grande casa borghese da poter affittare nel villaggio stesso.
Michel Epstein scrive una tavola pitagorica in versi per la figlia Denise.
Quanto a Irene, molto lucida, non ha dubbi sul fatto che l'esito degli eventi
sarà tragico. Ma scrive e legge molto. Ogni giorno, dopo la prima colazione,
esce di casa e a volte percorre fino a dieci chilometri prima di trovare il
luogo adatto al lavoro. Allora si mette all'opera. Esce di nuovo nel
pomeriggio, dopo il pranzo, e rientra solo a sera. Dal 1940 al 1942 le
Edizioni Albin Michel e il direttore del giornale antisemita "Gringoire"
accettano di pubblicare i suoi racconti sotto due pseudonimi: Pierre Nerey e
Charles Blancat.
A Issy-l'Évêque, fra il 1941 e 1942 Irène Némirovsky, che come il marito
porta la stella gialla, scrive La vie de Tchékhov e Les feux de l'automne, che
sarà pubblicato solo nella primavera del 1957, e pone mano a un'impresa
ambiziosa, Suite française, che non riuscirà a portare a termine. L'opera
comprende due volumi. Il primo, Tempête en juin, è una successione di
quadri sul tracollo della Francia; il secondo, intitolato Dolce, è redatto in
forma di romanzo.
La Némirovsky comincia, com'era sua abitudine, con lo stendere alcune
osservazioni sul lavoro in corso e con l'annotare le riflessioni che la
situazione della Francia le ispira. Compila la lista dei personaggi, i
principali come i secondari, e si accerta di averli tutti correttamente
utilizzati. Sogna un libro di mille pagine, costruito come una sinfonia, ma in
cinque parti. In base ai ritmi, alle tonalità. Prende a modello la Quinta
sinfonia di Beethoven.
Il 12 giugno 1942, pochi giorni prima del suo arresto, dubita di avere il
tempo necessario a concludere la grande opera intrapresa. Ha il
presentimento che le resti poco da vivere, ma continua a redigere i suoi
appunti, parallelamente alla stesura del libro. A queste osservazioni lucide e
ciniche dà il titolo di Notes sur l'état de la France. Esse dimostrano che
Irène Némirovsky non si fa illusioni né sull'atteggiamento della massa
inerte, "detestabile", dei francesi nei confronti della sconfitta e del
collaborazionismo, né sul proprio destino personale. Ecco cosa scrive
all'inizio della prima pagina:
Per sollevare un così grande peso ci vorrebbe la tua forza, o Sisifo.
Questa fatica non mi spaventa ma la meta è lontana e breve il tempo.
Irene condanna la paura, la vigliaccheria, quell'accettare docilmente
l'umiliazione, la persecuzione e i massacri. Ma è sola: nell'ambito editoriale
e letterario rari sono coloro rimasti immuni dal collaborazionismo. Ogni
giorno va incontro al postino, ma per lei non c'è niente. Non cerca di
sottrarsi al destino con la fuga, ad esempio verso la Svizzera che, seppur
con parsimonia, accoglie gli ebrei provenienti dalla Francia, soprattutto
donne e bambini. Irene si sente così abbandonata che il 3 giugno fa
testamento, indirizzandolo specificamente all'attenzione della tutrice delle
sue figlie, affinché quest'ultima possa prendersi cura di loro quando lei e il
marito non ci saranno più. Impartisce direttive precise, elenca tutti i beni
che ha potuto salvare e che costituiranno i fondi per pagare l'affitto, il
riscaldamento, l'acquisto di un fornello, l'assunzione di un giardiniere che si
occuperà dell'orto da cui ricavare le verdure in quel periodo di
razionamenti; fornisce l'indirizzo dei dottori che seguono le bambine, dà
istruzioni puntuali sulla loro dieta. Non una parola di ribellione. Si limita a
prendere atto della situazione quale si presenta. Vale a dire disperata.
Il 3 luglio 1942 scrive: "Decisamente [disperata], e a meno che le cose
non perdurino e non si complichino nel frattempo! Ma che almeno tutto
finisca, bene o male!" Vede la situazione come un seguito di scosse violente
che potrebbero ucciderla.
L'11 luglio 1942 lavora nella pineta, seduta sul suo maglione blu, "come
su una zattera in mezzo a un oceano di foglie putride inzuppate dal
temporale della notte scorsa, con le gambe ripiegate sotto di me!"
Quello stesso giorno scrive al direttore letterario della casa editrice Albin
Michel una lettera che non lascia dubbi sulla sua certezza di non
sopravvivere alla guerra che i tedeschi e i loro alleati hanno dichiarato agli
ebrei:
"Caro amico... non mi dimentichi. Ho scritto molto. Saranno opere
postume, temo, ma scrivere fa passare il tempo"
Il 13 luglio 1942 i gendarmi francesi suonano alla porta degli Epstein per
arrestare Irene, che il 16 luglio viene internata nel campo di concentramento
di Pithiviers, nel Loiret. Il giorno dopo la fanno salire con altri deportati sul
convoglio numero 6 diretto ad Auschwitz. Viene registrata nel campo di
sterminio di Birkenau, ma debole e stremata com'è passa per il Revier,1 per
essere poi eliminata il 17 agosto 1942.
Nota:
1. Revier: l'infermeria di Auschwitz in cui venivano confinati, in
condizioni atroci, i prigionieri troppo ammalati per lavorare.
Periodicamente le SS li ammassavano sui camion e li trasportavano nelle
camere a gas.
All'inizio Michel Epstein non si rende conto che arresto e deportazione
vogliono dire morte. Aspetta il ritorno di Irene ed esige che ogni volta
venga preparato il suo posto a tavola. Disperato, resta a Issy-l'Evêque con le
figlie. Scrive al maresciallo petain spiegando che la moglie è molto
cagionevole di salute e chiede di poter prendere il suo posto nel campo di
lavoro.
La risposta del governo di Vichy sarà il suo arresto. Nell'ottobre 1942
Michel verrà internato dapprima a Creusot, poi a Drancy, dove, come risulta
dal foglio della perquisizione, gli confiscano ottomilacinquecento franchi.
Anche lui sarà deportato ad Auschwitz, il 6 novembre 1942, e subito
avviato alla camera a gas.
Dopo aver arrestato Michel Epstein i gendarmi si erano presentati alla
scuola comunale per catturare la piccola Denise, che la maestra riuscì a
nascondere nello spazio fra il suo letto e il muro.
Ma la caccia si farà sempre più accanita; le due bambine saranno braccate
ovunque perché destinate a subire la stessa sorte dei genitori. La tutrice avrà
la presenza di spirito di togliere la stella gialla dai vestiti di Denise e di far
attraversare clandestinamente la Francia alle bambine, che passeranno mesi
e mesi nascoste in un convento, poi in diverse cantine nella regione di
Bordeaux.
Alla fine della guerra, persa la speranza di veder tornare i genitori, Denise
ed Elisabeth andarono a chiedere aiuto alla nonna, che aveva trascorso tutti
gli anni del conflitto a Nizza nel modo più confortevole. Fanny non aprì
neppure la porta, si limitò a urlare alle bambine che se i loro genitori erano
morti non avevano che da rivolgersi a un orfanotrofio. Quanto a lei, morì a
centodue anni nel suo grande appartamento di avenue du President-Wilson.
Nella cassaforte vennero trovati solo due libri di Irène Némirovsky: Jézabel
e David Golder.
La storia della pubblicazione di Suite française ha del miracoloso e merita
di essere raccontata.
Nella loro fuga, la tutrice e le bambine portarono sempre una valigia che
conteneva fotografie, documenti e l'ultimo manoscritto di Irene, redatto con
una grafia minuscola per risparmiare l'inchiostro e la pessima carta del
tempo di guerra - l'opera in cui la Némirovsky aveva tracciato un ritratto
spietato della Francia abulica, vinta e occupata.
La valigia accompagnò Elisabeth e Denise dall'uno all'altro dei loro
temporanei e precari rifugi; il primo fu un collegio cattolico dove soltanto
due suore sapevano che le bambine erano ebree. Avevano dato a Denise un
nome falso, ma lei non riusciva ad abituarvisi e in classe si faceva sempre
riprendere perché, quando la chiamavano, non rispondeva. Ma i gendarmi,
che non demordevano e non trovavano niente di più importante da fare che
consegnare ai nazisti due bambine ebree, ritrovarono le loro tracce. Le
piccole lasciarono quindi il collegio, e nelle cantine in cui si rifugiarono per
diverse settimane Denise si buscò la pleurite. Non osando portarla da un
medico, le persone che la tenevano nascosta le somministrarono come unica
terapia della resina di pino. Sul punto di essere scoperte, tutrice e bambine
dovettero fuggire di nuovo, con la preziosa valigia sempre a portata di mano
in caso di pericolo. Prima di salire su un treno, ogni volta la donna
raccomandava a Denise: "Nascondi il naso!"
Quando i sopravvissuti ai campi nazisti cominciarono ad arrivare alla
Gare de l'Est, Denise ed Elisabeth vi si recarono ogni giorno e, con un
cartello che portava scritto il loro nome, andarono anche all'Hotel Lutetia,
trasformato in centro di accoglienza per i deportati. Una volta Denise si
gettò all'inseguimento di una donna nella quale le era parso di riconoscere la
madre.
Denise aveva portato in salvo il prezioso quaderno ma non osava aprirlo,
le bastava poterlo guardare. Un giorno, però, decise di scoprirne il
contenuto, ma fu costretta a fermarsi: era un'impresa troppo dolorosa. Gli
anni passarono.
A un certo punto, d'accordo con la sorella Elisabeth, divenuta nel
frattempo dirigente editoriale con il nome di Elisabeth Gille, Denise prese la
decisione di salvare l'ultima opera della madre affidandola all'Institut
memoire de l'Edition Contemporaine. Ma, prima di separarsene, volle
dattilografare il manoscritto e, aiutandosi con una grossa lente, intraprese un
lungo e difficile lavoro di decifrazione.
In seguito Suite française fu inserito nella memoria di un computer,
dunque trascritto una terza volta nella sua stesura definitiva. Non si trattava,
come Denise aveva creduto, di semplici annotazioni, di un diario intimo, ma
di un'opera veemente e implacabile, un affresco straordinariamente lucido,
un'istantanea della Francia e dei francesi: strade dell'esodo, villaggi invasi
da donne e bambini stremati e affamati che lottano per dormire su una sedia
nel corridoio di una locanda di campagna, automobili stracariche di mobili,
di materassi, di coperte e di stoviglie ferme in mezzo alla strada senza una
goccia di benzina, ricchi borghesi disgustati dal volgo che cercano di
salvare i loro preziosi ninnoli, mantenute piantate in asso dai loro amanti
impazienti di lasciare Parigi insieme con la famiglia, un prete che scorta
verso un rifugio un gruppo di orfani i quali, liberatisi dalle loro inibizioni,
finiranno per massacrarlo, un militare tedesco alloggiato in una casa
borghese che conquista la giovane moglie di un prigioniero sotto gli occhi
della suocera. In questo quadro desolante solo due coniugi, una coppia
modesta il cui figlio è rimasto ferito nel corso dei primi scontri, conservano
la loro dignità. In mezzo ai soldati sconfitti che si trascinano a fatica sulle
strade, nel caos dei convogli militari che trasportano i feriti negli ospedali, i
due cercano invano di rintracciare quel figlio.
Quando Denise Epstein affidò il manoscritto di Suite française al
sovrintendente dell'IMEC provò un grande dolore. Pur non avendo dubbi
sul valore dell'ultima opera di sua madre non la fece leggere a un editore,
perché Elisabeth Gille, la sorella, già gravemente ammalata, stava scrivendo
Le Mirador, splendida "biografia immaginaria" di colei che non aveva avuto
il tempo di conoscere, giacché era solo una bambina di cinque anni quando i
nazisti le uccisero la madre.
Scarica