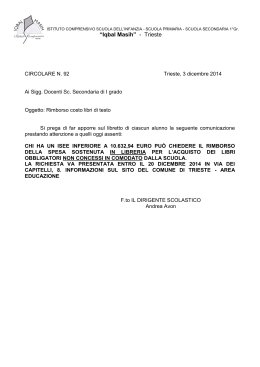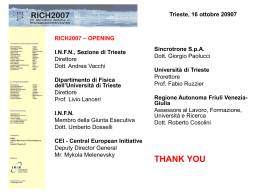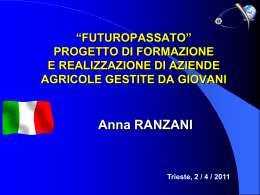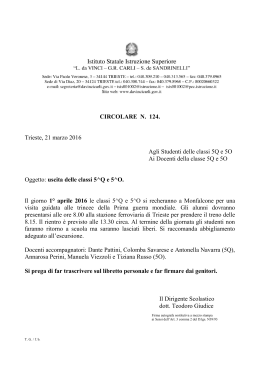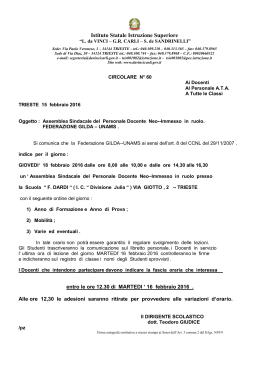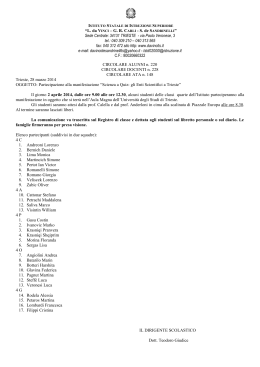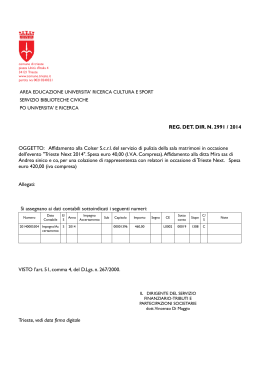1 COORDINAMENTO ADRIATICO 4 C A ANNO VII OTTOBRE-DICEMBRE 2004 TRIMESTRALE DI CULTURA E INFORMAZIONE Al Qaeda e le ramificazioni balcaniche N on è certo una rivelazione che nella lunga crisi balcanica, dal 1991 fino ad oggi, i volontari islamici abbiano svolto un ruolo importante: in Bosnia, nel Kossovo, nella ex-Macedonia iugoslava. Niente da dire, naturalmente, quando hanno difeso con le loro formazioni militari la giovane indipendenza bosniaca. La comunità internazionale li ha appoggiati e incoraggiati. Erano in qualche modo o potevano sembrare - nel filone romantico del volontarismo ottocentesco o delle resistenze anti-naziste e anti-fasciste. O, più realisticamente, della stessa funzionalità dei “contras” nicaraguegni. Anche nel Kossovo si sa che le forze di liberazione albanesi avevano nelle loro file confratelli musulmani venuti da ogni parte del mondo. Anche qui nulla da eccepire. Venivano a dar man forte a chi lottava contro l’oppressione serba e comunista. Qualche problema si è cominciato a porre nella crisi della Repubblica di Skopije, visto che l’azione dei guerriglieri albanesi veniva a minare l’unico espe- REDAZIONE: via delle Belle Arti, 27/a - 40126 Bologna Aut. Trib. di Bologna n. 6880 del 20.01.99 DIRETTORE RESPONSABILE: Giuseppe de Vergottini Spedizione Abbonamento Postale Comma 20/C art. 2 Legge 662/96 Filiale di Bologna STAMPA “LO SCARABEO” via delle Belle Arti 27/a - Bologna rimento di convivenza inter-etnica e religiosa che si era riusciti ad instaurare nella ex-Federazione iugoslava. Mano a mano negli anni si è appurato che tra i valorosi volontari molti erano affiliati ad organizzazioni terroristiche sovra-nazionali di ispirazione integralista islamica. Oggi si sa che sia in Bosnia-Erzegovina che nelle altre zone della ex-Iugoslavia esistevano cellule di Al Qaeda collegate a Bin Laden. Fino a quando i servizi segreti italiani sono venuti a sapere, alla fine di agosto, che un commando di otto terroristi di questa organizzazione erano pronti ad operare sul territorio italiano, avendo come loro base una località della Bosnia, dove evidentemente aveva costituito una rete abbastanza estesa ed efficiente da potersi permettere di farne una base di partenza per imprese così pericolose. E in Bosnia-Erzegovina operano da anni i contingenti internazionali della NATO. E con il contributo italiano si ricostruisce il famoso ponte di Mostar, che dà il nome alla bella città sulla Narenta. Encomiabile impresa Sommario Al Qaeda e le ramificazioni balcaniche In visita da Ciampi il Presidente croato Mesic Verso l'Euroregione Adriatica Scomparso lo storico Arduino Agnelli Trieste 1954-2004. Il senso di una celebrazione Garanzie formali e discriminazioni sostanziali Medaglia d'oro ai Caduti triestini del novembre 1953 Al capezzale della cultura italiana in Dalmazia La questione di Trieste nella politica italiana: un Convegno di studi storici Contributo alla conoscenza della storia e della cultura dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia Una mostra di storia postale a Trieste Libri • Sandi Volk, Esuli a Trieste • M. Franzinelli,Guerra di spie 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 2 tanto più che a costruire quei ponti - come raccontava Ivo Andric - erano stati i “maestri romani” delle città dalmate. Dopo il massacro di Beslan del settembre scorso e l’attivismo spietato della guerriglia cecena, certamente legata ad Al Qaeda, queste ramificazioni balcaniche acquistano un aspetto abbastanza sinistro. Anche i Talebani del resto furono aiutati in Afganistan per decenni dai Paesi occidentali in funzione anti-sovietica. E continuano a godere di finanziamenti da Paesi della penisola arabica filo-occidentali culla spirituale ed economica del terrorismo wahabita, anche dopo il crollo del sistema comunista sovietico. Le contraddizioni di Washington nel Medio Oriente furono plateali all’epoca di Carter. Da un lato Khomeini veniva sostenuto per il suo aiuto ai Mujaiddin afgani. Dall’altro bisognava sfidarlo per il sequestro di ostaggi con blitz aeroportati, risoltisi in fiaschi solenni. In questi mesi lo studio degli archivi statunitensi consente anche di risalire addirittura al 1945, per spiegare la lunga alleanza tra gli USA e le corti saudite. Per taluni sarebbe stato un vistoso errore storico di Franklin Delano Roosevelt stipulare un patto segreto di cooperazione politica, economica e militare con Abdullaziz Ibn Saud il 14 febbraio 1945 a bordo dell’incrociatore “Quincy”, lungo il Canale di Suez. Tornava da Yalta il presidente americano, dove aveva stretto un altro patto con Stalin per consegnargli metà dell’Europa. Certo gli europei non hanno molte frecce all’arco per accusare di miopia le amministrazioni americane, vista la politica confusa post coloniale che tutti i nostri Paesi hanno condotto dal 1945 in poi in quell’area. Per comprensibili interessi economici l’Italia o la Spagna o la Grecia. Per nostalgia degli imperi perduti la Francia e la Gran Bretagna. Sempre e comunque per egoismi e rivalità nazionali. Questi problemi sono venuti al pettine con l’intervento di Bush Junior in Irak, che ha messo a nudo contraddizioni e complicità durate a lungo e illusioni che si sono rivelate perniciose per l’Occidente e per la pace mondiale. Sta di fatto che l’opinione pub- blica americana, i suoi storici e i suoi analisti, stanno affrontando con serietà gli aspetti multiformi del nuovo terrorismo integralista. E anche nella trascorsa campagna elettorale Kerry è tornato a ripetere gli errori di valutazione di precedenti amministrazioni democratiche, contestando a Bush l’innegabile coraggio di guardare la realtà in faccia, anche a costo di commettere errori sul piano dell’applicazione pratica della nuova dottrina della “guerra preventiva”. E l’Europa? Non si può dire che il suo impegno sia da poco. Il bombardamento dei media, che esaltano le difficoltà americane e le divergenze di vedute tra le due sponde dell’Atlantico, ci fa dimenticare che attualmente, volenti o nolenti, sia attraverso la UE che attraverso la NATO, i 25 Paesi della nuova Unione si sono assunti responsabilità politiche e militari non indifferenti. Ma a questo impegno ufficiale non corrisponde una presa di coscienza coerente verso le problematiche che collegano la lotta al terrorismo alla stabilizzazione dei Balcani. Le esitazioni sull’ingresso della Turchia nell’Unione e la continua presa di distanze di molti Paesi nei confronti di Israele rendono la posizione complessiva dei paesi della UE irriconducibile a qualsiasi disegno strategico unitario, di breve o di lungo respiro. Questa risposta frammentaria e frammentata alle urgenze che via via si pongono rivela una mancata identificazione dei pericoli da scongiurare e dei comuni interessi da difendere. E fa dubitare seriamente che interessi comuni esistano davvero. Il pacifismo delle piazze viene cavalcato da alcuni governi, come quello francese, al solo scopo di mettere ad ogni occasione bastoni fra le ruote della politica americana, all’inseguimento maniacale di una grandeur perduta. L’atteggiamento dispersivo dell’Europa e la mancanza di strategie coerenti di fronte alle nuove sfide appare il frutto di una confusione che prima che politica è filosofica e morale. L’Europa non sa quello che vuole. Spiro Vitali Il Bollettino è inviato senza alcun onere a 1.200 indirizzi ed in particolare alle Comunità degli italiani e alle Istituzioni culturali in Croazia e Slovenia. Chi ritiene di poter contribuire al suo finanziamento può utilizzare l’annesso bollettino oppure fare un versamento sul conto corrente postale n. 28853406 oppure fare un bonifico bancario sul c/c 07400051356S della Cassa di Risparmio in Bologna – sede centrale – Via Farini n. 22 – cod. ABI 06385 cod CAB 02401 cod CIN T intestati a Coordinamento Adriatico. A partire da questo numero Coordinamento Adriatico ha un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni e-mail: [email protected] 3 In visita da Ciampi il Presidente croato Mesic I l presidente croato Stipe Mesic è stato ricevuto al Quiri na-le dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. «Abbiamo parlato dell’iniziativa di porre fine alle questioni inerenti la prima e la seconda guerra mondiale e di mandare un messaggio di collaborazione tra Italia, Slovenia e Croazia» ha detto fra l’altro Mesic. Al termine dei colloqui al Quirinale, il presidente croato Mesic nel corso di una cerimonia ha conferito delle onorificenze a tre cittadini italiani: Adriano Cestrone, direttore dell’Ospedale universitario di Padova, il giornalista Rai Antonio Bevilacqua, e lo scrittore Enzo Bettiza, nativo di Spalato. Mesic ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano “Il Messaggero”, nel corso della quale ha sottolineato che la «Croazia è intenzionata ad entrare nella Nato e rimanere il fattore di stabilità nella regione. Noi vogliamo soddisfare le condizioni e raggiungere gli standard necessari per accedere all’Alleanza atlantica. Quando riusciremo nell’intento, l’ingresso sarà solo una formalità». Il presidente croato ha proseguito affermando che per la Croazia «non c’è differenza tra l’Unione europea e la Nato, entrambe si basano sugli stessi valori, sulla stessa visione di un Europa che unisce e non divide». Uno dei problemi principali negli sforzi di Zagabria di entrare nell’U E è rappresentato dalla lunga latitanza del generale Ante Gotovina, accusato di crimini di guerra contro la minoranza serba. « L’unica ec- cezione è rappresentata da Gotovina. Parecchie volte ho ribadito che il generale può professare la sua innocenza soltanto davanti ai giudici dell’Aja». Ma, a tutt’oggi, gli stessi servizi segreti croati affermano di non avere idea di dove possa essere nascosto l’ex generale. Rimaniamo in fiduciosa attesa che l’interessato voglia cortesemente informare… gli informatori. L’incontro del Presidente Ciampi con Mesic era stato preceduto da un colloquio del Presidente della Repubblica con il nuovo Ministro degli Esteri, Gianfranco Fini. Si deve presumere che tra i temi del colloquio sia entrata la problematica relativa ai beni degli esuli e alla tutela della minoranza italiana. Caduti per Trieste italiana Il Presidente Ciampi ha conferito Medaglie d’Oro al Merito Civile alla memoria Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito, su proposta del Ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu, la medaglia d’oro al Merito Civile ai sei Caduti negli scontri per Trieste italiana del novembre 1953. Questi i nomi e la motivazione: Piero Addobbati Antonio Zavadil Leonardo Manzi Erminio Bassa Saverio Montano Francesco Paglia «Animato da profonda passione e spirito patriottico partecipava ad una manifestazione per il ricongiungimento di Trieste al Territorio nazionale, perdendo la giovane vita in violenti scontri di piazza. Nobile esempio di elette virtù civiche e amor patrio, spinti sino all’estremo sacrificio Trieste 5-6 novembre 1953». 4 Verso l’Euroregione Adriatica M entre stenta a decollare l’Euroregione italiana del Nord-Est, nonostante l’impegno e la determinazione del Presidente della regione Friuli- Venezia Giulia Riccardo Illy, è giunta notizia della firma a Termoli, in novembre, del protocollo d’Intesa per la costituzione della Euroregione Adriatica. Si tratta di una realtà associativa fra ben 25 soggetti territoriali comprendente le sette regioni italiane che si affacciano sull’Adriatico, i tre comuni sloveni dell’Istria, sette contee croate, cinque regioni albanesi, un cantone bosniaco, una regione montenegrina e tre regioni della Grecia bagnate dal Mare Ionio. L’iniziativa è stata determinata dalla evidente necessità di coordinare la fitta rete di progetti transfrontalieri europei, nazionali e regionali ed in particolare la gestione dei finanziamenti dei programmi Interreg, III A, che ammontano a circa 100 milioni di Euro per il 2000- 2006 e dei Fondi che verranno stanziati successivamente. Come è noto, l’Unione europea ha assegnato da tempo un ruolo di partenariato sempre più rilevante alla regioni e alle comunità locali nella gestione dei programmi di sviluppo transfrontalieri e anche l’Italia ha recepito la necessità di un decentramento nella cooperazione internazionale. La legge n. 131 del 2003 ha infatti riconosciuto alle regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) la facoltà di provvedere direttamente all’attuazione e all’esecuzione di accordi internazionali ratificati, nelle materie di propria competenza legislativa, e di concludere con territori all’interno di altri Stati, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Se il progetto di Euroregione Adriatica, come sembra, avrà prossima attuazione, si tratterebbe della prima esperienza italiana in questo campo, sull’esempio delle numerose Euroregioni transfrontaliere realizzate in ambito europeo (la prima risale addirittura al 1958) che hanno contribuito allo sviluppo di aree di frontiera, un tempo considerate marginali, e alla integrazione delle popolazioni coinvolte, dapprima in ambito comunitario e successivamente ai confini esterni della UE. Dagli anni Novanta infatti sono state costituite Euroregioni ai confini orientali, in un processo gestito prevalentemente dalla Germania, che sono diventate veri e propri “laboratori di integrazione europea”, in vista dell’allargamento della Unione Europea a 25 membri, che si è attuato nella primavera del 2004. Per quanto riguarda l’Italia (che non ha Euroregioni ai suoi confini) già da tempo è in atto, sia in ambito statale che regionale, uno straordinario impegno di cooperazione per la stabilizzazione e lo sviluppo socioeconomico dei paesi dell’Adriatico orientale, che si è rafforzato in seguito all’Iniziativa Adriatico-Ionica del 2000 e alla Dichiarazione della Conferenza di Ancona del 2003; per questo motivo la Unione Euro- pea ha affidato alle regioni italiane, giovandosi dello Strumento di Prossimità approvato dalla Commissione Europea, un preciso ruolo di guida nel processo di cooperazione transfrontaliera per favorire l’integrazione, la crescita produttiva, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e la conservazione della cultura sulle due sponde dell’Adriatico. Ciò anche in vista di un ulteriore allargamento della Unione Europea a Sud Est, in un’area contraddistinta da tensioni latenti e profonde (tanto che ancora è richiesta la presenza di forze internazionali Nato e Onu) e in cui il processo di democratizzazione è insidiato da una criminalità internazionale aggressiva e dal pericolo di diffusione dell’integralismo islamico. Se la firma del Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Euroregione Adriatica (il cui Consiglio provvisorio è presieduto da Ivan Jakovcic, presidente della Giunta regionale istriana) va salutata con soddisfazione, non mancano tuttavia delle perplessità. Ci si chiede: che fine ha fatto il progetto della euroregione Alto Adriatica, già in avanzata fase di studio, che si varrebbe fra l’altro della lunga esperienza di rapporti transfrontalieri, iniziati fin dal tempo di Alpe Adria? Verrà affossato, perché già superato da questa macro-euroregione? E come si pensa di gestire un organismo complesso come la euroregione Adriatica che conta circa trenta milioni di persone, quando non si è mai fatto esperienza di realtà più piccole, sull’esempio delle euroregioni del continente europeo, nate con dimensioni molto più modeste? Ci si chiede inoltre se si riuscirà a superare il miope nazionalismo di certi Stati che stentano a muoversi nell’ottica della integrazione europea come dimostrano, ad esempio le difficoltà che incontrano Slovenia e Croazia nella definizione del loro confine marittimo, per la disputa di pochi chilometri di costa sul Golfo di Pirano. E, sempre in Adriatico, va sottolineata la politica di chiusura della Croazia che ha proclamato unilateralmente, in acque internazionali, nonostante i vertici europei lo sconsigliassero, una Zona di protezione ittico-ecologica, quando la tutela del mare non può che essere affidata a una gestione integrata dei paesi che si affacciano su questo bacino comune, dall’equilibrio delicatissimo. Non vi è dubbio comunque che tutte le iniziative di cooperazione fra le due sponde del mare vadano perseguite con determinazione, tenendo presente un ambizioso obiettivo, quello di trasformare l’Adriatico da frontiera avanzata dell’Europa verso i turbolenti Balcani, in un mare interno europeo, qual’era ai tempi della Serenissima, quando veniva denominato Golfo di Venezia. Liliana Martissa 5 Scomparso lo storico Arduino Agnelli Era tra i fondatori di “Coordinamento Adriatico” L o storico Arduino Agnelli è morto il 26 novembre scorso nella sua casa triestina. Nato il 18 maggio del 1932, si era laureato in Legge all’Università di Trieste, specializzato alla Fondazione Rockefeller, nel 1963 iniziò ad insegnare Storia delle dottrine politiche, ottenendo dapprima una cattedra all’Università di Udine e poi in quella di Trieste, nella quale è rimasto per tren’anni. Nel 1982 il Partito socialista lo candidò e Agnelli ottenne un buon riscontro di consensi, primo degli eletti. Per 40 giorni fu sindaco di Trieste, quindi senatore per due mandati. Le tematiche del confine orientale gli sono state molto care: fu presidente della Deputazione di storia patria della Venezia Giulia e attivo collaboratore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Due mesi fa l’Università di Trieste gli aveva dedicato un convegno. In quell’occasione, Arturo Colombo, dell’Università di Pavia, aveva ricordato come esistano studiosi che scandagliano per una vita solo un tema, chiusi a riccio in un ambito circoscritto di ricerca e altri che, come le volpi, «percorrono spazi e tempi diversi e più vasti, affrontano nuove questioni e tematiche con rinnovata curiosità». «È un uomo che ha spaziato in molti campi delle dottrine politiche e delle scienze storiche, e forse uno dei maggiori conoscitori della questione nazionale e del socialismo, con particolare riguardo per l’Europa centrorientale e mitteleuropea» ricorda lo storico Roberto Spazzali. «Attento interprete dello spirito triestino, era uomo certamente di grandi capacità di mediazione, al quale va riconosciuta la generosità e l’entusiasmo con cui sempre si tuffava in tutte le iniziative culturali più diverse, e anche - ricorda Spazzali - la capacità magnetica di attrarre il pubblico nelle sue sempre alte ricostruzioni storiche» (era autore di importanti studi sul concetto di Mitteleuropa e sull’idea di nazione nel pensiero del socialismo austriaco). Anche lo storico Raoul Pupo non nasconde l’emozione: «l’ho visto pochi giorni fa, era travolgente come al solito. Non ho parole». Nel novembre del 1999 aveva partecipato alla conferenzastampa convocata dall’A NVGD nella sala della Camera dei Deputati a commento della mostra «I Croati: cristianesimo, cultura e arte» che si apriva in quei giorni nei Musei Vaticani, della quale egli, con altri storici autorevoli, aveva stigmatizzato il tentativo di appropriazione e di ‘traduzione’ in croato dell’arte italiana in Istria e in Dalmazia. Con la scomparsa di Arduino Agnelli “Coordinamento Adriatico” perde uno dei suoi fondatori. Lo storico triestino fu infatti tra quel gruppo di studiosi e di dirigenti dell’esodo giuliano che nel 1993 fondarono il suo Bollettino e diedero vita alle sue ini- ziative, miranti da un lato a riportare a un livello scientifico nazionale e internazionale le vicende che avevano determinato l’esodo istriano, fiumano a dalmato nel secondo dopoguerra; dall’altro a sollecitare l’opinione pubblica italiana ad approfondire le tematiche dell’area europea sud-orientale e delle responsabilità politiche che il nostro Paese doveva assumersi di fronte alla crisi delle nuove guerre balcaniche. Fu più volte relatore nei convegni organizzati da “Coordinamento Adriatico” e dalle associazioni degli Esuli giulianodalmati a Bologna, Udine, Trieste, Roma. Profondo conoscitore di tutta la realtà dei Balcani non dimenticò, lui laico e mitteleuropeo, di dedicare la sua attenzione di studioso al mondo ortodosso e ai rapporti storici tra etnie nella Balcania meridionale: rumeni, bulgari, slavo-macedoni, greci, albanesi, serbi e montenegrini, portando così il suo contributo illuminato a un disegno di riconciliazione culturale, che andasse al di là delle contrapposizioni ideologiche, nazionalistiche e integraliste. Arduino Agnelli è stato una delle più alte espressioni della civiltà triestina e giuliana, fatta di patriottismo risorgimentale, di amore incondizionato per la libertà, di rispetto per l’identità dei popoli, di rifiuto di ogni forma di intolleranza. Giuseppe de Vergottini Lucio Toth 6 Trieste 1954-2004 Il senso di una celebrazione T ra il 26 ottobre e il 4 novembre 2004 la Repubblica Italiana ha voluto ricordare il ritorno del capoluogo giuliano all’Italia, a mezzo secolo di distanza da quei mesi che avevano mobilitato l’opinione pubblica nazionale, ma soprattutto le piazze di tutta la penisola. Cos’è rimasto di quelle fanfare, di quei bersaglieri con le piume al vento in mezzo alla pioggia e alla bora, di quei corazzieri a cavallo, che scortavano il primo Presidente repubblicano, Luigi Einaudi? Studenti di tutte le università, licei, magistrali e medie, geometri e periti che daranno all’Italia il boom economico di quegli anni, scendevano nelle piazze, da Messina a Torino, con gli operai e gli impiegati e le donne di casa, per reclamare la restituzione allo Stato nazionale di quel lembo della Venezia Giulia che il Maresciallo Tito non si era ancora ingoiato. I partiti dell’”arco costituzionale” lasciarono fare. Forse il governo del tempo fece qualcosa di più, oltre a schierare le nostre poche divisioni, già inquadrate nella NATO, sulla frontiera isontina. I sindacati diedero la libera uscita agli operai per partecipare alla manifestazioni. L’Italia era in festa in quell’autunno del ’54. Che ne è rimasto? Nel guardare i servizi della televisione in molte case si saranno arricciati i nasi e si sarà sorriso con aria di sufficienza nell’ascoltare le parole di Ciampi, di Fini, di Martino, e di Illy, del Sindaco di Trieste Dipiazza e del Presidente della Provincia Scoccimarro. “Stantìa retorica patriottarda!” si sarà mormorato, osservando il viso commosso dell’economista Carlo Azeglio Ciampi, custode delle radici storiche della nazione - pardon - del “paese”. Che siano gli economisti i migliori presidenti della Repubblica? Ma in altre case di italiani si è rimasti ad ascoltare. Ci sono molte famiglie che hanno figli e padri in Marina, nell’Esercito, nella Polizia, nei Carabinieri. Molte famiglie hanno avuto giovani, e meno giovani, impegnati a Nassirya e in Kosovo, in Afganistan e in Bosnia. Altri lottano da anni contro la criminalità organizzata e quella comune. E altre famiglie ancora ricordano nonni e parenti, madri e sorelle, morti in una guerra ormai lontana di oltre cinquant’anni fa. Sono rimasti ad ascoltare. Per sapere, chi non aveva mai saputo niente di Trieste e dell’Istria, dal silenzio ostinato dei libri di scuola. Per ricordare con commozione chi queste cose le sapeva ed aveva sete di sentirsele dire da chi rappresenta la Nazione e lo Stato. Per capire la storia che ci ha fatto essere così come oggi siamo. Capire perché l’Italia rimase delusa dalla Grande Guerra, perché si affermò il fascismo e si persero vent’anni di sviluppo liberale e democratico. Perché ci si illuse di entrare alla pari in uno scontro di giganti come fu la Seconda guerra mondiale e quale è stata la vera posta in gioco in quel conflitto: tra democrazia liberale e totalitarismo. Perché questo scontro si protrasse nella guerra fredda e quali furono i prezzi che pagò l’Italia. Questi interrogativi non sono esercizi di memoria o erudizione storiografica. Ne è prova la passionalità che i temi del confine orientale e della “questione giulia- na” suscitano nei media e nel dibattito storico e politico di questi ultimi anni. Ci si è resi conto che nel mondo globalizzato del Duemila, con le sfide economiche dei grandi Paesi asiatici, il terrorismo fondamentalista islamico, la lotta alla povertà e alle malattie nel Continente africano, lo sviluppo dell’America latina fuori dagli schemi manichei tra dittature militari e rivoluzioni castriste, riflettere sulle vicende di Trieste, dell’Istria, delle Foibe e di Goli Otok non è un ozioso ritorno ad un passato che non passa, ma un’elaborazione necessaria della memoria collettiva della Nazione. In questi giorni cade il primo anniversario della strage di Nassirya. Si rifletterà sul ruolo dell’Italia nell’attuale crisi: un ruolo che appare più incisivo rispetto ai tempi della Guerra fredda, pur nei limiti di una realtà internazionale nella quale l’Italia, la sua capacità produttiva, la sua influenza politica, sono proporzionati al suo peso effettivo, al di là di ogni velleità di rivalsa storica, che sarebbe anacronistica e patetica, come spesso risulta essere la pretesa francese ad una grandeur perduta. Una Patria ritrovata non può che tornare utile a questa nuova presa di coscienza, che valga per tutti, a destra e a sinistra, per non deludere aspettative di Paesi alleati ed amici, che dagli USA alla Russia, al Medio Oriente, si aspettano da noi un’assunzione di responsabilità misurata ma non riduttiva. Tirarsi indietro, o “stare alla finestra”, non è più possibile, né per noi, né per l’Unione Europea. E da questa esigenza di chiarimento 7 sulla nostra identità e del ruolo internazionale del Paese, che nasce l’interesse per pagine dimenticate della storia nazionale. Ed anche per capire dentro di noi perché e su che cosa ci siamo tanto odiati e divisi in un secolo che è ormai chiuso e che, prima di essere archiviato, dev’essere interpretato con sincerità e vera correttezza politica, proprio per cancellare gli odii intestini in un mondo in cui non ha più alcun senso coltivarli. E poiché questi odi ancora persistono, e l’antitesi fascismo-antifascismo non è stata an- cora risolta, ingombrando la strada ai veri problemi del Paese, l’avere riportato alla luce le pagine della storia della Venezia Giulia e della Dalmazia nelle bufere del Novecento è un’opera meritoria che serve a scavare nelle radici della incomprensione reciproca che ha avvelenato la vita culturale e politica del paese. Che odii e rancori ci siano ancora, come miasmi che vagano nelle coscienze, lo prova la polemica, un po’ sconcia, sulla concessione delle medaglie d’oro ai sei morti dell’ottobre 1953 da parte del Presidente Ciampi. “Provocatori fascisti!” Ci risiamo! E dire che il padre di uno dei caduti era reduce dai lager tedeschi, per il suo antifascismo e la sua fede democratica. Ancora non si vuol capire che cos’era la passione italiana dei triestini e dei giuliani. Due dei morti venivano da famiglie di profughi da Fiume e da Zara. “Peggio! - risponderanno Fascisti di frontiera allora!” Ma la polemica è il sale della democrazia. E l’aceto della cattiva coscienza. Lucio Toth Garanzie formali e discriminazioni sostanziali Continua il processo di assimilazione in Slovenia. L ’ultima preoccupante vicenda riguarda la sospensione da parte della Corte costituzionale di Lubiana delle norme di legge sulla tutela dei consumatori in merito all’uso delle lingue minoritarie garantite dalla costituzione, l’italiano e l’ungherese. Il tutto nasceva dalla istanza di una azienda petrolchimica di Isola che lamentava che il rispetto del bilinguismo nei rapporti interni avrebbe pregiudicato la efficienza aziendale. Di qui l’esigenza di semplificazione utilizzando unicamente lo sloveno e il ricorso al momento accolto dalla Corte. Nonostante l’avvenuta inclusione nella Unione Europea e nel Consiglio d’Europa in Slovenia continua indisturbata la politica di assimilazione della minoranza italiana nei comuni costieri. In pratica l’esigenza economica della impresa ha avuto il sopravvento su un diritto fondamentale quale quello all’uso della lingua per i dipendenti di nazionalità italiana, garantito da un articolo della locale costituzione, dalla legge sull’uso pubblico della lingua, dagli statuti comunali del litorale, dagli strumenti internazionali ratificati dalla Slovenia e, in particolare, dalla antica normativa in tema di diritti delle minoranze prevista dallo Statuto speciale annesso al memorandum del 1954, fatta salva dall’articolo 8 del trattato di Osimo del 1975, trattato in cui la Slovenia nel 1992 ha dichiarato di subentrare alla antica repubblica federativa. La svista della Corte costituzionale slovena è dun- que macroscopica e di essa non sembra essersi accorto il Governo di Roma. Se ne sono accorti invece i rappresentanti delle locali comunità italiane che hanno stilato documenti di protesta e hanno inserito l’episodio nel quadro di un processo evidente di snazionalizzazione della attuale minoranza che passa attraverso l’annullamento progressivo del bilinguismo visivo, i tagli ai finanziamenti, la riduzione dei programmi televisivi minoritari. La gravità della situazione sembra avere colpito l’ombudsman (difensore civico) sloveno che si sarebbe impegnato a seguire la vicenda avendo constatato la fondatezza delle lagnanze degli esponenti italiani. In questo quadro una schiarita viene dal testo dell’accordo di coalizione fra i partiti della recente maggioranza di governo che prevede nuovi contatti con la minoranza italiana e ungherese al fine di assicurare il rispetto delle norme costituzionali e degli strumenti internazionali sulla tutela dei diritti minoritari. Espressamente si assume un impegno contro la assimilazione in atto, fenomeno che ha assunto proporzioni drammatiche che non potevano essere ignorate anche da partiti che in passato non si sono certo dimostrati benevoli verso la comunità italiana. Il documento ha al momento valore programmatico e dovrà essere specificato e attuato nei prossimi mesi. Il deputato italiano al parlamento di Lubiana Battelli ne ha giustamente sottolineato l’importanza. 8 Medaglia d’oro ai Caduti triestini del novembre 1953 È stata consegnata dal ministro Gasparri ai famigliari durante la cerimonia in Piazza Unità T rieste. La medaglia d’oro al valor civile alla memoria è stata conferita dal Presidente della Repubblica Ciampi ai sei Caduti per Trieste italiana negli scontri del novembre 1953. È stata consegnata ai famigliari delle vittime il 26 ottobre durante la cerimonia per il cinquantennale del ritorno della città all’Italia, in piazza Unità, dal ministro delle Telecomunicazioni Maurizio Gasparri. Pietro Addobbati, Erminio Bassa, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Francesco Paglia e Antonio Zavadil, sono stati definiti ultimi martiri del Risorgimento italiano. La notizia della decisione da parte del Capo dello Stato è stata annunciata ai giornalisti dal deputato di Alleanza nazionale, Roberto Menia. «Il conferimento della medaglia d’oro - ha commentato Menia - è il simbolo di un forte sentimento di italianità che ritorna in questo millennio caratterizzato dall’unificazione europea». Nella domanda di conferimento delle medaglie il Presidente della Lega Nazionale, Sardos Albertini, ha parlato dei «sei cittadini che il 5 e il 6 novembre 1953 caddero sotto il piombo straniero mentre manifestavano per il ricongiungimento di Trieste alla madrepatria italiana. Rappresen- tavano nel modo più completo la realtà triestina sia dal punto di vista anagrafico (dai 15 anni di Addobbati ai 65 di Zavadil) che da un punto di vista culturale e sociale (erano studenti, universitari, operai e impiegati). Erano accomunati dalla convinzione che l’identità di Trieste era in primo luogo italiana e che l’Italia doveva ritornare nella città di San Giusto.» Alla richiesta si erano subito associati il deputato della Margherita Ettore Rosato, Roberto Damiani del gruppo Misto e Alessandro Maran dei Ds. Nel suo intervento ha detto fra l’altro il ministro per le Comunicazioni Maurizio Gasparri: «Per cinquant’anni una storiografia distratta ha tentato, ingenerosamente, di sottrarre alla coscienza fatti tragici ed episodi esaltanti che appartengono alle pagine più care ed illustri della storia nazionale. Per fortuna il lavoro di Enti e associazioni culturali e politiche hanno permesso di conservare vivo l’esempio di chi alla Patria ha sacrificato la vita. Così Pierino Addobbati, di soli 15 anni, Antonio Zavaldin, entrambi caduti nel novembre del 1953 davanti alla Chiesa di Sant’Antonio Nuovo nel corso delle manifestazioni per il ricongiungimento della città giuliana all’Italia, Erminio Bassa, Save- rio Montano, Leonardo Manzi e Francesco Paglia, colpiti a morte il giorno successivo, rivivono nel ricordo degli italiani. La sensibilità del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha voluto conferire, alla memoria di questi eroi, la medaglia d’oro al merito. È un atto di grande rilevanza sociale e culturale, che esalta gli ideali di Patria e di unità nazionale, per i quali molti giovani hanno dato la vita. Ma è anche un momento di celebrazione e di raccoglimento, perché eventi tragici di quella portata possano costituire un incitamento alla concordia, alimentata sempre dal sentimento della Patria comune. Dal racconto dei superstiti, si è appreso che al loro ingresso a Trieste, i Bersaglieri ebbero paura che malintenzionati potessero provocare uno scontro. La pioggia e il vento forte di quel giorno non facevano distinguere le luci che si avvistavano in lontananza. In realtà non c’erano nemici a Trieste. Quelle luci provenivano dalla folla di italiani che, alle tre del mattino, andava incontro ai loro soldati per stringerli in un abbraccio fraterno. Oggi vogliamo rinnovare quel momento di unità e gioia incontenibile, nel segno della pace e del ricordo». 9 Al capezzale della cultura italiana in Dalmazia R ecentemente è apparso nella rubrica “Temi del giorno” del quotidiano di Spalato, Slobodna Dalmacija, l’articolo di un professore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università cittadina, accademico, ex ministro ed ex ambasciatore della Croazia a Roma, che tra le altre cose riferiva testualmente: “Alla cerimonia a Senigallia è arrivato galoppando, anche Mladen Culic Dalbello, presidente della Comunità degli Italiani di Spalato, come ha riportato il giornale Slobodna Dalmacija. Senza dubbio estasiato, ebbro di gioia, ha consegnato in dono a Fini il quadro di Spalato. A tale buffonata all’italiana per stupenda meraviglia, nessuno della stanca Croazia ha reagito. Tace anche l’Italia democratica”. Non volendo alimentare con lui una polemica di per sé inutile, dirò soltanto che i soci della Comunità italiana di Spalato mi hanno pregato di consegnare al Vice Presidente del Consiglio italiano, una riproduzione fotografica della sede della Comunità e non un quadro raffigurante Spalato come se fosse la caricatura della consegna delle chiavi cittadine al nemico “colonizzatore”, una proditoria vendita, come insinua maliziosamente il nostro libellista, che bolla l’atto come sovversivo. Al convegno è stata anche inviata e letta una lettera di saluto del Presidente della Comunità degli italiani di Zara (Zadar), rappresentata fisicamente da alcuni suoi componenti. L’onoreficenza poi che gli esuli dalmati hanno voluto conce- dere all’on. Fini consisteva in effetti in una medaglietta, raffigurante il letterato dalmata Niccolò Tommaseo. La stessa medaglietta che avevano consegnato, come ricordo, a Spalato all’ex Console d’Italia Marcello Apicella. Venti giorni dopo, da Senigallia, città che vide i natali di Papa Pio IX, il sottoscritto Presidente con i soci della Comunità, è giunto sempre “galoppando”, come usa dire il nostro giornalista, a Sotto il Monte, dove nacque il Papa Buono, grazie all’eccellente organizzazione del sig. Fabrizio Somma dell’Università Popolare di Trieste. Animati da spirito di fratellanza tra i popoli, abbiamo pregato nella chiesa in cui è stato battezzato Giovanni XXIII, che amò con tanto ardore anche i Croati come tutti i Papi, affinchè illumini le menti di alcuni opinionisti che mestano nel torbido e che sono pericolosi per la gente benintenzionata. Però è triste e preoccupante, che nessuno della componente ufficiale dell’Unione Italiana della Croazia non abbia reagito e fatto luce sull’articolaccio sobillatore di cui sopra, che ha avuto fra gli altri come bersaglio, il Presidente della Comunità Italiana di Spalato. A questo punto sorgono alcune domande fondamentali: a quale neoirredentismo si riferisce l’articolo, e in cosa esso consisterebbe? In attentati, in congiure…? Viceversa, i Croati trovano inserimento nel tessuto socio-economico in Italia, dove sorgono liberamente nuove Comunità croate, vedi per esempio Milano, ecc. Per contro, la presenza degli Italiani in Dalmazia, dal punto di vista numerico, è quasi nulla ed è ridotta ad un semplice fenomeno folkloristico e negli ultimi cento anni, è in costante diminuzione. Questo è evidente a chiunque, ma pare non a un accademico. Agitare continuamente lo spauracchio del neoirredentismo, in un’epoca in cui l’auspicato ingresso della Croazia nell’UE dovrebbe abbattere i vincoli delle barriere e promuovere la fratellanza tra i popoli, è disonesto e molto pericoloso. Di fronte a questi continui strali, finalizzati all’eliminazione totale della componente italiana in questa area, sarebbe doveroso attendersi dagli organi preposti dell’UI, finanziati dallo stato italiano, una presa di posizione finalmente categorica. La cultura e la lingua italiana in Dalmazia non hanno snazionalizzato i Croati, e non li potranno mai snazionalizzare, come ci insegna la storia. Al contrario, hanno contribuito, in buona parte, alla formazione e alla nascita della coscienza nazionale croata, come il politico spalatino A. Trumbic, a suo tempo ha rilevato. Allora, come interpretare le affermazioni di Rudolf? Come un’intimidazine e un tentativo di ridicolizzare chi, come me, cerca di difendere la presenza culturale italiana a Spalato? Il Presidente della Comunità Italiana di Spalato Mladen Culic Dalbello Tratto da “La Voce del Popolo” del 18 novembre 2004 10 La questione di Trieste nella politica italiana un Convegno di studi storici U n Convegno di studi storici a margine delle manifestazioni per il ricongiungimento di Trieste all’Italia si è svolto il 3 novembre nell’auditorium del Rivoltella. “La questione di Trieste nella politica italiana”, questo il titolo dell’incontro che ha raccolto gli interventi di una decina di storici coordinati da Arduino Agnelli (recentemente scomparso – n.d.r.). In esame gli anni antecedenti alla Grande Guerra e il ritorno di Trieste all’Italia. Che cosa ha significato Trieste per l’Italia, e che cosa ha significato l’Italia per Trieste?, questa la sostanza della riflessione storiografica che ha preso le mosse dal patto di Londra del 26 aprile 1915, “primo riconoscimento internazionale del diritto dell’Italia ad acquisire la sovranità di Trieste”, come ha spiegato Carlo Ghisalberti, dell’Università La Sapienza di Roma. Nessuno, ha ricordato Ghisalberti, immaginava il tracollo dell’’impero asburgico alla fine della guerra né la liberazione delle nazionalità che esso egemonizzava. Quella conclusa con la prima Redenzione fu dunque una guerra – l’ultima del Risorgimento – iniziando la quale non si tenne conto della complessità degli scenari e del sorgere di uno Stato per gli slavi del Sud “che avrebbe comportato per il paese forti difficoltà sul confine orientale”, come ha osserva- to Ester Capuzzo. Anche per questo, ha detto ancora la docente, “il 3 novembre del 1918 avrebbe segnato per Trieste un’irreversibile frattura non soltanto geopolitica nel senso della sua plurisecolare appartenenza asburgica, ma per l’essenza stessa della città che, non più ‘crogiolo’, si avviava a vivere il ruolo di città di frontiera nell’italianizzazione della sua ‘normalità’”. “Normalità” non innocua soprattutto con l’avvento “della burocrazia dell’Italia liberale” prima e del fascismo poi, come ha sottolineato lo storico Almerigo Apollonio. In particolare il fascismo “fagocitò tutte le istituzioni irredentiste ”, e diede alla città “l’impressione di perdere una parte di se stessa” quando impose le leggi razziali. “La comunità nazionale – ha aggiunto Apollonio – in realtà si ricompattò solo dopo il 12 giugno 1945” data più volte ricordata durante il convegno quale momento di ritrovata italianità. Aldo Ricci, dell’Archivio centrale dello Stato, citando i dossier del gabinetto della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno, ha dimostrato quanto i governi italiani post-bellici fossero praticamente sordi alle grida di dolore che arrivavano da Trieste subito dopo il 1° maggio 1945. Di fronte alla “massa di notizie” riversata dalle più diverse fonti il governo italiano o non capiva o faceva finta di non capire, “sia per la debolezza intrinseca dell’esecutivo sia per la condizione di subalternità politica e pscicologica rispetto agli Alleati”. Del resto, come ha detto Raoul Pupo, quella che va dal 1943 al 1947 “è la storia dell’assenza dell’Italia (intesa come soggetto) per Trieste”, nonostante i tentativi (durante il governo Pella), di “alzare la voce e di puntare onorevolmente i piedi”, secondo l’espressione usata da Paolo Nello dell’Università di Pisa nel suo intervento. Le relazioni di Marina Cattaruzza (“Tra Yalta e Potsdam. Alle origini della questione di Trieste”) e di Giorgio Petracchi (“Memorie di confine. Trieste, il Friuli e la Venezia Giulia dal 1945 al 1947”) hanno chiuso la prima giornata di riflessioni sulla difficile “questione di Trieste”. Escono dagli archivi episodi sinora sconosciuti, come quello rievocato da Petracchi: nel marzo 1946 – ha rivelato – per arginare un’eventuale invasione jugoslava gli Alleati idearono il “Piano Foggot”, con l’impiego di due divisioni costituite interamente da soldati polacchi già prigionieri nei campi di concentramento sovietici. L’iniziativa adirò Mosca che protestò all’Onu. p.c.h. Tratto da “Difesa Adriatica”, anno X, n. 10, novembre 2004 11 Contributo alla conoscenza della storia e della cultura dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia N el 2000, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Udine – pubblicava un volume, a cura di Silvio Cattalini, destinato agli insegnanti delle scuole medie superiori, che conteneva gli atti di una serie di conferenze ad alto livello scientifico, intitolato “Contributo alla conoscenza della storia e della cultura dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”. Il libro ha avuto, e continua ad avere, notevole fortuna ed è stato utilizzato come omaggio qualificato a giornalisti, storici e personalità politiche, nonché come strumento di lavoro per giovani e studenti che si accostano alle nostre vicende. La pubblicazione tratta diverse discipline: geografia, geopolitica, storia del Risorgimento e dell’Irredentismo, Prima e Seconda guerra mondiale, la storia di Fiume, le Foibe e il dramma dell’Esodo, il trattato di pace del 1947 e gli accordi internazionali successivi, le comunità italiane ancora sul luogo, l’arte e gli artisti delle nostre terre: argomenti finora spesso ignorati o trascurati dai programmi scolastici. Fra i relatori di queste lezioni ci sono stati Lago, Battisti, Agnelli, Salimbeni, Cortellazzo, Sema, Spazzali, Fiorentin, Tremul, Radossi, Ambrosi, Selva, Mattuglia, Redivo, Dassovich, Toth. Per facilitare l’apprendimento di tutte queste nozioni, il Comitato di Udine ha programmato, con il contributo della Legge 72/2001, una serie di filmati, realizzati dalla ditta VIDEO-E di Gorizia, attraverso la finzione narrativa di un viaggio immaginario compiuto dalla figlia di un esule, per raccontare in modo veloce e piacevole e senza alcuna pretesa di esaustività, i contenuti delle lezioni sopraccitate, in modo da suscitare interesse nei giovani e nei meno giovani per successivi approfondimenti. Incuriosita dai ricordi evocati dal padre, la giovane protagonista compie un percorso di scoperta, presentato in cinque videovolumi (ciascuno della durata di circa quaranta minuti), girati direttamente sui luoghi considerati da una troupe specializzata che, partendo da Pola, fa tappa a Capodistria, Fiume, Zara e, quindi Sebenico, Traù, Salona e Spalato, per arrivare alla bellissima e inespugnabile Ragusa. Presentare quello che resta dei territori di lingua e cultura veneta nel bacino adriatico risponde all’esigenza di offrire un quadro rigoroso e documentato di vicende che hanno avuto un peso determinante nella storia contemporanea. Senza scendere in dettagli o dare interpretazioni, la presentazione dei fatti e luoghi consentirà a giovani e meno giovani di avvicinarsi a una sezione di storia regionale importante, finora immeritatamente tralasciata dai programmi ufficiali. Questo percorso di scoperta della giovane protagonista viene presentato in cinque videovolumi. Il primo è dedicato a Pola e all’Istria romana, includendo anche Parenzo e il contado; il secondo è dedicato a Capodistria e all’Istria in epoca veneta, comprendente le saline di Pirano e il contado; il terzo a Fiume, per l’importanza del suo porto e i suoi rapporti con l’Austria e l’Ungheria; il quarto a Zara, per la sua storia e importanza durante il periodo bizantino e veneziano e il quinto al resto della Dalmazia per il suo patrimonio artistico e per i suoi numerosi uomini illustri. Il tutto in un quadro rigoroso e documentato, in cui il carattere didattico delle immagini delle città, delle opere d’arte, dei paesaggi, si accompagna alla storia remota e recente di queste nostre contrade. I cinque videovolumi portano i titoli: Pola – Capodistria – Fiume – Zara – Da Sebenico a Ragusa. Sono disponibili nelle esecuzioni sia in VHS (videocassette) che in DVD. L’opera completa è contenuta in un raccoglitore che comprende i cinque videovolumi e un libretto illustrativo, che sintetizza i testi adattati. Quest’opera è un utile strumento per la divulgazione della storia e cultura giuliano-dalmata, propedeutico per ulteriori approfondimenti della materia, che il Comitato Provinciale di Udine dell’A.N.V.G.D. mette a disposizione della struttura associativa, degli Enti culturali pubblici e privati e dei singoli cittadini. Il comitato offre ogni collaborazione perché questo programma possa trovare ampia divulgazione sull’intero territorio nazionale, in particolare in prossimità della Giornata della Memoria del 10 febbraio prossimo. Per ulteriori informazioni e ordinazioni rivolgersi al Comitato di Udine – Vicolo Sillio n. 5 – tel e fax sempre aperti 0432-506203, L’ufficio è aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 16,30 alle 18,30. E’ eventualmente disponibile l’indirizzo dell’abitazione e il numero telefonico personale dell’ing. Cattalini: via Teobaldo Ciconi n. 26 – tel. 0432/ 501682. 12 Una mostra di storia postale a Trieste P ioveva, quella grigia mattina del 26 ottobre 1954. Ma per i triestini la giornata non poteva essere più radiosa. Accompagnati dalle note del “flic-floc”, la loro fanfara, entravano in città i bersaglieri italiani, e la città ritornava alla madrepatria per la seconda volta in cinquant’anni, dopo nove anni di diverse occupazioni straniere. La prima volta era successo il 3 novembre 1918, quando l’incrociatore italiano “Audace” era attraccato a Trieste al molo San Carlo (che venne ribattezzato Audace) e il generale Petitti di Roreto, sbarcando, aveva battuto il piede destro a terra dicendo “In nome della Maestà del Re prendo possesso della città di Trieste”. C’era voluto un alto tributo di sangue per quel risultato, anche dei molti giuliani, dalmati, trentini che si erano arruolati volontari nell’esercito italiano. Tra i volontari vi era anche mio nonno, Bruno Crevato-Selvaggi, nato a Buie d’Istria, suddito austriaco, che combatté come tenente nell’esercito italiano. Ci volle ancora qualche lotta, ma nel 1924 erano entrate a far parte del regno d’Italia Trieste, Gorizia, l’Istria, Fiume, e in Dalmazia la sola città di Zara. Sappiamo bene, e non è il caso qui di rievocare, le vicende che portarono all’amarissima conclusione dell’ultima guerra: la perdita della Dalmazia, dell’Istria, dei retroterra triestino e goriziano; Trieste occupata dallo straniero dal 1943 al 1954. Ma quel piovoso 26 ottobre l’incubo era finito. Cinquant’anni dopo, il 26 ottobre 2004, il cielo era grigio ma non pioveva, e la città era tutta imbandierata. La ricorrenza è stata festeggiata con una gran- de cerimonia in piazza Unità, con i discorsi ufficiali e con la banda delle Forze Armate. Decorati i congiunti dei caduti del 1953, quando gli inglesi spararono sulla folla che reclamava l’Italia. E c’è stato un altro avvenimento ancora, che si è inserito nell’ampio programma delle celebrazioni: le Poste Italiane hanno emesso un francobollo commemorativo dell’evento. Un bel valore, che rappresenta piazza Unità con il Tricolore e l’alabardato gonfalone triestino. E non è finita: nel locale Museo postale e Telegrafico della Mitteleuropa, che si trova nel palazzo postale cittadino ed esiste dal 1997, il 26 ottobre si è inaugurata una grande mostra di storia della posta, aperta sino al 6 gennaio, che ha raccontato le vicende delle regioni orientali d’Italia dal 1918 (con un prologo del periodo precedente) al 1954 da un punto di vista un po’ particolare, sicuramente inusuale: la posta. Una struttura oggi magari poco usata per le comunicazioni personali, abituati ormai come siamo a telefoni, fax, sms e posta elettronica, ma che sino a non molto tempo fa aveva un suo preciso ruolo ed una centralità sociale ben diversa da quella odierna. Capace, quindi, di raccontare un mondo ed una società attraverso i suoi usi, i suoi simboli, modelli, francobolli. Francobolli, certo. Per esempio quelli già italiani che i tedeschi sovrastamparono “Deutsche Besetzung Zara”, o gli iugoslavi “Trieste-Trst” o “Istra” o “Fiume-Rijeka”; o gli anglostatunitensi “Amg-Vg” (Allied Military Government-Venezia Giulia) e poi “Amg-Ftt” (Allied Military Government-Free Ter- Ci sarà un asilo italiano a Zara? Dopo anni di sforzi la comunità degli italiani di Zara ha ottenuto una disponibilità di massima da parte della amministrazione comunale a aprire un asilo per i bambini italiani. Sembrerebbe naturale che in un paese civile i genitori possano soddisfare il desiderio di mandare i propri figli in una istituzione formativa in cui si usa la propria lingua. Ma evidentemente non è così anche in un paese come la Croazia che ritiene di avere le credenziali giuste per accedere alla Unione Europea. Nonostante le garanzie formali della costituzione e della legislazione e i numerosi strumenti internazionali ratificati ci sono ancora paesi che rendono difficile la vita a una minoranza. Specie se questa è ridotta al lumicino come nel caso di quella italiana di Zara dopo la distruzione e l’esodo. Per avere un’idea di quale sia lo stato d’animo della minoranza italiana di Zara basta ricordare il recente incendio doloso della sede realizzato con sforzi umani e finanziari inimmaginabili. Comunque è già un successo che gli italiani di Zara non si siano fatti intimorire e abbiano ancora la forza di dichiararsi tali. Va quindi dato un riconoscimento al loro impegno e va apprezzato lo sforzo della Unione italiana, dell’UPT e del Console italiano a Spalato Marco Nobili che si impegna assiduamente per assistere gli italiani di Dalmazia. 13 ritory Triest). Oppure quelli che nella zona B dell’Amg-Vg gli iugoslavi emisero per l’Istria ed il litorale sloveno (cioè la parte dell’Istria di pertinenza della Slovenia): le diciture erano in croato, sloveno e italiano, e quelle italiane dicevano “Littorale sloveno”. Giovannino Guareschi fece osservare che, più che una “t” in più, c’era uno “sloveno” in più. Ma non solo francobolli: lettere, ricevute, moduli, sistemi di instradamento, normative postali, c’è tutto un mondo che ci racconta quelle vicende, di cui è stato preciso ed attento testimone. Filatelicamente (che, conviene ripetere, non è l’unica né la principale ottica con cui guardare la mostra) il pezzo più succulento è stato un inedito, esposto per la prima volta e la cui esistenza finora non era nota ai più; proviene da quello sterminato scrigno di tesori che è il museo postale italiano di Roma. Dal 1947 al 1954, per l’uso nella zona A del Territorio Libero di Trieste i francobolli repubblicani venivano sovrastampati AMG-FTT, e così fu fatto per tutti, compreso il francobollo per le onoranze a Collodi, l’autore di Pinocchio. Ma l’uscita di questo francobollo era programmata in Italia proprio per il 26 ottobre 1954, e allora si decise naturalmente di distribuire a Trieste il francobollo italiano non sovrastampato. La tiratura sovrastampata venne ritirata e distrutta. Ma, prima della distruzione, tre fogli erano stati inviati al museo postale, dove ancora si trovano. Uno di questi, preziosissimo, ha fatto bella mostra di sé alla mostra. La mostra di Trieste ha ripercorso le vicende con i pezzi postali in 15 quadri cronologici, secondo questo percorso: 1. Uno sguardo retrospettivo: Venezia Giulia e Dalmazia austriache - XVIII secolo - 1918 2. Venezia Giulia e Dalmazia italiane - 1918-1925 3. La posta a Trieste tra le due guerre - 1921-1941 4. La posta in guerra in Venezia Giulia e Dalmazia - 12 aprile 1941 - 8 settembre 1943 5. La posta in guerra in Venezia Giulia e Dalmazia - 9 settembre 1943 - 30 aprile 1945 6. L’occupazione jugoslava di Trieste - 1° maggio - 11 giugno 1945 7. L’occupazione alleata di Trieste e della Venezia Giulia - 12 giugno 1945 - 21 settembre 1945 8 e 9. L’occupazione alleata di Trieste e della Venezia Giulia - 22 settembre 1945 - 15 settembre 1947 10.L’occupazione iugoslava della Venezia Giulia e della Dalmazia - Maggio 1945- 15 settembre 1947 11., 12., 13. Il Territorio Libero di Trieste zona A 16 settembre 1947 - 26 ottobre 1954 14.Il Territorio Libero di Trieste zona B - 16 settembre 1947 - 26 ottobre 1954 15.La fine del Territorio Libero di Trieste - 19541955. Seguivano alcuni quadri tematici specificatamente dedicati a temi filatelici. Il titolo era “1954 il servizio postale ritorna all’Ita- lia - 1918-1954 pagine di storia triestina”. la cura scientifica è stata di Bruno Crevato-Selvaggi; quella organizzativa di Chiara Simon, curatrice del Museo postale e Telegrafico della Mitteleuropa; il progetto grafico e l’allestimento di Alessandro Agostosi. C’erano i patrocini del Ministero delle Comunicazioni, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Gruppo parlamentari amici della filatelia e della Federazione fra le Società Filateliche Italiane. All’inaugurazione della mostra, il 26 ottobre, era presente anche il ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri, sempre attento ai temi a noi più cari. È uscito anche un libro-catalogo, con lo stesso titolo; l’autore è Bruno Crevato-Selvaggi. Di grande formato, tutto a colori, è un volume di 240 pagine, del prezzo di 25 euro; l’editore è Poste Italiane. È il catalogo della mostra, ma è anche un volume autonomo sulla storia della posta e della filatelia ai confini orientali d’Italia dal 1918 al 1954 (con una premessa sul precedente periodo austriaco ed italiano), così peculiare nel panorama italiano. Possiamo ripetere un passo dell’introduzione: “L’idea di questa mostra è nata al museo postale triestino per celebrare dal nostro punto di vista d’appassionati di storia postale le felici giornate dell’ottobre 1954 che videro il ricongiungimento alla madrepatria del capoluogo giuliano, non dimenticando la tragica cessione di ampi lembi di territorio italiano, rivendicati alla nazione in perpetuità dalla storia, dalla geografia, dal diritto naturale delle genti, nonché dalle nostre armi e dal nostro popolo nel novembre 1918. Tema, quindi, che mi sta a cuore oltre che per i motivi per cui dovrebbe stare a cuore ad ogni italiano consapevole della propria storia e della propria stirpe, anche per i vincoli famigliari che mi legano in modo indissolubile alla terra istriana. Nella nuova Europa di oggi, deposte le armi, le idee devono avanzare e propagandarsi con la forza ideale dello spirito, della memoria e della cultura, e studiare, preservare, valorizzare ed illustrare la storia, anche grazie ad una esposizione così particolare come questa, è atto di pietas così come di cultura”. E quelle di chiusura: “Le emissioni di Trieste e della Venezia Giulia dal 1945, che per ragioni storiche, amministrative e culturali di assoluta evidenza fanno parte integrante della collezione filatelica d’Italia, hanno visto periodi di grande interesse dei filatelisti italiani alternati ad altri di completo disinteresse. Attualmente siamo in un periodo di disinteresse, anche se alcuni timidi segnali — non ultima la mostra allestita a Trieste dal 26 ottobre 2004 al 6 gennaio 2005 — lasciano intravvedere un prossimo rifiorire, che non ci si può non augurare. Più che per il bene della filatelia, per omaggio alla Patria”. Il volume è acquistabile presso gli “sportelli filatelici” di Poste Italiane, che si trovano nelle sedi di Filiale nei capoluoghi di provincia, oppure ordinandolo a Poste via Internet. Bruno Crevato-Selvaggi • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • Sandi Volk, Esuli a Trieste, Editore Kappa Vu, Udine 2004 La casa editrice Kappa Vu di Udine ha pubblicato recentemente un volume di Sandi Volk intitolato “Esuli a Trieste”. L’opera – come ci informa uno dei risvolti di copertina – si propone di dimostrare in che modo l’insediamento a Trieste e dintorni di molti esuli giuliano-dalmati sia stato promosso dallo Stato italiano per “bonificare nazionalmente” e “rafforzare l’italianità” di un territorio in cui larga parte della popolazione locale avrebbe in precedenza guardato all’Italia “con molta sfiducia”. L’Autore (nato a Trieste nel 1959, laureato presso la locale Università, attualmente anche in possesso di un “master e dottorato” dell’Università di Lubiana) aveva già dedicato al problema degli esuli istriani e dalmati “numerosi saggi e articoli in italiano e sloveno” ed altresì due altri libri in sloveno. Secondo Sandi Volk (op. cit., p. 42) “l’emigrazione dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia è stata (ed è) quasi quotidianamente presente sulla stampa e nella polemica politica delle zone del confine orientale d’Italia, per assumere negli ultimi anni un rilievo nazionale ed internazionale”. Ma – se- condo il medesimo Autore – la “emigrazione” surrichiamata sarebbe stata “solo una parte, seppure importante, di un’ampia serie di movimenti migratori che coinvolsero la Venezia Giulia negli anni seguenti alla fine della seconda guerra mondiale”; e in questa “ampia serie” rientrerebbe anche il “trasferimento in Jugoslavia di alcune migliaia di persone dal monfalconese”. Ancora in proposito – come due note a piè pagina – si fanno due rinvii rispettivamente ad un’opere di Nevenka Troha (“Preselitve”, edizione dell’anno 2000) e ad un’opera di Andrea Berrini (“Noi siamo la classe operaia. I duemila di Monfalcone”, edizione dell’anno 2004). La suaccennata pagina di Sandi Volk apparirebbe quindi scarsamente documentata, considerato anche che il medesimo Autore non inserisce nelle sue “Fonti e bibliografia” (op. cit., pp. 356-368) opere non meno importanti di quella di Andrea Berrini: ad es. “Goli Otok (…gulag di Tito)” di Giacomo Scotti edita a Trieste sin dal 1991, “Fra Stalin di Tito, cominformisti a Fiume 1948-1956” di Alfredo Bonelli edita ancora a Trieste ma nel 1994, “”La grande truffa” di Bruno Fontana edita a Cervignano nel 1995 a cura dell’autore Fontana, “Italiani a Fiume” edita nel 1996 a Fiume a cura della locale Comu- nità degli Italiani. Fra le suaccennate “opere non meno importanti” vorremmo inserire anche una recensione di Gabriele Polo, dedicata alla terza edizione della “Goli Otok (… gulag di Tito)” dello Scotti e pubblicata nelle pp. 34 e 35 dell’edizione del 30 aprile 2003 del quindicinale “Panorama” della Fiume d’oltreconfine: e questo soprattutto per evidenziare un aspetto della “geopolitica” assai poco preso in considerazione da Sandi Volk. Ecco quindi i cenni iniziali della parte conclusiva della summenzionata recensione di Gabriele Polo (dedicata principalmente alle persecuzioni titoiste del 1948 contro duemila “monfalconesi” ed altri italiani in precedenza “emigrati” in Jugoslavia). Una parte conclusiva questa ove anzitutto si giustifica in questi termini quella ricerca documentaria e quella denuncia: “… per rispetto a quella storia, alla vicenda di migliaia di militanti stritolati dalle leggi della geopolitica”. Tito – si afferma subito dopo – poteva avere “mille ragioni per opporsi a Stalin e cementare su quella rottura una nuova identità nazionale e un nuovo assetto statale (…), ma nel farlo (avrebbe sacrificato) la vita di migliaia dei “suoi”, affermando quella discriminazione che (intendeva) negare. In mostra a Trieste capolavori dell’Istria e del Quarnaro S’intitola “Restauro di capolavori dall’Istria e dal Quarnero: da Paolo Veneziano a Tiepolo” la mostra allestita al Museo Revoltella, grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con l’alto patronato del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le attività Culturali. L’esposizione mette in luce i risultati del “restauro dei capolavori” che allo scoppio della seconda guerra mondiale erano stati messi in salvo in varie città italiane e che ora sono stati riportati all’originale bellezza dopo un lungo lavoro sulle tele e gli arredi sacri. Le tappe che hanno portato alla realizzazione di questa esposizione, sono state illustrate in una conferenza stampa, dall’On. Prof. Vittorio Sgarbi, il 22 dicembre 2004. Attraverso la proiezione di diapositive sono state presentate le varie fasi del restauro che ha coinvolto diversi laboratori oltre a quelli di Trieste e Udine, quelli di Venezia e Roma. Tutto il lavoro svolto è documentato in apposito catalogo. • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • Infine secondo Gabriele Polo, “il nazionalismo jugoslavo (doveva servire) a combattere i nazionalismi croato e serbo, ma (riprodusse), verso gli “altri”, le stesse dinamiche etnocentriche. (La) battaglia contro lo stalinismo e il culto della personalità di Stalin (diede) vita a un nuovo autoritarismo e a un uovo culto della personalità”. La Jugoslavia perderà infine la scommessa della democrazia socialista anche “abbattendosi su quegli “stranieri” arrivati lì in nome della rivoluzione e della solidarietà internazionalista”. Mario Dassovich Mimmo Franzinelli, Guerra di Spie. I servizi segreti fascisti, nazisti e alleati. 1939-1943, Mondadori Editore, 2004 Mondadori ha recentemente pubblicato un volume di Mimmo Franzinelli intitolato “Guerra di spie. I servizi segreti fascisti, nazisti e alleati. 1939-1943”. Vi ritroviamo fra l’altro – oltre alla vicenda dei fratelli fiumani Egone e Amauri Zaccaria – un accenno ad un proiettarsi (per la Venezia Giulia) della “questione slava” in ambito spionistico. Anzitutto – secondo il Franzinelli – nel contesto ora accennato “l’attività degli informatori ha come retroterra un progetto di distacco delle regioni nordorientali dall’Italia ed è collegata – a seconda delle circostanze – con emissari delle democrazie occidentali, dell’irredentismo nazionalista o del movimento comunista slavo”. E così imputazioni di spionaggio e di terrorismo avrebbero colpito “molti membri dell’associazione clandestina TIGR – acronimo di Trieste, Istria, Gorizia e Fiume (in sloveno Rieka) – i cui adepti dall’aprile 1937 (col riavvicinamento tra Italia e Jugoslavia), trovano appoggio negli stati democratici europei minacciati dal nazifasci- smo” (cominciando così “a lavorare per i servizi d’informazione francesi e inglesi raccogliendo dati militari segreti con l’aiuto sia dei militanti della TIGR della Venezia Giulia sia di singoli sloveni che prestavano servizio nell’esercito italiano; in compenso ricevevano dall’Inghilterra armi, esplosivi e altro materiale bellico che portavano clandestinamente in Italia”). Per queste sue prime indicazioni l’Autore con una nota rinvia il lettore a due specifici contributi di Milica Kacin Wohinz, apparsi sulla rivista “Storia contemporanea in Friuli” rispettivamente nelle annate XVIII/1988 (n. 19, p. 63) e XX/ 1990 (n. 21, pp. 27-62). Più avanti il Franzinelli afferma che (con) lo scoppio della seconda guerra mondiale all’intensificazione dello spionaggio militare si accompagnano sabotaggi di infrastrutture ferroviarie e depositi di esplosivo”. E l’apparato controspionistico italiano avrebbe scoperto “nel marzo 1940 un gruppo nazional-rivoluzionario con base a Villa del Nervoso (Ilirska Bistrica), … tre mesi più tardi vengono catturati i componenti (di un) nucleo comunista triestino …” . Per queste sue ulteriori indicazioni l’Autore con una nota rinvia il lettore ad alcuni contributi rispettivamente di Tone Ferenc (Lubiana, Borec, 1977), di Joze Pirjevec (riv. “Qualestoria”, a. X/1982, pp. 7594), di Maria Verginella (Udine, Gaspari, 2003, pp. 103-142). Infine il Franzinelli si sofferma su alcuni episodi dell’inverno 194041, quando affluiscono “nella Venezia Giulia e in Istria migliaia di soldati”. E quando il governo della “Repubblica” (sic!, N.d.R.) di Jugoslavia “interpreta questi movimenti come preannuncio d’invasione e i servizi segreti cercano di raccogliere quante più informazioni possibili sulla dislocazione di uomini e sulle caratteristiche degli armamenti” (“le reti spionistiche si giovano della tradizionale simpatia di una parte della popolazione, disponibile a fornire notizie utili alla messa a punto di contromisure militari ….”). Gradualmente il cerchio del controspionaggio italiano si sarebbe stretto “su alcuni abitanti di Castel Jablanizza che, pur essendo disoccupati, dispongono di denari in abbondanza e si recano spesso in Jugoslavia”. E col 31 ottobre 1941 sarebbero scattati gli arresti ed il 23 ottobre 1942 si sarebbe chiuso il relativo processo. In relazione a quest’ultimo procedimento giudiziario, l’Autore scrive: “Il fatto che – con l’eccezione (di un) foglietto in lingua slovena che innesca l’indagine – tutti i riscontri si basano sulle confessioni degli imputati, in un contesto nel quale gli interrogatori sono condotti con metodi “disinvolti”, solleva pesanti interrogativi sulla correttezza del processo …”. Da sottolineare infine che la “introduzione” dell’opera di Mimmo Franzinelli si chiude con queste parole: “Gli eventi del periodo 1943-45, non meno controversi e sanguinosi di quelli dello spionaggio militare nella fase della guerra con l’Asse cui è dedicato questo libro, saranno trattati in un volume a parte”. Dal canto nostro, non rinunciano a sperare che nel preannunciato “volume a parte” – o eventualmente in altra successiva occasione – si trovi il modo di illustrare anche le vicende giuliano-dalmate del periodo 1945-1954. Tutto ciò con particolare riferimento sia all’opera del “controspionaggio” della nuova Jugoslavia, sia a varie “imputazioni di spionaggio e di terrorismo” a carico di vari elementi della popolazione locale (imputazioni anche queste con riscontri basati su “confessioni degli imputati” in un contesto nel quale gli interrogatori erano condotti con metodi “disinvolti”). Mario Dassovich • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri •
Scarica