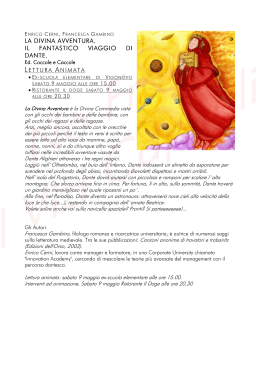Comune di Albenga
Fondazione
G.M. Oddi
Liceo delle
Scienze umane
Fondazione De Mari
Gruppo “003 e oltre”
INCONTRI INGAUNI
I CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA
-1-
DANTE
ATTI DEL CONVEGNO
(Albenga, 13-14 aprile 2012)
A cura di GIANNINO BALBIS e VALTER BOGGIONE
Edizioni del Delfino Moro
Albenga
2013
Quaderni del Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater” di Albenga
-2-
Comitato scientifico-organizzativo degli “Incontri Ingauni”
Giorgio Bárberi Squarotti (presidente, Università di Torino), Giangiacomo Amoretti
(Università di Genova), Alberto Beniscelli (Università di Genova), Valter Boggione
(Università di Torino), Giorgio Airaldi (Liceo delle Scienze umane “Redemptoris
Mater”, Albenga), Giannino Balbis (Fondazione De Mari, Savona).
Patrocini
Gli “Incontri Ingauni” hanno il patrocinio del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria, del D.I.R.A.A.S. (Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica,
Arti e Spettacolo) dell’Università di Genova e del Dipartimento di Studi Umanistici
(StudiUm) dell’Università di Torino.
Questo volume è pubblicato con il contributo della Fondazione De Mari
ISBN:
Indice
Interventi introduttivi
Giorgio Airaldi...................................................................................... p.
Mons. Mario Oliveri ............................................................................. p.
Rosy Guarnieri...................................................................................... p.
Giannino Balbis, Gli “Incontri Ingauni” con i classici della letteratura italiana p.
7
8
9
9
Valter Boggione, Prefazione .................................................................. p. 11
Prima sessione
(presieduta da Giangiacomo Amoretti)
Rinaldo Rinaldi, Il “gran seggio” di Enrico VII. Dante, l’Italia e l’Impero ......... p.
Pierantonio Frare, Le guide nella Commedia. Un modello ermeneutico........... p.
Romano Manescalchi, Sul primo canto dell’ Inferno: nuove prospettive
di interpretazione................................................. p.
Guglielmo Barucci, Percorsi e temi onirici nel Purgatorio........................ p.
17
29
45
77
Seconda sessione - Le tre cantiche presentate agli studenti liceali
(presieduta da Giorgio Bárberi Squarotti)
Emilio Pasquini, L’ Inferno dantesco ...................................................... p. 93
Francesco Spera, Il Purgatorio ............................................................... p. 99
Nicolò Mineo, La Commedia: Paradiso ................................................ p. 111
Terza sessione
(presieduta da Alberto Beniscelli)
Emilio Pasquini, Il linguaggio di Dante fra conquiste sintattiche
e invenzioni metaforiche .............................................. p. 139
Sergio Cristaldi, Artisti nella prima cornice ............................................ p. 145
François Livi, Scrittura profetica e scrittura apocalittica nella Divina
Commedia. Lettura del Paradiso terrestre.......................... p. 173
5
Benvenuti e grazie di essere presenti a questo convegno.
In occasione dell’inaugurazione del nuovo Polo scolastico diocesano di
Albenga, il Liceo “Redemptoris Mater” ha organizzato – in collaborazione con
il Comune di Albenga, con la Fondazione Gianmaria Oddi, con il Gruppo
poetico “003 e oltre” e con il prezioso apporto della Fondazione De Mari –
questo convegno di studi su Dante Alighieri. Si tratta del primo appuntamento
degli “Incontri Ingauni”, che il nostro Liceo intende promuovere annualmente,
per fornire al mondo della scuola e al tessuto culturale del Ponente ligure
significative esperienze di conoscenza e di approfondimento dei classici della
letteratura italiana, in particolare per cercare di rispondere all’esigenza di alzare
la qualità dello studio dei nostri giovani. Ciò è possibile se il mondo della scuola
e il territorio dialogano in funzione della formazione di tutti: in modo speciale,
poi, a noi preme veramente curare la formazione integrale della persona. Le
Università di Genova e di Torino, con le loro Facoltà letterarie, patrocinano
questa iniziativa. Quindi oggi ci troviamo qui per questa due giorni che si
prefigura come un evento culturale di altissimo profilo, non solo per la città ma
per l’intero nostro comprensorio.
Questo evento nasce perché il 2 aprile 2011 si è costituito presso il Centro
Scolastico Diocesano un Comitato scientifico, che ha accettato di condividere e
sostenere il progetto degli “Incontri Ingauni” che oggi prende avvio. Questo
prestigioso comitato – composto dal professor Giorgio Bárberi Squarotti (che ne
è anche presidente), dal professor Alberto Beniscelli, dal professor Giangiacomo
Amoretti, dal professor Valter Boggione e dal professor Giannino Balbis – ha
proposto di iniziare i nostri convegni nel segno del massimo poeta italiano: ecco
perché oggi qui ad Albenga abbiamo l’onore e il piacere di ospitare persone
altamente qualificate nell’interpretazione di Dante e della sua opera. Il
convegno è articolato in tre sessioni, che il professor Balbis, a seguire, avrà modo
di spiegare nei dettagli.
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ringrazio in special modo i
professori emeriti delle università italiane e della Sorbonne di essere qui oggi con
noi per celebrare questo momento nel quale vogliamo alimentare e condividere
il senso di un approfondimento culturale dal quale poter uscire tutti arricchiti.
Giorgio Airaldi
Preside del Liceo “Redemptoris Mater”
7
Partecipo con gioia all’apertura inaugurale di questo Convegno, per due –
penso importanti – motivi.
Innanzitutto, perché esso è stato voluto ed organizzato dalla nostra Scuola
Diocesana “Redemptoris Mater”, la quale in tal modo intende promuovere
buona cultura, e quindi necessariamente buona educazione dell’intelletto e della
volontà, non soltanto al proprio interno, ma anche oltre i propri specifici
confini od ambiti di azione. Amo ripetere, e non mi stancherò di farlo, che la
buona cultura, o la vera cultura, fa necessariamente riferimento al Vero, che si
raggiunge per via intellettiva, ed al Bene, che si raggiunge per via volitiva.
Stimo, poi, di gran valore questo Convegno, poiché ha voluto come suo
tema il sommo poeta Dante, e la sua somma poesia. Perché con verità Dante è
considerato “sommo poeta”? Perché la sua poesia è davvero l’arte di
rappresentare, o di esprimere per mezzo delle parole, cose e fatti con verità e
bellezza. In lui, è evidente in modo solare che la poesia non è soltanto – non
soprattutto – forma, ben compaginata, ma è contenuto veritativo ben rappresentato o espresso. Forma, modi espressivi, armonia di parole, trasmettono
magnificamente somme verità, od ancora meglio – in Dante, nell’opera vertice
della sua poesia, la Divina Commedia – somma Verità, la verità che riguarda
Dio, che è Dio.
Esprimo la mia gratitudine al Centro diocesano “Redemptoris Mater”, in
particolare nella persona del suo Direttore Mons. Mario Ruffino e del suo
Preside e del Presidente del Comitato culturale. Esprimo considerazione e
gratitudine agli illustri “Esperti” di Dante e della sua poesia, che hanno accolto
di intervenire a questo Convegno. Son certo che essi sapranno mostrare durante
il Convegno tutta la sapienza raccolta dalla profonda conoscenza di Dante e
della sua – lo dico una volta di più – somma poesia.
✠ Mario Oliveri
Vescovo di Albenga-Imperia
8
La Città di Albenga è lieta ed orgogliosa di poter ospitare questo
importante convegno dedicato a Dante Alighieri, una delle figure più
importanti della nostra storia e della nostra letteratura. È un onore ed un
privilegio, per il nostro Comune e per la nostra Amministrazione, poter ospitare
e poter partecipare a questa prestigiosa iniziativa culturale, che, grazie agli sforzi
degli organizzatori dell’Istituto “Redemptoris Mater”, ha portato docenti e
studiosi di fama nazionale ed internazionale ad Albenga.
Come scritto da alcuni organi di stampa, è proprio vero che Albenga, grazie
a questo convegno, in questi giorni è diventata la capitale degli studi danteschi.
Ringraziamo il Liceo delle Scienze Umane “Redemptoris Mater” e tutti i
responsabili dell’Istituto, a cominciare dal preside Giorgio Airaldi, da tempo
fautore di iniziative di altissimo livello, e ringraziamo tutti coloro che hanno
reso possibile questi Incontri Ingauni: la Fondazione Gian Maria Oddi, la
Fondazione De Mari, il Gruppo Poetico “003 e oltre” e “Lezione Seconda”.
Ci auguriamo, ma non abbiamo alcun dubbio che sarà così, che questo
incontro su Dante rappresenti il primo di una lunga, lunghissima serie di
approfondimenti di qualità, che servono ad arricchire notevolmente la già
straordinaria offerta culturale della Città di Albenga. Albenga è sinonimo di
cultura: la nostra Amministrazione Comunale crede fortemente in iniziative
come questa, di studio, di ricerca e di conoscenza, con le quali si persegue un
obiettivo che proprio Dante espresse a chiare lettere: “Fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.
Concludo augurando a tutti voi un buon pomeriggio letterario ed una
buona permanenza ad Albenga.
Rosy Guarnieri
Sindaco di Albenga
9
Gli “Incontri Ingauni” con i classici della letteratura italiana
Per chiudere questo momento introduttivo, a nome del Comitato
scientifico, che ho il compito e l’onore di rappresentare, ricordo brevemente
come è nata l’idea degli “Incontri ingauni”, che cosa questi Incontri si
propongono, come sono strutturati e articolati.
L’idea è nata semplicemente dalla passione per la letteratura di un gruppo
di “antichi amici” (se così posso chiamarli), sparsi fra Liguria e Piemonte,
capeggiati da Giorgio Bárberi Squarotti, e dal loro fortunato incontro, qui ad
Albenga, con alcune formidabili “intelligenze motrici”: persone, istituzioni,
enti, che hanno accolto il progetto dei convegni e ne hanno preso in carico la
macchina organizzativa, con una disponibilità e un entusiasmo davvero rari,
soprattutto in questi tempi di dolorosa povertade. Tutti – promotori, sostenitori,
collaboratori – sono già stati ricordati da chi mi ha preceduto: mi limito, quindi,
a sottoscriverne in toto le parole di apprezzamento e ringraziamento.
Che cosa si propongono questi “Incontri”? Per attingere ancora al
vocabolario dantesco, potrei dire che intendono dare vita ad una serie
(auspicabilmente lunga) di “convivi” annuali, dedicati ai maggiori autori della
nostra letteratura (il primo non poteva non essere Dante): un ideale viaggio
letterario che, di anno in anno, faccia il punto sullo stato degli studi, proponga
nuovi contributi e interpretazioni e, al contempo, offra agli studenti delle scuole
medie superiori l’opportunità di un incontro più diretto e consapevole con i
capolavori della nostra letteratura.
I convegni si articoleranno perciò sempre in due momenti: alle consuete
sessioni di lavoro (come quella che andrà a breve ad iniziare e come quella di
domani pomeriggio, sempre in questo Auditorium) si affiancheranno lezioni
per gli studenti (come quelle che domani mattina, al teatro Ambra, terranno il
prof. Pasquini, il prof. Spera e il prof. Mineo sulle tre cantiche della Commedia):
le une e le altre – sessioni e lezioni – naturalmente aperte anche al pubblico, a
tutti coloro che – addetti ai lavori, cultori, appassionati, a qualsiasi titolo
interessati – vogliano liberamente parteciparvi.
L’auspicio è che i nostri “Incontri” possano essere viaggi e convivi stimolanti, proficui, gustosi. E magari non soltanto letterari, viste le prelibatezze
storiche, architettoniche, artistiche, ed anche gastronomiche, che può offrire
una città di grande ed antico prestigio come Albenga. Buon lavoro ai convegnisti, buon ascolto al pubblico!
Giannino Balbis
10
VALTER BOGGIONE
Prefazione
Con l’incontro di quest’anno, intitolato a Dante, ha inizio ad Albenga una
serie di convegni dedicati ai classici della letteratura italiana, organizzati con
cadenza annuale dal Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater” e dal
Comune. In un panorama nazionale e internazionale di convegni di italianistica
che resta estremamente ricco e vario, per quanto falcidiato dai tagli alla cultura
degli ultimi anni, gli Incontri ingauni si distinguono per alcuni aspetti, che
rispondono ad un preciso progetto culturale.
Si tratta, innanzi tutto, della scelta – decisamente controcorrente ed
impegnativa – di un programma che non si esaurisce in un singolo episodio, ma
dura nel tempo, e si propone come bilancio degli studi critici intorno agli autori
di volta in volta affrontati. È il rifiuto della moda, effimera e passeggera, per il
lavoro magari meno appariscente, ma sicuro e costante: rifiuto che comporta
anche la rinuncia ad inseguire ad ogni costo anniversari e date simboliche, sicché
il secondo incontro, nell’anno del settimo centenario boccacciano, sarà dedicato
invece a Manzoni (e un convegno su Boccaccio verrà certamente un po’ più
avanti, per fare il punto sui risultati e sulle prospettive aperte dalle
manifestazioni del 2013).
Ma si tratta anche della volontà di portare la letteratura al di fuori degli
ambienti specialistici, dell’ambito – fertilissimo ma di necessità troppo angusto
– degli addetti ai lavori. I relatori invitati sono e saranno tutti esperti
riconosciuti, non della letteratura italiana in genere, ma degli autori prescelti:
non hanno nulla da dimostrare, semmai sono chiamati a chiarire, a precisare, a
divulgare – nel senso nobile e generoso del termine – i frutti dei loro studi. Il
lusinghiero successo della prima edizione ci conforta nella persuasione che
ancora esista un pubblico interessato alla letteratura in una maniera che non è
né specialistica né occasionale, capace di andare al di là dell’ossequio imperante
alla chiacchiera.
Proprio pensando al pubblico, gli Incontri ingauni sono articolati in due
momenti: due mezze giornate caratterizzate da relazioni su aspetti specifici e
rivolte agli appassionati di letteratura in genere, nel senso che si è appena detto,
e in particolare ai mediatori per eccellenza tra il libro e i suoi potenziali lettori,
gli insegnanti; ed una mezza giornata pensata in maniera specifica per gli
studenti delle scuole superiori, con relazioni di sintesi sugli aspetti fondamentali
dell’autore presentato e sulle interpretazioni critiche più recenti. Nel caso di
quest’anno, ad interventi sulla teoria politica di Dante, sul ruolo delle guide
11
nella Commedia, sulla funzione e sull’interpretazione del primo canto
dell’Inferno, e via di questo passo, si sono affiancate tre ampie letture, dedicate
rispettivamente all’Inferno, al Purgatorio e al Paradiso, affidate ad insigni dantisti
come Emilio Pasquini, Francesco Spera e Nicolò Mineo.
Questi convegni, concepiti e organizzati in una scuola, nati dall’entusiasmo
e dalla fede nella cultura di un dirigente scolastico, Giorgio Airaldi, e di un
insegnante, Giannino Balbis, insieme con un gruppo di docenti delle Università
di Torino e di Genova (Giangiacomo Amoretti, Giorgio Bárberi Squarotti e
Alberto Beniscelli, oltre a chi scrive), in un’atmosfera non solo di piena
condivisione, ma di lunga e affettuosa amicizia, si propongono infatti in primo
luogo di superare la barriera che a poco a poco, insensibilmente ma inesorabilmente, si è eretta tra la scuola e l’università, dovuta un po’ al quadro generale
di riferimento, un po’ a responsabilità distinte ma comuni.
Da una parte, i docenti universitari e i ricercatori si sono impegnati in studi
sempre più circoscritti e iperspecialistici, che presuppongono conoscenze non
sempre possedute dagli insegnanti, prima ancora che dagli studenti, scritti in un
linguaggio talvolta iniziatico. Non per nulla, la produzione critica degli ultimi
trent’anni si è indirizzata piuttosto ai colleghi della disciplina che a un vero
pubblico, e le opere cosiddette ‘divulgative’ sono state guardate con sospetto, se
non con esplicita ostilità. Molti dei nostri lavori riescono inadatti non solo alla
lettura colta, ma alla stessa didattica universitaria. D’altro canto, spesso la scuola
ha proceduto sulla linea di una semplificazione e di una banalizzazione
dell’insegnamento della letteratura, rinunciando ad una prospettiva storica,
riducendo fortemente il ventaglio dei testi antologici letti a favore di una
presunta acquisizione degli strumenti di analisi degli stessi, privilegiando gli
autori contemporanei e limitando fortemente l’attenzione rivolta ai classici.
Dopo anni di antologie-monstre, dal Materiale e l’immaginario in poi, le ultime
edizioni dei testi per l’insegnamento dell’italiano somigliano piuttosto ai
Bignami in uso ai tempi della nostra giovinezza. Su tutto, il disinteresse, che
spesso scivola nel disprezzo, con cui è guardata la cultura che non ha un fine
materiale e applicazioni pratiche (soprattutto economiche e commerciali), quale
è per eccellenza la letteratura; e l’attitudine dell’editoria a ridurre la saggistica
agli instant-books dei giornalisti.
A dispetto di ciò, la nostra capacità di collocare i grandi autori del passato
nel contesto culturale da cui sono nati e entro cui hanno operato e di
interpretarne i testi ha fatto grandi progressi: e di questi progressi gli Incontri
ingauni vogliono dar conto. Per ovvie ragioni simboliche, non si poteva non
cominciare con Dante. Ma nel nostro caso la scelta ha una valenza ulteriore: ed
è quella di ribadire la centralità didattica della lezione dantesca e la sua
imprescindibilità. Sempre più insegnanti limitano l’insegnamento della
12
Commedia al terzo anno della scuola superiore, con l’inevitabile conseguenza di
ridurre al minimo i canti letti e commentati. Pare che le antologie abbiano
ormai superato, nel numero di adozioni, le edizioni complete della Commedia.
Quando Roberto Benigni pensa di poter proporre alla platea televisiva un
segmento compatto dell’Inferno e celebra le bellezze del canto XI, da sempre
ritenuto un canto didascalico dotato di prevalente funzione strutturale, illustri
commentatori di Dante e moltissimi insegnanti ritengono superfluo anche solo
offrire la possibilità di una simile lettura.
Non sono un dantista: ma forse proprio per questo credo di poter dire che
la prima, grande lezione che ci viene dalla critica recente e dagli interventi di
questo convegno è l’invito a pensare alla Commedia come a un libro, e non come
a un insieme di canti potenzialmente autonomi, almeno a livello estetico. Non
è soltanto questione della ‘struttura’ dell’opera dantesca, con tutte le simmetrie
del caso e i presupposti di carattere filosofico e teologico sottesi all’organizzazione dell’aldilà; è, proprio, che lo stesso motivo del viaggio presuppone un
lettore che segua passo passo lo scrittore, ne riviva le paure e le sorprese e gli
entusiasmi, ripercorrendo attraverso la pagina e applicando a sé quell’esperienza
di crescita morale e intellettuale.
La Commedia, letta senza l’ottica deformante della scelta antologica e
l’effetto anestetizzante dell’abitudine e delle conoscenze pregresse, è uno straordinario libro d’avventura, che attraversa tutte le possibilità dell’esistenza umana,
tutta la storia e la cronaca, ricco di colpi di scena, di efferatezze e di scandali e
di manifestazioni di sublime nobiltà. Senza – si badi bene – che ne derivino di
necessità forzature in senso romantico. È un paradosso che l’opera più unitaria
dell’intera tradizione letteraria occidentale sia stata fatta a pezzi in maniera
sistematica, e si sia ritenuto possibile interpretarne i pezzi a prescindere
dall’insieme. Senza questa prospettiva fortemente unitaria e l’attitudine a
guardare all’opera dantesca come a un libro, non avrebbero avuto senso le tre
relazioni centrali del convegno, quelle destinate agli studenti, di Emilio
Pasquini, Francesco Spera e Nicolò Mineo: relazioni che costituiscono non un
banale riassunto delle tre cantiche, e neppure una chiarificazione dei principi
organizzativi e teologici ad esse sottesi, quanto piuttosto la ricostruzione
dinamica dell’esperienza dantesca nelle sue manifestazioni fisiche, morali e
intellettuali. Lo stesso si può dire per gli interventi di Pierantonio Frare sulle
guide della Commedia, in cui la funzione e i caratteri delle guide dantesche sono
messi in relazione con i luoghi e i tempi del viaggio; o di Guglielmo Barucci,
che riconosce nei sogni purgatoriali il segno di un passaggio di stato non
soltanto topografico e fonda la loro interpretazione in primo luogo sugli
elementi che li mettono tra loro in relazione. Il solo intervento incentrato su un
unico canto, quello di Manescalchi, si vale in realtà di una fittissima rete di
13
rimandi al resto dell’Inferno e all’intero organismo dell’opera.
Il secondo aspetto che mi sembra importante segnalare, nella critica
dantesca recente e nelle relazioni del convegno, è l’idea che la Commedia non
solo è un libro, ma è un libro in fieri, nel quale si possono riconoscere stati
evolutivi differenti, mutamenti di progetto in corso d’opera, soluzioni che
difficilmente – ad una revisione conclusiva – sarebbero potute riuscire definitive. È il nucleo fondante dell’interpretazione offerta da Pasquini, persuaso
che i segni di una progressiva evoluzione si possano riconoscere non soltanto a
livello ideologico o teologico, ma anche a livello di scelte espressive e costruzione
della frase. La storia della poesia di Dante è anche la storia di un affinamento
del verso e del linguaggio, nel quale importanza decisiva riveste l’uso, sempre
concettualmente pregnante, della metafora. Ma è un’idea che si affaccia qua e là
in numerosi interventi, e sostanzia l’analisi delle teorie politiche dantesche fatta
da Rinaldo Rinaldi, a partire dal testo della Monarchia. Rinaldi riconosce nei
discorsi di Dante sull’impero il passaggio da una dimensione di militanza
politica ad una dimensione extratemporale e sovraindividuale, ma anche i segni
di una contraddizione latente, che si fa esplicita nel raffronto tra il trattato e i
versi del Paradiso, segnati dall’incolmabile distanza tra sogno intellettuale e
realtà storica.
Un ultimo elemento mi pare poi importante segnalare, nei contributi del
convegno, nella prospettiva anche didattica che ci siamo dati: e cioè l’attitudine
a rifuggire da ogni trasposizione immediata della lezione dantesca in chiave di
modernità letteraria, l’impegno a riportare non solo il pensiero, ma quella che
un tempo si sarebbe definita la poesia tutta di Dante all’epoca in cui è stata
concepita. Dante è datato, irrimediabilmente datato: il suo discorso sulla vana
gloria dei superbi, in opposizione all’umile disponibilità di David a farsi
ioculator Domini, come ci insegna Sergio Cristaldi, è quanto di più lontano si
possa immaginare dall’entusiasmo moderno per l’artista che crea, che pone la
propria individualità a fondamento dell’esperienza letteraria. La rappresentazione del Paradiso Terrestre si sostanzia di una scrittura profetica e di una
scrittura apocalittica, con riferimenti puntuali e puntualmente ricostruiti da
François Livi, ormai del tutto estranee all’orizzonte e alle conoscenze dell’uomo
contemporaneo.
Ma lo scopo della letteratura non è farci trovare nel passato e negli altri ciò
che già vediamo e sappiamo: è farci vedere il mondo con occhi diversi dai nostri.
Come in tutti gli ambiti dell’esperienza umana, anche nelle lettere la diversità è
la vera ricchezza. Conta ciò che distingue, non ciò che omologa. Ho sempre
trovato singolare ma istruttivo che un celebre saggio di Montale sulla radicale
estraneità di Dante al sentire moderno (“Dante non può essere ripetuto. Fu
giudicato quasi incomprensibile e semibarbaro pochi decenni dopo la sua
14
morte, quando l’invenzione retorica e religiosa della poesia come dettato
d’amore fu dimenticata. Esempio massimo di oggettivismo e razionalismo
poetico egli resta estraneo ai nostri tempi, a una civiltà soggettivistica e
fondamentalmente irrazionale perché pone i suoi significati nei fatti e non nelle
idee”) sia riportato da diverse antologie ed edizioni scolastiche della Commedia
sotto intitolazioni che alludono alla sua attualità. Ma anche in questa
contraddizione c’è, in fondo, un germe di verità: “resta quasi inspiegabile alla
nostra moderna cecità il fatto che quanto più il suo mondo si allontana da noi,
di tanto si accresce la nostra volontà di conoscerlo e di farlo conoscere a chi è
più cieco di noi”.
15
RINALDO RINALDI
Il “gran seggio” di Enrico VII.
Dante, l’Italia e l’Impero
“A Enrico di Lucimburgo, settimo imperator
sacro, Matteo Visconti alla Motta gli promosse
una delibera, che gli era fatto presente di
centomila zecchini di oro. Questi centomila
zecchini di oro, al solito, li pagarono i milanesi.”
Bertrando Gozio guasco, pontefice in soglio
Clemente v°, standosi ad Avignone in castello
aveva apprestato ceremonia a Roma, ad Enrico.
Avvenne che il sediolone celeste fosse appetito et
occupato prima d’esser fatto. Quel caro e virtuoso
imperadore non pur s’avvisò di quell’allighieresco
fulgore, che spazientitosi a volervi insediare il
sedere ebbe a tirare le cuoia al Buonconvento
d’Arbia ove l’Etruria è detta Maritima, o
Maremma.
Una cotal favola ne dice: che le zanzarine d’Arbia
sono sennate a pinzare.”
C. E. Gadda, Il primo libro delle favole
1. Nel 2007 l’amico Renato Bordone aveva partecipato a una serie di letture
organizzate dall’Università di Parma e dedicate a Dante e la storia medioevale. Il
tema scelto da Renato in quell’occasione, La nobiltà e l’Impero nello sviluppo del
pensiero dantesco, gli permise di sviluppare alcune considerazioni importanti
dalle quali possiamo partire oggi.
Egli insisteva innanzitutto sulla formazione culturale “essenzialmente
cittadina”1 di Dante, sulla sua perfetta sintonia (prima dell’esilio) con gli ideali
comunali. A questi ideali corrisponde, ben visibile nelle prove poetiche giovanili
e stilnoviste, un’ideologia cavalleresca che vagheggia “il mito della corte come
luogo di celebrazione della cortesia”,2 e ben corrisponde alla “cultura delle élites
urbane”3 dell’epoca. Bordone osservava poi opportunamente che nel quarto
1
2
3
Cfr. R. BORDONE, La nobiltà e l’Impero nello sviluppo del pensiero dantesco, in R. GRECI - R.
BORDONE - G. CHERUBINI - S. BORDINI, Dante e la storia medioevale, Milano, Unicopli, 2008,
p. 73.
Cfr. ivi, p. 63.
Cfr. ivi, p. 58.
17
trattato del Convivio la tradizionale definizione di “gentilezza” come “vertude” e
“umana bontade”4 corrisponde sì a una nuova celebrazione dell’Impero, dopo la
“sofferta ammissione del fallimento dell’ideologia comunale, o meglio [...] della
sua concreta applicazione politica a causa della malvagità degli uomini”,5 ma che
al tempo stesso la forma della legittimazione imperiale evocata da Dante si serve
di strumenti giuridici “messi a punto proprio dalla più schietta cultura politica
comunale”6 e che in ultima analisi i “capitoli del Convivio dedicati all’imperatore” vanno “poco oltre il tradizionale riconoscimento formale”, escludendone
“l’ingerenza dagli sviluppi del diritto consuetudinario, secondo quanto i comuni
oltre un secolo prima avevano ottenuto a Costanza”.7 È ben nota, del resto, la
presenza delle città nell’opera dantesca fino al culmine della Commedia, che
disegna una vera e propria geografia e storia d’Italia attraverso i suoi comuni8 e
ha giustificato in passato l’etichettatura del poeta come “poeta nazionale”.9
Certo, di fronte alla progressiva decadenza degli antichi “valore e cortesia”10
che Marco Lombardo lamenterà in Purgatorio XVI, acquista straordinaria
rilevanza la nuova prospettiva disegnata da Dante nella Monarchia, dove i
concetti di nobiltà e di impero ricevono una completa rifondazione teorica e
ideologica. Eppure, anche in quest’opera di svolta, sopravvive una distinzione
che rinvia senza possibili dubbi alla moderna concezione dell’autonomia comunale, quella fra la “communis regula” imperiale e le singole “leges municipales”:
“Habent nanque nationes, regna et civitates intra se proprietates, quas
legibus differentibus regulari oportet.”11
Proprio di qui conviene partire, da questa traccia di contraddizione messa
in rilievo da Renato, per disegnare il profilo dell’Italia dantesca, dell’Italia
sognata e dell’Italia reale. Perché il viaggio italiano di Enrico VII di
Cfr. ivi, p. 70.
Cfr. ivi, p. 73.
6
Cfr. ivi, p. 75.
7
Cfr. ivi, p. 76.
8
Su questo tema si veda G. CHERUBINI, Dante e le città, in R. GRECI - R. BORDONE - G.
CHERUBINI - S. BORDINI, Dante e la storia medioevale, cit., pp. 85-118 (con ulteriore
bibliografia).
9
Cfr. M. BARBI, L’Italia nell’ideale politico di Dante, in ID., Problemi fondamentali per un nuovo
commento della Divina Commedia, Firenze, Sansoni, 1955, p. 89.
10
Cfr. D. ALIGHIERI, Purgatorio, XVI, 116.
11
ID., Monarchia, a cura di B. Nardi, in ID., Opere minori, a cura di P. V. MENGALDO - B.
NARDI - A. FRUGONI - G. BRUGNOLI - E. CECCHINI - F. MAZZONI, Milano-Napoli, Ricciardi,
1979, t. II, pp. 354-356 (I, xiv, sottolineatura nostra).
4
5
18
Lussemburgo fra il 1310 e il 1313, come è noto, segna una nuova fase di
conflitto drammatico fra il potere imperiale e le città-stato in un’epoca di
progressiva affermazione del concetto di sovranità nazionale in Europa.12 E il
programma dell’imperatore, che pure giunge in Italia come pacificatore delle
lotte fra guelfi e ghibellini nelle città italiane, non appare affatto ispirato al
compromesso: il controllo sul contado viene tolto ai comuni riaffermando le
prerogative dell’Impero sui territori usurpati; gli statuti municipali sono aboliti
o profondamente modificati in funzione dei tradizionali privilegi
dell’imperatore; la reintegrazione degli esiliati nelle loro proprietà avviene con
procedure semplificate, che mirano a stabilire uno schema generale di
riconciliazione delle parti sotto il sigillo imperiale senza tener conto delle singole
situazioni cittadine. Nulla, dunque, che faccia riferimento a “leges differentes”,
ma anzi un’azione politica concreta che contraddice l’armonico profilo
istituzionale tracciato nel primo libro della Monarchia: l’impresa stessa di Enrico
VII in Italia, del resto, è un fattore destabilizzante che porta all’estremo limite
delle contraddizioni già operanti nelle pieghe più profonde della realtà storica.
La letteratura si incaricherà, proprio con Dante, di comporre ogni frattura
nell’immagine mitica di un impero che comprende in se individui, città e regni,
realizzando i fini particolari di ogni comunità nel fine ultimo dell’universitas e
rendendo possibile il paradiso in terra. Il prezzo da pagare, come sempre in
questi casi, sarà un’altra contraddizione, non più radicata nella dialettica storica
ma spostata su un altro piano, quello che divide l’immaginario dalla realtà.
2. Enrico entra in Italia nell’ottobre 1310. Alle prime settimane
dell’impresa risale l’epistola che Dante, definendosi “humilis ytalus”, indirizza
“universis et singulis Ytalie Regibus et Senatoribus alme Urbis nec non
Ducibus Marchionibus Comitibus atque Populis”: un invito ad accogliere la
sublime aquila imperiale, che come sole di giustizia giungerà per asciugare le
lacrime dell’Italia sotto il segno della pace. Del 31 marzo 1311 è la lettera
parallela che Dante “florentinus et exul” invia “scelestissimis Florentinis
intrinsecis”, capovolgendo il tono dall’exhortatio all’invettiva per minacciare i
malvagi del meritato castigo se non si pentiranno di fronte all’Imperatore che
come nuovo Cristo si fa carico delle pene comuni. Il 17 aprile Dante scrive
direttamente a Enrico esortandolo a non indugiare in Lombardia ma a
dirigersi verso Firenze, radice di tutti i mali e vera causa delle ribellioni al
12
Si veda, anche per gli accenni seguenti ai provvedimenti dell’imperatore, l’ancora
fondamentale W. M. BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 13101313, Lincoln, University of Nebraska Press, 1960, passim.
19
potere imperiale.13 La cronologia della Monarchia, come è noto, è molto
discussa e aperta a ipotesi contrastanti, ma ci pare verosimile (anche in base a
una famosa testimonianza di Boccaccio)14 che l’opera sia stata – se non scritta
materialmente – almeno progettata negli anni dell’impresa di Enrico, proprio a
ridosso dell’epistola di aprile:
“ [...] circoscrivendo l’arco cronologico al periodo tra la primavera del
1312, quando la tensione tra il papa e l’imperatore si fece più acuta,
fino all’ingiunzione del primo al secondo di lasciare Roma dopo
l’incoronazione del 29 giugno 1312, e la morte di Arrigo VII, il 24
agosto dell’anno successivo.”15
In questo periodo, comunque, Dante non prende più iniziative pubbliche
epistolari ed è significativo – come è stato osservato – che egli mantenga un
“silenzio assoluto [...] negli ultimi due anni, circa, di presenza di Arrigo nella
penisola”.16 È una fase di crescenti difficoltà per l’imperatore alle prese con
l’aperta ostilità papale, con il doppio gioco di Roberto d’Angiò e con le manovre
della Lega Guelfa guidata da Firenze. È una fase marcata da numerosi errori
diplomatici e strategici da parte di Enrico, del resto già potenzialmente presenti
nella sua insufficiente comprensione della situazione italiana, fino al
malinconico fallimento dell’impresa. È dunque verosimile che la Monarchia sia
stato ideato quando le speranze di Dante erano al punto più alto, ma è anche
probabile che la stesura abbia accompagnato gli eventi quando più numerose e
oscure si allungavano le ombre su un’impresa annunciata come redenzione
dell’Italia e realizzata in modo ben diverso. Non è estranea a questa genesi la
scelta dantesca di spostare il ragionamento sul piano generale, cancellando ogni
allusione diretta all’attualità; l’imperatore della Monarchia diventa così un
emblema, una figura dell’immaginario in cui si può credere non più sulla base
di una realtà irrimediabilmente compromessa ma (come è stato detto) “soltanto
per fede, per scelta ideologica, giuridica, filosofica, o solo latamente
intellettuale; in fondo disperatamente”.17 Qualcosa di simile, all’inizio degli anni
Trenta e sul versante della propaganda, avrebbe fatto il fratello di Enrico,
l’arcivescovo di Trier Baldovino, commissionando il codice illustrato del
13
14
15
16
17
Si veda il testo delle tre lettere in D. ALIGHIERI, Epistole, a cura di A. FRUGONI e G.
BRUGNOLI, in ID., Opere minori, cit., t. II, pp. 540 ss. (V), pp. 550 ss. (VI), pp. 562 ss. (VII).
Si veda G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, in ID., Opere minori in volgare, a cura
di M. MARTI, Milano, Rizzoli, 1972, vol. IV, p. 377.
E. MALATO, Dante, Roma, Salerno, 1999, pp. 181-182.
Cfr. ivi, p. 62.
Cfr. G. ZANELLA, L’imperatore tiranno. La parabola di Enrico VII nella storiografia coeva, in Il viaggio di Enrico VII in Italia, a cura di M. TOSTI-CROCE, Città di Castello, Edimond, 1993, p. 51.
20
“Viaggio a Roma” per riproporre l’immagine ideale dell’incoronazione imperiale
ottenuta dalla casa di Lussemburgo.18 La teoria politica di Dante e il prezioso
manoscritto baldoviniano trasformano entrambi la storia in un mito.
La Monarchia dichiara che l’unico modo per attuare il fine ultimo ovvero
l’“opus proprium” del genere umano, cioè l’intelletto “prius ad speculandum et
secundario propter hoc ad operandum”, è la “pax universalis”:19 solo la pace,
realizzata nell’impero, permette di realizzare la beatitudine mondana come una
sorta di nuovo “terrestrem paradisum”.20 Ovvero, come in termini non filosofici
ma ‘civili’ si esprime l’epistola ai Fiorentini:
“Eterni pia providentia Regis [...] sacrosanto Romanorum Imperio res
humanas disposuit gubernandas, ut sub tanti serenitate presidii genus
mortale quiesceret et ubique, natura poscente, civiliter degeretur.”21
Ma il valore simbolico dell’impresa di Enrico VII come provvidenziale
azione pacificatrice (“relicta nobis est pacis hereditas”)22 è immediatamente
contraddetto dalla vicenda storica, poichè l’arbitrato dell’imperatore fra le parti
in lotta dei comuni italiani non dà risultati apprezzabili, attizza nuovi contrasti
e finisce per scatenare violente ribellioni che conducono a repressioni militari
(come avviene a Cremona e a Brescia). Non è forse un caso, come qualcuno ha
osservato, che nell’Inferno “in cui così grande spazio è dedicato al tema delle
lotte, delle discordie, degli odi, delle vendette, dei bandi”,23 non si parli
dell’impero come portatore di pace; poiché l’ideale dantesco della “pax
universalis” scavalca proprio
questo inferno che rispecchia a sua volta
24
fedelmente quello storico. Il progetto politico della Monarchia è infatti un
progetto ‘contemplativo’, al pari delle pagine in apparenza più attuali del
Purgatorio e del Paradiso.25
18
19
20
21
22
23
24
25
Si veda V. KESSEL, Il manoscritto del “Viaggio a Roma” dell’imperatore Enrico VII, ivi, pp. 21-24.
Cfr. D. ALIGHIERI, Monarchia, cit., pp. 302-304 (I, iv).
Cfr. ivi, p. 498 (III, xv).
ID., Epistole, cit., p. 550 (VI).
Cfr. ivi, p. 562 (VII).
Cfr. G. SASSO, Dante, l’Imperatore e Aristotele, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo, 2002, p. 103.
Per un’ipotesi diversa che va alla ricerca di consonanze fra le epistole ‘imperiali’ di Dante e
alcuni canti dell’Inferno (VIII-XVI), accettando la proposta di una datazione più tarda della
cantica rispetto a quella tradizionale, si veda Q. MARINI, Le epistole per Arrigo VII e i rapporti
con la “Commedia”, in “Per correr miglior acque...”. Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle
soglie del nuovo millennio, Atti del Convegno internazionale di Verona-Ravenna (25-29
ottobre 1999) sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, Roma, Salerno, 2001, t.
II, pp. 927-954.
Si veda ancora G. SASSO, Dante, l’Imperatore e Aristotele, cit., pp. 105-106.
21
3. Basta pensare al taglio rigorosamente e tecnicamente filosofico del primo
libro, che conferisce subito all’opera un tono di supremo distacco. Dante
definisce il monarca come imperatore-filosofo già nel quarto libro del Convivio:
“[…] è manifesto lo principale intento, cioè che l’autoritade del
filosofo sommo di cui s’intende sia piena di tutto vigore. E non
repugna a la imperiale autoritade; ma quella sanza questa è pericolosa,
e questa sanza quella è quasi debile, non per sé, ma per la disordinanza
de la gente: sì che l’una con l’altra congiunta utilissime e pienissime
sono d’ogni vigore.”26
E nella Monarchia tocca proprio all’imperatore il compito di attuare il “finis
universalis civilitatis humani generis”27 che è appunto squisitamente filosofico:
la realizzazione della “virtus intellectiva”,28 come si è detto, ottenuta appunto
“per phylosophica documenta [...] secundum virtutes morales et intellectuales
operando”.29 Dante opera in tal modo una sorta di intellettualizzazione della
politica corrispondente alla scelta argomentativa del trattato, che tende a uscire
dal tempo storico e dall’identità individuale: innanzitutto presentando l’impero
come universitas ovvero totalità del genere umano,30 poiché solo nella collettività
si può realizzare quella “civilitas humani generis” in cui l’Uomo trova la sua
perfezione non come individuo ma come tipo della specie, nuovo Adamo che
Dante stesso incarnerà nel Paradiso Terrestre, al culmine del Purgatorio;
esaminando poi non la persona ma l’ufficio dell’imperatore e sottolineando
anche nelle epistole la sua natura di universale imago allegorica (nuovo Cristo,
“Hectoreus pastor”, nuovo Davide);31 infine soffermandosi sulla sua figura di sol
iustitiae secondo la tradizione giustinianea e pre-giustinianea dell’imperatore
come lex animata,32 con una drastica spersonalizzazione evocata dallo stesso
Enrico VII nell’editto emanato proprio ad Asti il 18 novembre 1310 per
riaffermare i privilegi imperiali (“ex plenitudine sue potestatis [...] cum sit lex
26
27
28
29
30
31
32
D. ALIGHIERI, Convivio, a cura di C. VASOLI e D. DE ROBERTIS, in ID., Opere minori, MilanoNapoli, Ricciardi, 1995, vol. II, t. II, p. 594 (IV, vi).
Cfr. ID., Monarchia, cit., p. 288 (I, ii).
Cfr. ivi, p. 298 (I, iii).
Cfr. ivi, p. 498 (III, xv).
Si veda, anche per quello che segue, il capitolo dantesco nel classico volume di E. W.
KANTOROWICZ, Il due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale,
Introduzione di A. Boureau, trad. ital. Torino, Einaudi, 1989 (1a ed. 1957), pp. 387-426.
Cfr. ID., Epistole, cit., p. 540 e p. 544 (V), pp. 558-560 (VI), p. 572 (VII).
Si veda E. W. KANTOROWICZ, Il due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica
medievale, cit., pp. 109-123.
22
animata in terris”).33 Non diversamente, quando in Purgatorio, XXIX compare
l’allegorico grifone a trainare il carro della Chiesa, come figura insieme di Cristo
e dell’Imperatore,34 Dante lo associa non solo al mitico Fetonte e al Sole ma
ancora una volta alla giustizia (con un’allusione apparentemente criptica a quella
di Giove):
“Non che Roma di carro così bello
rallegrasse Affricano, o vero Augusto,
ma quel del Sol sarìa pover con ello;
quel del Sol che, sviando, fu combusto
per l’orazion de la Terra devota,
quando fu Giove arcanamente giusto.”35
Questa costruzione intellettuale non corrisponde tuttavia alla realtà storica,
visto che Enrico VII in Italia è messo di fronte a lotte comunali in cui le antiche
etichette di guelfi e ghibellini non esprimono più le posizioni del papato e
dell’impero ma solo gli interessi di parti in contrasto su problemi strettamente
locali e nient’affatto ideologici.36 Come dirà Giustiniano in Paradiso, VI,
l’impero rappresenta un tutto superiore a ciascuna delle due parti e la “giustizia”
che incarna non può identificarsi neppure nella fazione ghibellina:
“L’uno al pubblico segno i gigli gialli
oppone, e l’altro appropria quello a parte,
sì ch’è forte a veder chi più si falli.
Faccian li Ghibellin, faccian lor arte
sott’altro segno; ché mal segue quello
sempre chi la giustizia e lui diparte.”37
Il malinconico paradosso della storia è che l’imperatore, sceso in Italia come
arbitro superiore alle fazioni, è costretto progressivamente ad appoggiarsi ai
signori ghibellini della penisola, entrando suo malgrado nel ruolo che la
33
34
35
36
37
Citato in H. ZUG TUCCI, Henricus coronatur corona ferrea, in Il viaggio di Enrico VII in Italia,
cit., p. 37. Si veda anche W. M. BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and CityState, 1310-1313, cit., pp. 62-63.
Si veda J. A. SCOTT, Il mito dell’imperatore negli scritti danteschi, in Dante: mito e poesia, Atti
del secondo Seminario dantesco internazionale (Monte Verità, Ascona, 23-27 giugno 1997),
a cura di M. PICONE e T. CRIVELLI, Firenze, Cesati, pp. 100-102.
D. ALIGHIERI, Purgatorio, XXIX, 115-120.
Si veda W. M. BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 1310-1313,
cit., p. 9.
D. ALIGHIERI, Paradiso, VI, 100-105.
23
propaganda guelfa e fiorentina ha preparato per lui: quello dell’oppressore delle
libertà comunali.38 Ed altrettanto contraddittoria è la nuova istituzione dei vicari
che nei comuni dipendono direttamente dall’imperatore e ne rappresentano il
potere legittimo; poiché a partire dal marzo 1311, nominando a tale carica dei
potenti personaggi locali che di fatto già controllano le loro città (esemplare è il
caso degli Scaligeri a Verona), Enrico VII inaugura un processo di legittimazione
che rafforzerà la formazione delle signorie.39
È Dante stesso, peraltro, a misurare personalmente nel Purgatorio e nel
Paradiso l’incompatibilità fra l’Italia tardo-comunale e l’idea dell’impero, dopo
l’esortazione piena di speranza ad accogliere lo “sposo” che apriva l’epistola ai re
d’Italia:
“Letare iam nunc miseranda Ytalia etiam Saracenis, que statim
invidiosa per orbem videberis, quia sponsus tuus, mundi solatium et
gloria plebis tue, clementissimus Henricus, divus et Augustus et Cesar,
ad nuptias properat.”40
Questo ottimismo e quest’invito a cogliere l’“occasione” (se volessimo usare
il linguaggio della machiavelliana exhortatio nel Principe) non corrisponde alla
diagnosi famosa di Purgatorio, VI dove Dante riprende la figura del “cavallo” e
del “cavalcatore” già riferita nel Convivio all’imperatore e alla “misera Italia”:41
“Che val perché ti racconciasse il freno
Iustiniano se la sella è vota ?
Sanz’esso fora la vergogna meno.
Ahi gente che dovresti esser devota
e lasciar seder Cesare in la sella,
se bene intendi ciò che Dio ti nota,
guarda come esta fiera è fatta fella
per non esser corretta da li sproni,
poi che ponesti mano a la predella.
O Alberto tedesco ch’abbandoni
costei ch’è fatta indomita e selvaggia,
e dovresti inforcar li suoi arcioni,
38
39
40
41
Si veda W. M. BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 1310-1313,
cit., pp. 125-126, pp. 152-153 e passim.
Si veda ivi, pp. 91-95, pp. 102-105, pp. 210-211; e G. TABACCO, L’impero romano-germanico
e la sua crisi (secoli X-XIV), in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea,
vol. II: Il Medioevo, Torino, Utet, 1986-1988, t. II, p. 334.
D. ALIGHIERI, Epistole, cit., pp. 540-542.
Cfr. ID., Convivio, cit., p. 627 (IV, ix).
24
giusto giudicio da le stelle caggia
sovra ’l tuo sangue, e sia novo e aperto,
tal che ’l tuo successor temenza n’aggia !”42
L’Italia resta “selvaggia” nonostante le leggi di Giustiniano, perché non è
disposta ad accettare il domitor imperiale che proprio il Codice giustinianeo
legittimava come erede della lex regia.43 E non diverso è il giudizio sul padre di
“Alberto tedesco”, Rodolfo d’Asburgo, che ha lasciato morire l’Italia senza
lasciare alcuna possibilità di intervento efficace ai suoi successori:
“Colui che più siede alto e fa sembianti
d’aver negletto ciò che far dovea,
e che non move bocca a li altrui canti,
Rodolfo imperador fu, che potea
sanar le piaghe ch’hanno Italia morta,
sì che tardi per altri si ricrea.”44
Questo “altri” generico, che potrebbe nascondere il nome di Enrico, sembra
consumare definitivamente – al fuoco della realtà – il sogno dell’avventura
imperiale in Italia. “Le genti” infatti, dirà Dante in Paradiso, XIX anticipando
uno dei temi centrali dei Discorsi machiavelliani,45 sono “malvage” poiché
“commendan lei, ma non seguon la storia”.46 E quando il nome “de l’alto
Arrigo” finalmente risuonerà nella Commedia a chiare lettere, in Paradiso, XXX,
sarà solo per ribadire che egli “a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta”.47 È l’esatto contrario di quanto dirà Machiavelli dell’Italia, in tutt’altro
contesto, nel citato capitolo del Principe riecheggiando anche Purgatorio, VII:
“In modo che, rimasa come sanza vita, aspetta quale possa essere
quello che sani le sua ferite [...] tutta pronta e disposta a seguire una
bandiera, pur che ci sia uno che la pigli.”48
42
43
44
45
46
47
48
ID., Purgatorio, VI, 88-102.
Si veda E. W. KANTOROWICZ, Il due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica
medievale, cit., pp. 89 ss.
D. ALIGHIERI, Purgatorio, VII, 91-96.
Anche il secondo libro della Monarchia, col suo repertorio di exempla romani, avrà degli echi
rilevanti nel pensiero di Machiavelli.
Cfr. D. ALIGHIERI, Paradiso XIX, 17-18.
Cfr. ivi, XXX, 137-138.
N. MACHIAVELLI, De principatibus, in ID., Opere, a cura di R. RINALDI, Torino, Utet, 1999,
vol. I, t. I, pp. 389-390 (XXVI).
25
4. L’emblema di questa contraddizione, di quest’incolmabile distanza fra
sogno intellettuale e realtà storica, è appunto il trono vuoto con la corona
imperiale che accoglierà in Paradiso l’anima di Enrico:
“E ’n quel gran seggio a che tu gli occhi tieni
per la corona che già v’è su posta,
prima che tu a queste nozze ceni,
sederà l’alma, che fia giù agosta,
de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia
verrà in prima ch’ella sia disposta.”49
Se l’assenza dell’imperatore sul trono è ovviamente spiegabile con la
finzione cronologica del viaggio dantesco (che s’immagina svolto nel 1300),
l’assenza è anche il segno del fallimento dell’impresa e dell’inevitabile
insufficienza degli eventi e degli uomini a paragone dell’ideale imperiale.
Questo ideale è però incarnato dalla corona deposta sul trono vuoto, a
significare la continuità e la perennità dell’Impero: corona “immateriale” che
non rinvia alla persona privata di Enrico ma alla sua dignitas insieme politica e
sacra.50 La figura del trono vuoto, paradossalmente, accetta la sconfitta dell’idea
sul piano della storia ma la fa rimbalzare nell’eternità, trasformandola in una
Fenice51 destinata per sempre a risorgere. Qualcosa di simile, forse, si nascondeva già nel sogno che marcava l’ascesa di Dante alla porta del Purgatorio:
“in sogno mi parea veder sospesa
un’aguglia nel ciel con penne d’oro,
con l’ali aperte e a calare intesa;
[...]
Poi mi parea che, rotata un poco,
terribil come folgor discendesse,
e me rapisse suso infino al foco.
Ivi parea che ella e io ardesse.”52
La persona di Dante e il simbolo imperiale si annullano in Dio, ma
entrambi si perpetuano sotto una forma mitica e astratta insieme: l’uomo
individuale diventa il medioevale Everyman dopo la cerimonia di purificazione
49
50
51
52
D. ALIGHIERI, Paradiso, XXX, 133-138.
Sulla “corona” si veda E. W. KANTOROWICZ, Il due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia
politica medievale, cit., pp. 289 ss. e pp. 329 ss. (cfr. in particolare p. 290).
Anche per la Fenice si veda ivi, pp. 331 ss.
D. ALIGHIERI, Purgatorio, IX, 19-21 e 28-31.
26
alla fine del Purgatorio, l’Impero si sublima nel Trono e nella Corona alla fine
del Paradiso. È in questa dimensione extratemporale e sovraindividuale che va
inteso il discorso profetico dantesco, adottato fin dall’inizio dell’impresa di
Enrico VII (si pensi alla “presaga mens”53 che nell’epistola ai Fiorentini annuncia
le sventure che distruggeranno la città radice di tutti i mali) ma soprattutto
dominante nella Commedia dopo la morte dell’imperatore. La profezia del
“Veltro” nel primo canto dell’Inferno e quella parallela del “cinquecento diece e
cinque” nell’ultimo del Purgatorio54 trasformano così in un mito quella speranza
che era stata concepita nella contingenza, all’annuncio della discesa “de l’alto
Arrigo” in Italia: l’annuncio esce così dalla finitezza del tempo e si sposta nella
perpetuità dell’aevum,55 proiettando l’Impero nell’infinita durata del futuro. È
questo mito che Dante ridisegna nelle pagine della Monarchia e non si può
escludere allora, fra le molte proposte cronologiche, una stesura tarda del
trattato politico, contemporanea o addirittura posteriore al Paradiso.56 Con la
Monarchia l’idea imperiale riceve il definitivo sigillo, al limite estremo del
tormentato percorso politico di Dante.
Abstract
L’intervento presenta il pensiero politico di Dante in relazione all’impresa italiana di
Enrico VII. Particolare attenzione è dedicata al contradittorio rapporto fra la vicenda
storica e l’ideale imperiale della Monarchia, con una serie di sondaggi paralleli nella
Commedia.
53
54
55
56
Cfr. ID., Epistole, cit., p. 556.
Cfr. ID., Inferno, I, 100-111 e ID., Purgatorio, XXXIII, 37-45. Fra la fittissima bibliografia
critica si può vedere J. CLERICI, Ancora del “Cinquecento Diece e Cinque”, in “Studi
Danteschi”, LI, 1978, pp. 277-288; CH. T. DAVIS, L’Italia di Dante, trad. ital. Bologna, il
Mulino, 1988, pp. 57-75; P. REMBADI DAMIANI, “Un cinquecento dieve e cinque”: un’ipotesi per
risolvere l’“enigma forte” di Dante, in “Studi Danteschi”, LXX, 2005, pp. 103-117; S.
CRISTALDI, Inchiesta sul Veltro, in L’opera di Dante tra Antichità, Medioevo ed epoca moderna,
a cura di S. CRISTALDI e C. TRAMONTANA, Catania, c.u.e.c.m., 2008, pp. 125-233.
Sul concetto scolastico di aevum si veda E. W. KANTOROWICZ, Il due corpi del Re. L’idea di
regalità nella teologia politica medievale, cit., pp. 236-243.
Per una datazione al 1314 si veda M. PALMA DI CESNOLA, “isti qui nunc”, la Monarchia” e
l’elezione imperiale del 1314, in “Studi e problemi di critica testuale”, 57, 1998, pp. 107-130.
Per un quadro delle ipotesi di datazione più recenti si veda E. FENZI, È la “Monarchia”
l’ultima opera di Dante? (a proposito di una recente edizione), in “Studi Danteschi”, LXXII,
2007, pp. 215-238.
27
PIERANTONIO FRARE
Le guide nella Commedia. Un modello ermeneutico
1. QUANTE GUIDE?
Converrà cominciare questa nostra conversazione richiamando alcune cose
ovvie, che possono costituire un buon punto di partenza per approdare a
risultati non dirò nuovi, ma spero almeno poco noti. È convinzione
generalmente condivisa che le guide di Dante nel suo viaggio verso Dio siano
tre: nell’ordine dell’intreccio, Virgilio, Beatrice, san Bernardo. Come tutti
sanno, la successione ripete, in ordine inverso, quella delineata dallo stesso
Virgilio nel canto II dell’Inferno, quando ripercorre, ad uso del Dante
personaggio, la trafila che lo ha condotto da lui: la Vergine, santa Lucia,
Beatrice, egli stesso. Ripete, ma anche modifica: poiché il progetto delineato in
Inferno II viene rispettato solo per quanto riguarda Virgilio e Beatrice, mentre
santa Lucia viene sostituita da san Bernardo. Pare indubbio che si tratti di una
modifica in corso d’opera, molto probabilmente posteriore alla composizione di
Pg IX, nei cui versi 19-63 si racconta che Lucia-aquila conduce il pellegrino
all’ingresso del Purgatorio vero e proprio: ulteriore testimonianza che Dante, se
pur aveva chiaro il canovaccio dell’intera Commedia fin dall’inizio, non ne aveva
ancora stabiliti tutti i particolari; oppure, se li aveva stabiliti, che non esitava a
cambiarli, al sopraggiungere di altre e più cogenti ragioni. Se le modifiche
investivano anche parti già scritte, poteva intervenire solo se esse non fossero
anche già pubblicate; nel caso in questione, non poté farlo, probabilmente
perché l’idea di sostituire santa Lucia con san Bernardo giunse a Commedia già
parzialmente divulgata (del resto, gli ultimi canti del Paradiso furono
verosimilmente tali anche in ordine di composizione).
Non mi soffermo sulle ragioni che poterono indurre Dante alla modifica
del piano originario: già ne ha scritto Pertile, in un saggio molto interessante,
anche se forse non decisivo1. Segnalo, invece, che la corrispondenza tra If II 70114 e il macrotesto dell’intera Commedia coinvolge anche una quarta figura,
della quale si parla meno: cioè, la Vergine, che pure si colloca all’origine e alla
fine del viaggio, con una decisività che è già stata notata, ma che vale la pena di
ribadire. A If II 96 Beatrice rivela a Virgilio (il quale ne riferisce le parole a
1
Da cui ho ricavato gran parte delle osservazioni fin qui esposte: LINO PERTILE, Dimenticare
Beatrice, in ID., La punta del disio. Semantica del desiderio nella «Commedia», Fiesole, Edizioni
Cadmo, 2005, pp. 235-46.
29
Dante) un fatto fondamentale: il giudizio divino su Dante è già stato
pronunciato, ed è un giudizio di condanna. L’intervento della Vergine «frange»
quel «duro giudicio», salvando chi è già perduto: cosicché l’emergere di Dante
dalla selva è un vero riemergere dalle tenebre della morte e la sua salvezza assume
la configurazione di un miracolo vero e proprio, dovuto alla diretta intercessione
della Vergine. Ciò può avvenire perché la «benignità» di lei è tale che «non pur
soccorre / a chi domanda, ma molte fiate / liberamente il dimandar precorre».
Sono i versi 16-18 di Paradiso XXXIII, che forniscono la spiegazione psicologica
e teologica di ciò che è avvenuto a Dante all’inizio dell’opera, quando, senza suo
merito e senza averlo chiesto, viene salvato2.
Così come era stata all’origine della salvezza e del viaggio di Dante, allo
stesso modo la Vergine ne permette la conclusione: infatti, anche se l’ultima
parola e l’ultimo gesto spettano a san Bernardo, è la Madonna che consente «che
’l sommo piacer […] si dispieghi» a Dante (Pd XXXIII 33; e non credo che sia
del tutto causale che questa perifrasi che indica Dio si collochi al verso 33 del
trentatreeesimo canto). La differenza tra il progetto iniziale e quello poi
effettivamente realizzato fa sì che le guide di Dante siano in realtà cinque
(sommando quelle diciamo così in potenza e quelle in atto), tre delle quali con
doppia apparizione, iniziale e in corso d’opera (per un totale, dunque, di otto).
In ordine di comparsa nel testo le guide sono Virgilio, Beatrice, la Vergine, santa
Lucia (canti I e II); Virgilio, Beatrice, san Bernardo, la Vergine (canti I – C).
Non si perderebbe la struttura ternaria, poiché si tratterebbe pur sempre di due
coppie di tre guide (all’inizio, Virgilio, Beatrice, santa Lucia; in corso d’opera
Virgilio, Beatrice, san Bernardo), entrambe sovraordinate dalla Vergine, che
vanta uno statuto diverso e superiore; e si guadagnerebbe, credo, in
comprensione fenomenologica del testo.
2. GUIDA E DISCEPOLO: DA UNA RELAZIONE BINARIA A UNA TRINITARIA
La relazione che si instaura tra il Dante personaggio e le sue guide è
rigorosamente binaria: nel senso che essa si realizza di volta in volta tra l’agens e
il personaggio chiamato, per un tratto più o meno lungo, a ricoprire la funzione
di guida. La guide si avvicendano l’una all’altra, non si sovrappongono; anche
nell’ultimo canto del Paradiso, dove pure si verifica la compresenza di san
Bernardo e della Vergine, i ruoli sono ben distinti: il primo è propedeutico alla
seconda, tanto che Dante ha già distolti gli occhi da lui (Pd XXXIII 49-51).
2
Il collegamento tra Pd XXXIII 16-18 e If II 94ss si trova già nel commento della Chiavacci
Leonardi (DANTE ALIGHIERI, Commedia, con il commento di Anna Maria Chiavacci
Leonardi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1991, I, p. 63).
30
Una relazione duale, dunque, fondata su quel rapporto io-tu che è il
fondamento di ogni relazione, come ci ha insegnato Martin Buber; e che però a
sua volta è fondata su, e presuppone, l’esistenza di un egli, di un terzo. Nel caso
che qui ci riguarda, l’egli, il terzo, è Colui che ha consentito che fossero mandate
le guide; e coincide con Colui al quale la guida ha il compito di condurre il
discepolo. Il rapporto tra la guida e il discepolo può concepirsi solo sullo sfondo
e sul fondamento dell’obiettivo finale: Dio, insomma, che, anche quando non
nominato esplicitamente, si pone tuttavia all’origine del viaggio di Dante (è Lui,
ovviamente, ad avere permesso che la Vergine frangesse il duro giudizio che Egli
aveva già pronunciato su Dante) e si costituisce come obiettivo primo, ultimo e
unico del viaggio dantesco. Dunque, la relazione tra guida e guidato si configura, in realtà, come una relazione ternaria.
Non, però, dall’inizio: infatti, nel primo canto, Virgilio prospetta a Dante
il viaggio ultraterreno come se si trattasse di una propria iniziativa personale
(«“ond’io per lo tuo me’ penso e discerno”: If I 112), tacendo ogni riferimento
al mandato ricevuto. Sta qui, credo, la ragione essenziale del fallimento della
proposta di Virgilio: alla fine del primo canto, Dante pare muoversi, ma in
realtà non compie neppure un mezzo passo. Il viaggio comincerà solo alla fine
del canto successivo, dopo che Virgilio avrà esplicitamente dichiarato l’origine
divina della propria missione e, nel contempo, la propria dipendenza: egli può
fare da guida solo in quanto accetta e riconosce di essere stato a sua volta
guidato. Cioè, solo in quanto accetta di trasformare la relazione col suo
discepolo da esclusiva ed escludente a comprensiva e aperta, da duale o binaria
in ternaria. Se si considera che si tratta di una relazione fondata sull’amore e che
genera movimento, è facile vedere in essa un analogo della Trinità divina; un po’
come avviene per la terzina, forma metrica che riproduce in sé, per virtù del
numero e del movimento tra le rime, il numero e la dinamica inerenti alla
Trinità divina. Si tratta, credo, di una ulteriore dimostrazione della tesi svolta da
Raimundo Panikkar in un bel libretto: che la realtà stessa è trinitaria e che
l’intuizione trinitaria è una specie di universale culturale, e quindi umano3.
3. LA MORTE DELLE GUIDE
È solo se inseriamo il rapporto tra guida e guidato in questa relazione
trinitaria dinamica (da cui per imitazione – nel senso girardiano del termine nasce il movimento di Dante) che possiamo cogliere fino in fondo il significato
dell’obiettivo perseguito (e raggiunto) dalle guide di Dante: che è, generalmente
parlando, quello di annullarsi in quanto tali perché il discepolo possa conseguire
3
RAIMUNDO PANIKKAR, Trinità ed esperienza religiosa dell’uomo, Assisi, Cittadella editrice,
1989, pp. 5-7.
31
la sua autonomia. Per riprendere un celebre paragone di Wittgenstein, le guide
sono come delle scale che, una volta che hanno permesso di salire ai piani più
alti, possono essere buttate via4. Il culmine del percorso di progressiva
autonomia – e, quindi, libertà – del Dante personaggio si coglie in Pd XXXIII
49-54, quando san Bernardo lo invita, nel suo ruolo di guida, a guardare in alto,
verso la Vergine. Ma l’invito si rivela ormai del tutto superfluo, perché Dante ha
compiuto, di sua propria iniziativa, il gesto: «ma io era / già per me stesso tal
qual ei volea», frase nella quale vanno sottolineati l’uso del verbo esistenziale e
l’accentuazione del pronome personale, prima soggetto poi complemento, a
segnalare che si tratta di grazia divina, non di volontà umana.
A questa autonomia Dante era pervenuto per gradi. Il passaggio precedente
risale al commiato di Beatrice, le cui ultime parole nella Commedia sono una
profezia che riguarda Arrigo VII e Clemente V (Pd XXX 128-48). Quando
Dante, poco dopo, si volta verso di lei per porle altre domande, al posto suo
vede san Bernardo; ed è allora il discepolo stesso, in una preghiera che è – come
dovrebbero essere tutte le preghiere – lode e ringraziamento, a trarre il succo del
lungo lavoro di guida compiuto da Beatrice: «“Tu m’hai di servo tratto a
libertate / per tutte quelle vie, per tutt’i modi / che di ciò fare avei la potestate”»
(Pd XXXI 85-87)5.
È una situazione e sono dei versi che rimandano, mutatis mutandis
s’intende, al primo commiato, al discorso con cui Virgilio, alla fine di Purgatorio
XXVII, prende congedo da Dante, dichiarandone l’ormai raggiunta autonomia,
almeno rispetto a lui: «“Tratto t’ho qui con ingegno e con arte […] non aspettar
mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non
fare a suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio”» (Pg XXVII 139-42).
Dichiara l’autonomia del discepolo e, con ciò stesso, constata – chissà, forse con
un’ombra di ben comprensibile rimpianto – la propria sopraggiunta inutilità:
che il Dante autore non manca di far notare, segnalando lo sguardo pieno di
stupore con cui Virgilio risponde all’occhiata interrogativa con la quale l’agens
gli si rivolge per chiedergli lumi sulla testa della mistica processione che
comincia ad apparirgli. È l’ultimo scambio di sguardi tra i due: con esso
entrambi prendono coscienza della sopraggiunta inutilità di Virgilio, necessario
preludio alla sua sparizione, che l’auctor, con una notevole abilità narrativa, farà
vivere al lettore attraverso la sconfortata reazione dell’agens, il quale, voltatosi al
4
5
LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (1961), tr. it di A. G. Conte, Torino,
Einaudi, 1979, 6.54, p. 82.
PERTILE, Dimenticare Beatrice, cit., p. 241, ricorda un altro antecedente: Pd X 60, quando
Dante, invitato da Beatrice a ringraziare Dio di averlo tanto innalzato, si dimentica di lei (e
lei ne è contenta).
32
dolcissimo padre per trarne sostegno alla tremenda apparizione di Beatrice, non
lo trova più.
La funzione delle guide di Dante nella Commedia è dunque insieme chiara
e paradossale: esse hanno il compito di consentire al pellegrino di conseguire la
sua autonomia, cioè di non aver più bisogno di loro; e la prova della loro
perfetta riuscita consiste proprio nell’autoconsapevolezza e nella manifestazione
della loro inutilità, del loro valore puramente strumentale. Alla fine della
Commedia il pellegrino è solo – cioè, senza guide – davanti a Dio; e tenta, da
solo, di attingere il mistero: «veder voleva come si convenne / l’imago al cerchio,
e come vi s’indova» (Pd XXXIII 136-37). Si tratta di una situazione non
dissimile, a partire dallo sfondo silenzioso, da quella descritta nei primissimi
versi della Commedia, quando Dante, uscito non si sa come da una selva nella
quale, senza saper come, era entrato («io non so ben ridir com’io v’intrai», If I
10), cerca di salvarsi da solo, dirigendosi verso il colle. Ma da soli non ci si può
salvare, come l’agens impara presto a proprie spese, grazie alla paurosa lezione
impartitagli dalle belve. La somiglianza di situazione tra i primi versi dell’Inferno
e gli ultimi del Paradiso non significa, però, la riproposizione del circolare – e
immobile – ritorno dell’identico, ma si configura semmai come una figura
spiraliforme, retoricamente una correctio, caratterizzata dal movimento, poiché
sull’identità concrescono le differenze, assai più significative. Tanto per
cominciare, la solitudine iniziale è assenza di qualunque relazione, con Dio e
con gli uomini, mentre il silenzio finale è condizione della relazione diretta con
Dio, conseguita attraverso un percorso fitto di relazioni con le anime; in
secondo luogo, Dante – impossibile qui distinguere tra l’auctor e l’agens –
mostra di aver messo a frutto la lezione imparata dalle sue guide, che è poi una
lezione di umiltà, dichiarando che «non eran da ciò le proprie penne». Il
riconoscimento della propria insufficienza, l’annullamento della resistenza che il
sé offre all’intervento di Dio, apre la strada alla subita e istantanea rivelazione
della Grazia: «se non che la mia mente fu percossa / da un fulgore in che sua
voglia venne».
4. DANTE E VIRGILIO
Dopo aver delineato in generale la natura e la funzione delle guide nelle
loro relazioni con il discepolo, vorrei dedicare un po’ di tempo all’esame del
rapporto tra Dante e Virgilio. Virgilio è la prima guida di Dante, e quella che lo
accompagna per più tempo e spazio; insisterei sul fatto che è la prima, perché
ciò significa che il rapporto che si instaura tra i due costituisce l’origine, la
matrice – l’imprinting, vien quasi da dire – delle relazioni tra guida e guidato.
Ho già cercato di dimostrare altrove che il ruolo di guida di Virgilio si esplica
soprattutto attraverso la parola: essa innanzitutto rimuove la paura che si era
33
impadronita di Dante all’inizio del primo canto, in seguito riesce – dopo il
fallimento cui va incontro nel canto iniziale – a far muovere Dante6. Alla fine
del secondo canto, il lunghissimo discorso in cui Virgilio dimostra la propria
legittimità a fare da guida ottiene il risultato di indurre finalmente Dante a
compiere quel primo passo su cui era rimasto bloccato alla fine del canto
precedente. È da questo momento che Virgilio assume in pieno il proprio ruolo
di guida.
Dunque, sono state le parole di Virgilio a far muovere Dante, come credo
che nessuno dubiti e come, del resto, lo stesso agens si premura di riconoscere:
«“tu m’hai con desiderio il cor disposto / sì al venir con le parole tue / ch’io son
tornato nel primo proposto”» (If II 136-38). Eppure, i versi immediatamente
successivi, ancora pronunciati dall’agens, aprono una prospettiva diversa e
complementare: «“Or va’, ch’un sol volere è d’ambedue: / tu duca, tu segnore e
tu maestro”. / Così li dissi; e poi che mosso fue, / intrai per lo camino alto e
silvestro». In questi ultimi quattro versi, per due volte si mette in scena la
situazione reciproca: sono le parole di Dante a far muovere Virgilio, sia nel
discorso diretto dell’agens («“Or va’…”»), sia nella didascalia apposta dall’auctor
(«Così li dissi; e poi che mosso fue…»).
Naturalmente, non intendo certo negare la lettura tradizionale, né
rovesciarla, con un facile gioco retorico: Virgilio resta la guida, Dante resta il
discepolo. Ma certo è che questi versi consentono di delineare in modo non
unidirezionale, bensì reciproco la relazione tra le due figure e consentono di
apprezzare la straordinaria modernità di Dante, anche dal punto di vista delle
teorie pedagogiche. Il miglior maestro non solo è quello che realizza
compiutamente il proprio ruolo (una volta si diceva missione: parola bella, resa
inutilizzabile dalla sua recente contaminazione con l’inglese mission) quando
spende tutto sé stesso per consentire al discepolo di realizzare la propria libertà;
ma è anche quello che si apre agli insegnamenti provenienti dal discepolo stesso,
rendendolo suo collaboratore nell’opera educativa; è quello che, più
radicalmente, riconosce che egli può esistere in quanto guida perché esiste un
discepolo, e che da questo discepolo è disposto ad imparare. Non moltiplico gli
esempi, per non appesantire il discorso, limitandomi a citare due casi.
Il primo riguarda la struttura narrativa dell’opera. Ovviamente, è la guida
attenta e oculata – anche se non priva di errori, a volte corretti dallo stesso
discepolo – di Virgilio che consente a Dante di giungere fino al Paradiso
terrestre. Non si dovrebbe però dimenticare che il Virgilio personaggio della
6
PIERANTONIO FRARE, Il potere della parola. Dante Manzoni Primo Levi, Novara, Interlinea,
2010, pp. 17-45 (già in «Lettere italiane», LVI, 4, 2004, pp. 543-69 con il titolo Il potere della
parola. Su «Inferno» I e II).
34
Commedia – non quello storico, s’intende – non era mai uscito dall’inferno (né,
del resto, lo avrebbe potuto, a rigor di legge testuale), anche se lo aveva in
precedenza percorso fino al suo infimo punto, cioè fino al cerchio di Giuda,
come si premura egli stesso di rendere noto a un Dante molto preoccupato per
il suo fallimento di fronte ai demoni della città di Dite (If IX 25-30). Se ora può
superare quei confini, innanzitutto tornando sulla terra (esattamente, sulla
piaggia diserta), poi percorrendo l’intero purgatorio, fino a godere addirittura
della visione del Paradiso terrestre, ciò gli è consentito dal fatto di essere stato
chiamato a guidare Dante: è dunque grazie al discepolo che la guida supera i
propri limiti e che può conoscere il nuovo, accettando di divenire di fatto
discepolo del suo discepolo, in reciprocità di ruoli.
Il secondo esempio che intendo offrire concerne il punto decisivo
dell’investitura di Virgilio come guida. Torniamo dunque ai primi due canti, più
esattamente al secondo: esso si apre con una lunga e articolata domanda di
Dante, che viene normalmente intesa e riassunta in questo modo: “Io, Dante,
sono degno di compiere il viaggio che tu mi proponi?”. Certo, tanta facilità di
parafrasi dovrebbe venir messa a dura prova dal verso con cui Dante viator sigilla
il proprio discorso: «“se’ savio: intendi me’ ch’i’ non ragiono”» (If II 56). Se la
domanda di Dante è chiara, perché mai Virgilio dovrebbe usare tutta la propria
sapienza e saggezza per capire “meglio” – di più, in buona sostanza – di quanto
D. non abbia saputo o voluto dire? Normalmente i commentatori moderni
glissano su questa difficoltà, seguendo forse Barbi, che vede qui una «formula
usuale delle concioni»7. Tuttavia, a tacer del fatto che il secondo degli esempi
addotti da Barbi è posteriore alla Commedia e, a mio parere, risente della lettura
di essa; a tacere del fatto che tipica di Dante è la capacità di ravvivare e
significare forme e formule stereotipe, bisogna almeno dire che alla precedente
difficoltà se ne accoppia un’altra: infatti, la sesquipedale risposta di Virgilio (ben
84 versi: dal 43 al 126) dice molto più di quanto non paia necessario: la
rivelazione della trafila Vergine-Lucia-Beatrice-Virgilio pare funzionale non
tanto (o, almeno, non solo) a confortare Dante sulla propria dignità a compiere
il viaggio, quanto a rassicurarlo sul fatto che egli, Virgilio, sia per lui una degna
guida. E c’era ben bisogno di questa rassicurazione, se si ricorda che Virgilio, alla
fine del canto precedente, aveva prospettato al suo discepolo che lo avrebbe
guidato in un viaggio non solo difficile e doloroso, ma diretto ad un luogo in
cui egli non aveva il diritto di entrare, perché «l’imperador che lassù regna» non
ce lo voleva, in quanto era stato «rebellante» alle sue leggi (quale che sia il
significato preciso da attribuire al termine; ma confesso che preferisco,
7
MICHELE BARBI, Problemi di critica dantesca. Prima serie 1893-1918, Firenze, Sansoni, 1975,
p. 202.
35
all’interpretazione letterale di Hollander, quella meno radicale di Inglese: «non
osservante»8). Sarà quindi costretto a lasciarlo con altra guida, di lui più degna
(sarà proprio un caso che Dante riprenda il medesimo aggettivo parlando di sé?
ripetizione che sembra trascinare anche quella di «me’», sia pure con diverso
valore grammaticale, detto da Virgilio a I 112 e ripetuto da Dante nel verso
sopra citato). Noi sappiamo che si tratta di Beatrice: può essere che, nel
momento in cui componeva quei versi, nemmeno il Dante autore sapesse
precisamente a chi riferirli, almeno stando alle ipotesi di Martinelli9. Certo è che
non lo sapeva il Dante personaggio: se rileggiamo per intero il sommario del
viaggio ultraterreno fatto dalla guida (I 112-26), ponendoci nei panni del viator
ancora terrorizzato, esso acquista, credo, un alone di senso ben più misterioso e
molto meno rassicurante di quello che noi, dopo tante letture, inevitabilmente
vi attribuiamo. Di qui l’immobilità di Dante, che vuol sapere da colui che gli si
è proposto come guida («“Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi
segui ed io sarò tua guida”», If I 112-13) non solo se lui Dante è degno di compiere quel viaggio, ma soprattutto per mandato di chi egli Virgilio voglia condurlo fino a un luogo che non conosce, da un Dio alle cui leggi fu «rebellante».
Il «parlar coverto» di Dante10 – «coverto», sì, ma ben decifrabile dal «savio»
– forza Virgilio a rivelare l’origine del suo intervento e a prendere atto che, se
nessuno può salvarsi da solo, allo stesso modo nessuno può guidare se non è
stato prima guidato e se non riconosce di esserlo stato. La domanda di Dante,
cioè – e questo è il primo caso, ma non l’ultimo – facilita (forse addirittura
obbliga) Virgilio a chiarire meglio a sé stesso il proprio ruolo, gli permette di
andare oltre il proprio limite, che resta quello fissato nel primo canto.
Tra Dante e Virgilio si instaura insomma una vera e propria «relazione
dialettica (nel senso originario di discussione per domande e risposte)»11 della
quale – è questo il punto sul quale vorrei insistere – beneficiano entrambi.
JOHN HOLLANDER, Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia», Firenze, Olschki, 1983
(trad. di Anna Maria Castellini), pp. 125-28; Dante Alighieri, Commedia. Inferno, Revisione
del testo e commento di Giorgio Inglese, Roma, Carocci editore, 2007, p. 29.
9
BORTOLO MARTINELLI, Genesi della «Commedia»: la selva e il veltro, in «Studi danteschi»,
LXXXIV (2009), pp. 79-126, in particolare p. 88: «Nel canto X troviamo per la prima volta
il riferimento esplicito a Beatrice, a cui viene demandata la funzione di fornire i definitivi
chiarimenti relativi alle profezie riguardanti il futuro del poeta-personaggio al suo rientro in
terra (Ciacco, canto VI; Farinata, canto X). Ed è in questo contesto che si delinea il pieno
ruolo di Beatrice come adiuvante sacro e come guida, e Dante provvede a scrivere il canto II,
accorpandolo al canto I, per farne un unico modulo bipartito, rimediando così a quanto di
equivoco aveva lasciato presentire nel canto I con l’immagine della salvezza del naufrago, non
propiziata, in forme esplicite, da alcun ausilio della grazia divina”.
10
Sarà Dante stesso a definire in questo modo una domanda identicamente sottintesa, formulata
a Virgilio nel canto IV, 46-51.
8
36
Poiché mi paiono un po’ eccessive quelle letture, nate a partire da un importante
saggio di Hollander, che insistono sulle vere o presunte défaillances di Virgilio,
vedendo in Dante una sorta di sadico compiacimento ogni volta che può
cogliere in fallo il suo maestro12. Naturalmente, i vari casi andrebbero discussi
singolarmente: nel complesso, tuttavia, pare a me che Dante riconosca in
Virgilio il detentore di una parola che è insieme «ornata» e «onesta», e decida
quindi di accoglierlo come propria guida; il che non significa che egli
dimentichi che Virgilio è pagano e, di conseguenza, inferiore a lui. Dante, ad
ogni modo, sa bene che non è il caso di insuperbire di tale superiorità, poiché
essa è un dono della Grazia; certo, è questa superiorità che consente al discepolo,
quando sia necessario, di correggere la propria guida, e quindi condurla più
avanti; ma se il discepolo può questo, è perché ha riconosciuto il ruolo della
propria guida ed è stato condotto da essa fino a quel punto.
5. DANTE PERSONAGGIO - DANTE AUTORE
La relazione dialettica che si instaura tra Dante e Virgilio costituisce il
modello su cui si plasmano le relazioni tra altri personaggi della Commedia:
tanto per cominciare, tra il Dante personaggio e il Dante autore. Nella finzione
testuale – finzione presentata come verità – il Dante personaggio, compiuto il
proprio itinerario, si fa infatti guida del Dante autore, dettandogli («“I’ mi son
un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro, vo
significando”»: Pg XXIV 52-54) quello che ha visto, fedele a una ingiunzione
che ha ricevuto più volte (si ricordino almeno le parole di Cacciaguida in Pd
XVII 128: «“tutta tua visïon fa manifesta”») e che egli fa manifestamente propria
(si ricordi il paragone col pellegrino in Pd XXXI 43-5, dove il personaggio si
prepara a diventare narratore: «E quasi peregrin che si ricrea / nel tempio del suo
voto riguardando, / e spera già ridir com’ello stea»). E quella che ho appena
pronunciata è affermazione ovvia; tentiamone allora una forse un po’ meno
ovvia. Mi pare di poter dire che sono l’assiduo lavorìo linguistico dell’auctor, la
sua laboriosa e inintermessa ricerca dell’espressione più congrua, lo strenuo
inseguimento di un dire che non sia diverso dal fatto («sì che dal fatto il dir non
Cfr. L. DERLA, L’altro Virgilio dantesco, «Testo», 29-30 (1995), pp. 40-71: 40: «Una miglior
comprensione della sua stessa [di Dante] natura di personaggio non sembra possibile se non
si tien conto del fatto che egli fa coppia con Virgilio, deuteragonista, il quale solo
eccezionalmente si eclissa per lasciar torreggiare il pellegrino. Più radicalmente, è la sua
relazione dialettica (nel senso originario di discussione per domande e risposte) con la Guida
a determinare l’evoluzione poetico-critica del personaggio Dante».
12
HOLLANDER, Il Virgilio dantesco, cit. Si veda anche il bel saggio di E. FUMAGALLI, Il giusto Enea
e il pio Rifeo, in IDEM, Il giusto Enea e il pio Rifeo. Pagine dantesche, Firenze, Olschki, 2012,
pp. 1-33.
11
37
sia diverso»: If XXXII 12) che consentono al viator di rivivere – di ridare forma
e sostanza – all’esperienza fatta e di recuperarne più compiutamente, e in modo
irrevocabile, se non la totalità di essa, almeno gli effetti. Ce lo rivela, in
particolare, una terzina del canto XXXIII, in cui la distanza tra l’agens e l’auctor,
massima all’inizio del viaggio, si è ormai quasi annullata13. Dopo aver tentato di
descrivere, grazie all’immagine del volume squadernato, il rapporto tra la
molteplicità delle cose create e l’unità del Creatore, Dante scrive: «La forma
universal di questo nodo / credo ch’io vidi, perché più di largo / dicendo questo,
mi sento ch’io godo» (91-93). Il fatto di avere detto (o scritto?) ciò («dicendo
questo»), cioè di aver messo in forma linguistica quell’immagine, che pure è «un
semplice lume» rispetto allo splendore del vero, costituisce la condizione
necessaria e sufficiente per replicare l’esperienza di godimento già provata («più
di largo mi sento ch’io godo») e quindi per confermare nel pellegrino la certezza
della visione. Io – Dante autore – grazie al solo fatto di aver detto così, provo
un piacere maggiore e più profondo («più di largo»), il che mi rende ancor più
certo che, quando ero personaggio, avevo davvero visto «la forma universal di
questo nodo». Il Dante autore si fa, in tal modo, guida del Dante personaggio,
lo aiuta ad attingere la consapevolezza della verità della visione. Forse perché
non basta, a render completa la visione stessa, avere visto: occorre dire, perché
essa diventi intelligibile e comunicabile. Il Dante autore scrive quello che il
Dante personaggio ha visto; ma il Dante personaggio vede (o, almeno, ri-vede)
quello che il Dante autore racconta. Il Dante personaggio ha senz’altro visto più
cose o più in profondità (almeno, così ci dice): fatto sta, però, che la visione
prende forma attraverso la scrittura, la quale sola la fa consistere. Non sto
negando, si badi, la verità – interna alla finzione letteraria, s’intende – della
visione, né intendo aderire al relativismo linguistico: sto dicendo che il Dante
autore non è uno strumento passivo del Dante personaggio, non è lo scriba che
potrebbe essere sostituito da un altro; è colui che permette alla visione di farsi
parola, che la traduce in linguaggio; e che, traducendo la visione, la tradisce e la
riduce, certo, ma anche la precisa e la orienta – rispetto agli uomini, s’intende,
non rispetto a Dio14. Dunque, se è ovvio che il Dante personaggio è guida del
Dante autore, il quale ha bisogno di lui; è meno ovvio, ma non meno vero, che
allo stesso modo il Dante personaggio ha bisogno del Dante autore, il quale lo
guida a rivivere la sua stessa visione.
6.
13 L TESTO E IL LETTORE
JOHN FRECCERO, Dante. La poetica della conversione, Bologna, il Mulino, 1989, trad. di C.
Calenda (ed. or. Dante. The Poetic of Conversion, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1986).
14
Esamina acutamente questi versi, ricavandone altre considerazioni, PIERO BOITANI, Il tragico
e il sublime nella letteratura medievale [1989], trad. it. di Marina Peri, Claudia Castellani, Nives
Coppari, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 323-24.
38
Una volta conclusa la Commedia, la funzione guida passa dall’autore al
testo; e discepolo è, ovviamente, il lettore (quello implicito, s’intende). Infatti,
qualunque opinione si abbia sull’autenticità dell’epistola a Cangrande15, restano
indubbi almeno due fatti: che la Commedia si propone di portare il proprio
lettore all’incontro con Dio e che essa conta su un lettore che sia in grado di
crescere assieme al testo, che sviluppi man mano la propria abilità, le proprie
conoscenze, la propria competenza in modo da riuscire a non perdere la scia del
«legno che cantando varca». In coerenza con lo schema ermeneutico che ho
seguito fin qui, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che anche in questo caso
la relazione tra la guida e il discepolo, tra il testo e il lettore è biunivoca,
reciproca, dialettica.
Porto un solo esempio (altri se ne potrebbero addurre, anche grazie allo
spoglio e all’analisi condotte da Giuseppe Ledda nel suo bel libro sulla Guerra
della lingua16): è l’esistenza di quei «pochi» che drizzarono «il collo / per tempo
al pan degli angeli» che costruisce l’orizzonte linguistico, ideologico, tematico
dell’autore, in un rapporto che è di reciproca crescita. Del resto, è cosa nota che
il lettore implicito introiettato dall’autore implicito e depositato nel testo ne
orienta, in una feconda dialettica, le scelte. Basti ripercorrere, da questo punto
di vista, gli ultimi versi della Commedia: l’esplicita e continua dichiarazione di
insufficienza del proprio dire sarebbe inspiegabile se non postulasse un interlocutore tale – nelle conoscenze e nell’orizzonte di attesa – da poter pretendere
una resa fedele della visione, e nello stesso tempo tanto consapevole dei limiti
umani da potere accettare l’inadeguatezza del dire.17
7. LA COMMEDIA COME GUIDA
La Commedia, dunque, oltre a mille altre cose, racconta anche la vicenda di
un personaggio che da discepolo diventa guida, attraverso un apprendistato che
comincia fin dal primo canto; e, anche per questo motivo, può usare la propria
struttura verbale per fungere da Guida, nel senso in cui la intende María Zambrano: genere letterario che unisce poesia e filosofia, forma di conoscenza che
Si vedano, da ultime, le considerazioni contro l’autenticità di ALBERTO CASADEI, Il titolo della
«Commedia» e l’epistola a Cangrande, «Allegoria», 60, 2010, pp. 167-81.
16
GIUSEPPE LEDDA, La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella «Commedia» di
Dante, Ravenna, Longo editore, 2002, pp. 117-58.
17
Così conclude Ledda, nel libro già citato, l’analisi degli appelli al lettore: «Ma soprattutto gli
appelli contribuiscono non solo a ‘creare il lettore’, secondo la formula dell’Auerbach, ma
anche a creare l’autore, ad autorappresentare il narratore come testimone verace, come profeta,
ma soprattutto come poeta e autore di un’opera poetica eccezionale, sempre in lotta con la
propria materia e con i limiti dei propri strumenti umani» (ivi, pp. 155-56).
15
39
supera la frattura tra la ragione e la vita, «proiettata completamente verso chi
legge» e proprio per ciò capace di far uscire l’individuo perplesso che è in
ciascuno di noi dalla situazione di stallo in cui si trova, provocandolo al
movimento.18
La Guida è un «sapere che salva» perché, in quanto adatto (aptum) a
ciascuna persona diversa («Ogni Guida è tale per qualcuno che ha bisogno di
uscire da una certa situazione della sua vita»),19 ne trasforma la stasi (che è già
sul punto di diventare retrocessione, come il viator sperimenta in più occasioni)
in «cammino di vita»20 e offre un modello in continuo divenire, che si fonda sul
reciproco arricchimento tra guida e guidato: «L’immagine che [le guide] ci
offrono, la visione di ciò che dobbiamo essere, non si presenta confrontandosi
con ciò che siamo, bensì sviluppandosi in un movimento che tende
irresistibilmente a essere seguito»:21 cioè, imitato, e quindi riprodotto.
Ciascuno vede quanto queste righe, che alla Zambrano sono ispirate dalla
tradizione spagnola e in particolare dal Dottore dei perplessi di Maimonide,
calzino alla Commedia, specialmente se facciamo perno proprio sulla funzioneguida, che si trasmette da Virgilio (e Beatrice e Bernardo) al Dante viator, da
questi al Dante auctor, dall’auctor alla Commedia e, finalmente, dalla Commedia
al lettore. Qui, pur riconoscendo che la funzione performativa è essenziale alla
Commedia, dovremmo far punto, poiché non è di nostra pertinenza la ricerca di
casi biografici di ‘conversione’ (anche solo alla funzione-guida) provocati dalla
Commedia.
Tuttavia, non so rinunciare a proporre un esempio letterario, o
quantomeno la trascrizione letteraria di un fatto reale: mi riferisco al capitolo 11
del libro di Primo Levi Se questo è un uomo. Il capitolo si intitola Il canto di
Ulisse. Anche se la vicenda è notissima, la richiamo brevemente. Jean, il
benvoluto «Pikolo» (cioè il «fattorino-scritturale, addetto alla pulizia della
baracca, alle consegne degli attrezzi, alla lavatura delle gamelle, alla contabilità
delle ore di lavoro») del «Kommando Chimico» ha scelto Primo come aiutante
per il ritiro del rancio. In questo spazio-tempo privilegiato, perché sottratto alla
ferrea legge del lavoro disumano, Jean chiede a Primo di insegnargli l’italiano e
Primo decide di farlo, sorprendentemente, attraverso la Commedia, attraverso
appunto il canto di Ulisse.
MARÍA ZAMBRANO, La ‘Guida’, forma del pensiero, in ID., Verso un sapere dell’anima, Milano,
Raffaello Cortina, 1996 (ed. or. 1991; trad. di E. Nobili).
19
Ibi, p. 66.
20
Ibi, p. 63.
21
Ibi, p. 77.
18
40
Questo brano di Levi ci consente di spingere un poco oltre la nostra
riflessione, di guadagnare altro terreno pur restando nell’ambito del letterario,
grazie all’aiuto che ci fornisce il concetto di «applicazione», inteso da Gadamer
come superamento, da parte dell’interprete (cioè, in questo caso, del
personaggio Primo), della distanza – temporale, culturale, ideologica etc - che lo
separa da un testo e come coinvolgimento esistenziale nella comprensione di
esso22: la ripetizione e l’ascolto delle parole del canto di Ulisse trasformano
Primo in guida e Pikolo in guidato, ma tra la guida e il guidato si stabilisce un
rapporto in cui la subordinazione è già incrinata e il secondo si appresta a sua
volta a diventare guida. Rivelatrice è la frase con cui Primo replica mentalmente
alla preghiera di Pikolo di ripetere: «Come è buono Pikolo. Si accorge che mi
sta facendo del bene».23 Quanto di questo bene reciprocamente trasmesso
attraverso la Commedia pertenga alla pagina scritta e quanto alla vita è difficile
dire, anche se la testimonianza resa da Pikolo/Jean Samuel anni dopo è
fortemente significativa al riguardo.24
Allora anche Pikolo, come Dante, finisce per diventare una guida:
esattamente, guida di Primo, guida della sua guida: infatti, se è vero che Primo
guida Pikolo nell’apprendimento dell’italiano e nella scoperta di quel «qualcosa
di gigantesco» contenuto nelle parole di Dante, è altrettanto vero che è Pikolo a
scegliere Primo come compagno per la corvée del rancio, che è lui a tracciare il
percorso, infine che sono le sue domande che stimolano Primo a richiamare alla
memoria, con la maggior esattezza possibile, i versi danteschi.
Anche la relazione tra Primo e Pikolo, dunque, si configura come una
relazione dialettica, basata sulla reciprocità, sulla interscambiabilità dei ruoli, in
una parola, sull’eguaglianza (che è esattamente il contrario della logica di
sopraffazione vigente nel Lager, pure essa fondata, oltre che sulla violenza fisica,
anche sull’esercizio – distorto – della parola). Pikolo e Levi, grazie al potere della
parola di Dante, si fanno reciprocamente guida l’uno dell’altro verso il
HANS GEORG GADAMER, Verità e metodo, trad. e cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani,
1972, in particolare pp. 635-43.
23
PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, a cura di Simona Brenna e Elefteria Morosini, Einaudi
scuola, Torino 2010, p. 102. Cito da questa edizione perché arricchita dalle note, da una
Prefazione 1972 ai giovani e da una Appendice del 1976 stese dallo stesso Levi.
24
«Pourquoi a-t-il choisi Dante? Et pourquoi le Canto di Ulisse? Bien sûr, je n’ai pu que suivre
les efforts désespérés pour retrouver le texte, la découverte d’une lecture nouvelle, dans un
Enfer que même Dante n’avait pu immaginer. Mais j’ai vécu avec Primo par un effort subtil
d’interprétation (sur un même longueur d’onde), un moment de très grande exaltation
intellectuelle, qui fait partie depuis lors de notre patrimoine émotionelle commun»: J.
SAMUEL, Depuis lors, nous nous sommes revus souvent, in Primo Levi. Il presente del passato,
Consiglio Regionale del Piemonte-Aned, Milano, Franco Angeli, 1991, p. 24.
22
41
traguardo, confusamente intravisto ma infine raggiunto e posseduto
irrevocabilmente, dell’intuizione che un altro tipo di relazione tra uomini è
ancora possibile, perfino dentro il Lager. Il modello su cui impostare questa
relazione è offerto, una volta di più, dalla Commedia: non è però quello del
rapporto tra Ulisse e i suoi compagni (che è, semmai, l’antimodello da rifiutare,
attraverso la censura dell’oblio), ma quello del rapporto tra Dante e Virgilio.
7. UN MODELLO ERMENEUTICO?
A conclusione di questa mia chiacchierata, vorrei proporre a voi, miei
ascoltatori, di provare a spingere alle ultime e coerenti conseguenze il percorso
che ho delineato: quel che ho tentato di fare è cercare di spiegare il modello
soggiacente alla relazione che si instaura tra la guida e il discepolo nella
Commedia. Essa si presenta nella forma di una dialettica che va ben oltre quella
socratica, perché postula un’attiva collaborazione tra i due interlocutori,
collaborazione che sgretola la fissità dei ruoli di maestro e di discepolo,
rendendoli di fatto intercambiabili. Si realizza in tal modo una collaborazione
paritetica tra guida e guidato, una sinergia che permette che tra i due soggetti si
dia vita a quella che Gadamer chiama la «fusione di orizzonti», consentita dal
comune riferimento a un terzo elemento, l’obiettivo da raggiungere insieme
(talvolta, la guida lo raggiungerà non direttamente ma attraverso il discepolo,
come è il caso di Virgilio; Primo e Jean lo raggiungono insieme)25.
Ma, se le cose stanno così, non troviamo qui, nel rapporto tra Dante e
Virgilio, un modello del rapporto che si stabilisce – che si dovrebbe stabilire tra il testo e l’interprete? Il testo è, ovviamente, guida del suo interprete (o,
almeno, dovrebbe esserlo, in una situazione ideale), ma sono le domande
dell’interprete che consentono al testo di liberare, se non tutte, molte delle
potenzialità che resterebbero altrimenti solo latenti in esso, al puro stato di
virtualità; e l’obiettivo comune cui il testo (l’intentio operis) e l’interprete mirano
è la miglior comprensione possibile dell’opera.
Possiamo proseguire ancora oltre, sfruttando un suggerimento di Francesco
Spera, che ha notato la necessità, per il lettore d’oggi, di trovare nei critici
danteschi delle «guide analoghe» a quelle che accompagnano Dante,
«modernamente sagge e sapienti». A partire da queste parole, possiamo
finalmente raggiungere la nostra esperienza: il rapporto tra Dante e Virgilio
come l’abbiamo visto, non si riproduce forse in ogni relazione didattica, anche
in quella che si stabilisce oggi e qui tra di noi? Perché se io – del tutto
immeritatamente – e i miei colleghi possiamo essere ritenuti, limitatamente a
25
GADAMER, Verità e metodo, cit., p. 633 e passim.
42
questa giornata, s’intende, vostre guide, ciò può avvenire solo perché ci siete voi,
cioè dei discepoli che con la vostra presenza, silenziosa ma non per questo meno
interrogante, mi costringete a riflettere meglio e a dare forma ad argomenti e
punti che altrimenti lascerei in una nebulosa indeterminata. E può avvenire
anche perché entrambi – voi e io – ci poniamo in ascolto e al servizio di un
terzo: quella straordinaria opera che è la Commedia, capace, ad ogni nuova
lettura, di sprigionare significati ulteriori e di coinvolgerci personalmente, per
quanta distanza ermeneutica si voglia mettere.
Il coinvolgimento – che è ciò che Gadamer chiamerebbe applicazione –
avviene non per tutti, oggi, in forza delle convinzioni religiose che hanno fatta
nascere la Commedia e la innervano (anche se è chiaro che esse costituiscono il
fondamento delle scelte formali), ma per ragioni meno evidenti e più cogenti,
cioè grazie alle matrici formali che Dante vi mette in opera e che hanno una
grande forza modellizzate e un elevato valore interpretativo. Una di esse è la
relazione tra Dante e Virgilio, che si costituisce come interpretante e matrice di
ogni relazione tra guida e discepolo, nella finzione letteraria e fuori di essa.
Relazione così profondamente umana e così largamente diffusa che potremmo
ben definirla, mi pare, un universale antropologico. Di esso la Commedia
fornisce un esempio mirabile e una penetrante chiave di lettura.
43
ROMANO MANESCALCHI
Sul primo canto dell’Inferno: nuove prospettive di interpretazione
Questo è quanto succede, in una breve sintesi, nel primo canto dell’Inferno:
il protagonista (Dante stesso) dice di “ritrovarsi” in una selva oscura, avendo
smarrito la «diritta via» (v. 3). Il tentativo che fa per uscirne è frustrato da tre
fiere (lonza, leone, lupa) che lo fanno di nuovo “ruinare” (v. 61) in basso, dalla
posizione un po’ più in alto, fuori della selva, che aveva conquistato. A questo
punto gli si presenta un personaggio, che risulterà essere Virgilio, cui il poeta
chiede aiuto. Virgilio, valutata la posizione di Dante, pensa che egli non sia
ancora pronto ad affrontare l’ascesa del colle e gli propone un viaggio
nell’oltretomba, per fortificarsi: e riprendere, crediamo successivamente a questo
viaggio, a questa meditazione, il cammino ora interrotto: prospettiva da tenere
in conto, pensando alla richiesta che il poeta fa a Beatrice nel congedarsi da lei:
«La tua magnificenza in me custòdi, / sì che l’anima mia, che fatt’hai sana, /
piacente a te dal corpo si disnodi» (Par. XXXI 87-90).1 Il che significa che Dante,
fatto il viaggio, fatta questa meditazione, dovrà tornare a misurarsi con i
problemi concreti di ogni giorno e riprendere l’ascesa di quel “colle” (Inf. I 13),
ascesa che aveva abbandonato per non essere ancora pronto ed a cui, come
frutto del viaggio oltremondano, allora pronto invece dovrebbe risultare, anche
se con permanenti pericoli come per chiunque in questa vita (nonostante la
garanzia rilasciatagli da Beatrice): insomma ciò che lui conquista su di un piano
1
Richiesta non ripetuta, secondo una tesi che sta prendendo piede, a Par. XXXIII, 34-39, come
invece ancora si legge in quasi tutti i commenti. Che d’altro si parli in quei versi è stato di
recente riproposto (dopo una fugace apparizione già nei primi commentatori) da LINO
PERTILE, L’estremo oltraggio, in La punta del desio, semantica del desiderio nella Commedia,
Fiesole (Firenze), Cadmo, 2005, pp. 247-263, già pubblicato col titolo «Paradiso», XXXIII:
l’estremo oltraggio, in «Filologia e Critica», VI, 1981, pp. 1-21. La schiera dei critici che
sostengono questa nuova tesi è ormai molto vasta. Di particolare rilievo gli interventi di: M.
AVERSANO, La conclusione della Commedia, in ID. La quinta ruota. Studi sulla ‘Commedia’,
Torino, Tirrenia Stampatori, 1988, pp. 189-221; G. BÁRBERI SQUAROTTI, La preghiera della
Vergine: Dante e Petrarca, in «Filologia e Critica», XX 1995, pp. 365-74; P. A. PEROTTI, La
preghiera alla Vergine (Par. XXXIII 1-39), in «L’Alighieri» n.s. 6, anno XXXVI, 1995, pp. 75-83
(e specificamente pp. 80-81); R. PINTO, Il viaggio di ritorno: Pd. XXXIII 142-45 in «Tenzone»,
4, 2003, pp. 199-226; S. SARTESCHI, Il canto XXXIII del ‘Paradiso’, in EAD., Il percorso del poeta
cristiano. Riflessioni su Dante, Ravenna, Longo, 2006, pp. 173-92; GIUSEPPE LEDDA Paradiso
XXXIII 1-57, in Lectura Dantis Scaligera 2005-2007, a c. di E. SANDAL, Antenore, 2008, pp. 97135 (saggio quest’ultimo corredato da un’amplia bibliografia); R. MANESCALCHI, «… o mente che
scrivesti… / … la tua nobilitate» (Inf. II 8-9), «Campi Immaginabili», 40/41, 2009, pp. 46-58.
45
speculativo dovrà esser poi messo alla prova e realizzato sul piano pratico della
lotta quotidiana contro il peccato).
Cercheremo di capire meglio la situazione creata dal poeta alla luce di
alcune teorie emerse ultimamente, teorie che – è necessario ricordarlo – se sono
state “apprezzate” con la pubblicazione sulle riviste specializzate del settore (ed
anche con la loro convocazione a questo Convegno), sono tuttavia ancora sub
judice.
Ci soffermeremo soltanto sui punti salienti di questa nuova prospettiva di
interpretazione riguardo questo primo canto, introduttivo; e che quindi proietta
le sue interpretazioni su tutta l’opera, riassumendo rapidamente il resto della
narrazione, generalmente da tutti condiviso.
1) Dante “si ritrova” in una «selva oscura» (v. 2), “immagine” del peccato:
muovendosi in essa riesce ad uscirne - «ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto»
(v. 13). Questa «selva oscura» è detta subito dopo «valle» («là dove terminava
quella valle» v. 14):2 e come ripetuto più oltre a Inf. XV 50: «mi smarri’ in una
valle», e forse a Par. XVII 63: «con la qual tu cadrai in questa valle». E dunque è
una “valle selvosa”: la «valle di lacrime» della Bibbia?3 Con il termine “valle”
Dante solitamente intende una “cavità”, una “buca” ed a questa idea riconduce
il verso «mentre ch’i’ rovinava in basso loco» (Inf. I 61), essendo del tutto
evidente che non si “ruina” in un debole pendio: c’è poi il fatto che avanzando
in essa il poeta dice di entrare in un «cammin alto e silvestro» (Inf. II 142): in
che senso «alto», se non in quello di “profondo”, come per solito nel poeta?4 La
Per maggiori indicazioni su questo argomento vd. R. MANESCALCHI, La Configurazione
geografico-morale dell’oltretomba dantesco, apparso primamente in «Il Rinnovamento», Napoli,
nn. 104-105, dic. 1882, n. 106, genn. 1983, n. 108 marz. 1983, poi, riveduto e corretto, in
“Annali”, Città di Castello, Liceo Classico Plinio il Giovane, 1997, pp. 79-111; ed infine nel
volume di ID., Il Prologo della Divina Commedia, Torino, Tirrenia Stampatori, 1998, pp. 89111. Le varie argomentazioni vengono qui riprese sommariamente con qualche variazione e
integrazione.
3
Vd. «Beatus vir cuius est auxilium abs te: / ascensiones in corde suo disposuit in valle
lacrimarum [...]», Psalmi LXXXVIII 6. Il raccordo tra la valle selvosa e la valle di lacrime apparve
di sfuggita anche a Michele Barbi: «Non s’ha certo da intendere che […], rimessa la lupa
nell’inferno, il male avesse a scomparire dal mondo. Vi saranno pur sempre i malvagi e la terra
sarà sempre una valle di lacrime», Per la genesi e l’ispirazione centrale della Divina Commedia in
Problemi fondamentali per un nuovo commento Firenze, Sansoni, 1955, p. 37.
4
Ed ecco un esempio evidente di ciò che Dante indica con il termine valle: «Lasciammo il muro
e gimmo inver lo mezzo / per un sentier ch’a una valle fiede» (Inf. X 134/135). Prima di
scendere in questa valle i due poeti si trovano «in sù l’estremità d’un’alta ripa» (Inf. XI l).
Cotesta valle non era che una profonda buca, anzi un «burrato» (Inf. XII 10), come espliciterà,
dopo la lunga pausa del canto XI, nel canto XII, riprendendo: «Era lo loco ov’a scender la riva
/ venimmo, alpestro e, per quel che v’er’ anco, / tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva.
2
46
stessa “valle di lacrime” è poi solitamente intesa come ben profonda. Vedi:
«vallis interfectionis»5 o «Fovea tenebrarum».6 Che poi questa “valle” fosse
“selvosa”, oltre al fatto di essere chiamata “selva”, può risultare dal fatto che è
«oscura», ché è detta «selva fonda» (Inf. XX 129) e che in essa «’l sol tace» (Inf. I
60): fatti che non si combinano con l’idea che noi abbiamo delle “valli”. Con
questo termine poi il poeta indica solitamente l’inferno: esso è «valle d’abisso
dolorosa» (Inf. IV 8), «alta valle feda» (Inf. XII 40), «valle buia» (Inf. XII 86), «valle
inferna» (Purg. I 45), «valle dolorosa» (Par. XVII 137). Per il poeta il termine
“valle” può anche essere l’equivalente di abisso e baratro. Ciò che lui chiama valle
potrebbe benissimo essere chiamato «pozo profundato»,7 come Bonvensin da
Riva chiama l’inferno, “buca” che «insacca» (Inf. VII 18) tutto il male
dell’universo. E ci fu chi intese la valle selvosa come una “buca” già nel Trecento:
vedi miniatura qui sotto: a dir il vero si elimina la “selva” e si evidenzia lo
scoscendimento, quasi l’interno di un cratere vulcanico.
d
b
d
Oxford, Biblioteca Bodleiana, Mss. Canon. Ital. 109 (sec. XIV)
5
6
7
Qual è quella ruina che nel fianco / di qua da Trento l’Adice percosse, / o per tremoto o per
sostegno manco, / che da cima del monte, onde si mosse, / al piano è sì la roccia discoscesa,
ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse: / cotal di quel burrato era la scesa» (Inf. XII 1 – 10).
Conveniamo che il verbo ruinare (Inf. I 61) sarebbe sprecato se la lupa non ricacciasse Dante
in un luogo almeno simile a questo, dove, come si vede, valle equivale a burrato, in relazione
ai quali termini, vedi caso!, può anche essere usato il termine ruina o ruinare in entrambi i casi.
L’equivalenza di senso che a volte si stabilisce tra valle e abisso - nel linguaggio dantesco,
s’intende - può essere rilevata anche da questa curiosa espressione del Convivio: «Quando con
certa legge e con certo giro vallava li abissi» (Conv. III XV 16). Data questa situazione non deve
parer strano se Dante arriva a definire la profonda cavità infernale con il semplice termine
valle, senza alcun aggettivo qualificativo, come detto nel testo ed anche in questo caso: «lor
corso in questa valle si diroccia» (Inf. XIV 115). E non dimentichiamoci poi che Dante ha paragonato l’uscita dalla valle ad un’uscita dal pelago. Cioè gli ha mozzato il fiato. Ciò si può
giustificare solo se Dante ha fatto un grosso sforzo, come per esempio aver superato un’erta.
É una fatica morale. D’accordo! Ma essa viene tradotta sempre in un equivalente fisico.
L’episodio di Belacqua è costruito sulla fatica fisica che Dante farebbe nel salire il monte.
Anche lì si parla di «affanno» (Purg. IV 95), che è fisico e morale insieme.
Geremia, VIII 32.
SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Itinerarium mentis in Deum, Prologus, 4.
BONVENSIN DA RIVA, Il libro delle tre scritture e i volgari delle false scuse e delle vanità, a c. di L.
BIADENE, Pisa, 1902 (Il libro della scrittura negra, v. 213).
47
Pensiamo esser perfettamente logico che se l’eterno peccato viene
raffigurato in una “valle”, in una “valle” venga raffigurato anche il peccato in
questa vita, visto che lo prefigura: e se l’eterno peccato manca di luce, quello
umano per rassomigliargli ha l’ombra fittissima di un bosco: la rassomiglianza
di concetto si è tradotta in una rassomiglianza di raffigurazione. Questa la nostra
rappresentazione:
Valle
Valle selvosa
selvosa
Valle inferna
inferna
Valle
Tav. n. 1
Per l’idea di una profonda cavità, anticamera dell’inferno, vedi tra i
riferimenti classici: «Spelunca alta fuit vastoque immanis jatu / scrupea, tuta lacu
nigro nemorumque tenebris».8 (Eneis VI 237/238); «alte praeceps humus ore
profundo / dissilit ... illum ingens haurit specus» (C. C. STAZIO, Thebais VII
816/18).9 Il modello di Dante, comunque, molto probabilmente è Lucano:
8
9
Analogamente nelle Georgiche: «Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis / caligantemque nigra
formidine lucum ingressus», (IV 467 – 469). Come Dante, anche Virgilio ha immaginato che,
per entrare nell’Averno, si passasse prima di arrivare alle porte di esso - «alta ostia» - per una
spaccatura del terreno, faux, jatus; e per un bosco oscuro.
Ed è idea che aleggia nella nostra cultura: «Ecco Lipari, la reggia / di Vulcano ardua che fuma
/ e tra i bómbiti lampeggia / de l’ardor che la consuma: / quivi giunto il caval nero / contro il
ciel forte springò /annitrendo; e il cavalliero / nel cratere inabissò», G. CARDUCCI, Rime nuove
LXXVI 89-96 (La leggenda di Teodorico).
48
Haud procul a Ditis caecis depressa cavernis
in praeceps subsedit humus, quam pallida pronis
urget silva comis, et nullo vertice caelum
suspiciens Phoebo non pervia taxus opacat.
Marcentes intus tenebrae… 10
Per arrivare all’Averno anche secondo Lucano prima troviamo un’humus
depressa in praeceps, un abisso: esso è premuto da una selva pallida, per la
mancanza dei raggi del sole che non vi arrivano, come dirà poi. Quindi la selva
è, per Lucano, nella buca stessa. Ed a guardar bene è così anche in Virgilio:
infatti i luci Averni, (Aen. VI 118) dovevano estendersi sottoterra, non cingere
solamente l’ingresso dell’Ade: ciò si vede chiaramente a Aen. VI 385-86: «Navita
quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda / per tacitum nemus ire pedemque
advertere ripae». Caronte vede Enea e la Sibilla avvicinarsi alla riva
dell’Acheronte «per tacitum nemus»! E già la Sibilla aveva detto ad Enea che tra
la sua residenza, “ingens antrum” (Aen. VI 42) della rupe Euboica, e l’entrata vera
e propria dell’Averno «tenent omnia silvae» (Aen. VI 131). In Lucano questa selva
inoltre, ed è particolare tutto lucaneo, ha le chiome prone, cioè non diritte verso
il cielo, ma distese orizzontalmente: «nullo vertice caelum suspiciens» / «tale che
non rivolge al cielo nessuna sua cima», per cui si hanno «tenebrae marcentes».
Così:
Humus
depressa in
Humus depressa
in praeceps
praeceps
Averno
Averno
Tav. n. 2
10
M. A. LUCAIN, La guère civile (La Pharsale), texte établì et traduit par A. BOURGERY et M.
PONCHANT, Paris, Les Belles Lettres, 1948, VI, vv. 642-53.
49
Anche qui può tornare quella doppia V che abbiamo visto in Dante e
avremmo potuto trarre anche da Virgilio, Stazio o dalla Bibbia: con la humus
depressa in praeceps che vale, come la selva-valle di Dante, per abisso, come
intende anche il prof. Bourgery, curatore e traduttore del testo per Les Belles
Lettres, che non aveva alcun particolare interesse: «Non loin des obscures
cavernes de Dis la terre se creuse et s’enfonce en un abîme».11
In questa vita possiamo prendere una brutta “china” inoltrandoci nel
peccato, o salire verso il colle della virtù, e magari alternando lo scendere ed il
salire nei diversi periodi. Ed ecco tutto l’insieme:
colle
colle
piaggia
piaggia
Valle selvosa
selvosa
Valle
Valle inferna
Valle
inferna
Tav. n. 3
Tav. n. 3
Non può sfuggire la rassomiglianza del “colle” e della “valle selvosa”, l’una
il rovescio dell’altra, tanto che il “colle” potrebbe, rovesciato, riempire la “valle
selvosa”. Ma anche il cono purgatoriale, formatosi con la terra della cavità
infernale, rovesciato, può riempire esattamente l’Inferno. Così l’insieme:
11
Ibid. nel testo francese a fronte.
50
Tav. n. 4
Tav. n. 4
A questo punto si può trarre questa conclusione: la proiezione ingrandita
della “valle selvosa” ci dà l’inferno, di cui la “valle selvosa” è prefigurazione; la
proiezione ingrandita del «colle» (Inf. I 13) ci dà il purgatorio, di cui anche esso
«colle» è prefigurazione; ed il peccato in questo mondo (valle) prefigura il
peccato nel mondo dell’eternità (inferno), come il vizio in questo mondo (colle)
prefigura il vizio nell’altro (monte del purgatorio), ovvero il cammino verso la
salvezza (o virtù) – con la liberazione dal “vizio”) - in questo mondo - «colle» –
prefigura il cammino verso l’eterna salvezza -«purgatorio» o «monte» (Purg. I
108; II 60 e 122 ecc.), dopo che, liberati del peccato, ci si libera anche della
51
rimasta perdurante “tendenza a peccare” o “vizio”.12
C’è una differenza: in questa vita la posizione dell’anima è dinamica: può
salire o scendere, può scendere e poi tornare a salire, può salire e poi di nuovo
scendere; nell’altra vita sembrerebbe stabilizzarsi in una posizione definitiva di
figura “impleta” nell’inferno, mentre nel purgatorio sarebbe in cammino, ma
ormai soltanto verso l’alto, poiché, come dice il Guinizzelli, nel purgatorio
«poter peccar non è più nostro» (Purg. XXVI 132). Nel paradiso ancora una volta
le anime sarebbero “implete”.
Che ne viene? Potendo in questa vita modificare di continuo la nostra
posizione, conta la posizione che ci troveremo ad occupare nel momento del
trapasso: se in quel momento ci troveremo a metà della valle selvosa o a metà
del colle, passeremo rapidamente a metà della «valle inferna» (Purg. I 45) o a
metà della montagna purgatoriale. Avessimo raggiunto la vetta del “colle”, ci
troveremmo in un momento sulla vetta del purgatorio, nella «divina foresta
spessa e viva» (Purg. XXVIII 2), da dove, dopo forse qualche rito, spiccheremmo
il volo verso il paradiso.
2) «… si volse a rietro…», (Inf. I 26). Voltarsi indietro non è un indizio di
una aumentata determinazione a proseguire; ma piuttosto dell’inizio di un
ripensamento. Salvarsi dal peccato è un rinunciare a tutto, un «mori morti et
vitae vivere» (Agostino, Confess. VIII XI 25). Lo slancio iniziale si sta esaurendo.
Perché adesso? Perché non aspettare ancora un “pochettino”?13
12
13
Normalmente a proposito delle anime del purgatorio si dice che sono lì per liberarsi dei “peccati”
o dei “vizi”, senza distinguere tra i due concetti, come invece si deve. I peccati vengono puniti
nell’inferno. Le anime del purgatorio sono già libere dal “peccato”: in esse rimane una “tendenza
a peccare” o “vizio”, che per altro non avrà possibilità di realizzarsi perché, come dirà il
Guinizzelli, «poter peccar non è più nostro» (Purg. XXVI 132), ma di cui comunque l’anima deve
purificarsi per essere perfetta. Il purgatorio insomma non è il luogo di espiazione di un reato,
una “colonia penale”, come l’inferno, ma un luogo di purificazione, volto a redimere l’anima
attraverso un’adeguata penitenza: è un “penitenziario”. Non mi stancherò di ripetere questo
concetto, già detto varie volte: vd. R. MANESCALCHI, Di una possibile intervista a Dante Alighieri,
«Il Rinnovamento», 96 (gennaio) 1982, pp. 24-35, 97 (febbraio) 1982, pp. 34-46, 98/99
(marzo-aprile) 1982, pp. 19- 29, 101 (giugno) 1982, pp. 18-32 (di cui vd. particolarmente il n.
97 (febbraio) 1982, p. 38), poi in Il Prologo della Divina Commedia, cit., pp. 67-87
(specificamente p. 76); ed ultimamente vd. R. MANESCALCHI, «Ei son tra l’anime più nere» (Inf.
VI 85); «Dai lor costumi fa’ che tu ti forbi» (Inf. xv 69), LIA, XI, 2010, n. 17, p. 348, (ora anche
in Studi sulla Commedia, Napoli, Loffredo, 2011, n.16, p. 69), dove propongo di considerare il
purgatorio appunto un “penitenziario”. Le sette P verrebbero ad essere sette “Poenitentiae”. Vedi
in proposito Appendice.
La stessa situazione vissuta e raccontata da Agostino! «Ita sarcina saeculi, velut somno assolet,
dulciter premebar. Et cogitationes, quibus meditabar in te, similes erant conatibus expergisci
52
3) «lo passo / che non lasciò giammai persona viva» (Inf. I 26-27). Se prima
era spaventato dal peccato, adesso è spaventato dall’idea di dovere a tutto
rinunciare, il che equivale ad un “morire”, non fisico ma morale. Intendi: «il
passo che nessuna persona, “rimanendo viva”, abbandonò (oltrepassò) mai»:14
con «persona viva» inteso come soggetto. E pensiamo debba intendersi così: per
uscire dal peccato uno deve morire al mondo per nascere alla vera vita, ovvero
«mori morti et vitae vivere», come detto. Dante non sarebbe stato capace di
morire al mondo, di rinunciare a tutti i piaceri mondani e per questo verrebbe
riassalito dalle tre fiere, fino a capitolare e tornare nella valle selvosa. Il termina
“passo” si raccorda con i riti di passaggio, comuni a tutte le culture e che noi
vediamo come modello anche per la Commedìa. In un “rito di passaggio”
l’individuo muore (alla vecchia vita) e nasce (ad una nuova vita) in perfetto
accordo all’espressione di Agostino ed a ciò che Dante intende con il termine
«passo».15
4) «sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso» (Inf. I 30). Solo camminando
in piano «’l piè fermo» è sempre più basso dell’altro. Ma Dante non camminava
in una salita, anche se lieve, come la piaggia adiacente il “colle”? Dante vuol dire
che sta ripensando la decisione di salvarsi, fatto di cui ci ha già dato un paio di
avvisi: non è più convinto della decisione presa ed invece di procedere diritto
verso il “colle”, comincia ad andare di lato, «a passeggiar la costa intorno
errando», come dice a Purg. VII 59, con un’espressione ad altro rivolta essendo
diversa la situazione: e ciò costituisce una naturale psicologica premessa
all’assalto delle tentazioni raffigurato dalle tre fiere.
14
15
volentium, qui tamen superati soporis altitudine remerguntur… ita certam habebam esse
melius tuae caritati me dedere quam meae cupiditati cedere; sed illud placebat et vincebat,
hoc libebat et vinciebat… non erat omnino quid responderem veritate convictus nisi tantum
verba lenta et somnolenta: “Modo // tra poco”, “Ecce modo // Ecco, tra poco”, “Sine
paululum // ancora un pochettino”. Sed “modo et modo” non habebat modum et “sine
paululum” in longum ibat» (Conf. VIII V 12).
Per questo argomento vd. partic. R. MANESCALCHI, «…tanto l’impedisce che l’uccide» (Inf. I
96), LIA, anno XII, 2011, pp. 195-199. In questo saggio ho dato la versione definitiva
all’argomentazione relativa, argomentazione che compare varie altre volte nei miei saggi in
relazione al problema delle tre fiere.
Il termine “passo” vale, in Dante ed in generale in tutti gli autori, come “atto della
deambulazione scandito ora da una ora dall’altra gamba”, oppure “luogo attraverso cui si
passa, es. un “valico”, o l’atto di attraversarlo, “passaggio”, come nei seguenti “passi”
danteschi: Inf. I 26, II 12, v 114, VIII 104, XII 126, XIII 146, XIV 84, XXVI 132; Purg. XI 50; XIII
42; Par. XXII 123 ecc.
53
5) Le tre fiere (Inf. I 31-60). La critica sta ormai abbandonando l’idea che
con la “lonza” Dante voglia alludere alla “lussuria”, almeno intendendo con
questo termine «i peccator carnali» (Inf. V 38). Le argomentazioni ultimamente
proposte in merito alla “impossibilità” che Dante abbia voluto con la lonza
indicar questo peccato sono numerose ed ancora non contestate.16 Ne
riproporrò una, forse la più evidente, sebbene non la più solida: vi sostengo che
la lonza non può significar la lussuria perché nessuno, dico nessuno, ha mai
sostenuto, di fatto, questa tesi, se pur ancora si legga come la preferita in tutti i
commenti.
A noi appare, infatti, che nessuno, in definitiva, ha sostenuto che la lonza
significhi la lussuria, indicando tutti, nessuno escluso, caratteristica di questa
belva la “frode”. Per far qualche esempio, Pietro parla di «falatia multiplici sua»,
e di «diversis deceptionibus eius et maculis». E così Benvenuto: «Saepe fallit et
prodit, imo saepe vincit leonem fraude: ita et mulier virum fortissimum forma et
fraude vincit». Così Bruno Nardi, per chiudere la lunghissima serie con un
moderno: «per vedere, però, bene cosa hanno in comune tra loro Gerione e la
lonza, cioè la frode e la lussuria, […] soccorre un passo dell’Etica Nicomachea
nel quale Aristotile mostra di aver scoperto che un denominatore comune lega
la concupiscenza, ossia l’amor sessuale, alla frode: tale denominatore è la
seduzione, l’inganno, il dolo, l’insidia, il raggiro, la parphasis omerica» (B. NARDI,
GSLI, CXL, 1963, p. 218). E non so proprio se se ne voglia di più!
E dunque ci sarebbero insieme, per antichi e per moderni, la lussuria e la
seduzione, ovvero la frode, come Benvenuto dice esplicitamente: la lussuria viene
ricavata per conseguenza del fatto che questa fiera è fraudolenta: e se c’è frode, la
lonza indica lussuria! A me francamente pare che una simile conclusione poteva
anche non essere tratta. Indubbiamente in amore… ci sono anche gli inganni.
Ma non sempre dove c’è l’inganno c’è la lussuria. L’inganno può servire anche a
buggerare qualcuno in qualche affare di puro guadagno, è normalissimo nelle
contrattazioni commerciali, nel complotto politico, come tante volte nella
Commedìa.17 Il fatto che ci sia “inganno” non significa che ci sia, automaticamente, la “lussuria”.
16
17
Vd. R. MANESCALCHI, Cinque ragioni per cui la lonza del prologo non può significar lussuria,
«Il Rinnovamento», cit., n.75, dic. 1979, pp. 28-38, poi, riveduto e corretto in Il Prologo della
Divina Commedia, cit., pp. 13-36.
Vd. in Dante «per lui carpir si fa la ragna», riferito all’inganno, ragnatela, con cui i trevigiani
si sbarazzarono di Rizzardo da Camino che li governava «dispoticamente […] e con
arroganza» (PASQUINI-QUAGLIO, ad locum), dove, ed è del tutto evidente, la lussuria non
c’entra per nulla. E si possono riferire episodi a iosa, anche all’interno della Commedia.
54
Ed ora, però ed inoltre, gli “inganni” possono servire al lussurioso per
ottenere i suoi obiettivi, ma non sono la “lussuria”, bensì della “lussuria” sono
uno strumento. Inoltre se nella lonza c’è anche la “frode” non siamo più sul
piano dell’incontinenza in cui rientra la “lussuria”, bensì su quello della
“malizia”: siamo a Malebolge, dove i seduttori hanno un loro reparto in
compagnia dei ruffiani. Non può essere un peccato di incontinenza che può
averne in sé uno di frode e di violenza.18 Mentre è naturale che un peccato di
frode possa contenerne anche uno di incontinenza, sia, per così dire, funzionale
ad un peccato di incontinenza. Vanni Fucci, ad esempio, è un ladro e per esser
ladro viene punito. Ma nulla vieta che sia stato anche un crapulone ed un
lussurioso, cosa che si può rilevare come nemmeno tanto sottintesa. E così, se
prendiamo Venedigo Caccianemico o Alessio Interminei, non ci sarà stata in
questi peccatori soltanto la frode; ma, con la frode, anche passioni di incontinenza da soddisfare. Oltre l’inganno ci può essere in ognuno di questi peccatori
lussuria o gola o avarizia o iracondia, o anche tutti questi peccati insieme. Il
peccato maggiore può includerne, e normalmente ne include, molti di minori:
o sottintenderli. In Taide c’è adulazione, ma certo anche lussuria, avarizia, forse
gola ecc…. E così Giasone avrà peccato anche in lussuria amando Isifile che
lasciò incinta. Ma soprattutto di frode: «Isifile ingannò» (Inf. XVIII 92). E così
Mirra che, per lussuriosa soddisfazione, falsificò se stessa. Mirra, anzi, più che
altri personaggi, ci permette di vedere come Dante procedesse in queste
classificazioni. Ella è
[…] «l’anima antica
di Mirra scellerata, che divenne
al padre, fuor del dritto amore, amica.
Questa a peccar con esso così venne
falsificando se in altrui forma». (Inf. xxx 37-41)
Mirra pecca di lussuria, lussuria che è però anche violenza alle leggi naturali
e divine. Infine pecca di falso, di malizia. Ed è per questo peccato, il più grave,
che viene punita, rimanendo gli altri peccati come incorporati in esso.
Non è questa specie di malizia – la falsificazione della persona – che
caratterizza questo personaggio e giustamente, quando è salita sulla scena
tragica, è stata messa in rilievo la passione che la travolge e non il dolo, che dal
punto di vista artistico viene usato per mettere in rilievo l’intensità della
passione. Ma Dante non ha scelta. È prigioniero degli schemi morali con cui ha
costruito il suo Inferno: questi schemi vietano che faccia di Mirra una compagna
di Francesca. In Mirra ci sono lussuria, violenza e malizia? Mirra non può che
18
Per la classificazione dei peccati in Dante vedi Appendice.
55
esser posta tra i fraudolenti, nello specifico settore dei falsificatori della persona.
Peccando di malizia, gli altri peccati – se vi sono e solitamente vi sono e, direi,
non possono non esserci – di incontinenza e di violenza – vengono come
assorbiti in essa. Per questa legge, se Francesca non fosse giunta all’adulterio in
modo semi-inconsapevole, peccando essenzialmente per debolezza di volontà,
ma attraverso un meditato inganno, non sarebbe tra i lussuriosi, bensì tra i
fraudolenti.19
Torno a confessare il mio stupore nel constatare che questa
argomentazione, appena ora confutata, a mio modo di vedere tanto fragile,
abbia tenuto il campo per secoli senza che nessuno pensasse di farvi obiezione.
Non minore stupore costituisce per me il fatto che per questo problema
della “lonza”, esaminato tanto a lungo, tanto vastamente e con l’impegno delle
migliori intelligenze critiche, si sia tenuto conto di Alberto Magno,20 di
Isidoro,21 della Bibbia (Geremia),22 di Plinio,23 di Virgilio,24 dei bestiari,25 della
tradizione popolare anche posteriore a Dante26 ecc.; e non sia stata presa in
considerazione la “lonza” di due sonetti di Rustico,27 che avrebbe dovuto essere
il primo riferimento, visto il medesimo ambiente in cui vissero i due poeti (con
Ad ulteriore chiarimento di questo concetto vd. ancora Appendice.
ALBERTO MAGNO, De animalibus 2. 2. 1.
21
ISIDORO DI SIVIGLIA, Etymologiae sive Origines, XII II 20: «Lyncis […] bestia maculis terga
distincta ut pardus, sed similis lupo».
22
Hieremias, V 6: «Idcirco percussit eos leo de silva, lupus ad vesperam vastavit eos; pardus
vigilans super civitates eorum: omnis qui egressus fuerit ex eis capietur».
23
GAIO PLINIO SECONDO, Historia naturalis, VIII passim, partic. XXIII, 62: «Panthera et tigris
macularum varietate prope solae bestiarum spectantur»; XXVIII, 70: «pardorum maculis»; xxx,
72: «Lyncas vulgo frequentes».
24
Aen. I 323: «maculosae tegmine lyncis».
25
KENNETH MC KENZIE, The Problem of the “Lonza,” with an unpublished text, «RR I, (1910),
pp. 18-30. Cfr. anche MILTON STAHL GARVER – KENNETH MC KENZIE, Il Bestiario toscano
secondo la lezione dei codici di Parigi e di Roma, in SR VIII, (1912), pp. 1-100 [testo pp. 17-94;
per la lonza cfr. p. 86].
26
Cfr. GLORIA ALLAIRE, New evidence toward identifying Dante’s enigmatic lonza, EBDSA,
August 7, 1997.
27
Di una diversa fiera ch’è apparita v. 5, (XXVIII dell’ed. Buzzetti Gallarati, RUSTICO FILIPPI,
Sonetti satirici e giocosi, Roma Carocci 2005) e Ne la stia mi par esser col leone vv.9-11, (XIX
dell’ed. Buzzetti Gallarati, cit.), per la prima volta segnalati nel saggio R. MANESCALCHI, La
“lonza” in Rustico di Filippo ed in Dante, «Il Rinnovamento», XVIII-XIX (nn. 165 dicembre
1988 e 169 cit. aprile 1989), poi in Il Prologo della Divina Commedia, cit., pp. 53-65: e di
recente in ID. Osservazioni sulla «lonza» in Rustico Filippi ed in Dante, «Studi Danteschi», vol.
LXXIV, Firenze, Le Lettere, 2009, pp. 127-147 (ora in Studi sulla Commedia, cit., pp. 41-62).
Il Mazzoni invero segnala (senza per altro discuterlo) la «leuncia» del sonetto Ne la stia mi par
esser col leone vv.9-11: vd. Saggio di un nuovo Commento alla «Divina Commedia», Firenze,
Sansoni, 1967, p. 99. Di altri non ho notizia.
19
20
56
la frequentazione da parte di entrambi della casa di Brunetto Latini!), lo stesso
genere comico trattato, la leggera precedenza cronologica di Rustico rispetto a
Dante, per cui è quasi impossibile che Dante non conoscesse questi sonetti.
Le tre fiere per noi, concludendo, non possono che rappresentare la totalità
del peccato che Dante ci dà con «le tre disposizion che ’l ciel non vole» (Inf. XI
81), o con «superbia, invidia e avarizia» (Inf. VI 74) e «gent’è avara, invidiosa e
superba» (Inf. XV 68). La soluzione al problema va ricercata in questa duplice
direzione, forse non contraddittoria o incompatibile.28
A Inf. XVI 106 segg. Dante racconta di essersi discinto di una «corda» (v.
106), con la quale aveva pensato di prender questa «lonza» e di averla data a
Virgilio che la getterà nell’«alto burrato» (v. 114) sottostante, riuscendo con ciò
a chiamare Gerione. Questa la nostra lettura, come suggerito dalla ricostruzione
da noi sin qui fatta: Dante provò a metter ordine a Firenze (la “lonza”) tramite
la “legge” fatta dallo stesso Comune fiorentino (la «corda»). Dopo aver
constatato quale caos hanno provocato quanti si son messi su quella strada, per
quanto «a ben far [avessero posto] gli ingegni», Inf. VI 81, da Farinata a
Tegghiaio Aldobrandi, Iacopo Rusticucci ecc., comprende che le leggine fatte
dal Comune fiorentino (fatte ad ottobre non arrivano a novembre, per cui vd.
«… a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili» Purg. VI 143-44)
non sono bastevoli per problemi tanto grandi e consegna quelle leggine a
Virgilio, l’Impero, che con la sua “legge”, la legge dell’Impero, potrà ciò che
quelle non possono (sul momento con la legge comunale imprigiona,
ingannandolo, Gerione):29 il gettito della corda è il momento in cui il poeta si
distacca da Firenze, «si forbe» (Inf. xv 69) dei costumi di Firenze ed inizia a
meditare i problemi nell’ottica dell’Impero.30 In questa interpretazione la “lonza”
viene a rappresentare Firenze, come in molti han voluto che fosse. Ma la
“Firenze” di cui Dante si libera non è l’istituzione del Comune, che sarebbe un
ostacolo esterno, inammissibile in un’ascesi morale. Qui si tratta del liberarsi di
un modo di essere e di agire di chi opera nel Comune e che lo stava
contaminando: è di questo modo di essere e di agire che il poeta si “forbe”
dando la «corda» a Virgilio. Le circostanze vollero che di Firenze si liberasse
anche fisicamente con l’esilio. E fu un fatto certamente utile per la sua ascesi
morale e per la Commedìa, ma non indispensabile. Del modo di essere e di agire
Vd. R. MANESCALCHI, Di una possibile intervista a Dante Alighieri, in Il Prologo della Divina
Commedia, cit., particolarmente le pp. 75-76.
29
Per questo da me supposto inganno vd. R. MANESCALCHI, «Ei son tra l’anime più nere…(Inf.
VI 85) …dai lor costumi fa’ che tu ti forbi (Inf. XV 69)», cit., p. 76).
30
Ibidem.
28
57
di coloro che operano nella prospettiva delle leggi comunali poteva liberarsi
anche restando a Firenze (e forse se ne liberò quando ancora era a Firenze, anche
se sembra più ragionevole che l’esilio ed il distacco morale da Firenze
avvenissero insieme).
6) «chi per lungo silenzio parea fioco» (Inf. I 63). Dante ha abbandonato la
“piaggia”, poiché ha iniziato a rotolare in basso («mentre ch’i’ rovinava in basso
loco»: evidentemente è ormai sul pendio della “valle selvosa” (e vd. la
ricostruzione grafica prima fatta), nell’ombra della selva che si fa sempre più
scura man mano che procede. Il nuovo arrivato appare piuttosto “indistinto”
(«fioco» è riferito alla vista e non all’udito, poiché Virgilio non ha ancora parlato
e su questo il convincimento è ormai generale),31 “indistinto”e per l’ombra e per
il non essere, probabilmente, gli occhi di Dante ancora assuefatti alla scarsa luce
della selva in cui è appena rientrato. Di fronte a quell’immagine pallida e
smunta (smorta, sbiadita, scialba, spenta, livida, evanescente, tenue, labile),
spettrale, che ricorda senz’altro le «tenuis sine corpore vitas» (Aen. VI 292), le
«exanguis… umbras» (ivi, 401), Dante si domanda, come Lucano,32 se sia
ancora nella “valle selvosa”, ovvero ancora nel mondo dei vivi, o non sia già
trapassato nella «valle inferna» (Purg. I 45), non sia già nel mondo dei trapassati,
poiché le due “valli” sono contigue e… «facilis descensus Averno» (Aen. VI 126).
Rimane da chiarire cosa intendesse con l’espressione «per lungo silenzio» (VI
Per una bibliografia aggiornata vd.: G. BRUGNOLI, Chi per lungo silenzio parea fioco, in
Letterature comparate: problemi e metodo. Studi in onore di Ettore Paratore, vol. III, Bologna,
Patron, 1981, pp.1169-82; e soprattutto R. HOLLANDER, «INFERNO» I, 63: «Chi per lungo
silenzio parea fioco» e la tradizione esegetica, in Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia»,
Firenze, Olschki, 1983, pp. 23- 79.
32
In Lucano Erittone, la maga tessalica, ricordata a Inf. IX 23-24, addentrandosi nella “valle
selvosa” arriva ad incontrare le ombre del morti in un punto di tale oscurità che non è possibile
sapere se queste anime siano state tratte dalla maga nella “valle selvosa” appunto, o se essa
stessa sia discesa nell’Ade: «…dubium est, quod traxerit illuc, / aspiciat Stygias, an quod
descenderit, umbras / si è in dubbio se veda le ombre stigie, perché le abbia tratte lassù (illuc,
nella selva), o se perché essa stessa sia discesa tra di esse» (Phars. vi 652-653). In definitiva il
dubbio di Dante, conformandosi però al suo stato d’animo ed alla sua situazione, nonché alla
logica del suo racconto, è lo stesso: «qual che tu sii od ombra (e allora siamo già nell’Ade) od
omo certo (ed allora ancora non siamo nell’Ade)» (Inf. I 66). Tenendo presente che la “valle
selvosa” di Dante (e quella di Virgilio e di Lucano) è collegata con la «valle inferna» (Purg. I
45) si può dare del verso in questione una spiegazione forse infine pienamente soddisfacente.
Dante rifa, secondo la nostra ricostruzione, per cui vedi sopra, la stessa scena di Virgilio e
Lucano: un bosco la cui ombra è impenetrabile ai raggi del sole, sul cui fondo s’apre una
spelonca, l’«antrum immane» (Aen. VI 10-11): Virgilio risalirebbe dall’Ade per soccorrere
Dante e Dante lo vedrebbe come uno spettro.
31
58
131). Intendiamo che il nuovo arrivato sembrava «fioco», cioè “indistinto”, una
specie di “spettro”, per il “lungo” spazio di tempo passato tra le “umbrae
silentes”. Ed è ancora Lucano a darci l’appoggio per capire l’aggettivo «lungo»,
rimasta la vera crux del verso, chiedendosi gli interpreti come Dante possa
parlare di un “lungo silenzio” se il personaggio è appena arrivato e non ha
ancora parlato; ed anche notando, con acutezza, che le anime residenti nel
Limbo dantesco non appaiono affatto “silenti”, ma piuttosto ciarliere (cosa che
però, all’interno della finzione poetica, Dante non poteva ancora sapere. Per ora
Dante deve stare sull’opinione comune che il mondo dei morti è un mondo di
silenzio). Inutile andare a cercare il significato in un supposto valore allegorico,
che appare a tutti insoddisfacente. Veniamo a Lucano: «Marcentes intus
tenebrae pallensque sub antris / longa nocte situs» (Phars. vi 646-47). In Lucano
“longa” – e potremmo dire infinitamente “longa” – è la notte (la morte) che
avvolge le “animae silentes”, rendendo altrettanto “lungo” anche il loro
“silenzio”, quanto meno a noi che vorremmo con esse colloquiare (poi cosa
facciano tra di loro può essere un altro discorso). Intendiamo così: «si offrì ai
nostri occhi “uno” che appariva indistinto (quasi uno spettro), dando a credere
che provenisse dalla “lunga”, eterna, “notte” dell’Ade, dove regna il silenzio».
Invece di notte Dante dice silenzio, che qui è di notte sinonimo. Ci piace
riconoscere che molti critici sono arrivati a questa stessa conclusione, pur senza
essersi avvalsi né di Lucano, né della ricostruzione geografica da noi fatta.33
33
Molti esempi ne offre R. HOLLANDER, «Inferno» I, 63: «Chi per lungo silenzio …», cit., pp. 43
segg., particolarmente: «Fioco ist das Attribut des Fantoms, des corpo fittizio (Purg. XXVI 12),
der kein Gewicht hat (Inf. VIII 27), der keinen Schatten wirft (Purg. III 26), der vanità che par
persona (Inf. VI 36), die das Gegenteil einer cosa salda ist (Purg. XXI 136) nach dem Worte des
Statius, der Virgil den Fuss küssen will und vor dem Schatten (V. 131f ) daran erinnert wird,
dass sie keine körper sind» (A. FEIST, «Chi per lungo silenzio parea fioco», «Zeitschrift für
romanische Philologie», X, 1886, p. 567; «…mi si presentò una figura, che mi pareva
languida, inconsistente, come ombra di trapassato (come di chi tace da lungo tempo») (V. A.
ARULLANI, Intorno al verso «Chi per lungo silenzio parea fioco», GD, II, 1895, pp. 504-505 (hic
p. 505). L’Arullani poche righe prima aveva fatto riferimento, per Virgilio qui apparso, dopo
il Feist ma senza conoscerlo, alla «prima “vanità che par persona” che appaia al poeta nel suo
viaggio d’oltretomba» (Ibidem); «chi per appartenere ai regni de l’eterno silenzio appariva esile
come ombra» (F. RONCHETTI, Intorno a due versi dell’Inferno, GD, III, 1896, p. 335); «chi per
esser rimasto lungamente nei luoghi bui, sotterranei, appariva esile come un’ombra», (Ivi, p.
340), «Mi si presentò uno che parea esile come se appartenesse ai regni del lungo silenzio […]
Se silens per sé, valeva ombra, spirito, perché silenzio, e, a meglio determinarlo, lungo silenzio,
non potrebbe egli riferirsi al regno degli spiriti? tanto più da uno, studiosissimo di Virgilio, e
di Virgilio appunto parlando?», (Ivi, p. 342). Questi alcuni dei commentatori che vedono
Virgilio come “un’ombra”: «E quest’ombra, unica, labile parvenza “nel gran diserto {v.64}”, è
naturale che sembri fasciata di quel silenzio che suggella la bocca dei morti»; «una figura che
si mostrava (parea) con contorni indefiniti (fioco) nelle tenebre di quel paesaggio» (PASQUINIQUAGLIO, 1982); «uno che in quel primo momento appariva in modo evanescente […]; sì da
59
7) «vagliami ’lungo studio e ’l grande amore» (Inf. I 83),34 passo che noi
intendiamo come la reazione tipica di uno studente colto in fallo dal maestro:
«esamina attentamente, passami al vaglio, la preparazione che ho fatto (e vedrai
che studiare ti ho studiato)».
L’espressione «vagliami» potrebbe derivare dal verbo «vagliare», nel senso di
«passare al vaglio», «esaminare».35 Si confronti «Certo a più angusto vaglio / ti
conviene schiarar» (Par. XXVI 22-23) – è il primo esempio nella nostra letteratura del termine «vaglio» nel senso di «esame» – dove si intende «a più stretto
esaminamento» (Buti), «devi passar sotto più stretto e severo esame» (Biagioli);
cfr. anche «inter ea que remanserunt in cribro comparationem facientes» (De Vulg.
El. I XII 1); «te cribrare oportet» (Ivi II VII 3) e «in cribro tuo» (Ibidem.). L’immagine compare anche nel Detto d’Amore: «Amor nessun non vaglia» (v. 48). Dante
poteva ricorrere ad un’immagine «vaglio / esame» e «vagliare / esaminare» già
precedentemente usata, in latino, ed a cui poi ricorre nei passi del Paradiso sopra
ricordato, come ci ricorrono senza problemi il Buti e Benvenuto.
Il Dante che si fa ricacciare nella selva dalla lupa, insomma, sentirebbe di
venir meno agli insegnamenti del maestro e temerebbe di incontrarlo.36 Come gli
compare dinanzi una persona in quella sua particolare situazione, spera che non
sembrare, più che un uomo vivo, l’ombra di un morto » (PADOAN, 1967) ecc. Ma dopo i
consistenti contributi avutisi alla fine del XIX secolo (Feist, Fiammazzo, Arullani, Ronchetti,
ecc.), successivamente non si è aggiunto praticamente nulla nelle pur frequenti trattazioni,
tanto zeppe di citazioni, quanto confuse e poco convincenti, abbiano i contributori anche
nomi autorevoli come A. PÉZARD (Donat, Virgile et Dante, Appendice IV in Dante sous la pluie
de feu, Paris, Vrin, 1950, pp. 339-345); R. DRAGONETTI («Chi per lungo silenzio parea fioco»,
SD, XXXVIII, 1961, pp. 47-74); A. PAGLIARO (Ulisse, Ricerche semantiche sulla D. C, 1967,
Messina-Firenze, D’Anna, pp. 23-24; F. MAZZONI (Saggio, cit. pp. 113-115); H. GMELIN
(Kommentar, Stuttgart, Klett 1966 [1954]; C. SINGLETON (Inferno, Commentary, ad locum)
ecc. sui quali penso non sia il caso di insistere, poiché si limitano, al più, a ripetere quanto già
detto ed accertato, in genere dimenticando di citare i primi proponenti.
34
Per questo argomento vd. particolarmente, R. MANESCALCHI, «… e cantai di quel giusto /
figliol d’Anchise», Inf. I 73-74, “Annali” del Liceo Classico di Città di Castello, 2005, poi in
«Campi Immaginabili», Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2005, nn. 32-33, pp.
161-170 e partic. le pp. 165 sg.; ed ora in ed ora in Studi sulla Commedia, cit., pp. 91-106.
35
Testimoniato con questo senso, secondo Tullio de Mauro, «av. 1400; lat. *vallĭāre, der. di
vallus, dim di vannus “vaglio”».
36
Chi teme di incontrare uno studente che non ha fatto il suo dovere? Il maestro! Ed era notorio
il precetto, già in ambito classico e poi medievale, di regolarsi come se il maestro fosse sempre
presente: fra i tanti esempi cfr. Cicerone: «Id facillime facies, si me cui semper uni magis quam
universis placere voluisti tecum semper esse putabis et omnibus iis rebus quas dices et facies
interesse», Ad Quintum fratrem I I 46; Seneca: «“Sic fac, inquit, omnia tamquam spectet
Epicurus”. Prodest sine dubio custodem sibi imposuisse et habere, quem respicias, quem
interesse cogitationibus tuis iudices. Hoc quidem longe magnificentius est, sic vivere
60
sia lui – il maestro, Virgilio - ovvero spera che sia un «uomo certo» e non
un’«ombra».37 Ma è subito disilluso dalle prime parole che Virgilio pronunzia,
come avesse intuito i timori del discepolo: «Non omo…»,38 parole che agli
orecchi di Dante non possono non suonare minacciose, come le altre che
seguono, tutte indirizzate a fargli capire che è proprio il maestro colui che ha di
fronte: «parenti… lombardi…, sub Julo…, sotto il buon Augusto / al tempo
delli dei falsi e bugiardi… / Poeta fui e cantai di quel giusto / figliuol d’Anchise»
ecc. Son tutte parole che tolgono via via ogni dubbio (e speranza) al povero
Dante. Colui che ha davanti non può che essere Virgilio, il maestro! E le parole
che Virgilio dice, a guardar bene, non intendono tanto dare informazioni: in
realtà sono fendenti, staffilate, volte a far capire che si è ad una resa dei conti,
ineluttabile.
Di particolare evidenza il passo «e cantai di quel giusto / figliuol d’Anchise»,
con il che Virgilio gli ricorderebbe, secondo noi e come già detto nel saggio
indicato, il modello cui Dante avrebbe dovuto ispirarsi, cioè Enea.
7) «A te convien tenere altro viaggio»39
Di fronte alle resistenze di Dante che fraintende, finge di non capire,
Virgilio conclude, credo piuttosto sconsolato al vedere che sono andate in fumo
tutte le sue fatiche, che sia necessario un corso di recupero: «Portiamolo a vedere
Catone. Forse lui riuscirà a fargli capire ciò che non ha capito con Enea». Ciò si
tamquam sub alicuius boni viri ac semper presentis oculis, sed ego etiam hoc contentus sum,
ut sic facias, quaecumque facies, tamquam spectet aliquis: omnia nobis mala consuetudo
persuadet» Ad Luc. XXV, 5; «Elige itaque Catonem; si hic tibi videtur nimis rigidus, elige
remissioris animi virum Laelium. Elige eum cuius tibi placuit et vita et oratio et ipse animum
ante se ferens vultus ; illum tibi semper ostende vel custodem vel exemplum. Opus est,
inquam, aliquo ad quem mores nostri se ipsi exigant: nisi ad regulam prava non corriges», ivi
XI 10; ed infine Genesi: «Ambula coram me, et esto perfectus», XVII 1. Il maestro che Dante
si era scelto era Virgilio, come il Petrarca del Secretum si era scelto Sant’Agostino. Mi sembra
anche evidente che abbandonare la retta via sia perdere il maestro e sulla retta via ritornare
equivalga a ritrovarlo.
37
«Miserere di me…. qual che tu sii, o ombra [ciò che Dante teme] od uomo certo [come Dante
spera]», Inf. I 66. Già grande spavento gli aveva fatto il nuovo arrivato perché «per lungo
silenzio parea fioco», Inf. I 63, cioè gli aveva dato l’idea di essere un trapassato (come di fatto
era; e quindi, per Dante, poteva esser proprio il maestro, Virgilio!).
38
Virgilio, dicendogli «omo già fui», gli lascia forse intendere che è in grado di comprenderlo.
«Anch’io sono stato un uomo come te e ti posso capire». Ma può esserci anche un
ammonimento: «E comunque, proprio perché ti posso capire, a fare il furbo con me non
provarci nemmeno».
39
Per l’interpretazione qui proposta vd., soprattutto, R. MANESCALCHI, Una nuova
interpretazione del Catone dantesco, «Critica Letteraria», Napoli, Loffredo, anno XXXVI, fasc. III,
n. 140/2009, pp. 419-446, ed ora in Studi sulla Commedia, cit., pp. 133-160.
61
ricava da quanto dirà allo stesso Catone: «da l’alto scende virtù che m’aiuta /
conducerlo a vederti ed a udirti» (Purg. I 68/69), dal che si deduce che, già in
avvio del viaggio ultraterreno, Virgilio aveva pensato di condurlo da Catone.
Il passaggio da Enea a Catone come modelli da seguire – ed in riferimento
il primo a Didone, il secondo a Marzia – si trova anche in Convivio IV, dove il
capitolo XXVI (8-15) è dominato appunto dalla figura di Enea e Didone, ed il
XXVIII da quella di Catone e Marzia. Per giungere alla perfezione hanno dovuto
dominare quell’istinto, quell’appetito, staccarsi dai «dolci pensier» (Inf. V
113),40 da tanto «disio» (Ibidem). E così deve fare Dante che finge di non capire.
Le “pargolette”! Ci vorrà Beatrice e poi Piccarda41 per cacciargli in testa (e poi
efficacemente ribadirgli) il retto concetto delle cose.
Un’altra annotazione. Se le cose stanno come diciamo noi, ci troveremmo
di fronte, e nel IV del Convivio (cap. XXVI e XXVIII) ed in questo primo canto
dell’Inferno, di fronte ad un medesimo schema operativo. In entrambi i casi
Enea e Catone si succederebbero a Dante come modelli da seguire. La cosa non
può sorprenderci se teniamo conto che la composizione dell’ultimo libro del
Convivio – gli ultimi capitoli – e del primo dell’Inferno dovrebbero essere
concomitanti o addirittura paralleli: ci potrebbe essere stato anche un periodo
in cui il poeta avrebbe potuto lavorare alternativamente all’una ed all’altra opera:
per terminar l’una con gli ultimi ritocchi, l’altra all’inizio.42
Ma questo porta anche ad altre conclusioni: che cioè Catone non è
proposto come modello per la sua morte in Utica, ma per il suo comportamento
con Marzia, con cui mostra di aver conseguito un ben altro suicidio, una specie
di sradicamento del suo egoismo, di annullamento di sé (che era ciò che doveva
conseguire anche Dante). È il comportamento tenuto con Marzia che fa dire a
Dante «E quale uomo terreno più degno fu di significare Iddio, che Catone?
Certo nullo» (Conv. IV XXVIII 15). Dio lascia che l’anima vada nel mondo a
peccare e la riaccoglie quando a lui vuol ritornare: così ha fatto Catone con
Marzia. Il suicidio in Utica, che sarebbe stato attuato per salvaguardare la
Da notare che Didone e Francesca sono insieme: entrambe sopraffatte dalla passione amorosa,
non sono riuscite ad elevarsi alla vita razionale. Hanno considerato più importante il «talento»
che non la «ragione»: cfr. «la ragion sommettono al talento», Inf. V 39. Non così Enea e
Catone, che invece hanno voluto e saputo elevarsi alla vita razionale, producendo in
conseguenza di ciò grandi azioni e con ciò salvandosi, almeno idealmente.
41
Vd. R. MANESCALCHI, Il ruolo di Piccarda nella Commedia, «Critica Letteraria», Napoli,
Loffredo, anno XXXV, fasc. II, n. 135/2007, pp. 241-266, ora in Studi sulla Commedia, cit., pp.
107-131.
42
L’ipotesi è avvalorata anche dai minuti riscontri lessicali tra il quarto libro del Convivio e il
primo canto dell’Inferno messi in luce da G. PETROCCHI, Itinerari Danteschi, Bari, Adriatica,
1969, pp. 265-266.
40
62
propria libertà di fronte a Cesare, un suicidio compiuto anche da tanti altri, non
può concedere a Catone nessun speciale rilievo (Bruto e Cassio, suoi compagni
d’avventura, hanno ben altro risultato, che, sulla base di quel suicidio, non è
certo giustificato). Condivido in pieno un’osservazione di Marziale – sì, proprio
di Marziale – testimone oltretutto al di fuori di ogni disputa e non certo
interessato alle nostre tesi:
«Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior:
dum moritur, numquid maior Othone fuit?»43.
D’altro canto in che senso la tirannia di Cesare poteva insidiare la libertà
del filosofo? Quella «libertà», che è libertà morale o di coscienza, si esalta in
presenza di una tirannide: Boezio per tutti.
8) «per cui morì la virgine Cammilla / Eurialo e Turno e Niso (di ferute)»
(Inf. I 107-108).44 Questo elenco, già di per sé molto diverso da quelli fatti
altrove45 riguardo gli eroi della romanità – sono personaggi non di primaria
importanza, come invece di primaria importanza sono i Decii, i Fabii, Torquato,
Cincinnato ecc., nominati nelle altre circostanze – ha anche un’altra anomalia:
mescola chi ha lottato per favorire l’avvento dell’Impero, con chi ha cercato di
contrastarlo, una davvero “curiosa”46 mescolanza. Ma la sorpresa non è fondata.
Dante infatti non giudica secondo un criterio storico- politico, ma secondo un
Epig. VI XXXII 5-6.
Per questo argomento vd. particolarmente R. MANESCALCHI, Il ruolo di Piccarda nella Commedia, cit., ma anche ID., «… e cantai di quel giusto / figliol d’Anchise», Inf. I 73-74, cit.;
nonché ID.,Una nuova interpretazione del Catone dantesco, cit.,.
45
In Conv. IV V 10-20 «– Romolo, Numa, Tullo, […] Bruto «primo consolo», […] Fabrizio
[…] Torquato […], Deci […] Drusi […] Regolo […] Quinzio Cinninnnato […] Camillo (e
non Camilla!)»; in Mon. II X 1-11; in Inf. IV 121-129 – Elettra […] Ettor […] Enea […]
Cesare, Camilla […] Bruto (quello che «cacciò Tarquino») […] Lucrezia, Marzïa, Julia,
Corniglia; o del canto VI del Paradiso, tutti molto simili.
46
Vd. R. HOLLANDER, che parla appunto di una «curiosa disposizione intrecciata di nomi di
guerrieri che erano stati nemici tra loro», La Commedia di Dante Alighieri, Inferno, trad.
Simone Marchesi, Firenze, Olschki, 2011, p. 11. Per l’Hollander questo fatto aiuterebbe «a
capire che Dante considerava quella guerra come giusta e necessaria: è come se le sue vittime,
non importa su quale fronte, fossero state sacrificate alla causa della fondazione di Roma, la
‘nuova Troia’». E sono parzialmente d’accordo, anche se non si spiega perché in questo caso
l’elenco di coloro che hanno fatto l’Impero è così diverso da tutti gli altri di Convivio,
Monarchia e Commedia, né si spiega perché questa «curiosa disposizione intrecciata» o
«curious intermingling», come nel testo inglese (The inferno, New York, Doubleday, 2000) si
ripeta con i «giovinetti […] Scipïone e Pompeo» (Par. VI 52-53) e, sostanzialmente, con
Catone, che va inserito nell’“intreccio”. La variazione secondo noi è fatta perché in questo
43
44
63
criterio “morale”, l’unico criterio su cui si basa la Commedia, dove la politica,
non ancora machiavellianamente separata dalla morale (o teologia), è alla
teologia o morale subordinata, incorporata, assimilata: Dante è dentro la
“reductio omnium artium ad theologiam”, e non fuori. Quei giovani hanno
saputo donare tutto se stessi: ed è questo che conta nella valutazione dantesca –
morale e non politica –, indipendentemente dallo schieramento in cui si sono
trovati a combattere, schieramento che non loro hanno scelto. È questo il
sublime sacrificio – donare se stesso a tutto rinunciando – sublime sacrificio che
Dante non riesce a fare. È per questo che Virgilio crede bene offrirgli degli altri
esempi, oltre «il giusto / figliuol d’Anchise» (Inf. I 73-74) ricordato, io credo,
proprio per questo scopo, per indicargli quella «onesta e laudabile via e
fruttuosa» (Conv. IV XXVI 8), che Enea intraprese staccandosi appunto da
Didone: avrà anche letto tutta l’Eneide – la sa «tutta quanta» (Inf. XX 114), detto
forse con ironia – ma se poi basta una «pargoletta» (Purg. XXXI 59) a farlo
capitolare (già Didone era qualche cosa di più di un capriccio, come sembra
doversi intendere essere per Dante la «pargoletta»), ha capito ben poco del
contenuto del poema virgiliano. Catone può fornire un altro esempio su come
liberarsi dal fascino femminile. Ed anche Catone, quindi, può far parte della
«curiosa mescolanza» di cui prima si è detto, anch’egli avversario dell’Impero;
nonché i «giovinetti… / Scipïone e Pompeo», Par. VI 52-53, dove in un richiamo che ci sembra voluto, si ritrovano ancora una volta insieme due «giovinetti»,
che hanno militato in campi opposti: l’uno a favore dell’Impero (e dei Disegni
provvidenziali), l’altro contro: il richiamo ci sembra proprio voluto per dare una
chiara indicazione di lettura: morale e non storico-politica.
Fermiamoci ancora su una particolare scelta fatta da Dante. Scipione e
Pompeo sono, forse, con Cesare i tre maggiori generali che ha avuto Roma. Gli
storici che hanno parlato di loro hanno fatto, sì, qualche “cenno” al fatto che in
guerra – e con grosse responsabilità - ci sono andati «giovinetti», ma nessuno
autore è andato oltre un “cenno”, ed è poi subito passato a parlare delle loro ben
più importanti azioni militari e politiche. Dante invece estrapola questo
“dettaglio” e lì si ferma. Che cosa ha guidato la sua scelta? Il problema deve
essere posto, non si volesse accettare la proposta secondo cui ha voluto metterli
sullo stesso piano di Cammilla, / Eurialo ecc. Ma non può sfuggire che ancora
una volta vengono uniti degli avversari, uno a favore dell’Impero e dei disegni
momento non si tratta di vedere chi ha fatto la grandezza dell’Impero, ma di dare qualche
indicazione (o scudisciata) a Dante, mostrando esempi di tanti giovinetti che han saputo fare
ciò che lui, già con la «barba» (Purg. XXXI 68), non si decide a fare: non si decide a quel «mori
morti et vitae vivere», di cui si è trattato soprattutto ai punti 2 e 3 di questa trattazione, cosa
che quei giovinetti hanno invece saputo fare scegliendo non l’«amor sui usque ad contemptum
Dei, [ma l’] amor Dei usque ad contemptum sui».
64
della Divina Provvidenza ed uno (come poi anche Catone) che all’Impero ed ai
disegni della Divina Provvidenza si è invece opposto. Perché questa operazione,
del tutto conforme a quella fatta con Cammilla, Eurialo e Turno e Niso? Di
sicuro si può dire che a guidarlo in questa valutazione non sia stato un criterio
“politico”. Non è altrettanto sicuro che a guidarlo sia un criterio “morale”, per
cui non conterebbe tanto lo schieramento di appartenenza, ma la capacità che
hanno avuto di “donarsi” agli altri, il livello morale raggiunto? Ma se non così,
da cosa sarebbe determinata una scelta così inusitata?
Penso inoltre che “Pompeo”, l’eroe di Lucano, dovesse costituire un
problema per Dante, che da Lucano derivava anche il suo Catone. Pompeo non
è mai citato nelle opere precedenti. Come recuperarlo? La prospettiva “morale”
e non “politica” della Commedìa gli consentì di salvarlo, sul piano ideale
naturalmente, assieme a Catone: per analoghi motivi. Salvarlo nello slancio con
cui diciottenne si lanciò a difendere la patria: come Eurialo ecc.
Di più. Dante “deve” salvare Catone per portarsi sul livello di Virgilio che
lo ha appunto salvato facendolo giudice dell’Ade, dove lo si può vedere tra
«secretosque pios, his dantem iura Catonem» (Aen. VIII 670). E deve salvare
anche Pompeo, perché Virgilio lo eguaglia a Cesare, mostrandolo «paribus […]
fulgere in armis».47 Nel giudicare Catone e Pompeo, Virgilio, che pur è il poeta
dell’Impero, lascia da parte il fatto che si posero dalla parte di Cesare ed
Ottaviano, e valuta considerando soltanto il valore personale delle persone e non
prendendo minimamente in considerazione il fatto che Catone e Pompeo
hanno lottato contro l’Impero: per la libertà! Li esalta, ma non perché hanno
lottato per la libertà, prospettiva che non esiste nell’Eneide. Li esalta per se stessi.
Perché Dante avrebbe dovuto giudicare diversamente dal maestro che lo guida?
Ma forse c’è dell’altro ancora: una gara con Agostino – Dante è sempre in
gara con qualcuno di cui deve essere lui più bravo (sembra avere un formidabile
complesso di inferiorità):48 «Taccia Lucano… (Inf. xxv 94), «Taccia […] Ovidio»
ecc. (ibidem, 97) –. Agostino, quando gli si presentano tanti giovinetti e
giovinette – «pueri et puellae» – che hanno saputo fare la totale rinuncia ai beni
di questo mondo (lussuria inclusa) si dice: «Tu non poteris quod isti?» (Conf.
«Illae autem, paribus quas fulgere cernis in armis, / concordes animae nunc et dum nocte
premuntur», Aen. VI 826-27.
48
Forse era basso e “sfidava” continuamente gli altri per farsi vedere. Come Napoleone o
Cristoforo Colombo. Potessimo avere una qualche sua riga, sono sicuro troveremmo lo stesso
riccio della “spavalderia” (come in Colombo e Napoleone), il gesto di chi vuol crearsi uno
spazio, di chi cerca aria. È rimarcatissimo in Napoleone e Cristoforo Colombo, sempre unito
ad una decisa linea di “ardimento”, incontenibile: non si fermavano di fronte a niente pur di
farsi vedere, mettersi in mostra, motivazione vera, sublimata e nascosta da altre ben più nobili,
ma di copertura. Il più matto è Colombo: irraggiungibile.
47
65
VIII XI 27). Anche Dante si dice (o Virgilio in sostanza gli dice), di fronte ai
giovinetti che gli si presentano: «Tu non poteris quod isti? Quod ista
(Cammilla)?». Tu che hai ormai la «barba» (Purg. XXXI 68), come gli osserva non
troppo benevolmente Beatrice? Ma c’è qualcosa in più in Dante rispetto ad
Agostino, i cui «pueri et puellae» appartenevano al mondo cristiano, alla fede.
Agostino prima dice: «Tu non poteris quod isti, quod istae?». A seguire mette in
evidenza l’aiuto che in far ciò è venuto loro dalla fede: «An vero isti et istae in
se ipsis possunt ac non in Domino Deo suo? Dominus Deus eorum me dedit
eis. Quid in te stas et non stas? Proice te in eum, noli metuere; non se subtrahet,
ut cadas: proice te securus, excipiet et sanabit te» (Conf. VIII XI 27). Virgilio
invece gli presenta «pueri et puellae», che quel sacrificio hanno saputo fare senza
che fossero confortati dalla fede, e dalla speranza in un aldilà. Che quel sacrificio
hanno saputo fare “gratuitamente”. E tu, con la fede, non potrai fare ciò che
hanno fatto costoro che non avevano alcuna speranza di compenso? Ciò che ha
saputo fare anche Cammilla, una giovinetta, che ha immolato il suo desiderio
di una famiglia, di figli, in che sta il tutto di una donna? Cammilla! Dante!
Conclusione
Di fronte alla lupa Dante ripiega verso la valle selvosa, torna nel peccato,
nella “morte”. In che senso sarebbe “morto” anche se avesse affrontato la lupa?
Semplice: la lupa lo avrebbe “sbranato” e lui avrebbe potuto salire sul colle:
avrebbe cioè compiuto quel «mori morti et vitae vivere», (Conf. VIII XI 25) e si
sarebbe salvato: quella che crede salvezza è “morte”, e quella che lui crede
“morte” è in realtà la vera “vita”.49 Quel che deve fare Dante è «morire, ma senza
cessar di vivere».50 Ed il problema è che Dante, nonostante gli sbandierati
propositi in senso opposto, non vuol “morire”, questo “morire”, questo tipo di
morte, non la vuole: fa resistenza, recalcitra, inventa scuse, si è assuefatto alla
vita della selva e ci sta bene: sarà duro a morire e lo farà soltanto, ed ancora
facendo resistenza, sulla vetta del purgatorio.51 Come tutti è chiamato al
rinnovamento interiore, ad entrare nella Legge, come quasi tutti cerca di
scamparla, ché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. In questo senso, con
questa sua opposizione, con questo suo trovare scuse per non entrare nella
Legge, ci rappresenta tutti, ché la chiamata c’è, per tutti: la risposta è di pochi.
Vd. R. MANESCALCHI, «…tanto l’impedisce che l’uccide» (Inf. I 96), cit.
Cfr. «Senti ed impara. Gl’indiani ed i cristiani hanno trovata la vera medicina. Bisogna morire,
ma senza cessar di vivere», F. DE SANCTIS, Schopenhauer e Leopardi. Dialogo tra A e B, in Saggi
critici, a c. di LUIGI RUSSO, vol. 2°, Bari, Universale Laterza, 1965, p. 178.
51
Di fronte agli inviti di Virgilio perché faccia il passo decisivo, Dante resta “fermo”: «Ed io pur
fermo e contra coscïenza» (Purg. XXVII 33).
49
50
66
Un chiarimento in questo senso mi sembra essere dato dal verso «lo passo
che non lasciò giammai persona viva», Inf. I 27, il «passo» (di confine tra peccato
e virtù), cioè, che nessuna persona può oltrepassare rimanendo viva, ovvero
senza che avvenga una “morte”, che è “morte morale”, ovvero una totale
rinuncia ai beni effimeri di questo mondo («passo» che Dante avrebbe oltrepassato in uno slancio momentaneo, ma subito cominciando ad avere dubbi: come
si accorge di essere “morto” torna subito indietro. Nessuna contraddizione. Non
c’è santo o missionario che non abbia avuto un qualche “ripensamento”. I più
non ripartono, qualcuno sì).
La non volontà di salvarsi prende il sopravvento: in un primo tempo cessa
di avanzare verso il colle, ma comincia ad aggirarlo, “passeggia la costa intorno”,
cammina cioè in piano. Questo vuol dire, inequivocabilmente, «sì che ‘l piè
fermo sempre era il più basso» (Inf. I 30): non più verso l’alto, verso la virtù e la
salvezza; non ancora di nuovo verso il basso, verso il peccato e la “morte”: di
traverso, nel dubbio, incerto su che strada prendere: salire o scendere?
In questa sua irrisolutezza fanno breccia le tentazioni, raffigurate dalle tre
fiere, che non sono ostacoli esterni, ma interni, dell’animo, svolgendosi la lotta
di Dante tutta nel suo animo. E Dante capitola tanto da “ruinare” «in basso
loco», ovvero verso il fondo della valle selvosa, «fino al vallo estremo, / al buio,
perso il ricordo del mattino» (E. Montale, Noi non sappiamo quale sortiremo, vv.
7-8 in Ossi di seppia) luminoso, che lo guidava in alto, alle immacolate «non
tócche radure» (ivi, v. 8) della virtù.
Mentre “ruina” riflette sui libri che ha letto, sui suoi maestri, soprattutto su
quello che si è scelto come modello, Virgilio. Se lo vedessero in quella
situazione! Darsela a gambe, invece di lottare, come loro hanno fatto, come lui,
Virgilio, ha sicuramente fatto: e vincendo!
Ed ecco che il maestro, da lui stesso inconsciamente evocato, gli viene
incontro. Dante, che lo ha evocato, teme ora di incontrarlo e spera che non sia
lui – il maestro, Virgilio - ovvero spera che sia un «uomo certo» e non
un’«ombra».52 Ma è subito disilluso, come detto.
Anche ciò che segue non ha certo un carattere meramente informativo, ma
costituisce un velato ed aspro rimprovero: «… cantai di quel giusto figliol
d’Anchise» (Inf. I 73-74). Con il che Virgilio gli dice che l’esempio «giusto», da
seguire, lui glielo ha indicato. Il termine «giusto» infatti non è soltanto un’eco
da Virgilio: «quo iustior alter / nec pietate fuit, nec bello maior et armis» (Aen. I
52
«Miserere di me […] / qual che tu sii, o ombra [ciò che Dante teme] od uomo certo [come
Dante spera]», Inf. I 65-66. Già grande spavento gli aveva fatto il nuovo arrivato perché «per
lungo silenzio parea fioco», Inf. I 63, cioè gli aveva dato l’idea di essere un trapassato (come
di fatto era; e quindi, per Dante, poteva esser proprio il maestro, Virgilio!).
67
544-545). Ciò che è «giusto» in Dante serve da modello, come esempio da
seguire. Conferma ne è l’espressione: «Io non Enea, io non Paulo sono» (Inf. II
32.), che noi intendiamo così: «Tu vorresti che io fossi come Enea, che mi
trasformassi in Enea, ma io…», con Dante che tenta di sottrarsi al rimprovero
con l’esibire la sua insufficienza, la sua normalità. Mentre il rimprovero di
Virgilio continua, ormai in modo aperto:
«Ma tu, perché ritorni a tanta noia?
Perché non sali al dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?» (Inf. I 76-78).
Sembra sottinteso: «L’avessi avuta io la possibilità di salvezza che hai tu»
(Virgilio protesterà in ogni suo intervento, in modo più o meno palese ma certo
in tutti i suoi interventi, per l’esclusione dalla salvezza: sua e di tanti altri grandi
spiriti, esclusione di cui non riesce a capacitarsi, come del resto non se ne
capacita Dante stesso. È assolutamente un leit-motiv, uno dei problemi (o
addirittura “il problema” di Dante e della Commedìa?). Vedo queste parole
pronunciate con lo stesso tono con cui un padre operaio di Mirafiori (Fiat) dice
al figlio: «Perché non studi? L’avessi avuta io la possibilità di frequentare il Liceo
e l’Università!»53
Come cercherà di cavarsela il discepolo colto in fallo? Come tutti gli
studenti colti in simile situazione: dicendo che lui studiare ha studiato: era il
compito troppo difficoltoso. Come risponde un liceale in simili casi? «Non se la
deve prendere con me, professore. Esamini la mia preparazione e vedrà che io
studiare ho studiato. È la versione che era troppo difficile». Così Dante:
«Esamina il lungo studio e il grande amore con cui ho letto la tua opera» (Ed il
sottinteso è: «E vedrai che io studiare ho studiato. Se non riesco a vincere la lupa
è perché quella è una bestia che non si può vincere»).
Dante non può non sentirsi in colpa davanti a Virgilio che, con Enea, gli
ha dato i giusti ammaestramenti. Ed in quest’ottica l’espressione «con vergognosa fronte» (Inf. I 81), tipica di chiunque venga colto in fallo,54 è chiara
indicazione che Dante sa di aver mancato ad un suo dovere, di essere venuto
Si veda l’espressione «nel tempo de li dèi falsi e bugiardi» (Inf. I 72): a1 tempo di credenze
erronee, «deos falsos fallacesque», S. AGOSTINO, De Civ. Dei II XXIX 2. Non è certo più
un’informazione, ormai siamo al rimprovero: «Io, che ce l’ho messa tutta, non ho potuto
salvarmi, perché allora non ce n’era la possibilità: tu, che questa possibilità ce l’hai, fai tante
storie». Dante può, con la fede, andar oltre il livello raggiunto dagli antichi e non ne
approfitta! Il rammarico di Virgilio per la “salvezza mancata” è continuo nella Commedìa. Qui
costituisce un ulteriore rimprovero per Dante.
54
Essa è «paura di disonoranza per fallo commesso», Conv. IV XXV 10.
53
68
meno alla fiducia riposta in lui, di essere «colpevole», anche se non lo ammette
apertamente. Lo ammetterà però di fronte a Beatrice (altro esame, con
esaminatrice anche più inflessibile), quando non potrà farne a meno. Ed allora
riapparirà la vergogna: «tanta vergogna mi gravò la fronte» (Purg. XXX 78),
«Quali i fanciulli, vergognando, muti» (Ivi XXXI 64), «Tuttavia, perché mo
vergogna porte / del tuo errore» (Ivi XXXI 43), e «Da tema e da vergogna / voglio
che tu omai ti disviluppe» (Ivi XXXIII 31-32). Con Virgilio prova a scantonare.
Non che Virgilio ci caschi. Virgilio non ha però strumenti adatti a farlo
capitolare. È con Beatrice che non può più fare il furbo.
Di fronte alla resistenza opposta da Dante, Virgilio comprende che il
discepolo non è ancora pronto per l’auto-sacrificio e conclude, credo piuttosto
sconsolato al vedere dove sono finite tutte le sue fatiche, che sia necessario un
corso di recupero. E si dice e gli dice: «A te convien tenere altro viaggio», che
significa «Portiamolo a vedere Catone (per la capacità di rinunzia manifestata
con Marzia). Forse lui riuscirà a fargli capire ciò che non ha capito con Enea»
(capace di staccarsi da Didone: esempio però minore, non fosse che per le
titubanze che Enea ha avuto, di quello dato da Catone con Marzia, sacrificio per
cui Dante lo ha paragonato a Dio stesso). E dal viaggio nell’aldilà, conseguente,
trarrà, pensa Virgilio, anche tanti altri stimoli. Ciò si ricava da quanto dirà allo
stesso Catone: «da l’alto scende virtù che m’aiuta / conducerlo a vederti ed a
udirti» (Purg. I 68/69). Il corso di recupero è il viaggio nell’aldilà, che lo farà
meditare ed è voluto alla «corte del cielo» (Inf. II 125).
La lupa verrà vinta dal Veltro, che sarà anche la salvezza di «quell’umile
Italia» per cui morirono «la vergine Cammilla / Eurialo e Turno e Niso». Questo
inserto non c’entra molto con la linea del discorso, è un salto di binario, che
però ha una sua ragione di essere, perché dà una indicazione, io credo
inequivocabile, sul discorso della Commedìa tutta. I fatti di rilievo sono tre, e
tutti e tre voluti: a) i personaggi citati non sono i protagonisti (a parte Turno,
forse); b) non conta se abbiano favorito l’Impero o lo abbiano ostacolato (stessa
prospettiva per Catone e Pompeo); c) si mette in evidenza che “morirono”, da
intendere, credo, in senso morale prima che fisico, fatto che venne dopo.
Abbiamo forse la chiave della Commedìa. Virgilio ha trovato il modo, con
questo “salto di binario narrativo”, di porre sotto gli occhi di Dante quei tanti
giovani – e «qui juvenes!» (Aen. VI 771) – che seppero fare una totale rinuncia
ai beni effimeri di questo mondo, per un ideale, la patria, l’umanità.
Sostanzialmente insinuando: «Tu non poteris quod isti? Quod ista, Cammilla?»,
che è ciò che Agostino, in analoga situazione, si dice quando alla mente gli si
presentano tanti giovani e giovinette che hanno saputo fare quella totale
rinuncia che lui invece fatica tanto a fare.
69
Non so se questo modello può dar risposta a tutti i problemi proposti dalla
Commedìa. Quello che posso dire è che quanti problemi si sono presentati a me,
hanno trovato in questo modello una esauriente risposta: direi che si sono
infilati in esso come le perle nel filo e sarei desideroso di metterlo ulteriormente
alla prova: spero si presenti chi mi stimoli in questo senso.
70
Appendice
Il “peccato”, il “vizio”, la “virtù” nella Commedìa di Dante
Mi è già capitato di sostenere, sporadicamente ed all’interno di trattazioni
ad altro rivolte,55 che con l’inferno è collegato il “peccato”, con il purgatorio il
“vizio”: qui aggiungo che la “virtù” è collegata con il paradiso.
Tener presente questa distinzione consente di chiarire e risolvere qualche
problema, ragione per cui ho deciso di affrontare il tema in modo specifico.
Per prima cosa vediamo cosa intendono i vocabolari con il termine “vizio”:
«Pratica del male, intesa soprattutto come abituale incapacità del bene (è
concetto diametralmente opposto a quello di virtù); nella teologia morale, v.
capitali, i peccati capitali (superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia)
non come atti individuali ma come abitudini […] Abitudine radicata che
provoca nell’individuo il bisogno morboso di quanto per lui è o può esser
nocivo» (Devoto-Oli); «abituale disposizione al male», Tullio de Mauro. Queste
definizioni mettono ben in chiaro che con il “vizio” abbiamo una «abituale
disposizione al male non come atti individuali ma come abitudini». Insomma il
“peccato” si ha quando questa “abituale disposizione” si attua in “atti indivi55
Vd. R. MANESCALCHI, Di una possibile intervista a Dante Alighieri, cit., «Il Rinnovamento»,
97 (febbraio) 1982, specificamente p. 38), poi in Il Prologo della Divina Commedia, cit.,
(specificamente p. 76); ID. Anche l’Inferno, come il Purgatorio ed il Paradiso, ordinato secondo la
dottrina dell’amore?, ora in Studi sulla Commedia, cit., p. 197 (già in «Campi Immaginabili»,
2003, nn. 28/29, pp. 115-127, ma senza questa parte finale, aggiunta nella riedizione riveduta
per il volume loffrediano): «Forse è bene intendere che nel Purgatorio non ci sono più
«peccati», ma «vizi», correggendo quanto comunemente si crede. Se ci fossero ancora i
«Peccati» l’anima sarebbe nell’Inferno. Del “peccato” si è pentiti, Dio lo ha perdonato, rimane
la tendenza a commettere quel peccato, il vizio. Le sette P potrebbero essere sette «Penitenze»
che si fanno in questo «penitenziario» che è il Purgatorio: cfr. «lo mio dover per penitenza
scemo», Purg. XIII 126. Ripete il concetto anche il saggio «Ei son tra l’anime più nere…(Inf. VI
85) …dai lor costumi fa’ che tu ti forbi» (Inf. XV 69), LIA, XI, 2010, n. 17, p. 348 (poi in Studi
sulla Commedia, cit., n. 16, p. 69): «Il peccato, relativamente all’Inferno; il vizio, relativamente
al Purgatorio, la virtù, relativamente al Paradiso. Insomma le sette “P” non significano i sette
Peccati capitali, di cui il penitente dovrebbe liberarsi, poiché dei “Peccati” si è liberato con la
confessione all’angelo portiere. Nel Purgatorio non ci sono Peccati, come giustamente afferma
il Guinizzelli dicendo che il Purgatorio è luogo «dove poter peccar non è più nostro» (Purg.
XXVI 132). L’angelo assegna a Dante, secondo che si fa sempre con le confessioni, sette
Poenitentiae, perché possa liberarsi non del peccato, cancellato dalla confessione, ma della
tendenza a peccare che ancora rimane in lui, tendenza a peccare, ovvero “vizio”. Nel
purgatorio abbiamo penitenti e non peccatori, penitenti che “poenitentiam agunt”».
Sembra smentire il verso «che su di fuor sostegnon penitenza» (Inf. XI 87); ma forse qui si parla
ironicamente, si eufemizza: in questo caso non si tratta di “Poenitentiae”, ma di “Poenae”,
punizioni, castighi: per i peccati ci sono le “poenae”, per i vizi le “poenitentiae”.
71
duali”, cosa impossibile nel purgatorio, dove, come dice il Guinizzelli «poter
peccar non è più nostro» (Purg. XXVI 132). Questo concetto è confermato, ce ne
fosse bisogno, dalle parole di Oderisi da Gubbio: «che possendo peccar, mi volsi
a Dio» (Purg. XI 90) e da quanto Dante dice a Forese Donati affermando ancora
“potersi peccare” soltanto in vita: «Se prima fu la possa in te finita / di peccar più,
che sovvenisse l’ora / del buon dolor ch’a Dio ne rimarita» (Purg. XXIII 79-81);
ragione per cui Manfredi può dire, mettendoli al passato remoto, «orribil furon
li peccati miei» (Purg. III 121). Non esiste più il problema del “peccato” e del
“peccare”. Il “peccato” non costituisce più problema in purgatorio, non del “peccato” più si tratta ormai: il “peccato” è alle spalle, relegato all’inferno: si fa ancora
sentire una ormai comunque controllata spinta a peccare, ovvero il “vizio”.
Concludendo le cose andrebbero così. I “peccati” vengono puniti
nell’inferno. Accede al Purgatorio chi dei “peccati” ha fatto in tempo a
“pentirsi”, “rimaritandosi”, per cui vedi (Purg. XXIII 81), a Dio che altro non
aspetta e la cui «bontà infinita ha sì gran braccia / che prende ciò che si rivolge
a lei» (Purg. III 122-123). Qualora il “peccatore” abbia indugiato troppo a
“pentirsi”, dovrà attendere nell’antipurgatorio, dove «tempo per tempo si
ristora» (Purg. XXIII 84), un certo periodo, calcolato in corrispondenza ad esso
indugio, prima di essere ammesso alla “penitenza” purgatoriale.
Cosa rimane all’anima che del “peccato” si sia liberata? Le rimane una certa
tendenza, una certa abitudine a commettere amcora quel peccato, ovvero il
“vizio” e per migliorarsi deve anche di esso liberarsi, ovvero deve sradicare da se
stessa quella inclinazione che ancora si fa sentire, sebbene il “penitente” del
purgatorio riesca a controllarla. Insomma peccare non può più peccare poiché
gli stimoli ormai sono posti sotto controllo, ma ancora si sentono e devono
essere estirpati perché l’anima sia veramente libera da essi.
Tutto ciò è indicato in modo molto chiaro nell’episodio dell’incontro di
Dante con l’angelo portiere, a Purg. IX 64-145, in cui si avrebbe, secondo
l’opinione generale, la “confessione” nelle varie fasi della sua procedura. Ed ora
la confessione si conclude con l’assegnazione della “Penitenza”, che per essere
completa si suddivide qui in sette “Penitenze”, poiché ci si deve liberare di tutti
i sette “Vizi” capitali: il purgatorio è un “penitenziario”.56
Normalmente si intendono le sette P come i sette Peccati capitali. Per le
ragioni dette non può essere così. Sono i “Vizi” e non i “Peccati” le sette
«piaghe» di cui il poeta si deve “lavare” secondo l’invito fattogli dall’angelo
56
Fa sempre piacere trovare un sostegno in chi, inconsapevolmente e parlando d’altro, concorda
pienamente con questa tesi: il purgatorio è il «monte della Penitenza» come dice G. PADOAN, nel
commento a Inf. I, 63, (cioè d’altro parlando). E così penso abbiano fatto anche altri, non potendo
per ora però indicarne nessuno a parte questa citazione venuta fuori proprio in modo casuale.
72
portiere: «Fa che lavi, / quando se’ dentro, queste piaghe» (Purg. IX 113-114),
cui risponde il verso: «lo mio dover per penitenza scemo», di Purg. XIII 126.
A questo punto credo si possa risolvere almeno un problema: i sodomiti che
all’inferno sono inclusi tra i “violenti” e nel purgatorio invece tra i “lussuriosi”,
cavandosela in genere la critica con un “ripensamento” di Dante, come non può
essere, pena la coerenza dell’opera che non può assolutamente venir meno.
Occorre tener presente che “peccato” e “vizio” possono avere delle differenze. I
sodomiti in purgatorio sono “lussuriosi” perché il loro peccato in vita rimase al
livello di “trasporto”, come quello correttamente amoroso di Francesca:
insomma non seppero resistere alla tentazione, cui, magari, tentarono, senza
riuscirci, di opporsi. Commisero il peccato magari non volendolo, per
debolezza, rammaricandosene e pentendosi, per poi magari reiterarlo per le
stesse ragioni, e sempre pentendosi di quello che facevano, come accade a tanti
incontinenti, per nulla soddisfatti delle loro “performances”, che spesso
disapprovano, spesso prefiggendosi di non più “ricaderci”.
Se il vizio si concretizza in un “atto individuale” o “peccato” di questo tipo,
cioè “lussuria”, rimane “lussuria”, sia come “peccato” che come “vizio”.
Ma nel passare all’atto concreto o “peccato”, il “vizio” può mutare natura,
“ammogliandosi”57 con altri peccati (l’incontinenza, soprattutto, si può unire o
“ammogliare” con tutti gli altri peccati, di violenza o di frode. Poi il campo si
restringe e la violenza può “ammogliarsi” solo con peccati di frode e di tradimento). Nel caso specifico dei “sodomiti” dell’inferno Dante può benissimo
57
Il termine «animali» di Inf. I 100 può valere «uomini, esseri animati» oppure «peccati». Se è
vero, infatti, che i “peccati”, come da distribuzione nell’Inferno, sono una trentina, considerate
le diverse sottospecie per cui la frode, ad esempio, ne ha ben dieci, non si capisce come sia
possibile dire «molti» e «più saranno ancora». Non sono sempre quelli? È che, se le categorie,
e sottocategorie, sono una trentina, ogni peccato, poi, ha una sua specificità, è unico, e la pena
non è per tutti eguale in ciascuna categoria. C’è una innumerevole gradualità, per cui,
praticamente, ad ogni peccatore corrisponde un suo particolare peccato ed una sua particolare
pena: per cui tot peccatores, tot peccata. Ciò può vedersi molto bene tra i traditori degli ospiti
e dei benefattori, che hanno, dentro il ghiaccio, innumerevoli posizioni, corrispondente
ognuna allo specifico peccato del dannato. Tot capita, tot peccata, tot poenae! Così valutando,
dunque, «peccati» e «peccatori» vengono ad essere la stessa cosa e non c’è più alcuna necessità
di distinguerli ed il «più saranno ancora» può essere riferito sia a “peccatori” che a “peccati”,
che praticamente, in questo caso, sono sinonimi». Vd. questo concetto espresso anche in «Ei
son tra l’anime più nere…(Inf. VI 85) …dai lor costumi fa’ che tu ti forbi» (Inf. XV 69), cit.
Questa concezione è già in Virgilio che la esprime in modo limpidissimo: «Non mihi si
linguae centum sint oraque centum, / ferrea vox, omnis scelerum comprendere formas, /
omnia poenarum percorrere nomina possim» (Aen. VI 625-627). Potrebbe sostenersi
addirittura di più: uno stesso peccatore commette lo stesso peccato più volte ed ogni volta quel
“peccato” è, per situazioni, componenti, partecipazione ecc., un unicum. E quindi i peccati
sono innumerevolmente più numerosi dei “peccatori”.
73
aver considerato che, in questo caso, non ci sia stata soltanto una tentazione
incontenibile (e magari anche disapprovata nell’intimo, con propositi di mai più
“ricaderci” ecc.), come per i sodomiti del purgatorio; ma ci può essere stato
“consenso” della facoltà, ovvero della «virtù che consiglia / e de l’assenso de’
tener la soglia» (Purg. XVIII 62-63), come può esserci stata la decisione di metter
da parte la legge data da Dio per farsi una legge a proprio uso e consumo. Nel
caso di Brunetto Latini, ad esempio, e di tanti «litterati grandi e di gran fama»
(Inf. XV 107) Dante può aver giudicato esserci stata l’arroganza dell’intellettuale
che si sente superiore anche alle leggi naturali e pensa essergli lecito farsi lui le
leggi (atteggiamento molto diverso da chi condiscendeva rammaricandosene e
dicendo a se stesso: lo faccio, ma è l’ultima volta).
Così ragionando possiamo meglio mettere a fuoco anche la situazione dei
tre fiorentini «ch’a ben far puoser gli ingegni», Inf. VI 81, cioè Tegghiaio
Aldobrandi, Jacopo Rusticucci e Guido Guerra, che si trovano nello stesso
cerchietto. Avendoli incontrati in una schiera diversa da quella di Brunetto, e
“dopo”, è lecito dedurre che li considerasse più gravemente peccatori, poiché il
peccato diventa più grave mano mano che nell’inferno si avanza. È da credere,
secondo me, che nei tre Dante vedesse un doppio peccato di violenza. Essi
tentarono, come anche Dante, di mettere ordine a Firenze «a ben far puoser gli
ingegni», appunto. Ma con un difetto di base: non utilizzarono la legge data da
Dio, la legge dell’Impero, ma ebbero la presunzione di fare loro le leggi, quelle
leggi che fatte ad ottobre non arrivano a mezzo novembre.58 E questo peccato è
in qualche modo lo stesso commesso con la loro sodomia, dove, anche, hanno
avuto la presunzione di farla loro la legge, senza tener conto di Dio e della
Natura. Quindi hanno commesso non uno, ma due peccati di violenza, uno in
ambito privato ed uno in ambito pubblico: due peccati dello stesso valore,
comunque, che aggravano, quindi, ma non più di tanto, la loro posizione.
In base a questa considerazione si può capire come non ci sia coincidenza
tra l’ordinamento dell’Inferno e quello del Purgatorio, pur se ci si appoggia sullo
stesso ordinamento morale.59 Non c’è affatto alcun “ripensamento”, che sarebbe
un vulnus inaccettabile nella strutturazione dell’opera (meno grave in altri casi:
ma l’organizzazione dell’opera non può essere toccata, col rischio di far crollare
Cfr. «a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili», Purg. VI 143-144. Ho già
sostenuto che Dante, dopo il colloquio con Brunetto ed i tre fiorentini (a seguire quello avuto
con Ciacco e quello avuto con Farinata) si sarebbe liberato della legge fatta dal Comune di
Firenze – la “corda” di Inf. XVI 106, intesa appunto come la legge fatta da Firenze – si sarebbe
“forbito” dei costumi fiorentini che, datosi alla politica, era in pericolo di far suoi (vd. «dai lor
costumi fa che tu ti forbi» Inf. XV): cfr. «Ei son tra l’anime più nere…(Inf. VI 85) …dai lor
costumi fa’ che tu ti forbi» (Inf. XV 69), cit.
59
Vd. R. MANESCALCHI, Anche l’Inferno, come il Purgatorio e il Paradiso, ordinato secondo la
58
74
tutto). Si tratta di diversa materia morale: l’inferno si organizza secondo i
peccati, il purgatorio secondo i vizi. Il purgatorio è la “potenza”, l’inferno è
l’atto, per stare nei termini della filosofia aristotelica: e nel passaggio dalla
potenza all’atto si ha qualche complicazione.
La logica così vuole e naturalmente si può accettare che non venga sempre
rispettata: se Farinata ha contribuito a far «l’Arbia colorata in rosso» (Inf. x 86)
non ha peccato soltanto in “pensieri” come gli eretici tra cui si trova – si può
peccare “in pensieri, parole ed opere” – ma anche in “opere”, nel caso in atti di
violenza e Farinata stesso potrebbe esser posto nel Flegetonte, tra i sanguinari
tiranni che vi soggiornano. E così in tanti altri casi. Ma non arriverei a sostenere
che Didone ed altre eroine morte per amore non siano ben collocate tra i
lussuriosi, poiché il suicidio per amore mi sembra una fase della lussuria, che
avviene per trasporto incontenibile e non propriamente per “scelta”, come in
tutta evidenza lo è invece in Pier delle Vigne che si uccide, come dice, «per
disdegnoso gusto» (Inf. XIII 70). Chi forse è mal collocata sembra Semiramide
che «a vizio di lussuria fu si rotta, / che lìbito fé licito in sua legge», cioè si fece
una legge ad uso personale, come i tre fiorentini e, crediamo, Brunetto. Anche
se è da dire che non lo fece in spregio alla legge naturale o divina, come forse
fecero i peccatori fiorentini, ma «per tôrre il biasmo in che era condotta» (Inf. v
57, cioè non per fare violenza alla divinità: non un atto di presunzione di fronte
a Dio ed alla Natura, ma un atto di difesa della sua reputazione. E quindi il suo
gesto può vedersi come un’appendice, abbastanza innocua sul piano morale,
della sua devastante passionalità: essere come una fase di essa, una difesa del suo
nome, comprensibile se non scusabile: un’aggravante forse, ma che non cambia
la natura del peccato.
Il male dunque si divide in “peccato” e “vizio” e si oppone al bene che è
soltanto “virtù” e non ha scissioni. La “virtù”, invero, come predisposizione ad
operare il bene, si oppone soltanto al “vizio” predisposizione ad operare il male.
Probabilmente coopera con altre virtù, ma di questo probabile “ammogliarsi”
Dante non dice nulla. Certo c’è, ma rimane sottinteso.
Le “virtù” cardinali, praticate anche dagli antichi, dai gentili, sono
all’opera già nel purgatorio e sono soprattutto i rappresentanti del mondo
classico – Virgilio, Catone, Stazio – come predisposti per insegnarle a Dante.
Le “virtù” teologali – fede, speranza e carità – sulle quali Dante sarà anche
esaminato – cfr. i canti XXIV, XXV e XXVI del Paradiso – sono caratteristiche
invece del paradiso.
dottrina dell’amore?, «Campi Immaginabili», 28/29, 2003, pp. 115-127; e, soprattutto, Ipotesi
sulla costruzione della Divina Commedia sopra un unico principio, in Studi sulla Commedia, cit.,
pp. 199- 210, già in «Campi Immaginabili», 36/37, 2007, pp. 97-104.
75
A questo punto si presenta un problema. Giunto sulla vetta del purgatorio,
nella «divina foresta spessa e viva» (Purg. XXVIII 2), Dante non ha più le P sulla
fronte, a significare che si è liberato di ciò che esse rappresentano, il “Peccato”
come sin a qui si è creduto o le “Penitenze” che lo hanno anche liberato dal
“Vizio”, dalla radice da cui i “peccati” germogliano, come più giustamente
sembra a noi doversi sostenere: «libero, diritto e sano» (Purg. XXVII 140) è il suo
arbitrio, nemmeno più influenzato dalle “tentazioni”, cancellate dalla
purificazione purgatoriale che ha appunto eliminato anche le “tendenze” a
peccare. La sua natura è innocente come prima del peccato originale. Un’ombra
potrebbe ancora distendersi sulla sua anima, provocata dal ricordo dei peccati,
ma un ultimo rito, l’abluzione nel fiume Lete, cancella anche il ricordo di essi e
la tristezza che ne potrebbe derivare. Un sorso dell’acqua dell’Eunoè infine gli
rende vivida memoria di tutte le buone opere da lui fatte e la sua anima torna
felice, gioiosa, come quella creata da Dio nell’Eden.
E cosa gli porta ancora per la sua perfezione l’ascesa del paradiso, se ha già
recuperato la natura umana nella sua pienezza ed integrità? Dal momento che
deve esserci ancora progresso? L’anima può crescere ancora, immergendosi in
Dio. Ed è un tuffo infinito di tutte le anime del paradiso, le quali però, per
quanto avanzino verso Dio, da Dio saranno sempre infinitamente distanti, e
mai veramente “implete”: L’universo è tensione perenne, che mai si appagherà.
Solo Dio è “impleto” e può dire di sé «Ego Dominus et non mutor» (Malachia,
III 6).60 E vd. anche: «Ego sum qui sum // Io sono quello che sono», Ex. III 14.
Tutti diventano quello che sono, perennemente. Solo Dio non diventa: Egli è.
Ed in quanto “è”, è motore immobile «che tutto move»: non solo per spinta, ma
anche per attrazione, come è il caso delle anime del paradiso nel loro tuffo
infinito in Dio.
60
Frase così commentata da Tommaso d’Aquino: «Ad primum ergo dicendum quod illud
optime se habens quod sine motu possidet suum bonum, est Deus, qui est omnino
immutabilis, secundum illud Malach. III, ego dominus, et non mutor. Quaelibet autem
creatura est aliquo modo mutabilis, ut patet per Augustinum, VIII super Gen. ad Litt»,
Summa teologica, III Quaestio 57, art. 1. (4). Il santo dottore afferma, dunque, essere
“mutabilis” «quaedam creatura». E non esclude da tale condizione di “mutabilis” nemmeno lo
stesso Cristo, anche Lui, secondo Tommaso, “creatura” e, quindi, non del tutto “impleto”!
Così infatti continua il testo dell’Aquinate: «Et quia natura assumpta a filio Dei remansit
creata, ut patet ex his quae supra dicta sunt, non est inconveniens si ei aliquis motus
attribuatur» (ibidem), dove l’«aliquis motus» sarebbe stata la sua ascensione al cielo. La Chiesa
non accetta però questa posizione del Santo Dottore ed insiste nel dire che Gesù fu “generato
e non creato, della stessa sostanza del Padre”.
76
GUGLIELMO BARUCCI
Percorsi e temi onirici nel Purgatorio*
L’interpretazione dei sogni costituisce, naturalmente, uno dei più complessi
esercizi di decriptazione testuale, e gli stessi tre sogni del Purgatorio dantesco –
nel loro gioco di richiami e rispecchiamenti – disegnano un percorso onirico e
notturno la cui ambiguità ha prodotto letture anche molto diverse.
L’elemento essenziale è che i sogni costituiscono dei passaggi di stato; certo,
passaggi topografici, in primo luogo, dall’Antipurgatorio al Purgatorio, per il
primo (Pg IX); dalle prime quattro cornici alle ultime tre, per il secondo (Pg
XIX); l’accesso al Paradiso terrestre, per il terzo (Pg XXVII). Il concetto di limite
e soglia – e la loro non superabilità – è d’altronde enunciato già come premessa
di quell’immobilità notturna che è occasione contingente dei tre sogni. Nella
valletta del Purgatorio, infatti, Sordello traccia una linea per terra ed enuncia la
prima legge fondamentale del monte del Purgatorio, ossia l’impossibilità di
procedere dopo il tramonto: «Vedi? Sola questa riga / non varcheresti dopo ’l sol
partito» (VII 53-54). Il limite da superare, il varco, compaiono – in forme
diverse – però anche nel contesto dei sogni, tanto nelle immagini che ne
definiscono momento e forme, quanto nei miti che li impreziosiscono. E limite,
* Queste pagine costituiscono una ricomposizione di uno dei percorsi affrontati nella mia
monografia “Simile a quel che talvolta si sogna”. I sogni del Purgatorio dantesco, Firenze, Le
Lettere, 2012, uscita successivamente agli Incontri Ingauni di Albenga. In questa sede la
bibliografia sull’argomento, davvero vasta, è necessariamente ridotta all’essenziale. Si
segnalano comunque alcuni dei principali interventi sui sogni danteschi nel loro insieme: C.
SPERONI, Dante’s Prophetic Morning-Dream [1948] in American Critical Essays on The Divine
Comedy, edited by R.J. Clements, New York, New York UP, London, University of London
Press, 1967; G.P. NORTON, Retrospection and Prefiguration in the Dreams of Purgatorio, in
«Italica», XLVII, 4, 1970, pp. 351-365; R. STELLA, L’expression symbolique dans les trois rêves
du Purgatoire de Dante (Purg., IX, XIX, XXVII), in «Revue des études italiennes», XXV, 1979,
124-144; D.S. CERVIGNI, Dante’s Poetry of Dreams, Firenze, Olschki, 1986; K.L. LYNCH, The
‘Purgatorio’: Dante’s Book of Dreams, in The High Medieval Dream Vision. Poetry, Philosophy,
and Literary Form, Stanford, Stanford UP, 1988, pp. 146-162; Z.G. BARAŃSKI, Il carattere
riflessivo dei tre sogni purgatoriali [1989], in «Sole nuovo, luce nuova». Saggi sul rinnovamento
culturale in Dante, Torino, Scriptorium, 1996, pp. 255-279; P. BOYDE, Immaginazione e sogno,
in ‘Lo color del core’. Visione, passione e ragione in Dante [1993], Napoli, Liguori, 2002, pp.
137-159; M.A. BASILE, “Al mattin del ver si sogna”: i sogni di Dante nelle albe del Purgatorio, in
«Dante. Rivista internazionale di studi su Dante Alighieri», III, 2006, pp. 41-68.
77
varco e movimento sono parte integrante dello stesso immaginario onirico dei
tre sogni, così che il sogno si profila anche come proiezione del reale percorso
dantesco.
Il fulcro di questa parallela dimensione onirica, per certi versi, è
riconoscibile nel secondo sogno, quello della femmina balba1. È un sogno
decisamente particolare, che molti lettori hanno trovato – forse a torto – troppo
rigidamente allegorico, troppo costruito; eppure la sua densità concettuale, la
sua simbologia, le sue implicazioni autobiografiche e alcune anomalie rispetto
agli altri ne fanno un vero crocevia. Come è noto i tre sogni rispettano una
struttura a base nove, numero di Beatrice; una struttura imperfetta, peraltro,
perché il secondo sogno è sì preannunciato nel XVIII, ma è in realtà illustrato
all’inizio del XIX. Uno slittamento minimo, ma di assoluto rilievo, proprio
perché sembra incrinare quel percorso numerologico che porta a Beatrice nel
Paradiso terrestre. Un’anomalia, peraltro, rafforzata anche dal distacco tra
l’assopimento, a chiusa di Pg XVIII, e il sogno in sé. È questa forte cesura a
conferire al secondo sogno un’autonomia strutturale e un’evidenza figurativa –
accentuate ancor più dalla maggiore estensione (33 versi contro 21 e 20) –
assenti negli altri due casi.
Il terzo sogno, infatti, compare poco dopo la metà del ventisettesimo canto,
come a costituire solo uno dei momenti rituali del passaggio dall’ultima cornice
all’ingresso nel Paradiso terrestre; il primo, di contro, si colloca sì all’inizio del
nono canto ma in realtà l’incipit è occupato dalla descrizione del cadere della
notte e dall’assopirsi, e solo con il v. 13 abbiamo il sogno in sé. Pg XIX, invece,
si apre direttamente sul sogno, in tutta la sua forza visiva, come se lo stacco
narrativo tra i due canti coincidesse con il buio della caduta nel sonno,
conferendo una assoluta concretezza alle immagini, come se il lettore si trovasse
direttamente sprofondato nel sogno o, meglio, in un incubo tentatore. Un
sogno dunque di singolare forza impressiva anche a causa degli elementi che ne
connotano, negativamente, il momento: il freddo della luna; quel senso di
impotenza veicolato dall’impossibilità che il calore del giorno attenui il freddo
della notte; Saturno, pianeta freddo e melanconico2; quei geomanti la cui
fisionomia è quantomeno ambigua se non altro perché, da Isidoro in poi,
sempre inclusi negli elenchi di indovini, negromanti e vaticinatori che traevano
1
2
Fondamentale al riguardo C. NARDI, Sul diciannovesimo canto del “Purgatorio” in compagnia
dei padri della Chiesa, in «Studi danteschi”, LXXI, 2006, pp. 27-86.
Si vedano quantomeno R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY, F. SAXL, Saturno e la melanconia [1964],
Torino, Einaudi, 1983, pp. 54-115 e M. FATTORI, Sogni e temperamenti, in T. GREGORY (a
cura di), I sogni nel medioevo. Seminario internazionale (Roma, 2-4 ottobre 1983), Roma,
Edizioni dell’Ateneo, 1985, pp. 87-109: 98.
78
il loro potere di pre-conoscenza da un patto demoniaco3 alla cui origine era una
curiositas eccessiva che ne rendeva, di per sé, peccaminoso il sapere4.
Ne l’ora che non può ‘l calor diurno
intepidar più ‘l freddo de la luna
vinto da terra, e talor da Saturno
– quando i geomanti lor Maggior Fortuna
veggiono in orïente, innanzi a l’alba,
surger per via che poco le sta bruna –,
mi venne in sogno una femmina balba [...]
(Pg XIX 1-7)
E la forza figurativa del sogno è accentuata anche dal modo anomalo in cui
improvvisamente irrompe nel sogno la creatura oscena della femmina balba: non
“mi parea vedere” come per gli altri due sogni (Pg IX 19 e XXVII 97-98), e che
è anche formula tipica (basta pensare alla canzone Donna pietosa della Vita
Nova5), ma «mi venne in sogno», a indicare una forte differenza di statuto, tanto
della creatura, quanto del sogno. Non l’elaborazione interiore di materiali
psichici, secondo i precetti dell’oneirocritica già aristotelica e poi medioevale6, ma
quasi l’aggressiva irruzione dall’esterno di una realtà autonoma e distinta.
Insomma un vero sogno demoniaco, secondo le diffuse e popolaresche posizioni
di Gregorio Magno7 e Cesario di Heisterbach8, ma anche quelle ben più raffinate
e moderne di Tommaso: una teatralizzazione della tentazione a cui il viaggiatore
è soggetto – almeno come liturgia, come sacra rappresentazione – ancora dopo la
soglia del Purgatorio: «Intrate; ma facciovi accorti / che di fuor torna chi ‘n dietro
si guata», secondo l’ammonimento dell’angelo (Pg IX 131-132).
3
4
5
6
7
8
ISID. orig. 8, 9. Sui geomanti si vedano T. CHARMASSON, Recherche sur une technique
divinatoire: la géomancie dans l’Occident médiéval, Genève, Droz et Paris, Champion, 1980; S.
SKINNER, Terrestrial Astrology: Divination by Geomancy, London, Boston and Henley,
Routledge & Kegan Paul, 1980; V. CAPPOZZO, Libro dei sogni e geomanzia: la loro funzione
letteraria tra Islam, medioevo romanzo e Dante, in «Quaderni di Studi indo/mediterranei», II,
2009, pp. 207-226: 211.
«unde divinatio semper est peccatum» (TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, IIa-IIae, q.
95, a. 1, resp.).
«ed esser mi parea non so in qual loco / e veder donne andar per via disciolte» (vv. 45-46).
Sui sogni in generale si vedano almeno S.F. KRUGER, Il sogno nel Medioevo [1992], Milano,
Vita e Pensiero, 1996, nonché la miscellanea a cura di T. GREGORY, I sogni nel Medioevo cit.
e V. BARTOLI, Il sonno nella medicina medievale, in N. TONELLI (a cura di), I sogni e la scienza
nella letteratura italiana, Atti del Convegno di Siena (16-18 novembre 2006), Pisa, Pacini,
2008, pp. 83-107.
GREGORIO MAGNO, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), a cura di M. SIMONETTI, Milano,
Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori, 2005-06, IV 50, 2, p. 322.
CESARIO DI HEISTERBACH, Dialogus miraculorum, Turnhout, Brepols, 2009, VIII 4, p. 1512.
79
È però proprio alla fine del diciottesimo canto, nella descrizione
dell’assopimento, che si trova, credo, la chiave del sogno:
novo pensiero dentro a me si mise
del qual più altri nacquero e diversi;
e tanto d’uno in altro vaneggiai,
che li occhi per vaghezza ricopersi,
e ‘l pensamento in sogno trasmutai.
(Pg XVIII 141-145)
Il passare di pensiero in pensiero, il vaneggiare fino all’annichilimento nel
sogno, il trascorrere dal pensiero al sogno sono caratterizzati indubbiamente da
un grande realismo psicologico; ma quel “vaneggiare” intorpidito dei pensieri («e
tanto d’uno in altro vaneggiai») assorbe in sé anche il vacuum, il vuoto, proprio
a quella accidia che è punita in quella quarta cornice in cui il sogno si verifica e
che pervade l’intero episodio onirico9. L’accidia non è solo strettamente affine alla
melancolia (il cui segno sul sogno è impresso già dalla menzione di Saturno in
incipit di canto), l’umore che secondo la scienza antica e medioevale più
predisponeva ai sogni, e in particolare agli incubi10; e anzi il sogno della femmina
balba / sirena ha molti tratti tipici dell’incubo come descritto nella medicina
medioevale, con la visione di forme metamorfiche ed eteromorfe11, che – ed è
particolarmente interessante – sono specificate da Giovanni di Salisbury proprio
con la sirena: «ut si forte nec pes nec caput uni reddatur formae, dum taetrum
desinit in piscem mulier formosa superne»12. L’accidia infatti, nella teorizzazione
monastica già di Cassiano, ha tra le sue caratteristiche incostanza e inquietudine
È da ricordare poi che «pensamento» ha il valore negativo di “afflizzione, tristitia cordis”; cfr.
G. FOLENA, Pensamento guittoniano, «Lingua nostra», 16, 1955, pp. 100-104. La tristitia cordis
è proprio uno degli elementi dell’accidia.
10
Già in ARISTOTELE, Dei sogni, 3, 461A, ma così ancora in ALBERTO MAGNO, Somnium et
vigilia, II, i, 3, nonché GUGLIELMO D’ARAGONA (De pronosticatione sompniorum, a cura di
R.A. PACK, in «Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», XLI, 1966, pp. 23793: 269), PASCALIS ROMANUS (in S. COLLIN-ROSET, Le Liber thesauri occulti de Pascalis
Romanus [un traité d’interpretation des songes du XIIe siècle], in «Archives d’histoire doctrinale
et littéraire du Moyen Age», XXXVIII, 1963, pp. 111-198: 144), e nel Trattato dei sogni del
PASSAVANTI (in Lo specchio di vera penitenza, Firenze, Le Monnier, 1863, pp. 325-355: 329).
11
«inruentes in se vel passim vagantes formas a natura, seu magnitudine seu specie discrepantes,
variasque tempestates rerum vel letas vel turbulentas; in quo genere est ephialtes, id est
supersiliens qui lemur vel incubus dicitur» (PASCALE ROMANO, op. cit., pp. 157-158).
Similmente in ALCHERO DI CHIARAVALLE, Liber de spiritu et anima, c. 15, PL XL, 798. Il passo
in realtà proviene da MACROBIO (somn. 1, 3, 7).
12
GIOVANNI DI SALIBURY, Il Policratico, a cura di U. DOTTI, Torino, Aragno, 2011, II 15, 17-20.
9
80
che spingono a cercare nuovi orizzonti: tipico dell’accidia è quel così monastico
“fastidio della cella” che si traduce in insoddisfazione, ma anche nell’instabilità
fisica e nell’incapacità di concentrarsi sui testi, saltando di passo in passo e di
testo in testo, che così puntualmente si riflette nel continuo trapassare dei
pensieri pre-sonno di Dante che chiudeva Pg XVIII13.
L’accidia è dunque legata a una forma di inquieta curiositas, proprio quella
curiositas che è tratto dell’Ulisse menzionato nel sogno dalla femmina balba, una
volta che questa si sarà trasformata in sirena: gli stessi pensieri di Dante, prima
di addormentarsi, erano “diversi”, da intendere etimologicamente, come “fuori
strada, fuori rotta”14. Non solo: Dante e l’Ulisse onirico sono associati
quantomeno da un preciso nesso linguistico; Dante chiude gli occhi «per
vaghezza» (legato a “vagare”), e «vago» – quale che ne sia il significato, e quale
che sia il termine a cui attribuirlo, ma probabilmente da intendersi comunque
come “errabondo” – torna proprio nella dichiarazione di vittoria della sirena su
Ulisse: «Io volsi Ulisse del suo cammin vago / al canto mio» (Pg XIX 22-23)15.
La sirena del sogno fornisce dell’incontro con il navigatore un resoconto
profondamente, e radicalmente, diverso da quello sedimentato nella tradizione
classica e tardoantica, e che pure Dante – anche solo collazionando le numerose
fonti a lui accessibili16 – poteva ben conoscere; più che cercare pezze di appoggio
che giustifichino tale versione alternativa è bene concentrarsi sulla natura stessa
del sogno dantesco. Una serie di elementi “tecnici”, desunti in primo luogo dalla
dottrina sui sogni di Gregorio Magno, ne riconducono infatti la fisionomia
all’inlusio, una forma ibrida di tentazione esterna e pensiero interno (da
riconoscere, come già visto, negli instabili pensieri che chiudono il canto XVIII
segnando lo sprofondare del viator nel sonno).
Primo elemento di contrapposizione tra il sogno e la tradizione sul mito di
Ulisse è che siamo di fronte a un’unica sirena, non le tre canoniche. Questa
significativa riduzione al singolare è funzionale all’identificazione della sirena
CASSIANO, Conlationes X, 13, pp. 306-307 (CSEL XIII, pp. 306-307): «de hac quoque ad
alteram subintrante alia meditatione transfertur, et ita animus semper de psalmo rotatus ad
psalmum, de evangelii textu ad apostoli transiliens lectionem […] instabilis vagusque iactatur
[…] atque ita mens mobilis semper ac vaga in tempore quoque synaxeos velut ebria per diversa
distrahitur».
14
Si pensi ai «diversi salti» di Pd IX 126.
15
Il passo ha prodotto una vasta diversificazione di letture; fatta salva la possibilità di una voluta
ambiguità (che conserverebbe la forma “amorosa” del sogno), è probabilmente utile ricordare
un passo di Ugo di SanVittore in cui vagus è associato al perdersi di Adamo (figura su cui si
tornerà) dopo il suo peccato di curiositas: In Salomonis Ecclesiasten Homiliae XIX (PL 175, c.
167B): «Quid est deambulavit? Huc et illuc quasi errabundus et vagus in directum non
vadens; sed pergens quocunque, hoc est, deambulavit».
16
Un’utile rassegna in G. SASSO, Un sogno di Dante, in «La Cultura», XLV, 2007, 1, pp. 5-47: 8 sgg.
13
81
con l’ipostasi di quella curiositas inquieta che porta a percorrere la strada
sbagliata, a voler conoscere troppo (e quei geomanti indovini che compaiono
all’inizio del sogno sono allora un chiaro segno negativo). Al cuore del sogno,
quando la femmina balba si è già mutata in dolce sirena, e Dante quindi è
sprofondato in una fase onirica più profonda ed è già vittima della forza
suadente del canto della creatura, ritroviamo quel concetto di limite enunciato
da Sordello nella valletta del Purgatorio («sola questa riga / non varcheresti dopo
’l sol partito»): Ulisse, infatti, è per eccellenza colui che ha varcato i limiti, ed è
difficile sottrarsi alla suggestione di far risuonare le parole dell’angelo, una volta
svaniti sogno e tentazione, «Venite; qui si varca» (Pg XIX 43), con il «varco folle»
proprio di Ulisse (Pd XXVII 82-83). Ma lo stesso Dante onirico, proprio nel
suo incontro con la Sirena, si trasforma in un certo senso in un navigante, un
“marinaro in mezzo mar” (v. 20) come Ulisse17, e vale la pena di ricordare che
almeno il manoscritto Holkham Hall riproduce la sirena con la coda di pesce,
quasi a ricreare per suggestione uno scenario marino introdottosi nel sonno.
Il tema del viaggio, peraltro, è strettamente associato anche alle altre due
notti purgatoriali; la prima con il meraviglioso adagio che apre il canto VIII «Era
già l’ora che volge il disio», in cui abbiamo proprio i «navicanti» colti nel
momento della partenza, intrinsecamente associati al «peregrin» (v. 4)
tormentato dalla malinconia della sera. Nella terza notte, invece, l’arrivo
dell’alba – e significativamente l’attenzione si è spostata sull’alba, cristianamente
positiva, e non sul tramonto – è visto proprio in connessione alla gioia suscitata
nei “pellegrini” sulla via del ritorno (XXVII 109-111). È ormai in giudicato che
prima e terza notte siano associate a una partenza e a un ritorno, tanto che già
Benvenuto per il terzo sogno parlava di Dante come di un pellegrino che torna
alla sua patria, cioè il cielo18; e in fondo già in Pg II Virgilio aveva chiarito la
condizione di pellegrini di tutte le anime del secondo regno: «Noi siam peregrin
come voi siete» (v. 63). Non credo che sia un caso allora che lo stadio più
profondo del sogno centrale, in cui Dante è già passato dalla consapevolezza
della bruttezza della donna alla sua malìa, cioè in cui il Dante onirico si sta già
perdendo, si incentri su Ulisse, persosi per mare nella sua figura storica, e fattosi
sviare dalla sirena nella sua dimensione onirica.
Sul rapporto tra Ulisse e il secondo sogno è particolarmente giocato il bel saggio di M.
PICONE, Canto XIX in G. GÜNTERT e M. PICONE (a cura di), Purgatorio. Lectura Dantis
Turicensis, Firenze, Cesati, 2001, pp. 287-306.
18
«Et sic poeta facit comparationem tacite de se ad peregrinum: ipse enim velut peregrinus
revertens in patriam suam, quae coelum est, jam appropinquans illi laete videbat diem fieri,
ut terminaret cito desiderium et gaudium suum» (BENVENUTO, ad locum).
17
82
Ma il tema del viaggio compare, in associazione al secondo sogno, in almeno
altri due momenti, esterni alla dimensione onirica. In primo luogo in Pg XVIII
con la menzione degli esempi di accidia punita: gli ebrei che si rifiutarono di
entrare nella Terra promessa, e i troiani che preferirono fermarsi in Sicilia anziché
proseguire oltre il mare verso la penisola e il destino loro assegnato dagli dei19. In
entrambi i casi l’accidia, dunque, va ben al di là dell’indolenza, dell’indugio, ma è
collegata proprio a un movimento, a una deviazione rispetto al percorso assegnato
dalla volontà superiore, e i due esempi sono proposti a Dante quando già
“sonnolento vana” (v. 87) e dunque – secondo i più comuni principi dell’oneirocritica medioevale20 – sono destinati a sedimentarsi nell’immaginazione del viator
influenzandone la formulazione del sogno.
Il secondo momento è decisamente più criptico, ma forse ancora più
affascinante: il sogno viene ascritto a un momento particolare, quello in cui i
geomanti osservano nel cielo la Maggior Fortuna. Gli studi più specifici
sembrano riconoscere in questa figura una Y: il segno del bivio21. Ora, che
davvero la funzione di questa Maggior Fortuna, di questa Y figurata, sia quella
di introdurre, all’interno del sogno, il tema della scelta di fronte a due diverse
strade è indubbiamente discusso, forse anche discutibile. Soprattutto si è
contestata la sua sovrapposizione con la famosa scelta di Ercole al bivio –
conosciuta da Dante attraverso il De officiis22 – di fronte alle due figure
femminili di Voluptas e Virtus, nelle quali sarebbero riconoscibili rispettivamente la femmina balba e la donna santa e presta intervenuta a salvare il
viator23. In realtà, ha osservato Parenti24, nel passo di Cicerone non sono presenti
«Prima fue / morta la gente a cui il mar s’aperse, / che vedesse Iordan le rede sue. / E quella
che l’affanno non sofferse / fino a la fine col figlio d’Anchise / sé stessa a vita sanza gloria
offerse» (Pg XVIII 133-138).
20
Già in Aristotele il somnium animale era provocato dal riproporsi dei sedimenti dei pensieri
diurni; esemplificativo al riguardo è Tommaso nella Summa Theologiae: «Ea occurrunt
hominis phantasiae in dormiendo circa quae eius cogitatio et affectio fuit immorata in
vigilando» IIa-IIae, q. 95, art. 6). Il secondo sogno, inoltre, è riconosciuto come somnium
animale da P. BOYDE, op. cit., pp. 146 ss.
21
W.B. STANFORD, The “Maggior Fortuna” and the Siren in “Purgatorio” XIX, in D. NOLAN (a
cura di), Dante Commentaries. Eight studies of the Divine Comedy, Dublin, Irish Academy
Press, 1977, pp. 85-91: 86. Che la Maggior Fortuna simboleggi la scelta è condiviso da M.A.
BASILE, op. cit., p. 61.
22
CIC. off. 1, 118. Accenno al bivio, senza Ercole o alcuna forma narrativa, anche in CIC. Tusc.
1, 30, 72.
23
Si tratta di un’idea avanzata in embrione nel Cinquecento da V. CARTARI (Le immagini colle
sposizioni delli dei delli antichi, Venezia, Marcolini, 1556, pp. 337-38) e poi rilanciata con
grande fortuna da E. PANOFSKY, Ercole al bivio [1930], Macerata, Quodlibet, 2010, pp. 216220. Un certo ruolo il mito di Ercole gioca anche in C. HARDIE, Purgatorio XIX. The Dream
19
83
le due figure e si dovrà aspettare il Rinascimento perché iconograficamente i due
concetti astratti, virtù e piacere, assumano sembianza femminile. Può essere
utile però tornare sull’argomento; la Y, il cosiddetto bivium pitagoricum, è infatti
tema ben presente nella cultura medioevale. Valga qui un unico esempio, però
di un qualche rilievo, quello di papa Silvestro II, con tutto il suo fascino e i suoi
fulgori luciferini. Ora stando a Guglielmo di Malmesbury, Gerberto di Aurillac,
il futuro Silvestro II25, fuggì dal convento per scappare in Spagna, terra di
demoni e magia, proprio quando si trovò al suo Pitagoricum bivium, alla Y del
suo destino; e quella fuga in Spagna, secondo la descrizione di Guglielmo, è
motivata proprio da curiositas e accidia, intrinsecamente congiunte26.
La centralità del secondo sogno, con la sua trasformazione del mito di
Ulisse in mito onirico personale, costituisce per certi versi una sorta di myse-enabîme dell’intero viaggio. L’intera esperienza dantesca, nella compresenza di
modelli e generi, proietta anche quello di una visione in sogno: o quanto meno
un lettore medioevale doveva essere indotto a leggere in tal senso, al di là della
loro indubbia polisemia, i riferimenti al sonno che segnano inizio e fine della
Commedia, dal «tant’era pien di sonno» di If I (v. 11) al «perché ’l tempo fugge
che t’assonna» delle parole di Bernardo, tra le ultime parole umane a risuonare
alla memoria del narrans (Pd XXXII 139). Un gioco di rispecchiamenti onirici
ribadito dal fatto che Dante si trova smarrito nella selva avendo perduto la
“diritta via” (If I 3), la strada giusta, che però è anche la strada “destra”, che è
quella della virtù nella Y27, quel bivio pitagorico riconoscibile proprio nel sogno
della femmina balba. E vale la pena di ricordare che i manoscritti di Budapest e
Copenaghen raffigurano Dante, nella miniatura d’apertura a If I, nella posizione
iconograficamente tipica del melanconico, seduto, che si sorregge la testa con la
mano, come nel De officiis viene detto che Ercole si sedette a riflettere davanti
al bivio28. E così – per quanto concerne il rispecchiamento tra sogno e cornice
– è da ribadire che, è stato ricordato da Sasso di recente, il soccorso di Virgilio
of the Siren, in V. VETTORI (a cura di), Letture del “Purgatorio”, Milano, Marzorati, 1965, pp.
217-249: 234 ss.
24
G. PARENTI, Ercole al bivio e il sogno della femmina balba (Purgatorio XIX 1-33) in Operosa
parva per Gianni Antonini. Studi raccolti da Domenico de Robertis e Franco Gavazzeni, Verona,
Vladonega, 1996, pp. 55-66.
25
Su di lui si vedano M. OLDONI, Gerberto e la sua storia, in «Studi medievali», XVIII, 1977,
pp. 1195-1270 e «A fantasia dicitur fantasma» (Gerberto e la sua storia, II), in «Studi
medievali», XXI, 1980, pp. 493-622 e XXIV (1983), pp. 167-245.
26
GUGLIELMO DI MALMESBURY, Gesta Regum Anglorum, a cura di R.A.B. MYNORS, Oxford,
Clarendon, 1998, II 167, 1.
27
Ampia messe di citazioni al riguardo si trova in F. MAZZONI, Saggio di un nuovo commento alla
«Divina Commedia». Inferno – Canti I-III, Firenze, Sansoni, 1967, pp. 35-39.
28
«exisse in solitudinem atque ibi sedentem diu secum multumque dubitasse».
84
nel secondo sogno sembra riattualizzare l’intervento salvifico nella selva,
entrambi innescati da una figura femminile29.
Il tema del limite, del suo superamento, del movimento, però non è
confinato al solo secondo sogno; anche il primo sogno, quello dell’aquila,
naturalmente, inscena un movimento. Indubbiamente è da ribadire che il sogno
visualizza dei condizionamenti esterni, degli stimoli fisici: il trasporto da parte
di Lucia diventa il rapimento e l’ascesa verticale; il caldo del sole già levato,
l’incendio immaginato che brucia aquila e Dante. Insomma, siamo di fronte
all’applicazione di uno dei cardini della teoria aristotelica sul sogno, che vede la
forma più semplice e materiale di sogno (il somnium naturale o corporale)
proprio come una trasposizione di stimoli esterni30. Sarebbe però senz’altro
riduttivo vedere la funzione di questo primo sogno come una sorta di
duplicazione di quanto realmente avvenuto; certo, si può supporre anche, da
parte di Dante, la volontà di delineare un percorso di evoluzione dei sogni, da
uno in cui domina la dimensione sensibile fino al terzo, più intellettuale,
delineando così un perfezionamento delle capacità dell’immaginazione che
preluderebbe alla grande visione paradisiaca. Il sogno dell’aquila mantiene però
una fisionomia autonoma, con un sistema di simboli e elementi da ricondurre
al contesto in cui si svolge, arricchendone l’interpretazione. Imprescindibili in
tal senso sono prima la lettura di Auerbach31 e poi quella di Raimondi32 che
hanno tracciato il solco per chiunque si sia cimentato con il primo sogno; nelle
loro pagine – in estrema sintesi – si riconosce il tema dominante della penitenza,
che induce a considerare il volo come preannuncio dell’ascesa, o, ancor più
specificatamente e sulla base delle occorrenze del verbo “rapire” («ratto», v. 24,
e «rapisse», v. 30), come trasposizione di quel raptus al terzo cielo, concesso un
tempo a Paolo e ora a Dante, nuovo Paolo.
Il sogno dell’aquila non è però forse disgiunto da qualche ambiguità
destinata a sedimentarsi nella coscienza del lettore comune medioevale; questi
aveva infatti nel Libro dei sogni di Daniele33 uno strumento principe per
G. SASSO, op. cit., p. 18.
ARIST. De divinatione per somnum, 1, 463a. Si ricorda che Vincenzo di Beauvais riconduce al
calore esterno il sogno di essere nel fuoco (Speculum naturale, Duaci, Ex officina Typografica
Baltazaris Belleri, 1624 [anast. Graz, Akademische Druck, 1964], XXVI 54, c. 1872E). Sulla
lettura del primo sogno come somnium naturale si veda ad esempio A. MELLONE, Il canto IX
del Purgatorio dantesco, in Miscellanea di Studi Danteschi in memoria di Silvio Pasquazi,
Napoli, Federico & Ardia, 1993, II, pp. 519-531: 520.
31
E. AUERBACH, Passi della “Commedia”dantesca illustrati da testi figurali. Aquila volans ad escam
[1938], in Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 243-247.
32
E. RAIMONDI, Semantica del canto IX del Purgatorio [1968], in Metafora e storia. Studi su
Dante e Petrarca, Torino, Einaudi, 1977, pp. 95-122.
29
30
85
interpretare i sogni, per quanto certo rozzo e rudimentale con la sua meccanica
chiave per cui a immagine sognata corrisponde un significato fisso. Testo rozzo,
sì, ma di enorme fortuna; e basti ricordare, da un lato, che fu volgarizzato
persino in islandese, dall’altro che ebbe il dubbio onore di essere esplicitamente
citato nella condanna parigina del 1277. Ora, in un periglioso ma chiaro latino,
uno dei lemmi di questa chiave dei sogni, recita: “essere rapito da un uccello,
significa danno”34. Certo non si intende che il sogno dell’aquila debba essere
letto con il Libro dei sogni di Daniele alla mano, né che Dante presupponesse ciò
dal suo lettore; però, certo, nell’“immaginario” medioevale il rapimento
senz’altro non aveva un’immagine univocamente positiva. Peraltro con il primo
sogno di Dante siamo di fronte a un archetipo universale: e vale la pena di
ricordare che James Hillman, celebre analista junghiano, in un suo libro sugli
Animali del sogno dedica un intero capitolo proprio a quel diffusissimo
fenomeno, anche in età contemporanea, che è sognare di essere rapiti da
un’aquila, o, sua variante, di trasformarsi in aquila35.
Anche il sogno di Dante può essere leggibile come una metamorfosi, una
metamorfosi fallimentare, in aquila. Né forse è casuale il fatto che, nel XXXI
canto del Purgatorio, durante la confessione del Paradiso terrestre che avviene al
termine di quel percorso ascensionale cominciato proprio con il sogno
dell’aquila e che porta a Beatrice, dominino le metafore ornitologiche:
Non ti dovea gravar le penne in giuso,
ad aspettar più colpo, o pargoletta
o altra novità con sì breve uso.
Novo augelletto due o tre aspetta;
ma dinanzi da li occhi d’i pennuti
rete si spiega indarno o si saetta.
(Pg XXXI 58-63)
Dante, ancora al termine del percorso, è dunque un “pennuto imperfetto”,
che non ha saputo volare. Proprio Hillman riconduce il sogno di essere rapito
da un’aquila, o di trasformarsi in aquila, a difficili fasi di passaggio, di
trasformazione interiore; il primo sogno, dunque, come segno di una
metamorfosi interiore non ancora riuscita, e in fondo tutti e tre i miti che
compaiono prima del sogno, Titone, Progne, Ganimede sono in forme diverse
metamorfosi, “divinizzazioni” imperfette. Il movimento verticale dell’aquila e di
M. SEMERARO, Il «Libro dei sogni di Daniele». Storia di un testo “proibito” nel Medioevo, Roma,
Viella, 2002.
34
«Avem aliquam se rapuisse videre dapnum simg(nificat)».
35
J. HILLMAN, Animali del sogno, Milano, RaffaelloCortina, 1991, pp. 25-27.
33
86
Dante si interrompe nel fuoco, nel rogo; e inevitabilmente il pensiero corre a
due altri miti, due miti di voli terminati nel fuoco, o quantomeno a causa del
caldo, quello di Fetonte e quello di Icaro, citati insieme in occasione del volo su
Gerione36. Entrambi i voli provocati da un eccesso di curiositas, di volontà
illegittima di conoscere troppo. Quella stessa curiositas connessa a Ulisse, e
all’accidia del secondo sogno. E in fondo vale la pena di ricordare che, nel mito
di Alessandro Magno, c’è anche l’episodio di un suo volo verso il cielo sollevato
dai grifoni o, in una versione alternativa, dalle aquile; un episodio che era letto
come segno dell’eccellenza del giovane re, ma, in ambienti religiosi, come segno
di curiositas e superbia37; e tra i molteplici significati che ha l’aquila nella Bibbia
c’è tradizionalmente anche quello della superbia38. Il volo diretto verso la sfera
del fuoco sarebbe quindi una sorta di ascesa anticipata, affrettata, e quindi
erronea, rispetto al lento progresso imposto al viator, destinato in realtà a
riprendere solo dalla porta del Purgatorio. Il volo si interrompe, come a
denunciare proprio l’impossibilità per Dante di fissare gli occhi nel sole, di
addentrarsi in esso, e può essere utile ricordare che nei bestiari è diffuso il
racconto che l’aquila sia solita prendere tra le zampe i suoi nati, sollevarsi verso
il sole, e far ricadere quelli che non sono in grado di sostenerne la luce.
Questo percorso all’insegna della curiositas trova una conferma in una sorta
di sottotraccia che fa riferimento ad Adamo; il primo uomo viene menzionato
già nel primo sogno, allorché Dante fu vinto dal sonno perché «seco avea di quel
d’Adamo» (v. 10). Tale accenno, certamente, rafforza l’idea di un primo sogno
in cui la dimensione corporea e gli stimoli esterni influiscono sull’immaginazione; suggella però anche l’inizio di un percorso che porterà a quel Paradiso
terrestre da cui Adamo fu scacciato, e senz’altro in tale lettura soccorrono le
«Maggior paura non credo che fosse / quando Fetonte abbandonò li freni, / per che ’l ciel,
come pare ancor, si cosse; / né quando Icaro misero le reni / sentì spennar per la scaldata cera,
/ gridando il padre a lui “Mala via tieni!”, / che fu la mia [...]» (If XVII 106-112).
37
C. SETTIS-FRUGONI, Historia Alexandri elevati per griphos ad aerem. Origine, iconografia e
fortuna di un tema, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1973, p. 241.
38
Fondamentale in merito un celebre passo del profeta Abdia, «Si exaltatus fueris ut aquila / et
si inter sidera posueris nidum tuum / inde detraham te dicit Dominus» (Abd 4), strettamente
connesso peraltro a un brano di Isaia dedicato alla caduta di Lucifero, precipitato dopo aver
tentato di salire «super astra»: «quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris /
corruisti in terram qui vulnerabas gentes / qui dicebas in corde tuo / in caelum conscendam
super astra Dei exaltabo solium meum / sedebo in monte testamenti in lateribus aquilonis /
ascendam super altitudinem nubium ero similis Altissimo» (Is 14, 12-14). Sul complesso e
polisemico simbolismo dell’aquila si rimanda all’ottimo M.P. CICCARESE, Il simbolismo
dell’aquila. Bibbia e zoologia nell’esegesi cristiana antica, in «Civiltà classica e cristiana», XIII
(1992), 3, pp. 295-333 e M. SEMOLA, Dante e l’exemplum animale: il caso dell’aquila, in
«L’Alighieri», XXXI (2008), pp. 149-159.
36
87
costanti del pentimento riconosciute da Raimondi nella sua imprescindibile
lettura. Tale traccia sembra riaffiorare al termine del percorso onirico, allorché,
immediatamente dopo il terzo risveglio, Virgilio annuncia: «Quel dolce pome
che per tanti rami / cercando va la cura de’ mortali / oggi porrà in pace le tue
fami» (vv. 115-117). Il ritorno al Paradiso terrestre è indicato proprio con il
ritrovare il «dolce pome», delineando così una chiara antifrasi con Adamo che si
cibò del frutto proibito: ma è anche un frutto che l’umanità da allora cerca «per
tanti rami», con l’implicazione di un’inquietudine, di un’instabilità ulissiaca.
Ora, il primo uomo a dormire fu proprio Adamo, nel Paradiso terrestre: in un
certo senso nel percorso di Dante si svolge quel recupero della piena umanità,
quel ristabilimento della condizione persa da Adamo con la sua superba
curiositas; e difatti nella cultura cristiana la curiosità – con riferimento tanto al
peccato originale quanto alla ribellione di Lucifero – è strettamente associata alla
superbia39, e quest’ultima è indicata come origine di ogni male («initium
peccatis omnis superbia», Eccl. 10, 15).
La rilevanza sommersa della figura di Adamo, peraltro, potrebbe essere
ulteriormente illuminata dal già citato saggio di Gennaro Sasso, il quale ha
proposto di riconoscere nella femmina balba – o quantomeno ne ha colto
l’ombra nella definizione di «antica strega» adoperata da Virgilio nei suoi
confronti (v. 58) – proprio Eva, fonte di tutti i mali40. Ipotesi forse ardita, e che
pure non cessa di affascinare e che, come suggestione, ben si inserisce nel
percorso di Dante come Adamo che deve tornare in quel Paradiso terrestre da
cui fu esiliato. Certo, però, la colpa in cui Eva indusse Adamo fu proprio il
«trapassar del segno» (Pd XXVI 117), un’espressione che ricalca l’obbligo,
enunciato da Sordello, di non “varcare la linea”, così che i primi due sogni
sarebbero in un certo senso l’interiorizzazione di quell’obbligo di mantenersi
entro confini che Adamo non seppe rispettare. La sirena delineata da Cicerone41
– principale fonte dantesca, o quantomeno di estremo fascino proprio perché,
«Bernardus: “Primum vitium est curiositas”, per quod Lucifer cecidit et Adam et hodie multi
corruunt» (BONAVENTURA, Collationes in Hexaëmeron, edidit R.P. FERDINANDUS DELÓRME,
Florentiae, S. Bonaventurae, 1934, v. III, coll. 7, 1, pp. 213-14). Sempre nel Tractatus de
gradibus humilitatis et superbiae citato da Bonaventura, Bernardo aveva indicato proprio nella
curiositas l’innesco della superbia: «Primus itaque superbiae gradus est curiositas» (PL 182,
957B). Cfr. A.E. WINGELL, The Forested Mountaintop in Augustine and Dante, in «Dante
Studies», XCIX, 1981, pp. 9-48: 21-24.
40
G. SASSO, op. cit., p. 22; ma già prima N. YAVNEH, Dante’s “Dolce serena” and the Monstrosity
of the Female Body, in K. JEWELL (edited by), Monsters in the Italian Literary Imagination,
Detroit, Wayne State UP, 2001, pp. 109-36: 111.
41
CIC. fin. 5, 18, 48.
39
88
traducendone alcuni versi, capsula di un Omero altrimenti inaccessibile – è
d’altronde fortemente caratterizzata anche da quella voluttà del conoscere
(«discendi cupiditas» nel passo del De finibus) che trova un eccezionale riscontro
proprio nella figura di Eva, che – sollecitata dal serpente («aperiuntur oculi
vestri et eritis sicut dii scientes bonum et malum», Gn 3, 5) – sospinge Adamo
a un peccato di orgoglio intellettuale. Le due figure, dunque, sono unite dalla
curiositas, forma distorta del sapere, in cui Agostino riconosceva una «experiendi
noscendique libido»42. Una dittologia che innesca il ricordo dell’orazion picciola
di Ulisse, incentrata proprio sull’esortazione a ricercare esperienza e
conoscenza43. Per traslazione, quindi, anche la sirena dantesca di Pg XIX porta
con sé la sua natura di simbolo di una colpevole ricerca di conoscenza eccessiva;
una conoscenza che – proprio perché causata da una particolare forma di libido
– assume forma sensibile femminile, così riproponendo il traviamento eroticofilosofico seguito alla morte di Beatrice, come raccontato nella Vita nova,
allegorizzato nel Convivio, e rivissuto con dolore nel Paradiso terrestre allorché
Beatrice identificherà l’errore giovanile di Dante proprio con la metafora del
canto delle sirene:
Tuttavia, perché mo vergogna porte
del tuo errore, e perché altra volta,
udendo le serene, sie più forte,
pon giù il seme del piangere e ascolta
(Pg XXXI 43-46)
Che i sogni siano densi di metafore e immagini di matrice amorosa,
d’altronde, traspare in molteplici modi; e un ulteriore indizio di ciò è la
corrispondenza strutturale tra il fuoco del primo sogno e il muro di fuoco della
cornice dei lussuriosi. Un fuoco che anticipa di una mera trentina di versi il
sonno della terza notte ma che costituisce anche l’ultima soglia prima
dell’accesso al Paradiso terrestre e dell’incontro con Beatrice. Proprio davanti al
fuoco, nei primi inani tentativi di Virgilio di spingere Dante ad addentrarsi tra
le fiamme, abbiamo però un altro nesso con il sogno dell’aquila; Virgilio infatti
ricorda un altro volo, quello su Gerione, il primo volo della Commedia:
42
43
AVG. Confess. X 35, 55.
If XXVI 116-120: «non vogliate negar l’esperïenza, / di retro al sol, del mondo sanza gente. /
Considerate la vostra semenza / fatti non foste a viver come bruti / ma per seguire virtute e
canoscenza».
89
Ricorditi, ricorditi! E se io
sovresso Gerïon ti guidai salvo,
che farò ora presso più a Dio?
(Pg XXVII 22-24)
Gerione e l’aquila non sono associati solo dalla stessa funzione di veicolo,
dalla descrizione del lento ruotare di entrambi gli animali44, ma anche dalla
duplice menzione dello scorpione, per l’aspetto stesso del mostro infernale45, e
per la costellazione che orna la fronte dell’Aurora nel primo sogno
purgatoriale46. E proprio lo scorpione, di per sé signum diaboli e di disperazione,
era citato da Ovidio come costellazione percorsa da Fetonte nel suo ormai folle
volo47. Proprio questo riferimento a Gerione da parte di Virgilio indica la
conclusione di un volo, di un percorso, o meglio, la necessità, perché ciò
avvenga, di superare un limite, quello del fuoco dell’ultima cornice. Un limite
questa volta da superare realmente, e da superare – vincendo questa volta la
propria paura (che aveva caratterizzato tanto il volo su Gerione quanto il primo
risveglio), l’opposto della superbia – al richiamo del nome di Beatrice (Pg
XXVII 34-42), seguendo la promessa dei suoi occhi, e un canto che proviene
dall’altra parte del fuoco.
Appunto, il canto che proviene di là dal fuoco: «Guidavaci una voce che
cantava / di là» (Pg XXVII 55-56)48. È difficile non contrapporre questa canto a
quello, ritardante, di Casella, e a quello, sviante, della sirena. Ma a chi
appartiene questo canto? Forse all’angelo, ma più forse – proprio per quella
indefinita suggestione – a Matelda. Allora, il sogno di Lia, che coincide
interamente con il suo canto, è anche come l’elaborazione onirica di quel canto
sentito nel fuoco, di quegli occhi promessi. Alcune osservazioni sul contesto in
cui si inscrive l’ultimo sogno fanno, credo, rilevare la fine di un percorso. Non
siamo solo di fronte a una notte che viene descritta in un dispiegarsi che
«in sogno mi parea veder sospesa / un’aguglia nel ciel con penne d’or / con l’ali aperte e a calare
intesa» (Pg IX 19-21) e «Ella sen va notando lenta lenta; / rota e discende, ma non me
n’accorgo / se non che al viso e di sotto mi venta» (If XVII 115-7).
45
«Nel vano tutta sua coda guizzava / torcendo in sù la venenosa coda / ch’a guisa di scorpion
la punta armava» (If XVII 25-7).
46
«di gemme la sua fronte era lucente, / poste in figura di freddo animale / che con la coda
percuote la gente» (Pg IX 4-6).
47
OV. Met. 2, 199: «vulnera curvata minitantem cuspide vidit». Su Fetonte come anti-Dante si
veda K. BROWNLEE, Phaeton’s Fall and Dante’s Ascent, in «Dante Studies», CII, 1984, pp. 135144: 137.
48
«archetipico di tutte le inarcature» lo definisce R. FASANI, Canto XXVII in G. GÜNTERT E M.
PICONE (a cura di), op. cit., pp. 423-33: 426.
44
90
preannuncia gli spazi cosmici paradisiaci (vv. 70-72), ma anche Dante e le sue
guide si avviano al luogo che sarà teatro del sonno per una “dritta via”: «dritta
salia la via per entro ‘l sasso» (v. 64); certo, qui c’è il concetto di ripidezza, ma
sembra troppo marcato il riecheggiamento di quella “diritta via” che era stata
smarrita da Dante nel primo canto, per essere un caso, per non indicare che ci
approssimiamo alla conclusione di un viaggio “terreno” sul percorso giusto.
Non solo: la bellissima doppia similitudine (già segno di innalzamento
dello stile) delle capre e dei pastori che descrive il riposo di Dante e la veglia di
Virgilio e Stazio non dà solo il tono alla prossima comparsa delle figure di Lia e
Rachele (che compaiono in scena nel Genesi proprio in un mondo pastorale).
Quali si stanno ruminando manse
le capre, state rapide e proterve
sovra le cime avante che sian pranse,
tacite a l’ombra, mentre che ’l sol ferve,
guardate dal pastor, che ’n su la verga
poggiato s’è e lor di posa serve;
e quale il mandrïan che fori alberga,
lungo il pecuglio suo queto pernotta,
guardando perché fiera non lo sperga;
tali eravamo tutti e tre allotta,
io come capra, ed ei come pastori,
fasciati quinci e quindi d’alta grotta.
(Pg XXVII 76-87)
Né solo, grazie anche alla suggestione dell’immagine positiva del pastore49,
pone il sogno sotto la protezione divina, ribadita anche dallo schermo delle due
pareti di roccia. Essa delinea anche la conclusione di una parabola intellettuale
con quelle capre (simbolo di contemplatio, ma anche di peccato e curiosità50)
che, dopo essersi disperse per i pascoli, «rapide e proterve», infine si raccolgono;
in un certo senso, le capre, tornate «manse» e «tacite a l’ombra» sono dunque
l’antitesi di Ulisse e della sua curiositas, e sono il segno di chi ha saputo placare
quelle «fami» (v. 117) che lo avevano spinto per il mondo. E lo stesso ruminare
delle capre ha una sua implicazione: il ruminare – che ritorna non a caso negli
ultimi pensieri consci di Dante («sì ruminando e sì mirando in quelle [le stelle]»,
IS 40, 11: «sicut pastor gregem suum pascet / in brachio suo congregabit agnos et in sinu suo
levabit fetas ipse portabit».
50
BERNARDO DI CLAIRVAUX, Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae, 2, 10, 28 (PL 182, c.
957BC).
49
91
v. 91, con splendida paronomasia che produce l’effetto fonosintattico del
ruminìo) – è metafora della meditazione sulle sacre scritture («ruminatio
significat meditationem Scripturarum et sanum intellectum earum»51), della
concentrazione interiore, necessarie al percorso salvifico, in ciò opposte proprio
a quella “vaghezza” e a quell’instabilità della curiosità che caratterizzava la caduta
nel secondo sogno.
51
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 102, a. 6 ad 1. Si veda anche
BONAVENTURA, op. cit., III, coll. 7, 1, p. 218: «Semper ruminanda sunt dulcia Scripturae
eloquia pro habendo sapore vehementi animi applicatione».
92
EMILIO PASQUINI
L’ Inferno dantesco
Molte grazie per l’invito all’amico e collega Giorgio Bárberi Squarotti, cui
mi lega, oltre alla stima reciproca, un’antica e schietta amicizia. E’ quasi un
destino che io mi trovi qui a parlare di Dante, perché nel luglio scorso mi
trovavo a Castelvecchio di Rocca Barbena, non molto distante da Albenga, in
occasione di un cosiddetto “ludoconvegno”: ogni anno, in estate, colleghi
spagnoli e italiani si affrontano e discutono intorno a uno stesso testo di Dante.
Si tratta di un’esperienza molto istruttiva, attivata intorno alle 15 canzoni di
Dante, nell’ordinamento del Boccaccio rispecchiato dall’edizione critica delle
Rime curata magistralmente da Domenico De Robertis. Una alla volta, siamo
così arrivati alla quarta canzone, nella prospettiva del centenario del 2021,
alternando la Spagna con l’Italia: dopo i Pirenei, è dunque toccato alla Liguria,
terra ugualmente ospitale.
Vorrei premettere come i testi di cui ci occupiamo oggi non vadano intesi
in senso statico: sono oggetti di studio in movimento, come emerge bene,
gradualmente, in ogni esperienza scolastica, specie di chi da studente si è poi
trasformato in insegnante. Se io guardo indietro alla strada che ho percorso nella
lettura e conoscenza della Commedia, certi mutamenti appaiono chiari.
Studente al liceo classico “Galvani” di Bologna, avevo per le mani il commento
di Carlo Grabher (il mio professore era un innamorato di Foscolo, cresciuto a
una scuola che risentiva ancora della temperie carducciana): un commento
nutrito di De Sanctis e di umori romantici, con una netta inclinazione per la
drammaticità dell’Inferno. Quando arrivai all’Università, il mio maestro era
Raffaele Spongano, allievo di Attilio Momigliano: il quale non poteva non
proporre il raffinato commento dantesco del maestro, dove si respirava
un’atmosfera di primo Novecento, con una propensione per i toni sfumati del
Purgatorio. Diventato a mia volta professore di liceo, fui indotto ad adottare il
più recente e complesso commento di Natalino Sapegno, capace di far intendere
la potenza creativa e la tensione intellettuale del Paradiso. Non c’è dubbio infatti
che l’Inferno sia stata la cantica prediletta dal Romanticismo, che ben vi si
ritrovava nelle situazioni e nei personaggi; che il Purgatorio sia stato inteso e
gustato prevalentemente in un registro tra pascoliano e crepuscolare; e che
invece il Paradiso sia patrimonio e scoperta del secolo che si è da poco chiuso,
che ha visto gli uomini passeggiare sulla luna.
Mi sono poi ritrovato a commentare Dante nel mio insegnamento
universitario, prima facendo i conti con il commento di Umberto Bosco e
93
Giovanni Reggio, nato di concerto con le sicurezze dell’ Enciclopedia dantesca (a
cui avevo avuto l’onore di collaborare), poi come autore a mia volta, in
collaborazione con Antonio Enzo Quaglio, di un nuovo commento al poema,
edito da Garzanti. Io non so di quale commento voi vi serviate, fra i più recenti:
se di quello di Anna Maria Chiavacci Leonardi o dell’altro (ancora fermo al
Purgatorio) di Giorgio Inglese; o addirittura dell’ultimo nato, tradotto
dall’originale inglese, del dantista statunitense Robert Hollander. Voglio dire,
insomma, che ogni generazione legge Dante in modo diverso; tanto più ciò è
avvenuto nel passaggio da un secolo all’altro, non senza cadute di interesse,
incomprensioni, rifiuti, e poi recuperi. Non è un caso che la fortuna della
Commedia abbia subito eclissi anche non temporanee: fra il Cinque e il
Settecento, grazie soprattutto all’ostracismo di Pietro Bembo, il modello
dantesco si è inabissato come un fiume carsico, riemergendo solo con Vico e con
il Pre-romanticismo. Da allora però il capolavoro dantesco non ha più
abbandonato il proscenio della Weltliteratur, rientrando trionfalmente in ogni
possibile canone: perfino in quello, più di tutti esclusivo, proposto da Harold
Bloom, che infatti lo comprende in una terna indiscutibile, accanto a Omero e
a Shakespeare.
Veniamo ora al nostro Inferno, per non abbandonarlo più, e ai caratteri
distintivi che lo caratterizzano rispetto alle altre cantiche. Ripensando alla
grande linea interpretativa che da Hegel giunge a Foscolo e a De Sanctis, non vi
è dubbio che ciò che ha colpito primariamente i lettori, già in età romantica, è
la grandezza statuaria dei personaggi che vi compaiono, quel loro ergersi su una
sorta di piedistallo proiettato verso l’eternità; insomma, come dirà poi
Auerbach, quel risolversi della “figura” terrena nel “compimento” ultraterreno
che ne estrae, potenziandola, la quintessenza. Il segreto della vita rivelato dalle
voci dei morti nell’oltretomba. Chi vide per primo a fondo nella struttura
drammatica degli episodi e dei personaggi danteschi fu un amico di Manzoni,
Claude Fauriel, nelle sue lezioni parigine raccolte poi nel postumo (1854) Dante
et les origines de la langue et de la littérature italiennes, citato per la prima volta
(che io sappia) nel commento di Attilio Momigliano a Purg. V 135-136. A p.
502 del 1° volume si legge (mia la traduzione letterale):
In tutte le narrazioni di Dante si trova un lato pubblico, notorio, sul quale
egli sorvola, con una sorta di impazienza o di fastidio; ma in tutte
ugualmente sussiste, ovvero egli inventa, un lato misterioso, segreto, grazie al
quale esse appartengono già all’altra vita. E’ di questo secondo lato che egli
si impadronisce per metterlo in risalto. Detto in breve, gli avvenimenti sui
quali egli si sofferma non interessano e non commuovono la sua fantasia se
non nella misura in cui essi decidono la sorte eterna dei personaggi, in altre
parole fanno da tramite fra questo e l’altro mondo.
94
È evidente in vari luoghi del poema, specie nella prima cantica, il
meccanismo per cui il palcoscenico della vita si spalanca sull’oltremondo: spesso
favorito da versi lapidari, di una ambigua e sintetica drammaticità. Così, «quel
giorno più non vi leggemmo avante» (Inf. V 138) segna misteriosamente il
passaggio dalla vita alla morte all’aldilà, dalla sala del castello in cui Paolo e
Francesca, leggendo il romanzo di Lancillotto e Ginevra, scoprirono la passione
che li dominava, alla dannazione nel secondo cerchio dell’Inferno, quando
divennero consapevoli dell’inconsistenza dei miti letterari fra l’«amor che al cor
gentil sempre s’apprende» o l’«amor ch’a nullo amato amar perdona».
Analogamente il verso con cui si suggella il racconto di Ugolino, «Poscia, più
che ’l dolor, poté ’l digiuno» (Inf. XXXIII 75), resta volutamente ambiguo e
carico di sottintesi, fra la confessione di un atroce cannibalismo e la allusione
alla debolezza dell’affamato, più forte del dolore, che in qualche modo lo teneva
in vita. Ugolino rivela dunque al poeta, perché tornando in terra lo riferisca ai
vivi, che conoscono soltanto l’aneddotica della cronaca (cfr. vv. 16-18) come «la
morte sua fu cruda» (v. 20). In altre parole, Dante punta ora sul gesto decisivo
per la sorte eterna di un individuo, ora sul segreto di una fine già compromessa
con il destino del singolo personaggio. Questo aspetto della rappresentazione
dantesca è meglio (o più spesso) visibile nella prima cantica (si pensi a Guido da
Montefeltro o ad Ulisse), ma non latita neppure nella seconda: si pensi ai tre
versi che suggellano ambiguamente il mistero della vita e della morte di Pia de’
Tolomei (Purg. V 134-136).
Venendo alla struttura e all’ordinamento della prima cantica, non vi è
dubbio che si debba parlare per Dante di un Inferno “virgiliano”, per l’aderenza
al modello del VI libro dell’Eneide, almeno fino al canto XVII, con l’apparizione
di Gerione, primo demonio cristiano, incarnazione vivente della frode (non
senza addentellati figurativi nell’arte medievale, specie nei bassorilievi delle
cattedrali), e non semplicemente (come in Virgilio) «forma tricorporis umbrae».
E tuttavia anche nei primi 16 canti numerose appaiono le innovazioni
dantesche, a cominciare dal contrasto fra gli ignavi o pusillanimi del III canto,
non meritevoli di essere ricordati (dunque, non coincidenti con l’anawim
ebraico del Discorso della montagna, da tradurre “conscio dei propri limiti” e non
“povero di spirito”), e i magnanimi del Limbo, che hanno sede in un «nobile
castello», dove Dante colloca i grandi pagani nel solco del concetto di
megalopsykia (sviluppato nell’Etica Nicomachea di Aristotele, giunta a Dante
attraverso il commento di san Tommaso). Ma anche qui entra in gioco quella
sovrana ambiguità del linguaggio dantesco, in quanto il «foco / ch’emisperio di
tenebre vincia» (Inf. IV 68-69) può essere inteso (con vincia = “vinceva”, da
vincere), come la luce della gloria che supera le tenebre infernali, oppure (con
vincia = “circondava”, da vincire) come il buio dell’oltretomba che limita lo
95
splendore della fama; e qui potrebbe entrare in gioco, senza però essere
risolutiva, una pagina del Venerabile Beda, nell’ Historia ecclesiastica gentis
anglorum, con l’opposizione “buio” vs “luce”, legata alla cristianizzazione della
Gran Bretagna nel VI secolo. Se infatti Brunetto Latini viene lodato come il
maestro che insegnava «come l’uom s’etterna» (Inf. XV 85), altri passi nel poema
sottolineano l’illusorietà della fama (ad es., Purg. XI 100 ss.).
In ogni caso, non ci si deve stupire che nel poema siano presenti certe
contraddizioni, a volte – come io credo di aver chiarito fin dal 2001, nel mio
Dante e le figure del vero – dovute ai modi di composizione e diffusione della
Commedia, per canti sparsi o blocchi di canti. Il che impediva all’autore, nel
caso avesse mutato parere, di ritoccare quanto già “pubblicato”. Tale ipotesi
viene luminosamente confermata dalla cosiddette “profezie” dell’esilio (dico
cosiddette, in quanto Dante pone al futuro ciò che è già passato, avendo egli
collocato il viaggio ultraterreno nel 1300, due anni prima dell’esilio); in
particolare dalle profezie di Farinata e di Brunetto che alludono
inequivocabilmente a Beatrice (Inf. X 127-132 e XV 88-90) come al
personaggio che avrebbe procurato la rivelazione definitiva (si sa che, invece,
Beatrice non parlerà mai dell’esilio di Dante e che quel compito verrà affidato,
nel XVII del Paradiso, al trisavolo Cacciaguida). Dunque, una palinodia, fra le
tante che si ritrovano nel poema, specie nella terza cantica rispetto alle
precedenti. Ancor più macroscopico il mutamento di rotta circa il rapporto fra
Papato e Impero, che all’inizio dell’Inferno (II 20-24) viene prospettato in
chiave “guelfa”, col secondo in funzione del primo, luna contro sole; mentre in
seguito, fra il XVI del Purgatorio, la Monarchia e l’intero Paradiso, si svilupperà
una piena adesione alla teoria dei “due soli”, nella loro autonoma dipendenza da
Dio. Va da sé che, in certa misura, almeno nella mia prospettiva, Inferno e
Purgatorio diventano, unitamente alle opere minori, «umbriferi prefazi»
dell’ultima cantica (così in Par. XXX 78): un concetto in qualche modo
complementare alla formula di Gianfranco Contini, quando definiva la
Commedia come una grande palinodia.
Va da sé che in questa sede non posso ripercorrere le tappe dell’introduzione al commento che del poema, in anni ormai lontani (Milano, Garzanti,
1982-86), procurai in felice sinergia con Antonio Enzo Quaglio; al quale rinvio
per i paragrafi descrittivi riguardanti la prima cantica (struttura e ordinamento,
caratteri distintivi, allegorie profezie e digressioni, gli strumenti espressivi,
personaggi ed episodi salienti). Preferisco, in questa sede, soffermarmi sul
rapporto profondo fra due contesti dell’Inferno (un caso, dunque, di intratestualità), in quanto assume un valore generale al tempo stesso in cui permette
di archiviare una lezione che per troppo tempo si è affermata nelle più autorevoli
edizioni della Commedia, inclusa quella di Giorgio Petrocchi.
96
È noto come l’ordinamento morale dell’Inferno, a differenza di quello del
Purgatorio, fondato sui sette peccati mortali, non contempli il peccato di
superbia, anche se al centro della terra sta conficcato il superbo per eccellenza,
Lucifero. Eppure a due personaggi molto diversi Dante attribuisce il connotato
della superbia, un bestemmiatore e un ladro. Al primo, Virgilio si rivolge con
queste parole: «O Capaneo, in ciò che non s’ammorza / la tua superbia, se’ tu
più punito…» (XIV 63-64); del secondo, Vanni Fucci, la voce dell’autore, dopo
l’invettiva contro Pistoia, va descrivendo una superbia ancor più offensiva di
quella chiamata in causa per Capaneo: «Per tutt’i cerchi de lo ‘nferno scuri / non
vidi spirto in Dio così superbo, / non quel che cadde a Tebe giù da’ muri».
Potrebbe lasciare perplessi la designazione di Vanni Fucci, per bocca del
centauro Caco, come «l’acerbo» (XXV 18), ma tutto si chiarisce quando
riprendiamo in mano la domanda iniziale di Dante-personaggio a Virgilio, alla
vista di Capaneo: «chi è quel grande che non par che curi / lo ‘ncendio e giace
dispettoso e torto, / sì che la pioggia non par che ‘l marturi?». Così (con marturi
= “martirizzi”) suona anche l’edizione Petrocchi, la quale pur registra in
apparato, con l’avallo di codici quanto mai autorevoli, la variante maturi.
Quest’ultima non pare dubbio si debba promuovere a testo in quanto
confermata inequivocabilmente dall’acerbo di cui sopra. Si tratta infatti di due
superbi che i supplizi dell’Inferno non riescono ad ammorbidire. Vi ringrazio
per la vostra attenzione.
97
FRANCESCO SPERA
Il Purgatorio
La seconda cantica della Commedia si presenta abbastanza diversa
dall’Inferno e dal Paradiso dal punto di vista della costruzione strutturale del
testo. Le altre due cantiche possiedono una struttura più compatta nella
sequenza delle scene e una maggiore coerenza di toni e stili che si riflette sulle
reazioni del protagonista pellegrino e quindi sul lettore: il comportamento del
protagonista appare dominato dalla visione inquietante dell’orrore del male
nell’abisso infernale (in un alternarsi di note tragiche e grottesche), e invece dalla
visione ammirata del trionfo della beatitudine nei cieli paradisiaci. Nel
Purgatorio siamo invece sulla terra, nell’emisfero meridionale tutto ricoperto di
acqua e quindi disabitato dal genere umano, al cui centro si erge la montagna
altissima lungo le cui balze procedono le anime espianti che, morte in grazia di
Dio, devono però purificarsi prima di ascendere al Paradiso.
Dante segue la dottrina della Chiesa, che si era espressa da non molto
tempo su questa materia, nel concilio di Lione del 1274, individuando nel
Purgatorio un luogo di espiazione temporanea. Dal momento che non esisteva
una lunga e consolidata tradizione su tale dimensione preternaturale, lo scrittore
poteva muoversi con una certa libertà creando uno scenario appropriato per i
suoi fini. Opta quindi per la teoria di un Purgatorio situato in uno spazio
inaccessibile al genere umano, ma sempre sulla terra: l’origine della montagna
risalirebbe alla caduta di Lucifero, condannato per la sua ribellione a Dio con
gli altri angeli ribelli (tutti trasformati in demoni), quando la terra si ritirò per
non avere contatto con il principe del male e i suoi accoliti, formando così
quest’isola che si trova agli antipodi di Gerusalemme, come un enorme cono che
fuoriesce dall’oceano australe.
La montagna è divisa in tre parti: Antipurgatorio, Purgatorio, Eden. Sulla
spiaggia alla base della montagna sostano le anime che si sono pentite soltanto
alla fine della loro vita e vi rimangono in attesa secondo vari periodi, prima di
poter iniziare l’ascesa (si incontrano qui diversi tipi di personaggi: i pigri, gli
scomunicati, i morti di morte violenta, i principi negligenti). Il Purgatorio vero
e proprio è costituito da sette cornici: sono le sette balze che salgono in cerchio
su per la montagna, ognuna delle quali è dedicata a un peccato: prima il più
grave, la superbia, e poi l’invidia, l’ira, l’accidia, l’avarizia con il suo contrario,
cioè la prodigalità, infine la gola e la lussuria. Tutte le anime passano da una
cornice all’altra, trattenendosi il tempo necessario previsto dal giudizio divino,
che corrisponde alla maggiore o minore intensità di ogni tendenza peccaminosa
99
dimostrata nella vita terrena. Infine gli ultimi canti, tra i più importanti
dell’intero poema, descrivono l’ingresso e il percorso nel Paradiso terrestre, dove
Dante incontra Beatrice, che prima lo rimprovera per i suoi errori imponendogli
un totale esame di coscienza e un pentimento assoluto, e poi lo coinvolge in una
complessa cerimonia di investitura per la missione che dovrà compiere una volta
tornato sulla terra.
Ricordate sinteticamente le tre sezioni, bisogna aggiungere che, mentre
nella prima la pena consiste nell’attesa che le anime devono patire prima di
poter accedere alla purificazione, nella seconda le pene sono effettivamente
dolorose, pene corporali subite dalle anime da cornice a cornice; nella terza
invece siamo in un universo completamente differente, in cui si susseguono
articolate liturgie sacre che accompagnano le anime all’ascesa in Paradiso (e
anche lo stile cambia sensibilmente, avvicinandosi a quello più alto e talora
oscuro della terza cantica). Insomma la cantica è davvero intermedia tra Inferno
e Paradiso, presentando ancora aspetti, come quello della punizione, che erano
peculiari dell’Inferno, ma con la sostanziale differenza che qui le pene sono
temporanee perché le anime sono salve e non dannate, mentre tutti gli elementi
religiosi, le rappresentazioni rituali, dalle preghiere al canto corale, dalle
processioni alle profezie, fanno presagire il Paradiso.
Basta rileggere le prime terzine del canto I per comprendere le nuove
caratteristiche che l’autore vuole porre subito in evidenza per il Purgatorio:
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.
Ma qui la morta poesì resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono;
e qui Calïopè alquanto surga
seguitando il mio canto con quel suono
di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono.
Dolce color d’orïental zaffiro,
che s’accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro,
a li occhi miei ricominciò diletto,
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta
che m’avea contristati li occhi e ’l petto (Pg I 1-18).
100
Si noti come l’inizio con la canonica proposizione dell’argomento, grazie
alla metafora prolungata del viaggio marino, chiarisca in termini netti la
differenza radicale tra il male tanto crudele perché irreversibile dell’abisso
infernale, lasciato definitivamente alle spalle, e la positività del secondo regno,
dove si svolge un’espiazione destinata a consentire l’approdo celeste. La ripresa
del lessico del viaggio si lega alla necessità per l’autore di restare in primo piano
come protagonista, cosicché usa proprio la prima persona per sottolineare che
canterà (tipica formula dell’epica) appunto il Purgatorio (richiamato con
un’ampia e precisa perifrasi).
Di conseguenza nell’invocazione l’autore vuole rimarcare la differenza
anche del tipo di stile che vorrà adottare: non più la poesia tragica e grottesca
consona ai personaggi dannati alla morte eterna dell’Inferno, ma una poesia più
elevata, con il significativo rinvio alle Muse e in particolare a Calliope, musa
proprio dell’epica. L’emistichio “poiché vostro sono” è sicuramente
un’affermazione sicura e decisa, che ribadisce all’inizio della cantica la volontà
di confermare la propria convinta vocazione poetica. Del resto già all’inizio
dell’Inferno Dante era stato guidato da Virgilio nel Limbo, dove aveva
incontrato Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, insomma i più celebri poeti
dell’antichità, ed aveva parlato di sé come “sesto tra cotanto senno” (If IV 102.
Questa alta consapevolezza del proprio ruolo di poeta va di pari passo con la
puntualizzazione degli obiettivi cui mira anche la poesia del Purgatorio: una
poesia forte, severa, combattiva, come segnala il riferimento mitologico alle
Piche. Tra tutti i miti collegati alle Muse Dante sceglie un episodio con esito
crudele, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi: le figlie del re della Tessaglia,
Pierio, avevano osato sfidare nel canto le Muse, ma Calliope prima le sconfisse
e poi le trasformò in gazze. Il senso della citazione si inquadra nell’esigenza di
offrire una poesia che possa variare nello stile (per il principio stabilito della
retorica che a ogni contenuto si addice un certo stile), ma si presenti sempre
come eccellente, in grado di superare la difficile sfida di rappresentare l’aldilà
anche in questa dimensione così nuova, così multiforme, come quella del
Purgatorio.
La sorpresa per il lettore che arriva dall’Inferno si presenta subito alla quarta
terzina, con il verso “Dolce color d’orïental zaffiro”, che è il primo paesaggio
terrestre che appare nel poema. Non si tratta di una similitudine, ma proprio del
paesaggio naturale che si mostra agli occhi del personaggio Dante in tutta la sua
bellezza, la bellezza del creato cantata nei salmi. Siamo infatti sulla spiaggia di
un’isola irraggiungibile per gli uomini perché si trova nell’emisfero meridionale,
ma pur sempre sulla terra. La prospettiva non è la stessa di chi è abituato a vivere
nell’emisfero settentrionale, ma i numerosi paesaggi ripresi nei giorni di
permanenza nel secondo regno si richiamano evidentemente all’esperienza
101
comune del lettore, cosicché la materia della cantica rimane sì sempre
straordinaria perché racconta le vicende delle anime dopo la morte, ma appare
più vicina a una verosimiglianza terrena. Non a caso, mentre in Inferno e
Paradiso vige soltanto la dimensione dell’eternità, nel Purgatorio esiste il tempo,
appunto con il trascorrere delle ore e dei giorni. Questa scelta ha una
comprensibile motivazione logica perché le anime devono espiare per un certo
periodo, rimanendo a patire nelle varie cornici secondo durate diverse, con la
conseguenza che pure il periodo complessivo risulta alla fine diverso per
ciascuna di loro. Ma l’adozione di ritmi temporali analoghi a quelli terrestri
permette soprattutto allo scrittore di aggiungere ulteriori tasselli alla
rappresentazione della totalità dell’esistenza. Tanto per fare un esempio
rilevante: l’arrestarsi del viaggio di notte consente il racconto di tre sogni del
protagonista, che trasmettono significati profondi legati all’andamento del
viaggio ultraterreno. È nota per altro l’importanza della dimensione onirica
nella cultura medievale. L’autore del poema può quindi utilizzare questa
diversità del Purgatorio non solo per porre in scena un fenomeno dell’esperienza
comune di ogni uomo come sono il sonno e il sogno, ma anche caricarli di
ulteriori sensi che arricchiscono l’allegoria dell’opera.
Con il Purgatorio si rimane in un ambito preternaturale (nell’Epistola di
dedica del Paradiso a Cangrande, l’autore parla di un contenuto admirabilis, cioè
eccezionale, straordinario), ma indubbiamente il lettore troverà più elementi in
cui riconoscersi, elementi presenti nel suo mondo quotidiano che a poco a poco
l’autore inserisce nel prosieguo del testo, tanta da farlo apparire come quello più
“realistico” della Commedia (se è possibile usare questo aggettivo per un poema
del primo Trecento ambientato nell’aldilà, e senza quindi nessuna confusione
con il realismo ottocentesco). Il non raro ricorso a dettagli realistici nella
rappresentazione di scene e personaggi, nelle descrizioni, come si è già citato, di
paesaggi praticamente terrestri, di corpi e visi in cui sono riproposte le normali
sembianze umane (non martoriati quindi dalle pene infernali e neppure
praticamente invisibili come le anime beate del Paradiso), di quadretti a più
personaggi, talora movimentati e di fattura quasi teatrale, contraddistingue
fortemente questa cantica dalle altre due e la riporta in un’atmosfera più umana.
Per questo il poeta non adotta il tragico e il grottesco e neppure il sublime delle
altre due cantiche, ma propende per un stile patetico, nel senso di uno stile più
contenuto, che non mira a effetti emotivi troppo spinti, né verso il basso
disumano dell’Inferno né verso l’alto celestiale del Paradiso. Naturalmente non
mancano fin dall’inizio presenze incisivamente stranianti, come il Catone del
canto I, il celebre personaggio romano, repubblicano e morto per di più suicida,
scelto addirittura come guardiano dell’intero secondo regno. E in tutta la
cantica, come nelle altre due, svolge un funzione fondamentale il simbolismo,
102
che diventa infine dominante nei canti dell’Eden.
Occorre aggiungere che, oltre alla drammatizzazione individuale, con le
storie dei singoli personaggi che scaturiscono dai vari incontri e dialoghi, nel
Purgatorio si afferma anche una rilevante dimensione corale, con le anime che si
muovono, pregano e cantano spesso insieme, come in cerimonie liturgiche. A
segnare la differenza con l’individualismo sfrenato dell’Inferno, dove ogni anima
resta sola e si contrappone alle altre (tranne rare eccezioni), nel secondo regno
trionfa la solidarietà, la compassione nel senso vero del termine, come sentita
partecipazione ai dolori comuni (da qui la necessità appunto di uno stile
prevalentemente patetico). Le anime sono descritte in gruppo fin dall’inizio,
come gente “pudica in faccia e ne l’andare onesta” (Pg III 87), che si esprimono
e si muovono con parole misurate, con modi gentili. Già da questi primi canti
si può rilevare la ricca fenomenologia dei volti e dei gesti dei personaggi, come
testimonia il celebre inizio dell’episodio di Manfredi: “biondo era e bello e di
gentile aspetto” (ivi 106).
I dialoghi dei personaggi nell’Antipurgatorio si presentano parecchio
diversi da quelli infernali. Sono sì basati in partenza su informazioni con
domande e risposte, ma poi si risolvono in colloqui costruttivi, non in scontri e
dispute come spesso quelli infernali. Le anime dialogano alla pari con il
pellegrino umano perché c’è un’oggettiva analogia di posizione tra loro e il
protagonista: mentre nel primo regno Dante era superiore alle anime dannate e
nel terzo sarà inferiore alle anime beate, qui si verifica un parallelismo tra il
percorso di espiazione delle anime e il percorso di liberazione spirituale del
protagonista. Negli incontri le anime provano emozioni, dalla tristezza a una
gioia tutta umana, tanto che si può parlare di un vero e proprio repertorio di
emozioni (e quindi di notazioni psicologiche). Si veda l’incontro col musico
Casella del canto II, dove per la prima volta un personaggio della Commedia,
sorride: “Di maraviglia, credo, mi dipinsi;/ per che l’ombra sorrise e si ritrasse”
(Pg II 82-83). Il sorriso si ripete nella descrizione di Manfredi: “Poi sorridendo
disse: “ Io son Manfredi” (Pg III 112); diventa “riso” del protagonista stesso alle
parole ironiche del pigro conterraneo Belacqua: “Li atti suoi pigri e le corte
parole / mosser le labbra mie un poco a riso” (Pg IV 121-122). E si ritrova anche
sulle labbra di Virgilio quando, durante uno dei tanti riti nell’ascesa della
montagna sacra, vede Dante toccarsi la fronte per sincerarsi, al momento del
passaggio alla seconda cornice, dell’eliminazione del primo dei sette P che gli
aveva inciso l’angelo portiere come segno dei peccati da cui purificarsi: “A che
guardando, il mio duca sorrise” (Pg XII 136).
Anche quando si cambia atmosfera e si snodano racconti più drammatici,
come quelli di Manfredi e poi quelli dei tre morti di morte violenta del canto V,
si può cogliere un tono dolente ma rassegnato, e non astioso come in casi
103
analoghi dell’Inferno. Le anime narrano gli esiti drammatici della loro vita anche
con dettagli realistici, come nel racconto di Iacopo del Cassero: “Corsi al palude,
e le cannucce e ‘l braco / m’impigliar sì ch’i’ caddi; e lì vid’io / de le mie vene
farsi in terrra laco” (Pg V 82-84). Le loro espressioni sono essenziali, anzi talvolta
possono apparire persino troppo laconiche, come nel caso di Pia de Tolomei:
“Siena mi fé, disfecemi Maremma:/ salsi colui che ‘nnanelata pria/ disposando
m’avea con la sua gemma” (Pg V 134-136). Si confronti il pudore di queste
allusioni racchiuse in una sola terzina con i due ampi discorsi di Francesca da
Rimini, così risentiti e reticenti, segnati da tentativi di depistaggi e travisamenti.
Si pensi ancora alla cortesia che contrassegna gli incontri con Sordello nel canto
VI (cui fa da contrappunto l’invettiva sulla situazione politica dell’Italia) e con
il giudice Nino nel canto VIII.
Anche nei canti a tematica politica, prevalenti nell’Antipurgatorio, l’analisi
si dipana con toni più pacati, la tecnica della rappresentazione non prevede
punte troppo acuminate: non solo mancano scontri fra le anime, impossibili tra
coloro che si sono salvati (mentre tra le anime dannate finivano spesso con
insulti e maledizioni), ma l’andamento è più discorsivo e narrativo.
Naturalmente non manca la tipica tendenza dantesca alla valutazione molto
severa delle vicende politiche, come testimonia appunto l’invettiva che è
espressione diretta dell’autore, non senza qualche espressione forte: “Ahi serva
Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di
provincie, ma bordello!” (Pg VI 76-78). E si ricordi che, anche quando il
discorso è prevalentemente positivo, ogni tanto si affaccia lo stesso qualche
giudizio tagliente, come emerge nella rassegna dei principi nella valletta che
occupa tutta la parte finale del canto VII.
La costruzione letteraria si complica nella seconda sezione della cantica, dal
canto X al XXVII, dove sono raffigurate le sette cornici in cui avviene l’espiazione
delle anime. Essendo il numero delle cornici inferiore al numero dei gironi
infernali, la rappresentazione si fa più articolata, a grandi arcate di più canti, con
più personaggi, più dialoghi, più digressioni dottrinali. Si aggiunge la novità degli
esempi positivi e negativi per ciascuna cornice: ogni peccato capitale viene
illustrato con episodi negativi, ma anche con il suo contrario, cioè con episodi
positivi della virtù corrispondente. La prima cornice dei superbi inizia proprio
con la rassegna degli esempi di umiltà, cioè della virtù opposta alla superbia; nella
seconda degli invidiosi appaiono subito esempi di carità, cioè della virtù opposta
all’invidia. Questa struttura si ripete per ogni cornice dilatando gli spazi e
determinando una multiforme successione di scene. Ne risulta una costruzione
più narrativa, dove il perenne contrasto tra male e bene si arricchisce di molteplici
variazioni, tra rievocazioni del passato, visto che gli esempi vengono estrapolati
dal repertorio biblico e classico, e continui riferimenti al presente.
104
Colpisce infatti constatare come la seconda cantica sia di gran lunga la più
ricca di personaggi storici vissuti ai tempi di Dante. La scelta s’imponeva già
nell’Antipurgatorio, dove le anime devono attendere prima di cominciare
l’ascesa e l’espiazione: è chiaro che non si può pensare logicamente ad attese
troppo lunghe. Ma anche nelle varie cornici il pellegrino Dante incontra meno
personaggi rispetto all’Inferno e soprattutto quasi tutti morti da non molto, dal
momento che anche qui non si possono ipotizzare percorsi di espiazioni dalla
durata interminabile. Quelli vissuti più indietro nel tempo sono molto rari: Ugo
Capeto (decimo secolo) e Stazio, l’unico personaggio romano espiante di questa
cantica (insieme al guardiano Catone), entrambi presenti nella cornice degli
avari e prodighi. Quindi nessun personaggio mitologico o letterario, che invece
sono presenti nell’Inferno, e neppure personaggi lontani nel tempo, come sarà
invece possibile nel Paradiso, dove si incontreranno di nuovo personaggi antichi
come quelli biblici (a cominciare da Adamo), pochissimi personaggio latini e
soprattutto molti santi dei primi secoli in poi (a cominciare da Pietro).
Proprio questa caratteristica peculiare di personaggi più vicini a Dante nel
tempo determina le due tematiche maggiormente ricorrenti nella seconda
cantica: quella politica e quella culturale. Nella persistente ricerca di
rappresentare l’enciclopedia del suo tempo l’autore qui può includere una fitta
sequenza di personaggi che, raccontando come sempre la loro vicenda
personale, aggiungono altre tessere al variegato mosaico della scena politica degli
ultimi decenni. Tra Antipurgatorio e prime cornici si sussegue una galleria di
personaggi ragguardevoli ed esemplari: il già citato Manfredi, i due morti di
morte violenta Iacopo del Cassero e Buonconte da Montefeltro. Poi la tematica
politica si concentra prima nei tre canti fondamentali di Sordello e dopo nei due
canti degli invidiosi, raggiungendo l’apice nell’originalissimo intervento di
Guido del Duca che passa in rassegna con straordinarie metafore animalesche la
corruzione degli abitanti della valle dell’Arno (il discorso allude agli abitanti del
Casentino, di Arezzo, di Firenze e di Pisa):
Tra brutti porci, più degni di galle
che d’altro cibo fatto in uman uso,
dirizza prima il suo povero calle.
Botoli trova poi, venendo giuso,
ringhiosi più che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa torce il muso.
Vassi caggendo; e quant’ ella più ’ngrossa,
tanto più trova di can farsi lupi
la maladetta e sventurata fossa.
Discesa poi per più pelaghi cupi,
trova le volpi sì piene di froda,
che non temono ingegno che le occùpi (Pg XIV 43-54).
105
A riequilibrare il cupo pessimismo di queste parti del canto l’autore
inserisce il filone culturale che da tutti i critici è considerato come fondamentale
in questa cantica. Si tratta di un crescendo di interventi grazie all’incontro di
vari personaggi: già il musico Casella nel canto II, poi Oderisi nel canto XI dei
superbi. Ma la riflessione sul valore e i compiti della poesia trova ampio spazio
nei canti del poeta latino Stazio (XXI-XXII), che con geniale invenzione vien
fatto diventare cristiano da Dante: l’antico scrittore della Tebaide (altro grande
modello per Dante, dopo l’Eneide) nei suoi commossi discorsi rievocativi
celebra la forza ideale e persuasiva della poesia di Virgilio, che prima lo indirizzò
verso il bene e poi lo indusse a fargli abbracciare addirittura la vera fede cristiana
(secondo un’interpretazione allegorica travisata della quarta egloga, molto in
auge nella cultura medievale). Si deve dunque sottintendere che l’operazione
letteraria ideata e realizzata da Dante con il poema sacro della Commedia ha lo
stesso altissimo scopo: costringere il lettore a una rigenerazione totale secondo
verità e giustizia.
Per questo nei canti successivi entrano in scena importanti personaggi
quasi contemporanei, esponenti della cultura poetica, come Forese Donati e
Bonagiunta da Lucca nei canti dei golosi (XXIII-XXIV) e Guido Guinizzelli e
Arnaut Daniel nel canto dei lussuriosi (XXVI). Si può così ricostruire il
quadro della poesia moderna in volgare, rimarcare i suoi aspetti
plurilinguistici visto che Arnaut vien fatto parlare – grandissima invenzione
dantesca – nella sua lingua provenzale. Soprattutto si può fare un bilancio
della più innovativa scuola del tempo, il “dolce stil novo” (Pg XXIV 57), che
lo stesso Dante aveva praticato, ma che ormai vedeva come insufficiente
rispetto al poema “al quale ha posto mano e cielo e terra”, come si dice
all’inizio del canto XXV del Paradiso. L’amore cantato dai poeti stilnovisti è
troppo inferiore rispetto al vero Amore in cui crede ora l’autore della
Commedia: nel canto XVIII tocca Virgilio esporre la dottrina del rapporto tra
Amore e libero arbitrio, tra le prime inclinazioni individuali e il compito della
ragione che può e deve scegliere tra amori buoni e cattivi. In queste terzine,
dove si attinge uno dei punti supremi della poesia filosofica del poema sacro,
Virgilio fa esplicito riferimento a Beatrice, che interverrà ulteriormente sulla
questione. Dante sa che potrà finalmente incontrare Beatrice, ma non la
Beatrice del prosimetro giovanile della Vita nuova, muto personaggio
angelicato secondo la concezione dello Stilnovo, ma la nuova Beatrice allegoria
della scienza divina della teologia. In effetti nel canto XXVII Virgilio sprona
Dante a superare il muro di fuoco che lo separa dall’entrata nell’Eden e quindi
da Beatrice, salutandolo per l’ultima volta e sancendo solennemente la fine
positiva del suo percorso di liberazione dal male dell’Inferno e di espiazione
attraverso le sette cornici della montagna sacra.
106
Nel nuovo spazio, “la divina foresta spessa e viva” (Pg XXVIII 2) del
Paradiso terrestre si assiste a un cambiamento radicale. Intanto si ritorna in una
dimensione al di fuori dello spazio e del tempo, in uno scenario da idillio
preternaturale, dove si aggira una donna bella e misteriosa, Matelda, di cui però
sapremo il nome soltanto all’ultimo canto: “una donna soletta che si gia / e
cantando e scegliendo fior da fiore / ond’ era pinta tutta la sua via” (Pg XXVIII
40-42). Insomma non si dipana più un racconto drammatizzato come nelle due
sezioni precedenti, ma prevale la descrizione e quindi prende sopravvento
soprattutto l’allegoria in un crescendo di figure e quadri ricchi e allusivi: così il
canto XXIX s’impernia sulla sfilata di una lunga processione mistica, nel canto
XXXII si succedono scene e immagini di ispirazione apocalittica che rimandano
ai mali della Chiesa secondo figurazioni ispirate proprio all’Apocalisse, l’ultimo
libro della Bibbia, molto ripreso in questi canti finali del Purgatorio.
In questa allegorica trama universale che rimanda alla secolare storia del
genere umano, da quella ebraica a quella cristiana, s’inserisce anche la vicenda
individuale del protagonista giunto alla tappa cruciale del suo viaggio, che
prevede ora l’ascesa ai cieli del Paradiso nella terza cantica grazie alla nuova guida
Beatrice. Che si tratti di un momento di estrema tensione per l’autore e il
pellegrino emerge con evidenza dalla terzine che raccontano l’avvicinarsi della
donna:
così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,
sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.
E lo spirito mio, che già cotanto
tempo era stato ch’a la sua presenza
non era di stupor, tremando, affranto,
sanza de li occhi aver più conoscenza,
per occulta virtù che da lei mosse,
d’antico amor sentì la gran potenza (Pg XXX 28-39).
Colpisce da un lato la calcolata configurazione di un quadro iconografico
tipico da glorificazione di un santo, con accompagnamento di angeli e fiori e
con un gioco di colori scopertamente simbolico, dall’altro l’emergere con tanta
veemenza del dato emotivo del protagonista, che, pur non vedendo il viso in
quanto coperto da un velo, sente immediatamente l’epifania della donna della
sua vita e riprova dentro di sé gli effetti straordinari che gli aveva procurato
l’amore durante la sua giovinezza, come ricorda così efficacemente l’ultimo
107
verso. Anche in un momento così solenne, tanto al di fuori della sfera terrena,
l’umanità del protagonista risorge e riafferma la sua forza incoercibile, in una
perfetta fusione di individuale e universale, di umano e preternaturale.
Ma inizialmente il tanto atteso incontro con Beatrice si scopre invece meno
felice del previsto, dal momento che la donna, in quanto allegoria della teologia,
rimprovera severamente il protagonista lanciandogli una serie di accuse. Si tratta
di affrontare una particolare liturgia della confessione e purificazione: prima il
penitente ammette le proprie colpe passate, mostra un’autentica contrizione, e
poi viene sottoposto agli ultimi riti di purificazione con l’immersione nei due
fiumi sacri del Letè e dell’Eunoè per rigenerarsi alla fine “puro e disposto a salire
a le stelle”, come recita il significativo verso conclusivo della cantica (Pg XXXIII
145). Solo così Dante, nel corso di questa lunga e arcana iniziazione rituale, può
ascoltare le grandi profezie che riguardano lui stesso e il mondo dei viventi tra
cui tornerà, e soprattutto può ricevere la suprema investitura da parte di Beatrice
che lo rassicura sulla sua salvezza futura e insieme gli affida la missione di narrare
il suo viaggio in un’opera di altissimo valore che sappia efficacemente educare
alla verità e alla giustizia: “Tu nota; e sì come da me son porte,/ così queste
parole segna a’ vivi” (Pg XXXIII 52-53). Si ricordi infatti che la Commedia è
stata scritta per un fine morale pratico, per essere utile ai “viventes”, come è
detto esplicitamente nell’Epistola a Cangrande. Non è soltanto la testimonianza
autobiografica di un itinerario di salvezza individuale, poiché la prospettiva è
sempre doppia allargandosi dal singolo all’universale, mirando a portare un
contributo concreto alle drammatiche vicissitudini dell’essere umano e del
mondo nella terribile lotta del bene contro il male.
A questo fine risponde anche e soprattutto il Purgatorio, cantica intermedia,
con la maggior parte dei canti (quelli delle prime due sezioni) ambientati in una
dimensione insieme terrena e preternaturale, e quindi con strette interferenze tra
la vita vissuta nel presente e il mondo ultraterreno: un intreccio di quadri più
terreni, arricchiti quindi da notazioni realistiche, e quadri più preternaturali,
con uno stile che tende progressivamente ad elevarsi fino al sublime della terza
sezione, quella dell’Eden. L’autore era ben conscio che, soltanto includendo nel
suo poema totale una molteplice e armoniosa aggregazione di umanità e aldilà,
poteva realizzare la sua missione di giovare a tutti gli uomini: proclamare ad alta
voce con assoluta coerenza le ragioni della verità e della giustizia sulla terra e
additare così a tutti gli uomini il percorso di salvezza spirituale e celeste.
Soltanto dopo la ricca varietà del Purgatorio si poteva approdare alla scrittura più
complessa, teologica e sapienziale, del Paradiso.
108
Nota bibliografica
Si ricordi il capitolo Il trionfo poetico: la Divina Commedia, che chiude il libro di
JACQUES LE GOFF, La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1982. Tra le letture
trasversali dedicate alla seconda cantica si segnalano: FRANCO FIDO, Dall’Antipurgatorio
al Paradiso Terrestre: il tempo ritrovato di Dante, in « Letture classensi» 1989, 18, pp. 6578; CLAUDIO VARESE, Parola e immagine figurativa nei canti del Paradiso terrestre, in «La
Rassegna della Letteratura italiana» 94, 8, 1990, pp. 30-42; LUIGI BLASUCCI, Tempo e
penitenza nel “Purgatorio”, in «Soglie», 2000, 2, pp. 33-46; ANDREA BATTISTINI, La
“speranza de l’altezza”. La retorica patetica in “Purgatorio” XII, in «L’Alighieri», 2003, 21,
pp. 95-108; SANDRA CARAPEZZA, Le anime in attesa dell’ascesa: persistenze terrene e legge
divina, in La divina foresta. Studi danteschi, a cura di FRANCESCO SPERA, Napoli,
D’Auria, 2006, pp. 141-199; CLAUDIA CREVENNA, Retorica e teologia negli “exempla” del
“Purgatorio”, ivi, pp. 201-284; DANTE DELLA TERZA, Il “Purgatorio” dantesco come
complessa e autonoma avventura dell’anima, in «Dante. Rivista internazionale di studi su
Dante Alighieri», 2007, pp. 11-24; GUGLIELMO BARUCCI, «Simile a quel che talvolta si
sogna». I sogni del Purgatorio dantesco, Firenze, Le Lettere, 2012.
109
NICOLÒ MINEO
La Commedia: Paradiso
1 - Mi è avvenuto più volte di affrontare il tema dell’attualità di Dante e in
rapporto a questo di dover porre il problema del rapporto presente-passato. La
Divina Commedia è l’opera di lingua italiana più conosciuta al mondo e non è
seconda su questo terreno a nessun’altra di qualsiasi tradizione letteraria.
Recentemente intellettuali italiani di grande fama, appositamente interpellati,
hanno giudicato il poema l’opera più rappresentativa del millennio da poco
trascorso. Eppure non si può cancellare dal nostro ricordo l’antica domanda di
Marx. Perché le grandi opere del passato ci parlano ancora? Come è possibile che
abbiano ancora qualcosa da dirci? Il che si traduce nella domanda ricorrente
soprattutto in ambito scolastico: Dante è ancora attuale? Il rischio è che il problema venga banalizzato e che nelle risposte l’antico messaggio venga appiattito
acriticamente sul presente. Per la comprensione dell’evento artistico, come
dell’evento culturale, come di qualsiasi tipo di evento, le posizioni di più sicuro
prestigio dell’epoca moderna – e non solo – si fondano su un’istanza di dialogo
tra presente e passato. Le risposte di Dante, nella diversità e nella somiglianza,
possono illuminarci sulle urgenze del nostro tempo. Le analogie e le differenze
ci insegnano a riconoscerci anche nel nostro presente, a riscoprire l’uomo, le sue
cadute e la sua dignità. Che vuol dire riproporre la cultura problematica contro
l’appiattimento e l’omologazione di una società che non vuol guardarsi a fondo.
È necessario però definire i termini del dialogo, definirne le condizioni e il
profilo epistemologico. E le realtà a confronto debbono essere individuate nella
loro specificità e determinazione, sì che dal dialogo risulti rafforzato l’autonomo
significato. Invece assai spesso l’esito finale è la produzione di rappresentazioni
sfocate in un quadro di genericità e di generalizzazioni. E ciò perché le domande
sono poste in una condizione di difficoltà di fondo, di sostanziale spaesamento.
Sono domande non ammissibili o proposte in modo non corretto e
inappropriato. Il dialogo è produttivo di verità se avviene tra sistemi mentali e
orientamenti mentali affini per motivazioni e principi. Solo se mossi da una
tensione verso l’ordine e l’armonia, dalla cultura del rispetto di noi stessi e
dell’umanità e, in assoluto, del vivente, possiamo appropriarci della suprema
elevazione del poeta cristiano come se dicesse di tutti noi, del bisogno (il «disio»
e il «velle») di tutti noi.
È di grandissimo interesse che nei versi iniziali del XXV canto – si noti: del
canto centrale del gruppo di canti XXI-XXIX – Dante autore dia un’indicazione
sul tempo di composizione del poema, e non della sola terza cantica: un tempo
111
relativo, non assoluto, il tempo che l’ha «fatto per molti anni macro» (vv. 1-3).
Dunque la rivelazione della visione non è avvenuta subito dopo. Si coglie in ciò
una rispondenza, non sovrapponibile però, con la lettera 2 Cor., 12, 1-4, in cui
Paolo afferma di rivelare dopo quattordici anni la sua esperienza visionaria. Per
umiltà questo, per la difficoltà del dar forma di scrittura, si può ritenere, il
poeta. Come ho affermato altrove, e qui ridico di passata, è a partire da questa
dichiarazione che va ripensata la storia della composizione del poema e va
riproposta l’interpretazione stessa del suo significato poetico nell’interagire dei
tempi: della visione, della scrittura immaginaria, della scrittura effettiva.
2 - Per una descrizione della terza cantica del poema dantesco, composta
quasi sicuramente tra 1316 e 1321, è bene procedere per due direttrici:
l’evidenziazione degli aspetti di fondo e delle costanti e la rappresentazione del
suo svolgimento narrativo.
3 - Lo spazio materiale del Paradiso è la realtà astrale, i cieli corporei,
rappresentati secondo il sistema aristotelico-tolemaico. Al centro di questo
universo è la terra. Al di là esiste il mondo assolutamente spirituale, metafisico,
il non-spazio, quello che culmina in Dio: l’Empireo.
Luce, sempre di inimmaginabile intensità, e suoni, di insostenibile potenza,
ne sono la forma sensibile. L’organizzazione della materia e la rappresentazione
costituiscono una perfetta fusione di spiritualità mistico-religiosa, razionalità,
geometrismo.
Il più autentico protagonista è Dio, nel cui nome la cantica ha inizio e fine.
È evocato sia nella sua essenza trinitaria sia nelle persone. Se ne evidenziano con
insistenza il suo potere nel determinare la realtà e gli eventi e l’imperscrutabilità
delle sue decisioni. È stabilmente pensato ed evocato nel rapporto divino-umano.
Carattere precipuo della rappresentazione dantesca del mondo di là, anche di
quello celeste, è la costante presenza del mondo umano, imposta dalla convinzione che la realtà dell’uomo nel mondo sia determinante di quella nell’al di là.
Figura di decisiva presenza, alla conclusione dell’esperienza visionaria del
poeta, è quella di Maria. E generalmente si può dire che il poema sia variamente
percorso dal tema mariano.
Presenza via via più ricca di significato nel loro ruolo di mediazione tra Dio
e l’uomo è quella degli angeli, anche in dipendenza dalla loro funzione di
governo dei cieli. Di ognuno di questi poi – come leggiamo nel Convivio (II, 1314) – si può fissare una particolare rispondenza con una delle scienze del sapere
umano. E insieme di ognuno, secondo la sua natura, una rispondenza con gli
esseri umani che determina nel carattere e nel comportamento.
112
A Maria si lega strettamente la presenza di san Bernardo, che appare nel
XXXI canto, sostituendo Beatrice in funzione di guida. Guida di Dante sino
all’Empireo è appunto Beatrice, subentrata in questa funzione a Virgilio già nel
Paradiso terrestre. Beatrice, che qui rappresenta la sapienza divina.
Figura principale della vicenda rappresentata è Dante personaggio.
Nell’ascesa verso Dio percorre tutti i gradi della visione mistica sino al
rapimento estatico e alla finale contemplazione di Dio come potenza creatrice,
come forma trinitaria, come coincidenza di due nature nella persona del figlio.
È decisamente segnata l’analogia con l’esperienza visionaria di Paolo, il raptus,
che succede all’esperienza dell’oltretomba terreno, analoga a quella di Enea.
Sperimenta le varie forme del ricevimento della grazia e del lumen gloriae.
L’esame cui è sottoposto nel cielo delle stelle fisse sulla sua conoscenza e sul suo
possesso delle virtù teologali si conclude con una ennesima investitura profetica.
A lui competerà rinforzare negli uomini la speranza.
Dante incontra i beati nei singoli cieli, secondo la corrispondenza di essenza
spirituale e di grado di beatitudine. Le anime tutte hanno il loro luogo eterno
nell’Empireo, ma durante l’ascesa gli si presentano scendendo nei cieli corporei
per dare evidenza alla loro realtà. La diversa intensità di beatitudine non implica
inappagamento e desiderio, perché la beatitudine consiste nella piena adesione
alla volontà di Dio. Si presentano anime di ogni tempo della storia, da Adamo
agli apostoli, ai grandi teologi, come Tommaso e Bonaventura, ai contemporanei, come Piccarda e Carlo Martello. Rimangono fuori campo, perché non
appaiono nei cieli ma sono presenti in ampie rappresentazioni biografiche,
figure come San Domenico e San Francesco. Grande rilievo ha l’incontro con
l’avo Cacciaguida, che illumina il discendente sul passato e presente di Firenze
e sul suo destino in terra.
Negli incontri non è insistito il ricordo della condizione che caratterizzò
l’esistenza terrena delle anime. Centrale è invece sempre la considerazione
dell’attualità storica del mondo. Momento costante e cruciale è la condanna
della superbia e dell’avidità e l’accusa di traviamento contro pontefici e prelati.
Il Paradiso, scriveva De Sanctis, «è la più spirituale manifestazione di Dio;
e perciò di tutte le forme non rimane altro che luce, di tutti gli affetti non altro
che amore, di tutti i sentimenti non altro che beatitudine, di tutti gli atti non
altro che contemplazione. Amore, beatitudine, contemplazione prendono anche
forma di luce [...]». I risultati del lavoro svolto dalla critica della terza cantica
negli ultimi decenni si possono sintetizzare nell’aver riconosciuto nella sua
materia e struttura, così come è definita dal De Sanctis (e diversamente da quelle
che erano le sue conclusioni generali), non solo una autentica realizzazione
poetica, ma anzi la più alta forma di poesia della Commedia. Il motivo
113
luministico nel Paradiso non è un ripiego che permetta a Dante di sfuggire
all’aporia della irrappresentabilità dell’ineffabile. La luce è una realtà fisica e
metafisica e proviene da Dio e ne è manifestazione; con le sue varie gradazioni
di intensità e colore, con i lampeggiamenti e le eclissi, con la rarefazione e
spiritualità della sua essenza è il segno dell’ineffabile e dell’assoluto.
Certamente il mondo del Paradiso è il più uniforme delle tre cantiche e i
suoi personaggi non hanno differenze marcate. La minor varietà però si traduce
in intensità e approfondimento e in maggior complessità e dei temi trattati e
della condizione d’esistenza rappresentata. È pur vero che nel Paradiso
drammaticità e vita artistica hanno, più che gli uomini, le idee e le dottrine, per
il carattere di perentoria assolutezza che esse assumono e quindi di radicale
contrasto con tutto quel che, negandole, è errore e male. Meglio ancora, i
personaggi hanno una loro vita artistica in quanto portatori ed esponenti di idee
e dottrine. Ché quel che si può dire di tutta la Commedia, è proprio e precipuo
della terza cantica: esplicitamente ed implicitamente, dottrina, teologia,
ideologia, mistica, il sapere in una parola, sono la sostanza della concezione
dantesca del Paradiso e ne costituiscono il contenuto. Un sapere, che è,
oggettivamente, manifestazione di Dio e, soggettivamente, conoscenza di Dio.
All’intensificarsi progressivo della luce rispondono l’intensificarsi e l’approfondirsi della comprensione intellettuale e dell’intuizione mistica e l’arricchirsi ed articolarsi della condizione interiore del contemplante. La commozione della conquista conoscitiva e della partecipazione caritativa, tendendosi
verso il suo culmine, è funzione di sempre più alti oggetti, sicché contemplante
e contemplato escono progressivamente dall’ordine della legge naturale e si
immergono nel trascendente. L’oggettivo e il soggettivo si fondono in una
rappresentazione, che è unitario epos di Dio e della sua azione provvidenziale.
Alla condizione del contenuto, tra naturale e sovrannaturale, tra razionale e
sovrarazionale, tra intellettualismo e misticismo, risponde un linguaggio, che
alla chiarezza scientifica della definizione scolastica unisce la più sfumata e
suggestiva capacità denotativa e connotativa, che alla plasticità scultorea
dell’Inferno, alla figuratività pittorica del Purgatorio, sostituisce, in maniera
sempre più accentuata dai primi agli ultimi canti, una musicalità che suggerisce
più di quanto non raffiguri, ma senza distruggere l’immagine, anzi conferendole
rara pregnanza. È un linguaggio però che non esclude concrete e realistiche
rappresentazioni ed immagini, accolte anzi frequentemente a sottolineare il
contrasto tra ideale etico-religioso e deviazione mondana.
4 - CANTI I-II - La proposizione del tema nel primo canto annuncia il
motivo fondamentale della cantica («la gloria di colui che tutto move», I, 1) e
l’essenza mistica dell’ultima esperienza oltremondana di Dante («[…] vidi cose
114
che ridire / né sa né può chi di là su discende », I, 5-6). L’invocazione chiede
l’ispirazione divina per il poeta e dichiara, simbolicamente e allusivamente, la
sacralità della poesia del Paradiso. Si esprime, col più solenne dei linguaggi,
l’umile esaltazione del poeta, che riflette amorosamente sulla propria materia e
sente la suprema difficoltà di quest’«ultimo lavoro».
L’ascesa verso l’empireo, segnata da una situazione astronomica
simbolizzante le virtù, la perfezione, la passione, inizia in piena luce meridiana,
che è indice del fulgore massimo della divina grazia. Il pellegrino è colpito da
nuove mirabili sensazioni: una grande luce e un suono armonioso. È l’armonia
delle sfere e il bagliore della luce divina. Anche dentro di sé sperimenta una
nuova condizione, il «trasumanare»: «[...] tal dentro mi fei / qual si fé Glauco
nel gustar de l’erba, / che ’1 fé consorto in mar de li altri dei» (I, 67-9). Il
paragone fondativo con l’esperienza di un personaggio del mito pagano vuol
dimostrare l’universalità dell’aspirazione umana alla trascendenza. Ascende
fissando lo sguardo in Beatrice e non lo impedisce la corporeità, poiché,
perfettamente puro, il suo essere, obbedendo alla legge dell’amore, segue ormai
l’istinto naturale che lo muove verso Dio. Il moto ascensionale li porta nel
primo cielo, dentro la materia della luna, che è materia diafana e plasmabile:
«Parev’a me che nube ne coprisse/ lucida, spessa, solida e pulita, / quasi
adamante che lo sol ferisse. / Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette,
com’acqua recepe / raggio di luce permanendo unita» (II, 31-6).
Così ha vero e proprio inizio in Dante (dopo la preparazione nel paradiso
terrestre) la seconda fase del processo mistico-ascetico del cristiano. Nell’ascesa
verso l’empireo la sua esperienza è di ordine fondamentalmente conoscitivo.
Egli vive una travolgente ed esaltante alternativa di contemplazione ora di
Beatrice ora dei nuovi oggetti, di interiore modificazione e di stupore, di teso
ardore di conoscenza. L’esperienza centrale è la sovrumanizzazione.
L’immersione nel mondo del miracolo e della grazia dà al suo intelletto e alla sua
ricettività in genere come uno spazio nuovo e senza limiti e crea in lui la
condizione dell’esaltazione interiore, unita però all’umile coscienza della
gratuità dell’esperienza. A questi moti dell’anima si unisce, mediata da Beatrice,
la tensione verso l’alto. I momenti dell’ascesa, fisica ed intellettuale, sono
scanditi da parole, atti, espressioni di lei, per lo più dall’illuminarsi e risplendere
sempre più intensi ed ineffabili del suo volto. Beatrice è tutta nel suo slancio
ascensionale e nella sua amoroso-materna e ammaestrante funzione di
mediatrice di verità. Il suo magistero è animato dalla gioia del contemplare le
opere di Dio e dall’amorosa esaltazione di comunicare a Dante la verità, nel che
si realizza sublimata la funzione santificante che già assolse in terra. Ora lo
avverte esplicitamente dell’avvenuta ascesa («“Drizza la mente in Dio grata” mi
disse, / “che n’ha congiunti con la prima stella”», II, 29-30).
115
Il momento dell’ammaestramento-apprendimento si inserisce con naturale
necessità nella struttura dell’azione, ne è anzi il coronamento, il luogo di
massima tensione dell’intento rappresentativo. In esso si invera la sostanza
autentica della terza cantica, che è rappresentazione dell’atto contemplativo. Si
inverano anche i personaggi, la cui realtà ormai consiste di amore che vuol
conoscere e di amore che vuol elevare alla partecipazione della verità.
Beatrice illumina la mente di Dante, palesandogli il meraviglioso ordine
dell’universo (in cui «sono accline / tutte nature, per diverse sorti, / più al
principio loro e men vicine; / onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar
de l’essere, e ciascuna / con istinto a lei dato che la porti», I, 109-14) e la natura
spirituale della luce («Per la natura lieta onde deriva, / la virtù mista per lo corpo
luce / come letizia per pupilla viva», II, 142-4). Ma, nel loro ultimo significato,
i suoi insegnamenti, in cui spesso il ragionamento si esprime con immagini di
cosmico respiro, costituiscono una grandiosa lezione sulla più vera legge
dell’universo. Questa, quanto alla forma, non è fondata su rapporti quantitativi
e su determinismi della materia, ma ha cause, finalità e dinamica di natura
metafisica e di ordine puramente qualitativo; quanto alla sostanza, è il fondamento e l’essenza della metafisica e della teologia del cristianesimo (ancor prima
che si facesse aristotelico), poiché stabilisce un rapporto necessario tra materia e
forma, azione e creatore, in ultima analisi, tra umano e divino. Nell’ordine
finalizzante del creato, nell’azione delle intelligenze angeliche e degli astri sul
mondo inferiore, è rappresentato il duplice moto (feudalmente piramidale) del
cosmo cristiano, dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso, un moto che ha
inizio e la sua possibilità nell’alto, nella onnipotente volontà, che vuole
assimilare a sé le creature, pur nell’autonomia di essenza e di scelta di queste.
La vicenda individuale di Dante si inserisce nella vicenda cosmica come
parte di essa: il finito si fonde con l’infinito e il contingente con l’eterno. Un
siffatto contenuto è vissuto nella sua ineffabile sostanza di miracolo e la
rappresentazione tende verso un culmine di esaltata e rapita solennità, ma anche
e assieme verso una intensificazione di movimento in cui sembra tradursi un
interno moltiplicarsi di vita.
CANTI III-IX - Motivo dominante dell’ascesa del pellegrino è il progressivo
sublimarsi delle sue capacità, sensoriali ed intellettive, di apprendimento degli
oggetti che gli si offrono via via alla visione e alla riflessione. È una gaudiosa
lotta contro l’insufficienza e il limite umani, che deve vincere per adeguarsi alla
sublimità del mondo in cui è accolto. Quegli stessi oggetti che, dapprima,
trionfano sulle sue forze inadeguate sono cause e gradini dell’ascendere, dopo
che egli ha appreso a conoscerli. Beatrice con un atto o con un gesto sancisce la
fine di un momento e l’inizio di un altro momento dell’ascesa («poi si rivolse
116
tutta disiante / a quella parte ove ’1 mondo è più vivo», V, 86-7) oppure
semplicemente diviene più bella («Io non m’accorsi del salire in ella; / ma
d’esservi entro mi fe’ assai fede / la donna mia ch’i’ vidi far più bella», VIII, 135). Beatrice appunto, per quel che simbolizza e incarna, è condizione perché la
visione divenga apprendimento e possa ulteriormente volgersi verso oggetti
sempre più alti e misteriosi. Dante lungo i tre cieli inferiori muove i primi passi
nella via che porta alla conoscenza di Dio ed il suo stato d’animo, come il suo
comportamento, è di estasiata dolcezza per quanto vede ed apprende e di
insaziata e incontenibile brama di moltiplicare visione ed apprendimento. Il
conoscere è a questo punto un potenziamento di vita, quasi un bisogno fisico di
dilatare la propria sostanza vitale sino a farla coincidere con l’assoluto. È una
condizione che egli stesso riassume e teorizza: «“O amanza del primo amante, o
diva”, / diss’io appresso, “il cui parlar m’inonda / e scalda sì, che più e più
m’avviva, / [...] / Io veggio ben che già mai non si sazia / nostro intelletto, se ’1
ver non lo illustra / di fuor dal qual nessun vero si spazia. / Posasi in esso, come
fera in lustra, / tosto che giunto l’ha; e giugner puollo: / se non, ciascun disio
sarebbe frustra. / Nasce per quello, a guisa di rampollo, / a piè del vero il dubbio;
ed è natura / ch’al sommo pinge noi di collo in collo”» (IV, 118-20, 124-32).
Per questo Beatrice e le anime sentono come alto esercizio di carità l’appagare questa sete. Le anime si fanno incontro a Dante, nei vari cieli, muovendo
dall’empireo, riconfermando visibilmente (si direbbe) sul modello di Beatrice, la
dinamica di descensio del divino verso l’umano, della grazia verso la creatura. Il
loro rapporto con lui è analogo a quello di Beatrice, improntato com’è ad ardore
di carità e ispirato da una volontà di mediazione. Questo accresce la loro letizia,
manifestandosi come intensificazione della luce che le fascia. Il mondo di cui
Dante è ora partecipe infatti è un mondo di luce. Questa (come sappiamo già)
è il segno visibile della presenza trinitaria di Dio nel creato, della partecipazione
del divino da parte delle creature e proviene in esse dalla letizia dell’intendere e
dell’amare. Nel cielo della Luna la luminosità delle anime ancora non è più che
diafano candore, nel cielo di Mercurio l’«ombra» è ancora visibile e la nasconde
solo l’accensione della carità, nel cielo di Venere lo splendore nasconde del tutto
le anime ma ha solo l’intensità di una «favilla». Esse gli appaiono improvvisamente, come nel cielo della Luna, oppure gli si appressano con un
movimento ora relativamente lento, come in Mercurio, ora velocissimo, come
in Venere. Le caratterizza l’assenza di un ordine di disposizione, nel che si
simbolizza la loro relativa imperfezione o, meglio, l’incompletezza della loro
terrena adesione alla legge del cristianesimo. Sui primi tre cieli appunto, come
dice un’anima, «l’ombra s’appunta / che ’l vostro mondo face» (IX, 118-9) e in
essi appaiono le anime dei «seculares» (secondo la distinzione bernardiana), di
quelli cioè che mancarono di fortezza (cielo della Luna) o aspirarono ad «onore
117
e fama» mondani (cielo di Mercurio) o si abbandonarono ad amori carnali
prima di volgere rettamente la loro naturale disposizione (cielo di Venere).
L’apparizione nei vari cieli, oltre che dal rapporto derivante dal tipo di influsso
astrale sulla natura psichica dell’anima, è determinata dall’ulteriore possibilità di
caratterizzazione psicologica data dall’analogia tra cieli e scienze (da Dante,
come si è detto, proposta nel Convivio). La mutevolezza delle anime del primo
cielo è ben paragonabile alla «gramatica», che varia col variare della lingua; il
desiderio di gloria terrena di quelle del secondo è comparabile alla dialettica, che
è disciplina fondata non su certezze ma su probabilità; l’ardore di quelle di
Venere si assimila alla «rettorica», che è la più dolce ed allettatrice delle scienze.
La condizione dei beati (di tutti i beati) è quella manifestata a Dante nel cielo
della Luna dalla prima anima di paradiso con cui egli parla, Piccarda, e consiste
nel far propria con gioia la volontà dì Dio e quindi nel volere solo quello che
Dio vuole: «[...] ’n la sua volontade è nostra pace» (IV, 85). Le anime dei primi
tre cieli, in particolare, sono caratterizzate da un grado di beatitudine
oggettivamente minore rispetto alle altre anime, ma che tuttavia pienamente le
appaga.
Dante è preparato a fissare la loro luce dalla vista di Beatrice, divina
sapienza, che lo tempra ai nuovi fulgori (ulteriore sua azione mediatrice). Ella,
dal momento dell’ascesa al primo cielo, aggiunge al sorriso l’ardore: «sorridendo,
ardea ne li occhi santi» (III, 24); dopo il primo dialogo, di lui con anime beate,
già raggia in modo insostenibile: «[...] quella folgorò nel mio sguardo / si che da
prima il viso non sofferse» (III, 128-9); dopo un’ulteriore sua richiesta di spiegazioni, lo costringe a una condizione di smarrimento psichico: «Beatrice mi
guardò con li occhi pieni / di faville d’amor cosi divini, / che, vinta, mia virtùte
diè le reni, / e quasi mi perdei con li occhi chini» (IV, 139-42). Da ogni smarrimento egli esce rinvigorito, esaltato, trasumanato. Con nuova limpidezza di
immagini e rappresentazioni, in queste vicende Dante autore ha tradotto
momenti tipici delle esperienze apocalittiche: i lampeggiamenti degli enti e delle
realtà oltremondani e le estasi o le mistiche morti dei soggetti dell’esperienza.
Ha immesso però nella misterica sacralità di queste situazioni la concretezza di
un rapporto caritativo che continua e sublima la situazione, già stilnovistica, di
divina mediazione e di amore adorante. Nel trasmutarsi di Beatrice si esprime
l’essenza del personaggio, che, per la sua funzione di mediazione è, al tempo
stesso, distaccato e partecipe, lontano e vicino, teso verso un mondo che
trascende i rapporti umani e che, pure, li accoglie sublimandoli.
Il clima degli incontri con le anime di paradiso di norma non è intimo e
personale, come avveniva nel purgatorio. Ormai l’interesse per gli aspetti
particolari e individuali delle vicende biografiche, per il loro carico di pena o di
ansia o di tensione, è quasi del tutto superato. L’esperienza terrena ed umana è
118
ricordata solo per quel che essa è valsa sul piano religioso, in rapporto a Dio. Le
anime hanno bevuto le acque del Lete e guardano al mondo con interiore
lontananza. Né invitano Dante alla confessione, poiché sanno in Dio la sua
verità, gli chiedono solo di esprimere i suoi desideri: «[..] se disii / di noi
chiarirti, a tuo piacer ti sazia» (V, 119-20); «[...] tutti sem presti / al tuo piacer,
perché di noi ti gioi» (VIII, 32-3). Nel cielo di Mercurio è accolto con un chiuso
accenno alla sua funzione profetica, che porterà a un maggior amore per il buon
operare politico e civile: «Ecco chi crescerà li nostri amori» (V, 105). Nei beati
tuttavia il distacco dal mondo non è oblio o ignoranza o disinteresse, anzi il
mondo è visto sempre come il luogo del merito o del demerito, quindi come
luogo decisivo del destino dell’uomo. Al contatto con un vivente, e proprio per
la parte che questi dovrà avere nel mondo, l’interesse viene sollecitato e si
manifesta come giudizio, riprovazione o esortazione. Questi però discendono da
una visione che intende il particolare nel generale, la contingenza nell’eterno, e
da ciò trae l’illuminato distacco e la lungimirante comprensione.
Il mondo che i beati dei cieli inferiori giudicano è quello della vita politica
e civile, su cui deve vigilare il potere temporale. L’incompiutezza della loro
perfezione terrena si riflette, ma non come peso negativo, bensì come tipo di
interessi e come timbro della personalità, nel contenuto e nel tono dei discorsi.
Se Piccarda fa appena cenno di certi uomini, Giustiniano tiene la più lunga
orazione di tutta la Commedia per dire della sanità e provvidenzialità
dell’Impero e della dissennata malizia di chi lo combatte o se ne fa bandiera di
interessi particolari. Nelle parole di Carlo Martello, di Cunizza, di Folchetto
(canti VIII-IX) si apprende del malgoverno del regno di Napoli, della bestialità
dilagante nella Marca Trevigiana, dell’avidità ovunque imperante. Folchetto
però denuncia anche la responsabilità di papi e cardinali e conclude il suo dire
(e quello delle anime di questi cieli) con l’annuncio di un prossimo intervento
divino nel mondo, punitore e correttore. Il discorso sulla Chiesa sarà
ampiamente sviluppato poi, nei cieli più alti. Gli argomenti trattati sono in
armonia con le caratteristiche delle gerarchie angeliche che governano i singoli
cieli. Gli Angeli, che proteggono i singoli uomini, governano il cielo della Luna,
in cui si parla del destino, della volontà e della salvezza di singole persone. Gli
Arcangeli, che sono incaricati di grandi compiti in terra, governano il cielo di
Mercurio, in cui si parla dell’Impero e dell’incarnazione. I Principati, che
dominano sulle potenze terrene, governano il cielo di Venere, in cui si parla di
governi, di organizzazione dello Stato, di prossimi rinnovamenti nel campo
politico-religioso.
Questi discorsi sono preceduti o seguiti da altri discorsi, di impianto decisamente teorico e scolastico, di Beatrice o delle stesse anime, che servono a pro-
119
spettare al pellegrino contemplante le ragioni e le condizioni di fondo
dell’umano operare. Le lezioni di Piccarda sulla condizione beata (canto III), di
Beatrice sulla volontà umana, sulla natura del voto (canti IV e V) e sulla
necessità della passione di Cristo (canto VII), quella di Carlo Martello sulle
differenti attitudini di ogni uomo (canto VIII) tendono, in fondo, a dichiarare
un unico tema, quello del rapporto tra libertà-volontà dell’uomo e Dio e le sue
cause seconde, un tema aperto già nel I canto da Beatrice. In questo rapporto è
contenuto tutto il senso della storia dell’uomo e il senso del suo essere. Emerge
come verità ultima che il più santo uso della volontà-libertà da parte dell’uomo
è paradossalmente la rinuncia ad esse. La rinuncia instaura la condizione
paradisiaca, di cui è prefigurazione l’ordinato vivere civile, che si realizza
obbedendo alle disposizioni indirettamente infuse da Dio in ogni individuo.
Invece l’uso terreno e mondano di esse è all’origine del male e poté esser risanato
solo dalla passione del figlio di Dio. Punto fondamentale è la spiegazione della
natura del peccato e della necessità storica e metafisica della passione di Cristo
per il riscatto dell’uomo (VII, 25-120). È ancora il grande tema, posto nei primi
due canti in termini generalissimi, del senso e della forma del rapporto tra
creatura e creatore, che è rapporto tendente all’unione. L’unione appunto, e
questo è l’insegnamento implicito del VII canto, è suggellata dall’incarnazione
di Cristo, che realizza fisicamente e storicamente l’ordine metafisico. Un ordine
che è eccelsamente manifestato dalla natura dell’uomo, che, creato direttamente
da Dio, non è destinato ad estinzione («E quinci puoi argomentare ancora /
vostra resurrezion [...]», VII, 145-6). Entro lo sfondo funzionale costituito dalla
illuminazione su queste verità basilari si intendono in ogni implicazione i
discorsi sui comportamenti degli uomini particolari e storici, che non solo
presuppongono ed amplificano il «sapere», ma sono essi stessi sapere in quanto
sono per essa e nascono in essa.
Se per un momento l’idea del male ha turbato i beati, il loro presente di
beatitudine li riaccoglie tosto e in esso si immergono, riguadagnando la loro
incommensurabile distanza. Il turbamento rimane nel vivente, ma anch’egli può
guardare in alto e può godere, nel volto di Beatrice e negli spettacoli del cielo,
del suo trasumanare. La situazione è simbolizzata dalla conclusione
dell’incontro con Carlo Martello: «E già la vita di quel lume santo / rivolta s’era
al Sol che la riempie / come quel ben ch’a ogne cosa è tanto. / Ahi anime
ingannate e fatture empie, / che da sì fatto ben torcete i cuori, / drizzando in
vanità le vostre tempie! / Ed ecco un altro di quelli splendori / ver’ me si fece
[…] » (IX, 7-14).
I personaggi vivono dell’animazione loro conferita dalla coscienza del contrasto tra l’ordine, la giustizia, la verità, di cui essi godono, e il disordine, l’ingiustizia, l’errore dominanti nel mondo. Nell’animo del pellegrino questo si
120
traduce in una vicenda di gioia rapita e di rammarico, di adesione esaltante e di
progressivo distacco dal mondo. I personaggi, in cui la coscienza del contrasto
si esprime con maggior profondità e sensibilità e con i quali si crea un clima di
incontro più intimo e più ricco di risonanze, sono quelli di Piccarda e di Carlo
Martello, che Dante conobbe in vita. Forse la maggior terrestrità dei beati di
questi cieli ha determinato le scelte del poeta ed ha guidato la sua comprensione
dei personaggi. L’una e l’altro sono momentaneamente avvolti da un velo di
malinconia per il bene che non poterono operare in terra. In Piccarda si coglie
un moto di delusione unite a cristiana e femminile pietà per quanti operano il
male nel mondo. La vocazione d’adolescente a «fuggire» dal mondo per la pace
rassicurante del chiostro, alla rinuncia di sé per amor dello «sposo» divino, fu
frustrata proprio dalla empietà del mondo; ma ora trova esaltante compenso
nell’abbandono beato nel porto della divina volontà, nell’abbraccio di un
mondo di carità che non subisce mutamento. Nella memoria della terra da parte
del principe angioino non è un senso di ambizione insoddisfatta che si palesi
quanto una pena, che nasce da regale amore per i sudditi privati dal destino (la
«Fortuna» cristiana) di un buon principe. L’amore, nella sua sublimazione
politico-religiosa fa sì che, sia pur dalla distanza paradisiaca, egli partecipi
(com’è stato detto) «al dramma del loro mondo». Meno complesse sono le altre
figure: ammantato di imperiale solennità e autorità Giustiniano, ardenti e quasi
violenti nella condanna del male Cunizza e Folchetto. Figure suggestivamente
silenziose, una in ogni cielo, sono quelle che vengono indicate dalle anime
interlocutrici come tipiche della parabola umana e del destino ultimo che ogni
cielo esempla: Costanza, Romeo, Raab. Nella rappresentazione indiretta può
risaltare meglio la positività della vita del beato, la sua virtù o santità, che però
vengono presentati non come doni naturalmente posseduti, ma come frutto di
conquista tra i dolori e gli errori del mondo.
CANTI X-XX - L’ascesa al cielo del Sole segna il raggiungimento di una più
alta fase di contemplazione. Superati i cieli, su cui «l’ombra s’appunta / che ’1
vostro mondo face» (IX, 118-9), Dante è sublimato in un mondo di luce e di
grazia più intense. Avranno luogo incontri con spiriti che seppero improntare la
propria vita all’amore e alla legge di Dio («activi» e «proficienti»). Dante autore
sottolinea la novità qualitativa dell’ascesa con una rapita rappresentazione,
all’inizio del canto X, dell’ordine astronomico celeste, in che è quasi un
emblema della sua stessa assunzione in un mondo di perfezione razionale. Come
all’atto del congiungimento col primo cielo, il personaggio ringrazia con slancio
Iddio per la grazia concessagli e così farà ancora allorché sarà elevato al cielo di
Marte. Il suo trasumanare, quando la visione è divenuta ricordo del Dante
autore, permane come cosciente, maturo e gioioso rifiuto e distacco da quanto
121
è affannosa e assillante e pur erronea e peccaminosa attività terrena («O
insensata cura de’ mortali, / quanto son difettivi sillogismi / quei che ti fanno in
basso batter l’ali! / Chi dietro a iura e chi ad aforismi / sen giva, e chi seguendo
sacerdozio, / e chi regnar per forza o per sofismi, / e chi rubare e chi civil
negozio; / chi nel diletto de la carne involto / s’affaticava e chi si dava all’ozio, /
quando, da tutte queste cose sciolto, / con Beatrice m’era suso in cielo / cotanto
gloriosamente accolto», XI, 1-12), oppure è condizione acquisita di vittoria sulla
pena della caducità terrena («Qual si lamenti perché qui si moia / per viver colà
su, non vide quive / lo refrigerio de l’etterna ploia», XIV, 25-7).
Nel cielo di Marte l’itinerario profetico-apocalittico tocca uno dei suoi
culmini. Dal trisavolo Cacciaguida, martire della fede, Dante, dopo aver
appreso tutta la verità riguardo al suo destino futuro, all’ingiusto esilio che dovrà
subire, che è un destino di dolore uguale a quello dei profeti, viene investito in
modo deciso e solenne del compito di palesare in terra tutto il contenuto della
visione: «[...] rimossa ogne menzogna, / tutta tua visïon fa manifesta; / e lascia
pur grattar dov’è la rogna» (XVII, 127-9). La sua parola sarà «molesta nel primo
gusto», poi, una volta che se ne saranno colti i valori e il messaggio, diverrà «vital
nodrimento» (XVII, 130-32).
Meno insistente, nella rappresentazione, è per questa fase dell’ascesa il motivo della luce e bellezza di Beatrice. L’intensità ed altezza di queste il poeta non
rappresenta, ma suggerisce negativamente, affermandone la trascendenza e
l’ineffabilità: «[...] qual io allor vidi / ne li occhi santi amor, qui l’abbandono:
/ non perch’io pur del mio parlar diffidi, / ma per la mente che non può redire
/ sovra sé tanto, s’altri non la guidi. / Tanto poss’io di quel punto ridire, / che,
rimirando lei, lo mio affetto / libero fu da ogne altro disire, / fin che ’1 piacere
etterno, che diretto / raggiava in Beatrice, dal bel viso / mi contentava col
secondo aspetto» (XVIII, 8-18). In lei traluce (come già nel paradiso terrestre)
Dio e la contemplazione di lei da parte di Dante è già un’esperienza di ordine
estatico. È sempre Beatrice a indirizzare ed autorizzare le sue azioni. Ne
conosce, prima ancora che siano coscienti, i bisogni intellettuali e li palesa alle
anime (XIV, 10-8); ma anche lo esorta a manifestare lui stesso i suoi desideri,
evidentemente per esercizio di umiltà (XVIII, 7-12). Tale è tuttavia l’altezza
delle anime che parlano ora con lui, che Beatrice può lasciare ad esse
totalmente il magistero di verità. Tale va facendosi anche il suo grado di
elevazione, che nel cielo di Giove può rivolgersi alle anime senza attendere
l’assenso della guida (XIX, 19 sgg.). È preso dalla grandiosità e suggestività
luminosa degli spettacoli che gli si offrono tanto che, nel cielo di Marte,
raggiunge il massimo grado di slancio amoroso: «io m’innamorava tanto
quinci, / che ’nfino a lì non fu alcuna cosa / che mi legasse con sì dolci vinci»
(XIV, 127-9).
122
La luce delle anime è, nel cielo del Sole, così intensa da vincere quella dello
stesso astro, nel cielo di Marte, di uno splendore rosseggiante, nel cielo di Giove,
così risplendente da sembrare un rubino in cui «raggio di sole ardesse sì acceso,
/ che ne’ miei occhi rifrangesse lui» (XIX, 5-6). Però appaiono ora raggruppate
e ordinate in maniera da formare delle figure: il cerchio nel quarto cielo, la croce
nel quinto, lettere dell’alfabeto e poi un’aquila nel sesto. Sono figure
chiaramente simboliche, rispettivamente, della perfetta realizzazione della
propria vocazione, della passione, dell’Impero, e rispondenti alla qualità delle
anime: alla sapienza, che tende alla verità, che è una, il centro del cerchio (i
cerchi di anime si dispongono intorno a Beatrice, verità rivelata, oltre che a
Dante), alla «fortezza», che le indusse al martirio per la fede, alla giustizia, che
ha il garante nell’Impero. Inoltre, in armonia con le analogie cieli-scienze, la
perfezione e l’esattezza delle linee e del numero (due cerchi di dodici anime e,
poi, un terzo cerchio) si addicono al sole, comparabile all’aritmetica; il simbolo
della passione, segno rosseggiante allusivo a grandi eventi storici, si addice a
Marte, comparabile alla musica che muove i cuori; il simbolo dell’aquila,
allusivo all’Impero e alla giustizia, si addice a Giove, comparabile alla geometria,
che è scienza senza errore e ben delimitata nel suo campo. Marte, per di più, è
al centro dei nove cieli, sicché il segno della croce campeggia come simbolo
centrale. Le anime sono caratterizzate da una sorta di amorosa e gioiosa
mobilità, che è la danza in tondo dei sapienti e il moto rettilineo dei martiri
entro le linee della croce ed il vario disporsi in lettere dei giusti e i loro moti
collettivi nella forma dell’aquila. Il moto è unito al canto. Simbolo gioioso della
beatitudine e della tensione verso il divino. Il canto è in Marte una melodia di
tale dolcezza da rapire completamente Dante (ancora l’analogia Marte-musica)
ed è fatto di parole incomprensibili a lui (come anche in Giove), ma allusive alla
resurrezione di Cristo e alla sua vittoria sulla morte.
La visione celeste si offre in tutta la sublimità di un divino rivelarsi. La
pregnanza simbolica delle immagini, in cui si esprimono sia l’esaltazione contemplativa del pellegrino come la condizione oggettiva e soggettiva delle anime,
impedisce la caduta nella pura spettacolarità. Nelle forme dell’apparire delle
anime infatti è contenuta la rivelazione dell’ordine, della perfezione, della gioia
e della bellezza paradisiaci, e la rappresentazione esprime nella stessa descrizione
degli oggetti la spasmodica veglia di ogni facoltà di ricezione e l’esaltante
rapimento del soggetto contemplante. Il rappresentare, anche, ha una fermezza,
nettezza e misura di immagini e di struttura apprese dalla lezione dei classici, che
impedisce ogni scadimento oratorio come pure la fumosa genericità di certe
espressioni immediate dello stato mistico.
Nella luce, nell’ordine coreografico, nel movimento e nel canto si esprime,
prima ancora che nella parola, la condizione interiore dei beati, che ha una sua
123
dialettica complessità. La «contentezza», il totale appagamento, si associano a un
perenne slancio di amore, che le induce all’attività del moto e del canto.
L’appagamento genera l’amore, determinando pertanto un moto interiore senza
fine. Il loro venire incontro a Dante e il parlare con lui sono, ancora una volta,
un atto di amore. Molte le apparizioni in questi cieli, pochi i personaggi. Si dice
naturalmente delle anime che si presentano effettivamente nel cielo. Dominante
nel cielo del Sole è il personaggio di Tommaso, affiancato da Bonaventura e da
Salomone. Dei martiri, parla soltanto Cacciaguida. Nel cielo di Giove il
personaggio addirittura scompare, perché tutte le anime assieme parlano come
una sola persona. Il ricordo della vita terrena personale è scomparso quasi del
tutto, e le figure si caratterizzano per quel che dicono e solo indirettamente e
mediatamente per quel che furono. Così il dialogo non è intimo, poiché ormai
l’amore delle anime si manifesta come ammaestramento sulle grandi verità e
non si rivolge all’individuo Dante quanto all’essere dotato di grazia eccezionale
e ordinato a un compito. Neanche l’incontro col trisavolo è intimo e quel che
egli dice, riguardante la vita del discendente, non è intonato a umani sentimenti
di pena e consolazione o a umano interesse per il destino di una creatura, ma è
manifestazione di un habitus mentale volto a cogliere nel particolare il
manifestarsi di un destinato corso storico, il segno di una volontà che tutto ha
previsto ab aeterno.
La riflessione e il magistero dei beati in questi cieli si svolgono nella luce
dell’illuminazione trinitaria, come sembrano alludere l’evocazione della Trinità,
con cui si apre il canto decimo e che ritorna insistente in tutti i canti del cielo
del Sole, e la stessa figurazione dei tre cerchi dei sapienti, prefigurante i tre cerchi
della visione sensoriale di Dio nell’empireo. Sotto il segno del padre, in
particolare, si collocano i sapienti, sotto il segno di Cristo i martiri e sotto il
segno dello Spirito i giusti. Il tema del traviamento del mondo contemporaneo,
posto già nei primi cieli, viene approfondito ora nei cieli centrali ed è visto in
antitesi all’opera provvidenziale di Dio.
Il tema generale è svolto attraverso una serie di sviluppi autonomi di temi
specifici. Nel quarto cielo si manifestano indirettamente e direttamente le
qualità e la finalizzazione del vero sapere. La composizione delle corone (come
si è detto sopra) di per sé significa la concordanza nell’unica verità di interessi,
procedimenti e discipline diverse. È sottolineato tuttavia da Tommaso l’obbligo
della cautela e della responsabilità nella ricerca della verità. Lo stesso Tommaso,
a proposito della sapienza di Salomone, spiega come debba essere distinto un
tipo di sapere proprio del reggitore e finalizzato al buon governo. La dottrina
però deve anche, e forse soprattutto, essere volta all’intendimento della volontà
di Dio e del senso del suo operare nel mondo. È per questo che Tommaso e
Bonaventura parlano di Francesco e Domenico. Mostrano infatti come la divina
124
provvidenza abbia voluto l’avvento e l’opera dei due «principi» al fine di
ricondurre l’umanità sul sentiero della fede e della verità e come il traviamento
dei due ordini religiosi abbia annullato questa azione. Si può anche intendere
che lo stesso operato dei due santi fosse frutto (tra l’altro) di vera conoscenza.
La spiegazione di Tommaso, immediatamente susseguente al discorso sui
due ordini, sui modi della divina creazione ha la funzione di ribadire, su un piano
di pura astrazione teologica, il motivo della bontà di Dio e della sua provvidenza,
cui contrasta la «natura». Infine la definizione del sapere è coronata dalle parole
di Salomone sulla beatitudine dei beati, consistente nella conoscenza, una
conoscenza e una beatitudine che, alla fine dei tempi, il corpo risorto non solo
non ostacolerà, ma anzi rafforzerà. Si configura, implicitamente ed
esplicitamente, l’idea di una dottrina che si fa prudenza, volta com’è a intendere
l’operato e la volontà di Dio nel mondo e ad attuare in esso il bene sconfiggendo
il male, condizione per quella vittoria sulla morte che è la resurrezione del corpo.
Così nel Sole, in analogia ai compiti degli angeli che lo governano (Potestà) si
parla della lotta del bene contro il male predisposta da Dio.
Nel cielo di Marte invece, che è governato dalle Virtù, cui si devono
modificazioni naturali preannuncianti grandi mutamenti storici, Cacciaguida
parlerà del passato della Firenze che non è più e pronosticherà l’esilio di Dante
e le grandi opere di Cangrande della Scala. Si ha così, attraverso l’esempio
particolare, oltre che un persuasivo quadro della mutevolezza e contingenza
delle cose umane, una ammaestramento, attraverso l’antitesi di passato e
presente, sulla forma ideale di vita civile e politica e sull’entità del traviamento
in atto. È un quadro della deviazione etico-politica corrispondente a quello, del
cielo precedente, della deviazione della religiosità minoritica.
Dal particolare quindi si ritorna al generale, e, nel cielo di Giove, governato
dalle Dominazioni, che mediano il potere di Dio sul tempo e sull’eternità,
l’aquila, che è simbolo imperiale accusa i reggitori ingiusti ed esalta quelli giusti.
Come avviene sempre nel Paradiso, dal fenomeno si risale all’essenza e si pone il
problema della giustizia divina in rapporto alla grazia, mostrando come sia
imperscrutabile la cagione dei giudizi di Dio, che tuttavia non possono non
essere ispirati a giustizia, e come Dio proceda per vie del tutto trascendenti
l’umana possibilità di conoscenza. Esempio paradossale è la presenza, proprio
nel ciglio dell’aquila, dei pagani Rifeo e Traiano, cui per grazia fu data la fede.
La volontà di Dio non può essere ingiusta, perché «nullo creato bene a sé la tira»
(XIX, 89). L’ingiustizia nasce invece dalla cupidigia, come ha appreso Dante
autore, dalla cupidigia simoniaca in specie: «[…] io prego la mente in che
s’inizia / tuo moto e tua virtute, che rimiri / ond’esce il fummo che ’1 tuo raggio
vizia, / sì ch’un’altra fïata omai s’adiri / del comperare e vender dentro al tempio
/ che si murò di segni e di martìri» (XVIII, 118-23). Così si apprende del
125
fondamento divino della giustizia terrena e, allusivamente, del riconoscimento,
per la salvezza, del possesso anche della sola giustizia naturale. Da tutto questo
grandioso complesso di argomenti e di rivelazioni, ancora una volta, emerge la
contraddizione, nel presente, tra volontà divina, che predispone la salvezza
dell’uomo, e la colpa della volontà umana, che devia trascinata dall’amore dei
beni mondani.
Contenuti siffatti, svolti nello sfondo vertiginoso della coreografia celeste
escludono, come si diceva, l’intimità. Il tono generale delle parole dei beati anzi
è la solennità della rivelazione, la consapevolezza del valore degli incontri con
Dante in vista della sua missione, il sublime distacco dalla contingenza, l’estatica
gioia del possesso e della comunicazione di verità tanto assolute e limpide. La
beatitudine si palesa appunto come conoscenza, come amorosa volontà di
illuminazione e come posizione spassionata, se pur sdegnosa, dinanzi all’idea del
male. La rievocazione del passato buono non è tanto colorata di nostalgia, ma
ha piuttosto i toni dell’inno, poiché la perdita è vista solo come temporanea
mancanza e il bene che fu è valore perenne. Solennità, distacco, inno non
escludono tuttavia l’animazione e il movimento nei discorsi delle anime e
l’intensificarsi o lo smorzarsi dell’intensità del sentimento. Le rievocazioni dei
momenti salienti della vita di Francesco e Domenico, oltre che inneggianti ed
esemplari (più densa di significato è la prima), sono epico-cavalleresche per la
concezione ideologica, che fa dei due santi due ardenti cavalieri, e per la rude e
scarna, ma polivalente, evidenza delle immagini. La biografia di Francesco
rappresenta, nella ricchezza significante dei quadri in cui è divisa, fenomenicità
ed essenza dell’azione del santo, dando alla dispersività della cronaca e alla
astrattezza delle interpretazioni mistiche la fusione e la pregnanza del
comprendere e rappresentare della poesia. La rievocazione dell’antica Firenze, da
parte di Cacciaguida è soprattutto una lode e una proposta d’esempio e il
ricordo delle schiatte scomparse è ispirato da un solenne senso cristiano della
caducità delle cose umane.
Il sapere permea di sé come essenza ogni immagine e ogni momento della
rappresentazione. Quando ne è contenuto esplicito, si esprime col linguaggio
estatico ed esaltante della partecipazione al divino e caratterizza il beato essere
dei personaggi che la comunicano. Questi non possono avere caratterizzazioni
assolutamente individualizzanti, perché l’immersione nella volontà di Dio, la
conoscenza in Dio e l’amore li eguagliano. È possibile tuttavia distinguere la
pacatezza e la lucidità del ragionare scolastico di Tommaso, il calore immaginoso
di Bonaventura, l’umile ardore di Salomone, la ieratica cavalleresco-feudale
solennità di Cacciaguida. La vicenda personale di questo, nella rievocazione che
ne fa, richiesto da Dante, è riassunta con austera evangelica semplicità da cenni
essenziali ai momenti fondamentali del vivere (cristiano): nascita, battesimo,
126
nozze, milizia, martirio. Efficaci e suggestivi scorci, atti a caratterizzare una
vicenda umana sono spesso le presentazioni di anime da parte di altre anime,
come quelle fatte da Tommaso e Bonaventura nel cielo del Sole o dall’aquila nel
cielo di Giove.
CANTI XXI-XXIX - Dal settimo cielo al nono, l’ascesa è caratterizzata da
più intensi turbamenti e da un più estatico contemplare, in rapporto alla
maggior sublimità degli oggetti della visione. Si arricchisce e si intensifica il
motivo della tensione conoscitiva e della gioiosa estaticità del momento
soggettivo-contemplativo. Il raggiungimento di un più alto grado del
contemplare si esprime già, allusivamente, nell’assorta fissità e nella totale
astrazione del primo atto compiuto da Dante pervenuto al cielo di Saturno:
«Già eran li occhi miei rifissi al volto / de la mia donna, e l’animo con essi, / e
da ogne altro intento s’era tolto» (XXI, 1-3). Altri segni sono il fatto che ora
Beatrice non rida e le anime non cantino: la bellezza di lei, altrimenti, e
l’intensità dei canti sarebbero tali, per la vicinanza a Dio, nel settimo cielo, da
annientare le capacità di un mortale. Il silenzio sarà però quasi improvvisamente
rotto da un apocalittico «grido» (che è preghiera e profezia), così elevato di
suono che il pellegrino non può intenderne le parole e rimane «oppresso di
stupore» (XXII, 1). Nel cielo seguente, l’ottavo, il cielo delle stelle fisse, la
visione della «sustanza» di Cristo, trasparente dentro la «viva luce» di un «sole»,
provoca il suo primo rapimento estatico che lo aliena da se stesso e lo lascia
oblioso di quanto ha sperimentato: «la mente mia così, tra quelle dape / fatta
più grande, di se stessa uscio, / e che si fesse rimembrar non sape. / [...] / Io era
come quei che si risente / di visione oblita e che s’ingegna / indarno di ridurlasi
a la mente» (XXIII, 43-5, 49-51). L’esperienza però rafforza le sue capacità, che
divengono atte a fissare e comprendere minori oggetti. Ma nello stesso cielo, un
altro splendore, quello di Giovanni evangelista, fissato troppo intensamente, lo
abbaglierà sì da accecarlo temporaneamente, fino a che il raggio degli occhi di
Beatrice non solo vincerà l’ombra dei suoi occhi, ma anzi ne accrescerà la
potenza (XXVI, 100-XXVII, 81). Si ripropone in tutto ciò l’analogia con
l’apostolo Paolo e si vuol alludere forse all’oscuramento delle facoltà intellettive
dell’individuo prematuramente proteso alle massime rivelazioni, oscuramento
da cui solo la razionalità (sia pur fondata sulla rivelazione) può in un secondo
momento liberare.
La contemplazione si traduce anche in ineffabile ebbrezza e in etica elevazione: «Ciò ch’io vedeva mi sembiava un riso / de l’universo; per che mia
ebbrezza / intrava per l’udire e per lo viso. / Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
/ oh vita integra d’amore e di pace! / oh sanza brama sicura ricchezza!» (XXVII,
4-9). Si alternano nell’esperienza del personaggio visioni, apprendimenti e
127
slanci affettivi, con un ritmo accentuatamente dinamico nel cielo delle Stelle
fisse, con pacata e riflessiva lentezza nel Primo mobile. Due volte, nel settimo
e nell’ottavo cielo, Beatrice lo induce a guardare in basso e, approssimandosi
alle realtà più sublimi, a misurare l’altezza raggiunta e la pochezza anche
dimensionale della terra: «“Tu se’ sì presso a l’ultima salute” / cominciò
Beatrice, “che tu dei / aver le luci tue chiare e acute; / e però, prima che tu più
t’inlei, / rimira in giù, e vedi quanto mondo / sotto li piedi già esser ti fei […]”»
(XXII, 124-9; XXVII, 76-87).
La condizione contemplativa, prevalente nell’ascesa paradisiaca, è a lungo
interrotta, nel cielo delle stelle fisse, dal triplice esame di Dante sulle virtù teologali, fede, speranza e carità, impersonate dagli apostoli Pietro, Iacopo e
Giovanni. L’esame si svolge dinanzi a tutte le anime beate, discese dall’empireo,
mentre Beatrice vigila accortamente e opportunamente interviene o muove
l’azione. Al motivo dell’esame si intreccia strettamente quello investiturale.
L’esame si svolge infatti in un clima che non è soltanto scolastico (la «situazione
d’esame»), ma ha anche certe caratteristiche e venature da rito cavalleresco,
come se il personaggio ora affrontasse l’ultimo ostacolo di un’«avventura». Se
può esser paragonato al «baccielier», che «s’arma e non parla» e Pietro al
«maestro», che «la question propone » (XXIV, 46-7), non mancano tuttavia le
metafore tratte dal mondo della corte: «[…] per grazia vuol che tu t’affronti / lo
nostro Imperadore, anzi la morte, / ne l’aula più secreta co’ suoi conti» (XXV,
40-2). Il tono di Dante, nelle risposte, ha la baldanza di chi si accinge a sostenere
una battaglia decisiva con la sicura coscienza della vittoria. La ragione esplicita
dell’esame è l’opportunità che egli inneggi alle virtù che permettono l’ingresso
nel regno dei cieli. Ma è anche intuibile la ragione strutturale. Prima di essere
ammesso alle più alte visioni, il personaggio deve dar prova di possedere, con
pienezza emotiva, etica e intellettuale, le virtù necessarie per la beatitudine. È,
inoltre, una professione di virtù, che dovrà dissipare qualunque ombra sulla sua
ortodossia e quindi sulla sua totale credibilità come rivelatore profetico. In tutto
ciò è il nesso col momento investiturale. L’esame sulla fede si conclude con la
benedizione e coronazione da parte di Pietro: «[…] benedicendomi cantando, /
tre volte cinse me, sì com’io tacqui, / l’appostolico lume al cui comando / io avea
detto: sì nel dir li piacqui! » (XXIV, 151-4). È una sorta di sacra assunzione,
un’ammissione quasi nel «sodalizio eletto a la gran cena / del benedetto Agnello
[…]» (XXIV, 1-2). A questa coronazione, come necessaria conseguenza,
dovrebbe seguire quella terrena, la coronazione poetica in Firenze, con la fine
dell’esilio: «con altra voce ornai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte
/ del mio battesmo prenderò ’1 cappello» (XXV, 7-9).
Si susseguono i conferimenti di missione profetica, provenienti da ognuno
degli apostoli esaminatori. Dopo un cenno di Giovanni (XXV, 129), l’ultima
128
investitura viene a Dante dal primo dei pontefici, a conclusione dell’ampia
azione nel cielo delle stelle fisse: «e tu figliuol, che per lo mortai pondo / ancor
giù tornerai, apri la bocca, / e non asconder quel ch’io non ascondo» (XXVII,
64-6). Ma già prima, nel corso dell’esame sulla speranza, da Iacopo è stato
dichiarato il contenuto generale del messaggio profetico a lui assegnato. Lui che,
a detta di Beatrice, è tra i cristiani militanti il più dotato di speranza, da Dio è
stato predestinato a rinsaldare in sé e negli altri proprio questa virtù, fondandosi
sulla visione largitagli del paradiso: «[…] veduto il ver di questa corte, / la spene,
che là giù bene innamora, / in te e in altrui di ciò conforte» (XXV, 43-5). La speranza, specificamente, è virtù legata alla funzione profetica. La sua missione,
pertanto, venendo dopo quella di Paolo, che fu destinata a confortare presso i
fedeli la fede, la virtù su cui si fonda la speranza, sembra dover segnare un secondo tempo dell’era cristiana. Si tratta, indubbiamente, di speranza della gloria
futura in cielo, ma anche, implicitamente si può ritenere, di speranza del
realizzarsi del bene nel mondo: una speranza nel trascendente e una speranza,
sappiamo, storico-imperiale, necessaria ad armonica sintesi del viaggio
ripetizione-continuazione di quelli di Enea e Paolo. E, in piena rispondenza,
anche la speranza di un risarcimento personale, il ritorno a Firenze.
In questa fase dell’ascesa, Beatrice accentua il suo atteggiamento di materna
cura nei confronti di Dante: «[…] come madre che soccorre / sùbito al figlio
palido e anelo / con la sua voce, che ’1 suol ben disporre» (XXII, 4-6). Si
approfondisce il suo simbolismo e si colora di suggestioni e di misteriose e
allusive attese la sua funzione, sia che determini il clima di disiosa e fiduciosa
aspettazione all’aprirsi dell’azione nell’ottavo cielo, sia che inviti il poeta a
guardare la sua bocca («il santo riso», XXIII, 59) dopo la visione della tralucente
«sustanza» di Cristo, sia che determini e muova l’azione dell’esame e ne
costituisca un punto di riferimento, sia che gli ridoni con la luce dei suoi occhi
la vista perduta, sia che, raggiunto il nono cielo, profetizzi un prossimo
rivolgimento nel corso degli eventi mondani. La sua bellezza diviene sempre più
ineffabile («Se mo sonasser tutte quelle lingue/ che Polimnïa con le suore fero /
del latte lor dolcissimo più pingue, / per aiutarmi al millesmo del vero / non si
verria, cantando il santo riso / e quanto il santo aspetto facea mero», XXIII, 5560) e sempre più partecipe del divino («[…] ridendo tanto lieta, / che Dio parea
nel suo volto gioire», XXVII, 104-5). Nell’ultimo cielo mobile, ella concluderà
il suo magistero dottrinale, illuminando il pellegrino sulla natura e creazione
degli angeli e bollando quegli uomini di chiesa che, per leggerezza o vanità o
disonestà, alterano il senso della Scrittura e predicano «ciance».
Dal settimo al nono cielo, il processo di graduale elevazione di Dante
pellegrino è sottolineato dalla marcata scansione di valore nelle essenze che
129
attuano la descensio. Nel cielo settimo gli vengono incontro le anime della terza
categoria bernardiana: i contemplanti, «perfetti» quanto alla via della carità. Il
freddo pianeta li indusse in vita alla solitudine della vita conventuale, ove
esercitarono la virtù morale della «temperanza eroica» (Parodi) e quella
intellettuale della sapienza, raggiunta attraverso la contemplazione. Queste
anime appunto rappresentano il passaggio dal momento pratico del vivere a
quello, più alto, speculativo. La difficoltà e l’altezza della loro vita possono ben
raffrontarsi all’astrologia, la più difficile ed alta delle scienze, cui è analogo il
cielo di Saturno. Appare a Dante uno «scaleo» di «color d’oro in che raggio
traluce» e che sale verso l’alto sin dove non è più visibile (XXI, 28-30). È
simbolo della tensione ascendente della contemplazione e, particolarmente,
forse anche dello spirito della regola benedettina. Lungo i gradini di questo
scendono le anime («tanti splendor, ch’io pensai ch’ogne lume / che par nel ciel,
quindi fosse diffuso», XXI, 32-3), che poi, variamente, si fermano oppure vanno
via oppure si allontanano ma per ritornare, simboleggiando forse le varie forme
della vita monastica o della contemplazione. Simboleggia il raccoglimento
conventuale l’assenza di canti in questo cielo. Qui parlano a Dante Pier
Damiani e Benedetto.
Nel cielo ottavo il grado delle anime è ancora, e notevolmente, più alto.
Appaiono tutte le anime beate («le schiere / del triunfo di Cristo e tutto ’1 frutto
/ ricolto del girar di queste spere!» XXIII, 19-21), sovrastate da un «sol che tutte
quante l’accendea», Cristo (XXIII, 29). Ciò è in armonia con la natura del cielo,
che riparte distinguendoli tutti gli influssi celesti, e con l’analogia di questo con
la Metafisica, fondata sul fatto che in esso si scorgono effetti di cose invisibili e
la Metafisica tratta delle «prime sustanzie», che noi possiamo intendere solo
negli effetti. C’è anche analogia coi motori del cielo, i Cherubini, in cui si vede
Dio che è tutto luce (e qui appare Cristo). Tra gli spiriti si trovano gli apostoli e
Maria stessa: «Quivi è la rosa in che ’1 verbo divino / carne si fece; quivi son li
gigli / al cui odor si prese il buon cammino» (XXIII, 73-5). Qui è anche Adamo,
che parlerà a Dante alla fine del triplice esame, ultima anima che gli appaia e
stabilisca un rapporto con lui nei cieli planetari, quasi a significare le capacità
dell’uomo, una volta in possesso delle virtù teologali, di riacquistare la
primigenia purezza. Cristo invece e poi anche Maria risalgono verso l’empireo
prima che l’esame inizi. Un angelo, sceso dal cielo, circonda come corona
luminosa la Vergine, a ricordo dell’annunciazione, e continua a coronarla
durante l’ascesa. Tra questo momento e l’incontro con Adamo si situano i tre
esami. La vicenda dell’ottavo cielo si conclude con l’invettiva di Pietro contro i
papi degeneri.
Nel nono cielo, a un’invettiva di Beatrice contro la corruzione dei tempi
segue la visione di un’immagine di Dio come un «punto» di luce così acuta «che
130
’1 viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume» (XXVIII, 17-8) e
delle gerarchie angeliche, ruotanti come un alone in nove cerchi «d’igne»
(XXVIII, 25) intorno al punto. Qui Dante contempla soltanto, come nel cielo
precedente prima dell’esame, e ascolta la spiegazione di Beatrice. Dio è definito
da Beatrice come l’ente da cui «dipende il cielo e tutta la natura» (XXVIII, 42).
Si può intendere perché se ne abbia visione nel Primo mobile, poiché da esso dipende tutto il movimento e la vita stessa del cosmo, in analogia con la filosofia
morale, che è condizione per l’apprendimento delle altre scienze e dà ad esse
norma e finalità. Analogia esiste anche con la natura dei motori, i Serafini, che
fanno ardere l’universo di carità e lo illuminano di scienza, e qui è la luce affocante di Dio e quella ignea degli angeli.
La trama essenziale della tematica è ancora il raffronto, implicito o
esplicito, tra realtà del cielo e realtà della terra. Ora però comincia a prevalere
come oggetto di interesse la contemplazione della realtà celeste in se stessa
nell’abissale distanza che la separa dal terrestre, mentre il rapporto con l’umano
è visto più dall’alto, come fatto metastorico fondato su principi eterni, che solo
temporaneamente possono essere elusi. Si innesta naturalmente in questa trama
il motivo del raffronto tra passato e presente mondani, un passato in cui il
mondo accoglieva il divino, un presente in cui lo rifiuta. Nel settimo cielo torna
l’interrogativo sulle motivazioni delle decisioni divine, ma generalizzato come
domanda sulla predestinazione. La risposta sottolinea ancora, confermando
natura e limiti della contemplazione, il mistero e la trascendenza delle divine
volizioni, che nessun beato o angelo pienamente comprendere. Così il settimo
cielo media il passaggio verso il trascendente in sé che si offrirà gradualmente in
visione. In tutto il cielo ottavo motivo dominante anche se non esplicitamente,
alluso sin dall’inizio, è l’essenzialità della rivelazione e della passione per il
compimento dei fini dell’uomo. La presenza stessa dei beati, prova vivente della
vittoria di Cristo, e il contenuto dell’esame, quasi tutto fondato sui dati delle
Scritture e risolventesi in una confessione di debito totale dell’uomo alla verità
divina che lo illumina («la larga ploia / de lo Spirito Santo, ch’è diffusa / in su
le vecchie e ’n su le nuove cuoia, / è silogismo [...]», XXIV, 91-4), finiscono con
l’essere un inno all’amore divino, che volle largirsi agli uomini. È un discorso sul
trascendente, che scende verso l’umano pur rimanendo inattingibile dai mezzi
umani di conoscenza. L’umano qui, d’altra parte, è un umano sublimato ed
esaltato, colto in un individuo eletto e, per astrazione, proprio della specie
metastoricamente intesa. Nelle risposte di Dante sulle virtù, nella sua stessa
destinazione di profeta di speranza, si può scorgere una prova di possesso di
sapienza, offerta in armonia al luogo, governato dai Cherubini, che sono fiumi
riversanti sugli altri il proprio sapere. Nel nono cielo, le spiegazioni di Beatrice
sul Primo mobile, su Dio e sugli angeli prescindono da qualsiasi loro rapporto
131
con l’umano e si suggellano sul motivo dell’unità di Dio, che crea «uno
manendo in sé come davanti» (XXIX, 145). Ella disserta anche sulla natura degli
angeli e non si tratta di accademico dottrinarismo: dalla ribadita differenza
qualitativa tra uomo e angelo emerge ulteriormente la volontà divina di mediare
la propria trascendenza. Così è ripetuta l’analogia coi Serafini, motori del nono
cielo, in cui si scorge l’amore di Dio per se stesso e per le sue creature.
Il discorso sugli uomini e i loro errori completa la rappresentazione delle
colpe e della degenerazione della Chiesa. Ai contemplanti, conformemente alle
prerogative della gerarchia dei Troni, in cui si riflette la giustizia di Dio
giudicante, è affidata la denuncia della scomparsa di spirito ascetico nei
camaldolesi (derivati dall’ordine di san Benedetto), nei prelati della Chiesa e nei
benedettini (di cui il poeta sembra intendere il grande ruolo storico). San
Benedetto può ben suggellare la rappresentazione con un sintetico, semplice e
definitivo giudizio sui tre conventi della Chiesa: «Pier cominciò sanz’oro e
sanz’argento, / e io con orazione e con digiuno, / e Francesco umilmente il suo
convento; / e se guardi ’1 principio di ciascuno, / poscia riguardi là dov’è
trascorso, / tu vederai del bianco fatto bruno» (XXII, 88-93). Le ultime denunce
saranno quella, specifica, di san Pietro, che accusa l’infamia dei papi degeneri
(«in vesta di pastor lupi rapaci / si veggion di qua su per tutti i paschi», XXVII,
55-6), e quella, generale e non priva di coloriture apocalittiche, di Beatrice, la
quale smaschera i maestri e i predicatori menzogneri, che trascurano o
addirittura distorcono il senso delle Scritture, con incalcolabile danno per i
fedeli, che «tornan dal pasco pasciuti di vento, / e non li scusa non veder lo
danno» (XXIX, 107-8). Alla radice di tutto questo, viene ancora e più volte
ribadito, è la cupidigia: «Oh cupidigia, che i mortali affonde / sì sotto te, che
nessuno ha podere / di trarre li occhi fuor de le tue onde!» (XXVII, 121-3; cfr.
XXI, 126 sgg.; XXII, 79 sgg.).
Non solo gli ecclesiastici, ma tutti gli uomini contamina la «lupa», tanto
che «Fede e innocenza son reperte / solo ne’ parvoletti» (XXVII, 127-8). Così
Beatrice, e spiega: «Tu, perché non ti facci maraviglia, / pensa che ’n terra non
è chi governi; / onde sì svia l’umana famiglia» (XXVII, 139-41). L’origine prima
del male è quindi indicata da Adamo e Beatrice nella superbia, che fu causa del
peccato originale e, prima ancora, della ribellione di Lucifero: «Principio del
cader fu il maladetto / superbir di colui che tu vedesti / da tutti i pesi del mondo
costretto » (XXIX, 55-7).
Di contro al male presente si contrappone il ricordo affettuoso, commosso
e umilmente orgoglioso del passato, delle origini della Chiesa e dei suoi «conventi», come nelle parole del Damiani, di Benedetto, di Pietro, di Beatrice. Si
riconferma anche la fiduciosa attesa del futuro, come sicuro benché indefinito
annuncio profetico di grandi rivolgimenti, contenuto nel «grido» dei
132
contemplanti e, ancora, nelle parole di Benedetto, di Pietro, di Beatrice.
Come si diceva, momento contemplativo ascendente e momento santificante discendente si elevano verso vertici di intensità e significatività numinosa.
La rappresentazione si avvale degli stessi mezzi adoperati per le fasi precedenti
dell’ascesa. Alterna in uguale successione i motivi dell’azione di Beatrice, del
vedere ed agire del contemplante, dell’azione dei beati. I motivi si svolgono,
spesso, in un alone di musicalità e, sempre, nel fitto spessore e nell’intenso
splendore di luce, che domina e investe ogni oggetto. Le condizioni
rappresentate sono la beatitudine da una parte, il rapito ed esaltante moto verso
la beatitudine dall’altra, che ora si rivelano con sempre maggiore insistenza,
intensità e durata. La conoscenza e il ricordo del male suscitano sdegno e dolore,
intensi tanto da far scolorire il cielo; ma hanno rilevanza episodica e durata
momentanea. Il tono delle parole di Beatrice e degli altri beati è anch’esso
mutato e tende non più tanto o soltanto alla solennità, quanto alla semplicità
serafica e alla mistica pregnanza. Come pure l’insieme del linguaggio, che è
innervato su parole ricorrenti e possiede la duplice qualità della lucidità
definitoria della filosofia e della indefinitezza suggestiva della mistica. La
beatitudine di paradiso, l’illuminazione dell’intelletto, l’ardore della carità, la
sublimazione dell’essere sono rappresentati mediante l’inesauribile gamma di
notazioni luministiche, moltiplicate e ripetute, e di aperture descrittive di
panorami celesti svarianti all’infinito. L’ardore e l’esaltazione dell’ascesa o
dell’altezza investono la vasta tematica nella sua interezza, conferendole
un’intima animazione lirica, presente non solo nelle descrizioni dei beati
splendori, ma anche nel fitto intreccio di battute dei tre esami, nei dotti e
ispirati discorsi di Beatrice, nelle addolorate e offese denuncie del male.
I personaggi (Pier Damiani, Benedetto, Pietro, Iacopo, Giovanni, Adamo)
hanno accenni sempre più essenziali e sintetici al loro passato terreno, colto in
un solo sguardo nel suo senso prevalente e definitivo. Ma bastano perché si
diffonda sulla loro essenza di beati la luce, per quanto modesta, dei valori
terreni, che risuona come poesia della rinuncia ascetica, della gioiosa povertà,
della tensione apostolica, della testimonianza del martirio (canti XXI-XXIX).
CANTI XXX-XXXIII - Svanita, come le stelle al sorgere del sole, la visione
del punto e dei cerchi, Dante torna con lo sguardo a Beatrice. La sua bellezza
ora è assolutamente ineffabile: «la bellezza ch’io vidi si trasmoda / non pur di là
da noi, ma certo io credo / che solo il suo fattor tutta la goda » (XXX, 19-21).
La verità, che ella simbolizza, appunto è quasi del tutto trascendente, ora che è
raggiunto l’empireo. Siamo in un mondo che concilia l’infinitezza e
l’indefinitezza sconfinate della sua essenza assolutamente spirituale e luministica
col classico geometrismo armonizzante della sua disposizione e della sua
133
figuratività. La dichiarazione di impotenza a rappresentare la bellezza di Beatrice
ha qui una insolita durata ed è intrisa di malinconia quasi come per un nuovo
distacco. Ormai solo i canti angelici (il «maggior bando», XXX, 34) potranno
adeguatamente celebrarla. Si prefigura il commiato. Ella annuncia l’ultima
ascesa, l’uscita dalla corporeità cosmica verso l’assoluto spirituale, con
espressioni di lucida evidenza, in cui si cela profondo entusiasmo dinanzi alla
grandezza dell’evento e si esprime il miracolo della nuova realtà che ora li
circonda: «[…] Noi siamo usciti fore / del maggior corpo al ciel ch’è pura luce:
/ luce intellettüal, piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che
trascende ogne dolzore» (XXX, 38-42).
Dante è tosto investito da una «luce viva», il lumen gloriae, che lo fascia e
prima gli impedisce di vedere, poi lo fa «sormontar di sopr’a sua virtute», sicché
si raccende di «novella vista», capace di fissare qualsiasi luce (XXX, 57 sgg.). Ora
può obliarsi nella contemplazione del paradiso, il vero mondo del cristiano, e la
contemplazione è tanto esaltante e consolante quanto più l’empireo si rivela
come eterna realizzazione dell’ideale della civitas umana. Si rappresentano il
dilatarsi della sua anima ad acquisti sempre più sublimi, l’ardore del desiderio di
Dio, l’umile coscienza dell’umana fragilità e impotenza, la tesa sofferta e gioiosa
fruizione dell’eterno, dell’assoluto, dell’infinito, il beato riposo dell’ottenuta
armonia col tutto. La sua esperienza si è iscritta in un’atmosfera di altezza
vertiginosa eppur non distaccata né astratta, anzi ardentemente pervasa
d’amore.
Nell’altezza dell’empireo, la cui atmosfera è prefigurata dalla liberante apertura di paesaggio celeste con cui si apre la rappresentazione (XXX, 1 sgg.), il
mondo e le sue miserie sono ricordati per un momento dalle ultime parole
rivolte a Dante da Beatrice, che preannuncia il fallimento dell’impresa di Arrigo
e il tradimento di papa Clemente. Giustizia di Dio vuole che l’imperatore abbia
un «gran seggio» (XXX, 133) in paradiso e che il pontefice sia «detruso» (XXX,
146) in inferno, tra i simoniaci. E il poeta non manca di far ricordare come
figura di dannato anche Bonifacio VIII. Non più pena o acuto sdegno per le
colpe degli uomini, ma una visione che le colloca nel posto che la provvidenza
divina ha loro ab aeterno assegnato, una visione possibile nella realtà della vera
città, della Gerusalemme celeste o (con maggior fedeltà al dettato dantesco)
della Roma celeste. Qui tutto è ordine supremo e giustizia e amore. Il ricordo,
come modello antitetico, del mondo, quasi costante dapprima nella coscienza
del protagonista e dell’autore, a poco a poco sbiadisce fino ad eclissarsi. L’umanità però non è annullata, ma sublimata. Lo dimostra la persistenza dei tratti
umani nei beati, che ora Dante può finalmente contemplare (essendo anche luì
nella luce) nella autentica essenza e figura e dì cui può nuovamente cogliere
gesti, sorrisi, sguardi. Anzi, per suprema grazia, potrà vederli nella pienezza
134
anche corporea che riacquisteranno al momento del giudizio universale (XXX,
43-5). Qui non si registrano però incontri e dialoghi, ché il pellegrino non deve
apprendere se non l’ordine paradisiaco e la divina essenza. Le anime tuttavia non
sono estranee alla sua vicenda, assorte nel godimento dell’eterna beatitudine, e
il loro moto di silenziosa preghiera, ultimo atto di amore verso di lui, è come un
accoglimento e un’assunzione.
Hanno inizio successive visioni della stessa realtà e l’una è prefigurazione
dell’altra, pur non mancando di un autonomo simbolismo. Gli angeli in
perpetuo moto e le anime gli appaiono prima come un «lume […] fulvido di
fulgore» in forma di fiume, contenuto entro rive «dipinte di mirabil primavera»
(XXX, 61-3). Dal fiume, che è la grazia, escono «faville vive», che si posan sui
fiori, i risultati della grazia, e poi tornano a sprofondarsi nella luce. Poi, lo stesso
oggetto, ulteriormente fissato, si precisa come qualcosa non più di lineare, ma
di circolare, e finalmente si rivela nella sua realtà di duplice «corte del cielo»: le
faville sono gli angeli e i fiori i beati. Lo sguardo di Dante si posa, riposato, sul
vasto scenario dell’anfiteatro paradisiaco, che accoglie entro un larghissimo
cerchio di luce (emanante da Dio e riflesso dal primo mobile) tutti i beati. Nel
mezzo, da Dio ad essi e da essi a Dio, si muove la «moltitudine volante» (XXXI,
20) degli angeli. La sua vista «[…] ne l’ampio e ne l’altezza / non si smarriva,
ma tutto prendeva / il quanto e ’1 quale di quella allegrezza» (XXX, 118-20).
Dante contempla lungamente, lentamente, liberamente, assorto e stupito,
appagato e avido al tempo stesso. Prevalgono nella rappresentazione del suo
contemplare assieme al sentimento esaltante della sublimazione il senso di distensione pel raggiungimento della meta (la «patria» nel senso cristiano) e un
senso di interiore liberazione indotto dalla natura della meta stessa : «Io, che al
divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol
giusto e sano, / di che stupor dovea esser compiuto! / […] / La forma general di
paradiso / già tutta mio sguardo avea compresa, / in nulla parte ancor fermato
fiso» (XXXI, 37-40, 52-4). Siffatto contemplare è preparazione agli ultimi gradi
della contemplazione e all’ultima fase dell’itinerario mistico-ascetico. Il
passaggio è segnato dall’avvento dell’ultima guida, Bernardo, che gli appare
«diffuso […] per li occhi e per le gene / di benigna letizia, in atto pio / quale a
tenero padre si conviene» (XXXI, 61-3). Egli, ritenuto il più «tipico» dei
contemplativi dell’ultimo Medioevo, colui che «[…] ’n questo mondo, /
contemplando, gustò di quella pace» (XXXI, 110-1), simboleggia la terza luce
dell’itinerario, il lumen gloriae, che verrà sempre più copiosamente largito al
pellegrino. Seguirà, come effetto, la «terza conversione», che avviene per un atto
di perfetto amore ed è frutto della gratia consummata. Vale a dire che Dante
entra nella terza ed ultima condizione dell’itinerario spirituale, la «via unitiva»,
in stato di «carità perfetta», corrispondente al quarto, quinto e sesto grado della
135
contemplazione, consistenti nella conoscenza e visione della verità paradisiache
e, in stato di rapimento, dell’unità delle cose create in Dio e di Dio stesso.
Dante non prova dolore per l’allontanamento di Beatrice, che non è certo
un abbandono. Senza rompere il silenzio finora osservato, volge in alto lo
sguardo, la vede tanto lontana ma assolutamente visibile e, in spirito di
raccoglimento rituale, innalza a lei una preghiera, in cui sono gratitudine
somma per l’altezza ottenutagli e la santa e assoluta sublimazione dell’amore. Un
amore corrisposto nella suprema altezza e comprensività della carità: «“La tua
magnificenza in me custodi, / sì che l’anima mia, che fatt’hai sana, piacente a te
dal corpo si disnodi”. / Così orai; e quella, sì lontana / come parea, sorrise e
riguardommi; / poi si tornò a l’etterna fontana» (XXXI, 88-93).
Bernardo non indugia a svolgere il suo ruolo ed esorta Dante a contemplare
nuovamente il «giardino» di paradiso, che è via alla massima visione («che veder
lui t’acconcerà lo sguardo / più al montar per lo raggio divino», XXXI, 98-9), e
poi ad alzare lo sguardo verso la stessa Maria, attuando così il quarto grado della
contemplazione. Egli obbedisce e gli si offre una nuova visione di luce e di bellezza: «[…] quasi di valle andando a monte / con li occhi, vidi parte ne lo stremo
/ vincer di lume tutta l’altra fronte / […] / Vidi a lor giochi quivi e a lor canti /
ridere una bellezza, che letizia / era ne li occhi a tutti li altri santi» (XXXI, 1213 133-5). Bernardo gli spiega quindi l’ordinamento topografico e, implicitamente, selettivo e graduante delle anime nell’empireo. È un ordine che scaturisce da sapienza e giustizia: «Dentro a l’ampiezza di questo reame / casual punto
non puote aver sito, / se non come tristizia o sete o fame: / che per etterna legge
è stabilito / quantunque vedi […]» (XXXII, 52-6). Lo esorta poi a fissar
nuovamente Maria, la cui bellezza «sola […] può disporre a veder Cristo»
(XXXII, 87). Ancora una volta egli assiste ad una scena rievocante
l’annunciazione e poi, nuovamente, Bernardo lo incita a guardare tra i beati,
stavolta per indicargli i «gran patrici / di questo imperio giustissimo e pio»
(XXXII, 116-7): Adamo e Pietro, Giovanni evangelista e Mosè, Anna e Lucia.
Poi la finale apoteosi di Maria. La sua funzione mediatrice è altamente
proclamata dalla «santa orazione» di Bernardo («Vergine Madre, figlia del tuo
figlio, / umile e alta più che creatura, / termine fisso d’etterno consiglio, / […]
/ Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuoi grazia e a te non ricorre,
/ sua disïanza vuol volar sanz’ali», XXXIII, 1-3, 13-5), dal moto di preghiera dei
beati («vedi Beatrice con quanti beati / per li miei preghi ti chiudon le mani!»,
XXXIII, 38-9).
La preghiera di Bernardo (così diversamente interpretata nel suo valore
estetico) è costruita, per l’accoglimento delle strutture tipiche della preghiera
«paleo-cristiana» (che esprime l’essenza storico-dogmatica della figura invocata)
e per la natura affatto implicita e immanente del momento emotivo, pur
136
fervido, come un modello astratto ed assoluto di invocazione. È come un luogo
culmine di tutta una tradizione ed esprime l’universalità del rapporto con la
mediatrice per eccellenza, talché può essere, com’è, la preghiera non solo di
Bernardo ma di tutta la Chiesa trionfante. Della sua qualità ha anche l’implicita
e necessaria eloquenza. Così Maria veramente appare «fontana vivace» di
speranza (XXXIII, 12) per i mortali. La sua intercessione, rappresentata in un
gesto che è intimo e pur solenne (secondo la più autentica immagine cristiana),
il drizzarsi degli occhi verso Dio, suggella l’intera azione mariana del poema. Il
primo atto, in cielo, del conferimento di grazia era stato appunto il suo
intervento misericordioso: piegando «duro giudicio», aveva mosso Lucia e
indirettamente Beatrice a intervenire in aiuto di Dante (Inf., II, 94 sgg.).
Dante è ora al diapason del desiderio di vedere Dio («l’ardor del desiderio
in me finii», XXXIII, 48) e si appresta a vivere il momento più arduo e, al tempo
stesso, annichilante e trasumanante dell’intera vicenda. Un momento però che
ripete come esperienza universale le tensioni conoscitive e la ricerca che furono
già dei primi tempi degli uomini (tra la Sibilla e gli Argonauti - XXXIII, 65-6,
95-6). In una condizione di tensione estatica e di rapimento, che annulla quasi
completamente il ricordo delle cose viste, di cui rimane la sensazione dello stato
emotivo che vi fu associato, fissando strenuamente il raggio vivo ed acuto della
luce divina, giunge a unire «l’aspetto suo col valore infinito» (XXXIII, 81). Dio
gli si offre alla visione in tre momenti, corrispondenti il primo al quinto grado
gli altri due al sesto grado dell’itinerario contemplativo: prima come «forma
universal» di tutto il creato, poi come triplice cerchio «di tre colori e d’una
contenenza» (XXXIII, 117), che è il modo di apparire delle tre persone
trinitarie, poi nel mistero della duplice natura di Cristo, allorché il cerchio
mediano appare dipinto «dentro da sé, del suo colore stesso, / […] de la nostra
effige» (XXXIII, 130-1). Egli vorrebbe intendere intellettualmente quest’ultimo
mistero, ma lo potrà non per sua capacità, ma per una ultima illuminazione, in
cui è la completezza del rapimento e l’esperienza della beatitudine: «[…] la mia
mente fu percossa / da un fulgore in che sua voglia venne. / A l’alta fantasia qui
mancò possa; / ma già volgeva il mio disio e ’1 velle, / sì come rota ch’igualmente
è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle» (XXXIII, 140-5). Il logorante
sforzo di comprensione, che si palesa nella intensa ed esclusiva fissità dello
sguardo indagante trova così inaspettatamente e definitivamente la sua pace.
Sino alla fine, l’esperienza contemplativa viene rappresentata come fatto di
ordine visionario e di visionarietà corporea.
Il poeta ha affrontato la più ardua delle sue imprese, poiché la
rappresentazione doveva ora comunicare la vibrazione profonda, il turbamento
radicale, l’esaltazione ineffabile di un’esperienza mistica in cui culminavano
tutte le precedenti visioni ed estasi descritte nel poema. Infatti ora egli chiede a
137
Dio stesso aiuto a ricordare e a comunicare. Il motivo del chiarirsi progressivo
della realtà dell’oggetto contemplato evidenzia l’impegno soggettivo di
progressiva conquista e la pienezza e ricchezza di realtà della sostanza divina.
Alla descrizione segue immediatamente, momento per momento, l’espressione
intensamente esclamativa dello stato interiore del soggetto dell’esperienza o
dell’impotenza rappresentativa del poeta, tanto più efficace quanto più giocata
sul ripetersi insistente ed inesauribile del medesimo giro di idee. La diffusione e
durata maggiore della rappresentazione di questo momento rispetto ad altri
momenti del vedere esprime, indirettamente, l’insostenibile sopraffazione
esercitata da questa realtà, quasi ricordata appena e subito abbandonata, per
liberare nello sfogo dell’esclamazione lo spirito, oppresso nel ricordo
dall’intensità dei contenuti della visione. Ma la maggior suggestione comunicata
dalla situazione proviene dalla novità della condizione di Dante, che è per la
prima volta solo dinanzi al trascendente, sospeso tra l’unione pacificante e il
totale smarrimento. Così la rappresentazione esprime il senso di spasimo e di
gaudio assieme, proprio della visione prima della finale assunzione nell’ordine
universale. Esprime anche, come stato attuale del poeta nella vita terrena,
l’esaltazione del ricordo e l’angoscia dell’oblio e dell’insufficienza.
138
EMILIO PASQUINI
Il linguaggio di Dante fra conquiste sintattiche e invenzioni metaforiche
Ringrazio gli amici di Albenga e in particolare il collega Giorgio Bàrberi
Squarotti per questa presentazione così lusinghiera, che temo di non meritare.
Devo però dire che l’essere ormai esonerato dal normale insegnamento, in
quanto pensionato (sia pure emerito) dell’ Alma Mater studiorum consente di
accettare inviti come questo e di rendere partecipi i pubblici più diversi di
quanto si è imparato negli anni ed ancora si è in grado di trasmettere. E veniamo
all’argomento di oggi.
Tradizionale è l’immagine di Dante come padre della lingua italiana. Io
vorrei subito precisare che questa paternità resta legittima anche nel nostro
secolo, ma a condizione che non si punti tanto o soltanto sull’invenzione di
parole nuove, i neologismi, che pure ci sono e spesso si sono tramandati fino a
noi. Non dimentichiamo che Tullio De Mauro nella sua ancora oggi
fondamentale Storia linguistica dell’Italia unita registra in una preziosa tabella
che, se si fa riferimento alla lingua da noi normalmente parlata, quella insomma
della comune conversazione, essa era già formata nel Duecento per il 50% e dal
solo Dante aveva in seguito ricevuto un buon 16%; il che equivale a dire che il
66% della nostra lingua usuale era già costituito nel 1321, alla morte di Dante.
Ma dobbiamo aggiungere a questo punto che questa paternità dantesca è ancor
meglio giustificata dall’invenzione di una sintassi nuova. In altre parole, Dante
ha il merito di avere creato le basi della sintassi moderna italiana, ben diversa da
quella latina, in altre parole del nostro modo di costruire logicamente il
pensiero.
Vorrei qui aprire una breve digressione, muovendo da un libro di Raffaele
Simone uscito dodici anni fa, La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo
(Bari, Laterza, 2000), dove si insiste sulla perdita progressiva, presso i più
giovani, della profondità sintattica, ovvero della gerarchia logica del periodo. Il
che equivale all’abbandono di un modello “metaforico”, soppiantato da un
modello “metonimico”, organizzato non più su un asse verticale, secondo logica,
ma su un piano orizzontale, quasi considerando inutile lo sforzo della sintassi,
dunque nel registro di libere o piuttosto casuali associazioni. Qualcosa di simile
allo zapping, perpetrato da chi preferisce seguire contemporaneamente in TV
vari programmi rinunciando capricciosamente alla comprensione logica di un
unico testo. Aggiungo un elemento che si lega all’ universo della comunicazione,
divenuta oggi un fatto onnipresente e debordante, che ti insegue anche in
autobus o in treno. Alludo alla scomparsa o quasi della comunicazione
139
epistolare, sostituita dalla posta elettronica (e-mail) o dal messaggino telefonico
(SMS, “short message service”) o da altre diavolerie informatiche che per
fortuna la mia generazione non usa praticare. Insomma, non si scrivono più
lettere, che comportavano uno stile e una sintassi, con relativa punteggiatura.
Tale perdita si associa anche, nell’italiano parlato, all’impoverimento
drammatico del nostro lessico, dove i vuoti vengono a volte colmati con parole
di altre lingue, desunte in genere dall’inglese. A questa tendenza fatale è difficile
porre riparo; ci si può soltanto augurare che ne venga la spinta ad apprendere
una lingua straniera. Vale invece la pena di battersi per un recupero della
competenza sintattica, cioè dell’approccio logico alla realtà, magari ritornando
all’archetipo dantesco nella scia di pagine magistrali di Erich Auerbach, in
Mimesis, nel capitolo dedicato al canto X dell’Inferno, dal titolo Farinata e
Cavalcanti: dove all’ammirazione per la tessitura drammatica dell’episodio, in
tre tempi (con l’inserzione del padre di Guido fra la prima e la seconda parlata
dell’Uberti), si unisce lo stupore per le invenzioni o innovazioni sintattiche di
Dante rispetto all’uso vigente in tutta l’area della Romania (cioè delle lingue
derivate dal latino). Ciò si dica a cominciare da quel nesso Ed ecco, a segnare un
forte stacco nella narrazione, che ricalca l’ Et ecce biblico dell’Antico e del Nuovo
Testamento, fra Genesi 22, 11 (quando l’angelo trattiene la mano di Abramo, già
pronta a sacrificare a Dio il figlio Isacco) e Luca 24, 13 con l’incontro di Cristo
risorto coi due discepoli nella strada di Emmaus. Orbene, questo modulo
drammatico prolifera in Dante e si ritrova reiterato in molti luoghi del poema,
ovviamente con un’incidenza di gran lunga maggiore nelle prime due cantiche,
a partire dal canto I, con l’apparizione della lonza: «Ed ecco, quasi al cominciar
de l’erta…» (v. 31). Seguono «Ed ecco verso noi venir per nave / un vecchio…»
(III 82); «Ed ecco due da la sinistra costa, / nudi e graffiati…» (XIII 115); «Ed
ecco a un, ch’era da nostra proda, / s’avventò un serpente…» (XXIV 97); «Ed
ecco, qual sorpreso dal mattino, / […] Marte rosseggia…» (Purg. II 13); «ed
ecco il veglio onesto / gridando…» (II 119); «ed ecco l’altra con sì gran fracasso
/ che somigliò tonar…» (XIV 137); «Ed ecco, sì come ne scrive Luca / che
Cristo apparve» (XXI 7); «ed ecco dal profondo de la testa / volse a me li occhi
un’ombra…» (XXIII 40). Di contro, l’unico esempio del Paradiso, «Ed ecco un
altro di quelli splendori / ver’ me si fece…» (IX 13), a riprova di una scelta
stilistica che puntava su una complessità sintattica scevra di moduli drammatici.
Non vi è dubbio infatti che dalla prima alla terza cantica si assista a una
conquista progressiva anche nel settore della sintassi; il che non toglie che già nel
X dell’Inferno Auerbach potesse entusiasmarsi di fronte alla novità di sintagmi
come «chi fuor li maggior tui?»(v. 42), «Allor surse…» (v. 52), «da me stesso non
vegno» (v. 61), «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’elli ancora?» (vv. 67-68).
Insomma, resta difficile far accettare e diffondere quella che a me sembra una
140
verità incontrovertibile, il fatto che la Commedia non è nata in un blocco, non
è mai stata per intero a disposizione sul tavolo dell’autore per una riposata
correzione finale, ma si è diffusa a grappolo, quasi come un romanzo
d’appendice (di qui, le numerose ritrattazioni o palinodie, in corrispondenza di
altrettanti pentimenti); ma il work in progress ha significato anche un progresso
sul piano tecnico o più latamente artistico: non dimentichiamo che studiosi del
calibro di Natalino Sapegno e Mario Fubini ritenevano che almeno i primi due
canti del poema siano usciti dalla penna di un autore che ancora non dominava
il respiro della terzina.
Veniamo al primo campione della serie A, che vi ho offerto nel fascicoletto
allegato, corrispondente alla perplessità confessata a Virgilio da un Dantepersonaggio non ancora persuaso della legittimità del viaggio ultraterreno (Inf.
II 13-27). Si tratta probabilmente del periodo più involuto della prima cantica,
dove il pensiero fatica ad esprimersi nelle sue volute logiche e dunque la sintassi
risulta inutilmente complicata: si rifletta alla pesantezza della prolessi dei vv. 1618 rispetto alla principale «non pare indegno» e alla goffaggine di quel nesso
relativo, quasi trito nella logica medievale. Lo si paragoni all’esordio del XXX
canto del Purgatorio, che segna il momento in cui la processione si arresta, a
preparare solennemente l’apparizione di Beatrice sul carro. Macchinosa ma ben
dominata la struttura del lungo periodo, con quella premessa temporale
(«Quando il settentrïon del primo cielo…») seguita da due relative in parallelo,
a chiarire insieme la valenza simbolica dei sette candelabri e la loro funzione di
guida all’interno di quel corteo, che s’appoggia sull’arcata della brevissima
reggente («fermo s’affisse»); mentre la principale si biforca equilibratamente in
due coordinate, riferite, la prima, ai 24 seniori (corrispondenti ai libri
dell’Antico Testamento), la seconda al solo Cantico dei Cantici che intona il
Veni, Sponsa, de Libano. Ancor più complesse e insieme più armoniche le cinque
terzine con cui si avvia il XXX del Paradiso, congegnate come un’ampia
similitudine fra un cielo terrestre e il Primo Mobile. Si parte dalla principale,
suddivisa in due coordinate («Forse […] ci ferve l’ora sesta, e questo mondo /
china…»), cui seguono una proposizione temporale, introdotta da quando e
determinata da una consecutiva, e una seconda temporale che viceversa precede
la principale («’l ciel si chiude») in omaggio a un’idea di circolarità. A sua volta,
la seconda parte del periodo, che costituisce il secondo termine di paragone,
consta di una principale, articolata in due brevi relative e suggellata da una
coordinata dove il soggetto è relegato in fondo sempre in funzione di una
struttura circolare.
Un discorso analogo potrebbe condursi a margine di altri passi del Paradiso,
dove celebra i suoi trionfi una sintassi che ha elaborato in modalità “moderne”
la lezione ipotattica del latino: in questa chiave potete leggere nella seconda e
141
nella terza pagina del brogliaccio che ho fatto distribuire Par. X 140-148 (una
straordinaria chiusa di canto, su cui ritorneremo) e i tre esordi di XX 1-12,
XXV 1-12 e XXXI 1-12, dove il respiro sintattico si espande ugualmente per
quattro terzine (il secondo campione è quanto mai significativo in quanto si
tratta dell’ultima allusione di Dante all’esilio, in chiave di orgogliosa palinodia
rispetto a precedenti momenti di debolezza). Vorrei però richiamare ora la vostra
attenzione sul congegno stupefacente esibito dal discorso di Salomone nel cielo
del Sole (Par. XIV 37-60), a chiarimento del dubbio, concepito da Dante ma
espresso a suo nome da Beatrice (vv. 10-18), sulla possibilità o meno che nel
giorno della resurrezione della carne i corpi abbiano difficoltà a sopportare la
luce paradisiaca che avvolge le anime. Il ragionamento, chiusa la partita col
tradizionale schema ternario del sillogismo, si distribuisce in una sequenza in
quattro+quattro tempi, in forma di catena proporzionale in simmetria speculare, prima delineata dal basso all’alto (splendore:ardore di carità:visione:Grazia)
poi in senso inverso, dall’alto al basso (Grazia:visione:ardore di carità:splendore),
con l’esito – ancora una volta – di una perfetta circolarità. Se vogliamo ricorrere
a una simbologia matematica, 1:2 = 2:4 = 4:8 = 8:16 o, inversamente, 16:8 =
8:4 = 4:2 = 2:1.
Che sia questa l’icona peculiare della terza cantica, sul piano sintattico oltre
che su quello simbolico, è confermato dalla reiterazione di un immagine tratta
dalla realtà quotidiana, quella dell’orologio, divenuta familiare da non molti
anni per la sua presenza sulle torri o sui campanili delle città medievali.
Riprendiamo in mano il passo già citato di Par. X 139 ss., dove per la prima
volta nel poema compare il meccanismo sincrono dell’orologio (segnale della
preghiera del mattutino), chiamato in causa come termine di paragone a
significare l’armonica concordia della prima corona degli spiriti sapienti nel
cielo del Sole. Si sa che tale immagine ritorna una seconda volta, in forma più
scorciata, a Par. XXIV 13 («E come cerchi in tempra d’orïuoli / si giran sì, che
’l primo a chi pon mente / quïeto pare, e l’ultimo che voli…»), per il roteare
armonioso e insieme differenziato delle anime nel cielo delle Stelle fisse; meno
noto che la stessa, in forma ancora più ellittica, venga a suggellare l’ultimo canto
del poema, nascondendosi dietro quell’ambiguo termine rota che lo studioso
francese André Pézard voleva suggerito dalla “ruota del vasaio”: a ribadire,
insomma, che la concordia finale di Dante con il Creatore poteva trovare il
miglior termine di paragone proprio in una ruota dell’ingranaggio dell’orologio
(dunque, un Dio-orologiaio piuttosto che vasaio).
***
Veniamo ora alla seconda parte del nostro discorso, quella sui sistemi
metaforici in Dante, dove cercherò di essere più breve, attingendo alle pp. 1-4
142
della sequenza B nel brogliaccio a voi distribuito, non senza il rinvio alle pagine
che ho dedicato all’argomento nel mio volume del 2001, Dante e le figure del
vero. La fabbrica della “Commedia”, specie nel settimo capitolo, Il dominio
metaforico, aperto da una riflessione di Leopardi nello Zibaldone (7 settembre
1821): dove si riconosce come specifica del vero poeta «la facoltà e la vena delle
similitudini», cioè la scoperta di «vivissime somiglianze fra le cose». In altre
parole, l’invenzione di metafore nuove e insieme la capacità di concretizzare
l’astratto: un presagio, insomma, del «correlato oggettivo» di Eliot e di Montale.
Venendo invece alle radici medievali di questa tendenza, occorrerà far
riferimento alla transumptio dei dettatori e di Boncompagno da Signa, veri e
propri sistemi metaforici fondati sul parallelo fra caratteristiche umane ed
animali, ad esempio dando luogo alle coppie “astuto-volpe”, “imitatorescimmia”, “avido-lupo”, eccetera. Dante va ben oltre su questa strada,
esorcizzando ogni eccesso di stilizzazione ed evitando il rischio degli stereotipi.
Seguiamo la serie dei campioni, dalla selva di spiriti e dal castello luminoso
del Limbo (Inf. IV 66 ss. ) alle falde di fuoco del settimo cerchio in «dilatate
falde, / come di neve in alpe sanza vento» e alla «tresca / de le misere mani»,
quasi una “danza forsennata” delle mani dei violenti puniti in quel sabbione
rovente (XIV 29-30 e 40-41); o – in fondo a p. 1 – alle metamorfosi dei ladri
(XXV 58 ss.), col serpente che si avviticchia al corpo di Agnello con la forza
dell’edera e la mescolanza delle due nature paragonata al procedere della fiamma
in una carta, «che non è nero ancora e ’l bianco more». Segue l’immagine
dell’amore (Purg. XVIII 28 ss.), paragonato a un fuoco che tende verso l’alto, in
polemica con l’icona negativa di Guido Cavalcanti nella celebre canzone Donna
me prega (dove l’amore viene ragguagliato al buio dell’anima sensitiva). Ma
subito dopo puntiamo sull’immagine con cui Ugo Capeto, progenitore della
terza dinastia d’oltralpe, prima di raffigurare Filippo il Bello, «novo Pilato», nelle
sue azioni piratesche, specie quelle contro Papa Bonifacio VIII (lo schiaffo di
Anagni) e contro l’ordine dei Templari (XX 85 ss.), definisce l’ influsso perverso
della casa di Francia, «la mala pianta / che la terra cristiana tutta aduggia» (XX
43-44) e riflettiamo come a quest’ombra malefica si contrapponga l’influsso
benefico di san Francesco d’Assisi, visto come un sole che, appena sorto,
«cominciò a far sentir la terra / de la sua gran virtute alcun conforto» (Par. XI
55-57). All’icona dei campioni dell’avidità si contrappone così quella luminosa
dell’eroe della Povertà.
Di mezzo, si colga la novità della metafora con cui si evoca il momento,
fatale per Dante, del rivolgimento politico in Firenze col prevalere dei Neri sui
Bianchi grazie all’intervento “pacificatore” di Carlo di Valois (Purg. XX 70-75),
un vero e proprio tradimento favorito dal pontefice, che fa esplodere le
contraddizioni della città, «a Fiorenza fa scoppiar la pancia»: una metafora
143
preparata, come spesso avviene nel poema, da certe approssimazioni precedenti,
la pancia gonfia dell’idropico maestro Adamo, simile a un tamburo (Inf. XXX
49-57, 102-103, 119, 123) e il ventre mefitico della «femmina balba» (Purg.
XIX 32-33). La tensione e la puzza vengono così trasferite dalle persone alla
personificazione della città, vista come una donna malata o gravida di peccati,
giunta cioè a tale punto di tensione che la lancia del tradimento giunge a far
scoppiare tutte le sue contraddizioni.
Sempre su questa linea, del concrescere e dello svilupparsi di certe linee
metaforiche in Dante, si vada al primo campione di p. 3. Siamo ancora in
presenza del canto in cui san Tommaso rievoca la figura e la vicenda terrena di
san Francesco. Ebbene, al v. 93 si allude al primo sigillo con cui papa Innocenzo
III concesse la sua approvazione alla “regola” del fondatore dell’ordine
minoritico: dunque, con allusione letterale allo strumento con cui si garantisce
il valore e l’autenticità di un documento. Ma al v. 107 nell’espressione ultimo
sigillo si debbono riconoscere le stimmate, che sono appunto, metaforicamente,
il segno dell’approvazione suprema di Cristo, inciso sulla carne del santo, quasi
fosse un messaggio divino inviato dal cielo sulla terra, un dono autorizzato da
Dio stesso. Si potrebbe poi ritessere la storia o la formazione di questa metafora
del “sigillo” attraverso il poema (come ho tentato di fare nel mio libro del 2001),
a partire dal suggel di Inf. XIX 21 nel valore di “parola definitiva”, fino ad
arrivare al si disigilla di Par. XXXIII 64, ultimus cantus, applicato alla neve che
lentamente si scioglie, correlato oggettivo dello svanire delle estreme esperienze
dell’Empireo nella memoria del poeta. Ma una volta detto che questa insistenza
di Dante sul campo metaforico del “sigillo” si giustifica solo in una civiltà
dominata ancora dal mezzo epistolare e dalla concretezza cartacea dei
documenti (la mia generazione ha fatto ancora in tempo a ricevere dal Ministero
della Pubblica Istruzione la lettera di nomina a professore di liceo inclusa in una
busta suggellata con un timbro di ceralacca), guardo l’orario e penso di avere
abusato abbastanza della vostra pazienza. Rinuncio perciò a illustrarvi i troppi
esempi che vi avevo preparato e vi ringrazio per l’attenzione generosa.
144
SERGIO CRISTALDI
Artisti nella prima cornice
1. Gli stracci di Aracne
L’unità che lega i tre canti purgatoriali dedicati alla superbia si documenta,
oltre che nel gioco delle corrispondenze formali, anche in alcune linee tematiche
svolte organicamente, fra cui ha innegabile spicco l’indagine sugli artisti, sulla
tentazione autotelica che insidia il loro operare1. In Dante, il fermentare
dell’orgoglio entro l’esperienza artistica non sollecita semplicemente un assillo
privato, ma si fa problema indagato nel metadiscorso, nella riflessione che
l’opera conduce su se stessa, le sue possibilità, i suoi problemi. La posta altissima
di un poema sacro, volto ad abbracciare l’universo intero e lo stesso principio
originante, questa scommessa inaudita di un testo totale, inclusivo di
immanenza e trascendenza, portava inevitabilmente con sé il rischio della
pretesa e del fallimento, un rischio che Dante non rimuove, preferendo invece
una lucida tematizzazione, sia presso i segmenti testuali tradizionalmente
metadiscorsivi, come i proemi, sia in alcuni snodi nevralgici del viaggio
ultraterreno, che è sempre, contemporaneamente, viaggio della scrittura. La
prima cornice purgatoriale rappresentava un’occasione di verifica o, se si vuole,
un passaggio obbligato. L’ampia arcata di Purgatorio X-XII si deve anche
all’esigenza di approfondire analiticamente questa specifica questione.
È ben opportuno che in questi canti si dispieghi un’epifania della superiore
potenza di Dio, a delegittimazione di ogni pretesa umana, oggettivamente senza
fondamento, sconfitta in partenza per la sua intrinseca friabilità. Ma va ancora
notato che l’omnipotens Deus si pone qui sotto specie di artista impareggiabile,
fabbro di realizzazioni che nessun altro laboratorio può eguagliare, per quanto
attrezzato e all’avanguardia. Gli exempla euforici e disforici intagliati nella
roccia, rispettivamente sulla parete e sul pavimento, vengono difatti enfatizzati
come saggio strepitoso d’arte, un’arte non umana, ma frutto della perizia di Dio.
Conta dunque, prima ancora che il contenuto delle scene paradigmatiche di
vizio e virtù, la loro rappresentazione: quali che siano gli specifici casi di volta
in volta in oggetto, già essa costituisce una lezione imprescindibile, e non meno
per il personaggio-poeta che per le anime. Evidente che siffatta lezione riguardi
in particolare la presunzione degli artisti, oggettivamente screditata nel
confronto con l’energia creativa del Deus artifex. In quanto arte – e non
1
Cfr. P. MARINI, «La gloria de la lingua» nel trittico dei superbi. Considerazioni sul nodo arteonore-superbia-umiltà nella «Commedia», in «Italianistica», XXXVI (2007), pp. 65-88.
145
apparizione prodigiosa, non squarcio visionario – gli intagli aderiscono al
sistema semiotico di riferimento, nella fattispecie la scultura, e rispondono a
imprescindibili principi estetici, s’intende quelli vigenti all’epoca e largamente
condivisi, come la falsariga della mimesi e l’obiettivo didascalico. In quanto arte
divina, essi toccano peraltro un culmine assoluto, superando dall’interno il
condizionamento del mezzo, forzando la pietra a farsi movimento, parola,
melodia, effluvio, al di là della connaturata determinazione materiale, non
propriamente dissolta, ma vinta, resa trasparenza e non più velo opaco. Il
fruitore si trova di fronte a una semiosi che, rimanendo tale, rivela senza
contemporaneamente celare, porge senza nulla togliere, come invece si verifica
fatalmente in ogni prodotto artistico; e il contrasto tra gli occhi spinti a
percepire un canto o un profumo, in una sorta di vista sinestetica, e l’udito che
smentisce, l’olfatto che dice no (Purg., X, 58-63), comprova da una parte che
un’opacità è sfondata, dall’altra che in gioco è pur sempre una particolare
materia, altrimenti non sarebbe lecito parlare di arte. La formidabile presa
mimetica, in grado di restituire il vero nella totalità delle sue componenti, e non
secondo una sola dimensione – in questo caso, le masse dei corpi, i volumi delle
cose, aggancio proprio della scultura –, assottiglia al massimo, però, la linea
divisoria tra il darsi della rappresentazione e il darsi dell’oggetto. È a tal punto
combaciante, l’esito della mimesi, da azzerare quasi la dialettica tra copia e
originale. Piuttosto che un duplicato, più o meno felice, poco o tanto
somigliante, si staglia in certo modo il referente stesso, con tutti i suoi lati
sensibili, nella sua mossa cadenza temporale, e il pellegrino-spettatore
contempla l’evento in questione esattamente come i suoi originari testimoni:
«non vide mei di me chi vide il vero» (Purg., XII, 68). A indiziare una simile resa
varrà allora il nome di uno scultore insigne, ma come termine di un infinito
superamento, che trascende ogni eccellenza umana, anzi finisce per oltrepassare
la natura stessa: «non pur Policleto / ma la natura lì avrebbe scorno» (Purg., X,
32-33). La gerarchizzazione medievale di natura e arte, che Dante espressamente
approvava, viene scavalcata dal gesto di Dio, sicché all’opera artistica intenta a
imitare la natura, subentra la straordinaria opera divina, che non si limita a
riprodurre, ma senz’altro produce, dispiegando «non […] una ipernatura, ma, si
direbbe, una natura prodotta una seconda volta»2.
È da credere che la scelta di una delle arti figurative risponda al privilegio
che la gnoseologia scolastica assegnava alla vista, il senso massimamente
conoscitivo, nonché all’accento che i teologi ponevano sulle immagini,
raccomandandole come strumento di edificazione particolarmente efficace:
2
N. MINEO, Lettura del canto XII del «Purgatorio», in ID., Saggi e letture per Dante,
Caltanissetta-Roma, Sciascia Editore, 2008, pp. 187-229, a p. 223.
146
secondo una convinzione radicata nei maestri di sacra dottrina, l’apparato
iconico equivaleva a una «Biblia pauperum», ed era assai consigliabile nei luoghi
di culto, a soccorso degli illetterati e a giovamento comune, data la sua speciale
incisività, destinata a durare maggiormente nella memoria3. E se, all’interno del
figurativo, l’opzione dantesca premia in particolare la scultura, distribuendo
l’aggetto degli altorilievi sulla parete e l’intarsio dei bassorilievi sul pavimento,
ciò probabilmente si deve alla volontà di sottolineare la capacità del sommo
Artefice, vittorioso su una materia particolarmente sorda4. Tanto più eloquenti
e propedeutici gli intagli purgatoriali, che generano anzitutto ammirazione per
lo Scultore divino, riconoscimento della sua eccellenza, imparagonabile ai
conati degli artefici terreni, se il «visibile parlare» riesce «novello a noi perché qui
non si trova» (Purg., X, 96).
La sperequazione – giova ribadirlo – è strutturale: mentre l’artefatto divino
è in grado di coinvolgere ogni sfaccettatura sensibile-concreta, l’artefatto umano
resta di necessità unidimensionale, fortemente connotato dal tramite prescelto, si
tratti della pietra, del colore, della parola, della melodia, e intrattiene col vero una
relazione di gran lunga più debole, inevitabilmente parziale. Per conseguenza,
non viene forzato il rispettivo canale di ricezione: l’impatto sulla sfera sensoriale
di pertinenza la sollecita in maniera non sinestetica. È chiaro che il solco
semiotico di riferimento è condicio sin qua non: non c’è scultura fuori dalla pietra,
come non c’è poesia fuori dalla parola, e l’immagine non può che interpellare la
vista, il suono proiettarsi verso l’udito. Ma il mezzo, nell’arte umana, costituisce
un condizionamento forte, per cui o si staglia il “visibile”, o si dipana il “parlare”,
e l’uno esclude l’altro, senza possibilità di recupero. La resa sinestetica è qui un
traguardo fuori portata e il linguaggio visivo o verbale resta vincolato alla sua
specializzazione, traccia monodica che non riesce a oltrepassare se stessa. Dalla
contemplazione delle sculture purgatoriali, della loro stessa forma, poliedrica e
multivalente, nasce così, insieme alla meraviglia per la prova stupefacente di Dio,
anche il senso dell’angustia che contrassegna i prodotti umani, costretti sempre a
ridurre la ricchezza del mondo sensibile, ad appiattirla su un solo binario, proprio
nel momento in cui si prefiggono il calco efficace5.
3
4
5
Cfr. A. BATTISTINI, La “speranza de l’altezza”. La retorica patetica in «Purgatorio» XII, in
«L’Alighieri», n.s. XLIV (2003), pp. 95-108, alle pp. 96-97. Riguardo all’incidenza
dell’immagine sulla memoria cfr. inoltre P. VESCOVO, Ecfrasi con spettatore (Dante,
«Purgatorio», X-XVII), in «Lettere Italiane», XLV (1993), pp. 335-360.
Da ripensare in questa direzione la riserva di G. FALLANI: «Può sembrare che Dante abbia
chiesto troppo alla scultura: racconto e visione, parole e sentimento, dialogo e azione
drammatica. Il marmo è rigido e silenzioso» (Il canto X del «Purgatorio» [1953], Torino, SEI,
1964, p. 30).
Notevole F. TATEO, Teologia e «arte» nel canto X del «Purgatorio», in ID., Questioni di poetica
dantesca, Bari, Adriatica Editrice, 1972, pp. 145-158.
147
Si è attribuita, peraltro, a Dante una scommessa audacissima, se non
proprio superba. Con la sua analitica rassegna di questi intagli, trasferiti dalla
ricettiva contemplazione del protagonista all’enunciazione laboriosa del
narratore, Dante avrebbe veicolato sottotraccia un’analogia tra l’arte divina e la
propria, capace di appunto di accostare i contenuti effigiati dal sommo scalpello
e, insieme ai contenuti, anche la potenza di un procedimento inusitato,
piuttosto nuova produzione che non ausiliaria riproduzione. L’affondo critico
riesce stimolante. Fino a che punto è anche ricevibile? Non c’è dubbio:
traducendo i rilievi straordinari nei suoi versi, Dante si impegna a translitterare
il plasticismo della scultura nella linearità dei verba, e quasi risponde,
chiasticamente, con un parlare visivo al «visibile parlare»6. Ma non si annida
alcuna intemperanza in un cimento del genere. Intanto, l’imperizia dell’arte
umana incapace di accogliere sinteticamente il reale nella varietà e organicità
delle sue determinazioni sensibili, questa inettitudine mai vinta, mai scalzata,
riesce sconfortante a motivo di un’insopprimibile aspirazione a quel risultato. Il
campo dell’arte è meno un cimitero di rinunce che una piattaforma di tensioni
sempre insorgenti, come dimostra l’avvicendarsi incessante delle scuole, delle
poetiche, dei protagonisti; altrimenti, la doverosa coscienza del limite
perderebbe drammaticità, si ridurrebbe a una ritirata senza attrito interiore,
pronta ad ammainare un vessillo floscio in partenza. Del resto, l’impeto
dell’artista non fa che assecondare la direttiva della mimesi, che chiede una presa
sul reale non dimidiata. Ben nota l’argomentazione di Inferno XI sull’arte in
senso lato, vale a dire nell’accezione sovraordinata di operazione tout court: il
dinamismo umano si innesta entro quello naturale, con una spinta emulativa
che Dante rende attraverso l’immagine dell’allievo volenteroso, impegnato ad
approssimare il più possibile il livello del magister. Così è l’uomo di fronte al
modello della natura: «l’arte vostra quella, quanto pote, / segue, come ‘l maestro
fa ’l discente» (Inf., XI, 103-104). Sforzo encomiabile e anzi doveroso, se la
deviazione ostinata dal percorso naturale è, in sede etica, anomalia grave e
ingiustificabile, sanzionata infatti per l’eternità da un settore ad hoc dell’Inferno.
Entro quell’operazione particolare che è l’arte in senso stretto – afferente non
alla sfera dell’agere, bensì a quella del facere – ciò si traduce, appunto,
nell’imitazione come principio estetico, ad esempio, l’obbligo, in letteratura, di
6
Cfr. K. STIERLE, Canto XI, in M. PICONE e G. GÜNTERT (a cura di), Lectura Dantis Turicensis,
Purgatorio, Firenze, Cesati, 2001, pp. 157-172, a p. 171. Aveva già insistito sull’azzardo
dantesco, mirante a emulare Dio, T. BAROLINI, Ricreare la creazione divina: l’arte aracnea nella
cornice dei superbi, in EAD., La «Commedia» senza Dio. Dante e la creazione di una realtà
virtuale [tr. it. di The Undivine Comedy. Detheologizing Dante, Princeton, Princeton University
Press, 1992], Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 173-198.
148
un dire non divergente dal fatto (Inf., XXXII, 12). Già lo sappiamo: un
obiettivo del genere, per i motivi che abbiamo visto, non può essere mai
ottemperato pienamente; esso rimane nondimeno come prospettiva, come
orizzonte attrattivo verso cui ogni nuova opera si protende, lasciandosi alle
spalle l’incompiutezza delle precedenti. Spogliarsi di ogni pretesa di perfezione
non significa, per l’arte, abdicare a un fondamentale impegno, che essa invece
perseguirà «quanto pote».
Il passo ulteriore di Dante è rivivere la medesima tensione rispetto a un
termine che non è più la natura, bensì l’arte di Dio. Si noti. Nella sua accezione
medievale, la mimesi si muove sempre sulla scorta di un gesto divino. Dante lo
richiama in maniera esplicita in Inferno XI: assecondando la natura, che è a sua
volta obbediente seguace del suo Fattore, l’arte tallona, in maniera mediata (da
«nepote», v. 105), le orme di Dio. Ciò comporta l’assoggettamento a un divario
ancor più incolmabile, poiché il primus agens detiene un’iniziativa assoluta,
senza alcun precedente, senza alcun supporto (fosse pure una materia neutra e
inerte), accampandosi quale creatore ex nihilo, e non demiurgo; e difatti, ai sensi
della teologia scolastica, l’uomo non crea, e nemmeno la natura crea, poiché non
è nella loro disponibilità produrre l’essere delle cose7. Ma se una dinamica
imitativa si determina verso la natura, ciò comporta, in qualche modo,
un’imitazione del Dio che governa la natura; se pure imitazione indiretta, e
tanto più approssimativa e manchevole. Ebbene, i canti della prima cornice
inscenano una situazione in cui l’anello intermedio è saltato e il confronto è
senz’altro con un prodotto artistico che esce da mani divine. Se esso presenta
una multidimensionalità sinestetica, anche l’arte dantesca si sforzerà di evadere
dall’unidimensionale e di conseguire, a onta della materia delimitata, una
semiosi polivalente. Senza per questo centrare l’obiettivo, in difetto com’è delle
risorse necessarie. La rassegna degli intagli non è servile e non è trionfalmente
paritetica, rinnova la proiezione del discepolo verso il traguardo su cui si è
installato un superiore magistero. Certo, l’accostamento vale fino a un certo
punto: «Qual di pennel fu maestro o di stile / che ritraesse l’ombre e ’ tratti ch’ivi
/ mirar farieno uno ingegno sottile?» (Purg., XII, 64-66). La maestria di Dio
somiglia a quella umana e insieme la trascende, appartiene a logica affine e pur
diversa: contagia sì, sollecita l’emulazione, come i più eminenti pittori o
letterati, ma rimane fuori portata. Probabile che la dialettica tra la scultura e la
7
A commento di Inf., XI, 105 («vostr’arte a Dio quasi è nepote»), è stato citato TOMMASO
Summa Theologiae, I, 45, 8, 1: «In qualibet operatione naturae et artis est creatio».
Cfr. P. GIANNANTONIO, Il canto X del «Purgatorio», in «Critica Letteraria», V (1977), pp. 3-29,
a p. 11. Si noti, però, che Tommaso coinvolge l’asserto in parola per rettificarlo, rimanendo
sulla scia della sua tesi di fondo, secondo cui «creare est causare sive producere esse rerum», il
che spetta a Dio solo (I, 45, 6, r.).
D’AQUINO,
149
parola, gli esempi visti dal pellegrino e quelli descritti dal narratore, intenda
sottolineare un simile scarto, non la differenza orizzontale tra due sistemi di
segni convocati a certame, bensì quella verticale tra la natura prodotta
nuovamente da Dio e la sua resa attraverso una semiosi vicaria. Da valorizzare,
in questo senso, il richiamo non solo all’ékphrasis, ma soprattutto al titulus
medievale, «sottoscrizione versificata dell’immagine che esso spiega»8. Semmai
va precisato che, a differenza del titulus, sincronico e simbiotico con l’icona
corrispettiva, la descrizione dantesca si snoda in absentia, separata dagli intagli;
non per questo li eclissa, anzi risulta ancora più struggente nel suo tendersi verso
una perfezione non più disponibile («qui non si trova»).
Se passiamo adesso al contenuto degli exempla e puntiamo l’obiettivo sulla
terza anta del trittico, esaminando i casi di superbia punita che Purgatorio XII
squaderna, siamo attratti dalla terzina su Aracne, la tessitrice lidia fin troppo
consapevole delle sue doti e della sua reputazione, al punto da sfidare Minerva
in una perigliosa gara di abilità (vv. 43-45). Immediato il sentore che il riquadro
costituisca la mise en abyme del plesso tematico da noi appena considerato o, per
esser più precisi e sfatare sin d’ora ogni equivoco, la focalizzazione di un eccesso
nel rapportarsi dell’arte umana all’arte divina. Nonostante la sua concisione, il
passo in parola è dunque caricato di una notevole responsabilità. Consideriamo,
in via preliminare, la collocazione dell’episodio entro la serie. Per la verità, il
numero esatto degli esempi disforici è controverso; confondono le acque, subito
dopo la rappresentazione d’apertura dedicata a Lucifero, le due terzine che
raffigurano rispettivamente Briareo e i Giganti. Se si pensa a un unico episodio,
il computo complessivo delle vicende istoriate dà dodici; solo che questa
soluzione, in apparenza raccomandabile anche sotto il profilo numerologico, per
l’approdo a un multiplo di tre – cifra cardine di questi canti – lascia per altri
versi a desiderare ed è infatti respinta da molti lettori. Il fatto è che in tutti gli
altri casi della filiera si dà costante e perfetta corrispondenza tra singolo
exemplum e singola terzina, corrispondenza rafforzata dall’occorrere, all’inizio di
ogni terzina, di una parola anaforica, che per le prime quattro è «Vedea», mentre
diventerà «O» nella quaterna successiva e «Mostrava» in quella finale. Va
riconosciuto, dunque, che Dante distingue tra Briareo da un lato e i Giganti
dall’altro; per conseguenza, occorre rettificare il totale degli exempla, portandolo
a tredici. Un esito siffatto determina uno spostamento della storia di Aracne
dalla sesta posizione alla settima. Ma anche così l’episodio è al centro, anzi
diviene l’esatta chiave di volta tra sei e sei inquadrature.
8
La definizione, risalente a J. Schlosser e ai suoi sondaggi sulla letteratura artistica, è ripresa e
proiettata sulla descrizione dantesca da D. ISELLA, Gli «Exempla» del canto X del «Purgatorio»,
in «Studi Danteschi», XLV (1968), pp. 147-156, a p. 156.
150
Quale il significato di questa centralità? Il computo che abbiamo adottato
porta ad articolare la serie degli esempi disforici in tre quaterne, sulla base,
appunto, delle parole ricorrenti (la tredicesima terzina, sulla città di Troia, funge
da riepilogo, come indizia, del resto, la sua natura di “congedo”, con le tre
espressioni-perno che occorrono, nell’ordine, all’inizio di ogni verso). La prima
quaterna è relativa a ribelli in guerra contro la divinità; la seconda include
vanagloriosi con un sentimento smisurato delle proprie prerogative, tanto da
ritenersi uguali agli dei, o disobbedire ai loro decreti, o nutrire, in ogni caso, una
febbre di onnipotenza; l’ultima contempla, in contesti familiari e sociali, la
smania di primeggiare e di prevaricare9. Le due quaterne iniziali si apparentano
perché rivolte entrambe al rapporto fra l’uomo e Dio, mentre l’altra insiste sugli
scontri in seno ai gruppi umani, e difatti mostra colpevoli puniti regolarmente
dai propri simili. Ora, Aracne si trova nella seconda quaterna; non muove assalti
al cielo, come Lucifero, Briareo, i Giganti e Nembròt, semmai alimenta
un’autocoscienza a tal punto orgogliosa da non riconoscere nessuno superiore a
sé, presunzione condivisa con Niobe e Saul (nei riquadri precedenti) nonché
con Roboamo (nel riquadro successivo). La centralità della tessitrice lidia entro
la serie globale degli exempla si ridurrebbe allora a quella di un termine medio
(come gli altri della stessa quaterna) fra l’eccesso parossistico e la forma del male
meno virulenta, fra l’abissale protervia di angeli ribelli e di giganti (tale è anche
Nembròt) e l’arroganza tutta terrena dei personaggi di coda, Erifile,
Sennacherìb, Ciro, Oloferne. E in effetti è così, ma questo è solo un aspetto
della questione. Intanto, non va sottovalutato il fatto che i quattro esempi
inaugurali attengono a esseri al di sopra dell’umano, sicché Aracne esprime pur
sempre il culmine del male proprio degli uomini. Si tratta, certo, di un culmine
condiviso con alcuni affini, con Niobe, Saul, Roboamo. E all’interno di questa
cerchia gioca la legge dell’alternanza tra mitologia e Bibbia e, ancora, tra
femminile e maschile, capacità generativa e responsabilità politica: il mondo
dell’arte che Aracne rappresenta è uno dei termini di un simile avvicendamento,
entra in un monitoraggio che si sposta in maniera pendolare dall’una all’altra
sfera di attività. Eppure, quella collocazione al centro esatto dell’intero arco
degli esempi possiede un surplus di significato, indiziando la speciale attenzione
del poeta al problema dell’arte, e al plesso arte-superbia-umiltà.
La temeraria audacia di Aracne aveva già mobilitato un’ampia pagina delle
Metamorfosi10, senza dubbio stimolante per l’autore della Commedia, anche se
tutt’altro che risolutiva. La curvatura impressa al mito dal poeta pagano è
È, in sostanza, la decodifica di E.G. PARODI, Gli esempi di superbia punita e il «bello stile» di
Dante, in ID., Poesia e storia nella «Divina Commedia», Napoli, Perrella, 1920, Venezia, Neri
Pozza, 1965, pp. 147-151.
10
OVIDIO, Metamorfosi, VI, 1-145.
9
151
inequivocabile. Ammirata dagli uomini e dalle stesse ninfe, Aracne rifiuta di
dirsi allieva di Pallade e non esita a gareggiare con la dea apparsa al suo cospetto;
questa raffigura vicende di mortali colpevoli di hybris e puniti con degradanti
metamorfosi, quella mostra divinità che assumono sembianze zoomorfe per
ingannare innocenti fanciulle; nessuna delle contendenti riesce a prevalere,
poiché le tele di entrambe sono eccelse, e se le figure della dea danno
l’impressione della verità, quelle di Aracne mirano allo stesso effetto, anzi lo
raggiungono in modo più incisivo, con enorme irritazione dell’augusta
avversaria, lambita addirittura dall’invidia. La gara è allora troncata da un gesto
violento di Pallade, che squarcia la tela accusatrice degli dei e con la spola
percuote in fronte Aracne; non sopportando l’onta, la fanciulla si impicca e
viene trasformata, a quel punto, in ragno. Cospicuo il debito di Dante verso
l’auctor latino11; non meno rilevanti le rettifiche, funzionali a una mirata
risignificazione.
Intrigante la circostanza che proprio questo passo di Ovidio dispieghi una
fenomenologia del «visibile parlare»: sulle mirabili tele, Cinira «iacens lacrimare
videtur», ed Europa, incalzata sulla spiaggia dal toro («verum taurum, freta vera
putares»), sembra «comites clamare suas»12. Dante ha dunque prelevato dalle
Metamorfosi il portento dell’icona dotata quasi di parola e, in aggiunta, di
movimento. Ma a riguardo si innestano subito sostanziali divaricazioni dalla
fonte. Ovidio attribuiva all’uno e all’altro ordito l’immagine parlante: la sagoma
di Cinira, che pare davvero in lacrime, è opera di Pallade, quella di Europa,
accorata nel richiamo, spetta invece ad Aracne. Nella situazione ovidiana,
inoltre, la fanciulla raggiunge l’esito prodigioso in maniera assolutamente
autonoma dalla dea, avvalorando il suo iniziale rifiuto a dirsi allieva di costei, a
riconoscerla come propria maestra: «scires a Pallade doctam. / Quod tamen ipsa
negat tantaque offensa magistra»13. Per Dante, invece, il «visibile parlare» è, in
origine, prerogativa della sola arte divina e, semmai, oggetto di imperfetta
imitazione, secondo il paradigma del rapporto maestro-discepolo, e con la
variante di una primazia inattaccabile del primo rispetto al secondo, destinato a
rimanere in posizione subordinata, eterno apprendista, principiante sempre in
cerca di suggerimenti. Quando Dante attrezza la propria scena, dispiegando gli
intagli purgatoriali che l’io narrato contempla e l’io narrante descrive, impone
senz’altro questi nuovi parametri; non ritiene di poterlo fare nel momento in cui
Cfr. T. BAROLINI, Aracne, Argo e san Giovanni: l’arte trasgressiva in Dante e Ovidio, in EAD., Il
secolo di Dante. Viaggio alle origini della cultura letteraria italiana [tr. it. di Dante and the
Origins of Italian Literary Culture, New York, Fordham University Press, 2006], Milano,
Bompiani, 2012, pp. 245-265.
12
OVIDIO, Metamorfosi, VI, 100 e 104-106.
13
Ibidem, VI, 23-24.
11
152
riedita il mito ovidiano, e allora, semplicemente, taglia lo svolgimento della gara
e ci offre soltanto la conclusione. Le forbici depennano, ovviamente, anche il
vantaggio acquisito da Aracne, mortificata, secondo Ovidio, non già da una
bravura superiore, ma solo dal furore invidioso che le straccia la magnifica tela.
Nella Commedia non vi è spazio per il dispiegarsi della smagliante arte aracnea;
acquisiamo, anzi, dall’episodio infernale di Gerione che il manto screziato di
quel mostro supera, col suo lussureggiante cromatismo, i colori della pur
reputata fanciulla: «né fuor tai tele per Aragne imposte» (Inf., XVII, 18).
Rispetto alla realtà escatologica, che è poi la realtà definitiva, il prodotto più alto
del Deus artifex, la perizia dell’orgogliosa tessitrice resta indietro. Non casuale,
allora, il silenzio di Purgatorio XII sulla spettacolare performance della donna
mortale e sulla brutalità che lacera la prova evidente di una bravura eccelsa, forse
addirittura superiore a quella divina. Dante procede a un’espunzione sistematica
degli elementi incompatibili con la sua prospettiva, e lo comprova il disinteresse
verso le vicende effigiate da Aracne, altrettante denunce degli inganni divini,
degli innumerevoli stupri a danno di vittime fragili ed esposte, come in
definitiva la stessa accusatrice. Nessuna attenuante concede la Commedia alla
«folle Aragne», anzi nessun margine, fosse quello di uno strazio finale
meritevole, se non altro di pietà. «Pendentem Pallas miserata levavit», asseriva
Ovidio, attestando la compassione insorta nella dea e commiserando, anche da
parte sua, l’«infelix»14; nell’inquadratura dantesca c’è solo lo scempio della tela
che tormenta gli ultimi attimi umani della tessitrice «già mezza ragna», curva e
«trista» su quella maceria.
A indicare l’opera lacerata, Dante seleziona il plurale «stracci», ben più
marcato disforicamente rispetto all’etimo ovidiano – «Et rupit pictas, caelestia
crimina, vestes»15 – e volto a enfatizzare una disgregazione, la catastrofe
dell’intero ridotto in schegge. Secondo una concezione già matura all’altezza del
De vulgari eloquentia, e poi ereditata dal poema sacro, l’opera artistica è una
compiuta unità, esito di un accurato lavoro di connessione e di sintesi; di qui il
credito concesso alla metafora tessile. Il componimento poetico è appunto un
“testo”, un “tessuto”; e a formulazioni del trattato latino come «contextus carminum» (II, xi, 1), «habitudo quedam quam carmina contexendo considerare
debemus» (II, xii, 1) e simili, corrispondono, nella Commedia, le «carte / ordite
a questa cantica seconda» (Purg., XXXIII, 139-140), il far punto del poeta
«come buon sartore / che com’elli ha del panno fa la gonna» (Par., XXXII, 140141)16. La deflagrazione dell’opera in brandelli, in frammenti residuali, segna
OVIDIO, Metamorfosi, VI, 134-135.
Ibidem, VI, 131.
16
Un approfondimento, con ulteriori esempi, offre G. GORNI, La metafora di testo, in ID.,
Metrica e analisi letteraria, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 137-152.
14
15
153
allora il suo fallimento, il rovescio di una cifra compatta che pure poteva essere
raggiunta, come Dante ancora crede, restando in questo inconfondibile con
Petrarca, rassegnato a ipostatizzare la frammentarietà quale destino inesorabile17.
La parabola involutiva di un processo di elaborazione investito da una forza
centripeta è, per l’autore della Commedia, l’esito di una scelta erronea, quella
scelta che ha puntato tutto sul fare, ritenuto autosufficiente e assoluto,
addirittura in grado di competere col fare divino. Ai sensi di una nota
definizione teologica, la superbia è aversio a Deo e corrispettiva conversio ad
commutabile bonum: in rotta con la divinità, detestata e accusata, Aracne cerca
la sua consistenza nell’opera, nella realizzazione perfetta, e trova il contrappasso
dei frantumi inespressivi. Fallito l’obiettivo di una sintesi suprema, di una
sinestesia in grado di cooptare i vari sistemi semiotici e i diversi canali sensoriali,
il textus conosce l’opposto esito del totale spappolamento, ultima percezione
della tessitrice umiliata, che ha malamente scommesso, andando incontro
all’inevitabile sconfitta.
Entro il macrotesto della Commedia, Aracne trova immediata rispondenza
nelle Piche e in Marsia, a loro volta in competizione con l’arte divina, come
tramandato ancora da Ovidio, teologo dei Gentili e artefice della Bibbia pagana.
Aderente all’esito delle narrazioni ovidiane, dove la vittoria degli dei è
immancabile, Dante si tiene sempre le mani libere rispetto alla parabola che
conduce a quell’explicit, e così persegue ogni volta la sua coerente strategia di
risignificazione. Sintomatica la versione della gara tra le Pieridi e le Muse. Nelle
Metamorfosi, le nove sorelle, udito il responso sfavorevole delle Ninfe, a cui era
toccato di arbitrare, insorgevano con veementi proteste, ritenendosi penalizzate
a torto18; tutt’altro andamento presso Purgatorio I, con le sciagurate sfidanti
annichilite e in preda al panico al risuonare del canto divino che, nella sua
vertiginosa superiorità, ipoteca il verdetto e fa disperar perdono. Per Dante non
ci sono dubbi, il trionfo degli dei discende dalla loro stupefacente prestazione,
non da una torva aggressività, da un veemente sabotaggio della prova altrui, e
Pallade, le Muse, Apollo guadagnano una palma che non si discute. Entro il
riferimento al mito, Purgatorio I chiama in causa lo stesso Dante, come artefice
impegnato, anche lui, in una impresa assai ardua; una mossa replicata dal
parallelo proemio paradisiaco, in margine all’evocazione di Apollo e Marsia.
Esplicita, nell’uno e nell’altro contesto, l’auto-collocazione sull’asse divino
piuttosto che su quello umano, il che potrebbe rinfocolare il sospetto, indiziare
Sintomatico che Petrarca finisca per identificarsi con Aracne: cfr. M. PICONE, Dante nel girone
dei superbi, in «L’Alighieri», n.s. XLVI (2005), pp. 97-110, a p. 105.
18
«At nymphae vicisse deas Helicona colentes / concordi dixere sono. Convicia victae / cum
iacerent […]» (OVIDIO, Metamorfosi, V, 664-665).
17
154
una superbia dell’autore, certo del proprio rango sovrumano, della statura che
lo assimila alla divinità. Verrebbe qui alla luce un orgoglio solo implicito nel
trittico purgatoriale, anche se disseminato lungo la rappresentazione e
facilmente enucleabile. Ma occorre esser giusti. Dante ha parte con le Muse e
con Apollo perché ne domanda l’aiuto e ne assimila l’ispirazione, svuotandosi di
sé, al contrario appunto delle Pieridi e di Marsia; la sua enunciazione è in realtà
enunciazione altrui, al punto che nemmeno il titolo di auctor più gli spetta,
semmai quello di scriba e portavoce, a servizio di un dettato che affiora in lui
senza venire da lui. È a questa condizione che si può parlare come Dio, nella
misura, s’intende, accessibile a un veicolo umano, latore in ogni caso di echi, di
bagliori dimidiati: «O divina virtù, se mi ti presti / tanto che l’ombra del beato
regno / segnata nel mio capo io manifesti […]» (Par., I, 22-24). Nemmeno la
Commedia è l’ultima parola sul suo referente, sottratta nei secoli, per la
sublimità dell’oggetto e la resa ispirata, a ogni insidiosa concorrenza, al contrario
si presenta come «poca favilla», nell’auspicio che migliore preghiera e più
copiosa grazia inneschino con diverso successo la «gran fiamma» ancora da
venire (v. 34), dichiarazione che riapre i cancelli di una ricerca poetica
inesauribile. Al suo accamparsi sul proscenio, e in un luogo strategico come
l’introduzione metadiscorsiva alla terza cantica, l’autore non scioglie dalla
reticenza un orgoglio a lungo represso, coniuga invece magnanimità e umiltà,
sentore di un’indubitabile grandezza e persistente nozione del limite, laddove la
grandezza si inscrive sotto l’esponente del dono divino, mentre il difetto sta sul
versante dell’umana natura19. Quanto ai canti dei superbi, l’assenza di analoghe
proiezioni autoriali non dipende certo dall’occultarsi di un Ego ipertrofico
durante severi esercizi spirituali – manovra che non riuscirebbe peraltro a frenare
l’impennata di un’ekphrasis superba, segretamente compiaciuta della sua gara
con un originale tanto elevato –, bensì dall’opportunità di una messa in rilievo
del tema ascetico: per il momento, deve imporsi la catastrofe di Aracne, con la
sua dura lezione, ci sarà tempo per ritrovare, al di là della tracotanza mortificata,
l’equilibrio di un’umiltà magnanima, nutrita da Apollo e da Minerva, dalle
Muse che orientano il viaggio non autonomo del testo.
2. Quella gloria che è vana
Non è difficile trovare un collega della sciagurata fanciulla fra gli spiriti a
colloquio con Dante in Purgatorio XI. Naturalmente, è diversa la sorte finale,
19
Su magnanimità e umiltà nell’opera dantesca, P. MARINI («La gloria de la lingua» cit., p. 69,
n. 1) cita un qualificante passo tomistico: «Magnanimitas ergo facit quod homo se magnis
dignificet secundum considerationem donorum quae possidet ex Deo […]. Humilitas autem
facit quod homo seipsum parvipendat secundum considerationem proprii defectus» (Summa
Theologiae, II-IIae, 129, 3, ad 4um).
155
determinata dalla resipiscenza e non più dall’ostinazione. Ed è minore la colpa
in sé e per sé. Se, infatti, esaminiamo i curricula degli espianti incontrati dal
pellegrino in questo canto, non troviamo nulla che faccia pensare a una guerra
contro la divinità, e nemmeno a una considerazione di sé così eccessiva da
divenire delirio di onnipotenza, forsennato orgoglio erto fino alle stelle20. Presso
questi personaggi, il «gran disio / de l’eccellenza» – definizione generale della
superbia che, in Purg., XI, 86-87, ricalca, movimentandola mediante
l’enjambement, una tradizionale formula teologica – si è incanalato in
aspirazione a un primato mondano, condito il più possibile di consensi o,
quanto meno, di pubblici onori. Ossessione di tutti, non ancora interamente
smaltita, è infatti il «nome», parola-chiave del canto, accompagnata da un
seguito di lessemi variamente affini, nonché da una trafila di nomi propri in
forte aggetto, senza dire che la richiesta e la rivelazione delle generalità, o
eventualmente il rifiuto di palesarle, alimentano una serie di sequenze
diegetiche21. Se ne deduce che i personaggi suddetti scontano, ciascuno per la
sua parte, ciò che il più rilevante di loro, e anche il più impegnato nella
delucidazione, chiama «vana gloria» (Purg., XI, 91), la inanis gloria, appunto,
delle trattazioni morali, collegata alla superbia, o in essa inglobata come una
delle sue filiazioni22. Non sono però equiparabili, questi espianti, ai vanagloriosi
degli exempla, poiché tutti alieni, stando al testo dantesco, da folle concorrenza
con Dio. Una messa a fuoco può venire da un paradigma teologico autorevole,
nonché in calibrato equilibrio tra sbandamenti verso l’una o l’altra forzatura.
Secondo Tommaso d’Aquino, la inanis gloria sgorga dalla superbia, in quanto la
gloria è il principale dei beni attraverso cui si perviene all’eccellenza. Occorre,
però, evitare una generalizzazione che condurrebbe a impianti accusatori
indiscriminati: «Dicendum quod non omnis qui est inanis gloriae cupidus,
appetit sibi illam excellentiam quae competit soli Deo». Nell’eccellenza, infatti,
e nel suo riconoscimento va posta una fondamentale articolazione, con ricadute
non indifferenti sul piano etico: «Alia enim est gloria quae debetur soli Deo, et
alia quae debetur homini virtuoso vel diviti»23. Non alla prima hanno mirato gli
espianti di Purgatorio XI, ma solo alla seconda; e il loro profilo è meno estremo
sia perché pentiti e salvi, sia perché reduci da perversione non così acuta.
Lo nota N. BORSELLINO, Orgoglio e pentimento («Purgatorio» XI), in ID., Il poeta giudice. Dante
e il tribunale della «Commedia», Torino, Aragno, 2011, pp. 147-158, a p. 150.
21
Cfr. P. FRARE, La retorica del nome e del numero: «Purgatorio» XI, in C. CAPPELLETTI (a cura
di), Il centro e il cerchio, «Convegno dantesco, Brescia, Università Cattolica, 30-31 ottobre
2009», numero monografico di «Testo», XXXII (2011), pp. 123-143.
22
Cfr. C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo, Torino,
Einaudi, 2000, pp. 6 sgg.
23
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, 132, 3, ad 2um.
20
156
Piantato il doveroso distinguo, possiamo inquadrare la figura di Oderisi da
Gubbio, miniatore di carte ridenti e pivot dell’intero canto XI, a riprova della
generale tendenza del trittico a svolgere il tema dell’arte declinandolo spesso e
volentieri con un privilegiato riferimento alla produzione iconica. Ora,
l’episodio di Oderisi si pone in un entre-deux, preceduto com’è dall’incontro con
Omberto Aldobrandesco e seguito dalle considerazioni su Provenzan Salvani. Di
nuovo, l’artista al centro; e qui secondo una maggiore chiarezza di ragioni,
favorita dalla materia più snella del canto. In Purgatorio XI, Dante non ha la
responsabilità di includere tutte le facce del prisma, i più e meno gravi aspetti
che la superbia assume, non deve essere insomma esaustivo nelle partizioni e
abbondante nell’esemplificare, magari a risarcimento di una lacuna per un verso
inevitabile, per l’altro sofferta, l’assenza di un sito specifico per la superbia in un
Inferno strutturato secondo l’Etica Nicomachea. Avendo destinato all’ampia e
articolata fenomenologia l’ultima anta del trittico, egli può modulare l’anta di
mezzo con libertà e agilità, e così seleziona una problematica non abissale, pur
se intensa e grave, e chiama all’appello solo dei contemporanei, secondo la sua
tipica attenzione al presente. Presso queste personalità che condividono la stessa
diramazione del vizio e la medesima epoca, acquista allora importanza, come
fattore individuante, il ruolo sociale, e non meraviglia certo che da una parte ci
sia il nobile (la superbia è tipico peccato feudale) e dall’altra il leader del libero
comune (incarnazione del nuovo potere), in un pendant serrato per il condiviso
denominatore geografico, visto che Omberto appartiene a una schiatta
impiantata nella Maremma e Provenzano è tra i maggiorenti di Siena. Tertium
datur, tuttavia, e si tratta dell’artista, che in linea di diritto non patisce
marginalità nelle gerarchie della fama e, in ogni caso, è destinato al risarcimento
dei posteri, se il suo è il «nome che più dura e più onora» (Purg., XXI, 85),
apoftegma dotato, al suo risuonare, di universale estensione, ma certo sentito da
Dante in immediato nesso con la società del proprio tempo, con la convulsa
transizione dall’uno all’altro sistema sociale, dall’una all’altra supremazia di
classe. La rivendicazione è ferma: il perno gravitazionale attorno a cui ruota ogni
altra rinomanza, del feudatario come del cittadino emergente, è la gloria
artistica. Ma esattamente per questo motivo l’artista è particolarmente esposto,
e il suo vanto diviene obiettivo polemico dell’autocritico Oderisi che, nell’escatologia, depone la sua antica boria, anzi si fa fustigatore inflessibile del vizio
vissuto in prima persona.
Certo, la reprimenda in parola non sferza una distorsione riferibile
all’archetipo di Aracne, e difatti non evoca gare con Dio, bensì fra l’uno e l’altro
maestro, a conservare o conquistare un premio terreno, un primo posto entro
una graduatoria mondana. Non è un nume, il rivale di Oderisi, bensì il collega
Franco Bolognese, e Cimabue non viene sopraffatto da una divinità impunemente sfidata, ma dal più giovane Giotto, venuto dopo di lui e a lui
157
subentrato nell’eminenza. Le tenzoni si svolgono qui su un asse orizzontale, del
tutto immanente: in gioco non è il confronto verticale e acronico tra il limite
umano e l’assolutezza di Dio, ma piuttosto la dialettica temporale tra i
conseguimenti degli artisti, con le nuove botteghe che sopravanzano le antiche,
i movimenti letterari del presente in vittoriosa offensiva su tradizioni ormai
esaurite e, all’interno di ciascuna corrente, l’iniziatore declinante scalzato dal
seguace in irresistibile ascesa. Avevamo già accennato a questa vicenda
incessante, dovuta a una mai solvibile polarità: la spinta alla mimesi si scontra
con l’impossibilità di una compiuta adeguazione del vero, e un simile attrito
incita la continua ripartenza dei tentativi, come dire la reversibilità dei primati.
Immobile e senza possibilità di rovesciamento la classifica dove il divino eccelle
sull’umano; di continuo in evoluzione la hit parade che vede ogni numero uno
puntualmente deposto, Oderisi da Franco Bolognese, il primo Guido dal
secondo, e l’uno e l’altro dall’immancabile, vincente successore24. Se un primato
è disponibile all’artista – fatalmente sconfitto nel confronto con Dio – si tratta
di quello che lo fa eccellere fra colleghi; primato instabile però, destinato a
resistere solo per un certo lasso di tempo, più o meno breve a seconda del
particolare trend, ascendente oppure involutivo. Chi beneficia di un periodo
aureo seguito da etati grosse può sortire più durevole permanenza al vertice, ma
viene per ciascuno il momento di passare la mano, di cedere, in vita o in morte,
la palma che doveva assicurare una sopravvivenza nella memoria. Alla tragedia
vertiginosa dello sfidante della divinità, si sostituisce qui la vicissitudine del
maestro superato e dimenticato, vicissitudine non tragica, semmai
potenzialmente elegiaca25.
Eppure l’intervento di Oderisi si conforma a una rigorosa ascesi, senza
cedere in nessun momento al rimpianto malinconico, tipica deriva dell’elegia.
Ed è a tal punto radicale, questa lezione, da non preoccuparsi di restituire un
qualche pregio all’operosità umana e, nella fattispecie, artistica. Totalmente
immedesimato nel suo nuovo ufficio pedagogico, Oderisi si veste della massima
intransigenza e non concede nulla, ma proprio nulla: la reputazione passa
inevitabilmente, il successo è un vertice affacciato sulla voragine dell’oblio,
spegnersi nella vecchiaia, dopo un’esistenza operosa, è esattamente come morire
bambini, ancora legati al pappo e dindi, i segni sublimi della produzione
artistica pesano sulla bilancia quanto il balbettio infantile. Un punto di
Non affrontiamo, in questa sede, la querelle su colui che è destinato a impadronirsi del
primato letterario, secondo un passo controverso, fomite di contrapposizioni anche sull’esatta
identità dei due Guidi. Cfr. ora C. CALENDA, Due? Quali due? Più di due? Ancora sui «Guidi»
di «Purgatorio» XI, in «Rivista di Studi Danteschi», VII (2007), pp. 355-364.
25
Accenna a questa potenzialità M. MARTI, L’effimero e l’eterno: la meditazione elegiaca di
«Purgatorio» XI, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CLXI (1984), pp. 161-184.
24
158
osservazione altissimo, in grado di abbracciare la fatidica durata del millennio e
poi, sollevandosi ancora, di coincidere con l’eterno, dimostra il carattere
effimero di ogni reputazione: presto o tardi, il maestro a lungo onorato e
l’oscuro fanciullo scomparso prematuramente sono destinati al livellamento
della dimenticanza. E spesso, basta un lasso molto breve per determinare
un’eclissi (parziale o totale), e non di personalità minori, ma degli stessi
capiscuola, ciascuno regolarmente scalzato dal discepolo, ciascuno tradito, per
così dire, dalla sua stessa fortunata innovazione, dal plauso e dal seguito riscosso:
la sorte che condividono Cimabue e il primo Guido, magari anche Oderisi, se
considerato a sua volta un innovatore (e in tutti questi casi, sono in gioco
prosaici decenni, piuttosto che il millennio solenne e biblico).
A proposito di questi rapidi avvicendamenti, si è osservato che Dante sposa
una concezione «agonistica» della tradizione, almeno per quanto riguarda il
panorama recente: Franco Bolognese, Giotto, il secondo Guido assecondano
una lezione per oltrepassarla, per preparare il colpo di stato. Mai dichiarata ai
classici latini, antenati nobilissimi (e remoti), la guerra di successione è
edipicamente ostinata contro i padri (vicini fin troppo), rintuzza la loro
presenza, l’incombere che sottrae ogni spazio26. Opportuno aggiungere che la
concezione agonistica è qui incastonata entro una cornice etica. La competitività
del discepolo-rivale, roso da “angoscia dell’influenza”, appare soprattutto nella
sua funzione demolitrice, interessa in quanto abolisce l’aura di cui si circondava
il maestro, destinato a divenire già in vita un malinconico sopravvissuto, dopo
aver assistito in prima persona al crollo delle sue azioni. Che l’insofferenza dei
giovani verso ogni dittatura soffocante produca anche un avanzamento
culturale, modesto o rilevante, interessa adesso molto poco; conta la
perentorietà con cui le rivoluzioni destituiscono i mostri sacri e li spingono nel
silenzio, che è l’ultimo approdo delle stesse carriere fulgenti, e risucchia entro la
sua indistinzione tutti i nomi acclamati. Funge da detonatore, l’Edipo
agguerrito delle giovani leve; vale a sbriciolare un prestigio in apparenza
inattaccabile. E dalla vicissitudine di ascese e cadute sgorga l’insegnamento
ascetico. L’agonismo che determina una serie di defenestrazioni, abbattendo via
via gli idoli passivamente imitati dai mediocri, costituisce la prova regina della
fallacia di un atteggiamento, scredita un’opzione esistenziale decisa a investire
sulla rinomanza e sull’arte in vista della rinomanza.
Non è genericamente austero, Oderisi, nella sua denuncia. È chiaro, intanto che la demolizione da lui perpetrata non si colloca sotto il segno prudente di
Tommaso d’Aquino, il quale conosceva certo l’argomento sfruttato da Purga-
26
Cfr. P. BOITANI, «Ridon le carte». Guerra e pace nella tradizione, in «Strumenti Critici», XXV
(2010), pp. 3-10. Boitani saggia sul terreno dantesco una nota categoria di Harold Bloom.
159
torio XI, e denunciava a sua volta l’illusorietà di una fama caduca, ma non aveva
al suo arco solo quella freccia, né tendeva la corda a tal punto27. E va da sé che
in un clima del genere latiti anche il maestro di color che sanno, al quale non si
può attribuire alcuna responsabilità di un estremismo ben lontano dal giusto
mezzo. Priva del patrocinio aristotelico-tomistico, l’inflessione di Oderisi
ricorda semmai lo stoicismo, col suo acre disprezzo dei beni esteriori, verso cui
il sapiente deve maturare un distacco, la dose più alta di indifferenza
compatibile con le necessità della vita. Secondo l’etica stoica, che si distingue in
questo dall’impostazione di Aristotele, la virtù va perseguita esclusivamente per
se stessa, e non per i riconoscimenti che può suscitare. Questi sono di necessità
caduchi, come siffatto indirizzo sottolinea energicamente, distinguendosi
proprio per l’insistenza sulla fugacità e la labilità. Si sa che i versi di Purgatorio
XI sulla brevità della fama poggiano sul Somnium Scipionis28 e su un riverbero di
quest’opera nella Consolatio Philosophiae: «Ita fit, ut quamlibet prolixi temporis
fama, si cum inexhausta aeternitate cogitetur, non parva, sed plane nulla esse
videatur»29. Si dovrebbe anche acquisire che note del genere sono estranee alla
linea aristotelica, altrove dominante nella Commedia (vuoi per contatto diretto
del poeta con i testi del filosofo, vuoi grazie alla mediazione tomistica); la
capacità dantesca di integrare gli etimi non può farci smarrire il diverso timbro
di ciascuno.
Accanto all’impronta stoica, si rileva, in Purgatorio XI, quella francescana30.
La spiritualità di Francesco, beninteso, riabilitava le creature, tanto da
qualificarsi come dottrina della riconciliazione di natura e grazia; il Santo
nutriva però una forte diffidenza verso gli onori terreni, diffidenza pronta a
divenire – specie in qualche seguace intemperante, portato all’iperbole ancor più
del fondatore – rigetto e disprezzo. Nel francescanesimo, naturalmente, il no agli
onori era inserito in una prospettiva ulteriore rispetto a quella stoica, valeva a
Cfr. Summa Theologiae, II-IIae, 132, 1. Per Tommaso, la gloria «dicitur vana tripliciter»; perché
proveniente «de aliqua re fragili et caduca», ma ancora in quanto alimentata dagli uomini, il
cui giudizio non è certo, e infine se non riferita al fine debito, «puta ad honorem Dei vel
proximi salutem» (spunto qualificante, quest’ultimo, legandosi al riconoscimento di una
gloria non viziosa).
28
CICERONE, Somnium Scipionis, VII, 24.
29
BOEZIO, Consolatio Philosophiae, II, vii, 18. Ma si veda tutto il passo boeziano (a partire dal
par. 13), che misura l’irrilevanza di diecimila anni rispetto all’eterno; e si leggano le
puntualizzazioni di E. MALATO, La «fama» di Dante. Chiosa a «Purg.», XI, 103-106: «Che voce
avrai tu piú […] / pria che passin mill’anni?», in ID., Studi su Dante, Cittadella (PD),
Bertoncello Artigrafiche, 2005, pp. 493-508.
30
Cfr. A. MAZZUCCHI, Filigrane francescane tra i superbi. Lettura di «Purgatorio», XI, in «Rivista
di Studi Danteschi», VIII (2008), pp. 42-82.
27
160
qualificare l’amor Dei, che basta a se stesso: in Dio, l’asceta possiede tutto, ed è
per questa sovrabbondanza che fa tranquillamente a meno dell’applauso del
mondo. La dominante dell’amore non tacitava peraltro il contemptus, poteva
anche accrescerlo sino a manifestazioni eclatanti, venuta meno la rigida
compostezza stoica e subentrata la giocosa ilarità dei Frati Minori, pronti a dar
spettacolo, a farsi spettacolo sotto gli occhi di tutti, provocando e anche
scandalizzando, se necessario.
Ha notevole aggetto la tessera francescana innestata entro il Padre nostro dei
superbi, quella compatta terzina – «laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore / da
ogne creatura, com’è degno / di render grazie al tuo dolce vapore» (Purg., XI, 46) – che dilata con intenzione l’originale, il «sanctificetur nomen tuum»
dell’oratio dominica31. Viene dunque coinvolto il Cantico delle creature, e non
solo nella sua anafora portante – «Laudato sie, mi’ Signore» – ma ancora nella
mossa d’esordio, che sanciva in maniera inequivocabile l’unicità dell’oggetto
della lode: «Altissimu, onnipotente, bon Signore, / tue so’ le laude, la gloria, e
l’honore et onne benedictione. // Ad te solo, Altissimo, se konfano». In
apparenza, Dante non assume anche l’ultima puntualizzazione; eppure, accende
un’opposizione, ben visibile nell’arco del canto XI, fra la lode a Dio, che è
degna, e il consenso tributato agli uomini, che non merita considerazione. Cade
poi dentro il discorso di Oderisi, anzi lo sigilla, l’inquadratura “francescana” di
Provenzan Salvani, intento umilmente a chiedere l’elemosina: «liberamente nel
Campo di Siena, / ogne vergogna diposta, s’affisse» (Purg., XI, 134-135).
Un’agnizione entrata, a buon diritto, nella vulgata esegetica, convoca la vita di
Francesco redatta da Bonaventura, e in particolare la scena in cui il Santo prende
a mendicare, vincendo ogni attrito interno: «Depositaque omni verecundia
propter amorem pauperis Crucifixi, mendicabat»32. Collocandosi sotto questo
esponente, l’episodio aggancia il suo valore esemplare a una ben connotata
scuola di spiritualità.
Ogni lettore registra il contraccolpo che le parole di Oderisi sulla vanagloria
suscitano in Dante, la contrita ammissione con cui il pellegrino rimessamente
fa eco: «Tuo vero dir m’incora / bona umiltà, e gran tumor m’appiani» (Purg.,
31
32
Matth., VI, 9.
BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Legenda Maior Sancti Francisci, II, 7. Il riscontro si deve a
E. PANZACCHI, Il canto XI del «Purgatorio», letto nella sala di Dante in Orsanmichele, Firenze,
Sansoni, 1903, p. 30. L’espressione dantesca «s’affisse» non deve far pensare a un’altera
impassibilità: la posizione eretta di Provenzano, la sua rigidità «are the outward signs of a
intensely concentrated inward effort at self-domination», come puntualizza A. OLDCORN,
Gone With the Wind: A Reading of «Purgatorio» XI, in G.M. ANSELMI et alii (a cura di), Da
Dante a Montale. Studi di filologia e critica letteraria in onore di Emilio Pasquini, Bologna,
Gedit, 2005, pp. 35-63, a p. 57.
161
XI, 118-119). Palese, qui, un riconoscimento di colpa. È opportuno,
comunque, tener presente quale soggetto si esprima, e a proposito di quale capo
d’accusa, per afferrare il senso della palinodia: reo confesso è l’agens, e sta
ammettendo di aver desiderato un’eccellenza mondana, non di avere attentato
alla supremazia divina. Non è un caso che l’auto-incriminazione avvenga prima
del profilarsi degli exempla disforici. Naturalmente, la distinzione fra io narrato
e io narrante non deve diventare rigida, data la contemporaneità, nel testo, di
enunciato ed enunciazione, viaggio nell’aldilà e viaggio della scrittura: l’autore,
redigendo il poema sacro a fianco del suo alter ego impegnato su erte e cornici,
avverte l’impatto delle esperienze narrate, tant’è vero che, in Purgatorio XII, è
provocato dall’epifania maligna di Aracne, epifania attinente a rigore
all’enunciato, ma tale da entrare immediatamente in circolo coi miti delle Piche
e di Marsia, allocati a livello di discours e non di récit. Eppure, una distinta
personalità il pellegrino la possiede, e occorre verificare quale sua distorsione si
risenta sotto i colpi di Oderisi.
Non si può dubitare che sia in causa il curriculum messo insieme prima
dell’escursione oltremondana, con le connesse aspirazioni e attese, il
personaggio-poeta ha un discreto gruzzolo di pubblicazioni all’attivo, per non
dire dei successi già conseguiti ad ampio raggio. Ma verte, l’esame di coscienza,
su una costante, su un’ambizione sottesa all’intera produzione pregressa, dagli
esordi poetici fervidi e passionati fino all’attrezzata maturità in una prosa
robustamente ideologica? Stando alla testimonianza della Commedia, il
protagonista è soprattutto responsabile delle «nove rime» inaugurate da Donne
ch’avete intelletto d’amore (Purg., XXIV, 50-51). Questa fase della sua carriera,
però, rimane esente da sospetto: essa implica, sempre secondo il referto del
poema sacro, l’apertura a un dettato trascendente, l’adesione all’impulso di
Amore, atteggiamento rivendicato, nella sesta cornice, al cospetto di Bonagiunta
Orbicciani, ultimo alfiere della vecchia guardia. La differenza tra i due rimatori
sta tutta nella disponibilità mostrata dal più giovane verso gli input della forza
che muove il mondo e che sollecita il linguaggio poetico: «I’ mi son un che,
quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo
significando» (vv. 52-54)33. Il Dante stilnovista ha già sperimentato l’integrale
svuotarsi, l’accoglienza incondizionata dell’ispirazione scesa dall’alto; ponendo
così le premesse per l’ulteriore attitudine ricettiva che gli consentirà di scrivere
il poema sacro, assecondando le Muse e la divinità che entra in petto. Ma prima
della Commedia non ci sono soltanto le «nove rime». E Purgatorio II recupera
Amor che ne la mente mi ragiona, affidandone l’esecuzione smagante a Casella
33
Per il retroterra neotestamentario, cfr. G. GORNI, Il nodo della lingua, in ID., Il nodo della
lingua e il Verbo d’Amore. Studi su Dante e altri duecentisti, Firenze, Olschki, 1981, pp. 13-21.
162
dolce musico. Si tratta di una delle canzoni poi confluite nel Convivio e lì
interpretate in chiave filosofica, alla luce dell’allegoria. Del Convivio vero e
proprio, invece, nel poema sacro non si fa cenno. Questo silenzio è certo
giustificabile con la clandestinità di un’opera interrotta e non divulgata (mentre
le canzoni dello scartafaccio lasciato nel cassetto una loro autonoma circolazione
l’avevano avuta, tanto che Casella, appunto, si era votato a rivestirne
musicalmente una, quella da lui stesso intonata sulla spiaggia del sacro monte).
Ma è tutto quello che si può dire? Non è da escludere che Dante nutrisse un
segreto disagio per il progetto del trattato filosofico, se non altro per lo spirito
con cui era stato concepito. E forse, la confessione recitata dal pellegrino al
cospetto di Oderisi, a denuncia del maligno gonfiore, deprime sottotraccia
proprio le aspettative che avevano accompagnato il Convivio, davvero non
indifferenti, addirittura consustanziate alla genesi dell’impegnativa summa.
Dante, infatti, vi dichiarava espressamente (I, ii-iv) di cercare, come poeta e
come trattatista morale, il consenso e l’ammirazione dei contemporanei:
l’allegoresi in chiave filosofica delle canzoni era concepita come antidoto a ogni
sospetto di leggerezza amorosa, il complesso della monumentale enciclopedia
doveva controbilanciare, col suo sapere vasto e aggiornato, lo status dell’esule,
spregevole per l’indecorosa povertà.
Sia in gioco specificamente la disposizione del Convivio, oppure un
atteggiamento più diffusamente radicato nella carriera dantesca, è certo che
l’aspirazione disordinata al successo, pur non configurando vera e propria hybris,
si riveli al pellegrino assai insidiosa, ben altro che un’infezione epidermica,
piuttosto un vero e proprio «tumore». Da curare attraverso la contemplazione
della gloria fugace, dell’ascesa e caduta di artisti celebri, eclissati anche nel giro
di una breve stagione; non pietre miliari di una civiltà che, grazie all’apporto
comune, avanza verso nuove conquiste culturali e stilistiche, semmai astri
spenti, in grado al massimo di attestare la fine di una illusione.
Ciò non significa che, entro la Commedia, venga negata la forza delle
innovazioni e svuotato il progresso artistico, secondo una concezione antistorica
incline a sentire il tempo come pura pressione livellatrice e in ultima analisi
come forza che annienta, senza alcuna funzione di rischiaramento e sviluppo del
valore. Il monitoraggio della poesia di sì espletato da Purgatorio XXIV abilita
una storia della letteratura, e non solo quale mera successione di profili e
correnti: mette conto registrare una diacronia, dove il Notaro, Guittone e
Bonagiunta vengono prima, e gli stilnovisti subentrano dopo, poiché il prima e
il dopo segnano una graduale maturazione, una crescita degli esiti. In sostanziale
continuità, Purgatorio XXVI sottolinea l’acquisizione complementare che il
tempo rende giustizia all’autentica grandezza, tanto è vero che Guittone, sul
momento applaudito da tanti, alla distanza non ha retto, e Guiraut de Bornelh
163
si è dimostrato fragile a sondaggi critici maggiormente approfonditi (in questo
caso, i sondaggi progressivi di Dante, che aveva elogiato il limosino nel De
vulgari e adesso lo ridimensiona), mentre Arnaut Daniel rifulge sempre più in
un firmamento stabile, dove lo stesso Guinizzelli trova il suo posto, anche se
come luce minore. La qualità cristiana e medievale di questa valorizzazione della
storia emerge nel medesimo canto XXVI, che mette a confronto tradizione
recente e tradizione remota, modernità e antico. Guinizzelli scorge, insieme al
pellegrino, anche i due che procedono con lui, avvista insomma il terzetto di
poeti che sta scalando le ultime cornici e comprende, nell’ordine, Virgilio,
Stazio e, buon ultimo, Dante. L’apostrofe dell’espiante sottolinea questa
posizione apparentemente di retroguardia e con esatto intuito la attribuisce a
reverenza (Purg., XXVI, 16-17), eppure è rivolta proprio a colui che chiude il
drappello, per la ragione immediata che il suddetto fa ombra e desta maggiore
curiosità, ma a veder bene anche per una ragione più profonda, celata entro la
precedente. Dante gode di un «privilegio» esclusivo, quello di visitare, da vivo,
l’oltretomba in un itinerarium in Deum (v. 129), e una simile prerogativa lo
avvantaggia rispetto a tutti gli altri poeti, inclusi i latini; egli che, nella fila dei
tre, viene dopo, e difatti si mostra riverente verso gli altri, è in realtà in posizione
più avanzata. Postero e seguace di Virgilio e di Stazio, raggiunge un livello
impensabile a quei mentori, e lo raggiunge perché può giovarsi di loro, nano
sulle spalle di giganti, ma inoltre perché appartiene alla pienezza dell’era
cristiana, ancora in incubazione quando viveva Virgilio e solo albeggiante per il
convertito ma timido Stazio. La tradizione classica è la preparazione del
moderno, la premessa che ha dissodato il terreno alla novità del cristianesimo, e
in un certo senso è anche la prefigurazione del cristianesimo, il suo annuncio
tipologico, sicché le auctoritates latine stanno agli scrittori attuali, la cui punta
avanzata è Dante, come il Vecchio Testamento al Nuovo34. In una prospettiva
del genere, riaffiora un passo strategico della Vita nuova, in cui la donna di
Guido Cavalcanti corrisponde a Giovanni Battista e la donna di Dante
corrisponde a Cristo; a fase Commedia, beninteso, immediato precursore di
Dante non è più Cavalcanti, il ruolo di vox clamantis è assunto in toto da
Guinizzelli.
Una rivendicazione della storia è naturalmente aperta a un’idea positiva
della fama. E difatti, la Commedia, nella sua totalità di macrotesto, non depenna
irreversibilmente la rinomanza terrena, semmai si pronuncia per la sua
ricollocazione e subordinazione, e lo fa, si noti bene, in passi successivi a
34
Cfr. M. PICONE, Canto XXVI, in M. PICONE e G. GÜNTERT (a cura di), Lectura Dantis
Turicensis, Purgatorio, cit., pp. 407-422. Resta peraltro da precisare come si integrino, in
Dante, la logica della preparazione e quella, per dir così, “segnaletica” della prefigurazione.
164
Purgatorio XI, per esempio all’altezza di Paradiso VI. Qui rientra l’auctoritas di
Tommaso d’Aquino, come tutti i lettori hanno constatato, senza esaurire
peraltro le esplorazioni possibili. Se l’Aquinate smussa la gravità dell’amore di
gloria, derubricandolo a peccato veniale35, si spinge anche oltre, precisando che
riprensibile è propriamente l’aspirazione alla inanis gloria, mentre il desiderio
della gloria non è di per sé negativo: «Appetitus gloriae de se non nominat
aliquid vitiosum». Ecco l’ingranaggio argomentativo: la gloria, effetto della lode
e dell’onore, è manifestazione dell’opera buona e come tale consente la visibilità
del bene che l’uomo ha compiuto; ora, questa visibilità può riuscire di
giovamento a coloro che la recepiscono, per conseguenza, e non è concessione
indifferente, «homo laudabiliter potest ad aliorum utilitatem gloriam suam
appetere»36. A conforto, viene invocato un detto evangelico, che consente di
determinare la finalizzazione ultima: «Videant opera vestra bona, et glorificent
Patrem vestrum qui in caelis est»37. Un corollario doveroso mette semmai in
guardia chi si volge al bene per esclusivo appetito dei riconoscimenti umani:
costui non si può dire veramente virtuoso38. Come si vede, una dottrina serena,
che ha sicuramente contribuito, col suo equilibrio, alla soluzione ideata da
Dante per i «buoni spirti che son stati attivi / perché onore e fama li succeda»
(Par., VI, 113-114), ammessi in Paradiso con la condicio che i raggi del
desiderio, sia pure più debolmente, si fossero indirizzati anche al vero bene. E
non è tutto: se focalizziamo Paradiso XVII – il canto dove Dante personaggio
riceve l’invito a manifestare la sua visione e si augura lunga fama per la
composizione del poema sull’oltretomba –, ci imbattiamo in una peculiare
nozione della testimonianza davanti al mondo: questo appello deve essere
visibile e clamoroso, poiché gli uomini non fanno caso a ciò che è nascosto,
tant’è vero che sono scossi solo da figure e vicende «che son di fama note» (v.
138). A veder bene, è qui fondata la logica dell’exemplum. Il poema gremito di
personaggi esemplari guadagnerà, con la sua rinomanza, un valore aggiunto di
incisività, ampliando una sfera d’influenza che non deve essere circoscritta, ma
la più ampia possibile; in questo modo, l’onore dell’artefice, interamente
funzionale alla penetrazione del messaggio, si dimostrerà non più una
gratificazione individuale, ma uno strumento per l’utilità comune.
Insanabili incongruenze nel sistema della Commedia, smagliature da
riconoscere come tali, magari senza troppi rimpianti, magari scorgendovi una
Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, 132, 3. Il rinvio, ribadito da molti
commenti moderni, è divenuto pressoché d’obbligo.
36
Ibidem, II-IIae, 132, 1, r. e ad 1um.
37
Matth., V, 16.
38
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, 132, 1, ad 2um.
35
165
conferma di teorie e metodologie tardonovecentesche che, in luogo dell’identità,
premiano la differenza, e al Libro preferiscono la “scrittura” nella sua
dirompente forza centrifuga? In verità, Purgatorio XI deprime non la vanità tout
court della gloria, bensì quella gloria che è vana39. Denuncia insomma un eccesso
senza inibire un valore, avverte che la rinomanza non può essere assunta come
meta autosufficiente, in grado di assicurare autentica soddisfazione. Ecco il
tumore che deve essere appianato affinché l’itinerarium possa procedere,
confermandosi nella direzione del fine ultimo e subordinando a quel traguardo
il desiderio della propria reputazione, accettabile purché non autotelico. Se
Dante, prima della Commedia, aveva voluto promuovere senz’altro il suo
prestigio, adesso è chiamato a finalizzare la fama del proprio nome a quella del
nome di Dio: il primo splenderà perché venga glorificato il secondo, così come
l’opera conclusiva acquisterà credito per convincere al bene l’umanità sbandata
e dispersa. Ecco la prospettiva in cui la lezione di Oderisi va a collocarsi,
acquistando il suo pieno significato. Il segmento si comprende a partire
dall’insieme, il macrotesto illumina il contesto locale.
Riconoscerlo non deve portare, comunque, a un’evacuazione del singolo
passo, della sua forza e drammaticità, pena l’illanguidimento della stessa
funzione costruttiva esercitata in vista dell’intero. È un fatto: Oderisi non
riequilibra i suoi affondi, non riscatta l’azzeramento con una correlativa pars
costruens. Nel suo discorso, è assoluta l’assenza di storia, e dunque di storia
letteraria, rimane insomma senza attenuazioni la riduzione del diagramma a
nudo avvicendamento di nomi che si soppiantano uno dopo l’altro. Qui non si
avverte in nessun modo il progresso, c’è solo la reiterazione di una dinamica
demolitrice; non per caso è in evidenza un agonismo aggressivo, che non
contempla un passaggio del testimone ed è estraneo alla logica dell’inveramento.
Così pure, dalla formidabile requisitoria non si potrebbe dedurre in alcun modo
che esiste anche una gloria terrena non vana, termine di un’aspirazione lecita e
anzi produttiva; nemmeno uno spiraglio viene aperto, a nessuna eccezione è
fatto credito, e il paesaggio che si squaderna è di rovine.
Ma si capisce. Ponendosi all’interno di un percorso, dell’evoluzione che
conduce il pellegrino al traguardo del mistico, l’io narrato sino alla statura
dell’io narrante, questo richiamo deve essere, nella circostanza in cui scocca,
durissimo, persino unilaterale; solo così può provocare una svolta. Un’aggiunta
in positivo avrebbe indebolito, in quel momento, l’effetto del monito tagliente,
del coltello che recide. Come Oderisi, e a differenza di Aracne, il personaggiopoeta guadagnerà la salvezza, ma anche per lui qualcosa deve andare in pezzi;
39
Cfr. I. BERTELLI, Canto XI, in AA.VV., Lectura Dantis Scaligera, Purgatorio, Firenze, Le
Monnier, 1967, pp. 345-404, a p. 384.
166
sarebbe imprudente dedurre che gli stracci della tessitrice lidia rimandino
segretamente al Convivio rimasto incompiuto, ma è sotto accusa, di certo,
l’aspettativa che Dante aveva in alcuni momenti concepito e coltivato, il
desiderio di un successo a esclusivo vantaggio di sé, residuo impuro da espellere
una volta per tutte, per una rinascita dell’io e della sua vocazione autoriale.
3. Ioculatores Domini
Procedendo a ritroso, siamo passati dalla forma acuta di un vizio a un’altra
più agevolmente redimibile; ci attendono adesso gli exempla virtutis di
Purgatorio X. A norma di uno schema costante lungo le sette cornici, il supremo
modello è Maria, in questo caso regina dell’umiltà con la sua perfetta
obbedienza, il suo Ecce ancilla Dei che, a distanza di ere, risponde alla ribellione
di Eva. Non manca, d’altra parte, un esempio tratto dal paganesimo,
l’imperatore Traiano disponibile a rinviare un’impresa militare per esaudire la
richiesta di una vecchierella. L’avvicendamento binario di esemplarità cristiana
ed esemplarità pagana è peraltro integrato – e dunque spostato su un ritmo
ternario – da un riquadro che sta fra i due, e presenta la traslazione dell’Arca
Santa da Epata a Gerusalemme, con David giubilante nella danza.
Ad associare Maria, David e l’Impero era già un ampio e sostenuto passo
del Convivio, che asseriva anzitutto la contemporaneità di David ed Enea, e
registrava quindi l’analoga sincronia tra il parto della Vergine e l’instaurazione
della monarchia universale a opera di Augusto (Conv., IV, v, 4-6). Qui l’accento
è soprattutto sulla storia della salvezza e sul ruolo che vi svolge, costantemente,
l’Impero romano, associato sia a monte che a valle – eloquente simmetria – al
disegno di redenzione del genere umano. Non per caso si dispiega un
quadrilatero: la coppia di antenati (David, Enea) è l’emblematica prefigurazione
della coppia successiva (Maria, Augusto) o, per esser più precisi, una
contemporaneità antica annuncia e sottolinea quella che verrà nella pienezza dei
tempi, quando l’ottima disposizione del mondo procurata dall’Impero abiliterà
l’Incarnazione del figlio di Dio. In Purgatorio X, invece, il gioco delle sincronie
che, in maniera mirabile, si rispondono e si confermano a distanza viene messo
tra parentesi, e conta semmai la distinzione fra dimensione religiosa e
dimensione civile, laddove i due ambiti non entrano in una parabola storica che
entrambi contribuiscono a promuovere, ma stanno su un piano ideale (da un
lato la grazia, dall’altro la natura) in cui la storia è secondaria e in disparte, tant’è
vero che viene scelto un imperatore abbondantemente successivo a Maria (e ad
Augusto). La Vergine costituisce l’alternativa paradigmatica a ogni ribellione
sulla verticale, poiché la sottomissione di lei configura l’atteggiamento da
assumere di fronte a Dio. Appartiene, invece, a una diversa specie di umiltà,
inerente ai rapporti sociali, regolati da diritto e politica, la disponibilità di
167
Traiano verso la vecchierella affranta. Non per nulla, costei si appella
esattamente alla carica dell’altissimo interlocutore, supplicandolo di sanzionare
un violento sopruso: «Segnor, fammi vendetta / di mio figliuol ch’è morto»
(Purg., X, 83-84). Certo, Traiano è destinato, in via eccezionale, alla salvezza
eterna; ciò non toglie che figuri come araldo di un’umiltà, per dir così,
“naturale”, che si attiva entro dinamiche giurisdizionali. Acquista, allora, la sua
esatta luce quel singolare piegarsi del superiore verso l’inferiore. A veder bene,
non è in causa una generica eminenza, in atto di deporre virtuosamente la
propria dignità per incontrare e soccorrere chi sta in basso; è invece in causa
l’autorità politica, e segnatamente imperiale, nell’esercizio, si noti ancora, delle
sue precipue funzioni, insomma nell’amministrazione della giustizia. Ora, la
giustizia terrena, quella appunto a cui presiedono i magistrati di questo mondo,
e in particolare il magistrato per eccellenza, va integrata con la pietà, meglio, va
fondata sulla pietà. Si tratta del paradigma proprio del principato romano, come
specifica la Monarchia (II, v, 5), facendosi forte di una tradizione medievale:
«recte illud scriptum est: “Romanum imperium de Fonte nascitur pietatis”». I
due termini del binomio vengono attribuiti all’imperatore «non nel senso […]
che la giustizia appartenga alla sfera terrena della sua responsabilità, e la pietà
alla religiosa», ma perché «la giustizia non è piena se è astratta, se non tien conto
dell’uomo», e la pietà «non ne è solo essenziale componente, ma ne costituisce
la fonte»40. Questo anche il senso dell’asserto conclusivo di Traiano nel dialogo
con la vecchierella: «giustizia vuole e pietà mi ritene» (Purg., X, 93). L’umiltà
dell’imperatore al cospetto della vecchia madre rientra nella pietà indispensabile
all’esercizio della giustizia politica che, priva di quella fonte, si inaridirebbe.
Come valutare, allora, la presenza e la posizione di David? Se egli qui non
figura quale radice della Vergine41, deve incarnare una qualità vista sotto specie
ideale; al pari degli altri due exempla. Ora, tra le sue diverse prerogative, non
spicca certo, nell’altorilievo, quella regale: davanti all’Arca Santa, David non ha
ufficio né contegno di sovrano, come avverte con dispetto Micòl, che alimenta
nel sangue un’istintiva fierezza, da figlia dell’altero, ombroso Saul.
Commentando la condotta di David, il testo rimarca in maniera esplicita questo
trascendimento di un ruolo: «e più e men che re era in quel caso» (Purg., X, 66).
Dante ha voluto allora enfatizzare, in luogo del re, il sacerdote? La traslazione
dell’Arca a Gerusalemme è senza dubbio un evento religioso, in cui ha parte
eminente la casta sacerdotale; lo rimarca la tragica sorte di Oza che, al vacillare
Così U. BOSCO, nella sua introduzione al canto (La Divina Commedia, a cura di U. BOSCO e
G. REGGIO, Firenze, Le Monnier, 1979, II, Purgatorio, p. 169).
41
Lo sottolinea G. GÜNTERT, Canto X, in M. PICONE e G. GÜNTERT (a cura di), Lectura Dantis
Turicensis, Purgatorio, cit., pp. 139-155, a p. 151.
40
168
dell’Arca, in seguito a uno scarto improvviso dei buoi, la afferrò per sostenerla,
arrogandosi un diritto riservato esclusivamente ai sacerdoti, e a causa di una
simile temerarietà venne fulminato all’istante da Dio. A questo fatto Dante
dedica la prima terzina dell’ekphrasis. Ma sviluppando la descrizione
dell’altorilievo passa ad altro, si diffonde sui canti e sul giubilo attorno all’Arca;
e dopo aver inquadrato, in due terzine, il corteo degli accompagnatori diviso in
sette cori e il forte profumo degli incensi, punta l’obiettivo su David (una
terzina) e quindi, a contrasto, su Micòl (terzina finale). Se nell’originale biblico
l’entusiasmo di David precede e segue l’intermezzo funesto della fine di Oza,
nella Commedia quel tripudio appartiene esclusivamente a un secondo tempo
dell’episodio, a una fase ben distinta dalla violazione umana e riaffermazione
divina di un privilegio sacerdotale. David, del resto, è definito qui «salmista»
(Purg., X, 65), formula non incidentale se Par., XX, 38-39, evocando il
medesimo episodio, celebra «il cantor […], / che l’arca traslatò di villa in villa».
E non va trascurato che, all’altezza di Conv., I, vii, 14-15, i versi del Salterio
sono affiancati ai poemi di Omero, nel corso di una riflessione sulla natura della
poesia, le sue caratteristiche principali, i tratti che la identificano distinguendola
dalla prosa. In David esultante al seguito dell’Arca, il sovrano e il sacerdote si
lasciano assorbire dal poeta. Ed è inevitabile sospettare che la posizione centrale
dell’intaglio dedicato a David, fra quello sulla Vergine e l’altro su Traiano,
esprima ancora una volta la speciale rilevanza che i canti dei superbi
conferiscono all’arte.
Notevole che Dante non solo rimarchi il contenuto proposto dall’autore dei
Salmi, l’enunciato gravitante attorno alla gloria di Dio, ma sottolinei, insieme
all’enunciato, anche l’enunciazione, e insomma oltre al messaggio anche il gesto
che lo accompagna. Già nel riquadro della Vergine risalta l’«atto soave» (Purg.,
X, 38), ed è probabile che l’espressione «atto», ribadita ancora più avanti – «e
avea in atto impressa esta favella» (v. 43) – abbia una valenza precisa, «non
significhi solo, in modo generico, un “atteggiamento”, ma equivalga al
tecnicismo retorico dell’actio, ubbidiente quindi a quella parte dell’arte
sermocinale che riguarda la gestualità»42. Ebbene, in David il gesto si intensifica,
finisce per uscire dal suo carattere ausiliario e assurgere a una dimensione
autonoma: il salmista non è qui (soltanto) dicitore o cantore, è intensamente
impegnato nella danza, che finisce per colmare l’intera scena. Danza clamorosa
per tutti gli astanti, inaccettabile per Micòl, stagliata col suo biasimo nella
cornice di un «gran palazzo» – felice esplicitazione dell’originale biblico:
«Michol filia Saul prospiciens per fenestram vidit regem David»43. Se luogo
42
43
A. BATTISTINI, La “speranza de l’altezza” cit., p. 103.
II Reg., VI, 16.
169
idoneo all’umiltà è la strada o la piazza, sede particolarmente appropriata alla
superbia è la reggia. La Bibbia pone in bocca alla regina, fattasi incontro al
marito, un epiteto sprezzante, «scurra» nella versione geronimiana: «Quam
gloriosus fuit hodie rex Israel discooperiens se ante ancillas servorum suorum, et
nudatus est quasi si nudetur unus de scurris»44. Assieme alla danza congiura
dunque contro la dignità di David la nudità, coessenziale del resto alle mosse
sciolte del ballerino. Dante non manca di rimarcare questo ulteriore aspetto
nell’icastico participio «alzato», da intendere come participio congiunto in
riferimento (sottinteso) all’abito sollevato e stretto alla cintura, mentre
un’interpretazione indirizzata al saltare comporterebbe ridondanza
semanticamente superflua. E non è tutto. La danza alla testa del popolo è
presentata come una «tresca», trovando nella popolare tonalità di ballo
contadino la sua sigla calzante: «Lì precedeva al benedetto vaso, / trescando
alzato, l’umile salmista» (Purg., X, 64-65). Nella stessa cantica, le ninfe-virtù
dell’Eden avanzano «danzando» (Purg., XXIX, 122), e il Paradiso si fregia di
corone luminose che ruotano «danzando» (XXIV, 17); parallelo morfologicamente a quelle due espressioni, il gerundio attribuito a David ha un diverso
colore lessicale, e ci conduce alla prima cantica, addirittura al sabbione ardente,
dove le anime tormentate dalla pioggia di fuoco tentano di proteggersi con la
«tresca / de le misere mani» (Inf., XIV, 40-41). Nell’Inferno, «tresca» ha
ineccepibile pertinenza stilistica, risponde al contenuto depresso, ai dannati
scomposti e frenetici; nella seconda cantica, l’estetica del conveniens è scalzata, e
l’eminente David, a onta della divisione degli stili, viene linguisticamente spinto
verso il basso, verso il comico infernale, piuttosto che essere portato al livello
altamente decoroso dei canti dell’Eden o allo splendore espressivo del Paradiso.
La spiegazione dell’anomalia risiede in un tipico paradosso cristiano. Il gruppo
che giace nel sabbione è costituito dai bestemmiatori, e annovera in particolare
Capaneo, «grande» e «dispettoso» (Inf., XIV, 46-47), il quale si erse, durante la
vita terrena, contro Dio, scalando le mura di Tebe e da lì lanciando al cielo
ingiurie veementi, a immagine e somiglianza dei Giganti, semmai col tratto
distintivo del suo clamoroso bestemmiare, esatta antitesi della lode. Ebbene,
Capaneo patisce nell’escatologia il rovesciamento mortificante, la posizione
supina esposta senza rimedio alle falde infuocate, e nella sua caparbia e vana
ostinazione a sfidare tuttora la divinità, quando non riesce nemmeno a sollevarsi
da terra, risulta, piuttosto che eroico, grottesco45. L’altorilievo purgatoriale
44
45
II Reg., VI, 20.
Insistendo nella sfida e nelle bestemmie, Capaneo rivela «il grottesco della sua situazione di
vinto e punito per sempre, che crede di poter ancora – all’Inferno – riproporre come grandi
ed eroiche le azioni che lo hanno portato a tanta miseria» (G. BÁRBERI SQUAROTTI, Tutto
l’Inferno, Milano, Angeli, 2011, p. 102).
170
raffigura, invece, un abbassamento che ha luogo nella storia, la volontaria
mortificazione che caratterizzò David, distinguendolo da Micòl «dispettosa», e
gli schiuse l’apoteosi paradisiaca. L’«umile salmista», raffigurato mentre spicca
salti festeggiando l’Arca, spregevole come un popolano, seminudo alla stregua di
un saltimbanco – secondo un grottesco dell’umiltà – è l’incubazione del beato
che, nel cielo di Giove, trionfa fra gli altri giusti, e lì in maniera sublime
risplende, «luce» entro la pupilla dell’Aquila, manifestando pienamente la sua
statura eccezionale di «cantor de lo Spirito Santo».
L’altorilievo di David risente forse anch’esso di un’interferenza francescana:
spontaneo pensare ai giullari di Dio, non alieni da atteggiamenti eccentrici e
persino indecorosi, tanto da scandalizzare i benpensanti. Dante avrebbe tirato
la linea tra Francesco ioculator e David scurra, come dire tra attualità e
paradigma, il che farebbe sistema con il coinvolgimento del Cantico e della
Legenda bonaventuriana in Purgatorio XI. In ogni caso, va registrata la
sporgenza abnorme di questo istrione sacro rispetto a una concezione
largamente maggioritaria nella Commedia, che premia, in genere, il contegno
grave, assolutamente alieno da ogni scompostezza e, per quanto riguarda, in
particolare, l’immagine pubblica del poeta, converge sulla posa ufficiale e
solenne. Se torniamo a Purgatorio II, a Casella in atto di cantare Amor che ne la
mente mi ragiona, registriamo un’alternativa tra il decoro dell’esecuzione, fruita
da un assorto, immobile uditorio, e il disordine delle anime in fuga dopo il
rimbrotto di Catone, con la fretta che «dismaga» la debita «onestade» (Purg.,
III, 11). Ancor più rilevante quella scena “ideale” che corrisponde al culmine
della carriera poetica, e cioè l’apoteosi magnifica dell’incoronazione. Oggetto
costante del desiderio, la cerimonia splendida viene prefigurata più volte,
intanto entro Paradiso I e poi, con maggiore determinazione di dettagli,
all’inizio di Paradiso XXV, dove lo sfondo è il Battistero di Firenze, nobilissima
quinta su cui campeggia l’autore del poema sacro in atto di prendere il
«cappello» (v. 9). Ma una contrapposizione tra icone antitetiche sarebbe facile
e, peggio, fuorviante. Lungi dal perpetrare un’anomalia irriducibile, lo scorcio
giullaresco, se così è lecito definirlo, coopera a una pedagogia, funge da filtro
lungo una conversione religiosa e poetica. Al momento di auspicare per sé
l’amato alloro, Dante riconosce che la condicio è proprio svestirsi di sé, divenire
veicolo di un altro, la laurea sarà premio di un esito raggiungibile non certo in
autonomia, ma assecondando l’indicazione di Apollo: «vedra’mi al piè del tuo
diletto legno / venire, e coronarmi de le foglie / che la materia e tu mi farai
degno» (Par., I, 25-27). Non diversamente, il «cappello» verrà assunto grazie a
un poema a cui «ha posto mano e cielo e terra» (Par., XXV, 2). Il magnanimo,
cui si conviene anche il decoro degli atti, guarda in sé, tomisticamente, i doni
di Dio, e nasce perciò dall’umile, consapevole del proprio difetto. Se
171
adottiamo, assecondando il dinamismo testuale della Commedia, un diagramma diacronico e non sincronico, ci rendiamo conto che l’icona dell’umiltà
risulta sempre propedeutica a quella dell’esaltazione, e che il paradigma stoicofrancescano si integra con quello aristotelico-tomista. Senza che vada perduta,
in questa simbiosi, la veemenza del richiamo ascetico, frutto di un’intransigente eredità.
172
FRANÇOIS LIVI
Scrittura profetica e scrittura apocalittica nella Divina Commedia.
Lettura del Paradiso terrestre*
Ringrazio il presidente e ringrazio chi ha avuto la cortesia di invitarmi a
queste interessantissime giornate di Albenga. Titolo lungo per una
comunicazione breve, spero. Titolo ambizioso: non ho affatto la pretesa di
sciogliere tutte le cruces e i nodi problematici degli ultimi sei canti del
Purgatorio; semplicemente vorrei accennare a un percorso che, da una parte,
colloca questi ultimi canti – il Paradiso terrestre – in una prospettiva un po’
particolare, di cui vi parlerò subito, e, d’altra parte, vorrei mostrarvi
l’articolazione sapientissima che in questi ultimi canti del Purgatorio Dante fa
della scrittura profetica e della scrittura apocalittica
Innanzitutto due premesse, perché poi il discorso sia più chiaro e, spero, più
coerente. La prima è questa (non un postulato, ma per me un punto di partenza
in lavori recenti e forse futuri): l’unità molto forte in Dante-autore tra fede
cristiana e creazione poetica. Può sembrare una verità lapalissiana, ma non lo è
affatto. Intendo che, secondo me (ma non credo di essere l’unico a sostenere
questa tesi), non c’è cesura in Dante tra il credente che aderisce alla fede
cattolica e lo scrittore che con la sua forza creativa e con la sua immaginazione,
nella fattispecie della Divina Commedia, scrive un poema assolutamente
ammirevole che è ai limiti proprio della hybris della quale parlavamo prima. Il
rapporto che si stabilisce fra creazione poetica e fede cristiana è un rapporto che
chiamerei – e ho chiamato – di “interpretazione”. Vale a dire: per quanto
riguarda le grandi realtà prese in considerazione nella Divina Commedia, e cioè
la vita delle anime nell’aldilà, Dante parte da presupposti dogmatici, dalla
rivelazione, dal magistero della Chiesa, dalla tradizione, ma poi li interpreta
personalmente e poeticamente. La Scrittura parla naturalmente di pene
dell’inferno e della gloria dei beati, ma di queste realtà nessuno ovviamente, né
Paolo né Enea, sono in grado di darci una descrizione, trattandosi di realtà che
superano l’intelligenza umana. Dante, con la sua creazione poetica, non
propone nuovi articoli di fede ma semplicemente dà un’interpretazione
personale e politica, un’ipotesi nell’ambito molto ampio in cui i dogmi della
fede lasciano spazio a una possibile interpretazione; del resto Cristo stesso parla
* Non ci è pervenuto il testo scritto della relazione del prof. Livi, di cui pubblichiamo qui la
trascrizione integrale (con minime correzioni) sulla base della registrazione audio-video della
sessione pomeridiana del 14 aprile 2012. [Nota dei curatori]
173
delle nozze dell’agnello, del banchetto nell’aldilà. Sono immagini naturalmente,
ma il credente e, a maggior forza, il creatore, lo scrittore, il poeta devono
immaginare, non possono rinunciare a un tentativo di ipotesi, che sarà sempre
inadeguato alla realtà come risultato, ma può prospettare – insisto – non nuove
verità di fede ma una possibile ipotesi, attraverso la ricerca ovviamente della
bellezza, che è un sinonimo, nella filosofia medievale, dell’essere e della verità.
C’è quindi la necessità di tradurre in immagini concetti astratti che conducono
veramente l’uomo al limite delle sue possibilità di comprensione. Si è parlato
questa mattina, in termini magnifici, del modo in cui Dante, nell’ultimo canto
del Paradiso, prospetta questa debolezza strutturale della parola umana e, allo
stesso tempo, disegna delle immagini che certo non pretendono di darci il
significato della contemplazione del mistero trinitario, ma neppure rinunciano,
nonostante il limite del linguaggio, a questa sfida.
Quindi nessuna cesura tra fede di Dante e scrittura poetica o, in termini
che mi sembrano ormai superati, tra poesia e non-poesia, sovrastruttura e via
dicendo. Dò un’applicazione immediata che riguarda il Purgatorio, di cui ci ha
parlato questa mattina Francesco Spera. Nel 1274 a Lione si è svolto il secondo
Concilio ecumenico. La pressione turca era molto forte sull’Impero d’oriente, lo
scisma d’oriente era stato già consumato più di due secoli prima. Michele
Paleologo, l’imperatore d’oriente, e i rappresentanti della Chiesa latina si
mettono d’accordo su un punto decisivo, per un’unione che non è poi avvenuta,
e non avverrà neppure al concilio di Firenze del 1439. Il punto fondamentale è
quello del Purgatorio, perché la Chiesa di oriente sospettava nella visione latina
del Purgatorio tracce di origenismo, cioè di una dottrina, l’apocatastasi,
considerata eretica dalla Chiesa d’oriente e dalla Chiesa d’occidente: l’idea di
una riconciliazione finale dei peccatori con Dio, di un Dio misericordioso per
il quale quindi l’Inferno stesso non sarebbe eterno. La dichiarazione comune del
secondo Concilio ecumenico di Lione evita ogni ombra in merito e, per quanto
riguarda il Purgatorio, purificazione destinata a durare unicamente fino alla
parusìa, al ritorno glorioso di Cristo, si limita ad affermare, sul piano dottrinale,
la purificazione attraverso il fuoco (e della natura di questo fuoco non si deve
nemmeno discutere) e l’importanza dei suffragi per alleviare e abbreviare – se
questo termine ha un senso – il tempo di purificazione delle anime del
Purgatorio.
Ora, questi punti sono perfettamente rispettati da Dante, che conosce
molto bene la tradizione, almeno quella occidentale e patristica, in questo
campo. Vi dò un solo esempio, a proposito appunto dei suffragi: l’episodio di
Manfredi. Dante afferma il carattere imperscrutabile della volontà e della
misericordia divina: Manfredi, scomunicato, è salvato dalla misericordia divina
e chiede preghiere e orazioni a Costanza. Belacqua parla di “orazïone… / che
174
surga sù di cuor che in grazia viva”, cioè di preghiere formulate o elevate a Dio
da coloro che sono in stato di grazia, con una terminologia “tecnica” quanto mai
precisa. Stessa cosa per Forese Donati e Guinizzelli, che chiede a Dantepersonaggio di intercedere in suo favore presso il beati, secondo l’idea della
comunione dei santi e della solidarietà che esiste tra i beati e coloro che, essendo
certi della propria salvezza, devono comunque purificarsi. E poi c’è la magnifica
creazione poetica della barriera di fuoco destinata a purificare non soltanto i
lussuriosi ma anche tutte le anime che devono attraversarla per accedere poi al
Paradiso terrestre. Personalmente, al di là di altre interpretazioni molto fini e
condivisibili, per esempio quelle che richiamano le cerimonie del sabato santo
del fuoco, io vedo in questa creazione letteraria la ripresa di un elemento che ha
sempre affascinato l’immaginario, soprattutto orientale, ma anche occidentale,
cioè il famoso secondo battesimo dei giusti mediante il fuoco (lo troviamo in
Clemente Alessandrino, in Origene, in numerosi padri latini ma soprattutto
orientali): un fuoco che si distingue da quello che punisce i dannati e
rappresenta, nel momento della parusìa, l’ultima purificazione. Questa è una
mia ipotesi personale, ma l’architettura del Purgatorio rispetta perfettamente i
pochi dati dottrinali di cui Dante si poteva servire e, d’altra parte, il poeta non
pretende che le scene purgatoriali che ci presenta siano verità di fede.
Secondo punto. Qualche precisazione – e mi scuso di esprimermi in
termini volutamente molto semplici di fronte ad autorità in questa materia,
come Nicolò Mineo – sul rapporto tra profezia e scrittura apocalittica. Naturalmente ci sarebbe da dire (ma non dirò nulla) sulla concezione che nella
Firenze della fine del XIII secolo si ha del profeta. Invece vorrei ricordare che il
modello al quale Dante si rifà in gran parte, cioè il modello biblico, dà del
profeta caratteristiche molto precise. La profezia – che nel caso di Dante agens,
cioè di Dante personaggio, è innanzitutto un dovere di testimoniare, di rendere
conto di ciò che ha visto nei terreni dell’aldilà – dal punto di vista biblico veterotestamentario, è essenzialmente un carisma transitorio legato alla conoscenza e
dipende dalla scelta di Dio, non è scelta personale. Il carisma di profezia si
esplica attraverso la parola, ma anche molto spesso attraverso la gestualità.
L’autorità del profeta vetero-testamentario non dipende mai dalla qualità dei
prodigi, dei segni da lui realizzati, ma dall’intimità che ha con Jahvè. È il caso
di Mosè, il cui compito è, come sappiamo, quello di condurre il popolo eletto
nella terra promessa. Ma anche nella terra promessa il compito dei profeti non
cambia sostanzialmente: devono guidare il popolo contemplando le azioni non
tanto sub specie aeternitatis, quanto in funzione dell’alleanza con Jahvè: e questo
vale anche naturalmente dopo l’esilio, dopo la caduta dei due regni di Israele e
di Giuda e poi anche nel momento del ritorno del grande profeta – Cristo –
annunciato da Mosè. Con la venuta di Cristo la profezia in senso biblico non
175
esiste più, mentre invece esistono i profeti, il cui carisma è legato a quello
dell’annuncio della parola.
All’interno del genere profetico si colloca la letteratura apocalittica, cioè
rivelatrice di verità che quasi sempre rinviano a quelli che chiamavano i
“novissimi”, cioè la sorte dell’uomo dopo la morte. Ora, la letteratura
apocalittica presenta un certo numero di caratteristiche letterarie – un codice
letterario – che ritroviamo anche in Dante: l’ordine dato al profeta di trascrivere
fedelmente ciò che vedrà, una visione, una sorta di stordimento, di sonno o di
vertigine, segni della manifestazione della potenza di Dio, una teofania e poi,
con un ossimoro che è diventato classico, anche la “luminosa oscurità” che
soverchia anche le forze intellettuali del profeta, anche perché è complicata
dall’uso di simboli e allegorie e da una cronologia sempre incerta.
Quindi, quello che Dante chiamerà l’enigma forte è una caratteristica
propria del messaggio apocalittico, che rimane enigmatico agli occhi dello stesso
profeta che lo riceve e deve trasmetterlo. Naturalmente nell’Antico Testamento
abbiamo alcuni capitoli di Isaia, il libro di Ezechiele, il libro di Daniele e il
citatissimo libro dell’Apocalisse di Giovanni. Nel Paradiso terrestre, come
sappiamo, Dante riprende quasi letteralmente passi del 47º capitolo di
Ezechiele, nella descrizione del fiume fonte di fecondità per le terre che bagna.
Un elemento fondante della letteratura apocalittica è che il messaggio (questa
mattina Francesco Spera parlava giustamente di “mediazione”) non è mai
recepito direttamente o solo in un certo senso dal profeta, ma gli è spiegato da
qualcuno, da un intermediario: per esempio nel libro di Daniele è l’arcangelo
Gabriele che spiega il significato delle visioni alle quali il profeta ha assistito. E
poi naturalmente ci sono tutte le interpretazioni, che non ricordo ora,
sull’Apocalisse di Giovanni, di investitura profetica conferita direttamente da
Cristo. È l’oggetto di una sceneggiatura straordinaria. Cito due versetti finali:
“Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo
alle Chiese. […] Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo
libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli
descritti in questo libro; e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico,
Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa descritti in questo libro”.
E e poi naturalmente sappiamo tutto il successo delle apocalissi dell’esegesi
medievale, in particolare di Gioacchino da Fiore. La stessa polemica, tanto
presente nella Divina Commedia, è calata in un contesto di profezia e di verità,
almeno per quanto riguarda il Purgatorio e il Paradiso: sul piano della scrittura
questa considerazione, che può sembrare banale, è di una certa importanza.
Veniamo al Paradiso terrestre. Mi permetto di ricordare, molto
rapidamente, l’orditura degli ultimi sei canti del Purgatorio. Descrizione del
Paradiso terrestre collocato sulla cima della montagna del Purgatorio e protetto
176
dalla barriera di fuoco alla quale ho accennato. Dante, accompagnato ancora da
Virgilio e da Stazio, scopre l’incanto della selva antica dell’Eden, ampiamente
descritta poi con stilemi che rinviano ancora in parte alla stagione stilnovistica.
È un paradisum voluptatis, giardino dell’Eden, di cui è inutile ricordare il
successo straordinario per quanto riguarda l’iconografia: giardino chiuso (hortus
conclusus, non soltanto nel Cantico dei cantici) e locus amoenus, che Dante fa
coincidere esplicitamente con l’età dell’oro. Quindi, opposizione tra la foresta
del Paradiso terrestre e la selva oscura della prima cantica. C’è una sorta di
sospensione del tempo. Apparizione di Matelda e spiegazione dei due fiumi che
scorrono nell’Eden: il Lete, le cui acque cancellano il ricordo dei peccati
commessi, e l’Eunoè, creazione di Dante, che invece restituisce il ricordo delle
buone opere compiute. Poi inizia la maestosa e misteriosa processione, un vero
e proprio mistero liturgico, preceduta da un fulgore straordinario e da canti
ineffabili, che Dante è invitato a contemplare: “Frate mio, guarda e ascolta”,
dice Matelda. È una processione che compendia la storia della salvezza, dalla
creazione alla redenzione, cioè dall’inizio, dai primi libri dell’Antico
Testamento, fino alla conclusione della rivelazione con l’incarnazione. Il carro
trionfale simboleggia la Chiesa, trainato da un grifone, Cristo, nella sua duplice
natura divina e umana. Il dittico dei canti XXX-XXXI è dedicato alla visione di
Beatrice e all’incontro con lei dopo la decenne sete, a dieci anni dalla sua morte
(avvenuta nel 1290). Beatrice indossa la veste rossa che indossava nel primo
incontro con il poeta. Poi c’è l’ultima tappa della purificazione di Dante, reso
consapevole, dopo gli aspri rimproveri di Beatrice, del proprio traviamento
morale ma anche intellettuale (probabilmente, le sue simpatie per l’averroismo
latino). Alle lacrime per la scomparsa di Virgilio subentrano quelle di un sincero
pentimento: sono queste lacrime che poi consentiranno a Dante di contemplare
Beatrice non più velata dai fiori gettati dagli angeli, ma in tutta la sua bellezza,
nella quale si riflette anche l’immagine di Cristo. È nota l’architettura di questo
canto XXX: il nome Beatrice pronunciato al v. 73, preceduto da 72 versi e
seguito da 72 versi; il canto preceduto, nella Commedia, da 63 canti e seguito da
63 canti: si arriva sempre alla famosa cifra simbolica 9 (7+2, 6+3). Negli ultimi
due canti, XXXII e XXXIII, riprende la processione allegorica e vi è la
metamorfosi del carro della Chiesa, che rappresenta la visione fondamentale,
con il passaggio da un registro storico, che io chiamerei semplicemente
profetico, a un registro apocalittico, con l’investitura profetica di Dante. Cito da
Purg. XXXII, vv. 100 e 105: “Qui sarai tu poco tempo silvano; / e sarai meco
sanza fine cive / di quella Roma onde Cristo è romano. / Però, in pro del mondo
che mal vive, al carro tieni or li occhi, e quel che vedi / ritornato di là, fa che tu
scrive”. Non “quel che hai visto”, ma “quel che vedi”: cioè, le metamorfosi del
carro. Poi, nell’ultimo canto, dopo aver assistito alle metamorfosi del carro della
177
Chiesa, Dante riceverà una nuova investitura profetica da parte di Beatrice e la
spiegazione dello spettacolo al quale ha assistito.
Allora, nella prima prospettiva che ho indicato, cioè quella di una creazione
poetica che non è in contraddizione con i dati rivelati, il Paradiso terrestre
rappresenta un’anomalia, perché, per quanto felice e ricco sul piano poetico, è
una sorta di parentesi nell’itinerario di purificazione, non di Dante personaggio,
che poi è immerso nei due fiumi e quindi degno di spiccare il volo per il
Paradiso, ma nella configurazione teorica dello stesso Paradiso terrestre: il
passaggio dal Paradiso terrestre dovrebbe interessare tutte le anime e non
soltanto Dante e Stazio, che non pronuncia parola.
In questa prospettiva indico qualche perplessità, qualche problema, che
non ho la pretesa di risolvere ora. Il viaggio di Dante nell’aldilà si colloca
evidentemente prima della parusìa: il Paradiso terrestre, in questa prospettiva,
non può essere una interpretazione letteraria, una prefigurazione dei cieli e della
nuova terra di cui parlno l’Apocalisse e la seconda lettera di San Pietro.
Naturalmente Dante lo sa. D’altra parte, parlare di un ritorno all’Eden, luogo
della felicità naturale dell’uomo prima della disobbedienza di Adamo ed Eva,
non mi pare del tutto convincente, perché l’anima – dopo essersi purificata
attraverso l’ascesa della montagna del Purgatorio, ascensione e purificazione
dominate dall’esempio di Cristo e dall’intercessione costante di Maria, proposta
come modello – scoprirebbe allora il luogo di una felicità meramente naturale
prima di accedere a quella soprannaturale. Il caso di Dante è un po’ diverso,
sfugge a questo rilievo. Ora, né per Dante personaggio né per le anime del
Purgatorio, mi sembra che nulla possa giustificare un ritorno allo stato di felicità
naturale, perché tutte le cornici del Purgatorio sono rette da un’economia della
redenzione operata da Cristo. È stato proposto anche che per le anime purificate
si tratterebbe di scoprire il luogo ove Dio ha collocato Adamo ed Eva, luogo
vuoto perché appunto la disobbedienza d’Eva lo ha reso così; ma anche in
questo caso il Paradiso terrestre rappresenterebbe il ritorno a uno stato di natura
umana, eventualmente dotata di facoltà preternaturali o di doni preternaturali
– ma siamo sempre molto lontani dal regno della grazia, dalla visione beatifica
che attende le anime purificate in Paradiso – cioè a uno stato anteriore
all’incarnazione di Cristo, mentre tutta l’economia del Purgatorio è basata e
incardinata sulla redenzione.
Questo pone anche altri quesiti, che non tolgono nulla alla bellezza
straordinaria di questi canti e alla loro anche difficile interpretazione: i riti di
purificazione e la processione mistica riguardano unicamente Dantepersonaggio? Evidentemente il Paradiso terrestre, salvo Stazio e Matelda, è
praticamente vuoto, e la presenza di Stazio è una presenza muta. Ora,
evidentemente, non ci sono scene di purificazione collettive perché c’è la
178
coreografia straordinaria della processione mistica che le sostituisce. Però,
mentre la metamorfosi del carro appare come un messaggio apocalittico rivolto
unicamente a Dante, il lettore si domanda se questa processione teoricamente fa
parte del passaggio attraverso il Paradiso terrestre di tutte le anime.
Rapidamente, per non abusare della vostra pazienza, giungo all’ultimo
punto: il passaggio da una scrittura profetica ad una scrittura apocalittica. La
prima fase della processione allegorica (canto XXIX) si svolge tra un baleno e
una luminosità che cresce continuamente e un tuono che indica poi
l’interruzione provvisoria della processione: sono segni profetici, che indicano la
dilatazione e qualche volta anche la sospensione del tempo. La descrizione della
processione allegorica è inscritta esplicitamente da Dante in una tradizione
apocalittica. Vi leggo solo alcuni versi: “A descriver lor forme più non spargo /
rime, lettor; ch’altra spesa mi strigne, / tanto ch’a questa non posso esser largo;
/ ma leggi Ezechïel, che li dipigne / come li vide da la fredda parte / venir con
vento e con nube e con igne; / e quali i troverai ne le sue carte, / tali eran quivi,
salvo ch’a le penne / Giovanni è meco e da lui si diparte”. Quindi si invita il
lettore a rifarsi a Ezechiele e all’Apocalisse per cogliere il significato della
processione: i sette candelabri sono i sette doni dello Spirito Santo; i
ventiquattro vegliardi sono i libri dell’Antico Testamento; il vegliardo isolato,
colto in un momento di sonno estatico, che avanza quasi dormendo con la
faccia arguta, è naturalmente Giovanni o la sua Apocalisse. Per me, questa
descrizione della processione mistica, benché inserita da Dante in un contesto
apocalittico, è semplicemente una visione profetica, che non dà un messaggio
particolare a Dante-personaggio.
Viceversa, la metamorfosi del carro si iscrive perfettamente nel registro
apocalittico. Qui Dante riprende, con estrema finezza e con estrema cautela, un
episodio narrato da vari evangelisti, cioè la trasfigurazione e il sonno improvviso,
segno della teofania, che coglie Pietro, Giovanni e Giacomo quando la visione
dell’umanità già gloriosa di Cristo e l’apparizione dei due grandi profeti li
abbaglia e li stordisce. Subito dopo, Cristo dice di non parlare di questa visione
prima della sua resurrezione. Dante riprende questi elementi, perché cita
esplicitamente l’episodio della trasfigurazione; ma la ripresa è speculare: il sonno
di Dante precede la visione apocalittica. Al suo risveglio trova Matelda e poi
Beatrice, che diventerà un attore principale della scena della metamorfosi del
carro, perché respingerà l’eresia e poi, soprattutto, ne darà la spiegazione.
Quindi c’è, da parte di Dante, una specie di mise en abîme della dimensione
profetica: in quanto personaggio è profeta, cioè testimone oculare di ciò che
vede, ma le metamorfosi del carro sono una visione destinata a lui unicamente,
che è oggetto di una solenne investitura profetica da parte di Beatrice.
Non ho tempo per approfondire le quattro fasi della metamorfosi, peraltro
179
notissime. Nella prima, l’aquila, l’uccel di Giove, che si scaglia sulla Chiesa,
rappresenta, secondo la maggior parte degli interpreti, le persecuzioni
dell’Impero romano contro i cristiani. Anche qui c’è l’iscrizione in un codice
molto preciso: la barca è icona da sempre della Chiesa, la barca di Pietro. La
volpe, autrice del secondo attacco sferrato al carro, è l’eresia che cerca di
infiltrarsi all’interno della Chiesa ed è respinta da Beatrice. Se si pensa ai primi
secoli del Cristianesimo, è l’eresia monofisita o, più probabilmente, l’eresia
ariana; se si pensa all’epoca di Dante, è il manicheismo o l’eresia catara, ultima
manifestazione del manicheismo, che aveva attraversato i Balcani ed era dilagata
in Italia del Nord e in Provenza. Quarto assalto e quarta metamorfosi: il drago
rappresenta forse la donazione di Costantino, ma potrebbe essere il desiderio
disordinato di beni materiali: “O navicella mia, com mal se’ carca!”. La
metamorfosi vera e propria avviene quando il carro, per effetto dell’auri sacra
fames o, in termini giovannei, della concupiscentia oculorum, cedendo
all’attrazione delle ricchezze temporali, si trasforma in un mostro orrendo dalle
sette teste, i peccati capitali, tre delle quali sono spuntate sopra il timone e
quattro a ognuno degli angoli del carro, e dalle dieci corna, cioè i dieci
comandamenti continuamente trasgrediti. Quindi, nell’ultima scena,
impressionante, secondo i canoni della tradizione apocalittica, la Chiesa appare
come una puttana sciolta che siede sul mostro; questi versi sono conosciutissimi:
“Sicura, quasi rocca in alto monte, / seder sovresso una puttana sciolta /
m’apparve con le ciglia intorno pronte; / e come perché non li fosse tolta, / vidi
di costa a lei dritto un gigante; / e basciavansi insieme alcuna volta. / Ma perché
l’occhio cupido e vagante / a me rivolse, quel feroce drudo / la flagellò dal capo
infin le piante; / poi, di sospetto pieno e d’ira crudo, / disciolse il mostro, e
trassel per la selva, / tanto che sol di lei mi fece scudo/ a la puttana e a la nova
belva”.
Un lettore della Divina Commedia, se ha buona memoria, e all’epoca di
Dante questo era più facile che ai giorni nostri, probabilmente ricorda che
questo termine – che ha un significato apocalittico chiaro: la puttana è
l’adulterio, è il tradimento dell’alleanza con Dio, l’idolatria nel linguaggio
biblico; e poi naturalmente c’è l’immagine della magna meretrix, dell’Apocalisse
di Giovanni: Babilonia, poi diventata Roma, poi Avignone – è già nel canto
XVIII, vv. 133-134 dell’Inferno: Thais è definita la puttana e Trasone il suo
drudo. Per analogia si vede immediatamente che Filippo il Bello, re di Francia,
“prostituisce” per così dire la Chiesa, e così prima Bonifacio VIII e Clemente V,
primo papa avignonese. Nel canto XX del Paradiso, v. 55, sarà invece San
Domenico a essere definito amoroso drudo, ma stavolta della Fede. Queste tre
occorrenze creano una rete di analogie e di fortissima opposizione fra i primi
due casi e il terzo. Poi basta rileggere l’ottava epistola di Dante per rendersi
180
conto che il riferimento a Filippo il Bello è chiarissimo. Gigante come Golia,
lega a sé con amori adulterini la Chiesa e porta la magna meretrix nella foresta.
La spiegazione, in forma di profezia di speranza, è formulata da Beatrice nel
canto XXXIII, in versi celeberrimi: “Non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia
che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia preda; / ch’io
veggio certamente, e però il narro, / a darne tempo già stelle propinque, / secure
d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro, / nel quale un cinquecento diece e cinque, /
messo di Dio, anciderà la fuia / con quel gigante che con lei delinque”. E ancora:
“Tu nota; e sì come da me son porte, / così queste parole segna a’ vivi / del viver
ch’è un correre a la morte”. Molto giustamente è stato fatto notare che questa
morte può essere non soltanto la morte come fine della vita, ma la seconda
morte della tradizione neotestamentaria, cioè la morte del peccato.
Naturalmente non voglio risolvere il problema del cinquecento diece e
cinque. Semplicemente, per concludere, vorrei fare osservare due cose. Con
molta coerenza Dante si astiene dal pretendere che il messaggio gli sia stato
trasmesso direttamente da Dio. Questi canti del Paradiso terrestre non sono
l’Apocalisse di Giovanni. È Beatrice che funge da intermediario per spiegare il
significato della visione e per ingiungere a Dante il compito profetico. D’altra
parte, la caratteristica dello stile profetico e apocalittico, che è quella di una
voluta oscurità, scompare con le accuse dirette a Filippo il Bello, a Bonifacio
VIII, alla curia avignonese, per le ragioni alle quali si è già accennato – il
desiderio di ricchezze materiali – e anche per le dispute sotto il pontificato di
Giovanni XXII tra gli Spirituali, o piuttosto i Fraticelli, e i Conventuali a
proposito dell’usus pauper, con il papa avignonese che condanna la proposizione
secondo la quale Cristo non avrebbe mai posseduto nulla in proprio.
Che Dante-autore formuli questo messaggio di speranza, enigmatico,
prima o dopo il 24 agosto del 1313, cioè prima o dopo la morte di Arrigo VII,
in fondo poco importa, perché Dante ha comunque un’indefettibile speranza
nel ritorno, nella restaurazione attraverso vie provvidenziali, della giustizia sulla
terra. Ecco perché questa rivelazione, che è capitale nella Divina Commedia,
avviene nel Paradiso terrestre: perché è il “luogo” dell’aldilà in cui la nozione di
tempo ha forse ancora un senso.
181
Finito di stampare
nel mese di Giugno 2013
nella Tipolitografia F.lli Stalla
di Albenga
Scaricare