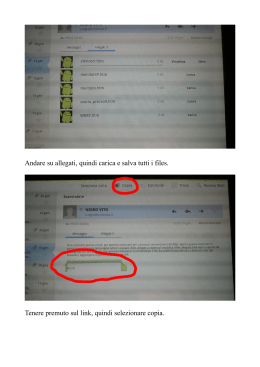8 CONCORSO NAZIONALE PER SCRITTORI INEDITI 2011 Parole in Corsa I RACCONTI Proprietà letteraria degli autori - tutti i diritti riservati E' vietata la riproduzione totale o parziale da parte di terzi Coordinamento: Michela Gastaldi Supervisione: Marco Gandini Responsabile editoriale: Alessandro Traverso Progetto grafico: Carlo Ponzano Stampa: Valterza - Casale Monferrato Novembre 2011 II 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 LA GIURIA Che ha selezionato i racconti premiati Presidente CLAUDIO BRAGGIO MASSIMO TAGGIASCO CINZIA ARIATTI 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 III IV 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il tema del trasporto ha in sé contenuti di varie sfaccettature, ma in particolare fa tornare alla mente l’idea del viaggio. Non solo il viaggio in terre lontane, per necessità o per soddisfazione personale o per curiosità, ma anche il viaggio in questa nostra provincia, caratterizzata da un’identità tutta particolare, che per storia, tradizioni e cultura si differenzia da altri luoghi con la mutevole morfologia del territorio e con l’indole degli abitanti, aliena dal riserbo dei piemontesi, dalla intraprendente sfrontatezza dei lombardi, dalla parsimonia dei liguri. Ma anche una provincia che ha saputo generare personaggi famosi in ogni campo, dalla cultura, alla storia, alla politica, allo sport ed allo spettacolo. E chissà se tra i generosi partecipanti a questa ottava edizione del Concorso, non emerga qualche “buona penna” che sappia conquistarsi una meritata celebrità? L’aver offerto l’occasione di un trampolino di lancio ci procura senz’altro un legittimo sentimento d’orgoglio. In ogni caso, indipendentemente dai risultati, per citare l’ideatore dei giochi olimpici, l’importante è partecipare. Ed i partecipanti anche quest’anno si sono presentati in nutrita schiera; un solo rammarico: i giovanissimi, gli appartenenti alla generazione dei “nativi digitali”, i quali non nutrono molte simpatie per carta e penna e tuttavia comunicano incessantemente con il mondo esterno attraverso l’etere con i nuovi strumenti della tecnologia offerti da Internet, sono pochissimi. Forse abbiamo commesso qualche errore nella diffusione delle informazioni, forse il nostro messaggio non è stato sufficientemente in grado di stimolare la loro partecipazione, forse non abbiamo abbastanza sottolineato il fatto che un componimento statico rappresenta comunque la comunicazione di un’idea che resta nel tempo ed assume valore sempre, anche se priva di risposta o di dialogo immediato. Ci ripromettiamo, per la prossima edizione, di colmare questa lacuna. A tutti i partecipanti un caloroso ringraziamento. Gian Paolo Cabella Presidente ATM 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 V INDICE Una Matita Il treno per uccidere La novanta I viaggi di Silvio Goodbye Dottor Faust Stop Biografia di un vegetale I RACCONTI DEI PREMIATI . . . . . . . ALESSIA SANTANGELETTA . . . . . . . . . . . . . . . FRANCESCO CHEYNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALESSANDRO CONTINIELLO . . . . . . . . . . . . . FLAVIA BORRELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FABRIZIO GOTTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROBERTA ZAVORRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUGENIO BERNARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 5 6 7 8 9 Il destino di un marinaio GIAN LUCA TROVÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Il rumore del mare Un lungo viaggio nel mio cuore C'e siest@ per te Il Mappamondo Una giornata come le altre. Gli zombi tra noi Ritorno a Prato La galleria Il viaggio di Chiara "Va giù" Il ritorno a casa In treno A sud del sud Sei fatidici numeri Le fermate del tempo Serata indimenticabile Ed io penso a te Mena Sono venuto nella polvere e me ne andrò nel vento In attesa di un cortese riscontro Una dimensione parallela La meta finale Piazza degli eroi Ma le farfalle prendono l'autobus? Tetraspazio Neve in boccia Viaggio tra i ricordi di un mondo che non c'è più Il viaggio della Hor VI I RACCONTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARCO ADORNETTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARCELLO ALFONSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREA ARDITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTONIO BARBARELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTEO BARONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAOLO BARTOLOZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANIELA BENAZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SILVANO CAPPELLETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIANLUCA D'ACQUINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTONIO CULCASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETTORE DEDOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTONIETTA DE LUCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREA DEPANIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRISTINA DI NARDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAUSTO FERRETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FEDERICA FERRETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARMEN FURFARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FABRIZIO GASCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIA NATALIA IIRITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERIKA LODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAVIDE MARAZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTONIO MARTONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FEDERICA MASTROLONARDO . . . . . . . . . . . ANGELA MAURIZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALESSANDRA MEROLLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIA GIOVANNA MURGIANO . . . . . . . . . . ANTONIA NAPOLANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Viaggio sulle linee di un viso La coperta di lana Ritorno agli anni verdi Spruzzi di colonia La spia dal dente d'oro Gedeone Uruguay andata e ritorno Le principesse si salvano da sole Il primo viaggio Viaggio temporale: dal futuro alla genesi Il regalo Principio e fine Il viaggio dei cavalieri La malinconia delle cose Otto e dieci La clinica Lettera ad una figlia 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 FABRIZIO NARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROSA OLIVETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORDELIA PAGELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIUSEPPINA PAGELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALERIA PARIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREA PESCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHELA POLLAROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CINZIA ROMANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRISTINA SARACANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIETRO PAOLO SCHERMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISABELLA SERAFINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASSIMO TASSISTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNA TRAVERSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMANUELA VERDONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SILVIA VINDITTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SILVIA VIPIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORRADO VISONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 53 54 55 VII VIII 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 I RACCONTI DEI PREMIATI 8 CONCORSO NAZIONALE PER SCRITTORI INEDITI 2011 Parole in Corsa I Racconti Dei Premiati 1 2 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Primo classificato Una matita ALESSIA SANTANGELETTA Telemaco era un giovane ragazzo nato in una famiglia poco abbiente al tempo di Napoleone e Leopardi. Abitava in un piccolo paese sulle colline del Monferrato, e da lì non si era mai mosso; per questo, da tempo, sognava di andarsene. Avrebbe tanto voluto fare un viaggio, una semplice vacanza, andare al mare o al lago e fare delle lunghe passeggiate respirando aria diversa da quella di casa. Vagheggiava la sua piccola evasione e attendeva con impazienza il giorno giusto per realizzarla. Un bel mattino partì: tutto quello che aveva era una bicicletta, ma il cielo era sereno, l’aria mite e si sentiva in forze, pronto a raggiungere il mare; tutto ciò gli sembrava abbastanza. Iniziò a divorare metri su metri: se gli altri camminavano, lui pedalava e li superava senza fatica. Ma dopo alcune ore si accorse che, per quanto si sforzasse di andare veloce, c’era chi lo sorpassava in carrozza e certamente sarebbe arrivato prima di lui a destinazione, qualunque essa fosse. Telemaco capì di non essere poi così fortunato e, sfinito, si arrese abbandonando il suo sogno. Telemaco non vide mai il mare. Alfonso, di poco più grande di Telemaco, aveva due cavalli e una carrozza. Anche lui voleva andarsene dal suo paese collinare per fare fortuna in America. Sapeva quanto fosse difficile intraprendere un viaggio simile, ma un giorno bardò i cavalli e partì. Gli sembrava di andare veloce: per la strada incontrava perlopiù persone a piedi, che in fretta si lasciava alle spalle con una punta di orgoglio; incrociò anche un ragazzo ormai esausto che arrancava con una bicicletta, e si sentì fortunato. Ma dopo qualche ora, per quanto spronasse i cavalli, si accorse che non bastava. Ci sarebbe voluta una locomotiva o una nave per arrivare in America, e lui aveva soltanto una carrozza. Alfonso capì di non essere fortunato come aveva pensato, e si arrese abbandonando il suo sogno. Alfonso non arrivò mai in America. Osvaldo era un ragazzino molto povero. Non aveva mai avuto molto dalla vita, se non una famiglia amorevole e un pezzo di pane per sfamarsi ogni giorno. Avrebbe voluto anche lui viaggiare e scoprire posti nuovi, ma non aveva niente e una piccola casupola ammuffita era il suo mondo. Quando era in strada, guardava con ammirazione le carrozze che passavano con i cavalli al trotto e in cuor suo pregava il cielo che almeno gli donasse una bicicletta. Non voleva andare al mare, e nemmeno in America: la sua fervida fantasia voleva raggiungere la luna, quel disco argenteo che molte notti lo faceva restare a naso insù per diverse ore, col fiato sospeso per la bellezza. E si doleva, perché non aveva nemmeno una bicicletta, e la luna non poteva certo raggiungerla a piedi. Se gli altri correvano, lui rimaneva indietro. Un giorno trovò una matita in terra e la raccolse; era consumata e sgretolata in cima, ma aveva la punta robusta. Pur non sapendo che farsene, Osvaldo la portò con sé. Quella sera, guardando la luna, se la girava e rigirava tra le dita come un portafortuna e fu lì che, all’improvviso, ebbe l’illuminazione. Sarebbe partito e avrebbe raggiunto la luna: non si sarebbe arreso. Osvaldo si procurò della carta e, con la sua matita consumata, iniziò a disegnare abilmente alberi, campagne fiorite, carri e buoi: così lui immaginava il disco luminoso della notte e, sebbene non l’avesse mai visto, i disegni gli parevano più reali della sua stessa casupola. La sua vita era in quei disegni. Chissà se Osvaldo diventò un artista? Ciò che sappiamo è che divenne un ragazzino sorridente. Felice dei suoi viaggi senza bicicletta, felice con la sua sola matita consumata. Osvaldo capì di essere più fortunato di quel che aveva pensato, pur senza una carrozza, ma non senza sogni. Osvaldo trovò la luna. Seguendo il proprio sogno e accontentandosi. Di una matita. I Racconti Dei Premiati 3 Secondo classificato Il treno per uccidere FRANCESCO CHEYNET Comprese che tutto stava finendo. Dal finestrino, l’orrore delle torce che venivano avanti, era il suo urlo nudo che non aveva la forza di chiedere pietà, e si perdeva nel ricordo delle atrocità stampate nella propria coscienza. La follia era stata cattiva consigliera nel far credere che il suo agire fosse stato giusto, reale, conseguenza di un rancore legittimo. Senza alcun pentimento, si accartocciò in un angolo del vagone e puntò il coltello all’altezza del cuore. Si riconobbe, nella sua vecchia abitudine di farsi del male, poi vinse la paura, spinse forte, e si perse per sempre. Il viaggio era cominciato due settimane prima. In un treno, fermo all’ultimo binario della stazione Termini, dopo un ultimo saluto al cellulare: - No mamma non torno a casa ho deciso di fare un viaggio. - Un viaggio per dove? - Aveva risposto la madre. - Prendo un treno per il Nord, non so dove mi fermerò. Nessuna fermata. Partì con impressa negli occhi l’ultima immagine rubata dal finestrino mentre il treno cominciava a muoversi: un cumulo di ferraglia e vari oggetti abbandonati accanto alla ferrovia. Dopo di allora un viaggio allucinato. Il pensiero di uccidere, di accoltellare, era una fabbricazione recente, ma la rabbia maturata nel corso tempo riversava nella sua mente fantasie troppo vibranti per essere parcheggiate, e nelle mani una lama per uccidere. In ogni stazione c’è un palo vicino ai binari, e a volte c’è una donna che cammina nel buio, troppo in ritardo dopo che i treni hanno fermato per l’ultima volta, o troppo in anticipo prima che i treni ricomincino a partire. “E’ stato come forare un materasso” pensò la prima volta che l’ebbe fatto. Aveva congelato in mente, come un trofeo del demonio, quell’impressione, ma accolse con fiero entusiasmo quel sentirsi diversi quando, allontanandosi con la paura che qualcuno avesse visto, si voltò per ammirare un corpo legato ad un palo. E mentre annusava il vento gelido della riscossa, scaldava il proprio orgoglio nella tiepida sensazione di aver cambiato palcoscenico, confondendo il copione di una trama insulsa, che da sempre gli aveva cucito addosso il ruolo di vittima e di comparsa. La seconda volta avvenne due sere dopo: il suo treno aveva fatto capolinea a Torino intorno alle 22 ed aveva atteso che le persone fossero scese tutte. Stette di guardia ad un finestrino, e quando vide una donna aggirasi li fuori, scese e colpì con fredda decisione. Un’alba scabrosa avrebbe trasportato nel cuore dei passanti una torbida emozione, nei loro occhi il rosso del sangue rappreso, e nei loro futuri incubi un palo di cemento che tratteneva una donna morta. Tornò sul treno vuoto dove avrebbe dormito e viaggiato di nuovo, secondo un rituale che avrebbe accompagnato quei giorni sino all’epilogo finale, ma prima che si addormentasse il cellulare squillò: - Sono preoccupata sono due giorni che non ti fai sentire. - Mamma sto bene non preoccuparti per me. - Ma dove sei in questo momento dove passi la notte? - Riprese ansiosa la madre. - Sono in albergo è tutto a posto. - Ma quando.... Non diede il tempo di terminare, chiuse la comunicazione, e si addormentò su un sedile. Nei giorni che vennero l’osceno spettacolo si susseguì a più a riprese. Ma i sogni della notte cominciarono ad essere confusi, deliranti, e spesso si confondevano con i pensieri del giorno: Il coltello impugnato al contrario che tagliava la sua mano; il personale del treno che gli offriva da mangiare; la donna che inseguiva ad un tratto gli era dietro. Si svegliava mille volte, dentro un crescendo di brividi e di sudore, in un frullato di pensieri scomposti. L’unica certezza che accompagnava i giorni del cambiamento, consisteva nel suo malessere. Aveva armato la sua mano e la sua rabbia, minato il sentiero del bene, oltraggiato ogni più elementare valutazione su ciò che potesse essere giusto o sbagliato, splendente o cupo, vero o falso. Era come se il filo logico del suo pensiero fosse guidato da una mano tremolante che con una penna unisce i numeri di un disegno incomprensibile, e ad ogni nuovo punto, una città per uccidere. Avrebbero messo fine al suo progetto, si che lo avrebbero fatto ma aveva senso fermarsi? Il giorno della fine lo aveva fatto di nuovo: a pochi metri dal treno, con in mano il coltello, aveva trascinato la sua ultima vittima vicino al palo. Una coltellata, poi un’altra e un’altra ancora. L’aveva lasciata legata tornando a ridacchiare sul treno: “proprio come forare un materasso”. Avrebbe telefonato alla madre se solo tre giorni prima non avesse gettato il cellulare dal finestrino, per paura qualcuno intercettasse la sua posizione. Ma quando udì delle voci crescere e vide le luci avvicinarsi, intuì che quella precauzione non era servita... e comprese che tutto stava finendo.... - Fino a ieri era qui, sono certa, gli ho portato da mangiare - Disse una ragazza con la torcia in mano. - Non da notizie alla madre da almeno tre giorni sei sicura si trattasse della stessa persona? - Rispose un volontario alle sue spalle. - La descrizione fatta dalla madre coincide perfettamente. Entrarono nel vagone e trovarono il corpo sanguinante e senza vita. Nella ricerca di un perché le torce puntavano fuori dal finestrino. Una scritta arrugginita indicava che quella era la stazione Termini. Poco più in qua un cumulo di ferraglia e vari oggetti abbandonati accanto alla ferrovia. Più distante un telefonino cellulare giaceva al suolo, e legato ad un palo un materasso forato in vari punti. Su un binario morto, l’ultimo binario della stazione termini, un treno dismesso e abbandonato da anni, aveva portato con se l’ultimo passeggero nel viaggio più assurdo che si possa immaginare. Una donna vi era salita nel disperato tentativo di vincere quella terrificante mania di farsi del male ma ne era derivata una sconfitta tragica e completa, senza possibilità rivincite. Non ci sarebbero stati giornali a scrivere di una spietata carnefice, non ci sarebbero stati mostri per sfamare le loro cronache. Quel che rimaneva, invisibile al mondo, era un viaggio mai iniziato, l’immaginazione straripare nella realtà, la solitudine inventare un riscatto nero, e, al di qua del confine, un cellulare a terra squillare senza che nessuno potesse più rispondere. 4 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Terzo classificato La novanta ALESSANDRO CONTINIELLO È terribile quello che mi è successo, solo ora trovo il coraggio di raccontarlo. A ripensarci tremo ancora come una foglia. Mi trovavo, come al solito, sul bus numero novanta: per capirci quello che porta da Via dell'Unità d'Italia a C.so Secessione. Erano le sette di sera. Era autunno. Il bus era colmo di gente: a mala pena ero riuscito ad entrarvi. Ad ogni modo parte del viaggio lo feci seduto, per poi cedere il posto ad una signora più anziana di me che, vista la verve, mi avrebbe seppellito. Il conducente era stanco: lo si poteva dedurre dalla sua fretta nel passare le fermate prive di persone in attesa. Anche lui certamente voleva far ritorno a casa. Quando si è sui mezzi pubblici si storce il naso nel percepire il vociare delle altre persone, censurando coloro che parlano al cellulare ma, inevitabilmente, si cerca di carpire i loro discorsi. Io non sono solito farlo, preferisco estraniarmi e viaggiare con il pensiero. Faccio un banale gioco: osservo le persone fuori dal vetro ed immagino dove si stiano recando e chi siano nella vita. Questo gioco mi permette, viaggiando con l'immaginazione, di confrontarmi con loro. Se piangono, cerco di capire cosa sia successo; se parlano da soli, mi fanno sorridere ma li comprendo. Anch'io sono come loro. Mi capita allorché vivo, anzi ho vissuto una situazione di profondo stress emotivo in cui avrei voluto rispondere in un certo modo all'interlocutore ma, o non ho avuto la possibilità o, morsicandomi la lingua, ho semplicemente desistito. Ma poi, ripensandoci, rivivo la scena come avrei voluto, immedesimandomi nuovamente ma con un finale differente: insomma dico quello che avrei voluto dire. È come se mi estraniassi dal corpo, tornassi indietro come in un viaggio nel tempo e ripetessi tutto nei minimi particolari tranne, tranne il finale. Capita che mi riprendo da questo sogno, torno alla realtà ed inizio a ridere per quello che ho fatto. Di solito termino con la frase “ma sei proprio scemo” e non capisco come mai la gente a me prossima annuisca. Mah? Ma che ti ridi, poi? Ci conosciamo? Lo penso solamente. Mi piace osservare la gente che ride, che ride da sola. Vuol dire che sta ripensando ad un fatto accaduto che le ha provocato gioia o simpatia. La camminata delle persone è un'altra stranezza: tramite la stessa si capiscono tante cose. Vi sono varie tipologie da me coniate: “a scimmia” ossia quelle persone a cui manca un anello nell'evoluzione darwiniana della specie; alla Celentano” ossia quelli che sembra abbiano delle molle sotto i piedi; i “disarticolati” che mentre camminano muovono, come se avessero degli spasmi, gli arti superiori. Io? Cammino benissimo chiaramente. Preferisco questo gioco rispetto al passatempo di leggere tutto quello che passa davanti agli occhi: si comincia con il contenuto pubblicitario dentro al bus per continuare con il resto. Come in ascensore: giunti al piano si sa vita, morte e miracoli dell'installatore. Il tragitto era quasi terminato e la mia fermata si stava avvicinando. Da lì in cinque minuti con passo tranquillo sarei giunto a casa. Mentre continuavo a fare il gioco dell'indovino, mi accorgo che si era creato un silenzio surreale: tutti i viaggiatori si erano simultaneamente zittiti. Mi guardo attorno circospetto con brevi movimenti del collo e degli occhi a destra e a manca per non destare troppi sospetti, e noto che i miei compagni di viaggio urbano mi fissavano. A questo punto simulo una tranquillità apparente e percepisco che una prima gocciolina di sudore mi pervade la fronte: non mi scalfisce la circostanza, consapevole che la temperatura corporea ormai alzatasi l'avrebbe fatta evaporare. Per stemperare la situazione, decido di guardare fuori dal finestrino e distrarmi: tanto penso che è solo un'allucinazione e presto tutto finirà. Ripeto tra me e me “non fa male dai, non fa male!” che noto un'altra circostanza analogamente strana. Anche la gente all'infuori del nostro acquario viaggiante si era fermata e mi osservava in silenzio. Ma cosa sta succedendo? Cosa volete tutti da me? Dico, parlando con il pensiero. Non riesco quasi a terminare la mia domanda amletica che percepisco un'unica voce comune indirizzata alla mia persona: “Ma la finisci di farti sempre gli affari nostri, tu ed il tuo gioco stupido?”. “Scusate, ma dite a me?”. “Si, si a te! Non fare finta di niente, barbagianni! Ogni giorno la stessa storia: ci guardi, ci osservi anzi ci scruti e commenti!”. “Per non parlare poi di cosa esce da quella tua bocca mefistofelica quando incroci una ragazza!”. “Ma scusate, cos'è una congiura! Vi siete messi tutti d'accordo?”. Muovo le orbite e noto che tutti continuano a fissarmi, anche il bambino con il cappello blu a visiera con sopra un elica ed altresì il gatto nella gabbietta. Lo fisso, mi guarda e mi dice: “Ma che ti guardi bipede?”. “Scusate voi tutti, posso farvi una domanda?”, e tutti coralmente, ma sempre con la bocca chiusa – al che pensavo fossero dei ventriloqui -: “Ma voi mi sentite quando parlo con il pensiero?”. E loro: “Ma che ti credi di essere l'unico?”. Attonito, scesi alla mia fermata e tornai a casa in silenzio vocale e soprattutto mentale. Non raccontai a nessuno questa storia e non presi più, per paura, quell'autobus. La novanta. I Racconti Dei Premiati 5 Quarto classificato I viaggi di Silvio FLAVIA BORRELLI Silvio aprì lentamente la porta di casa ed emise un grosso sospiro di sollievo quando sprofondò sul divano. Era esausto perché i suoi studenti, nonostante avessero tutti delle menti brillanti, erano troppo presi dai loro pensieri per dedicarsi seriamente alle sue lezioni e di conseguenza, ogni giorno, lui impiegava il doppio dell’energie per adempiere al suo lavoro d’insegnante. Con occhio clinico si guardò attorno e non poté far a meno di notare il sudiciume che regnava nell’appartamento da quando sua moglie lo aveva lasciato. Controvoglia si alzò deciso a far un po’ di pulizie poi vide il computer e, dimenticandosi dei suoi buoni propositi, lo accese. Da quando era rimasto solo quell’ammasso di microchip era la sua unica compagnia, lo amava e passava intere ore a chattare con degli sconosciuti inventandosi ogni volta una vita diversa e appagante. Quella sera decise di essere lo sceicco arabo Omar Shalir e parlò del deserto, dei cammelli, dei pozzi di petrolio e del suo harem popolato da giovani mogli bellissime e pronte ad esaudire ogni suo desiderio. Mentre le parole prendevano vita su quello schermo, il viaggio virtuale e fantasioso di Silvio iniziò e, come aveva imparato a fare sera dopo sera, si distaccò dolcemente dalla realtà pronto ad immergersi in una nuova e fantastica avventura. Adesso era realmente un grosso magnate dell’industria petrolifera, avvertiva il profumo esotico delle dolci e sensuali concubine che lo attendevano ed infine sapeva che se si fosse affacciato da una finestra della sua lussuosa residenza sarebbe rimasto senza fiato d’innanzi all’atmosfera magica e surreale che gli ispiravano quelle maestose dune sabbiose incorniciate da quella fiabesca luna. Si sentiva felice in quella notte incantata, ma purtroppo come accadeva ogni sera anche quel viaggio finì e lui, con l’amaro in bocca, fu costretto a tornare brutalmente alla realtà. Era di nuovo a casa, circondato dal disordine e dalla solitudine. Omar era sparito portandosi via la sua meravigliosa esistenza e lui era ritornato ad essere l’inutile professore che gli studenti non si degnavano di prendere in considerazione e il noioso Silvio, deriso da tutti, a causa del tradimento della moglie. Si sentì triste e solo, ma quello sconforto durò poco perché sapeva che ci sarebbero state altre sere e altri posti in cui viaggiare... Doveva solo attendere ed il tempo era l’unica cosa che non gli mancava. 6 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Quinto classificato Goodbye Dottor Faust FABRIZIO GOTTA “Good morning Victor“, era il fedele segretario George che tralasciando lo zelo per non essere irritante, maneggiava con prudenza le parole cercando di intercettare l’umore del suo padrone. Victor era uno snob, occupato dalle infinite frequentazioni di persone con reputazioni protette dalla seduzione. Quel mattino s’immaginò una vita diversa, voleva abbandonare il fascino discreto e blasè. Aveva bisogno di relazioni stravaganti, fare un viaggio avventuroso, diventare un’orchidea fra i denti di un leone. Chiamò George pregandolo di portarlo nella periferia di quella capitale, vestendosi senza ostentazione col colore delle foglie morte. Il fedele servitore lo mise in guardia preannunciando una perdita di poesia dentro a quel mondo delirante, consigliandogli un’indifferenza metafisica, ma Victor era determinato e senza indugi si buttarono in quella follia. Si trovarono circondati in una metropolitana multietnica, sbarcati poi sui marciapiedi dove la gente gridava per usare le parole. Si rifugiarono in un Fast Food con il bancone sfiancato dall’usura. George apparecchiava i pensieri con nuvole nere all’orizzonte, osservando Victor che si era sporto per guardare nel piatto del vicino, chiedendo il titolo di quell’opera, tralasciando per un momento il ricordo dei fagiani dorati al tartufo o del cigno muto di Siberia; l’interpellato intraprese tra un boccone e l’altro un curioso contenzioso in un dialetto sconosciuto, citando due o tre massime che maledivano la vocazione al disturbo. George e Victor guadagnarono l’uscita come dei gatti nella notte, celebrando una ritirata onorevole senza eccessi, rifugiandosi anonimi in una grande libreria del centro. Si chiamava Clara la giovane donna che gesticolava vistosamente con un manoscritto tra le mani; la sua gonna rossa ballava nervosamente attorno alla scrivania del Direttore. Era una trattativa, una richiesta di pubblicazione e lei stava declamando alcune pagine di quell’opera, cercando di impressionare l’intransigente editore. Si ritirò poco dopo lasciando distrattamente quei fogli sulla scrivania. George notò il particolare e Victor la rincorse riconsegnandole gli scritti. Affrontò la ragazza curando di incrociare i suoi occhi; cominciarono a parlare di quella circostanza letteraria e un mondo nuovo si fece avanti: lei citò la “Foresta nera “ in Germania, con quel nome così evocativo e casa sua Friburgo. Lui ricordava il colore delle stagioni sull’atmosfera discreta dei palazzi sfumati di rosa, in un viaggio precedente da quelle parti, ma fu interrotto bruscamente dalla giovane, che facendosi seria, raccontò la trama del suo racconto. I fulmini e le nuvole che riversavano sulla terra un buio diabolico, erano il segno di un patto col diavolo, che il Dottor Faust aveva contratto, vendendo la sua anima in cambio di ventiquattro anni di poteri assoluti. Lei aveva riletto più volte quella storia tragica, influenzata da una segreta paura di valicarne i limiti umani. Victor si sentiva coinvolto e quando Clara lanciò l’ultimo strale su quel dramma, raccontando che a Staufen in Baviera, alla “ Locanda del leone “ era avvenuta la lotta finale tra Faust e il diavolo nella camera numero cinque al terzo piano, disponibile per i più coraggiosi lui ne fu affascinato, decidendo di partire subito per quella località. Tutti e tre in un viaggio silenzioso, con i pensieri più cupi penetrarono nella “ Foresta nera “ come si sprofonda in un sogno inquietante. L’entrata della locanda azzardava uno stile di storia persa; George con autorità si avvicinò al bancone, raccogliendo l’immediata approvazione del gestore per quella scelta così coraggiosa perché, raccontava a voce alta, in quella stanza nell’ultima lotta con il diavolo il Dottor Faust fu sbattuto più volte contro i muri insanguinando le pareti e forse, altre tragiche vicende potevano accadere. Salutandosi per la notte, Clara regalò ai due un bacio più di conforto che spinta da un affetto di riconoscenza. George rintracciò dentro di sé un ultimo pensiero: “Perché non avere scelto un cottage in una magica valle del Galles?”, ma rientrò subito nella parte quando Victor aprì la porta della stanza numero cinque: sul muro, un quadro di Delacroix raffigurante Mefistofele che appare a Faust. Furono spente le luci e la buonanotte fra i due sembrava l’ultima drammatica assunzione di coraggio tratta dai poemi di Shakespeare. La notte aveva il silenzio agghiacciante del vuoto, gli scricchiolii generosi dei letti annunciavano barbare sentenze, finché un raggio di luce penetrò inaspettato colpendo in viso il diavolo, sconcertando George, mentre Victor intravide la tela muoversi con un lontano cigolìo che sembrava un gemito e subito dopo una sirena squarciò il silenzio, provocando riflessi di sangue sui muri. Furono rincuorati dal gestore che rapidamente spiegò l’accaduto citando un rumoroso sistema d’allarme, ma intanto i due erano già pronti per la partenza. Clara volle rimanere in quel borgo e mentre loro uscivano da Staufen, George propose a Victor un brindisi all’arrivo in villa nel padiglione di caccia, con un eccellente cuvée di champagne, pregustando quella pigrizia che non si condivide mai volentieri con nessuno. Goodbye Dottor Faust recitò poi sottovoce: il sipario poteva chiudersi, il viaggio nell’avventura era finito. I Racconti Dei Premiati 7 Sesto classificato Stop ROBERTA ZAVORRO Mi trovo in uno stanzino buio, stretto e umido. Non posso parlare, nonostante io stia provando a gridare con tutta la voce che ho in corpo; la mia bocca non emette alcun suono. Le gambe e le braccia non rispondono al mio comando. Sento solo voci che si sovrappongono e mi fanno male. Provo a seguirne una, quella più forte, più sicura: la voce di un uomo. Non mi sembra di riconoscerlo; grida: “Stop!! Fermati!” Io ho paura; paura che qualcosa possa succedere a me o alle persone che amo. La frase continua a tartassarmi il cervello; sento che tra un po’ crollerò. Mi sento sola; abbandonata. Poi, come se avessi espresso un desiderio, l’uomo si materializza davanti a me. Senza bisogno che parli, capisco che è lui, l’uomo della voce. Mi fa cenno di seguirlo. Dove?, mi domando io, se in questo stanzino non c’è neanche una porta. Non vedo come si possa uscire da qui. L’uomo resta accanto a me. Tutto ad un tratto mi sembra che sia l’unico che mi possa capire standomi vicino in questo buio. Improvvisamente me lo ritrovo a un palmo dalla faccia, le nostre labbra si potrebbero sfiorare; sembra quasi che mi voglia baciare, invece, senza dire niente mi carezza la mano. Il contatto con la sua pelle mi dà un senso di freschezza, di benessere. Chiudo gli occhi per assaporare meglio l’attimo. Quando li riapro non mi trovo più nello stanzino. Sono in una piccola casa, sembra che si trovi vicino alla stazione, perché sento lo sferragliare di un treno. Strana coincidenza questa, perché anche la mia casa si trova vicino alla stazione. Entriamo nel soggiorno e la cosa che mi salta subito all’occhio è un quadro di Parigi identico a quello che avevo comprato io due anni fa. Poi, tutto ad un tratto, mi vedo; vedo il mio riflesso allo specchio: peccato che io sia qui e quella non sia io. Il mio “sosia” si trova nel bagno e sta dividendo della polvere bianca su tanti pezzettini di carta stagnola sopra al marmo bianco del lavandino. Inizio a tremare perché in quel momento entra una persona. Nonostante le occhiaie riconosco in lei mia mamma, sconvolta da questa ragazza così simile a me, che sta trafficando nel mio bagno. Perché quella non posso assolutamente essere io, per il solo e semplice motivo che io non diventerò mai così. Vorrei che mi dicesse dove siamo finiti ma lui, invece di parlare, mi prende la mano e mi porta lontano. Sono dentro a un bagno per uomini, ma la persona che sta vomitando dentro al gabinetto è una donna. Vicino a lei una siringa, un cucchiaino e un laccio emostatico. Fisso l’uomo che continua a tenermi la mano. Capisco finalmente che quella donna sta male per causa mia. Improvvisamente mi accorgo dell’uomo che per tutto il tempo è rimasto accanto a me. Mi riprende la mano e io lo imploro di finirla con questo viaggio; vorrei poter tornare a casa e scordarmi di tutto. L’uomo ha deciso di no; mi porta, invece, a casa di mio padre. Questa volta lo capisco subito perché riconosco lo specchio all’entrata. Lo vedo mentre si prepara una canna, vicino a lui una scatolina con tutto il necessario dentro. Questo non può essere vero, perché lui fuma solo sigarette. Adesso sento che dal mio viso iniziano a sgorgare lacrime e l’uomo mi accarezza, asciugandomi il viso con mani di seta. Poi mi riprende la mano e mi ritrovo di nuovo nel piccolo stanzino buio. Sento che è la fine, che il nostro viaggio è terminato. Guardo l’uomo, che impassibile continua a fissarmi. Finalmente mi parla. “Stop!! Fermati!”. Oh no, adesso continuerà a ripetere questa frase all’infinito e io crollerò. Invece no; mi stupisce perché, questa volta, la frase prosegue: “Stop!! Fermati! Fermati per un momento e guarda questo mondo dal di fuori. Continuerà a girare anche senza di te. Osserva bene da che parte gira. Prendi tempo per pensare. Se è la parte sbagliata, tu comincia a girare nel senso opposto. Anche se andrai controcorrente non sarai sola; altri seguiranno il tuo esempio”. Poi l’uomo scompare e io riapro gli occhi. 8 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Settimo classificato Biografia di un vegetale EUGENIO BERNARDI Mi chiamo Anselmo Salice, ho 89 anni, e vivo davanti all’ unica fermata dell’ autobus del mio paesino. Per ovvi motivi naturali non posso muovermi, così passo la mia lunga giornata ad ascoltare i discorsi di tutti quelli che vengono a prendere il mezzo, anche se questo non è molto nobile, ma è l’ unico passatempo di cui dispongo. Ci sono un paio di personcine che movimentano la mia giornata, e altre che invece mi danno molto da pensare: c’ è il signor Guerriero Vernia, la malalingua, un vecchietto mio coetaneo un po’ sordo da un orecchio, che si siede tutti i giorni sulla panchina e cerca di attaccar bottone con chiunque, ma che appena può sputa sentenze. Poi c’ è la signora Leonora, un po’ misantropa, forse a causa del suo lavoro, sapete, fa la chiromante in fondo alla strada. Quando passa lei, davanti alla fermata dell’ autobus, tutti si fanno più rispettosi, per paura che getti loro il malocchio. Ogni tanto, di martedì, vengono pure gli “zuccherosi”: la signorina Valentina e il suo fidanzato, il giovane signor Matteo. Pensate che si incontrano sulla panchina sempre alla stessa ora, in modo che lei possa venire prima delle lezioni pomeridiane, e che lui non debba far tardi con il lavoro. Sono così dolci che se rimanessero qui sotto dieci minuti di più mi si alzerebbe il tasso di diabete. A volte, a notte fonda, si sentono gli sbraiti di Guido, lo “schizzato” che abita nel palazzo di fronte ed urla ad ogni ora del giorno e della notte. Non è che faccia rumore per qualche motivo sensato, lo fa per il puro piacere di dar fastidio. E che dire della Bisbetica Indomata e del suo caro pechinese Attila? Una coppia da far scappare il dottor Frankenstein! Viene tutti i santi giorni a “svuotare” il suo spocchioso cagnolino sotto il mio naso, così che io non possa muovere piede senza incappare in uno dei suoi regalini, cioè non che io possa veramente muovere i piedi, ma il senso è chiaro, no? Ma il peggiore di tutti è senza dubbio quel sadico piromane del Benzinaio Matto, che tutte le volte che viene a prendere l’ autobus, prima di salire, puntualmente mi spegne la sigaretta addosso. Che dolore! Se solo avessi qualcosa da tirargli! A questo punto voi vi starete chiedendo, quale pazzo spegnerebbe una sigaretta addosso ad una persona, e della mia età per giunta? Il fatto è che ne lui ne nessun altro potrebbe sentire le mie proteste. Tutti quanti sono eccezionali solo in una cosa: SFRUTTARMI! Proprio ora stanno arrivando i vandali appena usciti dalla scuola. In riformatorio dovrebbero mandarli! Quelle piccole pesti mentre aspettano l’ autobus cominciano ad usarmi come una matita da temperare. Incidono delle frasi senza senso sul mio UNICO cappotto, e sui miei UNICI pantaloni ci attaccano anche quelle cose appiccicose. Incredibile! Era meglio vivere nel parco! Mi andava bene anche un bosco. Oppure fare parte di una famiglia vivendo in un bel giardino. Non che il posto dove abito sia invivibile, il clima non è poi tanto male, d’ inverno non fa molto freddo e l’estate non è esageratamente calda. Anche se in autunno sono costretto a cambiarmi i vestiti. Ah, bei tempi quelli in cui i miei parenti dominavano tutta la terra. Ormai siamo rimasti in pochi,ed anche se siamo di vitale importanza per tutti, i pochi che sono rimasti, come me ad esempio, vengono anche maltrattati. E dire che la mia famiglia è abituata da sempre ai giardini ricercati. Però alla mia età faccio ancora la mia porca figura. Ma adesso basta lagne, sennò il soprannome che mi hanno appioppato me lo merito proprio, eppure ho anche molto senso dell’ umorismo. Forse avrete già capito chi sono veramente, ma nel caso non ci foste ancora, vi darò qualche altro indizio: il mio cognome e il mio soprannome vanno insieme, gli amici dicono che sono un tipo un po’ depresso (vorrei vedere voi in questa situazione!) e non è a causa dell’ età che non posso muovermi da dove vivo... Ci siete arrivati, no? Firmato Salice Piangente I Racconti Dei Premiati 9 Il destino di un marinaio GIAN LUCA TROVÒ Questo racconto per un errore di impaginazione è rimasto escluso dalla pubblicazione dell’anno scorso. Rimediamo inserendolo qui e ci scusiamo con Gian Luca. Era una gelida giornata di fine gennaio, anno del Signore 1477. In pieno oceano, al largo della costa irlandese, il cielo era coperto da nuvole minacciose che sembravano annunciare una brutta tempesta. La nave beccheggiava per effetto delle onde aizzate da un vento forte e freddo. Il ponte brulicava di attività frenetiche: era necessario regolare le grandi vele ma anche eseguire le manovre per affrontare al meglio i marosi evitando di arrecare danni alla merce stivata con cura prima della partenza. A poppa, il comandante sembrava insensibile al frastuono delle onde, del vento e dei tuoni, alle urla degli uomini dell’equipaggio, agli spruzzi di acqua salmastra che invadevano il ponte. Imperterrito, impartiva ordini, spronava i marinai, controllava la rotta e le condizioni meteorologiche. A bordo della nave mercantile vi era anche un marinaio straniero che al porto di Bristol, in Inghilterra, aveva insistito per far parte dell’equipaggio. Egli soffermava spesso lo sguardo sul comandante, rapito dalla sua fermezza e dal piglio autoritario che infondeva sicurezza a tutta la ciurma. A dispetto della giovane età, lo straniero aveva già maturato una buona esperienza in fatto di navigazioni. D’altronde era originario di Genova, una città di mare e di grandi marinai. Solo l’anno precedente, erano i primi di agosto, si era imbarcato da Noli, nei pressi di Savona. Per la prima volta aveva oltrepassato quelle che gli antichi chiamavano “Colonne d’Ercole” e aveva raggiunto Lagos e poi Lisbona, in Portogallo. Qualche mese dopo, a bordo di vascelli mercantili genovesi, aveva fatto rotta verso l’Inghilterra: prima era approdato nella nebbiosa Londra, quindi, attraversato in direzione ovest l’ imprevedibile canale de “La Manica” e doppiata l’estrema punta sudoccidentale dell’isola, aveva imboccato in direzione est il canale formato dal fiume Avon, giungendo infine a Bristol. Londra e Bristol erano scali fondamentali per i traffici commerciali tra l’area Mediterranea e i paesi del Nord Europa. Qui, ogni giorno, transitavano mercanzie di ogni sorta e di ogni provenienza. Nelle numerose locande che proliferavano in quei luoghi di passaggio, si incontravano, dunque, uomini di mare di culture e lingue diverse. Proprio in una taverna di Bristol, il giovane marinaio aveva udito storie sulle imprese dei famosi guerrieri vichinghi. Si diceva che avessero raggiunto, secoli prima, un’ isola ad ovest della Norvegia, da alcuni chiamata Tile da altri Islanda. Le leggende non si fermavano qui: si raccontava che gli esploratori nordici, sulle loro imbarcazioni dalla testa di drago, si fossero spinti ancora ad occidente, fino ad una terra denominata Groenlandia, poi rivelatasi poco adatta ad un insediamento stabile. Il marinaio genovese aveva ascoltato molto attentamente questi discorsi e spinto da un’insaziabile curiosità, si era unito al tavolo dal quale provenivano i racconti. Dopo aver offerto a tutti un altro graditissimo boccale di birra, aveva chiesto maggiori dettagli sulle vicende che fino a quel momento aveva ascoltato. I suoi occhi si erano illuminati quando qualcuno degli avventori aveva raccontato, fra lo scherno dei suoi compagni, che alcuni vichinghi avevano raggiunto addirittura territori ancor più a ponente, oltre l’inospitale Groenlandia. Anche se i suoi colleghi di mare sembravano non dare molto credito a quelle dicerie, il genovese era convinto che corrispondessero, almeno in parte, alla realtà ed era deciso a verificarlo di persona. L’occasione che attendeva si presentò nel dicembre dell’anno del Signore 1476, quando venne a sapere che la nave mercantile inglese, sulla quale ora si trovava, sarebbe partita da Bristol in direzione dell’isola di Tile. Una volta raggiunta l’isola del fuoco e del ghiaccio, avrebbe trovato il modo di raggiungere la Groenlandia e le terre ad ovest di quest’ultima. Erano dunque già alcune settimane che faceva parte dell’equipaggio del veliero britannico che, dopo aver fatto scalo al porto di Galway, in Irlanda, ora affrontava le imponenti onde dell’oceano in direzione nord. Cristoforo Colombo, questo era il nome del giovane genovese, osservò ancora il comandante: era convinto che il suo destino avesse in serbo per lui un futuro diverso da quello attuale. Prima o poi anche lui sarebbe divenuto capitano di una flotta che avrebbe guidato alla ricerca di nuove rotte, dimostrando che navigando verso ponente si sarebbero raggiunte le estreme terre orientali. La sua mente era affollata da questi pensieri quando, all’improvviso, il vento si placò e un pallido sole si affacciò da uno squarcio azzurro tra le nubi grigie. 10 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 I RACCONTI 8 CONCORSO NAZIONALE PER SCRITTORI INEDITI 2011 Parole in Corsa I Racconti 11 Il rumore del mare MARCO ADORNETTO Apro gli occhi , un bambino mi guarda, ha paura, resta attaccato al braccio della mamma, poi viene verso di me si avvicina e inizia a parlarmi. Ma tu vivi qui? Si bambino, come ti chiami? Mi chiamo Marco ,ma tu sei qui da quando sei nato? No Marco ,io ero un bambino proprio come te, avevo la mia camera piena di giocattoli, la mattina aprivo la finestra e vedevo passare i treni lontani. E perché ora sei qui? Volevo vedere i treni da più vicino e ho pensato di venire qui, e tu dove stai andando? Io sto andando con la mia mamma in vacanza; e tu, non vai in vacanza? Ero indeciso se andare al mare o in montagna, credo che ci penserò ancora un po’, di solito preferivo andare al mare, ricordo quanto mi divertivo a correre sulla spiaggia in mezzo alle conchiglie...Era tutto pieno di sole. E dopo? Cos’è successo? A forza di correre mi sono ritrovato qui e ora i treni vanno più veloci di me. Ma dov’è la tua mamma? A volte passa a trovarmi, mi saluta, si nasconde proprio su quella tettoia che copre questa banchina. E non hai una famiglia tua e un’altra casa oltre a questa? E una donna che ami? Si ma i miei figli hanno molti impegni, hanno la loro famiglia devono lavorare, non hanno molto tempo per i treni.... Caro bambino io amo il rumore di questi treni ,la pioggia che mi bagna e il sole che mi asciuga, il mormorio della gente che parte, le lacrime di chi si saluta e si dice addio, io non voglio dire addio più a nessuno, è per questo che sono qui. Marco guarda la mamma, vieni qui dobbiamo andare, il treno sta per partire ! Ciao, ora devo proprio andare, quando torniamo ti porterò una conchiglia. Ciao bambino..... Chiudo gli occhi, sento il rumore del mare. 12 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Un lungo viaggio nel mio cuore MARCELLO ALFONSI Luca mio caro; è tutto il giorno che leggo la tua mail... ma perché mi scrivi così? come si fa a leggere quello che hai scritto e a non sentire qualcosa dentro che pizzica, brucia, fa bene e fa male allo stesso tempo... Come si fa a non affezionarsi a te, a non volerti bene? Voglio che tu stia bene, voglio che tu sia felice e se “felice” è una parola grossa almeno che tu sia sereno... mi spaventa da matti pensare che forse la tua felicità dipende da me... spero di non deluderti, spero di riuscire a superare la difficoltà che ho a volere bene, bene veramente a qualcuno... Volevo scriverti prima perché di cose da dire ne avrei tante ma il tempo è poco al lavoro.. Ti chiedo “SCUSA” se ieri ho dato di matto... so che non basta ma non so che altro dire o fare, potrei prometterti che non succederà più ma mi conosco, so che sono un po’ viziata e capricciosa però cercherò per quanto possibile di fare la brava, perché te lo meriti, perché ci vogliamo bene e tanto basta... Mi piace farmi fare le coccole da te, e mi piace fartele, ho voglia di stare insieme nel fine settimana. Hai ragione ti do sempre tanti baci, non ci avevo fatto caso, baci piccoli, grandi, dolci o appassionati, baci sul collo...eppure non mi sembra ancora abbastanza. Mi raccomando mangia! Mangia tanto e non avere pensieri x noi, a fare dei brutti pensieri ci penso già io. Se mangi, se dormi e se stai bene io sto bene! Ci ho patito ieri a sapere che la tua ex ti aveva telefonato, ed ero anche un po’ gelosa, ma è normale perché ci tengo a te. Tu sei stato gentile e a modo perché non mi hai fatto stare in pensiero, sei stato onesto e sincero nel raccontarmi di lei.. ci sta ad aver provato un po’ di emozione nel sentirla, e poi so che fa piacere sapere che qualcuno a cui tenevi e che ti ha perso capisce quanto vali e forse vorrebbe tornare indietro.. Io non so se questa sarà per noi la storia più bella, matura e duratura per entrambi, a volte non so nemmeno bene cosa provo o cosa cerco, ma posso dirti che stamattina ho aperto la posta e c’era una mail del mio amico di università, è da qualche mese che si fa vivo, la mail era la solita mail di un amico (perché infondo io e lui siamo solo questo e forse anche meno) ma tra le righe mi faceva capire che con me era stato bene, che avevamo vissuto una favola.. dopo che l’ ho letta ho pensato che è stato proprio uno stupido a buttare via una “favola” e che invece TU quella favola la apprezzi..con i suoi travestimenti, la panna cotta a forma di cuore, le sfilate con i sandali, i fiori hawaiani tra i capelli... . Ci sta ad essere lusingati, confesso che la mail mi ha fatto piacere, come immagino ti abbia fatto piacere sentire Rebecca o i complimenti che ricevi in palestra ecc. . ma ancora di più fa stare bene sapere che qualcuno ti vuole bene e dà valore a quello che fai. Io l’ ho capito! Ho capito che i complimenti degli altri valgono meno, molto meno di quello che fai tu per me e che una carezza o un bacio dato a qualcun altro non avrebbe lo stesso sapore perché non avrebbe lo stesso significato. Sono contenta di averti incontrato...!!! Forse capiterà anche a me di perdere la “via” lungo il cammino, ma una cosa ti prometto: non ti mancherò mai di rispetto e non ti farò mai del male deliberatamente, perché TU non lo meriti... ora devo andare a lavorare. ciao Luchino mio.. un bacio grosso cucciolo! P.S.: Se ti va, anche se non siamo una vera coppia, alla tua amica puoi dire che si può andare anche domani sera a mangiare la pizza... decidi tu... Purtroppo qui a Torino piove... ma tanto tra cucinare, lavare i piatti, il film e tu lavori domani tempo per le coccole ne rimane poco... ma mentre guardiamo il film ti faccio i grattini sulla pancia, non aspetto 53 minuti stavolta. ”A dopo”. tua: Elisabetta I Racconti 13 C’e siest@ per te ANDREA ARDITI “Buona sera a tutti e ben ritrovati a “C’è siest@ per te”. Morticia De Profundis anche questa sera esordisce così. Qualcosa nella scenografia è però diverso dal solito: niente sombreri, via gli ombrelloni, una passata d’aspirapolvere alla spiaggia modello Bergeggi. Da casa ti sentirai disorientato. Comprensibile. Ma questa è una puntata speciale del programma. Non guardare sul calendario, non è Halloween. E’ il 21 di maggio, e puoi tirare un sospiro di sollievo: non ti sei sparato cinque mesi di coma su un lettino del San Giovanni Bosco. Avresti fatto felice l’ospite della serata, ma sappi che lo è ugualmente: telecamere formato zucca, ragnatele sui microfoni, scrivanie formato bara colmano quel senso di mortale insoddisfazione che l’attanaglia. “In questi giorni mi è arrivata una lettera aldilà di ogni aspettativa. Ho deciso di invitare in studio l’autrice, sicura che nessuno se la prenderà per una sua giornata di permesso” - esordisce la De Profundis indicando il palcoscenico. Dal sipario si fa strada una figura. Di primo acchito un frate francescano, ma non è. Abito simile, seppur nero. La signorina - incappucciata forse per mantenere l’anonimato - si dirige dinoccolata verso la seggiola. Accavallando le gambe, fa mostra della sua ossuta silhouette. “La ringrazio della cortesia, Morticia. Felice di essere qui. Difficile presentarmi: a seconda della zona mi rifilate un nome diverso. In Giappone Enma, nell’Islam sono Azrael. Ma all’occorrenza chiamatemi Death, Muerte o Morte: mi giro lo stesso. Nonostante sia famosa non me la sono mai tirata. Anzi, prima o dopo faccio visita a tutti - da Napoleone al più anonimo dei barbieri di Bastiglia - e nessuno dopo avermi conosciuto ha parlato male di me con gli amici. “Come avrete intuito, amici telespettatori, è l’ultima persona che vorreste vedere” interviene la De Profundis. “Tecnicamente sono proprio l’ultima che incontrate, Morticia” puntualizza la signorina. “Ma ci dica: perché è qui stasera?” domanda la presentatrice. “Duecento mila anni senza una vacanza le bastano? Regalate dei soggiorni in località da sogno che, vi assicuro, ho visto più e più volte senza mai pernottarci. Non so come starebbe lei al mio posto, ma io sono stanca morta”. “E come la metterà coi piani alti?” “Di loro non mi preoccupo, hanno sempre la testa tra le nuvole. Col capo sono rimasta d’accordo di appendere la falce al chiodo tutta la prossima settimana; abbiamo deciso di comune accordo di fare slittare Tsunami, terremoti e tragedie aeree di sette giorni. In caso di necessità, ho assicurato la reperibilità assoluta. “Curiosità mia, ma penso anche dei telespettatori: come vi terrete in contatto con l’Onnipotente?” “Con il cellulare aziendale: Thanatonic 33DC. Prende ovunque, e con la promozione Vodafone eternity parliamo gratis all’infinito, dopo uno scatto iniziale di trenta denari alla risposta”. “Ora la domanda preferita dai nostri ospiti: biglietto di andata/ritorno più soggiorno gratuito a...?” “Ho riflettuto molto signora De Profundis. In un primo momento ero propensa a un soggiorno balneare sul Mar Morto. In un secondo, ho pensato di svagarmi sull’Isola Mortorio o di sgranchirmi le ossa a Calos de Mort”. “E cos’ha deciso?” “Con tutto il rispetto per le altre località, darei la vita per visitare la Death Valley”. “Ottima scelta signorina. La lascio con il pubblico in studio per un ultimo saluto”. “A presto miei cari. Trapasso, e chiudo”. 14 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il Mappamondo ANTONIO BARBARELLI Lo guardavo sempre. Mi ci incantavo per ore. Volevo sapere cos’erano, tutte quelle parti blu, Verdi e marrone. Una volta gliel’ho chiesto alla mamma. Lei era impegnata a litigare con papà e non mi disse nulla. Ci volle la scuola per saperlo. La maestra pronunciò quel nome: mappamondo. Poi ci disse che era una raffigurazione del mondo in cui vivevamo. Io ci tornavo sempre davanti a quel negozio. Era un piccola bottega e il proprietario esponeva sempre i suoi manufatti in segno di gloria. Il mappamondo non mancava mai. Davanti a quel negozio ci sono passato centinaia di volte da piccolo. Era all’incrocio dove mia mamma lasciava la macchina. Lei era sempre nervosa, perché prima di arrivare al parcheggio, aveva già litigato una decina di volte con papà. E ripeteva sempre che non ce la faceva più. Davanti a quel negozio si sono litigati per l’ultima volta. Hanno gridato tanto forte che è uscito anche il proprietario, Ottavio, un signore tanto buono che ha cercato di farli ragionare. Da quel momento io andavo sempre più spesso davanti al negozio. Speravo di vedere passare mio papà, che aveva preso casa nel nostro quartiere. Per starmi vicino diceva lui. Ma non l’ho visto molto spesso. Frequentava una sua amica, che ogni tanto mi ha offerto anche un gelato, ma si vedeva che non le piacevo. Io però davanti al negozio ci andavo sempre perché il signor Ottavio, esponeva mappamondi sempre diversi. Quando ho avuto i mie primi soldi, ho comprato quel mappamondo che avevo visto la prima volta in vetrina. Lui non l’aveva venduto. Era rimasto lì. Mia madre mi aveva chiesto che ne dovessi fare. Non serviva a nulla, un pezzo di legno, vecchio per giunta. A me piaceva vederlo intero il mondo. Mia madre storceva il muso poi ritornava a blaterare. Dopo che mi sono laureato, ho cercato un lavoro che mi permettesse di viaggiare. Di vedere i posti del mappamondo. L’ho trovato. E su un aereo ho conosciuto Marta, hostess di una compagnia aerea nazionale. Ci siamo piaciuti subito. E quando le ho fatto vedere il mappamondo e raccontato la mia storia lei si è emozionata. Ma la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stata chiedere a Ottavio di costruire il mappamondo per mio figlio. Lui si è messo subito al lavoro. Sapevo già che avrebbe fatto un buon lavoro. E così è stato. I Racconti 15 Una giornata come le altre. Gli zombi tra noi MATTEO BARONE Svegliarsi tutte le mattine in un bagno di sudore, c’ho fatto ormai l’abitudine. Alla fine è quasi piacevole. Sentirmi addosso gli indumenti umidi, mi dà una sensazione di pulizia. Sì! Di pulizia e di disintossicazione. Perché sento che la maglia è impregnata, non di solo sudore, ma anche di sali e tossine, soprattutto quelle, le tossine, è il mio naso a suggerirlo. Ma a quel suono vibratorio che mi ronza sin dentro le ossa, a quello non mi sono ancora abituato. Nessuno di noi ci si abituerà mai. Chiedete pure e ogni eroinomane potrà darvi conferma. Che palle!... e che fastidio! Guardo il mio letto. Le lenzuola ricamate di mia madre sono finite sotto le coperte. Le coperte, sopra. Il cuscino è ai piedi. La federa? Boh! Forse non c’era neanche. Noto dei nuovi ricami di bruciatura di sigaretta, ma mia madre non può più rimproverarmi ormai... non può più. Vorrei tanto che fosse ancora viva per sentirla strillare i suoi rimproveri, per abbracciarla magari, per baciarla e chiederle scusa per le lenzuola... e molto altro. Inarco la schiena per stirare i muscoli ed a un tratto, un pensiero spaventoso mi blocca a metà: “ma che ore sono?”. Per chiunque altro, è una domanda normalissima, cui segue di solito una serie di numeri, ma per un vecchio fattone come me, 60enne, a serio rischio di crisi d’astinenza, non lo è. Mi accorgo che dalle tapparelle non filtra luce solare, è non è notte! La bocca secca, i muscoli indolenziti e la maglia fradicia lo confermano. Pomeriggio inoltrato, quasi sera e io sono a pezzi. Mi scocco dal letto come una freccia. Il mio corpo, che rimasto flesso, si scorda di tutti i malanni della vecchiaia e mi lancia come una freccia al mio “puntello”. Per fortuna pantaloni e scarpe si trovavano sulla traiettoria. Lavarsi la faccia neanche a parlarne. Altra cosa in comune con tutti gli altri drogolosi, è il fastidio che ci provoca il contatto con l’acqua quando siamo in astinenza, se fredda, ancor di più. Evitiamo l’acqua come dei febbricitanti. Ecco spiegate tutte quelle barbe incolte che si trovano al mattino sui tram e negli uffici, dietro quelle facce un po’ sbattute, con gli indumenti del giorno prima, con l’odore di sigaretta spenta a metà nel taschino della camicia, per non sprecarla, perché spesso in tasca, non ci restano nemmeno i soldi per ricomprarle. Non lo immaginate neanche quanti drogolosi ci sono. Faccio appena in tempo a raggiungere l’autobus che mi porterà all’appuntamento col pusher. Pagare il biglietto?. Chi vuoi che venga a chiedermi il biglietto? Sembro un cesto dei panni sporchi con le gambe Se non ci fossero i mezzi pubblici... non ci voglio nemmeno pensare. Intorno a me si forma il solito “spazio vitale”. Mi siedo al fianco di una vecchina che mi sorride e non mi evita, anzi, invade il mio spazio. Le ricambio felice il sorriso. Anche l’autista, che mi conosce, mi sorride. (wow, dev’essere il mio compleanno) L’autista di mezzi pubblici è il mestiere con il più alto rischio e carico di responsabilità che conosca. La gente non lo capisce, o non vuole capirlo. Intanto, sono arrivato a destinazione. “Lo spacciatore? Non è ancora arrivato? Meno male!” l’amico fraterno di spada mi rasserena, lo spacciatore è in ritardo. Amico caro, mio amico. Che belle notizie che sai dare. Come ti voglio bene! Quasi glielo direi, ma non so neanche chi caspita è! Come si chiama? Si fotta. Dal buio delle siepi vedo spuntare l’ombra amorfa di chi ero venuto ad incontrare. Tutto a posto, tutto giusto. I soldi ci sono, la roba c’è, il tempo per godermela anche. L’universo è al suo posto. Se all’andata ero stato veloce, al ritorno mi trovo davanti alla serratura di casa senza neanche sapere come ci sono arrivato. Una scheggia! Meno male che la porta è quasi un disegno sul muro, talmente è inutile, altrimenti mi sarei ritrovato a farmi sulle scale. Mentre preparo l’attrezzatura, scorrono davanti alla mente immagini e volti; sono le persone che ho visto e incrociato per strada e i loro sguardi. “S’impicchino! Qui con me ho tutto quello che mi occorre” .... almeno fino a domani, ma a questo ancora non ci penso. Gli Zombie tra noi Troppe cose diamo per scontato. Una di queste, è che spesso i mostri che vediamo per le strade, gli zombie, che camminano nelle medesime strade che noi stessi percorriamo, che frequentano gli stessi bar, gli stessi taxi, siano essi drogati, clandestini, rifiuti sub-urbani, puttane, persino i disoccupati, ecc. non hanno NULLA a che fare con noi. Sbagliamo! Sbagliamo di grosso. Perché quei volti sfatti, brutti, feriti, a volte tumefatti, sono soltanto il riflesso di tutte le nostre cattive azioni. Il risultato di ogni cattiva decisione, (presa o non presa) che magari, non ha direttamente prodotto un danno al mostro che distrattamente ci affrettiamo a evitare a sguardo basso, ma che in un modo o nell’altro, abbiamo contribuito a formare. Un’altra di queste cose che diamo per scontato, è che a noi, non potrebbe capitare niente del genere. Mai niente di brutto... mai. Eppure son certo... che sollevando gli occhi, per guardare sull’altro lato della strada, ci accorgeremmo, che c’è qualcuno che “distrattamente”, ci ha scansato. UNA GIORNATA COME LE ALTRE 16 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Ritorno a Prato Paolo Bartolozzi Sono salito sul treno che era ancora praticamente vuoto e così ho potuto scegliere il posto che prediligo: quello vicino al finestrino nella direzione di marcia. E’ più di cinque minuti che siamo fermi in questa galleria e do un’occhiata ai compagni di viaggio. Dall’altra parte del corridoio dei ragazzi che stanno andando a scuola, parlano di calcio, di ragazze e d’interrogazioni andate male. Davanti a me, una coppia di pensionati. Lei guarda persa nel vuoto e la sua testa è evidentemente altrove, probabilmente è preoccupata per qualcosa in relazione col viaggio che sta facendo con il marito. Lui, con i baffetti alla Clark Gable, se ne dorme con il capo affondato nel poggiatesta. Al mio fianco destro un impiegato sembra dormire anche lui profondamente. In realtà chi viaggia in treno non dorme mai completamente. Altrimenti le stazioni dei capolinea sarebbero piene di impiegati e operai che si sono dimenticati di scendere alla propria fermata. Essi sono un po’ come le mamme che possono dormire insensibili a qualsiasi altro rumore salvo quello, anche flebile, del bambino che piange affamato. Così anche lui si sveglierà, appena il treno comincerà a rallentare in vista della stazione, dove dovrà scendere. Mi volto verso la mia sinistra. Per un attimo incrocio lo sguardo di colui che siede da quella parte. Lo intravedo appena nella semioscurità della galleria. Osservo i suoi abiti e il suo volto. Non è né giovane né vecchio, ma la sua faccia ha molte più rughe di quelle dei giovani dall’altra parte del corridoio. Anche lui sembra guardarli e non è difficile immaginare i pensieri che gli vengono alla mente. Tutti siamo stati ragazzi, con i libri avvolti negli elastici, siamo andati a scuola, abbiamo riso e scherzato prima di entrare in classe, abbiamo patito e sofferto la pena delle interrogazioni e quelle inflitte dalle ragazze del primo banco. Per molti, se non per tutti, quegli anni non sono affatto gioia e spensieratezza ma nessuna delle rughe del mio compagno di viaggio sembra derivare da quell’età. Altri sono stati i motivi dei pensieri che hanno increspato quel volto, una volta liscio e pulito. Sono distratto dai ragazzi che tutto ad un tratto hanno smesso di fare chiasso. I loro sguardi ora sono diretti verso qualcuno che è entrato nello scompartimento. Due ragazze passano veloci, gettano un’occhiata a un paio di loro e, tra uno scoppio di risa, proseguono nel vagone successivo. Appena uscite, i ragazzi riprendono il loro chiassoso vocìo e un nuovo argomento si succede a quelli precedenti. Clark Gable si sveglia per il rumore del suo stesso russare e senza aprire gli occhi si sposta sull’altro lato del poggiatesta e continua a dormire. All’impiegato di destra cade il giornale per terra. La moglie di Clark Gable, premurosa, lo raccoglie e glielo appoggia tra le braccia. Gesto che non avrà mai nessuna gratificazione. Lui infatti, non si è accorto di niente e continua a dormire; la sua stazione è ancora lontana dall’arrivare e siamo ancora fermi in galleria. Anche i pensieri dell’uomo alla mia sinistra stanno correndo sicuramente verso altri viaggi in treno, un po’ più lontani nel tempo, tra libri avvolti negli elastici e ragazzine che gettavano sguardi d’intesa ridendo e passando velocemente nei corridoi, al di là dei quali vecchi e impiegati russavano e tiravano bilanci della loro esistenza. Ora il treno ha un sussulto, si ferma di nuovo, poi, lentamente, riprende il suo cammino. La nera parete della galleria cessa di riflettere la luce del vagone e il mio temporaneo compagno di viaggio scompare insieme all’improvvisato specchio. I Racconti 17 La galleria DANIELA BENAZZO Sono sdraiato su un giaciglio scomodo. Le ruote sotto di me provocano scossoni, colpendo ogni traccia del mio corpo. Altro non sono che un sacco di patate in preda a un sonno malato. Vorrei ricordare, ah come vorrei ricordare ogni singolo attimo della mia vita, dal primo vagito all’ultimo viaggio in auto di ieri sera, dall’uscita di quella discoteca anonima fino all’incrocio maledetto, ai fari puntati addosso, al rumore stridente, metallico, preannunciante l’arrivo del mio treno. Ora sono sopra quel treno ed è un treno scomodo, che accelera e rallenta maldestramente, provocandomi dolori atroci, ma le mie labbra non si muovono, la mia bocca non riesce ad urlare. Il treno continua la sua corsa; è un treno merci e io altro non sono che un sacco di patate buttato a caso sull’ultimo vagone. La gola brucia ancora dell’alcool trangugiato come fosse acqua, gli occhi trafitti da spicchi di luce accecante, come lampi nel buio o il sole d’inverno, quando il cielo è limpido e l’aria gelida contribuisce a rendere l’atmosfera rarefatta di una luminosità esagerata. Le ruote sotto di me non smettono la loro corsa. Un attimo fa ero ubriaco ma ora la mia mente torna lucidamente alla realtà. Sono cosciente di non essere su un treno, ma su una barella guidata da infermieri maldestri, che non comprendono che il carico che trasportano non è un sacco di patate ma un uomo. Un cretino, un idiota, che ha buttato la sua vita in un bicchiere e forse distrutto la vita di altri, ma pur sempre un uomo. Non capiscono che correndo così mi fanno male, non si rendono conto che ogni singolo scossone è una staffilata crudele ad ogni muscolo, ad ogni piccola terminazione nervosa delle mie percezioni? Mah sì, lasciali fare, è il loro mestiere: corrono per salvarmi la vita. Finalmente rallentano, ma non si fermano ancora. Percepisco attraverso gli occhi chiusi luci abbaglianti, fuochi, lampi, flash intermittenti. Meglio pensare al treno; voglio tornare ad essere un passeggero, gli altri facciano pure il loro lavoro. Adesso ho bisogno di riposare, come ogni mattina, quando sul treno raggiungo Genova, dove faccio l’impiegato. Ogni giorno mi lascio cullare dall’incedere regolare, a tratti più veloce, a tratti più lento, dal rumore cadenzato delle ruote sulle rotaie. Il torpore lambisce i nervi, il sonno potrebbe raggiungermi, se non fosse per luci troppo forti che muovono le pupille sotto le mie stanche palpebre. Fortuna che adesso il treno rallenta, imboccando una galleria. Il buio ristora. Sto meglio, mi sento leggero. Sembra che il treno non abbia più le ruote, ma viaggi su ali delicate; il lieve movimento accarezza il mio corpo, privo ormai di ogni dolore. Com’è lunga questa galleria. Sembra la galleria prima di Ronco Scrivia, che pare non finire mai; questa galleria però è più lunga, ne sono certo, e io non vado a Genova, non vado da nessuna parte. Non sono su un treno. Non so precisamente dove sono perché non sento più il mio corpo. Sono in una specie di galleria al buio e sto morendo. Lo capisco perché mi sento lentamente cadere; è come andare sull’altalena al rallentatore o passeggiare sulla luna. A un certo punto la galleria finirà, come termina quella lunga nel viaggio per Genova. Solo che là c’è la stazione di Ronco, qui invece non ci sarà una stazione. O forse sì? Vedrò qualcuno, ci saranno altri ad aspettarmi o sarò solo? Ancora buio ma con una lieve percezione di dolore alla testa. Sono ancora in galleria ma con rumori di voci sempre più distanti. Oltre il muro della galleria, c’è un altro luogo, forse una stanza. Una madre urla di dolore. Perché? Cerco di concentrarmi. Cosa sta succedendo? È nato, è appena nato un bimbo, oltre la galleria. Il suo pianto è chiaro, colma la mia mente e scende fino al cuore. Lacrime rigano il mio volto. Mentre muoio nella galleria, qualcuno è appena nato, di là, nella luce. Gli infermieri guardano il volto dell’uomo; uno di loro gli asciuga gli occhi con una salvietta, poi lo ricoprono con il telo verde. Ora del decesso: 9,11. Finalmente la galleria finisce e il treno si ferma alla stazione di Ronco Scrivia. Mi viene da ridere mentre scendo leggero sulle gambe un po’ incerte. Persone che ho amato mi corrono incontro. Non sono più solo. 18 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il viaggio di Chiara SILVANO CAPPELLETTI Quel viaggio sembrava non finire mai. Dopo otto ore di volo, Valerio non vedeva l’ora di rimettere i piedi a terra. Per ammazzare il tempo, prese a sfogliare distrattamente la stessa rivista per la terza volta. Alle ventidue e trenta, l’aereo toccò terra con uno scossone che lo fece sussultare. Il vento caldo della città africana, lo investì appena fuori dall’aeroporto. Raggiunto l’albergo si precipitò sotto la doccia per trovare un pò di refrigerio, ma anche l’acqua che ne usciva era calda. Si buttò sul letto e fissando il soffitto, ripensò alla telefonata di Chiara, appena due giorni prima. L’aveva rassicurato che stava bene, ma gli chiedeva di raggiungerla al più presto, perché aveva bisogno del suo aiuto, e che per telefono non poteva aggiungere altro. Per Valerio non era stato facile liberarsi dagli impegni, ma era comunque riuscito a prendere il primo volo in partenza. Per tutto il tempo del viaggio aveva considerato quanto Chiara fosse stata sconsiderata ad accettare quel lavoro in un paese a lei sconosciuto; senza preoccuparsi dei disagi che avrebbe potuto incontrare. Quando il direttore del giornale, per il quale lavorava, le aveva proposto un reportage in quel paese africano, lei aveva subito accettato. Lui aveva cercato di farla desistere, ma lei niente, testarda come al solito, non aveva voluto sentire ragioni. Si era alzata in punta di piedi e scompigliandogli i capelli con fare materno, lo aveva salutato. E adesso, chissà in che guaio si era cacciata. La chiamò sul cellulare per avvertirla del suo arrivo, ma niente, non era raggiungibile. Il bar dell’albergo era gremito di ospiti; cercò un tavolo ancora libero ed ordinò una birra ghiacciata. Il tempo di abituarsi all’ambiente e un tipo con fare indifferente gli passò accanto lasciando cadere un biglietto sul suo tavolo. Riconobbe subito la grafia di Chiara: “Vieni domani alle nove al bazar delle spezie”. Ma perché non l’aveva raggiunto? Cos’era tutto quel mistero?Quella notte, Valerio affacciato alla finestra, avrebbe potuto contare tutte le stelle del cielo africano, se non fossero state milioni; perché proprio non riusciva a prendere sonno. Dov’era Chiara? Al mattino seguente, quando entrò nel bazar fu pervaso da un senso di nausea. L’aria era pregna dell’odore delle spezie. Si guardò intorno spaesato. Nessuna traccia di Chiara. Ne comprò una qualsiasi per togliersi dall’imbarazzo, scelse una polverina rosso mattone, per lo meno il colore era invitante. Appena fuori dal bazar, lo avvicinò un uomo vestito con un caftano di mille colori. Con un tono di voce che non ammette rifiuti, gli disse di seguirlo: Chiara lo stava aspettando. Attraversarono la piazza, facendosi largo tra la gente che affollava il mercato, fino a raggiungere un vecchio edificio isolato che a Valerio ricordava una fabbrica dismessa da qualche tempo. Fu fatto accomodare in una stanza angusta, priva di finestre, le pareti annerite dal tempo. Un tipo che indossava una divisa militare, lo invitò a sedersi su l’unica sedia di fronte ad una scrivania sgangherata. Cosa significava tutto ciò? E cosa c’entrava Chiara in tutto questo? Quando la hostess di bordo riuscì a svegliarlo, l’aereo che lo riportava a casa era già in volo da diverse ore. Valerio si sentiva in uno strano torpore e, faceva fatica a tenere gli occhi aperti, era come se avesse ingerito una dose massiccia di sonnifero. E poi, cosa ci faceva su quell’aereo? Lui non ricordava proprio di esserci salito. L’ultima cosa che ricordava, era quella stanza soffocante, dove un militare gli aveva offerto una bibita ghiacciata, poi buio totale. L’aereo iniziò la fase di atterraggio. Era contento di essere di nuovo a casa. Ma che fine aveva fatto Chiara? Non avrebbe dovuto attendere molto per scoprirlo. Infatti, la incontrò all’uscita dell’aeroporto, lei era lì, lo stava aspettando. Non poteva credere ai propri occhi, restò a bocca aperta per la sorpresa. Cosa ci faceva lì? Che razza di storia era mai quella? Se pure con qualche difficoltà, Chiara era riuscita a portare a termine il suo reportage, ed era tornata a casa. Forse era stata un pò troppo precipitosa, avrebbe potuto evitare quel viaggio a Valerio. Alla fine, se l’era cavata da sola. Invece Valerio pensò che quel viaggio in Africa, tutto sommato non era stato poi così inutile. Ci aveva guadagnato una doccia calda, una bibita ghiacciata e chissà cos’altro c’era in quel bicchiere, e aveva portato a casa delle spezie rosso mattone, che al momento non sapeva proprio cosa farne, ma in futuro, chissà? I Racconti 19 “Va giù” - Una storia italiana GIANLUCA D’ACQUINO L’aria frizzante del mattino sbatteva dolcemente sul viso mentre risalivo la strada tortuosa che portava lassù, fra montagne aspre abitate da contadini che ne avevano assimilato l’indole. Stretti tornanti, pareti rocciose, gente schiva eppure, mentre viaggiavo sul mio sidecar, sognavo di vedere realizzato qualcosa che avrebbe attraversato il tempo, che sarebbe stato un punto di partenza e d’arrivo, e poi ancora una partenza, senza posa, senza tempo. Non scelsi. Mi ci trovai per motivi che adesso nulla valgono davanti alla storia dei miei ricordi che sono quelli delle migliaia di persone che l’hanno condivisa. Prima, lavoravo in un paese a cinque chilometri da lì e mi divertivo a scendere le strade sinuose in bicicletta a rotta di collo come un ciclista che insegue il traguardo. La risalita poi... Ecco allora che, con i risparmi messi da parte un po’ per volta, senza far mancare nulla a casa, arrivò un bel Gilera 300, quattro tempi, con il sidecar. L’avevo sempre sognato. Un giorno sarei andato per strade di mare con una bella donna al fianco, bionda, occhiali da sole e foulard, valige pieni di sogni e smania di scoprire il mondo. Già perché io vengo dal mare: Lido di Tarquinia. L’abitudine al profumo di salsedine e alle terrazze sulle onde increspate e spazzate dal vento non si perde facilmente. L’idea della montagna faceva un po’ paura ma finii per apprezzare quello scenario mozzafiato, i costoni rocciosi, le gole profonde, i torrenti in piena in autunno, gelati d’inverno, esuberanti in primavera e secchi d’estate. E con essi la mutevolezza della vegetazione a valle e l’immutabilità di quella a monte. Il nome del paese dove fui trasferito quando aprirono il nuovo Comando era impronunciabile, così come quello che si trovava dalla parte opposta della profonda gola che li divideva e che qualcuno pensò bene di riunire in un unico comune. Gli abitanti li chiamavano Nert e Cas, che così non dice granché. Già perché il primo è pronunciato in ladino dolomitico mentre il secondo in ladino friulano. Ma se li pronunci in italiano: Erto e Casso sono veramente imbarazzanti. Arrivai a Erto con il mio Gilera 300 del ’56, aveva due anni ma pareva nuovo. Non lo era invece il sentimento di amore e odio che la gente aveva per quel pezzo di storia d’Italia che si stava scrivendo sotto i loro occhi. Quel qualcosa, punto di partenza e arrivo, citato prima. Fra il ’50 e il ’60, la SADE, Società Adriatica di Elettricità, avrebbe realizzato la più grande diga al mondo, oltre 260 metri di altezza in una gola da brividi scavata dal torrente Vajont. Cosa facevo a Erto? Domanda lecita. Brigadiere dei Carabinieri. Cosa facevo tutto il giorno in un posto obliato da Dio e dagli uomini? Consegnavo espropri agli abitanti. Lo facevo con il mio Gilera 300 e l’Appuntato sul sidecar. Molto meglio della camionetta lenta, scomoda e rumorosa. «Devono costruire un serbatoio artificiale. Opera di pubblico interesse.» la formula era sempre la stessa. Lassù, la maggior parte erano contadini poco istruiti, montanari, gente semplice dal sorriso difficile, diffidente. Il Comune vendeva i terreni, la SADE comprava a prezzi stracciati, gli espropri erano inevitabili, io eseguivo ordini incontestabili. Anni dopo, qualcuno avrebbe benedetto quel Brigadiere in sidecar. Io il mio viaggio lo feci così, non per strade abbacinate dal sole, con l’aria salmastra sulla pelle e l’aroma della vita nelle narici, ma su un Gilera 300 per strade tortuose fra Erto e Casso, a portare espropri a poveri montanari. Il 2 ottobre 1963, arrivò il trasferimento. Come da costume del tempo, oggi per domani, senza preavviso. Due giorni e sarei stato a Caorle, sul mare. Accesi la moto con la gioia che gonfiava il cuore e mi lanciai verso valle. A un certo punto, mi voltai, guardai ancora una volta i paesi lassù e mi colpì quella “V” bianca fra le montagne nere che gorgogliavano e brontolavano notte e giorno. Metteva paura. Sostai in un’osteria di un paese là sotto. Longarone. La gente beveva bianchini la mattina, io presi caffè e latte freddo. Parlavano di comitati, politica, giornalisti: della diga. Facce sorridenti, uomini, donne e bambini che invitavano a fermarsi ancora fra quei monti maestosi e al tempo stesso inquietanti. Ma il mare chiamava e la moto era lì, con il suo quattro tempi, il sidecar pieno di valige. Il viaggio tanto sognato era vicino a realizzarsi. Ripartii. Il 9 ottobre, mi alzai all’alba e andai sulla spiaggia a respirare l’aria di mare. Vento fresco sulla pelle, profumo di vita. Venne correndo un Carabiniere, friulano, il volto sgomento. «Brigadîr, al è colâ il Toc!» «Il Toc?» domandai sbadatamente. «Dio!» esclamai preso dalla consapevolezza. Il monte Toc, Erto, Casso... «La diga!» «Longarón no al è plui.» la voce del Carabiniere arrivò a destarmi dai ricordi del passato. «Longarone?» «È mobilizazion generâl.» insistette. «Anìn!» Non finì. Ero già in moto. Il mio viaggio. Risalii strade tortuose, blocchi stradali, polizia e carabinieri, l’esercito. Cos’era successo? L’uniforme fu un lasciapassare. Salii fin dove possibile. «Dov’è Longarone?» domandai a una donna che veniva china e gemente con i vestiti in brandelli, la pelle lacera e fango dappertutto. «Longarón? S’è là...» indicò con mano tremante, senza voltarsi, senza fermarsi. Seguii la direzione del dito teso, e vidi il nulla. 20 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il ritorno a casa ANTONIO CULCASI Quando arrivò davanti alla cancellata della bottega la sua mente aveva ripercorso ancora una volta quel suo incredibile viaggio di ritorno a casa dalla guerra, mise da parte i suoi ricordi e prese in mano la grande chiave di ferro, ma prima di aprire rimase lì in piedi a fissare la serratura ancora per un attimo. Quante e quante volte aveva ripetuto quel gesto di strusciare la chiave sulla cancellata, ma questa volta era diverso. Erano passati molti anni da quando era appena un ragazzo e già alle cinque del mattino si recava ad aprire la bottega con quella stessa chiave, l’Antica Macelleria Dioguardi. Allora compiere quel gesto era quasi un rito fatto per esorcizzare la paura che sentiva ogni giorno quando si recava a lavorare al buio da solo, e tutto ciò era per portare a casa un chilogrammo di frattaglie di carne e mezza lira alla settimana. Quando era ragazzo la sua fame si svegliava sempre prima di lui, allora Natale per dar conto ad essa e a quell’ansia procurata da quel viaggio al buio, fra casa sua e la bottega, lungo il tragitto ogni mattina mangiava voracemente un filone di pane da mezzo chilo appena sfornato. Talvolta circa a metà del tragitto, l’unico suo conforto era l’incontro con lo “zù Peppino”, il quale all’avvicinarsi dell’alba aveva il compito di spegnere i lampioni lungo le strade. Oramai Natale si era fatto uomo, aveva folti capelli neri ben curati, portava i baffetti come si usavano allora ed aveva mantenuto il suo fisico asciutto, come da ragazzo. Ora lo “zù Peppino” purtroppo non c’era più e in quella mattina a fargli compagnia c’erano solo i suoi ricordi legati alla guerra. Quella guerra voluta a gran voce, ma allo stesso tempo odiata, ora era finita, l’aveva portato fino in Russia, per poi far dietro front verso la Francia con le truppe d’occupazione. Poi dopo l’8 Settembre, non si capiva più cosa fare e dove andare, la catena di comando si era interrotta, e tanti ufficiali erano spariti... Il dolore per la perdita dei propri cari e dei propri compagni era diffuso, in tutti viveva una gran paura mista al desiderio di ritrovare i propri affetti. Tutti desideravano ormai tornare a casa! Così Natale e i suoi commilitoni intrapresero il lungo viaggio di ritorno verso casa a piedi, l’unico mezzo a loro disposizione. Alcuni di loro dovevano attraversare persino tutta la penisola per andare al sud, viaggio in mezzo a tanta desolazione, disperazione e morti, accompagnato da tanta fame. Fame di verità, fame di vita, fame di pane. In quello sbandamento generale ognuno prese la strada che sentì più giusta. Natale arrivato in Toscana, si unì ad un gruppo di partigiani, e furono crepitii di fucili, imboscate, altri morti, e combattimenti in difesa della popolazione inerme, a riscatto della propria dignità. Poi l’ansia accumulata ogni notte, durante le poche ore di sonno, procurata anche dalla visione ricorrente della sorella più piccola che invocava aiuto, lo portò a lasciare ogni cosa per tornare finalmente a casa. Insieme ad altri fece il viaggio seguendo i binari della ferrovia cercando di evitare le rappresaglie dei tedeschi. Con l’olio lubrificante trovato nei vagoni distrutti facevano delle torce per la notte e per attraversare le gallerie. Un giorno in un vecchio fienile bombardato trovarono dei sacchi di ghiande e pensando che potessero essere buone per calmare la loro fame, ne mangiarono a sazietà dopo averle abbrustolite con le loro torce, ma durante la digestione ebbero dei seri problemi. In qualche casolare, gli anziani e le donne ancora presenti offrivano loro ospitalità e qualcosa da mangiare, in cambio di notizie, di un aiuto e della loro presenza come uomini, come fratelli o come mariti, tutte persone ormai disperse inesorabilmente. Proseguendo il viaggio un giorno nei pressi di Napoli, all’inizio di una galleria, si accorsero che sopra la massicciata dei binari era sparsa una spessa polvere bianca sulla ghiaia e negli anfratti, scoprendo con meraviglia e soddisfazione che quella polvere, in realtà era della farina, presero delicatamente tutte le pietre e le batterono una ad una sopra una casacca per raccogliere il loro prezioso carico, che già in serata venne trasformato in due pagnotte, e il fatto che il loro impasto fosse pieno di sassolini e terra non fu certo un problema. Così, avventura dopo avventura, passo dopo passo e con qualche sporadico mezzo di fortuna, giunsero a Villa S. Giovanni ove per passare lo stretto si accordarono con un pescatore che per duecentocinquanta lire a testa, nascondendoli dentro la stiva della propria imbarcazione li traghettò fino a Messina. Maiorana, il compaesano di Natale, pur non avendo i soldi necessari non venne lasciato indietro e poté traghettare grazie all’aiuto di tutti. In quel viaggio di ritorno a casa c’erano stati tanti accadimenti, ma fra tutti quella mattina avvicinandosi alla bottega chissà perché ricordò proprio quello del carro ferroviario semidistrutto, pieno di sacchi di posta squarciati, con dentro migliaia di lettere e cartoline postali mai giunte a destinazione. Tutte quelle parole scritte per raccontare momenti di vita, emozioni e ansie, ancora in cerca dei propri destinatari, rimanevano lì non lette, nelle loro buste ormai in disfacimento, alle volte insieme a una ciocca di capelli, a del denaro, a una foto, a una sigaretta, custodendo una così profonda umanità. Ognuna di esse sembrava essere stata scritta proprio per ognuno di loro. Questo fece crescere ancor più il desiderio di raggiungere i propri cari, per poter udire direttamente quelle parole che anche loro non avevano mai ricevute. Ma purtroppo Natale nel tornare a casa ebbe l’unica triste notizia della morte della sorella Maria. Il viaggio della memoria era finito e intanto Natale senza accorgersene era già arrivato alla macelleria. Tornato alla realtà, guardò quasi incredulo la chiave e con essa fece il solito gesto, ancora una volta la strusciò sulle aste della cancellata, come un peltro sulle corde di una chitarra, cercando di sentire il suono schietto del metallo integro, così come fanno i secondini durante le ispezioni alle celle, come faceva da ragazzo. La vita doveva continuare. I Racconti 21 In treno ETTORE DEDOLA Potrei stare a guardarti così per ore. Chi me lo vieta? Nessuno. Non di certo quel filo di phard rosa che hai spolverato lieve sulle guance. Non di certo quella frangetta di corvini capelli, simmetrica e perfetta cornice del tuo tondo viso, spigoloso solo dove serve. E poi sei arrivata dopo di me, non ho scelto io dove ti saresti seduta, forse l’ho sperato, certo. Sta di fatto che il treno è partito e tu sei li davanti a me. Misteriosa sconosciuta. Un tondo orecchino rosso, lucido, s’intravede sotto un ciuffo fuggitivo della basetta scappato al retro del lobo. Avrei voluto regalartelo io quell’orecchino. Te l’avrei regalato solo perché facesse da attento spettatore, come me, al movimento del tuo braccio e della tua mano che ricacciano indietro quel ciuffo fuggitivo nella sua prigione, dolce prigione, che se le prigioni fossero tutte così avrei già ucciso un milione di volte. Le sopracciglia le hai nere e sottili, leggermente rabbiose, corrucciate se vogliamo, forse sexy, per me semplicemente sublimi. Sono accenti che uniscono parole, dando loro un significato. Sono tratti di pennello che solo all’ultimo il pittore più bravo del mondo ha tolto dal quadro più bello del mondo, perché il troppo bello incendia gli occhi. Occhi... quelli li hai nascosti sotto le palpebre. Sottili lembi di carne bianca rigati da violette venucce, strade sulla mappa di un misterioso paese. Sono nascosti i tuoi occhi, ma li vedo muoversi impercettibilmente, guidati forse da sogni di cui vorrei sicuramente far parte, se solo si potesse. E invece sto qua a guardarli, sognandone il colore. In mezzo a questo sognare parte una strada delicata che termina su una punta da cui desidererei osservare un tramonto. Se io fossi minuscolo e tu sdraiata sulla sabbia, di schiena. Allora tutte le sere mi arrampicherei sul tuo naso a godere del tramonto. Sotto il naso hai le labbra. Morbidi petali che non puoi usare per parlare, lo so. Non possono essere usate, quelle labbra, per emettere suoni la cui utilità è quella di comunicare. Qui non c’è niente da comunicare, non c’è niente da capire. Non servono parole. Quelle labbra possono solo baciare. Dal mento risalgo la linea essenziale della mascella, fino a tornare all’orecchio su cui ora impera solitario il tondo orecchino rosso, lucido. E forse in quel momento muoio, perché d’improvviso arriva il paradiso. Non sono uno bravo scrittore, ma neanche il più bravo del mondo ci riuscirebbe. Perché sono sensazioni talmente intime che esternarle vorrebbe dire distruggerle, perderle per sempre, strapparle dall’onirico mondo in cui galleggiano leggere. È per questo che non dirò a nessuno il colore dei tuoi occhi, aperti d’improvviso e fissi nei miei per millisecondi, per anni. Poi li richiudi. E niente ha più un senso. 22 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 A sud del sud ANTONIETTA DE LUCA Il cacao si immerse nel latte. Riaffiorò lentamente zuppo di gioia. Erano le otto di una mattina soleggiata e calda a e questo era quanto leggeva Giovanni scritto su una busta gialla piena di golosissimi biscotti davanti al suo caffè nero, nerissimo. Lo sguardo estraneo non ha nulla a che fare con la letteratura. Si manifesta là dove non c’è bisogno di scrivere niente né di dire una parola: dove ci sono le suole di legno, la carne arrostita, il cielo del picnic, le patate. L’unica arte con cui si ha a che fare è quella di conviverci insieme. Non si ricordava di lui fino in fondo. C’era stato un momento in cui si accorse che era più alto di lei e sembrava incredibile, in fondo aveva solo l’età di suo fratello. Anche adesso che erano grandi, infatti, Giada considerava Alessio il massimo termine di piccolezza e di tenerezza dell’orizzonte umano. Nessuno era più giovane di lui, al massimo poteva essere uguale e quindi mai più alto, mai più magro, mai più innocente. Forse è che era vestito di nero, un colore che non le piaceva anche se a lui stava bene. Nella cornice naturale dell’isola, entrambi si erano trovati poche ore prima col naso all’insù davanti a questa iscrizione: L’Amministrazione comunale affrontava ed offriva un lodevole contributo al superamento delle innumerevoli difficoltà legate all’ondata di sbarchi clandestini di cittadini extracomunitari, impegnando i propri apparati socio-assistenziali e considerevoli risorse economiche. La popolazione tutta dava testimonianza dei più elevati sentimenti di umana solidarietà ed accoglienza verso gli immigrati, riscuotendo l’incondizionata ammirazione e gratitudine del Paese. 2001/2003 Lampedusa e Linosa. Era la Medaglia d’Oro al merito civile conferita ai cittadini nell’estate del 2004. Negli occhi di Giovanni erano passate molte ombre davanti a quelle parole. Era venuto da Parigi per un reportage e solo tre giorni prima aveva viaggiato con loro verso le coste libiche quando dal Sudan e dall’Eritrea pensavano ancora che quella fosse la direzione giusta per arrivare in Italia. Respinti sì, ma discretamente, per telefono. Lo stesso apparecchio che riceveva ancora vibrazioni più che ondulatorie dalla Farnesina: volevano che le sue immagini tacessero per scongiurare una crisi diplomatica. A Giovanni giravano da morire, anche se, in quella casa piena di sole, la signora Carmela faceva di tutto per coccolarlo come se fosse in famiglia. Coccolava anche me che stavo a pensione da lei fino alla fine dell’anno scolastico per una supplenza in una scuola disagiata e qualche volta ci guardava di sottecchi osservando l’estraneità che scorreva tra il mio cornetto e il suo, tra la mia vita e la sua. Spiantati sì, ma io regolarmente. Privi di legami coi luoghi e con le persone-lungheradici entrambi, ma lui persino straniero con quella ‘r’ moscia che aveva sviluppato in Francia e durante gli attraversamenti che lo vedevano riprendere in fotografia il mondo, illuminare ogni cosa della luce giusta perché esprimesse la verità dei fatti, la verità dei fatti integrale, così come un nudo. Tra spizzichi e bocconi era quello che Giada era riuscita a scoprire nelle ultime mattine dal bel tenebroso in visita a Lampedusa commentando l’iscrizione dedicata alla comunità sorta e riunita su quel lembo di placca africana emersa due milioni di anni prima e più vicina al continente nero che a Porto Empedocle. Tra Calacreta e Calafrancese, tra Grecale e Terranova, si annidavano storie di incontri certo più significativi del sabbioso nulla della desertica Lampione, dove giaceva solo un segreto ancora mai svelato dal 1986. Ecco perché non ripartiva ancora. Era chiaro a tutti: screzi tra i libici e gli americani dopo un pauroso attentato costato la vita a tre soldati statunitensi andati a ballare a La Belle con i 250 feriti che non scorderanno più la discoteca preferita di Berlino in quell’esordio di primavera nordica. Le bombe della sera prima sganciate durante le operazioni della El Dorado Canyon avevano distrutto la residenza del capo e ucciso una delle sue figlie adottive in tenera età insieme a decine di civili. Il minimo che ci si dovesse aspettare erano un paio di Scud sulla base americana dell’isola. Giovanni se lo era fatto raccontare per bene quel 15 aprile. Parlando a lungo le loro storie si intrecciarono ancora e la memoria risorse. Roma era due infanzie fa e due sentieri erano partiti dalle braccia del colonnato del Bernini in direzioni opposte. Ed ora si inarcavano nel flusso della gente nuova che arrivava dal mare e che affollava la tavola delle tante Signoracarmela con i profumi agri e le atmosfere ambrate. A Sud di Parigi, in un tempo quasi perduto, la capitale italiana dalle finestre della scuola elementare, più giù ancora l’isola siciliana a Nord di Tripoli e al mezzogiorno libico paesi dove la forbice della ricchezza e la mannaia delle dittature con la falce della guerra taglia vite e devia storie verso la stella polare. In mezzo un mistero di 25 anni prima, oltre dialetti e lingue nel dialogo d’arcobaleno dei popoli in marcia. I Racconti 23 Sei fatidici numeri ANDREA DEPANIS Lory smise di piangere. Si guardò allo specchio trattenendo a stento l’impulso di spaccarlo con un pugno. In realtà ciò che avrebbe voluto colpire si trovava ben al di là dello specchio. O al di qua. Un volto che avrebbe odiato per il resto dei suoi giorni. Il suo volto. Come aveva potuto essere così stupida! Abbassò lo sguardo sul lavabo. Il tubetto giallo con la scritta FENOBARBITAL era ancora lì insieme ad una manciata di pasticche sparse nel concavo della ceramica. Aveva provato a farlo. Non aveva trovato il coraggio di andare fino in fondo. Fece scorrere l’acqua facendo cadere con la mano le pasticche nel sifone. Tutto era cominciato per un fatidico pezzo di carta. Era ancora appoggiato sul ripiano dello specchio come se la osservasse con un ghigno beffardo. Lo prese con diffidenza quasi fosse uno di quei rifiuti che ogni mattina era costretta a portar via dal reparto Infettivologia dove lavorava. E dove purtroppo avrebbe lavorato ancora per molto tempo. Andò in camera da letto e riprese a piangere. Squillò il telefono. Senza alcuna emozione alzò il ricevitore. “Lory sono Denise, ma che fine hai fatto stamattina? Eravamo tutte preoccupate. Non ti fai vedere, nemmeno una chiamata...” Senza dire niente si alzò dal letto e strappò via il filo del telefono dal muro. Riprese in mano quel maledetto pezzo di carta fissandolo per qualche istante. Solamente sei numeri. Poi si perse nelle immagini della sera precedente. Era da poco tornata a casa dal lavoro. Il rituale che ormai andava avanti da circa tredici anni prese inizio: andò in cucina, accese il televisore selezionando la funzione televideo sulla pagina delle estrazioni del lotto e si mise comoda sul divano, accendendosi una sigaretta nell’attesa della pagina richiesta. Si gustò la prima boccata e la schermata comparve. Quando mise a fuoco la sestina vincente la venne un colpo. Incominciò a piangere dall’emozione. Erano numeri che conosceva bene. Numeri che giocava ormai da tredici lunghi schifosissimi anni. Poi l’euforia venne rimpiazzata dalla lucidità e la calma di chi ha la consapevolezza di aver risolto totalmente i problemi di una vita. Cambiò pagina per vedere il montepremi, ma ciò che vide la stordì ancora più violentemente della sorpresa precedente. NESSUN 6 All’unico 5+1 - €. 5.789.913 Non era possibile. Lory era certa che con i numeri che aveva giocato avrebbe dovuto fare un 6. Non che le facesse schifo un 5 + 1 ma era evidente che qualcosa non quadrava. Iniziò a rovesciare all’impazzata il contenuto della borsetta non curandosi delle cose che cadevano. Qualcosa andò in mille pezzi e capì che la sua costosa trousse aveva cessato di esistere. Raccolse il portafogli, strappò via la chiusura in pelle ecologica e finalmente trovò la schedina compilata a mano. Ma nessuna traccia del talloncino con il codice a barre che rilascia la ricevitoria. Ebbe un senso di vertigini e si lasciò cadere sul divano. Cercò di ricordare la mattinata. Un buon caffè all’angolo con Denise. Poi la solita sosta scaramantica in Piazzale Belvedere; poi prese il viale della stazione e... “Maledizione!” Realizzò in quell’istante che era arrivata all’Ospedale senza essere passata dalla ricevitoria. Ma com’era potuto accadere? Tredici dannati anni a fare la stessa cosa in modo così maniacale che avrebbe potuto dimenticarsi di andare al lavoro ma non di giocare la sua sestina... La canzone The Wall che scaturiva dal cellulare la fece ritornare al presente. Il brano dei Pink Floyd era associato alla chiamata di Denise, la voce che aveva udito poco prima dall’ormai defunto telefono. Raccolse il cellulare e lo lanciò dal balcone; quando lo vide schiantarsi dopo un volo di cinque piani, tutto le apparve più chiaro. Si era sempre chiesta cosa si provasse a volare e si convinse che per uscire di scena forse sarebbe stato un modo più elegante che impasticcarsi. Librarsi in “volo” per qualche secondo senza avere la possibilità di ripensarci. E non ci pensò una seconda volta. Scese in strada in vestaglia e pantofole. Un trucco sbavato dalle lacrime contrastava su un pallore innaturale, conseguenza della notte insonne. E finalmente giunse nel posto scelto come capolinea della sua esistenza: Piazzale Belvedere. Un luogo contemplativo, nel quale ogni mattina per tredici lunghi anni aveva pregato per una vita diversa, prima di andare a giocare i suoi numeri. Scavalcò il parapetto osservando il dislivello di quasi 18 metri senza alcun timore. Sorrise e si lasciò cadere. Ma qualcosa ruppe i piani. Una stretta salda le cinse le braccia. “Lory che stai facendo?” Lei tentò di divincolarsi inutilmente. “Lasciami in pace, chi sei?” “Mi chiamo Richard, lavoro nel reparto di Traumatologia. Tu non ti sei mai accorta di me, ma sono ben tredici anni che ogni mattina ti seguo in tutto ciò che fai prima di recarti al lavoro.” “Perché mi segui?” “Perché è triste essere innamorato di una persona e non avere il coraggio di avvicinarla” “Sei molto carino Richard, ma forse arrivi tardi. Non ho più nessuno stimolo ad andare avanti, se solo sapessi ciò che è successo, non ci crederesti...” “So tutto invece!” la interruppe bruscamente. “L’altra mattina ho subito capito che c’era qualcosa che non andava. Dopo averti vista qui al Belvedere, hai tirato dritto in Ospedale senza passare dalla ricevitoria. Così ci sono andato io e dopo aver fatto capire al commesso chi eri, gli ho chiesto se si ricordava i numeri che eri solita giocare. Lui mi rispose che ormai li aveva imparati a memoria ma era incerto sull’ultimo. Così ho deciso di tirarlo a sorte e il destino ha voluto che azzeccassi il 5 + 1.” Lory era disorientata. “Lory questi soldi sono tuoi, e se tu mi darai una possibilità, io voglio prendermi cura di te.” Lory non riuscì a trattenere le lacrime e si lasciò sprofondare nel solido abbraccio di Richard. 24 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Le fermate del tempo CRISTINA DI NARDO “Signorina è 28... le va bene?” disse sorridendo il professor Boldini. Gemma raggiante prese il libretto dalle mani del professore, balbettò un saluto e volò, letteralmente, fuori dall’aula. Non vedeva l’ora di dare la notizia a suo padre che aveva studiato con lei, aiutandola a ripetere, incoraggiandola nei momenti di sconforto, orgoglioso della sua prima figlia all’università. Gli avrebbe detto “Giovanotto ci siamo meritati un bel 28, come primo esame non è male, vero?” Oppure gli avrebbe fatto uno scherzo “ Beh sai papà non è che sia andata molto bene, abbiamo preso solo 28” O... no gli avrebbe mostrato il libretto e “ Ce l’abbiamo fatta, papà!” Ecco così. Si ritrovò sotto casa in un baleno e senza nemmeno accorgersene, fece le scale di corsa: presto, presto... Non bussò nemmeno, la porta era aperta, sua madre e sua sorella erano all’ingresso e... piangevano. ”Mamma... ma che...” “Gemma, papà...” Non la lasciò finire, subito corse nella camera dei genitori. Suo padre era sul letto, pallidissimo, gli occhi chiusi. Il dottor Camussi, il medico di famiglia, la bloccò. “Gemma, mi dispiace, un attacco cardiaco... Quando si è sentito male mi ha chiamato, io a mia volta ho chiamato il 118 ma... è stato tutto inutile “. Gemma non lo ascoltava più. Ancora con il libretto in mano si sedette sul letto, baciò il padre sulle guancie di ghiaccio e le parole che avrebbe voluto dirgli: “Papà ce l’abbiamo fatta!”e che non sarebbero mai più state dette, si trasformarono in un groviglio doloroso, giù in fondo al cuore. Gemma aspettava l’autobus delle 8 e 20. Quella mattina, alla scuola dove insegnava aveva la prima ora e compito in classe. Sarebbe stata una di quelle giornate toste... ma la sera Matteo, suo compagno di vita da oltre vent’anni, ritornava a casa da un viaggio d’affari e l’avrebbe portata fuori a cena. Questo pensiero la consolò e quasi non si accorse che il bus, solitamente puntuale, era in ritardo anche se di poco. Accidenti proprio oggi ....ma eccolo arriva, finalmente !” Ma sul bus campeggiava la scritta ‘DESTINAZIONE SOSPESI’ . “E adesso ? - si chiese Gemma - cosa vuol dire? Forse è guasto.” Ma inspiegabilmente, il mezzo s’arrestò alla sua fermata e aprì le porte. Gemma era esitante , poi vide che a bordo vi erano delle persone, si stava facendo tardi e in più cominciava a piovere. Quindi si decise e salì. “Senta - chiese al conducente io...” ”Va bene per lei - disse l’uomo - si accomodi pure, signorina” “Signorina?- pensò Gemma - questo o è scemo o non si è accorto che sono un’attempata signora” ”Vabbè - si disse divertita - tanto sono solo tre fermate” e prese posto come al solito vicino al finestrino. Prima fermata. Gemma si accorse con stupore che sul display lampeggiava la scritta luminosa ‘1930’, invece di ‘Via delle rose.’ Scesero alcune persone, ne salirono altre e il bus riprese la sua marcia. Seconda fermata ‘1956’ “Ma questo display è proprio rotto, dà i numeri - rise Gemma - vediamo alla mia fermata Via Viola che numero dà.” Terza fermata ‘1976’ “Signorina è la sua fermata, scenda su!”. Gemma, stupitissima, si rese conto che era rimasta da sola sul bus e quasi senza accorgersene, scese . Ed ecco che di fronte a lei si stagliò la sagoma imponente della Università. Come spinta da una forza sconosciuta Gemma entrò si diresse nell’aula di Storia del diritto Romano e... “Signorina è 28... le va bene? Disse sorridendo il professor Boldini. Gemma si alzò dalla sedia, come avvolta da una nuvola, si rese conto che dopo trent’anni aveva ridato il suo primo esame all’Università e si girò e lo vide. Suo padre era là sorridente, con la sua amata camicia a quadri e i jeans. “Papà - urlò Gemma correndogli incontro - ce l’abbiamo fatta!” e finalmente disse le parole che si portava dentro da trent’anni e che sciolsero il groviglio doloroso che si trovava giù proprio in fondo al cuore.” Non ne avevo il minimo dubbio - disse suo padre - siamo troppo in gamba io e te” e lei lo abbracciò e lo baciò sulle guance che erano calde e vive. “Adesso ti accompagno alla tua fermata - disse suo padre - devi prendere quello che ferma al 2005, vero? Ecco sta arrivando.” “Papà....” “Ciao Gemma sono molto orgoglioso di te!” disse lui, salutandola e dicendole le parole che avrebbe voluto dirle trent’anni prima. Terza fermata : ‘2005’ lampeggiò il display. “Signora è la sua fermata, scenda su!” Gemma sorrise al ‘Signora’ del conducente. Ma ora ne comprendeva il significato. Scese e si trovò proprio davanti alla scuola dove insegnava. Guardò l’orologio erano le nove in punto, giusto in tempo per il compito in classe. “La vita è un viaggio - pensò - e la direzione è obbligata. Si può andare solo avanti ma a volte qualcuno o qualcosa ci permette di fare un’inversione ad U e di tornare indietro, per un momento solo, per completare qualcosa che era rimasto sospeso.” Gemma, istintivamente, guardò in alto e a quel qualcosa o qualcuno disse a bassa voce ’Grazie’ ed entrò in classe. I Racconti 25 Serata indimenticabile FAUSTO FERRETTI Stasera devo incontrare Carmen, la ragazza conosciuta sabato scorso. Ho ottime possibilità che diventi qualcosa in più, però devo stare attento altrimenti andrò in bianco. C’è moltissimo traffico questa sera e si viaggia a rilento. Meno male che sono stato previdente partendo mezz’ora prima. Certamente, non assomiglio a mio fratello, sempre in ritardo. Questa sera andrà in discoteca, povero fesso, non sa cosa si perderà nel club. Non l’ho invitato solo io. Continuo a procedere a rilento, pensare che ho potenziato la macchina il mese scorso, ma in questi casi non è il mezzo a contare ma la linea che si percorre. Sono arrivato lo stesso in tempo. Stanno aprendo le porte del club privè proprio adesso. Entrando, mi guardo attorno, c’è qualche faccia nuova ma come al solito soltanto ragazzi. Cerco Carmen. La scorgo vicino al juke box mentre ascolta musica. È splendida. Il suo vestito attillato mette in risalto le forme sinuose del suo corpo. Quell’abito mi ha talmente colpito che mi sono agitato, per calmarmi decido di fare un giro del locale. Ne approfitto per andare in bagno. Appena ripreso il controllo mi dirigo al juke box. Mi accorgo di un tacchino che sta insinuando la mia preda. Chi si crede di essere! Il mio sguardo diventa truce e dirigendomi verso di loro, penso ai migliori improperi per scacciarlo in malo modo, quando Carmen, ridendo, mi dice. “Ciao. Ti presento Paolo. Mio fratello!” Ho sbagliato la mia valutazione, perciò assumo un aspetto da colpevole. Allora Lei mi prende per mano e mi accompagna da parte per poter parlare tranquillamente. Visti i risultati direi di aver azzeccato l’emozione espressa. Siamo vicini uno all’altra a chiacchierare da almeno un’ ora. Quando le nostre mani si sfiorano, le allontaniamo velocemente con uno sguardo complice. Parlando abbiamo scoperto di avere tantissimo in comune. Piacciono ad entrambi il mare, la montagna e le chiacchere con gli amici. Le ho raccontato della mia passione per i coleotteri che colleziono. Questo le fa un po’ senso. Devio il discorso, invitandola al bancone del bar. Mentre ordino da bere, lei estrae dalla borsa la maglietta con i suoi colori e me la regala. Questo è un pegno d’amore, vuol dire che ormai siamo una coppia. Avevo ragione, è una serata magica. Mio fratello se l’è proprio persa. Continuiamo a parlare ancora a lungo, quando mi decido a dirle la verità: “Lo sai che sei la mia prima ragazza?” Mi risponde con un sorrisetto malizioso “Mi vuoi far credere di non essere mai stato nelle sale private del club?” All’interno di queste sale si può fare qualsiasi cosa. Mi emoziono sul serio. È la prima volta che succede e devo dimostrarlo perciò, cambio volto almeno quattro volte: imbarazzato, impacciato, stupito e scandalizzato. Chiede la chiave al barista. Poi, tenendoci per mano, ci dirigiamo verso la stanza. Il tragitto è breve ma, essendo eccitato, mi sembra lungo un eternità. “Diciotto”. Ci metto un po’ a capire che mi ha detto il numero della camera. Tutto quello che faccio è annuire come un ebete. Non appena entriamo, vediamo una bella stanza d’albergo con al centro un grande letto a cuore. Lei si avvicina a me con passo sensuale, iniziando a spogliarsi. Non voglio essere da meno, mi tolgo gli abiti velocemente e, afferrandola, ci buttiamo sul letto. Volevo essere aggraziato ma sono sembrato un orso. Dopo molte carezze e moine, siamo arrivati alla parola fine di questa bella fiaba. Credo di essermela cavata egregiamente anche se era la mia prima volta, lo dimostra il suo viso soddisfatto. Mi da un ultimo bacio appassionato, dicendomi: “Domani mattina, devo lavorare.” “Ma è domenica”, replico cercando di abbracciarla. Allontanandomi risponde “C’è gente che lavora anche la domenica.” Mi viene in mente un’ idea e le chiedo: “Mi lasci il tuo contatto facebook?” “Solo contatti nel club. Non lascio a nessuno i miei recapiti, buona notte” dicendo questo si disconnette. La sua figura svanisce. Il rumore della ventola di raffreddamento del computer viene disturbato dai rintocchi dell’orologio. Le due di notte. Sono ancora emozionato per quello che è successo al mio avatar, è proprio un magnifico sabato sera. Prima di dormire controllo a che punto è lo scaricamento dei dati dal mulo. Spengo il computer. Sdraiandomi nel mio grande letto singolo penso a mio fratello. “Perché è andato in discoteca in mezzo a quel caos di gente, quando, su internet, il suo avatar è così indietro? Il buio della mia stanza solitaria mi avvolge. È l’ultima cosa che ricordo prima di addormentarmi. 26 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Ed io penso a te FEDERICA FERRETTI Improvvisamente, un rumore spaventoso, assordante, un frastuono lancinante che mi attraversa la testa. D’istinto scappo senza sapere dove, cercando di allontanarmi dal terribile boato. Sento che piccole pietre mi colpiscono nelle gambe, nelle braccia e mi si aggrovigliano tra i capelli. Alcune mi feriscono. Poi una nuvola di polvere mi avvolge completamente e inizio a tossire per cercare di buttare fuori la terra che mi si infila in gola. Poi più niente. Intorno a me solo silenzio e buio. Poi il rumore del mio respiro affannato e di quello dei miei compagni. Poi, a poco a poco, inizio a rendermi conto di ciò che è accaduto e a pensare a dove sono. E, per tutti noi, arriva la consapevolezza che, proprio oggi, il nostro quotidiano viaggio nelle viscere della terra potrebbe terminare qui. Mi siedo stancamente. Tolgo la polvere dalla pila sull’elmetto e illumino intorno a me. Stiamo tutti zitti. Preferiamo non parlare. Negli occhi dei miei compagni si manifestano sconforto e paura. Ed io penso a te, mamma. Non ti preoccupare, io sono forte. Non ho paura. Non sono come gli altri. Io sono giovane e qui sotto me la caverò. So già quello che devo fare. Come quando si resta chiusi in ascensore: bisogna mantenere la calma e non farsi prendere da timori che non esistono. D’altronde, ci sono solo pochi metri che ci separano dalla superficie e i soccorritori sanno come muoversi, soprattutto oggi, con i nuovi sistemi di salvataggio. Cara mamma, stai tranquilla, sono un uomo adulto. Non sono più un bambino pauroso e timoroso di affrontare le prime difficoltà. E le ore passano. Il caldo sta diventando insopportabile. Mi sono dovuto togliere la maglietta perché stavo sudando. Lo so, come dici sempre tu, mamma, non è elegante e non sta bene mettersi a torso nudo di fronte a tutti, ma il caldo è così opprimente che, solo nel togliermela, ho provato un po’ di sollievo. Anche gli altri sono rimasti solo con i pantaloni e, insieme, cerchiamo refrigerio appoggiando la schiena sulle rocce fresche. Mamma, come mai non sono ancora arrivati i soccorsi? Sicuramente dovranno ancora organizzarsi per la migliore strategia di recupero. In fondo, qua sotto non è così terribile. Tra di noi parliamo, cerchiamo di scherzare e di farci coraggio a vicenda. Raimondo dice che, quando uscirà, regalerà al figlio la bicicletta tanto desiderata e gliela comprerà di colore blu, blu come il mare lassù. Quindi, mamma, non temere, sto abbastanza bene e non ho ancora tanta paura. Ho ancora tanta speranza e non posso e non voglio credere a tutto quello detto da giornali e televisione. Sono già diversi giorni che siamo qui e la poca luce degli elmetti si sta esaurendo. Mi sta venendo fame e anche sete. Le provviste che ci siamo portati dietro stanno finendo e anche le poche riserve d’acqua. Con i pochi attrezzi ho provato a scavare per creare un’apertura, ma nulla, ci sono sempre e solo pietre e sassi inattaccabili. Cara mamma, e se quello che si sente dire in giro è vero? Se veramente per me, per noi, non c’è più speranza? Che cosa ho fatto di male? Quale è la mia colpa se non quella di essermi alzato presto ed aver intrapreso il solito cammino nel ventre della terra, come tutte le mattine? Mamma, non voglio rimanere qui sotto, imprigionato da pareti di roccia, polveri e detriti. Mi stanno mancando le forze e inizio ad avere paura. Sento che le mie mani e le mie gambe iniziano a tremare. Mamma, forse questa è paura. Paura di non rivederti più, paura di non riuscire più a continuare a vivere. Ti penso e mi viene da piangere. Ti vorrei vicina, vorrei averti accanto a me a credermi ancora quel bambino che ha bisogno di protezione e di carezze prima di addormentarsi. I giorni passano. E’ sempre più buio, fa sempre più caldo e ho sempre più fame e più sete. Mi sento mancare, tutto intorno gira e stento anche ad alzarmi. Mi sembra che non ci sia più aria respirabile. Alfonso, il più anziano, suggerisce di non parlare per non consumare ossigeno. Mi sdraio e cerco di addormentarmi per non pensare ma le lacrime arrivano, incontrollabili e inevitabili. Mamma, ti prego, aiutami! Chiama i soccorsi! Lo vedi che non sono a casa, che non sono rientrato. Non mi sono trattenuto a bere con gli amici fino a notte fonda e non sono con Luisa. Mamma, è tanto tempo che manco. Mamma, vuol dire che è successo qualcosa, vuol dire che sto male, vuol dire che sono andato a lavorare e da lì non mi sono più mosso. Mamma, ho solo diciannove anni. Mamma, sono ancora un bambino e ho ancora bisogno di tutto il tuo aiuto! Fai qualcosa! Ho tanto bisogno di te! E la mamma c’è. E’ fuori dalla miniera. E’ sempre stata lì, sin dal giorno in cui ha saputo che suo figlio è rimasto intrappolato sotto terra. E lei è ancora lì adesso, ad aspettarlo, in attesa che una miracolosa navicella entri nella galleria scavata nella roccia e lo porti fuori, tra le sue braccia e i suoi baci. E non è sola. Insieme a lei ci sono mogli, figli, padri, fratelli, sorelle, anche loro ad aspettare il tanto desiderato e sospirato viaggio di ritorno dal buio di una miniera ostruita da un crollo alla luce e agli spazi delle campagne, dei monti, e dei prati in superficie. Un viaggio reale, vero, reso possibile da una piccola e stretta capsula metallica, in grado di restituire vita e speranza a tante, a molte persone. I Racconti 27 Mena CARMEN FURFARO Capelli grigi e lunghi, sempre scarmigliati, ricci e crespi, due occhi grigi anche essi, vivi, sempre spalancati, grandi, enormi. Se li guardavi bene, notavi quel leggero alone di stanchezza, ma molto leggero, quasi impercettibile. Vestiva con scamiciate"a sacco", lunghe e sformate, chiare, e, sotto, si vedevano sempre sporgere le maniche bianche di un maglione con il collo alto. Ai piedi ampie scarpe "spanciate" sotto gambe malconce. Sia d'inverno, con il suo gelo, senza un cappotto, sia d'estate, con la sua calura: era questo il suo abbigliamento che non si modificava mai. Camminava per strada parlando da sola, Mena la Pazza, Mena la Bollata: qualcuno rideva di lei, ma parecchi nutrivano rispetto per quella figura che compariva nelle strade del paese, all'improvviso, come un fantasma. Nei pomeriggi primaverili si sedeva all'ombra della grande quercia, al parco giochi, vicino alle altalene dei bambini ed iniziava quei soliti suoi monologhi dove raccontava di ghetti, di prigioni, di corse intorno a campi, di lavori inutili, di pasti a base di vermi, di freddo pungente e di caldo insopportabile, di abbracci, di violenze... ma tutto con una grazia e maèstria che riusciva ad attirare tutti i bambini che a quei tempi giocavano spensieratamente nel parco. Riusciva ad esprimersi con un linguaggio così delicato che, anche se parlava delle più atroci sevizie a cui era stata sottoposta in quel campo di sterminio, non causava negli animi dei giovani ascoltatori nessun disturbo, anzi, era invitata a proseguire i suoi racconti che catturavano l'interesse di tutti i bambini e le bambine. Arrivava il tramonto e Franco, il figlio quasi quarantenne di Mena, che lavorava al circolo ricreativo adiacente al parco come barista, si avvicinava al gruppo di ascoltatori. Prendeva largo fino a raggiungere la madre, la baciava sulla fronte e la abbracciava, la teneva per mano e la riportava a casa, con una dolcezza sorprendente ogni giorno, anche se era la stessa. A quell'epoca comprendevo poco di quei discorsi, mi affascinavano, questo sì, non mi sentivo turbata, ma avvertivo la necessità di approfondire alcuni argomenti e di documentarmi su parole di cui non conoscevo il significato come "ebreo", "olocausto", "campo di concentramento"... Con il tempo ho trovato la chiave di lettura della vita di Mena e di quel figlio nato dalla violenza, ma cresciuto con amore. Ho compreso che "Bollata" era il "marchio", il numero di serie con cui venivano "timbrati" gli ebrei nei campi di concentramento e Mena lo copriva con il maglione dalle maniche lunghe, non per vergogna, ma perché le ricordava quell'odore di carne bruciata di quando le era stato impresso. Ho capito perché vestiva in quel modo neutro, per non far vedere le sue belle forme che erano state causa di sofferenza. E poi non era "pazza": Mena era fin troppo savia per quello che aveva visto, subìto e sofferto nella sua giovinezza. Non ho avuto più sue notizie perché da troppo tempo non vivo più nel mio paese, ma da poco ho saputo che è morta. Ho ripensato a lei e mi sembra di rivederla seduta, con le mani sul grembo a raccontare con gli occhi persi chissà dove, storie improbabili ma reali e vissute, con un entusiasmo di come si narrano le fiabe a bambini con la bocca aperta... Desidero ricordarla per il "Giorno della Memoria", ma non solo per quel giorno, per ogni giorno di ogni singolo mese, perché lei, come altri, hanno contribuito a formare il mio carattere con esempi di vita. Ma anche perché è una Vita Vera, una vita come tante, perdute, dimenticate, ma volute da quell'umanità che oggi non ne vuole più parlare! Vita Vera... ...in Armonia 28 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Sono venuto nella polvere e me ne andrò nel vento FABRIZIO GASCO Il sole mi sta bruciando. Non ce la faccio più, ma non posso fermarmi. Ho una promessa da mantenere. Non posso cedere proprio adesso. La strada non finisce mai. Quanti sassi. Quanta polvere. Fatico a respirare. Il sudore scorre impetuoso dalla fronte: dà sollievo alla schiena. Rende salata la mia bocca. Purifica i miei occhi di cenere. Sembra che scorrano giù lacrime, ma non ricordo nemmeno l'ultima volta che ho pianto. Sarà stato dieci anni fa o forse più. Con un colpo di mano ripulisco il viso, madido e grondante. Uno-due-tre. E uno-due-tre. Forza gambe, tenete duro. Sono sfinite. Ricoperte di graffi e di tagli prudono e appassiscono. Dai cuore, batti sempre più forte e non darti per vinto. Credo in te. Ma non posso fermarmi. Devo andare. Non posso più attendere perchè Katarina è là. La mia Katarina. Quanto tempo. Quanti pomeriggi vuoti. Senza i tuoi riccioli e il tuo sorriso. Sono veramente esausto. Non capisco più niente. Sono un aquilone rammendato e rappezzato che aleggia senza controllo. Devo andare. Solo sassi e polvere, maledizione. Katarina, ad ogni passo ti sento più vicina. Come un orizzonte. Vorrei chiedere uno aiuto a queste nuvole passeggere del vento, dirette verso casa. Icaro?! Ti vedo dondolare davanti a me. Vola via. Sei solo illusione ed inganno. Sto ancora correndo nella realtà oppure ho attraversato il confine dei sensi? Beh, queste pietre e questi rovi mi ricordano quanto io sia vivo e quanto le ferite facciano male. Un ruscello di acqua azzurra e pulita mi invita a sdraiarmi sulle sue rive. A prendere fiato e rinfrescarmi. A bere e irrigare la mia gola arida. Non posso. Non posso. Nemmeno un minuto potrei ancora sprecare senza di lei. I raggi roventi ed incandescenti avvampano i miei piedi e li riducono a due cenci aggrinziti che però continuano a battere la via e a intingersi di terra rossa. La strada monta e poi scende. Supero un'erta e un campo di camomilla. Il sentiero sfugge veloce alla mia vista. Lo inseguo. Lo raggiungo e lo supero. Un'immensa distesa di alberi di mele mi fa dono gratuito di ombra e frescura. È solo un attimo, troppo breve per restituirmi un po' di vigore. Ora la pianura riarsa mi accoglie in tutta la sua incendiaria vastità. Il sole mi osserva implacabile, le fiammate ardono la mia pelle. Quanto vorrei abbracciare la mia Katarina. Bella e silenziosa. Paziente e incantevole. Non ti lascerò più per nulla al mondo. Adesso però devo correre. Correre. Correre. La tosse scolpisce sui polmoni una statua di polvere che indurisce e diventa pesante fango. Il respiro diventa uno spasmo. Ho i crampi. Vomito. Sputo sangue. È nero e si dissipa nelle piaghe della terra. Mi sento svenire. Le mani sono diventate rosse e gonfie a forza di gravare verso il basso. La fronte è bollente. Forse ho la febbre. Basta. Mi fermo un attimo. No. No. No. Devo andare. Stanotte finalmente mi riposerò con Katarina. Sento già il profumo. Non mi sembra ancora vero. La gioia quotidiana, troppe volte disprezzata, di poter allungare una mano e cogliere un frutto oppure un calice. Ma adesso cosa succede? Una raffinata e vaporosa pioggia lava il mio viso. Leggera ed effimera. Pioggia fuggevole. Bentornato sole. Fammi un sorriso. Sei così sterminato che sembri cattivo. Eccola, laggiù in fondo, la città. Casa mia. Sento le voci in lontananza e mi sembra di udire i sorrisi della gente. Ancora una sforzo. Improvviso un ballo. Ultimo rettilineo. Ultima curva. Sono arrivato. Eccomi. Il festoso tumulto mi travolge. Quante persone intorno a me. Mi sorridono. Mi abbracciano. Mi baciano. Mi accarezzano. Quanto ho atteso questo momento. Voglio assaporarlo da qui all'eternità. Dove sei, Katarina? Dove sei? Grazie a tutti. Però lasciatemi andare da lei. Grazie, grazie a tutti. Katarina mia. Sei più bella che mai. Una farfalla. Come se fosse la prima volta. Sono tornato per te. Entriamo in casa adesso. Cosa volete voi? Cosa? La guerra? Ah già. Me ne ero dimenticato. Sì, l'abbiamo vinta. Ma niente di speciale. Sinceramente, non so se ne valesse la pena. Ora vi prego, lasciateci soli. Voglio rimanere con la mia Katarina. Sono molto stanco. Grazie a tutti davvero. Ho corso fin qui da Maratona senza fermarmi mai, per arrivare prima possibile da lei. - Katarina mia. Ho mantenuto la promessa. - Filippide, non ho mai avuto nessun dubbio. Vieni qui che sei tutto scompigliato... - Se vuoi la prossima volta mi porto dietro un pettine. - Che scemo che sei... Hai fatto questo per me. Mi hai dato il tuo cuore e non lo lascerò mai più. - Abbracciami e fammi sedere, sono così felice che mi gira tutta la testa. Una brezza improvvisa rinfrescò tutta Atene, rumorosa e spensierata. Un vento leggero e indimenticabile. I Racconti 29 In attesa di un cortese riscontro MARIA NATALIA IIRITI Caro tu da mesi attendo un tuo cortese riscontro di avvenuta ricezione per tutto quello che ti è pervenuto dal mio indirizzo. Nell’ordine ti ho inviato un biglietto di auguri per il tuo compleanno, quello sul quale un artista bambino ha disegnato una casa coi muri di colore marrone e un elegante comignolo a forma di fungo. Ci ho messo un’ora buona a sceglierlo, sparpagliando i compagni di carta nel cassetto, quello in basso, che umilmente sopporta il peso di tutti i libri della mia casa. Il biglietto ha compiuto un viaggio breve, da casa mia a casa tua, per passare dalle mie dita ai tuoi occhi. Davanti al tuo portone, che apri per andare a lavorare e ti chiudi alle spalle, prima di andare a dormire senza di me, ti ho lasciato un libro con una dedica. Una combriccola di gatti raminghi e analfabeti lo hanno annusato, sfogliando le pagine con le zampe, prima di capire che la carta non è cibo commestibile per i denti che desiderano la carne. E sono andati via con la coda dritta e il naso per aria, per dare un tono al breve viaggio di avanscoperta verso nuove sorprese che gli umani, a volte, sanno riservare. Dai miei viaggi ho sempre avuto un pensiero per te, pensieri di vaniglia e zucchero a velo, di cioccolato e metallo, pensieri di carta e cartone, pensiero di lana e cotone che indossi senza permettere che ti sfiorino appena. E per Natale un biglietto ho nascosto sotto al piatto, un biglietto con un Babbo Natale raffreddato come lo eri tu quella sera, a casa mia. Guardando la tavola che avevo preparato per l’ultima cena dell’anno in cui ci siamo conosciuti mi avevi detto che era bella al punto che ti dispiaceva mangiare. E c’era un’ombra di tenerezza e rimpianto nei tuoi occhi, come quelle cose che si sono a lungo desiderate ma arrivano quando è troppo tardi. Questa sono io per te: una persona che, giunta da un viaggio faticoso, piena di imprevisti angoscianti e sorprese caotiche, è arrivata troppo tardi. Io ho sorriso e ho guardato il lavoro di un pomeriggio, le noci, i capperi, il formaggio morbido nei fagottini di speck. E sulla mensa ho accarezzato i colori delle arance in insalata e degli involtini di radicchio, pensando all’anno vecchio che ci salutava e all’anno nuovo che ci avrebbe trovati insieme, a condividere i raggi delle passioni, i viaggi che facevamo parlando sul divano. L’anno nuovo, come una nave che piano piano lascia il porto verso la terra promessa. Quella sera abbiamo mangiato tenendoci per mano. E per tutta la cena tu non ti sei accorto del biglietto acquattato sotto al piatto. Ho dovuto dirti io di porgermi il piatto mentre il detersivo si scioglieva nell’acqua calda, profumando di zagara la cucina blu. E’ stato così hai guardato la busta. Hai letto il biglietto, appoggiato con la schiena al mobile della cucina. Hai letto ad alta voce le mie parole, sorridendo, e mi sembravi stupito di questa sorpresa che fanno i bambini ai genitori. Poi mi hai detto “grazie” e mi hai dato un bacio leggero alla base del collo. Io, appoggiata al lavello, ho risposto:“Prego” continuando a lavare i piatti della nostra ultima cena. Per nascondere la tenerezza che mi arrossava le guance. E’ stata l’unica volta che mi hai offerto un cenno immediato di avvenuta ricezione che io custodisco alla base del collo, un lieve francobollo che, nei momenti in cui mi manchi di più, io accarezzo, scostando le ciocche ribelli, respingendo l’acuta tristezza che bussa ai miei occhi. Impedisco così alla nostalgia di trasformarsi in disperazione, ogni giorno e in molte cose che faccio. Dopo quella sera sei partito per un viaggio attorno alle feste di Natale. Hai cambiato destinazione in corso, preferendo fredde bugie al calore delle nostre parole. Da quel viaggio sei tornato un altro. Altri vestiti, altri libri, altri gusti. Altre parole. Altri amori. Ora so poco e niente di te. Di te non mi resta niente altro che quel bacio leggero alla vigilia di Natale. Molti viaggi ci hanno separati ma oggi il destino ci ha avvicinati, nostro malgrado. Caro estraneo che sei diventato e di cui non riesco a fare a meno oggi ho cominciato a scrivere queste righe nel momento in cui ti ho rivisto dopo tanto tempo e sono riuscita a parlarti anche solo per rinfacciarti, con parole criptiche, il male che ho dentro. Un viaggio all’inferno col biglietto di sola andata. Un viaggio all’inferno da cui non riesco a ritornare sui miei passi consueti, sul sentiero che qualcuno, col mio assenso convinto, ha tracciato per me. Caro destinatario conosciuto l’amore è un viaggio in una terra straniera. Ti regalo le mie parole perché ho un bisogno ardente che mi soffi le tue alla base del collo, come un francobollo che ha bisogno di girare il mondo sul tappeto volante di una busta colorata prima di arrivare a destinazione. E in attesa di un cortese riscontro di avvenuta ricezione, amaro disamore mio, che ho a lungo cercato e a lungo atteso, ho a lungo desiderato nei viaggi senza fine della memoria, senza ottenere che dolore, porgo indistinti saluti perché sono molto triste e anche molto arrabbiata. Enne 30 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Una dimensione parallela ERIKA LODI Steso com'era in quel prato, aprì gli occhi e vide sopra di sé un cielo viola, dove sfrecciavano ad alta velocità dei piccoli mezzi a lui sconosciuti, a forma di lavandino. Siamo arrivati a Caccialat! Pensò Frank con entusiasmo. Ce l'avevano fatta. Da tempo, infatti, si dedicava allo studio dei viaggi spazio-temporali e, ora che era arrivato in un'altra dimensione, gli sembrava un sogno. Era un pomeriggio di marzo quando i suoi due amici, Andrea e Nikolas, si erano offerti di scendere in cantina a prendere il vino, mentre Frank era indaffarato a montare le mensole nella suo nuovo appartamento. Il vino serviva per festeggiare quella casa, punto di partenza di una nuova vita per lui e i suoi amici che, dopo una laurea in astrofisica, erano riusciti a sistemarsi. Non appena ebbe finito, Frank guardò l'orologio: era passata mezz'ora da quando i due amici erano scesi, al ragazzo sembrava strano. Sarà uno scherzo pensò. Ora scendo e li spavento io! Non appena scese in cantina si accorse che la porta era spalancata e luce accesa; da dentro non proveniva nessuna voce e quel silenzio gli pareva insolito. Quando varcò la soglia scoprì che non vi era più traccia dei suoi amici, al loro posto, steso sul pavimento, stava un orribile essere, le cui fattezze erano molto simili a quelle umane, tranne per il fatto che era molto basso e con le orecchie a punta; praticamente un elfo. “Dove sono i miei amici!” esclamò Frank impaurito; l'essere lo guardò incuriosito, poi rispose: “Wue stiamo calmi!” Frank si stupì, non tanto perché l'elfo parlasse la sua lingua, ma per il fatto che sfoggiasse un perfetto dialetto emiliano. Ancor più disorientato, chiese: “Chi diavolo sei?!” L'elfo disse di chiamarsi Taldor e di venire dal paese extragalattico di Caccialat; raccontò che nel suo paese era vietato il consumo di latticini (da cui il nome); in quanto il potere era detenuto da Beltafor, discendente della dinastia dei Caprapal, che, essendo capre, bevevano solo latte proveniente da ovini. La loro stirpe era malvagia, tanto da obbligare le madri a nutrire i propri figli con il latte di capra. Tale svezzamento aveva effetti negativi sui bambini che, di fatto, non crescevano di statura. Molto si è cercato di boicottare il governo dei Caprapal, ma il loro regime è così potente che ogni tentativo si è dimostrato vano. “Per questo sono qui” continuò “Riesco a viaggiare nello spazio-tempo! Userò questa capacità per portare la mia famiglia lontano dai Caprapal!” A quelle parole Frank si risentì: il modo per viaggiare nello spazio-tempo l'aveva trovato lui! Non avrebbe mai permesso che quell'essere si prendesse un merito così importante! “Ma Andrea e Nikolas dove sono?!” si ricordò poi. Taldor fece un sospiro, poi rispose che l'esperimento era mal riuscito, in quanto, passando in un'altra dimensione, il buco nero creatosi aveva risucchiato chi si trovava in quel momento nei dintorni. “Ah! Seguendo la mia procedura questo non succede!” disse Frank “E come sarebbe la tua procedura?” chiese Taldor “Te la spiego se mi fai venire con te a Caccialat, devo recuperare i miei amici”. L'elfo annuì e il nostro amico espose la procedura: “Dunque il meccanismo è questo: dovremmo metterci il rossetto sulle labbra e sulle guance; poi, tenendoci per mano, canteremo su un piede solo FIGLI DELLE STELLE , così il varco si aprirà. E' tutto chiaro?” si premurò Frank. Taldor annuì, si misero il rossetto e seguirono il piano alla lettera: il varco squarciò il pavimento, nonostante Taldor cantasse veramente male; a quel punto Frank mise un piede dentro trascinando con sé anche l'elfo e così sparirono. Ora Frank aveva aperto gli occhi e vedeva lavandini volare sulla sua testa. Girandosi verso sinistra si accorse che stava tenendo per mano Taldor che giaceva addormentato. “Saranno due pazzi reduci da una notte brava!” si sentì da non molto lontano, detto con accento emiliano. A quel punto Frank lasciò la mano dell'elfo, si mise seduto e, con le dita, cercò di levarsi il rossetto dalla faccia. Decise di aspettare prima di svegliare Taldor; voleva guardarsi un po' intorno. Caccialat sorgeva su una collina che stava sotto il livello del mare, mentre le montagne e le alture erano in basso, incassate nel terreno. Vicino a loro si estendeva un parcheggio azzurro, in cobalto, da dove partivano e atterravano lavabi di diversa natura e diversi colori. “FRANK!” gridò una voce dall'altra parte del parcheggio. Frank non riusciva a capire chi fosse, poi, avvicinandosi, vide Andrea e Nikolas fare i parcheggiatori abusivi di lavandini! Andrea corse a braccia aperte verso Frank, Nicolas lo seguiva a passo spedito. “Ma perché fate i parcheggiatori abusivi?” chiese Frank. “Bisogna pur mangiare!” rispose Nik. A Frank dispiaceva che si fossero ridotti così e li informò che era lì per portarli a casa. Così svegliò Taldor, fece riunire la sua famiglia, e seguendo la procedura che aveva studiato per anni, ritornò nella sua dimensione. Nessuno si era perso nei meandri dello spazio-tempo, nessuno aveva avuto effetti negativi, ma, anzi, Frank era riuscito a coronare il suo sogno di scienziato, infatti Taldor, per ringraziarlo, gli aveva lasciato tutti i meriti. La famiglia di elfi, invece, si trasferì in campagna, dove allevano mucche, producono latte e formaggi. Alla faccia dei Caprapal! I Racconti 31 La meta finale DAVIDE MARAZIA Solo con la mente ormai io posso viaggiare. Sono su una sedia a rotelle, e le mie povere gambe non mi sostengono più, rese anch’esse inservibili dal male oscuro e incurabile che mi divora ogni giorno di più nel corpo e nell’anima, consumandoli entrambi con lentezza dolorosa e inesorabile. Ma quel morbo malefico può fiaccare il mio corpo, non la mia mente, ed ogni giorno, osservando dalla finestra della mia stanza le nubi soffici come zucchero filato che aleggiano pigramente nel cielo azzurro di metà aprile e il gioco degli stormi di rondini che finalmente hanno portato con loro la tanto sospirata primavera dopo il lungo e rigido inverno, io volo libera insieme a tutti loro, lasciando vagare la mia mente in quel vasto cielo, sospinta solo dal vento dei miei sogni e desideri. A quel punto non c’è spazio che io non posso attraversare, non c’è confine che io non posso travalicare, e l’infinito è tale solo se io lo voglio e nessun luogo in nessun tempo mi è realmente inaccessibile e inarrivabile. Con la mente posso essere l’aquila più ardita che vola più in alto fino a raggiungere i limiti estremi del cielo, il più veloce raggio di luce che solca gli spazi cosmici come freccia di fuoco scagliata tra scintille di stelle e bagliori di soli lontani, il lampo più abbacinante e fulgido che attraversa il cielo nella più buia notte di tempesta o la cavallerizza che monta il destriero più impetuoso e che fa tuonare la terra sotto i suoi possenti zoccoli nella sua folle corsa per sterminate praterie solitarie; con essa posso udire il canto suadente e ammaliante degli angeli più splendenti e l’urlo feroce e disperato dei demoni più oscuri e posso giocare con le creature più fantastiche dell’immaginario e farmi svelare da esse i segreti più reconditi e insondabili di questo mondo; posso tornare indietro nel tempo fino al passato più remoto o balzare in avanti fino al futuro più inimmaginabile; posso far rivivere persone care e ormai perdute da tempo o riavvicinare a me quelle che mi sono lontane e che non so se mai più rivedrò; posso raddrizzare i molti torti subiti in passato e dispensare le punizioni più severe e posso salvare il mondo da sé stesso o distruggerlo mille e mille volte di più per vendicarmi dell’ingiustizia che il fato mi ha inflitto. Con la mente io posso essere libera dalla prigione della mia condizione, dalla gabbia limitante del mio stesso corpo in disfacimento, e posso raggiungere il mio luogo ideale, quel posto esistente solo tra sogno e desiderio, dove non c’è malattia né sofferenza ad affliggermi, quel luogo che sarebbe per me rifugio sicuro e che, forse, esiste solo se io voglio credere di poterlo costruire un pezzo alla volta, un sogno alla volta, un desiderio alla volta. Con la mente ogni giorno intraprendo questo viaggio verso quel luogo, cammino che mi porta a desiderare di trascendere i limiti del mio essere semplicemente una fragile persona e che spero sempre mi elevi al di sopra di questa realtà spietata e spesso insensibile ai bisogni dell’individuo come a quelli del suo animo, soffermandomi, lungo questo effimero tragitto, ad abbeverarmi alle fonti multiformi dell’illusione, che esse sole sanno come mitigare il peso degli affanni e dei dolori della vita di tutti i giorni. Solo con la mente io posso ormai viaggiare liberamente, giacché il corpo non può più farlo da molto tempo; e, quando assumo la mia razione quotidiana di farmaci e antidolorifici per mitigare le fitte che il mio male oscuro mi infligge giornalmente e quelle sostanze mi stordiscono fino a non farmi capire più niente o quando la chemioterapia a cui mi sottopongo periodicamente mi induce nausee che mi fanno vomitare anche l’anima, mi rendo conto che tutto questo è il prezzo da pagare per poter continuare a viaggiare una volta ancora e una volta di più con la mia mente e il mio spirito, perché nessuna libertà ti viene regalata, neppure quella di sognare. Anch’essa bisogna conquistarsela un pezzo alla volta, un brandello alla volta, una briciola alla volta, giorno dopo giorno, con quell’atto che noi diamo per scontato e che si chiama “vivere” e che, a volte, costa così tanto sacrificio. Quel viaggio effimero che io compio con la mente ogni giorno si chiama “speranza”, ed è in nome di essa che io mi azzardo a spingermi oltre ciò che è lecito aspettarsi dalla realtà e a desiderare per me l’impossibile e l’inarrivabile quale meta finale. Ma, più lascio vagare lontano la mia mente per gli affascinanti sentieri del sogno e del desiderio, per trarne forza per sostenere il mio spirito che ogni giorno è sempre più stanco, e più mi accorgo che quei percorsi sempre più mi riportano al punto di partenza, sempre più mi riconducono a me stessa, perché non importa quanto lungo sia il viaggio della vita, la meta finale più ambita da raggiungere sono sempre e soltanto io e un altro giorno in più per esserci ancora, per urlare “Sono ancora qua!” con tutte le mie forze al mio male oscuro. Il trillo acuto di una sveglia mi distoglie dal mio vagheggiare: è il segnale che mi avverte che è l’ora di prendere le mie medicine... di lottare una volta di più per continuare il viaggio un giorno di più. (dedicato a Luisella) 32 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Piazza degli eroi ANTONIO MARTONE Quando sono stanco, faccio fatica ad impormi sul mondo. E tuttavia, se è il mondo ad imporsi su di me, divento decisamente malinconico. Nello scompartimento fa caldo mentre fuori fa freddo. Il tramonto crea bizzarri giochi di luce sugli alberi spolpati dall’inverno e nelle pozzanghere acquitrinose. Avverto intorno a me un’atmosfera di gioia inopportuna. Mi torna in mente il giorno in cui mi telefonarono per dirmi che mio padre stava male. Giunsi appena in tempo per sentire il suo ultimo messaggio: “Sii felice”, mi disse, e poi non disse più niente. E da allora, stupidamente, continuo a chiedermi se sono felice... Nella mia carrozza, prende alloggio una squadra di judo di nazionalità ungherese. Sistemano le valigie e occupano ogni spazio possibile. Un’enorme borsa viene piazzata al centro dello scompartimento. Estraggono un mazzo di carte e cominciano a giocare. Il controllore non trova in regola i biglietti di alcuni di loro: dovrebbero pagare un tal supplemento. Una cascata variopinta di parole italiane, inglesi e ungheresi infiamma l’aria già calda del vagone. Alla fine, stanco di discutere e di mostrare il suo improbabile inglese - e non nascondendo un certo imbarazzo nel parlare con giovanotti che conoscono le arti marziali -, il controllore riesce incredibilmente a farsi consegnare la carta d’identità. A che cosa potranno servire quei dati rimane un mistero. Gli ungheresi si tratterranno soltanto pochi giorni in Italia e mi riesce difficile immaginare contravvenzioni che si muovono con disinvoltura in Europa; che raggiungono inesorabilmente qualche sperduto villaggio magiaro, minacciando sanzioni severe se non vengono liquidate. Una stazione dopo l’altra, corriamo tanto da consumare interamente la luce di quella giornata. Nei paesi sulle colline si scorgono ora tante piccole luci: viste dal treno, sembrano appartenere al cielo più che alla terra. Sono nodi di stelle - ferite o gioielli intrecciati sul corpo della notte. Una ragazza va a sedersi nell’unico posto libero. Vedo gli ungheresi distogliere l’attenzione dalle carte e il frastuono da bar placarsi - le viene dedicato un minuto di raccoglimento nutrito di sguardi e pensieri che non si fa fatica ad immaginare piuttosto torbidi. Nel giro di qualche istante, il suo profumo diviene parte dell’aria. Gli ungheresi, allora, più silenziosamente di prima, riprendono a giocare... Appoggio la testa e cado in un dormiveglia. Sogno il museo di Budapest. Rivedo Roxana - conosciuta presso la biglietteria della mostra su Klimt. Bellissima. Corpo imponente e viso delicato. Bionda. Occhi chiari e liquidi. La bocca atteggiata in un costante e schietto sorriso. Vestita di indumenti pesanti e con un rossetto intenso sulle labbra a fare da contrasto con la sua pelle bianchissima. A Piazza degli eroi, sotto i monumenti di uomini che ricordano da presso la storia enigmatica delle steppe orientali, sorseggiamo vino bollente ed io non sento più il freddo di Budapest. Mi sforzo di indovinare sul suo viso le contaminazioni fra etnie europee ed asiatiche che si sono svolte nella storia del suo paese. Nei movimenti del suo corpo, cerco di distillare l’orgoglio degli antichi cavalieri mongoli. Attribuisco la sua pazienza alla remissività della sua gente, vessata prima dai nazisti, e poi dai comunisti. Ma quando la sento sopra di me, con le gambe incastrate intorno al mio bacino, dimentico totalmente la storia dell’Ungheria. In verità, il suo culo possente sopra di me mi fa dimenticare anche tutto il resto - guardo trasognato, senza vederla, la finestra di fronte. Non ritorno cosciente neppure quando la sposto sul fianco e mi sistemo dietro di lei: stringo i suoi seni da dietro, pizzico le aureole enormi dei capezzoli e spingo, con ritmo variabile, il centro del mio godimento nel più profondo del suo corpo. Soltanto quando Roxana geme con parole che non conosco, il mio stato estatico si trasforma in un rapporto con lei - con una donna che vive in una casa piena di oggetti ungheresi e che dispone di una delle tante finestre di Budapest. Una finestra attraverso la quale in inverno, anche a mezzogiorno, e perfino quando si fa l’amore, entra una luce che sa soltanto di notte e di neve. Il treno lanciato nella notte si dirige verso Budapest - a Piazza degli eroi un cappotto scarlatto e una macchia di capelli biondi stanno ad aspettarmi. Mi scrollo e m’accorgo che stiamo per raggiungere Udine. Il viaggio è finito. Ancora assonnato, mi preparo a scendere. A terra, il freddo che m’investe il viso mi sveglia del tutto. Il profilo di un mantello si staglia sullo sfondo della banchina. Sì, è proprio lei: i capelli neri di Alessia interrompono il buio della notte. Il mio fiato è vapore fumante mentre i suoi passi mi vengono incontro. Sento le sue braccia avvolgermi la schiena e i seni schiacciarmi il torace. La sua fronte, protetta da una fascia di lana, si rintana nel varco della mia gola... I Racconti 33 Ma le farfalle prendono l'autobus? FEDERICA MASTROLONARDO Gioco con le mani alla luce del Sole e dò forma ai miei pensieri. Immagino di rinascere. Cosa vorrei essere? Il vento fra le foglie. La pioggia nel mare. Una nuvola bianca. Peter Pan. Un lupo tra gli alberi in un bosco. Una libellula. Una donna innamorata. Una storia a lieto fine. Un fiocco di neve. Un raggio di Sole. Un gelato al limone. Un abbraccio, un bacio, una carezza. La Tour Eiffel. Una lettera d'amore e la donna che la riceve. Un paio di mani operose. Il riposo che segue il lavoro. La perseveranza. La giustizia. L'onestà. Un gatto nero. Un panda. Una geisha. Un dolce al cioccolato. Jane Burden. Jane Austen. Elizabeth Bennet. Sulle ali delle farfalle volano i fantasmi del mio passato. Inseguendoli, corro per le strade con le mani tese: cerco te. Dovresti prender le mie mani e stringerle forte per non lasciarmi andare via. E se sapessi chi sono forse lo faresti. Lo faresti? La polvere di stelle può curare un cuore malato e creare tante piccole realtà, ma un cuore violentato di che cosa ha bisogno per ritornare tutto d'un pezzo? Il mio amore che tu hai calpestato, umiliato, deriso, maltrattato sarà sempre tuo. E le farfalle ti odiano per questo. Ogni mattina quando aspetto l'autobus, sogno di parlarti. Vorrei prenderti per mano e dirti: "Sono quella bambina che tu hai lasciato senza papà quando aveva solo quattro anni." Mi siedo accanto al finestrino, le farfalle mi fanno compagnia, e penso, penso che se ti fermassi un attimo sentiresti il legame che ci unisce e che non si è mai spezzato. Puoi rimpiazzare la mamma ma non puoi rimpiazzare me. Io ti appartengo, papà. Papà. Ho una tua fotografia che porto sempre con me. La guardo tante di quelle volte che mi sembra di conoscerti, anche se non mi hai dato il tempo di farlo, e la stringo al petto tante di quelle volte che mi sembra di sentirti, anche se il tuo calore io non lo ricordo più. Papà mi hai già abbandonata una volta. Se sapessi chi sono, lo faresti una seconda volta? Lo faresti? Da sei mesi prendo il tuo stesso autobus per parlarti, ma non trovo il coraggio. Sei qui, a pochi centimetri da me, se allungo la mano posso sfiorarti eppure sei tanto lontano che ti scambierei per un sogno. Sono sicura che da qualche parte dentro di te non mi hai mai dimenticata. Ma allora perchè non mi hai cercato? Perchè hai aspettato che fossi io a farlo? Perchè? Vorrei esser certa che tu ci sarai per sempre, che troverò la tua mano pronta ad accogliere la mia, che mi guarderai negli occhi e mi dirai: "Sono qui. Ti amo. Mi prenderò cura di te." E' forse un sogno la felicità? Un tenero, pallido sogno irrealizzabile? Quanto tempo rubato alla vita! Potremmo stringerci la mano, vivere insieme ogni giorno ed essere felici. Ma tu mi hai abbandonata lasciandomi una donna a metà. E forse dovrei abbandonarti anch'io: non ho tempo per essere infelice. La vita è tutta un'attimo, così mi han detto le farfalle. Non sono pazza, solo leggera. Leggera come le foglie, come una piuma. La vita va vissuta con un pizzico di leggerezza. Leggerezza. Leggerezza. Perchè sai, non è ancora finita. Io sono qui. Tu sei qui. Vicini, lontani, insieme, divisi: una cosa sola, un soffio di vento caldo sulla pelle. Voltati. Voltati. Guardami e riconoscimi. Papà io sono te. Sono te. Le farfalle si vergogneranno di esser state delle crisalidi? Tu non ti volti. Non lo fai mai. Continui la tua corsa, poi ti fermi, scendi e l'indomani ci rivedremo alla fermata. Di nuovo. E forse domani penserò di meno e avrò il coraggio di guardarti negli occhi e dirti la verità. Per il momento resti un battito mancato al cuore. Ho lo stomaco che svolazza, non avrò mica ingoiato qualche farfalla? 34 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Tetraspazio ANGELA MAURIZI Le tre dimensioni: il mondo Il caffè si adagiò nel latte. Il biscotto lo superò, sprofondandovi. Ne riemerse tremendamente inzuppato. La rima destra cominciò, infastidita dall’infiltrazione mattutina. Doppi margini adesi e combacianti. A copertura di immagini oniriche. Lentamente. Uno su...l’altro, chiaramente, giù. Fu il turno della sinistra. Ma il margine superiore non andò su. Quello inferiore restò a lui incollato. No! Non era ectropion né tantomeno entropion. Simblefaron? Neanche a parlarne. Era un cacalo. Una semplice concrezione mucinosa derivante dal film. Lacrimale si intende. A quel punto virtù fatta venne in soccorso sotto il nome di Necessità. Faticosamente. L’Osso narratore invocò: narrami, o Scapola , dell'articolazione gleno-omerale, che tanto ruotò, dopo che distrusse l’acre cacalo, porca troia! Occhi aperti. Due. Come due erano le braccia, due erano le mani, due le gambe e due i piedi. Il mento era uno. Non si potevano fare altrimenti. Ma si poteva fare testa-mento. Ed è quello che fece Aghiro strofinandosi il viso con le mani. Per riprendere il contatto con la realtà. Gravosamente. Altri cinque minuti. E si voltò sul fianco sinistro. Il lenzuolo, fedele, lo seguì. -4’59’’ -4’58’’ -4’57’’ dove F2,1 è la forza con cui l’oggetto uno è attratto dall’oggetto 2, G è la Gm 1 m 2 F 2,1 (r) = r costante di gravitazione universale, che vale circa 6,67 × 10-11 Nm²kg-2, 3 r m1 e m2 sono le masse dei due corpi, , dove gli indici si riferiscono alle due masse. In parole: due punti materiali si attraggono con una forza di intensità direttamente proporzionale al prodotto delle masse ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. -4’56’’ Stancamente. Gli occhi si richiusero. I giornali erano a disposizione dei lettori sin dalle prime luci dell’alba. Ma che fretta c’era. Aghiro ne avrebbe comprato una copia più tardi. Il fornaio era in opera da almeno tre ore. L’aroma del suo operato si espandeva nel vicinato. Aghiro amava quell’odore. Ma che fretta c’era di acquistarlo subito. Non avrebbe di certo mangiato pane prima dell’ora di pranzo. Il citofono alla solita ora. Il solito postino. Ma che fretta c’era, è risaputo che il postino citofona sempre due volte. -0’12’’ Fiaccamente. Aghiro tornò nella fase REM tra le note di “Bad day”. La 4° dimensione: Il cubo Rispetto a cosa si può curvare uno spazio a tre dimensioni? Siamo nel tetraspazio. Do Re Mi Fa Sol. La, dove tutto può accadere. Dove la scala è il tempo, ed il tempo è musica. Nel cubo ho rinchiuso Aghiro mentre dormiva. Ho provato ad urlargli -Aghiro svegliati!, Aghiro svegliati... A‘ ghiro e svegliateeee!Non ho ricevuto risposta. Ho quindi agito in pieno stile sleeping abduction. C’ho messo dentro anche Valentino. Eccolo lì, nel suo angolo preferito, in fondo a sinistra. A difendere il suo spazio intimo. Ed infine Feliciano. Che fatica schiodarlo da quel divano. Guardate come è arrabbiato. Quasi quasi per provocarlo un po’ lo chiamerò Tristano. Ne avrei potuti prendere a centinaia di questi omini. Invece prendo in mano il cubo. Che in realtà è un dado. Lo agito tra la mano sinistra e destra. Soffio tra le due. Gesto di scaramanzia. Lo lancio. Esce il numero sette. Impossibile direte voi. Beh, nella mia dimensione no. Qui decido io. Io sono il Tempo. E nel mio regno punisco la noia, l'indifferenza, l'afflizione, e lo scoramento che induce alla fuga. Il mio castigo non è doloroso. Io passo. E lascio il segno. Chi lo riceve non si accorge del marchio che gli imprimo. Lo scoprirà soltanto quando le fibre di elastina e di collagene diventeranno più lasse. E ci saranno alcuni che avranno ricordi, emozioni, affetti, con cui colmare quelle depressioni cutanee. Altri le chiameranno semplicemente rughe. Disprezzandole. Questi stolti ignorano che il loro tempo è trascorso e che oltre ad aver dimenticato di seminare e di raccogliere, hanno dimenticato di vivere. Io sono eterno. Ma a voi esseri umani do un tempo preciso. Quello di una vita. Che l’accidia non vi accompagni. O avrete perso voi stessi, oltre che ME. I Racconti 35 Neve in boccia ALESSANDRA MEROLLA Domenica. Letizia ciondola in piazza Unità d’Italia. Ha solo otto anni, trecce di capelli rossi e un sorriso imperfetto. Le mancano un po’ di denti. Un tunnel si è andato profilando nella sua bocca. Lei ne va fiera, grazie a ciò ha guadagnato molti soldi. Ha deciso: “Con i soldi mi comprerò un ricordino”. Non sa ancora quando, dove e cosa, ma sa che sarà bellissimo. I genitori, Gabriella e Giovanni, portano Letizia ed Elisabetta, la sorella di nove anni, in un estenuante tour estivo. Il mare, Letizia vuole andare al mare. Ma come? Ora non si preoccupa troppo di come realizzare il suo desiderio sta partendo da Trieste! Quando viaggia le sembra di essere agli Uffizi, dove mamma e papà le hanno distrutto le gambe l’anno scorso. Ad ogni passo si affaccia all’orizzonte un quadro, sempre nuovo, mai identico a quello precedente. Lei è sul treno che corre verso il mare, ne è certa. E’ mercoledì, sto dividendo il mio viaggio con una strana compagna e siamo sull’1 diretto al Lido di Venezia. Da quando ci siamo incontrate la mia compagna di viaggio non ha fatto altro che brontolare. Vuole il mare. Io ho le palle piene del mare e non lo dico solo in senso figurato! Sono seccata, anche io vorrei remare una gondola e vorrei sposare un marinaio. Perché lei riesce ad andare al mare e io non realizzo i miei sogni? Mah! Venezia è una città magica, io confido in questo. “Cosa stai pensando?” Mi chiede la mia compagna di viaggio mentre siamo sul vaporetto a Venezia. Non rispondo, ho smesso, sembra che io e Lei parliamo due lingue diverse. In realtà, penso che Lei non ci senta. Ha un problema di udito io di vista,spesso non riesco a vedere tutte quello che Lei vede. La mia compagna di viaggio è così emozionata che disturba i passeggeri, ora sta parlando con la signora di fianco a noi. Lei, la maleducata, ha avuto il coraggio di chiederle di raccontare la storia che stava leggendo. La signora spiega:” Tanti anni fa un russo ha vissuto in città per un po’ di tempo, dopo aver visto i meravigliosi palazzi veneziani, l’ ha descritta come fatta di pizzi e merletti”. Io non ho ben capito, ma la mia compagna, dopo aver riflettuto un po’, dice: “Ah, ho capito. Venezia è come il centrino di pizzo sulla tavola della sala. I ricami sono stati fatti dal battello-ago. La tavola è l’acqua”. Rimango senza parole. Ha ragione. Non è una tavola ma uno specchio cangiante grazie al moto del battello. Ma che fa ora? Spinge? La mia compagna spinge, ha fretta di scendere, finalmente siamo arrivati al mare. Il suo primo desiderio è stato realizzato. Ora non vedo più nulla, forse sono caduta. Bianco: vedo tutto bianco. Oggi, venerdì, finalmente si è realizzato un desiderio. Ho incontrato un capitano alla fermata di Palanca ma non l’ho sposato, lui era perfetto nella sua uniforme da marinaio. Due giorni dopo il comandante è salito a Zitelle, questa volta indossava la divisa da pompiere, ma cosa ci fa un pompiere in una città sull’acqua? Mentre lo osservo ascolto il racconto di un signore dell’isola intento a guardarlo . Si narra la leggenda di una festa del Redentore: il capitano, che aveva perso un po’ di venerdì - cosa vorrà mai dire? - indossò la divisa di comandante dei vigili e in riva alla fondamenta cominciò a dirigere il traffico delle imbarcazioni, che volevano godersi la festa sull’acqua.Il finto comandante dei vigili combinò una tale confusione che il bacino davanti San Marco con le gondole più che uno specchio d’acqua, sembrava, vista dall’alto, un’impepata di cozze. Il signore scende. Siamo a Sacca Fisola. Io e la mia compagna restiamo curiose di sapere come andò a finire quella festa del Redentore ma sappiamo che rincontreremo il capitano, con una nuova divisa. Voglio andare all’Accademia ed ecco che vengo nuovamente colta dal mio fastidiosissimo disturbo alla vista. Prima vedo il mondo a puntini poi tutto è bianco. Quando vedo di nuovo bene, sento un fastidioso dolore alla testa,capisco che la mia compagna non mi ha ascoltata, siamo sulla linea 42 e andiamo a Murano. Mi sento un pesciolino di fianco ad una balena, la 42 sta per essere sorpassata da una gigantesca nave. Uffa, io voglio remare! Voglio andare a casa mia. Già ma qual è casa mia e dov’è? Ho risolto i miei problemi di vista. E’ domenica, sono a Milano e vedo il Duomo. Sento in lontananza la voce di Letizia. Io sono una gondoliera dentro una boccia di vetro. I venditori ambulanti mi chiamano boccia di neve. Ho finalmente realizzato un altro desiderio: riesco a remare se fanno oscillare la boccia. Raramente vedo i puntini bianchi, succede solo quando gli amici di Letizia mi capovolgono. Dopo il viaggio a Venezia, Letizia mi ha dimenticato sulla sua scrivania davanti alla finestra. Questo è il destino dei souvenir. Io però conservo ricordi nevosi di Venezia. 36 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Viaggio tra i ricordi di un mondo che non c’è più MARIA GIOVANNA MURGIANO Luci ed ombre si susseguono nella vita, luci di spensieratezza, ombre di tristezza ed io ripercorrerò le mie ombre e le mie luci viste attraverso il ricordo delle lontane estati galluresi. I primi viaggi risalgono ad allora ed ho nitido l’interminabile tragitto. Partendo con la littorina dalla Stazione Centrale di Cagliari, dopo varie ore si arrivava alla stazioncina di Monti, storditi dalle continue oscillazioni: quella era la tappa intermedia dove attendevamo la “coincidenza” che ci avrebbe portati a destinazione. Annunciata dal petulante tintinnare della campanella la locomotiva in dotazione alle Ferrovie Secondarie a scartamento ridotto stantuffava fra uno stridere di bielle e pistoni, circondata da possenti sbuffi di vapore a capo del convoglio che oggi, recuperato per brevi percorsi turistici, viene denominato “Trenino Verde”. Le carrozze per i viaggiatori, tutte dotate di rigidi sedili di legno piuttosto scomodi, erano precedute dal carrello per il carbone da cui a tratti sporgeva la figura del fuochista che, un piede sul “tender” e l’altro sulla piattaforma della cabina, con una pala riforniva di carbone la caldaia tenuta sotto controllo dal macchinista. Al penetrante fischio del capostazione il locomotore ripartiva muovendosi pacioso e, aumentando lentamente velocità, superato il passaggio a livello animato da ragazzini che sbracciandosi ci salutavano, in breve si entrava nella fresca spaziosità della Gallura il cui scenario si poteva godere appieno sostando sul ballatoio dell’ultimo vagone. Dal finestrino guardavo il verde rigoglioso che mi passava davanti e certe piante erano così vicine che, allungando la mano verso un ramo potevo ritrarla piena di piccole foglie tenere, quindi ampie vallate percorse da rivoli d’acqua cristallina, fulvi cavalli con puledrini che si rincorrevano, bianche greggi al pascolo e solitari “stazzi”, insediamenti rurali, anticamente dimore di pastori costruite con “cantoni” di granito, attualmente in gran parte trasformati in strutture per “agriturismo”. Talvolta, in prossimità di queste costruzioni il “trenino” si fermava per far salire giovani in partenza per il servizio militare. Altra fermata era quella, abbastanza lunga, per rifornire d’acqua la locomotiva, dando modo ai viaggiatori di sgranchirsi le gambe passeggiando lungo i binari, poi, ad un fischio prolungato della locomotiva, il viaggio riprendeva. In lontananza il Limbara, nitido contro il cielo e picchiettato da sparsi sughereti o zone abbrunate, ricordo di incendi di boschi e sterpaglie, sempre uguale e pur sempre diverso come il mare, roseo ed iridescente sotto i raggi del sole al mattino, con riflessi d’ametista al pomeriggio, quasi sanguigno al tramonto e la notte nero contro il cielo livido, quasi scenario di tragedia. Il treno proseguiva il suo percorso infilandosi in strettissimi passaggi di pareti rocciose che di tanto in tanto improvvisamente si aprivano lasciando scorgere massi apocalittici di granito muschiato che pareva stessero per staccarsi precipitando. E con il calare delle ombre, avvolta da una brezza vagamente odorosa di timo, dopo l’ultima svolta, mi commuovevo alla vista della cittadina di Tempio Pausania, semiaddormentata ed occhieggiante attraverso finestre illuminate che si confondevano con le prime stelle. Al mattino, fresco e smagliante nell’aria limpida ed azzurrina, affacciandomi al balcone in ferro battuto brillante di petunie e portulache, guardavo le strade lastricate di granito che echeggiavano dei rumori di ogni giorno, suoni familiari che mi davano un senso di serenità: la cornetta del “banditore” seguita dall’annuncio di fatti e notizie nel dolce dialetto gallurese, il passo ticchettante delle “turacciolaie” che si recavano in fabbrica cicalando allegramente, lo stridere delle ruote dei carri caricati all’inverosimile con le cortecce sanguigne delle sughere, i canti dei contadini lungo le strade che conducevano alla campagna, suoni primitivi soffusi di gioia di vivere o di malinconia che arrivavano al cuore rauchi e profondi e col sopraggiungere dell’oscurità un fresco vento giungeva dalla montagna portandomi, inconfondibili, gli aromi della macchia mediterranea. Dieci agosto, notte di San Lorenzo, notte dei desideri...Una stella cadente...Un sogno, una speranza da affidare al cielo...Vorrei tornare qui tutti gli anni...Caduta, svanita anche l’ inconsistente scia d’argento... A lungo mi è rimasto il ricordo di quel palpitante firmamento a cui avevo affidato i sogni del mio mondo bambino. Per vari motivi non sono più tornata in Gallura: non sempre il cielo appaga desideri rivolti alle stelle, tanto meno quelli di una bambina, ma forse è meglio non forzare il destino verso ciò che vorremmo. La vita può riservare le sorprese più imprevedibili come è successo a me. Ma questa è una storia che racconterò un’altra volta! I Racconti 37 Il viaggio della Hor ANTONIA NAPOLANO La Hor Machine collegava il quarto pianeta del sistema solare, Marte, alla stella Horologii, nell’emisfero australe, dove aveva luogo il più grande mercato spaziale dell’ottavo millennio. Era un’astronave da trasporto, piccola rispetto alle navi generazionali che avevano iniziato a solcare lo spazio circa 2000 anni dopo il progetto Orione. La Hor Machine iniziava la sua corsa nel preciso istante in cui le stelle della costellazione ‘la Croce del Nord’ si allineavano. Partiva dall’Olimpus Mons, il più grande rilievo dell’intero sistema solare, stracolma di terrestri, cyborg e alieni, pendolari di ogni sorta dunque, con destinazione il grande mercato di Horologii dove le merci più strane venivano barattate. Poi le cose erano cambiate: il Patto Galattico che disciplinava l’intero commercio spaziale era stato sciolto. Un nuovo e possente impero, capeggiato da Mizar, aveva scosso le stelle e da una sperduta regione prossima al Polo Nord Celeste, in cui aveva sede il suo governo, aveva dato il via alle invasioni. Una dopo l’altra tutte le galassie erano state assoggettate al suo controllo, alle sue regole, alla sua politica dittatoriale e di economia pianificata. Il collasso non tardò ad arrivare. In pochi anni il commercio si arrestò, i popoli si impoverirono e ogni comunicazione tra gli abitanti delle diverse galassie venne interrotta. Per Mizar infatti la divisione rendeva deboli, insicuri e spaventati, necessari presupposti affinché il suo potere restasse illeso. Tutti i mezzi di trasposto vennero dunque condannati alla demolizione istantanea. Ma Castor, il giovane conducente della Hor Machine, e pochi altri dell’Olimpus Mons, si imbarcarono su di essa ed abbandonarono il pianeta. L’intento era quello di dirigersi all’ammasso della Chioma, formato da più di 1000 galassie, dove era insediato il grande impero del sire Hidra, noto per bontà e potenza, e chiedere aiuto. Il viaggio della Hor Machine risultò più difficile del previsto. Un ordine di arresto e di esecuzione immediati vennero emessi nei confronti del suo equipaggio nello stesso istante in cui fu resa nota a Mizar la loro fuga, ed ora il piccolo mezzo di trasporto si ritrovava non solo a dover compiere un viaggio spaziale non adatto alle sue dimensioni, con un carico più pesante del previsto, ma anche contro il tempo. Tuttavia Castor aveva fiducia nella Hor. Fu quando un razzo violaceo colpì in pieno il serbatoio del propellente che dovette stringere i denti. Fu allora che le dita si strinsero sul timone della navicella spaziale così fortemente da diventare violacee. E in un baleno la sua mente venne invasa da mille pensieri. Era da poco più di due giorni che quel viaggio interspaziale aveva avuto inizio ed era riuscito a scoprire più cose dell’universo in quel breve periodo che nei suoi 30 anni di vita. Certo era conducente della Hor da molto e viaggi nello spazio non gli erano mancati. Ma mai come quello. E pensare che da bambino aveva sempre desiderato compiere il più grande viaggio interspaziale della storia. Forse era stato per questo, per il ritorno a galla di tale desiderio, che ora si trovava ai calcagni l’armata di Mizar. Eppure non ne era pentito. A circa 200.000 km/h Castor aveva superato la costellazione del Leone e sorvolato quella della Chioma di Berenice. In tale corsa affannata aveva avuto modo di osservare da vicino le stelle più brillanti dell’universo: le nane bianche e quelle rosse, le stelle di Wolf-Rayet, ed anche un immenso buco nero formatosi nelle vicinanze di Proxima. Era stato un viaggio silenzioso, immerso in un mare tinto di blu e punteggiato di diamanti, fino a quando l’armata di Mizar non aveva accorciato le distanze tra di loro ed aveva preso a bombardarli. La Hor Machine infatti era quasi giunta agli estremi confini dell’ammasso della Chioma. Bisognava abbatterla prima o il sire Hidra sarebbe stato avvertito di quel che accadeva all’altra estremità dell’universo. Con un motore fuori uso ed un serbatoio danneggiato, la Hor proseguì il suo viaggio. Castor zigzagò con agilità tra le meteore che costeggiavano la Chioma e spronò la navicella più che potè. Aggirò un satellite e poi un altro ancora. Notò a poco distanza una catena di stelle multiple, mai viste prima e si catapultò su di esse. Fu una mossa azzardata: le sorvolò ad una vicinanza tale che la loro lucentezza abbagliò l’equipaggio. In un attimo il sibilo delle navi di Mizar svanì e il silenzio inghiottì la Hor. Pochi istanti dopo Castor strizzò gli occhi. Prima degli altri ebbe il coraggio di aprire le palpebre e, liberate le pupille da piccole pagliuzze bianche, residuo del precedente abbaglio, scoprì in quale zona dell’universo erano giunti. Un sorriso si dipinse sul suo volto: l’ammasso della Chioma con le sue 1000 galassie roteava come una spirale davanti a lui. Le stelle multiple che avevano superato segnavano il confine dell’impero di Hidra: erano in salvo. Il viaggio spaziale della Hor era stato concluso con successo. 38 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Viaggio sulle linee di un viso FABRIZIO NARDI Claudia, una tenera bambina di sette anni, si era perduta davanti al Muro del Mondo. Ancora una volta. Quella parete, sulla cui superficie era disegnata la carta geografica del Mondo, appariva infinita ai suoi piccoli occhi di Sole, al suo corpo ancora gentile e minuto che a malapena arrivava all’altezza del Madagascar. Claudia doveva sempre alzarsi sulle punte dei piedi per guardare aldilà del Mediterraneo. Un disegno, il Mondo, ancora troppo grande per essere compreso e troppo distante per essere abbracciato. Ma Claudia cercava qualcosa che forse non era più lì, nel Mondo, ma che da questo la chiamava a gran voce. Dove sarà Papà? Un fiocco rosso tra i capelli biondi, l’abito migliore da esibire per l’incontro tanto atteso, ma il desiderio della prima volta contrastava con il tempo, il dove, chi? Dicono che lei abbia il suo stesso viso, del padre. Dicono. Con ragione. Perché la forma si trasmette simile da un corpo all’altro se opera l’Amore. Le sue dita affusolate scorrevano sul disegno in cerca di qualcosa, di un segno che avrebbe potuto raccontarle di un luogo. Di quel luogo. Una pennellata di Giallo era sulla città di Roma. Il tratteggio era ancora fresco. Quello era un segno lasciatole dal padre. Si sarebbero incontrati per la prima volta in quel luogo, lì dove portano tutte le strade. Con la felicità dipinta sul viso, Claudia si allontanava dal grande Muro ed entrava nella sua Stanza. La sua Stanza, che sulla porta aveva inciso 101, aveva la caratteristica di essere come il Mondo: senza fine. Laboriosa come una piccola ape affaccendata, Claudia cercava qualcosa nel caos di quella stanza i cui confini erano in continua espansione. Le pareti, mai uguali, erano sommerse da oggetti provenienti da ogni parte del Mondo e che rappresentavano qualunque luogo del Mondo. La sua stanza era davvero il Mondo. Ed era un pensiero, il Mondo in una Stanza, che metteva i brividi. Sotto il suo letto ecco sbucare un pennello con le setole macchiate di Giallo, che macchiava a sua volta una piccola scultura raffigurate la Pietà di Michelangelo. Con i due oggetti tra le mani, il pennello e la statuina, la piccola era in attesa alla fermata del bus che era proprio fuori la porta della sua stanza. La Stanza, secondo il vecchio cartello stradale nei pressi, si trovava in Hope Street. Perduta nell’immaginazione di quel viso, di quell’uomo che dicono abbia il suo stesso viso, Claudia non si accorse che l’autobus, il 450 era già arrivato sulla fermata. Sulla vettura, Claudia mostrava all’autista, un uomo con il viso coperto da un berretto e da una lunga chioma bionda, il pennello e la statuina. L’autista, con il sorriso di chi aveva già capito, partiva veloce verso la nuova destinazione scandita dal nuovo cartello posto sul vetro della vettura: Largo San Giovanni. Claudia era seduta accanto al finestrino, curiosa verso tutto ciò che avrebbe visto scorrere dall’altra parte del vetro, linea di Confine tra ciò che fuori si trasforma lentamente, e le immagini immaginate di quel viso che sembra cambiare ad ogni istante. L’autobus arrivava a destinazione. Il manto stellato avvolgeva la Basilica di San Pietro. Il pensiero che quell’uomo potesse aspettarla lì dentro, in un baleno spazzava via tutti i sorrisi che l’avevano accompagnata durante il viaggio. Claudia era un punto smarrito in un disegno incompiuto ferma davanti alle grandi porte chiuse della Basilica. Dietro quelle porte c’erano tutti gli uomini del Mondo che erano stati chiamati sotto le stelle. Poteva quel Gigante di pietra, sempre uguale, contenere un viso che mutava ad ogni pensiero? Papà non è qui... sussurrava il cuore alla mente. La piccola risaliva così sul bus, silenziosa andava a sedersi all’interno della vettura. Aveva il viso solcato da lacrime. L’autobus ripartiva ed il suono della strada cercava di cullare, come una madre, il sonno triste di Claudia. Il viaggio finiva dove era cominciato. Claudia apriva gli occhi, svegliata da un raggio di sole che penetrava dal vetro dell’autobus fermo fuori la porta della sua stanza. L’autista non c’era più. Claudia si era fermata davanti al grande Muro. Quell’uomo, che dicono abbia il suo stesso viso, non l’avrebbe trovato nel Mondo disegnato sulla parete. Forse viveva in un altro. La porta della sua stanza era aperta. All’interno vi era un uomo dalla corporatura prestante che aveva gli stessi occhi di Claudia, ed anche gli stessi lunghi capelli biondi. Aveva anche il suo stesso viso. Lui aveva quel viso. Una nuova luce nasceva sul volto di Claudia mentre correva incontro a quell’uomo. Lo teneva stretto nel abbraccio come qualcosa che non avrebbe dovuto più andar via. Papà! Ti ho cercato ovunque! Dove sei stato? L’uomo, commosso, stringeva le maglie dell’abbraccio formandone uno solo, e, non visto, con il piede allontanava il berretto d’autista gettandolo sotto il letto. Io sono sempre stato qua. I Racconti 39 La coperta di lana ROSA OLIVETO Oggi c’è il sole, menomale! Sono finiti i giorni freddi e piovosi. Ho acceso la mia prima sigaretta, dopo averla tenuta nell’angolo della bocca per un’ora. Dicono che il fumo faccia male. Cazzate. Quando fumo mi sento proprio felice, mi inebrio, dimentico tutta la mia esistenza: è come se nascessi proprio dopo il primo tiro e quando finisce la sigaretta... torno alla realtà. Non è brutta la mia vita, quella di oggi. E’ ricca di attese e le giornate non sono mai uguali; hanno una sola componente in comune: l’assoluta libertà di disporre di esse. Non è stato sempre così, lo ricordo bene: sveglia alle sei, doccia, abito blu, consiglio d’amministrazione, aerei per Milano, Bologna, Firenze... per mesi, anni e poi... un giorno ti ritrovi a cinquant’anni che non servi più a nessuno. Avrei potuto provare ancora, cercare una nuova azienda, rimettermi sul mercato..., ma poi mi sono detto: “Tua moglie, insegnante, e i tuoi figli, già laureati, possono fare a meno di te... Che cosa vuoi realmente?”. Mi sono convinto che quello che desideravo di più non era una vita agiata ma stressante, fatta di lenzuola profumate in cui non mi accorgevo nemmeno di essere, ma qualcosa che mi facesse pensare a ciò che stavo facendo. Queste scelte si pagano: mia moglie mi ha confessato che non poteva capirmi e mi ha detto solo una cosa: “Fa’ quello che vuoi, ma in un’altra città!”. L’ho accontentata, per nulla al mondo avrei voluto procurarle del male! Ho saputo che ha raccontato ai nostri amici e parenti che sono andato a New York per un importante progetto che mi avrebbe tenuto lontano per anni..., ma cosa s’inventerà quando non mi vedranno più? Oggi è una bella giornata di sole. I primi raggi mi hanno raggiunto sebbene avessi la coperta di lana quasi fino agli occhi, mentre dormivo su una panchina nei pressi della stazione di Milano. Già! E’ qui che vivo. Conoscevo dapprima questa città. Numerose volte ho incontrato alti dirigenti del settore assicurativo, quello in cui ero il numero uno, talvolta pernottando nei più sontuosi alberghi. Allora, sebbene arrivassi in tarda serata, trovavo sempre il tempo per girarla di notte questa città dalle mille luci. Mi piaceva passeggiare lungo i Navigli. Lì, se avessi avuto tempo, sarei rimasto per ore a fissare il movimento dell’acqua, lieve e impercettibile, invece, dopo un po’ raggiungevo l’Hotel per concedermi quel poco di riposo necessario per affrontare, all’indomani, il ‘nemico’, e il vincitore era quasi sempre il sottoscritto, il dottor Laurenzi che ripartiva con l’ennesimo contratto tra le mani. Oggi sfido chiunque a riconoscermi dietro la barba lunga e i capelli incolti. E poi... i “signori” difficilmente guardano i barboni, non lo facevo nemmeno io. Non corro nessun rischio: mia moglie e i miei figli possono stare tranquilli... I figli... Quanto mi mancano! Accidenti se mi mancano! Ho scelto io questa vita e sono convinto di aver fatto la cosa giusta. E’ come se improvvisamente mi fossi svegliato e avessi realizzato che tutto il mondo che mi circondava, e a cui mi fregiavo di appartenere, era solo un enorme bluff, un castello di sabbia, una scacchiera su cui le pedine venivano mosse a piacimento. Ho detto basta. Dunque, dicevo... oggi è una bella giornata di sole. Mi sono alzato, ho raccolto la mia roba con un carrello e mi sono avviato alla banchina dei treni. L’ho sistemata su una di quelle panche di cui sono fornite le stazioni, accanto alla fontanella. Lo faccio tutte le mattine, oramai da mesi. Ho bevuto un po’ d’acqua: lo zampillo mi è arrivato in faccia e ho asciugato la bocca con il fazzoletto di carta. Ho acceso la mia prima sigaretta, gentilmente offerta da un passeggero, uno come ero io... un colletto bianco..., in procinto di salire sull’Eurostar ‘Milano-Roma’. C’è sempre tanta gente... gente che va... gente che viene come diceva qualcuno in un vecchio film della Garbo, mi sembra «Grand Hotel». Mi piace guardare... osservare... E’ questa la mia attività di oggi. Non ci si annoia mai, per questo ho scelto di vivere in una stazione. Ecco la signorina in carriera che trascina il suo trolley, la famigliola che va in vacanza, la signora di mezz’età che torna da un viaggio, un gruppo di ragazzini in partenza per la gita scolastica... Quante vite passano davanti ai miei occhi! E domani, dopodomani... altre ancora... solo io starò ancora qua. Ho sistemato nello zaino la mia coperta di lana: l’ho dovuta conquistare, sapete. Quando sono andato alla Caritas, ce n’era una sola, ma a chiederla eravamo in due: io e una donna che ha ceduto il malloppo perché la volontaria addetta alla distribuzione l’ha riconosciuta e le ha ricordato che ne aveva presa una simile il giorno prima. “Vieni domani Giovanna, te ne procuro un’altra!” le ha spiegato, mentre io, soddisfatto, stringevo tra le braccia il sacchetto gonfio. E’ bella grande. Deve trattarsi di una matrimoniale. La piego in due prima di arrotolarmi dentro e vi posso garantire che non sento freddo. L’ho rivista quella Giovanna con tutto il suo corredo dietro. Ci siamo scambiati anche uno sguardo, ma non abbiamo detto nulla né io, né lei. Per adesso c’è una assoluta diffidenza nei miei riguardi perché, in fondo, io sono quello che le ha ‘fregato’ la coperta, ma domani... chissà! 40 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Ritorno agli anni verdi CORDELIA PAGELLA Liana stava preparando la valigia e la borsa con gli effetti personali ed ogni tanto piangeva; sì la sua vita era stata difficile, oltre alla piccola invalidità, un matrimonio portato avanti a forza di volontà. Credeva nei valori della famiglia e per questo aveva sopportato tradimenti e abbandoni... Liana aveva perdonato ma era sempre lei “a tirare avanti la baracca” col suo stipendio, lui invece viveva negli sperperi, i debiti... Aveva scialacquato l’eredità di una zia in speculazioni sbagliate. Ed ora ella era giunta alla pensione, i figli si erano formati la loro famiglia, con la buonuscita si era acquistata una casetta... Ma il destino doveva accanirsi: in capo a pochi anni di “vita serena” accadde l’imprevedibile. Liana un giorno aveva invitato per un caffè, una vicina di casa, una giovane separata dell’età della figlia scomparsa e madre di un bimbo. In breve questa donna legò col marito che un giorno fuggì con la giovane tra lo stupore di amici e parenti. Liana ottenuta la separazione vendette la casa e si stabilì in affitto in un alloggio alla periferia della città. Una cugina quasi sorella l’aveva invitata nella sua villa, ella era felice sarebbe tornata al sud nei suoi luoghi d’origine e poi là dove visse i primi anni di vita,il padre funzionario del ministero degli interni era una delle autorità del luogo. “Sì tornerò laggiù, meglio se mio padre vi fosse rimasto “- Avrebbe voluto compiere ‘la traversata’ col Treno del Sole, invece i figli decisero di viaggiare in aereo. L’accompagnarono fino a Malpensa, all’aeroporto di Napoli ci sarebbe stata la cugina ad attenderla. Sì, volare... Sognava spesso di volare, essere sospesa in alto, al di sopra del suo difficile vissuto. Ora l’aereo la sollevava, le borgate divennero microscopici presepi, le città dei recinti indescrivibili, i monti verdi ondulazioni ma la mente di Liana volava più veloce... Era là poco più che bambina con le sorelline a spingere la carrozzella del fratellino più piccolo, la maestra si fermò a sorridere al piccolo... Più avanti il gruppo passò di fronte ad un bar - pasticceria ed altro ed ecco uscire la Rosetta “Benvenute sorelle Del Cavo voglio darvi delle caramelle e cioccolatini, una novità assaggiate!” e porse a loro un pacchetto di dolci “Apriamolo” “No, prima portiamolo a casa...” “Scusi signora - Liana si sentì scuotere - era il signore che si era seduto accanto, aprì gli occhi... “Ma sei Rosalia Del Cavo?” “Esatto, sono Liana... Lei signore non è faccia nuova...” “Sono Gianni, quel compagno di scuola della terza elementare con la maestra Concetta, mio padre aveva la trattoria del paese e il negozio di frutta e verdura” “Si, Gianni... ci regalavi la frutta, oh quelle ciliegie!” “Ora sono proprietario di due hotel a cinque stelle,ho lasciato la trattoria a mia sorella e ogni tanto faccio ritorno nella mia casa... Ma... Stai piangendo...” Liana non riusciva nascondere il dolore ed in breve gli raccontò la disavventura - “Ti invito presso la trattoria di mia sorella, sarà contenta di incontrarti” “ti ringrazio dell’invito, ci sarà mia cugina ad attendermi a Capodichino“ “Puoi venire anche fra qualche giorno, voglio che tu ritorni... Gigi, te lo ricordi, cercava di avere tue notizie, ora ha perso la moglie...” All’aeroporto c’era la cugina col marito, Liana presentò a loro il compagno di viaggio. Gianni non era poi nuovo anche per Consolata, la cugina. “Liana, voglio regalarti una vacanza - disse Gianni - nel locale di mia sorella”. La cugina promise che in capo a pochi giorni l’avrebbe portata là... Trascorsero alcuni giorni; la mente di Liana era laggiù, giocava con le sorelle, Gianni, Gigi ed altri bambini del luogo... sognò che quest’ultimo le chiedeva il perché di un suo allontanamento “Ti ho cercata ma ad un certo punto....” fu svegliata di colpo. Doveva partire con la cugina ed il suo consorte per andare proprio là. Fu accolta calorosamente dalla sorella di Gianni, la locanda era trasformata in una pensione per turisti, aveva pure un altro aspetto il borgo. Si informò su alcune persone, inevitabile il cambio generazionale e poi alcuni emigrati al Nord e chi all’estero... Seppe che la domestica che lavorava in casa del Cavo abitava in una splendida villa... Si era ben sistemata... E Gigi? Era stato sindaco del borgo, ma attualmente dopo il lutto era presso una figlia... ma sarebbe tornato. Mentre girava per le strade del borgo ad osservare le trasformazioni logistiche e paesaggistiche si trovò faccia a faccia con una sua compagna si scuola “ Sei Liana ,che sorpresa!” “e tu Nunzia come stai?” “Sto invecchiando, però ora ti rivedo dopo anni, com’erano belli quei tempi, la vita era più serena e poi... sollevò lo sguardo verso una casa tinta di verde... è tornato Gigi l’ex sindaco...” Ora raccontami di te.... Liana le raccontò le sue vicissitudini... “Ora sei qui e devi dimenticare”. Disse Nunzia... Il giorno successivo incontrò Gigi ,il quale le raccontò del suo lutto e lei parlò del suo infelice matrimonio... Gigi ogni tanto si recava al bar della locanda per il solito caffè trascorrendo anche qualche ora... Vi partecipavano anche Gianni e la sorella. A Liana pareva che il tempo si fosse fermato, la sua vita infelice non esisteva, ora si sentiva una bimba cresciuta ed invecchiata. Mentre era al bar con questa piacevole brigata suonò il cellulare Era un figlio,aveva bisogno di lei “Mi dispiace devo tornare , il suocero di Domenico è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale per un infarto,io devo tornare al più presto” “Oh come sono spiacente - proruppe Gigi - torna al più presto, devi tornare” “O sì, senz’altro”. Il giorno dopo la cugina e Gigi l’accompagnarono all’aeroporto di Capodochino col volo diretto a Malpensa, amarezza per l’inevitabile e necessario ritorno ma con la certezza di tornare in quel borgo. Il borgo degli anni verdi. I Racconti 41 Spruzzi di colonia GIUSEPPINA PAGELLA Li avevo incontrati per caso, una sera, in una via del centro: Carla e Sandro, la coppia di sempre, fin dai tempi delle Superiori. Baci... abbracci... Dopo i soliti convenevoli, cominciammo a ripercorrere, con gli occhi della memoria, uno dei periodi estivi che ci aveva visti insieme per parecchi anni: il servizio nella colonia marina di Arenzano, la perla del Mar Ligure. Allora erano molti i bambini che non avevano mai visto il mare e la meraviglia illuminava i loro occhi non appena intravvedevano quella distesa di acqua azzurra sempre in movimento. Il ritrovo con i “trecento” e le diciotto assistenti era nella palestra di una scuola superiore della città: dopo gli appelli e la formazione delle quindici squadre, ci si dirigeva a piedi, accompagnati dai genitori alla stazione dove ci attendevano le carrozze riservate del treno per Genova. Dopo la sistemazione negli scompartimenti, venivano distribuiti i sacchetti-pranzo e i bambini incominciavano a socializzare tra loro: “Avete visto le pecore ? Uh ! La galleria... Ho paura...”. Le assistenti, giovani maestre di vent’anni o poco più, incominciavano a rendersi conto delle varie problematiche e responsabilità: avrebbero gestito una squadra di venti bambini 24 ore su 24. Ma l’atmosfera era così coinvolgente, così divertente, che spesso si dimenticava il resto... A Genova le nostre carrozze venivano staccate dal treno e allacciate a quello locale per Arenzano. Finalmente l’arrivo... Le valigie venivano caricate su furgoncini che erano in attesa e l’interminabile fila dei trecento si avviava a piedi verso la colonia... Ah... il parco... Che frescura... Ci sembrava di risentire il profumo della magnolia secolare cresciuta di fronte alla maestosa villa che ci avrebbe ospitati... Dopo l’appello e le presentazioni, i bambini erano condotti in guardaroba dove venivano assegnate le divise; successivamente accompagnati nei dormitori: ecco i salti sui lettini, i lanci dei cuscini se l’assistente non vedeva... Alla sera, a cena, tutti in refettorio... Si riusciva ad ottenere un silenzio incredibile con un gioco fra le squadre che consisteva nell’assegnare punti a quelle più disciplinate, ordinate e “voraci” con la prospettiva di un bagno più lungo. Il giorno successivo... Il mare ! La nostra spiaggia riservata, in fondo alla passeggiata... L’attraversamento dell’ Aurelia, gli spogliatoi dove spesso venivano scambiati i sacchetti, le divise... Il bagno era previsto almeno due ore dopo i pasti per le squadre che scendevano in acqua a due a due, rigorosamente sorvegliate dal bagnino e dal suo aiuto, dalle assistenti e dalla sottoscritta (facente funzione di coordinatrice). Che tuffi, che spruzzi... I bambini erano così gioiosi... Qualcuno temeva l’acqua, allora il bagnino lo prendeva sulle spalle e cercava di fargli fare un tuffo... Era un’avventura senza fine. A questo punto chiedo a Carla : - Ti ricordi quando veniva a trovarti Sandro ? - Lo vedevamo spuntare sulla passeggiata, alto, dinoccolato e lei iniziava ad arrossire e a guardarmi. Io allora le dicevo: “Vai, vigilo io la squadra”. Lei si precipitava , si correvano incontro, si abbracciavano quasi a fondersi. Ed ora eccoli ancora qui, lei arrossisce, lui la guarda, come allora. 42 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 La spia dal dente d’oro VALERIA PARIN Treno per Vienna. Ore 9,20. Anita trascina la pesante borsa alla ricerca dello scompartimento. Posto vicino al finestrino, per godere del panorama. Sistemati borsone e sé stessa, Anita allunga le sue ancora scattanti gambe, una ravvivata con le dita ai capelli e “Velden arrivo!” sussurra eccitata. Chiusi gli occhi, un sorriso aleggia sulle labbra socchiuse mentre si vede passeggiare lungo le rive di quel lago così trasparente da potersi specchiare. Sta beatamente sognando quando “Clang!” il rumore della porta che si apre. “Rotto l’incantesimo” borbotta. “E’ occupato?” una voce maschile la fa sussultare e mentre pensa “Accidenti!” risponde “Non so”. “Avevo prenotato nello scompartimento accanto. L’aria condizionata non funziona. Le secca se resto qui?” “Prego” risponde Anita pensando “al diavolo!” e richiude. Ogni tanto sbircia l’uomo e pensa: “Non mi piace”. Il tipo, si fa per dire, inizia:” Scusi se la disturbo... ” E non la smette più. Lei ascolta, ma soprattutto lo guarda di sottecchi. Guarda il suo dente d’oro e per poco non scoppia a ridergli in faccia quando le dice di essere una spia. “Una spia in che senso?” chiede. “Ha presente gli 007? I servizi segreti? Ora sto tornando a casa, in Croazia. Lei da dove viene?” “Da Treviso”. “Sto cercando un appartamento vicino a Treviso. Ne conosce qualcuno che costa poco?” continua l’uomo. “Forte!” sganascia lei dentro di sé “ La spia non ha i soldi per fare la spia! Però, però...” Lo lascia parlare ancora un po’ e dopo prende una rivista dal borsone e inizia a sfogliarla. Un titolo a caratteri cubitali la colpisce: DELITTI IRRISOLTI. I misteri degli omicidi di Via Poma e dell’Olgiata a una svolta? Non le piace leggere di fatti cruenti ma adesso, piuttosto d’ascoltare l’uomo (neanche è piacevole a vedersi) andava bene anche quell’articolo. Vede che l’uomo è nervoso. Ritorna alla rivista: “...A una svolta i delitti irrisolti di Via Poma e dell’Olgiata? Un filo comune sembra collegare i due delitti ecc. ecc.” Il tempo di leggere il riassunto dei fatti e impallidisce: l’uomo le sta puntando addosso una pistola. “Zitta! Non fiatare!” “Come faccio a fiatare se sono morta di spavento” pensa, gli occhi incrociati per la paura fissi sulla pistola. “Clang!” il rumore della porta aperta. “Bum!” e l’uomo crolla sparato sui sedili. Parte un altro colpo che manda in frantumi il finestrino. Un’esclamazione di stizza contemporaneamente al secondo sparo. Delle braccia robuste hanno immobilizzato un giovane uomo dai capelli biondiutto bene signora? Sta bene, si?” Una donna poliziotto dalla voce gentile l’aiuta ad alzarsi e l’accompagna fuori. “Si grazie. Morta di paura, ma senza un graffio” balbetta vistosamente Anita. “Un regolamento di conti tra bande dell’est. L’uomo è, era, il capo di una banda specializzata nel rapire minori per farli prostituire. Chi l’ha ucciso è il killer di una banda rivale”. Biascica Anita: “Aveva detto che era una spia dell’est e che rientrava da una missione in Italia. Ma aveva un dente d’oro. Va be’ che ci sono tanti poveri nei paesi dell’est, ma che una spia avesse un dente d’oro non mi faceva tornare i conti”. Ride la poliziotta mentre offre un bicchiere d’acqua ad Anita che lo beve d’un fiato. Con un sorriso la donna le dice: “Venga signora, l’accompagno in un’altra carrozza. Qual è la sua borsa?” Anita gliela indica e lei la solleva come fosse una piuma. “Beata la forza della gioventù” sospira Anita e, ancora tremante, si lascia guidare verso un’altra carrozza. I Racconti 43 Gedeone ANDREA PESCE Quando riuscii a fermare la navetta, il cane era già morto. Era uscito all’improvviso. Vidi solo una macchia bianca e marrone che dal ciglio della strada compariva veloce. Conscio di fare la cosa giusta accostai e, sceso dal mezzo, mi avvicinai al cane rendendomi conto che era privo di vita. Non potendo fare altro, adagiai dolcemente il corpo sull’erba. Mi ripetei più volte che quel povero animale non aveva sofferto, che forse neanche si era accorto di quello che stava succedendo e che, in ogni caso, non avrei potuto evitarlo. Due giorni dopo stesso turno, stessa navetta, stessa ora. Un uomo che avrà avuto più o meno cinquant’anni, una lunga barba rossiccia con prevalenza di peli bianchi, stempiato coi capelli lunghi e due borse di nylon tra le mani, si avvicinò al posto guida e mi sussurrò: “Mi chiamo Gedeone e sono il compagno del cane che è morto l’altro ieri...”. Il contrasto tra la gentilezza di questa persona e il suo aspetto trasandato, mi colpirono fortemente, e subito volli dirgli che ero stato io ad ammazzare il cane, cercando di scusarmi per l’accaduto e manifestargli tutto il mio rammarico per l’incidente. La sua risposta fu di quelle che lasciano il segno: “Non ti preoccupare... I fatti che crediamo di vivere non accadono mai, Aristotele docet. Non conta la veridicità di un fatto accaduto, ma il convincimento che il messaggero di questo fatto riesce a trasmetterci”. Scese poco più in là, alla fermata successiva. Era senz’altro un uomo di cultura, un intellettuale alla deriva che aveva sentito il bisogno di comunicare qualcosa di sè. Con quella frase, che da sola bastava a far scorgere l’abisso che incombe sulle nostre vite, che mette in discussione tutta la nostra percezione del reale, mi aveva colpito nel profondo. Pensai che egli poteva anche non essere il “compagno” del cane, ma che poteva avere assistito al fatto e sfruttato quell’occasione per far sì che qualcuno si ricordasse di lui. Finito il turno, nel pomeriggio, tornai sul luogo dell’incontro. Domandai ad un uomo di passaggio se conosceva un clochard di nome Gedeone; chiesi nelle case circostanti sue notizie, ma nessuno seppe darmi informazioni su quella persona. Rinunciai. Dopo quasi un anno, mentre attendevo l’arrivo della stessa navetta per lo stesso turno, lessi su La Stampa di Torino che era stato trovato il corpo di un clochard sulla riva del Po. I rilevamenti della polizia scientifica attestavano che si trattava di Gedeone Scarlatti, scomparso nel nulla tre anni prima, docente di filosofia teoretica e storia delle religioni all’università di Torino, con cattedra onoraria alla Oxford University. Piccolo particolare. L’uomo era morto abbracciato al suo cane, un bastardino dal colore bianco e marrone. 44 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Uruguay andata e ritorno MICHELA POLLAROLO Una mia cara amica di nome Nidia, in una sera d’ estate sedute in un bar, mi ha raccontato con tanta emozione una parte della sua vita. Era l’anno 1968, quando un tornado distrusse la loro casa. Nidia e la sua famiglia furono costretti a lasciare il loro paese decidendo così di trasferirsi in Italia. Dopo qualche anno Nidia si è sposata ed ha avuto due figli Andrea e Davide. Suo figlio Andrea ha conosciuto una ragazza uruguaiana di nome Alis e si sono fidanzati. Dopo qualche anno è arrivato il piccolo Massimiliano così hanno deciso di sposarsi sia in Italia che in Uruguay. Sono cominciati i preparativi per le nozze con i parenti rimasti là. Le emozioni erano tante. Ai primi di gennaio 2011 Nidia e la sua famiglia sono partiti per questo lungo viaggio. Durante il volo le sono venute in mente tutti i ricordi della sua infanzia, ad esempio, per raggiungere la spiaggia usavano una carretta rossa, ed era molto bello vedere al tramonto le dune di sabbia che sembravano neve. Appena l’aereo è atterrato è scoppiata a piangere come una bambina dall’emozione. Ad attenderli c’erano parenti ed amici con degli enormi striscioni “VIENVENIDIS AL URUGUAY”. Ha trovato tutto cambiato: al posto della loro casa hanno costruito una grande fattoria con tanti cavalli. L’unica cosa che ha ritrovato è la casa dei suoi nonni, colorata di rosa e con il tetto di paglia. Il tempo è volato è ora di rientrare a casa con una bella storia da raccontare. I Racconti 45 Le principesse si salvano da sole CINZIA ROMANU “Oggi non è giornata! - disse Luca sbadigliando - Martina stanotte ci ha fatto ballare fino alle tre!”. Dopo una breve pausa al capolinea si accomodò al posto di guida mentre due ragazze correvano sbracciandosi per impedirgli di partire. Luca chiuse le porte subito dopo che furono salite e mise in moto. Vide le giovani passeggere sedersi vicine mentre una signora tutta cotonata notava le loro gonne troppo corte sulle gambe nude. Luca, fermo a un semaforo, guardò ancora le due ragazze. Erano entrambe belle, una con lunghi capelli biondi, l’altra con ricci ribelli che mandavano riflessi ramati: due vere principesse metropolitane. Considerò, con preoccupazione, che un giorno la sua Marty avrebbe avuto la loro età. Oggi, per lei, era l’uomo più importante del mondo, il principe che la difendeva dai draghi, il cacciatore coraggioso che la salvava dai lupi ma non dubitava che un domani avrebbe cercato un altro principe, magari di quelli con i jeans bassi e le mutande di fuori! Il pensiero era alquanto indigesto e Luca fece una smorfia come uno a cui si ripresentano i peperoni mangiati la sera prima... BEEEP! Frenò di colpo pestando sul clacson. “Certa gente nemmeno a piedi dovrebbe camminare...” imprecò tra i denti. Alla fermata successiva salì un ragazzo con indosso una canotta nera da cui spuntavano due braccia ricoperte di tatuaggi: diversi piercing decoravano (si fa per dire) il viso scavato. “E questo a quale categoria appartiene?”. La gente si spostava d’istinto guardandolo con timore misto a ribrezzo ed evitando qualsiasi contatto con il giovane ‘alieno’. “Se la mia piccola un giorno mi portasse a casa un individuo simile come reagirei?” si chiese un po’ angosciato. Gli rispose direttamente lo stomaco con un brontolio sommesso ed ebbe la netta consapevolezza che, da buon padre apprensivo, era condannato ai tormenti della gastrite o dell’ulcera; dipendeva dal numero di piercing e di tatuaggi che avrebbe avuto il suo futuro genero. Sospirò frustrato. “Povera la mia piccola, chi ti difenderà dalle insidie del mondo?”. “La volete finire?” L’attenzione di Luca fu distolta da una frase pronunciata in tono scocciato. Drizzò le antenne. Osservava sempre con attenzione le persone che trasportava, valutando se tra loro potessero esserci rapinatori, maniaci, vandali...in tanti anni ne aveva visti di tutti i colori. Istintivamente guardò in direzione dell’ ‘alieno’ tatuato, ma la voce non proveniva da lì. Spostò lo sguardo sulla destra e vide che di fronte alle due ragazze salite al capolinea se ne stavano due tipi fighetti con il camiciotto a quadri, aperto sulla maglietta, le bermuda di jeans sapientemente sfilacciate e le Converse d’ordinanza ai piedi. Non li aveva notati prima, erano due come tanti. “E dai, quante storie! - diceva quello biondo - Voglio solo sentire se sono vere!”. Così dicendo, il tipo cercava di palpare il seno ad una delle due ragazze che, puntualmente, lo respingeva. “La mia amica ti ha detto di smetterla, mi pare” intervenne infastidita quella con i lunghi capelli biondi. Il socio del molestatore per tutta risposta cominciò a ridere facendo il verso alla ragazza e infilandole la mano sotto la gonna corta. Si sentì uno strillo e il suono di uno schiaffo. Luca concluse che la faccenda stava degenerando. Approfittò della fermata per aprire le porte e uscire dalla sua postazione. “Allora, che succede?” disse avvicinandosi al gruppo. “E tu che c...o vuoi?” fu la risposta del biondo che si girò verso di lui mostrando i denti con aria bellicosa. Luca riconobbe un lupo travestito da fighetto. Cercò di restare calmo: “Sentite ragazzi non mi piace il vostro tono e nemmeno il vostro modo di fare, forse dovreste scend...”. Non riuscì a finire la frase perchè il compare del biondo partì come un toro e gli mollò una testata dritta sul naso. Luca cadde sul sedere portandosi le mani alla faccia. Molti gridarono e diversi scesero dandosela a gambe. Per un breve momento i presenti restarono immobili come in un fermo immagine dopodiché tutti si mossero contemporaneamente. Il biondo avanzò incattivito verso Luca che nel frattempo, pur dolorante, si era rialzato, “lunghicapellibiondi” si sfilò una scarpa tacco 12 con zeppa di legno e la calò sulla nuca dell’aggressore. Il biondo cadde sulle ginocchia mugolando di dolore; il suo socio si avventò sulla ragazza per disarmarla ma, prima che potesse raggiungerla, l’‘alieno’ tatuato l’agguantò e lo spinse fuori dal pullman. Il biondo allora afferrò per i capelli la principessa numero due che, per tutta risposta, gli piantò le unghie finte su una guancia e una ginocchiata tra le gambe. Il colpo gli strappò un guaito e non gli rimase che la fuga. Mentre le due ragazze si rassettavano le gonne, Luca si tastava cauto il naso e pensò, che tutto sommato, la sua Marty se la sarebbe cavata anche senza di lui. 46 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il primo viaggio CRISTINA SARACANO Sento che ci siamo... il mio viaggio acquatico volge al termine, sto per arrivare al capolinea... In effetti qui si sta molto bene, al riparo da tutto e da tutti, la mia mamma è premurosa, si muove con dolcezza come solo lei sa fare: è attenta, riesco a non sentire colpi o strattoni improvvisi, mi porta ovunque ma con la dovuta cura. E poi si nutre proprio bene la mia mamma: ciò che ricevo attraverso questo “tubicino” mi ha fatto crescere tanto, anche per questo adesso è giunto il momento di uscire fuori, questo spazio inizia a starmi un po’ stretto, e laggiù da voi c’è la vita... E’ tutta una fatica, sapete, io nuoto velocemente (a me sembra) mi faccio coraggio, spingo questa mia testolina giù, sempre di più, ma ancora non trovo la via d’ uscita. La mia mamma, lo sento, mi sta aiutando, spinge anche lei, proprio quando glielo dico io, chissà com’ è impegnata, come si agita e s’ affanna... Quotidianamente bisogna lottare con: le inquietudini le forti emozioni, le incertezze, la ricerca di risorse sempre nuove per rimanere a galla o riaffiorare se si è caduti in acqua, come sono io adesso da circa nove mesi... Adesso basta, un po’ d’ attenzione, altrimenti la faccenda diventa davvero complicata, ecco, la mia testa scende ancora, sono più avanti, c’è una strana atmosfera, è diverso, tutto differente rispetto a prima. Sento delle voci, tante voci, i miei occhi ancora non reagiscono, ma capisco che l’ acqua, la mia prima abitazione, me la sono lasciata alle spalle, ho raggiunto quel capolinea di cui parlavo prima: stanchezza e felicità sono tutto ciò che provo. E mia mamma? Mi stanno staccando da lei, tagliano il “tubicino“, si chiama cordone ombelicale, ma non è una separazione vera e propria perché lei sarà sempre presente quando ne avrò bisogno. E adesso? Mi stanno lavando, è incredibile, ho passato nove mesi in acqua e mi lavano... Che atmosfera... la Terra, ci sono altre persone, c’ è un signore che mi abbraccia con tanta dolcezza, sento le sue mani sulla mia testolina umida e delicata... è il mio papà, afferra uno strano “attrezzo” , lo tiene con entrambe le mani, appoggiato ad una spalla puntato verso di me: questa “cosa” si chiama videocamera, non lo so ancora ma successivamente me lo spiegheranno, mi faranno vedere com’ ero e com’ erano mamma e papà, tanto più eccitati di me sicuramente. Io sono qui ma non mi oriento ancora: un dottore tocca il mio corpicino, un’ infermiera parla con i miei genitori... mi viene paura, che cosa mi succederà? E se il viaggio finisse qui? Dove mi porteranno? Il mio pancino brontola, mi sento sempre peggio, inizio a piangere, sempre di più, sto strillando! Ora mi sgrideranno e mi cacceranno via, non saprò dove andare, da che parte incominciare questa nuova avventura! No, no mi rimproverano, sono felici, io piango e loro gioiscono... E’ proprio strano questo mondo dove sono capitato! E se non ce la facessi, voglio dire, se non avessi abbastanza capacità per affrontare la vita... Prima era tutto “liscio” come l’ acqua e tutto “comodo” ed io ero un ospite nel grembo materno, ora, sono solo... Dovrò imparare a parlare, camminare, sorridere, mangiare, correre, vestirmi; dovrò studiare, lavorare, essere gentile, paziente, forte, gestire una famiglia. Mi innamorerò, sarò felice e talvolta deluso, sarò la gioia dei miei familiari, li colmerò d’orgoglio, ma darò loro anche qualche preoccupazione. Mi sento carico di coraggio e di ottimismo. Il vero viaggio parte da qui per tutti noi: uomini o donne, neri o bianchi, ricchi o poveri, incomincia allo stesso modo nudi, spaventati, infreddoliti, affamati, stanchi... in un attrezzato ospedale, in una misera casa, in un paese civile, o durante le mostruosità di una guerra,siamo tutti uguali. Il nostro impegno contornato dalla buona volontà, da tanto amore e un pizzico di fortuna, renderanno questo passaggio unico. Dopo ogni rigido inverno arriverà una variopinta primavera e dietro ogni tortuosa curva ci sarà un posto ignoto ancora da scoprire... I Racconti Dei Giovani Premiati 47 Viaggio temporale: dal futuro alla genesi PIETRO PAOLO SCHERMA Nel 21 dicembre 2012, secondo una profezia maya, la vita sulla terra era destinata a scomparire. In quello stesso anno, nello stesso giorno, nacqui io. Mi chiamo Adamo, figlio di Giovanni e di Claudio e di una madre che non conosco e che non conoscerò mai. Lei mi ha portato per nove mesi in grembo ed alla nascita fui ridato ai miei genitori. Non mi ricordo molto dell’infanzia; mio padre lavorava sempre, l’altro mi crebbe e mi educò. La mia vita si trasformò quando all’età di 6 anni, cominciai a frequentare la scuola elementare. L’impatto con i compagni e con le maestre fu traumatico in quanto tutti ritenevano la mia famiglia uno scandalo ed ogni giorno mi deridevano, mi emarginavano, mi offendevano. Cominciai allora ad odiare tutto e tutti: la mia famiglia, i miei compagni, la mia vita stessa. Odiavo il giorno ed il pensiero di andare a scuola, amavo la sera dove con il buio anche le vergogne si celavano. Mio padre mi ricopriva di regali, l’altro mi stava vicino ma io li odiavo entrambi... incominciai a non parlare più ed ad estraniarmi dalla società così da non avere nessun amico. A venti anni avevo già girato tutto il mondo. Dalla Cina all’Alaska camminando verso occidente. Viaggiavo solo, con ogni mezzo. Arrivato in una città mi stabilivo per un giorno, dormivo sotto un ponte ed al mattino ripartivo. Per 4 anni feci solo questo. Niente e nessuno mi teneva bloccato in un paese. Mi attiravano le luci come quelle del Barri Gòtic, i colori del Prenzlauer Berg e l’allegria della notte di Lloret de Mar. Mi faceva paura invece il silenzio dell’alba quando l’uomo si sveglia e comincia a fare del male e comincia a giudicare. Ecco fuggivo dall’alba che ogni giorno mi perseguitava, fino a quando... Il 21 dicembre 2012 nacqui io. Mi chiamo Eva e sono figlia di un alcolizzato e di una drogata. Cosa poteva capitarmi di più? Scappai da casa a 16 anni per evitare le bastonate di mio padre e non sapendo dove andare cominciai a girovagare. Non avevo amici, nè fratelli nè sorelle. Solo io sapevo difendermi e lo facevo con anima e corpo. Nonostante tutto ero molto paurosa. Di notte mi nascondevo per paura di essere aggredita e di giorno viaggiavo, cambiavo città, ogni giorno. Per quattro anni feci solo questo. Viaggiavo senza meta. Dall’Alaska alla Cina camminando verso l’oriente. Di giorno mi godevo il paesaggio e la tranquillità del viaggio, per esempio ammiravo la potenza delle cascate del Niagara, il silenzio del Canyon e la bellezza dei Kew Gardens inglesi. La mia serenità spariva alle prime ombre della sera quando l’oscurità mi rendeva vulnerabile agli altri. Fino a quando... ...inevitabilmente due corpi opposti se posti vicino si attraggono... Io sono Eva e lui è Adamo, figli del peccato. Ci siamo incontrati una sera a Tromso (la città più settentrionale della Norvegia). Il paese contava poco più di 50000 abitanti. Il viaggio da Parigi era stato stancante. Il pullmann mi aveva lasciato nei pressi del comune ed io mi allontanai subito dal centro per cercare un posto un pò più nascosto. Mi recai verso la costa dove era iniziato da poco il tramonto. Così accellerai il passo ma ancora ero lontano dal mare. Cominciai a correre ma stava succedendo una cosa strana: nonostante il tempo passava, il sole stava fermo sempre lì, vicino all’orizzonte, mi fissava immobile. Non capivo perchè la notte non era ancora sopraggiunta e più rimanevo stupita e più quella la luce mi dava sicurezza. Pensando al miracolo continuavo a correre verso la spiaggia. Quando arrivai lì notai una grotta nascosta da un alto scoglio. Il mare era calmo, l’aria pungente, il cielo di un arancio dorato. Mi arrampicai per superare lo scoglio mentre la luce di quel sole che non tramontava mai guidava i miei passi e, dopo un balzo, arrivai davanti alla grotta e .... aaaahhh!! Un grido di spavento per la vista improvvisa di un ragazzo mi fece cadere in mare mentre il ragazzo urlava ancora di paura. Poi, dopo un attimo di smarrimento, il giovane si buttò a mare e mi portò a riva. Quattro occhi imbarazzati raccontarono le rispettive storie meglio delle parole ed in silenzio fissammo il sole che stava ancora lì e dava sicurezza ad entrambi. Finalmente Adamo ed Eva erano soli nel mondo, nel loro mondo. In quell’istante si sentirono veramente amati. Nel paradiso terrestre, a nord del mondo e di fronte alla cattiveria umana, non ebbero più paura ed alzando la testa si godettero quel lungo eterno tramonto della vita. Un attimo dopo, l’uomo, gli uccelli, il sole, le piante, il cielo, il mare ed il mondo, sparirono. 48 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il regalo ISABELLA SERAFINI Era una mattina piovosa, la pioggia era sottile e leggera, così uniforme che sembrava quasi non piovesse e il paesaggio era ammantato da una luce traslucida, biancastra. Puntinato da minuscole pagliuzze come quelle contenute nei gloss che illuminano le labbra. Era il giorno del suo compleanno, un giorno di riposo dal lavoro. Doveva organizzare cose... Ma si era crogiolata a letto un po’ più lungo a di quanto avesse programmato. Il risveglio della natura in quel preciso momento dell’anno aveva qualcosa di magico, come la trasformazione di un film dal bianco e nero al colore. Ogni ramo, siepe, aiuola non era più la stessa. Era un tripudio di colori e profumi che spazzava il puzzo di smog , almeno per un po’, davano l’impressione che fosse tutto nuovo, anche l’aria. Chiara si stiracchiò nel letto e poi di scatto sollevò la coperta, si infilò le pantofole poi incollò il naso alla finestra e guardò ancora fuori, assorta, lo sguardo giungeva oltre. Andò in bagno. In piedi di fronte allo specchio, accese la luce. La luce più inclemente che ci sia, verticale, diretta metteva in risalto ogni difetto. Si guardò, ora, scrutandosi, i lineamenti erano ancora belli, delicati. Il viso ovale era incorniciato da biondi capelli qua e la un po’ mossi con qualche filo bianco, il naso all’insù lo avrebbe voluto più corto, la bocca era a cuore, non carnosa, neanche sottile, fece un po’ di smorfie. Bolle di sapone, baci , urlo senza suono. Gli occhi erano il suo punto di forza... Quaranta anni, sono tanti pensò, tutti le facevano complimenti dicendole che era giovanile che dimostrava meno della sua età. Banalmente pensò, che in effetti non li sentiva i suoi quaranta anni. Subito dopo, chiese a voce alta allo specchio. “Cosa vuol dire non sentire quaranta anni? Era ora di darsi una mossa, un caffè forte e una fetta di crostata l’avrebbe resa efficiente come ogni giorno, come succedeva ormai da anni. Adorava il momento della colazione, ancora di più se le capitava di essere sola. L’odore di caffè nelle narici e sulle labbra, il dolce fatto in casa, il notiziario, a volte l’oroscopo... Le endorfine erano in circolo, si muoveva veloce ed efficiente nel sistemare ogni cosa, la casa era pulita ma in disordine come ogni giorno e oggi tutto doveva tornare al suo posto. In più doveva creare un’ atmosfera particolarmente accogliente. La sera sarebbero arrivati ospiti, per la sua festa. Cominciò dalla camera da letto, cambiò le lenzuola e mentre passava per riporre la biancheria sporca nel cesto, guardò la foto sopra la poltroncina chippendale. Si fermò con le braccia piene di lenzuola. Era raffigurato suo marito e il loro figlio più piccolo quando era ancora un bebè. La foto era molto bella, la luce sembrava solare anche se era una foto fatta in studio. Il bel viso abbronzato di lui si stagliava sullo sfondo e creava un bell’ effetto di chiaroscuro con la pelle del bambino che teneva in braccio. Il viso del bimbo con ombre di velluto era colorato da due occhi blu oltremare. Lui era uscito presto di casa quella mattina, gli aveva dato un leggero bacio sulle labbra e le aveva fatto gli auguri di buon compleanno sottolineando che era più vecchia di un anno, che lui al suo posto non avrebbe festeggiato. Lo stava dicendo ridendo, pensò Chiara, lui la prendeva sempre in giro, ironizzava, a volte era offensivo, denigratorio. Riflettè su questo pensiero e di come lei se la prendeva ogni volta. Ci soffriva. Possibile che lui non se ne rendesse conto, non cercasse di evitare di ferirla. Comunque oggi era il suo compleanno e non voleva avere pensieri negativi. Cominciò a fantasticare su cosa le avrebbe regalato. Sicuramente qualcosa di particolare, magari un gioiello. No, troppo scontato, anche se, è risaputo “i diamanti sono i migliori amici di una ragazza”. Forse un dipinto, si lei li adorava e lui non le aveva mai fatto un regalo così. Troppo, pensò anche se quaranta anni vengono una sola volta. Troppo pensò ancora, non riferendosi al denaro ma al tempo che lui avrebbe dovuto passare ad informarsi, scegliere, contrattare. Sperava solo che non avesse pensato a qualcosa di banale che si regala sempre, come una borsa, un vestito, un paio di scarpe. Ora che ci pensava erano sempre questi i regali ricevuti da lui e su indicazione di lei. Questa volta però non le aveva detto nulla nemmeno un accenno, questo era un buon segno, finalmente una sorpresa, qualcosa pensato per farla felice, per vedere accendere negli occhi la scintilla dell’amore per qualcosa che si riceve dall’amore. Toccò con il dito indice tutti i contorni del viso, nella foto, poi gli occhi ed infine la bocca. Pensò che la sera anche tardi, anche stanca, magari un po’ su di giri dall’alcol avrebbero fatto l’amore. Con tutta la passione e il trasporto di cui era capace. Passò la giornata, piena di cose da fare, aprì cinque volte la porta al fattorino che consegnò mazzi di fiori. Erano tutti molto belli, diversi, rispecchiavano le persone che li avevano mandati... Uno senza biglietto. Si ricordò di quando era molto giovane e uno spasimante volle mandarle fiori senza avere il coraggio di mettere il suo nome. Non era certo questo il caso. Pensò che potevano essere di suo marito che stava mettendo in atto il piano regalo, sorpresa. Certo non era da lui. Non le aveva mai regalato fiori. Mentre era assorta in questi pensieri il campanello suonò ancora. Andò al citofono. Era suo marito che le diceva di scendere nel cortile. Lei disse che aveva indosso il grembiule... Lui insistette, si sentiva nella sua voce una vena di euforia. Va bene, scendo. Lui era in piedi appoggiato alla parte interna del cancello che dava sulla strada. Chiara le andò incontro con un sorriso. Ti devo dire una cosa disse lui. Forse ho fatto una pazzia. Ti ricordi che negli ultimi tempi siamo andati spesso la domenica a vedere le automobili, così tanto per vedere le novità? Si, disse Chiara un po’ confusa, anche se non ci serve e non ci possiamo permettere un’automobile oltre alle due che abbiamo. Eravamo d’accordo. Si eravamo d’accordo disse lui, ma io l’ho comprata. E’ una Porche nera fiammante, è bellissima, vieni a vederla è proprio qui fuori. Lei uscì che le fluttuava la testa. La vide. Era bella, costosa, inutile. Ti sei fatto questo regalo, insomma, disse lei, il mio dov’è? Sono completamente ripulito, disse lui, sai l’anticipo. Anzi amorino ti devo dire una cosa. Ho messo la tua firma a garanzia, tanto non ci sono problemi, le disse lui sollevandola da terra mentre la baciava. I Racconti Dei Giovani Premiati 49 Principio e fine MASSIMO TASSISTRO “E’ buio qua, tanto buio. Mi sento un po’ stretto in questo luogo nero, devo stare rannicchiato, non posso distendermi. Forse non riuscirei nemmeno ad allungarmi. E’ strano, però, è tutto così buio, scuro, però mi sento bene, mi sento protetto. Non ho paura. Provo una sensazione di pace, tranquillità. Mi devo essere appisolato. Cos’è che mi ha svegliato? Sento un liquido fluire in me. Sembra rigenerante. Sì, mi sento meglio, in effetti prima ero un po’ stanco, ora invece sto bene. Mi sento sazio.” Non riesco ad aprire gli occhi. Non ho la forza di svegliarmi. Perché sono così stanco? Che cosa mi sta succedendo? «Nonno, nonno svegliati!» «Marco non urlare, non si può gridare in questo posto. Il nonno sta dormendo, lascialo riposare» «Ma mamma, perché non si sveglia?» «Davide, ho già detto a Marco che il nonno sta riposando» Sono tutti intorno a me e io non posso salutarli. Perché? Non ricordo nulla. Ieri stavo così bene, ero a pranzo da loro, Lucia aveva fatto i soliti cannelloni e nel pomeriggio eravamo andati al parco tutti insieme, poi...buio completo. Lo stesso buio che ora mi circonda, mi attanaglia. Ho paura. Non ho mai avuto paura in vita mia, ma questo buio mi terrorizza. Vorrei poter rivedere un po’ di luce. Chissà se la potrò rivedere? “Oddio cosa sono questi scossoni? Mi sembra di essere su una giostra. Sento uno strano ronzio. Ho come la sensazione che qualcuno mi stia osservando. Avverto come un occhio puntato su di me. Eppure è tutto buio intorno. Ahia! Così mi schiacciate, Ehi! Un po’ di delicatezza per favore, io sono debole. Ma cos’è tutto questo movimento? Ancora questo ronzio. Abbiamo finito? È stato terribile, spero di non provarlo mai più” «Guarda mamma, il nonno si è mosso, forse sta per svegliarsi» «Marco stai indietro, lascialo respirare. Ecco c’è un dottore. State fermi qua, arrivo subito» Lucia si allontana. Parlava di un dottore. Allora sono in ospedale. Ecco cos’è questo buio, sono ricoverato e sono... oddio... non voglio pensarci... che sia proprio...? E’ come se stessi dormendo e invece sento le voci di chi mi sta attorno. E’ forse questo il coma? No, non è possibile, non posso essere in coma. Per quale motivo? Stavo così bene, non avevo problemi. Anche se ho quasi novant’anni, mi sento ancora giovane, voglio passare ancora tanto tempo coi miei nipotini e mia figlia. Signore ti prego, aiutami, fammi vivere ancora. Non voglio morire. “Cavolo, sembro più grosso! Mi sento più forte. Sarà questo liquido rigenerante che, puntuale ogni ora, scende da questo tubicino. Vorrei toccarlo, ma non ci riesco. Non posso muovermi bene. Sono appena riuscito a guardarmi le due sporgenze lunghe in basso che non so a cosa servono, con quelle piccole protuberanze che ho provato a muovere. Subito non è successo nulla, ma poi ho capito che concentrandomi potevo comandarle. E’ sempre buio, ma sono contento. Ho avvertito altri scossoni, ma non mi fanno più male, anzi rispondo spingendo contro la parete: spingo, spingo, spingo, ah ah, mi diverto!” Ora non sento più nulla, o quasi. Le voci di Lucia e dei miei nipotini mi giungono ancora da più lontano. Mi sembra di udire un pianto. Marco? Davide? Lucia? Perché piangete? Forse perché sto morendo? E’ questo? Sto morendo? Oddio, perché, PERCHE’? Anita! Sei tu che mi stai chiamando? Vuoi che venga da te? Ti senti sola? Anch’io sento la tua mancanza, ma voglio stare ancora con mia figlia, ti prego. Poi ti raggiungo, lo prometto. “Ecco, ora devo girarmi. Sì, adesso cambio posizione. Un attimo, una bella spinta, forza. Non posso più stare messo così, sono troppo grosso, devo assolutamente spostarmi, ma quanto è difficile. Cos’è quel cosino piccolo che intravedo sotto il tubicino spara-fluido? A che mi servirà? Sono pieno di sporgenze, dovranno pur essere utilizzate per qualcosa. Ehi, un attimo che mi sto voltando. Accidenti a questo dannato tubo che mi dà un fastidio tremendo. Possibile che non si possa staccare? Adesso me lo stacco. Mi sta girando attorno al collo, che vuole? Sta lontano! Devo cercare di capovolgermi” «Nonno! Nonno! Mamma, ma il nonno sta morendo? Perché piangi? Significa che il nonno sta morendo, allora è vero? No! Nonno!» Sento un lontano brusio e sono stanco, tanto stanco. Devo dormire, sì forse è meglio che dorma un po’, così poi mi sveglierò e potrò rivedere i miei nipotini e la mia cara Lucia. E se non mi svegliassi più? Anita? Mi stai chiamando? Vedo una luce, evviva! Che bello, mi sto svegliando? Anita? Ma sei tu davvero? Certo che voglio venire da te, sì lo voglio! Cosa? Devo lasciare il posto a un nuovo bambino? Davvero? Per ogni bambino che nasce, bisogna che un anziano lasci la Terra? E tocca proprio a me? Allora d’accordo, non posso sottrarmi al mio dovere, se così è scritto. Mando un ultimo saluto ai miei cari, senza piangere, però, te lo prometto. Ciao Lucia, ciao Marco, ciao Davide, vi amo. Certo Anita, amo anche te e ora sono pronto. Guidami in questo viaggio. E come si chiamerà questo bambino? Diego? Bel nome. Bene, Diego, che Dio ti benedica. Non piango, però, lo prometto. “Ora si che sto meglio, in questa posizione. Ma che succede? Cos’è questo chiarore? Mi fanno male gli occhi, li devo chiudere. Chi mi spinge da dietro, verso la luce? Aiuto! Forse è lì che devo andare, per muovermi... vedere... vivere...? 50 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Il viaggio dei cavalieri ANNA TRAVERSA Don Carlo , parroco di Altavilla , amava alla sera fare un giro nella sua chiesa immersa nel silenzio , prima di andare a cena. Anche quella sera di fine novembre stava facendo il suo giro quando si accorse che nella navata centrale erano spariti il bassorilievo con i cavalieri che componevano la scena della battaglia di Vignale, avvenuta nel 1248 , dove i cavalieri di Altavilla guidati dal conte Bellone avevano sconfitto i Saraceni. Sconvolto don Carlo chiamò l’amico Guerrino e l’avvisò del futuro. Guerrino prese immediatamente la vecchia 500 e fatto salire il prete prese la strada che portava verso i boschi di Casazze. Arrivati ad un radura lasciarono la 500 e Guerrino disse a don Carlo di seguirlo per un piccolo sentiero . Ad un tratto un rumore sordo di passi li convinse a nascondersi e dopo qualche minuto videro passare i guerrieri di pietra del bassorilievo che marciavano composti in fila indiana . Don Carlo e Guerrino non potevano credere ai loro occhi: i guerrieri ordinati e in dila andavano sicuri verso un luogo prestabilito. Nello stesso tempo due ragazzi , Raimondo e Antonella , a bordo di un fuoristrada tornavano da una sagra svolta nel paese vicino . Videro la cinquecento vuota e incoriusciti scesero e imboccarono il sentiero nel bosco. Nascosti tra i cespugli Don Carlo e Guerrino fermarono i ragazzi poi tutti e quattro ripreso il viaggio nel bosco al seguito dei cavalieri . Arrivarono in uno spiazzo enorme dove i guerrieri stavano ascoltando un nobile : il conte Bellone. “Miei prodi siamo arrivati qui dopo aver viaggiato per strade e boschi , perchè questo è il luogo dove noi sconfiggendo i Saraceni , salvammo ‘Altacittà’. Ora un nuovo pericolo minaccia il nostro paese: questo luogo diventerà un luogo dove portare i rifiuti dei paesi vicini. Se nessuno interverrà dovremo di nuovo muovermi noi per salvare i nostri paese. “ Mentre il conte parlava Antonella si mosse e toccò un rospo che stava tra le foglie: l’urlo della ragazza attirò l’attenzione dei guerrieri; immediatamenti i quattro scapparono, raggiunsero l’auto e rifecero il viaggio al contrario sino ad arrivare nella piazza del paese. Raimondo disse : “Andiamo dai carabinieri a fare denuncia “. Ma don Carlo rispose che sarebbero stati presi per dei pazzi o peggio. Don carlo si svegliò al mattino presto e pensò di essersi sognato tutto,ma arrivato davanti alla chiesa trovò un Guerrino e allora il dubbio svanì. “Andiamo a costruire il Comitato Antidiscarica” disse Guerrino, poi andrai a dire Messa. La malinconia delle cose EMANUELA VERDONE “Narrami, o Musa, dell'eroe multiforme, che tanto vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia” All’inizio c’è solo quel gruppo di fogli. Un quinterno. Li ho raccolti quasi furtivamente, come se rubassi qualcosa. Prima esisteva un paese con le sue voci che si rincorrevano. Ora si fa fatica a camminare senza trattenere il respiro. Ebbene sì, sappiate che in questo luogo non ci sarà più storia, sembra suggerirmi qualcuno da una finestra diroccata che ancora resiste. Serviva per nascondere la vita privata che si svolgeva al suo interno, adesso è come un quadro, contorna i resti di un prima. Ho proseguito oltre i limiti delle transenne, non c’era nessuno a bloccarmi. Non c’è più nessuno. Sono tutti all’inizio del paese, in una gabbia. No, è un recinto. A destra il primo campo, a sinistra l’altro. Non fanno nulla di preciso. Aspettano. Aspettano che succeda qualcosa, che vengano ricostruite le case, che il telegiornale della tv da campo lì aggiorni – ma ormai che importa. Aspettano che venga l’ora della cena e che dalla tenda della protezione civile arrivi odore di cibo. Quel profumo che mi ricorda i pranzi all’asilo. Non invitante, solo rassicurante. Eppure è metà agosto, solo un anno fa quelle stesse persone erano in vacanza, magari al mare, a succhiare fino in fondo la vita. Ora il tempo non ha più molta importanza, si è cristallizzato tra le macerie. Io sono un’aliena. Per me l’orologio ha una direzione. Sono arrivata in macchina, un’ora fa ero in una casa solida. Tra un’ora avrò davanti una cena vera, da consumare nell’intimità di un gruppo familiare. Ci siamo fermati per vedere. E’ un cammino faticoso, perché siamo timorosi di violare qualcosa. Solo noi, e case diroccate. Tra le macerie sono mescolati cenni di vita precedente. E’ la banalità di questi oggetti a attorcigliare lo stomaco. Il silenzio è orribile. Non è possibile sopravvivere a lungo tenendosi stretta quest’angoscia, la paura di respirare troppo forte. Che ci faccio? Ho tanto deriso quelli del turismo macabro, che avevano approfittato della pausa del primo maggio e del 2 giugno per andare a dare un’occhiatina, perché le immagini in tv non bastavano più; ecco che anch’io sono arrivata fin qui. In realtà non era mia intenzione, ho seguito una delle deviazioni obbligate che dal Gran Sasso mi riconduce verso I Racconti Dei Giovani Autori 51 l’ingresso dell’autostrada, là dove prima c’era L’Aquila. Le cime ci sono sempre, solide e arcigne. Dicevo, ci sono i fogli. Un’edizione di lusso, di quelle da piazzare in prima fila, con la copertina in pelle ed i caratteri eleganti. Com’è epica la vita. Una buona lettura ti tiene compagnia in ogni occasione. I fogli sono ondulati dall’acqua, ricoperti di terra, ingialliti. Ma restano. Ancora non so spiegarmi il brivido che mi raggiunge quando li raccolgo. Non è la retorica per cui ci sono delle cose immortali, che rimangono nonostante tutto. Non è nemmeno quel barlume di vita che mi consegnano. Probabilmente è l’ironia, che mi schiaffeggia. L’immagine di letture serali al lume di una lampada. Uno studente che ha voglia di pensare ad altro che alla guerra di eroi improbabili. Mani che sfogliano, mani che si fermano su una parola, mani profane che piegano un lembo – domani si ricomincia da qui-, mani che intanto rincorrono i pensieri del giorno attorno ad un ricciolo di capelli. Che fine hanno fatto quelle mani, ora? Poniamo l’ipotesi migliore, che siano a pochi metri da qui, nel campo in cui si attende la cena davanti allo schermo della tv. Non è stata la transenna ad impedirgli di andare a recuperare quei fogli prima che la pioggia ed il sole in questi quattro mesi facessero il loro lavoro. E’ che la vita non è più tanto mitica, vista dalla prospettiva di un corridoio di una tenda da campo. Sempre troppo caldo, o troppo freddo. La fila per una doccia, i litigi furibondi per le piccole cose perché lo spazio condiviso è troppo angusto ed il tempo assieme troppo dilatato, il pudore messo a tacere davanti ad uno scatolone di abiti appartenuti ad altri da spartirsi. Si dice che vivere intensamente l’attimo presente sia il primo principio del benessere psicofisico. Qui non si fa altro, la realtà è fatta di tanti attimi presenti a perdere, uno a fianco dell’altro, senza la prospettiva di una settimana, o della sveglia che annuncia il lavoro, la mattina dopo. Ci si tiene in vita secondo i tempi del campo, poi si viene messi a letto, senza capricci. Eccomi seduta al computer, li ascolto. Sono mani giovani, quelle che vi accarezzavano, non è vero? Non le mani di una secchiona che vi avrebbero riempito di sottolineature e note minuziose. Erano le mani di un’adolescente curiosa, a cui era rimasto un tarlo, durante la sua lezione di liceo. Tra le righe si era messa alla ricerca di un uomo affascinante che aveva viaggiato a lungo, spinto dalla curiosità e dall’imprevisto. Ne aveva passate tante, come in ogni buon libro di avventura. Perché lui ce l’aveva una meta, però gli piaceva assecondare il destino e ritardare l’happy end ancora un po’. Le mani giovani una sera avevano preso il volume del padre, sullo scaffale alto del salotto. Il volume era forte, rilegato come quelli antichi, e frusciava sotto le dita. Esattamente il primo aprile, un po’ per scherzo, un po’ per curiosità. Ma poi questa curiosità si era trasformata in interesse, e persino in passione. Lui non era solo un personaggio polveroso da professoressa pedante. Era in sua compagnia, alle 3 di notte. Stranamente la madre non era passata in camera, a dirle di spegnere la luce. Stranamente quella sera la madre si era addormentata. Lei, invece, aveva avuto un presentimento, qualche minuto prima. L’abbaiare insistente dei cani, una sensazione nello stomaco. Ma forse era il compito di chimica del giorno dopo. Poi c’era stato il boato della terra, l’esplosione dei muri, la danza macabra dei pavimenti, l’inciampare nel buio. La ricerca delle scale dove prima erano le scale. Cadere la prima volta, rialzarsi trai calcinacci, il corridoio a carponi tra detriti di quadri piatti vestiti, il ginocchio che pulsa e le stelle nella testa. Urla senza volto. Era lei che urlava? Il suo grido si era amalgamato a molti altri. Lamenti e costernazione. La ricerca di un abbraccio in cui accasciarsi. Quando era tornata la luce, il suo paese non esisteva più. Vorrei parlare alla ragazza al di là della rete. E’ una bella ragazza, coi capelli in una coda ed il profilo fiero, appoggiata negligente su una panca. Maglietta e jeans corti. Guarda la tv da campo, come altri, nessun commento. E’ di spalle e nemmeno si accorge della mia presenza. Vorrei parlare proprio a lei, perché me la immagino che camminava rapida verso il suo liceo, qualche giorno prima di quel 6 aprile, e faceva la contestatrice caparbia nell’assemblea di istituto, ma poi tornava a casa e raccontava a sua madre tutto quello che si era detto, e ci scherzava sopra; ed il sabato pomeriggio è il giorno del passeggio in città, a L’Aquila, e quella stessa madre contrattava scherzosamente l’ora del ritorno, ma poi ripartendo sulla sua Punto era felice di vederla allontanarsi così viva, che rideva forte con le compagne. Adesso la ragazza con la coda si alza dalla panca e si muove svogliatamente verso la tenda centrale, è ora di cena. Niente assemblee di istituto, ne’ passeggiate ai Quattro Cantoni. Niente stelle cadenti d’agosto a cui affidare un sogno. L’evento è stato un G8 di cui si è tanto parlato, come l’eco di un valzer in lontananza a cui nessuno l’ha invitata. Cenerentola senza fatina che arriva all’ultimo momento per condurla alla festa. Nei prossimi mesi non conosce quale sarà la sua abitazione, dove verrà trasferita la sua famiglia, probabilmente in un angolo della provincia, in un agglomerato di case anonime abitate da reciproci sconosciuti. Molti suoi compagni del liceo non li sente da mesi, sono in albergo da qualche parte, turisti involontari della costa senza biglietto di ritorno. Se guarda al di là della rete c’è un buco nero al posto delle luci che prima le testimoniavano l’esistenza di una città festosa e viva a un paio di chilometri, la città di cui si sentiva parte. La ragazza non crede nemmeno che qualcuno le ridarà la sua piazza Palazzo di adolescente, luogo di intrighi occhiate e possibilità. No, stavolta non sarà come tornare a scuola alla fine delle vacanze, e trovarsi cresciuti di un palmo e con una nuova pettinatura. E’ questo attimo presente interminabile che la turba, e la sfianca. Vorrei dirle: d’accordo, anche nei poemi epici capita di inciampare, e non importa in fondo se Ulisse sia coraggioso, onesto, coerente di fronte al destino dispettoso. Non importa. Quel che conta è che l’eroe conserva la curiosità fino all’ultima pagina, quando torna a Itaca. E va bene comunque se per arrivare impiega un mese, o un anno. Ricordati, alla fine si torna sempre a casa. 52 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Otto e dieci SILVIA VINDITTI Otto e dieci, tardi da morire. Fino alla stazione sono pochi chilometri che sembrano non finire mai. Poi è giovedì, giorno di mercato. Fulvia si figura il percorso a mente: imboccherà il lungomare a piedi, poi la deviazione all’altezza del ponte e la svolta verso la stazione. Tutto di corsa, tutto di fretta. “Dove vai a quest’ora?” le domanda la nonna prima di uscire mentre Fulvia cerca di infilarsi il giubbino dalla manica sbagliata. “A lavoro, nonna” - risponde Fulvia, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì vado a prendere l’autobus”. “Non puoi prendere l’autobus di tuo zio?”- le chiede ancora la nonna. Ma lo zio non ha nessun autobus, è la nonna che perde qualche colpo. È strano come lei invecchi in un presente che non diventa mai passato. Ogni giorno ricomincia come fosse nuovo, ogni giorno è il primo di lavoro della nipote, perché quando Emilia la sera chiude gli occhi, il suo cervello si riazzera. In questo oggi sempiterno, Emilia non si annoia. Controlla il traffico dei passanti dal balcone, bisticcia con la badante anche se pensa che ne siano almeno un paio, perché quando ne parla nomina sempre “le ragazze”, chiama le amiche al telefono, si fa accompagnare a messa. L’aspetto particolare della vita di Emilia è che anche “ieri” non si è mai concluso. Entrano nel passato soggetti mai esistiti, accadano fatti mai vissuti ma così chiari nella sua mente che si stupisce quasi che tu non possa ricordarli. Poi per un attimo ti guarda fisso negli occhi ma si vede che è oltre, sbatte le ciglia e, facendo finta di niente, ripiomba sulla giusta data del calendario, quasi costretta tra la lancetta dell’ora e quella dei minuti. Fulvia sta guardando il quadrante: è ossessionata dal ritardo. È una di quelle persone che, per un motivo o per un altro, dovrai sempre aspettare e molti se ne stancano. Ma qualcosa in fondo ti dice che ad aspettarla farai bene. Anche il conducente dell’auto che la lascerà nei pressi dell’ufficio ha avuto la stessa sensazione la prima volta che l’ha vista nello specchietto laterale. Aveva notato che nel momento esatto in cui avesse ingranato la marcia per ripartire verso la prossima fermata, ecco che l’avrebbe vista spuntare: una testa di ricci rossi smanacciante nel tentativo di fermare la corsa. All’inizio Fulvia era solo una piccola sagoma riflessa che si dimenava in modo buffo e, Antonio ne era certo, qualche volta doveva avergliene dette di tutti i colori. Poi incuriosito, Antonio aveva deciso di andare incontro a questa sconosciuta in ritardo cronico: prima di arrivare alla solita pensilina iniziava un impercettibile ma costante rallentamento, questione di secondi, una variazione insignificante per i passeggeri ma importante per Fulvia che con il respiro affannato, ora riesce sempre a saltare sul bus. Saluta con un filo di voce e un grande sorriso. Ancora sorridente, va ad occupare il solito posto. Qualche volta l’ha seguita con lo sguardo, a corsa terminata: spalle piccole e andatura a zig zag. Così piccola che il vento di oggi sembra possa spazzarla via. E infatti Fulvia sparisce subito dietro l’angolo, ma rimane negli occhi di Antonio che la osserva. Sempre di riflesso. Antonio e Fulvia fanno il percorso insieme già da un anno, un tempo straordinariamente lungo se si pensa che Fulvia deve fare i conti con la visione del tempo della nonna. Antonio ha imparato ad aspettare Fulvia senza averle fatto capire che l’attende. Ha visto che ha gli occhi verdi, è riuscito a scambiarci qualche parola in più di un’occasione e ha notato che quando si imbarazza, passa una mano tra i capelli. Grazie a questo gesto ha intravisto un orecchino argentato che lo riporta indietro a tanti anni prima. Per Pasqua aveva aperto un uovo di cioccolato ma la sorpresa l’aveva deluso. “Che ci faccio con un regalo da femmina?” - aveva chiesto alla mamma facendo penzolare l’orecchino tra due dita come se avesse in mano la coda di un topo. “Lo puoi regalare”. Così il piccolo Antonio aveva passato in rassegna tutte le sue compagne di classe ma nessuna sembrava meritare il prezioso monile. Solo una ragazzina più grande, una di terza media. A lei l’avrebbe ceduto con una bella lettera, anche se quella passava sempre dritto senza filarlo. La consegna del regalo non andò proprio come si aspettava. Clara, così si chiamava l’alunna di terza, lo ringraziò frettolosamente sbagliando il suo nome, mentre alle sue spalle le amichette sghignazzavano dandosi spintoni col gomito. Uscirono insieme solo una volta, la storia non andò oltre la via di casa di lei, dove Clara gli confessò di preferire gli orecchini al suo amore. “Forse - penso tra sé e sé Antonio - avrei dovuto aspettare, scegliere meglio, cercare di più. Non era lei quella con cui andare lontano”. Con Fulvia davanti gli pareva di aver atteso abbastanza. “La porterò al mare, - immaginava a pochi passi da lei - la porterò ovunque voglia”. Fulvia intanto prende la parola: “Grazie... per quest’anno di attese, dico. Sono trecentoquarantatrè giorni che mi fai il regalo della puntualità, Antonio. Nessuno mi hai mai aspettato tanto”. Antonio capisce che per andare a lontano non bisogna forzare i tempi: basta incontrarsi a metà viaggio. Chi si preoccupa del presto o del tardi non ha ben chiara la meta. Antonio estrae dalla tasca due orecchini argentati, nuovi di zecca. Ora sa a chi donarli. I Racconti Dei Giovani Autori 53 La clinica SILVIA VIPIANA Anche quel giorno abbiamo iniziato una polemica su qualcosa che non ricordo di preciso e che , come spesso accade tra noi , diventa un pretesto per innescare una lunga lotta verbale. Ma quella volta le tue ultime battute ricordo che mi hanno sorpresa, ferita e zittita: “ultimamente vedo che ti stai trascurando dal punto di vista dell’aspetto fisico ,non volevo dirtelo ,ma mi hai costretto”. Io con un senso di sconforto e delusione avevo ribattuto con scarsa decisione: ”il mio viso mi sembra molto carino”, poi ho trattenuto il fiato come se avessi dovuto nuotare sott’acqua per risalire subito a galla. E tu senza un segno di esitazione: ”ma io parlo del tuo corpo e non del viso“ “ultimamente la tua pancia sta gonfiando e non ti vedo prendere alcun provvedimento!“. Una serie di emozioni hanno iniziato a girarmi nell’anima come dei panni in una centrifuga. In quel momento non avevo e non volevo risposte da darti, mi sembrava solo assurdo sentirmi “sezionata”, per altro dalla persona che mi aveva scelta ed avrebbe dovuto amarmi per come sono. Invece no, una parte del mio “essere” non andava più bene. Il giorno seguente non ci siamo visti, solo brevi messaggi sul cellulare, da parte mia una lucida freddezza. Ma quella mia “pancia gonfia e trascurata” iniziava a pesarmi e più non ci pensavo e più mi sentivo a disagio. La sera seguente ti ho chiamato per darti la notizia che le tue parole mi avevano toccata e stimolata e che avevo fissato un primo appuntamento presso una clinica specializzata in cure estetiche, programmi mirati per modellare il fisico mediante diete ed attività sportive. Ti ho anche comunicato che la visita sarebbe stata di sabato mattina verso le dieci e trenta ad Alba . Alla mia richiesta di accompagnarmi non hai esitato un istante “Certo che ti accompagno, amore! Figurati, mi fa piacere esserti vicino. ” Non ci credevo , avevi accolto la mia proposta di rivolgermi ad una clinica per un banale motivo di estetica. La tua risposta affermativa ed il tono compiacente mi avevano fatto infuriare ed eccitare allo stesso tempo. Avresti dormito da me il venerdì notte per partire con me la mattina seguente... Quando sei arrivato avevo già preparato tutto, vestiti ,borsa, cartina stradale, qualche panino e bibite per il tragitto. Sul tavolo dell’ ingresso avevo appoggiato il biglietto scritto a mano con l’ indirizzo della clinica - Bio Dynamica - C.so Margherita,7 - Alba - sabato 23 luglio - ore 10.30. Quel venerdì sera ci siamo addormentanti abbastanza presto. Sabato mattina ci siamo svegliati con un sole che preannunciava una giornata calda e luminosa. Ho fatto scivolare velocemente il biglietto nella borsa e siamo partiti. Io silenziosa e pensierosa al volante, tu assorto e ancora un po’ assonnato al mio fianco. Ogni tanto con la coda dell’occhio cercavo di cogliere qualche segno interrogativo sul tuo volto. Abbiamo subito fatto una breve sosta per un caffè. Come sempre mentre tu l’avevi già finito io stavo ancora aprendo la bustina dello zucchero; mi hai fissata , allora io ho continuato a sorseggiare il mio caffè con piacevole lentezza per sfidare la tua pazienza. Per tutto il tragitto abbiamo parlato normalmente ed ammirato distese verdi e collinari , ricoperte di vigneti. Rallentando all’ultima rotonda prima di decidere la deviazione da seguire ti ho chiesto con tono serio: ” Per favore, prendi la cartina dalla mia borsa e controlla se la direzione è esatta, non vorrei sbagliare proprio adesso che siamo quasi arrivati”. Tu hai iniziato a frugare con affanno nella mia borsa mentre ti suggerivo di controllare in una tasca laterale. L’hai aperta ed hai iniziato ad ispezionarla cautamente con la mano. Quando la tua mano è riemersa dalla tasca tenevi e facevi svolazzare il volantino di un parco safari . Ricordo perfettamente la tua espressione allucinata ” Ma dov’è l’indirizzo della clinica? “, io fiera ti ho risposto “E’ quello che hai in mano!”, “ma questo è un parco di animali !”, “Certo, è qui che inizierò la cura del mio fisico!”. Il tuo volto teso e incredulo si è rilassato, il tuo sorriso pieno di sorpresa ed anche ammirazione mi ha quasi imbarazzata. Abbiamo trascorso una stupenda giornata di sole, affrontando sentieri ripidi e impolverati , avvicinando musi di bisonti, accarezzando morbidi ciuffi di cammelli e folte chiome di cavalli selvaggi. Sentivo solo il vento tra i capelli come la ragazza cantata dai Rolling Stones! Abbiamo mangiato i nostri panini abbracciati, seduti tra uno struzzo curioso e due pavoni appisolati. La sera siamo rientrati a casa tutti sudati, pieni di foto e ricordi da salvare nella nostra memoria. In quella giornata ho curato un po’ l’anima con la natura e con te al mio fianco. 54 8° Concorso Nazionale Per Scrittori Inediti - 2011 Lettera ad una figlia CORRADO VISONE Marzo 1976, al Festival di Sanremo vince Peppino Di Capri con la canzone “Non lo faccio più”, al 2°posto si piazza Dori Ghezzi in coppia con Wess con la canzone “Come stai, con chi sei”, e al 3°posto finiscono pari “Volo AZ 504” degli Albatros e “Gli occhi di tua madre” di Sandro Giacobbe, quello che piaceva tanto alla tua, di madre. Aprile: in Portogallo si tengono le prime libere elezioni dopo la dittatura: vincono i socialisti e Mario Soares diviene primo ministro. Pol Pot è primo ministro in Cambogia. Il 4 maggio all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, alle ore 6.25 del mattino, nasci tu. Il 6 maggio, in prima serata, un violento terremoto è avvertito in tutta l’Italia del nord: l’epicentro è in Friuli. Oltre 1000 morti, migliaia i feriti, case distrutte, industrie sbriciolate. Paesi pieni di vita, la fatica di tanti anni, tutto scompare in un minuto. Gemona, San Daniele, Tarcento. Ci abitavano 75.000 persone, 35.000 sono rimasti senza casa. Una scossa del 9° della Scala Mercalli ha distrutto tutto, poi altre 29 hanno sbriciolato ciò che era rimasto in piedi a completare la sciagura. Fotografia in b/n: tua madre a letto in camicia da notte smanicata con te in braccio. Lei sorride. Tu stringi il dito indice di un giovane uomo che è appena dietro, con i suoi occhialoni neri. Quell’uomo sono io. Tu hai il viso sereno di chi riposa dopo un’immane fatica. Il campionato italiano di calcio è vinto dal Torino di Pulici e Graziani su Juve, Milan e Inter. La Fiorentina non va oltre uno scialbo nono posto. Il 20 e 21 giugno ci sono le elezioni politiche. I risultati portano a un recupero della DC. I comunisti prendono meno voti delle amministrative dell’anno prima, ma ottengono il miglior risultato elettorale della loro storia. Il travaso di voti nei due grandi partiti viene da tre gruppi perdenti: il PLI, il PSDI e l’ MSI. Il PSI non va molto lontano dai risultati del ‘72. Fotografia in b/n. Estate piena, al mare in Versilia. Ti tengo in braccio e tu piangi, sullo sfondo la spiaggia quasi deserta di mattina presto. Tu non guardi in macchina, io sì, ma il mio sguardo non è felice, è smarrito. Come se non sapessi come tenerti. Il 10 luglio, un agguato contro un magistrato: a essere falciato da 32 colpi di mitra sul sedile della sua auto è Vittorio Occorsio, il sostituto procuratore che stava indagando sulla strage di Piazza Fontana. Il 16 luglio viene eletto segretario del partito socialista Bettino Craxi. Il 9 settembre muore Mao Zedong. Fotografia in b/n. Chi la scattò è una delle cose che ho rimosso di quel periodo. Ci sono io quasi di spalle, vestito nero, spingo un passeggino dove ci sei tu. Dietro di noi alcune persone piangono. Davanti, il feretro di tua madre. Il 2 novembre Jimmy Carter del partito democratico è il 39° presidente degli Stati Uniti. Fotografia in b/n, Natale. Ti tengo in braccio mentre cerchi, con la linguetta fuori, di afferrare una palla dall’albero. Fotografia a colori: 1° giorno di scuola. Con un fiocco rosa più grande del tuo viso e una cartella colorata. La tua infanzia la posso raccontare per immagini e profumi. La nonna che odorava di pane, con le calze color carne; i regali e lo sguardo affranto di chi si è trovato a crescere un’altra figlia quando non era più il tempo. Le poesie di Natale: tu su una sedia che le ripetevi, le bamboline e i giochi. Filmino, a colori. La tua Prima Comunione. Tu vestita di bianco, con la coroncina in testa, io con un’orrenda camicia. Mi abbracci e guardi fissa l’obiettivo. Poi scappi, non ti fermi un momento, rincorri una farfalla, io urlo qualcosa, la nonna coi capelli tutti bianchi ti acchiappa, ti aggiusta e ti mette in posa. Come per una foto. C’è ancora una fotografia, a colori. Tu, seduta al mio posto in redazione, un sorriso di pochi denti, batti gli indici sulla macchina da scrivere. Intorno subbuglio per il ritrovamento di una coppietta ammazzata a San Casciano, le ultime vittime del Mostro. Nonna non c’era più, e io non sapevo dove portarti. Ricordo che nascondevi le mani sporche di giochi, in quel parco di pini e altalene. Quando le Cascine era un posto dove portare i bambini. Panchine di legno su cui baciare o dormire. Una fontanella che gettava acqua a intermittenza e gelava la bocca in inverno. Foglie di brina. Radici che ricamavano i sentieri di terra battuta. Dietro gli alberi, un campanile: i rintocchi catturavano il tempo. Il buio ci sorprendeva sempre alle spalle, inaspettato. La nebbia a volte creava atmosfere ovattate o una brezza leggera alzava polvere, pensieri, profumi di terra. Tutto ti incuriosiva: un giornale aperto, orme lasciate prima di noi. Un giorno, avevi sei anni, mi prendesti la mano: mi colpì quel contatto di dita piccole e dita grandi. C’è una fotografia sul mio comodino, in b/n: tua madre sorride, seduta su un prato con le gambe ripiegate. Non ho foto a colori di tua madre: aveva gli occhi azzurri come i tuoi. Ora quegli stessi occhi mi guardano dallo schermo televisivo. Raccontano di una strage di civili in Afghanistan. Il tuo sguardo cerca lo spettatore: sai comunicare il dolore. Dietro di te: un cartello azzurro scritto in arabo, basse case marroni, pali della luce. Quando ridai la linea al conduttore io spengo la tv. Anche oggi stai bene. I Racconti Dei Giovani Autori 55
Scaricare