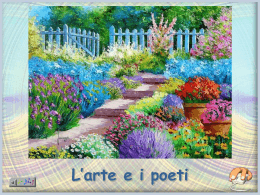§ PARAGRAFO RIVISTA DI LETTERATURA & IMMAGINARI Paragrafo Rivista di Letteratura & Immaginari pubblicazione semestrale Redazione FABIO CLETO ([email protected]), DANIELE GIGLIOLI ([email protected]), MERCEDES GONZÁLEZ DE SANDE ([email protected]), FRANCESCO LO MONACO ([email protected]), STEFANO ROSSO ([email protected]), AMELIA VALTOLINA ([email protected]) Ufficio 211 Università degli Studi di Bergamo P.za Rosate 2, 24129 Bergamo tel: +39-035-2052744 / 2052706 email: [email protected] web: www.unibg.it/paragrafo La responsabilità delle opinioni e dei giudizi espresso negli articoli è dei singoli collaboratori e non impegna la Redazione Questo numero è stato stampato con il contributo del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità dell’Università di Bergamo © Università degli Studi di Bergamo ISBN 88-87445-88-5 Edizioni Sestante / Bergamo University Press Via dell’Agro 10, 24124 Bergamo tel. 035-4124204 - fax 035-4124206 email: [email protected] - web: www.sestanteedizioni.it Stampato da Stamperia Stefanoni - Bergamo Paragrafo I (2006) Sommario PRESENTAZIONE 5 FORME §1. STEFANIA CONSONNI, Disegni e realtà. Le finzioni di Don DeLillo 9 §2. LUCA BERTA, Il neon di David Foster Wallace e il punto di vista dell’aldilà 31 §3. LAURA OREGGIONI, La punta dell’iceberg. Sten Nadolny e il senso della possibilità 53 GENERI §4. NICCOLÒ SCAFFAI, Altri canzonieri. Sulle antologie della poesia italiana (1903-2005) 75 §5. GABRIELE BUGADA, Lo specchio del sogno. Lo statuto della rappresentazione in Mulholland Drive di David Lynch 99 §6. GIOVANNI SOLINAS, Il mito senza fine. Poetica dell’immagine e concezione mitica in André Breton - Una proposta d’analisi 123 TEMI §7. ANDREA GIARDINA, Il viaggio interrotto. Il tema del cane fedele nella letteratura italiana del Novecento 145 §8. MICHELA GARDINI, Derive urbane fin de siècle 167 §9. GRETA PERLETTI, Dal mal sottile al mal gentile. La malattia polmonare e il morboso ‘interessante’ nella cultura dell’Ottocento 179 I COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO 199 Presentazione A paragraph writer shall kill you the stoutest man in the kingdom for his sixpence, and bring him to life again for another. Middlesex Journal, settembre 1769 Un paragrafo è un segmento di testo, un’unità di relazione. Che sia l’unità tematico-concettuale in un saggio o in una legge, un passaggio all’interno di una composizione musicale o la parte in responsione di un coro, una voce in un dialogo o una notarella giornalistica priva di titolo, il paragrafo segnala un inizio e uno scarto, apre una sequenza di periodi tra loro coerenti, ma che non producono un insieme autonomo. Un testo che avesse un solo paragrafo, non ne avrebbe in realtà neanche uno – nemmeno nei faits divers, il cui testo è l’insieme dei singoli paragrafi, delle singole notizie, che sintetizzano e offrono il disegno complessivo della cronaca. Una parte dunque, ma significativa: una sorta di unità di misura del pensiero, che distingue e organizza visivamente il discorso scritto, nella scansione del capoverso oppure nel segno grafico §, erede con ¶ di una tradizione che risale ai papiri e ai manoscritti medievali. Il paragrafo è pertanto metafora strutturale, strumento di localizzazione e figura di movimento (codificata, ad esempio, nel pattinaggio artistico, per analogia con il segno grafico). Ma il paragrafo, insegna l’etimologia, è anche l’intorno della scrittura, quanto si colloca a fianco di – e contro – l’autografo. La rivista che qui si presenta nasce dalle ambizioni e dal riconoscimento dei limiti inscritti nella metafora che mutua per titolo. Una rivista di studi letterari guidata dall’occasione, e dalla certezza che solo nella paziente e fiduciosa giustapposizione di molti lavori, tutti diversi tra loro, può prendere forma un discorso i cui contorni è possibile solo immaginare, e di cui solo il rapporto tra i paragrafi sarà in grado di suggerire un di- 6 / PRESENTAZIONE segno, tracciando figure, convergenze e relazioni inaspettate. La rivista intende infatti prendere le mosse dalla ricerca prodotta dall’Università di Bergamo, facendosi luogo di incontro fra le esperienze dei dottorati e centri di ricerca che vi trovano sede, ma senza coltivare alcuna velleità d’autonomia, e aprendosi invece agli apporti più diversi, affini o anche radicalmente contrapposti che siano – guai ai paragrafi, ai testi e agli autori che temono di contraddirsi. Di qui anche la necessità, quasi l’obbligo di incrociare l’ambito disciplinare della critica letteraria con altre modalità discorsive che ne rappresentano gli immediati dintorni, quali gli studi culturali, la critica d’arte o quella cinematografica, la semiotica o la sociologia della comunicazione, la filosofia o l’analisi del discorso, sotto l’egida di quella nozione di ‘immaginari’ che fa da bacino collettore all’universo delle pratiche simboliche. È intenzione della rivista privilegiare le ricerche – e le voci – in via di articolazione rispetto a quelle già compiute e mature, i risultati parziali e dagli esiti aperti rispetto a quelli che si pretendono definitivi: paragrafi di un testo ancora da scrivere, che solo insieme possono acquistare il loro significato. Se il paragrafo è in primo luogo un segno grafico che si pone a lato, ai margini di ciò che si scrive, proprio da quei margini – e non da una vana pretesa di definire un centro organico e autonomo – trae la sua capacità di dare forma, numero e ritmo al movimento del pensiero. § PARAGRAFO I forme § 1 Stefania Consonni Disegni e realtà Le finzioni di Don DeLillo The truest poetry is the most feigning As You Like It, III, iii Fantasticando sulla morfogenesi dell’universo nella sua “Guida galattica per autostoppisti”, Douglas Adams azzarda un’ipotesi. La realtà intera sarebbe un accidente causato nella notte dei tempi dalla frivolezza di particelle inerti che, tutto d’un tratto, scoprirono la possibilità di aggregarsi secondo stravaganti configurazioni. Quanto più arbitrario, impervio, il disegno, tanto più persistente, irreparabile, il risultato: Il nientesimo di secondo che occorse al buio per aprirsi e chiudersi si ripercosse avanti e indietro nel tempo nel più improbabile dei modi. Da qualche parte, nel passato profondamente remoto, traumatizzò un gruppetto di atomi che vagavano a casaccio nella vuota sterilità dello spazio, e li indusse a stringersi insieme secondo il più straordinariamente inverosimile degli schemi. Questi schemi impararono ben presto a riprodurre se stessi (il che faceva parte dell’estrema inverosimiglianza degli schemi stessi) e si misero a provocare gravi guai su tutti i pianeti che toccavano. Fu così che cominciò la vita nell’Universo.1 Dopo quasi cinquant’anni di carriera, e altrettanti titoli fra racconti, romanzi, saggi e opere teatrali, Don DeLillo potrebbe chiosare: la realtà è l’esito di morfologie complicate come labirinti, di strutture, “rapporti e legami strani, strani, strani”.2 Quanto più ‘strani’ – fittizi – tanto più veri. E in primo luogo narrativi. Come nota Marc Chénetier, infatti, non alle cose in sé ci spinge a guardare DeLillo, ma alle loro relazioni, a ciò che 1 Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979), trad. it. di Laura Serra, Guida galattica per gli autostoppisti, Milano: Mondadori, 1996, p. 83. 2 Don DeLillo, Players (1977), trad. it. di Maria Teresa Marenco, Giocatori, Torino: Einaudi, 2005, p. 169. PARAGRAFO I (2006), pp. 9-30 10 / STEFANIA CONSONNI Thomas Pynchon e Joseph McElroy chiamano le connessioni.3 Non su una tassonomia di formule d’intrattenimento fanno leva i suoi romanzi, ma su un’anatomia del linguaggio rigorosa e severa. Non, insomma, su un gioco di trivial pursuit fatto di codificazioni sature e pigre, ma su una corrispondenza più profonda, più stretta, fra esperienza e conoscenza, memoria e scrittura. Fra realtà e forma, vale la pena di aggiungere. Perché le costruzioni narrative in DeLillo – le sue trame, i suoi intrighi: i suoi complotti – non smettono mai, neppure per un attimo, neppure nei dettagli più remoti e ricercati, di interpellare la realtà. Ma in che modo, mediante quale connessione? O, detto altrimenti, che cosa rende ‘vera’ la finzione di DeLillo, qual è la marca strutturale del suo indubbio, ma sfuggente, ‘realismo’? Domande ampie, che già evidenziano un problema. Manca, e occorrerebbe, una riflessione morfologica sul lavoro di DeLillo, un’indagine approfondita delle relazioni fra i suoi disegni narrativi e l’idea di realtà che rappresentano. Che infatti quello fra funzione rappresentativa e linguaggio delle forme sia un nesso decisivo nella letteratura contemporanea lo segnala il dibattito sul ‘neorealismo’ di DeLillo, appunto, o Raymond Carver, Toni Morrison, Bret Easton Ellis, Jonathan Franzen; e di romanzi che, dopo la lezione di Pynchon, Barth e Barthelme, sembrano in qualche misura oltrepassare – si badi: intrecciandole – tecniche formali e strategie rappresentative “tanto del realismo ‘classico’ quanto (si può dire?) del postmoderno ‘classico’”.4 Romanzi, cioè, in cui preoccupazioni epistemologiche imponenti, e quanto mai attuali, “si fondono, si combinano, o addirittura (intenzionalmente o meno) si scontrano con il linguaggio formale del realismo”; in cui, in altri termini, realtà e paradigmi sciolgono i loro legami codificati (di volta in volta ‘classici’ o ‘postmoderni’, secondo la nomenclatura corrente), riarticolandosi in maniere nuove, e costruendo effetti di tensione “più evidenti man mano che questi due aspetti si allontanano l’uno dall’altro”.5 È appunto a un legame spezzato – o meglio, ricodificato, ridisegnato – fra forme e realtà che vorrei dedicare questa riflessione. Con un’avvertenza. Mi servirò, nell’osservare la finzione di DeLillo, tanto dei suoi romanzi quanto di interviste rilasciate negli ultimi vent’an3 Marc Chénetier, “Don DeLillo. La résistance aux systèmes”, Le Monde, 29 giugno 1994, p. 16. Ove non altrimenti indicato, le traduzioni sono mie. 4 Thomas Claviez, “Neo-Realism and How to Make It New”, Amerikastudien, 49:1, 2004, p. 6. 5 Ivi, p. 11. DISEGNI E REALTÀ / 11 ni; schivo, ma non quanto vorrebbe il luogo comune, lo scrittore ha infatti eletto alcuni recenti colloqui con la stampa e la critica a teatro anatomico della sua poetica, talvolta illustrando personalmente, e con straordinaria lucidità, il disegno – il design: la morfologia, l’aspetto presunto ‘fittizio’, ma volendo anche l’intenzione, il sembiante ‘vero’, autoriale – del suo lavoro sulla forma romanzo. Uno. Configurazione Una premessa, anzitutto. Anche senza addentrarsi nel dibattito filologico e critico sulle relazioni intermediali fra letteratura e arti visive,6 parlare di ‘forme’, di ‘disegni narrativi’, significa sovrapporre un metalinguaggio visivo, o spaziale – immediatamente percepibile nel termine disegno – con il medium della scrittura narrativa, che G.E. Lessing per primo, a metà Settecento, ha regolamentato nella sua natura temporale, o uditiva. Vuol dire indagare una specifica qualità visiva dei romanzi di DeLillo: la loro qualità configurazionale. Una qualità strutturale, embricata alla dimensione narrativa, che va anzitutto distinta dall’abilità tematica dello scrittore nell’esplorare la cultura contemporanea, nel confrontarsi con la crescente produzione iconica, con la dimensione ‘simulacrale’ della realtà; con il potere dell’immagine, insomma, ciò che Heinz Ickstadt chiama “la nuova religione dell’Immagine e i suoi santuari mediatici: la fotografia, il cinema, la televisione, la pubblicità, il digitale”, e che senza dubbio fa di DeLillo un “neorealista, uno storico del suo tempo, il cronista di una cultura che ha trasformato il ‘reale’ in un’immagine del ‘reale’”.7 6 Mi permetto di segnalare in merito la sezione “Strutture dello spazio” del mio Geometrie del tempo. La trama nel romanzo inglese del Settecento, in via di pubblicazione. 7 Heinz Ickstadt, “The Narrative World of Don DeLillo”, in Susanne Rohr e Sabine Sielke (a cura di), Faces of Fiction: American Literature and Culture from the Jacksonian Period to Postmodernity, Heidelberg: Winter, 2001, pp. 364, 375. Questo aspetto, particolarmente evidente in White Noise (1985), è stato peraltro oggetto di critiche feroci come quella di Bruce Bawer: “Se c’è una cosa comune ai suoi romanzi, oltre al motivo ‘addiosogno-americano’, è una sorprendente implausibilità. La rappresentazione del reale non è la sua specialità”. E ancora, citando un prodotto da fast food: “Se amate i romanzi infarciti di ‘filosofia McNuggets’, White Noise vi piacerà”. Bruce Bawer, “Don DeLillo’s America”, New Criterion, 3:8, aprile 1985, p. 38. D’altro canto, come nota Claviez riportando parole di Winfried Fluck, non mancano sintomi di una crescente insofferenza per la ricorrente equazione secondo cui DeLillo sarebbe un “card-carrying postmodernist”: “DeLillo non è Baudrillard. Rivelando quella che probabilmente è una differenza capitale fra teoria letteraria e scrittura creativa, […] si preoccupa di come riconoscere l’esistenza di nuove realtà, e di come continuare comunque a vivere” (op. cit., p. 11). 12 / STEFANIA CONSONNI In effetti, è l’autore stesso a distanziare in più di un’intervista la peculiare qualità visiva della scrittura letteraria da quella di altri media. Nel 1999, interrogato da Maria Moss sulla presenza di cinema e televisione nei suoi romanzi, e sul ruolo dello scrittore “in una società dominata dall’immagine”, risponde di non considerarsi in competizione con i media visivi, perché se ad esempio esiste una relazione fra il romanzo e il cinema, è data dal fatto che entrambi si basano sulla narrazione, il che li lega in maniera assai più significativa. Sennonché, prosegue, “il romanzo non segue il cinema, lo guida”. È questo il ruolo della letteratura: “creare un clima, un ambiente nuovo, non reagire a ciò che esiste già. I romanzieri devono vedere le cose prima degli altri”, poiché la scrittura “non è che una forma più concentrata di pensiero”.8 Sette anni prima, parlando con Brigitte Desalm di una presunta egemonia culturale del segno visivo, distingueva infatti due tipi di scrittore, quello per così dire ‘uditivo’, “che coincide semplicemente con una voce”, e quello ‘visivo’, che sa “creare anche immagini”. E tuttavia, precisava, “la differenza fra il mondo delle immagini e quello delle parole è straordinaria, e difficile da definire. Un’immagine è un po’ come una massa: una moltitudine di impressioni. Un racconto, invece, con il suo procedere lineare e ordinato di caratteri e parole, sembra più connesso all’individualità”.9 Una spazialità astratta, ‘privata’, dunque – DeLillo usa qui con sottile disimpegno (nel 1992, un anno dopo Mao II) l’opposizione ‘massa’ vs. ‘individuo’ –, inscindibile dalla temporalità (la linearità ordinata di caratteri e parole) connaturata al racconto, e in grado di vedere la realtà, di crearne immagini narrative intessendo le stringhe sequenziali e orientate del linguaggio verbale. È questa, cui torneremo a tempo debito, la sostanza configurazionale della narrazione quale disegno. Nessuno l’ha descritta meglio di Paul Ricoeur in Tempo e racconto. “Perché non si può – perché non si deve”, osserva in merito al racconto di finzione, “sottrarsi a qualche paradigma d’ordine per quanto raffinato, artificioso e labirintico sia”?10 Una prima risposta ci giunge, inaspettata e 8 Maria Moss, “‘Writing as a Deeper Form of Concentration’: An Interview with Don DeLillo”, Sources, primavera 1999, ora in Thomas DePietro (a cura di), Conversations with Don DeLillo, Jackson: University Press of Mississippi, 2005, pp. 156, 158, corsivo mio (d’ora in poi segnalato nel testo con la sigla M; il volume curato da DePietro sarà invece indicato con la sigla DeP). 9 Brigitte Desalm, “Masse, Macht und die Eleganz der Sätze”, Kölner Stadtanzeiger, 27 ottobre 1992. 10 Paul Ricoeur, Temps et récit II. La configuration dans le récit de fiction (1984), trad. it. DISEGNI E REALTÀ / 13 forse già paradossale, dalla tradizione settecentesca del realismo à la Fielding, imperniato su un intervento sempre più “sofisticato a livello della composizione”, sull’“invenzione di intrighi sempre più complessi e, in tal senso, sempre più distanti dal reale e dalla vita”, e votato a un singolare destino. Da un lato, la canonizzazione otto e novecentesca della forma romanzo, la “conquista di nuove regioni da parte del principio formale di configurazione”; dall’altro l’eterodossia, innegabilmente più affascinante, dell’anti-romanzo, la scoperta con Laurence Sterne “del carattere sempre più convenzionale di tale impresa”, e la crescente consapevolezza che “solo delle convenzioni sempre più complesse [possono] restituirci il naturale e il vero”.11 (Fra l’una e l’altra, come sappiamo, miscele e tensioni più o meno ‘classiche’ o ‘postmoderne’, recenti o originali.) Certo, non a una natura e a una verità uniche e stabili rimandano i lavori di DeLillo. Tutt’altro. Eppure, ci mostrano la limpida ineludibilità dei paradigmi, le metamorfosi elastiche delle morfologie narrative. “Si sente dire oggi”, prosegue Ricoeur, “che solo un romanzo senza intrigo, né personaggio, né organizzazione temporale precisa, è più autenticamente fedele ad una esperienza a sua volta frammentata e inconsistente rispetto al romanzo tradizionale”, cosicché se nel passato era la complessità sociale a esigere “l’abbandono del paradigma classico”, oggi “è la presunta incoerenza della realtà che richiede l’abbandono di qualsiasi paradigma”.12 È una posizione, quest’ultima, a suo modo forse attraente ma povera, poiché allestita attorno a un’idea insufficiente di struttura narrativa (la mimesis come copia della realtà), e lontana dal riconoscerne la funzione rappresentativa più potente, con la quale ogni finzione – dalla più oliata alla più discontinua – deve confrontarsi: l’intrigo è “sintesi dell’eterogeneo”, è una “nuova congruenza nella connessione degli accadimenti”, è “intelligenza nello schematismo”.13 Configurare un racconto, spiega DeLillo del canto suo, è infatti come risolvere un problema matematico articolato, la cui “soluzione è così semdi Giuseppe Grampa, Tempo e racconto. Vol. 2. La configurazione nel racconto di finzione, Milano: Jaca Book, 1985, p. 48. 11 Ivi, pp. 28, 29. 12 Ivi, p. 30. In un’intervista del 1982 DeLillo afferma che “non è vero che la vita moderna è diventata troppo fantastica perché la letteratura possa riuscire a catturarla”. È vero, semmai, che “i romanzi che davvero ci riescono sono impegnativi”: troppo. Robert Harris, “A Talk with Don DeLillo”, New York Times Book Review, 10 ottobre 1982, ora in DeP, p. 19. 13 Paul Ricoeur, Temps et récit (1983), trad. it. di Giuseppe Grampa, Tempo e racconto, Milano: Jaca Book, 1983, p. 8. 14 / STEFANIA CONSONNI plice ed evidente da meravigliarsi di non averla intuita prima. Ma quando ci arrivi, sai che è quella giusta [poiché] funziona secondo una sua propria logica”.14 Viene subito da pensare a Ratner’s Star (1976), il più calcolato dei suoi lavori sia nel tema – la matematica pura, “conoscenza segreta” e fonte “di linguaggi nuovi, di nuove connessioni” –15 sia nell’impianto narrativo, nitido e imperioso, in due parti modellate attorno all’Alice di Lewis Carroll e declinate sui codici della fantascienza e del cosiddetto ‘realismo isterico’ (o recherché postmodernism, come anche viene chiamato in scrittori quali Richard Powers, Salman Rushdie, o David Foster Wallace). Un romanzo, racconta DeLillo a Thomas LeClair, concepito “per essere nuda struttura”, affinché diventasse, nelle forme, “identico al suo oggetto. Strutture astratte e modelli di connessione. Un esercizio di matematica”. Un romanzo che è tutto disegno – come Under the Volcano, pensato da Malcolm Lowry quale struttura circolare, o Finnegans Wake, che invece “dovremmo leggere alla rovescia, dall’ultima pagina alla prima” (LeC, p. 11), o come la clessidra formata da The Ambassadors di James e la cattedrale della Recherche proustiana – e che incarna “un modello ordinato e armonico”, ossia “uno degli scopi tradizionali della matematica pura”.16 E sul medesimo principio si costruiva End Zone (1972), un romanzo sul football in cui anche “la narrazione in sé è una sorta di gioco”, cautamente strutturata com’è a veicolare “un senso di ordine, un elemento di dignità” (LeC, p. 6): i giochi, con le loro regole e i loro confini (le centro iarde di un campo, i sessanta minuti di una partita) sono per DeLillo un’altra metafora della costruzione narrativa. (Qualcosa di simile, ma più complicato, come vedremo, accade nel Prologo di Underworld con un incontro di baseball fra New York Giants e Brooklyn Dodgers.) Ma l’idea della configurazione narrativa come disegno della realtà – vero perché astratto, semplice perché sofisticato, audace perché convenzionale – è un Leitmotiv più o meno trasparente in tutti i suoi romanzi. Proviamo a interpellare il savant Murray Jay Siskind, sacerdote ispirato 14 Jonh Wilde, “The Day Kennedy Died”, Melody Maker, 19 novembre 1988, p. 53. Thomas LeClair, “An Interview with Don DeLillo”, in Thomas LeClair e Larry McCaffery (a cura di), Anything Can Happen: Interviews with Contemporary American Writers, Urbana: University of Illinois Press, 1983, ora in DeP, pp. 9, 11 (d’ora in poi LeC). Il protagonista di Ratner’s Star vede nella matematica una disciplina splendida perché “severa, obbediente a un codice di regole interne”, “austera” nel suo legame con “la semplicità e la permanenza”, nella sua ricerca di “conclusioni necessarie” e “forme significanti”, e generosa nella “multiforme libertà che offre proprio attraverso le restrizioni che sempre impone”. Don DeLillo, Ratner’s Star, New York: Knopf, 1976, p. 13. 15 DISEGNI E REALTÀ / 15 della banalità quotidiana. “Tramare significa vivere”, egli rivela a Jack Gladney in White Noise (1985); “tutta la vita è una trama, un piano, un diagramma. Un piano fallito, ma questo non c’entra. Tramare significa affermare la vita, cercarne una forma e il controllo”. Ogni cosa è “precisione, dettaglio, ordine, disegno”, perché “[t]ramare, mirare a qualcosa” significa “dare forma a tempo e spazio. È così che facciamo progredire l’arte della coscienza umana”.17 Tale è anche la convinzione di Owen Brademas, l’archeologo affascinato in The Names (1982) dalle lettere dell’alfabeto, “quelle forme stupende, strane”, che zittiscono, codificandolo, “tutto il borbottio, il balbettio e il chiacchiericcio” del mondo, e che “l’occhio avvolge” con “passione irragionevole […] stravagante, sciocca”, alla ricerca di “relazioni, strutture parallele […] un disegno che faccia parlare questo mucchio di caratteri”: tutta la realtà, infatti, “anche ciò che sembra casuale[,] assume un aspetto ideale e giunge a noi in forme pittoriche. È tutta questione di saper vedere […] un disegno nelle cose, […] momenti nel flusso”.18 Ancora prima, Lyle, l’anodino agente di Borsa che in Players (1977) si improvvisa terrorista, “[v]edeva nei numeri e nelle sigle […] un’ingegnosa riduzione del mondo esterno in materia stampata, un modello codificato di esattezza” da cui trarre “un’impressione di realtà separata dalla risonanza dei propri sensi”.19 E come trascurare Bill Gray, lo scrittore protagonista di Mao II (1991)? Omaggio a Pynchon e parziale autoritratto, “la vecchia testa melanconica e segnata”, Gray vive chiuso in una stanza e fermo sullo stesso romanzo da decenni, circondato da “grafici alla parete”, che sono l’alfabeto del suo libro, fatto di “riquadri sbilenchi e ghirigori”, di figure “interessanti da studiare, tutte le frecce e gli scarabocchi e i pittogrammi, le linee che collega[no] elementi dissimili”, in cui c’è “qualcosa di primitivo e di audace”.20 È una figura ambigua, la sua; da un lato è incarnazione della fede di DeLillo nella forma romanzo, un “grido democratico” accessibile a chiunque, 16 Anthony DeCurtis, “An Outsider in This Society: An Interview with Don DeLillo”, South Atlantic Quarterly, 89:2, 1988, trad. it. “Emarginati, assassini, misteri”, in AA.VV., Tra due oceani. Interviste con gli scrittori di “Linea d’ombra” (1983-91), Milano: Linea d’ombra, 1991, p. 188 (d’ora in poi DeC). 17 Don DeLillo, White Noise, trad. it. di Mario Biondi, Rumore bianco, Torino: Einaudi, 1999, pp. 347-48. 18 Don DeLillo, The Names, trad. it. di Amalia Pistilli, I nomi, Torino: Einaudi, 2004, pp. 24, 94, 43. 19 Don DeLillo, Giocatori, cit., p. 67. 20 Don DeLillo, Mao II, trad. it. di Delfina Vezzoli, Torino: Einaudi, 2003, pp. 152, 44. 16 / STEFANIA CONSONNI anche a un “un ignoto sgobbone, un desperado che non ha nutrito che un sogno”, il quale “può mettersi a sedere e trovare la sua voce”, facendo “qualcosa di così angelico da lasciarti a bocca aperta”.21 D’altro canto, Gray è il portavoce di una dignità etica, di un rigore morale radicato in un lavoro di configurazione non soltanto narrativa, ma più profondamente linguistica, che sancisce il confronto dello scrittore con la realtà,22 ed è pertanto un trait d’union con la figura del terrorista, alla quale ogni romanziere è legato dalla capacità di “rimpiazza[re] le cose reali con intrecci e invenzioni”, di restringere “il mondo entro i suoi angusti confini” e di plasmare con ciò la “vita segreta, la rabbia che cova sotto ogni oscurità e negligenza”, alterando così “la vita interiore della cultura”.23 Trame, complotti. Ecco la glossa di Walter ‘Win’ Everett, ex agente della CIA e cospiratore (mancato) in Libra (1988), colui che – dalla frustrazione professionale e dal risentimento seguiti al congedo dall’Agenzia dopo il fallimento di un’operazione anticastrista – distilla l’idea geniale di un attentato (mancato) al Presidente Kennedy: “Le trame possiedono una logica. […] La trama di un romanzo […] è il nostro modo di localizzare la forza della morte fuori dal libro, di esorcizzarla, di contenerla”.24 Per questa ragione, se noi tutti “[s]iamo personaggi di una trama”, e se “le esistenze che viviamo, esaminate attentamente nel complesso dei legami e della affinità, abbondano di senso, di significato, temi e svolte tortuose che non consentiamo a noi stessi di vedere completamente”, il compito del terrorista è quello di mostrare le occulte “simmetrie di una vita qualunque”. Di rimando, Nicholas Branch – l’analista della CIA segretamente incaricato di redigere la storia dell’omicidio – impiegherà nella ricostruzione del complotto “mani e occhi, colore, forma e memoria, la configurazione di cose significative”, fabbricando “teorie che splendono come idoli di giada, affascinanti sistemi di ipotesi, a quattro facce, aggraziati”, 21 Ivi, p. 172. “[O]gni frase compiuta ha una verità in attesa alla sua fine e lo scrittore impara a riconoscerla quando finalmente ci arriva. A un certo livello questa verità è il ritmo della frase, il suo polso e il suo equilibrio, ma a livello più profondo è l’integrità dello scrittore […]. C’è una forza morale in una frase quando ti riesce giusta”. Ivi, p. 54. Parole, queste, che potrebbero essere tolte a un’intervista di DeLillo, come vedremo. 23 Ivi, p. 216. Nel settembre 1988, appena dopo l’uscita di Libra, DeLillo è accusato da George Will sul Washington Post – con una formula diventata celebre, e cambiata di segno da Frank Lentricchia – di aver prodotto un atto di “vandalismo letterario e cattiva coscienza civile”. 24 Don DeLillo, Libra, trad. it. di Massimo Bocchiola, Torino: Einaudi, 2000, pp. 208-09. 22 DISEGNI E REALTÀ / 17 dando forma a ciò che “intendono gli scienziati quando usano il termine ‘soluzione elegante’”.25 Si obietterà ora, legittimamente, che la trama di Win Everett, così “originale, sobria e pulita” – e tuttavia aggrovigliata, fatta di “labirinti che si dirama[no] all’infinito”, “satur[a] di ansia, involut[a]” –, è destinata a smarrirsi nelle minuzie e a lasciar posto al piano militare, prosaico ma efficace, di T-Jay Mackey, Raymo e Frank Vasquez, cosicché l’elaborata cilecca fantasticata da Everett per le geometrie di Dealey Plaza diventerà un omicidio reale.26 Segno questo, del fatto che – per riprendere le parole di un personaggio in Running Dog (1978), riferite al fascino della pornografia – “line[e], grazia, simmetrie” non sanno tenere il passo con la realtà, e ancor meno con la storia, e che è dunque l’assenza di “psicologia” – di dinamiche “stran[e]”, cariche di “interesse umano” – a rendere i sistemi mere “formule. Concetti essenzialmente sterili”.27 Del resto, è lo stesso Everett a notare “una tendenza, nelle trame, a evolvere in direzione della morte”, il fatto cioè che la morte è “insita nella natura di ogni trama. Nelle trame di narrativa come in quelle di uomini armati. Più la trama di un racconto è fitta, più è probabile che approdi alla morte”. E ha ragione: lui stesso morirà senza gloria verso la fine di Libra, “nel maggio 1965 in [un] motel nei pressi di Alpine, Texas”; nella “stanza delle teorie”, e a dispetto del suo nome, Branch rimarrà una caricatura malinconica di Hayden White e della storiografia narrativa, poiché non riuscirà a comporre alcun disegno intelligibile dal labirinto di coincidenze inviatogli dal capoarchivista dell’Agenzia;28 e DeLillo chiuderà il romanzo con Marguerite Oswald che consegna alla Storia il nome – un nome misero in maniera commovente, senza dignità, mille volte rubato o respinto – del figlio appena sepolto. Si dirà pertanto che la realtà (la Realtà?) ha infine ragione delle forme, della loro astrazione e eleganza che nell’incontro, quasi sempre finale, con la morte – con la presentificazione estrema del reale – si rivela per ciò che è: riduzione di complessità. È raro trovare in DeLillo il sollievo morfologico di un’Apocalisse, e il lettore che l’aspetti rimarrà deluso. È quel che ac25 Ivi, pp. 75, 15-16, 28. Ivi, pp. 207, 390. 27 Don DeLillo, Running Dog, trad. it. di Silvia Pareschi, Torino: Einaudi, 2005, pp. 16, 146. 28 Don DeLillo, Libra, cit., pp. 209, 352. Branch, ‘ramo’, rimanda alla morfologia labirintica. Lo segnala François Happe, “La conspiration du hasard. Histoire et fiction dans Libra de Don DeLillo”, Revue française d’études américaines, 68, 1996, p. 102 (d’ora in poi H). 26 18 / STEFANIA CONSONNI cade in Players, con la morte senza motivo di Jack, un probabile suicidio, in seguito alla quale Pammy conclude che “le persone inconsciamente si piegano alle esigenze del mondo fisico, si impegnano in fantastiche danze con la natura ogniqualvolta la morte colpisce qualcuno vicino a loro”;29 in Running Dog, con la fine addestrata, orrenda, di Glen Selvy, che gli lascia il tempo di osservare la sabbia fra le ciglia del suo assassino;30 in Mao II, con Bill Gray che muore di una morte qualunque, irritante, su un traghetto che dovrebbe trasportarlo verso lo scrittore, ostaggio di un gruppo terroristico, attorno alla cui liberazione sono aggrappati gli ultimi brandelli della sua identità; e in White Noise, naturalmente, che la morte l’ha già nel titolo, con la sperimentazione del Dylar (un farmaco che dovrebbe smorzarne la paura), l’esposizione di Jack Gladney alla nube tossica di Nyodene D., e l’omicidio grottesco dell’amante di Babette. In tutti questi casi, il disegno narrativo si sfuoca e si allenta, spesso si interrompe o si smaglia rapidamente per gettarsi in finali disfatti, sconfitti, in tono minore, casuali o senza importanza. Quasi, insomma, che nell’architettare e mettere in crisi le strutture più articolate l’opera di DeLillo, nella sua interezza, fosse (e lo è) una meditazione sulla – e un’interpellazione della – morte, un lavoro di cordoglio che trova consolazione forse soltanto con Underworld (1997): un romanzo sulla desolazione, la nuda dolcezza di ciò che resta dopo la perdita e l’abbandono, e che ha già nel titolo una prospettiva sotterranea; che si apre con l’incontro fra il capo dell’FBI J. Edgar Hoover, incarnazione della paranoia americana degli anni Cinquanta, e il Trionfo della morte di Bruegel, che dal buio del Cinquecento gli piomba addosso, su una pagina di Life, per ossessionarlo, per sedurre il disegno terso – delirante – della sua mente con il disgusto informe delle cose reali; che si chiude con l’omicidio dell’orfana Esmeralda e la morte nel sonno di Sister Edgar; e che ha per protagonista Nick Shay, un uomo al quale la scomparsa del padre e una condanna per omicidio hanno sepolto la giovinezza, e la cui vita è legata ai rifiuti: alle cose che il mondo ha perso, o ha gettato via. Morte, dunque, se non – fatto ancor più grave – crisi delle morfologie? Senza dubbio. Ma è una risposta parziale, e non la più interessante. Come dimenticare infatti che il concetto di ‘crisi’ ha già nell’etimo crànw il ‘giudicare’, lo ‘scegliere’, il ‘decidere’? Qual è, se c’è, il discrimine? Ossia, nelle 29 30 Don DeLillo, Giocatori, cit., p. 188. Don DeLillo, Running Dog, cit., p. 253. DISEGNI E REALTÀ / 19 parole di DeLillo, quanto è sottile – quanto è duttile, capiente, creativo – quel margine ‘strano’ fra reale e fittizio, quel limite “che gli scrittori del passato forse non conoscevano” (M, p. 159), e che invece dà forma al suo lavoro? Per dirla con Frank Kermode, nel romanzo dobbiamo pensare “alla Fine come a un fatto immanente piuttosto che imminente”; nessuna Apocalisse, dunque, ma un’idea più compiuta della crisi come dialettica – ecco il punto – fra disegno e realtà, perché il racconto letterario “rivelerà sempre una congruenza con un paradigma”, quell’“insopprimibile quantità minima di geometria, un’esigenza umana di forma o di struttura”, che fa della “storia del romanzo [una] storia di forme rifiutate o modificate”.31 Imbastite, disfatte, alterate: mai defunte. Perché se la domanda di concordanza con la realtà è, come afferma Lotman, “parte dei presupposti insuperabili del discorso e della comunicazione”, allora i paradigmi, “modell[i] finit[i] di un mondo infinito”, sono probabilmente inesauribili;32 e, ancora, benché nulla ovviamente escluda che “la metamorfosi dell’intrigo s’imbatta da qualche parte in un limite al di là del quale non è più possibile riconoscere il principio formale di configurazione”, nulla impedisce di credere, viceversa, che “nuove forme narrative, che non sappiamo ancora nominare, sono già sul punto di nascere [per attestare] come la funzione narrativa possa subire una metamorfosi ma non morire”.33 Il romanzo avrà sempre potenzialità morfologiche, “anche se il mondo ne è privo”; continuerà a mentirci con le sue forme, perché solo attraverso “i modelli di parola e di pensiero” (che sono i nemici della verità ma anche il suo collante simbolico),34 può inscenare il suo rapporto con le cose. Ora, chi meglio di DeLillo sa tracciare le vicissitudini del senso, intrappolato fra eccesso e difetto di disegno, fra la levigatezza totalizzante del textum, la minaccia dell’entropia e la frammentazione della paranoia? Il senso straripa e deflagra, oppure cede, evapora, crolla. Tuttavia, è nella qualità world-making dell’artificio narrativo – in quello che credo si possa ritenere un paradosso tensionale della forma – nella discreta sovranità del 31 Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (1966), trad. it. di Giorgio Montefoschi e Roberta Zuppet, Il senso della fine. Studi sulla teoria del romanzo, Milano: Rizzoli, 1971, pp. 29, 113, 115. 32 Jurij M. Lotman, Struktura chdozestvennogo teksta (1970), trad. it. di Eridano Bazzarelli, Erika Klein e Gabriella Schiaffino, La struttura del testo poetico, Milano: Mursia, 1972, p. 253. 33 Paul Ricoeur, La configurazione nel racconto di finzione, cit., pp. 52, 54. 34 Frank Kermode, op. cit., p. 120. 20 / STEFANIA CONSONNI senso (non nel suo banale imperialismo), che si può ricercare una connessione fra intrighi e realtà, quel legame “superbamente strutturato e complesso” (come lo descrive François Happe) che di una forma e un tema sa fare un pattern e un significato.35 Mi pare che in questa direzione vadano ricche letture dialettiche come quella di Heinz Ickstadt, imperniata su una frattura insanabile – la relazione rappresentativa, che è barratura invalicabile e al contempo “legge impossibile di perfezione” – fra l’astrazione dei paradigmi e la materialità dell’esistenza, fra “le simmetrie del disegno” e “la storia raccontata da ciò (gli scarti, i rifiuti) che ci si è lasciati alle spalle”.36 Ci sono segni, in tutti questi romanzi, del fatto che “il regno dell’arte, del linguaggio, della coscienza non può essere radicalmente separato dalla storia e dalla vita – del fatto che questi due mondi interagiscono fra loro, si intrecciano”.37 Idee, queste, confortate dallo stesso DeLillo in una delle interviste più significative, quella del 1988 con Anthony DeCurtis, in cui dice che “per rappresentare il reale, bisogna essere estremamente artificiali”, poiché nell’arte ricerchiamo “modelli che ci sfuggono nell’esperienza reale” e mediante i quali “la narrativa riscatt[a] la storia dalla sua confusione”; vale a dire che il romanzo è dentro la storia, ma “può anche agire al di fuori di essa, correggendo, ripulendo e, forse la cosa più importante di tutte, trovando ritmi e simmetrie che semplicemente non incontriamo altrove” (DeC, pp. 195, 183). Occorre non semplificare tali parole. DeLillo non sta qui celebrando il divorzio fra artificio e naturalità, né ricamando sull’inversione imitativa fra scrittura e vita, ma esaminando il loro rapporto. Il racconto “tiene a distanza la realtà nello stesso momento in cui tenta di disporla in un modello formale”, cercando in tal modo di rivelare “i segreti all’interno dei sistemi” (DeC, p. 189). Forma e realtà, ordine e alterazione, disegno e dettaglio si richiamano così l’un l’altro incessantemente, in un intrico re35 François Happe, “Introduction”, in Maria Moss, op. cit., pp. 82-84. L’intervista di Moss, cui si è sinora fatto riferimento con la sigla M (cfr. supra, nota 8), comprende l’introduzione di Happe solo nella versione originale. 36 “La frattura fra le strutture e la materialità delle cose sembra confermare l’affermazione [di DeLillo] secondo cui l’arte è sia dentro la storia sia al di fuori di essa – intendendo qui con ‘storia’ l’ammasso senza forma di dati, fatti, cose, la materialità grezza della realtà, il terrore della vita e della morte, ciò che crea il bisogno di un ordine e di un disegno”. Heinz Ickstadt, op. cit., p. 389. 37 Heinz Ickstadt, “Loose Ends and Patterns of Coincidence in Don DeLillo’s Libra”, in Bernd Engler e Kurt Muller (a cura di), Historiographic Metafiction in Modern American and Canadian Literature, Paderborn: Schöningh, 1994, p. 311. DISEGNI E REALTÀ / 21 lazionale che va dall’armonia al conflitto, dall’identità al paradosso: ecco il legame spezzato e ridisegnato.38 Un intrico ancor più evidente se si confrontano – come peraltro fa DeLillo – le armoniche simmetrie di Ratner’s Star con le dissonanze geometriche di Libra; sono, queste, strutture legate da una sottile e organica complementarità, poiché la seconda non fa che rimuginare, complicandola (e quanto), sulla ricerca (fallibile, certamente, e spesso fallita) di “una traccia d’ordine nella nebbia” (DeC, p. 183), nel flusso della casualità. Ed è questa anche la tesi di Happe, a propria volta smagliante disegno che, nel solco lasciato da Borges, riconduce le trame di DeLillo a una logica paradossale: se è vero che le morfologie sono le marche estetiche “più visibili della finzione”, lo è altrettanto che esse rendono la realtà “più verosimile”, “troppo stravagante per essere inventata” (H, p. 103). Due. Costellazioni Possiamo, a questo punto, tornare al problema della spazialità, alla qualità visiva della configurazione, alle ricadute intermediali di ‘forme’ e ‘disegni’ narrativi, e tentare di definire meglio: i) le sue relazioni con la temporalità della scrittura, che è in primo luogo, come DeLillo riferisce a Desalm, la sequenzialità ordinata di caratteri e parole (cioè del linguaggio verbale), e in secondo luogo la temporalità insita nell’operazione narrativa, ossia la sua funzione di raffigurazione del tempo; e ii) il suo ruolo – e dovrebbe ora essere chiaro che si tratta di un ruolo mimetico in senso tensionale, dialettico – nella rappresentazione della realtà. Come ‘vedono’ la realtà, insomma, come la ‘raffigurano’, gli intrighi neorealisti di DeLillo? Due in particolare fra i suoi romanzi mi sembrano comporre le dinamiche sinora affrontate in articolati sistemi spazio-temporali, che non potranno però essere qui affrontati se non in sintesi. Il primo è Libra.39 Già nel titolo – il segno zodiacale, la Bilancia, di L.H. Oswald – è l’idea della configurazione, o meglio della costellazione. 38 Da questa materia, dall’attrito strutturale fra compimento e dissoluzione, fra fallimento e correzione, nasce peraltro – sotto la guida silenziosa ma chiarissima di DeLillo – anche la grande, misurata elegia di Jonathan Franzen. Per la generosità dei temi, per la bellezza delle strutture, The Corrections (2001) potrebbe infatti essere il romanzo (d’amore?) che DeLillo, a quarant’anni (l’età di Franzen), non ha scritto. 39 Sulla cui straordinaria complessità non soltanto morfologica, ma anche retorica, va segnalata l’analisi di Claudio Cattaneo in Il confine labile. Paranoia e teorie cospirative in Libra di Don DeLillo, Università degli Studi di Bergamo, mimeo, 2005. 22 / STEFANIA CONSONNI Una forma nitida, armoniosa, teleologicamente determinata (nell’astrologia), e composta tuttavia con quanto di più infido e corruttibile (fickle, ‘scostanti’, direbbe Shakespeare, che in effetti le considerava dramatis personae): le stelle. Ossia, il caso. Da un lato, dunque, un ordine e un significato – una sorte, un destino – imposti dalla finzione allo scorrere della realtà (e della Storia, quella del secondo dopoguerra e della Guerra Fredda) con una messa in intrigo che risponde, per riprendere l’idea di Douglas Adams, al “più straordinariamente inverosimile degli schemi”. Dall’altro, per l’appunto, l’irrompere dell’alea, e il fatto che proprio in quanto sistemi casuali – contingenti, accidentali – le costellazioni sono dotate di una morfologia misteriosa, e gravida di promesse: Libra, la Bilancia, ovvero l’equilibrio. Perché per raccontare quei sette secondi (tanto durò l’esecuzione materiale di Kennedy) che hanno “spezzato la schiena” al secolo americano, e che rimangono come uno squarcio nella storia contemporanea,40 DeLillo amalgama la ricerca documentaria più rigorosa – la lettura del diario di Oswald, dei suoi scritti programmatici, e soprattutto di tutti e ventisei i volumi del rapporto ufficiale della Commissione Warren, il romanzo che avrebbe potuto scrivere James Joyce, “se si fosse trasferito a Iowa City e avesse vissuto cent’anni”, un capolavoro di trivialità, “dalle cartelle dentistiche della madre di Jack Ruby alle foto di stringhe annodate”, una “straordinaria finestra sulla vita negli anni Cinquanta e Sessanta, [dai] detective privati di New Orleans [ai] ferrovieri di Fort Worth” (DeC, pp. 180-81) – con la scelta di un protagonista (Oswald) evidentemente libresco, contraddittorio, incarnazione di fattori imprevedibili come “la coincidenza, il sogno, l’intuizione e il possibile impatto dell’astrologia sull’agire umano”.41 La finzione si fa così matrice della realtà, ma – ed è importante – accade anche l’inverso, perché la relazione fra le forze è di natura dialettica, è per l’appunto un equilibrio: DeLillo la riassume a DeCurtis nella geometria di un ‘nucleo storico’ orlato da ‘variazioni finzionali’, in cui “l’elemento centrale [è] un fatto storico indiscutibile sul quale poter attuare […] variazioni romanzesche” (DeC, p. 175). Tensioni, queste, che la struttura bipartita del romanzo (in ventiquattro capitoli) traduce in un contrappunto ritmico fra due serie di segmenti testuali, magistralmente schema40 “In Libra mi ero dato un compito particolare: riempire quel vuoto. […] Ecco la mia sfida: creare quei sette secondi che erano spariti” (M, pp. 162-63). 41 Quest’ultima frase si trova soltanto nella versione originale dell’intervista di DeCurtis; cfr. DeP, p. 63-64. DISEGNI E REALTÀ / 23 tizzato come segue da Happe. L’una (la serie dei capitoli dispari, l’asse paradigmatico della diegesi), di ordine spaziale, inanella una teoria di luoghi (il Bronx, New Orleans, il Giappone, Fort Worth, l’Unione Sovietica, Dallas, ecc.), ossia le dodici stazioni nella via crucis degli ultimi dieci anni di Oswald, secondo una logica aleatoria – casuale, disperata – di discrezione e ripetitività; l’altra (la serie pari, l’asse sintagmatico), di ordine temporale, ripercorre la tappe della cospirazione contro Kennedy lungo un arco di sette mesi, dall’aprile al novembre del 1963 (ossia dall’iniziale piano di Win Everett fino all’attuazione coordinata da T-Jay Mackey, e all’uccisione di Oswald), secondo invece la logica continua, conchiusa – matematica, spietata – della necessità. L’embricarsi di spazio e tempo raffigura in tal modo in termini visivi, sotto i nostri occhi e lungo l’intero snodarsi della trama, il farsi reciproco fra circostanze (“l’esistenza amorfa di Oswald”) e intrigo (la “struttura che le dà una forma e una finalità”), vale a dire fra cospirazione, calcolo, ordine da una parte e caso, coincidenza, caos dall’altra, cosicché l’asse verticale di una topografia immaginaria, intersecando l’asse orizzontale di una cronologia reale, dà luogo a un sistema stereoscopico di coordinate – aggiungerei – reali perché finzionali, e viceversa: l’Oswald immaginato da DeLillo, a Dallas, il 22 novembre 1963.42 Ma c’è di più. Se osservato meglio, il contrappunto fra l’asse spaziale e l’asse temporale rivela proporzioni asimmetriche.43 Benché occupino nel romanzo all’incirca lo stesso numero di pagine (in termini narratologici, lo stesso ‘tempo del racconto’), i due segmenti di trama hanno infatti una durata (‘tempo della storia’) diseguale – dieci anni l’asse paradigmatico, sette mesi l’asse sintagmatico –, e dato che la freccia del tempo li dispone in parallelo (dagli anni Cinquanta al novembre 1963 il primo, dall’aprile al novembre 1963 il secondo), non di rado accade che la serie spaziale, più lunga, si ripieghi, si annodi, su quella temporale, dandole forma – la forma spaziale del tempo, la qualità ‘iconica’ della configurazione – con analessi, ripetizioni e prolessi che sono perciò al contempo i ‘punti’ di legatura dell’ossatura narrativa e le ‘lancette’ dell’arrangiamento temporale. Con almeno tre conseguenze importanti. Primo, che le due semitrame finiscono per convergere in un imbuto temporale, gli ultimi sette mesi di 42 H, p. 100. Si traccia in tal modo anche un gioco di variazioni aritmetiche e pattern numerologici fra i capitoli, impostati per lo più sull’11 e sul suo doppio (11/22, ossia 22 novembre, ecc.). Ne analizzano aspetti diversi Happe, Ickstadt e Cattaneo. 43 Osservazioni sull’asimmetria delle serie di capitoli si trovano anche in Ickstadt, “Loose Ends”, cit., pp. 304-05. 24 / STEFANIA CONSONNI vita di Oswald, forse l’unica vera Apocalisse dipinta da DeLillo, che infatti riconosce in Libra “l’unico [suo] libro in cui tutti i punti della trama sono risolti in maniera compiuta”, e riconduce tale caratteristica al desiderio, dialettico, “di riempire il racconto perduto di Kennedy e Oswald a Dealey Plaza”.44 Secondo, che l’immagine con cui l’autore descrive la struttura di Libra – un centro storico (il complotto contro Kennedy) contornato e infiltrato da variazioni finzionali (l’agiografia di Oswald) – si rispecchia visivamente nella reciproca costruzione di spazio e tempo. Terzo, infine, che l’equilibrio, il bilanciarsi delle forze nella rappresentazione narrativa, sta – paradossalmente – proprio in questa relazione sbieca, barrata, mai caleidoscopica, fra spazio e tempo, fra finzione e realtà. Alla metafora stellare di Douglas Adams potremmo così affiancare quella, proposta da Remo Bodei, della configurazione come multiversum, in cui la temporalità del racconto è rappresentata “dal processo intelligibile di allestimento [spaziale] degli avvenimenti, dalla loro inserzione in una costellazione di senso”.45 Connessioni parimenti se non più complesse affiorano dall’intreccio di Underworld, in cui il modello prismatico e spigoloso di Libra, fatto di tagli algidi e incisioni chirurgiche, si ammorbidisce e acquista una plasticità, sinuosa, avvolgente, quasi ‘serpentina’.46 Ai molti che l’hanno interrogato sulla nascita di questa enciclopedia della contemporaneità, su come abbia concepito e realizzato un affresco così sterminato e intenso, DeLillo ha quasi sempre risposto di non averne idea.47 Mi pare però che uno spunto essenziale emerga da un colloquio del 1999 con Chénetier e Happe.48 È legato alla funzione narrativa della memoria, a ciò che Walter Benjamin ha chiamato “l’elemento musale del racconto”, l’“antica connessione di anima, occhio e mano” che crea “la rete che tutte le storie finiscono per formare fra loro. L’una si riallaccia all’altra, come si sono 44 Lo afferma DeLillo il 23 ottobre 1995 in uno scambio di post via Internet con un gruppo di lettori. Il testo è riprodotto nell’ottimo sito curato da Curt Perival e dedicato a DeLillo’s America, all’indirizzo <http://perival.com/delillo/ddwriting.html>. 45 Remo Bodei, “Intrigue et multiplicité des temps dans le récit historique”, Revue de l’université d’Ottawa, 55, 1985, p. 250. 46 Per un’illustrazione narratologica e visiva di tale intreccio mi permetto di rinviare al mio “‘The Shot Heard Round the World’. Baseball e cospirazioni narrative in Underworld di DeLillo”, Nuova Corrente, 51, luglio-dicembre 2004, pp. 219-42. 47 Domanda: “Riesce a spiegarsi come ha scritto Underworld?” Risposta: “No” (M, p. 165). 48 Marc Chénetier e François Happe, “An Interview with Don DeLillo”, Revue française d’études américaines, 2001, 87, pp. 102-11 (d’ora in poi CH). DISEGNI E REALTÀ / 25 sempre compiaciuti di mostrare i grandi narratori”.49 È infatti nel ricordo autobiografico, nel fatto di scrivere in primo luogo degli anni Cinquanta, il periodo della sua adolescenza – DeLillo nasce nel 1936 da abruzzesi immigrati nel Bronx, nell’area italoamericana di Arthur Avenue –, e in secondo luogo del baseball, pure fra i passatempi di sempre,50 che l’autore riconosce uno stimolo ad aprire le frasi, “a scriverne di più lunghe”, e soprattutto a sbrigliare cronologie e paradigmi in un “intimo atto di fede nel romanzo, nella sua forma, quella forma così meravigliosamente ambiziosa che consente di spingere le forze della storia dentro le esistenze degli individui” (CH, p. 103). Proprio alla potenza creatrice della connessione mnestica DeLillo riconduce l’impressionante nitore formale di Underworld, l’intuizione – leggiadra e ritrosa, non un lungo processo di pianificazione ma un’idea “virtualmente istantanea”, un’ispirazione remota, proveniente da qualche “regno empireo” (CH, p. 105) – di invertire la direzione del tempo nella vita di Nick Shay, dalle discariche radioattive nel Kazachstan dei primi anni Novanta alle cronache familiari nel Bronx degli anni Cinquanta, e soprattutto di complicare e arricchire la morfologia del racconto in una rete sottile e ampia di riferimenti sincro-diacronici, poiché “questo è il modo in cui funziona la memoria: all’indietro” (CH, p. 104). La materia di Underworld, spiega infatti l’autore a Kim Echlin, è il modo in cui “le cose e le persone spariscono, o vengono tradite. Per due volte c’è una palla da baseball che sparisce, e per due volte un ragazzo viene tradito. […] Sparisce del plutonio, e un paese viene tradito. Il romanzo parla di tutte le cose che perdiamo, e perciò rovescia il flusso del tempo”. E non c’è altro mezzo per svilupparla se non uno schema temporale fatto di fearful symmetries: “trovo sempre un grande piacere nel costruire strutture. […] È questa la ragione per cui scrivo”.51 Perciò, per fare un solo esempio fra i molti possibili, la sezione che durante le fasi iniziali della stesura era pensata come prima, Composizione in grigio e nero, ambientata fra il 1951 e il 49 Walter Benjamin, “Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikola Leskov” (1955), trad. it. di Renato Solmi, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino: Einaudi, 1962, pp. 273, 262. 50 Racconta DeLillo in un’intervista con Diane Osen, condotta il 24 luglio 1997 e disponibile online nel sito di Curt Perival già menzionato: “[Da ragazzino, nel Bronx,] [m]i piaceva giocare. Appena uscito da scuola cominciavo subito a giocare in strada, a carte, nei vicoli, sulle rampe antincendio, palla prigioniera, pallamano, baseball, e cento altri giochi”. 51 Kim Echlin, “Baseball and the Cold War”, intervista pubblicata su Ottawa Citizen il 28 dicembre 1997, ora in DeP, p. 149. 26 / STEFANIA CONSONNI 1952, compare oggi – dopo un monumentale lavoro di configurazione, che ha riempito lo studio di DeLillo con diciassette faldoni di materiali, contenenti circa trecento pagine ciascuno (CH, p. 110) – come sesta, preceduta (nella linea del tempo) soltanto dal Prologo, Il trionfo della morte, che si svolge il 3 ottobre 1951 al Polo Grounds di New York, con il playoff Giants-Dodgers, e seguita (nella linea del racconto) da un salto di quarant’anni che ci trasporta, con l’epilogo Das Kapital, oltre la prima metà degli anni Novanta, ossia oltre la linea stessa del tempo. Così, il primo giorno nell’arco temporale delle vicende (il 3 ottobre 1951, il giorno della partita) e il successivo (il 4 ottobre, il giorno in cui Nick Shay uccide accidentalmente George Manza, azzerando e assieme invertendo il contatore della sua esistenza) sono separati nello spazio del testo da circa ottocento pagine, e nella linea del tempo da più di quarant’anni, vale a dire dalla quasi totalità del tempo raccontato. Si potrebbe continuare. Memoria e intelligenza delle connessioni: un buon romanzo, riassume E.M. Forster, è sempre attraversato da una vena inquieta, che “aleggerà senza tregua riordinando e riconsiderando, scoprendo nuovi indizi e nuovi agganci”, cosicché alla fine “quello che ci resterà non sarà […] una sequenza di indizi o di agganci, ma qualcosa di esteticamente compatto, che il romanziere avrebbe potuto rivelare subito, ma che, se lo avesse rivelato subito, non sarebbe mai diventato bello”.52 Non stupisce, dunque, che in questo labirinto del ricordo individuale e collettivo sia proprio l’artificiosa trama della palla da baseball – cimelio dello home-run battuto da Bobby Thomson per i Giants quel 3 ottobre 1951, che passa di mano in mano ai personaggi da Cotter Martin, che l’agguanta sugli spalti del Polo Grounds, fino a Nick Shay, che l’acquista nei primi anni Novanta – a colmare e arricchire il golfo fra 3 e 4 ottobre 1951, tracciando nel corso dei sei volumi una geometria spazio-temporale intermittente, zigzagante: ‘a puntini’, secondo l’espressione del collezionista che per primo la rintraccia negli anni Ottanta, Marvin Lundy, e che più tardi la venderà a Nick.53 In realtà nessuno sa cosa sia stato della palla (quella ‘vera’) dopo il match. Escamotage “ovvio e meraviglioso”, per riprendere le felici parole di DeLillo, il suo percorso immaginario – avanti e indietro in epoche e geografie – genera perciò il racconto, è ciò “che connette 52 E.M. Forster, Aspects of the Novel (1927), trad. it. di Corrado Pavolini, Aspetti del romanzo, Milano: Garzanti, 1991, pp. 95-96. 53 Don DeLillo, Underworld, trad. it. di Delfina Vezzoli, Torino: Einaudi, 1999, p. 182. DISEGNI E REALTÀ / 27 i personaggi nella storia”, tanto che “tutti i personaggi dotati di un qualche significato, eccettuato forse Lenny Bruce, vi sono collegati” (CH, p. 105). E non può che essere così, se consideriamo un fatto cruciale, e cioè che lo home-run di Thomson, con cui i Giants vinsero il campionato del 1951, racchiude nel Prologo di Underworld una dimensione tanto individuale quanto collettiva – tanto reale quanto finzionale – della memoria. DeLillo ricorda infatti, benché in sedi diverse, di aver concepito l’itinerario della palla ispirandosi a due fonti in particolare, l’una di natura storico-documentaria, l’altra poetico-letteraria: la prima pagina del New York Times del 4 ottobre 1951, in cui lo home-run è ribattezzato ‘the Shot Heard Round the World’ (il ‘Botto che ha fatto il giro del mondo’) e affiancato alla notizia del ‘botto’ del primo esperimento nucleare realizzato dall’Unione Sovietica,54 e un passo nei diari di John Cheever, in cui si dice che “il compito di un romanziere americano” non riguarda “donne adultere” o ogni sorta di oggetti alieni alla quotidianità, ma, ad esempio, “quattrocento persone che […] si azzuffano per una palla finita fuori campo”, oppure “il tuono sordo che si produce [nello stadio] quando in diecimila, alla fine dell’ottavo [inning], si dirigono verso l’uscita”.55 Lo home-run, il ‘Botto’, con la palla che resta a testimoniarlo nella memoria collettiva, riassume così sia l’incipit di un’epoca, quella della Guerra Fredda (fra gli spettatori del match, J. Edgar Hoover),56 sia lo schiudersi di un’emotività individuale, quella di Nick Shay, che nell’oggetto altero, ormai sciupato, dal quale la sua squadra è stata sconfitta in campionato, il giorno prima che lui stesso fosse sconfitto dal caso – o dal destino: poco importa distinguerli, in Underworld – trova “il sentimento di ciò che ha perduto. Nick non si identifica con [Bobby Thomson], ma con il pitcher [Ralph Branca] che in quel momento è stato battuto”.57 54 Don DeLillo, “The Power of Fiction”, New York Times Magazine, 7 settembre 1997, pp. 60-63. Altre fonti documentarie: il numero di ottobre 1951 di Life, contenente un articolo sul museo del Prado e un’illustrazione del Trionfo della morte di Bruegel, e le cronache radiofoniche della partita del 3 ottobre, nelle quali è registrata la presenza allo stadio di J. Edgar Hoover e altri personaggi celebri. 55 Passo citato in una conversazione privata e riportato in David Remnick, “Exile on Main Street”, New Yorker, 15 settembre 1997, p. 44. 56 Cfr. Phillip E. Wegner, “October, 3 1951 to September, 11 2001: Periodizing the Cold War in Don DeLillo’s Underworld”, Amerikastudien, 49:1, 2004, p. 60. 57 Bo Green Jensen, “Interview of Don DeLillo”, WeekendAvisen, 13 novembre 1998. A Andy Pafko, esterno sinistro dei Dodgers, DeLillo dedica inoltre nel 1992 “Pafko at the Wall”, il racconto che preparerà il Prologo di Underworld. 28 / STEFANIA CONSONNI Ma non è tutto, perché il Prologo inscrive tali dinamiche nella sagoma romboidale (il ‘diamante’) di un campo da baseball, nella geometria zigzagante e rigorosa di una palla che vi viene lanciata e ribattuta secondo schemi convenzionali; in una figura prismatica, cioè, che nella sua morfologia pulita riassume le rifrazioni spazio-temporali insite nel gioco del baseball e soprattutto nella narrazione, che viene perciò lanciata – come lo home-run – dal Prologo verso il suo svolgimento ‘a puntini’ nelle sezioni successive. L’intrigo di Underworld si origina dunque, dialetticamente, dal destino ambiguo e sfuggente di quest’oggetto, che nella realtà di quel 3 ottobre 1951 è semplicemente sparito, e che nella finzione del romanzo è però di volta in volta conquistato, trafugato, smarrito e recuperato, ed è perciò intriso di casualità, di ingiustizia, di perdita, di mistero (“se qualche tifoso avesse davvero saputo chi possiede la palla, come avrei potuto scrivere il romanzo?”; CH, p. 105); sorge da una non conoscenza che ne è, direbbe Henry James, il solo possibile ‘germe’; è chiamato a occupare un vuoto, a esporre un’assenza, ma anche a plasmare un pieno, a tessere un legame, a forgiare un linguaggio di “illuminazione”, di “rivelazione”. Di “devozione” (CH, pp. 110, 108). “Io scrivo per la pagina”, dichiara DeLillo senza mezzi termini (LeC, p. 13), e – ma solo in secondo luogo – per un lettore “anonimo che, in qualche cittadina anonima, abbia un’intuizione su certe [connessioni] nei miei libri”.58 E, ogni volta, scrivere si rivela una lotta, “una lotta contro il romanzo che non vuole rivelarsi, che rifiuta di lasciar schematizzare i suoi segreti” se non a tempo debito,59 se non nell’intimità spazio-temporale della configurazione narrativa. Occorre infatti saper aspettare, per avere “l’intuizione e il sentimento della forma” da cui può venire un romanzo “lungo, complicato, avvincente”, perché se “prima della storia, prima della politica viene il linguaggio” (M, p. 164), è proprio quest’ultimo – con i suoi ritmi e i suoi disegni – a rivelare il legame più profondo fra la realtà e il mestiere di scrivere.60 A tanto risponde per DeLillo la vocazione intermediale, tanto ‘visiva’ quanto ‘uditiva’, del romanzo, la sua capacità di “aggiustarsi attorno alla cultura contemporanea”, di avvolgere e incorpo58 Nell’intervista con Brigitte Desalm. Maria Nadotti, “An Interview with Don DeLillo” (1993), ora in DeP, p. 116. 60 Ricorda DeLillo: “Avevo cominciato [a scrivere Americana] da quasi due anni quando capii che ero uno scrittore – non perché pensai che il romanzo sarebbe mai stato pubblicato, ma perché frase dopo frase e paragrafo dopo paragrafo cominciavo a capire che possedevo delle abilità che nei lavori precedenti […] non avevo dimostrato” (DeC, p. 186). 59 DISEGNI E REALTÀ / 29 rare, amalgamandoli in capienti morfologie, “il saggio, la poesia, il film”.61 Una vocazione, questa, che tuttavia non nasce da una semplice accortezza tematica – dalla tempestività, pure innegabile, nel cogliere le sollecitazioni visive del mondo contemporaneo e dei suoi ‘simulacri’, dalla fotografia in Mao II alla televisione in White Noise, al world wide web in Underworld –, ma dall’antica malleabilità spazio-temporale riconosciuta nei paradigmi letterari da Kermode, Lotman e Ricoeur, dalla qualità al contempo visiva, uditiva, tattile del racconto di finzione: “c’è un elemento fisico nello scrivere. […] Non uso computer perché mi piace toccare la carta, fare correzioni a matita, conservare le pagine vecchie per tornarci in capo a un anno. […] Mi piace vedere le parole, le frasi, mentre prendono forma. È un fatto estetico. Quando lavoro ho un senso scultoreo della morfologia. [Perciò] uso una macchina da scrivere con tasti più grandi del normale, e più grandi sono, meglio è”.62 Che nasce, insomma, dalla qualità intersemiotica – dal “piacere sensuale” – di frasi e parole “finite, nitide, splendidamente formate” nella loro spazialità plastica,63 e al contempo ritmiche, costellate di “strane corrispondenze” temporali, musicali, che coinvolgono “non soltanto il loro significato, ma anche il suono e l’aspetto. Il ritmo di una frase può contenere un certo numero di sillabe. Una di troppo, e cambio frase”.64 Torniamo con ciò all’apologo che ha aperto questa riflessione. Nella realtà – di più: nell’universo –, scriveva Henry James, le connessioni non finiscono mai, e “lo squisito problema dello scrittore è, eternamente, […] quello di tracciare, con una propria geometria, il cerchio entro il quale esse sembreranno farlo”.65 Certo, lo scriveva a fine Ottocento e nemmeno, peraltro, con particolari intenti realistici. Eppure, nonostante la convinzione di molti, come recita il credo di DeLillo, la forma romanzo non 61 David Streitfield, “Don DeLillo’s Hidden Truths”, Washington Post, 11 novembre 1997, p. D1. 62 Maria Nadotti, op. cit., p. 117. 63 Adam Begley, “Don DeLillo: The Art of Fiction”, Paris Review, 35:128, autunno 1993, p. 297. 64 Maria Nadotti, op. cit., p. 117. Basti considerare la sonorità allitterante della prima frase di Underworld – “He speaks in your voice, American, and there’s a shine in his eye that’s halfway hopeful” – e ricordare, con Forster, che “l’occhio, con l’ausilio trasmutatore della mente, può raccogliere con facilità i suoni di un paragrafo […], se hanno valore estetico, e rinviarli al nostro piacere”. E.M. Forster, op. cit., p. 52. 65 Henry James, “Preface to Roderick Hudson” (1876), trad. it. di Agostino Lombardo, “Prefazione a Roderick Hudson”, in Id., Le Prefazioni, Roma: Cooper, 2004, p. 7. 30 / STEFANIA CONSONNI soltanto non è inadeguata a strutture, legami e rapporti sempre più ‘strani’, ma attraverso le sue connessioni – le sue costellazioni – saprà continuare a rinnovarsi.66 Perché è chiamata a dire la realtà con la finzione, e viceversa. Perché le restituisce con i suoi disegni molto più di quanto non le sottragga. Perché, come mostra Underworld, è votata all’astrazione più sofisticata e all’umanità più struggente, come se solo un’“anti-tecnologia” cristallina, impietosa, e al contempo esuberante, compromessa, piena di “passione, di eros, e di tutta la ricchezza del mondo naturale” (CH, p. 108), potesse restituire – con “astuzia e impertinenza” –67 l’ingenuità antica e artigianale del raccontare. 66 67 Kim Echlin, op. cit., p. 150. Walter Benjamin, op. cit., p. 267. § 2 Luca Berta Il neon di David Foster Wallace e il punto di vista dell’aldilà Provate a immaginare che io sia uno scarafaggio. Potrei raccontarvi la sensazione che si prova a possedere sei zampe, un esoscheletro, o un sistema nervoso assai più rudimentale di quello umano. Certo il tentativo di identificazione con il punto di vista dello scarafaggio, benché assai complicato, potrebbe condurre ad interessanti risvolti cognitivi, o dispiegare un suggestivo potere metaforico. Gli esempi non mancano in letteratura. Provate ora a immaginare che io muoia, e adesso sia morto. Tante volte una situazione di questo genere ci è stata presentata nei libri o nei film (dai poemi omerici al Sesto senso con Bruce Willis). Potrei raccontarvi cosa si prova, cosa c’è, chi si incontra, potrei fornirvi una miriade di dettagli senso-percettivi, trascinarvi lungo i sentieri della trascendenza, oppure dell’orrore. Tuttavia, non diversamente dal caso dello scarafaggio, rimarremmo nell’ambito della proiezione immaginaria, della metafora, dell’apologo magari consolatorio. Nulla riuscirebbe a scrostare dal nostro racconto quella patina di sapere di seconda mano, come la chiama Lévinas, che investe ogni discorso sulla morte. La differenza, in termini esistenziali, è piuttosto evidente: per ogni possibile narratore, diventare uno scarafaggio è impossibile, mentre morire è in via essenziale sempre possibile, in ogni momento – è il necessario. Nonostante questa differenza, le risorse narrative per affrontare i due casi sono le stesse: l’identificazione immaginaria, la fantasia, l’abilità metaforica. Non esiste altra esperienza accessibile all’uomo che veda limitata la sua narrabilità a questa sfera. Posso raccontare qualsiasi altro evento per averlo vissuto in prima persona, o per averlo raccolto da una terza persona come fonte, tranne la morte. La letteratura può raccontare ogni cosa, in un certo modo, ma la morte può essere raccontata solo nel modo delPARAGRAFO I (2006), pp. 31-52 32 / LUCA BERTA l’impossibile. Anzi, gli altri fatti impossibili paiono più comodi da raccontare: è più agevole tentare di immedesimarsi nel punto di vista di uno scarafaggio, per quanto alieno possa risultare, piuttosto che nel punto di vista del non esserci, del non essere al mondo. Questo significa che la morte, in quanto possibilità sempre presente, necessità – in quanto realtà – è il senza-racconto? Come trovare altrimenti il giusto punto di vista? Di conseguenza, allargando la prospettiva anche al di fuori del terreno esclusivamente letterario, la questione è se la morte, la morte di chi mi sta vicino, di chi ha convissuto, sia del tutto inaccessibile alla narrazione.1 La morte si situa in una dimensione senza linguaggio, condannata all’ineffabilità? Alcune opportunità di risposta vengono offerte dall’analisi di due diverse posizioni filosofiche. In primo luogo, l’analisi heideggeriana del fenomeno della morte, condotta in Sein und Zeit. Heidegger afferma che la morte non è un accadimento tra gli altri che si dispone lungo l’ordinaria sequenza cronologica, un accidente che non si è ancora presentato ma sopraggiungerà dall’esterno a interrompere una continuità ipoteticamente infinita. Un siffatto sentimento della morte, denuncia Heidegger, è del tutto inautentico. La morte invero, per questo carattere di ultimità ineliminabile, è un ‘non-ancora’ che incombe e al quale l’Esserci deve assiduamente rapportarsi secondo la struttura fondamentale della cura: l’essere-per-la-morte. L’uomo deve prendersi cura delle possibilità aperte dal suo essere (nel preoccuparsi di ciò che gli resta possibile è in gioco la sua esistenza stessa), dunque deve prendersi cura in ogni istante della morte che è la sua possibilità più estrema. Cioè la possibilità più propria, quella di non esserci più. Con la morte la tensione anticipatrice della cura si placa, e l’Esserci raggiunge la totalità autentica, l’ipseità. Di conseguenza la morte si offre come una sorta di esperienza sommamente esclusiva, propria nella misura in cui chiude il circolo dell’appropriazione delle possibilità di ciascuna esistenza. La morte è qualcosa di mio in senso assoluto, la morte vera è sempre la mia. Quella degli altri invece non offre nessuna esperienza effettiva: “Nei patimenti per la perdita del defunto non si accede mai alla perdita dell’essere qual è ‘patita’ da chi muore. Noi non sperimentiamo mai il morire degli altri”.2 Nella morte l’altro non c’entra, non c’è so1 Mi permetto di rinviare, per una trattazione più diffusa, al mio “Morte e racconto”, Il Verri, 17, novembre 2001, pp. 90-112. 2 Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), trad. it. di Pietro Chiodi, Essere e tempo, Milano: Longanesi, 1995, p. 294. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 33 stituzione, ed è precisamente questa insostituibilità a fondare la mia identità. Date queste premesse, è inevitabile rispondere che della morte non si dà alcuna possibilità di racconto: se la morte è solo la mia, non potrò mai raccontarla. Una prospettiva differente viene aperta dalle riflessioni di Lévinas. Il pensatore francese sostiene infatti che la morte dell’altro è la morte prima. Ovvero la morte dell’altro detiene un primato etico e cronologico che intacca in via essenziale anche la relazione alla mia morte. La morte si manifesta in primo luogo come morte dell’altro, del prossimo, che non risponde più. È il senza-risposta. Nella passività assoluta implicata dal trauma della morte dell’altro, io non pervengo a un sapere sulla morte – fosse anche un sapere sul nulla – ma esperisco l’effetto su di me, il sopravvissuto, da parte di ciò che non è più presente. Il senza-risposta dell’altro morto si fa esperienza perché diviene il senza-risposta della questione della morte, di cui io devo assumermi la responsabilità. L’altro non può rispondere, devo farlo io per lui, e questo compito mi individua nella mia singolarità. Anche per Lévinas la morte è ciò che non consente alcuna sostituzione, e consegna ciascuno alla sua individualità: ma si tratta della morte dell’altro, non della mia. Sono definito nella mia identità irrevocabile dalla responsabilità nei confronti dell’altro che muore, dal fatto di dover rispondere in prima persona per l’altro che non risponde più. La relazione alla morte dell’altro e la relazione alla mia morte non sono collegate da una procedura di identificazione, di sostituzione immaginaria. Il transfert dalla morte d’altri alla mia è invece costitutivo della mia stessa identità. Non c’è ‘io’ prima di questo appello irrevocabile che coincide con la morte dell’altro. In questo senso la prima persona trova la sua declinazione fondante non al nominativo, bensì all’accusativo della risposta: come Abramo che replica all’appello del Signore, “Eccomi!”. Se dunque la morte dell’altro non è un mero accidente, un analogo di ciò che accadrà a me, un fatto osservabile solo dall’esterno (vale a dire se è la morte, e non il decesso), allora il racconto della morte diviene possibile secondo modalità che travalicano quelle della relazione immaginaria. Certo non mancano né gli ostacoli né i rischi: di fronte all’impossibilità empirica di fare esperienza in proprio di essere altro e di essere morto, nasce l’esigenza di una finzione in cui la posizione dell’altro morto (che non può rispondere) mostra una terribile fragilità. Nel racconto sarà difficile resistere alla tentazione di ridurre l’altro a un caso, a un exemplum della morte, o persino a un simbolo, aggirando così il confronto con la sua al- 34 / LUCA BERTA terità e col suo insituabile punto di vista per tornare infine a se stessi, magari sotto le lusinghiere spoglie della consolazione. L’alterità è delicatissima da preservare, nell’istante in cui presto la mia voce all’altro, che non può rispondere. Ma cosa significa essere davvero un altro? Cosa si prova, tanto per fare un esempio, ad essere uno scarafaggio? e un pipistrello? Thomas Nagel, nel suo celebre articolo “What Is Like to Be a Bat”,3 impiega proprio quest’ultima domanda come un maglio per demolire alcune presunte certezze dei filosofi della mente riguardo la coscienza. Si riscontra una discreta unanimità, argomenta Nagel, sul fatto che i pipistrelli siano dotati di vita cosciente, benché la loro forma di coscienza sia poco assimilabile a quella umana. Ciò implica che ad essere un pipistrello si prova qualcosa. Ora, qualsiasi tentativo di comprensione oggettiva (a maggior ragione un atteggiamento di riduzione fisicalista) manca il bersaglio di questa domanda nella misura in cui trascura a priori la dimensione soggettiva di tale esperienza. Per spiegare un’esperienza cosciente non si possono escludere gli aspetti fenomenologici come si farebbe con quelli fenomenici, ovvero etichettandoli in quanto effetti sulla mente dell’osservatore, come di prassi nel corso di un esperimento scientifico. La coscienza è esperienza dal punto di vista soggettivo: se per comprenderla abolisce il punto di vista, non rimane nulla da comprendere. Si tratta della stessa fragilità cui accennavamo sopra: l’altro rischia sempre di essere ridotto a un qualcosa, di cui la mia immaginazione o la mia osservazione si farà carico come di un dato. E se anche sono così bravo da immaginare come potrebbe essere disporre dell’apparato senso-percettivo del pipistrello, “ne ricavo solo che cosa proverei io a comportarmi come un pipistrello. Ma non è questo il problema: io voglio sapere che cosa prova un pipistrello ad essere un pipistrello. Ma se cerco di figurarmelo, mi trovo ingabbiato nelle risorse della mia mente”.4 Non c’è scampo, l’altro è inaccessibile dal suo punto di vista. Nagel ne conclude che non sappiamo nulla di serio sulla coscienza, e che dovremmo forgiarci nuovi strumenti concettuali che non dipendano in via esclusiva dall’immaginazione, né tanto meno dall’osservazione oggettiva, poiché “ogni fenomeno soggettivo è sostanzialmente legato a un 3 Thomas Nagel, “What Is Like to Be a Bat” (1974), trad. it. di Giuseppe Longo, “Che cosa si prova a essere un pipistrello?”, in Daniel C. Dennett e Douglas R. Hofstadter (a cura di), L’io della mente, Milano: Adelphi, 1985, pp. 379-91. 4 Ivi, p. 382. 5 Ivi, p. 381. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 35 singolo punto di vista e pare inevitabile che una teoria oggettiva e fisica debba abbandonare quel punto di vista”.5 La letteratura in verità dispone di risorse che la smarcano agevolmente da quest’ultimo impaccio. La possibilità di abbracciare un punto di vista delineando i tratti di una soggettività è l’aspetto che contraddistingue la letteratura da ogni altro tipo di discorso. Nessun’altra tipologia testuale possiede una simile autorizzazione retorica all’adozione e variazione del punto di vista. Come nota icasticamente Kate Hamburger, la finzione narrativa offre l’unica dimensione cognitiva in cui l’Io-Origine (ovvero l’intersezione ‘io-qui-ora’ della soggettività) di una terza persona può essere rappresentata in quanto tale.6 Nella relazione pragmatica tra emittente e destinatario che presiede al racconto, l’altro di cui si parla può essere presentato nella sua soggettività, al punto che gli si può assegnare la posizione di riferimento ‘io-qui-ora’ e il punto di vista attraverso i quali viene filtrata la narrazione. Semmai il problema è quello di non sbilanciarmi sull’altro versante, cedendo tutto il campo all’immaginazione empatica, il che mi lascia imprigionato all’interno della mia mente. Non voglio sapere cosa provo io a essere un pipistrello, né mi interessa cosa provo a immaginare di essere al posto dell’altro che muore: voglio sapere cosa prova l’altro a morire. “Ma se cerco di figurarmelo – prosegue Nagel sul pipistrello – mi trovo ingabbiato entro le risorse della mia mente. Non riesco a uscirne né immaginando di aggiungere qualcosa alla mia esperienza attuale, né immaginando di sottrarle via via dei segmenti, né immaginando di compiere una qualche combinazione di aggiunte, sottrazioni, modifiche”.7 In effetti Nagel ha ragione nel sottolineare l’incapacità dell’identificazione immaginativa di uscire da sé per accedere alla mente dell’altro. Tuttavia va rimarcato un elemento: se anziché all’interno di una fantasia propria, mi trovo di fronte a un racconto, l’identificazione non è qualcosa che posso regolare a piacimento. Sono situato già fuori, in qualche modo. Non sono più solo nella mia mente ma in relazione a una traccia mentale altrui, il testo, che non controllo e che potrà condurmi ad un’esperienza non pianificabile, ad un incontro con un punto di vista che non avrei mai potuto originare in proprio. Come notano giustamente Dennett e Hofstadter, commentando l’ar6 7 Kate Hamburger, Die Logik der Dichtung, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1957. Daniel C. Dennett e Douglas R. Hofstadter (a cura di), op. cit., cit., p. 382. 36 / LUCA BERTA ticolo di Nagel, l’emulazione di un’altra mente crea un contesto mentale in grado di alterare tutta una serie ricorsiva di attivazioni di simboli (penso di essere un pipistrello, immagino di vedere come un pipistrello, forgio delle rappresentazioni basate su tali dati sensoriali ecc.), ma il processo non giunge mai al punto di annullare il simbolo del sé per farmi diventare l’altro. “L’unica cosa che Nagel non sembra aver riconosciuto – concludono i due – è che il linguaggio (fra le altre cose) è un ponte che ci consente di penetrare in un territorio che non è il nostro”. Grazie al linguaggio possiamo fare l’esperienza di cosa si provi ad essere un altro, seppur in maniera mai assoluta. Né d’altronde so mai cosa si prova in assoluto ad essere me, se non me lo dico in qualche modo: “È il linguaggio che ci caccia in questo problema (permettendoci di vedere la questione) e che ci aiuta anche a uscirne (in quanto è un mezzo universale di scambio di pensieri, che consente di rendere condivisibili e più oggettive le esperienze). Tuttavia esso non può farci arrivare fino in fondo”.8 Il linguaggio ci mette nella situazione paradossale di poterci chiedere cosa si prova a essere l’altro, di poter concepire l’accesso all’altro senza mai poterlo detenere. Non posso mai essere l’altro, e meno che mai l’altro morto, che non risponde più. Ma proprio per questo devo essere io a prendere la parola e rispondere per lui, per lei, sfidando l’aporia. “Io sono morto”: ma se parlo, non sono davvero morto, e se sono morto, non dovrei parlare. È questo il paradosso, la contraddizione performativa di cui ogni possibile racconto della morte dell’altro deve farsi carico, se non intende ridurre l’altro al semplice oggetto di un discorso, la sua morte a un passaggio verso un al di là immaginario, e ridursi di conseguenza ad un esercizio di fantasia, o di consolazione. Caro vecchio neon, il racconto di David Foster Wallace uscito nel 2004, non si concede nemmeno un istante prima di ingaggiare il corpo a corpo con la dimensione della paradossalità e della contraddizione performativa. Chi parla, verremo informati tra poco dalla sua stessa voce, è morto. Ed esordisce così: “Per tutta la vita sono stato un impostore [a fraud]”.9 Co8 Daniel C. Dennett e Douglas H. Hofstadter, “Riflessioni”, in Dennett e Hofstadter (a cura di), op. cit., pp. 401, 402. Dennett e Hofstadter suggeriscono peraltro che il teorema di Gödel sia un corrispettivo matematico di questa impossibilità. 9 David Foster Wallace, “Good Old Neon”, in Id., Oblivion (2004), trad. it. di Giovanna Granato, Oblio, Torino: Einaudi, 2004, p. 169. Da qui in avanti si rimanderà alle pagine di quest’edizione. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 37 me ovvio, un’affermazione del genere complica alquanto il patto narrativo, e fin dalla soglia di ingresso del testo problematizza la suspension of disbelief normalmente richiesta. È una sorta di appello in negativo al destinatario affinché non lasci filtrare alcuna informazione infondata sotto l’influsso di un patto ingenuo. “Ho praticamente passato tutto il mio tempo a creare un’immagine di me da offrire agli altri” (p. 169). Inevitabilmente, data la collocazione liminare dell’enunciato, non si può fare a meno di riferirlo non solo al carattere del personaggio che si autodescrive, ma anche al suo ruolo di narratore. Ogni narratore, in una certa misura, impiega il suo tempo per creare l’immagine di un sé, un punto di vista (in prima o in terza persona), da offrire al lettore, e di conseguenza risulta un impostore. Siamo avvisati, dunque: chi parla non cerca un gioco facile. Neal, così rivelerà di chiamarsi chi parla, prosegue fornendo alcuni esempi di questa propensione all’impostura, che non gli consente di godere pienamente, come soggetto, di nessuna esperienza: Ricordo di essermi trovato sul sofà della sala svaghi nello scantinato di Angela Mead e di averla convinta a lasciarmi infilare una mano sotto la camicetta e di non aver neppure sentito per davvero la morbida vivacità o quello che era del suo seno perché non facevo altro che pensare: “È a me che Angela Mead ha permesso di andare in seconda base”. Una cosa così triste, a ripensarci. (p. 169) Una incontrollabile alienazione del sé è perennemente in agguato. Come se Neal fosse sempre sdoppiato in un’altra persona che si osserva, e deve offrire una convalida a ciò che gli accade in prima persona: “non riuscivo a vedere niente se non come sarei apparso ai suoi occhi” (pp. 169-70). Eppure Neal pare genuinamente dispiaciuto di questo suo atteggiamento, perciò dopo un’inverosimile sequela di tentativi che spaziano dall’elettroshock-terapia alla massoneria al sesso sfrenato, decide di affrontare un percorso psicoanalitico. La situazione pragmatica generale è questa: Neal parla, funge da narratore in prima persona, e si dichiara un impostore rivolgendosi direttamente a un tu: “Ci siamo capiti” (You get the idea, p. 169). Un narratario viene chiamato in causa senza mezzi termini, ma il suo statuto resta indefinito. Dove ci troviamo? Qual è il contesto comunicativo specifico? Il tu interpellato è un personaggio che apparirà, o rappresenta il destinatario generale del racconto, ovvero sono io che leggo? Il successivo riferimento esplicito a questa seconda persona non scioglie certo l’enigma, poiché 38 / LUCA BERTA coincide con l’impossibile prolessi della morte del narratore, e proietta la situazione pragmatica in un tempo e un luogo di cui non si riesce ad immaginare l’estensione: “A proposito, lo so che questa parte è noiosa e probabilmente ti annoia, ma si fa assai più interessante quando arrivo alla parte in cui mi uccido e scopro quello che succede subito dopo che una persona muore” (p. 169). Senz’altro David Wallace non ha timore di alzare la posta in gioco. Una promessa narrativa di tale portata è ardua da soddisfare: io destinatario avrò pazienza durante le sequenze noiose, ma alla fine pretenderò il mio premio. Questa cornice pragmatica di dialogo tuttavia non si attesta in modo definitivo, ma tornerà in maniera intermittente, e con sempre maggiore frequenza all’approssimarsi della fine. Nell’immediato invece pare cedere la scena ad un altro contesto di riferimento, attorno al quale vengono organizzate le sequenze narrative e gli ancoraggi temporali. Si tratta del setting psicoanalitico con il dottor Gustafson. Inizialmente Neal ostenta durante le sedute una grande franchezza, che in verità è una copertura studiata per anticipare le mosse ermeneutiche del dottore e fargli capire retrospettivamente che Neal era già consapevole del suo problema: l’impostura. Neal ha bisogno di aiuto, lo riconosce, ma non può fare a meno di comportarsi da impostore. Ecco il punto: la consapevolezza non salva. E infatti quando Neal decide di rivelare la sua impostura al dottor Gustafson, e di confessare che inizialmente lo aveva ingannato per anticiparlo, in realtà non sta facendo altro che aggiungere un nuovo livello di impostura: “quella era la prima volta che sorrideva come un essere umano durante una normale conversazione. Eppure al tempo stesso avevo già capito a cosa mi esponevo… e infatti lui si buttò a pesce” (p. 174). Al pari di un abile truffatore, Neal gli sta già offrendo gli elementi per una nuova conclusione che si troverà già ad aver anticipato, e smentito. Si sa: non si è mai così esposti all’inganno come quando si crede di averne appena scoperto uno, di detenere la visione più ampia e certa. “Ero ragionevolmente sicuro che avrebbe detto qualcosa tipo: – E allora come ha fatto a fare quello che ha fatto un attimo fa? – come per dire che per essere un impostore ero bravissimo a essere onesto riguardo all’impostura, come per dire che era convinto di avermi beccato in una specie di contraddizione logica o paradosso” (p. 175). A questo punto Neal procede con l’esposizione del vero paradosso logico che gli pare descrivere, con la sua infernale ricorsività, lo stallo emo- IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 39 tivo in cui si trova. È il paradosso dell’impostura, che Neal ha formulato mentre seguiva un corso di logica matematica. Il paradosso funziona così: più ti sforzi di affascinare gli altri, meno ti trovi affascinante, perché sei un impostore. E quanto più ti senti un impostore, tanto più devi ricorrere all’impostura per affascinare gli altri ed evitare che si accorgano della tua natura di impostore. Ancora una volta, essere sufficientemente intelligenti da pervenire ad una visione certa (ma non è qui che ci si inganna?) del proprio stato, non conduce ad alcuna salvezza. Nessuna laminazione ulteriore fa regredire all’autenticità. Neal riporta un caso di menzogna della sua infanzia, legato alla sorella Fern. Riaffiora qui per un istante la cornice pragmatica del dialogo io-tu: “Non dimenticare che avevo solo quattro anni” (p. 178). Ma poi, dopo aver completato il resoconto dell’episodio, le coordinate spaziotemporali della narrazione vengono riproiettate sulla dimensione puntuale del setting: “il punto è che tutto questo e altro ancora mi passava per la testa nell’intervallo della breve pausa a effetto che il dottor Gustafson si concedeva prima di formulare la sua grandiosa reductio ad absurdum […]. So che tu sai bene quanto me come i pensieri e le associazioni mentali attraversino fulminei la testa” (p. 180). Se ne ricava l’impressione che le due cornici pragmatiche siano una incastonata nell’altra, non soggette a una stringente gerarchia di dipendenza temporale, e i contenuti narrativi possano sbocciare indifferentemente innestati sull’una o sull’altra, al pari di pensieri fulminei, lampi di narrazione puntiformi, senza reale estensione cronologica. Non bisogna dimenticare che la prolessi sulla morte di Neal ha già individuato un segmento temporale ulteriore, incollocabile, rispetto al quale tuttavia ogni altro deve porsi in relazione di anteriorità. Ecco dunque che Neal passa ad illustrare “un altro paradosso”, che affetta precisamente il nodo della relazione tra linguaggio e tempo. Il fatto è che i pensieri e le intuizioni fondamentali spesso balenano nella mente secondo una temporalità che non mostra nulla in comune con quella cronometrica delle azioni quotidiane: “hanno così pochi legami con quella lingua lineare, fatta di tante parole messe in fila, necessaria a comunicare fra di noi, che dire per esteso pensieri e collegamenti contenuti nel lampo di una frazione di secondo richiederebbe una vita intera ecc” (p. 180). Eppure tutti usiamo quella lingua tutti i giorni, nonostante siamo consapevoli che si tratta di un’impostura. Peraltro, ci rivela Neal (le cose cominciano a farsi interessanti), “[l]a velocità mentale intorno a quello che 40 / LUCA BERTA è di queste idee o ricordi, percezioni o emozioni e via dicendo è perfino più veloce – esponenzialmente, inimmaginabilmente più veloce – in punto di morte, cioè durante quel nanosecondo così minuscolo e sul punto di sparire che separa il momento in cui si muore tecnicamente da ciò che avviene subito dopo”. Qualcosa in più rispetto al luogo comune delle immagini della tua vita che ti scorrono in testa in un baleno: la morte comporta un tempo indescrivibile, senza successione e senza discontinuità tra istanti. “Ma non è affatto così. Non mi viene in mente un modo migliore per dirlo se non che succede tutt’a un tratto, ma questo a un tratto non significa certo un momento finito di tempo all’interno di una sequela ininterrotta nei termini in cui consideriamo il tempo quando siamo vivi”. Il tempo cronologico e il linguaggio lineare, sostiene Neal, sono corresponsabili di una mistificazione a proposito di ciò che accade “a livello elementare”. Ciononostante, Neal lo aveva già anticipato, questo linguaggio costituisce l’unica risorsa che abbiamo “per capirlo e per cercare di instaurare qualcosa di più vasto o più significativo e vero con gli altri, il che è un altro paradosso” (p. 181). La lingua è impostura, ma è l’unica strada verso il vero. Genera equivoci essenziali, ma questo non ci esime dalla responsabilità di impiegarla nella relazione con gli altri. Si annida qui la definitiva contraddizione performativa – parlare per affermare l’impossibilità di dire, di dire la verità di un tempo che non è quello in cui si srotola il linguaggio. C’è da scommettere che neanche stavolta Neal si lascerà cogliere in castagna. Da chi? Da me, vale a dire il ‘tu’ al quale torna a rivolgersi, delineando ora (ora? il presente della narrazione è ciò che risulta in questione) più nel dettaglio la cornice pragmatica: E naturalmente a questo punto avrai notato quella ha tutta l’aria di essere il paradosso centrale, che abbraccia tutto, e cioè che questa cosa dove io dico che le parole non bastano e il tempo in realtà non procede in linea retta è una cosa che tu senti a parole e per capirla devi cominciare ad ascoltare la prima parola e poi tutte le altre in fila in ordine cronologico, perciò se dico che le parole e il tempo cronologico non hanno nulla a che farci tu ti chiederai perché siamo seduti in questa macchina usando le parole e consumando il tuo tempo sempre più prezioso, nel senso che non è che mi starò contraddicendo sul piano logico fin dall’inizio. Ne va qui dell’esistenza stessa del narratore, della narrazione: “E poi come farei a sapere quello che succede, magari dico un mucchio di stronzate – se mi fossi ammazzato per davvero, come faresti a sapere certe cose? Nel senso che sono un impostore” (p. 182). Poiché impiega il linguaggio, il IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 41 narratore – che è morto, e sa cosa succede veramente – è un impostore. Che si tratti di Neal o di chi parla per lui. Se fosse un narratore onesto, non userebbe le parole per chiamarmi, ‘tu’, non consumerebbe il mio tempo (cronologico?). Cioè non racconterebbe niente. Un narratore morto onesto è un non narratore, ovviamente. Deve trattarsi di un caso di impostura. Certo qualcuno lo aveva già anticipato. A questo punto il quadro di riferimento torna ad essere quello delle sedute dal dottor Gustafson, seppur stavolta considerate in una dimensione iterativa. Su questo sfondo si innesteranno diverse digressioni, che riguardano la sorella Fern (Neal le vuole molto bene, tanto da trovarla “ammaliante”, attractive in a sort of witchy way, p. 183), i ricordi dell’antico amore per il baseball (quando si entusiasmava per l’odore dell’erba, e del vapore mentre stirava la sua divisa da gioco), la fascinazione per la chiesa carismatica, il corso di meditazione, un sogno, l’ambiente lavorativo. Tutto questo dopo che Neal è tornato ancora una volta al momento in cui l’analista proferisce la sua corriva reductio ad absurdum, in virtù della quale un totale impostore non avrebbe potuto confessare la sua impostura ed essere perciò onesto come Neal un attimo fa. Dunque Neal aveva ragione, il dottor Gustafson cade nel tranello, e Neal ne rimane in un certo senso amareggiato. In fin dei conti vorrebbe che il dottore opponesse una resistenza, e non risultasse così facilmente manipolabile: “Un corollario del paradosso dell’impostura è che vuoi raggirare chiunque incontri eppure al tempo stesso in qualche modo speri sempre di imbatterti in un tuo pari che ti tenga testa e non si lasci raggirare” (p. 185). Attenzione. Qui suona un campanello di allarme. A chi sta parlando Neal? Si tratta di una seconda persona generica, o si rivolge proprio a me, come nel paragrafo successivo, dove rispunta la cornice dialogica?10 Forse sono io l’impostore, quello che tenta sempre di anticipare le mosse dell’altro, al pari di Neal, e spero che Neal resista e mi sorprenda: questo sarà il mio premio. Oppure Neal mi sta mettendo in guardia, che almeno io non mi faccia raggirare con la deprimente facilità del dottor Gustafson. Ogni volta che viene sbandierato un paradosso sull’impostura (la narrazione) o la temporalità (il linguaggio lineare), lo statuto dell’intero racconto viene messo in questione. E non potrebbe essere diversamente nel caso di un racconto in cui il narratore afferma io sono morto. 10 “Tutto questo sarà anche tedioso e lacunoso, ma almeno ti stai facendo un’idea” (p. 185). 42 / LUCA BERTA Ma non mi lascerò ingannare dal fatto che Neal mi mette in guardia, sbattendomi in faccia i paradossi. Forse si sta solo schermendo come narratore davanti al ‘tu’, per poi anticiparlo un’altra volta – nella morte? – e sorprenderlo. Se non mi lascerò ingannare, tuttavia, vuol dire che seguo gli avvertimenti di Neal, che dunque mi avrà di nuovo anticipato. Torniamo alle sedute con il dottor Gustafson, che ha la mania di lisciarsi i baffi come per ottenere la conferma che ci siano ancora, con tutte le connotazioni sessuali del caso. A Neal questo fatto non sfugge: quando il dottore vuole suggerirgli che alla base del suo disagio si trova una falsa idea di mascolinità e dominio instillata dalla cultura americana, Neal intuisce che il dottore sta parlando in primo luogo di se stesso. La discussione prosegue, seppur interrotta a tratti dai ricoveri del dottor Gustafson, al quale hanno diagnosticato un cancro al colon. Anzi, il dottore potrà in seguito gettare una luce retrospettiva sul dibattito: “Io e il dottor Gustafson ci siamo fatti una bella risata dopo essere morti tutti e due, quando eravamo fuori dal tempo lineare e nel corso di un cambiamento drastico, puoi scommetterci. (A proposito, fuori dal tempo non è soltanto un’espressione o un modo di dire)” (p. 195). Comunque l’incapacità di amare del maschio americano finisce per rivelarsi come la chiave di lettura più promettente. Per la prima volta Neal percepisce un sollievo, un frammento di speranza. È in quello stesso periodo, però, che prende la risoluzione di suicidarsi. Neal avverte che le spiegazioni si mostreranno inevitabilmente semplificate, altrimenti, lo sappiamo, ci vorrebbe un tempo infinito per rendere conto di quanto ha avuto luogo nella sua mente. Non è che le parole e il linguaggio umano smettano di avere significato e importanza dopo la morte, peraltro. È più la disposizione temporale specifica, fatta di una cosa dopo l’altra, a risentirne. O forse no. […] Tutte le diverse parole ci sono sempre, ma non è più un problema di quale venga prima. […] Oppure immagina che tutto quello che è stato detto e anche pensato al mondo da chiunque che crolla ed esplode in un unico suono vasto, congiunto, istantaneo – anche se istantaneo è un po’ fuorviante, dato che implica altri istanti prima e dopo, e non è affatto così. (p. 199)11 A dire il vero la molla decisiva verso il suicidio pare tanto precisa quanto insulsa: nel corso di un telefilm, Neal coglie la battuta di un personaggio 11 Il modo migliore per descrivere tutto questo, secondo Neal, sarebbe usare il simbolismo logico, che è estraneo alla nostra nozione i tempo. La logica, altro linguaggio, “È la cosa più vicina a come è realmente” (p. 200). Per questo i paradossi logici fanno diventare matti e, aggiunge Neal, molti grandi logici si sono non a caso suicidati. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 43 di professione analista, che si lamenta degli yuppie che frignano perché non riescono ad amare. Neal si sente smascherato dal luogo comune da strizzacervelli, inchiodato dalla banalità alla sua ultima impostura. Probabilmente al ‘tu’ cui Neal si rivolge tutto questo sembra tutt’altro che condensato e semplificato, quanto piuttosto un differimento dell’istante cruciale, che non è ancora giunto benché definisca il presente in cui siamo (io e tu) e allo stesso tempo sia collocato cronologicamente nel passato: “tu penserai questo tizio non fa che tirarla per le lunghe, perché non arriva alla parte in cui si ammazza e spiega o giustifica perché è seduto qui accanto a me in questo bolide a raccontarmi tutto questo se è morto nel 1991” (p. 202). Ci siamo quasi, però. La mattina, prima di prendere un barbiturico, salire sulla sua auto e lanciarsi contro un pilone di cemento, Neal impiega un paio d’ore per scrivere un biglietto alla sorella Fern. La scrittura si offre come uno spazio privilegiato, una volta tanto, per esprimere sinceramente il suo affetto, scusarsi per il gesto e chiarire con franchezza alcuni episodi del passato. Come commenta Neal tra parentesi (e le parentesi sono una sorta di riserva protetta dell’autenticità lungo tutto il racconto, quasi confessioni post eventum), “[s]i scopre così che un biglietto di suicidio ti dà modo di discutere cose che in altri frangenti sembrerebbero troppo stonate” (p. 204). Neal torna con la memoria ad alcuni casi di crudeltà adolescenziale nei confronti di Fern, ma si affretta a rassicurarla di non aver nutrito eccessivi sensi di colpa che possano motivare il suo gesto estremo. “Mi limitai a dire, senza minimamente scendere nei particolari come ho fatto con te (perché lo scopo della lettera era naturalmente tutt’altro), che mi uccidevo perché ero una persona fondamentalmente disonesta” (p. 206). La verità come ovvio dipende dall’impostura, e implica che la scrittura (forse sono la stessa cosa in una certa misura) non sia lo spazio dell’autenticità, ma solo la ribalta per l’ennesima recita, in cui l’impostore si fa compiangere per essersi smascherato. Un altro campanello che attraversa la cornice pragmatica: la scrittura non salva, sono avvisato, ‘io’. Neppure quella che è indirizzata a me, come un biglietto dall’aldilà. Il passo successivo, quello di anticipare Fern, viene da sé: nel caso Fern dovesse pensare che Neal è troppo duro con se stesso, “allora doveva sapere che ero già consapevole che il mio biglietto avrebbe suscitato in lei proprio quella reazione, e probabilmente avevo elaborato il testo di proposito in modo da provocare almeno in parte proprio quella reazione” (p. 206). Nella scena della scrittura il processo di alienazione e impostura non 44 / LUCA BERTA solo permane, ma addirittura si complica, originando un elemento in più, un resto che darà luogo alla scena successiva. Sdoppiamento che produce un terzo: una parte di Neal scrive il biglietto con presunta sincerità, un’altra avverte l’impostura di anticiparne le reazioni, “mentre un’altra parte ancora osservava la scena di un uomo in camicia elegante e senza cravatta seduto nell’angolo della colazione a scrivere una nota accorata nell’ultimo pomeriggio che gli restava da vivere” (p. 209). È una sorta di fantasma, che “aleggiava su di me un po’ a sinistra” valutando la scena in termini teatrali: sarebbe una scena bella e sincera se l’inflazione di scene simili a teatro e nei libri non la rendesse stucchevole e poco avvincente, benché (paradossalmente, certo) a teatro e nei libri si trovino tante scene simili proprio perché “permettono di comunicare realtà emotive complesse e molto profonde che è quasi impossibile esprimere in altri modi”. Questo è il motivo della presenza della “scena madre [climactic scene] di scrivere” (p. 210), come la chiama Neal. Dunque nella scrittura c’è un altro che guarda, non siamo più solo io (sdoppiato) e te.12 Ma ora torniamo a noi due. Dobbiamo cercare di non fare confusione: l’irruzione di questo terzo sembra innescare un circuito di scambio tra posizioni. Siamo giunti finalmente al momento tanto atteso. Ci troviamo nell’auto, in Lily Cache Road, sono quasi le 9.17 durante una serata estiva densa di umidità che si leva dai campi. La visibilità non migliora se accendi gli abbaglianti. Chi li accende? Tu, il solito tu generico – è sempre così quando c’è nebbia: “Puoi cercare di usarli lo stesso per vedere cosa succede, ma quelli illuminano la nebbia facendola sembrare ancora più fitta” (p. 211). Il punto è che ci siamo solo noi due in macchina, e Neal pare avercela proprio con me. Non solo, Neal mi parla come se fossi proprio io quello che sta per andare a schiantarsi contro un pilone: “Bene – e c’è la costruzione e l’involucro TYVEK che sbatacchia contro le case dove se lo farai per davvero non vedrai nessuno andarci ad abitare. Anche se non farà male, sarà una cosa istantanea, questo posso assicurartelo”. Sono io che sto per morire, forse sono sempre stato io, il tu era una parte di me senza contenuto effettivo. Un tu impostore. Ma in questo spazio vuoto ogni ‘tu’, ogni possibile destinatario ha potuto prendere posto, assumere il punto di vista dell’altro senza cancellarlo – anche nella morte – e scoprire che si trattava di lui, di me. Qui accade la possibilità 12 Per la verità c’è un altro ancora nella scena, che sembra ricongiungersi circolarmente alla prima persona. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 45 del transfert dalla morte dell’altro alla mia, senza il quale non c’è relazione alla propria morte. Io sono tu, e posso fare esperienza della morte solo nella misura in cui assumo il tuo punto di vista perché tu mi avrai anticipato. Tu, Neal, e lo so che per questo sei un’impostore, e anche che è una finzione perché me ne parli nel linguaggio lineare, e che perciò la questione è tutt’altro che chiusa. Come posso fidarmi che tu racconti davvero come sei morto? che tu abbia fatto esperienza della morte in prima persona, e ora possa dirmelo? Bene, e siamo arrivati a quanto ti avevo promesso facendoti un riassunto noiosissimo di quello che c’è voluto per arrivarci senza perdere la fiducia. Cioè com’è morire, che cosa succede. Giusto? È quello che vogliono sapere tutti. Anche tu, dammi retta. Che ti decida ad andare sino in fondo o meno, che io ti dissuada in qualche modo come pensi che cercherò di fare o meno. Intanto, non è come si pensa. La verità è che sai già com’è. Conosci già la differenza fra l’ammontare e la velocità di tutto quello che ti balena dentro e quella parte infinitesimale e inadeguata che riusciresti a comunicare. (p. 211) Il punto è che so già com’è, perché la morte stessa è il paradosso, è l’esperienza del paradosso. L’impossibilità di racchiudere il vero e il tempo nel linguaggio (come un’enorme stanza piena che dovesse essere spremuta fuori dal buco della serratura), e la necessità di dire tutto ciò ora, a parole. Le parole sono queste, del racconto di Neal che si rivolge a te, e io sono quel ‘tu’. E l’ora, qual è? La stato, “dopo la morte di quello che ritieni essere te” (p. 212), sarebbe questo dischiudersi assoluto del tempo, in cui ogni istante della vita esplode dentro l’altro in una compresenza infinita che si lascia esprimere tutta in una volta. Tu con precisione cosa pensi di essere? I milioni e i bilioni di pensieri, ricordi, giustapposizioni – anche i più folli, come questo, penserai – che ti balenano nella mente e scompaiono? Una loro somma o rimanenza? La tua storia? Lo sai da quanto ti vado dicendo che sono un’impostore? Ricordi che stavi guardando l’orologio RESPICE FINEM appeso allo specchietto retrovisore che segnava le 9.17? E cosa stai guardando adesso? Coincidenza? E se il tempo non fosse passato? (p. 212) Quel tempo, in cui ‘tu’ stavi guardando l’orologio ereditato dalla matrigna, è questo stesso tempo in cui lo stai guardando, come se il tempo fosse bloccato, o viceversa assolutamente aperto nella sovrapposizione degli 46 / LUCA BERTA istanti. Io, l’io del narratore, è lo stesso che tu, che stai per morire, e quel tempo è lo stesso di questo tempo. Il tempo e l’altro divengono, forse solo per un istante trafitto dalle pieghe della scrittura, accessibili nel transfert. Certo non siamo al di fuori della lingua organizzata, nell’esprimibilità assoluta e contemporanea che saprebbe contenere il lampo. “Eppure [And yet]”, eppure non abbiamo altro che questa lingua, e dobbiamo usarla. Anzi, proprio per il fatto che nell’accostarci alla morte dell’altro – che è apertura infinita – rimaniamo nella strettoia del linguaggio lineare, possiamo fare esperienza del “paradosso centrale” (p. 182). Paradosso che, stando a quanto suggerisce Neal, è la dimensione essenziale della morte, il motivo per cui sappiamo già com’è. Il linguaggio è già esperienza della morte.13 Peraltro alla fine del paragrafo sopra citato, dopo la frase “E se il tempo non fosse passato”, accade un fatto che non ha precedenti nel racconto. Cioè appaiono un rimando e la correlativa nota, il che introduce per la prima volta una voce diversa da quella di Neal. È come se la nota di Wallace, o chi per lui, aprisse una botola che rivela un’intercapedine, la cui portata si estende all’indietro, avviluppando tutto il discorso di Neal. Una botola simile si sarebbe potuta aprire anche in precedenza, facendo emergere un’altra voce dietro la sua: ma allora era una sorta di play-back, e quella di Neal era una voce da impostore? Era già chiaro, no? E la nota, di cosa parla? Del tempo. David Wallace cita i paradossi che contaminano la nostra esperienza del tempo (come la nozione di velocità del tempo), e per illustrarli impiega la metafora del presente come una macchina (“questa macchina”, quella di Neal), che sfreccia sulla strada del tempo fendendo la nebbia del futuro. La conclusione più logica è che non ci sia affatto movimento. Ne deriva il dubbio di Wallace: “E se tutto questo si svolgesse in quel baleno che chiami presente, questa prima, infinitesimale frazione di secondo dell’impatto quando il paraurti anteriore dell’auto in corsa comincia a toccare la spalla del ponte […]?” (p. 213n). L’ipotesi di Wallace, che tutto quanto precede sia l’esplicitazione temporale di un istante immobile tra la vita e la morte, pare francamente riduttiva rispetto alla mobilità paradossale del tempo configurato dalla narrazione di Neal. Questo però dà agio a Wallace di procedere con una scenografica descrizione (sempre in seconda persona) del momento in cui il paraurti si ac13 Mi permetto di rinviare nuovamente, per ulteriori esplicitazioni, al mio articolo citato in principio. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 47 cartoccia e il piantone dello sterzo ti rimbalza nel petto. Un momento infinito, in cui l’intera esistenza e ogni sua possibile concezione “ha il tempo di balenare come il neon in forma di lettere corsive unite come quelle che le insegne e le vetrine amano tanto usare tutte assieme nella tua mente nell’istante letteralmente incommensurabile fra l’impatto e la morte, proprio mentre muovi incontro al volante a una velocità che nessuna cintura al mondo potrebbe frenare – FINE”. Wallace sembra quasi suggerirci intenzionalmente che questo era il finale originale del racconto. Mettetelo di seguito dietro alla frase del rimando a nota, e tutto fila, con la scena suggestiva che chiude proprio sull’istante che precede l’annichilimento, del personaggio quanto del racconto stesso “– FINE”. Ma qualcosa non quadra. Far convergere tutto nella semplice immobilità dell’attimo cruciale significa ricondurre l’intero discorso sulla morte e la sua paradossalità alla dimensione del decesso – che è sempre decesso di qualcuno, di qualcun altro. Manca qualcosa. Mi immagino Wallace che si arrovella su cosa ha lasciato fuori, e decide a un tratto di trasferire questo finale in una nota, aprendo la botola dell’altra voce sotterranea per fare spazio. A chi? A colui che ha dovuto prestare la sua voce a chi non poteva più rispondere. Forse quello stesso altro in più che osservava la “scena madre della scrittura”. Anche Wallace doveva sentirsi osservato mentre scriveva, e magari si chiedeva: – Sono un impostore? Dopo la scena della scrittura, la scena dello scrittore. Perciò dopo il rimando a nota, il racconto prosegue così, sopravvivendo alla sua “– FINE”: “La verità è che questo tu l’hai già sentito” (p. 212). Lo so già, lo conosco, è il paradosso. E cioè, continua la voce, il fatto che l’infinità ricorsiva dell’universo interiore non può essere mostrata. “La realtà è che morire non è brutto, ma dura per sempre. E per sempre non rientra nel tempo. Lo so che sembra una contraddizione, o magari un gioco di parole. In realtà si tratta, a ben vedere, di una questione di prospettiva” (pp. 213-14). È una questione di prospettiva, che va allargata per includere altri punti di vista. Bisogna distogliere gli occhi dalla scena per osservare la cornice, considerare il contesto più largo per non farsi raggirare, o per non raggirare se stessi. Wallace non vuole farsi raggirare dalla sua abilità nel produrre una finzione che assuma il punto di vista dell’altro. Di conseguenza può solo includersi, un altro in più, nella scena, per anticipare la finzione proprio quando stava per chiudersi nel giro perfetto dell’illusione: illusione che fosse davvero Neal, l’altro morto, a parlare. 48 / LUCA BERTA Dal quadro d’insieme [big picture], come si suol dire, risulta che tutto questo apparentemente interminabile andirivieni fra noi due ha fatto avanti e indietro nello stesso istante in cui Fern mescola una pentola che bolle sul fuoco per il pranzo, e il tuo patrigno […], e Angela Mead […], e David Wallace sbatte le palpebre mentre sfoglia oziosamente le foto dei corsi sull’annuario scolastico della scuola superiore Aurora West del 1980 e vede la mia foto e cerca, attraverso il piccolissimo buco della serratura di se stesso, di immaginare cosa possa essere successo per portarmi a morire tra le fiamme nell’incidente d’auto di cui aveva letto nel 1991. (p. 214) Ma certo, era prevedibile. David Wallace, ecco chi c’era dietro. Suona persino un po’ spiacevole sentirselo dire, arrivati a questo punto. Tutto questo, l’intero racconto, non è che il prodotto di un istante del pensiero di Wallace. È lui che esperisce il paradosso: “con David Wallace che si ritrovava ad avere una serie immensa e impossibile da organizzare di pensieri, sensazioni, impressioni e ricordi legati al tizio sulla piccola foto” (p. 214). È lui che giocava a baseball, stirava la divisa prima della partita, aveva problemi con l’idea di maschio americano e trovava Fern “così ammaliante” (witchily pretty, p. 215). Era lui il vero impostore. Questo istante lungo un battito di ciglia è sufficiente per rendere falsa la voce di Neal (in verità ci aveva sempre messo in guardia) nell’istante stesso in cui sembrava, paradossalmente, essere proprio lui. E invece no, era un altro (anche se ognuno può avere in sé degli altri che lo osservano, magari mentre scrive). Qui Wallace fa un passo indietro e dichiara la sua alterità rispetto a Neal. Così facendo, mette a repentaglio la sua finzione, scardina l’efficacia della simulazione mentale ricorsiva ricalcata sul punto di vista dell’altro morto. Ma allo stesso tempo, ne custodisce l’alterità: sì, era veramente un altro, e se non lo riconosco, rischio di assorbirlo, di assimilarlo a me stesso, di farne un alter ego. Invece no, era l’altro, autenticamente, cui ho prestato la voce perché è morto e non risponde – per questo non posso fare a meno di includermi nella sua morte. Ecco perché Wallace si include nella scena, nel ‘quadro d’insieme’, in cui presta la voce all’altro. Se lo fa solo qui, non è a causa di esigenze di manipolazione o di illusione scenica, quanto per rispettare una precedenza non meramente cronologica. Nell’istante in cui Wallace sbatte le palpebre, Neal sarà già morto. La morte dell’altro viene prima, come sostiene Lévinas, nel senso che nella responsabilità verso l’altro morto vengo individuato (passività assoluta) nella mia singolarità insostituibile. Cioè trovo la mia voce perché è lui che mi chiama: ‘tu’. Ovvio, è la voce di Wallace che fin dal principio del IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 49 racconto si nasconde nella botola dietro a quella di Neal. Ma se Wallace prende la parola, e scrive, è in risposta all’essere morto – senza-risposta – di Neal. Al fatto che la piccola foto sull’annuario non può dire nulla. Perciò Wallace si include qui, come partorito solo alla fine dal racconto, il racconto di Neal. Wallace ammette, sì, sono io, io che racconto e parlo per Neal: ‘Eccomi!’. Cioè anche: ‘Sono io l’impostore’. Se c’è David Foster Wallace, scrittore, che ha una sua voce, non è perché egli sia partito da sé prendendo la parola. Prima c’era l’altro, e la sua morte cui rispondere. Includersi qui, dopo la “– FINE”, significa riconoscerlo: riconoscere l’altro, riconoscere che la mia voce c’è ed è la mia, perché dipende dall’altro che manca. Ora posso rispondere per lui nell’ignoto, e rischiare di parlare al suo posto: come se ci fossimo scambiati, ‘io’ e ‘tu’, di posto su una macchina in corsa. A livello temporale, l’istante che partorisce la scena dello scrittore – l’eyeblink – non è che l’estrema diramazione di una sovrapposizione di istanti che deflagrano uno dentro l’altro intersecando le cornici pragmatiche (il presente del dialogo io-tu post mortem, l’attimo durante la seduta di analisi, la frazione di secondo nell’automobile in corsa). Tutti convergono verso l’immobilità del fuori dal tempo, che è compresenza assoluta congiunta ad assoluta esprimibilità spremuta nel linguaggio, cioè il paradosso – ovvero la morte stessa. Da questo eyeblink estremo la deflagrazione e il paradosso si riproiettano all’indietro (“tutto questo rintronava nella testa di David Wallace dell’’81 ogni secondo a una velocità tale da non dargli modo di afferrarlo e cercare di opporsi”, p. 215). Tutto il tempo ora può essere ripercorso nella dilatazione di questo istante. Dal punto di vista della temporalità enunciativa, ne risulta un effetto di inclusione paradossale per cui l’istante contenuto (l’eyeblink) si estende fino a ricomprendere il tempo che lo contiene. Inclusione paradossale, al pari di quella dell’io nella morte dell’altro – entrambe dipendono dal “paradosso centrale”: con David Wallace peraltro pienamente cosciente che il cliché secondo il quale non si può mai sapere veramente cosa avviene dentro qualcuno è vecchio e insulso ma [and yet] al tempo stesso cercava molto coscientemente di impedire a quella consapevolezza di sbeffeggiare il tentativo o di spingere tutta quella linea di pensiero in quella specie di spirale ripiegata su se stessa che non ti permette di arrivare a niente […], la parte più reale, più tollerante e sentimentale di lui a imporre all’altra parte di tacere come se la guardasse negli occhi dicendo, quasi a voce alta: “Non una parola di più [Not another word]”. (p. 215) 50 / LUCA BERTA È David Wallace l’alienato, lo sdoppiato che parla con se stesso. Egli è consapevole del paradosso, dell’impossibilità di essere un altro, dell’impossibilità di esprimere nel linguaggio lineare il fuori dal tempo della morte dell’altro, ma cerca – coscientemente – di non abbandonarsi a questa consapevolezza che conduce al silenzio, benché il conflitto ricorsivo delle consapevolezze lo faccia ricadere nel paradosso. Come portare al racconto l’altro che non c’è, se ogni parola lo tradisce (non è la sua voce, il suo proprio punto di vista), e mi scaraventa nell’aporia (non è il lampo)? Bisognerebbe che il racconto potesse non dire nulla. A rigor di logica, la logica dei paradossi di Neal, non si dovrebbe dire nulla. Non si tratta qui, l’abbiamo detto, di sapere cosa proverei io a essere Neal morto. Si tratta di sapere cosa prova Neal, Neal stesso, ad essere morto. E non si può, come sostiene giustamente Nagel, avere una visione oggettiva, dall’esterno, di ciò che si prova soggettivamente.14 Tanto più se l’esperienza in questione è sfuggente come la morte. Come raccontare ciò che è impossibile raccontare, e insostenibile da tacere? Posso provare a usare la finzione. Ma questo non significa automaticamente fare finta che non si diano questi paradossi, che lo scacco dell’impossibilità possa essere eluso con un semplice salto nell’immaginario. David Wallace non lo fa. Egli affronta i paradossi a più livelli. Innanzitutto facendone uno dei principali materiali da costruzione della narrazione: i paradossi sono oggetto del racconto, e offrono molteplici punti di innesto per episodi accattivanti, resoconti, riflessioni disperate. In secondo luogo Wallace sposta il confronto anche sul piano della dimensione strutturale, allestendo un sistema enunciativo e una concatenazione temporale che accolgono la paradossalità nel loro stesso seno, poiché rovesciano le premesse narrative che li hanno generati. Ma perché la manipolazione dei livelli logici e l’autoinclusività paradossale dovrebbero funzionare meglio, per rappresentare la morte, di una semplice intenzionalità semantica? Perché la morte stessa, suggerisce Wallace, è il ‘paradosso’. Ecco la soglia ulteriore su cui si ripropone il corpo a corpo con l’impossibile. Attenzione, non è un paradosso generico, bensì quello che discende appunto dalle aporie della temporalità e del linguaggio. Incarnare queste aporie nella forma del racconto, nelle strutture temporali e enunciative che lo compongono, significa dire qualcosa della 14 Bisognerebbe, afferma Nagel, forgiare dei nuovi concetti per poterlo fare. Forse il racconto di David Wallace è una fornace abbastanza incandescente perché il linguaggio cominci ad essere forgiato in questo senso. IL NEON DI DAVID FOSTER WALLACE / 51 morte nel senso di offrire un’altra dimensione di esperibilità. Linguaggio e tempo sono paradossali. Il racconto, che tenta di raccontare la morte, è linguaggio nel tempo. La morte sarà, tra l’altro, l’esperienza del paradosso incarnata nel racconto. David Foster Wallace non scavalca i paradossi con un balzo di finzione, anzi cerca di trasformarli in risorse espressive accettando il rischio che ciò possa minare alla base la solidità architettonica del testo e possa frantumare fin da subito il patto narrativo. Questo gli consente di intessere una configurazione temporale in cui gli istanti si attraversano e si riannodano l’uno all’altro, rimarcando i bordi di un impossibile fuori dal tempo. Lo costringe a tormentare la posizione dell’enunciatore, crivellandola per lasciar intravedere l’altro che non ha voce. Lo conduce a creare una struttura paradossale che sospende l’intero racconto all’impossibilità (impossibilità di usare il linguaggio lineare per raccontare la morte dell’altro) e alla necessità (bisogna usare il linguaggio, e infatti il racconto c’è). Impossibilità e necessità, cioè il paradosso. La densità potente e acuminata di questa sospensione si raccoglie nell’ultima frase, Not another word. L’unica del dialogo di Wallace con se stesso, cioè dell’istante che a posteriori include tutto il resto del tempo. È una piega diegetico-performativa,15 una di quelle frasi che appartengono all’universo diegetico (una porzione di dialogo riportato) ma che al tempo stesso agiscono performativamente anche sul testo che le include. Questa frase sembra sollevarsi dalla pagina, torcersi indietro e rivolgersi all’intero testo per intimargli un ordine: una volta raccontato tutto il racconto non sarà stato più di una parola – non una parola in più di quella (nessuna, invero) che può raccontare la morte dell’altro. Non si dovrebbe dire niente, si sa. E così l’intero racconto precipita in una contraddizione performativa che dalla sua piega finale torna su di sé per zittirsi, per annientarsi, per negare la parola presa e rifluire nel giusto silenzio di fronte alla morte dell’altro. Il racconto prova a uscire dal linguaggio per farsi lampo, boato di silenzio al di fuori della successione degli istanti. La contraddizione performativa di questa ingiunzione, Not another word, risponde alla contraddizione performativa situata sulla soglia di ingresso del racconto: Io sono morto. Se l’affermazione impossibile è stata pronunciata, in realtà è perché non c’era alcun linguaggio. La piega diegetico15 Ho cercato di proporre questa definizione e argomentarne l’opportunità nel secondo capitolo del mio Oltre la mise en abyme. Teoria della metatestualità in letteratura e filosofia, Milano: Franco Angeli, 2006. 52 / LUCA BERTA performativa apre retrospettivamente uno spazio di impossibilità in cui il racconto impossibile può avere luogo. “Eppure” anche questa risposta che incorpora l’impossibile cercando di cancellarsi, deve prendere corpo in una parola. “Eppure [And yet] al tempo stesso la lingua è tutto ciò che abbiamo” (p. 181) in questo tempo, e bisogna prendersi la responsabilità dell’altro che non ha più voce, bisogna prendere un’altra parola (another word), la parola dell’altro – almeno una. Ma non un’altra (not another), non una di più. § 3 Laura Oreggioni La punta dell’iceberg Sten Nadolny e il senso della possibilità Al di qua della scrittura è il regno di infiniti mondi possibili. È una dimensione immanente e sospesa, che la parola non è in grado di trattenere. Chi ha a che fare con la scrittura guarda a questo fenomeno con delle aspettative: si lascia irretire dal fascino della singola parola, la osserva “rigirandosela nelle mani” (im Handumdrehen).1 Nel caso della scrittura di Sten Nadolny ne risulta un’ossessione decisamente obbligante: si tratta infatti di annotare il piacere che deriva dalla finezza della narrazione e di ragionarvi sopra. Una concessione al desiderio di lasciarsi condurre dalla parola al regno di infinite possibilità che la colma di sé, essendo questo, suo malgrado,2 l’origine stessa della scrittura. Il senso della possibilità sottende l’opera di Nadolny e ne abita il pensiero a tal punto da potersi ritenere a ragione il nucleo fondativo della sua poetica. Lo scrittore vi fa esplicito riferimento in diverse occasioni: “Il senso della realtà […] si unisce a quello della possibilità (Come potrebbe ciò andare diversamente?). […] Il senso della possibilità è generalmente sottosviluppato, ma lo si può allenare”;3 “Attraverso il vagabondare dello sguardo e della mente, del senso della possibilità […] nascono […] storie”;4 “il 1 Sten Nadolny, Das Erzählen und die guten Absichten, München: Piper, 1990, p. 220 (laddove non altrimenti indicato, la traduzione è mia). D’ora in avanti la sigla EGA farà riferimento a questo volume. 2 Cfr. ivi, p. 224: “Verificare se vi è ancora una corrispondenza con il pensiero, i sentimenti. Ed eventualmente compiacersi del fatto che sia sorto qualcosa di completamente diverso”. 3 Sten Nadolny, “Zeitgemässe Literatur – Wunschziel, Unding, Selbstverständlichkeit?”, in Herbert Heckmann e Gerhard Dette (a cura di), Medium und Maschine, Göttingen: Wallstein, 1994, p. 18. 4 Intervista di Gerhard Altmann, “Flanieren des Blickes”, Buchkultur, 2, 1995, p. 16. PARAGRAFO I (2006), pp. 53-72 54 / LAURA OREGGIONI famoso senso della possibilità – tale che è possibile pensare a cose che non si ha mai vissuto, ma ce le si può immaginare ugualmente […]. È questo il bello: i concetti richiamano immagini sempre nuove e le modificano in continuazione”.5 La letteratura austriaca del Novecento si è mostrata particolarmente sensibile alla ricezione di questo tema, già predisposto nella scrittura di Hugo von Hofmannstahl e Thomas Bernhard. In Der Schwierige di Hofmannstahl è possibile ravvisare nel conte Karl Bühl un’estenuata propensione a riflettere, un particolare interesse per come si giunga da una cosa all’altra, la consapevolezza che non ci sia più nessuno in grado di spiegare alcunché, prima ancora che la parola traduca tutto in una serie di equivoci. Ma ancor di più, in Verstörung di Bernhard, nelle riflessioni dei personaggi e in particolar modo nel monologo del principe Saurau il pensiero, la pura elucubrazione cerebrale, è costantemente in primo piano: la voce narrante sospetta che ciò che egli pensa non abbia una corrispondenza esatta nella realtà, mentre il principe è assillato da domande incomprensibili che esigono un chiarimento, medita sulla stupidità del pensare e inoltre avverte lucidamente la devastazione che affligge il suo cervello e rende problematico lo svolgimento dei pensieri, il semplice addentrarsi della mente nel dominio della logica. Egli paragona i pensieri a dei fondali che vengono calati su un palcoscenico e il cervello è un impianto di illuminazione puntato sui fondali. Al senso della possibilità si fa invece esplicito riferimento in Der Mann ohne Eigenschaften di Musil, dove viene fornita una breve spiegazione del fenomeno, che, come vedremo, trova un’applicazione esemplare nella caratterizzazione dei personaggi nadolniani: Chi lo possiede non dice, ad esempio: qui è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere; ma immagina: qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o talaltra cosa; e se gli si dichiara che una cosa è com’è, egli pensa: be’, probabilmente potrebbe anche esser diversa. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe egualmente essere, e di non dar maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è.6 La scrittura di Nadolny trae inizio proprio dall’assunzione consapevole di 5 Intervista di Wolfgang Bunzel, “Ich bin ein leidenschaftlicher Oberlehrer”, in Wolfgang Bunzel (a cura di), Sten Nadolny, Eggingen: Isele, 1996, p. 130. 6 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1930-43), trad. it. di Anita Rho, L’uomo senza qualità, vol. 1, Torino: Einaudi, 1972, p. 12. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 55 questo frame mentale e dalla sua esecuzione a livello narrativo. Si tratta dunque di vedere in che modo il senso della possibilità percorra sottilmente il testo a più livelli. Innanzitutto, è utile notare che nell’opera di Nadolny, la dimensione mentale del soggetto è assolutamente fondamentale. Sia in Netzkarte (1981) che in Die Entdeckung der Langsamkeit (1983), il soggetto si rivela in maniera preponderante sotto forma di res cogitans. In entrambi i casi vengono svelati e riprodotti, secondo un esigente intento mimetico, i processi mentali dei protagonisti e nel contempo essi divengono oggetto dei loro discorsi: “La gente osserva tutto, ma poi che cosa se ne fa? Che cosa pensa dopo aver osservato qualcosa?”; “Quello che faccio da settimane non ha niente a che fare con il vedere, e meno ancora con il pensare. […] Solo regole ferree senza senso e dei compagni prestabiliti possono ancora salvarmi dal mio cervello”; “Ogni volta che cerco di passare da un pensiero ad un altro mi si frappone qualcosa. Questo è il rischio, ne sono sempre più certo!”; “Vorrei sapere che cosa passa per la testa quando si comincia a piangere. È come un treno sempre fermo lungo un marciapiede, ormai lo considerano tutti parte della stazione. Un bel giorno si crea un minimo contatto e il treno comincia a muoversi. Nessuno può fermarlo”.7 Considerazioni analoghe ricorrono anche in Die Entdeckung der Langsamkeit: “non faceva né pensava mai due cose diverse allo stesso tempo”; “Ogni rapporto era composto da una parte esteriore, coerente dal punto di vista logico e facile da capire, e da una parte interiore, che appariva solo nella mente di chi parlava”; “la sua testa non era più impegnata a dissimulare, a tradire o a costringere”; “All Fighting Cocks Inn aveva imparato come si tiene sotto controllo il nesso tra i propri argomenti”; “A John sembrava ora di percepire le pieghe più sottili di tutto il pensiero, gli elementi e persino la casualità di tutte le costruzioni, la stabilità e il dileguarsi di tutte le idee”.8 In secondo luogo, si noti come l’atto di porre delle domande assuma un certo rilievo. In Die Entdeckung der Langsamkeit esso diventa addirittura oggetto di discussione: il pittore “aveva la forza di tener testa alle cose e di chiedere se in realtà fossero quali apparivano. Per lui, John, questo 7 Sten Nadolny, Netzkarte, trad. it. di Giovanna Agabio, Biglietto aperto, Torino: Einaudi, 1996, pp. 26, 117, 121, 179. D’ora in avanti la sigla N farà riferimento a questo volume. 8 Sten Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit, trad. it. di Giovanna Agabio, La scoperta della lentezza, Milano: Garzanti, 2001, pp. 90, 101, 144, 166, 308. D’ora in avanti la sigla EDL farà riferimento a questo volume. 56 / LAURA OREGGIONI era fuori discussione. Chi chiedeva molto, doveva esser svelto. Di uno che poneva domande tutti cercavano di liberarsi il più in fretta possibile. Inoltre John sapeva bene che non si poteva sempre approvare le risposte. Per giunta una risposta strana creava scontento”; “Ora Franklin trasformò il suo modo di vedere in un nuovo tipo di domanda. Aveva scoperto che non aveva senso porre ‘domande-guida’, che richiedevano un sì o un no”; “Era solo una delle molte domande senza risposta, che si affollavano e si urtavano, era come il lavorio della sabbia del mare. John voleva dare spazio a tutte le domande, e sopportare con fiducia quello che avrebbero causato in lui” (EDL, pp. 100, 257, 294). In Netzkarte l’atto di porsi degli interrogativi viene esercitato di frequente. Complessivamente si possono distinguere domande inerenti ai processi mentali (“La gente osserva tutto, ma poi che cosa se ne fa? Che cosa pensa dopo aver osservato qualcosa?”, e sotto forma indiretta: “Una volta dovrei registrare tutto quello che non ho capito né approfondito nel corso della mia vita”), oppure sulla conoscenza delle cose (“Che cos’è in realtà una damigella d’onore, a che cosa serve, e perché non lo so?”; “Ma si può eliminare la conoscenza e limitarsi a guardare, come si guarda un film?”; “Ma andrò dalla gente e dirò: ascoltatemi, non so niente di niente – e voi, sapete qualcosa di più?”), e infine domande sul proprio sé (“Che cosa sono, che cosa faccio, che cosa mi dà gioia?”; “Che cosa mi fa soffrire in particolare?”) (N, pp. 26, 141, 28, 50, 183, 105, 122). Sono tutti quesiti che gravitano attorno alla sfera del soggetto. Il tema del soggetto che interroga se stesso alla ricerca del proprio sé e il tema del viaggio si fondono in un’unità incarnata da Ole Reuter. A conferma di quanto è stato enunciato da Claudio Magris (ovvero che “[c]iascun viaggio – non importa se sull’oceano o fra le quattro mura di una stanza – è un’Odissea, la ricerca avventurosa di una risposta alla domanda se, nel momento in cui fa esperienza del mondo e dell’altro, il soggetto trova se stesso o piuttosto si perde, se si compone o si disgrega e da qualche parte si arresta, se afferma se stesso oppure si ravvede della propria nullità”),9 il viaggio di Ole Reuter sembrerebbe proprio una sorta di cammino alla ricerca del sé. Tuttavia, è opportuno considerare anche qui il rapporto che intercorre tra realtà e finzione. 9 Claudio Magris, “Verteidigung der Gegenwart”, in Paul Michael Lützeler (a cura di), Spätmoderne und Postmoderne: Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Ismaning: Fischer Taschenbuch, 1991, p. 87. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 57 Esso si dispiega a tutti gli effetti a livello mentale del soggetto: “Il rapporto tra realtà e immaginazione, centrale in questo testo, viene esteso sul piano della coscienza psichica dell’eroe della narrazione”10 e “[a] livello mentale, a una realtà imperturbabile viene contrapposta la forza dell’immaginazione”.11 Ole Reuter insegue il miraggio della sua fantasia nella realtà, che nella sua mente aleggia come un’idea fissa. Nelle sue lezioni di poetica, Das Erzählen und die guten Absichten, Nadolny rivela il proprio interesse per le idee fisse e aggiunge che possono risultare deleterie per il soggetto. Egli si rifà direttamente a Netzkarte: Una volta, consultando l’orario ferroviario, a Ole Reuter, tanto per provare, è venuta in mente l’idea che a Jerxheim, presso il confine tra le due Germanie, lo aspettasse la felicità. Inizia così a fantasticare sulla figlia del panettiere, la quale abita lì e sta aspettando proprio lui ed è la donna della sua vita. Nel corso del viaggio non riesce più a liberarsi di quest’idea, prima o poi ci deve andare. Fortunatamente, la figlia del panettiere non esiste, così si potrebbe forse dire che in questo modo egli non può neppure incontrarla. Con ciò intendo dire che questo strano attaccamento a un’idea fissa m’interessa molto. Può essere qualcosa di buono, ma, altresì, è possibile che l’individuo che crede ciecamente alle ‘ispirazioni’ venga corrotto o crolli. (EGA, p. 41) Nel testo, il rapporto fra realtà e finzione si concentra attorno a un’idea fissa del protagonista: “sono in viaggio per Jerxheim. Questo luogo, di cui non so nulla, è diventato così importante per me dal punto di vista simbolico che devo vederlo. Scenderò in campo con la mia fantasia e sono curioso di vedere chi vincerà: lei o la realtà?” (N, p. 99). Di nuovo, egli riflette sul suo rapporto con la realtà e in seguito sembra insistere sulla convinzione che “[s]e esiste qualcosa di vero nelle idee fisse, ho pensato, e se a Jerxheim esiste qualcosa come la figlia di un panettiere, non può che essere lei!” (N, p. 186). Ma in questo caso, come è stato anticipato dall’autore, il perseguire un’idea fissa finisce per consolidare lo scarto fra la realtà e l’immaginazione a scapito del riconoscimento del sé. Si consideri, altresì, il rapporto che il soggetto intrattiene con il reale al di là del tema dell’idea fissa. Ole Reuter dubita costantemente del fatto che la realtà sia proprio quella che egli percepisce, sospettando della rela10 Uwe Schneider, “Denk ich an Deutschland in der Eisenbahn”, in Wolfgang Bunzel, op. cit., p. 48. 11 Ivi, p. 42. 58 / LAURA OREGGIONI tività del proprio sguardo: “Ma sono io a far risaltare queste qualità di Judith. Che cosa sarebbe lei se io non fossi la sua misura?”; “Le case qui sono piuttosto fatiscenti, o sono io che le vedo così?”; “In questo modo non si può mai essere obiettivi, non si sa mai se un tempo le estati erano davvero più belle o se eravamo solo noi a vederle così”. Infine, è il protagonista stesso a constatare che “[i]n realtà non entro in contatto con niente” (N, pp. 134, 135, 141, 135). Tale problematica si rinnova anche in Die Entdeckung der Langsamkeit, dove peraltro viene formulata esplicitamente in più occasioni: il pittore “aveva la forza di tener testa alle cose e di chiedere se in realtà fossero quali apparivano” (EDL, p. 100). John Franklin si lascia influenzare dalla teoria della percezione del vescovo di Cloyne: “Si raffigurava il mondo con tutti gli esseri umani, le cose e i movimenti, soltanto come un fenomeno apparente. Quindi il mondo era una storia che Dio, con l’aiuto di impressioni artificiali, raccontava ai cervelli, forse solo a uno, quello del vescovo di Cloyne. Infine esistevano soltanto il suo cervello, i suoi occhi e i suoi nervi e le immagini che Dio gli inviava”; “lui, John Franklin, era lo spirito dell’uomo, e qualcuno si limitava a simulare tutto davanti ai suoi occhi, per vedere se avrebbe fiatato, quando fosse accaduto qualcosa di spiacevole. Voleva provare a pensarla così: nulla esisteva realmente, tutto era apparenza, questa era l’unica cosa certa”; “Nelle strade di Portsmouth continuava a regnare un brulichio ebbro di vittoria – oppure era soltanto un’apparenza?” (EDL, pp. 119, 127, 133). Sotto questo punto di vista, l’opera di Nadolny appartiene a pieno titolo alla cosiddetta ‘letteratura dell’assenza’. Tuttavia, accanto alle osservazioni esposte da Magris a tal riguardo,12 è opportuno qui considerare il concetto di assenza specialmente nelle accezioni di finzione e dissimulazione. Lo sguardo del giovane Franklin è particolarmente sospettoso e allertato da quei fenomeni apparenti che sembrano avvenire furtivamente: per esempio, i movimenti rapidi del pollo che si susseguono distogliendo lo sguardo, ma che poi vengono smascherati se ci si dirige verso di esso; oppure i marinai che fingono di essere parte della nave e solo alle sue spalle osano movimenti umani; oppure ancora le case che crollano dal ponte quando non le si sta a guardare. Si noti la ripresa di un tema fre12 Cfr. Claudio Magris, op. cit., p. 86. Secondo Magris John Franklin apparterrebbe a “quegli antieroi di Kafka, Robert Walser, Svevo o Canetti che assumono su di sé la negatività del vivere e del loro tempo”. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 59 quentato in diversa misura dalla tradizione letteraria: quello della realtà data come inganno e messa in scena, limitata al solo campo visivo.13 Il pensiero di John Franklin dimostra un grado di autocoscienza talmente elevato da vedersi costantemente costretto a riflettere sul proprio stato e a fare i conti con l’apparenza delle cose: “Per non fissarli, John si mise a studiare il cervo bianco situato sul tetto del bovindo”; “Aveva il coraggio di sembrare sempre stupido finché non diventava intelligente”; “Ma uno che diceva la cosa giusta non doveva anche necessariamente fare una buona figura” (EDL, pp. 14, 145, 317; corsivi miei). La dicotomia realtà/finzione introduce quindi una variazione sul tema della possibilità, poiché ogni espressione del comportamento umano deve tenere conto di una controparte di eventualità che viene data insieme alla sua messa in atto. Non solo il dissidio fra soggetto e realtà trova rispondenza nel testo, ma anche le difficoltà del soggetto alle prese con la propria identità. È una circostanza, questa, alla quale Ole Reuter difficilmente sa applicarsi: “Dovrei esaminarmi, analizzare i miei ultimi quattro anni, scavare nel profondo. Già queste parole mi annoiano. La mia pigrizia, divenuta temporaneamente furia lavorativa in occasione del film, si è reinstaurata a tutti gli effetti. È più forte di qualsiasi altra necessità”. Tuttavia, egli non può nascondere a se stesso il proprio disagio: “‘Hai dei problemi?’ ‘Li ho sempre!’, ho gridato, sussultando al suono della mia stessa voce”; “Sono in conflitto con me stesso. […] Forse su di me non c’è niente da ridire, ma non mi piace l’immagine che do. O quella che vedo” (N, pp. 121, 93, 116). Quest’ultimo passo è fondamentale, in quanto dimostra che Ole Reuter ha una percezione del sé soltanto come proiezione. Il sé non ritorna compiutamente su se stesso, il processo di autocoscienza non ha termine, lo schema della riflessione viene interrotto: “una volta ho guardato in un pozzo, uno dei più profondi che abbia mai visto. In fondo in fondo a 13 Si rammenta in particolare Forse un mattino andando in un’aria di vetro dalla raccolta Ossi di seppia di Eugenio Montale: “Forse un mattino andando in un’aria di vetro, / Arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:/Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro/ Di me, con un terrore di ubriaco. / Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto / Alberi case colli per l’inganno consueto. / Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto / Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto”. E questa nota breve da Die Wand (1983) di Marlen Haushofer: “Da bambina avevo sempre sofferto della sciocca paura che tutto ciò che vedevo sparisse non appena gli voltavo le spalle. Nemmeno il raziocinio è servito a guarirmi completamente da quel timore” (La parete, trad. it. di Ingrid Harbeck, Roma: e/o, 1998, p. 166). Si vedrà in seguito come il riferimento all’infanzia risulti del tutto pertinente in questa sede. 60 / LAURA OREGGIONI grande distanza, ho visto la mia immagine riflessa”; “Incontrare il proprio sé come se fosse un altro non è cosa di tutti i giorni”; “da qui ho guardato in molti regni e nella bacheca dei bollettini parrocchiali ho visto me stesso” (N, pp. 96, 100, 102). Anche John Franklin è alle prese con una soggettività problematica. Egli spera che in mare possa vincere la paura che lo attanaglia fin da principio. In seguito, l’eroe saprà comunque fare i conti con questo lato del suo carattere: “A Trafalgar avevo già perso me stesso, e in seguito ancora di più. E poi volevo soltanto liberarmi dal tremito. Non volevo più sembrare vile o sciocco, mai più. Ed è stato uno sbaglio” (EDL, p. 141). A differenza di Ole Reuter, il personaggio di John Franklin segue un’evoluzione che lo induce ad acquisire una certa sicurezza di sé. Il viaggio da lui intrapreso segna un percorso di maturazione del tutto analogo a quello compiuto dal protagonista di un Bildungsroman. Nel caso di Ole Reuter, invece, il suo viaggio non ha sbocchi se inteso come occasione per una “esplorazione del sé” (Ergründung des Selbst).14 Lo stesso Reuter prende nota del sospetto che spostarsi non gli serva a nulla. In realtà, il viaggio fisico del protagonista è il surrogato esteriore di una forma di mobilità interna (“Come andarmene lontano, senza continuare a viaggiare?”), condotta forse nel timore di non capire se stesso (“Ho acquistato il primo biglietto aperto anche per liberarmi da sentimenti contrastanti, sogni e incubi”). Non a caso, egli è sfiorato più volte dal desiderio di annullare se stesso: “Se mi chiedessero che cosa vorrei essere risponderei: un palo per l’alta tensione”, oppure “ho deciso di disperdermi” (N, pp. 117, 181, 172, 149). Progressivamente, dunque, agli occhi di Ole Reuter il viaggio fisico appare sempre più irrilevante: inizialmente egli guarda se stesso viaggiare con lo sguardo di un estraneo (“Quindi vedo un ponte sul quale viaggio io stesso”); in seguito prova a venire a capo della propria situazione (“Devo concentrarmi sul viaggio, che è il vero problema, e non un mezzo per risolvere i miei problemi”; “In questo viaggio può ancora succedere qualcosa di importante, se mi do da fare”), ma infine vi rinuncia lasciando il problema irrisolto: “Dal viaggio non ricavo più molto”, “mi serve con urgenza una breve risposta alla domanda: che cosa ho fatto in queste sei settimane?” (N, pp. 127, 139, 146, 173-74). A tal riguardo, è opportuno osservare in che modo il senso della possi14 Uwe Schneider, op. cit., p. 42. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 61 bilità sia strettamente connesso al tema del progetto, che prende corpo all’interno della semantica del viaggio in rapporto alla questione dell’identità del soggetto. L’esperienza dell’eroe, in Die Entdeckung der Langsamkeit, oscilla precariamente fra le seduzioni dell’istante atemporale e la tirannia del progetto. Se da un lato l’ipotesi dell’atemporalità viene rifiutata definitivamente, il vero scopo del viaggio di John Franklin resta la scoperta del presente attraverso la lentezza. Il progetto rappresenta qui il punto di fuga che conduce al presente. Il tema del progetto come ossessiva previsione di vita è presente in modo particolare in Netzkarte. Mentre rimangono del tutto oscuri i motivi che spingono Ole Reuter ad acquistare un biglietto ferroviario aperto e vagare senza meta da un paese all’altro della Germania, è interessante soffermarsi sulle riflessioni del protagonista sulla natura, che egli osserva con gli occhi di chi, di fronte al rannuvolarsi del cielo, debba aspettarsi senz’altro il temporale: “Quando ognuno si comporta secondo le regole della vita animale descritta da Brehm è un idillio. L’effetto tranquillizzante deriva dal fatto che agisce secondo le aspettative. Persino gli uccelli rapaci assumono un tratto gentile, quando si comportano con la brutalità del rapace” (N, p. 29). In effetti, si intuisce gradatamente il desiderio da parte di Ole Reuter di aderire alla dinamica meccanicistica e ripetitiva dell’evento naturale, di per sé rassicurante, e nel contempo di sottrarsi alla logica spietata del progetto, all’essenza teleologica del comportamento umano. Lo stesso Reuter suppone che l’origine del suo tormento derivi dal fatto che mentre gli altri si dedicano a cose ragionevoli, “io […] guardo il paesaggio e mi aspetto miracoli” (N, p. 32). Di fatto, se fare progetti ‘tranquillizza’, il progetto di per sé non ha nulla di definitivo, al contrario rimanda per antitesi all’esistenza di una realtà imprescrittibile, di cui il protagonista prende atto e in margine alla quale egli “vive l’incanto di un’esistenza, che spezza i vincoli dell’economia, un’esistenza che si può considerare ‘vita’ a pieno titolo”.15 In tal modo, risultano evidenti le implicazioni che il senso della possibilità attua a livello mentale del protagonista: il progetto rappresenta infatti un atto di 15 Alexander Honold, “Das Weite suchen. Abenteuerliche Reisen im postmodernen Roman”, in Henk Harbers (a cura di), Postmoderne Literatur in deutscher Sprache: Eine Ästhetik des Widerstands?, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 2000, pp. 386-87. 62 / LAURA OREGGIONI resistenza organizzata, seppure provvisoria, nei confronti dell’impredicabilità del vivere; al contrario, Ole Reuter rimane volontariamente impreparato e irrisoluto di fronte al proprio umano smarrimento. Come è stato osservato, “[l]’esperienza del sé non può ancora avvenire, poiché Ole Reuter non è in grado di riconoscere la sua immagine esteriore, né tenta di penetrare la complessità della sua immaginazione, dal momento che egli non imbocca neppure la strada che lo conduce alla figlia del panettiere”.16 Tuttavia, a mio avviso, non è del tutto esatto ricondurre le cause dello straniamento del sé da se stesso “ai limiti imposti alla libertà […], i quali vengono assegnati da circostanze esterne, che riguardano lo Stato”.17 In realtà, è anche una questione di libertà, ma non nei termini in cui qui viene posta. Ancor più che da un ordine esterno imposto al soggetto, la libertà sembra essere circoscritta dal caso. Si tratta ora di vedere in che modo questo tema sia a sua volta connesso al senso della possibilità. In Die Entdeckung der Langsamkeit, John Franklin si confronta con il caso come se si trovasse per la prima volta di fronte al mare: “Niente si può prevedere. Nessuno sa spiegare perché le cose vanno così e non altrimenti. Il caso e la contraddizione sono più forti di tutte le previsioni”; “avrebbe voluto saperne di più sul caso”; “perché avveniva una cosa simile, e perché non avveniva?”; “che il caso facesse quello che voleva, era duro da sopportare” (EDL, pp. 100-01). Anche nel caso di Ole Reuter, se si riflette con attenzione sul senso delle domande che egli si pone – per esempio, quelle riguardanti la conoscenza: “Che cos’è in realtà una damigella d’onore, a che cosa serve, e perché non lo so?” (N, p. 28, corsivo mio); oppure quest’affermazione sul sé: “Quello che mi irrita è solo il fatto di essere esattamente come gli altri” (N, p. 128) – si deduce facilmente che l’interrogativo che s’impone nella mente dei protagonisti non consiste tanto nel chiedersi se le cose siano veramente quelle che sono, bensì ‘perché le cose sono così e non diversamente’. Ora, si tratta di una questione che evidentemente riguarda anche la conoscenza, nel momento in cui Ole Reuter indugia su certe riflessioni che lo portano a interrogarsi sul perché egli sia o meno a conoscenza delle cose. È un tipo di pensiero che, a quanto pare, suscita in lui una certa apprensione, dal momento che egli si chiede: “Ma si può eliminare la cono16 17 Uwe Schneider, op. cit., pp. 45-46. Ivi, p. 46. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 63 scenza e limitarsi a guardare, come si guarda un film? Sarebbe una specie di morte” (N, p. 50). Partendo altresì dalla constatazione che “[c]onoscere e vedere sono due cose che non vanno d’accordo”, è come se al protagonista venisse suggerito un espediente per sottrarsi a tale impasse mentale. Egli, infatti, decide: “Non ho bisogno di riflettere, non è necessario. Occhi e orecchie mi bastano” (N, pp. 50, 21). Il viaggio di Ole Reuter si riduce così a un processo di osservazione delle cose, che lo introduce a una dimensione d’alienazione: “Vorrei osservare il mondo dei piccoli animali”; “Sono sollevato e pronto a studiare i tesori della natura, che sto comunque osservando” (N, p. 115, 175). Anche in John Franklin è possibile percepire il medesimo sentimento d’incertezza; basti soffermarsi con attenzione sulla modalità con cui egli esprime le proprie sensazioni e opinioni: in tali formulazioni ricorrono sovente espressioni indirette del tipo sembra che, probabilmente, ma d’altra parte, come se egli non volesse escludere che le cose potrebbero essere anche altrimenti. Si consideri, inoltre, un esempio assai significativo di come il protagonista metta in discussione, mosso da tale dubbio, gli stessi criteri di percezione del reale: inizialmente egli descrive in questo modo la percezione differenziata di cose che si trovano a distanze diverse durante il movimento: “Questo era il dato sorprendente: a distanza ravvicinata era tutto un balenare e saltellare, paletti, fiori, rami. Più oltre c’erano mucche, tetti di paglia e colli boscosi, che apparivano e sparivano in una sorta di ritmo quieto e solenne. Ma i monti più lontani erano come lui stesso, stavano semplicemente là a guardare”. In seguito, invece, egli sembra persuaso del fatto che l’atto stesso di percezione sia del tutto arbitrario: “era come guardare fuori da una carrozza, e chi contemplava era libero di lasciarsi sfilare davanti ciò che era lontano e di lasciar saltellare ciò che era vicino” (EDL, pp. 12, 308). Infine, il senso della possibilità riguarda in particolar modo la lingua e la sintassi. Un’analisi dettagliata di Netzkarte può risultare illuminante in tal senso. Le riflessioni del protagonista sul proprio malessere non permettono di ricondurlo a una causa intelligibile. A livello intuitivo, se le dichiarazioni di Ole Reuter sul proprio stato d’animo venissero considerate complessivamente, venissero cioè raccolte con la stessa frequenza con cui egli stesso colleziona dati, non se ne ricaverebbe tanto l’impressione di dover tradurre l’intento comunicativo di un atto linguistico che abbia una funzione emi- 64 / LAURA OREGGIONI nentemente referenziale, ma piuttosto si avrebbe il sentore di trovarsi di fronte alla messa in scena dell’atto linguistico in sé. La successione irrelata di brevi frasi, a mo’ di constatazioni o aforismi, segue una giustapposizione disgiuntiva che sembra prescindere dal loro significato, come se il detentore dell’atto linguistico volesse mettere alla prova le diverse possibilità d’espressione del pensiero, volesse acquisire una certa confidenza sul piano linguistico col regno del possibile e dell’indeterminato. “1) Judith è colpevole di tutto, mi ha tradito; 2) Io sono colpevole di tutto, perché sono stato troppo ingenuo. Il mondo è malvagio, avrei dovuto saperlo. Oppure: Non sono fatto per questo mondo, pretendo troppo”; oppure “[a]desso ci sono tre possibilità: o la catastrofe è imminente, o tutto procede come prima. Oppure arriva la salvezza: a) dall’interno, b) dall’esterno” (N, pp. 126, 169): in realtà, è come se, da un punto di vista semantico, le affermazioni formulate dal soggetto di pensiero gli fossero indifferenti, si equivalessero, mentre ben più intrigante risulterebbe il semplice atto d’emissione della parola, con tutte le potenzialità ad esso sottese. Nel fare ciò, è come se la mente ‘guizzasse’ da un pensiero all’altro, così come lo sguardo di chi osserva dal finestrino di un treno corre da un oggetto all’altro. Condurre tale gioco implica necessariamente una compromissione dell’atto comunicativo in termini di emissione e di ricezione: Ole Reuter vorrebbe parlare con qualcuno dei suoi problemi, ma non crede di potervi riuscire; o meglio, si chiede se sia in grado di farlo o meno, e nel contempo il senso delle parole enunciate dai suoi interlocutori rimane spesso per lui un enigma. Complessivamente, si consideri questo breve ma significativo frammento di dialogo fra il protagonista e una donna: “‘Crede più alla morte nucleare o a una catastrofe ambientale? O crede che moriremo di fame per via delle crisi economiche?’ ‘Sa, – ho risposto – ho i miei problemi quando si tratta di scegliere – non riesco a fermarmi da nessuna parte’” (N, p. 171). D’altro canto, è il protagonista stesso a ritenere insopportabile l’equivocità del proprio carattere, propenso ad amare le idee più delle persone, e pertanto invita a diffidare di sé. In realtà, sembra proprio che alla base del malessere che induce Ole Reuter a cercare l’altrove vi sia una generale insoddisfazione circa il proprio modo di condurre l’esistenza, il sentore di una mancanza che crea inquietudine. Egli avverte il senso della mancanza, tuttavia non è in grado di spiegarsi in che cosa essa consista: “Tutto quello che ha l’aria di essere definitivo mi mette a disagio. Ad esempio le stazioni d’arrivo in cui scendo e devo restare” (N, p. 77). LA PUNTA DELL’ICEBERG / 65 In relazione a quanto detto in precedenza, si tratta dunque di mettere in discussione il campo d’esistenza del limite e di mettere alla prova quello dell’indefinito. Ora, il viaggio inteso come transito rappresenta qui il dominio ideale che fornisce le categorie utili per trascendere se stesso ed estendere il discorso sul piano del rapporto che il soggetto intrattiene con il reale. In un certo senso, è come se Ole Reuter trasferisse inconsciamente le competenze acquisite durante il movimento – in particolar modo la capacità di stabilire confronti e formulare un’immagine o una rappresentazione generale del mondo, le quali costituiscono “uno schieramento di difese costruito contro lo squilibrio del transito” –18 al livello di comprensione di sé e della realtà. Evidentemente, nel caso in questione, non si tratta tanto di un viaggio intrapreso per conoscere il mondo, per “sviluppare tecniche di lettura che gli permettano di cogliere, attraverso la superficie delle cose e delle persone, la loro interiorità, i rapporti, le funzioni e i ‘significati’”.19 La capacità di stabilire confronti appresa durante il viaggio rappresenta, a mio avviso, soprattutto uno strumento per ridurre le incertezze e far fronte al dolore. Nel testo tale aspetto può essere verificato in più occasioni: “Quando una ragazza mi ha lasciato, mi viene sempre in mente qualcosa, motti religiosi e guerreschi tratti dalle ceneri dei tempi gloriosi, ad esempio: ‘Uniti in eterno’”; “Quando rifletto sul punto 1) [la colpevolezza di Judith] e sul punto 2) [la mia colpevolezza] immagino un dialogo da radiodramma pieno di ripetizioni”; “Se mi sforzo di ricordare con precisione quello che mi fa soffrire, immagino un altro dialogo”; e infine, “ho passeggiato ore per le zone più buie della città, cercando di inquadrare la mia depressione in un’immagine solenne e imponente di dolorosa saggezza” (N, pp. 120, 126, 148). In tal senso, dunque, il viaggio diventa altresì il modello di riferimento che consente di esplorare le infinite possibilità d’espressione del pensiero in rapporto con la realtà. È d’altronde lo stesso Reuter a suggerirlo: “Capisco che devo mettere in relazione Judith, il viaggio in treno e gli idilli apparenti” (N, p. 133). Ed è proprio qui che risiede la differenza sostanziale che distingue la Wanderung romantica dal viaggio infinito dei moderni: mentre la prima va intesa soprattutto in termini di metafora della tensione verso l’infinito 18 Eric Leed, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Bologna: Il Mulino, 1992, p. 107. 19 Ivi, p. 85. 66 / LAURA OREGGIONI e l’ignoto, il viaggio di Reuter (che difficilmente si lascia definire mediante un termine assoluto)20 non assume mai il carattere di fuga nell’immaginario, bensì rimane circoscritto al dominio del reale.21 Ma se ciò avviene, non è tanto perché Nadolny abbia tentato invano di seguire la traccia di una metafora, che è stata a sua volta superata dalla realtà stessa,22 quanto piuttosto poiché egli ha voluto mettere in atto il tentativo di addentrarsi nel regno dell’infinitamente possibile a partire da un modello utile di riferimento che direttamente lo introducesse a tale impresa, ovvero il viaggio. Ora, le critiche che generalmente attribuiscono a Netzkarte una certa superficialità sono da considerarsi, a mio avviso, sommarie e discutibili.23 Il viaggio di Reuter non è nato per rispondere a una volontà di conoscenza in senso stretto, dal momento che non approda a una soluzione definitiva. L’indagine condotta nel regno dell’infinitamente possibile è infinita e dà adito a possibilità d’espressione infinite: “Per quanto abbia scritto non so ancora che senso abbia avuto il mio viaggio, e non trovo le parole giuste” (N, p. 187). Alla lingua dello scrittore è stata riconosciuta, invece, una certa importanza, se non altro per lo stile ironico e divertente. Anche questo mi pare un giudizio tutto sommato superficiale. Ole Reuter si sofferma più 20 Su questo punto si veda, per esempio, Gabriele Kreis, “Ole Reuters Reisen in die Zukunft und zurück”, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 19 aprile 1981: “Viaggio come piacere infinito? O come fuga? Oppure come idillio di libertà? Oppure tutto questo e altro ancora?”. Nadolny in Flanieren des Blickes, cit., lo definisce semplicemente “un’escursione nella vita” [ein Ausflug ins Leben]. Generalmente il viaggio di Reuter viene identificato col termine fuga: cfr. Paul Reitze, “Mit der Netzkarte zu sich selbst”, Rheinischer Merkur, 3 aprile 1981; Wolfgang Hädecke, “Flatternd durch die Lande”, Stuttgarter Zeitung, 13 giugno 1981; Martin Lüdke, “Hin und Her”, Die Zeit, 1 maggio 1981, il quale, più propriamente, parla di un tentativo di fuga congelato. 21 Cfr. Thomas Überhoff su Nadolny, in AA.VV., Kritisches Lexicon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München: R. Boorberg Verlag, 2001, p. 3; Gabriele Kreis, op. cit., e in particolar modo Martin Lüdke, op. cit. 22 È questa la tesi di Lüdke. 23 Si tratta di un giudizio largamente condiviso: Cfr. Josef Quack, “Don Juan auf der Bundesbahn”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 marzo 1981; Paul Reitze, op. cit.; m.v., “Zielloses Reisen”, Neue Zürcher Zeitung, 30 maggio 1981; Wolfgang Hädecke, op. cit., e Peter Jokostra, “Putzige Idylle auf Rädern”, Die Welt, 13 giugno 1981. Il primo romanzo di Nadolny è stato liquidato velocemente dalla critica. Gli interventi in merito si limitano quasi esclusivamente a qualche recensione di giornale (a eccezione di Uwe Schneider, op. cit.). Tuttavia, riteniamo che valga la pena soffermarsi sull’importanza assunta dalla parola in Netzkarte. Da un punto di vista linguistico, il testo offre degli spunti di riflessione preziosi che chiedono di essere isolati e registrati come fossero illuminazioni. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 67 volte a riflettere sull’utilizzo delle parole e sui molteplici significati che queste possono assumere: “‘Diogene’ anziché ‘Drogheria’. Mi esercito a leggere messaggi segreti. Prima o poi dirò: è questo, non potrebbe essere espresso meglio, e all’infuori di me nessuno riconoscerà la scritta sul muro” (N, p. 125). Ma soprattutto, è mediante la lingua che avviene la comprensione del sé. Si pensi, per esempio, all’episodio in cui il protagonista si reca in una biblioteca alla ricerca di una spiegazione di ciò che lo fa soffrire, di una definizione del proprio dolore fra molteplici voci enciclopediche, che seleziona e annota con cura. Infine, in un appunto scaturito come una sorta di illuminazione egli vi scorge “la chiave per decidere tutto il mio essere, e ho creduto di capire fino in fondo, fin nei minimi particolari che difficilmente si possono esprimere a parole, la frase che avevo scritto” (N, p. 36). È questa, in ultima analisi, la forma immanente del viaggio infinito: il tentativo di esplorare le infinite possibilità dell’eloquenza della lingua che, come la Wanderung, è terra di nessuno. Alcune considerazioni finali. Ciò che colpisce lo scrittore è il fenomeno della complessità in generale e il suo corollario che sostiene l’impossibilità di porre la varietà sotto controllo. Nondimeno, egli fa di tale fenomeno l’oggetto di un interesse quasi ancestrale: “un che di misterioso gioca con qualcosa di cerebrale oppure in relazione con le leggi oscure della creatività” (EGA, p. 31). La scrittura di Nadolny prende avvio dalla constatazione che il caos travolge la mente e così la conquista, diventando il suo prerequisito: chi non è verwirrt non è in grado di creare alcunché. Di qui l’attenzione dell’autore per chi si dimostra verunsichert e nachdenklich. Lo stesso rapporto fra realtà e immaginazione si rinnova a partire dal principio di infinite possibilità,24 il quale interessa specialmente il dominio della fantasia. Chi desidera confrontarsi con esso, con l’inconsueto – “un storia opposta, l’‘altra’ storia per eccellenza” (EGA, p. 62) – allora sviluppa una modalità percettiva che illumina ciò che è già noto da un punto di vista insolito. Egli diviene cioè consapevole di un potenziale destabilizzante insito in ogni cosa, un ‘altrimenti’ che investe la realtà così come 24 Si consideri tale aspetto soprattutto in Netzkarte. Cfr. Uwe Schneider, op. cit., p. 52: “Va sottolineata assai di più la possibilità di modificare il rapporto fra le componenti che ci interessano, ‘realtà’ e ‘immaginazione’, mediante una rete di parametri”. 68 / LAURA OREGGIONI il pensiero: “Si può saltare qua e là da ogni singola regione all’altra della mente, del ricordo, fra immagini possibili, pensieri”.25 La scrittura diventa così il luogo in cui esercitare una nuova modalità percettiva assolutamente immediata: “John fühlte einen Zweifel aufsteigen, er wusste aber noch nicht, wie er zu bestimmen war”; “er schien nachzudenken”; “war schwer zu beurteilen”; “Überhaupt hatte er etwas Undurchsichtiges und Entrücktes”; “John dachte über Buchans letzte Bemerkung nach und war etwas erschrocken, weil Barrows Frage nun noch eine Nebenbedeutung bekommen hatte, für die er mehr Zeit brauchte”; “John meinte eine Doppelbödigkeit der Rede zu spüren. […] Das bedrückte ihn, schon weil er boshafte Anspielungen oft nicht gleich verstand und um Wiederholung bitten musste”.26 Più volte viene ribadita l’importanza della percezione a fondamento della scrittura: è una riflessione che deriva dalla consapevolezza del suo carattere ipertrofico: di qui la lentezza, l’indugiare sull’esistenza delle cose, la necessità o meno di considerare le questioni che tale esistenza pone, la percezione esatta e assoluta di quei movimenti impercettibili, la cui lentezza sfiora la morte, la drammatizzazione del dettaglio che per certi versi rievoca la poetica rilkiana del Malte.27 Così la drammatizzazione del sentimento: si noti come la meditazione sul dolore e la paura non venga condotta fino in fondo, bensì soppiantata dal gioco linguistico delle similitudini e delle ripetizioni. 25 Intervista di Wolfgang Bunzel, cit., p. 132. “John sentì che gli veniva un dubbio, ma non sapeva ancora come definirlo”; “sembrava che riflettesse”; “Era difficile giudicare”; “ma d’altra parte c’era in lui qualcosa di impenetrabile e trasognato”; “John stava riflettendo sull’ultima osservazione di Buchan ed era un po’ spaventato, perché la domanda di Barrow aveva probabilmente un secondo significato, e per capirlo gli sarebbe occorso più tempo”; “Gli parve di avvertire una duplicità di discorso […]. Ne era preoccupato, anche perché spesso non capiva subito le allusioni maligne e doveva chiedere che gliele ripetessero” (EDL, pp. 88, 142, 162, 193, 282; corsivi miei). 27 Si veda in particolar modo il celebre episodio della mano sorpresa a cercare la matita caduta sotto il tavolo. Malte l’osserva muoversi come se fosse animata da volontà propria. Ricorrono in Die Entdeckung der Langsamkeit momenti analoghi: “Che cosa facevano i suoi occhi? Restavano fissi sulla mano” (p. 19); “Le sue mani ne avevano orrore, ma la sua testa, […] si comportava come se non comprendesse nulla” (p. 63); “Rimase immobile per un attimo a fissare i suoi stivali, li guardava giacere là in una quiete incomprensibile” (p. 139). Non è lui, John Franklin, ad agire, bensì le sue orecchie, le sue mani… Egli dimostra una meticolosità estrema dello sguardo allertato dalla casualità delle cose nei confronti dei fenomeni più elementari. Ciò non diventa però occasione di meditazioni esistenziali. 26 LA PUNTA DELL’ICEBERG / 69 Si tratta probabilmente di un dispositivo innato, un automatismo, che alimenta allo stesso tempo la predilezione dell’autore per l’enumerazione enciclopedica del sapere. Non solo l’autore immaginario di Glashütte bis Hautflügler trae l’ispirazione del romanzo scorrendo le voci di un dizionario enciclopedico, anche Ole Reuter rivela la sua passione per lo studio degli orari ferroviari e degli elenchi dei codici postali. Il ductus narrativo del romanzo aderisce esattamente a quest’inclinazione. È possibile supporre che tale tendenza esaudisca il desiderio di coprire progressivamente il Tutto, mossi da un’ossessione che è linguistica, non gnoseologica. È un tentativo di lettura lineare del caos. Tuttavia, l’elevata sensibilità percettiva e la divinazione della parola non permettono che tutto scorra senza lasciare traccia. Non sorprende, dunque, se la memoria di John Franklin risulti essere una sorta di archivio: è una memoria per immagini, o eidetica. Assoluta e precisa, trattiene ogni impressione particolarmente a lungo. Anche in questo caso, l’acuta sensibilità percettiva incide sulla modalità di selezione secondo un’ispirazione personalissima: si potrebbe dire che vi sia soggetta suo malgrado (“Non riesco a lasciar andare niente, […] nessuna immagine, nessuna persona e nessun insegnante”; EDL, p. 40). La medesima coscienza è artefice della singolarità di certe impressioni e sensazioni: a capo di tutto sembra esservi una riflessione condotta all’ennesima potenza, una riflessione sulla riflessione, che nel proiettarsi verso l’origine, cioè verso se stessa, sospende le scelte più scontate. A volte capita di doversi soffermare a riconsiderare determinati nessi causali, dal momento che la loro presenza nella frase non appare del tutto ovvia. Ma specialmente lo scrittore è visitato da “quei ricordi vaghi, i quali non si riferiscono a un dato certo, a un fatto o a qualcosa che si è già raccontato più volte, bensì lasciano affiorare sensazioni interiori e remote”, “ricordi di visioni, che abbiamo ignorato e lasciato perdere” (EGA, p. 36). È questa, a mio avviso, una dichiarazione di poetica a tutti gli effetti. Ora, si direbbe del tutto inopportuno spiegare, chiarire e capire quelle espressioni linguistiche che traducono tali sensazioni. Il lettore ideale deve assomigliare ai personaggi di Nadolny, essere ‘impressionabile come un bambino’, perché, a ben vedere, le ragioni del proprio compiacimento e forse addirittura l’eccezionalità dell’opera di Nadolny andrebbero ricondotte al fatto che il tipo di percezione che traspare dal testo, in fin dei conti, non è altro che lo sguardo del bambino sulle cose del mondo. Un esempio che non può essere dimenticato: la percezione di oggetti posti a 70 / LAURA OREGGIONI distanze diverse da una carrozza in corsa in Die Entdeckung der Langsamkeit è oggetto del medesimo stupore e attenzione che colgono il bambino di fronte al fenomeno reale.28 Il lettore si trova così di fronte a un tipo di scrittura assolutamente trasparente, che svela i suoi meccanismi, parla di sé, “un narrare del narrare” (ein Erzählen dieses Erzählens), una scrittura che riflette su se stessa con una coscienza assolutamente lucida, “non volta a trasmettere qualcosa, bensì autoconsapevole” (EGA, pp. 25, 124): lo stesso accade a chi (il lettore-bambino) non riesca a privarsi dell’incanto della parola e per sua natura, inspiegabilmente, debba farvi ritorno. È dote rara e raffinata l’origine della meraviglia e del compiacimento – si potrebbe quasi dire un orecchio assoluto per la parola: chi la possiede, per esempio, muove dall’ossessione di voler dire tutto e propende a volte alla superstizione ingenua.29 Infine, l’opera di Nadolny si offre come una sorta di trattato sulla parola. È per lo più una parola non definitiva, la quale, piuttosto che affermare, lascia intendere anche qualcosa d’altro, mette in dubbio se stessa: “quanto più si sforzava di descrivere i fatti reali, tanto più questi sembravano sfuggirgli. Quello che sapeva per esperienza, se formulato si trasformava in qualcosa che anche lui stesso ormai vedeva solo come un’immagine. Non c’era più confidenza, subentrava invece il fascino dell’ignoto” (EDL, p. 246). È una parola che sfugge a una presa sicura; d’altronde, il desiderio di poter disporre di essa è del tutto vano e costringe a verificare costantemente ciò che si è detto con ciò che si era voluto dire.30 A volte essa afferma e subito dopo smentisce se stessa: “Mi è difficile pensare a Judith. Mi è difficile non pensare a Judith” (N, p. 117). È come se versasse in un Umweg linguistico, una condizione di digressione in uno Zwischenraum alogico, in cui l’espressione del pensiero è regolata da un meccanismo di asserzione e immediata ritrattazione, il quale, infine, la28 Tutto ciò – vale la pena puntualizzarlo – è chiaramente indice di autorialità forte e di creatività geniale, il che sancisce l’estraneità dell’autore di Netzkarte e Die Entdeckung der Langsamkeit da qualsiasi compromissione con l’assunto poststrutturalista della morte dell’Autore. 29 Cfr. EGA, p. 26: “Le fonti d’ispirazione si lasciano facilmente ostruire dall’indiscrezione, specialmente dalla propria”. 30 Cfr. EGA, p. 89: “Nessuno dispone totalmente della lingua, in modo tale da poter esprimere tramite essa ogni meandro e riflesso del suo cervello narrante e neppure della realtà”. LA PUNTA DELL’ICEBERG / 71 scerebbe intendere una sorta di latenza del senso. E tuttavia, ciò non dà adito in alcun modo a una coscienza tragica: “Il tutto forse non quadra, mi è appena venuto in mente o ne ho il sospetto, eppure io penso: ‘Perdio, le cose possono essere anche così! E che cosa succede poi?’”.31 Sembra invece emergere un certo piacere ludico,32 ma soprattutto una vera passione per la parola. Lo scrittore la nota e ne rimane impressionato: “singole, adeguate parole”; “Ora le parole, i singoli vocaboli sono diventati per lei più importanti”; “di quando in quando trova davvero una parola insolita e particolarmente precisa” (EGA, pp. 89, 96). Lo scrittore le considera una a una, si sofferma sulle singole lettere: “preferiva immergersi nello spirito delle lettere singole. Nello scritto esse rappresentavano l’elemento durevole, ricorrente” (EDL, pp. 13-14). A volte egli considera la parola di per sé, svincolata dal suo contesto33 – “La sua mente pensò automaticamente: ‘Gliela faremo vedere!’ Perché questa era la situazione a cui aveva pensato, quando aveva sentito la frase per la prima volta” –, a volte egli ha difficoltà nel riconoscere un significato definitivo al di là della parola: “Ascoltava comunque volentieri e si rallegrava quando i frammenti di discorso captati risultavano aver senso” (EDL, pp. 62, 32). La scrittura non esaurisce la portata del pensiero, essa non regge di fronte alla sua capacità pervasiva; nondimeno, è proprio l’insufficienza della parola a renderla tanto sorprendente: “‘Mio padre era un commerciante’, dice la celebre frase iniziale del ‘Nachsommer’ di Stifter. Non è una frase meravigliosa? Può contenere un mondo intero, proprio perché è sufficientemente vuota – le parole e il lettore fanno la loro parte” (EGA, p. 89). La lingua, dunque, è una sorta di ricettacolo in cui non si riversa tanto un senso, quanto il senso della possibilità. Lo scrittore deve potervi accedere: il narrare deve poter essere sempre un Andersdenken, aperto a nuove possibilità, dal momento che la ragione di tutte le cose potrebbe sempre essere un’altra. Pertanto, egli riconosce che “[s]crivere è […] solo la punta dell’iceberg”:34 un’espressione conclamata, quasi una diagnosi 31 Intervista di Wolfgang Bunzel, cit., p. 136. Cfr. EGA, p. 124: “giocoso, intellettivo, […] buffonesco, apparentemente più d’intrattenimento, senza pretese”. 33 Cfr. anche Susan Tebbutt, “Borderlines and Communication: Sten Nadolny’s ‘Die Entdeckung der Langsamkeit’”, in Arthur Williams, Stuart Parke e Julian Preece (a cura di), ‘Whose Story?’: Continuities in contemporary German-Language literature, Bern: Lang, 1998, p. 59: “Nadolny evidenzia il limite fra parole singole e parole nel contesto”. 34 Intervista di Wolfgang Bunzel, cit., p. 136. 32 72 / LAURA OREGGIONI dell’intero suo progetto di scrittura, alla quale affidare il presentimento cronico che ci sia sempre dell’altro a cui pensare. Infine, egli desidera spingersi al di là della scrittura, incontro all’ultimo pensiero trascrivibile: “Là c’è la conoscenza di ciò che una volta si poteva e ora non più. Là si trova la percezione di ciò che si avrebbe potuto fare, ma non si ha fatto. E non ci si dispera di ciò; non si tenta neppure di correggere ancora qualcosa”.35 È la scoperta del presente. 35 Sten Nadolny, “Roman oder Leben—? Diesseits und jenseits des Schreibens”, in Uwe Wittstock (a cura di), Roman oder Leben. Postmoderne in der deutschen Literatur, Leipzig: Reclam, 1994, p. 237. § PARAGRAFO I GENERI § 4 Niccolò Scaffai Altri canzonieri Sulle antologie della poesia italiana (1903-2005) Antologie poetiche nell’età contemporanea. Problemi e tipologia 1. L’antologia poetica, tra le forme di maggior fortuna nello spazio letterario europeo,1 ha conosciuto nei secoli due principali funzioni: accogliere le reliquie di una letteratura cronologicamente esaurita, trasmettere gli esempi di una tradizione poetica in fieri. Nel XX secolo e all’inizio del XXI2 le due funzioni tendono a incrociarsi, talvolta con esiti paradossali; ciò soprattutto in Italia, dove “la lotta tra il vecchio e il nuovo” è stata più forte che altrove.3 Il paradosso dipende dall’attuazione dello scopo conservativo e di quello propositivo4 con la medesima materia prima: poesie degli stessi autori o composte negli stessi anni, lette ora come estreme epifanie di una tradizione di lontana origine, ora come voci di un dizionario di storia letteraria futura. L’ambigua declinazione delle sillogi novecentesche è legata soprattutto alla contemporaneità di autori e compilatori. In primo luogo, è inevita1 Cfr. il numero monografico della rivista Critica del testo, 2:1, gennaio-aprile 1999, dedicato a “L’antologia poetica”, con un saggio introduttivo di Roberto Antonelli, “L’antologia, il tempo e la memoria”; inoltre, Amedeo Quondam, Petrarchismo mediato. Per una critica della forma ‘antologia’, Roma: Bulzoni, 1974. 2 Cfr. Enrico Testa, “Due paragrafi sull’antologia”, Indizi, 2, 1993, pp. 151-59; Anna Nozzoli, “Lo spazio dell’antologia: appunti sul canone della poesia italiana del Novecento”, Archivi del nuovo, 3, 1998, pp. 23-39; Stefano Verdino, “Le antologie di poesia del Novecento. Primi appunti e materiali”, Nuova Corrente, 51:133, gennaio-giugno 2004, pp. 67-94; Sergio Pautasso e Paolo Giovannetti (a cura di), L’antologia, forma letteraria del Novecento, Lecce: Pensa MultiMedia, 2004. 3 Cfr. Stefano Verdino, “Antologia come racconto a tesi. Intervista a Edoardo Sanguineti”, Nuova Corrente, 51:133, gennaio-giugno 2004, p. 104. 4 Edoardo Sanguineti, Premessa a Poesia italiana del Novecento, a cura di Edoardo Sanguineti, vol. 1, Torino: Einaudi, 1969, p. xxvii. PARAGRAFO I (2006), pp. 75-98 76 / NICCOLÒ SCAFFAI bile che a distanza ravvicinata le sfumature siano solchi scavati tra l’uno e l’altro poeta o gruppo. Dalla necessità anche editoriale di classificare autori coevi in capitoli distinti deriva la possibilità che alcune classificazioni si sovrappongano o si contraddicano. In secondo luogo, la prossimità cronologica facilita la militanza e le idiosincrasie più o meno argomentate. Ad esempio, gli autori e i testi fondamentali di una “tradizione del Novecento”5 stimata con criteri linguistico-stilistici non coincidono con i campioni di un secolo letterario misurato con metro tematico-ideologico. In terzo luogo, la posizione relativa dell’antologizzatore rispetto agli antologizzati obbliga il primo a interpretare il proprio secolo (o comunque il periodo considerato) come snodo tra un passato che straripa nel presente e un futuro in costruzione. Ciò è in parte valido per ogni epoca, ma il sentimento del tempo è certo più intenso in un secolo precocemente definito ‘breve’ (quindi esposto ad esercizi di classificazione talvolta intempestivi) eppure destinato a adempiere le attese per un millennio in esaurimento. Tra le conseguenze della contemporaneità vi sono anche polemiche e dibattiti: tra gli editors e i poeti, tra un critico e l’altro sulla vitalità della poesia. Ad infittire le battute del dialogo a distanza contribuisce il doppio mestiere, di critico e di poeta, di molti protagonisti delle antologie. La stessa persona può comparire, tra testo e bibliografia (magari non nello stesso volume ma comunque in un giro di pubblicazioni prossime per intenti, cronologia, destinatario), come curatore, critico o recensore, poeta antologizzato. Il caso non è nuovo né raro: basti pensare a Fortini e soprattutto a Sanguineti. Sembrano però tratti originali degli ultimi anni la sistematicità del fenomeno e la tendenza a trovare in uno dei due mestieri l’implicita autorizzazione allo svolgimento dell’altro. Talvolta può non esser chiaro quale dei due sia il primo lavoro e quale il secondo. Accade, per esempio, che il critico e studioso della lingua letteraria Stefano Dal Bianco, presente in veste di poeta nella collana dello “Specchio” e in alcuni florilegi di poesia contemporanea, scrivendo su una diffusa rivista culturale, esprima – com’è nel suo diritto di recensore – alcune perplessità su una delle antologie di più recente uscita, La poesia italiana dal 1960 a oggi di Daniele Piccini. Accade, di rimando, che Piccini risponda nella me5 È appena il caso di ricordare che “la tradizione del Novecento” è il titolo di una serie di fondamentali volumi di Pier Vincenzo Mengaldo, La tradizione del Novecento: Prima serie, Milano: Feltrinelli, 1975 [nuova ed., Torino: Bollati Boringhieri, 1996]; Nuova serie, Firenze: Vallecchi, 1987 [nuova ed., Torino: Einaudi, 2003]; Terza serie, Torino: Einaudi, 1991; Quarta serie, Torino: Bollati Boringhieri, 2000. ALTRI CANZONIERI / 77 desima sede, difendendo – com’è doveroso – la bontà del suo operato. Ora, il botta e risposta tra chi recensisce e chi è recensito rientra nelle consuetudini di ogni normale repubblica delle lettere. Oltrepassa la norma, tuttavia, il fatto che il recensito, prima di argomentare una coerente risposta, riconduca le critiche del recensore al “dispiacere di vedersi poco stimato come poeta”. Motivo di ‘scandalo’ non sono le rispettabili posizioni dell’uno o dell’altro contendente, ma il rischio che la sovrapposizione non occasionale dei ruoli indebolisca il dibattito tra i critici e tra questi ultimi e i poeti, a svantaggio sia della critica, sia della poesia.6 Agli effetti della cronologia si sommano quelli della produzione: nel Novecento e nei primi anni del Duemila, il numero di poeti e di libri stampati è molto più alto rispetto alla media dei secoli precedenti. Senza qui analizzare nel dettaglio il fenomeno, si osserverà come l’infittirsi della schiera dei poeti renda inevitabile l’aumento di antologie spesso concepite per dare visibilità ad autori che rischierebbero di rimanere sommersi dalla massa di nomi e titoli. Il ritiro del mandato sociale, di cui parla Benjamin,7 non favorisce certo la visibilità dei poeti, né permette che il loro impatto non dico sulla società ma sulla cultura odierna sia apprezzabile. Ne deriva l’impressione erronea che la poesia contemporanea sia uguale e complessivamente insignificante. Erronea, non sottovalutabile: in Italia, a pronunciarsi contro la banalizzazione di un’idea romantica di lirica come ispirazione e contro l’equivoco di una poesia come forma universalmente praticabile sono stati, da punti di vista diversi, intellettuali come Montale e Mengaldo. Il primo, già nel 1963, denunciava i rischi connessi all’estrema accessibilità dell’espressione lirica.8 Il secondo ha osservato che “la società sta creando le condizioni alla poesia per/di tutti non in quanto sia stata liberata e rinnovata ma in quanto al contrario s’impaluda e si sfilaccia sempre più”.9 6 La polemica si è svolta sull’Indice dei libri del mese, 22:11, novembre 2005, e 22:12, dicembre 2005. 7 Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire”, trad. it. di Renato Solmi “Di alcuni motivi in Baudelaire”, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti (1962), a cura di Renato Solmi, Torino: Einaudi, 1995, pp. 89 sgg. 8 Eugenio Montale, “Tutti in pentola”, in Id., Auto da fé, ora all’interno di Id., Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a cura di Giorgio Zampa, Milano: Mondadori, 1996, p. 289. 9 Pier Vincenzo Mengaldo, “Grande stile e lirica moderna”, in Id., La tradizione del Novecento, Nuova serie, cit., p. 14. Cfr. anche Alfonso Berardinelli, “Poesia italiana da ieri al futuro”, in Id., La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, Torino: Bollati Boringhieri, 1994, p. 175. 78 / NICCOLÒ SCAFFAI Il pubblico e i critici, vinti dalla quantità, difficilmente riescono a selezionare per merito singoli esordienti (esordienti autentici, non autori che giungono alla poesia dopo aver praticato altri generi, aver lavorato nell’editoria o intrapreso la carriera accademica). L’antologia assolve così un compito di mediazione tra autori e lettori, tanto più utile quanto più ampia è la materia da ‘lavorare’ per renderne agevole la fruizione; ma la stessa proliferazione rende talvolta incerti il senso e la destinazione delle antologie, alimentando nei casi peggiori il sospetto della loro superfluità. Non si può smentire, insomma, la polemica conclusione cui è giunto Alberto Asor Rosa al termine di una ricognizione sulle antologie poetiche novecentesche: “Più che di nuove antologie […] si sentirebbe oggi il bisogno di nuova letteratura”.10 Asor Rosa passa in rassegna sei antologie, compilate tra il 1903 e il 1996. La sua sfiducia sarebbe forse maggiore al cospetto di una recensio che contempli, tra il 1903 e il 2005, centinaia di titoli (vedi più avanti la tabella, pur allestita non per esaurire l’inventario ma per adempiere l’istanza di sistematicità già da altri suscitata).11 Ciò escludendo dal novero la maggior parte delle antologie, anche pregevoli, concepite e adottate nelle scuole, le sillogi legate a premi letterari oppure di ambito e destinazione regionale o locale (mentre vi devono rientrare, per qualità e varietà delle voci, le antologie dialettali), i numeri ordinari di almanacchi e di riviste: l’inclusione di tali pubblicazioni, certo fondamentali per l’opera di mediazione tra autore e lettore cui si accennava, renderebbe ingestibile un canone già ipertrofico e insignificanti i tentativi di interpretazione. 10 Alberto Asor Rosa, “Sulle antologie poetiche del Novecento italiano”, Critica del testo, 2:1, gennaio-aprile 1999, p. 325. 11 Stefano Verdino, “Le antologie”, cit., p. 67. La tabella integra, almeno per il biennio 2004-2005, l’ampio regesto in Paolo Giovannetti (a cura di), “Per una bibliografia delle antologie letterarie novecentesche”, in Sergio Pautasso e Paolo Giovannetti, op. cit., pp. 29 sgg., molto documentato anche sulle antologie per l’insegnamento, ma di uso e fortuna anche extrascolastici, e su quelle regionali. Il repertorio di Giovannetti è organizzato per voci (Antologie generaliste e Antologie di poesia, a loro volta ripartite in Antologie generali, “Poeti d’oggi”, Antologie di programma, Antologie tematiche, Generi e forme, gruppi e movimenti, La poesia dei luoghi); nella tabella, invece, ho scelto di dare al materiale una disposizione annalistica, avanzando a parte le proposte tipologiche. ALTRI CANZONIERI / 79 Tabella Quando l’editore è seguito da una doppia data (es. 1996-2000), questa si intende riferita al primo e all’ultimo di una serie di volumi; le date tra parentesi quadre (es. [1993]) specificano l’anno dell’effettiva pubblicazione del volume, se diverso dall’anno dichiarato. Tra parentesi tonde, si forniscono i riferimenti a ristampe e nuove edizioni. 1903 – Ai nostri poeti viventi, a cura di E. Levi, Firenze: Tip. Cooperativa-Lumachi. 1912 – I poeti futuristi, con un proclama di F.T. Marinetti e uno studio sul Verso libero di P. Buzzi, Milano: Edizioni futuriste di Poesia. 1914 – Il tesoretto della poesia italiana, nuova ed., Firenze: Barbera. 1915 – Quadri e suoni di guerra. Poesie per i soldati, a cura di A. Monti, Milano: Treves. 1920 – Poeti d’oggi. Antologia compilata da Giovanni Papini e Pietro Pancrazi, Firenze: Vallecchi (seconda ed. riveduta e accresciuta 1925; nuova ed. a cura di A. Romanello, Milano: Crocetti, 1996). 1922 – Le più belle pagine dei poeti d’oggi, a cura di O. Giacobbe, Lanciano: Carabba, 5 voll. (nuova ed. accresciuta 1930, 8 voll.). 1923 – Antologia della poesia religiosa italiana, a cura di G. Papini, Milano: Vita e Pensiero. 1925 – I nuovi poeti futuristi, a cura di F.T. Marinetti, Roma: Edizioni futuriste di Poesia. – Poeti dialettali dei tempi nostri. Italia meridionale, a cura di A. Tosti, Lanciano: Carabba. 1928 – A. Santelli, L’adunata della poesia. Antologia valorizzatrice di duecento letterati italiani, Signa: Innocenti e Pieri (seconda ed., senza sottotitolo, Arezzo: Editoriale Italiana Contemporanea, 1929). – Italica. Prose e poesie della terza Italia, 1870-1928, pref. di E. Bodrero, Torino: Società anonima Casa editrice nazionale, 4 voll. – Poeti Novecento, Milano, Mondadori. 1929 – Scrittori contemporanei, Torino: Ribet. 1930 – E. Falqui ed E. Vittorini, Scrittori nuovi. Antologia italiana contemporanea, pref. di G.B. Angioletti, Lanciano: Barabba. 1932 – Antologia contemporanea di prose e poesie, a cura di G. Luongo e A. Manuppelli, Napoli: Clet. 1933 – E. Falqui e A. Capasso, Il fiore della lirica italiana dalle origini a oggi, Lanciano: Carabba. 1934 – Antologia e una cartina della poesia italiana contemporanea, a cura di A. Donzelli, Napoli: Vulcania. 1935 – C. Mariani dell’Anguillara e O. Giacobbe, Antologia di poeti fascisti, pref. di M. Bontempelli, Roma: Istituto grafico tiberino. – Poeti nostri. Antologia di Poesia contemporanea, Palermo: Chimera/Ed. Alfa. 1936 – Antologia dei giovani poeti e scrittori italiani, intr. di N. Salvaneschi, Milano: Editoriale moderna “900”. 1937 – Le più belle liriche italiane dell’anno, Roma: Modernissima, 1937-40, 3 voll. – Splendore della poesia italiana dalle origini ai giorni nostri, a cura di C. Govoni, Milano: Hoepli (seconda ed. aumentata, con il sottotitolo. Le più belle 500 liriche di tutta la nostra letteratura dalle origini fino ad oggi, Milano: Ceschina, 1958). 1939 – I. Domino, Poesie 1939. Antologia del tempo fascista, Pavia: Casa del Libro. – G. Zoppi, Antologia della letteratura italiana ad uso degli stranieri, Scrittori contemporanei, Milano: Mondadori. 80 / NICCOLÒ SCAFFAI 1940 – I. Domino, Cento e più poeti. Antologia della poesia italiana, pref. di F.T. Marinetti, Firenze; All’insegna del libro [1939]. 1941 – A. Gustarelli, Poeti della grande guerra. La poesia e i poeti della grande guerra. Alcune poesie commentate, Milano: Vallardi. 1943 – L. Anceschi, Lirici nuovi. Antologia di poesia contemporanea, Milano: Hoepli (nuova ed. Lirici nuovi. Antologia, Milano: Mursia, 1964). – Poesie della guerra, a cura di Krimer-Ugo Sarti, Roma: Colombo. 1944 – Perle dialettali. Poesie tra le più belle di trenta dialetti d’Italia, a cura di F. Polvara, Milano: Corticelli. 1945 – F. Giannessi, Invito alla poesia moderna. Breve raccolta di esempi con pref. e saggio, Milano: Poligono. – Poeti antichi e moderni tradotti dai lirici nuovi, a cura di L. Anceschi e D. Porzio, Milano: Il Balcone. – Poeti contemporanei, a cura di B. Dal Fabbro, Milano: Edizioni della Conchiglia. – Poeti lirici moderni e contemporanei con l’interpretazione di G. De Robertis, Firenze: Le Monnier (seconda ed. 1948). 1946 – G. Spagnoletti, Antologia della poesia italiana contemporanea, Firenze: Vallecchi. 1947 – Poeti prigionieri, a cura di G. Ungaretti, Torino: L.I.C.E-Berruti. 1948 – Antologia del sonetto vernacolo contemporaneo, a cura di M. Gastaldi, Milano-Roma: Gastaldi. – Poeti di “Ausonia”, a cura di L. Fiorentino, Siena: Maia, 1948-1950, 3 voll. 1950 – Antologia della poesia italiana (1909-1949), a cura di G. Spagnoletti, Parma: Guanda (edizioni successive 1952, 1954). – Nuovi poeti, a cura di U. Fasolo, Firenze: Vallecchi (Nuovi poeti. Seconda scelta, 1958). – Prima antologia di poeti nuovi, Milano: Edizioni della Meridiana (Seconda antologia, 1951). 1951 – L. Fiorentino, Mezzo secolo di poesia. Antologia della poesia italiana del Novecento, Siena: Maia. – Poetesse del Novecento, a cura di V. Scheiwiller, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. 1952 – C. de Franchis, I poeti del realismo lirico. Antologia, con pref. di A. Capasso, Roma: Edizioni del tripode. – G. Spagnoletti, Poeti del Novecento, Milano: Mondadori (seconda ed. riv. e ampliata, 1973). – Antologia della poesia religiosa italiana contemporanea, a cura di V. Volpini, con note critiche di E. Fenu e altri, Firenze: Vallecchi. – Linea lombarda. Sei poeti, a cura di L. Anceschi: Varese, Magenta. – Poesia dialettale del Novecento. Con traduzioni a piè di pagina, a cura di P.P. Pasolini e M. Dell’Arco, intr. di P.P. Pasolini, Parma: Guanda (nuova ed. con pref. di G. Tesio, Torino: Einaudi, 1995). – Poeti italiani, 1952, a cura di G. Gargiuto, Roma: Pace. 1953 – Lirica del Novecento. Antologia della poesia italiana, a cura di L. Anceschi e S. Antonielli, Firenze: Vallecchi. 1954 – Antologia della poesia italiana. 1909-1949, a cura di G. Spagnoletti, Parma: Guanda. – Poesie alla madre di alcuni poeti italiani contemporanei, a cura di V. Scheiwiller, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. – Quarta generazione. La giovane poesia (1945-1954), a cura di P. Chiara e L. Erba, Varese: Magenta. 1955 – E. F. Accrocca e V. Volpini, Antologia poetica della resistenza italiana, S. Giovanni ValdarnoRoma: Landi. – Antologia popolare di poeti del Novecento, a cura di V. Massello e G.A. Cibotto, Firenze: Vallecchi, 1955-1964. – Il castello. Poeti contemporanei, a cura di B. Rebellato, Padova: Rebellato. ALTRI CANZONIERI – – – – / 81 Il fiore. Rassegna della nuova generazione poetica, a cura di G.M. Mazzini, Firenze: Kursaal. Poeti del nostro tempo, a cura di C. Galasso, Firenze: Di Cinzia. Poeti italiani del secondo dopoguerra, Roma: Labor. Poeti stranieri del Novecento tradotti da poeti italiani, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. 1956 – G. Getto e F. Portinari, Dal Carducci ai contemporanei. Antologia della lirica moderna, Bologna: Zanichelli. – E. Falqui, La giovane poesia. Repertorio e saggio, Roma: Colombo (seconda ed. riveduta e aumentata 1957). – Poeti italiani del secondo dopoguerra. Antologia, a cura di M. Apollonio, Milano: Miano. 1957 – C. Bettelli, Il secondo ‘900. Panorama di poeti dell’ultima generazione, Padova: Amicucci. – Il sonetto. Cinquecento sonetti dal Duecento al Novecento, a cura di G. Getto ed E. Sanguineti, Milano: Mursia. – “Piccola antologia neo-sperimentale”, a cura di P.P. Pasolini, Officina, 9-10. – Poesia contemporanea d’ispirazione religiosa, a cura di G. Gargiuto, Roma: Armonismo. 1958 – Piccola antologia di poeti futuristi, a cura di V. Scheiwiller, Milano: Scheiwiller. – Poesia italiana del dopoguerra, a cura di S. Quasimodo, Milano: Schwarz. – Voci d’Italia (Antologia della poesia dialettale italiana contemporanea), a cura di G. Carpaneto, Modica: Gugnali. 1959 – S. Maturanzo, I poeti del mare. Antologia di poesia italiana ispirata al mare, pref. di R. Corso, Milano-Napoli: Istituto artistico letterario italiano. – Antologia della poesia cattolica italiana del Novecento, a cura di M. Nanteli, Roma: Upsic. – Mazzini nella poesia. Antologia, a cura di T. Grandi, Pisa: Domus mazziniana. – Nuovi poeti dialettali. Antologia, a cura di A. Miano, Milano: Miano. – Poesia italiana contemporanea. 1909-1959, a cura di G. Spagnoletti, Parma: Guanda (seconda ed., 1964). – Poeti italiani del Novecento, a cura di E. Calabria, Bergamo: Editrice la nuova Italia letteraria. 1960 – G.P. Bona, Elogio olimpico. Antologia di poesie sportive da Omero ai giorni nostri, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. – P.P. Pasolini, “Saggio per un’antologia”, Nuovi Argomenti, 46. – Pastor Angelicus. Antologia di poesia cattolica italiana contemporanea, a cura di S. Maturanzo, Milano-Napoli: Istituto Artistico Italiano. – Poeti del Novecento italiani e stranieri, a cura di E. Croce, Torino: Einaudi. – Poeti italiani del Novecento, a cura di F. Lala, Galatina: Mariano (nuova ed. col sottotitolo Dal Pascoli ai giorni nostri, Lecce: Milella, 1964). 1961 – C. Galasso e R. Laurano, Premesse e promesse della giovane poesia. Terza serie di “Poeti del nostro tempo”, Firenze: Cynthia. – Fiore della poesia dialettale, a cura di M. Dell’Arco, Roma: Dell’Arco, 1961-62, 2 voll. (nuova ed., Roma: Il nuovo Cracas, 1963-68, 6 voll.). – I Novissimi. Poesie per gli anni Sessanta, a cura di A. Giuliani, Milano: Rusconi e Paolazzi (nuova e d. riveduta, Torino: Einaudi, 1965; terza ed. 1972; quarta ed. 2003). – Sacerdoti poeti, a cura di R. De Roma e P. Rachetto, Torino: Voci nuove. 1963 – Antologia dei poeti italiani dell’ultimo secolo, a cura di G. Ravegnani e G. Titta Rosa, Milano: Martello (seconda ed., 1972). – Poeti futuristi, a cura di G. Ravegnani, Milano: Nuova Accademia. 1964 – S. Maturanzo, D’Annunzio, il poeta-soldato. Antologia di poesia italiana d’ispirazione d’annunziana, con la versione latina, inglese, francese e nel vernacolo partenopeo, ed in parodia, de La pioggia nel pineto, di G. D’Annunzio, pref. di F. Sapori, Milano: Istituto artistico letterario italiano. – Gruppo 63. La nuova letteratura. 34 scrittori, Palermo, ottobre 1963, a cura di N. Balestrini e A. Giuliani, Milano: Feltrinelli. 82 / NICCOLÒ SCAFFAI – Poesia satirica nell’Italia d’oggi, a cura di C. Vivaldi, Parma: Guanda. – Poeti italiani del Novecento, a cura di F. Lala, Lecce: Milella. 1965 – L. Pignotti, Antologia della poesia visiva, Bologna: Sampietro, 4 voll. – Le cinque guerre. Poesie e canti italiani, a cura di R. Laurano e G. Salveti, presentazione di S. Quasimodo, Milano: Nuova Accademia. – “Poeti nuovi 1945-1965”, a cura di R. Lucchese, Letteratura, novembre-dicembre. 1966 – R. Cervo, Canto di resurrezione. Antologia di poeti contemporanei per la celebrazione del ventennale della Resistenza e del trionfo della libertà nel mondo, Bergamo: Editrice la nuova Italia letteraria. – N. Tripodi, I crepuscolari. Saggio e composizioni, Milano, Edizioni del Borghese. – Antologia impopolare 1966. Con una lettera al signor Bonaventura, a cura di V. Scheiwiller, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. – Da Pound ai novissimi. Profilo per un’antologia dei poeti del Pesce d’oro, a cura di V. Scheiwiller, Milano: All’insegna del Pesce d’oro. – Manuale di poesia sperimentale, a cura di G. Guglielmi e E. Pagliarani, Milano: Mondadori. – Tutte le poesie della “Voce” raccolte e presentate da E. Falqui, Firenze: Vallecchi. 1967 – Poeti simbolisti e liberty in Italia, a cura di G. Viazzi e V. Scheiwiller, Milano: Scheiwiller, 1967-1972, 3 voll. 1968 – M. Guglielminetti, I poeti contemporanei, Torino: SEI. – “Il gesto poetico. Antologia della nuova poesia d’avanguardia”, a cura di L. Caruso e C. Piancastelli, Uomini e idee, 12. – Letteratura dell’Italia unita. 1861-1968, a cura di G. Contini, Firenze: Sansoni. – Il Novecento, a cura di S. Romagnoli, in Antologia della letteratura italiana, diretta da M. Vitale, 5. L’Ottocento (secondo) e il Novecento, Milano: Rizzoli. – Poesia futurista italiana, a cura di R. Jacobbi, Parma: Guanda. 1969 – La preghiera nella poesia italiana. Antologia, a cura di V. Volpini, Caltanissetta-Roma: Sciascia. – Poesia italiana del Novecento, a cura di E. Sanguineti, Torino: Einaudi (nuova ed. 1971). 1970 – La poesia italiana del Novecento, a cura di G. Cattanei, Roma: Edindustria Editoriale, 1970, 2 voll. – Presenze. Antologia della poesia italiana contemporanea, a cura di M. Letizia Cassata, Pisa: Giardini 1972 – B. Basile, La poesia contemporanea. 1945-1972, Firenze: Sansoni. – Antologia della poesia italiana contemporanea, dedicata alla prima impresa spaziale di Yuri Gagarin nella Vostok 1 (1961-1971), Roma: Zeus. – Junior. Antologia della poesia italiana contemporanea, a cura di A. Misuraca, Cefalù: L. Misuraca. 1973 – Cento e passa poeti dialettali, a cura di T. Giùttari e L. Grande, Milano: Todariana. – Per conoscere Marinetti e il futurismo, a cura di L. De Maria, Milano: Mondadori. 1974 – Poeti futuristi, dadaisti e modernisti in Italia, a cura di G. Viazzi e V. Scheiwiller, Milano: Scheiwiller. – Poeti del secondo futurismo italiano, a cura di G. Viazzi e V. Scheiwiller, Milano: Scheiwiller. – Tavole parolibere futuriste (1912-1944). Antologia a cura di L. Caruso e S.M. Martini, Napoli: Liguori, 1974-1977, 2 voll. 1975 – Il pubblico della poesia, a cura di A. Berardinelli e F. Cordelli, Roma: Lerici, (Trent’anni dopo, Roma: Castelvecchi, 2004). – I trovieri. Antologia critica di poeti dialettali italiani, a cura di T. Giùttari, A. Nicolini e P. Serarcangeli, Milano: Todariana (nuova ed. 1978). – 1945-1975. Poesia in Italia, a cura di G. Bonoldi, Milano: Moizzi. ALTRI CANZONIERI / 83 1976 – G. Almansi e G. Fink, Quasi come, Milano: Bompiani (nuova ed., 1991). – V. Boarini e P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione. La cultura letteraria del Novecento: testi e interpretazioni, Bologna: Zanichelli. – Da donna a donna. Poesie d’amore e d’amicizia, a cura di L. Di Nola, Roma: Ed. delle donne. – Donne in poesia. Antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, a cura di B. Frabotta, nota critica di D. Maraini, Roma: Savelli. – La poesia dialettale, a cura di D. Astengo, Torino: Marietti. 1977 – G. Raffo, Guida alla lettura della poesia italiana contemporanea, Roma, Bonacci. – I poeti per Montale, Genova: Bozzi. – Poesie e realtà 1945-75, a cura di G. Majorino, Roma: Savelli (nuova ed., 1945-2000, Milano: Tropea, 2000). 1978 – Dal fondo. La poesia dei marginali. Antologia, a cura di C. Bordini e A. Veneziani, I. Nigris e C. Troianelli per la sezione donne, postfazione di R. Roversi, Roma: Savelli. – Il dialetto da lingua della realtà a lingua della poesia. Da Porta e Belli a Pasolini, a cura di M. Chiesa e G. Tesio, Torino: Paravia. – I poeti del futurismo. 1909-44. Scelta e apparato critico a cura di G. Viazzi, Milano: Longanesi. – La parola innamorata. I poeti nuovi 1976-1978, a cura di E. Di Mauro e G. Pontiggia, Milano: Feltrinelli (nuova ed., 1980). – Qualcosa da ricordare. Raccolta di poesie inedite della Resistenza, a cura di P. Merlino, pref. di M. Salvadori, Roma: Quaderni della Fiap. – Poesia degli anni Settanta, a cura di A. Porta, Milano: Feltrinelli. – Poesia femminista italiana, a cura di L. Di Nola, Roma: Savelli. – Poeti italiani del Novecento, a cura di P. V. Mengaldo, Milano: Mondadori. – Sacerdoti-poeti del Novecento italiano, a cura di S. Spartà, Roma: Spada. 1979 – Di raccolte stagioni. Antologia della poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Oltre Eboli: La Poesia. La condizione poetica tra società e cultura meridionale. 1945-78, a cura di A. Motta, con interventi critici di C.A. Augieri. Intr. di L. Mancino, Manduria: Lacaita, 2 voll. – Poeti italiani di ispirazione cristiana del Novecento, a cura di M. Uffreduzzi, premessa di G. Sommavilla, Genova: Sabatelli. 1980 – S. Folliero, Gli avventoviri. Antologia di poeti contemporanei, Fossalta di Piave: Rebellato. – Care donne. Antologia di poesia, a cura di E. Malagò, pref. di G. Prosperi, Forlì: Forum/ Quinta generazione. – Custodi del tempo. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Gli anni del neorealismo, a cura di C. Venturi e A. Di Cicco, Bologna: Zanichelli. – Negli archi del vento. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Nuovi poeti italiani. 1, a cura di E. Faccioli e altri, Torino: Einaudi. – Per i vicoli del cielo. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Poesia italiana del Novecento, diretta da P. Gelli e G. Lagorio, Milano: Garzanti, 2 voll. (nuova ed., 1988). – Poesia Uno, a cura di M. Cucchi e G. Raboni, Milano: Guanda. – Shake well before using. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Spettacolo all’aperto. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Una porta aperta e una strada. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Una rosa e una rosa e una rosa. Antologia della poesia lineare italiana, a cura di Sarenco e F. Verdi, Verona: Factotum Art. – Voci tra la folla. Antologia di poesia italiana contemporanea, Pisa: Cursi. – Veleno (da Flaiano a Pasolini, da Delfini a Benni). Antologia della poesia satirica contemporanea italiana, a cura di T. di Francesco, Roma: Savelli. 84 / NICCOLÒ SCAFFAI 1981 – R. Barilli, Viaggio al termine della parola, Milano: Feltrinelli. – Dal simbolismo al Déco. Antologia poetica cronologicamente disposta, a cura di G. Viazzi, Torino: Einaudi, 2 voll. – Folia sine nomina. Il nome taciuto. Testi poetici italiani inediti degli anni Ottanta, a cura di C. Ruffato e L. Troisio, pref. di G. Almansi, Bologna: Seledizioni. – Poesia erotica italiana del Novecento, a cura di C. Villa, Roma: Newton & Compton. – Poesia italiana contemporanea, a cura di G. Raboni, Firenze: Sansoni. – Poesia italiana oggi, a cura di M. Lunetta, Roma: Newton & Compton. – Poesia tre, Parma: Guanda. 1982 – M. Montanari, Poesia mariana del Novecento in Italia. Antologia 1910-1963, Arezzo: Diakonia della Theotokos. – Addio a Proust. Poesia italiana del Novecento, Milano: Libreria Meravigli. – Il sesto poeta, pref. di G. Finzi, Milano: Spiragli. – Nuovi poeti italiani. 2, a cura di A. Berardinelli: Torino, Einaudi. – “Poesia per gli anni Ottanta”, presentazione di S. Verdino, Nuova Corrente, 39:88. – Versi d’amore. Inediti di autrici italiane contemporanee, a cura di M. G. Maioli Loperfido, Venezia: Corbo e Fiore. 1983 – Eidolon: le rovine e il senso. Antologia della poesia italiana contemporanea, a cura di Sangiuliano, Roma: Florida. – Gozzano e i crepuscolari, a cura di C. Ghelli, Milano: Garzanti. – La doppia dimenticanza. Poeti della sesta generazione, a cura di S. Fabbri, G. Laureano e M. Quagliotti, con un saggio di G. Baratta, Forlì: Forum/Quinta generazione. – L’io che brucia. La scuola romana di poesia, a cura di R. Paris, Cosenza-Roma: Lerici. – Poeti della quinta generazione, a cura di G. Ramella Bagneri, Forlì: Forum/Quinta generazione. – Poeti di frontiera, a cura di F. Mancinelli, postfazione di G. Manacorda, Roma: Quaderni di Stilb. 1984 – M. Pedrotti Probo, Resistenza e poesia. Antologia di poeti partigiani, pref. di E.F. Accrocca, Roma: Il ventaglio, 3 voll. – Il magico negli occhi. Poeti italiani contemporanei, a cura di A. Gaccione, intr. di M. Spinella, Milano: SquiLibri. – L’affermazione negata. Antologia di “Altri termini”. Poesia, teoria, critica, con un saggio di M. Carlino, Napoli: Guida. – La poesia in Italia al passaggio degli anni Ottanta. Antologia, a cura di F. Doplicher, in Poesia della metamorfosi, a cura di F. Doplicher, U. Piersanti e D. Zacchilli, Roma: Quaderni di Stilb. – La svolta narrativa della poesia italiana, a cura di G. Dego, L. Zaniboni e M. Straus, pref. di G. Dego, Lecco: Agielle. – Le parole di legno. Poesia in dialetto del Novecento italiano, a cura di M. Chiesa e G. Tesio, Milano: Mondadori, 2 voll. – Nuovi poeti italiani. 3, a cura di W. Siti, Torino: Einaudi. – Nuovi segnali. Antologie delle poetiche verbovisuali italiane negli anni Settanta e Ottanta, Rimini: Maggioli. 1985 – – – – La poesia contemporanea, pref. di B. Maier, Milano: Miano (quinta ed. riveduta, 1997). Made in Italy. Antologia di poesia contemporanea, Pisa: Giardini. Segni di poesia, lingua di pace. Libro di poeti per la pace, a cura di F. Bettini, Lecce: Manni. Testi poetici del Novecento. Antologia, a cura di L. Zaniboni, intr. di O. Locatelli e L. Zaniboni, Lecco, Agielle. – W la poesia, a cura di M. Marchi, Firenze: Vallecchi. ALTRI CANZONIERI / 85 1986 – Coscienza e evanescenza. Antologia dei poeti italiani degli anni Ottanta, a cura di F. Cavallo, Napoli: Società editrice napoletana. – Dialetti d’Italia. Antologia poetica, a cura dell’Associazione nazionale poeti e scrittori dialettali, Roma: Rari nantes/Graf, 1986-2000. – Il pensiero, il corpo. Antologia degli ultimi venti anni della poesia italiana, a cura di F. Doplicher e U. Piersanti, schede critiche di L. Birzoli e M. Lanti, Roma: Quaderni di Stilb. – La passion predominante. Antologia della poesia erotica italiana, a cura di G. Almansi e R. Barbolini, intr. di G. Almansi, Milano: Longanesi (ristampa Parma: Guanda, 1988). – Poesia italiana del Novecento, a cura di E. Gioanola, Milano: Librex. – Poesie d’amore. L’assenza, il desiderio. Le più importanti poetesse italiane contemporanee presentate da trentasei critici, a cura di F. Pansa e M. Bucchich, Roma: Newton & Compton. 1987 – M.M. Gabriele, Il segno e la metamorfosi, Forlì: Forum/Quinta generazione. – E. Gentile, La letteratura della Resistenza. Testimonianze e testi di narrativa e di poesia, Napoli: Federica & Ardia. – I. Vincentini, La pratica del desiderio. I giovani poeti negli anni Ottanta, Caltanissetta-Roma: Sciascia. – Argini: antologia della nuova poesia italiana, a cura di F. Castellano, Brescia: Edizioni bresciane. – Canti dell’universo. Dieci poeti italiani degli anni Ottanta, a cura di T. Broggiato, pref. di M. Luzi, Milano: Marcos y Marcos. – Poeti dialettali del Novecento, a cura di F. Brevini, Torino: Einaudi. 1988 – Franco Fortini, I poeti del Novecento, Roma-Bari: Laterza. – Amore amore. I poeti e gli scrittori italiani contemporanei raccontano il loro poeta più amato e ne presentano i versi a loro più cari, a cura di F. Pansa, Roma: Newton & Compton. – Donne in poesia. Incontri con le poetesse italiane, a cura di M. P. Quintavalla, Milano: Comune (seconda serie, Milano: Comune / Udine, Campanotto, 1992). – 80 poesia, a cura di F. Manzoni, Milano: Nuovi autori. 1989 – Poesia italiana della contraddizione, a cura di F. Cavallo e M. Lunetta, Roma: Newton & Compton. – Poesia italiana (1941-1988). La via lombarda, a cura di G. Luzzi, Milano: Marcos y Marcos. – Poeti dei giorni nostri. Antologia, Castel Maggiore (Bologna): Book Editore. – Viceverso. Antologia di prosa poetica, Milano: Corpo 10. 1990 – F. Gambetti, Ministoria di una rivistina. “Poeti d’oggi” 1937-1940. Antologia di autori italiani e stranieri, Roma: Auteditroma. – Canzoniere nazionale. Rassegna di poesia di autori italiani, a cura di S. Natale, Catanzaro: Carello. – Gruppo Golfo ’89. Per una poesia come ispirazione, a cura di E. Andriuoli e S. Demarchi, con interventi di V. Vettori, A. Papasso e M. Uffreduzzi, Forlì: Forum/Quinta generazione. – I crepuscolari. Da Gozzano a Palazzeschi, da Govoni a Oxilia, da Corazzini a Moretti, i versi dei poeti che, contro le rivoluzioni, gli eroismi e le utopie, cantarono i sogni della vita quotidiana, Roma: Newton & Compton. – Le più belle poesie d’amore della letteratura italiana. Dalle origini al Novecento, a cura di F. Ulivi e M. Savini, Roma: Newton & Compton. – Poesia italiana del Novecento. Da Gozzano a Zavattini, da Rebora a Montale, da Arbasino a Viviani novantacinque poeti italiani di questo secolo che tutti possono leggere, a cura di E. Pecora, Roma: Newton & Compton. 1991 – Dio nella poesia del Novecento, a cura di R. Ricchi e M. Rosito, note bibliografiche di A.C. Maremmi, Firenze: Firenze libri. – Fiori di passiflora. Antologia della poesia religiosa contemporanea, a cura di M. Di Campli, pref. di W. Mauro, Lanciano: Carabba. – “I sensi della poesia. 1980-90. Antologia”, a cura di L. Pignotti, Zeta, 12:14-16. 86 / NICCOLÒ SCAFFAI – Le donne della poesia. Oltre il femminile, a cura di D. Cara, Castelbolognese: Laboratorio delle arti. – Mozione dei poeti comunisti, pref. di F. Bettini, Lecce: Manni. – Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Spagnoletti e C. Vivaldi, Milano: Garzanti, 2 voll. – Poeti e pittori per un centenario. CGIL 1891-1991, Torino: Allemandi. – Poeti d’Italia, a cura di E. Golino e G. Spagnoletti, consulenza di M. Corti, Milano: Bompiani (vol. IV: Pasolini e i moderni). – Presenze poetiche. Antologia critica di autori italiani, a cura di S. Natale, Catanzaro: Carello. – Tanto gentile. Antologia di poesia al femminile, a cura di D. Attubato, Potenza: Il salice. – Zibaldone poetico italiano. Repertorio commentato, a cura di S. Natale, Catanzaro: Carello. 1992 – Antologia dei poeti di “Il cittadino”, a cura di S. Fumich, pref. di F. Pollavera, con un saggio introduttivo di R. Lollo, Milano: Prometheus. – Antologia della poesia contemporanea, Poggibonsi: Lalli. – Gruppo ’93. Le tendenze attuali della poesia e della narrativa. Antologia di testi teorici e letterari, a cura di A.G. D’Oria, Lecce: Piero Manni [1993]. – In my end is my beginning. I poeti italiani negli anni Ottanta/Novanta, Salerno: Ripostes. – L’anello che non tiene. Poesia Oltre-modernità Antagonismo: sui limini della nuova enunciazione poetica, Reggio Emilia: Elytra. – Poesie d’amore del Novecento, a cura di P. Dècina Lombardi, Milano: Mondadori. – Resistenze. Antologia di scritture polispoetiche, a cura di M. Palladini, Roma: Scettro del Re. – Via terra. Antologia di poesia neodialettale, a cura di A. Serrao, intr. di L. Reina, Udine: Campanotto. 1993 – G. Manacorda, Per la poesia. Manifesto del pensiero emotivo, Roma: Editori Riuniti. – S. Natale, Parnaso italiano. Selezione poetica contemporanea, Catanzaro: Carello. – Anni Ottanta. Poesia italiana. Antologia, a cura di L. Cesari, intr. di L. Carifi, Milano: Jaca Book. – Forme poetiche. Antologia critica di autori italiani, a cura di S. Natale, Catanzaro: Carello. – La moneta di Caronte. Lettere per il terzo millennio, a cura di G. Sicari, Milano: Spirali/Vel. – Poeti degli anni Ottanta, a cura di R. Chiapperini, Bari, Levante. – Poeti italiani del secondo Novecento, a cura di A.M. Ludovico, Milano, Centro incontri, 3 voll. – RZZZZZ! Scritture sotterranee, a cura di S. Rotino, Ancona: Transeuropa. – Terza ondata. Il nuovo movimento della scrittura in Italia, a cura di F. Bettini e R. Di Marco, Bologna: Synergon. 1994 – F. Ulivi e M. Savini, Poesia religiosa italiana. Dalle Origini al Novecento, Casale Monferrato: Piemme. – Poeti di Novecento, a cura di F. Manescalchi, Firenze: Novecento. – Ravenna. Il mercatino della poesia (1979-1994). Una scelta di testi, a cura di M.G. Maioli Loperfido, Ravenna: Essegi. – Una strana polvere. Altre voci per i nostri anni, a cura di P. Lagazzi e S. Lecchini, Udine: Campanotto. 1995 – G. De Angelis, Il canto ritrovato. D’Annunzio e i poeti contemporanei, Pescara: Tracce. – Antologia poetica della Resistenza italiana, a cura di G. Vacana e G. Minnocci, Frosinone: Amministrazione provinciale di Frosinone. – Con la violenza la pietà. Poesia e resistenza. Antologia dei maggiori poeti italiani, a cura di R. Cicala, introduz. di F. Fortini, Novara: Interlinea. – Haiku in Italia, a cura di G. Manacorda, con una nota di T. Araki, Roma: Empiria. – Il canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, a cura di G. Langella ed E. Elli, Novara: Interlinea (seconda ed. 1997; terza ed. accresciuta, 2004). – L’altro Novecento, a cura di V. Esposito, Foggia: Bastogi, 7 voll., 1995-2003. ALTRI CANZONIERI / 87 – Nuovi poeti italiani. 4, a cura di M. Bersani, Torino: Einaudi. – Poesia civile e politica, a cura di M. Lunetta, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato [1997]. – Poesia italiana del Novecento, a cura di E. Krumm e T. Rossi, Milano: Skira. – Quelle mani, quel volto. Poesie alla madre di autrici e autori italiani da Eugenio Montale a oggi, a cura di M.G. Maioli Loperfido, Ferrara-Roma: Corbo. 1996 – G. De Santi, I sentieri della notte: figure e percorsi della poesia italiana al varco del millennio, Milano: Crocetti. – L. Notari, Oltre il mare ghiacciato. I poeti e l’oggi, Udine: Campanotto. – Approdi. Antologia della poesia mediterranea, a cura di E. Bettini, Milano: Marzorati. – La furia di Pegaso. Poesia italiana d’oggi, a cura di M. Tornar, Milano: Archinto. – Nuovi poeti italiani contemporanei, a cura di R. Galaverni, Rimini: Guaraldi. – Poeti italiani del secondo Novecento, a cura di M. Cucchi e S. Giovanardi, Milano: Mondadori (nuova ed. accresciuta, 2004). – Un ricordo e un pezzo d’eternità. 48 poeti per Montale, a cura di M.G. Loperfido, Ravenna: Edizioni del girasole. – Voce donna, a cura di G. Lauretano, Cesena: Il vicolo-Il ponte vecchio, 1996-98, 3 voll. – Voli in libertà. Liriche del G.U.I.S.Co, a cura di R. Finati, Napoli: Artigrafiche Fiengo. 1997 – Antologia della poesia italiana del Novecento, a cura di R. Riccelli, Catanzaro: Carello. – Canti dell’universo. Dieci poeti italiani degli anni Ottanta, a cura di T. Broggiato, Milano: Marcos y Marcos. – Ci sono fiori che fioriscono al buio. Antologia della poesia italiana dagli anni Settanta a oggi, a cura di S. Caltabellotta, F. Peloso e S. Petrocchi, Milano: Frassinelli. – Melodie della terra. Novecento e natura, a cura di P. Perilli, Milano: Crocetti. – Post modernità e oltre. Testi e figure del Novecento. Poesia, a cura di S. Docimo, Roma: Enap. – Resistenze 2. Memorie random per il prossimo millennio, a cura di M. Palladini, pref. di G. Patrizi, Roma: Arlem. 1998 – L. Zannier, Il rosa del tramonto. Destini poetici dialettali, Udine: Campanotto. – Ante rem. Scritture di fine Novecento, a cura di F. Ermini, saggi critici di G. Baratta e altri, premessa di M. Corti, manoscritti autografi di A. Zanzotto, Verona: Anterem. – Il cuore costante. Poeti italiani del secondo Novecento, a cura di F. Manescalchi e A. Ventura, Firenze: Polistampa. – I poeti italiani della “Voce”, a cura di P. Febbraro, Milano: Marcos y Marcos. – Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, a cura di A. Cortellessa. Pref. di M. Isnenghi, Milano: Bruno Mondadori. – L’inconscio politico. 36 poesie su commissione, a cura di G. Manacorda, Roma: Castelvecchi. – Lune gemelle. Dodici poeti italiani degli anni Novanta, a cura di T. Broggiato, Bari: Palomar. – Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone d’autore in Italia, a cura di L. Coveri, Novara: Interlinea. 1999 – Antologia della poesia italiana. Novecento, a cura di C. Ossola e C. Segre, Torino: Einaudi (nuova ed., 2003). – Gli assassini della tenerezza... Poesie contro la guerra alla Jugoslavia, presentazione di F. Grimaldi, Napoli: La città del sole. – Il verso all’infinito. L’idillio leopardiano e i poeti della fine del millennio, a cura di V. Guarracino, Venezia: Marsilio. – La poesia dialettale, a cura di M. Cucchi, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. – L’altro novecento, a cura di V. Esposito, Foggia: Bastogi. – I poeti crepuscolari, a cura di G. De Rienzo, Milano: Mondadori. – La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, a cura di F. Brevini, Milano: Mondadori (vol. 3: Il Novecento). 88 / NICCOLÒ SCAFFAI – L’opera comune. Antologia di poeti nati negli Anni Settanta, a cura di G. Ladolfi, Borgomanero (Novara): Atelier. – Poesie del mare: poeti italiani del Novecento, a cura di R. Francesconi, Roma: Ufficio storico della Marina Militare. – Poesie di Dio. Itinerario spirituale del Novecento italiano, a cura di E. Bianchi, Torino: Einaudi (nuova ed., 2005). 2000 – Àkusma. Forme della poesia contemporanea, a cura di G. Mesa, Fossombrone: Metauro. – Dagli scapigliati ai crepuscolari, a cura di G. Palli Baroni, scelta ed intr. di A. Bertolucci, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. – I cercatori d’oro. Sei poeti scelti, a cura di D. Rondoni, Forlì: La nuova agape. – I poeti di vent’anni, a cura di M. Santagostini, Brunello (Varese): Stampa. – L’amorosa avventura. Antologia della poesia d’amore italiana contemporanea, a cura di G. Verbano, Catanzaro: Abramo. – La quarta triade. Poesie, a cura di G. Bàrberi Squarotti, G. Gramigna, A. Mundula, Milano: Spirali. – Natale in poesia. Antologia dal IV al XX secolo, a cura di R. Cicala e L. Erba, Novara: Interlinea. – Poesia contro guerra, a cura di A. Doria, con una nota di D. Fo, Milano: Punto rosso. – Poesia del Novecento in Italia e in Europa, a cura di E. Esposito, Milano: Feltrinelli, 2 voll. – Poesia italiana dell’Ottocento e del Novecento. Antologia personale di V. Gassman, Pref. di M. Luzi, Roma: Sossella. – Poeti nel tempo del giubileo, a cura di S. Albisani, Firenze: Paideia. – Verso l’inizio. Percorsi della ricerca poetica oltre il Novecento, a cura di A. Cortellessa, F. Ermini e G. Ferri, premessa di E. Sanguineti, intr. ai saggi di A. G. Gargani, manoscritti autografi di S. Martini, Verona: Anterem. – Vertenza Sud, a cura di D. Giancane, Nardò: Besa Editrice. 2001 – R. Deidier, La fondazione del moderno. Percorsi della poesia occidentale, Roma: Carocci. – Epigrammi italiani. Da Machiavelli e Ariosto a Montale e Pasolini, a cura di G. Ruozzi, Torino: Einaudi. – Gli Argonauti. Eretici della poesia per il XXI secolo, a cura di G. Galzio, pref. di G. Conte, Milano: Archivi del Novecento. – Il mio bicchiere da viaggio. Otto poeti italiani d’oggi, a cura di R. Bettiol, Milano: Archinto. – Il pensiero dominante. Poesia italiana 1970-2000, a cura di F. Loi e D. Rondoni, Milano: Garzanti. – I luoghi dei poeti, a cura di R. Galaverni, Bari: Palomar. – Natale dei poeti. Cento modi di leggere il Natale nella poesia italiana del Novecento, Milano: Àncora. – Poesia europea contemporanea. Antologia di scrittore, a cura di A. Cantò e F. Ermini, Verona: Anterem. – Poesia italiana contemporanea, a cura di S. Fava, Ragusa: Libroitaliano. – Poeti della malinconia, a cura di B. Frabotta, Roma: Donzelli. 2002 – R. Reim, Il corpo della musa. Erotismo e pornografia nella letteratura italiana dal Duecento al Novecento. Storia, antologia, dizionario, Roma: Editori Riuniti. – Appunti critici. La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte, a cura di G. Linguaglossa, Roma: Edizioni Libreria Croce-Edizioni Scettro del Re. – Dieci poeti italiani a cura di M. Clementi, con la collaborazione di M. Cucchi, P. Perilli e R. Roversi, Bologna: Pendragon. – Elogio della rosa. Da Archiloco ai poeti d’oggi, a cura di G. Davico Bonino, Torino: Einaudi. – Gruppo 63. L’antologia, a cura di N. Balestrini e A. Giuliani, Torino: Testo & Immagine. – Il canto del cielo. Gli angeli nella poesia italiana del Novecento, a cura di G.B. Gandolfo e L. Vassallo, Milano: Àncora. ALTRI CANZONIERI / 89 – L’imbuto bianco. Antologia di poesia italiana contemporanea. Con trad. in arabo, a cura di F. Buffoni, trad. di E. Anaya, Milano: Marcos y Marcos. – Passaggio sul mare. Poeti al Grand Hôtel Cervia, a cura di R. Galaverni, Milano: Archinto. – Per amore. Il sentimento amoroso nei versi più belli della poesia italiana contemporanea, a cura di F. Pansa, Roma: Newton & Compton. – Poesia del Novecento italiano, a cura di N. Lorenzini, Roma: Carocci, 2 voll. (1. Dalle avanguardie storiche alla seconda guerra mondiale; 2. Dal secondo dopoguerra a oggi). – Poeti italiani verso il nuovo millennio, a cura di D. Maffia, Roma: Edizioni Libreria CroceEdizioni Scettro del Re. – Vent’anni di poesia. Antologia di poeti premiati 1982-2002, Firenze: Passigli. – Versi d’amore: cento liriche di poeti italiani del Novecento per leggere e vivere l’amore nel terzo millennio, a cura di A. Donadio, Cinisello Balsamo: San Paolo. 2003 – Antologia della poesia italiana contemporanea (1980-2001), a cura di C. Vitiello, presentazione di G. Ferroni, Napoli: Pironti. – Lirici e visionari. Poeti italiani contemporanei, a cura di A. Moscè, Ancona: Il lavoro editoriale. – Ottanta poeti contemporanei. Omaggio a Luciano Erba per i suoi ottant’anni, con un saluto di P. Jacottet, Novara: Interlinea. – Parole di passo. Trentatré poeti per il terzo millennio, a cura di R. Crovi e altri, Torino: Aragno. – Pasqua dei poeti. Cento modi di leggere la Pasqua nella poesia italiana del Novecento, a cura di G.B. Gandolfo e L. Vassallo, Milano: Àncora. – Poesie d’amore per un anno, a cura di G. Davico Bonino, Torino: Einaudi. – Tutta la forza della poesia, a cura di D. Bulfaro e L. Picchi, Morbegno: Labos. – Un’altra voce. Antologia di poesia italiana contemporanea. Con trad. portoghese, a cura di F. Buffoni, trad. di G. Lanciani, Milano: Marcos y Marcos. 2004 – – – – – – – – G. Manacorda, La poesia italiana oggi. Un’antologia critica, Roma: Castelvecchi. 110 poesie per sopravvivere, a cura di M. Cucchi, Parma: Guanda. Nuovi poeti italiani. 5, a cura di F. Loi, Torino: Einaudi. Nuovissima poesia italiana, a cura di M. Cucchi e A. Riccardi, Milano: Mondadori. Oltre il tempo. Undici poeti per una metavanguardia, Reggio Emilia: Diabasis. Quell’infinito amore. Poesie italiane d’amore e d’affetto, Milano: Scheiwiller. Regina poetarum. Poeti per Maria nel Novecento italiano, Cinisello Balsamo: San Paolo. Voci di dentro. Poesie di ragazzi detenuti negli istituti di pena minorile, Pisa: ETS. 2005 – F. Giacomozzi, Campo di battaglia. Poeti a Roma negli anni Ottanta, intr. di G. Sica, Roma: Castelvecchi. – Conatus. Antologia di poesia contemporanea. L’utopia come bisogno, la poesia come seduzione, a cura di L. Giuggioli e S. Molinaroli, Roma: Coniglio Editore. – Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa, Torino: Einaudi. – Folia sine nomine secunda. 84 poeti anonimi, a cura di C. Ruffato e L. Troisio, Venezia: Marsilio. – L’amore, l’amicizia. Poesie edite e inedite, Milano: Baldini Castoldi Dalai. – La poesia italiana dal 1960 a oggi, a cura di D. Piccini, Milano: Bur. – “Nuovi poeti italiani”, a cura di P. Zublena, Nuova Corrente, 52:135. – Parola plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, a cura di G. Alfano, A. Baldacci, C. Bello Minciacchi, A. Cortellessa, M. Manganelli, R. Scarpa, F. Zinelli e P. Zublena, Roma: Sossella. – Poesia, n. 200, intr. di E. Savino (Il sesto senso della poesia) e antologia di 400 poeti del Novecento, con fotografia degli autori, Milano: Crocetti. – Poesia nazionale italiana. Antologia di testi, a cura di M. Beer, Roma: Bulzoni. – Samidzat. Giovani poeti d’oggi, a cura di G. Manacorda, Roma: Castelvecchi. – Trent’anni di Novecento. Libri italiani di poesia e dintorni (1971-2000), a cura di A. Bertoni, Castel Maggiore (Bologna): Book Editore. 90 / NICCOLÒ SCAFFAI 2. La cronologia mette in luce alcuni dati: 1) La precocità delle proposte antologiche rispetto alla durata del secolo: negli anni Cinquanta ne erano già disponibili varie e autorevoli (Papini-Pancrazi, Anceschi-Antonielli, Spagnoletti). Col progresso del tempo si definisce, inoltre, una coscienza del Novecento come periodo autonomo dall’Ottocento, anche se le antologie a cavallo tra l’una e l’altra epoca si pubblicano ancora oltre la metà del secolo: Contini 1968. 2) L’incremento delle pubblicazioni. Lo scarto avviene nei primi anni Cinquanta; nei Settanta l’antologia tende a farsi ‘genere’, perdendo il carattere di avanguardistica eccezionalità mantenuto negli anni Sessanta. 3) Il raggiungimento di un picco nel 1980. Vi si collega la percezione degli anni Ottanta come epoca rappresentativa: di qui le molte antologie sui poeti di quegli anni (di fatto, quasi un sottogenere sviluppatosi fino alla metà degli anni Novanta). 4) Il tempestivo interesse per i dialettali (1925), attenuatosi per tornare in auge nel secondo Novecento. 5) La corrispondenza tra evoluzione del contesto storico-sociale e successo dei temi: ad esempio, il progressivo affievolirsi del tema bellico con l’aumentare della distanza dagli eventi (a parte i recuperi storici come Cortellessa 1998) e la recente fortuna delle antologie femminili. 7) La propensione dei critici ‘giovani’ a raccogliere le poesie dei coetanei, particolarmente intensa negli anni successivi al 2000 e soprattutto nel 2005. Il fenomeno risalta dal confronto con il periodo corrispondente del secolo trascorso: nel primo decennio del Novecento si conta a malapena un’antologia di “poeti viventi”; nel primo lustro del Duemila ne sono state pubblicate diverse decine. 3. Le antologie contemporanee possono essere distinte prima di tutto in base a due criteri, intrinseco e estrinseco: l’uno riguarda contenuto e struttura della raccolta, l’altro aspetti non direttamente connessi con i testi o con la forma del macrotesto antologico, come editore o curatore. Le categorie qui proposte non devono esaurire l’intera casistica e non sempre vi sono rigide distinzioni o reciproca incompatibilità tra l’una e l’altra. La sistemazione non vale, insomma, come classificazione definitiva, ma come individuazione di casi concreti e ausilio per l’interpretazione.12 12 Altre categorie contempla Stefano Verdino, “Le antologie”, cit., pp. 68-69: I poeti d’oggi, Il Novecento, La lirica italiana, Dall’Unità d’Italia, Di tendenza, Militante, Europea, Esemplificativa, Scolastica, Multipla. ALTRI CANZONIERI / 91 In base al contenuto, dunque, si danno antologie: Canoniche, che tendono a proporre o confermare un canone di autori selezionato in base a criteri diversi, di nuovo intrinseci o estrinseci (da un lato la consistenza formale oppure la prossimità a una linea dominante o a una poetica, dall’altro la fortuna presso i continuatori, i critici, gli insegnanti oppure la visibilità nell’ambito dell’editoria maggiore).13 La selezione, che spesso sacrifica voci dissonanti, è compensata dall’ampiezza dell’arco diacronico, per cui il canone di un secolo o di un cinquantennio può comprendere decine di poeti. Sono canoniche, ad esempio, Mengaldo 1978, Cucchi-Giovanardi 1996, Ossola-Segre 1999. Tematiche, cioè imperniate su un solo tema di respiro tale da giustificare e rendere praticabile l’allestimento dell’antologia. I temi di maggior fortuna sono l’amore, la fede, la guerra. Per il primo, si veda Dècina Lombardi 1992 o Davico Bonino 2003; per il secondo Volpini 1952 o Bianchi 1999; per il terzo Cortellessa 1998. Di genere, concepite per raccogliere versi non tanto omogenei dal punto di vista tematico, quanto codificati in base a convenzioni linguistico-formali. Sono di genere le antologie satiriche di Vivaldi 1964 e Francesco 1980. Ispirate alla costanza di un codice formale sono anche Manacorda 1995 e Ruozzi 2001. Programmatiche, allestite per l’espressione delle istanze di un gruppo che ha maturato una coscienza condivisa o che riceve da un critico il crisma di ‘scuola’: Marinetti 1912, Anceschi 1952, Giuliani 1961, Balestrini-Giuliani 1964, Di Mauro-Pontiggia 1978, Bettini-Di Marco 1993. Generazionali, dedicate a poeti prossimi per ragioni di anagrafe. Rientrano nella categoria Chiara-Erba 1954, Ladolfi 1999, Santagostini 2000. Se l’idea di generazione viene messa in relazione con la data d’esordio, invece che con quella di nascita, antologie generazionali sono anche, per esempio, le cinque serie dei Nuovi poeti italiani pubblicate da Einaudi. Cronologiche, che prendono in considerazione testi scritti entro un arco di tempo definito. Se il periodo è breve e vicino all’anno di allestimento, l’opera avrà anche implicazioni programmatico-generazionali; se il periodo è più esteso, l’antologia assumerà una funzione canonica. Hanno termini cronologici Spagnoletti 1954, Quasimodo 1958, Contini 1968. Limiti più laschi sono quelli di Testa 2005 e Piccini 2005, comunque 13 Cfr. Massimo Onofri, Il canone letterario, Roma-Bari: Laterza, 2001, pp. 54-64. 92 / NICCOLÒ SCAFFAI tendenti o a individuare una cesura cronologica nel secolo trascorso o a mettere in rilievo la continuità tra quello e l’inizio del secolo presente. Speciali, che accolgono testi e autori estravaganti, vuoi per ragioni linguistiche (è il caso delle molte antologie di poesia dialettale), vuoi per fattori diastratici (ad esempio Voci di dentro 2004). In quest’ambito, una categoria speciale è la poesia femminile (cfr. Frabotta 1976). Dal punto di vista strutturale, è possibile distinguere almeno tre diverse forme di ordinamento interno: Diacronico, quando la successione degli autori si basa sulla cronologia, delle rispettive opere più che della nascita (Mengaldo 1978). Rientra nella categoria, come estrema applicazione del principio diacronico, Bertoni 2005. Tipologico, quando gli autori sono raggruppati secondo le poetiche o in base ad analogie di ordine linguistico, tematico, geografico, generazionale. Sono ordinate tipologicamente Ossola-Segre 1999 e Cucchi-Giovanardi 1996. La prima combina, con solidità un po’ scolastica, l’ordine cronologico e quello tipologico: così, subito a ridosso dell’esordiale Gozzano, si trovano “I crepuscolari”; il capitolo “Marinetti e il futurismo” accoglie, oltre all’autore eponimo, Buzzi, Cavacchioli, Altomare, Folgore, Soffici; non si fa cenno, ovviamente, alla logora e presunta triade ermetica, ma Ungaretti, Montale e Quasimodo sono comunque allineati in sequenza verso la metà del tomo primo; una sezione di “poesia in dialetto” è incastonata tra Luzi e Fortini.14 La seconda antologia è ripartita in sezioni meno prevedibili, alcune meritevoli di un’attenta verifica: “L’etica del quotidiano”, “Cinque percorsi appartati”, “In dialetto”, “Narratori poeti”, fino a “Per un nuovo progetto”. Teleologico, quando la sequenza dei capitoli tende a un approdo coerente con le premesse critiche o con la poetica del curatore. L’esempio maggiore è Sanguineti 1969, chiusa da una selezione di testi della “Nuova avanguardia” (gli autori sono Giuliani, Porta, Balestrini), cui lo stesso curatore appartiene. Ad incidere sulla struttura e sull’assetto delle antologie è anche la variabile dell’estensione, intesa in senso sia quantitativo, sia cronologico. Le antologie possono includere pochi autori (diciannove in Piccini 2005) o contemplare un canone ampio (quarantatré poeti in Testa 2005, sessanta14 Sulla selezione e la disposizione degli autori nell’antologia Ossola-Segre cfr. Pietro Cataldi, “Il canone e la critica. La poesia moderna nell’antologia di Segre e Ossola”, Allegoria, 12: 34-35, gennaio-agosto 2000, pp. 258-67. ALTRI CANZONIERI / 93 quattro in Alfano e altri 2005, ancora di più in Cucchi-Giovanardi 1996). Oltre agli autori contano, naturalmente, i testi e la loro quantità, più ampia nelle antologie canoniche, ridotta in altre categorie. L’arco cronologico avrà diversa ampiezza in base al contenuto e all’intento della raccolta. L’idea stessa di canone implica un periodo di tempo abbastanza lungo per la decantazione di gusti e valori o per la valutazione della fortuna incontrata dagli autori; la dimensione ideale, come mostrano specialmente le sillogi di Sanguineti 1969, Mengaldo 1978, Ossola-Segre 1999, è quella del secolo. Al contrario, le antologie generazionali e programmatiche devono la loro stessa efficacia propositiva alla tempestività con cui vengono registrate le nuove voci. La varietà strutturale può anche essere indice e riflesso della distinzione funzionale. Su questo piano, abbiamo già separato a priori le antologie di uso scolastico dalle altre; ciò non toglie che anche le crestomazie non direttamente concepite per lo studio e l’insegnamento possano avere una funzione in certa misura didascalica, attuata attraverso gli apparati: cappelli introduttivi, note di commento, schede bio-bibliografiche. È soprattutto la presenza del commento, in particolare delle note, a marcare una differenza funzionale (introduzioni e schede sono presenti nella maggior parte delle antologie, specialmente in quelle recenti: di alta densità critica sono, in particolare, i cappelli di Mengaldo 1978 e Testa 2005). Sanguineti 1969 introduce, sia pure in modo sporadico, chiose di commento letterale e rimandi intertestuali; i testi presenti nell’antologia Ossola-Segre 1999 sono invece sistematicamente annotati, con note metriche seguite dai commenti a piè di pagina. Tra le antologie pubblicate nel 2005, La poesia italiana dal 1960 a oggi di Piccini è l’unica con annotazioni, essenziali ma sistematiche, sulla metrica e la lettera del testo. I fattori estrinseci in base ai quali è possibile distinguere le antologie sono almeno due: le sedi editoriali e le figure dei curatori. Per le prime, il discrimine un po’ grossolano ma necessario è tra le grandi e le piccole case editrici. Per restare ai volumi pubblicati nel 2005, due provengono dall’editoria maggiore (Piccini da Rizzoli, Testa da Einaudi), le altre dalla minore. La classificazione non riguarda solo tiratura e diffusione, ma anche destinatari e specializzazione. L’editoria minore contempla infatti case editrici che da anni trovano nelle pubblicazioni di poesia un settore trainante (Castelvecchi, Crocetti) e altre che vi intravedono l’occasione di arricchire un catalogo votato alla sperimentazione (Sossella). Le distinzioni estrinseche confermano, in generale, quelle intrinseche. Le case edi- 94 / NICCOLÒ SCAFFAI trici canoniche tendono a pubblicare antologie canoniche (spesso stampate o ristampate in edizione economica, come i classici della narrativa), quelle settoriali e sperimentali antologie programmatiche, generazionali, speciali. Ciò vale sia per il presente (oltre a Piccini 2005 e Testa 2005 vi sono Ossola-Segre 1999, ancora da Einaudi, e Cucchi-Giovanardi 1996, da Mondadori), sia per il passato: Anceschi 1952 esce da Magenta, mentre Sanguineti 1969 e Mengaldo 1978 rispettivamente da Einaudi e Mondadori. In merito ai curatori, le variabili riguardano numero e ruolo intellettuale. Per la prima variabile, prevalgono le antologie in cui figura un solo responsabile, ma numerose sono anche quelle con un doppio curatore. Spesso, come in Ossola-Segre 1999 e Lorenzini 2002, gli editors principali ne coordinano altri cui è delegata la cura di uno o più autori: sono le antologie cosiddette ‘multiple’.15 Nel repertorio considerato, solo un’antologia, Parola plurale (2005), è allestita da un’équipe, comprendente otto curatori. Si dà inoltre il caso, abbastanza raro, delle antologie anonime (si vedano, ad esempio, Mozione dei poeti comunisti del 1991).16 Da rilevare, infine, la presenza dei medesimi curatori in antologie diverse (dei serial editors, per così dire): Spagnoletti e Scheiwiller (quest’ultimo nel doppio ruolo di curatore/editore) e, in anni più recenti, Cucchi, Cortellessa e altri. Per la seconda variabile, fatta salva la possibilità del ‘doppio mestiere’ – poeta e critico – su cui già si è riflettuto, la casistica prevede almeno i seguenti ruoli: editoriale (Scheiwiller, Riccardi); militante (specie nelle antologie programmatiche e generazionali – Balestrini-Giuliani 1964 – ma presente anche in sillogi di altra categoria: Sanguineti 1969); accademico (determinato non solo dalla patente professionale ma anche dalla volontà di scegliere e distinguere gli autori in base a criteri oggettivi – come, per Mengaldo 1978, la cronologia del primo libro – o a tradizioni consolidate, come nel caso di Ossola-Segre 1999); poetico (cioè assunto da poeti ‘di professione’; la categoria è riconoscibile per la soggettività della selezione e l’assenza degli intenti programmatici, propri invece del ruolo militante: cfr. Loi-Rondoni 2001). È trasversale la classe dell’antologia ‘d’autore’, introdotta da Stefano Verdino con riguardo a sillogi di varia indole e perio15 Stefano Verdino, “Le antologie”, cit., p. 69. Cfr. Simone Giusti, “I dintorni dell’antologia”, in Sergio Pautasso e Paolo Giovanetti (a cura di), op. cit., p. 96. 16 ALTRI CANZONIERI / 95 do, da Falqui-Capasso 1933 a Contini 1968, Sanguineti 1969, Mengaldo 1978. Merita la definizione un’antologia che non sia più “repertoriale, ma specchio dell’ideologia e della poetica critica del compilatore”. “Si tratta” prosegue Verdino “di antologie temperate da una vocazione saggistica e critica, che è elemento del tutto peculiare del quadro italiano, rispetto al contesto europeo, anche francese, da cui pure si presero le mosse”.17 Tra le recenti crestomazie, quella cui meglio si attaglia la qualifica ‘d’autore’, in ragione della coerente impostazione critica, è Testa 2005. Quattro antologie (2005): Dopo la lirica, Trent’anni di Novecento, La poesia italiana dal 1960 a oggi, Parola plurale “Gli anni Sessanta” scrive Testa nell’Introduzione a Dopo la lirica “costituiscono una delle fasi più significative della storia del secondo Novecento. In Italia sono, secondo l’analisi di Pasolini, il momento del ‘trauma’ […]. In questo rivolgimento […] la poesia interviene con una radicalità che forse non ha precedenti nel corso del Novecento. Ciò vale soprattutto sul piano linguistico, dove [cadono le] ‘paratie della secolare separazione di lingua della poesia e lingua della prosa’” (pp. v-vi). Da questa premessa deriva la scelta degli autori, dei testi e del titolo dell’antologia. I poeti inclusi in Dopo la lirica vanno dai quattro ‘maestri’ (Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci) ai poeti nati negli anni Cinquanta (come Frasca, Pusterla, Anedda).18 L’ordine generazionale conosce qualche inversione (ad esempio, Tiziano Rossi segue Patrizia Valduga), ma nel complesso l’andamento è scandito dalla cronologia, sulla scia di Mengaldo 1978. Le due antologie condividono anche l’assenza di partizioni e raggruppamenti interni; tuttavia, diversamente da quella di Mengaldo, l’antologia di Testa non è policentrica, perché individua, in base a categorie stilistiche (il parlato, il modo dialogico, la presenza di personaggi diversi dall’io lirico) o tematico-stilistiche (il dialogo con i morti, la deriva dell’io, l’irruzione del quotidiano) un’unica cruciale modalità di espressione ‘post-lirica’. L’esigenza di reperire i versi che meglio soddisfino le condizioni stilistico-tematiche poste nell’Introduzione spiega la ridotta quan17 Stefano Verdino, “Le antologie”, cit., p. 73. Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Volponi, Erba, Orelli, Cacciatore, Giudici, Ripellino, Pagliarani, Sanguineti, Porta, Rosselli, Raboni, Loi, Baldini, Neri, Bandini, Bellezza, Cucchi, Viviani, Conte, Ciabatti, Cavalli, De Angelis, Carifi, Merini, Ortesta, Scataglini, D’Elia, Valduga, Rossi, Magrelli, Benzoni, Ranchetti, De Signoribus, Sovente, Frasca, Pusterla, Anedda. 18 96 / NICCOLÒ SCAFFAI tità di poesie. Tale esigenza e la conseguente selezione (talvolta un po’ severa) confermano quanto è, del resto, ovvio: la costanza del modo post-lirico nella poesia del secondo Novecento è un assunto programmatico. Ciò non toglie che, tra le antologie degli ultimi anni, quella di Testa sia l’unica a suggerire un canone coerente nelle premesse formali, ragionevole nelle dimensioni, con pochissime dissonanze. Se anche è vero che per i più la poesia si identifica con l’afflato lirico, non vi è dubbio che, per la qualità degli esiti, la via maestra del secondo Novecento poetico italiano passa dagli autori e dai versi di Dopo la lirica. Trent’anni di Novecento rende anche visivamente apprezzabile ciò che in Mengaldo agisce come principio di metodo: nella trafila del secolo, la successione cronologica delle opere conta più di quella delle date di nascita. L’antologia è per così dire di secondo grado: non tanto i versi sono oggetto della scelta, quanto i libri. Anno per anno, entro l’arco indicato (1971-2000), Bertoni individua alcuni libri dei quali riproduce la copertina (quasi sempre l’originale) e fornisce un’essenziale descrizione tipografico-editoriale, cui seguono il profilo bio-bibliografico degli autori e la selezione dei testi (molto parca, al punto che l’insieme sembra a volte scontare l’originalità con l’eccessiva rapidità). Il merito che va riconosciuto al progetto di Bertoni è comunque di far reagire, con la forza del dato storiografico, autori e soprattutto opere che in altri studi o sintesi sono lontani e perciò più inerti. Ciò emerge già scorrendo i titoli del primo anno, il 1971: Satura di Montale, Viaggio d’inverno di Bertolucci, Trasumanar e organizzar di Pasolini. Maestri che appartengono a tre diverse generazioni, qui convocati e ordinati sulla medesima linea di partenza, a mettere in luce la polifonia delle voci poetiche italiane senza il ricorso a forzose compartimentazioni e false successioni. Nell’antologia della Poesia italiana dal 1960 a oggi curata da Piccini trovano spazio diciannove poeti,19 eletti anche per questioni di gusto ampiamente argomentate nella lunga introduzione. Le sezioni riservate a ciascun autore sono precedute da un cappello introduttivo, la scelta delle poesie è ragionevolmente ricca e distribuita fra opere diverse lungo l’arco delle singole carriere. L’apparato bibliografico è decisamente cospicuo: quasi centottanta pagine, molte di più rispetto al pur notevole corredo di Parola plurale (definito, forse troppo perentoriamente, Bibliografia sulla 19 Erba, Pagliarani, Sanguineti, Porta, Pierro, Rosselli, Giudici, Raboni, Piersanti, Scataglini, Loi, Baldini, Cucchi, De Angelis, Magrelli, Lamarque, Mussapi, Ceni, Rondoni. ALTRI CANZONIERI / 97 poesia italiana contemporanea), in cui tuttavia la secondaria sui singoli autori è dislocata dopo ogni cappello introduttivo. L’effetto è di solidità e utilità, in relazione agli autori contemplati. Sono scongiurati, per onorare un “debito mengaldiano” (così Piccini nell’Introduzione, p. 15) l’ecumenismo e la proliferazione dei poeti e delle categorie. Suscita perplessità, semmai, la delimitazione del canone. Il curatore non si impone una cesura cronologica, includendo così Erba, Giudici, Baldini, tutti nati negli anni Venti, e lasciando da parte almeno due dei loro più importanti coetanei, Fortini e Zanzotto (e Pasolini, che però è assente anche altrove: in Dopo la lirica, ad esempio). Né vale, come discrimine, la cronologia degli esordi: dei poeti della generazione degli anni Venti qui considerati, solo Baldini pubblica la prima raccolta dopo il 1960 (E’ solitèri, 1976); le carriere degli altri, compresi Erba e Giudici, iniziano prima, tra gli anni Quaranta e i Cinquanta. Inoltre, diversamente da Testa, Piccini non adotta un criterio stilistico-tematico netto per la selezione di autori e testi, cosicché il repertorio più ristretto dell’uno appare meno coerente di quello più ampio dell’altro. Poesia plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli aspira all’eccezionalità fin dalla veste materiale: una brossura di buon decoro artistico avvolge un tomo di circa 1180 pagine, dal peso di un kg e mezzo. Unica per la curatela d’équipe, maggiore di Testa e Piccini per quantità di autori, Poesia plurale è il più significativo tra i recenti volumi che ripropongono per l’antologia lo statuto di forma ‘primaria’: non solo riepilogo e selezione del Novecento, ma soprattutto scoperta e inclusione di autori per il nuovo secolo. Di qui i diversi pregi e i pochi punti discutibili dell’opera. Nell’antologia viene restaurata la ripartizione in categorie, ma ne è ridotto il numero e alterata la tradizionale funzione rispetto ai precedenti più canonici e vicini. Sono previste, infatti, appena quattro voci: I. Deriva di effetti, II. Ritorno alle forme, III. Rimessa in moto, IV. Apertura plurale. L’economia riscatta la genericità delle formule, abbastanza suggestive da evitare la polverosità o la stravaganza. Le parti sono inoltre in gran parte sincroniche: ciò evita i danni altrove prodotti da una scansione in periodi poco attendibile. Ciascuna categoria è accompagnata da due saggi, uno per ciascun membro dell’équipe. Ogni rubrica introduce una sequenza di poeti, per un totale – come da sottotitolo – di sessantaquattro.20 Tutto è estremamente sorvegliato, dunque, in un’anto20 Viviani, Conte, Cucchi, Coviello, Reta, Cavalli, De Angelis, Frabotta, Sovente, Prestigiacomo, Lamarque, D’Elia, Magrelli, Valduga, Ottonieri, Frasca, Scarabicchi, Benzoni, Benedetti, Salvia, Damiani, Villa, Pagnanelli, Held, Pusterla, Fiori, De Signoribus, Buffo- 98 / NICCOLÒ SCAFFAI logia che concilia la performance specialistica con l’esprit militante e generazionale. Carattere, quest’ultimo, che emerge soprattutto nella scelta degli autori. Collazionando altre antologie poetiche del secondo Novecento si ha l’impressione di poter circoscrivere almeno un repertorio di fatto che includa gli autori presenti più o meno in tutte le sillogi; ma Parola plurale sfugge all’opera di mediazione condivisa o di canonizzazione implicita, poiché molti dei sessantaquattro poeti che include si trovano soltanto qui. Ciò ha delle conseguenze positive, come far luce sulla “nuova letteratura”, la cui latitanza preoccupava Asor Rosa, ed evitare la sensazione di déjà vu. Può anche avere, però, risvolti problematici, legati allo stesso regime democratico che ha animato il progetto: in presenza di una selezione affidata per lo più al gusto o alle competenze dei singoli curatori, in assenza di un criterio di tipo stilistico o tematico (magari limitativo ma condiviso) che armonizzi e con ciò motivi le inclusioni, la felicità di alcune scelte è legata a una scommessa. Questo è senz’altro nelle legittime intenzioni dell’équipe; tuttavia, nei confronti di quale pubblico, se non quello di altri specialisti o autori, svolge il compito di mediazione un’antologia che abbia le proporzioni e accolga i poeti di Parola plurale? ni, Testa, Tripodo, Fo, Mesa, Frixione, Durante, Voce, Bàino, Gentiluomo, Berisso, Pierno, Pinto, Nove, Lo Russo, Grisoni, Rentocchini, Cecchinel, De Vita, Nadiani, Villalta, Dal Bianco, Anedda, Febbraro, Trinci, Bonito, Zuccato, Gardini, Inglese, Lombardo, Biagini, Frene, Maccari, Fusco, Santi, Giovenale, Sannelli. § 5 Gabriele Bugada Lo specchio del sogno Lo statuto della rappresentazione in Mulholland Drive di David Lynch I pensieri onirici che s’incontrano nell’interpretazione sono […] in generale costretti a rimanere inconclusi e a sfociare da ogni lato nell’intricato groviglio del nostro mondo intellettuale. Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, 1899 Il legame tra cinema e sogno, delineato con rigore dalle riflessioni di Metz o di Musatti, tende troppo spesso a smorzarsi in una pratica narrativa che riduce il racconto onirico a trito espediente. Nel 1955 Raymond Borde ed Etienne Chaumeton delineavano invece una ben più sostanziale incursione del cinema nel mondo ‘notturno’, pervaso dalle ombre e dall’ambiguità: “Il film assume il carattere del sogno e il pubblico vi cerca invano la buona vecchia logica di un tempo […] tutte le opere di questa serie presentano un’unità di ordine affettivo: si tratta dello stato di tensione provocato, nello spettatore, dalla scomparsa dei suoi punti di riferimento”.1 Con Mulholland Drive (2001) David Lynch prolunga il sottile fil noir che già percorreva Strade perdute (Lost Highway, 1996) facendone l’erede ideale della ‘serie’ così acutamente identificata da Borde e Chaumeton: testi sconcertanti, che suscitano turbamento nello spettatore non tanto tramite la semantica delle proprie rappresentazioni, quanto alterando i presupposti delle rappresentazioni stesse. Si tratta dunque di oggetti d’elezione per un’indagine che si interroghi sui processi di significazione, condotti qui in prossimità dei propri limiti, dei propri ‘punti di rottura’. Nella parte prima verrà fondata una prospettiva (nel senso epistemologico adottato da Deleuze) che conferisca profondità di campo al nostro sguardo, scegliendola sulla scorta dell’intuizione di Borde e Chaumeton: 1 Raymond Borde ed Etienne Chaumeton, Panorama du film noir américain, cit. in Leonardo Gandini, Il film noir americano, Torino: Lindau, 2001, pp. 27 sgg. PARAGRAFO I (2006), pp. 99-121 100 / GABRIELE BUGADA cercheremo di identificare alcune forme proprie e particolari che ‘il carattere del sogno’ introduce nel testo. Nella parte seconda i concetti proposti verranno applicati a Mulholland Drive: un film che cerca di impadronirsi delle prerogative della logica onirica nel modo più radicale e coerente (grazie ad un’accuratissima gestione delle soglie); che tramite lo ‘specchio del sogno’ riesce a comporre un intimo ritratto della propria protagonista; che consapevolmente intreccia un dialogo quasi comparativo tra la dimensione sognata e quella della veglia; che, infine, proprio su queste basi innerva un esplicito discorso metacinematografico, inevitabilmente centrato sui limiti dell’illusione referenziale e sul legame tra desiderio, rappresentazione e assenza. Lo Specchio Fumante Come tu ti vedi il viso nello specchio io ti metto davanti la tua anima nuda. Friedrich Maximilian Klinger, Giafar, 1792 1. Nel sogno il soggetto raccontante tende a coincidere con l’oggetto raccontato: lo osservano tra gli altri Ignacio Matte Blanco, che definisce il sogno “finestra nell’intimità dell’uomo”,2 ed Ezio Raimondi, che riconosce la “drammatizzazione del sogno come nuova esplorazione dell’individualità e dell’essere”.3 Sia la figura della finestra sia quella della rappresentazione drammatica presuppongono una posizione spettatoriale, occupata in primo luogo – ancora una volta – dal sognatore stesso. Per quanto riguarda la drammatizzazione, è immediato il richiamo alla freudiana Vorstellung per spiegare come gli oggetti interni divengano attori del sogno: nel teatro del sogno la realtà sognata traduce l’illusione o la delusione come attore o décor vivo; la raffigurazione avviene mediante le vicissitudini del sogno, attuando la copertura di processi indefiniti, spesso spaventosi, con immagini definite. Se è vero che nel sogno ci si esprime in prima et propria persona, va nondimeno ricordato che la persona latina è prima di tutto la maschera. È un tema ricorrente in Resnik, il quale lo collega direttamente alla sogget2 Ignacio Matte Blanco, “Il sogno. Struttura bi-logica e multidimensionale”, in Vittore Branca, Carlo Ossola e Salomon Resnik (a cura di), I linguaggi del sogno, Firenze: Sansoni, 1984, p. 290. 3 Ezio Raimondi, “‘Il sussurro fantastico’. Gli ‘occhi della mente’ (da Alfieri a Manzoni)”, in Vittore Branca, Carlo Ossola e Salomon Resnik (a cura di), op. cit., p. 437. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 101 tività scrivendo che nel sogno l’individuo dà luogo ad un microcosmo da interpretare tra le “pieghe […] della maschera onirica”,4 mai da svelare del tutto: è addirittura indispensabile la resistenza dell’enigma. Nella costruzione del personaggio il sogno ricopre allora il duplice ruolo di innescare una ‘risonanza’ dell’individuo con se stesso e – nel contempo – di problematizzarne la comprensione. La specificità della struttura delle ‘voci’ (nel senso di Genette) nel sogno non si limita tuttavia alla concomitanza di trasparenza e opacità in un discorso autoriflessivo. L’elemento più interessante è infatti la fluidità delle posizioni del soggetto, il quale si può porre: come narratore ex post o perfino ‘in diretta’ di un proprio racconto di sogno (tipico espediente drammaturgico per rappresentare il sogno); come personaggio – anche multiplo, eventualmente protagonista – del sogno; infine, come istanza di enunciazione che informa l’intero universo onirico: “il soggetto del sogno non è tanto il personaggio che dice ‘io’ [...] la prima persona onirica è il sogno stesso”.5 Le diverse posizioni sono compossibili – dando in tal caso adito ad una struttura ‘a scatole cinesi’ – ma non necessariamente compresenti. Il sogno instaura infatti una dialettica tra agire ed essere agiti, all’origine del fenomeno che Caillois ben mette in luce ne L’incertezza dei sogni:6 il sogno appartiene al sognatore eppure gli si impone come il mondo che egli percepisce da sveglio. La regia onirica pare così costituirsi in un ‘si impersonale’. La soggettività è insomma onnipervasiva e tuttavia può essere esautorata – all’interno del sogno – delle proprie consuete competenze cognitive e decisionali; in un apparente paradosso il sogno crea un cosmo di cui il soggetto è il logos, ma nel quale esso appare smarrito: perché deprivato delle proprie tradizionali prerogative, e perché – disperso in una molteplicità di posizioni instabili – resiste all’identificazione. Il sognatore si confronta in tal caso con un se stesso che – reso irriconoscibile dalla ‘maschera’ di una forma estranea ai consolidati ‘discorsi del soggetto’ – appare radicalmente altro. 4 Salomon Resnik, Il teatro del sogno (1982), Torino: Bollati Boringhieri, 2002, p. 236. D’ora innanzi indicato dalla sigla TS. 5 Michel Foucault, “Introduction”, in Ludwig Binswanger, Le rêve et l’existence (1954), trad. it. di Lucia Corradini e Carlotta Giussani in Sogno ed esistenza, Milano: SE, 1993, p. 59. 6 Roger Caillois, L’incertitude qui vient des rêves (1956), trad. it. di Vittoria De Fazio, L’incertezza dei sogni, Milano: Feltrinelli, 1983, p. 43. 102 / GABRIELE BUGADA Resnik esprime con accoratezza l’angoscia “claustrofobica” del “testimone”, di fronte ai mutamenti nell’organizzazione del discorso che contraddistinguono la narrazione del sogno: “Se il testimone viene inghiottito, avviluppato nel sogno, qual è lo spazio del sogno? Chi sono gli attori? Chi è il regista?” (TS, p. 235). 2. Il sogno implica inoltre – oltre all’autoreferenzialità intesa come processo scopico ed enunciativo del soggetto su se stesso – un’autoreferenzialità linguistica. Due fattori ‘congiurano’ nella trasformazione del linguaggio onirico in metalinguaggio. In primis il sogno in quanto tale opera un ‘lavoro’ di simbolizzazione, rappresentazione, drammatizzazione che ne fa un’ideale metaopera sui procedimenti all’origine del testo, in special modo sulla produzione di immagini. Non si entrerà qui nel merito di quanto il carattere narrativo del sogno sia riconfigurato dall’esistenza di forme narrative che lo raccontano, o di quanto esso già di per sé adombri una narratività pregressa: valga l’ipotesi ricoeuriana di una circolarità ermeneutica tra i diversi gradi di una triplice mimesis. In secondo luogo la potenzialità metalinguistica è attivata dall’abituale natura di sottotesto delle sequenze oniriche. Può essere utilmente recuperata una conclusione di Massimo Fusillo riferita originariamente alla presenza dello specchio nei testi cinematografici: “una qualsiasi superficie riflettente ha sempre un valore metalinguistico, in quanto produce un altro ‘quadro’ che può svolgere svariate funzioni narrative e tematiche”.7 Questa intuizione può essere efficacemente estesa a indicare il “valore metalinguistico” degli spazi narrativi incorniciati come microtesti all’interno di un testo principale, e in particolare di tutte le forme di enunciazione enunciata – delle quali il sogno costituisce un’occorrenza peculiare. Secondo quali modalità si attua tale propensione? Cazalé Bérard nota come nel sogno raccontato la memoria letteraria diventi “strumento dell’affermazione autoriale attraverso la scrittura praticata quale virtuosistica combinatoria intertestuale di temi, motivi, intrecci”. Il sogno si configura allora quale “gioco allusivo pluridimensionale e polimorfo della messa in relazione fine a se stessa di segni di varia provenienza”.8 7 Massimo Fusillo, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, Firenze: La Nuova Italia, 1998, p. 163. 8 Claude Cazalé Bérard, “Il sogno dell’avventura, l’avventura del sogno. Exempla, novella, romanzo”, in Gabriele Cingolani e Marco Riccini (a cura di), Sogno e racconto. Archetipi e funzioni, Firenze: Le Monnier, 2004, p. 14. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 103 La menzione del nesso tra sogno e gioco rende inevitabile una citazione da Winnicott, che precisamente a questa relazione ha dedicato una parte significativa della propria trattazione in Sogno, fantasia e vita reale: il soggetto produce “un elemento del potenziale onirico e vive con questo elemento in un selezionato contesto di frammenti della realtà esterna. Nel giocare manipola i fenomeni esterni al servizio del sogno e li investe con significati e sentimento di sogno”.9 Queste medesime considerazioni, trasposte nel campo letterario, risultano estremamente pertinenti e consentono di comprendere a fondo anche i cenni sbrigativi di André Green sulle corrispondenze tra il linguaggio onirico e le nozioni di ‘bricolage’ e ‘pensiero selvaggio’ elaborate da Lévi-Strauss:10 un parallelismo assai fertile per confrontarsi col tema della frammentarietà che avvicineremo nel prosieguo dell’analisi. Ritornando all’idea di ‘combinatoria’ proposta da Cazalé Bérard se ne devono segnalare due versanti: la “messa in relazione fine a se stessa” dei segni e la loro “varia provenienza”. Il primo punto è correlato all’emergenza di una modificazione sintattica che può essere letta in chiave metalinguistica sia in virtù dell’autoreferenzialità da cui è caratterizzata, sia in ragione dell’avvicinamento al linguaggio poetico (nel senso della proiezione del paradigmatico sul sintagmatico). Il secondo punto sottolinea l’attività di ibridazione verificantesi nel sogno. Si può ricordare al riguardo il caso di Mallarmé, cui fa riferimento Giorgio Agamben osservando – in un saggio incentrato proprio sugli ibridi linguistici – che la complicazione sintattica (‘dilazioni’, ‘anomalie’) fa risaltare la parola in un “puro rispecchiamento autoreferenziale”.11 3. Riprendiamo infine lo spunto – accennato pochi capoversi or sono – sull’attinenza del sogno con l’investigazione della produzione di immagini. Tramite il sogno la riflessione sull’immagine si sviluppa in una duplice direzione: nelle figure dei sogni (accomunabili in ciò all’eco, alle ombre, agli specchi) convivono l’inadeguatezza a rappresentare l’essenza e la pas9 Donald W. Winnicott, Playing and Reality (1971), trad. it. di Giorgio Adamo e Renata Gaddini, Gioco e realtà, Roma: Armando, 1974, p. 99 (corsivi miei). 10 André Green, “Dal Progetto all’Interpretazione dei sogni. Cesura e chiusura”, in Ferdinando Amigoni e Vanessa Pietrantonio (a cura di), Crocevia dei sogni. Dalla “Nouvelle Revue de Psychanalyse”, Firenze: Le Monnier, 2004, p. 117. 11 Giorgio Agamben, “Il sogno della lingua. Gli ibridi linguistici nel sogno dell’Hypnerotomachia Poliphili”, in Vittore Branca, Carlo Ossola e Salomon Resnik (a cura di), op. cit., p. 419. 104 / GABRIELE BUGADA sione che viene suscitata non tanto dal contenuto della raffigurazione quanto dalla visione in sé e per sé (ovvero dalla compartecipazione al processo di rappresentazione) – come nell’interpretazione data da Hillman del mito di Narciso. Se da un lato è dunque possibile sostenere – con Blanchot – che “l’immagine di un oggetto non soltanto non è il senso di quest’oggetto e non aiuta alla sua comprensione, ma tende a sottrarvelo mantenendolo nell’immobilità di una somiglianza che non ha niente a cui somigliare”, d’altro canto nel ‘riflesso di riflesso’ messo in scena dal racconto di sogno ad affascinare è proprio l’elusione di una referenzialità indiscussa, l’interrogarsi su relazioni altrove date per scontate. È lo stesso Blanchot a rendersene conto, scrivendo poco oltre: l’immagine “rischia anche di rinviare sempre non più alla cosa assente ma all’assenza come presenza”.12 Meno sibillinamente possiamo osservare come la figurazione onirica esprima una trasformazione e una sostituzione, dall’oggetto percepito all’oggetto immaginato; se l’oggetto è assente possiamo qualificarne la percezione come un’apprensione (nell’accezione di Kant) il cui contesto è una ‘presenza vuota’, una presentificazione dell’esperienza del vuoto. Non sorprende scoprire in un saggio dedicato a Leopardi una notazione di notevole congruità rispetto a questo tema: in “Imago”. Il sogno-oggetto e il testo-sogno nella poesia leopardiana di Emma Giammattei leggiamo infatti che “nel tragitto moderno della crescente impossibilità della rappresentazione e quindi dello statuto problematico dell’immagine, il sogno […] o la messa in scena della situazione onirica […] viene finalizzato al governo poetico dell’assenza”. L’autrice conclude: “lo spazio del sogno è un iperspazio del pensare dove l’immagine può essere affermata nel momento stesso in cui viene negata”.13 Il momento in cui l’immagine viene ‘affermata’ corrisponde a quella seduzione delle superfici di rappresentazione – una seduzione che prescinde dalla referenzialità, o che la trascende – già fatale a Narciso. Il sogno si costituisce in rappresentazione fantasmatica di un dramma in sé reale poiché nello spazio onirico possono assumere una posizione complessa – tra realtà e irrealtà – una serie di forme ‘vere’ in quanto integrate 12 Maurice Blanchot, L’espace littéraire (1955), trad. it. di Gabriella Zanobetti, Lo spazio letterario, Torino: Einaudi, 1971, pp. 228-30. 13 Emma Giammattei, “‘Imago’. Il sogno-oggetto e il testo-sogno nella poesia leopardiana”, in Silvia Volterrani (a cura di), Le metamorfosi del sogno nei generi letterari, Firenze: LeMonnier, 2003, pp. 134-45. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 105 nell’universo onirico. Nell’uso narrativo le sequenze oniriche si prestano in tal modo a condurre un’apologia della finzione poetica in quanto tale. Questa rielaborazione delle strutture referenziali giunge secondo Dombroski e McNeece a fare del sogno, “o meglio del sognare”, una “metafora della scrittura” come “narrazione poematica che è rivelazione (e incanto)” di verità diverse, altre, nascoste al mondo – o in esso annidate dacché “antitetiche forme di potere” impediscono di vedere oltre “l’opaca superficie delle cose”.14 Come in Calderòn l’inconsistenza onirica si proietta sulla presuntiva realtà della veglia (che diviene così il quadro del mondo), sottolineandone il carattere sostanzialmente finzionale. Si possono allora attribuire allo spazio linguistico del sogno alcune proprietà delle eterotopie, ricordando come Foucault abbia teorizzato che l’esistenza dell’eteroclito agisce sugli spazi “normali” inducendo in essi delle “trasformazioni”; quest’azione trasformante “si dispiega tra due poli estremi”: le eterotopie possono, infatti, “creare uno spazio illusorio che indica come ancor più illusorio ogni spazio reale”; esse possono, altrimenti, creare “un altro spazio, uno spazio reale, così perfetto, così meticoloso, così ben arredato al punto da far apparire il nostro come disordinato, maldisposto e caotico”.15 Il tessuto dei sogni There is a special class of dreams, in my experience, that are not dreams at all but quite as real as so called waking life and completely unfamiliar as regards my waking experience but, if one can specify degrees of reality, more real by the impact of unfamiliar scenes, places, personnel, even odors. William S. Burroughs, My Education, 1995 4. In Mulholland Drive Lynch riesce ad embricare gli aspetti più ambivalenti del racconto di sogno, le apparenti contraddizioni che sorgono sul crinale tra ‘sogno raccontante’ e ‘sogno raccontato’: da una parte l’affermazione incontestabile di sé e del proprio discorso che il sogno attua du14 Robert Dombroski e Lucy Stone McNeece, “L’archeologia del sogno. Consolo e Meddeb”, in Vanessa Pietrantonio e Fabio Vittorini (a cura di), Nel paese dei sogni, Firenze: Le Monnier, 2003, pp. 195 sgg. (corsivi miei). 15 Michel Foucault, “Des espaces autres” (1967), trad. it. di Pino Tripodi, “Spazi altri”, in Id., Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, a cura di Salvo Vaccaro, Milano: Mimesis, 2001, pp. 30-31. 106 / GABRIELE BUGADA rante l’esperienza onirica; dall’altra l’irriducibilità di quel discorso al linguaggio della veglia, il margine di incompatibilità che genera un conflitto tra i codici di rappresentazione ‘notturno’ e ‘diurno’, ciascuno dei quali denuncia la vanitas dell’altro (il sogno insensato o ingannevole, l’illusorio quadro del mondo). La bipartizione del film non è una semplice giustapposizione, ma un dialogo nell’ambito del quale avviene una continua ri-scrittura del testo. Ciascuna delle due macro-sequenze è una forma di riflesso speculare dell’altra: rammentiamo però, con Eco, che lo specchio è sempre percepito come un doppio asimmetrico.16 Dapprima ci viene presentato l’ordine del sogno: come è proprio del discorso onirico (e – insinua Lynch – del cinema o della narrazione in genere), esso ci avvince con un’assolutistica illusione di realtà, per quanto tale illusione possa essere costruita su una logica di fatto frammentaria ed ellittica. Il risveglio ci introduce in un mondo caotico e delusorio, che incrina i tentativi di comprensione precedenti, e che tuttavia – pur nella sua apparente incoerenza – fornisce i dati necessari a ricomporre la gerarchia contenitore/contenuto che struttura il testo. Accingiamoci ora ad esaminare le differenze nell’organizzazione delle due parti dell’opera, rispettivamente recensite come “lineare” e “un labirinto angoscioso e sensuale”:17 verranno poste in questione tale linearità e tale costruzione labirintica, per approdare ad un’interpretazione della trasformazione che le correla. 5. Nella lunga sezione più propriamente onirica di Mulholland Drive la connessione tra le diverse sequenze avviene tramite una grammatica visiva della contiguità che sfuma spesso nella semplice contingenza: quando la transizione è marcata, lo è tramite dissolvenze in/dal nero o tramite un lasco montaggio alternato (la telefonata a zia Ruth). Anche la sintassi narrativa si articola grazie ad una retorica dell’accostamento o dell’accidente; è ovviamente esemplare l’incidente d’auto, ma tale logica è generalizzata: gran parte degli sviluppi della storia non hanno luogo in virtù delle azioni di qualche personaggio, bensì in conseguenza di interventi ex machina – tipicamente manifestati da mediatori di qual16 Umberto Eco, “Sugli specchi”, in Id., Sugli specchi e altri saggi, Milano: Bompiani, 1985, pp. 10-11. 17 “Mulholland Drive”, in Laura, Luisa e Morando Morandini (a cura di), Dizionario dei film, Bologna: Zanichelli, 2003. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 107 che sorta – o in ragione della guida di una (invero impalpabile) ‘regia delle coincidenze’. Si pensi per la prima categoria alla convocazione di Betty al provino, o alla decurtazione dei conti correnti di Adam; oppure, per il secondo genere, all’ingresso da parte di ‘Rita’ nell’appartamento proprio nell’intervallo tra la partenza di zia Ruth e l’arrivo di Betty, all’inopinato ritorno a casa di Adam, al provvidenziale squillo del telefono della vicina a Sierra Bonita. A costituire il motore delle evoluzioni nella vicenda delle due donne troviamo anche le improvvise quanto inspiegate reminiscenze di Rita: è addirittura nel sonno che ella capirà di ‘dover’ visitare il Club Silencio. Per contrasto, i volenterosi tentativi di Betty (la telefonata alla polizia, la lettura del giornale, la telefonata – di nuovo – a Diane Selwyn) non hanno alcun esito materiale. Allargando la prospettiva pure ai filoni narrativi che si rivelano conchiusi in una o al più due sequenze (l’uomo spaventato del Winkie’s, mister Roque, il killer maldestro) sorprende la naturalezza con cui un numero decisamente esiguo di indicazioni – tutt’altro che determinate, per di più – ridimensioni l’incongruità di questi segmenti rispetto alla materia principale: la prima apparizione di mister Roque è visivamente introdotta da un primo piano di ‘Rita’ dormiente, ed è giustificata solo dal conciso “the girl is missing”,18 che esclusivamente sulla base di un’aspettativa di pertinenza (relativa ad una narrazione ideale) può essere attribuito alla donna… un’aspettativa di pertinenza che l’intera prima parte di Mulholland Drive sembra voler ostinatamente disattendere. La comparsa del killer è ‘agganciata’ al resto del testo in modo ancor più blando: vi si giunge dopo una dissolvenza in nero al termine dello sfregio di Adam alla limousine dei Castigliani. L’unico appiglio concessoci è l’accenno ilare ad un incidente: trattandosi di “incidente” può richiamare alla mente quello iniziale (forse non così divertente). Il “libro nero” il cui furto motiva l’omicidio non comparirà più nella parte ‘sognata’ del film. Rivedremo invece il killer in una breve scena di poco successiva, mentre chiede ad una prostituta informazioni su una “nuova” ragazza “bruna” eventualmente vistasi in strada. Ancora una volta gli elementi che potrebbero indurci a stabilire un collegamento con il resto del testo sono scarsi e vaghi: forse è questo killer l’uomo di cui abbiamo scorto la mano nella sequenza delle telefonate, for18 “la ragazza è scomparsa”. Laddove non altrimenti indicato le traduzioni sono mie. 108 / GABRIELE BUGADA se allora la fantomatica ‘bruna’ corrisponderebbe alla “missing girl”, forse si tratta di Rita. È molto significativo – alla luce del recupero e della distorsione attuati da Lynch nei confronti dei generi narrativi codificati – che tutte queste inferenze siano dettate da presupposizioni fondate su codici di genere: la sequenza delle telefonate come contatto con un assassino prezzolato (frasi ellittiche non compromettenti, intervento di intermediari, lo squallido contesto del telefono col neon), Rita come donna del mistero compromessa con la malavita (è appena sfuggita ad un tentativo di assassinio, la gran quantità di denaro inspiegabilmente detenuta, la pistola). Di fatto però queste presupposizioni non trovano concreti riscontri testuali: anzi, esse sono indebolite da un’esibita incoerenza, sia nell’estromissione dei volti nella sequenza delle telefonate, sia nelle cesure imposte ai dialoghi che hanno come protagonista il killer biondo – la prima scena inizia in medias res privandoci della descrizione del citato ‘incidente’, la seconda scena risulta tronca dell’inizio ma soprattutto della conclusione, e dopo di essa il killer non comparirà più all’interno del sogno. Addirittura per quanto riguarda la scena al Winkie’s l’unica connessione propostaci durante la prima parte del film è una sequenza ambientata nello stesso luogo, priva di qualsiasi altro richiamo tematico. Perfino l’atteso intrecciarsi delle due vicende portanti (Betty/Adam), dopo uno scambio di sguardi carico di sottintesi e promesse, non prelude ad alcuno sviluppo – anzi, Adam sparirà ex abrupto dalla narrazione onirica. Parrebbe insomma che la nuda paratassi possa bastare a reggere una struttura narrativa che, a dispetto della propria frammentarietà, viene percepita come ‘lineare’. Scrive però Adriano Piccardi: tutta questa prima parte si sviluppa secondo un tragitto nell’insieme riconoscibile: un succedersi di eventi e personaggi riconducibili a una logica che tiene, pur con qualche intromissione apparentemente slegata da tutto il resto, rispetto alle quali, come sempre in questi casi, si attendono delucidazioni nel prosieguo del racconto.19 Nelle parole di Piccardi si intuisce la caratteristica chiave che in effetti sostiene il racconto onirico: “un tragitto nell’insieme riconoscibile”, “una logica che tiene” – è la logica onirica di cui si discuterà tra poche righe; come nota Graham Fuller: “nor is it illogic that characterises Mulholland 19 Adriano Piccardi, “Il tempo d’un sogno”, Cineforum, 413, aprile 2002, p. 5. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 109 Drive, but dream logic, which permits a stream of non sequiturs and cul de sacs”.20 Lynch riproduce il linguaggio del sogno, inclusa la sua più inafferrabile proprietà: quella di negare la propria natura fittizia fintanto che esso opera; la capacità di imporre un ordine e una logica che, profondamente contrastanti con quelli della ‘realtà’ della veglia, si affermano come reali sospendendo la percezione delle proprie incongruenze, pur a fronte di una sintassi che sembra improntata alla mera giustapposizione. Proprio in questo senso Resnik definisce il sogno “una iper-realtà, che ha una consistenza più vera del reale ed è per questo incontestabile” (TS, p. 31). Petrella sostiene che “la rappresentazione in opera nei sogni scongiura, domina e così allontana una minaccia: morte, perdita di sé o dell’oggetto d’amore”; una descrizione che si attaglia perfettamente al sogno di Mulholland Drive. Poco oltre egli soggiunge che “contro tutto ciò sogno e arte edificano il loro ordine”.21 A questo punto le similitudini già evidenziate tra sogno e gioco vanno necessariamente arricchite con queste parole di Huizinga: “entro gli spazi destinati al gioco, domina un ordine proprio ed assoluto […]: esso crea un ordine, è ordine. Realizza nel mondo imperfetto e nella vita confusa una perfezione temporanea, limitata”.22 Tornando al parallelismo tra ‘sogno’ e ‘arte’, la medesima corrispondenza viene instaurata da Lynch, facendo così di Mulholland Drive una riflessione sul cinema e sull’arte di raccontare. Vernet ha scritto che “il personaggio […] è il centro del mondo concepito come caos finalmente organizzato, messo in scena da e attraverso lo sguardo; ed è per questo che il personaggio cinematografico fa del mondo uno spettacolo”:23 questa condizione generale del ‘personaggio cinematografico’ viene ‘elevata al quadrato’ in Mulholland Drive dove lo ‘spettacolo’ è costituito in gran parte dal mondo che il sogno di Diane organizza (“attraverso lo sguardo”) attorno a Betty – cioè attorno a se stessa come personaggio. Rifacendoci a quanto asserito in precedenza, nell’indagare l’ordine del 19 Adriano Piccardi, “Il tempo d’un sogno”, Cineforum, 413, aprile 2002, p. 5. “Non è l’assenza di logica a caratterizzare Mulholland Drive, bensì la logica dei sogni, che consente a interruzioni e vicoli ciechi di susseguirsi in modo fluido”. Graham Fuller, “Babes in Babylon”, Sight and Sound, 12, dicembre 2001, p. 15. D’ora innanzi indicato dalla sigla BB. 21 Fausto Petrella, “Estetica del sogno e terapia a cento anni dalla Traumdeutung”, in Stefano Bolognini (a cura di), Il sogno cento anni dopo, Torino: Bollati Boringhieri, 2000, p. 48 (corsivo mio). 20 110 / GABRIELE BUGADA sogno l’attenzione verrà concentrata sulla posizione del soggetto – in particolare sulle sovrapposizioni con l’istanza di enunciazione (l’installazione di un punto di vista sugli eventi; la messa in scena dell’universo del sogno) e sulla carica passionale sottesa alle rappresentazioni oniriche. Già il fatto che il sogno sia preceduto – a mo’ di soglia d’ingresso – da un’inquadratura in soggettiva è molto indicativo, anche perché con essa Lynch manifesta una prima contravvenzione alle consuete grammatiche di montaggio, contravvenzione che sarà poi sostanziale nel condurre il racconto del sogno: si tratta nuovamente di un’omissione, quella del controcampo rivelatore della sede dello sguardo. Ritroveremo nel sogno consimili ‘soggettive senza soggetto’, a punteggiare la prima parte del film, distinte da quelle attribuibili a personaggi precisi proprio per l’impossibilità di determinarne l’origine: possono essere citati il movimento di macchina che abbandona il volto di Rita accoccolata tra le piante, per soffermarsi infine sull’ingresso di Havenhurst; la macchina da presa ‘a spalla’ che accompagna nervosamente la sequenza del racconto del sogno sull’uomo nero dietro al Winkie’s; la complessa scena della telefonata con zia Ruth; lo zoom ‘a inseguire’ sulla porta del Club Silencio; lo sguardo ‘situato’ che segue le due donne al rientro in Havenhurst dal club. Questa figura viene categorizzata da Francesco Cattaneo come “sfasamento del discorso”, ovvero uno “sfasamento linguistico” che “concerne, con maggiore o minore sottigliezza, gli elementi più propriamente filmici della messa in scena”. È lo stesso Cattaneo a constatare, quasi incidentalmente, che “la soggettiva ha un ruolo preponderante in questo film, avendo la funzione linguistica di accentuare precarietà e inquietudine”:24 la precarietà non è solo quella intradiegetica, ma piuttosto quella del linguaggio quasi impercettibilmente forzato da Lynch (anche nella seconda parte del film dove – come vedremo – la soggettiva muterà ulteriormente il proprio statuto). Si assiste ad un’alterazione sottile, e in pieno accordo con la logica enunciativa del sogno: il testo ribadisce a più riprese la presenza di qualcuno (interessante il fatto che la mdp ondeggiante rimandi ad una corpo22 Johan Huizinga, Homo ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur (1939), trad. it. di Corinna van Schendel, Homo ludens, Torino: Einaudi, 1973, pp. 15-16. 23 Marc Vernet, “Personaggio”, cit. in Leonardo Gandini, “Dissoluzione e metamorfosi del personaggio hollywoodiano”, in Franco La Polla (a cura di), The body vanishes. La crisi dell’identità e del soggetto nel cinema americano contemporaneo, Torino: Lindau, 2000, p. 29. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 111 reità, ad uno sguardo non puro ma in qualche maniera ‘antropizzato’) che osserva/produce il quadro visivo, e tuttavia viene inibita – finché il sogno dura – ogni perturbazione dell’illusione referenziale tramite l’esilio di questo soggetto in un persistente fuori-campo. Il mondo del sogno si dimostra inoltre coerentemente ammobiliato dal punto di vista visivo e precipuamente cromatico secondo il criterio di una omogeneità marcata (e.g.: l’alternanza rosa/blu). La soggettività a cui allude lo stile non è però quella autoriale, bensì quella di Diane: nella seconda parte i tratti specifici ‘si ritirano’, e restano riconoscibili solo nel modo che la protagonista ha di ‘scrivere’ il proprio corpo e lo spazio diegetico della propria esistenza; non sembra casuale l’accento posto su abiti e trucco, la correlazione tra mise e mise en scène, tra make-up e il making up dell’universo finzionale – d’altro canto il maquillage è storicamente figura dell’artificio e della maschera (basti citare la shakespeariana tirata di Amleto ad Ofelia). È opportuno evidenziare il fatto che, sebbene a posteriori l’uniformità stilistica si costituisca come indizio o traccia che rende manifesta l’azione di un narratore, di per contro all’interno del sottotesto onirico essa è uno dei fattori preminenti nel garantire la “logica che tiene” e la “consistenza” che vengono generalmente ascritte al sogno (così come, naturalmente, alla prima parte di Mulholland Drive) nonostante i “non sequiturs” e “cul de sacs” propri della “dream logic”. Come pure nel caso della paranoia (caratteristica del noir), nel sogno l’assoluto imperio del soggetto assicura tanto l’infrangibilità dell’illusione quanto l’incommensurabilità con il reale. La medesima configurazione viene riproposta a livello di fabula: benché il vaglio di un criterio di causalità e pertinenza non possa che appurare un grado di coerenza ridotto (lo abbiamo visto), l’andamento della vicenda nella prima parte del film viene definito ‘lineare’; si intuisce ‘un tragitto’. Ciò avviene poiché in effetti gli avvenimenti sono orientati, essi si ricompongono in un’ordine delle cose che polarizza la narrazione secondo percorsi identificabili: Fuller asserisce che Mulholland Drive “riecheggia Strade perdute anche nel modo in cui mostra un sogno che va smarrendosi [miscarrying], dalla soddisfazione del desiderio, all’ansia, alla veglia [wakefulness]” (BB, p. 17) – la parabola emotiva è ovviamente quella di Diane. Obbedendo alla regia invisibile di Diane il sogno si struttura allora 24 p. 8. Francesco Cattaneo, “Il doppio organizzato del caos”, Cineforum, 413, aprile 2002, 112 / GABRIELE BUGADA per un verso in conseguenza dell’incombere ansiogeno del risveglio, per l’altro nell’ottica della realizzazione dei desideri della protagonista. È la risonanza emotiva con il soggetto a garantire il “surplus passionale” che “deborda dagli eventi narrati fino a diventare il senso vero e inglobante, astrazione sensibile”25 su cui si fonda la prima parte del film. Ci occuperemo più oltre della trasformazione corrispondente al ridestarsi di Diane; volgiamo dunque l’attenzione alle traduzioni del materiale reale che il sogno opera sulla scorta della soggettività desiderante. I desideri di Diane si possono considerare indirizzati secondo due direttrici principali: la soddisfazione professionale e quella sentimentale; entrambe comportano poi riflessi sugli altri personaggi: soprattutto negativi per Adam, in un certo senso positivi per ‘Rita’/Camilla nel momento in cui – anzitutto – scampa al proprio assassinio. Il sogno nel disporre le proprie immagini in accordo con questo schema letteralmente ‘raccoglie i pezzi’ di una realtà lacerata per inaugurare il proprio ordine; più esattamente: esso rifiuta la coerenza/cogenza della veglia, e ne cancella pertanto i vincoli – storie, memorie, legami – per intraprendere a partire dai margini e dai frammenti la propria costruzione. Non per niente ‘Rita’/Camilla ha perso la memoria; Betty/Diane è appena arrivata a Hollywood; di Coco non si dice se sia la madre di Adam; quest’ultimo, Betty, ‘Rita’, ‘Camilla Rhodes’ non si conoscono neppure… In uno scambio di battute nella scena d’amore tra Betty e Rita sembra riassunto il senso di queste alterazioni: “Tu l’hai mai fatto prima?” – “Non lo so… E tu?” – “Io voglio farlo con te”; alla consequenzialità di chronos (e alle pretese di consequenzialità e pertinenza del linguaggio) si sostituisce direttamente l’intenzionalità del desiderio. Viceversa l’azione creatrice del sogno si esplica al meglio su alcune figure – più o meno di contorno – presenti alla festa: molti personaggi trovano la propria chiave crittografica in piccole agnizioni o epifanie sommesse durante la sequenza del party, tanto da far balenare l’idea che tutto il cast del film viva in costante metamorfosi. I casi più limpidi sono quelli del Cowboy, che transita ai margini del quadro visivo; di ‘Castigliani’, il cui sguardo serioso è incrociato da Diane alzando gli occhi da una tazzina di caffè (dando quindi adito ad un processo associativo simile alla scrittura automatica); ma anche del ragazzo della piscina e della ex-moglie di 25 Giulia Carluccio e Guglielmo Pescatore, “Dal nero. Del noir, dello schermo”, Cinema&Cinema, 61, maggio-agosto 1991, p. 61. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 113 Adam, sbucati da una facezia di questi. Nella prima parte del film quasi tutti i personaggi tendono inoltre ad assurgere al ruolo di “rappresentanti fantastici” di “classi di equivalenza”, in conformità con quanto teorizzato da Ignacio Matte Blanco26 (gli stereotipati mafiosi; il Cowboy, fin dal nome; la coppia di poliziotti; l’Uomo Nero; l’imbonitore-illusionista; la coppia di anziani, genitori/giudici in un’ambivalenza carica di significato; l’Attore Attempato; e via dicendo). 6. Consideriamo ora il ‘terzo atto’ di Mulholland Drive – la veglia – per poter definire meglio il risveglio come processo in cui è leggibile (per speculum?) la traccia della trasformazione onirica. Ciò ci consentirà anche di chiarire il significato dell’angoscia a cui si è accennato come secondo asse portante nell’organizzazione del sogno. Piccardi descrive così quanto segue il ridestarsi di Diane: “da qui in avanti, il racconto procede […] attraverso passaggi ‘intricati’, connessioni ‘instabili’, perplesse ‘porosità’. Eppure è proprio da ora in poi che si potranno tirare le fila di tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. Che si potrà ricostruire il puzzle”.27 I nessi sono così “intricati” e “instabili”? Ci troviamo davvero in un “labirinto angoscioso e sensuale”? È opinabile. Lynch costruisce la sintassi del ‘reale’ con rigore e profondità ipotattica ben maggiori di quanto abbia fatto nel sogno: è innegabile tuttavia lo smarrimento percepito ‘all’apparir del vero’. La vicenda si dipana infatti grazie ad un lungo flashback, incorniciato da sequenze collocabili al presumibile tempo presente della narrazione. L’orientamento all’interno di questa struttura è assicurato da oggetti che Lynch inquadra in primissimi piani (o addirittura a livelli di dettaglio) ai limiti del surreale, impiegandoli dichiaratamente come segnali, quasi marcatori grammaticali che situano l’azione: la chiave blu – che indica l’avvenuto omicidio di Camilla – e il pianoforte/portacenere, la cui presenza individua invece il passato (assistiamo alla sua rimozione nella scena immediatamente dopo il risveglio). Il flashback è a sua volta suddiviso in diversi segmenti, dei quali è dubbia la successione cronologica: essa potrebbe anche corrispondere a quella del racconto, sebbene gli stacchi che conducono da un segmento all’altro diano talora un’impressione diversa. Il motivo è semplice: l’intero 26 27 Ignacio Matte Blanco, op. cit., p. 290. Adriano Piccardi, op. cit., p. 5. 114 / GABRIELE BUGADA flashback è organizzato secondo un principio esplicativo – sia nei confronti delle relazioni causa-effetto sia nei confronti di quelle deittiche/anaforiche – cosicché quando viene presentata una scena che specifica il referente di un pronome anaforico si tende a pensarla come antecedente, sul modello del linguaggio verbale; allo stesso modo, se viene mostrata una situazione che potrebbe essere la causa di uno stato d’animo, essa viene ritenuta un ante hoc. È opportuna un’esemplificazione. Dalla prima scena del flashback (carezze e bisticcio sul sofà) si passa a quella in cui vengono presentati Adam e la sua relazione con Camilla (bacio sotto gli occhi di Diane) per spiegare la concisa domanda “è per lui?” con cui Diane ha reagito alle resistenze di Camilla: l’ipotesi che si tratti di un ‘ricordo nel ricordo’ è avvalorata essenzialmente dai motivi linguistici di cui sopra. Da questa scena si passa alla sfuriata di Diane: consecutiva e conseguente, quindi non ci sono problemi. Poi c’è la disperata masturbazione della ragazza rimasta sola, che termina su uno squillo del telefono il quale funge da aggancio per la lunga sequenza della festa; come in altre occasioni Lynch mantiene un’ambivalenza sulla funzione sintattica o semantica di alcuni elementi del testo: nel primo caso lo squillo articolerebbe soltanto il montaggio di una sequenza successiva in termini sia di storia sia di racconto, nel secondo caso esso attiverebbe diegeticamente in Diane un ricordo – che ci viene mostrato. A far propendere verso questa interpretazione è di nuovo una deduzione ‘linguistica’: il fatto che gli eventi della festa potrebbero essere causa della rabbia e della disperazione di Diane così drammaticamente espresse nel literal self-abuse (“l’abusare – letteralmente – di se stessa”)28 appena raccontatoci. A chiudere, l’estrema conseguenza – in ogni accezione – della triste parabola: un significativo rumore di stoviglie in pezzi ci guida dalla festa all’assoldamento del killer, e di qui la chiave blu inchioda infine Diane al presente. La realtà è insomma complessa, cioè composta di svariati elementi interdipendenti e correlati in modi molteplici: da questo punto di vista, sì, un labirinto. Lynch si premura tuttavia di fornirci un filo di Arianna: figurativamente con un montaggio costituito di incastri puntuali – concretizzati specialmente negli oggetti – e narrativamente grazie all’implacabile sottolineatura dei legami – legami tra cause ed effetti, tra pronomi e persone, ma anche tra esseri umani. Finalmente infatti possiamo ‘ricostruire 28 Kim Newman, “Mulholland Dr.”, Sight and Sound, 13, gennaio 2002. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 115 il puzzle’, cioè rimettere assieme i pezzi: scoprire ad esempio ‘che cosa c’entrano’ Adam, il killer maldestro, la bionda raccomandata (e così via) con le due protagoniste. Rinaldo Censi scrive che si tratta di “reinventare il tempo di un trauma attraverso […] alcuni oggetti. […] Qui, a noi resta l’immagine di un portacenere… o una tazza di caffè che con uno stacco di montaggio (un impercettibile salto temporale) si trasforma in un bicchiere di whisky posato su un tavolino. Stanze che mutano d’arredamento: scene di un nuovo teatro della memoria”.29 Gli oggetti invitano lo spettatore a farsi segugio, a pedinare la storia lungo il racconto, con la sicurezza – da essi assicurata – di una permanenza dei significati quanto dei significanti. Gli oggetti – come tracce/legami – e la memoria stabiliscono il dominio della realtà, in aperta antitesi rispetto al sogno dove, lo abbiamo visto, la memoria è abolita e gli oggetti non riescono a rimandare ad alcunché (“questi soldi tu non lo sai da dove provengono?” chiede Betty senza ottenere risposta; l’orecchino di perla, indizio sulla scena dell’incidente, che sprofonderà nell’oblio con i due detective e l’indagine stessa; l’enigmatica chiave blu). È usuale la contrapposizione tra realtà e sogno fondata sulla stabile consequenzialità della prima a confronto della labilità del secondo:30 si pensi allora in quest’ottica alla funzione esplicativa dei flashback testé descritta. 7. Si paragonino a questo punto le due macro-sezioni di Mulholland Drive. Alla logica dell’accostamento, della giustapposizione paratattica, si è sostituita quella del collegamento, cioè del vincolo di pertinenza o causalità. Da dove deriva dunque il disorientamento tanto diffusamente attestato nella seconda parte? Sono in gioco due fattori, uno dei quali appare però poco influente – sebbene non insignificante – e verrà pertanto descritto in seguito. Invece il fattore principe è facilmente desumibile dall’argomento a cui tanto spazio è stato dedicato analizzando il sogno di Diane: è l’ordine proprio del sogno – riprendendo Vernet, “messo in scena da e attraverso lo sguardo” – che nella realtà viene a mancare. Lo sconvolgimento che il risveglio provoca nello spettatore (e in Diane) risiede eminentemente nella perdita dei punti di riferimento che quell’universo – nel pieno valore etimologico della parola – offriva. Gli avveni29 Rinaldo Censi, “In statu nascendi”, Cineforum, 413, aprile 2002, p. 13. Su questa consolidata contrapposizione Gautier fonda l’infrazione paradossale che regge la trama de La morte amoureuse. 30 116 / GABRIELE BUGADA menti della realtà hanno un ‘significato’ (il valore di un fatto, in rapporto alle ragioni che lo hanno motivato o alle eventuali conseguenze), ma non il ‘senso’ (congruenza con un ordine, qui l’ordine del discorso: inteso non come disposizione ma come ordine immanente) che il racconto di sogno invece garantiva. Muovendo dal sogno (in quanto si proviene dal sogno), per Diane – sulla quale è focalizzata anche la seconda parte del film, come si ribadirà tra breve – la realtà risulta contraddittoria, incontrollabile, caotica: irrimediabilmente corrotta dalla perdita dell’innocenza e dell’oggetto d’amore, dapprima a causa del fallimento e dell’abbandono, poi definitivamente a causa del crimine; Lynch riesce a precipitare in una consimile condizione (fatte le debite proporzioni!) anche lo spettatore, privato dei presupposti narrativi che era stato fin lì indotto ad accettare. Si conferma quanto affermato all’inizio di questo secondo paragrafo: tra le due dimensioni del film sussiste un dialogo che comporta una reciproca e assidua riscrittura. La “simmetria enantiomorfa”31 che regge le due parti dà adito ad un testo ‘contrastato’, espressione dell’incommensurabilità del sogno: per recuperare le parole di Foucault, un’eterotopia radicale che alternativamente crea “uno spazio illusorio che indica come ancor più illusorio ogni spazio reale” oppure “un altro spazio, uno spazio reale, così perfetto, così meticoloso, così ben arredato al punto da far apparire il nostro come disordinato, maldisposto e caotico”. Non è perciò sostenibile che Mulholland Drive sia un film palindromo (come invece lo è, entro certi limiti, Strade perdute): dipendono fortemente dalla dispositio del discorso sia l’incoscienza con cui si sprofonda nella narrazione onirica sia l’infrangersi atrocemente delusorio di questa; entrambe caratteristiche indispensabili ai fini degli effetti di senso – inerenti la relazione sogno/realtà – veicolati dal testo. Prima di procedere oltre è opportuno dedicare, come è stato anticipato, una breve digressione al fattore di destabilizzazione secondario in azione nel ‘terzo atto’ del film. Anche qui il discorso è focalizzato su Diane: benché non sia più identificabile con l’istanza di enunciazione, la sua soggettività contamina profondamente il testo; ce lo ricordano gli episodi allucinatori, nonché le frequenti soggettive, in particolare quelle sfocate – ‘velate di lacrime’, per così dire – che si ripropongono poi come oggettive irreali e stacchi di transizione nella scena della festa. 31 Juri Lotman, La semiosfera, a cura di Simonetta Salvestroni, Venezia: Marsilio, 1985. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 117 Tale ‘soggettivazione’ ambigua e sospesa del discorso – caratteristica del cinema noir – incrina l’attendibilità del testo ad ogni livello. Con una sorta di ‘colpo di coda’ Lynch finisce per precipitare l’intera materia narrativa nel calderone dell’illusione, peraltro in pieno accordo con le dichiarazioni metacinematografiche già sottese al testo e rafforzate dall’ultimissima inquadratura del film che fa del Club Silencio la cornice più estrema palesataci. Nondimeno – per quanto attiene l’effetto contingente della seconda parte – questo fattore è poco influente (seppur assai significativo in fase di valutazione globale del testo): nel diretto confronto col sogno l’impianto mirato alla resa di un realismo mimetico pone in second’ordine la natura comunque discorsiva e soggettiva di quanto vediamo; inoltre le informazioni forniteci, se interpretate come fatti reali, generano una lettura complessiva assolutamente coerente e funzionale. Si può pertanto ritenere che siano altre le chiavi di volta del turbamento da cui viene colto lo spettatore: quelle esposte supra, e quella che sarà affrontata ora. Il risveglio corrisponde in Mulholland Drive ad uno smarrimento, non solo in senso cognitivo: qualcosa (qualcuno?) è perduto. Intuiamo di che cosa si tratta a partire dal concetto di sogno come “riparazione” in Resnik: “è un modo di rintracciare e ri-tracciare […] l’oggetto [che] è stato distrutto e perduto”; la perdita per eccellenza è naturalmente la morte, vissuta come “lacerazione” e “frantumazione” (TS, p. 124). Il sogno supplisce ad un’assenza – grazie all’immagine. L’immediata conseguenza è quella rilevata da Khan in uno studio sui sogni omerici: se il sogno evoca un assente di cui si sente la mancanza, tra dolore della perdita (la morte di Camilla nel nostro caso) e risveglio non può che instaurarsi un rapporto di reciproca corrispondenza.32 Riprendiamo le parole di Fuller: Mulholland Drive “riecheggia Strade perdute anche nel modo in cui mostra un sogno che va smarrendosi, dalla soddisfazione del desiderio, all’ansia, alla veglia”. Nel sogno si individua un percorso angosciante verso il risveglio e la coscienza. È necessario osservarne una caratteristica cruciale: esso si sostanzia sempre di rappresentazioni ambivalenti, che alludono per un verso alla finzionalità della costruzione onirica, per l’altro all’avvenuto assassinio di Camilla. La coscien32 Laurence Khan, “Legare o slegare il sogno”, in Ferdinando Amigoni e Vanessa Pietrantonio (a cura di), op. cit., p. 34. 118 / GABRIELE BUGADA za è quanto il misterioso cubo blu dischiude, sia nell’accezione cognitiva (contrapposta all’inconsapevolezza onirica donata dal sonno), sia in quella morale (l’acuta percezione del proprio crimine, obliata nel sogno). Ripercorriamo allora i momenti salienti di questo parallelismo. Il ritrovamento del cadavere in Sierra Bonita fa riferimento non solo alla morte ma pure alla natura delle immagini, iscritto com’è in un gioco di repliche e sdoppiamenti (ricordiamo i concetti di somiglianza cadaverica in Blanchot33 e quello barthesiano di noema fotografico34). La scena del Club Silencio è un’ovvia riflessione sullo statuto delle rappresentazioni, permeata tuttavia anche di angosciosi accenni alla morte – soprattutto nella canzone e nel mancamento di Rebekah Del Rio. Decisivo infine il ruolo della chiave blu: essa nella realtà è il segno (messaggio/memento) del fatto che l’omicidio sia stato ormai perpetrato. A che cosa corrisponde nel sogno? All’interruzione dello stesso, alla sospensione del ‘dittatoriale’ regime di rappresentazione onirica: tutto ciò, una volta che il cubo blu è apparso, manifestandosi in perfetta coincidenza con la consapevolezza che “è tutto un’illusione”, “è tutto registrato”. Volendo concedersi un po’ di condiscendenza verso le frasi a effetto si potrebbe insomma dichiarare che in Mulholland Drive viene raccontato un duplice assassinio, quello di Camilla e quello dell’immagine onirica (nonché – come spesso accade nel noir – cinematografica: lo vedremo). È stato detto che il delitto perfetto sarebbe quello in cui niente consente di concludere che si tratta di assassinio o – meglio ancora – che ci sia stato un qualche assassinio:35 nello smontare il paradigma investigativo, Lynch lo riproduce paradossalmente su un altro piano, invitando lo spettatore a questa ardua detection – smascherare un doppio crimine perfetto. Dapprima è la morte di Camilla a essere insinuata tra le pieghe del sogno, per essere rivelata sempre più chiaramente – come in ogni investigazione che si rispetti! – nel finale; prende frattanto sottilmente piede la crisi dell’immagine, che per Diane – e per lo spettatore – inscena nuovamente (raddoppia) lo smarrimento/la perdita dell’oggetto amato. Nella feroce disillusione del risveglio Lynch pare riecheggiare la lucreziana con33 Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, cit. in Allì Caracciolo, “Il teatro il sogno. La luna capovolta: un esperimento di messinscena”, in Gabriele Cingolani e Marco Riccini (a cura di), op. cit., p. 357. 34 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie (1980), trad. it. di Renzo Guidieri, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino: Einaudi, 2003, p. 78. 35 Ignacio Matte Blanco, op. cit., p. 281. LO SPECCHIO DEL SOGNO / 119 cezione di “eros come esperienza di frustrazione assoluta prodotta da immagini ingannevoli, da eidola per l’appunto”.36 Come è stato precedentemente suggerito, Lynch si spinge ancora oltre. Nel primo paragrafo abbiamo individuato il valore metalinguistico che il sogno assume nel momento in cui l’arte riconosce in esso un proprio analogon e ne adotta pertanto le forme in chiave autoreferenziale: Mulholland Drive condivide questo intento, come è palesato dalla tematizzazione del mondo cinematografico, dall’insistenza su figure dell’esibizione o dello spettacolo, ma soprattutto dal modo in cui il film si avvia e si chiude – sono infatti molto indicative sia la scelta di rendere perfettamente coincidente con il sogno gran parte del testo (indebolendo la soglia d’entrata), sia quella di concedere l’ultima parola al “Silencio”. Se ne rende ben conto Fuller quando afferma che Mulholland Drive “presenta comunque una dissonante osservazione sul tradimento che ha luogo quando l’illusione cinematografica […] è messa a nudo in quanto trucco” (BB, p. 15); e poi, quando evidenzia acutamente una somiglianza tra Velluto blu (Blue Velvet, 1986) e Mulholland Drive: Dean Stockwell’s Ben lipsynchs the song with the same baroque affectedness demonstrated by Del Rio, but he too is cut short when Frank rips the cassette of the song from the tape recorder. On both occasions Lynch is breaking through the dream fabric of the film, reminding us of the fragility of cinema’s hallucinatory power.37 Tutto il cinema è “registrato”, “un’illusione”, un nastro che corre lasciando allo spettatore l’onore o l’onere di investire le immagini di referenzialità, senso, passione. Vale così non solo per Betty ma anche per Diane – e per l’intero apparato filmico – quanto Borges racconta ne Le rovine circolari: “voleva sognarlo con minuziosa completezza e imporlo alla realtà”, però “anche lui era un’apparenza, […] un altro lo stava sognando”.38 Si può sottoscrivere in pieno ciò che asserisce Censi: 36 Massimo Fusillo, op. cit., p. 42. “Il personaggio di Ben interpretato da Dean Stockwell canta in playback con la stessa affettazione barocca esibita dalla Del Rio, ma lui pure viene bruscamente interrotto quando Frank strappa la cassetta dal registratore. In entrambe le occasioni Lynch squarcia il tessuto onirico del film, rammentandoci la fragilità del potere allucinatorio del cinema” (BB, p. 15). 38 Jorge Luis Borges, “Las ruinas circulares” (1940), trad. it. “Le rovine circolari”, in Id., Finzioni, a cura di Antonio Melis, Milano: Adelphi, 2003, pp. 47, 52. 37 120 / GABRIELE BUGADA Ciò che appare diventa sistematicamente evanescente. Evapora. E di questa seduta ipnotica che minaccia l’intero film? Che cosa resta? Universi temporali scollati. Instabili. Con la scusa dell’impossibile detection, Lynch ci costringe a costruire temporalmente (e dunque narrativamente) un percorso che non porta da nessuna parte; se non a quel teatro, a quella ribalta ormai vuota dove si chiude il film.39 Il film assume “l’aura di un canto di Sirena, che adesca [luring] lo spettatore in un sontuoso inganno [deception]” (BB, p. 14); tramite il fatale canto delle Sirene (qui il potere dell’immagine e della narrazione) lo spettatore è trascinato in quel sogno-trappola di cui parla Chion – “il sogno che non si controlla […] potrebbe forse essere quello di un altro, il sogno in cui si rischia di essere preso in trappola?”.40 Queste ultime righe sono destinate ad un fugace confronto con alcune letture critiche che divergono da quella qui sviluppata, e propendono invece per uno sgretolamento più o meno sostanziale delle possibilità di comprendere nel suo complesso il testo. Si può essere solo parzialmente d’accordo con Cattaneo quando conclude che “il progetto di cinema di Lynch come scrittura del sogno è […] coerente con se stesso fin dai tempi del suo primo lungometraggio, Eraserhead. E in effetti quella di Lynch continua a essere una ‘mente che cancella’ (eraserhead), che rompe e toglie nessi, piuttosto che consolidarli”.41 Sono anche maggiori le divergenze rispetto alle posizioni di Zonta, il quale, domandandosi che cosa si apprenda in Mulholland Drive, arriva a rispondere: “Il limite stesso della comprensione. Mulholland Drive è un film che non vuole essere capito. […] Non c’è nulla di reale in Mulholland Drive. Solo apparenze da un altro mondo, invisibile e impalpabile”.42 Discutendo a proposito del rapporto tra sogno e immagine abbiamo notato che “lo spazio del sogno è un iperspazio del pensare dove l’immagine può essere affermata nel momento stesso in cui viene negata”. Sono perciò eccessivamente riduttive le interpretazioni ‘nichiliste’ che neghino alla fascinazione esercitata dalle rappresentazioni il potere di essere “narrazione poematica che è rivelazione (e incanto)”: Lynch conosce e dispiega 39 Rinaldo Censi, op. cit., p. 12 (corsivi miei). Michel Chion, David Lynch, Torino: Lindau, 2000, p. 223. Cfr. Resnik, “il testimone [che] viene inghiottito”. 41 Francesco Cattaneo, op. cit., p. 10. 42 Dario Zonta, “Del meraviglioso mondo di David Lynch”, Duel, 94, febbraio 2002, p. 10. 40 LO SPECCHIO DEL SOGNO / 121 il potere della narrazione onirica, che non risiede nella referenzialità quanto nella metafora. Egli certamente “rompe e toglie” dei nessi, ma nel contempo ne consolida altri (si pensi alle diverse forme di coerenza che abbiamo ravvisato ed analizzato); così come – per quanto la comprensione venga problematizzata – suona superficiale la rinuncia a riconoscere una logica solo perché profondamente diversa da quella a cui si è adusi: in Mulholland Drive ci sono ‘di reale’ quantomeno le passioni e le immagini stesse, le – vane? – ‘apparenze’. Lynch elabora insomma un linguaggio che “adopera il sogno per decostruire – tramite l’autoriflessività – la propria articolazione, nonché quella degli altri linguaggi che si vorrebbero fondati sulle retoriche del sogno e che si rivelano invece viziati da un fondamentale rifiuto della logica onirica”.43 Un linguaggio che non teme di inoltrarsi attraverso lo specchio del sogno. 43 Valerio Massimo De Angelis, “L’incubo della realtà: ‘Young Goodman Brown’ di Nathaniel Hawthorne”, in Gabriele Cingolani e Marco Riccini (a cura di), op. cit., pp. 273-74. § 6 Giovanni Solinas Il mito senza fine Poetica dell’immagine e concezione mitica in André Breton Una proposta d’analisi Nella riflessione del surrealismo storico convivono paradossalmente l’esaltazione per l’universo mitico ed una visione del linguaggio basata sul rigetto delle forme codificate. La pratica della scrittura automatica, ed ancor più il procedimento di costruzione dell’immagine poetica (nell’accezione che il Manifesto riprende dalla formula originaria di Reverdy),1 corrispondono al tentativo di obliterare lo stesso ordine concettuale della conservazione, garante della riutilizzabilità infinita di una riserva di identità e di significati fissati. Il surrealismo – lo si sa – aspira all’assurdo logico di una lingua che non è codice, ed in cui tutto si dà come per la prima volta. In che modo un simile orientamento può essere compatibile con il funzionamento di quel linguaggio mitico che è invece, teoricamente, figlio della conservazione? Un linguaggio che prevede la cristallizzazione dei suoi contenuti in forme prototipiche, in motivi e schemi che, per quanto sottoposti a variazioni costanti, fanno della riconoscibilità il proprio carattere specifico, tanto da costituirsi come luoghi di una memoria condivisa. In realtà credo che un’analisi approfondita dei termini di questo paradosso possa portare, in parte, a chiarire i motivi per cui essi non vengono concepiti come incompossibili dal pensiero surrealista. Ciò che queste pagine dovranno proporsi di fare sarà dunque mettere in evidenza come (per quanto negli effetti la contraddittorietà tra i due ambiti non possa essere abolita) le motivazioni che portano il surrealismo a coltivarli en1 Notissima la definizione di Reverdy: “L’immagine è una creazione pura dello spirito. Non può nascere da un paragone, ma dall’accostamento di due realtà più o meno distanti. Più i rapporti delle due realtà accostate saranno lontani e giusti, più l’immagine sarà forte”. Pierre Reverdy in Nord-Sud, marzo 1918, cit. in André Breton, Manifeste du surréalisme (1924), trad. it. di Guido Neri, Manifesti del Surrealismo, Torino: Einaudi, 1987, p. 26. PARAGRAFO I (2006), pp. 123-41 124 / GIOVANNI SOLINAS trambi siano da ascrivere ad un medesimo orizzonte teorico. Si prenderà in considerazione in particolare la riflessione di André Breton, sia quella – di area linguistica – relativa alla questione dell’‘immagine’ surrealista, sia quella che interessa, invece, il tema del mito; ciò nel tentativo di mostrare come la logica che presiede alla visione bretoniana della sfera mitica, considerata nella sua natura di complesso di forme simboliche che interagiscono con la mentalità collettiva, sia apparentabile a quell’attitudine vitalistica che anima la sua concezione del linguaggio poetico. Il senso sospeso Per mettere in chiaro da subito l’angolo di approdo che si intende assumere nell’avvicinare la complessa questione dell’immagine surrealista, potrà essere fruttuoso ricorrere ad una sorta di gioco di sponde tutto interno al macrotesto di Breton. Si può partire, cioè, dalle pagine di Nadja in cui il poeta introduce la nozione di signal.2 Il signal è l’avvenimento casuale, fortuito, che si pone di fronte al soggetto con una profonda forza di sollecitazione. Un evento che chiama dall’esterno, e che si fa portatore – per chi lo sa recepire e si dispone a farlo – di un significato rivelativo. Manifestazioni di questo particolare fenomeno sono i deliri onirici di Desnos, capace di far sgorgare dallo stato di semiveglia cui si abbandonava immagini ed analogie sorprendenti per precisione e potenza invocativa,3 o (per citare un altro celebre caso) la permanenza insistente, nella memoria visiva del Breton flâneur, della scritta di un’insegna parigina (il famoso Bois-Charbons ricordato in Nadja).4 Il signal verbale, apparentemente insensato, del tutto autoreferenziale, racchiude il potere di indurre, o quantomeno di annunciare degli eventi rivelatori. Alla sua apparizione, come di fronte ad una formula magica, si attende la risposta di un accadimento. 2 André Breton, Nadja (1928), Paris: Gallimard, 1964, p. 21. Dove non altrimenti indicato, la traduzione è mia. 3 Sostiene l’autore che chi non abbia assistito di persona a questo impressionante fiotto di “sbalorditive equazioni poetiche” (ivi, p. 35) non avrà mai la possibilità di comprendere quale fosse l’impatto di quelle parole nuove, in che cosa consistesse “il valore assoluto di oracolo” (ibidem) assunto dal linguaggio in quell’occasione. 4 Racconta Breton: “Le parole Bois-Charbons, che si dispiegano nell’ultima pagina di Champs Magnetiques, mi hanno consentito, per un’intera domenica durante la quale ho passeggiato con Soupault, di poter esercitare uno strano talento di prospezione nei confronti di tutti i negozi che esse servono ad indicare. Ho l’impressione che potessi dire a quale altezza sulla destra, sulla sinistra questi negozi sarebbero apparsi nelle strade che imboccavamo” (ivi, p. 29). IL MITO SENZA FINE / 125 Ora, se si considera la particolare natura dei signals tralasciando l’aspetto più propriamente letterale del loro potere oracolare, e concentrandosi sulla dimensione della sospensione implicita nell’idea dell’annuncio, dell’anticipazione-induzione che essi sono detti attuare, si riesce ad ottenere un modello descrittivo direttamente applicabile all’immagine. Così come il potere pragmatico del signal, la natura linguistica dell’immagine surrealista, è anch’essa dotata, infatti, di una natura liminale, sospesa. L’immagine si colloca in una sorta di terra di nessuno, al di là dell’ordinarietà denotativa del linguaggio, ma allo stesso tempo distante dal potere semantico di secondo grado della metafora, il tropo che più le si avvicina. Vediamo di spiegare. Le svariate proposte d’interpretazione del meccanismo metaforico, al di là dell’eterogeneità teorica delle loro prospettive, sono comunque accomunate dal considerare il processo di generazione di senso della figura come un’azione scandita su due tempi successivi: ad un’impennata iniziale, con cui il discorso sembra smarcarsi improvvisamente da ogni regola di coerenza, segue il momento interpretativo, che consente al lettore di decifrare l’immagine. Dunque tensione e rilascio, rottura traumatica della coerenza semantica, corrispondente all’esplosione dell’immagine, e momento interpretativo immediatamente susseguente, che riporta lo scarto entro l’alveo del senso; un senso, naturalmente, più o meno complesso, più o meno rivelatore nel suo apporto cognitivo, ma la cui apparizione assume comunque una valenza propositiva, capace di subordinare a sé il gesto della negazione iniziale. Ora, lo spazio di sospensione entro cui si colloca l’immagine surrealista sembra coincidere esattamente con lo iato che separa questi due momenti. A detta di gran parte dei teorici che hanno commentato il problema, infatti, l’immagine, nonostante sia esteriormente identica, nella struttura, al nesso metaforico, non può essere ricondotta all’ambito della figuralità;5 la 5 Per questa prospettiva si può vedere, ad esempio, Groupe m, Rhétorique de la poésie (1977), trad. it. di Alfredo Luzi, Retorica della poesia, Milano: Mursia, 1985, p. 185. Interessanti anche: Monroe Beardsley, “La metafora come tensione categoriale”, in Mariano Cristaldi (a cura di), La metafora e lo stato. Saggi di retorica e politica, Cassino: Garigliano, 1979, p. 194; Lucio Gabellone, L’oggetto surrealista, Torino, Einaudi, 1977, p. 27. La posizione più estrema, in questo senso, è però quella che si trova in Michel Riffaterre, La production du texte (1979), trad. it. di Giorgio Zanetti, La produzione del testo, Bologna: Il Mulino, 1989, p. 296. Un caso opposto è rappresentato dalla visione di Lotman, che invece considera gli accostamenti fra realtà apparentemente incomunicabili introdotti dalle avanguardie, come esempi emblematici del funzionamento dei tropi, e del loro potere di rinnovamento linguistico-conoscitivo. 126 / GIOVANNI SOLINAS distanza fra le realtà che essa collega è tale da non consentire alcuna interpretazione a posteriori capace di gettare la luce rigenerante del senso sul plesso verbale. Quest’ultimo, si potrebbe dunque concludere, attua la prima delle due fasi analizzate, gettandosi con un deciso gesto di rottura fuori dallo spazio cartografato della cogenza semantica, ma non accede al secondo momento, e resta imprigionato nella regione interlocutoria dello stato tensionale con cui si identifica l’evento del suo darsi. In un saggio del 1978, Michel Deguy fa precedere l’analisi della poesia di Breton Sphynx Vertebral dal confronto con le pagine di Signe ascendant, uno degli scritti teorici in cui lo stesso Breton si è soffermato sul problema dell’analogia all’interno dell’immagine e sulle questioni riguardanti la sua definibilità e la sua funzione espressiva ed estetica. Il testo di Breton, ed ancor più il filtro interpretativo attraverso cui Deguy fa scorrere i suoi argomenti, risulta – mi sembra – illuminante per l’ottica che qui cerco di sviluppare. Breton sembra voler rielaborare la sua originaria definizione di ‘immagine’, fornendo certe chiarificazioni, ma soprattutto introducendo alcuni nuovi, significativi concetti: “L’immagine analogica […] si muove, tra le due realtà in presenza, in un senso determinato che non è in alcun modo reversibile. Dalla prima di queste due realtà alla seconda, essa segna una tensione vitale rivolta il più possibile verso la salute, il piacere, la quiete, la grazia resa, gli usi consentiti”.6 Ad un primo livello di lettura l’enunciato può essere inteso come un’indicazione di ordine espressivo. Per innescare la scintilla dell’immagine non basta semplicemente accostare due termini qualunque, purché drasticamente distanti. Il secondo termine è chiamato ad elevare il primo, a potenziarlo, si dovrebbe dire, esteticamente, a portarlo insomma verso la luce.7 Il saggio di Deguy prospetta, però, un ulteriore piano interpretativo. A questo livello il termine decisivo è quello di irreversibilità, l’irreversibilità di un movimento di ascesa, dunque l’abbandono di una condizione originaria. Il passaggio dal primo al secondo dei termini presi nell’immagine segna una sorta di salto, di elevazione improvvisa rispetto alla 6 André Breton, Signe ascendant (1947), in Id, Œuvres complètes, vol. 3, Paris: Gallimard, 1992, p. 769. Alle Œuvres di Breton si rimanderà d’ora in poi nel testo con la sigla O, seguita dal numero di volume e di pagina. 7 A conclusione del saggio Breton riporta questo ‘apologo zen’: “Per bontà buddistica Bashô modificò un giorno, con ingegnosità, un haikaï crudele composto dal suo umoristico discepolo Kikakou. Avendo questi detto: ‘Una libellula rossa – strappatele le ali – un peperoncino’, Bashô vi sostituì: ‘Un peperoncino – mettetegli delle ali – una libellula rossa’” (O, 3, p. 769). IL MITO SENZA FINE / 127 quale non è possibile tornare indietro. Deguy considera la “tensione ascendente, siderante”8 che caratterizza il percorso univettoriale del rapporto analogico fra le due realtà linguistiche, come una ‘risalita’, un remonter. Ma qual è l’elemento che fa da resistenza al remonter del linguaggio? ‘Contro cosa’ il linguaggio risale? “In contro-pendenza, controcorrente… di che cosa? Se non di se stesso?” (ibid.). Il linguaggio si dà svolgendosi contro se stesso. Ancora una volta siamo nell’ambito dell’opposizione fra la ‘normalità’ del discorso denotativo, letterale, e la capacità della lingua di infrangere quest’ordinarietà per confondere il rapporto biunivoco fra parole e cose. Secondo Deguy è unicamente attraverso questa dinamica di autocontraddizione della parola che il logos può aspirare a palesarsi nella sua forma più autonoma, più pura. Il linguaggio nega la propria natura elementarmente nominativa, cerca di inibire la propria vocazione indicale, la sua tendenza ad aggrapparsi a dei sensi riconoscibili. Crea così una sorta di corto circuito interno al proprio funzionamento, grazie al quale ciò che è ‘al di sopra del visibile’, il logos, appunto, inteso come qualcosa di non nominabile, di ‘indicible’, trova lo spazio attraverso cui mostrarsi. Dunque: “Il dire assume il contraddirsi”, e “nell’intenzione che le interdice, le ‘parole’, negate, possono dire ‘l’indicibile’ a dirsi” (ibid.). Mi sembra che questa lettura, svincolata dal suo versante più marcatamente idealista, dal riferimento ad un indefinibile pneuma al quale il carattere autocontraddittorio del linguaggio sarebbe in grado di dare accesso, metta in rilievo un dato molto importante. Deguy sembra suggerire, cioè, che il linguaggio dell’immagine trovi la sua qualità essenziale in una sorta di stato tensionale costante. Qual è il senso di quella ascensione siderante di cui Deguy parla? Probabilmente è proprio la dinamica per cui ognuno dei due termini del plesso verbale fa decollare l’altro, lo strappa dalle radici che lo tengono ancorato alla significazione, vale a dire al riferimento. Credo che la descrizione si applichi soprattutto alle immagini più astratte, meno legate ad un carattere allucinatamente visivo. Si pensi soltanto, per esempio, al titolo di uno dei componimenti di Revolver à cheveux blancs: “Noeud de miroirs”. Dal punto di vista linguistico ciò che avviene è facilmente spiegabile. Le due realtà, una volta accostate secondo un vincolo assolutamente arbitrario, perdono la nettezza dei confini altrimenti appartenente al proprio campo di senso. Si genera così un effetto 8 Michel Deguy, “Du Signe ascendant au Sphinx vertébral”, Poétique, 34, 1978, p. 231. 128 / GIOVANNI SOLINAS di sovrapposizione, di indebolimento dei discrimini. Un annebbiamento che (per dirla con gli strutturalisti) mette in discussione la certezza delle differenze. C’è però qualcosa di più del semplice spaesamento provocato dall’assurdità del legame. Ciascuno dei significati originari viene letteralmente rapito dall’altro (tensione siderante), e condotto in una sorta di illocalizzabile regione dell’assenza in cui non è più se stesso, ma neanche, in realtà, qualcosa di nuovo (autoannullamento del linguaggio). Il plesso linguistico così formato, trasfigurati i termini che lo compongono, si innalza verso uno stato d’astrazione dal quale non ridiscende, dal momento che l’impertinenza rifiuta di essere sciolta in un senso metaforico di secondo grado. Il linguaggio dunque fugge dalla dinamica di riferimento in cui la significazione consiste. Riferirsi, applicarsi a un significato, ad un concetto, anche nel momento in cui questo concetto fosse del tutto nuovo (è il caso delle metafore non scontate) significherebbe ricadere, essere riportato nell’ambito di ciò che trova luogo, che accetta la propria collocabilità. Oppure, se la si vuole vedere da un’altra angolazione, è il suo senso ad essere preso in una sorta di indecidibilità. Esso tende costantemente verso un nuovo che non realizza, e vive di questo stato di tensione, che gli consente di non depositarsi, cioè di non determinarsi, e dunque di non essere fissato. Sarà proprio la ricerca di un simile stato di fluidità, la propensione anti-determinativa coincidente con la promozione di una condizione tensiva che non conosce rilascio, e che fugge la localizzazione definitiva, a ripresentarsi entro l’idea di mito coltivata da Breton. Un nuovo mito collettivo A ben guardare l’interesse del surrealismo per la dimensione del mito può essere indagato secondo due differenti angolazioni d’approccio, corrispondenti, se si vuole, alle due principali modalità attraverso le quali gli esponenti del gruppo hanno percepito ed elaborato il loro rapporto con l’universo mitologico. La prima nasce contestualmente al sorgere stesso del movimento, ed è ampiamente condivisa dai suoi membri storici, per i quali, da subito, il mito assume la valenza del vero e proprio ideale collettivo. Istituendo un gioco d’abîme fra l’oggetto ed i modi della sua considerazione si dovrebbe dire che la questione è sviluppata proprio nei modi della produzione e dell’esaltazione fideistica di un contenuto mitico. A IL MITO SENZA FINE / 129 trovare alimento è, insomma, una sorta di mitologia del mitico, basti pensare alle forme in cui si esprime l’interesse per il tema in questione: se la lingua dei miti è per definizione sovrapersonale, se la leggenda si vuole racconto non riconducibile ad un’origine, una storia che non deriva da nessuno ed appartiene a tutti, allo stesso modo la celebrazione surrealista della sfera mitica tende a trasmettersi attraverso il mezzo di una sorta di voce collettiva. I temi, i concetti, il linguaggio dei luoghi della produzione surrealista in cui il tema appare, paiono confondersi, divengono quasi interscambiabili. In questa accezione il piano di interesse prioritario è costituito dalla naturale affinità che avvicina il dominio della libera immaginazione allo spazio mitico. Al mito appartiene un orizzonte conoscitivo che ignora in parte le norme costrittive del pensiero positivo, della logica diurna; un orizzonte in cui trova posto il meraviglioso, onnipresente idolo del pensiero surrealista. In questo senso, ne Le Paysan de Paris Aragon istituisce un rapporto pressoché identificativo fra la nuova mitologia di cui registra la nascita e la dimensione del ‘meraviglioso quotidiano’.9 I due domini vengono considerati dall’autore quasi indistinguibili, il che contribuisce non poco a gettare luce su questo primo livello della visione surrealista del mito. Nelle pagine del testo il mito – la natura sovrannaturale di ciò che appartiene al mito – è associato alla potenza rivelativa cui assurgono gli incontri con gli esseri animati e inanimati dei passages parigini, una volta che agli stessi si applica il détournement immaginativo del flâneur. Si pensi alle pagine che descrivono il venditore di canne.10 Colto dallo sguardo deformante di Aragon il dato reale è investito di un’energia auratica, che gli assegna la valenza epifanica dell’evento straordinario. La sua apparenza ordinaria esplode per rivelare la meraviglia di un fuoco d’artificio. Lo schema sembra chiaro: la nuova mitologia professata dal surrealismo corrisponde ad una percezione del quotidiano cui è restituita la com9 Andrà ricordato che Le Paysan de Paris è introdotto da una breve “Prefazione a una mitologia moderna”. Aragon vi si esprime in questo modo: “Dei miti nuovi nascono sotto ciascuno dei nostri passi. Là dove l’uomo ha vissuto comincia la leggenda, là dove vive. Voglio rivolgere la mie mente soltanto a queste disprezzate trasformazioni. Ogni giorno si modifica il sentimento moderno dell’esistenza. Una mitologia si annoda e si snoda. È una scienza delle vita che appartiene soltanto a coloro che non ne hanno esperienza”. Louis Aragon, Le Paysan de Paris (1926), Paris: Gallimard, 1981, p. 15. 10 La visione delle canne è l’occasione che consente al nastro delle trasformazioni immaginarie di innescarsi: la devanture del venditore si metamorfizza in una sorta di paesaggio sottomarino, rischiarato da un luce soprannaturale, ed abitato da una sirena (ivi, p. 31). 130 / GIOVANNI SOLINAS ponente magica, incantata, la meraviglia, appunto. Una percezione che si riappropria del sacro, per dirla con Leiris. Il contributo offerto da quest’ultimo alle riflessioni del Collège de sociologie è rappresentato da un testo intitolato proprio Le sacré dans la vie quotidienne;11 qui Leiris dà vita ad una sorta di immersione nel ricordo che, per quanto egli tenesse a distinguere (perché più vicina all’autoetnografia) dalle operazioni esplicitamente autobiografiche de L’âge d’homme (1939) o di Biffures (1948), assume una connotazione marcatamente letteraria. Leiris ritrova nelle sensazioni dell’infanzia la traccia di una visione miticizzante del reale. Il sacro è identificato proprio con l’esito di una dinamica di deformazione dilatante che il Leiris bambino esercitava su realtà men che ordinarie ad uno sguardo adulto (la stufa, le stanze della casa, i prati vicini). Il meraviglioso, il sacro corrispondono dunque alla possibilità di riconquistare alla realtà lo spazio dell’ultranaturale, di associare alle figure che affollano la quotidianità dell’esistenza la stessa aura di potere magico e di forza rivelatrice che è propria del mondo mitologico. Quest’ordine di motivazioni è, certo, determinante anche per quella che si è definito come la seconda modalità di elaborazione surrealista della problematica mitica. Solamente in parte, però. Rispetto ad essa, infatti, una valenza prioritaria è rivestita da un altro plesso di questioni, che non si identifica semplicemente con l’apertura alla sfera del meraviglioso quotidiano, ma è semmai da mettere in stretto rapporto con la natura sospesa e con la propensione alla non riconducibilità associabile al linguaggio dell’immagine. Va detto che questa ulteriore accezione comincia a delinearsi a partire dalla metà dagli anni trenta, ed assume un profilo definitivo soltanto nel decennio successivo. Inoltre essa è affidata in modo quasi esclusivo all’elaborazione teorica del solo André Breton. Tentando di riassumerla con una formula si dovrebbe riprendere la definizione utilizzata da Jacqueline Chenieux-Gendron: il mito, in questa prospettiva, è visto nei termini del “modello proiettivo”.12 Viene considerato, cioè, dal punto di vista della sua possibile azione sulla mentalità sociale, sulla fisionomia del pensiero collettivo. In questo senso esso non è più soltanto sinonimo di meraviglioso, e la mitologizzazione dell’esistenza non si limita ad identificarsi con il recupero del mistero, del sacro, chiamati a far vibrare l’ingrigi11 Il testo è raccolto in Denis Hollier (a cura di), Le collège de sociologie. 1937-39 (1979), trad. it. di Marina Galletti, Il collegio di sociologia, Torino: Bollati Boringhieri, 1991. 12 Jacqueline Chenieux-Gendron, Le surréalisme, Paris: PUF, 1984, p. 147. IL MITO SENZA FINE / 131 to commercio tra l’individuo e la realtà. Il mito, il suo modo di produrre senso, e di offrirlo all’interpretazione, diventa un sistema complessivo di riferimento; il bacino della nuova mitologia, alla cui definizione contribuirà innanzitutto l’arte surrealista, rappresenta una costellazione di simboli a partire dalla quale dovrà prendere vita una nuova forma di coscienza collettiva. Dunque, apparentemente, mito come modello. Tutto sta, credo, nel tentativo di definire quale sia la natura di tale modello, quale il modo della sua azione. Se di dinamica modellizzante si può parlare, infatti, lo si dovrà fare in un’accezione talmente indebolita da disperdere lo stesso specifico concettuale della nozione. Ma procediamo con ordine. All’altezza degli anni Trenta il riferimento al ‘mito collettivo’, e, più precisamente, al surrealismo come istanza generatrice di un nuovo mito collettivo, si segnala per la sua quasi formulaica ricorsività all’interno del discorso teorico di Breton. Lo si trova ad esempio in un testo di estrema importanza programmatica come Posizione politica dell’arte di oggi (1935), in cui Breton si esprime in questi termini: “Ed ecco perché, in queste condizioni, forse non si tratta neppure più, nell’arte, della creazione di un mito personale, ma col surrealismo, della creazione di un mito collettivo. Perché questo fatto fosse contestabile, bisognerebbe, come ho già detto, che al surrealismo potesse essere contrapposto […] un movimento di tutt’altro carattere che abbia rilevato la stessa forza d’attrazione sulla mente dei giovani”.13 Il passo comincia a chiarire in quale ottica debba essere letto l’impiego della nozione di mito: innanzitutto la nuova mitologia coincide con la crescente massa di produzioni d’arte d’ispirazione surrealista. In secondo luogo, come detto, essa interessa soprattutto per la sua capacità di intervenire sulle forme della coscienza collettiva. In questa prospettiva il motivo si ripresenta negli scritti successivi. Del 1938 l’intervista in cui Breton ribadisce come, per quanto sia evidente che nel fiorire di testi concepiti secondo la tecnica della scrittura automatica, il rapporto fra quantità e qualità non possa che andare a sfavore della seconda, è comunque necessario continuare a percorrere quella via. Ed è vitale, aggiunge Breton, che così facendo “il mito collettivo al quale noi vogliamo giungere continui a elaborarsi” (O, 3, p. 122). 13 André Breton, Position politique de l’art d’aujourd’hui, trad. it. in Id, Manifesti, cit., p. 162. Il passo riprende un accenno più breve al medesimo motivo, presente già nella prefazione a Posizione politica del surrealismo. Si parlava, lì, del surrealismo come “modalità di creazione di un mito collettivo” (ivi, p. 136). 132 / GIOVANNI SOLINAS A partire dai primi anni quaranta il tema si fa più esplicito. I Prolegomeni al terzo manifesto del surrealismo (1942) affrontano di petto la questione: Breton fa propria la domanda cui, ricorda, molti degli intellettuali di allora si sforzavano di trovare risposta: “Che cosa pensare del postulato ‘non c’è società senza mito sociale?’; in quale misura possiamo scegliere e adottare, e imporre un mito in rapporto con la società che riteniamo desiderabile?”.14 Breton non si discosta da una visione squisitamente progettuale. L’attributo cui fa ricorso Chenieux-Gendron, in questo senso, si rivela quanto mai appropriato. Il ragionamento bretoniano si svolge nei termini della mera proiezione: quale sarà l’esito di un percorso di formazione di un’identità collettiva ancora a venire, fondata sull’adesione ad un linguaggio simbolico esso stesso in via di elaborazione? Precedenti di qualche anno i Prolegomeni, le pagine di Limites non frontières du surréalisme (1937) si erano confrontate, invece, con un altro aspetto del problema, vale a dire con il tentativo di fornire una – se pur molto abbozzata – interpretazione della natura e dell’origine dell’immaginario mitologico, di cui Breton spiega la forza pervasiva riconducendola al suo legame con l’inconscio collettivo dell’epoca in cui sorge. Ne viene fuori una lettura storica pseudo-deterministica, che sembra voler eleggere suoi impliciti padrini teorici Marx e Jung assieme: la fortuna del romanzo gotico settecentesco si deve prevalentemente alla sua capacità di aver dato forma visibile alle tensioni che agitavano l’inconscio di un intera comunità. Allo stesso modo il surrealismo dovrà proporsi non di tradurre il contenuto storico “manifesto” dei suoi anni, ma il loro “contenuto latente” (O, 3, p. 665). Il che, ribadisce Breton, corrisponde esattamente alla “elaborazione del mito collettivo proprio alla nostra epoca, allo stesso titolo con cui, volente o nolente, il genere ‘noir’ dev’essere considerato come patognomica del grande sconvolgimento sociale che s’impossessa dell’Europa alla fine del XVIII secolo” (O, 3, p. 667). Questi due aspetti del nesso mito/coscienza collettiva (la visione proiettiva e quella per così dire eziologica) ritornano in due testi del 1947 molto importanti per la mia prospettiva, Devant le rideau e Comète surrealiste. I due scritti condividono la medesima occasione extratestuale. Entrambi, infatti, costituiscono un commento della esposizione internazionale del surrealismo che si tenne a New York in quello stesso anno.15 L’esposizione, 14 André Breton, Manifesti, cit., p. 220. Devant le rideau apparve come introduzione del catalogo della mostra. Per la ricostruzione dell’evento cfr. la “Notice” in O, 3, p. 1367. 15 IL MITO SENZA FINE / 133 nella forma del suo allestimento, nei suoi contenuti ed in genere nel significato complessivo che l’intera operazione avrebbe dovuto assumere, era totalmente ispirata alla dimensione del mito. Il projet initial, sorta di guida per il visitatore redatta dallo stesso Breton, ed annessa al catalogo illustrativo dell’esposizione, spiegava come il percorso della mostra andasse concepito alla stregua di un cammino iniziatico, durante il quale il visitatore era posto di fronte alla “emergenza poetica e plastica di un mito nuovo, presente allo stato latente e che cerca la sua figurazione nella sala dei dodici ‘altari’ mitici” (O, 3, p. 1367). La mostra, dunque, cercava di ricreare quantomeno un’allegoria del rapporto di fruizione partecipativa, fideistica se si vuole, che gli individui, nelle culture in cui alla mitologia si assegna o si è assegnata una valenza sacrale, con quei contenuti stabiliscono.16 Evidentemente la mostra rappresenta un episodio fortemente significativo nella storia del rapporto fra il movimento e la sfera del mito. Un episodio con cui fa il paio un altro capitolo di quella vicenda, vale a dire la composizione del libretto per immagini e didascalie De la survivance de certains mythes, nel quale il poeta assembla un florilegio di icone (foto, dipinti, fotogrammi di film) attinte dalla storia, antica e recente, del repertorio immaginario umano, associandole a temi mitologici sia ancestrali che moderni. L’invito alla costruzione di una nuova fantasmagoria mitica, destinata a stimolare e ad alimentare la sensibilità collettiva, trova in questi esempi dei tentativi embrionali di applicazione. E del significato di questi esperimenti gli scritti riferiti all’esposizione de 1947 contribuiscono a fornire una spiegazione. Devant le rideau torna senza mezzi termini sugli argomenti già intravisti. Il potere di attrazione e di fascinazione esercitato sul pensiero dalle creazioni surrealiste assegna a queste ultime – spiega Breton – una valenza rivelativa. Esse “determinano un movimento di adesione, provocano un dono di se stessi così totale” (O, 3, p. 749) che difficilmente si potrà continuare a descriverle semplicemente come opere d’arte. “Il carattere insorgente di queste opere così come l’interrogazione, la sollecitazione sempre più ardente di cui esse sono oggetto, la resistenza che oppongono ai mezzi 16 Dal piano terra, dove cominciava la visita, lo spettatore accedeva al piano superiore, attraverso una scala di 21 gradini, recanti ognuno un simbolo degli arcani maggiori dei tarocchi. Si entrava così alla “Sala delle superstizioni” la quale, spiegava Breton nel Projet initial, “deve rappresentare la sintesi delle principali superstizioni esistenti e obbligare a superarle per proseguire la visita” (O, 3, p. 1367). La sala finale era quella degli altari, divisa in spazi ottagonali: “Ognuno dei dodici alveoli ottagonali […] sarà consacrato a un essere, una categoria di esseri o un oggetto SUSCETTIBILE DI ESSERE DOTATO DI VITA MITICA” (ibid.). 134 / GIOVANNI SOLINAS di apprensione che l’intendimento umano, al suo stato attuale, conferisce […] accreditano l’idea che un mito parta da esse, che dipenda soltanto da noi definirlo e coordinarlo” (ibid.). L’approccio proiettivo ad un mito in formazione a partire dal quale potrà cominciare a definirsi una nuova mentalità collettiva, è riproposto del resto in Comète surréaliste. Qui tornano anche, come già accennato, i termini della lettura eziologica precedentemente intravista, che fa del mito il collettore delle tensioni latenti, delle dinamiche inconsce degli individui. Il nutrimento che nell’ambito del surrealismo, spiega Breton, l’immaginario poetico ha offerto alle forme plastiche è un segnale determinante; esso: “potrebbe già indurre a pensare che le forme frammentarie e sparse del desiderio collettivo, il quale resta un segreto per ogni essere umano, tendono a un punto di convergenza unico e che al loro punto di incontro un mito nuovo ci attenda” (O, 3, p. 754). Andrà detto, per completare il quadro, che nell’elaborare la visione proiettiva relativa all’azione del mito sul pensiero collettivo, Breton sembra tener presente l’impostazione del Collegio di Sociologia, il gruppo di ricerca che costituiva in pratica il corrispettivo scientifico della riflessione surrealista sul mito. Bataille e Caillois professavano, in quegli anni, la necessità di ricostituire, entro il tessuto delle società occidentali, un principio unificatore che consentisse di considerarle non semplicemente come la somma di una serie di soggettività, ma come organismi complessi e vitali; organismi definibili a partire da ciò che i due intellettuali chiamavano “movimento comuniale”, vale a dire da quello stato di coerenza elettiva che nelle società arcaiche era assicurato anche e soprattutto dalla credenza condivisa nel mito. Vicinissimo, d’altronde, al ragionamento di Breton il passo in cui Caillois chiama in causa i tre poli della letteratura, del mito e del pensiero collettivo. Balzac e Baudelaire, sostiene Caillois, hanno inteso “integrare nella vita le richieste che i romantici si rassegnavano a soddisfare sul piano dell’arte”, e si sono votati così ad un’impresa “ben apparentabile al mito, che significa sempre un accrescimento del ruolo dell’immaginazione nella vita, dal momento che per natura, esso è suscettibile di spingere all’atto”.17 In questa direzione, secondo Caillois, si dovrebbe chiedere all’arte contemporanea di proseguire: “È in effetti altrettanto importante concepire la possibilità di piegare l’estetica verso la drammaturgia, cioè verso l’azione sull’uomo”.18 17 18 Roger Caillois, Le Mythe et l’homme (1938), Paris: Gallimard, 2002, pp. 172, 172-73. Ivi, p. 174. IL MITO SENZA FINE / 135 A questo punto i dati su cui basare un’analisi più approfondita del particolare carattere ‘modellizzante’ assegnato da Breton al mito ci sono tutti. E credo che si debba partire proprio dalla compresenza, nella riflessione del poeta, dei due aspetti che si è cercato di evidenziare in questa rapida panoramica. Secondo Breton il linguaggio mitico è traduzione, o se si vuole espressione, dell’interiorità profonda, inconscia della collettività – dunque emanazione di una componente costitutiva dell’identità del soggetto sociale – ed allo stesso tempo bacino immaginario cui il pensiero collettivo tende, insieme di simboli esterno agli individui, in riferimento al quale essi sviluppano una nuova visione: in definitiva qualcosa cui ispirarsi, cui conformare la propria coscienza. La circolarità di questo rapporto mostra tutta la propria natura paradossale: l’immaginazione mitica è, allo stesso tempo, dentro (sebbene inconsciamente) e fuori l’individuo; essa è generata dal soggetto, ma insieme è fattore, istanza della rigenerazione dello stesso. In definitiva, dunque, è attivata, promossa ma contemporaneamente subita dall’uomo. Quest’ultimo la crea e la riceve, è attivo e passivo insieme. In realtà la dinamica non dovrebbe stupire più di tanto chi ha una certa confidenza con alcune delle nozioni varate da Breton. Si pensi al concetto di humour objectif, che Breton riferisce a quegli incontri, quegli eventi totalmente casuali nei quali, però, paradossalmente l’individuo riconosce il segno del proprio destino.19 La necessità nasce dall’aleatorietà, ciò che è frutto dell’hazard è, allo stesso tempo, qualcosa che non poteva che essere così. Anche in questo caso, dunque, circolarità. E non diverso è il corto circuito fra passato e futuro implicito nella ricostruzione storica dell’evoluzione letteraria saltuariamente abbozzata nei testi del poeta: in Rimbaud, Nerval, Roussel e negli altri numi protettori del movimento, il surrealismo vede non soltanto il proprio passato storico, ma anche il proprio futuro: non solo ciò che è stato, ma ciò che dovrà essere.20 Gli autori del passato sono insieme punto di partenza ed indicazione di un termine d’arrivo. 19 L’humour oggettivo chiama in causa la nozione di casualità oggettiva, cioè “quella specie di casualità attraverso la quale si manifesta in modo ancora molto misterioso per l’uomo una necessità che gli sfugge, sebbene egli la provi vitalmente come necessità”. André Breton, Manifesti, cit., p. 199. 20 In Originalité et liberté (solo per citare un esempio), Breton si riferisce alla consueta serie di autori invocati quali antenati del surrealismo (Novalis, Nerval, Blake, Poe…): “una linea di resistenza imprescrittibile passa attraverso questi nomi, che noi abbiamo trovato rivolti non verso il passato, ma verso l’avvenire, carica di forza premonitrice sulla nostra strada” (O, 3, p. 179). 136 / GIOVANNI SOLINAS Ora, non è probabilmente possibile indagare, nello spazio di queste pagine, la particolare specificità epistemologica di un modello di visione che prevede il superamento delle vecchie ‘antinomie’ ancora vigenti fra ‘realtà’ e ‘immaginazione’, ‘passato’ e ‘futuro’, ‘tradizione’ e ‘libertà’.21 Ciò che mi sembra interessante sottolineare è l’idea di irrisolvibilità legata alla dinamica della circolarità. Se si traduce il modello della co-implicazione nei termini dello schema chiastico, in cui due linee divergenti condividono la stessa origine, si dispone di una sorta di versione visualizzabile di tale irrisolvibilità. Ognuno dei due principi non riesce a vedere interamente l’altro come dato assoluto, a sé esterno, e da sé distanziato. Per quanto tenti di farlo c’è sempre un tratto, anche minimo, in cui i due corpi si confondono. D’altronde, a questa prima declinazione della circolarità entro la dimensione del mito, ne corrisponde un’altra tutta interna alla questione della credenza: anche in questo caso la collettività è assieme soggetto attivo ed oggetto passivo, funzione d’innesco ed allo stesso tempo istanza ricettiva. Essa determina la condizione sacrale dell’universo mitico, concede ad esso la propria disponibilità a credere e così facendo lo investe di uno statuto sovrannaturale. Nello stesso tempo, però, si pone come il destinatario della sacralità, come il bacino su cui questa si esercita, come lo spazio in cui il mito è ricevuto e recepito come tale. Non diversamente attraverso il rito la comunità, riattualizza (torna a conferire realtà), di volta in volta, i contenuti mitici, ma con lo stesso gesto definisce la propria condizione di comunità di fedeli, dunque il suo statuto di mero recettore della sacralità del mitico. Del resto la stessa meccanica della trasmissione orale dei materiali mitologici prevede, secondo Detienne, il passaggio dei contenuti leggendari attraverso il filtro selettivo dell’ascolto comunitario; diventano mitologia soltanto quelle narrazioni che sono passate attraverso la “‘censura preventiva’ del gruppo”.22 Lo schema della circolarità che governa tutti questi aspetti del rapporto fra mito e collettività, si ripropone, infine, in un ultimo ambito. In modo identico, infatti, esso sembra governare il circuito chiuso che si instaura fra la creazione ex novo di inedite forme simboliche – creazione che solo inizialmente dovrà essere portata avanti dagli artisti surrealisti, ma 21 L’appello all’abbandono di una visione che considera i termini di questi binomi nella prospettiva della insormontabile contraddizione lo si trova in Situation du surréalisme entre les deux guerres (O, III, p. 722). 22 Marcel Detienne, L’Invention de la mythologie (1981), trad. it. di Flavio Cuniberto, L’invenzione della mitologia, Torino: Boringhieri, 1983. IL MITO SENZA FINE / 137 che in seguito dovrà essere di tutti – e la volontà di identificarle ad un moderno tessuto mitologico al quale ci si affida come ad un esterno patrimonio di riferimento. Evidentemente si è posti di fronte ad una fusione implicativa fra il gesto attivo per antonomasia, quello dell’invenzione, della realizzazione di qualcosa a partire dal nulla,23 e la disposizione passiva ad aderire – come fosse un dato di natura – alla costellazione di forme che è l’esito di tale processo creativo. L’uomo produce lo stesso contenuto mitologico che riceve. O se si vuole, quest’ultimo si esercita sull’uomo ed insieme ne è esercitato. Si è visto come per definire l’azione del nuovo mito surrealista sulla collettività la Chenieux-Gendron faccia ricorso alla formula del ‘modello proiettivo’. Ma come definire un sistema di modellizzazione in cui, a più livelli, il modello è in gran parte generato da ciò che dovrebbe modellare, in cui, cioè, i due principi, anziché distinguersi, si coappartengono? In questa prospettiva non è la stessa specificità concettuale del concetto di modellizzazione che finisce per dissolversi? Modellare significa assegnare a qualcosa una forma che corrisponde ad un’altra forma, o ad uno schema, un insieme di coordinate, ideale o fisico, predeterminato o ancora da determinare, ma che comunque ad un certo punto deve darsi, dev’essere fissato in modo stabile. Non ci può ispirare ad un modello, farvi riferimento, cioè ri-portarsi ad esso, se questo non è definito, se non è localizzabile. Nella dinamica circolare che si è illustrato il modello è in pratica indecidibile, non si dà mai in modo definitivo. È infatti costantemente preso in quel rapporto di implicazione con il soggetto (cui dovrebbe rivolgersi), che non gli permette di staccarsi da quest’ultimo per diventare un dato assoluto, dove l’aggettivo è da intendersi nel suo significato strettamente etimologico di sciolto da, individuato. 23 In effetti la dimensione della creazione presenta, en abîme, l’ulteriore grado di circolarità di cui si è detto: la creazione è assolutamente libera, è innovazione pura, ma allo stesso tempo viene riconosciuta come riproduzione, traduzione di un fondo inconscio, di un contenuto interiore. Ricorda però Beaujour come secondo Patrick Waldberg il “nuovo mito” che Breton aspirava a creare durante gli anni del suo esilio a New York “non avrebbe dovuto fondarsi su alcun contenuto predeterminato”. Qualsiasi oggetto, al di là della sua valenza simbolica, era suscettibile di essere eletto a nuova forma mitica. Per dirla con le parole dello stesso Waldberg (citato in Michel Beaujour, Réthorique et terreur, Paris: Place, 1999, p. 79): “Breton dava fortemente l’impressione di non interessarsi ad una simile avventura se non nella misura in cui essa diventava perturbante, vale a dire esteriore, ed in cui provocava la creazione di nuove forme”. 138 / GIOVANNI SOLINAS Quest’ordine di considerazioni può probabilmente contribuire a spiegare come, per Breton, il ricorso al mito istituisse un paradigma alternativo a quello su cui ordinariamente si basa il rapporto della mentalità sociale con l’ordine della tradizione. In quest’ultimo il meccanismo è basato sul riconoscimento di un fondamento, sulla possibilità di rifarsi, appunto, ad un insieme di conoscenze e di contenuti determinato; nel rapporto con l’universo mitologico, al contrario, è in qualche modo negata la condizione che permette la riconducibilità dell’identità collettiva ad un patrimonio dato. Tale patrimonio, infatti non arriva mai a porsi come qualcosa di definitivamente esterno al pensiero collettivo. Non arriva mai, cioè – sembra suggerire Breton – a depositarsi definitivamente, a divenire repertorio. Cosa che, a sua volta, sottrae alla coscienza sociale la possibilità di definirsi conformandosi ad esso. Alla mancata piena codificazione del nuovo mito, corrisponde la mancata codificazione dell’identità degli individui. Se si accetta questa interpretazione del pensiero di Breton, il rapporto con la visione che si è visto sottendere la concezione dell’immagine risulterebbe innegabile. I due campi della riflessione bretoniana sembrano ispirati da un ideale comune. Naturalmente anche nella sua applicazione all’ambito del mito, un simile ideale si rivelerebbe minato da una serie di aporie che ne pregiudicano la realizzabilità. Si pensi, per citare quella principale, all’obiezione fondamentale che la distinzione fra tradizione e mito solleva. Perché, infatti, distinguere fra contenuti mitici e contenuti appartenenti alla tradizione? Le vicende e le figure mitiche fanno tradizione. Tanto più che anch’esse, ed anzi esse in misura maggiore, possono essere associate alla natura del modello. I miti sono per definizione dei prototipi, dei topoi. Introducendo la nozione di mitema, Lévi-Strauss ha formalizzato un aspetto da sempre connaturato al mito.24 Le sue varianti possono essere ridotte ad un’unità sintagmatica minima, cioè ad una struttura base, uno schema immutabile di motivi che ne permette la riconoscibilità qualunque sia la versione che lo reinterpreta. Impossibile non parlare di una forte funzione modellizzante. Certo, la dinamica della circolarità si applica non al rapporto fra il prototipo ed i suoi rimodellamenti, ma a quello fra il pensiero collettivo e la galassia mitologica. Ciò non toglie, però, che quest’ultima, se secondo i modi del linguaggio mitologico deve funzionare, verrà recepita dagli indi24 Claude Lévi-Strauss, L’Homme nu, Paris: Plon, 1971, p. 560. IL MITO SENZA FINE / 139 vidui nella forma di una serie di archetipi, di contenuti topici fortemente codificati. Vediamo la cosa da un’altra angolazione. In un recente articolo Ivane Riallanc riprende un concetto introdotto a suo tempo da Jauss; si tratta di una sorta di variante in chiave ermeneutica dell’idea strutturalista di mitema. Il filosofo tedesco spiega come la relazione ipertestuale fra le versioni successive dello stesso motivo mitico, si svolga sullo sfondo di una sorta di terzo assente, coincidente con il mito stesso quale “testo ideale”. Quest’ultima è l’espressione che Riffaterre utilizza per definire la nozione di intertesto, molto vicina a quella di “terzo assente”. Non esiste una versione originaria del mito, un testo-archetipo che incarni un primum assoluto. L’intertesto (o il terzo assente) si definisce, in sostanza, come la ‘media’ – riducibile, poi, ad una frase matriciale – risultante da una nebulosa di versioni che del testo ideale rappresentano le singole, concrete realizzazioni. Il terzo assente è interessato da una doppia dinamica: da una parte è frutto di un’accumulazione potenzialmente infinita di variazioni, dunque è indefinitamente modificato, costitutivamente aperto ed in accrescimento, non si fissa. Da un’altra parte il testo ideale funziona come un fattore di riduzione ad un’unità di base immodificabile (lo schema matrice) delle singole variazioni. Dunque è modello, prototipo. La nebulosa mitica, “prende posto come terzo assente, spazio aperto insieme diacronico e sincronico, bricolage e palinsesto”.25 Breton sembra voler vedere soltanto il primo aspetto, la continua accumulazione, la ridefinizione perpetua, la nebulosa, anziché il prototipo. Forse per questo il mito dev’essere un ‘mito nuovo’, un mito in cui il testo ideale non si è ancora formato, in cui i simboli e le figure che lo compongono si aggiungono ridefinendolo, modificandolo senza che esso ne cancelli la specificità e le omologhi ad uno schema base.26 In realtà, però, 25 Ivan Raillanc, “Mythe et ipertextualité”, documento disponibile online all’indirizzo <http://www.fabula.org/atelier.php?Mythe_et_hypertextualit%26eacute%3B>. A ben vedere questo è forse il livello più profondo delle dinamiche di circolarità che interessano l’universo del mito: non a caso viene chiamato in causa Jauss: il modello fonda le sue interpretazioni ed allo stesso tempo ne è costituito. Il che, però, non toglie che esso possieda per il pensiero collettivo una valenza fortemente prototipica. 26 Il fatto che la concezione del mito come alternativa alla tradizione modellizzante sia soltanto uno dei motivi dell’adesione del surrealismo all’ordine della mitologia, è dimostrato dall’atteggiamento non univoco dei suoi membri. Breton e gli altri sono infatti ben lontani dal limitarsi alla produzione di miti nuovi. Attingono anzi a piene mani dal repertorio mitologico antico. Sulla convivenza di rito antico e mito contemporaneo cfr. Philippe Lavergne, André Breton et le mythe, Paris: Corti, 1985, soprattutto pp. 75-76. 140 / GIOVANNI SOLINAS anche questo non basterebbe: il mito, se tale, prima o poi diviene prototipo, fondamento, tradizione. Anche prima che la comunità cessi di credervi, prima che la leggenda si trasformi in letteratura. Si è già detto dell’ipotesi di Detienne, che vedeva esistere già a livello della trasmissione orale del mito un principio di selezione dei racconti basato sulla loro memorabilità: delle diverse versioni che si susseguono, spiega Detienne parafrasando Lévi-Strauss, di tutto l’insieme dei discorsi, si deposita “soltanto ciò che dà a un racconto una struttura più stabile”.27 In definitiva è come se il surrealismo aspirasse alla realizzazione di una mitologia che riesce a non divenire repertorio, al paradosso di una fantasmagoria simbolica percepita come tessuto culturale condiviso senza essere riserva memoriale. In questo senso, probabilmente, va letta la correzione che Chenieux-Gendron apporta alla sua stessa definizione, precisando come la mitologia surrealista si debba vedere: “non un contenuto di credenze, imposto dall’esterno a una coscienza umana […] ma il desiderio di spaesamento sensibile, il cui contenuto è da inventare da parte di ognuno di noi”.28 L’ottica è pressoché identica a quella adottata nella discussione sul linguaggio: alla nuova parola poetica si chiede di non ricadere nella significazione, di evitare il riferimento, cioè la condizione della fissabilità (e dunque della repertorizzazione) del significato. Le si chiede di restare in una condizione di tensione, che non le permetta di essere ricondotta alla dimensione del riferimento, dunque dell’identificazione (cioè della localizzazione) di un senso. Allo stesso modo si vuole che il linguaggio mitico non si depositi, non possa essere termine di riferimento, piedistallo, ma rimanga preso in un rapporto di continuo movimento, di costante fluidità, che rende il suo rapporto con il pensiero collettivo un commercio vivente, una storia in svolgimento. Forse uno dei più ostinati contenuti mitici coltivati da Breton è proprio questo, il mito dell’identificazione costante fra il soggetto e la pura energia tensionale del mutamento. In questo senso lo sguardo dell’individuo è sempre rivolto in avanti, sempre diretto verso ciò che si deve compiere. Del resto è proprio in Arcane 17, in un’opera in cui così centrale è il ruolo del mito, che Breton fornisce la descrizione esatta di quel demone della tensione che impone all’individuo di incarnare l’energia dinamica, il movimento stesso di quella trasforma27 28 Marcel Detienne, op. cit, p. 57. Jacqueline Chenieux-Gendron, op. cit., p. 152. IL MITO SENZA FINE / 141 zione incessante che è il corpo della temporalità al suo stato più puro: la libertà, ribadisce “non può esistere che allo stato dinamico”, e chiosa: “Alle aspirazioni dell’uomo alla libertà dev’essere mantenuto il potere di ricrearsi incessantemente; è per questo che essa dev’essere concepita non come stato, ma come forza viva, implicata in una progressione continua”.29 29 André Breton, Arcane 17 (1947), in O, 3, pp. 91, 92. § PARAGRAFO I TEMI § 7 Andrea Giardina Il viaggio interrotto Il tema del cane fedele nella letteratura italiana del Novecento Nel Bestiario della letteratura che l’austriaco Franz Blei pubblica nel 1924, appare il termine animaletterato.1 La parola serve a identificare il risultato del processo a cui sottopone la letteratura europea contemporanea, classificata secondo criteri di zoologia fantastica che si estendono a comprendere forme incerte (Rilke sta tra l’animale e la pianta), cose (il vaso da notte Francis Jammes), uomini (lo zoologo Nietzsche). La storia della letteratura diventa un’irriverente serie tassonomica di forme ibride. Blei era un cattolico-marxista, ostile alla società di massa, convinto che l’arte fosse ormai scissa dalla verità e destinata ad essere, con le parole di Claudio Magris, un “oggetto bizzarro, interessante perché misterioso”. Nostalgico del barocco, egli diventa “uno scrittore moderno del vuoto e dell’assenza”,2 fino a mettere in dubbio qualsiasi possibilità di ordinare il reale. Blei riserva a se stesso una parte nel Bestiario, quella del “pesce di acqua dolce, che si tuffa e rituffa sinuoso in tutte le acque fresche”. In tale direzione apre la strada alla modernità: l’osservatore è anche l’osservato, e lo è in senso letterale in quanto il pesce ha una pelle così sottile e trasparente che “si può sempre vedere che cosa ha appena mangiato”.3 “L’intelligenza che vuol catalogare il mondo”, ha scritto ancora Magris, “scopre di essere soltanto uno degli innumerevoli e sfuggenti fenomeni di quel mondo ch’essa vorrebbe giudicare e ordinare […]. L’io indivisibile, che deve instaurare il giudizio sul molteplice, discende e si disperde nella caotica molteplicità dei particolari sui quali credeva d’innalzarsi”.4 1 Franz Blei, Das grosse Bestiarium der Literatur (1924), trad. it di Lorenza Rega, Il bestiario della letteratura, Milano: Il Saggiatore, 1980. 2 Claudio Magris, “Franz Blei e la superficie della vita”, in Franz Blei, op. cit., p. 17. 3 Franz Blei, op. cit., p. 47. 4 Claudio Magris, op. cit., p. 7. PARAGRAFO I (2006), pp. 145-65 146 / ANDREA GIARDINA La letteratura del Novecento è, per molti aspetti, ‘animaletteratura’. L’animale si insedia sulla pagina, diventa protagonista, impone attenzione, facendosi parola evocatrice, ‘alterità’. Non a caso compare insieme al marziano di Wells, al perturbante di Freud, al pensiero selvaggio di LéviStrauss. Porta con sé altre visuali, come ha insegnato, per primo, il biologo tedesco Jacob von Uexküll. Il confronto-impatto determina una rivoluzione dei punti di osservazione sulle cose – che è una ridefinizione dei ruoli, un capovolgimento dell’umano, o un suo smottamento. L’animale è l’enigma, l’insetto della Metamorfosi kafkiana, l’‘Ocapi’ di Montale, il ‘Versipelle’ del Presepio di Manganelli: presenza che inquieta, vicina e lontana nello stesso tempo, che si impone perché c’è – le parole la richiedono pur se inesistente – e che disorienta per gli stessi motivi. Animale significa discesa verso l’indecifrabile e l’indecidibile, i ‘buchi neri’ a portata di mano, esposti alla nostra quotidianità, solo in apparenza irraggiungibili ‘altrove’. Non a caso l’animale ha dimestichezza col sacro e agli dèi è (stato) destinato in sacrificio. Arbitrario, a-razionale, elusivo, sconvolgente, l’animale preferisce pensare agli uomini attraverso i loro sogni, come hanno scritto Jung e Hillman. Eppure l’animale non si allontana dall’uomo, anche quando non lo si vede, come i microbi di Pasteur. Forse per ridurne i soprassalti, sono proliferate le nomenclature, esse stesse però sempre più svuotate di fondamento, secondo la procedura di Borges e Guerrero nel Manuale di zoologia fantastica. Come ha mostrato Blei, d’altra parte, non solo gli animali circondano l’uomo, ma l’uomo è tra gli animali. Dopo L’origine della specie la distanza si è accorciata, fino a consentire metamorfosi, salti interspecifici. Gilles Deleuze e Félix Guattari riferendosi a Kafka hanno sostenuto che “la metamorfosi è il contrario della metafora. Non è più senso proprio né senso figurato ma distribuzione di stati nel ventaglio della parola”. Non c’è più somiglianza tra uomo e animale, perché “non c’è più né uomo né animale, perché l’uno deterritorializza l’altro in una congiunzione di flusso, in un continuum di intensità irreversibile”.5 L’allentarsi dei confini è traccia del progressivo sfaldarsi dell’io, della sua insufficienza. Non è soltanto l’animale ad emergere, ma è anche l’uomo a sommergersi nell’animalità. “I divenire-animali”, scrivono ancora Deleuze e Guattari, “sono deterritorializzazioni assolute […]. Divenire animale significa […] trovare un mondo 5 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure (1975), trad. it. di Alessandro Serra, Kafka. Per una letteratura minore, Macerata: Quodlibet, 1996, pp. 39-40. IL VIAGGIO INTERROTTO / 147 di intensità pure, in cui tutte le forme si dissolvono, e con loro tutte le significazioni, significanti e significati, a vantaggio d’una materia non formata, di flussi deterritorializzati, di segni asignificanti”.6 L’animale ‘specchio dell’uomo’, riflesso dei suoi vizi e delle sue qualità, appartiene ad una linea indirizzata verso il passato, a una letteratura di matrice esopiana (con una dimensione ‘mimetico-naturalistica’) che aveva ben netto di fronte a sé il confine tra l’umano e il non umano. Ora l’animale diventa una possibilità aperta, esplosione dell’istinto bestiale con il conseguente carico di angoscia; oppure, soprattutto, si fa via al nichilismo, che, nella proposta interpretativa di Stefano Lanuzza, è “l’unico modo non sovradeterminato – non demiurgico – per ridare dignità all’animale-uomo”.7 L’essere altro dell’animale, attraverso questo percorso, si traduce nell’essere altro dell’uomo stesso, o, ancora, nel suo essere ‘nient’altro’, nel suo intermittente o definitivo ‘deterritorializzarsi’: andare verso l’animale è un andare verso altri luoghi. Lo scrittore di animali, a ben vedere, è uno scrittore di viaggio. Come chi si muove nello spazio, infatti, desidera spaesarsi, sommare un nuovo io al precedente. Pur nei limiti di quelli che possiamo considerare tentativi di ri-definizione del rapporto uomo-mondo,8 e nel rispetto delle diversità di approccio al tema dei singoli autori, quanto si registra è insomma la crisi di ogni antropocentrismo, il sapersi parte – facciamo ricorso ancora a Manganelli, all’altezza del suo primo libro, Hilarotragoedia – di una comune sorte “discenditiva”, quella di chi – deiezione di un “diomorto” – è destinato a precipitare di grado in grado verso la morte definitiva. Se uomo e animale sono due mondi disposti a scambiarsi i ruoli, a trasmettersi ‘spaesamenti’ indirizzandosi verso il nihil, il cane – la metafora cane, l’avatar letterario – sta nella ‘terra di nessuno’. Il cane predilige questo ‘luogo di mercato’, area di condivisione e di scambi, incrocio di passato e futuro, di Esopo e Kafka, di appropriazioni e di addii, che è però anche roccaforte dell’io. Deleuze e Guattari lo hanno definito “l’animale-edipico per eccellenza”,9 quello che ostacola il “divenire-animale”, 6 Ivi, p. 23. Stefano Lanuzza, Bestiario del nichilismo. Scrittura e animali, Bologna: Book, 1993, p. 40. 8 Deleuze e Guattari analizzando i racconti di Kafka sottolineano come il divenire-animale conduca invariabilmente a un fallimento: “Il divenire animale mostra effettivamente una linea di fuga, ma è incapace di seguirla e di prenderla esso stesso” (p. 66). Il passaggio successivo è il macchinismo, di cui gli animali sono “indizi” (p. 86). 9 Ivi, p. 27. 7 148 / ANDREA GIARDINA cioè il processo di deterritorializzazione. Se il cane non è l’uomo, non è nemmeno l’animale. Nei bestiari novecenteschi – usiamo il termine nell’accezione più ampia, quella di opere in cui “domina la rappresentazione mitopoetica degli animali” –,10 sembra disporsi sul versante che dovrebbe trattenere l’umano al di qua della soglia. Anche l’uomo che si fa cane rimane infatti un uomo, essendo la ‘caninità’ la sponda da cui tenersi lontani. Il cane non cancella l’umano, lo riflette, lo riproduce, lo sdoppia, lo relativizza, lo rinsalda. Nell’opera di scrittori in cui l’animale è presenza inquietante, come Landolfi e Manganelli, il cane è un uomo degradato, su cui riversare risentimenti e a cui attribuire insolenti pretese. Nei libri di Montale, Primo Levi, Calvino, Anna Maria Ortese, Bonaviri,11 dove si incontrano continue presenze animali, il cane è una presenza eccentrica, fastidiosa, tipizzata (come Ottimo Massimo, il cane de Il barone rampante) o assente. Tra gli scrittori in cui l’animale è più raramente messo a tema, quali Pavese e Volponi, il cane è comunque presente. Significativamente, in un libro di quest’ultimo, Il pianeta irritabile, nel quale i protagonisti sono animali-‘post-umani’, il cane rimane cane, essere intermedio delegato al servizio di un’umanità quasi scomparsa. Se per Pirandello il cane è a livello di molti altri animali, cioè fornisce gli strumenti per osservare l’uomo da altre prospettive, misurandone paradossalmente proprio il grado di bestializzazione, per Federigo Tozzi, in un libro fondativo quale Bestie, il cane è il “canettaccio bastardo, spelacchiato e rattrappito”,12 che per strada segue a fatica una donna miserevole, sposata con un tisico giallastro. Debenedetti ha scritto che Tozzi in quest’opera si prefiggeva di “far parlare il mondo, anziché il nostro spirito”,13 ovvero di fare esistere personaggi, cose, fatti che trasmettono un loro senso, senza declinare un loro perché, soprattutto senza giustificare la presenza o le ragioni intellettuali o sentimentali di chi ne registra l’apparire, o li mette in scena. Semmai, se un rapporto si stabilisce è quello che deriva dall’essere tutti compartecipi, il mondo che appare, l’artista e il lettore, del fenomeno ‘vita’. Un simile rapporto è appunto tipico con le bestie […]. Le bestie significano intenzioni diverse della vita, noi non sappiamo precisamente 10 Enza Biagini, “La critica tematica, il tematismo e il ‘bestiario’”, in Enza Biagini e Anna Nozzoli (a cura di), Bestiari del Novecento, Roma: Bulzoni, 2001, p. 16. 11 Significativamente il cane non c’è in un romanzo costruito attorno alla metamorfosi di figure animali quale La divina foresta (Milano: Rizzoli, 1969). 12 Federigo Tozzi, “Bestie”(1917), in Id., Opere, Milano: Mondadori, 1987, p. 578. 13 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento (1976), Milano: Garzanti 1981, p. 85. IL VIAGGIO INTERROTTO / 149 quali, a meno che non accettiamo i significati convenzionali della favolistica e dell’araldica, o non ci appaghiamo dei piaceri o del disgusto o dello sgomento che dà la loro vista. Noi possiamo al massimo vedere le conseguenze, i risultati di ciò che fanno, del loro comportamento allorché si mettono in azione. Le bestie di Tozzi rompono col naturalismo, con “la constatazione oggettiva delle cose” e “diventano movimenti di vita, chiusi e complessi grumi di un divenire nel quale riconoscono poi, ma solo in un momento ulteriore, la sagoma di un destino che ci riguarda in quanto è una piega possibile della nostra vita”.14 Al cane tocca allora il compito di star attaccato alla miseria dell’uomo, divenendo esso stesso stigma del destino di decadenza della nostra specie. Che il cane sia eccessivamente compromesso col mondo degli uomini, per esempio, è chiaro a Kafka, il quale nelle Indagini di un cane ricapitola la vita di un ‘contro-cane’, attaccando in tal modo, sempre a detta di Deleuze e Guattari, “le tentazioni sospette di rassomiglianza che l’immaginazione può proporgli; attraverso la solitudine del cane egli mira a cogliere la differenza massima, la differenza schizo”.15 Insomma il cane è “umano, troppo umano”. Le metafore (o le affordances) che gli pertengono (intelligenza, coraggio, lealtà, fedeltà, aggressività, indegnità, istintualità), proprio in quanto metafore,16 riguardano scale di valori e disvalori umani e conservano la traccia dell’antichissimo patto del cibo tra le due specie, dell’offerta di protezione in cambio del nutrimento. Il cane è integralmente un ‘prodotto’ dell’uomo, ovvero, secondo la zooantropologia,17 una sintesi della cooperazione tra specie. “Angelo di seconda classe” (è una definizione di Manganelli),18 il cane è un ‘ibrido’, una creatura ‘teriomorfa’, che cerca di aiutarci a sopportare i pesi della vita. È soprattutto all’archetipo del cane fedele che la letteratura affida il compito di arrestare il processo di dissoluzione della forma e di fornire ancoraggi. Assolutamente dominante nelle società umane, la fedeltà ribadisce la centralità dell’io che scrive, interrompe il suo slittamento verso 14 Gilles Deleuze e Félix Guattari, op. cit., p. 86. Ivi, p. 25. Più avanti nel testo si precisa però che il cane “si fa deterritorializzare dai cani musicanti all’inizio, ma riterritorializzare, riedipizzare, dal cane cantante alla fine” (p. 66). 16 Sempre Deleuze e Guattari (op. cit., p. 66) scrivono che le metafora ha “un seguito antropocentrico”. 17 Roberto Marchesini e Karin Andersen, Animal Appeal, Bologna: Hybris, 2005. 18 Giorgio Manganelli, Improvvisi per macchina da scrivere (1989), Milano: Adelphi, 2003, p. 250. 15 150 / ANDREA GIARDINA una dimensione ‘altra’, frena – talvolta solo temporaneamente – il bruciante contatto con l’incontrollabile. Equiparando il procedere in direzione dell’animale a un viaggio, possiamo constatare come il percorso verso la fedeltà sia breve. Un viaggio interrotto, appunto. L’animale fedele si muove sui tracciati pensati dall’uomo, o almeno tale è la convinzione umana.19 In un mondo che frana, dove la relatività dei punti di vista è chiamata continuamente in gioco, la fedeltà ribadisce un ordine. È una proprietà conservatrice, che si rivolge a sfere assolute, di cui il rapporto quotidiano è matrice ridotta e sbiadita. Nella prima versione del Gattopardo, nella pagina che apre la quarta parte del romanzo, si trova scritto: Ad uno sconforto generalizzato e cupo, a uno sconforto per così dire metafisico del padrone l’affetto di un cane può arrecare vero sollievo; quando però le ragioni di cruccio sono circoscritte e precise (una lettera penosa da scrivere, una cambiale che scade, un incontro sgradevole da affrontare) non vi sono scodinzolamenti che tengano; le povere bestie provano e riprovano, continuano ad offrirsi all’infinito, non servono a nulla; la loro dedizione è rivolta a sfere superiori e generiche dell’affetto umano e contro guai individuali le loro profferte cadono nel vuoto; un alano da accarezzare non consola di un rospo da inghiottire.20 Fedeltà significa dedizione, incondizionata disponibilità al conforto, capacità di convivere con quieta serenità, scambio di predilezioni. La fedeltà richiede e determina amore, attivando un percorso fondato sulla reciprocità, anche se è don Fabrizio che decide quando l’alano Bendicò può tornare al suo fianco. Perché la fedeltà è un sentimento gerarchizzato, che presuppone un’opposizione forte/debole, maschile/femminile, adulto/bambino. “L’unico che mi abbia capito bene”. La fedeltà come amicizia Spesso la morte del cane è l’occasione per ricapitolare i termini della relazione affettiva. Quando, nel Gattopardo, don Fabrizio agonizzante fa il bilancio della sua esistenza, dopo Tancredi, ricorda i suoi cani: “Fufi, la 19 Si legge in Stephen Budiansky, The Truth about Dogs (2000; trad. it. di Daria Restani, L’indole del cane, Milano: Raffaello Cortina, 2004, p. 83) che “i cani cercano di stare vicino al padrone, lo leccano, gli fanno le feste e si stendono vicino a lui, proprio come fanno i lupi con il maschio alfa. È una questione d’amore o forse di lealtà? Di sicuro è un espediente, e l’evoluzione ha dotato i cani, e i loro atavici parenti, di una straordinaria capacità di ingraziarsi l’altro”. 20 Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo: fonti e varianti”, in Id., Opere, Milano: Mondadori, 1995, p. 265. IL VIAGGIO INTERROTTO / 151 grossa mops della sua infanzia, Tom l’irruento barbone confidente ed amico, gli occhi mansueti di Svelto, la balordaggine deliziosa di Bendicò, le zampe carezzevoli di Pop, il pointer che in questo momento lo cercava sotto i cespugli e le poltrone della villa e che non lo avrebbe più ritrovato”.21 È uno stilema che ritroviamo in molti altri scrittori. Eugenio Montale, nella Farfalla di Dinard (la prima edizione esce nel 1956, due anni prima del Gattopardo) dopo aver scritto che i cani “restano nel ricordo, chiedono di sopravvivere in noi”, ne propone l’elenco: Il cane Galiffa di cui posso esibirvi la fotografia, egregia collega, è morto più di quarant’anni fa. in questa foto, che è l’unica di lui esistente, figura accanto a un amico mio, morto anche lui. Io sono dunque la sola persona che ancora conservi il ricordo di quel festoso bastardo di pelo rossiccio. Mi amava e quando fu troppo tardi l’ho amato anch’io. “Passepoil” proseguii “fu il mio secondo cane, uno scottish terrier di purezza molto dubbia. Non ci amammo molto e lo cedetti ad alcuni amici. Non ne ho il ritratto, ma lui forse nei Campi Elisi dei cani, ricorda che lo salvai in uno scontro automobilistico. Il terzo cane fu Buck, un lupo. Era buono, molto affezionato a una mia tartaruga con la quale divideva i pasti. Quando fu incimurrito riuscii a mandarlo presso certi contadini, in Val di Pesa, presso Firenze. Ma la notte successiva egli fuggì e tornò a casa, dopo un viaggio di trenta chilometri. Il cimurro cresceva e una puntura avvelenata lo tolse di mezzo. Non lo vidi morto. Eutanasia o quasi, Frau Brentano, come vede siamo quasi in argomento. Il quarto cane era Pippo, uno Schnautzer di razza. È nato nella villa di Olga Loser, una casa tra gli ulivi con dentro otto quadri di Cézanne. La vecchia padrona è morta, io sopravvivo. Pippo vive pure in una città delle Marche. Era molto permaloso e non mi perdonò mai di averlo regalato. Ma a un certo punto la vita mi impedì di tenere cani.22 Veder morire il proprio cane – l’imperfetta sovrapposizione temporale tra la vita dell’uomo e dell’animale ne moltiplica la possibilità – fissa il ricordo e ribadisce il sentimento, rafforzando, nell’idea della sorte condivisa, la solidarietà tra le specie: “Noi faremo la stessa fine”, dice Giacco in Con gli occhi chiusi di Tozzi, mentre il cane Toppa viene sotterrato.23 21 Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo (1958), in Id., Opere, cit., p. 233. Eugenio Montale, “L’angoscia”, in Id., La farfalla di Dinard (1960), in Id., Prose e racconti, Milano: Mondadori, 1995, p. 207. 23 Federigo Tozzi, “Con gli occhi chiusi” (1919), in Id., Opere, cit., p. 100. Sul tema della morte si veda Cristiano Spila (a cura di), Cani di pietra. L’epicedio canino nella poesia del Rinascimento, Roma: Quiritta, 2002. 22 152 / ANDREA GIARDINA La stessa funzione è propria del momento della caccia che, come ha scritto Carlo Levi, per l’uomo contemporaneo rappresenta ancora “un piacere di libertà naturale […] così intenso e pieno di energia che non può non venire che da un riaffiorare e riesplodere di un mondo arcaico che è in noi, dal ricordo presente di un’antichissima magia, di una barbarie primitiva o ritornata, preistorica o feudale”.24 La caccia coinvolge il versante più ancestrale della collaborazione tra le due specie, quello in cui la fedeltà è una necessità e una disciplina da imparare. La fusione di emozioni e di intenti tra uomo e cane, l’intesa tanto più allargata quanto meno esibita, creano una situazione difficile da spiegare. Il cacciatore protagonista di Alba e Franco di Rigoni Stern, conclusa la battuta, mentre dà al cane il cuore e il fegato della lepre appena uccisa, e in silenzio gli accarezza la testa e gli pulisce gli occhi e le zampe con un fazzoletto, “sentiva dentro una cosa, una cosa ecco che si fa fatica a dire e che a volte non si prova nemmeno per i cristiani”.25 Nella caccia l’uomo e il cane si dispongono sullo stesso versante, riannodano ogni volta il loro antico accordo contro gli altri animali. Siamo alle origini della dinamica antropocentrica, all’alba del dominio dell’uomo sulla natura. La fedeltà determina un ritorno attivo sull’uomo contemporaneo, che dal cane riceve quanto avverte di aver smarrito o di non aver mai trovato tra i suoi simili. Nelle letterature della crisi che si estendono lungo il Novecento, l’immagine del cane fedele (la metafora della fedeltà) riattribuisce sensi (umani) alle cose. Trattare il tema del cane fedele e amico equivale a esprimere il desiderio di colmare un vuoto, di puntellare la propria solitudine con un’altra solitudine. Sono riflessioni sull’io di chi scrive, quelle sulla fedeltà. Coetzee ne La vita degli animali, riferendosi a Rilke e Hughes, ne ha descritto la natura in questi termini: “Quando convogliamo in parole la corrente di sentimenti che scorre tra noi e l’animale, la astraiamo per sempre dall’animale. Perciò la poesia non è un dono al suo oggetto, come è invece la poesia d’amore. Rientra in un’economia interamente umana in cui l’animale non trova posto”.26 Così la fedeltà di Belbo ne La casa in collina di Pavese è l’occasione 24 Carlo Levi, “Il primo cacciatore”, in Le ragioni dei topi (1957), Roma: Donzelli, 2004, p. 23. 25 Mario Rigoni Stern, “Alba e Franco”, in Id. Storie dell’Altipiano, Milano: Mondadori, 2003, p. 1517. 26 John M. Coetzee, The Lives of Animals (1999), trad. it. di Franca Cavagnoli e Giacomo Arduini, La vita degli animali, Milano: Adelphi, 2000, p. 64. IL VIAGGIO INTERROTTO / 153 per far riflettere Corrado sul suo isolamento dal mondo e dalle sue ideologie (il cane è il suo “ultimo confidente sincero”, ed egli inoltre è convinto di come “non ci sono che i cani per giudicare il prossimo”) e sul riemergere dell’orizzonte infantile (“Fin da ragazzo” egli aveva avuto la convinzione che “andando per i boschi senza un cane” avrebbe perduto “troppa parte della vita e dell’occulto della terra”).27 In Cane come me Curzio Malaparte racconta che trovandosi in esilio a Lipari da alcuni mesi e non bastandogli “l’aperto orizzonte marino”, per ritrovare il senso della libertà morale, decide di prendere un cane: “Sembrandomi che un cane fosse il più proprio ad essermi amico disinteressato, impedirmi che io a poco a poco mi avvilissi, mi umiliassi, cadessi in quello stato di indifferenza e di prostrazione, che è il più vicino all’abiezione”. Il cane Febo gli insegna che “l’incontro fra un uomo e un cane è sempre l’incontro fra due spiriti liberi, fra due forme di dignità, fra due morali disinteressate. Il più gratuito degli incontri”.28 Febo diventa “un riflesso” del narratore, e lo aiuta “con la sua sola presenza, a riacquistare quel distacco dal bene e dal male, che è la prima condizione della serenità e della saggezza nella vita umana”.29 Il cane, col tempo, tende ad assomigliargli, divenendo la “sua coscienza”. Ennio Flaiano narra come Giorgio Fabro, scrittore italiano di sceneggiature residente a New York, e il cocker spaniel Melampo (che dà il titolo al romanzo) divengano “vecchi amici che non si danno reciproco fastidio e amano anzi nell’altro più i difetti che le virtù”. Nato casualmente, il loro rapporto si rivela solidissimo. Quando Melampo muore, travolto da un autocarro, l’ultimo sguardo è per il suo padrone. Con gli occhi ha detto: “salvati, io resto a guardarti le spalle”.30 Giovanni Giudici in Sottocane (Lume dei tuoi misteri) definisce il cane come “l’unico che mi abbia / capito bene”, rendendolo altero “della sua fedeltà”.31 La fedeltà sembra attribuire al cane uno ‘statuto d’eccezione’. Barone, che Carlo Levi descrive nel Cristo si è fermato a Eboli, ne L’orologio e in Quaderno a cancelli, per i contadini di Gagliano è un “animale 27 Cesare Pavese, La casa in collina (1948), Torino: Einaudi, 1991, p. 4. Curzio Malaparte, “Cane come me” (1938), in Id., Opere scelte, Milano: Mondadori, 1997, p. 374. 29 Ivi, p. 375. 30 Ennio Flaiano, “Melampo”, in Id., Gioco al massacro, Milano: Rizzoli, 1970, pp. 149-50. 31 Giovanni Giudici, “Lume dei tuoi misteri” (1984), in Id., I versi della vita, Milano: Mondadori, 2000, p. 639. 28 154 / ANDREA GIARDINA araldico, il leone rampante su uno scudo del signore”, anche se in effetti è “soltanto un cane, un frusco come tutti gli altri”.32 L’uomo fa del cane il suo doppio. Per cui non può sorprendere quanto Levi scrive (riprendendo il motivo classico dell’ubi sunt?) alcuni anni dopo la morte del cane, proprio nel Quaderno a cancelli: “Dove sono i balzi di Barone, che erano quelli del mio stesso essere?”33 Sono le stesse sintonie insondabili che nel Gattopardo fanno dire a don Fabrizio: “Vedi tu Bendicò, sei un po’ come loro, come le stelle: felicemente incomprensibile, incapace di produrre angoscia […]. E poi con quei tuoi occhi al medesimo livello del naso, con la tua assenza di mento è impossibile che la tua testa evochi nel cielo spettri maligni”.34 Una ancor più evidente ricaduta della fedeltà sul soggetto umano è ravvisabile quando la relazione uomo-cane riproduce la relazione genitorefiglio. Roberto Marchesini ne ha spiegato scientificamente i termini, evidenziando come il cane abbia sviluppato caratteri giovanili (neotenia) per andare incontro agli uomini, per natura portati ad occuparsi (intenerendosi) di ciò che è infantile.35 Così il barboncino Cheap descritto da Montale in Ti cambieresti con è “un batuffolo mezzo calvo e mezzo ispido” trattato come un figlio dalla vecchia signora che è diventata sua “mammina”.36 Flush (che riprende il nome del cane a cui Virginia Woolf dedica una biografia), lo spaniel de La camera da letto di Attilio Bertolucci, dopo la nascita di Bernardo, è passato, senza eccessivi rancori, a ricoprire il ruolo di “unico, insostituibile, designato dagli astri” custode del figlio del poeta.37 Non è stato un cambiamento di poco conto, perché il “piccolo essere venuto a rompere l’intreccio egoisticamente, unicamente amoroso”38 della giovane coppia, lo ha scalzato dalla posizione di ‘bambino’. Se l’uomo e il cane si dispongono sullo stesso versante, è il linguaggio 32 Carlo Levi, Cristo di è fermato a Eboli (1945), Milano: Mondadori, 1991, p. 103. Carlo Levi, Quaderno a cancelli, Torino: Einaudi, 1979, p. 203. 34 Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cit., p. 88. 35 Roberto Marchesini, L’identità del cane, Bologna: Perdisa, 2004, pp. 36-42. L’autore spiega che “per poter rispondere alle forti esigenze parentali del cucciolo d’uomo – per differimento dell’età evolutiva e immaturità alla nascita – la nostra specie ha dovuto sviluppare controlateralmente una robusta predisposizione epimeletica”, che “ha dato il via alla cooptazione di comportamenti parentali intraspecifici verso cuccioli di altre specie”. 36 Eugenio Montale, “Ti cambieresti con?” in Id., La farfalla di Dinard, cit., p. 151. 37 Attilio Bertolucci, “La camera da letto” (1984), in Id., Opere, Milano: Mondadori, 1997, p. 750. 38 Attilio Bertolucci, “Argumenta de La camera da letto” (1997), in Id., Opere, cit., p. 828. 33 IL VIAGGIO INTERROTTO / 155 verbale l’unico ostacolo a una piena comprensione. Ma la barriera talvolta sembra facile da aggirare, perché, secondo quanto sostiene Bassani ne L’airone, ci può essere un cane (o una cagna, come nel caso in questione) “così intelligente che se un bel giorno avesse cominciato a fare ‘mamma’, soltanto chi non la conosceva avrebbe potuto stupirsene”.39 Lo sforzo di arruolare il cane tra gli umani conduce a trasformare le parole del cane in parole dell’uomo. Landolfi ne La tempesta racconta del tentativo di far parlare la cagna Châli, attuato da un personaggio evidentemente folle davanti ad un frastornato testimone.40 L’esperimento riesce solo in parte perché l’osservatore, quando la cagna formula alcuni suoni assai simili a parole umane, prorompe in un grido che spezza l’incantesimo. Se Landolfi colloca la situazione in un contesto contrassegnato dalla violazione di ogni norma razionale, Buzzati, invece, in racconti come Il cane letterato oggi non è in vena, o L’Einstein dei cani si intenerisce per i gatti41 si riallaccia alla tradizione favolistica del cane parlante che mette a nudo i difetti dell’uomo.42 A questo livello, siamo in una zona che si dispone sul crinale opposto a quella in cui Deleuze e Guattari posizionano Kafka, nei cui scritti “l’animale non parla ‘come un uomo’, ma estrae dal linguaggio della tonalità prive di significazione”.43 Il cane capace di dialogare con l’uomo è il punto estremo del processo di antropomorfizzazione, che ritrae se stesso nell’operazione-specchio condotta da Landolfi in Nuove rivelazioni della psiche umana. L’uomo di Mannheim,44 dove si immagina che i cani siano diventati i padroni del mondo. Chiusi in un ferreo ‘cinocentrismo’, essi accolgono con disappunto la notizia che l’uomo (ridotto al rango di un animale da compagnia) sappia parlare e addirittura, sulla base di quanto raccontato da un “cane sciamano del Mato Grosso”, un tempo sia stato specie dominante.45 Lo stesso presupposto antropocentrico, anche se volto ad un 39 Giorgio Bassani, “L’airone” (1968), in Id., Opere, Milano: Mondadori, 1998, p. 853. Tommaso Landolfi, “La tempesta”, in Id., Il Mar delle blatte e altre storie, Firenze: Vallecchi, 1944, pp. 82-85. 41 Dino Buzzati, Bestiario, Milano: Mondadori, 1991. “Il cane letterato oggi non è in vena” si trova a p. 259, “L’Einstein dei cani si intenerisce per i gatti” è alle pp. 307-12. 42 Si tratta di una linea che risale a Esopo e che, presente nella favolistica, ha conosciuto una ripresa nel Settecento, culminata nella satira degli Animali parlanti (1802) di Giambattista Casti. Nel Novecento, in Italia, hanno usato questo espediente poeti come Trilussa, e narratori come Giuseppe Berto, che nel pamphlet Colloqui col cane (1986) si serve del dono della parola del cocker per mettere sotto accusa l’Italia di fine anni Sessanta. 43 Gilles Deleuze e Félix Guattari, op. cit., p. 40. 44 Tommaso Landolfi, Il Mar delle blatte e altre storie, cit., pp. 191-215. 45 Ivi, p. 215. 40 156 / ANDREA GIARDINA fine antitetico – cioè mostrare la divaricazione tra i linguaggi dell’uomo e del cane – sta a monte della situazione capovolta, quella in cui sono gli uomini a comprendere i cani. L’acquisizione del punto di vista animale sulla realtà conduce ad un effetto straniante, come evidenzia il racconto di Svevo, Argo e il suo padrone, dove il protagonista umano riesce con grande pazienza a introdursi nel linguaggio del cane, ‘traducendone’ il pensiero. Per scoprire che cosa? Che tra uomini e cani i fraintendimenti sono numerosi e che i due universi non sono in contatto.46 La decisione di spezzare il legame di fedeltà, in genere, viene presa dall’uomo.47 Lasciare a se stesso il cane allontana un fantasma dalla coscienza e nello stesso tempo denuncia quanto il cane sia vissuto come ‘un supporto’ dell’io. Pirandello in Pallino e Mimì narra come la cagnolina Mimì venga abbandonata, dopo che si è accoppiata per la strada con Pallino (un cane ex randagio) davanti agli sguardi divertiti dei villeggianti di Chianciano. La ‘storia d’amore’ tra i due animali riproduce, al contrario, quella tra la padrona di Mimì, “Miss Galley”, e l’uomo d’affari Basilio Gori. Avvelenata dal trattamento riservatole dall’uomo, che l’ha improvvisamente lasciata, la “signorina” dapprima sfoga la sua rabbia sulla leziosa Mimì e poi l’abbandona, trasformandola in una cagnetta di strada evitata da tutti: Nessuno si mosse a prenderla, nessuno la chiamò. E Mimì seguitò a vagar, sotto la pioggia […]. Di tratto in tratto s’arrestava a guardare con gli occhietti cisposi tra i peli, come se non sapesse ancora comprendere come mai nessuno avesse pietà di lei così piccola, di lei così carezzata prima e curata: come mai nessuno la prendesse per riportarla alla padrona, che l’aveva perduta, alla padrona ch’essa aveva cercato invano per tanto tempo e che cercava ancora. Aveva fame, era stanca, tremava di freddo, e non sapeva più dove andare, dove rifugiarsi.48 Fulvio Tomizza in Trick. Storia di un cane racconta di un cane rinnegato dai padroni nel momento in cui nasce il figlio.49 Una situazione almeno in 46 Italo Svevo, “Argo e il suo padrone” (1949), in Id., Racconti, Milano: Mondadori, 2004, pp. 95-118. 47 Non sempre, però. Marco Lodoli in Cani e Lupi (Torino: Einaudi, 1995) descrive il caso di Rorò che fugge dalla vecchia padrona che lo tiene prigioniero. Ma la museruola gialla che gli rimane addosso diventa il simbolo del suo insuccesso. 48 Luigi Pirandello, “Pallino e Mimì”, in Id., La vita nuda, Novelle per un anno (1922), vol. I, t. 1, Milano: Mondadori, 1985, p. 297. 49 Fulvio Tomizza, Trick. Storia di un cane, Milano: Mondadori, 1975. IL VIAGGIO INTERROTTO / 157 parte analoga è proposta da Carlo Cassola ne L’uomo e il cane, dove Jack è il cane (ritenuto dal padrone Alvaro una bocca da sfamare alla stessa stregua del bambino) di cui ci si sbarazza appena se ne offre l’occasione. La perdita della famiglia costituisce l’ingresso in un mondo in cui Jack smarrisce la propria fisionomia, perché “un randagio è solo fisicamente un cane. Socialmente gli manca lo stato che lo dichiara tale, cioè la dipendenza da un padrone”.50 Di fatto, il cane possiede uno spazio d’esistenza soltanto in rapporto all’uomo. E al cane si attribuisce l’idea che non ci possa essere vita senza padrone. Goffredo Parise mette a punto in Anima (Sillabari) una situazione narrativa in cui un cane “di nome Bobi che aveva e non aveva un padrone” vaga “per le strade di una città italiana”, trascinato dalla malinconia e dalla noia della solitudine. Solo dopo la morte, avvenuta quello stesso giorno, riceve la visita del presunto padrone, che “ricordando con grande dolore passeggero Bobi e certe sue distrazioni si domandò (o si disse?) una cosa molto bella e degna di lui: ‘I cani hanno l’anima’”.51 Il cane senza padrone – che talvolta diventa simbolo della libertà, dell’estraneità alle regole, contrapponendosi al cane ‘burocrate’ –52 può essere accettato solo da uomini che si mettono ai margini, come il protagonista della Vittoria delle formiche di Pirandello. “Ridotto alla fame, da agiato come il padre l’aveva lasciato morendo, abbandonato dalla moglie e dai figli”, l’uomo vive solo in una baracca in campagna. Se da un lato è tormentato dal rimorso di aver sprecato l’esistenza, dall’altro, nella rinuncia, ha trovato un equilibrio che non ha mai conosciuto in precedenza. Scrive Pirandello: Aveva scoperto questa nuova ricchezza, nell’esperienza che può bastar così poco per vivere; e sani e senza pensieri; con tutto il mondo per sé, da che non si ha più casa né famiglia né cure né affari; sporchi, stracciati, sia pure, ma in pace; seduti, di notte, al lume delle stelle, sulla soglia d’una catapecchia; e se s’accosta un cane, anch’esso sperduto, farselo accucciare accanto e carezzarlo sulla testa: un uomo e un cane, soli sulla terra, sotto le stelle.53 La stessa solidarietà lega il ragazzo Cinci al cane Fox, solitari protagonisti 50 Carlo Cassola, L’uomo e il cane (1977), Torino: Einaudi, 1983, pp. 53-54. Goffredo Parise, Sillabari (1984), Milano: Adelphi, 2004, pp. 36-40. 52 La definizione è di Giorgio Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo, Torino, Einaudi, 1977, p. 121. 53 Luigi Pirandello, “Vittoria delle formiche”, in Id., Una giornata. Novelle per un anno (1937), Milano: Mondadori, 1990, vol. III, t. 1, p. 704. 51 158 / ANDREA GIARDINA di un’altra novella di Pirandello, Cinci.54 I due vagano insieme per la campagna, uniti da un affetto silenzioso, fino a quando Cinci, avendo visto un ragazzo prendere al cappio una lucertola, si lascia travolgere dalla rabbia e nella colluttazione lo uccide, mentre il cane osserva la scena. Il più celebre degli esclusi pirandelliani, Mattia Pascal, pur desiderandolo, evita invece la compagnia del cane. Possedere un animale vorrebbe dire ridimensionare quel progetto di libertà a cui aspira dopo aver abbandonato la vita soffocante che aveva trascorso fino ad allora. Ero […] stanco di quell’andar girovagando sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentire il bisogno di un po’ di compagnia […]. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinajo […] gli scoprii tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo, di pochi giorni, che tremava tutto di freddo e gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiola! Domandai al vecchio se la vendesse. Mi rispose di sì e che me l’avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto […]. Comprando quel cane, mi sarei fatto, sì, un amico fedele […], ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa: io che non ne pagavo più! Mi parve come una […] compromissione della mia libertà.55 Il cane servo e schiavo. Sottomissione e asservimento al potere L’altro versante della fedeltà è la sottomissione. Il cane fedele è un servitore dell’uomo, è un suo dichiarato inferiore. La sua intelligenza si misura, in tal senso, nella capacità di obbedire e di eseguire ordini. Il processo verso la ‘deterritorializzazione’, il viaggio, è qui bloccato alla radice. L’io dell’individuo non ammette cedimenti, forse proprio perché ne ha paura. Il cane servo rimanda a personalità umane in conflitto con le cose e con il mondo, irresolubilmente fragili, incapaci di amore. Landolfi nel 1947 scrive Racconto d’autunno. Un soldato in fuga raggiunge una desolata villa tra i monti. Attraverso una spiraglio tra gli scuri, egli vede due cani-lupo dalla “fisionomia feroce” che percorrono un salone fatiscente e sontuoso “a gran passi silenziosi, fermandosi talvolta a fiutar l’aria o balzando su un seggiolone a grattarvisi furiosamente, per mera nervosità”.56 I cani stranamente non abbaiano, come se obbedissero a una 54 Luigi Pirandello, “Cinci”, in Id., Berecche e la guerra, Novelle per un anno (1934), Milano: Mondadori, 1990, vol. II, t. 3, pp. 667-75. 55 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (1918), in Tutti i romanzi, vol. I, Milano: Mondadori, 2000, pp. 418-19. 56 Tommaso Landolfi, Racconto d’autunno (1947), Milano: Rizzoli, 1975, p. 19. IL VIAGGIO INTERROTTO / 159 “volontà superiore”. Quando l’uomo, spinto dalla fame e dalla necessità di trovare un riparo, si decide a sfondare la finestra, i cani, pur latrando furiosamente, non gli si avventano contro. Né lo fanno allorché entra in casa. Il loro comportamento gli suscita un’inspiegabile (data la circostanza) pietà, “quasi fosser creature infelici o anime in pena, astrette in quella dimora da un crudele incantesimo”. In effetti questa è la loro condizione. Essi temono l’anziano padrone di casa apparso subito dopo nella sala da pranzo. Sono così sottomessi e “ineluttabilmente attratti” dall’uomo che, lasciati soli, continuano a “percorrere a gran passi la sala […] levare il muso in dolorosi guaiti, […] rispondere al vento con ululati ancor più strazianti”.57 Lucia, la figlia del vecchio, che svela la sua presenza negli ultimi capitoli del libro quando il padre è ormai morto, ha con i due cani un atteggiamento diverso. Prigioniera come loro della volontà paterna, ha fatto dei due cani-lupo gli unici suoi confidenti e compagni. I cani, in quanto ‘fratelli’, godono di un altro privilegio: sono esclusi dalla furia sadica (è la tara familiare, il motivo della morte della madre e il ‘segreto’ del padre) che la spinge a torturare tutti gli altri animali, dai topi agli uccelli. Appare inevitabile che quando la ragazza viene uccisa da un gruppo di soldati sbandati, i cani muoiano assieme a lei, abbattuti da una scarica di mitra. Il tema del cane sottomesso al padrone, in cui la fedeltà non si esprime attraverso la cooperazione ma l’ubbidienza, si incontra con frequenza nei libri di Landolfi. La voce che narra le storie intrattiene un rapporto difficile e diseguale con la realtà. Il suo comportamento è stravagante, ama la solitudine, fatica ad aver commercio con gli altri umani, gli è negata la possibilità d’amare. Gli animali diventano i suoi prossimi, le creature viventi che, uniche, gli stanno vicino (suscitando sentimenti ancipiti, si veda il rapporto con i ragni o le ‘labrene’). Ma col cane il rapporto è squilibrato: l’animale è l’elemento debole, che deve accettare la situazione perché il suo istinto lo piega in quella direzione. La sua è una fedeltà-prigione. Così spesso il cane è terrorizzato dal padrone folle, di cui, come in Settimana di sole (racconto contenuto in Dialogo dei massimi sistemi), segue con lo sguardo i movimenti. Sono i suoi stessi istinti ad esserne condizionati, come accade alla cagnetta di Federico, il solitario protagonista di Mani (si trova sempre nel Dialogo dei massimi sistemi), “costretta” ad assalire un topo con brutale accanimento perché è il padrone a volerlo. Nel primo racconto della raccolta, Maria Giuseppa, il narratore afferma 57 Ivi, p. 59. 160 / ANDREA GIARDINA di aver plasmato il carattere del proprio cane, facendone una bestia introversa e diffidente. D’altra parte, Maria Giuseppa, la donna di campagna brutta e sgraziata che fa da cameriera al protagonista è, a più livelli, equiparabile ai cani, insieme a cui è fatta oggetto di scherno, di dispetti, di violenza.58 Questo comportamento dell’uomo verso il cane diventa metafora di un atteggiamento diffuso tra gli uomini stessi, e, nello stesso tempo, comune anche alla ‘società dei cani’. Sono le idee che sostanziano due libri di Gavino Ledda, Padre padrone e Lingua di falce. Nel primo, l’asservimento del cane Rusigabedra al pastore è totale. Quando l’uomo arriva col figlio nella tanca, il cane lo saluta abbaiando, saltando e scodinzolando finché non gli viene gettato un pane di crusca che afferra al volo. Il cane è il prezioso compagno di lavoro del pastore. Quando il padre si allontana, Gavino non ha altri aiuti. Ma Rusigabedra sa il fatto suo, avendo ricevuto l’‘investitura’ dal suo signore: riesce così ad allontanare dei ladri di bestiame che Gavino non aveva notato. Mentre il rapporto col bambino è paritario (con lui si muove per la montagna, divertendosi a inseguire le tracce del selvatico), quello col padre è diseguale per legge. Quando avverte il suo arrivo, il cane cambia atteggiamento: il giovane padrone sembra non esistere più, ogni sforzo è orientato ad accogliere il vero padrone, a cui deve far festa per poter avere in cambio il cibo. La relazione così impostata rende evidente, secondo Ledda, come in Sardegna “i padroni hanno sostituito la logica del branco con l’egoismo della proprietà”.59 Perduta l’armonia originaria, a ogni livello si è venuta delineando la condizione di asservimento a un capo, che considera gli altri cose di sua proprietà. La stessa logica domina tra i cani e i tentativi di ribellione al capobranco, come è scritto nelle pagine iniziali di Lingua di falce, sono destinati a fallire.60 Il cane fedele però normalmente non si ribella, perché nell’uomo vede il suo dio. Da lui accetta tutto, per lui è disposto a sacrificarsi. Giovanni Giudici in una serie di poesie comprese in Lume dei tuoi misteri evidenzia il legame morboso che può stringere il cane al padrone. In Spiegazioni si legge: “Ama e sbrana / Gelosia lo divora – attaccato al padrone / Morbosamente al punto / Che se gli va vicino / Assale il suo bambino”.61 La sottomissione diventa talora addirittura parossistica: il “cane canaglio” descritto 58 Tommaso Landolfi, Dialogo dei massimi sistemi (1937), Milano: Rizzoli, 1975. Gavino Ledda, Padre padrone. L’educazione di un pastore, Milano: Feltrinelli, 1975. 60 Gavino Ledda, Lingua di falce, Milano: Feltrinelli, 1978, pp. 2-3. 59 IL VIAGGIO INTERROTTO / 161 da Tiziano Scarpa in Groppi d’amore nella scuraglia riporta sempre indietro il sasso che l’uomo getta nel fosso, perché è convinto che “tutto tene significanza”.62 Talvolta il contrasto tra la volontà del padrone e quella del cane provoca un conflitto nell’animale, come scrive Saba in Primissime scorciatoie: “Vorrebbe sfogare i suoi istinti (appena coperti) e al tempo stesso conservarsi l’amore del padrone. Ma l’una cosa e l’altra non può fare. Trema. Ha senso di colpa. Guardate i suoi occhi; so che li guardate volentieri, che li capite, che vi sono anche troppo fraterni”.63 Il servilismo può diventare un atteggiamento necessario per farsi accettare. Il cane è capace di umiliarsi, di cancellare ogni frammento di dignità. Ma comportandosi in questo modo non segue comunque la natura? È questo il tema (e la domanda) che si incontra nella parte conclusiva del secondo romanzo di Bassani, Gli occhiali d’oro,64 in cui, poco prima di suicidarsi, il dottor Fadigati – l’omosessuale protagonista del libro – si imbatte per le vie di Ferrara in una cagna che gli rivolge “uno sguardo umido, trepidante”. L’incontro con un animale che cerca ad ogni costo di farsi accettare, trascinandosi “sui ciottoli verso le scarpe del dottore”, rovesciandosi “sul dorso pancia e zampe all’aria, completamente alla sua mercé”,65 lo turba profondamente. Fadigati, che arriva a far dormire la cagna in camera sua, osservando l’atteggiamento dell’animale giunge alla conclusione che forse gli uomini dovrebbero “saper accettare la propria natura”, anche se ritiene improbabile che possano “arrendersi” fino a quel punto all’istinto animalesco che pur li anima. Se c’è una differenza tra uomini e animali, questa sta probabilmente nel fatto che i sentimenti delle bestie sono “più semplici” di quelli umani, “più direttamente sottomessi all’imperio della legge naturale”.66 La versione estrema del rapporto di fedeltà è rappresentata dalla tra61 Giovanni Giudici, “Lume dei tuoi misteri”, in Id., I versi della vita, cit., p. 622. Tiziano Scarpa, Groppi d’amore nella scuraglia, Torino: Einaudi, 2004, p. 47. 63 Umberto Saba, Tutte le prose, Milano: Mondadori, 2001, p. 877. 64 Giorgio Bassani, “Gli occhiali d’oro” (1958), in Id., Opere, cit., pp. 297-303. 65 Ivi, p. 297. 66 Ivi, p. 305. Il motivo della cagna più sottomessa del cane è un topos ricorrente. In tale direzione si muove Saba nella poesia A mia moglie e, seppur su un piano di reciprocità, Montale (Xenia I), per il quale la fedeltà canina diventa modello di fedeltà coniugale: “Non ho mai capito se io fossi / il tuo cane fedele e incimurrito / o se tu lo fossi per me”. Eugenio Montale, “Non ho mai capito se io fossi…”, in Id., Tutte le poesie, Milano: Mondadori, 1984, p. 293. 62 162 / ANDREA GIARDINA sformazione del cane in un aggressivo strumento di potere al servizio dell’oppressore. Il cane fedele diventa, come scrive Manganelli in più libri, il ‘sicario’, definizione che si estende a comprendere sia il cane da guardia tenuto alla catena (è anche il Bargello di Sciascia ne Il giorno della civetta e la lunga serie di ‘cani da pagliaio’ che percorre la nostra letteratura contemporanea) sia le SS. Ennio Vittorini propone in Uomini e no una tragica versione del legame uomo-cane: è quello che unisce il capitano Clemm ai suoi tre cani-lupo, Blut, Greta e Gudrun, nel fosco clima dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale. I cani vengono addestrati per uccidere. La loro natura è piegata al servizio degli obiettivi criminali perseguiti dagli aguzzini nazisti. Non c’è modo di interrompere questo legame perverso, anche se uno dei cani, il giovane Kaptän Blut, sembra quasi cedere di fronte alle parole di Figlio-di-Dio, il partigiano infiltrato tra i tedeschi che vorrebbe convincerlo ad abbandonare quella vita. Tra il partigiano e Clemm la distanza è enorme, come rivela questo scambio di battute: “I cani non tradiscono sono sempre fedeli”. “Questo non è,” disse Figlio-di-Dio, “una buona qualità”. “No?” disse l’ufficiale. “No, capitano. Un uomo va bene, e il cane gli è fedele. Un uomo va male, e il cane lo stesso gli è fedele”.67 Il tempo non è però stato sufficiente per modificarne la natura e il cane è costretto a eseguire gli ordini impartiti da Clemm. L’occasione è data dalla brutale esecuzione dello sventurato Giulaj, un giovane venditore di castagne colpevole di aver ucciso Greta, che viene fatto sbranare proprio da Blut e da Gudrun. Daniela Amsallem ha studiato come nella letteratura ebraica il cane sia stato spesso sovrapposto al nazista.68 Nei campi di concentramento i cani sono parte integrante del paesaggio: accolgono i prigionieri al loro arrivo abbaiando furiosamente, mentre le SS urlano ordini che assomigliano a latrati secondo la tradizione prussiana della Dill. Cani e milizia nazista procedono spesso appaiati, perché le SS se ne servono per evitare le fughe dei deportati, per improvvisare cacce all’uomo, per mantenere 67 Ennio Vittorini, Uomini e no (1945), Milano: Mondadori, 1965, p. 125. Daniela Amsallem, “Le symbolisme du chien: Primo Levi et la littérature juive après la Shoah”, Croniques italiennes, 33-34, 1993, pp. 27-44. 68 IL VIAGGIO INTERROTTO / 163 l’ordine e incutere terrore in occasione delle esecuzioni capitali o per far sbranare i deportati. Agli occhi dei prigionieri cani e uomini diventano perciò una sola cosa. Primo Levi in Se questo è un uomo si rifà a questa immagine e il cane diventa Cerbero, il custode infernale. Come ha affermato Marco Belpoliti, il cane è per Levi “l’immagine dell’individuo solo, asservito, come gli aguzzini nazisti, a una legge a lui superiore, è cioè l’uomo privato della sua libertà”.69 Il disprezzo di Levi verso il cane servo riemerge anche ne I sommersi e i salvati, in cui appare il cane di Pavlov, l’animale usato per lo studio del comportamento canino, e in Fosforo (Il sistema periodico) dove la bibliotecaria è associata a un cane da pagliaio, “uno di quei poveri cani che vengono deliberatamente resi cattivi a furia di catene e di fame”.70 Levi, d’altra parte, avvicina al cane anche la condizione di chi è vittima della violenza. Così è il prigioniero del lager reso progressivamente simile a un cane, come evidenzia il gesto di lappare la zuppa (mentre ne La Tregua la sua condizione di disorientamento lo porta a identificarsi con un cane randagio).71 Analogamente, uno scrittore sensibile al tema del potere e della sua brutalità come Pier Paolo Pasolini nel film Salò o le 120 giornate di Sodoma rappresenta la scena dei giovani ‘trasformati’ in cani tenuti al guinzaglio dai torturatori e obbligati anch’essi a lappare il cibo dai piatti. L’equiparazione del cane al nemico viene proposta da Giorgio Voghera ne Il segreto: la paura per i cani è il probabile riflesso dell’ostilità nutrita dai compagni di classe austriaci nei suoi confronti in quanto cittadino, italiano e, soprattutto, ebreo. Si noti che, in questo caso, siamo negli anni della prima guerra mondiale, ma già l’antisemitismo era sentimento diffuso in Austria dove la famiglia di Voghera, originario di Trieste, era sfollata. I cani si trasformano in incubi per il bambino che li teme a tal punto da pensare che abbiano qualche profondo motivo di malevolenza nei suoi confronti: “Se il cane faceva proprio tutti gli sforzi possibili per assalirmi, se si dimostrava tanto addolorato di non poterlo fare, voleva dire che nella sua testa 69 Marco Belpoliti, “Animali”, Riga 13, Milano: Marcos y Marcos, 1997, p. 168. Primo Levi, “Fosforo”, in Id., Opere, vol. I, Torino:Einaudi, 1997, p. 841 71 Amsallem ricorda come altri scrittori ebrei descrivono casi simili. Yoram Kaniuk in Adamo risorto (1968) propone il personaggio di Adamo, il più celebre clown tedesco, che sfugge alle camere a gas ma è obbligato a diventare il ‘cane’ del comandante Klein, che lo costringe a salire le scale a quattro zampe. Ne L’ultimo dei giusti (1959) di André SchwarzBart, Ernie Lévy, non riuscendo a liberarsi dal senso di colpa per essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia, rinuncia alla natura umana e diventa un cane. 70 164 / ANDREA GIARDINA ci dovevano essere delle ragioni profonde, assai serie, per odiarmi. Voleva dire che la mia presenza gli arrecava un’offesa ben grave”.72 Ridicolizzati e asserviti al potere militare che ha portato il mondo allo scontro e all’apocalisse sono i cani descritti da Paolo Volponi nel Pianeta irritabile. Alcuni sono servi nel circo degli uomini, come lo spinone che dopo anni trascorsi nel gruppo dei cani saltatori ed equilibristi, riesce a sopravvivere guidando il motociclo argentato, o come la cagnetta Neue Ideologie “idolo delle folle”, che balla in tutù e con un delicato fiocchetto color pesca sulla testa tutto il Lago dei cigni. Altri sono strumenti di guerra, e perciò vengono equiparati, come afferma Moneta irritato dalla derisione cui lo fa oggetto il nano Mamerte, a “dirigenti”, adeguatamente “istruiti” per uccidere.73 Pavese ne La luna e i falò si richiama a questa immagine del cane servo per prospettare un’impossibile forma di ribellione: “Sono soltanto i cani che abbaiano e saltano addosso ai cani forestieri e [Nuto gli diceva] che il padrone aizza un cane per interesse, per restare padrone; ma se i cani non fossero bestie si metterebbero d’accordo e abbaierebbero addosso al padrone”. La metafora politica, sullo sfondo delle vicende resistenziali, è evidente e viene ribadita con il successivo richiamo alla seconda guerra mondiale, dove si sono visti “tanti cani scatenati dal padrone perché si ammazzassero e i padroni restare a comandare”. Si tratta, afferma Nuto, di una legge universale: “il mondo è pieno di padroni che aizzano i cani”.74 La fedeltà diventa, per questa via, non più una qualità, ma un limite del cane. Negli Improvvisi per macchina da scrivere, Manganelli afferma che i cani hanno acquisito tratti deprecabili: considerano “l’uomo come un essere superiore” e “fanno buone azioni” a tal punto che “hanno qualcosa dei falliti”. I cani hanno cessato secoli or sono di esseri animali, allo stesso modo per cui si dicono animali le tigri e le giraffe. Il cane ha rinunciato a tutti i termini della sua qualifica psicologica, ed è diventato un’altra cosa. Che cosa? Oserei dire che è diventato un sintomo. Il cane-animale, simpatico e fantasioso chiassone, non esiste più; al suo posto abbiamo questo strano prodotto non strettamente genetico delle inquietudini, dei disagi, dei malumori, degli estri, dei dispetti dell’uomo incivilito. 72 Anonimo Triestino (Giorgio Voghera), Il segreto, Torino: Einaudi, 1961, p. 46. Paolo Volponi, Il pianeta irritabile (1978), Torino: Einaudi, 1994, p. 169. 74 Cesare Pavese, La luna e i falò (1950), Torino: Einaudi, 1978, p. 75. 73 IL VIAGGIO INTERROTTO / 165 Il cane, spogliato della sua natura, è diventato così l’oggetto dei sogni umani: come gli incubi, i fantasmi, anche certe figure angeliche, mirabili ma innaturali. Ecco: ci furono millenni in cui il cane fu ’naturale’, come l’acqua e il fiore; ma oggi non è naturale, è come noi; un’artificiale trovata, un’invenzione. Forse uomo e cane sono nel mondo i soli esseri che abbiano conseguito una totale, irreparabile innaturalità. Il cane è la nostra nevrosi, il simbolo di qualcosa che non possiamo mai amare abbastanza; e quale sorta di malattia siamo noi per il cane? Una malattia che lo ha reso schiavo.75 75 Giorgio Manganelli, Improvvisi per macchina da scrivere (1989), Milano: Adelphi, 2003, pp. 206-07. § 8 Michela Gardini Derive urbane fin de siècle L’opposizione romantica tra natura e città tende a svanire nel corso della seconda metà dell’Ottocento privilegiando una riflessione sempre più incentrata sulla realtà urbana.1 Tale prospettiva, inaugurata da Baudelaire, non manca a sua volta di farsi foriera di un’antitesi di fondo, contrapponendo da una parte la città moderna, tentacolare e massimamente seduttiva e, dall’altra, la città d’antan, nella direzione, quest’ultima, non solo di un passato archeologico, ma anche mitologico e archetipico. Parigi è naturalmente il luogo in cui questi contrasti trovano, soprattutto sul finire del secolo, la loro più intensa manifestazione.2 Specularmente al desiderio di rifugiarsi nelle città del passato, quali le città orientali e la stessa Roma imperiale, anche il filone utopico sullo sfondo di Parigi è da leggersi come inadeguatezza al presente e fuga in un mondo altro, questa volta proiettato nel futuro. È quanto emerge, secondo Marie-Claire Bancquart,3 da Paris (1896) di Zola, dove la città assume 1 La riflessione più illuminante ed esauriente a tal riguardo risale certamente a Walter Benjamin, che ha indagato il rapporto tra la città moderna, la folla e gli scrittori dell’Ottocento. Da segnalare anche il testo di Karlheinz Stierle, La Capitale des signes. Paris et son discours (Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2001), che, sulla scia di Benjamin, ha rivisitato il mito di Parigi. 2 Numerosissimi sono gli studi miranti a ripercorrere le tracce del mito di Parigi. Ricordiamo, oltre alle opere di Benjamin, per quanto concerne l’Ottocento, Pierre Citron, La poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire, Paris: Éditions de Minuit, 1961; Nathan Kranowski, Paris dans les romans d’Émile Zola, PUF, 1968; MarieClaire Bancquart, Paris fin-de-siècle (1979), Paris: La Différence, 2002; per il Novecento, sempre di Bancquart, Paris des Surréalistes (1973), Paris: La Différence, 2004; infine gli studi trasversali di Giovanni Macchia, Il mito di Parigi, Torino: Einaudi, 1965 e Le rovine di Parigi, Milano: Mondadori, 1985. 3 Cfr. Marie-Claire Bancquart, Paris fin-de-siècle, cit. PARAGRAFO I (2006), pp. 167-78 168 / MICHELA GARDINI un valore emblematico. Ma l’afflato utopico-rivoluzionario della capitale trova forse la sua più adeguata formulazione nel Tableau de Paris (1882) di Jules Vallès, che, già nel titolo allusivo all’omonimo testo di Louis-Sébastien Mercier, si inserisce consapevolmente nel solco delle utopie del XVIII secolo. Vallès invita a squarciare il velo polveroso che attanaglia Parigi nella morsa del passato, simboleggiato dal Quartier Latin, dalle università e dai licei, tutti luoghi che come prigioni impediscono all’energia cittadina di manifestarsi. Laddove si ergeva il Palais des Tuileries, demolito proprio nel 1882, Vallès invoca la futuristica costruzione di un immenso palazzo di cristallo contenente venti industrie in venti case di vetro, immagine che ricorda peraltro il celebre falansterio concepito da Charles Fournier. “L’utopista – scrive Raymond Trousson – sogna una trasparenza dove ciascuno è uno specchio: tutti si riflettono e si rinviano mille volte la propria immagine felice, unanime ed integra. L’anima dell’utopiano è una lastra liscia che fa scintillare lo sguardo collettivo”.4 L’eredità di tale sguardo utopico verrà raccolta all’inizio del XX secolo dai poeti unanimisti che crearono realmente una comunità, chiamata l’Abbaye, sul modello fournieriano, vera e propria ville unanime, all’insegna della trasparenza e dell’apertura positiviste. La città, utopicamente trasformata in un falansterio di cristallo con Vallès, diventa realmente un’immensa vetrina in occasione delle Expositions. Parigi ormai, scrive Philippe Hamon, è “una città organizzata panotticamente dall’amministrazione che la suddivide geometricamente in viali illuminati, dove la società si mette in mostra ed offre a se stessa lo spettacolo quotidiano dei suoi riti, delle sue mode, delle sue vetrine, della sua etichetta mondana”.5 Ma il panoptismo, come afferma Foucault, ha inciso sottilmente sul tessuto sociale, col risultato che “la nostra società non è [più] quella dello spettacolo, ma della sorveglianza”,6 ciò che spiegherebbe anche il rapido diffondersi del romanzo poliziesco, riflesso di una società concepita nella sua interezza come un’immensa trama poliziesca: un occhio indagatore scruta la città, facendosi breccia tra la nebbia e la coltre notturna.7 4 Raymond Trousson, Voyages aux pays de nulle part, Bruxelles: Éditions de l’Université, 1999, p. 18. Laddove non altrimenti indicato, la traduzione è mia. 5 Philippe Hamon, Expositions. Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris: José Corti, 1989, p. 14. 6 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), trad. it. di Alcesti Tarchetti, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino: Einaudi, 1976, p. 236. 7 Il romanzo poliziesco, invenzione della letteratura moderna, è un genere strettamente urbano. Si vedano Jacques Dubois, Le roman policier ou la modernité, Paris: Nathan, DERIVE URBANE FIN DE SIÈCLE / 169 Tuttavia il filone utopico rappresenta solo uno dei molteplici semblants di Parigi nella seconda metà dell’Ottocento. In testi quali L’Œuvre (1886) di Zola, Double (1889) di Poictevin, Le Soleil des morts (1898) di Mauclair, per citare solo alcuni esempi, Parigi appare come una città dai contorni sempre più indefiniti, una città sospesa tra sogno e realtà, avvolta nella nebbia e nell’ombra, seppellita sotto la neve, fuggente e mutevole come l’acqua della Senna. Questa indecidibilità di Parigi trasforma la città in un mirabile spazio ambiguo, non più femminilizzato e da conquistare come in Balzac, ma nemmeno virile, piuttosto un androgino decadente, all’insegna della sterilità e della morte. In questa prospettiva assume un particolare significato quello spazio entre-deux per eccellenza che è la periferia, un “paesaggio che cerca di essere la campagna dietro a un muro che dà riparo a tre milioni di esistenze e che si impregna di esse, freme dei loro respiri”.8 Nella seconda metà dell’Ottocento la periferia rappresenta la grande novità dell’immaginario parigino, come conseguenza del vasto sviluppo urbano risalente all’intervento di Haussmann. Figura dunque nella letteratura da una parte come testimonianza dei mutamenti storici, politici e sociali di un’epoca, ma dall’altra facendosi carico della nuova sensibilità estetica, che induce Mauclair a definirla barresianamente “mélancolique beauté”.9 Le passeggiate del protagonista del suo romanzo, André de Neuze, si svolgono ormai lontano dal centro, a Neuilly, “misteriosa e taciturna”. La “natura insudiciata” di quest’angolo di periferia esercita sul personaggio un fascino ben più forte dei quartieri centrali: “L’isola della Grande-Jatte e i suoi tremoli grigi, Asnières e le sue fabbriche, i pendii di Courbevoie e le loro ville rosa e verdi, la distesa curva della Senna con i suoi promontori di pioppi, la pace claustrale del par1992; Jean-Noël Blanc, Polarville. Images de la ville dans le roman policier, Presses universitaires de Lyon, 1991. In particolare, Jacques Dubois e André Rouillé (in L’Empire de la photographie, Bruxelles: Fernand Nathan-Labor, 1983) si soffermano sulle analogie tra romanzo poliziesco e tecnica fotografica: sia l’uno che l’altra, infatti, si caratterizzano per la diffusione di massa e la riproduzione senza fine. Inoltre, Dubois sottolinea il contributo offerto dalla fotografia alla nascente criminologia. Si veda, a tal proposito, Georges DidiHuberman, L’Invention de l’hystérie: Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière, Paris: Macula, 1982. 8 Camille Mauclair, Le Soleil des morts, in AA.VV., Romans fin-de-siècle, 1890-1900, Paris: Robert Laffont, 1999, p. 924. 9 Il fascino malinconico della periferia è stato esaurientemente analizzato da Pascaline Mourier-Casile in “Promenades ex-centriques (Esthétique fin de siècle de la banlieue)”, in Jeannine Guichardet (a cura di), Errances et parcours parisiens de Rutebeuf à Crevel, Paris: Université de la Sorbonne-Nouvelle, 1986, pp. 147-56. 170 / MICHELA GARDINI co di Neuilly erano lo sfondo appropriato al suo desiderio di tranquillità così come al suo mutevole impressionismo”.10 La pittura non mancherà di mostrarsi sensibile al medesimo rinnovamento estetico, come testimonia la proliferazione di tele ambientate nella periferia parigina (vd. ad esempio Quai de la Seine à Clichy di Signac, Île de la Grande Jatte e Passerelle d’Argenteuil di Sisley, Fabrique près de Pontoise di Pissarro, Le dimanche d’été à la Grande Jatte di Seurat). L’affresco della periferia si compie, in ultima analisi, nell’evocazione del paesaggio industriale. Ma per lo più veicola un’immagine di decadenza e di sfacelo: i macchinari, anziché testimoniare di un radioso progresso sono arrugginiti, il terreno tutt’intorno è incolto e deserto (Mauclair e Poictevin), infeconde vestigia della città industriale trionfante e prometeica enfatizzata da Verhaeren.11 Quello che qui chiamiamo entre-deux equivale alla nozione di ‘nonluogo’ teorizzata da Marc Augé12 per definire la ‘surmodernità’. La periferia decadente, con i suoi terrains vagues, le sue fabbriche, strade e ferrovie si configura come prodromo privilegiato dei nonluoghi tipicamente novecenteschi, sulla base della comune assenza di ‘identità’, ‘relazionalità’ e ‘storicità’. La periferia è priva di memoria, diversa quindi anche dalla città baudelairiana che, come ha illustrato Starobinski, integra il nuovo e l’antico. In questo consiste inoltre, sempre secondo Augé, la differenza tra modernità e surmodernità, proprio perché la prima si fonda sulla coesistenza di passato e presente, allorché la seconda annulla la dimensione storica. La crisi del centro, a sua volta, produce come conseguenza la frammentazione della visione urbana. Allo sguardo dominatore di Balzac che mette in bocca a Eugène de Rastignac la celebre sfida à nous deux maintenant!, lanciata a Parigi dominata con lo sguardo dall’alto del Père-Lachaise, succede lo sguardo interrotto di Huysmans che, nel breve testo La Bièvre (1890), si rammarica dell’impossibilità di spingere lo sguardo sino al Panthéon e al Val-de-Grâce partendo dal quartiere della Bièvre, a causa delle nuove costruzioni che si ergono in Rue de Tolbiac. La veduta d’insie10 Camille Mauclair, op. cit., p. 931. Émile Verhaeren, con la raccolta di poesie Les Villes tentaculaires (1895) si pone in controtendenza rispetto all’estetica decadente della città malinconica, enfatizzando invece l’aspetto trionfante e virile della città industriale. L’autore belga risulta in tal modo piuttosto l’anticipatore del Futurismo italiano e russo. 12 Cfr. Marc Augé, Non-lieux (1992), trad. it. di Dominique Rolland, Nonluoghi, Milano: Elèuthera, 1993, e Id., L’impossible voyage. Le tourisme et ses images (1997), trad. it. di Alfredo Salsano, Disneyland e altri nonluoghi, Torino: Bollati Boringhieri, 1999. 11 DERIVE URBANE FIN DE SIÈCLE / 171 me, unitaria, d’ispirazione rinascimentale, svanisce progressivamente sfociando in una visione frammentaria, come apparirà anche figurativamente, agli albori del Novecento, nel quadro di Delaunay La ville de Paris (191012). Parlare della città come di un corpo organico non è più possibile, come testimonia la rappresentazione della città sempre più per sineddoche, come nel caso di Roma nei Contes de la décadence romaine (1898) di Richepin, dove si assiste al truculento smembramento della città che non esiste più in quanto tale, bensì ne esistono gli emblemi, quali il quartiere della Suburra, il Circo e la Cloaca. La mutilazione dei corpi dati in pasto alle bestie feroci nell’arena costituisce quindi piuttosto la mise en abîme dello smembramento dionisiaco della città stessa, alla luce dell’estetica decadente della disjonction, secondo la definizione di Jankelevitch.13 Nella rappresentazione surrealista di Parigi, il mercato delle pulci di periferia diventa con André Breton una sineddoche esemplare, a testimoniare la concezione anti-funzionale della città, dove tutti quegli oggetti “fuori moda, frammentari, inutilizzabili, quasi incomprensibili, perversi”14 rispondono, secondo Francesco Orlando, ad un imperativo polemicamente antiborghese; la città abdica alla propria funzione pragmatica, strutturandosi contrastivamente come scena dell’inconscio e del ritorno del rimosso.15 Il passaggio immediatamente successivo alla defunzionalizzazione dei luoghi è la malattia, che diventa un elemento privilegiato nella rappresentazione della città decadente. Il testo già menzionato di Huysmans, La Bièvre, mette in scena un frammento di Parigi malato, infestato da microbi ed escrescenze di ogni sorta. La Bièvre o, meglio, quel che resta del corso d’acqua di un tempo, è “senza fiato”, “l’acqua in lutto” è “malata, febbricitante e in lacrime”, agonizzante lancia “i suoi ultimi rantoli”, mentre le case che vi si affacciano sono antropomorficamente “ventri 13 Cfr. Vladimir Jankélévitch, “La Décadence”, Revue de Métaphysique et de Morale, 55:4, ottobre-dicembre 1950, pp. 337-65. 14 André Breton, Nadja (1928), trad. it. di Giordano Falzoni, Nadja, Torino: Einaudi, 1972, p. 46. 15 Cfr. Francesco Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, Torino: Einaudi, 1993. Cfr. anche Lino Gabellone, che individua nel marché aux puces un esempio di eterotopia, sulla base della definizione che in Les mots et les choses ne dà Michel Foucault in contrapposizione all’utopia: “il disordine che fa scintillare i frammenti di un gran numero di ordini possibili, nella dimensione senza legge né geometria dell’eteroclito”. Lino Gabellone, L’oggetto surrealista. Il testo, la città, l’oggetto in Breton, Torino: Einaudi, 1977, p. 68. 172 / MICHELA GARDINI gonfi”, soverchiate da “tetti impazziti”.16 Nella stessa ottica di compiacimento difronte alla materia in decomposizione, Jean Lorrain così ritrae la città della Valletta nel racconto La dame turque (1898): “Si pensa anche a un vasto lazzaretto, un lazzaretto per i lebbrosi di tutto l’universo, davanti alle silhouettes in rovina, tanto sembrano selvagge e dorate, di questa città senz’alberi, senz’erba, senza verde”.17 Evidentemente, il campo lessicale della malattia disegna tutto un universo antiproduttivo che si pone in forte contrasto con la logica borghese, sfociando in una vera e propria poetica dell’antinatura e della mostruosità. Questo aspetto, enfatizzato anche dalla frequentazione dei luoghi di relegazione, quali ospedali, asili per alienati mentali, o addirittura conventi, cimiteri, ossari, caratterizza largamente l’immaginario urbano fin de siècle. Non dimentichiamo neppure Barrès, per il quale la città di Aigues-Mortes (Le jardin de Bérénice, 1891) è indissociabile dalla febbre che sale dai suoi stagni e dove le case sono “pallide” e i giardini “gracili”, esattamente come a Venezia, celebrata da Barrès stesso (Amori et dolori sacrum, 1900) come “una bellezza che va verso la morte”. Dalla città malata alla città morta il passo è breve. Sempre Parigi, nei testi già citati, è sottoposta ad un percorso di devitalizzazione, per lo più attraverso la ricorrente immagine finale di un cimitero di periferia che trasforma la capitale in un vasto spazio di morte (L’Œuvre, L’Assommoir, Le Soleil des morts), passando attraverso altri segni evidenti di sterilità, quali la neve, le vie deserte e il soverchiante silenzio. Perfino un quartiere come Montmartre, conosciuto e frequentato almeno dagli artisti, racchiude un angolo di città morta, ed è qui che il protagonista del romanzo di Mauclair si sente trasportato a Bruges, paradigma incontestato della città morta fin de siècle: Amava questa città strana, morta, dove non va nessuno, che persino molti artisti nemmeno sospettano e che, al di sopra della vistosa accozzaglia di colori delle birrerie e dei music-hall che cingono la sua base, delimitando la Parigi frequentata, si staglia potente e tenebrosa, in pieno cielo, eroicamente povera […]. André de Neuze, da tempo, aveva assaporato questo fascino disfatto di Montmartre sconosciuto. Quella sera, vi penetrò ancora più avidamente. L’infinito silenzio di quelle viuzze entrò nel suo animo. Nessuno. Ad una vecchia finestra, fra due ante sconnesse, pal16 Joris-Karl Huysmans, La Bièvre (1890), in Id., Œuvres complètes, Paris: Plon, 1925, pp. 11-22. 17 Jean Lorrain, La dame turque, Paris: Hatier, 1996, p. 41. DERIVE URBANE FIN DE SIÈCLE / 173 pitava un chiarore indeciso. La via del Mont-Cenis, bianca di luna, saliva, si apriva sul cielo, sbarrata da alti confini neri. La via Saint-Vincent era come scolpita nel silenzio […]. Il giovane giunse alla piccola place du Tertre […]. Era una di quelle piazze come se ne vedono nelle città del Nord, o in certi borghi delle Fiandre, e André de Neuze vi ritrovava un angolo di Bruges.18 Il testo fondatore del mito di Bruges è il romanzo di Rodenbach Brugesla-morte, pubblicato nel 1892. La città vi appare massimamente defunzionalizzata, una città-museo immortalata in una dimensione atemporale più che ancorata al passato, teatro perfetto per la rappresentazione della triade dell’assenza, del desiderio e del fantasma. Se, da una parte, il protagonista Hugues Viane crede di aver ritrovato la sposa morta in Jane, giovane ballerina di teatro scorta nel dedalo delle vie di Bruges, dall’altra, in realtà, è la città nella sua interezza a costituirsi come il doppio della donna amata e perduta, in una progressiva ofelizzazione dello spazio (“L’aveva riveduta meglio, meglio ascoltata, aveva ritrovato nei canali, a filo d’acqua, il suo volto di Ofelia fuggitiva”). Bruges finisce per divenire una città-tomba, “anche lei sepolta nei canali orlati di pietra”.19 Lungi dallo strutturarsi, quindi, come uno spazio sociale, Bruges si offre come interlocutore esclusivo del protagonista, ormai racchiuso in una dimensione solipsistica, consegnato integralmente al suo statuto di vedovo. Bruges, estremamente improduttiva, è una città d’arte, ma i monumenti artistici oggetto dell’interesse di Hugues Viane potenziano ulteriormente il carattere mortifero della città. Infatti, si tratta per lo più di chiese colme di tombe e di quadri raffiguranti l’agonia di Cristo. Da ciò deriva la valenza simbolica della città, luogo liminale tra il mondo visibile e il mondo invisibile della morte e dell’inconscio. La città si affranca, così, da una dimensione precipuamente umana per consegnarsi completamente alla pietra e all’acqua. Se la pietra, da una parte, veicola già di per sé un’idea di sterilità, dall’altra anche l’acqua stagnante dei canali di Bruges possiede per sempre l’immagine della sposa defunta (“Ofelia fuggitiva”), riattualizzando il mito di Narciso. Nella stereotipizzazione di Bruges convergono manifestamente le ricerche mallarmeane sulla poesia. È in particolare intorno alla definizione di 18 Camille Mauclair, op. cit., pp. 961-962. Georges Rodenbach, Bruges-la-morte, trad. it. di Piero Bianconi, Bruges la morta, Milano: Rizzoli, 1955, p. 16. 19 174 / MICHELA GARDINI ‘nozione pura’ che Mallarmé prima, Rodenbach poi fondano un linguaggio basato sull’assenza, che trova le formulazioni più salienti nei campi lessicali del bianco e del vuoto, di cui la parola dentelle (merletto, pizzo) costituisce la sintesi più efficace. Nella propria casa Hugues Viane ha appeso delle “impenetrabili tende di pizzo, tatuaggi di gelo aderenti ai vetri”,20 mentre nel secondo romanzo di Rodenbach, sempre a Bruges dedicato, Le Carillonneur (1897), la pietra stessa è assimilata al merletto: “Poiché il Palazzo adesso era un merletto di pietra, bisognava che diventasse un museo di merletto”.21 Vent’anni più tardi Paul Klee dipingerà delle città-merletto (villes-dentelles secondo la definizione di Marcel Brion), fragili e instabili perché costruite sul vuoto, simili a “delle tele di ragno sospese nella luce, come trappole tese alla ragione dall’immaginazione”.22 E proprio dalla pittura proviene un contributo fondamentale alla definizione di Bruges come città dell’assenza. Pensiamo in particolare al ciclo di quadri che Khnopff ha dedicato alla città belga, dove il recupero pittorico di Bruges assume la connotazione di un vero e proprio ritorno alle origini, a quell’età mitica che è l’infanzia. Da qui il desiderio di immobilizzare la città in una dimensione atemporale, in cui lo scorrere del tempo venga neutralizzato a vantaggio di una rappresentazione quasi surreale. Doppio pittorico dei romanzi di Rodenbach, i quadri di Khnopff mettono in scena, in maniera preponderante, l’acqua, la pietra ed altre superfici riflettenti, quali il vetro, cui è affidata un’impressione di vuoto e di assenza, per l’appunto. D’altra parte, i motivi decorativi delle vetrate disegnate da Khnopff non assomigliano forse a dei fini merletti? Inoltre, l’abolizione pressoché totale della presenza umana finisce per annunciare la città metafisica di De Chirico, in un percorso di crescente devitalizzazione. Ed è in quest’ottica che prende corpo la peculiarità di Bruges rispetto all’altro modello di città decadente rappresentato da Venezia. Scrive Jean De Palacio: “La morte di Bruges non è la stessa di quella di Venezia, alla quale la si paragona spesso. Non si fonda sul disfacimento, ma sulla trasparenza. Città fantasma, diafana e traforata, luogo di specchi e riflessi, Bruges perde via via consistenza, sempre in procinto di scomparire […]. Al cromatismo veneziano si oppone così la decolorazione di Bruges”.23 20 Ivi, p. 79. Georges Rodenbach, Le Carillonneur, Bruxelles: Le Cri, 2000, p. 89. 22 Marcel Brion, L’Art fantastique, Paris: Albin Michel, 1989, p. 78. 23 Jean de Palacio, “Bruges-la-morte: ville sur le papier?”, in Id., Figures et formes de la décadence, Paris: Séguier, 1994, p. 241. 21 DERIVE URBANE FIN DE SIÈCLE / 175 La decolorazione di Bruges si attua in due fasi. Nel primo romanzo, infatti, Rodenbach dà forma ad una città-Pierrot, una città in bianco e nero che diventa grigia proprio dalla fusione dei due contrari: “un grigio che pareva fatto con il bianco delle cuffie delle monache e il nero delle tonache dei preti”.24 Jean Lorrain se ne ricorderà allorché scriverà Monsieur de Bougrelon (1897), dove Amsterdam rappresenta manifestamente una variante di Bruges: Amsterdam, è sempre acqua e case dipinte in bianco e nero, tutta vetro, con frontoni scolpiti e tende di pizzo; nero e bianco che si sdoppiano nell’acqua. Dunque è sempre acqua, acqua morta, acqua marezzata e acqua grigia, viali d’acqua interminabili, canali protetti da dimore simili a domino enormi.25 Il bianco ed il nero si annullano dunque nel grigio uniformante, luogo di non contraddizione, spazio di morte, suprema reductio ad unum. Ma è col secondo romanzo, Le Carillonneur, che Rodenbach imprime alla città un’irreversibile decolorazione: il bianco impregna di sé le vie, i muri, le case, i giardini, i cigni, la luce, la musica. Attraverso questo processo di “albogenesi”, secondo l’interpretazione di De Palacio, Bruges diventa un enorme foglio bianco, une ville sur le papier: il bianco è “invadente, tentacolare, come i margini della pagina che vincono sul nero e dicono l’impossibilità quasi patologica di mettere nero su bianco […]. Bruges diventerebbe così come la metafora dell’opera scritta, bella ma fragile, città di merletto o di carta”.26 L’immaginario orientale spinge alle estreme conseguenze questa rappresentazione che finisce per confluire in una riflessione metaletteraria. Pierre Loti, nei suoi viaggi in Oriente, è sedotto dal sentiment de la décoloration27 che emana dalla città, un sentimento che gli permette di vivere i suoi viaggi secondo l’illusione di un percorso a ritroso, una sorta di regressione verso un paesaggio tanto più puro quanto più sterile. In quest’ottica, descrivendo la moschea imperiale di Ispahan, Loti ne enfatizza l’aspetto glaciale: “sembra di ghiaccio; non solo una pace, come sempre, emana dalle sue vicinanze, ma si ha anche l’illusione che sprigioni del freddo”.28 24 Rodenbach, Bruges la morta, cit., p. 40. Jean Lorrain, Monsieur de Bougrelon, in AA.VV., Romans fin-de-siècle, cit., p. 107. 26 Jean de Palacio, op. cit., p. 221. 27 Pierre Loti, Fantôme d’Orient (1892), Paris: Calmann-Lévy, 1923, p. 142. 28 Pierre Loti, Vers Ispahan (1904), Exeter: University of Exeter, 1989, p. 123. 25 176 / MICHELA GARDINI Se già nella prima metà dell’Ottocento l’Oriente rappresentava l’alterità, la possibilità di un ailleurs ricettacolo dei sogni e dei desideri dello scrittore occidentale, sul finire del secolo l’Oriente assurge gradualmente a metafora della condizione dell’artista decadente e della sua scrittura, all’insegna della cifra comune della sterilità.29 Ecco perché l’immaginario urbano orientale della fin de siècle trova nella città morta e nella città bianca le due figure privilegiate. Ad Alessandria, Istanbul, Ispahan, ecc. sembra che il tempo si sia fermato, simili più a delle necropoli che a delle città viventi. Così Alessandria nel romanzo di Pierre Louÿs Aphrodite (1896): La spiaggia era deserta, morta la città. […] Nulla esisteva, oltre il silenzio. […] La prospettiva della via disegnavasi in linee architettoniche pure, non turbate da un carro, da un cavallo, da uno schiavo. Alessandria era una vasta solitudine, un simulacro di città vetusta, abbandonata da secoli.30 Istanbul, in Aziyadé (1879) di Pierre Loti, è “desolata e morta sotto quest’ultimo vento d’inverno”,31 mentre a Ispahan “tutto è disabitato, caduco e funebre”.32 All’interno di questa poetica della città morta si inserisce l’immagine della città bianca, a sua volta in rapporto dialettico con il biancore dei personaggi femminili, anch’essi simulacri di morte. Aziyadé, “bianca come una fanciulla morta”, “fredda come una statua di marmo” abita in una casa posta in una “grande piazza deserta di Mehmed-Fatih, circondata da una serie di piccole cupole morte che hanno il biancore di un sudario”.33 Chrysis, nel romanzo citato di Pierre Louÿs, assomiglia ad una statua, evocando l’elemento della mineralizzazione anch’esso associato tanto al paesaggio quanto ai personaggi femminili; un tema, questo, caro ai decadenti perché funzionale alla vocazione autoreferenziale dell’arte. La città e la donna si vogliono sottratte a qualsiasi finalità produttiva. La scena che viene rappresentata davanti all’“ampia parete bianca” di Alessandria, nel romanzo di Louÿs, si presta particolarmente ad una ri29 L’aspetto della sterilità come mito, con particolare riferimento all’opera di Pierre Louÿs, è sviluppato da Mariella Di Maio in Pierre Louÿs e i miti decadenti, Roma: Bulzoni, 1979. 30 Pierre Louÿs, Aphrodite, trad. it., Afrodite, Milano: S.A.C.S.E., 1935, p. 67. 31 Pierre Loti, Aziyadé, Paris: Calmann-Lévy, 1923, p. 247. 32 Pierre Loti, Vers Ispahan, cit., p. 96. 33 Pierre Loti, Aziyadé, cit., p. 146. DERIVE URBANE FIN DE SIÈCLE / 177 flessione metaletteraria: “Erano giunte davanti al Ceramico. Da un capo all’altro, l’ampia parete bianca era arabescata di scritti. Quando un amante desiderava presentarsi a una cortigiana, bastava ch’egli scrivesse i due nomi col prezzo proposto”.34 Da una parte il muro, sineddoche della città, e la cortigiana vengono associati dal comun denominatore del biancore, dall’altra lo scrittore e l’amante partecipano entrambi dell’atto della scrittura. La cortigiana, quindi, costituisce per l’amante ciò che la pagina bianca significa per lo scrittore, e cioè una sfida. Quanto alla pagina bianca, lo scrittore cerca di possederla attraverso la scrittura, tuttavia resta un ostacolo da superare. Il bianco rivela, in ultima analisi, tutta la contradditorietà dell’artista decadente: da una parte esso si erge a simbolo della sua stessa arte, areferenziale, dall’altra dice anche la condizione di smacco e d’impotenza rispetto alla logica della produttività borghese. Un ulteriore contributo originale alla definizione dell’immaginario orientale fin de siècle viene offerto dal racconto già citato di Jean Lorrain La dame turque, che determina una svolta all’interno del genere. In prima battuta l’Oriente vi subisce un rovesciamento di prospettiva tale da creare piuttosto un mito dell’Occidente: l’Oriente non seduce più l’Europa, avviene invece il contrario. Leggiamo: Ah! Parigi! Era il sogno di Shiamé Esmirli. Lei e lui, Bascia, avrebbero tanto voluto venirvi. Parigi! La città dove ci sono dei vestiti così belli e dove le donne sono libere! Shiamé e lui erano pronti a seguirci; lei acconsentiva a non rivedere mai più Beirut e, lui, mai più Alessandria, se solo avessimo voluto portarli con noi.35 La “decostruzione dell’orientalismo”36 si compie in rapida successione. Lo testimonia il fatto che è soltanto a bordo del battello che Jean nota la bellezza della città, in questo caso Tripoli: “Tripoli per i nostri addii si era fatta bella”, dopo la delusione provata il primo giorno. Ma ciò che sgretola il mito orientale è la scelta di parlare dell’Oriente da un nonluogo: il battello appunto. L’Oriente non è più consono a porre termine all’erranza dell’artista decadente, l’esilio è la sua unica condizione possibile. Scrive Sophie Basch: 34 Pierre Louÿs, op. cit., p. 31. Jean Lorrain, La dame turque, cit., p. 53-54. 36 Cfr. Sophie Basch, “La dame turque ou la Déconstruction de l’orientalisme”, in Jean Lorrain, La dame turque, cit.. 35 178 / MICHELA GARDINI Il narratore e la dama turca, questi due esseri “scollati dalla terra, che guardano dietro e davanti” hanno provato sino a che punto l’Oriente era inabitabile. Inabitabile dietro al viaggiatore che si allontana deluso di non aver incontrato in Oriente una terra più favorevole alla sua malinconia; inabitabile davanti a Shiamé Esmirli, incerta della sorte che l’aspetta al ritorno, votata forse ad una interminabile erranza. Inabitabile per l’Occidentale, e per gli Orientali nati dalla sua immaginazione.37 Con l’opale che Shiamé getta nel mare in chiusura del testo, è tutto l’orientalismo che Lorrain getta fra i flutti, dopo che Jean aveva rifiutato di portare l’anello che la donna, come segno della sua devozione, gli aveva offerto. Spetterà ad Albert Camus nella Peste (1947) testimoniare del definitivo sgretolamento del mito orientale, mettendo in scena una città, Oran, completamente priva delle seduzioni tradizionalmente attribuite, con l’eccezione di Lorrain, alle città orientali. Da subito il lettore viene messo sull’avviso che Oran è una città ordinaria, per lo più brutta. Dopo questo esordio sotto tono, la tensione cresce cristallizzandosi proprio sulla città poiché, con la diffusione del contagio, essa diviene una città-prigione, il cui fondamento mitologico è sempre pronto a ripresentarsi sotto forma di minaccia, come ci avverte l’autore stesso nel saggio L’été (1954): “Orano è un gran muro circolare e giallo, coperto da un cielo duro. Da principio si erra nel labirinto, si cerca il mare come il filo di Arianna. Ma si gira in tondo in vie selvagge e opprimenti, e, alla fine, il Minotauro divora gli oranesi”.38 Nel corso del Novecento l’immaginario orientale sopravviverà, profondamente rinnovato, in due filoni: da una parte la letteratura francofona magrebina, dall’altra la letteratura post-coloniale, con i romanzi di Marguerite Duras dedicati al ciclo dell’Indocina. Ma si fa strada, ormai, un nuovo mito: il Nuovo Mondo e la città di New York.39 37 Ivi, p. 16. Albert Camus, L’été, trad. it. di Sergio Morando in Il rovescio e il diritto. Nozze. L’estate, Milano: Bompiani, 1995, p. 108. 39 Patrice Terrone, nel suo articolo “La ville du Nouveau monde: ‘toujours plus loin’”, Iris, 17, 1999, pp. 75-90, sviluppa ampiamente l’immaginario del Nuovo Mondo, con riferimento non solo ai testi letterari (Malraux, Céline, Auster) ma anche alla serie di quadri di Piet Mondrian dedicati a New York. 38 § 9 Greta Perletti Dal mal sottile al mal gentile La malattia polmonare e il morboso ‘interessante’ nella cultura dell’Ottocento Nel 1853 Karl Rosenkranz, stimato successore della cattedra di Kant a Königsberg, pubblica con il titolo Estetica del Brutto un curioso trattato, che probabilmente a causa del suo inconsueto oggetto d’indagine rimane a lungo negletto nella tradizione critica del filosofo tedesco.1 Prefiggendosi di offrire in quest’opera una trattazione sistematica delle norme estetiche a fondamento della percezione umana del brutto, dell’inappropriato e del ripugnante nella natura e nell’arte, Rosenkranz si sofferma anche sulla controversa questione della bellezza o bruttezza del corpo malato. Poiché comporta sempre una trasformazione (o deformazione) nella regolarità del corpo sano, secondo Rosenkranz la malattia tende a suscitare il sentimento del brutto: l’identità tra bellezza e salute costituisce infatti uno dei principî fondanti della sua estetica. Eppure, dopo aver presentato questa verità generale, il filosofo tedesco ammette l’esistenza di casi in cui la malattia pare addirittura abbellire l’aspetto di chi ne è colpito. La tisi, o etisia o consunzione polmonare, figura tra questi mali sottratti alla competenza del brutto: La malattia provoca sempre il brutto quando deforma le ossa, lo scheletro e i muscoli. Essa è in genere causa di brutto quando altera in modo abnorme la forma: come nel caso dell’idropisia e simili. Ma non lo è quando, come nella cachessia, nell’etisia e negli stati febbrili, conferisce all’organismo quel colorito trascendente che lo fa apparire etereo. Il dimagrimento, lo sguardo bruciante, le guance pallide o arrossate dalla febbre 1 Per una ricostruzione della difficile fortuna critica di quest’opera, si veda l’Introduzione di Remo Bodei nel volume Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen (1853), trad. it. Estetica del Brutto, a cura di Remo Bodei, Bologna: il Mulino, 1984. PARAGRAFO I (2006), pp. 179-98 180 / GRETA PERLETTI possono far intuire in maniera ancor più immediata la presenza dello spirito. In quello stato lo spirito è già come separato dall’organismo. Il corpo nella sua trasparente ‘morbidezza’ non ha già più significato di per sé, è in tutto e per tutto espressione soltanto dell’anima che se ne distacca, indipendentemente dalla natura.2 Alla luce di come, subito dopo le considerazioni qui riportate, Rosenkranz si affretta a precisare che una più autentica e ammirevole bellezza scaturisce dalla guarigione – “[u]n convalescente è uno spettacolo degno degli dèi” –3 lo storico Sander Gilman deduce che l’apologia del sentimento estetico suscitato dalla tisi nel passo citato sia soltanto apparente, poiché l’aspetto tubercolare si limiterebbe a imitare la salute, incoraggiando quindi una percezione del bello ingannevole e fallace.4 Le riserve espresse da Gilman circa la celebrazione dell’aspetto tubercolare all’interno di un testo che per molti versi si presta invece ad appoggiare il discorso evoluzionistico (che proprio in quegli anni si andava formando), con la sua asserzione della superiorità anche estetica dei fittest, ci permette di far risaltare in maniera ancora più evidente l’importanza dell’anomala scelta di Rosenkranz di escludere la malattia polmonare dall’ambito della degenerazione. In questo saggio vorremmo proporre che il motivo che sostiene sia la reticenza del filosofo tedesco ad annettere la tisi al dominio del brutto, sia la sua decisione di riservarle un ruolo di ‘eccezione’ all’interno del proprio testo, vada ravvisato nello speciale rapporto che lega la tisi alla definizione dell’identità ‘interessante’, e mostrare in che modo questo legame, nel contesto culturale dell’Ottocento, si affermi e si consolidi grazie alla mediazione della nuova categoria epistemologica espressa dal concetto di ‘morboso’. 2 Ivi, p. 67. Ivi, p. 68. 4 La bellezza della tisi “non è bellezza per Rosenkranz. […]. La tubercolosi la imita soltanto, e perciò offre un’immagine falsa di bellezza”. Sander Gilman, “The Ugly and the Beautiful: Cross-Cultural Norms and Definitions in the Medical Culture of Sexuality”, in Id., Health and Sickness: Images of Difference, London: Reaktion, 1995, pp. 51-66 (laddove non sia altrimenti indicato, la traduzione è mia). Tuttavia, l’idea che la malattia imiti la salute non sembra presente nel testo del filosofo neppure quando questi elogia il valore estetico della guarigione: “Se, in alcuni casi, la malattia riesce addirittura a rendere l’uomo più bello, essa può ancor più diventare causa di bellezza quando scompare. Il progressivo ritorno alla salute conferisce allo sguardo una maggiore chiarezza e un sano rossore sulle guance”. Karl Rosenkranz, op. cit., p. 46. 3 DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 181 La malattia polmonare, l’eccezionalità dei malati e “l’epoca delle belle morti” Quando Rosenkranz assegna un valore di ‘eccezione’ alla malattia che oggi chiamiamo tubercolosi, egli accoglie implicitamente una connotazione della tisi ben consolidata nell’immaginario ottocentesco. La tisi è infatti un male ‘di eccezione’, non solo nel senso predicativo del termine (essa è, come nell’anti-estetica di Rosenkranz, un’eccezione rispetto ad altre patologie), ma soprattutto in virtù dell’eccezionalità che viene attribuita a chi ne è colpito. Il topos del lamento per la crudeltà di questa malattia, che arresta esistenze giovani e meritevoli, imperversa egualmente tra romanzieri e medici, e non è casuale ritrovarlo amplificato in un testo che deve forse la sua fortuna di bestseller all’intrigante indecidibilità della sua collocazione disciplinare. Che si tratti di un lavoro di fiction con pretese ‘scientifiche’ o di un testo medico ‘romanzato’ (come ebbe a sostenere perfino l’autorevolissimo Lancet), possiamo ipotizzare che la seduzione che questo sedicente Diary of a Late Physician esercitò sulla cultura che di lì a pochi anni sarebbe stata definita ‘vittoriana’ si sprigionasse proprio dalla reciproca – e visibile – interferenza dei discorsi della medicina e della letteratura, che condividono il medesimo immaginario: Terribile, insaziabile tiranno! Chi può arrestare la tua avanzata, o contare le tue vittime? Perché attacchi quasi esclusivamente i più belli e i più ammirevoli della nostra specie? […] Per quale infernale raffinatezza hai escogitato di render sino ad ora vane le più importanti abilità della scienza, di sconcertare completamente gli insegnamenti dell’esperienza, e di renderti manifesta solo quando ti sei irrimediabilmente assicurata la tua vittima, e le tue zanne sono rosse del suo sangue? O angelo distruttore! Perché ti riproponi di abbattere così coloro che sono i primi della nostra umanità sofferente?5 In questa personificazione della tisi come ‘tiranno insaziabile’, a risuonare come un ritornello più che noto nella cultura ottocentesca è soprattutto la crudele selettività con cui questa malattia opera: il destino di questi ‘primi dell’umanità’ appare a tal punto ineluttabile da indurre a credere che, come sostiene con una lapidaria riflessione un altro medico, nel caso della con5 Al successo di questo testo, che si presentava come il diario postumo di un medico, contribuì probabilmente la polemica sull’irrispettosa violazione del segreto professionale accesasi poco dopo la pubblicazione sulla rivista medica The Lancet. L’esemplare qui consultato è Samuel Warren, Passages from the Diary of a Late Physician (1832), EdinburghLondon: William Blackwood, 1834, vol. 1, p. 144. 182 / GRETA PERLETTI sunzione polmonare “se esiste in una famiglia una persona più affascinante o più dotata delle altre, quello è l’individuo che sicuramente morirà”.6 La convinzione che i soggetti che contraggono la tisi presentino con allarmante ripetitività straordinarie doti intellettuali, morali o estetiche inizia a essere formulata e sostenuta con insistenza nel corso del XVIII secolo. Grazie al retaggio di una lunga tradizione umorale che avvicinava e spesso confondeva – in nome di un ‘male inglese’ che affascinerà per un momento anche il Rousseau delle Confessioni –7 la tisi con i mali evanescenti che nel Settecento iniziano a essere denominati ‘dei nervi’, si creano i presupposti per promuovere un rapporto di reciproca causalità tra la malattia polmonare e la finezza d’animo di chi soffre di una non comune sensibilità. Per questo motivo, nel 1761, un medico eminente come Samuel Auguste Tissot non inserisce la tisi nel volume dedicato alle patologie proprie della gente comune, ma la fa figurare, nove anni più tardi, tra i mali della gente definita “del gran mondo”.8 Nel raro caso che il contadino contragga la consunzione, essa non sarà provocata dai “tubercoletti,” come accade ai cagionevoli cittadini, dediti all’esercizio di una sensibilità civile che, nel bene e nel male, “fa sì, che le genti dedite a’ piaceri del mondo siano pur anche le vittime delle loro più oneste affezioni” (SGM, p. 34). Il contadino potrà ammalarsi soltanto di una consunzione per così 6 Thomas Harvey Burgess, The Physiology or Mechanism of Blushing, London: J. Churchill, 1839, p. 65. 7 L’espressione ‘male inglese’, originariamente riferita alla generica ‘consunzione’, viene associata più specificamente alla malinconia, all’isteria o genericamente allo spleen dopo il 1733, anno di pubblicazione dell’influente opera di George Cheyne, The English Malady: or, a Treatise of Nervous Diseases of all Kinds, London: Strahan and Leake, 1733. Ma Rousseau nelle Confessioni accoglie ancora la confusiva sovrapposizione tra l’immaginario della malattia nervosa e quello della consunzione polmonare. Quando si reca a Montpellier per curarsi di una malinconia che lo “consuma” a dispetto del suo “sano torace” egli decide di darsi più credibilità facendosi passare per un inglese di nome Dudding. Inoltre, accanto ai sintomi della malinconia, egli ha anche un episodio di emottisi, riconducibile verosimilmente a un disturbo polmonare. Jean Jacques Rousseau, Les Confessions (1789), trad. it. di Valentina Valente, Le Confessioni, a cura di Andrea Calzolari, Milano: Mondadori, 1990, pp. 281, 316. 8 Samuel Auguste André David Tissot, Avis au peuple sur sa santé (1761), trad. it. di Giampietro Pellegrini, Avvertimenti al popolo sopra la sua salute, Venezia: Antonio Zatta, 1766, e Id., Essai sur les maladies des gens du monde (1770), trad. it. di C. Pompeati, Saggio intorno alle malattie a cui è soggetta la gente dedita a’ piaceri del mondo, Napoli: Gaetano Stampellani, 1771; i successivi riferimenti a questa edizione saranno segnalati con la sigla SGM. DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 183 dire di second’ordine, derivata cioè dalla degenerazione di una di quelle comuni e impoetiche “infiammagioni” che, come la peripneumonia, la pleurisia, il catarro e il raffreddore, costituiscono i soli “mali di petto” che trovano spazio tra le pagine dell’Avis au peuple sur sa santé (SGM, p. 54). È chiaro che ciò che spinge Tissot a sostenere – verosimilmente a dispetto della sua stessa esperienza clinica – l’immunità delle classi indigenti alla malattia polmonare è la sensazione di incompatibilità tra la tisi e il contadino o il povero, due categorie che agli occhi del medico svizzero paiono, per la loro inciviltà e insensibilità, egualmente prive di qualità eccezionali. Come sostiene nel 1785 anche il medico londinese Thomas Hayes, a perire per mano della tisi sono gli individui migliori della società, “gli uomini con i più grandi talenti” e “le donne dall’aspetto più attraente e la sensibilità più spiccata”,9 ciascuno colpito in ragione della particolare eccezionalità che esprime. Contrariamente a una simile distinzione di genere, tuttavia, nell’Ottocento si assiste a una universale insistenza sulla bellezza del malato di tisi, un fenomeno di cui peraltro le considerazioni di Rosenkranz in apertura ci hanno fornito una brillante esemplificazione. Che sia uomo o donna, in punto di morte il malato si trasforma in una creatura interessante e attraente: ogni accenno alla fisicità della sofferenza scompare dai tratti del volto, l’incarnato assume le sfumature di un pallore simile alla purezza infantile, gli occhi acquistano una lucentezza e un acume sconosciuti ai giorni della salute. Nei case histories presenti nei testi medici a partire dalla fine del XVIII secolo, il tributo alla ‘phthisical beauty’ finisce spesso per oscurare del tutto le pagine dedicate alla diagnosi o quelle rivolte alla terapeutica di questa malattia. Ora, proprio il significativo cambiamento che nel Settecento e soprattutto nell’Ottocento si fa subire all’antica facies hippocratica – che un testo del 1672 ritraeva ancora come “cadaverica, e livida, con un cerchio scuro bluastro o marrone intorno alle palpebre inferiori, gli occhi […] vuoti, piatti, rimpiccioliti, privi della loro naturale lucentezza” –10 può offrire lo spunto per una riflessione approfondita sui motivi che sostengono la rappresentazione della malattia polmonare come ‘angelo distruttore’ che sceglie con crudele precisione le proprie vittime. 9 Thomas Hayes, A Serious Address on the Consequences of Neglecting Common Coughs and Colds (1784), London: J. Murray, 1785, p. 61. 10 Gideon Harvey, Morbus Anglicus, or a Theoretick and Practical Treatise on Consumptions, and Hypochondriack Melancholy (1672), London: William Thackerai, 1674, p. 174. 184 / GRETA PERLETTI All’analisi della pervasiva insistenza sulla bellezza eterea del malato di tisi lo storico Philippe Ariès dedica una parte importante del proprio monumentale studio sulla storia delle rappresentazioni della morte in Occidente.11 Focalizzando il discorso sul XIX secolo, e servendosi di fonti eterogenee (diari, lettere, testamenti, biografie e romanzi) e di due campioni esemplari come le famiglie La Ferronays e Brontë, falciate entrambe dalla tubercolosi, Ariès individua nella costruzione dell’eccezionalità del malato il fattore che permette alla cultura ottocentesca di risolvere, attraverso la costruzione dell’ingigantita irripetibilità di chi muore, la propria angoscia nei confronti di una morte ormai privata dell’aura di familiarità e ‘naturalità’ del passato, e divenuta quindi incomprensibile e selvaggia. Il compromesso collettivo che mira alla trasformazione della morte in un’entità “patetica e bella” (UM, p. 726; per Ariès l’Ottocento è appunto “l’epoca delle belle morti”) si alimenta certamente anche di paralleli mutamenti nelle pratiche rituali e sociali (in particolare, lo spostamento dei morti fuori dalle città, con la conseguente fioritura della scultura funeraria e del culto dei cimiteri da parte dei sopravvissuti), ma individua la tappa fondamentale del cammino verso la cancellazione dell’angoscia proprio nel passaggio, favorito dalle morti per tisi, dal memento mori al memento illius. Promuovere una versione estetizzata del moribondo servirebbe così a nascondere l’orrore della morte dietro la copertura della capacità seduttiva della bellezza. Tuttavia, quando leggiamo le stesse fonti analizzate da Ariès nella sua argomentazione, pare difficile far scivolare la verità della morte all’ombra dell’eccezionalità del malato, poiché nel XIX secolo tutto, in coloro che soffrono di tisi, rimanda continuamente alla morte. Se vi è un elemento che accomuna tutti i ritratti estetizzati di questi malati – nella medicina come nei romanzi, nei diari privati di chi assiste la malattia di una persona cara come nel testo filosofico di Rosenkranz – esso può essere ravvisato nella presenza di un riferimento più o meno marcato all’impressione di spiritualizzazione che investe il malato. Chi attraversa le ultime fasi del male polmonare diviene oggetto di contemplazione estetica precisamente nel momento in cui il suo corpo si fa teatro della liminale compresenza della vita e della morte. Se torniamo a Rosenkranz, possiamo ricordare come la percezione della bellezza nell’etisia scaturisse dalla visibilità dello spirito garantita dall’assottigliamento ‘trasparente’ di un corpo già proiettato nella ‘morbi11 Philippe Ariès, L’homme devant la mort (1977), trad. it. di Maria Garin, L’Uomo e la Morte dal Medioevo a oggi, Roma-Bari: Laterza, 1980 (d’ora innanzi, UM). DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 185 dezza’ della morte. Il critico letterario John Middleton Murry, cui spetta nelle edizioni del Diario della moglie Katherine Mansfield l’ultima parola sull’esistenza della scrittrice, descrive le ultime ore della donna suggerendo che la perfezione estetica operata nel suo aspetto dalla tisi discenda direttamente dalla morte, tanto che “per questa purificazione, aveva perduto la vita”.12 In modo simile, nel ritratto di Smike morente nel romanzo Nicholas Nickleby (1839) di Charles Dickens, che fa della tisi la malattia che più di ogni altra affina la vittima mescolando in modo inquietante la vita con la morte,13 riecheggiano e trovano un modello innumerevoli simili quadri presenti nei casi clinici ottocenteschi.14 Sembra dunque essere la visibilità della morte, piuttosto che la sua cancellazione, a creare le premesse per la percezione estetica della tisi, e a evocare il diffuso interesse dimostrato dalla cultura ottocentesca per la malattia polmonare. Del resto, Ariès stesso si sofferma sulla fortissima, ambivalente fascinazione che la cultura ottocentesca avverte per la visibile contaminazione tra la vita e la morte. Nella moltitudine di testimonianze relative all’ossessione collettiva per la morte apparente, si registra secondo lo storico francese un significativo mutamento nella valutazione della morte, che oltre a suscitare orrore per la sua alterità selvaggia viene per la prima volta associata ai medesimi discorsi che riguardano il sesso, diventando così oggetto, oltre che di timore, anche di un’inspiegabile tensione erotica.15 12 “Non ho mai visto né vedrò mai un essere più bello di lei, in quel giorno. […] l’ultimo granello di ‘zavorra’, le ultime ‘tracce di degradazione terrena’, si erano staccate da lei per sempre. Ma per questa purificazione, aveva perduto la vita”. Katherine Mansfield, Journal (1927), trad. it. di Mara Fabietti, Diario, Milano: Dall’Oglio, 1988, p. 508. 13 “Vi è una temibile malattia che a tal punto prepara, per così dire, la sua vittima alla morte; che a tal punto la ripulisce degli elementi più volgari […] che giorno dopo giorno, e pezzo dopo pezzo, la parte mortale si consuma e si raggrinzisce; […] una malattia in cui vita e morte sono così bizzarramente mescolate, che la morte assume la lucentezza e il colorito della vita, e la vita la scarna e sinistra forma della morte”. Charles Dickens, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (1839), London: Penguin, 1999, p. 601. 14 Tra gli innumerevoli, menzioniamo brevemente il ritratto di phthisical beauty del medico londinese John Armstrong: “l’occhio ha un aspetto lucente e brillante; e un’espressione di interesse, addirittura di bellezza viene non di rado conferita all’intero aspetto, un fenomeno particolarmente evidente in persone il cui volto era prima insignificante [plain]”. John Armstrong, Practical Illustrations of the Scarlet Fever, Measles, Pulmonary Consumption, and Chronic Diseases, London: Baldwin, Cradock and Joy, 1818, p. 256. 15 “La gravità del sentimento della morte, che aveva coesistito con la familiarità, si trova a sua volta ad essere intaccata: si giocano con la morte giochi perversi, fino ad andare a letto con lei. Si è stabilito un rapporto tra la morte e il sesso; perciò essa esercita un fascino, un’ossessione come il sesso; indizi di un’angoscia senza nome” (UM, p. 475). 186 / GRETA PERLETTI La drammatica ‘evidenza’ della possibile compresenza della vita e della morte, esibita in maniera emblematica nella morte apparente e nel malato di tisi ‘spiritualizzato’, e il sentimento di ambivalente fascino e orrore che ne deriva, vengono da Ariès confinati (con un’operazione di drastica riduzione della loro complessità e diffusione)16 entro i limiti della parentesi – che lo storico stesso definisce “limitata, scongiurabile, che non si estende all’intero mito” (UM, p. 476) – rappresentata dalla paura per la sepoltura prematura negli anni a cavallo tra il secolo XVIII e il XIX. Al di là di questo ambito definito e circoscrivibile, lo studio di Ariès ipotizza un processo di progressivo allontanamento della vita dalla morte, che viene dimenticata attraverso un immotivato investimento estetico (nell’Ottocento, con la finzione della morte bella) o ripudiata tramite l’imperativo del silenzio (nel Novecento, con il sentimento di vergogna e pudore che circonda il discorso sulla morte). Nella sua tensione verso una ‘teleologia negativa’ che dispieghi la progressiva degenerazione dell’atteggiamento umano dinanzi alla morte – da una sana familiarità a un patologico ripudio –17 l’opera di Ariès non coglie le ricche potenzialità sprigionate nell’Ottocento da quella problematica mescolanza di vita e morte che la tisi non si limita ad esibire sui volti morenti delle sue vittime, ma che essa ha in un certo senso reso possibile – e irresistibile – percepire. Sono infatti le ricerche sulla tisi a contribuire in misura significativa a quella rivoluzione epistemologica che Foucault individua nella nascita dello sguardo anatomo-clinico, caratterizzato da una paradossale coincidenza del sapere sulla morte e di quello sull’individuo.18 Sulle modalità di affermazione di un simile mutamento nella concezione dei rapporti tra la vita e la morte 16 Il rifiuto dell’interpretazione psicoanalitica del fenomeno è probabilmente all’origine di questa riduzione: nel volume di Ariès non vi è neppure un riferimento a Freud, che considera la morte apparente, per la sua natura di rovescio della fantasia della vita prenatale nel grembo materno, una importante fonte di perturbante. Sigmund Freud, “Das Unheimliche” (1919), trad. it. di Silvano Daniele, “Il Perturbante”, in Id., Saggi sull’arte la letteratura il linguaggio, Torino: Bollati Boringhieri, 1991, p. 297. 17 Si vedano a questo proposito le riflessioni di Jonathan Dollimore, Death, Desire and Loss in Western Culture (1998), London: Penguin, 1999, alle pp. 120 sgg. 18 Per Foucault il movimento di progressivo avvicinamento tra la clinica e l’anatomia patologica inaugura un intreccio discorsivo tra la morte e l’individuale: “conoscere la vita è dato solo a questo sapere crudele, riduttore e già infernale che la desidera solamente morta. […] [La morte] è […] costitutiva di singolarità; solo in essa l’individuo si realizza”. Michel Foucault, Naissance de la Clinique. Une Archéologie du regard médicale (1963), trad. it. Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, a cura di Alessandro Fontana, Torino: Einaudi, 1998, p. 185 (d’ora innanzi, NC). DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 187 – un mutamento che, come vedremo, incide in maniera significativa sull’immaginario ottocentesco – conviene soffermarsi più diffusamente. Il ‘morboso interessante’ e la nascita dell’individuo ‘polmonare’ Che la vita e la morte non possano più essere concepite come due categorie ontologicamente distinte è evidente nei discorsi della medicina occidentale sin dalle ultime decadi del XVIII secolo. L’enorme attenzione riservata in tutta Europa, ma soprattutto in Inghilterra e in Germania, a un testo come gli Elementa Medicinae dello scozzese John Brown, pubblicato nel 1780 e caratterizzato per molti versi da una disarmante ingenuità, viene dagli storici della medicina ascritta all’innovativa abolizione, promossa da quest’opera, della diversità ‘essenziale’ dei fenomeni della vita e della malattia.19 Secondo Brown, la vita consiste in una incessante reazione agli stimoli che provengono dall’esterno e mirano alla sua dissoluzione; in questo processo dialettico di resistenza alla ‘non-vita’ che ispirerà la Naturphilosophie del romanticismo tedesco, la malattia insorge quando la risposta dell’organismo è eccessiva o all’opposto insufficiente. Di qui la riduzione di tutte le malattie esistenti in due soli gruppi, le ‘steniche’ e le ‘asteniche’, e di qui, soprattutto, la radicale proposta di considerare la salute e la malattia come due varianti solo quantitativamente diverse di un medesimo fenomeno. Nell’impossibilità di concepire la vita se non nell’opposizione a ciò che tende alla sua negazione, il sistema medico di Brown impone così all’immaginario non solo scientifico dell’Occidente la fondamentale immanenza della morte rispetto alla vita. Ciò che accade all’inizio dell’Ottocento a Parigi muta però in modo ancora più significativo la percezione del rapporto tra la vita e la morte. La controversa ‘riscoperta’ tardo-settecentesca dell’anatomia patologica, che come ricorda Foucault era in realtà praticata sin dal Rinascimento ma veniva considerata uno strumento di quella ‘sorella inferiore’ della medicina che era la chirurgia, è resa possibile da un cambiamento di prospettiva operato dalla clinica classica nei confronti delle potenzialità epistemologiche riconosciute al cadavere. Mentre nella concezione tradizionalmente clinica della malattia l’autopsia non può avere valore gnoseologico, poiché l’immobilità della morte nulla dice rispetto a una malattia intesa come dispiegamento temporale di una sequenza di sintomi, le innovative 19 Sull’influenza del pensiero di Brown nella medicina occidentale, si veda Brunonianism, numero speciale di Medical History (8, 1988), a cura di Roy Porter e Walter F. Bynum. 188 / GRETA PERLETTI ricerche di Xavier Bichat, Gaspard Laurent Bayle e René Théophile Laënnec presuppongono uno sguardo medico che non può dirsi ‘scientifico’ se non si appropria della lezione anatomica: al medico non è dato di riconoscere la malattia del paziente se non sa percepire l’interno del corpo vivo con la medesima chiarezza che gli si offre nell’apertura cadaverica. Nasce così un tipo di conoscenza che si serve di uno sguardo contaminato dalla morte per fondare la profondità dell’individuo. Mentre nella salute è la superficie esterna del corpo a trattenere lo sguardo, rendendo opaca e impenetrabile la visione dell’interiorità, la presenza della malattia invita l’occhio a un esercizio di scavo che “ha il potere di portare alla luce una verità che accoglie solo nella misura in cui le ha dato vita” (NC, p. 7). Guidato dalla luce chiarificatrice dell’apertura cadaverica, lo sguardo solleva, strato dopo strato, tutti quei veli che, opponendosi solo in apparenza alla vista ‘scientifica’, di fatto fondano non soltanto la profondità nascosta al di là della superficie visibile, ma anche la natura assolutamente veritiera e interessante di ciò che da quella profondità emerge. Da ciò deriva il nuovo statuto della malattia polmonare nella medicina di inizio secolo: dissimulando la propria presenza negli anfratti più inaccessibili del corpo, la tisi diventa il ‘segreto’ dell’individuo, la macchia interiore il cui reperimento diventa oggetto di un’irresistibile operazione di conquista. Grazie all’orizzonte di visibilità fornito dall’anatomia patologica, diventa possibile per Jean Nicholas Corvisart, medico personale di Napoleone e professore onorario di medicina clinica alla Scuola di Parigi, imporre all’attenzione europea, insieme alla validità clinica della percussione,20 soprattutto il potere scopico garantito al ‘segno’ che dalla percussione si produce. Si origina così, oltre alla validità diagnostica riconosciuta all’auscultazione del paziente, anche la supremazia scientifica del segno prodotto nel corpo dall’arte medica rispetto al sintomo riportato dal malato. Opposto all’opacità “infedele” dei sintomi, il segno profondo della percussione diventa la “vera luce” che rivela “il reale stato degli organi del petto”:21 a occhi esercitati a “disegnare in filigrana la futura autopsia” 20 Il metodo della percussione del torace del paziente era stato proposto nel 1761 da Leopold Auenbrugger, ma la sua proposta viene ignorata fino alla riscoperta di questo metodo promossa a inizio Ottocento da Corvisart. Foucault motiva il ritardo nella diffusione del testo di Auenbrugger con la ‘scandalosa’ preminenza del segno sul sintomo. Cfr NC, pp. 172-76, e John O’Neal, “Auenbrugger, Corvisart, and the Perception of Disease”, Eighteenth-Century Studies, 31:4, estate 1998, pp. 473-89. 21 Jean Nicholas Corvisart, “Sur la percussion de la poitrine” in AA.VV., Enciclopédie des Sciences Médicales, Paris: Bureau de l’Enciclopédie, 1848, p. 198. DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 189 (NC, p. 176) si apre insomma il mondo complesso e solo in apparenza imperscrutabile dell’interiorità individuale. Come ricorda Bichat, le funzioni degli ‘invisibilmente visibili’ cuore e i polmoni sono, “se mi è consentito usare quest’espressione, il termometro dell’anima”.22 A partire da queste considerazioni sulla natura veritiera del segno prodotto dalla percussione, Laënnec spinge a un’interpretazione ancora più radicale la simultanea coincidenza del discorso della morte e di quello dell’individualità. Egli infatti combina le osservazioni di Corvisart con la lezione di Gaspard Laurent Bayle, che durante la discussione della propria tesi di laurea scandalizza gli autorevoli maestri della commissione (tra cui figurava Philippe Pinel nel ruolo di presidente)23 con la sua concezione della tisi come ontologicamente inscindibile dalla lesione polmonare. Facendo propria l’intuizione di Bayle che non vi è tisi se non vi è ferita nel polmone, Laënnec rivoluziona la concezione clinica della malattia, e annette la morte al centro stesso dell’individualità. Mentre in Bichat e in Corvisart è ancora riconoscibile una certa fedeltà alla clinica classica, poiché la morte si pone come l’orizzonte di visibilità che consente di rintracciare il ‘segreto’ di una malattia che continua a essere caratterizzata da un decorso clinico ancora fondamentalmente ‘essenziale’, Laënnec individua nei tubercoli la forma con cui la morte non soltanto si attualizza nella vita, ma diventa responsabile dei fenomeni patologici che nella vita si registrano. Si tratta di un mutamento epistemologico significativo, destinato a cambiare non solo la diagnostica, ma anche la nosologia tradizionale: da causa prossima o effetto secondario della malattia, come era nella clinica tradizionale, l’alterazione polmonare si trasforma nel principio originario da cui si irradiano successivamente tutti i sintomi, facendo così della morte non soltanto la conferma ma anche – con un cruciale cambiamento di prospettiva – la ragione stessa di quel segreto profondo che è la tisi. L’uso dello stetoscopio, scoperto e proposto appunto da Laënnec nel suo Traité de l’Auscultation Médiate (1819), si rivela come il sistema più efficace per la produzione di segni “nuovi, sicuri, per lo più salienti”:24 la 22 Marie François Xavier Bichat, Recherches Physiologiques sur la Vie et la Mort (1800), Paris: Brosson, 1805, p. 302. 23 Si veda il saggio di Mirko D. Grmeck “La discussione della tesi di Gaspard-Laurent Bayle. Atto di fondazione della scuola anatomo-clinica parigina”, BioLogica, 2-3, 1989, pp. 29-38. 24 René Théophile Hyacinthe Laënnec, Traité de l’Auscultation Médiate (1819), Bruxelles: Culture et Civilisation, 1968, vol. 1, p. 8. 190 / GRETA PERLETTI voce che pare “uscire direttamente dal petto”25 illumina26 caverne, escavazioni, intasamenti, componendo in un unico movimento la localizzazione spaziale e l’estensione diacronica della malattia. Ma l’insistenza con cui Laënnec istruisce il proprio pubblico relativamente alla precisione e all’abilità tecnica necessarie per cogliere la relazione biunivoca tra il segno e la mappatura spazio-temporale della lesione ci consente anche di riconoscere un corollario importantissimo di questa nuova centralità epistemologica della morte. Quando il medico parigino si profonde nei dettagli della descrizione dei segni, accogliendo nella sua spiegazione metafore e paragoni desunti dal mondo naturale – il rantolo “secco sonoro” assomiglia tanto al verso di una tortorella da far credere al medico che il paziente ne nasconda una sotto il letto; le dimensioni dei tubercoli al primo stadio sono comprese tra quelle di un grano di miglio e di un grano di canapa –27 il suo linguaggio ci mostra l’avvenuto passaggio da una concezione ‘essenziale’ della malattia a una ‘individuale’. Nella sua apertura a una nuova “raffinatezza qualitativa, sempre più concreta, più individuale, più modellata” (NC, p. 183), il linguaggio di Laënnec sfida l’aristotelica indegnità scientifica dell’individuo, sostituendo all’insignificanza attribuita alla variante individuale nella tradizione essenziale della malattia la assoluta necessità di una lettura differenziale dei casi. Al vecchio motto scolastico che insegnava che “Individuum est ineffabile”,28 Laënnec contrappone insomma il concetto di ‘vita patologica’, una morte-in-vita che non è dicibile se non entro la rubrica dell’individualità attualizzata. Le ricerche sulla tisi di Laënnec presuppongono dunque un rapporto non di semplice simultaneità, ma di vera dipendenza, tra il sapere sull’individuo e quello sulla morte. La visibilità della morte trasforma il tisico, nelle parole di Foucault, in “uomo […] ‘polmonare’” (NC, p. 186) proprio perché lo rende riconoscibile come individuo profondo e interessante. Il legame della tisi con l’individualità interessante – un legame che ri25 Ivi, p. 17. In questo senso l’etimologia del termine ‘stetoscopio’ (‘vedere il torace’) pare in perfetta sintonia con il panorama epistemologico che lo fa nascere e che privilegia, appunto, la vista rispetto agli altri sensi; stupisce la meraviglia di autori come lo storico Thomas Dormandy, che considera la scelta del sostantivo stetoscopio una “definizione non appropriata [a misnomer] poiché significa solo ‘esame visivo’”. Thomas Dormandy, The White Death: A History of Tuberculosis, London-Rio Grande: Hambledon Press, 1999, p. 33. 27 René Théophile Hyacinthe Laënnec, op. cit., vol. 2, p. 3 e vol. 1, p. 21. 28 Cit. in Carlo Ginzburg, “Spie. Radici di un paradigma indiziario” (1979), in Id., Miti, emblemi, spie, Torino: Einaudi, 1986, p. 171. 26 DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 191 sulta fondante nell’analisi delle metafore della tubercolosi svolta da Susan Sontag nel celebre saggio Malattia come metafora –29 si origina dunque nella medicina grazie alla vicinanza con la morte, e questo ci permette di avanzare una spiegazione dell’eccezionalità del malato alternativa rispetto a quella suggerita da Ariès. Lo storico francese non si chiede perché l’ossessiva estetizzazione del malato riguardi in maniera pressoché esclusiva persone affette da tisi, ma alla luce dell’analisi dei discorsi medici relativi al male polmonare si può forse ipotizzare che la centralità di questa malattia dipenda dalla sua capacità di promuovere il passaggio non tanto dall’orrore della morte alla perfezione del malato, quanto piuttosto da una morte intesa come “falce, che livella tutte l’erbe del prato”30 a una morte che invece è incaricata di dar forma all’individuale. All’irrilevanza ‘macabra’ dell’individuale nelle malattie ‘essenziali’ si sostituisce insomma la modulazione necessariamente individuale del ‘morboso’,31 una modulazione che costituisce peraltro la probabile spiegazione della lunga fortuna della tisi come malattia ereditaria e non infettiva. Sebbene alcuni autori di trattati medici sulla tisi avessero avanzato l’ipotesi della contagiosità della tisi tra XV e XVII secolo,32 nel Settecento e fino a tutta la prima metà dell’Ottocento la proposta di trasferire la specificità della malattia dalle peculiarità individuali della costituzione del malato a un agente patogeno capace di colpire indiscriminatamente viene per lo più tacciata di ignoranza e superstizione. Le lettere di John Keats e di George Sand (che assiste Chopin nelle fasi terminali della malattia) sono fitte di indignati riferimenti all’assurda paura mostrata dal popolo italiano nei confronti della trasmissibilità della malattia polmonare; e gli stessi Bay29 “Fu con la tbc che venne chiaramente formulata l’idea della malattia individuale […]. La malattia era un modo per rendere una persona ‘interessante’ – che era la definizione originaria del ‘romantico’”. Susan Sontag, Illness as Metaphor (1977), trad. it. di Ettore Capriolo e Carmen Novella, Malattia come metafora, Torino: Einaudi, 1992, p. 30. 30 Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, Torino: Einaudi, 1960, p. 558. 31 “[I]l Macabro implicava una percezione omogenea della morte, una volta varcata la sua soglia. Il Morboso autorizza una percezione sottile del modo in cui la vita trova nella morte la sua figura più differenziata.” (NC, p. 185). 32 I più noti sostenitori della possibile natura infettiva della tisi sono Fracastorio nel Rinascimento e Sylvius nel XVII secolo. Per la ricostruzione delle posizioni a favore della trasmissibilità della tisi nel XVII e XVIII secolo, e delle resistenze che a questa teoria vengono mosse, rimandiamo al classico lavoro storico di René e Jean Dubos, The White Plague: Tuberculosis, Man, and Society (1952), New Brunswick-London: Rutgers University Press, 1987, pp. 28-33, e allo studio di Charles Coury, Grandeur et déclin d’une maladie. La tuberculose au course des âges, Suresnes: Lepetit, 1972, pp. 104-10. 192 / GRETA PERLETTI le e Laënnec periscono entrambi di tisi senza sospettare che il contatto con i pazienti possa aver contribuito all’insorgere della loro malattia. Ciò che appare inaccettabile nella concezione infettiva della malattia è proprio la negazione dell’individualità interessante che il contagio presuppone. Concetti come l’ereditarietà e la diatesi si configurano allora – fino alle soglie di quel cruciale 1882 che segna, con la scoperta del bacillo da parte di Robert Koch, l’inizio di un radicale mutamento di segno nelle metafore mediche della tubercolosi –33 come gli ultimi baluardi che la medicina ottocentesca erge a difesa del potere individualizzante attribuito alla tisi per la sua capacità di fare intravedere quel ‘morboso’ che la medicina stessa ha costruito come ‘interessante’. È proprio questo sodalizio tra la tisi e l’individualità interessante a favorire la trasformazione della malattia polmonare da ‘mal sottile’ a ‘mal gentile’, con la trasfigurazione del sintomo della magrezza in un superiore affinamento spirituale prodotto nel contatto con la morte. Nella celebrazione della bellezza tisica trapela così anzitutto la funzione di ‘segno’ attribuita alla spiritualizzazione del malato: essa ha il potere di certificare in maniera inequivocabile, con la sua mera presenza, l’appartenenza a una gens elitaria, la cui aristocrazia si misura meno sui diritti di sangue che sul valore tutto borghese dell’individualità speciale. Nell’ultima parte di questo saggio, vorremmo rivolgerci alle riflessioni evocate nell’immaginario culturale dal riconoscimento del valore ‘gentile’ della malattia polmonare, per soffermarci sulle luci e le ombre generate da un simile affidamento della convalida dell’individualità interessante al discorso della morte. Le ambiguità del mal gentile: tra spiritualità e spettralità In una breve novella del 1910, Luigi Pirandello individua il dramma dei fratelli Annibale e Marco nella minaccia che, sotto le spoglie della tisi che ha già sterminato l’intera loro famiglia, incombe sulle loro esistenze.34 La 33 Da malattia individualizzante, la tubercolosi diviene lo stigma degli strati più poveri della società, il simbolo di una degenerazione sociale che può essere trasmessa per contagio o per ereditarietà. Rimandiamo a Linda Bryder, Below the Magic Mountain: A Social History of Tuberculosis in Twentieth-Century Britain, Oxford: Clarendon, 1988; Barbara Bates, Bargaining for Life: A Social History of Tuberculosis, 1876-1938, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992; Sander Gilman, “Tuberculosis as a Test Case” in Id., Kafka, the Jewish Patient, New York-London: Routledge, 1995, pp. 169-228. 34 Luigi Pirandello, “L’uccello impagliato” (1910) in Id., Novelle per un anno, Milano: Mondadori, 1990, vol. 1, pp. 363-73. DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 193 novella narra il tentativo dei due protagonisti di sottrarsi a un destino che parrebbe già segnato, ma il rigoroso rispetto di un regime di vita depurato da ogni eccesso concede almeno all’assennato primogenito Marco una apparente vittoria sulla malattia (Annibale invece, cedendo alla tentazione proibita dell’amore, cade vittima della consunzione). Il titolo di questa novella, “L’uccello impagliato”, fa riferimento a un grottesco oggetto che, caro a Marco negli anni della sua lotta alla malattia, viene dall’uomo distrutto quando, credendo di aver vissuto abbastanza e essendosi dunque risolto ad abbandonare i propri modi frugali, egli viene sopraffatto dalla mancata comparsa del proprio personalissimo nemico e, in maniera in apparenza inspiegabile, si suicida. Nella centralità riconosciuta nel titolo della novella all’uccello impagliato, con la sua problematica compresenza della vita e della morte, si condensa la ricca congerie di significati assegnati alla tisi nell’immaginario. Quando l’illusione della vittoria sulla malattia si rivela a Marco nella sua natura di mero differimento della morte, l’uomo non riesce a sostenere la vista dell’uccello impagliato: distruggendone l’imbottitura, egli mira soprattutto alla liberazione dall’inquietudine suscitata dalla morte-in-vita di cui l’oggetto è emblema. Allo stesso modo, la malattia polmonare, attraverso l’esibizione di un’avvenenza che poggia sulla spiritualizzazione, costringe a un equilibrio precario quel tipo di percezione estetica: la magrezza e il pallore diventano in quest’ottica non soltanto leggiadri, ma anche spettrali, e l’aspetto etereo del tisico può rovesciarsi nella sinistra supposizione che la vita in questi individui sia soltanto apparente. Gli studi sul folklore registrano, soprattutto nella regione del New England, casi di identificazione popolare del malato tubercolare con il morto-vivo,35 e a quest’interpretazione non sono peraltro estranei neppure alcuni testi medici, se fino alla metà del Settecento si poteva trovare in un’autorità come van Swieten il vampiresco rimedio di far coricare il malato accanto a “giovani ragazze ben fresche e sane” affinché potesse assorbirne quasi osmoticamente la salute.36 Nella sua condizione liminale tra il discorso sulla vita e quello sulla morte, l’‘individuo polmonare’ entra a far parte di quella costellazione di fenomeni, esperienze e figure che, soprattutto nella forma del vampiro, recepisce quel sentimento di “ambivalenza 35 Si vedano gli episodi che, sulla base dei risultati di ricerche di tipo antropologico, vengono citati in Thomas M. Daniel, Captain of Death: The Story of Tuberculosis, Rochester: Rochester University Press, 1997, pp. 166-74. 36 Cit. in Charles Coury, op. cit., p. 132. 194 / GRETA PERLETTI affettiva”37 connaturato allo straniamento perturbante dell’originaria funzione di “assicurazione di sopravvivenza”38 richiesta al doppio. Non stupisce che nella figura dell’artista tisico gli effetti di simili riflessioni si amplifichino a dismisura. La malattia polmonare si presta infatti, in virtù della duplice connotazione di spiritualità e spettralità riconosciuta alla sua sintomatologia, a rimandare come in un infinito gioco di specchi le ambiguità implicite nella vicinanza metaforica tra l’artista e il vampiro. Tanto il motivo dell’artista come “parassita psichico”39 che sfrutta le energie altrui per riversarle nella propria opera quanto, all’opposto, quello della vampirizzazione delle forze umane operata dal lavoro creativo, sono generati dall’attribuzione all’arte di un potere paradossalmente ‘individualizzante’, e per questo motivo particolarmente affine alla disturbante eccezionalità del mal gentile. Non diversamente dalla sinistra ‘elezione’ concessa all’uomo ‘polmonare’ dal tocco della morte, l’ingresso nel mondo dell’arte comporta sia un’elevazione spirituale sia una condanna spettrale, come dimostra la circolarità inestricabile che si crea nel XIX secolo tra i motivi intrecciati della genesi morbosa della creatività da un lato e della morbogenesi dovuta alla creatività dall’altro. Questa duplice azione del processo artistico si ritrova in una lettera che il poeta John Keats scrive mentre sta assistendo il fratello Tom, affetto da consunzione polmonare (la lettera è del 1818, e precede quindi di due anni l’episodio di emottisi che rivelerà al poeta di aver contratto la medesima malattia): Vorrei poter dire che Tom sta un po’ meglio. Durante tutto il giorno, la sua identità grava su di me così tanto che sono costretto a uscire – e sebbene mi fossi ripromesso di dedicare qualche tempo solo allo studio sono costretto a scrivere, e a immergermi in immagini astratte per liberarmi dell’aspetto, della voce, della debolezza di Tom – con il risultato che [so that] ora vivo in una febbre continua – deve essere come veleno per la vita, anche se mi sento bene.40 37 L’espressione, mutuata da Totem e Tabù di Freud, viene ripresa da Serpieri per spiegare in chiave psicoanalitica le ragioni della persistenza della figura del vampiro nell’immaginario occidentale. Alessandro Serpieri, “Il mito del vampiro tra l’immaginario antropologico e l’immaginazione letteraria” in Ada Neiger (a cura di), Il vampiro, Don Giovanni e altri seduttori, Bari: Dedalo, 1998, p. 147. 38 Sigmund Freud, op. cit., p. 287. 39 James B. Twitchell, The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature, Durham: Duke University Press, 1981, p. 142. 40 John Keats, The Letters of John Keats, 1814-21, a cura di Hyder Edward Rollins, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1958, vol. 1, pp. 368-69. DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 195 Il ricorso alla scrittura, inizialmente motivato da un impulso che spinge il poeta a creare un argine ‘simbolico’ alla minaccia di contagio psichico rappresentata dalla sofferenza del fratello, si carica invece di una valenza patogena, che trasforma il ‘rimedio’ in un ‘veleno’. L’uso alquanto inaspettato della seconda proposizione consecutiva di questo brano salda in una concatenazione strettissima i due volti di questa arte-pharmakon, che si configura tanto come una ‘spirituale’ rielaborazione provocata da un incipiente processo morboso (dalla pressione dell’identità del fratello al contatto con le immagini astratte) quanto come uno ‘spettrale’ agente di disorganizzazione organica (la febbre). Per questa paradossale coincidenza di elevazione e condanna che ripropone nel processo del ‘divenire-artista’ la medesima compresenza di vita e morte associata all’orizzonte metaforico della malattia polmonare, la morte per tisi finisce con l’essere identificata con la realizzazione della morte dell’io necessaria alla superiore affermazione dell’arte. L’affinamento graduale assicurato dalla spiritualizzazione del ‘mal gentile’ sembra confermare la paradossale convinzione che la rinuncia al sé sia la condizione dell’accesso a una più alta dimensione dell’esistenza. Nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia, Hegel sostiene che la morte per consunzione di Spinoza sia “in accordo perfetto con il suo sistema, all’interno del quale pure ogni singolarità, ogni individualità scompare [verschwindet] nell’unica sostanza”.41 Una simile associazione tra la tisi e una sorta di ideale cupio dissolvi dell’individualità in un superiore elemento trascendentale è particolarmente incoraggiata dalla lingua tedesca, in cui il termine stesso di consunzione, Schwindsucht, porta inscritto letteralmente l’anelito (Sucht) verso la perdita del sé (schwinden, ‘scomparire’). Nei racconti Il Monaco Nero (1894) di Anton Čechov e Sebastian van Storck di Walter Pater (1897) la consunzione dei due protagonisti li spinge verso uno schopenhaueriano abbandono del principium individuationis, necessario per trasformarli in ‘soggetti conoscenti puri’. Per Kòvrin come per Sebastian, il raggiungimento di una soggettività speciale, che li innalzi al di sopra degli uomini comuni, è inseparabile dall’azione della malattia della creatività. La tisi di Kòvrin realizza quel graduale assottigliamento del corpo anticipato dal monaco nero, oggetto della follia allu41 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (1833), trad. it. di Ernesto Codignola e Giovanni Sanna, Lezioni sulla Storia della Filosofia, Firenze: La Nuova Italia, 1964, vol. 3, p. 106. 196 / GRETA PERLETTI cinatoria del protagonista, come vera conditio sine qua non per una autentica comprensione del mondo: “tu hai sacrificato la tua salute all’idea, ed è prossimo il tempo in cui le sacrificherai anche la vita. Che c’è di meglio? È ciò cui tendono tutte le nature nobili che il cielo ha altamente dotate”.42 In modo simile, l’aspirazione di Sebastian verso l’ideale contemplativo dell’“unica mente assoluta” viene definita esplicitamente dal narratore “passione di Schwindsucht – noi non possediamo la parola equivalente”,43 e questa “consunzione intellettuale” alleata alla “vena di mal sottile fisico” (SS, p. 121) di Sebastian è intrecciata diffusamente all’isotopia dell’acqua,44 rafforzando l’impressione di scioglimento garantita dall’elemento che, nelle parole di Bachelard, “dissolve nel modo più completo. Ci aiuta a morire totalmente”.45 L’idea che la tisi possa sancire la celebrazione della soggettività artistica nel momento in cui viene promossa la morte del sé non è scevra, come è intuitivo immaginare, di risvolti ‘spettrali’. La conclusione di entrambi i racconti è in questo senso emblematica: colto dalla morte, Kòvrin dimostra una gioia velata dal terrore, che proietta un’ombra sinistra sulla genialità che l’uomo ritiene di aver raggiunto (MN, p. 316). Secondo una logica simile, Sebastian si fonde con l’amato mare d’Olanda solo quando tenta di salvare la vita di un bambino, emblema di quella particolarità finita e accidentale che costituiva nel suo sistema filosofico il maggiore impedimento alla contemplazione trascendentale (SS, pp. 113-14). Ma è soprattutto nell’alterità riconosciuta dagli altri personaggi ai protagonisti di questi due racconti – considerati l’uno temibile per una incontrollabile follia (MN, p. 310), l’altro sospettabile di una oscura cospirazione politica (SS, p. 110) – che è possibile intravedere come, a fine secolo, la dipendenza dell’individualità dalla morte si colori di toni sinistri. L’aspirazione 42 Anton Čechov, “Čërnyj Monách”, trad. it. di Agostino Villa, “Il Monaco Nero”, in Id., I racconti, Torino: Einaudi, 1994, vol. 2, p. 299 (d’ora innanzi, MN). 43 Walter Pater, “Sebastan van Storck”, trad. it. in Ritratti Immaginari, a cura di Mario Praz, Milano: Adelphi, 1980, p. 105 (d’ora innanzi, SS). 44 Quando il narratore menziona la predisposizione alla tisi del giovane Sebastian, ricorda che essa avrebbe potuto essere ovviata “se un altro accidente avesse fissato la sua dimora tra i monti invece che sulla riva” (SS, p. 121). Poco oltre, il medico di Sebastian esprime l’opinione che la consunzione sia legata al suolo olandese, per la presenza di “acque, egli osservava, non al loro posto, ‘al di sopra del firmamento’” (SS, p. 123). 45 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière (1942), trad. it. di Marta Cohen Hemsi e Anna Chiara Pedruzzi, Psicanalisi delle acque, Como: RED, 1992, p. 72. DAL MAL SOTTILE AL MAL GENTILE / 197 alla morte-in-vita dell’arte rischia infatti di venir confusa con l’interesse morboso per quell’annullamento della vita che il discorso della degenerazione non esiterà a identificare con l’atteggiamento debole e rinunciatario che caratterizza l’arte del ‘tramonto delle nazioni’. In questa prospettiva, si può forse spiegare anche la violenza del ‘tuono’ che chiude, in maniera abbastanza sorprendente, il capolavoro La Montagna Incantata (1924) di Thomas Mann, il testo che, pubblicato dopo una gestazione decennale, può considerarsi l’ultima riflessione sull’individualità ‘morbosamente interessante’ del malato di tisi. Certo non è possibile in questa sede rendere ragione della ricchezza ermeneutica dell’opera di Mann, ma si può forse suggerire che alla Bildung di Hans Castorp non sia estranea la consapevolezza della dipendenza dell’individualità speciale dalla morte. Quando il giovane ingegnere apprende, dopo una frettolosa auscultazione, dell’esistenza nei suoi polmoni di un ‘punto molle’, l’ambivalente reazione del suo “cuore […] dolorante di una gioia e una speranza mai conosciute prima”46 registra già la natura paradossale dell’eccezionalità che ha scoperto di possedere. Ma è soprattutto la successiva esperienza della radiografia a farlo pervenire all’intuizione che l’improvvisa evidenza della profondità interiore – che egli scruta con un “travolgente piacere dell’indiscrezione” e insieme un senso “di commozione e devozione religiosa” (MI, p. 202) – dipende dall’adozione di uno sguardo che osserva “in anticipo […] la futura opera di decomposizione” (MI, p. 203) del suo stesso corpo. La “libertà” che, come segnala il paragrafo successivo a questa rivelazione, deriva dall’ingresso ‘da paziente’ nel sanatorio è in fondo identificabile con la decisione di esplorare le potenzialità ‘individualizzanti’ del ‘morboso’. In questo senso, l’‘incremento’ che nel viaggio spiritual/spettrale di Castorp viene raggiunto, all’insegna di un placet experiri che fa rifiutare al giovane anzitutto la scissione tra la vita e la morte proposta, con movimento uguale e contrario, dai due pedagoghi, è legato all’attraversamento quasi nietzscheano della morte emblematizzato nell’episodio “Neve” (MI, p. 437-65). E tuttavia il culto dell’individualità ‘geniale perché morbosa’, già minata dai divertiti commenti della voce narrante sul controverso valore dell’otium della montagna, subisce un drastico arresto con l’irruzione della guerra alla fine del romanzo. 46 Thomas Mann, Der Zauberberg, trad. it. di Ervino Pocar, La Montagna Incantata, Milano: Corbaccio, 1992, p. 170 (d’ora innanzi, MI). 198 / GRETA PERLETTI Posta al vaglio dell’imperativo dell’azione, la validità del modello del ‘morboso interessante’ viene a mancare, suggerendo che la dipendenza dell’individualità speciale dalla morte possa ormai valere solo nel tempo ‘incantato’ (o intossicato) della montagna. Quando Castorp si ritrova a imbracciare le armi nella pianura, egli si rivela insomma pronto a entrare in quella nuova “mondiale sagra della morte” (MI, p. 689) che, rendendolo indistinguibile dagli altri soldati in balìa del medesimo ‘incanto’ di distruzione, sancisce il crollo delle potenzialità ‘gentili’ del culto morboso dell’individualità. Nell’avvento di una diversa ‘febbre maligna’ che interesserà l’intera umanità, si chiude l’era delle potenzialità elitarie della tisi: ormai riconosciuta come tubercolosi, ad essa spettano nuove metafore e nuove storie. I collaboratori di questo numero LUCA BERTA ([email protected]) ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e Analisi del Testo presso l’Università di Bergamo. Collabora con alcune riviste letterarie e filosofiche, e ha pubblicato i volumi Derrida e Artaud. Decostruzione e teatro della crudeltà (Roma: Bulzoni, 2003), Oltre la mise en abyme. Teoria della metatestualità in letteratura e filosofia (Milano: Franco Angeli, 2006), e la raccolta di racconti Imitazioni della vita (Milano: Sironi, 2006). GABRIELE BUGADA ([email protected]) si è laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Attualmente è dottorando in Teoria e Analisi del Testo presso l’Università di Bergamo. STEFANIA CONSONNI ([email protected]) svolge ricerca post-dottorato presso l’Università di Bergamo. Ha pubblicato Linee, intrichi, intrighi (Genova: ECIG, 2003), sull’estetica del Settecento inglese, e alcuni saggi sulle forme narrative anglo-americane moderne e contemporanee. Ha contribuito al Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi (2005) e al Dizionario Bompiani degli Autori (2006). Sta completando Geometrie del tempo, un volume sulle configurazioni spazio-temporali nel romanzo settecentesco, e ha in preparazione una monografia su Don DeLillo. MICHELA GARDINI ([email protected]) insegna Cultura Francese presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bergamo. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Recherches sur l’imaginaire all’Università di Grenoble nel 2003. Si occupa di letteratura francese dell’Ottocento e del Novecento. Ha svolto ricerca, in particolare, sull’immaginario urbano. Attualmente ha in preparazione per le edizioni Sestante/Bergamo University Press un volume sull’immaginario della distruzione. ANDREA GIARDINA ([email protected]) si occupa di letteratura italiana contemporanea. Ha collaborato con Piero Gelli all’edizione del Dizionario dello spettacolo del Novecento (Milano: Baldini & Castoldi, 1998) e dei “Nani- 200 / I COLLABORATORI classici” pubblicati dallo stesso editore. Ha tradotto dal francese il saggio di Myriam Anissimov, Primo Levi. Tragedia di un ottimista (Baldini & Castoldi, 1999), e curato le antologie Contro la guerra. Pensieri per la pace (Milano: Zelig, 2001) e Parole della montagna (Baldini & Castoldi, 2003). Collabora con L’Indice dei libri del mese e con Riga. LAURA OREGGIONI ([email protected]) è Fulbright Fellow presso il Department of Germanic Studies della Indiana University (USA), dove frequenta il corso di Ph.D. in Modern German Literature and Culture. Nell’ambito di Synapsis – Scuola Europea di Studi Comparati, ha scritto un saggio su Gottfried Benn e il tema della finestra, in corso di pubblicazione nel volume Finestre a cura di Letizia Bellocchio (Firenze: Le Monnier). I suoi attuali interessi di ricerca si concentrano sulla letteratura della Weimarer Republik e sull’intersezione fra letteratura e scienze cognitive, in particolar modo sul pensiero analogico. GRETA PERLETTI ([email protected]) ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e Analisi del Testo con una tesi sull’immaginario culturale e letterario della malattia polmonare tra Settecento e Ottocento. Attualmente è assegnista di ricerca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bergamo, e sta lavorando a un progetto di ricerca sulla trasformazione dell’‘arte della memoria’ in ‘scienza della memoria’ nella cultura anglosassone del XIX secolo. NICCOLÒ SCAFFAI ([email protected]) è borsista presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bergamo, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e Analisi del Testo nel 2003. Si è occupato di letteratura italiana (dal Medio Evo al Novecento) e di teoria e storia comparata della letteratura. Ha pubblicato Montale e il libro di poesia (Lucca: Pacini Fazzi, 2002) e Il poeta e il suo libro. Retorica e storia del libro di poesia nel Novecento (Firenze: Le Monnier, 2005). Ha in preparazione per gli Oscar Mondadori il commento ai racconti e alle prose di viaggio di Montale. GIOVANNI SOLINAS ([email protected]), dottore di ricerca in Teoria e Analisi del Testo presso l’Università di Bergamo con una tesi sulle estetiche performative nella poesia sperimentale del Novecento, si occupa di teoria della letteratura e di problemi relativi alle avanguardie novecentesche. Ha pubblicato “Complotti innocenti”, in Cospirazioni, trame. Quaderni di Synapsis II (Firenze: Le Monnier, 2003), e “Autobiografia del luogo comune. In margine a una recente mostra di Andy Warhol” nella rivista web Elephant & Castle. Finito di stampare nel mese di marzo 2006
Scaricare