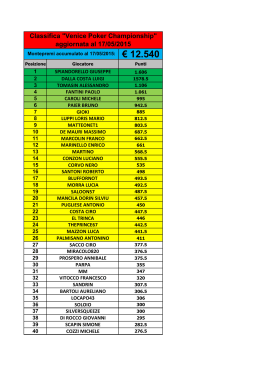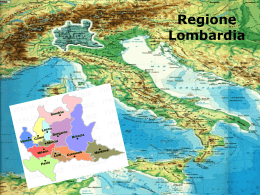Terry Dalfrano LA CHIAVE DELLA VERITÀ TEDALIBER FIRENZE © 2011 di Terry Dalfrano. Tutti i diritti riservati. Quarta edizione: luglio 2012 Terza edizione: gennaio 2012 Seconda edizione: novembre 2011 Prima edizione: luglio 2011 [email protected] Questa è un’opera di fantasia e ogni riferimento a persone e fatti reali è del tutto casuale. Perfino i personaggi e gli accadimenti storici sono stati assoggettati al dominio dell’estro creativo, sicché la loro ricostruzione non ha alcuna pretesa di attendibilità storiografica. Attenzione: L’opera contiene parole, espressioni e idee che possono essere ritenute offensive, discutibili, violente o volgari. È quindi destinata a un pubblico adulto e consapevole. Avvertenza “La storia si può definire una guerra umile contro il Tempo, perché togliendogli di mano gli anni che ha già ucciso li richiama in vita e tenta di schierarli di nuovo in battaglia.” Così sia chiaro: l’avvertenza è rivolta a quei miei venticinque lettori che in un testo cercano la scienza oltre allo svago. Gli altri la possono saltare. I quaderni che mi accingo a pubblicare li ho trovati fra le miscellanea di una biblioteca universitaria. Narrano di una studentessa di sociologia che si prostituisce coi professori e che si trova coinvolta in una vicenda di omicidi accademici nella quale vorrebbe giocare il ruolo dell’investigatrice, tra orge e conversazioni filosofiche, rischiando però di assumere quello di vittima. Si lascia coinvolgere perché il primo morto della serie è il professore di cui era innamorata. I quaderni non sono altro che il diario intimo dove lei prende nota delle indagini svolte, mentre rievoca l’amore travagliato che l’ha scombinata. Rivelano un’ambizione narrativa mal celata da uno stile forse volutamente dozzinale e alquanto pasticciato. Dentro c’è un romanzo giallo, un romanzo rosa, un romanzo porno, un romanzo d’avventura, un romanzo esoterico, un romanzo filosofico. Il tutto mescolato e agitato per benino. Cosa voleva ottenere? Un romanzo decostruttivo? La decostruzione del romanzo? O qualcosa di ancora peggio? Ai critici l’ardua sentenza. Ero stata tentata di riscriverli di mia mano, un po’ per normalizzarli e adeguarli alle regole del mercato e della scrittura creativa; e un po’ per tonificarne lo stile e renderlo meno sguaiato, oltre che per liberarlo di alcuni idiotismi toscani e di qualche eleganza inglese. Avrei anche voluto eliminare quell’eccesso d’intellettualismo e quello sfoggio di erudizione in cui sembra tradirsi l’immaturità di una giovane neolaureata alle prese con un asfissiante mondo accademico. Ma infine ho rinunciato ad apportare qualsiasi miglioramento stilistico. È un atto di fiducia nel lettore, che mi aspetto sarà in grado di scontare tutte le anomalie di forma: quello avveduto saprà guardarci sotto; quello sprovveduto, più felicemente, ci passerà sopra. Così mi sono limitata ad aggiungere poche minime interpolazioni, tanto per rendere il libro leggibile come un vero romanzo. Mi sono sforzata comunque di restare fedele alla scrittura originale del diario. È lo stile di un’epoca che, sebbene lontana da noi nemmeno un quarto di secolo, resta pur sempre dell’altro secolo. 3 Il problema che mi ha veramente assillato riguarda proprio la lontananza che s’interpone fra noi e quei tempi. Ci interessano ancora gli eventi tragici, le travagliate passioni e le vigorose idee di allora, oggi che viviamo nell’epoca dei turbamenti virtuali, degli amori liquidi e dei pensieri deboli? Eppure, mi son detta, il gran baciapile e mangiapreti lombardo era riuscito a parlare dei suoi tempi narrando fatti accaduti due secoli prima. D’altronde, se è vero che il Tempo della storia procede in accelerazione, un quarto di secolo di oggi potrebbe essere ben più denso di cambiamenti di quanto lo fossero quei secoli là. Alla luce dell’inquietante dubbio ho letto i quaderni per una seconda volta e mi sono resa conto che l’autrice del diario era perseguitata dalle conseguenze di eventi accaduti vent’anni prima. Si tratta dunque della storia di due generazioni, per cui il distanziamento temporale si raddoppia: quasi due quarti di secolo. Il che complica le cose, però basta per giustificare la pubblicazione dell’opera così com’è. E se le cause dello sfacelo odierno fossero state poste dalle gesta di una di quelle generazioni, o dalle sue sconfitte? Un ultimo chiarimento. Tra le pagine dei quaderni c’erano alcuni fogli con degli appunti di filosofia. Erano talmente pieni di concettini pretenziosi che forse non meritavano la pubblicazione. Tuttavia a una terza lettura mi sono accorta che svolgono un certo ruolo nel dipanarsi della vicenda. Perciò ho dovuto pubblicare anch’essi. Li ho messi in allegato. Il lettore che non è interessato alla scienza, o almeno all’enigmistica, li può ignorare senza perdere molto. Firenze, maggio 2011 4 QUADERNO 1 PROLOGO IN CIELO “Pi cubo più valore assoluto di a meno otto per valore assoluto di esse meno otto.” Disse Luciano. E siccome restammo tutti a bocca aperta, aggiunse: “Ora molti di voi non ci capiranno un’acca. Col tempo vi accorgerete che si tratta di una cosa di vitale importanza. Dunque imprimetevela bene nella mente questa formula: Pi cubo più valore assoluto di a meno otto per valore assoluto di esse meno otto.” Furono le ultime parole che disse. Poi si sedette in un angolo e parve come assentarsi. E la festa ebbe inizio. Ebbe inizio in modo ridicolo, col gioco delle carte e dei pegni, gli abiti che volavano via un pezzo per volta, le coppe di spumante che si svuotavano una dopo l’altra, le risatine isteriche che riempivano l’aria, la tensione che voleva sembrare eccitazione. Perfino il Naima di John Coltrane dava l’impressione di girare a vuoto sul piatto del giradischi, senza riuscire a placare gli animi. Luciano se ne stava nel suo angolo, abbacchiato, lo sguardo verso di me, ma oltre. Pareva ascoltare parole lontane. Io, di fronte a lui, dall’angolo opposto della piccola stanza esagonale, seduta per terra, le gambe incrociate, loquace, brillante, scherzosa, facevo il mio lavoro, cercando di tenere su l’ambiente. Alla mia destra Silvio, sbracato alla romana, su di giri solo un po’, partecipava al gioco con apparente flemma e avresti detto che si faceva una partita di scopone scientifico. Gianrico invece, alla mia sinistra, garrulo più di una cornacchia, pareva giocare a briscola. Alla destra di Luciano, stravaccata come una troia di bordello, gli si strusciava addosso Lilli. Di fronte a lei Giuliano, detto il Menga, dalla nota legge, dirigeva la partita con la con- 5 sueta autorevolezza. Infine Lucrezia, poverina, se ne stava un po’ indietro, accovacciata sull’unica poltrona della sala, tra Giuliano e Luciano, impacciata e quasi ritrosa. Il gioco delle carte e dei pegni andò avanti un bel pezzo senza che l’atmosfera si scaldasse al punto giusto. Infine, quando eravamo già tutti quasi nudi, Giuliano, che lo era completamente, spense la luce, e l’atmosfera mutò all’improvviso. A metà long playing John Coltrane, galeotto ad alta fedeltà, cambiò musica e passò a un frenetico Olé. Le risatine e il chiacchiericcio si spensero subito e cominciarono i muti assalti. Su di me si avventarono insieme i due marpioni più vicini, Silvio e Gianrico. Giuliano toccò a Lucrezia, che gli stava seduta accanto. Luciano deve esserselo presa per prima Lilli. Non starò a descrivere i particolari. Per me d’altronde, unica del gruppo, era un mestiere, anche se a quel convegno, formalmente, partecipavo gratis. Quando terminò il disco, nessuno lo rimise su e l’aria fu piena di mugolii e bisbigli e del sommesso tramestio dei corpi che si strofinavano. Faticai molto a portarmi verso il centro della stanza. Stavo su quattro zampe. Silvio, da dietro, mi scuoteva freneticamente agitandosi come un forsennato. Gianrico invece, che mi stava di fronte in ginocchio, frenava il mio lento procedere verso Luciano. Lo feci venire subito e me ne liberai senza difficoltà. Lui si accasciò sotto di me e io tentai un balzo in avanti. Con poco successo, ahimé. Ero bloccata dalle mani di Silvio, il quale mi aveva agguantato i fianchi, quasi timoroso di perdermi, mi sbatacchiava avanti e indietro e non aveva intenzione di mollarmi. Con una mano però riuscii a raggiungere una caviglia che, per il punto in cui si trovava, pensai poteva essere di Luciano. La tenni salda, aspettando che il porco dietro di me finisse i suoi comodi. Quando ebbe fatto, me ne liberai con un colpo d’anca e cominciai ad avanzare verso la mia preda. Tastando e palpando al buio, cercai di rendermi conto della situazione. Luciano se ne stava disteso sul tappeto, rilassato. Lilli, in ginocchio, gli teneva la testa tra le proprie cosce. Lui l’aggranfiava alle gambe con le mani, come per frenarne gli ardori. 6 Tutto il resto del suo corpo sembrava inerte. Avrei potuto approfittarne subito, ma non volevo dividerlo con nessun’altra. Cercai di liberarmi di Lilli rapidamente. Mi misi a cavalcioni sul petto di Luciano e abbracciai la bagascia da dietro. Cominciai con le carezze sul ventre e sui seni, baci sul collo e lingua nell’orecchio. Poi presi a strizzarle un capezzolo con le dita di una mano, mentre con l’altra le sfregavo la clitoride. La lingua di Luciano, come d’intesa, collaborò all’operazione. In un attimo ci sbarazzammo dell’intrusa e fummo tra le braccia l’uno dell’altra. La stanza era piccola e con la sua pianta esagonale offriva scarse possibilità di appartarsi. La mobilia si riduceva al rack dell’impianto hi-fi e a una poltrona davanti ad esso, qualche tappeto e pochi cuscini. Con calma e silenziosamente spostammo la poltrona in modo che formasse un cantuccio con il rack, e dietro di essa ci nascondemmo. Lui mise un nuovo disco a caso. Era sempre John Coltrane: First Meditations, ora. Una volta pensavo che lo speciale interesse, lo strano interesse che Luciano suscitava in me, un interesse non propriamente professionale, fosse dovuto alla sua particolare abilità tecnica, oltre che al fascino del personaggio, alla sua raffinata ars amandi, alla sua capacità di farmi godere come nessun cliente era mai riuscito a fare. In seguito ci ho riflettuto sopra, e ora non ho più dubbi: c’era qualcosa in lui, per me; c’era qualcosa tra lui e me che solo un’ottusa volontà di svilire ogni rapporto umano mi ha impedito di capire a pieno fino a pochi giorni fa. E sento ancora il calore del suo corpo addosso al mio, il tremore delle sue carezze sulle mie gambe, il peso della sua testa sul mio petto, mentre ce ne stavamo lì abbandonati e inebetiti, drogati da una voluttà languida. Poi una sua mano, pigra, si mise in movimento in cerca del sesso. Scivolò dal seno verso la pancia, adagio, molto adagio, pareva titubante. Giunta nei pressi dell’ombelico arrestò la sua discesa e tracciò un percorso a spirale che terminò in un’immersione. Con un dito v’indugiò dentro per qualche secondo. Quindi riprese la marcia verso il basso. Giunse al monte di venere, frugò tra i peli in cerca di qualcosa. Infine scivolò giù e la trovò. La carezzò per un po’. Disegnò qualche cerchio sul pube e 7 risalì a spirale sul ventre. Raggiunse i seni e vi sostò, trastullandosi intorno ai capezzoli, anche lì per lunghi secondi, finché riprese a salire. Quando raggiunse il collo mi afferrò alla gola con una stretta calma, forte, sempre più forte. Mi tolse il respiro e mi tenne così, sospesa nel vuoto, per un tempo interminabile. Ora capisco che quel mimare lo strangolamento forse non era tanto un espediente tecnico, quanto il segno di una cosa che anche lui, come me, era incapace di dire. Quando mi liberò il collo, ridandomi il respiro, cominciò coi baci, proprio sul collo, lì dove aveva affondato le dita. Pian piano le sue labbra salirono su verso le mie. Prima indugiarono sugli angoli della bocca, poi strisciarono umide lungo le guance, poi raggiunsero gli occhi, che tenevo chiusi nel buio. Nell’istante in cui capii che lui poteva farmi ciò che voleva, me lo stava già facendo. Mi penetrò con un movimento calmo che mi fece perdere l’ultimo barlume di controllo. E io me ne stavo lì, più passiva di una cosa, schiacciata dal peso del suo corpo, rimestata da un’oscillazione lenta e profonda, sperando che l’orgasmo non venisse mai. Venne presto, il mio. Il suo invece non venne. Quando ebbi finito, lui si trasse da parte e aspettò che mi riprendessi. Era una prassi ormai consolidata questa, nell’intesa che il nostro rapporto non potesse risolversi comunque in altro che in un semplice scambio. Lui lavorava su di me e per me; quindi le parti s’invertivano ed ero io a darmi da fare. In tal modo potevo concentrare tutta l’attenzione e tutti i sensi sul mio piacere quando era il mio turno di passività, mentre quando agivo mi godevo il mio dominio su di lui e il suo orgasmo. Per lui era lo stesso. Con nessun altro uomo ho avuto un rapporto, diciamo così, onesto come con lui. Con nessuno come con lui ho raggiunto tali vette d’abbandono. Stavolta però lui non ebbe la sua ricompensa. Gli ero montata sopra a cavalcioni, prendendo il suo potere dentro di me, nella posizione che lui amava di più, gli avevo strizzato un capezzolo tra le labbra e i denti, con quel morso delicato che lo mandava in fibrillazione; poi gli avevo messo le mani al collo e avevo cominciato a stringerlo con forza crescente; quando qualcuno mi 8 caracollò addosso da sopra la poltrona, disarcionandomi violentemente e facendomi sbattere la testa al muro. Mi prese forse uno sturbo. Feci appena in tempo a riavermi dallo stordimento, che venni afferrata per le gambe e trascinata al centro della stanza. Ciò che accadde subito dopo non merita di essere ricordato. Ma il tragico finale del festino sì. “C’è un morto.” Disse qualcuno. Un attimo di silenzio. “Non sto scherzando.” Riconobbi la voce di Lilli. Fui io ad accendere la luce. Il presentimento fece appena in tempo a manifestarsi e già la coscienza era invasa dall’immagine del corpo di lui, nudo e pallido, immobile e stranamente composto. Era steso accanto al giradischi dietro la poltrona. Mi avvicinai, m’inginocchiai, lo toccai. Ne ebbi una scossa di gelo. Gli accostai la testa al petto, tutti gli occhi su di me, nel silenzio assoluto. Ascoltai attentamente. Gli altri capirono dal mio sguardo. Si gettarono sugli abiti e si rivestirono di furia, in un tentativo precipitoso di fuga. Quando furono pronti per andarsene, Giuliano sbarrò l’uscita col suo corpo e parlò: “Che fare?” Erano le cinque del mattino. Dai vetri colorati delle finestre antiche penetravano le prime luci dell’alba. La riunione durò ancora qualche minuto. Parlarono solo Giuliano e Lilli. Discussero brevemente e decisero che l’indomani notte avrebbero vestito il cadavere e lo avrebbero portato in un altro sito, dove avrebbero simulato un qualche incidente. Approvammo senza esitazione; e anche senza riflessione, mi viene fatto di pensare ora. Giuliano aprì la botola e uscimmo tutti, rapidi e silenziosi, ingolfandoci nella scala stretta. Io uscii per ultima. Eccoli qua – mi dissi – gli amici fraterni. In un lampo improvviso colsi l’anima del gruppo, una piccola comunità di gente che si conosceva praticamente da sempre, coesa come una nazione di animali feroci; uomini e donne incapaci di stare separati gli uni dagli altri ma quasi naturalmente predisposti a usarsi quali mezzi gli uni degli altri, in relazioni di scambio opportunistiche in cui il malanimo reciproco costituiva 9 un sentimento così forte e condiviso da fungere pur sempre da collante sociale. La sala dell’orgia stava in cima alla torre maggiore di palazzo Stibbert. Da lontano, prima di salire in macchina per la fuga, mi voltai indietro. La torre si stagliava nera contro il cielo sbiadito della notte che moriva. Nella testa mi ronzava ancora la musica allucinata di John Coltrane. Ora, mentre scrivo queste righe, la mia stanza è piena di quella musica. Mi alzo e rimetto il disco dall’inizio. Love, il primo movimento delle First Meditations è un urlo di disperazione. Mi parte dal fondo della schiena e mi sale per il midollo spinale su su fino al cervello. Mi schianta. Sono le dieci di sera. Per tutto il giorno ho cercato di dormire, ma non sono bastate tre pillole di Lendormin. Adesso me ne ciucciò altre tre e vediamo cosa succede. È il 12 maggio del 1988. 10 Lunedì, 13 maggio I fatti appena narrati li ho scritti a caldo ieri notte. In questo momento sono le undici e mezzo di un’altra notte. Solo adesso mi si snebbia un po’ il cervello. E sento di nuovo il bisogno impellente di scrivere. Mi avvicino al mio tavolo di studio. Apro il cassetto e ne tiro fuori un voluminoso quaderno a righe da una serie di cinque che vi avevo amorevolmente riposto una settimana fa. È un quaderno bellissimo, made in China. È rilegato come un libro, la copertina di carta nera, la costola e gli angoli rifiniti in tela rossa. Sui bordi delle parti in tela sono incisi dei disegni floreali dorati. Ci passo sopra le dita della mano destra, mentre con la sinistra lo tengo stretto al petto. Chissà se sapevo a cosa sarebbero serviti questi quaderni, quando li comprai. Ora capisco che erano predestinati a ricevere la scrittura del dramma che mi sta travolgendo. E la decisione di scrivere è così naturale che non ho neanche bisogno di prenderla. Mi sembra che sia l’unico modo per non impazzire. O forse è già un sintomo di pazzia. Dunque scriverò un diario. Sarà il resoconto di quello che promette di essere il periodo più angoscioso della mia vita. Comincerò con il risveglio. Sono le tre del pomeriggio quando mi desta lo squillare del telefono. È insistente, feroce, un martello pneumatico che vuole penetrarmi il cranio. Alzo il ricevitore, sul comodino, solo per far cessare la tortura. Ho la testa a pezzi e la cecagna mi affoga i sensi e la mente. Il Lendormin ha funzionato infine! “Sono Giuliano,” dice il telefono, “sono appena tornato dalla torre. Il cadavere è scomparso.” “Uhm.” Faccio io. “Mi senti?” Insiste. “Ho detto che il cadavere non si trova più.” “Uhm.” “Svegliati! é una cosa preoccupante. Dobbiamo parlarne. Mo’ alzati dal letto, fatti una doccia, un caffè e preparati. In mezz’ora sarò lì.” In mezz’ora è qui, con una faccia buia che pare un comunista dopo un’elezione. Neanche mi guarda, quando entra; va dritto al 11 mobile-bar, si versa un bicchiere di whisky, lo beve tutto d’un fiato. Poi se ne versa un altro e si siede sul divano. Dà un sorso, mi guarda con uno sguardo che per un attimo si perde nel vuoto. Finalmente comincia a parlare: “Mi fido di te, perciò sei la prima persona con cui mi sbottono. Stamattina sono andato a prelevare il cadavere. Avrei dovuto fare il lavoro con Lilli, ma lei non è voluta venire. Così sono andato da solo.” “Be’?” “Be’, il cadavere non c’era.” “Come non c’era?” “Non c’era! Scomparso!” “Che vuol dire?” “Ci fai o ci sei?” “Ci sono,” ammetto, sorseggiando il secondo caffè, “sono completamente rincoglionita. Mi stai dicendo che qualcuno ha fatto sparire il cadavere prima che tu e Lilli andaste a prelevarlo?” “Prima che io andassi. Ti ho detto che Lilli non è venuta.” “Perché?” “Brava. Vedo che cominci a connettere. Perché non è venuta?” “Sospetti di lei?” “Sì, e di tutti gli altri. Di lei un po’ di più.” “Cosa intendi fare?” “Voglio indagare. Ieri notte, nella fretta, non abbiamo manco cercato di capire com’è stato ucciso Luciano. Ora voglio scoprirlo. E voglio scoprire chi ha fatto sparire il cadavere. Chi l’ha fatto sparire è l’assassino. Voglio sapere chi l’ha ammazzato e per quale motivo.” Così entriamo in una conversazione da romanzo giallo. Per farla breve: Giuliano vuole indagare sulla morte di Luciano e vuole che io l’aiuti. Anzi conta molto su di me per avere informazioni. L’assassino è uno degli altri partecipanti all’orgia. Di me non sospetta, dice, ma non mi spiega perché. Così, escludendo anche lui, gli indiziati si riducono a quattro: la sua segretaria Lilli, l’ex compagna di Luciano, Lucrezia, e i presidi delle 12 facoltà di Economia e Sociologia, Gianrico e Silvio. Lavorano tutti alla LUFSS, la Libera Università Fiorentina di Scienze Sociali. Giuliano ne è il direttore amministrativo, in realtà l’autorità indiscussa. Molti dicono: il despota. È un uomo di potere, in effetti. Ne ha accumulato tanto di potere, con ogni mezzo, lecito e illecito, che nessuno ormai in quest’università osa prendere decisioni senza tenere conto della sua volontà. Perfino il senato accademico e i consigli di facoltà e di dipartimento, che sono le istituzioni di gestione delle attività didattiche e scientifiche e che hanno nell’ufficio amministrativo solo un organo tecnico, hanno imparato, a loro spese, a tener conto di lui. Una decisione che non piacesse a lui verrebbe boicottata, dilazionata, insabbiata, con tutti i mezzi a disposizione del burocrate. Ad ogni modo è un potere basato su una sorta di torbido consenso. Lui è piuttosto tollerante verso inghippi e furbate dei docenti, anzi li incoraggia. Così li tiene sotto ricatto mentre li rende complici del suo governo. Intrighi, ricatti, cavilli, abusi di potere, omissioni in atti d’ufficio, sono le sue armi più affilate. Nessuno comunque è mai riuscito a beccarlo in castagna, in realtà pochi ci hanno provato. In Giuliano l’apparenza non inganna. Lui è proprio ciò che appare, con quel torace grosso e squadrato, e la supponenza con cui lo porta sulle gambe nerborute, con quella faccia spigolosa, nera di barba forte anche quando è ben rasata, gli occhietti cattivi che ti guardano dritti in viso e sembrano scandagliarti il cervello, e quel sorriso immobile... ah, quel sorriso immobile! È la parte veramente inquietante della sua figura quel sorriso. Le labbra tumide, sono sempre innaturalmente tese sopra i denti radi da felino che cercano di nascondere, e spingono in su i baffetti mongoli facendogli formare due angoli retti ai lati della bocca. Ostenta sicurezza, quel sorriso, e offre protezione a chi si sottomette. Suscita timore in tutti gli altri. Ed è difficile parlare con Giuliano guardandolo in viso. Ma non per me. Guardandolo dritto negli occhi gli dico: “Perché vuoi fare lo Sherlock Holmes? Perché io dovrei farti da Watson? Perché non lasciamo fare la polizia?” 13 “I panni sporchi è meglio lavarli in casa, almeno prima di mostrarli in pubblico.” Lui parla così, coi proverbi e i luoghi comuni. “Come che sia,” aggiunge, “tu hai un validissimo motivo per indagare su questa faccenda.” “Sarebbe?” “Non avevi con Luciano un rapporto privilegiato, se non proprio affettivo? Non t’importa saperne di più su di lui? E scoprire chi è il suo assassino?” “Che ne sai dei miei rapporti affettivi?” “Io so tutto, di ciò che m’interessa.” “Non sai chi ha ucciso Luciano.” “Non ancora. Però se tu mi aiuti...” “Non lo farò.” Rispondo in tono conclusivo. Mi alzo dalla poltrona e gli tolgo il bicchiere vuoto di mano. Ma lui: “Grazie, versamene un altro.” Non si smonta facilmente il Menga. Capisco che non c’è modo di liberarmene finché non vuole lui. La conversazione continua a lungo. A lungo respingo la sua proposta. Vuole che svolga le indagini a letto. Sa che coi miei clienti intellettuali mi piace indugiare nelle confidenze, dopo un rapporto sessuale. Qualche volta lo faccio anche con lui. La cosa piace a me, per l’arricchimento culturale che mi dà, e piace a loro, forse per il senso di liberazione che ne traggono. Gli faccio un po’ da psicanalista e un po’ da confessore. È una cosa che so fare bene. Sono una grande ascoltatrice. Mi basta dire poche parole, nel momento giusto e col tono giusto, e loro si sciolgono come peccatori pentiti. È una dote che Luciano mi aveva aiutato a rivelarmi. Mi piaceva stare ad ascoltarlo; e a lui piaceva essere ascoltato, specialmente da me – diceva. Sosteneva di amare in me la ricettività. La considerava una dote rara e una predisposizione alla letteratura, e voleva che la coltivassi. Narrare – asseriva – significa raccontare storie, non descrivere fatti. Scrivere di cose vedute è facile, ma è un riempitivo, e non c’è autore grande o piccolo che non l’abbia usato per allungare la minestra. Il difficile è scrivere di cose ascoltate. È difficile perché si rischia di 14 fare la lezioncina. Ma tu che non credi a nulla non corri questo rischio. Perciò non tentare mai di esporre idee, cerca piuttosto di descrivere con le idee, come fossero tic nervosi. E ricorda sempre: l’oggetto della narrazione è la narrazione. Sarà questo lo spirito con cui mi avvicino al mio diario? Ad ogni modo, ho sempre avuto il sospetto che le lodi di Luciano alla mia ricettività fossero piuttosto un modo elegante per stigmatizzare la mia abulia, quell’oscuro lato del mio carattere che non riesco a illustrare se non in termini di un’assoluta mancanza di personalità. È una sorta di sensazione di vuoto, di paralisi mentale, che mi coglie spesso quando dialogo con i miei clienti, specialmente nel dopo: mi prende un torpore della mente e mi sento senza centro. Mi sembra di perdere l’identità, di diventare una tabula rasa capace soltanto di registrare la personalità altrui. Allora mi dispongo all’ascolto, faccio qualche breve domanda, e commenti minimi ma appropriati, tanto per mostrare che ci sono, e lascio che le parole dell’altro m’invadano. Me ne lascio compenetrare, quasi più dai suoni che dai significati; non senza comprendere, tuttavia. Credo che sia proprio la mia capacità di comprensione passiva, fisica, direi, che predispone l’altro a fidarsi, confidarsi, aprirsi. Sarà vero che questa è una qualità letteraria? Mentre Giuliano cerca di convincermi a collaborare, mi viene un’idea. Perché non farmi narrare di Luciano? Dopotutto, chi potrebbe conoscerlo meglio di lui che è stato il suo migliore amico per tanti anni? “Io sono interessata a Luciano, non al suo assassino.” Lo interrompo mentre lui mi esorta a fidarmi. “Capisco,” fa, “un interesse personale! Be’, hai trovato la persona giusta. Nessuno lo conosceva meglio di me. Eravamo amici fraterni...” “Fraterni? Non mi risulta.” “Già, in effetti la nostra amicizia si è un po’ incrinata negli ultimi tempi. Ma non l’ho mai perso di vista. Tu lo conoscevi da due anni, io da venti. Potrei dirti molto su di lui, chi era, che faceva, che cercava. A te piacciono i rapporti di scambio. Bene, te 15 ne propongo uno. Io ti racconto di Luciano, tu mi raccogli le informazioni che mi servono per l’indagine.” Faccio fatica a parlare. Ho ancora la testa che mi scoppia. All’improvviso sento che quest’uomo mi è diventato odioso, da poco simpatico che mi stava. Mi alzo dalla poltrona e, decisa, gli tolgo il bicchiere di mano. “Ora lasciami,” dico, “devo rimettermi in sesto e riacquistare la capacità di ragionamento. Rifletterò sulla tua proposta e ti farò sapere.” La LUFSS, l’università in cui Luciano era assistente di ruolo, è la stessa dove lui e l’ex amico, che ora ne è direttore amministrativo, si erano laureati all’epoca del movimento studentesco. È a quei tempi che risale la loro amicizia. Questo l’ho saputo da Luciano stesso. Il quale però è sempre stato restio a parlare del passato. Odiava rievocare le glorie trascorse, anche se dava l’impressione di voler dimenticare qualcosa. Lucrezia, la sua infelice ex compagna, un giorno mi ha detto che per capire Luciano bisogna capire cosa ha fatto nel Sessantotto. Bene, è la storia che voglio farmi raccontare da Giuliano. Quando lui finalmente se ne va, mi butto sul letto e crollo di nuovo nel sonno. È un sonno agitato, con brevi e fastidiosi risvegli, incubi in stato di dormiveglia, e la testa che non cessa di dolermi. Alle otto della sera mi alzo, mi faccio una doccia, mi cuocio una bistecca, mi ciuccio un caffè forte. Poi telefono a Giuliano, e alle nove me lo ritrovo in casa. Vuole scopare, il porco. Ma mi basta uno sguardo... Lo faccio accomodare nel salotto serio, ché non sia distolto dal compito che ho intenzione di assegnargli. Gli preparo un abbondante whisky con ghiaccio, uno lo verso per me. Mi siedo sulla poltrona di fronte a lui e: “Chi era Luciano nel Sessantotto?” Gli faccio. Lui ci pensa un po’, neanche tanto. Un sorriso d’intesa appena accennato. Quindi attacca: “Bisogna cominciare dall’autunno del ’67, a Roma. È lì che ci conoscemmo, partecipando alle prime occupazioni della facoltà di Lettere. Frequentammo insieme diverse commissioni del movimento. La nostra amicizia maturò nei dibattiti di quelle com- 16 missioni. Eravamo appena matricole, diciannovenni tutti e due. Prendemmo parte a molte manifestazioni. La nostra amicizia diventò fratellanza a Valle Giulia.” “Luciano partecipò alla battaglia di Valle Giulia?” “Proprio così. E anch’io.” Lo dice con orgoglio non celato. Si vede subito che muore dalla voglia di rievocare antiche glorie. “Questo non lo sapevo. Vai avanti, racconta.” “Il movimento era partito a Lettere già da settembre. Si estese rapidamente ad altre facoltà. Il Magnifico Rettore diede un contributo importante al processo di diffusione. Noi si occupava Lettere e lui mandava la polizia. Il giorno dopo si occupava Fisica, e si univano al movimento gli studenti di quella facoltà. Il rettore mandava la polizia e noi si passava a Chimica, e si univano altri studenti. Lui mandava la polizia e noi si passava a Matematica. La storia andò avanti così per qualche mese. E il movimento cresceva a vista d’occhio. Le assemblee erano sempre più numerose. Gli scontri con la polizia sempre più duri. A un certo momento, verso la fine di febbraio, il rettore fece occupare tutta l’università dalle forze dell’ordine, non solo la città universitaria, anche le facoltà situate all’esterno della cerchia delle sue mura fasciste, Ingegneria, Magistero, Architettura, Economia. La sera prima della grande battaglia il comitato d’agitazione, riunito in via dei Frentani, in cui aveva sede la Federazione Giovanile Comunista, deliberò che era giunta l’ora di una risposta decisa. La mattina appresso, alle otto, il movimento era schierato sulle gradinate di Trinità dei Monti. Io e Luciano facevamo parte dei catanghesi, il servizio d’ordine. Ricordo che, per riconoscerci, portavamo al braccio delle fasce col distintivo della Roma, rosse bordate di giallo. Non eravamo moltissimi, quando ci muovemmo, millecinquecento, duemila. Facevamo una gran caciara. Ci incanalammo per via del Babuino, verso la facoltà d’Architettura. Pochi si aggiunsero per strada. Si urlava di rabbia e di gioia. Si gridavano slogan contro la polizia, contro il rettore, contro l’imperialismo americano. Credevamo di andare verso il nostro Vietnam. I negozi abbassavano le saracinesche. Dalle finestre degli uffici si affacciavano gli impiegati. Ci guardavano come fossimo marziani. 17 Fino allora il movimento non era praticamente mai uscito dalla città universitaria e quella prima sortita era un evento già di per sé. Arrivammo a Valle Giulia che il sole era alto. Architettura, in cima alla sua collina, si stagliava tronfia contro il cielo primaverile, sembrava una fortezza. Quando il corteo cominciò a salire per il viale alberato che portava alla facoltà, le quattro file di poliziotti che la difendevano ebbero un ondeggiamento. Noi giungemmo davanti a loro in pochi minuti e cominciammo a gettargli addosso manciate di monetine da cinque lire. – Servi dei padroni! – gli gridavamo in faccia. Il cozzo delle aste delle nostre bandiere sugli scudi dei celerini fu una deflagrazione. La polizia resistette all’urto e reagì immediatamente con una carica feroce. Il movimento sbandò, si arruffò su se stesso e prese a indietreggiare lentamente in un infuriare di corpo a corpo. Il piazzale antistante alla facoltà terminava in una scarpata. Giunti sul suo ciglio, quando non fummo più in grado di sostenere l’urto delle schiere grigioverdi ci precipitammo di sotto a valanga. La polizia non ci seguì e tornò sulle sue posizioni a ridosso alla facoltà. Pareva che fosse tutto già finito. Invece era solo l’inizio. – Non è che l’inizio! – gridavamo, e il maggio francese era ancora di là da venire. Ripreso fiato, salimmo di corsa su per la scarpata e, armati di sassi e di bastoni, ci avventammo di nuovo addosso al nemico. Le bandiere e i cartelli erano stati strappati dalle aste e ormai nessuna finzione si frapponeva tra noi e quelle schiere di proletari asserviti. Ricominciò il contrattacco della polizia e il nostro indietreggiamento. Poi di nuovo giù per la scarpata, poi di nuovo su e ancora all’assalto, con rabbia montante. La vicenda andò avanti per un bel pezzo. Ci saranno stati quattro, cinque nostri assalti, non ricordo bene, e le rispettive cariche della polizia e le nostre ritirate. Ma sempre tornavamo alla carica, con irruenza crescente, senza dare tregua. Finché la nostra rabbia raggiunse il parossismo. L’ultima scalata alla collina fu la più impetuosa. E appena iniziato il nuovo assalto assistemmo a uno spettacolo mai visto: i celerini si divisero in due schiere disordinate e presero a fuggire a destra e a sinistra. Noi, con un urlo unisono di trionfo, ci gettammo sulla nostra Bastiglia e la prendemmo. Dopo un po’ le finestre della facoltà 18 cominciarono a colorarsi con gli striscioni, i cartelli, le bandiere rosse e quelle vietnamite e le facce raggianti degli studenti e le camicette di cento colori che ansimavano sui petti gloriosi delle studentesse. I corridoi e gli androni della facoltà si empirono dei nostri canti e di slogan rivoluzionari. Cantavamo la vittoria e pensavamo di aver finito. Non era che l’inizio. I megafoni, su per le scale, chiamavano all’assemblea in aula magna. Mi ci stavo avviando, quando incontrai Luciano. Mi afferrò per un braccio e mi trascinò fuori. Disse che la battaglia non era finita. Che sarebbe arrivata altra polizia e che noi del servizio d’ordine dovevamo pensare a preparare la difesa della facoltà. Però non ci fu tempo per preparare niente. Da tutti i punti cardinali, la città ci mandava urli di sirene, dei lunghi ululati che diventavano sempre più acuti e sempre più forti. Nel giro di mezz’ora la valle sotto la collina si era riempita di poliziotti. Saranno stati un migliaio e più. Si schierarono in pochi minuti. C’era la Celere coi gipponi grigioverdi, e i carabinieri coi loro cellulari neri. Allineati e immobili, da lontano sembravano carri armati pronti a sparare. La loro carica fu una sorpresa. Non ci fu quasi scontro perché non avevamo avuto il tempo di prepararci. Il grosso del movimento stava ancora dentro la facoltà e non si era accorto di niente. La resistenza disordinata che tentammo noi catanghesi fu rotta in breve tempo. Quindi la polizia si riversò dentro l’edificio e cominciò il rastrellamento. Dalle finestre del piano terra schizzavano fuori gli studenti come il succo da un limone schiacciato. Ci fu un fuggi fuggi generale mentre le forze dell’ordine ripresero possesso della collina e della facoltà. Il movimento si raccolse di nuovo in fondo alla valle. Qui si svolse lo scontro più cruento della battaglia. Ora la polizia non commise l’errore di schierarsi a ridosso dell’edificio, ma si portò sul ciglio della scarpata, impedendoci il contrattacco. Noi eravamo tutti in fondo alla valle, già in parte decimati dal primo rastrellamento. Di fronte avevamo la collina della facoltà tenuta dalla polizia. Ai due lati, dove il grande piazzale di Valle Giulia si stringeva su due viali solcati dai binari del tram, stavano immobili, in assetto di battaglia, altre schiere di celerini e di carabinieri. Dietro a noi, sul lato opposto alla facoltà, si elevavano le ampie scalinate che 19 portavano a Villa Borghese. Nessuno pensò di andare da quella parte, all’inizio. C’era una grande agitazione. Qualcuno gridava al megafono contro la polizia e il rettore che l’aveva mandata. Molti urlavano slogan e urli di guerra – Giap, Giap, Ho Chi Min! – Altri ribattevano: – Due, tre, molti Vietnam! – Un gruppetto, sotto la scarpata, cantava Bandiera Rossa per provocare la polizia. Al centro della piazza si cominciò a divellere il selciato. I sampietrini venivano raccolti in piccoli mucchi in diversi punti della valle. Molti del servizio d’ordine, forti della fascia giallorossa al braccio, si agitavano tra la folla, dando ordini e indicando le posizioni da prendere. Pochi gli davano retta. C’era una confusione esaltante. Nessuno sapeva cosa fare. Tra i canti, gli slogan e le urla, la rabbia montava come il fuoco in un bosco. Si avvicinava la grande buriana. Di lì a un momento ci saremmo potuti avventare sul nemico su tutti e tre i fronti contemporaneamente. Quel momento non venne. La polizia prese l’iniziativa. Cominciò con le bombe lacrimogene. I primi spari ci spaventarono. Nessuno di noi ne aveva ancora mai sentiti. Ci fu un attimo di panico. Però quando le bombe arrivarono a terra, la battaglia ricominciò. Raccoglievamo i candelotti con le mani e li rilanciavamo al mittente insieme a gragnole di sampietrini. Per pochi minuti la valle fu piena di fumo, che il vento spazzò via presto. Allora la polizia smise di sparare e cominciarono le cariche. Ci furono addosso da tutti e tre i lati. Gli scontri furono durissimi. Noi avevamo smesso di cantare e di urlare slogan, e per l’aria si sentivano solo grida di rabbia e i comandi dei poliziotti. Le sirene avevano cessato di suonare. Al centro della piazza si era fermato un tram pieno di gente, bloccato da un mucchietto di sampietrini su una rotaia. Il conducente aveva chiuso le porte e i passeggeri, in piedi davanti ai finestrini, assistevano allo spettacolo con gli occhi sbarrati. Non so quanto durò lo scontro di corpo a corpo. Ricordo che a un tratto i poliziotti si ritirarono di nuovo. E fu un urlo di trionfo. Luciano stava ancora vicino a me. Del sangue gli scendeva dalla fronte e lui se lo puliva con la mano sinistra, mentre con la destra impugnava un’asta che aveva divelto da una panchina. Io avevo il bastone di una bandiera. Mi faceva male l’avambraccio 20 sinistro, su cui avevo preso qualche manganellata. Ci guardammo negli occhi, senza fiatare. Quello sguardo, in quell’istante, suggellò un legame che nulla potrà mai sciogliere. Anche la seconda vittoria fu di breve respiro. Infatti entrarono in azione i gipponi della Celere. Si avventarono sulla folla a tutta velocità e cominciarono dei caroselli sfrenati. I nostri che fuggivano finivano tra le braccia dei carabinieri. I cellulari si riempivano a ondate. Ricominciarono gli ululati delle sirene. Cellulari se ne andavano pieni di studenti, cellulari tornavano vuoti. E la battaglia continuava. Contro i gipponi usammo i sassi. Li prendevamo più grossi possibile dai bordi delle aiuole. Dalle posizioni sopraelevate, sul declivio di Villa Borghese, piovevano giù dei veri e propri macigni. Io e Luciano stavamo sempre vicini, in mezzo alla piazza. All’improvviso, accanto a noi, un compagno fu intruppato dal parafango di un gippone. Cadde a terra. Si rialzò subito cercando di fuggire, ma cadde di nuovo su una gamba malconcia. Io e Luciano lo prendemmo da sotto le ascelle e lo portammo via rapidamente. Aveva una gamba ridotta piuttosto male. Appoggiandosi a noi però riusciva a stare in piedi sull’altra. Ci rifugiammo sulla scalinata che porta a Villa Borghese, dove le auto della polizia non potevano arrivare. Lì ci fermammo a guardare la scena, tutti e tre, abbracciati come fratelli, io, Luciano e lo zoppo, che si chiamava Fabrizio. Alcuni compagni accanto a noi divelsero un masso di travertino dalla scalinata e lo fecero rotolare giù dalle scale. Quando giunse sulla massicciata, capitò davanti a una camionetta che sopraggiungeva a velocità sostenuta, a venti metri da noi. L’autista cercò di virare per non prenderlo in pieno, ma non ci riuscì, e quando la ruota sotto sterzo colpi il blocco di marmo l’auto si rovesciò. I due celerini che ci stavano dentro schizzarono via come due ranocchie grigioverdi e scapparono inseguiti da un nugolo di studenti, lasciando al suo destino l’auto rovesciata sul fianco. Noi tre guardammo la macchina, ci guardammo negli occhi, e avemmo contemporaneamente la stessa idea. Luciano raccolse da terra un pezzo di giornale. Fabrizio, lo zoppo, tirò fuori dei cerini e gli diede fuoco. Io l’afferrai e lo andai a buttare dentro il gippone. I sedili di vinilpelle presero fuoco in un attimo e la colonna di 21 fumo turbolento che si alzò nera nel cielo fu un segnale di guerra. Dopo un po’, sparsi nella valle, altri tre o quattro automezzi erano in fiamme. Sai chi era quel Fabrizio?” “Chi era?” “Fabrizio Gledo.” “Il brigatista?” “Proprio lui. L’abbiamo conosciuto a Valle Giulia e siamo rimasti amici fraterni, tutti e tre, fino all’epoca in cui lui entrò in clandestinità. Ma questa e un’altra storia.” “Finisci di raccontare la battaglia.” “Ormai volgeva al termine. I gipponi, dopo aver fatto varie tornate di caroselli, di fronte alle fiamme e al fumo si ritirarono precipitosamente. Anche i cellulari tornarono sulle loro posizioni, stavolta senza il loro bottino di studenti. Fu la terza vittoria della giornata. Le forze dell’ordine lasciarono passare alcuni minuti. Poi ricominciarono ad avanzare con le auto, adagio, in fila, da entrambi i lati della valle. Dietro le auto, schiere di carabinieri. Sembrava la fanteria tedesca nella Battaglia dei giganti, in quell’avanzata lenta e inesorabile dietro i panzer neri. I pochi di noi che tenevano duro tentarono un’ultima resistenza con i selci. I gipponi non fecero una piega. Infine, di fronte al loro avanzare compatto i nostri ripiegarono, convergendo al centro della valle. Man mano che l’accerchiamento stringeva, l’ormai sparuta massa di studenti s’incanalava su per le scalinate di Villa Borghese. Appena fu chiaro che ci stavamo ritirando, i carabinieri superarono i gipponi e caricarono d’assalto, tutti assieme. La gente, dai finestrini del tram, stava sempre lì a guardare a bocca aperta. Ci fu un ultimo breve contatto dei più coraggiosi col nemico, dopo di che cominciò una fuga precipitosa verso Villa Borghese. Le nostre colonne erano ormai decimate e molto inferiori di numero rispetto a quelle della polizia. A centinaia i compagni riempirono le questure e gli ospedali. Anche il nemico però aveva lasciato molti feriti sul campo. Ecco, questa fu la battaglia di Valle Giulia. Fu il vero inizio del Sessantotto in Italia, un anno che durò fino al 1973. Almeno per me e Luciano. Fabrizio invece volle prolungare la festa. E ora è in galera con vari ergastoli sulle spalle, il fesso.” 22 “Eccoti tornato te stesso, cinico e sprezzante. Prima, quando raccontavi la battaglia, quasi non ti riconoscevo. Avevi una luce negli occhi, parevi un altro.” “Immagino!” “Cosa?” “Ti sarò sembrato mio nonno che raccontava storie della prima guerra mondiale.” “Ti assicuro: parevi un altro.” “Ero stato un altro... a quei tempi. Ma non era che una festa d’adolescenti ritardati. Non si può restare giovani per sempre.” “Non avevi delle idee, delle convinzioni?” “Sì, e molto slancio. E per allora andavano bene. Ogni stagione i suoi fiori. Ora m’interessano le azioni, non le idee.” “Luciano e Fabrizio hanno subito la stessa evoluzione?” “Ah no, loro no. Lo dimostra il fatto che uno sta in galera, mentre l’altro, in quindici anni di carriera universitaria, non si è mosso dal gradino più basso.” “Tu invece sei arrivato in cima.” “Non nella professione accademica. Lì vai avanti, con quelle idee, se accetti di cambiarle. Nella mia strada invece, la carriera amministrativa, basta rinunciarvi: ai professori si chiedono delle convinzioni, ai burocrati no. Questo, se vuoi, è stato il mio modo per salvarmi l’anima: gettare a mare ogni convinzione. Adesso torniamo ai fatti.” “Torniamo ai fatti.” “Quello che m’interessa ora è l’omicidio di Luciano.” Così torniamo ai fatti. Giuliano vuole insistentemente che lo aiuti nelle indagini. Mi fa un contorto discorso, trincando il mio whisky e fumandosi una sigaretta dietro l’altra. Quando lo guardo negli occhi, fugge il mio sguardo. Sicuramente nasconde qualcosa. Non riesco a capire perché ci tiene tanto a fare l’indagine e perché vuole tenerne fuori la polizia. Addirittura pretende che le autorità giudiziarie siano tenute all’oscuro di tutto finché non si rintraccia il cadavere. Vuole che domani io vada a trovare Lilli e cominci a indagare su di lei. Vuole sapere se è stata lei a organizzare l’orgia dell’altra notte. E si mostra perplesso quando gli dico che su questo punto non c’è bisogno di indagare, 23 l’organizzatrice essendo stata proprio Lilli su suggerimento di Luciano. Mi domanda perentorio: “Ne sei sicura?” “Certo.” “Ne sei del tutto sicura?” “Non sono mica rimbambita?” “E ti è sembrata una cosa normale?” “Non particolarmente bizzarra. Avevamo avuto qualche incontro a tre, nel passato, io, lei e Luciano. Un incontro a sette mi è parso esagerato, ma non mi sono scandalizzata. Se gli altri ci stavano, non avevo nulla da obiettare, visto che li conoscevo tutti. Lei mi assicurò che gli altri ci stavano.” “Hai notato niente di stravagante, a parte la lista dei partecipanti?” “No.” “Pensaci bene. Che so? Ti ha dato qualche notizia particolare, qualche informazione insolita?” “L’unica cosa stramba è che mi diede un numero magico.” “Magico?” “Così lo definì lei. La cosa mi fece sorridere. Allora mi spiegò che m’interessava personalmente perché nelle scienze occulte quel numero rappresenta la puttana santa. Il mio sorriso divenne un’aperta risata. Lei reagì bruscamente e m’ingiunse di scrivermelo e di non perderlo in nessun modo. Prima o poi avrei capito.” “Che numero era?” “Quattro cifre. Sembrava l’interno di un telefono d’ufficio.” “Che c’è di strambo?” “C’è che ho provato a telefonare a quel numero nella rete dell’università, senza risultato. Non dava né libero né occupato. Evidentemente non era un interno telefonico.” “Ma che numero era?” “2919.” Al che Giuliano ha una reazione strana. Dapprima si mostra preoccupato, poi si domina e mi esibisce un sorrisetto di sicumera. Vuole sapere se quel numero è stato rivelato anche a Gianrico e Silvio. Io non ne ho idea. Mi chiedo che importanza ha questa 24 cosa. Glielo domando. Lui non ha nessuna intenzione di spiegarmelo. Mi convinco così definitivamente che mi nasconde qualche verità essenziale, e che la faccenda è meno chiara di quanto pareva a prima vista. Sono decisamente incuriosita. Perciò alla fine decido di stare al gioco. Tuttavia non è solo sull’omicidio di Luciano che voglio capirci di più. Infine: “Va bene,” dico, “ti aiuterò nell’indagine. Domani stesso andrò a parlare con Lilli.” “Brava, allora ci risentiamo domani sera.” “Aspetta.” Lo blocco appena accenna ad alzarsi dalla poltrona. Gli verso di nuovo da bere. “Fermati ancora un attimo, finisci la storia di te, Luciano e Fabrizio Gledo.” “Che altro vuoi sapere?” “Come fu che arrivaste a Firenze, alla LUFSS, se stavate all’Università di Roma?” “Lettere e Filosofia, la nostra facoltà a Roma, non ci piaceva, e per l’intero anno accademico 1967-68, presi come eravamo dalla rivoluzione, non demmo neanche un esame. Fabrizio, che aveva un anno meno di noi, stava prendendo la maturità. Fu lui che ci propose di andare a Firenze, dove c’era una facoltà di Sociologia, l’unica d’Italia a quei tempi. Già il nome, Sociologia, era tutto un programma. Inoltre il movimento studentesco fiorentino produceva dei documenti teorici di un certo livello e si stava affermando quale una delle migliori teste pensanti delle lotte sociali su scala europea. Anche i docenti erano interessanti. Quasi tutti giovani e di sinistra, dialogavano con il movimento e, a modo loro, partecipavano alla festa. Infine, ed ecco il motivo che ci convinse, andare a Firenze significava andarsene da casa.” “Tu non sei fiorentino?” “Sì, la mia famiglia però si era stabilita a Roma da molti anni. Così io avevo un motivo in più per venire a Firenze. E poi Firenze significava soprattutto la libertà. In breve, a novembre eravamo qui tutti e tre, io, Luciano e Fabrizio. Prendemmo in affitto un appartamento di quattro stanze in Santa Croce, ci iscrivemmo a Sociologia e cominciammo a vivere. Ma per stasera basta, sono stanco, è tardi. Domani la seconda puntata.” 25 Martedì, 14 maggio. Non sono propriamente cordiali i rapporti tra Giuliano e Lilli. Lei è la sua segretaria e lui ha cercato in vari modi di liberarsene facendola trasferire ad altri uffici. Senonché perfino un direttore amministrativo ha i suoi limiti. Le leggi della burocrazia sembra proibiscano a un alto dirigente pubblico di scegliersi i collaboratori. Le voci, peraltro, dicono che Lilli è stata un’imposizione del consiglio d’amministrazione, cioè delle persone che contano. Sarebbe stata messa lì apposta per controllare Giuliano. Alcuni dicono che è una spia di Gianrico Delandi, il preside della facoltà di Economia, altri di Silvio Moscanti, quello della facoltà di Sociologia. È una donna dalla figura slanciata, alta e ben proporzionata, corpo flessuoso da indossatrice. I capelli ossigenati biondo platino sono intonati con l’incarnato bianchissimo del viso. Ogni dettaglio è perfettamente curato in lei, dalla pelle liscia di retinolo al vestire elegante con tutte le griffe giuste; dal portamento aristocratico e un po’ altezzoso al modo di parlare calmo e grave. Si avvia alla cinquantina, ma pare sia riuscita a mettere sotto controllo i processi d’invecchiamento. Lei cura ciò che veramente conta per il mondo, vale a dire l’apparenza: il viso, gli occhi, le mani, i capelli e la linea, ovviamente. Non per niente se ne va per il mondo portandosi sempre appresso un necessaire pieno di boccette e flaconi dai contenuti incredibili. Altro che fard, mascara e kajal. In confronto il mio maquillage, che pure non è ingenuo, è all’acqua di rose. Le telefono alle dieci e la invito a pranzo. All’una la trovo che mi aspetta, sorseggiando un bitter, a un tavolo del ristorante Vecchia Fiesole. La saluto con un bacio e mi siedo accanto a lei, e resto per un attimo col fiato sospeso di fronte alla grande vetrata che guarda giù verso Firenze. Una bruma morbida si sforza invano di nascondere al sole i mille lucernari della città e questi, coi loro giochi di luci e di riflessi, danno l’impressione di un grosso tesoro di perle e di diamanti sparso nella terra. L’aria, qui su in collina, è umida e calda. Le ombre sono nette e se ne stanno schiacciate sotto le cose. 26 Lilli è già informata della scomparsa del cadavere. Vado subito al sodo, senza neanche un po’ di manfrina, e le dico che ho deciso di indagare sull’omicidio. Lei promette di collaborare. “Bene,” cerco di coglierla di sorpresa, “chi hai visto nei giorni prima dell’orgia, delle persone che vi hanno partecipato?” Lei esita solo un po’, quanto basta per farmi capire che ho toccato un tasto delicato. Perché sia lei che Giuliano sono così in pena sulla faccenda dei giorni precedenti l’orgia? E sui contatti di Lilli con gli altri partecipanti? Intanto il cameriere, direttamente dal barbecue, ci serve un piatto di fettunta, che lei aveva ordinato prima del mio arrivo. È una tipica raffinatezza fiorentina: pane casereccio bruscato, condito con aglio, olio e sale. Un antipasto niente male, se hai lo stomaco di un carrettiere. Ed è con la foga di un carrettiere che Lilli lo aggredisce. Lei normalmente è a tavola che libera il suo Mister Hide proletario. Mi domando come fa a mantenere la sua linea da indossatrice. L’ho domandato anche a lei, una volta, e mi ha risposto che non sono gli unti della cucina popolare che fanno ingrassare, sono i dolci di quella borghese. Però non mi ha convinto. “Nei giorni precedenti l’orgia ho incontrato tutti, compreso te.” Risponde dopo un lungo silenzio, appena inghiottito il primo boccone. “D’altra parte, nel mio mestiere sono sempre in contatto con molta gente dell’università.” Io perdo il filo del discorso, per un attimo. Ma recupero subito. “Secondo te chi può aver avuto interesse a uccidere Luciano?” “Vuoi cominciare col movente?” “Be’,” dico, “di alibi non mi sembra il caso di parlare, visto che eravamo tutti presenti al momento del fattaccio, e nemmeno di arma del delitto, visto che, essendo sparito il cadavere, non siamo in grado di stabilire il modo in cui il delitto è stato commesso.” “Già, e può darsi che chi l’ha fatto sparire abbia voluto nascondere qualche indizio.” 27 “Non cambiare discorso. Rispondi alla mia domanda. Chi l’ha ucciso, secondo te?” “Ehi, sei entrata nella parte!” Continua a mangiare in silenzio, per un po’, senza badare a me. Sembra di poterlo sentire il lavorio del suo cervello. “Secondo me dovresti indagare sull’ex compagna.” “Lucrezia? Perché proprio lei?” “Lo odiava.” “Non ci credo. Si erano separati in malo modo, lo so, e avevano fatto qualche brutta litigata; ma non mi risulta si odiassero fino a questo punto.” “Credimi. Sono ben informata.” “Racconta, racconta!” Non le pare vero. Attacca: “Era lei che aveva voluto la separazione. Lui si opponeva, soprattutto per il bene della bambina, che all’epoca aveva sei anni. Lei era stata inesorabile, e restò fregata. L’avvocato di Luciano fu abilissimo, non tanto perché dimostrò che Lucrezia aveva avuto delle relazioni con altri uomini, che non era una madre affidabile eccetera eccetera, quanto perché, sfruttando la fratellanza massonica, era riuscito a farsi assegnare un giudice compiacente. Al quale giudice non gliene fregò niente se anche Luciano aveva avuto delle amanti. La figlia fu assegnata al padre. Lui però fu magnanimo e propose alla compagna di continuare la convivenza almeno da amici. Lucrezia, per non perdere la bambina, accettò.” “Mi risulta che avevano instaurato un rapporto abbastanza civile.” “Apparenze. Lei lo odiava violentemente, e aveva qualche ragione. Era stato Luciano, con la teoria della coppia aperta, a indurla in relazioni proibite, diciamo così. Lei non ne fu mai entusiasta. Lo fece per compiacerlo, la cretina. Alla fine, quando la cosa fu usata contro di lei, la considerò una vigliaccata.” Non mi convince. Non ce la vedo Lucrezia ad ammazzare chicchessia, né per questa né per altre ragioni. Penso piuttosto che Lilli stia prendendo tempo e, tanto per non smentirsi, abbia voluto spargere un po’ del suo celebrato veleno. Non l’ho mai 28 sentita parlare bene di un’altra donna. Degli uomini sì, ma sempre in termini di ammirazione o invidia, mai di affetto, mai di simpatia. Di Lucrezia, poi, ha sempre parlato malissimo. E si capisce, visto che si sono contese Luciano a lungo, prima della separazione. Io e Lilli abbiamo una cosa in comune, soltanto una, però essenziale. Ce l’ha fatto notare un amico che è ricercatore al dipartimento di Economia, uno dei meno banali economisti della nostra università. Un giorno che c’incontrò a un night, dove cercavamo di ammazzare insieme la noia, ci disse: voi avete il privilegio di essere sole, di vivere di luce propria. Uno dei meno banali. Mi fa tenerezza questa tardoncella dal look signorile, nel suo orgoglioso isolamento. L’ammiro, per la sua abilità nel farsi strada in un mondo di uomini, per la sua capacità di lottare contro di loro ad armi pari, sul loro terreno, accumulando potere e giocandolo al loro modo. La invidio anche un po’, per la sua forza di carattere, l’autonomia di pensiero, la volontà di autodeterminazione. La compatisco invece per la sua incapacità di amare. Certo non dovrei essere io a dare lezioni sulla materia, a parte tutte le mie attenuanti. D’altronde è accaduto che proprio con Luciano, quasi senza che me ne accorgessi, era sorto in me un sentimento. Lei invece Luciano lo ha sempre usato. Forse pure Lilli ce l’ha qualche attenuante. Cosa ci si può aspettare da una donna vissuta in funzione del marito fino a 40 anni e poi divorziata, senza neanche uno straccio di figlio a cui aggrapparsi, costretta a ricominciare tutto da zero a un’età in cui non si è più considerate donne da marito? Be’, è stata bravissima, anzi, eroica. È ripartita dal suo diplomino di segretaria d’azienda, iniziando la carriera femminile per eccellenza, quella di segretaria appunto, la carriera che finisce dove comincia. Per lei è stato invece un trampolino di lancio. Nel giro di dieci anni è diventata una delle personalità che contano nella LUFSS. Segretaria del direttore amministrativo, è vezzeggiata dai professori, riverita dai burocrati e temuta perfino dal potentissimo Giuliano Serlo, il suo capo. 29 Lilli è vissuta a lungo fuori dal mondo, al caldo dell’affetto coniugale. Però, appena vi è stata gettata dentro, in questo zozzo mondo, ne ha capito le leggi quasi subito, senza fatica. Dopo due o tre tentativi falliti di ritrovare marito, ha realizzato che gli uomini la cercavano solo per usarla; a quarant’anni suonati! Appresa la lezione, non ha tardato a recuperare il terreno perduto. In poco tempo si è trasformata radicalmente, imparando a usare gli uomini, per fare carriera, per divertirsi, per migliorarsi, per crescere culturalmente, soprattutto per accumulare potere. Credo si sia appassionata al gioco del potere, un gioco che io invece non riesco a mandare giù, proprio come questi orrendi bocconi di fettunta. Il fatto di lavorare in un’università l’ha facilitata molto. Ha sempre avuto amanti colti e potenti e da tutti ha sempre ottenuto più di quanto ha dato. “Ti vedo pensierosa.” Mi fa, dandomi un buffetto sulla guancia. “A che pensi?” “Scusa, mi sono distratta. Ogni tanto mi lascio trascinare dai pensieri, che mi portano chissà dove.” “Dove ti hanno portato ora? No, non me lo dire. Indovino. Scommetto che stavi pensando a Gianrico e Silvio.” “No, a Giuliano.” Mento. “Che opinione te ne sei fatta?” “Come indiziato dell’omicidio di Luciano? Be’, Giuliano è capace di tutto. Però non farebbe nulla senza una valida ragione pratica. Ad ogni modo, se vuoi indagare su di lui, devi scandagliare nei suoi rapporti con Luciano e Fabrizio.” “Fabrizio chi? Il brigatista?” “Esatto.” “Me ne ha parlato ieri proprio Giuliano raccontandomi la battaglia di Valle Giulia.” Dico, pentendomene subito. “Interessante. Si vede che la lingua batte dove il dente duole.” “Cos’è che duole? E che rilevanza ha quel terzetto di spostati?” “Hai detto giusto: terzetto. Erano un gruppo molto coeso.” “Non mi risulta, anzi pare che da molto tempo se ne fossero andati ognuno per la sua strada, e su strade divergenti.” 30 “Fumo negli occhi. Avevano costituito una sorta di setta segreta all’epoca della contestazione. E se Giuliano ti ha parlato di quel sodalizio, non è andato fuori tema.” “Fuori quale tema?” “L’omicidio di Luciano. Devi indagare sulla setta.” “Che setta?” “Ti ha detto niente Giuliano dei cavalieri del nulla?” “No.” “Ah ah!” “Cosa avrebbe dovuto dirmi?” “Che quella associazione esiste ancora, nonostante i tre eroi se ne fossero andati ognuno per la sua strada.” “Che c’entra con la morte di Luciano?” “Questo dovresti fartelo dire da Giuliano. E non ti ha detto il signor direttore amministrativo che i tre continuavano a tenere corrispondenze molto strette?” “Cara, mi sa che ti sei fatta prendere la mano dalla tua passione per l’occulto.” “Pensa quel che vuoi. Credimi però se ti dico che le cose veramente importanti Giuliano non te le ha rivelate.” “In effetti mi ha rivelato molto poco.” “Ma insomma che ti ha detto?” Sono nella confusione più nera. Più lei parla, meno mi ci raccapezzo. A questo punto mi faccio guardinga. Non voglio riferirle il succo della mia conversazione con Giuliano fino a che non ci capisco qualcosa. Perciò cerco di cambiare discorso. “Così perdiamo il filo.” Riprendo. “Di Giuliano parliamo dopo. Torniamo a Gianrico e Silvio. Cosa stavi dicendo di loro?” “Niente. Ma te lo dico adesso. Anche loro avrebbero avuto dei validi moventi.” “Sentiamo.” La vedo impaziente di sciorinarmi uno o due dei suoi tremendi pettegolezzi. “Non si tratta di pettegolezzi.” Fa lei, quasi mi avesse letto nel pensiero. “Sono fatti provati, noti in tutte le accademie d’Italia e oltre. Solo gli studenti non li conoscono, e quindi niente ne sai tu.” “Di che si tratta?” Ora sono incuriosita. 31 “Ti ha mai parlato Luciano della sua carriera accademica?” “No, anzi ha sempre evitato accuratamente l’argomento.” “Ci credo. La lingua, in questo caso, batteva da per tutto meno che sul dente che doleva. Luciano, a quarant’anni, era ancora assistente, il gradino più basso della scala gerarchica; caporale, diciamo. I suoi coetanei erano diventati colonnelli, se non generali, cioè professori associati e ordinari. Perfino qualche suo allievo lo aveva sorpassato. Lui invece è sempre rimasto lì dove aveva cominciato, in un ruolo a esaurimento, sicuro ormai di restarci fino all’esaurimento. Sai chi sono stati i diretti responsabili della sua rovina?” “Non me lo dire.” “Quei due: Gianrico e Silvio.” “Sarebbe un movente per Luciano, se fosse stato lui ad ammazzare loro.” “Niente affatto. Luciano era troppo orgoglioso per lasciarsi coinvolgere in faccende di carriera. Anzi, ostentava una certa fierezza per il suo fallimento accademico; per non parlare dell’ostentazione di disprezzo nei confronti dell’ambiente universitario in genere. Io credo che in realtà, pur se si sforzava di nasconderlo, soffriva molto per questa situazione. Cosa che si notava dall’eccesso di sufficienza con cui spesso parlava dei colleghi che gli stavano avanti nella scala gerarchica, vale a dire quasi tutti.” “Anch’io ho notato un certo malcelato astio...” “In ogni caso, l’aspetto interessante della faccenda è quello delle ragioni che hanno indotto Gianrico e Silvio a stroncargli la carriera. Luciano aveva rovinato la loro reputazione. Li aveva sputtanati di fronte alla comunità scientifica internazionale. Da quanto ho capito, sembra che avesse dimostrato che la loro gloria di scienziati era stata impastata con farina presa dal sacco di qualcun altro. Non ne so molto. Questo è un argomento tabù nella nostra università. Giuliano forse ne sa qualcosa di più. Ma meglio chiedere agli interessati.” “Se fosse vero ciò che dici, dovrebbero aver problemi a parlare della faccenda.” 32 “Non fare l’ingenua. Gianrico sarà felicissimo di sparlare di Silvio e viceversa.” “Mi hai incuriosito.” Rifletto ad alta voce: “Ecco l’occasione per conoscere meglio i due marpioni, e la natura del loro rapporto con Luciano.” “Falli venire da te e falli parlare. Naturalmente poi mi riferirai quello che hai saputo. E domandagli una cosa: se hanno trovato la chiave della verità.” “Che?” “La chiave della verità.” “Che vuol dire? È un indovinello?” “Non ti preoccupare. Chiedi a entrambi precisamente questo: se hanno trovato la chiave della verità. Memorizza le loro reazioni e fammi sapere. Dopo ti dirò il resto.” Ecco un altro Sherlock Holmes che vuole farmi fare il Watson. È evidente che lei sa molto di più di quanto mi ha detto. Ahimé, io le ho detto più di quanto volevo. Eppure c’è qualcosa di particolare che lei vuole da me e che ancora non ha osato chiedere. La vedo pensierosa, titubante. Sento che sta per aprirsi, che lo farà se ha un po’ d’incoraggiamento. Così la pungolo: “Va bene cara, è evidente che non sei venuta qua oggi per raccontarmi quattro pettegolezzi accademici o per incuriosirmi con un enigma su chiavi e sette misteriose. Cos’è che vuoi da me?” “Hai detto giusto: la chiave della verità è un enigma. Io lo voglio risolvere e per risolverlo ho bisogno di uno scritto di Luciano, uno scritto che hai tu.” “Io?” “Sì. Sono degli appunti di filosofia. Luciano mi ha detto che ce l’hai tu. Credo che in quegli appunti ha nascosto la chiave.” La mia mente va in subbuglio. In effetti lui mi aveva dato dei fogli con delle annotazioni di filosofia, ma non mi aveva detto che contenevano un enigma. Sarà vero? O è solo un’altra delle stramberie prodotte dalla passione di Lilli per le scienze occulte? Devo vederci chiaro prima di scoprirmi. Perciò le dico che non ho nessuno scritto di Luciano. Lei non ci crede e mi ripete che glielo ha detto proprio lui. Io tengo duro nella menzogna. Non 33 devo farmi fregare, penso. Dopo aver celiato un po’ su enigmi filosofici e chiavi occulte, bevo un ultimo sorso di vino e: “Si è fatto tardi!” Dico, banalmente. Nel frattempo lei è arrivata al dolce, un tiramisù non meno greve dell’antipasto, una vera sbobba. Io, da parte mia, dopo essermi messa quel sasso di appetizer nello stomaco, col primo e il secondo ho spilluzzicato appena. Il dessert glielo lascio tutto. La saluto in fretta e faccio per alzarmi. Ma lei mi mette una mano sull’avambraccio e mi trattiene. Mi guarda con uno sguardo liquido. All’improvviso sembra sciogliersi, perde la sua aria di sicumera. Con voce trepidante mi fa: “Ho assolutamente bisogno degli appunti di filosofia di Luciano.” “Perché?” Lei non risponde. Il suo sguardo si fa ancora più intenso, quasi implorante. Io sono turbata. La guardo senza saper cosa dire. Poi, credendo di cambiare discorso, le domando a bruciapelo: “Perché non sei voluta andare con Giuliano a rimuovere il cadavere l’altro giorno?” “Appunto. Perché, secondo te?” “Dimmelo.” “Temo per la mia vita. Se non decifro subito quegli appunti, la prossima vittima potrei essere io.” I suoi aforismi filosofici Luciano me li aveva dati dopo che c’eravamo bazzicati per un po’ di tempo. Avevo iniziato a frequentarlo due anni fa. L’anno accademico era appena cominciato. C’era un annuncio nella bacheca della facoltà di Sociologia: ‘Nuovo corso di filosofia nel boudoir, seminario trimestrale tenuto dal dottor Luciano Vinel’. Prima di allora lo conoscevo solo di fama. Ne avevo sentito parlare da qualche studentessa in termini da romanzo rosa. Pareva fosse un vero Casanova, il che me lo rendeva poco seducente. Mezzo corpo studentesco era innamorato di lui. I maschi invece ne parlavano come di una figura misteriosa, un personaggio d’altri tempi, un rivoluzionario in disarmo, un filosofo un po’ matto, uno scettico dalla parola tagliente, un trasgressore, un arrogante, un originale. Devo dire che tutto ciò 34 mi sconfinferava alquanto. L’idea che se n’erano fatta gli studenti mi intrigava più della fantasia coltivata dalle studentesse. Come professore, ad ogni modo, nessuno sembrava stimarlo molto, né i maschi né le femmine. Peraltro, pur non essendo professore nella gerarchia universitaria, così lo chiamavano gli studenti – il professor Vinel, con l’accento sulla e – evidentemente un omaggio tributato più alla sua cattiva fama che al ruolo accademico. Fatto sta che quel seminario mi attrasse immediatamente, appena ne lessi l’annuncio, se non altro per l’argomento. M’incuriosiva l’idea di filosofare intorno al mio mestiere. Tuttavia capii subito che non aveva alcuna attinenza. Cominciai a frequentare che era già alla terza lezione. C’erano cinque uditori, me inclusa, tra cui due docenti. Più tardi lui stesso si vantò di non essere mai riuscito a tenere corsi con molti studenti. Alla prima lezione accorrevano in molti, alla seconda gli uditori si dimezzavano, alla terza restavano solo pochi eletti. Rimasi immediatamente presa e non tanto dall’argomento che, appunto, aveva poco a che fare con ciò che mi aspettavo, quanto dal modo di esporlo, quel parlare rapido, essenziale, rigoroso, quella mancanza di ogni concessione all’uditorio, quasi rivolgendosi solo a se stesso. Verso la fine dell’ora cominciò una discussione animata con i due colleghi, discussione che proseguì dopo la lezione. Si formò un gruppetto peripatetico al quale ci aggregammo noi studenti. Cammina cammina, finimmo al bar Università. Mi piaceva stare a sentire quelle conversazioni filosofiche, pur capendoci poco. Gli altri due studenti se ne andarono alla chetichella e restammo in quattro intorno al tavolo, a bere birra. Luciano era seduto accanto a me. Io avevo una sigaretta spenta in bocca da un po’ di tempo. Tutta presa dall’ascolto dell’astruso scambio d’idee, mi ero dimenticata di accenderla. A un certo punto i due docenti si misero a discutere tra loro. Luciano si voltò verso di me e disse: “Che vuol dire ’sta sigaretta spenta in bocca?” Non mi feci cogliere di sorpresa. “È un simbolo fallico.” Risposi. 35 “No,” ribatté lui, “per Freud la sigaretta è una gratificazione orale.” E io: “Embè, un simbolo fallico non può essere una gratificazione orale?” Ci conoscemmo così, e la nostra amicizia prese subito la piega giusta. Un amore a prima vista. Lo invitai a casa mia. Lui non mostrò nessuna sorpresa quando gli dissi che volevo essere pagata; anzi, tirò un sospiro di sollievo. In seguito mi rivelò che non sperava di meglio. Un rapporto mercantile, sosteneva, è un rapporto paritario e leale. I due soggetti danno e ottengono quello che vogliono e mantengono la propria autonomia. “Se la puttana non ha un pappa, non produce neanche plusvalore.” Disse. Chiesi delucidazioni: “Che vuol dire?” E lui, paziente: “Che non è sfruttata.” E siccome restavo perplessa, chiarì: “Quando chiamo l’idraulico a sturarmi il lavandino gli pago l’intero valore del suo servizio, e se lui è un lavoratore autonomo non c’è nessuno che ci guadagna sulle sue fatiche. Insomma scambio eguale.” Mi spiegò che nello scambio eguale i rapporti umani resterebbero liberi da incrostazioni ideologiche e le motivazioni, depurate dal sentimento, verrebbero ridotte alla loro pura base materiale, il piacere, fisico, animale, o i soldi, che è lo stesso. Gli obiettai che lo scambio non è realmente paritario, visto che una parte aliena il proprio corpo, cioè se stessa, mentre l’altra dà via solo il proprio denaro. Lui rispose che questo è vero per la prostituzione come per qualsiasi altra attività lavorativa remunerata e che anch’io, quando andavo a lezione da lui, pretendevo una parte della sua persona in cambio di denaro. Imparai subito che non ci si poteva ragionare con lui quando si trattava di rovesciare il senso comune. Trovava sempre un argomento che ti metteva a tacere. 36 Una volta provò perfino ad analizzarmi. Esordì con una sparata: “Le oneste puttane mi piacciono perché sono le uniche donne capaci di guardare un uomo negli occhi dicendogli sinceramente quello che vogliono.” Un’uscita niente male, che però non mi fece effetto. Lui capì dal mio sguardo che non sono una che si lascia incantare da certe battute alla Woody Allen, e non ci provò più. Poi cercò di spiegarmi, lui, le ragioni che mi avrebbero indotto a scegliere questo mestiere. A letto, finito di fare l’amore, i clienti si scoprono missionari, dopo le prime volte, e mi domandano delle circostanze che mi hanno spinto alla prostituzione. Accade con quasi tutti. Ormai lo so, e mi sono preparata due o tre storielle, tipo ragazzamadre-cacciata-dalla-famiglia e simili. Racconto l’una o l’altra a seconda della persona che ho davanti. Luciano invece affrontò l’argomento dopo qualche tempo che ci frequentavamo, dopo avermi conosciuto un po’. Mentre stavo cercando di raccontargli una di quelle storielle, m’interruppe. “L’ultima persona a cui chiedere perché un’onesta puttana ha scelto il mestiere è lei stessa.” Disse. “Immagino che se invece lo chiedo a te avrò tutte le spiegazioni del caso.” Lui prese l’abbrivio: “Le motivazioni possono ridursi a due. La prima è il piacere. Nessuna fa la prostituta se non le piace. Sarebbe un piacere, più che fisico, spirituale, non quello della troia, quello della ribelle: il piacere della trasgressione, non del godimento. In una cultura dove alla donna è concesso di usare il corpo per tutti gli scopi meno che solo per il proprio piacere, si deve provare un gusto terribile a usare il corpo solo per i propri scopi. La seconda motivazione sarebbe la libertà. In una società che consente alla donna di entrare in rapporto spirituale con gli altri soltanto corporalmente, dando via il proprio corpo, al marito, ai figli, al principale, alla chiesa, l’unica libertà possibile per lei è di dare agli altri soltanto il corpo, di non entrare in rapporti spirituali, di conservare il proprio spirito per se stessa.” Lo interruppi io stavolta: 37 “Hai detto onesta puttana. Ci sono anche le puttane disoneste?” “C’è l’ampia classe delle puttane, che include quasi tutte le donne, comprese quelle sposate. C’è poi il sottoinsieme delle puttane oneste, costituito dalle prostitute in senso stretto. Infine c’è un insieme ancora più piccolo, che è quello delle troie.” Mi lasciai coinvolgere in una discussione concettosa che presto si allontanò dalla mia persona e prese il volo verso l’astrazione. E mi accorsi che mi piaceva. Lui lo capì, e colse l’occasione per trarne profitto, la mia parcella essendo un po’ salata per le sue finanze. Disse che in nessun posto meglio che a letto si può capire la filosofia del boudoir. Mi resi conto che in realtà stavamo entrambi cercando di stornare il nostro rapporto dallo squallore dello scambio mercantile. Gli prospettai un accordo, gli proposi di pagarmi in natura, dandomi lezioni private. La cosa gli piacque e l’accettò subito. Così prendemmo l’abitudine di farci delle lunghe discussioni filosofiche dopo le consuete pratiche di letto. Più tardi gli chiesi una bibliografia per seguire il Nuovo corso di filosofia nel boudoir. Lui disse che non esisteva bibliografia. Mi suggerì di leggere il vecchio corso, tanto per farmi un’idea dello spirito del Nuovo, il quale tuttavia sarebbe troppo nuovo per potersi appoggiare a qualsiasi altro testo di riferimento. Dopo molte mie insistenze, acconsentì a farmi leggere i suoi appunti per il seminario. Era poca roba, una ventina di pagine di aforismi raccolti in quattro capitoli. Su ciascun aforisma, durante la lezione, lui faceva qualche meditazione. È in questo modo che si svolgeva il corso. Solo dall’ascolto della sua parola, diceva, si potevano capire quegli aforismi. In realtà non ci si capiva molto neanche così. E gli appunti non mi furono di grande aiuto, anzi, mi confusero ulteriormente le idee. 38 Mercoledì, 15 maggio. Stamani presto mi telefona Lucrezia e mi chiede un appuntamento. Ha bisogno di parlare con qualcuno e la prima persona che le è venuta in mente sono io. Arriva alle cinque. La faccio accomodare nel salotto rosa, dove accolgo i clienti. Lei mi dice subito che vuole soltanto parlare. È una donna che quasi non conosco per niente eppure m’intriga parecchio. Forse m’identifico in lei, e se cerco di evocare con diligenza il suo aspetto è perché la vedo come l’essere infelice con cui il genio faustiano è stato per qualche tempo quasi ammogliato. Così per descriverla non ho trovato niente di meglio che usare belle parole rubate, e tanto peggio per chi le troverà stucchevoli. Ha un viso simpatico, seppur un po’ stanco, e un corpo da adolescente di una freschezza insolita. Ha dei begli occhi neri, come giada, come le more mature, non molto grandi ma animati da uno sguardo aperto e limpido, limpido come il rosso moderatamente vivo delle labbra. Non c’è niente di artificiale in lei, nessun atteggiamento, nessuna simulazione. La grazia naturale con cui i capelli neri sono tirati a crocchia sulla nuca richiama il lavoro di mani intelligenti, mani che non stanno mai ferme, come in una danza continua. Il suo sorriso non molto frequente e il riso ancora più raro scoprono denti piccoli e bianchissimi. Facciamo un po’ di convenevoli per avviare la conversazione, ma senza risultato. Per un buon quarto d’ora i silenzi si susseguono più lunghi dei sospiri. Poi lei rompe gli indugi. “Sono distrutta.” Dice, agitandosi sul divano senza trovare requie. “Stavamo ricostruendo il nostro rapporto, con Luciano, e le cose sembravano ricominciare a ingranare. Invece...” “Capisco, sono esperienze tragiche.” Faccio, per mostrarle un po’ di partecipazione. La conversazione stenta ancora ad avviarsi. Allora le chiedo se vuole un tè. Dice di sì. Vado in cucina a prepararle un Lichee. Lei mi segue, si appoggia con le spalle al muro e mi guarda in silenzio. Io, taciturna quanto lei, preparo il tè. L’atmosfera è da imbarazzo freddo, come quando ti senti un 39 lui alle spalle e ti aspetti una dichiarazione d’amore che non desideri. Metto la teiera e due tazze su un vassoio di latta, un vassoio russo, tanto bello quanto naif, con quei ghirigori di fiori improbabili su fondo nero. Ricordo che lei lo trovò incantevole quando lo vide la prima volta. Sul vassoio ammucchio dei cantuccini di Prato. Quindi afferro il tutto con una mano, che sembro una cameriera di bar. Con l’altra prendo quella, timida, di lei. La trascino nel soggiorno, nel salotto verde ora. Il boudoir rosa è una specie di ambiente di lavoro, una saletta di passaggio dal piccolo ingresso alla piccola alcova nella mia piccola casa-bottega. Penso che forse è l’ambiente inadatto che ci impedisce di rompere la freddezza, bloccando la conversazione. Ci ricevo i clienti nel mio boudoir. Per questo scopo è fantastico, col suo arredamento dannunziano, i mille ammennicoli sui mobili orientali, le false stampe cinesi e i batik tanzaniani, i tappeti persiani, i cuscini indiani a fiorami che ricoprono il divano di vacchetta, e i mazzi di fiori di seta distribuiti con disordine nella stanza, e il narghilè, il fornelletto per l’incenso, l’ukulele, l’aulos e la sitar appesi al muro, insomma tutto l’armamentario kitsch con cui confeziono la mia merce. Il salotto verde invece è riservato alla mia privacy, è sobrio e caldo nello stesso tempo: divano e poltrone Frau color verde marcio, in un angolo; nell’altro un vecchio fratino tarlato che uso come scrivania; una parete ricoperta da una libreria con gli scaffali ricolmi; mentre sulle altre tre campeggiano sei belle riproduzioni di opere di Andy Wharol, oltre a un quadro che ritrae me stessa al lavoro, regalo di un vecchio cliente affezionato, una tela che spero un giorno varrà qualcosa, quando l’autore sarà diventato celebre dopo la morte. Appoggio il vassoio sul tavolinetto e verso il tè nelle tazze. Lucrezia si accomoda sul divano alla mia sinistra. Basta già il morbido profumo del Lichee a riconciliarmi col mondo. Anche lei si mostra subito sensibile a questa delizia. La guardo negli occhi, mentre riempio le tazze fumanti. Lei, per distogliere lo sguardo, si accende una sigaretta. Dà una tirata profonda e adagia la schiena sulla spalliera del divano. 40 Per qualche secondo guarda assorta un poster di Andy Wharol, sulla parete di fronte, che riproduce il volto di Marylin mentre sogna il suicidio. Dà altre due tirate alla sigaretta e la spegne. Afferra la tazza e con un unico sorso quasi la svuota. Cristo! Si sarà lessato l’esofago. Si versa ancora del tè e finalmente riprende: “Ho pensato molto negli ultimi giorni. Non riesco a venirne a capo. Credevo di aver superato Luciano, di poterne fare a meno, e che proprio questa maggiore autonomia mi consentisse di riavviare uno straccio di rapporto. Invece mi accorgo di non aver mai cessato di amarlo, dopo quello che mi ha fatto. Mi sento vuota, depressa. Mi sembra che sia tutto così privo di senso. Se non avessi da badare alla bambina...” “È una bambina abbastanza grande ormai.” Dico con spontanea cattiveria, ma me ne pento subito. Basta però per bloccare di nuovo la conversazione. Stava prendendo una piega spiacevole. Odio i piagnistei e i sentimentalismi. Mi accendo una sigaretta io, adesso, metto un disco di Gino Paoli e cerco di riavviare il discorso, portandolo dritto su Luciano. Che è ciò che interessa entrambe. Lei vuole sapere qualcosa che le è sempre sfuggito, qualcosa che non ha mai capito di lui. Non vedo come posso aiutarla. Mi chiede di raccontarle del mio rapporto con lui: in che occasione l’ho conosciuto, quando, perché, cosa ho rappresentato per lui. Mi assicura di non essere gelosa. Luciano le ha parlato spesso di me, dicendole che si trattava di una relazione professionale, ma anche che mi stimava parecchio. Stronza. “Sì, professionale,” mi difendo, “doppiamente professionale: cliente-puttana, professore-allieva. Vuoi che ti parli di me e di lui? Bene. Peggio per te.” Lei mi guarda con quegli occhi di bambina sconsolata, che vorrebbero dirmi: non essere cattiva. Mi lascio commuovere e le racconto il modo in cui conobbi Luciano a quella lezione di filosofia. Mi accorgo che mi piace parlare di me con Lucrezia. La cosa è insolita, dato che raramente riesco ad aprirmi con gli altri, e mi disturba un po’, a dire la verità. Ma ora prevale il piacere della confessione. Per cui continuo a narrarle gli inizi del mio 41 amore con Luciano. Evito di calcare la mano sulle nostre pratiche sessuali e insisto soprattutto sugli scambi intellettuali. L’effetto non è meno deprimente per lei. “Questa è una cosa in cui credo di aver mancato con lui.” Mi dice, come esternando un discorso interiore. “Da lungo tempo ormai non discutevamo più di filosofia, di sociologia, di politica, insomma di temi elevati.” Parla sorseggiando calma, adesso, e guardando nel vuoto, con uno sguardo triste che mi fa una tenerezza... “Nei primi tempi,” riprende, “tra il ’69 e il ’73, si parlava invece molto di teoria. Si andava alle assemblee e alle manifestazioni, si discuteva, si studiava insieme.” “Hai fatto il Sessantotto con lui?” “L’ho conosciuto nel ’69, a una manifestazione. Erano giorni di entusiasmo e di slancio.” Gesù! Un’altra ex combattente, mi viene da pensare. Quello che lei dice subito dopo, però, cattura completamente la mia attenzione. “Mai un filo di grettezza nei rapporti umani,” continua, “l’altruismo, la dedizione, erano sentimenti veri, seppur rivolti a oggetti abbastanza astratti. I nostri rapporti personali partecipavano di questo senso di trascendenza. Vivevamo in un universo a parte, diverso dal mondo reale. Lì crebbe il nostro amore. Fu quando quell’universo finì che cominciarono i problemi.” A questo punto s’interrompe e mi guarda perplessa. Vede che mi sono fatta attentissima. Non sa se andare avanti. La sento così indifesa, così sofferente. In uno slancio d’affetto mi avvicino a lei, le prendo una mano nella mia e le metto un braccio sulle spalle. Lei piega la testa sul mio braccio e si mette a piangere in silenzio. Dopo un po’ si calma, si accende un’altra sigaretta e riprende a parlare: “Nel ’73 smettemmo con la politica. Lui vinse una borsa di studio all’università. Io mi avviai al lavoro di assistente sociale. Le nostre strade cominciarono a divaricarsi. Le cose continuarono a filare bene per un po’ di tempo, ad ogni modo. Forse fu merito della bambina, che nacque quell’anno, e alla quale ci dedicammo completamente, entrambi. Il dialogo tra noi però già 42 si faceva scialbo: non più i grandi problemi, la rivoluzione, l’uomo nuovo eccetera eccetera, bensì i pannolini, l’affitto, e chi doveva fare la spesa e chi lavare i piatti. Lui poi, a un certo punto, gli prese una gran frenesia sessuale. Non era soddisfatto di niente, il nostro rapporto non lo appagava. Mi proponeva sempre cose strane e diverse. Io mi prodigavo, ma la sua insoddisfazione cresceva. Il fatto è che non sapeva neanche lui cosa voleva. I normali orgasmi non gli bastavano, e ti assicuro che non erano tanto banali. Quanta gente si sarebbe accontentata di molto meno! Un giorno mi propose di fare la coppia aperta. Io naturalmente rifiutai.” “Perché?” Domando a bruciapelo. “Perché non erano più tempi per quelle stronzate. Sapevo dove si sarebbe andati a finire. Pensavo che lui mirasse soltanto ad avere il mio consenso per provarci con altre donne. Io del resto non ne avevo bisogno. Ma il mio rifiuto non servì. Lui anzi se ne sentì autorizzato a badare ai fatti propri e cominciò a cercare rogna con le segretarie, le baby sitter e le studentesse. Il peggio fu che me lo venne a raccontare, il cretino. Io avrei anche fatto finta di niente se avessi potuto. Invece fui costretta a darmi da fare. Fui costretta, capisci? Per non perdere la mia dignità. Non sarebbe stato un rapporto paritario se io non fossi stata capace delle cose di cui era capace lui. Proprio io, che stavo così bene coi miei due orgasmi settimanali. Insomma, preferii rischiare di perdere lui piuttosto che la sua stima. Naturalmente, come temevo, l’uomo si dimostrò al di sotto delle sue stesse aspettative. Fu una debacle completa. Quando ebbi trovato un amante anch’io, e lui lo ebbe saputo, i nostri rapporti si raffreddarono definitivamente. Innanzitutto sul piano sessuale. Semplicemente lui non aveva più voglia di fare l’amore con me, e questa fu la classica goccia. Con l’amante non ci provavo un gran gusto, con Luciano ormai non combinavo niente. Fatto sta che cominciammo a litigare di brutto. Il seguito è storia scontata: la separazione, la convivenza forzata e tutto il resto.” “Non stavate riavvicinandovi, recentemente?” “Imparammo a convivere. Io non me ne sarei mai andata senza la bambina e, per non far vivere nell’inferno anche lei, cer- 43 cammo di comportarci da persone civili. All’inizio fu difficile, soprattutto perché i miei sentimenti per Luciano si erano fatti un po’ confusi e piuttosto tendenti all’odio. In seguito imparai pian piano a distaccarmi da lui. Non che ne scoprissi i difetti: li conoscevo già da tempo. Ma ne smascherai i pregi, lo smitizzai. Nello stesso tempo imparavo a fare i conti coi miei limiti, la mia dipendenza dagli altri, la mia continua ricerca di sostegno. Infine capii che lui non era una parte indispensabile della mia esistenza e che potevo farne a meno. Giunsi alla conclusione, a quei tempi, che il mio attaccamento era solo un segno della mia debolezza, di un bisogno di sicurezza. La separazione mi ha fatto crescere. Ai suoi occhi riacquistavo valore man mano che mi dimostravo capace di fare da sola. Da parte mia, diminuiva il risentimento. Così, gradualmente, il nostro menage riprese una piega umana. In seguito ricominciammo ad avere qualche rapporto sessuale.” “Aveva smesso con le altre?” Mi guarda storto: “Aveva smesso con te?” “Scusa.” “Nelle altre non cercava il piacere sessuale, tanto meno l’amore. Era una specie di malattia dello spirito. Non precisamente dongiovannismo, piuttosto un desiderio di stordimento, un’urgenza di fuga.” “E quelle cose strane che ti aveva chiesto, te le chiedeva ancora?” “Sì, e alcune le facevo, ma non tutte mi piacevano. Per esempio, ce n’era una che proprio non digerivo. La chiamava tecnica di Oshima, sai...” “Sì, la praticava anche con me qualche volta.” “E con Lilli, soprattutto con lei. Con lei gli veniva bene, sembra. Be’, sai che ti dico? Secondo me può ben essere morto in quel modo. A me faceva impressione dovergli stringere la gola, vederlo diventare tutto rosso, gli occhi fuori dalle orbite, al limite della soffocazione. Smettevo sempre prima del momento giusto, prima di quando lui riteneva necessario. Posso credere invece che la sadica lo stringesse fino all’ultimo istante desi- 44 derato. Non può aver esagerato una volta? Magari nella foga di un’orgia?” “A me Luciano disse che non sarebbe stato possibile; che un attimo prima di perdere conoscenza mi avrebbe fermato.” “Lo disse anche a me. Ma cos’è un attimo? D’altronde credo che la cosa gli piacesse proprio perché era rischiosa.” “A me l’aveva spiegata diversamente.” “Immagino. Ti avrà raccontato quattro fregnacce sul tantrismo, lo yoga e tutto il bla bla bla mistico. Sono balle a cui poteva credere quella strega, non io. Insisto. L’assassina potrebbe essere Lilli. Forse involontaria. Forse ha esagerato senza volerlo. Chissà... al buio... nella confusione.” “È un’ipotesi interessante. Voglio sentire lei.” “Cosa vuoi che ti dica?” “Certo non le chiederò se l’ha ammazzato.” Conclusi. “Cercherò di capire se quella sera hanno praticato la tecnica di Oshima.” È mezzanotte quando finiamo di parlare. Lucrezia sembra stanca. Si alza dal divano e si avvia verso la porta. L’accompagno. Mi ha fatto piacere parlare con lei così apertamente. Le dico che vorrei essere sua amica. Sulla porta l’abbraccio e la bacio. Lei sorride timidamente e se ne va. Un giorno, diversi mesi dopo che lo avevo conosciuto e quando la conoscenza si era fatta dimestichezza, chiesi a Luciano perché si era separato da Lucrezia. La risposta fu secca: “Era finito l’amore.” “Ma va là!” “Non ti sembra un motivo valido?” Era uno dei rari momenti magici che seguono una scopata felice, di quelle in cui i corpi esprimono sentimenti. Stavamo nudi sul letto a fumarci la consueta sigaretta distensiva. Fu lui che cominciò a parlare dell’ex compagna e del senso di fallimento da cui era stato pervaso dopo la separazione. Così mi venne naturale fargli quella domanda scema. La sua risposta mi suonò provocatoria. No, non mi sembrava un motivo valido. Glielo dissi, e aggiunsi: 45 “Non ho mai sentito un uomo giustificare la separazione in questo modo. Suona insincera. È poco convincente.” “Quale sarebbe stata una risposta convincente?” Domandò con un tono che ora suonava sarcastico. “Che so? Vi siete separati perché lei ti ha scoperto con l’amante.” “Ora ti stai identificando in lei. Capisco che una donna possa sentirsi meno annientata se il suo uomo le dice che la lascia per un’altra piuttosto che perché non l’ama più.” “Certo. Si sentirebbe tradita, non umiliata.” “Solo se fosse una donna superficiale.” “In che senso?” “Primo: il tradimento sarebbe la causa immediata, ma cos’è che lo avrebbe causato a sua volta? Un uomo non si fa l’amante se ama ancora la compagna. Secondo: perché mai la confessione del disamoramento dovrebbe causare umiliazione?” “Mio caro, sei tu adesso che ti mostri superficiale. Il fatto è che se una donna è abbandonata per un’altra, può attribuire la colpa del proprio fallimento alle arti dell’altra e alla debolezza di lui. Ma se è abbandonata perché lui non l’ama più si sentirà distrutta, incapace di essere amata, uno sfacelo esistenziale, una colpa propria, e senza speranza di remissione.” “Non stavo dicendo la stessa cosa?” M’interruppe. “Non mi sembra.” “Perché non mi hai fatto finire di parlare. Alla tua spiegazione io aggiungo che la donna abbandonata dovrebbe sentirsi ugualmente miserevole, anche se la motivazione immediata fosse il tradimento. Miserevole, non umiliata.” Lo guardai incuriosita. Non riuscivo a capire se era sincero o mi stava prendendo per il culo. “Mi sa che mi stai prendendo per il culo.” Dissi. “Ma perché?” “Come se non fosse mai accaduto che un marito tradisce la moglie per fare una scappatella.” “Allora non si parla più di amante. E guarda che una sveltina non è mai stata un valido motivo per la separazione.” 46 “Questo è vero,” approvai, “ma solo perché i matrimoni solidi non sono fondati sull’amore.” “Cara, veramente sei così cinica?” “Sei tu il cinico. Stiamo a letto dopo una scopata appassionata e mi vieni a parlare d’amore come se fosse una religione.” “L’amore è una religione,” sentenziò sottolineando il verbo, “l’unica fede che ci è ancora concessa.” “Questa me la devi spiegare.” Non l’avessi mai detto. Lui spense la cicca, scese dal letto e andò al mobile bar, dove si versò un mezzo bicchiere di cognac. Poi andò al giradischi e mise su La canzone di Marinella. Proprio la musica appropriata. Indossò una vestaglia, tornò a letto, si sedette con le gambe incrociate, appoggiò la schiena alla testiera, e si dispose a tenermi una lezione. “Viviamo in un mondo senza senso. La vita non ha senso, la storia non ha senso, la società non ha senso. Dio si è preso gioco di noi: ci ha dato la ragione solo per farci capire che Lui non esiste, e quindi che l’esistenza non ha senso.” “E allora?” “E allora perché dovremmo arrabattarci a tirare avanti?” “Dimmelo tu.” “Per l’amore. Quando amiamo, tutto acquista senso.” “Com’è possibile, se non per una forma di autoinganno? La ragione che ci fa capire la morte di Dio, come può farci credere alla sua verità?” “L’amore mette a tacere ogni ragione, e ci fa entrare in una realtà trascendente in cui tutte le assurdità della vita perdono forza. Quando amiamo ci sentiamo trasportati oltre noi stessi. Formiamo con la persona amata una comunità perfetta, la nostra individualità diventa inconcepibile se vista come separata dall’altro.” Io lo stavo a sentire un po’ turbata e un po’ perplessa. Non riuscivo a capire cosa mi stava dicendo, cosa voleva dirmi. Era solo una futile disquisizione speculativa, o stava tentando di rivelarmi qualcosa di vero? L’incertezza mi spinse a interromperlo bruscamente: “Di cosa stai parlando?” 47 “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore?” “Bellina la citazione minimalista. Il che conferma che stai facendo della letteratura.” “No, della filosofia, nel senso più profondo.” “Tesoro, è un esame che ho già fatto. La conosco la teoria dell’essere per l’altro.” “Lascia perdere Hegel. Ho detto filosofia, non teologia.” Se lo avesse detto stizzito, lo avrei forse preso sul serio. Invece c’era quel sorrisetto sarcastico sulla sua bocca che mi disorientava sempre di più. Fui io a stizzirmi: “Sto aspettando una risposta. Di cosa parlavi?” Lui non fece una piega, e scrutandomi con uno sguardo divertito concluse: “Quando l’altro diventa parte di te e tu di lui, quando riesci a rapportarti a te stessa come a un noi, allora e solo allora giungiamo a sentire che la vita è degna di essere vissuta.” Quel sorrisetto non sarebbe bastato a convincermi che stava celiando. Fu il passaggio dal tu al noi che mi convinse del tutto. Per cui decisi di tagliare corto: “Mi sa che mi stai proprio prendendo per il culo.” “Amore, è questo che mi affascina di te. Tu sei l’incarnazione del disincanto del mondo.” “Ah, ecco perché ti piaccio!” “Questo è solo il fascino intellettuale. C’è dell’altro.” Seguì una breve sospensione, che a me sembrò lunghissima. Mi feci attenta, in bilico tra la speranza e il timore. Quale altra stronzata mi stava preparando? O voleva dichiararmi un sentimento? Non interloquii, aspettando che fosse lui a riprendere il discorso. Infatti: “Tu mi piaci”, disse, “perché sei più troia che puttana.” Restai in silenzio. Avevo voglia di aggredirlo, ma mi controllai. Lui spiegò: “Fra una puttana e una troia c’è la stessa differenza che corre fra Lucia Mondella e la monaca di Monza.” “Adesso sì che è chiaro.” 48 “Una puttana è una che usa il proprio corpo come mezzo per conseguire un fine, il danaro, la protezione, la sicurezza… la pensione di reversibilità.” “E una troia?” “Lo usa come un fine.” “Aridaje con la filosofia!” “Beh, mi dispiace ma ora una vera lezione te la devo proprio fare. Vedi, il tipo della donna-puttana, quale si è affermato nella cultura occidentale moderna, è un prodotto del cristianesimo. Nella cultura greco-romana la donna era una cosa, un oggetto sotto il completo dominio del maschio, poco più che una schiava. Nell’Antico Testamento si trova la stessa realtà. Il comandamento di Mosè dice: Non desiderare la donna d’altri, né lo schiavo, né l’asino, né la casa, né il campo. Alla strettissima minoranza di donne che volevano considerarsi persone, nelle società antiche, erano aperte solo due vie: quella del sacerdozio, nella quale ci si liberava uscendo dal mondo, e quella della cultura, in cui si sfidavano i maschi sul loro terreno più elevato, una via temeraria.” “Già, Saffo, Ipazia…” “Brava, capisci al volto.” “E che fece il cristianesimo?” “Liberò la donna dalla schiavitù facendone un soggetto giuridico, però limitandone le facoltà contrattuali.” “Che vuol dire?” “Non la liberò abolendo i diritti di proprietà sul suo corpo, bensì assegnandoli a lei stessa, insieme alla responsabilità morale del suo uso. E tra gli usi moralmente leciti non ammise il godimento sessuale. Poteva usare il proprio corpo, ma non per il proprio piacere. Doveva usarlo con finalità superiori: la riproduzione, la carità, la coesione famigliare…” “Ho capito. Il cristianesimo ha desessualizzato il corpo della donna mentre le assegnava il potere di usarlo come un mezzo. Per questo tutte le donne sono puttane.” “Esattamente.” “Dunque mi stavi facendo un complimento quando mi davi della troia.” “Si, amore.” 49 “Come hai detto?” “Ora non ti montare la testa. Ciò che volevo dire è che tu sei una delle poche donne a mia conoscenza che hanno portato a compimento la rivoluzione morale iniziata da Kant e proseguita dalle moderne streghe.” “Insomma il tuo è un amore filosofico.” “Ti sembra poco?” 50 Giovedì, 16 maggio. Telefono a Lilli e la invito a cena. Alle otto di sera mi si presenta a casa. Porta con sé Puffi, un chihuahua tanto brutto quanto smanceroso. I cani non sono la mia passione. Tra tutte le razze, poi, questi mostriciattoli in miniatura li trovo insopportabili: più che di accarezzarli mi verrebbe voglia di acciaccarli. Lilli invece... si tiene il suo Puffi sotto il braccio come si può portare una borsetta di pelle pregiata. Appena lo posa per terra lui mi bagna la moquette. Evidentemente i miei sentimenti sono ricambiati. Meno irritata di me è la mia gatta la quale, alla vista di quella bestia, dall’alto dello scaffale su cui sonnecchia fa uno sbuffo di noia e si rimette a ronfare. Lilli è completamente partita per il cagnetto. Un giorno abbiamo avuto anche una conversazione semiseria sugli animali domestici. Io amo le gatte. Ne ho una sensuale e superba, so che la mia morte non potrebbe sfiorarla e ciò mi rasserena. Si chiama Elsa, non è di razza pregiata, ma è elegante, col suo manto nero corvino, il passo flessuoso, le movenze indolenti. Dei gatti mi piace soprattutto il carattere, la loro indipendenza, direi quasi la loro indifferenza verso l’uomo. Mi danno l’idea di un assoluto distacco dalle cose terrene. Se ne stanno per conto loro. Non danno niente a nessuno e non chiedono niente. Frequentano gli esseri umani con dignità e con un certo disincanto. Né gli è mai passata per la mente l’idea di avere un padrone. Sono piuttosto portata a credere che quello che per noi è un padrone per loro è solo un incomodo coinquilino. Lo sopportano, a volte con sufficienza, altre con condiscendenza; gli permettono perfino delle carezze e, se ci tiene, possono arrivare a fargli le fusa. Ma sempre senza il minimo coinvolgimento sentimentale. Proprio il contrario dei cani, con quei loro scodinzolamenti e sculettamenti, le immonde leccate sulle mani del padrone, i ripetuti atti di sottomissione, quando si sdraiano per terra a pancia all’aria, quel loro implorare benevolenza, quando poggiano la testa sulle ginocchia del padrone per farsi accarezzare, insomma tutta la loro indecorosa affettività. Credo che il cane sia un animale per 51 uomini frustrati, e per una ragione molto semplice: soddisfa il loro bisogno di padronità, ciò che mi fa riflettere sulle virtù di Lilli e mi dà una chiave della sua anima. Dunque: Lilli. Per farsi perdonare della pisciata del cane, e sembra se lo aspettasse, mi porge una scatola di marron glacé con un sorriso inverecondo. In cambio s’invita a cena. Questa leccornia, lei lo sa, mi piace sfacciatamente. Ci sediamo nel salotto rosa e ci divoriamo subito la scatola di dolci. Dopo di che preparo una cenetta estemporanea, più un brunch che altro, a base di salmone affumicato, crostini di paté e pinzimonio. Il tutto bagnato con un Morellino del ’79 dal retrogusto di fragola. Facciamo un po’ all’amore, senza entusiasmo, neanche da parte sua. Dopo, a letto, chiacchieriamo a lungo. Quando lei se ne va, è notte fonda. Ora sono qui sul mio diario, e medito attendendo il mattino. Lilli, a letto, è precisamente come nella vita, dinamica, efficiente, attiva. Però non è questo il suo meglio. In certi momenti sa anche essere dolce. Quando le appoggio la testa sul ventre, lei mi passa le mani tra i capelli e mi parla con la sua voce calda. Mi dice le parole semplici e affettuose che una madre può dire a una bambina. Quando si mette a carezzarmi delicatamente, e le sue mani scivolano leggere sul mio corpo, sento che le forze mi vengono meno e cado in uno stato di abbandono. Mi rilasso così a fondo, con lei, sia pur per pochi momenti! Per quei momenti sarei disposta a pagarla io. È una strana donna, Lilli. Mi paga per fare l’amore e fa tutto lei. M’inibisce ogni iniziativa e mi tratta come una cosa da manipolare a sua volontà. A volte riesce a darmi due o tre orgasmi per notte, e lei mai niente. “Con te cerco il piacere di dare piacere.” Dice. “Mi sento viva quando ti vedo fremere sotto le mie mani. Quando ti vedo gemere e tremare e scuoterti tutta, mi prende un emozione potente e mi viene un groppo alla gola. È una specie d’orgasmo di testa. Con nessun uomo provo una sensazione del genere. E tra le donne solo con te la provo lancinante a tal punto. Tu sei così tenera, arrendevole, così malleabile tra le mie mani, che mi sembri un oggetto di mia proprietà in quei momenti, e il tuo orgasmo 52 mi sembra mio. So che è anche mestiere, per te. Sei molto brava, lo so. Ma i tuoi orgasmi sono veri. E il fatto di riuscire a provocarteli pur a dispetto della tua venalità rende ancora più intenso il mio piacere. O devo credere che sei una donna dall’orgasmo facile? Hai l’orgasmo con tutti i tuoi clienti?” “Figuriamoci! Con pochissimi. Non crederai mica che faccio questo mestiere per piacere!” “Allora perché lo fai?” “È facile, remunerativo, non faticoso...” “Insomma, se non piacevole...” “Vedi, con il corpo che ho, la cultura, l’eleganza e tutto il resto, posso permettermi cose che la puttana media neanche si sogna. Intanto, una parcella salatissima. Poi una clientela selezionata, selezionata nel senso che i miei clienti me li scelgo io. Così non sono costretta agli straordinari e a pratiche disgustose, e ho meno rapporti sessuali in un mese di quanti ne ha una sposina innamorata.” “Una scelta razionale e meditata...” “Forse non precisamente una scelta. È venuta da sé. Una volta facevo la segretaria. Ho cominciato col darla al principale, un bell’uomo ricco e potente. In seguito ho dovuto fare l’accompagnatrice con qualche cliente della ditta. Qualcuno ci provava, anzi quasi tutti. Io feci resistenza dapprima. Poi quello stesso principale mi fece un discorsetto. Be’, i soldi mi piacciono e il resto puoi immaginarlo. Più avanti mi licenziai da segretaria e passai a un’agenzia di escort, ma feci presto a capire che mi conveniva mettermi in proprio. Insomma la scelta è venuta naturale, direi, e ora la vivo come una specie di vocazione.” “Non ti sei mai innamorata?” “Dei clienti mai. Prima di cominciare il mestiere sì. Due volte, follemente, e finì con due grosse delusioni. Dopo di che mi sono proibita di cascarci di nuovo. Si soffre troppo con l’amore. Quando t’innamori di un uomo ti metti nelle sue mani, ne diventi la schiava, sia pure felice, e sei disposta a dare tutta te stessa per lui. La tua vita si risolve in lui, vi trova uno scopo, ne ottiene un senso. Per lui è diverso. L’uomo ha sempre qualcosa d’importante da fare. Non può perdersi in una donna. Tu non 53 puoi fare a meno di lui e lui ti accetta solo se non intralci il perseguimento dei suoi fini superiori, meglio se lo aiuti a raggiungerli. Tu ti metti nelle sue mani e lui ti usa. Tu ti fai un fine di lui e lui si fa un mezzo di te. Insomma io ho avuto dei rapporti più umani con alcuni dei miei clienti che con gli uomini di cui sono stata innamorata. Con quelli almeno sono sempre me stessa, appartengo sempre esclusivamente a me stessa. A loro non do l’anima, gli vendo un servizio. Se dovessi spiegare la mia scelta in quattro parole, potrei farlo con una frase che non troverai mai in un bacio Perugina: io non ho bisogno di chiedere a un uomo se mi ama per sapere che esisto.” “Questa me la devo scrivere. E con Luciano non era sorto un amore?” Mi prende di contropiede, non tanto per il sarcasmo della prima frase quanto per l’improntitudine della seconda. “Mah?! Con Luciano non ci ho mai capito niente. Lui non era un cliente qualsiasi, lo riconosco. Avevo un legame speciale con lui, un rapporto alquanto travagliato. Peraltro era uno dei pochi uomini che riuscivano a darmi degli orgasmi veri. Dell’amore avevamo addirittura teorizzato l’inutilità. Ora penso che forse ne avevamo paura. Il gesto di darmi i soldi prima di entrare nel mio letto, i primi tempi del nostro rapporto, era una specie di esorcismo. Tant’è vero che, dopo aver deciso di passare al baratto, con lui che mi dava delle lezioni di filosofia, il nostro interscambio sembrò diventare meno autentico. Come che sia, devo ammetterlo: alla fine mi sa che mi sono innamorata.” “Sul serio avevi l’orgasmo con lui?” “Sì, era molto bravo, tecnicamente. Più che la tecnica, però, contava l’atteggiamento, quel suo modo di trasformare tutto in gioco, quella pacata affettuosità.” “Con me non c’è mai riuscito.” M’interrompe. “Non ho mai avuto un orgasmo con lui. Certo era piacevole scoparlo. E da me si faceva proprio scopare, sapeva che mi piaceva così. Mi divertivo con lui. Imparavo anche un sacco di cose…” “Quali cose?” La conversazione comincia a farsi interessante e cerco di prenderne le redini. “Sai che m’interesso di scienze occulte. È una passione cominciata diversi anni fa, subito dopo la mia entrata in solitu- 54 dine. Mi ha preso un po’ per curiosità e un po’ per noia. Col passare del tempo mi ha assorbito sempre di più e oggi è una vera missione. Bene, Luciano aveva una conoscenza vastissima della materia. Aveva studiato su testi antichi, indiani, tibetani, giapponesi e mi dava consigli di lettura, mi spiegava le cose che non capivo, mi chiariva il senso di molti simboli, mi rivelava il significato di certi riti.” “Luciano credeva a quelle cose, secondo te?” “Non proprio, almeno non nel senso che pensi tu adesso. Sosteneva che certe antiche pratiche mistiche contenevano una saggezza profonda e prefiguravano alcune tecniche delle psicologie umanistiche moderne. Per esempio, lui praticava il training autogeno, una tecnica di rilassamento psico-fisico e autoipnosi. Non solo l’aveva sperimentata, ma l’aveva modificata e adattata ai propri bisogni. Be’, sosteneva che lo yoga non sarebbe altro che una forma primitiva di training autogeno, una forma molto contorta, almeno il tipo di yoga giunto fino a noi, soprattutto per l’ideologia spiritualista di cui era impregnato. Però, trattandosi di una pratica sperimentata da millenni, sosteneva che avrebbe potuto essere più efficace del training autogeno se si fosse riusciti a liberarne l’aspetto tecnico dalla sovrastruttura mistico-religiosa. Lui faceva degli esperimenti anche con lo yoga, e qualcuno lo facevamo insieme.” “Come il Panchatattva?” “Il Panchatattva lo praticavamo spesso. È un rito proveniente dal tantrismo. La filosofia sottostante è sconvolgente per la nostra mentalità occidentale, per una mentalità formatasi sulla matrice religiosa giudaico-cristiana. L’idea di fondo è semplice: nell’unione che l’uomo e la donna raggiungono al momento dell’orgasmo si verifica l’unità dei due principi fondamentali dell’universo, Shiva e Shakti. La gioia dell’orgasmo non è altro che il segno della raggiunta unione, un’esperienza mistica. La civiltà ha teso costantemente a diseducare l’uomo e la donna all’esperienza del sacro, quindi a indurli ad avere orgasmi meno lunghi e meno intensi possibile. Luciano sosteneva che l’estasi è un’esperienza sommamente distruttiva dal punto di vista della convivenza sociale, perché svela il vuoto su cui poggiano tutte 55 le certezze umane. Per questo la società ha sempre teso a soffocarla. I monasteri e i manicomi non sarebbero altro che degli strumenti di ghettizzazione del sacro.” “Parlami del rito. In cosa consiste?” Non le dico che ne so almeno quanto lei. “Abbi pazienza, ora ci arrivo. Dunque, il Panchatattva è una tecnica dell’estasi; una tecnica dell’estasi essenziale, in quanto interpreta l’illuminazione per quello che veramente è: un orgasmo portato al parossismo. Scarta le umilianti pratiche della sofferenza e della macerazione della carne, e va dritto alla meta servendosi dello strumento più efficace, il sesso.” “E siete riusciti a raggiungere l’estasi?” “Io no, ma non dispero, anche se ora dovrò trovarmi un altro partner.” “E Luciano?” “Lui qualche volta aveva degli orgasmi potenti, che però considerava dei fallimenti. Cercava qualcos’altro.” “Avete mai provato la tecnica di Oshima?” Vado al sodo, visto che lei continua a girarci intorno. “Ehi, vedo che la sai lunga pure tu.” “L’abbiamo praticata, qualche volta. Lui comunque non mi ha mai spiegato molto.” Mento. “Ho sempre pensato che fosse una delle tante tecniche amatorie di cui era esperto, solo un po’ più rischiosa delle altre.” “Era una variante del Panchatattva. L’aveva vista in un film di Oshima. Sosteneva che il regista doveva averla appresa in qualche bordello tradizionale. In Giappone deve essere stata praticata da tempi remoti in connessione con delle tecniche d’illuminazione buddista. Le geishe devono essersela trasmessa di generazione in generazione. Noi la eseguivamo così. Lui se ne stava immobile, supino, sotto di me. Si rilassava e si concentrava su un’immagine mentale. Io, sopra, lo cavalcavo come una Walkiria, col suo pene tutto dentro di me. Cercavo di eccitarlo e di farlo godere con ogni mezzo. Ma più io mi scatenavo, più lui si rilassava. E continuava a rilassarsi, finché diveniva un oggetto completamente passivo nelle mie mani, con il pene, però, sempre desto. Lo scopo era di aumentare l’eccitazione ritardando 56 l’orgasmo. A un certo punto gli mettevo le mani al collo e cominciavo a stringerlo, gradualmente, costantemente, fino ai limiti della soffocazione. In questo modo l’afflusso del sangue al cervello si sarebbe ridotto, il che doveva contribuire a creare le condizioni fisiologiche dell’estasi.” “Interessante. Non sapevo che avesse un significato religioso.” Mento di nuovo. “Qualche volta Luciano ha voluto provare la tecnica con me, per quanto non ne sembrasse particolarmente entusiasta. Né ha dato mai segni di estasi. Forse con te ha raggiunto quello che cercava.” “Bah! Di solito finiva con un orgasmo, più o meno potente. Lui, come ti ho detto, ne restava insoddisfatto. Una volta...” “Perché insoddisfatto?” la interrompo. “Perché l’estasi, secondo lui, non è soltanto un orgasmo estremo.” “E cos’è allora?” “Uno stato alterato di coscienza. Ma fammi finire. Una volta accadde un fatto inquietante. La mia stretta intorno al suo collo durava già da un pezzo, quella sera, e lui non dava segni di vita. Dopo un po’ mi sembrò che fosse durata troppo a lungo. Così allentai la presa e scesi da cavallo. Lui niente. Cercai di svegliarlo, pensando si fosse addormentato a forza di rilassarsi. Lui niente. Lo scossi violentemente, pensando a uno svenimento. Lui niente. Fui assalita dal terrore. Lui era diventato più bianco di un lenzuolo e più freddo di un pezzo di marmo. Gli sentii il polso, e non batteva. A quel punto persi la testa e cominciai a urlare e a schiaffeggiarlo. Ci fu subito il miracolo. Lui si svegliò di colpo, si alzò a sedere e mi guardò come se non mi conoscesse. Poi ci riprendemmo dallo shock, entrambi, e tutto tornò normale.” “Cos’era stato? Uno sturbo?” “Lui disse che si trattava di un esperimento riuscito parzialmente. Se fosse successo di nuovo, non avrei dovuto svegliarlo: si sarebbe svegliato da solo. Un esperimento di catalessi.” “Stai scherzando?” “No. Catalessi, un trucchetto da fachiri indiani. Una specie di morte apparente. Il respiro diventa così debole da essere impercettibile. Il cuore quasi si arresta, con un battito al minuto o giù 57 di lì, il corpo simula la morte. Dice che alcuni fachiri si facevano seppellire in catalessi, restavano nella tomba per diversi giorni e successivamente, dissepolti a una data prefissata, risorgevano vivi e vegeti.” “Luciano si divertiva con queste cose?” “Le provava. La catalessi, mi aveva detto, era un esperimento che praticava in solitudine, nella sua casa di campagna. Richiedeva silenzio, concentrazione. Quella non era la prima volta che gli riusciva. Però era la prima che l’imbroccava in presenza di qualcuno. Non lo aveva programmato. E non si aspettava che gli riuscisse con la tecnica di Oshima. Ciò lo preoccupava: significava che non controllava bene la situazione. Ero preoccupata anch’io. Chi impediva che lo strangolamento, una volta causata la perdita di conoscenza, non portasse alla morte vera?” Così, arrivate al dunque, le sfodero a sorpresa la domanda che covavo sin dall’inizio di questo dialogo surreale: “Ritieni possibile che Luciano sia stato ucciso in questa maniera l’altra notte?” Lei ci riflette un po’. Quindi risponde calma: “È possibile. Ci ho pensato. Ma se è andata così, non sono stata io. Dopo tutto, la tecnica di Oshima Luciano la praticava anche con te e con Lucrezia. Ad ogni modo è un’ipotesi ridicola. Se ci mettiamo sulla strada delle congetture più fantastiche, potremmo perfino arrivare a credere che Luciano la notte dell’orgia non sia effettivamente morto, che sia soltanto entrato in catalessi. No, secondo me è stato un omicidio premeditato, e per motivi molto concreti.” Il che ci porta a discutere dei possibili moventi. Le riferisco dei risultati delle mie indagini: che per nessuno finora sono riuscita a trovare un movente valido; che quelli suggeritimi da lei per Lucrezia, Gianrico e Silvio non mi convincono. Poi veniamo a parlare della chiave. Lei è curiosa di sapere cosa me ne ha detto Giuliano. Per vedere se riesco a stanarla, le rispondo mentendo spudoratamente. Le dico che Giuliano mi ha parlato della chiave ma me ne ha rivelato ben poco, consigliandomi di approfondire proprio con lei. La metto alle corde. Non le dirò niente di ciò che so, se non mi rivela quello che sa lei su questa cazzo di chiave. 58 Facciamo un po’ di schermaglia. Infine conveniamo di procedere nel seguente modo: io riferisco le informazioni in mio possesso; lei mi dice se sono vere o false. Attacco subito con una menzogna: “Giuliano dice che si deve trovare una chiave per risolvere un certo enigma.” “Vero.” “Che è nascosta negli appunti di filosofia di Luciano.” “Vero.” “Forse è la chiave di un tesoro.” Lavoro d’intuito. “Forse.” “Dunque,” riassumo, “è la chiave di un enigma e di un tesoro, forse. Già questo mi pare un enigma. Chi ce l’avrebbe questa chiave?” “Cosa ne dice Giuliano?” “Niente, ma mi sembra di aver capito che c’entrerebbe Fabrizio Gledo.” “Vero.” “Come fa a entrarci Fabrizio Gledo, se sta in galera da oltre dieci anni?” “Magari c’entra proprio per questo.” “Ti diverti con gli enigmi?” “Veramente, non posso dirti altro.” “Perché?” “Ne va della mia vita. Credimi cara, sto rischiando di brutto.” Smette di parlare, si alza dal letto e comincia a vestirsi in silenzio. All’improvviso è diventata frettolosa. Prende la borsetta, tira fuori il libretto degli assegni, ne scrive uno generoso e lo depone sul comodino. Di Lilli si può dire tutto meno che è una micragnosa. Sulla porta si prende il cane sotto il braccio, mi lancia un bacio e se ne va di corsa. Io resto sdraiata sul divano a riflettere su ciò che lei mi ha detto di Luciano. Però non sono le tecniche sessuali che mi appassionano. Presto il pensiero va sui sentimenti. Lilli ha un grande intuito per queste cose. Ha suggerito che Luciano era innamorato di me? 59 Certo che lui non me l’ha mai dichiarato apertamente. Qualche volta sembrava volesse dirmelo, ma più con gli occhi che con la bocca. In certi momenti fissava i suoi nei miei, mentre facevamo l’amore, con uno sguardo languido così intenso che mi faceva sciogliere tutta. I corpi si fondevano e le sensazioni diventavano sentimenti. Dopo, quando ci rilassavamo, subentrava una sorta d’imbarazzo. Volevo dirgli qualcosa, e non osavo farlo. Lui mi dava l’impressione di avere lo stesso problema. Era come se le parole avessero paura di rovinare un incantesimo, come se lo spirito temesse di contraddire la materia. Quando tornavamo freddi e razionali, dopo quei momenti, cazzeggiavamo di letteratura romantica. Una sera mi parlò di uno scrittore americano che si era sposato con la donna del suo migliore amico. Lo scrittore non era innamorato di lei. Perciò pensava che il matrimonio sarebbe stato a prova di divorzio. Poi scrisse il racconto di due sposi felici che si erano giurati castità eterna. Si desideravano alla follia, l’amore cresceva ogni giorno insieme al desiderio, e questo cresceva tanto più forte quanto meno veniva appagato. Tirarono avanti il loro menage ascetico per qualche anno, finché un giorno furono incapaci di resistere e cedettero alla tentazione. Quindi si lasciarono. “Perché mi parli sempre per enigmi?” Gli domandai. “Perché hai bisogno di nasconderti dietro degli intellettualismi? Cos’è che vorresti dirmi veramente?” “Non ti far venire strane idee.” Mi gelò. “La letteratura è una maschera dietro cui non c’è nulla. Non vuole dire altro che quello che dice apertamente.” Eppure ero certa che lui indossava una maschera, almeno con me, e che con le chiacchiere cercava sempre di nascondermi il volto che le stava dietro, quel volto ombroso che lui dissimulava coi lineamenti del nulla. Tuttavia qualche volta si faceva cogliere di sorpresa, senza maschera. Allora non avevo dubbi. Una sera, ricordo, si addormentò immediatamente dopo una scopata. Non me la presi perché lo avevo fatto faticare parecchio. Stetti lì per un po’, con la testa sulla mano, il gomito puntato sul cuscino, a guardarlo dormire. Dopo qualche minuto cominciò ad agitarsi. Digrignava i 60 denti, mugolava, smaniava, girava la testa di qua e di là. Andò avanti così per un pezzo. Io non sapevo se era il caso di svegliarlo. Finché lui si svegliò da solo, all’improvviso, scattando a sedere con un rantolo soffocato. Gli portai un drink ghiacciato e quando si fu rilassato gli chiesi di raccontarmi l’incubo. “Ho sognato il mio cane, Cencio. Nel sogno aveva il suo reale aspetto fisico, ma un carattere molto diverso. Diciamo che non aveva la sua abituale spavalderia. Era pauroso, e quando incontrava un altro cane, invece di accostarglisi scodinzolando e cercando di annusargli il culo, come fanno tutti i cani che si rispettino, digrignava i denti e ringhiava per tenerlo alla larga. Però se quello dava qualche minimo segno di reazione aggressiva, lui si metteva la coda tra le zampe e correva subito a rifugiarsi dietro di me. Era un problema, perché non riusciva neppure ad avvicinare le cagnette e quando andava in fregola si aggrappava alle ginocchia delle persone che gli capitavano a portata di zampa e simulava l’atto sessuale. Anzi non simulava. Per lui era l’unica vera possibilità di esperienza erotica. Cencio non aveva ancora capito di essere un cane. Dunque, nel sogno incontrava la tua gatta Elsa e anche in quest’occasione aveva modo di dar mostra della sua eccentricità. Invece di aggredirla e correrle dietro, le si avvicinava scodinzolando. Lei, seppure con sussiego, mostrava qualche segno di confidenza. Le due bestie cominciarono a girarsi intorno, dapprima tenendosi a distanza, poi avvicinandosi cautamente. Io assistevo alla scena ed ero mosso da sentimenti contraddittori, una sorta di contrasto tra ragione e sentimento. Però ero dominato dall’inquietudine, una sensazione forse ingiustificata, un’ansia incomprensibile che cresceva sempre più man mano che le due bestie facevano amicizia. Volevo richiamare Cencio e rompere sul nascere quell’innaturale flirt, mentre la ragione mi diceva che non ce n’era motivo. Avevo già cominciato a filosofare sul carattere eutopico di un mondo in cui cani e gatti sono amici, quando all’improvviso, mentre Elsa stava annusando beatamente il culo di Cencio, lui le fece un rapido giro intorno e le montò sopra. Sfoderò un enorme pene, rosso come un peperone, e la montò. Lei ci stava, dando segni di godersela alquanto. Al che, la ragione in me cessò di prevalere. Fui preso 61 da un’angoscia incontenibile e corsi verso le due bestie per dividerle. Ma appena gli misi le mani addosso, loro si separarono e mi si rivoltarono contro. Ruggivano che sembravano leopardi e sicuramente mi avrebbero sbranato se non mi fossi svegliato in tempo.” Questo era Luciano Vinel, con l’accento sulla e. 62 Venerdì, 17 maggio Monte Giovi è una montagna non alta, però massiccia, che sorge sopra Firenze in direzione Nord-Nord-Ovest tra le valli della Sieve e dell’Arno. Dai suoi dorsali arrotondati scendono diverse piccole valli d’erosione in tutte le direzioni. Nel Medioevo la montagna era feudo dei conti Guidi e i castelli che la popolavano furono teatro di diverse battaglie, tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, quando Firenze lottava per affermare la sua volontà sul contado. Oggi è un angolo dimenticato della Toscana. Nessuno più la frequenta, nessuno ne parla, nessuno la conosce più. Lei se ne sta lì, pigra e altera, spregiando il mondo, ad appena venti chilometri dalla città. La raggiungiamo in mezz’ora di macchina, io e Giuliano, stamattina presto. Parcheggiamo vicino a Polcanto, in una strada sterrata tra le fratte. Cominciamo a scalarla verso le sei. Nove ore abbiamo camminato, tra l’andata e il ritorno, e non abbiamo incontrato anima viva. Eppure non è natura selvaggia. Non puoi camminare tra i suoi boschi senza imbatterti di tanto in tanto nei resti di antichi castelli medievali e dimore quattrocentesche. Puoi incontrare anche qualche casa colonica disabitata ma ancora in piedi. Qua e là, appena nascosti dal bosco ceduo, s’intravedono filari di cipressi scuri, ultime vestigia di viali di residenze signorili. I boschi stessi, per quanto selvaggi, si vede che sono stati fatti oggetto di ripetute attività di devastazione e rimboschimento. Passeggiandovi dentro capisci che qui la natura e la cultura sono così intricate l’una con l’altra che è difficile parlarne in termini di dialettica. La passione per la montagna è la cosa che mi piace di più in Giuliano. Lui ha un modo tutto particolare di andarci in montagna. Si mette lo zaino in spalla e va, con passo costante, metodico, senza guardarsi intorno, come se salisse le scale di una casa. Va su tenace, duro, e apparentemente senza stancarsi. Va su, pare, per adempiere a un dovere e non si ferma se non in cima. La prima volta che sono andata in montagna con lui sono rimasta sconcertata, oltre che stroncata dalla fatica. Non riuscivo a inqua- 63 drare il personaggio nell’ambiente. Poi ho capito. Me l’ha spiegato così: “Non è la montagna in sé che mi affascina, è l’andarci. Ciò che cerco è l’ascesa, la lotta.” “La lotta contro la montagna?” “No, lei e indifferente. La lotta contro me stesso, contro la fatica e il dolore, contro la pigrizia e il disordine. È una lotta tra la volontà e l’entropia. La conquista della cima è una metafora di un’altra vittoria. Amo la montagna perché non è gratis e solo con la violenza si può conquistarla, perché ti impone una disciplina, con cui educa ed esalta la tua forza. Pensandoci bene, credo che anche nel mio amore per la natura c’è una componente di questo tipo. Ciò che più mi piace dell’andare in montagna con Giuliano, però, è la silenziosa lotta che combatto contro di lui, quando mi metto appiccicata alle sue costole e salgo su col suo stesso passo, al ritmo del suo respiro, senza mollarlo un attimo. La sua stima per me è salita alle stelle appena arrivati in cima, e anche la mia. La montagna mi mette in pace con me stessa. E quando giungo alla meta mi sento in pace con il mondo. Giuliano lo sa. Ecco perché mi ha invitato all’escursione di oggi. Vuole mettermi nella migliore disposizione d’animo per chiedermi qualcosa. In cima al monte, sdraiati sull’erba, stanchi e rilassati, mangiati, bevuti e fumati, parliamo. Innanzitutto della maledetta chiave, parliamo. Gli dico quel che so. Non ho motivi per nascondere alcunché. A volte mi piace giocare a carte scoperte, usando la verità quale tecnica d’indagine; cosa che spesso disorienta l’interlocutore più dei sotterfugi. Giuliano si mostra interessatissimo alla faccenda della chiave, soprattutto a capire chi mi ha dato le informazioni che gli riferisco. Insiste su Lilli. Vuole sapere se lei mi ha parlato della chiave per mia o per sua iniziativa, e se ne ha parlato anche agli altri. Mi tempesta di domande, tutte intorno a questo problema, non tutte a me comprensibili. Lo lascio sfogare, in attesa che venga il mio turno di fare domande. Finito il suo interrogatorio, non lo aggredisco subito col mio. Ci facciamo una scopatina rilassante, lì tra gli alberi sotto un 64 venticello tiepido, e gli simulo un orgasmo così convincente che me lo godo anch’io. Infine attacco: “Raccontami la seconda puntata della storia di te, Luciano e Fabrizio, ai tempi del movimento studentesco. Cosa accadde quando arrivaste a Firenze?” “Sarebbero altre due, le puntate, ben distinte, due epoche distanti un millennio. Dopo la prima, che va dal ’67 al ’68, ce n’è una seconda, dal ’69 al ’72, e una terza che abbraccia l’intero ’73 e sbocca nel finale tragico.” “Che finale?” “L’avvio del terrorismo, e per Fabrizio l’inizio della fine.” “Sono tutta orecchi.” “OK, procediamo con ordine. Partecipammo subito totalmente alla vita del movimento studentesco fiorentino. Non fu solo politica. Forse proprio non fu politica. Il movimento era sorto all’improvviso, e se ne stava come un corpo estraneo dentro il corpo pigro di questa città chiusa e provinciale, arroccata nella difesa di morte glorie lontane, fuori dal mondo e dal tempo e ancora indecisa se entrare o no nel ventesimo secolo. Noi ci divertivamo a provocarla, e a deridere i fervori della mistica lapiriana. Ricordo quasi fosse ieri lo scandalo suscitato da quella studentessa che si presentò all’anagrafe insieme a due compagni per registrare la nascita di un bambino. Pretendeva che fosse dichiarato ufficialmente figlio di entrambi i padri, visto che lei non sapeva a chi attribuirlo. Quando poi occupammo l’ex ospedale S. Lucia, in ribellione contro le autorità comunali che non ci davano alloggi, e fondammo la Comune Carlo Marx...” “Tutto molto bello,” lo interrompo, altrimenti non quaglia, “ma parlami di voi tre.” “Bene, noi ci bastò un anno per raggiungere una posizione di rilievo all’interno del movimento. Nessuno dei tre, come singolo, aveva la stoffa del leader. Insieme eravamo ineluttabili. Diventammo noti come la Setta. Nomi di battaglia: Il Tigre, Il Leone, Il Leopardo.” “Il Leone era Luciano, suppongo.” “No, Fabrizio, e io Il Tigre. Luciano era Il Leopardo. Lui era una specie di eminenza grigia. Non parlava quasi mai alle assem- 65 blee e stava sempre vicino a Fabrizio, con cui confabulava continuamente. Fabrizio interveniva spesso, invece. Aveva un parlare sciolto e vigoroso, ma poco accattivante. Si ergeva sulle assemblee severo come un Savonarola, senza suscitarvi grandi simpatie. Non aveva un seguito di massa; però si era costruito una ristretta cerchia di gregari, per mezzo dei quali riusciva a controllare il movimento. Più che del leader, aveva la stoffa del boss. I nemici lo chiamavano Don Fabrizio o Don Gledo. I suoi interventi erano sempre determinanti quando si trattava di correggere una deviazione o di imprimere una svolta alla politica del movimento. Ad ogni modo la linea la dava Luciano. Era lui la vera anima occulta del movimento. La sua mente stava dietro a tutte le decisioni e i documenti teorici importanti.” “E tu?” “Io ci mettevo l’organizzazione. Ero il capo del servizio d’ordine. Quando il movimento entrava in azione, nulla accadeva senza la mia supervisione, si trattasse di distribuire volantini davanti a una fabbrica o di organizzare uno scontro con la polizia.” “Vivevate nella stessa casa, mi hai detto l’altro giorno.” “Sì, avevamo un appartamento nel centro storico. Era il covo. Quattro stanze: una, quella grande, per le riunioni e le feste; tre più piccole, personali, per dormire, studiare e...” “Avevate anche il tempo di studiare?” “Scherzi!? Si studiava da matti! Magari non ciò che volevano i professori, ma si studiava.” “Perché vi separaste?” “Così arriviamo subito alla terza puntata.” “Meglio. Già cominciavo ad annoiarmi. La seconda era meno bella della prima.” È ben altro che voglio sapere da Giuliano. “Nel ’72 ci trovavamo ormai nel tratto discendente della parabola. Si era formata una miriade di partitini. Finita la fase magmatica, il movimento assisteva inerte alla propria implosione. I gruppuscoli lottavano per l’egemonia, mentre si andava perdendo ogni presa sulla realtà sociale. Nello stesso tempo diventava sempre più forte la sensazione che il mondo si accingesse a schiacciarci. L’azione di sfondamento era fallita e ci si preparava alla lotta di lunga durata. Però cosa una tale lotta dovesse essere 66 nessuno lo capiva bene. Su questo problema cominciammo a scontrarci duramente nel movimento. Anche la Setta entrò in crisi. Io e Luciano pensavamo a una lotta di massa che coinvolgesse vasti strati del proletariato. Fabrizio invece sosteneva che si era entrati in una fase in cui lo stato apparecchiava l’aggressione militare e che quindi bisognava organizzarci militarmente. Per circa un anno continuammo a discutere e litigare. Alla fine Fabrizio scomparve di scena. Nel corso di quell’anno, a nostra insaputa, si era andato organizzando un suo nucleo d’acciaio. Quando entrò in clandestinità, capimmo che tutto era finito.” “Non avete avuto più contatti?” “Nessuno, fino a due anni fa. Lo beccarono nel 1978. Lui, pur in galera, continuò nella sua pervicacia. Per sei anni andò avanti a scrivere documenti, a sbeffeggiare i giudici, a dare direttive, insomma a ignorare la realtà. In seguito, proprio due anni fa, scrisse una lettera a Luciano. Era infine entrato in crisi. Per farla breve, si avviò sulla strada della dissociazione. Qualche lettera la scrisse anche a me, ma con Luciano teneva una corrispondenza regolare. Con lui aveva un rapporto più profondo.” “Però la chiave la diede a te.” Cerco di sorprenderlo. Lui infatti ha un sobbalzo. “Come fai a saperlo?” “Vedi che sono meno sprovveduta di quanto credi? Basta collegare i pochi indizi e ragionarci sopra.” Lui mi guarda con sospetto. Chissà se capisce che sto tirando a indovinare, che ancora non ci ho capito niente, che lavoro d’istinto? Ah, l’intuito femminile! Dunque ho colpito nel segno. Cosa ho indovinato? Dunque, questa maledetta chiave sarebbe stata data da Fabrizio a Giuliano. Che vuol dire? che c’entra con la morte di Luciano? “Visto che siamo in tema,” riprende lui, “devo chiederti una cosa.” “Sentiamo.” “Tu hai delle carte di Luciano. So che te le ha date recentemente. Vorrei vederle.” Anche lui gioca di contropiede. Gli chiedo di spiegarmi che c’entrano quelle carte con tutta la fac- 67 cenda, ma senza avere soddisfazione. Alla fine, per trovare una risposta alla domanda, cedo alla sua insistenza e confesso: “Sì, è vero. Luciano mi aveva consegnato degli appunti di filosofia. Più che altro era una raccolta di aforismi, schemi concettuali che usava per sviluppare le sue lezioni. Li ho letti e riletti, capendoci poco e niente. E pensa che due settimane fa, quando ormai me ne ero dimenticata, lui mi aveva chiesto se li avevo penetrati quegli appunti, cosa ne avevo appreso. Mi aveva interrogato come una scolaretta, e infine mi aveva suggerito di andare a rileggerli.” “È proprio il manoscritto che cerco.” “Da quando in qua ti occupi di filosofia?” “La filosofia non m’interessa. Ciò che m’interessa è il messaggio che deve essere nascosto in quelle pagine. Vedi, facevamo un gioco nella nostra casa di studenti, io, Luciano e Fabrizio. Lo chiamavamo il gioco della scienza. In realtà era una specie di enigmistica. Consisteva in questo. Luciano ci passava dei testi, brevi riflessioni, aforismi, poesiole e simili. Io e Fabrizio cercavamo di decifrarli. Infatti, al di là del loro significato apparente, quei testi contenevano un messaggio nascosto, un parola, una breve frase, che bisognava trovare sciogliendo un enigma. Non si trattava soltanto di risolvere anagrammi, crittogrammi e simili. Era un gioco più difficile, poiché bisognava innanzitutto trovare il codice, la chiave di lettura, e poi usare il codice per risolvere l’enigma.” “E perché mai delle noterelle di filosofia scritte quali tracce per un seminario dovrebbero contenere dei giochetti enigmistici?” “Intanto, sono convinto che Luciano non li considerava dei semplici giochetti. Lui pensava che un testo profondo dovesse aprirsi a diversi livelli di lettura, che qualsiasi prodotto del pensiero contenesse sempre, spesso a dispetto dell’autore, un messaggio essoterico e uno esoterico.” “Sì, ricordo che mi espose una teoria del genere una volta, ma per criticarla, credo. Molti che hanno da dire qualcosa che pensano ne valga la pena – diceva – hanno da scrivere tre libri: uno per molti lettori, uno per pochi, uno per nessuno, cioè per sé 68 stessi. Quelli che scrivono più di tre libri ne scrivono di superflui. Alcuni ne scrivono uno e continuano a pubblicarne tanti che non sono altro che lo stesso rigirato in vari modi. Quelli che ne scrivono meno di tre, lasciano un’opera incompiuta, salvo gli eletti che riescono a far stare i tre libri in uno.” “Sono sicuro che lui voleva tentare la terza strada.” “Ma sembrava non crederci in quella teoria.” Insisto. “Me ne parlò in tono beffardo, come per dire: pensa quanto sono scemi gli scrittori che mirano a delle profondità. E comunque non è la stessa cosa cui accennavi tu prima. Non si tratta di nascondere degli enigmi tra le righe. Con tutto ciò,” concludo, “perché la faccenda dovrebbe interessare te? E che c’entra con la morte di Luciano?” “Lasciameli decifrare e te lo dirò.” Insiste. Mi propone uno scambio. Anche lui ha delle carte di Luciano, poesie, limerick, pensierini della sera, alcuni di quei vecchi testi con cui giocavano all’enigmistica. Inoltre ha delle cose di Fabrizio, compresa una poesia che causò all’autore una tremenda litigata politica con Luciano. La sua proposta è di passarmi tutte queste carte in cambio di quelle che ho io. Non ho motivo di rifiutare. Gli dico che anche Lilli mi ha chiesto di dargli quegli appunti. A lei li ho negati, ma a lui li darò. Però prenderò delle precauzioni. Gli consegnerò un capitolo per volta, passando al successivo soltanto se mi comunica la soluzione che ha trovato, ammesso che ce ne sia una. Lui nicchia, più per un proforma che per abbassare il prezzo. La trattativa va avanti neanche troppo a lungo. Alla fine concordiamo sui seguenti termini. Gli consegno i primi due capitoli del corso di filosofia. Se trova la soluzione e me la comunica, gli passerò gli altri due capitoli. Inoltre, in cambio dei primi due lui mi dà le carte di Fabrizio in suo possesso; in cambio degli ultimi due, quelle Luciano. Sono queste che m’interessano di più, le carte di Luciano. Mi viene in mente la sua scrivania, tutta piena di blocchi note e fogli sparsi, densi di una scrittura fitta e stortignaccola. Quando la vidi per la prima volta ne restai sorpresa. Per essere uno che pubblica 69 poco, scrive fino troppo, pensai. Fu la notte in cui il nostro rapporto fece un salto di qualità. Nel pomeriggio mi aveva telefonato: “Oggi non posso venire da te,” disse, “ma ho voglia di vederti. Ci verresti a cena a casa mia?” Non potevo crederci. Era la prima volta che m’invitava nel suo covo. Ebbi un tuffo al cuore. Mi controllai e risposi: “Per cena ho un altro impegno. Se vuoi, posso venire dopo.” “Magnifico. È anche meglio. Così evito di mettermi a cucinare.” “Va bene, a più tardi.” “Senti,” disse rapidamente mentre stavo per riattaccare, “me lo faresti un piccolo favore?” “Se posso.” “Non mettere i pantaloni quando vieni stasera. Metti una gonna, e sotto… niente mutandine.” “Figuriamoci! Non ci penso nemmeno!” Risposi d’istinto. Non ne avevo motivo. Cerco sempre di soddisfare le richieste del cliente. Perché non una tanto infantile? Ma quella sera stava cambiando qualcosa tra di noi, e cominciò con un cambiamento delle mie reazioni. Lui viveva in un antico fienile ristrutturato dall’architettura elementare: una stanza al piano terra e una al sottotetto. La prima era un enorme salone che fungeva da soggiorno, cucina e camera da letto. Il pavimento era in mattonelle di cotto, talmente logore e spezzettate che inducevano a camminarci sopra con cautela. Le pareti in pietre grezze di vari colori, tra il beige e il terra di Siena, avrebbero dato proprio l’impressione di un fienile, o di una stalla, se due di esse non fossero state ricoperte da grandi librerie svedesi in noce, piene di volumi che dalle costole sembravano piuttosto antichi. Nella terza parete c’era una fila di elettrodomestici incassati tra muretti di mattoni coperti da una lunga tavola di noce massiccio. Accanto ad essi campeggiava una vecchia credenza contadina di un legno dal colore indefinibile e grezzamente intagliato. Nella quarta parete c’era un vasto camino col fuoco acceso, davanti al quale troneggiavano due poltrone e 70 un divano in pelle. Il letto, a una piazza e mezza, se ne stava quasi nascosto in un angolo, tra una libreria e il muro del camino. “Questa è la mia vera casa.” Spiegò. “Qui vivo in solitudine, anche se ci sto solo tre o quattro giorni a settimana.” “E gli altri tre o quattro?” “A Firenze con la mia ex e mia figlia.” Stappò la bottiglia di Vernaccia che gli avevo portato, riempì due coppe e mi fece sedere sul divano accanto a lui. Bevemmo in silenzio. Lui riempì di nuovo le coppe, svuotò subito la sua e cominciò a ruzzare. Io non mi sentivo in vena, presa com’ero dal tentativo di interpretare la stranezza della stanza, di leggerci segni della sua personalità. Avevo l’impressione che mancava qualcosa. Lui mi mise una mano su una coscia, mentre io guardavo la legna che bruciava nel camino. Il fuoco produceva un caldo enfatico, ma l’atmosfera era ancora troppo fredda perché potessi lasciarmi andare. Quella sera sembrava che il mio corpo avesse deciso di rinunciare al mestiere. Lungo la parete sopra il camino saliva in diagonale una scala dai gradini in pietra serena. “Dove porta quella scala?” Domandai. “Nel Sancta Sanctorum.” “Lo voglio vedere.” “E io te lo faccio vedere.” Rispose con rattenuta insofferenza. Mi prese per mano e mi trascinò al piano di sopra. Nell’altra mano teneva strette la bottiglia e la sua coppa vuota. La mia era ancora semipiena e me la portai su vuotandola mentre salivo le scale. Quando arrivammo in cima, lui aprì una porta mezza sgangherata e accese la luce. “Oh, Gesù!” Mi salì spontaneo alle labbra. Era un’altra casa rispetto alla stalla rifinita del piano di sotto. Il pavimento di cotto s’intravedeva appena, coperto com’era da una distesa di tappeti persiani. Le pareti erano intonacate e verniciate di un tenue rosa antico. Anche qui due pareti erano interamente rivestite da moderne librerie in noce, elegantissime nelle loro semplici linee svedesi. Dalla parete di fronte alla porta si staccava una grande stufa in ceramica di colore bordò ornata di bassorilievi floreali. Accanto ad essa risaltava una cristalliera con 71 i ripiani densi di libri, alta quanto un uomo e larga due. Era impiallacciata di un bois de violette dalle venature amaranto e finemente decorata con intarsi in madreperla e avorio. “È del Settecento.” Fece lui. “Non avevo dubbi.” La parete alla sinistra della porta era arredata da un’altra libreria, ma bassa, così bassa che mi arrivava alla vita. Più in alto era tutta tappezzata di quadri e stampe antiche. In fondo a questa parete, in posizione obliqua rispetto alla stanza, campeggiava un largo tavolo ricoperto di libri e delle carte di cui ho detto sopra. Era dello stesso stile della cristalliera, anch’esso rivestito di un’impiallacciatura rossiccia e con l’intarsio che correva lungo la cintura. Le sottili gambe arcuate a piedi di cervo gli davano un’aria di leggerezza che rasentava l’audacia, a guardare la gran mole di carta che sostenevano. Lungo la parete alla destra della porta, addossata alla libreria, c’era una bassa dormeuse tappezzata di velluto genovese dalle decorazioni rococò e con la parte in legno intarsiata come il tavolo e la cristalliera. Ero incantata. Entrai nella stanza con reverenza. Feci una passeggiata tutto intorno, soffermandomi a guardare le stampe antiche. Con una mano accarezzai il bordo del tavolo. Poi andai al centro della stanza e alzai lo sguardo verso l’alto. Tre massicce travi cesellate dai tarli sorreggevano il tetto a colmo, e dei correnti ugualmente cesellati univano file di pianelle color mattone. Non c’erano lampadari pendenti dal soffitto. La luce proveniva da quattro faretti sporgenti dagli angoli più alti delle librerie, oltre che da due piantane troneggianti accanto a due aduste poltrone a guance en confessional, una davanti al tavolo e una rincantucciata nell’angolo a fianco della cristalliera. Anch’esse erano tappezzate in velluto di Genova con motivi rococò. “È incantevole questa stanza,” dissi, “ma sono perplessa.” “Lo capisco.” “La persona che vive qui”, chiarii, “non può essere la stessa che vive nella sala di sotto.” “Non finisco mai di sorprenderti, vero?” Nel dir ciò, si riempì di nuovo la coppa di vino. Si sbracò alla romana sul lit de jour e 72 alzando la bottiglia m’invitò ad accostarmi per riempire la mia coppa. Mi avvicinai a lui ma, non volendo incoraggiarlo, non mi sedetti sulla dormeuse. Mi accomodai per terra, incrociando le gambe su un sacro tappeto di preghiera. L’ambiance sofisticata mi aveva intimidito, il che mi infastidiva. Non sapevo cosa dire. Anche lui sembrava un po’ imbarazzato. Bevvi un sorso e domandai: “Ti piace questo vino?” “È il mio aperitivo preferito. Ci hai azzeccato in pieno. Grazie del regalo.” “Figurati! Con tutti quelli che mi hai fatto tu…” “Quello che ti faccio oggi è speciale: una vecchia edizione della Stagione all’Inferno…” “No, basta,” dissi arrabbiata, “non la reggo più questa ipocrisia!” “Ipocrisia?” Proruppe lui con aria offesa. “Certo! Quest’abitudine di regalarmi un libro o un disco ogni volta che scopiamo è un modo apparentemente raffinato di pagare le mie prestazioni, in realtà ipocrita.” “Se è solo un pagamento, perché sarebbe ipocrita?” “Perché mi lasci intendere che non è solo un pagamento e così vellichi la parte molle della mia anima.” “Cosa che a te non dispiace però.” “Appunto. E tu ti risparmi delle esose parcelle giocando sulla mia debolezza.” “Stai dicendo che hai un debole per me?” “Eccola di nuovo la tua ipocrisia. Lo sai benissimo che…” “Non pensavo fosse una cosa tanto grave. Ne vuoi parlare?” “Come a un confessore? No grazie. Non sei nello stato d’animo giusto.” “Allora che facciamo?” “Vabbè, allora facciamo quello per cui stai sbavando.” Posai la coppa di vino per terra, appoggiai le mani sul tappeto dietro la schiena e alzai leggermente le gambe, che tenevo incrociate. La gonna scivolò qualche centimetro giù dalle ginocchia. Alla fine avevo deciso di fargli il piccolo favore che mi aveva chiesto al 73 telefono. Lui ebbe un lampo lubrico negli occhi, mentre guardava il buio. “È quando fai così che mi piaci di più.” Disse. “Quando troieggio, eh?” “Che c’è di male?” “Niente, ma quel libro oggi non lo voglio. Me lo regalerai per il mio compleanno. Oggi niente doni di contraccambio, solo doni.” E facemmo l’amore, oh! tristemente! Era come se l’aria fosse piena di elettricità statica. Gli abiti che ci toglievamo sembrava volessero restare appiccicati ai corpi. Il silenzio teso dei suoi assalti nutriva il mio silenzio interiore. Avrei voluto darmi da fare, metterci almeno un po’ di mestiere, però ero paralizzata. Io cercavo i suoi baci e i suoi occhi, lui le mie zone erogene. E più si dava fare, meno quagliava. Più cercava di accendermi, più mi spegneva. Alla fine, dopo un lungo saggio di perizia erotica, tanto defatigante quanto inefficace, quasi con stizza mi montò sopra, mi allargò le gambe e mi penetrò. E venne subito. Fu uno shock per entrambi, sebbene per motivi diversi. Io ero mortificata. Lui ci tenne a chiarire che era la prima volta che gli capitava. “Lo so, scemo! Non ti angustiare. È colpa mia.” “Tu dici?” “Io dico, e mi puoi credere.” Bastarono queste parole per tirarlo su di morale e fargli recuperare tutta l’albagia del suo sarcasmo: “Sentiamo che dice la psicologa.” Mi fece imbestialire! Mi venne voglia di ferirlo, e gli risposi a tono: “Non la psicologa, la puttana. Pura esperienza professionale. Molti uomini entrano in ansia di prestazione se la donna non si eccita. Lo vivono come un fallimento, si sentono incapaci e perdono sicurezza. Non riescono a dominare la situazione. Allora sentono la fica come una minaccia, una trappola per topi, e cercano di fuggirne prima possibile. Il corpo favorisce la fuga con un’eiaculazione precoce.” “Tutto qua?” 74 “Sì caro, è un fenomeno molto comune. Tu non sei tanto diverso dagli altri.” Rinfoderò l’albagia. “Sarà così.” Concluse. Si girò dall’altra parte, smucinò tra il mucchio degli abiti lì vicino, tirò fuori delle sigarette dalla tasca della sua giacca, me ne offrì una e una se la mise all’angolo della bocca. Fumammo in silenzio e demmo fondo alla bottiglia di vino. Giacevamo nudi su un morbido tappeto di lana, guardando il fine lavoro dei tarli sulle travi. La delusione ci gelava entrambi. Quando dissi che avevo freddo, si alzò, raccolse i suoi e i miei vestiti, mi prese per mano e mi portò giù nella stalla. Nel camino c’era ancora un po’ di brace accesa, che emanava un piacevole tepore. “Non vale la pena riattizzare il fuoco,” disse, “è tardi. Andiamo a nanna.” Il letto era stretto, ma dormimmo ognuno per conto suo, senza toccarci. All’alba fui svegliata dallo scoppiettare di un motorino. Diedi un’occhiata dalla finestra accanto al letto. Luciano stava rasando l’erba del prato. Guardai l’orologio. Cristo! Erano le sei e mezzo. Mi alzai e mi vestii. Sul tavolo di cucina c’erano dei biscotti e una tazza di caffè. Non toccai nulla. Quando uscii all’aperto fui sferzata dal fresco del mattino primaverile. Il cielo era tutto una cappa di nuvole e il sole appena sorto sopra le colline di Montalbano riusciva a mala pena a schiarirne una striscia sottile. Mi soffermai a contemplare l’oleografico panorama bucolico. Campi d’ulivi cinerini scivolavano lungo i declivi. I cipressi si ergevano scuri sui confini dei poderi. Sparse case coloniche sonnecchiavano sulle cime dei colli. Appena mi vide, Luciano spense il tosaerba, mi sorrise e mi venne incontro. Fece per baciarmi. Gli porsi la guancia. “Non è stata una gran serata.” Disse sogghignando. “Mi dispiace,” lo rassicurai, “è stata colpa mia.” Sì, era stata colpa mia, della mia scriteriata illusione, delle mie aspettative infantili. Lui naturalmente capì tutto, e sparò: “Forse è proprio così. Non hai voluto il mio regalo e mi hai offerto una prestazione commisurata al prezzo.” “Hai capito tutto.” 75 Sabato, 18 maggio Ho avuto una mezza nottata riposante dopo la passeggiata su Monte Giovi. La stanchezza mi ha aiutato a rilassarmi. Mi sono buttata sul letto appena rientrata a casa e sono caduta nel sonno. Al risveglio ho cercato di non pensare alla tediosa faccenda investigativa e a un certo punto ho perfino creduto di riuscire a liberarmene. Che ci vuole? mi sono detta, basta fregarsene! Ahimé, troppo semplice! Nel pomeriggio viene a trovarmi Giuliano, tutto gasato, per comunicarmi la soluzione dell’enigma. “Sarebbe la chiave della verità?” Domando. “In un certo senso. Guarda, è nel primo capitolo.” Tira fuori di tasca quattro dei fogli che gli avevo consegnato, le fotocopie del primo capitolo degli appunti di Luciano. Il testo è allegato in appendice per chi è interessato all’enigmistica. L’avevo letto e riletto con attenzione nei giorni scorsi, se non altro perché le argomentazioni filosofiche che vi erano sviluppate mi avevano sconcertato. Così ho voluto sondare l’interpretazione che ne aveva ricavato Giuliano: “Che pensi del contenuto teorico del capitolo?” “Non è altro che una delle tante bravate sovversive di quel genio, un femminismo spinto all’estremo.” “Il femminismo c’entra poco, credo. Mi sembra piuttosto l’espressione di quell’eterno sentimento maschile che si può capire scavando nella vita interiore: il sogno di un’universale prostituzione femminile.” “Cara, stai diventando contorta come il tuo amico del cuore.” “Che è l’autore di questo capitolo, nel quale ha messo il meglio del proprio pensiero.” “Non puoi immaginare quanto me ne frega. A me interessa la chiave che contiene.” Chiuso l’argomento. Così, dopo aver ridato un’occhiata agli aforismi, rendo i fogli a Giuliano. Lui, anticipando la mia domanda, fa: “Ho penato moltissimo per decifrarlo. Ci ho lavorato tutta la notte. Ho provato decine e decine di codici, e svariate soluzioni, 76 alcune quasi sensate. Solo una mi è sembrata soddisfacente. Vedi? Sono ventisei aforismi. Prendi la quinta lettera del primo aforisma. Quindi salti al sesto aforisma e prendi anche qui la quinta lettera. Vai avanti saltando ogni volta cinque aforismi. Il risultato che ottieni è molto semplice e col senno di poi direi ovvio: LILLI.” “Mi pare impossibile che il significato recondito di una pagina così densa di concetti possa essere trovato in un’unica parola, in un nome. Che senso ha?” “Non credere sia stato facile trovarla...” “Bah!? È una cosa talmente arbitraria! Per esempio, cosa avresti trovato se avessi saltato gli aforismi di quattro in quattro, invece che di cinque in cinque?” “Ti assicuro che le ho provate tutte e con pessimi risultati. Ma alla fine l’ho azzeccata. Ripeto: questa che ti ho esposto è l’unica soluzione sensata. Guarda? Il primo aforisma dà il codice, o la chiave, se vuoi. Infatti contiene venticinque parole, che è il numero degli altri aforismi. Inoltre contiene le tre elle che compaiono in Lilli. Contiene anche venti lettere i. Togli lo zero da venti, e resta due: le i di Lilli. Il nome Lilli è composto di cinque lettere. Dividi venticinque per cinque e trovi cinque, che è il numero di aforismi che devi saltare partendo dal primo. Cinque inoltre è il numero della posizione della lettera significativa in ogni aforisma rilevante.” “Ingegnoso. Però ancora non mi convince. Perché sei andato a guardare il numero delle lettere elle nel primo aforisma e non, mettiamo, delle erre o delle esse o altre?” “L’ho fatto. Ti assicuro che LILLI è l’unica soluzione sensata che ho trovato.” “Sarà!?” “Non fa niente. Non m’interessa che tu ci creda. Per me questa è la soluzione. Ora però mi raccomando: non dirlo a nessuno. Nessun altro del gruppo dell’orgia deve saperlo oltre noi due.” Su ciò insiste molto, tanto da farmi pensare che vuole proprio ne parli a tutti. Così, appena se ne va mi attacco al telefono. Co- 77 sa ho da perdere, visto che non ci capisco niente? E può sempre darsi che gli altri mi aiutino a capire. Le reazioni che ottengo sono eterogenee, ma non inattese. Lilli si mostra preoccupata, Lucrezia indifferente. Gianrico e Silvio sono parecchio interessati. La natura del mio rapporto con Luciano cambiò radicalmente dopo quella deludente serata a casa sua, anche se ci volle qualche mese per farci capire a entrambi che era cambiata in meglio. All’inizio invece pareva che si fosse guastato tutto. Lui non m’invitò più per un po’ di tempo, anzi neppure mi telefonò per ben due settimane. Io passavo le sere in attesa degli squilli del telefono. L’ansia cominciava a crescere nel pomeriggio e non mi abbandonava fino a notte tarda. Alla fine alzavo la cornetta e lo chiamavo io, soffocando l’orgoglio e rovinando ogni strategia d’amore. Erano telefonate brevi. Cercavo di parlare allegra e noncurante, ma non sapevo cosa dire. Lui rispondeva gentile con frasi brevi, a volte scherzose. Chiudevo salutandolo con un “ci vediamo” e tornavo al mio tormento. Alla fine mi feci coraggio e lo invitai a pranzo per il mio compleanno. Lui si presentò con quel libro che non avevo accettato due settimane prima. Mangiammo e bevemmo poco, raccontandoci cose insignificanti. Sembravamo due adolescenti invaghiti che si ritrovavano da soli per la prima volta, imbarazzati e maldestri. Era come se volessimo dirci cose importanti senza trovare le parole per farlo. Dopo pranzo sedemmo sul divano a prendere il caffè. Stavamo in punta di culo, rigidi e impettiti. Neppure il disco che cantava wild is the wind on my life riusciva a riscaldare l’atmosfera. Luciano sorseggiò il caffè pigramente. Quando l’ebbe finito, si alzò, andò al mobile bar, si versò un abbondante bicchierino di cognac e tornò al divano. Mi si accostò stretto e mi mise un braccio sulla spalla. “Versalo anche a me un bicchierino?” Dissi. Si alzò pazientemente per servirmi. Quando tornò a sedersi, io mi ero allontanata per cambiare musica. Misi su un disco preso a caso in mezzo a tanti. Cantava: mi sono innamorato di te perché 78 non avevo niente da fare… Ma che sto combinando? – mi sono detta – io non sono innamorata di lui. “Sei una spudorata romantica.” Disse. “E tu sei uno spudorato.” “E tu sei una fottuta moralista.” “Ah, questa poi…” “Sì cara, moralista, e della peggior specie.” “Perché non mi piacciono i filmini pornografici e le ballerine che mostrano le chiappe in televisione?” “Proprio così. È quell’ipocrisia ideologica che si rivela nei goffi tentativi di far passare per rivolta femminista contro la mercificazione del corpo femminile ciò che invece è solo una pruderie appresa a scuola dalle suore.” “Lascia stare. È un discorso che abbiamo fatto a uffa. Ti ho già spiegato che non capisci niente di certe cose.” Avevo deciso di stroncare sul nascere i suoi assalti filosofici quando miravano a ferirmi. Così conclusi: “In questo momento non sei in grado di ragionare. È l’orgoglio ferito della tua foia che parla. Mettiti l’animo in pace, ché tanto oggi non scopi.” Seguirono altre due settimane di broncio, di mie telefonate sprovvedute e di sue battutine scherzose. Stavo male. Non riuscivo a capacitarmi del cambiamento intervenuto nel suo comportamento. Fino a due settimane prima andava tutto a gonfie vele, passavamo delle lunghe mezze giornate insieme e spesso delle nottate intere, parlavamo di cose profonde, facevamo l’amore a meraviglia. All’improvviso si era rotto l’incantesimo. Sentivo che lo scacco dipendeva da me, e avevo dei rimorsi. Lui rivoltava il coltello nella piaga, quando gli telefonavo, o scherzando sulla mia sopravvenuta frigidità o rinfacciandomi un mio presunto puritanesimo. “Bellina quella gonna da educanda”, mi apostrofò un giorno, solo perché una volta tanto non mi ero vestita in modo vistosamente sexy. Certo che dipendeva da me. Ero io che stavo cambiando. Non accettavo più il grigiore di un rapporto banale. Cercavo qualcosa che non capivo cos’era. Non sono innamorata – continuavo a ripetermi. Per quale motivo ora non volevo che mi toccasse pur desiderandolo scriteriatamente? 79 Un bel pomeriggio, dopo tre settimane che non lo vedevo, lo andai a trovare a sorpresa nella sua casa di campagna. Era una splendente giornata di maggio e il sole spalmava luminosità smeraldine sui campi d’erba. Parcheggiai in una strada sterrata davanti al cancello di legno che chiudeva il resede dell’abitazione. Tirai il campanaccio e restai in attesa. Nessuna risposta. Tirai una seconda e una terza volta inutilmente. Infine mi feci coraggio, spinsi il cancello ed entrai. Andai a bussare alla porta del fienile, e anche lì rimasi senza risposta. Eppure lui doveva essere d’attorno, visto che la sua motocicletta era parcheggiata vicino al cancello. Gli diedi una voce, prima sommessamente, poi un po’ più forte. Infine gridai il suo nome a squarciagola. Mi rispose un lontano abbaiare proveniente dall’uliveto. Doveva essere Cencio, il suo cane da guardia. Mi avviai in quella direzione. A una ventina di metri dalla casa il resede terminava in un muretto di pietre, oltre il quale il terreno scendeva ripidamente verso una valletta tutta piena di ulivi. Gridai di nuovo il nome di Luciano e l’abbaiare si fece risentire dal fondo della valle. Imboccai un sentiero che scendeva giù scosceso. Dopo qualche minuto di cammino ecco Cencio che mi viene incontro di corsa, risalendo il sentiero e abbaiando furiosamente. Mi fermai gelata dalla paura, ma lui appena mi raggiunse cominciò a girarmi intorno con balzi di gioia. Avevamo fatto amicizia nella mia precedente visita e ora mi aveva riconosciuto. Ricambiai i suoi festeggiamenti carezzandolo e strapazzandolo un po’. Quindi gli vociai: “Dov’è Luciano? Portami da Luciano!” Rizzò le orecchie e subito scattò di corsa lungo il sentiero verso il fondovalle. Lo seguii quasi di corsa anch’io. Quando lo raggiunsi stava saltellando e abbaiando intorno a un enorme ulivo. Su una branca del quale svettava Luciano, una mano aggrappata a un ramo, l’altra che brandiva un seghetto da potatore. “Ciao amore!” Mi apostrofò. “Questa sì che è una bella sorpresa.” Non potevo aspettarmi accoglienza migliore. Lui scese dall’albero con un balzo, mi venne incontro, mi abbracciò e mi baciò con ardore. Ci sedemmo sull’erba, all’ombra diafana dell’ulivo. Bevemmo acqua fresca da una borraccia militare. Il 80 panorama era intrigantemente idilliaco. Il campo d’ulivi scendeva ancora digradando verso un torrentello in fondo alla valletta e proseguiva risalendo lieve dall’altra parte del torrente, fino a terminare ai margini di un’altra collina, di fronte a noi, tutta selvaggia di un bosco tenebroso. Luciano mi spiegò che stava finendo la potatura di primavera e che era in ritardo sui tempi. Ne avrebbe avuto per un’altra settimana almeno. Ero sorpresa. Non mi aspettavo che fosse entrato così a fondo nella parte del contadino. Lui puntualizzò che anzi questa era la parte in cui si divertiva di più. Mi fece una breve lezione sulla potatura dell’ulivo, come arte e come scienza. Poi m’invitò a cena per assaggiare il suo olio extravergine. Rimanemmo a lungo lì, seduti nel verde, a conversare serenamente, mentre Cencio giocava a cacciare lucertole. Quando il mio uomo si sdraiò per terra lo imitai. Stemmo in silenzio per qualche minuto, tutti i sensi accesi dalla primavera. Ero sommersa dall’erba alta, invasa da sensuali profumi di fiori e dal lieve effluvio del sudore di lui. Tenevo le mani coi dorsi in terra, le palme verso l’alto in muta preghiera. Sentii la mano di Luciano che si posò su una mia. Gliela strinsi. Avevo una voglia convulsa di girarmi e saltargli addosso, ma ero paralizzata. Non osavo manco girarmi verso di lui per guardarlo negli occhi. Neppure lui si mosse, e restammo così per un po’, mano nella mano, a parlare in leggerezza di cose futili. All’imbrunire ci alzammo e ci avviammo verso casa. Mi preparò una cenetta rapida: due hamburger alla piastra e una misticanza condita con un piccante olio d’oliva. Dopo cena mi fece assaggiare un vinsanto niente male di sua produzione, e proprio mentre mi stavo rilassando mi comunicò: “Stasera ti porto a ballare.” “Magnifico! È un sacco di tempo che non vado in discoteca.” “Ma che discoteca! Andiamo a La Bolera, nella Casa del Popolo di Montelupo: tango, walzer e foxtrot.” “Dici sul serio?” “E certo!” 81 “Amore, io non li ho mai ballati e non li so ballare quei balli là, e il liscio non mi piace.” “Come fai a dirlo, se non l’hai mai provato?” “Anche questo è vero.” “Non ti preoccupare. Sono facili. T’insegno io.” “Be’, allora non desidero di meglio.” Arrivammo al dancing verso le nove. C’era un’ampia pista da ballo e tutto intorno delle poltroncine e dei tavoli bassi. In fondo alla sala una band di tre persone faceva più chiasso di un’orchestra sinfonica. Una quindicina di coppie ballavano il tango sul canto sguaiato di un imitatore di Celentano. Un’altra quindicina di coppie sedevano ai tavoli bevendo chinotti e spume bionde. Luciano mi spiegò che era ancora presto e che la sala avrebbe cominciato a riempirsi verso le dieci. Mi aveva portato a quell’ora in modo da potermi fare lezione senza rischio di essere presi a calci. Mi afferrò la mano e mi trascinò in pista. “Il tango è semplice,” disse, “quattro passi: slow, slow, quick, quick. Tu vai indietro e io avanti. Le figure te le insegno un’altra sera.” Tentai, e imparai subito. All’inizio gli pestai i piedi diverse volte. Poi presi l’abbrivio e cominciai a muovermi trascinata dalla musica. Il ballo successivo era un walzer inglese. “Questo è un po’ difficile, tre passi: slow di sinistro indietro, slow di destro laterale, chiusura quick col sinistro. Dopo di che ricominci col destro indietro e vai laterale a sinistra.” Provammo. Sotto la sua guida era più facile a farsi che a dirsi. Poi fu la volta del foxtrot e infine della beguine. M’impegnai a fondo e dopo un’ora d’inciampi e ginocchiate, già mi muovevo con una certa armonia. Me lo disse lui e mi gratificò sussurrandomi all’orecchio che ero una ballerina nata. A mezzanotte la sala si era riempita fino all’inverosimile. Le coppie si lanciavano nella bolgia e si muovevano seguendo un flusso circolare in senso antiorario. Le gomitate si sprecavano, ma nessuno ci faceva caso. Entrare in quella fiumana dava la sensazione di perdersi in una corrente vorticosa. L’orchestrina sembrava aver alzato il volume, se possibile. Il ritmo delle can- 82 zoni entrava nel corpo e lo governava come le onde di un fiume un fuscello di legno. A un certo punto vennero i balli di gruppo, cha cha cha, mambo, hully gully, bachata, tarantella. Era esaltante, tutti i ballerini stavano allineati che sembravano una compagnia di bersaglieri in parata. Si agitavano unanimi muovendo piedi e corpi avanti, indietro, a destra, a sinistra. Dava l’impressione di una perdita collettiva d’identità. Avevo voglia di buttarmi nella mischia. Luciano mi dissuase. Disse che lì in mezzo rischiavo di brutto se non sapevo muovermi. Quei balli me li avrebbe insegnati un’altra volta. Ci sedemmo su due poltroncine e ci rilassammo. Mentre sorseggiavo un Martini, mi misi a osservare la gente. Volti tagliati con l’accetta, occhi illuminati dalla foga, sorrisi sgargianti, corpi rudi vestiti volgarmente, gli uomini in pantaloni attillati e t-shirt tese sulle trippe muscolose o camicie con le maniche rivoltate sugli avambracci, le donne con tacchi pretenziosi, calze a rete nere e scollature arroganti sui forti petti. Età media cinquanta anni. “Che razza di gente è questa?” Domandai. “Operai, contadini, artigiani, negozianti, tutti comunisti vecchio stampo.” “Sono stupefatta. È possibile che un intellettuale raffinato e anticonformista come te si mescoli a un tale popolo rozzo e incolto?” “Né rozzo né incolto. Non istruito, certo. Ma hanno la coscienza di classe e una cultura atavica non banale. Qui in mezzo c’è gente che potrebbe recitarti canti interi della Divina Commedia e commentarteli con cognizione di causa; e qualche vecchio partigiano che potrebbe spiegarti con acume le contraddizioni della nostra costituzione repubblicana. Ci sono di quelli che si dilettano nei certami in ottava rima.” “Che roba è?” “Una tradizione popolare toscana. Due contendenti armati di chitarre si fronteggiano ai capi di un tavolo d’osteria. Gli astanti gli danno un tema qualsiasi, che so? le corna del sindaco, le cazzate di Craxi. Loro, accompagnandosi con le chitarre, attaccano a recitare versi improvvisati in rime baciate, intercalando 83 un’ottava ciascuno. Il primo verso di una strofa deve rimare con l’ultimo di quella dell’avversario. Battute salaci, allusioni pesanti, ma sempre musicalmente poetiche. Il pubblico applaude e incita alla battaglia, si schiera con l’uno o l’altro dei cantori, si divide in partiti, prosciugando fiaschi e fiaschi di Chianti. Può durare delle ore.” Verso l’una la sala cominciò a sfollarsi. Noi restammo ancora un po’, più a guardare che a ballare. Alla fine solo una dozzina di coppie giravano stanche nella pista, sempre con quel movimento circolare che ora dava il senso di un rigoroso ordine gravitazionale. “Guarda là.” Disse Luciano, mentre sorseggiava il quarto Martini. Indicò il centro della pista. C’era una coppia di vecchietti che ballava stretta stretta. Avranno avuto un secolo e mezzo in due. Erano alti, ricurvi l’uno sull’altra, si muovevano elegantemente con passetti piccoli e aggraziati entro lo spazio di un metro quadrato. Avvinghiati come due adolescenti che pomiciano, cheek to cheek, non si staccavano neanche nell’intervallo tra una canzone e l’altra. “Che tenerume!” Dissi, e mi voltai verso Luciano. Gli occhi gli brillavano di dolcezza. Mi venne quasi da piangere. Lo presi per mano e lo trascinai al centro della sala, dove ci mettemmo a imitare i due vecchietti. Facemmo tre balli. Poi l’orchestrina attaccò un cha cha cha. Allora, sempre tenendolo per mano, lo portai di corsa al guardaroba. Prendemmo le nostre giacche e ci precipitammo a casa. Quella notte facemmo l’amore col corpo e l’anima, e non ci addormentammo prima dell’alba. 84 Lunedì, 20 maggio Lilli è stata uccisa ieri sera, il giorno dopo quello in cui ho avuto l’ultimo colloquio con Giuliano. Ieri il giornale cittadino riportava la notizia in prima pagina: Assassinata una dipendente della LUFSS RITI SATANICI IN VILLA STIBBERT? Sulla scena del delitto le tracce raccapriccianti di un sacrificio rituale. In effetti ne ha tutte le caratteristiche. Il corpo è stato ritrovato, nudo, con una ferita di pugnale nel petto. Era disteso sull’altare del tempietto egizio di villa Stibbert. Ai polsi e alle caviglie sono state rilevate delle abrasioni che lasciano supporre la vittima sia stata legata. La polizia non ha trovato l’arma del delitto, ma ha avanzato l’ipotesi che potesse provenire dal museo della guerra ospitato nella dependance della villa. Dal quale museo è stato denunciato il furto di un prezioso pugnale dell’epoca della seconda crociata. Il museo non è dotato di un efficiente sistema antifurto, e qualsiasi visitatore può aver asportato il coltello senza correre troppi rischi. Tanto più che i molti custodi, quando non riescono a coinvolgere i turisti in una visita guidata per una mancia lauta e anticipata, se la dormono beatamente. Tutto ciò, in sintesi, riferisce il giornale. Però è chiaro che un visitatore qualsiasi non va a rubare un coltello di giorno per usarlo di notte nel giardino prospiciente il museo. Probabilmente è stato preso la notte stessa. Perciò doveva trattarsi di qualcuno che aveva le chiavi del museo. Ora, queste chiavi sono depositate negli uffici dell’università, in villa Fabbricotti, e sono sicuramente accessibili ai presidi e al direttore amministrativo, cioè a Gianrico, Silvio e Giuliano, oltre che, probabilmente, a una vasta schiera di dipendenti grandi e piccoli della LUFSS. Anche Lilli avrebbe potuto impossessarsene facilmente. 85 Povera Lilli, ora che è morta la sento più vicina, quasi più umana. Da viva suscitava in me sentimenti contrastanti, con quei suoi atteggiamenti maschili, quel modo di fare autoritario, quel parlare calmo e compassato. Non era nella schiera delle amiche preferite, se posso considerarla un’amica. Lei aveva scelto una sua via, nella lotta contro gli uomini, che esigeva grandi rinunce in termini di rispetto di sé. Lei lottava con le loro armi, sul loro stesso terreno. Riusciva perfino a divertircisi, così almeno diceva, nel giocare il gioco del potere, ma quanta perfidia, quanta falsità, quanta miseria doveva respirare ogni giorno. In più doveva sopportare l’ignominia di usare, quali mezzi volti a un fine, le peculiari qualità che permettono a una donna di farsi strada tra i maschi supplendo all’handicap di essere femmina. Lo considerava un’arma, il look alteramente sexy della sua figura, un’arma da usare senza scrupoli e senza pudori, forse perché l’unica di cui era stata dotata generosamente dalla natura, lei, donna senza arte né parte, nel gran gioco tra uomini colti e potenti. Alla fine è dovuta soccombere, chissà se a causa di quel gioco? Mi domando di cosa aveva paura quando esitava a darmi informazioni sulla maledetta chiave? Sarà legata a questa faccenda la sua morte? Oppure, più banalmente, si è trattato proprio di ciò che mostra la scenografia magica? È possibile che infine le sia stato fatale quel residuo d’ingenuità e, direi, di sincerità femminile, che si esprimeva nella sua passione per l’occulto e la stregoneria? È verosimile che non ci sia alcun legame tra gli omicidi di Luciano e di Lilli? due fatti avvenuti a distanza di tempo e di luogo così ravvicinata? Dunque, facciamo il punto. 8 giorni dopo la morte di Luciano nella torre del cielo di villa Stibbert, viene uccisa, nel giardino della stessa villa, una delle persone che sono sospettate del suo omicidio. È da considerare ancora indiziata? O può essere stata uccisa dall’assassino di Luciano? Dei cinque individui su cui sto indagando per quell’omicidio, tre avrebbero un movente, almeno a quanto diceva Lilli, e sono Lucrezia, Gianrico e Silvio; due no, Lilli stessa e Giuliano. Uno di questi due ora è morto. Se è stato ucciso dallo stesso assassino di Luciano, può esserlo stato per lo 86 stesso movente. Ciò porterebbe a escludere Gianrico e Silvio, che avrebbero potuto uccidere Luciano per rancore professionale. Bisognerebbe poi escludere Lucrezia, se può aver ucciso il compagno per puro odio. Perché uccidere anche Lilli? Per gelosia? Per vendetta? Mettiamo che non sia valida nessuna di queste ipotesi. Allora l’assassino potrebbe essere stato Giuliano. Del quale però non conosco il movente. Può avere a che fare con la maledetta chiave? C’entra veramente la soluzione dell’enigma contenuto negli appunti di Luciano? Soluzione consistente appunto nel nome di Lilli? C’è un’altra possibilità: che l’assassino sia lo stesso, ma il movente diverso. In tal caso rientrerebbero in gioco i primi tre indiziati, restando da chiarire il movente per l’omicidio di Lilli. È possibile che lei sia venuta a conoscenza di qualche prova relativa all’omicidio di Luciano e che la cosa abbia costretto l’assassino a liberarsene? Anche Giuliano può ancora essere sospettato in questo caso. Anzi, direi che la sua colpevolezza non è da escludere affatto, se non altro perché nessuna delle varie ipotesi sembra convincente. Più ci penso, meno ci capisco. Mi sa che non sono tagliata per fare l’investigatrice. Certo le cose, nella vita, non sono così semplici come appaiono nei romanzi gialli. Ora mi tornano alla mente le ottobrate godute scorazzando insieme a Luciano nella campagna toscana! A volte stavamo insieme delle intere giornate anche durante la settimana lavorativa. Lui mi veniva a prendere la mattina presto, spesso senza manco una telefonata di preavviso. Mi costringeva a fare una rapida colazione e a vestirmi di furia. Poi mi trascinava in strada, quasi contro la mia volontà. Io mi lasciavo forzare di buon grado. S’inforcava la sua Harley nera e si andava, easy rider. Si correva su stradine deserte, tra le colline e i boschi, col vento dell’alba che ci pungeva la pelle mentre il sole sorgeva davanti a noi. Si attraversavano antichi paesini di montagna, tra panorami fuori del tempo. All’improvviso ci si fermava. Poteva essere davanti a una chiesetta diroccata o una fatiscente villa antica o un castello in 87 rovina. Si smontava, ci si sgranchivano le gambe e si girava intorno al monumento. Lui tirava fuori un libraccio di storia o un vecchio Baedeker, e si metteva a spiegarmi tutto, la storia del castello o il valore artistico della chiesa, e i fatti che vi erano accaduti. Quindi si entrava, se possibile, e camminando con reverenza si cercava qualcosa. Non andava mai al buio, lui. Mi portava davanti a una pala del Quattrocento o una formella dei Della Robbia o un trittico di Mariotto di Nardo o altri incanti del genere, e m’istruiva. Infine ci si rimetteva in moto. Verso l’una o le due ci si fermava a una trattoria di campagna e si gustavano i cibi e i vini schietti di questa terra. Ricordo come fosse ieri quella volta che mi portò a mangiare alla Gargotta, un ristorante specializzato nella cucina rinascimentale fiorentina. Ne avevo già sentito parlare, ma non avevo mai avuto occasione di provarlo. La ragione è che si tratta di un ristorante scarsamente noto, sperduto tra i monti del Mugello, in un posto che è difficile arrivarci per caso. Grande fu la mia sorpresa quando Luciano, alla fine della cena, chiese al cameriere di chiamare lo chef, e questi venne e buttò le braccia al collo del mio amico. Si conoscevano dai tempi del Sessantotto. In pochi minuti capii ciò che c’era da capire: che si erano divisi all’epoca del terrorismo, movimento a cui quello aveva partecipato sin dall’inizio; e per sua fortuna era stato arrestato prima di potersi macchiare di delitti di sangue; così se l’era cavata con otto anni di carcere, e quando uscì tutto era finito. Aveva comprato questo ristorante e ora viveva una sua vita appartata tra i fornelli e le biblioteche. Gli chiesi chiarimenti sulla faccenda biblioteche. Non l’avessi mai fatto! Si sedé al nostro tavolo, si riempì un bicchiere di vino e cominciò una conferenza sulla cucina fiorentina che non durò meno di un’ora. Fu interessantissima, almeno per me, che adoravo questo delizioso campo di ricerca. Il nostro chef sosteneva che tutta la rinomata e tanto decantata tradizione culinaria francese discendeva dalla fiorentina, la quale era stata esportata in quel paese, ancora semibarbaro all’inizio dell’età moderna, da Caterina dei Medici quando andò in sposa al 88 re di Francia Enrico Cazzotorto. Lo chef aveva fatto delle ricerche in alcune antiche biblioteche e aveva ritrovato le ricette originali di molti piatti francesi. A quel punto si scatenò con gli esempi. La famosa anatra all’arancia, per dirne una, non sarebbe altro che il paparo alla melarancia, la cui presenza nelle cucine nobili fiorentine è documentata già nell’epoca della seconda crociata. E poi la soupe aux oignons, ah, la meravigliosa zuppa di cipolle che mi era stata servita come primo! Una versione più raffinata di quella francese, la sola che lui cucinava, veniva servita alla tavola degli Strozzi sin dal primo Trecento. Il suo nome fiorentino è Carabaccia. Quella che prepara lui è la vera e originale Carabaccia stilnovista. Qui, manco a dirlo, il mio squisito conferenziere non seppe resistere alla tentazione di sciorinarmi la ricetta nei minimi particolari. Io tirai fuori penna e taccuino e mi misi a scrivere sotto dettatura in religioso silenzio. “Si pestano un etto di pinoli e un bastoncino di cannella e si tengono affogati nell’aceto per un’ora. In una terrina di coccio si scalda un chilo di cipolline affettate sottili. Si tengono a cuocere nell’olio d’oliva finché non ammorbidiscono, ma bisogna impedire l’indoramento. Al momento opportuno si mescolano i pinoli cannellati con le cipolle e si amalgama ben benino. Si aggiunge un cucchiaio di zucchero e un po’ di pepe e sale. Nel frattempo si è preparato un litro di brodo di carne. Vi si getta dentro l’impasto di cipolle e pinoli e si fa cuocere per mezz’ora. Infine si versa il tutto su delle fette di pane casereccio bruscate sulla brace. Servire ancora bollente. Resuscita i morti!” E così ce l’aveva fatta servire quella sera, accompagnata da un Sassicaia d’annata che ci aveva esaltato. Nello scrivere quest’ultima parola mi accorgo che sto divagando un po’ troppo e me ne domando la ragione. Però basta una rapida riflessione per realizzare che il ricordo dell’incontro con lo chef brigatista è emerso nella mia mente stasera non del tutto a sproposito. Infatti, e adesso la cosa mi torna alla memoria molto bene, maturai la convinzione che Luciano era andato a trovare l’amico sperduto tra i monti con un intento preciso. Voleva sapere qualcosa di Fabrizio, il comune amico ex terrorista, e disse all’altro che nessuno meglio di lui, che era stato suo compagno di 89 clandestinità e che lo aveva poi incontrato in carcere, nessuno meglio di lui poteva aiutarlo a togliersi qualche dubbio. Quali fossero i dubbi non lo capii bene, lì per lì. La loro conversazione diventò oscura, forse nel goffo tentativo di nascondersi qualcosa a vicenda pur nell’impegno alla rivelazione. Ma rivelazione di che? Un argomento particolare mi fece una certa impressione allora, una confusa impressione che adesso invece, in questo strano ricordo un po’ insensato, mi sembra si stia schiarendo. A un certo punto i due ex rivoluzionari si misero a parlare di espropri proletari, e Luciano insistette per sapere quando e quanti, soprattutto quanto. Ancora più impressione mi fece il fatto che Luciano fu tutto ringalluzzito per il resto della giornata. 90 QUADERNO 2 Mercoledì, 22 maggio. Verso Nord, a partire da una specie di confine che passa lungo Via Vittorio Emanuele, Firenze cessa di essere città e comincia ad arrampicarsi su per le colline che portano a Fiesole e a Terrarossa. Viuzze strette e contorte, sormontate da alti muri grezzi o pieni di studiati graffiti, si snodano sulle salite e tra i dossi, irretendo il verde disordinato delle ville e dei giardini. Qui le antiche dimore nobili non si distinguono da quelle della borghesia recente. C’è uno stile architettonico omogeneo, dalle linee armoniose e semplici, che si è formato nei secoli ed è ormai entrato a far parte della natura. Perfino le poche case coloniche sopravvissute riverberano un’eleganza rinascimentale fatta di proporzioni e linearità. È un’eleganza tuttavia che non sarebbe perfetta se fosse troppo uniforme. Così, qua e là, disseminate a caso, una su cento, sorgono costruzioni strane, volgari imitazioni di castelli trecenteschi, con i muri di pietra, le terrazze sormontate da schiere di merli guelfi, le piccionaie che sembrano torri di guardia. Queste costruzioni, quando si trovano accanto alle normali case dall’architettura elegante e sobria, creano un contrasto forte che disorienta il passante sprovveduto. Uno di tali contrasti può essere osservato al meglio proprio nella LUFSS. La Libera Università Fiorentina di Scienze Sociali fu fondata negli anni ’60 per iniziativa di un magnate locale, che mise l’idea e un po’ di soldi, e con il sostegno del Comune, che mise Villa Fabbricotti e Villa Stibbert. Sono, queste, due costruzioni della seconda meta dell’Ottocento che sorgono in cima a due collinette prospicienti, a ridosso di Via Vittorio Emanuele, e che riflettono, nella diversità delle loro architetture, gli splendori 91 e i contrasti e anche un po’ le miserie intellettuali che il secolo romantico portò in Italia. Palazzo Fabbricotti è un inno al Cinquecento, con la sua pianta rettangolare, le cornici sottili che separano i due piani, il movimento del bugnato che ne riveste il primo, le finestre a croce rinascimentale. Lo Stibbert invece riflette pesantemente, già nel coacervo di stili che lo formano, quella tipica espressione della decadenza estetica italiana che fu il neogotico ottocentesco. L’imitazione del Trecento domina la scena, con un susseguirsi di bifore e trifore dai vezzi più strani, di terrazze merlate, di archi ogivali e lanceolati. Belle e assurde sono le due torri di guardia. Quella quadrata, detta ‘torre della terra’, è bassa e severa. L’altra è esagonale, è snella, audacemente alta e un po’ frivola, con le sue finestre colorate e la corona di merli ghibellini. È chiamata ‘torre del cielo’, ed è in una saletta alla sua sommità che si tenne l’orgia nefasta. Il tutto non è sgradevole, e basterebbe quel gioiello della loggetta Cantagalli con le colonnine di ordine composito sormontate dai graziosi archetti trilobati per capire che non fu il cattivo gusto a formare questo mostro architettonico, ma il genio della trasgressione. Dalla collina di fronte, a dimostrare che la trasgressività dei Fabbricotti non fu da meno, una brutta torre merlata, quasi oscena nella sua ottusità, si alza pesante, a soffocarne l’eleganza, sul palazzo dalle proporzioni rinascimentali. I giardini delle due ville esprimono lo stesso contrasto. Semplice e ordinato è quello dei Fabbricotti. Un grande viale di cipressi risale la collina con ampi tornanti, dal cancello d’entrata, giù in Via Vittorio Emanuele, fino al palazzo, in cima alla collina, incrociando una lunga serie di aiuole e di scalinate. A parte i colori mutevoli delle aiuole, tutto il parco è dominato da una tonalità di verde scuro che proviene dai pochi tipi di alberi sempreverdi. Cipressi, cedri e lecci si addensano sulla collina a formare una specie di bosco; qua e là s’intromettono ciuffi di palme nane e altre esoticherie che danno vita a varie piccole radure di un verde irreale. In cima signoreggia un maestoso cedro del 92 Libano che si apre a candelabro davanti al palazzo e sembra voler imporre un rispetto aristocratico al giardino benpensante. Caotico e arzigogolato invece è il parco Stibbert, con la sua grande varietà di piante consuete, pini silvestri e domestici, cipressi maschi e femmine, lecci, tigli, ippocastani e querce; e il suo rigoglio di piante rare, corbezzoli di Grecia, cedri dell’Himalaia, sughere e querce rosse, aceri americani e pini neri e cento tipi di palme. Per non parlare delle mille circonvoluzioni dei viali e dei vialetti, giù nella valle e intorno al piccolo lago, tra fontane dalle forme strane, statue dalle espressioni misteriose, grotte, grottini, tempietti. Infine, ultimo shock per il visitatore impreparato, quella suprema epifania del gusto romantico che è il tempietto egizio, lì in riva al laghetto artificiale, con le sue sfingi di terracotta e le statue ieratiche che parrebbero voler infine rivelare il segreto di tutto il giardino, ma restano mute. Il turista rimane dapprima interdetto, di fronte a certe stranezze, e pensa trattarsi del prezzo che si deve pagare quando una società è agitata da una dinamica economica troppo rapida rispetto ai ritmi con cui le classi sociali emergenti riescono a elevarsi culturalmente. Però se si ferma e si dà tempo per assimilare lo spirito di questa terra, come credo stia finalmente accadendo a me, capisce di essersi sbagliato nel suo primo giudizio. Fa parte dell’anima fiorentina il gusto della trasgressione aspra, del vociare chiassoso, dell’esibizione arrogante; ma si tratta di una cortina fumogena che serve a velare una superiore cultura estetica, quasi una superiore eticità, in un atteggiamento d’irrisione verso il resto del mondo. Il fiorentino è così avanti, così oltre, nell’evoluzione dello spirito umano che gioca il gioco dell’eleganza con un grado superiore di raffinatezza. E, nel suo modo di giocare, il kitsch entra quale specifica regola formale mirata a mostrare la caducità delle regole. La vera eleganza deve esprimere la personalità, la vera bellezza deve essere unica. Quindi per ottenerle non basta sapere applicare le regole, è necessario anche saperle trasgredire. La becerata colta è il mezzo con cui la finezza dei fiorentini cerca di superarsi. Va da sé che si tratta di un’impresa difficile, proprio come piace a loro. Il segreto, credo di aver capito, sta sempre nelle proporzioni, nel tenta- 93 tivo di dare ordine e misura perfino alla trasgressione delle regole. Un fiorentino non si metterebbe mai l’orologio sopra al polsino della camicia. A questa categoria di persone appartiene Gianrico Delandi, il preside della facoltà di Economia. Lo vado a trovare durante l’orario di ricevimento, dato che per telefono si è fatto negare. Mi fa accomodare su una rozza sedia davanti alla sua scrivania. Io mi do un’occhiata intorno mentre lui si perde nei convenevoli. La stanza è piuttosto piccola: – un affogatoio – l’ha definita lui stesso. È arredata con gusto e sobrietà, stile rustico ricercato, diciamo così. Sulla mia sinistra c’è una vecchia credenza logorata dal tempo, color noce scuro, lucida di usura più che di cera. I ripiani per le stoviglie sono stati trasformati in scaffali e su di essi sono ammucchiati libri e scartafacci in magnifico disordine. La scrivania di fronte a me non è una scrivania, ma un tavolaccio di rovere non meno usurato della credenza. È un tavolo ampio, e le sottili gambe affusolate lo tengono quasi sospeso a mezz’aria in una grazia rude. Sul ripiano sono sparsi fogli di quaderno scritti a mano, alcuni faldoni gonfi di carte e una risma di print-out di computer. La sedia su cui siede lui è un gran seggiolone impagliato dagli alti braccioli. Tavolo e credenza sono tanto grandi che occupano un terzo della stanza. Il resto della mobilia si riduce a una vecchia Savonarola di un color cuoio sporco e a una cassettiera da orefice, adattata a tavolinetto, con diversi piccoli cassetti di metallo e uno stretto ripiano rivestito di una pelle dello stesso colore della sedia. In terra, un frusto Kasghai logoro di passeggiate meditabonde. Poche le suppellettili, tutti i ripiani disponibili essendo ricoperti di libri. Alle pareti, infine, cinque stampe di Firenze com’era, che dal colore della carta sembrano essere piuttosto antiche. Se dicessi che l’arredamento di questa stanza riflette alla perfezione la personalità del suo abitatore, direi una banalità. Be’, pazienza, ma è proprio così. Gianrico, da dietro quel suo magnifico tavolo, mantiene le distanze, pur trattandomi giovialmente. È un uomo di media statura, magro, aitante, col sorriso cordiale e gli occhiali spessi da balucano. I capelli grigi e le rughe sulla fronte rivelano che si 94 avvia alla sessantina; il vestire casual e giovanile, blazer blu e jeans Armani, che si sforza di resistere. Il meglio di Gianrico è nel modo di esprimersi. Ha una parlata forbita, che divaga continuamente tra la frase aulica e il detto popolare, con frequenti intercalari di citazioni erudite. Il lessico, poi... ah, dà l’impressione di provenire da una lingua fantastica. È un misto di vernacolo fiorentino e purismo arcaizzante, una vera delizia dell’orecchio e della mente. Insomma Gianrico sembra un gran cruscheggione. In realtà è un virtuoso di diglossia italofiorentina, e senza l’ingenuità del toscano medio che crede di parlare italiano quando usa la lingua che gli ha insegnato mamma. La sua trasgressione odierna è rappresentata da un paio di calzini di seta bianchi, così corti da coprire appena le caviglie. Anche lui a volte ci prova con l’eleganza che tende al pacchiano. Lo aggredisco subito: “Sto indagando sulla morte di Luciano e di Lilli. Devono avere a che fare con una certa chiave. Cosa ne sai?” “Che chiave?” Risponde sorpreso. “La chiave della verità.” “Cos’è, un rompicapo?” “No, è una cosa seria.” Ribatto, dura. “E, tanto per chiarezza, me ne ha parlato Lilli, che mi ha suggerito di chiedere proprio a te. Per la precisione, mi ha detto di chiederti se l’hai trovata, questa chiave della verità.” “Te l’ha sballata grossa! Ti ha corbellato!” Parla in tono sincero, solo leggermente beffardo, ora. “Tutto quello che so di codesta chiave me lo ha detto giusto Lilli. Non vedo come io possa rivelarti più di quanto ne sapesse lei.” “E cosa ti avrebbe detto?” “L’ho incontrata tre giorni prima del congresso amoroso alla torre del cielo. Mi aveva cercato lei. Era agitata. Disse che le era cascato il fiato, che aveva paura. Giuliano sarebbe in possesso di una certa chiave misteriosa. Lei non sapeva bene a cosa servisse. Mi accennò a qualcosa tipo un tesoro, da farci un gran lombo, ma ne parlò in termini di molto ambigui. Disse che per accedervi bisognava conoscere una certa verità segreta. Inoltre disse che 95 c’entrava Fabrizio Gledo, il vecchio compagno di Luciano che ora è in carcere. La qual cosa puzzava di bottino ed io stetti guardingo.” “Perché te ne parlò?” Non mi risponde subito. Manipola qualche oggetto sulla scrivania, sovrappensiero. Poi riprende: “Credeva di essere in possesso di una verità pericolosa. Mettendone a conoscenza altri, penso, cercava di procurarsi una sorta di protezione.” “Cosa voleva precisamente da te?” “Vallo a capire. All’inizio mi sembravano tutte ciarle. Ho pensato si trattasse di una delle solite stravaganze di Lilli, con quelle sue manie per il misterioso e l’occulto, e non le ho dato punta importanza. Ma ora che lei è morta...” “Sai se ne parlò anche ad altri?” “Forse a Silvio. So che andò a trovarlo lo stesso giorno in cui parlò con me.” “Non pensi che possa essere Silvio l’assassino?” La domanda che si aspettava. “Non so se può aver avuto un movente specifico. Tuttavia è noto che Silvio odiava Luciano fino allo spasimo.” “Parlami di questo. A me non è cosa nota.” “È una storia lunga alquanto. E ora devo andare a lezione.” Non ho nessuna intenzione di mollarlo. Così lo invito a pranzo da me per farmi raccontare la storia con calma. Lui nicchia un po’. Lo convinco minacciando di accompagnarlo a lezione. Di fronte al rischio di farsi vedere in giro a braccetto con me, cede subito. La lezione è alle undici. Alla mezza lui è a casa mia. Gianrico è il principale responsabile della mia attuale condizione di vita. Mi disse la parola cruciale nel momento cruciale. Fu circa cinque anni fa, a Roma, la mia città natale, quando stavo attraversando uno dei miei periodi neri. Avevo cominciato la professione due anni prima. Dopo un anno già non ce la facevo più con questo mestiere zozzo, o almeno quello che facevo lì, nella mia città e in quel modo. Soprattutto odiavo l’idea di dover andare a letto con chiunque volesse, indipendentemente da ciò che volevo io. Con l’agenzia non si scherzava: eri un mezzo di 96 produzione e non potevi fare troppo la schizzinosa. Odiavo anche, e non meno, l’idea di dover spartire fifty fifty con un’organizzazione che dopo tutto svolgeva solo la funzione di un centralino telefonico. Così decisi di mettermi in proprio. Fu come passare dall’inferno al purgatorio, se non altro perché potevo selezionarmi i clienti. Il peggio venne dopo, però, dopo il primo anno di libera professione, quando ormai mi ero sistemata per benino. Il lavoro rendeva e, data la qualità della clientela, non era manco troppo sgradevole. No, il peggio venne quando cominciai a realizzare che non era la parte tecnica del lavoro che mi disturbava di più, né quella economica, bensì qualche altra cosa che non riuscivo a capire cosa fosse. E dire che non ero certo frenata da remore morali. Anzi, avevo consapevolmente teorizzato la stupidità di certi handicap etici. Non sono il tipo della puttana che esercita per amore del pappa o, peggio ancora, il tipo che è sempre in attesa del principe azzurro che ti leva dalla fogna. Tanto meno coltivavo illusioni consolatorie tipo fanciulla-traviata-dall’autolesionismo. Niente di tutto ciò. La mia era stata una scelta deliberata e meditata. Direi, addirittura, una scelta indotta da un calcolo razionale di massimizzazione dei profitti, se posso esprimermi con parole di Gianrico. Eppure c’era qualcosa che non andava. Proprio quando mi ero sistemata niente male, mi prese una specie di smania, non dico angoscia, nemmeno ansia, no, qualcosa di più blando ma più sottile, che sfuggiva al mio controllo razionale. Era forse quella perdita di controllo sui miei stati d’animo che mi disturbava maggiormente. Il sintomo peggiore, ad ogni modo, era che mi annoiavo a morte. Cercai di uscirne evitando di pensarci. Fu così, credo, che mi buttai sulla lettura. A scuola non ero mai stata una secchiona e in italiano avevo sempre studiato il minimo indispensabile per sopravvivere. Avevo fatto le letture di programma, noiose quanto i professori che ce le propinavano e diseducative in sommo grado. Perciò fu una sorpresa scoprirmi lettrice accanita. Leggevo solo narrativa, e di ogni genere. Cominciai con i gialli e la fantascienza, robaccia comprata in edicola a caso. Poi, sulla spinta di quei libri di carta straccia che a volte i giornali e i grandi settimanali 97 vendono a prezzi stracciati per farsi perdonare dai lettori, passai alla letteratura seria. Infine, quando cominciai a sentire anche il gusto di avere tra le mani un libro di buona fattura, di palparlo, di sfogliarlo con delicatezza, di annusare l’odore della carta e dell’inchiostro, capii la verità. Dice il saggio: libro e puttana nutrono da tempo immemorabile uno sfortunato amore l’uno per l’altro. Allora passai dalle edicole alle librerie serie. L’idea di prendere i libri in prestito in biblioteca non mi è mai passata per la mente. No, dovevano essere miei. Li compravo con foga, con furore, e sempre senza logica, alla rinfusa. Ne compravo tre o quattro per ognuno che ne leggevo, e ne leggevo in media due a settimana, instancabilmente. Ormai tutto il tempo che non perdevo nel lavoro lo consacravo alla lettura. E i libri si ammucchiavano in pile sbilenche e instabili sui tavoli, le sedie, le poltrone e per terra addosso alle pareti. Gianrico ne fu colpito. Se ne accorse, un giorno, mentre stava seduto sul mio letto, la schiena appoggiata alla spalliera, che cercava di riprendersi da una scopata particolarmente faticosa. Guardò con meraviglia quei mucchi disordinati di libri. Si alzò e andò a scartabellare. Con la testa reclinata ora su una spalla ora sull’altra, cercava di leggere i titoli sulle costole dei miei libri. Alcuni li prendeva in mano, con due dita, quasi ne fosse schifato; li osservava bene, poi li rimetteva a posto. Fece tutto in silenzio. E quella testa inclinata sulla spalla come un punto interrogativo esprimeva la sua meraviglia meglio di ogni commento. “Abbiamo una buggerona colta!” Disse. “No, una che si coltiva.” “Da sola non ce la fai. Se ci tieni veramente, devi farti coltivare.” Mi suggerì di iscrivermi all’università. L’idea non mi fece un grande effetto, lì per lì. Mi piaceva leggere dei bei romanzi e non credevo che conoscere la storia della letteratura mi avrebbe fatto aumentare il piacere. Lui disse che non pensava alla facoltà di Lettere, ma di Sociologia. Mi consigliò quella della LUFSS, che era, a suo dire, la migliore d’Italia. Sicuramente non quella di Roma, – sottolineò – che era la peggiore. Mi si accese un lume nella mente. Per un mese intero non pensai ad altro. 98 Allora non me ne resi conto. Invece oggi ho le idee molto chiare su quali furono i motivi veri che mi resero così allettante la proposta di Gianrico. Sociologia della LUFSS aveva una gran pessima fama. Era stata un covo di tremendi rivoluzionari, la matrice di tutte le nefandezze politiche che hanno agitato i sonni della nostra classe dirigente negli ultimi vent’anni e l’alma mater dei peggiori maestri di varie generazioni di giovani traviati. Il che costituiva ai miei occhi una valida ragione per andarci a studiare. Per altro, andare a Sociologia significava andare a Firenze, la mia città ideale, realizzare uno dei miei sogni d’adolescente, andare ad abitare nella capitale universale dell’arte e della bellezza. Anche se i sogni adolescenziali li avevo ormai perduti da tempo, la sola possibilità di realizzare questo che era il più ameno mi fece sussultare l’anima con un conato di romanticismo. Oggi, ahimé, ho l’impressione che forse si trattava di un rigurgito di sentimentalismo giovanile. Ma allora no. Sembra un secolo fa. Allora avevo un sogno che solleticava le parti molli del mio spirito ancora immaturo, le poche che resistevano. In realtà c’era un altro motivo dietro tutto quel ribollire di fantasie puerili, ed era il vero motivo. Me ne sono resa conto in epoca piuttosto recente, com’è giusto. Andare a Sociologia significava andare via da Roma. Non era tanto l’imbarazzo di esercitare in una città dove vivevano i miei parenti e i conoscenti più perfidi. No. Era proprio l’idea di lasciare Roma. Qui non posso fare a meno di spiegare cosa significa per me la mia città, pur al costo di qualche scivolata nella sociologia. Io sono nata a Centocelle, non un quartiere, non una città nella città: una dimensione dello spirito. E, nello stesso tempo, molto meno: quattrocento mila abitanti e non un teatro, non un liceo, non una biblioteca, non un giardino. Ci ho perduto i miei primi vent’anni. È stato come vivere nel cuore della barbarie però alle porte della città più superba del mondo. Il muro di Berlino è un monumento di civiltà a confronto delle mura aureliane, quelle che separano il centro di Roma dalla periferia. Tutto ciò che di bello ed elevato si può immaginare in una città eterna, stava dall’altra parte del muro. Tutto ciò che di disgustoso si può concepire in una megalopoli da quarto mondo, stava di qua. Roma era un universo, 99 meglio di qualsiasi altra capitale universale. Aveva in sé l’intera gamma delle condizioni di vita di questo turpe mondo, dal Papa a Mamma Roma. E io l’amavo allo stesso modo in cui un bambino senza padre può amare una madre mignotta. Volevo stare con lei, sempre con lei; e lei mi tradiva. Io la desideravo, la cercavo, la invocavo; e lei mi sfuggiva. Io la sognavo; e lei m’ignorava. Io stavo dall’altra parte del muro. Quando si andava al centro si diceva: andiamo a Roma. Ricordo come fosse ieri quell’estate infernale, quella mia prima stagione di lavoro, di onesto lavoro, quando, all’età di quindici anni, mio padre mi trovò un posto di commessa in una panetteria a Piazza Vittorio. Ero una fanciulla ancora imbevuta di aspirazioni fiabesche, e mi dovevo alzare la mattina alle sei. Prendevo il tranvetto a Piazza dei Mirti, nell’ora che era pieno fino a scoppiare, pieno di lavoratori dagli sguardi spenti di sonno e di tristezza. Faceva tutta la Casilina dentro la periferia, il tranvetto grigio, coi suoi tre vagoni da trenino lillipuziano e il fischio sifilitico, una fermata ogni tre minuti. Ci metteva tre quarti d’ora per arrivare al capolinea della stazione Laziali. Ogni tre minuti gonfiava il suo carico di muratori, bancarellari, posteggiatori. Nel caldo dell’estate e del pigia pigia, tra una tastata alle chiappe e una strizzata al petto, i puzzi di aliti e d’ascelle insieme al fumo delle Alfa e delle Nazionali salivano densi al soffitto come una nebbiolina greve. Avevo quindici anni e già la vita mi mostrava il suo meglio. Dal giorno della mia nascita mio padre aveva deciso che io non sarei dovuta restare nella sua classe sociale. Avrebbe sostenuto qualsiasi sacrificio pur di farmi studiare fino al diploma di ragioneria. D’estate però, a cominciare dai quindici anni, dovevo farmi le mie brave vacanze di lavoro, più con scopi educativi che per contribuire al pur magro bilancio famigliare: dovevo capire cosa significa guadagnarsi da vivere con la fatica del corpo. L’ho capito fin troppo bene, meglio di quanto mio padre si sarebbe aspettato. Così, era passato appena un mese da quando Gianrico mi aveva dato il suo consiglio, e già mi trovavo a Firenze ad arredare il mio piccolo appartamento a Montughi. Per questo dico che Gian- 100 rico è il principale responsabile delle mie attuali condizioni di vita. In realtà lui fu soltanto l’evento scatenante di una catastrofe spirituale che avevo covato a lungo dentro di me. Ora è chiaro, e mi rendo conto che forse dovrei provare dei sentimenti di gratitudine nei confronti di Gianrico. Dopo tutto, il cambiamento di vita a cui mi ha spinto ha rappresentato una sorta di rinascita per me. Il problema è che non so bene se sono rinata in un corpo migliore o in uno peggiore. Il problema è che, terminato il primo anno di entusiasmo, con le visite ai musei, ai giardini, ai monumenti e a tutte le altre mirifiche attrattive per turisti, Firenze mi ha riportato a galla quel confuso miscuglio di sensazioni e sentimenti che le città d’arte finiscono sempre col suscitare in me, quel senso di convenzionalità e di estraneità, quella specie di spleen in basso ostinato che mi rende sorda l’anima a ogni rigurgito della vita, le poche volte che se ne dà uno, specialmente quando butta sull’estetica. E che se fossi rimasta a Roma mi avrebbe almeno salvato la rudezza del vitalismo borgataro. A Roma ero un’esclusa; a Firenze sono una sradicata. Infine questi ultimi fastidi: il coinvolgimento in un thriller tanto assurdo quanto complicato, in cui non capisco se finirò col giocare la parte del detective o della vittima; e lo sgomento di essermi di nuovo innamorata; e di un uomo scomparso; e non comprendo bene se mi disturba maggiormente l’assenza dell’oggetto o la ricaduta in sé. Insomma no, proprio non riesco a essere grata a Gianrico per avermi spinto a cambiare la mia vita. Glielo dico papale papale, e anche con una certa asprezza, mentre lui, sornione, se ne sta spaparanzato sul mio divano a sorseggiare vodka e lime. All’una ci mettiamo a tavola. Gli ho preparato un pasto non molto leggero: abbacchio al curry, rinfrescato con ananas, seguito da pecorini toscani e bagnato con un denso Chianti. Ce ne scoliamo una bottiglia, lui tre quarti. Dopo il caffè, il mio pollo è ben cotto. Forse ho esagerato, e all’inizio fatico a farlo esprimere. Pian piano però si scioglie, il babbione, e comincia a parlare, dapprima adagio, con la bocca ancora impastata di vino, poi sempre più lucidamente, specie dopo il caffè. Tuttavia, quando ci 101 si avvicina all’argomento che m’interessa, lui si blocca, ci gira intorno e tergiversa. “Di quella storia non posso parlare,” dichiara infine, “c’è un gentleman agreement tra me e Silvio, giuppersù.” Lo dice senza ironia. “In realtà tutta la comunità scientifica che traffica intorno alla LUFSS ha steso un pietoso velo sulla pietosa faccenda. Proprio non posso parlarne. D’altronde a me non piace punto cianciare.” Si vede invece che muore dalla voglia. Solo, non sa da che parte prenderla. Io, appena afferro la cosa, decido di tenerlo sulla corda. Dato che non vede l’ora di spiattellarmela tutta, deve essere lui a cedere. Così accade, infine. A un tratto mi posa una mano sulla coscia e mi fa: “Cara pispolina mia, non potrei ma a te la racconterò. E sai perché? Perché hai il più bel bel di Roma di Roma e di Firenze.” “Eh?” “Il bel di Roma non è solo il Colosseo. È anche altro, la qual cosa ti spiegherò con le parole usate dal poeta osceno per descrivere il gesto di una buggerona che, quando si china e abbassa giù la chioma, alza le gruppe e mostra il bel di Roma.” “Bello! Molto poetico! Ma ora veniamo al dunque. Per quale motivo Silvio odiava Luciano?” “Devo dire che era un odio ben meritato.” Attacca. “Il tangano era un uomo esecrabile e sapeva farsi voler male da tutti nell’universo mondo, specialmente in quello accademico. Aveva una mania distruttiva e autodistruttiva fuori del comune, il bischeraccio. E aveva deluso molte delle speranze che i colleghi anziani, me compreso, avevano riposto in lui. Tutti, nella nostra università avevamo nutrito grande fiducia nelle sue doti intellettuali, tutti c’eravamo aspettati una luminosa carriera scientifica. Invece a tutti lui dava la quadra: non produceva che contributi ipercritici e demolitori e sembrava provasse un gusto sadico ad abbattere le teorie altrui, tanto più quanto più erano giudicate importanti. Di costruttivo non aveva mai prodotto niente, lo strullo. Se ci ha rimesso la buccia non può prendersela con altri che con se stesso.” “Scriveva poco?” 102 “No, a scrivere scriveva. Aveva sbotrato un ponderoso manuale didattico, nonché una serqua di recensioni. Mai una monografia organica, né un articolo con un contributo creativo. Per quanto…” E qui si ferma meditabondo. Lo incoraggio: “Per quanto…” “Recentemente aveva scritto quegli appunti di filosofia; so che li ha consegnati giusto a te. Non negare. Lo so per certo. Me l’ha detto Lilli.” “Aridaje co’ st’appunti!” Lo provoco in romanesco. “Vedo che te li hanno già chiesti. Chi? Lilli? E glieli hai dati?” Mi domanda, con una nota di trepidazione nella voce. “Decisamente no.” “Però li hai dati a Giuliano. Perché a lui sì?” “Me li ha ben ricompensati.” “A me li daresti? Te li pagherei bene anch’io.” “Non ci penso nemmeno.” Taglio corto. Lui finge di prenderla con nonchalance. Gli chiedo di continuare il racconto dei fallimenti accademici di Luciano. Così ricomincia a spiegare: “In positivo non ha mai compicciato nulla il nostro. In quella sua preferenza per i lavori manualistici e divulgativi i colleghi vedevano una sorta di spregio per l’attività di ricerca vera e propria. Le sue recensioni poi erano sempre piene di veleno. A parte il manuale, scriveva solo stroncature. Prendeva un grande contributo teorico, possibilmente di uno scienziato famoso, lo smontava pezzo per pezzo e ne mostrava le debolezze. Quando si sapeva che di un libro stava per uscire una sua recensione, puoi star certa che all’autore il culo gli faceva lippe lappe. Si era costruita una sua reputazione. I colleghi lo chiamavano ‘il recensore folle’. Lui sosteneva di assolvere una funzione positiva, ché al progresso della scienza contribuisce di più chi abbatte le verità ricevute che chi le erige. Era dominato da una sorta di grandigia intellettuale. Ed era un tipo piccoso: quando si metteva in testa di dare pugni in cielo non lo fermava nessuno. A volte quest’attitudine veniva usata per sostenere loschi giochi accademici. Se uno voleva colpire un collega, combriccolava per fargli assegnare 103 Luciano come recensore in una rivista o come discussant a un congresso.” “E lui si prestava?” “A buco a buco. Credo avesse sviluppato una sorta di mania di grandezza, il fanfano. Era roso dalla voglia di fare grandezzate. Si sentiva un castigo di Dio.” “È per questo che gli hanno rovinato la carriera?” “Io dipoi non so se qualcuno abbia voluto rovinargli la carriera. Quel che è certo è che il tangano ha contribuito in maniera decisiva alla propria rovina. Non si progredisce con i manuali e le recensioni. Uno potrà pur avere di molti numeri in quanto loico, potrà essere anche geniale, ma se vuole fare carriera deve avere anche un po’ di gnegnero in zucca, e se vuole essere stimato dai colleghi deve produrre le cose che piacciono a loro. Lui invece... Credo si fosse lasciato travolgere da una specie di circolo vizioso, in forza del quale la professione rispondeva con astio alla sua pervicacia critica e lui reagiva corbellando il prossimo e coltivandosi la vocazione distruttiva.” A questo punto ho un momento di defaillance. Sono distratta, come se la mente fosse presa da qualcosa che non arriva ad afferrare e, nello sforzo, perdesse concentrazione. Il pranzo è finito da un pezzo e la digestione è in fase avanzata. Mi viene voglia di accucciarmi e farmi una pennichella. Per resistere prendo la mia borsa, ci smucino dentro, ne estraggo un chewing gum, lo scarto e me lo metto in bocca. Cerco di fare il punto su ciò che mi ha appena detto il signor preside, ma non riesco a quagliare. Ho un singolare flashback, l’immagine di Giuliano che prima si mostra preoccupato quando gli dico che Lilli mi ha rivelato il numero 2919, poi mi chiede se l’ha rivelato anche ai presidi delle due facoltà. Per associazione mi viene alla mente il suggerimento di Lilli riguardo ai moventi dei due presidi. Gianrico si accorge del mio smarrimento. Domanda: “A cosa stai pensando?” Cerco di recuperare: “A Silvio Moscanti. Aveva qualche particolare motivo di astio nei confronti di Luciano?” 104 “Astio è dir poco. Al vecchio barbagio Luciano ne aveva combinata una delle sue più grosse. Ne aveva compicciate di brutte anche contro altri che lo avevano aiutato. Perfino a me ne aveva fatta una barbina, a me che l’ho cresciuto amorevolmente. Ché lui fa sempre come l’America: la piglia e non rende. Io ad ogni modo l’ho perdonato, sebbene ancora non mi sia sbollita. Lo considero tuttora un mio allievo, per quanto degenere. Silvio non lo perdonò mai invece.” “Cosa gli aveva fatto di così terribile?” Interrompo, cercando di troncare le sue tergiversazioni. “Devi sapere che Silvio aveva vinto la sua cattedra di sociologia con un importante libro su Simmel. Luciano, che si era laureato con lui proprio su Simmel, aveva intuito che quel libro non era farina del suo sacco. Si mise a bracare, a fare delle ricerche, delle vere e proprie indagini poliziesche. Lui ha sempre avuto la passione per il giallo: sosteneva che l’indagine scientifica ha molto in comune con l’inchiesta poliziesca: la raccolta d’indizi, le congetture, le verità che non sono mai certezze e via di seguito.” “Non divagare, se no facciamo notte.” “Breve: scoprì che vari anni prima di lui un altro studente si era laureato con Moscanti su Simmel. Ne cercò la tesi in biblioteca e non la trovò. Questo fatto lo insospettì. Di una tesi di laurea si devono sempre depositare due copie. Se di quella non se ne trovava punta, era oltremodo probabile che qualcuno l’avesse fatta sparire. Lui non si diede per vinto. Rintracciò l’autore della tesi e andò a chiedergliela. Ne ottenne addirittura la copia originale manoscritta. Così scoprì quel che sospettava: che il Moscanti era un dottor dell’uggio, che il suo famoso libro era solo una versione lievemente modificata di un lavoro altrui, di una tesi di laurea. Il peggio venne dopo. Sai cosa fece il bischeraccio? Senza dire né ai né bai, andò da un suo amico che lavorava in una casa editrice di secondo ordine e fece pubblicare la tesi. Fu uno scandalo.” “Un bel processo per plagio, immagino.” “Dio mi subissi, no. Niente di tutto ciò. Dal punto di vista legale Silvio era inattaccabile. Esiste una vecchia legge che auto- 105 rizza un professore universitario a pubblicare a proprio nome una tesi di laurea di cui è stato relatore. La ratio è che lo studente è guidato dal professore e le idee che esprime non possono non essere influenzate dalle ispirazioni di colui. Sia come sia, Moscanti è uscito dallo scandalo con la reputazione scientifica distrutta.” “Ma quello studente, se era così bravo, perché non si era fatto sentire?” “Forse era timido. Moscanti peraltro gli aveva fatto ottenere un buon posto al ministero della pubblica istruzione. Certo il poveretto deve aver covato un gran risentimento. Difatti, da quanto mi ha raccontato Luciano, non gli fu difficile farsi consegnare il manoscritto originale della tesi.” Non vengo a sapere altro da Gianrico. Termina il suo racconto verso le cinque e se ne va via di filato e tutto contento. Questa storia è molto interessante. L’odio di Silvio per Luciano doveva essere veramente grande. Può essere stato un buon movente per l’omicidio? Ma lui, Luciano, era mosso da odio? Sprezzo? Presunzione? Cos’è che lo spingeva all’insolenza, a oltraggiare un padre amorevole? Non poteva essere solo autolesionismo. Ecco che la mente mi scivola verso il ricordo di lui. A volte, dopo aver fatto l’amore, rimaneva disteso sul letto, con gli occhi fissi al soffitto, muto; pareva ascoltare una qualche musica struggente. Alle mie domande rispondeva con monosillabi, fino a che non mi stancavo. Spesso mi appisolavo e svegliandomi lo ritrovavo là, come lo avevo lasciato, chiuso e inerte. Raramente in quelle occasioni ero in grado di penetrare nel flusso dei suoi pensieri. Poteva accadere, però, che con un piccolo inganno o una provocazione riuscivo a distoglierlo dal tenebrore e indurlo a uno sfogo o a una sparata delle sue. Quando ci riuscivo mi divertivo non poco, perché le sparava veramente grosse. Un giorno, appena finito di scopare e prima che lui entrasse in quello stato di abulia, afferrai il telecomando e accesi il televisore che stava sul comò davanti al letto. C’era un servizio sulla Thatcher e i nuovi conservatori inglesi. “Mala tempora...” Provocai. Lui abboccò: 106 “Stultorum plena sunt omnia.” “Proprio così: tutt’er monno è monnezza.” “Ci sono epoche sane ed epoche malate.” Disse con tono tra il profetico e il beffardo. “Nelle prime gli imbecilli sono costretti al silenzio. Nelle altre si manifesta quella che potrebbe essere definita ‘stupidità aggressiva’. Nelle epoche come la nostra gli imbecilli si stanno facendo arroganti. Pretendono non solo il diritto di parola, ma perfino di mettere a tacere gli altri. Presto prenderanno il potere dappertutto.” “Chi sarebbero gli imbecilli, oggi?” Lo incalzai. “Il mondo ne è pieno. C’è stata una specie d’invasione aliena a partire dalla fine degli anni ’70. Dapprima hanno dato vita a eventi culturali innovativi. In reazione alla ventata rivoluzionaria d’inizio decennio, s’è scatenata un’ondata controrivoluzionaria che ha assunto i caratteri del nuovismo. E ogni popolo ha dato il meglio di sé, secondo le proprie tradizioni. In Francia ci sono stati i nouveau philosophes, in Germania i neopagani, in Inghilterra i nuovi conservatori, in America i nuovi economisti classici…” “E in Italia?” “Cosa poteva produrre l’Italia di peculiarmente nuovo?” “Non lo so. Dimmelo tu.” “I nuovi comici. E ti assicuro che non è stata la peggiore di tutte quelle mode culturali, anzi…” Lasciò in sospeso la frase. Pareva volesse ricadere in quello stato di abulia. Lo sollecitai: “Anzi cosa?” “Direi che l’Italia è in controtendenza, per ora.” Si riprese. “I nuovi comici cercano di contrastare l’ondata d’imbecillità. Invece tutti quegli altri innovatori si sono mossi sulla cresta dell’onda, così favorendo e quasi legittimando i cambiamenti politici.” “Dunque noi italiani possiamo considerarci fortunati.” “Non credo. Spesso i risultati delle azioni vanno oltre le intenzioni. D’altronde i movimenti culturali anticipano quelli politici e, se i neo-conservatori e i nuovi economisti classici hanno preparato l’avvento di una classe politica reazionaria e ultraliberista, dobbiamo aspettarci che i nuovi comici precorrano i successi di una classe politica farsesca.” “Mi sembra un’estrapolazione un po’ meccanica.” 107 “Spero di sbagliarmi, ma se la storia è maestra di…” “Quale storia?” “Le pagliacciate di Mussolini non furono precedute da quelle di Marinetti e D’Annunzio?” “Non vorrai mica paragonare Benigni e Verdone a Marinetti e D’Annunzio.” “Certamente no, è tutto un altro spessore.” “E allora?” “Bisogna considerare un secondo processo. A livello macrosociale la domanda crea la propria offerta. Gli attori comici che graffiano hanno bisogno di un oggetto di derisione, e gli elettori italiani glielo daranno.” “Non è l’offerta che crea la domanda?” “Lascia stare l’economia. Non è la tua materia.” “E che ci dice l’economista?” “Che per la legge della tendenza all’intensificazione delle crisi, una classe d’imbecilli di capacità inusitate sta per erompere sulla scena politica anche da noi.” “Chi sarebbero questi nuovi politici?” “In alcuni paesi sono già andati al potere. Ci sono dei popoli giovani che credono ancora la religione abbia a che fare con la purezza della fede. Guarda cosa è accaduto agli americani, che si stanno facendo governare da un attorucolo fondamentalista. Tra tali popoli gli imbecilli hanno il coraggio di venire allo scoperto e di assurgere a maggioranza.” “Immagino che ti riferisci al partito degli American Idiots.” “Non solo. Gli americani stanno all’avanguardia.” “M’interessa di più l’Italia.” “Nei paesi dove una millenaria dimestichezza con la religione cattolica ha insegnato alla gente a diffidare delle verità forti, gli imbecilli hanno difficoltà a conquistare un seguito di massa. Allora si camuffano e si nascondono. Non per questo sono meno pericolosi. Noi italiani crediamo di essere stati graziati dal cielo, quando osserviamo che qui i pinzocheri organizzati si riducono a quei quattro buontemponi di Chierichetti Liberali. Sbagliamo. Quelli che vengono a galla rappresentano, diciamo così, la coda di destra della distribuzione di frequenza della stoltezza. Da noi 108 gli idioti sono dei virtuosi dell’entrismo, e anche se non arrivano a raggiungere il potere assoluto, cui pure aspirerebbero, riescono ugualmente ad appestarti la vita.” “E chi lo prende il potere?” “Da noi ci sono i furbi, e ce ne sono più che in ogni altro paese al mondo. Noi siamo un popolo qualunquista. Penso al qualunquismo endemico, alla turpitudine di tutta la nostra storia di gente programmaticamente menefreghista. Nei periodi di normalità questa gente usa gli imbecilli in funzioni ancillari: inquisitori, censori, pubblicitari. Ma al potere ci mette i furbi. Che i governanti siano corrotti non è un problema, anzi, è garanzia d’indulgenza. Non sappiamo che farcene di un governo che governa, ne vogliamo uno che ci lasci fare i fatti nostri. In tali epoche gli uomini ragionevoli sono emarginati, tuttavia conservano il diritto di parola, di critica, di contestazione.” “E nei periodi di anormalità?” “Nelle epoche malate gli imbecilli vanno comunque al potere, occultamente o in modo palese. Il fascismo del ventennio ne è un esempio, certo un evento patologico ma non per questo singolare, diciamo: il ricorrente parossismo febbrile di una malattia cronica. Né è da escludere che fra qualche anno arrivi un’altra montata di febbre. Quando i furbi si fanno governare dagli imbecilli, le persone ragionevoli sono condannate al silenzio. Gli individui sani non riescono a dare un senso sociale alle proprie aspirazioni, nemmeno il senso di una critica radicale. I loro pensieri vengono deviati e le loro azioni diventano antisociali. Gli uomini stessi, questi uomini, voglio dire, diventano sempre meno numerosi, vengono isolati e si trasformano in eroi stendhaliani. O si chiudono in se stessi, nella noia e nella superbia, o esplodono nel gesto sconsiderato o si riducono a leccarsi le ferite narcisisticamente o si consolano con la risata collettiva.” “Tu a quale categoria appartieni?” “Io sono tignoso e cerco di resistere, sebbene la rabbia che mi tiene su si faccia sempre più debole, sempre più impotente. Prima o poi ci sarà il crollo, e sento che sarà piuttosto prima, ormai.” 109 Ecce homo: questo era Luciano Vinel. Chissà se il finale della trista orgia non ha rappresentato un naturale epilogo per la sua vicenda? Chissà? Dipende dalla sincerità che metteva in quegli sfoghi. E confesso che non sono mai riuscita a capire quanto era sincero nelle sue sparate. D’altra parte, forse per una salutare forma di autoironia, o forse in ossequio al profilo di scassapalle crudo e beffardo che si era costruito, lui stesso dava l’impressione di non prendersi troppo sul serio. 110 Giovedì, 23 maggio Oggi tocca a Silvio. Lo vado a trovare nel suo studio di preside e lo blocco mentre sta chiudendo bottega. Lo convinco a ricevermi dicendogli che ho delle cose importantissime da riferirgli a proposito della morte di Luciano. “Quali cose?” Mi aggredisce arcigno, dopo avermi fatto accomodare su una poltrona bassa e avvolgente. Lui mi domina dall’alto di una splendida sedia Tonet. Siamo nel suo studio di preside, un ambiente sobrio e asettico, dalle pareti bianche appena movimentate da alcune stampe di antichi velieri. In un angolo c’è un salottino con due poltrone e un divano. Seduto di fronte a me, mi fissa negli occhi. Parla adagio, e non gesticola come invece fa Gianrico. È calmo, composto, sicuro di sé. Gli occhi, lievemente socchiusi, rivelano una cattiveria controllata. È un uomo alto, dritto sulla schiena fin quasi alla rigidità, il cranio lucido di calvizie, la bocca impudicamente mobile e sensuale. Un’eleganza stucchevole di doppiopetto gessato e cravatta a tinte severe ne tradisce le molte pretese signorili svelandone le poche capacità. Non è fiorentino; parrebbe piuttosto un industrialotto brianzolo arricchito troppo rapidamente, se non proprio un burino ripulito. Mi si atteggia sussiegoso, come fa di solito con le persone che giudica sotto di sé. Sussiegoso sì, ma si vede che è imbarazzato. A momenti sembra addolcirsi, a momenti si scioglie fino al mellifluo. Quello predominante tuttavia è un atteggiamento di autorevole burbanza. Certo deve considerarmi potente, in qualche modo, memore del trattamento che gli riservo a letto. Ora però non mi considera la sua puttana. Anche se non ci riesce bene, si sforza piuttosto di trattarmi da studentessa. Ciò mi fa riflettere sul modo in cui molti professori usano la cattedra. Con essa lui vorrebbe incutermi timore. Senonché io conosco il mestiere e so trattare i miei polli. Accavallo le gambe mentre lo fisso severamente. So bene come farti abbassare la cresta, vecchio bacucco! “La cosa importante sarebbe che esistono seri sospetti su di te riguardo all’omicidio di Luciano.” Sparo. Lui non fa una piega: 111 “Sentiamo.” “Ho saputo dell’affair Simmel. Mi sembra un movente robusto.” Stranamente lo vedo rilassarsi. Ne resto interdetta. Forse sono fuori pista. Lui si avvantaggia della sorpresa e riprende a parlare. Sostiene che se quello è un movente, altre persone che erano presenti all’orgia ne avrebbero di altrettanto robusti; e che Gianrico, che intuisce essere stato il delatore del misfatto, avrebbe un movente non meno robusto del suo. “Se volevi incuriosirmi, ci sei riuscito.” Gli dico. “Dunque ora raccontami del misfatto di Gianrico.” Esita ancora un po’. È accigliato, titubante, e sembra volersi sottrarre al compito che gli ho assegnato. Cerco di incoraggiarlo facendogli delle moine. Infine acconsente, ma in cambio vuole una cosa. Vuole niente meno che gli appunti di filosofia di Luciano. Anche lui, come Gianrico, è disposto a pagarmeli. Anche lui, come Giuliano, mi spiega che in quegli appunti ci sarebbe nascosta la soluzione di un enigma. Siccome voglio che mi parli del possibile movente di Gianrico, non gli dico di no. Ma neanche di sì. La vaga speranza in cui lo lascio lo induce alla rivelazione sul preside di Economia: “Devi sapere che Luciano gli aveva combinato una marachella, diciamo così, simile a quella che aveva combinato a me, anzi peggio. Gianrico è un economista di fama internazionale. La sua reputazione poggiava su un modello di commercio estero a cambi fissi, o qualcosa del genere, elaborato nei primi anni Sessanta. È noto come modello Miller-Delandi. Miller è un economista americano che elaborò una teoria molto simile a quella del nostro, grosso modo nello stesso periodo. La coincidenza di scoperta non suscitò un grande interesse allora. Esiste una teoria delle scoperte multiple che è ampiamente accettata dalla comunità scientifica. L’idea è che, quando una nuova teoria è matura, casca dall’albero della conoscenza e chi c’è sotto la raccoglie. Può accadere che venga raccolta da più di un ricercatore simultaneamente. Idea abbastanza ovvia, si capisce. Senonché Luciano non sopportava le idee ovvie. Quando cominciò a non sopportare Gianrico, si mise a indagare su questo particolare caso di 112 scoperta multipla. C’erano anche delle voci che giravano, a dire il vero; le quali dicevano che Delandi aveva passato un anno sabatico nell’Università di New York prima di pubblicare la sua scoperta; e che proprio in quell’università insegnava Miller. Bene, Luciano partì per l’America e lì cominciò a indagare, scartabellare, intervistare. Alla fine scoprì che le idee essenziali del modello Miller-Delandi erano state presentate dall’americano a un seminario precisamente nell’anno in cui Delandi spendeva a New York il suo congedo. Tornato in Europa, Luciano parlò del fattaccio in un convegno. Diede i riferimenti necessari per rintracciare le minute di quel seminario nella biblioteca dell’Università di New York, oltre all’elenco dei partecipanti, Delandi incluso. Lui era presente al convegno. Quando tutti gli sguardi gli si riversarono addosso, non mosse ciglio. Si limitò a fissare Luciano come guardando nel vuoto. E una cosa fu immediatamente chiara a ognuno di noi: che la carriera di Luciano come economista era terminata. Io credo che ci fosse del masochismo spirituale, una forma di autolesionismo, nel comportamento di quel cane, pace all’anima sua. Non solo fece delle boiate di questo genere, ma le fece alle persone che lo sostenevano e che gli dimostravano amicizia.” “Delandi gli era amico?” “Direi di più. Gli era un padre. Gli aveva dato una borsa di studio, gli faceva pubblicità tra i colleghi. Per tutti Luciano era il suo allievo prediletto. Tutti si aspettavano una carriera rapida e brillante: era molto intelligente, se non geniale, e aveva alle spalle il potente Delandi. Così la bravata fu interpretata come uno sputare nel piatto in cui mangi, capisci? Ma era peggio: una pugnalata alle spalle di un padre che ti accudisce premurosamente.” “Parli bene tu …” “Lasciamo perdere... Comunque, sì, ne fece altre di boiate, compresa quella che fece a me. Nessuno è riuscito mai a capire il comportamento accademico di Luciano. Forse la spiegazione è semplice: lui era uno che non sa stare al mondo. Con il sottoscritto, dire che si comportò da traditore è dir poco. Quando fu cacciato dal dipartimento di Economia, venne a piangere da me. 113 Sì, perché dopo si rendeva conto dell’idiozia compiuta. Io dirigevo il dipartimento di Scienze Sociali all’epoca. Lo accolsi a braccia aperte, se non altro per fare un dispetto a Gianrico. Lo riorientai verso la sociologia e lo mandai alla Sorbona, da dove tornò tre anni dopo con un dottorato in Scienze Umane.” “Luciano aveva una laurea in economia e una in sociologia?” “No, una in economia e due in sociologia.” “E io che pensavo fosse un filosofo!” “Nessuno può dire cosa fosse precisamente Luciano, cosa credeva di essere, chi credeva di essere. In realtà era una bestia. Insomma, lo avevo appena avviato a una brillante carriera di sociologo, che lui mi pugnalò alle spalle, anche me!” “E fu cacciato dal dipartimento di Scienze Sociali.” “Era il minimo. Non mi vergogno di riconoscerlo: ho desiderato la sua morte, e ora che è morto non piango. Ma non l’ho ucciso io.” “Poi che successe? Quando lasciò Sociologia, dico.” “Cominciò un turbinio di migrazioni da un dipartimento all’altro. Se li è fatti tutti, compreso quello di Metodi Matematici. Cacciarlo dall’università non si poteva: era assistente di ruolo. Rifiutargli l’afferenza a un dipartimento di sua scelta non si poteva: era un diritto. Però nessuno era obbligato ad amarlo e a rendergli la vita facile.” “Secondo te”, lo interrompo bruscamente, “potrebbe essere stato Gianrico ad ammazzarlo?” “No, secondo me non è la pista giusta.” “Quale pensi che sia la pista giusta?” “Vallo a capire!” “Potrebbe entrarci la chiave della verità?” Dico, sottolineando la parola ‘chiave’. Stavolta lo sorprendo. “Ehi! Vedo che la sai più lunga di quanto sembra!” “Allora, che cosa sai della chiave?” Lo incalzo. Così comincia un gioco a rimpiattino, fatto di caute domande e battute spiritose, che non approda a nulla e che non starò a riferire. Va avanti un bel pezzo. Dopo di che decido di cambiare tattica. Trascino il mio uomo su una poltrona e gli zompo in braccio. Puttaneggio un po’, lo provoco, lo vezzeggio. Lui è 114 molto sensibile a questo gioco. Basta mettergli una mano su una coscia per fargli perdere la testa. Anche qui, per amore di brevità, non starò a descrivere la scena. Ad ogni modo, per restare a quel che conta, senza che lui se ne accorga riesco a strappargli qualche conferma. In particolare tre. Prima: si tratterebbe della chiave di un enigma da risolvere. Seconda: potrebbe trovarsi nascosta nei famigerati appunti di filosofia. Terza: nella faccenda sarebbero implicati pure Fabrizio e Giuliano, i due ex compagni di lotta di Luciano. Non riesco a sapere altro. Lui, forse credendo di avermi detto troppo, si alza bruscamente, si ricompone e mi congeda con garbo. Sembra proprio un enigma. 115 Venerdì, 24 maggio. Spinta da un impulso irresistibile, stamani decido di prendermi un giorno di vacanza per ritemprarmi lo spirito. Andrò a spasso per la città, a zonzo coi sensi accesi tra le viuzze, i canti e le piazzette del quartiere Diladdarno. La prima visita la faccio in chiesa, dove mi fermo un quarto d’ora in contemplazione della Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Poi esco su Piazza del Carmine e mi riempio il cuore di ardore mistico di fronte alla facciata nuda della cattedrale. Capisco che oggi è giornata di meditazione sul tema dell’amore eterno e del peccato. Così tonificata, imbocco Via Santa Monaca e mi avvio verso Via Maggio, la vera meta del pellegrinaggio odierno. Al Canto della Cuculia mi fermo in un negozietto di libri usati, più uno stracciarolo che una libreria. Su un lungo tavolaccio tarlato c’è un mucchio di volumi sfuggiti al macero. Sembra che sono stati gettati lì a palate. Non ci perdo meno di mezz’ora a rovistare tra quelle pagine polverose, ci pesco qualche chicca e me ne esco soddisfatta con lo zainetto pieno della riserva mensile di letture. Un isolato più avanti c’è una libreria antiquaria internazionale. Sosto davanti alla vetrina ad ammirare preziosi esemplari d’incunaboli e cinquecentine venete, e una stupenda incisione del 1732 con veduta panoramica di Firenze, ma resisto alla tentazione di entrare. Non è tanto una questione di prezzo, anzi oggi ho deciso di darmi alle spese folli, quanto l’impazienza, ché sento impellente l’attrazione di Via Maggio lì vicino. Nella strada più romantica del mondo spicca la casa di Bianca Cappello, la nobildonna veneziana fuggita con l’amante dallo scandalo che aveva suscitato nella sua città, per venire ad accenderne uno non meno scellerato nella città di Dante. Leggo la storia su una guida ai misteri di Firenze regalatami da Luciano, che aveva piegato un’orecchia sulla pagina dedicata alla tragica vicenda. Un giorno che il Granduca Francesco I passeggiava per la via, lei gli gettò una rosa dalla finestra. Lui alzò lo sguardo e fu amore a prima vista. Dopodiché, le sue assidue passeggiate tra palaz- 116 zo Pitti e Via Maggio, attraverso quello che era il quartiere a luci rosse della città, oltre al furore della Granduchessa suscitarono anche le ire del cardinal Ferdinando. Costui gridava allo scandalo più che per il peccato di pubblico concubinato, per le eretiche pratiche sessuali a cui si diceva che i due amanti si dedicavano. Si applicavano alla ricerca della pietra filosofale tramite l’unione di mercurio e zolfo, cioè le essenze femminile e maschile della materia spirituale. Peraltro Ferdinando era il fratello di Francesco e il legittimo aspirante alla successione al trono, visto che la consorte del Granduca non riusciva a dargli un erede. L’erede glielo diede la concubina, ma il bastardo non poteva vantare alcun titolo di legittimità. Quando la Granduchessa si decise a mettere al mondo un vero principe, ebbe una serie di colpi di sfortuna. Poverina! Il bambino morì a cinque anni e poco dopo morì anche lei in circostanze misteriose. Bianca e Francesco si affrettarono a convolare a nozze. Poverini anche loro! Avevano appena coronato il sogno di regolarizzare con una pubblica cerimonia il matrimonio alchemico, quando morirono entrambi in circostanze non meno misteriose: undici giorni di agonia con terribili mal di pancia, dopo essere stati a cena dal cardinale. Il medico ufficiale accertò una normalissima morte per ‘malaria perniciosa’ e Ferdinando salì al trono, affrettandosi a punire le malelingue e i propalatori di sospetti. Ma la storia non perdona. Recentemente le viscere di Francesco sono state riesumate e analizzate da alcuni ricercatori dell’università di Firenze, che le hanno trovate piene di arsenico. La morale della favola sarebbe forse piaciuta a Luciano: non c’è crimine che tenga di fronte al tribunale della scienza. Più avanti, in fondo a Via Maggio, c’è Casa Guidi, dove hanno vissuto Elisabeth Barrett e Robert Browning, fuggiti anch’essi dalla patria per lo scandalo suscitato dalla loro relazione amorosa. A Firenze condussero una vita appartata, la famigliola al completo col figlioletto Pen e il cane Ash. Scrivevano poesie e monologhi sotto l’ispirazione che saliva dalle stradine puzzolenti e gloriose. Ricevevano visite di rari amici letterati, con cui parlavano di poesia e fate ambigue, magia e mattinate fiorentine. Qui lei aveva scritto poesie deliziose in cui esprimeva un amore 117 quasi mistico per l’uomo della sua vita. Qui aveva partecipato con il cuore e la mente alla causa del risorgimento italiano, auspicando il riscatto delle donne attraverso una partecipazione attiva alle lotte politiche. Qui infine morì, dopo quasi tre lustri di felicità, qui nella sua seconda a più amata patria, l’anno della dichiarazione dell’unità. Robert, da parte sua, aveva scritto poemi esoterici, storie di anime travagliate e vite di alchimisti che per conquistare la verità avevano rinunciato all’amore e che per questo avevano fallito. Ebbe il triste destino di sopravvivere a Elisabeth per ben ventotto anni. In un ermetico sermone impartitomi durante una delle nostre conversazioni arcane, Luciano mi aveva spiegato che il poeta tornò in Inghilterra per dare la dovuta istruzione anglosassone al figlio, ma soprattutto per compiere una missione segreta affidatagli nientemeno che dal colonnello Stibbert; però quando giunse la sua ora Robert non poté fare a meno di venire e morire in Italia. Trattenendo una lacrima di commozione, chiudo il libro e decido di sfogarmi nello shopping. Imbocco lo Sdrucciolo, faccio pochi passi su un marciapiede in secolare rovina e svolto in Via Toscanella. Alzo la testa a rimirare i muri fatiscenti delle abitazioni popolari, un ammasso di cubi e parallelepipedi addossati l’uno all’altro, con l’aria solenne di vecchi guerrieri superstiti di mille battaglie, le facciate di un caldo beige scalcinato ingentilite da briosi rosai. Non è immaginabile come sia possibile che edifici così poveri e scarni siano tanto eleganti, tanto pregni di rigorosa perfezione geometrica. Incrocio Via Sguazza, da cui si gode uno scorcio sui graffiti misteriosi del palazzo di Bianca Cappello, poi Via dei Velluti, Via dei Vellutini, Via dello Sprone, ed ecco Piazza della Passera. Resisto alla tentazione di sfogliare il libro di Luciano per trovare l’origine della lasciva denominazione. D’altronde questo era il cuore del quartiere a luci rosse ai tempi di Francesco I. Mi siedo al caffè degli Artigiani, mi riposo un po’ e mi rinfresco con un calice di Vernaccia. Poi mi alzo e mi avvio finalmente all’orgia consumistica che avevo programmato. 118 La prima visita è a un’antica seteria. L’avevo progettata da tempo, ma solo ora mi sono decisa a farla. Imbocco lo Sprone, passo davanti ai luoghi in cui vissero Guicciardini e Machiavelli e mi perdo in un dedalo di vicoli, finché mi ritrovo davanti al cancello chiuso di una villa cinquecentesca. Suono il campanello e aspetto qualche minuto. Mi viene ad aprire un signore di mezza età dall’aria burbera, che mi si presenta come il maneggere della ditta. “Il che?” “La parola da cui deriva ‘manager’. Noi restiamo fedeli all’originale.” “Che vuol dire?” “Viene da ‘maneggio’, la gestione dei cavalli con cui la ditta trasportava merci in tutta Europa.” Mi fa strada lungo un viottolo di ghiaia che si snoda tra aiuole ben coltivate e disseminate di statue misteriose e bizzarri vasi di terracotta, oltre che di palchetti su cui sono stese matasse di seta ad asciugare al sole. Giunti davanti a un edificio dalla facciata austera, mi apre il portone, si scosta e mi fa entrare con un inchino. Il primo impatto è una raffica di sensazioni violente, un forte profumo di non so che e un’inondazione di colori vivaci. L’uno e l’altra provengono dalle stoffe stese sulle pareti e ammucchiate sui tavoli, stoffe incredibili, dai nomi dimenticati. Il maneggere me le illustra, facendomele accarezzare coi polpastrelli: velluti Medici, ermesini Pitti, damaschi Frescobaldi, broccatelli Strozzi. Mi spiega che oggigiorno si usano più per gli arredamenti che per gli abiti, salvo le provocazioni di qualche stilista originale. “Mi domando come riuscite a fare affari, se è così difficile trovare questo posto?” “Noi non produciamo per i turisti giapponesi di passaggio. Abbiamo una clientela internazionale, cui vendiamo su ordinazione. E non abbiamo concorrenza, perché siamo gli unici al mondo a produrre stoffe così particolari.” “È possibile che qualche multinazionale giapponese non vi abbia imitato?” 119 “È possibile perché i macchinari e i procedimenti che usiamo sono ancora quelli dei nostri antenati.” Da dietro una porticina in fondo al negozio mi giunge il rumore di telai al lavoro. Chiedo se posso visitare il laboratorio. La sua prima risposta è categorica: proibito dalle norme di sicurezza. Allora gli sfodero il più timido dei miei sorrisi troieschi, una malia a cui non ho trovato nessun uomo capace di resistere. Infatti lo vedo quasi sbiancare. Ed è per celare un leggero tremito delle labbra che mi risponde subito con un: “Beh, che gusto c’è ad avere le regole se non si possono fare le eccezioni?” Il laboratorio è un salone rettangolare pieno di un’aria umida e calda e del frastuono di macchinari di legno e di ferro. Una dozzina di operaie di diverse età lavorano con estrema concentrazione; lavoratrici specializzare che si sono trasmesse il mestiere di madre in figlia, spiega la mia guida. Poi mi mostra i pezzi forti della fabbrica-museo, tutti ancora in funzione: un orditoio settecentesco costruito su disegno di Leonardo, un telaio del Seicento adibito alla produzione di frange e galloni, e la macchina più moderna del laboratorio, un orditoio semimeccanico Benninger del 1872. Tornati nella sala d’esposizione, non sto a perdere tempo. Ordino subito tre metri di un meraviglioso damasco a fiorami fucsia che avevo adocchiato appena entrata. Lo userò per ingentilire il verde muffa del mio divano Frau. Mi lascio tentare anche da una specie di arazzo dalla figurazione rievocante bellezze botticelliane. Vi aggiungo otto metri di fine ermesino color avorio con cui voglio rifare le tende della mia stanza da letto. Infine poso gli occhi su un foulard rosso più delicato di un velo da sposa, che ottengo come omaggio della ditta. Consegno un biglietto da visita con l’indirizzo a cui spedire la merce, insieme a un assegno dalla cifra smodata. Me ne vado appagata, non prima di aver incoraggiato il maneggere a fare la consegna di persona. Alle undici e mezzo sono di nuovo in strada. Mi devo affrettare, ché la prossima visita è su appuntamento e l’ho prenotata per mezzogiorno. 120 Percorro i Lungarni Torriggiani e Serristori e giungo a San Niccolò. Qui, al piano attico di un palazzo del Trecento, c’è la profumeria più esclusiva del mondo. Il maestro profumiere mi accoglie affabilmente e mi fa accomodare in un salotto con vista mozzafiato sulla città. Dopo qualche convenevole chiama una commessa, che giunge con un carrello pieno di boccette dalle forme esotiche. Il maestro ne prende alcune, le apre e me le fa annusare, illustrandomene i valori spirituali. C’è Alamut, estratto da tutti i fiori delle Mille e una notte, c’è Dilmun, essenza di paradisi mesopotamici, e poi Incensi, l’incanto della regina degli alberi, e Piper Nigrum, che porta l’odore del vento sulle carovane orientali delle spezie. Lo interrompo gentilmente, spiegandogli che non sono venuta per acquistare uno dei suoi pur meravigliosi profumi standard. Mi hanno detto che lui ne crea di personalizzati. Il suo contegno cambia immediatamente. Con un cenno licenzia la commessa. Si distende sulla poltrona, incrocia le mani sul ventre e mi esamina con uno sguardo intenso che sembra volermi penetrare l’anima. Riavvia la conversazione con tutt’altro tono. Ora si è fatto meno cordiale ma più intimo. Mi spiega che un profumo personale è un’opera d’arte. Non faccio questione di prezzo, sta per dirgli la mia anima borgatara. Per fortuna mi trattengo. Lui, dopo aver insistito sull’idea che un profumo personale deve cogliere l’essenza della persona, mi fa una serie di domande confidenziali, quasi più con le maniere di un inquisitore che di un confessore. Vuole sapere dove sono nata e quando, i paesi che ho conosciuto e le impressioni che mi hanno fatto, i miei gusti artistici, musica, pittura e lettere, le passioni, i sentimenti, l’amore, cosa mangio e cosa bevo. Quando chiede della mia professione, gli dico che studio sociologia. Mentre parlo, prende appunti su un taccuino, su cui intravedo lo schizzo di un disegno del mio volto che sta prendendo forma sotto la sua mano rapida. L’interrogatorio non dura meno di un’ora. Infine mi congeda dandomi appuntamento alla settimana successiva per le prove. “Le prove?” 121 “Bambina mia, se un abito su misura lo devi provare, a maggior ragione lo farai per un profumo su misura.” All’una e mezzo mi ritrovo in strada, e mi avvio verso Ponte Vecchio. Il sole risplende feroce e la mia anima se lo beve a garganella. Non mi lascio tentare dal ponte dei gioiellieri. Per oggi non ho bisogno di altre gratificazioni. Mi avvio verso Porta Romana. Giunta lì, mi fermo al barroccino di un trippaio, gloriosa istituzione fiorentina che risale alla notte del medioevo. Decido che mi merito un raffinato fast food proletario. Chiedo un panino col lampredotto ‘completo e bagnato’, cioè condito con una piccante salsa verde e la mollica della pagnottella inzuppata nel sugo greve. Il lampredotto è ricavato dall’abomaso, uno dei quattro stomaci del manzo. I macellai del resto d’Italia lo trattano allo stesso modo degli altri stomaci. Nelle regioni con la puzza al naso ne fanno addirittura trippa per gatti. Non i fiorentini, per i quali l’abomaso costituisce una raffinatezza. In effetti ha un sapore molto particolare. Nonostante la triplice bollitura, lo strato muscoloso del tessuto resta gommoso, come la carne di lampreda, da cui il nome. Ed è piuttosto insapore. Lo strato di mucosa invece ha un gusto delicato e succulento ad un tempo, e la consistenza di un paté spugnoso. Le due parti vengono mangiate insieme, sicché la necessità di una lunga masticazione dello strato gommoso consente al palato di estrarre tutta la soavità di quello più morbido. Quando Luciano m’invitò a mangiarne la prima volta, rifiutai schifata. Lui però insistette, e alla fine mi lasciai convincere. Non me ne sono pentita, tanto che ormai non so passare davanti a uno di questi barroccini senza fermarmi ad assaggiare la rara prelibatezza, che sia pranzo, cena o colazione. Oggi me ne divoro un panino così ripieno che pare un doppio king burger. La mollica, ammorbidita dal sugo caldo, mescola la sua tenerezza con quella della carne spugnosa, mentre la crosta croccante del pane gratifica le fatiche sostenute dalla mascella per rompere la resistenza del muscolo gommoso. Me lo pappo lì davanti al carretto, restando in piedi appoggiata a una mensola, e lo bagno con un bicchie- 122 re di Chianti non meno greve del sugo di cottura. Torno a casa nel primo pomeriggio, stanca e appagata. Quale tremenda sorpresa, quando trovo la porta manomessa e la casa tutta in soqquadro: le librerie vuote e i libri sparsi per terra, i cassetti rovesciati, la biancheria disseminata sul pavimento insieme ai libri, gli sportelli degli armadi spalancati, i cuscini dei divani sottosopra… insomma un casino senza pari! Corro subito al comò. L’ultimo cassetto, dove tengo nascosti i gioielli, è aperto e in minuzioso disordine. I miei valori però non sono stati rubati. Vado al tavolo di lavoro. Il ripiano è stato ripulito dei libri, delle penne e degli scartafacci che ci tenevo sopra. Sono sparsi per terra tutt’intorno. Ma c’è rimasto il mio diario, aperto all’ultima pagina scritta. La sedia ben sistemata davanti al tavolo mi fa capire che il ladro s’è concesso un po’ di tempo per leggere le mie confessioni. ‘Ladro’ tuttavia non è la parola giusta. Lo capisco la sera quando, dopo aver perso un pomeriggio per rimettere in ordine, mi rendo conto che non è stato rubato nulla. Dunque cosa cercava il malfattore? La mia mente balza subito alla conclusione più ovvia: cercava gli appunti di filosofia di Luciano. In questi ultimi giorni me li avevano chiesti Gianrico, Silvio e Lilli, e a tutti e tre li avevo negati. Lucrezia non era parsa interessata. Giuliano ne ha le fotocopie. Lilli è morta. Perciò il malfattore è uno dei due presidi. È rimasto fregato, visto che quegli appunti li tengo gelosamente custoditi nello zainetto Prada che portavo appresso. O forse è proprio Giuliano, nel qual caso evidentemente cercava ciò che ha trovato: il mio diario. Magari voleva sincerarsi dei risultati delle mie indagini. Alle dieci osservo soddisfatta il mio lavoro di riassetto, e ancora più soddisfatta mi compiaccio per averli fregati tutti, i miei marpioni. Decido che per coronare la piacevole giornata farò festa. Mi chiudo in casa, stacco il telefono e prendo un lussurioso bagno bollente. Alle undici ceno con pane e nutella. Nel godermi il peccato di gola, perdo il controllo della mente e mi lascio trascinare dal rimuginio, proprio ciò che oggi avevo deciso di evitare. 123 Quest’indagine sull’omicidio di Luciano mi fa montare l’ansia. Scavo e scavo e non ci capisco niente. Ho l’impressione che tutti ne sanno più di me e che tutti cercano di utilizzarmi per sapere qualcosa da me. Mi domando se non è il caso di mollare. In fondo che me ne frega di chi ha ucciso Luciano? Rileggendo le pagine del diario, mi accorgo che il vero oggetto delle conversazioni che ho avuto nel corso dell’indagine non è stato l’omicidio di Luciano ma Luciano stesso. A rifletterci bene, mi rendo conto che è lui che m’interessa, che è lui che voglio capire chi è, piuttosto che il suo assassino. E riandando alla passeggiata di stamattina capisco che è stato lo spirito di Luciano a guidarmi. Così, finito di rileggere ciò che ho appena scritto su questa giornata, metto sul giradischi Prayer and Meditation, la più inquieta delle suite di Coltrane, e mi abbandono al ricordo di Luciano. È stato lui a iniziarmi a Coltrane, il virtuoso del jazz che usa il sassofono per fondere l’angoscia con la rabbia. Mi aveva riempito casa di dischi, oltre che di libri. Me li regalava sistematicamente, monotonamente, una volta un disco, una volta un libro, quasi ogni settimana. Spesso, dopo aver fatto all’amore, quando non entrava in quel suo stato di abulia che lo rendeva muto e inerte, scendeva dal letto, avviava il giradischi, si stravaccava su una poltrona, si accendeva un mezzo Toscano, e cominciava a leggere poesie ad alta voce, con la sua voce fiacca e sforzata, soffocata dal fumo. Il sigaro Toscano è un’altra cosa su cui mi ha erudito. La lezione me la impartì proprio il giorno che mi portò in giro per il quartiere popolare di Firenze. Stavamo seduti a un tavolinetto all’aperto del Caffè degli Artigiani in Piazza della Passera. Eravamo circondati da avventori che, ad altri tavolinetti, bevevano e fumavano come turchi. Avevano tutti l’aria di turisti intellettualoidi. Tanto per dire qualcosa di spiritoso, chiesi a Luciano il suo parere su un’osservazione che avevo fatto a proposito degli intellettuali radical-chic, e cioè che molti di loro sono fumatori. O almeno, diversi miei amici dell’università sono dei fumatori 124 accaniti. Dice che in America ormai fumano quasi soltanto i negri e i portoricani, e che le fumatrici però sono in aumento. In Italia i portoricani non ci sono e i negri non fumano più degli altri. Gli intellettuali sovversivi invece sembra di sì. Chissà se c’è un significato profondo? Glielo chiesi. Lui disse che gli intellettuali scontrosi sono assimilabili non tanto ai portoricani quanto alle donne, e che se queste fumano sempre di più, è meno un segno di emancipazione che di maturità spirituale. Poi tirò fuori un toscanello, se lo accese e cominciò la lezione. “Questo sigaro”, disse, “è una delle più alte espressioni della toscanità, è il condensato di secoli di civilizzazione. Ed è il contrario della sigaretta: vuole un fumatore sensibile e consapevole, uno che sappia capire nel fumo la metafora della lenta morte che è la vita e riesca a goderne; e, se la cosa comporta lo sdegno delle persone sagge e dei crociati della tua salute, prendere anche ciò come una metafora della vita e fumarci sopra.” Avevo sempre provato ripugnanza per quel tanfo di terra bruciata e di marcio. Lui me ne spiegò la segreta filosofia, di un piacere severo che discrimina ferocemente il fumatore passivo dall’attivo, solo al secondo concedendo i suoi favori esclusivi. Mi fece dare qualche tirata, mentre sorseggiavo della vodka, e mi stimolò alla percezione dell’aroma di muschio e di sesso che si nasconde dietro l’odore acre, quell’aroma che secondo lui si riesce a cogliere quando si consente al fumo di invadere il palato e ristagnarvi a lungo. Non mi convinse. La lezione teorica mi aveva affascinato, l’esperienza pratica non m’indusse alla conversione. Poco prima, mentre mi spupazzava per le viuzze d’Oltrarno, mi aveva erudito sui misteri dell’amore e della morte, misteri nascosti dai muri delle torri medievali e dei palazzi rinascimentali. Mentre passeggiavamo in Via Maggio mi aveva parlato dell’amore di Francesco e Bianca e di quello di Elisabeth e Robert. Aveva accennato a un misterioso collegamento fra le due vicende, senza spiegarmi molto però, ed eccitando la mia curiosità con allusioni confuse alle insolite pratiche amorose delle due coppie, alle ricerche alchimistiche di Francesco e al fatto che pur 125 a distanza di secoli i due uomini sarebbero appartenuti alla stessa consorteria iniziatica. Erano parole e frasi smozzicate, buttate lì quasi distrattamente mentre ammiravo incantata gli ermetici graffiti incisi sulla facciata del palazzo di Bianca Cappello o la ieratica espressione di un busto di pietra esposto nella vetrina di un antiquario vicino a Casa Guidi. Se voleva incuriosirmi, ci era riuscito in pieno. Così, quando ci fummo ristorati al Caffè degli Artigiani, e dopo la lezione sul Toscano, gli chiesi chiarimenti. Lui non si sottrasse, anzi, sembrava che non aspettasse altro. Però, invece di parlarmi di Bianca ed Elisabeth, mi raccontò la storia di altre due donne, dolci metà di altre due coppie enigmatiche, di cui pure mi aveva fatto vedere le residenze, o meglio, i luoghi delle occulte alcove. Una era Ginevra degli Amieri, amante di Antonio Rondinelli. Lui era un mercante che si dilettava nell’arte regia, lei era una delle più belle donne di Firenze alla fine del Trecento. Antonio, che risiedeva in Borgo Ognissanti, nella zona nobile della città, aveva un piedaterre in Santo Spirito, proprio vicino alla piazza in cui noi stavamo frescheggiando, dove si diceva che i due amanti s’incontravano clandestinamente per darsi a pratiche sessuali sfrenate. Il padre di Ginevra, per cementare un’alleanza finanziaria, diede la figlia in sposa a un ricco banchiere. Questi, gelosissimo del proprio onore, faceva controllare la moglie giorno e notte, sicché lei fu costretta a rompere la relazione con l’amante. Accadde che un bel giorno Ginevra si ammalò gravemente ed entrò in coma. I medici, i preti e i parenti la diedero per morta, le allestirono un sontuoso funerale e la seppellirono in Duomo. Senonché, la notte stessa della sepoltura, quando ancora la pietra tombale non era stata sigillata, Ginevra si risvegliò dal coma. Uscì dalla tomba stravolta dall’orrore e, pallida come un cero, corse subito a casa dal marito, che però la credette un fantasma, si spaventò a morte e la cacciò, ingiungendole di tornare nel regno dei trapassati e di non tormentarlo più. Allora lei andò a casa dei genitori, dove tuttavia non ricevette accoglienza migliore. Alla povera donna non restò che chiedere aiuto all’ex amante, 126 il quale l’accolse a braccia aperte e la tenne presso di sé per il resto dei suoi giorni. Quando il marito ebbe saputo che in casa di Antonio Rondinelli viveva non il fantasma di Ginevra ma lei in carne e ossa, pretese di riavere indietro la sposa. Si rivolse al Vicario del Vescovo e querelò Antonio per sequestro di persona e pratiche magiche. Al processo lei prese le parti dell’amante e fu così convincente che infine il Vicario sentenziò salomonicamente: poiché padre e marito l’avevano trattata come una morta, così lei sarebbe dovuta restare per loro. Chiarì che la Chiesa non ammette l’inumazione di esseri viventi, ed essendo stata la donna dichiarata morta dai medici e dal sacerdote che le aveva impartito l’estrema unzione, la sua sepoltura ne implicava la morte estinguendo ogni obbligo coi vivi, compresi il vedovo e i genitori. Al processo un avvocato sostenne che Ginevra non aveva la forza per sollevare da sola la pietra tombale, che qualcuno lo avrebbe fatto dall’esterno nottetempo, sarebbe penetrato nella tomba e avrebbe risvegliato la morta, che il fantasma apparso ai genitori e al marito sarebbe stato una messinscena, e perfino che la morte apparente di Ginevra sarebbe stata il risultato di un incantesimo messo in atto da Antonio col di lei consenso. Ma non fu creduto. In seguito un candido poeta, deducendo dalla sentenza del Vicario che Ginevra era resuscitata, scrisse un poema in cui traeva l’ovvia morale dell’amore che vince la morte. “Meno banale”, concluse Luciano enigmaticamente, “sarebbe stata una morale sull’amore che corteggia la morte per conseguire i propri scopi.” L’altra donna di cui mi narrò era Giovanna, figlia di Carlo Duca di Calabria, podestà di Firenze all’inizio del Trecento. Astrologo e consigliere del Duca era Cecco d’Ascoli, uno dei più celebrati negromanti di tutti tempi. Quando nacque Giovanna, Cecco le fece l’oroscopo e predisse che sarebbe diventata potente e desiderata, nonché proclive alla libidine. In seguito si assunse l’incombenza dell’educazione della bambina e, quando lei fu diventata una colta e sensuale fanciulla, se la prese come amante. 127 Il Duca non gradì la bricconata e punì severamente i due innamorati. A Giovanna combinò un matrimonio dinastico che la rese regina di Napoli. Nella capitale partenopea poi lei si diede alla pazza gioia, ebbe quattro mariti e un numero imprecisato di amanti, suscitando scandali e gelosie a non finire, così realizzando la profezia di Cecco. I cortigiani la soprannominarono ‘Giovanna la Pazza’, il Papa la scomunicò e infine qualcuno la strangolò nella sua camera da letto. A Cecco il Duca riservò una sorte non meno impietosa. Sfruttando le sue amicizie ecclesiastiche, lo fece processare dai tribunali della fede e condannare per errori contro la dottrina, risultato che non gli fu difficile conseguire, visto che gli inquisitori già da tempo sospettavano nel mago un adepto di Satana. Il sospetto divenne certezza quando il Duca rese pubblico l’oroscopo che Cecco aveva fatto a Cristo prevedendone la crocifissione a trentatré anni. Una grande folla di cittadini ai lati delle strade assisteva al passaggio del corteo che accompagnava Cecco al rogo. Quando la processione passò vicino a Santa Maria Maggiore, il martire chiese un po’ d’acqua. E stava per ottenerla dai popolani che ancora lo amavano, senonché una suora di nome Berta, che si affacciava da una finestrella del campanile, gridò di non dargli acqua, poiché se il negromante ne avesse bevuta avrebbe potuto usarla magicamente per rendersi invulnerabile alle fiamme. – Se beve non brucerà più, – urlò. Allora lui la maledisse: – E tu non leverai più la testa di lì. “Infatti”, concluse Luciano, “il corpo di Cecco fu consumato dal fuoco, e la testa pietrificata di Berta si può vedere ancora oggi che sporge da una parete di quel campanile.” Ero incantata. Quando Luciano dismetteva i panni del filosofo e indossava quelli del narratore, tirava fuori il meglio di sé. Io ho riassunto i fatti che mi aveva raccontato, ma lui me li aveva esposti con dovizia di osservazioni toccanti. Sembrava quasi che s’identificasse coi suoi eroi romantici, e parlava delle non meno romantiche eroine con una nota di tenerezza nella voce che mi induceva a mia volta a identificarmi in loro. “Perché mi hai narrato queste storie fantastiche?” Domandai. 128 “Ti assicuro che non c’è nulla di fantasioso.” “Sia pure. Quello che voglio sapere è perché me le hai raccontate? Perché proprio queste?” “Sono storie interessanti. Non ti sono piaciute?” “Molto mi sono piaciute.” Confermai con un sorriso di gratitudine. “Allora”, mi fece il verso, “perché proprio queste, secondo te?” “Sembrano episodi molto simili pur essendo accaduti a distanza di secoli.” “Molto simili è dir poco. In realtà sono la stessa storia ripetutasi diverse volte. Lo stesso uomo, il mago, che cerca la stessa cosa; e la stessa donna, la puttana santa, che cerca la stessa cosa.” “Quale cosa?” “È ciò che devi capire da sola.” “Non ci arrivo.” “Prima o poi ci arriverai.” 129 Sabato, 26 maggio Gianrico e Silvio arrivano a casa mia alle nove. Sbrighiamo subito la faccenda sessuale, tanto per salvare le apparenze, e perché la giornata non vada sprecata. Quindi ci accomodiamo nel salotto serio e parliamo per due ore buone della faccenda che ci interessa di più. Non posso lasciar cadere la questione sesso, però, senza fare una riflessione sull’ipocrisia maschile. In nessun modo meglio che osservandoli in un’impresa amorosa comune, quale può essere un rapporto a tre, si riesce a capire quanto è artificiosa la sessualità degli uomini, specialmente se sono uomini che hai prima conosciuto a fondo nell’intimità di un rapporto a due. ‘Impresa’ è la parola giusta. Quando si osservano l’un l’altro, o quando osservano se stessi, i maschi si sentono impegnati a fare l’amore, a fare. Esibiscono una sessualità risolta nella vigoria e nella tecnica, una sessualità che nessuno riuscirebbe a distinguere da una bravata eroica, se non per la peculiarità dell’abbigliamento e il ridicolo che ne deriva. I campioni ti prendono, letteralmente, ti manipolano, ti girano e ti rigirano, ti cavalcano, ti montano, ti sbattono. Ti fanno di tutto, e non si capisce con quale scopo particolare, visto che tutto quello che ti fanno non serve al loro orgasmo, per non parlare del tuo. Alcuni, specialmente i quarantenni, si applicano molto per il tuo piacere, indugiano nei preliminari, ti coccolano, ti carezzano, baci languidi e parole tenere. Ma sempre di tecnica si tratta. In realtà non è precisamente il tuo orgasmo che gli interessa, bensì la loro capacità di procurartelo. È esclusivamente a se stessi che guardano, se stessi che ammirano. Così capisci che la loro sessualità si risolve al 90% nello specchiarsi. Si specchiano in te, nelle tue reazioni alle loro manipolazioni, nella risposta del tuo piacere alla loro azione. E tanto peggio per te se ti limiti a simulare. Per loro va bene perfino la finzione, purché entro certi limiti di verosimiglianza, quanto basta per rendere convincente la commedia. Meglio di tutto è quella finzione inconsapevole a cui ricorrono spesso con l’auto- 130 inganno le donne volenterose. Qui, per inciso, si misura l’abilità di una buona puttana o di una brava moglie. Si rimirano dunque, in ogni istante. Io ho un grande specchio accanto al mio letto, un potente strumento di depravazione. Come ci si lasciano impaniare! Non distolgono mai gli occhi dall’immagine che riflette, e seguono la propria azione e le tue reazioni con un fervore quasi religioso, una vera e propria venerazione. Così capisci che la grande, profonda, eterna religione maschile è ancora quella dei miti eroici dell’antica Grecia, ma in maschera e, in fondo in fondo, risolti in Narciso. Con tutto ciò, se sei una donna decisa e dalle idee chiare puoi arrivare qualche volta a disarmarli e a farli sciogliere. Allora puoi scoprire il tenero che c’è in loro, e puoi addirittura goderteli se sei riuscita a insegnargli a non fare il maschio. Be’, io sono stata capace di fare sciogliere perfino Gianrico e Silvio. Il primo, per esempio, l’ho conosciuto che soffriva di eiaculazione precoce. La sua strategia preferita era questa. Arrivava tutto ingrifato. Si faceva subito masturbare per un rapido orgasmo. Dopo di che, riuscendo a resistere a lungo nel secondo giro, mi montava più baldanzoso di un cavaliere errante. Gli sono bastati un po’ di mesi in cura da me, però, e ha imparato ad abbandonarsi, a lasciarsi fare, a non avere vergogna della parte molle di sé. È emersa la fanciullaggine, il bisogno di carezze e affettuosità materne, a volte qualche lieve sculacciata. Così è riuscito a godersi l’orgasmo, anche se precoce; tanto, di me, che mi paga, può fregarsene. È stato comunque un progresso. Silvio aveva un problema diverso, solo apparentemente opposto a quello di Gianrico: poteva starsene una mezz’ora con il membro dritto, continuando a pomparmi che pareva uno stantuffo, senza raggiungere il climax quasi mai. Per me era una tortura, si capisce. Ma lui dava l’impressione di godersela da matti, urlava che sembrava un cow boy al rodeo e non si fermava fino a quando non imploravo basta. Allora scendeva, fiero di avere sfiancato una mignotta, e se lo rimirava orgoglioso, allo specchio, come un bambino la sua pistoletta a ditalini. Con lui ho faticato parecchio. Dapprima ho cercato di sgonfiargli l’orgoglio con delle strategie orali, inutilmente. Poi ho provato ad ammor- 131 bidirlo lavorandolo su tutto il corpo, e ancora niente. Infine scoprii il suo tallone d’Achille in una notte di furore quando, a sorpresa, gli ficcai un dito nel buco del culo, giusto nel momento di uno dei suoi rari orgasmi. Ebbe un attimo di panico e mi strinse il dito nello sfintere così forte che poteva stritolarmelo. Senonché io lo tenevo anche per lo scettro, e non mollai. Così fu costretto a lasciarsi andare. In seguito ho faticato per fargli accettare la realtà. Ma contro il piacere del corpo non c’è religione che tenga. Recentemente mi ha regalato un pene di gomma di suo gusto, e ora si fa fare l’amore da me come da un tenero amico. Lo fa solo con me. Mai oserebbe con un maschio. Ovviamente quelle rare volte che vengono a trovarmi insieme Gianrico e Silvio riescono a essere tutto meno che sé stessi. Così è oggi. Devo cibarmi alcune fra le posizioni più tortuose, tra ‘acca’,‘sandwich’, ‘seicentonovantuno’ e altre plasticità del genere, mentre loro si dimostrano a vicenda quanto sono bravi. Fortunatamente dura poco, visto che sono venuti a trovarmi per parlare. A letto, dopo la sfacchinata, parliamo in un’atmosfera surreale, senza approdare a nulla. I due bulli, sdraiati ai miei fianchi, guardano il soffitto fingendo indifferenza. Osservo Gianrico. Mi dà l’impressione di un bacarozzo kafkiano: potrebbe agitarsi dalla disperazione. Osservo Silvio. Stessa impressione. Gli animi sono tesi, logorati, paiono dominati da un sentimento di straniazione. Per cui quando gli servo il caffè, li faccio accomodare in salotto, i miei minchioni. Pian piano si placano gli animi e la conversazione si avvia garbata. Parliamo di cose insignificanti, all’inizio. Insisto per farmi raccontare ancora dei problemi di carriera di Luciano. È Gianrico il più loquace dei due. “L’uomo era un vero grullaccio,” attacca, “ma accio accio. Dopo tutto quello che aveva combinato, avrebbe dovuto capire che non c’era speranza per lui nel mondo accademico. Avrebbe dovuto prendere le sue carabattole e andarsene dall’università. Invece insistette, col risultato di fare una figura cacina dietro l’altra.” 132 “Forse amava le situazioni difficili,” suggerisco, “forse perseverò perché doveva lottare...” “Ci vuol altre barbe per spuntarla nella nostra giungla. Però è vero che lui sapeva stare alla dura. Più che altro, credo che avesse preso un drizzone. Come a Don Chisciotte, nessuno poteva toglierli la lancia dalla resta una volta che avesse intravisto un mulino a vento, e come Don Chisciotte, faceva sempre fico. Mi torna alla mente quel dì che presentò domanda per un concorso di professore di sociologia.” “No, questa no, per favore!” Interrompe Silvio. Ma lo fa con un tono esitante e divertito. Sembra impaziente di sentirsela raccontare per l’ennesima volta. Infatti Gianrico ignora la sua implorazione. “Proprio il nostro gingillone costì, codesto maestro di fintaggine, proprio Silvio era presidente della commissione di concorso. Devo riconoscerlo: costruì un vero capolavoro di perfidia nel portare il concorso all’esito che ebbe.” Qui si arresta e si pone in meditazione. “Quale esito?” Domando. Lui ignora la mia domanda. Si gira verso di me, mi appoggia una mano su un ginocchio e lancia uno sguardo di complicità al collega. “Eh, Silviuccio? Ti aveva fatto entrare la fotta, il tuo bardotto! Eh? Così tu, come disse Virgilio al Poeta a proposito della puttana sciolta, glielo hai messo nel chiocchiero.” “Dai, adesso racconta.” Insisto. “Se volevi incuriosirmi, ci sei riuscito.” “Ebbene, si dimostrò un vero stratega il nostro presidente di commissione. All’inizio seguì una tattica di aggiramento, cercando d’imbecherare i commissari: sostenne Luciano a spada tratta, ma punto esito, ovviamente.” “Perché dici ovviamente?” “Perché Luciano era odiato da quasi tutti i commissari, nove quant’erano. Silvio ottenne due voti per lui. Continuò a ottenere solo due voti, tre con il proprio, per un intero semestre. Tuttavia tre non bastavano, ce ne volevano cinque. Intanto, man mano che procedevano i lavori, venivano piazzati altri candidati e lo spazio 133 per Luciano si restringeva. Era una commissione assai giudiziosa, vero Silviuccio?” “Ah, non c’è dubbio. Giudiziosa e leale. Stabilimmo subito le regole del gioco.” “Quali regole?” Domando. “Due regole molto semplici. Prima: ogni commissario, in linea di principio, aveva diritto a un certo numero di posti, quattro se era della maggioranza, due se della minoranza; i posti rimanenti ce li saremmo giocati. Seconda: nessun commissario avrebbe dovuto leggere i titoli dei concorrenti.” “E questo perché? Non era un concorso per titoli?” “Per evitare di farcene influenzare.” “Che volpi!” Interrompe l’altro. “Le due regole funzionarono abbastanza bene,” riprende Silvio, “ma non alla perfezione, visto che continuammo a discutere a lungo. Il resto te lo racconterà Gianrico, che sa narrare le storie. Vai pure avanti, Gianricuccio. Però sii conciso.” “Va bene, dirò le cose come sono andate, senza tanti girigogoli. Per non farla pallottolosa: dopo qualche mese avevano sistemato ventotto candidati e restavano da assegnare tre posti. Su quei posti si scannarono a lungo. Il presidente della commissione continuava a proporre il nome del nostro eroe. Riuscì infine a ottenere quattro voti. Gliene mancava uno. A questo punto Silvio fece in modo che Luciano venisse a conoscenza della situazione. E quello sciabicotto, appena ne fu edotto, s’illuse come un merlo. Così si mise in azione. Mi è stato riferito che si attaccò al telefono e cominciò a tartassare gli amici, gli amici degli amici, perfino gli amici dei nemici. Andò avanti e insistette, con la sua proverbiale pervicacia, finché non raggiunse il risultato che voleva.” “Che sarebbe?” “Ma è ovvio: il voto che gli mancava!” “Come fece?” “Ah, questo lo ignoro. Probabilmente esiste una specie di mafia sovversiva, chi sa? magari un’associazione segreta, ex combattenti e reduci, vecchi pinguini. Ebbene, il genio di Silvio si rivelò nell’essere riuscito a usare le armi del nemico contro il 134 nemico stesso. Insomma, giunti al finale, per la precisione, alla penultima riunione della commissione giudicatrice, Luciano aveva ottenuto i suoi cinque voti, spinte o sponte, e pareva avercela fatta.” “Invece?” “Invece alla riunione successiva Silvio acciabattò una proposta dell’ultimo minuto e tirò fuori il coniglio dal cilindro, anzi il gatto.” “Cioè?” “Cioè disse che ci aveva ripensato, che il candidato ideale per quel posto non era Luciano. – Cesare Gatto è il candidato giusto – disse.” “Chi sarebbe costui?” “È ciò che si domandarono gli altri commissari. Era un candidato di cui non si era mai parlato fino allora. Anzi, proprio non lo conosceva nessuno. D’altra parte, i titoli non erano stati letti, e il fatto di non conoscere quelli di codesto nuovo candidato non preoccupò nessuno. Inoltre erano tutti stanchi di discutere e volevano chiudere presto. Così alla fine il concorso lo vinse il professor Gatto, e fu lui a essere chiamato nella nostra università.” “Ma Luciano non aveva ottenuto i suoi cinque voti? Non erano sufficienti?” “Le cose non sono così semplici. In situazioni d’incertezza e di conflitto i voti si danno a miccino, e si danno al commissario, non al candidato. Il commissario dichiara come vorrebbe impiegare i suoi voti. Però è lui a decidere. Se cambia idea all’ultimo momento, cortesia vuole che gli altri commissari non si mettano a rivedere le bucce. Il bello venne dopo, vale a dire il giorno dell’inizio di quel corso di Sociologia, quando si scoprì che il vincitore del posto non era altri che il gatto di casa Moscanti: non Cesare Gatto, bensì il gatto Cesare. Il corso naturalmente doveva iniziare in ogni modo, e quindi fu assegnato per supplenza a Luciano stesso.” “Vuoi dire che il concorso fu vinto da un vero gatto?” “Esattamente.” A questo punto non posso evitare di girarmi verso Silvio e gettargli uno sguardo di stupore e di ammirazione. Lui fa degli 135 sforzi notevoli per imporre al proprio volto la necessaria maschera d’impassibilità, anche se si vede chiaramente che dentro di sé sta sorridendo d’orgoglio. “Scusa,” domando, rivolgendomi sempre a Gianrico, “al Ministero non avevano fatto dei controlli?” “Vien via!” “Deve essere stato un bello scandalo.” “Macché. L’evento fece un certo rumore, però in ambienti ristretti. Prima che giungesse ai quotidiani, un membro di quella commissione pubblicò su un giornalino intellettuale di provincia un racconto umoristico dal titolo Un gatto accademico, in cui narrava per filo e per segno ciò che era accaduto. Così il mondo della cultura scambiò la cosa per una trovata letteraria e tutto finì lì. In ogni caso, il risultato pedagogico fu gagliardo: per quattro mesi, dal momento della chiusura del concorso a quello dell’inizio dell’anno accademico, Luciano si era trovato nella condizione di assistente del gatto di Silvio. Puoi immaginare quanto fosse arrembato quando dovette iniziare il corso al posto dell’animale.” “Stupendo,” faccio io, “un vero capolavoro di perfidia! Quale sarebbe la morale della favola?” Risponde Silvio, con voce cantilenante, attraverso il suo subdolo sorriso: “Tanto va il leopardo al lardo...” Non finisce la frase. Invece si volta verso di me e, tramutando quel velato ghigno di gloria in un aperto ammiccamento di lascivia, mi fa scivolare una mano sul petto. Io, per tutta risposta, giro la testa dall’altra parte. Ahimé, neanche Gianrico mi dà scampo. Allunga una mano sul mio petto e fa: “Ecco che mi hai rimesso l’uzzolo, pispolina mia. Dunque, come dice il poeta casto, è ora di nuovo di venire al tasto.” Torniamo a letto, dove devo sciropparmi i loro gloriosi assalti per un’altra mezz’ora. Dopo, di nuovo in salotto, riprendiamo la conversazione, stavolta parlando di cose serie. Così ottengo due conferme alle ipotesi su cui sto lavorando nella mia indagine poliziesca. La prima è che effettivamente Giuliano aveva ricevu- 136 to una certa chiave; la seconda, che Lilli aveva confidato il suo segreto solo per paura. “Proprio così,” è Silvio che parla, “anche se non sono riuscito a capire bene di cosa precisamente aveva paura.” “Avesse.” Corregge Gianrico. “Non scassare. Dunque dicevo: non sono riuscito a capire bene niente perché, per la stessa ragione, cioè per la paura, lei non mi aveva detto tutto ciò che sapeva.” “Ho avuto la stessa impressione,” fa Gianrico, “e neanch’io sono riuscito a capire di cosa avesse paura. Sembrerebbe che fosse venuta a conoscenza di un terribile segreto e, forse per liberarsene la coscienza, forse per diminuirne la pericolosità dividendolo con altri, l’abbia voluto rivelare a noi. Nello stesso tempo la paura le impediva di svelare la reale natura di quella verità.” Ha un attimo di esitazione. Poi aggiunge: “Mi raccomando però, di queste cose non devi far motto con nessuno, non devi alitare.” “Insomma, in cosa consisteva il segreto?” Domando, un po’ brusca. “Chi lo sa?” Riprende. “La benedetta chiave potrebbe essere stata data a Giuliano da Fabrizio Gledo, il quale, com’è noto, è un gran combriccolone.” “Ma quello sta in galera!” Dico. Questa volta interviene Silvio: “Può darsi che per lettera gli ha rivelato il modo in cui trovarla, la chiave, magari in un nascondiglio. È verosimile che, per sfuggire alla censura carceraria, abbia usato qualche codice segreto; che abbia cercato di nascondere l’informazione, che so? tra le righe di una lettera di saluti o qualcosa del genere.” Sì, è verosimile, penso. Quadra con ciò che mi ha riferito Giuliano riguardo alla loro vecchia passione per i giochi enigmistici. E quadra con la sua fissazione sulle carte di Luciano. Dopo tutto, ci ha effettivamente trovato un messaggio nascosto, in quelle carte. Guarda caso, il messaggio era LILLI. Faccio notare la coincidenza ai due marpioni. Loro si mostrano perplessi. “Che c’entrano le carte di Luciano?” È Gianrico che parla. “Capirei che ti avesse chiesto carte di Fabrizio.” 137 “Quei vecchi giochetti che facevano da studenti li facevano in tre.” Dico. “Perché non avrebbero potuto continuarli per corrispondenza dopo l’incarcerazione di Fabrizio?” “Tutto è possibile, ma non ci sarebbe sugo.” Controbatte lui, quasi più per saggiare le mie reazioni che per esprimere un suo dubbio. “D’altra parte che rapporto ci sarebbe tra una tale ipotetica corrispondenza e degli appunti di filosofia?” Di filosofia avevo parlato molto con Luciano all’inizio del nostro flirt. Smettemmo quando il flirt divenne un menage parafamiliare. Allora cominciammo a parlare di cose più terrene, di orto, giardinaggio, cucina. La mattina dopo quella notte favolosa di ballo m’invitò a restare a casa sua per il fine settimana. Saremmo tornati a Firenze il martedì, propose. Poi, se volevo, potevo venire in campagna con lui il fine settimana successivo. Se volevo? Lo volli. Fu così che cominciò una fase sublime del nostro idillio. Durante la settimana lavorativa, dal martedì al venerdì, abitavamo a Firenze nelle nostre rispettive case, io nel mio appartamento di studentessa lavoratrice, lui con l’ex compagna, solo per stare con la figlia – aveva messo in chiaro. Gli altri giorni della settimana, da venerdì pomeriggio a martedì mattina, li passavamo insieme nel suo lussuoso fienile. Che vita di sogno facemmo in quei weekend! Proprio come due sposini infatuati. Durante il giorno lui lavorava nell’uliveto e nell’orto. Io mi occupavo del giardino, oltre a preparargli dei pranzetti e delle cenette amorevoli. Certe sere si andava a ballare, altre si studiava insieme fino alle due di notte, oppure ci abbrutivamo felicemente davanti alla televisione sbracati sul divano. Mi comprai dei libri di giardinaggio e li lessi con gusto, scoprendomi una passione inaspettata che, unita a quella della cucina che già mi conoscevo, faceva di me una mogliettina perfetta. Il suo giardino era praticamente inesistente: solo un grande prato d’erba e fiori selvatici. Tutt’intorno, diversi cipressi, qualche oleandro e due enormi acacie. Decisi di renderlo splendente. A novembre piantai una certa quantità di bulbi e semi di fiori, alcune piantine di lavanda e di gelsomino e una dozzina di cespi di rose. Li disposi sui bordi del prato e intorno agli alberi a for- 138 mare delle aiuole in apparente disordine. Quando venne l’esplosione primaverile, fu uno sbocciare di gioia. Luciano mi prendeva per mano e mi faceva girare tra i fiori chiedendomene i nomi. Poi ci spogliavamo e ci sdraiavamo sul prato a prendere il sole e fare l’amore, tra i profumi della lavanda e del gelsomino che trascinavano tutta un’orchestra di effluvi. “Mi hai riempito il giardino e la vita di fiori.” Disse un giorno di prima estate mentre giacevamo sul prato a prendere la tintarella integrale. Mi venne una specie di extrasistole e non seppi rispondergli altro che con un mugolio di piacere. Avrei voluto fermare quell’istante, farlo durare per sempre. Ahimé, con Luciano non era possibile. Lo capii qualche tempo dopo, quando feci un passo falso che ancora non mi sono perdonata. Ma come facevo a sapere quali erano i confini invalicabili dei suoi sentimenti? Stavo imparando. E s’impara con gli errori. Un giorno, verso fine agosto, in uno di quei momenti inebrianti, mentre guardavo il cielo sdraiata sul prato accanto a lui, mi feci coraggio e proferii le seguenti idiozie: “Tesoro, vorrei dirti una cosa importante. Sei disposto ad ascoltarmi? Ti va di parlare?” “Certo che mi va, cara. Basta che non si parli d’amore.” Fu una mazzata tra capo e collo. Deglutii la saliva più di una volta. Però mi controllai e dopo un lungo silenzio domandai: “Perché non si può parlare d’amore?” “L’abbiamo già trattato in passato quest’argomento. Non so se ricordi. E in quell’occasione tu mi hai insegnato che oggigiorno parlare d’amore è come raccontare la favola di Cappuccetto Rosso al lupo cattivo.” La ricordavo benissimo la conferenza che mi aveva tenuto una volta mentre ci crogiolavamo a letto dopo una scopata felice. Ma mi sembrava piuttosto che allora era stato il lupo cattivo a cercare di raccontare la fiaba a Cappuccetto Rosso. Non reagii. Volevo evitare di ficcarmi in una discussione concettosa col grand’uomo. Manifestai il mio disappunto restando in silenzio e guardandolo di traverso. Siccome io tacevo, fu lui a riprendere la domanda, fuggendo il mio sguardo: 139 “Vuoi sapere perché non si può parlare d’amore?” Infierii col silenzio. Lui però non mi si filava più. Osservava un punto all’infinito, mentre a me mi saliva un groppo alla gola. Non riuscii a impedirgli di lanciarsi in una disquisizione filosofica. E attaccò: “Non si può parlare onestamente d’amore nell’era delle filosofie del sospetto, delle soap opera e dei partiti leggeri. Molti sostantivi forti sono stati svuotati di sostanza dalla storia. Come fanno i dannati della terra a ragionare di liberazione quando è diventata uno slogan dei chierichetti? Come fa la classe operaia a reclamare il comunismo quando tutti i partiti comunisti al potere si sono trasformati in macchine di oppressione e sfruttamento dei lavoratori?” “Ti prego, non mi affliggere con queste stronzate. Non le reggo più le tue fughe filosofiche.” “Dolcezza, la filosofia è vita. E la filosofia di oggi compenetra un mondo che si è fatto diffidente…” Ecco: diffidente. Mi sembrò la parola giusta detta al momento giusto. Così infine abboccai. “Perché diffidente?” Gli chiesi. “Perché si gioca disinvolti.” “Non capisco.” “Te lo spiego con un esempio. Mettiamo che il leader del partito degli affari decida di chiamarlo partito dell’amore. Allora ce la vedresti la Sandrocchia dirgli ‘ti amo’? Ce la vedresti la moglie dirgli ‘non t’amo più’?” “Non capisco ancora.” “Certe parole sono state così logorate dall’uso ideologico che non riusciamo più a cogliere le intenzioni nei significanti.” “Veramente il partito dell’amore l’ha fondato Cicciolina, e non mi è sembrato un uso ideologico.” Obiettai. “Quella è solo un’ingenuità, candida e molto retrò.” Replicò. Evidentemente sentiva la tensione della mia voce e il montare dell’irritazione. Forse per questo fu infine costretto a scendere dall’empireo dell’ermeneutica. Domandò: “È di cose cicciolose che mi vuoi parlare? Cos’è che vorresti dirmi veramente?” 140 “Veramente vorrei dirti quanto sei stronzo.” Venne l’autunno e poi l’inverno e furono lugubri. La nostra passione scese dai picchi che aveva scalato nelle stagioni calde e si avviò verso il piattume. Ero avvilita. Quei barlumi di fede e speranza che mi si erano accesi all’epoca del ballo e delle fioriture si erano spenti, e con essi anche i vaghi bagliori di carità. Emerse in me quasi un senso di commiato. Per lui non sono che una puttana, continuavo a dirmi. Mi tiene esclusivamente per soddisfare i suoi bisogni sessuali. Tutte le dolcezze quotidiane che mi elargisce non sono altro che mosse in un gioco disinvolto. Come fa a essere così vigliacco? Poi lui mi faceva una carezza mentre ci scaldavamo al fuoco del camino e io tornavo a sciogliermi. Quanto sono infantile – diceva l’anima razionale dentro di me. Ma il demone dell’innocenza resisteva. Allora tornavo sulle mie riflessioni amareggiate, e poi cercavo di disinnescarle. Forse è sincero quando mi stringe a sé guardandomi con quegli occhi teneri, pensavo. Forse non è completante evirato di sentimenti, ha solo timore di esprimerli. Magari ha paura di rivelarli a se stesso. E io non posso abbandonarlo al suo grigiore. Devo aiutarlo a sciogliersi. Così mi assumevo il compito di salvarlo. 141 Lunedì, 27 maggio Mi telefona Lucrezia, stamattina, e mi dice che ha un urgente bisogno di vedermi. Combiniamo un incontro per cena. Alle otto di sera la trovo che mi aspetta, nervosa e preoccupata, seduta a un tavolo della Buca Nera. È, questa, una trattoriola senza pretese ricavata dallo scantinato di un antico e fatiscente palazzo in Santa Croce, una taverna scalcinata che più popolare di così non si può. Però in nessun posto al mondo meglio che qui si mangia la ribollita e l’acquacotta e i crostini col pane sciapo di Prato e tutte le altre pesanti raffinatezze della cucina popolare toscana. I turisti non lo sanno, per fortuna. Ecco perché ancora si salva. Ordiniamo cacciucco entrambe e Chianti della casa, tanto per restare sul leggero. Nell’attesa, ci sgranocchiamo dei crostini di fegato. Parte il primo mezzo litro di vino. Quando arriva il cacciucco sono già in fiamme. Lei invece è sempre spenta. Ha due occhiaie marcate, dal fondo delle quali mi osservano due occhietti lucidi, mobilissimi, da scimmia, ma tristi. Le guance paiono scavate più del solito sul viso privo di trucco; e i capelli, tirati sulla nuca a crocchia, sono sorretti malamente da una grossa forcina nera della nonna. I vestiti alla zingara, che indossa sempre con ricercata trascuratezza, e che spesso contribuiscono a darle un’aria giovanile e maliziosa, stasera sono particolarmente trasandati, la fanno apparire una stramiciona e sembrano volerne rivelare lo smarrimento. Finalmente si decide: “Mi devi scusare se t’importuno per una cosa di cui probabilmente non ti frega niente. Con diverse amiche sono in rapporti più intimi che con te. Ciò nonostante, quando ho sentito il bisogno di parlare di questa cosa, ho capito che non potevo farlo che con te.” “Quale cosa?” “Sono terrorizzata. Dopo la morte di Lilli...” “Si, è stata sconvolgente.” La interrompo. “Non è solo questo,” riprende lei, “ho paura per me, ora.” “Per te? Che c’entri tu?” 142 “Ieri mattina è venuto a trovarmi Giuliano. È entrato in casa a valanga, mi ha fatto sedere su una sedia, quasi fosse lui il padrone di casa, si è seduto anche lui e ha cominciato a tempestarmi di domande.” “Che voleva sapere?” “Di Luciano, cosa aveva fatto nei cinque giorni precedenti l’orgia, dove era stato, se si era mosso da Firenze. Ha detto che stava indagando sulla sua morte e che dovevo aiutarlo a trovare l’assassino. Inoltre voleva vedere la corrispondenza di Luciano con Fabrizio.” “E tu gliel’hai mostrata?” “Certo che no!” “Se ti chiedessi io di darle un’occhiata?” “Non vedo come la corrispondenza con Fabrizio possa servire a far luce sull’omicidio di Luciano, dato che quello sta in galera. Le lettere che ho letto erano piene di boiate sessantottarde, tra il politico e il filosofico. Loro due avevano ormai solo la nostalgia in comune. Sono rimasta impressionata soprattutto da una cosa: dal potere che ha la memoria sullo spirito dei depressi. Anche quando scrivevano di problemi attuali, non riuscivano a pensare niente senza usare la remota esperienza politica comune quale punto di riferimento. Gliel’ho dette queste cose, a Giuliano: che non ci avrebbe trovato che spazzatura nostalgica in quella corrispondenza. Gli ho detto che comunque non gliel’avrei mostrata, essendo roba personale. Ma lui insisteva. E dopo che gli ebbi ripetutamente chiesto la ragione del suo interesse, mi sono sentita dire che, secondo lui, Fabrizio e Luciano si trasmettevano dei messaggi, dei messaggi in codice per passare la censura carceraria. Gli ho domandato che tipo di notizie potevano essere. Lui ha nicchiato. Il che mi ha ulteriormente insospettito. Figuriamoci se gli darò mai quelle lettere. Lui, quando ha visto che non riusciva a sfondare su questo fronte, ha cambiato argomento e mi ha domandato se sapevo niente di una certa chiave della verità che Luciano può aver avuto da Fabrizio, e se ne ho mai sentito parlare da Gianrico o da Silvio, da Lilli o da te.” “Tu che gli hai detto?” “Gli ho detto di sì.” 143 “Di sì?” “Sì.” “Sì, cosa? Che Luciano ha ricevuto quella chiave o che ne hai sentito parlare?” “Fammi finire. Quando gli ho detto che l’altro ieri erano venuti da me Gianrico e Silvio a chiedermi le stesse cose che mi stava chiedendo lui, l’ho visto sbiancare. Poi è diventato ancora più duro, se possibile, e minaccioso. Mi ha ordinato di non darle a nessuno le lettere di Luciano e Fabrizio, se non volevo darle a lui. Infine è tornato a parlare del mio uomo e mi ha chiesto se stava scrivendo qualcosa nei giorni precedenti la sua morte.” “Perché voleva sapere questo?” “Gliel’ho domandato, senza ottenere risposta. Così sono stata reticente anch’io. Gli ho detto che Luciano scriveva poco e niente.” “Ed è vero?” “Sì e no. In realtà scriveva parecchio, salvo poi bruciare quasi tutto. Lui era, come dire? un autolesionista intellettuale. Le cose che pubblicava erano quelle in cui non investiva gran che. Invece le cose che lo coinvolgevano a fondo lo lasciavano sempre scontento. Per spiegare questo fatto aveva anche elaborato una teoria, tanto per cambiare. Tuttavia si trattava di un malessere più profondo di quanto lui stesso era disposto a riconoscere.” “Dimmi della teoria.” “Era convinto che l’ambiente dove lavorava, cioè l’università, lo costringeva a muoversi entro degli steccati stretti che gli impedivano di pensare le cose veramente importanti, o di pensarle nel modo giusto. Di questo ne so abbastanza perché il suo disagio intellettuale era l’unica cosa elevata, diciamo così, di cui parlavamo ancora un po’. Sentiva il dovere di rendermi conto dei suoi fallimenti e del suo trastullarsi inconcludente tra una scienza e l’altra, che ne era la causa principale. Lo viveva come una colpa.” “Si sentiva in colpa?” “Sì, per la sua aggressività intellettuale. E peggio: il sentirsene in colpa lo mandava in bestia.” 144 “Hai detto che le sue spiegazioni nascondevano un malessere più profondo.” “Credo che lavorasse in lui un meccanismo psichico micidiale. Da una parte era consapevole della propria intelligenza e ciò lo portava a pensare in grande. Dall’altra non era mai sicuro della validità di quel che scriveva. Durante i periodi di furore intellettuale poteva stare alla scrivania dieci, dodici ore al giorno. Riempiva quaderni e quaderni di appunti. Poi li rileggeva ed entrava in crisi. Si metteva a correggere, limare, riscrivere, scarabocchiare, con foga sempre decrescente. Alla fine bruciava tutto. Dopo di che passavano mesi in cui non osava neanche prendere la penna in mano. Con i lavori occasionali invece, le critiche, le recensioni, i manuali, non aveva di questi problemi, evidentemente perché non lo coinvolgevano a fondo. Era un tragico ciclo cerebrale di creazione e autodistruzione, simile a un processo sentimentale che pure lo metteva periodicamente in crisi, anzi, ci metteva, essendovi implicata anch’io.” La storia diventa interessante e mi faccio attentissima. Lei se ne accorge e ha un attimo di esitazione. “Ma perché ti sto raccontando queste cose?” Domanda. “Perché hai bisogno di aprirti. Io ti capisco, come una sorella. Vai avanti.” Riprende: “Ne avevamo parlato a iosa del secondo tipo di oscillazione. Lo chiamavamo ‘il suo ciclo leopardo-coniglio’. Aveva dei periodi di titanismo, una smisurata fede in se stesso, la convinzione di poter fare a meno degli altri, dell’amore e della solidarietà, insomma una sorta di Sturm und Drang personale da bestia bionda e solitaria. Era in questi momenti che mi lasciava per scatenarsi con le studentesse e le segretarie. Finché non dava la classica capocciata al muro. O può darsi che veniva assalito dai rimorsi, non so. Sia come sia, seguivano sempre dei periodi di crisi. Allora tornava all’ovile e faceva il mea culpa. Erano i momenti migliori. Tornava dolce e remissivo e si lasciava curare dalle coccole e dalle carezze. Io vivevo in funzione dei suoi cicli, sempre in attesa dei suoi soprassalti di conigliaggine.” Mi guarda con occhi dubbiosi. Domanda: 145 “Ma a te che te ne frega di queste cose?” “Ti assicuro che me ne frega molto.” “Uhm. Torniamo a Giuliano.” Così torniamo a discorsi pedestri. “Cos’hai raccontato a lui?” Le chiedo. “Voglio dire: degli scritti di Luciano.” “Gli ho detto che non aveva scritto niente nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio, anche se questo non è vero.” “Ah no?” La interrompo, interessatissima. “Ho trovato cinque paginette di robaccia matematica sulla sua scrivania. Evidentemente non ha fatto in tempo a rileggerle e bruciarle. Non me le chiedere, però. Voglio prima studiarle io e vedere se c’è da capirci qualcosa. Giuliano mi ha messo in sospetto con la storia dei messaggi in codice. A lui non gliene ho neanche parlato, di quelle pagine. Se lo verrà a sapere...” “È di lui che hai paura?” “Sì. Ma principalmente ho bisogno di capire cosa sta succedendo. Tu che ne pensi? Voglio dire, della morte di Luciano e ora di Lilli, e di tutti questi enigmi, messaggi in codice, chiavi misteriose.” Così viene il mio turno di parlare. Le dico ciò che so, sinceramente; che peraltro non è molto. Parlo delle varie ipotesi che ho formulato su chi può essere l’assassino di Luciano e di Lilli, eccetto quella che riguarda lei, alla quale peraltro credo meno di tutte. Quando esaurisco l’argomento, ho appena ripulito il mio piatto di fagioli all’uccelletto, una delicatezza da bassa osteria che solo pochi eletti sanno apprezzare... se incontrano uno dei pochi eletti che la sanno cucinare. Poi arriva la zuppa inglese, dolce italianissimo e paradisiaco se è ben fatto. Col dessert ci portano un vino adatto, un brioso Müller Turgau trentino. Non che me ne intenda gran che, ma questo vino mi manda in estasi, e quando riesco a trovarne una bottiglia in qualche cantina o ristorante fiorentino non me la lascio sfuggire. Il cambiamento di vino e di cibo, col passaggio dal greve e piccante al delicato e dolce, coincide con un cambiamento d’umore repentino. Terminati i discorsi lugubri, anche per effetto 146 della bottiglia di Chianti che ci siamo scolato, la conversazione diventa sciolta e amichevole. Parliamo di noi. Soprattutto la faccio parlare di sé. Capisco che ha bisogno di aprirsi. D’altronde sento il desiderio di conoscerla più intimamente. Il dover parlare al di fuori della consueta relazione venale mi mette all’inizio un po’ in imbarazzo, forse perché, per parafrasare il saggio, il rapporto non mercantile mi si presenta come un tradimento all’autenticità. A poco a poco, tra quelli che sembrano dei veri e propri fumi dell’alcool, riusciamo ad attizzare una lieve fiammella di affetto. La cosa strana è che non me ne ritraggo turbata. Lei mi parla del suo mondo, della sua bambina, delle sue amicizie, che sono ristrette e selezionate. Mi dice dei suoi interessi culturali, anch’essi molto selezionati, per lo più limitati alla letteratura, anzi a pochi autori. Pochi, dei quali ha letto e riletto ogni cosa. Parliamo a lungo di letteratura. Non abbiamo gli stessi gusti, già nell’approccio al libro. Io leggo di tutto, senza ordine, senza guida e, lo ammetto, anche un po’ superficialmente. Odio le profondità. Un autore che approfondisco mi pare di smascherarlo e di perderne la magia. Mi piace preservare l’incanto della scoperta a ogni libro. Lei invece va a fondo. Quando trova un autore che le piace, non lo molla fino a che non ne ha penetrato l’anima. Le domando se per caso non ha qualche ambizione letteraria. Nega. Si contenta di saper leggere. La vita è così breve, sostiene, che solo chi non l’ama può preferire lo scrivere al leggere. Per fortuna ci sono quelli che non l’amano la vita. Quando esprime questo concetto si rende conto di aver esagerato; per cui, quasi a correggersi, chiarisce: “La si ama veramente la vita solo se la si accetta nella sua finitezza. Scrive chi non l’accetta, chi vuole vivere in eterno.” Poi le domando del suo lavoro. È assistente sociale in una struttura comunale. Per arrotondare lo stipendio, insegna italiano agli studenti stranieri della LUFSS. Mi piace sempre di più questa donna man mano che imparo a conoscerla. Mi piace la sua onesta semplicità e la sua chiara intelligenza, la modestia e la profondità, l’ingenuità e la disponibilità verso gli altri. Mi piacciono le sue debolezze e le contrad- 147 dizioni. Mi ricorda tanto Luciano! Chissà perché? È talmente diversa da lui! Eppure... non riesco a pensarli se non insieme. È come se si completassero l’un l’altra in una maniera intima e necessaria. Deve essere stato un autolesionista spirituale, l’uomo che si è separato da una simile metà. Sono tentata di invitarla da me stasera, ma mi trattengo. Avrei voglia di amarla fisicamente. Ho paura però che si tratti solo di una voglia perversa, un desiderio malefico di rompere la magia di questa momentanea sorellanza. Lei sicuramente non apprezzerebbe di me tutto ciò che piaceva a Luciano, a cominciare dall’esigenza di voltare i sentimenti in esperienze fisiche. No, con lei sento di dover restare sul platonico, anche se i miei capezzoli hanno un fremito di turgore quando la bacio sulla guancia per salutarla. La mia tendenza a voltare i sentimenti in esperienze fisiche era effettivamente una dote che Luciano apprezzava. Io non gradivo un tale apprezzamento. Anzi, da quando avevo cominciato a frequentarlo, e in misura crescente man mano che il nostro rapporto si sviluppava, specialmente dopo che mi ero prefissa il compito di salvarlo da se stesso, avevo cercato di invertire quella tendenza e indurre in lui un tipo diverso di considerazione. Non lo facevo scientemente. Ora me ne rendo conto: era un modo istintivo di innalzare la nostra intimità a un livello più alto di passione. Una notte, dopo aver fatto l’amore in modo particolarmente intenso, e nell’immediato postumo di un orgasmo strepitoso, mi accorsi che lui non era venuto, una situazione che talvolta mi disturbava un po’. Quella notte invece ne provai un inverecondo senso di piacere. Fu un’emozione improvvisa, come se l’orgasmo fisico si fosse improvvisamente tramutato in una frenesia morale. Fui invasa da un senso di annullamento, e con una folgorazione compresi cosa intende dire una donna quando dice ‘sono tua’. E fu il petto, non la testa, a farmi proferire le parole: “Amore mio, cosa vuoi?” “Voglio tutto.” Disse lui con un sorriso infantile. “Oh sì.” Rispose la mia anima estatica. 148 Seguì qualche secondo di silenzio pensoso, mentre lo sguardo liquido di lui penetrava nei miei occhi. Dissi: “Fai di me ciò che vuoi.” “No, fallo tu.” Mi rimisi al lavoro, lasciando il comando alla troia che è in me, anche il comando della mia volontà e dei sentimenti, e tutte le arti dell’amore che avevo accumulato in anni di professione si tramutarono in un esercizio spirituale di devozione. Lui se ne stava abbandonato accanto a me, le mani rivolte verso l’alto, il corpo inerte. Gli montai sopra a cavallo e presi di nuovo il suo potere dentro di me. Era come se volessi dare a lui tutta me stessa, anche il mio orgoglio, anche la mia identità. Come se volessi donargli la mia verginità più riposta. Presi le sue mani nelle mie, i suoi occhi nei miei. “Non ti muovere.” Dissi. “Neanche tu.” Restammo così per un’eternità, muti, inerti, immobili, tutti i sensi esaltati. Ma lo sentivo muovere dentro, sentivo le intense vibrazioni della sua virilità. E la mia carne rispondeva con ritmiche contrazioni, come se volesse catturarlo per non lasciarlo più. “Sei mio.” Dissi. “Sì.” “Sono tua.” “Sì.” “Per sempre.” “Un attimo infinito.” La mia mente era invasa da visioni dell’altro mondo. Verdi prati sconfinati cosparsi di stelle, cieli risplendenti di fiori, canti di sirene celestiali, profumi liquidi d’impudicizia. La mia pelle bruciava di piacere, le mie viscere in subbuglio fremevano, tutto il mio essere era proiettato oltre me stessa. Ora lo so che nessuno ci crederà, ma quando lui infine venne, riempiendomi l’anima con un prolungato urlo selvaggio e il ventre con un getto della sua energia vitale, ebbi un orgasmo quale non avevo mai provato, uno spasmo unisono del corpo e dello spirito in un senso di perdizione. 149 Scesi di cavallo e mi distesi prostrata al suo fianco. Mi strinsi al suo corpo, lo abbracciai e gli poggiai la testa sul petto. C’era una sorta di comunione di essenza, come se fosse emersa finalmente una nostra verità assoluta, una verità segreta esistente da sempre e ora rivelata. Avevo voglia di prolungare quella sensazione di totale compenetrazione, anzi, approfondirla con le parole, dirgli che lo sentivo parte di me, che mi sentivo svanire in lui. Ma non osavo aprire bocca. Avevo paura di rompere l’incantesimo. Temevo che un qualche scherzo della voce desse un valore ironico all’espressione di quel sentimento. Anzi avvertivo che la mia voce interiore mi aveva già giocato lo scherzo nel portare il sentimento al livello della coscienza. Lo ruppe lui l’incantesimo: “Questo modo di fare l’amore piace molto alle femministe amazzoniche.” Drizzai la testa e lo guardai sbigottita. Dissi soltanto: “Eh?” “Quelle che piuttosto che rifarsi il seno preferirebbero farselo tagliare. Danno una certa importanza ai problemi linguistici e pensano che il concetto di ‘penetrazione’ comunichi un significato oppressivo. Alcune hanno proposto di sostituirlo con ‘avvolgimento’. Per altre neanche questo era politically correct. Allora è stato prospettato il termine ‘inghiottimento’, che infine ha ricevuto il consenso generale nei loro circoli esclusivi. Capisci, in questa posizione i movimenti dei tuoi muscoli interni simulano una presa di possesso. Se inoltre rifletti sul significato della posizione dell’amazzone, ti rendi conto del valore politico di tutta la faccenda.” Mi sentii sgomenta e rasserenata ad un tempo. Da una parte ebbi l’impressione di un crollo di ogni speranza. Dall’altra ero rinfrancata. Fortuna che non avevo parlato d’amore! Sai che figura ci avrei fatto? Lui avrebbe apprezzato la dichiarazione prendendola per una facezia. Mi venne voglia di umiliarlo. Lo guardai trattenendo le lacrime dietro un sorriso beffardo. “Tu sei malato.” Dissi. “Già.” Silenzio. Dopo una lunga pausa riprese: 150 “A volte i pensieri mi escono dalla mente come il pus da un bubbone.” “Non è questo. È una malattia ben più grave, una sorta di amputazione spirituale.” “Sentiamo.” “Caro, tu vai forte coi chakra del basso ventre e della testa. Quelli del petto invece sembrano morti. Così l’energia che ti si sprigiona dall’inguine bypassa il cuore e arriva direttamente al cervello.” “Pensi che sia una cosa grave?” “Mortale.” Conclusi, guardandolo con un ghigno severo. “Ti deludo sempre, vero?” “È più che delusione, annientamento.” Dissi, ora sperando che il rimorso lo avesse reso vulnerabile alla verità nascosta dal sarcasmo. “Capisco,” fece lui, “avresti voluto sentirti dire altre cose.” “Avrei apprezzato anche il silenzio. Ma dimmi tu! È questo il momento di esibirti in una disquisizione politica?” Quindi entrai con un colpo basso: “Io mi sentivo tutta trasportata in te, e tu mi ammorbi l’anima con la teoria dell’inghiottimento.” “Hai ragione, cara. Ti chiedo perdono.” Adesso non c’era più rischio che non capisse la verità. Perciò mi sbracai senza ritegno: “Troppo tardi. Ormai mi hai spento. Prima mi hai fatto bruciare come un cero alla madonna e poi mi hai smorzato con un soffio.” “Ti chiedo perdono.” Si alzò, andò al frigo, prese una lattina di birra e tornò a letto. Si appoggiò con la schiena alla testiera e sorseggiò in silenzio. Dopo un po’ prese a parlare di cose insignificanti. Sembrava volermi far capire che era accaduta una cosa banale, niente di eccelso. Mi diede l’impressione di essere quasi infastidito per il modo apocalittico con cui avevo accolto la sua tirata filosofica. Evidentemente l’aveva capita bene l’esperienza di compenetrazione assoluta che avevo appena fatto, ma la cosa lo lasciava indifferente. O forse voleva che così fosse. Mi resi conto che l’impresa di salvarlo sarebbe stata titanica. 151 Mercoledì, 29 maggio Oggi è giornata di Giuliano. Gli telefono a mezzogiorno e gli comunico di aver trovato la soluzione dell’enigma. Il giorno stesso della morte di Lilli mi aveva fatto sapere di essersi convinto che LILLI non era la soluzione giusta. La soluzione giusta l’ho ora scoperta io e gliela comunico per telefono. È semplice. Si tratta di un acrostico. Si prende la prima lettera del primo aforisma, la seconda del secondo e così via. Il risultato è la seguente frase: Cerca oltre cerca ancora cerca. Alle cinque del pomeriggio lui mi si presenta a casa tutto arrazzato, e armato di un mazzo di rose rosse. Capisco subito che ha intenzioni serie. Prendiamo un tè rapidamente e passiamo a letto. Facciamo appena in tempo a riprendere fiato, dopo la scopata, che lui comincia a parlare. Ammette di aver sbagliato nell’interpretazione del primo capitolo del Nuovo corso. Gli domando qual è, secondo lui, il significato del nuovo messaggio. “È elementare,” risponde, “significa che Luciano si è preso gioco di me. Significa che per trovare la soluzione dell’enigma bisogna cercare in un altro capitolo, che le notti in cui mi sono spezzato la schiena scavando nel primo sono state tempo perso. È tipico di Luciano. Anche dopo morto continua a beffare il prossimo, e la beffa è tanto più cocente quanto più semplice è la chiave che dà la soluzione.” “Certo,” dico, “in un senso particolare è tipico di Luciano. Uno applica difficili e raffinate tecniche enigmistiche per decifrare un testo e trovarvi un messaggio che abbia un significato e lui glielo nasconde nel più ovvio degli acrostici. Ci deve essere una sorta di morale della favola, ma non riesco a coglierla.” “Però col prossimo capitolo non mi frega,” riprende, “ho già controllato, e le lettere che si trovano nelle posizioni di quell’acrostico non contengono nessun significato, comunque combinate.” “Sei veramente convinto che quest’enigma abbia una qualche relazione con l’omicidio di Luciano?” Gli domando, dopo aver dato un’occhiata ai fogli. “Non ho dubbi.” 152 “E quello di Lilli come lo colleghi con tutto il resto?” “Be’, ora la faccenda sembra più complicata. Perciò lavoriamo da scienziati: partiamo dai dati accertati.” “Quali sarebbero?” “Intanto, le circostanze della morte di Lilli, l’apparato magico e rituale, ad esempio. Lo sapevi che Lilli era un’appassionata di scienze occulte?” “Sì. Prosegui.” “Lo sapevi che in quest’università ci sono altre persone che coltivano interessi del genere?” “Chi sarebbero?” “Per esempio, le vergini rosse.” “Le due matte?” “Sì.” “Mi pare un legame piuttosto tenue.” “Aspetta. Lo sapevi che il giardino della casa delle due donne confina con quello dell’università, proprio dalla parte in cui è stato trovato il cadavere di Lilli? E che c’è un buco nella rete che separa i due giardini? E che la polizia ha già interrogato le matte?” “E cosa ha scoperto?” “Per ora niente. Ma fammi finire. Lo sapevi che le due, in passato, erano state viste vagare di notte nel giardino Stibbert, tutte nude, a quanto si dice, al chiaro di luna? E che una notte sono state viste scavare una buca in un punto non molto distante dal luogo dove poi è stato scoperto il cadavere di Lilli?” “Interessante. Come fai a sapere queste cose?” “Sono il direttore amministrativo della nostra università, e nulla che vi accada di giorno o di notte mi è ignoto.” “Va bene. Però se si segue questa traccia si deve accettare l’idea che l’omicidio di Lilli non ha niente a che fare con quello di Luciano.” “Non è detto. Lo sapevi che anche Luciano si occupava di magia e di scienze occulte?” “Per lui era un interesse puramente scientifico.” “Che vuol dire? I maghi si consideravano scienziati, a modo loro. Ma aspetta, non ho ancora finito. Forse non sai che di que- 153 ste scienze Luciano parlava non solo con Lilli. Ne parlava pure con le vergini rosse.” Mi fissa con gli occhi leggermente socchiusi, senza nascondere un sorriso di soddisfazione. Quindi ha un cedimento del braccio destro, cosicché la testa, che poggiava sulla mano come su un piedistallo, crolla sul cuscino. Lo osservo perplessa. Lui si mette a guardare il soffitto con aria di trionfo. Stiamo in silenzio per qualche istante. Mi alzo e vado al giradischi. Metto su Vedrai vedrai, tanto per giustificare l’ansia che mi sta assalendo. Passo al mobile bar e torno a letto con due Martini dry, con gin e olivetta come si deve. Lui rimette la testa sulla mano destra e afferrando il bicchiere con l’altra mi guarda ora con aria di complicità. Un movimento appena percettibile sotto il lenzuolo mi svela che non c’era bisogno della bevuta. Gli tolgo il bicchiere di mano senza dargli manco il tempo di un sorso. Lo appoggio sul comodino e mi rimetto al lavoro per un’altra ventina di minuti. Poi, di nuovo relax. Quando lo vedo ben cotto gli rimetto il bicchiere in mano e riattacco: “Di cosa poteva mai discutere uno come Luciano con due stolte come le vergini rosse?” “Di stoltezze, appunto, di magia. Non ne so molto. So solo che alcune volte le due donne sono state viste entrare nella stanza di Luciano al dipartimento di Filosofia. Qualche volta è stato visto lui entrare nella loro riservatissima e inaccessibile villa. Questa è la cosa più incredibile.” Proprio così: incredibile, se vera. Le vergini rosse sono proverbiali per la loro maschiofobia. Sono quasi due istituzioni della facoltà di Sociologia, una specie di sceme del villaggio. Qualcuno sostiene che la più anziana delle due, quella che è soprannominata ‘la madre’, è iscritta fin dal lontano ’68. ‘La figlia’ invece si sarebbe iscritta negli anni ’80. Si vedono poco in giro. Non frequentano le lezioni. Raramente fanno esami, che sostengono sempre in coppia, coi professori che lo consentono. La maggior parte delle volte toppano vergognosamente, ma non perché sono impreparate, si dice. La ragione sembrerebbe piuttosto di ordine politico, se non propriamente psichico: se si tro- 154 vano un professore maschio in commissione d’esame e sono interrogate da lui, fanno scena muta. Siccome quindi possono superare gli esami soltanto quando sono interrogate da una donna, ci sono delle materie che riusciranno a passare, eventualmente, alla morte o al pensionamento del titolare di cattedra. La leggenda dice che l’unico docente maschio con cui sono riuscite a superare un esame è stato Luciano. Me l’hanno raccontata così: lui gli poneva le domande dandosi le risposte da solo, ad alta voce. Alla fine disse che, potendo il loro silenzio essere considerato una risposta affermativa, e dato che le risposte erano esatte, le candidate meritavano non meno di un trenta e lode; glielo diede e le liquidò. Così si dice, però io non ci credo, anche se con Luciano tutto è possibile. Le due donne sono appariscenti, alte e magre, non prive di sensualità. Ogni tanto le si vedono passeggiare a braccetto su per le viuzze tra le ville di Montughi, vestite di rosso, con due zainetti di jeans alle spalle e, ai piedi, scarponi da alpino e calzettoni di lana rossi. E parlano tra loro, parlano, parlano, sembrano due vecchie amiche che si ritrovano dopo molti anni. Passeggiano nelle ore più solitarie, tra l’una e le tre del pomeriggio. Oppure la notte tardi. Spesso lasciano la strada e, varcato un recinto o un muricciolo, proseguono la loro passeggiata dentro i giardini privati o tra le vigne e gli uliveti, come fossero di loro proprietà. Ciò accade quando gli si fa incontro un uomo: per evitarlo. Se per caso non ci riescono, perché, mettiamo, la strada è chiusa da reti o muri troppo alti, sfoderano una tecnica di difesa impressionante: appena l’ignaro passante gli si avvicina a una distanza limite di cinque o sei metri, le due sciroccate cominciano a sbraitare e gesticolare, a dare in escandescenze. Il poveretto, dieci volte su dieci, affretta il passo e si sottrae rapido dalla loro portata. Nessun maschio, dice sempre la leggenda, è mai riuscito a venire in contatto con loro. Eccetto padre Egisto, curato della vicina chiesetta di S. Martino in Montughi, al quale si dice che una volta tirarono un brutto scherzo. Dunque, lui stava officiando uno di quei matrimoni chic che l’alta borghesia fiorentina ama celebrare nella magnifica 155 scenografia di questi gioielli di chiesette antiche sparsi nei sobborghi nobili della città. Loro due se ne stavano ai lati del portale del tempio, con le schiene appoggiate ai due stipiti, un piede dentro la chiesa uno fuori, che sembravano due bravacci. Stettero lì a sentire la messa prendendo il sole durante tutta la durata della funzione. Alla fine gli sposi e gli invitati uscirono. Quando uscì, per ultimo, il prete, loro gli si avventarono addosso; una lo afferrò con una mano per i coglioni immobilizzandolo; lui non fece in tempo a dire ‘ah’; l’altra, calma, gli stese tre sganassoni in faccia, tre. Dopo di che lo mollarono e se ne andarono tranquille. ‘Le vergini folli’ le chiamano, oppure ‘le vergini rosse’, e si capiscono gli aggettivi. Quanto al sostantivo, anche qui circolano molte leggende, ma contrastanti. Alcuni dicono che sono madre e figlia, e che la giovane sarebbe stata concepita nell’unico rapporto sessuale avuto dalla madre, con un prete. Altri ne parlano come di due amiche lesbiche oltranziste che non avrebbero mai avuto rapporti sessuali con maschi. Per altri ancora si tratterebbe di due sorelle orfane che vivono in perfetta castità una loro vita vaneggiante liberata dalle brutture del mondo. L’unica cosa certa, in ogni versione, è l’ossessività della loro separatezza. Abitano in via di Montughi, in una stupenda villa antica, quasi una fortezza, circondata da alte mura e chiusa da un cancello di ferro, un cancello massiccio e incrostato di ruggine che sembra non sia mai stato aperto. Tutto quel che so della villa, è ciò che si intuisce dalle cime tetre degli alberi secolari che si intravedono oltre il recinto e dal primo piano della casa con le sue finestre sempre sbarrate. Né sono riuscita a sapere molto facendo domande in giro. E dire che ne ho fatte di domande, ché le due donne mi hanno sempre incuriosito se non affascinato. Questa curiosità è arrivata al parossismo ora, dopo quanto mi ha detto Giuliano dei loro contatti con Luciano. Ora, inoltre, ho un valido motivo per indagare su di loro: l’omicidio di Lilli. 156 Giovedì, 30 maggio Stamani presto Giuliano mi viene a prendere con la sua Porsche. Si ferma sotto casa e si mette a strombazzare a tutto spiano. Ha deciso che oggi faremo una gita sulle Alpi Apuane. Carichiamo zaini e scarponi, ci facciamo un cappuccio e una brioche in un bar appena aperto, e via a 160 all’ora verso i monti di marmo. Il cielo si accende dei primi chiarori dell’alba, mentre l’aria fredda appanna i vetri e fischia sulle gomme. Arriviamo a Stazzema, un paesino sulle basse pendici del Procinto, appena in tempo per vedere il sole che sorge tra le cime rosa. Ce ne stiamo per qualche minuto lì, seduti su un tronco al lato della strada, mentre il sole si alza lentamente da dietro la Pania alla Croce. Lentamente vi si alza sopra, illuminandone i fianchi maestosi, e pare una luce di scena che prepara lo spettacolo solo per noi. Finito di assistere alla rappresentazione, mettiamo gli scarponi con le dita irrigidite dal freddo e impacciate dalla smania di metterci in cammino. Carichiamo gli zaini in spalla, e si va. Le Apuane sono tra le più belle montagne d’Italia. Sorte dall’unione tra Alpi e Appennini, hanno preso il meglio dei due genitori. I boschi cedui dilagano dalle valli risalendo i monti fino a mezza costa. Lì interrompono seccamente la loro ascensione e cedono il passo ai prati brulli e alle rocce. In cima marmi bianchi si rizzano in cielo come faraglioni acuminati e i sentieri che si snodano tra di essi corrono lungo orridi e precipizi oscuri da far invidia alle dolomiti. Saliamo per un’ora e mezza tra i boschi. Una breve sosta in un rifugio pieno di gente assonnata ed eccoci a ridosso del Procinto. È, questo, uno strano monte a forma di panettone. Si leva superbo, con le pareti verticali di roccia rosa, da un morbido letto boscoso. Sembra il pugno di un demone arrabbiato che, in odio agli uomini e insofferente di un destino tellurico, abbia voluto sfondare il mondo dal di sotto e poi per punizione sia rimasto impietrito in quell’atto per l’eternità. Mentre sto così, estasiata, di fronte all’imponenza del monte, Giuliano prepara la prima sorpresa della giornata. Tira fuori dallo zaino due imbracature, due paia di scarpe da arrampicata e delle 157 corde. Mi fa indossare scarpe e imbracatura, armeggia con nodi e moschettoni e mi comunica che oggi avrei fatto la prima scalata seria della mia vita. Per un momento mi sento smuovere il corpo. Tiro un respiro profondo e gli faccio notare che non ho mai seguito un corso di roccia. Lui mi tranquillizza. I passaggi più difficili non sono che di quinto grado! Inoltre andremo su in corda doppia col massimo di protezione. Infine c’è lui a guidarmi e prendersi cura di me. Detto ciò, comincia ad arrampicarsi e va su per una ventina di metri, mentre io, da sotto, gli do corda e gli faccio da sicurezza. Dopo un po’ si ferma in un anfratto della roccia e comincio a salire io. Non è difficile. La parete è piena di appigli e di buchi in cui assicurare mani e piedi. La regola è che, avendo negli arti quattro punti d’appoggio, non ne devo mai muovere uno senza che gli altri tre siano ben saldi. Ogni tanto, salendo, incontro un chiodo a cui è agganciato un moschettone nel quale passa la corda. Sgancio il moschettone e procedo. Non oso guardare giù. Mi sembra di sentirla nel vento la profondità del baratro che mi si apre sotto e che diventa sempre più orrendo man mano che salgo. In dieci minuti raggiungo Giuliano nel suo anfratto. Mi rannicchio accanto a lui addossandomi alla roccia e riprendo fiato. Lui mi gratifica con un sorriso pieno di maschia fierezza: “Sei venuta su che parevi un razzo, meglio di una vecchia guida alpina.” “Grazie per il vecchia.” Ribatto con nonchalance. Ma sono piena d’orgoglio, come una scolaretta che ha preso dieci e lode. Poi si ricomincia a salire. Lui avanti e io seguo a razzo. La cosa si dimostra meno tremenda di quanto pensavo all’inizio. La vera paura in realtà non è causata dalla difficoltà dell’ascesa, bensì dal fatto di sentirmi legata a Giuliano, la mia vita nelle sue mani. Di ciò mi rendo conto solo più tardi quando, giunti in cima, dopo mezz’ora di passeggiata sulla cresta del monte si pone il problema della discesa. Ad un tratto ci troviamo sopra a una parete alta come un palazzo di dieci piani. Guardo giù per un attimo e mi sento di nuovo smuovere il corpo. Tuttavia non mi tiro indietro. Con calma mi giro verso Giuliano. Lui non mi dà tempo di fiatare. M’infila 158 una corda nell’imbracatura in un modo speciale che non ci capisco un cacchio. Ne prende un capo e lo fa passare per un anello di acciaio fissato nella roccia. Quindi mi dice cosa si deve fare: lui tiene la corda, facendola sfilare senza fretta nell’anello, mentre io, appesa all’altro capo, devo lasciarmi scivolare giù, lungo la parete; devo tenere le gambe a squadra, puntarle sulla roccia, dare dei colpetti di ginocchia per fare dei saltelli orizzontali, e confidare in lui. Guardo giù di nuovo. Il baratro pare sprofondare senza fine sotto di me. Soltanto il mio forte sfintere m’impedisce di farmela addosso. Eppure devo buttarmi. In un momento di debolezza, con la voce un po’ fessa, chiedo se non esiste per caso un’altra via. Ma mi pento subito. Riprendo il controllo di me, mi giro con le spalle al baratro, i piedi sull’orlo, guardo Giuliano negli occhi. Lui mi guarda negli occhi, non una parola, come da uomo a uomo. Tendo la corda e mi butto. È una delle esperienze più eccitanti della mia vita. Sto lì, sospesa nel vuoto, attaccata a una corda il cui altro capo è nelle mani di un uomo che potrebbe volere la mia morte. Nei dieci minuti di discesa mi rendo conto di quanto mi è estraneo quest’uomo. Sono invasa dalla sensazione che nella sua testa potrebbero passare pensieri bui. Ho l’impressione di essere una cosa astratta, una cosa che appartiene alla sua mente, il che mi dà una specie di ebbrezza fredda. Scendo leggera e m’illumino di smarrimento nel vuoto intorno a me, ed è con voce sonora e spavalda che rispondo ai suoi richiami dall’alto. “Tutto OK?” “Tutto OK!” “Sei fantastica!” “Sei fantastico!” Continuo a venire giù con leggerezza, con quegli assurdi saltelli orizzontali lungo la parete verticale, mentre la corda sfila tra le mani di lui. Un’ora più tardi ci troviamo di nuovo al rifugio. Ordiniamo torta di mele e ne divoriamo subito mezzo chilo, bagnandola con una grappa alla ruta che ci restituisce la pace dei sensi. Gli occhi di Giuliano brillano di gioia come quelli di un bambino. I miei, 159 ne sono sicura, non meno dei suoi. La sua stima per me è alle stelle. Stranamente non è aumentata la mia stima per lui e neanche la mia fiducia; e quest’uomo, nonostante tutto, mi resta ancora un estraneo. Al ritorno, sull’autostrada, con i muscoli indolenziti ma rilassati sugli avvolgenti sedili della coupé, Giuliano mi sfodera l’ultima sorpresa della giornata. Ha decifrato il secondo capitolo degli appunti e ha trovato il nome giusto: GIANRICO. Non mi spiega neanche come ha fatto per arrivarci. Se non gli credo – dice – posso tentare da sola; ho già dimostrato, col primo capitolo, di essere più brava di lui. Appena arrivo a casa mi piazzo davanti alla scrivania, apro davanti a me i fogli del secondo capitolo del Nuovo corso e mi metto a studiarli. Per quanto mi sprema le meningi, non riesco a trovare nessuna chiave di lettura sensata; nessuna chiave che mi apra la porta alla parola GIANRICO. Vado avanti per tre ore buone, provando e riprovando, con acrostici, anagrammi, palindromi, logogrifi e un’altra mezza dozzina di giochi enigmistici. Niente. È stressante scavare per ore e ritrovarsi sempre al punto di partenza. Molto più divertenti i giochi in cui mi sono esercitata negli ultimi giorni sulla Settimana enigmistica e su due libri specialistici regalatimi qualche tempo fa da Luciano. Devo aggiungere che un tale frivolo studio mi ha portato a fare una meravigliosa scoperta culturale: l’enigmistica d’alto livello è una scienza seria. Perché no, se lo è la letteratura? Magari non ha alcuna utilità immediata, non per questo è più spregevole di altre scienze formali; penso a certe geometrie non euclidee e a certi modelli di equilibrio economico generale, giochi di squisita raffinatezza che Luciano mi aveva insegnato ad apprezzare oltre che per le proprietà estetiche anche per la potenza conoscitiva controfattuale. Forse alla fine realizzerò che la storia dei messaggi nascosti nei capitoli del Nuovo corso è una patacca, e il tempo che avrò dedicato a queste impossibili decifrazioni si rivelerà una perdita di tempo. Ma qualcosa mi resterà. Almeno una cosa mi resterà: 160 l’arricchimento spirituale che ho ottenuto dallo studio di una piacevole scienza. Le gite di Giuliano erano diverse da quelle di Luciano, diverse come la montagna e la campagna, o meglio, la natura e la cultura. Mi piacevano entrambe e non saprei decidere quale preferissi. Nutrivano due distinti bisogni del mio spirito, direi, una sete e una fame dell’anima. L’angoscia della solitudine, da una parte, chiedeva un appagamento elevato che mi desse un arricchimento culturale. Dall’altra il risentimento sociale, se non proprio esistenziale, mi spingeva verso le sensazioni forti, le sensazioni che solo la natura selvaggia può dare. Una volta volli unire le due esperienze. Dopo vari tentativi, riuscii a convincere i due amici a fare un’escursione noi tre insieme. Andammo a monte Senario, una montagnola venti chilometri a Nord di Firenze che accoglie sulla cima un antico monastero benedettino. I miei due cavalieri cominciarono a litigare fin dall’inizio. Lasciata la macchina ai piedi del monte, Luciano prese una cartina e una bussola e fece il punto. Con una matita tracciò due linee rette sulla mappa e disse, indicando col braccio il folto del bosco: “Si va in questa direzione.” Giuliano si mise a ridere. Poi, con un tono tra l’ironico e il condiscendente, cercò di far capire all’altro che in montagna non si va come in mare; che le rotte sono già tracciate dalla tradizione, nei sentieri; che esistono delle regole dell’andare in montagna, sia pur non scritte; e che queste regole vanno rispettate, non solo per il proprio bene, ma anche per amore della montagna. Luciano rispose che il bello delle regole sta nel trasgredirle e che lui, quando può, disobbedisce a quelle che non si dà da sé. La discussione s’infervorò subito. E continuò per un pezzo. Infine decidemmo di separarci, dandoci appuntamento sulla cima. Luciano si avviò sulla sua rotta. Io e Giuliano seguimmo il sentiero segnato. Restammo sorpresi quando, giunti in cima, trovammo l’amico che ci aspettava. Se ne stava seduto su un masso, con un libro in mano, un dito tra le pagine, lo sguardo sperduto nel vuoto, 161 assorto in una sua contemplazione triste, davanti a una grottina buia e umida. Si girò verso di noi, quando gli fummo vicini, e ci ordinò di sedere per terra e di stare zitti. Ci raccontò la storia dei soci fondatori del santuario di monte Senario, due ricchi mercanti fiorentini, non ricordo i nomi, i quali in un giorno radioso del Duecento decisero di diventare santi. Abbandonarono ogni ricchezza e gli onori e i piaceri della città e si rifugiarono in quella grotta a meditare nel silenzio. Luciano narrava tutto ispirato, sembrava parlare di sé. Neppure il velo d’ironia del suo abituale sorriso spento riusciva a nascondere l’anelito d’ascetismo che traluceva dai suoi occhi e dalle sue parole. Giuliano lo lasciò finire senza interrompere. Poi, sempre in silenzio, tirò fuori dallo zaino birre e panini e li distribuì. Dopo pranzo i due amici, se posso usare questa parola senza dare l’impressione di fare dello spirito, ricominciarono a discutere, stavolta su Firenze, l’Italia e la sua capitale. Era un argomento che li interessava entrambi e molto: Luciano, che era romano, perché aveva eletto Firenze a sua città ideale, proprio come me; Giuliano perché qui ci era nato e, sebbene emigrato a Roma sin da bambino, si sentiva fiorentino al cento per cento. “Firenze sarebbe l’unica vera capitale d’Italia,” disse Luciano, “se solo questa nazione avesse una più profonda coscienza di sé.” “Scherzi?” Lo interruppe il fiorentino. “Stai parlando di una città provincialissima, dominata culturalmente e politicamente dalla classe dei bottegai, chiusa nella contemplazione delle glorie passate e refrattaria a ogni cenno di innovazione.” “Provinciale sì, e appunto perciò rappresentativa della nazione. Cos’è l’Italia se non un’immensa provincia? E come fa a riconoscersi in una capitale dello splendore di Roma? Infatti non vi si riconosce. La città eterna si è sempre vissuta quale centro del mondo ed è, nel bene e nel male, l’unica vera metropoli cosmopolita d’Italia.” “E Milano dove la metti?” “Milano è una bella cittadona,” riprese il romano, “pulita, efficiente, ordinata, anche sontuosa; può aspirare a essere la capitale del Lombardo-Veneto, niente di più. Quanto alla capitale 162 morale... Be’, ha ampiamente dimostrato di essere la vera capitale dell’Italia furbacchiona. A parte questo, la metto sul piano di Lione, Zurigo o Monaco, non la confronterei con le grandi capitali spirituali d’Europa: Parigi, Londra, Vienna, Berlino, Roma. Il problema è che gli italiani non si riconoscono in Roma come i francesi in Parigi e gli inglesi in Londra, un chiaro segno del loro provincialismo. Un popolo che non è capace di elevarsi oltre se stesso fino a identificarsi in una capitale cosmopolita, non è degno di essa. Un popolo provinciale che per un puro scherzo della storia abbia avuto in dono una capitale del genere non può non provare un sordo rancore verso di essa. Ecco la ragione profonda dell’odio degli italiani verso Roma.” “Pensavo piuttosto che l’odio dipendesse un po’ dalla fama d’inefficienza e di corruzione di cui gode la classe politica romana, un po’ dalla lunga storia dei tradimenti e delle sopraffazioni perpetrati dalla capitale della cristianità ai danni delle altre città italiane e della nazione.” “Qui hai torto e ragione allo stesso tempo. La prima spiegazione non ha molto senso. La classe politica romana, e v’includo il top management della chiesa, l’alta intellighenzia, l’alta burocrazia, è l’unica classe sociale non romana che vive a Roma. Le lotte politiche in provincia selezionano i migliori cervelli del paese per spedirli alla capitale. Che colpa ne ha Roma se tra i requisiti necessari per vincere la competizione rientra l’opportunismo, l’astuzia e la perfidia? Questa gente poi, appena giunta nella città eterna, comincia a vivere in un suo mondo elevato, a nutrirsi di valori universali, a fare la grande politica e la grande cultura, snobbando i piccoli problemi pratici che affliggono la provincia. Anche per ciò è odiata dagli italiani. Loro hanno prodotto la classe politica, e mandandola a Roma ne hanno fatto una smandruppata: una tronfia prostituta che si scopre soddisfatta di sé per essere finalmente riuscita ad accasarsi, si sbraca sulla città e se la gode. In realtà la sua corruzione è una prova dell’odio degli italiani verso Roma, non una giustificazione. Anzi, del loro odio verso se stessi.” 163 “Ahi ahi ahi! Si entra nella psicologia dei popoli!” M’intromisi, gelandolo per un attimo. Lui non si lasciò intimidire e non ci diede tregua: “Aspetta, fammi finire. Volevo aggiungere che invece nella parte storica della sua spiegazione Giuliano ha ragione, almeno in parte.” “Volevo ben dire!” Fece l’altro. Ma lui, imperterrito: “È vero che Roma negli ultimi sei-settecento anni di storia ha lavorato sistematicamente al disfacimento politico della nazione. Il che, però, non si spiega soltanto con l’esigenza della Chiesa di stroncare sul nascere ogni potenziale minaccia alla propria esistenza come stato. Perché il diabolico progetto potesse avere successo era necessaria la collaborazione delle altre città, le quali infatti hanno contribuito sistematicamente all’opera di annichilamento morale dell’Italia; primo, in quanto hanno fatto propria l’ideologia cattolica, in tal modo disarmandosi da sé di fronte al nemico; secondo, in quanto non sono mai state capaci di superare gli stretti orizzonti delle loro politiche parrocchiali, armando in tal modo il comune nemico in Roma. Così torniamo al punto di partenza: è il provincialismo d’Italia che spiega la pervicacia, stavolta sì, di Roma, non viceversa.” “E la Peppa!” Lo interruppi di nuovo, ora decisa. “OK. Niente psicologia dei popoli.” “A me interessava di più il discorso su Firenze.” Dissi. “Dunque sarebbe la degna capitale d’Italia per i suoi difetti, non per le sue qualità, perché è provinciale, non perché...” “Non è proprio questo che intendevo.” Abboccò subito. Fece una pausa, come per riprendere fiato prima di un nuovo assalto, diede una lunga sorsata alla birra, poi si accese un toscanello. Ormai si era infervorato e non lo fermava più nessuno. Né avevo intenzione di fermarlo io, semmai di provocarlo ancora. D’altronde gli succedeva così raramente di infervorarsi! Di solito interveniva nelle discussioni elevate, quando interveniva, con atteggiamento di controllata ironia, parlando poco e cercando di abbattere gli argomenti degli altri piuttosto che di dare forza ai propri. Nei rari casi in cui si lasciava accalorare, si trattava di discussioni futili, come questa sulla vera capitale d’Italia, e 164 tendeva a trasformarle in monologhi. Allora gli piaceva assumere punti di vista paradossali e sostenerli con tutti i mezzi possibili, con la freddezza della logica e la forza della retorica. E non si capiva mai se ci credeva veramente nelle idee che difendeva o se non era piuttosto mosso da un’inconsulta voglia di aggressione verso il senso comune. “Quando dico che una nazione provinciale deve essere rappresentata da una capitale provinciale,” riprese, “dico una banalità...” “Ma no?” Giuliano. “In realtà,” continuò l’altro, “ci sono due tipi di capitali provinciali: quelle che abbassano e quelle che elevano; Whashington e Bonn da una parte, Madrid e Atene dall’altra. Firenze apparterrebbe al secondo tipo. Una capitale che eleva una nazione è un centro che ha contribuito in modo essenziale a farne la storia nei suoi momenti migliori. Al contempo non si distingue da essa in nulla di essenziale, così da riuscire a esprimerne il livello culturale e morale diffuso. La nazione però vi riconosce la sede delle proprie radici e v’identifica la parte nobile di sé. Una nazione provinciale che vuole elevarsi si sceglie una capitale che non è molto diversa da sé, ma è in grado di incarnare ed esprimere il meglio di sé. Una tale città per l’Italia sarebbe Firenze, se gli italiani fossero meno...” “Dove lo vedi questo meglio di sé in Firenze?” Interruppe il fiorentino. “In che modo la città esprime il meglio della Lombardia o del Piemonte? Nel lerciume delle strade, nelle case fatiscenti, nell’incuria con cui sono tenuti i giardini, i monumenti e l’arredo urbano, nell’arroganza della gente, nell’inefficienza degli uffici pubblici, nella stolidità dell’assessorato al traffico, nella preclusione a ogni novità? Io la vedrei bene quale capitale dell’Italia meridionale, a Sud della linea gotica.” “Questi che hai appena elencato sono aspetti inessenziali, esteriori, e sono le caratteristiche per cui Firenze rappresenta la medietà: più sporca di Bologna e meno di Napoli, più disfatta di Milano e meno di Roma.” “Non credo siano qualità tanto esteriori. Sono espressione di un abito culturale. Né sono tanto medie. Prendi le strade. Nessu- 165 na città d’Italia ha strade così sfasciate, neanche Napoli o Palermo. Parlo di cose banali come la pavimentazione dei marciapiedi o...” “È vero, ma questa è colpa della pietra serena.” “Esatto. La pietra serena si usa solo in Toscana. È un materiale brutto e fragile, si sfalda con la pioggia, si spacca col sole, si sfarina sotto le ruote delle automobili. Eppure i fiorentini non hanno mai pensato di cambiarla. Perché? Perché non sostituirla, per esempio, con il forte porfido romano o con l’indistruttibile travertino? Te lo dico io perché: è che si tratta di un lascito della tradizione. In ciò i fiorentini somigliano agli inglesi: non importa se la tradizione è bella o brutta, buona o cattiva; è sacra, e in quanto tale non va toccata. Il che, mi dirai, è un segno di provincialismo. E sarei d’accordo...” “Ti sbagli.” Lo incalzò il romano. “E non potevi scegliere esempio migliore a sostegno della mia tesi. Il travertino di Roma è indistruttibile. I monumenti e i marciapiedi fatti di travertino sono eterni e sono adatti a una città che si sente universale. Da parte sua la pietra serena intanto non è per niente brutta, con quel grigio creta che si sposa così bene con il bianco ombrato dei palazzi rinascimentali. Guarda i colonnati del Brunelleschi che circondano piazza SS. Annunziata. Si può paragonare la loro sobria eleganza con la spocchia di piazza S. Pietro? Soprattutto, per restare al tuo argomento, io credo che la caducità della pietra serena sia una qualità che i fiorentini hanno ricercato consapevolmente. Una qualità che esprime un senso della vita niente affatto tradizionalista, bensì modernissimo, se non postmoderno. La pietra serena sta al travertino come l’effimero all’eterno. E il senso dell’effimero è uno dei prodotti spirituali più elevati dell’umanesimo fiorentino. Qui il modo di vivere e di sentire dell’uomo per la prima volta nella storia perde i toni superbi della metafisica e assume dimensioni mondane. Gli individui cessano di cercare fondamenta spirituali alla propria esistenza e si acquietano nel quotidiano. La trasformazione culturale che genera l’uomo moderno iniziò a Firenze, pressappoco nell’epoca in cui il gusto letterario superò Dante per lasciarsi guidare da Boccaccio. I fiorentini questa eredità se la portano nel sangue. Il 166 loro disincanto, la sobrietà nel vestire, la misura dei toni, la raffinatezza delle loro bestemmie, perfino la beceraggine del loro sarcasmo, sono espressioni di levatura spirituale. Il loro senso di superiorità nei confronti di tutti gli altri popoli d’Italia e del mondo è in un certo senso giustificato dalla loro capacità di guardare al mondo con distacco, dal di fuori e dall’alto. Quando rifiutano le innovazioni non si oppongono al mondo moderno, bensì a quanto di volgare c’è in esso. È vero che sono molto selettivi coi doni della civiltà industriale, ma lo sono perché cercano di ottenere il meglio, lasciando il peggio agli americani. Il loro provincialismo è il modo d’essere che hanno consapevolmente scelto per porsi al di fuori del vortice e conservare la propria saggezza. Ora, queste qualità, quest’atteggiamento verso la vita, sono presenti in diversa misura anche nel resto d’Italia; e si sa che dietro il complesso d’inferiorità che il Belpaese esibisce agli occhi d’Europa si nasconde piuttosto un complesso di superiorità. In Firenze non si nasconde più e da complesso si tramuta in consapevolezza. Perciò dico che l’unica vera capitale di questa nazione, l’unica città capace di rappresentarla elevandola alle proprie aspirazioni e rivelandola a se stessa, sarebbe Firenze.” Si fermò e prese un altro lungo sorso dalla lattina di birra. Io e Giuliano ci guardammo perplessi e capimmo di nutrire lo stesso dubbio: che Luciano ci stesse prendendo per il culo. Lui, quasi a rispondere alla nostra muta domanda, alzò il braccio destro puntando un dito verso il cielo e sentenziò: “Ma ciò non poteva accadere. Poiché sta scritto: se tutt’Italia fosse Toscana, povero mondo!” 167 Venerdì, 31 maggio Per pranzo sono da me Gianrico e Silvio. Non è stato difficile convincerli a venire. È bastato un cenno a una nuova soluzione del maledetto enigma e alla possibilità che Giuliano l’avesse trovata. Si mostrano un po’ sorpresi di incontrarsi. Non si aspettavano un tête a tête. In effetti li ho invitati senza informarli l’uno della presenza dell’altro. La mia intenzione è di metterli a confronto, come fa un giudice con due testimoni contrastanti. Se è valida l’ipotesi del movente connesso alle malefatte accademiche di Luciano, uno dei due può essere l’assassino. D’altra parte ciascuno dei due, calcando la mano sul movente dell’altro, l’ha di fatto accusato. Però voglio anche sapere qualcosa riguardo a Lilli. Era la segretaria di Giuliano, ma si dice che fosse un’informatrice di Gianrico, secondo alcuni, di Silvio, secondo altri. Forse lo era di entrambi e probabilmente giocava una sua partita personale destreggiandosi fra i tre. Gianrico e Silvio, messi insieme, sembrano due personaggi pirandelliani. Quando facciamo l’amore in tre, si comportano come se non si conoscessero. Ora che abbiamo un colloquio serio indossano garbate maschere da gentiluomini accademici e fanno il possibile per nascondere la tensione che la presenza dell’uno suscita nell’altro. Tuttavia le maschere sono così diverse che sorge spontaneo il dubbio se tra i due sia mai esistita una qualche relazione, o piuttosto se ne esista la possibilità. Silvio è distaccato, serio, sobrio, di una gentilezza perfino stucchevole. Parla con calma, scherza poco, mi guarda sempre fisso negli occhi con un’espressione paternamente amorevole, quasi partecipando dei miei sentimenti. Gianrico invece è esuberante, rumoroso, brillante. Si atteggia a filosofo francese, un po’ blasé e un po’ naif. Parla il suo eloquio immaginifico e frizzante. Ogni tanto sfodera una battuta arguta, di quell’arguzia ruspante che solo i fiorentini DOC riescono a simulare così finemente. So bene io come fargli abbassare la cresta a tutti e due. Intanto gli ammannisco un pranzetto che non direi proprio leggero: Pizzoccheri valtellinesi, di cui Gianrico va matto, bistecche di maiale al pepe verde, di cui va matto Silvio; per contorno, 168 sformato di spinaci e purè di patate al parmigiano; il tutto bagnato da un corposo Tignanello del ’77 che sturerebbe un lavandino intasato; per antipasto, crostini di salsiccia e stracchino; infine un dessert di frutta in mostarda con mascarpone e shortbread scozzesi. Col dolce gli passo del vinsanto di caratello che gli taglia definitivamente le gambe. Alle due, quando si accomodano sui divani del mio boudoir, subito dopo l’abbuffata, sono cotti a puntino, lo sguardo spento di soddisfazione, la lingua impastata, gli stomaci affaticati che pare di sentirli lavorare. Non mi ero mai interessata di cucina prima di abbracciare la professione. Ora invece è diventata una vera passione. La coltivo come un’arte, e senza secondi fini, per lo più. La coltivo soprattutto per il piacere immediato che ne ottengo e meno nel consumarla che nel prepararla. Ho attraversato vari periodi. Prima l’haute cuisine francese, poi la nouvelle cuisine, in seguito la cucina rinascimentale fiorentina. Solo recentemente, sotto l’influsso della lettura rivelatrice del divino Artusi, ho cominciato ad apprezzare la cucina popolare italiana, una cucina modesta, eppure così sapiente! Infine mi sono accorta che si tratta di una vera arte e, abbandonati i libri alla critica roditrice dei topi, ho cominciato a sperimentare in corpore vili, facendo scorrerie nelle trattorie e nei buchi dei quartieri popolari di Firenze e dei paesini di provincia. Ma anche quando viaggio nel resto d’Italia cerco di fare esperienze. Stringo amicizia con i trattori e i cuochi e mi faccio rivelare i loro segreti. Se mai scriverò un libro serio, sarà un libro di cucina. La coltivo, quest’arte, per il piacere immediato che ne ottengo, dicevo, sebbene non disdegni a volte di usarla per qualche fine secondo. Così ho fatto oggi coi miei due capoccioni. Dunque, tornando a loro, gli comunico a sorpresa la scoperta di Giuliano. E la sorpresa è forte. Gianrico ha un sobbalzo quando faccio il suo nome dicendogli che è la parola nascosta nei famigerati appunti di filosofia. Mi domanda cosa significa, ma io l’incalzo dicendogli che è lui che deve spiegarmelo. Silvio mi dà ragione, faticando a nascondere un sogghigno di perfidia. L’altro resta muto e assorto. L’unica battuta che si lascia sfuggire è rivolta a se stesso: 169 “La cosa non mi garba punto. Proprio no. Direi anzi che la mi disgarba alquanto.” La conversazione, di reticenza in reticenza, stenta ad avviarsi e non risulta particolarmente produttiva. Ciò che riesco a capire è che Gianrico è piuttosto preoccupato e non si sente a suo agio nei panni della soluzione dell’enigma. Sembra sinceramente non capirci un gran che. Né parla molto. Ha perso all’improvviso tutta la sua facondia. Pure Silvio è più pensoso che loquace. A fatica riesco a strappare dalle loro bocche poche frasi riluttanti, insistendo per sapere cosa pensano dell’omicidio di Luciano. Mi pare di capire che entrambi ora sono propensi ad attribuirlo a Giuliano. La conversazione è faticosa, e i silenzi parlano per le parole. Devo aver esagerato con il pranzo e il vino. Servo il caffè. È l’occasione per cambiare argomento. Penso che sull’omicidio di Lilli potrebbero parlare di più. Domando se credono che possa essere collegato con quello di Luciano. Risponde Gianrico: “È difficile credere che non lo sia.” “Cosa pensate di tutto l’allestimento scenico da messa nera?” “Una messa... in scena, appunto.” “Carino.” Osservo. “Senonché Lilli si interessava veramente di magia, e anche Luciano...” “Vien via! Codesta è una cosa che non ha né babbo né mamma.” “Vuol dire né capo né coda.” Spiega Silvio. E prosegue: “Sono abbastanza d’accordo con te, Gianrico, però non sottovaluterei la faccenda. Luciano si era interessato di parapsicologia in uno dei suoi vagabondaggi intellettuali, per quanto lo facesse con spirito, diciamo così, scientifico.” “Questo m’interessa. Con spirito, diciamo così, scientifico?” Gli faccio il verso, ma mi pento: “Veramente, m’interessa molto.” “Sì.” Riprende lui senza scomporsi. “Era una delle sue avventure intellettuali. Aveva sempre bisogno di studiare cose nuove. Si faceva prendere continuamente dalle passioni più strampalate, senza approfondire veramente mai nulla, anzi, direi, per evitare di approfondire alcunché. Una volta l’antropologia, un’al- 170 tra la psicanalisi, un’altra la poesia. L’ultima era appunto la parapsicologia.” “Sulla quale si era del tutto inciuchito, il fanfero.” S’intromette Gianrico. L’altro non gli dà spago, e prosegue: “Ne ho parlato con lui recentemente. Il suo interesse per un campo di ricerca tanto squalificato accademicamente meravigliava me non meno degli altri colleghi: un ricercatore razionale e razionalista come lui!” “Forse il fatto che fosse squalificato”, fa Gianrico, “era ciò che più lo attraeva, quel tenebrone.” “Sì, lui stesso dava una spiegazione del genere. La cattiva fama della parascienza, l’ostinazione con cui gli scienziati cercherebbero di confonderla con le pratiche dei fattucchieri e dei prestigiatori sarebbero, secondo lui, una tipica manifestazione d’intolleranza religiosa.” “Questa non l’ho capita.” Interrompo. “Religiosa perché determinata dall’educazione cristiana che la stragrande maggioranza degli scienziati si porta dietro. I miracoli, per il cristianesimo, accadono solo per opera di Dio o del Diavolo, e quindi non possono essere fatti oggetto di ricerca scientifica. O Dio esiste, e allora i miracoli sono al di fuori della portata della scienza. O non esiste, e allora non possono esistere neanche i miracoli. Così, sosteneva, gli scienziati atei e materialisti sono peggio degli spiritualisti negli sforzi volti a screditare la parapsicologia. Secondo Luciano invece un atteggiamento seriamente scientifico dovrebbe spingere ad aprire la mente fino a farle affrontare il problema dell’esistenza degli angeli. Il fatto che non è stata provata sperimentalmente non autorizzerebbe nessuno scienziato a sostenere che non si dà, non più di quanto autorizza un fesso a sostenere il contrario. Deve valere per gli angeli ciò che vale per i buchi neri: non possono essere osservati direttamente; dunque si tratta di affinare le esplorazioni degli indizi e le teorie per pensarli.” “Va bene,” s’intromette di nuovo Gianrico, “ma se non esistono non ci sarà teoria che possa scapolarla, né osservazione che possa...” 171 “Bravo, è l’obiezione che gli feci io. Sai cosa mi rispose? Che le osservazioni non possono dimostrare le teorie e che questa è la ragione per cui la scienza si evolve continuamente.” “Mi sembra una lucianata.” Di nuovo Gianrico. “Però, per tornare a Bomba, è vero che recentemente il grullo si era messo a introgolarsi con certa razzumaglia, maghi, fattucchiere, cavalieri del nulla o giù di lì...” Non finisce la frase. Anzi, s’interrompe bruscamente quasi mordendosi la lingua. “Che vuol dire?” Domando. “Lascia perdere,” fa lui, “razzumaglia e basta.” “Come le vergini folli?” “Anche. Ma soprattutto frequentava strane letture, che non direi proprio scientifiche. Insomma era ringrullito. Qualche settimana fa ho avuto una richiesta d’accesso alle stanze riservate della biblioteca.” “Che stanze?” Domando seccamente. La cosa m’interessa. “Ci sono dei testi antichi, roba di carattere religioso, la maggior parte di provenienza indiana e tibetana, canoni buddisti, induisti e affini. È materiale antico e molto raro, e non è accessibile al pubblico se non previa autorizzazione del direttore della biblioteca, il quale la concede dietro parere favorevole di un preside di facoltà.” “Non sapevo che Luciano ti avesse richiesto questo parere.” Interviene Silvio. “Che libri consultò?” “Non solo consultò, se ne portò a casa alcuni. Erano testi tantrici, magia sessuale e robaccia simile.” Conoscevo bene quei testi. Alcuni li avevo studiati insieme al mio uomo. Ma non lo dico ai due presidi. È Silvio a riprendere il discorso: “Se Luciano si occupava veramente di certe cose, sarebbe confermata l’ipotesi di un collegamento tra i due delitti.” “In tal caso,” proseguo io, “lo sfondo magico-rituale non sarebbe una messinscena.” “Già,” ribatte lui, “ma per me resta una pista poco convincente. Mi sembra più verosimile l’altra.” “Cioè?” Il dialogo ora si svolge tutto tra me e Silvio. 172 “Quella dell’enigma nascosto negli appunti di filosofia.” “Non potrebbero essere la stessa pista?” “Difficile dirlo. Nella pista dell’enigma è implicato Giuliano e ora, a quanto pare, anche tu, caro Gianricuccio,” dice, voltandosi verso di lui, con un filo di malignità nella voce, “e non vi ci vedo, nessuno dei due, interessati a faccende di parapsicologia.” “Che mi dite delle vergini rosse?” Insisto. “So che sono state interrogate dalla polizia per l’omicidio di Lilli. E sapete cosa? Hanno presentato un alibi che la polizia non è riuscita a controllare, un alibi incredibile.” “Che alibi?” Domando all’unisono con Gianrico. “Non indovinerete mai.” “Sentiamo.” “Sapete cosa hanno risposto, quando la polizia gli ha domandato dove si trovavano la notte della morte di Lilli?” “Dai, non fare il noferi, taglia corto.” Lo sollecita Gianrico. “Che hanno passato tutta la notte in compagnia di Luciano.” “Di chi?” Di nuovo in coro. E lui, scandendo le sillabe con un sorriso beffardo: “Di Luciano.” “È un alibi folle.” Dico io, dopo un attimo di sconcerto. “Mah? Probabilmente quella sera se ne stavano a casa per conto loro. Probabilmente, non essendo al corrente della morte di Luciano, hanno sperato che lui gli avrebbe confermato l’alibi. Si dice che fosse il loro unico amico. D’altra parte è un alibi insensato, certo, ma non dal nostro punto di vista. Se l’omicidio di Luciano è collegato a quello di Lilli, la loro ignoranza del primo le proverebbe estranee anche al secondo.” “Dunque tu pensi che loro non sono implicate.” Riprendo. “Penso di no.” Poi la conversazione torna sull’enigma nascosto negli appunti di Luciano. Vogliono vedere quei maledetti appunti. Gli dico che non li ho. Loro non sembrano convinti. Si sono svegliati del tutto ora, e cominciano a farmi un sacco di domande sul direttore amministrativo. Quali sono i miei rapporti con lui, quali le sue intenzioni verso di loro, e se è stata trovata quella famosa chiave della verità. Io non ne so più di loro, glielo dico e glielo ripeto; 173 senza essere creduta, purtroppo. La conversazione va avanti ossessiva per un bel pezzo, per quanto né io né loro riusciamo a cavarne qualcosa di concreto. Alla fine, stanchi non meno di me, se ne vanno. Sono le sei del pomeriggio. Una giornata persa. La faccenda degli studi parapsicologici di Luciano mi evoca ricordi tristi, di quando il movimento ciclico del nostro amore entrò in una profonda crisi di depressione. Nella fissa di salvarlo da se stesso, mi ero riproposta di entrare nella sua testa, di penetrare il suo mondo chimerico, e mi ero messa a studiare con lui quegli antichi testi religiosi. Capii subito che non era precisamente di parapsicologica che s’interessava, nonostante che tra i suoi libri ci fossero alcuni trattati di questa pseudo-scienza scritti da professoroni californiani. Era un richiamo più spirituale, eppure molto pratico. Non le favole mitologiche e le fisime simboliche lo appassionavano, bensì le tecniche psico-fisiche praticate dagli antichi santoni. Quando vide che la cosa cominciava a interessare anche me, ne fu felicissimo. Si eresse a mio guru personale e mi diede degli esercizi da fare. Mi consigliava letture di testi sacri e, dopo avermi spiegato il significato tecnico di certi riti, mi dava indicazioni su come praticarli. M’insegnò a rilassare i muscoli di tutto il corpo, a controllare il respiro e il battito cardiaco, a svuotare la mente e visualizzare immagini. All’inizio gli esercizi li facevo in posizione supina, e incappavo quasi sempre in una difficoltà: arrivata alla fase del vuoto mentale mi addormentavo. Allora Luciano mi cambiò metodo. Mi faceva sedere su uno strano sgabello, alto un palmo e con il ripiano leggermente inclinato in avanti. I polpacci dovevo tenerli sotto lo sgabello, di modo che stavo inginocchiata ma senza che il corpo gravasse sulle gambe. La posizione era comoda, l’unica fatica che richiedeva era di tenere il busto eretto in equilibrio sul culo. Questo minimo sforzo era sufficiente per evitare l’addormentamento. Poi m’insegnò a controllare le visualizzazioni. Per un po’ di tempo ho meditato a occhi chiusi. Quando giungevo alla fase del vuoto mentale, comparivano spontaneamente immagini di ghigni 174 e volti sconosciuti, a volte benevoli, più spesso diabolici e terribili, tanto da spaventarmi e farmi perdere la concentrazione. Allora Luciano mi disse di tenere gli occhi aperti e fissarli su un mandala appeso alla parete davanti al letto. Era un quadro indiano astratto, con un’infinità di colori e una certa varietà di motivi disposti simmetricamente, fiori, croci, svastiche, stelle, lune, soli. Al centro c’era un occhio stilizzato, sul quale concentravo l’attenzione. Dopo un po’ di tempo che lo fissavo, le figure cominciavano a cambiare forma e a muoversi, spesso con un moto circolare, talvolta ondulatorio. Il difficile fu imparare a dominare quelle immagini. Con la forza della mente dovevo controllare i cambiamenti di configurazione del mandala fino a dar vita a una figura umana. Infine riuscii a visualizzare il corpo di Luciano senza guardare lui, ma facendolo emergere dalle trasmutazioni delle forme astratte. Quando mi fui impratichita nel metodo, m’introdusse a delle tecniche sessuali, come quella in cui, invece di inginocchiarmi sullo sgabello di meditazione, mettevo in atto l’esercizio yoga stando a cavalcioni su di lui. Erano giochetti che avevamo già fatto diverse volte, però ora li praticavo con una certa consapevolezza. Soprattutto, ero in grado di condividerne con lui il significato spirituale. Il dramma fu che così riuscì a spoetizzare anche quei giochetti. In passato vi avevo partecipato con gusto, prendendoli quali variazioni sul tema dei preliminari e dell’eccitazione. Ora che me li aveva ridotti a esercizi yoga il gusto andò perso. Per un certo periodo le nostre scopate le classificai in due specie: tecniche e passionali. Poi cominciai a pensare che per lui erano tutte tecniche. L’orgasmo, che io vivevo come il culmine dell’amore, lui lo prendeva come il segno di un esperimento fallito. Mi disse chiaramente che non lo voleva, non lo cercava. All’epoca sperimentava la pratica della ritenzione del seme. Si trattava di arrivare alle soglie del parossismo e non superarle. L’energia accumulata doveva essere incanalata verso la testa a provocare un’illuminazione. Va da sé che era difficile. Lui, arrivato sulla soglia, raramente riusciva a restarne al di qua. Quando ci riusciva, invece di avere il satori si ritrovava con un vergogno- 175 so ammosciamento. Io ovviamente non mi stavo ad angosciare per i superamenti della soglia. Lui invece s’irritava. Diceva che non collaboravo, che non gli servivo a niente, che anzi lo boicottavo. Fatto sta che in quel periodo toccammo il fondo del nostro ciclo amoroso. In effetti non riuscivo a collaborare secondo i suoi desideri. Era l’idea di servirgli a qualcosa che mi disgustava. La teoria e la metodica spirituale mi avevano affascinato, ma quando capii che la pratica si risolveva nello svilimento dell’unica cosa che sembrava unirci profondamente mi disamorai. “Perché le cose funzionavano meglio quando non conoscevi il vero significato di queste tecniche?” Mi domandò un giorno, subito dopo un risultato per lui deludente, cioè dopo un orgasmo simultaneo strepitoso. “Forse proprio perché non conoscevo.” “Allora non t’interessa un cazzo dell’impresa che stiamo tentando.” “Amore, un cazzo m’interessa…” “Amore un cazzo! Tu sei capace di capire solo una cosa.” “Una cosa che tu invece ancora non hai capito.” Fu a quei tempi che il nostro rapporto si deteriorò seriamente. Io non avevo più voglia di fare l’amore con lui e lui mi chiedeva di farlo di rado. Continuavamo con lo studio e con le tecniche sessuali, ma oramai la scopata passionale me l’ero scordata. Il mio uomo era riuscito a svilire perfino quella. Furono giorni di tristezza. Si era ridotto anche il tempo che stavamo insieme, per non dire del tempo che dedicavamo al sesso. Anzi, ebbi l’impressione che cercasse soddisfazione altrove. Chissà, magari c’era un’altra geisha, una che si applicava meglio di me e gli dava tutto lo spago che voleva. Non volli indagare. Entrai in una fase di abulia. Avevo l’impressione che il tentativo di salvarlo si fosse risolto in una debacle totale: invece di riuscire a salvare lui, mi stavo perdendo me stessa. Oramai cercavo solo di salvare il salvabile, mi contentavo del poco che mi chiedeva e tiravo avanti in attesa di tempi migliori. 176 Un giorno gli dissi che stavo meditando di smettere con la professione. Chissà cosa pretendeva la mia contorta anima infantile. Lui non fece una piega, anzi mi provocò: “Tesoro, il bello della libera professione è che sei libera di professarla o no.” “Che vuoi dire?” “Che non hai bisogno della mia autorizzazione per smettere di battere. Non sono mica il tuo pappa.” “Non cercavo la tua approvazione, tantomeno l’autorizzazione. Volevo solo informarti di una decisione che sto ponderando da qualche tempo e capire come l’avresti presa.” “Tranquilla. La prenderei sportivamente.” Quando faceva così mi mandava in bestia. In quel momento lo odiai, e la mia angoscia toccò il fondo. Ebbi la sensazione dell’inizio di una fine. 177 Sabato, 1 giugno Spesso mi scopro a pensare a Lucrezia. Il mio interesse per questa donna cresce di giorno in giorno. Un po’ ho l’impressione che il suo ruolo in tutto l’intrigo sia più importante di quanto sembrava a prima vista. Un po’ credo che su di lei si stiano trasferendo parte dei miei sentimenti per Luciano. In fondo, penso, nessuno deve aver conosciuto l’uomo meglio di lei. Eppure tutto ciò non mi dà ancora ragione del mio interesse per Lucrezia. Le mie tendenze lesbiche mi paiono abbastanza moderate e peraltro sono sempre riuscita a tenerle sotto controllo, coltivandole come attività professionale. Che mi succede ora? È possibile che la morte di Luciano abbia risvegliato in me pulsioni che credevo di aver superato da tempo? Oggi, alle sette di sera, mi presento a casa di Lucrezia e m’invito a cena. “Ho voluto contraccambiare la visita.” Le dico sulla porta. Lei mi accoglie gentilmente, senza mostrare sorpresa o imbarazzo. La bambina è dai nonni. Peccato: mi sarebbe piaciuto conoscere la figlia di Luciano. La cena, sobria e fredda, è poco impegnativa, ma bagnata da una delizia di Schiava Gentile della val di Cembra che ci scioglie la lingua senza intorpidirci la mente. La conversazione scorre piacevole, seppur adombrata da un lieve tono di mestizia. Dopo cena frescheggiamo su un balcone con vista sul giardino di Boboli, un balcone piccolo piccolo e pieno di fiori, tanto piccolo che c’entrano appena due sdraie l’una accanto all’altra. Siamo così vicine, distese su quelle sdraie, che quando ci guardiamo i nostri fiati si confondono. Pian piano si crea un’atmosfera d’intimità, mentre ci godiamo l’affaccio sul verde. La conversazione procede amabile e vuota. Appena mi accorgo che sto cedendo all’abbandono, mi do una scossa e con uno stacco netto, che lei neanche finge di non notare, porto il discorso sulle cose serie. Le dico della scoperta di Giuliano riguardo al nome di Gianrico e registro le sue reazioni, che sono di completa indifferenza. Poi le parlo della conversazione avuta ieri con i due presidi e mi soffermo sulle strane 178 letture di materia magica e religiosa frequentate da Luciano. Le domando cosa ne sa e che ne pensa. “È vero,” risponde, “recentemente si era messo a studiare quella roba. Non ci vedo niente di strano, se non altro perché la bizzarria intellettuale era una cosa normale in lui. Cambiava continuamente i suoi interessi di studio. Si lasciava appassionare da cose incredibili. Io non me ne meraviglio più di tanto. Un sociologo che spende le sue giornate su un trattato di metrica italiana, per quale motivo non dovrebbe perdere tempo su un testo di magia sessuale induista?” “Insomma un intellettuale perditempo.” “Però in questo caso doveva trattarsi di un interesse legato al lavoro. Mi aveva accennato a una tesi di antropologia culturale di cui era relatore.” “Che tesi?” “Non ne so molto. So di quei libri strani che leggeva da mattina a sera. Passava delle giornate intere con le due studentesse che preparavano la tesi. Aveva dovuto richiedere un’autorizzazione speciale per accedere all’inferno della biblioteca Stibbert, e un’autorizzazione simile l’aveva fatta ottenere alle due studentesse.” Continua a parlare, mentre io non l’ascolto. Il mio cervello si mette a lavorare febbrilmente. Penso che la pista degli omicidi rituali meriterebbe più attenzione di quanta gliene ho riservata finora. Intanto consentirebbe un collegamento diretto tra le vergini rosse, Luciano e Lilli. Poi: perché Silvio non mi ha detto che le due sciroccate avevano anche loro l’autorizzazione per accedere alle segrete della biblioteca? Senza neanche pensarci, mi sale alla bocca una domanda: “Sei sempre convinta che l’assassina di Luciano è Lilli?” Lei mi guarda perplessa. Evidentemente stava parlando di tutt’altro argomento. Risponde: “Sì.” “Allora pensi che la morte di Lilli non sia collegata con quella di Luciano?” “Non dovrebbe?” “Non capisco ...” 179 “Neanch’io.” Si alza e va in cucina. Torna con una nuova bottiglia di Schiava Gentile, la stappa pigramente e riempie i bicchieri. Per un po’ ce ne stiamo in silenzio, sorseggiando il vino lieve. Pare che non abbiamo più niente da dirci, eppure mille pensieri premono per prendere forma. Mi volto verso di lei. È assorta. Guarda un punto lontano nel cielo ormai buio e sembra non accorgersi di me. In questi momenti mi ricorda Luciano. All’improvviso mi assale una matta voglia di baciarla. A fatica riesco a frenarmi. Ma il mio spiritello maligno mi tira un brutto scherzo, spingendomi a un approccio maldestro: “Che ne pensi del pensiero lesbico?” E lei: “Che è impensabile.” Sono avvilita. Improvvisamente mi sento disarmata. Ce ne stiamo in silenzio per qualche minuto. Sono le dieci. Il cielo è nero e le stelle non riescono a ravvivarlo. È come una tenda scura stesa davanti a noi per nasconderci qualcosa, e dà l’impressione che potremmo toccarlo allungando una mano. Abbiamo finito la seconda bottiglia di vino e il buio del cielo, lievemente, sta invadendoci la mente. Mi volto verso Lucrezia. Nell’oscurità riesco appena a scorgere il suo profilo. Mi pare di sentire il soffio della brezza tra i suoi capelli. Timidamente ci immergo una mano in quei capelli morbidi, e dico: “Chiedendoti cosa pensi delle lesbiche...” Lei si alza calma e, quasi ignorandomi: “Ora devo andare a prendere la bambina.” Dice. Si volta verso di me e mi toglie di mano il bicchiere vuoto. Proprio non ci so fare con le donne. Né si può dire che ci sappia fare con gli uomini, almeno quelli che m’interessano. Con Luciano ero giunta a un punto di alienazione totale dopo avergli permesso di ridurre il nostro rapporto sessuale a una tecnica di meditazione. Ormai si scopava raramente. Né io né lui eravamo più capaci di eccitarci. Non parliamo della passione o almeno del desiderio dei nostri corpi. 180 Me ne feci una malattia, una malattia innanzitutto spirituale. Quando stavo con lui non riuscivo a liberarmi di un sentimento di rabbia e di ripulsa. Quando gli stavo lontano, non riuscivo a non pensare a lui. Lo volevo, avevo bisogno di vederlo, lo desideravo, ma come un sogno utopico. Era però anche una malattia fisica. La notte dormivo tre o quattro ore. La sera crollavo a letto spossata, per risvegliarmi all’una o alle due con forti dolori di pancia. Mi ritrovavo l’addome gonfio d’aria, così gonfio che lo specchio mi restituiva il profilo di una donna incinta di quattro mesi. Dovevo fare una mezz’ora di ginnastica dura per liberarmi di tutto quell’inferno che mi ribolliva in ventre. Poi mi rimettevo a letto senza riuscire a prendere sonno, torturata stavolta dall’inferno che mi ribolliva in testa. Va da sé che di giorno ero stremata. Tra l’altro mi si era chiuso lo stomaco. A colazione non riuscivo a prendere più di un tè e una fetta biscottata. A pranzo mi sforzavo di mangiare almeno una braciola e una mela. A cena, quando si avvicinavano le tenebre e il tormento, non riuscivo a mandar giù neanche una tazza di latte, però gli davo giù col cognac. Anche la professione ne risentì. Ogni volta che un cliente mi toccava mi si torcevano le budella e dovevo fare degli sforzi ardimentosi per simulare un orgasmo credibile. Spesso mi accadeva anche con Luciano, ma con lui non riuscivo a simulare. La cosa non gli dispiaceva. Forse interpretava la mia frigidità come un segno di maturazione spirituale. Si mostrò però preoccupato per i disturbi intestinali, e mi portò da diversi specialisti. I gonfiori addominali parevano non avere spiegazioni cliniche evidenti, dopo che una lunga serie di analisi aveva portato a escludere allergie e intolleranze alimentari. Tutti i medici ci dissero che non c’era nessuna causa organica, e tendevano a spiegare la patologia come una malattia psicosomatica. In realtà non ci capivano niente. L’unico che pretendeva di aver capito tutto era proprio Luciano. Quando i miei strizzoni in sua presenza erano diventati abitudine, aveva smesso di preoccuparsi. Mi spogliava, mi faceva distendere sul letto e mi rimetteva al mondo con un pro- 181 lungato massaggio shiatsu. Mi tranquillizzava dicendo che non c’era nulla di allarmante, solo un po’ di stress e di debolezza fisica, come sostenevano i dottori. Cercava di farmi mangiare per rimettermi in forze, nonostante la mia inappetenza e i conati di vomito. Ma dava l’impressione di saperla più lunga. A volte se ne usciva con battutine sarcastiche sul mio infantilismo sentimentale. Spesso metteva un muso lungo peggio di un somaro bastonato. Capivo che non gradiva il rapporto infermierepaziente al quale si era ormai ridotto il nostro menage. Cercavo di parlarci, di farlo aprire, di aiutarmi a capire ciò che sembrava aver capito lui, senza risultato. I miei strizzoni addominali non facevano che esasperare il suo mutismo. “Il mio medico dice che dovrei tentare un po’ di psicoterapia. Che ne pensi?” Lo sollecitai un giorno. “Quello che può spiegarti un’analista lo puoi capire da sola.” “Io non lo capisco. Aiutami.” “Sono l’ultima persona che può aiutarti in questa faccenda.” “Non dico di aiutarmi con le spiegazioni cliniche. Puoi aiutarmi coi fatti.” “Lo vedi che non sei stupida?” “Allora perché non mi aiuti?” “Perché non posso.” “Vabbè, almeno dimmi cosa ci hai capito.” “Ho capito che stai attraversando una crisi profonda, una crisi d’identità, forse una crisi professionale. Può darsi che i tuoi gonfiori addominali vogliano simulare una gravidanza. Ecco a che ti serve la malattia. Ecco perché non sono in grado di aiutarti. Pensi che potrei darti quello che vuole la tua pancia?” “Questa è la tua diagnosi? Tutta qua la tua profonda scienza?” “Freud non poteva fare meglio. Sei un’anima semplice.” “E qual è la terapia?” “Ti devi curare da sola.” “Come?” “Crescendo.” “Non riesco a farcela da sola. Non voglio un figlio da te, ma sento che solo tu puoi aiutarmi.” “Non sarebbe più una crescita.” 182 “Non può esserci una crescita in due?” “Immagino che qualche medico ti ha consigliato la terapia di coppia.” “Esatto.” “Non ha senso.” “Perché?” “Perché non siamo una coppia.” Non ebbi la forza di reagire. Mi si era ingolfato un groppo alla gola e sentivo che stavo per sbottare a piangere. Il fuoco nel caminetto languiva. Le casse dell’hi-fi riempivano l’aria con le note struggenti del tredicesimo movimento della Passione secondo Matteo. Mi venne in mente quella scena di Accattone in cui il magnaccia si rotola per terra lottando con il cognato. Cessata la lotta con la propria sconfitta, lui si rialza in piedi adagio e se ne va in silenzio. Così feci io. Mi alzai, presi il mio soprabito e me ne andai. Fine di un amore mai nato, mi dissi. 183 Domenica, 2 giugno In mattinata telefono alle vergini folli e gli chiedo un incontro per parlare di Luciano. Inaspettatamente mi dicono subito di sì e m’invitano a prendere un tè da loro. Alle cinque del pomeriggio mi trovo davanti al tetro cancello della loro villa. Suono il campanello. Dopo un’interminabile attesa, uno scatto metallico della serratura m’invita a entrare. Sospingo il cancello esitando. Non c’è nessuno ad accogliermi. Sempre più esitante faccio un passo avanti ed entro. Mi trovo di fronte allo spettacolo di un giardino che pare abbandonato a se stesso da anni. Cespugli ed erbacce invadono i viottoli che si snodano tra quelle che devono essere state delle aiuole, mentre l’edera assale gli alberi come a volerli soffocare. C’è una miriade di fiori di cento colori che sembrano straripati dalle aiuole. Insieme all’erba formano un’ondata di vegetazione selvatica. Salendo su dalla valletta di via Cernaia, il mare di verde variopinto minaccia di aggredire tutta la grande casa, e questa a stento si sforza di dare un centro, un senso, al giardino incantato che si inerpica verso di lei. L’erba e qualche fiore s’insinuano qua e là anche tra le crepe che segnano i muri fatiscenti della villa e del recinto, dando una sfumatura di frivolezza al loro beige scalcinato. Le persiane sono serrate, o almeno lo sono quelle delle due facciate che vedo dal punto in cui mi sono fermata a osservare. Sto lì, pochi passi oltre il cancello, incantata, con l’impressione che sia piuttosto il giardino a osservare me, minacciosamente, quasi fossi un corpo estraneo che disturba la sua pace senza tempo. Non so quanto dura il momento di stupore. Vengo destata da un miagolio che mi fa voltare verso un angolo in ombra del giardino. Tra le gambe di un tavolo di marmo tutto sbocconcellato c’è un gattino nero. Mi avvicino e mi accorgo che non è solo: ce n’è un’intera nidiata nascosta tra l’erba. Mi avvicino ancora per accarezzarli, ma appena giungo a due passi da loro, da dietro i resti di una panchina sbuca una mamma gatta minacciosa che mi taglia la strada e mi costringe a fermarmi. Giro sui tacchi e mi guardo intorno. Non c’è anima viva. Mi decido ad avvicinarmi alla casa. Senza fretta, seguendo le deboli 184 tracce di un sentiero tra l’erba, costeggio la più grande delle due facciate dalle persiane sprangate. Man mano che procedo, altri quattro o cinque gatti sbucano dall’erba e mi tagliano la strada, neghittosi, osservandomi di sottecchi. Finalmente completo il mezzo giro dell’edificio, volto l’angolo e mi trovo al cospetto delle due padrone. Una delle quali si dondola pigramente su una sedia di vimini, mentre l’altra è seduta accanto a un tavolo di ferro dipinto di bianco. Appena mi vedono si alzano e mi vengono incontro sorridendo cordiali, come se non fosse passata un’eternità dal momento in cui ho suonato il campanello. “La bellezza del nostro giardino selvatico può essere meglio apprezzata in solitudine.” Dice Elvira, la più matura delle due. Ci presentiamo. La giovane si chiama Gina. Ha capelli rossi, ricci e luminosi, che incorniciano un viso pallido di cera. Due grandi occhi celesti, su un sorriso che li anima appena, si sforzano di ravvivare quel viso mesto, ma con poco successo. Delle profonde occhiaie scure riescono a dargli un po’ di vita, seppure molto spirituale. Non riesco a definirne l’età. Potrebbe essere una mia coetanea, diciamo: tra i venticinque e i trenta. L’età di Elvira invece sembra aggirasi sui quarantacinque. Pur somigliando alla giovane nei lineamenti del viso e nella figura del corpo, è un tipo del tutto diverso. Ha capelli lisci e morbidi, di un biondo carico, artificiale, che emanano riflessi dorati. Rosse le labbra carnose e sensuali. Il viso, un ovale perfetto, è di un colore ambrato che pare irradiato dagli occhi a mandorla castani. Due rughe verticali tagliano la fronte sopra al naso e danno allo sguardo un piglio severo che solo a sprazzi il sorriso affabile riesce ad ammantare d’umanità. È lei che fa le presentazioni. Nella mano sinistra ha un’elegante piccola pipa di ceramica bianca dal lungo bocchino nero. Ne esce un gagliardo profumo di Toscano con un vago accenno di hascisc. Mi fa accomodare su una sedia di vimini, mentre Gina versa quattro cucchiaini di tè nella teiera fumante, già pronta sul tavolo. Accanto ad essa stanno tre delicate quasi trasparenti tazze di ceramica celesti. Non permetto che i convenevoli durino a lungo. Dopo qualche chiacchiera vuota domando a bruciapelo: 185 “Avete avuto contatti recenti con Luciano?” “Certamente. Sono quattro mesi che lavoriamo con lui per la tesi di laurea.” È sempre Elvira che parla. Per tutto il pomeriggio dialogo praticamente soltanto con lei. L’altra si limita a dei monosillabi e si occupa di servire il tè e i pasticcini, calma e cerimoniosa più di una geisha. Ma gli occhi attenti mostrano che partecipa alla conversazione senza perdere una parola. “Una tesi di parapsicologia?” Domando. “Direi proprio di no. Lui si occupa di parapsicologia con finalità che non abbiamo capito bene.” Parla sempre al plurale, il che dà al suo discorrere un tono professorale. “Noi ci siamo interessate di storia della magia quale forma di cultura alternativa femminile. Lui sicuramente non per questa ragione. Tuttavia, qualunque fossero, i suoi interessi s’intersecavano coi nostri, e ciò ci permetteva di dialogare.” “La vostra tesi di laurea rientra in tali intersezioni?” “Sì. È un argomento che ci ha proposto lui, e ci ha subito appassionato: Il giardino Stibbert e l’occultismo europeo di fine Ottocento.” “Un tema affascinante! È per preparare questa tesi che voi e Luciano frequentavate la sala riservata della biblioteca?” “Sì e no.” “Cioè?” “È una storia lunga.” “Non ho fretta.” “Vedi, la sala contiene dei lasciti di Federigo Stibbert. È del materiale di due tipi: scartafacci personali e testi religiosi antichi. Noi siamo interessate a quello del primo tipo, lui a quello del secondo, per quanto ci fosse un po’ di sovrapposizione tra le due ricerche.” “La cosa si fa misteriosa.” “Devi sapere che il padre di Federigo Stibbert era un colonnello dell’esercito inglese. Aveva trascorso lunghi anni in India. Lì aveva combattuto molte battaglie, ma senza trascurare un qualche interesse intellettuale. Quando andò in pensione, si stabilì a Firenze, si sposò con una contadina molto più giovane di lui e cominciò una vita nuova. Mise su una casa niente male, con 186 una discreta collezione di armi antiche e una di testi religiosi portati con sé dall’India. Le due eterogenee collezioni furono arricchite dal figlio, che inoltre ingrandì la casa facendone la sontuosa villa dove ha oggi sede la LUFSS. Alla sua morte, Federigo lasciò tutto al comune di Firenze.” “È a quei libri che era interessato Luciano? Che roba è?” “Per lo più testi tantrici, sia buddisti che induisti, trattati di meditazione, yoga, magia sessuale.” “E gli altri documenti, quelli che interessano a voi?” “Sono corrispondenze, memorie, relazioni. La nostra tesi è che i due Stibbert fossero al centro di una rete segreta che collegava, e forse collega ancora, tutte le società e i gruppi occultisti occidentali. Abbiamo accertato che erano in contatto con la Golden Dawn in Inghilterra, con varie famiglie di Rosacroce in Germania, perfino in America, e con diversi gruppi simili in altri paesi europei. Secondo noi i due Stibbert, prima l’uno e poi l’altro, sono stati gli animatori dell’intero movimento occultista della loro epoca. Abbiamo trovato una memoria, di pugno dello Stibbert padre, che ricostruisce la storia della tradizione esoterica in occidente. Sostiene che il fondatore ne sarebbe stato addirittura Giulio Cesare. Il quale, al ritorno dalle Gallie, resosi conto della decadenza dei valori su cui poggiava il potere di Roma, decise di erigere un baluardo, anzi due. Il primo è noto a tutti: diede avvio al processo di fondazione dell’impero. L’altro sarebbe stato noto solo a pochi iniziati: un centro di culto segreto al dio Marte, l’ORDO, Opus Romanae Dominationis Orbis. Quindi avrebbe fondato Firenze per insediarvi questo culto. Il suo compito era di dirigere segretamente le forze che nell’impero lottavano per la salvezza della tradizione.” “Il suo di chi?” “Del centro segreto; e della città che lo accoglieva. Così, mentre Roma diventava un ricettacolo di corruzione e discordia, Firenze, piccola e appartata, cresceva come la vera Roma, una Roma occulta, dietro e a difesa di quella palese. Il dio Marte tutelava entrambe le città. L’intera storia d’Europa degli ultimi duemila anni sarebbe stata una storia di lotte tra il principio della disgregazione e il principio della tradizione. In tutti i paesi le 187 forze della tradizione sarebbero dirette da centri segreti. I quali in alcune epoche avrebbero dato vita a dei gruppi d’azione manifesti, per intervenire nella politica durante i momenti di crisi e quando era necessario fare proselitismo. I Templari, i Fedeli d’Amore, i Rosacroce, la Golden Dawn, sarebbero i più famosi di tali gruppi. Ma si tratterebbe delle manifestazioni essoteriche dell’azione del centro superiore. Questo si sarebbe sempre tenuto nascosto, accessibile solo ai cavalieri del nulla, gli alti iniziati del nucleo occulto. Ebbene, la nostra tesi è che i due Stibbert furono gran maestri del supercentro segreto e che si trasmisero la carica per via ereditaria.” A questo punto si ferma, sorseggia il suo tè, morde un pasticcino e osserva le mie reazioni di ascoltatrice allibita e perplessa. Allibita per l’assurdità del racconto fattomi dalla donna; perplessa perché, mentre lei parlava, sono stata afferrata da una sensazione di deja entendu. È una sensazione forte, ma per quanto mi sforzi di venirne a capo resta solo un rovello nella mente. Durante la conversazione il rovello continua a frullarmi nella testa come una mosca in trappola. La mia interlocutrice, imperterrita, afferra la pipa ormai spenta, la svuota, la pulisce, la ricarica e l’accende con calma. Poi riprende: “Bada bene, non sosteniamo che il contenuto di quel documento sia storia. Tuttavia dalla corrispondenza degli Stibbert risulta che le persone con cui loro erano in contatto credevano nella sua veridicità.” Si ferma di nuovo. Nota che sono ancora allibita e ne ha una reazione di compiacimento appena velato dallo sguardo severo. In effetti me ne sto lì, con la bocca aperta, a domandarmi come sia possibile che Luciano provasse interesse per una tale farragine di fregnacce. La conversazione langue per un po’. Cerco di riportarla alle cose concrete: “Non avevi detto che la vostra tesi riguarda il giardino di villa Stibbert? Che c’entra il giardino con tutto ciò?” “Il giardino fu costruito da Federigo, e rappresenta la più alta ed elaborata espressione del suo mondo spirituale. È un antilabirinto.” “Un che?” 188 “L’opposto di un labirinto. Mentre di un labirinto si tratta di trovare la via d’uscita, dell’antilabirinto si deve cercare l’entrata. Se hai mai fatto una passeggiata in quel giardino osservandolo attentamente, ti sarai accorta della sua stranezza.” “Effettivamente me ne sono accorta. Mi è sembrato la creazione di uno spirito bizzarro.” “Bizzarro sì, non insensato. Apparentemente è un incredibile guazzabuglio di simbologie magiche e religiose.” “Apparentemente?” “Sì, perché in realtà è governato da un rigoroso ordine intellettuale. Trovare la via d’entrata significa trovare il filo logico che gli dà un senso. Noi l’abbiamo cercato, quel filo, e con l’aiuto delle carte Stibbert l’abbiamo trovato infine.” Si ferma e mi scruta di nuovo con attenzione, per vedere se è riuscita a destare il mio interesse. Un po’ c’è riuscita. Afferra la teiera e si riempie la tazza di un liquido nero e freddo, ormai, che solo vagamente ricorda il tè. Ne beve un lungo sorso. Si alza e va a rovistare tra un mucchio di carte accatastate su una scrivania. L’ampio tavolo di legno scuro, tutto rovinato dall’usura e dal tempo, non è privo di una sua eleganza. Se ne sta, come appartato, accanto alla porta che collega il giardino con la veranda. Sopra c’è una pila di libri antichi, alcuni quaderni gonfi di scrittura, penne, matite, attrezzi per fumatori e un mucchio di cianfrusaglie. Tra le altre cose spicca un leggio da messale su cui giace, aperto nel mezzo, un quaderno di computisteria. È uno strano quaderno, con le pagine incartapecorite per l’uso e pieno di una scrittura fitta dalla tessitura ingarbugliata. Di fronte ad esso, un computer acceso gli restituisce, dallo schermo bluastro del monitor, una pagina limpida e ordinata, e sembra che la macchina sia stata posta lì con il preciso compito di mettere un ordine logico in quella magia di anticaglie. La ricerca di Elvira non dura a lungo. Dalle pagine di un librone ingiallito esce fuori un foglio ripiegato in quattro. Soddisfatta, la donna torna da me aprendo il foglio; si siede e me lo mostra. “Ecco una mappa del giardino. I segni rossi li abbiamo aggiunti noi. Sono il risultato del nostro lavoro di decifrazione e 189 ricostruzione. Questa linea lunga, che congiunge il punto A con il B è la spina dorsale dell’antilabirinto. In A c’è l’entrata del giardino. Ora osserva bene il punto B e cerca di localizzarlo mentalmente nei ricordi delle tue passeggiate. Cosa vedi?” “Un cancelletto di ferro.” “Esatto. Dove dà il cancelletto?” “Su un viale.” “E dove porta il viale?” Guardo attentamente la cartina. Poi rispondo: “A un certo punto si biforca su due vialetti che curvano a U e si ricongiungono con il viale principale da Est e da Ovest.” “Ti pare normale?” La guardo perplessa. Torno a guardare la cartina. Non ci vedo niente di eccezionale. “Osserva bene e rifletti.” Continua lei. “ Un cancello serve per chiudere un luogo, deve separare un luogo chiuso dall’aperto. Questo invece non chiude niente. Il suo interno dà accesso a un viale che porta su due altri viali, dai quali si può tornare all’esterno del cancello. È un cancello di cui non si sa qual è la faccia interna e quella esterna. L’esterno è interno e viceversa. I viali che congiunge sono due serpenti che si mordono la coda. Ora, a che serve un cancello se non apre e non chiude niente?” “È vero,” dico, “non ci avevo fatto caso. È molto strano. Che significa?” “Aspetta. Prima devo farti notare altre cose. Guarda: nel punto C la linea AB incontra la EF e forma con essa una croce latina. Però, se invece di partire dal punto A, partiamo dal D, ne risulta una croce greca. Se consideriamo anche le stanghette trasversali che passano nei punti E, F, B e D, abbiamo una croce potenziata. Ora seguimi bene. La linea AB separa il monte, a sinistra, dalla valle, a destra. Osserva le varie serie di scalette: sono ascendenti da destra a sinistra. Il monte rappresenta il mondo manifesto, il profano, la materia; la valle, l’occulto, il sacro, lo spirito. La linea EF invece separa il Nord dal Sud, che rappresentano il principio attivo e quello passivo delle forze dell’universo.” “Vabbè,” la interrompo, “che senso avrebbe tutto ciò?” 190 “Abbi pazienza! Intanto gli si possono dare due diverse interpretazioni, non necessariamente contrastanti: una storica e una magica. Per esempio, la croce greca è un sottoinsieme, quasi il nocciolo, della croce latina. Vuol dire che dietro e dentro la tradizione cattolica si nasconde una più antica tradizione pagana, e che la prima tende a soffocare la seconda. Il punto di congiunzione delle due croci è in D. Qui si trova la statua del Marzocco, il leone rampante simbolo di Firenze. Le cronache dicono che con l’avvento del cristianesimo Firenze cessò di essere consacrata al dio Marte e si votò a S. Giovanni Battista. Il cambiamento fu sancito provvidenzialmente da una piena dell’Arno, la quale un giorno si portò via la statua del dio Marte che troneggiava sull’accesso di Ponte Vecchio. Accadde che, mentre le autorità ecclesiastiche sostituirono la statua di S. Giovanni a quella dell’antico dio, le civili vi sostituirono il leone rampante, a cui alzarono una statua dall’altra parte del ponte, di qua d’Arno. Il leone era l’animale sacro a Marte, e il nome Marzocco deriva dalla radice Mars. Il motto iscritto sullo scudo che il leone sostiene con la zampa sinistra è Si leo ruggiet, quis non timebit, che sarebbe anche il motto del centro esoterico fondato da Cesare. Tutte le lotte intestine di questa città doppiamente sacra sarebbero manifestazione del dissidio tra i due principi religiosi che la governano, quello cattolico ed essoterico, che cerca di soffocare ogni manifestazione di paganesimo nel mondo, e quello pagano ed esoterico, che cerca invece di mantenere le redini sul collo dell’altro. Tutte le principali conquiste culturali dell’Europa moderna, Umanesimo, Rinascimento, Riforma, Rivoluzione scientifica, Illuminismo eccetera, sarebbero state covate, apertamente o in segreto, nella sua città ombelico, e sarebbero il prodotto dei tentativi della tradizione esoterica di guidare il mondo verso ciò che i profani chiamano ‘fine’. Pure tutte le ondate di reazione che hanno periodicamente investito l’Europa, Crociate interne ed esterne, Controriforma, caccie alle streghe, Inquisizione, Restaurazione, sarebbero state concepite segretamente qui, dalle forze che contrastano quella tradizione, nella città che è il cuore del continente prediletto dagli antichi dei. Questa interpre- 191 tazione ci è stata suggerita da Luciano. È un’interpretazione però che deriverebbe da una visione di parte...” “Che parte?” “Una setta, una fazione dell’ORDO, il quale sarebbe stato diviso in due partiti...” “Interessante.” La interrompo, senza nascondere un sentimento di scetticismo. “E il significato magico?” “Torniamo al cancelletto. Secondo la nostra ricostruzione, è l’accesso alla via alta per il paradiso terrestre. Alta e nobile, in quanto presuppone l’avvenuto passaggio dal principio passivo all’attivo. Il paradiso terrestre ha sede nel punto G, nell’isoletta dell’Eden, appunto. Il viaggiatore che, entrato nel mondo dal punto A, percorre la via della vita, AB, ha diverse possibilità di accesso alla valle sacra. Ognuna di queste vie rappresenta una forma di ascesi: la preghiera, l’esicasmo, lo yoga, la meditazione. La più elevata e difficile è quella che passa per il punto B. Ora viene il bello. Fai di nuovo mente locale. Riesci a visualizzare le due statue che sorgono sui bassi pilastri ai lati del cancelletto?” “Sì. Sono due statue curiose.” “Cosa hanno di curioso?” “Boh? Non saprei, ma le ho sempre percepite come molto strane.” “Pensaci bene. Una è la statua di un vecchio con tanto di barba, che porta una toga un po’ discinta. Con una mano tiene su la toga e ci si copre il seno. Se lo guardi di profilo ti accorgi che quel seno, pur coperto, appare ben prominente. Se guardi la statua da dietro, dove la toga non copre quasi niente, cogli subito le forme giovani e femminili di questo singolare vecchio. È la statua di Tiresia, il veggente che Zeus trasformò in donna per punirlo di aver separato due serpenti in amore. L’altra statua rappresenta la figura di una giovane donna, anche lei coperta da una toga che a mala pena nasconde le forme del corpo. L’impressione netta però è che si tratta di un corpo maschile, con quelle spalle larghe, quei polpacci muscolosi e quel seno piatto sotto la toga, così in contrasto con le fattezze morbide del vecchio. Inoltre, nella mano sinistra la misteriosa donna tiene un corto bastone, forse uno scettro, oppure un papiro arrotolato, un segno del po- 192 tere o della scienza, comunque un simbolo fallico. La statua rappresenta Ifi, la fanciulla che Iside trasformò in uomo per permetterle di accoppiarsi con la giovane amante.” “Intrigante! Non avevo mai fatto caso a queste stramberie.” In realtà non è che la storia m’interessi da morire, oltre alla curiosità suscitata dalle cose insolite. Mi sembra il prodotto di una gran sega mentale. Ora cerco di portare il discorso sull’argomento che mi preme maggiormente. Con un dito indico un punto della mappa. È il luogo dove è stato trovato il cadavere di Lilli. “Vedo che il braccio Nord della stanghetta che passa nel punto F termina nel tempietto egizio. Che significa?” “L’egizia è la più antica delle grandi tradizioni occidentali. È quella in cui il fondatore dell’impero avrebbe ricevuto l’iniziazione suprema. Il tempietto ha un’uscita con delle scale che danno sul lago verso l’isola dell’Eden. Rappresenta l’ultimo livello dell’iniziazione, l’ultima fase della via magico-rituale al Paradiso.” “È concepibile dunque che ci si siano tenuti dei riti magici?” “È stato costruito appositamente per questo scopo.” “Perciò la recente morte della segretaria del direttore amministrativo può essere avvenuta in un rito del genere.” Proprio mentre termino la frase, le campane della vicina chiesetta di Montughi battono le sette. Elvira si alza calma. Come se non avesse sentito la mia domanda mi fa, con tono deciso: “È tardi.” E comincia a togliere tazze e teiera dal tavolo. “Veramente avrei diverse altre domande da fare. Il tuo racconto è stato interessantissimo e mi ha incuriosito molto.” Però non riesco a recuperare. Lei mi porge la mano, gentile e perentoria nello stesso tempo. “Ormai è tardi. Per stasera basta. Il resto te lo racconteremo un altro giorno.” Conclude. 193 Lunedì, 3 giugno Vittima il preside della Facoltà di Economia NUOVO OMICIDIO RITUALE ALLA LUFSS Il cadavere dell’economista Gianrico Delandi è stato ritrovato nei giardini dell’università Indossava strani paludamenti magico-religiosi Così oggi titola in prima pagina il giornale cittadino. Leggo l’articolo tutto d’un fiato, mentre faccio colazione al bar Università. Poi corro a comprare altri giornali e mi rifugio in casa. Le notizie sono scarse. Il cadavere, pugnalato al petto, è stato scoperto ieri mattina dal guardiano dei giardini. Era vestito con antichi paramenti neri, bordati e ricamati d’oro, e stava disteso sul pavimento del cosiddetto grottino degli spiriti, a fianco del tripode di marmo che contribuisce allo scarno arredamento di quell’antro. È, questa, una strana grotta artificiale, larga come una sala da bagno, situata a una ventina di metri dal tempietto egizio in cui è stato trovato il cadavere di Lilli l’altro giorno. Il commissario di polizia, recatosi immediatamente sul posto, ha dichiarato di non avere dubbi sul collegamento dei due omicidi. Furbo! La ragione principale di tale certezza sarebbe che la strana ferita a croce trovata sui due corpi mostrerebbe che sono stati colpiti con la stessa arma. Si tratterebbe di un pugnale dalla lama insolita, a sezione di croce appunto, proprio il tipo di coltello che è stato trafugato dal vicino museo della guerra. Finito di leggere i giornali, mi reco all’ufficio di Giuliano, in Villa Fabbricotti. Lui però non c’è. La nuova segretaria non sa dirmi dov’è. Gli telefono alla sua abitazione. Non lo trovo neanche lì. Lo cerco per tutta l’università inutilmente. Verso le quattro mi stanco e torno a casa. Ed è qui che l’incontro. Sta seduto sulla mia poltrona preferita e si beve meditabondo un vodka e lime. In una mano ha dei fogli dattiloscritti. “Come hai fatto a entrare?” Gli domando dura. 194 “Con la chiave.” “Chi te l’ha data la chiave di casa mia?” “Non certo Luciano!” Mi chiedo come fa a sapere che a Luciano, unico tra i miei clienti, avevo dato le chiavi di casa? “Allora, come te la sei procurata?” “Io ottengo sempre le chiavi che m’interessano.” “E hai ottenuto anche la maledetta chiave della verità?” “Non ancora, però non dispero.” Sona incazzatissima, ma cerco di controllarmi. Lo lascio solo e vado in cucina a prepararmi un caffè. Con la tazzina in una mano torno in salotto e mi siedo davanti a lui. Sorseggio il caffè in silenzio, guardando Giuliano negli occhi senza nascondergli la mia rabbia. Appena mi sento un po’ più calma, attacco: “Che c’entra ’sta maledetta chiave della verità con gli omicidi di Luciano, Lilli e, adesso, Gianrico?” “Non ne ho idea.” “Non ci credo. La vuoi smettere di fare il misterioso? È tempo che tu mi dica tutto ciò che sai. Finora non mi hai fatto che domande, e non mi hai dato una risposta. Mi hai fatto fare delle indagini, mi hai utilizzato per scopi che non conosco; e io cosa ho ottenuto in cambio?” “Guarda che neanche tu mi sei stata molto utile. Hai indagato, indagato. Cosa hai trovato?” “Proprio niente.” “Be’, nemmeno io.” Do una sbirciata ai fogli dattiloscritti che ha in mano e mi accorgo che sono gli originali degli ultimi due capitoli del corso di Luciano. Glieli strappo di mano, arrabbiatissima. Fortuna che lo colgo di sorpresa. “Come ti sei permesso di rovistare tra le mie carte?” Lo aggredisco. “Mi sono limitato a prendere ciò che mi spetta secondo i patti. Ti ricordi? Stabilimmo che ti avrei dato una poesia di Fabrizio in cambio dei primi due capitoli degli appunti di filosofia e una di Luciano in cambio degli altri.” “Non mi sembra che fosse così.” 195 Lui tira fuori dalla tasca un foglietto ripiegato e tutto sgualcito. Lo posa sul tavolino accanto al portacenere. “Eccoti una poesia,” riprende, “ora dammi quei due capitoli. Quando li avrò decifrati, ti farò avere l’altra poesia.” “Non certo gli originali. Ti darò delle fotocopie, più tardi.” Afferro il foglietto. Lo apro con una sventagliata della mano e gli butto sopra un’occhiata. È una poesia scritta a penna stilografica, con caratteri piccoli, in linee ordinate e regolari. Mi accendo un’altra sigaretta con il mozzicone di quella che ho appena finito. Schiaccio la cicca nel portacenere e mi brucio un dito. Faccio fatica a controllarmi. Infine tiro un respiro profondo, succhiandomi mezzo litro di nicotina, e riprendo: “Mi vuoi spiegare per favore cosa cerchi in questi cazzo di appunti di filosofia?” “La chiave della verità!” Con un sorriso beffardo. “Sii serio, per favore.” “Vedi, mi sono accorto che il messaggio nascosto nel secondo capitolo non era quello giusto. Ricordi? Ero arrivato alla conclusione che la parola cercata fosse GIANRICO.” “Invece il messaggio vero era un altro.” “Quale?” Domanda, ansioso. “Lo stesso del primo capitolo: Cerca oltre cerca ancora cerca.” “Come hai fatto a trovarlo? Ci ho provato anch’io, e ho cercato questo risultato. Ma il codice che valeva nel primo capitolo non ha portato a nulla col secondo?” “Infatti. Bisogna cambiare codice. Però bisogna farlo restando fedeli al primo. Non ti svelerò quello nuovo, ad ogni modo. Dovrai trovartelo da solo. Evidentemente il codice con cui avevi trovato GIANRICO era sbagliato.” “Evidentemente era sbagliato. Interpreteresti Cerca Oltre come un suggerimento di cercare nel capitolo successivo?” “Boh? Non me ne frega niente.” “Voglio decifrare il terzo. Naturalmente ti dirò la soluzione.” “Naturalmente. Con un’alta probabilità che sia di nuovo sbagliata. E poi che me ne faccio della soluzione, se non mi spieghi a che serve? Insomma, dove devono portare le soluzioni di tutti questi enigmi?” 196 “Mia cara, è ovvio: alla chiave della verità.” Andiamo avanti così per un’altra oretta, e non riesco a strappargli un’informazione utile che sia una. Alla fine mi stufo. Prendo da un cassetto le fotocopie dei due capitoli, che avevo pronte da tempo, gliele consegno e lo congedo di mala grazia. Sono le sette di sera. Già mi sento stanca morta. Mi riempio un bicchiere di cognac e mi metto subito alla scrivania. Verso le undici, proprio mentre sto scrivendo queste note, mi telefona Giuliano tutto ringalluzzito per dirmi che già ha decifrato il terzo capitolo. La soluzione dell’enigma sarebbe il nome di Silvio, guarda caso. Stavolta neanche gli chiedo di rivelarmi il codice. Tanto mi pare una castronata. Tuttavia dopo me ne pento. Tiro fuori il capitolo e mi metto alla ricerca del messaggio senza molto entusiasmo. Difatti dopo mezz’ora mi stanco e lascio perdere. Avevo avuto una lunga conversazione con Silvio diversi giorni appresso a quello in cui avevo lasciato Luciano andandomene via come un Accattone sconfitto. Dopo la debacle avevo raccolto tutte le mie forze e deciso di reagire virilmente alla disfatta. Una bella mattina andai al dipartimento di Sociologia durante l’ora di ricevimento di Silvio. Attesi che se ne fossero andati gli altri studenti ed entrai nella sua stanza con decisione. Mi sedetti sulla sedia davanti alla scrivania e lo affrontai in modo formale: “Professore, vorrei fare la tesi di laurea con lei.” “Andiamo cara, lascia perdere il professore. Tra noi possiamo parlare teneramente. Dimmi cosa ti frulla per la testa.” “Semplicemente quello che ho detto. Ormai mi mancano solo tre esami per completare il piano di studi. Quindi vorrei cominciare a lavorare alla tesi.” “Hai un’idea sull’argomento?” “Sì, qualcosa sulla filosofia della scienza nel giovane Marx e la sua critica all’idealismo.” “Non mi dire altro. Già so chi ti ha ficcato in testa quest’idea.” “Come fai a saperlo?” “So che qualche mese fa il tuo amico del cuore ha tenuto un seminario sul tema. Io non sono andato a sentirlo, ma mi hanno 197 riferito cose turche. L’aula era piena di marxisti ortodossi, che l’hanno attaccato violentemente...” “Proprio così,” lo interruppi, “io c’ero a quel seminario e ne sono rimasta conquistata.” “Sai dirmi perché i marxisti-leninisti lo attaccarono?” “Dissero che era un revisionista anarchicheggiante scettico e piccolo-borghese.” “E lui?” “Disse che loro erano i soliti compagnucci della parrocchietta.” “Cosa aveva sostenuto di tanto eretico da guadagnarsi la condanna dei preti rossi?” “Niente meno che questo: che non esiste il Marx, che ne esistono diversi, e nel periodo giovanile almeno due. Li chiamava Dottor Marx e Mister Karl.” “Ah, ah, ah. È una storia che ho già sentito…” Non gli diedi tregua. Lo interruppi di nuovo e lo incalzai: “È la doppia anima che m’intriga. Ho avuto l’impressione che Luciano parlasse un po’ di se stesso…” Stavolta fu lui a interrompermi: “Ah, qui ti sbagli di grosso. Lui ha un’anima molto più che doppia. Senz’altro però ha una certa doppiezza d’animo.” “Non m’interessa la psicologia, ma la filosofia della scienza, e non Luciano ma il giovane Marx.” Conclusi, negando quel che avevo rivelato poco prima. Lui si alzò dalla sua sedia dietro la scrivania, si andò a sbracare su un divano all’altro angolo della stanza e m’invitò ad accomodarmi su una poltroncina lì davanti. Ci addentrammo in una discussione epistemologica che non durò meno di mezz’ora. Pur essendo entrambi interessati alla psicologia del personaggio, cercammo di buttarla sul filosofico. Alla fine della conversazione lui mi disse che gli sembravo preparata e che davo l’impressione di aver approfondito l’argomento. Mi chiese cosa avevo letto sul tema. Avevo letto poco e niente. Glielo dissi. Ne avevo comunque parlato con Luciano, e ora avevo voglia di approfondire con uno studio serio. “Allora perché non la fai con lui la tesi?” Mi sorprese. 198 “È l’ultima persona con cui vorrei studiare.” “Già, visto che è lui che vorresti studiare.” Mi rivelò di non sentirsi preparato sulla materia e insistette perché andassi da Luciano. Io tenni duro, né esitai a fargli capire che c’erano dei motivi personali a impedirmi di rivolgermi al suo assistente. Ci lasciammo senza quagliare. Restammo d’accordo che ci avremmo pensato entrambi e ci saremmo rivisti la settimana successiva per decidere il da farsi. Due giorni dopo mi telefonò Luciano. Silvio gli aveva parlato del mio progetto di tesi. “Perché non vuoi farla con me?” Domandò. “Non fare l’idiota. Lo sai benissimo perché.” “Sentiamo.” “Non voglio vederti.” Tagliai corto. Lui rimase in silenzio per qualche secondo. Riprese esitante, bofonchiando delle scuse. Ma io non gli diedi spago. Parlavo poco e per monosillabi. Lo sentivo imbarazzato. Si era pentito per la superficialità del suo comportamento. Anzi, si rendeva conto di essere stato piuttosto rozzo e gli dispiaceva molto. Poi mi propose di rivederci. Rifiutati seccamente. Allora s’informò sulla mia salute e manifestò un premuroso dispiacere al sentire che era peggiorata. Dopo quella chiacchierata continuò a telefonarmi, un giorno sì e uno no. Mi proibii di rivederlo. Non avevo voglia di fare niente, mangiavo pochissimo e dimagrivo paurosamente. All’appuntamento con Silvio non ci andai e accantonai l’idea di mettermi a lavorare alla tesi. Alla fine volli dare un taglio secco. Ingiunsi a Luciano di non telefonarmi più e seguii il consiglio di un medico secondo il quale nessuna medicina poteva guarirmi meglio di una vacanza in montagna. Era appena iniziata l’estate e decisi di passarla in Alto Adige. Una sera prenotai in una pensioncina in Val d’Ultimo. La mattina appresso mi misi in macchina e la raggiunsi nel primo pomeriggio. L’aria era fresca, trasparente. La casetta sorgeva a mezza costa di una montagna verde, al limitare di un bosco di abeti. Dal balcone della stanza che mi fu assegnata si godeva un vista idilliaca sulla valle sottostante e i monti maestosi che la delimitava- 199 no verso Sud. A Ovest la valle proseguiva in leggera ascesa per terminare ai piedi dello Sternai, un massiccio dalla cima innevata e i fianchi rocciosi ingrigiti da una tenue foschia. Bastò quella vista per cominciare a squarciare il grigiore che mi offuscava l’anima. Ci restai per due mesi. La signora Maria, una sudtirolese energica che parlava uno stentato italiano, gestiva la pensione e i turisti come fosse una grande famiglia. Mi prese subito a ben volere. All’inizio feci resistenza. Me ne stavo chiusa nella mia camera tutto il giorno, a leggere romanzi rosa, al massimo affacciandomi al balcone di quando in quando. Lei mi faceva portare i pasti in camera da una delle due giovani figlie. Quando vide che i vassoi le tornavano in cucina quasi intatti, cominciò a interessarsi a me con attenzioni materne. La mattina prese a venire lei a rifarmi la stanza, e quando era lì mi coinvolgeva in conversazioni insignificanti sulla sua vita grama: quattro giovani figli da accudire, due maschi e due femmine, e il marito che era sempre assente, l’estate ad alpeggiare le vacche in alta montagna, l’inverno a lavorare in una fabbrica di liquori a Merano. Lei non ce la faceva a stare appresso a tutto, specialmente l’estate con la gestione della pensione, l’orto, gli animali, la cucina, la spesa, le pulizie, la contabilità. Qualche volta mi portava la colazione lei stessa e si metteva a mangiare con me, forzandomi a trangugiare qualcosa. Un giorno, essendosi ammalata la sguattera, mi chiese di darle una mano in cucina. Lo feci volentieri, e lei m’insegnò a preparare alcuni piatti tipici sudtirolesi. Speciale era la torta al papavero, una sorta di pan di Spagna corposo, infarcito di semi della pianta oppiacea. Mi piacque subito e imparai a mangiarne delle discrete quantità a colazione e a cena. Aveva un effetto rilassante, leggermente soporifero. Pian piano ripresi a mangiare. A pranzo spilluzzicavo qualcosa in cucina con Maria. La mattina presto lei mi mandava alla stalla a mungere Nerina e Bianchina, le due vacche di cui si occupava la figlia tredicenne Erika. Il primo bicchiere di latte, prelevato direttamente dal secchio pieno, era riservato a me, ancora caldo di mammella, senza neanche bollirlo, e guai se rifiutavo. 200 Qualche volta mi mandava a prendere le uova nel pollaio o a cogliere i broccoli nell’orto. Un giorno mi chiese di aiutare Heinz, il figlio quattordicenne, ad ammazzare due conigli per la cena. Quando vide che esitavo, “vai, vai, non mi fare la schizzinosa,” disse, “se ne occuperà Heinz, tu devi solo tenere i conigli fermi mentre li sgozza.” Lo feci, e non m’impressionò più di tanto. Dopo tre settimane di questo regime, mi erano tornate un po’ di forze, non dico la gioia di vivere, ma almeno ero ingrassata di un chilo. E senza che me ne accorgessi, mi erano cessati gli strizzoni. La pancia mi si era un po’ sgonfiata e la notte riuscivo a dormire addirittura per sei ore di seguito. La mattina mi svegliavo prima dell’alba, uscivo in balcone a respirare ampie boccate di aria frizzante, poi mi vestivo e scendevo in cucina, dove mi attendeva la colazione da preparare per i villeggianti. Quando Maria mi chiese di accompagnare Heinz all’alpeggio per portare degli attrezzi al padre e riportare giù delle forme di cacio, accettai subito. La passione per le escursioni in montagna non mi era passata, anche se fino a quel momento non mi ero mai allontanata dalla pensione. Ora mi sentivo in condizioni di provare qualche esperienza ardita, e lo presi per un segno di guarigione. Dopo l’ascesa con Heinz, presi a fare delle scalate in solitario, metodicamente, due o tre volte a settimana. Mi alzavo alle sei, trangugiavo qualcosa e poi riempivo lo zaino: panini allo speck e al formaggio, una lattina di birra, due barrette di cioccolata, biancheria di ricambio, borraccia, coltello, poncho, cartina Kompass, binocolo e bussola. Alle sei e mezzo ero già in cammino. Tornavo verso le cinque pomeridiane. Il primo tratto lo facevo attraverso prati di erba medica, salutando i contadini alla fienaggione. Il secondo era tra i boschi, freschi, oscuri, silenziosi. Quindi raggiungevo la parte brulla della montagna. I sentieri si snodavano tra le rocce ripidi e sdrucciolevoli, imponendomi la massima attenzione. La fatica era tanta, il pericolo non meno. Affrontare l’ascesa in solitudine era un’impresa temeraria che mi suscitava uno strano sentimento misto di potenza e timor panico. Quando mi avvicinavo alle creste, 201 le rocce si facevano irte, i sentieri si perdevano tra di esse, e spesso dovevo procedere aiutandomi con le mani. Di solito giungevo alle creste quando il sole era alto. Per il caldo e la fatica il sudore mi colava lungo la schiena. Allora mi toglievo la camicetta e procedevo prendendo la tintarella. Infine arrivavo in cima. Qualche volta ci trovavo escursionisti che si erano svegliati prima di me, più spesso mi ritrovavo sola. Mi sedevo su una roccia, mi volgevo verso la valle e mi estasiavo, colmandomi di una sensazione di pace. Una volta riposata, mangiavo, bevevo, fumavo e poi mi stendevo seminuda al sole per non meno di un’ora, la mente vuota, il corpo rilassato, il sangue che pulsava nelle tempie, il respiro che usciva lieve dai polmoni portandosi via tutti i mali dell’inferno. Le discese erano più rapide ma ugualmente faticose. Le affrontavo con un senso di appagamento che mi disponeva alla meditazione. Era durante quelle camminate verso l’adempimento di una giornata proficua che attivavo la mia terapia spirituale. Niente di particolarmente astruso, niente autoanalisi, tanto meno rievocazioni di cose dette, di colpe, di errori fatti, di orrori subiti. Solo un po’ di cinismo spicciolo, banali riflessioni sul senso della vita, che non c’è, sulla miseria morale dell’uomo, sull’assoluta nostra incapacità di determinare alcunché del nostro destino, sull’inutilità delle mete da raggiungere, di ogni meta, di ogni speranza. Cerca oltre cerca ancora cerca? Figuriamoci! Ma cosa? Ma perché? Allora la mia mente si svuotava di qualsiasi ambizione, di qualsiasi miraggio. E con i sogni se ne andavano gli incubi. Quando infine giungevo alla pensione, mi bastava il sorriso materno di Maria per rimettermi in pace col mondo e con me stessa. Una regola aurea si consolidava nel mio animo: prendi le cose come vengono, senza lottare, senza desiderare. Se non c’è senso, non c’è colpa. Non gioia, né dolore. È con questo stato d’animo che tornai a Firenze. Appena arrivata, andai a trovare Silvio per dirgli che non avevo problemi a fare la tesi con Luciano. Lui lo chiamò al telefono e nel giro di un quarto d’ora me lo ritrovai davanti. Lo salutai con fare distaccato. Gli dissi brevemente del progetto di tesi e gli chiesi di farmi da relatore. La prima cosa che mi domandò è se avevo sostenuto 202 esami di matematica. No, neanche uno, essendo facoltativi e del tutto inutili per lo studio della sociologia. Lui fu categorico: dovevo farne almeno due, se volevo averlo come relatore. “A che mi serve la matematica, se la tesi è sul giovane Marx?” “Non fare la lavativa. Devi mettere in cantiere due esami di matematica e uno di economia politica.” Mi faceva imbestialire quando assumeva quei toni autoritari. Mi veniva voglia di prenderlo a schiaffi. Ma non ci fu niente da fare. Lui era il supervisore e io la laureanda. Dovevo piegarmi. Così fui costretta a modificare il piano di studi, togliere i tre esami che mi ero lasciata per ultimi, tra i più facili, e inserire i tre più difficili, e perdere altri sei mesi di tempo. Mandai giù il rospo. Poi, mentre il preside rideva sotto i baffi, presi dalle mani di Luciano il foglio con la bibliografia che aveva già preparato, salutai i miei due polli e me ne andai incazzata. 203 QUADERNO 3 Martedì, 4 giugno La prima cosa che faccio stamani è una telefonata a Silvio per informarlo di ciò che Giuliano ha scoperto. O è meglio dire inventato? Silvio non riesce a prendere la cosa con filosofia. Quando gli dico che il messaggio decifrato non sarebbe altro che il suo nome, mi risponde con un lungo silenzio, ma un silenzio così eloquente che mi sembra di vedermelo davanti, il feroce coniglio, il viso che gli si fa più pallido di un lenzuolo. Con voce tremante mi fa: “È la mia condanna a morte.” E riattacca. Certo che c’è da essere preoccupati. Giuliano scopre che la chiave dell’enigma è il nome di Lilli, e il giorno dopo Lilli muore. Poi scopre che la chiave è il nome di Gianrico, e il giorno dopo questi muore. Nei panni di Silvio avrei già preso il primo aereo per il Brasile. Però non è solo lui ad avere paura. Alle due del pomeriggio, mentre sto per farmi una pennichella e recuperare il sonno perduto nelle ultime notti, suonano alla porta. Vado ad aprire un po’ assonnata e un po’ scocciata. È Lucrezia. Mi guarda con quegli occhi sperduti che non sanno nascondere niente. La faccio accomodare nel salotto verde e cerco di metterla a suo agio: “Sono felice e sorpresa. Non mi aspettavo che ricambiassi la mia visita tanto presto.” “Già. Neanch’io.” Silenzio. Dopo un po’ riprendo: “Cosa c’è che non va?” “Ho sempre più paura.” 205 “Di chi? Di Giuliano?” “Sì. Stamattina è venuto di nuovo a casa mia e mi ha sottoposto a un vero e proprio interrogatorio.” “Che voleva?” “Vallo a capire! Mi ha domandato un sacco di cose. Prima ha voluto sapere di me. Mi ha chiesto dei miei movimenti giorno per giorno, a partire dai cinque precedenti l’omicidio di Luciano. Era così duro, deciso... Pareva un poliziotto. Io, paralizzata, rispondevo alle sue domande come una colpevole. Poi ha voluto sapere dei rapporti di Luciano con Lilli, Gianrico, Silvio e te. Infine è passato a Fabrizio.” “Che voleva sapere di Fabrizio?” “Insisteva sulla corrispondenza tra lui e Luciano. Voleva vederla. A quel punto però avevo ripreso il controllo di me.” “Naturalmente non glie l’hai data la corrispondenza.” “Naturalmente. Da quando è morto Luciano, passo delle giornate intere a scartabellare alla sua scrivania. Ho trovato un voluminoso pacco di corrispondenza che inizia con l’epoca del processo a Fabrizio e continua fino a poche settimane fa.” “Che avevano da scriversi quei due?” “Sembra un epistolario settecentesco, tutto pieno di filosofia e teoria politica. Più politica agli inizi, poi sempre più filosofia. Infine, in epoca recente, ha assunto toni letterari e spirituali, quasi intimistici. Mi domando: come faceva Giuliano a sapere di questa corrispondenza?” “Glielo ha detto Luciano.” “Che ne sai tu?” Mi fa, meravigliata. “Ho assistito a una loro discussione. Vedi, ogni tanto cercavo di metterli insieme quei due. Mi piaceva vederli discutere. Erano due uomini che m’interessavano parecchio, così diversi l’uno dall’altro! Luciano, scettico e introverso, è l’incarnazione dell’intellettuale disadattato. Giuliano, al contrario, è un uomo d’azione, cinico e determinato, e non meno intelligente dell’amico. La sua intelligenza lo mette in condizioni di avere delle idee chiare su qualsiasi problema in cui scopre un motivo di interesse pratico. Luciano invece dava l’impressione di usare la propria so- 206 lo per confondere le idee, agli altri e a se stesso. Insomma, due gemelli, ma: l’ombra e il baleno.” “Gemelli?” “Sì, ti sembrerà strano. Avevano molto in comune, qualcosa che non saprei definire, però di profondo. Fatto sta che quel giorno il discorso andò a finire su Fabrizio Gledo. Luciano parlò della corrispondenza che teneva con lui e di come coltivasse la dissociazione del comune amico.” “Be’, c’è riuscito: è di poche settimane la notizia che Fabrizio è entrato nel novero dei dissociati.” “Lo so.” La interrompo per non perdere il filo del discorso. “Credo anche di aver capito il senso di tutta quella storia. Sul problema del terrore Giuliano e Luciano avevano discusso accanitamente un giorno che si erano incontrati qui da me. Per Giuliano il terrorismo è un fenomeno d’infantilismo politico, la conseguenza sociale dell’incapacità psicologica di accettare la sconfitta del movimento. Luciano invece sosteneva che le radici del male sono più profonde e che vanno ricercate nel tentativo di proiettare nel sociale un terrore di natura spirituale. La psiche dei brigatisti – diceva – è devastata dal risentimento verso la società e dal connesso senso di persecuzione. Nel loro rifiuto della realtà i brigatisti maturano una solitudine totale. Dall’incapacità di sopportarla derivano il senso di debolezza esistenziale e la disperata paura dell’altro da cui nasce la lotta armata. L’aggressione preventiva serve a tenere a bada l’ansia generata dalla paura dell’aggressione nemica. La loro esibizione di potenza nel colpire lo stato serve a provare la sua vulnerabilità e quindi a ridurre la sua capacità distruttiva. Quanto più violenta è la loro azione, tanto maggiore la sua efficacia nell’erigere una barriera contro l’ansia. Nello stesso tempo, d’altra parte, quanto più aggressivo è il loro atteggiamento, tanto più forte la paura che il nemico reagisca violentemente. Il terrore proiettato verso l’esterno quindi, mentre alza delle difese contro l’ansia, aggrava le manie di persecuzione e fa aumentare il terrore interiore. Questo circolo vizioso spinge i terroristi a scegliere bersagli sempre più grandi e azioni sempre più violente. La cosa ovviamente non può durare all’infinito, in quanto gli individui, come anche i gruppetti di 207 venti persone, sono incapaci di distruggere la società. Può terminare solo con l’autodistruzione del terrorismo, cioè dei terroristi stessi, col suicidio o il pentimento.” “Be’, suicidio e pentimento non sono la stessa cosa.” “Secondo Luciano sì, poiché il pentimento comporta l’abbandono completo della propria anima nelle mani del nemico. Al pari di un guerriero sconfitto che si dà schiavo al vincitore, il pentito rinuncia semplicemente a sé stesso. Non è un caso che tutti i pentiti usciti di galera dopo avere confessato le proprie colpe e quelle dei complici sono diventati dei lemuri – diceva lui.” “Per questo Luciano cercava di spingere Fabrizio alla dissociazione piuttosto che al pentimento?” “Credo di sì. Il dissociato riconosce la sconfitta e cede le armi. Sconta la pena ma salva l’anima. Il pentito no, lui è un dannato: si dà anima e corpo al nemico. Un pentito è come un morto. E la sua stessa sopravvivenza civile, a dispetto della morte spirituale, è prova dell’onnipotenza dello stato. Su un punto Luciano insisteva particolarmente: che non è lo stato a sconfiggere i terroristi; sono loro stessi che alla fine devono autodistruggersi. Lo stato può influire solo sui modi. Può essere un colpo di mitra o l’assoluzione in confessionale. In entrambi i casi è sempre e soltanto lui, l’uomo, che, più o meno consapevolmente, ha deciso di porre fine alla propria esistenza di uomo. Ricordo che questa discussione avvenne all’indomani della condanna in primo grado di Gaddi, condanna che Luciano prendeva a esemplificazione della propria tesi.” “Com’è possibile?” M’interrompe. “Ti riferisci al Gaddi che è stato accusato di essere il mandante dell’omicidio del commissario Pugliesi?” “Proprio lui.” “Non capisco. Lo sanno tutti che quello di Gaddi non era un gruppo terroristico. Nel quale gruppo, tra l’altro, avevamo militato io, Luciano, Giuliano...” “E Fabrizio.” “Sì, però prima che lui entrasse in clandestinità. Quanto a noi, io, Luciano e Giuliano, non sapevamo neanche che esistesse un livello occulto dell’organizzazione.” 208 “Ah, no? Non avevano formato una setta segreta i tre amici?” “Che c’entra? Quello era solo un gioco innocente.” “Ne sei sicura?” “Ma sì!” Risponde, con un sorriso di sufficienza. “Non ti far prendere da certe fantasie romanzesche. Non credere a tutto ciò che ti può aver raccontato quella strega di Lilli. Ad ogni modo, per tornare al processo Gaddi, non sono emerse prove evidenti che lui era il mandante dell’omicidio Pugliesi. Così il verdetto di condanna è stato una sorpresa per tutti.” “Luciano batteva precisamente su questo punto: nonostante che il processo non ha dimostrato la colpevolezza di Gaddi, i giudici lo hanno condannato.” “Evidentemente erano prevenuti...” “No. La tesi di Luciano,” le spiego diligentemente, “era che i giudici avevano seri dubbi sull’innocenza di Gaddi riguardo allo specifico reato di cui era accusato, e nell’incertezza lo hanno condannato. Né sarebbe questa l’unica stranezza. Ancora più strano, secondo lui, il fatto che l’imputato, pur continuando a dichiararsi innocente, dopo la condanna in primo grado ha rinunciato a ricorrere in appello. Non doveva rinunciare, secondo Luciano. Per un innocente il diritto a un giudizio di secondo grado è anche un dovere. E non è soltanto un problema giuridico, ma morale e politico, specialmente per uno come Gaddi, che ha assunto su di sé una condanna impartita a un’intera generazione. O non riconosceva legittimità a quel tribunale oppure aveva il dovere di lottare per dimostrare la propria innocenza. Se rinuncia a ricorrere in appello di fronte a una sentenza ingiusta, di fatto e di diritto ne ammette la legittimità e si riconosce colpevole, ratificando colpevole l’intera generazione che rappresenta sul banco degli imputati. Così la pensava il tuo compagno. Su questo punto si accese una discussione accanita tra lui e Giuliano.” “Posso immaginarla. Giuliano avrà detto che Gaddi non era così ferrato nella filosofia del diritto.” “No. Sosteneva due tesi. Primo: che Gaddi non si considerava più un leader e dunque che lottava solo per se stesso, fregandosene di tutti quelli che lo sostenevano riconoscendosi in lui. Secon- 209 do: che la rinuncia a ricorrere in appello era la conseguenza di una specie di bluff andato male.” “Un bluff andato male?” “Secondo lui,” riprendo la spiegazione, “Gaddi ha cercato di forzare la mano ai giudici. Siccome oggi in Italia non è ammessa l’assoluzione per insufficienza di prove, succede che nei casi incerti i giudici di primo grado tendono a condannare. L’assoluzione comporterebbe il rischio di assolvere un colpevole. Il giudice di primo grado, di fronte a prove insufficienti per condannare, è portato a pensare siano insufficienti per assolvere, fiducioso che un eventuale errore può sempre essere corretto in secondo grado.” “Insomma, se ho ben capito, in caso d’incertezza il giudice di primo grado tenderebbe, con una condanna, a scaricare la patata bollente su quello di secondo.” “Più o meno. Prima che la corte emanasse la sentenza, Gaddi aveva dichiarato pubblicamente di rinunciare in ogni caso al ricorso, accettando il verdetto come definitivo qualunque fosse. Così, secondo Giuliano, pensava di mettere i giudici con le spalle al muro.” “Cioè di forzargli la mano e costringerli ad assolvere in caso d’insufficienza di prove.” “In realtà un’arma a doppio taglio. Perché, una volta condannato, per non sputtanarsi non ha potuto fare ricorso in appello. In altri termini si è fregato con le proprie mani.” “Mi sembra una spiegazione sensata.” Fa lei, con l’aria di chi non è convinta. “Non lo sembrava a Luciano.” “C’era da aspettarselo. Cos’è che non gli andava?” “Gli pareva semplicistica. Lui sosteneva che Gaddi era perfettamente consapevole del fatto che con lui stavano processando il Sessantotto e che cercò di farsi carico a modo suo di questa responsabilità. Ma lo fece nella maniera sbagliata.” “Vale a dire?” “Da pentito. In tutte le sue deposizioni Gaddi ha sempre mostrato un sincero pentimento per le colpe vere che la società gli attribuiva, che lui stesso si attribuiva...” 210 “Scherzi?” “Fammi finire. L’imputato, sebbene si dichiarasse innocente di quell’omicidio, si riteneva pienamente responsabile del clima morale entro cui il delitto era maturato. Con i suoi articoli sul giornale del gruppo, con i comizi, le manifestazioni e tutto il resto, aveva prima incitato all’assassinio e poi l’aveva giustificato. L’ammissione di responsabilità, sempre secondo Luciano, era ancora una manifestazione di quella sopravvalutazione di sé che è tipica dei leader. Gaddi ha continuato a credersi un piccolo Lenin, pur molto tempo dopo che il gruppo che dirigeva si era sciolto. Anzi, nella sua smisurata presunzione si è eretto a leader di un’intera generazione, anche di quelli, la gran massa del movimento, che non avevano vissuto la contestazione come un gioco al massacro, che non lo avevano seguito nel gioco dell’insurrezione. Ebbene quell’erronea convinzione lo aveva messo in una posizione insostenibile al processo: ora doveva dar conto di azioni e pensieri di un’epoca che aveva superato, ma delle quali non poteva considerarsi non responsabile. Il Gaddi di oggi, che doveva difendere il Gaddi di ieri, aveva da tempo rinnegato l’avventura rivoluzionaria. Sta di fatto che l’accusa se ne fregava del Gaddi di oggi. Era quello di ieri che voleva condannare.” “Certo, un bel dilemma per lui.” “Dal quale è uscito nel modo peggiore: accettando il punto di vista dell’accusa. Ripudiando il Gaddi di ieri e riconoscendone la colpevolezza, se non giuridica, almeno morale, tutti i suoi interventi difensivi sono stati in realtà dei micidiali atti di autoaccusa. Nell’ingenua convinzione che il pubblico ministero cercasse il mandante vero dell’omicidio Pugliesi e non quello morale, Gaddi ha riconosciuto le proprie colpe. Come quando una vittima si piega alle convinzioni e alla volontà dell’inquisitore per accattivarsene la benevolenza e il perdono, Gaddi ha messo la testa nel cappio con slancio. Così si è condannato da sé, e i giudici ne hanno preso atto. La sua ammissione di colpa morale è stata plausibilmente presa come un’inconscia confessione di colpevolezza. Il pentimento di Gaddi era sincero. Lui veramente aveva ripudiato il proprio passato. Così il bisogno della società di condannare un’epoca si è incontrato con il bisogno di espiazione di 211 un pentito. La condanna che ha ricevuto, Gaddi se l’è cercata e se l’è meritata. E se non ha chiesto un giudizio d’appello, è perché in effetti, intimamente, non l’ha ritenuto necessario. Vedrai che non chiederà manco la grazia. Questo sosteneva Luciano.” “Una spiegazione niente male. Mi pare più sensata di quella di Giuliano. Però ci sono due cose che non mi quadrano.” “Sentiamo?” “Primo, i pentiti ottengono il perdono in cambio della denuncia dei complici.” “Gaddi ha fatto una chiamata di correo per tutta una generazione, anche di quella parte, la stragrande maggioranza, che non aveva le sue colpe. Il massimo dell’infamia. Vai avanti: Secondo?” “Secondo, hanno un interesse materiale: oltre al perdono, ottengono un condono della pena. Dov’è l’interesse di Gaddi, se non va in appello e non chiede la grazia?” “Vedrai che riceverà il suo condono, e nel modo più umiliante.” “In che modo?” “Lo butteranno fuori del carcere come infermo.” “Tu pensi?” “Torniamo ai fatti.” Dico. “Stavamo parlando della corrispondenza tra Fabrizio e Luciano.” Per segnare il passaggio, mi alzo e vado in cucina a preparare un caffè. Sono le cinque ormai. Lucrezia mi raggiunge e si mette ad aiutarmi. Prende un vassoio, ci versa dei pasticcini e ne mangia uno mentre mi guarda armeggiare con la moka. Torniamo in salotto con i due vassoi in mano, il suo pieno di pasticcini, il mio pesante di caffettiera e tazzine. Ci sediamo sul divano quasi toccandoci. Mentre sorseggio il mio caffè, mi volto verso di lei guardandola negli occhi e le faccio una domanda diretta: “Cosa voleva precisamente da te Giuliano?” “Voleva quella corrispondenza. In particolare ha insistito per una poesia. Era molto bene informato.” “Una poesia?” 212 “Sì. Una poesia di Fabrizio. Doveva trovarsi in una sua lettera. Mi sono domandata come faceva Giuliano a saperlo, anche se ora capisco che può averglielo rivelato Luciano.” “Ti ha detto perché la voleva?” “Sì. Perché poteva contenere la chiave di un certo enigma che lui stava cercando di risolvere.” “E gliel’hai data?” “No.” “A me la daresti?” “Non ce l’ho.” Bisbiglia, con uno sguardo dolce di bambina. Poi: “Però ho la lettera di Fabrizio, nella quale c’è il titolo della poesia. L’ho portata apposta per te. La lettera è strappata a mezza pagina e qualcuno, forse Luciano stesso, s’è portato via la metà con la poesia.” Tira fuori un foglio di carta intestata al Carcere di Massima Sicurezza G. Pugliesi e me lo mostra. Eccone il contenuto. Caro Luciano, ho ricominciato a scrivere poesie. Te ne invio una che è un po’ la ritrattazione di quella follia di tanti anni fa, quella su cui litigammo così duramente, quando tra noi si aprì il baratro. Sono passati quasi vent’anni e mi sembra ieri. Finalmente credo di doverti dare ragione. Questa poesia si spiega con quella. Il titolo è ‘P3+A-8xS-8 con leggero white noise’. Oulipeggia un po’, ma tu la capirai. Usa lo Zingarelli e il Worterbuch Sansoni. “Che ci capisci?” Domanda. “Niente. Eppure il titolo mi ricorda qualcosa.” “Certo: è la formula enunciata da Luciano all’inizio della riunione nella torre del cielo. Ricordi?” “La notte dell’orgia! È vero!” Dico, quasi gridando. “Che significa?” “Vallo a capire.” “Però quel riferimento a un’altra poesia mi fa venire in mente una cosa raccontatami da Giuliano.” “Cioè?” “Cioè che molto tempo fa,” spiego, “quando stava meditando l’entrata in clandestinità, Fabrizio aveva scritto una poesia che 213 era stata occasione di una discussione accanita con Luciano. Potrebbe essere quella a cui si riferisce nella lettera.” “Se potessimo averla...” “Ce l’abbiamo.” E le dico del foglio datomi da Giuliano in cambio degli appunti del Nuovo corso di filosofia nel boudoir. Le spiego tutta la storia degli appunti e di quanto Giuliano ne è ossessionato. Vado avanti per qualche minuto, fino a che lei m’interrompe bruscamente per dirmi: “Quei capitoli che tu hai, non erano gli unici. Ce n’è un quinto tra le carte di Luciano. Te ne avevo già accennato.” “Non mi avevi detto che era un capitolo del Nuovo corso. Luciano non me ne aveva mai parlato. Perché mi ha passato solo quattro capitoli se ce n’erano cinque?” “Forse perché il quinto era ancora provvisorio. In effetti è poco più di una serie di scarabocchi, con grafici e formule matematiche di un astruso che non ci si capisce niente.” “Lo hai fatto vedere a Giuliano?” “Certo che no. Anche su questo lui ha insistito.” “Vuoi dire che ne conosceva l’esistenza?” “Esatto.” “Hai fatto bene a non darglielo. A me lo faresti vedere?” “Naturalmente. Ho provato a studiarlo, senza approdare a nulla. Possiamo cercare di decifrarlo insieme, se si tratta di qualcosa da decifrare. Domani faccio una fotocopia e te la do. Ora vediamo la poesia di Fabrizio.” Non posso dirle di no. E, pensandoci bene, non ne ho motivo. Mi alzo. Vado alla scrivania, apro il cassetto e tiro fuori il foglio con la famigerata poesia. Torno a sedermi di fronte a lei e leggo. ROSSO SANGUE Al Leopardo, ché rinnovi l’assalto sempre Questa poesia di Ezra Pound era un urlo di lacerazione della coscienza borghese. Io l’ho tradotta e tradita fino farne un grido di rivoluzione per il proletariato. 214 All’inferno! L’ordine appesta l’intero universo. La tregua a tutti nasconde il suo volto bugiardo. Tu, cane sfruttato, vieni! Dammi la musica! Io non ho vita se non quando vedo bandiere rosse E bandiere, bandiere rosse levarsi al vento. Allora urla il mio cuore, colmo di folle furore. Nel fervore dell’estate provo una gioia immensa Quando le tempeste uccidono la pace sulla terra E i fulmini dal cielo scuro sfolgorano spaventosi E i tuoni furiosamente squarciano il silenzio E i venti ululano tra le nuvole e si scontrano. E s’innalzano per tutto il cielo le armi del popolo. Facci udire al più presto l’urlo della mitraglia E i gridi acuti dei guerriglieri nella battaglia, Inferno! E il pugno serrato opporsi al ferro rovente. Meglio solo un’ora di lotta che un anno di tregua, Fra trogoli colmi, lubrichi lazzi e vino e... sfruttamento. Perché non c’è vino che uguagli il sangue del prete! E io amo vedere il sole sorgere rosso sangue Sull’alba e la sua luce penetrare il buio della notte. E il petto mi si empie di forza e di tripudio E la mente di una musica devastatrice Quando lo vedo così sfidare l’ordine oscuro, La sua libera forza spazzare le tenebre via. L’uomo che non si ribella e cerca di opporsi A queste parole di lotta non può liberarsi. Mai. È adatto solo a marcire nell’alienazione, Lungi da dove s’erge il lavoro a creare la storia. La morte di certe baldracche non piangerò. Anzi, di musica sacra empirò l’aria. Compagni, compagni! Correte! Alla musica! Non c’è canto che uguagli il furor delle masse Non c’è urlo simile al grido: ‘Rivoluzione!’ Quando si desta, con la violenza, l’odio di classe E le nostre barricate innalzano bandiere di fiamma. L’inferno condanni per sempre chi vuole la tregua 215 E il suono della mitraglia muto lo renda! “Non è agghiacciante?” Domando. “Da far accapponare la pelle! Ricordo che verso il 1972 l’amicizia dei due eroi attraversò un periodo burrascoso, con liti accanite e discussioni avvelenate. Erano problemi politici; non pensavo che c’entrasse la poesia.” “Qui la poesia c’entra poco, credo. Da come me l’ha raccontata Giuliano, il tuo uomo accusava l’autore di avere cambiato le parole dei versi di Ezra Pound, non la sostanza. Insomma vi scorgeva sentimenti fascistoidi, mentre Fabrizio credeva di averne cambiato il segno politico.” “Questa non l’ho capita.” “Giuliano mi ha spiegato il retroterra culturale, che tuttavia non mi sembra particolarmente rilevante per il nostro problema.” “Ora mi hai incuriosito. Spiegalo anche a me.” Insiste. “La poesia di Pound è scritta come se fosse cantata da Bertrand de Born, un poeta provenzale parecchio apprezzato da Dante. In un verso della poesia di Pound, Bertrand incita alla resistenza contro l’assalto del Leopardo, cioè Riccardo Cuor di Leone, che, forse per la sua ribellione nei confronti del legittimo re d’Inghilterra, o forse per il ruolo svolto durante la seconda crociata nel minare l’autorità di Federico Barbarossa, è identificato da Dante con le forze della sovversione, le forze che lottavano contro la tradizione e l’autorità sacra. Così c’è un’identificazione del punto di vista di tre poeti che, notoriamente, sono stati dei campioni della reazione conservatrice, Bertrand, Dante e Pound. Fabrizio tentò un rovesciamento di punto di vista. Le movenze e il tono della sua poesia sono gli stessi di quella di Pound, di cui viene proposta solo una traduzione, anzi un tradumento.” “Un che?” “Tradumento è una traduzione-tradimento, un esercizio letterario che Luciano aveva insegnato agli amici.” “Vai avanti.” “Il messaggio politico della poesia di Fabrizio vorrebbe essere l’opposto di quello della poesia di Pound. Fabrizio assume il punto di vista della sovversione e dedica la sua poesia al Leopar- 216 do, che ora identifica, oltre che col ribelle Riccardo, anche con Luciano.” “Già, Leopardo era il soprannome di Luciano negli anni della rivoluzione.” “E Leone quello di Fabrizio. Il suo estro poetico propone un’identificazione dei tre sovversivi, lui stesso, Luciano e Riccardo Cuor di Leone, come se quest’ultimo appartenesse alla Setta.” “Interessante. Ma tutto ciò quanto ci illumina su...?” “Non ci illumina in nulla.” Se ne va verso le otto, la mia amica. L’accompagno alla porta, le do un bacio casto sulla guancia e la saluto. Mentre sto per chiudere, lei mi ferma e mi fa: “Mi è appena venuta in mente una cosa che potrebbe interessarti.” “Che cosa?” Rientra, si chiude la porta alle spalle e dice: “C’era un libro sul tavolinetto dell’ingresso. Parlo di casa mia. Era stato messo lì per essere spedito, mi aveva detto Luciano. Restò sul tavolinetto per diversi giorni, come se lui fosse indeciso. Io gli buttai sopra un’occhiata, incuriosita dalla sua titubanza. In seguito, cinque giorni prima dell’orgia alla torre, il libro sparì. Evidentemente si era deciso a spedirlo.” “Perché la cosa dovrebbe interessarmi?” Domando. “Sopra c’era un post-it giallo con su scritto: cavalieri del nulla; per la Puttana Santa. Ho pensato che volesse spedirlo a te.” Ho un lampo nella mente, e di nuovo una sensazione di deja entendu. Stavolta però la memoria non fa cilecca. Mi ricordo subito che della puttana santa aveva bofonchiato Luciano il giorno che mi portò a spasso di là d’Arno, poi che me ne aveva accennato Lilli quando mi aveva rivelato quel cosiddetto numero magico. Anche la faccenda dei cavalieri del nulla l’ho già sentita. Ne avevano parlato prima Gianrico e poi Elvira in due recenti conversazioni. Ricordo che in tutti e due i casi registrai l’espressione mentalmente quale materia da approfondire, il che non ho mai avuto occasione di fare. 217 Stranamente, invece di chiedere delucidazioni su questi temi, come se la mia volontà fosse pressata da problemi più importanti, domando: “Che libro era?” “Una cosa sull’Africa. Tu dovresti saperlo bene, se il pacco è stato spedito a te.” “Io non ho ricevuto nessun libro del genere. Evidentemente...” All’improvviso mi torna alla memoria uno strano episodio verificatosi pochi giorni fa. Il postino mi aveva fermato sulla porta di casa e mi aveva chiesto se poi quel signore tanto autoritario me lo aveva consegnato il mio pacco postale. Mi aveva spiegato che qualche giorno prima stava suonando al mio campanello per consegnarmi un plico, quando era uscito dal portone un signore burbero dai baffi alla mongola. Aveva dato una sbirciata al plico e appena visto il nome del mittente glielo aveva strappato di mano. Dopo di che aveva tirato fuori cinquantamila lire e gliele aveva date, dicendo che me lo avrebbe consegnato lui, il pacco. Il postino si era scusato molto con me: aveva ammorgiato meno per la mancia che per i modi prepotenti di quel signore. Evidentemente era il libro spedito da Luciano. Se n’è impossessato Giuliano. Già, ma che c’entra un libro sull’Africa? Mi domando. Non c’entrerà mica anche l’Africa in questa specie di ro-manzo d’appendice? Quando Lucrezia se ne va, mi butto subito sul mio diario. Non posso chiudere le annotazioni di oggi senza registrare un fatto che potrebbe essere rilevante. O forse è del tutto insignificante, tanto insignificante che in effetti me ne ero completamente dimenticata. Solo ora che mi si chiudono gli occhi dal sonno mi torna alla mente. Oggi è proprio la giornata della memoria. La scena è quella della mia conversazione con le vergini folli. “Chi sono questi cavalieri del nulla?” Domandai, quasi involontariamente, quando Elvira ne accennò. Entrambe le donne ebbero un trasalimento appena percettibile. Accadde tutto in un attimo. Rapido come un fulmine, il mio demone indagatore, senza neanche consultare la coscienza, decise di fare una verifica. Allungai una mano per prendere dal tavolo la tazza del tè e distolsi lo sguardo dalle mie interlocutrici; ma con 218 la coda degli occhi le tenni sotto controllo. Così mi accorsi che loro, approfittando della mia apparente distrazione, si lanciarono un’occhiata che può essere stata di cruccio. Tutto in un attimo accadde, e devo aver registrato l’avvenimento al livello preconscio. Per questo me n’ero dimenticata. La risposta alla mia domanda fu che loro non ne sapevano niente. Io insistetti, chiedendo se per caso i fantomatici cavalieri del nulla non erano collegati ai recenti fattacci di villa Stibbert. Non so per quale motivo feci quella domanda, come la precedente, del resto. Loro non capivano di cosa stavo parlando. In effetti non lo capivo neanch’io, benché la cosa mi puzzasse un po’. Mio Dio! Eppure mi sono detta e ridetta mille volte che non devo fidarmi del cosiddetto intuito femminile. Tornando al libro sull’Africa, il fatto che Luciano me lo avesse spedito mi sorprendeva. Era parecchio tempo che non me ne regalava più. E poi, semmai, perché non darmelo di persona? Avevo ripreso a frequentare il mio uomo per via della tesi di laurea. Ci vedevamo una volta a settimana; però solo al dipartimento di Filosofia e solo per parlare della mia ricerca. Lui mi passava dei foglietti con delle indicazioni bibliografiche. Dopo di che trascorrevo intere giornate in biblioteca a studiare. Scrivevo un paragrafo della tesi e glielo consegnavo quando ci incontravamo. Lui mi riconsegnava quello della settimana precedente facendomi le sue osservazioni e le sue critiche. Io prendevo nota, a volte chiedevo chiarimenti, altre ribattevo. Spesso si accendevano discussioni accanite. A lui piaceva quando ammettevo i miei errori interpretativi, ancor più quando difendevo le mie posizioni. Non parliamo di quando lo beccavo in castagna e lo costringevo a rivedere qualche sua idea. La sua stima per me saliva alle stelle. Un giorno mi disse che le nostre discussioni lo arricchivano e che si aspettava che l’allieva superasse il maestro. La tesi cresceva bene e lui mi fece capire che non meritava meno di un 110 e lode. Più di una volta mi propose di incontrarci nella sua casa di campagna – esclusivamente per discutere della tesi – mi assicurava. Figuriamoci! Rifiutavo seccamente. Gli dissi chiaro e tondo 219 che non volevo precipitare di nuovo nel baratro del sesso alienato e dei sentimenti frustrati. Il rapporto puramente intellettuale che stavamo costruendo mi andava benissimo. Mi permetteva di avere da lui solo il meglio. Il sentimento di stima che ne emergeva non era il massimo che ci si può attendere dalla vita, ma era almeno genuino. Non gli dicevo che sul piano affettivo stavo vivendo un periodo di grande fragilità. Lui mi aveva risvegliato un bisogno vitale che ero riuscita e neutralizzare per diversi anni, e poi me ne aveva negato l’appagamento. In quei giorni ridussi drasticamente la mia attività professionale. Mi selezionai una dozzina di clienti affezionati, dei più teneri e gentili. Gli altri li scoraggiai dandomi malata. Ricevevo soltanto quei dodici. Li trattavo da amici, affettuosamente. Quando arrivava l’amico di turno, gli preparavo una cenetta succulenta e un’accoglienza calorosa. La notte lo intrattenevo a lungo e qualche volta gli chiedevo di restare a dormire con me. La mattina mi svegliavo con la pancia dolorante e la testa adagiata sul suo petto. Cercavo di non svegliarlo e indugiavo a lungo nell’abbraccio inconsapevole di lui. Spesso mi scoprivo a piangere sommessamente. 220 Domenica, 23 giugno Giuliano mi ha invitato a una vacanza in Tanzania, un inclusive tour Avventure nel Mondo con scalata al Kilimangiaro e safari nei parchi. Non ho saputo resistere, e non me ne sono pentita. È stata un’avventura inebriante. Solo di una cosa mi rammarico: di non avere scritto un diario del safari. Ma mi sembrava così banale! Il fatto è che non pensavo il viaggio potesse acquistare un valore diverso da quello legato al piacere immediato dello svago turistico. Invece adesso capisco che ha assunto un grande significato in relazione a tutta questa storia. Intanto mi è servito per conoscere meglio Giuliano, un personaggio che pare voler giocare un ruolo nuovo nel dipanarsi di quella che era cominciata come la storia di un altro. Poi, nel dialogo con lui, che si è fatto più intenso, il flusso d’informazioni si è accresciuto, e in entrambe le direzioni; sicché ora credo di aver fatto qualche sostanziale passo avanti nell’indagine sugli omicidi. Né escludo che le mie informazioni possano avere aiutato lui nella ricerca della sua chiave della verità. Infine c’è la letteratura. Il viaggio, specialmente il viaggio in Africa, è il luogo letterario per eccellenza. E se c’è del romanzo nel diario che sto scrivendo, questo safari lo rivelerà. Sento che in qualche modo le impressioni di turista che non ho scritto avrebbero potuto contribuire a svelare il senso più vero del diario delle indagini che sto scrivendo. Perciò ora, con uno sforzo della memoria, sperando almeno di trarre qualche vantaggio dalla sua inconsapevole selettività, e anche cedendo al desiderio di rivivere certi momenti indimenticabili, scriverò un resoconto di quelle impressioni. Gli darò il titolo che merita. 221 IL LEOPARDO PERDUTO Diario di safari Partenza e primo giorno. Nel pomeriggio di venerdì 7 giugno siamo partiti da Fiumicino. Al check-in dell’Egipt Air abbiamo fatto la conoscenza dei nostri compagni di viaggio, otto tra ragazzoni e ragazzone sui 25-30 anni che non starò a descrivere, data la loro completa irrilevanza nell’economia di questa vicenda. Da Roma al Cairo abbiamo volato senza storia. Dopo quattro ore di sosta nella capitale egiziana, abbiamo cambiato aereo e siamo ripartiti all’una di notte tutti rincoglioniti dal sonno. Il decollo lungo e mozzafiato ci ha svegliato subito, ma in pochi minuti il sonno ci è ricaduto addosso più pesante di un macigno. Le hostess hanno distribuito coperte e cuscini e i passeggeri, ad uno ad uno, si sono rapidamente addormentati. Non Giuliano però, al quale l’eccitazione del decollo aveva fatto venire la fregola. E di conseguenza nemmeno io, che ho dovuto sopportare i suoi assalti infoiati sopra e sotto la coperta. Invano ho cercato di fargli capire che non era aria, che avevo sonno e che era meglio rinviare alla notte meravigliosa che ci attendeva all’hotel Masai. Lui, tutto arrapato, non dava cenni di saggezza, sicché alla fine ho ficcato la testa sotto la coperta e gli ho fatto un servizio veloce e brutale, in quel silenzio soffocato dal ronzio dei motori e dal russare dei passeggeri. Dopo di che lui si è placato e io sono riuscita a farmi una pennica. Quando siamo sbarcati a Nairobi faceva freddo, il primo impatto con le gelide albe dell’altopiano. Ci siamo imbacuccati e siamo partiti per la Tanzania su un pulmino scassato. Nel viaggio verso Arusha, dove ci attendeva un comodo albergo, non è successo niente, a parte le prime visioni della savana selvaggia e di varie bestie da zoo, zebre, giraffe, impala. Ma eravamo tutti troppo assonnati per entusiasmarci. Giuliano è stato di un tremendo malumore. Secondo giorno. In sei ore di pullman ci siamo trasferiti da Arusha a Marangu, ai piedi del Kilimangiaro. A metà strada, 223 verso Moshi, è cominciato a piovere, una pioggerellina fine che non ci ha più abbandonato per il giorno intero. Anche il paesaggio è cambiato: dopo Moshi, un rigoglio di coltivazioni che pareva Val Padana; quando abbiamo preso a salire i primi contrafforti del monte, sono comparse le piantagioni di banani e di caffè, fitte, lussureggianti, verdissime, punteggiate di capanne e animate dal via vai di uomini e donne e bambini vestiti di colori sgargianti. Siamo scesi all’hotel Masai, affollato di turisti, guide e portatori. Dopo una passeggiata sotto la pioggia per vedere le cascate di un vicino torrente, siamo tornati all’albergo, dove abbiamo cenato sontuosamente bene a prezzi oltraggiosamente bassi. Più tardi, relax nella grande hall dell’albergo, un arioso locale dalle pareti ricoperte di cimeli, bandiere, cartine geografiche, foto e autografi di famosi esploratori. Al centro della stanza, un ampio camino circolare, intorno al quale ci siamo seduti a gustare birra locale. Le poltrone coloniali inglesi e gli sgabelli ricavati da vecchi tamburi Sonjo contribuivano all’ambiance hemingwayiana. Nell’aria, un clima di festa e di attesa, artificioso solo un po’. I ragazzi del gruppo hanno fatto baldoria raccontando all’italiana, cioè a voce alta e sguaiata, barzellette sui carabinieri. Infine, tanto per farsi riconoscere da tutti, si sono messi a cantare a squarciagola canzoni di Jovanotti: Mamma, guarda come mi diverto! È una libiiidine! È una rivoooluzione!” Giuliano si è allontanato dal gruppo quasi subito, si è rifugiato nell’angolo più remoto della hall e si è messo a leggere un libro. Io l’ho seguito poco dopo, mi sono seduta accanto a lui e gli ho chiesto: “Cosa leggi?” “Verdi colline d’Africa.” “Lettura quanto mai appropriata.” Terzo giorno. È piovuto tutta la notte, ininterrottamente, e ci siamo svegliati di umore nero. Nero era il cielo gonfio di nuvole 224 e non dava segni di tregua. C’è toccato iniziare l’ascesa sotto il diluvio. Da Marangu al rifugio Mandara, nostra prima tappa sulle falde del Kilimangiaro, sono circa mille metri di dislivello, cinque ore di marcia sotto la pioggia battente. Dopo dieci minuti ero già bagnata fino all’osso, a dispetto dei vari strati di giacche e mantelle impermeabili. I piedi sciacquavano negli scarponi come in due pozze di fango. Lo zainetto, impregnato d’acqua, pesava il doppio del normale. Dopo un’ora di marcia ero stanca morta. Ogni passo sollevavo un macigno. La stradella di terra rossa serpeggiava nella giungla. A tratti, larga e pianeggiante, dava respiro, ma per lo più saliva contorta e stretta tra gli alberi, le radici dei quali vi formavano una sconnessa gradinata di pozzanghere. La foresta, di un verde intenso, appena ingrigito dalla pioggia e dalla bruma, si alzava ai lati del sentiero formando due muraglie minacciose. Non un grido, non un rumore ne usciva. Solo la pioggia monotona sembrava vivere. Il gruppo si è sfaldato subito. Dapprima ci siamo sgranati lungo il sentiero, noi avventurieri e i portatori. Poi, a poco a poco, questi ultimi ci hanno distanziato e se ne sono andati avanti per conto loro. Dopo venti minuti li avevamo persi di vista. Noi invece ci siamo raccolti in due gruppi che a loro volta si sono gradualmente separati fino a perdersi di vista. All’inizio ho camminato con i quattro del gruppo di testa. Parlavano dei loro viaggi nel Nepal e ai Caraibi e mi hanno annoiata subito. Così ho rallentato e mi sono aggregata ai quattro del gruppo di coda. Parlavano anch’essi di viaggi nel Nepal e ai Caraibi. Ho mollato anche loro e mi sono messa a camminare in solitudine tra i due gruppi, grosso modo alla stessa distanza dall’uno e dall’altro. Dopo la prima ora di marcia quella distanza era tanto aumentata che avevo perso di vista tutti i miei compagni di sventura. È stato emozionante camminare così nella giungla. Per due ore sono andata avanti nel silenzio sommerso dal rumore della pioggia, fra i muri incombenti di alberi giganti. In certi momenti, quando la massa verde e grigia si stringeva su di me, ero invasa da un trepido rispetto; e quando la stradella si assottigliava in un vago sentiero d’erba, mi afferrava la paura di perdermi nella giungla. Ma ho saputo mantenere il dominio dei nervi, e perfino 225 da quel senso di controllato timor panico ho tratto del piacere, un perverso piacere di annullamento. Più di una volta però sono stata lì lì per cedere. Spossata dalla fatica, la coscienza sul bilico dello sgomento, ogni tanto mi scoprivo a domandarmi: Che senso ha tutto ciò? Chi me l’ha fatto fare? Non era meglio una vacanza a Viareggio? È stato in uno di quei soprassalti di sconforto che mi è venuto in mente Giuliano. Pensandoci bene, ho realizzato che non era né col gruppo di testa né con quello di coda. Dunque, dato che non si sarebbe mai fatto lasciare per ultimo, doveva trovarsi avanti a tutti, pure lui in ascesa solitaria. Presa da un impulso immotivato, mi sono fatta un lungo sorso di tè tiepido dal thermos, mi sono ciucciata due pastiglie di Enervit, quindi ho ingranato la terza, ho dato un’accelerata e ho cercato di raggiungere l’uomo. La fatica è stata immane, ai limiti del dolore acuto in certi momenti in cui la salita si faceva più ripida. Tuttavia dopo mezz’ora superavo il gruppo di testa e dopo un’altra mezza ero in vista di lui. Con un ultimo strappo l’ho raggiunto. L’ho afferrato per una manica della giacca e gli ho domandato: “Allora?” “Allora?” “Sì, allora? In tutto questo sconquasso un dubbio mi perseguita come uno spettro: a che scopo? fino a dove?” Silenzio. Ma io ho insistito: “Perché mi hai portato qui?” Lui si è fermato, si è voltato verso di me e ha dichiarato, in tono molto formale: “L’Africa è l’ora della verità.” Poi ha ripreso a camminare. Io non ho mollato. L’ho raggiunto di nuovo, di nuovo l’ho fermato e ho insistito: “Dimmelo.” E lui: “Al termine di quest’avventura saremo a conoscenza di tutto ciò che c’è da sapere sulla chiave della verità.” La pioggia dava qualche segno di tregua. In lontananza si scorgevano i tetti delle capanne di Mandara. 226 Quarto e quinto giorno. Dopo una notte travagliata di freddo e di stanchezza, ci è stata servita una magra colazione a base di tè, banane nane e sandwich farciti di strane fette di salame color lillà. I nostri portatori hanno sparecchiato i tavoli del rifugio, hanno sistemato i bagagli con calma e si sono rimessi in marcia. Noi abbiamo indugiato ancora un po’. Qualcuno si è fatto una sigaretta, qualcuno un cicchetto, e tutti ci siamo scaldati le mani intorno a un fuoco fumoso di legna umida. Quindi abbiamo ripreso il cammino. Per un’ora siamo saliti nella giungla. Era spiovuto, ma stavamo proprio in mezzo a una nuvola. La nebbia fitta rendeva più tenebrosi i muri di vegetazione. Dal profondo di quell’oscurità ci giungevano ora urli bestiali. Il Kilimangiaro è una specie d’immensa mammella con due capezzoli: uno, il Kibo, è grosso e tondeggiante; l’altro, il Mawenzi, meno alto, ha un profilo audace, coi suoi picchi frastagliati di rocce aguzze. Ai piedi dei due capezzoli si apre una vasta distesa ondulata, marezzata di verde e di giallo. Il cambiamento dell’ambiente, quando si giunge in vista dell’altopiano, è improvviso, una specie di miraggio. La foresta termina bruscamente e con essa la parte ripida del sentiero. Si entra in un paesaggio alieno, popolato di cespugli bassi e radi, di seneci e di lobelie, arbusti e fiori di un altro mondo. Il sentiero sale dolcemente tra questa vegetazione rarefatta e la sua fuga si perde lontano verso un orizzonte brullo, dietro la linea del quale si scorgono le cime dei due capezzoli. La nebbia subito si disperde bassa tra gli arbusti, sotto un sole di fuoco. Ti volti indietro e vedi ai tuoi piedi il mare di nuvole bianche che ti ha affogato la coscienza fino a un minuto prima. La vita torna a sorridere. Il resto della camminata, verso le capanne di Horombo, a 3750 metri di altitudine, è stato poco faticoso e senza storia. La mia mente era sospesa in un’atmosfera irreale. Nella contemplazione della brughiera, si è lasciata portare su senza interferire col corpo. La tregua è stata breve. All’arrivo è cominciato il mal di montagna, la testa stretta in un cerchio di ferro, i polmoni annaspanti in cerca di aria. Era la mia prima volta sopra i 3000 metri. 227 Dopo una notte di pessimo sonno senza riposo, abbiamo ricominciato a salire alle nove. Il sole era già alto e bruciava forte. Giunti ai piedi del Mawenzi, abbiamo assistito a un’altra metamorfosi del paesaggio. I cespugli si sono fatti dapprima sempre più piccoli e radi. Quando siamo entrati nella vasta sella che separa i due picchi, la brughiera si è dissolta e ha ceduto il terreno a un rovente deserto rosso, piatto e desolato, abitato solo da sassi e macigni sparsi, lasciti delle antiche eruzioni del vulcano. L’aria era soffocante, e non capivo bene se per il caldo o la rarefazione. Al Kibo hut, l’ultimo rifugio, siamo giunti spossati. Ci siamo stesi per terra, sui sassi, e siamo stati così, senza parlare, almeno per un’ora. La testa martellava nelle tempie e alla nuca. Quando ho ricominciato a ragionare erano le quattro del pomeriggio. Alle cinque abbiamo cenato, ma io quasi non ho mangiato per niente. Alle sei tutti a nanna, in vista dell’ultimo sforzo. Non ho chiuso occhio. La testa mi doleva senza misericordia. Con la bocca aperta e disseccata annaspavo al buio, nell’aria fredda del dormitorio. Rannicchiata nel sacco a pelo, e pur ricoperta di vari strati d’indumenti, non riuscivo a scacciare il freddo che s’insinuava tra le piume e la lana per invadermi il corpo. Udivo i rumori dei miei compagni che si rivoltavano nei letti a castello. Di tanto in tanto dal fondo della sala giungeva l’eco di un conato di vomito. Ad un tratto ho sentito nel buio dei passi avvicinarsi al mio letto. Poi il corpo di un uomo è salito su e mi si è stretto addosso. Era Giuliano. “Più stiamo vicini, meno freddo sentiamo.” Ha detto. Abbiamo aperto lo zip del mio sacco a pelo e l’abbiamo richiuso con quello del suo, ottenendo un sacco a due piazze. Ci siamo strofinati un po’ e ci siamo subito scaldati. La testa continuava a dolere. Dormire, neanche a pensarci. Così abbiamo cominciato a parlare, sottovoce, con le teste dentro il sacco per non sprecare neanche il calore dei fiati. Dapprima abbiamo parlato di cose assurde, in uno stato di dormiveglia. A un certo punto però mi è parso che lui volesse venire al sodo e mi sono destata completamente. Voleva che gli rivelassi come ho fatto a trovare le parole nascoste nel secondo 228 capitolo del Nuovo corso. Gli ho detto che non mi avrebbe strappato una parola di bocca se prima non rispondeva ad alcune mie domande. Abbiamo fatto un po’ di schermaglia. Infine si è concordato che lui avrebbe accettato un mio interrogatorio; e avrebbe risposto sinceramente a patto di poter usare il no comment. Dopo di che sarebbe venuto il suo turno di fare domande. E avrei dovuto rispondergli altrettanto sinceramente. Così ho attaccato: “La chiave della verità è una chiave vera e propria?” “Sì e no.” “Cosa sai del famoso tesoro delle BR?” “Quello che hanno scritto i giornali ai suoi tempi.” “Cioè?” “Tu non li hai letti i giornali? Cosa ne sai tu?” “So che si favoleggiava di un bottino di decine di miliardi di lire nascosto in una cassetta di sicurezza.” Ho sparato. “Qualcuno ha sostenuto che Fabrizio sarebbe stato il tesoriere del gruppo terroristico e che, chiusi gli anni di piombo, con tutti i capi brigatisti in galera o sottoterra, lui sarebbe rimasto il padrone del tesoro, l’unico a sapere dov’era nascosto. È vero?” “Questo lo scrissero i giornali, ma nessuno è riuscito a dimostrarlo, neanche i giudici d’appello.” “Mettiamo che sia vero.” L’ho incalzato. “Non potrebbe Fabrizio aver dato la chiave del tesoro a qualche amico?” “Perché avrebbe dovuto farlo?” “Guarda che siamo nella fase in cui le domande le faccio io. Tu limitati a rispondere.” “Va bene.” “Tutto ciò può avere qualcosa a che fare con la morte di Luciano?” “No comment.” “Secondo Lilli la chiave ce l’hai tu. È vero?” “No comment.” “Se ce l’hai tu, cosa cerchi?” “Appunto.” “Allora Lilli mentiva?” “Sì e no.” 229 Abbiamo continuato così per un po’. Avevo l’impressione di girare a vuoto dentro un circolo vizioso. Lui rispondeva apparentemente senza mentire, ma senza dire niente. Più chiacchieravamo, più mi s’ingarbugliavano le idee. E se non ci fosse nessuna relazione tra quella chiave, Fabrizio, Luciano e tutto il resto? D’altronde, in che senso sarebbe una chiave della verità, se fosse una chiave vera e propria? E come potrebbe essere una chiave del tesoro se servisse solo a dare accesso alla soluzione di un enigma? Giunto il turno del suo interrogatorio, è scoccata la mezzanotte. La porta del dormitorio si è aperta con fracasso ed è entrata la nostra guida Masai, Vincent il magnifico, bardato di scarponi, giacca a vento e passamontagna. Lui è il capo dei portatori. Ha il piglio di un re e lo sguardo di un segugio. “Wake up boys! It’s time to go!” Poi in italiano: “Qui si parrà la vostra nobiltà.” E Giuliano: “Si avvicina l’ora della verità.” Sesto giorno. Uscire da quel letto di pena è stata una liberazione e una tortura nello stesso tempo. Non ne potevo più dell’ansimare dei polmoni in crisi d’astinenza e dell’ansia dell’attesa in vista dell’ultimo sforzo. Appena alzata mi si è ficcato un chiodo nella nuca, che già mi doleva manco poco. È venuta la nausea forte e il solo stare in piedi mi dava le vertigini. I portatori ci hanno servito una veloce colazione di tè, biscotti e banane. Io ho trangugiato due sorsi del liquido caldo. Ci siamo bardati in fretta, se non altro perché tutti eravamo andati a letto completamente vestiti. Alle mani, per consiglio di una guida, ho messo guanti di pelliccia e, sopra a questi, un paio di calzini di lana pesanti. Doppi calzini ai piedi. In testa un passamontagna, un berretto da aviatore e il cappuccio della giacca a vento. Dentro il rifugio faceva un freddo cane. Figuriamoci fuori. Difatti ci ha subito aggredito un vento sottile che faceva scrocchiare l’aria. Le tre guide che dovevano portarci in cima ci hanno ammassato, ci hanno passato in rivista e ci hanno dato gli ultimi consigli: 230 “Non fermarsi, non parlare, non bere, non preoccuparsi.” Era Vincent il magnifico che cazzeggiava. E siamo partiti. I primi contrafforti del Kibo si ergevano sopra di noi neri come una condanna. Ho alzato gli occhi su di essi e ho visto file di lucine che si snodavano lontane lungo il sentiero ripido, su su in alto. Non eravamo partiti per primi. Qualche comitiva di giapponesi era stata più mattiniera di noi. Anche qui il nostro gruppo si è subito sfaldato, dividendosi di nuovo in un quartetto di testa e uno di coda. Io stavo sempre in mezzo. Non volevo restare con gli ultimi e non riuscivo a stare coi primi. Giuliano di nuovo fuori vista. Mi stavo chiedendo se fosse in testa o in coda, quando mi ha sorpassato con un’andatura da forsennato. Era già più di un’ora che camminavamo. Non mi ha neanche guardato. Sembrava uno zombi. Giunto a una distanza di venti metri davanti a me, si è fermato, si è piegato in due, ha avuto un violento conato di vomito, poi un altro, poi un altro ancora. Quindi si è raddrizzato e ha ripreso a camminare. Non ho potuto non imitarlo. Mi sono fermata un minuto e sono stata scossa dal vomito anch’io. La prima ondata è stata di tè, nero e acido. Dopo mezz’ora, un’altra sosta e la seconda ondata, stavolta di succhi gastrici, gialli e schiumosi. Altri venti minuti, altra sosta, ed è arrivata la terza ondata, ma ora di nulla, ed è stata la più dolorosa. Ho capito che mi prendeva il vomito non appena mi fermavo. Dunque non potevo concedermi un minuto di riposo. Da quel momento sono andata avanti senza fare una sosta. Ho preso un ritmo regolare, passi brevissimi, un piede davanti l’altro, tacco punta, tacco punta, gli occhi fissi sul terreno, appena illuminato da una fioca torcia elettrica. Quando ho raggiunto Giuliano, lui non mi ha guardato, non si è neppure accorto di me. Avanzava lentissimamente, ansimando, con passi pesanti e irregolari, sbandando ora a destra ora a sinistra che pareva una macchina sbalestrata. L’ho sorpassato e ho tirato dritto. Dopo un po’ mi sono voltata indietro. Il buio della notte aveva eretto una cortina impenetrabile tutto intorno a me. Solo dalle poche lucine lontane che tremolavano giù in basso capivo che lì sotto c’era un sentiero e non il vuoto. 231 Ogni tanto in quella desolazione mi veniva voglia di tornare indietro. Tuttavia la prospettiva di attendere il ritorno dei compagni nel rifugio, insieme a qualche altro sfigato, di notte, al gelo, la prospettiva di una tale sconfitta mi ha dissuaso. Dunque dovevo andare avanti, senza fermarmi mai. Ogni volta che guardavo su, i contrafforti del Kibo mi sembravano più alti. Le gambe erano diventate di legno ormai, la testa mi scoppiava, la nausea mi soffocava il respiro. Andavo su sola. Se guardavo in alto, era un incubo di silenzio, se in basso, una vertigine di tenebre. Dentro gli scarponi, i piedi si erano fatti di pietra. Per paura che mi si congelassero le dita mi sono messa a muoverle spasmodicamente artigliando le suole. Poi mi ha assalito il sonno. A ogni passo mi veniva da chiudere gli occhi e dormire. Sempre più frequentemente mi veniva voglia di dire basta e la domanda tornava a frullarmi nella testa: che senso ha tutto ciò? All’improvviso, mentre avanzavo stordita in quello che era ormai diventato una specie di dormiveglia, mi è esplosa davanti agli occhi un’immagine, forse un ricordo di antiche letture, oppure di un’altra persona che, per magia, si era impossessata della mia mente approfittando dello stato di dormiveglia; un ricordo confuso, ma dai colori vividi. Nella scena che mi passava davanti agli occhi, io cascavo dal sonno e camminavo trascinando le gambe. Un’aria balsamica mi annunciava una ricompensa che si poteva ottenere solo al prezzo delle più dure fatiche. Sapevo che ne valeva la pena. Passavo rapidamente attraverso cancelli lontani gli uni dagli altri. Dei cani tutto intorno sorvegliavano i miei passi e coi loro latrati mi incitavano all’impresa. Mentre avanzavo rivedevo con gli occhi della mente, sogno nel sogno, un certo viale della stazione, coi tigli sui marciapiedi illuminati dalla luna. In quella stazione passavano treni che non si fermavano mai. Ad un tratto lui mi fece fermare. Un lui senza volto, che camminava accanto a me e stava dentro di me. Mi domandò: – Dove siamo? – Io non capivo se era una domanda d’esame o che altro. Sfinita dal camminare, gli confessavo candidamente che non ne sapevo nulla. Lui alzava le spalle e rideva. Allora dalla tasca della sua giacca tirava fuori una chiave e me la mostrava dicendo: – Ecco la risposta. Con la chiave m’indicò, dritta davan- 232 ti a me, una certa cosetta, no, una casetta, no, una cassetta. Stava in un giardino che si apriva in fondo alla strada, a porre termine a quel viaggio. Poi è venuto il miracolo. Alle cinque del mattino la luce ha dato i primi segni di vita. Le stelle sono scomparse e il cielo ha cominciato a trascolorare al blu, da nero di pece che era. Ho guardato in alto e mi è parso di vedere la cima del monte a una cinquantina di metri di distanza in linea d’aria. Mi sono sentita rinascere. Le forze sono tornate all’improvviso e l’ultimo tratto l’ho fatto schizzando su con la lingua di fuori, alla stessa velocità del sorgere dell’alba. Sono giunta in cima nell’istante in cui il sole ha dato il primo segno di esistenza. All’improvviso il mal di testa e la nausea sono scomparsi. Mi sono seduta sulla roccia più alta di Gilman’s Point, 5685 metri sul livello del mare. Ho voltato la faccia a oriente e ho assistito a uno spettacolo di una bellezza spirituale. Sotto di me un mare di nuvole grigie aveva invaso l’orizzonte. Le guglie del Mawenzi emergevano da quel mare, dritte e superbe come un fascio d’itifalli. Il sole sorgeva maestoso, tingendo le nuvole di rosa, mentre il cielo s’incendiava. Sono rimasta a bocca aperta, a contemplare l’epifania del nulla, per un’eternità di secondi. Tutta presa dalla visione, mi sentivo fuori del corpo. È stata quasi un’esperienza mistica. Chissà cosa ne avrebbe pensato Luciano. Io mi sono detta: ne è valsa la pena. Quando sono tornata nel mondo mi sono guardata intorno. Tre dei miei compagni se ne stavano sbracati per terra e boccheggiavano felici. Altri due stavano giungendo proprio allora. Altri ancora li vedevo lontani, piccoli come insetti, disseminati in basso lungo il sentiero sassoso. L’ultimo di loro non sarebbe giunto in meno di un’ora. Gilman’s Point non è la cima più alta del Kibo. Più alta è l’Huhuru, la Libertà, a quota 5895. Ci si arriva con un’aggiunta di fatica di tre quarti d’ora. Vincent ci ha chiamato a raccolta e ha proposto che i meno stanchi si rimettessero in cammino per completare l’impresa. Io non sarei mai rimasta con gli stanchi. Ho raccattato tutto il mio misero residuo di forze e mi sono aggregata al gruppo degli indomiti. 233 Siamo prima scesi per una ventina di metri, poi abbiamo ricominciato a salire su un declivio lungo la cresta dell’antico vulcano. In un attimo siamo giunti sulla vetta dell’Africa. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto tè freddo e Centerbe, 70 gradi alcoolici, una granata nello stomaco. Ci siamo riposati, sdraiati sulla terra fredda e sotto il sole che già cominciava a bruciare. Riacquistato il ritmo normale del respiro, i miei compagni hanno tirato fuori le macchine fotografiche, e per cinque minuti è stato tutto in clicchettio di otturatori. Io invece ho preso il binocolo, mi sono allontanata dal gruppo di qualche passo e ho fatto un giro d’orizzonte. All’interno del cratere si estendeva un paesaggio lunare disseminato di pietre nere, di polvere grigia e, qua e là, di piccoli crateri rotondi dentro crateri più grandi. Sulla cresta opposta a quella dell’Huhuru, davanti a me, si ergeva l’ultima rovina di un antico ghiacciaio. Ne potevo vedere i contrafforti che si rizzavano verticali con l’audacia di un muro ciclopico. Formavano delle file compatte di colonne bianche e azzurre e sembravano una cascata d’acqua che era stata gelata all’istante da un dio stravagante. A lungo sono rimasta a contemplare il ghiacciaio col binocolo. Poi ho fatto un altro mezzo giro d’orizzonte e mi sono fermata a guardare Gilman’s Point. In quel momento vi stava giungendo Giuliano, locco locco, col passo rotto dalla stanchezza, barcollante che pareva un ubriaco. Appena in cima, invece di buttarsi per terra, come avevamo fatto tutti, ha riacquistato vitalità. Si è diretto al cippo di ferro che segna il punto più alto del rilievo. Si è chinato in ginocchio. Ha aperto una cassetta metallica fissata ai piedi del cippo e ne ha tirato fuori una specie di grosso quaderno, simile a quelli che si trovano sulle cime delle Alpi e nei quali gli alpinisti appongono le preziose firme a perenne memoria dell’impresa appena compiuta. Lui però non ha messo nessuna firma. Invece ha cominciato a sfogliare freneticamente il quaderno finché non ha trovato ciò che cercava. Si è fermato su una pagina. In pochi secondi ha letto qualcosa. Poi ha tirato fuori di tasca 234 una matita e un’agendina e ha trascritto quel qualcosa. Infine si è steso su una roccia e si è attaccato alla borraccia. La cosa mi ha incuriosito. Ho raccolto il mio zaino e mi sono subito messa in cammino per raggiungere Gilman’s Point. Gli altri mi hanno seguito contro voglia. Quando sono giunta alla meta, il quaderno era stato rimesso al suo posto. Giuliano se ne stava seduto nella posizione del loto, discosto dal gruppo, con le spalle rivolte al cippo, osservando il cratere del Kibo. Mi sono seduta al suo fianco e: “Cosa cerchi?” Gli ho fatto. E lui: “La carcassa di un leopardo.” “Che carcassa?” “Ernest Hemingway narra di una carcassa di leopardo trovata sulla cima del Kilimangiaro, domandandosi come mai la belva fosse venuta a finire qui, cosa ci fosse venuta a cercare.” Non finiva di sorprendermi quest’uomo. Quando il gruppo si è rimesso in marcia, Giuliano si è alzato e si è aggregato, mentre io ho traccheggiato un po’ armeggiando con lo zaino. Ho aspettato che gli altri si allontanassero un bel pezzo. Sono corsa al cippo metallico, ho tirato fuori il quaderno dalla cassetta e l’ho sfogliato con attenzione. Non ho dovuto cercare a lungo. Ho trovato una pagina in cui la monotonia delle firme era interrotta da una specie di poesiola scritta in italiano. Ho tirato fuori il mio taccuino e ve l’ho trascritta. Eccola: P3+A-8xS-8 CON LEGGERO WHITE NOISE Al Leopardo dal Leone Un signore si fermò E mai quattro più giri Fece intorno ricominciò Il dopo di quarto Treviri. Posticcia quella silfide mezza materiata di tricot! 235 Mah? Luciano diceva che la poesia, una volta conquistate le masse, diventa un ricettacolo di luoghi comuni. Questo forse era un modo per evitarlo. Mi sono rimessa in cammino. Quando ho raggiunto il gruppo Giuliano, che si era accorto del mio ritardo, mi ha domandato spiegazioni. L’ho ignorato. Settimo e ottavo giorno. Una giornata per raggiungere Horombo, un’altra mezza per tornare ad Arusha. Il tempo si era messo al sereno e noi si veniva giù leggeri, eppure con nessuna delle emozioni dell’ascesa. È dunque la sofferenza che rende interessante la vita? Il pomeriggio dell’ottavo giorno l’abbiamo dedicato al riposo, bighellonando nella cittadina in cerca di souvenir e sensazioni, ma senza una gran soddisfazione. Giuliano mi ha perseguitato senza tregua. Voleva riprendere l’interrogatorio, voleva scopare, voleva la verità. Era tutto ringalluzzito, ora che aveva in tasca un certificato di scalatore della più alta montagna africana, rilasciato dal Kilimanjaro National Park, con tanto di timbri, firme e controfirme. Mi ha proprio perseguitato. Io l’ho tenuto a bada. Nono e decimo giorno. È cominciato il safari. All’alba del nono giorno siamo stati svegliati dall’assordante cantilena di un muezzin; il quale, dalla moschea vicina all’albergo, con l’aiuto di potenti altoparlanti, rompeva i timpani a mezza città, un po’ come da noi le campane quando sono registrate in hi-fi e trasmesse a diecimila decibel tutte le sante domeniche mattina direttamente nelle orecchie dei fedeli e dei miscredenti. Così mi è venuto in mente un pensierino della sera che mi sembra niente male: che la scienza moderna, lungi dall’avere affossato la religione, è servita invece per fornirle armi e strumenti che la rendono più invadente e aggressiva. Alle otto ci siamo imbarcati su due Land Rover scassate e ci siamo messi in viaggio. Imbarcati è la parola giusta. Dopo due ore di una monotona strada asfaltata che dirigeva, dritta e piatta, verso Occidente, verso l’interno selvaggio del paese, abbiamo deviato a Nord e siamo entrati in una pista della savana tutta pie- 236 na di polvere. C’erano buche ampie e regolari, disposte in sterminate serie come le onde del mare. Su di esse una jeep robusta può correre veloce quanto una barca nella tormenta con tre mani di terzaroli: sotto il maestrale rulla e beccheggia, e il mare non le dà tregua. Così le nostre Land Rover, rullando e beccheggiando a tutta la velocità possibile, fendevano quel mare verde e giallo alzando scie di polvere rossa dietro di sé. Stavo seduta nel sedile accanto a Vincent, alla testa della carovana, e ho cercato di imbastire una conversazione per conoscerlo meglio. Così ho scoperto che è un uomo di cultura. È figlio di un capo tribù, ma ha rinunciato al trono per emigrare nella civiltà. Ha studiato in Inghilterra e in Italia. Poi è tornato in patria per mettere su un’impresina che organizza avventure per turisti in cerca di emozioni hemingwayane. Parla un discreto italiano, e con una certa flemma. Ogni tanto però si accalora, ed ecco la perla di monologo con cui mi ha deliziato mentre guidava il fuoristrada scartando dossi e fossati: “La Land Rover, anzi, la Land, così la chiamiamo noi aficionado, è una jeep portentosa, un vero mito. Sulla pista sconnessa della savana è capace di fare derapage da spider, e sa scattare leggera come uno scooter in terza. Parte sempre in pole position e fila via, dribblando fra le teorie sconfinate di rovi e di arbusti, che pare una Jaguar sprint fra i guard rail di una strada di campagna. Ha il design di un tank, il ruggito di un jumbo jet, lo chassis di un camion... il clacson di una city car. Per garage gli basta un’acacia, nella notte della Rift Valley, e al mattino può partire senza starter. Non offre certo i comfort di una station wagon americana, ma carica bagagli più di un container e passeggeri meglio di un pullman. Non va mai in tilt, mai che dia forfait, mai che si fermi in panne. Neanche i giapponesi, con tutto l’avanzamento del loro know how, sono riusciti a costruire una safari car all’altezza di questo capolavoro della sapienza inglese.” Il lago Manyara è stato la prima rivelazione della vera Africa da cartolina: giungle intricate nella valle intorno al lago, immensi baobab spogli sulle colline, acque tinte di rosa dalle colonie di fenicotteri. 237 I miei compagni di viaggio scattavano foto senza ritegno. Io la macchina fotografica non l’ho voluta portare, se non altro per ridurre il peso dello zaino personale. Lo zaino serio, quello che pesa venti chili, lo portavano i negretti, sul Kilimangiaro. Quello piccolo, con le cose di uso immediato, che portavo io, pesava già cinque chili senza macchina fotografica. Quanto alle foto, ne ho poi comprati due libri in un negozio per turisti, ed erano più belle di quelle che avrei potuto scattare da me. Il giorno seguente ci siamo rimessi in moto dopo una dura notte passata sul duro pavimento di una tendina canadese. Ancora chilometri e chilometri di polvere e sudore e schiene a pezzi, in mezzo a paesaggi di una bellezza esagerata. Ho notato che neanche Giuliano aveva una macchina fotografica. Cominciavo ad apprezzarlo il mio bove. Questo viaggio, inaspettatamente, è servito a portare alla luce lati del suo carattere per niente spregevoli. Dal tettuccio aperto della mia Land Rover, da cui sporgevo con tutto il busto, ogni tanto lanciavo uno sguardo verso la sua. Lui se ne stava seduto sul tetto, le gambe che penzolavano una fuori e una dentro la macchina. Più di una volta i nostri sguardi si sono incontrati, di lontano, ammiccando in un segno d’intesa. Con quel cappello kaki a falde flosce, la sua faccia larga, i baffi neri, il sorriso che variava continuamente tra il cordiale e il beffardo, Giuliano sembrava un vecchio Ernest. Il gruppo infatti gli ha subito appioppato il soprannome giusto, zio Ernest, così riconoscendogli un’autorità di fatto, se non altro quella dell’anziano. Finalmente, verso mezzogiorno, siamo arrivati al parco di Ngorongoro. Il paesaggio è cambiato all’improvviso. La strada ha cominciato a inerpicarsi sulla montagna e la savana ha ceduto il campo alla giungla. Ngorongoro è un cratere, un grande cratere vulcanico, sul fondo del quale si stende una valle splendente quasi di luce propria. Al centro della valle, un lago azzurro-cielo. Tutt’intorno, una vasta catena circolare di monti verdi. Ngorongoro è un cratere. È stato prodotto da un’apocalittica eruzione vulcanica in tempi remotissimi. Una caldera immensa: seconda al mondo per vastità, dicono le guide, prima per bellezza. La bellezza è indubbiamente 238 esaltante. Non riesco a definirla che come ineffabile. Suscita il senso del sacro. Non starò a narrare delle scorrazzate in Land Rover tra leoni e rinoceronti e tutte le altre bestie da safari. Il bello è venuto la sera quando, tornati sui monti, ci siamo accampati nella foresta. Una radura neanche tanto grande, con al centro un immenso albero solitario, era il camping messo a disposizione dall’ente del turismo. Non c’era una rete di recinzione né una capanna per i servizi a tradire un sia pur blando segno, non dico di civiltà, ma almeno di organizzazione. Le tende dei turisti, comprese le nostre cinque, erano una decina. Dalla giungla giungevano urli bestiali. Entrare nella foresta in cerca di legna per il fuoco è stata un’impresa in cui si sono cimentati solo i maschi più coraggiosi. Il fuoco poi è stato debole e di breve durata. Verso le undici, quando si stava per spegnere, si è avvicinato un negro alto e bello come Cassius Clay. Aveva un fucile a tracolla. “Sono il ranger del campo.” Ha detto in un rozzo inglese. “Non vi preoccupate se stanotte sentite qualche ruggito. Però se lo sentite troppo vicino alle tende, mettetevi a urlare a squarciagola. Basta che gridate: – hallo, hallo. – Io vengo e sparo.” Ci ha proprio tranquillizzato. Difatti, entrata nel sacco a pelo, non ci ho messo meno di due ore per addormentarmi. Avevo appena preso sonno, credo, quando sono stata svegliata da un ululato, o un ruggito, non saprei, comunque terrificante. Ho aperto gli occhi, nel buio della tenda, e non ho mosso un dito. Le orecchie mi si sono forse drizzate. Silenzio assoluto. Il respiro di Giuliano, accanto a me, non era per niente regolare, sembrava anch’esso soffocato dallo spavento. È passato un quarto d’ora, e stavo per cadere di nuovo nel sonno, quando ho sentito un altro ruggito, più forte e più vicino del primo. “Cos’è?” Ho chiesto a Giuliano con un bisbiglio. “Una iena.” Ha risposto lui sicuro. “Non temere. Le iene mangiano solo carogne.” “Figuriamoci! Ernest dice che una iena, di notte, può assalire una tenda e morderti la faccia.” “Ernest scriveva romanzi.” 239 Poi di nuovo silenzio. Anche la iena non si è fatta più sentire. Ad ogni modo quella notte non ha dormito nessuno nel campo. Né abbiamo dormito noi due. Dopo un po’ Giuliano si è voltato verso di me e ha detto: “Potremmo approfittare per fare conversazione. Ho diverse cose da domandarti.” Non ho potuto tirarmi indietro. D’altro canto bisognava pur trovare un modo per passare la notte. Così: “Va bene, attacca con le domande.” “Non ho intenzione di porti domande precise. Voglio soltanto che mi spieghi come hai fatto a decifrare il messaggio nascosto nel primo e nel secondo capitolo del Nuovo corso. Io ci ho lavorato duro per giorni e notti, e ho sempre sbagliato. Tu evidentemente sei in possesso della chiave di lettura, o di un codice, insomma di qualcosa che è necessario per orientarsi in quei labirinti di parole.” “È così.” “Dai allora, racconta.” “Dobbiamo partire da un fatto letterario.” “Vabbè, basta che non la prendi troppo larga.” “La soluzione era pronta da molto prima che mi mettessi a cercarla.” “Dov’era?” “In una poesia regalatami da Luciano per il mio ultimo compleanno. Lì per lì non ci avevo capito granché. Era una poesia concettosa, ermetica. Non avevo capito cosa avesse a che fare con me. Pensavo che avrebbe potuto regalarla a qualsiasi persona. Lui però mi aveva detto che era un dono personalizzato. L’aveva scritta espressamente per me. Il perché lo capii più tardi e proprio quando stavo cercando la chiave di lettura dei capitoli del Nuovo corso.” “Come hai fatto a capirlo?” “Era una notte fredda e insonne. Mi rivoltavo nel letto da ore, la mente offuscata da un qualche assillo che ora non ricordo. Verso le prime luci dell’alba mi appisolai, ma di un sonno leggero, agitato, non del tutto incosciente, una sorta di dormiveglia attraverso cui entravo e uscivo continuamente dal torpore. A un 240 certo punto devo essermi addormentata sul serio, e all’improvviso mi sono svegliata di soprassalto...” “Un incubo?” “Non precisamente un incubo, neanche un delirio di piacere. Un sogno strano. Così strano... vivido... così vivido... che pareva realtà.” “Racconta.” “Mi trovavo in una sudicia mansarda in una sudicia casa del quartiere latino a Parigi. Ero seduta in meditazione su una grande sedia impagliata davanti a una finestra spalancata. Era notte fonda. L’alba sarebbe sorta di lì a poco. Passò del tempo e il cielo, di un buio senza stelle, cominciò a mostrare i primi segni di pallore. Dapprima il nero trascolorò in un blu intenso. Poi si schiarì fino ad assumere una sfumatura di viola appena percettibile. Era un blu strano, che non avevo mai visto, profondo e denso, pregno di un’elettricità magica. Mi aspettavo che sorgesse il sole. Invece all’improvviso c’è stato uno squarcio.” “Uno squarcio di che? Del cielo?” “No. Uno squarcio. Non saprei dirlo diversamente. Una specie di rottura dell’ordine del mondo, che esplose dentro di me e dilagò tutt’intorno. Nello stesso istante comparve un’immagine al centro della finestra, sospesa in quel blu magico del cielo. Ebbi un trasalimento, della mente, del corpo, non so.” “My god, un satori!” “Certo, è patetico. Ma era solo un sogno. Fui ipnotizzata dall’immagine. Mi sentivo vuota e cosciente allo stesso tempo, passiva e padrona di me. E lei se ne stava là, vuota e passiva anch’essa...” “Lei chi? Che immagine era?” “Era una persona, non saprei dire se maschio o femmina. I capelli lunghi, neri e lisci. Duri i lineamenti del viso, non belli sebbene trasfigurati da un’aura di dolcezza eterea e impersonale. Il colore della pelle e degli occhi era blu, ancora il blu magico del cielo. La tunica che indossava era dello stesso colore. Nella mano sinistra, sospeso all’altezza del cuore, teneva un libro aperto, anch’esso di quel colore incredibile. C’erano scritte delle parole che io non riuscivo a leggere. La mano destra invece era at- 241 teggiata a un gesto ieratico, con il medio e l’indice uniti in un segno che sembrava di benedizione e di minaccia a un tempo. Indicava il libro e pareva volesse invitarmi o costringermi a leggerne il contenuto. Io mi sforzavo di decifrare le lettere senza riuscirci, e più passavano i minuti più diventava difficile. Sentivo l’angoscia crescere dentro di me. Sentivo che se non fossi riuscita, qualcosa di terribile mi sarebbe accaduta. Infatti cominciai a precipitare nel vuoto. Man mano che andavo giù l’angoscia montava. Solo se fossi riuscita a decifrare quelle parole mi sarei salvata. Credetti di essere entrata in un sonno da cui non mi sarei mai risvegliata se non fossi riuscita a penetrare il libro. L’angoscia, l’oppressione e la caduta sarebbero continuate in eterno con intensità e velocità sempre crescenti. Quand’ecco che, con calma, quella mano terrificante si mosse. Si volse verso di me, mostrandomi il palmo. Nello stesso tempo dischiuse il pollice, l’indice e il medio. Capii che mi voleva significare il numero tre. No, era un tredici; no, un ventisei. All’improvviso sentii di essere lì lì per capire. Mi svegliai, ma un istante prima riuscii a leggere tre lettere del libro.” “Che lettere?” “Una E, una A e una P.” “Che significa?” “Il sogno? Magari lo sapessi.” “No, le tre lettere. Non hai detto che ti hanno dato la chiave per decifrare il libro di filosofia?” “Ho detto che alla fine sono riuscita a trovare quella chiave. Il sogno è stato il punto di partenza di una catena di associazioni mentali che mi hanno portato alla soluzione. Però se mi chiedi di spiegarti il senso delle associazioni mi metti in difficoltà. Ho capito il punto d’arrivo, non come ci sono arrivata.” “Vabbè, continua.” “Dopo il sogno sono rimasta a letto madida di sudore e non ancora del tutto sveglia. Ero stanca e angosciata. Volevo riaddormentarmi, anche se avevo paura di rientrare in quel sogno. Così il mio corpo ha cominciato a rigirarsi tra le coperte e la mente a frullare più veloce di una trottola. La prima associazione 242 che mi si è presentata era di una discussione che avevo avuto con Luciano su uno scrittore americano.” “Molto interessante, ma mi sa che ti stai prendendo gioco di me.” “Aspetta. Sono quasi arrivata. Dopo essermi ricordata di quella conversazione letteraria, all’improvviso ho trovato il bandolo della matassa. Sono corsa a prendere la poesia che mi era stata dedicata da Luciano, l’ho riletta, l’ho confrontata con un’altra e ho subito trovato la chiave di lettura.” Giuliano stava per dire qualcosa quando nel silenzio della notte, vicinissimo al campo, è prorotto un altro ululato. Gli ha ucciso le parole in bocca. Io mi sono stretta a lui. Poi si sono sentiti dei passi d’uomo accanto alla tenda. “Chi è là?” Ha gridato Giuliano. “Don’t worry, it’s me. I’m watching over you.” Era il ranger del campo, col suo inglese singhiozzante. E in swahili: “Pole, pole m’suri!” Cioè: “non vi preoccupate!” Figuriamoci! Fortunatamente la tela della tenda cominciava a schiarirsi alla prima luce dell’alba. Giuliano era rimasto a bocca aperta e guardava fisso in alto. Non capivo se era preso dalla riflessione o dalla paura. Ne ho approfittato per alzarmi. Sono uscita dalla tenda in pigiama. Il ranger se ne stava lì davanti, volgendomi le spalle, a pochi metri dalla tenda, guardando verso la vallata di Ngorongoro. Mi sono avvicinata a lui. Ho guardato anch’io e sono rimasta sconvolta dalla visione. Il sole non era ancora sorto e già il cielo si era tinto di rosa laggiù dietro le grandi montagne nere. Noi stavamo in uno dei punti più alti del cerchio montuoso. Alla nostra destra, oltre il muro massiccio dei monti che chiudeva la vallata, un’immensa ondata di nuvole nere avanzava inesorabile, decisa a traboccare nel cratere. Noi stavamo a guardare in attesa di un evento. Il mare di nuvole avanzava. Poi, appena il sole è uscito fuori dall’altra parte della valle davanti a noi, quel mare scuro ha aggredito la cresta del cratere e ha cominciato a riversarcisi dentro. Nello stesso istante ha cambiato colore. Si è formata una specie di cascata di panna rosa. Lentamente veniva giù, scivolando a picco lungo i fianchi verticali dei monti, e diventava sempre più luminosa. Il sole con- 243 tinuava ad alzarsi, rosso come un grumo di sangue. Appena si è staccato dalla cima dei monti, la cascata di nuvole ha toccato il fondo della valle. Si era ormai tutta colorata di un rosa carnicino, e il cielo le faceva da specchio. Sull’occhio del sole si stagliavano tre linee orizzontali di cirri neri. Doveva avere ragione Luciano quando sosteneva che dietro la mia pertinace volontà di svilire il mondo si nasconde un inguaribile animo romantico. Non si spiegherebbe altrimenti questa infantile capacità di entusiasmarmi di fronte a certi oleografici squarci di albe africane. Undicesimo e dodicesimo giorno. La savana sterminata di Serengeti, coi suoi gnu e i ghepardi, le zebre e i bufali, le giraffe, i coccodrilli e i saussage trees, non ci ha impressionato più di tanto, dopo il lago Manyara e Ngorongoro. L’abbiamo attraversata in un giorno. Una notte ci abbiamo dormito, in tenda, in un campo in mezzo alla prateria. Neanche gli sghignazzi notturni delle iene ci hanno fatto grande impressione. La mattina presto abbiamo imboccato la strada per il lago Natron, fuori dai parchi nazionali e dai percorsi turistici, in cerca di un’avventura seria. Usciti da Serengeti, la strada, tutta sconnessa e polverosa, è diventata una pista incerta che si perdeva spesso tra l’erba disseccata, i cespugli e i fossi dei torrenti prosciugati dal sole. Le Land Rover hanno resistito eroicamente. Le nostre schiene e i nostri culi però erano a pezzi quando ci siamo fermati a Wasu, dopo sette ore di gincana. Wasu è un villaggio primitivo, come quelli che si vedono nei film di Tarzan, con le capanne di fango e di frasche. I Masai erano genuini, nella loro gloriosa e sporca seminudità. Tre di loro, vestiti nei tipici drappi amaranto, ci sono venuti incontro con atteggiamento non proprio amichevole. Può sembrare incredibile, ma erano armati di lance e bastoni nodosi. Entrambe le mani armate avevano e ai fianchi dei lunghi machete di ferro. Le guide hanno fermato le jeep ai bordi del villaggio, sono scese insieme a Giuliano e hanno cominciato una trattativa faticosa. Traducevano dalla lingua Masai all’inglese e il nostro capo sudava abbondantemente nello sforzo di capire e farsi capire. Poi è tornato alle 244 macchine e ci ha detto che potevamo scendere e scattare qualche foto. Aveva pagato il biglietto d’ingresso: sessanta dollari, una cifra spropositata. Abbiamo gironzolato per il villaggio, stretti l’uno all’altro, circondati da nugoli di ragazzini e giovanotti che ci guardavano come fossimo scimmie allo zoo. Qualcuno ci toccava, altri ridevano, altri ancora discutevano animatamente. Poi sono venute delle donne che volevano venderci collanine e braccialetti di perline colorate. Infine abbiamo trovato una capanna più grande delle altre con un cartello di legno bianco su cui campeggiava una scritta sghemba e alquanto pretenziosa: restaurant. Siamo entrati e abbiamo chiesto da mangiare. Servivano solo una pietanza: chapati. Ne abbiamo ordinati 27 e, spinti dalla tremenda puzza, siamo subito usciti all’aria aperta. Tanto ci voleva del tempo per prepararli. Il sole, quasi a picco, bruciava peggio di un forno. Ne abbiamo ordinati 27 di chapati, tre per uno. Infatti eravamo diventati nove. Uno di noi mancava all’appello. Chi poteva essere? Giuliano, naturalmente. Doveva essersi allontanato quando siamo entrati nel restaurant. Dov’era andato? Ad un tratto ci siamo accorti che le jeep erano sparite. Abbiamo sbirciato tutto intorno, ma non se ne vedeva l’ombra. Neanche le nostre guide tanzaniane si vedevano più. Nel posto in cui erano state parcheggiate le macchine, ora c’erano i tre capi Masai che parlavano animatamente tra di loro. Noi nove ci siamo guardati negli occhi. Nessuno ha aperto bocca. Le macchine fotografiche avevano smesso di clicchettare. Ho avuto paura. Neppure le facce dei miei amici parevano tranquille. Siamo rimasti lì, davanti al restaurant, in attesa del nostro pranzo, e di qualcosa d’impensato. C’è voluta mezz’ora per cuocere 27 chapati. La vecchia che li cucinava li aveva impastati e cotti uno per volta con una calma biblica. Finalmente la cuoca è venuta fuori. Teneva sotto il braccio un mazzo di frittelle calde, unte e puzzolenti di strutto, avvolte in fogli di vecchi giornali. Le abbiamo prese e pagate. Ce le siamo subito distribuite, tre per uno. Però nessuno osava avvicinarle alla bocca. E 245 dire che la fame era grande: non mangiavamo dal pranzo del giorno precedente. La paura e il disgusto mi avevano afferrato allo stomaco. Che fine avevano fatto le nostre guide? E le nostre macchine? Poteva essere successo di tutto. Poteva succederci di tutto. Era questa, finalmente, l’avventura? È passato un altro quarto d’ora, con noi lì, in silenzio, paralizzati dalla fifa, circondati da selvaggi sghignazzanti. Quand’ecco che abbiamo sentito, di lontano, i motori delle Land Rover che si avvicinavano. Ci siamo voltati all’istante. Sotto una nuvola di polvere, dalla direzione opposta a quella da dove eravamo venuti, le nostre jeep correvano a velocità sostenuta. In mezzo minuto hanno raggiunto il villaggio. Sono entrate dentro. Hanno inscenato un rapido carosello intorno a noi, facendo schizzare via i Masai come polli spaventati. Si sono fermate senza spegnere il motore. Giuliano era nella prima macchina. Ha aperto uno sportello e ci ha fatto un rapido cenno. Noi siamo saltati dentro e le macchine sono ripartite a razzo sgasando nella polvere. Non eravamo ancora usciti dal villaggio, che ci ha investito una pioggia di lance e di sassi. Uno dei quali, il più grosso di tutti, ha centrato in pieno il vetro posteriore della jeep in cui ero salita io. Il vetro è andato in frantumi e il sasso mi ha sfiorato una spalla. Ho fatto appena in tempo a rannicchiarmi sul sedile che eravamo già fuori pericolo. Vincent, che ora si era dimostrato un abile e accorto autista, oltre che magnifica guida alpina, ci ha detto che si erano allontanati dal campo perché avevano intuito che i Masai volevano derubarci. Volevano razziare i bagagli che stavano ammucchiati sui tettucci delle macchine. Chissà se era vero? Certo è che se hanno voluto farci provare il brivido dell’avventura ci sono riusciti. Abbiamo fatto una sosta e Giuliano si è venuto a sedere accanto a me. Ha bevuto dalla borraccia. Ha addentato con un unico morso due dei miei chapati, che gli avevo ceduto volentieri. Si è voltato verso di me, ha dato un altro fiero morso alle frittelle puzzolenti. Quindi, con la bocca piena, ha parlato: 246 “Chissà, forse rientra tutto nel programma di Avventure nel Mondo. Questi poveracci di Masai devono pur guadagnarsi da vivere. Può darsi che i soldi che abbiamo versato servissero a pagare la sceneggiata.” Siamo andati avanti per altre cinque ore sotto un sole soffocante. Gradualmente la savana si è diradata, fino a trasformarsi in un paesaggio semidesertico. Per l’intero tragitto non abbiamo visto un essere vivente che fosse uno, neanche un animale. Alla fine siamo giunti alla nostra meta, il lago Natron dei fenicotteri rosa, paradiso di struggente bellezza – parola del Touring Club. Ci siamo fermati in un altro villaggio Masai, uno più civilizzato del precedente, sebbene solo un po’. Dove il più avanzato livello di sviluppo s’intuiva da due cose: dalla pianta rettangolare delle capanne, invece che rotonda, e dall’esistenza di uno spaccio. Non ho visto restaurant, il che mi è parso un buon auspicio. Lo spaccio non era altro che una capanna con una finestra quadrata senza imposte. Alcuni di noi si sono avvicinati e si sono sporti dentro. Anch’io l’ho fatto, dietro gli altri. Sui muri giallo sterco dell’interno pendevano quattro rudimentali scaffali di latta su cui erano esposte poche merci essenziali: sale, fiammiferi, sigarette, sapone, strutto, gallette e coca-cola. Nient’altro. Abbiamo fatto incetta di gallette e coche. Queste erano calde come ciofeche, eppure non ce ne siamo scolate meno di tre ciascuno. Le gole riarse dalla polvere e gli stomaci incendiati dai chapati ne hanno ricevuto un sollievo piuttosto fugace. Mentre il gruppo si rinfrescava, diciamo così, è successo un fatto strano. Giuliano, insieme a Vincent, si è allontanato dagli altri e si è inoltrato nel villaggio perdendosi tra le capanne. Due Masai li accompagnavano e altri quattro li seguivano poco discosti. Noi, tutti gli altri, ci siamo seduti per terra, con le schiene appoggiate allo spaccio, a goderci le coche calde sotto il sole rosso del tramonto. Siamo stati circondati dai ragazzini e dalle donne. Sembravano più cordiali dei loro compatrioti di Wasu. “Picture! Picture!” Gridavano i ragazzini. Volevano essere fotografati per incassare il pedaggio che, per una legge non scritta ma inderogabile, gli 247 spettava di diritto: una foto, una moneta. Le donne invece ci assillavano coi loro innocenti manufatti di perline. Da venti metri di distanza ci osservava un gruppetto di guerrieri armati. Sorridevano onestamente. Erano belli come eroi di un mondo primevo, nei loro dignitosi stracci amaranto che coprivano malamente i corpi lisci e duri. La pelle d’oro brunito, tesa sui muscoli calmi, lasciava vagheggiare ebbrezze e furori selvaggi. È passata una mezz’ora. Giuliano e gli altri sono tornati. Ci siamo rimessi in moto e dopo pochi minuti ci siamo fermati a quello che le carte davano per l’unico camping attrezzato nel raggio di cinquecento chilometri. Era una casupola di mattoni e bandoni, in cui vivevano due giovanotti inglesi. C’erano anche una mezza dozzina di servi negri. Tutt’intorno alla casupola, a formare un cerchio poco più ampio di un quarto di ettaro, un’alta palizzata di tavole ben tagliate e intrecciate col filo spinato. Pareva un fortino. Era il camping, ma non c’era una tenda che fosse una. Il prezzo era di 16 dollari a tenda per notte, per campeggiare dentro la palizzata, 4 dollari per campeggiare fuori. Naturalmente abbiamo scelto la seconda soluzione: L’aventure est l’aventure. Abbiamo montato le tende, sempre circondati da ragazzini e donne Masai. Poi il sole è calato all’improvviso, portando una notte minacciosa. Abbiamo acceso un fuoco stentato, ci siamo seduti intorno e abbiamo mangiato in silenzio delle scatolette di tonno e fagioli che c’eravamo portati dall’Italia. I Masai se n’erano andati col sopraggiungere del buio. Siamo rimasti intorno al fuoco ancora qualche decina di minuti, chiacchierando stancamente. Infine ci siamo ficcati nelle tende e siamo crollati nel sonno. Dodicesima notte e tredicesimo giorno. Sono stata svegliata da certi rumori sulla tenda, come se qualcuno ci grattasse sopra con le unghie. Con un calcio ho svegliato Giuliano, che russava al mio fianco. Lui ha smesso di russare, e anche i rumori fuori la tenda sono cessati. “Che c’è?” Ha detto. “Ho sentito dei rumori strani.” 248 “Io no. Dormi.” Siamo rimasti in silenzio per qualche minuto. Quando lui si è riaddormentato e ha ripreso a russare è ricominciato il raspare alla tenda. Ho mollato un altro calcio. “L’ho sentito di nuovo.” “Gesù, Giuseppe e Maria!” “Aspetta. Non ti riaddormentare. Ascolta.” Mi sono messa a imitare il suo rantolo monotono. Quel rumore sulla tenda si è fatto subito risentire. Veniva dalla parte di Giuliano. “Che vuoi che sia?” Ha detto. “Una scimmia curiosa.” “O un leopardo.” “Sì, magari un uomo-leopardo.” “Cioè?” “Te lo racconto domani, ora dormi.” Ha dato un colpo con la mano sulla parete della tenda. Dei passi rapidi e lievi si sono allontanati. Sarà stata proprio una scimmia curiosa. Ho cercato di riaddormentarmi. Giuliano si è girato dall’altra parte. Dopo qualche minuto si è rigirato, e poi ancora una volta. E ancora e ancora. Anch’io non riuscivo a prendere sonno. I primi chiarori dell’alba filtravano tra l’ordito della tenda. “Visto che ormai non si dorme più,” ha detto lui, “potremmo riprendere quel discorso.” “Che discorso? “L’altra notte mi hai raccontato un sogno assurdo senza arrivare al dunque. Mi vuoi spiegare le cose per benino ora?” “Ti ho già detto quasi tutto. Resta solo che ti reciti la poesia che contiene la chiave, forse la chiave che stai cercando.” “La sai a memoria?” “Naturale. Prendi carta e penna, ché te la detto.” Lui ha rovistato nello zaino, ha tirato fuori la sua agendina e la matita, ha acceso la lampadina e: “Sono pronto.” Ha detto. “È intitolata ‘La chiave della verità. A valentine.’ Particolare rilevante: le ultime due parole vanno in corsivo. Recita così: Ti leggon quasi tutti sulle righe verità, tra le righe molti meno, 249 happy fews, venticinque o giù di lì. Nel libro per tutti, per pochi e per nessuno stai scritta soltanto nei nomi e ti trova chi ti cerca oltre, chi ti cerca altrove. Per svelarti ti veli di menzogne, non sai darti senza negarti, né dirti senza smentirti, verità più vera. E però non ha fine la cerca della chiave, perché non esiste una fede che una logica tagliente non possa smembrare. Né c’è yogin che apra una porta che non apra la strada verso un’altra, non c’è un’ultima porta da aprire. Non c’è da credere, proprio no, che esista una stanza da cui si possa uscire senza entrare dentro un’altra. La cerca del Graal è una condanna: non appaga, ma non dà tregua, neppure quando infine ti rivela il senso, che non c’è. Ed è vero: la scienza dà il meglio di sé nel demolire: costruire, sa solo creare nomi e parole per prendere il mondo. Perciò la formula che trovi, mia cara, non chiederle di darti la chiave per capire il mondo, ma solo qualche scarna lettera di un nome. E il nome cerca, indaga la parola, but remember: le parole della scienza sono molto più eloquenti se dette da un poeta… Non t’inganna la parola che si serve dell’inganno, – come disse D. A. F. Leroy nel Code Saint Peerlesfoy – non t’inganna se detta da un poeta. 250 You go on, then: never cease trying. Even if you know that you would not read the riddle, go on: riddle the read, go on. But remember: non c’è nodo che infine non sciolga una spada, che infine non ceda alla lama di una logica affilata. “Ecco,” ho concluso, “se esiste una chiave della verità, è nascosta in questa poesia.” “Bene, qual è?” “Devi scoprirlo da solo. Devi decifrarla tu.” “Chi è Valentine?” “Qui sta il bello. Rifletti. Ti ho detto che le ultime due parole vanno scritte in corsivo. Ma non voglio dirti altro. Non voglio toglierti il gusto della scoperta. Ti ho dato tutti gli elementi necessari per venirne a capo. Rifletti bene a quanto ho detto l’altra sera, a quei pezzi di discorsi fra l’onirico e il letterario. Ricollega le parti e ricostruisci l’insieme. Puoi riuscire a risolvere l’enigma. Bene, ora cambiamo discorso, ché anch’io ho da togliermi una o due curiosità.” “Sentiamo.” “Che siete andati a fare oggi tra le capanne del villaggio Masai, tu e Vincent? E dove sei andato ieri, quando ti sei allontanato dal gruppo nell’altro villaggio?” “Ah ah! Potrei dirti che sei in grado di capirlo da sola. Collega le parti e ricostruisci l’insieme, potrei dirti.” “Stronzo.” Ho chiuso la conversazione e mi sono girata dall’altra parte. Lui si è fatto una risatina. Mi si è accostato e mi ha messo un braccio sulle spalle. L’ha fatto scivolare sul petto. Ha titubato per qualche secondo. Mi si è stretto addosso e, a dispetto di due strati di sacco a pelo, mi ha fatto sentire le sue intenzioni senza parlare. L’unica cosa che ha rimediato è stata una gomitata nello stomaco. Stranamente sono riuscita a riprendere sonno. 251 Quattordicesimo giorno. Sono stata svegliata dal vociare della brigata. Erano le nove. Ci si preparava a un’escursione che prometteva bene. Mi sono affrettata a vestirmi e ho raggiunto gli altri mentre stavano per lasciare il campo. Dovevamo risalire l’Uaso Nyiro, il principale affluente del lago Natron, fino a raggiungere delle cascate che per le guide turistiche erano di una bellezza edenica. Siamo andati avanti per una mezz’ora, sotto il sole che avvampava feroce, su un terreno bianco di sabbia e di sassi. Abbiamo raggiunto il fiume in un punto in cui usciva dalla stretta di due colline brulle. Più che un fiume era un grosso torrente, largo sui tre metri. Ma eravamo lontani dalla stagione delle piogge. Il sentiero che lo costeggiava era appena visibile e spesso si perdeva nelle acque, costringendoci al guado diverse volte. Il torrente scendeva dai monti tra due pareti di roccia gialla e nera che diventavano sempre più ripide e più alte man mano che si saliva. Spesso si stringevano sul fiumiciattolo quasi a volerlo strozzare. In alcuni tratti, stando in mezzo al torrente si potevano toccare le due pareti stendendo le braccia. Diverse volte ci siamo dovuti arrampicare sulle rocce per andare avanti. Abbiamo scalato i monti così, di guado in guado, arrancando sui sassi e le pareti scoscese per un’oretta buona. Alla fine, dopo un’ultima ansa, siamo giunti su un ripiano. Le pareti rocciose si aprivano in cerchio a formare un ampio seno. Tra di esse il fiume si allargava tramutandosi in un laghetto. Le acque verdi erano circondate da rive erbose. In fondo, di fronte a noi, una cascatella scendeva da una parete di rocce popolate da palme e seneci. Non era una gran cascata. Alta una decina di metri, scendeva giù sottile che pareva poco più di una fila di docce. Erano quattro giorni che non ci facevamo il bagno e tutti abbiamo avuto la stessa idea. Incuranti della bellezza edenica del posto, abbiamo tirato fuori shampoo e saponette, ci siamo spogliati e siamo corsi sotto le docce. È stata una lussuria ed è durata a lungo. Poi abbiamo nuotato nelle acque intorbidite dalla nostra invadenza. Infine ci siamo stesi nudi sull’erba a prendere il sole. Soltanto allora ci siamo veramente accorti della magia del posto. 252 Accanto a me c’era Vincent. Per quasi tutto il viaggio ero stata seduta accanto a lui, nel sedile anteriore della sua Land Rover, e avevo avuto modo di conoscerlo. Non era molto amato dal resto del gruppo, che preferiva l’altro autista, il gentile e servizievole Otto. Vincent invece, raro soggetto di Masai civilizzato, ha sempre svolto il suo lavoro con dignità e distacco e senza nascondere un’ombra di sprezzatura verso la banda di turisti vocianti e volgari che pretendevano di trattarlo da Andalù. Proprio per questo invece a me piaceva. Non solo: aveva due occhi grandi, lo sguardo fiero, il naso camuso e le labbra tumide ma senza esagerazione e ben modellati l’uno e le altre. Alto di statura e di pelle vellutata, il suo corpo esibiva muscoli elastici senza eccessivi turgori. Fin dall’inizio mi era sembrato una promessa di furore. Ora che lo avevo visto nudo non desideravo altro. Lui se ne stava lì, sdraiato accanto a me. Sentivo il soffio del suo respiro calmo. Mi sono voltata verso di lui e l’ho guardato in tutto il suo splendore, nudo com’era. Dopo qualche secondo lui s’è voltato verso di me e mi ha guardato negli occhi, nuda com’ero. “Vuoi venire con me?” Ha detto. “Dove?” “In Paradiso.” “Oh, sì.” Ci siamo alzati. Ci siamo tuffati in acqua e abbiamo nuotato fino alla cascata. Vincent vi si è spinto sotto, si è alzato in piedi e si è addossato alla roccia. L’ho seguito. C’era un gradino naturale, nascosto poco sotto il livello dell’acqua. Aggrappati alla parete, le abbiamo strisciato contro, camminando su quel gradino. L’acqua della cascata ci nascondeva malamente alla vista degli altri. Dopo qualche metro il gradino è rientrato dentro la montagna e ci siamo trovati in una fenditura, alta un due metri e larga appena da lasciarci passare una persona. Sul fondo scorreva un’acqua vorticosa. Vincent mi ha preso per mano e mi ha trascinato nel buio del tunnel, che saliva in leggera pendenza penetrando nella montagna. Si faceva fatica a procedere, tanto era forte il flusso. Dopo una ventina di metri il tunnel ha svoltato a sinistra e dal suo fondo è emerso un raggio di luce. Abbiamo 253 camminato nei flutti vorticosi per un’altra ventina di metri, finché non ci siamo trovati di nuovo sotto il sole. Ora capivo com’era possibile che quella cascata esile in cui avevamo fatto la doccia potesse alimentare l’Uaso Nyiro. Non era possibile; infatti una buona metà della portata del fiume proveniva dal tunnel. Il torrente, oltre la grotta, assumeva un andamento a rapida. Lo abbiamo risalito per un breve tratto, fra rocce e sassi, e ci siamo trovati in mezzo a uno slargo che formava una pozza di piccoli vortici furiosi. Tutt’intorno si alzavano delle pareti scoscese, umide di muschio, e piene di fiori e di piante rampicanti. I raggi del sole vi disegnavano sopra ghirigori dai riflessi arcobaleno. Un vero paradiso in miniatura. L’acqua nel piccolo slargo era tiepida e mi arrivava all’altezza dei fianchi. Pareva un vigoroso idromassaggio. Veniva voglia di lasciarsi andare alla corrente, se non fosse stato per le rocce su cui si sarebbe andati a sbattere. Ho allargato le gambe e mi sono piegata sulle ginocchia. Flutti violenti mi avvolgevano il petto, i fianchi, il ventre, le cosce, come mille mani vogliose e impazienti. Sentivo solo il rumore delle acque, e la presenza muta di Vincent dietro di me. Mi sono voltata adagio, alzandomi di nuovo in piedi. Lui stava lì che mi guardava estatico, gli occhi perduti in una sorta di dolorosa contemplazione. La pelle d’ebano ramato, tutta imperlata di rugiada, tratteneva a stento il vibrare dei muscoli tesi. I miei occhi, stregati, sono scivolati inesorabilmente lungo quel corpo stupendo. Tra il vorticare delle acque hanno intravisto il membro possente. Allora il mio corpo ha preso le redini. Si è mosso verso il suo senza che neanche ci pensassi. Gli ha gettato le braccia al collo. Ha sollevato i piedi dal fondo del fiume e si è lasciato gettare dalla corrente contro di lui. E mentre lui si piegava leggermente in avanti per reggere la spinta, le mie gambe si sono avvinghiate ai suoi fianchi. Ho chiuso gli occhi e mi sono abbandonata al suo abbraccio. Ho perso la cognizione del tempo e ho avuto un orgasmo selvaggio. È esploso dentro di me con un urlo di furore e non so quanto è durato. Poi ho mollato la presa delle braccia dal suo collo e, stendendole in fuori nella posizione del morto a galla, mi sono affidata alle acque. Ma con le gambe sono rimasta avvinghiata al suo 254 corpo. Lui mi stringeva i fianchi con le mani, sempre stando un po’ piegato in avanti, e dimenava il bacino con ritmo lento e vigoroso. Le ondate delle sue reni si confondevano con i flutti del fiume e mi facevano oscillare la mente. Ho aperto gli occhi e ho visto il cielo sopra di me, lontanissimo, sperduto tra le alte pareti rocciose. Sotto, sentivo i vortici, e sembrava volessero liquefarmi il corpo. Dentro, un rimescolio dello spirito. Ed ecco, innescato da un’accelerazione dell’onda dei fianchi di lui, è esploso un altro orgasmo, più potente del primo, se possibile. È esploso su di lui, insieme al suo. Improvvisamente c’è stato un grido, e il mio corpo s’è irrigidito intorno al suo; allora la mia mente è stata sbalzata in spazi al di là del nulla. Alleluia! Mammamia, quale insulsa letteratura devo aver letto per scrivere roba come questa?! Quattro ore dopo ancora non mi ero ripresa dallo shock. Stavo seduta accanto a Vincent nel sedile anteriore della Land Rover, sulla via del ritorno. Era l’ultimo giorno dell’avventura. Finalmente, quando una sua mano, staccatasi dal volante, si è posata sulla mia, mi sono risvegliata dal sogno. “A cosa stai pensando?” Ha detto lui. Ma ormai l’incantesimo era rotto. “A Niente.” Ormai l’incantesimo era rotto. Così ho ripreso il controllo della situazione. Volevo sapere cosa erano andati a fare lui e Giuliano quando si erano inoltrati tra le capanne del villaggio Natron, il giorno precedente, e cosa erano andati a cercare quando si erano allontanati con le macchine dal villaggio Wasu due giorni prima. Gliel’ho domandato. Lui me l’ha rivelato senza problemi. Erano andati a cercare l’uomo-leopardo, uno sciamano che secondo Giuliano doveva trovarsi nell’uno o nell’altro villaggio. Lo avevano trovato a Natron. Giuliano gli aveva chiesto di poter assistere a un certo rituale. Qualche tempo prima era venuto un altro turista italiano che vi aveva assistito e glielo aveva riferito. Adesso era curioso di vedere anche lui. Aveva offerto una bella mancia d’incoraggiamento. Però lo sciamano non aveva voluto saperne e non c’era stato verso di convincerlo. 255 La deviazione al lago Natron era stata un’idea di Giuliano, e Vincent era stato convinto con una mazzetta a fare quel viaggio fuori dei consueti percorsi turistici. Dopo tre ore ci siamo fermati per sgranchirci le gambe. Ne ho approfittato per cambiare jeep e sedermi accanto a Giuliano. “Cos’era quel rituale che lo sciamano del villaggio Natron avrebbe dovuto eseguire espressamente per te?” Gli ho chiesto a bruciapelo. “Oh, oh! Volevo ben dire!” “Cosa?” “Che tu, almeno per una volta, ti fossi goduta una scopata gratis. Così il bel Vincent...” “Di questo non ti curare. Le mie scopate ti devono interessare solo quando le paghi tu. Ora rispondi alla mia domanda. O siamo di fronte a un altro dei tuoi ermetici segreti?” “No, no. Nessun segreto. Sono venuto al lago Natron proprio per incontrare l’uomo-leopardo. È un soggetto piuttosto famoso tra gli studiosi di parapsicologia. Sai perché?” “Perché?” “Perché sarebbe capace di entrare in catalessi restando seduto, e poi levitare.” “Ma va là!” “Io non ci credevo, Luciano invece sì. Ne avevamo discusso. Il viaggio in Africa lui lo aveva già fatto e aveva conosciuto lo stregone. Ad ogni modo sospettavo che non c’era venuto per quest’unico motivo. Così, ho voluto seguirne le orme. Solo per curiosità, beninteso. Anzi solo per vacanza. Tant’è vero che ti ho portato con me.” “Solo per vacanza, eh? Per vedere lo stregone.” “Esatto.” “O magari per vedere anche lo stregone.” “E soprattutto...?” “E soprattutto per trovare la poesia che Luciano aveva trascritto sul quaderno degli alpinisti a Gilman’s Point.” “Brava. Non ti sfugge niente.” “Eppure Luciano non può essere venuto in Africa esclusivamente per nascondere la poesia di una caccia al tesoro.” 256 “Lo penso anch’io. Credo che la poesia fosse lo specchio per l’allodola, che poi sarei io. La volevo fino allo spasimo quella poesia. Luciano, per farmela avere, mi ha fatto venire a prenderla in Africa. Così avrei potuto vedere lo stregone e credere all’incredibile.” “Insomma, lui cosa cercava in Africa? “Cosa ha sempre cercato Luciano?” “Dimmelo tu.” “La luna nel pozzo, l’utopia, l’uomo nuovo, e di più, ancora di più.” “Di più? Che altro ancora?” “Levitazione. Lui voleva staccarsi dalla terra, voleva librarsi nell’aria.” “Bella metafora, coglie un aspetto essenziale del grand’uomo. Non ti facevo poeta.” “Cara, il tuo ganzo lo conosco da molto più tempo di te.” “Ma l’uomo-leopardo?” “Questa è un’altra storia, e piuttosto lunga.” Ha detto, duro, quasi a voler mettere un punto. Guardava avanti, attraverso il finestrino tutto opaco per la polvere della savana. La macchina continuava a sobbalzare sulla pista sconnessa. Le nostre schiene ormai neanche reclamavano più e i corpi indolenziti se ne stavano spaparanzati sui sedili scomodi della jeep, come intontiti da un sonno leggero e disordinato. Le menti però erano sveglie. L’Africa mi ha dato se non altro l’esperienza di una mistica separazione della mente dal corpo. Mentre pensavo questa fantasia, continuavo a guardare Giuliano. Lui, dopo qualche secondo di assenza in cui forse stava provando la stessa sensazione di dissociazione che stavo vivendo io, s’è risvegliato e s’è voltato verso di me. “Vedi,” ha ripreso il discorso senza interromperne il filo, “la contorta mente di quel genio è imperscrutabile, ma io, che non sono stupido, credo di aver capito il suo rovello.” “Sentiamo.” “Morte le speranze rivoluzionarie, Luciano si era ripiegato su se stesso, senza tuttavia rinunciare neanche a un grammo della sua aspirazione all’assoluto. Si era chiuso nella torre d’avorio, 257 dall’alto della quale sputava in testa ai comuni mortali, e aveva continuato la ricerca dell’uomo nuovo. La mia impressione è che in realtà, nella mente del genio, l’eroe ricercato si fosse gradualmente trasformato, che avesse subito una metamorfosi, diventando sempre meno marxiano e sempre più nietzschiano. Gliele avevo dette a lui queste cose. Sai cosa mi aveva risposto?” “Cosa?” “Che non avevo del tutto torto e neanche del tutto ragione…” “Ovvio.” “E che la cosa era meno contraddittoria di quanto pensavo.” “Che c’entra lo sciamano?” “L’uomo nuovo, diceva, sarebbe un assassino. Un assassino dell’uomo vecchio, dei suoi idoli, delle sue illusioni.” “E allora?” “Allora per uccidere un mito non basta negarlo. Bisogna dissipare il fondo di oscurità da cui prende vita. Secondo lui gli idoli più tenaci sarebbero quelli generati dal pensiero magico e religioso.” “Addirittura!” “Sosteneva che questa tenacia era legata all’esistenza di certi territori bui, certe zone d’ombra della mente che suscitano fenomeni non ancora spiegati dalla scienza.” “Come la catalessi?” “Sì. Il suo miraggio era di strappare quel velo d’oscurità, di ridurre i miracoli a una formula matematica.” “Il che mi sembra credibile. Quadra con il personaggio, anche se non mi convince del tutto.” “Neppure a me. C’era dell’altro.” “Cosa?” “Luciano era affascinato, anzi, ossessionato, da quelle zone d’ombra.” “Vabbè, ma l’uomo-leopardo?” Ho insistito. “È lo sciamano. Secondo certi miti Masai i suoi poteri arrivano al punto di consentirgli una metamorfosi nell’animale. Di giorno sarebbe uomo, di notte leopardo. Una bestia molto singolare: non vagherebbe nella foresta; si aggirerebbe invece in cerca 258 di qualcosa tra le capanne dei villaggi e in tutti i posti frequentati dagli uomini.” “In cerca di che cosa?” “Non lo so. Lui gira nei villaggi tra gli uomini che dormono. Cerca di penetrare nei loro sogni, di carpirne i segreti. Magari era proprio lui che raspava alla nostra tenda stanotte.” “Già. E magari era sua quella famosa carcassa sulla cima del Kilimangiaro.” “Perché no? Hemingway aveva capito che era solo una carcassa. Luciano non lo aveva ancora capito.” “Da cosa lo deduci?” “Dal fatto che voleva ucciderlo.” Sono rimasta in silenzio, a guardare attraverso il finestrino sempre più opaco di polvere. A causa di quei vetri sporchi il panorama ci giungeva nebbioso, immerso in una grande ombra. Il deserto cancellava i pochi rimasugli di savana. Cespugli spinosi e basse acacie di un colore giallo smorto lo popolavano radi, a perdita d’occhio. In quel momento la jeep stava correndo su un leggero rilievo collinare. Non era molto alto, quanto bastava per farci abbracciare con lo sguardo un immenso panorama di fantastica desolazione. Lontano, davanti a noi, si elevava una bassa catena montuosa. Ai suoi piedi, dei vortici di vento avevano formato delle altissime colonne di polvere, quasi dei piccoli tornado. Ce n’erano diversi. Si alzavano in cielo più alti del profilo biancastro delle montagne e parevano dei sinuosi simboli fallici. Era uno spettacolo primordiale e disumano. Per un attimo ho avuto la strana impressione di assistere al manifestarsi di un evento ultramondano. Non è stato un satori, stavolta. Ciononostante mi è venuto un altro bel pensierino della sera degno di Luciano. Ho pensato che la ragione per cui le religioni trascendentali non hanno mai veramente attecchito in Africa è che qui il sacro è immanente al quotidiano. L’unica vera religione africana può essere quella che i cristiani chiamano ‘animistica’, i cristiani che conoscono Dio dai libri. 259 Mi è sembrato un bel pensiero e l’ho annotato sul mio taccuino. Ahimè, più passa il tempo più mi scopro simile a Luciano. Già mi colgo a vedere il mondo per aforismi. Forse per questo il mio demone della saggezza mi ha proibito di scrivere un diario del safari. Adesso, evidentemente, sono sotto il dominio del peggior Luciano che si annida in me. Come che sia, al momento ero soddisfatta della pensata. Così mi sono voltata verso Giuliano per comunicargliela. Lui non mi ha manco sentito. Se ne stava lì, con gli occhi perduti nel vuoto, a contemplare anche lui, un po’ estatico e un po’ allibito, quell’epifania dell’essere. Quando ha sentito il mio sguardo su di sé, si è voltato pigramente dalla mia parte e ha detto: “Mi sa che ho capito cosa cercava quel leopardo.” Dunque il leopardo. La mia mente da un po’ di tempo frullava intorno a questo soggetto. In quel momento mi misi a pensarci intensamente, all’uomo-leopardo, ma soprattutto ancora a Luciano, che proprio allora mi sono ricordata veniva chiamato Leopardo ai tempi del movimento studentesco. Stavo per parlarne con Giuliano; quand’ecco, manco a farlo apposta... Lontano, sulla pista davanti a noi, si vedeva un camion in sosta e degli omini che gli giravano intorno. Saranno stati distanti un chilometro e in pochi minuti li abbiamo raggiunti. Le nostre jeep si sono fermate e noi siamo scesi a valanga, contenti di poterci sgranchire le gambe. Il camion era ricoperto da un telone, da sotto il quale venivano strani rumori. Due degli omini che gli giravano intorno erano i giovanotti inglesi del camping sul lago Natron. Dietro il camion, alla sua ombra, tre inservienti tanzaniani stavano apparecchiando un tavolinetto per il tè. In un anfratto distante un centinaio di metri c’era una pozza d’acqua potabile, ci dissero le nostre guide. Tutti si precipitarono in quella direzione. Io invece rimasi accanto al camion e attaccai discorso con i due inglesini. Loro, con rude gentilezza colonialista mi ordinarono di sedermi a prendere il tè. Non chiedevo di meglio. Così iniziammo un’interessante conversazione sul leopardo. Sotto la tenda del camion c’erano due gabbie abitate da due esemplari di questa bestia. Erano destinati a uno zoo svizzero. 260 Gli inglesini li avevano appena catturati e ora li portavano a Nairobi per spedirli. “Ah, ecco qual è il vostro vero mestiere!” Ho detto. “Sì, ma oggi non rende. I paesi civilizzati si stanno liberando dei giardini zoologici, che non vanno più di moda. Per fortuna ci sono gli svizzeri.” Queste cose le ha dette Bruce, un tipo nerboruto dal ciuffo biondo-cenere che gli cadeva sugli occhi, la pelle abbronzata che pareva cuoio conciato. Intanto l’altro, Michael, un moretto dagli occhi azzurri e gli occhiali cerchiati d’oro, tipo intellettuale cantabrigense, mi versava un tè profumatissimo in una squisita ceramica di Sèvres. Gli ho chiesto di parlarmi dei leopardi. “Sono animali che conosco poco e che m’interessano molto.” Ho detto. Ha risposto Michael, sorseggiando il tè fumante. Stava seduto con composta nonchalance sulla sua sediola di tela, una gamba accavallata sull’altra, gli occhietti penetranti fissi su di me. “Il leopardo”, ha detto, “è il vero re della foresta...” “Lo sarebbe”, ha interrotto Bruce, “se...” “Già, è troppo anarchico per essere re.” Ha ripreso l’altro. “È un animale individualista. Non fa branco. Non fa famiglia. Anche nell’accoppiamento, morde e fugge. La femmina si fa ingravidare e poi se ne va per conto suo ignorando completamente il maschio. Non ci sono divisioni di ruoli tra i leopardi. Non ci sono proprio ruoli. Il leopardo vive solo. Rifiuta ogni legge e ogni costrizione. Ed è difficilissimo cacciarlo, appunto perché non ha regole né abitudini. È imprevedibile più di un serpente, intelligente più di una tigre, feroce più di un leone. Se viene ferito diventa una belva implacabile. È capace di vero odio, e quando ammazza un cacciatore si accanisce su di lui fino a ridurlo in pezzi. Non gli basta uccidere, deve dilaniare. È di una scaltrezza quasi umana. Quando caccia il bufalo, per esempio, si rotola nei suoi escrementi per confondere gli odori e sorprendere la vittima. Quando viene inseguito dai cacciatori non si limita a fuggire, ma si allontana quanto basta per poter tornare indietro non visto, tracciando un ampio cerchio, e cogliere alle spalle i 261 suoi nemici. Non per niente il leopardo incarna lo spirito della distruzione e della trasformazione nella religione Masai.” “È stupendo,” ha concluso Bruce, “la bestia più elegante della foresta. Le macchie delle pellicce sono diversissime da un esemplare all’altro e possono assumere forme strane. Lo sfondo giallo acquista riflessi dorati sotto la luce del sole e nella notte brilla del colore della luna. È un vero peccato ucciderlo, un sacrilegio prenderlo vivo.” “Ed è ignobile catturarli per mandarli a rinchiudere in uno zoo svizzero.” Ha continuato Michael. “Ci sarebbe da vergognarsi se non fossimo inglesi.” Chi ha detto che gli inglesi sono incapaci di autoironia? In quel momento, da sotto il telone, è esploso un tremendo ruggito che mi ha gelato il sangue. “Sarebbe possibile vederli?” Ho chiesto a bruciapelo. I due giovanotti si sono guardati. “Perché no?” Ha detto Michael. Al che Bruce ha dato un ordine secco in swahili. I tre inservienti si sono precipitati dall’altra parte del camion e con uno strappo violento hanno tirato giù il telone. Due gabbie di ferro troneggiavano sull’automezzo. Dentro di esse due magnifici esemplari di leopardo dalla pelliccia d’oro maculata. “Questa è Karen,” ha detto Bruce, indicando la bestia più vicina a noi, “una femmina non tanto giovane.” Ha concluso, guardandola con ammirazione innamorata. Lei, fiera e flemmatica, volgeva con calma la testa di qua e di là, guardandosi intorno. Nella gabbia stretta e bassa se ne stava seduta sulle zampe posteriori, il busto eretto, il collo dritto. Si vedeva subito che era una creatura orgogliosa. Sembrava ignara della cattività. Non lo era. Quanto avrei dato per ammirarne il passo elegante! E pensare che sarebbe finita ad allietare le giornate dei figli degli impiegati di banca. Cosa avrebbe pensato lei della sua nuova condizione, lassù nei paesi civili? Avrebbe rammentato il suo paese perduto? Le savane, i deserti, i fiumi, le montagne azzurrine e le scorribande sulle colline di Ngong? 262 “L’altro è Denys,” ha continuato Bruce, “un giovane maschio nel pieno del vigore fisico. Li abbiamo catturati durante l’accoppiamento. È stato facile. Due colpi di pallottole soporifere e voilà. Difficile è stato il prima, e rischioso: dover aspettare una notte di appostamento, immobili come piante in una capanna di frasche.” Denys era tutto il contrario di Karen. Non stava un attimo fermo. Pur nella stretta della gabbia continuava a girare intorno a se stesso. Ogni tanto si fermava e cercava di ficcare la testa tra le sbarre. Poi alzava le fauci al cielo e gli lanciava un terribile ruggito. “Ora che gli abbiamo ridato la luce del sole è diventato più nervoso.” Ha osservato Michael. “Dobbiamo rimettere su il telo.” “Aspetta ancora un po’,” ho detto, “fammelo guardare ancora un po’. È così bello!” Era stupendo nella sua rabbia non repressa. Gli occhi roteavano nelle orbite. La testa continuava a volerla ficcare tra le sbarre. Poi alzava una zampa e la brandiva fuori della gabbia mostrando i lunghi artigli bianchi. Poi tornava a incastrare la testa tra le sbarre. E ruggiva tremendamente. Povero Denys, chiuso nel tuo piccolo nuovo mondo di ferro, già lontano mille miglia dagli spazi sconfinati della tua fantasia. Vorresti morire e non puoi. Il resto del viaggio l’ho fatto nella tristezza più nera, sulla jeep sobbalzante, senza neanche accorgermi degli ultimi scorci di quel mondo meraviglioso che l’indomani avrei lasciato forse per sempre. Verso le otto siamo giunti in vista di Arusha, ed è stata una liberazione. Dall’alto delle colline si vedeva la città, distesa sul fondo di una piana sterminata, che accendeva le prime luci nella sera. Infine è calata la notte, è calata in un istante, come un sipario sulla scena. Ultimo giorno. Il ritorno è stato senza storia, identico all’andata, sull’aereo dell’Egypt Air che volava alto sopra un mare di nuvole. Perfino l’alba purpurea che si spalancava su quel mare non mi ha fatto un grande effetto. Mi è solo venuto da pensare che, stranamente, non saranno le savane, le giungle, gli animali e tutto 263 il resto a imprimersi in modo indelebile nei miei ricordi d’Africa, ma le albe, le prodigiose albe africane, prodigiose e un po’ oleografiche, sì, ma prodigiose. Sì, è stato un ritorno senza storia e non meriterebbe di essere menzionato se non per rievocare una conversazione letteraria che, rilassati nei comodi sedili dell’aereo, ci siamo goduti io e Giuliano sorseggiando Champagne. “Bisogna risalire a Rimbaud”, ha attaccato, “per capire il senso profondo delle ricerche di Luciano in Africa.” “Sono tutta orecchi.” “E per capire cosa cercava Rimbaud in Africa bisogna partire da Livingstone.” “Il grande esploratore?” “Proprio lui. Era un uomo di religione, membro della Società delle Missioni di Londra. Stranamente, nei suoi viaggi in Africa non ha mai impiantato una missione, né convertito un pagano. E non si è mai riusciti a spiegare perché si era fermato a Ujiji così a lungo, quando tutti lo avevano dato per disperso.” “Insomma un fesso.” “Non direi. Nessuno ai suoi tempi conosceva l’Africa meglio di lui. Per capire la sua grandezza bisogna entrare nel suo mondo spirituale e uscire dalle banalità della vulgata.” “Tu naturalmente l’hai capito.” “Non sei molto spiritosa. Cerca almeno di essere paziente. Vedrai che questa storia t’interesserà. Le cose che sto per dirti me le ha raccontate Luciano. Sono il risultato di sue personali ricerche e il prodotto di sue ipotesi. Io te le riferisco come tali.” “OK. Vai avanti.” “Livingstone sarebbe stato un gran maestro della Golden Dawn. Luciano mi ha detto che alla biblioteca della LUFSS ci sono le carte di una corrispondenza tra Livingstone, Robert Browning e gli Stibbert padre e figlio, dalle quali risulterebbe che il grande esploratore sarebbe stato mandato in Africa in missione speciale. “Che missione?” “Trovare il re del mondo.” “E la Peppa!” 264 “Non ti agitare. Sappi che qui siamo in una zona di confine tra la letteratura e la follia, e ricorda che sto riferendo delle tesi di Luciano. Per quanto...” “Per quanto?” “Per quanto anch’io, stimolato da lui, ho fatto qualche lettura sulla materia, solo per divertimento, però, te l’assicuro.” “Su questo non ho dubbi.” “Il percorso apparentemente sconclusionato dei viaggi africani di Livingstone acquista un senso se letto nell’ottica di quella ricerca. Si tratta infatti di una serie di viaggi intorno ai Monti Mitumba nel Congo orientale, con un movimento concentrico mirante al cuore del continente. A Ujiji Livingstone si sarebbe fermato in attesa del permesso per penetrare nel regno.” “Chi avrebbe dovuto dare il permesso?” “Tippu Tib, un personaggio ambiguo, a quei tempi noto in Africa orientale per essere il più importante trafficante di schiavi e d’avorio. Sembra che nessun esploratore poteva penetrare nel continente senza il suo consenso. Lui conosceva i luoghi, i capi tribù, le lingue, le regole, ed era in grado di dare ordini a tutti. Stanley ne parla come del ‘re occulto’ del cuore d’Africa.” “Stanley chi?” “Sir Henry Morton.” “Il salvatore di Livingstone?” “Il cosiddetto salvatore...” “Anche lui naturalmente cercava il re del mondo.” “Esatto. Anche lui era membro della Golden Dawn. Però aveva un grado d’iniziazione inferiore a quello di Livingstone.” “Chi sarebbe questo re del mondo?” “Nella mitologia buddista è il reggitore segreto dell’umanità. Vive in un paese occulto a cui solo i grandi iniziati possono accedere. Secondo alcuni la residenza del personaggio semidivino sarebbe stata in Asia. Ma per Luciano la tesi asiatica sarebbe fumo negli occhi. Il re del mondo coinciderebbe con il Prete Gianni, incarnazione europea medievale della leggenda. Esisterebbe una tradizione occulta occidentale che risalirebbe addirittura ad Apollonio di Tiana, il grande mago riformatore della religione pagana che operò nel primo secolo. Questi, dopo 265 aver girato tutti i santuari e i templi dell’impero romano, andò a cercare l’iniziazione suprema perfino in India, inutilmente. Infine la ottenne in Africa, da una congrega di santi chiamati Gimnosofisti, saggi nudi. Insomma secondo la più antica tradizione occidentale la vera residenza del re del mondo sarebbe stata nel cuore dell’Africa.” “Dove cercavano di penetrare Livingstone e Stanley.” “Dove Livingstone cercò invano di penetrare e Stanley riuscì a entrare. Il successo del secondo fu reso possibile dalla sua maggiore rozzezza e dall’ignoranza dovuta al basso grado in cui si trovava nella gerarchia iniziatica. Mentre Livingstone si era fermato in meditazione a Ujiji, in attesa del permesso del re occulto, Stanley, seguendo la massima del Vangelo, cercò di conquistare il regno dei cieli con la violenza. Infine ci riuscì. O almeno riuscì a raggiungere il Prete Gianni, che poi sarebbe proprio quel famoso Tippu Tib.” “Parlami di questo regno africano: cosa sarebbe?” “Una sorta d’impero ultramondano e tuttavia reale. Nel Medio Evo se ne aveva una conoscenza leggendaria. Successivamente, dopo le prime scoperte geografiche, i navigatori portoghesi portarono in Europa favole di un tenebroso regno africano. Ne ebbero solo informazioni indirette, quanto bastò per dare esca alla peggiore letteratura esotica. Nel Settecento ci ricamarono sopra i filosofi del buon selvaggio.” “Perché tenebroso, se era un regno dei cieli?” “Be’, se ne sono sempre avute notizie piuttosto vaghe. Eppure non si allontanarono molto dalla realtà quegli scrittori che lo rappresentavano come un regno del sangue, del sesso sfrenato e altre simili nefandezze. Luciano sosteneva che si trattava di una copertura essoterica mirante a nascondere la verità dicendone solo una parte. Nessuno sa con precisione cosa accadeva in questo regno, il cui nome sarebbe Butua. Lo stesso Stanley, che c’era penetrato due volte, fu reticente. Possiamo farci un’idea di cosa sarebbe successo a chi vi entrava essendo disarmato spiritualmente. C’e un passo di un libro di Jacob Wassermann, un acuto biografo di Stanley, che è parso rivelatore sia a me sia a Luciano.” 266 Così dicendo si è chinato e ha allungato una mano sotto il sedile. Ne ha tirato fuori la sua borsa da viaggio. L’ha aperta e ne ha estratto un libricino tutto rovinato dall’usura e dagli anni. Me l’ha messo in mano. “È il libro che hai sottratto al mio postino?” Ho domandato. “Sì. Diciamo che l’ho preso in prestito. Ora te lo restituisco.” Era un libro dalla copertina arancione, della serie ‘Quaderni della Medusa’. Titolo originale: Bula Matari. “Che razza di titolo è?” “È il nome che gli africani diedero a Stanley. Vuol dire Spaccatore di Pietre.” “Significa qualcosa?” “Può darsi! Non sta forse scritto: Su questa pietra edificherò la mia chiesa?” “Mah!?” “Apri il libro alla pagina con l’orecchia e leggi le parti sottolineate. Parlano di cosa accadde a un plotone di soldati della seconda spedizione di Stanley in Congo, un gruppo di uomini male in arnese che fu lasciato indietro, nel cuore dell’Africa, per consentire al grosso della spedizione di avanzare più speditamente verso il Sudan meridionale.” Ho aperto a quella pagina e ho letto: “Interiormente il grado d’infiacchimento è inimmaginabile. O, per dir meglio, di rammollimento, di perdita di sostanza morale e intellettuale. Si ha il senso di un dilagare di brutture. Si insinua in loro un’avidità cieca, ma affatto impotente. Qualunque cosa facciano o si propongano finisce in un conato impotente [...] Il cervello è spento, la memoria paralizzata, l’energia dileguata [...]; pare loro, a volte, d’aver perduta la propria identità [...] L’oscurarsi della memoria, il colpevole distacco dal passato, lo scindersi del nesso tra causa ed effetto come era prima concepito, l’oblio parziale o totale, in una parola l’inabissarsi in un irrigidimento del corpo e dello spirito, pigro, inerte, avvelenato, solcato soltanto da dolorosi bagliori del superstite sentimento dell’Io [...] ‘Per qualche segreto motivo essi si aggrappano con tenacia estrema a Tippu Tib, tornando sempre a prestar fede alle sue promesse’, dice Stanley [...] Ora il ‘segreto motivo’ non può consistere che in una seduzione ben determinata, che li spingeva verso Tippu Tib. Ma come? Stanley [...] non accenna in nessun luogo, nemmeno con l’al- 267 lusione più lieve, a motivi sessuali od erotici, per quanto ovvii essi appaiano ad un osservatore spregiudicato. E d’altra parte non si è mai tentato, che io sappia, di spiegare l’enigma di Butua da questo lato [...] Non occorre un grande sforzo di fantasia per penetrare oltre il velo di riserbo e d’onesto riguardo di Stanley [...] Tuttavia in un luogo dove torna a parlare della morte di Bartelot [un Maggiore che Stanley aveva lasciato al comando del drappello ritardatario – spiega Giuliano], egli menziona il canto delle donne Maniema e dice che tali canti erano una vera mania delle donne del campo. Egli si esprime in modo assai enigmatico e lascia intendere che quelle donne avevano atteggiamenti da forsennate, ‘o, per essere più preciso – aggiunge – andavano soggette ad attacchi isterici e col loro perpetuo canto di notte impedivano alla gente di dormire [...] E ogni costrizione, anziché far tacere le sciagurate, non faceva che immergerle vieppiù nel loro stato morboso’. L’esplosione di furore in seguito al canto avrebbe causato anche la morte del Maggiore [...] In mancanza di documenti o di informazioni circa gli eventi svoltisi dietro le quinte, tutto rimane affidato all’ipotesi; ma che vi sia stata una decomposizione e disorganizzazione morale, risulta già con chiarezza dai dati di fatto. Al ‘re occulto’ Tippu Tib doveva premere molto di mettere a modo suo fuori combattimento gli intrusi europei, giovani inesperti e per lui stolti [...] Impiegando antichissime arti del suo paese [...], forse che gli sarebbe riuscito difficile inscenare le seduzioni più raffinate? Egli non ha che da fare un cenno, e le sue creature saranno ai suoi comandi come i Ginn e i Giann a quelli del mago delle Mille e una notte: Danzatrici d’Arabia, e le belle more di Somalia, le slanciate fanciulle nere dell’alto Congo, i ragazzi arabi, maturati per tempo nell’amore da uomo a uomo; ricorrerà alla musica barbarica che sferza i nervi e farà risuonare nella foresta vergine canti misteriosi; il ritmo tormentoso, ipnotico, eccitante dei tamburi di legno metterà in ebollizione il sangue degli sciagurati – l’angoscia è così vicina alla voluttà; egli sarà l’ospite generoso, la cui suprema ambizione è che i suoi amici europei si trovino bene presso di lui; sa benissimo che i piaceri sensuali tornano sempre a richiamare con magico potere chi li prova al luogo dove li godette; sa dosare i suoi doni, accrescere l’attrattiva, riattizzare la brama spenta con nuove promesse: in tutta questa scienza è maestro; e come potrebbe non riuscire con la sua superiorità, il vecchio corrotto, a cogliere nelle sue reti quei giovani e maldestri miscredenti [...]? E quelli vanno da bravi in bocca al lupo; egli non ha affatto bisogno di darsi gran daffare [...]: i loro sensi depauperati si attaccano ai miseri, barbarici, occulti piaceri con i quali egli li adesca; è per loro 268 come un hascisc, uno stordimento della coscienza, il vizio in forma mai veduta, un paradiso di voluttà e di morte. Forse che egli non conosce la forza che si cela nella fragranza dei fiori, nei succhi delle piante, nelle figure dei tappeti, non sa distillare bevande afrodisiache e giovarsi dell’aiuto galeotto della notte tropicale? Sotto questo rispetto le sue risorse sono illimitate.” “Bello,” mi sono lasciata sfuggire, appena finita la lettura, “sembra un brano di Conrad.” “Invece è la descrizione di fatti veri.” “Be’, insomma, direi piuttosto un’interpretazione.” “Secondo Luciano è una vaga descrizione degli effetti di un tipo di riti iniziatici della mano sinistra, una descrizione fatta da un profano.” “Ah, la cosa diventa sempre più misteriosa. La mano sinistra, eh? Spiega, spiega.” “Qui entra in scena Rimbaud.” “Già, il cantore dello sregolamento di tutti i sensi.” “Vacci piano col sarcasmo. È una cosa seria, se non tragica. Devi sapere che il poeta maledetto era uno studioso di scienze occulte. Inizialmente praticava l’ascesi usando la poesia, l’hascisc e pratiche sessuali sfrenate.” “Addirittura!” “Strumenti per rompere la corazza culturale che impedisce l’apertura delle porte della percezione.” “È sempre l’interpretazione di Luciano!?” “Ti assicuro che è un’interpretazione plausibile.” “Sarà!?” “A un certo punto Rimbaud si sarebbe reso conto che necessitava di strumenti più acuminati, soprattutto che aveva bisogno di contatti con persone...” “Non mi dire che anche lui era affiliato alla Golden Dawn.” “Questo non si sa. Ma è possibile. Lui faceva su e giù tra Parigi e Londra proprio ai tempi in cui Robert Browning, lasciata Firenze, si era ristabilito in Inghilterra, e in cui Livingstone e Stanley scorazzavano per l’Africa. Le date sono significative. Nel 1878 esce Through the Dark Continent, il libro di viaggi africani di Stanley. A novembre di quello stesso anno Rimbaud 269 s’imbarca per Alessandria d’Egitto. Gira un po’ per il Mediterraneo Orientale e poi nel 1880 si sistema in Africa, ad Harrar, la città santa. Lì si converte all’islamismo, si prende una compagna africana e inizia una serie di scorribande verso l’interno del continente.” “Per fare cosa?” “Secondo le biografie ufficiali, per commerciare: avorio, caffè, armi, perfino schiavi.” “Secondo Luciano, invece?” “Per cercare l’iniziazione nera, una forma d’ascesi che usa la rottura di tutte le leggi del corpo e dello spirito, che pratica la droga, il sesso, la danza...” “Non mi convince. Ci sono varie cose che non quadrano. Per esempio, se ben ricordo, Rimbaud viaggiò in Abissinia, non nel Congo. E, come tu stesso hai detto, si fece mussulmano, non pagano.” “Incongruenze solo apparenti. Nella teoria di Luciano, il regno di Butua sarebbe stato circondato, geograficamente, da una serie di cerchi concentrici che lo proteggevano. C’era una prima fascia di stati ben organizzati, pressoché sconosciuti agli occidentali, come i regni di Buganda e Bunyoro nel territorio che oggi va sotto il nome di Uganda. I primi esploratori europei che li avevano visitati parlavano con ammirazione e sorpresa dell’ordine, della civiltà e dell’organizzazione di questi stati. C’era poi una fascia di territorio abitata da tribù guerriere, cosiddette selvagge, per esempio i Masai. C’erano infine gli stati copti e mussulmani della costa orientale. Qualcosa di simile esisteva anche negli altri punti cardinali. Le tre fasce rappresentavano una specie di triplice barriera culturale che doveva essere penetrata e superata dall’adepto; un superamento che richiedeva varie metamorfosi spirituali. La prima delle quali imponeva ai cristiani di passare all’islamismo. I musulmani invece avrebbero dovuto convertirsi al cristianesimo. Per un cristiano, l’abiura della propria fede e la conversione all’islamismo sarebbero state il primo passo verso la liberazione spirituale.” “Che c’entra l’uomo-leopardo in tutto ciò?” 270 “Quella degli uomini-leopardo è una società iniziatica intertribale, il vero cemento che tiene unito un popolo apparentemente anarchico come i Masai. Ma non è limitata alle loro tribù. Nel Congo, tra i Babali, c’è la setta degli anyoto, parola che significa appunto ‘uomini-leopardo’. Vi si pratica il rito del mambela ancora oggi, un rito terribile, dicono.” “In che consisterebbe questo rito?” “Impossibile saperlo. Probabilmente la ricostruzione di Wassermann si avvicina alla realtà: pratiche a sfondo orgiastico, con uso di droghe, musica, danze, sangue. Una sorta di misteri dionisiaci in terra d’Africa. Non tutti lo superano e gli europei, cui manca il necessario retroterra culturale, incontrano speciali difficoltà. Chi non lo supera muore. Comunque non se ne sa niente di preciso. Gli iniziati non parlano. Chi osa farlo viene ucciso nelle maniere più atroci, sbranato dai leopardi, divorato dagli adepti...” “Stai cercando d’impressionarmi?” “Ti assicuro che...” “È questo che cercava Rimbaud?” “Sembra di sì.” “E anche Luciano?” “Ahimé, lui stesso mi aveva detto che stava seguendo la via di Rimbaud.” “Forse aveva in mente qualcosa di letterario. Dopo tutto Rimbaud era un poeta.” “Che aveva abbandonato la poesia per venire in Africa. – La letteratura dà scienza, non luce, la verità si trova oltre – diceva.” “Chi?” “Indovina.” 271 Mercoledì, 26 giugno Ho speso tutto l’altro ieri alla ricerca di Giuliano. All’università non l’ha visto nessuno. Né l’hanno visto i vicini di casa. A più riprese, mattino, pomeriggio e sera, ho bussato inutilmente alla sua porta. Al telefono risponde un nastro registrato: “Questa è la segreteria telefonica di Giuliano Serlo. Avete trenta secondi di tempo per lasciare un messaggio dopo il bip.” Certo che il registratore non contribuisce a rendere il personaggio meno scostante. La sua voce baritonale incute timore anche in sua assenza. Io poi ho sempre avuto difficoltà col telefono, la sensazione di parlare con un ordigno, un essere impersonale, piuttosto che con un uomo o una donna di là dal filo. Figuriamoci le segreterie telefoniche! Infatti riattacco sempre prima del bip. Dopo vari tentativi al telefono, ieri ho deciso di scrivergli una lettera. L’ho ficcata personalmente nella sua buca della posta. Ero sicura che il marpione si era semplicemente barricato in casa. Oggi, alle cinque del pomeriggio, ricevo la risposta per pony express. È una strana lettera, la prima che ricevo da lui. Mi conferma nel cambiamento d’opinione che sto maturando nei suoi riguardi. Più sta e più mi si rivela un personaggio diverso da quello rozzo e arrogante che avevo sempre conosciuto, un personaggio non privo di erudizione o almeno di una certa qual dimestichezza letteraria. Né escludo che il contenuto della lettera se lo sia completamente inventato. Scrive: Mia cara puttanella, ti ammiro perché la tua troiaggine è l’opposto di quella di Emma Bovary. Per questo non so dirti di no. Tanto più volentieri quindi rispondo alle tue domande ‘oziose’, come le definisci tu stessa. Le quali sono tre ma si fondono in una. Dunque, bisogna risalire alla comunità di uomini formata nei tempi gloriosi da Luciano, Fabrizio e me. Ti ho già detto che i nostri nomi di battaglia erano Leopardo, Leone e Tigre. Li consideravamo nomi esoterici. Un po’ per gioco, un po’ per presunzione filosofica, appartenevamo a una sorta di ordine iniziatico, una setta di monaci guerrieri che avevamo denominato Cavalieri del Nulla. Discutemmo a lungo degli 272 scopi da assegnare alla Setta, senza venire mai a capo di niente. E accanitamente discutemmo della regola. Non c’è ordine monacale che si rispetti che non sia dotato di una sua regola. Però anche su questo tema le nostre discussioni si rivelarono sempre inconcludenti. Le principali difficoltà, riguardo a entrambi i problemi, venivano da Luciano. Pareva sempre che noi altri non fossimo all’altezza delle sue idee. Così alla fine non se ne fece niente, e la cosa rimase allo stato di un gioco abortito. Tra noi, tuttavia, continuammo a lungo a rievocarlo scherzosamente, e spesso ci rivolgevamo l’un l’altro usando i nomi esoterici. Quello di Leopardo, Luciano se l’era scelto da sé. Ne potrai capire il significato riflettendo sul fatto che, secondo lui, si tratta della più femminile delle bestie feroci. Lui aveva una specie di fissazione sulla donna, una vera e propria mitizzazione. Per dartene un’idea ti riporto dei brani da una lettera che il Leopardo scrisse a noi adepti sul tema della regola. «Cari compagni d’ascesi, non insensibile alle vostre pene, mi sono fatto un dovere di istituire una regola. Dopo lunghe meditazioni sono giunto a una determinazione che, tradotta in pratica, non potrà non alleviare quelle pene. Per una comunità come la nostra, che ha individuato nel nulla la sua vocazione, può esserci solo una regola: la legge del nulla. Che non vuol dire nessuna legge. Contrariamente al comandamento di Rabelais, io non vi dico ‘fate ciò che volete’. Vi dico ‘vogliate ciò che fate’. Forse nessuno meglio della nostra santa patrona, Eloisa la pura, monaca blasfema, protettrice di streghe e meretrici, nessuno meglio di lei potrà chiarire il senso dell’eccelsa regola. Scrive infatti: «Non c’è cosa che sia sì poco in poter nostro come l’animo: a cui siam più costretti a ubbidire che liberi di comandare […] Per questo, se non m’inganno, decisero dunque i santi padri di non prefiggere una regola, quasi nuova legge per noi come invece per gli uomini [secondo] quel detto dell’Apostolo: «La legge provoca infatti la reazione; che, dove non c’è legge, neanche c’è l’illegalità»; poi ancora: «Ma sopravvenne la legge, onde abbondasse il delitto» [...] C’è dunque di che pensare ai casi nostri: di che guardarsi dall’assumere noi donne quei pesi sotto cui vediamo piegare – e perfino perire – gli uomini ormai quasi tutti. Il mondo è invecchiato, lo vediamo bene: uomini e cose vi han già perduto il pristino vigor di natura: raffreddata vi si è – secondo la previsione di Verità – la stessa carità non di molti, ma quasi di tutti: sino a doversi, a quanto sembra, cambiare o temperare le stesse regole scritte per gli uomini.» 273 C’è quindi di che pensare se si vuole dar credito al profeta Gioacchino quando annuncia l’avvento dell’era dello Spirito Santo. Ché, se fu dato solo agli uomini di far ritorno al paradiso nell’era del Padre, e se fu detto che solo i fanciulli vi sarebbero potuti entrare nell’era del Figlio, allora io in verità vi dico: solo coloro che si faranno liberi come le donne vi avranno accesso nell’era che sta per venire.» Così il Leopardo. E questo povero Tigre, che non ci aveva capito un gran che, continuò a ruggire nel buio. Un bacio dove meno te lo aspetti, tuo Giuliano 274 QUADERNO 4 Venerdì, 28 giugno Ieri è stato ucciso Silvio. Stesso macabro rituale degli altri due omicidi nel giardino Stibbert, stessi paramenti, stessa arma. Non leggo neanche gli articoli dei giornali. Mi bastano i titoli. Tanto non ci troverei niente d’inatteso. Non è inattesa neanche la telefonata di Giuliano, stamattina, e il suo invito a pranzo. All’una sono a casa sua. Ho la sensazione di entrare nella tana dell’orco, ma non ho paura. Mi sento vuota, stanca, non ho voglia di parlare. Lui, da parte sua, è di umore tetro e non proprio loquace. Ha preparato un pranzo freddo che mi serve all’aperto nell’ampia terrazza del suo attico con vista sull’Arno. Fa un caldo afoso. L’ombrellone che copre il tavolo di ferro su cui è servito il pranzo ci ripara appena dai raggi del sole più diretti e non riesce a rendere l’aria meno irrespirabile. Mangiamo poco e beviamo molto, chiacchierando stancamente, ognuno preso dai suoi pensieri. La conversazione si ravviva un po’ quando arriviamo alla macedonia. Giuliano m’informa di cose scontate: che il messaggio da lui trovato nel terzo capitolo del Nuovo corso era sbagliato e che bisognerà guardare nel quarto. Io gli comunico una cosa che ora è scontata per lui; che il messaggio giusto era quello solito – cerca oltre cerca ancora cerca – e che l’ho trovato applicando un nuovo codice. Lui prende atto della soluzione dell’enigma senza mostrare un grande entusiasmo. Dà un lungo sorso alla quarta birra direttamente dalla bottiglia. Mi passa la bottiglia mezza vuota. Poi si alza dalla sedia, si spoglia fino a restare in slip e va a buttarsi su un ampio tappeto turco steso sul pavimento arroventato dal sole. Non rie- 275 sco a pensare a niente di meglio che imitarlo: vada per la tintarella. In pochi sorsi ci scoliamo un’altra bottiglia di birra. Il calore dell’aria è così forte e quello della birra così piacevole che i pensieri, gradualmente, diventano più evanescenti del vapore acqueo. Il pavimento è duro sotto il tappeto. Giuliano si gira e si rigira senza riuscire a trovare una posizione comoda. Io non ce la faccio neanche a voltare la testa dall’altra parte. Alla fine, annoiata da tutto il rigirio, mi distendo sul fianco dando le spalle a quell’anima in pena. E per la fiacca non faccio neanche un movimento quando sento il contatto del suo corpo col mio. – My God – penso – con questo caldo! – Ma lui non aveva intenzione. O forse percepisce la mia nausea. Così, con un altro movimento estenuato, si gira dall’altra parte e mi mostra le spalle a sua volta. Dopo un po’ si mette a smaneggiare nel mucchietto dei suoi vestiti lì accanto. Mi alzo sul gomito per vedere cosa fa. Estrae la camicia dal mucchio di vestiti, infila una mano nel taschino e ne tira fuori un sacchetto di tabacco. Lo apre. Scava fra i trucioli di tabacco e ne tira fuori un pacchetto di cartine da sigarette giganti e un piccolo involto di carta stagnola. Apre l’involtino e ne porta alla luce il prezioso contenuto, una pallina di hascisc non più grande di un cece. La prende tra l’indice e il pollice della mano sinistra e la scalda alla fiamma di un cerino. L’hascisc si scurisce subito sporcando di nerofumo la pelle delle dita, mentre nell’aria si sprigiona quell’odore forte, quell’afrore acre e dolce che risveglia sempre in me un piacevole senso del peccato, una delle poche cose al mondo ormai che hanno questo potere. Prendo il pacchetto delle cartine. Ne estraggo una. La apro tra le dita, vi distendo sopra un abbondante ricciolo di tabacco e passo il tutto a Giuliano. Lui afferra la cartina e se la adagia tra l’indice e il medio della mano sinistra tenendola ferma con il pollice. Con il pollice e l’indice della destra sbriciola il cece di hascisc sul tabacco. Finita l’operazione, arrotola la cartina con un movimento rapido. Con la lingua ne bagna il bordo e la chiude. Attorciglia un’estremità della sigaretta a mo’ di caramella, per non far cadere neanche un grano della preziosa sostanza. 276 Me la infila in bocca per l’altra estremità e l’accende. La prima tirata è profonda. Espirando mi distendo di nuovo sul tappeto, adagio, e mi sembra che il fumo, uscendo dalla bocca e dal naso, si porti via con sé le residue forze che mi tenevano seduta. Do altre tre tirate e passo la sigaretta a Giuliano. Lui fuma un po’ e me la ripassa. Andiamo avanti così per un bel pezzo. Fumiamo calmi, cercando di farla durare a lungo, come indugiando su dei preliminari. L’effetto però è immediato. Comincia con la prima tirata e continua in crescendo. Gli occhi ce l’ho chiusi e il corpo, abbandonato al calore del sole, quasi non lo sento più. Non ne percepisco più i confini, sento che si confonde con l’aria calda che mi circonda e mi soffoca dolcemente. A me questa roba, normalmente, mi fa un piacevole effetto, mi rilassa e mi annebbia la mente, e spegne quel senso di angoscia sottile che domina le mie ore. Per lui invece è tutta un’altra cosa: gli basta mezza canna per mettersi a vaneggiare di marziani e di anarchia come Jack Nicholson in Easy Rider. Ecco perché se ne fa una ogni morte di Papa, dice. Qualche volta gli funziona perfino da eccitante: lo arrazza fisicamente e gli accende l’immaginazione. E quanto è tedioso doverselo cuccare sopportandone anche i vaneggiamenti della fantasia. Così accade oggi. Il resto dell’accaduto, vaneggiamenti compresi, non merita di essere raccontato. Torno a casa alle due di notte, e sono completamente sveglia. Mi siedo subito alla scrivania e apro il mio diario. Ormai, da quando ho cominciato a scrivere questo tormento di diario, pur non andando quasi mai a letto prima delle quattro non prendo sonno che alla luce dell’alba. Ma potrei mettermi a scrivere alle otto dopo cena e, calcolando una durata media di scrittura di due ore, andarmene a letto verso le dieci. Mi addormenterei comunque all’alba. Il fatto è che dal giorno in cui ho cominciato a scrivere il diario, cioè dal giorno successivo a quello della morte di Luciano, la sera, se non ho qualche cliente da trastullare, mi piazzo davanti alla televisione e mi abbrutisco fino a tardi. L’unico palliativo che sono riuscita a trovare alla mia insonnia e ai miei ri- 277 svegli col mal di pancia è andare a letto molto tardi. Così nelle notti migliori riesco a farmi fino a quattro ore di sonno, ma sono notti sempre più rare. Inoltre mi sveglio in pieno giorno, e la luce del sole sembra avere un qualche potere di dissoluzione sul mio inferno interiore. Il disturbo è un regalino che mi aveva lasciato Luciano. Lui stesso, tuttavia, oltre a farmene una diagnosi ridicola, mi aveva suggerito l’unico rimedio efficace: quello delle ore piccole, una strategia psichica che definiva ‘combattere l’inferno con le sue armi’. Nel caso specifico si trattava di rubargli la notte. Ora mi domando: questa recrudescenza dell’insonnia che è seguita alla scomparsa di Luciano, non può avere un significato, dopo tutto, piuttosto ovvio? Non potrebbe darsi che nella perdita di Luciano io abbia visto la perdita definitiva di ogni speranza? All’improvviso mi si chiudono gli occhi dal sonno. Faccio appena in tempo a riaprirli per alzarmi dalla sedia e andarmi a buttare sul letto. Eppure, appena mi ritrovo sotto il lenzuolo, mi accorgo di non riuscire ad addormentarmi, nonostante che la notte già mostri intenzione di cedere il campo al nuovo giorno. La mia mente rimugina febbrilmente. Sento che qualcosa non va in ciò che ho appena scritto. Così mi alzo e torno alla scrivania, se non altro per ammazzare l’insonnia. E dire che pochi minuti fa me ne ero allontanata per la cecagna! Rileggo le pagine scritte oggi e capisco subito l’inghippo. Ad un tratto sono brutalmente saltata di palo in frasca, per dirlo come l’avrebbe detto Giuliano. Stavo scrivendo del trip hasciscetico avuto in casa di lui e all’improvviso sono passata a descrivere i miei disturbi del sonno. Quale nesso c’è? Boh? Queste devono essere le pagine più sconclusionate di tutto il mio diario. Stasera sono proprio sbalestrata. Adesso mi rendo conto che in realtà sono tornata alla scrivania perché voglio scrivere di un ricordo, un episodio che segna un punto di svolta nella mia travagliata relazione con Luciano. Da quando avevamo preso a incontrarci per discutere della tesi di laurea avevo sempre respinto le sue avance erotiche, nono- 278 stante le proponesse mostrando segni di crescente tenerezza, sia quelle che qualche volta tentava maldestramente nel suo studio al dipartimento, sia quelle che prometteva di tentare invitandomi a cena o a ballare. Il rapporto docente-discente mi bastava, mi dava un appagamento che non derivava solo dal sentimento di stima reciproca. Lui stesso mi spiegò che in alcuni casi quel tipo di vincolo tende a travalicare i confini accademici e a creare una specie di transfert affettivo come tra padre e figlia. L’allieva s’innamora del maestro, da cui riceve conoscenza, formazione, stimolo alla crescita. Il maestro s’innamora della figlia spirituale, a cui dà un pezzo della propria anima e in cui ritrova la parte migliore di sé, quella che aveva perduto lasciandosi alle spalle gli anni degli slanci giovanili. Devo riconoscere che questo flusso di transfert si era indubbiamente insinuato tra noi, suscitando nei nostri incontri scientifici un’atmosfera d’intesa emotiva che esorbitava le semplici manifestazioni di riconoscimento intellettuale. Un giorno m’invitò a passare una serata al circolo Arci di Montelupo. Era il posto dove mi portava a ballare nei tempi migliori. Stavo per dirgli di no, ma prima che aprissi bocca mi assicurò che ci saremmo divertiti. La locale sezione del Partito Comunista lo aveva invitato a tenere una conferenza sulla situazione generale del paese e lui aveva accettato proponendo l’argomento ‘Il ciclo infernale della politica italiana: cosa ci aspetta nel futuro prossimo?’ “Che ci va a fare uno come te alla parrocchietta?” Lo burlai. “A fomentare.” Ero esitante. Lui m’invogliò con un argomento persuasivo: “Ti servirà in vista del tuo esame di laurea.” “Parlerai di Marx?” “No, ti mostrerò come si fa a provocare un uditorio.” La sala della conferenza non era molto grande, avrebbe dovuto contenere una cinquantina di uditori. Però ce n’erano parecchi di più, stipati sulle scomode sedie e in piedi lungo le pareti. Arrivammo verso le nove e mezzo e all’inizio fu tutto un susseguirsi di strette di mano e abbracci di compagni vecchi e nuovi, 279 alcuni dei quali riconobbi per quelli che avevo frequentato alla Bolera, la vicina sala da ballo. Da cui ci separavano le pareti di una stanza attigua e ci giungeva un lontano sottofondo musicale. Luciano fu introdotto dal segretario di sezione e presentato come un professore di Firenze che ci avrebbe spiegato la situazione politica dell’Italia dei nostri giorni, fine anni ’80. Lui si alzò in piedi, distese uno sguardo accattivante e dominatore sulla platea, indugiando per qualche secondo. Poi attaccò: “Nel 1529 Firenze fu posta sotto assedio dagli eserciti del Papa e dell’Imperatore.” Dal pubblico si levò un brusio di sorpresa. “Ma non doveva parlarci dell’Italia di oggi?” Disse sottovoce uno seduto in prima fila accanto a me. Luciano, come se lo avesse sentito, chiarì: “Vi parlerò dell’Italia di sempre. Il che ci illuminerà su quella di oggi.” La conferenza non durò meno di un’ora, e un’altra se ne andò per il dibattito che seguì. Avevo preso degli appunti, da brava allieva, che ora utilizzerò per riassumere il succo degli argomenti trattati. La prima mezz’ora Luciano la dedicò alla ricostruzione degli eventi storici. Ci spiegò che nel 1494 il popolo di Firenze aveva cacciato dalla città la famiglia Medici, che l’aveva tiranneggiato per buona parte del secolo. Aveva quindi restaurato una forma di governo repubblicano in cui le classi popolari riuscivano a esercitare un embrione di potere democratico. In quella repubblica avevano dato il meglio di sé Girolamo Savonarola, profeta e arruffapopolo, e Niccolò Machiavelli, cancelliere, diplomatico e ideologo della Repubblica. Nel 1512 i Medici erano riusciti a tornare al potere con un colpo di stato e l’aiuto dell’esercito spagnolo. Ma i fiorentini li avevano cacciati di nuovo nel 1527, restaurando la repubblica per l’ultima volta. Senonché a quei tempi il capo mandamento della famiglia Medici era niente meno che il Papa, Clemente VII. Ebbene costui non esitò ad allearsi col suo arcinemico naturale, l’imperatore Carlo V, pur di riconquistare alla propria famiglia il potere su Firenze. 280 Fu così che la città finì sotto assedio. Era stata abbandonata, per paura o per opportunismo, da tutti i suoi alleati e ora si ritrovava a combattere una guerra per l’esistenza, sola contro il resto del mondo. La combatté magnificamente, con un esercito popolare e una compagnia di ventura, contro due eserciti preponderanti in numero di armati e armamenti e che raccoglievano la più fecciosa soldataglia di Spagna, Germania e Italia. Le milizie popolari fiorentine vinsero quasi tutte le battaglie con atti di eroismo che suscitarono l’ammirazione del mondo, ma persero l’ultima e decisiva per un tradimento del comandante generale del suo esercito mercenario, che era in combutta col Papa stesso. Così i Medici tornarono definitivamente al potere, dapprima con Alessandro, un despota ladroncello e debosciato che si diceva fosse il bastardo di Clemente, poi con Cosimo, uno scaltro demagogo altamente dotato di capacità tattiche. Non solo per Firenze, per l’intera penisola fu la fine degli ultimi residui delle aspirazioni repubblicane e l’inizio dell’era più buia della sua storia. Narrando questi fatti il mio uomo si era accalorato, parlava con voce sonora, gesticolava elegantemente ed esibiva una retorica patriottarda che faticavo a credere genuina. Il pubblico si era lasciato trascinare in un delirio sciovinistico da chiamata alle armi. Si era creata un’atmosfera esaltata, gli ascoltatori pendevano dalle labbra di Luciano come scolaretti da quelle di un maestro che narra le avventure di Pinocchio. Lo guardavano a bocca aperta, a volte facevano dei commenti appassionati, non riuscivano a stare fermi sulle sedie, e tifavano rumorosamente, soprattutto quando Luciano prese a raccontare le gesta di Francesco Ferrucci, il comandante partigiano che, combattendo nelle campagne e sui monti del contado fiorentino, aveva ripetutamente umiliato un reggimento del maramaldo esercito papale comandato da Fabrizio Maramaldo. Quando descrisse la finale battaglia di Gavinana, in cui i 4.000 partigiani di Ferrucci furono disfatti da un’armata di 10.000 criminali al soldo del Papa, l’angoscia che aleggiava nella sala si fece bruciante. Il parossismo fu raggiunto con la tragica fine del Ferrucci. La battaglia era praticamente terminata e lui ancora combatteva, spada alla mano, sopra un 281 mucchio di cadaveri nemici. E quando fu ferito a morte, e quando stava per ricevere il colpo di grazia da Maramaldo, e quando infine pronunciò le fatidiche parole ‘vile, tu uccidi un uomo morto’, le lacrime sgorgarono dagli occhi di molti montelupesi scivolando sulle rudi facce di lavoratori. Mi ero emozionata perfino io. A quel punto Luciano gettò una bomba a mano. Si fermò, si ricompose, fece una lunga pausa, cambiò il tono della voce, che divenne freddo e sibilante. Disse: “Ciò che fu ucciso così vilmente fu la libertà, e i responsabili ultimi dell’omicidio siete voi, cari compagni.” In sala ci fu un gelo improvviso e subito dopo un’ondata di sconcerto. “Sì, avete capito bene.” Infierì Luciano. Da un istante all’altro poteva esplodere il linciaggio. Lui lo prevenne: “Non vi agitate. Datemi tempo. Ora vi spiegherò.” “Siamo tutt’orecchi.” Disse beffardo il segretario di sezione, che presiedeva la riunione. “A Firenze c’erano tre partiti, i palleschi, i piagnoni e gli arrabbiati. Sono gli eterni e universali partiti della politica italiana. Muovetevi attraverso la nostra storia e la nostra geografia e troverete sempre questi tre partiti, mutatis mutandis.” “E cambiando le mutande con quelle di oggi, come si chiamerebbero i tre partiti?” Lo interruppe il segretario, suscitando l’ilarità della sala. “DC, PCI e…” “BR?” Lo interruppe di nuovo quello, scatenando un’altra risata collettiva. “No, le BR sono un bubbone cresciuto sul corpo ideologico di voi piagnoni.” In sala tornò il gelo. “I palleschi erano i seguaci dei Medici.” Riprese Luciano con tono aggressivo, quasi a tacitare preventivamente ogni possibile sollevazione dell’uditorio. “Sono il partito endemico e naturale del popolo italiano, quello che governa normalmente il paese. Sostenevano un blocco di potere dominato dall’alta borghesia 282 magnatizia e articolato in un’alleanza che abbracciava tutte le classi sociali, dalla media e piccola borghesia giù giù fino alla bassa plebe. Il cemento che teneva unita l’alleanza era un impasto formato dalla politica del favoreggiamento, l’etica del sacro egoismo e l’ideologia cattolica. Ognuno era libero di farsi i cazzi propri purché non mettesse in discussione il potere centrale. Ai padroni si assegnavano appalti, ai bottegai si consentiva di evadere le tasse, ai poveri si elargivano donativi e pensioni d’invalidità. A tutti l’impunità. La chiesa benediceva.” “Non capisco la faccenda dell’ideologia cattolica e della benedizione della chiesa.” Urlò una vecchietta dal fondo della sala. “È una faccenda seria. I preti godevano di privilegi eccezionali, dall’esenzione fiscale all’autonomia giurisdizionale, per non dire delle generose regalie statali. Erano l’azienda più ricca del paese ed erano ammanicati a doppio nodo col potere dei Medici, i quali avevano dato alla chiesa ben due papi. Il servizio che i preti rendevano al potere mediceo era essenziale. Il loro ruolo era di continuare a formare il carattere italiano, come avevano sempre fatto dai tempi di Costantino. Opportunismo, servilismo, dispregio dei valori collettivi e del bene pubblico…” “Ah, questa poi…” Disturbò la vecchietta. “Questa poi è l’essenza del problema. Per la chiesa cattolica la civiltà politica è la città del male. I fedeli non possono impegnarvi la propria anima, che devono invece proiettare verso la città di Dio. Il controllo sullo stato deve essere esercitato dai preti, non dai sudditi. L’individualismo economico e civile è un peccato veniale nella misura in cui la dedizione al bene pubblico è un disvalore. La chiesa è sempre pronta a perdonarlo in cambio di qualche elemosina e pateraveggloria.” “Il cattolicesimo ideologia individualista?” Domandò il segretario. “Peggio, utilitarista.” “Questa me la devi spiegare.” “La chiesa cattolica ha inventato l’utilitarismo trascendentale. Poiché le azioni umane ricevono nell’aldilà un premio o una punizione, i credenti sono indotti a sviluppare l’etica del comportamento razionale per massimizzare la felicità. Le azioni morali 283 sono dei mezzi per conseguire un fine, un fine che giustifica ogni mezzo, il valore del premio essendo infinito. Siccome la chiesa è l’istituzione che detiene la verità assoluta, il cattolico che le obbedisce ciecamente si comporta in modo razionale. Se accade che la verità della chiesa viene a trovarsi in contrasto con le leggi civili e il bene pubblico, il cittadino cattolico che agisce razionalmente deve mettersi contro le leggi e il bene pubblico.” “Perché dici cattolico?” Urlò la vecchietta. “Perché non cristiano?” “I protestanti si sono dissociati adottando la dottrina della predestinazione, secondo cui il premio celeste è impartito da Dio arbitrariamente. In tal modo l’azione morale acquisisce valore in sé, non come mezzo per massimizzare l’utilità trascendente.” “Se fosse così,” intervenne il segretario, “tutti i cattolici del mondo sarebbero opportunisti, non solo gli italiani.” “No. In Francia, Spagna, Austria, Polonia la chiesa si è alleata con la nazione, per il semplice motivo che ha usato quegli stati per difendersi dall’invadenza dell’Islam e degli imperi ghibellino, ortodosso, protestante. In Italia invece ha sempre lavorato contro la nazione, dato che la sua stessa esistenza politica presupponeva l’inesistenza di uno stato unitario. Così è accaduto che soltanto in Italia l’utilitarismo cattolico ha indotto sentimenti e comportamenti antinazionali e antisociali, soltanto in Italia l’opportunismo è diventato una norma morale positiva. Ebbene è precisamente questa forma di eticità abietta che rende stabile il potere pallesco. La repubblica medicea era la prevaricazione di tutti contro tutti; a ognuno assicurava una certa libertà di depredare, ovviamente in proporzione al potere detenuto. La funzione del governo era di far sì che nessuno osasse travalicare i limiti della competizione tra persone e cricche isolate e che ogni suddito ne ottenesse un sia pur piccolo vantaggio economico. Il comandamento fondamentale era: defrauda il prossimo tuo come tu stesso sei da lui defraudato. Ruba anche alla repubblica; basta che non ti organizzi insieme ad altri in una guerra rivoluzionaria di classe.” “Vabbe’, la descrizione della Democrazia Cristiana ci piace. Sono più o meno le critiche che noi le abbiamo sempre rivolto.” 284 Disse il segretario in tono sarcastico. “Ora sentiamo che ci dici dei piagnoni.” “Erano il partito moralista. Criticavano i Medici per la loro corruzione, per il lusso, le orge, l’omosessualità, i gioielli e le scollature delle donne, e ovviamente per la loro azione di pervertimento morale delle istituzioni statali. Predicavano la prevalenza del bene pubblico su quello privato e la restaurazione di costumi morigerati, la modestia, l’austerità…” “Non osare toccare Berlinguer!” Urlò uno dal centro della sala, ricevendo un fragoroso applauso. Luciano, imperterrito, riprese a provocare nel mezzo dell’applauso e alzando la voce per soffocarlo: “Nell’ideologia piagnona c’era molto di Girolamo Savonarola, ma anche qualcosa di Machiavelli.” “Ora ci dirà della doppia morale.” Se ne uscì il segretario, stavolta con durezza e senza ombra d’ironia. “Non ce n’è bisogno. Vedo che la sapete lunga. Vi dirò invece di ciò che i piagnoni avevano in comune coi palleschi. Erano anch’essi cattolici.” Pausa meditabonda. Poi: “Cattolici della specie più pericolosa, onesti e idealisti, e fortemente protestatari, quasi protestanti. Volevano la città di Dio in terra. Infatti appena presero il potere trasformarono la repubblica in monarchia, elevando al trono niente meno che Cristo Re. Loro si contentavano di esserne i ministri. La loro idea di democrazia si risolveva nella dottrina del governare per il bene del popolo, non per suo mandato. Tanto è vero che lo stato savonaroliano escludeva dai diritti politici tutta la plebe e la borghesia piccola e media, e assegnava il diritto di voto solo ai migliori…” “Lascia stare Togliatti!” Risata generale. “Chi? Il factotum di Stalin?” “Ora stai esagerando!” Alzò la voce il segretario. “Lo scherzo è bello quando dura poco.” Luciano non fece una piega. Sfoderò un sorrisetto dalemiano e sfidò l’uditorio con un lungo silenzio. Neanche un brusio si levò dalla sala. L’atmosfera era tesa e vi aleggiava di nuovo quell’ansia di linciaggio. Io cominciavo a preoccuparmi. Ma anche a guardare al mio ganzo con occhio nuovo. È incredibile com’era 285 riuscito a manovrare i sentimenti di quegli uomini rudi. Prima li aveva esaltati, emozionati, commossi. Ora li provocava e li irritava. Riprese il discorso con freddezza: “Passiamo agli arrabbiati.” “Ecco, sarà meglio.” Disse il segretario cercando di allentare la tensione. “Erano ferocemente anticlericali. Odiavano i piagnoni non meno dei palleschi. S’ispiravano alla teoria repubblicana di Machiavelli. Erano atei e materialisti. Oltre che ‘arrabbiati’, erano chiamati ‘libertini’, col significato che oggi si dà a ‘libertari’. Si professavano radicalmente democratici. Infatti puntavano sulla spinta rivoluzionaria del Parlamento, che allora consisteva nell’assemblea di tutto il popolo in Piazza della Signoria. Uno di loro, certo Pier Filippo Pandolfini, tenne un discorso incendiario alle milizie popolari, sostenendo che non bastava armarsi per combattere il nemico esterno, cioè l’esercito papale-imperiale che assediava Firenze. Il nemico più pericoloso stava dentro la città ed era costituito da quelle classi privilegiate che sfruttavano e opprimevano il popolo lavoratore. Contro di esse bisognava rivolgere le armi prima di ogni altra cosa, se non si voleva che la città fosse riconsegnata ai Medici con qualche tradimento.” Qui si fermò, forse aspettandosi una reazione dal pubblico. Siccome tutti tacevano perplessi, lanciò un’altra bomba a mano: “Pandolfini s’è rivelato profeta lungimirante. Difatti alla fine il tradimento si materializzò, e non fu solo opera del comandante generale dell’esercito mercenario, Malatesta Baglioni. Costui era al soldo dei fiorentini, ma in segreta macchinazione col Papa e in ambigua intesa col suo partito dentro la città. Il tradimento fu sostenuto politicamente dai palleschi. Però non sarebbe stato possibile se voi piagnoni aveste dato retta a Pandolfini, se aveste avuto il coraggio di scatenare una rivoluzione sociale per togliere ogni potere economico e politico alle classi magnatizie e al loro partito. Per questo dico che i responsabili ultimi della morte della libertà non sono stati i palleschi e il Baglioni, che hanno armato la vile mano di Maramaldo, bensì voi piagnoni che glielo avete permesso con la vostra dabbenaggine.” Urla dalla sala: 286 “Provocatore! Anarchico! Troschista! Bucaiolo!” “Calma, calma, compagni!” Intervenne il segretario alzandosi in piedi e battendo una mano sul tavolo. La caciara andò avanti per un po’, mentre quello continuava a battere la mano. Infine, quando fu in grado di farsi sentire da tutti, disse: “Riservate le vostre critiche per il dibattito. Credo che ora il professore abbia finito e che possiamo dare la parola al pubblico.” “No, non ho finito,” lo interruppe Luciano, “il meglio deve ancora venire.” Fischi e improperi dalla sala. Lui assunse un tono professorale: “È giunto il momento della generalizzazione. In quei tempi a Firenze si manifestò in modo esemplare, quasi paradigmatico, quello che io chiamo il ciclo infernale della politica italiana. Funziona così. In tempi di normalità governa il partito pallesco e dilaga la politica del sacro egoismo, attuata all’interno nel modo che ho detto e all’estero con la prontezza con cui si corre in soccorso del vincitore in tutte le diatribe europee. La politica estera non è mai giustificata da forti motivazioni ideali, bensì dal dogma etico nazionale: Francia o Spagna, basta che se magna. Ora, se l’Italia non si trovasse in un consesso europeo molto conflittuale, sarebbe governata permanentemente dai palleschi. Invece ogni tanto il loro potere entra in crisi. Il che accade o perché l’alleato che si presagiva vincitore alla fine perde la guerra o perché la vince ma non riconosce all’Italia i presunti meriti e non le paga adeguatamente il contributo alla vittoria. Qualche volta la crisi arriva per implosione interna, specie quando la stabilità del potere genera un livello di corruzione tale da compromettere perfino la minima efficienza economica della guerra di ognuno contro ogni altro, cosicché il governo non riesce più a dare il contentino a tutti. A quel punto il potere passa ai piagnoni, che normalmente sono minoritari salvo vedersi aumentare i suffragi popolari, inattesi e immeritati, nei periodi di crisi.” “Oh, finalmente arrivano i nostri!” Suggerì il segretario, suscitando l’applauso e le risate. 287 “Finalmente arrivano i vostri. Ottengono il potere. Che ci fanno? Scatenano la rivoluzione sociale? Scardinano le istituzioni del comando borghese? Tagliano gli alimenti alla chiesa? Nulla di tutto ciò. Cercano di moralizzare la vita pubblica, non solo quella della classe politica, anche quella del popolo, costringendolo all’austerità e a pagare le tasse. Cosa propongono per risolvere il problema dello sfruttamento del lavoro? Le fabbriche agli operai? No, la filiera etica. Ve da sé che durano poco, poiché se i palleschi riuscivano a comprare il consenso degli sfruttati e degli sfruttatori, loro di entrambi riescono a guadagnare nient’altro che il disdegno.” Lunga pausa. Poi: “Così giunge il momento degli arrabbiati.” “Facci qualche esempio. Chi sono questi arrabbiati?” Urlò la vecchietta di prima. “Il Pandolfini, il Ferrucci e i loro partigiani.” “Ma oggi?” “Il quarantotto, il biennio rosso, la resistenza, il sessantotto.” “Tutte sollevazioni vittoriose!” Lo motteggiò il segretario. “Tutte sconfitte, ovviamente.” “E perché?” “Per colpa di voi piagnoni. Che a quel punto vi spaventate e correte ad accodarvi ai palleschi.” Strepito e fischi in sala: “Basta! Quando la pianti?” E lui: “Il peggio deve ancora venire.” “Speriamo che venga presto!” “È presto detto. Segue un periodo di disordine e incertezza. I palleschi sono fuori gioco, i piagnoni sono in ritiro spirituale, gli arrabbiati sono in galera. A quel punto…” “Arriva Mussolini.” Sempre la vecchietta. “Vedo che qualcuno mi capisce al volo. A Firenze arrivò Cosimo dei Medici, il despota demagogo. Il suo compito è duplice. Primo, deve fare piazza pulita delle vecchie classi dirigenti. Secondo, deve sopprimere le istituzioni che hanno fallito nel precedente sistema politico. Quando lui uscirà di scena, si ricostitui- 288 ranno in vesti nuove i partiti pallesco e piagnone, il primo per governare, il secondo per deplorare.” “E oggi chi sarebbe il despota, Bettino Craxi?” Domandò il segretario. “No, a Bettino mancano le doti più importanti, l’abilità tattica e la simpatia popolare.” “Allora chi sarà il nuovo uomo della provvidenza?” “Non lo so. Però so che deve venire, con la necessità di una legge naturale. Se non chi è, vi posso dire come sarà.” “Sentiamo. Come sarà?” “Furbo come un bidonaro, maneggione come un democristiano, fariseo come un prete, machiavellico come uno stalinista, arrogante come un fascista, e carismatico come Arlecchino.” “E l’onestà?” “Non è una qualità necessaria, anzi può essere una remora. È vista con sospetto dal popolo.” “Qual è l’ideologia del despota?” “È indifferente. Può essere un ex garibaldino, un ex socialista, un ex liberale, un ex democratico. Il punto è che deve diventare un ex, poiché deve fare piazza pulita della vecchia cultura politica.” “E come ottiene il consenso popolare?” “Affranca il popolo da ogni ritegno morale che i piagnoni avevano tentato di inculcargli e diffonde una nuova ideologia della libertà, intesa come facoltà di depredare. Insomma, libera legittimandoli gli istinti bestiali degli italiani. Il futuro Cosimo dirà al popolo: – Guardate me. Ho fatto il furbo per tutta la vita e sono diventato l’uomo più potente del paese. La posizione che ho me la merito per il semplice fatto che me la sono conquistata. Il merito è un valore ed è giusto che appartenga a chi vince. Perciò sentitevi liberi di fare come me, liberi da ogni senso di colpa. – Così preparerà il ritorno alla normalità.” Seguì il dibattito, che non fu meno lungo e meno rovente della conferenza. Io smisi di prendere appunti, e anche di seguire le discussioni. Ero più interessata a capire il personaggio, il quale stava esibendo ancora un altro volto. Prima li aveva entusiasmati e commossi quegli uomini rudi, poi li aveva provocati e irritati, 289 ora li conquistava intellettualmente. Rispondeva alle loro domande in modo persuasivo, alle recriminazioni in modo conciliante. Cercava di trascinarli al ragionamento e alla critica. Ora s’identificava con loro, li incoraggiava a parlare, li spingeva a riflettere, gli tirava fuori idee confuse per restituirgliele chiarificate, e gli rimetteva un sentimento di rabbia condivisa. Fu allora che riuscii finalmente ad afferrare il bandolo della sua anima aggrovigliata. Dietro le sue molteplici maschere, dietro la facciata d’intellettuale blasé, di critico provocatore e di superuomo nichilista, si nascondeva il volto di un visionario, un rivoluzionario sconfitto e disperato ma ancora sognante: ancora sognante in quanto disperato. Non una figura beffarda e farsesca, come lui si atteggiava, ma tragica. Fu allora che colsi tutta la fragilità dell’uomo, e la tenerezza, e capii perché mi ero innamorata di lui, e riconobbi che ero perdutamente innamorata. Uscimmo dalla sala alle undici e mezzo. Lui era spossato. Parlava con un filo di voce, le spalle ricurve come sotto un peso intollerabile. Mi prese sottobraccio, quasi a volersi appoggiare a me, e si avviò verso la motocicletta. Mi aspettavo che mi avrebbe invitato a passare la notte nella sua casa di campagna, che distava pochi chilometri da Montelupo. Invece disse semplicemente: “Vieni, ti riporto a Firenze.” “No, ancora no.” Mi sorpresi a dire. “La notte è lunga. Ho voglia di fare quattro salti alla Bolera. Non senti che musica?” Dalla sala da ballo ci giungeva il ritmo di un walzer travolgente. Lui non fece resistenza e si lasciò trascinare come un bambino che va a scuola contro voglia. Lo portai prima al bar. Lo scossi con un caffè scecherato. Poi ordinai due bicchieri di Biancosarti, l’amaro che ti dà la carica, gliene misi uno in mano e lo guidai alla sala da ballo. Lì trovammo alcuni di quelli che avevano partecipato alla conferenza. Ci accolsero amichevolmente e ci fecero accomodare al loro tavolo. C’era anche la vecchietta dalle domande intelligenti. Avrà avuto una settantina d’anni, ma portati magnificamente. I capelli biondi dai riflessi argentei le illuminavano il volto come una veneranda aureola. Gli occhi verdi, messi in risalto da una sottile linea di kajal, brillavano di un’intensità adolescenziale. I linea- 290 menti delicati, il mento con la fossetta, le labbra mobili, appena ravvivate da un rossetto rosa incarnato, tutto rivelava una residua bellezza che in tempi migliori doveva essere stata conturbante e che ora le rughe sulla fronte, le occhiaie pesanti e la pelle stanca contribuivano a nobilitare. Era vestita con una certa finezza. Un foulard del colore del rossetto si sforzava di nascondere i cedimenti del collo, la camicetta e la gonna nere aderivano a un corpo asciutto esaltando forme ancora provocanti. Le gambe accavallate esponevano due ginocchia ossute, ma le calze di nylon color carne ne compattavano i muscoli e insieme alle scarpe rosa coi tacchi alti da ballerina contribuivano a confezionare un certo qual fascino sensuale. Cercò subito di monopolizzare Luciano. Lo invitò a sedere accanto a sé e lo aggredì con un sorriso malizioso: “Bellina quella tua teoria dell’utilitarismo trascendentale, peccato che non funziona.” “Perché?” Abboccò lui. “Perché la chiesa cattolica guarda ai propositi con cui si compiono le azioni. Sei fai un’opera di bene con lo scopo di guadagnarti il paradiso ottieni l’inferno. Le opere di bene non bastano, devono essere accompagnate dalla coscienza, dalla consapevolezza di voler fare del bene.” “Ah, ah! Sai una cosa? L’economia sperimentale ha dimostrato che le creature più razionali che ci sono al mondo sono gli animali. Razionalità utilitarista vuol dire efficienza economica, capacità di trovare il mezzo migliore per conseguire un fine. Certi animali trovano sempre la strada meno costosa per raggiungere le loro mete, che si riducono al cibo e al sesso. E gli animali non hanno né intenzioni né coscienza né consapevolezza.” “Ma gli uomini sì.” “La psicologia del profondo poi ha dimostrato che gli esseri umani possiedono una grande capacità di autoinganno. Possono convincere la propria coscienza di star perseguendo un certo fine, mentre inconsciamente tendono a un altro. Ciò che differenzia l’animale cattolico dalla bestia selvatica è precisamente questa capacità. Da essa origina la nota ipocrisia pretesca, che non è 291 quella di don Abbondio, ma quella del cardinal Borromeo, non la doppiezza di chi predica bene e razzola male, ma la commedia interiore di chi è sinceramente convinto di razzolare bene quando invece nei più reconditi recessi dell’anima mira solo al proprio bene, terreno o eterno che sia.” S’intromise il segretario: “Ma c’è il comandamento dell’amore.” “Questo non dovevi dirlo.” Fece la vecchietta. “Perché?” “Perché così dai ragione al professore.” “In che senso?” “Dice Giovanni: ‘Il comandamento di Dio è che ci amiamo gli uni gli altri, come ci ha ordinato. Chi mette in pratica i suoi comandamenti rimane unito a Dio e Dio è con lui.’ Dunque si deve amare per avere Dio dalla propria parte. La lettera ai Corinzi chiarisce: ‘Se do ai poveri tutti i miei averi ma non ho amore, non mi serve a nulla.’ E Matteo: ‘Se voi amate soltanto quelli che vi amano, che merito avete?’ Insomma l’amore è un merito, e in quanto tale mi serve a qualcosa.” Uno sfoggio di erudizione che Luciano non riuscì a far passare liscio. Replicò con una citazione raffinatamente ingenua: “L’essenza del problema fu colta con acume dal grande tedescologo tedesco, che così faceva recitare il fanciullo soave: ‘Chi pel prossimo intercede a se stesso anche provvede, e chi prega Dio per tutti che l’eterno amor gli frutti.’ Dopo di che fece obiettare al genio faustiano: ‘L’uomo pio ha da sapere che fa l’utile proprio pregando per gli altri? Ma il disinteresse se ne va non appena si sa che reca qualche vantaggio’.” “E allora?” Domandò il segretario, con un’aria da fanciullo soave. “L’amore vero è un sentimento,” concluse perentoria la tardona, “un moto dell’animo che scaturisce spontaneamente dal cuore. Non può essere un dovere; se lo imponi con una norma morale, per di più una norma che ne fa un mezzo per accumulare meriti, lo uccidi.” “Bravissima.” La provocò Luciano. “Si vede che hai studiato dalle suore.” 292 “E tu dai preti.” Una breve pausa di sorrisi. Bevvero entrambi guardandosi negli occhi. Ebbi un impeto di gelosia. Il segretario però non era ancora convinto: “Fatemi capire bene, ché io non ho studiato né dalle suore né dai preti.” “Ragiona.” Fece Luciano. “A un merito è sempre associata una ricompensa.” “E con questo?” “L’amore come sentimento è premio a se stesso. Se diventa un mezzo per acquisire un premio altro da sé non è più amore vero. L’amore si sente, la carità si fa. Ecco l’essenza dell’ipocrisia cattolica. Un sentimento è stato trasformato in virtù meritevole di retribuzione, cosicché l’autoinganno può arrivare al punto di credere di fare del bene al prossimo mentre si fa il proprio.” “Da come la metti tu, sembrerebbe che le aspirazioni terrene siano meno ipocrite di quelle eterne.” “Esattamente. E sai perché? Perché lo stesso adattamento della coscienza è funzionale all’efficacia della condotta utilitaria: si mente meglio quando si mente anche a se stessi. Senonché quando l’interesse egoistico è perseguito apertamente la coscienza non ha bisogno di fare salti mortali. È il caso della stragrande maggioranza degli italiani. È accaduto che l’atavica dimestichezza con l’assurdità dei dogmi e dei riti cattolici e con la perfidia dei loro officianti ha fatto degli italiani il popolo più ateo del mondo. Così, caduta la copertura trascendentale, il loro edonismo è diventato puro opportunismo materialista, una razionalità strumentale che non ha bisogno dell’autoinganno. Questo è un popolo di furbi, non d’ipocriti.” “Furbi quelli che evadono le tasse e poi si lamentano che i servizi pubblici non funzionano?” “È il dramma dell’opportunismo, e un teorema dell’economia politica: se ognuno mira al massimo benessere personale ai danni degli altri, tutti ottengono il minimo. L’Italia è una dimostrazione del teorema in corpore vili.” A quel punto mi ero scocciata. Mi feci coraggio e gli intimai un alt: 293 “Compagni, ora basta con la politica. Siamo qui per divertirci.” “Parole sacrosante.” Approvò la tardona. Prese il mio uomo per mano e lo trascinò in pista. Io mandai giù il rospo insieme a un sorso dell’amaro che ti dà la carica. Poi mi girai verso il segretario, che non poté fare a meno di invitarmi a ballare. Tornai al tavolo per prima e mi sedetti al posto della vecchietta. Luciano si mise accanto a me. Da quel momento facemmo coppia fissa e ballammo senza posa. Lui cominciò a riscaldarsi dopo il secondo tango e il quarto bicchierino. Alla fine della serata, verso le due di notte, la sala si era quasi svuotata e noi ancora danzavamo. Le musiche si erano fatte melense. Ballavamo stretti stretti, guancia a guancia. Quando ci buttarono fuori dalla sala perché chiudeva, salimmo in moto e ci avviammo al suo fienile lì vicino. Per la stanchezza non combinammo niente. Ma la mattina mi risvegliai felice tra le sue braccia e mi godetti come un dono del cielo il suo russare sommesso e la carezza del suo respiro sui miei capelli, quasi un sussurro dell’anima. 294 Sabato, 29 giugno Fa un caldo infernale. A Firenze d’estate il caldo picchia feroce. Quest’anno poi è venuto in anticipo e a giugno già martella peggio di Ferragosto. Alle tre del pomeriggio spacca le pietre. Io me ne sto lì, alle tre del pomeriggio, nascosta dietro una colonna del loggiato esterno di villa Stibbert, a fare la posta alle vergini folli. L’ombra debole e corta della colonna è uno sfottio del sole e non riesce a rendere l’aria respirabile. È più di mezz’ora che aspetto, quando finalmente si apre il cancello della villa delle sciroccate. Le due donne escono dal loro covo con fare circospetto. Si guardano intorno, controllano la strada deserta, si chiudono il cancello alle spalle e iniziano la passeggiate delle tre. Ho dovuto ricorrere a questo stratagemma per vederle. Tutto ieri non ho fatto che telefonare inutilmente per chiedere un appuntamento. Sono andata anche a suonare il loro campanello, diverse volte, sempre inutilmente. Eppure le matte erano in casa. Me l’ha confermato il guardiano di villa Stibbert che le ha viste uscire e rientrare, per la consueta passeggiata, sia ieri che l’altro ieri. Aspetto che s’inoltrino un po’, su per la viuzza stretta tra i muri di cinta delle ville. Appena svoltano, mi metto a seguirle a distanza. Procedo così per qualche tempo, senza farmi vedere, allungando quando loro svoltano e fermandomi quando vanno su tratti rettilinei. Dopo che si sono allontanate dalla loro villa quanto basta perché non possano sfuggirmi rincasando, gli do una voce e cerco di raggiungerle. Le colgo di sorpresa. Ai miei primi richiami fanno finta di non sentire e allungano il passo. Io le rincorro. Appena sto per raggiungerle, eccole che esplodono in una di quelle loro sceneggiate balzane. Si mettono a gridare e farfugliare gesticolando con le braccia. Urlano parole incomprensibili, digrignano i denti, sbarrano gli occhi. I corpi interi entrano in agitazione. Insomma recitano da forsennate. La scena fa veramente senso. Capisco che può essere un potente meccanismo di difesa, un efficace strumento per tenere alla larga presenze indesiderate. 295 Però me non m’impressionano. Mi avvicino rapida al loro cerchio di gesti inconsulti, lo penetro, getto le braccia al collo di entrambe le donne in un abbraccio deciso e dico: “Calma ragazze, con me non funziona.” Difatti si smontano subito. Giustifico il mio pedinamento raccontando di come ho cercato invano di raggiungerle ieri. Ora che le ho trovate, glielo dico chiaro e tondo, non ho intenzione di mollarle fino a che non hanno risposto ad alcune domande. Propongo di farla insieme la passeggiata odierna e di parlare cammin facendo. Senza molto entusiasmo, e anzi piuttosto passivamente, accettano la mia proposta. Riprendono il cammino, io con loro, in mezzo a loro. Mi aspetto un tour de force podistico, ma non mi preoccupo. Non le aggredisco subito con le domande che m’interessano. Cerco di farle sciogliere parlando di banalità. Loro restano mute e remissive. Dopo un po’ mi stanco di parlare, e non solo per l’aridità della conversazione. La strada è in salita e vuole la sua dose di fiato. L’ambiente inoltre diventa sempre più insolito, man mano che ci allontaniamo dall’abitato. Camminiamo tra stradine così strette che non ci passano due macchine affiancate, stradine serpeggianti tra ville misteriose e fiancheggiate da alte cinte murarie. I muri sono pieni di graffiti, alla maniera fiorentina, con motivi geometrici insoliti e disegni ornamentali astratti che danno l’impressione di nascondere significati arcani. Dietro di essi s’intravedono le cime di alberi fronzuti e, confusi tra loro, tetti di tegole antiche largamente aggettati sui fianchi delle case, e altane oscure sorrette da agili colonne in pietra serena, e torri posticce coronate da merli guelfi. Cammina cammina, passiamo da via Montughi ad altre vie dai nomi suggestivi: della Pietra, degli Incontri, dei Massoni. Giungiamo in cima a una collina da dove si abbraccia con lo sguardo tutta la città nell’aria tremolante di calura. Firenze laggiù, coi suoi tetti rossastri e i muri bianchi e gialli, sembra un’enorme pizza margherita appena tolta dal forno. Accenno a fermarmi, tanto per riprendere fiato, ma le due matte continuano tetragone 296 per la loro strada. Evidentemente non è una passeggiata senza meta. Ora si cammina in aperta campagna e le ville cedono il campo a sparse case coloniche. A un certo punto ci si trova su una stradella sterrata e parzialmente invasa dall’erba. Passiamo attraverso orti coltivati a carciofi e cavoli neri. Più avanti il sentiero si perde in una macchia fitta di sambuchi, che raggiungiamo in pochi minuti. Avanziamo a fatica nel folto degli arbusti, spostando rami con le mani e con le gambe. La camminata nel verde dura un bel po’, e non faccio in tempo a meravigliarmi per l’esistenza di un tale prodigio di wildlife alla periferia della città, quando il bosco improvvisamente si apre e cede la vista a una stupenda valletta verde e gialla di erba medica e grano. È attraversata da un torrente, sulla cui riva sorge una casa contadina minuscola e tutta bianca, dalle linee semplici e aggraziate. Mi fermo a contemplare l’inattesa visione. Intanto le mie due compagne di passeggiata si siedono a terra e si dissetano a una borraccia. “Non è incredibile”, fa Elvira, “che quasi dentro la città possa esistere un posto così fuori dal mondo?” È ansiosa di saziare la mia evidente curiosità. Riprende: “Quel fiumiciattolo si chiama Terzollino. È tanto piccolo che non si trova neanche sulle cartine Kompass. Pochi ne conoscono l’esistenza, come della valle che lo abbraccia. A Est e a Ovest della valletta, due colline coperte da boschi. A Nord, verso Fiesole, passa la via Bolognese. A Sud, costeggiando il Terzolle, torrente non più grande del Terzollino, corre la via delle Masse. Due rilievi e due vie di comunicazione così poco importanti che la città non si è manco accorta della valle.” La donna s’è sciolta tutta insieme, forse placata dalla bellezza bucolica del posto. Si volta verso la compagna e sorride. Bevo alla loro borraccia e mi siedo per terra anch’io. Cerco di cogliere l’attimo di disgelo per avviare la conversazione. Qualche breve divagazione arcadica e arrivo subito al sodo. “Vorrei farvi alcune domande su Luciano Vinel.” Ed Elvira: “Anche noi.” 297 “Bene,” cercando di dissimulare la sorpresa, “allora cominciate voi.” Le sorprese sono appena cominciate. Lei vuole sapere nientemeno che questo: “Perché una donna emancipata e intelligente come te fa il mestiere?” Che c’entra con Luciano? – Mi domando. Non fa niente. Devo stare al gioco. Mi viene da pensare che la donna è stata presa da un rigurgito di moralismo. Così, per sorprenderla a mia volta, le snocciolo tutta la solfa dell’intrinseca puttaneria femminile nel mondo del dominio maschile: “Una moglie cosa fa che non fanno le puttane? Qual è la differenza reale, a parte il maggior grado d’ipocrisia?” “Giusto.” Conclude lei. “Come dice quella femminista inglese: cos’è una moglie se non una puttana addomesticata?” Evidentemente la teoria riscuote un certo gradimento. Alle vergini folli suona a conferma della validità della loro scelta di un’assoluta separatezza. Così passo a un discorso più aggressivo. Cerco di provocarle con una citazione rivoluzionaria: “Se le donne potessero parlare, direbbero: il nostro valore d’uso può interessare gli uomini. A noi, come cose, non compete. Ma quello che, come cose, ci compete, è il nostro valore.” “Sono d’accordo,” interrompe Elvira, “e l’unico modo per non rinunciare al nostro valore...” “No, non hai capito. Non ‘Valore’ con la V maiuscola, semplicemente ‘valore’. Gli unici valori che contano nell’attuale società sono quelli che interessano alle banche. Noi ci rapportiamo ai nostri simili solo come valori di scambio.” “Ho capito benissimo. Vuoi dire che nella società degli uomini tutte le donne sono puttane. Ecco una profonda verità, peraltro confermata dal fatto che tutte le puttane sono donne. Tanto è vero che tutti gli utenti sono uomini. Utente è colui che usa. L’uomo ha una storia di utente, di soggetto. La donna, di cosa, di complemento oggetto.” Le spara con sicumera e in tono saccente queste trivialità. “No. Non hai capito ancora. Ciò che voglio dire è che senza il valore di scambio il valore d’uso è uno spettro, perché non c’è uso senza relazione. È lo scambio che costituisce la relazione e 298 rende possibile l’uso. Nella nostra società i rapporti umani si riducono a relazioni tra merci; perciò l’unico tipo possibile di rapporto umano è quello basato sui valori di scambio. Chi rinuncia a tale tipo di relazione rinuncia alla propria umanità.” Beccati questa! Segue qualche secondo d’imbarazzo. Lei, dando l’impressione di voler cambiare discorso, riprende: “Anche i tuoi rapporti con Luciano erano puramente mercenari?” Lì per lì non capisco che non sta affatto cambiando discorso. “Sì.” Rispondo. “A noi risulta che lui aveva un interesse particolare per te.” “Davvero?” Cado subito nella trappola, come una scolaretta. “Ci risulta che si trattava appunto di un interesse, sebbene un interesse poco materiale.” “Cioè?” “Lui ti usava per scopi, diciamo così, spirituali. Praticava con te certe tecniche yoga con cui si riproponeva di attivare degli stati alterati di coscienza.” Me la sono voluta. Mai abbassare la guardia quando si lotta contro la perversità del sentimentalismo e del moralismo, il proprio sentimentalismo e il moralismo altrui. Riprendo subito il controllo di me. “Non c’era niente di spirituale nel nostro rapporto. Comunque mi usava, sì.” “Ma tu volevi qualcosa di più...” Stavolta non mi faccio fregare. “Come fate a conoscere le intenzioni mie e di Luciano? Intuito femminile?” “Abbiamo parlato a lungo con lui: del giardino Stibbert, del paradiso terrestre, dell’ascesi, dei cavalieri del Graal...” “Che c’entra tutto ciò con il rapporto che Luciano aveva con me?” “Eh, c’entra, c’entra.” Fa lei. Poi, per chiudere il discorso, si alza in piedi e riprende il cammino. Gina e io ci guardiamo esitanti. Ci alziamo anche noi e la seguiamo. Va veloce come un treno, la ‘madre’. Noi, dietro a ruota. Giungiamo in fondo alla valletta in dieci minuti, oltrepassiamo il torrente con un salto e riprendiamo a salire. L’altra collina non è 299 più ripida di quella da cui siamo scese. Però farla in salita e quasi di corsa non è la stessa cosa che farla in discesa. Elvira va su spedita. Noi, sempre dietro, trafelate. Dopo un quarto d’ora siamo in preda al fiatone. Neanche pensarci alla conversazione! Tuttavia provo: “Mi hai fatto le tue domande e non mi hai dato tempo per farti le mie.” Silenzio. “Vorrei farne una molto importante e un po’ delicata.” Silenzio. “Posso? Chi tace acconsente?” Silenzio. “Allora: ho saputo che in alcune notti siete state viste aggirarvi nel giardino Stibbert e che vi avete scavato una buca in terra. È vero? Cosa cercavate?” “Ecco una domanda a proposito.” È Gina che parla, sorprendentemente; parla con un filo di voce, soffocata dall’affanno. Elvira se la cava con una risatina. La passeggiata continua a velocità sostenuta. Solo il rumore dei passi e dei respiri ansimanti rompe la monotonia del silenzio, dopo che ho rinunciato a fare altre domande. In poco tempo siamo lontane dagli ultimi sparsi agglomerati suburbani. Il sentiero torna a inoltrarsi nella boscaglia, inerpicandosi ripido sulle pendici di Monte Morello. La vegetazione diventa più varia e produce quella strana atmosfera di disordine e di abbandono che è tipica delle campagne deruralizzate ma non ancora inurbate, mescolata com’è con una sporcizia fatta di scarichi di calcinacci, sacchetti di plastica e altre immondizie cittadine. E le frangole e i rovi, gli ornielli e le filliree e i soliti sambuchi cercano invano, con la loro delicatezza, di fare finta di niente. Man mano che si sale, l’altezza e il volume degli alberi crescono. Prima sono roveri e roverelle; più avanti, in un crescendo d’intensità spirituale, cerri, lecci e farnie. Camminiamo per mezz’ora nel querceto. Quand’ecco, l’atmosfera cambia di nuovo. Il sentiero s’incurva sopra un costone ed entra in un bosco di cipressi. 300 Ora bisogna sapere che già il cipresso maschio, quello sottile, lungo e affusolato, è il prodotto di una selezione culturale, inequivocabile opera dell’uomo. Il bosco di cipressi poi è una cosa che proprio non esiste in natura. Dove c’è, è perché qualcuno ce l’ha messo. L’atmosfera che vi si respira dunque è quella di un luogo magico, di un regno fantastico in cui vigono le leggi di una natura artificiosa. La mano dell’uomo non vi compare di persona, però la sua presenza è svelata da ogni particella vivente e perfino da quelle morte, i sassi, i rami secchi e il sottobosco composto di foglioline squamose e di galbuli color ruggine. Poco più avanti infatti il bosco si apre e quasi si infrange su un muro. È una parete alta, dritta e lunga. L’intonaco è stato raschiato via dal tempo. Il sentiero, che ora procede addossato al muro, è indurito di calcinaccio. Lo seguiamo affascinate. O almeno, io sono tutta presa dal fascino di questa nuova magia. A un certo punto il muro forma un angolo. Il sentiero lo aggira e prosegue lungo il nuovo tratto di muro. Lo seguiamo. Le due donne avanzano sicure, una avanti e una dietro a me. Giungiamo in un tratto dove la barriera si rompe in una breccia. Non è larga: poche pietre divelte, quanto basta per lasciarvi strisciare una persona dentro. Elvira vi s’infila senza esitazione. Gina, dietro di me, mi fa cenno di non indugiare. Entro anch’io. Lei mi segue. Come avevo intuito dalle cime degli alberi che si scorgevano oltre il muro, il recinto racchiude un giardino. Avverto che è un giardino molto particolare, ma stento a capire cos’è che lo rende tale. I sassi che avrebbero dovuto racchiudere le aiuole sono pressoché sommersi dal verde e dal sottobosco; e a fatica si riesce a intravedere i viottoli su cui si cammina. La vegetazione è fitta e selvaggia. Diverse piante rampicanti hanno assalito gli alberi e penzolano dai loro rami come liane. Fiori e cespugli d’insolite varietà hanno invaso il terreno. Gli alberi sono anch’essi svariati e delle specie più strane. Eppure mi paiono familiari. Mi viene da pensare che non si tratta né di un giardino né di un bosco, bensì di una via di mezzo. Evidentemente è un antico giardino trasformato in bosco da una prolungata incuria, penso. 301 Non ho tempo di perdermi nelle riflessioni. Le mie due guide si sono già inoltrate nel fitto della vegetazione. Per non perderle, mi metto alla loro coda. Le raggiungo e non mi stacco più da loro. Una sorta di trepidazione si sta facendo strada dentro di me e fatico a resisterle, anche se il contatto con le due donne mi infonde un po’ di coraggio. Loro camminano spedite, chiaramente conoscono la strada. Ogni tanto troviamo, nascosti tra le ortiche e i rovi, qualche pietra antica, pezzi di panchine di marmo, frammenti di statue e di capitelli. “Questo giardino ha qualcosa di strano,” dico, “ma non riesco a capire cosa.” “Ti evoca visioni note, vero?” Risponde Elvira. “Proprio così. Ma non capisco.” “Ti aiuto io. Qui abbiamo una copia del giardino Stibbert, una copia non perfetta, una copia volutamente difforme.” All’improvviso le due donne si fermano. Dobbiamo aver attraversato tutto il parco, perché davanti a noi, parzialmente nascosti dal folto di una residua vegetazione, s’intravedono i muri di una costruzione. Gina si toglie lo zaino dalle spalle, lo posa a terra, lo apre e ne estrae un librone e un laptop. Inserito tra le pagine del libro, c’è un foglio di carta protocollo. Mentre Gina avvia il computer, l’altra afferra il libro e ne tira fuori il foglio. Sbircio il titolo del libro: Alberi esotici in Italia. Il foglio è ripiegato in quattro. Una volta aperto, mi rivela senza pudore il suo contenuto, che non è altro che un lungo elenco di nomi latini di piante. La passeggiata riprende. Ora si procede senza fretta. Ci si ferma a ogni albero. Elvira lo osserva, scorre con la penna lungo il foglio protocollo e mette una crocetta accanto a un nome. Infine declama un numero. Qualche volta, prima di scorrere l’elenco, dà una rapida sfogliata al libro in cerca di conferme. Ognuno dei numeri declamati viene battuto da Gina sul quaderno elettronico, che tiene appoggiato sull’avambraccio sinistro mentre vi lavora sopra con la mano destra. Si va avanti così per un bel pezzo, albero dopo albero, sistematicamente. L’operazio- 302 ne diventa monotona e non riesco a trattenere dei segni d’impazienza. “Non ti agitare, abbiamo quasi finito. Sei stata fortunata. Sei capitata il giorno in cui concludiamo. È un lavoro che va avanti da diverse settimane e solo oggi ne vedremo la fine... spero.” È sempre Elvira che parla. “Che lavoro?” Domando. “Il censimento di tutti gli alberi di questa villa e del giardino Stibbert.” “Perché...” “Un attimo. Non farmi distrarre. Tra poco la tua curiosità sarà soddisfatta.” Il gioco continua ancora per una ventina di minuti, lungo un percorso contorto. Alla fine ci ritroviamo sul margine del bosco, al cospetto di una costruzione tetra, le finestre sprangate da assi di legno, i muri sbrecciati e logorati dall’età. Un grande portone nero è tenuto chiuso da una catena di ferro arrugginito. Il tutto suscita un’impressione di decadenza e di mistero. Le due matte si siedono su una vecchia panchina di pietra, e Gina si concentra sul lavoro al computer, che ora tiene appoggiato sulle ginocchia. Elvira attende il risultato del calcolo, direi con ansia. Il calcolo non dura a lungo. Alla fine Gina dice: “Ci siamo. È il numero 79.” Elvira apre il foglio protocollo. Cerca il numero 79. Legge il nome che gli corrisponde. Poi, data una veloce scorsa all’indice analitico del librone, cerca la pagina che descrive quell’albero. Legge con attenzione, molto concentrata, in silenzio. Infine erompe: “Non poteva essere che lui: il siliquastro, Cercis Siliquastrum.” “Non poteva essere che cosa?” Domando. “La dimostrazione della nostra teoria, e la risposta alla tua domanda di poco fa.” “Quale?” “Cosa stavamo cercando, quella notte che scavammo nel giardino Stibbert?” “Cosa stavate cercando?” 303 “L’albero della vita. Già sai che quel giardino è un antilabirinto, la rappresentazione della perdizione del mondo e nello stesso tempo delle vie che conducono a un altro mondo, cioè al paradiso terrestre, un paradiso che è appunto terrestre. È altro dal mondo, ma non sta altrove. Solo che è inaccessibile ai più. Bisogna cercarlo. Bisogna cercare la via d’accesso, al contrario che in un labirinto, di cui devi cercare la via d’uscita. E molti sono i chiamati, sta scritto, non tutti. Pochi gli eletti, ad ogni modo.” “Che c’entra il siliquastro?” “Secondo la Genesi, Adamo ed Eva furono cacciati dall’Eden per aver mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Furono cacciati per impedire che mangiassero anche il frutto dell’albero della vita e diventassero, così, simili a Dio. È questo lo scopo dell’ascesi, della ricerca della verità nel mondo: trovare l’albero della vita, un albero che sta nascosto nel paradiso.” “È l’albero che stavate cercando?” “Esatto. Avevamo elaborato un modello che ci doveva dare la chiave dell’enigma. Ricordi il cancelletto di Tiresia e di Ifi? Te ne abbiamo parlato l’altra volta.” “Sì.” “Si apriva su un vialetto che si biforcava in due altri vialetti che conducevano di nuovo al cancello.” Tira fuori dallo zaino la mappa del giardino, la dispiega, la stende per terra davanti a me e con un dito m’indica un punto su di essa, un punto segnato con la lettera C. “Questo, vedi? è il punto critico della mappa. Da esso, girando in un cerchio di vialetti, si passa al cancello. Ad esso si torna seguendo i viali su cui il cancello apre. Ad esso convergono tutti i viali del giardino. Infine questo punto rappresenta il centro della croce formata dal cardo e dal decumano del parco. Qui doveva trovarsi l’albero della vita. Però non c’era.” “Dov’era andato?” “Doveva essere stato lì ai tempi degli Stibbert. In seguito, morti loro, può essere stato tagliato da qualche giardiniere comunale. Così, per verificare la nostra teoria siamo andate a scavare in quel punto.” 304 “E cosa avete trovato?” “Poco, quasi niente. Una terra di consistenza e colore diversi da quella circostante, indizio che lì potevano effettivamente esserci state le radici di un albero. Ma ciò non provava nulla. Ad ogni modo non potevamo sapere quale tipo di albero fosse.” È sempre Elvira che parla. L’altra se ne sta seduta per terra con la schiena appoggiata al siliquastro, gli occhi persi nel vuoto. Pare in trance, e sembra non ascoltare la nostra conversazione. “Per fortuna c’era quest’altro giardino.” Riprende, sempre Elvira. “Già, che c’entra quest’altro?” “Era un’antica villa. Nell’Ottocento divenne anch’essa proprietà degli Stibbert, che l’affittarono a Robert Browning. Abbiamo cercato di risalire indietro nella storia e siamo arrivati fino al Quattrocento, quando apparteneva a un mecenate che si dilettava di filosofia neoplatonica. Nel tardo Cinquecento è appartenuta al granduca Francesco I, l’alchimista; nel Seicento, a un ricco medico che fu processato e messo al rogo per stregoneria. Secondo gli atti del processo, si erano tenute terribili pratiche magiche in questo giardino.” Mi corre un brivido nella schiena. Gina si volta verso di me e mi guarda assorta negli occhi senza parlare. Poi si alza, si mette lo zaino in spalla e, rivolta a Elvira: “Bisogna andare,” dice, “se non vogliamo far notte.” “Andare dove?” Domando. “In cima a Monte Morello, dove dobbiamo verificare un’altra ipotesi.” Risponde Elvira. Così ci alziamo e ci rimettiamo in marcia. Gina ci precede di una dozzina di passi. Io ed Elvira avanziamo l’una accanto all’altra, continuando la conversazione. “Gli Stibbert”, riprende lei mentre camminiamo a passo sostenuto, “comprarono la villa nel 1858 e la ristrutturarono completamente. È probabile che la ristrutturazione sia stata realizzata insieme a quella di villa Stibbert, che pure nella stessa epoca fu fatta oggetto di ampi rimaneggiamenti architettonici. Ebbene, questo giardino è una copia della villa fiorentina.” 305 “Una copia difforme.” Precisa Gina che, pur distanziata da noi di diversi metri, non si perde una parola della conversazione. “Infatti,” riprende l’altra, “una copia della sola metà settentrionale, la sezione che abbraccia la parte greca della croce.” “Che vuol dire?” La interrompo. “Secondo noi vorrebbe dire che la villa di monte Morello rappresenta una sorta di anima esoterica dell’altra. In essa dovevano svolgersi le cerimonie più segrete dell’Ordine. Gli alberi delle parti dei due giardini che si sovrappongono sono pressoché gli stessi, delle stesse specie, voglio dire, e dislocati nello stesso modo. A ogni albero di qui ne corrisponde uno di là.” “Hai detto ‘pressoché’?” “Be’, è passato un bel po’ di tempo dalla morte di Federigo Stibbert, e qualche pianta sarà caduta, nuovi alberi saranno cresciuti. Tuttavia per gli alberi secolari la corrispondenza è perfetta. Anche per i meno antichi è molto buona, non per i giovanissimi. Segno che fino a una certa epoca, magari abbastanza recente, una tradizione è stata rispettata. Mi segui?” “Perfettamente. Vai avanti.” “Insomma abbiamo ricostruito lo schema dei due giardini, riempiendo i vuoti e cancellando le piante che ci sembravano troppo giovani. Alla fine abbiamo individuato l’albero della vita. Che è uno che si trova, nel giardino del monte, precisamente nel luogo che corrisponde al punto C del giardino della città. È un albero che deve avere poco più di cent’anni. Quindi può essere stato piantato dagli Stibbert. Senonché non esiste un suo corrispondente nell’altro giardino. Segno che lì deve essere stato tagliato.” “O che non c’è nessuna corrispondenza. Ma non mi hai detto perché ci tenevate tanto a conoscere la specie dell’albero della vita.” “Siamo convinti che quest’albero esprime in nuce la filosofia del giardino Stibbert.” “Hai detto ‘convinti’?” “Sì, nel noi includo Luciano. È una ricerca che abbiamo svolto insieme a lui.” 306 “E lui, un uomo così razionale e ipercritico,” sparo, “vi seguiva in tutta questa farragine di occultismo?” “Anzi è stato lui che ci ha avviato alla ricerca, ci ha indirizzato e istruito. Lui è quasi completamente d’accordo con le nostre idee. O forse dovrei dire ‘le sue’. Ci divide però una divergenza interpretativa di non poco conto...” “Su cosa?” “Sulla Genesi. Noi tendiamo a una visione storica ed escatologica. Lui a una soteriologica.” “Soterio che?” “La scienza della salvezza dell’anima.” Detto ciò, si ferma. Prende la borraccia, dà un lungo sorso. Me la passa e si rimette in cammino. Bevo anch’io e riprendo fiato. Il sentiero ha ricominciato a salire ripido. Sono le cinque del pomeriggio, il sole continua a picchiare duro. La stanchezza si fa sentire e mi fa sudare abbondantemente. Le mie compagne di passeggiata non soffrono di meno. Il sudore è così abbondante sul corpo di Gina che short e t-shirt sarebbero da strizzare. Gli si sono appiccicati alla pelle e svelano al sole e ai miei occhi ammirati forme snelle e flessuose di una delicata sensualità. “Quanto manca alla cima?” Domando con uno sbuffo. “Mezz’ora circa.” Risponde Elvira, da dietro di me, invisibile, nascosta dagli alberi oltre una curva del sentiero; e sembra la voce di un genio del bosco. Il quale bosco nel frattempo ha di nuovo cambiato aspetto. Adesso è dominato dagli abeti, i pini mughi e i larici, i veri alberi di montagna, con la loro atmosfera cupa e severa. Ma, qua e là, ancora qualche quercia maestosa cerca di preservare l’aura di sacralità che dà il tono a tutto il monte. “Parlami di quest’albero della vita.” Continuo, rivolta a Elvira. “Il siliquastro è noto anche come albero di Giuda. Secondo un’antica tradizione eretica è l’albero sotto cui Giuda baciò Gesù e ai cui rami infine si impiccò. Giuda non sarebbe un volgare traditore, bensì l’apostolo che interpretò il messaggio di Cristo in termini iniziatici. Con il bacio a Gesù tentò di farsi simile a Dio, di completare l’opera cominciata da Eva e Adamo. L’albero della conoscenza del bene e del male aveva dato all’uomo la coscienza 307 morale, differenziandolo dall’animale. L’albero della vita gli avrebbe fatto fare un altro passo avanti. Giuda tentò l’impresa ma fallì. Dopo di lui altri tentarono in nome di Cristo. Tutta la saga della cerca del Graal, ad esempio, s’inscrive in questa tradizione.” “Che c’entra il Graal adesso?” “Vedrai che c’entra.” Ne prendo nota mentalmente, ricordandomi che il Graal era menzionato nella poesia dedicatami da Luciano. Poi riprendo: “Torniamo all’albero della vita.” “Il siliquastro è noto ancora con un altro nome...” “Cioè?” “Albero dell’amore, nome che probabilmente gli deriva da alcune sue proprietà morfologiche. Le foglie hanno una perfetta forma di cuore. I fiori, di un intenso color porpora, hanno la forma di piccole labbra. Ma la cosa più interessante è che si tratta di una pianta ermafrodita.” “Perché interessante?” “Ecco una domanda interessante. Sull’interpretazione di questo simbolo vertevano le principali divergenze tra il compagno Luciano e noi.” “Cosa pensava Luciano?” Lei, ignorando la mia domanda, e come seguendo un suo dialogo interiore, fa: “Sta tutto scritto nella Bibbia. Epperò quante diverse verità in ogni parola! Secondo noi la Genesi è una teoria della filogenesi umana e contiene una chiara implicazione teleologica, una promessa utopica. L’essere umano fu creato maschio e femmina, dice Mosè. Ciò significa che nell’orda preistorica non esistevano stratificazioni sociali basate sul sesso. La storia dell’umanità comincia con la dialettica dei sessi. Tutta la storia è storia di lotte di genere. Prima ci fu il conflitto tra Adamo e Lilith, la diavola che non accettava il rapporto sessuale in posizione sottomessa. Poi la vicenda di Adamo ed Eva e quella di Caino e Abele, quest’ultimo essendo una figura della femminilità. Il racconto delle origini narra dei tentativi del maschio di sottomettere la femmina e della femmina di liberarsi dal potere maschile. Il messaggio fonda- 308 mentale della Genesi è che l’uomo incarna il principio d’autorità, la donna il principio di ribellione. La donna, nata alla storia già sottomessa, quale costola dell’uomo, non può affermare la propria umanità se non rivoltandosi contro il primum movens della propria oppressione. Nel movimento della propria liberazione trascina con sé l’uomo stesso. Tutto il dinamismo della storia conosciuta, il progresso, la crescita, la civilizzazione, proviene dall’impulso rivoluzionario che le donne riescono a infondere negli uomini. Per questo la femmina, complice di Lucifero, l’angelo ribelle, ha sempre rappresentato il peccato e la tentazione. Tutto quel che è reazione e conservazione, d’altra parte, rientra nell’orizzonte politico del maschile.” “Vabbè, ma che c’entra con l’albero di Giuda?” “Con l’albero dell’amore! O della vita.” “Sia pure.” “L’albero dell’amore è ermafrodito. In quanto tale è simbolo della condizione primigenia dell’umanità. Il frutto dell’albero della vita, a cui il genere umano ha perennemente teso fin dalla nascita, è il sogno di un’umanità pacificata. Il movimento storico è una grande rivoluzione. Come un pianeta compie una rivoluzione facendo un giro completo intorno al sole, così l’umanità compirà la propria rivoluzione quando tornerà alla promiscuità delle origini. Tuttavia, poiché il sole è in movimento, il punto d’arrivo non sarà lo stesso del punto di partenza. Il comunismo finale, per dirlo col giovane Marx, nega e realizza la storia e riporta alle origini, però a un livello di coscienza superiore. Il comunismo primitivo è lo stato animale dell’umanità, quello finale è lo stato divino. Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, cioè maschio e femmina.” Senza accorgercene ci ritroviamo in cima al monte. Il bosco, come fosse stato rasato da un gigantesco rasoio, s’interrompe seccamente ai margini di un’ampia radura verde. Una volta fuori dal folto degli alberi, ancora cinquanta metri di lieve pendio ed eccoci sul cucuzzolo calvo del monte. Sono stanca morta. Appena arrivo in cima mi stendo per terra e cerco di riprendere conoscenza. L’orologio segna le cinque e mezzo e il sole è sempre splendente. Non c’è un alito di vento, né l’ombra di un albero 309 sotto cui cercare refrigerio. Anche le mie due accompagnatrici si sdraiano in terra, giusto il tempo di calmare il respiro. Dopo di che, si alzano e si rimettono al lavoro. Gina tira fuori dallo zaino un binocolo, una cartina geografica e una bussola. Passa gli ultimi due strumenti all’amica e con il primo si mette a scrutare lungo le pendici del monte. Incuriosita, sollevo il busto da terra anch’io e guardo giù. Per piccolo e non bello che sia, monte Morello se ne sta maestoso sopra a Firenze; e lei, distesa sul fondo della val d’Arno, giace ai suoi piedi come un tappeto di preghiera al cospetto dell’eterno. Elvira, quasi traducendo in prosa il mio sentimento, dice: “Questo, per i romani, era il monte sacro di Firenze. Il suo nome era monte Amor, dove ‘Amor’ sta sia per ‘amore’ sia per il rovescio di ‘Roma’. Era consacrato alla trinità pagana, Giove, Marte e Quirino. Ha tre cime, infatti, e ognuna è dedicata a un Dio. Monte Amor, capisci? I fiorentini, col passare del tempo, un po’ per l’influsso del cristianesimo blasfemo e un po’ sotto la spinta della vena iconoclasta che fluisce dalla loro titanica anima di bottegai, hanno trasformato Amor in Amorello.” Mi volto indietro a guardare le altre due cime del monte, che prima avevo solo intravisto. Sono arrotondate e calve anch’esse. Poi torno a osservare le bellezze della val d’Arno mentre il cielo comincia a riempirsi dei colori caldi che preludono al tramonto. Le due donne lavorano. Elvira orienta la cartina. Poggia la bussola su di essa lungo un segmento tracciato con la matita. Finite le operazioni di orientamento, impartisce delle istruzioni a Gina: “Un po’ più a destra, ancora un po’. Ecco, ora dovresti esserci.” L’altra, col binocolo incollato agli occhi, segue le istruzioni cambiando la direzione di osservazione con un movimento rotatorio del busto. Quando trova la direzione giusta, smette il movimento orizzontale e ne comincia uno dall’alto in basso e viceversa. Continua così per qualche minuto, adagio, su e giù col binocolo, puntandolo ora su Firenze ora sulle pendici del monte. Infine prorompe: 310 “Eccola! Sembra proprio a metà strada.” E passa il binocolo all’amica, indicando col dito il punto in cui guardare. L’altra osserva, poi afferra la cartina e con la matita ci traccia sopra una crocetta. “Si può sapere cosa state facendo?” Domando. “L’ultima verifica della nostra teoria.” Risponde Elvira. “E sarebbe?” “Guarda.” Dice, mostrandomi la cartina e indicando con la matita i due punti terminali della linea disegnata. Prima l’uno e poi l’altro me li mostra, ripetutamente. “Questo è il posto dove ora ci troviamo noi e questa è villa Stibbert.” Quindi, dopo essersi accertata che ho osservato bene, m’indica il punto con la crocetta a metà linea. Conclude: “Questa è la villa del siliquastro.” “Che vuol dire?” “I tre punti sono perfettamente allineati lungo l’asse NordSud. Rappresentano tre luoghi sacri della tradizione occulta che faceva capo agli Stibbert, e tre livelli della scala iniziatica. Villa Stibbert era la porta esterna; la villa del siliquastro, la sede segreta in cui si svolgevano le cerimonie dell’alta iniziazione; la cima del monte, l’altare in cui si praticavano i riti più sacri.” “Che riti?” La interrompo. “Non ne sai niente tu?” La domanda mi coglie di sorpresa. Lei insiste: “Non ci sei mai stata qui con Luciano?” La mia sorpresa ora raddoppia. Mi viene in mente che proprio una settimana prima di morire Luciano mi aveva invitata a una escursione su monte Morello, che però non facemmo. “Allora, ci sei mai stata?” Insiste Elvira, che si è accorta della mia incertezza. “No.” “Be’, comunque ti ci avrebbe portato, prima o poi.” “Perché? E come fai a saperlo?” “Noi conosciamo bene la natura del rapporto che legava Luciano a te. La conosciamo meglio di quanto la conosci tu stessa.” “Per questo, prima, mi avete fatto quelle domande sulla mia professione e tutto il resto?” 311 “No. Solo per capire qual è il tuo livello di consapevolezza.” “Cosa avete capito? “Che non è il top.” “Cos’è che non saprei?” “Come Luciano ti usava. Per lui eri la puttana santa.” Al che esplodo in una risata fragorosa, e quasi convinta. “C’è poco da ridere.” Interviene Gina, stavolta. “Abbiamo letto una quartina mostrataci da lui. Sappiamo che era destinata a te. È intitolata proprio così: Puttana santa.” “Dedicata a me?” “No, ho detto destinata. Tu eri la sua Ginevra. Tu...” Ma non finisce la frase, la bocca della verità. È gelata da uno sguardo di Elvira. La quale, riacquistata la sua durezza, si alza di scatto e afferra lo zaino. “Si sta facendo scuro,” dice, “è ora di andare.” E si avvia verso la discesa. Gina si alza subito e le si mette dietro come un cagnolino ma arrabbiato. Dopo un attimo di esitazione mi alzo anch’io e inseguo le due matte. Mi sovviene che Puttana santa era la destinataria che compariva sul post-it attaccato da Luciano sul libro speditomi prima del viaggio in Africa. Ora la mia curiosità è alle stelle. Cerco di riavviare la conversazione. Non ho intenzione di mollare le due donne finché non mi hanno detto tutto ciò che sanno. La discesa è veloce e piuttosto pericolosa. Le ginocchia mi dolgono e il fiatone mi fa boccheggiare. Non c’è modo di sostenere una gran conversazione. Nondimeno qualche notizia riesco a strapparla, qualche notizia e una promessa. Dopo un’ora di cammino Elvira si stacca da me e da Gina e se ne va per conto suo. Pare una bambina capricciosa. Noi altre due ne approfittiamo per rallentare la marcia e scambiarci poche parole. Così vengo a sapere che quella quartina Luciano l’ha scritta a matita sulla pagina di un libro antico conservato nell’inferno della biblioteca Stibbert. La promessa è di mostrarmi il libro. “Anche Elvira dovrà convincersi che è necessario mostrartelo.” Conclude. Mi spiega che lo faranno dopodomani sera, quando ci vedremo a casa loro. 312 Martedì, 2 luglio Ormai comincio a vederci abbastanza chiaro. Restano da inserire alcuni tasselli e il puzzle sarà ricomposto. L’ultimo tassello spero di poterlo mettere quando avrò letto Puttana santa. Perciò stamani presto mi reco all’ufficio di Giuliano. La segretaria che ha preso il posto di Lilli è una ventenne super sexy, viso da bambola e corpo da Barbi con una lieve tendenza al lardoso. È qui da poche settimane e già tratta Giuliano come cosa che gestisce lei. “Il dottore è molto occupato ora e non può ricevere nessuno.” Mi fa. “Se crede, posso fissarle un appuntamento per un altro giorno.” “Senti sciacquetta, alza quelle chiappe cellulitiche e va subito da lui. Digli solo che lo voglio vedere io.” Quando torna ha abbassato la cresta. Con una voce stridente di rabbia repressa mi dice semplicemente: “Può entrare.” Lui sta prendendo il caffè. Tiene la tazzina fumante nella mano sinistra con l’indice e il pollice, mentre la sigaretta, tra l’indice e il medio della stessa mano, mischia il suo fumo a quello del caffè. Con l’altra tiene il ricevitore del telefono, che posa sull’apparecchio appena mi vede. Mi accoglie cordialmente e mi offre un caffè. Dal citofono ordina alla sciacquetta di andare subito a prenderlo al bar. Mi siedo davanti alla sua maestosa scrivania di direttore amministrativo e la prima cosa che faccio è di ingiungergli di restituirmi il mio diario. Me l’ha sottratto l’altro ieri, non contento di avermi già derubato del libro sull’Africa speditomi da Luciano. Due giorni fa, rientrando a casa la notte tardi ho trovato di nuovo la scrivania sottosopra e tutte le mia carte sparse per terra. Il diario era sparito. Il resto della casa non era stato toccato. Evidentemente il ladro sapeva cosa cercare. Non è stato difficile dedurre che doveva essere Giuliano. Perché è tanto interessato al mio diario? O forse cercava qualcos’altro? Magari il quinto capitolo del Nuovo corso? Se è così, è rimasto fregato, perché quel manoscritto non è ancora nelle mie 313 mani. Gli ingiungo di rendermi il diario. Lui mi guarda beffardo da dietro la scrivania. Mi osserva in silenzio per qualche secondo. Quindi, calmo, apre un cassetto, ne tira fuori il diario e me lo restituisce. Intanto è arrivato il caffè. Mentre lo sorseggio, passiamo ad altri argomenti. Chiacchieriamo del trekking sul Kilimangiaro e del safari, che ormai sembra un’esperienza da collocare tra i ricordi perduti. Infine veniamo al sodo. Gli rivelo che ho decifrato il quarto capitolo del Nuovo Corso e che ho trovato il solito messaggio. Gli spiego il codice, stavolta. Lui prende una matita e si scrive la formula su un blocco note. Poi tira fuori dal cassetto i cinque fogli con gli aforismi del quarto capitolo. È poco convinto. Dà una scorsa ai fogli seguendo la lettura con la matita. Man mano che legge, individua le lettere del messaggio applicando la formula che gli ho rivelato. Le sottolinea e le trascrive ad una ad una sul blocco note. Infine afferra il blocco e legge: “Cerca oltre cerca ancora cerca.” Dopo alcuni secondi che paiono di profonda riflessione, ma che forse sono di perplessità, dice: “Bene, grazie. Mi hai risparmiato un lavoro inutile. Vuol dire che bisognerà proseguire la ricerca nel quinto capitolo.” “Non ce n’è bisogno. Ho decifrato pure quello.” Mento. “Che hai trovato? Il solito messaggio anche lì?” “No. Stavolta no.” “Che cosa, allora?” Con un’alzata di sopracciglia appena percettibile. Cerco di tenerlo sulle spine: “I vari messaggi non potevano rinviare sempre oltre. Ci doveva essere un punto d’arrivo. Siccome il quinto capitolo è l’ultimo...” “Qual è il punto d’arrivo?” “È stata una sorpresa. Tutto m’aspettavo, meno che una cosa del genere. Infine, quando ho trovato questa cosa, ho capito.” “Hai capito tutto?” “Quasi. Mi manca un’ultima informazione, che non dispero di trovare presto.” 314 “Trovare cosa?” “La chiave della verità, naturalmente.” “Come la troverai?” “Devo incontrare delle persone.” “Chi sono?” “Non telo dico.” “Tanto lo so. Sono le vergini rosse, le due pazze.” “Bravo.” “E quando l’avrai trovata, la verità, spero vorrai mettermi in condizione di conoscerla anch’io.” “Giuliano, non fare il furbo con me. Lo so che tutto ciò che io scopro, in questa storia, tu già lo conosci.” “Quasi tutto, potrei dire con le tue parole.” “Infatti.” “Intanto”, prosegue, “non conosco il messaggio nascosto nell’ultimo capitolo del Nuovo corso.” “Questo te lo dico io.” Lui mi fissa intensamente. Lo tengo a rosolare ancora per un po’, infine sparo: “Il messaggio è un nome di persona.” “Quale?” “Il mio.” Lui continua a guardarmi intensamente. Solo un impercettibile assottigliarsi degli occhi ne tradisce l’incertezza. Sicuramente si sta domandando: – sarà vero? Lascia passare qualche altro secondo di silenzio. Infine, come risvegliandosi da un breve sonno, dice: “Sai cosa significa?” “Sì. E non ho paura. Sai perché?” “Perché?” “C’è una cosa che tu hai bisogno di conoscere: quella che forse scoprirò domani.” “Bene. Quindi possiamo incontrarci domani.” “No. Dopodomani. A casa mia. Alle nove.” “Magnifico!” 315 Me ne vado senza una parola di più. Quando passo davanti alla segretaria cellulitica, manco rispondo al suo saluto reverenziale. Sono già tutta in fermento per l’attesa di un altro appuntamento: stasera alle sette, con Lucrezia. Sono emozionata. Da giorni non penso ad altro. Ho anche riflettuto sulle ragioni di questa eccitazione e non mi è stato difficile ammettere una semplice verità: che la donna mi attrae. Potrebbe essere una specie d’innamoramento vicario, che so? una proiezione sulla sua ex compagna di un sentimento suscitato e frustrato da Luciano. Ho evitato però di approfondire la faccenda. Bando alla psicologia! No, non ho voluto cedere all’elucubrazione mentale. Invece mi sono lasciata prendere dal sentimento peggio di una fanciulla alle prime armi, e mi sono abbandonata alla reverie. Già faccio con lei dei deliziosi dialoghi interiori e non passa notte che non sogni di dormire nel suo letto, solo dormire, abbracciate come due sorelle. Stasera mi decido: si viene al sodo, accada quel che accada. In ogni caso ho da chiarire con lei due questioni di una certa importanza. Appena giunta a casa sua, affronto la prima. Seduta su un divano, con in mano una coppa di Ferrari freddo al punto giusto, le dico apertamente che temo per la sua vita e che deve stare in guardia da Giuliano. Lei, seduta a terra con le gambe incrociate in mezzo a un mucchio di cuscini indiani, mi guarda con amore filiale. La mia apprensione non la sconvolge. Insisto sulla gravità della situazione fino a strapparle la promessa che nei prossimi giorni starà alla larga da quell’uomo. Quindi passo all’altra questione: il quinto capitolo del Nuovo corso di Luciano, di cui lei possiede l’unica copia esistente. Mi ero preparata un lungo discorso e un’accorta strategia di persuasione. Avrei dovuto avere il capitolo ad ogni costo. Invece, appena lo menziono, lei si alza e va in un’altra camera. Torna con cinque fogli manoscritti tutti ciancicati e me li consegna col più dolce e disarmante dei sorrisi. Sbrigate le faccende pratiche, ci ritroviamo con la notte intera davanti a noi. Mangiamo in cucina, un localino angusto con le pareti piene di ammennicoli e poster floreali. Un ventilatore si 316 sforza con scarsi risultati di abbattere il caldo della sera. Non è una cena pretenziosa. Il vino da tavola amabile e senza nome è quasi un dispetto a confronto di quello che abbiamo bevuto per aperitivo. I cibi sono semplici, insalata di riso, fettine alla pizzaiola e panna cotta, e tutti preparati con le sue manine d’oro. Alla fine si torna alla mezza bottiglia di Ferrari. Con una coppa ciascuna, piena fino all’orlo, torniamo in salotto e ci sediamo vicine sul divano. Nelle viscere di un CD-player gira un John Lennon d’annata, sempre lo stesso da quando sono entrata. Contribuisce a creare l’atmosfera giusta. Rapita da quella musica di malinconica ribellione, Lucrezia sembra cadere fuori dal mondo di tanto in tanto e mi guarda trasognata. Quando si riprende, la conversazione torna viva e piacevole. Parliamo a lungo, delle cose più insulse e insignificanti, così, per il solo piacere di comunicare. Ripetutamente cerco di portare la conversazione su di lei. Voglio conoscerla meglio e le faccio molte domande, sulla sua vita, i suoi interessi, il lavoro. Appena mi avvicino a questi argomenti, lei s’irrigidisce, come bloccata da una sorta di timidezza infantile, una pudicizia non scevra di una certa malizia però. Allora decido di aggirare l’ostacolo e porto la conversazione sul suo rapporto con Luciano, argomento che peraltro m’interessa di per sé. Le chiedo di spiegarmi i motivi profondi della loro rottura. Lei fa qualche resistenza ma non troppa. Dice che me ne ha già parlato. Io ribatto che non fa niente, che mi piacerebbe risentirla quella triste storia. Mentre lei parla, mi rendo conto che di ciò che mi racconta su Luciano mi importa relativamente poco. Più interessante è ciò che dice di se stessa. “Avevamo due caratteri diversi,” attacca, “se non proprio opposti. All’inizio non era un problema. Ci completavamo: io gli davo stabilità, lui mi dava la carica. Mi diceva che avevo tutte le qualità che a lui mancavano e che, stando con lui, gliene passavo un po’. Si sentiva, per merito mio, più concreto, più aperto, più ottimista e anche più sicuro di sé. Pareva un sogno, e durò a lungo. Poi venne l’inferno. Quando cominciammo ad allontanarci, le mie doti divennero difetti, e io un castigo di Dio.” 317 “Come possono delle doti trasformarsi in difetti?” “Ah, semplicemente le guardava da un’altra prospettiva. La mia disponibilità, la mia apertura verso gli altri, la mia tendenza a commuovermi per le sofferenze umane, erano diventate forme di sentimentalismo deamicisiano. Quando regalavo mille lire a un lavavetri, lui s’incazzava a morte. Diceva che così non facevo del bene al prossimo, ma incoraggiavo la furfanteria. Mi spiegava che non lo facevo veramente per amore del prossimo bensì per compiacere un demone puerile che mi dominava e si burlava di me.” “Già. Lui detestava il demone della bontà.” “Io non mi facevo turbare. Erano due opposte filosofie della vita che finalmente venivano alla luce e si scontravano. Recentemente ho lavorato sui tossico-dipendenti in un quartiere di degrado sociale. I colleghi mi chiamano ‘la buona samaritana’, soprannome che peraltro non mi dispiace. Semplicemente, svolgo bene il mio mestiere e quindi lavoro di più di quanto fanno in media i miei colleghi. Io me ne frego dei colleghi e penso che riuscire a salvare un solo ragazzo dall’abbrutimento sarebbe una gratificazione sufficiente per compensare, oltre che la loro irrisione, il mio sopralavoro. Be’, sai cosa mi disse Luciano quando gli feci un discorso del genere?” “Cosa?” “Che quand’anche fossi riuscita a salvare un ragazzo dall’eroina, il mondo non sarebbe cambiato minimamente e sarebbe rimasto lo stesso sistema di sfruttamento, alienazione e oppressione che spinge i ragazzi a bruciarsi il cervello.” “E tu?” “Io credo che un mondo con un infelice in meno è meglio di un mondo con un infelice in più. Forse quello che facevo io era poco, gli dissi. Ma era senz’altro molto rispetto al niente che faceva lui.” “E lui?” “Diceva che avevo sempre avuto l’animo della dama di S. Vincenzo.” “Che stronzo!” “Lo puoi dire forte.” 318 “Che stronzo!!!” “Inoltre derideva il mio senso del dovere e il rispetto che ho per la legge, le convenzioni sociali e il galateo. Io insegnavo a mia figlia a stare a tavola, a usare correttamente coltello e forchetta, a non fare rumori con la bocca. E lui ogni tanto ci mollava dei rutti tremendi. La cosa che più m’irritava è che lo faceva con intenti educativi. Bisogna conoscere le regole – diceva – ma a volte bisogna saperle trasgredire. Quando cercavo di spiegargli che le norme rendono possibile la convivenza civile, che nessuno ama pestare le cacche di cane sul marciapiede e che chi porta il cane a cacare sul marciapiede non è un anarchico, è un cane, lui sai cosa mi rispondeva?” “Cosa?” “Che non mi sono mai liberata della mentalità piccolo borghese. Lui i cani e gli infami, i delinquenti e gli schizzati li aveva eletti a proprio ideale. Li definiva ribelli senza fedi e li collocava un gradino più in alto dei comunisti e degli anarchici. Io non capivo bene se scherzava o faceva sul serio.” “Secondo me non faceva mai sul serio.” “Una volta”, riprende, “ci scontrammo duramente in una discussione sul senso della vita.” “Addirittura!” “Sì, sul senso della vita. Secondo me è la ricerca della felicità che dà valore a una vita. Ognuno ha una sua idea personale della felicità; ma tutti la perseguono, consapevoli o no. Secondo lui questa era una cacata ideologica. Roba da Secolo dei Lumi. Oggi non ci crederebbero più neanche gli americani.” “Li odiava tanto gli americani!” “No, al contrario. Li ammirava. – Hanno dato al mondo tre cose importanti – diceva – il pragmatismo, Marilyn Monroe e l’Harley Davidson.” “Torniamo alla felicità.” “Lui sosteneva che una vita mossa dalla ricerca della felicità non sarebbe degna di essere vissuta, e poi che le cose in realtà non andrebbero in questo modo. Sarebbero ben altre le forze che tengono in vita gli uomini, secondo lui.” “Quali?” 319 “La fede, l’orgoglio, l’amore, l’odio, il senso del dovere o di un destino da compiere. Insomma: le passioni. Non solo è così, insisteva, ma è bene che lo sia.” “Perché?” “Questo non me l’ha spiegato. Il fatto è che così piaceva a lui. Continuava a tacciare le mie idee di perbenismo piccolo borghese. Che è la massima offesa, detta da lui. A volte era veramente offensivo. Anzi, credo che spesso cercava le discussioni elevate proprio per cogliere l’occasione di offendermi. Ci metteva una particolare cattiveria nello sparare i suoi giudizi perentori e le sue stronzate filosofiche.” “E tu come reagivi? Ti lasciavi insultare?” “Io non me la prendevo...” “Male!” “Sapevo che il problema era suo. Cercavo per quanto possibile di non scendere al suo livello e spesso rispondevo con la comprensione. Il che naturalmente lo mandava in bestia. Sai cosa mi disse una volta?” “Cosa?” “Che il mio più potente meccanismo di difesa era la dabbenaggine.” “Che stronzo!” “Lo puoi dire forte.” E insieme: “Che stronzo!!” Scoppiamo a ridere e ci abbracciamo, e nell’abbraccio i nostri visi si toccano. Indugio qualche istante nel caldo contatto, inspirando il profumo della sua pelle. Lei non si tira subito indietro e quei pochi istanti sono più deliziosi di una promessa. Si è creato il clima giusto. Lucrezia, forse imbarazzata da quel fugace contatto fisico, si alza dal divano e va al rack per cambiare musica. Le dico che John Lennon mi piace e le chiedo di lasciarlo. Mentre lui ricomincia a cantare Immagine, lei torna a sedere accanto a me. “Ti piace questa canzone?” Mi fa. “Sì, anche se non è roba della mia generazione.” 320 “A me piace da morire, per le parole e per la musica. Conosci le parole?” “Vagamente.” “Parla di un mondo senza paradiso e senza inferno, dove la gente vive alla giornata.” Traduce in prosa man mano che il poeta canta. “Non ci sono né patrie né religioni. Né nemici da uccidere né fedi per cui morire. Non esiste proprietà e quindi niente avidità e niente miseria. Tutti gli uomini sono fratelli e posseggono il mondo in comune. Dirai che sono una sognatrice, ma non sono la sola, e se tu ti unisci a noi allora il mondo...” Che tenerezza. Deve aver superato la quarantina questa donna, e ha ancora l’animo di una sovversiva. Mi viene da piangere per la commozione. Lei se ne accorge e capisce fischi per fiaschi. S’interrompe e mi guarda negli occhi con uno sguardo interrogativo tra l’ingenuo e il perplesso, uno sguardo limpido, dal profondo dei suoi occhi neri. Metto la mia mano destra sulla sua sinistra, che tiene appoggiata su un ginocchio. Lei gira la mano e mi porge il palmo. Ci stringiamo le mani che sembriamo due tredicenni. Stiamo così per un po’, mano nella mano, occhi negli occhi, mentre John Lennon, galeotto, ci canta la sua poesia smielata. Ora dice: Love is touch Touch is love Love is reaching Reaching love Love is asking To be loved. Chiedo: “Vuoi ballare?” Lei abbassa lo sguardo e arrossisce come una smorfiosetta. Non mi risponde. Allora le stringo più forte la mano, che ho ben salda nella mia, e la tiro su. Lei si lascia trascinare. Non le faccio fare neanche un passo, per paura che si rompa l’incantesimo. Proprio lì, tra il divano e il tavolinetto, le metto un braccio alla vita e la stringo a me. Lei mi lascia fare. È in uno stato di completa passività, una mano abbandonata nella mia e l’altra lungo i 321 fianchi. Accenno a un lieve passo di slow, appena un cenno. Lei mi segue. Ora non ci guardiamo più negli occhi. Sento il calore del suo alito sul mio collo. Il suo corpo aderisce al mio. È morbido e cedevole. I seni, piccoli eppure incredibilmente sodi per la sua età, si schiacciano sui miei come labbra sulle labbra. Siamo entrambe senza reggiseno, entrambe con due camicette di seta. Sento sul ventre e sulle cosce la pressione del suo ventre e delle sue cosce. Accosto il mio viso al suo. Lei mi lascia fare. Lentamente, ma lentamente, faccio scivolare la mia guancia sulla sua con una leggera rotazione del viso. Le faccio sentire il tremore delle mie labbra. Lei mi lascia fare. Le do dei bacetti sulla guancia. Lei mi lascia fare. Mi avvicino alla sua bocca. E lei... L’ultimo passo lo fa lei. Appena l’angolo delle mie labbra sta per sfiorare quello delle sue, lei gira il viso decisa e schiaccia la sua bocca sulla mia, mentre il suo braccio morto si risveglia e mi si avvinghia al collo. Il resto non voglio scriverlo. Ho paura di rovinarlo. Dirò solo che è stata una notte meravigliosa, come non ne ricordavo più dai tempi della mia vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi miei ridenti e fuggitivi e risalivo lieta e pensosa il limitare della gioventù. Mi ero quasi dimenticata di quant’è bello fare l’amore quando c’è la tenerezza. Ai primi di maggio ci fu il mio esame di laurea. Fu un esame memorabile. Luciano era il relatore della tesi e si supponeva che avrebbe dovuto aiutarmi a difenderla. Per fortuna non lo fece. Mi presentai con un look sobriamente provocante. Indossavo un abito di seta indiana, di un colore rosa che sfumava al cremisi, vagamente trasparente, lungo fino alle caviglie, con uno spacco laterale a mezza coscia. Non era aderente, ma il movimento della stoffa morbida sul mio corpo era tutto un gioco di controllata sensualità. Rimmel e kajal agli occhi e un rossetto dello stesso colore dell’abito completavano l’armamentario che avevo predisposto per quel tentativo di circonvenzione d’incapaci. Tali infatti si dimostrarono i membri della commissione di laurea. Caddero immediatamente nel vischio; tutti meno la professoressa Toselli, vecchia ultrà femminista lesbica ancora rab- 322 biosa. Si fecero ammaliare, i baroni, e con la scusa di farmi domande dotte e astute mi tennero sotto torchio per un’ora intera. Solo questo fatto sarebbe già un chiaro segno della perdita di senso della realtà a cui avevo trascinato la commissione. C’era come un’atmosfera d’incantesimo nella sala. Il pubblico assisteva devotamente a quella specie di cerimonia vudu. Il silenzio era totale, a parte la mia calda voce che modulava teorie e confutazioni. I commissari ascoltavano ipnotizzati, gli occhi sbarrati e le bocche aperte. La Toselli dava l’impressione di fare degli enormi sforzi di volontà per resistere alla bufera di malie che le scagliavo addosso. Luciano fu l’unico a tenersene fuori. Non fece neanche una domanda e restò tenebroso per l’intera seduta. Sicuramente non era questa la provocazione che si era aspettato da me. Assisteva alla scena con uno sguardo che rivelava irritazione, godendosi però il supplizio che trapelava dagli occhi dei colleghi. La discussione sul voto fu lunga. Me l’ha riferita Luciano stesso, quasi parola per parola. Quando io e tutto il pubblico fummo usciti dall’aula, lui propose subito la lode e i due correlatori l’accettarono. Senonché la Toselli si impuntò e costrinse la commissione a una defatigante diatriba. Il suo potere era enorme, giacché per attribuire la lode è necessaria l’unanimità. Luciano se ne stette in disparte pure in questa fase. Il che contribuì a fargli assumere un’insolita posizione di distaccata neutralità. Alla fine il presidente della commissione si rivolse a lui, sperando che riuscisse a trovare la via d’uscita del vicolo cieco in cui li aveva cacciati la Toselli. Lui riconobbe che le critiche della collega al comportamento provocatorio e provocante della candidata erano giustificate. Poi si rivolse a lei: “Ma il punto è: l’hai letta la tesi?” Lo domandò anche agli altri professori. Così si scoprì che oltre al relatore e ai due correlatori non l’aveva letta nessun altro. Quando sentenziò che la lode era meritata, i correlatori ribadirono il loro assenso e nessuno osò contraddirlo. La Toselli dovette ingoiarsi tutto il veleno che le ghiandole salivali le avevano prodotto nelle ultime due ore. 323 In serata andammo a festeggiare in un ristorantino nel Chianti, io e lui soli soli. Era piuttosto teso e, dopo aver terminato il resoconto della discussione sul voto, me ne disse di tutti i colori. Tanto per cominciare, mise in chiaro che la lode non l’avrei presa se non fosse stato per il suo intervento decisivo. Poi disse di non essere sicuro che il suo giudizio era stato determinato dal valore della tesi e non piuttosto dal ricordo dei servizi della mia magica bocca. Io l’ascoltavo impassibile. Allora passò a una paternale, cercando di farmi capire che in certe occasioni l’atteggiamento verso gli altri deve essere consono ai ruoli sociali e che, se ci sono momenti in cui può essere bello civettare con i gonzi, ce ne sono altri in cui bisogna mantenere la dignità. “A me non me ne frega niente dei ruoli sociali.” Lo interruppi nel mezzo della paternale. “Io sono come sono, integralmente me stessa, mi mostro per quello che sono, e tanto peggio per chi non mi capisce.” “Anche una puttana si mostra per quello che è, e di solito lo fa in ogni situazione, senza preoccuparsi dei ruoli. Tanto è vero che le puttane sono sempre facilmente riconoscibili.” Non feci una piega. Lui riprese le sue critiche e disse che non c’era stato uno solo degli altri commissari maschi che durante la discussione fosse riuscito a cogliere gli apporti innovativi della tesi, e ciononostante erano tutti favorevoli alla lode. Erano rimasti inebetiti per il sortilegio dei miei occhi e delle mie labbra. “Mi sa che sei geloso fino al midollo.” L’interruppi di nuovo. “Ti dà fastidio che mi guardino gli altri uomini.” “Al contrario, gli sguardi degli uomini che ti sbavano dietro mi danno un’emozione di orgoglio e di potenza. – Fatevi le seghe, cazzoni! Questa è la mia donna – mi verrebbe voglia di gridare a tutti.” “Eh sì, sei proprio geloso. Ma sei sicuro che sono la tua donna?” Ebbe un lampo di sgomento negli occhi. Precisai: “Io non sono di nessuno. Sono mia.” 324 “Bambina cara, sei rimasta un po’ indietro con gli slogan. Questo era di moda negli anni ’70.” Insomma l’intera serata andò avanti così, in un battibecco insensato e inconcludente, con lui che cercava di farmi capire e io che cercavo di farlo arrabbiare. Ebbe meno successo lui. Fece un brindisi per chiudere la serata e bevve la sua coppa di spumante tutta d’un fiato, quasi con stizza. Alla fine però, quando stavamo per andarcene, riuscì a far breccia nella mia corazza di spavalderia. Disse: “Sei veramente sicura che quella lode l’hai presa perché la meritavi?” Lo guardai fisso senza dire niente e per un momento sentii di star per cedere al panico. Lui insistette: “Eppure sei una donna intelligente.” “Eppure!?” “Già. Secondo me tu sei dominata da un profondo senso d’insicurezza proprio riguardo alla tua dote migliore.” “Che sarebbe?” “L’intelligenza, appunto. Io credo che sia questa insicurezza che t’induce a sfoderare tutto il tuo potere seduttivo con gli uomini di cui temi il giudizio intellettuale.” Lo guardai negli occhi con cattiveria. Volevo fulminarlo, dirgli un improperio feroce. Ma sentii che la voce mi avrebbe tremato. Distolsi lo sguardo e mi nascosi dietro la coppa di spumante, che mi scolai senza fretta. “Credi veramente che non l’ho meritata la lode?” Domandai poi con un filo di voce. Lui allungò una mano e mi fece una carezza. “No amore, non lo credo.” Disse. “È stata una delle mie tante cattiverie. Mi dispiace. Ti chiedo perdono. La verità è, l’ho scoperto solo oggi, la verità è che sono spudoratamente geloso.” Accettai l’invito a passare la notte con lui. E fu una notte fantastica. Sarebbe stato un nuovo inizio? Forse sì, se di lì a tre giorni Luciano non fosse uscito di scena nella fatidica orgia. 325 Mercoledì, 3 luglio Dopo la notte passata con Lucrezia, torno a casa alle sei di mattina. Lo specchio delle mie brame mi rimanda l’immagine di un viso sfatto dalla stanchezza e gli stravizi. Dalle persiane chiuse filtra la luce di un’alba matura. Gli occhi mi si chiudono dal sonno. Mi butto a letto dimenticandomi di prendere le mie due pillole di Lendormin. Incredibile! Dormo tredici ore e mi risveglio alle sette di sera! Da epoche immemorabili non riuscivo a farmi un sonno continuo più lungo di sei ore. Merito della dolcezza della notte passata con Lucrezia? Forse il profumo lasciato dal suo corpo sul mio ha avuto un effetto rasserenante. Ancora lo sento, come un’aura creata dalle sue carezze. Mi crogiolo nel letto per un’ora ascoltando un disco di John Lennon. Dopo di che mi alzo allegra e pimpante. Faccio una doccia fredda con sapone di lavanda; una rapida cena di biscotti integrali, cioccolato di carruba e aranciata; una toletta anche più rapida; ed eccomi pronta per l’appuntamento con le vergini folli. Arrivo a casa loro poco dopo le nove. Trovo il cancello socchiuso. Entro senza suonare il campanello e attraverso il giardino nel buio, costeggiando i muri della casa. Le due donne stanno nella veranda. Sedute nell’oscurità, mi aspettano godendosi il fresco che solo a quest’ora comincia a levarsi dai giardini circostanti. M’invitano a sedermi e a bere caffè. Bisogna aspettare un po’, dicono, tempo che faccia buio completo e che il guardiano dello Stibbert si addormenti davanti alla televisione. “Perché?” Domando. “Perché dobbiamo introdurci nella villa di soppiatto.” Risponde Elvira. “Per quale motivo?” “È l’unico modo per arrivare all’inferno della biblioteca di notte. La quartina che t’interessa si trova in un libro antico. E da qualche tempo ci è proibito accedere alle stanze riservate della biblioteca. Il permesso speciale che ci era stato rilasciato per intercessione di Luciano ci è stato revocato.” “Da chi?” 326 “Dal direttore amministrativo. Però noi conosciamo un passaggio segreto.” È sempre Elvira che parla. “Così tutte le notti andiamo in biblioteca a lavorare. È bello di notte. C’è una solitudine perfetta, un silenzio assoluto. E le nostre menti sono al massimo di rendimento dalle undici alle tre. La nostra ricerca è andata avanti e anzi non è andata mai così bene come da quando ci è stato revocato quel permesso.” “Stasera andate lì per lavorare?” “No, per mostrarti la quartina.” “Perché ci tenete tanto a farmi vedere quella poesia?” “Perché potresti aiutarci a capire cosa significa e a confermare una nostra ipotesi. Ora rilassati e finisci il caffè. Aspettiamo ancora mezz’ora, poi andiamo.” Conclude, guardando l’orologio da polso. Mi rilasso, o almeno cerco. Distendo la schiena sulla sdraia e guardo il cielo. È di un blu scuro, picchiettato di stelle che sembrano strass su un abito da sera. L’aria è piena del canto dei grilli. Dal fondo della valletta che collega il giardino Stibbert con Villa Fabbricotti sale un venticello fragrante di fiori. Gina mi versa una seconda tazza di caffè caldo. È un caffè americano, lungo, zuccherato appena. Va giù liscio come una bibita e mi scalda lo stomaco rinfrescandomi la mente. Per un po’ ce ne stiamo tutt’e tre lì, senza parlare, sdraiate a contemplare il cielo. Sono io che rompo quella pace: “Ci sono molti punti oscuri nelle storie che mi avete raccontato l’altro ieri. Vi dispiace se vi faccio qualche domanda per chiarirmi le idee?” “No, dato che dobbiamo aspettare senza fare niente.” Risponde Elvira. L’altra continua a meditare sul cielo stellato. “Intanto mi piacerebbe approfondire la faccenda della Genesi e del paradiso terrestre. Mi avete dato la vostra interpretazione, non quella di Luciano, che avete detto è diversa.” “Sì, diversa. Forse opposta, forse complementare. Noi tendevamo a una visione di tipo sociale. Lui privilegiava la fisiologia.” “Sentiamo.” “Lo stato di promiscuità originario, secondo lui, sarebbe fondato sull’ermafroditismo. La Bibbia andrebbe presa quasi alla 327 lettera: Dio avrebbe fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza e cioè maschio e femmina, un individuo dotato dei caratteri sessuali maschili e femminili. Sarebbe stata la cultura a determinare la diversificazione dei sessi.” “No, non ci credo.” “A cosa?” “A che Luciano potesse pensare una tale idiozia.” “Fammi finire. Lo stato originario non va inteso in senso storico. È uno stato di natura ipotetico, sebbene presente nella storia come possibilità oggettiva. Luciano aveva abbracciato una teoria sessuale elaborata recentemente da alcuni sessuologi americani.” “Questo m’interessa.” “In natura non esisterebbero due forme di sessualità alternative, quella maschile e quella femminile, bensì due polarità sessuali presenti entrambe in ogni individuo in una vasta gamma di gradazioni e di combinazioni. Ci sarebbe un polo di sessualità attivo, che nel maschio si esprime nell’orgasmo uretrale e nella femmina in quello clitorideo; e uno passivo, che nel maschio produce l’orgasmo prostatico e nella femmina...” “Quello vaginale.” “No, quello grafenberghiano.” “What?” “Procediamo con ordine. L’orgasmo prostatico è quello di cui godono gli omosessuali maschi passivi. La penetrazione anale porterebbe il pene a esercitare una pressione interna sulla prostata. Il che provocherebbe nel soggetto passivo una lenta eiaculazione, non tanto forte da stimolare l’uretra, ma abbastanza da generare una scarica di languore. Secondo questa teoria il maschio sessualmente completo dovrebbe essere bisessuale, attivo e passivo, e ovviamente libero da ogni condizionamento culturale.” “E la donna?” “Per la donna le cose non sarebbero sostanzialmente diverse. La clitoride, anzi, il clitoride, secondo la teoria, è omologo al pene, e l’orgasmo clitorideo...” “Va bene, questo lo so. M’interessa l’altro.” 328 “Quello grafenberghiano sarebbe simile all’orgasmo prostatico maschile. Grafenberg era un medico tedesco che aveva scoperto l’esistenza di una protuberanza all’interno della vagina, una specie di bernoccolo grande quanto un fagiolo. Dal nome del suo scopritore è stato chiamato ‘punto G’. Sarebbe l’omologo della prostata. Esercitando una forte e ripetuta pressione su di esso si otterrebbe un orgasmo lungo, languido e struggente. È quello che una volta si chiamava ‘orgasmo vaginale’, ma erroneamente, perché non è la penetrazione della vagina che lo scatena, bensì la pressione sul punto G. Il modo migliore per esercitare questa pressione, per esercitarla efficacemente, si avrebbe con la penetrazione venus aversa.” “Che?” “More ferarum. Coitus a tergo.” “Insomma a pecoroni.” “Per dirlo in termini scientifici. La civiltà, imponendo la posizione del missionario, venus obversa, avrebbe fatto dimenticare l’arte di tale tipo di sessualità.” “Interessante.” Dico. “Luciano non mi aveva mai accennato a questa teoria.” “Ce ne saranno ben altre di cose che ti ha fatto fare senza spiegartele.” “Come lo sai?” “Lui non faceva mai nulla che prima non avesse elaborato teoricamente, anche se spesso si teneva le teorie per sé.” “Si vede che non ci credeva molto.” “O non credeva negli altri.” “La faccenda della puttana santa rientrerebbe in queste cose?” “Dalla tua ignoranza al riguardo sembrerebbe di sì.” “Mah?! Comunque sia, finite con la faccenda della Genesi.” “Il paradiso terrestre sarebbe una condizione umana, una condizione solo allegoricamente collocata alle origini della storia. In realtà è una condizione sempre accessibile a ogni individuo capace di liberarsi dalle limitazioni culturali e di espandere la propria sessualità ermafrodita. La divisione funzionale dei sessi, e la connessa identificazione di ruolo con cui gli individui vengono costretti a definire la propria appartenenza di genere, non avrebbe 329 nulla a che fare con alcuna differenza naturale nella capacità di godimento sessuale. Sarebbe nient’altro che il prodotto della necessità della riproduzione entro rapporti politici conflittuali.” “Sì, ma c’è una bella differenza tra pene e clitoride.” “Una differenza connessa alla funzione riproduttiva, non alla capacità di godimento. Come che sia, l’evoluzione della specie lavorerebbe alla graduale eliminazione delle differenziazioni funzionali dei sessi.” “Com’è possibile?” “Questa è la parte più audace della teoria di Luciano. Secondo lui nascono continuamente degli individui ermafroditi, dei veri ermafroditi. Nella stragrande maggioranza sono sterili, eppure si verificano casi di fecondità. Gli ermafroditi perfetti sarebbero individui privilegiati, dotati di pene, testicoli, prostata, ovaie, vagina e utero e tutto perfettamente funzionante. La società finora li ha considerati dei mostri, perciò ha sempre cercato di annientarli. Gli spartani li gettavano giù da una rupe. Oggi li si normalizza con operazioni chirurgiche in età neonatale. Ad ogni modo non gli si dà la possibilità di accoppiarsi e riprodursi. Senonché i costumi culturali si evolvono verso l’ermafroditismo. Nei paesi civili sono già consentiti matrimoni tra omosessuali. In un futuro non lontano gli ermafroditi avrebbero la possibilità di unirsi legalmente e proliferare. Ecco com’è che il paradiso terrestre solo allegoricamente appartiene ai primordi dell’umanità. In realtà sarebbe un progetto da realizzarsi nei tempi dell’Apocalisse.” “Tutto ciò è molto bello...” Commento, senza nascondere il mio scetticismo. “Luciano era fatto così. Per lui nessun sogno, nessuna utopia sarebbe irrealizzabile.” “Sono le undici, è ora di andare.” C’interrompe Gina. Come svegliandosi da uno stato di trance, si alza neghittosa, beve un ultimo sorso di caffè e, afferrato il solito zainetto, si avvia spedita lungo il sentiero invaso dalle erbacce, facendosi luce con una torcia elettrica. Noialtre ci alziamo e la seguiamo silenziose. Nel mare di fiori e di erba c’è tutto un viavai di gatti. Attraverso il buio se ne scorgono qua e là gli occhi stregati pieni di luce. 330 Il sentiero scende verso il fondo della valletta, ma non lo seguiamo fino al termine. Ad un tratto Gina vira a destra e si inoltra tra gli alberi. Camminiamo fuori sentiero per pochi minuti, finché non ci troviamo di fronte a una rete di recinzione. Gina apre lo zainetto e ne tira fuori una pinza, con cui si mette a snodare dei cappi di fil di ferro che tengono uniti due bordi di rete. In pochi secondi apre un varco, nel quale ci insinuiamo cautamente. Ed eccoci all’interno di Villa Stibbert, di notte, alla luce di una torcia elettrica. Il punto dove ci troviamo non dista molto dal laghetto e dal tempio egizio. Il gracidare delle rane ora prevale sul canto dei grilli. Ci addentriamo nel giardino. Gli alberi si fanno più fitti e con le loro masse nere nascondono le stelle. L’atmosfera è tetra. Avanziamo in un viale di ghiaia. Superiamo il tempio e in pochi passi ci troviamo davanti al grottino degli spiriti, quello in cui è stato trovato il cadavere di Gianrico. È chiuso da un cancello di legno tenuto serrato da un grosso lucchetto. Elvira tira fuori di tasca una chiave e apre il lucchetto. La grotta è piccola e la torcia elettrica la illumina tutta. Al centro c’è un tavolino di marmo a tre piedi e intorno ad esso cinque piccoli sedili rotondi, sempre di marmo. È una grotta artificiale. La volta e le pareti sono ricoperte di finte escrescenze rocciose di malta. Giriamo intorno al tavolino e ci fermiamo di fronte alla parete opposta all’entrata. Elvira dirige il fascio di luce su una scritta che campeggia sulla finta roccia. È incisa rozzamente, ma con la pretesa di un font lapidario, e recita: Jehoshua-Lanceolatus. “Che vuol dire?” Domando. “Sono due nomi di persona.” Risponde Elvira. Intanto la taciturna afferra la roccia con la scritta e la spinge con forza dentro il muro. Un passaggio segreto è il meno che ci si poteva aspettare. “Nomi di chi?” Insisto. Alla pressione sulla roccia segue uno scatto metallico, e un’altra roccia, più bassa e più grossa della prima, si muove di qualche centimetro. Le due donne introducono le dita nella fessura apertasi nella parete e tirano a sé quello che ora appare essere un portello. Si apre un pertugio dai contorni irregolari largo circa un metro. 331 “Sono i nomi di due eroi.” Capisco che ora dovremmo introdurci in quel buco. Le due matte sembrano esitare. Le comprendo. Dal pertugio esce un’aria puzzolente di muffa e di cimitero. La conversazione ci permette di tergiversare un po’. “Il paradiso ha sette porte, guardate da sette patriarchi,” prosegue Elvira, “sette porte ufficiali, diciamo così.” Intanto Gina cerca di incastrare due sassi sotto il portello per bloccarlo in modo da impedirne la chiusura. “Ma esiste un ottavo accesso, una via proibita, per la quale, l’unica, si può entrare da vivi. Secondo l’Antico Testamento, il solo uomo che sia riuscito nell’impresa è Jehoshua, un asceta che ha potuto sconfiggere l’angelo della morte facendo ricorso all’inganno. Gli ha rubato la spada di fiamma e ha dato l’assalto al cielo. A Dio stesso ha imposto il fatto compiuto. È riferendosi a lui, forse, che Cristo ha potuto dire che il regno dei cieli si conquista con la violenza. In epoca cristiana lo stesso tentativo è riuscito a Lanceolatus, un cavaliere romano, personaggio mitico del quinto secolo, delle cui gesta il ciclo del Graal rappresenta una tarda rielaborazione letteraria. Il suo nome volgare è Lancillotto.” “Possiamo andare.” Interrompe Gina, che ha terminato l’operazione di bloccaggio del portello. Ci pieghiamo sulle ginocchia e ci introduciamo nella stretta apertura, prima Elvira, poi io, infine Gina. Ci ritroviamo in un corridoio stretto, alto quanto basta per starci in piedi. La torcia elettrica non riesce a mostrarne la fine. Le pareti sono scavate nella roccia. Sotto la guida di Elvira ci avviamo lungo il corridoio, per sboccare su una scalinata dai gradini scavati anch’essi nella roccia. La scalinata conduce a un altro corridoio, che è più ampio del precedente. La volta è a tutto sesto e come il pavimento e le pareti è rivestita di mattoni murati a taglio alla maniera romana. Avanziamo seguendo la luce della torcia sul pavimento. Le pareti sono in ombra. Guardando con attenzione, mi accorgo che non sono disadorne. A un metro e mezzo d’altezza dal pavimento e a una distanza regolare di circa due metri l’uno dall’altro, ci sono, infissi nella parete, degli stemmi di pietra serena. Hanno le 332 fogge più strane. Molti hanno la forma di scudi, scudi romani, normanni, inglesi. Altri di losanghe, altri ancora di cerchi, libri aperti, papiri srotolati, insomma una gran varietà di figure, tutte piuttosto belle. Per non parlare dei simboli araldici che vi sono incisi sopra. Ce n’è una quantità, a destra e a sinistra, e il corridoio non finisce mai. Stranamente gli stemmi mi suscitano un’impressione di familiarità. Elvira anticipa la mia domanda: “Non ti sembra di averli già visti?” “Infatti. Dove?” “Pensaci bene. Dove puoi averli visti?” Ci penso bene ma non mi viene in mente niente. “Prova a visualizzare palazzo Stibbert, il muro che dà sul giardino verso il cancello Sud,” insiste lei, “quel muro nascosto dalla grande camelia.” Ora è come se ce l’avessi davanti agli occhi. È un muro interamente ricoperto di stemmi nobiliari, una delle bizzarre collezioni degli Stibbert. “C’è una qualche corrispondenza tra quegli stemmi e questi?” Domando. “Una perfetta corrispondenza. Per ognuno di quelli lassù ce n’è uno identico quaggiù. Li abbiamo verificati uno a uno.” “Che significa?” “Si tratta delle armi dei gran maestri dell’Ordine. Qua sotto potrebbero esserci le urne cinerarie, murate dietro agli stemmi. Ma non l’abbiamo verificato. Quelli infissi sulla facciata del palazzo sono disposti in apparente disordine. Questi qui invece sono in ordine cronologico, i più antichi più all’interno.” “Quindi si può sapere chi è l’ultimo gran maestro morto.” “Sì.” “E chi è?” “Un illustre sconosciuto. È morto nel 1977.” “E sapete chi è quello vivente, ammesso che ce ne sia uno? “Abbiamo una teoria.” “Non ne avrei dubitato. Non ve l’ha per caso suggerita il relatore della vostra tesi?” “Luciano ne rideva. Diceva che tutta la storia dell’Ordine fondato da Cesare non sarebbe che una fandonia inventata in 333 epoca recente, magari dagli Stibbert stessi, sotto l’influsso del clima occultistico che ha infestato la cultura romantica dell’Ottocento. Ma non ci ha mai convinte su questo punto.” “Che punto?” “La faccenda dell’inesistenza dell’Ordine. Abbiamo sempre avuto l’impressione che la sapesse più lunga di quanto desse a intendere. Tra le carte Stibbert c’erano dei trattati di alchimia e magia sessuale risalenti al Cinquecento, e Luciano vi era molto interessato.” “Quale sarebbe la vostra teoria?” “Lascia stare!” “No,” interviene Gina, da dietro le mie spalle, “è bene che sia informata. Altrimenti come potrà esserci d’aiuto?” “Avete bisogno del mio aiuto?” “Non proprio.” Risponde Elvira, secca, quasi a voler chiudere la conversazione. Ormai ho capito la divisione dei ruoli tra le due donne. Una parla, l’altra agisce. M’interrogo sui motivi che le fanno interessare a me. Perché mi hanno trascinato in questa ridicola prospezione tellurica? Cosa vogliono? Ora intuisco, inoltre, che c’è una certa divergenza tra le due matte, una divergenza che riguarda appunto me. È un bel pezzo che camminiamo in quella specie di catacomba, quando finalmente il budello si restringe. Si rimpicciolisce gradualmente fino a ridursi a un meato piccolo e nero che da lontano sembra un buco di culo. In pochi passi giungiamo all’orifizio. Non è più alto di un metro e mezzo. Ci chiniamo e lo oltrepassiamo, per ritrovarci in un altro corridoio con una nuova scalinata. Comincio a stancarmi. Saliamo in silenzio le scale, e alla fine arriviamo a una porta di ferro arrugginito con un pomello anch’esso di ferro. Elvira lo agguanta e lo gira con calma. La porta si apre e la torcia illumina degli scaffali di biblioteca che chiudono il passaggio come delle enormi sbarre. I libri sono vecchi e logori e, visti dal davanti invece che dalla costola, suscitano un sentimento di straniazione. “Stiamo dietro gli scaffali della sala riservata della biblioteca.” Dice Elvira. 334 Gina intanto toglie i libri da uno dei ripiani. Apre così un passaggio nel quale ci insinuiamo a fatica, sempre nell’ordine: Elvira, io, Gina. Ci ritroviamo in un bugigattolo non più grande di un salotto, tutto tappezzato di libri dal pavimento al soffitto, con un tavolino al centro e tre sedie intorno. La torcia illumina la stanzetta con una luce spettrale. La taciturna apre lo zainetto, ne tira fuori cinque libri e uno a uno li ripone nei loro loculi, mentre l’altra fa scorrere lo sguardo su uno scaffale. Lo percorre anche con la mano destra, oltre che con gli occhi, sfiorando i libri con i polpastrelli, come se, per fare la ricerca, non si fidasse di un solo senso. Si ferma in fondo allo scaffale, afferra un librone con una copertina di pergamena giallastra e lo tira fuori. Si volta verso di me e me lo consegna. “Qui c’è quello che cerchi. È nell’ultima pagina.” Sono emozionata. Potrei finalmente trovare la chiave della verità, penso. Prendo il libro nelle mie mani, delicatamente. Lo accarezzo, lo osservo, lo annuso. È un in-quarto molto bello, più spesso di un mattone e più pesante. Lo apro. Il frontespizio reca una lunga serie di righe scritte in caratteri di grandezza decrescente man mano che si scende in fondo alla pagina. Il titolo è lapidario: Saint Peerlesfoy. Non c’è indicazione d’autore. “È il primo testo noto del ciclo del Graal,” dice Elvira, “traduzione provenzale di una precedente opera latina. Può essere dell’undicesimo secolo. L’originale romano, che è andato perduto, dovrebbe risalire ad almeno cinque secoli prima.” Sfoglio il codice con delicatezza. Le pagine sono gialle e rigide. Danno l’impressione di potersi spezzare al minimo tentativo di piegarle. Finalmente mi faccio coraggio e apro il libro all’ultima pagina. Contiene una poesiola scritta a matita. “È questa?” Domando. “Sì.” “Non vi sembra una profanazione avere sporcato un libro tanto fiero di anni?” “L’ha scritta Luciano.” “Capisco.” “Sbrigati a copiarla che dobbiamo andarcene.” 335 Nel frattempo Gina, finito di riporre i suoi cinque libri negli scaffali, ne ha prelevati altri sette. Li infila delicatamente nello zainetto. “Che fate?” Domando. “Non ti preoccupare, non li rubiamo.” “Come avete fatto a conoscere questa specie di passaggio segreto? No, non me lo dite. Scommetto che ve l’ha rivelato Luciano.” “Ti decidi a ricopiare la poesia?” Fa Gina. Da un po’ di tempo sta diventando loquace. Potrebbe arrivare a proferire cento parole al giorno. Glielo dico, scherzosamente. Lei fa finta di non aver capito, e prosegue: “O non t’interessa? Se è così, rimetti il libro a posto, che ce ne andiamo.” “No, no, m’interessa e come!” Lei mi passa una penna e un foglietto di carta strappato da un taccuino. Io copio. PUTTANA SANTA Al Leopardo Ti possiede chi ti paga, ma ti apri A chi cerca il Graal, purché abbia la chiave. Il tuo corpo è uno scrigno prezioso e Lo Spirito Santo risiede in te, Ginevra. “Chi è il Leopardo?” Domando, più che altro per avere una conferma. “Luciano, naturalmente.” Risponde Elvira. “È il suo nome iniziatico.” “Iniziatico?” “Il leopardo era l’animale araldico di Lancillotto, il leopardo lanceolato, un animale mitico dalla pelliccia dorata e le macchie nere di forma triangolare.” “In che senso ‘iniziatico’?” “Ora andiamo. Te lo spieghiamo a casa.” A casa siamo di ritorno a mezzanotte. Le due matte sono tutte contente, e anche Gina ha ripreso un sembiante umano. Sembra- 336 no due ladre che l’hanno fatta franca. Brindano con della grappa e io partecipo alla festa. Si crea subito un’atmosfera distesa e allegra e le due donne diventano perfino cordiali. Ne approfitto per chiedere delucidazioni. “Mi spiegate il senso di questa quartina?” “Sei tu che ce lo devi spiegare. Ti abbiamo aiutato apposta. Abbiamo motivo di credere che la poesia è stata trascritta lì proprio per te.” È Elvira che parla. “Luciano s’è imbarcato in un’impresa che lui stesso ha assimilato alla cerca del Graal.” “Non ci credo. E comunque io che c’entrerei?” “Tu sei la puttana santa, la sua Ginevra.” “Che vuol dire?” “Nella versione popolare del ciclo della tavola rotonda solo uno dei cavalieri giunge alla meta: Galaad, il figlio di Lancillotto. A un certo momento, nel corso della cerca, Galaad giunge a un bivio e deve fare una scelta. Decide per la via della mano destra, che si rivela come la scelta che lo conduce al Graal.” “Ho sentito già parlare di questa via della mano destra. Cos’è?” “È un metodo. Il metodo della tradizione e dell’ordine, della disciplina, del digiuno, della preghiera, della castità.” “Ma c’è una versione esoterica.” S’intromette Gina, come se volesse tagliare corto. “OK, vai avanti tu.” Le fa l’altra. Lei prosegue: “Nella versione esoterica, che si trova esposta nel Peerlesfoy, il Graal sarebbe stato conquistato anche da un altro cavaliere.” “Lancillotto.” Dico io. “Esatto. Il quale seguì la via della mano sinistra.” “Che è quella del disordine e della sovversione, naturalmente.” “Proprio così.” “E l’amore, il sesso, la magia rossa…” “Vedo che sei informata.” Interrompe Elvira. “Conosco alla perfezione tutta quella paccottiglia di dottrine orientali con cui Luciano cercava di rendere più interessanti certi giochetti erotici.” 337 “È una cosa meno ridicola di quanto credi.” “Che c’entra Ginevra?” “È la regina, la moglie di re Artù, la forza della regalità. Per sua virtù si ottiene il regno. La via della mano sinistra è quella della trasgressione suprema: tradire il re e impossessarsi della regalità costringendo la regina a tradirlo. Per mezzo della sovversione d’amore si conquista il paradiso. È la via della violenza e dell’anarchia interiori. Jehoshua vinse l’angelo della morte, Lanceolatus l’angelo dell’amore. La stessa via: la mano sinistra. “Capisco.” Dico, più per rispondere a un mio interrogativo che per interrompere il discorso. “Be’, noi non lo capiamo perfettamente, il collegamento di amore e morte. È qui che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Luciano ci ha parlato di un certo rito antico, ma in termini piuttosto generici, una sorta di tecnica dell’estasi che spinge l’amore fino al limite della morte.” “Non sarò certo io a spiegarvelo. Di teoria ne so meno di voi, probabilmente. Quanto alla pratica, si trattava solo di giochetti erotici, piuttosto eccitanti, a dire il vero, però niente di più.” Le due donne mi guardano dubbiose. Non sono sicura che l’abbiano bevuta. In realtà non è la cosa che gli preme sapere da me, lo capisco al volo. Le vedo titubanti. Così decido di incoraggiarle: “Dai, non è per conoscere queste fregnacce che mi avete scarrozzata per boschi e per monti, per non parlare dei passaggi segreti e le catacombe. Avanti, cosa volete sapere veramente da me?” “Va bene,” dice Elvira, “allora veniamo al dunque. Noi abbiamo motivo di credere che i recenti omicidi di villa Stibbert abbiano a che fare con L’Ordo.” “L’Ordo?” Lì per lì non capisco. Poi mi torna alla mente la fantastica storiografia stibbertiana. “Si, l’Ordo.” Risponde lei. “Te ne abbiamo già parlato. Vuol dire ‘ordine’ in latino, e anche ‘Opus Romanae Dominationis Orbis’, il centro superocculto...” “... Fondato da Cesare. Come no?” 338 “Non c’è bisogno di fare del sarcasmo. Per noi non è che un oggetto di studio, sebbene ormai...” Ha un attimo di esitazione. Io la incalzo: “Sebbene ormai...” “Ormai ne siamo state coinvolte in prima persona: gli inquirenti ci sospettano per quegli omicidi.” “Questo m’interessa. Che c’entrano gli omicidi con l’Ordo?” “Potrebbero essere il risultato di una lotta intestina. Ti ho già detto che nel 1977 muore l’ultimo gran maestro dell’ordine.” “L’ultimo?” “L’ultimo che è stato sepolto. Non sappiamo se ce n’è uno vivente e chi sia. Ma abbiamo degli indizi. Secondo una congettura di Luciano, un nuovo gran maestro non è stato ancora nominato.” “E perché una tale stranezza?” Ora risponde Gina, ignorando il mio tono ironico: “La ragione potrebbe essere che gli adepti non sono riusciti a trovarne uno che andasse bene a tutti. E l’unanimità era la regola in ogni decisione presa dal gruppo dirigente, i cavalieri della tavola rotonda.” “Chi sarebbero questi cavalieri?” “È la domanda a cui non siamo riuscite a dare una risposta. Neppure uno ne conosciamo con certezza, per quanto abbiamo dei sospetti. È qui che entri in gioco tu.” “In che modo?” “Cosa sai della setta dei cavalieri del nulla?” “Nulla. Anzi, speravo di saperne qualcosa da voi.” “Per favore. Noi siamo state gentili e sincere con te.” “Hai ragione. Scusa. Ma ne so veramente poco. Me ne ha parlato Giuliano.” “Questo vuol dire che lui ne faceva parte?” “Sì.” “Ecco una conferma. E Luciano?” “Ne faceva parte anche lui. E Fabrizio Gledo, il brigatista. Di altri non so. Però mi risulta che non era una cosa seria. Nient’altro che una goliardata. È una vecchia storia, ormai chiusa e sigillata da tempo.” 339 Le due donne sono attentissime. Gina prende perfino appunti, mentre io racconto le altre cose che so. A me continua a sembrare una faccenda insignificante, loro invece la considerano importantissima. Nel seguito della conversazione vengo a conoscenza dell’ipotesi su cui stanno lavorando: cioè che i cavalieri del nulla fossero membri del circolo della tavola rotonda, e fossero al suo interno i sostenitori di una linea nichilista, checché ciò voglia dire; che la lotta intestina durava da anni e che sarebbe giunta al redde rationem proprio ai nostri giorni; e che il criterio dell’unanimità, che viene sempre adottato nelle loro deliberazioni, sarebbe responsabile dell’uso dell’omicidio quale strumento di decisione collettiva. Punto. Non c’è bisogno di aggiungere altro. E mi domando se sono più matte loro, le vergini folli, o io che sono stata a sentirle. Torno a casa che è notte tarda. Camminando nel silenzio da thriller delle stradine deserte intorno a villa Stibbert, mi accorgo di non essere impressionata nemmanco un tantino dalla tesi delle due donne, sebbene sia colpita dalla forma di serena razionalità assunta la loro follia. È possibile che razionalità e fantasia possano intrecciarsi così strettamente da generare un tale mostro di visione romanzesca della storia? Per un attimo provo a prendere sul serio l’ipotesi da loro suggerita sulla catena di omicidi di villa Stibbert. Ma la scarto subito. Troppo bene conosco Luciano e Giuliano per crederli tanto idioti. 340 Giovedì, 4 luglio Ormai non dormo che di giorno. Di notte la mia mente è desta. Le tenebre mi eccitano i sensi e lo spirito. Sono sempre più frequenti i giorni in cui mi addormento e mi desto nel pomeriggio. Stasera sono le sei quando Giuliano mi sveglia con una telefonata. Mi ricorda il nostro appuntamento delle nove e mi domanda se ho letto i giornali. No, non li ho letti. Lui non ci crede. Chi se ne frega. Glielo dico. Mi ordina di andare subito a comprarne uno. Ci troverò una notizia tragica che mi riguarda. Ribadisce l’ora del nostro appuntamento e in tono minaccioso mi consiglia di non mancare. Scendo all’edicola. Compro La Nazione e La Repubblica, il più moderato e il più sinistro dei giornali italiani. La notizia che mi riguarda la trovo in prima pagina. Lucrezia è stata assassinata. In casa sua. La stessa arma usata negli altri tre delitti. La stessa messinscena da rito satanico. La morte è avvenuta tra le cinque e le sei di ieri mattina. Cristo! L’ora in cui ci siamo lasciate! Mi prende un tremore per tutto il corpo. Le gambe mi si fanno molli. Faccio appena in tempo ad afferrarmi a una sedia e cadere seduta davanti a un tavolino del bar Università. Viene subito il cameriere a chiedere l’ordinazione. Mi devo controllare. Devo resistere all’impeto di piangere e urlare. Ordino un caffè corretto al mistrà. Solo dopo averlo mandato giù, tutto d’un sorso, incendiario com’è, solo allora riprendo il controllo di me. Torno a leggere gli articoli sull’omicidio. Poi piego i giornali e rifletto. Stasera potrebbe essere il mio turno. Il primo impulso è di correre a un aeroporto e partire per le Bermuda. Ma sarebbe un errore: come confessarmi omicida. Ho passato quella notte con Lucrezia e l’ho lasciata più o meno nell’ora del delitto. La sua casa sarà piena delle mie impronte. Devo mantenere il sangue freddo, e ragionare con la testa. L’accusa di omicidio non è il rischio peggiore che correrò nelle prossime ore. Alle nove ho un appuntamento con la morte, mi dico senza autoironia. Stasera sarà in gioco la mia vita. Devo giocarmela bene. Mi faccio portare un secondo caffè corretto. Lo bevo tutto di un fiato, come il primo. Mi ripasso mentalmente il 341 piano che ho preparato già da qualche giorno in vista dell’ora della verità. È infine giunto il momento di entrare in azione. Pago il conto e senza manco passare a casa torno di corsa alla valle del Terzollino. L’altro giorno vi ho scorto delle piante di stramonio e voglio farne raccolta. È praticamente diventato impossibile trovare quest’erba in Toscana da quando, un anno fa, all’ospedale di Lucca furono ricoverati dieci adolescenti inebetiti dagli effetti inebrianti dell’erba magica. Dopo che i giornali hanno diffuso la notizia per mettere in guardia i giovani, si è affermata la moda di rallegrare i party giovanili con infusi di stramonio. Bande di adolescenti hanno battuto la campagna in tutta la regione, riuscendo a fare in pochi mesi quello che la guardia forestale, ordinata di debellare il nuovo flagello sociale, non sarebbe riuscita a fare in molti anni: la pianta è diventata introvabile. Evidentemente l’isolamento della valle del Terzollino ne ha salvata un po’. Ne raccolgo un bel mazzetto e scappo subito via. Torno in città che sono le otto. Prima di salire a casa, passo in farmacia e compro una siringa e un flacone di salicitato di eserino, l’antidoto dello stramonio. Preparo un infuso dell’erba e lo faccio micidiale, di foglie e semi. Quindi m’inietto una pera di salicitato e mi rilasso un attimo. Preparo una cenetta sbrigativa ma speciale. Quando lui arriva, ho appena finito di cuocere il riso e il pesce. Li dispongo in due piccoli vassoi di terracotta. In un altro vassoietto metto dei pezzi di carne cruda. In un bricco di porcellana mescolo lo stramonio con un bicchiere di sakè. Lascio che il campanello della porta suoni a lungo. Vado ad aprire e lo trovo spazientito. Cerco di rabbonirlo col più troiesco dei sorrisi: “Oggi ti riserverò un trattamento eccezionale,” gli dico, facendolo entrare, “da cliente molto speciale.” “Non sono nello spirito giusto.” Fa lui bruscamente. Entra, va diritto al salotto verde e si accomoda su una poltrona. Ma ‘accomoda’ non è la parola giusta. Se ne sta lì in punta di culo, con la schiena rigida e le mani aggranfiate ai braccioli. Mi siedo anch’io. Lui mi guarda negli occhi e dice: “Veniamo al sodo.” 342 Dunque veniamo al sodo. Non voglio contraddirlo. Lui quasi non apre bocca. Se ne sta sempre lì, rigido come un palo. Mi guarda fisso, arcigno, e sembra un professore davanti a una studentessa impreparata. Io però sono tutt’altro che impreparata. Gli confesso subito che la mia rivelazione riguardo al nome nascosto nel quinto capitolo del Nuovo corso era una bugia: che non avevo ancora capito una cosa elementare quando gli dissi, qualche giorno fa, che il nome nascosto era il mio. “Quale sarebbe questa cosa elementare?” M’interrompe. “Che in realtà non c’era stato nessun nome nascosto in nessun capitolo.” “Come hai fatto a sgamarlo?” “Alla fine mi è venuto un dubbio. Ho riflettuto sul fatto che solo del codice che ti aveva portato a LILLI mi avevi dato spiegazione. Per gli altri nomi avevi fatto assegnamento sulla mia credulità. Così ho avuto l’ispirazione di andare a vedere se quel codice funzionava davvero. Non funzionava.” “Brava, vai avanti.” “Se prendi ventisei aforismi e prelevi una lettera da alcuni di essi partendo dal primo e saltando di cinque in cinque, ottieni sei lettere. E in LILLI ce ne sono cinque. Inoltre la quinta lettera del nome cercato, quella che si trova nel ventunesimo aforisma, non è una I, è una T. Insomma ci hai provato. Hai contato sul fatto che ti avrei creduto sulla parola, è proprio il caso di dirlo, e al più mi sarei limitata a verificare le prime due o tre lettere. Ma me non mi freghi facilmente.” “Molto brava. Adesso rivelami il messaggio nascosto nel quinto capitolo.” “Spiacente, niente messaggio. Non l’ho trovato.” “Strano. Nei primi quattro sì e nell’ultimo no?” “Può darsi che nell’ultimo non ci sia, forse perché è un capitolo incompiuto.” “O forse, essendo l’ultimo, non poteva contenere il solito Cerca Oltre.” “In tal caso conterrebbe il messaggio decisivo, quello veramente significativo. Se è così, io purtroppo non l’ho trovato. Pro- 343 vaci tu.” Prendo i fogli con gli aforismi del capitolo e glieli mostro. “Ti sfido a cercare il messaggio nascosto.” Riprendo. “Io non sono riuscita a trovare nulla di sensato. Probabilmente, se il capitolo fosse stato completato, avrei ottenuto la solita massima: Cerca oltre cerca ancora cerca. Ora non credo che la frase rinvierebbe a un sesto capitolo. Si tratterebbe piuttosto di una sorta di aforisma essa stessa, un condensato della filosofia della scienza elaborata da Luciano.” Qui m’interrompe di nuovo: “Qual è la regola per estrarre i messaggi?” “Nel primo capitolo la regola é semplice, già la conosci se hai decifrato A valentine: prendere la prima lettera del primo aforisma, la seconda del secondo e via di seguito. Uno pensa che valga la stessa regola per il secondo capitolo. Ma si sbaglia.” “Infatti ci ho provato, senza approdare a niente.” “Il punto è che, se parti dall’idea che si tratta di una cosa facile, contribuisci a renderla più difficile.” “Questa non l’ho capita.” “Ora te la spiego. Sulla base della regola applicata al primo capitolo e del fatto che non funziona col secondo, uno può pensare che in questo valga un’altra regola. Mi sono messa a cercarla, e per semplificarmi il problema l’ho scomposto in due sottoproblemi, uno riguardante la posizione della lettera cercata nel primo aforisma di ciascun capitolo, l’altro la posizione delle lettere cercate negli aforismi successivi al primo. Per il secondo sotto-problema credetti che la soluzione fosse semplicemente la stessa che funzionò per la poesia intitolata ‘La chiave della verità. A valentine’ e cioè: in ogni strofa o aforisma si prende la lettera corrispondente alla posizione di quella scelta nel primo aforisma più un numero corrispondente all’ordine dell’aforisma meno 1. In formula: l(a)=a-1, dove l(a) è la posizione della lettera scelta nell’aforisma numero a.” Giuliano prende una matita e un foglio di carta e scrive la formula. Osserva: “Non sembra complicato.” 344 “Aspetta, ora viene il bello. C’è il primo sotto-problema: individuare la posizione della lettera scelta nel primo aforisma dei diversi capitoli. Questo, per semplificarlo, l’ho scomposto a sua volta in quattro sotto-sotto-problemi. Nel primo capitolo la formula sembrava banale: l(1,c)=1, dove l(1,c) è la posizione della lettera cercata nel primo aforisma del capitolo c. Secondo questa formula la lettera cercata sarebbe stata la prima del primo aforisma in ogni capitolo. Abbiamo visto però che il risultato è valido solo col primo capitolo. Nel secondo perciò mi sono messa alla ricerca di un’altra formula. Dopo svariati tentativi ho trovato questa: l(1,c)=c, che mi dà 1 nel primo capitolo, 2 nel secondo e via di seguito. La nuova formula è una generalizzazione della precedente, ma purtroppo funziona col primo e col secondo capitolo, non col terzo e il quarto. Così mi sono messa alla ricerca di un’altra formula ancora.” “Vabbè, taglia corto.” “Infine ho creduto di aver risolto il problema con la formula l(1,c)=2(c-1), che genera la serie 1, 2, 4, 8 e va bene per i primi quattro capitoli. Per il quinto non funziona. Ripeto: siccome questo è un capitolo incompiuto, secondo me Luciano non deve aver fatto in tempo a strutturarlo secondo una formula.” “Oppure la formula c’è e tu non sei riuscita a trovarla. Perfino tu avrai i tuoi limiti. Dunque, se ho ben capito, in ogni nuovo capitolo il lavoro di decifrazione diventa più complicato. Prima devi trovare la formula per individuare la lettera giusta nel primo aforisma, una lettera posta in una posizione diversa in ogni capitolo, poi devi usare un’altra formula per individuare la posizione della lettera negli aforismi successivi al primo.” “No. Qui sta il bello. Tutto il crescendo di complicazione, come dicevo, è derivato dai miei sforzi semplificatori. Ricorda che prima ho scomposto il problema in due sotto-problemi, poi ho ridotto uno di questi a quattro sotto-sotto-problemi.” “Invece?” “Invece, se fossi stata più ambiziosa, avrei puntato fin dall’inizio a cercare un’unica formula generale.” “E saresti riuscita a trovarla?” 345 “Be’, alla fine ci sono riuscita. Eccola.” E la scrivo sul foglio in fondo alle altre. “l(a,c)=2(c-1)+a-1, dove l(a,c) è la posizione della lettera scelta nell’aforisma numero a del capitolo numero c.” “Questa funziona con tutti i capitoli?” “Tutti meno il quinto, il quale quindi è senza dubbio incompiuto anche rispetto alla codificazione.” “Insisto: è sempre possibile che col quinto non sei riuscita...” “Se fosse così, vorrebbe dire che la mia formula generale non è ancora sufficientemente generale. In tal caso ti lascio volentieri il compito di proseguire la ricerca.” “Non credo che ne varrebbe la pena. Dopotutto pare poco più che un balocco intellettualistico. È tipico di Luciano. Ci ha fatto perdere un sacco di tempo e si è preso gioco di noi.” “Io ho piuttosto l’impressione che il giochetto nasconda una specie di morale della favola. Mi viene in mente una lezione di filosofia della scienza in cui Luciano cercò di smontare la tesi della crescita della conoscenza...” “No! Pietà! Basta con la filosofia. Io cerco un’altra cosa.” “Lo so. Tu non cerchi la chiave della verità, cerchi la verità della chiave.” “Cioè?” “Tu la chiave ce l’hai già. Dimmi se sbaglio. È la chiave di una cassetta di sicurezza, una cassetta che contiene il tesoro delle BR.” “Non sbagli,” fa lui, con uno sguardo di apprezzamento, “ci hai azzeccato in pieno. È una cassetta numerata. La banca che la custodisce non è interessata all’identità del proprietario. Per accedervi bisogna usare un numero.” “Tu conosci quel numero.” “Sì, e lo conosceva anche Luciano.” “Ciò che non conosci è la banca. Semplicemente non sai dove si trova la cassetta, banale e ridicola situazione. Hai la chiave, ma non ti serve a niente.” “Brava. Molto brava davvero. Continua.” “Fabrizio Gledo, il capo e tesoriere delle BR, vi ha rivelato il numero della cassetta. A te e a Luciano l’ha rivelato. Successiva- 346 mente è riuscito in qualche modo a farti avere la chiave. Questa l’ha data solo a te. A Luciano invece, e solo a lui, ha fatto conoscere il nome della banca. Magari voleva farvi un regalo. Tanto lui, coi suoi quattro ergastoli, non se li sarebbe mai goduti quei soldi. Magari vi ha chiesto di farne un uso particolare. Senonché...” “Senonché…” “Per costringervi a gestirli insieme, quei soldi, ha distribuito i poteri. A te la chiave della verità, pardon, della cassetta. A Luciano la verità della chiave, vale a dire il nome della banca. A entrambi il numero della cassetta. Ma...” “Ma…” “Lilli è riuscita a sapere qualcosa e ha intuito quanto stava accadendo. Forse è riuscita anche a impossessarsi di una delle due informazioni, o addirittura della chiave. Questo punto non mi è chiaro.” “Te lo chiarisco io. Lei mi controllava la posta. Cinque giorni prima di quello della morte di Luciano arrivò la lettera in cui Fabrizio mi rivelava il numero della cassetta. Lilli l’aprì.” “Ecco perché eri tanto interessato a sapere cosa lei aveva fatto nei cinque giorni che precedettero l’orgia.” “Lei ha capito quasi tutto, ed era a conoscenza del numero della cassetta. Si è resa conto del pericolo che correva per essersi impossessata dell’informazione. Così, per assicurarsi ripartendo il rischio, ha rivelato quel numero a varie persone, te compresa.” “Io non avevo capito inizialmente. Non so se ad altri disse di più. Io lì per lì non avevo capito l’importanza della rivelazione. Poi, dopo la serie di omicidi e dopo aver decifrato la poesia intitolata P3+A-8xS-8 …” “L’hai decifrata?” “Eh, eh, tu non ci sei riuscito. Quando l’hai trovata sulla cima del Kilimangiaro hai creduto che fosse nascosta lì la chiave della verità e hai cercato di decifrarla.” “Proprio così, e non ci sono riuscito. Tu invece sì? Cosa hai trovato?” “Ciò che già sai. È una poesia che deve essere decomposta per capirla. Ma non è il suo contenuto letterario che ci interessa ora. 347 Dalla poesia ho avuto conferma del fatto che Fabrizio vi aveva rivelato quel numero. Il titolo, oltre a dare la chiave per l’interpretazione letteraria della poesia, è una formula matematica. Luciano sapeva che a tutti Lilli aveva rivelato il numero della cassetta e che tutti cercavano un’altra informazione. Così, all’inizio dell’orgia ci ha comunicato la formula matematica facendoci credere che contenesse l’informazione cercata. In realtà ci dava l’informazione che già conoscevamo. La soluzione della formula è il numero che Lilli mi aveva rivelato: P3+A-8xS-8= 2919.” “Come si fa a trovare questa soluzione?” “Non te lo dico. Così ti diverti a trovarla da solo. Però ti voglio dare due indizi. La soluzione si ottiene assegnando il giusto valore alle variabili P, A e S. I due indizi sono questi: S sta per sostantivo, A per aggettivo.” “Non mi diverto con certi giochetti. E mi fido di te se dici che il numero è la soluzione. Dopo tutto, è quello giusto.” “Infatti. Fabrizio a te aveva mandato il numero, a Luciano la formula con cui poteva determinarlo. Così il Leopardo si è preso doppiamente gioco di te quando ti ha spedito sul Kilimangiaro a cercare la chiave della verità. Ti ha fatto trovare l’informazione che già avevi.” “O forse era destinata a te? Il libro sull’Africa…” “Può darsi. Ma torniamo a Lilli. Lei non si rese conto che con quella rivelazione aveva fatto il più grosso errore della sua vita.” “Giusto.” Dice lui. “Continua.” “No, continua tu.” “Con la tua versione o la mia?” “Perché? Divergono?” “Precisamente a questo punto cominciano a divergere.” “Allora dimmele entrambe.” “Va bene.” Fa, assumendo un atteggiamento pedagogico. “Cominciamo con la tua. Io non volevo spartire il malloppo con altre sei persone. Luciano aveva rivelato la formula a tutti, all’inizio dell’orgia. Non sapevo che fosse solo la formula per conoscere il numero della cassetta di sicurezza. Invece pensavo che rivelasse il nome della banca. Se Luciano avesse spiegato a qualcuno come risolvere la formula, la situazione mi sarebbe sfuggita di ma- 348 no. Dico: qualcuno dei personaggi che hanno partecipato all’orgia. Quando Luciano fu ucciso, ho pensato che quel qualcuno lo avesse ammazzato per prendersi i soldi. Io non sapevo chi era quel qualcuno.” “Così li hai ammazzati tutti.” Concludo. “Non soltanto per evitare che altri si prendessero i soldi. Volevo anche venire in possesso dell’informazione eventualmente detenuta dell’assassino di Luciano.” “Logico. Magari li avrai torturati per farli confessare.” “I famosi nomi nascosti nei capitoli del Nuovo corso non c’erano affatto in quegli aforismi. Li ho detti io a te, quei nomi, affinché tu li rivelassi agli altri del gruppo dell’orgia. Avendo reso pubblico tra gli interessati il nome della vittima designata, la colpa dell’omicidio sarebbe potuta ricadere su ognuno di essi. Si sarebbero sospettati gli uni gli altri e ciò avrebbe facilitato il mio compito.” “Con Lucrezia però non c’era bisogno della messinscena, dato che saremmo rimasti io e te.” “Tant’è vero che il nome di Lucrezia non l’ho fatto. Ma tu hai fatto il tuo.” “Feci il mio nome per distogliere la tua attenzione da lei.” “Io non avevo ancora capito tutto, mentre tu mi stavi attirando nella tua trappola.” “Questa non l’afferro.” Dico. “Sì che l’afferri, mia cara. Perché quella che ti ho appena raccontato è solo la tua versione della verità. Esiste un’altra versione, la mia.” “Che naturalmente è la vera! Sentiamola.” “Molto semplice. L’assassina sei tu. Ti sei fatta rivelare da Luciano il suo pezzetto di verità, dopo avere avuto da Lilli il mio. In seguito hai fatto fuori i potenziali concorrenti. Ora sarebbe venuto il mio turno, poiché hai il numero della cassetta e il nome della banca, ma ti manca la chiave, che ho io.” “Tutto qua?” Dico, cercando di nascondere la sorpresa con un sorriso di sufficienza. “Ti sembra poco? I particolari lasciamoli agli inquirenti. A noi interessa...” 349 “Così, se ora mi ammazzi la presenterai come legittima difesa.” “La stessa cosa vale per te.” Dice sibilando. “Vai avanti.” “Io sarò in grado di dimostrare con una prova oggettiva che l’assassina sei inequivocabilmente tu.” “Come?” “Possiedo l’arma del delitto. Mi sarà sufficiente far trovare agli inquirenti quell’arma con le tue brave impronte digitali impresse sul manico.” “Capisco.” Ripeto ancora, stavolta freddamente, e guardandolo dritto negli occhi. A questo punto cala un silenzio che definire imbarazzante sarebbe eufemistico. Ci guardiamo fissi per qualche secondo. Sono io che distolgo lo sguardo per prima. Fingo di cercare il mio pacchetto di sigarette. Ma mi accorgo di avere un vero bisogno di fumarmene una. Da una parte ho la sensazione di stare nella fossa del leone. Dall’altra mi sento dentro la sicurezza e il disagio di chi ha il dito sul grilletto. Continuo a cercare invano le mie sigarette con lo sguardo. Non oso alzarmi. “Dammi una sigaretta.” Gli dico. Lui tira fuori il suo pacchetto di Camel e me ne offre una. Per accenderla si alza dalla poltrona e si viene a sedere sul divano accanto a me. Se ne accende una anche lui. Dà una tirata profonda ed espirando lentamente si appoggia allo schienale rilassandosi. Mi mette un braccio sulle spalle. Il che non contribuisce al mio rilassamento. Fisso il vuoto davanti a me. Mi sento il suo sguardo addosso. Finalmente mi volto verso di lui. Faccio: “Allora?” “Allora abbiamo davanti a noi tre possibilità.” “Sentiamo.” “Primo: io ammazzo te. Secondo: tu ammazzi me.” “Terzo?” “Ci mettiamo d’accordo. Si tratta di un bottino veramente favoloso, che ora andrebbe spartito solo in due. Tu non hai la chiave della cassetta e io non conosco il nome della banca.” “Come la mettiamo con la polizia?” 350 “In due sarebbe più facile. Ci forniamo un alibi a vicenda. Ci inventiamo un serial killer, anzi due...” “Le vergini folli?” “Perché no? È forse senza una ragione che si sono meritate questo soprannome? Non sarà difficile convincere i giudici della loro ossessione per le scienze occulte.” “A proposito, mi devi togliere un ultimo dubbio.” Lo interrompo. Gli racconto la faccenda dei cavalieri del nulla e la tesi delle due matte, domandandogli cosa ne sa. “Tutte cazzate.” È la sua risposta. “I cavalieri del nulla erano una goliardata.” “Loro ci credevano fermamente. E anche voi, tu e Luciano, ci avete creduto.” “Solo delle menti immature possono dare importanza a certe fandonie. Noi ci giocavamo al tempo della nostra tarda adolescenza. Loro non ne sono ancora uscite da quel ritardo. Torniamo agli omicidi.” “Torniamo agli omicidi.” “Bada che fra noi due chi rischia di più sei tu.” Dice fissandomi. “Per tutti gli altri delitti sembra che la polizia non abbia uno straccio d’indizio. Però con Lucrezia hai lasciato tracce in ogni angolo della sua casa. Da cui sei uscita alle sei precise.” “Come lo sai?” “Lo so.” “Brutto porco.” “Devo pur difendermi.” “Stai bluffando.” “Ti ho visto coi miei occhi. L’altro ieri, quando mi hai detto che il messaggio nascosto nel quinto capitolo era il tuo nome, mi sono insospettito. Sia tu che io cercavamo il quinto capitolo del Nuovo corso. Tutti e due sapevamo che ce l’aveva Lucrezia. Così ti ho seguito, quella notte, mi sono appostato davanti alla sua casa e ho aspettato. Quando tu sei uscita io sono entrato...” “E l’hai ammazzata.” Concludo. “Questa è la tua versione.” “Invece la tua?” 351 “Ho trovato il cadavere ancora caldo. Ciò che non capisco è perché hai sparso tutte quelle tracce in giro. Hai addirittura lasciato il pugnale nel corpo della vittima. Dovevi essere fuori di te.” “Brutto porco. “ “Ma io ti voglio bene e mi preoccupo per te. Ho preso il pugnale, l’ho lavato per benino e te l’ho portato.” Così dicendo, infila la mano nella tasca interna della giacca e ne estrae un involto, un fazzoletto bianco arrotolato. Lo srotola sul tavolino accanto al posacenere. Ne esce fuori un prezioso pugnaletto. La strana lama ha una sezione a forma di croce e non è più lunga di un palmo di mano. L’impugnatura è d’argento. “Non raccontare storie.” Lo incalzo. “Conosco benissimo le tue intenzioni. Mi strozzerai per legittima difesa preventiva, e poi metterai le mie impronte digitali sul manico del pugnale.” “Guarda che io propendo per la terza soluzione.” Mi rendo conto che sto rischiando di brutto. Devo giocarmela fine. D’altronde avevo previsto qualcosa del genere. Così gli dico che la terza soluzione va bene anche per me. Discutiamo ancora un po’ per definire i particolari, e per convincerci a vicenda che non stiamo barando. Ma sono tutt’altro che convinta, e dubito che lo sia lui. Per festeggiare l’accordo beviamo del Porto. Fatichiamo molto a sciogliere la tensione. Solo quando decidiamo di scambiarci i nostri due segreti, il mezzo litro di vino che ci siamo scolati comincia a far sentire i suoi primi effetti. Giuliano si riempie un altro bicchiere fino all’orlo e lo manda giù d’un fiato. Quindi infila la mano nella stessa tasca dove aveva tenuto l’involto del pugnale e ne tira fuori una chiave. L’appoggia sul tavolinetto e mi guarda negli occhi. “Ora sta a te.” Dice. “È la filiale di Ginevra del Banco di Santo Spirito.” Dico. “Mi devi convincere.” Al che mi alzo, vado alla scrivania, prendo il foglietto su cui ho trascritto Puttana santa e glielo mostro. Gli recito la poesia: “Ti possiede chi ti paga, ma ti apri a chi cerca il Graal, purché abbia la chiave. Il tuo corpo è uno scrigno prezioso e lo Spirito Santo risiede in te, Ginevra.” 352 Lui segue la mia recitazione con gli occhi inchiodati sul foglio. Quando finisco alza lentamente la testa e punta nei miei occhi uno sguardo freddo. Però si riprende in un attimo e la sua espressione torna subito falsa e cordiale come prima. “Tutto qui?” Mi fa. “Che significa?” “Non l’ha scritta Luciano. È dedicata al Leopardo. Così ho pensato che l’aveva scritta Fabrizio. Dopo di che non è stato difficile risolvere il doppio senso, sapendo che poteva avere a che fare con un tesoro. Sembra avere un significato esoterico. La realtà è più triviale: lo scrigno prezioso è la cassetta; il Graal, il tesoro; benché il proprietario è colui che ha pagato il servizio bancario, se ne appropria chi possiede la chiave; e lo Spirito Santo che risiede in Ginevra è la banca, una filiale svizzera del Banco di Santo Spirito. “Fantastico!” Fa lui. Quasi lo grida. “Semplice e geniale.” Si sta entusiasmando. L’atmosfera ormai si è riscaldata. Il balordo comincia a ruzzarmi attorno e io sto al gioco. È il momento di mettere in esecuzione il mio piano. È un piano molto elaborato. L’ho denominato ‘soluzione terminale’. Fase prima: gli do una bella stranita. “Ti farò passare una notte indimenticabile.” Dico, scolandogli la bottiglia nel bicchiere semivuoto. “Questa è già una notte indimenticabile. Siamo miliardari.” “Io ti darò di più. Ti farò vedere il volto di Dio.” “Proprio quello che cercavo.” “C’è un rito sessuale fantastico. Ne avrai sentito parlare e so che ne sei curioso.” “Ah, la famosa tecnica di Oshima?” “È solo una parte. È un rito tantrico. Si chiama Panchatattva, che vuol dire ‘cinque elementi’.” “Ho sentito dire che è una cosa pericolosa.” “Tu non sei tipo da temere pericoli del genere.” “Che genere?” Domanda, con una lieve risonanza di trepidazione nella voce. “Lo saprai al momento giusto.” 353 Lo prendo per mano e lo trascino giù per le scale verso il seminterrato. Lì c’è la mia sauna già in funzione. Lui vi si lascia trascinare senza opporre resistenza, però guardingo. “Prima dobbiamo purificarci e rilassarci.” Dico. Lo spoglio rapidamente e lo spingo sotto la doccia bollente. Mi spoglio anch’io e lo raggiungo. Giochiamo e ridiamo. Ci insaponiamo le cicce indugiando sulle parti immonde. Ci strofiniamo e ci baciamo. Lui si fa subito tutto un turgore. Ma non appena giro la manopola dell’acqua fredda, si sgonfia. Si sgonfia in un attimo. Si sgonfia con un urlo, sotto l’acqua gelata. “Bisogna soffrire, per godere.” Lo consolo. Poi ci lanciamo nel cubicolo di legno di frassino, dove la temperatura è già altissima. Con un grosso mestolo di legno raccolgo dell’acqua da un catino e la getto sulle pietre di granito che si arroventano sopra la stufa. Se ne sprigiona uno sbuffo di vapore bollente. Lui si distende sulla panca di fronte a me. Ripeto per tre volte l’operazione. L’umidità e la temperatura salgono rapidamente. Mi distendo anch’io sulla panca di legno umido. Per dieci minuti ce ne stiamo così, a goderci il calore infernale, distesi senza forze e senza volontà. Dopo di che usciamo e ci tuffiamo sotto la doccia bollente. Passiamo dall’acqua calda alla fredda con urli agghiacciati, è proprio il caso di dirlo. Ci riposiamo due minuti su dei lettini di gommapiuma e infine torniamo dentro il forno di frassino. Getto di nuovo dell’acqua sulle pietre roventi. La temperatura e l’umidità salgono ancora. Per tre volte ripetiamo ordinatamente tutte le operazioni: sauna, doccia, lettino e di nuovo sauna. Alla fine siamo cotti. Con l’umidità e la temperatura al massimo, me ne sto lì distesa sulla panca dura, gli occhi chiusi, madida di sudore, la mente vuota, il corpo abbandonato, il sangue che mi pulsa rumorosamente negli orecchi, quando sento una mano strisciare sulle mie cosce. Apro gli occhi a fatica. Giuliano è seduto accanto a me sulle tavole dell’impiantito e guarda il mio pube imperlato di sudore. “Sarebbe questo quel rito pericoloso?” Domanda. “Figuriamoci! No. La sauna serve solo per rilassarci. Per purificare il corpo e la mente.” 354 “Per rilassarci non c’è niente di meglio di una scopata.” China la testa sulla mia pancia e comincia a baciarmi. Con le labbra, la lingua, i denti mi esplora tutto il corpo. Potrei quasi eccitarmi, se non fosse per l’oppressione del caldo e dell’aria satura d’umidità. Lo lascio fare. Meglio che si spompi. Lo avverto: “Guarda che io sono completamente passiva.” “Non chiedo di meglio.” Fa lui. Mi prende per la vita e mi rigira come una porchetta. Poi mi afferra i fianchi e mi mette a pecorina. Lo lascio fare. Lui mi si dà dattorno con le mani e la lingua, e meno per infiammarmi che per lubrificarmi. Non sono eccitata. Però lo lascio fare. Non tento neanche di simulare un orgasmo. D’altronde conosco il cliente e so che una completa passività da parte mia lo arrazza meglio di un pompino. Gli sembrerà di farmi una sottile violenza. Infatti mi penetra con foga. “Non stancarti troppo,” gli dico, “il meglio deve ancora venire.” “Voglio godermi ogni istante di questa notte.” Ci mette un bel po’ per venire. Ma devo riconoscere che è già tanto che ci riesca, in quelle condizioni. Quando usciamo per l’ultima rinfrescata lui è più sderenato di un abbacchio pasquale, e si sostiene a me nel breve tragitto dall’inferno di vapore alla doccia. Solo quando si ritrova sotto il getto di acqua fredda riprende vita. Altri cinque minuti di riposo sopra i lettini di gommapiuma. Dopo di che ci asciughiamo, risaliamo le scale e torniamo in salotto. Inizia la fase seconda: lo faccio volare fino alle stelle. Gli metto addosso un kimono di seta giapponese di un bel colore azzurro cesio ricamato d’argento. “Sono colori lunari.” Dico. “Il rito implica una sorta d’inversione dei ruoli sessuali, sul piano spirituale.” Lui si lascia vestire. Poi si stende sul divano e si abbandona all’abbiocco. Mentre si riposa vado in camera da letto e preparo l’ambiente. Inzuppo tre bastoncini d’incenso in una tazza di acqua ragia e gli do fuoco. Bruciando piano piano, riempiranno l’aria del loro profumo spirituale. I vapori d’acqua ragia ci stor- 355 diranno la mente preparandola all’ebbrezza perversa che ci attende. Metto sul giradischi un pezzo di musica sacra indiana. Accendo una piccola abat-jour e la copro con un velo rosso. Riempio una ciotola di olio profumato al muschio e la poso sul comodino accanto al letto. Accendo il grande ventilatore appeso al soffitto facendolo andare a bassa velocità. Indosso il mio kimono di seta giapponese, in realtà una vestaglia leggera e semitrasparente, dipinta a fiorami d’ibisco rossi e dorati. È molto corta, poco più di un baby-doll. Sotto, un cache-sex rosso fuoco. Infine: “Vieni,” grido, “si aprono le danze!” Quando lui entra nella camera e mi vede vestita così, sdraiata sul letto, ha un sussulto di voluttà negli occhi. Il suo kimono slacciato lascia intravedere flaccide vergogne. Avanza cautamente. Ancora non si è ripreso dallo shock della battaglia in sauna. Mi alzo, gli vado incontro, lo prendo per mano, lo trascino verso l’alcova. Lui mi segue in silenzio. Ci fermiamo accanto al letto. Mi accosto a lui, aderisco al suo corpo, mi sollevo in punta di piedi e gli do un bacino sulla bocca. La mia mano libera striscia sul suo petto e risale con una lunga carezza fino al collo e alla nuca. Infilo le dita sotto il kimono all’altezza delle spalle e gli faccio scivolare via l’indumento. Lo spingo a sedere sul letto. Lui appoggia il viso sul mio addome e mi bacia l’ombelico. Lo spingo di nuovo e lo faccio sdraiare. “Ora immagina di essere Shiva, il dio maschio. Chiudi gli occhi e ripeti questa formula: ‘Shiva hum’. Vuol dire: ‘io sono Shiva’.” Chiude gli occhi. Io mi siedo accanto a lui. Mi ungo le mani di olio muschiato e comincio a massaggiarlo delicatamente. Parto dal collo e scendo al petto, al plesso solare, alla pancia, all’inguine. Lo ungo tutto e continuo a massaggiarlo, finché la pelle non ha assorbito completamente l’essenza profumata. Lui se ne sta lì, moscio moscio che pare già in coma, con gli occhi chiusi e un sorriso ebete sulla bocca. Solo qualche timido mugolio di piacere mi rivela che non sta dormendo. Gli infilo la mano sotto la schiena, lo faccio girare bocconi e ricomincio a ungerlo. Lo friziono adagio, dalle spalle scendo giù, 356 verso i lombi, i fianchi, i glutei. I quali glutei sono ancora troppo duri e tesi. Li picchietto con il taglio delle mani e insisto e insisto fino a rompere ogni resistenza. Poi scendo alle cosce e garbatamente gliele allargo a 30 gradi. Le massaggio all’interno e faccio risalire le dita fino a raggiungere il perineo. Sposto la mano sinistra sui suoi fianchi e lo tengo fermo. Con il dito medio della destra gli titillo vigorosamente il piccolo fascio di muscoli e nervi che congiunge l’ano al pene. Lui ha un brivido di piacere. “Qui risiede Kundalini,” dico, “la potenza dell’universo. Ha la forma di un serpentello attorcigliato. Se ne sta assopito in attesa che qualcuno lo risvegli. La stragrande maggioranza delle persone non si accorge della sua esistenza nel corso di una vita intera. Solo pochi eletti lo sanno, e tentano il risveglio. Solo pochissimi ci riescono. Dice l’Apocalisse: chi oserà risvegliare il demone che si annida nel ventre dell’uomo?” “A questo mira il nostro rito?” Domanda lui, con la vocina di un bambino. “Sì. Il Panchatattva mira al risveglio per via sessuale. Bada, però, che una volta risvegliato, il serpente può diventare pericoloso. Il problema non è tanto di destarlo, quanto di controllarlo. Bisogna dirigerne i movimenti, farlo risalire lungo la spina dorsale e portarlo alla testa. Lì, se si riesce a farcelo arrivare, produrrà l’esplosione estatica. Quello è il momento più delicato e pericoloso.” Intanto lui si gira e si mette supino. S’intreccia le mani dietro la testa e mi guarda con quei suoi occhietti perfidi e lubrichi, mentre io continuo a massaggiargli il perineo. “Non crederai di spaventarmi con queste bubbole!” Dice. Risalgo con il massaggio fino al petto e gli titillo i capezzoli. Lentamente torno a scendere giù. Con la mano sinistra gli accarezzo le trippe, mentre con la destra scivolo verso il pube. Comincia finalmente a vedersi qualche segno di vita. “Kundalini si risveglia.” Fa lui. “Non è così semplice.” I segni di vitalità si fanno rapidamente più appariscenti. Al che mi alzo e vado in cucina. Torno con il vassoio dei cibi. Lo poso al centro del letto. Mi spoglio nuda e mi metto in ginocchio 357 accanto al vassoio. Gli occhi di lui luccicano di voglia. Mi chino sul vassoio, prendo del riso e glielo metto in bocca. Lui non mi lasca andare la mano prima di avermi leccato tutte le dita. Ripeto l’operazione del riso con me stessa. “Il riso è il simbolo della terra.” Dico. “Il pesce invece rappresenta l’acqua.” Porto la mano alla ciotola del pesce, ne raccolgo un po’ e gliene do da mangiare. Ne mangio anch’io. Passo alla carne e ripeto l’operazione. “La carne simboleggia l’aria e, con il cardamomo, la vita organica.” Mangiamo dei semi di cardamomo. “Ora berremo una bevanda potente.” Proseguo. Afferro il bricco di ceramica e verso il liquido verde in due grandi coppe di cristallo. Bevo prima io, un sorso breve, poi un altro. Lui mi guarda un po’ sospettoso, poggia le labbra sul bicchiere e assaggia. “Ha uno strano sapore,” dice, “non male. Che roba è?” “Strakè, un miscuglio di stramonio e sakè. È una bevanda diabolica. Nell’antichità la usavano le pitonesse, con il vino al posto del sakè ovviamente. La usavano per darsi la trance. Nel Medioevo era la bevanda preferita delle streghe, che ne facevano uso e abuso, soprattutto durante i sabba. Lo stramonio infatti veniva chiamato ‘erba delle streghe’. È una strana droga. In piccolissime dosi è un medicinale. In dosi più abbondanti diventa un allucinogeno e in dosi massicce un veleno. Può portare al coma, a volte irreversibile. Stai tranquillo, comunque. Questo è in dosi da blando allucinogeno, giusto per esaltare i sensi. Così lo usavo con Luciano, che me ne ha svelato i magici segreti.” Per metterlo a suo agio, ne prendo un lungo sorso. Lui, come se le due coppe non fossero state riempite dallo stesso bricco, posa la sua sul vassoio, mi toglie la mia dalle mani e se la scola quasi tutta. “Lo strakè simboleggia il fuoco. Ora abbiamo assunto in noi quattro degli elementi fondamentali dell’universo. Ci resta il quinto.” “Che sarebbe?” “Maithuna, il sesso.” “Che simboleggia...?” 358 “L’unione di Shiva e Shakti, la creazione. Shakti è la divinità femmina.” “Che sarebbe incarnata in te.” “Fino a un certo punto. Anzi, fino a un certo momento. Dopo di che i ruoli dovranno invertirsi. Tu diventerai Shakti, la potente, io Shiva, il distruttore.” Mangiamo ancora un po’ di carne e pesce, e di nuovo qualche seme di cardamomo, che in realtà serve a purificare l’alito. Beviamo gli ultimi sorsi di strakè. A questo punto la musica sacra finisce. Scendo dal letto e rimetto il disco. Inizia la terza fase del piano: gli mostro il volto di Dio. “È l’ora del maithuna.” Dico. “Si,” fa lui, ammiccando alla bestia che ha tra le gambe, tornata alle sue dimensioni anormali, “Kundalini freme dal desiderio di risveglio.” Non ha capito un cazzo. Mi afferra per le spalle e mi costringe a sdraiarmi supina. Comincia a baciarmi per tutto il corpo, con le sue labbra umide e dure. Indugia sul seno e intorno ai capezzoli, che s’inturgidiscono subito. Quando si mette a stuzzicarmeli con la lingua e a stringerli tra le labbra e a mordicchiarli coi denti, sento ondate di brividi che salgono su per la schiena fino a raggiungere la sommità della testa. Poi lui abbandona il mio seno e si avvia con la lingua strisciante verso l’ombelico. Vi cincischia un po’ intorno e dentro, per ricominciare subito la marcia d’avvicinamento verso laggiù, dove sono già tutta bagnata. Mi apre le gambe infilandoci in mezzo la testa. Mi s’incolla con la bocca alle grandi labbra, mentre la lingua mi frusta dentro come un pesce nella rete del pescatore. Ogni tanto risale in superficie per lambirmi la clitoride. Allora mi lascio sfuggire degli urli di gloria, mentre lui se ne sta là piegato in due, in ginocchio tra le mie gambe, che sembra un peccatore al cospetto del suo Dio. Viene il momento di quagliare. Lo afferro per la testa, stringendogli le tempie con le mani, e lo tiro su verso di me. Il suo corpo si distende strisciando sopra il mio. Viene su piano piano, guidato da me. La penetrazione è fluida e profonda come di una lama affilata. 359 “Sento che verrò presto,” gli dico, “tu invece non devi venire, altrimenti il rito non può neanche iniziare. Recita lo ‘Shiva hum’ mentre lavori.” “Quando inizierà questo rito?” Mi fa lui, tra un ansito e l’altro. “Quando sarai cotto al punto giusto. Devi essere più eccitato di un santo al cospetto delle cinque tentazioni. Ora recita la formula e applicati.” Lui prende a pompare con un movimento calmo. Io, da parte mia, che solo quando sono veramente infiammata soffro di orgasmo precoce, gliene simulo subito uno, esplosivo e spasmodico. “Non ti fermare,” gli intimo, “ne voglio un altro e un’altro ancora. Intanto continua a recitare lo ‘Shiva hum’.” Per fortuna lui è tutt’altro che un eiaculatore precoce. E la lotta nella sauna sarà pure servita a qualcosa. “Bravo.” Gli dico, dopo aver inscenato il terzo orgasmo in dieci minuti. “Il segreto per la riuscita del rito è la ritenzione del seme, e in questo tu sei anche più forte di Luciano.” Lui, con un sorriso prostrato, esce da me e si accascia al mio fianco, il membro sempre pieno di superbia. Ci riposiamo un po’, quanto basta per riprendere fiato. Quindi attacco: “Finora è stato tutto normale. Adesso comincia la vera musica. Per prima cosa dobbiamo realizzare un’inversione di polarità.” “Come si fa?” “Da questo momento dovrai identificarti con Shakti. Hai ancora negli occhi l’immagine del mio corpo che freme. Ora recita la formula: ‘so Khum’. Vuol dire: ‘io sono lei’. Fra poco dovrebbero farsi sentire i primi effetti dello strakè.” “Già li sento. La testa è piena di stelle che ballano.” “Bene. Lasciati andare alle nuove sensazioni, ma senza perdere il controllo. Raccontami quello che ti succede. Ti aiuterà a restare consapevole.” I suoi occhi sono fissi sui fiori rossi della mia vestaglia, che pende dalla testiera del letto. “Cosa vedi? Dimmelo.” Gli ingiungo. 360 “Il fuoco. Si sprigiona dai fiori. I fiori sono di fuoco. Si alzano a piccole fiamme e crescono fino al soffitto... È un’edera rossa che si arrampica su colonne d’aria. No, è viola, nera, cobalto. Salendo, produce una musica soave. Tamburi e cembali che suonano note armoniose... La musica scende dal soffitto... sembra pioggia. No, dal cielo. Dal cielo rosso. Scende come una pioggia leggera e oscillante. Le gocce sono perline variopinte. Mi bagnano il corpo. La musica adesso si fa più forte. Viene da dietro quella porta chiusa, oltre la parete bianca. Vuole sfondarla, ma la porta nera resiste. La porta... La porta resiste. È una musica di violini. Entra dal buco della chiave ed è un filo di fumo viola. Ora nel buco c’è una chiave. Gira... gira... gira. Ma lei non si apre. La musica passa da sotto la porta... passa attraverso le fessure. È un flusso di vapori variopinti. Vola verso di me con potenti onde melodiose... Violini che rullano come tamburi... Sento rumori terribili di là della porta. Ma lei non si apre. Se ne sta salda, con lo sguardo feroce sopra di me. La chiave continua a girare. Sento rumori infernali di là della barriera. Belve che danzano al buio su un fuoco liquefatto. Ma lei non si apre. Sento una voce che viene da dietro la porta, che parla dentro di me, che dice qualcosa, che soffia, che ringhia... Legge da un libro dissigillato: ‘cosa non si farebbe per il cazzo’. E recita salmi. E preme sulla porta. E la chiave continua a girare... Ma lei non si apre. L’aria s’è fatta rovente. Sono sospeso nell’aria. Mille lombrichi giallastri mi strisciano addosso... le dita di mille puttane... piene di anelli di mille colori. Ah, quei violini! Che rumore assordante! Più forte dell’odore di una passera mestruata. Spandono note di fiele che si squassano contro la porta, venti di fiamma. Sento le danze selvagge di cento leopardi di là. Gli uomini cantano feroci come belve. Battono i piedi per terra e fanno vibrare l’intero universo. Battono, battono, contro la porta... spandono intorno un puzzo di fiera infoiata. La chiave continua a girare, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. La porta potrebbe squarciarsi. E io lo voglio. Apriti! Apriti! Sì! Ecco, ora si apre. Si apre. Scompare. Sì, non c’è più. Tutti i colori della notte mi si avventano addosso. Sono una troia in calore. Gli uomini danzano intorno. Ne sento 361 l’odore di belva, ne sento il rumore. I piedi che battono il tempo per terra.” Qui si ferma. Seguono cinque minuti di silenzio. Sono impressionata. Non avevo mai visto un effetto così potente. Non me lo aspettavo dallo stramonio. Può darsi che il dosaggio sia stato troppo leggero. Prevedevo una rapida entrata nel coma, con scarsi effetti allucinogeni. E invece no… Ora forse arriva l’esito che attendevo. Giuliano se ne sta lungo sul letto, rigido come un bastone, i muscoli tesi, gli occhi e la bocca serrati con forza. Ora dovrebbe essere finita la fase allucinatoria. Ora entra in coma, mi dico. Lo osservo con attenzione, ne spio ogni minimo segno di vita, ogni tremore della pelle... E invece no. Dopo un po’ i muscoli tornano a rilassarsi. La bocca si distende. Gli occhi si socchiudono. Guarda verso di me. Guarda attraverso me. Apre la bocca. Vorrebbe dire qualcosa. Emette un bisbiglio incomprensibile. Mi avvicino con l’orecchio. Il bisbiglio si fa sempre più chiaro e più forte. Ricomincia a vaneggiare: “È buio. È buio completo. Un buio lucente che penetra tutti i miei pori. Le dita delle mille puttane mi suonano il corpo creando armonie dolorose. L’aria s’increspa di piccole onde caliginose... Onde fragranti di fiori e di morte. E di nuovo quella terribile voce che legge dal libro proibito: ‘cosa non si farebbe per il cazzo’. Ma ora lo vedo, è lui, lo sento, l’uomo-leopardo... Danza lontano oltre la porta che non c’è più. Batte per terra i suoi piedi mostruosi... batte il tamburo coi suoi piedi dorati. E gira intorno a se stesso, gira dentro la notte. Danza e saltella e piroetta dentro la gonna d’organza. E gira e rigira e rigira, e viene verso di me. Tiene sul capo e le spalle una pelliccia maculata... E viene verso di me... Viene dentro di me. Aaaah. Mi copre la testa e le spalle con quella pelliccia. Ecco, la testa è una maschera d’oro, la testa dell’uomo-leopardo. Aaaah.” Ancora qualche secondo di silenzio. Poi riprende. “Ora vedo con gli occhi di lui... di lei. L’uomo-leopardo è una donna, sono io. Continuo a danzare, faccio dei piccoli salti verso il soffitto. Ora non giro, non giro più. Faccio dei piccoli salti nell’aria dolce e odorosa di morte, dei piccoli salti sopra la punta dei piedi, senza piegare le ginocchia. La notte è nera come il ma- 362 re infernale. Vedo nell’aria i numeri d’oro che reggono tutte le leggi del mondo. I salti si fanno potenti... Resto sospeso nell’aria sempre più a lungo... Sono in attesa dell’ultimo salto. Ma l’uomo-leopardo non è... non sono... L’uomo-leopardo sei tu, sono io.” Gli occhi ora li tiene sbarrati, le pupille dilatate. Le labbra si muovono appena. Le ultime parole si confondono in un soffio. “Non ti fermare,” lo esorto, “continua a guardare e a descrivere quello che vedi.” Lo dico con voce ferma. Lui sembra sotto l’effetto di un’ipnosi, e mi obbedisce prontamente. “Sono... in attesa...” “Di cosa?” “L’ultimo salto... Eccone uno...” “Così. Non ti fermare. Fai dei respiri profondi. Continua a recitare la formula magica: so khum.” Silenzio. “Ripeti con me,” insisto, “ripeti: so khum.” Silenzio. “Ripeti: so khum. Ripetilo.” “So khum.” Barbuglia in un soffio. “So khum.” “So khum.” Sempre più debole. Gli prendo un braccio. È freddo e legnoso. Lo sollevo in aria e lo lascio andare. Ricade sul letto a peso morto. Lo tocco in vari punti del corpo. È freddo dappertutto. Sembrerebbe un cadavere, se non fosse per quegli occhi sbarrati e terribili, fissi su di me. Le labbra sono socchiuse e i respiri, lievi e profondi, gli sollevano il petto con un ritmo lentissimo. L’enorme membro in erezione palpita come un animale ansimante. Ora è cotto al punto giusto. Gli monto a cavallo e prendo il suo pene dentro di me. Lo faccio penetrare a fondo. Comincio a cavalcare con un ampio movimento del bacino. Gli poggio le mani sul petto e gli titillo i capezzoli. I suoi occhi hanno un lieve sussulto, appena un cenno. C’è un’espressione di gioia e inquietudine in quegli occhi terribili. “Continua a recitare la formula magica e non pensare ad altro.” Dico. 363 Le sue labbra fanno un movimento appena percettibile. “Ora ti trovi in stato di grazia. Lo strakè sta producendo su di te i suoi effetti magici. Su me non lo può, perché ho preso l’antidoto. Il tuo corpo è paralizzato, i tuoi muscoli sono morti e ne hai perso ogni controllo, mentre i nervi e il cervello sono desti come non mai. Ora ti trovi in stato di assoluta ricettività. Sei lei. Non puoi fare niente eppure recepisci tutto. Non sei più un soggetto. Sei un oggetto, un oggetto nelle mie mani; un oggetto sensibile, direbbe il filosofo. Lo so che vorresti ribellarti. Non puoi. Lo so che vorresti farmi mille domande. Non ti preoccupare. Le farò io le tue domande e ti darò le risposte.” L’espressione dei suoi occhi subisce una violenta metamorfosi sotto la violenza delle mie parole. L’inquietudine si tramuta in terrore. Non gli do requie: “Mettiti l’animo in pace, considerati già morto e goditi questi ultimi istanti di vita. Sì, ora ti ucciderò, amore mio. Non potevo mica correre il rischio di fare la fine di Lucrezia e tutti gli altri? Ti ho fregato, amore mio. Ti ho dato una dose massiccia di stramonio. Ti procurerà il coma. Non sono sicura che sarà irreversibile. Ma non ce ne sarà bisogno, poiché non ti ucciderà lo stramonio. Ti ucciderò io. Ti strozzerò, per legittima difesa. E tu dovrai anche ringraziarmi, perché sarà una morte bella.” Così dicendo, gli metto le mani al collo e comincio a stringere, dolcemente, gradualmente. Intanto il mio bacino continua a cavalcare sul pene rigonfio. “Ora ti trovi in stato di grazia,” insisto, “le tue capacità di comprensione, di percezione, di godimento sono al loro climax, mentre il tuo corpo attivo è come morto. Ora in un certo senso sei un puro spirito, liberato dal peso della materia. È così, non ci puoi fare niente. Perciò non ti angosciare e goditi il gran finale. Ti farò provare il più potente orgasmo della tua vita, e forse vedrai veramente il volto di Dio.” Le mie mani si stringono intorno alla sua gola con forza crescente. Già il viso gli comincia a diventare paonazzo. “Questa è la famosa tecnica di Oshima, di cui eri tanto curioso. Me l’ha insegnata Luciano. È una tecnica dell’estasi. La riduzione dell’afflusso sanguigno al cervello serve ad attivare uno 364 stato alterato di coscienza. Luciano usava la tecnica in cerca dell’illuminazione. Qualche volta usava lo stramonio; e allora lo scopo era di entrare in catalessi. Tu in catalessi quasi ci sei. Prima, comunque, ti darò un satori. Credimi, non è una cosa facile per me, nonostante l’esperienza. Non è facile. Devo dosare la stretta al collo in modo da non ucciderti subito e, nello stesso tempo, in modo da accendere lo stato alterato di coscienza un istante prima dell’orgasmo. In Luciano questa tecnica, quando riusciva, impediva l’orgasmo fisico e ne provocava una sorta di uno mentale, lo scatenamento di Kundalini nella sfera dello spirito. Non era facile, no. Con te lo sarà ancora meno, perché voglio provocarti un orgasmo che è sia fisico sia mentale e farlo un attimo prima della morte, il massimo del massimo.” Tuttavia è più facile di quanto credessi. All’improvviso l’espressione dei suoi occhi muta di nuovo, e al terrore, in un istante, subentra un’esplosione di felicità; ma un’esplosione così potente che sembra gioia ineffabile. D’altronde c’è poco da affabulare. In quello stesso istante il suo corpo comincia a vibrare col ritmo di una lavatrice in centrifuga. Gli stringo le cosce ai fianchi. Il suo viso è ora diventato blu. E gli occhi... oh, quegli occhi! Cosa avranno mai visto? Proprio mentre mi sento inondata da un getto potente di energia, lungo e ripetuto, quegli occhi che vogliono esplodere fuori dalle orbite mi lanciano un ultimo lampo di odio e di stupore, sì, e di beatitudine. Quando scendo da cavallo sono spossata. Però non mi do tregua. Vado in salotto e prendo l’arma del delitto. Il pugnale crociato luccica tra le mie mani. Tenendolo col fazzoletto per la lama, metto l’impugnatura nella mano destra di lui. Gli stringo intorno le sue dita, in modo che ci lascino delle impronte chiare. Dopo di che mi crolla addosso una stanchezza infinita. Allora mi ciuccio le solite due pillole e mi concedo qualche ora di sonno senza sogni. 365 EPILOGO Le impronte sull’arma dei delitti non lasceranno dubbi agli inquirenti. Né mi sarà difficile convincerli che ho ucciso Giuliano per legittima difesa. Mi rendo conto che nella spiegazione che fornirò alla polizia dovrò fare ricorso a delle mezze verità, anzi, a delle vere e proprie menzogne. È inevitabile. Chi testimonierebbe altrimenti la verità vera? Certo – direbbe lui – sarebbe la tua versione. – La quale è per me l’unica – potrei rispondergli. Qui mi si apre un problema di natura logica che parrebbe scombinare tutto il diario, questo diario così ambiguamente veritiero. Ora che l’ho riletto da cima a fondo, e con attenzione, ho trovato che è un resoconto particolareggiato dei fatti… secondo la mia versione: Giuliano è l’assassino di almeno quattro vittime e io sono la quinta vittima designata che si è difesa uccidendo. Nondimeno mi rendo conto che il diario rappresenta un valido riscontro per me, che sono convinta della sua veridicità, e solo per questo. Ho provato a rileggerlo in un’altra ottica, quella di Giuliano, e ho capito che lo stesso resoconto dei fatti, interpretato come non del tutto veritiero, potrebbe sostenere altrettanto bene la sua verità, cioè che la pluriassassina sono io e lui la quinta vittima designata. A questo punto mi viene un dubbio. Che la cosa mi sia sfuggita di mano? Che io stessa sia andata inconsciamente oltre le mie intenzioni? Però non vedo perché dovrei farmi impressionare da certi problemi. Sono problemi del lettore, non miei. Il mio problema è un altro, in quanto c’è qualcosa che ancora non quadra nella stessa mia versione dei fatti. Ho proposto, nella vittima dell’ultimo omicidio, l’omicida delle precedenti quattro vittime. Non ho un’idea di chi sia l’omicida della prima. Chi ha ammazzato Luciano la notte dell’orgia? Se quei quattro sono stati uccisi perché uno di loro poteva essere in possesso di un segreto carpito a Luciano dal suo assassino, quest’ultimo non può essere la stessa persona che ha ucciso quelli; se il segreto lo avesse 366 carpito lui, non avrebbe avuto bisogno di ammazzare nessun altro dopo Luciano. D’altra parte, se l’assassino di Luciano fosse stato una delle successive vittime, allora la serie degli omicidi si sarebbe interrotta a quello dell’assassino stesso. Giuliano avrebbe continuato a uccidere finché non avesse trovato l’omicida di Luciano. E siccome l’ultima sua vittima designata ero io, proprio io avrei ucciso Luciano. Tesi che risulterebbe confermata dal fatto che infine il segreto, il nome della banca, era in mio possesso. Questa versione in ogni caso è basata sul presupposto che sia valida la mia verità; e dunque potrebbe essere contraddittoria, giacché nella mia verità non rientra la possibilità che Luciano lo abbia ucciso io. Se invece partissi dalla versione di Giuliano, allora, essendo lui l’ultima vittima designata, proprio lui avrebbe dovuto possedere il segreto del nome della banca. Ma ciò non ha senso, visto che lui lo cercava da me. Così nessuno degli altri sei personaggi dell’orgia può aver ammazzato Luciano, se la mia logica non difetta. Chi l’ha ucciso? Ecco il problema. La soluzione ora mi si presenta nella forma di un bivio. La prima strada conduce a una verità sofistica: che la logica della storia non solo può essere diversa da quella del narratore, ma può essere più di una. Perché esclusivamente la verità di Giuliano o la mia? Perché non due, tre, molte verità? Perché una di esse non potrebbe risolvere il problema della morte di Luciano? E perché non potrebbe esserci una verità dal punto di vista di ogni personaggio? Mettiamo, ad esempio, le vergini rosse: non potrebbero scoprire nell’epilogo di questa storia una conferma della loro tesi sul complotto esoterico? Certo, in quest’ottica tutto è possibile, perfino che Luciano sia stato ucciso per sbaglio da Lilli, o addirittura da me, con la tecnica di Oshima. E che il romanzo giallo che ne è seguito debba risolversi alla fine in un’apocalisse scatenata dal caso. Però, se ne può risultare una visione incoerente, oppure coerente col punto di vista delle vergini folli, allora perché non anche una coerente, che so? con un punto di vista di Luciano? 367 Qui si apre la seconda strada del bivio, ed è più bella e romantica di una Weinstrasse altoatesina. Con essa narrerò la fine di una storia che, alla fin fine, potrebbe ben avere un lieto fine. Dopo tutto, è la verità che io preferisco. Anzi, se volessi misticheggiare, potrei dire che è quella che preferisce me. Infatti non so resistere all’impulso di scegliere la strada del sogno e dell’incanto; un impulso tanto forte che, appunto, sembra sia stato questo finale a tessere le fila della storia per trascinarmi a lui. Perché Luciano non potrebbe essere vivo? Ho riletto il diario alla luce dell’assurda domanda e mi sono accorta che vi sono disseminati indizi che sembrerebbero tramare a favore di una conclusione così stravagante. Evidentemente la narratrice li ha registrati senza accorgersene; potenza della debolezza del soggetto! L’ipotesi è che Luciano, durante quell’orgia, si sia appartato in un angolo e si sia messo in catalessi. Noi altri sei, presi dall’ansia e dalla precipitazione, l’abbiamo scambiata per morte. Più tardi, dopo la nostra fuga, lui s’è risvegliato e se n’è andato. In seguito, o magari anche prima del fattaccio, può aver deciso di giocare con noi come un gatto coi topi. Si sarà nascosto in qualche luogo appartato da cui avrà osservato l’evoluzione del gioco, magari intervenendo quando necessario. Potrebbe essersi nascosto in casa delle vergini folli. Non è forse vero che loro avevano rinviato a Luciano come a un alibi per l’omicidio di Lilli? E il loro interesse alla mia persona negli ultimi capitoli della storia, quel loro condurmi per mano lungo la strada che portava alla soluzione di ogni enigma, non può essere stato un agire manovrato da lui? Lui se ne sarebbe rimasto in disparte, aspettando che ci ammazzassimo tutti, l’uno dopo l’altro. Sì, più ci penso, più mi convinco: questa è la soluzione giusta. O no? No, è troppo incredibile! È troppo bella! E se fosse vera? Se lo fosse, ora dovrei poter dire: lupus in fabula. Infatti mi pare di sentire dei passi fuori della porta. Sì, deve essere lui. Mi pare di sentirlo. O me lo sto sognando? Potrebbe essere proprio lui, o potrebbe non essere. 368 Ora salirebbe le scale. Mi pare quasi di vederlo mentre sale gli scalini dell’ingresso, con il suo passo strascicato, il cronico broncino sotto i baffi spioventi, i pollici infilati nelle tasche posteriori dei jeans come Paul Newman in Hud il selvaggio. Oddio, ora mi accorgo che di lui non ho mai dato una descrizione. Quanto deve essere lacunosa la mia narrazione se il protagonista è senza volto! Però è giusto che sia così, se la storia ha voluto farsi scrivere così. D’altronde non era lui un protagonista fantasma, un soggetto assente? E non è stato presente, quando lo è stato, solo coi prodotti della mente? E perché un’esposizione di prodotti mentali dovrebbe essere meno efficace di un tratteggio figurativo? By the way, adesso mi accorgo di un’altra lacuna: non ho mai dato uno straccio di descrizione neanche di me stessa. E di me non posso certo dire di essere stata assente col corpo e presente solo con la mente. Pazienza! Del resto non è detto che anche questa lacuna non abbia il suo significato. Dunque ecco, Luciano salirebbe le scale adagio, consapevole della suspense in cui mi terrebbe appesa. Si fermerebbe un istante davanti alla porta. Poi busserebbe coi suoi tre inconfondibili brevi colpi secchi. Io andrei ad aprirgli con calma, frenando un impulso a correre, e i capezzoli mi s’indurirebbero sotto la camicetta. Aprirei. Ci guarderemmo senza fiatare. Entrerebbe. Faremmo roba. Subito. Senza fiatare. Dopo potremmo riacquistare l’uso della parola, solo dopo, nell’atmosfera magica delle First Meditations di John Coltrane. Luciano mi reciterebbe la nostra poesia, quella stramba poesia che mi regalò il giorno del primo anniversario del nostro menage post-idillico: MINESTRONE ALLA MAJAKOVSKIJ Solo una pioggia di baci saprebbe spegnere il fulgore di una coppia di glutei ardenti. Come in un letto di morte il giorno ci vorrebbe sprofondare dentro, un tuffo che vale mille mietiture di vendetta. Hai voglia ad affilare i denti della rabbia sulla pietra dura della democraxia! Non esiste rivalsa 369 che tenga al furore di un affondo in quell’oscurità. Non c’è sole che bruci o fiume che scavi come la sete di quel nulla. Né so di un solo discepolo del buio, di un solo anarchico dall’animo assassino, che non abbia voluto abbeverarsi a quella notte prima che la bocca del cielo possa spalancarsi sull’alba dei secoli. All’orda dei sensi scatenata da un solo desiderio non basta l’urlo di tutte le utopie. La rivolta che ingolfa il mio respiro non conosce tregua, eppure proprio non tiene contro i secreti di una vulva turgida. L’amore è un cocktail di umori corporali. E come le flotte corrono al porto, e più veloce dei treni verso la stazione, corre l’amore all’approdo tra i monti dei seni e fa rombare il sangue agli orecchi. E quando fianchi rotondi come coppe si aprono allo schianto della mente, le schiere delle idee e delle visioni si sfaldano all’urto delle sue armate. Dice: Oltre l’amore non c’è sole. Proprio così: L’amore è meglio di tutte le più prelibate zuppe di cavolo. Non avevo mai penetrato il senso di questa poesia, e se debba essere interpretata come una dichiarazione. Ma ora l’ho afferrato. “Non m’inganni più caro.” Gli direi. “Finalmente ho capito una cosa di te che tu non hai compreso.” “Sarebbe?” “Tu, quando parli di sesso, credi di svilire l’amore. Invece cerchi di esorcizzarlo. Ma…” “Ma?” “Quando parli di sesso, tu parli d’amore.” Lui si schermirebbe, e cercherebbe di confondermi le idee con la filosofia: “Resta il fatto che aveva ragione il filosofo della follia: La verità è laggiù.” “E allora a che serve la chiave della verità?” “Ormai dovresti averlo capito. A che può servire se non a sorprenderla?” Ovvio no? E mi affretterei a cambiare discorso: “Così alla fine”, gli direi, “i soldi te li becchi tu.” 370 “Li spartiremo fraternamente.” “E tutto questo cataclisma di morte, solo per qualche miliardo di Lire? Quindi l’uomo nuovo non è che un volgare opportunista.” “Volgare, sì,” direbbe lui, “un superuomo comune.” “Ma l’uomo comune non ha filosofie. Che ne sa del mondo?” “Che del mondo in sé non vale la pena di sapere niente.” “L’uomo nuovo è uno che non sa niente?” “Sa che il mondo è retto da un’unica legge.” “Sentiamo.” “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.” “E basta?” “No.” “Cos’altro?” “Non gli basta.” Che bello se la storia finisse così! Sarebbe come l’inizio di un mondo nuovo. Ma purtroppo non ho ancora sentito nessun toc toc toc sulla porta di casa. Ciò mi fa tornare coi piedi per terra. E come accade di solito, quando precipito dalle vette dei miei sogni ad occhi aperti tendo a sprofondare sotto il livello dei piedi. Mi sento annientata, svuotata, irrimediabilmente disperata. Neanche la mia terapia cinica riesce a salvarmi dall’avvilimento. Non è vero che, se nulla ha senso e nulla valore, insieme alla gioia perdiamo anche il tormento. Aveva ragione quella maitresse americana quando diceva che una puttana che pensa è una puttana triste. Ora la fantasia corre al mazzetto di stramonio che è rimasto sul tavolo di cucina. Ce n’è quanto basta per farne una pozione letale. E se mi decidessi a dargliela vinta? Magari potrei farlo domani, quando si sarà completamente esaurito l’effetto dell’antidoto nelle vene. Ma forse domani lui verrà. Ecco che mi lascio di nuovo travolgere dall’inclinazione a sognare ad occhi aperti. Ah, che sogno sarebbe poter dire FINE 371 ALLEGATO NUOVO CORSO DI FILOSOFIA NEL BOUDOIR 373 Capitolo I DEL DESTINO DELL’UOMO: LA DONNA C’è del nulla in tutti i soggetti. Non dico ‘Soggetto’: questi morì uccidendo Dio, prendendone coscienza. Ma proprio ‘i soggetti’. Attendiamo un omicidio definitivo. C’è del nulla in ogni uomo. Ma col nichilismo compiuto nasceranno uomini nuovi: quando avranno imparato a non essere per se stessi, a trasgredire tutte le leggi, a infischiarsene di tutti i valori, a rinunciare a ogni fine. E anche qui: non la Legge, il Valore, il Fine, ma molto di più. Però si tratta precisamente di quel famoso salto che la filosofia non può fare. Si tratta di farlo, non di pensarlo. Per farlo si dovrà rinunciare ad agire: l’azione infatti è un movimento verso un fine sostenuto da valori e regolato da leggi. L’abbandono sostituirà l’azione. E anche la volontà di potenza, quest’ultimo baluardo dell’essere, se ne va con l’azione. Gli uomini nuovi rinunceranno all’essere e a ogni suo strascico. Allora verrà il momento della donna. Lei sa, la donna, cosa vuol dire non essere, e in quest’impresa si troverà in una posizione privilegiata. Non è rinunciando a essere ciò che altri hanno deciso per lei, che la donna si libererà, ma essendolo fino in fondo. Così libererà l’uomo. Dall’io femminile partirà l’ultima azione, dalla coscienza della propria nullità. Questa presa di coscienza è una non-azione sommamente disgregatrice. Solo annientando in se stessa ogni residuo di umanità la donna si libererà. Così soltanto potrà liberarci. Quando non ci saranno più oggetti, gli uomini impareranno a non essere dei soggetti. 375 Altro, oltre, altrove: questo è la donna nel mondo degli uomini. Perciò è sacra. E sulla sacralità di lei poggia ogni metafisica, fonte e prodotto dell’immaturità dell’uomo. Però l’oppressione della donna poggia sull’immaturità dell’uomo. E lei, in quanto coltiva la propria sacralità, si fa strumento della propria oppressione. Se lei si piega alla volontà dell’uomo, lo fa rendendosi preziosa, desiderabile, inavvicinabile. L’uomo la desidera come una parte di sé perduta. Solo perché lei non gli si dà lui la vuole. È con l’uomo e con se stessa che la donna deve lottare. L’uomo ha bisogno di conquistare la donna, di corteggiarla, di adularla, di sedurla, di violentarla. Ha bisogno di possederla. L’uomo non ha la donna presso di sé. Per questo ha bisogno di prenderla. Contro tutto ciò lei deve lottare. Che ne resta della donna, una volta conquistata? La donna conquistata ne deve pagare la colpa. Da quel momento sarà eternamente in colpa. Per questo si darà. La dedizione è il destino della donna conquistata. Così l’uomo la pretende come un risarcimento per la perdita del sacro, la dedizione della donna; la donna la concede come un’espiazione. L’uomo ha bisogno di ottenerla, la donna di darla. La donna, appena conquistata, come in una pena del contrappasso, diventa lo scrigno di ogni delizia, o almeno la parvenza. Esisterà per dare piacere. Per questo non potrà mirare al proprio piacere. Farà l’amore per l’uomo. A lui darà il piacere. Ma se la vera causa dell’oppressione della donna non è la dedizione, bensì ciò che la causa, la sua sacralità, allora solo dandosi liberamente la donna potrà liberarsi. 376 E quando l’uomo non avrà più bisogno di cercarla, di cercarla altrove, quando l’avrà presso di sé, imparerà a riconoscersi in lei e non dovrà più volerla conquistare. Liberamente la donna si darà. Chi lo fa è una free prostitute. Non è per l’altro. Non è per sé. Non è oggetto. Non è soggetto. Free nel senso duplice di ‘libera’ e ‘gratis’. Lei si dà all’altro senza freni e senza prezzo. Questo non è libero amore, è il suo opposto: la free prostitute non si dà a chi vuole, ma a chi la vuole. Cosa abolisce la free prostitute? Abolisce la necessità della conquista, insieme al premio. Non chiederà altro prezzo, ai propri clienti, che il piacere. Dandosi liberamente, rifiuterà ogni dedizione. La totale disponibilità di lei non sarà altro che una forma di egoismo senza limite. L’uomo che la frequenterà imparerà a sue spese che il proprio piacere non è più neanche concepibile se non in funzione del piacere altrui. Alla fine solo gli uomini liberi frequenteranno le donne. La free prostitution, se accadrà che si avveri questo sogno, può essere la salvezza dell’umanità: con essa l’umanità imparerà a perdersi. Le donne che realizzano questa filosofia si fanno pubblicane, peccatrici immonde. Esse non subiscono imposizioni, né riconoscono leggi, valori e fini nel decidere che fare, neanche le leggi, i valori e i fini che possono provenire dalla propria identità. Questa filosofia potranno realizzarla le donne che si fanno pubblicane, esattrici esose. Loro si danno a tutti. In cambio vogliono tutto. Guai all’uomo che le frequenta senza rinunciare a se stesso. Il sogno sarà conquistato quando anche gli uomini avranno imparato a darsi senza freni e senza prezzo. 377 Tutta la storia, ma la storia scritta, è storia della preparazione della donna a questo atto. È dall’istante della nascita che l’uomo si è messo in attesa di questo momento. Lo ha desiderato e sognato. E lo ha preparato educando la donna al vuoto e alla ribellione. Ora che finalmente vede il paradiso, l’uomo si fa impaziente, e freme, e grida: Donne, ancora uno sforzo… se volete essere pubblicane. 378 Capitolo II DELLA LETTERATURA BREVE STORIA DI UN LUNGO INGANNO È col suo primo atto di liberazione che devasterà le nostre lettere la donna. E porterà a compimento il lungo processo di rivelazione attraverso cui la regina delle scienze umane giungerà infine a realizzarsi nel proprio annullamento. Questa disciplina aspirava a dire la verità, e s’era costruita nella menzogna il proprio metodo. La disciplina del metodo piegava lo scrittore a dire la verità mentendo. Egli non capiva che precisamente in questa ambizione a dire la verità stava la menzogna più profonda. Il Trecento diede avvio alla vicenda che avrebbe portato alla perdita dell’aura. Cominciò con la produzione di merci. E bisogna dire chiaramente che le condizioni di quella perdita non si danno nel processo lavorativo bensì in quello di valorizzazione. Cominciò nel Trecento, ma cominciò appena, quando si prese la vita della gente comune a oggetto d’indagine. Cosa fu il Decamerone se non la prima rivelazione delle aspirazioni scientifiche di questa disciplina? Ogni campo d’indagine ha la sua scienza. Le relazioni sociali pertengono alle scienze sociali: in quanto merci, all’economia; in quanto ruoli, alla sociologia; in quanto vita, alla letteratura. La vita, cioè lo spirito inteso come secrezione degli scambi sociali: si trattava solo di scriverla. Questa era la materia della scienza di Boccaccio e di Shakespeare. Però è anche col metodo che si identificano le scienze. Quello delle lettere è il modo della scrittura. Poiché scrittura è descrizione, la buona descrizione deve essere buona scrittura. Solo in quanto tale essa potrebbe rivelare il vero della vita. Il bello era il metodo del vero. La menzogna della scienza borghese, così, fu duplice! Poiché la vera materia era solo la falsa coscienza degli oggetti descritti; e il 379 metodo solo la forma assunta dalla sua speciale retorica nel tentativo di autoccultamento. Poi ecco la seconda fase: il romanzo. Il dovere scientifico alla verità già si piegava consapevolmente al servizio di un’ideologia. Così la storia naturale dell’umanità si tramutò in una sorta di entomologia sociale. Un passo indietro e due avanti, comunque. Il verismo fu il massimo della menzogna: si faceva passare per spiegazione, ora, l’ossequio più spudorato al senso comune. Questo era il passo indietro. Per le pretese filosofiche, però, fattesi più limpide, vennero i primi segni di cedimento. Dalle crepe della falsa coscienza trapelavano squarci di luce. Gli scrittori più acuti sapevano che i fatti che contano sono quelli che accadono nella testa della gente. E questo fu il primo passo avanti. Dostoievski chiuse l’era aperta da Cervantes. Quando entrò nei mercati, abbandonando le corti, il metodo divenne stile. Questo fu il secondo e il più importante dei passi avanti, perché dietro l’apparenza dell’imitazione connotativa cominciò a fare capolino la vaga intuizione della produzione di merci. La terza fase l’annunciò, con un secolo d’anticipo, il Divino Marchese. Il quale mise in chiaro tre cose: che il sociale risiede nell’individuo, che lo spirito si nutre del suo corpo, che la scienza è discorso. Ma restava ancora un passo da fare per il raggiungimento della perfetta consapevolezza: la presa d’atto della natura di merce del prodotto letterario. Fu solo con tale consapevolezza che l’aura poteva andare veramente perduta. Altro che rivoluzione tecnologica! Si trattava di capire che la disciplina nella rappresentazione della vita non era che la forma, anzi, la confezione, con cui l’ideologia borghese poteva essere rivenduta alla borghesia come verità. Questo fu il passo più lungo e difficile. Già de Sade sapeva di scrivere per un pubblico particolare. Poi vennero i romanzi a puntate, e l’interazione tra consumo e produzione di- 380 venne più stretta, il contenuto di una puntata venendo a dipendere dalle reazioni del mercato alla puntata precedente. Il processo si era quasi concluso quando Jack London decise che non avrebbe lavorato per scrivere il Grande Romanzo Americano. 1000 parole al giorno, dieci cents a parola; e quando perdeva a poker, gli straordinari. Jack London assunse su di se con la gioia del martire il fardello dello scrittore libero: la coscienza di produrre merci. C’eravamo quasi. Ecco invece che venne il Novecento, la grande reazione antiborghese dello scrittore borghese. Quelli che avevano capito furono relegati nelle note a pie’ di pagina come scrittori minori. E si cercò di ricreare una sorta di aura posticcia. La descrizione del sociale era solo riproduzione di un’ideologia? Allora: via il sociale! Si trattava dell’ideologia della borghesia? Allora: via la borghesia! Peggio, una borghesia vincente? Allora: via l’eroe! Si ridusse a studiare l’animo umano, il romanzo. Distrutta l’oggettività del sociale, restava un’ancora di salvezza: l’oggettività dell’io, se non proprio la sua semplice esistenza. Ma si era solo sostituita all’imitazione della sociologia quella della psicologia, la più tremenda delle scienze borghesi. Dall’entomologia sociale si passò alla teratologia spirituale. Ahimé, poi non parliamo del metodo. La forma era solo una gabbia del pensiero? Ed ecco l’avanguardia! Il grande equivoco della quale fu questo: che dietro la legittima aspirazione a liberare le parole dal Bembo e dal Petrarca e le idee dal capitale e dal partito, si nascondeva la velleità di rigenerare l’aura perduta. E si sa: nel trito romanzo borghese lo scrittore poteva mentire; il lettore lo sapeva e faceva finta di niente. Ma restava saldo un principio di onestà, di sana moralità mercantile: si scriveva per farsi leggere. Il lettore pagava e lo scrittore era tenuto a fornire una merce fruibile. Il mercato comunque assicurava il rispetto della legge: niente vendite, niente pubblico; niente pubblico, niente lettore; niente lettore, niente scrittore. 381 Fu basata su una nuova convenzione la letteratura d’avanguardia: non più il patto di sospensione dell’incredulità fra scrittore e lettore, ma un patto di sospensione dell’onestà. Lo scrittore non scrive per farsi leggere, perché non vuole produrre merci. Il lettore non compra per leggere (è noto che nessuno ha mai letto Laborintus fino in fondo, neanche Sanguineti, neanche in bozze). Perché mai allora uno comprerebbe un libro d’avanguardia? Ebbene: per poterlo citare dentro un altro. Con l’avanguardia non si legge più, si scrive soltanto. E la citazione è fondamentale: serve all’identificazione, è un segno d’appartenenza al club degli scrittori antiborghesi. È così che si pensava di aver ricostituito l’aura: un prodotto che non è più merce ed è fruibile solo da un’élite. Il nuovo autoinganno fu reso possibile, in realtà, da un nuovo fenomeno sociale: la nascita dell’intellettuale-massa. Cosa garantirebbe altrimenti le dimensioni minime del mercato? I nuovi poeti non sapevano che la produzione crea il proprio mercato e che è in grado di preservare il suo carattere di massa solo in quanto sa produrre merci diverse per segmenti diversi del mercato. La produzione di massa crea mercati specializzati e merci speciali: Asimov per i bancari, Maigret per i pensionati, Alberoni per le casalinghe, Queneau per gli intellettuali. Però l’avanguardia fu il canto del cigno dell’illusione che la letteratura sia altro. Dopo c’è solo il riconoscimento di un fatto elementare: che nella mercificazione dell’arte non c’è la sua morte, ma la sua rinascita. È qui che entrano in scena le donne. Le donne, relegate alla più consueta delle loro funzioni, quella di riproduzione, sono state sempre escluse da ogni forma di produzione, quindi anche dalla letteratura (a parte, com’è ovvio, le note a piè di pagina). Ora è perché vogliono il potere di produrre che le donne danno l’assalto alla letteratura. Ed è perché vi cercano solo il potere di pro- 382 durre che la conquistano. Ed è perché la conquistano loro che la restituiscono a se stessa dopo secoli di virili menzogne. E la nuova letteratura non cercherà la verità, ma la produrrà, non vorrà descrivere mondi, ma crearli, non vorrà penetrare la realtà, ma giocarla. La nuova letteratura la butta in gioco. Per essa non c’è nulla di latente dietro il nulla manifesto, e tutta la sostanza che c’è sta nell’apparenza. Una scoperta, questa, che, mentre ci toglierà i fondamenti da sotto i piedi, ci libererà dal tragico della loro perdita. La nuova letteratura mira a molto di più che a rappresentare la vita: mira a inventarla. Andrà perduto anche il metodo, con l’oggetto d’indagine. Quando la sostanza non si distingue più dall’apparenza, non avrà più senso tenere separata la forma dal contenuto. Per questo, anche, la nuova letteratura sarà territorio di conquista delle donne. Solo chi cerca in essa la libertà potrà usarla per liberarsi da ogni disciplina. La rinuncia a scrivere il Grande Romanzo cambierà la forma del romanzo: lo disgregherà. Il nuovo romanzo, se così si potrà ancora chiamare, sarà giallo, rosa, nero e tutti i colori dell’arcobaleno, e saggio e trattato e poesia e musica. Infine, quando si sostituirà consapevolmente all’ambizione di scrivere il capolavoro quella di scrivere il best seller, allora, e solo allora, avrà veramente senso rinunciare allo stile in favore degli esercizi di stile. Il decalogo della nuova letteratura: Non esistono parole privilegiate. Si scrive ciò che si dice. Uno stile vale meno di molti stili. La connotazione non vale né più né meno della denotazione. Ogni pretesa di originalità è un’ammissione d’ignoranza. La musica non è privilegio di un genere. Non fatti, ma parole. Le parole sono idee. La sociologia e la psicologia sono peccati mortali. Scopo principale di un libro è di essere letto. Gli unici valori che contano sono quelli del mercato. Scrittori non si nasce, si nasce analfabeti. 383 Capitolo III DELLA SCIENZA: CHE NON SI DISTINGUE DALL’ARTE Perché mai si dovrebbe dar credito all’illusione idealista secondo cui l’attività umana è mossa da tre distinti fini supremi? Il fine è uno solo: l’utile. Il bello è il mezzo. Quanto al vero, solo da poco tempo si è scoperta la tragica ed esaltante verità: che la verità della verità è la sua utilità. Non c’è che l’azione umana alla base di tutto. Un’azione presuppone una decisione, e questa uno schema d’azione, cioè un insieme di segni strutturato nella forma di una relazione tra determinati fini e i mezzi per perseguirli. La teoria è prassi: una legge è uno schema d’azione astratto da fini particolari, un insieme di segni che individua una relazione tra mezzi e fini indeterminati. Nell’indeterminatezza dei fini sta il segreto della scienza. Dei fini indeterminati non sono concepibili come fini di un’azione determinata, non sono proprio concepibili come fini. I fini accade che siano camuffati e trasformati in effetti. L’indeterminatezza si tramuta in generalità, mentre i mezzi assumono la forma di cause. Lo schema d’azione diventa legge scientifica. La stessa accettazione, lo stesso riconoscimento della verità di una teoria svolge una funzione pratica. Per intraprendere un’azione sulla base di una teoria bisogna essere convinti che la teoria funzionerà, bisogna essere convinti della sua verità. Insomma la verità si riduce a un giudizio di valore e assume il valore pratico che effettivamente le compete: quello di un’esperienza. E si sa: la comunicazione scientifica svolge un ruolo essenziale nell’attività di ricerca. Una scoperta che non viene comunicata resta coperta e quindi inutile. Per farla accettare dalla comunità scientifica lo scienziato cerca di stabilirne la verità. 384 Così, stabilire la verità di una teoria significa convincere molti soggetti dell’efficacia degli schemi d’azione da essa implicati, di rendere intersoggettivo il giudizio sul suo valore di verità. Ebbene, due sono i concetti di verità usati nella scienza: verità come necessità, verità come senso; necessità dei nessi individuati dalla teoria, senso dell’esistenza dei fenomeni. È nella verità nel primo significato che si manifesta la sua dimensione formale. Il mezzo di comunicazione è un gioco linguistico; il modo, l’estetica. L’estetica non è altro che la retorica della verità. Varrà come vera una teoria che piace. Il gioco linguistico viene usato per imitare i nessi interni dello schema d’azione. L’uso rigoroso delle regole del gioco mira ad esprimere con efficacia la necessità dell’azione prefigurata dallo schema. Tanto più rigorosamente è mostrata tale necessità, tanto più convincente e accettabile è una teoria. Una teoria accettabile è una teoria che può piacere. Una teoria accettata è considerata vera. E una singola teoria non dice alcunché sul mondo. Una singola teoria si riferisce a un particolare fenomeno. Il mondo è l’insieme dei fenomeni. Il mondo di una disciplina è l’insieme dei fenomeni che appartengono al suo campo d’indagine e d’azione. Solo un sistema teorico, cioè un insieme ordinato di teorie, può dire qualcosa del mondo. Se uno si convince che il fenomeno cui si riferisce una teoria rileva, cioè che la sua esistenza è rilevante per lui, allora e solo allora quella teoria acquista senso. Quando ciò accade, si dice che la teoria è vera nel secondo significato. Un fenomeno irrilevante è un fenomeno inesistente. Visto che i fenomeni non possono essere individuati se non in relazione gli uni agli altri, nessuna singola teoria può acquistare valore di verità se non all’interno di un sistema teorico. D’altra parte è anche vero che i fenomeni non possono essere definiti che dalle teorie. Ma, 385 se un sistema teorico non è altro che un insieme di teorie, la sua capacità di attribuire valori di verità non può provenire dall’esterno di esso. Per un sistema teorico che si rispetti, la pretesa di essere un riflesso del mondo è più ridicola che riduttiva. Un sistema teorico è molto di più di ciò: è la creazione di un mondo, il mondo di un soggetto. Un soggetto vede il come del mondo, non l’essere, e lo vede in funzione dei suoi fini. Il mondo viene ricreato mentalmente in vista dell’azione che si vuole svolgere in esso. Poiché soggetti diversi possono avere scopi contrastanti, è possibile che vengano costruiti sistemi teorici, non solo diversi, ma alternativi. D’altronde un sistema che viene accettato da molti soggetti non è altro che un sistema di verità intersoggettive. Le regole dei giochi linguistici non esauriscono il processo che porta all’accettazione o al rifiuto definitivi. Il rispetto delle regole del gioco è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accettazione di un sistema. Diversi sistemi alternativi possono essere tutti perfettamente in regola dal punto di vista formale e tuttavia implicare verità alternative. La verità di un sistema teorico implica un atto di fede. Un tale atto di fede è un’azione. Infatti porta il soggetto ad accettare una particolare visione del mondo e quindi a predisporsi ad un particolare atteggiamento pratico. B musica poesia pittura architettura letteratura antropologia psicologia sociologia economia biologia fisica E Figura 1 386 Non esistono dei confini netti tra arti e scienze. Arte e scienza non sono cose sostanzialmente diverse, a parte le ovvie differenze dei giochi linguistici usati. Le altre differenze sono solo di grado. E sono differenze del tutto estrinseche: attengono al peso con cui si combinano il fattore estetico, B, e quello pratico, E, nella rappresentazione che le diverse discipline danno di sé. Queste differenze riguardano solo la superficie. L’apparenza più superficiale è che le varie discipline si distribuiscono su una scala di valori in cui la relazione tra B ed E assume la forma di una mappa, B=B(E), B’<0, che è mostrata in figura 1. Ma questa apparenza nasconde un’altra realtà. Se si definisce Z come il grado di privatezza dell’esperienza, allora si può vedere che dietro la mappa B(E) ce ne sono altre due, B=ß(Z), ß’>0, e E=E(Z), E’<0, con Z=E-1(E)=µ(E). Le due mappe sono mostrate in figura 2. B E musica fisica letteratura letteratura fisica musica Z Z Figura 2 Evidente che B(E)=ß(µ(E)). La figura 3 mostra come si ottiene la 1 dalla 2. ß(Z) e µ(E) rappresentano ancora uno strato piuttosto superficiale della realtà. Bisogna scavare più a fondo. Le varie discipline differiscono soprattutto nell’oggetto d’indagine. Il quale oggetto può essere più o meno duro, materiale, concreto, ovvero più o meno soft. Evidentemente Z è una mappa del grado di softness, N, cioè Z=F(N), F’>0. 387 Questo tipo di diversità può essere anche misurato tecnologicamente o economicamente. Con l’inverso di N infatti crescono le dimensioni e il costo degli apparati hardware di cui si servono le varie discipline. B ß(Z) B(E) Z E Z=Z µ(E) Z Figura 3 A questo terzo strato della scienza non ci si può ancora fermare: è ancora piuttosto superficiale. Bisogna scavare più a fondo. Dov’è l’utile della musica e della poesia? Per quali azioni esse dovrebbero creare schemi d’azione? Di cosa danno conoscenza? Per i campi d’indagine e d’azione delle arti si può dare una definizione basata sul senso comune: le arti si occupano degli stati d’animo e dell’esperienza interiore. Le azioni da esse suscitate sono cambiamenti d’umore, conquiste dello spirito. Sono fenomeni mentali, ma non per questo sono meno reali. Non meno solida la conoscenza proveniente dalle arti, la quale consiste in nient’altro che in quell’improvvisa illuminazione che spesso s’accompagna all’esperienza di un mutamento psichico. Né l’individualità dell’illuminazione costituisce una peculiarità dell’arte. Anche 388 qui la verità è un’esperienza che va oltre l’individuo solo in quanto accede all’intersoggettività. La conoscenza nell’arte è solo la coscienza del cambiamento che produce. Precisamente come nella scienza. E ora un’ultima parola su una vexata quaestio: l’unità della scienza implica unità del metodo? Se il metodo è l’insieme dei criteri volti alla giustificazione della verità, un metodo indipendente dai sistemi teorici sarebbe metascientifico. Ma se ogni sistema produce i propri metodi, allora l’unico criterio metodologico che può unificare le scienze è il principio di Mao-Feyerabend: che cento fiori sboccino. Se non esiste un unico metodo in ogni disciplina, figuriamoci uno per tutte. 389 Capitolo IV DELLA CONOSCENZA OGGETTIVA: CHE NON SI DÀ (DIALOGO TRA UNO SCIENZIATO E UNO SCETTICO) SC1. Tutte le cose esistenti costituiscono l’universo, chiamiamolo U. SC2. Ciò implica l’assunzione che esistano delle cose. SC1. No. Non è che una definizione. Per ora l’universo può anche essere vuoto, cioè 0⊆U. SC2. OK, vai avanti. SC1. Dell’universo si può dire che i suoi elementi, cioè le cose, si dividono in due sottoinsiemi, i soggetti, S, e gli oggetti, G. I primi sono in grado di concepire delle mappe dai secondi in se stessi. SC2. Dunque S⊆G=U. SC1. Esatto. E ora – Cogito, ergo sum – posso dire. Perciò 0≠U. SC2. No. Il pensiero è una proprietà del soggetto. La sua presenza non implica nulla riguardo ad alcuna realtà oggettiva. Non posso provare l’esistenza di una realtà oggettiva, cioè indipendente dal mio pensiero, anche soltanto la realtà della mia esistenza, a partire dal mio pensiero. Se parti dal pensiero puoi solo dire: Cogito. SC1. Mi dispiace, ma dovrò pur cominciare da qualche parte. SC2. No problem. Puoi assumere di esistere come oggetto pensante. E sottolineo ‘assumere’. Allora puoi dire: Sum, ergo cogito. SC1. E va bene. Esisto come oggetto pensante. Io, I, esisto. Dunque 0≠I⊆S⊆G=U e U≠0. Mi segui? SC2. Come un’ombra. Ma tieni a mente che 0≠I⊆G è solo un’assunzione. Ha lo stesso valore della proposizione: Dio esiste. Comunque, se deve essere un’assunzione utile, tanto vale che sia anche S⊂G. Così eviti il solipsismo. 390 SC1. OK. E vada per S⊂G. Allora, se posso procedere, adesso dirò che l’universo è immerso in uno spazio oggettivo, oR3. SC2, Qual è la struttura di oR3? SC1. Due passi per volta, al più! Prima di rispondere alla tua domanda devo sapere come si osservano gli oggetti in oR3. Un’osservazione, C, è una mappa dallo spazio oggettivo allo spazio soggettivo, 3 3 3 3 sR . Cioè C: sR → oR . Lo spazio soggettivo è il codominio di oR . È euclideo, come risulta dalla comune esperienza. Che ne dici? SC2. Finora vai benone, salvo il fatto che non hai ancora risposto alla mia domanda. E poi, se parli di osservazione come di una mappa, devi tirare in ballo la teoria. SC1. E veniamo alla teoria, T. È una mappa più o meno complessa dallo spazio del codominio dell’osservazione in se stesso, T: sR3 → sR3. SC2. Naturalmente T pretenderà di essere un omeomorfismo. SC1. Perché mai? Potrebbe bastargli di essere iniettiva. La conoscenza non ha bisogno di essere perfetta per essere oggettiva. SC2. Non capisco di cosa stai parlando. Non so ancora cos’è la conoscenza, figuriamoci quella oggettiva. Comunque, ciò di cui stai trattando ora è soltanto la conoscenza teorica. In cosa consiste? SC1. La conoscenza teorica è un’immagine attraverso T. Quella osservativa, un’immagine attraverso C. Di conseguenza d’ora in poi possiamo ignorare T e concentrarci su C. SC2. In realtà dovremmo risalire oltre C. Infatti le osservazioni partono dai dati sensoriali, non dalla realtà oggettiva. Ciò vuol dire che, prima di capire cos’è la conoscenza, dovremmo sapere cos’è la coscienza, cioè la percezione dei dati sensoriali. Si porrebbe quindi il problema di definire la coscienza come, eventualmente, una mappa di ordine superiore dallo spazio oggettivo in quello percettivo. Ma capisco che ciò non farebbe che spostare in avanti il problema senza modificarne la natura. Perciò ti concedo di ignorare il problema della coscienza, oltre quello della teoria. E facciamo anche finta che sia ragionevole assumere la possibilità di un riflesso di C su T e non il contrario. 391 SC1. Se riesco a dimostrare, ora, che C dà una genuina conoscenza, posso sostenere che il lavoro scientifico e teorico è uno strumento conoscitivo. SC2. Cos’è una genuina conoscenza? SC1. La conoscenza può essere considerata genuina solo se è oggettiva, cioè solo se il codominio di C riflette il dominio fedelmente e indipendentemente dal soggetto che la formula. SC2. Ora sì che ti sei messo in un bel guaio. SC1. No. La definizione della conoscenza che ti ho appena dato è fedele al senso comune. SC2. Appunto. SC1. Non capisco la difficoltà. Dov’è? SC2. Emergerà non appena ti porrai il problema di spiegare in cosa consiste la fedeltà del codominio e la sua indipendenza dal soggetto. Se non vedi la difficoltà è perché assumi implicitamente che, se non T, almeno C sia un omeomorfismo. SC1. Che ci sarebbe di male? Puoi assumerlo anche esplicitamente, se vuoi. SC2. Ciò naturalmente ti toglie da ogni imbarazzo con la giustificazione dell’oggettività della conoscenza. Ma così facendo, come dicono gli inglesi, you are begging the question. SC1. Spiegati meglio. Cos’è che non va? SC2. Se C è un omeomorfismo, allora il codominio di oR3 può riflettere abbastanza fedelmente il dominio. Però solo se il codominio di oR3 è riflesso fedelmente puoi essere certo che C è un omeomorfismo. Così finora l’unica cosa che garantisce l’oggettività della tua conoscenza è un’assunzione arbitraria, un’assunzione la cui indipendenza dal soggetto è essa stessa non giustificata. 392 SC1. Non dispererei. Si può fare ricorso all’esperimento. Un’osservazione, C, implica qualcosa sulla struttura di U e quindi di oR3. Con un esperimento posso verificare se quella implicazione è valida. SC2. Come? SC1. Producendo dei fenomeni che poi... SC2. Allora stai dicendo che, sulla base di un’osservazione, C, si può costruire una teoria, T, che individua dei nessi causali tra elementi del codominio di C. Se, usando la teoria, sei in grado di produrre dei fenomeni in oR3 la cui immagine in una nuova osservazione, C’, corrisponde a quella di C, concluderai che l’osservazione è verificata. SC1. Con te si può ragionare senza perdere tempo. Mi piace. SC2. Resta vero che la tua conoscenza sperimentale è ancora l’immagine di una mappa. Cosa garantisce che C’ non deformi la realtà, se C la deforma? Di nuovo: devi assumere che C’ è un omeomorfismo. E ti ritrovi da capo a dodici. SC1. Un esperimento può esser fatto da diversi scienziati! SC2. E con ciò? Se ogni scienziato ha una sua personale C deformante, cosa impedisce che anche la sua personale C’ sia deformante? Per di più entra in ballo la questione della comunicazione scientifica. Dammi una definizione di comunicazione scientifica. SC1. Comunicazione è trasmissione di conoscenza. Esistono delle regole linguistiche che consentono di istituire delle mappe, M, dagli spazi delle teorie e delle osservazioni di un soggetto a quelli di un altro, cioè M: sR3 → sR3. SC2. Ciò non fa che complicare ulteriormente la faccenda. Ora bisognerebbe anche dimostrare che M stesso è un omeomorfismo, sebbene questo problema non è insormontabile. Poiché M dipende da regole prodotte dai soggetti stessi, cioè da convenzioni, si può stabilire, per convenzione, appunto, che sia un omeomorfismo. SC1. Capisco dove vuoi arrivare: con ‘oggettività della conoscenza’ intendiamo qualcosa di puramente convenzionale. 393 SC2. No. Voglio arrivare alla conclusione che l’oggettività della conoscenza è un nonsenso. Poiché ogni conoscenza, per tua stessa definizione, è il risultato di una mappa istituita da un soggetto, di conoscenza oggettiva non si può neanche parlare. SC1. Però, se fosse così, non si potrebbe parlare neanche di conoscenza tout court. Dunque cosa conosciamo? Conosciamo? SC2. Hai messo il dito nella piaga. Se non sappiamo niente di certo e oggettivo sulla natura di C non sappiamo niente di certo e oggettivo neanche sulla struttura del suo dominio. E viceversa. Tuttavia non disperare. Possiamo sempre fare delle ipotesi e stabilire delle convenzioni. Nemmeno l’esistenza di U è self evident. Ricorda che è stata data per assunzione essa stessa. La conoscenza è convenzionale e inter-soggettiva. Nulla di più. SC1. Ecco un risultato appena insoddisfacente. Che conoscenza sarebbe quella per cui non sai nulla con certezza della natura dell’oggetto? SC2. Quella che mi basta per agire. L’uomo sta nel mondo come un cieco in un labirinto. Ha bisogno di farsene un’idea per muovercisi. Nulla garantisce che una certa idea rifletta fedelmente la realtà. Ma non qualsiasi idea va bene. Quelle che fanno dare capocciate al muro sono scartate. SC1. Mi sembra che col tuo modo di non ragionare dovresti arrivare a una conclusione ancora peggiore: visto che 0≠I⊂G è un’assunzione arbitraria, nulla garantisce che un’idea del mondo, e, anzi, il mondo stesso, non sia un sogno. SC2. Perché peggiore? Perché mai dovresti avere bisogno di garanzie ontologiche, se il vero problema è solo quello di muovercisi, nel mondo? 394 Capitolo V DELLA COSCIENZA: COME SQUARCIARLA Siano X1, X2, X3 le dimensioni della realtà che percepiamo in un ordinario stato di coscienza, OSC; X4 quella (una, per semplicità) che percepiamo in uno stato alterato di coscienza, ASC. Sul significato delle Xi, i=1,...4, non si può dire nulla in generale, visto che il tipo di esperienza che ne facciamo dipende dallo stato di coscienza. Per comodità, e in ossequio al senso comune, si possono pensare come delle dimensioni spaziali delle immagini degli oggetti. Si ipotizzerà inoltre che la coscienza dipende da quattro parametri percettivi, Pj, j=1,...4. P1 è il grado di lateralizzazione cerebrale, con P1>0 in presenza di pensiero logico (prevalente lateralizzazione sinistra) e P1<0 in presenza di pensiero analogico (prevalente lateralizzazione destra). P2 è il negativo del grado di vigilanza mentale, con P2>0 in stato di sonno e P2<0 in stato di veglia. P3 è il grado di determinazione o volontà di ottenere un certo stato di coscienza. P4 è il grado di convinzione o fede nella capacità di ottenerlo. P1 e P2 sono parametri psicologici, P3 e P4 parametri culturali. Sia σ una particolare mappa che chiameremo ‘funzione di coscienza’ e scriveremo come (X1,...X4)=σ(X1,...X4;P1,...P4). Applicando lo splitting lemma di Thom, la σ diventa σ(X1,...X4;P1,...P4)=CatX4+ Σ(i=1…3)liXi2, dove li sono trasformazioni dei parametri. Si ha coscienza Xi-dimensionale quando Xi>0. In equilibrio percettivo di OSC si verifica che in Σ(i=1…3)liXi2 è Xi>0. Il problema si riduce quindi allo studio di CatX4, della quale si assume trattarsi di un potenziale, π. Per semplicità d’ora in poi il simbolo X4 verrà sostituito dal simbolo X. Perciò si può scrivere CatX=π(X;P1,...P4). Si ponga che la coscienza sia il risultato di un processo psichico di minimizzazione del potenziale percettivo: di tutti gli attributi dell’og- 395 getto che sono potenzialmente percepibili, solo quelli selezionati dall’intenzionalità della coscienza vengono effettivamente percepiti. Perciò da CatX si ottiene il gradiente dX/dt=-∂π/∂X, e in equilibrio, quando il potenziale è minimizzato, -∂π/∂X=0. Per poter rappresentare graficamente la catastrofe percettiva che può verificarsi su X, conviene, per il momento, ridurre i parametri a due, limitandosi a quelli psicologici. In tal caso si ha CatX=(1/4)X4+(1/2)P2X2+P1X, che è una catastrofe a cuspide. I punti critici della catastrofe sono individuati dalla condizione -∂π/∂X= X3+P2X+P1=0, che viene rappresentata come la varietà V in figura 4. X 0 V P2 P1 B Figura 4 La proiezione della fold curve di V sullo spazio dei parametri dà origine all’insieme di biforcazione, B, mostrato anche in figura 5, nella quale sono indicati alcuni stati di coscienza e alcune traiettorie. OSC è l’ordinario stato di coscienza di veglia; si ottiene in tutto il quadrante Sud-Est con valori negativi di X. ASC1 significa ASC da sogno razionale, e implica anch’esso valori negativi di X. ASC2 significa ASC con ESP in stato di incoscienza (ad esempio: trance e 396 ipnosi) e implica valori positivi di X. ASC3 significa ASC con ESP in stato cosciente (ad esempio: telepatia e chiaroveggenza) e implica sempre valori positivi di X. ASC4 infine significa ASC con lucidità mentale (ad esempio: illuminazione da meditazione trascendentale o training autogeno) e si ottiene, per valori positivi di X, nell’area compresa tra il braccio destro dell’insieme di biforcazione e l’asse P2. P2 T1 ASC2 ASC1 T2 P1 OSC ASC3 T3 B ASC4 Figura 5 Ora si possono reintrodurre i parametri culturali. Saranno misurati in modo tale che le loro variazioni modificheranno la posizione e la forma dell’insieme di biforcazione nel seguente modo: una crescita di P3 aumenta l’ampiezza di B; una crescita di P4 sposta B verso il quadrante Sud-Est. Questi cambiamenti sono mostrati in figura 6. Le tecniche che si possono usare per ottenere un ASC4 sono di tre tipi: 1) tecniche di condizionamento psichico, 2) tecniche di condizionamento culturale, 3) tecniche di shock psico-fisico. Non sono alternative, e possono essere usate insieme. Nelle tecniche di condizionamento psichico si modificano i valori di P1 e P2 in modo da imprimergli una traiettoria che punta verso l’ASC desiderato. Tre di tali traiettorie, T1, T2, T3, sono mostrate in figura 5. 397 P3’> P3 P4’> P4 P2 P2 P1 P1 B(P3’) B(P3) B(P4’) B(P4) Figura 6 Nelle tecniche di condizionamento culturale si mira ad alterare l’atteggiamento verso la vita e la visione del mondo del soggetto in modo da modificare i parametri P3 e P4 nella direzione voluta. Testimonianze del ruolo giocato dai parametri culturali sono fornite dal fenomeno sheep-goat (che agisce su P3) e da fenomeni di psi-mediated instrumental response (che agiscono su P4). L’influenza esercitata dalla relazione sperimentatore-soggetto agisce probabilmente su entrambi i parametri. Di qui l’importanza di una guida. Nelle tecniche di shock psico-fisico si interviene sulla dinamica rapida della percezione in modo da innescare la catastrofe percettiva all’interno dell’insieme di biforcazione, possibilmente nel quadrante Sud-Est. Qui sono utili molti strumenti di destabilizzazione della coscienza: sesso, allucinogeni, deprivazione sensoriale, esasperazione dell’emotività, dolore, danza, musica ecc. Per mezzo degli strumenti di destabilizzazione della coscienza in parte si cerca di modificare P1 o P2 nella direzione voluta. Ma in parte, e soprattutto, si cerca di aumentare l’ampiezza del rumore bianco, che per ciò stesso cessa di essere tale, in modo da riuscire a toccare dal basso la sezione instabile della varietà V. Ciò è mostrato in figura 7 col caso di una tecnica sessuale. 398 X orgasmo P1 Figura 7 Il satori è una catastrofe della coscienza. In ASC4 si può raggiungere la verità. Se, dopo avere operato un cambiamento di coordinate, le Xi sono trasformate in variabili come “nomi e parole per prendere il mondo”, allora la verità può essere ridotta a una semplice formula. X ≡ X 4 = ( X1 − X 2 ) U ( X 3 − X 2 ) 399 INDICE Avvertenza 3 QUADERNO 1 Prologo in cielo Lunedì, 13 maggio Martedì, 14 maggio Mercoledì, 15 maggio Giovedì, 16 maggio Venerdì, 17 maggio Sabato, 18 maggio Lunedì, 20 maggio 5 11 26 39 51 63 76 85 QUADERNO 2 Mercoledì, 22 maggio Giovedì, 23 maggio Sabato, 25 maggio Lunedì, 27 maggio Mercoledì, 29 maggio Giovedì, 30 maggio Venerdì, 31 maggio Sabato, 1 giugno Domenica, 2 giugno Lunedì, 3 giugno 91 111 130 142 152 157 168 178 184 194 QUADERNO 3 Martedì, 4 giugno Domenica, 23 giugno Il leopardo perduto: Diario di safari Mercoledì, 26 giugno 205 221 223 272 QUADERNO 4 Venerdì, 28 giugno Sabato, 29 giugno Martedì, 2 luglio Mercoledì, 3 luglio Giovedì, 4 luglio Epilogo 275 295 313 326 341 366 ALLEGATO: Nuovo corso di filosofia nel boudoir Del destino dell’uomo: la donna Della letteratura: breve storia di un lungo inganno Della scienza: che non si distingue dall’arte Della conoscenza oggettiva: che non si dà Della coscienza: come squarciarla 373 375 379 384 390 390
Scarica