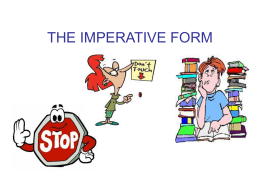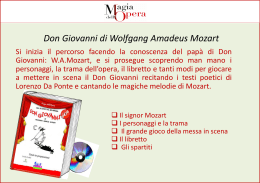Collana “Quaderni di Diogene” Anna Colaiacovo, Marco Giacintucci, Bruno Nasuti ST ILI DI V ITA Quanto libere sono le nostre scelte? Il Giardino dei Pensieri “... comme un arbre de son jardin” La ricerca dell’originalità e della novità, considerate massime espressioni della libertà, sembra dominare nella società ipermediale in cui viviamo; ed è pur vero che in nessun altro periodo della storia l’individuo ha avuto, almeno sul piano teorico, possibilità così grandi di orientare la propria vita in funzione dei propri desideri, ma chi stimola e plasma il desiderio? Copertina e impaginazione: Jimmy Knows S.C.P., Barcelona (ES) ISBN 978-88-98227-38-9 © Edizioni del Giardino dei Pensieri di Mario Trombino Via Nadi 12, 40139 Bologna I edizione, gennaio 2014 INDICE PREFAZIONE L’IDENTITÀ COME PROBLEMA Mente e società EROI, SUPEREROI, GENTE COMUNE 7 10 10 25 Il potere delle immagini 25 Il rebus dell’identità: Zelig, di Woody Allen 42 Economia dell’identità: imitare 51 Economia dell’identità: distruggere 67 Il compito dell’identità: progettare 82 Il compito dell’identità: decostruire 96 La contemporaneità IL DON GIOVANNI DI WOLFGANG AMADEUS MOZART Per uno stile di vita: Il Don Giovanni di Mozart STILI DI VITA 110 126 126 149 Riflessioni su alcune figure rappresentative della postmodernità 149 Il viandante: una possibile via per l’autenticità? 194 NOTE 202 BIBLIOGRAFIA 231 P REF AZIONE Quanto libere sono le nostre scelte? Per rispondere a questa domanda, la nostra ricerca è partita dall’antropologia, ovvero da una riflessione sulle forme che l’identità ha assunto storicamente, all’interno della civiltà occidentale. Le forme, in effetti, variano nel tempo: se nella comunità tradizionale l’identità veniva imposta all’individuo sulla base della nascita, all’interno di ruoli sociali non modificabili, e nella società moderna era possibile forgiarla da soli o con l’aiuto delle istituzioni, nella società contemporanea, liquida e frammentata, l’identità tende al mutevole, al molteplice, alla ‘emergenza’. La nostra ipotesi di fondo è che le differenze che si riscontrano non sono frutto della natura, ma sono il risultato della costruzione di codici simbolici attraverso i quali le varie ‘culture’ plasmano le menti. Quando parliamo di cultura, la intendiamo in senso antropologico, come ‘memoria non ereditaria della collettività’ (Lotman); in tutte le società, essa ha il compito di rispondere ai bisogni primari e di creare una certa omogeneità tra i membri della collettività, con l’obiettivo di generare ordine, consenso e di evitare conflitti. In questa direzione, la comunicazione che risulta più efficace è quella che fornisce messaggi uguali per tutti, in grado di dare certezze, di trasformare in 7 verità rassicuranti il timore che si avverte di fronte al ‘divenire’. In questo modo, la condivisione di uno stesso codice culturale porta alla naturalizzazione dell’artificiale, di ciò che è ‘costruito’ dall’uomo. Nel passato l’opera di ‘manipolazione’ delle menti, che è sempre frutto di una élite, è avvenuta tramite le religioni o le varie forme di ideologia; oggi, che sul piano teorico si hanno ampie possibilità di libertà per l’individuo, è il mercato a fornire un ‘pensiero unico’ che passa attraverso i mass media. Le immagini, che l’industria culturale crea, sono sempre più invasive e il linguaggio che, come sappiamo, è il codice primario attraverso il quale il flusso della realtà acquista un senso, è sempre più semplificato e omologato. Da sempre, invece, le arti e la filosofia hanno cercato di esaltare il dubbio per risvegliare le menti e individuare altri modi di leggere la realtà; ed è quello che abbiamo cercato di fare con la nostro ricerca, attraverso la de-costruzione delle immagini, la ricostruzione dei processi e la riflessione sui processi in atto. Sul piano pratico, abbiamo scelto l’indagine di dieci film in grado di rappresentare in successione dapprima la dimensione del problema dell’identità, successivamente le varie tipologie identitarie elaborate nel tempo, quindi le varie soluzioni antropologiche ovvero l’eroe epico della classicità, quello problematico della modernità e quello del super-eroe come via di fuga rispetto alla catastrofe della gente comune. Abbiamo dato un particolare rilievo, per il suo essere un modello esemplare della contemporaneità, alla figura archetipica di Narciso che di fatto accompagna l’evoluzione della società moderna a sottolineare il compito dell’uomo nella modernità e le estreme contraddizioni della modernità stessa. Il personaggio ha meritato una attenzione speciale, a partire dal Don Giovanni di Mozart, esaminato anche nella complessità della tessitura musicale. 8 Infine, abbiamo operato una riflessione su alcune figure rappresentative della postmodernità: il narciso, il giocatore, il turista, il palestrato, lo straniero (espressioni dell’homo psycologicus), per concludere che il soggetto sociale del nostro tempo è generalmente alla ricerca di una identità che abbia i caratteri dell’‘autenticità’, ma vuole facilmente attingerla ovvero ‘comprarla’ rapidamente e senza sforzo ricorrendo alle ‘mode’ proposte dall’industria culturale; mentre una identità autentica va costruita lentamente, con fatica, con l’angoscia del dubbio e con la consapevolezza della sua precarietà. A questa ‘fatica’ abbiamo dato un nome: il viandante. 9 PARTE PRIMA L ’IDENT ITÀ COME P ROBLE MA “Come si diventa ciò che si è? Perché questa paradossale domanda continua a interpellarci? Perché essa racchiude in qualche modo l’enigma dell’identità personale”. Roberta De Monticelli, La novità di ognuno 1. MENTE E SOCIETÀ La mente Le nostre azioni sono libere? La risposta a questa domanda mette in gioco la nostra natura di animal symbolicum (Cassirer), cioè di essere vivente che entra in contatto con l’ambiente, in modo diverso rispetto agli altri organismi viventi. Le ultime ricerche nell’ambito delle neuroscienze ci aiutano a comprenderne i meccanismi. Se negli altri animali, all’attivazione degli stimoli, corrisponde una risposta automatica in relazione al DNA ereditato (il software in dotazione elabora velocemente i dati in funzione dei bisogni elementari di sussistenza e sicurezza), nell’uomo la risposta è legata alla scelta più efficace in rapporto alla rappresentazione della situazione data (possibile 10 per l’ampia gamma di software di cui dispone e in funzione, certo, dei bisogni di sussistenza e sicurezza, ma anche di libertà e di senso). L’uomo entra in relazione con l’ambiente attraverso un ‘circolo funzionale’ composto da due elementi in continua interazione: un sistema ricettivo (i sensi sono le nostre finestre sul mondo1), tramite cui si percepiscono e si elaborano selettivamente gli stimoli sensoriali provenienti dal mondo esterno e dallo stato del proprio corpo2, e un sistema efficiente che elabora i dati provenienti dall’ambiente fino a dar loro un senso, un ordine. Ogni individuo, quindi, entra in contatto con le ‘cose’ dando loro forma, non direttamente, ma tramite una doppia azione di filtraggio, prima attraverso la propria elaborazione neuronale, una sorta di hardware ereditato, poi attraverso i codici elaborati dalla società storica entro cui si attua il suo processo di socializzazione. È evidente che, se il sistema recettivo seleziona i dati in ingresso e quello efficiente li struttura (e la funzione di sintesi è opera della corteccia cerebrale), quel che percepiamo del mondo fisico è una semplificazione del molteplice e del dinamico che ci circonda3, ed è altrettanto evidente che la conoscenza che ne scaturisce non è la realtà, ma una sua costruzione e rappresentazione4. In questo senso, antropologico, la conoscenza è cultura, ‘memoria non ereditaria della collettività’ (Lotman). La società Ogni uomo vive all’interno di un gruppo sociale e ne assimila gli atteggiamenti e i comportamenti. La recente scoperta dei neuroni specchio5 (che avvalora anche sul piano scientifico l’osservazione di senso comune che noi umani siamo esseri intensamente sociali) dimostra che esistono cellule del cervello che si attivano non solo quando facciamo qualcosa in prima persona, ma anche quando vediamo un altro compiere un’azione. Allo stesso modo, se osserviamo negli altri una manifestazione di 11 piacere o dolore, si attiva anche in noi la medesima reazione emotiva e probabilmente questo meccanismo, che mette insieme informazione visiva e motoria, è presente in più circuiti neurali. Possiamo dire che, attraverso l’osservazione, si imprimono nel cervello comportamenti, emozioni e meccanismi di funzionamento della società. Ogni individuo assorbe, quindi, la cultura del gruppo sociale a cui appartiene, cioè le forme che consentono a quel gruppo di risolvere i problemi fondamentali dell’esistenza, sia nei rapporti con l’ambiente naturale, sia per risolvere i conflitti che sorgono tra i suoi membri. È cultura l’insieme delle attività manuali e intellettuali che caratterizza ogni società indipendentemente dal grado di complessità delle sue forme: è cultura un’opera d’arte come lo è farsi un tatuaggio o portare i capelli in un certo modo. Ogni cultura si struttura in forma di sistema, vale a dire come un complesso di elementi interconnessi (che riguardano il diritto, la scienza, l’arte, etc.) in modo da proporre leggi, regole che diano senso all’esperienza. Questa costruzione di ‘messa in ordine’ opera innanzitutto una modellizzazione dello spazio-tempo, poi una rappresentazione determinata della natura, dell’individuo e della società; consente di stabilire regole, norme di comportamento per organizzare i rapporti tra il singolo e la collettività, in termini di bene/male, giusto/ingiusto; crea una situazione di consenso che elimina dubbi e incertezze; permette una comunicazione all’interno della collettività grazie alla condivisione di uno stesso codice culturale. Il linguaggio verbale Se ogni esperienza culturale si esprime nella costruzione di modelli6, di codici, il linguaggio verbale (la lingua naturale) è sicuramente il codice primario che ha la funzione di far ‘esistere’ le cose nominandole e ponendole in relazione. Sul codice primario, all’interno del quale il flusso della realtà acquista un 12 senso, si innestano poi le lingue secondarie (come quelle della scienza) che costruiscono un proprio sistema di simboli a partire dalla lingua naturale e consentono di cogliere altri ‘sensi’ tra gli stimoli provenienti dall’ambiente. Natura-cultura Di norma, però, le regole che vengono proposte all’individuo che si forma all’interno di un gruppo sociale non sono considerate un modello ‘costruito’, ma sono ritenute regole sostanziali della realtà: natura. Ma quanto di ciò che in altri tempi era considerato ‘naturale’, sappiamo oggi essere figlio di una determinata cultura e soggetto a cambiamenti? Un esempio lampante è la subordinazione della donna all’uomo, per lungo tempo ritenuta naturale o stabilita da Dio (in molte culture è ancora oggi così), quindi immodificabile7. La dicotomia Natura-Cultura ha dominato la storia del pensiero occidentale8: per natura si intendeva ciò che è immodificabile e per cultura ciò che è costruito dall’uomo; la terza strada individuata da Darwin ha rivoluzionato questa visione: nella formulazione del suo concetto di ‘Storia Naturale’ è implicita una modificazione della natura in forme casuali e imprevedibili. Oggi è chiaro che tutti gli elementi naturali, compresi quelli che sembrano invariabili in quanto caratteristici della specie umana, possono essere sottoposti a mutazione; inoltre ciò che caratterizza la condizione umana è la capacità di mutare la propria dotazione genetica con nuove acquisizioni intervenendo su se stessa e sul mondo. Pertanto se la storia è determinata dalla natura, la natura è a sua volta modificata dalla storia. Mutamenti sociali, politici e tecnici hanno demolito la visione dicotomica della realtà. Il colpo finale è arrivato dallo sviluppo delle neuroscienze e dalla “(…) sovrapposizione tra virtuale e reale nello spazio immateriale” (Esposito) della rete. 13 La ‘frontiera’ come ordine Sappiamo dall’antropologia che ogni società si struttura nel tempo e presenta quindi al suo interno sistemi culturali egemoni, espressione di chi detiene il potere e si considera depositario della verità, modelli in via di dissolvimento che saranno progressivamente sostituiti e modelli in via di formazione, espressione di gruppi che, all’interno della stessa società, esprimono bisogni nuovi e ambiscono a sostituire il sistema esistente. Ogni gruppo sociale considera la propria cultura unica rispetto alla ‘non cultura’ degli altri. La percezione di questa differenza fa sì che tenda a delimitare il proprio spazio ‘ideale’, la propria separatezza rispetto agli altri gruppi; per questo utilizza un meccanismo che permette il riconoscimento dei membri della stessa cultura e segna la diversità dall’estraneo: la frontiera. La linea di frontiera, che non è altro che un operatore semiotico che marca il passaggio da un territorio all’altro, produce, nella sua essenza, il passaggio da un modello conoscitivo a un altro. Lo schema con cui Lotman e Uspenskiy raffigurano la delimitazione di un modello culturale è questo: ES IN ES Lo spazio interno (IN), chiuso, è un insieme costituito da un numero finito di punti; è quindi conoscibile e controllabile. Il quadrato esterno (ES), costituito da un numero infinito di punti, corrisponde a una realtà non conoscibile e non controllabile; è ciò che esiste ‘fuori’ dello spazio organizzato. In definitiva 14 nessuna frontiera è naturale, essa è sempre il risultato di una complessa rete di significazione e comunicazione. Lo spazio più che essere, come suggerisce la filosofia kantiana, un apriori dell’esperienza, è una costruzione discorsiva. Un territorio che non possiede una forma spaziale provoca un senso di perdita di identità ed è probabilmente per questo che la società contemporanea, che esprime una tendenza alla globalizzazione, quindi alla eliminazione delle frontiere, tende, nello stesso tempo, alla ricomposizione dell’identità con la nascita dei localismi: dialettica globale/locale. Tre tipi di società Prendiamo ora come modello tre forme di società che si sono sviluppate nel tempo, ma che possono attualmente, per certi aspetti, anche coesistere nello spazio: la società comunitaria, la società moderna, la società postmoderna. Le esaminiamo schematicamente attraverso la rappresentazione che ognuna di esse dà dello spazio, del tempo, delle relazioni sociali e del potere9, per arrivare poi a individuare in che modo si forma l’identità personale all’interno di questi modelli. a) Società comunitaria Lo spazio, percepito con i sensi e con l’esperienza diretta (vicino/lontano), è gestibile e percorribile con sicurezza e facilità. Attraverso segni materiali, per esempio un muro, si dà forma al territorio e si distingue così un ‘dentro’, regno che acquista un ordine, e un ‘fuori’, regno del disordine naturale. La messa in forma del tempo procede attraverso la marcatura del concetto di ‘inizio’ che ha con sé quello complementare di ‘fine’. All’interno della gamma dei fenomeni esistenti vengono valorizzati quelli che hanno un inizio rispetto a quelli che non ce l’hanno: esaltazione delle ‘radici’ ovvero dei miti di fondazione ed esaltazione della tradizione, di ciò che si conserva e si ripete. 15 Le relazioni sociali sono segnate dall’appartenenza al clan, alla tribù, alla famiglia, alla comunità e si svolgono all’interno di uno spazio concreto controllato dai sensi che dà sicurezza e permette di gestire i conflitti sulla base della contrapposizione amico/nemico (vicino/lontano, dentro/fuori). Il conflitto sorto all’interno viene percepito come esterno e trasferito all’esterno (sociologia del ‘capro espiatorio’). Sul piano del potere, i depositari della conoscenza, che consiste nel percepire i messaggi degli dèi, rappresentano una casta magico-sacrale che interpreta i segni della natura e del tempo. Attraverso la ‘parola’ espressa in forma ambigua e in spazi definiti avviene una comunicazione carismatica che rinforza il senso di sicurezza della comunità10 e materializza la differenza tra chi parla (l’autorità) e chi deve ascoltare. Le decisioni vengono prese dai saggi, dagli anziani che contrappongono la loro autorevolezza ai rumores della folla. Non mancano, all’interno del gruppo, le voci dissidenti che in forma anonima ricorrono al carnevalesco per corrodere l’autorevolezza dei pochi prescelti. b) Società moderna Lo spazio non è più percepito solo con i sensi, ma attraverso una elaborazione concettuale che utilizza le scienze (geometria, matematica) per misurare, trovare relazioni, in una parola per razionalizzare la natura e renderla funzionale ai bisogni sociali: la società moderna nasce con la gestione ordinata dello spazio. L’elaborazione di uno spazio pubblico civile e la creazione della ‘nazione’ rendono possibile la regolamentazione delle differenze, permettono cioè che lo scontro/incontro delle diversità individuali e sociali si risolva con una continua mediazione tra esigenze diverse (come avviene nel libero mercato). Il tempo viene percepito in modo lineare, all’interno di un movimento avanti/indietro e si può rappresentare con una freccia rivolta verso il futuro. Ne deriva, sul piano individuale e sociale, la focalizzazione sul ‘progetto’ che dà senso all’esi16 stenza individuale e collettiva. Prendendo come riferimento il modello mercantile, il tempo è valutato sulla base del parametro dell’utilità (inutilità dello spreco e della soddisfazione immediata ed esaltazione dell’’investimento’ sul futuro). Il tempo buono è quello che, sia dal punto di vista individuale che sociale, produce un miglioramento delle condizioni umane, in una parola: ‘progresso’. Le relazioni sociali sono fondate non tanto su rapporti di empatia quanto di distanziamento. L’altro, essendo lontano dallo spazio concreto in cui si vive, è poco conoscibile, quindi portatore di ‘angoscia’, per cui i rapporti sono governati non dalle emozioni ma da regole impersonali (si ripete sia il modello del mercato, dominato dall’utile, sia il modello della scienza retto da categorie astratte). Il singolo costruisce la propria identità attraverso il confronto continuo con ‘l’altro’, che va conosciuto e affrontato. Il conflitto è gestito all’interno dello spazio comune, anche se rimangono tendenze proprie della società comunitaria (i lager e i gulag sono applicazioni moderne, tecnicamente elaborate, dell’antica pratica del capro espiatorio). Il fenomeno della presenza degli ‘stranieri’ viene affrontato con la strategia del dominio sociale (assimilazione/ esclusione). Nella modernità il potere è soprattutto macchina (Hobbes) e, come tale, sempre più impersonale, diffusa e pervasiva. Ogni struttura di potere, per esempio fabbriche, ospedali, scuole, organizza gli individui11 attraverso una disciplina del tempo, dello spazio e dei corpi (biopotere). D’altra parte l’istituzionalizzazione del diritto alla parola, la nascita della scuola pubblica (per la formazione del cittadino) e dello spazio pubblico (come luogo di confronto civile) permettono una dialettica continua tra potere, opinione pubblica ed esperti. Attraverso il confronto e il dibattito si possono mettere a punto, di volta in volta, soluzioni razionali ai conflitti presenti nella società. Il controllo autoritario, lì dove avviene nella modernità, passa attraverso la negazione del diritto alla parola e l’eliminazione, con la propaganda, dello spirito critico. 17 c) Società postmoderna Lo spazio viene percepito come ‘campo di forze’: mentre i movimenti della modernità riguardavano quadri di riferimenti chiari nelle loro strutture spaziali (le nazioni), ora, a causa dell’abbattimento delle frontiere e delle distinzioni, grazie alle nuove tecnologie che annullano le distanze e velocizzano la trasmissione di conoscenze e di merci, i movimenti sono improntati alla velocità e alla flessibilità con conseguente compressione spaziale. Lo spazio pubblico civile scompare; rimane come luogo di eventi, performance e non di argomentazione. Il tempo è inteso come flusso, evento, presente. Le relazioni sociali, in una situazione in cui si amplia a dismisura lo spazio fisico di riferimento e si accelerano i tempi di contatto con l’altro da sé, si fanno sempre più imprevedibili e indefinibili: con gli ‘altri’ è difficile stabilire un rapporto di tipo patetico (amico/nemico), ma è altrettanto difficile giungere a definire i rispettivi spazi di diritti e doveri (regole comuni impersonali). L’individuo di fronte a questa liquidità sociale elabora o una reazione che si può definire ‘malinconica’ (che consiste nel rifiuto del presente e nel rifugio in un atteggiamento di indifferenza o di ritorno al passato o di approdo a una nicchia di sopravvivenza) oppure una reazione narcisistica (che vede nella molteplicità delle occasioni e delle esperienze la possibilità di estrinsecare al massimo il proprio sé e di rappresentarlo nella forma dell’onnipotenza illimitata). In realtà la società postmoderna se, sul piano dei principi, riconosce all’individuo ogni libertà, di fatto però ne riduce gli spazi di realizzazione e lascia il soggetto completamente solo nel tentare di realizzare le proprie ambizioni (la sconfitta ricade su di lui), anzi fa sì che percepisca gli altri come un ostacolo nel suo desiderio di autoaffermazione. Sul piano del potere, si continuano a utilizzare termini propri della modernità come ‘cittadini’, ‘opinione pubblica’, ‘intellettuali’, ma sono contenitori che esprimono ormai concetti 18 diversi da quelli originari. Lo sviluppo dell’industrializzazione e della mondializzazione economica, la prevalenza del potere extra-nazionale e l’alleanza tra scienza, tecnica ed economia fanno sì che gli individui si sentano impotenti rispetto a decisioni che vengono prese altrove e cerchino il senso della propria vita nello spazio personale e familiare. Il controllo sociale viene realizzato non attraverso la coartazione, ma attraverso la seduzione attuata dal mercato dei media. L’identità personale in che modo si forma all’interno di questi modelli?12 -Nella società comunitaria il soggetto percepisce come naturale la propria collocazione sociale, che è tale per nascita (quindi voluta da Dio); apprende un modello di comportamento in linea con essa e agisce all’interno dei ruoli sociali ereditati; l’assimilazione avviene nella forma della ‘iniziazione’ e dell’inserimento in una realtà non modificabile; -nella società moderna l’individuo si percepisce come persona, titolare di diritti e doveri, capace di progettare la propria vita da solo o con l’aiuto delle istituzioni (l’identità come compito). È l’homo oeconomicus che ha fiducia in un ‘Io’ fondato sulla razionalità (Cartesio), in grado di controllare ma anche di esprimere le proprie passioni (ricerca di approvazione e capacità di dilazione della gratificazione personale e sociale), proiettato verso il futuro e aperto al mondo. È un individuo con un forte senso dei confini tra sé e l’altro, che investe le proprie energie sul sé e sulla collettività, alla ricerca del successo come soluzione di problemi, che percepisce come naturale il modello culturale ereditato, fondato sul mito del progresso. Come cittadino si sente chiamato a dare un suo personale contributo alla produzione della nuova società e in questo modo, pur essendo radicato in una specifica realtà nazionale, può aspirare ad essere unico, a esprimere la propria ‘autenticità’. I privati 19 cittadini mediante giornali, riviste, associazioni possono far sentire individualmente e socialmente il peso dei propri pareri e interessi e formano quella che ancora chiamiamo ‘opinione pubblica’ che, attraverso l’elaborazione di nuove proposte per la soluzione di problemi, contribuisce al cambiamento del ‘senso comune’ (termine con cui si indicano gli orientamenti di base di una collettività adottati inconsapevolmente). -nella società contemporanea, liquida e frammentata, l’identità tende al molteplice, al mutevole. L’individuo è debole, aperto alla manipolazione, apatico, insofferente alla rinuncia (vuole tutto e subito), disinteressato all’altro. E’ l’homo psycologicus, edonista, desiderante, ancorato al presente, centrato sul culto di sé e della propria immagine (dall’Io cartesiano si passa alla maschera nietzschiana). L’individuo non è più visto come cittadino ma come consumatore, nel senso che non è più chiamato a fornire un personale contributo allo sviluppo sociale e a realizzare così la propria autenticità, ma è spinto a consumare, ad abbandonarsi alle pulsioni dell’identità ‘estetica’. Rispetto alla stampa, acquisiscono sempre più peso i nuovi media che determinano l’invasione del mondo esterno nel privato e modificano la stessa percezione della realtà. Il variare delle forme di identità con il variare delle tipologie di società dimostra che il soggetto è socialmente formato dall’ambiente a cui appartiene, ne assimila la cultura, i codici simbolici, che hanno non solo la funzione di risolvere i problemi fondamentali dell’esistenza dei membri della collettività, ma anche quella di creare una situazione di omogeneità e consenso al fine di evitare conflitti sociali. Il soggetto come socialmente formato ma non determinato Se è vero, però, che il soggetto è socialmente formato, questo non significa che è ‘determinato’ dall’ambiente in cui vive, 20 perché, come sostiene Mead, l’individuo reagisce continuamente nei confronti della società, che risulta costituita da un continuo e complesso dialogare degli esseri umani. “Noi siamo individui nati in una certa nazione, situati geograficamente in un certo luogo, con rapporti familiari e politici di questo o di quel tipo. Tutto ciò rappresenta una certa situazione, che costituisce il ‘ME’; ma necessariamente implica anche un’azione continua dell’organismo nei confronti del ‘ME’. Gli uomini nascono all’interno di strutture sociali che essi non hanno creato, vivono in un ordine istituzionale e sociale che essi non determinano, si trovano costretti entro i limiti del linguaggio, dei codici, dei costumi e delle leggi. Tali limiti entrano nel ‘ME’ come elementi costitutivi quantunque l’ ‘IO’ reagisca sempre alle situazioni preesistenti in modo unico, proprio come nella concezione [leibniziana] dell’universo, ciascuna monade rispecchia quell’universo da un diverso punto di vista, e ne rispecchia così un aspetto o una prospettiva diversa13”. L’identità personale emerge, quindi, dall’interrelazione tra l’ambiente e l’individuo in termini d’integrazione e differenziazione. Alla stessa conclusione giunge la filosofa De Monticelli: “Forse la novità stessa della nostra specie, che si compendia nello strato di realtà che abbiamo aggiunto all’ecosistema naturale – le civiltà, le loro opere, la storia – non si darebbe senza la novità di ognuno14”. Ed è proprio grazie alle nostre decisioni - non dimentichiamo la domanda da cui siamo partiti: le nostre azioni sono libere? - che definiamo la nostra unicità. Ma – la filosofa aggiunge – “la nostra epoca vede una tremenda banalizzazione, nel senso e nella cultura comune, di questa dimensione dell’espressività personale, per la quale del resto abbiamo perduto occhio, orecchio e attenzione. Così accade nella società della comunicazione e del marketing, con la riduzione che essa causa dell’espressione verbale e non verbale ai cliché più semplici e uniformi15”. 21 Industria culturale e formazione Se nella società comunitaria la formazione avveniva essenzialmente in famiglia e, nella società moderna, oltre che nella famiglia, nella scuola, nella società postmoderna la costruzione dell’identità è opera soprattutto dell’industria culturale che, attraverso la forza delle immagini e la molteplicità e istantaneità delle notizie, sembra in grado di plasmare la mente degli individui in maniera più efficace rispetto al passato. Come mai? Ancora una volta, per tentare di capire qualcosa di più, dobbiamo riferirci alle recenti scoperte delle neuroscienze da cui apprendiamo che il nostro cervello è unico, ma il suo funzionamento è sintonizzabile su due modi di procedere: un modo di funzionamento ‘parallelo’16, che è spontaneo, veloce, evocativo, poco costoso sul piano delle energie che richiede (permette di distrarsi e passare da un argomento all’altro), e un modo di funzionamento ‘seriale’17 che è rigoroso, consequenziale e molto dispendioso (Boncinelli). Con la lettura, la scrittura o con la risoluzione di problemi complessi obblighiamo il nostro cervello a incrementare il funzionamento seriale (che è poi la presa di coscienza) e questo ci costa molta fatica. Naturalmente, nella nostra vita, abbiamo bisogno di utilizzare sia il ragionamento che ci consente di giungere a conclusioni corrette sia il modo di funzionamento evocativo e veloce18. Spontaneamente, però, noi useremmo il sistema parallelo (e lo usiamo infatti quando siamo stanchi, malati, ubriachi o quando invecchiamo) perché la struttura del cervello è intrinsecamente parallela. Il problema è che oggi, la comunicazione operata dai media favorisce questo uso in quanto, inducendo alla semplificazione che ha i caratteri della seduzione, lascia poco spazio all’attenzione, alla concentrazione e alla riflessione e non facilita certo lo sviluppo delle capacità critiche. Non a caso assistiamo a un ridimensionamento del settore più tradizionale del mercato della comunicazione, quello editoriale, perché debole sul piano finanziario e a una progressiva omo22 geneizzazione tra mercato della comunicazione e quello dei consumi. La società dello spettacolo Nella produzione culturale attuale in cui l’unico obiettivo è quello di realizzare profitti naturalmente non c’è più molto spazio per la sperimentazione e l’innovazione. L’industria culturale19 ha sempre più bisogno di soggetti consumatori che condividano i ‘valori’ del mercato e i riti dello spettacolo20. Oggi essa produce simulacri di realtà che sembrano in grado di forgiare interamente l’immaginario collettivo. Paradigmatico è il caso dell’informazione televisiva diventata ormai una sorta di varietà, in una confusione di informazione e spettacolo che ha generato il neologismo infotainment. La regia degli eventi, il montaggio, l’impaginazione hanno l’obiettivo di costruire un’illusione di realtà mai noiosa e sempre rassicurante: ci sono terribili eventi ‘fuori’, ma nel salotto di casa siamo al sicuro, qualcuno pensa per noi (Volli, Calabrese). Inoltre, poiché tutto può essere interpretato in molti modi ed è privo di premesse e di effetti, tutto diventa ugualmente irrilevante: si vanifica la capacità di distinguere che è essenziale per valutare e decidere. La dimensione spettacolare è applicata a tutti i settori ed è portata al massimo livello di espressione a tal punto che il rapporto sociale fra individui è mediato dalle immagini (Debord)21. Diventa spettacolo anche il linguaggio verbale, la stessa facoltà umana di comunicare, con l’effetto di narcotizzare le menti e di ridurre il giudizio a ‘mi piace/non mi piace’. Secondo Baudrillard22 ciò che caratterizza gli odierni mezzi di comunicazione è l’ostacolo alla comunicazione stessa e l’annullamento della differenza tra realtà e immagine mediata (iperrealtà); nella società ipermediale la realtà scompare (anche se permane un’illusione di reale nelle tracce che lascia), si moltiplicano gli schermi e le immagini e il soggetto stesso in fondo si riduce 23 a un puro schermo su cui si proiettano immagini. Non sono le immaginazioni dei soggetti a diventare sociali, ma sono i simulacri della società che si impongono sui soggetti che in definitiva traggono i modelli identitari dal sistema dei media. Come difendersi? In questa situazione, in cui tutta la civiltà politica e culturale dell’Occidente fondata sulle categorie vero-falso, reale-apparente, impegno-disimpegno (Perniola) rischia di diventare marginale e di non essere più in grado di incidere sulla realtà, occorre mettere in campo strumenti ermeneutici in grado di operare una continua riflessione sui processi in atto con l’obiettivo di riattivare un percorso di consapevolezza che conduca a una lenta e faticosa ricerca della autenticità di ognuno. 24 PARTE SECONDA EROI, SUP EREROI, GENT E COMUNE “Ho contrapposto l’eroe all’uomo comune e qualcuno si è offeso. Non li distinguo come due specie umane – in ciascuno di noi c’è la via tracciata per un eroe, ed è appunto da uomo comune che la si realizza”. J.Lacan, L’etica della psicoanalisi “Certo che siamo criminali. Siamo sempre criminali. Dobbiamo essere criminali”. F. Miller, Batman. Il ritorno del Cavaliere Oscuro 1. IL POTERE DELLE IMMAGINI Conoscere il mondo (costruire informazioni) è possibile nelle due modalità del ‘veloce’ (immediatezza) propria degli animali, e del ‘lento’ (proprio dell’uomo): le immagini assicurano velocità e facilità, ma nascondono la storia della costruzione delle immagini ovvero della costruzione dell’informazione. Il potere gioca da sempre sulle immagini (anche nelle forme che hanno a che fare col tempo (riti, miti): oggi colonizza massicciamente le menti con i media dell’industria culturale che mira all’omologazione per favorire il mercato globale. Necessità di una filosofia che de-costruisca le immagini, alleni alla ricostruzione dei processi, ri-fletta attraversa i prodotti di massa per fare da virus fuori dalle nicchie; convincere è ‘vincere’. 25 Natura / cultura Siamo quel che siamo perché ci siamo (nati) o perché ci siamo diventati? Nella dimensione del ‘senso comune’, in fondo, la complessa questione dell’identità viene interpretata come un aspetto particolare della più generale contrapposizione ‘natura’ / ‘cultura’. Oggi sappiamo che il problema dell’identità va risolto spostando il centro dalla prospettiva della coscienza (‘natura’) a quella del linguaggio (‘cultura’): sulla base dell’ampia gamma di studi di fenomenologia sociale, strutturalismo, integrazionismo simbolico, sociologia drammaturgica, costruttivismo, cognitivismo ecc., ipotizziamo ormai che il cosiddetto ‘soggetto pensante’ più che un oggettivo osservatore della res extensa sia il risultato della costruzione dei vari codici simbolici con cui il singolo individuo (animal symbolicum, per dirla con Cassirer) si trova a connettersi con il flusso della realtà per darle ‘forme’ e ‘senso’. La riprova di questa ipotesi è nella storia dell’uomo che dimostra che, in relazione col variare dello spazio e del tempo, cambiano le forme di identità: in particolare nelle società comunitarie (Tonnies) l’identità è percepita come un dato ‘naturale’ (si è – e si accetta di essere - quel che lo status sociale di nascita ci consente); in quelle moderne è un ‘compito’ (l’individuo è un progetto a cui dare forma in rapporto dialettico con i processi di razionalizzazione delle specifiche società nazionali); in quelle contemporanee è una costruzione molteplice e precaria, pluralistica e attiva (Mead). insomma dall’homo naturalis all’homo oeconomicus all’homo psycologicus; dalla identità come condizione statica (staticità) alla identità come punto d’arrivo d’un progetto (direzione lineare), all’identità come trasformazione – movimento senza direzione. 26 L’ordine sociale come ‘manipolazione’ All’interno della nostra ipotesi, ovviamente queste differenze (come già detto) sono opera non della natura ma dell’azione plasmatrice delle varie ‘culture’ sociali che per creare ordine devono sempre creare una certa omogeneità antropologica tra i suoi membri, e per farlo ricorrono alla ‘manipolazione’ delle menti, attraverso codici più o meno diversi negli specifici risultati storici ma tutti simili negli scopi e nelle procedure totalizzanti. Cervello collettivo genetico e culturale Per capire (spiegare) queste procedure può essere utile assumere la distinzione, attiva tra i neuroscienziati, tra cervello collettivo genetico e cervello collettivo culturale. Il primo è, per così dire, un hardware che, da una parte, è rigido nelle sue strutture di base – strutture che presiedono a molte funzioni automatiche o quasi (ad esempio le espressioni emotive del volto, le modalità di elaborazione dell’informazione, e così via) – ma dall’altra è anche pronto, per così dire, all’impianto di una molteplicità illimitata di software. Il secondo (il cervello collettivo culturale) è al contrario dinamico, in quanto varia nel tempo e nello spazio (e di fatto equivale, come già detto, alla molteplicità dei software che agiscono entro l’hardware di base). L’economia della comunicazione Ebbene dalla antropologia sappiamo che in ogni società umana, per ottenere una situazione di consenso – ovvero di quiete, pax – si elaborano modelli di rappresentazione del reale e conseguenti modelli di comportamento che creino omologazione e condivisione, per evitare le inevitabili forme di conflit27 to relative ai bisogni fondamentali di sussistenza e sicurezza. Nel tempo, in questa opera di inculturazione, si sono mostrate particolarmente efficaci le forme di comunicazione che risultano più ‘economiche’, quelle che cioè riescono a trasformare il thauma (lo stupore, il timore) che si avverte di fronte al flusso delle cose, in certezze e verità in modo semplice, eliminando la strada lunga e perniciosa del dubbio. La coesione sociale è insomma assicurata dalla pratica di diffondere messaggi identici a tutti i membri della società, attraverso modalità che eliminano la fatica del pensare (cioè di valutare criticamente i dati) ovvero attraverso sensori neurologicamente potenti come quello della vista, che non solo (in entrata, bottom – up) presiede il 50 % dell’elaborazione corticale rispetto a tutte le sollecitazioni che provengono dall’esterno, ma anche in uscita (top – down) comunica in modo ‘istantaneo’ l’informazione, nel senso che una immagine in genere porta con sé tutta o quasi l’informazione di un dato messaggio (o perlomeno così viene percepita): “è evidente!”. Naturalmente ogni immagine è in effetti costruita dai vari apparati sensori, dalla rete neuronale addetta e quindi dalle categorie mentali che ‘guidano’ la ricezione. Insomma ogni immagine ha – per così dire – una sua ‘storia’ che la precede; e questo è tanto più vero quanto più l’immagine è frutto di azione umana, ovvero se la sua ermeneutica dipende in effetti da codici non ‘naturali’ ma ‘artificiali’, ovvero dai sistemi di simboli con cui essa emerge dal fluire caotico per assidersi nel discreto della forma e del senso. Conoscenza e ‘visione’ La vista – anche nella tradizione filosofica e scientifica occidentale, nelle sue diverse modulazioni e sublimazioni – è stata sempre considerata come equivalente della ‘natura’, per poter costruire argomentazioni deduttive di vario tipo. Prima nella forma più materica del ‘rito’23 e in quella più astratta del 28 ‘mito’24; poi in quelle del logos25, dell’arte26 e della poiesis27; oggi in quelle dello ‘spettacolo’28 e dello ‘storytelling’29. La parola come immagine Certo l’immagine da sola è un’astrazione irrealistica: l’immagine ha sempre a che fare col tempo (cosa succede?) ma da sempre, visto che non si può fare a meno del ‘tempo’, anche le comunicazioni che devono distribuirsi analiticamente nella successione temporale, cercano di supportarsi con le ‘immagini’, cioè di uscire dal tempo (dal ‘divenire’) per attingere alla staticità dello ‘spazio’: così la parola arriva ad un certo punto della storia dell’umanità a farsi immagine con la scrittura, sostituendo l’oralità (e l’udito) con le icone (e la vista). Certo, c’è differenza tra le immagini che vogliono riprodurre le cose nella loro specifica unicità (le figure appunto), quelle che vogliono rappresentare le stesse cose nella loro invarianza (i segni grafici della geometria e della matematica) e quelle che vogliono riprodurre suoni e concetti (alfabeti, riti, miti come codici di base, metafora, metonimia, analogie come procedure particolari). E così la comunicazione fa sempre i conti con lo spazio, con le immagini, a maggior motivo nelle sue forme più astratte (come la geometria, la matematica), che sono tali perché cercano di allontanarsi dalla variabilità del tempo (del Divenire) per attingere alla staticità dello spazio (dell’Essere). Naturalmente nelle varie società umane è sempre stata una élite a praticare e controllare queste operazioni in cui le immagini concrete (in sé neutre) acquistano un valore simbolico (un ‘senso’): sono loro a elaborare codici particolari che siano capaci di rispondere alle insicurezze delle masse con messaggi facili da capire ed efficaci nell’abbattimento dell’aggressività. Le strategie ricorrenti consistono da un lato (sul piano della forma, del ‘come’) nel dissimulare concetti astratti (quali bene comune, lealtà ecc.) in trame di immagini (che come detto 29 sono messaggi ‘istantanei’, apparentemente elementari da decodificare); dall’altro (sul piano del contenuto, del ‘cosa’) nel riempire queste trame con eventi d’amore’ e di ‘guerra’, eventi che di fatto creano una estrema risonanza emotiva perché risultano la sublimazione ‘culturale’ più raffinata di quelli che sono i bisogni biologicamente determinanti per la sopravvivenza, cioè il sesso e il cibo.30 Queste tematiche globali non incontrano ostacoli per arrivare al cervello (a differenza delle argomentazioni, del dubbio e dell’analisi) ma anzi attivano endorfine di ‘piacere’. Le favole, i miti, le storie in genere sono allora strumento di formazione della nostra idea del mondo, quindi del conseguente sistema di valori proposti in modo emotivamente forte e neurologicamente vantaggioso: storie particolari capaci di dire l’universale (e questo sia nello spazio limitato della casa – in cui si raccontano fiabe – sia nello spazio aperto delle istituzioni pubbliche – in cui il racconto prende la forma ambiziosa dell’epos o del romanzo). Immagine e riduzionismo Oggi, con i mass media sempre più invadenti e decisivi, sotto il controllo del mercato dell’industria culturale della globalizzazione, queste pratiche sono sempre più invasive rispetto alla situazione premoderna (della casa patriarcale) e a quella moderna (delle istituzioni pubbliche): l’identità non viene più costruita entro le mura di casa o a scuola, magari coi libri, ma dall’industria culturale che ormai è maestra nell’agenda setting e nella proposizione di raffinati ipermercati di life style, operando massicciamente a favore della perdita di plasticità della corteccia neuronale e contro ogni tentativo di sviluppare la funzione critica della corteccia cerebrale. La tv e il cinema hollywoodiano, internet e i micromedia poggiano la loro forza sul trionfo dell’immagine istantanea e sulla negazione del tempo, mirando ad una sorta di omologazione totale che ha tra i 30 suoi effetti quello di evitare i conflitti. È vero infatti che i gradi di libertà presenti allo stato potenziale alla nascita vengono diminuiti dall’esperienza. È ragionevole pensare che il grande compito dell’esperienza nel periodo postnatale non sia quello di render il cervello dell’individuo più individuale possibile, ma al contrario di diminuirne l’individualità, facendo aumentare la parte del cervello che abbiamo in comune con gli altri, in altre parole estendendo il cervello collettivo31. Insomma la quiete sociale si conquista attraverso la metodica e rassicurante ripetizione, che rinforza i concetti progressivamente in modo indelebile, fino a farli apparire ‘naturali’: appunto i ‘riti’ (vere e proprie performance ‘teatrali’ che agiscono in modo completo sulla psiche dei partecipanti) e i ‘miti’32, ma certamente è quello che si vede a segnare immediatamente la conferma del precedente, del già dato, dello sperato, contro il divenire che minaccia se si è fuori del gruppo. Tutto quel che è diverso viene accuratamente marcato in termini negativi come male, come caos, come diabolico (come elemento che appunto divide) L’identico e il differente Storicamente nelle comunità premoderne dominava la costruzione dell’ordine sociale attraverso l’esercizio della ripetizione (in pratica ogni membro della comunità era tenuto a eliminare ogni gesto che suonasse diverso dalle consuetudini comunitarie); in quella moderna l’ordine sociale nasce da una interazione dinamica e ambigua tra pratiche della ripetizione (i doveri) e pratiche della differenza (cioè diritti individuali); oggi sembra esserci un paradosso: l’ordine sociale viene ricercato attraverso l’esaltazione illimitata e trionfante delle libertà individuali). Ma in effetti oggi le persone nell’esercizio di queste libertà si muovono all’interno di una serie limitata di opzioni, in quanto quella che sembra una pratica di individua31 zione (shopping alla ricerca del piacere, edonismo) è in concreto la manifestazione di un cervello collettivo. Per lo più le persone vengono a contatto con la res extensa (con il mondo materico delle cose e degli eventi) quasi solo tramite il filtro onnipresente dei ‘media’ (che per l’appunto è ‘mediano’): i desideri quindi non sono altro che il risultato dell’azione ‘culturale’ dei media33. L’omologazione totalizzante a cui puntano non è l’adesione di tutti ad un solo ‘prodotto’ ma nell’identificare la propria identità nel possesso (di oggetti, persone). L’industria culturale (la vera ‘istituzione’ della globalizzazione) da un lato fa in modo che la realtà venga percepita come un fluire inarrestabile (come Divenire), come spazio illimitato di occasioni ‘nuove’ entro cui ‘combattere’ per il successo; dall’altro attiva un infinito mercato di oggetti e situazioni enterteinement, merci capaci di ristorare, nel ‘qui e ora’, l’insicurezza. Il risultato è infine una condizione sociale di tensione (la vita è una lotta) e psicologica di precarietà e transitorietà, ma vissuta con rassegnazione, come ‘ontologica’ dimensione del reale se non addirittura con l’entusiasmo di chi spera nel ‘successo’. E il cinema è appunto mezzo basilare in questa strategia dell’invasione delle menti. Cinema e inculturazione Dapprima forse in modo inconsapevole ma ormai con piena razionalità progettuale l’industria del cinema contribuisce a portare le menti là dove la razionalità della globalizzazione vuole: consumo come metodo di realizzazione del sé, estetica come dimensione profonda dell’io (“godi”, “divertiti”), accettazione dell’esistente per quello che è, la competizione come pratica (etica) del successo. Secondo Chris Vogler34 è da decenni che Hollywood utilizza con efficacia gli studi antropologici di Joseph Campbell35 per costruire i suoi film, recuperando la dimensione ‘poietica’ del mito36 con i mezzi molto più attraen32 ti, rispetto all’antichità, delle immagini e dei suoni. Il cinema insomma è una macchina antropologica formidabile che, in combinazione con la televisione, dà forma alle menti globali secondo procedure (invisibili) top – down, realizzando in modo nemmeno lontanamente pensabile in termini di numeri quello che era lo scopo di autori come Orazio: ‘istruire’ coprendo la ‘morale’ con il miele37. Chi produce cinema a livello di mercato38 sa bene che l’uomo che vive nelle società complesse ha interesse non per questioni ontologiche (cos’è il mondo, quale la sua essenza?) ma etiche (che devo fare in questo mondo impossibile da capire?): sanno che fragili o arroganti sembrano all’uomo della ‘società liquida’ le questioni metafisiche della filosofia, ma che certamente è per lui necessario riflettere sul ‘senso’ dell’esistenza così instabile e sfuggente. E sanno anche che proprio il ‘raccontare’, specie nelle ricche forme iconiche dei media contemporanei consente di proporre risposte fascinose e gratificanti: “compra”! soddisfa i tuoi desideri!39 L’identico e il differente nel cinema È chiaro allora che lo spettatore globale della contemporaneità chiede al film per così dire ‘il miele’, cioè un’esperienza di rallentamento rispetto ai ritmi e agli eccessi della vita concreta: pronto soprattutto a farsi coinvolgere nelle emozioni della trama, vuole ‘divertirsi’40. Ma questo tipo di divertimento è possibile solo nella misura in cui ci si allontana dalla ‘cultura’ e ci si avvicina alla ‘natura’, cioè se non si pensa41 e ci si ‘abbandona’ alle semplici condizioni ‘biologiche’ di piacere. Se si abbandonano le situazioni in cui il singolo – per agire – è costretto a fare scelte tra le varie ‘forme’ (soluzioni) elaborate dalla società e ci si ‘abbandona’ agli automatismi dettati dalle pulsioni. Insomma divertirsi significa in questa situazione42 soprattutto passare dallo stato di stress tipico delle ore di negotium in cui l’organismo/mente è sottoposto a ‘sfide’ (scelte) 33 continue (sempre crescenti nelle società glocali) ad uno stato di ‘piacere’, di ‘non scelta’ appunto, in cui il logos sia dominato / sostituito dal mythos43, il complesso dal semplice, la mancanza dalla pienezza, il caos dal gioco, il conoscere dal ri-conoscere (le procedure in default in riduzionismo, di ‘iterazione’ automatica e non di problem solving). Insomma ci si predispone alla eliminazione del perturbante dell’esperienza sociale44, per ri-approdare ancora alla condizione gratificante della tana, alla felicità immaginativa del nido, alla tranquilla sicurezza del ‘come se’, all’antica ‘costruzione’ del reale sulla base dei propri bisogni. Andare al cinema (guardare un film) significa allora soprattutto cercare conferme gratificanti e confortanti ai propri desideri, come quando da bambini si vuole ascoltare la stessa fiaba per sentire le stesse risposte alle stesse domande: chi sono? da dove vengo? cosa mi succederà quando morirò? cosa significa? quale è il mio posto? quale la meta del mio viaggio? È per questo che lo spettatore in genere non gradisce le storie che procurano choc, sorprese, meraviglia, se non nella misura in cui mostrano strade nuove per arrivare alla stessa conclusione attesa. Se sorpresa c’è (e in effetti deve esserci perché l’esperienza sia verosimile) deve essere inserita in una forma ‘rituale’ in cui l’irruzione del perturbante venga senz’altro controllata per riattivare comunque – infine – scene ‘familiari’ dove gli elementi e le relazioni siano quelle riconoscibili, dove infine l’ordine’ sia garantito e ri-creativo45. In fondo ogni racconto, come ha già ben chiarito Aristotele, ripete all’infinito questa invarianza: l’ordine (INIZIO) viene (spesso) disturbato da qualcuno / qualcosa (sorpresa, imprevisto, il cigno nero) ma infine si supera la sorpresa e si ristabilisce un ordine (FINE) . Il racconto come autoregolazione quindi: in questo l’adulto è assolutamente identico al bambino. La differenza è nel fat34 to che, mentre nel piccolo uomo i meccanismi di retroazione sono più ‘diretti’ (costruisce ‘liberamente’ le sue retroazioni, i suoi ‘giochi’, i suoi ‘simboli’), nell’adulto – sempre più col procedere del tempo – sono mediati (ricorre a simboli bell’e pronti): grazie all’educazione, all’acculturazione, egli dispone di un repertorio preesistente46 di soluzioni compensatorie: spettacoli, libri, riti, feste, racconti che procurano facili vie di autoregolazione, in cui l’ordine artificiale creato dal codice simbolico corregge il disordine che emerge continuamente dalla realtà empirica. I miti, le favole, una volta: ora i cartoon, i film, i serial, i videogiochi. Vere e proprie cure quindi: storie, metafore, leggende capaci di guidare, guarire, dare un significato all’esistenza. Ma senza pensare, senza inventare: solo facendo lo ‘spettatore’; le decisioni le ha prese il produttore del film. Metodi della differenza Stando così le cose, occorre a maggior ragione allenare le funzioni cerebrali del cervello non solo a riconoscere le invarianti delle situazioni vissute (la scienza) ma anche a percepirne le varianti, le variabili; occorre non solo attivare risposte automatiche ai problemi per economizzare energia (ed evitare lo stress), ma anche innescare procedure di ‘rallentamento’ per accrescere la gamma delle soluzioni. Questo in fondo hanno sempre cercato di fare la filosofia e l’arte: celebrare il dubbio, eliminare il torpore della ‘conoscenza’ data, evidenziarne la natura di artificio, moltiplicare le prospettive di indagine: ma se nel passato questo sforzo era diretto soprattutto contro le religioni e tutte le variegate forme di assolutismo culturale, comprese le varie ideologie della modernità, tese tutte a ‘ridurre’ la complessità del reale in formule monolitiche e acquietanti47, oggi esso deve essere rivolto contro il Mercato e 35 i suoi Miti, spacciati come ‘verità’, ossia struttura metafisica della ‘realtà’, come ‘essere’ che sostanzia e motiva il ‘divenire’ dei fatti. Per realizzare questa critica, certamente non basta solo appropriarsi delle ‘competenze’ compartimentate e specialistiche sbandierate dalle varie culture positivistiche come fonte di ‘crescita’48: infatti, se è vero che ’sapere è potere’, come si sa fin dal secolo dei Lumi, è il ‘cosa’ sapere che determina la differenza sociale, sempre, non solo il fatto in sé di apprendere49. E oggi la vera forza è nascosta nella interazione ‘modesta’50 della molteplicità di discipline che ‘raccontano’ la complessità della dimensione dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature, qualitative oltre che quantitative. Epistemologia antropologia psicologia sociale teoria dei sistemi cibernetica semiotica emergenza ecc. contribuiscono a determinare una rete di conoscenze che promettono di mantenere margini di azione anche a fronte di situazioni ‘catastrofiche’: è nella ‘connessione’ che consiste il mistero della ‘conoscenza’ non tanto nella singola unità (senza la quale per altro non si potrebbe dare la connessione). Stando così le cose, passando dal generale al particolare del cinema, quanto sopra detto comporta che è nel ‘montaggio’ il ‘segreto’ del film: non basta percepire le singole scene (o all’interno della scena i singoli dettagli) per pensare di averlo ‘capito’; occorre al contrario cercare di ricostruire quale filo connette le parti, quale non dichiarata logica di significazione consente al testo di ‘funzionare’ come ‘messaggio’. Insomma il film è certo un testo fatto di ‘segni’: ma essi ci parlano davvero solo se li intendiamo come ‘indizi’ e se ci poniamo di fronte al testo come investigatori che devono svelare l’enigma, se non ci si limita a guardarlo con procedure deduttive o induttive ma se attiviamo procedure abduttive e analogiche51. 36 Che fare? Quindi non basta semplicemente leggere e scrivere saggi secondo la tradizione occidentale inaugurata con l’invenzione della scrittura: occorre affrontare il ‘nemico’ (l’industria culturale’) sul suo campo ‘mitologico’ per svelarne le sue procedure, per destrutturare i suoi ‘miti’, per avviare lo spettatore alla conquista di percorsi utili alla sua ‘trasformazione’ nel tempo, cioè alla sua “individuazione”52: che corrisponde alla uscita dalla nicchia di pura sopravvivenza meccanica e cercare di essere davvero capaci di auto-direzione. Per questo non può non apparire come una variazione dell’‘altrove’ romantico la pratica di rassegne e convegni elitari caratterizzati dall’autoreferenzialità: certo è gratificante ritrovarsi con chi parla lo stesso linguaggio, con chi pratica le stesse scelte, con chi condivide le stesse idee; ma queste pratiche finiscono nonostante tutto per proporsi come soluzioni estetiche (‘stare bene’ nell’hic et nunc, in una sorta di moderno ‘locus amoenus’) piuttosto che soluzioni etiche. Stando alla deriva edonistica e riduzionista che vediamo sempre più diffondersi nella società reale, quella che i sociologi chiamano il ‘senso comune’, è chiaro come le forme di comunicazione tipiche della modernità non sono certamente in grado di incidere sulla formazione della mente collettiva: servono, continuano a servire, a chi è già sulla via della individuazione, non a chi è immerso nel pensiero conformistico53. Anzi, immesse, come sono a volte, nel sistema dello ‘spettacolo’54 rischiano di creare l’effetto ‘Chaltron Hescon’: la semplice presenza ad un ‘evento’ culturale basta a convincersi di essere ‘colti’, secondo la procedura della metonimia (magia per contatto)55. Non è facile dunque modificare lo stato delle cose. Una delle possibilità potrebbe essere quella di trasformare in veri e propri ‘circoli ermeneutici’ le situazioni comunicative tradizionali caratterizzate da processi comunicativi strettamente top – down 37 (in cui la parte di dialogo consiste nel ritornare a precisare dettagli del già detto). Ma soprattutto si può ricorrere a strumenti della comunicazione dello ‘spettacolo’, come appunto il cinema, nella consapevolezza che è lì, nel mondo dei media che si produce oggi ‘cultura’, che si determinano ‘le vite degli altri’. Allargare i contatti56, accettare di ‘sporcarsi’ le mani con prodotti ‘di massa’57, allargare le riflessioni dal piano cognitivo a quello metacognitivo58, aprire il ventaglio dei codici utili a decrittare i messaggi59 a tutta la serie delle nuove discipline a cavallo tra scienza e umanesimo. Insomma diffondere una pratica di una lettura che sia ‘filosofica’ nel senso etimologico del termine: passione per il conoscere. Impresa da eroe ariostesco60: prima di tutto il bisogno in generale di ‘leggere’ testi; poi quello delle metodologie specifiche per i tanti linguaggi implicati; e ancora le connessioni con l’antropologia, le neuroscienze, la varie forme di sociologia e psicologia, le retoriche, nonché ovviamente l’archivio della ricerca filosofica nella sua estensione complessa61, ecc. Obiettivo possibile: non capovolgere il sistema, ma diventare virus all’interno del sistema, consapevoli del fatto che nei sistemi complessi anche una piccola variazione potrebbe portare a grandi cambiamenti. Anche se non è prevedibile in quale direzione andranno i tentativi, se ne possono ipotizzare alcuni: a. creare almeno due categorie entro cui inserire i testi; b. imparare a scegliere con consapevolezza tra prodotti destinati alla ‘leggerezza’ e prodotti destinati alla ‘pesantezza’; c. leggere i testi con ‘occhiali’ adeguati: ovvero riconoscere l’identico nel diverso (ridondanza = analogia), ’immaginare’ collegamenti di senso in rapporto agli scopi (cognitivo, etico, estetico, pragmatico)62. 38 Insomma, sappiamo che non c’è direzione nelle cose, ma sappiamo anche che ce la dobbiamo ‘inventare’: “la contingenza storica libera […] non solo il passato dai suoi giochi finalistici, ma libera anche il futuro, che rientra a pieno titolo nella sfera di ciò che è soggetto al potere causale dei singoli eventi, cioè le azioni che noi decidiamo di introdurre nel flusso della storia”63. Dal nostro punto di vista, in rapporto alle questioni finora sollevate, l’azione fondamentale da ‘introdurre nella storia’ è acquisire (far acquisire) una tecnica procedurale con cui ‘trattare’ i testi in modo non estetico64 ma semiologico. Ecco alcuni esempi. - Classificare ‘tutti’ gli elementi di un testo (narrativo) all’interno di due categorie (codici) fondamentali: codice proairetico e codice ermeneutico65. Ogni parola, ogni immagine, ogni suono è da considerare un ‘indizio’ inserito intenzionalmente66 dall’autore o per costruire la storia di superficie67 (a far andare avanti la trama, come nota il formalista russo Tomasevskj) o per ‘alludere’ al significato68, ovvero a costruire l’enigma’ di senso che il testo pone in profondità69. - Discriminare gli indizi attraverso una operazione di metonimia (per la trama) e di metafora / analogia per il messaggio70. - Focalizzare al massimo l’attenzione sulla ‘cornice’, ovvero sugli inizi e sulle conclusioni. - Dare rilievo, all’interno delle singole scene, soprattutto ai dettagli apparentemente inutili, non funzionali a quello che sta succedendo71. - Connettere ‘questo’ testo con altri testi, secondo rapporti di affinità (genere, citazioni, topoi…) o di opposizione. 39 La scelta: la tematica L’eroe, il supereroe sono lo specchio dell’uomo comune. Potremmo ripetere l’argomentazione che Feuerbach introduceva per spiegare l’origine antropologica del concetto di Dio adattandola al concetto di eroe: l’uomo è consapevole della sua situazione di costante ‘inferiorità’ rispetto alle sfide dell’esistenza; è abituato a razionalizzare le diversità costruendo categorie (‘generi’), insomma a generalizzare; è consapevole (a differenza degli animali) di appartenere appunto ad un ‘genere’, quello ‘umano’, riconoscibile rispetto agli animali per la sua ‘riflessività’; quindi costruisce un modello astratto di ‘perfezione’ che si realizza pienamente in un suo doppio, l’eroe, cioè l’uomo al massimo della sua ‘umanità’ (al massimo della specifica ‘umanità’ elaborata dal gruppo di riferimento). Questa invenzione, questa ‘figura’ / ‘immagine’, per l’uomo comune, – continuamente stimolato dalle situazioni esterne ad abbandonarsi alle pulsioni dell’‘anymal’ che è in lui72 – è un punto di riferimento che dà sicurezza, ovvero un Simbolo, un linguaggio (artificiale) che dà forma / ordine (artificiale) al flusso che è nella mente (l’Immaginario): c’è, c’è stato qualcuno che davvero sa essere ‘uomo’; c’è, c’è stato qualcuno che è capace di creare ‘ordine’ rispetto al disordine della esperienza fenomenica. C’è un ‘modello’ da seguire, l’archetipo fondamentale che attiva energia e potenzialità consentendo l’attivazione e lo sviluppo del sé, cioè l’individuazione73. Ma naturalmente all’interno del singolo c’è l’Immaginario, che dà spazio alla differenza, ovvero c’è – per dirla con Freud – l’inconscio che nelle sue pulsioni porta alla liberazione illimitata di eros e thanatos. E all’interno delle società, accanto alla cultura dominante che impone i suoi modelli, c’è – più o meno strutturata – la presenza anche di qualche elemento culturale periferico, certo, sottomesso, compresso, ma in qualche modo capace di fornire situazioni di omeostatiche vie di fuga rispetto all’or40 dine dominante, avvertito più o meno confusamente come ‘artificiale’, falso74. Esso gioca a destrutturare quel che altrove, in alto viene costruito: c’è insomma il carnevalesco, la satira, la distruttività: e quindi accanto e contro l’eroe c’è l’antieroe. Ma si arriva anche ad un punto in cui il gioco dell’eroe, nella sua veste doppia di serio e comico, si esaurisce: la fine delle utopie, delle ideologie, delle ‘narrazioni’ porta mano a mano il livello del racconto dall’epos al romanzo, dal romanzo all’aforisma: dalla struttura solida di un Io che si riconosce in ‘eroi’ ad un Io cadente, dimidiato, privo di certezze, un io ‘liquido’ e cinicamente consapevole dell’artificiosità dei modelli antichi e moderni: un io che ha perso definitivamente l’illusione di ‘appartenere’ ad una qualunque comunità dotata di certezze identitarie, capace di produrre modelli certi e garantiti di identità75. Il singolo ‘globale’ si ritrova abbandonato a se stesso, costretto a inventarsi non solo un lavoro, un ruolo sociale, ma anche i suoi modelli. E allora nel concreto si assiste alla moltiplicazione delle vie di fuga dal disastro in direzione di ‘ruoli76’ più o meno efficaci nell’affrontare l’esistenza, ma anche una predominante invasività dell’industria culturale nello specializzarsi (‘silenziosamente’) nell’assumere il ruolo di ‘centro’ semiotico, di propositore di soluzioni esistenziali, di agenda setting ‘comprate’. Molti allora volano verso il supereroe, molti verso un comunitarismo d’accatto (sport, sette), pochi verso la differenza sofferente (arte), molti verso una flessibile disponibilità all’Altro. I titoli I singoli film sono scelte, per così dire, sperimentali: altri, molti altri, si prestano a costruire un percorso significativo. Essi hanno appunto valore solo di ‘percorso’, cioè di – per così dire – una passeggiata tra gli archivi personali alla ricerca di una linea di ragionamento che consenta una riflessione coerente con quanto sopra indicato. 41 2. IL REBUS DELL’IDENTITÀ: ZELIG, DI WOODY ALLEN Il film di Woody Allen, Zelig del 1984, propone, in forma narrativa, la rappresentazione più chiara e completa delle idee con cui attualmente le varie scienze disegnano la complessità di quello che si continua a chiamare ‘individuo’, cioè ‘non divisibile’, ma che ormai sarebbe corretto denominare ‘dividuo’, cioè divisibile. La trama Leonard Zelig è un ebreo americano povero, nato a Brooklin, presumibilmente nel 1900. Vive l’infanzia senza affetti e modelli: i suoi genitori, anziché proteggerlo, gli addossano “la colpa di tutto”77, per cui la sua vita consiste in un fluire indifferenziato di situazioni senza senso. Comincia ad “esistere”78 (cioè ad uscire dall’indistinto della massa anonima e passiva) quando, ancora giovane ma già adulto, si distingue dagli altri perché mostra regolarmente un mimetismo79 camaleontico, fisico e culturale: inizialmente viene arrestato in quanto ‘deviante’ pericoloso socialmente80 (e finisce sui giornali come notizia, come cioè ‘mostro’, esempio di eccezione81); successivamente il suo modo di essere ‘diverso’ viene catalogato come “malattia”(e oggetto di studio degli scienziati, con conseguente lotta tra le varie accademie)82. Tra i tanti medici maschi, si fa caparbiamente largo una donna, Eudora Fletcher, che volge su Leonard (per la prima volta?) uno sguardo materno83: ma lei è interessata alla malattia non a Leonard, ovvero pensa alla cura e non alla singolarità di Leonard. Comunque, una volta sottoposto a terapia analitica, comincia a migliorare finché non viene cinicamente abbandonato dalle autorità84 nelle mani della sorella e del cognato85 che ne sfruttano la notorietà esibendolo come fenomeno da baraccone. Solo Eudora tenta di invano di 42 proteggerlo dalla spettacolarizzazione e dalla mercificazione in cui viene trascinato86: alla fine, quando Leonard non regge più emotivamente l’eccessiva sovraesposizione mediatica, fugge dagli USA per trovare rifugio in Europa, nell’anonimato della massificazione totalitaria87. Eudora lo cerca e lo trova in una adunata nazista, alle spalle di Hitler: dopo averlo tratto in salvo, insieme trasvolano l’oceano su un piccolo aereo, a testa in giù. Accolti trionfalmente a New York come eroi, Eudora e Leonard si cristallizzano nel mito perché la normalità è un’astrazione. La forma Questa storia, a parte le specificità delle situazioni, è organizzata secondo la struttura del ‘bildungsroman’ ottocentesco: il protagonista attraversa varie peripezie alla ricerca della propria identità ‘autentica’. In tal modo l’autore invita lo spettatore al consueto processo di identificazione patetica con le traversie dell’’eroe’ e con lui ‘interiorizza’ progressivamente attraverso le emozioni suscitate dalle forme grottesche della ‘caricatura’ espressionistica la sua stessa realtà di uomo ‘debole’. Ma accanto alla tipica struttura testuale del mythos, Allen propone anche una struttura che attiene al logos: le vicende strettamente narrative sono in effetti inserite all’interno di una ‘cornice’ argomentativa, che utilizzando le tecniche del ‘documentario’ si interroga sulle cause dei fatti presentati per arrivare, al di là della certezza degli elementi della superficie, alla profonda ‘verità’ delle cose. Si alternano interviste a personaggi della storia (i genitori) e ad ‘esperti’ che spostano l’attenzione dello spettatore dall’emozione al ragionamento. In pratica il film è capace di dare forma figurata (visiva) ad una vera e propria rappresentazione epistemologica: ci sono sempre fatti ‘certi’, ma il loro ‘vero’ senso risiede oltre la contingenza, nella ricostruzione della trama di cause ed effetti che 43 sono riconoscibili solo sulla base della disponibilità di materiali documentari non narrativi e se si inquadrano le evenienze all’interno di ‘modelli’ scientifici (qui identificati nelle ‘figure’ fisiche di esperti). Senza nulla dire quindi delle varie parole e questioni che affollano le varie scuole novecentesche a proposito della problematica della conoscenza, Allen sottopone lo spettatore all’esperienza di un doppio processo conoscitivo, una sorta di doppio codice, facilmente accettato in realtà, per il tono ironico e leggero con cui viene costruito tutto il film. Certamente lo spettatore medio, abituato a scegliere il film da vedere soprattutto sulla base del criterio del ‘genere’ (ovvero della fiducia di godere della ‘ripetizione’ di forme e temi che garantiscono di star entrando in un preciso ‘mondo’, con caratteristiche etiche ed ontologiche note e amate) si trova a fare l’esperienza dello straniamento, di una sorta di spaesamento appunto, nel senso che si aspetta una ‘storia’ e si ritrova far i conti con ‘idee’. In effetti in ogni racconto i concetti coesistono con i fatti, ma in una relazione sottotraccia , per così dire, nel senso che in primo piano ci sono solo i fatti e sullo sfondo (implicite e non esplicite) le idee con cui sono tessuti i fatti: invece in Zelig si ritrovano affiancati, rivelati entrambi, a sottolineare come i fatti acquistano ‘senso’ solo se li si connette non solo ad altri fatti88 ma anche a ‘parole’ (concetti’, categorie generali cioè)89. Insomma la rappresentazione dell’evento cede il posto alla rappresentazione della forma. Il tema All’interno di questo montaggio, la tematica dell’individuo, per quanto ironica possa essere la trattazione dei singoli elementi, assume una dimensione non proprio leggera, in coerenza con la tesi che in effetti sorregge tutta la tessitura sopra indicata: il singolo rappresentante del genere ‘uomo’ è un elemento molto plastico, che si presta facilmente ad assumere 44 le forme che l’ambiente, la ‘situazione’, propone/impone, pur di realizzare la condizione di equilibrio ‘ideale’ (cioè con poco consumo energetico) in rapporto agli stimoli esterni. L’‘io’ è cioè un camaleonte, ovvero è una macchina auto regolativa caratterizzata dalla tendenza all’adeguamento del ‘dentro’ al ‘fuori’. 90 Si pone la domanda ‘adesso, che devo fare?’ e per trovare la risposta si limita inevitabilmente a guardare quello che succede intorno a lui, quello che fanno gli altri91. Questa condizione è stata spiegata innanzitutto con il fatto che la base dell’esistenza umana è l’insicurezza92 e che la strategia fondamentale per combatterla è la flessibilità; fermo restando il problema (insicurezza) e la soluzione (sicurezza) variano le strategie di soluzione. Ma il variare delle soluzioni rischia, generando imprevedibilità93, di determinare nuova insicurezza, in un loop senza fine: per cui nei vari gruppi sociali si tende a elaborare una sorta di ritualità, a inserire queste strategie in pratiche di reiterazione, che alla fine ‘fissano’ modelli di comportamento e sistemi stabili di valori . A differenza degli animali, l’uomo non solo percepisce questa insicurezza ‘in situazione’, cioè nello specifico ‘hic et nunc’, come strumento fondamentale della propria autoregolazione, ma (in quanto capace di elaborare i dati percepiti nelle forme particolari dello script94) la proietta nel tempo trasformandola da ‘pulsione’ in ‘desiderio’. Quando infatti avverte, nelle situazioni specifiche in cui vive, la varietà concreta delle soluzioni (l’imprevedibilità), e percepisce la sua condizione come quella di una mancanza (frustrazione della pulsione), sotto la spinta della struttura omeostatica del suo organismo continua a cercare la pienezza (la soddisfazione della pulsione, la ‘quiete’), ma – dotato com’è della capacità di immaginare nella successione lineare l’analogia con quella causa /effetto – riesce a ‘procrastinare’ nel tempo la soddisfazione della pulsione, a porsela come obiettivo da perseguire in un altro spazio/tempo. 45 Insomma lo stato di quiete, grazie all’immaginazione, diventa un oggetto di desiderio. Il problema conseguente è allora dare una direzione specifica, concreta, per così dire ‘spaziale’ a questo desiderio colorato di vaghezza: secondo Girard “vi è passione, desiderio intenso, a partire dal momento in cui le nostre aspirazioni indeterminate si fissano su un modello che ci suggerisce cosa desiderare il più delle volte desiderandolo lui stesso. Questo modello può essere la società nel suo insieme ma è spesso un individuo che noi ammiriamo. Gli uomini hanno il potere di trasformare in modello chiunque ai loro occhi sia dotato di prestigio, e questo vale non solo per i bambini e gli adolescenti, ma anche per gli adulti”95. Sembra che Woody Allen utilizzi questa ipotesi come elemento strutturante della trama del film: infatti per Zelig lo stato di insicurezza (determinato da un’infanzia difficile…) si può trasformare in quiete solo quando trova modelli con cui identificarsi; sia quando si trova in gruppi sociali ampi (se tutti dicono che hanno letto Moby Dick, anche lui non può che ‘ripetere’, dire lo stesso, per conquistare l’identità) sia quando sta a contatto con singoli individui (come lo psicanalista...). Cosicché tutto il film si può leggere come presentazione lineare (nel tempo) di una collezione di ‘figure’ diverse, come una raccolta di figurine, quasi: solo che quelle diverse ‘figurine’ hanno come comune denominatore lo stesso nome, Zelig. E le diverse figure in effetti sono diversi ‘copioni’, per stare alle denominazioni di Goffman, cioè diversi ‘ruoli’ sociali che il singolo si trova a interpretare nelle diverse situazioni: ma proprio questa diversificazione costante se soddisfa ‘in situazione’ il bisogno di trovare un centro che dia senso’ al fluire, rende complessa l’opera di costruzione dell’‘identità’, ‘identità’ che è determinata dalla ‘ripetizione’ di un copione fondamentale; questa difficoltà viene superata solo quando si riesce a trovare anche una ‘trama’ (in termini cognitivi un ‘frame’) che connet46 ta le diverse ‘parti’ in modo organico (in cui cioè le ‘differenze’ siano non in contrasto ma funzionali al sistema generale del frame). Allora si approda ad una ‘norma’ (una ‘ratio vitae’) entro cui finalmente pare realizzato l’equilibrio cercato tra cambiamento e permanenza96. E la trama del film è parossistica e paradossale rappresentazione della difficoltà di Zelig a trovare una ‘trama’ e una ‘scena’ finale in cui superare l’incertezza. Durante l’infanzia, Zelig ha subito maltrattamenti e vissuto situazioni che gli hanno impedito di formarsi una personalità stabile. Tutto ciò che faceva − o era − andava in contrasto con il mondo che lo circondava ed è questo che gli ha impedito di formarsi una personalità definita. L’episodio che racconta, in cui finge di aver letto Moby Dick perché tutti ne parlavano, è stata la prima imitazione. Essa è dovuta al fatto che in quel momento poteva imitare gli altri senza entrare in contrasto con loro. La conquista dell’‘identità’ passa, quasi filologicamente, per la ripetizione dello ‘stesso’ (idem, appunto): essere parte del gruppo significa infatti possibilità di avere dei modelli stabili. La condizione di ‘liquidità’ di questa presunta ‘identità’ è poi rappresentata da Allen attraverso il linguaggio cinematografico più semplice: le immagini. Quel che si vede è solo rappresentazione sensoriale di quanto avviene all’interno di ognuno di noi nel corso delle varie esperienze di vita97: ci ‘adattiamo’, cioè cambiamo. Così Zelig trasformando il suo aspetto dice allo spettatore come anche lui in effetti cambi dentro, senza che lo pensi o al contrario interpretando queste variazioni come passi di un ‘piano’ finalistico individuale invece che come risposta meccanica all’esposizione mimetica a questo o quell’ambiente. La prima trasformazione fisica di Zelig avviene in un pub frequentato da irlandesi il giorno di San Patrizio: acquista un’identità ‘nazionale’ sulla base del fatto che la ‘nazione’ consiste banalmente nell’unione di persone che 47 condividono soprattutto (se non esclusivamente) determinate caratteristiche ‘pubbliche’, cioè esibite negli spazi condivisi, in cui si conferma di essere uguali. Se nonché Zelig vive in una società multietnica e in balia di mode che cambiano con ritmo frenetico per cui diventa asiatico o obeso allo stesso modo in cui il resto della società cambia opinione su tutto da un giorno all’altro: questo continuo movimento (high school, baseball98, club, negozi) rende insopportabile la vita negli Usa, soprattutto quando diventa un ‘mito’ dei media, e viene integrato non già per la sua reale dimensione personale ma in quanto ‘feticcio’ ideologico utile al sistema per cui trova conforto e soluzione nel totalitarismo: fugge nella Germania, dove trova la possibilità di una identità fissa e semplice, determinata dall’alto: insomma trova ‘salvezza’ nel conformismo99. Naturalmente questa soluzione è trovata tutta nella sfera del ‘pubblico’: è in qualche modo la celebrazione dell’‘appartenenza’ ad un gruppo in modo definitivo: ma con l’annullamento totale della propria sfera privata100. Insomma un eccesso, che omeostaticamente può essere riequilibrato solo con il cambiamento di direzione verso il privato, verso la conquista della propria differenza: così reagisce alle proposte di Eudora, che lo va cercare tra i nazisti a Norimberga e suscita in lui comportamenti anomali in mezzo alla massa compatta (disturba le riprese di Leni Rosenthal, si muove mentre tutti sono fermi101) Così quando infine Zelig accetta di sposare Eudora Fletcher102 non è tanto perché lei lo ami, quanto perché nel matrimonio finalmente trova un centro stabile, una trama (un ‘piano’) in cui coesistono con bastante equilibrio il dentro (la ‘differenza’, il ‘privato’) e il fuori (la ripetizione di un modello che appartiene anche agli altri componenti della società, il ‘pubblico’): col matrimonio, la “guarigione” di Zelig è poter imitare un solo modello, interpretare un solo ruolo: il marito. Insomma il trionfo del modello statunitense dell’individualismo di massa. A questo punto forse è possibile cominciare a 48 dare un senso alla seconda scena del film (in realtà la prima scena della parte diegetica strictu sensu, perché la prima in assoluto propone il patto narrativo della linea testuale argomentativa): la sfilata trionfale nella Quinta Strada a Manhattan: la location suona per l’americano medio come una citazione obbligata di un testo epico – narrativo, in quanto è qui che si sono celebrate le vittorie dopo le varie guerre del XX secolo – solo che tutta la scenografia (che all’inizio è presentata con campo lunghissimo e dall’alto per comunicare proprio l’effetto collettivo di popolo che partecipa ad un rito identitario per rafforzare appunto con la ripetizione e con il numero il proprio particolare modo di ‘essere americano’) vede al centro – ironicamente – non guerrieri o personaggi che abbiano compiuto azioni utili alla collettività, ma solo due ‘comuni’ cittadini che hanno semplicemente fatto la scelta di essere ‘americani’: la fuga di Zelig dalla Germania insieme ad Eudora è in effetti una parodia della trasvolata di Lindbergh (la fanno a ... testa in giù!) e suona come una espressionistica caricatura dell’epopea dei supereroi che, nel secondo dopoguerra, hanno colonizzato l’immaginario americano (ed europeo). È messo in scena il trionfo dell’uomo medio, dell’uomo massa, che in qualche modo riesce a liberarsi del pericolo più grande, il totalitarismo, scivolando però nel conformismo o come dice la letteratura sociologica più accorta nella conformità, cioè nella scelta di stare alla regole, assumendo ruoli (Winnicot), ma con la consapevolezza di stare giocando, in qualche modo, di vivere all’interno di regole che vincolano ma che possono anche essere interpretate con ‘stile’ originale. Si pensi in effetti alla scena finale del film: la coppia che si espone alla riprese di una cinecamera, con movimenti particolari in uno scenario idillico: Il locus amoenus della campagna, la casa bassa, il portico, gli sguardi, il nascondersi, l’ammiccare. In questa scena l’importante non è tanto cosa viene rappresentata, ma il come. La cinepresa è parte per il tutto: vuol sot49 tolineare la definitiva e chiara natura ‘linguistica’ della nostra identità. Se è vero che noi siamo quello che gli altri ci riconoscono, l’io è un mero gioco linguistico (Mead103, Goffman104, Winnicot105): esiste una polarità costante tra un ‘io latente’ (che rimane separato da quanto appare nella scena sociale e sempre teso alle sue possibilità di sicurezza, ma mai in grado di attingere il proprio essere (Sartre)106) e l’‘io evidente’ (che si gestisce localmente nelle varie cornici che riconosce – interlocutori, gruppi, sfide..). Stando così le cose, fondamentali sono le denominazioni che attribuiamo alle cose in generale: ma ancor più i nomi che diamo alle persone, specialmente all’interno di un testo di ‘invenzione’ quale non può non essere un film: e allora è il caso di cercare di capire il sovrasenso di questo nome così esotico ai nostri orecchi, Zelig. La risposta è ovviamente nella filologia, nella ricerca di cause, derivazioni, per poter arrivare allo svelamento, cioè all’aletheia, non certo alla verità: ebbene un po’ di stupore sopravviene quando si scopre che la derivazione dallo yiddish107 ci propone il concetto di ‘benedetto’! allora quale è il ‘gioco’ linguistico in cui ci ha portati l’autore? Forse vuol dire che la ‘benedizione’ arriva come nel caso di Giobbe, consiste nell’esposizione alle contraddizioni della realtà, o nello scoprire il ‘non senso’ della realtà. O forse, più semplicemente nell’ironia dell’antifrasi: ecco quanto valgono le ‘nominazioni’ umane, quanto fraintendimento c’è nelle costruzioni umane. 50 3. L’ECONOMIA DELL’IDENTITÀ: IMITARE Ulisse, l’eroe classico; Excalibur, l’eroe medievale Per combattere questa entropia determinata dal comportamento omeostatico dei suoi membri, ogni comunità crea modelli antropologici di perfezione cui fare riferimento per combattere il disordine delle cose consuete. L’Essere (in opposizione al Divenire) viene rappresentata in forma di mythos, cioè attraverso racconti (ed eventualmente immagini materiali): insomma un ‘modello’ di uomo che nei suoi comportamenti particolari (nelle storie, avventure) che gli capitano propone lo schema (il frame!) di tutte le storie possibili108. L’uomo comune, debole e incerto, trova così un preciso punto di riferimento: nei casi dubbi sa cosa fare, basta che ripeta (imiti) lo schema dell’eroe. Naturalmente il contenuto ideologico di questa invariante rispecchia le specifiche realtà storiche, per cui l’eroe a volte è un saggio, a volte un guerriero: in ogni caso si tratta di individui superiori alla norma, capaci di trascurare il proprio specifico interesse per assicurare la sopravvivenza del gruppo109. Nella sua perfezione l’eroe incorpora, spesso contemporaneamente, quasi tutti gli elementi positivi degli archetipi junghiani: del senex la stabilità, la maturità, la saggezza, il senso di responsabilità; della persona la capacità di adattarsi; del puer le risorse creative e le capacità di rinnovamento; dell’anima la funzione relazionale (eros); dell’animus la funzione razionale (logos) e la constantia; del Sé la capacità di connettere, di dare struttura unitaria e totale totalità alle varie espressioni della psiche, sulla quale esercita un effetto ordinatore. Naturalmente la cultura occidentale conosce una infinita serie di eroi, che in un modo o nell’altro, propongono all’uomo comune queste categorie strutturanti per trovare senso nel 51 disordine delle proprie vite reali: ma appunto in rapporto al variare delle caratteristiche peculiari dei vari gruppi, questi archetipi finiscono per accompagnare diversi messaggi ideologici, diverse visioni del mondo. Per intenderci se troviamo queste caratteristiche in un santo o in un guerriero, uguale è l’effetto sulla psiche, ma diverso è l’effetto sul piano dell’azione sociale: se l’eroe è un eremita, lo stimolo è a vivere con parsimonia, a controllare il corpo; se l’eroe è un guerriero, lo stimolo è certamente a esaltare le potenzialità del corpo. Naturalmente il riuso che fa il cinema di questi modelli non è mai neutro: in un modo o nell’altro l’autore reinterpreta l’antico dalla prospettiva della sua visione del mondo ma anche e soprattutto tenendo conto della committenza (l’industria culturale che mira da un lato a realizzare profitti, ovvero ad avvicinare le vicende del film alle attese presunte del pubblico, dall’altra a propagare (se non proprio propagandare) precise ideologie, per realizzare l’egemonia culturale che trasformi in senso comune quel che è solo un punto di vista. Così la narrazione del mito di Ulisse o della vicenda (storica ma sentita come mito) di Spartaco nel corso degli anni Cinquanta del secolo scorso sono da connettere alla cornice della Guerra Fredda, ovvero della lotta tra le due visioni del mondo dominanti allora (capitalismo vs comunismo), riassumibili sbrigativamente nell’opposizione individualismo vs comunitarismo, ovvero – seconda la propaganda occidentale Libertà vs Schiavitù. Diversa è la narrazione dei miti celtici in Excalibur: siamo negli anni del ‘riflusso’ o dell’‘edonismo reaganiano’, e – stavolta all’interno del modello culturale occidentale – ormai circolano gli spiriti irrazionali delle controculture giovanili che combattono il modello borghese di una vita utile e seria, integrata nel sistema dell’economia produttiva, a favore della ‘immaginazione’, della ‘liberazione’ della ‘autenticità’. In fondo non si fa 52 che recuperare gli schemi consunti della cultura romantica di centocinquant’anni prima, per riportare in auge il modello del Ribelle, il mito dell’Altrove. Così Boorman opera una trasposizione quasi filologica delle saghe celtiche esasperando però le qualità della fiction in quanto fiction: mentre il racconto di Camerini nell’Ulisse del 1954 è per così dire realistico nella sua precisa ricostruzione di ambienti, costumi e scene110, quello di Boorman vira verso effetti espressionistici per quanto riguarda la fotografia, le inquadrature, gli effetti speciali111. Al di là delle intenzioni dei registi, è inevitabile che le storie narrate continuino a proporre autonomamente i propri nuclei ideologici: di sicuro ad accomunare i due racconti c’è il tratto che in genere accomuna gli eroi delle società premoderne, cioè la celebrazione del valore massimo della ‘misura’. La trama: Ulisse, di Comencini Comencini rispetta l’ordine delle vicende narrate nell’Odissea: prima la situazione di disordine che regna a Itaca (i Proci che sollecitano Penelope, l’impossibilità ad agire di Telemaco e di Laerte, la tela fatta e disfatta, il canto dell’aedo che ricorda la guerra di Troia), poi i Feaci e il racconto di Ulisse (Polifemo Sirene..), infine il ritorno e la vendetta. La trama: Excalibur, di Boorman Uther riportato ordine in Cornovaglia dopo aver vinto in battaglia il duca, ottiene dal mago Merlino Excalibur, la spada del potere e simbolo del regno, e anche la possibilità di possedere la moglie del nemico in cambio della cessione al mago del futuro figlio, Artù. Caduto in un’imboscata, Uther conficca la spada in una roccia. Diversi anni dopo molti cavalieri si sfidano inutilmente per provare ad estrarre la spada: vi riesce Artù, ap53 pena scudiere, che perciò viene nominato re. Con l’aiuto della spada magica vince anche l’invincibile Lancillotto, il migliore di tutti, sì che può finalmente consacrare il suo regno alla pace, facendo costruire una tavola rotonda attorno alla quale riunisce tutti i cavalieri, entro il castello di Camelot. Complica la scena stavolta non la guerra ma l’amore: quando Lancillotto e Ginevra, moglie di Artù, si innamorano, cercano di resistere al desiderio, ma invano. Scoperto il tradimento, Artù abbandona la spada e Il regno cade in rovina. Morgana, sorellastra di Artù, ne approfitta prima per apprendere la conoscenza da Merlino, grazie alla quale lo imprigiona nel ghiaccio, e poi per avere un figlio da suo fratello. Quando Artù si ammala e la terra continua a peggiorare assieme al suo re, i cavalieri allora partono alla ricerca del santo Graal, ma tutti falliscono. Dopo molti anni il figlio di Artù e Morgana, Mordred, reclama il regno, ma Perceval, trovato il santo Graal, vi fa bere il re che, così rinforzato, va in battaglia ancora con il sostegno di Excalibur, custodita nel frattempo da Ginevra, che si era fatta suora, e di Merlino, che in sogno istiga Morgana ad accettare la sfida con lui, e di fatto le fa perdere i poteri, fino ad essere uccisa da Mordred. Nella nebbia, i pochi cavalieri ancora in vita affrontano l’esercito di Mordred e vincono anche grazie al ritorno di Lancillotto: Artù e Mordred si uccidono a vicenda e spetta a Perceval il compito di gettare Excalibur in uno specchio d’acqua. Letture Proviamo ad analizzare i due film secondo una delle procedure metodologiche indicate, cioè osservando in particolare le cornici entro cui le storie sono costruite. 54 Ulisse, o della razionalità strumentale Nel caso di Ulisse i titoli di testa scorrono su uno sfondo che deve creare il patto narrativo: innanzitutto una musica di stampo grandioso, che vuole introdurre in una dimensione ‘epica’, staccando nettamente dalle mediocrità quotidiane che vivono appena al di là delle pareti della sala. La parte strettamente figurativa propone nel tempo questa successione: dapprima il cielo, ricco di nembi e cirri, ma molto luminoso; poi, con movimento dall’alto verso il basso, il mare scuro, con onde in movimento; successivamente una tempesta notturna con le acque frementi, ed ecco là in mezzo una nave antica di legno, con vele abbassate; infine il mare calmo e luminoso, di giorno, con un piano americano entro cui scorre la barca che avanza da sinistra verso destra, coi rematori forti e fieri; la nave viene poi ripresa da una prospettiva più alta e lontana, accompagnando il suo movimento nel mare in direzione trasversale, da poppa; infine la camera torna a inquadrare il cielo luminoso. Infine un tramonto rosseggiante sul mare, mentre scorrono in sovraimpressione parole che in modo enfatico raccontano la premessa della storia che sta per essere raccontata (Troia, sfida con Nettuno). Questi, sommariamente, i dati testuali: cerchiamo adesso di ipotizzare le implicazioni antropologiche sottese112. Il movimento iniziale alto/basso, nella sua ‘naturalezza’, in effetti rinforza una precisa visione del mondo: innanzitutto c’è una realtà chiara nella sua ‘differenziazione’ (il cielo vs il mare, l’aria vs l’acqua), ovvero c’è una realtà divina (colma di evidenza, in cui le cose appaiono chiare nella staticità delle immagini, anche se le nubi presenti sembrano poter indicare qualche minaccia) e una non divina, caotica nel suo movimento, torbida nel suo colore; in secondo luogo la direzione del movimento fa ri-conoscere allo spettatore occidentale una gerarchia ben 55 nota: il cielo è il mondo della luce, del bene, della qualità, il mare che sta in basso ed appare scuro è il mondo pericoloso dell’ombra, del male, della lotta. Insomma siamo al momento banale dei titoli di testa, ma già il campo ermeneutico è indirizzato allo spettatore senza far ricorso a parole dirette, che potrebbero insospettire) ma solo alle immagini: il messaggio subliminale è “tutte le storie del mondo, siano di uomini o di eroi, sono sempre la storia di una relazione tra chi sta su e chi sta giù”. Ricordando che siamo nel 1954, questa banale combinazione di immagini colori suoni (e infine parole) funziona già come aperta conferma dell’antropologia sacra della tradizione occidentale, e implicitamente – per default – come critica alla visione laica e materialistica della propaganda socialcomunista. La prima sequenza vera e propria ci introduce in un interno, ripreso con piano americano, che vede sulla scena, con movimento da sinistra verso destra, prima alcune ancelle che tessono, poi la nutrice che le redarguisce, e successivamente Penelope che chiede alla vecchia di aiutarla a interpretare un sogno; intanto cresce un rumore di fondo a sottolineare, fuori campo, la presenza di altri in un altro luogo della casa. Quando la scena apre su un totale del salone affollato dai Proci, sguaiati e vocianti, subentra un primo piano (alternato a dettagli su una mano che tocca le corde della cetra) in cui un aedo canta le vicende di Ulisse a Troia (scene che lo spettatore naturalmente vede, in una sorta di a parte, come facevano i cantastorie della tradizione mediterranea, in una luce meno nitida e attraverso una rapidissima successione di azioni, a sottolineare la non oggettività del racconto (cavallo, violenze, sfida sacrilega agli dèi, la maledizione di Cassandra). L’ultima scena del racconto dell’aedo vede Ulisse che viene aggredito verbalmente dalla profetessa: lei in alto su una scalinata, lui in basso circondato dalla massa di violenza e morte. La stessa disposizione alto/ 56 basso si trova nella scena in cui si torna alla sala della reggia: da una parte la regina, accompagnata dal vecchio Laerte alla sua destra e dal figlio Telemaco alla sinistra113; dall’altra il totale dei Proci che, ripresi poi in piano americano, assumono progressivamente una dimensione di individui affini ma diversi per i toni e le parole e i gesti114; dall’alto Penelope con l’aiuto dei suoi due uomini cerca di resistere agli oltraggi dei pretendenti, senza successo. Questi elementi potrebbero sembrare sorprendenti all’interno di un discorso eroico: le scene sono ambientate in interni e non su campi di battaglia. Ma l’eroicità di Ulisse è molto complessa, come si nota anche in sua absentia: a differenza di un campo di battaglia, che rappresenta semioticamente il campo aperto del rischio, dell’incontro con l’Altro, con il diverso, e quindi dello scontro, la casa – qualunque casa – in effetti rappresenta quella parte di realtà che artificialmente costruisce uno spazio di ius, che semioticamente segna con le sue mura la frontiera tra uno spazio di disordine possibile (fuori) e quello di ordine sicuro, garantito dalla permanenza di regole e gerarchia. Iniziare con l’ambientazione così familiare rinforza l’idea moderna della centralità della famiglia nella struttura della società, specialmente se si contrappone la parte più protetta (quella dove vivono le donne) a quella sociale dell’incontro con l’Altro (il salone). Se questo è lo sfondo antropologico, è chiaro che la situazione messa in scena è di un equilibrio rotto, di mancanza e disordine. Nello spazio privato femminile ancora in parte funziona il nomos, è rispettata la gerarchia: quel che è vecchio (nutrice) guida e consiglia quel che è giovane (ancelle) o meno giovane (Penelope). Lo spettatore riconosce facilmente il codice patriarcale, ed entra in empatia con i personaggi: insomma Penelope e la sua cerchia sono un preciso segno che rinforza la contrapposizione tra il sistema “famiglia” e il rischio dello stare 57 in comune, segno che favorisce una identificazione estetica (cioè di tipo emotivo) con quelli che di fatto sono valori etici. A rinforzare questa prima semina di indizi arriva, all’interno della scena stessa, un elemento sonoro: come già ricordato, mentre Penelope ed Euridice parlano, cominciano ad avvertirsi voci di fondo. La struttura d’ordine è resa precaria dalla presenza di ‘rumore’: le voci fuori campo, disturbando la comunicazione, segnalano allo spettatore che non si è in una situazione idillica e che è il ‘nemico’ (il disordine, il caos) è dentro casa. In effetti le scene di violenza, inganno e dissacrazione sono presentate prima attraverso il canto dell’aedo: se teniamo presente che la tela che fa da sfondo al colloquio tra Euriclea e Penelope rappresenta la famosa scena in cui Ulisse per non andare alla guerra finge di voler arare la sabbia e viene smascherato quando gli si pone davanti il figlioletto, allora la messa in scena della tela è un modo per sottolineare che in effetti la guerra ha trasformato Ulisse, l’ha peggiorato, facendogli perdere il senso della misura, la preferenza per la metis (mente) rispetto alla bia (violenza): e non è allora secondaria la scelta di disporlo in posizione di inferiorità rispetto a Cassandra. Egli ha mancato di rispetto al nomos, ha superato i limiti che la legge sacra pone (il vecchio ucciso, tra le voci fuori campo di bimbi, la statua divina divelta), si è appunto abbassato al livello della massa animalesca che si abbandona alle pulsioni di morte, invece di mantenere l’autocontrollo. La sua assenza allora, il suo ritardo, non sono senza colpe: sono effetto di questo ‘eccesso’, di questa oltranza, di questo mancato riconoscimento del nomos115. Insomma si trova in quella circostanza allo stesso livello dei Proci che adesso invasa la sua casa, attentano alla gerarchia, impongono prepotenze, non rispettano i confini sacri dell’ordine stabilito: anche essi stanno in basso rispetto a Penelope, anche essi sono tracotanti, peccano di hybris. Ma la loro presenza in casa sua è dovuta non solo alla effettiva incapacità personali dei singoli pretendenti di stare alle regole, bensì 58 proprio alla sua stessa tracotanza: la lontananza non è una scelta, ma una conseguenza del suo eccedere. Naturalmente l’impossibilità di agire da parte di Laerte e Telemaco in questa situazione rinforzano ancor più, in absentia, la necessità della presenza dl patriarca per ottenere il rispetto delle regole: le parole del vecchio non sono appunto che parole mancanti di forza, e le azioni del giovane sono mancanti di metis. Le scene finali ovviamente si collegano in modo circolare a quelle iniziali. Innanzitutto la gara con l’arco e la carneficina conseguente sciolgono nello spettatore l’attesa suscitata all’inizio dalla rappresentazione di una catastrofe imminente: l’ordine è stato restituito, il patriarca è tornato, il padre ha proposto al figlio la metis necessaria per dare efficacia alla passione, i portatori di disordine (i nemici interni alla casa, alla società)116 sono stati eliminati: è vero però che la catarsi finale comporta nuovamente il ricorso alla dismisura (come sottolineato dallo sguardo angosciato e stupito di Penelope che si trova sempre in alto rispetto a quel che avviene in basso). Sbrigativamente dopo un totale un cui la scena del massacro vede in fine il padre e il figlio accomunati117, in piedi, al centro della sala ricolma di corpi e di sangue, Ulisse lava le mani prima di salire da Penelope: il padre ha trasmesso al figlio la consapevolezza che l’azione per essere efficace dev’essere preceduta dallo studio, dall’analisi, dal ricorso alla metis; ma che nel momento dell’azione occorre essere eccessivi, lasciarsi guidare dal cuore selvaggio che alberga dentro di noi. In secondo luogo la riconciliazione finale suona facilmente come un inno al lieto fine, soprattutto una riscrittura in chiave sentimentale (ti amo) di quello che nel testo omerico è semplicemente il ritorno all’ordine, il riconoscimento dello ‘stesso’, come indizio del nuovo inizio. Per sottolineare l’epicità del narrato, la sua dimensione fuori del tempo, tornano ancora, come all’inizio delle scritte che ricordano il valore dell’eroe nei secoli. Insomma se non bastano le immagini, le parole rinforzano il messaggio proposto. 59 Questo percorso dal disordine all’ordine, dalla guerra alla pace, propone allo spettatore alcuni frames fondamentali per costruire delle certezze nella sua contemporaneità: l’armonia familiare dipende da quello che si combatte all’esterno; la pace, la vita armoniosa va conquistata anche a rischio della vita; ma soprattutto una vita mortale è preferibile a una vita immortale. È nell’episodio di Calipso (colei che nasconde) che emerge chiara in Ulisse, nella sua logica umanistica, una certezza: vivere continuamente in una dimensione senza fine, illimitata, di bellezza, pace, pienezza, senza tempo, fuori dallo spazio (l’isola di Calipso si trova ai confini estremi del mare) è meno attraente di una esistenza finita, limitata, dura, piena di sfide, vuota spesso, in uno spazio e in un tempo limitato. Come dice Luc Ferry, il rifiuto di Ulisse di diventare dio vuol comunicare che “lo scopo dell’esistenza umana non è, come penseranno i cristiani, ottenere con ogni mezzo, anche i più morali, e i più difficili da accettare, la salvezza eterna, giungere all’immortalità, perché una vita da mortale realizzata è di gran lunga superiore ad una vita da immortale fallita! in altri termini Ulisse è convinto che una vita ‘delocalizzata’, lontano da casa, senza armonia, fuori dal proprio luogo naturale, ai margini del mondo, sia peggiore della morte stessa”118. Insomma occorre preferire una condizione da mortale, ma conforme all’ordine delle cose (come appunto la morte e tanti altri limiti) piuttosto che tendere ad una esistenza infinita ma macchiata dalla tracotanza, dall’eccesso. Il senso delle cose esiste, insomma, solo in luoghi e con persone con cui si hanno legami, radici119, cioè solo se si ha una ‘identità’ di riti e situazioni che ripetono la tua appartenenza a qualcosa di storicamente determinato: i luoghi vuoti dell’astrazione, dell’indeterminato e dell’impersonale sono incapaci di dare una direzione di senso alla esistenza120. In definitiva la figura dell’eroe che viene disegnata all’interno di questa cornice, può essere interpretata, in coerenza con le 60 ipotesi della scuola di Francoforte, come archetipo dell’individuo borghese moderno, che costruisce la sua identità all’interno di un preciso luogo (la nazione) e che agisce nel mondo per risolvere problemi con gli strumenti propri della razionalità occidentale, efficaci ma ambigui: da un lato mostra una potenza demitizzante ed emancipativa121, ma anche la sua segreta complicità con il dominio: la sua razionalità da un lato consente di limitare122 gli eccessi dell’incanto’, la tracotanza delle passioni, di indicare come ci possono essere vie diverse per risolvere gli scontri; ma è anche evidente che la sua razionalità strumentale e calcolante è soprattutto utilizzata come mezzo di sopraffazione dell’altro, come autoaffermazione, così come viene celebrata dalla modernità razionalistica (da Machiavelli in poi)123. Excalibur Il patto narrativo viene cercato immediatamente con le primissime scene del film: sfondo totalmente nero su cui campeggia una scritta per esprimere in modo solenne, in coerenza con la musica orchestrante di ampia drammaticità, il clima gotico del racconto: l’età nera, quella della discordia. Si passa immediatamente a una sequenza caratterizzata da due colori. Il nero del buio della notte, il coruscante giallo del fuoco di fiaccole che illuminano malamente vaghe figure di cavalli scalpitanti; quando l’inquadratura da lunghissimo piano passa a piani più ravvicinati, mano a mano lo spettatore è in grado di riconoscere armature, movimenti obliqui, tagli non regolari delle scene, e nel fumo emergere un primo piano che mostra per un attimo un uomo che avanza, vestito di nero, con un bastone (o uno scettro?) in mezzo al fumo in movimento. Con una successione di campi lunghi e medi fino a piani americani, si individuano infine due figure: il cavaliere Uther e il mago Merlino, che si scambiano una richiesta (la spada del potere, Excalibur) e una 61 promessa (‘al lago’). Cambiata la scena, di fronte a Merlino e Uther, accompagnato dai suoi cavalieri, dalle acque ferme di un lago emerge Excalibur, portata su dalla mano di una donna (la Demoiselle du lac). Una volta ottenuta la spada, divenuto re, l’arrogante Uther esprime i suoi proclami (‘una terra un Re’, ‘questa è la mia pace’) ma viene spinto da Merlino a frenare la sua ambizione e a cedere parte del regno al controllo del duca suo rivale e appena sottomessosi. La terza scena avviene nel castello del duca: si celebra la pace con un banchetto e con una danza sensuale della moglie del duca che eccita la lussuria di Uther: ma a modificare la situazione sarà soprattutto il vanto del duca (tu sarai pure re, ma nessuna regina sarà mai pari a lei). A sottolineare la climax della situazione cresce la violenza del ritmo delle armi battute a ritmo come accompagnamento della danza. Uther si sente sfidato e allora, quarta scena, attacca il castello del duca: scene nuovamente notturne, con fuochi, catapulte, arieti, alternanza di prospettive dall’alto (duca) e dal basso (Uther) a sottolineare la condizione psicologica diversa. Infine Uther, impossibilitato a entrare nel castello, ottiene da Merlino, tramite un rito magico, di poter godere della moglie del duca: mentre quello è andato ad attaccare il suo castello, Uther volando sopra le nuvole a cavallo, assume le sembianze del rivale, entra nel castello e possiede la donna, sotto lo sguardo consapevole della figlia Morgana che lo vede per quel che è e che in sogno apprende della morte del padre. Merlino come da promessa, avrà il figlio della violenza: Artù. Le scene finali mostrano, in successione, dapprima l’ultima battaglia, nella nebbia fluttuante, poi il lancio della spada nel lago (raccolta dalla mano della Demoiselle du lac) da parte di Percival, in un clima grigio e brumoso, e infine la visione dall’alto di una barca che porta al largo, verso il mare, il feretro di Artù, ucciso dal figlio Modred. L’ultimissima scena, col sottofondo epico di musica cupa, propone un lunghissimo piano in cui la 62 barca è ormai minuscola, sulla sinistra nella parte bassa dello schermo, mentre intorno e in alto ci sono nuvole e acque che si confondono, a sottolineare la grandiosa asimmetria tra le forze della natura e la presenza dell’uomo, presente peraltro nella sua sconfitta (la morte). La particolare attenzione ai colori e alla fotografia nelle scene d’apertura vogliono sottolineare la differenza con i colori vivaci e brillanti delle scene che caratterizzano la vita della Cornovaglia quando con Artù davvero il castello (segno semiotico per eccellenza nella cultura cortese, in quanto espressione di ordine al suo interno e di forza verso l’esterno) è luogo di ius e non di vis: ecco, i tempi neri sono quelli in cui esiste il disordine caotico delle contese; i tempi belli sono quelli della pace, quando la guerra diventa il gioco del torneo, quando alla sfrenata violenza succede il controllo delle regole d’ingaggio124. In questa serie di scene, Boorman pare abbia messo in scena il tema centrale della teoria della mimesis di Renè Girard: come del resto già sottolineato precedentemente, la caratteristica fondamentale dell’uomo è la ricerca della sicurezza e questa sicurezza si trova soprattutto nella ripetizione, nella imitazione come mostra ampiamente lo Zelig di Woody Allen: per Girard però questo processo di ‘ripetizione’ non porta solo alla conquista di una sicurezza psichica (faccio quel fanno gli altri), ma anche alla crescita della conoscenza (anzi è il modo fondamentale con cui il singolo acquista conoscenza). Ebbene questo processo che costruisce ordine per il singolo in effetti procura disordine per la società: il rischio è in effetti che attraverso la mimesis si produca infine l’indifferenziato, ovvero una condizione in cui non esistono più differenze, categorie che creano distinzioni e consentano gerarchie. Se la possibilità di dare senso al mondo è passare dal caos al cosmos, il cosmos (l’armonia) consiste proprio nel riconoscere le diversità e nel costruire chiare relazioni tra loro (gerarchie appunto). Ora il racconto di Boorman con la forte carica espressionistica che usa 63 per rappresentare la condizione di caos, in effetti sembra sottolineare come l’assenza di chiare distinzioni porti all’impossibilità dell’ordine, cioè dell’armonia e della pace: Uther e il duca non sanno stare ai patti, non sanno mantenere le distinzioni appena dichiarate (tu re, tu duca), perché insistono entrambi - con motivazioni in superficie diverse ma in fondo identiche - sulla propria volontà mimetica, sulla propria volontà di fare quello che fa l’altro, ovvero sul desiderio di avere quello che ha l’altro. Quando il duca vanta la moglie di fronte a Uther in effetti vuole ribadire che anche lui ha qualcosa di unico, come il re ha la spada: e la lussuria che porta Uther a rompere la pace non è altro che luxus come dice la semantica della lingua latina, ovvero eccesso, tracotanza: vuole la donna del duca perché vuole avere la sua stessa ‘cosa’, esattamente come il duca vuole avere la sua ‘cosa’, la spada. La competizione che nasce dalla mimesis si può gestire, in termini di retroazione, solo se i contendenti sono capaci di retroagire rispetto alla loro voglia di mimesis, se attenuano l’ambizione, la voglia del tutti contro tutti: ma questo, secondo Girard, avviene solo attraverso una nuova forma di competizione: non il tutti contro tutti, ma tutti contro uno, ovvero con il sacrificio del capro espiatorio. Questa parte misterica è affidata nella saga celtica alla figura di Percival, che incarna la figura del cavaliere che va in cerca non della donna, ma del Graal, che è una coppa ma che si identifica con tutto il misterioso rituale del re malato, ovvero dell’individuo che si sacrifica per consentire la pace. Cert’è che, se sacrificio viene da sacrum + facere, la violenza del capro espiatorio significa riportare appunto ad un rapporto equilibrato con l’indistinto, l’intoccabile, la confusione originaria, ovvero con la natura. Insomma l’ordine umano (la volontà umana di creare ordine: simbolicamente i re, la spada) è sempre un’artificiale distinzione di categorie e di gerarchie che, in una continua retroazione di rinforzo positivo della mimesis, procura infine catastrofi, da cui è possibile liberarsi solo con un capro espiatorio (meglio se consapevole e volontario): ed è 64 quello che avviene alla fine del film, quando Artù si sacrifica, torna a combattere vecchio per liberare il regno dalla tracotanza crudele e violenta del figlio, e infine muore, celebrato con il funerale nell’acqua. Come la spada ritorna all’acqua, anche Artù torna all’acqua: come dire che si torna all’indifferenziato della natura. Al sacro delle forze primigenie. La logica che emerge da questo accostamento Excalibur/mimesis è particolarmente consentaneo ad una parte della ‘mitologia’ della new age che si afferma sulla spinta del movimento sessantottino (l’indistinto della natura è da preferire al distinto della civiltà; la ‘pace’ data dal rifiuto delle categorie è preferibile alla ‘guerra’ imposta dalla affermazione delle categorie, delle gerarchie e della competizione). A rinforzo di questa prospettiva c’è anche la componente centrale del mito celtico, la magia: la figura del mago Merlino, protagonista di aforismi epidittici e di interventi decisivi nella ratio degli avvenimenti narrati, impone di riflettere sul film anche da una prospettiva epistemologica. La sua persona in fondo vuol rappresentare una visione del mondo secondo cui accanto al modo tipicamente umano di creare ordine procedendo alle distinzioni, creando categorie che ci liberano dalle angosce del sacro, esiste il modo analogico della con-fusione, in cui le differenze scompaiono, in cui l’ordine è dato dalla capacità di superare i limiti del visibile per attingere alla realtà (altrimenti inconoscibile) dell’invisibile. Merlino, che sa di essere alla fine dell’epoca della magia per l’avvento del cristianesimo125, che colonizzerà diversamente il campo dell’alea, del desiderio, del timore126, in effetti sintetizza concretamente alcune certezze antropologiche espresse dalla magia: egli esprime il suo potere d’azione tramite il linguaggio (si pensi alle strane parole pronunciate in occasione di vari sortilegi), tramite il ricorso alle analogie e al rito. Le sue pratiche in effetti sono esattamente quel che caratterizza la civiltà umana: come già detto 65 sono le parole che danno vita alle cose (esistono solo le cose che siamo in grado di nominare, esistono solo le relazioni a cui sappiamo accoppiare dei segni)127; è il rito (cioè il costruire una sequenza di gesti, suoni, movimenti, giaculatorie) che dà struttura al tempo e senso di appartenenza, tramite il principio (ancora) della ripetizione128; è l’analogia che costruisce ponti che aprono nuove vie alla conoscenza, che collega quel che la ratio vuole allontanare, è l’analogia che sa dire le cose attraverso immagini invece che attraverso concetti. Insomma la magia non è altro che forma narrativa antica per sottolineare l’esistenza di un modo di entrare a contatto con la realtà (il mythos) alternativo alle astrazioni del logos129. In conclusione come si diventa eroi, in che consiste essere eroi secondo questo film? Attraverso la differenziazione, spostandosi, dal mondo dell’imperfezione a quello della perfezione, come appare dallo sviluppo del personaggio di Artù: prima accetta il ruolo di scudiero (ovvero l’ordine gerarchico dal basso); poi accetta il ruolo di cavaliere (una volta avuto il ‘segno’ dell’elezione: tira fuori la spada dalla roccia) mostrando ‘misura’ e ‘generosità’; poi commette l’infrazione (imita Lancillotto nel desiderio di Ginevra e perde la spada); infine recupera il ruolo e la spada fino al sacrificio/rinascita. Tutto questo, detto nel 1984, sembra suggerire agli spettatori che è davvero l’ora di lasciare un po’ da parte le argomentazioni quadrate, le ferree logiche delle progettazioni soggettive e collettive, e di tuffarsi nei beati meandri dell’analogico: l’arte, il ritmo, lo spirito, l’oriente diventano allora soprattutto una moda, che consente di curare le illusioni brucianti delle utopie mancate, del narcisismo gabellato per impegno, e dell’engagement (come si diceva negli anni Cinquanta). Comincia la generazione dell’Aquarium, come proclamava un musical dell’epoca. 66 4. ECONOMIA DELL’IDENTITÀ: DISTRUGGERE Brancaleone alle crociate, di Monicelli Alla costruzione dell’eroe corrisponde quella dell’antieroe Infatti, se le società umane, nella loro lotta contro l’entropia, elaborano modelli di comportamento che vengono proposti come perfette descrizioni dell’Essere che non varia130, ovviamente l’esperienza quotidiana dominata dall’imperfezione del ‘flusso’, ricorda continuamente che l’esistenza concreta è segnata non dalla precisione ma dall’approssimazione, non dalla ripetizione ma dall’imprevedibilità, non dal successo ma dall’insuccesso, non tanto dall’ambizione della mente quanto dai limiti del corpo: e allora gli esclusi, i reietti, gli ‘inferiori’ danno luogo alle caricature espressionistiche del carnevalesco131. Semplificando, potremmo sintetizzare questo atteggiamento antropologico con una espressione del genere: “non so quale sia il vero ordine delle cose, ma sono davvero chiacchiere senza senso le regole che vogliono far passare sulla mia testa”132. L’antieroe naturalmente trova spazio anche, anzi prima di tutto, all’interno della cultura dominante: si pensi a Tersite quale oppositore di Ulisse nell’Odissea, ai nani presenti nei romanzi cavallereschi del medioevo, al diavolo133 come nemico del Dio cristiano. Tramite queste figure si rafforza in effetti la tessitura semiotica del sistema; il bene viene meglio compreso solo se ‘de-finito’, cioè se si segna una frontiera che segnali in modo netto la differenza134. Ma naturalmente nel carnevalesco i portatori del segno del disordine e del male prendono il sopravvento su quelli dell’ordine e del bene, proprio perché percepiti non come essenze 67 ‘naturali’ ma artificiali imposture. Rimangono le separazioni, le categorie di classificazione del reale, ma vengono rovesciate le gerarchie epistemologiche, e conseguentemente anche i valori etici e i modelli di comportamento135. Brancaleone è da questo punto di vista una figura esemplare: nella costruzione di Monicelli egli assume il punto di vista di un vero cavaliere, nel senso che ‘vuole’ essere un eroe, nella convinzione che per esserlo basti eseguire i protocolli del codice cortese, espressione manifesta dell’ordine perfetto che tiene insieme nel profondo il mondo; ma le sue intenzioni, le sue azioni, nella costruzione della trama, mostrano l’inevitabile collisione con l’inesorabile disordine del Divenire. Brancaleone vorrebbe vivere la dimensione del ‘sublime’ ma si trova far i conti con le bassezze del ‘comico’. Trama Brancaleone, mentre è diretto in Terra Santa, alla guida di pellegrini fedeli al papa Gregorio, è attaccato da seguaci dell’antipapa Clemente: si salvano solo quattro persone oltre lui, che, sentendosi disonorato per non essere morto in battaglia, invoca l’Angelo della Morte che gli si palesa. Ma Brancaleone, spaventato, gli chiede una proroga, per poter compiere una gloriosa impresa, che gli viene eccezionalmente concessa136. Insieme alla nuova armata dei quattro sopravvissuti, riprende la via verso Gerusalemme e incontra nuove avventure. Innanzitutto strappa un neonato, figlio di Boemondo re di Sicilia partito per una crociata, dalla mani di Thorz, mercenario che lo vuole uccidere su ordine del fratello del re, il principe Turone di Squillace: cavallerescamente si impegna a riconsegnarlo al padre, a Gerusalemme. Lungo il percorso, Brancaleone continua ad agire secondo l’etica del cavaliere ‘senza macchia e senza paura’: così aiuta deboli d’ogni tipo, che include pro68 gressivamente nel gruppo di pellegrini: prima un penitente (da sé nominatosi “Pattume”, condotto fino ad un eremita che lo potrebbe assolvere); poi una ragazza, presunta strega, strappandola dal rogo; e ancora un lebbroso (che in seguito si rivelerà essere la principessa Berta d’Avignone). Inoltre, dopo aver incontrato un albero con delle persone impiccate (con cui riescono a parlare grazie alla strega) ed essere sfuggito al principe Turone e ai suoi soldati, si offre come scorta del papa (Gregorio) in visita a uno stilita nel deserto, e – stavolta malvolentieri – come ‘campione’ in un giudizio di Dio con cui si risolve la contesa fra papa Gregorio e l’antipapa Clemente. Arrivato finalmente in Palestina, Brancaleone riconsegna il bimbo a Boemondo. Diventato nobile sul campo, Brancaleone può battersi contro il principe Turone, alleatosi con i Mori, mirando in effetti ad avere la mano della bella principessa Berta: ma perde la contesa per un maleficio della giovane strega innamorata di lui. Brancaleone la insegue nel deserto dove si ripresenta l’Angelo della Morte, venuto a reclamare il suo credito: quando viene a sapere che sono stati uccisi tutti i cristiani tranne la principessa Berta d’Avignone, il soldato Thorz che si è convertito all’Islam ed il re Boemondo, accetta la sorte (la morte) ma l’affronta a modo suo, combattendola. Riesce anche a sferrarle un colpo apparentemente fatale: ma la morte non può morire. Ciononostante Brancaleone riuscirà a salvarsi grazie alla giovane strega che, per amore, si immolerà al suo posto, facendo andare via la Morte. Alla fine si rimette in cammino nel deserto, ma incontra una gazza, che riconosce essere la giovane strega Felicilla. Forma L’opera di Monicelli, ma dovremmo dire di tutta la commedia cinematografica degli anni del primo dopoguerra, ha mostrato 69 la profonda efficacia conoscitiva ed etica del comico, superando tutte le prosopopee dei filosofi tradizionali, seri, dimostrando come questo stile è ben più che uno stile: o meglio che questa forma, proprio per la sua particolare maniera di selezionare e connettere gli eventi umani, è capace di superare le rigidità e le arroganze del pensiero serio: anzi nella forma particolare della satira, ne è il correttivo omeostatico, ne è lo stimolo vitale che consente anche al tragico di rivivere137. In senso generale (in accordo con le tesi di Huizinga, Bergson, Frye e Bachtin) si può senz’altro affermare che - la satira (il riso, grottesco, espressionismo, realismo) demistifica il falso (idealismo, sublime, calligrafismo); - la satira impone distanza (ratio, ethos) invece che vicinanza (coinvolgimento, pathos); - la satira è metaconoscenza (riflessione, conoscenza della conoscenza, di come funzionano i meccanismi di ‘falsificazione’ della conoscenza, della ‘cultura’ alta); - la satira decostruisce la superbia antropocentrica, la hybris.138 E Monicelli nel personaggio di Brancaleone ha saputo far fluire tutta una serie di suggestioni ‘alte’, come quelle di Shopenauer139, Pirandello140 e Bergson141. In effetti è come una macchina che ‘ripete’ secondo i meccanismi girardiani della mimesis, che indefessamente ricorre ai protocolli che conosce come guida alla perfezione, senza mai tener conto del contesto; insomma si ride della meccanica adesione all’‘essere’ (in una qualunque delle sue manifestazioni esistenziali) senza tener conto del ‘divenire’ delle cose, dei contesti, e così via. Insomma il riso di Monicelli è come il riso di Democrito che si oppone al pianto di Eraclito: alla compartecipazione, alla pietà dominanti, alla ‘falsa coscienza’ imperante, al ‘buon senso’, alle parole del potere, alla corsa all’omologazione, oppone il 70 disincanto142, il distacco di chi ‘sa’ che tutte le preoccupazioni umane sono ‘inutili’, senza senso, sul piano della realtà ontologica: sono ‘gesta’ senza sostanza, per cui non vale la pena troppo preoccuparsi. Alla fine c’è sempre la Morte: e l’unica cosa seria da fare è in fondo imparare a morire. La visione di Brancaleone, la catalogazione di tutte le sue inadeguatezze143 porta in effetti lo spettatore ad acquisire un atteggiamento critico rispetto alle ‘sorti magnifiche e progressive’ vantate dall’Italia del boom perché, dai suo clamorosi fiaschi, impara che se c’è un pericolo nell’affrontare la nuova strada della modernità è l’eccesso, la fissazione irriflessa, l’adesione totalizzante al nuovo stile di vita rampante e libertario: impara che il ridicolo si nasconde proprio nelle cose ‘serie’, nei fatti e nei gesti quotidiani, nelle pieghe del discorso, nelle più banali situazioni o vicende, se non si è capaci di leggere il contesto, di interpretarne le anomalie e di esitare prima di applicare meccanicamente le proprie routines, che con la loro adesione mimetica all’identico, sembrano garantire sempre la sicurezza. Brancaleone è appunto l’antieroe adatto a demistificare l’entusiasmo modernistico degli anni sessanta che ha innescato l’avvio della tragica (questa sì, purtroppo) mutazione antropologica denunciata da Pasolini, che porta fino alle sciagurate derive della contemporaneità: il nuovo modello ‘industriale’, nel suo avventurismo, non riesce più a comprendere il disaccordo tra le idee e le cose, e perde il senso del limite, la capacità (la necessità) di autoregolarsi.144 Naturalmente il modello di Brancaleone è ancor più attuale oggi, epoca di assolutismi mascherati da libertà: nell’epoca della società ‘liquida’ occorre ricorrere alla modestia epistemologica, per dirla con Bauman, non solo se si presume di essere intellettuali, ma in ogni procedura, in ogni relazione, in ogni esistenza. È la riscoperta dell’autarcheia145 stoica, della limitazione epicurea come pratiche sommative di difesa nel 71 mare magnum di una società in cui l’individuo è lasciato solo a se stesso: il disincanto, la leggerezza, la provvisorietà, la soglia, la imminenza della fine, sono la via che porta non solo alla ‘robustezza’ come dice Nasim Taleb ma ad acquisire l’antifragile capacità del flaneur razionale, che al contrario del turista146, prende a ogni passo una decisione in modo opportunistico per riadattare la sua tabella di marcia (o la tappa successiva) così da poter assorbire le cose in base alle nuove informazioni ricevute”. Insomma ‘ricercare’ opzionalità invece che estirpare il caso dalla nostra vita147. Per riaffermare continuamente questo processo di disincantamento dalla rigidità e favorire l’avvicinamento alla flessibilità, Monicelli procede in modo chiaro: ogni volta che la situazione è sul punto di volare alto, spinta dalle circostanze verso un eroico ardimento, verso un successo clamoroso o una vantaggiosa opportunità, eccola franare ignominiosamente148, e il cavaliere si muove come un clown impacciato149. A rinforzare questo processo di mescolanza tra alto e basso, tra sublime e grottesco intervengono ovviamente anche le scelte linguistiche. Gli sceneggiatori, Age e Scarpelli, continuano a far parlare i vari personaggi in una sorta di gramelot alla Dario Fo, in cui si mescolano latinismi e dialettismi, capaci di dare un sapore di ‘autentico’ antico, ma rispetto al primo film, riducono al minimo il goliardico per le risate facili, e ricorrono a citazioni e intertestualità, fino a introdurre il gioco degli ottonari a rima baciata, nel momento in cui a cui entra in scena Boemondo. È vera e propria parodia di uno stilema del sublime. Infatti la presenza di personaggi di lignaggio alto, comporta, secondo la teoria della divisione degli stili, l’innalzamento del registro: e così fanno gli sceneggiatori, che accompagnano la scenografia imponente del campo militare reale, ricco di addobbi e di 72 sfarzo colorato, con l’improvviso innesco di un eloquio in rima, sorprendono e divertono ulteriormente lo spettatore a danno delle smancerie rituali, cui per tradizione si deve ricorrere in tali situazioni: una ritmicità forte che fa rilevare un cambiamento, per così dire, di clima. Anche chi non sa di metrica avverte negli ottonari adottati dal re e da Brancaleone che si è entrati in una sorta di gioco delle parti, in un tipo di duello particolare dove contano le ‘forme’ più che le cose, per mostrare la propria ‘mimetica’ adesione ad una norma ‘alta’. Brancaleone infatti si adegua perché pensa che sia finalmente venuto il momento della realizzazione del suo ideale del divenire cavaliere. Parlar per rime è come conformare la giustezza delle sue ambizioni: non conta solo e tanto l’azione, ma il modo in cui si fa150. Ma anche in questa situazione l’attesa viene smentita e il successo pregustato si tramuta in beffa. L’elevata qualità letteraria del secondo Brancaleone trova conferma ovviamente in più occasioni, nel senso che si sa adeguare alle situazioni scegliendo le forme necessarie per affrontare i problemi. Così, ad esempio, si autodefinisce Brancaleone quando si rivolge al papa, per cercare di evitare la prova del fuoco, come invece gli impone la sua avventata candidatura a campione in difesa dell’antipapa: “Sono impuro. Eh eh! Bordellatore insaziabile, beffeggiatore, crapulone, lesto di lengua e di spada, facile al gozzoviglio... fuggo la verità e inseguo il vizio”. Non si limita a parole sconclusionate, ma argomenta bellamente, proponendo prima di tutto la tesi generale (‘sono impuro’, predicazione che rivela piena consapevolezza della questione teologale di cui si sta dibattendo) e successivamente le argomentazioni che si appoggiano, secondo le procedure della retorica scolastica, a categorie generali del vizio, non a singoli episodi, troppo deboli per convincere l’uditore; non secon73 daria è anche la struttura retorica del periodo, che in forma di climax passa da vizi deboli (incontinenza) a vizi forti (matta bestialità) e fortissimi (malizia) rivelando una nascosta citazione della struttura etica che sorregge la struttura dell’Inferno dantesco. Questa insospettabile letterarietà si ritrova ancora in citazioni più o meno esplicite151 ma è la fonte nascosta di tutta la straordinaria koinè parlata dai vari personaggi: lingua vera e propria, dunque, che mescola un latino maccheronico ai dialetti regionali italiani, con un paradossale ma assoluto effetto di verosimiglianza, fino a creare nello spettatore l’impressione di penetrare in una reale dimensione storica. In questo senso è straordinaria la cantilena che ritma il cammino dolente dei pellegrini capace di sintetizzare in effetti quel medioevo nascosto dallo stereotipo accademico di stampo clericale misticheggiante: “Senza armatura / Senza paura / Senza calzari / Senza denari / Senza la brocca / Senza la gnocca / Senza la mappa / Senza la pappa / Senza cavallo / Né caciocavallo / Vade retro Satan!” Questo canto isola gli elementi che caratterizzano quello che Monicelli mette in scena accanto a Brancaleone: una umanità povera, senza poteri, indifesa, affamata, senza guida affidabile, ma robusta nell’affrontare il male, perché a differenza dei preti, sa che la vita è tutta qui, e perciò non ha nulla da temere, non cede minimamente alle lusinghe fragili del desiderio (il demonio). Insomma una umanità umile ma antropologicamente sicura. I pellegrini infatti sottolineano in questa cantilena da cuccagna, come il male vero non è metafisico ma concreto: e vanno tutti dietro al profeta che promette di dare certezze, rinviando al ‘lontano’ (terra santa) e al ‘futuro’ (oltremondo) la realizzazione del ‘bene’. Insomma la religione dà una direzione immediata all’interno del flusso costruendo sia una ‘rappre74 sentazione‘ del mondo (alto\basso, gerarchia spirito>corpo) sia delle pratiche (modelli di comportamento) che ‘trascinano’ anche la gente comune (monaco, eremita, stilita, crociato): immagini di greggi dietro il ‘buon pastore’. In qualche modo una anticipazione dell’ ‘etica del viandante’. Anche con queste invenzioni linguistiche152 insomma il film demistifica la tradizionale immagine scolastica (libresca) di un medioevo dotto, pio, eroico (tutto spirito): di quell’immaginario si ripresentano le varie tipologie sociali (penitenti, pellegrini, crociati, streghe, stiliti, eremiti, papi e antipapi, cavalieri, principesse, lebbrosi, ordalie, giudei, mercanti, incursori, vagabondi, gogne, roghi…) ma per destrutturarle e risemantizzarle, per fare cioè una vera e propria opera di ‘verità’ filosofica attraverso lo ‘svelamento’ non certo attraverso le affermazioni di paradigmi. Quali allora le falsità svelate? La Morte non come inizio della perfezione (come asserisce l’escatologia cristiana) ma come segno assoluto della precarietà della condizione umana (lo testimoniano gli scismatici a testa in giù, gli incontri con la Morte, l’albero degli impiccati, il rogo per la strega, la malattia del lebbroso...). Poi circa il problema dell’identità, l’Eroe presentato come un ‘giocatore’, un eroe che è tale non perché perfetto o perché vince ma perché ‘tenace’ nel ‘desiderio’, nella volontà di perseguire un senso. Circa la magia, si sottolinea che di fatto essa non ha a che fare con il male e che il legame col diavolo consiste in una forma di conoscenza alternativa a quella di chi esercita l’egemonia culturale, ovvero ad una modalità di relazionarsi con il mondo, che ha che fare soprattutto con il corpo, attraverso l‘esasperazione’ dei sensi: Felicilla, la giovane strega, è certamente por75 tatrice di uno stile di vita centrato sugli affetti, in senso positivo e in senso distruttivo, con gli eccessi della istantaneità delle pulsioni; ma è l’unica forma di relazione che apporta calore e dono in un mondo o troppo pragmatico o troppo illuso. Anche su i valori simbolici dello spazio, si propone una risemantizzazione: è la Natura che offre opzionalità antifragili superiori a quanto offre la ‘città’, cioè la società organizzata in polis con regole e vincoli: è nel deserto che si apre la scena dei pellegrini in viaggio nel nulla, è nel deserto che si chiude la storia con Brancaleone felice della compagnia di Felicilla-gazza; è il deserto che rivela nella sua arida asciuttezza l’‘arido vero’ della realtà umana, senza orpelli: partenza e inizio della storia umana quindi. Anche la strada (il cammino) col suo labirinto di possibilità, offre la sorpresa di incontri, quindi la possibilità di ‘rivelazione’, al contrario delle strutture chiuse, che coi loro vincoli escludono il ‘diverso’. È in un villaggio tutto ben costruito, razionalmente organizzato che si celebra il processo alla strega. Infine la messa a fuoco reiterata della ‘futilità’ del teatro clericale, sia nelle ‘scene’ dei santi (inutili a sé e ingombri di polvere, come l’eremita e lo stilita, che al momento di affrontare problemi si dichiarano di fatto incompetenti), sia in quelle delle dispute teologiche che però (leopardianamente) aggiungono male a male. Due scene esemplari Primo dialogo con la morte: “Brancaleone: E voaltri, voaltri, rognosi! Come osaste voi restar vivi fra cotanti morti? Chi vi dette tanto infame coraggio? Uno dei sopravvissuti: E a te, chi te lo dette? Te, campi come nui altri. 76 Brancaleone: No, eh! stupido cieco! Non come voaltri... (pausa) Onta, onta su di me! Che l’onta mi sommerga e mi soffochi! Che mi sia tolta la colpa d’essere vivo fra cotanti morti! (si allontana, verso il deserto)”. L’eroe si distingue dagli altri non nella realtà dei fatti (è vivo come i compagni) ma nel ’modo’ in cui vive la situazione: l’uomo comune è più che contento di quello che sta succedendo (hanno salvato la pelle), sulla base della visione ‘limitata’ dell’uomo\animale fermo alle pulsioni di base, che risponde spontaneamente al bisogno di vivere, a qualunque costo; l’eroe è invece capace di ‘dare senso’ a quello che sta vivendo, lo interpreta in modo ‘ideologico’, sulla base di un filtro ‘culturale’ che gli torna chiaro proprio di fronte alla percezione della contraddizione che gli viene dall’Altro. La sua differenza sta nella riflessività, diremmo con Giddens e Beck, ovvero – con linguaggio ‘umanistico’ – nello ‘stile’: ‘onta’ è l’antitesi di ‘onore’; e ‘onore’ vuol dire aderire ad un ‘codice’ (ad una forma) e applicarne le ‘regole’ in modo da differenziarsi dalla massa anonima. Il soggetto che ‘sa’ della ‘necessità’ dello ‘stile’ come ‘fondamento’ della vita umana (cfr. umanesimo) può anche sbagliare (può tornare ad essere vittima delle pulsioni), ma sa anche correggersi per riprendere la strada ‘retta’ appena lasciata. “Brancaleone (solo, nel deserto): Vieni, Morte, bella Morte: piglia anco me! Orsù, che indugi? Io ti invoco, tu non mi spaventi! Che è mai la vita? Un breve romore, seguito da un fiato ammorbante... E però vienimi, vieni Morte! Strappami ad essa, ti affretta! Che fai, Morte? Tentenni? Presto, accorrimi, più non reggo! Io te l’impongo!” Una volta solo, nella sua interiorità, l’eroe lascia da parte i gesti rituali da bravaccio e rivela – senza più dover recitar davanti agli altri – il suo ‘sé ideale’: più che un guerriero atto a menar le mani si rivela un filosofo, ma un filosofo democriteo, non uno di quelli che aspirano a consolazioni ideali, a trovar giusti77 ficazioni a quello che succede nel mondo: ‘Che è mai la vita? un breve romore, seguito da un fiato ammorbante’. Romore è senz’altro da intendere prima di tutto nel suo significato letterale di suono dissonante, che non si riconosce come ‘armonia’, cioè ‘ordine’; quindi disturbo; ed è in questo senso metaforico che nella teoria della comunicazione sta a indicare l’impossibilità di ‘comunicare’, ovvero di trovare un ‘messaggio’, un ‘senso’ nelle cose. Semplice che esso sia ‘breve’ rispetto al ‘desiderio’ senza ‘limite’ tipico dell’uomo, macchina desiderante all’infinito, che mira sempre ad altro, all’’oltre’… Quanto al fiato è chiaro che è un ironico parodico ri-uso del termine ‘anima’ che in latino significa ‘respiro’, ovvero ‘vita’ nella sua dimensione più materiale, senza allusioni metafisiche. La vita è un ‘fiato’ (traduzione quindi, corretta filologicamente più di tutte le letture idealistiche e religiose); ma a togliere ogni prospettiva estetizzante di armonie e idilli rinascimentali arriva l’aggettivo ‘puzzolente’ a sottolineare che ha nella sua struttura ontologica la putrefazione, che è destinato alla dissoluzione, che non è ‘ordine armonico’. Insomma alla domanda metafisica per eccellenza, segue una risposta ‘ironica’ per eccellenza: non c’è senso nella morte perché non c’è senso nella vita. “La Morte: Son qua. (la morte parla con accento toscano) Brancaleone: Chi è? Chi tu sie? La Morte: Son la tua morte. Non mi chiamasti? Brancaleone: Io? La Morte: Sì. Fosti tu ad invo’armi. Brancaleone: Ah... sì... son parole che sfuggono nell’empito dei sentimenti... Che si sape, mai furon prese a serietà. La Morte: D’ora innante lo saranno. Preparati a morire.” Il topos dell’incontro con la morte mette a nudo la dimensione ‘teatrale’ della scena precedente: Brancaleone anche quando 78 sta da solo in effetti sta recitando la parte dell’eroe riflessivo; insomma si atteggia, come davanti ad uno specchio, assumendo pose e parole ‘magnifiche’; è come se stesse a ‘giocare’ a fare la parte del ‘gran cavaliere’, come un qualunque bambino che gioca ‘al dottore’… è davanti allo specchio della propria ‘coscienza’ (se la vogliamo chiamare così) e sceglie le ‘pose’ più adatte a confortarlo, a rimettere a posto la figuraccia fatta davanti alla gente comune poco prima. Il sé ideale come medicina del sé reale: una risemantizzazione dell’errore. Ma la comparsa della Morte (che nel mondo reale, si sa, non avviene) sconvolge la situazione: gli sceneggiatori scelgono di portare sulla scena (giusto secondo quanto avviene nei poemi epici, in cui il fantastico è strumento di varietas ma sopratutto di rappresentazione ‘materiale’ di processi ‘mentali’) la metafora del dialogo con la morte (che è tipica del filosofo ‘solitario’, tipico dell’esame di coscienza, tipico degli esercizi spirituali dei gesuiti) per far capire come nel profondo anche l’eroe (l’uomo che si presume superiore agli altri, l’uomo che non teme la morte, che non ha paura) ha invece paura, teme quindi la morte come rappresentazione dell’abisso che ci caratterizza al fondo, anche da vivi, come il pozzo senza fine entro cui cade la nostra voglia di sapere e capire e dare senso. “Brancaleone: Lo come? In su l’istante? La Morte: (ride) O che s’aspetta? Io ci sono, tu ci sei... Ti fo scegliere: un coccolone? Peste improvvisa? Vermiculite? Ovvero un fulminante disciogliersi del corpo?” Ecco quel che appare evidente è soprattutto che quel che conta una volta di più è il modo: occorre evitare la sorpresa, meglio, occorre arrivare alla morte ‘preparati’, bisogna arrivarci nella ‘maniera giusta’, evitando soprattutto che essa sia ‘banale’, uguale a quella di tanti altri (ovvero nella situazione di chi si limita a subire l’attacco della natura... una morte ‘gloriosa’, 79 ‘questo mi spetta: son cavaliere’). È tornato il principio della cultura filosofica greca per cui il senso delle cose della vita è nel fare le cose che le condizioni ti permettono, né di più né di meno: se sei cavaliere devi ‘giocare’ a fare il cavaliere fino alla fine, non devi vincere, devi però vivere e morire ‘come se’ davvero quello fosse l’unico senso dell’esistenza. Il kairòs va letto e affrontato nella sua pienezza di limiti e opportunità: il ‘destino’ (se vogliamo usare questa ambigua parola antica) è appunto di ‘morire’ da cavaliere ancor più che vivere da cavaliere (la fine è semioticamente il segno che spezza l’esitazione del significato e rende chiaro infine quel che si è: si pensi alla domanda di Creso a Solone sull’uomo più felice), tradotto per noi comuni mortali: dobbiamo vivere con pienezza (densità) la vita che ci siamo scelti di vivere, di realizzare al meglio lo ‘stile’ con cui decidiamo di riempire il ‘vuoto’ che è la vita (breve romore). “Brancaleone: (ride, rinfrancato) Le misere proposte... Brancaleone deve avere una morte gloriosa, con l’arme in pugno et per causa iusta. Questo mi spetta: son cavaliere. La Morte: Come tu vuoi. Hai tempo le sette lune, trascorse le quali io verrò a ti pigliare, dove unque et come unque. Brancaleone: Sette lune! Mi basta l’arco di un sol jorno per trovare la mia degna morte.” La Morte: Quand’è così voglio aiutarti. Le cinque miglia da qui, il loco detto Ponterragno, stassi per compiere un delitto contra uno innocente. Tu tenta salvarlo, et havrai così gloriosa morte. Io là sarò tra minuti dieci. Procedi! Brancaleone: Dieci minuti, col caval mio Aquilante? Facimo in fra un’oretta, et ivi sarai mia. Birba chi manca! La Morte: Birba!” Quando Brancaleone recupera questa consapevolezza, recupera la sicurezza: non ha più paura, accetta la sua ‘morte’ con spavalderia allora ed è in grado di scherzare addirittura con la 80 morte, in chiave di sfida. La precisazione della Morte recupera ancora il senso greco della vera capacità umana nel darsi una direzione e un contenuto entro una condizione di ‘buio’ tragico. Si pensi alla sfida delle Olimpiadi: a quell’ora, in quel giorno, in quell’anno ci si troverà pronti per la sfida agli dèi! Per vincere o perdere non importa: l’importante è organizzarsi per quell’appuntamento ‘artificiale’! ecco quindi Brancaleone come un greco che si muove a realizzare la pienezza della sua vita nella morte..., nello stile della morte. P.s.: Quanto allo stile: perché la morte parla toscano? Probabilmente c’entra il fatto che Monicelli è toscano ed ha ereditato lo spiritaccio delle beffe boccaccesche, dei poemi canterini, delle vite mercantili, delle disgrazie popolari, che portano ad un nichilismo dissacratore di tutto e ad una visione disincantata e beffarda delle chiacchiere degli uomini sul mondo. La satira (secondo Frye) è la forma letteraria della ‘morte’, della perdita di illusioni, dell’inverno, della neve che tutto copre, dell’eiron: e il toscano, assunta la veste di lingua popolana dopo l’affermazione del classicismo del Bembo, è più questo (Angiolieri) che quello (Dante). 81 5. IL COMPITO DELL’IDENTITÀ: PROGETTARE La grande illusione, di Jean Renoir Nella società borghese della modernità l’identità non è ereditata ma compito dell’individuo che nel tempo può dare forma alla sua particolare maniera di essere uomo, utilizzando il tempo in maniera ‘utile’ (investimento): le figure del mercante e dell’imprenditore sono sublimate in quelle dell’avventuriero (che mira a realizzare comunque un ‘modello’ di uomo ‘sociale’ che gli preesiste: onore invece che gloria). Successo economico (ricchezza guadagnata) lavoro e famiglia come parametri di riconoscimento . Naturalmente a determinare questa mutazione antropologica concorrono molteplici fattori, ma sicuramente la registrazione di questi cambiamenti tocca agli uomini di cultura, a quelli che nel medioevo erano chiamati ‘chierici’ (in quanto agivano all’interno della chiesa) e che adesso (agendo in spazi laici e con atteggiamento laico) assumono denominazioni varie, da ‘filosofo’ a ‘scienziato’, da ‘bibliotecario’ a ‘libertino’, da ‘giornalista’ a ‘filosofo naturale’, e così via fino (alla fine del XIX secolo) a ‘intellettuale’. Certo, per segnalare la nuova situazione, la narrativa cambia strategia, passando dalle forme dell’epica, in cui si celebrano eroi saldi e duri, al romanzo, in cui agiscono uomini imperfetti e alle prese con il problema fondamentale di quale identità darsi nel tempo. Entro questa linea di tendenza, anche il cinema infine, nel XX secolo, contribuisce a proporre soluzioni, a volte imitando la letteratura ma sempre più spesso elaborando un proprio immaginario capace di dare risposte, più o meno semplici, alle domande di fondo: “chi devo essere? E che devo fare per esserlo?” Presto, ancor più dei singoli eroi di celluloide, sono gli 82 interpreti a diventare veri e propri eroi: ma in fondo a sedimentare nuovi segni nell’immaginario collettivo, a costruire forti sistemi antropologici (di rinforzo magari a quelli che già si sono formati nella realtà materiale) contribuisce proprio la produzione seriale di film di genere, come i western e le commedie (anche musicali), da cui emergono tra gli altri come modelli da imitare il pistolero (cioè l’individualista che risolve da solo le sue storie), e la black lady (la donna che rovina). Nell’insieme è un preciso modello di vita che invade il mondo: l’american way of life diventa l’humus antropologico progressivamente accettato anche in Europa come ‘naturale’ dimensione dell’uomo, come archivio di modelli da cui attingere quando ci si trova in crisi. Il merito, la competizione, il successo, il lavoro, la famiglia, la patria, la guerra sono i parametri che consentono di riconoscere la normalità delle persone. Ma naturalmente c’è, specie in Europa, la consapevolezza che dalla massa ci si deve difendere, che si deve attivare una propria specifica via, se si vuole essere individui. E sono moltissimi i film che affrontano la questione dell’individuazione, dell’autenticità o dell’alienazione dell’individuo in forme narrative piacevoli e affascinanti, ma anche problematiche e drammatiche, capaci in effetti di competere per qualità e profondità con la migliore letteratura dell’epoca, ma molto più efficaci nell’arrivare all’attenzione delle masse. Un film esemplare in questo ambito è La grande Illusione che, raccontando le esperienze di chi ha vissuto la Grande Guerra da soldato, consente a tutti di riflettere sul senso della propria vita, abbandonando definitivamente l’incanto (la via breve) del mito e la traccia dell’eroe (la perfezione ideale) per approdare alla sfera della ‘responsabilità’ della scelta personale. 83 Trama Durante la Prima Guerra Mondiale, un capitano (Boëldieu) e un tenente (Maréchal) dell’aviazione francese, abbattuti con il loro aereo dall’asso tedesco von Rauffenstein, vengono trasferiti in un campo di detenzione (Hallbach). Qui familiarizzano con altri prigionieri francesi (un attore abile nei giochi di parole, un professore, un ingegnere del catasto, un sarto figlio di ricchi banchieri, Rosenthal, che divide con i compagni i pacchi inviati dalla famiglia) e collaborano alla costruzione di un tunnel per evadere in gruppo, oltre a organizzare una festa teatrale en travestì. La fuga è impedita però dal trasferimento in altri campi, dove sono ripetuti ma inutili i tentativi di evasione. Infine arrivano in una fortezza (Wintesborn) comandata da von Rauffenstein che, ferito in una missione aerea, è stato destinato a compiti meno rischiosi. Il capitano Boëldieu consente la fuga a Maréchal e a Rosenthal, che si calano dalle mura del castello, guidando prima un ammutinamento musicale (che distrae la guarnigione) sfidando poi, in uniforme e guanti bianchi, il comandante: suona un piffero con insolenza sul cammino di ronda costringendolo a sparargli addosso. Trova così la bella morte che cercava. Maréchal e il soldato Rosenthal tentano la fuga verso il confine svizzero, ma quando stentano ad avanzare, trovano rifugio in una fattoria tedesca, accolti per tutto l’inverno da una vedova di guerra. Nonostante l’affetto che si stabilisce fra lei e Marechal, i due francesi in primavera ripartono verso la Svizzera; vengono avvistati da una pattuglia tedesca; un soldato punta l’arma, ma il compagno gli impedisce di sparare; Rosenthal e Maréchal sono finalmente liberi. 84 Lo sfondo Con la fine della prima guerra mondiale c’è finalmente modo di valutare il trauma definitivo di quella esperienza che nella coscienza dell’Europa ‘civile’ era chiamata ‘modernità’ e che nell’immaginario era percepita come ‘Grande Promessa’: la scoperta della non linearità della storia, la consapevolezza della natura complessa del mondo. Ci si domanda a lungo (tra gli intellettuali più consapevoli) il senso di quel che era successo: non molti videro con lucidità che era stata non una tra le tante guerre ma un evento totalizzante che, come cartina di tornasole, aveva rimosso il velo di Maja dalle illusioni ottimistiche del positivismo svelando la tragicità dell’antropologia della modernità. Pochi si rendono conto che non è in ballo questa o quella idea di civiltà ma il concetto stesso di civiltà: la prima guerra mondiale porta alla luce, nella sua forma totalitaria, quel che fino ad allora era rimasto sottotraccia, nascosto dai ritmi di crescita economica, dai successi militari nelle colonie, dalle meraviglie della tecnica: l’inevitabilità di un sistema che procede senza retroazione lungo strade già tracciate. L’incremento parossistico dei valori moderni dell’utile, della razionalizzazione, dell’individualismo non poteva non portare all’accentuazione della conflittualità, elevata a mito positivo della nuova umanità moderna: è la competizione che genera il miglioramento, si grida, è il merito che garantisce giustizia. Applicati in modo esclusivo, questi concetti portano alla crescita esponenziale dell’aggressività quale elemento centrale nella formazione dell’identità sociale moderna: essa è in effetti una forma genetica di difesa nell’animal che è in noi, ma la sua ‘razionalizzazione’ (il suo passaggio dalla dimensione della pulsione a quella della ratio vitae come scelta consapevole) comporta la trasformazione della guerra e del ‘soldato’. La guerra da strumento ‘religioso’ introdotto per risolvere i conflitti (con rituali e 85 codici di comportamento condivisi dalle parti in causa, in modo da assicurare un limite alla distruttività e da sublimare la violenza in funzione della sicurezza della comunità) diventa uno strumento ‘laico’ di semplice eliminazione dell’ostacolo che si frappone alla propria ‘linea’ d’azione all’interno di un progetto di ‘dominio’ del mondo, ovvero di ‘distruzione’ del nemico, senza rispetto per codici o regole, seguendo esclusivamente i principi dell’efficienza, del risultato, ovvero della ‘vittoria’. Insomma si scopre che anche la guerra, nonostante si continui a interpretarla e propagandarla secondo i modelli della tradizione ‘feudale’ (‘cavalieri’, ’cortesia’, ’gentilezza’) è diventata una realtà ‘povera’, priva di ogni apparato simbolico sublimante: non più l’occasione per confrontare individui di valore (dotati di coraggio, onore, dignità) ma un mezzo ‘utile’ per risolvere un problema di supremazia economico-politica in termini di esclusiva razionalità, cioè secondo la logica del rapporto costi/ guadagni, senza incidenze morali. Il risultato e basta. La massa dei volontari che in tutte le nazioni coinvolte nel conflitto si dedicano alla guerra con l’entusiasmo eroico di chi vuole cogliere l’occasione per ‘fare la storia’ si ritrova presto davanti alla consapevolezza del fallimento: scontri di armi, scontri di uomini con barriere di terra, metallo, bombe, non scontri di uomini vis a vis, non leale sfida tra coraggiosi, ma ‘banali’ massacri di moltitudini... L’individuo scopre allora in modo traumatico la realtà dell’essere uomini: innanzitutto non si è auto diretti, ma etero diretti, nel senso che non siamo noi a fare la storia, ma la storia (gli ‘eventi’) a trasformare noi; in secondo luogo questi eventi rispondono non a logiche della causalità lineare, ma a logiche della casualità, della ‘fortuna’. Scopre che non è tanto eroico ‘fare’ la guerra ma subirne le conseguenze. 86 Temi Il film di Renoir propone una doppia riflessione: sulla guerra in generale e – in modo più analitico – sulle risposte antropologiche alla guerra. Circa la prima, la posizione di Renoir sembra ricalcare in qualche modo quella di Kant: la guerra si eliminerà se si terrà conto dei Diritti dell’uomo, ovvero se anche i conflitti tra nazioni si risolveranno come quelle tra uomini, ovvero non con il ricorso alla violenza diretta bensì – come insegna la civilizzazione –, se la legge sostituisce la Faida, affidandosi alla ‘impersonalità’ di giudici terzi invece che alla ‘personalità’ delle relazioni dirette dei contendenti. In effetti, però, una Grande illusione, per l’appunto. Si rifiutano certamente non le idee primigenie di Eraclito (‘Polemos è il padre di tutte le cose’ vuol dire che esistono certamente sempre conflitti, non che non li si possa gestire), ma quelle alla Hegel, che nella logica della dialettica istituzionalizza il conflitto quale componente ‘necessaria’ al disvelarsi della Ragione Assoluta e, pur sottolineando gli elementi negativi delle guerre, ne esalta la necessità per modificare l’esistente. Il pacifismo di Renoir è chiaramente basato su concetti come l’artificiosità delle frontiere, la prevalenza delle analogie tra i popoli pur diversi (nella trama: tedeschi, francesi, russi...). La tesi di fondo è che l’uomo non solo vuole vivere e vuole vivere ‘bene’, ma anche che, anche quando è coinvolto in una situazione di distruttività, è capace di riconoscere nell’Altro l’Identico, ovvero nel riconoscersi una identità che supera lo specifico spazio / tempo della esistenza materiale e – magari artificiosamente – accetta di incontrare l’incertezza. In particolare è l’episodio finale della contadina a rivelare l’argomentazione implicita: alla maniera di Levinas, nell’altro io vedo me stesso, e quindi è una sorta di preveggenza che mi 87 porta a trattarlo bene; prima o poi c’è il rischio che mi possa capitare lo stesso. Ovvero sappiamo tutti che la vita è fatta di ‘mancanze’: ma non è detto che le devo risolvere necessariamente con l’aggressività, bensì esiste l’alternativa del dono. In questo episodio si vede anche agire nei protagonisti una modalità di relazionarsi con il tempo assolutamente nuova rispetto alla consueta antropologia borghese: non l’investimento della lunga durata, non la meta giudaico-cristiana, ma la densità dell’attimo, della situazione, del kairòs. Infatti, come dicono gli studi di antropologia della guerra, essa è nata nelle società primitive, come soluzione omeostatica al problema demografico: quando c’è un eccesso di presenze in un certo territorio, si ricorre alla retroazione ‘negativa’ della guerra, ovviamente portatrice di morti, in modo da assicurare al gruppo di poter continuare a rapportarsi in ‘equilibrio’ con l’ambiente, senza rischio di eccesso di domanda (bocche da sfamare) rispetto alla offerta (risorse naturali). Insomma la guerra esprime alle origini una sorta di logica maltusiana. Ebbene vale anche l’opposto: laddove la grande guerra ha ecceduto nell’assottigliare il numero delle braccia-lavoro (per il suo carattere totalizzante ma soprattutto per la sua prolungata consunzione di risorse di ogni tipo, a partire dalle vite umane, forza lavoro appunto), a questo bisogna dar rimedio (pare dire implicitamente anche il film): dove c’è un vuoto di uomini devono subentrare altri uomini per assicurare la soluzione dei bisogni fondamentali della sicurezza. Dove è eccessiva la domanda appunto si risponde con la ricerca di ogni offerta. Logica del benessere sociale, quindi, non tanto etica spirituale. Circa la seconda questione (cosa rivela la guerra sulla struttura dell’uomo), dal film emerge che le differenze sociali alla realtà dei fatti contano spesso di più delle identità nazionali. Se l’esperienza choccante delle trincee ha distrutto la percezione della guerra come elitario gioco/sport per spiriti superio88 ri, entro cui mettere in mostra la propria differenza (qualità), possono essere solo esponenti della nobiltà (indipendentemente dalla nazione di nascita) a desiderarla comunque come occasione di riscatto rispetto alle grigie mediocrità di una vita moderna (industriale, tecnica...) fino a buttarsi in braccio, per questioni di “onore”, alla cosiddetta bella morte. Gli altri, i non nobili semplicemente percepiscono bene la distruttività assoluta della guerra e vogliono banalmente vivere, rifiutando la logica dell’eroismo e scelgono la soluzione di buon senso della mentalità borghese, nella doppia versione ‘utilitaristica’ (quella pragmatica, perbenista, della solidarietà sociale: Marechal) ed ‘edonistica’ (quella libertina e creativa: Rosenthal). Così al posto di un eroe centrale, il film propone un sistema variegato di personaggi-individui che elaborano in modo diverso la propria risposta alle domande ‘chi sono? cosa devo fare per esserlo?’. Per realizzare questo progetto la prima straordinaria scelta da parte dell’autore è quella di fare un film di guerra senza mai mostrare la guerra: a lui interessa, come detto, non descrivere i massacri (del resto fin troppo presenti nella memoria di molti dei contemporanei e dei possibili spettatori) ma mostrare come si modificano le vite dentro questa situazione estrema. Ed evitare di mettere in primo piano il sangue, evita in partenza anche la possibilità di raccontare (secondo le consuete esaltazioni parapatriottiche del dopoguerra) gesta ‘eroiche’, di dire insomma il falso. Gli spazi sono allora quelli dei campi di prigionia. Con quali effetti semiotici? Intanto la categoria stessa della prigione rappresenta una condizione esistenziale di coazione, di repressione, di limitazione: sul piano più profondo probabilmente può indicare la condizione umana dell’uomo implicato nella guerra. Costretto, limitato, impedito di esercitare la sua ‘differenza’, appiattito. Sul piano più specifico è in effetti il modo 89 per curiosare tra le retrovie della guerra e presentare davvero individui, che pur nelle regole della prigionia, hanno comunque – o forse ancor più – modo di ricercare la propria autenticità la propria differenza. Rimangono gradi e regolamenti, ma quel che vince è alla fine l’aria di cameratismo, l’inevitabile complicità che si forma non solo tra prigionieri, ma anche tra prigionieri e guardie. È una di quelle occasioni che i greci definivano kairòs, opportunità, ovvero qualità che è però non solo nelle combinazioni delle cose ma nella intenzione del singolo e Taleb, come già detto, definisce ‘opzionalità’: quel che accade di catastrofico determina certamente la fine di qualcosa, ma consente altre strade, altre opportunità. Quanto alle prigioni concrete, l’iterazione (il trasferimento da una prigione all’altra dopo un tentativo di fuga) comporta necessariamente il confronto: la prima è di fatto una normale caserma, che consente tutta una serie di attività, compreso teatro; l’ultima è un vero e proprio castello medievale – a sottolineare anche la regressione verso la rigidità di von Stroheim – in cui il rigore si fa soprattutto visivo. Spazi angusti, luce cupa, più controlli, meno tolleranza. Una delle conseguenze di questa scelta è anche il fatto che il film propone per tre quarti dello svolgimento un universo esclusivamente maschile, come impone tradizionalmente la ‘storia’ delle guerre: ma questa è già un precisa scelta dell’autore, perché la prima guerra mondiale aveva già mostrato con il suo carattere totalizzante, di avere implicato direttamente anche le retrovie lontane, modificando le esistenze, i ritmi, le percezioni quotidiane di tutta la comunità. All’interno di queste situazioni lo sguardo di Renoir sceglie di isolare, come in vitro, alcuni elementi per disegnare infine un quadro/un modello dell’umanità pericolosamente ‘formata’ dalla guerra. In questo senso, segno semiotico per eccellenza è la divisa che 90 tende a sottolineare un elemento tipico della nuova società, la ‘democratizzazione’, ovvero – in questo caso – la ‘massificazione’, la riduzione delle differenze a ‘identico’. Mentre la scena guerresca tradizionale è ricca di colori e di variazioni di segni a distinguere le diverse tipologie di guerrieri ovvero – più indietro nel tempo, quando c’erano gli scudi e gli stemmi – anche la specifica appartenenza genetica, se non addirittura le diverse personalità, adesso salvo piccoli elementi l’esercito cala su tutti, dal generale al fante, una unica veste dello stesso colore. Si vuole evidenziare l’eguale appartenenza, ovviamente, si vuole realizzare simbolicamente l’identità ‘nazionale’, e nei colori l’efficienza della invisibilità al nemico: ma di fatto si afferma la uguale indifferenziata ‘dipendenza’ dei combattenti dalle evenienze intricate del nuovo inaudito modo di combattere, o meglio di subire il combattimento. Più in generale è l’eguale (aspirata) identità sociale di massa che trova comunicazione in forma figurativa e che tende ad appiattire le differenze, di merito e di qualità individuali: sta di fatto che i protagonisti sono caratterizzati da qualche anomalia proprio per indicare allo spettatore la possibilità/necessità di mantenere una propria cifra distintiva pur nella massificazione. Così Gabin-Marechal, quando entra in scena si aggira con un giaccone da aviatore scuro e slacciato, a segnalare la scarsa abitudine alla forma, la origine popolana; ascolta musica, con sguardo sghembo che si concentra sul giradischi, guarda foto; insomma vive nella dimensione del privato pur in mezzo ad una folla di estranei (in una capacità soggettiva di evadere con l’immaginazione lo spazio della reclusione). Come rappresentante della classe media e inurbato con un lavoro da tecnico, si mostra capace di agire, di risolvere le situazioni (ad esempio la fuga): è il ‘cittadino’ tipo che sa vivere nel mondo com’è; ha poca cultura, ma duttile com’è e aperto alla sorpresa dell’Altro, assorbe a mano a mano le novità e infine, attraverso l’esperienza doppia del sacrificio del maggiore e del dono di Lotte, 91 scopre una dimensione completamente diversa, per cui da patriota neutro e inconsapevole del mito nazionalista, dall’apologia dell’esclusione (mi faccio i fatti miei) passa a quella della inclusione (partecipazione), registrando a voce alta le sue ‘scoperte culturali’. Per lui si può parlare di una sorta di ‘romanzo di formazione’ borghese. Anche il capitano Boëldieu sembra proporre un’evoluzione: all’inizio, al momento del primo incontro con von Rauffenstein, è inappuntabile e comunica immediatamente con il nemico secondo i modi della cavalleria: col nemico, di fatto, condivide non solo un codice, uno stile di vita, ma addirittura amicizie. Successivamente la divisa comincia ad apparire aperta, e infine si abbandona alla informale tenuta degli altri nel freddo del castello: questo cambiamento sembra accompagnare la crescita della sua capacità di avvicinarsi ai suoi sottomessi, anche mantenendo ferme certe regole. Ma nelle ultime scene torna a vestire in modo inappuntabile per realizzare in qualche modo il ‘beau gest’ che deve dar senso alla sua vita militare altrimenti grigia e ‘borghesizzata’: non pensa tanto alla fuga, ma a come poter ripetere, anche in questa realtà disumana, il duello tipico della tradizione cavalleresca. E per l’occasione ‘rimette i guanti’ a segnare la consapevolezza di star assumendo un copione. Certamente aiuta i suoi amici francesi a fuggire (rinnovando così anche il senso proprio della ‘liberalità’ con cui agisce il cavaliere, il dare senza pretendere nulla in cambio), ma essenzialmente ricostruisce la scena del sogno perduto: un rapporto personale, non freddo, un vis a vis con uno con cui condivide etica e codici di comportamento. Di proposito infrange le regole del castello e in uno scenario medievale, con la lucida baldanza del cavaliere antico, provoca l’avversario, costringendolo a sparargli. Naturalmente von Rauffenstein è ligio alle regole, anzi probabilmente sa di collaborare di fatto con l’amico/nemico nel tentativo di fuggire non dalla prigione strictu sensu, ma dalla dimensione antieroica della prigionia. 92 Lo svolgimento del duello rivela che per il francese la vera vittoria non è fuggire davvero (come desiderano fare e fanno i borghesi Marechal e Rosenthal), ma evitare l’ignominia della ‘quiete’, ignominia che consiste nel non aver cercato la ‘quest’ che caratterizza i cavalieri della tavola rotonda: dal suo punto di vista, il cameratismo è stato un errore che l’ha portato come si dice a ‘imborghesirsi’ (ad apprezzare troppo la vita in sé), a farsi massa in qualche modo. E allora riscopre la via dell’onore attraverso la pratica del sacrificio, facendo da capro espiatorio (il suo è l’unico sangue presente in qualche modo nel film). Ma in fondo è stata una lotta sì, ma nella forma del play più che del game, lotta in cui ha vinto davvero colui che apparentemente ha perso: ferito, recupera l’onore e vola via verso la perfezione, mentre il tedesco, rammaricato, sa di essere stato come dice ‘carnefice’, ovvero il sacerdote che rende possibile il sacrificio, perché quello in questa situazione era il suo ‘ruolo’. In von Rauffenstein, la caratterizzazione estetica è molto più marcata proprio per la sua appartenenza ad una categoria sociale la cui autocoscienza si esprime nelle forme controllate, fino alla ‘sprezzatura’, alla nonchalance. Cert’è che le anomalie rispetto alla divisa sono due, una sciarpa nelle prime scene, un busto rigido nelle finali. La prima sottolinea appunto la volontà di marcare la distanza rispetto alla massa con uno stile personale (il ‘disordine’ del particolare rispetto alla regola come scelta estetica che rinvia ad un implicito e segreto codice etico chiaro solo a chi possiede uguale codice simbolico, al di là della lingua e dell’appartenenza). Il secondo segno di distinzione (il busto) rappresenta figurativamente la mancanza di flessibilità ideologica dell’ufficiale tedesco, che rifiuta la via dei sentimenti anche di fronte ad una conoscenza approfondita di un nemico ‘riconosciuto’ come persona (nelle sue qualità individuali, nelle sue differenze) e non già come generico rappresentante di un ‘nome’ collettivo (il nemico). Al momento del dubbio, quando di fronte all’ufficiale francese 93 che sta fuggendo, può fare la scelta individuale di uscire dalle forme coattive e impersonali dello stato moderno (la scelta di ‘persona’ per intenderci che fa la sua conterranea Lotte, contadina che conosce il senso della vita nelle sue qualità pragmatiche e affettive, cioè sa davvero riconoscere nell’Altro se stessa come individuo) si sottopone al rigore delle alte norme sociali della ‘cavalleria’ (ancora più rigorose), regole che chiedono al singolo di rinunciare di fatto ad essere ‘differente’ nel tempo, quindi ad essere costante, sempre uguale, immobile nel rituale. In tal modo finisce per agire in perfetta coerenza con i protocolli ‘tecnologici’ di efficienza imposti dalla ‘legge’ dello stato, della nazione: in definitiva è la Legge della Parola, la legge del Padre che in forme diverse porta allo stesso risultato. A completare la rassegna di varia umanità che la guerra porta a confrontarsi, ci sono altre figure particolari: Rosenthal e Lotte. Il primo è guidato fondamentalmente dall’edonismo, dalla voglia di vivere in modo piacevole le situazioni in cui si trova: è l’esatto opposto di Von Rauffenstein, è dominato dal desiderio, in qualche modo travolto dalla tensione compulsiva al godimento che lo rende flessibile, vorace e frenetico nella sua capacità di ‘giocare’ sempre e ovunque. ‘Gioca’ a scavare la buca per la evasione, ‘gioca’ a fare il teatro, ‘gioca’ a fare il marito tradito: e gioca sempre perché nella sua voluta mediocrità, nel suo disincanto ironico, ‘sa’ che la guerra non lo riguarda troppo (come quasi tutto quel che avviene), ‘sa’ che le frontiere sono convenzioni, ‘sa’ che il distacco umoristico è una strategia possibile per dirigere il male, per attraversare la vita. Lotte rappresenta semioticamente il personaggio fondamentale del film: in quanto donna rappresenta il segno opposto a quello maschile dell’aggressività codificata nella guerra; è lei che, narrativamente, davvero ‘dona’. Il capitano si è ‘sacrificato’, ma lo ha fatto soprattutto all’interno di un narcisismo autarchico, che 94 decide in sé e per sé regole, obbiettivi, mezzi, tempi e azioni. Insomma ‘dà’, ma solo nella misura in cui si sente ‘riconosciuto’, quando ha un pubblico che in lui guarda la ‘recita’ dell’onore’ e della ‘gloria’. È un dono ‘estetico’. Invece il donare di Lotte, che ospita i francesi fuggitivi, è un dono etico: quando dà, non sa cosa avrà in cambio; lo fa perché pensa che donare sia la strategia vincente fondamentale perché l’uomo – in generale – possa vivere. La guerra (teorica fonte di eroismo e di ‘dono’ di sé alla comunità) si rivela ai suoi occhi solo come perdita: ha perso il marito, ha perso forza lavoro, ha perso gli affetti, ha perso le sicurezze. La soluzione è allora, come già detto, nel kairòs, nell’accoglienza, nell’inclusione, nella jouissance, nel play. 95 6. IL COMPITO DELL’IDENTITÀ: DECOSTRUIRE Animal house, di Landis Il secondo dopoguerra determina una vera e propria crisi generazionale. I figli del baby boom, all’interno della società del benessere, risolvono in modo variegato il compito del darsi una identità, ma sostanzialmente le scelte si muovono all’interno di due poli: farsi carico della “realtà – borghese – così com’è” (cioè ripetere l’Ordine, come l’ha costruito il Padre, in forme di retroazione positiva) o rischiare altre strade (quelle del Disordine da cui ricavare un altro ordine, in forma di retroazione negativa). Questa polarità è stata rappresentata in modo satirico dal film di Landis, diventato cult forse proprio perché coglie la problematica antropologica fondamentale delle esistenze della seconda metà del XX secolo. Livello della coesione: la trama, la superficie che vede Larry e Kent, due giovani matricole, sono impazienti di iscriversi ad una delle varie fratellanze del college. Rifiutati dalla “Omega Theta Phi”, composta da studenti ricchi e snob, vengono accettati dalla sgangherata “Delta Tau Chi”, composta solo da studenti ripetenti con voti infimi e una condotta disastrosa, e da cui è bandita ogni regola sociale. Ma il rettore e la fratellanza rivale Omega decidono di accanirsi contro la Delta per farla chiudere. “Bluto” ed i suoi compagni non ci stanno, e decidono di ribellarsi. I protagonisti dichiarati sono le matricole, per cui la storia è potenzialmente (secondo le procedure tipiche del ‘patto narrativo’) quella di un ‘romanzo di formazione’ di stampo ottocentesco, nel senso che lo spettatore si aspetta che il film racconti come i due, da una condizione iniziale di esclusione, in quanto 96 portatori di disordine (pulsioni, differenze) passino, attraverso varie prove, ad una di inclusione all’interno di un gruppo di eletti (in cui vige l’ordine, l’ordine della Parola). Insomma da disordine a ordine: e che l’ordine finale sia appunto il modello sociale ed esistenziale da imitare. E in effetti l’iniziazione avviene, ma in una direzione opposta a quella attesa: i due tentano la strada ‘giusta’ (quella dominante, quella del Padre), ma trovano quella ‘sbagliata’ (quella periferica della Devianza). Livello della coerenza: codice ermeneutico, la profondità da cercare In effetti, all’interno di questo percorso, il vero processo non è la conferma del Medesimo (identità) ma la scoperta dell’Altro: i veri protagonisti, secondo il codice ermeneutico, sono infatti Dean Verron, il motociclista, Otter Stratton, il ‘bello’, e soprattutto Bluto Blutarski, il brutto. Essi in effetti mettono in scena ruoli sociali alternativi a quelli rigidamente codificati della tradizione borghese (il ragazzo ‘per bene’, il soldato, il pragmatista, cioè le tipologie riconoscibili negli Omega): sono appunto modelli di trasgressione, ognuno a suo modo, incarnazioni narrative della varietà di subculture giovanili che proliferano negli Usa a partire dagli anni Cinquanta. Così la moto è una citazione del ‘selvaggio’ interpretato da Brando, l’eleganza trasandata un richiamo alle forme di comunicazione della cultura rock, e la sporcizia una esasperata imitazione del ‘naturismo’ hippie. È chiaro che, a loro volta, questi modelli – per così dire vicini (nel tempo e nello spazio) – sono elaborazioni di più lontani e più sofisticati miti della modernità, come il flaneur, il libertino e il primitivo che dominano l’immaginario europeo (prima che americano) come forma di resistenza all’invadenza dell’utilitarismo e della razionalizzazione. 97 La cornice: l’inizio Nella prima scena abbiamo il cronotopo (Bachtin) della storia: due ragazzi escono da un edificio in stile neoclassico e si avviano, seguendo una precisa mappa mentale, verso un altro edificio. La strada per Bachtin, nell’immaginario della modernità, è segno tipico dell’incontro con il Caso, ovvero l’inizio della destrutturazione del già dato; ma questa strada è interna al campus di un college, e quindi foriera non di incontri con l’imprevisto (il monstrum) ma con il medesimo. Insomma la scena ci propone una situazione antropologica facilmente riconoscibile grazie proprio alle nette marcatura di ‘frontiera’: c’è un mondo (quello del noi, ovvero gli studenti o meglio l’accademia, l’élite sociale corrispondente) e un non-mondo (quello degli altri, ovvero i non studenti, gli ignoranti, la massa degli esclusi). Insomma la prima scena nella sua banalità apparente già costruisce e comunica come ‘naturale’ una rappresentazione della realtà: c’è un ordine perché ci sono categorie e (implicitamente) gerarchie. E questa è la cornice implicita entro cui avvengono le peripezie successive, che determineranno una ulteriore categorizzazione gerarchica: Omega e Delta, cioè il bello contro il brutto, il pulito contro lo sporco. Torniamo a considerare il movimento dei due ragazzi: anch’esso sta a rappresentare antropologicamente un preciso modello: ci sono due persone che hanno ‘bisogno’ di entrare a far parte di una confraternita; anche qui è dato come ‘naturale’ in questo ‘mondo’ appena delineato, il fatto che il singolo esiste (ha senso) solo nella misura in cui ‘appartiene’ ad un gruppo, solo se è ‘parte di’ una comunità. Sullo sfondo del ‘non detto’ (lasciato volutamente fuori dal microcosmo narrativo del film) esiste però la società fordista, la stessa realtà da cui arriva lo spettatore, la società ‘solida’ o ‘liquida’ che sia, in cui ci si deve misurare da soli nella lotta per l’autoaffermazione: è la società 98 della competizione, del merito, che nella sua forma estrema è impersonalità, disinteresse (se non timore) per l’altro, dove quel che conta è il successo individuale, la carriera. Ebbene in questa miniatura del mondo che è il college, a differenza di quanto avviene tra le mura domestiche (altro riferimento semiotico implicito), cominciano ad aver vigore i valori del merito e della concorrenza (magari mimetizzata dalle ‘buone maniere’, come nel caso degli Omega), ma c’è ancora spazio per la dimensione adolescenziale della svagatezza, del conforto del gruppo con cui identificarsi e riconoscersi, in cui ci si può abbandonare finalmente alle pulsioni finora represse, in cui si trova chi ti riconosce nella tua differenza, da cui si può ancora ricevere aiuto e solidarietà, senza calcoli, fino a scoprire un altro senso della vita. In questo mondo artificiale che media tra l’infanzia e il lavoro, si recuperano pratiche premoderne, quelle che una volta si elaboravano all’interno dei clan. Solo che mentre una volta di fatto non c’era differenza tra clan e clan se non per il fatto materiale di appartenere ad un gruppo piuttosto che ad un altro (come comunicava la precisa semiotica dei segni esteriori, come tatuaggi et similia), qui (in questo film) entrare in un clan o nell’altro significa di fatto iniziare un percorso di valori (modelli di comportamento) completamente diversi tra loro. Nella scena iniziale si può dire che tutto rinforzi questa dimensione iniziatica. Così, la focalizzazione sulla statua del fondatore attiva un preciso modello di riferimento: è quello della gravitas, del labor et studium, insomma della strada dritta della serietà; ma contemporaneamente passano lì vicino ragazzi che fanno jogging, a sottolineare che c’è anche il corpo, anzi i diritti del corpo ad avere spazi ludici. Non è neutro nemmeno il fatto che la scena si svolga di notte: il buio sottolinea la condizione di non evidenza delle cose, il mistero. È come il bosco che nelle fiabe sta indicare la natura labirintica del reale. Anche il 99 fatto che i protagonisti sono due invece che uno, richiama il topos delle coppie di uguali/complementari di tante situazioni narrative tradizionali, che in effetti è solo la manifestazione narrativa dell’archetipo dell’amicizia (non dell’amore): Orlando e Olivier, Cloridano e Medoro, Eurialo e Niso, fino a... Stanlio e Ollio, Ciccio e Franco (e così via). A questo punto si susseguono due sequenze, che conducono i protagonisti e gli spettatori a conoscere le due vie possibili dell’esistenza: prima la sede degli Omega, poi quella dei delta. La casa degli Omega Nel primo caso gli elementi semiotici fondamentali sono: la soglia, l’etichetta e il rituale della presentazione, la ghettizzazione. La parola chiave è discreto, ovvero la volontà di separare. Per creare ordine occorre eliminare tutto quel che è marcato come disordine, creando categorie. È l’operazione semiotica fondamentale che si costituisce sulla base dell’opposizione (polemos, direbbe Eraclito): ovvero costruendo una frontiera (Lotman) che consenta di dividere le cose (le persone, gli eventi) in due categorie, una del positivo (bene, bello) l’altro del negativo (male, brutto). Il manicheismo è insomma il principio stesso che consente di passare dall’indeterminato al determinato, dall’in-finito al de-finito. Ebbene in qualunque racconto la soglia assume, secondo Bachtin, una valenza fondamentale: può unirsi al motivo dell’incontro, ma il suo completamento più essenziale è che di fatto è la manifestazione figurata della Crisi, della svolta di una vita. Anche in racconti realistici questo cronotopo continua ad avere la sua valenza semiotica (anche se non più misterica). Ebbene i due protagonisti una volta sulla soglia degli Omega sono lasciati in attesa: la porta è appena socchiusa (a sottolineare la tendenza all’esclusione, della difficoltà ad aprirsi), finché 100 addirittura non viene schiacciata addosso ad uno dei due. La prendono come una ‘prova’ da superare ed entrano infine. Ma una volta all’interno, immediatamente vengono affrontati da due ragazze che hanno il compito di etichettare i nuovi venuti, appiccicando segni di riconoscimento: precisa opera di categorizzazione razionale, secondo un codice astratto e impersonale. Non sei una persona ma parte di una classe di persone! Non c’è quindi tempo per scambiare due chiacchiere e conoscersi come individui nelle proprie differenze, magari attraverso i consueti preliminari di ogni nuovo incontro, che nella loro banalità di contenuto di fatto consentono di comunicare in forma empatica le specifiche caratteristiche relazionali delle persone con cui ci si trova a contatto. Al contrario l’etichetta evita di perdersi in equivoci, evita confusioni, rende tutto più semplice (cioè banale): ma è anche la manifestazione più aggraziata dell’alienazione propria della società delle ‘belle maniere’, perché essa ti consente di non porti problemi, è un protocollo delle relazioni sociali, in cui quel che conta è appunto il risultato, cioè che ogni cosa sia al suo posto, che non ci sia spazio per l’anomalia, la differenza. Ma così il soggetto si spersonalizza, appunto perde la differenza. I ragazzi una volta ‘etichettati’ vengono portati in giro per le sale. Ci sono sorrisini, strette di mano e ‘trasparenza’. Si accorgono che è tutta forma che nasconde la sostanza di indifferenza glaciale, specialmente quando infine vengono portati alla meta reale di questo apparente vagare: il posto riservato ai ‘diversi’, un vero e proprio ghetto, necessario in ogni sistema ordinato che si rispetti, che quel che non può escludere (buttare fuori dalla frontiera) include ma isolandolo in settori appositi, in forma di reclusione. I due ragazzi sono infatti esteriormente dei tipi qualunque. Il loro corpo non corrisponde allo stereotipo jankee: invece di essere alti, biondi, dotati di sorriso smagliante, atletismo e ottimismo che sprizza nei ge101 sti, sono esagerati (uno grasso, l’altro piccolo), con capelli dal coloro indefinito, impacciati e senza stile (come sottolineano anche i Delta al momento della loro accettazione). Sta di fatto che vengono messi a sedere insieme a pakistani e cinesi. Insomma una ‘riserva indiana’. La casa dei Delta Usciti dagli Omega, si arrendono all’idea di tentare l’estrema soluzione della degradazione, i Delta. Quando i due si avvicinano alla casa, mentre stanno ancora fuori, arriva volando dall’alto, un mezzo manichino buttato via dalla casa: il movimento è dall’interno verso l’esterno. È il primo segno semiotico dell’antropologia Delta, appunto è apertura verso l’esterno; ma quel che viene lanciato è apertamente e onestamente un ‘rifiuto’: immondizia, ecco i primi segni semiotici che accolgono i nostri eroi; non forme apparenti di inclusione che nascondono volontà reale di esclusione, ma forme esplicite di violenza contro quel che non corrisponde ai modelli umani del gruppo: il manichino, rotto, sta probabilmente a segnalare che nel gruppo non si vogliono appunto ‘manichini’, cioè uomini-macchina, uomini alienati che hanno dimenticato il corpo e l’hanno sostituito con congegni inerti e insensibili, destinati a rompersi e incapaci di rianimarsi, di ricominciare. Certamente questo gesto violento introduce il perturbante nell’immaginario di chi è abituato solo al mondo delle buone maniere: comunica bruscamente che esiste il frammento, la distruzione, la fine, la morte. Il secondo elemento semiotico viene loro incontro sempre all’esterno: è un tipo grasso che sta facendo pipì sul prato e che girandosi non si cura affatto di smettere e bagna quindi i nuovi arrivati. È un vero battesimo iniziatico, il battesimo reale della 102 materia organica. Non guanti asettici delle ragazzine carine ma il corpo nella sua manifestazione più oscena (fuori scena): il vero con-tatto levinasiano, con la conoscenza dell’altro che è immediata nella sua diversità più animalesca. Puzzo, sporco, rifiuto. ‘Estetica’ quindi non ‘anestetica’: sensi veri, emozioni forti e non forme, recite, ruoli; persone e non manichini, appunto. In questa scena quindi l’autore costruisce l’intero codice ermeneutico con cui leggere il seguito del film: nello stesso spazio troviamo un mezzo manichino rotto buttato via e un grassone ubriaco che urina su chi passa. Collegando il manichino per antifrasi a quanto visto nella sequenza precedente, si trova esplicitata anche la tesi del film: meglio un ubriacone che un uomo manichino. Insomma ecco il ‘mondo’ del film, la rappresentazione del mondo reale: le categorie sono due, gli uomini marcati dal segno della ‘pulizia’ e gli uomini marcati dal segno dello ‘sporco’; la gerarchia assegna la negatività al ‘pulito’ e la positività allo ‘sporco’; la gerarchia della Legge assegna la negatività al ‘pulito’ e la positività allo ‘sporco’; ma i Delta sono contro la Legge del Padre. Da questo momento in poi, tutte le scene non fanno che ritornare costantemente a rinforzare questa visione della realtà, che non si fa fatica ad assegnare al carnevalesco di cui si è già parlato a proposito di Brancaleone. La chiave figurativa fondamentale sarà sempre più la contrapposizione del ‘pulito’ e dello ‘sporco’, categorie che di fatto corrispondono alle modalità di comunicazione antropologica proprie del potere neoliberista globale. Sono queste categorie estetiche in sé ‘evidenti’ e da sempre connotate con preciso sistema di valori che consentono, senza darlo a vedere, di realizzare l’egemonia culturale, trasformando in ‘naturali’ pratiche che sono del tutto artificiali. Esaltare all’infinito il ‘pulito’ come portatore di bello significa di fatto manipolare il pensiero 103 collettivo: da un lato ci si appoggia al fatto che davvero fare pulizia è la procedure fondamentale d ogni operazione antropologica che vuole creare un ordine ‘umano’ contro il caos ingovernabile della natura; ma quando si nasconde lo sporco, cioè gli ‘avanzi’ di questa operazione ordinatrice, di fatto si nega la dimensione complessa del sistema-realtà, si opera un riduzionismo epistemologico, che trasforma le menti in semplici macchine che applicano protocolli (manichini appunto). Vedere il mondo in maniera ‘banalizzata’ (Lotman, Prigogine) comporta che anche l’etica di fatto non ha più ragion d’essere: ci si limita ad applicare protocolli e non si vedono biforcazioni se non nei termini di elemento ‘riconoscibile’ e elemento ‘non riconoscibile’ all’interno di questo o quel protocollo (ovvero di ‘identico’ e di ‘non-identico’). Ne consegue appunto che la conoscenza è di fatto solo ri-conoscimento; che la sicurezza psichica si costruisce solo col riconoscere il già noto, con l’eliminare il nuovo (esclusione); che nella comunicazione estetica si privilegia il levigato, la forma ‘pulita’ appunto contro le forme sperimentali e abnormi. Insomma gli effetti del riduzionismo neopositivistico, dell’anestesizzazione della società dello spettacolo (Debord) e della iperidentificazione del narcisismo imperante (Recalcati), sono appunto comportamenti apparentemente vari e in rapido cambiamento, ma tutti entro la logica della precisione, della perfezione, della sterilizzazione: si pensi alla passione per le docce, per i prodotti estetici, per le palestre, per l’architettura dalle linee pure, per gli arredi postmoderni. Tutto questo ha a che fare proprio con la volontà di eliminare gli scarti, di nascondere l’inappropriato, di riscattare la bruttura della vita (del corpo) per acquisire una completa libertà dalla miseria delle passioni e la possibilità di organizzare razionalmente tutto in termini di previsioni quantitative, di progetti verificabili e controllabili. Manichini, dunque. 104 La cornice: la fine Titoli di coda: mentre Bluto, lo sporco, corre intrepido e felice sulla decapottabile, insieme alla sua bella, appena strappata al ‘nemico’ pulito, compaiono delle scritte sullo schermo, alla maniera dei film epici, a indicare la solidità definitiva di quel che si sta dicendo: è l’elenco dei vari protagonisti, ma accompagnato dall’indicazione del risultato della loro iniziazione giovanile. I risultati sono particolarmente graffianti, a volte sorprendenti, con l’effetto di destabilizzare maggiormente lo spettatore distratto. Così, se ci si aspetta che il fanatico militarista di stampo nazista non possa che morire in modo violento, è un po’ sorprendente che sia per mano dei commilitoni in Vietnam; e certamente carnevalesco è il fatto che diventi senatore proprio quello che lo spettatore ha imparato a conoscere come il ‘peggiore’ della compagnia, Bluto. E così via: ogni ‘fine’ ricapitola e dà la chiave ermeneutica esplicita per riandare a leggere e capire meglio gli eventi precedentemente narrati. A questo punto è chiaro che non basta lo schema del carnevalesco a dare senso alla storia, ma che occorre connetterla con altri modelli anche non artistici o antropologici. Insomma la storia non è solo una parodia irriverente e giocosa di certi elementi del sogno americano, ma propone anche una vera e propria novità epistemologica: l’ordine non deriva dall’ordine, ma dal disordine. Il caso del militare è fondamentale per argomentare a contrario quanto appena detto: egli, interpretando all’eccesso il copione del duro, pensa che solo l’esclusiva insistenza sulle stesse forme garantisca la permanenza (la Patria); e invece procura danno ai compatrioti che alla fine lo eliminano. Fuori di metafora bisogna evitare l’eccesso. L’ordine senza retroazione porta all’implosione del sistema: cioè disordine dall’ordine. 105 Al contrario il disordine crea ‘altro’ ordine, consente di prosperare: cioè, esemplificando con uno slogan, ordine dal disordine, come pare voler dire la vicenda di Bluto, che ottiene il più alto successo sociale svolgendo un ruolo (politico) utile alla nazione, senza dover ammazzare nessuno. Apparente paradosso che però si spiega facilmente all’interno del paradigma della complessità, cioè dell’epistemologia che nasce dalla connessione delle informazioni di varie scienze e di varie teorie (emergenza, cibernetica, biologia, fisica, sociologia, psicologia ecc). Se ad esempio teniamo presenti, tra le altre, le ipotesi di Prigogine, Varela e von Bertalanfy, si può fare la descrizione del fenomeno della vita come un sistema dinamico aperto: essa non è qualcosa che si possa isolare, chiuso verso l’esterno, statico, caratterizzato da isotopia, ovvero da equilibrio statico; al contrario è un sistema dissipativo, con anisotropia (equilibrio omeostatico cioè in movimento), che vive proprio quando e se scambia energia (informazione) coi sistemi limitrofi (se corregge cioè la propria entropia assorbendo energia dall’esterno, modificando continuamente il suo stato (neghentropia), strutturando da sé nuove forme di organizzazione, secondo la logica dell’emergenza. In definitiva ogni sistema-vita tende a mantenere il suo stato di equilibrio ovvero a mantenere la sua organizzazione: ma il tempo comporta entropia (diminuzione dell’energia) fino ad una soglia oltre cui o collassa (perde organizzazione) o si da una nuova organizzazione (assorbendo energia, informazione dall’esterno). Questi meccanismi in effetti soprassiedono, ovviamente, a quasi tutti gli accadimenti di cui abbiamo chiara percezione nella nostra quotidianità, a partire da quelli che a noi sembrano banali: così ad esempio, un uomo vive solo se mangia (e poi si libera degli scarti), un’ auto corre se brucia benzina (e si libera degli scarti) ecc. 106 Il punto chiave in questi meccanismi è che esiste la ‘freccia del tempo’, esiste cioè l’irreversibilità del tempo, per cui l’ordine, qualunque ordine (cioè organizzazione) è sempre provvisorio e non è mai identificabile con una esperienza passata. Quindi la rigidità delle culture dell’ordine, che puntano alla difesa di un equilibrio ideale (che in effetti coincide con un particolare stato di equilibrio del sistema all’interno di una rete di relazioni) è semplicemente motivo sufficiente per determinare velocemente il collasso di quell’equilibrio. Insomma detto con i termini semiotici del film, la cultura del ‘pulito’ è destinata a collassare se si ostina a non voler assumere informazioni nuove dall’esterno, ovvero ad accettare che esista lo sporco come diversità che crea ordine, come altro ordine possibile. L’America, dice il film, è destinata a salvarsi solo se acquista informazioni da tipi come Bluto, se continua a mescolare, a contaminarsi, non a cercare la purezza, la pulizia appunto. Entro questo orizzonte concettuale diventa davvero chiaro il senso di alcune delle famigerate battute del film, battute che ci consentono di intravedere la logica profonda dell’etica dello ‘sporco’: - “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” - “Si tratta di fare un’azione futile e stupida” Nel primo caso si sta in effetti riformulando quanto si è sopra detto a proposito della soglia di collassamento dei sistemi dinamici e aperti: il sistema in questione a livello narrativo è il gruppo Delta, che sta per essere sciolto. Ecco, a questo punto, se non si può mantenere l’equilibrio precedente si assume una organizzazione diversa, il gruppo si auto organizza per così dire rilanciando in alto: si accetta la situazione e si struttura in termini adeguati. Al cinismo, alla malafede, alla ‘violenza’ si risponde con cinismo, malafede, violenza portando il gruppo ad essere altro: e comincia la festa finale (game vero e proprio 107 per gli organizzatori, cioè le varie istituzioni che rappresentano i valori della rigidità) entro cui la presenza dei determina una catartica trasformazione. Chi vuole costituzionalmente rifiutare lo sporco, il disordine, si trova costretto a subirne l’invasione: questa è la vita, questa è la storia. La seconda frase è organizzata semioticamente sulle coppie futile/utile e stupido/intelligente. I termini impliciti in effetti rimandano ai cardini della cultura della modernità (utile = utilitarismo, efficienza, efficacia; intelligente = razionalismo, razionalizzazione), cultura che, come già più volte ricordato, comporta l’abbattimento dell’empatia (calore delle relazioni legate allo specifico hic et nunc in cui ci mette il corpo) a favore dell’impersonalità (freddo delle relazioni legate ad uno spazio tempo astratto). La frase esalta innanzitutto la futilità e poi la stupidità: si intende come ‘scelta’, come espressione di quel gioco di cui si è parlato sopra. Un gioco per essere davvero tale dev’essere inutile e stupido, capace cioè di rifiutare la legge della Parola, liberare verso le pulsioni controllate, spostare dal mondo del reale al mondo del possibile, ovvero determinare una vera e propria nuova organizzazione del sistema. Per dirla col linguaggio dei latini si tratta di contrapporre al linguaggio della virtus cioè della perfezione, della ‘pulizia (caratterizzata da gravitas, pietas, constantia) quello dell’imperfezione, dello ‘sporco’, dell’animalitas (cioè levitas, empietas, mutatio); di contaminare il bello col brutto, dando vita ad una nuova realtà (sintetizzata rapidamente come già detto nei titoli di coda). Si trasforma in positivo tutto quel che è classificato come negativo nel sistema del Padre, trasformandolo in spinta alla auto organizzazione: è bello essere stupidi e futili, ovvero essere superficiali ‘irrispettosi dei doveri, mutevoli, muoversi a caso, in erranza in particolare si dà importanza a qualcosa che per i protocolli vigenti è del tutto secondario periferico non 108 centrale (superfluo), cambiando continuamente le scelte in rapporto alle specifiche situazioni. A questo punto è allora possibile dare senso alle denominazioni delle due confraternite: gli Omega si chiamano così perché figli della cultura escatologica, ovvero della visione lineare non solo della storia ma anche delle più semplici pratiche quotidiane: l’omega è l’ultima lettera dell’alfabeto greco e viene appunto proposta dai cristiani come segno della meta finale a cui tendere senza esitazione; schema che poi, laicizzato, è stato ripreso dalla cultura della modernità che punta al perfezionamento della società, al progresso, ad una meta in cui finalmente tutto il movimento cessi. L’antropologia quotidiana degli Omega non è altro che la banalizzazione di questa idea: esiste una via, esiste una certezza, tutto il resto è errore, va eliminato come immondizia. Al contrario i Delta derivano la propria denominazione da una lettera che nell’alfabeto greco è all’inizio: come a dire andiamo avanti sì, ma poco, e lentamente. C’è eventualmente tanta strada da fare ancora. Insomma ‘festina lente’ (affrettati adagio) e ‘modestia’ (epistemologica). In particolare si dà importanza a qualcosa che per i protocolli vigenti è del tutto secondario e periferico, cioè superfluo, cambiando continuamente le scelte in rapporto alle specifiche situazioni. 109 7. LA CONTEMPORANEITÀ L’avvertimento della crisi La fine del XX secolo segna in effetti la fine di un’intera epoca, almeno sul piano dell’immaginario. La crisi del petrolio del ’73, l’avvento della Thatcher e lo smantellamento del welfare state, l’edonismo reaganiano e la caduta del muro di Berlino sono eventi che, oltre ad aver determinato effetti concreti sulle esistenze individuali, hanno senz’altro contribuito, insieme ad altri fattori, a modificare la percezione del tempo e dello spazio, quindi del’individuo e della società. Semplificando al massimo, quasi all’improvviso è scomparso il futuro: o meglio da promessa di progresso si è trasformato in incertezza e angoscia. Il singolo si ritrova all’improvviso lasciato a se stesso, senza più il Padre che lo vincoli ma lo indirizzi, senza la Parola che dia senso alle cose del mondo, senza miti a cui credere o eroi da imitare. E il presente diventa un luogo senza direzione, la realtà un Nulla. Diminuiscono allora le possibilità di autorealizzazione, se si cercano i soliti percorsi del passato, ma paradossalmente se ne aprono altre nel momento in cui il Divenire ha perso il suo carattere deterministico. La cultura e le arti si muovono entro questa polarità epistemologica, sperimentando operazioni di vario segno: descrivono, celebrano denunciano rimuovono scavano mescolano citano colorano distruggono, ma interrogano soprattutto. Anche il cinema, dentro e fuori il sistema dell’industria culturale, partecipa a questa ricerca contribuendo a suscitare nello spettatore (se ben intenzionato) la riflessività. Opera significativa al riguardo è senz’altro America oggi di Altman che, proponendo una complessa raffigurazione delle esistenze fram110 mentate della gente comune, può funzionare come strumento conoscitivo della situazione generale. Alla luce di questo sfondo (che rileva soprattutto la condizione ontologica di non direzione delle vite quotidiane contemporanee) è possibile, con più consapevolezza, attribuire senso anche alle diverse scelte di vita che fanno i protagonisti di film come Batman, Basquiat, Le invasioni barbariche, e Irina Palm. La cornice: America oggi di Altman Una lettura deleuziana da parte di Zizek (in Organi senza corpi) sottolinea quanto efficacemente il film sia capace di mettere in scena la negatività della situazione sopra indicata (nella prospettiva della mancanza di ‘riconoscimento’ di ordini di prevedibilità, di conferma del ‘senso’ dell’ ‘essere’, del permanere di elementi granitici della nostra visione del mondo); ma nota anche la positività della situazione straniata del film (nel fatto che, sartrianamente, la mancanza di percorsi obbligati consente anche lo spostamento dalle regole imposte, la liberazione dal determinismo). L’universo altmaniano, per Zizek, è fatto senz’altro di “incontri contingenti tra una moltitudine di serie, un universo in cui serie differenti comunicano tra loro e risuonano a livello di quella che lo stesso Altman denomina ‘realtà subliminale’ (choc meccanici privi di significato, incontri di intensità impersonali che precedono il livello di senso universalmente riconosciuto”. Ma la qualità contingente di questi incontri non è solo indizio di disperazione silenziosa nella vita quotidiana, (cioè dello sbandamento che segue alla perdita della Legge, di una direzione sicura da ripetere); ma anche possibilità di liberazione dal determinismo, di kairòs (cioè della possibilità di dare densità qualitativa al tempo privato della sua inesorabile freccia). Insomma il Divenire come apertura di possibilità altre rispetto a quelle previste dall’Essere (dalla permanenza). 111 L’esistenza non ha più progetti da realizzare ma situazioni immediate da risolvere, problemi per cui non si hanno soluzioni date, a cui si danno soluzioni estemporanee. Si cerca la routine, delle proprie isole esistenziali, ammesso che sia possibile costruirle, ma gli incroci imposti dallo spazio labirintico della metropoli creano prima o poi l’occasione in cui la maschera, la scorza non basta: bisogna accorgersi dell’altro e prendere posizione, non si può più fingere anaffettività. Per Sennet sono esperienze epifaniche, sfida al mimetismo conformista alla Zelig. Prima o poi svanisce il senso di libertà che ci deriva dall’illusione di attraversare la metropoli restando estranei, di sparire. Per rappresentare questa rete di relazioni Altman sceglie una forma adeguata: non un protagonista e un plot lineare, ma un complot, cioè un intreccio continuo di più plot, a rappresentare la casualità e la causalità conseguente di questa dimensione non determinata delle esistenze contemporanee. Un po’ come la foresta/labirinto di Ariosto, la Los Angeles/labirinto di Altman si propone come uno spazio che connette, dove quando sembra che ti perda in effetti incontri l’Altro e sei chiamato, come già detto, a fare i conti con l’identità che vuoi avere di volta in volta. È il montaggio quindi lo strumento formale determinante nella costruzione del senso del film: lo spettatore più che in altri tipi di intreccio è costretto chiedersi il senso della successione dei frammenti di plot che si succedono e anche se scopre che il procedimento figurativo d’aggancio tra le scene è spesso metonimico (si vede un televisore alla fine di una scena, per ricominciare da un altro televisore in quella successiva) in effetti fa fatica a capire cosa tiene insieme queste vicende (la coerenza di fondo): il lettore è più che mai sollecitato a spostare l’attenzione dalla superficie al profondo, dai fatti certi al significato probabile, e si mette a caccia di regolarità (isotopie direbbe il semiotico, cioè significanti diversi per lo stesso significato). E 112 certamente la prima operazione che non può non fare è creare categorie tematiche (la morte, il gioco ,la musica, la tv, il sesso, i cronotopi) per arrivare a cercare infine il legame che tiene insieme l’inizio con la fine: gli elicotteri che disinfestano la città di notte e il terremoto che accomuna tutti con la paura Lo spettatore di America oggi apprende insomma lo stato delle cose oggi: ma ovviamente non solo in America. E cerca di approfittare della rappresentazione di Altman per coltivare, nei suoi limiti, il tempo non più (o non solo) in forma di kronos che tutto divora, ma di kairòs, di qualità. E nella particolare libertà data dalla mancanza di eroi da imitare, inizia percorsi nuovi. Vie di fuga Il supereroe: Batman, Il ritorno del Cavaliere oscuro, 2008, di Cristopher Nolan La prima reazione compulsiva di fronte alla fine di qualcosa è guardare al passato per ricercarlo, almeno nella memoria: è la base dell’atteggiamento malinconico, che porta inevitabilmente a negarsi una direzione nell’esistenza. Ma si può anche guardare al passato con un pizzico di nostalgia, senza però cadere nella trappola della ricerca dell’identico: basta passare ad un altro livello di ripetizione. E se davvero non ci può essere davvero la perfezione, si può sempre ‘giocare’ ad essere perfetti: il passato ritorna allora non nella dimensione impossibile della ontologia, ma nella consapevole e possibilissima dimensione del ‘gioco’. In un mondo in cui non ci sono più eroi, si possono ‘creare’ eroi consapevolmente falsi, che possano diventare per così dire non punto di riferimento per collettività ma per le solitudini desideranti del postmoderno. Insomma, se non ci sono eroi, li possiamo inventare: e a piacere, quanti ne vogliamo e come li vogliamo, su misura. L’industria culturale, in effetti, ha da tempo scoperto grazie 113 all’antropologia, che al di là dei miti moderni, ormai consunti, la psiche del soggetto può trovare dentro di sé i suoi modelli negli archetipi junghiani e proppiani: e quindi tra gli ‘oggetti’ da consumare il mercato culturale introduce con continuità nuovi eroi, che si è presto finito per definire supereroi, perché vivendo consapevolmente solo nel mondo delle fiction, superano tutti quelli del passato per capacità, poteri ed efficacia. E in un mondo in cui non esistono più le grandi istituzioni della modernità (o se continuano ad esistere sono davvero contenitori di interessi non pubblici) si può far agire il supereroe senza più lo scopo antico del bene della collettività, solo per il proprio godimento. Così lo spettatore assimila un nuovo decisivo modello di umanità: agire per sé, per realizzare la propria jouissance. “Perché no?” dicono i protagonisti del Mucchio selvaggio prima di andare a sfidare la morte (certa) alla conclusione delle loro avventure. E questo atteggiamento caratterizza anche Batman, specialmente nella versione del 2008, in cui la caratteristica principale è proprio l’escalation del suo agire, il progressivo esasperare la propria azione, proprio facendo intendere che a muoverlo è qualcosa in più rispetto alla voglia di fare il bene comune. In generale lo si vede agire in preda a sensi di colpa, a tormentata riflessioni e ambiguità, fino a rendere alle volte ambigua la distinzione tra le varie forme di violenza. Batman, a differenza dell’eroe della tradizione, si costituisce come Soggetto adeguandosi a quello che Lacan chiama das ding, alla cosa più grande, non entro le regole già date. Non si riconosce quindi per la capacità antica di darsi un limite ma, al contrario, perché eccede, come un folle, trascinato com’è da questa cosa oscura chiamata godimento (che riconosce e chiama come Altro da sé). Non si espone quindi disarmato al nemico, all’Altro (Levinas) per farsi riconoscere identico, ma lo contrasta con le stesse armi, con lo stesso stile; non guarda al passato, ma eroicizza il presente , anche se con distanza. 114 Tutto questo movimento (nel film diretto contro Joker) comporta una proposta chiara per lo spettatore: in un mondo complesso, senza direzione, quindi senza norme oggettive a nessun livello, risolvere i problemi significa non rispettare le regole: al di là del bene e del male; oltrepassare le frontiere dei codici ereditati dalla società. Come dice Regazzoni: ”compito dell’etica dell’eroismo: fare fuori l’idiota della morale, ligio alla Legge e al dovere”. Si realizza, si deve realizzare, per Bataille una decostruzione del mito del Soggetto autonomo libero e sovrano, quindi costruttore di etica: al cuore dell’etica si pone proprio il ‘Male del godimento’ o il ‘godimento del Male’, come suggerisce Recalcati nella sua rilettura di Lacan. Batman sembra in effetti ben dimostrare quanto dice Zizek a proposito di eroi come l’Antigone sofoclea: “Il bene della comunità è la scusa standard per compromettere il proprio desiderio”: quel che va cercando l’eroe, il supereroe è semplicemente la realizzazione di sé, proprio fuori della legge. E questa è la morale sostanziale non formale. Infatti, secondo Derrida, se la morale consiste nello scegliere, ebbene esiste morale solo al di fuori della legge codificata che in effetti comporta una ripetizione coatta; ovvero esiste nel comportamento ‘superiore’ alla legge. Certo. Questa idea di superare la legge in nome di una morale superiore spinge nei territori dell’indeterminazione, e nella sua vaghezza favorisce l’entrata in gioco anche di Joker e di quelli come lui. In definitiva il supereroe Batman propone come modello postmoderno di eroe l’eccesso, anzi l’eccesso nel ‘godimento’: anche se con la scusa del ‘bene comune’. Il vero scopo è l’autorealizzazione come chiarisce questa constatazione: “Un uomo è sorto per mostrarci che il potere è, ed è sempre stato, nelle nostre mani. Siamo sotto assedio – ci sta mostrando che possiamo resistere”. 115 All’interno di questa prospettiva diventa illuminante e riassuntiva la regola di comportamento che secondo Sloterdijk ci si deve dare per definire i limiti della propria individuazione eroica: ‘perché no?’ (il why not? del film Mucchio selvaggio). La conseguenza fondamentale di questo eroismo del godimento è da un lato la solitudine dall’altro, la sottomissione alla CosaAltro, oscura, notturna, primordiale, che lo abita. La maschera è allora segno che del fatto che questo eroismo ha che fare con l’Oltreuomo. La maschera spinge Batman fuori dell’umanità, rivela doppiezza delle sue azioni: e l’insistenza con cui Joker lo sfida a togliersi la maschera ha che fare con la consapevolezza del male oscuro che ‘agisce’ non solo Bruce ma anche lui. Certo è, come dice Friedrich Nietzsche, che chiunque combatta i mostri deve stare attento che nel farlo non diventi egli stesso un mostro. E quando guardi a lungo dentro l’abisso, anche l’abisso guarda dentro di te (Al di là del bene e del male). L’intellettuale: Le invasioni barbariche di Arcand La storia racconta come si avvicina alla morte un cinquantenne professore, circondato dalla comunità di figli e amici. Da sempre socialista utopico è passato attraverso tutti gli ismi della sua generazione, mantenendo intatto un senso vorace e gioioso della vita e un egoismo di superficie temperato dall’aver capito progressivamente i limiti propri e dell’umanità. Il senso profondo della vicenda è indicato nel titolo, che disegna un campo semiotico netto: i barbari e la civiltà. Ma non è un film di storia: i barbari sono tra noi, sono i nuovi modelli antropologici del ‘godimento’ che segnano di arroganza e prepotenza la realtà presente. Chi ha destinato la sua esistenza all’utopia, all’impegno politico, al mito di un eroismo dedito al bene comune, fa fatica ad accettare appunto queste ‘invasioni barbariche’, cioè il predo116 minio della volgarità, del cinismo, dello strapotere, che sono in effetti la fenomenologia dell’eroismo del godimento banalizzato. L’individualismo rampante trova facile destrutturare la complessità antropologica e filosofica di supereroi come il Cavalier Oscuro per ridurlo alla opportunistica giustificazione del superegoismo, del narcisismo iperidentificatorio che corazza contro le passioni e consente di usare il mondo, gli altri, le istituzioni come funzioni del proprio godimento. La resistenza contro questo stile di vita (nel film rappresentato dalla figura scostante del figlio del protagonista, saccente manager che è fuggito nella lontana Londra per distanziarsi dalle manie umanistiche del padre) si fa estetica ancor prima che etica. Ma l’opposizione è inerte perché rimane ancorata al proprio spicchio di realtà: il protagonista infatti si accontenta di fare in fondo delle scelte ‘estetiche’ mirate a realizzare il suo diverso ‘godimento’; praticare certi luoghi e certi amici; leggere certi libri (Levi, Cioran, Platone, Montaigne); praticare un disinvolto dongiovannismo, darsi all’edonismo del simposio. Insomma si costruisce una sorta di impossibile locus amoenus, che conosce pure delusioni (il divorzio, un figlio distante, gli studenti indifferenti..) spingendosi anche a mediocri compromessi sessuali. Ma anche da questo piccolo sgangherato eden viene cacciato quando si fanno prevalenti le ragioni del corpo, stavolta non quelle dell’edonismo ma della malattia. Ancora una volta è la catastrofe che mostra accanto al suo aspetto di dolore quello di un kairòs da coglier per ricostruire un altro ordine. A questo punto entrano in scena due giovani, a prima vista negativi, ma di fatto portatori in modi diversi delle ‘informazioni’ che riescono a dare senso, a riorganizzare la situazione: il cinico figlio manager organico al mondo dei ‘barbari’ e una ragazza tossica, l’alfa e l’omega della condizione dei giovani, 117 nel senso che il primo rappresenta lo yuppie sorretto dalla sindrome supereroica della superidentificazione (Superego senza inconscio per dirla con Recalcati); l’altra la sindrome della risposta illimitata alle pulsioni (l’Es senza inconscio). Entrambi, in modo diverso, barbari: ma entrambi responsabili della soluzione di vari problemi pratici che consentono al professore una morte accettabile e confortata. Il figlio, applicando la morale del godimento che si realizza al di sopra della legge, ma stavolta uscendo dalla sua corazza di cinismo, a vantaggio del padre, compra tutto e tutti, pur di rendere migliore la fine del padre: alla fine (come Telemaco?) sembra finalmente riconoscere il valore strutturante del Padre che castra ma che costruisce la via all’autoregolazione. Anche la ragazza conosce un percorso di trasformazione con cui esce dall’autismo affettivo di partenza, per ritrovare qualità relazionali calde, nel momento in cui comincia a conoscere l’Altro, non solo nel volto dolorante del professore ma in quello simpatetico nel figlio, per ritrovare quindi un po’ di se stessa. Anche lei agendo, come l’altro giovane fuori delle regole, secondo la morale del godimento, fornisce al malato l’eroina per lenire le sue sofferenze fisiche. L’intreccio tra il nuovo e il passato, tra gioventù e maturità, tra civile e barbarico si fa sempre più stretto ed avvincente e alla fine rimangono le cose davvero importanti, quelle che rendono in qualche modo accettabile l’inevitabile entropia della morte: gli amici, il sorriso, la gioia dei sensi, la cultura, ma che la tecnica, cioè, il Pc portatile attraverso cui Remy (un magnifico Rémy Girard) riceve l’ultimo saluto dalla figlia lontana. I temi fondamentali che emergono per combattere contro la barbarie sono quelli del ‘dono’ e della ‘morte’. Nel primo caso è proprio il concetto di inutile da contrapporre alla logica vincente dell’efficientismo tecnocratico a ricordare e recuperare i valori fondanti dell’umanesimo: la philia, l’agape, insomma la condivisione sono solo parole diverse per recita118 re il fondamentale valore della cooperazione della solidarietà, che si riconosce materialmente innanzitutto nel tempo che gli amici regalano a Remy per aiutarlo nel momento più difficile. Nel secondo caso Arcand vuole contrastare la strategia postmodernistica della decostruzione della immortalità. Mettendo in scena la lunga morte di un cinquantenne, denuncia allo spettatore la barbarie della fabbrica postmodernistica della permanenza (Baumann), la pratica meschina di nascondere la morte, trasformandola in parola o spettacolo, evitando ogni possibilità che proponga dubbi, e offuschi le ‘magnifiche sorti e progressive’ del neoliberismo imperante. Naturalmente un’appendice non da poco di questa scelta è la conseguente focalizzazione della questione della cura nella morte: quali i limiti di intervento, quali i diritti del malato? La risposta di Arcand è naturalmente in linea con la sua formazione umanistica, che si riconosce negli esempi dei classici, corredati di fatto dalle riflessioni di tanti altri filosofi (Kierkegaard, Heidegger ecc). L’artista: Basquiat, di Schnabel Si è già detto che la fine delle narrazioni crea un vuoto di senso e di regole per aprire spazi più consapevoli al gioco e alla responsabilità. Ebbene l’arte è da sempre il campo privilegiato di questa dimensione dell’umano, nel senso che l’artista ha sempre praticato terreni strani, follie creative, derive esistenziali spesso dolorose. L’artista semplicemente ha la sensibilità privilegiata per vedere quel che gli altri non vedono: e sente la responsabilità di comunicare alla gente quel che vede, quel che sa, per aiutarla appunto ad allargare la sua conoscenza del mondo, delle persone, delle cose. 119 I suoi destini variano da sempre in rapporto ai contesti in cui agisce: spesso è integrato col potere, a volte è ribelle. Nella contemporaneità deve fare i conti con il mercato: e rischia di perdere la sua autonomia, la possibilità di ‘cercare’ quel che sente di cercare. Basquiat racconta la ‘follia’ di un artista che nasce per strada e rimane presto bruciato dal fuoco del mercato. La sua dimensione specifica, la sua dimensione di modello antropologico è rappresentata nelle prime scene del film. Nella prima c’è un bambino portato dalla mamma in un museo a guardare Guernica di Picasso. La donna si commuove e volge lo sguardo al piccolo, che si ritrova avvolto da una aureola d’oro. È la rappresentazione della genesi dell’arte: da un lato c’è la componente femminile della capacità di affetto, di apertura all’altro, che viene trasmessa al maschio; dall’altro la forza della tradizione, il collegamento con chi ci ha preceduti. Come corollario non da poco, la scelta del quadro (Picasso) pare indicare sia una ascendenza tecnica (il rifiuto del realismo, il cubismo) sia una indicazione tematica (rappresentare il brutto). Infine l’aureola, come citazione baudelairiana, segna il recupero della differenza sacrale dell’artista nella dimensione volgare della contemporaneità: ha il compito di rimettere sulla scena la con-fusione del sacro, non le distinzioni del kitsch; Nella seconda scena, in piccolo parco di new York c’è una grossa scatola di cartone, quando si apre – è mattino – esce un giovane nero caracollante, coi capelli rasta, che appena in piedi, dopo aver guardato in giro, si volge al cielo e lì scorge luminose onde del mare. Nel frattempo un altro giovane vestito in modo strano, seduto sulla panchina, ragiona dell’arte e dell’artista. È la via individuale di fuga dal mondo materiale: pochezza di beni materiali, isolamento alla Diogene, ma grande visione, capacità di veder quel che gli altri non vedono; accanto, la presenza di quello che di fatto è un critico d’arte, il mediatore, l’interprete. 120 Basquiat, scoperto da Wharol, ebbe una vita breve, consumata, da maledetto, tra le pratiche iniziali di writer di strada (samo era la sua firma = Sam old shit) e le luci del mercato. Il suo modello antropologico è naturalmente fascinoso agli occhi delle ultime generazioni condannate ad una precarietà che diventa stile solo se viene scelta come forma di autorealizzazione. L’eroismo nuovo della gente comune: Irina Palm, di Garbarski Ognuno di fronte alle difficoltà della nuova società globale senza welfare e senza solidarietà si può ingegnare a modificare le proprie pratiche consuete, flettendo la mente e aprendosi a nuova dimensione dell’esistenza, fino a travolgere le regole e le convinzioni di sempre. Ancora una volta la catastrofe può diventare una opzionalità, se si sa vedere il tempo non solo come qualcosa che consuma ma anche come kairòs. La storia Maggie è una vedova poco più che cinquantenne, che si decide ad un lavoro avvilente pur di procurare soldi per le spese mediche del nipotino malato: in un locale porno, deve masturbare i clienti. Il padrone del locale che all’inizio la tratta con distacco e ironia, la rivaluta quando ‘sperimenta’ la sua ‘efficienza’ artigianale; la relazione procede sulla base di chiare dichiarazioni di interessi. Nulla per nulla. Se mi inganni ti vengo a cercare e ti uccido, conclude Niki, quando le anticipa seimila sterline. Non è buono: lui sa di star facendo un affare. La metamorfosi definitiva si ha quando Maggie gli dimostra che, pur potendo lasciare il suo locale a favore di un altro lavoro più redditizio, rimane seguendo la logica dell’affetto e a quel pun121 to ne tira fuori confessioni, intimità, sincerità, umanità, progetti, sorriso (“dovresti sorridere più spesso”, gli dice e lui le fa confidenze sulla sua precedente amante, della casa a Maiorca per la pensione). Insomma Niki capisce che Maggie non è solo un ‘affare’ ma una ‘persona’ (tu non sei Luisa, mi piace come cammini): insomma si rivela sotto la scorza del duro cinico macho un uomo con dolori rimossi, nascosti. E l’accompagna alla stazione solo per farle compagnia. E le prepara un regalo per Natale (un accendino), ricacciando indietro la voce dell’utile che bussa alla porta. La scena iniziale Siamo nelle campagne attorno a Londra: dall’alto si osserva la campagna inglese, linda, ridente, ordinata nelle sue casette, con bei prati e la luce che dice civiltà, se non felicità. Un mondo idillico, appunto. La tecnica è quella della carrellata che stavolta dall’alto plana progressivamente a inquadrare un abitato basso a forma di corte, insomma un quadrato, a sottolineare ancor più questa impressione di una comunità precisa e soddisfatta, realizzata; da uno dei lati si vede uscire un uomo, che entra in una automobile parcheggiata lungo il marciapiede. Quando l’inquadratura diventa americana si vede che è un giovane, dall’aspetto florido, anche se con l’aria corrucciata. Mette in moto e dopo dieci metri ferma, suona, e arriva da un appartamento della corte, una donna anziana, grossa se non grassa, coperta da un leoncino di pezza; la scena prosegue dentro l’auto, con lo scambio apparentemente banale di battute, sul leoncino, intorno alla sua utilità o meno, al senso o meno di portarlo. Silenzio per lo più. La stessa scena si ripropone verso la fine a segnalare i cambiamenti avvenuti. Figlio e madre insieme aspettano un taxi davanti al vialetto delle loro case, e si parlano. In auto rimangono totalmente in silenzio: il figlio ancora non accetta quel che è 122 avvenuto. La relazione con la nuora ora, invece, è calda, vuole che vada con loro in Australia. È Maggie che stavolta rinuncia ancora all’offerta di condivisione ‘obbligata’ per sottolineare la gratuità del gesto e perché sa che la sua presenza sarebbe ancora motivo di disturbo al figlio: ancora sacrificio (lei vorrebbe stare col nipotino), ma certo non nelle forme cruente o rituali del passato. Maggie e gli altri In realtà per lei si può utilizzare il concetto di ‘sacrificio’ nella sua etimologia: andare dal mondo umano dell’ordine simbolico con chiare distinzioni di ordine e disordine, al mondo divino della confusione, dove non è facile distinguere il bene dal male (inizio della storia: aereo, suoni, cornacchia e campana; ovvero male malaugurio e bene divino) e ovviamente questo non è facile farlo capire o accettare dagli altri. Le amiche si scandalizzano (fingono che una di loro ha avuto una storia col marito morto), fino a quando non le affronta ed è costretta a patire la loro turbata meraviglia di chi solo e sempre dentro la Legge: è un uomo interessante? lo fai per soldi? come fai tecnicamente? Le risposte sono semplici e dirette, con l’orgoglio di chi fa bene il suo lavoro e la freddezza di chi ha passato la frontiera, ha varcato la Porta. La nuova identità la porta a superare la linea della separatezza, della forma, del perbenismo e a vantare secondo le regole dell’efficienza e del mercato, il proprio ‘merito’. Se guadagno, se risolvo problemi, acquisto onore. Solo la nuora, che pure all’inizio pare fredda, accetta e capisce: il figlio almeno all’inizio fa valere il ‘suo’ dolore da monade leibniziana senza finestre, narcisisticamente attaccato alla propria iperidentificazione, per arrivare infine – in forma di mimesis – a capire e oltrepassare la porta della Legge. Quel che conta è il ‘bene’ del figlioletto. In tal modo si mette in scena la dialettica tra etica dei principi 123 (delle intenzioni) ed etica della responsabilità: da una parte il figlio/padre che vuole rifiutare i soldi della madre perché procurati con un lavoro per lui disonorevole, ma che si chiede: “che conseguenze ci saranno per mio figlio?”; dall’altro la nuora che conclude “oggi ho scoperto che la mamma ha rischiato tutto per mio figlio e io le sono grata”. È il mantenere la divisione che dà senso alle vite ‘normali’ del figlio e delle amiche, perturbati ciascuno a suo modo dalla con–fusione (madre vs prostitua; donna perbene vs prostituta) che si riscontra nella vita di Maggie\Irina. A sottolineare e risolvere sarcasticamente questa contesa antropologica provvede il corpo: il gomito risente del lavoro eccessivo e Maggie è così ‘marchiata’ come nelle antiche favole da un segno che indica agli altri la ‘straordinarietà’ della protagonista, la sua assunzione al cielo. La malattia indica una ‘rivelazione’, è indizio di un destino diverso, di una metamorfosi salvifica, dell’assunzione della propria superiorità morale come sfida alle regole dell’idiotismo morale, fino ad una ‘rinascita’. Spersonalizzazione e oggettivazione Il fatto che Maggie scelga quel particolare tipo di ‘lavoro’ (far ‘godere’ dei maschi senza mai vederli, toccando solo una specifica parte del corpo), da parte dell’autore vuole probabilmente sottolineare la fine delle relazioni personali. Mentre nella società premoderna le relazioni anche di scambio erano sempre personali (tra persone che possono e magari devono anche “venire alle mani”), con l’introduzione del mercato la soggettività si assenta e nello scambio entrano in gioco solo gli oggetti e il loro valore espresso in denaro. Così una quantità sempre maggiore di contenuti di vita si spersonalizza e viene oggettivata: entrano in una dimensione dove l’appropriazione degli oggetti, ma anche del tempo e delle relazioni di vita, 124 diventa un’azione impersonale, che prescinde dagli impulsi e dalla pulsione di prevaricazione (troppo costosa in termini di coinvolgimento e di mediazione). Insomma si mette a tacere il desiderio soggettivo (sia il corpo o la mente a formularlo), per procedere ad una valutazione oggettiva, ad una riflessione (in termini di costo/guadagno). L’individuo quindi non è più visto e riconosciuto come titolare di ‘personalità’, ma solo come titolare di interessi: il rapporto non è quindi più tra gli uomini, ma tra le ‘cose’ di cui gli uomini sono semplici rappresentanti. Anche il sesso consumato nel locale è frammentato: il contatto tra la donna e il cliente si limita al contatto mano/pene. Il resto non importa. Del resto, ha detto Lacan, il rapporto sessuale non esiste. Nella situazione di Irina, quello che si chiamava e si continua a chiamare amore, viene svelato allo spettatore attraverso questo codice narrativo particolare per quello che è diventato oggi, ma quindi per quello che è diventata la società nella sua interezza: scambi, abilità di interessi, di oggetti, di parti, di persone come oggetti. È la forma estrema di razionalizzazione. 125 PARTE TERZA IL DON GIOVANNI DI W OLF GANG AMADEUS MOZART “Non si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste. Altre cure più gravi di queste, altra brama quaggiù mi guidò!“ Don Giovanni, Atto II, Scena 17 1. PER UNO STILE DI VITA: IL DON GIOVANNI DI MOZART Il Don Giovanni, ovvero Il dissoluto punito, dramma giocoso, in due atti, di Wolfgang Amadeus Mozart, (K 527, Bibliothèque Nationale, Parigi), su libretto di Lorenzo da Ponte, fu rappresentato a Praga, presso il Teatro degli Stati Generali, il 29 ottobre del 1787. All’autore salisburghese, reduce dai trionfali consensi e dall’enorme successo de Le nozze di Figaro, rappresentate poco prima nel medesimo teatro, fu chiesto dall’allora sovrintendente ai reali spettacoli di procedere alla stesura di un’opera nuova che eguagliasse il successo della precedente, e che, soprattutto, mettesse in luce le rampanti doti canore del giovane baritono italiano Luigi Bassi, che già aveva avuto modo di distinguersi nell’allestimento delle Nozze. 126 Influenze e fonti Il celebre librettista italiano Lorenzo da Ponte, collaboratore di Mozart già in occasione de Le nozze di Figaro (la terza delle tre opere italiane su libretto di da Ponte sarà Così fan tutte, suggerì di lavorare sulla vicenda del dissoluto punito, fabula non nuova, ma che offriva notevoli spunti di interesse, e che aveva precedenti illustri (tra gli altri, in L’ingannatore di Siviglia di Tirso da Molina, del 1630). Si ispirava alla leggenda popolare, nota in terra di Spagna e poi diffusa in tutta Europa, di Don Juan Tenorio, che uccise il comandante della città di Ulloa dopo averne sedotto la figlia153; era costui un impenitente libertino che dedicava tutto il proprio tempo e le proprie energie ad una unica attività: le “donnesche imprese”; la vicenda era posta di solito in un ambito di tre giornate, e, dopo vari, licenziosi, drammatici e talora buffi accadimenti, poteva concludersi indifferentemente con la redenzione o con la punizione del protagonista. La leggenda doveva essere molto popolare e di gran successo, a giudicare dalla gran mole di opere ispiratevi, in tutta Europa. Mozart ne fa un archetipo, amplificandone i tratti più universali ed estendendoli ad universale realtà; forniamo qui, a titolo di elenco, il novero delle principali attinenze, in tema o in nome, relative alla vicenda del Don Giovanni: • El burlador de Sevilla y el convitado de piedra, Tirso da Molina, 1630 • Il nuovo risarcito convitato di pietra, dramma per musica di Giovan Battista Andreini, 1651 • Il convitato di pietra, dramma di Onofrio Giliberto, stampato in Napoli per Francesco Savio, 1652, a tutt’oggi disperso • Don Giovanni o Il convitato di pietra, tragicommedia di Molière, 1665 • Il dissoluto punito, Metastasio 127 • Don Giovanni Tenorio, tragicommedia di Carlo Goldoni, 1736 • Don Juan, balletto di Christoph Willibald Gluck, 1761 • Il convitato di pietra, musica di G. Gazzanica su libretto di G. Bertati, 1787 • Il convitato di pietra ossia Il dissoluto, opera buffa di Vincenzo Righini, 1776 • Il convitato di pietra, musica di Giuseppe Calegari su libretto di P. Pariati, teatro S. Cassano, Venezia 1777 Composizione La composizione dell’opera ebbe uno svolgimento, per così dire, estemporaneo ed episodico, in linea con il carattere estroverso dell’autore: la maggior parte delle arie, dei cori e dei recitativi pare vennero redatte in meno di due mesi, nel settembre e nell’ottobre del 1787, mentre la leggenda ci informa che l’Ouverture – uno dei vertici compositivi mozartiani! – venne scritta addirittura il giorno antecedente alla prima. Rappresentazioni Alle quattro rappresentazioni praghesi del Don Giovanni che Mozart diresse personalmente - come già detto, nel 1787-, seguì un successo non comune, che tuttavia non si ripeté, l’anno successivo, il 7 maggio 1788, presso il Burgtheater di Vienna, dove la vicenda così disinibita e spregiudicata di un libertino, sebbene castigato, probabilmente mal si confaceva all’ambiente più rigido ed austero della corte asburgica: “Il Don Giovanni non è pane per i denti dei miei viennesi”, pare abbia commentato l’Imperatore Giuseppe II dopo aver assistito alla rappresentazione154 (cfr. oltre). Ed è infatti in occasione di tale allestimento, oltre a varie mo128 difiche, che venne cassato il coro-sestetto finale, dal carattere giocoso e ironico, ponendo termine alla vicenda, tragicamente e romanticamente, sulla morte del protagonista, tra le fiamme e gli abissi infernali; ma su ciò si avrà modo di riflettere in seguito. È direttamente Lorenzo da Ponte ad informarci circa le prime rappresentazioni dell’opera: “Io non avea veduto a Praga la rappresentazione del Don Giovanni; ma Mozzart m’informò subito del suo incontro maraviglioso, e Guardassoni mi scrisse queste parole: «Evviva Da Ponte, evviva Mozzart. Tutti gli impresari, tutti i virtuosi devono benedirli. Finché essi vivranno, non si saprà mai che sia miseria teatrale». L’imperadore mi fece chiamare e, caricandomi di graziose espressioni di lode, mi fece dono d’altri cento zecchini, e mi disse che bramava molto di vedere il Don Giovanni. Mozzart tornò, diede subito lo spartito al copista, che si affrettò a cavare le parti, perché Giuseppe doveva partire. Andò in scena, e... deggio dirlo? il Don Giovanni non piacque! Tutti, salvo Mozzart, credettero che vi mancasse qualche cosa. Vi si fecero delle aggiunte, vi si cangiarono delle arie, si espose di nuovo sulle scene; e il Don Giovanni non piacque. E che ne disse l’imperadore? «L’opera è divina; è forse forse più bella del Figaro, ma non è cibo pei denti de’ miei viennesi.» Raccontai la cosa a Mozzart, il quale rispose senza turbarsi: «Lasciam loro tempo da masticarlo.» Non s’ingannò. Procurai, per suo avviso, che l’opera si ripetesse sovente: ad ogni rappresentazione l’applauso cresceva, e a poco a poco anche i signori viennesi da’ mali denti ne gustaron il sapore e ne intesero la bellezza, e posero il Don Giovanni tra le più belle opere che su alcun teatro drammatico si rappresentassero”. Personaggi Don Giovanni, giovane cavaliere irriducibile libertino, baritono/basso) 129 Leporello, servitore di Don Giovanni (basso baritono) Il Commendatore, padre Di Donna Anna (basso profondo) Donna Elvira, dama di Burgos, sedotta ed abbandonata da Don Giovanni (soprano) Donna Anna, dama promessa in moglie a Don Ottavio (soprano) Don Ottavio, duca (tenore) Masetto, contadino, sposo di Zerlina (basso) Zerlina, contadina (mezzosoprano) Villici, servitori, domestici, demoni, musici e ministri di giustizia (cori) Vicenda155 Atto I, scena I-III La scena con cui si apre l’opera è ambientata in una città probabilmente Spagnola, attorno al XVI secolo, nella fattispecie nel cortile della dimora del Commendatore e di Donna Anna, sua figlia; qui Don Giovanni si è furtivamente introdotto nottetempo, fingendosi il fidanzato di quest’ultima, Don Ottavio, con il disdicevole disegno di sedurla; intanto Leporello, servo di Don Giovanni, di guardia, attende, sbuffando e deprecando il suo tristo ruolo, che il padrone faccia i suoi comodi. Improvvisamente il portone si spalanca con violenza, e ne escono Donna Anna, scarmigliata e urlante, e Don Giovanni, da questa trattenuto per il braccio nel tentativo di impedirne la fuga; alle grida accorre il vecchio padre, che, nonostante l’età avanzata, sfida il libertino per difendere l’onore della figlia; mentre questa accorre in casa in cerca di aiuto, Don Giovanni, riluttante, accetta il duello, che si conclude, inevitabilmente, con la morte del Commendatore; non riconosciuto da alcuno, fugge poi con Leporello sulle urla strazianti di Donna Anna e 130 sulle promesse tiepide di Don Ottavio, tardivamente accorso giurandole vendetta. Atto I, scena IV-VI Sulla via del ritorno, ormai sul far dell’alba, Leporello rimprovera impertinentemente al padrone la deprecabile impresa di quella notte; lungo il cammino scorgono da lontano, non visti, una figura velata ed in lacrime, Donna Elvira, che si lamenta per essere stata sedotta a Burgos proprio da Don Giovanni e abbandonata dopo soli tre giorni; Don Giovanni, non avendola dapprima riconosciuta, la avvicina come per consolarla, ma in realtá per aggiungerla alla lunga lista delle sue vittime amorose; ma la donna riconosce il suo vecchio e menzognero amante, e gli si fa da presso; anche lei è riconosciuta dal dissoluto, che, con abile favella, riesce a sottrarsi dalle sue accese rimostranze, allontanandosi furtivamente con una scusa e lasciando l’incombenza di risolvere la vicenda, come al solito, al povero Leporello. Il fedele ma critico servitore, con celeberrima aria, allora svela in tutta la sua crudezza il vero, descrivendo le “donnesche imprese” del padrone e enumerando la lunghissima lista delle sue sterminate ed “internazionali” conquiste femminine: in Italia 640, in Alemagna 231, in Francia 100, in Turchia 91 e in Spagna 1003! Dopo questo tenero enueg, Leporello fugge a sua volta, lasciando Donna Elvira nella disperazione e nell’ira. Atto I, scena VII-XIV A sole ormai levato, giunti dinanzi un’osteria, i due assistono al passaggio del corteo nuziale di due villici sposi, Masetto e Zerlina; quest’ultima solletica immediatamente l’interesse di 131 Don Giovanni, che mette in atto una ennesima macchinazione per sedurla: invita tutti gli ospiti a continuare i festeggiamenti per le nozze nel proprio palazzo, e dà disposizioni per allestire il banchetto… Intanto Leporello avrebbe distratto l’ignaro ma recalcitrante Masetto, mentre Don Giovanni avrebbe nel contempo condotto Zerlina in un suo casino di caccia, luogo appartato, con l’obiettivo di abusarne; alle lusinghe ipocrite e ammaliatrici e alle promesse di miglior nozze da parte di Don Giovanni, Zerlina sta per cedere, affascinata; ma “l’incanto” viene interrotto bruscamente da Donna Elvira, tempestivamente sopraggiunta, che irrompe mettendo in salvo la “trepida sposina” e conducendola via. Giungono nello stesso luogo Don Ottavio e Donna Anna, in cerca dell’assassino di suo padre; Donna Elvira intanto li informa delle malefatte del libertino; i due iniziano ad insospettirsi, ma Don Giovanni, con perfetto autocontrollo, apostrofa Elvira come una povera pazza; anzi, si finge addolorato per la morte del Commendatore, arrivando perfino a simulare aiuto in loro favore, fornendo false indicazioni prima di allontanarsi; ma Donna Anna riconosce nella voce del nobile quella del suo parricida, e ricostruisce le vicende di quella funesta notte a Don Ottavio: come un uomo, travestito, si fosse spacciato per quest’ultimo ed introdotto in camera sua stringendola a sé, e, smascheratolo, come lei fosse riuscita a liberarsi dal malevolo amplesso di quello sconosciuto, senza riuscire tuttavia ad arrestarne la fuga. A Don Ottavio non rimane altro che giurarle ancora acerba ma vana vendetta. Atto I, scena XV-XIX La vicenda si sposta nel maniero di Don Giovanni; qui Leporello lo informa che ormai Zerlina è stata ricondotta da Masetto; Don 132 Giovanni non accetta il diniego, e, ordinando il da farsi per il banchetto serale, pregusta già il sapore della posticipata conquista. Intanto nel giardino della villa, ove sono convenuti tutti gli invitati, Zerlina tenta di riconciliarsi con Masetto, ragionevolmente adiratosi: la donna mette in atto una “candida” palinodia, riuscendo infine a rabbonire lo sfortunato sposo, che si allontana. Ma la pace dura poco, in quanto torna all’assalto il determinato Don Giovanni, che si fa da presso alla sposa; Masetto è sempre più sospettoso, e si nasconde in una edicola del giardino per spiarli, ma viene scoperto dal nobile stesso, che aveva condotto proprio lì Zerlina per goderne in pace; con ulteriore capacità di sangue freddo, Don Giovanni si sottrae dall’imbarazzo adducendo che aveva scorto lo sposo, e come fosse lì convenuto per restituirgli la smarrita sposina; ma intanto è già quasi l’ora del banchetto, e il singolare terzetto si avvia al festino in maschera. Giungono al ballo intanto Donna Elvira, Donna Anna e l’immancabile Don Ottavio, altrettanto singolare trio in maschera, con l’intenzione di affrontare Don Giovanni e condurlo alle proprie responsabilità; avendoli Leporello scorti dal balcone, ed avvertito il padrone, Don Giovanni li invita con lucida ospitalità alle danze; le tre figure mascherate invocano, prima di entrare, l’aiuto del cielo. Atto I, scena XX-XXI Si dà inizio ai festeggiamenti, in un clima di gaia spensieratezza; ma Don Giovanni non trascura il suo turpe obiettivo, corteggiando impunemente Zerlina, incurante delle accese rimostranze di suo marito Masetto; l’orchestra intanto inizia fortunatamente a suonare musiche per il ballo, in cui contemporaneamente si odono tre danze diverse: una “alla tedesca” per i villici, una “contraddanza” per i borghesi e un “minuetto” per la nobiltà; nella confusione Don Giovanni intima a Leporello 133 di distrarre nuovamente Masetto, invitandolo “forzatamente” alle danze, mentre egli avrebbe condotto Zerlina all’amplesso, in una stanza del piano superiore. Poco dopo si odono le urla della donna, che provocano il subitaneo intervento delle tre maschere, Elvira, Anna ed Ottavio; impassibile e geniale come sempre, Don Giovanni riesce a cavarsela, urlando contro Leporello, tenuto per il braccio, e additato come autore della violenza; non creduto, si dà alla fuga, lasciando tutti nella confusione generale; le tre figure, sollevandosi la maschera, rivelano la loro vera identità, invocando contro il dissoluto, come al solito, la vendetta celeste. Atto II, scena I-VI Il giorno seguente, in strada, Leporello tenta verosimilmente di prendere congedo dal suo padrone, non avendo più intenzione di sottostare alla sua riprovevole condotta di vita; ma il proposito cede di fronte ad una profferta di denaro, che Leporello accetta a patto che Don Giovanni rinunci alle donne, condizione respinta senza appello; e dunque si rimettono in cammino, in cerca di nuove conquiste. Infatti Don Giovanni vuole ora concupire la fantesca di Donna Elvira, procace e sanguigna avventura; e per rendere ancor più certa la conquista, determina di mutar panni con Leporello; negli abiti del padrone, Leporello reciterà a Donna Elvira una finta scena d’amore sotto il suo balcone; Don Giovanni, nascosto, parlerà in sua vece; il trucco ha successo, e Donna Elvira, cedendo alla sua mai sopita passione, accetta le suppliche di perdono e scende nel giardino per unirsi all’empio libertino; ma il vero Don Giovanni simula ad arte un agguato, e fuga i due goffi amanti. Liberata la via, Don Giovanni finalmente si dedica alla conquista. Si appresta a cantare una serenata alla cameriera, accom134 pagnandosi con un mandolino; ma, non appena la donna si mostra alla finestra, irrompe in strada un gruppo di contadini, armati di mazze e forconi, capeggiati da Masetto, armato anch’esso di moschetto: essi reclamavano vendetta su Don Giovanni; questi invece, imitando la voce di Leporello, si unisce all’improvvisata brigata di vendicatori, guidandoli abilmente fino a disperderli; rimasto solo con Masetto, lo disarma con l’inganno e lo picchia violentemente con un bastone, per poi allontanarsi lasciandolo a terra; viene soccorso poco dopo da Zerlina, disposta a curarlo maliziosamente con un “balsamo” che solo lei può offrirgli... Atto II, scena VII-XI Nell’atrio della casa di Donna Anna, giungono Leporello e Donna Elvira, che non riesce a districarsi da quella incresciosa situazione; giungono nel contempo Donna Anna e Don Ottavio, seguiti poco dopo da Zerlina e Masetto, determinati ad impedire l’ennesima fuga di colui che credono Don Giovanni (in realtà Leporello); soltanto donna Elvira tenta di difenderlo, convinta della sua redenzione ad opera dell’amore. Vedendosi minacciato di morte, Leporello si decide a rivelarsi, ma viene comunque accusato di imbroglio e di aver aggredito Masetto; dopo una rocambolesca giustificazione del suo operato, egli riesce infine a fuggire. Don Ottavio dichiara colpevole Don Giovanni, e invita i compagni a consolare la sua donna Anna; Donna Elvira intanto è divisa tra l’amore per Don Giovanni e il desiderio di vendetta. Atto II, scena XII È notte di plenilunio. Don Giovanni e Leporello possono finalmente ricongiungersi, al riparo da tutti, in un celato cimitero di 135 campagna; si restituiscono i rispettivi vestiti, mentre Don Giovanni si prende burla del servo, raccontandogli di aver giaciuto con una ragazza che lo credeva Leporello; questi reagisce con gelosia, suscitando le risa del padrone. Nel tetro silenzio del cimitero, rischiarato dalla luce lunare, si ode una voce bronzea rivolta a Don Giovanni: “Di rider finirai pria dell’aurora”… È la voce del Commendatore ucciso, la cui statua di pietra è lì da presso, recante l’iscrizione “Dell’empio che mi trasse al passo estremo attendo qui la vendetta”. Leporello balbetta terrorizzato, ma Don Giovanni, per nulla intimorito, anzi sprezzante, gli ordina di invitare a cena la statua, la quale, con un cenno del capo, accetta. Atto II, scena XIII-XIV Nel frattempo, in casa di Donna Anna, Don Ottavio non trova di meglio da fare che chiedere inopportunamente la sua mano, mentre ella, cortesemente, gli risponde di lasciar passare almeno un po’ di tempo dalla morte del padre. Atto II, scena XV-XVII Nel suo palazzo, Don Giovanni attende che gli sia servita la cena; Leporello lo assiste a digiuno; i musicisti di palazzo iniziano a suonare durante la cena: per la prima portata, un’aria dall’opera Una cosa rara, di Martin Y. Soler; per la seconda, un’aria da I due litiganti, di Giuseppe Sarti; per la terza, una autocitazione mozartiana: Non più andrai, celebre aria da Le nozze di Figaro, al cui ascolto Leporello esclama ironicamente: “Questa poi la conosco pur troppo!” Mentre Don Giovanni sollazza il suo pantagruelico appetito e insieme a Leporello, che gli ruba un po’ di fagiano, prorompe 136 Donna Elvira, nell’estremo tentativo di convincere al ravvedimento colui che, in fondo, amava; ma Don Giovanni, disdegnoso, la respinge, costringendola ad andare via. Mentre Donna Elvira varca l’uscio, vede qualcosa di terrificante e fugge via, tra urla di raccapriccio, in opposta direzione; Leporello è incaricato da Don Giovanni di sincerarsi della cosa, e, rivolto lo sguardo sull’atrio, urla di sgomento e rientra frettolosamente in casa, riferendo al padrone che è in procinto di entrare, inesorabilmente, la statua del Commendatore, il convitato di pietra, la stessa che avevano irriso nel cimitero. Il convitato ora bussa alla porta. Don Giovanni ordina a Leporello di fargli strada, ma questi si rifiuta, riluttante e sgomento; allora decide di fare gli onori di casa egli stesso. Dà ospitalità quindi al Convitato, cui fa servire la cena, ma questo rifiuta, adducendo che “Non si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste”, invitando a sua volta Don Giovanni ad un altro simposio; questi accetta stringendogli la mano. Improvvisamente viene pervaso da un gelo infernale da cui non riesce a liberarsi. Il Convitato reiteratamente lo invita a pentirsi e a “cangiar vita”, ma Don Giovanni, in modo eroicamente sprezzante, rifiuta per ben tre volte (!); ad un tempo vortici e lingue di fuoco lo avviluppano, sprofondandolo nei baratri infernali, mentre un coro di spiriti demoniaci rende alito sonoro all’agghiacciante visione. Atto II, scena XVIII La scena muta radicalmente: l’aria si rischiara; Leporello riemerge da sotto il tavolo ove si era nascosto; giungono Donna Elvira, donna Anna, l’instancabile presenzialista Don Ottavio, Masetto, Zerlina, accompagnati da un gendarme incaricato di 137 arrestare Don Giovanni; Leporello descrive l’accaduto, e tutti reagiscono nella perfetta normalità, come nulla fosse accaduto. Ciascuno dichiara il proprio progetto per l’avvenire: Leporello si recherà all’osteria, in cerca di nuovo padrone; il pesante Don Ottavio e Donna Anna (meschina donna!) saranno sposi entro un anno; Zerlina e Masetto riprenderanno il loro usato desco, dove lo sposo potrà meditare sulla propria condizione di cornuto; Donna Elvira, unica eroina di coerenza, vedova del proprio amante, anch’esso demone di coerenza, si ritirerà in un convento a celebrare nell’eterna castità l’unico vero amore dell’intera vicenda. Per uno stile di vita: analisi comparata Don Giovanni/Don Ottavio L’intera opera è strutturata su un contrasto: tra io e mondo, tra natura e cultura, tra essere e sembrare, tra l’universale e il particolare; per risolvere tale contrasto occorre “cercare, nel vario e nel mutevole, il conforme e il costante”156; e prendere contezza che “tale impresa è la coscienza di certe tensioni fra il locale e l’universale; o, se si preferisce, fra il particolare e il generale (…) conviene rilevare quei concetti estremi che racchiudono una serie di opposizioni generali, applicabili a situazioni differenti: fra la circostanza e il mondo (i mondi); fra ciò che è presente e ciò che è assente, fra l’esperienza e il suo senso; fra l’io e quanto gli è estraneo; fra il percepito e il desiderato; fra ciò che c’è e ciò che dovrebbe esserci; fra ciò che esiste e ciò che è”157. Nella lettura della vicenda, occorre riflettere su alcune costanti, quali 1) la violenta e non esclusivamente repentina rottura di un’iniziale stabilità; 2) la ricostituzione di un nuovo equilibrio su basi nuove e diverse; dal punto di vista squisitamente narratologico, anche per esse sono valide quelle persistenze concettuali individuate dal Propp158: 138 Funzioni dell’affabulazione Equilibrio iniziale Rottura di tale equilibrio Prove Catastrofe Ricostituzione di un nuovo equilibrio Sistema dei personaggi Protagonista Coprotagonista Antagonista Aiutante-i Comparse Appare dunque universalmente valida, per tale analisi, la rappresentazione mentale e culturale di catastrofe: concetto non tragico, bensì escatologico, inteso come sovvertimento palingenetico di un vecchio ordine a vantaggio di un altro, nuovo, non necessariamente negativo. Neanche il giudizio morale sembra pervadere le pagine del Don Giovanni, anzi la morale è altro, non è oggetto di interesse, da parte sia di Mozart che di da Ponte; “Certo Mozart, come divino ispiratore delle sue creature, regge le fila della situazione, certo si identifica in loro, nelle loro azioni e reazioni, eppure si sottrae a noi garantendosi il distacco dello spassionatamente obiettivo. Non condanna mai, nemmeno là dove quasi tutti i personaggi, all’infuori del protagonista, sono dominati dall’idea di condannare il protagonista. (…) In una rigorosa neutralità di giudizio e al di là di ogni morale Mozart sostiene i principi del positivo come del negativo – per quanto si possa parlare di positivo, dato che le prerogative di ciascun personaggio si ma139 nifestano quasi esclusivamente in relazione all’eroe negativo, Don Giovanni, che tiene tutti gli altri in suo potere. La capacità di immedesimazione di Mozart è ripartita senza la minima parsimonia ma con equanimità – con una equanimità che ci sorprende e stupisce – tra la forza e la debolezza, tra disperazione e trionfo, malvagità e bontà. Anche se quest’ultima è invero un po’ sacrificata in quest’opera: a nessun personaggio viene offerta la possibilità di farne un uso attivo perché nei confronti del demone qui operante ciascuno è il prossimo di sé stesso.”159 Tale visione del mondo appare in tutta la sua forza nella comparazione tra due personalità del dramma: Don Giovanni e Don Ottavio, figura apparentemente di secondo piano; il loro agire, all’interno della vicenda, riflette due estetiche e due diverse Weltanschauung. Sul piano musicologico, i due personaggi sono in linea con il carattere della composizione, “dramma giocoso” nell’epigrafe, ma formalmente opera buffa; è infatti caratteristica dell’opera buffa italiana, come della già citata tragicommedia160, la coesistenza di motivi “seri” e di situazioni “buffe”, così come di personaggi “scuri” ad altri più “comici”; ma nel Don Giovanni tale peculiarità viene amplificata dalla caratterizzazione psicologica dei personaggi, a ragione del dilatamento speculativo generato dalla fusione perfetta tra il soppesato testo dapontiano e la programmaticità filosofico-musicale mozartiana. Le azioni dei due personaggi sono modellati sul concetto di catastrofe: l’uno, Don Giovanni, tende al nuovo, all’eccesso, procede a spezzare i vincoli socio-culturali-etico-antropologici della società, l’altro, Don Ottavio, tende invece a ricomporli, a moderare ogni sperequazione, ad affermare lo status quo dell’ancien régime; l’uno è il futuro dall’incerta sagoma, l’altro guarda il passato con rassicurante monotonia; l’uno cinestesico e demoniaco, l’altro statico e immobilmente tedioso. 140 Don Giovanni sembra incarnare appieno il concetto di genio: esso interpreta, preveggente, il proprio tempo, manifestando “devianze” che permettano di anticipare estetiche e visioni valoriali future161; Don Ottavio, invece, è egli stesso il proprio tempo, impegnato nella indefessa missione di riaffermare costantemente sé stesso in un contesto che non lo riconosce, se non come tale. E infatti il Don Giovanni si configura come una “commedia di carattere”, vieppiù imperniata su un solo personaggio – in questo caso negativo – del quale interpreta le vicende e svela il destino; gli altri personaggi vivono, pensano, agiscono e si muovono unicamente in relazione ad esso, e delle loro dinamiche vengono rivelate soltanto quelle che de esso traggono origine; opera in cui, quindi, soltanto del protagonista è offerta una reale ed esaustiva caratterizzazione, mentre degli altri personaggi viene presentata soltanto una parziale rappresentazione, contestuale, monografica e difforme. Fatte queste preliminari considerazioni, sembra opportuno, nell’analisi comparata, attraverso il testo, dei due personaggi, focalizzare l’attenzione su due aspetti interessanti: l’azione e l’inazione. Don Giovanni è homo faber, teso costantemente all’azione, persino riprovevole, ma necessaria all’incessante perpetuarsi del mondo162; don Ottavio è homo spectans, preoccupato di conservare l’equilibrio della situazione in cui vive, in una inazione civile e confortante. O, per dirla con anacronistico ordine psicanalitico163, don Giovanni è eros, principio di piacere, spazio estetico, madre-ruolo affettivo, ES; Don Ottavio è thanatos, principio di realtà, spazio etico, padre-ruolo istituzionale, EGO. Ma passiamo a cogliere tali aspetti direttamente dalle parole dei due personaggi164. 141 Don Ottavio, ovvero l’inazione Esempio magistrale del carattere inattivo di Don Ottavio si ha quasi subito, nella scena III dell’Atto I, quando Don Ottavio, tardivamente intervenuto in difesa della promessa sposa Donna Anna, trova lo scempio già avvenuto: si china al “capezzale” del morente Commendatore – ucciso in regolare duello, sebbene causato da tentata violenza – e “con ferro ignudo in mano” grida: “Tutto il mio sangue verserò, se bisogna: ma dov’è il scellerato?”. Preferisce parlare al futuro, nell’inazione del momento, mentre il ribaldo assassino fugge – e lo vede fuggire! –, e a Donna Anna, accasciata a terra nel tentativo di soccorrere il padre, nonostante il trauma della tentata violenza e della visione del sangue paterno, promette di versare il proprio (!) nella difesa, ma, bada bene, “se bisogna”: e quale momento, se non quello, necessiterebbe di uno slancio? E intanto, sempre nella pigra e pavida staticità che lo caratterizza, demanda ai servi il compito di agire: “Ah! soccorrete, amici il mio tesoro. Cercatemi, recatemi qualche odor... qualche spirto... Ah! Non tardate. Donn’Anna!... sposa!... amica!... il duolo estremo la meschinella uccide! (i servi tornano) Già rinviene. Datele nuovi aiuti.” Nell’ordinare la rimozione del cadavere del commendatore, “oggetto d’orrore”, Don Ottavio ne approfitta per ribadire, inopportunamente, la promessa di matrimonio, con la pretesa, probabilmente di ingenua buona fede, di poter essere per la sposa, da allora in avanti, sia marito che padre: “Senti, cor mio, deh! senti, guardami un solo istante: ti parla il caro amante che vive sol per te.” Donna Anna a stento lo riconosce: “Tu sei... Perdon, mio bene... l’affanno mio... le pene... ah! il padre mio dov’è?”, ma egli insiste: “Il padre... Lascia, o cara, la rimembranza amara: hai sposo e padre in me”, ribadendo giuramenti d’amore e vendetta: “Lo giuro! Lo giuro! Lo giuro agli occhi tuoi, lo giuro al nostro amor”, così come nella scena 142 XIV dell’ Atto I, quando Don Ottavio, rimasto solo, apostrofa al cielo: “Come mai creder deggio di sì nero delitto, capace un cavaliero! Ah, di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi! Io sento in petto e di sposo e d’amico il dover che mi parla: disingannarla voglio, e vendicarla.” Massima staticità si ha nell’Aria, in cui Don Ottavio discioglie se stesso nell’esistenza dell’amante (tenero!), annullandosi in ella: “Dalla sua pace la mia dipende, quel che a lei piace vita mi rende, quel che le incresce morte mi dà. S’ella sospira, sospiro anch’io; è mia quell’ira, quel pianto è mio; e non ho bene, s’ella non l’ha”. E ancora promessa generica di vendetta, nella scena VII dell’Atto II: “Tergi il ciglio, o vita mia! E da’ calma al tuo dolore: l’ombra omai del genitore pena avrà de’ tuoi martir”. “Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l’empio uccisore del padre di Donn’Anna. In questa casa per poche ore fermatevi: un ricorso vo’ far a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dover, pietade, affetto”. Ancora, nell’Aria successiva, Don Ottavio demanda ad altri di consolare la sposa: “Il mio tesoro intanto andate a consolar. E del bel ciglio il pianto cercate di asciugar”, perché egli, da cavaliere senza macchia né paura, partito in vendetta, non sarebbe tornato se non come latore di strage e ruina (!?!): “Ditele che i suoi torti a vendicar io vado, che sol di stragi e morti nunzio vogl’io tornar.” Emblematica poi la scena XIII del I atto. Cornice patetica, finalmente Donna Anna concede al “fidanzato per eccellenza”165 una vaga e confusa, nonché tardiva, confessione circa le vicende accadute la precedente notte, quando un non riconosciuto (?!?) seduttore, fascinoso e misterioso, si stese nel suo letto, … l’esitazione colta nelle “note” di Donna Anna è recepita compiutamente dal povero Don Ottavio, il tarlo si insinua nella sua trepida mente, e l’”Ohimè respiro” del povero duca assume 143 valore liberatorio, come se non volesse ascoltare oltre parole che potessero suscitargli ulteriori perplessità circa l’innocenza della sua promessa sposa.166 Si sfiora poi il ridicolo quando, nell’estremo del dolore di Donna Anna per il ricordo della recentissima morte del genitore, come già detto, Don Ottavio non trova di meglio da fare che chiedere inopportunamente la sua mano, “Calmatevi, idol mio: di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi. Vendicati sarem… Convien chinare il ciglio al volere del cielo. Respira, o cara! Di tua perdita amara fia domani, se vuoi, dolce compenso questo cor, questa mano... che il mio tenero amor...”, mentre ella, cortesemente, gli risponde di lasciar passare almeno un po’ di tempo dalla morte del padre: (Donna Anna): “Oh, dèi! che dite... In sì tristi momenti...”. A Don Ottavio non rimane altro che ripiegare sul vittimismo: “E che! Vorresti, con indugi novelli, accrescer le mie pene? Crudele!” Sebbene Shaw167 ipotizzi che Don Ottavio “avrebbe poi sposato Donna Anna, ingravidandola di una dozzina di figli”, e che avrebbe felicemente coronato il suo borghese sogno d’amore, è purtroppo chiara la distanza che sembra separare i due fidanzati: la tragicità di Don Ottavio “consiste proprio nel fatto che egli non riesca assolutamente ad avvicinarsi alla vita interiore di lei (Donna Anna)”168. Fortunatamente, nelle ultime scene, il Cielo ascolta le vane promesse del duca Don Ottavio, sprofondando il nemico Don Giovanni nei precipizi infernali, liberando così il duca dalla preoccupazione di dover procrastinare ulteriormente la sua più volte annunciata vendetta; Don Ottavio allora ci riprova: “Or che tutti, o mio tesoro, vendicati siam dal cielo, porgi, porgi a me un ristoro: non mi far languire ancor”. Donna Anna gli dà allora l’ultimo benservito: “Lascia, o caro, un anno ancora allo sfogo del mio cor”. Ciao Don Ottavio. 144 Don Giovanni, ovvero l’azione Don Giovanni appare dotato di una forza soprannaturale, di una staticità convulsa, ferina, ossessiva e delirante, ma nel contempo fortemente determinata e pervicace. Ciò rende il suo modello estremamente prossimo alla cultura di noi postmoderni; il messaggio del dissoluto, ironico e dissacratorio nei confronti della maggior parte dei valori condivisi, non può lasciarci indifferenti, anzi, ci costringe alla inazione statica della nostra coscienza, disorientata tra opposti segni – bene e male – di un’unica via di percorso/valore assoluto: la ribellione dell’ethos sull’ethnos169, vale a dire il primato delle leggi dell’universo e dello stato di natura sulle sovrastrutture umane e sociali – e quindi culturali – quali la tirannia e il sopruso. Sufficiente, ai fini del nostro discorso, la Scena XVII dell’Atto II, quella della soteriologica cena. Alle sonore parole del Convitato: “Don Giovanni! a cenar teco m’invitasti, e son venuto”, Don Giovanni si oppone subito al destino e alla morale comune: “Non l’avrei giammai creduto, ma farò quel che potrò. Leporello, un’altra cena fa’ che subito si porti!” Il Convitato scolpisce parole divine nell’aria della stanza: “Non si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste. Altre cure più gravi di queste, altra brama quaggiù mi guidò!”. Adesso è lui ad invitare Don Giovanni, ma alla cena celeste della giustizia divina, cui egli vorrebbe che questi si piegasse: “Parlo, ascolta: più tempo non ho. Tu m’invitasti a cena: il tuo dover or sai. Rispondimi: verrai tu a cenar meco?” È qui che la grandezza eroica di Don Giovanni, sebbene di segno negativo, si palesa in gran forza: “A torto di viltate tacciato mai sarò! Ho già risolto! Ho fermo il core in petto, non ho timor: verrò!“ 145 Don Giovanni offre la destra alla statua, che, nella stretta marmorea, raggela in un rabbrividente terrore l’uomo: “Che gelo è questo mai!”; il convitato-messo oltremondano chiede allora al dissoluto in ultimo appello, un pentimento: “Pèntiti, cangia vita: è l’ultimo momento! Pèntiti scellerato!”; per ben tre volte Don Giovanni strenuamente si rifiuta, finché lo spirito pronuncia la sentenza: “Ah! tempo più non v’è!”. È il trionfo dell’azione sulla contemplazione, della libera e spregiudicata forza dell’uomo – ormai dannato ma libero – sulle sovrastrutture e sui dogmi; il destino del libertino è ormai tracciato: “Da qual tremore insolito... sento... assalir... gli spiriti... Donde escono quei vortici di fuoco pien d’orror?... Chi l’anima mi lacera!... Chi m’agita le viscere!... Che strazio! ohimè! che smania! Che inferno!... che terror!...”; un coro di spiriti canta lugubre “Tutto a tue colpe è poco. Vieni: c’è un mal peggior!”, mentre, con l’urlo finale del nero protagonista, rabbrividente e sconcertante atto di chiusura di un’opera altrettanto sconcertante, nel contempo si compie la piena affermazione dell’uomo sul dio, del mithos sul logos.170 Considerazioni finali Circa il carattere dell’opera, il Don Giovanni, così come richiesto dal committente, e in linea con le intenzioni sia dell’autore che del librettista, venne concepito come “dramma giocoso”: apparente ossimorico neologismo, al pari della settecentesca “tragicommedia”, ad indicare un poema in cui un tema estremamente drammatico veniva condotto in tono leggero e allegoricamente rassicurante, in ragione di quell’estetica settecentesca che ispirava i coevi contes philophiques dei grandi illuministi; intento, quindi, dichiaratamente epidittico ed esemplare, fors’anche pedagogico-didattico, trasposizione letteraria di quelle bibliae pauperum dei cicli di grandi affreschi medioevali. 146 Il libretto venne concepito secondo questa visione, ma la musica di Mozart, in linea con l’aspetto più particolare e interessante della di costui ispirazione, rivela tensioni sotterranee ed inquietudini ora larvate ora più palesi, veicola picchi di ispirazione lirica che scavano nel profondo l’estetica e la coscienza – ma sempre in un clima di classica compostezza e di rigore formale, che solo talora lasciano trasparire per intero dolore e angosce, così come i grandi interrogativi insoluti dell’uomo. L’estetica del XVIII secolo quindi favoriva tale visione del mondo, classica ma già preromantica, e Mozart, soprattutto nelle ultime opere di catalogo, esprime appieno questa transizione; senza inoltrarci oltre tempo nella polemica classico-romantica, occorre tuttavia riflettere sul fatto che è proprio del ‘grande’ interpretare il proprio tempo e nel contempo anticipare motivi futuri; sarebbe tuttavia un errore e un anacronismo considerare il Don Giovanni opera già romantica: se è pur vero che l’opera appare fortemente ‘tragica’, non si deve omettere, per onestà intellettuale e rigore filologico, che essa rientra nel perfetto clima settecentesco di cui sopra, secondo il quale le grandi tensioni dell’uomo e le inquietudini dell’esistenza, tragicamente sviluppate, trovano espressione in una eleganza formale senza eccessi e senza catastrofi, secondo cui tutto viene ricomposto nell’equilibrio rasserenante dello status quo e nello spirito del raisonnable illuministico: “Questo è il fin di chi fa mal: / E de’ perfidi la morte. / Alla vita è sempre ugual.” L’uso dunque – nella rappresentazione viennese così come in molte altre moderne e persino contemporanee –, di omettere il finale, dal carattere di giocondo e leggero dramma satiresco, per terminare dolorosamente l’intreccio sulla morte catartica del dissoluto, tra le fiamme e i baratri demoniaci, in uno spasimo di altero e raccapricciante terrore, significa porre in essere un parametro di interpretazione già tendente alla visione romantica del mondo, e indulgere vieppiù ad essa. 147 Ma è pur vero che Mozart stesso aveva accettato e previsto tale alternativa, come testimonia la già citata rappresentazione viennese del 1788; ciò che rende forse più cara a noi contemporanei l’opera, è il fatto che così sembra risolvibile, oltre che nella ‘modernità classica’ del nostro compositore, nella sua genialità: la nota demoniaca che la musica stessa lascia scorgere nel personaggio, il suo avverso titanismo, il suo pervicace desiderio di perseguire il male (quale?) e il suo strenuo orgoglio di eroe nero, non confliggono con la grazia e con la leggerezza e, mi si permetta, anche con la stucchevolezza incipriata delle altre figure, proiettate in un universo luminoso e celeste senza errori e senza incertezze, di cui soltanto Don Giovanni stesso può intuirne le crepe stridenti. Tale apparente scissione è rappresentata in tutta la composizione, ma soprattutto nell’Ouverture: tale brano è in genere la composizione iniziale di ogni opera, e ne anticipa tutti i temi, fusi in unica soluzione; nel caso di quella del Don Giovanni, essa appare bipartita in un iniziale Andante con moto dal carattere sacrale (che contiene il tema del Convitato dell’ultima scena, un ostinato incedere di scale ascendenti e discendenti, fortemente modulanti e programmatiche), e un Allegro, che ne riassume le arie più festose; si tratta, formalmente quanto sostanzialmente, di una dicotomia composta in cui sono ben ravvisabili le gnoseologiche successioni tra confortanti paesaggi e scure profondità dell’abisso, tra la domestica castità coniugale e la allettante seduzione del peccato, tra la contemplazione della leggera e gaia serenità e l’amaro fascino delle vertigini infernali. E tutto ciò rende tremendamente attuale un’opera che da sempre è stata emblema del patto vitale dell’intera umanità, in perenne bilico tra pulsioni e repressioni, immersa in una catabasi senza discolpe né vie di fuga. 148 PARTE QUARTA ST ILI DI V ITA “Ogni azione continua a creare noi stessi, ogni azione tesse il nostro abito multicolore. Ogni azione è libera, ma l’abito è necessario. La nostra esperienza di vita – questo è il nostro abito”. Nietzsche, Aurora 1. RIFLESSIONI SU ALCUNE FIGURE RAPPRESENTATIVE DELLA POSTMODERNITÀ 1.1. Introduzione “Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora”. M. Heidegger, Lettera sull’umanismo Esercitare il pensiero critico Compito dei filosofi è sempre stato quello di guardare oltre l’esistente e di esercitare il pensiero critico per dire che cosa realmente accade, spesso in contrapposizione con il potere. In questo modo i filosofi diagnosticano il presente di una cultura (Foucault). Già i pensatori della ‘scuola del sospetto’ (Marx, 149 Nietzsche, Freud) avevano introdotto il criterio di smascheramento nei confronti della cultura tradizionale (pensiamo a cosa si nasconde dietro al concetto di ‘coscienza’ per Freud o a cosa sta dietro alla ‘volontà di potenza’ nietzschiana). Più tardi sono stati i filosofi della decostruzione (Derrida, Foucault, Lyotard) che hanno denunciato gli inganni di una lettura semplificata della realtà. Soprattutto Derrida ha messo in luce la complessità delle strutture sociali evidenziando cosa celano certi comportamenti o pensieri. Così le diadi uomo/donna, europeo/non europeo, coscienza/inconscio sono per il filosofo decostruzionista coppie apparentemente antitetiche, ma in realtà complementari e se ne coglie la relazione solo se risaliamo ai processi che li hanno generati. Allo stesso modo ciò che nel postmoderno può apparire ‘nuovo’ e ‘attuale’ spesso si dimostra essere ‘vecchio’ come le piramidi. Pensiamo per esempio al potere della scrittura che oggi si manifesta attraverso la registrazione e l’archiviazione di dati; queste tracce costituiscono ‘tecniche di sopravvivenza’ che ci permettono di non sparire completamente. Ripartire dal linguaggio Oggi che ‘Dio è morto’ e ‘la nuova teologia è l’economia’, la sfida di chi vuole esercitare il pensiero critico è quella di demistificare l’inganno con cui il mercato – creando molteplici forme di seduzione – ci induce ad accettare le sue regole. Inganno che utilizza un’arma potente: il linguaggio. E, quindi, dal linguaggio occorre ripartire. Unico tra i viventi, l’uomo non si è limitato a utilizzare la lingua come una capacità tra le altre, ma ha messo in gioco nel linguaggio la sua stessa vita. La lingua umana si è costituita nel momento in cui il vivente si è impegnato a rispondere, in prima persona, con la sua vita, delle sue parole e, nel ‘giuramento del linguaggio’, ha legato insieme in un nesso etico 150 e politico le parole, le cose e le azioni. “Il ‘flagello’ che esso doveva arginare non era soltanto l’inaffidabilità degli uomini, incapaci di mantener fede alla loro parola, ma una debolezza che riguarda il linguaggio stesso, la capacità delle parole di riferirsi alle cose e quella degli uomini di prendere atto della loro condizione di esseri parlanti”171. Quando il nesso etico si spezza, ed è ciò che sta avvenendo nel nostro tempo, si assiste ad un proliferare di parole vane172, per di più amplificate dai dispositivi tecnico-mediatici della società dello spettacolo. Basta osservare quanto accade nei talk show televisivi: il rapporto con la verità dei fatti è inconsistente; non si discutono tesi, ma si attaccano persone puntando a colpire l’emotività degli spettatori; si mescolano gli argomenti in modo da creare una realtà fittizia o, se si è abbastanza potenti, una notizia falsa che, a furia di essere ripetuta, diventa vera. Ne deriva una situazione che la filosofa Franca D’Agostini, definisce ‘di grigiore epistemico’: la difficoltà di riconoscere il vero dal falso, all’interno di un flusso d’informazioni continuo e incontrollabile. Inoltre un linguaggio ridotto a format, da un lato, semplifica e distorce la realtà (lo straniero come potenziale delinquente da cui guardarsi, l’impiegato come fannullone), inibendo qualsiasi capacità di distinguere; dall’altro, produce una sfiducia generalizzata e una disaffezione all’azione politica che cancellano ogni spazio democratico e impediscono di vedere i dispositivi di potere che, attraverso controlli, intrusioni e divieti, hanno ormai invaso anche la sfera del privato. La filosofia è sempre stata ed è critica nei confronti del giuramento del linguaggio, nel senso che mette in discussione il vincolo sacramentale, senza scadere, però, nella parola vuota. Nella fase che stiamo attraversando in cui sembra dominare, nelle lingue europee, il ‘parlare a vanvera’, “è ancora dalla filosofia che può venire, nella sobria consapevolezza della situazione estrema cui è giunto nella sua storia il vivente che ha il linguaggio, l’indicazione di una linea di resistenza e di svolta”173. 151 Parole di plastica Occorre, quindi, prendersi cura del linguaggio e la cura comincia dal vocabolario sempre più povero e malato. Già Nietzsche aveva riscontrato una ‘mostruosa malattia’ nel linguaggio e Karl Kraus aveva individuato nella distruzione del linguaggio la premessa di ogni futura distruzione. La lingua di cui stiamo parlando è la lingua della comunicazione quotidiana; è il codice primario, all’interno del quale il flusso della realtà acquista un senso, che ha la funzione di far ‘esistere’ le cose nominandole e ponendole in relazione. Sappiamo bene che è la condivisione di uno stesso codice che rende possibile la comunicazione all’interno di una collettività, perché la lingua vivente non è solo un mezzo di scambio utile per trasmettere messaggi, è anche un orizzonte di senso e una creatrice di legami. Nella pratica della conversazione quotidiana aderiamo a presupposti comuni condivisi, in quanto siamo ‘inclusi’ nei confini (culturali) stabiliti da una determinata collettività. La partecipazione a una visione comune non implica, però, una adesione meccanica e, quindi, una risposta automatica a una domanda e alle aspettative sottese alla domanda. La quantità di libertà dell’individuo sta proprio nella ‘esitazione’ nella risposta e nella possibilità di una risposta diversa rispetto a quella attesa. Nei regimi totalitari del secolo scorso è accaduto qualcosa di inedito, è stata creata una neolingua artificiale che, attraverso la ripetizione di singole parole o di intere frasi milioni di volte, ha reso possibile la trasformazione della lingua vivente in una lingua modulare e ha reso estremamente difficile l’articolazione di una diversa visione del mondo. “Il modulo è un elemento costruito in serie, con caratteristiche omogenee, che permette soluzioni di assemblaggio molto varie. (…) Con il parlare modulare la competenza comunicativa diventa una competenza burocratica174”. È come se si dovessero semplicemente riempire le parti lasciate in bianco nel modulo con le risposte già pre152 viste dalla burocrazia. È stata così attuata dai regimi totalitari una semplificazione brutale del linguaggio. In questo modo la comunicazione diventa un puro e semplice mezzo di trasmissione e il messaggio diventa un ordine: scompare la possibilità di immaginare un ‘altrimenti’. È questo un tema trattato ampiamente da Orwell in 1984 e, in tempi più recenti, da Uwe Pörksen175 che ha ripreso le analisi di Orwell. Riferendosi alla lingua che parliamo nell’attuale stadio della storia dell’Occidente, Pörksen si sofferma sulla diffusione di quelle che definisce ‘parole di plastica’, cioè parole che, presenti da molto tempo nel linguaggio comune, sono state fatte proprie dalla scienza, per poi essere reimmesse nel linguaggio colloquiale. Nel momento in cui le parole di uso comune, che hanno una grande plasticità semantica in funzione dell’uso concreto, emigrano nell’ambito scientifico diventano termini tecnici, utilizzati dagli esperti. Quando tornano nel linguaggio colloquiale, colonizzandolo, il loro significato diventa vuoto e generico, anche se conservano l’aura della scientificità e del prestigio. Come i mattoncini Lego, queste parole possono combinarsi in molti modi e consentono di costruire qualcosa che sembra oggettivo, ma in realtà tolgono il potere di definizione a colui che parla, sono povere di contenuto, disancorate dalla storia e dietro l’apparente neutralità nascondono comandi, prescrizioni. Alcune delle parole che prende in esame Pörksen sono sviluppo, sessualità, comunicazione, identità, progresso, informazione. A queste potremmo aggiungerne, oggi, molte altre: tanti mattoncini che, come crescita, ripetuta come un mantra negli ultimi tempi, plasmano la nostra idea di mondo, dal momento che l’aura di scientificità che le caratterizza impedisce una loro problematizzazione. Ma da quali settori provengono le parole di plastica? Veicolate dagli ‘esperti’, che diventano i custodi del ‘senso’ del153 la vita, partono dai vari settori della scienza, della tecnica e dell’economia e, tramite i mezzi di comunicazione di massa, conquistano la società. Sono parole che hanno la capacità di ristrutturare la comunicazione tra i parlanti e di costruire un nuovo modello di realtà. Non c’è da stupirsi, quindi, se oggi il linguaggio configura un pensiero unico che spinge ad accettare la realtà come immodificabile, facilita la diffusione del ‘si fa’, ‘si dice’ che caratterizzano, secondo Heidegger, la vita inautentica e spengono la singolarità di ognuno, pur esaltando, come vedremo, l’individuo. Il pensiero unico Se è vero che la precarietà appartiene alla condizione umana che è mortale, è anche vero che, nel passato, la religione, la nazione, la famiglia (attraverso la generazione di figli), hanno dato senso e rassicurazione all’esistenza individuale, anche oltre la morte. Oggi, invece, il soggetto si ritrova sempre più solo e vulnerabile, in balia del mercato. La morte delle ‘grandi narrazioni’ che, secondo Lyotard, ha posto fine alle ideologie e generato la postmodernità, ha, di fatto, lasciato il posto a un pensiero unico, di stampo neoliberale. È una nuova ideologia per la nuova società individualizzata (Bauman) che prende di mira lo ‘Stato assistenziale’ e la solidarietà sociale ed esalta la ricerca personale del successo e del riconoscimento sociale. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, la responsabilità è degli individui. Possiamo tranquillamente affermare che la civiltà odierna è tenuta insieme dalle idee e dalle parole del business: solo queste sono universali, penetrano in ogni nostro discorso e modellano i nostri comportamenti. Secondo Hillman176 il loro potere è stato interiorizzato al punto tale che concetti come produttività, crescita, efficienza, efficacia, non solo vengono utilizzate senza alcuna riflessione all’interno del mondo degli affari, ma pervadono ormai ogni aspetto della no154 stra vita, da quello medico a quello educativo. Il pensiero neoliberale, che, come abbiamo detto, esalta la libertà degli individui, delega loro la responsabilità di trovare risposte a problemi creati socialmente. Un tempo questi problemi erano affrontati dagli Stati, ma tra potere e politica è avvenuta una netta separazione: i poteri si sono emancipati dai confini nazionali e dalle limitazioni imposte dagli Stati-nazione e gli Stati si sono indeboliti e arresi alle pressioni dei poteri globali. Il tramonto del welfare state e la diffusione della globalizzazione hanno generato incertezza e precarietà che da sempre alimentano il sentimento della paura. Ma – non dobbiamo dimenticarlo – proprio dall’esigenza di controllare la paura, e l’insicurezza che ne deriva, è nato lo Stato ‘Leviatano’ di Thomas Hobbes e, in tempi più recenti, lo Stato sociale. Oggi il mercato, che ha generato tale situazione e che la alimenta continuamente (esiste un business dell’insicurezza), ci chiede, attraverso i media che sono un prodotto del mercato stesso, di gestire la paura individualmente. Diventiamo così ‘individui per decreto’, ma non siamo ‘individui di fatto’ (Bauman), nel senso che dobbiamo trovare soluzioni ‘private’ a problemi che non abbiamo creato – e non riusciamo a dare un nome a chi li ha creati – ma ci mancano la conoscenza necessaria e la potenza richiesta. Individuo per decreto Quali sono i tratti dell’‘individuo per decreto’? O, detto in altri termini, quale identità ha il soggetto che vive nella postmodernità? Tendenzialmente un’identità molto debole. Infatti, muovendosi all’interno di un mondo governato da un continuo mutamento, privo di riferimenti certi e di valori consolidati, è costretto a decidere e agire in tempi rapidi, in un continuo calcolo di costi e benefici. Come afferma Lasch, non sceglie mai una volta per tutte perché la prossima occasione potrà 155 rivelarsi migliore. È un soggetto che, in nome della libertà e dell’affermazione personale, accoglie e legittima il conflitto (la vita come un reality), che sente la sconfitta come un fallimento personale (non sono stato capace), che sviluppa risentimento verso chi lo ha escluso, e che corre continuamente il rischio di cadere nell’ansia (da prestazione) e nella depressione, se si crea uno scarto troppo forte tra il modo in cui si rappresenta e la realtà della propria identità soggettiva. Ma, anche in questo caso, ecco che il mercato è pronto a offrire rimedi per i vari problemi psichici, anzi prospera su questi. Homo psycologicus Per dirla con la filosofa Pulcini, il soggetto, ‘solo’ di fronte alla precarietà dell’esistenza, immerso nel presente, costretto alla provvisorietà dei ruoli e alla superficialità del senso, tende a ‘psicologizzare’ ogni evento e azione e ad assumere una ‘mentalità terapeutica’ che equivale al disinvestimento delle proprie energie emotive da tutto ciò che esula dal culto di sé e della propria immagine177. Cerca la gratificazione immediata, non è più alla ricerca di una meta, di un senso; è avido di novità, ma è incapace di interiorizzarle. In un mondo di esperienze frammentate, tende ai rapporti discontinui e di breve durata senza l’obbligo di doveri da rispettare, conserva soltanto un interesse estetico: tutto rientra nell’ambito del gusto, non della responsabilità. È questa la descrizione dell’homo psycologicus, esemplare del postmoderno, che può essere ben rappresentato da varie figure. Ne esamineremo alcune: il Narciso, il Giocatore, il Palestrato, lo Straniero, il Turista. Il soggetto sociale del nostro tempo è generalmente alla ricerca di una identità che abbia i caratteri dell’‘autenticità’, ma vuole facilmente attingerla, ovvero ‘comprarla’, rapidamente e senza sforzo ricorrendo alle ‘mode’ proposte dall’industria culturale; mentre una identità autentica va costruita lentamente, 156 con fatica, con l’angoscia del dubbio e con la consapevolezza della sua precarietà. La sfida della filosofia La filosofia, che non è nata nelle Università ma nelle piazze - e se diventa accademia è autoreferenziale –, può svolgere oggi un ruolo importante di riflessione critica e di formazione identitaria se, tornando nell’agorà, in mezzo alle donne e agli uomini del nostro tempo, smuove sedimentazioni di pensiero; ripristina la buona argomentazione; evita la semplificazione; problematizza i concetti; smaschera la naturalizzazione dell’artificiale; ricostruisce la memoria personale e collettiva. 1.2. Il Narciso: l’amor di sé? “Donna folle! Indarno gridi: chi son io tu non saprai” Mozart, Don Giovanni Chi è Narciso? Nella società dello spettacolo in cui noi tutti viviamo, la figura del narciso è non soltanto molto diffusa, ma anche apprezzata. Potremmo dire che la nostra società educa al narcisismo. Basta leggere gli annunci riguardanti le proposte di lavoro: cercasi giovane bella presenza, ambizioso, intraprendente, sicuro di sé, desideroso di realizzarsi... Certo, una sana dose di amor proprio e di stima di sé è positiva, se non addirittura desiderabile, ma come possiamo stabilire quando dalla normalità si passa alla patologia? Un utile indicatore è l’età. 157 Freud, infatti, distingue un narcisismo primario, fase che tutti i bambini attraversano, in cui la libido è concentrata sul proprio corpo, e un narcisismo secondario dell’età adulta, in cui la carica libidica, invece di orientarsi verso gli altri, ritorna sull’io. Se è vero che il narcisista è un soggetto che appare profondamente innamorato di sé e della propria immagine, che ha continuamente bisogno di essere al centro dell’attenzione, di sentirsi gratificato e ammirato dagli altri, è anche vero che noi guardiamo con tenerezza un bambino che vuole catturare a ogni costo l’attenzione dell’adulto o con indulgenza un adolescente che passa ore e ore davanti allo specchio, mentre valutiamo con sospetto un adulto che ha lo stesso comportamento. Nel processo di costruzione dell’identità, la fase narcisistica è fondamentale, ma va superata attraverso lo sviluppo della capacità di entrare in relazione con gli altri. Un altro importante indicatore è la cultura del tempo in cui si vive. Non c’è ombra di dubbio sul fatto che nella nostra società ci sia un vero e proprio culto dell’immagine, dell’apparire, e comportamenti che in altre fasi della storia sarebbero stati bollati come narcisistici, oggi appaiano normalissimi. Ma sull’influenza della cultura torneremo più avanti. Infine, il più importante indicatore della differenza tra normalità e patologia è la qualità delle relazioni che intrattiene il soggetto: nel narcisista, l’incapacità di amare è una costante. Il mito di Narciso Per comprendere meglio il rapporto del narcisista con sé e l’altro da sé, ci può essere di grande aiuto il mito. Partiamo innanzitutto dal significato del termine greco Nàrke che può essere tradotto con torpore (da esso deriva per esempio narcotico). 158 Allude al sonno, ma anche alla morte (il narciso era un fiore molto utilizzato nei riti funebri). Nel mito, Narciso è un giovane bellissimo, innamorato di se stesso, che muore perché non può congiungersi con sé. Innamorata di Narciso è la ninfa Eco che si consuma d’amore e di lei rimane solo... l’eco. Il filosofo Umberto Curi178 ha letto in queste due figure del mito una corrispondenza non risolta. Narciso è il simbolo di un riflesso di carattere visivo: non può amare la propria immagine riflessa nell’acqua se non immergendosi in essa, e quindi morendo. Eco che, punita da Era, poteva soltanto rispecchiare le parole altrui, è il simbolo di un riflesso di carattere sonoro. Prova nei confronti di Narciso un sentimento autonomo, ma non è in grado di comunicarlo. Tra Eco e il suo amato si consuma il dramma dell’incomunicabilità: l’amore rimane racchiuso all’interno dei singoli personaggi. Narciso muore giovane. Alla sua nascita il vate Tiresia aveva previsto per lui una lunga vita, a una condizione però: Se non conoscerà se stesso. Il Conosci te stesso, quasi un paradigma della grecità, viene rovesciato. È paradossale che Narciso muoia per conoscersi, ma il punto è: per conoscere che cosa? Il riflesso di sé, l’essere nulla. Una rappresentazione letteraria di Narciso Il mito ci indica una strada che viene percorsa nella letteratura da altre figure che incarnano il narcisismo. Prima fra tutte: Don Giovanni. “Don Giovanni è invece fondamentalmente un seduttore. Il suo amore non è psichico ma sensuale, e l’amore sensuale secondo il suo concetto non è fedele, ma assolutamente privo di fede, non ama una ma tutte, vale a dire seduce tutte. Esso infatti è soltanto nel momento, ma il momento è concettualmente pensato come la somma dei momenti, e così abbiamo il seduttore”179. 159 Secondo Søren Kierkegaard, Don Giovanni è un esteta. L’etimologia della parola rinvia al termine greco ‘aistesis’ che significa sensazione. L’esteta è colui che vive nell’immediatezza del desiderio, che cerca la pienezza nell’istante. Il tempo diventa per lui una sequenza infinita di istanti e la ripetizione si propone come unica modalità per esprimere il desiderio e la sua soddisfazione. Non seduce quella particolare donna, ma la donna in generale, ciò che quella fanciulla ha in comune con tutte le altre. Vive sul piano dell’infinita possibilità, ponendosi al di là di ogni impegno etico. Non sceglie mai, perché la scelta è quell’atto che porta al superamento dello stadio estetico e genera l’individualità e la personalità morale. Don Giovanni, nelle sue numerose varianti letterarie, conquista tante donne. Pensiamo alla lista che il servo Leporello esibisce nella famosa ‘aria del catalogo’, nel primo atto dell’opera di Mozart, su libretto di Da Ponte. È il desiderio ad avere un effetto seducente sulle donne anche se, poi, Don Giovanni utilizza la finzione e usa l’inganno per far sì che la realtà si pieghi ai suoi voleri. In realtà Don Giovanni, che è un camaleonte e diventa i personaggi che recita, coltiva l’illusione dell’onnipotenza e non conosce limiti; non può abbandonarsi al sentimento perché rischia di perdersi. Narciso non consegna la propria immagine al confronto con l’altro; Don Giovanni non svela la propria identità: “Donna folle! Indarno gridi: chi son io tu non saprai!”, canta all’inizio del dramma giocoso di Mozart. Rivelarsi, infatti, andare autenticamente verso l’altro espone alla rottura del guscio narcisistico. E che cosa si nasconde dietro quel guscio? Il volto nascosto di narciso è, secondo Julia Kristeva180, la depressione. Chiariamo meglio questo punto. Nel momento in cui ognuno di noi si lascia andare all’amore si trova in una condizione di estrema vulnerabilità: ci si scopre indifesi, in balia dell’altro, esposti al rischio di fallimento e di sofferenza. Ma è un rischio 160 che bisogna correre per non sprecare la ricchezza della vita. Mantenerci aperti alle esperienze emotive, abbandonarsi alla fluidità del sentimento significa abbandonare tutte le corazze difensive e esporsi alla possibilità del tradimento e al dolore a esso connesso. I narcisisti non sono disposti a correre questo rischio. Perché? A un livello superficiale il narcisista si presenta come una persona dominante, sicura di sé, di successo. In realtà è fondamentalmente un insicuro che non è in grado di affrontare la paura di doversi riconoscere e accettare come una persona inadeguata e vulnerabile e che, proprio per difendersi da questi sentimenti per lui inaccettabili, esprime una continua esaltazione di sé. La modernità liquida Ora lasciamo agli psicologi e agli psicoanalisti la ricerca (complessa) delle cause che possono produrre una personalità così fragile. Noi torniamo alla questione che abbiamo lasciato in sospeso: ma è proprio vero che la nostra società incoraggia il narcisismo? Partiamo dall’acuta analisi di Zigmunt Bauman, un grande sociologo che nei suoi testi ha ben individuato i caratteri della fase storica che stiamo attraversando e l’ha definita modernità liquida. Perché liquida? Perché i liquidi non conservano a lungo la propria forma, non fissano lo spazio, hanno bisogno di contenitori, di forme esterne per mantenere una coesione interna. La prima fase della modernità, quella solida, era fondata su istituzioni durevoli e stabili, su un controllo razionale dello spazio e del territorio, sulla negoziazione dei diritti. Dal punto di vista dell’individuo, era basata sulla fiducia: nelle proprie capacità (posso imparare a fare qualcosa), negli altri (ciò che 161 ho appreso mi viene riconosciuto) e nelle istituzioni, nella loro stabilità (garantiranno che ciò che ho costruito nella mia vita varrà anche domani). Il pilastro di questo modello (secondo Bauman, endemicamente esposto al rischio di totalitarismo) era la razionalità, ovvero la fiducia nella capacità umana di conoscere e controllare, attraverso la scienza e la tecnica, il corso degli eventi e di indirizzarlo verso il progresso (considerato l’unico motore della storia). L’esistenza di uno spazio pubblico, il luogo deputato alla discussione politica, testimoniava la presenza di una società civile in cui i cittadini potevano far sentire la propria voce e partecipare così allo sviluppo collettivo. La società della modernità liquida, la nostra, è caratterizzata, invece, da una erosione della politica a scapito dell’economia: da leggi di mercato spietate e da istituzioni che non sono in grado di regolarne gli effetti (il mercato non persegue alcuna certezza, anzi prospera sull’incertezza). Oggi dominano la precarietà e la sfiducia ( tutti lo sappiamo, basta guardarsi intorno) che Bauman ben rappresenta attraverso una metafora: “L’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota”181. Nel nostro mondo globalizzato assistiamo al trionfo delle politiche neoliberiste (meno Stato, più mercato) figlie di un pensiero unico (neoliberale) che tendiamo ad accettare come naturale e quindi immodificabile (un dogma). L’individuo non è più chiamato a dare un contributo alla produzione di una nuova società; l’eliminazione dei vincoli (politici) in nome di un incremento delle libertà personali ha prodotto una progressiva privatizzazione, la scomparsa dell’idea di bene comune, la distruzione dello spazio pubblico. La sfiducia nella politica e nella possibilità di cambiare il mondo (poiché sappiamo che il vero potere, nell’età della globaliz162 zazione, è extraterritoriale e fluttuante), ci porta ad affrontare i problemi individualmente e a ricercare la nostra autenticità in un altrove che può essere il cibo, lo shopping, il ballo... Il consumatore ha preso il posto del cittadino e gli spazi pubblici sono diventati i luoghi in cui scegliamo che cosa acquistare o quelli in cui ci divertiamo (anche se, negli ultimi tempi, la crisi economica con relativa crisi dei consumi ha aperto scenari nuovi, ancora tutti da decifrare). La cultura del narcisismo In questa situazione quali spazi di autonomia può avere l’individuo? E quali relazioni può stabilire con i suoi simili? Se la precarietà è dappertutto e rende incerto il futuro, il problema non è più quello di avere forze sufficienti per raggiungere un obiettivo domani, ma nell’essere continuamente vigili sulle strade percorribili (opportunità?), oggi. Ed ecco allora che l’identità personale prende la forma di una continua sperimentazione. Secondo Christopher Lasch “le identità di cui si va alla ricerca ai nostri giorni sono quelle che possono essere indossate e poi scartate come un abito”182. Da un lato, rispetto al passato, abbiamo certamente margini di libertà e flessibilità più ampi, ma, dall’altro, siamo esposti al rischio continuo di cadere nell’ansia da prestazione, perché, sul piano concreto, le libertà sono limitate e il singolo viene lasciato completamente solo, a tal punto che tende a percepire gli altri come ostacoli per la sua affermazione. Se l’autoaffermazione, però, non si realizza, l’individuo tende a colpevolizzarsi: non sono stato capace. Da qui il rischio della depressione. In un mondo di esperienze frammentate, gli individui hanno in comune la tendenza ai rapporti discontinui, ai legami deboli, facilmente gestibili e di breve durata, ma l’unico gestore dei legami – immaginate la rete di internet con i relativi nodi – rima163 ne il creatore stesso che ne ha il controllo e che può cancellare l’altro in un istante. Naturalmente, però, tutti gli individui hanno le stesse possibilità e da qui nasce una grande insicurezza. Le relazioni, quando si creano, devono potersi sciogliere facilmente perché sono viste come un impedimento verso altre opportunità, una limitazione delle libertà. Senza l’obbligo di doveri da rispettare, esse conservano soltanto un interesse estetico: tutto rientra nell’ambito del gusto, non della responsabilità: il successo del “mi piace” del social network Facebook è emblematico! Nella modernità liquida il soggetto, estraneo alla vita pubblica, incapace di relazioni durevoli e di reale confronto con l’altro tende a psicologizzare ogni evento e azione, ad assumere una mentalità terapeutica (provate a considerare quante volte incontrate il termine terapia nella vostra esperienza quotidiana, dalla musicoterapia all’aromaterapia...) e a investire le proprie energie emotive nel culto di sé e della propria immagine. Il corpo acquista, nella costruzione dell’identità, un ruolo rilevante sia perché la società dello spettacolo lo esalta, sia perché attraverso i progressi realizzati nell’ambito dell’alimentazione, della medicina e della chirurgia, si offrono infiniti modi per modificarlo, ripararlo, abbellirlo. Il corpo diventa un prodotto da gestire come un capitale finanziario che nutre un mercato che si dilata sempre più (chirurgia estetica, cosmesi, palestre, centri benessere) e che accresce il narcisismo. In conclusione, riassumiamo i tratti dell’individuo del nostro tempo (cioè di noi stessi), nella società globale occidentale: edonista, ancorato al presente, desideroso di immediate gratificazioni personali, centrato sul culto di sé, tendente a legami liquidi. La nostra società, in effetti, alimenta il narcisismo e la figura del narciso costituisce una buona chiave di accesso per comprendere la fase storica che stiamo vivendo. 164 1.3. Il Giocatore: la vita come una lotteria “La vita è un fanciullo che gioca, che sposta i pezzi sulla scacchiera: reggimento di un fanciullo. Eraclito183 Il gioco della vita Nell’ambito del gioco, il mondo è il giocatore che valuta il rischio e decide le proprie mosse; ciò che importa è quanto bene riesca a farlo. Ogni partita viene giocata come se fosse la prima o l’ultima, senza conseguenze sulle altre: è, in definitiva e sempre, una possibilità che si rinnova. In un’epoca come la nostra dominata, come abbiamo sostenuto più volte, dall’incertezza e dalla precarietà e dall’esaltazione della libertà individuale, misurarsi con la sorte sembra diventato uno sport molto diffuso, potremmo dire ‘uno stile di vita’. Il complesso gioco della vita diventa, per la figura del giocatore, una serie di brevi partite da attuare in una dimensione di tempo sospeso, senza ancoraggio con il passato (memoria) o il futuro (progetto), e da concludere velocemente. È necessario, però, prima ancora di affrontare la questione riferendola al nostro tempo, riflettere su quale funzione ha avuto e ha il gioco nello sviluppo della civiltà e in quanti modi si può declinare questa fondamentale esperienza umana. Homo ludens Secondo lo storico olandese Johan Huizinga184, “la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco”, cioè la cultura nasce in forma ludica. Il gioco appartiene alla natura umana ed è presente 165 in tutte le società. È un fenomeno culturale, non un’esigenza biologica come mangiare, riprodursi o difendersi. È, infatti, “anzitutto e soprattutto un atto libero”, cioè è apertura di uno spazio del desiderio non ingabbiato dalla necessità naturale e neppure costretto entro il vincolo sociale: in fondo il gioco è “superfluo”. Le forme e le funzioni del gioco possono essere molto diverse nei vari tipi di società, la stessa parola può indicare attività ed esperienze diverse, ma ovunque si gioca. All’azione del gioco, non è legato alcun interesse materiale. Con quest’ultima precisazione Huizinga esclude, dalle tipologie di gioco, l’azzardo185, che è invece considerato, dallo studioso francese Roger Caillois 186, una tipica manifestazione ludica, almeno fino a quando non genera dipendenza, che eliminando la libertà, distrugge l’essenza stessa del gioco. Tipologie di gioco Secondo Caillois, i giochi possono essere classificati sulla base della loro regolamentazione interna per cui avremo i giochi di improvvisazione, definiti paidia (in inglese play) e i giochi fondati su regole precise ludus (in inglese game). Inoltre i giochi possono essere anche descritti sulla base di quattro componenti che possono essere in essi presenti in maniera variabile: -agon (competizione) -mimicry (imitazione) -ilinx (vertigine) -alea (fortuna) Molti giochi si basano sulla sfida e sull’abilità del giocatore (agon), ma la componente dalla fortuna (alea) è sempre molto forte. “Agon e alea esprimono atteggiamenti opposti e in qualche modo simmetrici, ma obbediscono ambedue a una stessa legge: la creazione artificiale, fra i giocatori, di condizioni di 166 assoluta uguaglianza che la realtà nega sempre agli uomini”187. Nei giochi in cui prevale la mimicry, trionfa, invece, l’immaginazione, il travestimento, la simulazione. La regola, in questo caso, è unica: affascinare lo spettatore in modo da indurlo a credere, per un certo tempo, all’illusione, all’artificio che l’attore ha creato. Molto usata nell’infanzia (giocare ‘a fare finta di’ è il gioco più antico del mondo), l’imitazione degli adulti rende possibile ai bambini la riproduzione e la comprensione del mondo che li circonda. La ricerca della vertigine, dello smarrimento, dell’alterazione di coscienza, presente ad esempio nella roulette russa, prevale nei giochi di ilinx. Il rischio calcolato permette di affrontare l’ansia, le paure che appartengono a ogni essere umano. È possibile definire il gioco? Nonostante questi tentativi di classificazione del gioco e di definizione delle sue caratteristiche, secondo Eugene Fink188, un’analisi concettuale del fenomeno è destinata al fallimento perché il gioco si sottrae a categorie univoche e, ogni volta che proviamo a catalogarlo, si rifugia velocemente nell’ambiguità delle sue maschere. Il gioco non è la vita ordinaria, non è ‘il mondo’. Il gioco ha la capacità di creare una realtà parallela: avviene in uno spazio-tempo distinto dalla vita quotidiana, ed è governato da regole diverse da quelle ordinarie. Il rispetto delle regole è, però, essenziale, altrimenti il gioco non esiste. Il gioco implica uno spazio definito, sia sul piano letterale che metaforico, e, per quel che riguarda il tempo, non giungiamo a un suo annullamento, ma a una sua sospensione. È evidente che, nelle situazioni in cui ogni istante ha il suo peso, lì la giocosità non 167 trova posto. Giochiamo per lasciare il mondo, per entrare in un’altra realtà governata da un ordine diverso, senza correre troppi rischi. Il gioco è un atto libero Attraverso il gioco ci apriamo a nuove opportunità di libera sperimentazione, accettiamo rischi che normalmente non assumiamo e ci rendiamo disponibili al cambiamento. Siamo totalmente coinvolti in quello che stiamo facendo ma, nello stesso tempo, siamo consapevoli di vivere in una dimensione ‘altra’ volontariamente scelta. “È nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, adulto o bambino, è in grado di essere creativo e di far uso dell’intera personalità, ed è solo nell’atto creativo che l’individuo scopre il sé”189. Il gioco è ‘come se’ L’analogia e la simulazione sono insiti nel gioco che potremmo definire una esperienza simulata e indiretta (il come se) della realtà, e in questo senso il gioco è connesso al rituale. In questa esperienza umana, come in qualsiasi esperienza creativa, è fondamentale il ruolo dell’immaginazione, intesa come possibilità di esplorare altri mondi con altre regole. Il gioco è improduttivo e offre piacere Il gioco è fonte di gioia, è gratificante in sé, non tanto e non soltanto per il fine che produce. C’è il piacere della sfida ben condotta, della imitazione ben riuscita, della partecipazione a un’attività collettiva appagante. Il gioco non appartiene alla sfera del comico, basta vedere giocare i bambini per rendersi 168 conto che prendono molto sul serio l’attività ludica, ma conserva qualcosa della leggerezza del comico. Il gioco è al centro della vita infantile Il bambino è interamente e seriamente assorbito nell’azione del gioco che è la modalità originaria del suo aprirsi al mondo. Il gioco è, per il bambino, la via maestra per esplorare e conoscere la realtà, ed è, nello stesso tempo, la strada che gli permette di entrare in relazione con se stesso. Attraverso il gioco, il bambino esplora, in condizioni di sicurezza e in maniera creativa, i confini tra sé e l’altro, tra l’interno e l’esterno e rafforza le risorse emotive e immaginative della sua personalità. Il gioco è un’attività complessa e precaria che, attraverso i ruoli che si assumono e le regole che si seguono, contribuisce a costruire l’identità di ognuno. Inoltre, “insegna alle persone a vivere con gli altri senza controlli; esso collega le esperienze di vulnerabilità e sorpresa alla curiosità e allo stupore, anziché a una paralizzante apprensione”190. E, anche per questo, ha un ruolo importante nella formazione della cittadinanza democratica. La cultura popolare e il gioco Il gioco ha sempre avuto un grande peso nella cultura popolare. In un mondo in cui gli oppressi subivano angherie e sopraffazioni quotidiane da parte del potere, la possibilità di esprimere liberamente, nel carnevale e nei baccanali, il dissenso e la critica era vitale; significava avere la licenza, per un periodo e in uno spazio definito, di giocare con le categorie di un mondo su cui, di norma, non si aveva alcuna influenza e di rovesciarne l’autorevolezza. In questo modo individui e gruppi provavano il piacere di sperimentare un linguaggio triviale e osceno, di dar luogo al trionfo del corpo, del licenzioso, di dar vita a tutto ciò che dalla cultura dominante era considerato ‘basso’. 169 Il limite è alla base della differenza tra gioco e vita quotidiana. Proprio perché è una esperienza separata dalla realtà quotidiana, il gioco presuppone la consapevolezza del limite che non si può superare. Può essere un limite sociale (uomo/donna, giovane/vecchio) o un limite simbolico (realtà/immaginazione, distensione/accanimento morboso). Giocare d’azzardo per esempio, secondo Caillois, rappresenta un’attività ludica che, molto diffusa sin dall’antichità, ha una gratificazione in sé in quanto consente di interrompere la routine quotidiana e permette di vivere momenti di sfida da condividere con gli amici. Se viene vissuta in questo modo, rimane una semplice attività sociale; se, invece, l’aspetto ludico diventa secondario rispetto al bisogno di vincere e non si è più in grado di smettere di giocare, entriamo nel campo della patologia. Il Gap (gioco d’azzardo patologico) è classificato come ‘difficoltà e impossibilità a contenere gli impulsi’. Il giocatore è completamente assorbito dal gioco e pensa al gioco anche fuori di questo, al punto che sono normalmente compromesse anche le sue aspirazioni personali, familiari e di lavoro. La società dello spettacolo e il superamento del limite Se è vero che dalle patologie che esistono nella società possiamo ricavare ‘lo spirito del tempo’ e i caratteri della società stessa, non vi è dubbio che oggi assistiamo a una diffusione preoccupante di giocatori patologici che manifestano sintomatologie tipiche dell’abuso di sostanze stupefacenti. Diffusione favorita dalla promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo, incentivato dalle politiche economiche e finanziarie e dai mezzi di comunicazione di massa. Ma, al di là della patologia, potremmo dire che oggi, in un certo senso, siamo tutti giocatori. Perché? Secondo Horkheimer e 170 Adorno la valutazione positiva della fortuna è il nucleo intorno al quale l’industria culturale ha costruito il suo sistema; suggerire che, senza fatica e senza responsabilità, si può raggiungere il successo dà luogo a una visione della vita come una lotteria, in cui si può vincere o perdere indipendentemente dai meriti individuali: l’importante è rischiare! Se pensiamo, inoltre, al livello di spettacolarizzazione che ha raggiunto la nostra società, ci rendiamo conto che tutto quello che un tempo si esibiva solo in una situazione di sospensione dalla quotidianità (il Carnevale) oggi si mostra tranquillamente nei reality show, sotto forma di nudità, sessualità o altri bisogni corporei, e nei talk show televisivi, attraverso l’ingiuria e la rissa continua. È saltato un altro limite: il confine tra pubblico e privato, con la riservatezza che caratterizzava il primo. Ma se la sospensione del pudore nel Carnevale aveva il senso dell’opposizione alle regole e ai tabù (anche nella forma delle virtù esaltate dalla Chiesa) di un potere riconosciuto come tale e sentito come vessatorio, oggi ha il senso della perfetta integrazione nel potere spettacolare: “Per quanto riguarda l’aspetto concentrato il suo centro direttivo è oramai diventato occulto: non è più occupato da un capo conosciuto né da un’ideologia precisa. Per quanto riguarda l’aspetto diffuso, l’influenza spettacolare non aveva mai contrassegnato fino a questo punto la quasi totalità dei comportamenti e degli oggetti prodotti socialmente191”. È indubbio che, nel nostro mondo dominato dai mezzi di comunicazione di massa, i confini tra gioco e serietà sono diventati meno distinti, molto più permeabili. Lo spettacolo si è consolidato ed esteso ovunque riducendo tutto a una ‘messa in scena’. Del resto spectaculum deriva da spectare, cioè guardare; anche quando sembriamo attivi, siamo in realtà spettatori di un gioco di cui non scriviamo le regole. Chi stabilisce la verità delle regole? Ed è possibile cambiare le regole del gioco che stiamo vivendo nella nostra quotidianità? 171 Siamo tutti giocatori? Secondo Bauman, nel nostro mondo dominato dall’incertezza, siamo tutti giocatori. La percezione della precarietà della nostra vita, in una società in cui siamo chiamati in prima persona a risolvere problemi che non abbiamo creato individualmente, è aumentata a dismisura. Ci rendiamo conto sempre più che la contingenza appartiene alla nostra esistenza. Nello stesso tempo, però, sappiamo che non c’è posto per tutti, che bisogna combattere per affermare se stessi, fidando nella sorte: è come se fossimo tutti dentro una lotteria. Ma si può ancora parlare di gioco se saltano i confini tra realtà e finzione? 1.4. Il Palestrato: il culto per il corpo “Il corpo è una grande ragione, una molteplicità con un unico senso, una guerra e una pace, un gregge e un pastore”. F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra Il dualismo in Occidente Il culto per il corpo, che comprende un’attenzione spesso maniacale per il controllo dell’aspetto fisico e per l’alimentazione, è oggi molto diffuso. Possiamo dire che la nostra è l’epoca dell’ansia per il corpo perfetto, per l’oggetto da plasmare secondo un modello ideale. Eppure, nella tradizione occidentale, il corpo è stato a lungo trascurato in funzione dell’esaltazione dell’anima (con la filosofia greca e la religione giudaico-cristiana), e della mente (a partire da Cartesio). Il dualismo ha segnato la nostra storia, un dualismo cosmico che è diventato anche un dualismo antropologico: terra/cielo, 172 vita/morte, corpo/anima, corpo/mente. La divisione manichea tra corpo (regno della corruzione) e anima (immortale) si è protratta fino a Cartesio e si è ulteriormente accentuata con la riduzione cartesiana del corpo (e della natura tutta) a materia in movimento. Anche se negli ultimi secoli la riflessione filosofica, con Nietzsche, Freud, Foucault e la fenomenologia, ha provato a ricomporre la scissione corpo/mente, siamo molto lontani, come vedremo, dall’aver raggiungere questo risultato. Differenze tra Oriente e Occidente L’Occidente, nella sua storia, a partire dal mondo greco, ha privilegiato il pensiero analitico, lineare, decontestualizzato, fondato sul principio di non contraddizione e sulla relazione di causa ed effetto, capace di sicure dimostrazioni. Diverso è stato l’approccio alla conoscenza in Oriente ed è per noi molto difficile accedere a un pensiero che, partendo da una visione del mondo in continuo cambiamento (con una costante interazione tra opposti), si muove in senso circolare, considera sempre il quadro globale (per cui è necessario ogni volta contestualizzare), e privilegia il metodo analogico, allusivo. Se prendiamo come riferimento il taoismo, scopriamo che la via per vivere in armonia con la natura e con gli altri è il Tao, il cerchio che rappresenta la totalità del reale, distinto in Yin, principio femminile che rappresenta la passività, l’oscurità, l’introversione e in Yang, principio maschile indicatore dell’attività, del caldo, della luce. In ogni aspetto del cosmo, e quindi anche nel corpo umano, troviamo aspetti Yin e Yang che interagiscono armonicamente. La malattia è il segnale di uno squilibrio, la cura non si rivolge a un solo organo, ma opera sulle connessioni (ad esempio l’agopuntura). 173 La natura dentro di noi Nella cultura orientale prendersi cura del corpo significa saper ascoltare la sua voce ovvero prestare attenzione alla respirazione, aprire le porte alla percezione, rallentare il flusso dei pensieri nella meditazione, sentire l’armonia con la natura. Pratiche come lo Yoga e le arti marziali non hanno semplicemente lo scopo di scolpire il corpo, come accade generalmente con le pratiche occidentali, ma sono un modo di affrontare la vita per “cambiare sé e il mondo attraverso una disciplina del corpo”192. Non si può pensare di conservare l’equilibrio ecologico se non ci si sente parte della natura stessa. “Si parla molto di ecologia e della necessità di arginare la crisi dell’ecosistema globale, ma non ci può essere soluzione ai problemi della natura se non sappiamo ritrovare la natura dentro di noi, e non si può ritrovare la nostra natura senza passare per il corpo”193. Il trionfo dell’Io in Occidente In Occidente, il rapporto con la natura (e con il corpo che le appartiene) è stato ed è radicalmente diverso. A eccezione di alcune grandi personalità (fra tutte, S. Francesco di Assisi) il modo di pensare la natura è stato (ed è) segnato dalla consapevolezza della superiorità dell’essere umano, inteso come anima, e, a partire da Cartesio, dalla esaltazione di una soggettività, fondata sulla res cogitans, ritenuta capace di conoscere e controllare il mondo naturale. Il nucleo dell’identità moderna, espressione di un Io che, libero da imperativi trascendenti, diventa protagonista della propria vita è, secondo la filosofa Pulcini, l’amor di sé; è l’Io che cerca in se stesso (penso, dunque sono) le proprie certezze e che, nel suo processo di autoaffermazione, coglie, nella disponibilità della realtà che lo circonda, possibilità illimitate. 174 La modernità solida Nell’età della modernità solida, l’affermazione dello Stato-nazione che fa della ‘natività della nascita il fondamento della propria sovranità’, tracciando confini netti tra ‘noi’ e ‘loro’ (e in questo modo certificando l’identità), sviluppa nei suoi membri un forte senso di appartenenza e di fiducia e rende possibile il perseguimento del sogno della ragione di cambiare il mondo, di andare oltre i limiti, attraverso le conoscenze e le abilità tecniche poste al suo servizio. Per utilizzare a pieno le possibilità che si offrono, occorre, però, distruggere i diritti e gli obblighi consuetudinari che impediscono ogni spirito di iniziativa e costruire un ordine nuovo (e migliore), fondato sulla ragione, in cui gli individui, liberati dai vecchi vincoli, possono cercare, sulla base delle loro capacità, nuove prospettive di vita. Il pellegrino laico In fondo, l’idea stessa di progresso, che è alla base dello sviluppo dell’Occidente, è fondata sulla fiducia degli individui in se stessi, sulla fiducia negli altri membri della stessa società e sulla condivisione del futuro. La fiducia in se stessi, negli altri e nelle istituzioni rende possibile una proiezione nel futuro, rende possibile fare progetti a lungo termine. Con la metafora del pellegrino laico, Bauman delinea i tratti dell’individuo immerso nel mondo solido della modernità. Come in un tempo e in una cultura diversi, il pellegrino chierico intraprendeva un lungo e faticoso viaggio di redenzione e di espiazione in vista di una ricompensa eterna, così il pellegrino laico viaggia per raggiungere un obiettivo, per realizzare il suo progetto di vita. Il pellegrino affronta una esperienza simile ad un rito di passaggio: si separa dalla propria residenza e dai legami sociali, sospende le regole di vita consuetudinarie e tende verso una meta definita che, sia per chierico che per il laico, è sacra. 175 La biopolitica Per compiere a pieno il processo di civilizzazione e migliorare la condizione umana il potere politico espresso dagli Stati-sovrani interviene massicciamente sugli individui, modificandone il comportamento, educandolo con le istituzioni scolastiche, curandolo con le terapie mediche e isolando i refrattari al cambiamento nei manicomi e nelle galere. Per la prima volta il potere prende in carico la vita attraverso un processo di normalizzazione del corpo che Michel Foucault definisce biopolitica. La biologia, la demografia, la psicologia vengono utilizzate per regolare lo sviluppo della popolazione, per controllare l’igiene, l’alimentazione, la sessualità, la natalità, la morte. Il corpo si trasforma in oggetto (non a caso la medicina nasce, come sostiene Foucault, dalla dissezione dei cadaveri) e la salvaguardia della salute si trasforma in un compito che riguarda tutti (il proprietario e gli operatori). La biopolitica, come disciplina dei corpi, non implica costrizione, ma è l’indicazione di comportamenti convenienti, di ciò che è meglio fare per raggiungere il benessere di tutti; è l’indicazione di una norma che ci porta a disapprovare tutto ciò che non le corrisponde. Dopo Foucault, sappiamo che non esistono scienze neutre, tutte influiscono nella formazione di rapporti di potere. La modernità liquida Nella modernità liquida, in cui oggi viviamo, il sogno della ragione di cambiare il mondo, di migliorare le condizioni dell’umanità, è tramontato. Gli Stati-sovrani sono rimasti in piedi, ma hanno perso gran parte del loro potere che è ormai nelle mani delle nuove forze globali che inneggiano all’iniziativa individuale e al libero mercato. I nuovi poteri extra-nazionali si muovono velocemente e ignorano i problemi e i vincoli locali, che sono visti solo come un ostacolo all’affermazione dei loro interessi. Se la modernità fin dall’inizio è caratterizzata dall’ec176 cesso di mezzi rispetto ai fini, oggi possiamo dire che scomparsi i fini (soprattutto l’idea del progresso) rimangono solo i mezzi, sempre più potenti a disposizione dei poteri globali: “Ora tremiamo nella nudità del nichilismo in cui la condizione di onnipotenza si accompagna a quella della quasi vacuità, la più grande abilità a un sapere minimo194”. Spetta al singolo individuo, disorientato e sfiduciato, la responsabilità di badare a se stesso e di ricercare il benessere. Salute e malattia L’attenzione nei confronti del corpo non è diminuita, è semplicemente affidata all’individuo stesso che cerca nella salute il fine da raggiungere, ma è una ricerca che non ha mai fine e che nasconde una profonda angoscia di morte. La paura della malattia e della morte (la scoperta di nuove malattie, il rischio di essere contagiati), alimentata dai media, ci fa vedere pericoli ovunque e fa sì che ci affidiamo agli ‘esperti’ per acquisire un po’ di sicurezza, per esorcizzare i nostri timori. Parliamo continuamente di ‘salute’ e dimentichiamo che anche questa ‘ossessione’ è frutto della civilizzazione. Prima, chi era sano non ne parlava. Il problema si poneva solo con il sopraggiungere di una malattia. Sono stati gli ‘esperti’ dell’ambito bio-medico a prendere il termine dal linguaggio comune e a forgiarlo in modo tecnico, individuando una distinzione, all’interno di una scala flessibile, tra normalità e patologia. Ma, una volta rientrata nel linguaggio comune, questa parola e tante altre espressioni del linguaggio medico che ritroviamo nelle conversazioni quotidiane, introducono “una norma o meglio una barriera ogni giorno più alta tra ‘sano’ e ‘malato’, tanto che siamo identificati sempre più come malati. Questa norma viene ben presto avvertita come naturale, e di coloro che l’hanno elaborata nessuno si ricorda più195”. 177 Fine della crescita? Anche il rapporto con la natura è mutato. Se l’Io della modernità coglieva, nella conoscenza e nello sfruttamento della natura una possibilità di miglioramento delle condizioni umane, l’io della post-modernità ne coglie, invece, i pericoli; l’inquinamento ambientale è, oggi, un grande problema; la scarsità delle risorse e i limiti della capacità di rigenerazione della biosfera sono una minaccia per l’umanità. La cura del corpo Occuparsi del corpo vuol dire compiere una serie di atti pratici attraverso i quali pensiamo di avere il controllo della nostra vita. È un modo per dare fondamento all’esaltazione della libertà individuale che – ripetuta come un mantra nel nostro tempo – ci spinge a essere quel che desideriamo, a scegliere la vita che vogliamo; certo è più semplice cambiare il nostro aspetto piuttosto che intervenire sul mondo. Non è un caso che tra i libri più venduti ci siano i manuali di cucina e i testi che si occupano delle diete da seguire per diventare più snelli e più sani. Gli imperativi categorici del nostro tempo sono, infatti, essere magri e apparire (se non lo si è più) giovani! Naturalmente occuparsi del corpo significa anche andare in palestra regolarmente. Il palestrato Quando la passione per l’attività fisica diventa eccessiva, fare fitness diventa un’ossessione e ‘scolpire i muscoli’ la principale occupazione, ci troviamo di fronte a una figura che, secondo alcune statistiche, rappresenta il 20- 30% dei frequentatori abituali delle palestre: il palestrato. La preparazione fisica copre molta parte della vita di uno ‘sportivo’ che fa della musco178 latura il suo tratto distintivo, che controlla con estrema attenzione anche l’alimentazione, che tratta il proprio corpo come una macchina da oliare. È la versione patologica del nostro rapporto ordinario con il corpo: concepirlo come un prodotto plasmabile secondo i nostri desideri, non viverlo come un’esperienza. L’immagine corporea Desideriamo, dunque, avere un corpo che corrisponda a un’immagine ideale. Mentre lo schema corporeo è la percezione immediata del nostro essere ‘incarnati’, per cui “io non sono di fronte al mio corpo, ma sono il mio corpo” (MerleauPonty), l’immagine corporea è, per ognuno di noi, una rappresentazione complessa e oggettivante che si forma sulla base di emozioni, percezioni, credenze, intenzioni. Nella formazione dell’immagine corporea ha un peso rilevante la relazione con l’ambiente sociale, con la cultura del tempo e la nostra cultura, espressa dalla ‘società dello spettacolo’, offre modelli identitari centrati essenzialmente sul corpo; un corpo sicura garanzia di successo, se bello, giovane, desiderabile. E allora ogni tentativo deve essere perseguito per far sì che il corpo reale corrisponda all’immagine ideale utilizzando, se si possiedono i mezzi economici, tutti gli strumenti che l’estetica, la dietetica e la chirurgia mettono a disposizione. “Continuiamo in fondo a inseguire un modello che in principio fu divino e che ora è semplicemente divistico, un tempo sopra di noi ora dentro di noi”196. Il corpo nell’arte Mentre gli individui mirano a ridurre il corpo reale alla perfezione plastificata dell’immagine ideale, artisti del tardo Novecento come Francis Bacon e Lucien Freud (nipote di Sigmund) rappre179 sentano in immagine la complessa e angosciante realtà di un corpo libero da stereotipi, fragile e sofferente. Bacon giunge a deformare e sfigurare i volti e i corpi fino a condurli verso derive animali, Freud mette in scena corpi nudi martoriati e li indaga con occhio feroce che non teme censure. L’osservatore è posto di fronte alla realtà di un’umanità fragile che si svela nella pesantezza e sofferenza della carne. L’arte mette a nudo l’umanità. 1.5 Lo Straniero: il perturbante “Lo straniero ti permette di essere te stesso facendo di te uno straniero”. Edmond Jabès, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato Xenos: colui che viene da fuori Nella lingua greca xenos indicava colui che non appartiene alla comunità, ma poiché era incerta la sua vera identità – sotto mentite spoglie si poteva nascondere o un nemico o una divinità – questa ambivalenza imponeva di trattarlo benevolmente. La stessa etimologia crea ambiguità in quanto con lo stesso termine si indicava sia l’ospitante che l’ospite e quest’ultimo, quindi, poteva rivelarsi un nemico, e in tal caso veniva eliminato o schiavizzato, oppure poteva divenire un nuovo membro della comunità. Per i Greci l’ospitalità era una pratica e una virtù religiosa, al punto che esisteva un istituto, la xenia, che imponeva il rispetto dello straniero considerato sacro. Ne ritroviamo un esempio nell’ospitalità ricevuta da Ulisse da parte di Nausicaa: “Ma costui è un infelice, qui arrivato ramingo, che ora ha bisogno di cure: mendicanti e stranieri sono mandati da Zeus. Il dono sia piccolo e caro. Ancelle, date all’ospite cibo e bevanda, fategli il bagno nel fiume, dove c’è un riparo dal vento”197. 180 Altra cosa è da intendersi con il termine barbaros che è colui che balbetta, che utilizza una lingua sconosciuta, non greca: “Il barbaros rappresenta in un certo senso il rovesciamento o la negazione di ciò che – pur nelle differenze – rende simili tutti gli uomini, ed è soltanto nei confronti di queste figure intrinsecamente antiumane, quali sono i barbaroi, che non solo è consentito sottrarsi alle regole dell’ospitalità, ma è addirittura necessario ricorrere alla violenza estrema del polemos”198. Hospes e Hostis Per i Romani, nel latino arcaico l’hospes era al tempo stesso ospite e straniero; tra essi si stabiliva un rapporto di reciprocità di dare e ricevere. Se ci si riflette, del resto, il termine hostis (nemico) e hospes (ospite) hanno la stessa radice. Solo nel I secolo a. C. hostis diventa il nemico pubblico contro cui combattere. Lo ius, che è metaforicamente ciò che è dritto, consente ai Romani di segnare i confini tra l’ordine che esisteva nel loro territorio dominato dal diritto e il fuori ‘l’altro’, territorio del disordine. Anche con il Cristianesimo c’è il riconoscimento della sacralità dello straniero: “(…) ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”199. Stato sovrano e stranieri Nel mondo moderno la formazione dello stato sovrano, fondato, secondo Hobbes, sulla paura di perdere la vita e la sicurezza, garantiva all’interno ordine e protezione e permetteva di stabilire confini precisi tra il dentro e il fuori, a cui corrispondeva il meccanismo della assimilazione/esclusione dello straniero. Con l’assimilazione, gli stranieri venivano conformati al nuovo ordine, mentre venivano annullate le distinzioni sul piano culturale e religioso. Con l’esclusione, venivano espulsi: 181 “Che sia maledetto di giorno e di notte, mentre dorme e quando veglia, quando entra e quando esce (…); che il suo nome sia per sempre cancellato da questo mondo e che piaccia a Dio di separarlo da tutte le tribù di Israele (…). Che nessuno dimori sotto il suo stesso tetto e che nessuno legga alcuno dei suoi scritti”200. Oppure venivano distrutti fisicamente. Quest’ultima soluzione viene adottata da un modello di stato nazionalista e razzista che nega la possibilità di un cambiamento della psiche umana. Diverso è l’approccio liberale che crede nel valore dell’educazione e del cambiamento. Nella società attuale che posto occupano gli stranieri? Se nella modernità erano destinati all’annientamento, oggi rappresentano per il loro numero rilevante un problema con cui ci dobbiamo misurare. È vero che anche nell’antichità lo spostamento di intere popolazioni poteva dar luogo a guerre e tragedie ma, di norma, i nomadi erano in numero accettabile. È prima di tutto la loro quantità, per esempio in un paese come l’Italia abituato a visitatori e non immigranti, a suscitare paure e rifiuto. A livello planetario, secondo i dati della Organizzazione internazionale per le migrazioni, il numero totale degli emigrati viene censito in 215 milioni di persone, con una crescita di 25 milioni nell’ultimo quindicennio. Il numero totale di stranieri (individui che non sono cittadini del paese in cui risiedono) dimoranti nel territorio di uno Stato membro dell’UE alla data del 1° gennaio 2010 era di 32,5 milioni di persone, pari al 6,5 % della popolazione dell’UE-27. La decolonizzazione, la fine della guerra fredda, l’approfondirsi delle disuguaglianze nel mondo e la consapevolezza crescente delle disuguaglianze stesse e, nello stesso tempo, l’enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione hanno prodotto quella che Kapuściński201 definisce 182 ‘febbre migratoria planetaria’ che ha generato un mondo più frammentato dove coesistono spinte diverse sia verso il globale che verso il locale. In Europa – ci ricorda Bauman – abitano tre milioni di individui senza fissa dimora, venti milioni di esclusi dal mercato del lavoro, trenta milioni di esistenze al di sotto della povertà. È impossibile rispondere alla presenza degli stranieri con la strategia della assimilazione/esclusione sia per la loro volontà di preservare la propria identità, sia per l’indebolimento degli stati nazionali. Se l’altro nella società moderna era rivale e uguale nella debolezza e nella vulnerabilità (Hobbes), e quindi qualcuno con cui si poteva venire a patti attraverso una soluzione razionale che liberasse gli uomini dalle insicurezze e dalla paura, oggi invece, l’altro, percepito come il diverso, l’estraneo, portatore di una differenza che si traduce in una disuguaglianza, è il perturbante che genera angoscia. Dobbiamo imparare a vivere permanentemente con il diverso che non si assimila. L’appartenenza a un mondo multiculturale richiede, però, una identità forte ed è proprio ciò che manca nella nostra società liquida, in cui la costruzione dell’identità assume la forma di una continua sperimentazione. “Meno gli individui sono in grado di controllare le loro vite e le loro identità, più essi percepiranno gli altri come ‘vischiosi’ e cercheranno in modo più frenetico di districarsi, di staccarsi dagli stranieri, percepiti e sperimentati come una sostanza informe, che avvolge, soffoca e opprime”202. L’indifferenza e il Diniego Diversi studiosi (Zoja, Zamperini, Galimberti) hanno posto l’accento su un atteggiamento oggi molto diffuso nei confronti di chi è diverso da noi e può crearci problemi: l’indifferenza. Il ‘passante’ è la moderna figura dell’indifferenza; colui che 183 guarda, ma non vede o distoglie lo sguardo. Siamo “una moltitudine di sonnambuli ammalati di coartazione emozionale e anestesia relazionale”203. Non dimentichiamo che, nel periodo nazista, l’eliminazione del contatto fisico e la conseguente costruzione della distanza, attuata attraverso la legislazione e soprattutto la propaganda, permise la trasformazione del vicino in ‘ebreo’ e in ‘straniero’. Secondo Galimberti è oggi dilagante il meccanismo del diniego, un nuovo vizio che, a differenza dei vizi capitali, non è personale, ma è una tendenza collettiva, caratterizzata dal negare ciò che esiste e si conosce, dal non provare sentimenti di fronte a situazioni che dovrebbero suscitarli, dal non sentirci responsabili per esse e quindi dal non agire di conseguenza. Strategie per contrastare la proiezione persecutoria Secondo Douglas, essendoci un nesso tra paura dei rischi globali e paura dell’altro, ‘la dinamica del capro espiatorio’ nasce dalla necessità di attribuire a qualcuno, individuato sempre tra i più deboli e svantaggiati, la colpa dei pericoli e delle insicurezze attuali. Questa dinamica del diniego potrebbe interrompersi se gli uomini imparassero ad avere paura, riconoscendosi in prima persona come ‘artefici del pericolo’. Ma forse questa risposta non è sufficiente, se è vero che la paura è la passione primordiale più antica che caratterizza la vita e l’esperienza umana e deriva, prima di tutto, dal bisogno di proteggersi dalla minaccia identitaria per conservare o ristabilire l’ordine sociale. Lo strano in noi Ma perché oggi ‘la paura delle paure’ si concentra sull’immigrato? Forse perché l’immigrato ci appare come uno specchio scomodo del nostro essere – come lui – sradicati. “Con lo stra184 niero si instaura una dialettica speculare tra sé e l’altro dove l’altro assume i caratteri del sé e dunque ci rispecchia e ci ricorda la nostra stessa alterità. Il sé, infatti, porta dentro questo carattere di perenne sradicamento, come scriveva Simone Weil, che la modernità ha cercato di cancellare con una dialettica distruttiva di sé e dell’altro. Questa dialettica ha assunto i suoi caratteri più violenti nella fase centrale del XX secolo, ma a tutt’oggi continua a determinare le dinamiche sociopolitiche in gran parte del mondo, anche nel nostro paese”204. Già Freud, senza mai parlare dello straniero, sottolineava (‘Il Perturbante’) come lo straniero è dentro di noi, ci abita, è la faccia nascosta della nostra identità: quando lo combattiamo, lottiamo contro il nostro inconscio, questo -improprio- del nostro possibile -proprio-. Forse il solo modo per non perseguitarlo è quello di riconoscere l’inquietante estraneità che è loro come nostra. Lo straniero è dentro di me, quindi siamo tutti stranieri. Se io sono straniero, non ci sono stranieri. Ancora il poeta Jabès: “La nostra estraneità si trova in fondo a noi stessi ma noi esitiamo a mostrare il fondo”205. Dalla paura di alla paura per… La paura più temibile è la paura indistinta, priva di una causa definita; la minaccia che si intravede ovunque, ma non si mostra mai chiaramente. ‘Paura’ è il nome che diamo alla nostra incertezza (Bauman). Tuttavia il riconoscimento di questa passione potrebbe essere la precondizione per la fondazione di un’‘etica del futuro’ (Pulcini) che sappia sanare le nefandezze prodotte dai nostri illimitati poteri. Attraverso l’esercizio di un pensiero anticipante, quello che si nutre dell’immaginazione (facoltà che, come ricorda Arendt, consente di rappresentare intuitivamente quello che non è presente) possiamo disporci a una ‘paideia 185 della paura’ (Pulcini) che riattivi questa passione in modo produttivo fino a condurci a un ‘etica della responsabilità’, fondata sulla capacità del soggetto di farsi carico dell’altro da sé. Come sostiene Anders: ‘non più paura di’ ma ‘paura per’, uomini non più spettatori o vittime, ma attori di eventi. Incontrare l’alterità La paura del contagio, nelle sue varie forme, dalla paura dello straniero al timore che i virus si annidino nel sistema informatico, alle patologie endemiche, conduce a un eccesso di difesa e a una richiesta urgente e continua di strategie di immunizzazione. La comunità si difende ergendo mura, simboliche o fisiche; l’individuo isolando l’altro, lo straniero. Dalla stessa immunologia, però, apprendiamo che non ci si immunizza isolandoci, ma assumendo quantità non letali di virus che stimolino la formazione di anticorpi. L’etimologia aiuta: pharmakon è, nello stesso tempo, veleno e rimedio. Se un organismo è sano, la malattia lo rafforza e questa affermazione è valida sia se riferita al corpo umano che al corpo sociale; l’inclusione, e non la ghettizazione dello straniero, può dar modo alla comunità di ricomporsi su una linea di orizzonte più ampia (Esposito). Se è vero, infatti, che la globalizzazione in quanto perdita dei confini e dell’opposizione dentro/fuori alimenta la paura della contaminazione tra il noi e il loro scatenando reazioni di difesa identitaria, essa offre anche la possibilità di una conversione che, attingendo ai temi della nostra democrazia, ci porti ad accettare l’idea della differenza, nel duplice significato di alterità e diversità. Lo straniero – colui che viene per restare – (Simmel) non può né essere assimilato perché è ancorato alla propria cultura e alla propria identità, né essere espulso oltre i nostri confini, in quanto con la globalizzazione l’idea dell’altrove non esiste più. Dobbiamo dunque essere disposti a riconoscerlo come differente, cioè come rappresentante di una diversità 186 al tempo stesso ‘ineludibile e inassimilabile’ (Pulcini). Tuttavia questo riconoscimento può esserci solo se l’identità di ognuno è relazionale, in continuo divenire e capace di esporsi al ‘contagio’ (Bataille) con l’alterità, per arrivare attraverso la dinamica del confronto, che include il turbamento, lo spaesamento, il disagio, e che non esclude il conflitto, a un riconoscimento tra diversi, fino alla possibilità di una reciproca trasformazione. L’Altro e l’Incontro con l’Altro che “venendomi incontro mi espelle dalla mia solitudine” (Levinas), costituisce, secondo il filosofo lituano, non solo la dimensione fondamentale dell’esistenza e dell’etica, ma anche la fonte dell’Identità, che va dall’Altro all’Io: nell’Incontro con l’Altro si realizza la possibilità di essere, di essere me stesso. 1.6. Il Turista: il movimento come stile di vita “Il viaggio è nella testa”. Jean Baudrillard, Cool memories II, 1987 - 1990 L’eterno presente del turista Le figure della postmodernità sono riconoscibili per alcuni tratti comuni, tipici di una identità ‘fluttuante’ (che intende lasciarsi aperte tutte le possibilità); ognuna di esse, però, ne evidenzia un aspetto che la caratterizza. Il Narciso esprime l’immediatezza del desiderio e la superficialità delle relazioni; il Giocatore la visione del mondo come una serie di partite da giocare; il Palestrato la ricerca di perfezione attraverso il corpo che muta; lo Straniero la difficile relazione con l’altro da sé e con l’altro in sé. La caratteristica dominante del Turista è il movimento in uno spazio privo di vincoli e in una dimensione temporale di eterno presente. 187 Globalizzazione e turismo Il turismo è un prodotto della modernità. È nato, come fenomeno di massa, con l’industrializzazione e l’urbanizzazione, cioè con la distinzione tra attività lavorativa standardizzata e il tempo libero; si è caratterizzato, fin dal principio, come un’attività organizzata dall’industria turistica volta a rispondere alle esigenze sociali di intrattenimento e di pausa ricreativa; si è sviluppato, soprattutto negli ultimi decenni, con l’espansione delle informazioni, delle comunicazioni e delle immagini. Il mondo del turista rappresenta in maniera efficace alcune ambiguità del nostro tempo. La globalizzazione, con la libera circolazione delle merci e lo sviluppo dei mezzi di trasporto, ha alimentato il ‘mercato’ del turismo che, da settore marginale, è diventato un aspetto importante dell’economia di ogni paese. Simultaneamente, però, si sono amplificati i grandi movimenti migratori, chiaro segnale di un’epoca – la nostra – in cui è aumentata vertiginosamente la differenza tra i ricchi, che si muovono per poi tornare nel loro territorio, e i poveri migranti che partono dal loro territorio per fermarsi nei paesi più ricchi. I percorsi turistici sono organizzati in modo tale da evitare che i due gruppi si incontrino e da impedire che i turisti entrino in contatto con le zone più povere dei paesi che visitano. Ma non basta. I percorsi turistici sono anche organizzati in modo da fornire esperienze piacevoli e nuove, ma non pericolose, perché il turista è alla continua ricerca di esperienze piacevolmente diverse, fuori dall’ordinario, ma non vuole correre rischi. Il criterio che guida il suo ‘spostarsi’ è estetico: il mondo deve esaudire i suoi desideri. 188 Turista e Vagabondo Secondo Bauman, l’alter ego del turista è il vagabondo. Il primo si muove per libera scelta, il secondo si muove perché il luogo in cui si trova a vivere è inospitale. Mentre il turista cerca nuove avventure sapendo che ritroverà sempre, al suo ritorno, una casa (rifugio) da cui poter tranquillamente ripartire, il vagabondo è un senzatetto senza alcuna destinazione, che vive una vita dura in uno spazio con confini invisibili ma invalicabili. Ambedue, da figure o attività marginali quali erano nella modernità solida, sono diventate centrali nel nostro mondo caratterizzato dal continuo movimento nello spazio. La differenza tra loro è lo status economico, ma, in una realtà dominata dalla precarietà, la possibilità di diventare un vagabondo è una minaccia che aleggia e fa paura. Il vagabondo è l’incubo del turista. Turista e Viaggiatore Il turista si muove per lo più acquistando in anticipo un ‘pacchetto’ tutto compreso, scelto leggendo attentamente l’etichetta; con il ‘prodotto’ compra la libertà di muoversi in uno spazio diverso dall’ordinario, in cui fare esperienze piacevoli, ma non impegnative. Lo scopo del viaggio è una esperienza per lui nuova, ma accuratamente pianificata per non creare problemi, perché la sicurezza fa parte del pacchetto. Il viaggio diventa, così, un insieme di occasioni di consumo di luoghi e persone visti con uno sguardo superficiale, senza un vero interesse, utilizzando le consuete categorie mentali; diventa anche un viaggio spettacolo in cui il turista fruisce di attrazioni pittoresche o folkloristiche ‘costruite’ per lui. Diverso sembra essere il caso del ‘viaggiatore’ che parte perché vuole scoprire luoghi nuovi, non raggiungibili dal turismo di massa; che non definisce in anticipo il tempo di permanenza; che va alla ricerca dell’autenticità e mostra una ‘attitudine alla visione’ (Onfray) 189 dilatando i cinque sensi. Ma “anche se quella del viaggiatore vuole essere una penetrazione profonda dello spirito del luogo e del suo talento, egli non potrà far altro che approssimarsi alla vita effettiva degli ‘autoctoni’ da cui dista enormemente, mentre sarà più prossimo al modello di turista comunemente inteso”206. Appare inevitabile ormai, già da alcuni decenni, pensare al viaggio come a una forma di consumo culturale in cui le relazioni che si sviluppano sono strumentali e a bassa intensità affettiva. Forse oggi, per certi aspetti, solo il migrante, che lascia il proprio paese e si deve confrontare con un’altra lingua, altri costumi e tradizioni, conserva le caratteristiche del viaggiatore di un tempo. Turista e flâneur Mentre il turista si muove in uno spazio diverso dall’ordinario, alla ricerca di esperienze piacevoli da consumare rapidamente, il flâneur, che si può tradurre con ‘bighellone’, è attento a tutto ciò che accade nello spazio urbano ed è capace di utilizzare la sensibilità come una vera e propria forma di conoscenza. Figura celebrata da Charles Baudelaire e codificata da Walter Benjamin, incarna lo spirito errabondo di chi sperimenta un modo diverso di vivere i luoghi metropolitani, attuando una esplorazione apparentemente casuale del territorio, con una particolare attenzione per i dettagli, per ciò che è normalmente considerato marginale. Il flâneur si immerge nella folla della metropoli, in un vagabondaggio senza meta, con una percezione non bloccata da pregiudizi che gli consente di vedere uomini e cose in modo nuovo; è una sorta di ‘sognatore ozioso’ che, di fronte al nuovo mondo urbano, figlio dell’industrializzazione, sceglie, non la fuga, ma una disposizione riflessiva che apre allo sguardo altri spazi e altri tempi di vita. Benjamin individua nel flâneur colui che, camminando lungo i passages parigini (gallerie commerciali), incarna il desiderio di libertà, 190 pur restando all’interno di uno scenario urbano percorso da masse di lavoratori e borghesi che si muovono freneticamente e che, sottoposti allo stress del loro lavoro e all’eccesso di stimoli, sono incapaci di vedersi e sentirsi. Ancora più attuale appare la proposta di Benjamin nella nostra società dell’eccesso, dai ritmi vertiginosi, satura di immagini e di stimoli di ogni tipo. È vero che, oggi, i viali dove si passeggia sono diventati “shopping malls, ovvero viali dove si cammina mentre si fanno acquisti e dove si fanno compere mentre si passeggia. I mercanti hanno fiutato l’attrattiva e il potere di seduzione delle abitudini dei flaneur e si sono dati da fare per modellarle nella vita”207. È sempre possibile, però, recuperare lo spirito della flânerie e sottrarsi ai ritmi standardizzati e al consumismo dilagante: stare ‘dentro’ la città, ma mantenendo un certo distacco, uno sguardo ozioso alla ricerca di frammenti di autenticità. Il primato delle immagini Obiettivo del turista è arrivare nel più breve tempo possibile sul luogo dove sarà consumata la vacanza. La preparazione, la partenza e lo spostamento sono percepiti come tempo perso e sono normalmente affidati a una agenzia che lo solleva da ogni responsabilità. In fondo il turista compra il diritto a non essere disturbato, a essere tutelato e protetto. Ma come si sceglie una vacanza? Fondamentale, in una società come la nostra dominata dalle immagini, è, prima della partenza, la visione dei luoghi attraverso i depliants turistici offerti dagli operatori del settore. Durante la vacanza, poi, si va alla ricerca proprio di quei luoghi già visti in immagine, per cui il viaggio diventa una specie di verifica di quello che si è già visto: è la realtà a dover corrispondere alla sua immagine. E, attraverso le foto ricordo, che si fanno corrispondere a quelle viste in cartolina, si presume di aver individuato l’identità dei luoghi stessi, mentre si è riprodotta solo una immagine stereotipata. Non parliamo poi 191 dei posti che sono già costruiti come ‘copie’, come ‘falsi’, tipo Las Vegas o Disney, che hanno sempre tanti visitatori attratti evidentemente dalla finzione. Il successo di luoghi proposti o come ‘simulacro’ o come ‘finzione’ è in linea con la spettacolarizzazione presente nella nostra società che rende sempre più difficile la distinzione tra la realtà e la sua rappresentazione. Negli ultimi tempi si va sviluppando un’altra forma di turismo, la si può definire ‘noir’, che va alla ricerca dei posti dove sono avvenuti disastri; sembra essere eccitante uno sguardo alla Concordia incastrata nella roccia, o una visita alla città di New Orleans flagellata dall’alluvione. Nonostante le proteste degli abitanti dei luoghi, che sono disturbati da questi intrusi, la clientela è in continua crescita. La curiosità morbosa raggiunge l’acme con l’ansia di fotografare la catastrofe: il mondo trasformato in immagine. Il post-turista Se il turista è consapevole della ‘costruzione’ operata dall’industria turistica e sa quindi di non vivere una esperienza autentica, ma di essere un ‘turista’, per lui ogni esperienza può diventare un gioco e può interagire ironicamente sugli sguardi e i significati preconfezionati. Siamo in questo caso in presenza del post-turista. Viaggio e comunicazione Il viaggio, nella storia, ha avuto diverse connotazioni; ci sono stati viaggi di scoperta di territori e viaggi di conquista di popoli, ma anche viaggi di scoperta di sé e dell’altro da sé. Oggi è possibile viaggiare anche restando fermi; la metafora del viaggio è la rete e infatti ‘navighiamo’ in internet: il viaggio diventa sinonimo di comunicazione. Internet dissolve gli ostacoli spaziali e temporali, sostituisce i corpi con le immagini, permette 192 un collegamento istantaneo che crea facilmente contatti, crea l’illusione di poter vedere tutto e sapere tutto. È l’apoteosi della ‘comunicazione’, diventata con tutta evidenza un’altra parola di plastica “usata per plasmare modelli in grado di mobilitare persone”208. Secondo Perniola la ‘comunicazione’ è l’opposto della conoscenza perché semplifica e banalizza, “si sottrae a ogni determinazione, come se fosse la peste. Aspira a essere contemporaneamente una cosa, il suo contrario e tutto ciò che sta in mezzo tra i due opposti”209 e per di più si presenta sotto le insegne del progresso e della democrazia. La pratica attuale del turismo ha molti più punti di contatto con la comunicazione che con il viaggio di scoperta di sé e dell’altro da sé. Viaggio e nuove tecnologie L’influenza della rete, del viaggio virtuale, negli ultimi anni ha modificato profondamente il viaggio reale e ha trasformato le relazioni sociali che sono diventate reticolari e mobili; ad esempio i contatti possono avvenire in rete, ma poi spesso sono necessari gli incontri in presenza. L’integrazione tra nuove tecnologie e mobilità fisica si coglie anche nella diffusione dei blog, che permettono il racconto dell’esperienza del viaggio in tempo reale e consentono di mantenere i contatti con parenti e amici, riconfigurando il blog come luogo simbolico familiare. I confini tra l’esperienza del viaggio e la vita quotidiana si attenuano e il viaggio non può più essere pensato come rottura rispetto alla dimensione di vita ordinaria; anzi le due sfere si collegano e si compenetrano. È talmente forte la convergenza tra viaggio, comunicazione e forma delle relazioni sociali da portarci ad affermare che lo stile di vita del turista, senza legami e impegni definitivi, continuamente in movimento e a caccia di novità, ricercatore e consumatore di esperienze ‘attraenti’, è una buona chiave di lettura della società contemporanea. 193 2. IL VIANDANTE: UNA POSSIBILE VIA PER L’AUTENTICITÀ? Il nomadismo come stile di vita “Il viandante non conosce la strada, questa si fa nel suo stesso cammino”. Antonio Machado, Proverbios y cantares Siamo agenti o, invece, siamo agiti? La visione ottimistica della storia che, negli ultimi secoli e in forma laicizzata, ha accompagnato la vita degli esseri umani, in Occidente, è tramontata da tempo. Il mito del progresso si è consumato e l’incertezza domina la nostra esistenza. La mancanza di riferimenti e valori consolidati e la liquidità sociale spingono gli uomini e le donne del nostro tempo o a rifugiarsi in nicchie protettive che ricordano l’antica società comunitaria (da notare che la communitas, secondo Esposito, è tenuta insieme da una mancanza più che da una appartenenza210) o ad assorbire, come abbiamo cercato di evidenziare, modelli provenienti dal mondo dei media. Nel primo caso abbiamo una risposta malinconica, di ripiegamento (nel passato, nel locale, nel culturale); nel secondo caso, una reazione espansiva, di tipo narcisistico: il soggetto è incoraggiato a ricercare opportunità sempre nuove per esprimere al massimo il proprio sé. La ricerca dell’originalità e della novità, considerate massime espressioni della libertà, sembra quindi dominare nella società ipermediale in cui viviamo; ed è pur vero che in nessun altro periodo della storia l’individuo ha avuto, almeno sul piano teorico, possibilità così grandi di orientare la propria vita in funzione dei propri desideri, ma chi stimola e plasma il desiderio? Abbiamo visto come la fine delle grandi narrazioni (Lyotard)) 194 abbia prodotto non la scomparsa delle ideologie, ma quello che Pierre Bourdieu ha chiamato ‘il pensiero unico’ (la pensée unique), che rappresenta il mondo come un grande mercato pieno di merci (oggetto di potenziale consumo), e un’umanità in cui si distinguono individui che vi hanno accesso (e hanno successo), e gli esclusi. Per l’ideologia della privatizzazione in cui siamo immersi, ciò che accade a ogni singolo individuo dipende dalla sua personale scelta e il mancato riconoscimento sociale deriva dalla sua inadeguatezza. Il successo mondiale di un programma come il Grande Fratello ci fa capire come sia penetrata fino in fondo l’idea che la vita sia una dura lotta per la sopravvivenza e che necessariamente ci dovranno essere dei perdenti: è una legge di natura! I perdenti potranno riprovare di nuovo, giocare un nuovo gioco, ma, per farlo, dovranno riacquistare la fiducia in se stessi e superare l’ansia da prestazione. Il mercato offre pronti rimedi: cure farmacologiche, psicologiche, psichiatriche… Tra i vincenti (anche loro però dovranno essere sempre all’erta; nella lotta per la sopravvivenza la vittoria non è mai definitiva), invece, abbiamo i soggetti che hanno il diritto di consumare e che tendono a conformarsi ‘dolcemente’ ai modelli seducenti offerti dalla società dello spettacolo. A questo punto, come afferma Natoli, sorge spontanea la domanda: “qual è il grado della nostra libertà? Quanto siamo agenti e quanto invece siamo agiti, per di più nella convinzione di essere liberi?”211 Porsi la domanda è già fare un bel passo avanti. Desiderio e consumo La nostra è una società che alimenta il desiderio in una forma mai vista prima e fa sembrare una libera scelta la nuova forma di sottomissione che caratterizza l’edonismo di massa del nostro tempo. Siamo tutti diventati ‘macchine desideranti’212, che alimentano il sistema e lo riproducono, che hanno bisogno di consumare per poter esistere e che non sono disponibili a pro195 crastinare la soddisfazione del desiderio (come avveniva nella modernità solida). Ma il possesso non placa il desiderio, anzi stimola altri desideri. La crisi economica che stiamo vivendo non ha modificato nella sostanza il quadro che abbiamo delineato. Ha forse introdotto, nell’attesa del superamento della crisi, una temporanea austerità, attraverso le nuove figure del debito/colpa, ma non ha scalfito il modello spettacolare e la promessa di felicità che le immagini – scelte da altri – producono. Riconoscersi nelle immagini dominanti del desiderio significa, come ci ricorda Debord, non comprendere la ‘nostra’ esistenza e il ‘nostro’ desiderio. Occorre, quindi, imparare a gestire il desiderio e, appunto per questo, è necessario ripartire dal corpo e intenderlo non come macchina o prodotto o risorsa, come è avvenuto (con qualche eccezione), nella storia dell’Occidente, ma come esperienza, come apertura originaria al mondo. Il nostro corpo non è un vestito che indossiamo (e attraverso la tecnologia possiamo cambiare, se non ci piace); è il nostro veicolo dell’essere nel mondo (Merleau-Ponty). Ciò che sappiamo di noi stessi è, innanzitutto, un’informazione sul nostro corpo, sui suoi stati interni e sulla sua posizione nello spazio. Il nostro corpo possiede una sua intenzionalità, rappresenta il centro intorno a cui si organizzano le nostre percezioni e le nostre azioni. È necessario, quindi, ascoltare la voce del corpo (non solo quando siamo costretti a farlo per un malessere), ripartire dai cinque sensi, risvegliarli dal torpore in cui sono immersi, far sì che esprimano tutte le loro potenzialità e così aprire le porte alle emozioni e alla relazione perché “il desiderio non si compie nel possesso, ma piuttosto nella ‘relazione’, nel sentirsi momento e parte di un tutto e perciò di qualcosa più grande di noi che ci accoglie (…) Questo atteggiamento predispone all’incontro, a crescere con l’altro – cose o uomini che siano – e non a distruggerlo”213. Il ‘pensiero unico’ ci induce a consumare perché la crescita è necessaria, altrimenti si arresta lo sviluppo economico. Ma le 196 risorse non sono illimitate e, a causa del nostro consumo indiscriminato, beni naturali ‘comuni’, come l’acqua, l’aria, il suolo, cominciano a scarseggiare; non solo ne impediamo l’accesso alle popolazioni più povere, mettiamo anche a rischio il futuro stesso dell’umanità. È necessario, quindi, ripensare il mito stesso della crescita prima che sia troppo tardi, mettendo in atto atteggiamenti e comportamenti diversi, nella consapevolezza, però, che la società dei consumi ha l’abilità straordinaria di assorbire e riutilizzare a suo vantaggio le forme di dissenso che suscita al suo interno, rendendole così inoffensive. Fare o agire? La nostra è una società del fare; darsi da fare è un invito pressante che viene rivolto agli individui perché da quello dipende il successo o l’insuccesso nella vita; ma, come già Aristotele aveva chiarito, fare e agire sono attività profondamente diverse: nel fare si può essere ‘agiti’; l’azione, invece, richiede scelta, cioè consapevolezza del senso e della direzione da dare all’azione stessa. L’azione, inoltre, crea relazione, perché implica un rapporto con altri soggetti, e viene giudicata non in base alla competenza tecnica che si dimostra, ma in termini di valore. Oggi abbiamo mezzi tecnici spaventosi che ci consentono di ‘fare’ al di là del pensabile, ma non sappiamo bene come agire, cioè quale direzione dare al nostro fare: “Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante, esige un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l’uomo”214. Ma quale etica può scongiurare il rischio di uno sviluppo incontrollato della tecnica? Non l’etica cristiana che guarda essenzialmente alla buona o cattiva intenzione sottesa all’azione e non tanto ai suoi effetti; ma, nel caso della tecnica, sono proprio gli effetti ad essere pericolosi. Non l’etica laica, fondata sulla razionali197 tà, che ha avuto la sua massima espressione in Kant, che non considera il danno che l’uomo può fare alla natura (e in definitiva a se stesso), perché il suo principio ispiratore ‘L’uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo’ riguarda solo i rapporti tra gli uomini e non il rapporto degli uomini con il mondo. Neppure l’etica della responsabilità, teorizzata da Weber e ripresa da Jonas, sembra, però, in grado di dare orientamenti all’azione, perché, per poter essere responsabili, bisogna essere in grado di prevedere le conseguenze delle azioni, ma lo sviluppo della tecnica apre scenari imprevedibili. In definitiva, al nostro delirio di potenza corrisponde un forte limite conoscitivo rispetto agli effetti possibili del nostro potere. E, allora, che fare? Quali orientamenti assumere? Intanto forniamo alle future generazioni: un’educazione che le metta in grado di conoscere che cosa è ‘conoscere’ (la conoscenza della conoscenza ) per prepararle ad affrontare i rischi permanenti di errore e illusione (Morin); una conoscenza capace di cogliere i problemi globali, essenziale in un mondo complesso come è il nostro (l’attuale frammentazione disciplinare è un grande problema); la capacità di affrontare le incertezze attraverso le conoscenze che possediamo e l’incerto che ci circonda; la consapevolezza della relazione esistente tra l’io, l’altro e la natura in un mondo complesso e globalizzato (comprensione e rispetto per l’altro da me, coscienza ecologica); capacità di riconoscere il carattere ternario della condizione umana che è, nello stesso tempo, individuo, specie, società (Morin). Frontiere: barriere o passaggi Il mondo in cui viviamo si presenta come un mondo ‘globale’ in cui gli spazi di circolazione e consumo si espandono; il nostro è anche, però, un mondo in cui aumentano le frontiere e i divieti. Certo, la frontiera è, come abbiamo visto, una necessità an198 tropologica, un meccanismo che appartiene a ogni gruppo sociale, che permette il riconoscimento dei membri di una stessa cultura e segna la diversità dall’estraneo, ma le frontiere possono essere barriere invalicabili o confini necessari, passaggi che possono essere attraversati. Nel primo caso, a dominare è la paura dell’altro, la paura che possa mettere in discussione il nostro tenore di vita; infatti, non a caso, nel nostro mondo, le merci possono circolare liberamente, le persone no. Nel secondo caso, è il desiderio del confronto con l’altro, perché, per costruire la nostra identità, per identificare le nostre frontiere, abbiamo bisogno di confrontarci con altri che riconosciamo realmente ‘diversi’ da noi. Il reale confronto con l’altro è sempre l’attraversamento di una frontiera che, una volta varcata, ci cambia e da cui non si torna indietro. Il viandante Esposti come siamo all’imponderabile su vari fronti, e senza orientamenti certi, invece di ripiegare nel passato o adeguarci alle mode, possiamo, nella consapevolezza che non esiste una meta sicura da raggiungere, vivere la nostra esperienza di vita nel mondo valorizzando il cammino e cercando, di volta in volta, buone ragioni per agire, mantenendo quella che Franco Volpi ha chiamato “ragionevole prudenza di pensiero, quel paradigma di pensiero obliquo e prudente, che ci rende capaci di navigare a vista tra gli scogli del mare della precarietà, nella traversata del divenire, nella transizione da una cultura all’altra, nella negoziazione tra un gruppo di interessi e un altro215”. È una riformulazione, adeguata al nostro precario presente, di quella capacità che Aristotele chiama phrónesis, che si può tradurre con saggezza, sapere orientato all’azione, che presuppone la capacità di valutare le situazioni e i mezzi a nostra disposizione, di immaginare scenari diversi, di anticipare il futuro, per poter agire nel modo migliore nelle condizioni date. 199 La saggezza presuppone conoscenza ed esperienza: conoscenza del mondo e conoscenza di sé. Il Conosci te stesso! è alla base del modo greco di intendere la vita e non smette di sollecitarci dopo millenni. Comprende la conoscenza della natura umana e del modo di essere umano da parte di ognuno, che significa conoscenza del proprio carattere, perché per l’uomo il carattere è il suo demone (Eraclito)216 e conoscenza dei propri limiti e delle proprie possibilità. L’uomo è, infatti, tra i viventi, ‘un animale non stabilizzato’ (Nietzsche): il limite non è inscritto nella sua natura, deve essere continuamente cercato per dare forma e confine alla sua espansione vitale, ma il confine deve esistere, anche se va continuamente spostato. La saggezza presuppone anche la conoscenza del mondo ovvero la consapevolezza che “l’immagine di mondo non ce l’ho – come sostiene Wittgenstein – perché ho convinto me stesso della sua correttezza, e neanche perché sono convinto della sua correttezza. È lo sfondo che mi è stato tramandato, sul quale distinguo il vero dal falso”217. Non è un orizzonte di verità, ma di credenza, che fornisce regole utili per orientarsi nel mondo; è necessario però non ignorare le ragioni per cui quelle regole sono nate e comprendere che, venendo meno le ragioni, almeno per noi, anche le regole possono essere modificate. È questo un processo che consente all’individuo di dis-identificarsi dal modo di vivere collettivo. L’archetipo218 del viandante di Jung si presta bene a rappresentare la tensione del soggetto che, pur avvertendo il desiderio di approvazione sociale che si ottiene conformandosi all’immagine di mondo in cui è immerso, sente l’esigenza di andare oltre, alla ricerca della propria autenticità. È un cammino che è importante in sé, per tutto ciò che si può sperimentare, non per la meta da raggiungere. È anche un cammino che implica la necessità di fare i conti con il proprio passato nel tentativo non solo di comprenderne il significato profondo, ma anche di cogliere quanto di esso dirige ancora l’andare. È, inoltre, un 200 cammino che Implica la capacità di spostarsi fuori dagli usuali punti di riferimento, altrimenti… si corre il rischio di arrivare a Trude. Ma, che posto è Trude? È una delle ‘città invisibili’ immaginate da Italo Calvino: “Se toccando terra a Trude non avessi letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto d’essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri. (…) Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. - Puoi riprendere il volo quando vuoi, - mi dissero - ma arriverai a un’altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un’unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all’aeroporto”219. Se il viandante pensa di cambiare il suo stile di vita semplicemente cambiando luogo, si illude, perché è con se stesso, innanzitutto, e con il suo ‘sguardo’ che deve fare i conti. Uno sguardo che ha un estremo bisogno di immaginazione, di immaginare ‘diversamente’. Rappresentare il cammino con la figura del viandante non significa soltanto dare importanza all’andare rispetto alla meta, suggerisce anche la necessità di recuperare il silenzio, perché la pratica del silenzio permette l’ascolto di sé, dell’altro e della natura. Indica, inoltre, la necessità di recuperare la lentezza, che, sola, permette di osservare il mondo in modo diverso, di coglierne le sfumature, di seguirne i ritmi. Indica, infine, la necessità di non sottomettersi a uno dei miti del nostro tempo, la velocità, perché rallentare diventa un’esigenza quando si è immersi nel pensiero. 201 NOT E 1 Non possiamo per esempio rivivere l’esperienza di un altro essere vivente che ha presumibilmente sensi diversi: “Il sonar di un pipistrello, nonostante sia chiaramente una forma di percezione, non è simile nel suo operare a nessuno dei nostri sensi, e non c’è nessuna ragione di supporre che sia qualcosa di simile a ciò che possiamo esperire o immaginare. Ciò sembra creare difficoltà per una definizione di che cosa si provi ad essere un pipistrello” (T. Nagel, What is it like to be a bat?, in The Philosophical Review, vol. LXXXIII, n.4, pp. 435-450). 2 Prima ancora delle scoperte delle neuroscienze Husserl e Merleau-Ponty avevano superato l’opposizione cartesiana fra mente e corpo mostrando che non è possibile una esperienza di sé senza esperienza del corpo e del mondo. 3 Secondo Boncinelli i sensi non osservano passivamente il mondo ma ‘gli pongono delle domande’; inoltre ogni percezione - che è la presa di coscienza delle sensazioni - è un confronto tra aspettativa e verifica: il presente è lo spartiacque tra quello che mi aspetto e quello che si verifica. 4 Come sosteneva Kant, non conosceremo mai la realtà come essa è in sé e per sé (il noumeno), ma conosciamo una sua rappresentazione, anche se le forme considerate apriori da Kant sono verosimilmente un risultato dello sviluppo evoluzionistico. 5 La scoperta dei neuroni specchio, avvenuta a metà degli anni ’90 a opera dell’equipe del prof. Giacomo Rizzolatti del dipartimento neuroscienze dell’Università di Parma, ha messo in discussione il modello dell’analogia funzionale della mente con i calcolatori e ha dato enorme importanza, nell’apprendimento, al ruolo dell’esperienza corporea in relazione con il movimento. I neuroni specchio, che sono una particolare classe di cellule nervose, sono stati scoperti inizialmente nella corteccia premotoria ventrale del macaco (scimmia che, come l’uomo, è un essere particolarmente sociale) attraverso l’uso di elettrodi così sottili da poter essere impiantati nelle singole cellule; le cellule nervose si attivavano sia quando la scimmia afferrava qualcosa, sia quando vedeva qualcun altro afferrarla. Successivamente sono stati fatti esperimenti sugli esseri umani e si è scoperto che il cervello dell’uomo ospita moltissimi sistemi di neuroni specchio preposti non solo a imitare le azioni, ma anche a captare le intenzioni e le emozioni di un’altra 202 persona. L’apprendimento per imitazione dei bambini, che imparano guardando, si spiega con i neuroni specchio. 6 Con l’espressione ‘modello culturale’ si indica in antropologia, in termini molto generici, l’insieme delle conoscenze e dei valori che formano la ‘visione del mondo’ di un determinato gruppo sociale, visione condivisa da tutti i membri del gruppo. Alla elaborazione della nozione di modello culturale, che ha una sua notevole complessità interna, hanno contribuito molti studiosi tra cui Benedict, Kroeber, Lotman e Uspenskij. 7 Nel mondo greco Aristotele, filosofo dotato di straordinarie capacità logiche, così si esprimeva: “(…) perché lo schiavo non possiede in tutta la sua pienezza la parte deliberativa, la donna la possiede ma senza autorità, il ragazzo infine la possiede, ma non sviluppata. È necessario dunque supporre che sia lo stesso anche delle virtù morali e cioè ne devono partecipare tutti, non però allo stesso modo, bensì solo quanto <basta> a ciascuno per compiere la sua funzione (…) non è la stessa la temperanza d’una donna e d’un uomo, e neppure il coraggio e la giustizia, come pensava Socrate, ma nell’uno c’è il coraggio del comando, nell’altra della subordinazione, e lo stesso vale per le altre virtù” (Aristotele, Politica 1260a, in Opere filosofiche, Laterza , Roma-Bari 1986, p. 27). Eppure il suo maestro, Platone, pur se in funzione dei problemi interni al suo pensiero (esigenza di eliminazione della famiglia e ricollocazione della donna nella società), aveva sostenuto, servendosi della dialettica e dell’analogia con il regno animale, l’effettiva eguaglianza di donna e uomo: “Non c’è, quindi, amico, nessuna attività, nel governo della città, che sia della donna in quanto donna, né dell’uomo in quanto uomo, ma le nature (cioè le capacità) sono ugualmente disseminate in ambedue (…)” (Platone, La Repubblica, vol. II, libro V, Rizzoli, Milano 1998, p.169). 8 Un tempo il mondo appariva dicotomico: potere vs sapere \ polis vs oikos \ pubblico vs privato\ mondo storico in divenire vs mondo della natura ripetitivo\ scienze della natura vs scienze dello spirito\ res cogitans vs res exensa \ stato naturale vs stato civile. 9 Ci riferiamo ai testi di Tönnies, Lotman, Simmel, Buber, Arendt, Popper, Bauman, Perniola. 10 “Nei sistemi sociali semplici un modo di vivere sicuro (…) veniva ottenuto per mezzo di convinzioni religiose a proposito della vera esistenza, della natura del soprannaturale, e ancora per mezzo del mito, del linguaggio, del diritto naturale” (N. Luhmann, La fiducia, Il Mulino, Bologna 2002, p. 73). 11 “Il momento in cui si è passati da meccanismi storico-rituali di formazione dell’individualità a meccanismi scientifico-disciplinari, in cui il normale ha dato il cambio all’ancestrale, e la misura ha preso il posto dello status (…) 203 sostituendo, così, all’individualità dell’uomo memorabile quella dell’uomo calcolabile, questo momento in cui le scienze dell’uomo sono diventate possibili, è quello in cui furono poste in opera una nuova tecnologia del potere e una diversa anatomia politica del corpo” (M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976, p. 211). 12 Il campo di ricerca in questo ambito è molto vasto. Qui riportiamo alcune caratteristiche identitarie, tipiche delle società sopra esaminate, tratte da studi di Tocqueville, Lasch, Pulcini, Bauman, Galimberti, Giddens, Zoja. 13 G.H.Mead, Mente sé e Società, in Lewis A. Coser, I maestri del pensiero sociologico” Il Mulino, Bologna 1983, p. 171 14 R. De Monticelli, La novità di ognuno, Garzanti, Milano 2009, p. 18. 15 Ib, p. 314. 16 Ciò che vediamo, sentiamo o richiamiamo alla memoria passa contemporaneamente nel nostro cervello. 17 Procede lentamente, un passo dopo l’altro; per ragionare bene occorre prestare attenzione alla stessa cosa per un certo periodo di tempo. È un modo tipico del ragionamento filosofico e non a caso la nascita e lo sviluppo del pensiero filosofico occidentale hanno favorito il sorgere della scienza. 18 Ogni grande opera artistica è il risultato del funzionamento delle due modalità cerebrali e anche le scoperte in campo scientifico avvengono per l’utilizzo dell’immaginazione oltre che del ragionamento. 19 Il carattere industriale della cultura non riguarda il processo produttivo, ma la mercificazione e la standardizzazione della cultura stessa (Horkheimer e Adorno). 20 Il concetto di ‘spettacolo’ è stato coniato negli anni ’60 dai gruppo dei Situazionisti, a cui apparteneva Guy Debord, e proposto come misura della critica al mondo della comunicazione di massa. 21 Nel suo libro più famoso, La società dello spettacolo del 1967, Guy Debord sostiene che il senso della pratica del sistema economico-sociale in cui viviamo è la riduzione, attraverso le immagini-oggetto, della comunicazione a merce, simile a tutte le altre merci: “lo spettacolo è il momento in cui la merce è pervenuta all’occupazione totale della vita sociale.” Se, nella prima fase dello sviluppo del capitalismo, la realizzazione dell’uomo era passata dall’essere all’avere, nella attuale fase avanzata, dall’avere siamo pervenuti all’apparire e, solo nell’apparire, l’avere acquista senso. 204 22 La società dei consumi (1974). Il potere repressivo teorizzato da Foucault è oggi diventato il potere cinico e seduttivo dei media. 23 Ogni rito consiste in una performance che si situa in uno specifico spazio/tempo messo-in-forma in modo da comunicare immediatamente, attraverso i sensi in generale ma certamente soprattutto attraverso la visione, un ‘ordine’, una struttura ordinata, che dia ‘senso’ al flusso delle cose nelle forme della ripetizione di movimenti e parole codificati. 24 Il mito è ovviamente racconto: ma un racconto che ‘mette in scena’ dei fatti, ovvero delle azioni di specifici individui che l’ascoltatore è inevitabilmente in grado di ‘vedere’ attraverso gli stimoli delle parole che descrivono e suscitano emozioni. Ogni mito consiste in una serie di ‘scene’, ovvero come dice il termine di situazioni spaziotemporali in cui agiscono dei personaggi, proprio alla maniera del teatro. 25 Una ‘legge’ scientifica non è altro che la descrizione dell’invariante che viene ‘vista’ al di sotto del variare dei fenomeni che fluttuano: ed essa si esprime attraverso ‘schemi’, ovvero configurazioni spaziali in cui le variabili individuate vengono messe in connessione attraverso ‘segni’ (codici) che esprimono relazioni ‘logiche’ di vario tipo, fuori dal tempo. 26 L’arte è da considerare una ‘rappresentazione’ concreta di concetti ‘generali’: essa, ovviamente specialmente per quelle visive, trasforma in elementi ‘sensibili’, cioè percepibili dai sensi, cioè immediatamente, quel che la mente contiene nel profondo, come logos e come pathos. 27 La poesia, come recita l’etimologia della parola, è ‘produzione’ di realtà: in origine tutte le parole in tutte le lingue sono – come ben sanno i linguisti contemporanei – la rappresentazione analitica dello spazio materiale e delle relazioni spaziali, solo col tempo, attraverso i procedimenti dell’analogia (il procedimento che Boncinelli definisce ‘parallelo’) le parole acquisiscono la capacità di dire i concetti astratti. 28 Se n’è già parlato nella prima parte di questo lavoro (vedi la nota 21). 29 Negli ultimi decenni si assiste al trionfo del racconto in ogni ambito di comunicazione, all’interno della crisi del logos e nella convinzione che la ‘pateticità’ narrata crea comunicazione semplice ed efficace. 30 Tutti gli esseri viventi dotati di respiro (animalia) per riprodursi (cioè per dare continuità ai propri geni) esercitano in varia forma sesso: la cultura umana, che è tale perché artificiale, ha codificato (‘messo-in-forma’) questa pulsione trasformandola in ‘desiderio’ e in rituali che, generalmente, vengono fatti coincidere con la parola ‘amore’. Lo stesso si può dire per la dimensione materiale (e di fatto nel profondo cinicamente brutale del mors 205 tua vita mea) del sopravvivere: la pulsione del cibo (dell’ingurgitare in varia forma parte dell’ambiente) è sempre codificato, sia nelle forme aggressive della acquisizione (la guerra, la lotta, l’aggressione) sia nelle forme pacificate del simposio, della condivisione. Ovviamente la guerra è per dirla lotmanianamente da esercitare contro chi/cosa è al di fuori della ‘frontiera’ propria della propria comunità; il simposio con chi è al di qua. Insomma esclusione vs inclusione. 31 Maffei, La libertà di essere diversi. Natura e cultura alla prova delle neuroscienze, Il Mulino, Bologna 2011. 32 Secondo Shank (Il lettore che capisce, La Nuova Italia, Firenze 1992), e Minsky (La società della mente, Adelphi Milano, 1989), la mente mette – in – forma i dati percepiti (crea ordine) attraverso due pattern fondamentali: frame (una rete di connessioni – per così dire - spaziali) e script (una connessione sequenziale che simula la successione temporale). In particolare per Goffman (Frame analysis. L’organizzazione dell’esperienza, Armando, Roma 2001) lo script, cioè il racconto, è la matrice fondamentale di gran parte dei rapporti impersonale e di scambio immateriale che stanno alla base delle relazioni umane… gli altri modelli probabilmente sono stati creati in momenti successivi della vicenda umana. È invece grazie agli infiniti racconti che si sono costruiti nel tempo archetipi e stereotipi, fissando categorie, inserendole in gerarchie, innovandole e ponendole in relazione, fino a creare un vero e proprio Cosmo narrativo (Pinardi, Narrare, Paginauno, 2010). 33 Oggi è in effetti più che mai evidente quali sono le vie attraverso cui si realizzi l’’egemonia culturale‘ (Gramsci) e come la razionalità del soggetto è in effetti una razionalità intersoggettiva (Habermas). 34 Chris Vogler, Il viaggio dell’eroe, Audino, Roma 2005, p.11: “Non è un caso che Hollywood cominci a seguire le teorie che Compbell presentò nei suoi libri: per lo scrittore, il produttore, il regista o scenografo, tali concetti sono uno strumentario di arnesi validi per il mestiere di narratore. Con detti attrezzi si può costruire una storia in grado di affrontare qualsiasi situazione, una storia che sarà sceneggiabile, divertente e psicologicamente credibile; si possono diagnosticare le debolezze di quasi tutte le trame zoppicanti e correggerle per arrivare ad una efficacia massima” . 35 J.Campbell, L’eroe dai mille volti, Guanda 2008. Il viaggio dell’eroe è un ‘monomito’ riconoscibile in una serie incredibilmente ricorrente di elementi che scaturisce dai recessi più profondi della mente umana. In pratica è una vera e propria mappa della psiche umana psicologicamente valida anche quando rappresenta avvenimenti fantastici. Ovviamente il pensiero di Campbell si sovrappone da un lato a quello di Propp, che per primo ricono206 sce la struttura invariante delle fiabe, dall’altro a quello di Jung che introduce il concetto di ‘archetipo’ per indicare quei personaggi o quelle forze che si riaffacciano nei sogni di tutti e nei miti di tutte le culture. 36 Poiesis, da poieo, significa costruzione. 37 Naturalmente Orazio pensa ad una istruzione che procuri davvero quello che Jung chiama ‘individuazione’, mentre adesso siamo davvero alla ‘massificazione’ orwelliana. 38 Le ricerche e le scoperte nei vari campi delle scienze, della tecnica e delle scienze sociali sono ovviamente a disposizione di tutti: la logica del mercato e dell’efficienza fa sì che gli specialisti nei vari campi vengano chiamati a trasformare le cognizioni ‘pure’ in attività pratiche, utili. Dunque ‘sanno’ vuol dire selezionare gli esperti giusti. 39 La varietà degli accadimenti delle esistenze di tutti è semplificata da Campbell in un modello formale ternario (1. Partenza, separazione, 2. Discesa, iniziazione, penetrazione; 3. Ritorno) che attraverso altre ulteriori compartimentazioni (mondo ordinario, richiamo all’avventura, rifiuto del richiamo, incontro con il mentore, varco della prima soglia, prove alleati nemici, avvicinamento, prova centrale, ricompensa, la via del ritorno, resurrezione, ritorno con l’elisir) rappresenta la struttura fondamentale delle esistenze reali: si vive in un mondo ordinario da cui ci si allontana (procedendo all’esterno o all’interno di sé) per affrontare prove che fanno crescere e cambiare l’eroe/individuo. Ogni spettatore fruitore riconosce nelle scene le situazioni e i problemi della sua personale esperienza (di cui in genere non ha consapevolezza razionale, ma che qui riconosce in termini psicologici: paure, speranze, odi, lotte...). Facilmente, pur nella diversità dello spazio-tempo (che attrae in superficie e distrae, anzi diverte come un viaggio nell’altrove, nell’esotico) ci si identifica (ci si riconosce) nell’ ‘eroe’ che deve risolvere i suoi stessi problemi esistenziali: insomma chiunque trova in queste forme lo specchio in cui trovare modelli da ripetere, trova le risposte pret a porter che la vita reale e la forme elaborate di cultura non sanno o non vogliono dargli. 40 L’etimologia di ‘divertimento’ rimanda al verbo latino “de-vertere”, ovvero all’azione del ‘volgere’ dall’alto verso il basso, proprio nel senso di ‘calare’ di grado, di gerarchia, di abbassare l’impegno. 41 Pensare viene dal latino pensum, peso: pensare vuol dire valutare la relazione che esiste tra due elementi, si pensi pure alla semiotica che propone la possibilità di un significato solo se si costruisce un quadrato semiotico, a partire appunto da una coppia. 42 È chiaro che il ‘divertimento’ - secondo la prospettiva dell’omeostasi 207 (concetto che partendo dall’ambito biologico - Bernard - si è progressivamente esteso - a partire da Bateson - alla sociologia, alla psicologia, alla comunicazione) si esprime sempre come movimento opposto all’eccesso, come ‘retroazione’ rispetto ad una situazione in cui la saturazione rischia di far implodere il sistema: del resto, “Niente di troppo!” diceva l’oracolo di Delfi! In pratica il divertimento consiste nel cercare, in presenza di un eccesso di ‘cambiamento’, uno stato di quiete (il sonno dopo la veglia, il riposo dopo la fatica, il fresco dopo il caldo, l’acqua dopo la secca …; ma anche nel cercare il ‘cambiamento’ di fronte ad un eccesso di ‘stasi’ (adrenalina vs la noia, il ‘nuovo’ rispetto al ‘vecchio’, il ‘diverso’ rispetto all’eguale’…) 43 Un universo ‘uniduale’, grazie a cui l’uomo vive ‘sicuro’ perché in esso la dimensione coattiva del logos è sostituita da quella liberatoria del simbolo, in cui lo spazio e il tempo empirici sono sostituiti da spazio e tempo ‘falsi’ capaci di corrispondere agli archetipi junghiani (rito, templum, ecc.): cfr. E. Morin, Il metodo, 3. La conoscenza delle conoscenza, Cortina, Milano 2007, pp. 169 ss., ma anche R. Callois che ne I giochi e gli uomini, Bompiani, Milano 1981, propone il ‘gioco’ come elemento fondante della stessa cultura, nel senso che consiste sempre nel mettere – in – forma le situazioni disordinate del Divenire ovvero nel costruire situazioni in cui il ‘come se’ del simbolico sostituisce il banale caotico movimento dei fenomeni. 44 Per Freud l’ordine sociale è sempre una forma artificiale che si può ottenere solo attraverso la re–pressione, ovvero la compressione delle pulsioni dei singoli. 45 Nel senso etimologico di essere capace di creare di nuovo (‘re’) una situazione di quiete in cui riconoscere gli stati edenici di fuori dal tempo e dallo spazio 46 Per R. Girard (Menzogna romantica e verità romanzesca, Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita, Bompiani, Milano 1965) è esemplare in questo senso la figura di Don Chisciotte, che rinuncia alla prerogativa fondamentale dell’individuo (la scelta degli oggetti del suo desiderio) per affidarsi ad modello mediatore (nel caso di Cervantes è Amadigi). Naturalmente questo atteggiamento è proprio di tutti gli uomini, che sono organizzati secondo il meccanismo antropologico della mimesis, a sua volta sorretta dalla dimensione biologica dei neuroni specchio 47 Le ideologie otto/novecentesche sono guidate da una carica utopistica di cambiamento che nasce in effetti non dalla vantata conoscenza (e conseguente controllo) delle strutture profonde della ‘realtà’, ma dalla cieca sovrapposizione delle ‘figure’ del proprio desiderio di cambiamento (‘ordine’ immaginato) ai dati caotici e confusi della esperienza (disordine). 208 48 L’affermazione del primato della razionalità ‘lineare’ dei ‘numeri’, cioè della ‘quantità’ quale unico strumento efficace nel determinare ‘efficienza’, è più che evidente nella invasiva ossessione per il modularismo che sta travolgendo la scuola contemporanea: l’ideologia del riduzionismo impone l’obbligo di eliminare dalle prospettive dell’educazione i grandi problemi non quantificabili in numeri e di addestrare esclusivamente ad ‘abilità’ destinate a risolvere piccoli problemi compartimentali, ma a non toccare il ‘sacro’ tesoro delle vere conoscenze che determinano la differenza (il potere, ovvero per dirla alla Gramsci l’egemonia). Il ‘prodotto finito’ di una scuola del genere sarà, nel migliore dei casi, un tecnico ‘efficace’ se esperto in qualche settore speciale della conoscenza al punto da saper applicare al momento giusto i giusti protocolli appresi, secondo le procedure del tanto celebrato problem solving; ma in effetti del tutto disabilitato alla soluzione di problemi che superino i confini delle proprie discipline per l’ignoranza della cultura della ‘ complessità’ e del tutto inadatto alla gestione di situazioni non lineari (i ‘cigni neri’ di cui parla Taleb in Il cigno nero). 49 Non a caso fin dalla notte dei tempi le conoscenze decisive sono state sempre accompagnate da un’“aura” di sacralità (sciamani, sacerdoti e vati sono esemplari di questa pratica di sacralizzazione) e le lotte socio – politiche sono state di fatto un processo di desacralizzazione delle conoscenze: basti ricordare cosa ha caratterizzato la nascita della letteratura latina (i plebei che conquistano l’accesso alla gestione delle conoscenze patrizie), l’origine di quelle volgari nel basso medioevo europeo (sottrazione dell’esclusiva alla Chiesa da parte di laici di vario tipo), il trionfo dei ‘lumi’, (cioè l’affermazione del principio della ‘trasparenza’ - diremmo oggi - contro il ‘segreto come strumento fondamentale del potere assolutistico) la lotta - oggi - contro le intercettazioni di vario tipo. Naturalmente la storia registra processi di recupero per così dire della ‘sacralità’ delle conoscenze ristrutturando in modo nuovo il sistema della produzione e fruizione della cultura: e non sempre sono operazioni condotte con violenza (censure varie) o percepibili con evidenza (controriforme). A volte vengono gabellate anzi per avanzamenti: si pensi alle varie ‘riforme della scuola’ che mano a mano che concedevano in teoria l’accesso alle conoscenze a masse più elevate di individui, come la scuola media unica o l’università per tutti i diplomati, di fatto hanno svuotato quelle istituzioni di qualità (si pensi alla banalizzazione dei processi di selezione del personale insegnante) e quantità (paradossalmente la moltiplicazione di ‘saperi’ sempre più micro e sempre più modulari), spostando il ‘sacrario’ delle conoscenze decisive ad altri livelli (master, scuole private elitarie, ecc.). Naturalmente a modificare il sistema della costruzione della egemonia culturale interviene sempre più dal XX secolo la serie di mass media che consentono in modo invisibile di penetrare in casa (televisione) 209 e manipolare le menti a favore di una ‘mente collettiva’ sempre più desiderosa di esperienze ‘estetiche’ e non ‘etiche’, e tanto meno epistemologiche. Il cinema naturalmente rientra a pieno titolo in questo quadro di ri-sacralizzazione della cultura. 50 Z. Bauman parla di ‘modestia epistemologica’ come dovere proprio dell’intellettuale nella società complessa, in La decadenza degli intellettuali, Da legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Torino 1992. 51 Se cioè passiamo dalla dimensione del ri-conoscere (con minimo consumo di energia) a quella della ricerca, della inchiesta (con accentuazione del ‘movimento’, della ‘sfida’). È appena il caso di ricordare brevemente che l’analogia consiste nel ‘connettere’ elementi che nel mondo della logica fanno parte di categorie diverse (è un ‘errore’ logico); e che l’abduzione consiste di fatto nel connettere in frame del tutto ipotetici elementi che potrebbero dar luogo ad altre configurazione. Insomma con l’analogia e con l’abduzione si passa dal mondo del ‘reale’ a quello del ‘possibile’: ma con cognizione di causa, cioè con la ‘modestia’ epistemologica di cui parla, come appena detto, Bauman. 52 È questa la parola con cui Jung indica il processo che conduce il singolo a conquistare spazio per la propria differenza rispetto ai meccanismi sociali di conformizzazione. 53 Anche le pratiche dei cinefili maniaci delle enclaves sperimentali troppo spesso si riducono a forme specialistiche di lettura attente soprattutto al ‘come’ ma spesso distratti rispetto al ‘cosa’: appassionate analisi di inquadrature, luci, colori, musiche, recitazione, ma poca attenzione alle questioni antropologiche e filosofiche messe in atto da quelle scelte formali. Domina la pratica dell’esotico, dello straniamento, dello psicologismo ma, paradossalmente, disattenzione per la dimensione della ‘comunicazione’ stessa, della messa-in-forma della ‘realtà’ ai livelli più astratti. 54 Per G. Debord, (La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 2008) la caratteristica della situazione culturale contemporanea è che l’uomo medio è portato non a partecipare alle decisioni, a qualunque livello, ma ad ‘assistere’ compiaciuto alle decisioni prese altrove, ad accettare – con entusiasmo acritico – quel che dall’alto viene proposto. 55 T. La Branca in Chaltron Hescon (Einaudi, Torino 1998) mette a fuoco il processo di ‘banalizzazione’ della cultura nella società dello spettacolo: la via breve dell’happening, del ‘bel gesto’. Al posto della via lunga del labor, della fatica per conquistare profondità, per arrivare alla qualità costruita nel tempo dall’uomo con l’ars, per l’appunto, e non certo con l’attimo di ‘spettacolo’, di partecipazione passiva ad una situazione che si vuole catalogare come estetica. 210 56 Non certo il ‘porta a porta’ del venditore o il ‘carro di Tespi’ dell’antico giullare possono essere pratiche di comunicazione efficace: è solo se si inserisce nel curricolo scolastico a tutti i livelli la pratica e la lettura del cinema (in modo non casuale ed estetico, ma appunto etico semiotico, che si può davvero realizzare un contatto capillare con la massa. È, di fatto, uno dei ‘saperi fondamentali’ nella formazione dell’individuo della società dell’informazione, prima ancora che non la tecnologia digitale, arma letale definitiva del trionfo del riduzionismo tecnocratico. 57 La questione del giudizio di valore rimanda a gerarchie che non hanno più sostanza ontologica: esso dipende non dal ricorso a ideologie estetiche ma dal controllo delle procedure di codifica e decodifica delle specifiche province disciplinari. Non il ‘bello’ ma l’’efficace’: e il vero problema è allora individuare gli scopi del testo fruito, la coerenza delle varie scelte con questi scopi. 58 Non solo, cioè, il ‘significato’, ma ‘come si costruisce il significato’. È il campo delle neuroscienze, del cognitivismo, della semiotica in particolar modo. 59 Il settarismo e il corporativismo delle tradizioni disciplinari correnti (sia a livello di università che di scuole secondarie ed elementari) teme la complessità: certo, ridurre tutto, creare frontiere in nome della specializzazione, è un preoccupante segno di cecità di fronte alla evidenza della crisi dell’episteme’ ottocentesca. Quel che si può concedere all’uomo comune è colpa grave per chi pratica attività intellettuali di responsabilità antropologica. 60 Nell’Orlando Furioso (canto 1,22) Ariosto esclama “o gran bontà de li cavalieri antichi”: la natura spinge i guerrieri nemici (Ferraù e Rinaldo)a distruggersi vicendevolmente, ma la cultura (la cortesia delle buone maniere, i valori della fides, cioè della lealtà) li spinge a cooperare in presenza di una ‘nuova’ situazione. Così, in genere, l’uomo nella sua evoluzione, che consiste appunto generalmente dal costruire un ordine proprio (finalistico) contro quello (senza teleologia) della natura. E così le nostre ‘imprese’ (‘intraprese’). 61 Tra gli altri, ad esempio c’è Deleuze che affronta direttamente la problematica del cinema, riallacciandole alle concezioni di Henri Bergson sulla natura del movimento e del tempo. 62 Ogni testo, non solo linguistico, va affrontato con la consapevolezza che le invarianti, i parametri da cui indagarlo (‘Leggerlo’) sono quelli indicati dalla textlinguistik di Dressler e De Beaugrande fin dagli anni Ottanta (Introduzione alla linguisticatestuale, il Mulino, Milano 1984): coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità, intertestualità, proceduralità. 211 63 T. Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di una evoluzione che non ci aveva previsto, Cortina, Milano 2011. L’umanesimo evoluzionistico rifiuta l’idea che ci sia un piano intelligente a determinare l’origine e le forme della vita nel tempo, elimina conseguentemente l’idea che ci sia una direzione data da seguire una ‘logica del mondo’: “l’uomo contemporaneo è chiamato a dominare il caso” (Natoli), ovvero a modificare con la sua tecnologia la stessa identità biologica (Boncinelli) e a edificare - da sé e per sé - una vera e propria etica dell’uomo, assumendo finalità che non esistono in natura. 64 ‘Mi piace’ o ‘non mi piace’ sulla base del ‘mio gusto’. 65 R.Barthes, S/Z, Einaudi, Torino 1981. 66 Intenzionalità della textlinguistik. 67 Accettabilità. 68 Informatività. 69 Detto altrimenti, con i termini della textlinguistik, ogni elemento è utile o alla ‘coesione’ (livello della visibilità, comprensibilità immediata) o alla ‘coerenza’ (livello della non visibilità, del ‘segreto’ da decifrare). 70 Se appare in scena un coltello esso può essere collegato metonimicamente ad un prossimo uso (cucina, omicidio, tagliaunghie…) o analogicamente al topic (si fa per dire) della violenza, della lucidità, della speranza riconoscibile in altri ‘oggetti’ testuali (isotopia). 71 In America oggi di Altman, una delle storie vede ad un certo punto la distruzione completa di un appartamento (mobili, suppellettili, tende…) salvo il televisore, per altro acceso e che continua a rimanere acceso quando arrivano i proprietari: la domanda da farsi è ”perché il regista ha fatto questa scelta? Perché tutto distrutto e la tv no? E perché rimane accesa?”. Naturalmente le ipotesi di risposta sono lecite solo se le colleghiamo al tessuto della storia e se, a un livello più astratto, ci colleghiamo alla visione del mondo del regista, a modelli interpretativi di simboli ecc. 72 È questo il livello del Reale, cioè quella parte che, nella elaborazione lacaniana della psiche, esiste all’esterno della psiche: essa mette-in-forma il reale, dopo la scoperta dell’Altro nella fase dello ‘specchio’, attraverso Simbolo e Immaginario. Questa teoria è in effetti una descrizione del processo semiotico attraverso cui l’uomo costruisce il suo rapporto ‘artificiale’ (simbolico) con il mondo, rapporto per cui Cassirer arriva a definirlo come animal symbolicum: l’uomo di fatto dà ordine al mondo noumenico solo attraverso l’elaborazione di codici, ovvero di sistemi di simboli, che non sono quindi pensiero ‘debole’ rispetto ai concetti, ma la forma originaria di tutte le ela212 borazioni concettuali dell’uomo in quanto uomo: lingua, mito, arte, scienza, religione ecc. è il simbolo che fa l’uomo, sono le forme simboliche che consentono all’uomo di percepire e comprendere la realtà in modo ‘riflessivo’. 73 Per Jung gli archetipi sono modelli profondi connaturati alla psiche umana, che rimangono attivi per tutto il corso della vita in tutte le scelte esistenziali, anche se sotto traccia, in forma poco riconoscibile: sono risposte fondamentali alla domande essenziali di ogni esistenza: da cosa mi devo guardare (paura)? quale è lo scopo della mia vita (meta)? e cosa devo fare per arrivarci (compito)? 74 Per Girard è fondamentale la spinta alla mimesis nella strutturazione delle società umane: che non vuol dire solo ripetizione, imitazione, ma anche competizione, rivalità (‘se lo fai tu, lo posso, lo voglio fare pure io’). 75 Crisi della famiglia innanzitutto, con conseguente esaurimento della figura archetipica del Padre (M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del Padre, Feltrinelli, Milano 2013); nonché svuotamento della funzione ‘umanistica’ della scuola e dell’università a favore di ‘istruzione tecnica’, mirata a settori parziali dell’esistenza, al ruolo di ‘utilità’ produttiva e basta. 76 Winnicot e Mead hanno chiarito come le dinamiche sociali della soggettività consistono essenzialmente nella gestione di veri e propri ‘copioni’, alla maniera delle rappresentazioni teatrali: ognuno interagisce assumendo, più o meno consapevolmente, atteggiamenti in genere già inscritti nelle pratiche sociali e, appunto, ‘copiati’ dai singoli nel corso delle varie esperienze di vita. Entro tali prospettive l’identità consiste appunto nel ripetere l’identico che è fuori di noi: la differenza sta nel montaggio, nella recita. 77 Chiara la utilizzazione del modello freudiano: le ferite della infanzia determinano l’impossibilità di essere ‘normali’. 78 Esistere ha come etimologia latina ex (fuori da) e sisto (stare fermi in piedi continuativamente). 79 Quel che può sembrare solo un’invenzione giocosa da comico, in effetti, corrisponde alle teorie di Bateson e soprattutto di Girard sulla mimesis come meccanismo primario di costruzione del Soggetto. 80 Qui si sintetizzano le tesi foucaultiane della costruzione moderna di ordine sociale come controllo delle diversità come biopolitica che esclude il diverso dal sociale con la reclusione in luoghi esclusivi (ospedali, carceri, fabbriche, scuole, fino alle razionalizzazioni novecentesche dei lager e dei gulag). 213 81 Elemento tipico della società di massa, parallelo all’operazione suddetta di costrizione dei corpi, è la operazione antropologica’ di ‘mostrificazione’ del diverso: l’attenzione morbosa alle anomalie sono segno della progressiva omologazione del cervello collettivo che, nel momento in cui si accentua la curiosità per il ‘mostro’, costruisce dentro di sé chiare e nette distinzioni tra ordine e disordine, tra bene e male. 82 La scienza moderna, fino a quando non si comincia a ragionare in termini di olismo, porta con sé il limite della ‘oggettività’, cioè della illusione di avere a disposizione categorie di ‘verità’ indiscutibili, e non di ‘certezze’, relative e provvisorie: la irriducibilità della contingenza alle assolutezze del logos spostano progressivamente l’attenzione verso le singolarità, la complessità, l’emergenza. 83 Nella cultura novecentesca, progressivamente capace di notare i limiti del razionalismo positivistico, sempre più si fa strada una attenzione particolare alla diversità, alla specificità della donna nei confronti del maschio: a partire dalla sua condizione biologica, mostra forme di relazioni diverse da quelle del maschio, maggiore tendenza alla cooperazione (a patto di dipendere poco dai protocolli sociali della tradizione). 84 La caratteristica fondamentale dello stato moderno è il passaggio da relazioni ‘personali’ a relazioni ‘impersonali’: ‘la legge è uguale per tutti’ garantisce l’uguaglianza sul piano dei diritti e dei doveri, ma appunto, come nel caso della scienza, insensibilità alle singolarità, alla dimensione imprevista della realtà. Determinando a volte più disastri di quanto voglia. Insomma la burocrazia è ‘fredda’ e ‘insensibile’ rispetto ai casi specifici. Basti pensare alle valutazioni scolastiche. 85 Si conferma la crisi della famiglia. non solo i genitori sono indifferente alla persona dei figli, ma anche gli altri familiari si muovono solo sotto la spinta del guadagno, dell’utile, vero ideale di vita della modernità. 86 I media, la stampa, tradiscono la loro ‘nobile’ funzione illuministica di favorire lo sviluppo dell’opinione pubblica (argomentativa) quando sollecitano solo emozioni e banalizzano l’informazione a livello di chiacchiera (Leopardi, Nietzsche). 87 La società di massa portata all’eccesso: esiste l’anonimato delle ‘belle’ forme regolari delle adunate, in cui ci si sente parte di un sistema. 88 Relazione di tipo metonimico: il fatto X si collega al fatto Y per contatto, per intersecazione. 89 Relazione di tipo analogico: il caso specifico va inserito in un sovra insieme che lo contiene, secondo la relazione ‘X è un Y’. 214 90 In sociologia, ovviamente la parola che sintetizza questo modello è: ‘conformità’, ovvero – se non c’è retroazione, e c’è l’eccesso - ‘conformismo’. 91 La conferma ‘scientifica’ di questa strategia di risposta viene anche dalle neuroscienze che da qualche anno hanno individuato i cosiddetti neuroni specchio quale meccanismo auto regolativo fondamentale nell’adattamento all’ambiente. 92 Secondo Pievani, come gli altri esseri viventi dotati di respiro (animalia, da anima, che in latino significa appunto respiro, l’animale uomo deriva dall’ambiente in cui si trova l’energia necessaria per alimentare la sua sopravvivenza: ma a differenza degli altri animali, ‘sa’ di questa condizione di dipendenza e percepisce il rischio che ne consegue in termini di ‘mancanza’ (di fonti di energia) e di pericolo (di essere a sua volta preda, fonte di energia per altri). L’uomo in sostanza nei suoi rapporti con il mondo ha paura, appunto è insicuro: questa insicurezza è dunque l’effetto della consapevolezza culturale di fondo della sua esistenza e caratterizza ogni sua iniziativa culturale, nel senso che qualunque atto è in qualche modo sempre teso a conquistare ‘sicurezza’, a qualunque livello e nelle diverse forme che le varie culture elaborano (fino al suicidio come conquista di autonomia, libertà…). 93 Imprevedibilità che oggi viene di fatto catalogata come ‘emergenza’. 94 Cioè in una successione sequenziale che organizza i dati secondo una successione prima – dopo che di fatto rappresenta in forma analogica la successione causa-effetto. La prova originaria di questa trasformazione dei dati spaziali in logos attraverso la elaborazione della loro dimensione temporale (trasformazione di dati specifici variabili in categorie generali di invarianti) è sedimentata, come mostrano gli sviluppi della texlinguistik in connessione con quelli della cibernetica) nelle strutture stesse delle lingue. Oltre al fatto che tutto il vocabolario nasce da elementi percepiti nello spazio per poi assumere, nell’uso, valori analogici astratti (basti ricordare come ‘ratio’ prima che il processo mentale rappresenti la linea dritta scavata dall’aratro) è tutto il sistema sintattico che si regge su relazioni semiotiche di fondo di tipo spaziale: in particolare sulla coppia stasi/movimento per quanto riguarda le categorie fondamentali dei verbi (Il cosiddetto predicato nominale, che esprime una corrispondenza di eguaglianza tra due entità, esprime di fatto la condizione di ‘stato’ cioè fotografa una situazione stabile, mentre il cosiddetto predicato verbale rappresenta una ‘trasformazione’, il passaggio da uno ‘stato’ ad un altro ‘stato’ in una specifica situazione) e sulla coppia partenza/ arrivo per quanto riguarda il sistema dei casi (in latino, l’‘ablativo’ che deriva da ab fero, cioè da ‘portare via’, si contrappone – nei termini tipici del quadrato semiotico – all’’accusativo’, che deriva da ad e ‘cado’, cioè da ‘andare verso’: punto di partenza vs punto di arrivo). 215 95 R. Girard, La pietra dello scandalo, Adelphi, Milano 2004, p. 21. 96 Ovviamente l’equilibrio è sempre instabile, come ci dice l’omeostasi, ma la cultura finisce per ‘cristallizzare’ le varie forme che si rivelano ‘efficienti’ nelle situazioni critiche da cui nascono in modo da proporre come ‘naturale’ quel che è di fatto artificiale e lo stesso singolo, per non disperdere energia, tende inevitabilmente al ridurre la complessità effettiva delle relazioni sociali entro ‘identità’ che garantiscano uno stato di certezza continuativa. Gli effetti, in entrambi i casi , non possono che essere l’eccesso’, ovvero retroazione positiva, che inevitabilmente, prima o poi porta all’esplosione / implosione del sistema (la pazzia di Orlando, il suicidio di Emma, la fuga di Zelig). 97 La stessa epistemologia accompagna la fiducia rinascimentale del fatto che la ‘forma’ esprima, debba esprimere, la sostanza: la ‘grazia’ esteriore (estetica) come ‘evidenza’ dell’ordine interiore (etica). Naturalmente col cinema, dopo l’esperienza barocca della mancata corrispondenza tra ‘fuori’ e ‘dentro’, tra linguaggio (qualunque tipo di linguaggio) e realtà, siamo semplicemente alla consapevolezza tecnica comunque con dei segni si costruisce il senso: e che la più rapida delle comunicazioni sensoriali è quella della vista (si pensi a tal proposito alle riflessioni fondamentali di Merleau-Ponty). 98 “Adoro il baseball: non lo capisco, ma...” Abbozziamo un elenco dei vari ruoli ricoperti da Zelig nelle sue trasformazioni: facoltoso repubblicano di Boston; militante di sinistra che arringa gli sguatteri in cucina; gangster; musicista jazz nero; psichiatra; rabbino; obeso; cinese; francese; barbuto; scozzese con kilt; pellerossa; chirurgo; chitarrista messicano. 99 In una delle numerose interviste a personaggi reali che si trovano nel film, lo psicologo Bruno Bettelheim sostiene che Zelig, più che costituire un raro caso di malato di mente, rappresenta piuttosto l’estremizzazione di un meccanismo comune a tutti, che in Zelig però assume caratteri estremi, facendolo diventare il conformista per antonomasia. Altri intellettuali che prendono la parola in prima persona, garantendo al gioco del documentario una sostanza di seriosità accademica, sono Saul Bellow, Susan Sontag, Irving Howe: sono gli ‘esperti’ specialisti che a partire dal Settecento ricoprono (in sostituzione dei religiosi) il ruolo laico di depositari dei segreti della conoscenza umana con la responsabilità di indicare ai comuni mortali la via da seguire di fronte ai problemi. 100 In tal modo Allen propone anche un’adeguata rappresentazione di quello che è stato il fenomeno centrale della storia del XX secolo: il trionfo della massa, l’abbandono del modello ‘partecipativo e deliberativo’ della società liberale sorretta dall’opinione pubblica ‘argomentante’ a favore del modello ‘estetico’ della società dello spettacolo sorretta dal riduzionismo a 216 tutti i livelli e dal ritorno – in forme nuove – al ‘pastoralismo’ premoderno. 101 Anche questa ‘accidentalità‘ spaziale, come si vede, appare una semplice coreografia, ma di fatto corrisponde a rinforzare il contrasto omoestatico tra identità conformista (culturale) e ipseità (bisogno di essere se stessi nel variare del tempo in termini per così dire privati, interiori e non attraverso adeguamenti sociali passivi). 102 Eudora etimologicamente suona “colei che dona bene, che fa buoni doni”: probabile l’intenzionalità dell’allusione, ironica, alla Pandora del mito greco, che dona provocando danni perché dona tutto a tutti, indifferenziatamente; invece lei è che di cognome fa Fletcher (assonanza con l’inglese ‘felther’, cioè uno che prende cose per dare agli altri) è capace (dopo l’iniziale accostamento a Zelig in qualità di dottoressa che scientisticamente e positivisticamente guarda al malato in modo indifferenziato, cioè cerca di curare’ la malattia, e non la specifica dimensione irripetibile del malato: l’ipnosi è il segno di questa irredimibile perdita di controllo dell’individuo sulla propria vita, la sua totale passività rispetto alla ‘scienza’) di selezionare la sua attenzione e cerca/cura/avverte la specifica complessità della persona Zelig, e lo va ‘prendere’ lontano nel profondo della sua alienazione (inautenticità) per riportarlo vicino alla sua ‘autenticità. 103 Il singolo è senz’altro un ‘attore sociale’, sia nel senso etimologico del termine (‘agisce’ sulle cose, non le subisce semplicemente) sia nel senso ristretto del teatro (agisce adottando ruoli, recitando copioni). Le premesse di questa posizione sono nella riflessione sulla simulazione e dissimulazione che vien fatta dalla cultura barocca. 104 Il sé è un ‘attaccapanni a cui si appendono molteplici ruoli sociali, senza che si identifichi con qualcuno in particolare: il rischio è nell’eccesso di distanza, che comporta il cinismo, definibile antro questo discorso come una retroazione positiva in termini di flessibilità. 105 Il sé si costruisce solo attraverso la consapevole separazione dalla madre attraverso oggetti sostitutivi (ovvero modelli alternativi), la capacità cioè di operare discrezione, di passare dall’indeterminato al determinato, dall’indefinito al finito: e questo è possibile solo attraverso il gioco (in latino ‘ludus’, da cui il-lusione cioè entrare nel gioco, ma anche de-lusione, ovvero uscire dal gioco) che consiste nella consapevole costruzione di un mondo ‘altro’ rispetto a quello reale, caratterizzato da precise regole (elementi e relazioni e procedure, come in tutti i sistemi) laddove nel reale tutto viaggia sulle onde dell’emergenza. Il rischio è solo quello di dimenticare che è una costruzione riduzionistica del reale (come avviene per le utopie spesso, sempre nelle ideologie). 217 106 Infatti, come già detto con Girard, il desiderio non è qualcosa che nasce spontaneo dalla nostra ‘natura’ (dal nostro essere nati ‘così’ o ‘così’) ma è espressione di una ‘mediazione’: tra ‘noi’ e il nostro ‘oggetto del desiderio’ c’è sempre, infatti, un modello-mediatore. È questo “terzo” a sancire che cosa è desiderabile e che cosa no per il soggetto che lo assume a modello: la direzione del nostro movimento ‘verso’ qualcosa/qualcuno è insomma sempre etero diretto. 107 Non secondario è il fatto che giace al fondo, cioè la cultura ebraica di Allen, in particolare il modello dell’ebreo errante ,che comporta la continua consapevolezza dell’essere fuori registro, della mancata corrispondenza dei propri modi con quelli delle culture dominanti: straniamento, scetticismo, distacco, ironia appunto. 108 Nelle mitologie dei vari popoli ovviamente agisce direttamente l’archetipo dell’eroe, ma in lui e con, con gli altri personaggi, sono attive altre figure archetipiche, che danno struttura al rapporto del singolo con la realtà, costituendo la propria specificità psichica: nel linguaggio junghiana le figure fondamentale sono quelle della Madre, del Senex, del Puer Aeternus, dell’Ombra, della Persona, dell’Anima, dell’Animus, del Sé. ognuno di questi elementi presenta contemporaneamente aspetti che rinsaldano la struttura psichica ed aspetti che ne minano la compattezza, sempre secondo la logica omeostatica di base di retroazione (che eviti cioè l’eccesso, la fissazione). Ad esempio l’immagine primordiale della madre si manifesta sotto molte forme, ad esempio la “vecchia saggia” o la “dea della fecondità”, nel suo lato positivo, la “strega” o la “madre terribile” in quello negativo. 109 L’invarianza di questa ‘costruzione’ mitica può apparire figlia di arretratezza se guardata con gli schemi contemporanei che esaltano il ‘progresso’ attraverso la celebrazione dell’individuo. Ma in effetti, proprio le conoscenze scientifiche più recenti (in particolare l’archeologia, le neuroscienze, la genetica) ci assicurano sempre più che se un senso esiste nelle trasformazioni in atto tra i sistemi viventi sulla terra è semplicemente nella sopravvivenza del genotipo attraverso il fenotipo: il singolo al servizio della collettività dunque, esattamente in corrispondenza di questi antichi ‘miti’. 110 L’effetto che si vuole raggiungere è cioè di fare in modo che lo spettatore si trovi davanti a situazioni in cui ri-conosca la Grecia classica per come l’ha studiata, per come i libri e le riproduzioni classicistiche l’hanno descritta nei secoli della modernità: il realismo è naturalmente solo in questi termini. Il vero choc sarà provocato da Pasolini quando, mettendo in scena miti greci, propone situazioni, ambienti, vesti molto meno eleganti, povere, probabilmente coerenti maggiormente con la dimensione pauperistica delle antiche società. 218 111 Anche in questo caso ovviamente c’è un filtro dell’immaginario artistico precedente: i preraffaelliti, l’estetismo sono le fonti delle formulazioni spettacolari degli interni e degli esterni. 112 È appena il caso di ricordare che le interpretazioni possibili non necessariamente sono esplicite nella mente degli autori: a volte sono portate dalla partecipazione alla mente collettiva della società di cui si fa parte, e vengono proposte in modo apparentemente spontaneo, come effetto di ‘gusto’, come si dice; altre volte è davvero la mentalità del destinatario (individuale o collettiva poco conta) a rimettere insieme i dati secondo forme nuove rispetto all’autore, in base a modelli e connessioni prima impossibili. 113 Un vero trittico medievale, che rimane abbastanza a lungo per suggerire il richiamo di quelle composizioni sacre in cui al centro emerge la Madonna e ai lati assistono dei santi: una citazione che in sé è probabilmente involontaria ripetizione di un gusto estetico, di ordine, che comunque rinforza quella forma di comunicazione sacra che fonda la mentalità occidentale. Anche sul numero tre si potrebbero fare riflessioni pseudo teologiche. Ma qui, ripetiamo, conta solo la ripetizione di uno schema che pur vuoto è comunque segno che rinvia ad un sistema, una conferma insomma di qualcosa di già noto. 114 In tal modo si consente allo spettatore di ‘differenziare’ all’interno del gruppo delle categorie che consentano di riconoscere quelle gradazioni sfumature tipiche della realtà, che nel testo omerico sono ben introdotte a sottolineare come anche le differenze, alla fine, contino poco di fronte se non si è capace di operare quella più grande sostanza. 115 Che in greco (derivando dal verbo nemo) significa sia divisione (legge che differenziando crea confini, impone liniti sia pascolo (che corrisponde a muovere le bastie entro confini segnalati, confini che differenziano le proprietà). 116 I nemici interni, i proci, i pretendenti, naturalmente sono elementi che fanno parte della stessa società e che accampano, per dirla coi latini, la voglia di res novae, cioè vogliono rompere l’ordine costituito: è un invito implicito alle masse del tempo a guardare bene in faccia i propri vicini per riconoscere in loro i segni del nemico, che fino a poco prima era, nelle logiche del nazionalismo, non poteva che essere lo Straniero. Invece è il Vicino, all’interno della frontiera (reale) a portare il caos. 117 Naturalmente in questa scena si ha una situazione, quella dell’uno (quasi) contro tutti che suona come schema affine a quanto propone Girard circa la pratica salvifica del capro espiatorio per ricreare ordine sociale: in effetti qui a morire sono i ‘tutti’ e non l’’uno’. Ma rimane intatto la valenza 219 antropologica dello schema: occorre un sacrificio, occorre sangue per restaurare l’ordine umano, occorre ritornare all’indifferenziato della natura, all’animal che abbiamo dentro. 118 Luc Ferry, Imparare a vivere. La saggezza dei miti, Garzanti, Milano 2008, p. 14. 119 Ovvio il richiamo al Dasein di Heidegger. 120 Naturalmente anche questo progetto filosofico può essere letto come un rinforzo di quanto finora detto: avere una patria e non l’internazionalismo consente di avere, per l’appunto, un’identità, delle certezze: contro l’aporia di Zelig, occorre decisamente un Ulisse che tende sempre, anche nelle situazioni più complesse, a recuperare lo “ stesso”, ovvero la sicurezza. Insomma Ulisse nell’isola di Calipso rischia di fare la fine di Zelig: adattarsi ad una identità che non gli appartiene, a perdersi nell’indeterminato, anche e soprattutto per la mancanza dell’Altro, del contrasto, del problema, della sfida. 121 Il disincanto verso la guerra, verso la figura dell’eroe eccessivo’ nello scatenamento esasperato delle pulsioni, anche se in favore del proprio gruppo. 122 È una salvezza senza dio, risposta alla domanda di vita buona non fornita dall’ascesi ma dai propri sforzi mentali: la vittorie sulle pene è grazie alla quest (materiale e interiore), allo scambio con l’altro, che consente infine di ridurre le attese, di limitare la Hybris. 123 Da Hobbes al pragmatisti: sarebbe lungo l’elenco di filosofi che esprimono in modo diverso questo atteggiamento. 124 Questa trasformazione è tutta nella simbologia di Excalibur. La spada è sì un oggetto d’uso, ma come dice Ramon Llull, “ha due tagli, e la cavalleria è fatta per mantenere la giustizia, che consiste nel dare a ciascuno il suo; per questo la spada vuol dire che, per mezzo di essa, il cavaliere deve onorare la giustizia. Ricca è in realtà la simbologia cresciuta intorno a questo oggetto: ad esempio per l’elsa si sottolinea che la sua forma allude ai valori del cristianesimo (la croce); la lama (con la duplicità del taglio) è come un doppio specchio dove il cavaliere può veder riflesse le sue virtù o i suoi vizi; il cavaliere che porta la spada è in grado di unire lo spirituale e il fisico, il controllo (la misura) e la pulsione (la forza). 125 Il mago è il residuo di quello che si chiama sciamano o stregone o uomo medicina per le culture premoderne: naturalmente non mai sparito dalle pur razionalistiche società occidentali, cambiando semplicemente nome e a volte campo di azione: intanto esistono tanti ‘maghi’ che davvero ‘lavorano’ per ‘curare’ i destini individuali di tanti soggetti alienati; a livello apparen220 temente più elevato si parla di santoni e guru di varia specie; ma di guru si parla ormai anche in ambito ‘scientifico’, dove non è mai venuta meno la pratica di ‘adorare’ questo o quel ’maestro’, come portatore di misteri e di farmaci risolutivi. 126 Il dio unico caccerà la molteplicità del politeismo che creava in effetti una maggiore possibilità di appartenenza. Ogni dio era legato al luogo, esattamente come ogni singolo era legato alla sua tribù, al suo territorio, alla sua casa, alle sue amicizie. Col dio unico, impersonale e assoluto, si perde questa relazione: ma la si ristabilisce con la proliferazione di santi, che consentono di tornare (continuare) con la pratica dell’individuazione divina: in teoria uno solo, di fatto, a ciascuno il suo! È il santo quello a cui si chiede aiuto e conforto: la madonna poi rappresenta ancor più la continuità con le figure della magna mater, dell’archetipo junghiano della Madre. 127 Per Lotman la lingua è il sistema semiotico di primo tipo, quello che appunto consente di passare dal fluire indistinto del contingente. Alla distinzione della conoscenza del mondo; è sulla sua base, solo dopo di essa, che si possono costruire gli altri codici conoscitivi, cioè le varie discipline, che lui per questo motivo denomina ‘sistemi semiotici di secondo tipo’. 128 Danze tribali, della pioggia, danze artistiche, ma anche quelle contemporanee del postmoderno (si pensi ai balli di gruppo); la sintonia dei movimenti delle masse (la partita, la spiaggia, il weekend, la manifestazione, il concerto, l’aperitivo). 129 Ma c’è una distinzione da fare; se in Merlino la magia è magia del conoscere, dell’esplorare percorsi strani, della curiosità che espande, in Morgana, la magia è magia del fare, è tecnica funzionale, che vuole solo risolvere problemi concreti, che vuole avere potere e dominio. 130 Questo processo di controllo socioculturale è stato descritto da Gramsci per spiegare la mancata realizzazione delle rivoluzioni proletarie previste da Marx nelle società industrializzate: oltre alla dimensione delle strutture economiche a guidare gli individui ci sono appunto le idee sul mondo che diventano base per determinare le gerarchie di valori e quindi premessa fondante dei comportamenti. Per Gramsci si deve parlare di egemonia culturale quando il gruppo al potere, si rivela capace “di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche quotidiane e credenze condivise, i propri punti di vista fino alla loro interiorizzazione, creando i presupposti per un complesso sistema di controllo” (quaderni dal carcere). 131 Chi ha messo a fuoco la dimensione antropologica sociale e politica oltre letteraria della satira è M. Bachtin che completa, in un certo senso, l’intuizione gramsciana della ‘egemonia culturale’ con la complementare 221 descrizione del ‘carnevalesco’ come cultura ‘di periferia’, di ‘resistenza’ rispetto a chi detiene il potere culturale all’interno della società. Insomma alla cultura egemone, qualunque sia, corrisponde – più o meno consapevole – il suo rovesciamento, appunto il carnevalesco. Esso nasce da una intuizione filosofica di buon senso, si può dire: il gruppo egemonico in effetti, con la sua coazione pone prima l’essere o l’identità come un ordine assoluto già dato, escludendo l’alterità come non ordine. È chiaro che allora in ogni gruppo sociale strutturato, strutturalmente non ci può essere ascolto, attenzione per la differenza, se non in termini di predominio e coazione appunto: e appunto contro questa dimensione di assoluto che si origina il movimento opposto della dissacrazione, del disincanta mento, della distruzione. La presa in giro, la caricatura, lo sberleffo in mancanza di autonoma elaborazione culturale vuol dire agire ancora all’interno del modello dominante, ma in termini semioticamente negativi. 132 In questi termini si evita di identificare il discorso di Bachtin solo con situazioni storico – letterarie o con fenomeni antropologicamente ‘esotici’. Bachtin introduce una categoria che restituisce senso (cioè ‘ordine) alla quasi totalità dei comportamenti dei ragazzi nei confronti di tutte le istituzioni possibili: la causa profonda della ‘caricatura’ è spiegata ovviamente dalla psicanalisi nei termini di opposizione alla Castrazione del Padre, ma le sue manifestazioni specifiche sono senz’altro da catalogare come tentativi di costruire un ‘ordine’ alternativo al dominante, anche se come semplice rovesciamento. Insomma nulla di più inefficace che agire entro ‘regole’ già date e valutare in termini morali le gesta degli adolescenti: essi sono portatori, più o meno consapevoli, di sub-culture se non di contro-culture. Il problema che nel mercato contemporaneo dell’industria culturale, questa diversificazione viene immediatamente soddisfatta con il consumo di specifici prodotti che nutrono l’ansia di diversità con prodotti ammantati sempre dell’alone di ‘novità’, quindi di ‘alternatività’. 133 La nota divertente di questo fatto è che naturalmente diavolo deriva dal greco a indicare ‘colui che separa’: cioè il male è identificato con chi, attraverso l’opera di ‘definizione’ – costruzione di confini – consente in effetti di dare ordine al disordine delle cose che fluiscono. Come si vede il paradosso è che proprio l’invenzione del diavolo consente alla religione di costruire ordine: appunto separando. quel che decide è ovviamente non la separazione come metodo allora, ma ‘chi’ opera la distinzione: ad esempio tra le categorie (separazioni) di un professore e quelle di un alunno ovviamente vincono le prime se ci si trova in una classe, ma certamente le seconde se ci si trova fuori della scuola. 134 Il discriminare è l’elemento fondante del senso: si pensi in campo mitologico all’inizio della Bibbia (nel contrasto luce/ombra come passaggio 222 dal nulla all’essere); si pensi in campo scientifico alla struttura del quadrato semiotico ( A vs B, non A vs non B) come indicazione della procedura generale della costruzione (artificiale) di categorie d’ordine. 135 Nella storia del pensiero occidentale, il concetto di ‘riso’ è sempre sottovalutato, inattuale perché sempre concepito come l’opposto di ciò che è “serio”, vale a dire di ciò che è univocamente accettato, stabile, valido, importante. In un certo senso, pericoloso, perché costituzionalmente contrastante lo sforzo mimetico che costruisce l’identità, individuale e collettiva. Sta di fatto che l’opposizione semiotica “serio/comico” invece di essere vista come la descrizione di due modalità diverse di copioni, di stili, è stato quasi sempre pensato nei termini di un’opposizione del tipo “positivo/negativo” (cioè etica), o razionale/irrazionale” (cioè epistemologica). In effetti, la filosofia occidentale si propone subito come una strada “seria” perché va alla ricerca del principio ‘stabile’, ‘vero’ di tutte le cose: sull’Essere, sulla Verità, su ciò che è Bene, su ciò che è Giusto. Salvo scoprire presto che le cose stanno diversamente: ma anche in questo caso la scena rimane sul serio, attribuendo indefinitamente alla comicità tutto ciò che è superficiale, scadente, inutile, mutevole ed accidentale. 136 Possibile parodia, secondo molti critici, della scena omologa presente ne Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, nella quale il cavaliere Antonius Block di ritorno dal Santo Sepolcro chiede alla Morte di giocare una partita a scacchi per avere il tempo di ravvedersi e posticipare il momento fatale. 137 Si pensi alla teoria di Frye, che propone una corrispondenza archetipica tra le forme artistiche e le condizioni esistenziali (ma anche ontologiche per così dire del reale): alla serie alba/mezzogiorno/tramonto/notte corrisponde la serie primavera/estate/autunno/inverno e quella romance-lirica/commedia/tragedia/satira, a sottolineare come alla fase della nascita, della genesi, corrisponde organisticamente una evoluzione prima di crescita poi di crisi e infine di fine. La satira sarebbe allora l’espressione della fine di ogni progetto, del distacco dalle illusioni e desideri, sarebbe insomma la fase, la forma della conoscenza pura, fuori da ogni prospettiva di gioco, capace di cogliere le cose nella loro dimensione senza direzione. 138 Umberto Eco ne Il nome della rosa ha messo in scena proprio questa dimensione dissacratoria del ‘riso’ attraverso lo scontro tra Guglielmo di Baskerville e il bibliotecario Jorge, insistendo proprio sulle capacità sovversive del riso nell’ambito non della politica ma in quello più decisivo per il potere della manipolazione delle menti: Eco fa dire a Jorge: “Il riso distoglie, per alcuni istanti, il villano dalla paura. Ma la legge si impone attraverso la paura, il cui nome vero è timor di Dio. E da questo libro potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio: e il riso si disegnerebbe 223 come l’arte nuova, ignota persino a Prometeo, per annullare la paura”. Jorge è ben consapevole dell’artificiosità dell’ordine del mondo umano, che dovrebbe ripetere quello del macrocosmo divino, per effetto di discrezione, separazione. Ma risponde Guglielmo di Baskerville, recuperando ovviamente il valore etimologico della parola diabolos, “Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è l’arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità che non viene mai presa dal dubbio. Il diavolo è cupo perché sa dove va, e andando va sempre da dove è venuto. Tu sei il diavolo e come il diavolo vivi nelle tenebre”. Il diavolo è colui che separa, colui che fa opera di separazione, che ‘banalizza’ il mondo: il riso invece riesce a far presente la compresenza di elementi altrimenti esclusi, propone la inevitabilità della ‘contraddizione’ nella reale dimensione del mondo. 139 Per Schopenhauer, il riso è una rivincita sulla vita: esso nasce dalla rilevazione di una incongruenza avvertita tra un concetto e un oggetto, una situazione reale. E appunto tutta la commedia all’italiana del cinema degli anni Sessanta esprime una straordinaria capacità nel rilevare queste incongruenze tra le varie forme di teorie che dominavano la società del boom e gli effettivi accadimenti. E con l’operazione Brancaleone, qui ancor più che con il primo, Monicelli destabilizza non certo il cavalier cortese medievale, quanto lo schema implicito che lo sorregge, cioè il non voler far i conti con la realtà, il far finta anche di fronte all’evidenza, l’arrampicarsi sugli specchi: Brancaleone insomma è un antieroe che aiuta a cambiare registro, ad accettare come normale la sfida ma soprattutto ad accettare le sconfitte, a non prendersi troppo sul serio, appunto. In particolare propone allo spettatore che aspetta solo di ridere la comparsa e l’accettazione della morte, che la cultura della modernità tende a nascondere, come fastidiosa anomalia rispetto alla fanfara del progresso e del successo. 140 Pirandello distingue tra l’avvertimento del contrario (comico) e Il sentimento del contrario (umorismo), intendendo con il primo la semplice percezione di anomalia nei comportamenti umani (un eccesso, una anomalia) e col secondo la capacità di scomporre quel che la cultura umana compone, di vedere la asimmetria dove si è costruita una artificiosa e falsa simmetria: in un paio di situazioni la figura di Brancaleone rivela una incrinatura rispetto all’integralismo con cui in genere ‘recita’ la parte del cavaliere: di fronte alla morte, quando la tirata retorica del disprezzo della morte, comporta l’effettiva venuta della morte e un conseguente scambio di battute fino alla entente cordiale basata comunque sul valore fondante della lealtà (mantenere la parola è fides); l’altra quando, di fronte alla necessità di camminare su carboni ardenti per difendere il papa nel giudizio di Dio, improvvisamente cambia copione e improvvisa una tirata sui suoi vizi, mostrando la sostanza di paura che nutre la recita di coraggio. 224 141 Per Brancaleone si ride solo di quello che è ‘umano’ creando una distanza, una sospensione della sim-patia: ma si ha bisogno della ‘complicità’ di altri che condividano il rilievo della contraddizione. Fondamentale è il rilevare/applicare un comportamento rigidamente meccanico a ciò che è (o immaginiamo che sia) vivente. E Brancaleone ha effettivamente del meccanico, dell’automa, nelle sue scelte: si trova ad indossare una vera e propria parte teatrale (il cavaliere cortese) in modo automatico, anche per default, in (quasi) tutte le situazioni (salvare e proteggere i deboli, appunti, senza mai tema di imbrogli, senza mai riflettere su conseguenze, senza mai abbassare lo sguardo alle quotidiane forme di passione, come l’amore umanissimo e geloso che ha per lui la giovane strega). Disaccordo che il personaggio stesso non riesce a comprendere; il fattore scatenante quindi è la sua conseguente meccanicità o rigidità rispetto alle circostanze. Sicché gli automatismi, l’ingenuità e l’impreparazione, i gesti riflessi, le idee fisse, gli equivoci sono tutti motivi del riso, come tutti i caratteri precostituiti, pregi, difetti, vizi e virtù che isolano l’individuo inducendolo alla insocievolezza. 142 Proprio questa mancanza di coinvolgimento però fa del comico, secondo Bergson, un’arte diversa da tutte le altre forme di rappresentazione: non basta a chi la elabora il raccoglimento, l’autocomunicazione, ma richiede la condivisione, come già accennato. La sua mancanza di coinvolgimento drammatico, e dunque la sua fondamentale genericità ed esteriorità non portano infatti a rappresentare l’individuale o gli aspetti più profondi della natura umana, ma a riflettere, a ragionare, a generalizzare: insomma il riso si rivolge non al cuore ma all’intelligenza. Ma questa intelligenza deve rimanere in rapporto con altre intelligenze: non potremmo apprezzare il comico se ci sentissimo isolati. Sembra che il comico abbia bisogno di un’eco. Cert’è che la tipizzazione di figure realizzata nel film ha portato rapidamente a d adottare nel linguaggio comune espressioni come ‘armata Brancaleone’ e ‘Brancaleone’ per indicare, con sussiego misto a simpatia, delle forme stilizzate di comportamento ‘distratto’ e non formalizzato. 143 In definitiva il personaggio di Brancaleone, con la sua ostinata tendenza alla ripetizione, alla mancata percezione della specificità delle situazioni, alla connessione di serie indipendenti, allo scambio di situazioni, alla degradazione o alla esagerazione a sproposito, al fraintendimento, alla distrazione, propone un modello umano totalmente privo del senso del ridicolo, ma ridicolo. Lui stesso: insomma un modello che offre all’italiano del tempo un filtro , una protezione contro l’aborrita mancanza di spirito, contro l’ignominia dello stoltezza che sono avvertite come il vero antico motivo di disonore: deboli, poveri, vittime sì, ma mai stupidi! 144 Naturalmente il ricorso a Gassman per l’interpretazione di Brancaleone 225 non sembra casuale se si pensa alla sua performance in Il sorpasso di Risi, nel 1962, in cui propone in modo ambiguo ma similare una parallela rappresentazione della nuova umanità cinica e disincanta. 145 Lo stoicismo di Seneca riguarda l’addomesticamento non la soppressione delle passioni: si tratta ad esempio non di cancellare completamente la paura (sia nei modelli ‘eroici’ di uomini duri senza paura appunto, sia negli stili di vita che negano a tutti i livelli l’esistenza di limiti, di concetti che hanno a che fare con sconfitta, fine, morte, sofferenza) ma di trasformare la paura in prudenza, il dolore in informazione, gli errori in nuovi inizi e il desiderio in iniziativa. 146 Che ama solo la ripetizione, ambienti e situazioni confortevoli, senza rischi. 147 “Si applica alle supermamme di figli superimpegnati, agli impiegati statali di Washington, ai pianificatori strategici, agli ingegneri sociali, ai manipolatori che sgomitano ecc.” (N.N. Taleb, Antifragile. Prosperare nel disordine, Il Saggiatore, Milano 2013, p. 475) 148 Per dirla con Taleb, ecco che sopravviene un ‘cigno nero’, ovvero quello che il sistema ideologico fragili sta non vuole prevedere, alla ricerca com’è di ‘solidità’. 149 Si pensa di attraversa ‘lo mare’ e ci si trova su un lago; si attaccano i saraceni e si trovano dei pastori: è la situazione di don Chisciotte, con la differenza che la disillusione per Brancaleone è sempre immediata. Non sbaglia gli obiettivi: sbaglia proprio le situazioni, sbaglia nel percorso: mira all’eroico e trova sempre il banale. Anche quando finalmente sembra in procinto di fare la scelta eroica (la sfida alla morte) si imbatte improvvisamente con la sua pusillanimità. 150 Questa dimensione per così dire ‘formalistica’ nasconde in effetti, al di là dell’aura di comicità della situazione, una dimensione etica fondamentale, ribadita in concreto da Brancaleone. Proprio alla fine del film: quando si deve morire quel che conta è decider il come. Nelle nostre possibilità appunto, questa è in fondo la lezione positiva di Brancaleone, è lo stile, il modo: non nel senso assolutistico dei classicisti (che corrisponde alle fragili forme di etiche della linearità monodirezionale), ma nel senso situazionalistico dell’allegorismo (alla Kafka, alla Montale: ciascuno crea il ‘suo’ stile, non ripete ma elabora, fatica, per trovare a volta a volta la sua strada). 151 È una e propria parafrasi del Villon del Canto degli impiccati, il discorso dei morti appesi. 152 È stato anche osservato una certa affinità del linguaggio figurativo del 226 film con quello della pop art: gli elementi caratterizzanti in questo senso sono la giocosità (non filologica cura del dettaglio, della corrispondenza documentaristica), l’esasperazione dei colori, l’Iperbole, l’esasperazione della violenza (pulp, spaghetti western), il pastiche (nei generi: film in costume + commedia all’italiana + neorealismo oltre ‘come visto, nel linguaggio), l’iperrealismo (medioevo ‘esagerato’, cristallizzato = significante autoreferenziale, sottolineatura della finzione delle operazioni di messa-in-forma), la scomposizione della sequenza lineare in una successione di ‘exempla’. 153 W. Hildesheimer, Mozart, Rizzoli, Milano 1982, p.243. 154 Lorenzo da Ponte, Memorie, I-II, Gallone, Milano 1998. http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/da_ponte/memorie/pdf/ memori_p.pdf, p 67 155 S. Sadie, in Don Giovanni, Deutsche Grammophon, Hamburg 1967. 156 Arturo Graf, Lezione inaugurale, in Guillen, cit., p. 27. 157 Claudio Guillén, L’uno e il molteplice, Il Mulino, Bologna 2008, p.15. 158 W. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino 1966. 159 W. Hildesheimer, Mozart, cit., p.168. 160 Tragicommedia in DEUMM, Dizionario enciclopedico della musica e dei musicisti, Utet, Torino 2005. 161 Ibidem. 162 Leopardi, Operette morali, Garzanti, Milano 2004. 163 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, Bollati Boringhieri, Torino, 2002; L’Io e l’Es e altri scritti 1917-1923, Bollati Boringhieri, Torino 2006. 164 W. Mozart, Tutti i libretti d’opera, I-II, Newton Compton, Roma 1996. 165 Th. W. Adorno, Klemperers Don Giovanni, in “Sueddeutsche Zeitung”, 24. II. 1967. 166 Hilesheimer, Mozart, cit., p. 247 167 G. B. Shaw, Uomo e superuomo, Mondadori 1957. 168 Hildesheimer, Mozart, cit., p. 247. 169 M. Domenichelli, Il canone letterario europeo, in XXI Secolo, Treccani 2009. 170 N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 1971. F. Brezzi, Dizionario dei termini e dei concetti filosofici, Newton Compton, 227 Roma 1995. T. Ariemma, Fenomenologia dell’estremo. Heidegger, Rilke, Cézanne, Mimesis, Milano 2005. 171 G. Agamben, Il sacramento del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 12. 172 E “di dispositivi legislativi che cercano ostinatamente di legiferare su ogni aspetto di quella vita su cui sembrano non avere più alcuna presa” (ib., p. 96-97). 173 Ib., p. 98 174 R. Rocchi, Come fare Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012, p. 34. 175 U. Pörksen, Parole di plastica, la neolingua di una dittatura internazionale, Textus, L’Aquila 2011. 176 J. Hillman, Forme del potere, Garzanti, Milano 1996. 177 E. Pulcini, L’individuo senza passioni, Boringhieri, Torino 2001. 178 U. Curi, Miti d’amore, Bompiani, Milano 2009. 179 S. Kierkegaard, Enten-Eller, Adelphi, Milano 1981, p.163. 180 J. Kristeva, Sole nero, Feltrinelli, Milano 1988. 181 Z. Bauman, la solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000, p. 28. 182 C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Milano, Feltrinelli, 1985, p.24. 183 Ippolito, Confutazione, 9, 9, 4 in G. Colli, La sapienza greca, III, Adelphi, Milano 1993, p. 35. 184 J.Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Torino 1946. 185 La parola ‘azzardo’ dal francese hasard deriva dal termine arabo zahr con cui si designava il ‘dado’. 186 R. Caillois, I giochi e gli uomini - la maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 1981. 187 Ib., p. 36. 188 E. Fink, L’oasi della gioia, Idee per una ontologia del gioco, Ed. 10/17, Salerno 1986. 228 189 Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma 1971, pp. 102-103. 190 M. Nussbaum, Non per profitto, Il Mulino, Bologna 2011, p. 116. 191 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 2008, p. 195. 192 D. Bolelli, Per un cuore da guerriero – le arti marziali, la filosofia e Bruce Lee, Add, Torino 2013, p. 9. 193 Ib., p. 31. 194 H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna 1991, p. 63. 195 U. Pörksen, Parole di plastica, cit., p. 132. 196 M. Niola, Miti d’oggi, Bompiani, Milano 2012, p. 82. 197 Omero, Odissea, Mondadori, Milano 1991, vv. 206-209. 198 U. Curi, Straniero, Cortina, Milano 2010, p. 80. 199 La Sacra Bibbia, Vangelo secondo Matteo, Edizioni Paoline, Milano 1987, cap. 25, vv. 35-36. 200 E. Giancotti Boscherini, Baruch Spinoza 1632-1677. Dichiarazione rabbinica autentica datata 27 luglio 1656 e firmata da Rabbi Saul Levi Morteira ed altri, Editori Riuniti, Roma 1985, p.13 e ss. 201 R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, Milano 2006. 202 Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 1999, p. 70. 203 A. Zamperini, L’indifferenza, Einaudi, Torino 2007, p. 8. 204 R. Esposito, Intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, 3 gennaio 2007 205 Jabès, Il libro dell’ospitalità, Cortina, Milano 1991, p. 80. 206 N. Barile, La mentalità neototalitaria, Feltrinelli, Milano 2008, p. 104. 207 Z. Bauman, La società dell’incertezza, cit. pp. 40-41. 208 U. Pörksen, Parole di plastica, cit., p. 113. 209 210 Esposito, partendo dall’etimologia del termine communitas, cum munus, ha capovolto l’interpretazione classica della comunità, intesa come piccola patria, come un pieno da difendere, mostrando che essa è un vuoto, un dono nei confronti degli altri: R. Esposito, Communitas, Einaudi, Torino 2006. 229 211 S. Natoli, Il buon uso del mondo, Mondadori, Milano 2010, p. 4. 212 L’espressione ‘macchine desideranti’ si trova in un famoso libro degli inizi degli anni Settanta di Deleuze e Guattari: L’Anti-Edipo. I due filosofi francesi criticano la posizione freudiana, accusandola di prevaricazione in difesa del capitalismo, ed esaltano la capacità eversiva del desiderio deterritorializzato. Qui, invece, parliamo di macchine desideranti funzionali al sistema. 213 S. Natoli, Il buon uso del mondo, cit., p. 142. 214 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990, Prefazione, p. XXVII. 215 F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 178. 216 I presocratici, Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1969, I, p., 220. 217 L. Wittgenstein, Della certezza, Einaudi, Torino 1969, p. 19. 218 Gli archetipi sono per Jung rappresentazioni mentali primarie, o meglio possibilità di rappresentazioni primarie che appartengono all’inconscio collettivo. Sono forme presenti nella psiche come un’eredità genetica. Si manifestano, attraverso immagini simboliche presenti in ogni periodo della storia e in tutte le culture, nei miti, nelle favole, nei sogni. 219 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1993, p. 129. 230 BI BLIOGRAF IA N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 1971 H. Abert, Mozart - La maturità 1783-1791, Il Saggiatore, Milano 1985 Th. W. Adorno, Klemperers Don Giovanni, in “Sueddeutsche Zeitung”, 24 II 1967 G. Agamben, Il sacramento del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2008 A. Albertini, Mozart -la vita, le opere-, Fratelli Bocca editori, Milano 1946 T. Ariemma, Fenomenologia dell’estremo. Heidegger, Rilke, Cézanne, Milano, Mimesis, Milano 2005 Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2002 L. Ariosto, Orlando furioso, Einaudi, Torino 1992 M. Augé, Rovine e macerie, Bollati Boringhieri, Torino 2004 M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Riso,carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1979 N. Barile, La mentalità neototalitaria, Feltrinelli, Milano 2008 R. Barthes S/Z, Einaudi, Torino 1981 G. Bataille, La parte maledetta, Bollati Boringhieri, Torino 2003 Z. Bauman, la solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000 Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 1999 Z. Bauman, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 Z.Bauman, La decadenza degli intellettuali, Da legislatori a interpreti, Bollati Boringhieri, Torino 1992 Z. Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, Il Mulino, Bologna 2012 D. Bolelli, Per un cuore da guerriero. Le arti marziali, la filosofia e Bruce Lee, Add edizioni, Torino 2013 F. Brezzi, Dizionario dei termini e dei concetti filosofici, Newton Compton, Roma 1995 231 I. . Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1993 J. Campbell, L’eroe dai mille volti, Guanda, Milano 2008 R. Caillois, I giochi e gli uomini - la maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 1981 E. Cassirer Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze1961 G. Colli, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1993 U. Curi, Miti d’amore, Bompiani, Milano 2009 U. Curi, Straniero, R. Cortina, Milano 2010 L. da Ponte, Memorie e altri scritti, Longanesi, Milano 1971 L. da Ponte, Memorie. Libretti mozartiani: Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Milano, Garzanti 1976 L. da Ponte, Memorie, Gallone, Milano 1998 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 2008 R. De Monticelli, La novità di ognuno, Garzanti, Milano 2009 G. Deleuze e F. Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 1975 R. de Beaugrande e W.U. Dressler, Introduzione alla linguistica testuale, Il Mulino, Bologna 1984 J. Dent, Il teatro di Mozart, Rusconi, Milano 1979 R. Esposito, Communitas, Einaudi, Torino 2006 R. Esposito, Immunitas, Einaudi, Torino 2002 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976 M. Foucault, La cura di sé, Feltrinelli, Milano 1985 M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2003 E. Fink, L’oasi della gioia, Idee per una ontologia del gioco, Ed. 10/17, Salerno 1986 S. Freud, Opere, Boringhieri, Torino 1968-1993 F. Furedi, Il nuovo conformismo, Feltrinelli, Milano 2005 U. Galimberti, La casa di psiche, Feltrinelli, Milano 2005 U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano 2007 U. Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano 2010 232 R. Girard, Menzogna romantica e realtà romanzesca. Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita. Bompiani, Milano 1965 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980 E: Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969 P. Hadot, La filosofia come modo di vivere, Einaudi, Torino 2008 W. Hildesheimer, Mozart, Rizzoli, Milano 1982 J. Hillman, Forme del potere, Garzanti, Milano 1996 J. Hillman, Re-visione della psicologia, Adelphi, Milano 1983 J. V. Hocquard, Mozart, Mondadori, Milano 1960 J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Torino, 1946 H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna 1991 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 P. J. Jouve, Il Don Giovanni di Mozart, Milano, Adelphi 2001 C. G. Jung, Opere, Boringhieri, Torino 1969-1993 R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, Milano 2006 S. Kierkegaard, Enten-Eller, I, Adelphi, Milano 1981 S. Kierkegaard, Don Giovanni, Milano, Rizzoli 2006 J. Kristeva, Sole nero, Feltrinelli, Milano 1988 J. Kristeva, L’avvenire di una rivolta, il Melangolo, Genova 1998 T. La Branca, Chaltron Hescon, Einaudi, Torino 1998 J. Lacan, Scritti, I-II, Einaudi, Torino 1974 C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Milano, Feltrinelli 1985 M. Livolsi, manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2000 J. Lotman La struttura del testo poetico, Mursia, Milano 1972 J. Lotman e B.Uspenskij Tipologia della cultura, Mursia, Milano 1975 N. Luhmann, La fiducia, Il Mulino, Bologna 2002 G.H.Mead, Mente sé e Società, in L.A. Coser, I maestri del pensiero 233 sociologico, Il Mulino, Bologna 1983 R. Màdera, La carta del senso, Psicologia del profondo e vita filosofica, Cortina, Milano 2012 L. Maffei,La libertà di essere diversi. Natura e cultura alla prova delle neuroscienze, Il Mulino, Bologna 2011 H. R. Maturana - F. Varela, Macchine ed esseri viventi Astrolabio, Roma 1992 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, il Saggiatore, Milano 1965 M. Mila, Lettura del Don Giovanni di Mozart, Einaudi, Torino 1988-2000 A. Minsky La società della mente, Adelphi, Milano 1989 M. Montanari, La filosofia come cura, Mursia, Milano 2012 E. Morin, Il metodo. 3.La conoscenza della conoscenza, Cortina, Milano 2007 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano 2001 W. Mozart, Tutti i libretti d’opera, Newton Compton, Roma 1996 S. Natoli, Agire nell’età del rischio, Mondadori, Milano 2010 F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Rizzoli, Milano 1985 M. Niola, Don Giovanni o della seduzione, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2006 M. Niola, Miti d’oggi, Bompiani, Milano 2012 M. Nussbaum, Non per profitto, Il Mulino, Bologna 2011 M.Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino 2004 D. Pinardi, Narrare. Dall’Odissea al mondo Ikea. Una riflessione teorica. Un manuale operativo, Paginauno, 2010 Otto Pöggeler, Il Don Giovanni di Mozart nell’estetica idealista, www.emsf. rai.it, 1992 Poggi, E. Vallora, Mozart - Signori, il catalogo è questo - dal K 1 al K 626: l’analisi ragionata di tutte le composizioni, Einaudi, Torino 1991 Popper, la società aperta e i suoi problemi, Armando, Roma 1974 U. Porksen, Parole di plastica, la neolingua di una dittatura intenazionale, Textus, L’Aquila 2011 234 E. Pulcini, L’individuo senza passioni, Bollati Boringhieri, Torino 2001 S. Regazzoni, Sfortunato il paese che non ha eroi, Salani, Milano 2012 M. Recalcati, Ritratti del desiderio, Cortina, Milano 2012 M. Recalcati Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2013 P. Roy, Ricerca per American demographics, 1996 per Anna: è un libro? Casa editrice? R. Ronchi, Come fare Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012 S. Sadie, in Don Giovanni, Deutsche Grammophon, Hamburg 1967 R. Schank Il lettore che capisce. La Nuova Italia, Firenze 992 G. Simmel, Filosofia del denaro, Utet, Torino 1984 B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, Boringhieri, Torino 1959 N.N. Taleb Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, Il Saggiatore, Milano 2008 N.N. Taleb, Antifragile. Prosperare nel disordine, Il Saggiatore, Milano 2013 F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2004 C. Vogler, Il viaggio dell’eroe. La struttura del mito ad uso degli scrittori di narrativa e di cinema, Audino, Roma 2005 Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma 1971 L. Wittgenstein, Della certezza, Einaudi, Torino 1969 A. Zamperini, L’indifferenza, Einaudi, Torino 2007 S. Žižek, Dalla tragedia alla farsa, Salani, Milano 2010 http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/da_ponte/memorie/pdf/ memori_p.pdf 235 RINGRAZIAMENTI Ringraziamo tutti i soci e gli amici de Lo Spazio di Sophia (Associazione culturale per la diffusione delle pratiche filosofiche) di Pescara per la partecipazione attiva e assidua alle attività di Caffè-Filo, Cine-Filo, Musica-Filo. Un ringraziamento particolare va a Silva Fallavollita, Presidente dell’Associazione e cara amica e collega, per il prezioso contributo offerto all’elaborazione e alla stesura del presente lavoro.
Scaricare