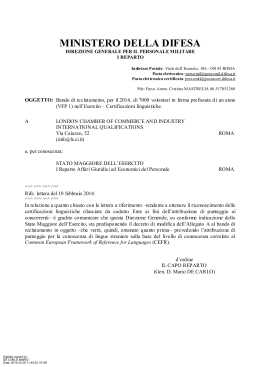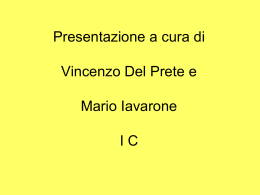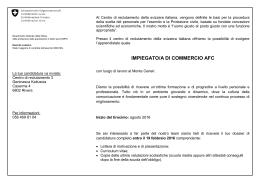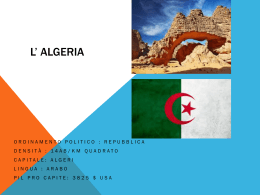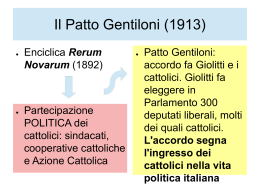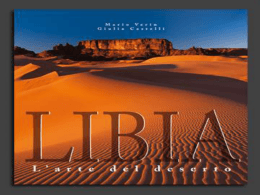Editoriale Mario Lana direttore Le rivoluzioni arabe, l’Islam, i diritti umani Venti anni fa su questa rivista salutavo come anno dei miracoli quello in cui si erano verificati due eventi straordinari: la caduta del muro di Berlino e la liberazione di Nelson Mandela. Gli eventi tragici, ma al tempo stesso esaltanti, che stiamo vivendo dall’inizio di questo 2011 ci provocano la stessa emozione ma ci stupiscono anche per la simultaneità in cui si stanno verificando con un effetto a cascata da nessuno previsto o prevedibile. Probabilmente la colpa è di noi osservatori occidentali, soprattutto europei, preoccupati di curare il proprio orticello e pervasi di una cultura eurocentrica che ci rende generalmente incapaci di percepire fenomeni così vasti e profondi come quelli che si svolgono vicino a casa nostra. Tenterò su queste pagine, così come feci venti anni fa a proposito della guerra in Iraq, di dipanare la complessa vicenda sia in sede storica che giuridica con le sole armi che abbiamo a disposizione cioè la passione di militanti di diritti umani e di “guerrieri di pace” nel mondo che ci circonda. Esaminerò, così, paese per paese all’interno del mondo arabo a noi più vicino da dove sono partiti i movimenti che hanno fatto la storia recente di quei popoli, tenendo conto anche delle analisi e di tutta la documentazione raccolta in quegli anni soprattutto mettendo a frutto le preziose opportunità colte durante i venti anni (1958-1978) di collaborazione con Lelio Basso. Parlerò anche delle utopie (sogni ed emozioni, immaginazione), delle speranze e delle delusioni che sono seguite alle varie rivoluzioni o cambiamenti fino ad oggi, cioè, alla “redenzione” dei popoli arabi che, con la ricerca della libertà e dignità di ognuno e di tutti, stanno pagando purtroppo un prezzo di sangue altissimo, soprattutto tra i giovani, che ne sono i principali protagonisti. Questa analisi mi potrebbe perfino obbligare a porre interrogativi anche inquietanti per la mia coscienza di militante dei diritti umani e di democratico. Non ne sono né preoccupato, né tantomeno spaventato, nella consapevolezza di fare appello umilmente alla coerenza di decenni e decenni di impegno civile nel nostro paese e fuori, direttamente anche nei paesi di cui parlerò. Perciò, valuterò i comportamenti dei protagonisti di queste vicende e il tipo delle società che emergeranno dal cambiamento, unicamente con il metro del rispetto dei diritti umani, pur tenendo conto che ognuno di questi paesi ha il diritto di creare una sua democrazia, anche diversa da quella di tipo occidentale, così come scriveva autorevolmente l’economista indiano Amartya Sen. “È diffusa l’abitudine di considerare la democrazia un’idea tipicamente occidentale [...] anche la storia del Medio Oriente e la storia dei musulmani contemplano moltissimi esempi di discussioni pubbliche e di forme di partecipazione politica attraverso il dialogo [...] il mondo occidentale non ha il copyright 1 sulla democrazia. Se le moderne forme istituzionali di democrazia sono ovunque relativamente recenti, la storia della democrazia, nella forma della partecipazione e del dibattito pubblico, è diffusa in tutto il mondo”. 1 Comincerò proprio dalla Libia, nella quale, mentre scrivo, divampano gli scontri per la conquista della capitale. Non so quante vite umane ancora dovranno essere sacrificate, ma l’esito della dittatura di Quadhafi potrebbe essere segnato. Non erano certo queste, le premesse della sua avventura politica, così, come tutta quella del nazionalismo arabo. Ricordo, infatti, personalità come quella di Mansur el-Kekhia, il primo Ministro degli Esteri della allora Repubblica libica, nel gennaio 1970, quando l’ho incontrato per la prima volta con il mio maestro Lelio Basso all’inizio di una esaltante esperienza professionale, umana e politica, con tutti i protagonisti di una, allora, “autentica” rivoluzione anticoloniale, liberatrice e riappropriatrice di immense risorse naturali. Si trattava di un movimento al quale partecipavano tutte le maggiori tribù libiche, le quali avevano mandato i loro figli nell’esercito, anche perché quello era l’unico modo per poter dar loro un’istruzione, dato che il colonialismo italiano aveva impedito che i libici potessero andare avanti nel corso regolare degli studi. A quell’epoca, ripeto, a partire dal gennaio 1970, si trattava di ricostruire un paese dopo il cambiamento di regime e, soprattutto, dopo la lunga parentesi coloniale non ancora del tutto superata. Mansur elKekhia non era un militare, ma un intellettuale, educato alla Sorbona, figlio del capo di una delle tribù che avevano combattuto durante la resistenza contro l’occupazione italiana. La resistenza libica aveva ricevuto un colpo durissimo nel 1931 con l’impiccagione di Omar al-Mukhtar ma, in realtà, era proseguita sino alla vigilia della seconda guerra mondiale pagando un alto tributo di sangue, con la detenzione di intere tribù in campi di concentramento nel sud del Paese. Suo padre, prima di arrendersi a Italo Balbo, aveva negoziato con gli italiani che i suoi due figli sarebbero stati educati in Europa, uno a Roma, l’altro a Parigi. Abdullatif, educato al Convitto Cavour di Roma, era nel 1971 il mio collega arabo come Vice presidente della Camera di Commercio italo-araba, fondata su incarico della Lega degli Stati Arabi. Mansur, educato a Parigi alla Sorbona, era appunto il Ministro degli Esteri della Rivoluzione libica del 1969, alla quale metteva a disposizione la sua raffinata cultura illuminista, le sue utopie. Mansur era un uomo mite, con un profilo elegante, di vastissima cultura e un senso quasi eroico del dovere che lo portava in pratica a vivere nel suo ufficio del ministero; aveva di fronte un compito arduo: ricostruire l’immagine della Libia nel mondo, proprio mentre stava avendo luogo la nazionalizzazione delle risorse petrolifere, così sottratte al controllo della British Petroleum e Texaco. La Libia era divenuta indipendente nel 1951, ma solo nel 1959 erano state scoperte le sue importanti risorse petrolifere. Prima di allora, era solo uno dei paesi più poveri del mondo. Durante gli anni sessanta, aveva attirato gli appetiti delle nazioni occidentali e il re non era stato in grado di resistere a 1 AMARTYA SEN, Identità e violenza, Bari 2006, pp. 52-56. 2 quelle pressioni. Gli inglesi, in particolare, avevano investito sempre più nelle infrastrutture e nel settore petrolifero con la loro compagnia di bandiera, la British Petroleum – Bunker Hunt. Da parte loro, gli americani avevano consolidato la base aerea di Wheelus (oggi aeroporto internazionale di Mitiga). Anche la presenza italiana pre e post coloniale rimaneva significativa. Però le ricchezza del paese rischiavano di essere sfruttate in massima parte dalle nazioni straniere. Infatti, nel 1958 il 55% del territorio libico era stato assegnato in sfruttamento a 14 compagnie petrolifere. 2 Il Re Idriss, che era anche il capo della confraternita cirenaica Senussiyya, era considerato incapace di resistere alle pressioni estere, anche se la sua figura oggi potrebbe essere riconsiderata. Il colpo di stato dei giovani ufficiali capeggiati da Moummar al-Quadhafi avvenne proprio il 1° settembre 1969, approfittando dell’assenza del Re Idriss, in Turchia per cure. In effetti, il re aveva già trattato con inglesi e americani la chiusura delle loro basi entro il 1970. Il suo maggiore limite politico era, forse, quello di non essere riuscito a conquistare completamente la lealtà della Tripolitania, dato che la sua dinastia si era consolidata soprattutto in Cirenaica, nella regione nella quale oggi i rivoltosi sono tornati a sventolare l’antica bandiera monarchica e non nascondono le loro simpatie per Muhammad al-Senussi, il quarantottenne erede al trono educato, in Inghilterra. Fu in quel periodo, che il nostro studio di diritto internazionale venne incaricato della consulenza giuridica per tutti i Ministeri, assieme alla difesa delle fonti petrolifere e alla modifica dei rapporti tra popolo libico e governi stranieri, prima di tutti quello italiano, nonché di studiare la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni provocati dalle potenze belligeranti durante la Seconda Guerra mondiale, per aver riempito di mine il suolo libico, senza avere poi né consegnate le mappe, né bonificato il terreno. Dal 1974 in poi, Mansur el-Kekhia divenne il rappresentante libico alle Nazioni Unite, fino all’inizio degli anni ottanta. Quell’incarico era, in un certo senso, la naturale prosecuzione del suo ideale nazionalistico di realizzare, insieme alla piena indipendenza del suo popolo, il riconoscimento dei suoi diritti, compreso quello al risarcimento dei danni provocati dal colonialismo. Nel frattempo, a partire dal 1975 il maggiore Quadhafi, che si era autoproclamato “colonnello”, sin dal 1° settembre 1969 (forse scimmiottando il suo maestro ideale Nasser), iniziava la sua riforma “verde”, pubblicando un libretto che reinterpretava – in chiave libica - la rivoluzione culturale cinese della “banda dei quattro”. Criticando la democrazia e il sistema elettorale, il “libro verde” prospettava la partecipazione diretta del popolo attraverso 600 Comitati popolari che, di fatto, finivano per essere gli strumenti per attuare una rapida epurazione di molte delle personalità che avevano affiancato Quadhafi durante il colpo di stato del 1969. Il “libro verde” era una singolare sintesi tra categorie socialiste - in omaggio alla sempre maggiore influenza sovietica - e strutture organizzative tribali che caratterizza, tuttora, in maniera significativa la società libica. 2 GEOFFREY LESLIE SIMONS, Libya: the struggle for survival, Basingstoke UK 1993, p. 192. 3 Secondo il rapporto sui diritti umani del 2004 del Dipartimento di Stato americano, una percentuale tra il 10 e il 20% della popolazione libica era cooptata all’interno dei Comitati popolari con attività di spionaggio nei confronti del resto della popolazione, non diversamente da quanto avveniva in Cina e in altri paesi dell’Est comunista. Nel 1980, il colonnello faceva adottare dal Consiglio del comando rivoluzionario una risoluzione in cui “l’eliminazione fisica diventa lo stadio finale della lotta rivoluzionaria”, in seguito alla quale venivano invitati tutti i dissidenti libici in esilio a tornare in patria per ricevere i suoi ammonimenti finali, oppure essere liquidati fisicamente 3 . Vittima illustre di questa politica, tra tanti altri, fu proprio il mio amico Mansur el-Kekhia. Dimessosi da rappresentante della Libia presso le Nazioni Unite, era entrato in clandestinità, divenendo un militante dei diritti umani. Ero rimasto in contatto con lui e l’avevo incontrato più volte a Londra ove operava accogliendo i rifugiati libici, in poche parole, tutti coloro che riuscivano a sottrarsi alle esecuzioni sommarie di Quadhafi. Nel 1993, mentre partecipava ad una conferenza internazionale al Cairo – in cui ci saremmo rivisti ancora una volta – come grazioso regalo di Mubarak a Quadhafi, fu rapito dai servizi segreti egiziani e portato in Libia per essere impiccato. Si può dire che, con questo episodio, in Libia si era completato il passaggio traumatico da un regime inizialmente autenticamente rivoluzionario e liberatore per il proprio popolo, a quello feroce, autoritario, corrotto e per decenni terroristico, guidato da un personaggio che lo stesso Nasser definiva “il pazzo di Tripoli”. D’altra parte, nella storia criminale dei dittatori, nessuno di loro aveva definito “ratti” i propri cittadini! Non aveva, quindi, tutti i torti Nasser a usare quella definizione a proposito del collega libico. In un volume intitolato “La verde Libia” di Quadhafi 4 , lo storico francese Pierre Rossi, ispirandosi al delirio megalomaniaco del dittatore – un uomo “narciso, refrattario alla vergogna, sopraffattore, insensibile al ridicolo” (così lo definisce Franco Cordero su La Repubblica del 6 marzo u.s.) - ricostruisce la storia della Libia nei millenni, esaltandone il ritorno al “suo apogeo rappresentato dalla stella di Cartagine”. Tanto credeva in questa pseudo ricostruzione storica Quadhafi che aveva dato il nome di Annibale ad uno dei suoi figli. Il volume, pubblicato nel 1979, contiene un attacco allo stato di diritto e al sistema politico democratico ed è una lettura consigliata a tutti gli analisti e commentatori delle vicende libiche attuali. Il capolavoro della spregiudicatezza e cinismo pseudo-rivoluzionario, Quadhafi l’aveva raggiunto verso la fine degli anni ottanta, ad esempio accrescendo smisuratamente la capacità militare terroristica dell’IRA con l’invio da Tripoli in Irlanda di almeno quattro navi cariche di armamenti moderni, tra i quali alcune tonnellate del micidiale esplosivo Semtex. Se decidessi di fare un inventario ragionieristico, potrei addirittura affermare che sono stati circa 28 i Paesi in cui il dittatore libico è intervenuto 3 4 IAN BUTTERFIELD, The Heritage Foundation, 25 novembre 1981. PIERRE ROSSI, La verte Lybie , 1979. 4 militarmente – attraverso strumenti tipicamente terroristici – per propagandare una c.d. rivoluzione, nel frattempo diventata sempre più familiare-dinastica. Posso, quindi, con assoluta tranquillità affermare che, negli anni 80, Quadhafi fu il referente del terrorismo internazionale, privilegiando rapporti, sostegno economico e militare perfino al più tristemente noto terrorista internazionale Abu Nidal (responsabile di più di 20 attentati per un totale di oltre 900 morti e feriti) e organizzatore delle stragi di Fiumicino e Vienna nel dicembre 1985. Come posso, poi, dimenticare che nel 1988, come ritorsione del bombardamento americano a Tripoli all’epoca di Ronald Reagan – che aveva l’obiettivo di eliminarlo fisicamente e nel quale fu salvato da informazioni tempestive dei servizi segreti italiani – fece esplodere un aereo della Pan Am a Lockerbie determinando centinaia di vittime? La c.d. “carriera” internazionale del dittatore che aveva portato il suo paese fino ad essere inserito nella lista dei c.d. “Paesi canaglia” e a subire pesanti sanzioni dalle Nazioni Unite capaci di danneggiare anche i suoi interessi personali, vede finalmente una svolta con un riavvicinamento all’occidente, al quale si offre come garante di una barriera contro l’integralismo islamico divampato nel mondo dopo la rivoluzione khomeinista. E’ per questo motivo, che nel 1999 le Nazioni Unite sospesero le sanzioni alla Libia e le eliminarono definitivamente nel settembre 2003. Così, nel 2004, il dittatore poté compiere una visita di Stato a Brussels, ricevuto con la massima cordialità dal Presidente della Commissione europea. Le multinazionali, in particolare, hanno trovato in lui uno strumento molto importante per operare all’interno di situazioni di crisi. La guerra dei diamanti, che sconvolse per anni il Centrafrica, fu orchestrata da rivoluzionari come Charles Taylor in Liberia e Foday Sankoh in Sierra Leone, che si erano addestrati in Libia e che da Quadhafi continuavano a ricevere aiuto. Così, dopo il riavvicinamento, le compagnie petrolifere ritornano nel paese, Halliburton e Texaco/Chevron così come la Exxon Mobil. Per gli inglesi, è stato John Brown, amministratore delegato della British Petroleum, a sdoganare il dittatore divenendone in cambio il maggiore esportatore di gas dalla Libia. Come erano lontani i tempi nei quali il regime rivoluzionario e anti coloniale libico nazionalizzava la compagnia British Petroleum provocando una reazione di tipo coloniale che il nostro studio internazionale riuscì a contrastare con una vittoria clamorosa, che è, tutt’ora, un precedente giudiziario internazionale fondamentale nel campo delle relazioni petrolifere tra Stati! D’altra parte, non si può trascurare l’importanza dell’azione che le multinazionali hanno svolto in Africa come nel resto del mondo, nel destabilizzare intere regioni in modo da poterne trarre vantaggio politico ed economico. Le multinazionali agiscono in prima battuta tramite funzionari definiti Economical hit men (EHM), il cui compito principale è quello di identificare i Paesi che possiedono le risorse utili per le loro aziende. Una volta individuati gli obiettivi, seducono, corrompono e costringono i leader locali a politiche di sfruttamento: vengono contratti prestiti che quei paesi non potranno mai ripagare, si 5 privatizzano i beni di proprietà dello Stato, si legalizza la distruzione dell’ambiente e si svendono alle multinazionali le risorse più preziose. Quando i leader di questi Paesi si oppongono, vengono messe in atto politiche intimidatorie, se non vere e proprie guerre civili 5 . Per fortuna, ci sono ancora paesi nel mondo nei quali il senso della dignità e dell’onore è più forte del denaro! Ne è esempio l’Ecuador, dove la Chevron/Texaco è stata condannata dalla Corte di Lago Agrio (Sucumbios) a pagare 8,6 miliardi di dollari a titolo di multa e altrettanti come risarcimento per i danni ambientali per oltre un ventennio di produzione petrolifera. Tra il 1970 e il 1992 sono state riversate nella foresta amazzonica 15 milioni di litri al giorno di acque contaminate. Lo sfruttamento economico delle risorse naturali non ha portato, nel frattempo, il minimo beneficio alla popolazione. Al contrario, il livello ufficiale della povertà è salito dal 50 al 70% e il debito pubblico è cresciuto da 240 milioni a 16 miliardi. Nel frattempo, la quota delle risorse nazionali distribuite alle famiglie più povere è scesa dal 10% al 6%. Grazie alla multinazionali e alla corruzione da loro incoraggiata nel cosiddetto “terzo mondo”, l’1% della famiglie ricche detiene dal 70 al 90% del patrimonio privato e delle proprietà immobiliari, la percentuale esatta varia da paese a paese. Ho indicato nel titolo di questo editoriale le rivoluzioni arabe. Entro ora a tentare di spiegare il mio punto di vista sia su quelle di 50/60 anni addietro sia su quelle recentemente in corso nel bacino del Mediterraneo. Le rivoluzioni dei paesi arabi degli anni 50/60 non furono rivolte di popolo, ma anche e soprattutto, rivolte di una borghesia che si vedeva completamente esclusa dalla possibilità di incidere nel futuro dei propri paesi e, in questi anni, nella maggioranza dei paesi arabi, la borghesia era strettamente legata all’esercito, anzi la borghesia si identificava con l’esercito. Lo stretto legame tra classe media ed esercito era appunto emersa tra i tanti temi da me affrontati durante gli incontri a Damasco svoltisi a metà degli anni sessanta con Michel Aflaq, massimo ideologo del nazionalismo arabo. Aflaq era un siriano appartenente a una famiglia greco ortodossa. La sua teoria era che i militari esprimevano la borghesia del mondo arabo, cioè una classe nuova e dinamica, chiamata a svolgere un ruolo paragonabile a quello svolto dalla prima borghesia europea nella fase delle rivoluzioni del 1848. Solo che, mentre in Europa si era combattuto per formare gli stati nazionali, i militari arabi combattevano contro il colonialismo, nella sua forma più cinica e barbara dello sfruttamento delle risorse naturali. L’esercito arabo, quindi, era l’unica forza in grado di trascinare il popolo e quindi era su di esso che si sarebbe dovuto puntare. Il partito Ba’th, ispirato da Aflaq, propugnava un’ideologia basata sull’alleanza di tutti gli Arabi, molti dei quali cristiani, in un’unica entità politica; il suo panarabismo era basato proprio sulla funzione dell’esercito come punto di congiunzione di un’intera società nella lotta contro il colonialismo. 5 Cfr. JOHN PERKINS, Confessioni di un sicario dell’economia, Roma 2010. 6 Secondo Michel, la funzione dell’esercito si rendeva necessaria anche perché lo sviluppo nel mondo arabo di una vera e propria borghesia economica e culturale era stato ostacolato per decenni dal colonialismo straniero. Tuttavia in molti casi – sempre secondo Aflaq - le rivoluzioni dell’esercito erano state tradite dai loro stessi protagonisti e, così, dal colonialismo si era passati al “colonnellismo”. Seguendo questo ragionamento e prendendolo per buono, si potrebbe spiegare perché l’odierna “primavera araba” abbia toccato, almeno finora, soprattutto paesi come la Tunisia e l’Egitto, dove l’esercito che aveva avviato il cambiamento è stato poi lentamente marginalizzato a favore delle polizie e delle strutture di controllo rivolte in maniera massiccia contro la popolazione civile. Infatti, in questi mesi, in paesi come l’Egitto e la Tunisia, l’esercito, prima, è stato neutrale, poi si è schierato con i manifestanti, contrapponendosi, appunto agli apparati polizieschi dei regimi. In Tunisia, il 7 novembre 1987 il generale Ben Ali aveva ottenuto il potere con un colpo di stato ai danni dell’eroe della resistenza tunisina, Habib Bourguiba, con l’aiuto sostanziale dei servizi segreti italiani 6 ai quali il dittatore sarà sempre riconoscente. Dopo aver conquistato quel potere Ben Alì pensò bene di marginalizzare progressivamente l’esercito, a tutto vantaggio dell’apparato di polizia, il cui organico – centoventimila uomini – fu addirittura quadruplicato negli ultimi 20 anni, mentre invece, l’esercito, si è ridotto a sole 35 unità, nella quasi totalità fanteria, male equipaggiato e sottodimensionato. D’altra parte, Ben Alì non si fidava dei suoi stessi ex colleghi dell’esercito al punto che nell’aprile del 2002, tutti e tredici i membri dello Stato maggiore delle forze terrestri morivano in un misterioso incidente d’elicottero 7 . Hosni Mubarak ha vissuto una parabola analoga: ha avviato la carriera politica come comandante delle forze aeree egiziane, divenendo nel 1975 vice presidente e successivamente, presidente della repubblica egiziana, nel 1981, dopo l’assassinio di Sadat, al quale pare non sia stato del tutto estraneo il leader libico Quadhafi. Tuttavia, già a metà degli anni novanta, la sua immagine politica era in crisi e la sua sopravvivenza al potere fu affidata al permanere di una dura macchina repressiva. Infatti, la legge d’emergenza approntata da Nasser nel 1958, all’epoca del tentativo di unione con la Siria, era stata rimessa in vigore da Mubarak nel 1986 dopo l’assassinio di Sadat e, poi, rinnovata ogni tre anni ininterrottamente fino ad oggi: ogni attività politica non governativa veniva di fatto sospesa, soprattutto le manifestazioni pubbliche. In tutti questi anni la polizia ha così potuto arrestare e detenere chiunque, senza che fosse necessario formulare accuse, e per un periodo imprecisato di tempo: la conseguenza è stata che i prigionieri politici si contano a decine di migliaia. Ancora nel 2006, Mubarak aveva promesso di sospendere la legge d’emergenza senza, poi, mantenere l’impegno assunto pubblicamente. La mancanza di reale pluralismo politico è, forse, tra le cause principali della rivolta odierna con la diffusione della “primavera araba” e della caduta dei regimi, in Egitto come altrove. 6 CARLO CHIANURA, L'Italia dietro il golpe in Tunisia. L'ammiraglio Martini: Craxi e Andreotti ordinarono al Sismi di agire, La Repubblica, 10 ottobre 1999. 7 SAMY GHORBAL, Rachid Ammar, homme fort de la Tunisie: “L'armée ne tire pas”, Rue 89, 16 gennaio 2011. 7 Affrontando questo problema in sede storica, osservo che, ad esempio, in Egitto la borghesia è rimasta schiacciata prima dalla presenza inglese, poi, è stata compressa tra la vecchia classe politica dei proprietari terrieri e la massa dei burocrati di Stato. Per questo motivo, il governo cosiddetto “liberale” che aveva guidato il paese tra il 1922 al 1952 non aveva potuto esprimere una classe politica indipendente. Dopo il colpo di stato militare contro il Re Farouk, promosso dal generale Naguib nel 1952 e soprattutto con l’avvento del colonnello Nasser al potere nel 1954, l’Egitto aveva conosciuto un momento di grande fermento, durante il quale si è verificata una generale redistribuzione della ricchezza e parzialmente avviata la partecipazione di nuove classi sociali alla vita pubblica. Secondo statistiche internazionali, l’indice di distribuzione della ricchezza è stato particolarmente positivo nel 1975 ma, all’inizio del XXI secolo, ritorna ai livelli della fase pre-rivoluzionaria. In conclusione, il periodo nasseriano, in considerazione del vasto consenso popolare di cui godeva, può essere realmente visto come la piena realizzazione delle teorie di Aflaq, mentre altrettanto non si può dire dell’epoca governata da Mubarak. Nel tradimento degli ideali nasseriani si potrebbe, forse, ritrovare una delle tante ragioni di fondo delle “primavere” arabe che stanno caratterizzando questo secondo decennio del XXI secolo. In tal senso, l’Algeria sembra collocarsi come una eccezione, per cui almeno per ora, è stata solo sfiorata dal movimento riformista. Ci sono precisi motivi sociali per cui la manifestazione svoltosi ad Algeri il 12 febbraio u.s. non ha avuto il seguito che c’è stato in altri paesi. Gli scontri che avevano visto i giovani di Algeri scendere in piazza già il 6 gennaio scorso erano probabilmente dovuti a un problema grave, ma circoscritto, come quello dell’aumento dei prezzi di alcuni generi di prima necessità. Alcuni generi di base come zucchero e olio avevano subito notevoli aumenti, tanto che il ministro del Commercio, Mustapha Benbada, si era affrettato ad affermare che gli aumenti erano dovuti non solo alla crisi economica internazionale, ma anche e soprattutto ai produttori e ai distributori locali che pretendevano margini di profitto “esagerati”. Ricordo che l’Algeria è stato il primo paese arabo ad essere colonizzato, già nel lontano 1830. La presenza coloniale francese, inoltre, è stata molto dura e repressiva e si è protratta molto più a lungo che in altri paesi arabi. Tuttavia, al momento dell’indipendenza, nel 1962, l’Algeria aveva una classe politica più sviluppata che altrove, compreso l’Egitto, educata sia nelle scuole occidentali, sia in quelle islamiche. I due presidenti delle maggiori associazioni religiose della prima metà del XX secolo avevano ricevuto un’ottima educazione: Ben Badis aveva studiato all’università islamica di al-Zaytuna di Tunisi e el-Hafidhi in quella di al-Azhar del Cairo. Inoltre l’Algeria possedeva un buon numero di strutture educative indipendenti dalla Francia: nel 1954 erano attive più di 110 scuole frequentate da circa 20 mila studenti, dove si sono formati buona parte dei quadri politici responsabili del movimento d’indipendenza degli anni successivi. A questi si univano quelli che avevano studiato in Francia, 8 componendo così un quadro culturale particolarmente ricco. Si trattava, naturalmente, di una élite, la maggior parte della popolazione essendo completamente analfabeta. Il passaggio immediatamente conseguente alla proclamazione dell’indipendenza, frutto da un lato di una lotta popolare nelle città e, dall’altro, dell’avanzata vittoriosa dell’esercito popolare guidato dal generale Houari Bouméedienne, che aveva già liberato una parte del paese, si concluse in un primo momento con il tentativo di Ben Bella, primo presidente nominato nel 1963, di esautorare l’esercito con l’instaurazione di un regime ispirato a modelli sovietici sia nella gestione centralizzata del partito, sia soprattutto nella rigida pianificazione della gestione economica. Il disastro economico che ne è seguito consentì a Houari Boumédienne, con il colpo di Stato del giugno 1965, nella sua qualità, appunto, di capo dell’esercito popolare e di leader dell’FNL (Fronte Nazionale di Liberazione), di consegnare il potere ai militari, forti anche di un solido appoggio popolare. Così, per i decenni successivi Boumédienne è rimasto il garante della repubblica nata dalla resistenza contro il colonialismo e, al tempo stesso, garante dell’autonomia del suo Paese rispetto all’influenza delle multinazionali. A questo proposito, non c’è bisogno di ricordare il ruolo che aveva giocato Enrico Mattei con l’ENI, pagato con la vita, a sostegno della guerra di liberazione algerina. E’ difficile negare, accanto ai gravi errori nel settore dell’industrializzazione pubblica, ripeto, attribuibili soprattutto all’influenza ideologica dell’URSS, che le ricchezze provenienti dagli idrocarburi siano state meglio distribuite che in altri paesi arabi ricchi di petrolio. Posso, così, affermare che, almeno fino al 1995 (unico periodo in cui si hanno dati statistici), il coefficiente di ineguaglianza nella distribuzione delle ricchezze è diminuito, mentre nel resto del nord Africa è aumentato o, quanto meno, rimasto stabile 8 . L’Algeria, inoltre, è stato il primo paese a prendere la strada del pluripartitismo, con la costituzione del 1989, anche se poi ha dovuto fare i conti con il parallelo sviluppo del fondamentalismo islamico. Devo dire che ho provato una certa emozione rileggendo, in questi giorni, la Costituzione algerina, che all’art. 29, sull’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e sul compito della repubblica di rinnovare tutti gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione concreta, riecheggia – quasi con le stesse parole – il primo capoverso dell’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, scritto, com’è noto, da Lelio Basso, relatore ad hoc nella commissione dei 75 padri fondatori della nostra repubblica. Detto questo, non si può certo dire che nell’Algeria di oggi siano tutte rose e fiori. Al contrario, la reale situazione sociale ed economica del paese, emerge in tutti i suoi aspetti contraddittori e purtroppo negativi in un recente rapporto della FIDH 9 . Senza, poi, dimenticare che anche all’interno delle istituzioni vicine al regime sono emerse di recente critiche al tempo stesso spietate e liberatorie. Ne è 8 9 UNU-WIDER World Income Inequality Database, Version 2.0c, May 2008. Algérie. La “mal-vie”: rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en Algérie, n. 541f, maggio 2010. 9 testimonianza l’intervista alla prestigiosa e antica rivista Jeune Afrique 10 resa dal collega Farouk Ksentini, Presidente della Commissione nazionale consultativa per i diritti umani. In questa intervista dal titolo emblematico “Le sette piaghe dell’Algeria”, si anticipano puramente e semplicemente le critiche al regime contenute nel rapporto annuale al Capo dello Stato, a nome appunto della Commissione presieduta da Ksentini. Voglio tuttavia ricordare di aver constatato, nei venticinque anni che sono stato al loro fianco soprattutto nei momenti più bui e tragici del terrorismo fanatico, durante il quale ho pianto la perdita di tanti amici, sia protagonisti della resistenza contro i francesi, sia militanti dei diritti umani (cito per tutti Mohamed Farrah, eroe della resistenza, e Youcef Fathallah, Presidente della Lega algerina dei diritti umani) – da parte dei colleghi giuristi algerini membri di quell’organismo un impegno civile e una “voglia” di democrazia, riscontrati in pochi paesi arabi. Posso anche testimoniare che al processo svolto ad Algeri due anni fa contro il collega Amine Sidhoum - assistevo come osservatore giudiziario internazionale su incarico della FIDH e di altre note organizzazioni dei diritti umani - la sala di udienza era stracolma di avvocati solidali con lui, mentre il collegio di difesa vedeva, tra gli altri, oltre al Presidente dell’Ordine, lo stesso Ksentini, presidente di una associazione per i diritti umani autorevole ma tanto poco indipendente da essere “attaché à la Présidence de la République”. Devo, così, riconoscere che quel processo non è stato molto lontano dal modello di “giusto processo” come noi lo intendiamo e non mi risulta che, poi, i colleghi avvocati presenti in aula siano stati perseguitati così come è successo più volte, ad esempio, in Tunisia, prima della rivoluzione del gennaio u.s. Per capire il quadro in cui si collocavano le rivoluzioni arabe degli anni 50-60, ma anche per tentare di prevedere l’esito di quelle odierne - con una certa approssimazione qualificate da molti osservatori come quelli dei “giovani del web” - se siano o no condizionate, o almeno fino a che punto, dal pericolo dell’integralismo islamico, ritengo opportuno fare una riflessione anche sui rapporti tra religione e vita pubblica, molto forti nel nord Africa, così come in altri paesi islamici. La dottrina islamica non prescrive una particolare forma di governo. Lo stesso califfato, fino alla sua estinzione nel 1924, ha conosciuto forme e strutture molto diverse nel corso dei secoli. La democrazia, quindi, non solo non sarebbe esclusa, ma, in un certo senso raccomandata, quanto meno sotto l’aspetto della “consultazione pubblica”, shura. Tuttavia, parallelamente alla soppressione del califfato, nascevano nel mondo islamico i movimenti fondamentalisti, soprattutto quello dei Fratelli Musulmani, fondato da Hasan al-Banna (1906-1949) nel 1929, in Egitto. L’ideologia della Fratellanza, così come quella dei molti movimenti e partiti che nel corso del XX secolo le si sono ispirati, non è mai stata ben definita, suscettibile così di numerose e diverse interpretazioni. Infatti, Hasan al-Banna promuoveva una sorta di “socialismo islamico”, più attento agli aspetti politici che a quelli religiosi. Il discorso della Fratellanza 10 Jeune Afrique, n. 2606, 19-25 dicembre 2010, pag. 40 e ss. 10 assumeva un carattere più apertamente “religioso”, solo con Sayyd Qutb (1906-1966), vicino ai Liberi Ufficiali che avevano operato il colpo di stato del 1952 e più apertamente ispirato al fondamentalismo protestante, che aveva potuto conoscere durante il suo soggiorno negli Stati Uniti (1948-1950). La strumentalizzazione politica della religione sarebbe, quindi, un aspetto del tutto nuovo nella storia dei popoli islamici, mai del tutto condivisa dalla maggior parte degli intellettuali e dei rappresentanti ufficiali, anche quando i Fratelli Musulmani sono cominciati a proporsi come movimento di massa, a partire dagli anni settanta. L’ispirazione religiosa alla giustizia e alla libertà ha animato fortemente le rivolte di questi giorni che sembrano scandite dalle parole Allahu Akbar, “Iddio è il più grande”, come si può sentire in tutti i messaggi audio e video che provengono dai luoghi degli scontri. Non sono solo le parole della liturgia islamica, ma anche quelle che venivano ripetute in occasione dell’insediamento dei governanti arabi, come monito contro l’arroganza e la presunzione, contro i pericoli della vanagloria e della esaltazione personali. Tanto l’Islam è pluralista dal punto di vista religioso e giuridico – almeno quattro sono le diverse prospettive “ortodosse” sul diritto – quanto il fondamentalismo è esclusivista nei confronti delle altre religioni e persino in quello degli stessi musulmani che non sposano le dottrine radicali. Sono state proprio queste ultime tra le cause principali dello sviluppo dell’integralismo nei paesi arabi, come è evidente nel caso dell’Algeria. Ricordo che, insieme alla corruzione diffusa era stata l’austerità, resasi necessaria durante gli anni ottanta per far fronte al forte indebitamento esterno e al fallimento delle politiche di industrializzazione di Stato ad esasperare la popolazione, a consentire al FIS (Fronte Islamico di Salvezza) espressione della Fratellanza nel Nord Africa, di intercettare tale malcontento e di vincere le elezioni amministrative del 1990 e il primo turno delle politiche del 1991 con l’obiettivo dichiarato di cambiare radicalmente l’ordinamento repubblicano e la stessa vita pubblica del paese, seguendo il modello iraniano. Nei mesi che seguirono al mancato svolgimento del secondo turno delle elezioni politiche, si aprì una gravissima crisi: da un lato, c’era chi sosteneva che al primo turno elettorale, tenendo conto del 52% delle astensioni e del 16% delle schede nulle, in realtà soltanto il 26% del corpo elettorale aveva votato per il FIS e, quindi, questo partito non avrebbe vinto e tantomeno avuto diritto di cambiare il Paese; dall’altro, i dirigenti del FIS che, in un delirio di “purificazione etnica”, affermavano che “se occorre uccidere due milioni di algerini per purificare la società, allora ne uccideremo due milioni” non avendo scrupolo a passare dalle parole ai fatti, con lo sgozzamento di tutti coloro che non erano d’accordo con loro. In questa situazione drammatica, il Presidente Chadli Benjedid si dimise e il Paese fu costretto a richiamare dall’esilio in Marocco Mohamed Boudiaf, uno tra i più prestigiosi capi della guerra di liberazione. Il suo primo provvedimento di “salute pubblica” fu quello di decretare lo stato di 11 Dell’Alto Comitato faceva parte anche Ali Haroun (già Capo della resistenza algerina in Francia e giurista raffinato noto a livello internazionale), nominato poi Ministro dei diritti umani nel governo presieduto da Sid Ahmed Ghozali, considerato anche lui una “riserva della repubblica” per il suo passato politico e di governo dopo il 1963. Ali Haroun ci ha rilasciato ad Algeri una recente e illuminante intervista, nella quale lamentava il fatto che “per più di un decennio l’Algeria, messa praticamente sotto embargo, è stata lasciata sola a combattere il terrorismo islamista” 11 . Tuttavia, il testimone più credibile e autentico di quegli avvenimenti, rimane senza alcun dubbio proprio Sid Ahmed Ghozali, premier di quel governo di “salute pubblica”, che li ha descritti in un libro che mi ha illustrato in un recente incontro ad Algeri 12 . Nel giugno dello stesso anno, il Presidente Boudiaf veniva assassinato dalla sua stessa guardia del corpo infiltrata dagli integralisti islamici. Si apriva, così, un decennio di guerra civile animato dall’ala militare del FIS, il GIA (Gruppo Islamico Armato). Molte cose tuttavia restano da chiarire riguardo a quel periodo torbido, non ultimo, come sia stato possibile per circa ventimila miliziani che avevano combattuto in Afghanistan arrivare in Algeria e scatenare una guerra civile costata più di centomila morti. Sicuramente vi sono responsabilità anche da parte di alcuni paesi stranieri tanto che, nel 1993, l’Algeria ruppe le relazioni diplomatiche con l’Iran e con il Sudan, con l’accusa di sostenere i terroristi islamici. Il “pericolo” islamista di cui si parla in questi giorni come possibile conseguenza delle rivoluzioni in Tunisia ed Egitto e fatto proprio, guarda caso da Quadhafi, sembra, però, del tutto fuori luogo. La “primavera araba”, infatti, non è assolutamente appannaggio di alcuni gruppi radicali, ma rappresenta un vasto movimento di popolo, sopratutto di giovani. Sono loro, oggi, la nuova forza sociale che anima il mondo arabo, la nuova borghesia, colta, preparata, in grado di utilizzare i mass media e gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal web che si riconosce nelle radici tradizionali islamiche, ma al tempo stesso considera il governo della cosa pubblica come una realtà fondata sulla giustizia e sulla dignità dell’uomo. Gli stessi Fratelli Musulmani, pur “moderati” rispetto ad altre formazioni integraliste, durante le elezioni del 2005 non avevano raccolto più del 20% dei seggi e anche i più recenti sondaggi non attribuiscono loro una quota tanto maggiore di elettorato 13 . Quindi, non è un caso se le recenti osservazioni della Commissione egiziana per le riforme costituzionali, incaricata di portare il paese alle elezioni libere, si siano concentrate sulla limitazione delle prerogative presidenziali, impedendo anche la creazione di corpi speciali di polizia, e sulle condizioni di eleggibilità dei candidati, ma lasciando inalterato l’art. 5 della Costituzione che limita la possibilità di In questa rivista, n. 3/2009, p. 79. SID AHMED GHOZALI, Question d’Etat. Changer on disparaître, 2009. 13 SCOTT ATRAN, Egypt’s Bumbling Brotherhood, The New York Times, 2 febbraio 2011. 11 12 12 creazione di partiti “religiosi”. Mentre l’articolo 2 - il quale recita che “L’islam è la religione dello stato, l’arabo e la sua lingua ufficiale, la shari`a è la fonte principale della sua legislazione” - non viene percepito come ostacolo alla democrazia, ma anzi garanzia di un pluralismo che proprio la tradizione islamica, ripulita dalle interpretazioni radicali moderne, incoraggia e tutela. E’ bene sottolineare che la “primavera araba” ha colto di sorpresa non solo gli osservatori esterni, ma gli stessi antichi protagonisti della scena politica nel Nord Africa. Infatti, non solo i partiti tradizionali ma anche gli stessi Fratelli Musulmani si sono fatti trovare spiazzati da un numero crescente di giovani arabi sempre più determinati, colti e in grado di usare i mezzi di comunicazione moderni. Alcuni dati demografici devono far riflettere. Gli over 65 sono il 7,3% della popolazione in Tunisia, il 4,3% in Egitto, il 4,4% in Libia. In Italia, per fare un confronto, sono più del 20%. Il Nord Africa è giovane e dinamico, molto di più della maggior parte dei paesi europei. Sono questi giovani ad aver preso il testimone delle rivoluzioni che nei decenni precedenti erano state compiute dai militari. Lo hanno potuto fare, in primo luogo, costruendo una rete di solidarietà estesa a tutto il mondo arabo, in secondo luogo con la loro capacità di trascinare con se tutta una popolazione oppressa e impoverita dai regimi dittatoriali. E’ così che sono stati capaci, per la prima volta nella storia dei Paesi arabi, di realizzare una sintesi tra diritti umani e diritti dei popoli. Com’è noto, infatti, la società araba è ancora in parte attraversata dalle segmentazioni in clan, tribù e famiglie che non sempre riconoscono la centralità dell’individuo, così come è avvenuto storicamente nel mondo occidentale. Questo spiegherebbe in parte il diverso approccio ai diritti umani. Con la discesa in campo, i giovani arabi oggi rivendicano la libertà degli individui e la dignità dell’uomo, prima ancora che l’appartenenza alla nazione. Al tempo stesso, sono stati protagonisti assoluti dei diritti dei popoli sanciti nella Carta di Algeri del 1976, il cui preambolo è ancora di straordinaria attualità: “Noi viviamo tempi di grandi speranze, ma anche di profonde inquietudini - tempi pieni di conflitti e di contraddizioni;tempi in cui le lotte di liberazione hanno fatto insorgere i popoli del mondo contro le strutture nazionali e internazionali dell’imperialismo e sono riusciti a rovesciare i sistemi coloniali. Ma questi sono anche tempi di frustrazioni e di sconfitte, in cui nuove forme di imperialismo si manifestano per opprimere e sfruttare i popoli”. Questa sintesi tra diritti umani e diritti dei popoli realizzata dalla “primavera araba” sono convinto sia la vera novità assoluta con cui si dovrà fare i conti in futuro e sulla quale intendo tornare a esprimermi anche nei prossimi mesi in modo più approfondito. Avevo detto all’inizio, che avrei valutato con il metro dei diritti umani il tipo di società che sarebbero emerse dal cambiamento innescato dalla “primavera araba”. Cercherò, quindi, di esorcizzare i possibili esiti negativi di quest’ultima, ricordando i moti europei del 1848 che, purtroppo, fallirono provocando una restaurazione degli imperi centrali e un rinnovato slancio coloniale. La mia preoccupazione è infatti che, dietro l’attenzione della maggior parte dei Paesi che hanno partecipato alle decisioni adottate dal 13 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si possano celare quegli stessi interessi economici e finanziari che da sempre hanno condizionato la storia del popoli. Se c’è una speranza di futuro concreto e irreversibile cambiamento nei paesi arabi, questa è legata alle realizzazioni dei “presupposti” che ne stanno alla base. Mi riferisco al contenuto dell’appello lanciato il 12 febbraio a Parigi dal Forum mondiale delle organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti umani per l’Egitto (ma potrebbe valere anche per la Tunisia oggi e per la Libia, speriamo, domani). Questo elenco va dalla gestione degli affari del paese condivisa tra esercito e organismi civili, allo scioglimento oltre che del Parlamento anche del Consiglio della Shura e dei consigli locali, fino ad oggi strumento di potere elettorale di Mubarak; dallo scioglimento dei servizi segreti, alla gestione del Ministero degli interni affidata ai civili; dal ristabilimento di tutte le libertà pubbliche (di associazione di stampa, di creare partiti e sindacati liberi); a una nuova costituzione che stabilisca uno stato di diritto e di pieno rispetto per i diritti umani. Come militante dei diritti umani, se è vera la mia analisi sulle rivoluzioni negli anni 60/70 dei militari arabi, mi attendo da loro, oggi, nell’interesse dei rispettivi paesi, la massima collaborazione ai protagonisti odierni della “primavera araba”. Questo sarà possibile se le parole democrazia e libertà non avranno subìto quel “furto della parola” come dubita Gianrico Carofiglio nel suo bellissimo libro, intitolato, appunto La manomissione delle parole 14 . Tornando alla Libia, dinanzi al sangue che viene versato nelle strade e nelle piazze di Tripoli, mentre osservo in TV scorrere le immagini dei carri armati nella capitale, ci assale un interrogativo angoscioso, al quale non sono capace, almeno in questo momento, di dare una risposta esauriente. Perché la ricetta che ha funzionato in Egitto e Tunisia - cioè che a sparare sulla popolazione che protestava e chiedeva il cambiamento di regime siano stati gli apparati polizieschi, mentre l’esercito, prima si è mantenuto neutrale, poi si è addirittura schierato con i manifestanti e, da oggi, è in qualche modo “garante” del cambiamento - invece non funziona in Libia dove l’esercito - almeno finora - sta col regime? Cosa c’è, se c’è, di diverso in questo Paese arabo, rispetto agli altri? A questo punto, non è forse opportuno da parte della comunità internazionale - in coerenza con le sanzioni già adottate e col deferimento alla Corte penale internazionale del dittatore - accogliere con urgenza l’appello drammatico che viene da chi si è ribellato e, ora, combatte ad armi impari contro un esercito super accessoriato da strumenti di morte forniti in gran parte dall’Italia? Se questo intervento non si verificasse, o si verificasse in ritardo, sarebbe legittimo interrogarsi sul perché dei “due pesi e due misure”: in Europa, oltre Adriatico, sì, perché, in fondo, siamo tutti europei, in Libia, invece, no, perché sono africani e si è impauriti per l’onda migratoria che potrebbe venire dai paesi del sud, cioè dai “dannati della terra”. 14 GIANRICO CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, 2010. 14 Cos’ha Quadhafi che Milosevic non aveva? Se la risposta cinica fosse: il petrolio, dovrei ancora una volta - come scrissi a proposito della guerra del Golfo (n. 2) - concludere sconsolatamente che i diritti umani per la comunità internazionale sono soltanto un optional, da usare quando fa comodo per scaricare la coscienza! Ma c’è un elemento che a partire dal Consiglio di sicurezza ONU i responsabili dei governi europei dovrebbero considerare: cosa altro è, se non una “pulizia etnica” quella che viene esercitata dai militari della tribù meglio armata, perché quella del dittatore, nei confronti delle altre tribù soprattutto della Cirenaica? E se un giorno le truppe del dittatore usassero addirittura le armi chimiche che tuttora probabilmente detengono (secondo l’Agenzia di Vienna AIEA), nonostante gli impegni internazionali assunti dalla Libia nel 2003, dove sarebbe la differenza tra Quadhafi (che già le aveva usate nel 1986 nella guerra con il Ciad) e Saddam Hussein che quelle armi di distruzione di massa usò contro i curdi nel 1988? Mi avvio alla conclusione, riallacciandomi al percorso storico delineato in partenza (evoluzione e poi involuzione) delle rivoluzioni arabe nel Mediterraneo, quelle che Joaquin Navarro-Valls ha definito su La Repubblica del 3 marzo u.s. “la metamorfosi dei dittatori”, e la “conversione progressiva della forza democratica iniziale dei popoli in dispotismo individuale e prepotente”. Non posso non condividere la sua amara conclusione sul comportamento dell’occidente che, da sempre, si è disinteressato dei popoli in lotta per il cambiamento e, invece, interessato dando appoggio per decenni e decenni ai regimi dittatoriali, sacrificando - nella più totale “assenza di proposte etiche” - i diritti umani a interessi energetici e militari. Il futuro dirà, questo è l’augurio sincero, se potremo un giorno vedere tutti i popoli del Mediterraneo assaporare il frutto a volte aspro, a volte dolce, della libertà. Per la Libia, ho fatto un sogno, lasciando libera la mia immaginazione: ritrovare qualcuno che nel 1969 partecipò alla rivoluzione del 1° settembre (e ce ne sono, per esempio, alla Lega degli Stati Arabi come El Huni che aveva abbandonato Quadhafi nel 1975 nonché tra i vecchi ambasciatori e intellettuali che vivono in esilio tra Ginevra e Londra) insieme ai giovani del 2011 che stanno dimostrando di essere capaci di coniugare l’amore per la libertà con quello del proprio paese. Se c’è, come credo ci sia, un filo rosso che lega i superstiti del Consiglio rivoluzionario del 1969 con i giovani rivoluzionari di oggi, mentre mi auguro che questo filo non venga spezzato dai bombardamenti vendicativi del dittatore asserragliato nel suo bunker a Tripoli come lo fu Hitler nel suo, mentre Berlino bruciava, a lui, a Quadhafi ricordo che è tempo di levare la sua tenda e che, non è certo per lui, che “suona la campana”. 15
Scaricare