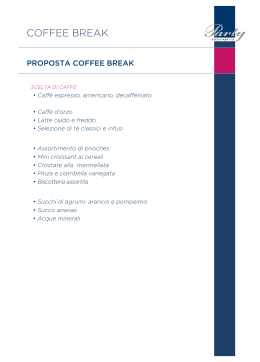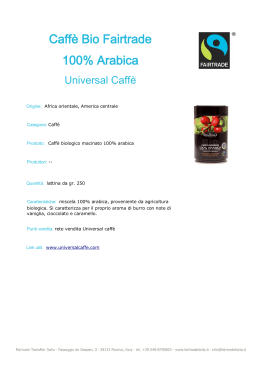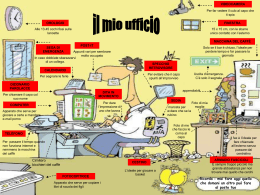LADOMENICA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 NUMERO 455 DIREPUBBLICA CULT A casa Mao di All’interno La copertina Ecco perché la discrezione può vincere sull’apparenza A centovent’anni dalla nascita siamo andati nel suo villaggio per vedere come e perché sopravvive il mito ANAIS GINORI e GABRIELE ROMAGNOLI Il libro Da Picasso a Marilyn le memorie di Topor DARIA GALATERIA Straparlando IL GIOVANE MAO ZEDONG E SULLO SFONDO LA SUA CASA NATIA IN UN DIPINTO DI XU BAOZHONG (1978) Gualtiero Marchesi “Io, il risotto e il vizio della perfezione” DISEGNO DI MASSIMO JATOSTI ANTONIO GNOLI L’opera La storia “Sono io il bambino che Giacomelli fotografò a Scanno” MICHELE SMARGIASSI Spettacoli Parla Keith Jarrett “Voglio pura musica altro che Facebook” GIUSEPPE VIDETTI GIAMPAOLO VISETTI N SHAOSHAN el reliquiario di Mao Zedong ogni oggetto è sacro. Le sue sigarette non fumate, un thermos per il tè, la boule azzurra che gli riscaldava lo stomaco, il lucido per le scarpe, la racchetta verde da ping-pong, i suoi mutandoni di lana. Due piani di reperti esposti nella penombra, a temperatura costante, illuminati e protetti come capolavori. La colonna dei pellegrini scorre in silenzio davanti alle vetrine che esibiscono “i calzini del Presidente Mao”, il suo pettine e le scatole dei biscotti di cui aveva bisogno non per la gola, ma “perché lavorava sempre”. Alcuni anziani, al cospetto di un pigiama rattoppato, non trattengono le lacrime e qualche donna tocca un busto presidenziale mormorando parole di preghiera perché il figlio recuperi salute e prosperità. Il funzionario che mi guida nel museo del Grande Timoniere improvvisamente si ferma davanti al celeste letto, immenso e in pendenza per “ospitare le montagne di libri che divorava di notte”. Respira a fondo e intona di colpo L’Oriente è rosso. Gli operai impegnati a ritinteggiare la sale, cambiare le lampadine, scrostare i vetri e sostituire i bambù ingialliti, attaccano l’inno con lui. C’è un certo odore di mobili in decomposizione, ma sulle pareti scorrono immagini ad alta definizione che ritraggono il Presidente Mao mentre “nuota sorridente in un lago dalle acque gelide”. L’uomo che ha fondato la Repubblica Popolare Cinese, cambiando il destino dell’umanità, nacque centovent’anni fa e nel suo villaggio resta un dio immortale. Tanto più eterno adesso, alla vigilia dell’anniversario: «Ventisei dicembre 1893 — si affretta a puntualizzare la guida al termine della sua baritonale esibizione di maoismo spontaneo — il giorno in cui è venuto al mondo il bambino che i genitori chiamarono profeticamente “Ze-dong”, ossia “splendere sull’Oriente”». Shaoshan, cinquanta chilometri a sud di Changsha, capoluogo dello Hunan, contava allora quattrocento famiglie di contadini e le sue colline erano infestate dalle tigri. Si aravano le risaie con i bufali e la vita, sotto l’agonizzante dinastia Qing, scorreva come nel Medioevo: la notizia della morte dell’imperatore giunse nella fattoria dei Mao casualmente, due anni dopo il decesso. (segue nelle pagine successive) Il bel Falstaff di Luca Ronconi tra locomotive in bianco e nero GUIDO BARBIERI L’arte Il Museo del mondo L’Orlando di Delacroix MELANIA MAZZUCCO Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 28 Il reportage LA STANZA DA LETTO Milioni di cinesi vanno in pellegrinaggio nel paese di Mao LA CAMERA DEI GENITORI IL DEPOSITO PER IL RISO Dove nacque la Lunga marcia GIAMPAOLO VISETTI (segue dalla copertina) ex borgo conta oggi centoventimila abitanti, di cui quarantamila si chiamano Mao, e quasi nessuno coltiva la terra. È stato ribattezzato “Città della Memoria Rossa” e qui tutti vivono grazie al culto di Stato per il padre del comunismo cinese. Un gigantesco manifesto affisso in piazza Mao Zedong, proprio davanti a una statua di Mao alta sei metri, ricorda che “il nostro eroe è morto prematuramente il 10 settembre 1976, all’età di quasi 83 anni, ma noi ameremo per sempre il Presidente Mao”. Un simile trasporto non permette che qualcuno faccia la fame e dopo centovent’anni il Grande Timoniere, mummificato nella piazza Tienanmen a Pechino, può dire di aver reso ricchi i suoi compaesani. A Shaoshan, per onorare la sua casa natale, arrivano cinque milioni di cinesi all’anno. Solo in dicembre, per la ricorrenza, se ne attendono altri due milioni. Assolti i lunghi doveri di fede, tutti entrano in un ristorante per mangiare “maiale stufato alla Mao” e “tagliolini della felicità”, acquistano una copia del Libretto Rosso e una piccola effige magnetica con il volto del divino per il cruscotto dell’auto, a benedizione dei viaggiatori. Ma soprattutto tutti sono invitati dalle autorità ad assistere allo spettacolo che mette L’ in scena infanzia e giovinezza del Presidente Mao e a trascorrere una notte in albergo. Lo show, dopo decenni di sempre più stanche correzioni politiche, è in via di riadeguamento alla sensibilità dei nuovi leader e alle imminenti celebrazioni. Due ore di fiamme, battaglie, vittorie, sangue, fiori e bandiere rosse, chiuse dai fuochi d’artificio del trionfo. Il messaggio è semplice: le forze occidentali erano il Male e Mao, grazie al suo coraggio, ha salvato il popolo cinese dalle belve del Novecento, facendo prevalere il Bene. Buona parte del pubblico, al termine di una giornata sfiancante nel santuario maoista, crolla in un sonno ostinato, che resiste anche ai fragorosi inni rivoluzionari. Quando cala il sipario però sono tutti doverosamente commossi. L’albergo Shengdi, storico rifugio dei dirigenti spediti dal partito a omaggiare il padre della nazione, è invece un mito a sé. Sconfinato, in marmo bianco, imbottito di moquette rossa e gialla. Troni e tavoli fingono di essere d’oro, come le teste di leone e i putti trombettieri appesi alle pareti. Nelle sale risuona la colonna sonora del film Titanic e le cameriere accorrono per mostrare i wc giapponesi riscaldati e i soffitti affrescati delle stanze, che illustrano l’epopea del Presidente Mao come fossero le scene della vita di Cristo narrata dal Vangelo. Non si può dire che la struttura, ai piedi della Montagna del Drago, esalti la frugalità delle origini, messaggio essenziale affidato a Shaoshan dai successori del “padre di tutti noi”. «L’hotel è vuoto — avverte la cameriera incaricata di sorvegliare il mio piano — Duecento camere, lei è l’unico cliente. Sono scomparsi tutti, dopo la caccia scatenata da Xi Jiping contro corrotti, lussi e stravaganze. Pensi: anche il gala organizzato per l’anniversario del Presidente Mao è stato cancellato». Lo spreco di Stato per non smettere di venerare la sola figura tuttora capace di tenere uniti i cinesi è in effetti un problema ideologicamente imbarazzante. A quasi quarant’anni dalla sua scomparsa, nella Cina iperconsumista che l’ultimo Plenum ha appena aperto al “mercato decisivo”, che è l’opposto di quella teorizzata dal Grande Timoniere, il partito scopre di essere ancora Mao-dipendente. Altro che riforme: il potere dei “prìncipi rossi” discende dal suo ricordo, che sostiene la società, lo Stato, il regime, tutto. Nessuno, da Deng Xiaoping a Jiang Zemin e Hu Jintao e ora a Xi Jinping, ha avuto il coraggio di mettere sostanzialmente in discussione il dio dei cinesi e la nazione si scopre ancora prigioniera del dittatore da cui non ha saputo affrancarsi, nemmeno dopo la sua morte. Discutere in modo aperto di Mao equivarrebbe a parlare liberamente del partito-Stato, permettere la ricerca della verità: come imprimere un sigillo sulla fine del regime. Pechino deve così alimentare la fiamma della sola fede ammessa: chi si astiene resta un traditore. Alimentare il culto di massa, dopo centovent’anni, è però tremendamente dispendioso e il popolo degli ex compagni, pronti a piangere davanti alle “scarpe bucate del Presidente Mao”, è meno propenso ad assolvere i costi di una propaganda che, assieme al padre, promette di consegnare all’eternità anche i figli, auto-proclamati successori. Per la prima volta, alla vigilia del sacro anniversario, la Cina si indigna dunque per i 2,5 miliardi di dollari stanziati dal governo per i festeggiamenti del 26 dicembre a Shaoshan. Una bestemmia: condannare le energie profuse per «dire collettivamente grazie al Presidente Mao». Eppure è così, la nuova classe media dei consumatori urbanizzati alza la voce contro i nostalgici nazionalisti dell’antico mondo rurale e si capisce perché nel villaggio natìo, investito della titanica missione di «gestire sedici piani patriottici» senza smarrire uno yuan, non si vedono volti rilassati. Mao Zedong costa, la ri-maoizzazione succede alla de-maoizzazione, e il partito rischia. Bisogna ammettere che, nell’eccesso obbligato di zelo apologetico, si è esagerato. A Changsha, dove “l’ultimo imperatore” studiò e insegnò nell’Accademia Yuelu, una sua testa di granito alta trentadue metri domina il fiume Xiang e funge da sfondo per le foto degli sposi. Di qui parte l’auto- Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 29 Un culto ancora oggi funzionale sia alla Cina comunista sia a quella consumista IL CORTILE INTERNO CON I CONTADINI Mao Zedong davanti alla casa di Shaoshan in cui nacque il 26 dicembre 1893, ora trasformata in museo (nelle foto a colori) In basso, la grande illustrazione raffigura il pellegrinaggio verso la casa: sotto il disegno si legge la scritta “Shaoshan, il luogo in cui sorge il sole rosso” strada personale di Mao, che in un’ora conduce direttamente alla fattoria dove è nato. L’asfalto è tirato come un velluto e centinaia di operai rabboccano a mano impercettibili buche. Il percorso è deserto e l’autista del pullman non può smettere di suonare per disperdere stormi di gazze che riposano sulla corsia di sorpasso. La “Città della Memoria Rossa” invece è in fermento. Ordini dall’alto: centinaia di botteghe di souvenir rinnovano le fotografie dei vecchi leader, gli album con le poesie del Presidente Mao e quelli con la sua “struggente calligrafia”. Su una spianata di cantieri si costruiscono il nuovo “Museo di Mao e della Cina”, alcuni alberghi, una nuova stazione per i treni ad alta velocità, un centro commerciale «a tema rivoluzionario», cinema e teatri per replicare «un’adolescenza leggendaria». Le impalcature nascondono anche la casa degli avi dei Mao, eretta nel 1763 e trasformata in scuola per la seconda moglie del giovane Zedong, come i venerati “bagni sovietici” color smeraldo del bunker anti-atomico segreto, scavato nel 1960 sotto il dosso dove è sepolto suo nonno. Dietro la statua del centenario, voluta da Jiang Zemin nel 1993, si cambiano i fiori, si potano i sessantatré pini, uno per ogni etnia, e si sostituiscono le corone con la scritta “Noi ameremo Mao per sempre”. La coda per accedere alla casa natale del Presidente Mao comincia qui, a poco meno di un chilometro dal letto in cui la madre, fervente buddista, lo partorì dopo due figli defunti. Eserciti di guide turistiche e ambulanti assediano i fedeli-clienti, ordinati fuori dai pullman delle gite di partito. Giovani in abiti da monaci e sosia presidenziali, di varie età, si offrono a prezzi proletari per foto-ricordo. Nessun grande dittatore del Novecento, non Lenin, non Stalin, e tantomeno Mussolini o Hitler, ma neanche alcun statista democratico, conserva un memoriale così impressionante e ancora decisivo, fondamentale per la sorte della Cina e tanto influente sul destino del mondo, quale è la fattoria dove Mao Zedong «cominciò a vivere aiutando i genitori nei lavori della stalla». Chi ci arriva è stato preparato: conosce biografia e storia a memoria, ha scorso centinaia di fotografie d’epoca, digerito decine di documentari seppiati e si limita a dire «vado alla Casa». Sa che, dopo due ore d’attesa e giorni di viaggio, scorrerà in cinque minuti attraverso sei stanze spoglie di una vecchia dimora contadina con muri e pavimento di fango, in riva a uno stagno, davanti a una risaia e alla collina dove riposano l’amata madre e l’odiato padre del Presidente Mao. Eppure, dopo centovent’anni dal divino vagito, la massa dei cinesi indebitati per una berlina tedesca e con il sogno inconfessabile di fuggire in America, procede in religioso silenzio tra il focolare e la vasca per l’acqua, commossa dalla propria, presto dimenticata povertà. È questo il capolavoro della propaganda maoista, più forte del silenzio che torna ad avvolgere lo sterminio del “Grande Balzo in Avanti” e i crimini della Rivoluzione culturale, abomini negati o ignorati del maoismo. Il messaggio universale della rinnovata nomenclatura è potente: l’energia dell’epocale successo cinese continua a derivare dalla forza di questa mi- seria, dalle privazioni, dal sacrificio, dall’onestà, dall’abnegazione filiale, dalla frugalità, dalla determinazione che permisero a un giovane contadino dello Hunan di trascinare la patria colonizzata dall’impero al socialismo, mutando il corso di due secoli. È il cuore dell’aggiornata ideologia capital-comunista della svolta riformista annunciata il 12 novembre da Xi Jinping: «Spianare le montagne», «arricchirsi gloriosamente» e ora «consegnarsi al mercato», ma non rinunciare «all’anima marxista del servire il popolo». A questo appalto della persuasione resta affidata l’irrinunciabile sacralità della casa natale del Presidente Mao. Si può evitare il mausoleo di Tiananmen, non la culla di Shaoshan. Cinque minuti di raccoglimento e una fotografia sull’augusto uscio, come in una Mecca materialista, bastano per una vita obbediente, se si riconosce l’autorità del luogo-mito. Il rinnovato impegno a una tale fedeltà vale ben l’investimento di Pechino che, per l’occasione, rompendo un altro storico tabù, si appresta a lanciare il cartoon Quando Mao Zedong era giovane, a esportare il film d’animazione Come si fa a diventare presidente e a stampare il volume Qualcuno deve finalmente dire la verità, che nega i quaranta milioni di morti del “Grande Balzo in Avanti”. «Nessuno spreco per l’anniversario — dice il funzionario che mi accompagna a salutare l’ultima vicina di casa che assicura di essere stata ami- ca del Grande Timoniere — Mao non appartiene alla sinistra, è l’ispiratore di ogni cinese e i giovani di tutto il mondo devono conoscerlo». L’ambiguità scientifica della divinità e dei suoi interpreti: dopo centovent’anni, grazie all’umiltà della Casa, il Presidente Mao resta il volto del partitoStato, ma diventa pure l’immagine dei suoi oppositori interni, del montante ma imperseguibile dissenso-maoista che vorrebbe abbattere la casta corrotta che, proprio nel nome di Mao, torna a teorizzare il potere come dinastia ereditaria dei grandi interessi di clan. Primo difensore e atto d’accusa, sintetizzati in unico mandato del cielo, «insidiato solo — assicura la guida — dalla tentazione del denaro». Lo spirito di Mao però non ha impedito alla Cina di crescere fino a diventare la potenza più ricca del secolo. Un tappeto di teste adoranti, mentre la notte risale il passo del “Riposo della tigre”, si inchina così emozionata davanti alla gigantesca macina di pietra che il piccolo Zedong «riuscì a muovere già all’età di tre anni». Fantasie, storia, parabole, propaganda: quanto tempo resisterà questa Cina del dopo figlio unico e liberata dai campi di lavoro, ma costretta ad aggrapparsi all’unico dio che riconosce come proprio, per poterlo quotidianamente abbattere senza crollare? «Mao Zedong vivrà per sempre — recita il falegname che entro il 26 dicembre deve finire di restaurarne l’altare domestico degli avi — Ma una cosa è certa: se Lui tornasse qui e vedesse ciò che siamo diventati, altro che riforme, farebbe subito un’altra rivoluzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 30 L’attualità Nome George Cognome Nyonge Professione Venditore Daniel Ndunju 24 anni Venditore di peluche Segni La sua moto particolari è negozio e magazzino Nome Cognome Età Professione di paralumi Guadagno Fino a 1000 scellini al giorno (10 euro) Famiglia Sposato con 4 figli Slum economy George è specializzato in paralumi, Jackson in scarpe, Michel in reggiseni, Erastus canta Piccolissimi imprenditori del ghetto sono (anche) loro gli artefici della nuova Africa I negozi di Nairobi hanno buone gambe MARCO MATHIEU FOTO DI FILIPPO ROMANO Nome Cognome Età Professione aniel, per esempio. Ha 24 anni, una moglie, un figlio. E la vecchia motocicletta con cui gira, sommerso da una montagna di pupazzi di peluche, tra i vicoli di questa immensa distesa di baracche. Ovvero, Mathare: slum alla periferia di Nairobi dove provano a sopravvivere D Johnston Mutunga 21 anni Venditore di pesticidi Guadagno 200 scellini (circa 2 euro) al giorno Segni Indossa un cappello particolari “da topo” per attirare l’attenzione dei clienti più di seicentomila persone. E decine di venditori ambulanti, come Daniel. Oppure Jackson e Mike, 36 anni in due, specializzati in scarpe usate: dopo averle scelte tra quelle che riempiono i container in arrivo da Europa e Stati Uniti, le hanno aggiustate, lavate e lucidate. E ora le vendono, arrivando a guadagnare anche 3.000 scellini (l’equivalente di 30 euro) in una settimana. Un piccolo patrimonio, da queste parti. Dove quello dell’ambulante è diventato il nuovo mestiere, l’ipotesi di un pezzo di futuro, per molti giovani del ghetto. Evitando i furti, la violenza e il controllo della malavita locale fanno circolare merci, sorrisi, trattative e oggetti. Dalle giacche vendute da Isaac ai paralumi di George, fino agli scaldavivande in plastica di Peter. Tutti hanno bisogno di qualcosa, tutti offrono qualcosa. Come le scope di saggina di Josiah o le sim card di Ben. Ma anche le marionette di Bernard e i cappelli di Jimmy, i medicinali di Lessiamon e i vestiti da bambini di George. Per la musica, invece, basta rivolgersi a Erastus, 27 anni: speaker a tracolla e microfono in mano, canta e improvvisa sulle basi registrate raccogliendo le offerte tra il pubblico. Perché questa è una storia fatta di piccoli, ma importanti esempi. Dentro un movimento continuo di facce e commerci, che arriva fino a noi grazie alle immagini scattate da Filippo Romano, quarantacinquenne milanese. A Mathare lavora con due ventenni: Jfam, rapper molto noto nel ghetto, e Adigo, attivista e volontario di una ong. «Sono le mie guide, le mie antenne, ma soprattutto condivido- Nome Cognome Età Professione Guadagno Famiglia Segni particolari Michel Mtuo 50 anni Venditore di reggiseni 300 scellini (circa 3 euro) al giorno Ha 4 figli Parla bene l’inglese Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 31 Nome Lessiamon Età 25 anni Professione Venditore Nome Jack Professione Lucidatore di scarpe di medicine tradizionali Segni particolari Nella tanica ha un siero antimalarico venduto per 30 scellini (30 centesimi di euro) al bicchiere no il mio progetto (LiveInSlums) che parte dal rapporto speciale che gli abitanti dello slum hanno con le immagini», racconta Filippo. «Se entri in una baracca chiunque ti mostra il suo album personale con le foto in formato 10x15. La fotografia diventa il modo per raccontare la propria vita: sono scatti fatti in giorni speciali, tutti tendono a essere eleganti, attenti al modo in cui si vestono». Compresi i nuovi ambulanti che si muovono veloci tra le strade dissestate di Mathare. «Ho iniziato tre anni fa a raccogliere le loro storie: a ognuno di quelli che ritraggo regalo una foto, perché ricordi il giorno che muzungo — il muso bianco — lo ha ritratto. E quelle immagini servono poi per entrare nel circuito del microcredito, che è diventato il nuovo e piccolo motore economico dello slum». Piccoli scambi, altri esempi. I nuovi ambulanti vengono infatti aiutati — con un principio simile a quello delle start-up — da WhyNotAcademy, la scuola che li mette in relazione con una piccola galassia di ong e imprenditori. Sono poi loro a sostenere l’avvio dei progetti, muovendo così un circuito virtuoso di potenziale riscatto sociale in questa gigantesca area precaria di umanità alla ricerca della sopravvivenza. Come in- Guadagno 150 scellini (1,50 euro) per ogni paio di scarpe Gli ambulanti che sfidarono l’apartheid PIETRO VERONESE egli anni Ottanta del secolo scorso, meno di dieci anni prima di crollare per sempre, il regime segregazionista sudafricano appariva ancora forte. Certo, i ghetti neri erano in rivolta, il governo costretto allo stato d’emergenza, il prezzo di sangue era molto alto, ma la forza del regime razzista appariva invincibile. Eppure, l’azione combinata della instabilità interna e delle crescenti pressioni internazionali cominciarono a produrre le prime crepe. Ci fu un tentativo di ammorbidire il rigore delle leggi segregazioniste. Il simbolo di questa svolta inattesa furono gli hawkers, i venditori ambulanti. Le leggi dell’apartheid disciplinavano in maniera rigidissima la separazione delle razze. Separate, in particolare, erano le aree di residenza. Alla sera i neri dovevano rientrare nei loro sterminati quartieri-ghetto e per uscirne dovevano a richiesta esibire dei lasciapassare, dei “passaporti interni”. Nelle zone dei bianchi erano ammessi solo per motivi di lavoro, e il lavoro era a sua volta molto rigidamente codificato. La manodopera necessaria alle varie attività era puntigliosamente quantificata. Così il venditore ambulante, che propone la sua merce a un angolo di strada, incarnava ciò che l’apartheid combatteva con tutte le sue forze: un moto di libertà. Ed era perseguito alla stregua di un sovversivo, di un terrorista. Per questo la notizia che il governo aveva deciso di liberalizzare il commercio ambulante suonò, in quel con- N testo, sconvolgente. Gli hawkers, che subito popolarono i marciapiedi del centro città con ogni sorta di mercanzia, erano gli araldi di una rivoluzione. Lo sbarco dei venditori di paccottiglia nel central business district di Johannesburg mise infatti sotto gli occhi di tutti due cose. Primo, che sebbene negli schieramenti della guerra fredda il regime sudafricano fosse stato un baluardo del “libero mercato”, esso era in realtà statalista, ipernormativo, illiberale nel campo economico forse ancor più di quanto non lo fosse in quello politico. Non a caso il grande capitalismo privato, a cominciare dalle multinazionali di oro e diamanti, gli era diventato ostile. La seconda era il suo carattere radicalmente anti-africano. Come confermano i ritratti fotografici pubblicati in questa pagina, scattati a Nairobi, il venditore ambulante è in tutta l’Africa la cellula economica di base. Potremmo chiamarlo un liberismo antropologico, prima ancora che economico. Egli incarna una verità spiacevole che non amiamo sentirci dire: siamo stati noi europei, con la conquista coloniale prima, con le regole di scambio ineguali poi, saccheggiando le materie prime in regime di monopolio o mettendo fuori gara gli agricoltori africani perché sovvenzioniamo slealmente i nostri, a impedire a questi umili venditori appostati all’incrocio di diventare competitors sul mercato mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA segna la storia di Tommy, o almeno così tutti lo chiamano a Mathare. «Faceva parte di una delle tante gang di rapinatori», ricorda Filippo. «Ma nel ghetto il controllo della malavita è pressoché totale e non ammette sgarri, eccezioni. Sono frequenti gli episodi in cui la mafia locale trova questi giovanissimi banditi e li espone al linciaggio delle persone comuni, fino a bruciarne i corpi». Tommy ce l’ha fatta: si è tirato fuori accedendo al progetto dello scambio, raccontando la sua storia e facendosi fotografare, iniziando così anche lui ad andare in giro a vendere qualcosa: canna da zucchero, che la gente compra e poi succhia, mentre lui gira con il suo carrello tra i vicoli. Perché il futuro è un concetto lontano, in questo slum a venti minuti dal centro di Nairobi. Ma i giovani ambulanti ora provano ad arrivarci con un altro scambio. Un altro piccolo, ma importante esempio. E a sentire Filippo sembra già di rivedere il sorriso di Daniel, sulla sua moto in mezzo alla montagna di pupazzi di peluche. «Faremo un libro, con le immagini e le storie di questi ragazzi, organizzeremo una piattaforma online per far continuare il racconto a loro, sul web». © RIPRODUZIONE RISERVATA Nome Cognome Età Professione William Thega 24 anni Cammelliere Ogni corsa dura 10 minuti e costa 10 scellini Guadagno 500 scellini (circa 5 euro) al giorno Segni particolari Il cammello è suo Nome Cognome Età Professione Erastus Kamau Wa Shaini 27 anni Canta su basi registrate Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 32 La storia FOTO © ROBERTO SERRA Incroci Tutto solo, le mani in tasca, lo sguardo sereno e un’aureola intorno Quell’immagine magica scattata nel paesino abbruzzese alla fine degli anni Cinquanta finì poi al MoMa di New York. Ora la nipote del grande fotografo italiano ha scoperto chi è quel ragazzino. Noi l’abbiamo incontrato: “Se sto così rigido è perché faceva freddo e avevo addosso soltanto un golfino...” MICHELE SMARGIASSI «L’ LIVORNO ho trovato!», esulta Simona via email. Simona è un’eccellente archivista e ricercatrice di fotografia, trovare è il suo mestiere. Ma ha trovato cosa? «Il bambino! Il bambino di Scanno, quello nella foto dello zio. Non ricordi?». Simona Guerra è anche la nipote di Mario Giacomelli, il Leopardi del bianco-e-nero, il genio irregolare di Senigallia, uno dei quattro o cinque nomi che tutto il mondo conosce nella storia della fotografia italiana. Sì, ricordo, un paio d’anni fa, quando Simona pubblicò un suo lungo colloquio biografico con lo zio registrato poco prima che morisse nel 2000, parlammo di quella foto di mezzo secolo fa che diventò la sua più celebre, la foto magica col bambino aureolato di luce in mezzo alle donne in nero, nel paesino abruzzese di Scanno, e le dissi: «pensa che emozione sarebbe incontrare oggi quel bambino... La riapparizione del Referente...». Lei non sembrava convinta. Invece poi l’ha trovato. Nel modo più semplice: è andata a Scanno con la fotografia sottobraccio, e ha cominciato a fermare la gente per strada: «Riconosce questo bambino?». Non ha dovuto insistere. «È Claudio De Cola», prima due anziani, poi un capannello, identificazione corale, «Abitava vicino alla chiesa. Ci stanno ancora i suoi genitori». E i genitori, che quella fotografia celebre non l’avevano mai vista: «È Claudio», confermano sicuri, tirano fuori l’album delle prime comunioni, e non ci sono dubbi: ecco Claudio, più grandicello ma identico, sopracciglia, orecchie, stempiatura, stesse mani in tasca. “Sono io il capolavoro di Giacomelli” Claudio non vive più a Scanno da decenni. Ha una sessantina d’anni, è sposato, ha figli, abita in Toscana. Bene, andiamo a trovarlo. «No, io non vengo», risponde Simona, lapidaria. Ma come? L’hai cercato per anni... «Io mi fermo qui. A Scanno ho cercato qualcosa di me, la mia infanzia, quel che mi ha dato quell’immagine, e io le resto fedele. Le fotografie bisogna lasciarle stare. Cercare è meglio che trovare». Resto senza parole. Simona, nelle foto ci sono le nostre emozioni, ma anche il mondo... Certe fotografie ti tirano dentro, e questa è una. Come disse Roland Barthes di fronte a uno scatto di Kertész, ritratto di un bimbo dell’età di Claudio: «È possibile che Ernest viva ancora? Ma dove? Come? Che romanzo!». Ecco Simona, io vorrei il romanzo. «Allora vai tu», sospira, capisco che solo l’amicizia le impedisce di essere più brusca, «scriverò un libro su questa foto, pubblico la scoperta sul mio sito, ma con questo ho rag- giunto il mio ultimo scalino. Tu se credi cerca il tuo». Ed eccomi davanti a un condominio anni Cinquanta, nel centro di Livorno. Apre la porta, sorridendo un po’ imbarazzato. Stempiatura. Sopracciglia. E ha le mani in tasca! «È più forte di me», ride «non sa che fatica trattenermi, quand’ero in divisa...». Claudio è stato per quarant’anni un finanziere. È andato in pensione un anno fa col grado di luogotenente, poi la nomina a cavaliere. Il salotto è pieno di quadri. La fotografia di Giacomelli non c’è. «Devo avere il ritaglio da qualche parte». Sì, l’aveva già incontrato il suo avatar in bianco e nero. Una quindicina d’anni fa la foto era apparsa su un quotidiano, e un conoscente gli aveva detto «guarda, ci sei tu». Ma Claudio pensava fosse una delle tante foto storiche di Scanno. Città fotogenica, fin troppo. Da quando, nel 1952, passò di lì Henri Cartier-Bresson, e creò il cliché arcaico me- ridionale delle donne in nero fra stradine di ciottoli e scalinate, quel paesino montano d’Abruzzo divenne la Mecca dei fotoamatori, che ci facevano le gite domenicali, ma anche di grandi firme, Berengo Gardin, Roiter, Cresci, Monti... I bar espongono foto da museo, c’è pure una “via della Fotografia”. Giacomelli, tipografo intellettuale e un po’ misantropo, andò a Scanno due volte, nel ’57 e nel ’59, anche un po’ per sfidare lo stereotipo di eden del pittoresco che Scanno era diventata. Per lui era «posto di favola», luogo immaginario, forzò i diaframmi per evitare il documento, tornò a casa con un pugno di immagini rarefatte, contrastate, «sporche», di bianchi bruciati e neri catramosi. Il critico Piero Racanicchi se ne innamorò. Le mostrò a John Szarkowski, direttore della sezione fotografia del MoMa di New York. Che ci impazzì. Il “bambino di Scanno” fu l’unica fotografia italiana tra le cento della mostra- spartiacque “Looking at Photographs”. Quel bambino aureolato in realtà non entusiasmava il suo autore, la sua foto più famosa non è mai stata la sua preferita, al collega Alfredo Camisa confessò addirittura che quell’alone rinforzato in camera oscura gli era venuto «mascherato male», «quasi una porcheria». Ma il guru americano stravide per le diagonali, i contrasti, per quei profili malinconici di donne scure che gli parvero «bersagli di un tirassegno meccanico»... «Ma no, avevano freddo», sorride Claudio, mite e senza retorica. «A Scanno fa freddo d’inverno. Vede, io sto rigido perché ho freddo e ho solo un golfino. E quelle donne di sicuro hanno lo scaldino sotto il mantello». Me ne mostra uno, di quegli scaldini, piccolo braciere di ottone, stufetta portatile: «Per questo camminano così curve». Esplora la fotografia che gli ho portato, col dito, centimetro per centimetro. Giacomelli ha “mangiato” i dettagli, ma Clau- Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 FOTO © SIMONE GIACOMELLI / ARCHIVIO GIACOMELLI SENIGALLIA ■ 33 FOTO © RENZO TORTELLI FOTO © MATTIA GALLO FOTO © MATTIA GALLO dio li ripesca: «Questa è la chiesa di Sant’Antonio. Io abitavo nell’ex convento, queste sono le finestre di casa mia, ci sono i nostri panni stesi, vede?». Un anno fa Claudia, sua figlia, laureata in Storia dell’arte, incontrò questa foto su una parete del Mart di Rovereto. «Babbo sei in un museo», gli telefonò. Appresero con stupore la fama di quella immagine vista forse da milioni di persone in mezzo mondo. «E dire che a me non piace viaggiare...». Claudio guarda il suo alter ego con moderato affetto, come fosse uno dei suoi cugini emigrati. Quel momento, però, non lo FOTO © LISA CALABRESE LE IMMAGINI In alto, il “Bambino di Scanno” di Mario Giacomelli (per gentile concessione dell’Archivio Giacomelli di Senigallia e di Simone Giacomelli). Nell’altra pagina, Claudio De Cola in posa con il suo ritratto da bambino A sinistra, dall’album di famiglia, una foto di Claudio da piccolo messa a confronto con quella di Giacomelli Qui accanto Simona Guerra, nipote del fotografo, con la madre e (sopra) il padre di Claudio; cerchiato in rosso, Giacomelli nel 1957 a Scanno ricorda. Giacomelli che lo fotografa non c’è, nella sua memoria. «Curioso, quello spiazzo era sempre pieno di bambini, chissà come ha fatto a prendermi da solo». La solitudine di quel bimbo è il fascino che ha reso celebre l’immagine, come il suo volto, unica cosa a fuoco, unico volto sereno, l’unico che sembra guardare verso un futuro... «Mi sa che stavo andando da mia zia», si schermisce Claudio. «Ma qualcosa di vero c’è. Qui avrò forse sei anni. L’anno dopo mi misero in collegio dalle suore, all’Aquila. Questa fotografia segna un passaggio nella mia vita. Da allora non ho mai più vissuto a Scanno». Non ci sono più cose da dire. Sapersi l’originale di un’opera d’arte, sentirsi come la Monna Lisa della fotografia, è stata per lui una curiosità piacevole, «ma non mi cambia la vita». Ci salutiamo. Promette: «Magari un giorno andrò a New York a vedermi in quel museo». Più tardi, Simona mi chiama al cellulare. Un po’ ansiosa. «Allora?». Tranquilla. Anche io ho raggiunto il mio gradino. Oggi ho incontrato una persona, non una fotografia. Spesso le strade delle persone e delle fotografie si incrociano, rare volte quell’incontro produce immagini che restano patrimonio dell’umanità. Ma dura pochi centesimi di secondo, poi foto e persona prendono ciascuna la propria strada. Rarissime volte, per qualche istante, si incontrano di nuovo e si salutano con rispetto e distaccata cortesia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 34 Spettacoli Duri e puri “Vivo isolato dal mondo ma contro la stupidità non c’è muro che tenga” Il grande jazzista racconta a “Repubblica” la fatica di vivere ai tempi di Facebook Ma pure l’entusiasmo per il suo ultimo lavoro “Arriva da un luogo dove sempre più raramente i creativi hanno accesso” I DISCHI La copertina di No End (edizioni Ecm), ultima fatica di Keith Jarrett: in un doppio cd venti brani sovraincisi in splendida solitudine nel 1986 e fino a oggi rimasti inediti Sotto, la copertina di The Köln Concert (1975), il disco più venduto della storia del jazz (4 milioni di copie) e quella di Restoration Ruin (1968), il suo “manifesto hippie” Nell’altra pagina Jarrett oggi, sessantottenne. Tutt’intorno alcune copertine dei suoi oltre 100 dischi pubblicati Keith Jarrett Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 35 “La mia musica sorprende anche me” GIUSEPPE VIDETTI straordinario sentirlo ridere. Non la smorfia a denti stretti che indirizza al pubblico alla fine dei più felici concerti in trio, ma scoppi allegri, fragorosi, irrefrenabili. Ricordare, l’esercizio che l’ha sempre indispettito, ora lo diverte. Quando parla di Miles Davis ne imita perfettamente la voce, quando racconta dei suoi anni Sessanta è sereno e divertito. Keith Jarrett, sessantotto anni, pianista sublime il cui genio e tormento non hanno uguali se non in Glenn Gould nella storia musicale del Novecento, ha ritrovato il buonumore riascoltando una serie di registrazioni che aveva seppellito nello studio di Warren County, nel New Jersey. Un raptus che lo colse nel cuore degli anni Ottanta: abbandonato in un angolo il pianoforte, prese a sovrincidere basi di chitarra elettrica, basso, percussioni e voce — quelle tipiche intrusioni vocali sempre più udibili nei suoi concerti. Il risultato esce soltanto adesso e sta in un doppio cd, No End (pubblicato contemporaneamente al triplo per piano solo Concerts: Bregenz/Münchene alle Sonate per violino e tastiera di Bach eseguite con Michelle Makarski). Sono venti movimenti musicali senza titolo, diario sonoro di uno stato di grazia e di una leggerezza di cui non lo credevamo capace; un’esperienza sorprendente nella sua vasta discografia di quasi cento album, tra incisioni per pianoforte (The Köln Concert, del 1975, è il disco più venduto della storia del jazz con quasi quattro milioni di copie), in trio e incursioni nella musica classica e contemporanea (Bach, Händel, Mozart, Shostakovich e Arvo Pärt). Qui non c’è ombra del Jarrett ombroso, scontroso, egotista, schizoide, lacerato da un fervore creativo che sfida l’impossibile. No end è piuttosto una serie di mantra antistress, suoni per un moderno Zabriskie Point. «Danze tribali di mia invenzione», le chiama Jarrett entusiasta. «I miei amici, anche musicisti, che l’hanno ascoltato mi hanno guardato stupefatti. “Che roba è?”. Poi, alla fine: “Una cosa è certa, sei tu!”», aggiunge soddisfatto. Sembra ancora più sorpreso di noi quando parla di No End. «Lo sono. È musica diversa, ricca, ritmica, contagiosa». Cosa ricorda di quei giorni trascorsi in solitudine nel suo studio? «Sono passati ventisette anni, non eravamo ostaggi del terrorismo, sedotti dalla Apple, indottrinati da subdoli messaggi politici. La felicità era ancora a portata di mano, la libertà era un diritto acquisito. Suonare era gioia allo stato puro. Il resto è nebuloso; feci tutto da solo, mi ero preso terribilmente sul serio anche come ingegnere del suono. C’erano momenti in cui mi lasciavo andare, uscivo da me; come se stessi ascoltando la performance di un altro musicista. La medesima euforia È che ho provato quando ho cominciato a riascoltare le vecchie cassette e lavorare alla postproduzione del cd. Ho impiegato almeno settanta ore per ottenere un risultato sonoro accettabile. E non mi sono mai annoiato». Furono musiche registrate in ordine sparso o lo stream of consciousness di un artista? «Ero in preda a una sorta di smania creativa, andavo in studio ogni giorno senza nessuna idea melodica o ritmica in mente, improvvisavo dall’alba al tramonto. Ricordo solo il feeling, lo stato di grazia in cui mi sentivo, ispirato, in estasi, rapito in una dimensione parallela che stento a decifrare. Ogni volta che imbracciavo uno strumento era come se mi preparassi a suonare nel gruppo di qualcun altro». Qual era lo strumento guida? «Di solito era la batteria a entrare per prima, un drumming primitivo che accompagna vibrazioni decisamente rock, il rock come l’intendo io, non come i batteristi tradizionali che ripetono lo stesso ritmo fino alla noia. Alteravo i volumi a seconda di com’era l’ascolto in cuffia. Oggi ottenere lo stesso risultato sarebbe più difficile che fare rafting alle sorgenti del Nilo. È un esperimento unico e irripetibile; in quel momento avevo l’energia di sei musicisti, e questo è uno dei motivi per cui oggi non sarei in grado di rifarlo. Le sembrerà ridicolo, patetico, ma mentre ero intento alla preparazione del disco immaginavo le conversazioni di studio tra vari musicisti — e lo facevo ad alta voce. Ci sono almeno sei diversi Keith Jarrett in questo progetto». Musica per risollevare lo spirito: ci riporta a Ravi Shankar, ai viaggi intergalattici di John Coltrane e alla musica totale che lei sperimentò col gruppo di Miles Davis nei primi anni Settanta. «Infatti oggi ripenso a quella come a un’esperienza mistica. I miei figli erano giovanissimi all’epoca — uno era in pieno trip punk con il taglio da moicano e tutto il resto, l’altro invaghito di Michael Jackson. Entrai in studio e presi in mano la chitarra pensando: riuscirò mai a suonare qualcosa che li interessa? Ma siccome credo fermamente che qualsiasi musicista di un certo livello non sia capace di suonare per altri che per se stesso, una volta che quest’avventura prese piede dimenticai i miei figli, era una cosa mia e solo mia. Noah, il più grande, che ora ha più di trent’anni e non aveva mai ascoltato queste musiche, è venuto a trovarmi qualche giorno fa e le ha trovate geniali; sua figlia, la mia nipotina di cinque anni, si è messa immediatamente a ballare. Noah ha esclamato: “Papà, hai allargato la tua platea al pubblico dell’asilo”. In effetti fu un approccio innocente. Non ricordo esattamente perché lo feci. Fu un’esigenza liberatoria? Stavo preparandomi a uno di quegli estenuanti tour per piano solo? Era musica terapeutica, nel senso più primitivo del termine, e ancora lo è». Lasciare in un angolo il piano, cui concede solo un cameo, e suonare altri strumenti le servì ad allentare la tensione? «Non direi. Il punto è un altro: riesco a stabilire un rapporto di maggiore intimità con gli strumenti che posso imbracciare. Il pianoforte è uno strumento molto complicato, tra lui e me c’è un costante scontro di personalità, non sono mai me stesso come con una chitarra, un basso o un sassofono che stringo in mano. Ricordo un concerto che tenni a New York molti anni fa, alla fine degli anni Sessanta (con Charlie Haden e Paul Motian), in cui cercavo di far suonare il pianoforte come una chitarra. Miles Davis, che era venuto ad ascoltarci, mi disse: “Tu suoni lo strumento sbagliato”. Sapevo esattamente quel che intendeva. In quegli anni nella mia testa ronzavano altri suoni, voci e chitarre soprattutto». Era il 1986, sembra un secolo fa. In No End si lasciò andare a una musica che sembra l’appendice del sogno hippie. Evidentemente lo spirito degli anni Sessanta era ancora ben vivo. «Mi trasferii a San Francisco nel periodo di massima fioritura del movimento, quando sembrava che nessuno capisse quei messaggi di pace e amore così semplici ed efficaci se non coloro che ruotavano nell’area di Haight-Ashbury. Abitavo in un seminterrato proprio nel quartiere dei figli dei fiori. Una mattina chiesi al mio vicino di casa — ora non ricordo il suo nome — se avesse voglia di venire a suonare qualcosa con me. “Se ne incontriamo altri lungo la strada potremmo formare una band”, gli dissi. Rimasi a suonare il sassofono sotto un albero del Golden Gate Park fino al tramonto. La musica è qualcosa che viene da dentro, qualsiasi circostanza esterna, qualsiasi forzatura uccide la spontaneità; la musica affoga quando è costretta a nuotare in acque limacciose». Che ragazzo era all’epoca, di quali sogni si nutriva come artista? «Non ho mai preso droghe di nessun tipo sebbene come gli altri hippie fossi alla ricerca di una verità fuori del dogma. Avevo appena lasciato il gruppo di Charles Lloyd, ero disoccupato. Nella West Coast c’era una scena musicale molto effervescente e un locale, il Fillmore West, che era il sogno di tutti i musicisti. Ero un figlio dei fiori a tutti gli effetti, presi anche a frequentare corsi in cui si parlava di spiritualità e del ruolo dell’uomo nell’universo». Nel 1968 incise Restoration Ruin, il suo manifesto hippie, in cui usava anche voce e sassofono. «Lo spirito era lo stesso, ma No End suona molto meglio. Odio gli studi di registrazione, asettici come sale operatorie. In quello che mi sono costruito qui nel New Jersey c’è una grande finestra che si spalanca su uno sconfinato paesaggio americano. Quando suono e guardo fuori, lo spirito si ricrea. Qui dentro ho superato un complicato esaurimento nervoso (nel 2008, dopo la separazione dalla seconda moglie, ndr). Avevo bisogno di un posto dove suonare liberamente, magari per tutto il giorno, proprio come a Golden Gate Park». L’America e il mondo intero sembrano aver dimenticato le aspirazioni pacifiste di quegli anni. «Tutto sepolto sotto una coltre di conformismo e perbenismo. La musica che si ascolta oggi ne è il riflesso — schiavi della ripetizione. Non ci sono più certezze, tutto è soggetto a mera valutazione economica. Un artista non dovrebbe farsi influenzare dalle circostanze esterne. Vivo in completo isolamento, dunque non sono costretto a subire l’inquinamento acustico di altri condomini, non ascolto musica a meno che non voglia farlo. Ma nonostante la mia priorità — che probabilmente conosce: mantenere la musica a un livello più puro possibile — non riesco a prendere le distanze da tutta la merda che c’è lì fuori. Non ci sono mura che riescano a isolarti dalla stupidità, nulla è più potente dell’ignoranza. Credo che gli avvenimenti degli ultimi anni abbiano scosso tutti gli artisti, anche quelli più impermeabili. È triste, e per questo sono così affezionato a queste musiche: arrivano da un luogo dove sempre più raramente i creativi hanno accesso». Si sente isolato? «No. Sto finendo di leggere The Circle, l’ultimo romanzo di Dave Eggers, una storia ambientata nell’era dell’informazione globale che rischia di appiattire le nostre identità, fare scempio della privacy, neutralizzare le opinioni prima ancora che vengano espresse. Mi dispiace, ma non mi sento parte della cosiddetta corporate life né della community di Facebook. Ma sono pur sempre cittadino del Paese dove questo ha avuto origine, lo stesso che ha prodotto una musica straordinaria, meravigliosamente multirazziale e multiculturale». Il jazz: la musica classica del ventesimo secolo? «Speriamo non ci vogliano due secoli per acclararlo». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale LA DOMENICA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 36 Next Trasporto aereo Molto più economiche, ecologiche, veloci e perfino belle, le funivie stanno conquistando i grandi centri urbani 10 volte meno incidenti rispetto al treno 50 volte meno incidenti rispetto all’auto Dopo Londra, Rio e Medellin, dove si viaggia già sospesi, anche Amburgo, Ankara e Lagos (tra le tante) avranno presto una metropolitana in cielo Città volanti Le Se il traffico è appeso a un filo VALERIO GUALERZI È neidettagli che si nasconde il diavolo. Così, tra un futuro visionario e uno molto più banale, la differenza può farla un semplice filo. Intere generazioni di autori di fantascienza hanno immaginato città avveniristiche dove il traffico è sparito, sostituito da un viavai di navicelle che si muovono libere nell’aria. Effettivamente è ciò che sembrano riservarci gli anni a venire, ma il merito non sarà di qualche rivoluzionario sistema di trasporto capace di vincere la gravità. A trasferire buona parte degli spostamenti a qualche decina di metri da terra sarà piuttosto una tecnologia vecchia di oltre un secolo: la funivia. Più ecologica, più economica, più semplice da gestire e spesso decisamente più bella, la funivia sta emigrando dalle cime delle montagne per conquistare sempre più spazi in città, dimostrando di essere anche nelle zone di pianura una validissima alternativa a bus, tram e metropolitane. «Le cabinovie e i sistemi di transito a cavo sono al momento una delle tecnologie più dinamiche e a più rapida diffusione al mondo», spiega Steven Dale, urbanista canadese a capo del Creative Urban Projects. «Mano a mano che un numero crescente di città fa a gara per realizzare reti di trasporti sempre più complesse, aumenta il ricorso alle funivie per risolvere i loro problemi», sottolinea. «È GLOSSARIO FUNIVIA AEREA CABINOVIA Cabine per passeggeri o contenitori per le merci viaggiano sospesi e trainati da un sistema di funi Mezzo a fune che prevede il funzionamento continuativo di più di due cabine per il trasporto di persone Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 37 I PROGETTI ANKARA Con una portata di 2.400 persone l’ora su un percorso di 3.204 metri, sarà la più lunga tra Europa e Asia TOLOSA Sarà ultimata entro il 2017 una linea di 2,6 km: unirà tre punti strategici trasportando 7.000 persone all’ora LAGOS Anche la capitale nigeriana avrà la funivia nel 2015: farà risparmiare ai cittadini fino a 70 minuti nel traffico FOTOMONTAGGIO DOPPELMAYR GROUP, JOHANNES GEISLER DESIGN FONTI: UNIVERSITÀ DI CATANIA, ACI una tendenza generale, ma a trascinare il boom è soprattutto l’America Latina», conferma Carlo Iacovini, manager di Clickutility e curatore di un recente convegno dedicato al tema dalla fiera Citytech. «L’economicità delle linee — osserva — consente l’accessibilità per quelle aree localizzate in collina e poco raggiungibili con servizi di terra. Spesso si tratta di periferie degradate ad altissima densità abitativa che si possono raggiungere solo sorvolandole. Medellin Metrocable in Colombia è in servizio dal 2006; ha reso accessibile il quartiere Aburra Valley trasportando seimila passeggeri all’ora e risollevandolo da una situazione di degrado e isolamento. Rio de Janeiro ha inaugurato la prima Teleferica Do Aleman nel 2011 con 3,5 km di lunghezza e sei stazioni che collegano alcuni quartieri residenziali con il centro, con una capacità di tremila persone all’ora. Il successo è stato tale che si è replicato con una seconda linea aperta in queste settimane che unisce il quartiere di Morro da Providencia (la più antica favelas di Rio) con il centro in pochi minuti». I numeri dei collegamenti via cavo sono sorprendenti. Ogni chilometro costa tra i tre e i quattro milioni di euro contro i cento di una linea metropolitana, ma può garantire lo spostamento anche di tre o quattro mila persone all’ora, con punte fino a ottomila. «Ancora più interessanti sono i costi di gestione, davvero bassissimi visto che queste linee hanno bisogno di poco personale di controllo e solo alle stazioni del capolinea», sottolinea Maurizio Todisco, manager della Leitner, azienda altoatesina leader del settore. Molto più silenziose e meno inquinanti grazie ai motori elettrici, le funivie hanno anche tempi di realizzazione decisamente più rapidi visto che, se il percorso non prevede ostacoli particolari, un classico tracciato cittadino da 56 km richiede meno di un anno per la sua realizzazione mentre tram e metropolitane possono avere bisogno di oltre un decennio. Così, a fronte di questi vantaggi, la lista delle città che hanno già scelto o che si accingono a scegliere la mobilità via cavo si allunga di mese in mese. «Nel giro di pochi anni la parte del nostro fatturato derivante da cabinovie urbane è passato dal dieci al venti per cento del totale e siamo convinti che il business del futuro ormai sia sempre più questo», sottoli- nea ancora Todisco. La Paz, Tolosa, Groningen, Lagos, Amburgo, La Mecca sono solo alcuni dei nomi di un elenco di progetti che tocca ormai i cinque continenti, ma il caso più clamoroso è forse quello di Ankara dove è in via di realizzazione un vero e proprio reticolo di linee aeree che anche nella mappa ricorda a tutti gli effetti la tipica ragnatela di un efficiente sistema di metropolitane. E chi non passa alle funivie per risolvere i problemi di traffico lo fa per richiamare turisti, come Londra, dove la linea che sorvola il Tamigi inaugurata in occasioni delle Olimpiadi del 2012 è diventata una delle principali attrazioni. Sostanzialmente assente da questo grande fermento l’Italia, malgrado abbia in casa un’azienda come la Leitner che insieme agli austriaci della Doppelmayr si spartisce il mercato mondiale del settore. Da noi, da Segrate a Genova, dal Ponte sullo Stretto all’Eur di Roma, siamo fermi a qualche progetto a corto di soldi o in attesa di passare dalle tante forche caudine burocratiche. Eppure non mancano le idee d’avanguardia. L’architetto Stefano Panunzi, docente di Ingegneria edile all’Università del Molise, sponsorizza da anni la proposta di una «circolare volante» che unisca i vecchi forti dismessi che fanno da corona al centro di Roma, ma davanti allo stop della sovrintendenza collabora ora alla battaglia per la realizzazione di una cabinovia che unisca una zona periferica (Casalotti) al capolinea di una linea della metro (Battistini). «Ma non bisogna farne una questione ideologica, le funivie non sono una panacea, occorre promuoverle partendo dal basso, sulla spinta dei cittadini e dei comitati di quartiere finalmente consapevoli che esistono delle valide alternative, economiche ed ecologiche, per riqualificare i loro quartieri». Anche quest’ultimo progetto per il momento è solo un sogno, ma come spesso accade, nel Paese dove il normale è quasi sempre impossibile, a volte succede qualcosa di eccezionale. È il caso di Perugia, dove dal 2008 è in funzione il primo esemplare al mondo di “minimetro”, una teleferica composta da 25 vagoni privi di conducente che adagiati su un binario vengono tirati da un cavo lungo un percorso di 4 km articolato in sette fermate, compresi i capolinea. LIMA Pronta per l’estate 2014 la linea che collegherà il Parco Muraglia con il Cerro di San Cristobal LA PAZ La più lunga teleferica urbana del mondo, con 10.337 mt. per 3 linee e 11 stazioni, sarà pronta tra un anno GENOVA Potrebbe essere la prima in Italia: una linea che in 90 secondi porterà dal centro all’aeroporto Colombo © RIPRODUZIONE RISERVATA TELEFERICA MINIMETRO RETICOLO Impianto per il trasporto di materiali Il più diffuso è il continuo trifune, costituito da due funi portanti e una traente Evoluzione della funicolare: trasporto automatico su rotaia, con trazione a fune Il primo è a Perugia Sistema di funivie a ragnatela che mira a sostituire le linee ferroviarie della metro, come ad Ankara ROMA Una teleferica che da Monte Mario arriverà allo Stadio Olimpico: un progetto ancora sulla carta Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 38 I sapori Più che il gusto poté il marketing. Fatto sta che i nuovi modi di preparare la bevanda più amata dagli italiani conquistano sempre più fette di mercato Acqua Temperatura ambiente, minerale oligominerale o microfiltrata, per evitare che cloro e calcare rovinino gli aromi del caffè Mai superare la valvola Filtro Inserito sulla caldaia e riempito senza pressare la polvere (rapporto di 1 a 10 con l’acqua) Controllare periodicamente che i forellini siano liberi Moka Familiari A ottant’anni dalla nascita dell’ “Omino coi baffi”, tocca quindi schierarsi: vecchia macchinetta o modernissima capsula? LICIA GRANELLO himai potrebbe prepararmi un caffè come me lo preparo io, con lo stesso zelo... con la stessa cura... Capirete che, dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente». Il monologo di Eduardo de Filippo in Questi fantasmi! suona come il racconto di uno dei piccoli lussi che scandisce le nostre giornate. Roba per palati adulti, da concedersi in compagnia o in beata solitudine, a piccoli sorsi o tutto d’un fiato, nero e bollente o ingentilito da un nonnulla di latte, buono a tutte le ore o contingentato per paura della caffeina. Un piacere lungo un secolo — dai primi brevetti delle macchine espresso — che non conosce flessioni. Anzi, là dove la fruizione casalinga non andava al di là di napoletana e “Moka Express”, inventata da Alfonso Bialetti nel 1933, oggi furoreggiano le mini-espresso. Una rivoluzione annunciata, destinata a dividere gli appassionati. Il fuori-casa è indissolubilmente legato al consumo del cosiddetto “caffè da bar”: i tempi compressi, l’ansia di un altrove da raggiungere un attimo dopo l’ultimo goccio, lo scambio rapido di battute con i vicini di bancone. Un consumo “sociale” così abitudinario che qualità della miscela e bravura del barista spesso scadono a optional: con un tristanzuolo cambio di vocale, il gesto diventa più importante del gusto. A casa, il caffè obbedisce a una ritualità diversa, che solletica tutti i sensi. Il gorgoglìo del liquido che sale, l’aroma di tostatura, la tazzina calda tra le mani, il sapore deciso accompagnano l’inizio giornata in milioni di case. Una tradizione così rapida a radicarsi che già negli anni ’30 la ditta torinese Gaud aveva lanciato una caffettiera-sveglia pronta a entrare in funzione all’ora desiderata, arrivando perfino a versare il caffè direttamente nella tazzina. Un rapporto d’affezione testimoniato dai quasi due milioni di pezzi venduti lo scorso anno. Così, negli ultimi anni Illy, Lavazza e Nespresso si sono mossi con l’obbiettivo di scardinare il potere dell’Omino coi baffi — caricatura dello stesso Bialetti ideata dal grafico Paul Campani per una fortunata serie di Carosello — e conquistare il mercato del caffè porzionato. Più del caffè (solo negli ultimi mesi si è arrivati alle capsule mono-origini), hanno potuto i poderosi investimenti nel marketing — le campagne con Clooney e Brignano testimonial — e nella tecnologia (comprese le primissime portatili). Sforzi capaci di produrre una prima erosione sensibile, se è vero che oggi quasi il 15 per cento delle famiglie italiane ha già affiancato, quando non sostituito, l’espresso alla Moka. Se ancora non avete deciso a chi far vincere il derby del caffè, regalatevi una gita a Milano, dove fino all’8 dicembre il Museo della Permanente ospita “La Moka si mette in mostra, 80 anni di un’intuizione geniale diventata mito”. Quando uscite, andate in uno dei bar della “Rete del caffè Sospeso”, che il 10 dicembre in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, riproporrà l’usanza napoletana di lasciare un caffè pagato (sospeso) a chi non può permetterselo. Bevetene uno e pagatene due. Perché il caffè è un piacere: se non lo puoi condividere, che piacere è. «C © RIPRODUZIONE RISERVATA L’evoluzione Caffè Macinatura non troppo fine (al momento, se possibile), conservazione in frigo in un barattolo a chiusura ermetica di metallo Il de rb i gioca in c a s a affè s el c yd Fiamma Rigorosamente bassa, da spegnere al primo gorgoglìo, per estrarre solo le parti più nobili, sacrificando la coda del caffè, sovraestratta e amara 240 milioni i chilogrammi di caffè tostato consumati nel 2012 in Italia Tazzina In ceramica spessa, per mantenere il calore, di forma conica (maggior superficie aromatica), preriscaldata in un pentolino d’acqua o nel microonde IN MOSTRA Un manifesto degli anni ’60 e un disegno della Moka in mostra a Milano. Sopra, macchine per il caffè dall’inizio del ’900 a oggi Gli indirizzi TORINO TORREFAZIONE GRAN BRASILE Corso Cadore 33 Tel. 011-8990895 MILANO TORREFAZIONE HODEIDAH Via Piero della Francesca 8 Tel. 02-342472 VERONA TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFÈ Via Vittorio Merighi 5 Tel. 045-569499 VENEZIA CAFFÈ DEL DOGE Sestiere San Polo 608 Tel. 041-5227787 BOLOGNA TORREFAZIONE CAFFÈ LELLI Via del Mobiliere 1 Tel. 051-531608 Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 ■ 39 LA RICETTA Cialda Crostata al caffè Ingredienti Per la frolla: 30 g. di burro 3 g. di sale 110 g. di zucchero a velo 40 g. di farina di nocciole 60 g. di uovo intero 290 g. di farina Rigore e creatività nei dolci di Gianluca Fusto, che aprirà un concept store milanese dedicato ai dolci moderni, come quello ideato per i lettori di Repubblica La polvere chiusa in un filtro di carta, spesso intercambiabile tra i vari marchi Viene utilizzata anche per i caffè alternativi (orzo, aromatizzati) + 20% l’aumento delle vendite di caffè in cialda rispetto alla moka nel 2013 Per la ganache: 500 g. di panna UHT 160 g. di copertura al cioccolato bianco Ivoire 40 g. di caffè in grani 1 g. di caffè in polvere 1 g. di vaniglia in polvere Capsule Monoporzione in materiale rigido, contenente da 5,5 a 7 grammi di polvere, declinata in miscele diverse Compatibilità limitata tra le macchine A tavola E poi c’è quello sospeso SILVIO ORLANDO onosco a memoria, grazie a Eduardo, l’autentica ricetta del caffè, quello da preparare col coppittello sul becco della caffettiera. Ma non l’ho mai messa in atto, perché non è che poi io sia un fanatico del caffè. Mi rendo conto, nel confessarlo, della gravità inaccettabile di questa affermazione per un napoletano che ha avuto l’onore di interpretare Pasquale Lojacono in Questi fantasmi!. Ma a casa il caffè lo fa mia moglie Maria Laura, a fuoco lentissimo, senza pressare la miscela nel filtro, lasciandolo pippiare e servendolo bollentissimo. Quello delle varie macchinette con capsule e cialde sostiene non essere caffè, e chi sono io per contraddirla? In casa si beve solo quello della moka, e quando si vuole l’espresso bello cremoso e ristretto si va al bar. Dove, se lo si trova “sospeso”, è ancora più gustoso. Perché all’aroma caldo della miscela giusta si aggiunge quello dell’amicizia. Quella del caffè sospeso è un’usanza napoletana che, risalente al Secondo Dopoguerra, dicono si sia diffusa in molti altri Paesi, perfino in Svezia o Australia. In questi casi temo si tratti di una ciofeca sospesa, ma non è il caso di fare del razzismo, quel che conta è il pensiero. La tradizione è nata, durante un periodo di miseria nera, per regalare un sorriso all’anima di chi non aveva nemmeno uno spicciolo in tasca da spendere al bar. Sebbene, di questi tempi, forse sarebbe più gradito uno smartphone sospeso, purtroppo c’è ancora chi quel caffè non se lo potrebbe altrimenti permettere. Quello di trovare un caffè pagato da un amico è un’attenzione che anche io e Maria Laura, non ancora indigenti nonostante la crisi del cinema, gradiamo ricevere al bar Farnese in via dei Baullari a Roma, vicino casa, dove Angelo è oltretutto rapido nel servirti al bancone un espresso fatto a pressione davvero come Dio comanda. E su questo garantisce mia moglie. C © RIPRODUZIONE RISERVATA MONSUMMANO TERME (PT) SLITTI CIOCCOLATO & CAFFÈ Via Francesca Sud 1268 Tel. 0572-640240 NAPOLI GRAN CAFFÈ Piazzetta Arenella 7 Tel. 081-5562023 CATANIA CAFFÈ CONDORELLI Via Rapisardi 436 Tel. 095-354701 CAGLIARI CAFFÈ GRAFFINA Via XX Settembre 23 Tel. 070-651852 PALERMO CAFFÈ MORETTINO Via Nuova 105 Tel. 091-6883736 Espresso ✃ FROLLA. Ammorbidire il burro a 25°C. Aggiungere zucchero a velo e uovo Unire la farina di nocciole, poi i primi 70 g. di farina. Terminare con la farina restante. Conservare in frigo 3h, stendere in due teglie quadrate di 18 cm di lato a 2.5 mm. Cuocere 22’ in forno a 160°C GANACHE. Bollire 150 g. di panna e mettere in infusione i chicchi di caffè scaldati, il caffè in polvere e la vaniglia. Filtrare, riportare a bollore la panna, poi versarla sulla copertura di cioccolato tritata. Aggiungere la panna restante liquida, frullare. Conservare al fresco per 2 o 3h. Riprendere con la frusta e colare una parte della ganache nel fondo di pasta frolla raffreddata1h in frigo Montare il resto della ganache. Collocarla in due stampi quadrati di 15 cm di lato e raffreddare ancora. Togliere la ganache dallo stampo, appoggiarla sulla frolla e decorare a piacere Iperespresso Grazie alla doppia estrazione, la crema ingloba più aria e resta a lungo nella tazzina Si smaltisce come gasolio È un brevetto Illy A leva Ideata a fine anni ’40, ha una caldaia con resistenza elettrica e un gruppo con pistone azionato da una leva per l’erogazione del caffè Automatica Un solo pulsante per ottenere il caffè, da ristretto a lungo Il grinder con dosatore macina i chicchi per preparare la singola tazzina Repubblica Nazionale DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 LA DOMENICA ■ 40 L’incontro Saggi Da piccolo a salvarlo fu Gino Cervi, ha lavorato poi con Strehler (e c’era anche Brecht), ha prestato la voce a Humphrey Bogart (“la mia scuola”) ed è stato il volto del fustino di detersivo (“mi infuriavo quando in teatro qualcuno mi faceva il verso”) Dopo più di settant’anni di onorata carriera si è ritirato in campagna: Paolo Ferrari “È tempo di chiedermi che cosa sono venuto a fare su questa palla” ennaio di quest’anno. Nel teatro di Casatenovo, provincia di Lecco, Paolo Ferrari recita con Andrea Giordana in Un ispettore in casa Birling. Quindi a un sito internet della locale annuncia, serenamente e senza clamori, il suo ritiro dalle scene dopo più di settant’anni di lavoro. «Gli anni passano via veloci. Fare teatro vuol dire stare lontano da mia moglie, stare lontano da casa. Recito da quando avevo cinque anni, ne ho ottantaquattro. È tanto no? Così mi sono detto “adesso basta. Mi fermo qui”» racconta oggi. Veterano dello spettacolo italiano, interprete teatrale di commedie brillanti, il mitico Archie Goodwin di una delle più belle serie tv di Nero Wolfe, la voce italiana di Humphrey Bogart, Ferrari ha scelto di allontanarsi dalla ribalta con la stessa discrezione con cui ci ha vissuto. Ha scelto di farsi dimenticare, più che di dimenticare. Si è ritirato in un posto magico, nella campagna romana, in una bella villa a un piano, solitaria, isolata tra pioppi e querce, con un prato davanti e tutto intorno un bosco fitto, silenzioso. Un luogo bello e pauroso. «Ma no, è un posto che invita a guardarsi dentro — dice Ferrari con la celebre voce dal timbro caldo che è stata la sua fortuna — Un posto dove leggere, ascoltare musica, coltivare rose, andare in bicicletta, meditare. Alla meditazione io dedico ogni giorno qualche ora. Lasciar passare i pensieri, lasciarli andare senza trattenerli grazie a tecniche speciali, all’om... aiuta, fa bene. Io lo faccio da parecchio tempo. Quando recitavo mi mettevo in camerino e meditavo. Era un modo per ‘‘ facile doppiarlo perché non apriva mai la bocca, andare in sincrono era una sfida, ma doppiandolo ho potuto vedere come modificava il suo personaggio, come cambiava il modo di mettere la sigaretta tra le dita, in bocca, il suo sguardo... L’ho studiato imparando enormemente». Paolo Ferrari è stato un tipo di attore molto borghese, misurato, discreto, equilibrato, perfino modesto. «È vero, ma anche nella mia vita sono capitate cose strane. Mio padre, per esempio, era un uomo dotato di una grossa forza medianica: parlava e la gente si sentiva come toccata. Una volta parlando alla radio salvò un uomo che, confessò poi, si stava per suicidare, ma ascoltandolo desistette. E pensare che mio padre per me era stato a lungo “lo zio”. Solo quando sono diventato grande ho saputo che era il mio vero papà, e non mi dispiacque. Sì c’era stato anche un padre “formale”: il mio cognome vero sareb- Per tanti anni ho chiamato “zio” mio padre perché mi riconobbe solo da grande Quando parlava la gente si sentiva come toccata FOTO CONTRASTO G SANT’ORESTE (Roma) concentrarmi sullo spettacolo». Paolo Ferrari ha fatto l’attore per un tempo esagerato. Appunto, tutto cominciò che aveva cinque anni. Bambino, si era pericolosamente avvicinato all’acqua di un lago ma Gino Cervi lo aveva preso in braccio portandolo via. «Ho un vago ricordo di quell’episodio, ma essere stato tra le braccia di quel grande attore dev’essere stata una predestinazione». Sta di fatto che a soli nove anni recita in Ettore Fieramosca, film storico-avventuroso di Alessandro Blasetti, e alla radio fa il giovane balilla; a tredici anni è già in carriera come attore di cinema, a diciannove debutta con Giorgio Strehler, a trenta è uno dei volti più popolari della tv. Con Vittorio Gassmann e Marina Bonfigli, sua prima moglie, fa Il mattatore nel ’59, l’anno dopo con Enza Sampò approda al Festival di Sanremo come presentatore, poi sarà protagonista di show, varietà, serie tv. Nel ’64 sarà il signor Collalto del Giornalino di Gian Burrasca di Lina Wertmuller con la Pavone (ed era già stato Barozzo nella versione cinematografica di Sergio Tofano del ’43). Alla metà degli anni Settanta il grande successo, è Archie Goodwin nel Nero Wolfe con Tino Buazzelli. «Quando girai quella serie non avevo letto neppure un romanzo: non volevo essere influenzato. Tino Buazzelli? Un autentico ciociaro, un casinista. Il contrario di Gassman che era timidissimo, nonostante sembrasse così sicuro di sé. Che risate con Vittorio una volta, doveva essere proprio durante Il mattatore. Facevamo uno sketch in cui io dovevo tirargli in testa una sedia, ovviamente fatta apposta per rompersi facilmente. Senonché un tecnico puntiglioso l’aveva rinforzata, così quando gliela diedi in testa non solo non si ruppe ma un rivolo di sangue cominciò a scendergli sul viso... Finimmo poi per riderci su ogni volta che ci incrociavamo. Per esempio in occasione de Il sorpasso di Risi. Io fui chiamato a doppiare Jean Louis Trintignant. Mi arrabbiai: “Non lo potevo fare io, il personaggio di Trintignant? Non sono Alain Delon, ma neanche lui”. Mi intortarono col fatto che era una coproduzione italo francese...». Il doppiaggio è stata una parte importante della sua carriera di attore fin dal ’48: David Niven, Franco Citti e, dall’inizio dei ’70, Humphrey Bogart ne Il mistero del falco, Il grande sonno, Agguato ai tropici. «Non ho frequentato nessuna scuola di recitazione. La mia scuola è stata Bogart. Non era be Vitta. Ferrari era mia madre, Giulietta, quotata pianista che introdusse in Italia la musica di César Franck. Fu lei a dirmi del mio vero padre e io pensai subito che se ero figlio di un uomo così, qualche cosa dovevo avere dentro anch’io. Era console italiano in Belgio. E questo è il motivo per cui fui scodellato a Bruxelles». In una vita ricca e luminosa, la sola ombra oscura era il fratello, Leopoldo, che era stato nella polizia fascista e morì annegato nel lago di Como. «Era il ’45, eravamo sfollati. Una mattina mi salutò dicendo che doveva andare in un posto. Lo vidi allontanarsi con un uomo, non tornò più. Lo giustiziarono i partigiani. Per me fu uno shock. Dormii per cinque giorni consecutivi. Non ce l’ho mai avuta con i partigiani per questo, però mi piace ricordare che quando il padre di un suo amico gli aveva proposto di fuggire per salvarsi, Leopoldo aveva risposto: “Questa divisa l’ho presa, l’ho portata, ho la coscienza pulita, non la tolgo e accada quel che deve accadere”». Il giovane Paolo passa il dopoguerra tra i tavoli di ping pong («giocavo puntando soldi e vincevo») e il cinema. «Finché nel ’49 mi chiamò Strehler. Fu una cosa divertente e strana. Io non ero nessuno, avevo fatto fino a quel momento parti da tenentino, nulla più. Fatto sta che mi chiama il Piccolo Teatro per una piccola parte ne Il Corvo di Carlo Gozzi. Io avevo avuto un’altra proposta dalla compagnia StoppaMorelli. Quindi dissi no al Piccolo. Ma loro insistevano, due, tre, quattro volte. Paolo Grassi in persona mi scrisse un telegramma: prendiamo atto della sua indisponibilità ma ci teniamo a dirle che nessuno ha rifiutato con tale ostinazione una nostra proposta, scrisse. Io ero incosciente, mi ero pure detto che forse c’era una omonimia... perché non capivo quella ostinazione: io non ero proprio nessuno. Sta di fatto che lo spettacolo con Stoppa e Morelli saltò. Il Piccolo venne a saperlo e mi richiamò ma l’offerta del mio cachet era stata abbassata. Non mi restò che prendere il mio trenino di terza classe e andare a Milano. Al Piccolo recitai per qualche anno e nel ’56 dalla platea seguii anche le prove de L’opera da tre soldise ben ricordo con Bertold Brecht presente che fece anche correzioni sul testo». Il Piccolo, soprattutto, lo laurea definitivamente alla carriera teatrale: con il Teatro dei Gobbi insieme a Paolo Panelli, Marina Bonfigli, Anna Menichetti, Mo- nica Vitti, Francesco Mulè, con De Bosio, con De Lullo prima di dedicarsi al repertorio brillante accanto a Valeria Valeri, per tutti gli anni Settanta e Ottanta, l’unica attrice di cui ha la foto sulla scrivania dello studio. «Il teatro è stata una grande passione. Di diventare famoso non mi è mai importato granché. Quando feci la pubblicità del Dash, quella di “Le do due fustini in cambio del suo Dash” e per anni in teatro a ogni mia apparizione sentivo dalla platea il sibilo del “Dashshshsh”, diventavo furente». Alla visibilità ha sempre preferito il pudore; alla fama, la sicurezza; agli eccessi, la propria malinconia, tanto che il personaggio che più ha amato è Adriano di Anima nera, il dramma di Patroni Griffi su un uomo tormentato. «Che bel testo», dice cercando nella memoria come in trance le battute che un tempo diceva in scena. “E tu non hai niente da dirmi? E tu non hai niente da dirmi? Nooo”, urlavo, “Nooo”». Le manca essere quello che è stato? Silenziosamente si volta e dalla libreria prende un cofanetto dell’opera omnia di Beethoven e dal tavolino il libro delle poesie e dei racconti di Rilke come due totem pronti a difenderlo dall’isolamento. «Mi stendo su questo piccolo divano e dalla finestra che mia moglie ha disegnato con questo grande arco, guardo il bosco, leggendo le mie poesie e ascoltando la mia musica. Andare a Roma? A teatro? Al cinema? No, troppa fatica. E perché poi? Qui ho un po’ di tempo per ampollosamente guardarmi dentro, per guardare che succede e farmi qualche domanda... Che sono venuto a fare o che dovrei fare dal momento che sono su questa palla. Cose così... E mi bastano». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ ANNA BANDETTINI Repubblica Nazionale
Scarica