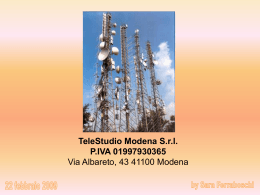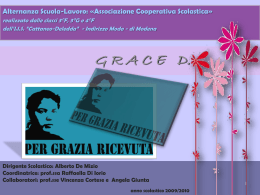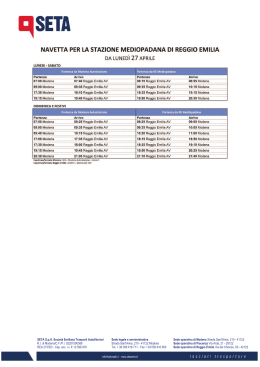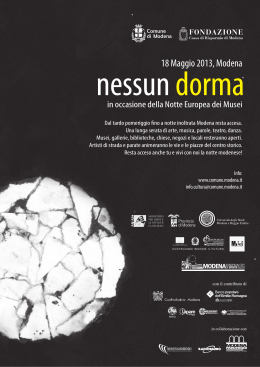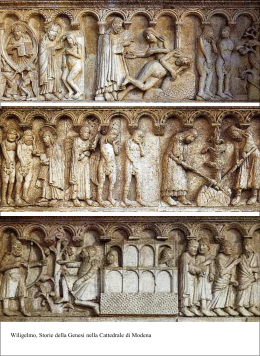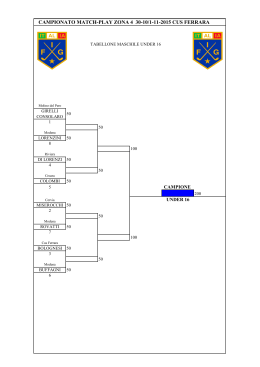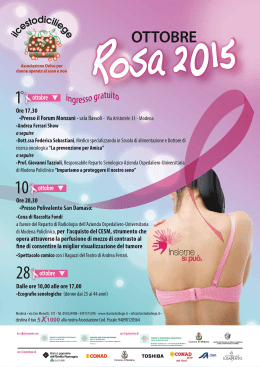La diffusione delle idee protestanti Intorno al 1517, anche in Italia trovavano ampia diffusione tutte le ragioni che provocarono in Germania e nel resto d’Europa il successo della Riforma. Consapevoli della situazione, e sicuri del successo della loro opera, fin dal 1524 alcuni intraprendenti e coraggiosi tipografi veneziani cominciarono a diffondere in traduzione italiana gli scritti di Lutero, che facilmente varcavano i confini della Repubblica approfittando del gran numero di mercanti che frequentavano il Fondaco dei tedeschi. A volte, tali libri proibiti portavano sul frontespizio il nome di Erasmo, oppure erano attribuiti ad autori inventati, al fine di aggirare i controlli più superficiali e grossolani. La situazione, tuttavia, doveva essere effettivamente abbastanza seria, se un decreto emanato nel 1538 menzionava bel 42 titoli di libri circolanti clandestinamente all’interno di Milano e del territorio circostante. Inoltre, le autorità ecclesiastiche mostrarono di essere del tutto impreparate di fronte a un altro fenomeno inedito: la rapidissima diffusione, tra la gente comune, della tendenza a dibattere delicate questioni teologiche. In effetti, come riferisce sdegnato il vescovo di Verona nel 1553, le «persone basse» avevano preso l’abitudine di discutere di problemi religiosi nelle circostanze e nei luoghi più impensati: «per le piazze, per le botteghe, per le taverne et insino per li lavatoi delle donne». In un primo tempo, i timori della Chiesa si concentrarono su Venezia, ove la nuova fede fece diversi proseliti non solo tra umili arrotini, liutai, pollivendoli e sarte (come recita un processo del 1533), ma anche tra i rampolli di alcune tra le più prestigiose e nobili famiglie della Repubblica. Peggio ancora, la causa della Riforma trascinò a sé il vescovo di Bergamo Vittore Soranzo e il patriarca di Aquileia Giovanni Grimani, mentre città importanti come Vicenza e Padova (sede di una prestigiosa università, e quindi di appassionati dibattiti intellettuali) sono descritte rispettivamente come «molto infetta di queste nove opinioni contra l’honor de Dio» e «piena di heretici», negli anni Cinquanta. In questo momento storico, tuttavia, pareva ormai del tutto tramontata non solo l’ipotesi che Venezia aderisse al protestantesimo e si trasformasse nella porta della Riforma in Italia, ma anche la possibilità che la Repubblica continuasse la politica di indifferenza, omertà e neutralità, che di fatto la caratterizzò per circa trent’anni. Le autorità veneziane rimasero profondamente colpite dalla disfatta dei principi luterani a Mühlberg, da parte di Carlo V (1547) e dall’inizio degli scontri per motivi religiosi in Francia (1562). Questi due eventi misero in luce che uno Stato privo di omogeneità confessionale rischiava la disintegrazione e la guerra civile. Pertanto, 1400 volumi eretici furo- no dati alle fiamme a Rialto nel 1548, mentre nel 1556 furono autorizzate le prime estradizioni a Roma di individui accusati di eresia dall’Inquisizione (tali soggetti, tuttavia, non erano cittadini della Repubblica, bensì stranieri). InF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Diffusione dei libri proibiti Frontespizio della prima edizione della Bibbia di Martin Lutero. UNITÀ 5 PERCORSI DI STORIA LOCALE 1 La Riforma in Italia e il caso di Modena La Riforma in Italia e il caso di Modena PERCORSO DI STORIA LOCALE PERCORSO DI STORIA LOCALE PERCORSO DI STORIA LOCALE PERCORSO DI STORIA LOCALE LA DIFFUSIONE DELLA RIFORMA IN EUROPA ALLA METÀ DEL XVI SECOLO Anabattisti Calvinismo Luteranesimo Chiesa anglicana JOHN KNOX SCOZIA NORVEGIA SVEZIA DANIMARCA Cambridge Konisberg Londra Francoforte LUTERO Utrecht Anversa Münster W i t t e n b e r g Lipsia Wartburg Cateau-Cambrèsis Smalcalda ENRICO VIII Gand Parigi POLONIA Worms Basilea CALVINO Zurigo Berna FRANCIA Trento SVIZZERA Venezia Vienna UNGHERIA Genova Modena UNITÀ 5 SPAGNA Madrid L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 2 Ferrara centro eretico Firenze Roma IMPERO OTTOMANO fine, con un decreto del 1564, le autorità veneziane si impegnarono solennemente a ripulire il loro Stato da «quella mala sorte di huomeni che seguono le nuove opinioni in materia di religione, le quali non possono essere salvo che scandalo delli huomeni catholici christiani et di perturbatione della Signoria nostra». Nel resto dell’Italia settentrionale, le fonti ricordano la presenza di numerosi eretici a Cremona (vero epicentro del dissenso religioso lombardo), Mantova e soprattutto Ferrara; in quest’ultima città un nutrito gruppo di protestanti trovò a lungo protezione e rifugio grazie alla presenza della duchessa Renata, francese di origine e calvinista dichiarata. Calvino stesso, nel 1536, per un breve periodo soggiornò a Ferrara, ove il duca Ercole II d’Este non approvava la «mala religione» della moglie e minacciò di mandarla sotto processo. La duchessa fu rinchiusa nelle proprie stanze, mentre dall’ambiente di corte furono cacciati numerosi dei «lutherani ribaldi che tenevano infestata tutta questa città», come recita un commentatore del tempo. Tuttavia, la situazione tornò alla normalità solo dopo la morte del duca e il ritorno della vedova in Francia, nel 1559. In Italia centrale, ci viene testimoniata la presenza di numerosi eretici in Romagna (ad esempio a Imola e Faenza) e soprattutto a Siena e a Lucca. Per quanto minacciati dall’espansionismo dei Medici, questi due centri toscani erano ancora città autonome e libere, il che spiega la riluttanza delle magistrature locali ad accettare l’intervento di qualsiasi autorità esterna, non esclusa l’Inquisizione. Senese fu uno dei più celebri predicatori itineranti della prima metà del XVI secolo, Bernardino Ochino, che nel 1541, fuggì a Ginevra; lucchese invece fu un altro celebre fuggiasco, rifugiatosi anch’egli nella città riformata svizzera: Giovanni Diodati, noto per un’eccellente traduzione della Bibbia in volgare italiano, pubblicata nel 1607. Sia a Siena che a Lucca, numerosi giovani delle famiglie più in vista della città, o comunque esponenti del patriziato locale aderirono alla Riforma, prima che la repressione cattolica colpisse in modo sempre più pesante e sistematico, a partire dalla fine degli anni Quaranta. Al Sud e in Sicilia, i gruppi organizzati furono meno numerosi, ma comunque non mancano segnalazioni di libri proibiti a Napoli o a Palermo, insieme a denunce a singoli intellettuali che a titolo personale condivisero uno o più principi del luteranesimo o del calvinismo. F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 La novità del Beneficio di Cristo F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 Una religiosità intensa, ma sobria Sebastiano Luciani, Ritratto del cardinale inglese Reginald Pole, 1543-1545 (San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage). 3 La Riforma in Italia e il caso di Modena Verso la fine del XVI secolo, la maggioranza dei gruppi e degli intellettuali italiani che avevano scelto la Riforma si indirizzarono verso Ginevra e il calvinismo. Nei decenni precedenti, invece, la teologia dei protestanti italiani fu disponibile ad accogliere e mescolare elementi di diversa origine e matrice, che nel resto d’Europa erano considerati affatto incompatibili gli uni con gli altri. Il dato forse più interessante riguarda Erasmo da Rotterdam, che in Italia, a metà Cinquecento, era universalmente considerato luterano sia dagli inquisitori sia dai dissidenti, malgrado l’aspra polemica sul libero arbitrio che aveva contrapposto l’umanista olandese al riformatore tedesco. D’altra parte, sia i responsabili della repressione, sia le loro vittime, nell’Elogio della follia e in altre opere di Erasmo trovavano varie tematiche e questioni che potevano senza sforzo essere trasformate in strumenti di polemica protestante: l’insistenza sulla Sacra Scrittura e sui padri della Chiesa, più che sulle dichiarazioni dei papi e delle autorità ecclesiastiche; il ripudio di ogni forma di superstizione e delle pratiche puramente ritualistiche, compiute come se fossero riti magici, efficaci in virtù di una formula misteriosa pronunciata nel modo corretto; l’attacco frontale contro l’insistenza posta dalla religiosità tardo-medievale sui santi, su Maria, sulle immagini sacre, sul purgatorio e sulle indulgenze. In generale, quello che veniva cercato era una religiosità intensa, sotto il profilo spirituale, ma sobria, unita allo sforzo di strappare al clero il monopolio della gestione della vita religiosa, che lo storico Massimo Firpo ha definito «volontà di riappropriazione del sacro, sottratto al controllo clericale su una pietà oggettualizzata». Nel 1543, a Venezia apparve per la prima volta, in forma anonima, un libretto intitolato Il beneficio di Cristo, che negli anni seguenti avrebbe avuto un successo strepitoso. Nel 1549, un vescovo veneto scriveva che, a suo giudizio, nei sei anni precedenti ne erano state vendute 40 000 copie solo a Venezia. Può darsi che tale cifra sia esagerata; resta che tale volume è regolarmente citato in innumerevoli processi, a testimonianza della sua ampia diffusione nell’Italia del XVI secolo. Si trattava di un testo molto particolare, sotto il profilo teologico; infatti, da un lato non si lasciava mai andare ad alcuna polemica contro il papa o contro la Chiesa, ma dall’altro presentava la giustificazione mediante la sola fede e perfino la predestinazione come gli strumenti privilegiati scelti dalla grazia e dalla misericordia di Dio, al fine di salvare tutti gli uomini. In tal modo, il testo accoglieva il nucleo centrale del messaggio riformato, interpretando l’universale ansia diffusa tra i cristiani comuni per la prospettiva della dannazione eterna, ma spogliava tale messaggio rassicurante di qualsiasi contenuto anticattolico e antiromano. Questa ambigua prospettiva teologica si comprende tenendo conto della genesi dell’opera, che fu composta nel 1540 dal monaco Benedetto Fontanini da Mantova e completata due anni più tardi da Marcantonio Flaminio, che viveva a Viterbo, nella casa del cardinale inglese Reginald Pole. Fu Pole, insieme al cardinale Giovanni Morone, a promuovere la pubblicazione del Beneficio nel 1543. Negli stessi anni, i due cardinali stavano cercando di gestire la faticosa convocazione del Concilio che avrebbe dovuto affrontare tutti i problemi sollevati dalla rivolta di Lutero. Tuttavia, Pole e Morone concepivano il Concilio come un’importante e significativa opportunità di discussione, non come un’assemblea incaricata solo di condannare gli eretici e di ribadire o al massimo precisare le tradizionali verità cattoliche. Per Morone e per Pole, occorreva dare una risposta credibile alle diffuse ansie religiose dei credenti e trovare soluzioni dottrinali di compromesso, accettabili da entrambe le parti, per evitare la definitiva rottura dell’unità cristiana. A Trento, il loro progetto fu completamente sconfitto; anzi, di lì a poco il Beneficio fu inserito nell’Indice dei libri proibiti. IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE UNITÀ 5 IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 4 Il beneficio di Cristo DOCUMENTI I due brevi passi che riportiamo mostrano che gli autori del volumetto Il beneficio di Cristo recepirono l’istanza fondamentale della Riforma, cioè il concetto di giustificazione mediante la sola fede. In tal modo, Benedetto Fontanini da Mantova, Marcantonio Flaminio e altri intellettuali italiani per un breve momento si illusero di poter ricucire lo strappo portato all’unità della Chiesa dall’appassionata protesta luterana e dalla speculare intransigenza cattolica. Del peccato originale e della miseria dell’uomo La Scrittura santa dice che Dio creò l’uomo ad imagine e similitudine sua, facendolo, quanto al corpo, impassibile [non sottoposto alle sofferenze, n.d.r.], e, quanto all’animo, giusto, verace, pio, misericordioso e santo. Ma poiché egli, vinto dalla cupidità del sapere, mangiò di quel pomo proibito da Dio, perdette quella imagine e similitudine divina, e diventò simile alle bestie e al demonio, che l’avea ingannato: perciocché, in quanto all’animo divenne ingiusto, mendace e crudele, impio e inimico di Dio; e, in quanto al corpo, diventò passibile e soggetto a mille incomodi e infermità, né solamente simile, ma ancora [perfino, n.d.r.] inferiore agli animali bruti. E, sì come, se gli nostri primi padri fussero stati ubbidienti a Dio, ci averebbero lasciato, come cosa ereditaria, la loro giustizia e santità; così, essendo stati disubbidienti a Dio, ci hanno lasciato per eredità la ingiustizia, la empietà e l’odio loro verso dio: di modo che è impossibile che con le forze nostre possiamo amar Dio e conformarci con la sua volontà, anzi li siamo inimici, come a quello che, per esser giusto giudice, punisce li peccati nostri, né ci possiamo mai fidar della sua misericordia. Insomma questa nostra natura per lo peccato di Adamo tutta si corruppe e, sì come prima era superiore a tutte le creature, così divenne suggetta a tutte, serva del demonio, del peccato e della morte, e condennata alle miserie dello inferno. Frontespizio di un’edizione de Il beneficio di Cristo. Due opinioni sulla giustificazione Ora giudichi il pio cristiano qual di queste due opinioni sia più vera, più santa e più degna di essere predicata: o la nostra, che illustra il beneficio di Cristo e abbassa l’arroganza umana, che vuole esaltar le sue opere contra la gloria di Cristo; o l’altra, la quale, dicendo che la fede per se stessa non giustifica, oscura la gloria e il beneficio di Cristo e inalza la superbia umana, la quale non può patire [accettare, sopportare, n.d.r.] di essere giustificata gratis per Iesù Cristo Signor nostro. Oh mi diranno: – È pur grande incitamento alle buone opere il dire che l’uomo per esse si fa giusto appresso Dio –. Rispondo che ancora noi confessiamo che le buone opere sono grate a Dio e ch’egli per mera sua liberalità le remunera in paradiso; ma diciamo che quelle sono veramente buone opere, come dice ancora sant’Agostino, le quali sono fatte da li giustificati per la fede; perché, se l’albero non è buono, non può far frutti buoni. Oltre che, i giustificati per la fede, conoscendosi giusti per la giustizia di Dio, eseguita in Cristo, non fanno marcantanzia [non contrattano, non mercanteggiano, n.d.r.] con Dio delle buone opere, pretendendo con esse di comprar da lui la giustificazione; ma, infiammati dello amore di Dio e desiderosi di glorificare Cristo, il qual gli ha giustificati, donandogli tutti i suoi meriti e tutte le sue ricchezze, attendono con ogni studio a fare la volontà di Dio, e combattono virilmente contro allo amor proprio e contro al mondo e al diavolo. E, quando cadono per fragilità della carne, risurgono tanto più disposi [desiderosi, n.d.r.] di bene operare e tanto più inamorati del suo Dio, considerando che li peccati non gli sono imputati da lui per la loro incorporazione in Cristo, il quale ha soddisfatto per tutti i membri suoi [per tutti gli uomini, n.d.r.] sul legno della croce e sempre intercede per Quali sono gli essi appresso al Padre eterno, il qual, per amor del suo unigenito Figliuolo, gli risguardo sem«incitamenti pre con volto placidissimo, e li regge e difende come carissimi figliuoli, e alla fine gli donerà la amorosi […] che eredità del mondo, facendoli conformi alla gloriosa immagine di Cristo. Questi incitamenti amomuovono i veri rosi sono quelli che muovono i veri cristiani alle buone opere, i quali, considerando che sono cristiani alle buone diventati per la fede figliuoli di Dio e partecipi della natura divina, sono incitati dallo Spirito santo, opere»? che abita in essi, a vivere come si conviene a figliuoli di un tanto Signore, e si vergognano di Per quale motivo non servare il decoro della loro celeste nobiltà, e però mettono ogni studio nella imitazione del il cristiano loro primogenito fratello Iesù Cristo, vivendo in somma umiltà e mansuetudine, cercando in giustificato per fede, ogni cosa la gloria di Dio, ponendo l’anima per gli fratelli, facendo bene alli nemici, gloriandosi in caso di ricaduta nelle ignominie e nella croce del nostro Signore Iesù Cristo. nel peccato, non deve disperare della B. FONTANINI DA MANTOVA, M. FLAMINIO, Il beneficio di Cristo, Claudiana, Torino 2009, salvezza eterna? pp. 27-28, 62-64, introduzione e note a cura di S. CAPONNETTO F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 PERCORSO DI STORIA LOCALE F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Un abile diplomatico Riferimento storiografico 1 UNITÀ 5 pag. 8 5 La Riforma in Italia e il caso di Modena Nato nel 1509, Giovanni Morone era figlio di un alto funzionario del duca di Milano Francesco Sforza; Girolamo Morone, il padre del futuro cardinale, come Francesco Guicciardini e papa Clemente VII era preoccupato dello straordinario potere che Carlo V aveva assunto in Italia, dopo il clamoroso successo di Pavia, nel 1525. Pertanto, appoggiò il progetto di una lega antimperiale, che tuttavia sfociò nel disastro del sacco di Roma (1527) e provocò la completa rovina sia del duca di Milano, sia della famiglia Morone. Pur essendo inizialmente privo di una sincera vocazione religiosa, e persino sfornito di una specifica formazione teologica, il giovanissimo Giovanni ottenne allora dal papa la possibilità di diventare vescovo di Modena, a partire dal 1529, e poi una serie di incarichi diplomatici presso la corte di Vienna, che gli permisero di entrare a diretto contatto con l’esplosiva situazione tedesca. Mentre altre figure disponibili al dialogo con i luterani giunsero alle loro posizioni concilianti e dialogiche in virtù di percorsi spirituali e raffinate meditazioni teologiche, Morone agì quasi sempre da abile politico: aveva toccato con mano che la repressione, da sola, non avrebbe mai ricucito lo strappo apertosi con le Tesi di Lutero, che per altro toccava una serie di veri problemi, molto sentiti da tutte le coscienze cristiane più sensibili del tempo. Tali questioni erano di tipo morale (si pensi al comportamento scandaloso e mondano di vari papi, all’inizio del Cinquecento), disciplinare (molti preti erano ignoranti, così come numerosi vescovi non erano all’altezza del loro compito di guide della Chiesa, a livello locale) e perfino teologico, in quanto il senso del peccato e il timore della punizione eterna generavano angosce e frustrazioni, che trovavano sfogo nel culto mariano o nella venerazione delle reliquie dei santi. Morone cercò sempre il dialogo, con i protestanti, seguendo una procedura che – con il passar del tempo – fu ritenuta sempre più sospetta da Gian Pietro Carafa, il cardinale che sosteneva nel modo più coerente la necessità della linea dura: «Li heretici si voleno trattare da heretici», soleva dire, insistendo sul fatto che i dissidenti dovevano sottomettersi, oppure essere schiacciati. In virtù del suo «heretico spirito di cercar d’accordare fra catholici et heretici», quando Carafa divenne papa (nel giugno 1555) con il nome di Paolo IV, il tribunale dell’Inquisizione (o Sant’Uffizio) aprì formalmente un’inchiesta contro Morone, che fu addirittura arrestato e detenuto a Castel Sant’Angelo dal 1557 al 1559. Solo la morte di Paolo IV pose fine al procedimento, che si concluse con una solenne assoluzione proclamata il 13 marzo 1560. Nell’istruttoria del processo, ebbe un ruolo determinante il domenicano Michele Ghisleri, mentre Morone poté invece sempre contare sul leale appoggio di Carlo V, che condivideva i suoi sforzi di trovare strade di mediazione alternative alla repressione pura, per affrontare la delicata situazione religiosa tedesca. Nel 1566, Ghisleri fu eletto papa con il nome di Pio V, e la sua candidatura fu apertamente sostenuta dal nuovo re di Spagna, Filippo II, figlio di Carlo V, che dunque spostò il proprio sostegno «dal Morone al Ghisleri, dall’inquisito all’inquisitore, dall’imputato al giudice» (M. Firpo). Era segno che non solo la Chiesa, ma anche il più potente dei sovrani cattolici aveva scelto la via della guerra senza quartiere contro l’eresia, svuotando di qualsiasi significato i progetti di chi ancora sognava una riconciliazione o almeno una convivenza pacifica e una soluzione politica basata sulla tolleranza. IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA Giovanni Morone Ritratto del cardinale Giovanni Morone, dipinto della prima metà del XVIII secolo di artista ignoto (Bologna, Quadreria dell’Università). La linea cattolica intransigente Dio volesse, illustrissimo et reverendissimo monsignore, che le cose concernenti la santa fede fussero state sempre trattate con quella reverentia di Dio et vive fede che oggi sono trattate da Quale atteggiamento assumevano «coloro la Santità di Nostro Signore, et Dio volesse che quello heretico spirito di cercar d’accordare fra che stanno de catholici et heretici non avesse regnato, et hoggidì non regnasse in molti: perché di qua stimo mezzo»? Quale che sia nato tutto il fondamento del male che hoggidì pate [soffre, n.d.r.] la christiana repubblica, beneficio hanno et peggiori sono questi che stanno de mezzo, più dannosi questi mediatori della concordia che portato, secondo non sono li manifesti heretici. […] So ben che simil cose non ponno [non possono, n.d.r.] esser l’autore, agli ricordate senza lagrime da chi è christiano, et concludo che chi è tale deve più tosto voler mointeressi della rire che lasciar levar ad istanzia di heretici [per compiacere gli eretici, n.d.r.] un solo iota [la letChiesa di Roma? tera più piccola dell’alfabeto ebraico, n.d.r.] delle sacre Scritture né alterare la verità della santa Quale accusa viene fede o vero vendere li santi dogmi di quella per dinari da far guerra al Turcho. mossa all’imperatore M. FIRPO, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo tedesco? processo d’eresia, Morcelliana, Brescia 2005, p. 467 Il caso modenese 6 L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II DOCUMENTI La posizione di Pole, di Morone e degli altri religiosi disponibili a dialogare con i protestanti anche sul terreno dottrinale emerge con particolare chiarezza se confrontata con l’atteggiamento intransigente di chi voleva ricorrere solo alla repressione. Il testo seguente si incontra in un lungo memoriale inviato nel gennaio 1559 da Zaccaria Delfino al cardinale Carlo Carafa, a proposito della grave situazione tedesca. «Per la Chiesa di Roma, prima ancora di una lotta dura e difficile contro un nemico esterno, contro le eresie dei riformatori e gli eserciti dei principi tedeschi, questi decenni segnarono anzitutto un aspro scontro interno per la definizione dei presupposti, delle verità e degli strumenti con cui quei nemici avrebbero dovuto essere combattuti e vinti» (M. Firpo). UNITÀ 5 IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE 2 Riferimento storiografico pag. 10 Una città “infetta” Modena, la città di cui Morone fu vescovo nei decenni centrali del XVI secolo, contava 12 268 anime nel 1509, ma poi fu colpita da carestie e pestilenze negli anni 1526-1528. Nei decenni seguenti, si registrò un significativo processo di spostamento della popolazione dal contado al capoluogo; pertanto, nel 1549, la città contava circa 20 000 anime, una cifra che rimase sostanzialmente costante fino al 1581. In questi trent’anni, Modena registra un discreto e stabile benessere economico, proveniente soprattutto dall’esportazione di tessuti pregiati in lana, velluto e seta. In quell’ambiente benestante e relativamente colto, il messaggio protestante riuscì a diffondersi e a mettere stabili radici per diverso tempo. Modena è la città italiana che ha conservato l’archivio dell’Inquisizione più ricco e più completo. Oltre tutto, questo centro nel cuore dell’Emilia-Romagna registrò nel Cinquecento un’altissima presenza di eretici, al punto che un principe luterano tedesco, negli anni Trenta, la definì come la «sola benedica in Italia». I primi segnali di dissenso religioso in direzione lutherana (il termine, però, è spesso usato dalle fonti in modo alquanto vago e generico) comparvero nel gruppo dei sacerdoti che prestavano servizio in cattedrale e che a quell’epoca erano denominati canonici. Inoltre, si fece notare in breve tempo un circolo culturale denominato Accademia e composto da laici, alcuni dei quali erano medici (come Giovanni Grillenzoni), altri docenti di scuola, altri ancora esponenti di spicco delle più prestigiose famiglie cittadine (come i Molza e i Rangoni). Il vicario del vescovo Morone – spesso assente dalla città, per gli incarichi diplomatici ricevuti dal papato, da svolgere in terra tedesca – non riuscì a tenere sotto controllo la situazione. Solo a partire dal 1542 iniziò una lenta controffensiva cattolica, che prima di tutto ricondusse all’ordine gli accademici, obbligati a sottoscrivere una dichiarazione di ortodossia. Coloro che non vollero piegarsi si allontanarono dalla città; è possibile, tuttavia, che numerosi degli intellettuali obbligati a conformarsi per evitare un processo lo abbiano fatto solo in apparenza, conservando in coscienza le proprie convinzioni eretiche. Questa opinione è sostenibile in base al fatto che, negli anni Quaranta, la città era stata tutt’altro che purgata dall’infezione dell’eresia. Semplicemente, questa modificò i propri connotati e i propri caratteri. Innanzi tutto, registriamo una capillare diffusione di opi- F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 7 Un sospetto eretico viene torturato durante un interrogatorio di un tribunale dell’Inquisizione. Donne ed eresia nel ducato di Modena Nei verbali dei processi modenesi, ricorre con notevole frequenza il fatto che gli inquisitori dedicarono un interesse del tutto speciale alle donne delle famiglie in cui uno o più soggetti fossero stati sospettati di eresia. Innanzi tutto, esse vennero usate come arma per violare la segretezza di un gruppo ereticale chiuso su se stesso. Infatti, quando la madre o la sorella di una figura di dubbia fama religiosa si recava in confessionale, d’accordo con l’inquisitore il prete incaricato di amministrarle il sacramento minacciava di negare l’assoluzione alla devota, se non denunciava i nomi di coloro che sapeva fossero eretici. In altri casi, spontaneamente, alcune donne denunciavano altre figure femminili; poteva trattarsi di amiche che si erano lasciate andare a discorsi irriverenti nei confronti della messa o del purgatorio. In almeno un caso (nel 1553) abbiamo invece una serva che segnala agli inquisitori il comportamento atipico della propria padrona, che non dice mai le preghiere cattoliche tradizionali, non si fa il segno della croce e non impone a figli e familiari i divieti alimentari tipici della quaresima. Un episodio verificatosi a Sassuolo (distante una ventina di chilometri da Modena) ci rivela invece una signora che, con un pretesto, nel 1556 si recò fuori città dal lunedì prima di Pasqua fino al lunedì successivo la festività. Agli occhi degli inquisitori, si trattava di una chiara strategia per eludere l’obbligo – imposto ai cattolici fin dal 1215 – di conF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Denunciare l’eresia e i comportamenti sospetti La Riforma in Italia e il caso di Modena nioni protestanti a livello popolare (lutherani mechanici, li chiama il vicario del vescovo nei suoi scritti), mentre la prima ondata, come si è visto, aveva investito in prevalenza elementi del clero, della borghesia colta o del patriziato. In secondo luogo, il gruppo dei fratelli si diede una vera struttura ecclesiale, cioè si trasformò in una vera Chiesa alternativa, mentre accentuava lo sforzo di non dare nell’occhio. Se negli anni Trenta non erano mancate le prediche pubbliche a scopo di provocazione, in chiesa o nelle piazze, dopo il 1542 i protestanti modenesi si riunirono di nascosto, in luoghi segreti e clandestinamente, sperando di non essere scoperti. Infine, dai fascicoli dell’Inquisizione emerge un progressivo radicalizzarsi delle posizioni teologiche, che tendono ad abbandonare Lutero per avvicinarsi al calvinismo (sul tema della predestinazione e della negazione del libero arbitrio) o alle dottrine di Zwingli (a proposito dei sacramenti). L’offensiva nei confronti dei fratelli fu lanciata in grande stile a partire dall’autunno del 1566: nell’arco di circa un anno, fu celebrata una ventina di processi, seguiti da altri cinquanta istruiti nel 1568. Un colpo decisivo al movimento fu inferto da un documento papale del 10 febbraio 1567, che autorizzava il vescovo di Modena ad assolvere e ad ammettere di nuovo all’interno della Chiesa gli eretici della città che si fossero personalmente rivolti a lui e che, nel momento in cui si impegnavano a cambiare completamente strada, avessero denunciato i propri confratelli. Si verificò allora, all’inizio degli anni Settanta, un vero esodo di modenesi, diretti innanzi tutto in Svizzera, nel cantone riformato dei Grigioni. Qui poi, a quanto sappiamo, molti di essi non si sarebbero adattati passivamente al calvinismo, ma avrebbero assunto posizioni molto radicali che, a volte, li avrebbero costretti a un ulteriore esilio. IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE UNITÀ 5 IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE 3 Riferimento storiografico pag. 11 fessarsi e comunicarsi almeno una volta all’anno, in occasione appunto della Pasqua. Grazie a tale pratica, ciascun parroco aveva la possibilità di tenere sotto stretto controllo tutti i suoi fedeli, minacciandoli della dannazione eterna in caso di confessione fasulla e di comunione sacrilega. Una decina d’anni più tardi, di propria iniziativa, si presentò invece al vescovo Morone in persona una certa Bartolomea della Porta, la quale – in cambio dell’impunità da poco riconosciuta ai rei confessi disposti a tornare da penitenti all’interno della Chiesa cattolica – confessò numerose deviazioni ed errori. La donna, in effetti, riconobbe di aver rifiutato come contrari alla Sacra Scrittura la fede nell’intercessione dei santi, la pratica devota dei pellegrinaggi e il culto delle immagini. Inoltre, dichiarò di aver letto con passione Il beneficio di Cristo e di averne condiviso la dottrina fondamentale, cioè la giustificazione mediante la sola fede. I processi testimoniano dunque una diffusione capillare dell’eresia luterana tra le donne modenesi, di tutti i ceti sociali, non esclusi quelli alti. Eppure, i verbali conservati nell’archivio dell’Inquisizione mostrano che la comunità protestante modenese non era per nulla femminista. Nella città emiliana, non si verifica quel fenomeno di promozione ed emancipazione femminile che l’adesione a una setta religiosa dissidente avrebbe svolto, circa un secolo dopo, nell’Inghilterra sconvolta dalla rivoluzione. Nel Seicento inglese, non è raro incontrare donne che affermano la propria libertà adottando una religione diversa da quella del padre e del marito; inoltre, nei gruppi inglesi più radicali, l’idea secondo cui lo Spirito santo è concesso in egual misura a tutti i battezzati, senza distinzione tra uomini e donne, fece sì che in alcune comunità la preghiera comune o la predicazione fossero guidate da soggetti femminili. All’opposto, le donne eretiche di Modena vivono all’ombra di figure maschili che le hanno istruite, o che comunque detengono le leve più importanti sia della cultura sia della guida della comunità. Anche agli occhi dei giudici dell’Inquisizione, sono sempre mogli o sorelle di qualche imputato, non soggetti dotati di autonomia decisionale e portatori di una personale, sia pur eretica, esperienza spirituale. L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 8 Riferimenti storiografici 1 Il cardinale Giovanni Morone, tra Modena e l’Europa Giovanni Morone fu una delle figure di punta dell’evangelismo italiano, un orientamento che tentò di trovare un accordo con i protestanti recependone il concetto teologico di base (la giustificazione per sola fede) e respingendo ogni prospettiva di repressione violenta dell’eresia. I sostenitori della linea dura, tuttavia, respinsero questa prospettiva e cercarono addirittura di portare Morone davanti all’Inquisizione. Giovanni Morone era uno dei tanti figli di Girolamo Morone il gran cancelliere di Francesco Sforza duca di Milano, l’artefice primo, insieme con papa Clemente VII, di un tentativo di coalizione politica che cacciasse fuori i barbari – come aveva voluto Giulio II qualche anno prima – per contrapporsi al dilagare dello strapotere di Carlo V al di qua delle Alpi. Tentativo miseramente fallito, com’è noto, destinato a concludersi con quella vera e propria tragedia che fu il sacco di Roma del 1527, la cui brutale violenza e il cui epocale significato storico hanno lasciato tracce ancor oggi visibili sugli stessi affreschi di Raffaello nelle stanze vaticane, dove le alabarde dei lanzi tedeschi incisero la definizione di Roma come Babylon e il nome provocatorio di Luther su quei capolavori, in cui l’immagine della Chiesa di Roma come erede del mondo antico e la sintesi tra classicità e cristianità celebravano i loro fasti supremi. Non stupisce che il fallimento di quell’infausta iniziativa politica e la caduta dello Stato di Milano comportassero anche il crollo, la fine, l’esaurimento del ruolo politico – e anche delle fonti di sostentamento, della ricchezza, del rango sociale – della famiglia del Morone. Giovane non ancora ventenne, con numerose sorelle da sposare e fratelli di scarso talento, molto disposti a spendere e poco a guadagnare, per parte sua egli non poté fare altro che cercare rifugio sotto le protettive ali della Chiesa e precipitarsi nella Roma sconvolta e miserabile all’indomani del sacco, allora definita dall’Aretino non più come caput ma F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 In che modo Giovanni Morone si è dedicato alla vita religiosa? Si può affermare che vi si sia dedicato per autentica vocazione? Spiega l’affermazione secondo cui, a giudizio di Morone, ai problemi posti dai luterani «occorreva M. FIRPO, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo dare una risposta processo d’eresia, Morcelliana, Brescia 2005, pp. 38-40 anche in positivo». F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 Fascicolo in cui sono contenuti gli atti del procedimento e la sentenza definitiva di assoluzione del cardinal Morone dopo l’inchiesta aperta su di lui dal tribunale dell’Inquisizione. 9 La Riforma in Italia e il caso di Modena come cauda mundi [non più capo, ma coda del mondo, n.d.r.], per gettarsi ai piedi di Clemente VII (l’alleato di suo padre) e chiedergli un qualche decoroso beneficio ecclesiastico che consentisse a lui e alla sua famiglia di sbarcare il lunario. Fu così, quasi per caso e controvoglia, che nel 1529 egli divenne vescovo di Modena. Eppure, anche in virtù della straordinaria esperienza politica da cui proveniva, entro un breve volgere di tempo il Morone non tardò a rivelarsi come il più abile diplomatico di cui la Chiesa potesse disporre in quegli anni, proprio nel momento in cui si imponeva con ineludibile urgenza una rinnovata iniziativa politica per affrontare finalmente il problema della Riforma protestante con la serietà che richiedeva, come la tragedia del ’27 aveva ormai evidenziato agli occhi di tutti. Pressoché ininterrotto fu l’impegno diplomatico del Morone in Germania e in Fiandra dalla metà degli anni Trenta fino al 1542 e costante la sua presenza alle diete imperiali (Hagenau, Worms, Ratisbona) in cui si svilupparono gli ultimi tentativi di ricomporre pacificamente sotto l’egida [protezione, direzione, n.d.r.] imperiale i conflitti religiosi che dilaniavano il mondo tedesco e l’Europa tutta. A Gand e a Vienna conobbe i grandi e dignitari e intellettuali che frequentavano la corte imperiale, con alcuni dei quali intrattenne veri e propri rapporti d’amicizia personale, primo tra tutti Ferdinando d’Asburgo, fratello e poi successore di Carlo V sul trono imperiale. Fu allora che egli venne maturando una concezione politica fondata sulla moderazione, sull’irenismo [sulla risoluzione pacifica del conflitto, n.d.r.], sulla volontà di confronto e di mediazione con i protestanti, sempre più convinto che gli strumenti della repressione fossero del tutto inutili e anzi controproducenti, che anche gli eretici dovessero essere trattati humaniter [con umanità, senza violenza, n.d.r.], che solo con le armi della persuasione e del dialogo quelle fratture avrebbero potuto essere ricomposte, che a quella ostilità e a quella rabbia, così come alle esigenze religiose che vi si esprimevano, occorreva dare una risposta anche in positivo, senza limitarsi ad anatemi e condanne. […] La sua non era soltanto una posizione astratta, di principio: era piuttosto il risultato della consapevolezza di chi vedeva le cose come erano, con grande realismo ma senza rassegnazione, di chi assisteva allo svuotamento dei conventi e dei monasteri, al saccheggio delle chiese, allo sradicarsi di una millenaria istituzione dal tessuto sociale, di chi quindi si rendeva conto di quanto fosse del tutto illusorio pensare, come ancora molti facevano a Roma, di poter affrontare il problema della Riforma protestante e la frattura della respublica Christiana [l’insieme degli Stati cristiani, in teoria sottoposto alla duplice guida del papa e dell’imperatore, n.d.r.] solo con le armi delle alleanze politiche e degli eserciti mercenari. Di qui la sua insistente sollecitazione a Roma perché si avviasse finalmente una qualche incisiva riforma, che consentisse alla Chiesa di recuperare una qualche credibilità religiosa, di presentarsi con un volto rinnovato ai suoi interlocutori e avversari tedeschi, di rendere possibili le trattative necessarie all’avvio dell’impresa conciliare. La conoscenza diretta della realtà effettuale delle cose tedesche, tuttavia, non poteva esaurirsi sul terreno politico, ma imponeva anche l’esigenza di indagare più a fondo sulle motivazioni religiose che da vent’anni turbavano e sconvolgevano quel mondo, per capire le ragioni profonde da cui erano scaturite le radicali istanze di rinnovamento, e poi di rottura e di lacerazione che avevano innervato la Riforma protestante. […] Esaurita la stagione dei colloqui di religione, nel 1541, anche il Morone tornò in Italia, dal momento che a quel punto non restava altra strada da percorrere se non quella del concilio, la definizione della cui sede a Trento fu il frutto di un’altra sua efficace missione diplomatica in Germania l’anno seguente. E fu allora, nell’estate del ‘42, che a soli 33 anni, come riconoscimento dei suoi meriti e dei risultati da lui conseguiti nel corso del lungo impegno in Germania, egli venne insignito della porpora cardinalizia e, nell’autunno, inviato a presiedere la prima e presto fallita convocazione del Tridentino insieme con Reginald Pole. Tutto ciò contribuisce a spiegare la grande autorevolezza di cui per molti anni il Morone godette ai vertici del potere curiale, in virtù del suo personale prestigio e della stima e della fiducia nutriti nei suoi confronti da parte dei sovrani asburgici, che in futuro ne appoggeranno più volte l’elezione alla tiara [ne sosterranno la candidatura a papa; Morone, però, non fu mai eletto papa, n.d.r.] IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE PERCORSO DI STORIA LOCALE IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA 2 Nel Cinquecento, Modena fu definita nei modi più svariati. Se un principe protestante tedesco la definiva come la «sola benedica in Italia», le autorità cattoliche usano espressioni durissime, come eretica marza (eretica marcia) e infetta del contagio de diverse heresie come Praga. In effetti, insieme a Lucca, il capoluogo emiliano fu sede di una consistente comunità riformata, dispersa dalla sistematica attività dell’Inquisizione locale. UNITÀ 5 Assente dalla diocesi a causa di un pressoché ininterrotto impegno nelle nunziature [attività di ambasciatore del papa, n.d.r.] in terra tedesca tra il 1536 e il ’42, il vescovo Giovanni Morone fu tenuto costantemente informato degli sviluppi della situazione dal suo efficiente vicario, Giovanni Domenico Sigibaldi, attento a percepire e a denunciare con parole sempre più preoccupate il dilagare di «molti errori in dishonor d’Iddio et roina dell’anime», come il Morone stesso si premurava di far sapere a Roma nel marzo del ’40. «Per diverse vie sono avisato da Modenna – scriveva poche settimane più tardi – ch’in quella città vi sono pessimi principii di heresia, et pubblicamente si parla del purgatorio, delle indulgenze, della messa, della intercessione de santi, dell’autorità del papa, del libero arbitrio et altri articoli nel modo che si fa appresso a lutherani, et gli seminatori di queste zizanie sono astutissimi et cauti et dotti, et si trovavano già haver gran piede». Zizanie la cui scoperta si intrecciava, nelle lettere del Sigibaldi di quei mesi, con la desolata constatazione delle deprimenti condizioni in cui versava un clero cittadino ignorante e indisciplinato, di cui non costituivano certo eccezione i canonici della cattedrale, veri e propri «asini da bastone», a cominciare dal preposito Bonifacio Valentini, unanimemente «reputato luterano perfetto» e in rapporto con alcuni stranieri sospetti (tra cui Camillo Renato, proprio allora fuggito da Bologna) che andavano in giro per le botteghe «a subornar de queste materie rancide lutherane». […] «Tutta questa cità (per quanto è la fama, è maculata, infetta del contagio de diverse eresie come Praga. Per le botege, cantoni, case, etc. ogniuno (intendo che) disputa de fede, de libero arbitrio, del purgatorio et eucharestia, predestinatione», insisteva nel novembre del ’40 il Sigibaldi, inducendo il Morone a chiedere a Roma che si mandassero inquisitori «discreti, fideli et dotti», capaci di rimediare a quella situazione prima che fosse troppo tardi, «perché se li buoni ingegni et buone lettere di quella città con qualche adiuto externo si fondassero nel male, come forsi disegnorno, sarebbe danno irrecuperabile, et fra puoco tempo se ne sentirebbe nova per tutto». 10 L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II Modena, città heretica marza Pierre Mortier, Pianta della città di Modena, 1630 ca. F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 3 Donne, eresia e inquisizione a Modena nella seconda metà del Cinquecento L’adozione di alcune dottrine protestanti non significò affatto lo scardinamento dell’ordine sociale, e tanto meno comportò significativi mutamenti nelle relazioni di genere. Gli inquisitori erano perfettamente consapevoli di questo dato, cosicché dedicarono la maggior parte delle loro indagini agli uomini. Per le donne, sarebbe stato il Seicento il tempo della persecuzione, allorché le preoccupazioni per il diffondersi dell’eresia sarebbero state sostituite da quelle nei confronti del reato di stregoneria. Ci troviamo dunque a contemplare un affresco in cui, benché alle donne fosse accordata una partecipazione formalmente paritaria alle comunità del dissenso, non era ammessa o riconosciuta la possibilità di un ruolo propositivo e concettualmente attivo delle stesse. In altri termini, esse potevano discutere, ripensare e raffreddare, come Bartolomea, le antiche devozioni per far spazio alle consolanti parole della Riforma […], ma, in ultima istanza, era inconcepibile, tanto per gli inquisitori come per i fratelli, che dalla loro iniziativa potesse germogliare l’adesione agli articoli della fede rivisitata. Sono gli uomini che diffondono catechismi proibiti; sono ancora loro a evangelizzare le donne – mogli, sorelle, amiche – e a portarle nei circuiti della protesta; sono sempre gli uomini a guidare le nuove comunità o i circoli che le componevano. Di questa impostazione al maschile dell’intera vicenda ereticale sembra rinvenirsi traccia proprio nella conduzione dei processi a donne accusate di eterodossia, tutte interrogate non già in quanto potenziali soggetti di autonoma elaborazione teologica e dottrinale, ma in virtù del potere suasorio che gli uomini con cui erano in contatto (e a cui i giudici miravano) esercitavano su di loro. […] Anzitutto può costituire un dato su cui riflettere il computo numerico e la distribuzione tra i sessi dei fascicoli ancor oggi conservati all’interno dei fondi inquisitoriali: tra il 1540 e il 1570-75, su circa 180 imputati per eresia, solo una decina sono donne, ciò che in termini percentuali sta a indicare come appena il 5-6% degli accusati si possa ricondurre alF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 5 11 La Riforma in Italia e il caso di Modena Ma per il momento nulla cambiò: «La setta va pur perseverando et moltiplicando, ma nullo [nessuno, n.d.r.] viene a denunciare», tornava a ripetere nel gennaio del ’41 il vicario, che due mesi dopo, sempre più desolato nel constatare la sua impotenza, si scagliava ancora contro quei «novi evangelisti smemorati del Christo, non inamorati come se finzeno», tra i quali «moltissimi manzano carne venere, sabbati non fanno oratione né ieiuni etc. Aboninatione grande!». […] «Sono pegior questi de la setta qua che non è lutherani, perché mi pare di comprehendere ch’habiano abrazato tutte le eresie germanice», si affannava a comunicare in Germania il povero Sigibaldi nell’aprile del ’41, ormai convinto che «a raffrenar le vane opinioni de questa setta non giova prediche né publiche lettioni», bensì severi provvedimenti repressivi concordemente messi in atto dalle autorità civili e religiose. Lo stesso vescovo suggeriva ormai di venire «alla radice del male senz’alcun risguardo» per evitare «che tal infirmità… stando nascosta ammorbi tutta quella Chiesa». Ma anche passare alle maniere forti non era facile, perché «nullo vole essere delatore né a me né all’inquisitore», scriveva il vicario, rivelando la sua amara consapevolezza delle potenti protezioni sociali che circondavano gli uomini più in vista del movimento eterodosso. Le notizie sui colloqui religiosi tra cattolici e protestanti tenutisi a margine delle diete di Hagenau, Worms, Ratisbona circolavano tra gli aderenti alla «setta come se n’havessero lettere ogni giorno, et de tempo in tempo vano dicendo molte impertinenze contra li dogma approvati, secondo l’openioni ch’egli tengono o vorrebbero». Nel giugno l’asprezza delle discussioni dottrinali era giunta al punto di far ritenere «un gran pericolo a valenthuomini predicar o leger publicamente in questa cità, dove alchuni vano ad uno estremo, altri da l’altro circa le buone opere, ne le quali alchuni si confidano troppo, altri in tutto le sprezano dicendo essere soverchie». Per poter ristabilire un minimo di disciplina in mezzo a tanta confusione era dunque indispensabile un Da quale campo chiarimento dottrinale, in grado di chiudere la bocca a quanti parlavano a vanvera dei più sacri semantico vengono misteri della fede, che in passato erano stati di esclusiva pertinenza dei teologi di professione e tratte le espressioni ora parevano invadere le case e le piazze di tutta la città. Ognuno si sentiva ormai autorizzato a usate per definire discutere di fede e di opere, di predestinazione e libero arbitrio, ponendosi alla scuola di chi non l’eresia? Quale nascondeva la «speranza (utinam vana) che l’authorità ecclesiastica vada in fumo et che ne li alrisultato si ottiene tri articoli li sia licito quel che li piace, secondo la libertà christiana carnale a loro modo intesa». con tale scelta? Testimonianza inequivocabile, se ancora ce ne fosse bisogno, degli echi e dei consensi che anQuali difficoltà che a Modena avevano trovato gli scritti dei grandi maestri della Riforma. incontrò, in un primo M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. Un profilo storico, momento, l’attività Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 54-58 dell’Inquisizione? IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE UNITÀ 5 IPERTESTO LOCALE PERCORSO DI STORIA PERCORSO DI STORIA LOCALE L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II 12 l’universo femminile. Un indice significativo sotto certi aspetti, ma pur sempre riprova di un coinvolgimento marginale delle donne nel processo di repressione frontale dei fermenti di dissenso posto in essere dall’Inquisizione Romana. Quanto poi emerge dall’indagine sul merito dei procedimenti a carico di imputate per eresia è la strategia processuale e le finalità per cui i giudici del Sacro Tribunale intrapresero azioni specifiche nei loro confronti: le donne – per lo più mogli, frequentatrici assidue o sorelle – finiscono per costituire una facile via d’accesso al sistema e all’organizzazione della protesta modenese, in grado di descriverne in maniera precisa i contorni, evitando le reticenze o gli scontri frontali messi in campo dai capi della contestazione religiosa cittadina. Se dunque, come si è più volte accennato, il ruolo femminile nell’assetto generale dell’eterodossia locale fu marginale, ciò fu dovuto non a un’esclusione tout court delle donne dai circuiti del dissenso, quanto piuttosto a una configurazione differente e per molti aspetti complementare della funzione a esse assegnate: le donne furono essenzialmente discepole, più o meno convinte, dei propri mariti, amici e affini, talora disposte a coprirne segreti e dissimulazioni, altre volte inclini a confessioni e prese di distanza dettate da motivi di opportunità. Eppure fu proprio questa collateralità a una intellighenzia del tutto maschile a garantire quella diffusione capillare del fenomeno ereticale: assieme ad altri fattori, fu il convincimento e il coinvolgimento del mondo femminile a portare la protesta nelle case, nei mercati e nelle piazze della piccola città estense e degli altri centri ducali. L’estensione di questo contagio, giunto sino alle radici del tessuto sociale, fu alimentato in maniera determinante dal contributo di quelle donne dell’eresia di cui si è cercato di indagare il profilo. Ma molte altre donne furono di fatto schierate – a diverso titolo – sul fronte opposto, configurandosi come delatrici e accusatrici di eterodosse, coinvolte nel circuito repressivo e di controllo posto in campo dalla macchina inquisitoriale. Se si volesse articolare una proposta di lettura della vicenda eterodossa sulla scorta della distinzione di sesso e nell’ottica offerta dai fondi [dai materiali conservati negli archivi, n.d.r.] del Sant’Uffizio, si potrebbe concludere che, mentre il dissenso religioso cinquecentesco ebbe una connotazione spiccatamente (e quasi esclusivamente) maschile, nel secolo successivo le parti s’invertirono per la rinnovata attenzione dei giudici al mondo della stregoneria gestito (ancora una volta quasi esclusivamente) da donne. Certo in questo secondo caso non ci si trova più di fronte a deviazioni dall’ortodossia assimilabili alle idee più o meno radicali di cui l’Accademia prima e i fratelli poi si erano fatti portatori. Come ricorda Brian Levaci «è vero che le streghe venivano solitamente considerate eretiche…, ma l’eresia della strega era qualcosa di completamente diverso dall’eresia di un cattolico o di un protestante non ortodosso». Entrambi però, conclude Levack, «potevano essere perseguiti dalle stesse autorità ed entrambi potevano fungere da capri espiatori dei mali della società». Questo mutamento di prospettiva – a fronte della permanenza dello stesso tribunale – era il prodotto di un cambiamento nella scelta dell’eresia da perseguitare (in parte conseguente al rientrato allarme per l’ondata eterodossa cinquecentesca), nelle priorità che le autorità inquisitoriali avevano posto all’ordine del giorno e nel quadro più generale che faceva da sfondo alle vicende considerate. Senza addentrarsi in una materia di per sé complessa, ciò che si vuole indicare è come il XVI secolo non fu, negli ipotetici laboratori delle dottrine ereticali diffusesi in Italia, un tempo venato dalle sfumature del mondo femminile. Sarà invece il Seicento a porre al centro della scena – almeno di quella del tribunale di fede – «migliaia di persone, in maggioranza donne… processate e condannate a morte con l’accusa di aver stretto il patto con il diavolo e/o di aver praticato malefici mortali (G. Romeo). […] In questa miscela di innovazione e conservazione si deve concludere, con Susanna Peyronel Rambaldi, che «le donne del popolo o quelle appartenenti ai ceti borghesi sembrano apparentemente essere state ai margini della discussione religiosa di quei decenni e sono poche quelle coinvolte nei processi inquisitoriali». Resta dunque condivisibile il giudizio espresso dalla studiosa secondo cui «una storia della Riforma al femminile… è ancora tutta da scrivere, ed è probabilmente assai difficile da farsi e forse ingiustificata». M. AL KALAK, Gli eretici di Modena. Fede e potere alla metà del Cinquecento, Mursia, Milano 2008, pp. 74-82 Spiega l’espressione «impostazione al maschile», utilizzata per descrivere la dinamica di diffusione della protesta religiosa a Modena. A quale titolo e con quale ruolo varie donne furono coinvolte nel circuito repressivo e di controllo posto in campo dalla macchina inquisitoriale? Spiega l’affermazione secondo cui «una storia della Riforma al femminile», non solo è ancora tutta da scrivere, ma forse è addirittura «ingiustificata». F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Scarica