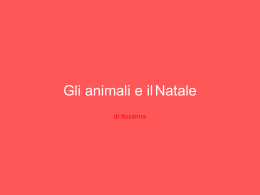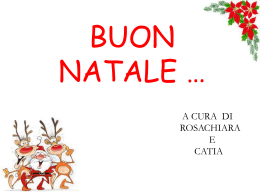ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI Sezioni Valsarmento, Senise, Lagonegro Natale del maestro Episcopia, 28 dicembre 2014 Riflessione dell’Assistente regionale mons. Rocco Natale Vorrei offrire qualche riflessione e proposta per una proficua discussione sui tre punti che questo incontro vuole tenere presenti: l’Aimc, il Convegno ecclesiale di Firenze, il Natale, assumendoli nel loro intreccio. 1 - ..riposatevi un po’. Prendiamo le mosse da un brano del vangelo secondo Marco: “Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: “ venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po’ ” (Mc 6, 31). Nell’orario della giornata, nella scuola e soprattutto nei collegi, troviamo più volte il termine “ricreazione”. Esprime la necessità che abbiamo, ogni tanto, di riposarci, di ricrearci per continuare e migliorare il nostro agire nel quotidiano che, sempre più, diventa logorante fisicamente, mentalmente e, troppo spesso soprattutto oggi, anche spiritualmente. Il corpo per ricrearsi ha bisogno di nutrirsi adeguatamente, di dormire, di recuperare energie. Per ricreare lo spirito sarà necessario ascoltare parole di riconoscimento, di incoraggiamento, di correzione, vedere e confrontarsi con testimonianze concrete, fare esperienza di relazioni sincere, vitali, di conoscenze nuove. Pensiamo al bambino che fa vedere il compito alla maestra: ricevuta l’approvazione, si sente maggiormente motivato nel suo impegno nello studio. Tutte le religioni hanno luoghi, tempi, gruppi per ricrearsi e ritornare al quotidiano più entusiasti, più forti, più decisi, più operativi. Anche noi abbiamo i Santuari, i tempi liturgici forti, le celebrazioni particolari, le feste (specie di gruppi ) che ci sottraggono momentaneamente al quotidiano, ma che sono anche occasione per ascoltare, vedere, scambiare esperienze per poi rinviarci al quotidiano più motivati, più forti e più decisi. Se, però, questi tempi, luoghi, gruppi diventano uno scopo, fine a se stessi, allora si aprono e si chiudono lì e anziché rinviarci al faticoso quotidiano (all’agorà della vita), ce ne distolgono esaurendosi in una generica condanna della vita quotidiana. Rivive così in noi la tentazione dei tre apostoli sul monte Tabor: “E’ bello per noi stare qui: facciamo tre tende… ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: alzatevi e non temete”. Scesero dal monte e andarono verso Gerusalemme, dove Gesù andò incontro alla passione e morte. 2 - La missione Sono convinto che gli incontri dell’Aimc presentano un buon livello culturale e di essi abbiamo bisogno. Siamo chiamati però a riscoprirne e a viverne la validità come nuova forza rigenerante generica e specifica, ricreativa innanzitutto per noi, ma anche per la realtà in cui viviamo, non fuggendo da essa, ma assumendola con idee più chiare e con forze nuove, superando una certa stanchezza. E’ il motivo di fondo per cui esistono la chiesa, la scuola, l’Aimc e tutti i vari gruppi: la missione. Ho parlato di forza rigenerativa: 1 Generica: intesa come arricchimento di idealità, di forza interiore per assumere e gestire difficoltà e conflitti, arricchirsi delle testimonianze degli altri, del confronto con gli altri. - Specifica: ritrovare, purificare le idealità della professione come formatori di coscienze con la trasmissione di un messaggio capace di stupire e non solo come trasmettitori di conoscenze. Siamo chiamati a rigenerarci per andare nelle periferie della storia: - con il proprio specifico da conoscere e portare (non si va da persone neutre, senza colore, senza odore, senza sapore perché così non lasciamo nessuna traccia). - e insieme agli altri (altri gruppi, associazioni, ecc.). E’ finito il tempo in cui ognuno coltiva il proprio orticello. Per fare un esempio, i vari gruppi di studio non devono chiudersi o prevaricare l’uno sull’altro, ma ognuno, nella sua specificità, convogliare nell’assemblea il proprio contributo. Individuare la causa di questa stanchezza che ci porta a vivere in modo distorto i momenti, i luoghi, i gruppi come fine e non come mezzi, come momenti esaltanti, ma chiusi e non aperti alla vita quotidiana da cui continuiamo a mantenerci estranei e di cui abbiamo addirittura paura, può essere di aiuto anche alla Chiesa alla ricerca di come abitare le periferie della storia. Presentando il tema “ Cento piazze” avevamo detto di riscoprire, ritornare alla piazza, alla strada, al circolo, al partito come luoghi educativi in cui maturare i presupposti per stare gioiosamente insieme, pensare insieme, decidere insieme, lavorare insieme attraverso il calore umano, la reciproca conoscenza personale, la comunicazione di progetti condivisi. Recuperare tempi e luoghi che facilitano l’ascolto nell’atteggiamento di chi ha il cuore aperto a Dio, agli altri, al mondo e vuole ancora ricevere per crescere, può essere un primo passo. Credo, infatti, che la stanchezza derivi dal non vedere la significanza dei nostri incontri, la loro incidenza nella realtà: scuola, diocesi, parrocchia, paese. 3 - Chiamati alla profezia Viviamo una vita piatta, assente. Nella professione “Anche quelli tra loro che sono cattolici, che vanno a Messa la domenica ecc., quando indossano il camice ( di lavoro) diventano atei. La loro fede rimane un fatto del tutto privato che non interferisce con la professione” (M. Marzano in “ Quel che resta dei cattolici”, pag. 82) Nella chiesa I laici in parrocchia sembrano essersi ritagliato un ruolo di nicchia tra la sfera di responsabilità diretta della trasmissione della fede (delegata ai preti) e l’impegno socio politico e professionale per il quale non dimostrano particolare interesse, preferendo l’aspetto organizzativo-liturgicocaritativo. Hanno scelto cioè “la facile religione del tempio” formando una comunità ecclesiale circoscritta alla sola dimensione liturgico- catechetica-assistenziale, ( là dove il pericolo tace o è lontano) trascurando lo spazio della “liturgia della vita”, faticosa e sofferta, ma necessaria per la lievitare la storia (costruire il regno di Dio) e avvicinarla all’eternità. Nella società Nel convegno di Napoli “Chiese del sud, chiese nel sud” di qualche anno fa, il prof. Savagnone, circa la crisi che ci attanaglia, ha chiamato in causa la responsabilità delle comunità cristiane e dei laici “per non aver trasmesso una fede incarnata nella storia e nelle sue trasformazioni, preferendo una spiritualità intesa in chiave intimistica, disincarnata e disimpegnata, diventando complici di una visione di vita che non permette vera novità (cieli nuovi e terra nuova) e perciò implica la rassegnazione a ciò che è stato e sempre sarà”. Il papa incoraggia: andare nelle periferie, assumere le periferie esistenziali dell’essere umano nel mondo, vivere le periferie. Preferiamo essere feriti per essere usciti o l’asfissia dell’immobilità? Accettiamo chi puzza di pecora per essere uscito o preferiamo l’amorfo senza puzza, ma anche senza odore? 2 Forse è da rivedere il nostro andare, il nostro essere, il nostro vivere in periferia per una parola che salva, per una profezia, per ridare speranza. Il mondo d’oggi ha bisogno di profezia, ha bisogno di profeti perché possa ritrovare la strada (per noi in particolare ritrovare la strada per educare ripensando i percorsi pedagogici) per sperare. Noi siamo chiamati ad essere profeti Per il popolo ebraico il più grande castigo era il non avere profeti. “Ogni profeta è teso e conteso tra due parole: la parola degli uomini e la Parola di Dio. Non è profeta chi ascolta solo Dio, non è profeta chi ascolta solo gli uomini; è profeta chi ascolta Dio e gli uomini. E’ profeta chi parla agli uomini di Dio e parla a Dio degli uomini”. ( G. Florio in Shalom, pag. 417). Abbiamo avuto altre occasioni per affrontare questo aspetto della profezia. Aggiungo solo un concetto espresso da Enzo Bianchi, il priore di Bose : “ la famiglia, la scuola, la chiesa, per educare sono chiamate a ridire la parola e a ridare la parola”. Oggi nella scuola, nella chiesa rivolgiamo tante parole, ma queste non riescono a suscitare interesse, a creare slancio, sequela, a esprimere la visita di “Dio che salva”. Nell’ultimo seminario organizzato dalla Consulta diocesana il prof. Palmese ci ha detto che “le parole sono stanche”. La difficoltà proviene anche da chi ascolta. Nell’incontro per il Natale 2013 avevamo ricordato che il teologo ortodosso Christòs Jannaràs parla di una società attuale senza slanci, senza èros, senza gusto; parla dell’uomo “incapace di uscire da se stesso, dal suo egoismo e quindi incapace di stupirsi, di innamorarsi: di una persona, di una idea, di un progetto di vita, di una verità senza rinunciare all’egocentrismo di possederla e viverla da sé e per sé”. Vale anche oggi. 4 - Ridare sapore al nostro sapere! In più occasioni abbiamo sottolineato che forse dobbiamo mediare qualcosa dalla civiltà contadina. E’ necessario preparare il terreno attraverso azioni previe come il contadino fa con la terra. Seminare su un terreno non preparato non dà frutti buoni. Fuori di metafora, senza capacità di meravigliarsi, di stupirsi, di uscire da noi stessi, non siamo capaci di essere educati e di educare. Certamente sono da rivedere le modalità dell’azione educativa nella famiglia, nella scuola, nella chiesa. Stiamo dando troppa importanza alle conoscenze, a concetti che non hanno più forza lievitante, incidenza educativa. E non riusciamo a tessere relazioni. Certamente i concetti sono importanti, ma se non supportati da relazione si svuotano. Anche la fede realizzata per riferimento alla nuda parola del vangelo sarebbe solo illusoria e incapace di divenire effettivo principio di integrazione della vita. Senza fondamento solido, senza una storia su cui fondare le parole (passato) e senza profezia (senza accogliere le esigenze dell’altro, senza dare ad esse una prospettiva futura, senza suscitare speranza) non c’è trasmissione di fede. Un affamato non viene nutrito da una bella lezione sulla sana alimentazione, ma da un pezzo di pane anche se duro Tutta la pedagogia di Dio verso il popolo ebraico si fonda sulla liberazione dalla schiavitù egiziana “fatta con mano potente e segni grandi” e sulla promessa del dono di una terra in cui “scorre latte e miele”. Queste due realtà sostengono il cammino del popolo nel deserto, l’alleanza, l’accettazione e l’osservanza delle leggi come via alla vita.“Vedi io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male.. ti comando di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi” ( Dt 30,15-16). Per educare è necessario poter raccontare una storia, aprire a prospettive nuove. Se ad un ebreo veniva chiesto: “per te chi è Jahwè” ? avrebbe risposto: “mio padre era un arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce.. e il Signore ci fece uscire dal paese d’Egitto con mano potente…, operando segni e prodigi…” (Dt 26, 5). 3 Anche nella missione di Mosè Dio si presenta: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe” (Es 3,15). Sempre nell’incontro per il Natale 2013 ricordavamo con Teresa Ciccolini che “Anzitutto in un percorso di crescita umana non puoi pretenderla da altri senza metterti in gioco anche tu: nella misura in cui anche tu percorri un cammino di crescita puoi condividere con chi hai davanti il loro cammino o puoi risvegliare il desiderio” ( “Percorsi di crescita umana: la credibilità del maestro” in Servitium n. 198, pag. 100). 5 – Coscienza sociale “Che tristezza camminare insieme e non farsi compagnia!” (C. Jannaràs, Variazioni sul Cantico dei cantici, pag. 51) Non si educa a distanza, dall’esterno, per televisione: è essenziale la presenza del maestro, la presenza del presbitero. Ne siamo teoricamente convinti, ma in pratica oggi viene meno proprio la mediazione storica, cioè il racconto, la testimonianza, la condivisione, anche quando si sta insieme, si lavora insieme. Sull’esempio dei profeti siamo chiamati a vivere la dura quotidianità con le sue problematiche, con le sue potenzialità e deficienze, nella famiglia, nella parrocchia, nella scuola, nel paese per poter portare una parola e ricevere (necessità di conoscenza) una parola. Molte volte abbiamo offerto la nostra parola che gli altri hanno pure ammirata, ma non l’hanno comprata, non l’hanno fatta propria, perché noi non abbiamo ascoltato le parole degli altri, le esigenze degli altri, non siamo entrati in relazione e non abbiamo chiuso il cerchio educativo. Tuttalpiù siamo stati docenti, ma non abbiamo saputo o voluto diventare discenti. La conseguenza è che non mettendoci in relazione con gli alunni, con i fedeli, con i cittadini, non abbiamo creato una coscienza matura idonea per scelte responsabili, al massimo abbiamo creato una identità da vivere da sé e per sé, ma non in relazione all’Altro. Manca completamente una coscienza sociale. Un indicatore per esaminarci a tal proposito: sentiamo la responsabilità delle parole non dette? “Figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia”. (Ez. 3, 17) “Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo….”. (Lc. 23, 35) Quanti misfatti avvengono in pieno giorno, sotto i nostri occhi e nessuno vede, nessuno sente, nessuno interviene! Così con il nostro silenzio (con le parole non dette) diventiamo corresponsabili del male fatto e del bene non fatto, perché abbiamo taciuto là dove avremmo dovuto parlare. 6 – Uscire e incontrare Il Natale che abbiamo appena celebrato è storia di salvezza. Tutte le storie positive di salvezza hanno in comune una uscita, un cammino faticoso e incerto, un incontro. Vale per Abramo, per Mosè, ma anche per i protagonisti del primo Natale: Maria e Giuseppe, i Pastori, i Magi. Non vale per Erode, che “riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta” (Mt 2, 4). I Magi sanno che è nato, ne hanno l’intima certezza: la stella del mattino è già accesa nei loro cuori; essi chiedono solo dove lo si possa incontrare per adorare. Non bastano le informazioni, è necessario avere un’attitudine all’incontro. E’ indispensabile ridestare e mantenere vigile una sensibilità spirituale, avere gusto, capacità di stupirsi, desiderio di accogliere. Il sapere (le semplici conoscenze) senza quest’attitudine non serve. 4 Erode sa, perché ha tutte le informazioni sul luogo dai sommi sacerdoti e dagli scribi, ma non incontra Gesù, perché non ha questa attitudine. Erode e i sommi sacerdoti sanno, ma le loro conoscenze non li aprono alla novità altra, non li fanno uscire, non li mettono in cammino, non permettono di incontrare. Per loro non ci fu Natale, non ci fu salvezza. Il Natale è un uscire, un mettersi in viaggio per andare a Betlemme, perché solo accettando questa sfida, solo volendo andare verso il Signore Gesù, il suo Natale può essere un incontro, qualcosa di più dell’ennesimo ritorno di una ricorrenza ormai tante volte attraversata senza che ne rimangano tracce consistenti. Questo viaggio, come per i protagoniste del primo Natale, si sostiene con mezzi umanamente fragili, ma all’orizzonte dei quali occorre anche imparare a leggere l’inverno del mondo, il deserto della storia e ad attraversarli offrendo speranza e contrastando ogni avvilimento, vivendo della promessa ( il Dio della promessa…). La nostra vita non ci è data come un libretto in cui c’è tutto scritto, ma è un continuo uscire (a cominciare dalla nascita), camminare, cercare, andare incontro all’imprevisto, saper vedere… Si deve entrare nell’avventura della ricerca, nella gioia del lasciarsi cercare e incontrare dall’Altro. Ogni viaggio è veramente tale solo se nasce da uno sradicamento dalle proprie abitudini, convinzioni, tradizioni (uscire), se conduce ( cammino ) a un vero incontro con l’altro (meta), subendo un trapasso, altrimenti lascia immutato chi lo compie. Nel mettersi in cammino si accetta un rischio, si mette in conto l’imprevisto, positivo e negativo. E’ l’imprevisto, il rischio dell’incontro che sempre propone un “esodo” diverso, un trapasso verso una vita altra. ( es. parabola mercante perle preziose, l’incontro amoroso, la nascita di un bimbo). Allora come non pensare che sarà così anche per il nostro viaggio di Natale che, attraverso deserti e montagne, nel freddo inverno, ci conduce davanti alla luce di Colui che è nato, sotto il segno della stella che arde nei cuori? Questa stella potrà anche eclissarsi, ma, come avvenne per i Magi, ricomparirà e ci condurrà all’incontro. I Magi entrarono, videro, prostratisi lo adorarono, poi “per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”. Anche noi celebrato il Natale torneremo al nostro quotidiano!“Tornammo ai nostri luoghi, ai nostri regni, ma ormai non più tranquilli nelle antiche leggi, fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli”. ( “ Il viaggio dei Magi “ nella lirica di T. S. Eliot ). Queste parole, che all’apparenza comunicano tristezza, contengono una sana inquietudine e una missione da compiere anche nelle ostilità. Se, celebrato il Natale, non siamo più tranquilli delle nostre conoscenze e teorie, della nostra teologia e pedagogia, abbiamo celebrato con frutto il Natale, perché abbiamo accolto il seme di una vita altra. Se troviamo gli altri (figli, alunni, cittadini) ancora aggrappati ai propri idoli, sono coloro a cui raccontare quanto “udito e visto”. Anche i pastori, infatti, ritornano ai loro greggi con parole e comportamenti nuovi capaci di stupire: “se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto… Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano”. (Lc 2, 20). 7 – Conclusioni Nell’emergenza educativa tutti, famiglie, scuola, chiesa, società viviamo l’attesa di un Messia come Salvatore della difficile situazione. Il Messia è già venuto e verrà, ma chiede la fatica della nostra ricerca e del nostro cammino, la nostra attitudine nel riconoscerlo nei piccoli segni, il coraggio di accettarlo liberandoci delle nostre certezze (teologiche, pedagogiche, didattiche, morali, economiche ), la nostra apertura alla verità altra: “E’ la fede cristiana che deve aprirsi e farsi “investire” dalla ricchezza – non sua – della storia e della cultura umana che viene dal di fuori del cristianesimo, senza accaparrarsela. E’ lei che deve 5 aprirsi a quest’ultima e ascoltarla come “una profezia straniera”, “altra da sé stessa”, altra dalla fede cristiana. La percezione che il cristiano abitudinario ha della sua fede, della sua chiesa e del mondo deve lasciarsi interpellare dal di fuori.” (Servitium n.198 “Credibilità e fiducia”, pag. 112). “La chiesa in effetti, vive troppo su posizioni difensive, da “cittadella assediata” e non possiede l’audacia del dialogo con l’uomo d’oggi. La chiesa deve avere maggiore fiducia nell’uomo.” (E. Bianchi, Ridire la fede, in Settimana del clero. n. 36/2012) La testimonianza di papa Francesco ne è una prova con la sua apertura al mondo e l’invito alla chiesa ad uscire da se stessa per entrare con slancio e fiducia nelle pieghe della storia. ( E.G. n.2 ) I problemi non sono stati risolti, ma almeno si è aperto uno spiraglio, un nuovo modo di vedere, sentire, rapportarsi, nel rinnovato impegno di vivere da figli del Regno. Quale la verità altra a cui aprirsi? Nella scuola: la riscoperta delle grammatiche educative, affinché, attraverso relazioni equilibrate, i ragazzi ritornino a saper leggere, scrivere, far di conto, e sappiano fare, da cittadini e da cristiani, scelte sapienti e responsabili. Nelle famiglie: il rapporto autentico con i propri figli. “Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore (coscienza); li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti sveglierai” ( Deut. 6, 7); “ perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che ho compiuto” (Es.10, Nella società: la riscoperta della legge come via alla vita.“Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che significano queste istruzioni, queste norme che il Signore nostro Dio vi ha date? tu risponderai a tuo figlio: «Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi così da essere felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi”. (Deut. 6, 20-21) Il Natale è uscita, cammino, incontro, novità di vita, salvezza: “ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà per tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). A ciascuno, alla scuola, alla chiesa, alla società auguro che nel Natale 2014 possiamo compiere almeno il primo passo: l’uscita da noi stessi. Il resto ci apparirà …e sarà più facile. Perché “solo se esci da te stesso, potrai capire cosa il tuo Dio vuole da te e cosa significa per te andare dietro a Lui ” . Buon Natale! 6
Scarica