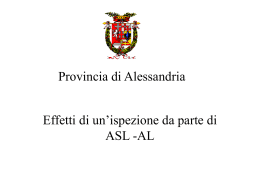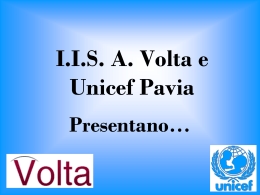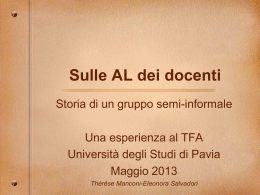Introduzione a MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale Giuseppe Muliere Provincia di Pavia – Divisione Ambiente Settore Risorse Naturali – U.O. Aria&Energia Dipartimento di Ingegneria Elettrica Università degli Studi di Pavia 1 Prima parte Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale L’esempio della provincia di Pavia Seconda parte Hands-on MarkAl tramite l’interfaccia ANSWER: elaborazione di un semplice modello di partenza 2 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Nella seconda metà del ’900 forte sviluppo delle società industrializzate 1992 conferenza di Rio: - Agenda 21 - UNFCCC Tra il 1950 e il 1970 tasso di crescita medio annuo mondiale dei consumi di combustibili fossili pari al 5% circa. Nella conferenza di Stoccolma del 1972 si afferma che lo sviluppo deve essere compatibile con la salvaguardia delle risorse Nel 1997 viene elaborato il protocollo di Kyoto entrato poi in vigore nel 2005 Il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale è imprescindibile da una pianificazione delle risorse energetiche 3 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Capitolo 28 di Agenda 21 “Le comunità dei paesi che hanno stipulato l’accordo, devono creare linee guida per uno sviluppo sostenibile all’interno della loro area di competenza, chiedendo anche la collaborazione dei propri cittadini (A21L)” 4 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Quali informazioni possono essere utili a livello di Amministrazione provinciale? * Verifica delle politiche di derivazione regionale, quale impatto sul territorio? maggiori informazioni per tavolo di confronto e coordinamento * Quante centrali autorizzare? * Quali sono le tecnologie che risultano vincenti per raggiungere gli obiettivi di Kyoto? * Verifica delle politiche di promozione di certe attività * Verifica delle politiche di incentivazione su rinnovabili vs. efficienza energetica? * Qual è il ruolo della biomassa come risorsa energetica del territorio provinciale 5 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Quali strumenti in mano alle province per decidere circa la pianificazione energetica sul proprio territorio? L’analisi di un sistema energetico territoriale può essere affrontata con l’ausilio, tra gli altri, di due strumenti: il Bilancio Energetico Territoriale il Modello del Sistema Energetico Territoriale Il Bilancio Energetico consente di conoscere quantitativamente la situazione energetica di un determinato territorio evidenziando, a vari livelli di dettaglio, i dati relativi a: – – – – le produzioni di fonti energetiche primarie, le trasformazioni di energia primaria in energia secondaria, gli scambi dei vari vettori energetici con gli altri territori, la domanda di energia richiesta dai dispositivi di uso finale 6 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Il Bilancio Energetico Territoriale Questo insieme di informazioni fornisce una fotografia della situazione energetica del territorio per ogni anno preso in considerazione e consente, sulla base delle serie storiche, di valutare i trend evolutivi del sistema in esame. E’ quindi uno strumento certamente utile alla pianificazione, con funzioni non solo di verifica ma anche di indirizzo, permettendo di evidenziare linee di tendenza utilizzabili come primo, ancorché limitato, supporto alle scelte del decisore pubblico. 7 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Uno strumento notevolmente più efficace è rappresentato dal Modello del Sistema Energetico nel quale le caratteristiche (tecnologiche, economiche e ambientali) dei vari componenti del sistema (impianti di produzione e trasformazione, infrastrutture, tecnologie di uso finale) i flussi di energia associati sono descritti in forma analitica in modo da consentire l’applicazione di diverse metodologie di analisi, sia statiche sia dinamiche, essenziali per valutare il comportamento del sistema nell’ambito di scenari evolutivi della domanda, della disponibilità di risorse energetiche e delle tecnologie. 8 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Il Modello svolge diverse funzioni; ma, in particolare: • fornisce una struttura ed un linguaggio comune per le discussioni tra gli attori della pianificazione territoriale; • favorisce la comunicazione in quanto nuove idee (relative a tecnologie e vettori) e nuove necessità (domande di energia elettrica) possono essere valutate molto velocemente; • gestisce facilmente la grande quantità di dati necessari per un’analisi complessa e disaggregata alle varie scale descrittive; • é uno strumento interattivo e trasparente nel senso che i metodi di calcolo, i dati d’ingresso e le ipotesi di base sono palesi ed accessibili da tutti i gruppi coinvolti 9 Introduzione alla pianificazione energetica su scala locale Approccio mediante scenari Per individuare i meccanismi di evoluzione serve un approccio mediante scenari (variazione delle condizioni al contorno) A partire da: – informazioni tuttavia incomplete sul sistema – ipotesi circa le forze guida del cambiamento e le tendenze in atto – con l’analisi di scenario si possono analizzare sviluppi possibili dello status quo per progettarne cambiamenti e verificarne indirizzi. L’obiettivo dell’analisi mediante scenari NON è una predizione di quello che accadrà, ma la possibilità di immaginare configurazioni alternative, date certe condizioni ed entro ragionevoli limiti di probabilità e valutare l’impatto di certe azioni/misure. Questo è l’obiettivo dell’analisi dei sistemi energetici estesi mediante modelli tecnologici complessi come quelli della famiglia MarkAl. 10 MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale MarkAl è un generatore di modelli bottom-up di equilibrio economico parziale basato sulla programmazione lineare, sviluppato nell’ambito dell’Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) dell’International Energy Agency (IEA). A partire da un anno assunto come riferimento “costruisce” le traiettorie energetiche che soddisfano i requisiti della Funzione Obiettivo (costo totale del sistema) e dei vincoli imposti. Infatti, sulla base di criteri definiti dall’operatore, MarkAL: per genera un modello di equilibrio economico parziale del sistema energetico in esame, descrive i diversi processi (tecnologie) e i vettori in termini tecnologici, economici e ambientali, analizzare l’evoluzione del sistema nel medio o lungo termine e consentire studi di allocazione ottimale di investimenti oltre che di spese 11 annuali. MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale Il software crea l’assetto di equilibrio economico domanda-offerta del sistema energetico considerato sul lungo periodo(allocazione ottima delle risorse) MarkAl permette una descrizione dettagliata delle tecnologie e dei vettori (bottom up) e il sistema energetico è descritto tramite il RES (Reference Energy System) Fornisce in output: • la consistenza dei parchi tecnologici (lampadine alogene, centrali elettriche a ciclo combinato); • i flussi dei vettori energetici (consumi di gas naturale negli uffici, produzione di gasolio dalle raffinerie, etc.). 12 MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale Prezzo demand curve Prezzo di Equilibrio Supply curve Consumer surplus Producer surplus Production costs Domanda di Equilibrio Curve di domanda e offerta Quantità 13 MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale 14 MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale Il sistema modellistico MarkAl è composto da: -una banca dati di migliaia di tecnologie energetiche, organizzate in un reticolo topologico detto Reference Energy System (RES) -una struttura matematica composta da un motore (GAMS) e algoritmi in grado di risolvere problemi con centinaia di migliaia di equazioni; - un’interfaccia software di introduzione dati e lettura agevole dei risultati, detta ANSWER. 15 MarkAl come strumento per la pianificazione energetica su scala locale Calibrazione: Verificare che il modello costruito sia coerente RES all’anno BASE (2000): ricostruire una fotografia il più verosimile possibile del sistema energetico in esame: •Studio del sistema energetico •Ricerca dati attendibili •Formulazione ipotesi coerenti •Modellizzazione del sistema energetico con il software (tecnologie, fabbisogni) Analisi senza vincoli ambientali, Economici: scenario BASE Aggiunta vincoli ambientali, Economici, ecc…. Analisi di scenari alternativi allo scenario BASE 16 L’esempio della provincia di Pavia Consumo di energia in provincia di Pavia nel 2000 (fonte: BEP) Dall’analisi del BEP risulta evidente che il settore civile svolge un ruolo di primaria importanza nel sistema energetico provinciale 17 L’esempio della provincia di Pavia Consumo di energia in provincia di Pavia nel 2000 (fonte: BEP) il 65% dei consumi del settore civile è rappresentato dal settore termico; l’80% di questo è attribuibile al settore termico residenziale. 18 L’esempio della provincia di Pavia Consumi del settore termico per comparto di utilizzo e vettore energetico in provincia di Pavia (2000) cucina acqua calda sanitaria gas 5000 kWh = 1.1 TEP = 46 GJ 1 TEP = 1213 Sm3 =1000 kg olio combustibile 1 kWh 0,52 kg CO2 1 Sm3 gas naturale 2,15 kg CO2 1 PJ = 23,9 kTEP gpl gasolio biomassa riscaldamento centralizzato elettricità riscaldamento autonomo 0 1 2 3 PJ 4 5 6 19 Gas Naturale Tec. a gas naturale residue Tec. a gas naturale nuove LTH C.Cogen Gasolio Tec. a LTH Tec. a gasolio residue Tec. a gasolio nuove En Elettrica Tec. elettriche residue Domanda di ACS Pavia Domanda di ACS Pr-PV Usi ELE residenziali Domanda di RA Pavia Tec. elettriche nuove GPL Tec. a GPL residue Tec. a GPL nuove Energia Solare Tec. solari nuove Biomassa Tec. a Biomassa residue Tec. a Biomassa nuove IN (€) OUT (Pj) IN (, €/kW…) OUT (kW, € …) Domanda di RC Pavia Domanda di RA Pr-PV Domanda di RC Pr-Pv IN (Pj) 20 L’esempio della provincia di Pavia 1 - Recupero dei consumi di combustibile per il settore (BEP) 2 - Ipotesi sulla distribuzione dei consumi per tecnologia di domanda (database visite ispettive provinciali) 3 - Calcolo dei rendimenti reali medi stagionali delle diverse tecnologie di domanda (database visite ispettive provinciali) 4 - Calcolo del fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria per ogni tipologia di tecnologia: DomandaACS i ACTi ACTi i Ci yi 21 L’esempio della provincia di Pavia Calcolo del fabbisogno di riscaldamento: 1 - Divisione del parco edilizio in 24 tipologie a seconda: • Caratteristiche pareti verticali esterne • Tipologia di superficie vetrata elaborazione dati ISTAT periodo costruzione edifici in provincia 2 - Calcolo del fabbisogno unitario per ogni tipologia costruttiva attraverso un modello di calcolo in Excel basato su: • Norma UNI 7357 (Calcolo del fabbisogno termico) • Valori delle trasmittanze termiche per tipologia di parete (Comitato Termotecnico Italiano) 22 L’esempio della provincia di Pavia 3 - Ogni tipologie costruttive risultanti, grazie al fabbisogno unitario calcolato, è stata attribuita alla specifica classe energetica: Fabbisogno di Calore Classe Classe A fino a 30 kWh/m 2 Classe B ≤ 50 kWh/m 2 anno Classe C ≤ 70 kWh/m 2 anno 17% Classe D ≤ 90 kWh/m 2 anno 76% Classe E ≤ 110 kWh/m 2 anno 7% Classe F ≤ 130 kWh/m 2 anno Classe G ≥ 130 kWh/m 2 anno FEtot ( FEumi S cli ) i 7,35 PJ 23 Classe A Classe B Classe C Classe D edifici ad uso abitativo (1946 1971) in muratura mattoni pieni - doppi vetri edifici ad uso abitativo (1972 1981) in muratura mattoni pieni vetri doppi edifici ad uso abitativo (1972 1981) in muratura mattoni pieni - vetri singoli edifici ad uso abitativo (1982 2000) in muratura mattoni pieni - doppi vetri edifici ad uso abitativo (1982 2000) in muratura mattoni pieni - vetri singoli edifici ad uso abitativo(1982 2000) in muratura cassa vuota - doppi vetri Classe E Classe F Classe G edifici ad uso edifici ad uso edifici ad uso abitativo (1900 al abitativo (1900 al abitativo (1900 al 1945) in muratura 1945) in muratura 1945) in cls - vetri mattoni pieni mattoni pieni - vetri singoli doppi vetri singoli edifici ad uso edifici ad uso abitativo (1946 abitativo (1900 al 1971) in muratura 1945) in cls - doppi mattoni pieni - vetri vetri singoli edifici ad uso edifici ad uso abitativo (1900 al abitativo (1946 1945) in muratura 1971) in cls - doppi cassa vuota - doppi vetri vetri edifici ad uso edifici ad uso abitativo (1946 abitativo (1900 al 1971) in muratura 1945) in muratura cassa vuota - doppi cassa vuota - vetri vetri singoli edifici ad uso edifici ad uso abitativo (1946 abitativo (1946 1971) in muratura 1971) in cls - vetri cassa vuota -vetri singoli singoli edifici ad uso abitativo (1972 1981) in cls - doppi vetri 24 L’esempio della provincia di Pavia Scenario TENDENZIALE: Scenario 311: Scenario CLASSE A: Andamento della domanda nel caso Ristrutturato: un solo in cui non fossero intervenute leggi passaggio di classe in materia di risparmio energetico Nuovi edifici: stesse classi dell’anno base Andamento attuale della domanda grazie al recepimento della legge 311 che impone la costruzioni di edifici almeno in Classe C Ristrutturato: 80% C, 15% B, 5% A Nuovi edifici: 75% C, 15% B, 10% A Andamento ipotizzabile della domanda nel caso in cui i decisori politici spingessero verso la costruzione di edifici altamente efficienti (in classe A) Ristrutturato: 80% C, 15% B, 5% A Nuovi edifici: 10% C, 20% B, 70% A 25 L’esempio della provincia di Pavia Andamento della domanda nei tre scenari: 9,500 8,79 PJ 9,000 8,500 PJ 8,000 7,35 PJ 7,500 6,67 PJ 7,000 6,500 6,000 6,27 PJ 5,500 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Tendenziale 311 Classe A 26 L’esempio della provincia di Pavia Andamento dei consumi: 33 31 29 26,06 PJ PJ 27 25 23 19,07 PJ 21 19 17 17,78 PJ 15 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Tendenziale 311 Classe A 27 L’esempio della provincia di Pavia Andamento delle emissioni di CO2: 800 Obiettivo Kyoto al 2012: 697 kt 750 kt 700 650 600 550 500 2000 2003 2006 2009 2012 Tendenziale 2015 2018 311 2021 Classe A 2024 2027 2030 28 L’esempio della provincia di Pavia Andamento del costo totale del sistema: 850,0 800,0 M€ 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 311 Classe A Tendenziale 29 L’esempio della provincia di Pavia Andamento della potenza installata per tecnologia: 60 Caldaia a gas naturale 50 Impianti solari termici PJ/anno 40 Boiler Elettrici 30 Caldaia a GPL 20 Teleriscaldamento 10 Caldaie a Biomassa 0 Caldaie a Gasolio 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 30 L’esempio della provincia di Pavia Analisi di sussidi economici per consentire la penetrazione nel mercato delle tecnologie solari e a Biomassa: Contributo del 3% sul costo della caldaia a biomassa Penetrazione minima della tecnologia a biomassa, gli impianti solari rimangono sui valori dello scenario 311 Contributo del 6% sul costo della caldaia a Biomassa Contributo del 20% sul costo degli impianti solari Livello di penetrazione delle tecnologie tale da consentire di avere entro il 2020 il 20% dei consumi totali da fonti rinnovabili (Nota Consiglio Europeo Marzo 2007) 31 L’esempio della provincia di Pavia 35 30 PJ/anno 25 Obiettivo EU: 20% dei consumi da fonti rinnovabili 20% consumi tot 20 15 10 12% consumi tot 5 0 2000 2003 2006 2009 2012 tec. da fonte rinnovabile (senza sussidio) 2015 2018 2021 2024 2027 2030 tec. da fonte rinnovabile (con sussidio) 32 L’esempio della provincia di Pavia L’impegno dell’istituzione pubblica nel raggiungimento di determinati obiettivi (Public Commitment) è fondamentale per l’inserimento di alcune tecnologie nel mercato Dall’analisi degli scenari si valuta che si possa intervenire attraverso: • Sgravi fiscali sul costo d’investimento delle tecnologie più costose ma da fonte rinnovabile • Sensibilizzazione del consumatore ai temi del risparmio energetico • Divulgazione e forte informazione in merito ai benefici economici e ambientali derivanti dall’acquisto di case altamente efficienti 33
Scarica