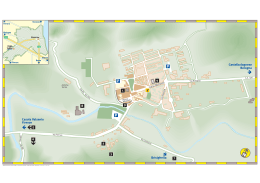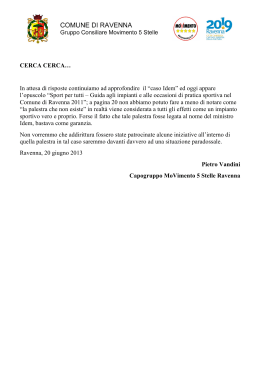Area esterna Palazzo Mauro de André Giovedì 10 giugno 2004, ore 21 ORION di Philip Glass in collaborazione con Mark Atkins, Ashley MacIsaac, Wu Man, Ravi Shankar, Foday Musa Suso e Uakti Composizione commissionata dalle Olimpiadi Culturali di Atene 2004 Produzione Pomegranate Arts New York in collaborazione con Change Performing Arts - Milano In esclusiva per l’Italia FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA con il patrocinio di: SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Fondazione Ravenna Manifestazioni Soci Comune di Ravenna Regione Emilia Romagna Provincia di Ravenna Camera di Commercio di Ravenna Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Associazione Industriali di Ravenna Ascom Confcommercio Confesercenti Ravenna CNA Ravenna Confartigianato Ravenna Archidiocesi di Ravenna e Cervia Fondazione Arturo Toscanini Fondazione Teatro Comunale di Bologna Ravenna Festival ringrazia ASSOCIAZIONE AMICI DI RAVENNA FESTIVAL ASSICURAZIONI GENERALI ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA BANCA POPOLARE DI RAVENNA BARILLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA CIRCOLO AMICI DEL TEATRO “ROMOLO VALLI” - RIMINI CMC RAVENNA CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA COOP ADRIATICA CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE ENI EURODOCKS FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA GRUPPO VILLA MARIA ITER LEGACOOP ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI SAPIR SEDAR CNA SERVIZI RAVENNA TELECOM ITALIA - PROGETTO ITALIA THE SOBELL FOUNDATION THE WEINSTOCK FUND UNICREDIT BANCA UNIPOL ASSICURAZIONI UNIPOL BANCA ASSO Presidente Gian Giacomo Faverio Vice Presidenti Roberto Bertazzoni Lady Netta Weinstock Comitato Direttivo Domenico Francesconi Gioia Marchi Pietro Marini Maria Cristina Mazzavillani Muti Angelo Rovati Eraldo Scarano Gerardo Veronesi Segretario Pino Ronchi Guido e Liliana Ainis, Milano Maria Antonietta Ancarani, Ravenna Antonio e Gian Luca Bandini, Ravenna Marilena Barilla, Parma Francesca e Silvana Bedei, Ravenna Roberto e Maria Rita Bertazzoni, Parma Maurizio e Irene Berti, Bagnacavallo Paolo e Maria Livia Brusi, Ravenna Giancarla e Guido Camprini, Ravenna Italo e Renata Caporossi, Ravenna I DI Presidente onorario Marilena Barilla IC C O NE A I Z M IA Glauco e Roberta Casadio, Ravenna Margherita Cassis Faraone, Udine Giuseppe e Franca Cavalazzi, Ravenna Glauco e Egle Cavassini, Ravenna Roberto e Augusta Cimatti, Ravenna Ludovica D’Albertis Spalletti, Ravenna Tino e Marisa Dalla Valle, Milano Andrea e Antonella Dalmonte, Ravenna Roberto e Barbara De Gaspari, Ravenna Giovanni e Rosetta De Pieri, Ravenna Letizia De Rubertis, Ravenna Stelvio e Natalia De Stefani, Ravenna Enrico e Ada Elmi, Milano Gianni e Dea Fabbri, Ravenna Lucio e Roberta Fabbri, Ravenna Mariapia Fanfani, Roma Gian Giacomo e Liliana Faverio, Milano Paolo e Franca Fignagnani, Bologna Domenico e Roberta Francesconi, Ravenna Giovanni Frezzotti, Jesi Adelmo e Dina Gambi, Ravenna Idina Gardini, Ravenna Vera Giulini, Milano Maurizio e Maria Teresa Godoli, Bologna Roberto e Maria Giulia Graziani, Ravenna Dieter e Ingrid Häussermann, Bietigheim-Bissingen Pierino e Alessandra Isoldi, Bertinoro Michiko Kosakai, Tokyo Valerio e Lina Maioli, Ravenna Franca Manetti, Ravenna Carlo e Gioia Marchi, Firenze Gabriella Mariani Ottobelli, Milano Pietro e Gabriella Marini, Ravenna Paola Martini, Bologna Luigi Mazzavillani e Alceste Errani, Ravenna Alessandro e Claudia Miserocchi, Ravenna Ottavio e Rosita Missoni, Varese Maria Rosaria Monticelli Cuggiò e Sandro Calderano, Ravenna Maura e Alessandra Naponiello, Milano Peppino e Giovanna Naponiello, Milano Vincenzo e Annalisa Palmieri, Lugo Gianpaolo e Graziella Pasini, Ravenna Desideria Antonietta Pasolini Dall’Onda, Ravenna Fernando Maria e Maria Cristina Pelliccioni, Rimini Giuseppe e Paola Poggiali, Ravenna Giorgio e Angela Pulazza, Ravenna The Rayne Foundation, Londra Tony e Ursula Riccio, Norimberga Stelio e Pupa Ronchi, Ravenna Lella Rondelli, Ravenna Stefano e Luisa Rosetti, Milano Angelo Rovati, Bologna Mark e Elisabetta Rutherford, Ravenna Edoardo e Gianna Salvotti, Ravenna Ettore e Alba Sansavini, Lugo Guido e Francesca Sansoni, Ravenna Francesco e Sonia Saviotti, Milano Sandro e Laura Scaioli, Ravenna Eraldo e Clelia Scarano, Ravenna Leonardo e Angela Spadoni, Ravenna Italo e Patrizia Spagna, Bologna Ernesto e Anna Spizuoco, Ravenna Gabriele e Luisella Spizuoco, Ravenna Paolo e Nadia Spizuoco, Ravenna Enrico e Cristina Toffano, Padova Leonardo e Monica Trombetti, Ravenna Ferdinando e Delia Turicchia, Ravenna Roberto e Piera Valducci, Savignano sul Rubicone Silvano e Flavia Verlicchi, Faenza Gerardo Veronesi, Bologna Marcello e Valerio Visco, Ravenna Luca e Lorenza Vitiello, Ravenna Lady Netta Weinstock, Londra Giovanni e Norma Zama, Ravenna Angelo e Jessica Zavaglia, Ravenna Aziende sostenitrici ACMAR, Ravenna Alma Petroli, Ravenna Associazione Viva Verdi, Norimberga Banca Galileo, Milano CMC, Ravenna Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Deloitte & Touche, Londra FBS, Milano FINAGRO - I.Pi.Ci. Group, Milano Ghetti Concessionaria Audi, Ravenna ITER, Ravenna Kremslehner Alberghi e Ristoranti, Vienna L.N.T., Ravenna Rosetti Marino, Ravenna SMEG, Reggio Emilia SVA Concessionaria Fiat, Ravenna Terme di Cervia e di Brisighella, Cervia Viglienzone Adriatica, Ravenna Philip Glass Ensemble Philip Glass tastiere Michael Riesman direttore musicale, tastiere Kurt Munkacsi sound designer Jon Gibson, Richard Peck, Andrew Sterman strumenti a fiato Lisa Bielawa tastiere Eleanor Sandresky tastiere Dan Dryden live sound mix artisti ospiti Eleftheria Arvanitaki (Grecia) voce Mark Atkins (Australia) didjeridoo Ashley MacIsaac (Nuova Scozia - Canada) violino Wu Man (Cina) pipa Gaurav Mazumdar (India) sitar (su musiche originali di Ravi Shankar) Foday Musa Suso (Gambia) kora Uakti (Brasile) Philip Glass rion, il nuovo concerto del Philip Glass Ensemble, mi è stato commissionato dalle Olimpiadi della Cultura 2004 e viene presentato ad Atene prima dell’inizio dei Giochi Olimpici. Per questo evento speciale – che verrà replicato solo in Italia (Ravenna) e Spagna (Barcellona) – ho chiamato un gruppo di noti musicisti – che sono sia strumentisti che compositori – a collaborare con me a un’opera che nella sua forma multinazionale intende riflettere il carattere delle Olimpiadi. Con me ci saranno Mark Atkins (didjeridoo) dall’Australia, Wu Man (pipa) dalla Cina, Foday Musa Suso (kora) dall’Africa, Gaurav Mazumdar (sitar) – che suonerà musiche appositamente scritte dal grande Ravi Shankar – dall’India, Ashley MacIsaac (violino) dalla Nuova Scozia-Canada, Eleftheria Arvanitaki (voce) dalla Grecia e i polistrumentisti di UAKTI dal Brasile. Ognuno di questi artisti ha lavorato con me e tutte le parti sono state incorporate nell’opera intera. Inoltre ci saranno tre interludi formati da duetti di tre coppie di artisti. Orione, la maggiore costellazione del cielo notturno, è visibile in ogni stagione, sia dall’emisfero settentrionale che da quello meridionale. Sembra che tutte le civiltà abbiano creato miti e si siano ispirate a Orione. In questa opera ognuno dei compositori-performer, me incluso, è stato libero di lasciarsi guidare da quella ispirazione nel suo lavoro. In questo modo il cielo stellato visibile da ogni punto del nostro pianeta ci ispira nel comporre e presentare un vero progetto musicale internazionale e multiculturale. O Philip Glass 9 Nebulosa Testa di cavallo, una parte della costellazione di Orione. GUARDARE LE STELLE, ASCOLTARE LE NUVOLE gni tanto, seguendo ritmi regolari come il pulsare della sua musica, Philip Glass esce dall’Immagine e dal teatro musicale – che gli fa scrivere un lavoro ogni due anni, come questo Orion –, lascia a casa l’Ensemble che esegue come-si-deve le sue partiture in giro per il mondo, si siede al pianoforte e si offre al pubblico per quello che è. Suona pezzi scritti per lo strumento, ma soprattutto riduzioni di brani nati per la scena, per la danza, per il cinema, per l’orchestra. Accetta di mostrare la sua musica senza difese, nella semplicità della forma, nell’immediatezza dello stile, riconoscibile al primo arpeggio, nell’essenzialità disarmata delle sue trame. Test che ogni autore dovrebbe compiere a intervalli regolari, per sapere in quale direzione ciò che scrive stia andando. Se incontro o contro la gente, se sulla highway del gusto dominante o sui fuori pista che un giorno tutti scopriranno, grazie a lui. Senza le sonorità nervose dell’Ensemble amplificato, senza le voci e le polifonie dei contesti acustici (sempre più amati negli anni), sullo schermo di una Tac immaginaria la musica di Philip Glass mostra la sua griglia metallica: bassi ostinati, melodie geometriche, segmenti spezzati e ricomposti, onde quadre. Il catalogo è quello. Semplice, troppo semplice, dicono tutti. Bene. Ma quando Philip Glass da Baltimora (31 gennaio 1937) sbatte sul tavolo la sua storia, quanti possono dire di conoscerla per intero? Quanti sanno dire con esattezza come e perché Philip Glass “è” la musica di questo secolo, nel capitolo a suo tempo rivoluzionario chiamato impropriamente minimalismo? “Guardate il cielo azzurro quando c’è qualche nuvola; guardatelo per cinque minuti e, cinque minuti più tardi, avrete l’impressione che nulla è cambiato. Eppure il cielo non è più lo stesso”. L’idea prima della musica americana cosiddetta minimalista, o ripetitiva, continua ad assomigliare a quella immagine poetica e in apparenza evanescente che ne diede Lukas Foss, compositore, direttore e interprete di una Nuova Frontiera verso cui l’Avanguardia storica della vecchia Europa ha sempre nutrito sospetto anche a causa di un motivo: piacque O 11 subito ai musicisti pop. Anzi, affondava le radici quasi nello stesso terreno incolto. Già una ventina di anni fa qualcuno si affrettò a dire che la ripetitività era un linguaggio di dominio pubblico, che non aveva più ragione di esistere di per sé, in quanto già riassorbito come elemento negli altri. Il vaticinio si è rivelato lacunoso, perché nel già avviato terzo millennio, sebbene la ripetitività sia una vecchietta, il pubblico che la incontra allo stato puro per la prima volta (ed è ancora molto) ne rimane sconcertato, disturbato, perplesso. Segno che i suoi obiettivi – la dilatazione del tempo musicale e sensoriale, la confusione dei codici di ascolto – non sono del tutto accettati e/o assimilati. La ripetitività ha vissuto negli anni Novanta una specie di analfabetismo di ritorno e una sorta di schizofrenia: è stata la più ascoltata avanguardia della storia recente e, al tempo stesso, con le avanguardie ha condiviso un certo isolamento. Il cosmo della musica d’oggi è disseminato di ripetitività: dal rock al teatro musicale contemporaneo, anche europeo e italiano, i lampi ripetitivi si vedono ovunque. La ripetitività è in effetti il linguaggio più diffuso nelle sue influenze e derivazioni esterne, ma come movimento storico è semisconosciuto, sia nel pubblico, sia – circostanza più grave – nei musicisti e nei critici. Il suo inquadramento si riduce a qualche nome, qualche disco (recente), a formulette stereotipate che rivelano una cosa: il movimento ripetitivo non è stato vissuto né conosciuto nel momento in cui esprimeva il suo messaggio di rottura o di alternativa. Ma per lo più attraverso i suoi derivati, le sue code, le sue ricadute. Molti lo giudicano oggi con un grado di conoscenza paragonabile a quello di chi veda La donna del lago di Rossini senza conoscere Tancredi, o ascolti il terribile Concerto per viola di Penderecki senza conoscere il sublime De Natura Sonoris. Molti hanno visto l’ultimo film di Godfrey Reggio, Naqoyqatsi, o anche i già storici Koyaanisqatsi e Powaqqatsi, senza aver mai sentito, di Glass, Two Pages o la Music in Twelve Parts; vedono e ascoltano il Dracula di Bela Lugosi senza sapere nulla di Akhnaten o, peggio, di Einstein on the Beach. Ma così va all’inferno quel senso della storia che rende l’ascolto completo, perché di storia si tratta, e lunga. 12 La musica ripetitiva ha per tutti una data di nascita ufficiale e un padre, che tale è solo per caso. La data è il 1964, anno in cui Terry Riley (padre presunto o putativo) registrò per la Cbs il suo In C (In Do), pezzo in cui un piccolo organico di strumenti a fiato e metallofoni (rinvio chiaro al gamelan di Bali) s’imponeva la sfida trappista di creare varietà col minimo materiale possibile (da cui anche minimalismo): pulsazioni in Do – con motivo-guida in crome – in tutte le combinazioni possibili. I cento metri su un piede solo. In realtà anche questa era una piccola distorsione discografica, un delay, un ritardo. In C fu registrato nel 1964, ma composto prima ed eseguito nel 1962-63 da un ensemble in cui compariva anche Steve Reich, terzo capostipite del movimento insieme a Riley e Glass, pur su binari distanti e paralleli. Le radici del movimento vanno inseguite più a fondo nel terreno del dopoguerra americano: il Trio per archi di LaMonte Young, nel 1958, contiene i primi semi del pensiero ripetitivo. Ma già nell’Ottetto di fiati – 1957 – Young introduce, all’interno di uno stile fortemente influenzato dal serialismo, lo scarto di alcune note tenute (anche tre-quattro minuti), e lunghissime pause (anche un minuto), che insinuano nella sua ricerca la vocazione principale della ripetitività stessa: il ritorno al Tempo nella sua forma originaria. Stiamo dunque parlando di una avanguardia che ha già compiuto, anzi superato, i quarant’anni e non è più giovane di quel post-serialismo che si è invece imposto nel dopoguerra, soprattutto in Europa, come ideologia dominante. E che giudichiamo “agée”. I capolavori “strutturati” di Boulez, Berio, Nono, Stockhausen che hanno segnato il nostro tempo non precedono di molto i primi sbocchi minimalisti o ripetitivi. Segno che questi avevano vita autonoma e non erano necessariamente una “risposta” a quelli. Philip Glass ammette di aver visto la sua strada e scoperto i fondamenti della sua musica studiando i millenari segreti del Raga e del Tala, forme le cui rigidissime organizzazioni interne si tramandano da maestro a discepolo, come simbolo di una ars memorativa da noi perduta forse con i Trovatori. Glass conobbe Ravi Shankar a Parigi, dove seguiva i corsi di Nadia 13 Boulanger, forgiatrice di una bella serie di avanguardisti colti. Con pochi soldi in tasca, Glass si guadagnava la pensione facendo da copista delle parti d’orchestra per Shankar, che componeva la colonna sonora del film Chappaqua (prima commissionata a Ornette Coleman, che ne aveva prodotta una giudicata troppo ostica). Più che sui banchi di scuola della Boulanger, Glass trovò domande interessanti da porre al maestro di Benares. Ma due anni prima era stato in India, e dall’inizio appare chiaro che la musica di Glass si muove sui cardini stessi della tradizione indiana: la melodia e il ritmo. Anzi, il ritmo e la melodia – all’inizio – come se la seconda uscisse per associazione di altezze dal primo. Il pezzo con cui Glass fa il suo ingresso nella corrente ripetitiva è essenzialmente ritmico: 1+1 (1968), per esecutore e tavolo amplificato, pezzo formato da due figure ritmiche combinabili e prolungabili a piacere. Di un anno dopo è la Music in Fifths, dove il processo additivo è del tutto formato. Seguiranno la Music in Similar Motion, la Music with Changing Parts e la monumentale Music in 12 Parts, vera Arte della Fuga ripetitiva. Con quest’ultima (1971), Glass ammette di aver concluso la sua fase sperimentale, di non aver più nulla da aggiungere nella definizione dello stile, nella formulazione della sintassi. Fondato il Philip Glass Ensemble, comincia l’applicazione sistematica del linguaggio ripetitivo alle varie destinazioni. Nascono Einstein on the Beach (1975) per il teatro, North Star (1977) per lo schermo (un documentario sullo scultore Mark Di Suvero), Dance (1979) per la danza, Satyagraha (1980) ancora per il teatro, Koyaanisqatsi (1982) per il cinema, The Photographer (1982), Akhnaten (1983) terza parte della trilogia “operistica”, The CIVIL warS (1983 e 1984), Mishima (1984) per il film di Schrader, The Juniper Tree (1984) su una favola dei fratelli Grimm, il Concerto per violino e orchestra (1987), le cadenze per il Concerto per pianoforte K 467 di Mozart, Powaqqatsi (1987), il pezzo sinfonico The Light per la Cleveland Orchestra (1988), 1000 Airplanes on the Roof (1988) “dramma musicale di fantascienza”, Hydrogen Jukebox (1990) con Allen Ginsberg, Passages (1990) con Ravi Shankar, The Voyage (1992) opera per i 500 anni dello sbarco di Colombo, 14 Anima Mundi, la “Low” Symphony, le musiche per un Woyzeck di Büchner (1993), la trilogia ispirata ai film di Cocteau (Orphée, La Belle et la Bête, Les enfants terribles, 1993-96), Monsters of Grace con Bob Wilson (1998), il Dracula per quartetto d’archi (il Kronos). E questo è solo un estratto “per varietà” di un catalogo che sfiora ormai l’opus n.100, in trentacinque anni di arco temporale. Ci ostiniamo a dire Novecento come fosse un secolo in corso. Scriviamo e leggiamo ancora di Prokof ’ev, Stravinskij, Schönberg, Cage, Webern, Šostakovič, venando la formula “musica del Novecento” di delusione e di paura: arte di un secolo pericoloso, ostile. E, invece, semplicemente conosciuto così, a macchia di leopardo, distrattamente più di quanto sia logico e dovuto. Tutto si muove troppo velocemente, invochiamo. Tutto, tranne il nostro senso delle prospettive. Cominciamo ad accorgerci che anche la nostra cultura musicale ha usato troppo il telecomando. Ma ogni opera nuova di Philip Glass ci invita ad aprire quel cassetto di Magritte, pieno di nuvole bianche in cielo azzurro, dove la musica ritorna su se stessa, si genera per autoinseminazione, si aggancia per amore e per forza alle radici primitive del tempo e del ritmo, offrendo alla memoria appigli tipici della musica bassa, ma ingannandola anche. Con i suoi slittamenti in avanti, millimetrici, è pur sempre l’idea che costringe la nostra percezione, educata a fuggire la ripetizione come un errore, a muoversi su un terreno dove l’orecchio è più miope. In fondo mancava a noi una musica che insegnasse a guardare il cielo per gustare il passaggio delle nuvole. Non mancava agli indiani, ai balinesi, agli arabi. Carlo Maria Cella 15 Magritte, La Mémoire, 1948, olio su tela, collezione dello Stato Belga. 16 RIACCENDIAMO LE LUCI DEL CIELO e proprio non vogliamo accogliere quell’appassionato appello di Guido Ceronetti che invitava a fare a pezzi la televisione, “un rettangolo grigio un po’ convesso sul quale passano delle immagini, delle ombre che parlano”, e scriveva che dà le vertigini pensare “la forza di espansione del male rinchiusa in questo mezzo truce”, almeno in una delle prossime notti questo luminoso autunno usciamo a guardare il cielo. Ma mentre si spegne la televisione bisognerebbe anche far spegnere le luci delle città e delle case e i fari delle automobili che non ci fanno scorgere le stelle. Nelle notti serene ogni tanto bisognerebbe fare questo. Sarebbero felici gli astronomi e, forse, meno violenti gli uomini. A osservare di notte la pianura Padana dall’alto di una montagna si vedono solo luci e luci a non finire: gialle, rosse; azzurre, verdi; a strisce, a macchie, tremolanti, lampeggianti. Luci vacue senza miti né storia: sole, vieni a farle sparire, luna, impallidisci queste luci che ci nascondono il cielo stellato. Lassù, per millenni, i nostri predecessori hanno letto storie meravigliose e nell’armonia dei movimenti degli astri calcolato l’evolversi delle stagioni, come sul quadrante di un cronometro che mai non falla. Ora sono pochi gli uomini che sanno guardare e incantarsi di fronte alla volta stellata, eppure quale grande stupore ho constatato in cittadini che una notte d’inverno hanno alzato gli occhi uscendo da casa mia. Nel passato il contatto della gente con il firmamento era continuo e accompagnava la vita. Venere, “lo bel pianeto che d’amar conforta”, al mattino indicava l’ora di lasciare il letto per riprendere il lavoro, alla sera quella di smettere e rincasare. In Veneto la chiamavano la Stella Boara e nel vicino Friuli la Biele Stele: una stella da pregare come la Madonna per fare finire la guerra e far ritornare al paese l’amato. Le Pleiadi erano “le gallinelle”, ma anche “la chioccia con i pulcini”; le tre stelle della cintura di Orione “tre viaggiatori” che andavano per il cielo; nella luna si vedeva Caino, lassù esiliato e condannato per l’eternità a portare sulle spalle un fascio di spine. S 17 L’immaginazione popolare riempiva la volta celeste di vicende e storie antiche che la fantasia, in quell’immenso video, non seguiva supina come una telenovela o un film dell’orrore. Forse a qualcuno non sembrerà vero, ma quando molte notti mi toccava bivaccare sotto il cielo, riuscivo a leggere lo scorrere del tempo nel movimento delle stelle; e se nel mio primo libro ho incominciato scrivendo del “quadrato di Cassiopea” che mi stava sopra la testa nelle notti sulla riva del Don e scambiavo per Pegaso, forse era perché “quadrato” mi dava la sensazione di solido, di “far quadrato” per resistere ad ogni avversità; e Cassiopea, che era stata portata lassù da Poseidone, mi piaceva come nome femminile. Fu così che nacque nel Sergente nella neve il “quadrato di Cassiopea”, che rimase anche dopo che Vittorini e Calvino lo lessero e lo notarono forse senza spiegarselo. Ma lo capirono Fruttero e Lucentini quando ripresero l’incipit per un loro libro. Con immaginazione e fantasia i pastori delle regioni dell’Asia Minore, le popolazioni lungo il Nilo, i cinesi iniziarono a nominare stelle e costellazioni dopo che sole, lune e pianeti erano entrati nei loro linguaggi. È certo che nei millenni trascorsi gli uomini sapevano osservare e prevedere; nel cielo leggevano le vie del mare e determinavano la posizione dei vascelli; interpretavano grazie alle stelle i tempi delle transumanze, delle semine e dei raccolti che poi Ovidio e Virgilio riportarono in poesia. Nelle costellazioni si fissarono i miti greci e romani degli dèi, degli eroi, delle grandi storie d’amore. Ritornando a Guido Ceronetti che ci consiglia di disfarci della televisione, a questo mio invito a spegnere ogni tanto le luci per poter guardare il cielo, ci si dovrebbe rendere conto di quello che abbiamo perduto in poesia e fantasia e, forse in libertà. Le luci, le troppe luci artificiali, hanno fatto il buio nell’anima; perciò: “e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Mario Rigoni Stern 18 AL SETT SIDAR: LA COSTELLAZIONE DI ORIONE, ‘CERNIERA’ FRA I DUE EMISFERI E SIMBOLO DI AMICIZIA onsiderata da astronomi e astrofili la più bella costellazione del cielo, Orione risplende imponente nel cielo invernale in una zona ricchissima di altre famose costellazioni (il Toro, i Gemelli, l’Auriga, ecc.), di asterismi (Pleiadi, Iadi, ecc.) e di stelle brillanti (Aldebaran, Capella, Sirio, Procione, ecc.). La sua inconfondibile forma di grande trapezio la rende facilmente individuabile anche ai meno esperti, che riconoscono al centro le tre stelle allineate della cintura, note anche come i tre Re Magi o le tre Marie e sotto la quale è ben visibile la nebulosa di Orione (M 42), unica nebulosa del nostro emisfero visibile ad occhio nudo. Nella raffigurazione la nebulosa è considerata la spada, che Orione brandisce minaccioso contro il Toro che gli sta alla destra. Fra Orione e il Toro un arco di stelle raffigura invece lo scudo del gigante cacciatore. Le tre stelle della “cintura”, infine, puntano verso Sirio (che si trova a sud est della costellazione), la stella più luminosa del cielo visibile ad occhio nudo. È di colore bianco-azzurro ed è una delle stelle più vicine al Sole (da cui dista circa 9 anni luce). Due le stelle più brillanti: Betelgeuse (in alto a sinistra), una gigante rossa distante circa 500 anni luce e la bianco-azzurra Rigel (in basso a destra) che dista un migliaio di anni luce. Completano il trapezio Bellatrix e Saiph. Complessivamente, dunque, Orione è caratterizzata da sette stelle particolarmente brillanti (le quattro dei vertici del trapezio e le tre della cintura), ma nella zona della costellazione ne sono visibili molte di più, come ricorda Giordano Bruno: C Che fa Orione tutto armato a scrimir solo, con le spalancate braccia, impiastrato di trent’otto stelle, ne la latitudine australe verso il Tauro? (Spaccio de la bestia trionfante, Dialogo I, Parte II) Le più evidenti sono comunque le sette sopra ricordate e ad esse si è evidentemente ispirato il nostro modo di dire dialettale l’è al sett sidar, usato dai nostri nonni per definire le fredde notti invernali. Il termine dialettale 19 sidar, infatti, deriva dal latino sidus (stella) e al sett sidar sono evidentemente le sette stelle di Orione e non, come vorrebbe una interpretazione tradizionale, le sette stelle dei Carri. Alle nostre latitudini, infatti, le stelle dei Carri (Grande e Piccolo) sono “circumpolari” e dunque visibili per tutte le notti dell’anno, mentre le sette stelle di Orione sono osservabili solamente nella stagione invernale. Come conseguenza della sua particolare collocazione sulla volta celeste, la costellazione sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest e pertanto può essere utilizzata per l’orientamento e in questo senso è utilizzata da Giovanni Verga nelle Novelle rusticane: “Dal lato opposto, verso le terre su cui Orione inchinavasi, altre esistenze sconosciute e quasi misteriose palpitavano e sentivano, chissà? povere gioie e poveri dolori…”. La sua posizione sull’equatore celeste (le stelle della “cintura” si trovano proprio sotto l’equatore celeste) la rende una costellazione “cerniera” fra i due emisferi. Orione, dunque, appartiene sia all’emisfero nord che a quello sud, e questa sua caratteristica rende ancor più significativa la scelta di Ravenna Festival di inaugurare l’edizione del 2004 con una nuova opera musicale del compositore statunitense Philip Glass, che ad Orione si è ispirato, identificando nella costellazione un significativo segno di amicizia e di unione fra mondi, culture e latitudini diverse. Nella mitologia Orione è il gigante cacciatore figlio di Poseidone e di Euriale. Reso cieco da Enopione per aver amato sua moglie Merope, Orione è guarito dalla cecità da Helios per consentirgli di andare alla ricerca di Enopione e vendicarsi. E mentre Orione cerca l’oggetto della sua vendetta uccide tutti gli animali che incontra sul suo cammino, non per necessità ma solamente per il gusto di uccidere. Questo suo comportamento non è però condiviso dalla madre Gea che per punirlo gli manda contro un piccolo scorpione. Alla vista dell’animaletto Orione ha un atteggiamento di sufficienza, ma lo scorpione lo punge in un piede e il suo veleno micidiale lo fa morire all’istante. Giove, però, che ha assistito alla scena, non consente che del gigante Orione si perda la memoria e perciò lo trasforma in costellazione insieme ai suoi cani fedeli Sirio (Cane Maggiore) e Procione (Cane Minore). Moltissimi sono i riferimenti a Orione nei classici greci e latini e in tutte le letterature e qui ricorderemo solamente 20 alcune citazioni fra le più significative. Una delle prime citazioni si trova nel libro XXII dell’Iliade, quando Omero descrive lo scudo di Achille forgiato da Vulcano, che ha voluto raffigurarvi il Sole, la Luna e: … gli astri diversi onde sfavilla incoronata la celeste volta, e le Pleiadi, e l’Iadi, e la stella d’Orion tempestosa … (Iliade, XXII vv. 673-676) L’aggettivo “tempestosa” fa riferimento alla stagione invernale ed è ricorrente nelle descrizioni della costellazione. Questi aspetti meteorologici sono sottolineati anche da Aristotele: Orione è ritenuto apportatore di tempo incerto e burrascoso al suo calare e sorgere perché la sua comparsa e la sua sparizione coincidono col mutare delle stagioni, estate e inverno, e perché per la grandezza della costellazione, esse durano molti giorni, ed i mutamenti di tutte le stagioni sono turbolenti per la loro indeterminatezza. (Metereologica, II, V, 361 b14) Apollonio Rodio paragona un’azione di Ercole a una scena tempestosa durante il periodo in cui incombe la costellazione: E come quando inaspettatamente, proprio nella stagione del tempestoso scenario del funesto Orione, una impetuosa raffica di vento si abbatte dall’alto, e sradica un albero della nave dal suo alloggio, così fa Ercole sradicando il pino… (Argonauticon, I, 201) Stazio, descrivendo la statua equestre di Domiziano che campeggiava nel foro di fronte al tempio di Giulio Cesare, paragona la spada dell’imperatore a quella di Orione: Il fianco è reso sicuro dalla spada, sebbene immobile: essa è grande come l’appuntita lama con cui Orione minaccia le notti d’inverno e spaventa le stelle. (Silvae, I, 43-45) È ancora associato alla stagione invernale il famoso incipit della Caduta del Parini: Quando Orïon dal cielo declinando imperversa; 21 e pioggia e neve e gelo sopra la terra ottenebrata versa (La caduta, vv. 1-4) Manilio presenta Orione in tutta la sua imponenza: È possibile avvistare Orione vicino ai Gemelli, che allarga le braccia su una grande estensione di spazio celeste e con non minore ampiezza di passi si solleva alle stelle. (Astronomica, I, 387-389) e anche Valerio Flacco lo definisce “tantus Orion” (Argonautiche, II v. 62) così come, in tempi recenti, Giovanni Camerana lo definì “superbo”: Tale in sua tregua il bieco Etna regnava. Sul gran cono era l’Orsa; il formidabile nel ponente Orion superbo ardea. (Catania, vv. 9-11) Esiodo ricorda Orione come costellazione invernale quando mette in guardia i marinai dal mettersi in mare quando in cielo splendono le sue stelle: Se ti prende il desiderio della perigliosa navigazione, bada! Quando le Pleiadi fuggono nel tenebroso mare l’impero del possente Orione, infuriano i soffi di tutti i venti. (Le opere e i giorni, 618-620) In un altro passo, però, usa ancora la costellazione di Orione come indicatore temporale per la battitura delle messi: Appena Orione possente appare, ordina ai servi di battere bene la sacra spiga di Demetra. (Le opere e i giorni) Tutto questo potrebbe sembrare una palese contraddizione, ma in realtà qui Esiodo fa riferimento al fenomeno detto “levare eliaco”, che è diverso dall’apparire di un oggetto celeste nel cielo di una determinata stagione. All’epoca di Esiodo il “levare eliaco” di Orione, infatti, si verificava ai primi di luglio e dunque in piena stagione della mietitura. Il “levare eliaco”, inoltre, è di brevissima durata e pertanto era osservabile solamente dagli attenti osservatori del cielo. Il fenomeno corrisponde all’apparire di un oggetto celeste poco prima del sorgere del Sole, per cui l’oggetto finirà col non essere più visibile. 22 L’imponente Orione compare anche in alcune poesie di Giovanni Pascoli, un poeta della nostra terra che ha sempre mostrato particolari attenzioni alla astronomia: passano stelle e stelle in lenta corsa; emerge dall’azzurro la grand’Orsa, e sta nell’arme fulgido Orione (Rammarico, vv. 5-7) Il poeta del “fanciullino” descrive il tramonto delle Pleiadi (chiamate anche “le Gallinelle”) in funzione di Orione: Le Gallinelle fuggono lo strale già d’Orione, e son cadute in mare (L’ultimo viaggio, vv. 95-96) Crediamo non sia superfluo ricordare che Omero e gli altri poeti della classicità osservavano Orione nella forma con cui lo vediamo noi oggi, a dimostrazione di quella che gli antichi ritenevano l’immutabilità della volta celeste. In realtà la volta celeste non è immutabile, perché le stelle sono animate da “moti propri” che al passar del tempo determineranno variazioni delle loro posizioni. Gli effetti di questi spostamenti, però, saranno evidenti solamente su intervalli temporali sufficientemente lunghi (almeno centomila anni) per cui nel breve spazio (astronomicamente parlando) di qualche migliaio di anni il cielo può ritenersi con ottima approssimazione praticamente immutabile. Orione, dato il suo splendore, è una costellazione ben visibile anche nei nostri cieli troppo illuminati ed inquinati, ma in un cielo pulito e terso lo spettacolo della costellazione è davvero straordinario. Quel grande quadrilatero sembra una immensa porta di stelle che mette in comunicazione l’uomo coi misteri del cielo inducendogli suggestioni e sensazioni che lo fanno sentire partecipe di una realtà che lo sovrasta. Va infine ricordato che alla costellazione di Orione è associata anche una pioggia di stelle cadenti, le Orionidi, così chiamate perché per un effetto di prospettiva le meteore luminose sembrano provenire da un punto (chiamato “radiante”) che si trova all’interno della costellazione. Le Orionidi presentano un massimo intorno al 21 ottobre, quando si possono contare in media una 23 ventina di meteore ogni ora. Il fenomeno delle stelle cadenti si verifica quando la Terra, durante il suo movimento di rivoluzione attorno al Sole, attraversa l’orbita di una cometa, una zona molto ricca di gas e polveri, materiali che un tempo costituivano le caratteristiche code. Nel caso delle Orionidi, il fenomeno si verifica perché la Terra incrocia l’orbita della cometa di Halley (la Terra incrocia l’orbita della cometa anche all’inizio di maggio, dando origine alla pioggia delle Aquaridi). La costellazione più spettacolare del cielo, dunque, è associata alla cometa più famosa di tutti i tempi. E ciò non può che aumentare l’interesse per questa costellazione che non finisce di affascinare quanti alzano ancora lo sguardo al cielo stellato. Franco Gàbici Direttore del Planetario di Ravenna Wenzel Hablik, Firmamento, 1913, olio su tela, Itzehoe (Germania), Wenzel Hablik Museum. Gli artisti PHILIP GLASS Philip Glass nasce a Baltimora, nel Maryland, il 31 gennaio del 1937. Scopre la musica nel negozio di riparazioni di suo padre, Ben Glass, che oltre a riparare radio vendeva dischi e, quando vedeva che alcuni rimanevano troppo a lungo in negozio, li portava a casa e li faceva ascoltare ai suoi tre bambini, per cercare di capire perché non interessassero ai clienti. Fu così che al piccolo Philip divenisse precocemente familiare musica allora considerata “fuorimoda” come i quartetti di Beethoven, le sonate per pianoforte di Schubert o le sinfonie di Šostakovič. Comincia a studiare violino a sei anni e flauto a otto. Diplomatosi alla high school si trasferisce a Chicago per frequentare l’università, mantenendosi con lavori part-time come cameriere o come facchino all’aeroporto. Durante i ritagli di tempo si dedica allo studio del pianoforte avvicinandosi a compositori come Ives e Webern. A 19 anni, laureatosi in matematica e filosofia e determinato a diventare un compositore, si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School. Messa da 26 parte la tecnica dodecafonica appresa a Chicago, i suoi interessi si focalizzano ora su alcuni compositori americani come Aaron Copland e William Schuman. Ventitreenne segue le lezioni di Vincent Persichetti, Darius Milhaud e William Bergsma. Rifiuta il serialismo allora imperante negli ambienti accademici e si avvicina, invece, a compositori “dissidenti” o sperimentali come Harry Partch, Charles Ives, Moondog, Henry Cowell e Virgil Thompson, senza però riuscire ancora a trovare una dimensione personale. Decide allora di trasferirsi a Parigi per studiare con Nadia Boulanger. Durante il soggiorno parigino gli viene commissionata dal regista Conrad Rook la trascrizione delle musiche composte da Ravi Shankar per il film Chappaqua (una rappresentazione allucinata e surreale dei miti della beat generation, dove compaiono sia William Burroughs che Allen Ginsberg, del 1966) ed è così che scopre la musica indiana (conosce anche il tablista Alla Rakha, che lo introduce ai cicli ritmici denominati Tal), un incontro che cambia radicalmente la sua visione estetica, tanto che dopo essersi buttato alle spalle tutta la sua musica precedente e dopo alcune ricerche sulla musica del Nord Africa, India e Himalaya, torna a New York dove inizia ad applicare le tecniche orientali al proprio lavoro compositivo, strutturandolo non più mediante i tradizionali metodi armonici occidentali ma attraverso cicli ritmici, spesso di durata inusuale. Nel 1974 aveva già composto un consistente numero di nuove composizioni nel suo nuovo stile (tra le altre citiamo: Strung Out per violino solo amplificato, 1967; Two Pages per organo elettronico, 1968; Music in Contrary Motion, Music in Eight Parts, Music in Fifths, Music in Similar Motion, 1969; e Music in Changing Parts, 1970), alcune della quali destinate agli spettacoli della compagnia teatrale Mabou Mines, di cui è uno dei fondatori, ed altre al suo gruppo di esecutori, il Philip Glass Ensemble, fondato nel 1968 (al quale si aggiunge, nel ’70, la figura chiave del sound engineer Kurt Munkacsi). Questo periodo particolarmente fertile culmina con Music in Twelve Parts, vera e propria summa (anche in termini temporali, con una durata di oltre tre ore) della nuova musica di Glass, e con l’opera in quattro atti Einstein on the Beach firmata con Robert Wilson nel 27 1976, considerata uno dei capisaldi del teatro musicale del XX secolo. L’esperienza di Glass con l’opera si rivelerà piuttosto fruttuosa e proseguirà poi con Satyagraha, basata sui sacri testi indiani delle Bhagavad-Gita (1980); l’opera da camera The Photographer (1982); Akhnaten (1983), The Fall of the House of Usher, da Edgar Allan Poe (1988); l’opera “fantascientifica” 1000 Airplanes on the Roof (1988), la cui prima ha avuto luogo nell’Hangar n. 3 dell’aeroporto internazionale di Vienna; Hydrogen Jukebox, basato sulle poesie “beat” di Allen Ginsberg (1990); The Voyage (1991-92), ispirata ai viaggi di Cristoforo Colombo; La Belle et la Bête, opera “per ensemble e film” (si tratta ovviamente del capolavoro cinematografico scritto e diretto da Jean Cocteau; sempre di Cocteau Glass musicherà l’Orphée e Les Enfants Terrible); la “pocket opera” In the Penal Colony, dall’omonimo racconto di Franz Kafka; la prima opera digitale in 3-D Monsters of Grace, in collaborazione con Robert Wilson e su testi del poeta Sufi Rumi; Galileo Galilei, frutto della collaborazione con Mary Zimmerman (2002); fino alla sua opera più recente (2003): The Sound of a Voice, su libretto di David Henry Hwang. Glass ha collaborato alla realizzazione di svariati progetti con molti artisti di diverse discipline ed ha arricchito il suo repertorio spaziando dalla musica per opera, danza, teatro, ensemble da camera, alla musica per orchestra ed alle colonne sonore per il cinema. Fra le incisioni effettuate in collaborazione con altri artisti ricordiamo Songs from Liquid Days, del 1986, con testi di David Byrne, Paul Simon, Laurie Anderson e Suzanne Vega; Passages (1990), in collaborazione con Ravi Shankar; The Screens (1992), con Foday Musa Suso; e Aguas da Amazonia (1999), dei brasiliani Uakti. Glass ha creato anche musiche per orchestra fra cui le composizioni di ampio respiro per coro e orchestra Itaipu (1989) e la Sinfonia n. 5 (1999), su testi sacri e sapienziali di diverse religioni e civiltà; le sinfonie n. 2 (1994), n. 3 (1995), n. 6 (Plutonian Ode), su testo di Allen Ginsberg, e le sinfonie “Low” (1992) e “Heroes” (1997), entrambe basate sulla musica di David Bowie e Brian Eno. Fra le produzioni di Glass figurano concerti per violino e orchestra (1987), per quartetto di sax e orchestra (1995), per due timpani e 28 orchestra, e per clavicembalo e orchestra. Il suo Tirol Concerto for Piano and Orchestra ha debuttato nel 2000 al Klanspuren Festival in Tirolo, Austria, mentre il Concerto per violoncello e orchestra, che ha avuto la sua prima esecuzione nel 2001 al Beijing Festival, è stato commissionato per il cinquantesimo compleanno del violoncellista Julian Lloyd Webber. L’assidua frequentazione di Glass della scena della danza contemporanea newyorkese lo porta a collaborare con Lucinda Childs, a partire da Einstein, per la quale concepisce le musiche di Dance (1979), altro lavoro cult degli anni ’70, con le proiezioni di Sol Le Wit, ideate per moltiplicare l’azione dei danzatori in scena. Altra riuscita collaborazione sarà poi quella con Twyla Tharp: In the Upper Room (1986). Notevole l’impegno di Glass nell’elaborazione di colonne sonore per il cinema: particolarmente fruttuosa si è rivelata la collaborazione con il regista Godfrey Reggio, con il quale ha creato la celebre trilogia composta da Koyaanisqatsi (1983), Powaqqatsi (1988) e Naqoyqatsi (2004), oltre ad Anima Mundi (1992), sempre di Reggio. Ricordiamo poi la collaborazione con il regista Errol Morris: The Thin Blue Line (1988), A Brief History of Time (1992) e The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003). Ancora, Mishima di Paul Schrader (1984); Candyman di Bernard Rose (1992) e Candyman 2 di Bill Condon (1995); nonché una partitura originale per la riedizione di Dracula del 1930 con Bela Lugosi. Fra le colonne sonore più note: Kundun di Martin Scorsese (1997), per la quale Glass ha ricevuto il premio LA Critics Award, oltre alle nomination per l’Academy Award e il Golden Globe per la migliore colonna sonora; e The Truman Show di Peter Weir (1999) per il quale Glass ha vinto il Golden Globe. L’ultima colonna sonora creata da Glass per il film The Hours di Stephen Daldry ha ricevuto le nomination per il Golden Globe, il Grammy, e l’Academy Award, ed è stata premiata dalla British Academy of Film and Television Arts dell’Anthony Asquith Award come miglior colonna sonora. 29 PHILIP GLASS ENSEMBLE Fondato da Philip Glass, il primo concerto dell’ensemble risale al maggio 1969 al Whitney Museum of American Art a New York. Inizialmente legato agli artisti figurativi attivi a Soho, i suoi primi concerti erano considerati eventi visivi quanto musicali e avevano spesso luogo in gallerie d’arte, studi di artisti e musei, piuttosto che nei luoghi tradizionalmente deputati alla musica. Da allora i membri del PGE sono riconosciuti come i migliori esecutori delle musiche di Philip Glass, con il quale collaborano alla scrittura di nuove composizioni. Negli ultimi trent’anni il gruppo ha suonato in quattro continenti, partecipando ai festival più prestigiosi ed esibendosi nelle sale da concerto di tutto il mondo. L’ensemble ha partecipato alle opere teatrali di Philip Glass Einstein on the Beach, Hydrogen Juke Box, 100 Airplanes on the Roof, The Photographers, La Belle e la Bête e Monsters of Grace. Tra i recenti impegni ricordiamo la tourneé dello spettacolo Philip on Film, una scelta di musiche per film di Glass suonate dal vivo come colonna sonora delle pellicole: Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, La Belle e la Bête, Dracula e Shorts. 30 ELEFTHERIA ARVANITAKI Eleftheria Arvanitaki, nata e cresciuta al Pireo, inizia la sua carriera nei primi anni Ottanta come cantante della Opisthodromiki Kompania, un noto gruppo di revival della rembétika, il particolare genere musicale che si era sviluppato in Grecia tra le classi sociali più umili all’inizio del Ventesimo secolo e che è stato fortemente influenzato dai rifugiati greci provenienti dall’Asia Minore all’inizio degli anni ’20. Nel 1985 – l’anno successivo all’uscita del primo disco a proprio nome (in cui esegue canzoni di importanti compositori di rembétika come Vassilis Tsitsanis, Manolis Hiotis e Apostolos Kaldaras) – dà inizio alla sua carriera di solista affermandosi ben presto come la più promettente voce femminile sulla scena musicale greca. Alcuni incontri segnano la sua carriera, come quello con l’autore di canzoni Stamatis Spanoudakis (con cui pubblica il disco Kontrabando), o l’intenso sodalizio con Nikos Xydhakis da cui scaturiscono alcune delle migliori incisioni di Eleftheria, come Konda sti Dhoxa mio Stigmi, considerato uno dei dischi fondamentali degli ultimi vent’anni. 31 La copertina che la prestigiosa rivista inglese Folk Roots le dedica nel 1987, assieme alla sua partecipazione, l’anno successivo, al festival WOMAD (fondato da Peter Gabriel), proiettano il nome di Eleftheria Arvanitaki nella scena internazionale della “world music”. Tra le più recenti e prestigiose apparizioni di Eleftheria citiamo quelle, nel 1999, al Festival Jazz di Montreaux ed alla Town Hall di New York; la partecipazione, nel 2000, a Roma, all’evento “Giubileo della Terra”, organizzato dal Vaticano (e trasmesso in mondovisione dalla RAI); e la sua esibizione, nell’ottobre del 2002, ad Alessandria d’Egitto, in occasione dell’inaugurazione della Nuova Biblioteca. Le qualità vocali di Eleftheria, e le sue abilità nel combinare la musica tradizionale e contemporanea greca, hanno ispirato alcuni dei più noti compositori, parolieri e poeti contemporanei che hanno scritto per lei canzoni ormai considerate dei veri e propri “classici” della musica greca. Tutti i suoi numerosi album sono diventati Dischi di Platino. 32 MARK ATKINS Noto come uno dei migliori suonatori australiani di didjeridoo*, collabora con i principali compositori e musicisti contemporanei. Atkins discende dal popolo Yamijti, originario dell’Australia Occidentale, e da antenati irlandesi/australiani. Non solo noto per la sua abilità come suonatore di didjeridoo, è conosciuto anche come narratore, scrittore di canzoni, percussionista, artista visivo e creatore di strumenti musicali. Sia nella dimensione solistica che in ensemble, Atkins ha la capacità di evocare con il suono del suo didjeridoo veri e propri paesaggi sonori immaginari, fondendo le sue esecuzioni sia a composizioni per grande orchestra che a spettacoli teatrali e di danza. Importante in tal senso è la sua collaborazione con REM Theatre Company, con cui ha effettuato anche una tournée in Europa, con lo spettacolo toteMMusic, programmato anche nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale di Musica di Lucerna. Nel corso della sua carriera si è esibito con la London Philharmonic e la Sidney Philharmonic, ed in festival 33 come il WOMAD (Seattle 1999); è fondatore dei gruppi musicali interculturali Kooriwadjula (che significa letteralmente “uomo bianco-uomo nero”) e Anakala e ha collaborato con i compositori Philip Glass e Peter Sculthorpe, con il chitarrista irlandese Donald Lunny, con Jimmy Page e Robert Plant dei Led Zeppelin, nonché con alcuni tra i più noti artisti australiani come James Morrison, Jenny Morris, John Williamson. Nel 2000 si è esibito nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Sidney, assieme a Charlie McMahon e al gruppo Gondwana. La collaborazione di Mark Atkins con Philip Glass risale al 2001, con due concerti alla Melbourne Town Hall ed al Lincoln Centre a New York nei quali viene eseguita la composizione Voices. For Organ & Didjeridoo e prosegue l’anno successivo con la partecipazione di Atkins all’incisione della colonna sonora del terzo episodio della trilogia cinematografica di Glass/Reggio, Naqoyqqatsi. Mark crea e dipinge personalmente i suoi didjeridoo, scegliendo gli alberi adatti nel corso di escursioni nel bush a nord-ovest della sua casa a Tamworth, nel New South Wales. Il suo lavoro come artista visivo, nel quale coniuga arte tradizionale e contemporanea, è esposto in Giappone, Europa e negli Stati Uniti. Nel 2003 ad Atkins è stato dedicato il documentario Yamaji Man: Geralton 6350 via New York. * Strumento a fiato degli aborigeni australiani che funziona in parte come una tromba e in parte come megafono. Consiste in un ramo di eucaliptus lungo circa 1,50 m. e del diametro da 5 a 10 cm., scavato all’interno con l’ausilio di insetti che divorano il legno; a volte il ramo è sostituito da una canna forata con un ferro rovente. Un rudimentale bocchino è ricavato da un anello di cera fissato ad una estremità del tubo. La vibrazione delle labbra genera, come nella tromba, il suono fondamentale, cui si sovrappone l’emissione di vocalizzi e suoni gutturali all’interno del tubo. 34 WU MAN Wu Man è uno dei più importanti solisti di pipa* oggi in attività. Erede della scuola di pipa Pudong, una delle più antiche e rinomate della Cina, Wu Man non padroneggia esclusivamente il repertorio tradizionale, ma è anche la più importante interprete della musica per pipa contemporanea. Nata a Hangzhou, Wu Man inizia a studiare a dieci anni e si diploma al Conservatorio centrale di musica di Pechino (è la prima studentessa in assoluto a farlo), in seguito è vincitrice del Primo Concorso Accademico Nazionale Cinese per Strumenti Musicali Cinesi. Trasferitasi negli Stati Uniti, Wu Man ha continuato la sua opera di sensibilizzazione nei confronti del proprio strumento, commissionando nuovi lavori a compositori di rilievo come Tan Dun, Bun-Ching Lam, Liu Sola, Zhou Long, Chen Yi, e altri. Ha collaborato, tra gli altri, con il violoncellista Yo-Yo Ma, il Kronos Quartet, il chitarrista folk inglese Martin Simpson, la vocalist cinese Liù Sola, il New York New Music Consort, il Pittsburgh New Music Ensemble, il BBC Scotland Ensemble, l’Orchestra 35 Sinfonica della Radio Austriaca, e il Nieuw Ensemble in Olanda. Suona nei principali centri musicali e partecipa ai più importanti festival internazionali. Wu Man ha inciso tre album a proprio nome: Chinese Music for the Pipa (1995) e Chinese Traditional and Contemporary Music (1996), entrambi prodotti dall’etichetta inglese Nimbus; From A Distance (Naxos, 2003). Compare inoltre come solista in Ghost Opera, la composizione di Tan Dun – per quartetto d’archi e pipa – eseguita dal Kronos Quartet (Nonesuch, 1996); in Carry the Day (Sony, 1994) del musicista jazz Henry Threadgill; e in Silk Road Journeys. When Strangers Meet (Sony, 2001), l’ambizioso progetto musicale di Yo-Yo Ma “sulla vie della seta”. * Strumento a corde pizzicate introdotto in Cina sotto la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) consistente in un liuto a manico corto, scavato in un unico blocco di legno con fondo leggermente arcuato. Monta 4 corde di seta serrate da grossi bischeri conici inseriti in un cavigliere ricurvo che reca alla sua estremità un pipistrello scolpito. La tastiera è costituita da quattro grossi tasti d’avorio o di bambù incollati al manico, e da altre barrette incollate alla tavola armonica. La melodia è suonata pizzicando con le dita le corde, di cui in pratica solo la prima viene tastata. 36 FODAY MUSA SUSO Foday Musa Suso è nato in Gambia cinquant’anni fa ed appartiene alla tribù dei Mandingo (o Mandè), che originariamente popolava l’Impero del Mali, retto dalla dinastia dei Keita, situato nell’attuale Africa Occidentale e comprendente Senegal, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Costa D’Avorio, Burkina-Faso, Liberia, Gambia e Sierra Leone. Musa Suso canta ed è un virtuoso di kora*, vero e proprio simbolo della cultura mandinga, ma soprattutto Musa Suso è erede di una tradizione antichissima, quella dei griot: musicisti e poeti dell’Africa Occidentale, che hanno l’importante funzione di raccogliere e preservare – analogamente a delle librerie ambulanti – le storie, i miti e i conflitti tribali, tramandati per via orale. Alla conoscenza della kora, che nella sua complessa tradizione riunisce in sé cinque modalità di accordatura e una gamma stilistica molto ampia, il musicista africano affianca dunque un’approfondita competenza in campo storico e antropologico, che lo rende testimone di civiltà ancestrali. A questo si aggiunge la padronanza di molti altri strumenti provenienti dall’Africa, come i “tamburi 37 parlanti”, il balafon, la kalimba e la susa, una sorta di violino africano. Trasferitosi nel ’75 in Germania e due anni dopo negli Stati Uniti, Musa Suso fonda a Chicago il gruppo Mandingo Griot Society, formazione che riuniva musicisti africani, caraibici e statunitensi (e tra di essi figurava anche il grande trombettista jazz Don Cherry) e che attuava una sintesi tra rock, funk, reggae e musica africana. Da questa esperienza è scaturita la conoscenza e la collaborazione con numerosi artisti, tra cui Bill Laswell, Herbie Hancock, Philip Glass, Pharoah Sanders, Jack De Johnette e Ginger Baker, ed il Kronos Quartet (che gli ha commissionato cinque lavori). Si è esibito in tutto il mondo in importanti festival e rassegne ed in sedi prestigiose come il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York, il California Institute of the Arts, lo Staatsoper di Vienna e la Royal Festival Hall di Londra. La collaborazione di Foday Musa Susa con Philip Glass nasce nel 1988 in occasione delle riprese del film Powaqqatsi, del regista Godfrey Reggio, per il quale Glass ha composto la colonna sonora che vede la presenza di Foday Musa Suso, e successivamente si sviluppa con The Screens, il lavoro teatrale di Jean Genet (I paraventi, del 1958) di ambientazione algerina, per il quale i due musicisti compongono le musiche, poi pubblicate in CD. * Strumento a corde dell’Africa occidentale, consiste in una grande cassa armonica ricavata da una zucca, nella quale è infisso un manico a bastone: da questo partono numerose corde (il numero può oscillare da 18 a 25, ma lo standard è di 21 corde) che si inseriscono sulle tacche di un grosso ponticello perpendicolare al piano armonico di pergamena. Lo strumento viene suonato con tre dita di ciascuna mano, che pizzicano contemporaneamente le corde libere ai due lati del ponticello, creando così elaborate polifonie e raffinati contrappunti. 38 GAURAV MAZUMDAR Gaurav Mazumdar appartiene ad una famosa dinastia di musicisti di Allahabad. Inizia il suo apprendistato musicale sotto la tutela dello zio Shri J.D. Mazumdar, delle cugine Kamala Bose e Jayashree Roy, del padre Shri Dulal Mazumdar e del Guru Pandit Nand Kishore Vishwakarma. Nel 1985 diviene allievo di Ravi Shankar, sotto la cui tutela apprende la tecnica del sitar, completando un lungo percorso di iniziazione musicale iniziato come cantante e violinista. Inizia poi l’attività concertistica, esibendosi in India e all’estero, e collaborando con importanti musicisti indiani (sia di stile carnatico che hindostano) e occidentali. È regolarmente ospite dell’importante festival musicale che si tiene annualmente a Chennai. Compone le musiche per un balletto ispirato a Siddhartha di Hermann Hesse. Nel giugno 2002, al Feldkirch Festival in Austria, Gaurav ripropone, in un concerto, i brani della “storica” collaborazione di Ravi Shankar con il violinista Yehudi Menuhin (East meets West), suonando a fianco di Daniel Hope, allievo dello stesso Menuhin. Gaurav Mazumdar è 39 stato inoltre sino ad oggi l’unico musicista indiano ad esibirsi in Vaticano. Oltre alla carriera concertistica Gaurav si dedica sia all’insegnamento che alla composizione. 40 RAVI SHANKAR Ravi Shankar, virtuoso di sitar* e compositore, è il più stimato ambasciatore musicale dell’India nel mondo, e rappresenta un fenomeno unico nell’ambito della musica classica occidentale e orientale (e del loro dialogo). Ravi Shankar è nato a Varanasi, nell’Uttar Pradesh, nel 1920. Durante l’infanzia studia musica e danza col fratello Uday; dopo un soggiorno a Parigi, inizia, nel 1936, a studiare con Ustad Allauddin Khan a Maihar. Dal 1949 al ’56 dirige l’ensemble strumentale di All-India Radio e poi compie tournée in Europa e Stati Uniti (195657). Nel 1958 partecipa ad un concerto per l’UNESCO a Parigi, nel 1963 si esibisce al Festival di Edinburgo. Instaura una feconda e duratura collaborazione artistica col violinista Yehudi Menuhin, testimoniata da importanti edizioni discografiche. Sempre negli anni ’60 ha luogo lo “storico” incontro con George Harrison, che introduce la sua musica ai Beatles, contribuendo così a renderla universalmente nota, anche in ambito pop. Assieme ad Harrison, Ravi Shankar si esibirà infatti sia al Festival di Woodstock nel 1969 che nei due concerti organizzati per il Bangladesh. Partecipa anche al Festival Pop di Monterey. 41 A Los Angeles fonda la Kinnara School per l’insegnamento della musica indiana. Nelle vesti di compositore Ravi Shankar, oltre a numerose colonne sonore per film prodotti in India (citiamo la trilogia di Satyajit Ray’s: Pather Panchali, 1955; Aparajito, 1956; e Aput Sansar, 1959), ha scritto due concerti per sitar e orchestra (1971 e 1976), duetti per violino e sitar (per Menuhin e se stesso), musiche per il flautista Jean Pierre Rampal, per il virtuoso giapponese di sakuhachi Hosan Yamamoto e per il virtuoso di koto Musumi Miyashita. Nel 1990 la collaborazione artistica con Philip Glass sfocia nell’album Passages, nel quale Ravi Shankar esegue composizioni di Glass e viceversa (Glass aveva già conosciuto Ravi Shankar nel 1965, a Parigi, e grazie a lui e ad Alla Rakha, era rimasto fortemente influenzato dalla musica “classica” indiana). Per la sua attività di musicista, compositore ed insegnante, e per il suo lavoro pionieristico di diffusione della musica indiana in Occidente, Ravi Shankar ha ottenuto innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti sia nel proprio paese che in tutto il mondo. Tra questi ci limitiamo a citare le sue nomine a membro del Rajya Sabha (la camera superiore del Parlamento indiano), 1986, membro onorario della American Academy of Arts and Letter, e membro della United Nations International Rostrum of Composers. * Strumento a corde pizzicate indiano appartenente alla famiglia dei liuti e contraddistinto dalla particolare cassa armonica ricavata da una zucca. Il nome sitar, con cui, durante il Medioevo, divenne popolare nell’India settentrionale il setar persiano a 3 corde, indica oggi i moderni liuti a manico lungo che, nella maggior parte dei casi, presentano da 4 a 7 corde. Normalmente solo una delle corde viene utilizzata per la melodia, mentre le altre sono impiegate come bordoni, e talvolta potenziate da corde simpatiche aggiuntive. Il sitar viene pizzicato con un plettro d’acciaio ed è particolarmente adatto all’esecuzione virtuosistica. 42 ASHLEY MAC ISAAC Ashley MacIsaac è nato nell’isola di Cape Breton, in Nuova Scozia (Canada), ed è considerato uno dei migliori fiddler (suonatore di fiddle, il violino folk) di ambito “celtico” dei nostri tempi. Fin da piccolo subisce l’influenza dei fiddler di Cape Breton, come Angus Chisholm, Winston “Scotty” Fitzgerald e soprattutto Buddy McMaster. Nel 1992, all’età 16 anni, dopo un apprendistato in piccoli festival, pub, chiese e sale da ballo di piccole comunità celtiche sparse tra Canada, Massachusetts e California esce il suo primo album (acustico), Close to the Floor. Diciottenne partecipa ad una lunga e particolarmente intensa (oltre 160 date) tournée del cantante di Toronto John McDermott assieme ai Chieftains. 43 Nel frattempo Philip Glass, su suggerimento della moglie Joanne, che aveva assistito ad un’esibizione di Ashley in occasione di un ballo a Cape Breton nel ’92, contatta Ashley per le sue musiche per il Woyzeck di Büchner (New York, 1993). Nel 1995 pubblica Hi, How Are You Today?, dove mescola audacemente musica celtica, punk, elettronica, hip-hop e giunge. Il disco è un successo (per tre volte Disco di Platino in Canada). Segue l’anno dopo l’album Fine, Thank You Very Much, di impianto più tradizionale, che conquista il Disco di Platino in meno di tre mesi. Seguono importanti collaborazioni con artisti del calibro di Paul Simon, David Byrnee, Melissa Etheridge e Roger Greenwalt. Il suo ultimo album uscito per la Decca – prodotto da Roger Greenwalt – è intitolato con il suo stesso nome, Ashley MacIsaac. 44 UAKTI UAKTI, il gruppo brasiliano di musica sperimentale composto da Paulo Sérgio dos Santos, Artur Andrés Ribeiro, Décio de Souza Ramos Filho e il direttore musicale e creatore di strumenti, Marco Antonio Guimarães, si è fatto conoscere ed apprezzare nel corso dei decenni attraversando e ridefinendo i confini tra i generi musicali. Partendo dalla consapevolezza che qualsiasi oggetto possa generare suoni, UAKTI crea i propri strumenti utilizzando materiali come vetro, metallo, pietre, gomma, zucche e addirittura l’acqua. Il nome UAKTI deriva da una leggenda degli indios dell’Amazzonia che narra di un’enorme creatura che viveva sulle rive del Fiume Negro, nel cuore della grande foresta pluviale. La creatura mitica UAKTI aveva il corpo disseminato di buchi, e quando correva nella foresta il vento, passando attraverso il suo corpo, produceva suoni inusuali e fantastici. Le donne indiane venivano rapite dalla bellezza dei suoni e gli uomini, gelosi, cacciarono ed uccisero UAKTI. Nel suo luogo di sepoltura, crebbero tre grandi palme, i cui tronchi furono usati per realizzare degli strumenti musicali che riproducevano i suoni prodotti dalla creatura nelle sue folli corse attraverso la foresta. 45 UAKTI ha collaborato con artisti famosi quali Philip Glass, Paul Simon, Manhattan Transfer e Milton Nascimento. L’intensa e proficua collaborazione con Glass (nella veste di produttore o compositore) ha dato vita a tre importanti album ed alla partitura per la compagnia di danza brasiliana Grupo Corpo, intitolata 7 or 8 Pieces for Ballet (contenute nel CD Aguas da Amazonia, Point Music, 1999). Nel corso degli anni UAKTI ha ricevuto diversi riconoscimenti per il proprio lavoro, tra i quali l’importante premio del Ministero della Cultura brasiliano come Migliore Gruppo di Musica Popolare brasiliana, così come il premio “Satista 97” per le innovazioni nella Musica Popolare Brasiliana. 46 A cura di Franco Masotti, Susanna Venturi Segreteria di redazione Andrea Albertini Coordinamento editoriale e grafica Ufficio Edizioni Ravenna Festival Stampa Grafiche Morandi - Fusignano
Scarica