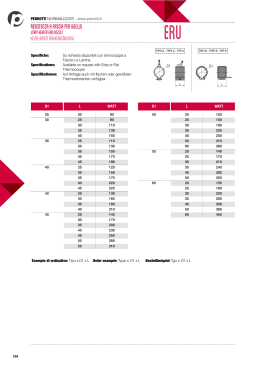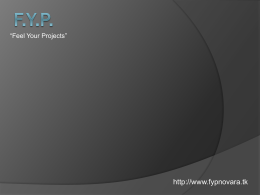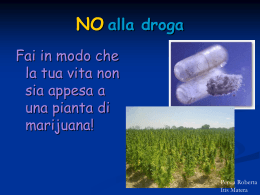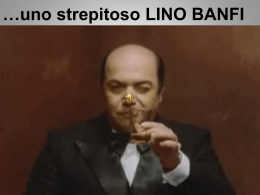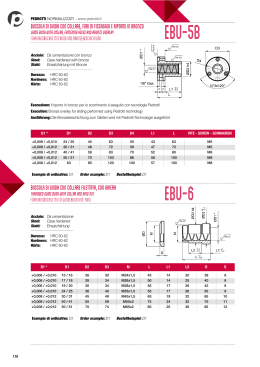Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Gli amici della musica, aprile 2004 Noi filologi: facciamo il punto di Roberta Pedrotti MILANO - Noi filologi era la progettata quarta Inattuale di Nietzsche, poi accantonata per la redazione di Richard Wagner a Bayreuth e mai più ripresa. Un bel titolo, che, nella sua semplicità quasi monumentale, suggerisce una riflessione su quegli studi affascinati e preziosi quanto fragili, se già Seneca attaccava il Litterarum inutilium studium e lo Studium supervacua discendi di chi, tra capziose questioni filologiche, dimentica l’oggetto reale dello studio. Eppure si tratta spesso di dettagli di grande importanza, come quel Tamquam restituito filologicamente nella Germania di Tacito in luogo di un Quanquam che permetteva di interpretare il passo come una conferma delle teorie naziste, quando lo storico latino notava semplicemente caratteristiche fisiche simili "per quanto possibile in una popolazione così numerosa". Rispetto a quella letteraria, però, la filologia musicale presenta l’ulteriore difficoltà di dover ricostruire un linguaggio stilistico ed interpretativo che va oltre il segno scritto. Il vero filologo deve essere, dunque, egli stesso interprete di un’arte cui dona nuova vita, fornendo un testo il più possibile vergine, svelando così all’artista innumerevoli chiavi di lettura, tutte plausibili perché legate al testo ed alla realtà in cui operava l’autore. Spesso la tradizione arriva a cristallizzare delle varianti, contro all’ammonimento di Garcia: «Si deve variare un pensiero ogni volta che questo pensiero si ripete, sia in totalità, sia in parte; è questa una cosa indispensabile, e per comunicare una nuova attrattiva al pensiero, e per sostenere l’attenzione dell’uditore». I mezzi per rendere attraente il pensiero e catturare così l’attenzione, sono dati dalla filologia, che libera, appunto, il pensiero e ne ricostruisce il linguaggio. L’opera del filologo deve però trovar riscontro nella sensibilità degli artisti di cui si fa strumento, dai quali può ricevere nuovi, fondamentali stimoli. Sotto questo profilo la Beatrice di Tenda vista agli Arcimboldi è un esempio illuminante di come l’interprete possa rivelare un volto nuovo ed autentico (ma non unico) dell’opera, direttamente ispirato dal testo di Bellini e Romani (in questo caso nella revisione di Armando Gatto). L’estetica, inevitabilmente perduta, del primo ottocento è assunta e rivissuta in una moderna interpretazione drammaticamente incalzante, grazie soprattutto alla felicissima collaborazione fra Mariella Devia e Renato Palumbo. Né soprano leggero né drammatico d’agilità, la Devia si potrebbe oggi definire un soprano di coloratura drammatica, capace di conferire al belcanto più puro e celestiale una sua specifica intensità, una particolare carnalità, ben evidente nella scena finale della Beatrice. Questa sublimazione che nulla concede all’astrazione, ma che continua a palpitare di vita trova perfetto riscontro nel gesto di Palumbo, capace di cesellare sfumature e dettagli dinamici senza perdere l’intima tensione che innerva una lettura drammaticamente vivissima. Non si tratta solo, dunque, di un eccelso soprano e di un direttore di grandissimo talento, conoscitore come pochi delle voci e del teatro, ma soprattutto la perfetta sintonia tra due artisti di rara intelligenza e personalità. Lo dimostrano le variazioni scelte ed in particolare la mancanza di acuti al termine delle cabalette . Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Come ricorda anche Marco Beghelli nel suo bel saggio sul Trovatore (Per fedeltà a una nota, "Il Saggiatore Musicale",VIII, 2001), la questione delle puntature acute è filologicamente piuttosto complessa, ma generalmente la prassi, almeno fino a quel periodo di svolta che va dalla prima Traviata (1853) al primo Boccanegra (1857), prevedeva l’eventuale acuto non sulla tonica nell’ultima battuta, ma sulla dominante della penultima. Senza ipotizzare un assurdo decalogo delle variazioni permesse o meno, è chiaro che avvicinare l’opera, con variazioni ed acuti più appariscenti, ad un romanticismo espada lontano da Bellini, può falsare la prospettiva di una moderna ricezione della Beatrice. Composta nel 1833, mentre Bellini, Donizetti e Meyerbeer elaboravano l’eredità rossiniana e alla loro ombra si formavano Verdi e Wagner, Beatrice di Tenda, tutt’altro che un’opera minore, presenta un intreccio politico e psicologico, senz’ombra di reale intrigo erotico. Filippo ama Agnese, sorta di Seymour o di Eboli in sedicesimo, o piuttosto la contrappone ad una sposa che l’ha annoiato? Che sviluppo hanno i sentimenti di Agnese ed Orombello, se non vendetta e debolezza? Non stupisce dunque l’importanza assunta dai recitativi, come il magnifico arioso di Beatrice ed il successivo dialogo con Orombello che aprono il finale primo, continuamente esaltati dalla concertazione sempre accesa e ben calibrata. Il discorso è analogo per i pezzi d’assieme, che costituiscono il vero nucleo di una partitura dove si contano ben pochi numeri solistici (la cavatina di Beatrice e l’aria di Filippo, oltre alla cavatina di quest’ultimo incastonata nell’introduzione ed all’aria dell’eroina nel finale secondo) e due duetti nel primo atto. L’introduzione, quadro eloquente della noja e del martire del Duca; il travolgente finale primo; la grande scena del giudizio (della quale si può ravvisare un precedente in Bianca e Falliero, su libretto dello stesso Felice Romani): si tratta sempre di brani in cui è sì presente la classica ripartizione della solita forma (tempo d’attacco, concertato, tempo di mezzo e stretta), ma elaborata verso un discorso musicale più unitario e drammaticamente coeso di quanto non facciano immaginare strutture i cui confini sono abilmente sfumati da Bellini. È perciò entusiasmante e rivelatrice la fluidità con cui Palumbo sul podio stacca dinamiche in continua evoluzione, dimostrando come tali schemi formali non siano più che uno strumento concettuale. È, sosterrà Boito anni dopo, la Formula contrapposta alla Forma, là dove anche le formule sono elementi d’un linguaggio poetico (potremmo negare valore letterario ai versi omerici?), ma che deve essere compreso, letto e vissuto nell’ambito di un’unità formale superiore unica e complessa, quale può essere la Beatrice, il melodramma del primo ottocento, l’idea stessa del teatro musicale come erede della tragedia classica. Questo è il vero scopo della filologia, che, come in questo caso, arricchisce l’interprete e diviene arte a sua volta. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Bresciamusica, ottobre 2004 La traviata: presentazione di Roberta Pedrotti “Si chiamava Alphonsine Plessis, dal quale nome ella aveva composto quello più armonioso e più elevato di Marie Duplessis. Era alta, molto sottile, nera di capelli, bianca e rosa in volto. Aveva la testa piccola, dei lunghi occhi smaltati come una giapponese, vivaci e arguti, le labbra rosse come ciliegie, i più bei denti del mondo; si sarebbe detta una figurina di Saxe. Nel 1844, quando la vidi per la prima volta, sbocciava in tutta la sua opulenza e bellezza. Morì nel 1847, d’una malattia al petto, all’età di ventitre anni.” Così Alexandre Dumas fils ricorda la cortigiana più nota ed ammirata di Parigi, consegnata all’immortalità, sotto il nome di Marguerite Gautier, da un amante meno abbiente di altri, ma dal grande talento letterario. Verdi, con tutta probabilità, assistette nel ’51 alla pièce che Dumas trasse da La dame aux camèlias e se ne innamorò: aveva trovato il soggetto per la sua nuova opera. Alphonsine, dunque, mutava nuovamente nome, questa volta in Violetta Valery, ma con non poche precauzioni da parte del librettista Piave. Questi, dopo i guai con la censura per Rigoletto, decise di addolcire la provocatoria attualità di un soggetto che, santificando una prostituta, additava con disprezzo l’ipocrisia della morale borghese. Che in questo Verdi sentisse un richiamo autobiografico alla sua convivenza con Giuseppina Strepponi è dettaglio più romanzesco che storico; certo, mal sopportò l’ambientazione “nel 1700 circa”, ai tempi di Richelieu e del Re Sole. Tuttavia, nonostante la volontà dell’autore, l’indicazione oggi comunemente riportata nel libretto, “1850 circa”, non si affermò con facilità e perfino le figurine Liebig, nel ‘900, riportano una Violetta simile a Lucia, un Alfredo che potremmo confondere con Arturo Talbo. In realtà questa somiglianza non pare del tutto incongruente se si prende in considerazione la prima versione della Traviata che andò in scena alla Fenice di Venezia il 6 marzo 1853. Non si trattò di un fiasco, ma nemmeno di un trionfo, soprattutto per la prova non esaltante dei cantanti, ma anche qui si è troppo romanzato sulle forme paffute e poco credibili della povera Fanny Salvini-Donatelli, ed un anno dopo Verdi licenziò al teatro S. Benedetto della stessa città la versione corrente, che egli stesso definì, con astuta diplomazia, “la stessa stessissima che si eseguì l’anno passato alla Fenice ad eccezione di alcuni trasporti di toni, e di qualche puntatura […] non un idea musicale è stata mutata.” Naturalmente non era così: le differenze sono molte ed aiutano a meglio comprendere la modernità e la genialità della drammaturgia musicale dell’opera così come oggi viene eseguita. Basti pensare a Germont, un vero padre verdiano, meschino e borghese finché si vuole, ma pur sempre padre verdiano; nella scrittura acutissima e manierata del ‘53 sembra invece l’ultimo avanzo d’una stirpe di genitori autoritari e tenorili che da Handel (Tamerlano) e Mozart (Mitridate ed Idomeneo) giungeranno nell’800 con Rossini (Tancredi, Bianca e Falliero) e Donizetti (Otto mesi in due ore, Maria Padilla) fino all’Elèazar della Juive di Halevy. Non a caso il brano che fu rielaborato più profondamente fu il duetto fra Germont e Violetta, nododrammatico e patetico dell’opera che nella prima versione è ancora concepito secondo la rigida scansione tradizionale, Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) come dimostra il deciso cadenzare dopo ogni sezione, evidente soprattutto fra “Così alla misera” e “Dite alla giovine”, quasi fuse, poi, nel canto accorato di Violetta. Confrontando le due versioni appare chiara la portata rivoluzionaria di una costruzione musicale tesa ad un realismo che, è bene precisarlo, è proprio del romanticismo italiano, e segnatamente milanese, e non può essere confuso con un’anticipazione del verismo. Il vero naturalista, infatti, differisce profondamente dal vero manzoniano. Violetta è parente più stretta di Lucia (Ashton o Mondella) che di Mimì, ma, pure, è un’eroina moderna, mai vittima, perché capace di guardare negli occhi l’amante che l’ha insultata con la fermezza di un amore incrollabile: “Alfredo, Alfredo, di questo core/ non puoi comprendere tutto l’amore…/Tu non conosci che fino a prezzo/del tuo disprezzo – provato io l’ho./ Ma verrà il giorno, in che il saprai…/ Com’io t’amassi confesserai…/Dio dai rimorsi ti salvi allora,/io spenta ancora – pur t’amerò.” Bresciamusica, ottobre 2004 Andrea Chénier: presentazione di Roberta Pedrotti Il Settecento, fra XIX e XX secolo, godette di grande fortuna musicale: piacque a Puccini e Massenet per le passioni d’una sedicenne avida d’amore e denaro; a Cilea per sventure d’una temperamentosa prim’attrice; a Strauss per le dotte disquisizioni sull’estetica del teatro musicale come per gli intrecci sentimentali di nobili che sono eco nostalgiche degli Almaviva mozartiani; ancora a Stravinskij per le geometrie formali di un piccolo Faust con ambizioni da Don Giovanni o per qualche bella arietta, forse, di Pergolesi. In particolare, però, fu la Rivoluzione francese, che da sempre aveva ispirato poeti e drammaturghi, a fornire argomenti di sicuro effetto agli operisti, in particolare italiani: Mascagni con Il piccolo Marat (1921), Respighi con Marie Victoire (composta intorno al ’13, debuttante a Roma ne 2004), Giordano con la commedia Madame Sans Gêne (1915), e, soprattutto, Andrea Chénier, “dramma d’ambiente storico in quattro quadri” del 1896 su libretto di Luigi Illica. Frutto della collaborazione di due degli esponenti più eminenti della Giovine Scuola, lo Chénier non è tuttavia un capolavoro, piuttosto un’opera di solida scrittura e sicuro impatto teatrale, ancorché di grandi ambizioni. L’intreccio principale piuttosto scontato (l’amore fra la nobile Maddalena e l’idealista Chénier prima osteggiato dal geloso Gérard che, pur pentito, non potrà salvarli dal patibolo) è collocato in un affresco storico ricostruito con meticolosa precisione verista sia nel libretto sia nella partitura, con citazioni della Marseillaise, di Ça ira e della Carmagnole. Le tricoteuses commentano l’aumento del prezzo del pane (colpa degli Inglesi, si dice), Robespierre appare sul fondo, muto ed inquietante. Ai protagonisti si contrappone una folla indistinta, da cui emergono figure minori che più che veri personaggi sembrano tipi, caricature: il sanculotto Mathieu, la vecchia Madelon, l’Incredibile, quasi una versione repubblicana del mozartiano Don Basilio, ma anche dell’Abate e di tutti gli aristocratici che popolano il salotto della Contessa di Coigny nel primo quadro, in fondo non troppo differenti drammaturgicamente dal coro rivoluzionario. A costoro si oppone la nobile umanità di Chénier e Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Maddalena, romantici ed idealisti, e di Gérard, il personaggio forse più compiuto e complesso, protagonista morale dell’opera. Lo si avverte già nel primo quadro, il più ambizioso e ricercato per il contrasto fra il tramonto di una fittizia arcadia rococò e l’imminente Rivoluzione, rappresentata più che dalla scherzosa irriverenza di Maddalena o dai proclami utopistici di Chénier, dai tormenti di Gérard, che infine si strappa platealmente la livrea. Il commento della Contessa è emblematico, “Quel Gérard! l’ha rovinato il leggere! Ed io che tutti i giorni Faceva l’elemosina…”, come lo sono il coretto danzato “O pastorelle addio!” e quello fuori scena dei poveri di Parigi, o la livida gavotta in cui gli aristocratici paiono ostinatamente pietrificati. Ancora, il topos del ricatto erotico, presente nell’Ermione rossiniana, nel Trovatore come in Tosca, ha qui più rapida e nobile risoluzione: piuttosto che uno snodo drammatico (la sentenza è inesorabile, a Maddalena non resta che corrompere il carceriere per sostituirsi ad una condannata e seguire l’amato), è un momento importante nell’evoluzione psicologica della contessina e del suo ex servitore. Lei da ragazza “capricciosa e un po’ romantichetta” è divenuta una giovane donna provata dal dolore; Gérard, che già aveva aderito con schietta partecipazione e consapevolezza intellettuale alla Rivoluzione, si trova ora “servo obbediente di violenta passione”, capace di uccidere tradendo l’ideale, e dolorosamente si ravvede. Per questo “Nemico della patria”, non deve essere inteso come uno sfogo platealmente retorico, ma come un intenso momento di introspezione; ugualmente “La mamma morta” di Maddalena e le tre arie dell’eroe eponimo (ispirate in larga parte a poemi del vero Chénier), oltre che manifesti della vocalità verista, rappresentano appunto tasselli fondamentali nella definizione dei personaggi e nello sviluppo di un dramma forse ingenuo, ma perfettamente costruito. Bresciamusica, ottobre 2005 I Capuleti e i Montecchi: presentazione di Roberta Pedrotti «Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche; […] non per diventare imitatori, ma per uscire di quelle usanze viete, le quali durano nella letteratura come nelle compagnie i complimenti, a pregiudizio della naturale schiettezza. Che se le lettere si arricchiscono colle traduzioni de’ poemi; traducendo i drammi si conseguirebbe una molto maggiore utilità; poiché il teatro è come il magistrato della letteratura.» Così, nel 1816, scriveva Madame De Staël nella sua lettera Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, destinata a innescare un incendio dalle polveri già incandescenti del dibattito fra classicisti e romantici. Cita espressamente Shakespeare, la baronessa, ma si dovrà attendere il declinare degli anni ’30 perché, dopo sparuti tentativi settecenteschi, si intraprendesse un’organica versione italiana delle opere del massimo drammaturgo inglese su iniziativa di letterati come Carlo Rognoni e Andrea Maffei, ovvero intellettuali fra i più vicini a Verdi, il primo italiano ad aver dato alle scene un melodramma direttamente tratto da Shakespeare: Macbeth. Le opere precedenti, per quanto assimilabili nei soggetti, avevano fonti diverse, oppure si rifacevano alla mediazione delle riscritture francesi di Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Jean François Ducis, impegnatissimo nel rendere alle regole aristoteliche quei drammi che lo stesso Voltaire giudicava men che barbari. Non ottenne però particolare fortuna operistica il suo fantasioso Romèo et Juliette, che vedeva Montecchio, novello Conte Ugolino, rinchiuso da Capellio nella torre della Fame con i tre figli, due dei quali rimarranno preda del delirio antropofago del padre, mentre il solo Romeo tornerà a Verona con il padre assetato di vendetta. La vicenda degli sventurati amanti, melodrammatica come nessuna mai, arriva sulle scene italiana attraverso il recupero della storia e della novellistica medioevale e rinascimentale cui il classicismo metastasiano stava cedendo il passo. Gerolamo Della Corte con le Storie di Verona e Matteo Bandello con i Quattro libri delle novelle ispirano infatti il libretto di Giuseppe Foppa per il Giulietta e Romeo di Zingarelli (1796), al quale guarderà Felice Romani per l’opera omonima destinata a Nicola Vaccaj (1825), basato anche sulla tragedia di Luigi Scevola (1818), che sta a Shakespeare quanto l’Otello di Giovanni Carlo Cosenza. Quando Bellini nel 1830 rimette in musica i versi del suo poeta prediletto (che avrà provveduto a rielaborarlo personalmente) il nome del bardo di Stratford on Avon s’insinuava con insistenza sempre maggiore nei circoli intellettuali progressisti, eppure I Capuleti e i Montecchi è un’opera fondamentalmente rivolta al passato. L’intreccio è il medesimo dei rossiniani Tancredi o Bianca e Falliero e come nei modelli Romeo ha voce di contralto, lo stesso contralto eroico e malinconico di Zingarelli (dov’era un castrato) e Vaccaj. Il confronto con quest’ultimo è peraltro sollecitato oltre che dal libretto pressoché identico, dalla fortuna dell’opera del tolentinate, tale da far sì che Maria Malibran, impersonando il Romeo del catanese, sostituisse il finale con quello di Giulietta e Romeo. Detto che la distribuzione dei ruoli è in Vaccaj più tradizionale, con il padre tenore e l’amante deluso basso nobile, mentre Bellini farà di Capellio un basso e di Tebaldo un bel tenore preverdiano. È però proprio il confronto dei finali quello rivelatore: si avvertono subito la maggiore scolpitezza e la drammaticità del recitativo belliniano, la sua melodia, poi, deriva sì direttamente dalla scuola napoletana, ma le sottende un sostrato armonico quasi chopiniano, che ben giustifica l’ammirazione di Wagner: «Deh! Tu, bell’alma» è un’aria sublime, quella corrispondente di Vaccaj, «Ah! Se tu dormi svegliati!», è semplicemente bella e più patetica. Dopo il duetto, infine, Bellini prende alla lettera il greco katastrophé precipitando le ultime battute sulla scoperta dei due cadaveri, quando in Vaccaj non era negata a Giulietta un’ultima aria di follia di fronte a Capellio e Lorenzo. I Capuleti e i Montecchi inorridì Berlioz come il libretto dell’Otello di Rossini inorridì Stendhal, ma l’opera italiana non è Shakespeare, tant’è vero che solo la musica francese sembra aver colto la fatua leggerezza di Mercutio, il personaggio più schiettamente shakespeariano del dramma. Forse Donizetti ne avrebbe fatto una sorta di Gondì della Maria di Rohan o di Maffio Orsini della Lucrezia Borgia, ma non era nella sorte dell’amico di Romeo entrare nell’opera italiana, a lui così estranea, nemmeno nel fedelissimo Romeo e Giulietta di Marchetti (1865) o in quello decadente di Zandonai (1922). Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Bresciamusica, ottobre 2005 Nabucco: presentazione di Roberta Pedrotti Riguardo Nabucco esiste un tale intreccio di storia, leggenda, aneddoti e luoghi comuni che risulta difficile riscoprire il dramma lirico dietro al simbolo, al dorato santino del melodramma quale appare nell’immaginario collettivo. Una mitologia in buona parte da sfatare, ma, comunque, nel bene e nel male, ormai parte integrante dell’identità di quest’opera. È bello immaginarsi un giovane Verdi, provato dalle morti premature di moglie e figli oltre che dal fiasco di Un giorno di regno, che si commuove leggendo i versi del “Va’ pensiero” e riprende a comporre, trovando anche consolazione nelle braccia della primadonna Strepponi. Bello come un Rossini che compone “Di tanti palpiti” mentre cuoce il riso: la storia è altra cosa e Nabucco non è solo “Va’ pensiero”, tant’è vero che alla prima del 9 marzo 1842 il coro bissato fu “Immenso Iehova”. L’ambizioso quadro storico, con scontri di popoli e fazioni, richiama alla tradizione del gran-opèra francese e la Bibbia era soggetto favorito dai tempi dell’oratorio barocco fino al Rossini di Ciro in Babilonia e dei due Mosé (italiano e francese), trattandosi anche d’un comodo stratagemma per aggirare i rigori quaresimali o le maglie della censura. L’amor di patria e l’oppressione straniera toccavano i cuori dell’Europa restaurata, ma nel libretto di Solera Verdi trovò soprattutto un dramma conciso e serrato, il dramma di Abigaille e Nabucco, diversamente lacerati fra affetti privati e sete di potere. Se l’una rinnegherà la propria umanità riconquistandola solo nel suicidio, l’altro compirà il percorso inverso segnato dalla follia che punisce l’hubris del tiranno proclamatosi Dio. Oppresso dalla sua stessa brama di potere del re assiro anticipa le angosce di Macbeth, un’altra delle rare pazzie maschili del melodramma italiano, il cui modello si riconosce nel delirio di Assur in quella Semiramide che ben più del tanto citato Mosé condiziona la composizione di Nabucco. Oltre che nella follia del protagonista maschile, lo si può notare nel brevissimo primo atto, giocato sull’alternanza fra maestosità epica e squarci intimisti, non immemore dell’Introduzione dell’opera rossiniana, come pure la grande cavatina della primadonna già apparsa precedentemente, il grande duetto di scontro fra questa e il basso-baritono, la ricomposizione finale che segue alla morte di lei. Abigaille è, dunque, sì figlia di Semiramide, Nabucco di Assur, Zaccaria di Oroe (anche se la Profezia molto deve a quella di Hiéros nel Siège de Corinthe), ma ovviamente la maestosità delle forme rossiniane mal s’accordava all’impellenza della drammaturgia verdiana, debitrice anche delle esperienze di Bellini, Donizetti e, innovatore anche più ardito, Mercadante. Se un’analisi non può prescindere da una prospettiva storica, questa non deve essere unilateralmente eziologia o teleologica, bensì valutare la dialettica fra innovazione e tradizione che sottende a ogni opera d’arte. La scrittura vocale e strumentale, la vibrante teatralità sono quelle del Verdi di Galera, preannuncianti già le opere più mature, mentre le volatine di “Tale ti rendo, o misero, il foglio menzogner” chiarificano bene che di belcanto ancora si tratta, come belcantisti erano i primi interpreti, soprattutto il baritono Giorgio Ronconi, insigne interprete di Bellini e Donizetti, e capace di rendere quindi il giusto involo al cantabile “Dio di Giuda”, derivata chiaramente dal linguaggio musicale del catanese e del bergamasco, come del resto le cabalette, Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) ultimo avanzo d’una stirpe assai felice. D’altra parte lo stesso fantomatico soprano drammatico d’agilità, come vengono definite con una pericolosa semplificazione alcune primedonne verdiane, non è altro che l’evoluzione della coloratura di forza rossiniana, passata attraverso le eroine di Bellini e Donizetti, e inserita ora nel fraseggio verdiano. Se Abigaille, dunque, non è una Walkiria con l’agilità, la compianta Ghena Dimitrova rappresenta una miracolosa eccezione, mentre dovrebbe esser rivelatore il fatto che il repertorio d’elezione della pur eclettica Callas, Abigaille storica al pari della bulgara, fosse proprio fosse appunto quello neoclassico e protoromantico. Abigaille, Odabella, Lady Macbeth portano l’agilità drammatica al suo dorato tramonto, dopodiché il soprano prenderà altre strade. Bresciamusica, ottobre 2006 Anna Bolena: presentazione di Roberta Pedrotti Caterina D’Aragona, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anna di Kleve, Catherine Howard, Catherine Parr. Matrimoni, più che d’amore, di passione, d’interesse politico o dinastico (l’unico, agognato maschio, Edward, morrà giovanissimo, ma Elisabeth, dichiarata illegittima nel processo contro la madre Anne, è fra i più grandi sovrani della storia); uno scisma addirittura per il primo divorzio, poi la scure, il ripudio o la morte naturale a separare Enrico VIII dalle sue sei mogli. Sarebbe però errato fare del re un volubile Barbalblù senza collocarlo nel complesso quadro politico dell’Europa riformata e controriformista, oltre che in una corte popolata da figure come l’ambizioso sir Thomas Boleyn, padre di Anne e di Mary, anch’essa resa, se non regina, almeno madre dall’esuberante sovrano. Quella per la seconda moglie fu però vera passione, che anche nel suo tramontare offrì al nostro melodramma romantico il topos favorito dell’eroina condannata ingiustamente per infedeltà, come Pia de’ Tolomei e Beatrice di Tenda, tanto più che il contesto politico suggeriva anche una componente storica manzoniana, in cui l’ideale dell’innocenza e del sentimento si scontra con il reale dell’interesse e della lotta per il potere. Felice Romani, il classicissimo librettista, è maestro nello sviluppare i caratteri dosando passione e ambizione, cosicché l’innocenza cede spesso il passo all’amara consapevolezza della colpa. Già nel primo quadro la situazione suggerirebbe sublime mestizia: la notte volge al termine e Anna, con la sua corte, ha atteso ancora invano la visita del re, che la ignora ormai apertamente. Il coro però accenna alla vendetta della ripudiata Caterina e la regina stessa svela la propria antica ambizione nel raccomandare a Seymour, che ancora non immagina rivale, «Ah se mai di regio soglio | ti seduce lo splendor, | ti rammenta il mio cordoglio, | non lasciarti lusingar». La stessa Seymour confesserà al re di bramare «onore e fama», tosto rimproverata: «Anna pur amor m’offria, | vagheggiando il soglio inglese, | ella pure il serto ambia | dell’altera aragonese». A differenza di Norma, la regina non è tradita per una giovane innocente Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) sedotta: Romani sa bene che ciò che rende interessante la contrapposizione fra le rivali non è ciò che renderà, esattamente un anno dopo (26 dicembre 1831), interessante il rapporto fra Norma, Adalgisa e Pollione. Stabilita la netta polarità fra Enrico, convinto d’essere amato solo per interesse e dunque a sua volta freddo ed egoista, e l’amore romantico di Percy, dipinta con melanconica sensibilità la bella figura del paggio Smeton, è fra la Bolena e Seymour che si sviluppa una dialettica tesissima, proprio per l’analogia di moventi e sentimenti. Se nella regina che mai rinuncia alla dignità reale si fa via via predominante il rimpianto, in Seymour è il rimorso a esplodere nell’aria «Per questa fiamma indomita» una volta compreso che quelle nozze chieste al re comportavano anche la morte della regina. Eppure mentre Anna sale al patibolo Giovanna sale al trono e mai risulta chiaro, forse nemmeno a ella stessa, se la fiamma indomita, in fondo, divampi per Enrico o per la sua corona. Questa tensione non può che esplodere in un duetto che, se nel contenuto di pentimento e perdono rammenta più quelli di Norma e Adalgisa, risulta soprattutto un antecedente dello scontro fra Aida e Amneris. Tuttavia, più che alla libertà e alla concisione del Romanticismo, Donizetti guarda ai modelli classici codificati da Rossini, sviluppa la forma con il medesimo rigore e la medesima plasticità, esaltando il virtuosismo espressivo in una monumentalità nella quale ben s’iscrivono lo spessore psicologico e i contrasti di potere d’un dramma che non è solo e puro scontro di passioni. Il primo atto assume, così, amplissime proporzioni, con equilibrata alternanza di pezzi solistici e d’assieme, fino al duetto fra Anna e l’antico amante Percy, che si lega al finale primo fungendo praticamente da tempo d’attacco del concertato. Come da tradizione il secondo atto è più sintetico, ma pure replica con diverso ordine la proporzione fra il duetto e il terzetto da una parte, le arie di Giovanna e Percy dall’altra. L’apoteosi formale potrà così emergere dalla struttura pensata da Donizetti e Romani, nemica d’ogni taglio per la sua complessità, nel sublime finale, vera Gran Scena della protagonista, che dal delirio nostalgico per il castel natìo e l’amore di Percy, prorompe nell’estremo eroico perdono della coppia iniqua, in una provvida alternanza di consapevolezza e follia che rammenta la fine della manzoniana Ermengarda. Bresciamusica, ottobre 2006 Faust: presentazione di Roberta Pedrotti «Je veux la jeunesse! À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses! A moi leurs caresses! A moi leurs désirs! A moi l’énergie des instincts puissants, et la folle orgie du cœur et des sens! Ardente jeunesse, à moi tes désirs! A moi ton ivresse! À moi tes plaisirs!» [Io voglio a giovinezza! A me i piaceri, le giovani amanti! Le loro carezze! I loro desideri! A me l’energia dei possenti istinti, e l’orgia folle del cuore e dei sensi! Giovinezza ardente, a me i tuoi desideri! A me la tua ebbrezza! A me i tuoi piaceri!]. Il credo superficialmente sensista del Faust di Gounod sembra talmente diverso da quello dello studioso goethiano da giustificare il distacco con cui i tedeschi usavano titolare l’opera Margarete. Soprattutto negli anni della guerra franco prussiana (la prima versione, come opéra-comique, è del 1859, quella ampliata con recitativi musicati e balletti, tuttora in uso, del ’69, Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) alla vigilia del conflitto) è difficile pensare che i concittadini di Goethe potessero vedere la trasformazione del solo primo tomo del dramma in una vicenda sentimentale dai contorni romanticamente soprannaturali. Eppure, come nessun testo letterario ha mai rappresentato lo spirito tedesco quanto il dramma di Goethe, poche opere riassumono l’effimero trionfo della borghesia francese prima di Sedan al pari del lavoro di Gounod. L’inno gaudente «Vin ou bière», il valzer «Ainsi que la brise légère», il canto dei soldati «Gloire immortelle» sono il quadro di questa società e delle sue illusioni presto spezzate, l’ode dei nipotini di merveilleuses e incroyables che nell’eleganza danzante e leggiadra celano tutti i peccati che la rispettabilità borghese impone di negare. La stessa religione è esibita e vantata nei simboli più che nella sostanza con l’uso magico della croce o dell’acqua santa contro le arti di Méphistophélès. La stessa apoteosi finale è una rassicurante illustrazione della vittoria del bene sul male, mentre un’inquietudine più profonda pervade la scena della chiesa, in cui il demonio svela un più complesso conflitto morale. Egli, infatti, è scandaloso perché sovverte le convenzioni e mostra ciò che si deve nascondere. Inneggia all’oro e alla lussuria, usa il sarcasmo contro l’ipocrisia. La Nuit de Walpurgis non è forse un festin in cui, come in una galleria alla moda di dipinti à la Moreau, alla sfilata «des reines et des courtisanes», a Cléopâtre e Laïs prestano volto e – soprattutto – corpo disponibili modelle e ballerine? La morte redentrice di Marguerite non ricalca forse la postuma santificazione della sua omonima Gautier, al secolo Marie Duplessis? La fanciulla traviata dalla società parigina e quella perduta dagli incanti del diavolo, lo splendore delle feste o di un cofanetto di gioielli, il disprezzo del suocero mancato o del fratello, il pentimento, la caduta e la morte salvatrice. La storia in fondo è la stessa: Boito lo capì modellando il suo quadro del carcere sul terzo atto della Traviata, Gounod lo svelò nel fare del sardonico Méphistophélès colui che cinicamente smaschera e amplifica in grottesche caricature i vizi della sofisticata società parigina. Colui che vede nella pulsione di Faust per Marguerite l’impeto carnale e, come in Goethe, non ne comprende il mutarsi in sentimento: lo studioso del prologo non avrebbe potuto intonare un’aria come «Salut demeure». Così amici e parenti di Armand Duval capiscono che si possa desiderare la splendida cortigiana, non amarla. Eppure anche per Faust l’amore dalla carne sublima nello spirito e, nell’opera, nell’aria. E quest’opera, vasta e talvolta retorica, contiene arie fra le più belle dell’intero repertorio, tanto belle che né Faust, né Marguerite, né Valentin, né Siebel potranno mai mentire, forse proprio perché come prigionieri di quella melodia troppo morbida e perfetta per ammettere ambiguità. Nemmeno Méphistophélès mente, ma perché lui conosce la chiave di questo linguaggio, e lo piega alla sua espressione in ogni istante diversa, sempre distaccata e sempre sardonica, nella Ronde come nella Sérénade. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Bresciamusica, ottobre 2008 Turandot: presentazione di Roberta Pedrotti Le prove per conquistare la mano di una principessa costituiscono uno dei più diffusi topoi fiabeschi e, se nella maggior parte dei casi esse sono imposte da un’autorità superiore (magica, divina, genitoriale), non mancano i casi in cui sia la stessa fanciulla a stabilire la posta per ottenerne la mano. È il caso, per esempio, della vergine Atalanta, che, confidando nelle proprie straordinarie doti atletiche, sfida nella corsa ogni pretendente, o della Brunilde del Nibelungenlied, disposta a concedersi solo a chi le si dimostri superiore in velocità e nel lancio del peso (la sua omonima wagneriana avrà una parete di fiamme innalzata dal divino padre). Assai meno fiabesco ma non meno diffuso, e legato a quello della donna che sceglie di sottoporre a prove insolvibili i pretendenti, è il tema della femminilità che si arroga diritti e prerogative tradizionalmente maschili sovvertendo, nell’astinenza o nella voracità, anche le leggi della sessualità. Turandot, la principessa cinese che impone al padre di accettare le sue condizioni e di concederla in sposa solo a chi la supererà in intelligenza sciogliendo tre enigmi, rappresenta forse l’archetipo massimo di questi topoi, codificato per la prima volta in letteratura, dopo una florida tradizione orale, nella raccolta I mille e un giorno, corrispettivo delle Mille e una notte nel quale invece di fornire allo spietato Califfo di Bagdad eloquenti esempi di fedeltà femminile, si narrano alla scettica principessa Farrukhnaz le vicende di innamorati sinceri capaci di conquistare le fanciulle più ritrose. Conosciuta in Europa dai tempi di Luigi XIV, la raccolta persiana, ma di possibile origine indiana, susciterà vasta eco, soprattutto con novelle come Re Cervo, Il baule volante e, appunto, La storia della Principessa Turandot e del Principe Calaf, volta per il teatro da Gozzi (1762), in aperta polemica con il realismo di Goldoni, e poi rivisitata secondo i principi del romanticismo tedesco da Schiller (1801). A cavallo fra XIX e XX secolo il soggetto, che all’esotismo di moda poteva affiancare torbidi temi decadenti o espressionisti e suggestioni freudiane, non poteva non tornare a interessare. La fuga nel fiabesco si accompagna alla sua riscoperta sotto nuova luce simbolica e, mentre Busoni nella sua Turandot tedesca (1917) rievoca la commedia dell’arte fra citazioni neoclassiche e inquietudini espressioniste che ricordano certi dipinti di Ensor, Puccini con la sua ultima opera (1926) si concentra sul dualismo delle figure femminili iscrivendosi in una tradizione recente di cui coglie tutta la complessità e modernità, rimaste solo in boccio nel giovanile, scapigliato Edgar (dove a fronteggiarsi erano la ribelle, crudele e sensuale Tigrana e la ben più domestica Fidelia). Nella Rusalka di Dvorak (1901), su un soggetto praticamente identico a quello della Sirenetta di Andersen, la ninfa è disperatamente incapace di diventare donna e di amare come tale e dopo il sacrificio che l’ha relegata nel limbo del fondo del lago darà suo malgrado la morte al Principe con il suo freddo bacio. La sua rivale e il suo doppio è la Principessa Straniera, seducente e carnale. Del 1917 è Die Frau ohne Schatten, di Strauss-Hofmannshtal, che nelle figure dell’Imperatrice e della Tintora contrappone, con lieta conclusione, una creatura soprannaturale che anela a divenire donna – e madre – e una figura umana, che invece la femminilità rinnega. L’opera di Puccini oppone la docile, remissiva, devota Liù alla gelida dominatrice, all’amazzone che rifiuta il matrimonio non per Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) non sommettersi al potere altrui, ma per puro odio verso il sesso maschile. Altoum, l’imperatore, non ha altra autorità sulla figlia che di chiedere il rispetto del giuramento allorquando, finalmente, Calaf scioglie i tre enigmi, ma è una sacra figura da paravento, senza lo spessore concesso a Timur, padre del pretendente fortunato, re spodestato ramingo e dolente. Per dirla con Nietzsche, Turandot narra con ferocia “l’odio mortale fra i sessi”, ma anche la sua conciliazione, senza lasciar spazio alle figure paterne, ridotte a spettatori, per quanto di primo piano. Tutto ruota invece intorno alla donna Turandot che sostituisce l’amore con la morte e solo nella morte del suo opposto, la piccola Liù, potrà scendere sulla terra dal suo tragico cielo. Di fronte al gelo che diventa fuoco, del rifiuto che non diventa tanto sottomissione quanto accettazione del sentimento, Calaf sembra un personaggio unidimensionale, perfino odioso nella sua insensibilità alle preghiere di Liù e ai pericoli cui sottopone lei e il padre, ma non si può cercare una psicologia, né tantomeno una morale, in colui che è semplice energia vitale, motore erotico del cambiamento di Turandot privo d’identità propria: si presenta come Principe Ignoto, alla fine sarà rinominato Amore dalla principessa. E questo è, né più né meno: la forza primigenia e sprezzante dell’Eros. L’umanità è rappresentata piuttosto, dalle Maschere, i tre ministri Ping Pong e Pang, cui spettano i ragionamenti spicci della gente comune (Se la spogli nuda, è carne, carne cruda!Roba che non si mangia…Lascia le donne! O prendi cento spose, ché, in fondo, la più sublime Turandot del mondo ha una faccia, due braccia e due gambe, si - belle – imperiali, belle, si ma sempre quelle!), le chiose ciniche e le nostalgie distillate nel bellissimo terzetto che apre il secondo atto (Ho una casa nell’Onan…). Questo universo simbolico perfettamente strutturato è tradotto musicalmente in una partitura che più d’ogni altra ci sembra iscrivere Puccini nell’Olimpo dei grandi del Novecento, spazzando via i luoghi comuni sui sentimenti semplici per sartine. Piuttosto, è dato ancor più rilevante che un’opera tanto avanzata nell’armonia e nella tecnica compositiva abbia saputo raggiungere una tale popolarità. La stessa patina esotica di certe melodie non è meramente decorativa: è vero che Puccini apprese da un carillon alcuni modi musicali cinesi, ma se ne appropriò alla maniera di Debussy quando ascoltò il gamelan giavanese. Non una citazione, dunque, ma la rielaborazione originale e sorprendente di moduli nuovi, di materiali lontani che offrono nuova linfa all’ispirazione d’un artista che ha già valicato i confini della tradizione e della convenzione. L’opera, è vero, è incompiuta: alla prima Toscanini posò la bacchetta dopo la morte di Liù a indicare il punto in cui il Maestro aveva cessato di comporre e il finale, affidato da Ricordi ad Alfano, è stato variamente tagliato, poi riscritto da altri, fra cui Berio. La qualità di quanto possiamo oggi ascoltare e la quantità di appunti lasciati da un Puccini già segnato dal cancro, però, difficilmente possono far pensare a un’insormontabile crisi creativa, piuttosto all’impegno titanico richiesto da una partitura che è insieme l’ultimo grande melodramma italiano e un vertice assoluto della musica europea inesorabilmente proteso verso il futuro. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Bresciamusica, ottobre 2009 Cose delicate: ricordo di Virgilio Savona di Roberta Pedrotti La sera è scesa più malinconica che mai. Frasi di circostanza e cordoglio di superficie rischiano di addomesticare nei rassicuranti confini familiari dell’intrattenimento il ricordo di Virgilio Savona e della sua attività, con Quartetto Cetra e come solista. Antonio Virgilio Savona è nato a Palermo il primo gennaio 1920 e morto a Milano il 27 agosto del 2009, ha vissuto e si è formato a Roma, ha sposato una bolognese. Già nei dati anagrafici sembra iscritta la storia del Novecento, ma Savona fu molto di più, intellettuale e musicista fra i maggiori che il nostro paese abbia conosciuto, benché forse non conosciuto e stimato quanto in realtà meritasse. Dieci anni fa moriva Fabrizio De André, dieci giorni prima di Savona se ne andava Fernanda Pivano e la coincidenza non può non suggerire una riflessione sulla statura culturale del cantautore e del compositore. Mentre il regime s’avviava al tramonto e la guerra volgeva alle sue fasi più aspre, la Pivano iniziava la sua opera di traduzione di Lee Masters e Hemingway; nel frattempo lo studente di pianoforte del Conservatorio di Santa Cecilia, divenuto cantante, introduceva il jazz e il blues all’EIAR. Mentre, dopo il ’68, De André pubblica la maggior parte dei suoi capolavori, Savona rallenta l’attività con il quartetto si dedica a una produzione politicamente impegnata anche in collaborazione con Giorgio Gaber (la voce dell’album Sexus et Politica, su testi sempre attualissimi di poeti latini) e Michele Luciano Straniero, il fondatore del cantautorato italiano di radice popolare e contenuto sociale. Per chi lo collegava alla Vecchia fattoria, a Vecchia America e al Vecchio palco della Scala l’ascolto di Sono cose delicate poteva rivelarsi uno choc. Testi duri, aspri, apertamente schierati. Lo stesso Savona ne pare consapevole e con amara ironia affida alla canzone eponima una sorta di commuovente autobiografia intellettuale. Il testamento dell’artista che non può rimanere sganciato dall’attualità, ma che si sente in dovere di far sentire la propria voce, anche se gli argomenti sono delicati e dal simpatico occhialuto di Studio Uno proprio non ce li si aspettava. Cose da pazzi veramente, ma questo cosa vuole fare? Dico, perché non si sta zitto, che fa? si mette a protestare! Ma come? Vive agiatamente, tiene la macchina, va al mare E vuole fare l’impegnato e si permette di parlare! Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare! Ma di che si va a impicciare? Questo si vuole rovinare! Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i caroselli, canti alla televisione! Non si vada ad immischiare con la contestazione. Ma questo come si permette di toccare le cose serie? Non ci ha fatto fin da bambino il buffone ed il burattino? Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare! Ma di che si va a impicciare? Questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Nessuno dice che è vietato, se vuole scrivere canzoni, Ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E si ricordi che va bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare, ma che? Ci ha preso per minchioni? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare! Ma di che si va a impicciare questo si vuole rovinare! Sono cose delicate, non devono essere toccate. E che seguiti a cantare quella, com’è?.. la Fattoria: Che faccia pure, l’ascoltiamo, canta, pazienza, così sia! Ma questo legge, questo pensa, si atteggia a fare il comunista! Che fa? Si mette a parodiare gli intellettuali di sinistra? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare! Ma di che si va a impicciare? Questo si vuole rovinare! Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare! Ma di che si va a impicciare? Questo si vuole rovinare? Se diventa irriguardoso e continua a sfrucugliare Lo mettiamo un po’ a riposo, a pensare, a meditare Sulle cose delicate che non devono essere toccate. Sia Savona sia De André riprendono le forme della ballata popolare, il primo è forse più musicista (nella prefazione alla Buona Novella l’autore si schermisce per la propria “balbuzie melodica”), il secondo più poeta. Non tanto perché solo ora, come cantautore, Savona lavora direttamente e regolarmente ai testi che, nel Quartetto, erano appannaggio in primis di Tata Giacobetti, ma perché il suo sguardo è più asciutto, più amaro, più violento. Difficilmente si trova quella tenera umanità, quella poesia degli umili che si respira negli LP del genovese, al contrario troviamo la rabbia del quarto stato, troviamo il dolore degli oppressi. Savona è legato a doppio filo all’attualità e cita senza mezzi termini manifestazioni, di ribellione studentesca, delle diverse anime della sinistra, di scontri e occupazioni con precisi riferimenti. Una tenerezza quasi fiabesca emerge quando meno ce la si aspetta, come in una canzone intitolata La merda. Mai titolo meno poetico per un testo tanto affettuoso, nel quale la delicatezza verso il soggetto bilancia la fermezza della critica. Eccolo, l’amico e il collaboratore di Gianni Rodari (sui testi del quale, su invito di Luciano Berio, comporrà tra l’altro l’Opera delle filastrocche), eccolo a raccontarci che non è giusto prendersela con quella materia biodegradabile, naturalissima, tenera e perfino utile accostandola a politici, venditori di fumo e di armi, sfruttatori ben più dannosi e puzzolenti, oltre che difficili da eliminare. L’accusa diretta al “grande capo americano” (all’epoca Nixon) non avrebbe potuto essere più dura. Se De André fu un anarchico e un ateo umanamente partecipe ai sentimenti evangelici, dalle canzoni di Savona traspare chiarissima l’immagine di un comunista visceralmente anticlericale, sia nella parodia sorridente di Pretini rossi Moniche bianche, sia nel j’accuse velenoso del Testamento del parroco Meslier, scabra messa in musica dell’ultimo scritto del sacerdote francese del primo Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) settecento, considerato fra i padri del socialismo per il pensiero che sfociava in espressioni rivoluzionarie e in concetti non dissimili da quelli che avrebbero espresso in materia di religione Feuerbach e Marx. C’è tuttavia anche Prete visionario, quasi un ritratto di Don Milani, a ricordarci che esiste una chiesa lontana dai giochi di potere e vicina ai valori originali, la chiesa del popolo e dei preti operai. Pur tuttavia sarebbe un errore dividere nettamente la carriera di Savona fra impegno e disimpegno, senza e con il Quartetto Cetra. L’osservazione critica spesso acuminata della realtà attuale faceva effettivamente parte della poetica dei quattro, se si pensa a una canzone come Troppi affari, cavaliere, scritta da Giacobetti come satira degli industriali rampanti e densa d’allusioni profetiche (l’invito a lasciar perdere i giornali, la crisi della borsa, guai con moglie e avvocati), o anche alla Ballata del critico TV, che, sbeffeggiando certa stampa snob che li accusava di presenzialismo, satireggiava già l’alienazione televisiva di oggi (e nell’era squallida dei reality fa sorridere l’ironia su chi passava le giornate fra sceneggiati e Studio Uno). Lo stesso Savona, in una recente intervista alla Repubblica rivendicava un atteggiamento critico e persino sovversivo già dai primi anni, quando con i suoi compagni d’avventura riusciva, fra adattamenti e traduzioni, a contrabbandare “musica afro-epilettoide o barbara anti-musica negroide” nell’Eiar fascista e autarchica. E non furono da meno l’arguzia critica e l’humour nero (l’allegro uxoricidio di Però mi vuole bene) di cui erano intrisi anche brani apparentemente leggeri. Su tutto però dominava, e garantiva l’efficacia dei contenuti, la straordinaria qualità musicale frutto di un percorso favorito anche dalla sorte. Nel 1940 attorno a Giovanni Giacobetti, detto Tata, si raduna il Quartetto EGIE (Enrico De Angelis, Giovanni Giacobetti, Iacopo Jacomelli ed Enrico Gentile), pieno di buona volontà ma povero di basi musicali. Un brillante studente di pianoforte al Conservatorio, che il padre vorrebbe avviato alla carriera di concertista, viene invitato da tata a curare gli arrangiamenti e nel giro di pochi mesi, dopo la defezione di Jacomelli, Virgilio Savona entra a far parte del gruppo anche come cantante. Il quartetto ora si chiama Ritmo, ma un altro dei componenti iniziali abbandona l’iniziativa e viene rimpiazzato da un giovane di Latina, ottimo cuoco e stornellatore, dotato di una vocalità grave particolarmente duttile e di ottima verve: Felice Chiusano. Nel 1941 nasce il Quartetto Cetra, completamente maschile e, pur lavorando di concerto, i ruoli sono già definiti, Virgilio è il compositore, Tata il responsabile dei testi, anche se è impossibile non citare i contributi di Age, vecchio amico dei ragazzi del gruppo dai tempi dell’EGIE, Gorni Kramer e Lelio Luttazzi. Nel frattempo Enrico De Angelis deve rinunciare per adempiere al servizio militare e, inaspettatamente e indirettamente la soluzione viene dallo stesso Savona. Si propose infatti come nuova voce una bella ragazza bolognese dotata di un registro acuto cristallino e intenzionata a unire una nuova esperienza artistica (non s’erano ancora visti in Italia gruppi vocali misti) alla possibilità di stare più vicina al marito Virgilio. Lucia Mannucci, giunta alle nozze dopo un periodo di convivenza affatto raro per l’epoca, permise di valorizzare la vocazione drammatica del quartetto e gli aprì vie artistiche prima insospettabili, in teatro come in televisione. Canzoni drammatizzate, rivista, parodie e sketch televisivo. L’impasto vocale era perfettamente amalgamato e permetteva una perfetta articolazione polifonica, i caratteri ben definiti. La voce più chiara e leggera di Tata, insieme con i lineamenti sottili, lo rendevano perfetto per i personaggi più giovani, fatui, amorosi, ingenui o ambigui, come Telemaco, il Fornaretto di Venezia, Ashley, Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Aramis, Dracula. Virgilio, con il suo eclettismo timbrico si collocava preferibilmente su tessiture baritonali, spaziando fra figure nobili, tenebrose e misteriose e altre più caricaturali: è Athos, Rett Butler, Antinoo, ma soprattutto un fascinoso e implacabile Conte di Montecristo, magistrale nell’incarnare la trasformazione dal goffo buon marinaio Dantés. Felice, versatile voce di basso, affronta ruoli più maturi, spesso buffi o bonari (Geraldo O’Hara, Porthos) senza trascurare figure negative (Chauvelin nella Primula rossa, Bondumier nel Fornaretto di Venezia ) o grandiose come Napoleone o Ulisse. La primadonna è Lucia: Mercedes, Milady, Penelope (in gara con la Calipso di Milva e la Circe di Elena Sedlak), Rossella. Esemplare, in tal senso, la distribuzione nel Fornaretto di Venezia, dove i conti Lorenzo e Clemenza Barbo sono Virgilio e Lucia, Lauretta Masiero Sofia Zeno, Sandra Mondaini Annella e un superlativo Lelio Luttazzi come Alvise Guoro. Proprio nel Fornaretto emergono le qualità drammatiche dei Cetra, che toccano corde indiscutibilmente tragiche nel finale, con la doppia esecuzione dell’innocente Fornaretto e del conte che, giunto troppo tardi a confessare la sua colpevolezza, sceglie comunque di seguirloe sul patibolo. Il commiato, pronunciato come d’abitudine dalla deliziosa Grazia Maria Spina, mentre per le calli si rianima il carnevale è realmente commuovente, senza compiacimenti. Non traggano in inganno le situazioni comiche (il Doge che si esprime solo in rime gastronomiche, il cameo di Raimondo Vianello come pittore veneziano) perché come in Shakespeare queste, per contrasto, rendono ancor più forte la tragedia. Di più, anche Lucia che canta “Guoro mio perché sei morto” sulle note di Maramao sottolinea un uso etimologico della parodia come costruzione su un canto preesistente. Quante messe polifoniche rinascimentali sono composte su temi popolari anche profanissimi? I Cetra alzano addirittura il tiro e utilizzando più volte lo stesso brano ne enfatizzano una plasticità semantica che fa pensare ad Hanslik o all’autoiprestito rossiniano. Per chi conosca il motivo originale la reminescenza sarà inizialmente ragione di sorriso, ma non si potrà negare l’appropriatezza del tema alla situazione. D’altra parte il citato Visconte di Castelfombrone era passato tranquillamente al carosello della China Martini e alla lettera di delazione di Fernando e Danglars ai danni di Edmondo Dantes (“All’ufficio Regio del Prefetto…”) e Siam tre piccoli porcellin può diventare Siam tre impavidi moschettier. L’apoteosi è raggiunta nel ciclo di parodie cinematografiche di un anno precenti (‘62/’63) alla Biblioteca: qui il personaggio femminile, all’incirca a metà, intona E’ scesa malinconica la sera, sia che attenda un vampiro o l’esito della battaglia di Waterloo. Una reminiscenza dell’aria di baule dei divi del belcanto? Un’ironia iperbolica su un singolo brano, un esercizio semantico. Esperimento o convenzione portata all’eccesso? Ogni lettura è lecita. Del resto quando nella Storia di Rossella O’Hara lo stesso tema introduce alla spensieratezza della festa alle Dodici Querce e viene poi intonato con tutt’altro spirito da Rossella affranta in una Tara distrutta dalla guerra non si può non pensare a un uso significativo del tema non ignaro del Leitmotiv. La convenzione teatrale, il formalismo quasi operistico, nelle più estese parodie di Biblioteca di Studio Uno si concretizza, peraltro, nell’appuntamento fisso di un brano a quattro voci – quasi un concertato – che si colloca spesso come nodo dell’azione. Nell’Odissea, per esempio, sulle note di Che centrattacco! si consuma l’ingresso di Ulisse camuffato da mendicante al banchetto dei Proci. La virtù straniante della musica permette poi di dipanare con un sorriso soluzioni poco accomodanti e sempre intinte in un disincantato cinismo. Non si può mai parlare di adattamento edulcorato, non si accettano varianti liete, a costo di mostrare più morti dell’Amleto, non c’è scampo per Valentina e Donna Renata Villefort, né per Fernando, Edmondo abbandona Mercedes preferendone la fedele Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) (e più fresca) Haydée; nessuno scampa alla strage dei Proci; Rossella spara senza problemi a un Nordista assai esplicito per la RAI dell’epoca (“Bella sudista, ci sono altre libertà che ora mi prenderò con te!”, ma un anno prima Tata/Ottaviano si lamentava con Lucia/Cleopatra d’essere stato l’unico, fra Cesare e Marcantonio, ad essere “andato in bianco”). Rossini, come si è detto, non si era comportato diversamente, aveva prestato le note della commedia alla tragedia, dimostrando come gli affetti fondamentali della musica potessero svincolarsi e superare le contingenze verbali. Travolta proprio il virtuosismo in questi mutamenti accentua l’effetto del dramma, i meccanismi della lacrima e della risata, della pietà, del terrore, della catarsi. Nella forma piacevole e nell’arte sublime della leggerezza il disimpegno – coltissimo – dei Cetra diventa impegno. Non inferiore a quello del Virgilio Savona compositore, cantautore e studioso di musica popolare. Del Virgilio Savona che nel suo album Sono cose delicate si concede il vezzo di un autoimprestito sfacciato, affidando alla stessa musica la rivendicazione autobiografica del brano eponimo e l’allegoria del Formichiere che trasforma le formichine ribelli e rivoluzionarie in impiegati e segretarie funzionali all’ordine costituito. Resta Lucia Mannucci, resta il figlio Carlo Savona a ricordare un’epoca in cui la responsabilità delle idee e della cultura poteva essere rappresentata da uomini come Virgilio Savona o Gianni Rodari (ma anche, fra i tanti, De André, Pivano, Gaber, Straniero) dagli artisti di una generazione che conosceva l’impegno ma, forte di una solidissima e profonda preparazione, lo viveva con il virtuosismo sublime della leggerezza. Gli amici della musica, novembre 2007 Ariane simbolo di libertà senza vendetta di Roberta Pedrotti TORINO_ Non so se qualcuno abbia già pensato ad accostare René Magritte a Paul Dukas. Entrambi perdono la madre in modo traumatico, il pittore tredicenne la vede suicida in un fiume, a cinque anni il compositore la perde mentre da alla luce la sorellina. Paul eredita la vocazione musicale dalla madre, eccellente pianista, ma mortifica la vena compositiva con una severissima autocritica; René replicherà il trauma nelle figure velate come il cadavere materno, ritrovato con la camicia da notte avvolta sul viso. Come la vena surreale, i sottintesi simbolici di Magritte trovano realizzazione in una pittura apparentemente semplice, formalmente compiuta, così Dukas ripropone cromatismi wagneriani e moduli à la Debussy in strutture sinfoniche – anche nell’opera – solidamente strutturati nel solco della tradizione. Così è L’apprenti sorcier, il titolo più noto del pur sparuto catalogo di Dukas; così è l’Ariane et Barbe Bleu, unica partitura teatrale completa. Il legame con Pelléas et Mélisande e il suo autore sembra, peraltro, ineludibile, non solo perché il libretto è dello stesso Maeterlinck, non solo perché una delle mogli di Barbablù ha il nome e gli splendidi capelli dell’evanescente sposa di Golaud, ma anche perché al drammaturgo belga riuscì a imporre come protagonista quell’amata Georgette Leblanc già vigorosamente rifiutata da Debussy per la sua opera (e bene pare abbia fatto, giacché non pare che come Ariane si sia coperta di gloria). Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Non è però per mera convenienza teatrale che Maeterlinck riscrisse la fiaba di Perrault ponendo in tale rilievo l’ultima moglie. Ariane et Barbe Bleu è una parabola simbolista non immune dal misticismo che innerva la corrente belga del movimento e fa dell’eroina la portatrice della bonne nouvelle, che immagina alla fine il marito padrone, aggredito dai contadini, come un Cristo deposto accudito dalle pie donne. Ariane è una donna indipendente, emancipata, portatrice di un messaggio ribelle e femminista. È anche, però, il simbolo universale della libertà: scende nel labirinto sotterraneo tornando alla luce, come Arianna, ma sarà lei ad abbandonare un uomo che è insieme Minotauro e Teseo, vittima e carnefice, ferino e amato amante. Come Antigone si ribella a una legge che ai suoi occhi non ha ragione, come Ulisse ha ingegno versatile e multiforme, segue virtute e canoscenza, quandanche, come per Edipo, la ricerca possa portare alla catastrofe. Ariane è la luce che svela se stesse alle donne già sepolte prima di aver infranto il divieto ( je me n’etonne plus s’il ne vous amait pas autant qu’il eût fallu […] il n’avait que vos ombres). Il velo che avvolge i volti di Magritte come quello della madre che aveva preferito annegarsi, il velo metaforico che celava Mme Dukas e il suo talento nelle mura domestiche è lo stesso nel quale Ygraine, Sélysette, Mélisande, Bellangère e Alladine si sono nascoste. Eppure, quando riscoprono la luce e la natura, quando rinasce la loro femminilità e si adornano degli splendidi gioielli del tesoro di Barbablù, esse non si vendicano del castellano. Non lo fa Ariane, che lo libera e poi lo lascia senza odio, ma per amore della libertà; non lo fanno le altre mogli che l’accudiscono e restano con lui. Forse è vero che la libertà (come la democrazia) non può imporsi uguale per tutti, che si possono scegliere diverse forme di felicità e realizzazione: tutte le donne hanno attraversato il labirinto e conquistato la luce, la délivrance potrà essere inutile (come recita il sottotitolo del dramma) ma l’aggettivo ha valore quantomai relativo. A un secolo dalla prima del 1907, il Regio di Torino ci offre l’occasione di tornare sull’Ariane, opera ambigua e affascinante, per quanto figlia disciplinata del suo tempo più che geniale rivelazione. Lo fa grazie soprattutto all’ottima concertazione di Emmanuel Villaume, a suo perfetto agio nel linguaggio di Dukas, grazie anche all’orchestra e al coro del Regio, in forma strepitosa. Peccato che la protagonista, Kristine Ciesinski, non abbia entusiasmato: suoni troppo aperti, vibrato largo, interpretazione poco soggiogante. Pazienza, il ruolo è assai impegnativo e la Ciesinski è stata chiamata all’ultimo dopo la defezione – nota da qualche mese – di Sonia Ganassi e – più recente – di Hermine May. Marcel Vanaud canta solo poche frasi nel primo atto, ma il suo Barbablù è subito caratterizzato e autorevole. Gli anni pesano più sulla Nutrice di Nadine Denize, mentre si disimpegnano con disinvoltura le mogli: le cantanti Sophie Pondjiclis (Sélysette), Daniela Schillaci (Ygraine), Gisèle Blanchard (Mèlisande), Gemma Cardinale (Bellangère) e la mima Katiuscia Cauzzi (Alladine). I contadini erano Oliviero Giorgiutti, Giancarlo Pavan e Devis Longo. La messa in scena, assai sobria e senza sorprese, si doveva a Danielle Ory (regia), Philippe Fraisse (scene), Rossana Caringi (costumi) e Roberto Venturi (Luci). Alla recita domenicale pochi vuoti in sala e alcuni spettatori anche da oltralpe. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Gli amici della musica, dicembre 2009 A Torino Daniela Barcellona conferma la sua eccellenza d'artista completa Tancredi capace di toccare anche gli animi più ruvidi di Roberta Pedrotti TORINO - Nell'estate del 1999 Daniela Barcellona si rivelava come Tancredi al Rossini Opera Festival raccogliendo il testimone di Lucia Valentini Terrani, scomparsa un anno prima. Sempre a Pesaro Antonino Siragusa, già allievo dell'Accademia Rossiniana, era Belfiore nel Viaggio a Reims e Selimo in Adina. Nell'estate 1999 Patrizia Ciofi cantava Traetta a Martina Franca, dove si era già segnalata nella Sonnambula, nel Re e nel Mese mariano di Giordano e dove di lì a un anno sarebbe stata Isabelle in Robert le diable. Le promesse di dieci anni fa ora sono consolidate certezze e trovarle radunate per Tancredi al teatro Regio di Torino lascia presagire una delle migliori produzioni possibili oggi. E così, in effetti, è, o, meglio, sarebbe, se sul podio non si trovasse il giovane estone Kristjan Järvi, figlio d'arte dedito soprattutto alla musica del XX secolo e al suo debutto nel repertorio italiano. L'estraneità al fraseggio e all'articolazione stessa del suono nella nostra lingua è evidente, così come traspare dagli attacchi indecisi e imprecisi, dallo stacco dei tempi privo di reale coerenza e respiro musicale, dalla resa dell'orchestra e del coro decisamente inferiore alla media e dall'indubbia difficoltà, se non fastidio, palesata dai solisti lasciano intuire una preparazione decisamente inadeguata al cimento. Peccato: non solo la scelta si è rivelata fallimentare, ma ha creato non poche difficoltà a chi Rossini lo conosce e lo frequenta ormai da parecchi anni con soddisfazione. Con altra bacchetta avremmo forse potuto uscire dal teatro gridando al miracolo, ma i momenti di eccellenza non sono mancati. Sembrerebbe, infatti, superfluo rimarcare ancora una volta le virtù del Tancredi di Daniela Barcellona, ma a dieci anni dal debutto (e alla sua tredicesima produzione) riesce ancora a stupire per la cura espressiva nel pieno rispetto della scrittura e dello stile, ad ammaliare per il canto morbido e appassionato, a commuovere in una scena della morte nella quale non una sillaba è sprecata e, anzi, si intende la perfetta fusione fra un recitar cantando d'ascendenza monteverdiana e il petrarchesco Cantar che nell'anima si sente vagheggiato da Rossini. Impossibile trattenere le lacrime, anche per gli animi più ruvidi. La sintonia con l'Amenaide stilizzata ed evanescente, come da poema cavalleresco, di Patrizia Ciofi è tale che spiace si sia scelto di omettere il primo duetto, L'aura che intorno spiri, spostando nel primo atto quello del secondo, Lasciami, non t'ascolto. È importante ricordare che questa soluzione proviene sì dalla versione che Rossini approntò per Ferrara, ma anche che solo il finale - quello tragico su testo del conte Lechi - è stato proposto nella stessa versione, che prevederebbe anche il taglio della seconda aria di Argirio (Ah segnar invano io tento), fortunatamente eseguita, e la sostituzione dell'aria di Amenaide No che il morir non è con la meno interessante Ah se pur morir degg'io. Proprio nella scena del carcere, Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) peraltro, la Ciofi raggiunge gli esiti più alti, cesellando variazioni e cadenze con somma eleganza e perizia musicale e stilistica. Se le donne erano comunque veterane dei rispettivi ruoli, debuttava in quello di Argirio, per di più decisamente più basso di quelli nei quali siamo abituati ad ascoltarlo, Antonino Siragusa, ormai sempre più impegnato sul fronte del Rossini serio. La sua interpretazione avrebbe sicuramente entusiasmato Stendhal, perché il colore limpido e solare del tenore siciliano rievoca un ideale neoclassico che per accento e autorità vocale s'ammanta di dignità paterna, restituendone nobiltà e spessore psicologico. L'esecuzione, poi, della perigliosa seconda aria è notevolissima. Ai tre protagonisti, felici conferme, s'affiancano interessantissime nuove voci, come il basso baritono Simone Del Savio, ottimo Orbazzano, e i mezzosoprani Paola Gardina, fresco Roggiero, e Annunziata Vestri, intensa Isaura. Tutti stilisticamente e interpretativamente inappuntabili. Come si è detto, invece, meno a fuoco del solito coro e orchestra, piuttosto piatti i recitativi accompagnati da Gianandrea Agnoletto. L'allestimento, proveniente dai principali teatri spagnoli, è di Yannis Kokkos, che sceglie una via fiabesca e volutamente antirealistica ispirandosi al mondo dei pupi siciliani e di un'araldica surreale. Uno spettacolo coerente e ben costruito di cui abbiamo apprezzato soprattutto l'uso della torre del palazzo d'Argirio, elemento scenico praticabile che permette suggestioni stilnoviste o trobadoriche (l'amour de loin), ma anche posteriori (il balcone di Giulietta o quello di Melisande, con la quale la Ciofi condivide le lunghe chiome ramate). Bellissimo anche il finale pittorico con Tancredi morente accasciato sul suo stesso scudo come un eroe antico o un martire (le frecce infitte suggeriscono un San Sebastiano). Teatro pressoché esaurito e pubblico giustamente entusiasta per il cast, premiato con lunghe e ripetute acclamazioni. Qualche sacrosanto mormorio per il direttore. Brescia: nel teatro Grande un'opera di Donizetti e un altro insolito dittico La figlia "italiana" e la strana coppia di Roberta Pedrotti BRESCIA - La fille du régiment "italiana"- Filologia, questa sconosciuta. Non, per fortuna, sul palcoscenico, dove abbiamo visto restituire alle scene la versione italiana della Fille du régiment così come Donizetti la scrisse e l'edizione critica la riporta. È nella comunicazione che la disciplina risulta tristemente trascurata, tant'è che, non trovando nessuna delucidazione su quello che è a tutti gli effetti un testo inedito né nella cartella stampa né nel programma di sala della stagione non è rimasta altra alternativa che contattare direttamente il curatore dell'edizione, il cui nome le locandine bresciane tacciono sistematicamente. Il professor Claudio Toscani, molto gentilmente, chiarisce tutti i dubbi, ma ci resta il rimpianto che l'occasione di spiegare al pubblico la scelta di questa versione (che non è una semplice traduzione) non sia stata colta appieno. Da qualche anno il Grande organizza un ciclo di conferenze, Pazzi per l'opera, in cui appassionati colti, ma non addetti ai lavori - classicisti, storici dell'arte, avvocati… - introducono le opere in cartellone. Perché, per esempio, non affiancare loro, soprattutto in casi come questo, i curatori dell'edizione critica? Il successo di pubblico di Bruno Cagli, Philip Gossett o Luciano Canfora Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) insegna che non bisogna aver paura degli studiosi! Tornando in argomento La figlia del reggimento italiana che Donizetti curò per la Scala nel 1840 prevede ovviamente i recitativi secchi in luogo dei parlati e la soppressione dei couplets della Marchesa, eliminando così due tratti caratteristici dello spirito originale dell'opèra comique. Anche la parte di Tonio è rivoluzionata, gli si offre una cavatina buffa di carattere tratta dal Gianni di Calais (Feste? Pompe? Omaggi? Onori?), negandogli però la splendida Pour me rapprocher de Marie. Ah mes amis, invece, era stata approntata dall'autore con alcune varianti anche per Milano, ma il tenore dell'epoca preferì non affrontarla, per cui il brano rimase nel cassetto, non riportato per molti anni nei libretti italiani (finché non rientrò per influenza francese). La rielaborazione dell'aria esiste, tuttavia, e il tenore che desideri cantarla potrà farlo con ogni diritto filologico anche in italiano. La differenza più vistosa rispetto a quanto conosciamo, anche dalle incisioni nella nostra lingua, resta dunque il finale, che non culmina nel rondò Salut à la France /Salvezza alla Francia ma, alla maniera dei Puritani di Bellini, in un rondò a due voci - non memorabile - fra tenore e soprano, Su questo sen riposati. Nel libretto tradotto da Calisto Bassi abbiamo, infine, qualche variante rispetto a quanto si legge abitualmente ( la Francia , per esempio, diviene Savoia, Berkenfield e Krakentorp rispettivamente Lauffen e Swingen). Il risultato è purtroppo decisamente più debole dell'originale francese, l'opéra comique camuffata da opera buffa si appesantisce, perde agilità e freschezza e solo un'esecuzione superlativa ne può giustificare una ripresa che vada al di là della curiosità filologica. I recitativi, innanzitutto, sono correttamente realizzati con l'apporto del violoncello e del contrabbasso al fianco della tastiera, ma con tale mancanza di fantasia e leggerezza da rendere lo scrupolo esecutivo un'inutil precauzione. Parimenti scrupoloso è nella cura dell'orchestrazione d'epoca il maestro Alessandro D'Agostini, ma non giova a molto quando quel che si ascolta è generalmente uniforme, spesso troppo lento e gli accompagnamenti non brillano per fantasia ed elasticità. Yolanda Auyanet, con il suo timbro dal sapore antico, è valorizzata soprattutto dalle pagine più liriche e non teme di lanciarsi in puntature acute, mentre nei momenti di coloratura più brillante si trova meno a suo agio e si avverte persino qualche asprezza in alto. Il personaggio di Maria è reso comunque con simpatica immedesimazione e risulta alla fine convincente. Convince meno Gianluca Terranova, Tonio cui difettano la grazia e la solarità che dovrebbe essere il tratto distintivo del personaggio. La natura generosa lo sostiene nella scalata ai nove do, ma la tecnica sembra ancora disordinata. Francesco Paolo Vultaggio è un puntuale Sulpizio e Dionisia Di Vico si disimpegna come può con una Marchesa ridotta, in questa versione, quasi ad una macchietta. Sara Palana è la contessa, Andrea Tabili il caporale, Gianfranco Giuntoli il notaio. Andrea Cigni, regista scenografo e costumista, colloca l'azione nel secolo scorso: Maria rifornisce la cucina del reggimento muovendosi in sidecar, brandisce carciofi e padelle ma sogna la battaglia. Vive in una sorta di stato di natura, in un mondo già adulto ma illuministicamente - o fiabescamente - ingenuo. Al contrario il mondo della Marchesa è una sorta di casa di bambole dominata da un mastodontico orsacchiotto, un'infanzia cristallizzata e artificiale, sclerotizzata come gli invitati alla festa, vecchietti decrepiti e un po' rimbambiti. Difficile non ricordare l'allestimento recente e fortunato di Laurent Pelly, per molti versi simile, ma Cigni sa comunque mantenere un tratto d'originalità, e se non ha anche sempre convinto tutti in egual maniera, lo spettacolo è stato accolto dal pubblico bresciano con schietto divertimento (nella sfilata dei nobili geriatrici le risate in platea e loggione non riuscivano a soffocarsi) e calorosi apprezzamenti. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Poulenc e Leoncavallo, la strana coppia - Dopo l'inaugurazione con Brecht e Weill ecco un nuovo dittico inusuale sulle scene del Teatro Grande. Questa volta si tratta della Voix humaine di Poulenc e dei Pagliacci di Leoncavallo, titoli certo lontani per stile e drammaturgia, fra i quali potremmo azzardare paralleli ispirati per esempio alle frequentazioni culturali francesi di Leoncavallo, o al tema della solitudine e del fallimento dei sentimenti. La semplice giustapposizione, però, non è da rigettare, anzi, può servire a valorizzare le peculiarità di ciascuna partitura e, magari, a suggerire nuove prospettive d'ascolto. Un forte elemento di continuità scenica è intanto suggerito dall'ambientazione voluta da Leo Muscato, che, avvalendosi della scena di Antonio Panzuto, colloca entrambi i drammi su uno squallido marciapiede di periferia. È un angolo suburbano su cui si affaccia un piccolo teatrino che ospita compagnie di giro per farse piuttosto grossolane. Lì la donna, forse ancora sotto l'effetto dei barbiturici, si è schiantata con l'auto contro un lampione e telefona all'amante che cercava di raggiungere. Il dramma della comunicazione ideato da Cocteau si sposta dalla solitudine di una camera da letto ormai vuota alla desolazione di un marciapiede. Il vecchio telefono a disco è sostituito da un cellulare e la presenza delle centraliniste da problemi di campo e batteria. L'adattamento conferma l'attualità del testo, il dramma della solitudine nell'era della comunicazione globale, ma, certamente, deve sottostare a qualche piccola forzatura (l'appello alla signorina del centralino diventa richiesta d'aiuto a una prostituta di passaggio) per enfatizzare il naufragio di questa donna alla deriva che, aggrappandosi a una storia ormai finita, diventa ella stessa da vittima mentitrice che finge di trovarsi in casa quando invece ha quasi raggiunto l'abitazione dell'uomo. Lo spettacolo si regge tutto, com'è inevitabile, sulla prova sorprendente di Tiziana Fabbricini, che ha superato brillantemente i postumi di un intervento chirurgico che d'urgenza l'ha costretta a rinunciare alle prime recite della produzione. Beniamina - a ragione - del pubblico bresciano, non è mancata all'appuntamento all'ombra del Cidneo e non solo si è riconfermata straordinaria attrice (eccezionale per gesti, pause, colori, senso della parola), ma ha anche sfoderato una notevole sicurezza vocale: il solo do acuto di Je devenais folle, per di più assai scomodo, basterebbe a mettere a tacere chi dubita delle virtù della Fabbricini anche cantante in questo repertorio. Una nota precisa e sicura che è allo stesso tempo, come nella scrittura di Poulenc, un grido disperato, l'acmé di una spasmodica ricerca d'amore e sicurezza. La Fabbricini , capelli sciolti sulle spalle, tacchi a spillo e soprabito sopra il ginocchio, è veramente una giovane donna non priva di fascino, ma provata duramente dalla vita e dal crisi della sua vita sentimentale, dal crollo d'ogni certezza affettiva. Una donna maltrattata dalla vita, maturata e sfiorita nell'animo, ma ancora nel pieno della sua femminilità. Per quaranta minuti il teatro la segue con il fiato sospeso, poi esplode di una meritatissima ovazione. Poi è la volta dei Pagliacci, scompare il muro grigio e il palazzo rivela lo spaccato del teatro: sala, retropalco, camerini diventano lo spazio di un'azione - sempre ambientata ai giorni nostri - ben narrata e articolata. Nei panni di Tonio il bresciano Ivan Inverardi coglie finalmente un successo in patria: più di Verdi, indubbiamente, questo repertorio gli si confà anche per personalità scenica, l'interpretazione risulta azzeccatissima e gli acuti del prologo gli valgono l'applauso a scena aperta. Molto impegnato il Canio di Michael Spadaccini, cui rendiamo l'onore delle armi dopo il malore che l'ha colto in palcoscenico nella recita precedente, ma per il quale non possiamo non evidenziare il rischio di un repertorio troppo oneroso (specie nella zona centro grave) per la sua voce, portata a un repertorio Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) Selezione stampa Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS) più lirico e con maggiore facilità nel registro medio acuto. Esther Andaloro è perfetta nella scena ma poco timbrata e convincente nel canto. Enrico Marabelli è Silvio e Giulio Pelligra Peppe, entrambi ben inseriti nello spettacolo. Ottimo il coro del Circuito Lombardo e convincente la direzione del giovane Matteo Beltrami, che si conferma uno dei nomi più promettenti delle giovani generazioni. Buon ritmo teatrale pur in un'impostazione è prevalentemente sinfonica, i dettagli sono ben curati senza indulgere in effetti (peccato veniale solo la piccola pausa per attendere l'applauso nel prologo). Con il tempo e l'esperienza potrà sicuramente riservare buone soddisfazioni: intanto garantisce l'ottima resa di un dittico non facile che non ha mancato di entusiasmare e stupire il pubblico bresciano. Roberta Pedrotti tel. 338 4310725/ 328 6653500 [email protected] via Monsuello 16/b 25065 Lumezzane (BS)
Scarica