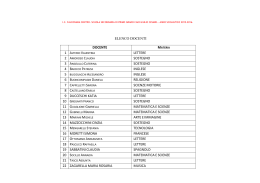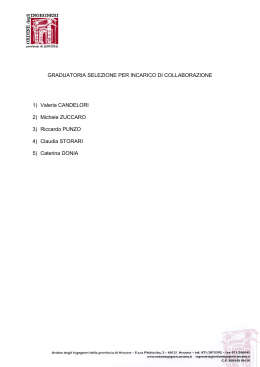Narrativa Aracne 26 Ogni riferimento a fatti o persone realmente esisteni è puramente casuale. Tulio Ampez La riscossa dei baroni ARACNE Copyright © MMVI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 88–548–0531–9 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: maggio 2006 Si può partire da Alessio Pahor. Chi era? Dove lavorava? Forse, fra qualche anno sarebbe diventato professore associato di tecnologia meccanica; conseguentemente avrebbe vinto un nobel per l’hobby della meccanica quantistica, avrebbe accettato con modestia i saluti da cravatte sconosciute lungo il viale XX Settembre, e più ancora, si sarebbe indaffarato a rispondere a lettere di sensibili ammiratrici, parimenti intelligenti e gnocche. Ma per il momento, Alessio Pahor, ricercatore di Tecnologia Meccanica all’Università di Trieste, rileggeva per la terza volta il saldo che lo scontrino del bancomat fissava a milleseicento euro al mese. A dire la verità Alessio era perfettamente a conoscenza dei propri emolumenti, che già da sei mesi, da quando aveva ricevuto la conferma di ricercatore erano passati da novecento a mille e sei. Il fatto è che un venerdì mattina di un mese prima, mentre si 5 recava al lavoro lungo via Giulia, aveva chiesto conferma al nuovo bancomat della filiale Unicredit. Quella scatoletta computerizzata, che per Alessio è inequivocabilmente di genere femminile, si era conquistata la sua amicizia rivelandogli il gradiente economico. Felicità. Immediata. Inaspettata. Ebbe così tanto quella prima volta che, da allora, il rito si ripete ogni venerdì mattina. Riscosso lo scontrino, se lo mise in tasca, rincagnò la scheda in un portafogli dove solo gli spiccioli per il caffè trovavano posto tra illeggibili appunti a matita e brani di scienza ed entrò nel centro commerciale “Giulia” per trangugiare l’ennesima ultima accoppiata di croissant e cioccolatina. Preferiva il bar del centro commerciale a quello di Ingegneria. Non gli piaceva, non c’era verso, non gli piaceva farsi vedere mentre mangiava nel bar di Ingegneria dove — per inciso — i croissant erano flaccidi e la crema pasticcera assomigliava ad una gelatina gialla cotta e ricotta. Non gli piaceva proprio; quelle poche volte che aveva tentato il rifornimento mattutino all’Università non era riuscito a trovare un posto discreto per la pancia che si era appoggiata irriverente al bancone; mentre apriva i denti, lo specchio di fronte, ben pulito e sfruttato dai capelli delle matricole, gli aveva mostrato una bocca ingorda, spropositata, un organo che gli altri uomini avrebbero potuto definire un buco, un buco che deve chiedere poco. E poi c’era Mario Stafani, il suo capo che quando lo sorprendeva mangiare gli palpava la pancia divertito e riciclava battute. Poteva proprio risparmiarsele le sue allegorie, i suoi ossimori. Mamma Pahor impediva al figlio di dire e pensare parolacce, ma quando Stafani si prendeva la libertà di infastidirlo di primo pomeriggio, in concomitanza 6 alla pausa pranzo ed al panino, solo il desiderio di giudicarlo un pezzo di merda ed un coglione gli davano la forza per inghiottire permettendosi anche il lusso di masticare. Attraversò via Giulia con ancora il gusto della crema pasticcera fra i denti, si sincerò della presenza dello spazzolino nella tasca della giacca ed affrontò la fatica della salita di via Dello Scoglio. A metà, quando il ricordo della crema pasticcera se n’era andato chissà dove, si riposò stando in piedi aggrappato al palo che sostiene e delimita il marciapiede. Ci stette un buon minuto, mimetizzandosi alla meglio come un ragazzone di quasi quarant’anni potrebbe fare in mezzo ad una via stretta e vuota. Infine piedi e muscoli delle cosce gli diedero il via libera ed affannandosi raggiunse la porta del suo ufficio. Ma prima di trovare la chiave giusta sperando di non averla dimenticata a casa — rifare la salita significava morire e risuscitare di nuovo — sentì il passo martellante del professor Mugnai in persona. Click. La porta si apre, ma non riesce ad infilarsi in tempo. — Allora, tutto a posto? — gli chiese il professore avvicinandosi talmente tanto che avrebbe potuto sniffare qualche residuo di crema pasticcera. Alessio indietreggiò masticando qualche sì, sì. — Siamo sicuri? Sai che è una cosa importante. — Sì, sì, sono partiti. Quando il prof se ne andò, Alessio, seduto alla sua scrivania, deposito di datasheet e manuali di tecnologia meccanica, si chiese se aveva fatto bene ad immischiarsi in quella faccenda. L’avevano proprio infinocchiato di brutto. E lui non era portato per quelle cose, proprio non lo era. 7 E chi sarebbe questo professore Alberto Mugnai? È qualcuno che conta? Non avrebbe mai immaginato Alberto che anche in seguito, durante le arringhe in Consiglio di Facoltà, avrebbe ricordato la rivelazione del pomeriggio del 5 agosto del 1972, come la più netta linea di separazione nella sua vita. Il solco lo tracciò Claudia, la figlia del meccanico sotto casa, alle due e trentasei esatte, dopo cinque giorni dall’inizio del campeggio organizzato dalla parrocchia a Cinte Tesino. Era caldo, ed il prete aveva concesso autorizzazione a trovare conforto nei gavettoni. Così, dopo una guerra ben impostata con squadre miste ragazzi e ragazze, escluse quelle affette dal misterioso male delle mestruazioni, Alberto si sedette ad asciugarsi a torso nudo vicino alla vasca di legno. Là si abbeverano le vacche. Sarebbero ritornate?, Dove erano in questo momento?, si chiese scegliendo qualcosa da domandarsi espressamente a caso. Ogni anima del campeggio ricevette piena gratificazione; il prete si rallegrò di aver avuto così tanti iscritti quell’anno, individuò addirittura due o tre bravi ragazzi che con le giuste raddrizzate avrebbero potuto vestire in futuro la veste nera dai mille bottoni; le ragazze strillarono per tutto il campo per farsi cecchinare; i maschi, poi, si diedero animo per centrare e liquefare quante più magliette poterono e memorizzare le forme dei capezzoli incappottati privi di mammelle. In tal senso Alberto si diede un gran da fare; corse, aggredì con precisione, non rise mai per non perdere concentrazione e in un paio di occasioni gli ballonzolarono di fronte imma- 8 gini di polpe femminili che non si sarebbe mai aspettato: quei dati erano fondamentali per le intime operazioni della notte ed Alberto possedeva la ferma volontà di affidarsi più al ricordo che alla fantasia. Erano le due e mezza. La battaglia volgeva al termine. Claudia gli si avvicinò, strizzò l’angolo della maglietta, si pulì le chiappe dal fango e girandogli intorno, gli svelò tutto, cinica, ignara degli effetti, dall’inizio alla fine. Tutto. Tutto partì da una semplice constatazione, da una osservazione naturale. Dopo aver eseguito l’analisi, Claudia si girò e come se la propria presenza fosse motivata dall’esigenza di lasciare un messaggio, ormai fuori posto, priva di verità, fece per allontanarsi. Alberto avrebbe compiuto vent’anni il prossimo mese. Ma in quel momento, mentre Claudia se ne andava verso la propria tenda tentando invano di sculettare, priva di culo, il giorno del suo compleanno gli sembrò una data insignificante. Si alzò, sollevò il macigno che la coetanea gli aveva lasciato appeso al collo, si trascinò nella sua di tenda pur sapendo che il prete non voleva nessuno negli alloggi prima di sera, si asciugò, si ricordò che un Dio esiste con un padrenostro ed infine trascorse i restanti dieci giorni di campeggio con la necessità irrefrenabile di ritornare a Bologna il più presto possibile per verificare. E se era una verifica che cercava, quella che ottenne fu impietosa. Ovviamente non disse nulla a Claudia. In pochi giorni tracciò i nuovi orizzonti della propria misera esistenza e quando, all’inizio del primo anno di Università, cambiò vita, appartamento, la Guzzi, palestra, rasoio e le punte delle camicie, si mise in testa di intra- 9 prendere quella carriera che avrebbe dovuto portarlo a diventare cattedratico, rettore e parlamentare. Per il momento Alberto Mugnai, o meglio, il professor Alberto Mugnai, docente di Telecomunicazioni era riuscito a salire solo sul primo gradino. E con molta fatica. A cinquantacinque anni, con una lotta della madonna, aveva sbraitato in lungo ed in largo talmente tanto in Facoltà, che i colleghi gli avevano bandito un concorso interno per professore di prima fascia. Era quel che si usa definire con un termine tecnico in Facoltà un rompicoglioni. Gli anni dai venti ai cinquanta non trascorsero così velocemente come avrebbe voluto, malgrado gli impegni, lo studio, le cariche ufficiali, quelle informali e quelle che lui stesso si attribuiva ma che ai più non fregavano molto. Prima di approdare a Trieste si ripulì dell’accento bolognese, si procurò una giacca nuova, una cravatta intonata scelta da lui stesso dopo averne scartate molte senza il giusto equilibrio tra grigio e grigio, una agenda di quelle coi fogli rimovibili, un cappotto che il venditore — e lui riproponeva la stessa tesi a chiunque — garantiva essere cammello ed una stilografica. Ma prima, molto prima si procurò una moglie. Neanche quella fu impresa facile dato che il Dio consumato dai sui padrenostri per ottenere continui favori, lo aveva dotato di un insaziabile attaccamento alla bellezza. Purtroppo lo stesso Dio si dimenticò di fornirgli occhi azzurri, capelli biondi e centottanta centimetri di muscoli. Così accadeva che, quando si ritrovava nelle balere, la sera, dopo lo studio, individuava le tre o quattro ragazze più carine della sala. Senza poterlo evitare, iniziava ad in- 10 filzarle con gli sguardi, tutte quante, quanto più poteva, passando da una sala all’altra, divorando spume e fumando sigarette accartocciate che si sforzava di far assomigliare a spinelli. Ne perdeva una di vista e subito ne trovava un’altra. Sperava che qualcuna lo avvistasse, per la miseria; che si avvicinasse, che si accorgesse che lui era speciale e non aveva niente a che vedere con la media della marmaglia là dentro il cui unico interesse era sbronzarsi e ballare il bughi–bughi. Invece la più gnocca se ne andava sempre a braccetto di qualche fighetto con la camicia bianca ed i pantaloni appiccicati alle chiappe. Nemmeno lo guardava. Né si prendeva la briga di ringraziare chi le aveva dedicato gli occhi per tutta la sera. Poi se ne andava la seconda più bella, poi la terza, finché non si esauriva la rosa delle accettabilmente belle. Quando i raggi perforanti delle sue pupille arrivavano al punto di vagare tra tutte le sale per più di due volte, rendendosi conto di inforcare solo labbra grosse, zigomi allargati, mascelle da maschio, corpi mediocri, allora, solo allora si precipitava verso l’uscita. Voleva ogni volta farlo prima degli altri. Per la miseria, lui non era come gli altri. In verità Alberto non era affatto un brutto ragazzo. È ragionevole pensare che lo spermatozoo che lo concepì forse fosse stato più corto degli altri, visto che solo con i tacchi arrivava ad un metro e settantuno, ma per il resto aveva un bel sorriso, occhi vivi, fronte, zigomi e guance con tutto al loro posto. Si era perfino dedicato alla palestra e d’estate poteva esibire bicipiti accentuati ed una pancia piatta. Ma quello che aveva da offrire poteva andare bene per un equivalente femminile, non certo per le perfezioni in minigonna che il suo animo si sentiva in tutto e per tutto degno di amare. In realtà non voleva sco- 11 parsele, anzi. Per quello bastava qualsiasi figliola compresa tra i cinquantacinque e sessanta chili con qualcosa di scabroso da offrire come la consapevolezza di due tette grosse, un paio di fantasie o delle calze che sua madre non avrebbe mai osato mettere. No, la bellezza che cercava disperatamente gli serviva per altro. Semplicemente era il metro di misura di se stesso. Mettiamola così. Se una ragazza intelligente, bella, sensibile, invidiata da tutti, soprattutto invidiata da tutti, si fosse innamorava di lui, ecco che si beccava un trenta e lode (dato che la ragazza valeva un trenta e lode). Se invece conquistava un viso dolce, dagli occhi grandi come quelli di una santa, con però polpacci e cosce da camminatrice cortinense, ecco invece che si assegnava un ventisette. Se poi la ragazza con cui riusciva a flirtare aveva un difetto al viso, come, non so, un labbro troppo grosso, o gli occhi che cadevano ai lati, passava a venticinque. E così via. Un venti: inaccettabile. Nemmeno lo prendeva in considerazione. Significava sicuramente una ragazza un po’ insipida, ciompotta o allungata, o col muso stirato, coi capelli appiccicati al cranio, disciplinatamente pettinati, senza la minima intenzione di evidenziare femminilità ma solo per il decoro che la madre le aveva indotto fin da bambina. No. Lui non era per un venti. A volte un ventitré poteva guadagnare punti se in possesso di requisiti inaspettati come ad esempio un paio di tette generose provenienti da geni lontani che avevano poco in comune con il resto dell’anatomia, oppure degli occhi particolarmente azzurri. Capitava anche che il suo metro di misura venisse dilatato da considerazioni puramente irrazionali; come quando una ragazza libera, senza particolari meriti, diciamo un ventiquattro, che bazzicava nei dintorni del branco di studenti a cui 12 lui apparteneva, veniva adocchiata da più coetanei, e tutti coetanei che viaggiavano su medie alte. Allora il ventiquattro poteva arrivare perfino ad un ventisette. Ovviamente le valutazioni delle prede di caccia non avevano nulla a che fare con le Telecomunicazioni, perciò Alberto non ebbe mai chiaro dove fosse il libretto dei voti dentro al suo cervello così razionale. Anzi, in realtà, venne a sapere solo molto tardi di questa sua propensione alla valutazione, quando di valutazioni non si riempiva più le serate. Sarebbe stata sua moglie a rivelarglielo; in uno di quei litigi in cui si vanno a sguainare le armi più in là nel passato, quelle più arrugginite, che fanno più male e che colpiscono indefinitamente: i difetti sono più deleteri delle colpe, e questo sua moglie lo sapeva benissimo. Erano in soggiorno. Alberto, in piedi, di fronte al caminetto che avevano appena comperato, guardando il golfo di Trieste, per un attimo prese in considerazione la fondatezza di quell’analisi, ma poi la gettò nel mare e negò tutto. Ma figuriamoci se un professore universitario del suo stampo, con tutta la responsabilità e la raccolta di cariche che gli imponevano di pranzare a tramezzini d’ufficio, aveva il tempo di occuparsi della propria adolescenza. Si voltò, si avvicinò alla moglie (silenziosa), ricacciò indietro ogni rancore per l’incomprensione che arrivava da chi gli rifaceva il letto ogni mattina, la perdonò, la baciò sulle labbra, ed andò nel suo studio ad estrarre carte da buste. La sera, poi, quando la moglie si addormentò — quindi non doveva più affrontarla — tentò di ricordare il motivo per cui avevano litigato. Non lo trovò. Però, prima di addormentarsi ebbe il tempo di rammaricarsi del fatto 13 che, nella sua vita, non era stato un punteggio abbastanza elevato per la moglie, ma questo riguardava solo il suo aspetto fisico. La testa: un’altra faccenda. Prima di sposarsi, ci vollero cinque anni per una ricerca meticolosa. Ovviamente puntò ad un trenta. Non trovò nulla. Nel frattempo ottenne il posto di ricercatore di Telecomunicazioni all’Università di Bologna. Affittò un piccolo appartamento tutto suo, vi ci mise dentro una scrivania, un letto, un paio di bilancieri, una mensola piena di libri sulle telecomunicazioni ed una, a fianco, piena di libri di storia e romanzi dell’ottocento ancora da leggere. In quei cinque anni, tra le poche feste che si concesse e le studentesse tardone di psicologia che avevano più o meno la sua stessa età, non riuscì ad andare oltre un venticinque. Così, quando rincontrò una sua vecchia amica d’infanzia che dopo lo sviluppo era arrivata ad un ventisei, non ci pensò su due volte e se la sposò. Si può dire che Claudia Anselmi apparteneva a quella metà del mondo felice che dichiara di avere avuto un’infanzia infelice. Claudia Anselmi si infilò le prime minigonne il giorno in cui smise di giocare con le chiavi inglesi ed i cacciaviti. Per sua madre fu un gran successo, proprio nel momento in cui si era già rassegnata all’idea di vedere l’insegna dell’officina di famiglia rinnovata: “Officina da Umberto & figlia”. Per il padre invece, uno dei primi comunisti bolognesi di via Schiavi, promotore del ruolo progressista della donna, fu un duro colpo, proprio nel mo- 14 mento in cui si era già abbandonato all’idea di vedere l’insegna dell’officina di famiglia rinnovata: “Officina da Claudia & padre”. Era domenica. Claudia aveva quindici anni. L’officina era chiusa come avevano imposto i vicini molti anni prima; almeno la domenica mattina si deve un po’ dormire senza il tamburellare di quel meccanico che, quando non usa il martello, sputa comizi in faccia a chiunque si avvicini alla sua serranda. — Ecco, così, una attimo di pazienza, Claudia — le disse una tipica madre bolognese fatta doppia da agnolotti e gnocchi fritti. Claudia se ne stava in piedi, sopra uno sgabello, con una gonna appena oltre il ginocchio, gonna che la madre si sorprendeva di confermare essere una minigonna. Spazientita, avrebbe voluto togliersi il cilindro di stoffa scozzese, infilarsi la tutta unta, le scarpe da maschio coi buchi e scendere in officina a sciacquare spinterogeni con la nafta. Ma la domenica non si può. Gliel’aveva detto anche suo padre. Così non le rimase altro che far contenta la madre. Per l’occasione mamma Agata aveva posticipato ogni appuntamento con i clienti e si era dedicata alla figlia, il suo unico gioiello. Come era potuto accadere che un fiore così bello attecchisse tra grasso, cilindri e pastiglie di freni, non era l’unica a chiederselo. Anche le zie in visita ripetevano sempre la stessa cosa: mio Dio, una bambina così bella, così bella, un angelo che sta sempre a giocare coi motori. Lo dicevano quando non c’era il padre perché sapevano che prima o poi lui le avrebbe prese a calci in culo. Claudia non dette mai retta alle zie. In fondo erano tutte vecchie, vestite di nero e parlavano in un modo 15 strano senza mai ridere, facendo degli “ooooo” lunghissimi e guardando dritto negli occhi, che se fossero state delle pretesse, avrebbero intuito i suoi peccati ancora prima della confessione. Claudia aveva l’impressione che anche da piccole, da bambine, quelle donne fossero state vestite di nero ed avessero emesso gli stessi sospiri in lungo ed in largo per una Bologna coi cavalli al posto delle auto. E poi erano democristiane. Questo l’aveva detto anche la mamma, senza dare importanza alla cosa. Ma papà Umberto sapeva bene cosa voleva dire anche se ogni volta che lo spiegava alla figlia, forniva sempre una definizione diversa; Claudia non voleva avere niente a che fare con quelle democristiane, perciò non le stava mai ad ascoltare. — Insomma, Claudia, stai un po’ ferma altrimenti rischi di pungerti — la esortò con tutta la dolcezza che poté. Si era allenata coi clienti. Quelli più esigenti, quelli che avevano sviluppato un gusto ed una sensibilità che li faceva sentire per poche ore divi e preziosi, quelli che volevano vestiti con stoffe uniformi, leggiadre, ma con tasche piccole, perché di soldi da metterci dentro non ne avevano. Mamma Agata era una sarta. Lavorava in una delle due stanze sopra l’officina del marito. Perciò, dato che non si poteva portare i clienti in camera, aveva allestito uno studio del tutto originale in cucina. Papà Umberto trovava tutto ciò molto progressista e non di rado capitava che al bar Sport se ne vantasse con gli amici, i quali, più informatori famigliari che comunisti, riferivano tutto alle proprie mogli che riferivano alle mogli degli altri, finché la voce ritornava in via Schiavi opportuna- 16 mente abbellita. Perciò i più erano convinti che in casa Anselmi i materassi fossero sotto il tavolo della cucina, che il bagno bisognasse farselo nel lavabo dei piatti e che per risparmiare, gli agnolotti li si mangiasse nei copri ruota delle Fiat Centoventiquattro. La realtà invece era fatta di un fornello, di quelli smaltati di bianco, con soli due fuochi, appoggiato sopra ad un cubo di legno, un tavolo per quattro, uno specchio, uno sgabello sotto al tavolo, un manichino che tutti usavano come attaccapanni ed un lavabo che avrebbe finito per bucarsi da quanto le due donne lo strofinavano prima dell’arrivo dei clienti, la mattina presto. A mamma Agata il mobile dei fornelli era costato ascolti ininterrotti dei comizi del marito mentre si lamentava dei vari governi De Gasperi, Pella e Fanfani. Ma non poté farci niente. Da quando una delle prime volte che scese in officina aveva visto il marito infilare cacciaviti e brugole nei dodici cassetti del cubo, concepì la missione di appropriarsene sottraendolo a suon di moine, carezze e suppliche. Ci impiegò due anni a convincerlo; nel frattempo preparò la carta zucchero con cui ricoprire l’interno dei cassetti e mentre di giorno lavorava in cucina, di sera, quando Umberto era al bar Sport, scendeva a misurarne gli interni e sognava, sognava. Sognava paratie per rocchetti, uncinetti, spille da balia, ditali, forbici, forbicette, metro, spilli, aghi. E poi bottoni, serie complete di bottoni che non si sarebbe mai potuta permettere di possedere, anche quei bottoni automatici di cui qualcuno parlava, ma di cui in via Schiavi era arrivata solo la descrizione al bar Sport. Prese le misure, rimetteva chiavi e macchie al loro posto e ritornava su in cucina a gongolarsi come una donna incinta mentre si accarezza la pancia. 17 Infine Umberto cedette. Quella sera se la sarebbero ricordata entrambi per il resto della loro vita. Ci fu un solo intoppo, quando, svuotati i dodici cassetti, prima di portare il cubo in cucina, Umberto esigette di far l’amore in officina, come in una vera ottica progressista dei valori, lontano da quell’alcova, che nei manuali dei giovani sposi della chiesa, stava al sesso come il tabernacolo alla particola. Naturalmente, a mamma Agata, che conosceva bene le bizzarrie del marito, non sembrò un grave peccato vendere il proprio corpo per il cubo dei desideri. Tanto più che le zie, future democristiane, non sarebbero mai venute a saperlo. Perciò, più pratica che progressista, sul primo scalino, nella penombra della saracinesca completamente abbassata, si tolse il vestito blu, quello di sempre e rimase in reggiseno e mutande avvolgenti fino all’ombelico, con le mani congiunte all’altezza del pube. Primo intoppo: Umberto, che dai comizi non era mai passato all’azione operaia, sorpreso dalla sua stessa richiesta, che la moglie non avrebbe mai dovuto assecondare, non riuscì a trovare alcun mutamento incoraggiante dentro alla tuta da lavoro. Rimase lì, fermo, inebetito, chiedendosi se doveva poggiare la bussola da tredici e lo stelo, oppure sbattersela in testa. Fu quando Agata, spazientita, vincendo la timidezza, si tolse il reggiseno, che Umberto si ricordò che un comunista è anche un uomo. Secondo intoppo: quando le si avvicinò, dopo averla baciata, abbracciata e detto che l’amava per la terza volta nella sua vita, senza contare il giorno del fidanzamento e la prima volta che fecero l’amore, guardandosi intorno si accorse che non c’era nessun metro quadro sufficientemente degno e pulito per accogliere le loro schiene. La buca era una pozza d’olio, la pedana della 18 scrivania non era mai stata scopata, che lui ricordasse. Rimaneva solo il bancone d’acciaio. Ed è lì che Umberto ed Agata si diedero all’azione, dopo aver appoggiato entrambe le mutande sul manico della morsa. Forse perché dovettero comunicare più di altre volte per rendere efficace l’accoppiamento, forse perché Dio non trovò nulla di strano nel far l’amore in officina piuttosto che nel letto, quella sera Agata, otre al cubo dai dodici cassetti, ottenne anche la sua piccola Claudia. — Ecco, ho finito — disse mamma Agata alla figlia indicando lo specchio. Questa volta Claudia non poté fare a meno di dar ragione alle zie democristiane: non solo gli occhi della madre scoppiavano dalla commozione per aver appiccicato una gonna alla propria figliola, esorcizzando definitivamente il ricordo di un concepimento tra l’olio ed i carburatori, ma anche gli occhi di Claudia, incredibile, proprio incredibile, videro qualcosa di bello che le apparteneva. Quando mamma Agata registrò il mutamento, considerandolo semplicemente una tappa inderogabile di ogni figlia, come l’abbandonare il seno, i pannolini, il menarca, volle renderlo irreversibile. Si alzò in piedi, guardò la figlia negli occhi attraverso lo specchio, spostò la pentola del minestrone che bloccava in parte la vista delle gonne, le appoggiò un palmo sulla spalla e, quando la commozione le lasciò un po’ di tregua, le prese le dita. — Claudia, ormai sei una signorina, non puoi andare in giro con le unghie sporche di grasso. — Si mamma, ma io mi lavo, è che non va via, nemmeno con la pasta dell’officina. Quando ritornarono a guardare le gonne sullo specchio, Claudia tenne le mani dietro la schiena. In segui- 19 to avrebbe trovato più pratico passare meno tempo possibile in officina, malgrado il desiderio di seguire papà Umberto, il suo modo impeccabile di rifasare i carburatori delle Alfa ed i suoi comizi non la abbandonarono mai. Così quel giorno imparò il valore del compromesso oltre al fatto di essere bella. E per iniziare subito, prima di cena, uscì di casa per andare a mostrare al papà le sue nuove false minigonne al bar Sport. Mentre percorreva la fine di via Schiavi, si domandò se quell’aria fastidiosa che le si infilava in mezzo alle gambe peggio che in una valvola a farfalla, avrebbe continuato a infastidirla per il resto della vita. Tutto sommato la storia di Claudia Anselmi è una storia normale, non altrettanto si può dire di Ludovico Cadorin. Chi meglio di un dermatologo che ha rinunciato a fare il dermatologo può conoscere il mare? Ludovico Cadorin ne fu l’esempio più riuscito. Ed è per questo che la giunta del Consiglio di Facoltà gli affidò il difficile compito che lo poneva in mezzo all’Adriatico e dintorni. Benché fosse nato in un paese del Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, dove gli abitanti fino al milleottocento non avevano mai visto le coste della Serenissima Repubblica, Ludovico familiarizzò con l’acqua a cominciare dall’infanzia. Apprese le tecniche marinaresche sulle riviste di vela e poi, molto poi, ma prima che le esigenze di una famiglia gli impedissero di rinunciare al 20 desiderio di fare il giro del mondo in barca, si comperò un tredici metri motorsailer con cui annunciare a tutti il suo voto di obbedienza al mare. In realtà, almeno all’inizio, il passaggio non fu così immediato. Da Padova, dove aveva studiato medicina, si trasferì a Trieste. Lì tentò inutilmente di prendere un posto di ricercatore. Malgrado il professore che aveva elargito promesse gli avesse assicurato che in una decina d’anni non ci sarebbero stati problemi, rinnovandogli i suoi progetti su una dermatologia impegnata a livello internazionale, lui ne rimase fuori. Aprì quindi di necessità uno studio privato di dermatologia in viale Turzi, vi ci mise dentro una segretaria, fece della segretaria sua moglie, comperò appunto la barca, divorziò dalla segretaria che già da un paio d’anni aveva rinunciato a fare la moglie e prese in sposa Aidia, il vero amore della sua vita. Ma ad un certo punto, all’età di quarantadue anni, quando i guadagni gli avevano fatto dimenticare le velleità universitarie, decise di abbandonare tutto, studio, casa e professione e vivere con Aidia in mezzo alla baia di Muggia. Si può essere più precisi sulle motivazioni. Alcuni dicono che lo fece perché Dio commise un errore a farlo nascere in mezzo ai monti invece che in un peschereccio, altri videro in quella scelta il fascino di colui che abbandona il mondo frenetico per la sicurezza quantitativa del mare. …ma la maggior parte pensa che giocoforza lo ebbe una ricetta sbagliata alla persona sbagliata. Da quando Melania Frinzi, figlia di uno dei massimi dirigenti delle Assicurazioni Generali di Trieste, si trovò con la pelle delle guance definitivamente compromessa 21 a causa di una reazione allergica ad una pomata di sua invenzione, Ludovico smise di credere nel connubio tra omeopatia e farmaci. Si guadagnò in una settimana la fama delle pagine del Piccolo, il giornale locale, e tre mesi dopo le azioni legali lo videro quasi completamente prosciugato. Fu allora che disse di sì ad Aidia, la sua barca che divenne anche casa e fonte di lavoro. Con i soldi che salvò poté assicurarsi un attracco alla darsena di Muggia. E lì si impegnò a dimenticare il mondo. Ma per dimenticare il mondo gli serviva un amico che non gli facesse sentire la nostalgia del mondo. Così ne scelse uno tutto suo: Andrea Micheli. Quando Ludovico incontrò Andrea, il sole si era già abbattuto sul golfo di Trieste per una giornata intera, allontanando anche i gatti a capacità termica più elevata. In porto vecchio, a Muggia, dove sono in pochi a portare a riparare le barche in legno, il vecchio Andrea Micheli si rivolse a Ludovico come un padre si rivolge ad un figlio inconsistente. — Tu sei quello che ha sfregiato la figlia del Frinzi, non è vero? Ludovico rimase per un po’ a pensare come questo vecchio potesse rivolgersi ad un estraneo con così tanta invadenza. Per far finta di niente ci voleva un bel paio di palle e lui, dopo aver perso lo studio, i soldi e l’onore, era convinto di averne due indistruttibili. — Mi hanno detto che qua c’è qualcuno che può aiutarmi a trovare un posto per la mia barca. — Vieni qua, avvicinati — gli rispose il vecchio senza distogliere lo sguardo dal proprio lavoro. 22 Stava infilando uno stoppino dentro ad una fessura tra trave e trave di una chiglia in legno. Con forza, con un pennello mimetizzato di nero, vi ci mise sopra della pece. Poi aspettò. A non più di un metro di distanza, Ludovico si presentò in attenti. Il vecchio Micheli lo guardò meglio dal suo sgabello treppiede ed annunciò soddisfatto: — sei proprio tu quello che ha combinato quel casino con i Frinzi. C’eri anche sui giornali. Ludovico stava per andarsene, continuando a convincersi che aveva le palle enormi e che non avrebbe mai ceduto alla tentazione di prendere a calci quel vecchio. Invece, al momento di fare dietro front, si fermò e rispose. — Sì sono proprio io. — Beh, ma mandali a cagare tutti quanti. Allora, accortosi di come la difesa del vecchio irriverente gli avesse procurato un certo sollievo mai provato nemmeno quando l’ex moglie tentò di consolarlo al telefono per più di tre quarti d’ora, decise che Andrea Micheli sarebbe diventato un albero maestro. In realtà ad attrarlo fu proprio ciò che più detestava in lui, e cioè il potere ed i modi da ufficiale di marina che Micheli esercitava senza il ben che minimo rispetto o misura sociale. Comunque il vecchio assegnò a Ludovico un posto sulla darsena come un tenente furiere assegnerebbe asciugamani ed anfibi ad una recluta. Gli spiegò dove stavano le manichette e gli orari a cui i pochi privilegiati, quelli che andavano a genio al capo della darsena, cioè lui stesso, dovevano sottostare. Ma gli fece capire anche che gli orari possedevano proprietà flessibili. Infine offrì la mano per stipulare un accordo senza aver nemmeno parlato di soldi. 23 Ludovico rispose alla stretta, stupito di non aver dovuto salutare militarmente e sbattere il tacco e, senza sapere i dettagli economici di quel contratto vidimato con la pece tra i palmi, per due volte nella stessa ora, si sentì sollevato. In seguito avrebbe compreso che queste frequenti piane dell’animo erano associate ai comandi di Micheli che prendeva decisioni ed addirittura imponeva. Quando era stato libero di scegliere, le sue scelte più risolutive gli avevano fatto perdere una moglie, una segretaria e lo studio. Quanto meglio sarebbe stato diventare allievo ufficiale di marina, avere avuto obiettivi semplici, chiari ma altrettanto duri come finire la specialità di dermatologia. Quanto meglio sarebbe stato preoccuparsi solamente di non scontentare un ammiraglio perennemente scontento per una divisa bianca che non rimane bianca. Ed eccolo qua il suo ammiraglio, a capo di una accademia composta di due soli elementi. Quella sera, prima di addormentarsi dentro all’Aidia, vittima dei suoni delle maree di Muggia, Ludovico si ricordò di avere quarantacinque anni. Visto che Ludovico passa parecchio tempo con Micheli e molto probabilmente in questo momento Micheli è in Adriatico nella stessa barca, si può sapere qualcosa in più di lui? Certo non si può dire che Micheli, da buon vivente, non avesse motivi per essere scontento. Anzi, ne aveva a non finire. A cominciare dal fatto di essere solo. Aveva 24 permesso al mare di allontanare qualsiasi affetto. E mettiamoci pure che era l’ultimo capostipite di tre generazioni di chirurghi delle barche. Il nonno del vecchio Micheli era infatti un calafà, un artigiano della barca, non colui che le fabbrica, ma colui che riesce ad individuarne la più piccola falla. Quando ne diagnosticava una, con stoppini, pece e pialla, ricomponeva la piaga senza che occhio umano potesse notare la cicatrice. Quand’era piccolo, Andrea andava a trovare il nonno dalle parti di Cittavecchia, vicino all’Arco di Riccardo, di domenica. Assieme andavano fino alla darsena; il nonno lo usava come bilanciere sorreggendolo con la mano destra mentre la borsa degli attrezzi stava sulla sinistra. E lì il piccolo Andrea rimaneva ad ammirarlo. Più tardi arrivava anche suo papà, anche lui un calafà, altrettanto bravo, ma meno importante del nonno. In seguito, il vecchio Micheli si sarebbe sorpreso parecchie volte la sera, d’estate, a filmarsi quei momenti senza versione ridotta. Il fatto era che allora il nonno era stimato da tutti; sua madre diceva che era ricco, che era il calafà più famoso di Trieste e che la gente, se voleva una barca senza acqua sottocoperta doveva rivolgersi a lui. Quando, contro ogni principio naturale, qualcuno decise che le barche dovevano essere prodotte in ferro, i calafà di Trieste si accorsero di non avere pialla e pece adatte e molti di loro riuscirono a sopravvivere solo centellinando le ricchezze acquisite nei tempi indietro. Alla fine ne rimase uno solo, Andrea Micheli, custode di una barca e medico di quei pochi esemplari in noce o mogano che hanno più o meno la sua stessa età. 25
Scarica