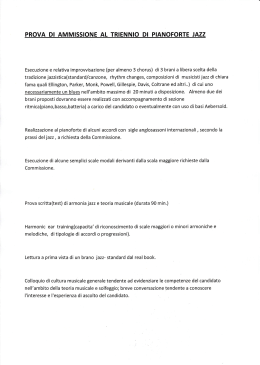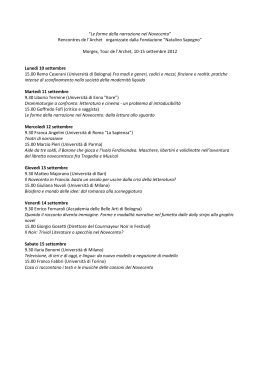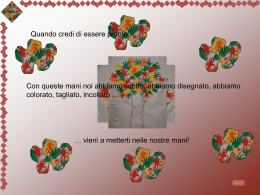— speciale novecento / parte prima Suoni (parole e segni) del Novecento verso exempla – nomi, luoghi, movimenti, poetiche – abbiamo dunque provato a tracciare una mappa ideale del Novecento (ma sarebbe più appropriato dire «dei tanti Novecento», considerata l’infinita stratificazione di questo secolo travagliato), senza avere naturalmente alcuna pretesa di individuare tutti i suoi snodi cruciali. Così, figure coHE COS’È IL contemporaneo? è il titolo di un recente lime Debussy e Stravinskij lasciano spazio alla Vienna della bricino di Giorgio Agamben (Nottetempo, 2007), Secessione, le strutture compositive di Schoenberg, Berg all’interno del quale il filosofo romano fornisce una e Webern si intrecciano con la nascita del jazz e il fortuserie di definizioni di questa parola, tanto utilizzata ai giornato genere della musica da film. Senza mai voler (né poni nostri da correre il rischio di finiter) divenire un compendio di storia re inflazionata. Il più delle volte indella musica novecentesca – ne esifatti si fa ricorso al concetto di «constono già molti e autorevoli, che gotemporaneo» per indicare qualcosa dono di uno spazio estremamente di essenzialmente connesso al presente maggiore di quello della nostra riviin cui chi parla è immerso. Ma questa – abbiamo quindi cercato di costa nozione, a ben guardare, sfugstruire – dove è stato possibile – un ge dalle classificazioni e dalle cateponte tra il mondo delle note e le algorie comuni (basti pensare alla più tre espressioni della creatività umabanale delle obiezioni, secondo la na, con il duplice obiettivo di mettequale ciò che è presente in un dare in luce collegamenti magari non to momento il momento successitroppo noti e di stendere un’ideavo appartiene già al passato). Ecco le linea retta in cui fenomeni culche allora Agamben va oltre, e deturali e artistici diversissimi stessefinisce la «contemporaneità» come ro in rapporto di scambio e conseuna «singolare relazione col proprio quenzialità. Ed ecco dunque Giacotempo, che aderisce a esso e, insiemo Puccini e Benjamin Britten rapJuan Gris, Omaggio a Picasso, 1912. me, ne prende le distanze. Più precipresentare tappe fondamentali delsamente, essa è quella relazione col l’evolversi musicale novecentesco speciale C tempo che aderisce a esso attraverso una insieme a Karlheinz Stockhausen e Luisfasatura e un anacronismo». gi Nono, per pescare soltanto quattro Le difficoltà connaturate all’utinomi a caso. lizzo di questo termine cruciaLa mole dei materiali che si sole (e al concetto cui direttamenno accumulati – grazie alla gete si riferisce) si incontrano ovnerosità degli studiosi e critici viamente anche quando lo si che hanno gentilmente accetvoglia applicare a una disciplitato di partecipare – ci ha in na artistica specifica. Ad esemseguito costretti a suddividere pio, che cosa significa (cosa inin due tappe questa «ricogniclude e cosa esclude) il sintagma zione», stabilendo come sem«musica contemporanea»? Quali plificatoria linea di demarcazioGe sono gli elementi che la contraddine (anche se alcuni interventi non 2. 1 o r ge 19 , o stinguono, al di là di generalizzaziorispetteranno del tutto questa ripartis B ra q u e , U o m o c o n v i ol i n ni un po’ superficiali, che inducono il sozione) la seconda guerra mondiale, natuspetto nel non addetto ai lavori? rale spartiacque tra le due metà del secolo. Questi interrogativi sono stati alla base della riflessione Quello che proponiamo ai nostri lettori è quindi uno a più voci che occupa le pagine seguenti. Grazie infatti alsguardo sul Novecento volutamente né sistematico né l’incontro con Mario Messinis – alla cui generosa disponianalitico, ma fondato su suggestioni, accostamenti nobilità ancora una volta abbiamo attinto – e ai suoi preziosi ti e inediti, compresenze e linee di tendenza conflittuali. suggerimenti, ci è stato subito chiaro che l’unica possibilità Uno sguardo che fotografa parzialmente e secondo l’andi uscire dalle dispute terminologiche sarebbe stata quelgolatura personale di ciascuno degli interventi un segla di affrontare la questione con un approccio di tipo stomento della nostra storia più recente, sperando di fornirico-critico: soltanto mettendo insieme le re qualche chiave di lettura – e perché no principali esperienze che hanno contribuidi ulteriore dibattito – per avvicinarsi into a determinare la musica del nostro temfine con minor timore agli artisti che opeQuesta sezione po – intesa anche come metonimia dell’arrano e vivono qui e oggi, testimonianè dedicata te in generale – avremmo potuto trovare do e raccontando con il loro lavoro quea Carlo De Pirro delle griglie interpretative efficaci. Attrasto nostro incerto e difficile tempo. (l.m.) ◼ speciale — novecento / parte prima Debussy e la Nuova Musica n di Emilio Sala eLL’oDierna TenDenZa a rimescolare le carte, a ri- speciale mettere in discussione valori e posizioni, un punto abbastanza fermo nella storia del modernismo musicale novecentesco sembra essere il ruolo fondamentale svolto in esso da Debussy. Contro l’idea di una musica debussyana improntata al mero colorismo impressionista e al flou, si opposero negli anni sessanta compositori e critici quali Boulez, Jarocinski e Bortolotto (tra gli altri). Il superamento del tematismo e della temporalità vettoriale o direzionata (se non della temporalità tout court), l’emancipazione del timbro e la ricerca di una forma aperta (derivata dall’elaborazione stessa del materiale), se non addirittura il pensiero seriale, furono negli anni sessanta sentiti e collocati spesso sotto il segno di Debussy. Fu Boulez a promuovere per primo a Darmstadt il parallelo tra Debussy e Webern, e in questa prospettiva un culto particolare venne riservato a uno degli ultimi capolavori debussyani: Jeux (1913). Il carattere «seriale» di Jeux sta nella parità di diritti con cui timbro, ornamento, metro, dinamica ecc. concorrono alla creazione della forma. Lo stretto rapporto tra «formanti» e forma, su cui insisterà molto Boulez nella sua concezione della forma aperta, deriva in gran parte dal- esame, si ha il diritto di riconoscere i primi segni premonitori del “post-webernismo”. Con cos’altro abbiamo a che fare se non con delle “fasce sonore” di cui oggi [1966] tanto si parla?». In Italia è stato Mario Bortolotto il primo a promuovere l’immagine «seriale» di Debussy. Il suo saggio Fase seconda. Studi sulla Nuova musica (1969) parte infatti dalla svolta debussyana e dalla sua eredità presso i compositori della neue Musik. Polemizzando con la visione riduttiva della musica debussyana espressa, in un’ottica tutta aust ro-tedesca, da Adorno («la forma Claude Debussy [di Debussy] è imprecisa, l’ultimo Debussy: L a mer, Martyre de Saint Sébastien, Jeux ecc. Stefan Jarocinski, nel suo i mpor t a nte studio Debussy: impressionnisme et symbolisme (trad. fr. 1970; ed. orig. – in polacco – 1966) affronta la musica «sonoriale» debussyana nei termini della «mise en place sonore», sottolineando come essa si costituisca a mo’ di complesso autonomo e pluristratificato in cui non c’è più differenza tra figura e sfondo, tra orizzontale e verticale: la stessa idea di polifonia perde di senso in una concezione sonoriale come quella di Debussy. E qui vale la pena di citare Jarocinski alla lettera: «Nei procedimenti debussyani che abbiamo preso in […] il colorismo è eccessivo e sovrapposto ai complessi armonici»), Bortolotto invita a prendere in considerazione soprattutto la temporalità debussyana. La sua utopia di riassorbire il tempo nello spazio, il suo tentativo di immobilizzarlo (il tempo). Lascerei senz’altro a lui (a Bortolotto) l’ultima parola: «I giardini di Debussy non conoscono le potature di Versailles, sono invece piccole giungle, amabili o incantatorie, e per di più sconvolte o arruffate dalla pioggia. Boulez pone l’accento sul dato essenziale: la nozione di istante,, che Stravinskij bloccherà anche più. E già la semplice indicazione è carica di una filosofia precisa: l’universo di Debussy è, nell’istante, sospeso all’eterno». ◼ — speciale novecento / parte prima «Ravel e l’anima delle cose» di Enzo Restagno Q UeSTo TeSTo È l’Introduzione al volume di Enzo Resta- gno Ravel e l’anima delle cose, che verrà pubblicato nel 2009 per i tipi del Saggiatore. speciale L’esprit sert à tout et ne suffit à rien Questa frase è così bella e profonda che vorrei lasciarla nella lingua originale senza appesantirla con una traduzione che per assolvere il suo compito dovrebbe contenere spiegazioni molto circostanziate. Riflettere sul significato di parole così garbatamente inesorabili è d’altronde quello che mi propongo di fare in questa introduzione, ma procediamo con ordine. Satie, caustico fino alla crudeltà nei confronti di Ravel, lo definì un précieux degouté e commentò il rifiuto che il collega aveva opposto all’assegnazione della «Légion d’honneur» con un sarcasmo destinato a passare alla storia: «Ravel rifiuta la Légion d’honneur ma tutta la sua musica l’accetta». La battuta è così efficace che non si può fare a meno di ammirare colui che è stato capace di coniarla. Ammirazione, forse anche un po’ di invidia per coloro che sanno formulare battute così acuminate da conficcarsi come spilli nel tessuto della storia: questo sì che è il trionfo dell’esprit! Probabilmente senza avvedersene, Ravel doveva aver fatto parecchio per attirare le trafitture di Satie; le sue partiture realizzate osservazione dei personaggi che le formularono, dovrebbero destare qualche sospetto sul potere fuorviante che si nasconde nell’amore per una battuta agile e scattante come un triplo salto mortale concluso col sorriso sulle labbra in mezzo a un’umanità goffa e incespicante. Rinchiudere un’epoca o la personalità di un artista in una battuta di spirito è un’impresa intellettualmente eccitante poiché ci fa vivere per un istante l’illusione di sconfiggere la finitezza e la precarietà di ogni definizione, anche delle più meditate. Ecco dunque che una breve frase sussurrata con nonchalance sembra innalzarci sopra ai nostri limiti dianoetici. Una battuta cerca infatti di cogliere con elegante concisione un’entità difficilmente afferrabile nella sua interezza, ma torniamo a Ravel che è un personaggio nel quale l’esprit convive con altre qualità meno appariscenti ma indubbiamente più complesse e profonde. La sua musica, non si può negarlo, è una delle massime espressioni di eleganza che si conoscano nell’arte dei suoni e quanto agli atteggiamenti dell’uomo non possono esserci dubbi: erano ispirati a quella cultura che induceva Mallarmé a dichiarare che «esibiva con perfetto dandismo la sua incompetenza su qualsiasi argomento tranne che sull’Assoluto». «Esprit» e «Humor» erano parole chiave di quella concezione del mondo, codificata nel 1845 da Barbey D’Aurevilly nel suo Du Dandysme et de George Brummel, e Ravel le seppe praticare in maniera così personale e disinvolta che vale la pena di riferire qualche esempio. Il 9 maggio 1911 il pianista Louis Aubert suona alla salle Gaveau le «Valses nobles et sentimentales»: è un concerto organizzato dalla «Société Musicale Indépendante» che ha deciso di presentare quelle nuove composizioni pianistiche senza rendere noti i nomi degli autori. Durante l’esecuzione delle «Valses» il pubblico fischia con un nitore e una perfezione che non ammettevano replia più non posso, specialmente il vicino di Ravel, che spiritosamenche sembravano fatte apposta per suscitare l’invidia te estrae di tasca una chiave e la porge all’uomo della poltrona acdi un musicista sulla cui professionalità era lecicanto dopo avergli mostrato come, soffiandoci dentro adeguatato nutrire qualche dubbio. La sua «allure» così mente, se ne possa estrarre un fischio terrificante. Sulla partitura spontaneamente elegante, la gentilezza senza di quelle «valses» così geniali da apparire a tutta prima sconcertanpari e l’inti, perfino irritanti, si può legtelligengere una frase che è un coml tema di questa monografia è quello dell’esprit, categoria spirituale-intelza che ripendio del più puro dandilettuale che ha un ruolo preciso soprattutto nella tradizione francese dei luceva in smo: «Le plaisir délicieux et grandi letterati e poeti. Si tratta di un involucro esteriore elegante e pieno di humor, che veste anche Ravel. Tuttavia, la vita di Ravel e il suo operare affonogni getoujours nouveau d’une ocdano le radici in aspetti ben più solidi, fondati sulla pazienza e sul lavoro assiduo. sto facevacupation inutile». Il motto, di Ho impiegato molti anni per la realizzazione di questo lavoro, un libro nel quale no di lui un Henri de Régnier e non di Ral’aspetto musicale, analitico, prevale sulla componente meramente biografica, alla dandy che vel, sta certamente in relazioquale tuttavia sono dedicate ricerche minuziose. Il volume inizia, cinematograficamente, con un flashback che rievoca l’incidente d’auto che travolse Ravel nel 1932. poteva anne con l’episodio della chiave La vicenda viene descritta in modo puntuale, così come il rapido e tragico evolverche parere un ma, rispetto alla musica che si degli eventi fino alla morte, il tutto nel giro di poche pagine. E da qui si comincia précieux degouté degouté: introduce, svolge una funzioa ripercorrere la sua carriera di compositore. «impassibile e ne di antifrasi. Sappiamo dalMolto spazio è riservato agli ambienti, alla vita mondana della Parigi della belle epoque, ma anche alla relazione che intercorre tra la musica e le altre arti, la pittura crudele», secondo le testimonianze di tutti gli ine la letteratura che influenzarono il compositore. Per quanto concerne il titolo, rila definizione di una terpreti che studiarono le «Valvebera la passione che Ravel aveva per gli oggetti, per la loro ombra metafisica. Gli maîtresse à penser coses» sotto la guida dell’autore automi, le marionette lo affascinavano enormemente nella loro perfezione atarasme Madame de Saint-Marche quell’esperienza si risolse, sica, nel loro non esser toccati dalle passioni. A forza di essere usati dall’uomo, eccoli però umanizzarsi, acquistare un’anima. Proprio questo è il tema della sua opeceaux, oppure «nero, elea causa dell’estrema difficolra più celebre, L’Enfant e les Sortileges su libretto di Colette. Mi soffermo infine sulla gante e ricco», come piactà, in una vera e propria tortucosiddetta “inattualità” di Ravel nello scenario della modernità. Negli anni venti que descriverlo a Jules Rera. Lo humor dell’episodio delil musicista vive un periodo molto critico: a Parigi spira un vento di modernità tranard nel suo «Journal». la chiave e l’esprit, implicito nelvolgente, che lo investe in forma aggressiva. Ravel reagisce con tranquillità e grande fedeltà a se stesso, alle sue capacità di compositore e alla sua idea di bellezza. È Queste definizioni l’uso della frase di Henri de così possibile fare un bilancio e vedere che, contro la modernità intesa come impecosì poco perspiRégnier, evidenziano una ferrativo categorico, grazie a questa sua coerenza Ravel è rimasto nella storia come il caci, malgrado la tile contraddizione. grandissimo compositore che tutti conosciamo». fine capacità di Enzo Restagno Prendiamo un altro esem- «I Maurice Ravel speciale — novecento / parte prima ti che arricchiscano l’immagine del compositore ma difficilmente li troveremo nei documenti biografici. Bisogna andarli a cercare nelle opere ed ancor più nella lunga pratica artigianale dalla quale esse sono scaturite; dovremo cercarli in un modo di pensare la musica che è frutto di una longue patience. Seguendo questa strada si scopre via via un’immagine di Ravel che non cancella quella precedente ma la rende infinitamente più problematica e più ricca. Proviamo a segnalare qualche indizio che ci consenta di addentrarci in questa prospettiva: al termine di una laboriosissima estate Ravel scrisse a un amico che aveva praticamente finito di comporre il suo Trio; gli restavano da scrivere solo i temi! Noi sappiamo che i temi del Trio sono bellissimi e facciamo fatica ad accettare che siano stati calati all’ultimo momento in una struttura architettonica al cui allestimento il compositore aveva dedicato quasi per intero le sue fatiche. La struggente bellezza del tema iniziale del Trio non nasce da un istante di illuminazione ma è frutto di una lunga meditazione che trova il suo coronamento proprio in quell’exploit. Poco prima di affrontare il Trio, Ravel aveva messo in musica i Trois poèmes de Mallarmé e nella prima lirica di questo mirabile trittico compare l’immagine di «un candido getto d’acqua che sospira verso l’azzurro». Sale e ricade, il getto d’acqua, e nel suo moto ascensionale non raggiungerà mai stabilmente l’azzurro del cielo verso il quale continua tuttavia a indirizzare «fedelmente» i suoi sforzi. In questa inestinguibile fedeltà verso una meta irraggiungibile Mallarmé e Ravel individuano la teleologia interna del getto d’acqua; per dimostrare però come quella tensione finisca col confondersi con l’oggetto del desiderio, Ravel inventa una scrittura musicale fatta di soli suoni armonici in cui l’acqua, l’aria e il colore del cielo fluiscono insieme, fusi in un’unica eterea e trasparen- mento omonimo di Liszt al punto da sfiorare la citazione ma per cogliere la differenza fra le due opere senza avventurarsi in analisi musicali basta confrontare i motti che accompagnano le due partiture. In quella del musicista romantico la citazione è prelevata dai Vangeli – «Sed acquam quam ego dabo ei, fiet in eo fons acquae salientis in vitam aeternam» – nel caso di Ravel ci imbattiamo in un verso di Henri de Régnier che suona come un auspicio di sorridente leggerenza: «Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille». Eleganza quanto mai ricercata – provate a leggere la descrizione del guardaroba del musicista effettuata, sia pure con qualche eccesso, da Jean Echenoz nel suo Ravel1 – un epistolario redatto, perfino graficamente, con rara finezza e un profluvio di aneddoti certificanti una gentilezza che nasceva dal profondo dell’animo: da qualsiasi angolatura lo si osservi, il personaggio è sempre impeccabile ma questo trionfo ininterrotto del «bon ton» ha finito col sovrapporsi alla sua musica come uno stereotipo. Ravel era veramente quel cultore un po’ freddo della perfezione che i sarcasmi di Satie, l’antipatia di Milhaud, l’infastidita riluttanza di Debussy e l’ambiguità dei giudizi di Diaghilev, Stravinsky e Cocteau lasciano intendere? Non basta contrapporre a questi giudizi quelli di Roland-Manuel, di Hélène Jourdan-Morhange, di Colette, di Lèon-Paul Fargue, di Manuel De Falla, di Alban Berg, di Honegger, di Poulenc e di tutti coloro che lo ammirarono e gli vollero bene, poiché la musica resta in gran parte estranea a questo conflitto di opinioni e di sentimenti. Dopo aver preso atto di tutte quelle testimonianze bisognerebbe andare in cerca di altri elemen- tissima sostanza. Su questo trascendere, grazie alla studiatissima perfezione dell’invenzione musicale e delle leggi del movimento, esiste una testimonianza in cui è il compositore stesso a svelarci il segreto. In una intervista rilasciata nel 1931, Ravel affermò che «tutto il piacere dell’esistenza consiste nell’incalzare la perfezione sempre un po’ più da vicino e nel rendere un po’ meglio il fremito segreto delle vita». La forma in cui è redatta questa dichiarazione – perfino i vocaboli impiegati – rammentano, questa volta di lontano, il culto de l’esprit che in gioventù induceva Ravel a valersi delle epigrafi di Henri de Régnier, ma la sostanza di questo detto memorabile affronta un teorema di enorme portata. Ravel usa il termine «piacere» in ossequio alla sua tradizione dandistica, ma non v’è dubbio che si tratta del «significato dell’esistenza» e quell’interminabile ricerca della perfezione, rivolta a un oggetto alto come «il fremito della vita», travalica la dimensione estetica per entrare in quella etica. Che «lo spirito serva a tutto ma non basti a nulla» significa che per dare un senso all’ammiratissimo esprit occorre sottoporlo aunacontinuaefedeleapplicazione.◼ speciale pio: questa volta si tratta di una breve lirica per voce e pianoforte composta nel 1924 e intitolata «Ronsard à son âme». Gran parte dell’accompagnamento pianistico consiste in una sequela di quinte «vuote». Commentando la frugalità della sua scrittura, Ravel si limitò a dire che quelle poche note le aveva disposte su un solo pentagramma giusto per tenersi libera una mano con la quale fumare una sigaretta! Ecco il précieux degouté intento a dissimulare con un tocco di understatement il suo sommesso eppur efficacissimo colpo di genio! Attraverso la lesione del profilo ritmico del valzer viene messa in crisi la gioiosa Weltanschaung di un’intera epoca storica, mentre da quelle quinte «vuote», allineate da una mano sola, sprigiona una solennità che guarda oltre l’estremo confine della vita. In queste musiche l’esprit sorride come un riflesso che illumini la superficie dell’opera per allontanare ogni sospetto di fatica e tuttavia non vorrei che questo elogio della leggerezza e della semplicità venisse equivocato; i profili nitidi e lievi della musica di Ravel nascono da quell’esigenza esistenziale alla quale Nietzsche aveva dato nella sua Quarta Considerazione inattuale una formulazione indimenticabile: «Ma proprio in ciò sta la grandezza e indispensabilità dell’arte, che essa suscita l’apparenza di un mondo più semplice, di una soluzione più breve degli enigmi della vita… Quanto più la conoscenza delle leggi della vita si fa difficile, tanto più ardentemente desideriamo l’apparenza di quella semplificazione, anche se solo per un attimo». Ancora un esempio della vocazione a trasformare il sublime in sottile ironia: nel 1901 un ventiseienne Ravel, che fino a quel punto ha collezionato bocciature al «Prix de Rome» e forgiato qualche minuscolo gioiello apprezzato nella cerchia dei salotti più esclusivi, compone i suoi pianistici Jeux d’eau. Era memore del componi- 1 Jean Echenoz, Ravel, Les éditions de minuit, Paris 2006. — speciale novecento / parte prima Il Carrozzone di «Parade» a Roma Q di Marco Vallora UeLLo CHe SConVoLGe, ma non sorprende, è che in speciale fondo, all’epoca di Parade, erano poco più che ventenni. Massine ne aveva giusto venti. Cocteau un poco di più. Picasso stava scantonando verso i trenta e quello che pareva a loro un vecchione bizzoso e bizzarro, con il pince-nez a lacrima piangente e barba fluviale da satiro di Pratolino, nemmeno cinquanta. Erik Satie, Monsieur Piège de Meduse, trappola per meduse: ed era un vero incantatore, che s’era rimesso a studiare il contrappunto da zero, per scrivere quei capolavori «bianchi» che sono il Socrate e Mercure. Ma qui siamo ancora nel periodo di Parade, 1917. Nel suo Coq et l’Arlequin, geniale testo di riflessione sul Rappel à l’ordre (ma non come «rientro» di capitolazione nelle convenzioni accademiche, anzi, come «riorganizzazione dell’anarchia») Cocteau segnalerà Satie come il vero Virgilio, per addentrarsi nella musica del futuro. Molto meglio di Debussy e Stravinsky, che lui considera sì «delle stupende piovre», ma che impantanano troppo i passi nell’umida foresta delle brume wagneriane. Lui ha bisogno d’una netta pulizia monacale, quella che gli offre Satie: «che addita una strada bianca su cui ciascuno può imprimere liberamente le proprie orme». «Voglio che mi costruiscano una musica da abi- s’è rivolto a questo giovinotto intraprendente ed un poco emmerdeur – tutti lo trattano così – per smacchiare le scene. E gli ha sparato: «Sbalordiscimi». Cocteau era già pronto a sfidarlo. Pensa ad un balletto moderno, «sbaragliante», cubista, ove vagano saltimbanchi accidiosi e aggallano ritmi da music-hall. Appunto, non resta che «scritturare» i suoi due miti del momento (i compositori del Gruppo del Sei, cui dedicherà il Coq, non sono ancora all’orizzonte) ovvero il mercurio del cubismo, Picasso e il mago della musica d’»ammobigliamento», Satie. Il miracolo è a portata di palcoscenico. Trama, l’impavido Jean «l’uccellatore», quasi fosse lui il vero impresario, all’insaputa dell’inconsapevole Diaghilev, che non amando traversare l’Oceano vede partire un contingente dei suoi Ballets Russes per l’America (sono anni difficili, di guerra) e una parte viene con lui a Roma: quasi una trasferta «drole de guerre», per imbandire al Teatro Costanzi una serata d’avanguardia. Con i Feu d’Artifice di Strawinski-Balla e un progetto di balletto, su musiche di Ljadov e fiabe russe, con la coppia cubo-futurista di scenografi Larionov-Gontcharova (dunque ha già deciso di far «pulizia» nel suo guardaroba. Con i petardi imprevedibili delle Avanguardie). Anni dopo, sempre più dispeptico, il vecchio Satie, che non si può definire proprio attendibile (quando morì, sul suo camino, trovarono infiocchettate tutte le lettere ricevute in vita, un’esistenza piuttosto sociale, non da eremita, ma completamente sigillate, mai lette, con lui che continuava a corrispondere e dialogare, rabdomantico) ebbene confesserà che non ne poteva più di quel ragazzino intrigante, che voleva imporgli miriadi d’interventi «futuristi- tare come una casa! Si esige pane musicale, dopo esagerato Wagner». Non «amache dorate» o «gondole» offenbachiane. Parade, appunto, come ritorno ad un realismo essenziale. Il giovanissimo dandy, che posa a Rimbaud, gira i salotti recitando il suo rivoluzionario e jazzato Potomak («non addolorarti se muto di strada / e non amo più le cose che amavo», scrive alla madre adorata-cherie, in dediche ed epistolari quasi quotidiani, utilissimi per ricostruire il suo burrascoso diario di bordo. «Perché la grande voce che ascolto/ non erra mai»). La sua persistente poetica del non essere altro che un’umile, elegante valvola rice-trasmittente d’una Voce superiore d’ispirazione. Che non sappiamo da dove proviene, ma sappiamo esser la Poesia. Caparbio, egli ha fatto di tutto per incrociare Picasso e Satie, che intuisce essere i fari, anche alla moda nascente, del Futuro. Picasso, che gl’incute un po’ di soggezione, gliel’ha presentato il musicista bruitista Edgar Varèse, pronto a salpare per le Americhe. Satie, che è per lui un vecchio nonno burbero, gliel’ha fatto incontrare Valentine Gross, costumista in attesa di diventare signora Jean Hugo, il figlio del grande Victor e delizioso pittore colto-naif. Satie sta eseguendo con il virtuoso raveliano Ricardo Vines i Trois morceau en forme de poir. Colpo di fulmine, reciproco, almeno ad ascoltare Cocteau: «una strana telepatia ci ispirò istantaneamente il desiderio di collaborare». Il nevrastenico Diaghilev, l’Orco, come lo chiamano confidenzialmente, appena tradito dal «suo» Nijinskij ed anche da Fokine, probabilmente non meno stanco dei falsi deliqui fioriti, satrapeggianti e molto Mondo dell’Arte dei Bakst e Benois, satollo ed esausto di perfide Cleopatre, Semiramidi e Sultani, ci», a lui, l’essenziale, alieni: voci deformate d’altoparlanti e dettati assolutamente asemantici, insensati, pre-dada. Alla fine per logoramento accetterà solo l’eco di sirene portuali e ticchettii di macchine per scrivere. Ma non può evitare di bisbeticare: «Cocteau continua coi suoi ‘trucchi’ indisponenti. Ci ‘scoccia’, Picasso e me, tanto che sono veramente stufo. Per me tutto va bene. Ma perché allora Erik Satie visto da Pablo Picasso novecento / parte prima non ha fatto lui le scene e i costumi e non ha scritto anche la musica di questo povero balletto?». Questo, quando Parade sta per andare in scena, al Théâtre du Chatelet a Parigi, mecenate Coco Chanel. Ma alle sorgenti del progetto, il bisbetico d’Arcuil sembra molto meno ostile e prevenuto (anche se che i troppi musei lo metton di cattivo umore: cavalcata frenetica alle Gallerie del Vaticano, paradossalmente snobbando manieristi ed il disprezzato Tintoretto, per incantarsi di fronte all’apollineo Raffaello. Michelangelo per carità, pare ad entrambi un «futurista erotomane»: «un montparnassien finito male». Non si sa nemmeno se si sian affacciati nella Sistina, che più tardi Picasso definirà una sorta di «chilometrica affiche alla Daumier». Sorprende tutti, perché incomincia a decantare Corot, ed anche lui si mette a dipingere Villa Medici, in tutti gli stili, come uno scatolone vuoto (anche il Vaticano gli pare un orrendo «padiglione di posta da esposizione americana») oppure in variopinto contrasto cromatico, pointilliste. Poi scopre tra le ballerine la russa Olga e le impedisce di salpare, sposandola. Al magnifico sipario dipinto di Parade, collaborano anche Carlo Socrate, che Longhi definiva maliziosamente «il Valloton dello spadinismo» e Fortunato Depero, mago dell’ingrandimento da palcoscenico che, siderato da Picasso, dimentica d’occuparsi del suo balletto per Diaghilev, Le Chant du Rossignol (che non andrà mai in scena) su musiche di Strawinsky. Che gira pure lui per quelle contrade e non la smetspeciale Parade speciale — 5 preferisce, ripete, i suggerimenti «geniali» di Picasso). «Ricevuto manoscritto. Assolutamente sensazionale. Devo riordinare le idee. Mi scriverà vero, Jean? C’è un lavoro da cani». Cocteau ha gettato giù una labile traccia, ma davvero rivoluzionaria: è in gioco la parata d’un circo di saltimanchi scalcagnati, con un prestigiatore cinese (Massine entusiasta accoglie pure l’idea di deglutire in scena un uovo sodo) un cavallo finto, che caracolla sghembo, con due ballerini sotto la gualdrappa e i managers americani sguaiati, uominisandwich con megafono ed addosso dei finti grattacieli di cartapesta: ondeggianti tele cubiste in balletto. Arrivano tutti in trasferta, a Roma, febbrili. La prima cartolina a mammà è «dal tunnel sotto il Quirinale». Come se fossero sgusciati fuori di qui, per miracolo, appena lasciata la Gare du Lyon, dopo una notte bianca, causa «guasto sleeping car». Gertrude Stein li ha accompagnati, tra le proteste dei cubisti più austeri, che vedono nel viaggio-cedimento a Diaghilev una sorta di corruzione. Roma, guardata con un po’ di diffidenza anti-classica: il Foro pare presto un cassetto sventrato d’antichità, in cui ci si mette di soppiatto pure la Chiesa Cattolica, come un gattone rognoso, molto meglio la Napoli ‘pompeiana’ ove la «morte è al lavoro», ma all’inizio no, par proprio un Eden intoccato: «Abitiamo il Paradiso Terrestre», assicura alla madre. «Hotel in un giardino in pendenza che domina Roma, si raccolgono le arance dalla finestra e il sole scalda i mobili di satin blu cielo». Picasso, che pure è l’unico che si fa capire, col suo spagnolo, non ha voglia d’uscire, reclina gli inviti eleganti nelle case aristocratiche (si fa viva pure la pittoricissima «pitonessa» Marchesa Casati). An- te di dar consigli e scappa con loro a Napoli, a farsi catturare dal gusto pergolesiano dei Pulcinella: è davvero la fucina viva del Rappel à l’ordre. (Il solito Longhi, per esempio, in un testo rimasto curiosamente inedito, si stupisce di veder planare sul sipario due «ciociari», che gli paiono piovere direttamente da Hubert Robert. Ed anche lo spagnolissimo Eugenio d’Ors è convinto che a quell’epoca Picasso sia più un pittore italiano, pompeiano, che non franco-spagnolo). In mezzo a tutto questo bailamme chic, non poteva mancare anche Apollinaire, il poeta d’origine italiana, che tenta vanamente di sanare i contrasti tra futuristi e cubisti, convinti d’esser stati depredati dagli italiani, che anche Cocteau tratta con sufficienza: «futuristi molto piccola provincia. Dipingono male e gesticolano troppo». Solo Ricciotto Canudo, il profeta della Settima Arte, il cinema, il «barisien fort parisien», perché barese d’origine, dispensa consigli sui casini. E Apollinaire scrive il programma di sala, assai lungimirante, in cui si parla di Esprit Nouveau, ma soprattutto si schiude la cova d’una parola gravida di molto futuro: «surrealismo». «Punto di partenza d’uno spirito nuovo, che si promette di cambiare a fondo le arti e i costumi nell’allegria universale», come ascoltando tra le quinte i suggerimenti d’un profeta quale Nietzsche, così caro a Cocteau. «Con una verità così lirica, così umana, così gaia, che sarà capace di illuminare lo spaventoso sole nero della Melancholia di Duerer e che Cocteau definisce un balletto realista». Curiosa, felice idea di realtà sovversiva. «Magia surreale della quotidianità». ◼ 6 — speciale novecento / parte prima Puccini e il Novecento di Massimo Contiero D aPPrima era ToCCaTa a Verdi l’accusa di conservato- speciale rismo. Era quasi certamente lui il bersaglio dell’Ode saffica di Boito: Alla salute dell’Arte Italiana / Perché la scappi fuora un momentino / Dalla cerchia del vecchio e del cretino / Giovane e sana. La risposta di Verdi si ebbe con Falstaff, opera rivoluzionaria scritta ad ottant’anni, nel 1893, per di più su libretto di un Boito ravveduto. Poi toccò a Puccini. Nel 1912, si leggeva nel pamphlet del musicologo Fausto Torrefranca, Puccini e l’opera internazionale: «Nel Puccini la ricerca veramente personale del nuovo è assente: egli applica, non ritrova, lavora cautamente sul già fatto, assimila da francesi e da russi, da tedeschi e da italiani suoi contemporanei.» Gli studi di Carner, D’Amico e Girardi hanno fatto giustizia di queste critiche. Torrefranca era il mentore di quella generazione dell’ 80, cui appartenevano Malipiero, Casella, Respighi, Pizzetti, che si proponeva, con nobile intento, di combattere l’egemonia totalizzante del melodramma nel nostro Paese, ricercando le radici del comporre nella tradizione strumentale settecentesca, adottando una linea di canto che risaliva ai modelli di Monteverdi, del Rinascimento, se non addirittura del gregoriano. Furono questi i musicisti che scrissero la storia della musica del novecento in Italia. Puc- quasi abdicato ad una produzione di musica strumentale, è nei fatti. L’ultima grande fiammata fu Paganini. Un pianista virtuoso sì, ma colto come Liszt, riferisce di una situazione di arretratezza umiliante: in un suo recital alla Scala (!), per attirare l’attenzione si ridusse ad improvvisare su temi che il pubblico metteva in un’urna e gli toccò perfino descrivere il Duomo, la strada ferrata e se sia meglio essere scapoli o sposati… Il pianoforte, che giganteggia per tutto l’Ottocento, non ispira un capolavoro italiano. Forse per riparare, Giordano lo metterà in scena in Fedora, Puccini ne La Rondine ed uno straordinario epigono, Nino Rota, ne La visita meravigliosa. È vero però che rispetto a tutto questo Puccini e contemporanei rappresentarono una reazione. Puccini che, cini morì nel ’24, gli altri membri della Giovine Scuola, del Verismo, non seppero rinnovare i successi degli anni giovanili, o rimasero inerti come Cilea, dopo l’insuccesso di Gloria alla Scala (1907). Giordano e Mascagni si spesero senza pudori in favore del fascismo. Nessuna meraviglia che in Addio, fiorito asil, il melodramma italiano da Boito al verismo, Rubens Tedeschi, a lungo giornalista dell’l’Unità, abbia guardato tutto il movimento con spirito critico, o, nel migliore dei casi, con paternalistica bonomia. Che l’Italia, nel XIX secolo, sia stato un Paese che abbia Giacomo Puccini a dispetto di Torrefranca, resta uno dei nostri più raffinati conoscitori dell’orchestra, si rivelò, al saggio di diploma, con un Capriccio sinfonico e nelle Villi, oltre al preludio che cita alla lettera l’Abendmahl-Motiv del Parsifal, ci sono ben due intermezzi sinfonici, «L’abbandono» e «La tregenda». L’Intermezzo di Manon (come quelli di Cavalleria e di Pagliacci) rimanda alla moda francese dei fragments, dei frammenti orchestrali da opere, aventi lo scopo di una ancor maggiore loro popolarizzazione e che erano incoraggiati dall’attivismo di direttori d’orchestra come Colonne, Lamoureux, Pasdeloup, i quali li inserivano nei loro concerti. Si abbiano per esempio la Meditation per violino e arpa dalla Thaïs e il Clair de lune dal Werther di Massenet. Il Verismo musicale insomma non aveva quei connotati provinciali di cui lo si rimprovera. Significò invece adesione alle esigenze di realismo del teatro borghese contemporaneo, puntando a far coincidere quanto più possibile il tempo musicale con quello reale, e ricercando nel contempo la comprensibilità del testo grazie al cosiddet- novecento / parte prima cini e lo consolò per il fiasco di Butterfly con i versi beneauguranti «la farfalletta volerà». In effetti il mondo piccolo, la poetica del fanciullino del letterato romagnolo, sembrano riaffiorare nella «bianca cameretta» di Mimì, nella «casetta» di Tosca, nella «casetta» di Butterfly, nella «stanzuccia» laggiù nel Soledad di Minnie, nella «casetta» sognata da Frugola e Talpa in Tabarro, nella «casa nell’Honan, con il suo laghetto blu» di Ping in Turandot. Se Rossini si vantava che la sua casa di Passy fosse l’unica senza illuminazione a gas e aborriva la strada ferrata, Puccini comprò automobili, motoscafi, amava i lussi tecnologici dei transatlantici che lo portavano in America. Era un uomo in cerca della modernità e Fanciulla del West è un omaggio alla colossale invenzione del cinema, alla nascente epopea del western, con la consapevolezza che la musica si sarebbe affiancata al nuovo mezzo con una funzione tutta nuova, di totale connessione con gli accadimenti. Il commento dell’orchestra alla famosa «partita a poker» è degno, nella sua essenspeciale to «canto di conversazione». Comportò l’abbandono della struttura «a numeri chiusi» dell’opera all’italiana in favore della tecnica wagneriana dei Leitmotiven, incentivò il protagonismo dell’orchestra. I suoi filoni erano quelli di attualità. Faremo solo un paio di esempi: l’orientalismo che parte da Iris (1898) di Mascagni, passa per Madama Butterfly (1904) e arriva a Turandot (1924). È un interesse che ritroviamo nel Debussy di Pagodes, nel Ravel di Laideronette imperatrice des Pagodes (1908), nelle poesie cinesi usate da Mahler in Das Lied von der Erde (1907). Strawinsky mette in musica Trois poesie de la lyrique japonaise (191213) e sceglie l’ambientazione cinese de Le chant du rossignol (1914), da Andersen. In diverse misure, quasi tutti questi compositori fanno ampio uso di scale pentafoniche ed esatonali senza i semitoni. Ancora Mascagni arriva per primo sul tema delle Maschere (1901) con clamoroso lancio contemporaneo dell’opera in sei teatri, il 17 gennaio (Venezia, Milano, Roma, Torino Genova, Verona con Napoli che si aggiunge speciale — 7 due giorni dopo). Sfileranno maschere in Ariadne auf Naxos (1912) di Strauss, Arlecchino o Le Finestre (1917) di Busoni, L’amore delle tre melarance (1921) di Prokofiev, fino ad arrivare a Ping, Pong e Pang della Turandot pucciniana del 1924. Quanto ai gusti letterari, Puccini non s’incontrerà mai con D’Annunzio. Lo faranno Franchetti (La figlia di Iorio, 1906), Mascagni (Parisina, 1913), Zandonai (Francesca da Rimini, 1914). Secondo Montale alcune battute di Bohème – «Mi piaccion quelle cose che han sì dolce malia..»- e di Butterfly - «Noi siamo avvezzi alle piccole cose» – avrebbero il sapore gozzaniano delle «care vecchie cose di pessimo gusto». Ma Sanguineti rileva la non coincidenza dei tempi e propende per una vicinanza con Pascoli, che fu ammiratore di Puc- zialità, delle più smaliziate soundtracks dell’avvento del sonoro. Soprattutto Puccini era informato dei grandi rivolgimenti in atto nel linguaggio musicale. Ascoltava Mahler, Strauss, Debussy, Strawinsky, fece un viaggio apposta per sentire Pierrot Lunaire. I livelli di lettura e di fruizione delle partiture pucciniane possono essere diversi. Al di là dell’abbagliante bellezza dell’invenzione melodica, che gratifica il pubblico più vasto, un’analisi approfondita rivela la perfetta organizzazione formale, frutto di un’economia sapiente del materiale usato. In Butterfly, 19 temi circolarmente innervano tutta l’opera. L’armonia di Puccini è simile a quella dei suoi contemporanei. Il breve preludio di Fanciulla è tutto costruito su sequenze di accordi aumentati, frutto della scala esatonale, il valzer di Tabarro ha un accompagnamento in settime degno di Strawinsky, episodi di bitonalità, uso di tredicesime sono sparsi ovunque. All’esordio di Turandot, sotto il declamato del Mandarino, la punteggiatura in accordi dissonanti in ostinato ricorda Les Noces. I passaggi in quinte parallele (già in Bohème, già in Tosca) creano un paradigma: sono le Puccini Quinten della terminologia tedesca. La ricerca di una sovrapposizione complessa di discorsi differenti, quasi a ricreare il senso di disordine sonoro della modernità, ha esemplificazione nella scena al Quartiere latino di Bohème o del Te Deum di Tosca. La spazializzazione del suono è magistralmente perseguita all’inizio del quadro alla Barriera d’Enfer, III quadro di Bohème. Il canto proviene dal fondo (doganieri, spazzaturai, lattivendole, carrettieri), dal Cabaré (Musetta e Voci) e dal proscenio (Mimì e Marcello). ◼ — speciale novecento / parte prima Gli anni della Secessione viennese mien. A leggere l’elenco di chi nel 1897 a Vienna voltò le spalle alla Genossenschaft bildender Künstler Österreichs (Consorzio degli artisti figurativi dell’Austria) e partecipò quindi alla Wiener Secession si direbbe che ci fossero proprio tutti gli artisti del momento. Era una secessione diversa da quelle che l’avevano preceduta, a Monaco e a Berlino, pur non essendo neppure queste paragonabili a quel movimento che a Parigi trent’anni prima era sfociato nel Salon des refusés. A Berlino e a Monaco si protestava contro la tradizione accademica, ma anche contro la situazione politica e sociale. Niente del genere a Vienna, e se poi qualche dipinto di Gustav Klimt, che ne divenne il presidente, non piacque ai professori dell’università cui era destinato, Francesco Giuseppe era pur andato a visitare una delle prime mostre dei transfughi: Rudolf von Alt, che invitò ufficialmente l’Imperatore, era diciotto anni più vecchio di lui. Cosa voleva dunque la Wiener Secession? Le motivazioni di quel distacco e le dichiarazioni dei critici che accompagnarono il fenomeno, sono abbastanza vaghe. Se si vuole intravedere uno sfondo sociale e politico, se ne ritrova un’eco là dove si parla di un’arte meno commerciale, più consapevo- movimento. «Nuda veritas» sta scritto sotto l’immagine ieratica di una donna nuda dalla lunga chioma scura e dallo sguardo severo che nella destra tiene sollevata una sfera di cristallo, uno specie di specchio ustorio rivolto a chi la guarda, perché, come sta scritto in maiuscole sul bordo superiore: «Wahrheit ist Feuer und Wahrheit reden heisst leuchten und brennen» (La verità è fuoco e dire la verità significa illuminare e bruciare). Un’Iside secessionista, disse qualcuno, diversa comunque dalle figure femminili Jugendstil che, giunte dal nord, a Vienna assumevano spesso tratti malinconici e si muovevano esili e forse un po’ malate tra betulle e ninfee. Per il manifesto della prima mostra della Secession lo stesso Klimt aveva disegnato un muscoloso Teseo in lotta con il Minotauro, ma poi fu obbligato dalla censura a nasconderne la virilità dietro tronchi d’albero. Verità, dunque, ma in che senso, se tutto, anche l’erotismo assume qui per lo più una qualità altamente stilizzata fino a congelarsi in un alfabeto di forme misteriosamente allusive? Tanta passione per il vero e tanta energia rivolta contro le forze oscure chiama in causa il termine opposto, ossia la menzogna. Se non si sapeva bene cosa fosse la verità, si sapeva cosa era la menzogna. Per Hermann Bahr, Ludwig Hevesi, i più attenti fiancheggiatori del movimento e poi, e con maggior forza, per Adolf Loos, la menzogna era palese, suntuosamente e sfacciatamente visibile negli edifici della Ringstrasse, negli edifici pubblici (il parlamento, l’università, il municipio, il teatro) costruiti rispettivamente in stile neoclassico-greco, gotico, neorinascimentale e barocco, con un eclettismo architettonico ripreso poi nelle imponenti di- le di quanto avveniva in Europa in quegli anni e anche più diffusa tra la popolazione, pervasiva della vita quotidiana, come poi a Vienna effettivamente lo fu grazie alla sua forte componente artistico-artigianale. Comunque a unire i secessionisti non erano tanto delle opere con una spiccata e «scandalosa» tendenza quanto «una volontà di arte» e una fiducia nell’arte che permetteva una gamma di espressioni proprio perché scartava le parole d’ordine (naturalismo, impressionismo, simbolismo e in seguito espressionismo) per fare spazio alla singolarità dell’artista, al suo modo del tutto personale e interiore di riflettere una realtà considerata ormai più o meno apertamente inafferrabile. Non di realtà si trattava infatti (come pretendeva il naturalismo), ma di verità. E Gustav Klimt la verità l’aveva raffigurata in oos uno dei primi lf L o d fascicoli di «Ver A sacrum», la raffinatissima rivista ufficiale dei Secessionisti che proprio per la varietà degli interventi (grafici e letterari) è il manifesto eloquente del more cittadine dell’alta e ricchissima borghesia erette a partire da metà Ottocento. Erano il prodotto dello storicismo, di un gusto che pretendeva di esprimere solidità e sicurezza e invece rivelavano, come ebbe a dire poi Hermann Broch in un famoso saggio sul giovane Hofmannsthal, solo impotenza, ed erano dunque monumenti di menzogna. Già prima di Loos, Otto Wagner aveva fatto il nome di Potëmkin: «Non c’è biasimo sufficiente... per la cialtroneria traboccante di falsità che richiama alla memoria i villaggi di Potëmkin. Nella storia dell’arte non c’è un altro periodo che possa esibire tali mostruosità.» Arthur Schnitzler, che aveva studiato medicina e leggeva Freud più dei suoi compagni letterati, formulava la diagnosi della situazione proclamando per bocca di uno dei suoi personaggi che «Sicherheit ist nirgends»(Non c’è sicurezza) e raffigurando sulla scena la labilità dei cosiddetti valori. Per smentirli e smascherarli niente era più efficace che metterli a confronto con il momento estremo dell’esistenza, n di Eugenio Bernardi speciale on erano CerTo dei ribelli e nemmeno dei bohé- novecento / parte prima speciale — speciale ossia con la morte. Hofmannstahl Drasticamente, e quindi fin troppo sonoche, a differenza di Schnitzler, colramente, l’obiettivo era racchiuso laborava con saggi, poesie e scein quella frase iscritta sone drammatiche a «Ver Sacrum», pra la porta dell’edificio aveva lo stesso obiettivo quando, della Secession: «Der Zeit giovanissimo e coltissimo, in un ihre Kunst, der Kunst ihre testo drammatico intitolato apFreiheit». Ossia: ogni epoca punto Der Tor und der Tod (Il foldeve trovare il proprio mole e la morte) mise in scena un do congeniale di esprimersi esteta chiamato a render cone questa espressione non deve to di come avesse trascorso trovare impedimenti. Valeva la vita. La sacralità della priper l’architettura in primo luomavera espressa dal titogo, e per la pittura, ma varrà poi lo della rivista era da insoprattutto per la musica. È neltendere dunque su quela musica che si avranno i più tuH u go sto sfondo: non tanto comultuosi scandali, sia perché l’udiv on H ofman me scatenamento (in una primaveto è il più conservatore dei sensi, sia nstha l ra dionisiaca) delle passioni nascoste sotto la perché, se nell’impero austro-ungamaschera dell’onorabilità, ma come l’urgenza di un’etirico esisteva una tradizione unificanca da rifondare sollevando quella maschera e analizzando di te paragonabile a quella che nel moncosa fosse fatta quella soggettività moderna che l’arte, liberado tedesco aveva al suo centro Goethe ta dalle parole d’ordine, doveva esprimere. e Weimar, questa era la tradizione musicale da Mozart a Compito difficile, evidentemente, che spettava ai letteraBrahms. La vera rivoluzione estetica di Vienna avverrà proti più che ai pittori e agli architetti della Secession. Accanto e in prio in campo musicale, una rivoluzione di cui ancora oggi parallelo con costoro c’erano infatti i poeti e gli scrittori vienviviamo le conseguenze. nesi che si ritrovano non tanto nelle sale di esposizione, ma Mentre in architettura lo smascheramento della menzogna nei caffè, soprattutto al Griensteidl, e che in analogia con i in nome della verità si traduce soprattutto nel rivelare semgruppi analoghi di Berlino, furono chiamati Junges Wien, o pre più il rapporto tra facciata e funzione degli spazi interni anche Junges Österreich. Come i secessionisti, anche i lettera(senza però rinunciare totalmente al ritmo dell’ornamento) ti ebbero il merito di diffondere a Vienna le opere degli artisti e scrittori di attualità nell’Europa di quegli anni. Mentre le sale della Secession ospitavano gli impressionisti francesi, i letterati leggevano Ibsen, Swinburne, Maeterlinck, Hamsun, Jacobsen, Turgenev, Huysmans. In tutti e due i settori sono molto indicative le preferenze: Khnopff ebbe un successo trionfale (come del resto Hodler), mentre Munch non ne ebbe affatto. Che la prospettiva non fosse quella del disfarsi della forma (forse proprio perché se ne temeva la possibilità), ma qualcosa d’altro che non era neanche il simbolismo, lo indica il trionfo di Rodin e soprattutto l’enorme successo di Max Klinger e del suo monumento a Beethoven a cui la Secession dedicò tutto lo spazio disponibile e per cui Klimt dipinse un fregio famoso che si estendeva lungo le quattro pareti della sala. Altrettanto indicative sono le preclusioni o perlomeno le riserve entro il versante letterario di questo momento viennese, in alcuni casi iscritte nella biografia degli autori. Di Hofmannsthal in primo luogo che fu certo la personalità più straordinaria del gruppo anche per la precoce coscienza della situazione in cui operava e per le affinità che intuiva nell’ambito della cultura europea. Il suo iniziale entusiasmo ma poi le riserve per l’opera di D’Annunzio, per esempio, o la sua attrazione/repulsione per il personaggio di Stefan George (che in ambito tedesco costituiva il contraltare al naturalismo imperante) sono, anche in questo caso, segnali che permettono di intravedere la fisionomia profonda di quanto nelle arti e nella letteratura stesse avvenendo a Vienna, anche al di là dei fenomeni di maggiore evidenza e di grande popolarità (meritata, evidentemente) come era il caso di Schnitzler. e se nella pittura la nudità viene scandita in ritmi che l’esaltano e nello tempo la spersonalizzano, il più sottile e inquietante attacco ai valori ammantati di verità, viene dal versante letterario e più precisamente letterario-psicologico. La cognizione che «l’io non si salva» Hermann Bahr, che accompagna con fervore il movimento viennese su tutti e due i versanti, la doveva a Ernst Mach, un filosofo e psicologo, professore di matematica e fisica sperimentale. Nelle sue analisi delle emozioni Mach aveva spiegato che non è l’io a essere il fattore primario, ma sono le emozioni, e che se postuliamo un’unità della nostra coscienza lo facciamo solo per fini pratici e transitori. Se è così, dove va a finire quella verità che l’arte si proponeva di svelare, l’arte che di per sé veniva definita come espressione della singolarità dell’io contro qualsiasi imposizione esterna? Su tutti e due i versanti, quello figurativo-architettonico e quello letterario-psicologico, la breve storia della Secession (il gruppo della Giovane Vienna si disperde dopo la demolizione del Caffé Griensteidl, la Secession vera e propria si conclude quando Klimt ne abbandona la presidenza) vive di queste tensioni e di queste contraddizioni, tra impulso alla verità e consapevolezza della finzione, tra estetismo e tormenti etici, tra «analisi della vita e fuga dalla vita» come diceva il giovanissimo Hofman- ▶ 5 — speciale novecento / parte prima così dire una versione più minacciosa e ferrigna, come di un fortilizio con torrette e angeli dalle grandi ali che ne vigilano l’accesso. L’interno è quindi una sorpresa, costituito com’è da un unico grande spazio che può far venire in mente l’interno del Pantheon, ma è luminosissimo, ha la volta disegnata da una decorazione che ricorda le stelle, ha grandi finestre colorate e un altare con baldacchino smagliante di ori. È uno spazio esaltante o meglio, di esaltazione, intenso e sconcertante, tanto più se si tiene presente la sua funzionalità rispetto ai malati che lo frequentano e ai loro bisogni (anche corporali). In campo letterario il quesito sulla verità è più o meno evidente ovunque, e tanto più nelle pièce teatrali. Si pensi a Schnitzler e ai dialoghi a volte spietati tra i suoi personaggi. Volendo però indicare un esempio più aderente a quella tensione che si ritrova negli esempi di architettura suddetti, è inevitabile citare, anche in questa sede, la famosa Lettera di Lord Chandos (1902), un testo famoso di Hugo von Hofmannsthal. Lo scrittore immagina che nel 1603 un letterato, Lord Philipp Chandos per l’appunto, autore di straordinari scritti letterari e filosofici, scriva a Francesco Ba- mente alla sua funzione. Era costruito «come si costruisce una ruota», era uno spazio capace di mettere nel massimo risalto le opere che ospitava, opere frutto del tempo e delle personalità che le avevano create, perché «la verità è come ciascuno la percepisce» e l’arte è dunque sempre diversa, «inarrestabilmente diversa» e richiede continui adeguamenti nello spazio espositivo e nella ricezione da parte dello spettatore. Tempio e funzionalità, e quindi anche eternità e temporalità, che è la tensione su cui tutto questo si basa. Nella pittura (e qualche volte nella decorazione) questa tensione (o l’utopia di una conciliabilità degli opposti) si esplica nell’uso dell’oro e del mosaico dorato, soprattutto da parte di Klimt che ne aveva visto l’effetto a Ravenna. L’oro ossia il massimo del colore, la gloria della luce, compare sempre più nei suoi fregi e nei suoi ritratti e raggiunge la sua massima valenza quando si intreccia e dialoga con l’acqua ossia con l’elemento che più indica l’inarrestabilità del tempo ma anche l’inafferrabilità della mente creativa. In architettura l’esempio massimo di questa tensione creativa è senz’altro la Leopoldskirche in cui culmina allo Steinhof una vasta area collinare destinata a ospitare in singoli padiglioni le varie forme della malattia mentale. La chiesa, costruita da Otto Wagner nel 1907, dà l’impressione di citare altri edifici sacri (la Karlskirche innanzitutto), ma offrendone per cone una lettera in cui gli confessa di non essere più in grado di scrivere nulla, di essere addirittura incapace di formulare le parole della vita quotidiana: improvvisamente le parole hanno per lui il sapore di «funghi imputriditi». Lo si è letto come un documento della crisi di uno scrittore e di un’epoca, e indubbiamente lo è , ma per formularla Hofmannsthal la racchiude dentro una composizione stilistica di grande sapienza retorica che smentisce quella crisi di linguaggio che confessa. Si tratta di una strategia straordinaria, tipica della modernità: produrre un’opera proclamandone l’impossibilità. Volendo cercarne una lontana (ma ben consapevole) propaggine, si pensi a Thomas Bernhard. Non tutti erano d’accordo con questa enfasi, né tutti credevano alla possibilità di conciliare (almeno provvisoriamente e con tutte le perplessità del caso) le divergenze, l’arte moderna «dei nervi» e lo splendore immortale dell’oro. Basti pensare al sarcasmo dei Karl Kraus. Ma pure tra i sostenitori (anche finanziari) del movimento, vi erano delle perplessità. La famiglia Wittgenstein, i grandi magnati dell’industria che fin dall’inizio avevano generosamente sostenuto la Secession, a un certo momento commissionarono a Klimt un ritratto della figlia, ma non ne furono soddisfatti: lei stessa, Margaret Wittgenstein-Stonborough, non si riconosceva in quel volto dallo sguardo sognante, in quell’abito bianco dai riflessi d’argento né soprattutto in quello spazio atemporale in cui Klimt, come era sua abitudine, incorniciava le figure femminili per farne delle icone della modernità. Il ritratto rimase appeso per qualche settimana in salotto, ma poi finì in cantina. ◼ speciale nsthal che fin dalle prime prove mostrava di aver scoperto i pericoli di una sensibilità finissima, frutto di una irrinunciabile cultura e nello stesso tempo labile maschera dietro cui poteva nascondersi la violenza e l’orrore. Vi sono, nel vasto (vastissimo) panorama della Secession viennese alcuni momenti di questa tensione che diventano straordinari se li si guarda avendo presente l’orizzonte (sociale, politico, filosofico, scientifico) su cui si stagliano. Uno è proprio l’edificio della Secession, costruito da JoseAr th ur Sc ph Maria Olbrich nel 1898 e hnitz l er tornato a risplendere dopo i recenti restauri e soprattutto dopo la rinascita degli studi su questo periodo viennese (promossa in primo luogo da studiosi americani, francesi e italiani). Nel descriverlo Hermann Bahr ne parla come di un’opera davanti alla quale non era più questione di gusto, ma di verità: un’espressione unica e insostituibile, un risultato necessario e quindi paradigmatico dello spirito della Secession. Era una specie di tempio infatti e l’atrio secondo Bahr era pensato come un luogo in cui «purificarsi dalla quotidianità e predisporsi alla devozione», era «una silenziosa clausura dell’anima». D’altro canto l’edificio corrispondeva perfetta- speciale — 5 novecento / parte prima Schönberg e Kandinskij: un incontro n eLL’inConTro Tra KanDinSKij e SCHÖnBerG fu speciale il pittore il primo ad avvertire profonde affinità elettive e a proporre un accostamento tra la «necessità interiore» della pittura astratta e della musica atonale, ponendo entrambe sotto il segno del «principio della dissonanza». All’inizio vi fu la folgorazione di un concerto a Monaco l’1 gennaio 1911, cui assistettero accanto a Kandinskij, Gabriele Münter, Franz Marc, Alexej Jawlenskij e altri della Neue Künstlervereinigung München. Il programma comprendeva il Quartetto n. 2 op. 10 e i 3 Klavierstücke op. 11. Il 18 gennaio 1911 Kandinskij scrisse la prima lettera a Schön- zo si approda all’inserimento di una voce di soprano che intona due liriche di Stefan George (da Der siebente Ring), la disperata invocazione di Litanei e la esperienza visionaria, legata a un sentimento cosmico, di Entrückung (Rapimento), che spinge Schönberg a liberare la musica da ogni legame, a farle respirare veramente «l’aria di un’altra sfera» del primo verso, a strappare quasi «un’eco proveniente dal regno della libertà» (Adorno). In questo di Paolo Petazzi anelito visionario la tonalità viene abbandonata e la musica sembra nascere con visionaria immediatezza dalla risonanza delle parole, da una sorta di suono interiore da loro destato. I Pezzi pianistici op. 11 appartengono alla incandescente esplosione creativa che seguì tra il 1908 e il 1909, insieme con i 15 Lieder op. 15 dal Libro dei giardini pensili di George, i Cinque pezzi op. 16 per orchestra e il «monodramma» Erwartung. Anche i Tre Pezzi op. 11 sono momenti essenziali nella ricerca di un linguaggio libero dalle funzioni e dalle gerarchie tonali, non condizionato dagli schemi simmetrico-estensivi ad esse collegati: Vasilij Kandiskij, Improvvisazione 26, 1912 il linguaggio dell’interiorità, della perdita di ogni certezza, della crisi del soggetto. Si pensi solo ai berg. E forse già dal 3 gennaio dipinse Impression 3 (Konzert), il quadro che si ritiene rifletta l’emozione provocata dalle musiche di Schönberg (e che si trova a Monaco, Galerie im Lenbachhaus). Kandinskij chiamava «Impressioni» i quadri ispirati alla «natura esteriore» (e «Improvvisazioni» quelli suscitati da «eventi di carattere interiore»). Uno schizzo preparatorio conservato nello stesso museo mostra chiaramente un pianista davanti ad un pianoforte a coda con il coperchio sollevato, e intorno a lui il pubblico. Il confronto tra l’abbozzo disegnato e il dipinto svela un modo di procedere frequente in Kandinskij nel periodo delle prime esperienze astratte: l’astrazione sembra nascere dalla stilizzazione e dalla trasformazione di immagini che conservano ancora una certa riconoscibilità. In Konzert una grande macchia nera (il pianoforte divenuto macchia nera) è affiancata da una zona gialla sulla destra, dall’effetto violento. Difficilmente si può riconoscere in una delle fasce bianche che attraversano la macchia nera la posizione del pianista, mentre nella varietà cromatica della parte sinistra del dipinto, soprattutto in primo piano, è ancora abbastanza leggibile la presenza del pubblico. Che cosa aveva potuto ascoltare Kandinskij in quel concerto? Con il Quartetto op. 10, iniziato nel marzo 1907 e dopo diverse interruzioni finito nell’estate 1908, e con le altre opere degli stessi mesi Schönberg era giunto ad un momento decisivo nel cammino verso il superamento della tonalità. Il Secondo Quartetto può anche essere letto come una concentratissima «autobiografia musicale»: dalla tonalità ci si allontana infatti nel corso dei quattro tempi del pezzo, che sono ciclicamente collegati fra di loro da alcuni materiali tematici. E dopo il lacerato Scher- gesti più liberi e dissolti (in rapidissimi trentaduesimi) che segnano vere e proprie fratture nel percorso formale del primo pezzo, secondo un disegno che sembra rispondere a una istanza interiorizzata puramente espressiva. Oppure alla violenza innovativa del terzo pezzo, sensibilmente più breve e concentrato degli altri, in grado di esercitare un significativo influsso anche sul pianismo di Boulez: la densità incandescente della scrittura, lo scatenarsi, quasi, della materia sonora in una invenzione costantemente rinnovata hanno fatto parlare di «informale» a proposito dell’esito di questa pagina. Questi erano i pezzi che indussero Kandinskij a scrivere a Schönberg nella prima lettera il 18 gennaio 1911: «Ho appena ascoltato il Suo concerto: è stata ▶ Arnold Schönberg 5 — speciale per me una autentica gioia. […] Nelle Sue opere Lei ha realizzato ciò che io, in forma naturalmente indeterminata, desideravo trovare nella musica. Il cammino autonomo lungo propri destini, la vita delle singole voci nelle Sue composizioni è esattamente ciò che io tento di esprimere in forma pittorica.» Già questa prima lettera, e la risposta di Schönberg (il 24 gennaio) toccano alcuni dei temi centrali dell’epistolario degli anni 1911-14, che costituisce un contrappunto alle riflessioni teoriche e alle creazioni dell’artista e del compositore in quel periodo. Kandinskij sottolinea che il suo modo di concepire la costruzione non va cercato «attraverso una via “geometrica”, ma al con- terizzate da ricerche sinestesiche come Die glückliche Hand e Der gelbe Klang, dei primi lavori astratti di Kandinskij e di una produzione pittorica ancora intensa da parte di Schönberg (affiancata all’improvviso rallentamento dell’attività compositiva, tra il 1910 e il 1913 limitata ai Piccoli pezzi op. 19, al Pierrot lunaire e alla lunga genesi della Glückliche Hand). Nelle lettere appare determinante il principio della «necessità interiore», che può dare un senso al luogo comune che associa la pittura astratta e il superamento della tonalità (sebbene l’astrattismo possa ispirarsi ad una dimensione musicale non necessariamente atonale). Le visionarie intuizioni, le interiorizzate folgorazioni espressive rispondono alla logica di una pura «necessità interiore». Il musicista viennese e l’artista russo riconoscevano affinità elettive nelle loro creazioni, e a questo proposito, senza indulgere ad approssimativi giochi di corrispondenze tra linguaggi e personalità differenti, è forse inevitabile instaurare confronti tra la sconvolta visione dello spazio pittorico del primo astrattismo di Kandinskij (uno spazio privato di un «centro» di riferimento) e il vertiginoso stravolgimento dello spazio sonoro che negli stessi anni produce in Schönberg l’abolizione di un centro tonale. Un altro tema delle lettere, non separabile dalla urgenza espressiva e dalla tensione della «necessità interiore», riguarda le ricerche sinestesiche compiute dai due artisti l’uno indipendentemente dall’altro. Prima dell’incontro con Schönberg Kandinskij aveva già formulato la sua idea di «Bühnenkomposition» (Composizione scenica) e fin dal 1908/9 aveva posto mano al suo più noto lavoro teatrale, Der gelbe Klang (Il suono giallo), su cui ritornò più volte, anche dopo averlo pubblicato nell’almanacco del «Cavaliere azzurro» (Der blaue Reiter) nel 1912. E Schönberg speciale Vasilij Kandiskij, Impression 3 (Konzert), 1911 novecento / parte prima trario attraverso una via rigorosamente antigeometrica, antilogica. Questa via è quella delle “dissonanze nell’arte”, quindi tanto nella pittura quanto nella musica. E la dissonanza pittorica e musicale “di oggi” non è altro che la consonanza di “domani”.» Schönberg risponde a Kandinskij che «l’arte appartiene all’inconscio! Bisogna esprimere se stessi! Esprimersi con immediatezza!». Accenna anche alla propria esperienza come pittore, commenta la cartella e le fotografie che Kandinskij gli ha inviato, e si dichiara favorevole al superamento di una dimensione figurativa in nome dell’esigenza di «esprimere soltanto processi interiori». Fin dalle prime lettere dunque, talvolta con parole un poco diverse, appare essenziale la convergenza intorno al problema di costruire la nuova «dissonanza» partendo da una intuizione inconscia. Il primo conflitto mondiale e il periodo trascorso da Kandinskij in patria separarono a lungo i due artisti, che poterono riprendere le comunicazioni nel 1922; ma per poco. Alma Mahler (ormai Werfel) aveva riferito a Schönberg alcune opinioni di Kandinskij sulla «questione ebraica», determinando il rifiuto del compositore all’invito di insegnare al Bauhaus e una provvisoria rottura. Al di là dei pettegolezzi di Alma, verosimilmente infondati, ci sono nell’autodifesa che Kandinskij inviò a Schönberg nel 1923 affermazioni che potevano rafforzare la lucida e vigile diffidenza del compositore. Qui devo limitarmi a sottolineare che il nucleo essenziale dell’epistolario è circoscritto agli anni 1911-14 e costituisce un contrappunto alle riflessioni teoriche e alle creazioni di quel periodo. Era l’epoca del Trattato d’armonia e dello Spirituale nell’arte (1911), della pubblicazione dell’almanacco del «Cavaliere azzurro» (1912), della creazione di opere carat- non poteva saper nulla della «composizione scenica» quando concepì, nel 1910, il progetto di Die glückliche Hand (La mano felice), di cui pubblicò subito il testo, ma solo nel 1913 portò a termine la musica (con numerose interruzioni). La sua lettera a Kandinskij del 19 agosto 1912 accenna al compimento del Vasilij Kandinskij Pierrot lunaire e a un progetto (poi non realizzato) da Seraphita di Balzac, parla della insolita lentezza nella composizione della Glückliche Hand e commenta il Suono giallo e altri contributi di Kandinskij all’almanacco del «Cavaliere azzurro»: «La Sua composizione scenica mi piace moltissimo […] Il suono giallo non è una costruzione, ma semplicemente la riproduzione di una visione interiore. […] È esattamente ciò che ho cercato di realizzare nella Mano felice. Solo che Lei va più lontano di me nel- speciale — 5 novecento / parte prima la rinuncia a ogni idea consapevole, a ogni azione di tipo naturalistico. Certo, questo è un grande vantaggio. Dobbiamo renderci conto che siamo circondati da enigmi. E dobbiamo avere il coraggio di affrontarli senza chiedere vilmente di avere una «soluzione». È importante che la nostra capacità creativa riproduca enigmi in base a quelli che ci circondano, affinché la nostra anima tenti non di risolverli, ma di decifrarli. […] Essi sono, infatti, il riflesso dell’inattingibile.» Sotto il segno di questa disperata tensione si pone Die glückliche Hand, che, a differenza di Kandinskij (che affidò la musica del Suono giallo a Thomas von Hartmann) Schönberg poté concepire in ogni dettaglio del testo, della musica, delle scene, della regia. Mentre in Erwartung aveva voluto «rappresentare tutto quanto si svolge in un secondo di massima eccitazione spirituale, diluito nel tempo, per così dire al rallentatore», in Die glückliche Hand aveva progettato «un grande dramma concentrato in circa venti minuti, per così dire ripreso all’acceleratore». Colpisce qui la ricerca di un convergere di mezzi espressivi (scene, luci, colori) in una prospettiva per qualche aspetto affine a quella del Suono giallo di Kandinskij (che in verità è di natura più marcatamente astratta, come lo stesso Schönberg sottolinea nella lettera citata). Il protagonista della Mano felice si trova nella stessa condizione di disperata solitudine della Donna di Erwartung; ma l’azione è spostata su un piano ancor più nettamente antinaturalistico e si presenta come un succedersi di immagini che appaiono in sogno (e che pure riflettono conflitti reali). Nel simbolismo del testo l’Uomo incarna l’immagine della personalità creatrice, spiritualmente elevata, che vive l’esperienza negativa, inesorabil- ri, tentando una sintesi delle arti, una ricerca sinestesica che ha le proprie radici nel primo Romanticismo, riceve nuove formulazioni in Wagner e nel clima culturale del Decadentismo per approdare all’Espressionismo e in modo particolare al Blaue Reiter (dove fra l’altro un ampio articolo di Sabanejev informa sul Prometeo di Skrjabin). Schönberg mirava alla sintesi di ogni mezzo in nome della «rappresentazione dei processi interiori». Non solo la «tempesta di luci» della terza scena (dove ogni mutamento di colore è minuziosamente indicato in partitura), ma tutta la Glückliche Hand nella tensione visionaria verso la rappresentazione «to- mente destinata al fallimento, del contatto con una realtà sociale dalla quale è escluso, condannato all’angoscia, a perseguire l’assoluto in una disperata solitudine. Illusoria è la breve felicità dell’incontro con la Donna, vano il grande gesto del creatore che con un solo colpo di maglio foggia uno stupenArnold Schönberg do gioiello. Il fallimento esistenziale dell’Uomo è sancito inesorabilmente dal ritorno, alla fine, della stessa situazione iniziale con il mostro che gli conficca i denti nella nuca e il coro che gli rivolge amari ammonimenti, rendendo ancora più esplicito il significato della vicenda. Schönberg intende «far musica con i mezzi della scena». Le minuziose didascalie in partitura indicano con precisione le corrispondenze tra gli avvenimenti musicali e il mutare di luci e colo- tale» rivela una natura profondamente diversa dal Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) di Wagner, un segno mutato: l’ansioso anelito di ricondurre tutto all’immediatezza interiore, ad un radicale soggettivismo, ad una assoluta libertà creativa approda non ad una immagine compatta, di semplice e coinvolgente fusione, ma ad un esito frantumato, dalle convergenze e interazioni problematiche che si inverano nella incandescente invenzione musicale, sotto il segno di una disperata consapevolezza, di una intensità lacerante. Il simbolismo dei colori, dall’azzurro che segna i momenti positivi, al giallo (legato alla massima eccitazione, alla lotta), al violetto (che appartiene al mondo della Donna), al verde (che è il colore dell’annientamento, quello che avvolge gli sguardi del coro all’inizio e alla fine) si basa semplicemente su una intuizione (come Schönberg sottolinea nella conferenza di Breslavia) e presenta casuali punti di contatto con alcune indicazioni dello Spirituale nell’arte. Anche per Der gelbe Klang la ricerca approda a qualcosa di diverso dal Gesamtkunstwerk, sebbene con una impostazione più astratta rispetto alla ricerca «totale» schönberghiana. Il segno della ricerca sinestesica si potrebbe anche riconoscere nel contributo musicale di Schönberg all’almanacco del «Cavaliere Azzurro», già nella scelta del testo: si tratta del Lied per soprano, arpa, celesta, armonium Herzgewächse, traduzione tedesca di Feuillage du coeur di Maeterlinck. ◼ speciale Vasilij Kandinskij, Giallo, rosso, blu, 1925 L’epistolario Schönberg-Kandinskij, pubblicato nel 1980 a cura della studiosa kandinskyana Jelena Hahl-Koch insieme a testi e documenti (come, fra l’altro, «Der gelbe Klang» e «Die glückliche Hand»), è stato tradotto in italiano da Mirella Torre nel 1988 per Einaudi. Lo stesso libro, esaurito, è stato ristampato nel 2002 a Milano da SE. 5 — speciale novecento / parte prima Anton Webern oltre la Nuova Musica L ’aBBiamo GiÀ DeTTo, lo pensiamo più che mai: Webern è l’inizio della musica nuova; tutti i compositori che non hanno profondamente sentito e compreso l’ineluttabile necessità di Webern sono del tutto inutili». La stessa perentorietà con cui qualche anno prima l’intemperante Boulez aveva liquidato la lezione di Schoenberg con un lapidario «Schoenberg è morto». L’esperienza della Nuova Musica ci ha mostrato in quale radicale direzione sia andata ramificandosi l’assunzione di Webern quale imprescindibile punto di partenza per nuove avventure sonore, col risultato che il «webernismo» – Robert Craft, il famulus stravinskiano cui si deve una meritoria registrazione del- Anton Webern speciale « di Gian Paolo Minardi sità, timbro, attacco del suono, a toccare l’approdo a quella «serialità integrale» di cui Webern venne considerato, non senza qualche forzatura, il padre. Vera e propria «situazione coercitiva» quella degli anni cinquanta in cui, come ricorderà poi con disincantata sensibilità Wolfgang Rihm, «si ordinava: hai ricontrollato le serie? Forse una serie era stata rubata e con ciò un’esistenza distrutta… È mai possibile?» A una considerazione attuale, quando il mito della panserialità appare indubbiamente aver fatto il suo tempo, l’idea di un Webern precursore di un nuovo ordine compositivo – addirittura vi fu chi vide in lui l’anticipatore della musica elettronica – ha trovato un contemperamento grazie a una più riflessiva lettura della pagina weberniana, riportata alle intenzioni e allo spirito del compositore. Testimonianza preziosa in tal senso è quella delle Variazioni op. 27 nell’approfondimento critico di Peter Stadlen, il pianista viennese che aveva studiato questo lavoro con le stesso Webern e che ne proporrà la prima esecuzione tedesca pro- l’integrale del musicista austriaprio a Darmstadt nel 1948. La vico, parlava ironicamente di «wecenda interpretativa che è andaberniti» – ha finito per orientata sviluppandosi attorno a quere la lettura della sua opera lungo ste Variazioni – un brano che ha direttrici oltremodo sghembe. trovato ampio accoglimento nel L’esaltazione per Webern da repertorio dei pianisti, da Gould parte di quei giovani musicia Pollini, allo stesso Sviatoslav sti convenuti a Darmstadt subiRichter – lascia ben trasparire la to dopo la guerra la si può comdoppia immagine attraverso cui prendere con il senso di libertà si è proposta in maniera sfaccetche andava erompendo dopo la tata, spesso contraddittoria, tutpremente chiusura operata dal ta l’opera del musicista: una annazismo. Webern e non Schoecora legata a una tradizione, pur nberg, appunto, come a voler serievocata attraverso la rarefaziognare un taglio netto con quel ne della scrittura, l’altra proietpassato che sembrava ancora intata verso il futuro, come lascinervato nelle fibre dell’autore di to esemplare di un nuovo moPierrot lunaire. Significativa la tedo di comporre, essenzialmente stimonianza di Stockhausen: «Il strutturalistico, la visione domiprimo incontro con la musica di nante a Darmstadt, appunto: doAnton Webern resta indimentive peraltro non mancarono voci Anton Webern e Arnold Schoenberg cabile. Si torna con la mente aldissonanti, quella di Maderna in l’epoca in cui si passava l’un l’alparticolare il quale ha sintetizzatro copia delle sue partiture, e si to con la sua consueta pregnanstringevano amicizie sulla sola za questo dualismo: «Come si fa base della comune passione per questa musica». a considerare astratto Webern, con le sue minuziosissime Ciò che attraeva soprattutto, in una naturale spinta verindicazioni (dolce, dolcissimo, sparire ecc.). Prenda l’op.27: so il futuro, era la proiezione del serialismo dal piano delle se la si esegue in una pienezza di sensibilità è un lavoro mealtezze a quello degli altri «parametri», ossia durata, intenraviglioso; se la si realizza seguendo il cosiddetto oggetti- novecento / parte prima speciale — 55 speciale vismo è una macchina idiota, con le serie che vanno avanpiù ancora in relazione all’impiego del pedale e quindi al ti e tornano indietro…» concetto di suono, concepito in termini di durata e non di A parlare di «totale oggettivazione» era stato anche semplice «punto». In effetti Webern voleva un fraseggio Adorno mentre Krenek, proprio riguardo a queste Variaestremamente libero e che ogni intervallo, ogni nota foszioni parlava di «freddo mondo autosufficiente di forme se caricata di intensità, e non è un caso che indicasse coastratte». me riferimento per il primo movimento l’ Intermezzo in mi Un contrasto di cui lo stesminore di Brahms, mentre il so Webern era stato spesso modello per il secondo era testimone, con disagio di la Badinerie dalla Suite in si mifronte a esecuzioni fondanore di Bach. Significativo, te esclusivamente sulle ranel commento di Stadlen, il gioni strutturali. Riferiva, fatto che durante la preparaad esempio, del proprio diszione Webern si concentrò senso di fronte all’esecuzioesclusivamente sugli aspetti ne della Sinfonia op. 21 diespressivi, rifiutando di sofretta da Klemperer, il quafermarsi su quelli composile aveva rifiutato che durantivi: solo pensando all’inite la concertazione Webern zio del brano per cui Wegli facesse da guida. «Una bern raccomandava «fresco nota alta, una bassa, una al appassionato – lirismo delcentro – come la musica di l’espressione» e ancora parun pazzo! » sarà il commenlava di «lamento trattenuto del compositore. to»; quindi alla parte cenA portare luce decisiva su trale, all’episodio in arpegtale problematica sarà, cogi che Webern voleva parme si è accennato, la pubbliticolarmente animato: «urcazione, nel 1979, del fac-sigente», «liberamente imRobert Craft e Igor Stravinskij mile del testo usato da Peter provvisativo», per giungere Stadlen, con le annotazioall’epilogo, con quelle ulti- ni che vi aveva apportato lo stesso Webern durante la minuziosa preparazione, un lavoro di alcune settimane per quelle poche pagine. Oltre alle annotazioni a matita del compositore Stadlen ha corredato il testo con altre indicazioni fattegli verbalmente. Si tratta di un documento di straordinaria importanza per l’interpretazione weberniana, che va oltre lo specifico testo delle Variazioni. Se già l’edizione corrente recava indicazioni espressive significative, questo nuovo testo appare oltremodo sollecitante, proprio per la quantità di segni d’espressione che rivelano la forte intenzionalità emotiva racchiusa in quel linguaggio così scarno e così chiuso nel suo rigore simmetrico. A tale testimonianza si aggiunge il conforto sonoro recato da una registrazione, pur tecnicamente primitiva, che un amatore ha fissato della esecuzione di Stadlen del 1948 a Darmstadt, non poco illuminante sia per quanto riguarda il tempo, assai meno veloce di quello correntemente proposto da molte interpretazioni weberniane, ma me tre note sussurrate, intese da Webern come «ultimo sospiro», pensando forse a quel «come un soffio» che conclude l’ultimo dei 6 piccoli Klavierstücke dell’op.19 di Schoenberg. «Importante – diceva – era imparare come si doveva suonare il pezzo, non come era fatto». Viene da pensare alle conferenze di Berg, prima del Wozzeck, quando dopo l’analisi minuziosa della complessa partitura, invitava il pubblico a dimenticare il tutto e concentrarsi nell’ascolto. Con la sempre sorprendente qualità di penetrazione giunge ineffabile il pensiero di Stravinskij, dopo quella sua sibillina evoluzione degli anni cinquanta nata dalla suggestione per i miAlban Berg steriosi reticoli strutturali del musicista viennese; assimilati però entro una superiore consapevolezza poetica: un artista, dirà il vecchio père Igor, che «…porta alla musica una voce nuova, intensamente individuale, e ha senz’altro il potere di commuovere. Nella musica del XX secolo non c’è momento più eloquente della coda della Sinfonia op. 21». ◼ 56 — speciale novecento / parte prima Šostakovič e Britten: un ponte tra est e ovest nella guerra fredda liarità questo modo di rivolgermi a Lei. In caso di rapporti ufficiali, le abitudini russe esigono che si utilizzino nome, patronimico e cognome. Io però provo per Lei i sentimenti più amichevoli e per questo non posso rivolgermi a Lei secondo il galateo ufficiale». Così scriveva nel 1965 Dmitrj Šostakovič a Benjamin Britten. I due si erano incontrati per la prima volta a Londra nel 1960 e avevano stretto da allora una cordiale amicizia. Šostakovič e Britten erano all’epoca compositori assai in vista nei rispettivi paesi, assurti da tempo a fama internazionale. E proprio tra il 1960 e il ’65, mentre la guerra fredda attraversava le sue fasi più critiche, il loro rapporto si rinsaldò: interrogarsi sui fattori che possono averlo favorito ci servirà anche ad osservare l’opera dei due in un’ottica non convenzionale. Qualsiasi compositore abbia operato attorno alla metà del Novecento non ha potuto evitare il confronto con le coordinate ideologiche correnti, che, schematizzando un po’, possiamo esprimere sotto forma di opposizioni del tipo: società vs. storia, oppure kitsch vs. avanguardia. In sostanza: erano allora atti- opera, Il naso, tratta dalla celebre novella di Gogol’, rappresentata a Mosca nel 1930. Qui l’irrisione delle tradizionali e borghesi convenzioni operistiche da parte del giovane e brillante autore sovietico è evidente, ad esempio, nello straniamento prodotto dalla voce di falsettista richiesta per il personaggio del poliziotto; o nell’entr’acte al termine della seconda scena dell’atto I, interamente scritto per strumenti a percussione a suono indeterminato; o ancora nella successiva «cavatina» del protagonista Kovaliov, senza testo, tutta singulti e gutturemi. Šostakovič a meno di trent’anni era dunque il compositore simbolo della giovane e turbolenta repubblica sovietica. Tanto più inattesa e traumatica fu la svolta che coincise con la seconda opera, Una lady Machbeth del distretto di Mcensk (1934; poi rimaneggiata come Katerina Izmajlova, 1963). Di tutti i personaggi dell’opera, che nella versione originale non mascherava contenuti fortemente anti-maschilisti ed erotici, si dà una rappresentazione disumanizzata grazie all’uso di inflessibili ostinato ritmici e dal ricorso costante a un linguaggio grottesco e semicaricaturale; di tutti tranne che della protagonista Katerina, l’unica a cui uno stile di canto più lirico e tradizionale concede di mostrare il proprio spessore psicologico. (Abbiamo qui un primo eloquente esempio di dinamica drammaturgico-musicale ottenuta attraverso l’accostamento tra stili radicalmente opposti.) Accolta trionfalmente a Leningrado e a Mosca, l’opera fu immediatamente ripresa in mezzo mondo, sinché, a due anni dalla prima, non incappò nella censura della Pravda che, probabilmente su pressione di Stalin in persona, con il celebre articolo «Caos invece di musica» mosse al compositore la terribile accusa di «formalismo». A Šostakovič si rimproverava di voler com- ve le avanguardie musicali, che operavano nella certezza di innestarsi in un processo di evoluzione stilistica e tecnica necessaria, determinato dalle leggi intrinseche della Storia e del materiale sonoro stesso. Quelle leggi, però, non coincidevano necessariamente con quelle della normale percezione umana: il rigore tecnico-compositivo poteva implicare dunque per gli autori la perdita del contatto con il pubblico. All’ascolto la musica delle avanguardie novecentesche poteva apparire ostica, preoccupata com’era innanzitutto di scavare un solco tra sé e il retaggio della tradizione ottocentesca. Alle avanguardie si opponevano i compositori che pensavano la propria opera in funzione, più che della storia, della società, e continuavano a prediligere la possibilità della comunicazione all’imperativo dell’espressione. La loro musica appariva più immediatamente comprensibile all’ascoltatore medio. Britten e Šostakovič li ritroviamo entrambi su quest’ultimo versante, anche se le motivazioni che li guidarono furono assai diverse: Britten scelse liberamente il rapporto con il pubblico quale stella polare del proprio percorso stilistico; il percorso di Šostakovič fu invece pesantemente condizionato dalle ingerenze del totalitarismo stalinista. Nato a Pietroburgo, compositore precocissimo e pianista dotato, Dmitrij Šostakovič assurse a fama internazionale a diciannove anni allorché al Conservatorio di Pietroburgo fu eseguita la sua Sinfonia n. 1 (1926). La vena satirica che la pervade, evidente nell’adozione di forme neoclassiche filtrate attraverso la lente deformante della «nuova oggettività» (allusione a generi subartistici e continuo sconfinare verso gli estremi della tavolozza espressiva), si espresse ancor più chiaramente nella prima piacere soltanto orecchie colte ed estetizzanti, senza riguardo per l’impegno educativo che doveva contraddistinguere ogni opera d’arte nell’Urss. Il colpo per il compositore fu terribile: da allora in poi la sua vita fu lacerata tra professioni di fede nel realismo socialista da un lato e dall’altro tentativi di ritagliarsi ogni possibile spazio di espressione artistica autonoma. Il che coincide con il «problema Šostakovič» per la critica musicale moderna: che credito concedere alla sincerità dell’artista? Come recuperare alla nostra coscienza storica opere concepite sotto una tale pressione ideologica e psicologica? Recentemente va prendendo piede una lettura delle opere di Šostakovič secondo cui almeno alcune di esse nasconderebbero una sorta di criptotesto stilistico che, se decifrato correttamente, sarebbe in grado di rovesciare il segno della loro apparente ortodossia ideologica. La Sinfonia n. 5 (1937), ad esempio, è comunemente considerata l’opera della riabilitazione del compositore, una sorta di «ritrattazione» in musica: all’epoca della prima, la stampa di regime apprezzò il modo in cui il positivo e retorico finale spazza via il clima tragico del Largo precedente. In quel finale, però, la virata verso la trionfalistica perorazione conclusiva in re maggiore appare tanto plateale da essere poco convincente: un’impressione che neppure la recezione coeva poté ignorare. Chi ascolti in quest’ottica il finale si accorgerà che la forza ivi sprigionata non dissipa le nubi del Largo, ma le tinge di colori ancor più sinistri. Sarebbe questo, dunque, il vero messaggio veicolato dalla Sinfonia: non l’esaltazione delle «magnifiche sorti e progressive» care al potere, ma la loro negazione. C aro Benjamin, non consideri come eccessiva fami- speciale « di Mario Carrozzo novecento / parte prima speciale — 57 filtrare quasi inavvertitamente un messaggio subliminale che le mettesse in discussione. Ad esempio, nel Peter Grimes (1945), la prima opera del britannico, il personaggio del titolo è un crudele pescatore, che tratta tanto brutalmente i giovani apprendisti affidatigli da provocarne la morte. Libretto e partitura lasciano però intendere che Grimes sia a sua volta ostracizzato dalla comunità di cui fa parte, sulla quale finisce dunque per ricadere almeno in parte la responsabilità di quei delitti. Il tema dell’opera non è la crudeltà del pescatore, ma la sua emarginazione sociale: in patente parallelismo ideologico con il Wozzeck berghiano e con la Lady Machbeth di Šostakovič. Come per Šostakovič, anche per Britten l’ibridazione stilistica costituiva un’opzione chiave della strategia drammaturgica. Nell’ultima opera, Death in Venice, tratta dal romanzo di Thomas Mann, Tazio, il giovinetto di cui lo scrittore Gustav Aschenbach si invaghisce fino all’autodistruzione, è interpretato da un danzatore anziché da un cantante. La sua apparizione sulla scena è accompagnata dall’evocazione del gamelan, la musica per ensemble di percussioni tipica dell’isola di Bali. In questo caso, però, il gamelan è emblema non di ciò che è culturalmente «altro» rispetto all’Occidente, ma dell’istintualità stessa; e si identifica con l’aura erotica e trasgressiva che inconsapevolmente Tazio porta con sé. Un meccanismo di significazione che non può prescindere dallo scarto esistente tra l’esotismo del gamelan e la relativa «normalità» del tessuto musicale che contraddistingue gli altri personaggi. Anche in questo caso, dunque, l’allusione a stilemi musicali tradizionali appare non come una concessione al conservatorismo del pubblico ma come una necessità drammaturgico-mu- che nel 1939 assieme al poeta Wystan H. Auden (uno dei librettisti del Rake’s Progress stravinskijano) e al compagno di sempre, il tenore Peter Pears, aveva seguito l’ondata migratoria dei pacifisti verso gli Stati Uniti. Nel Requiem i testi liturgici sono contrappuntati dagli amari versi del poeta Wilfred Owen: l’ultima lirica, accostata al Libera me Domine, racconta l’incontro nell’oltretomba di un soldato britannico con il nemico tedesco ucciso il giorno prima. Il compositore nella prima esecuzione volle che le parti solistiche fossero eseguite dal soprano russo Galina Višnevskaja e dal baritono tedesco Diether Fischer Dieskau, oltre che dal britannico Pears. Il significato simbolico dell’opera non poteva essere reso più esplicito. Il Requiem fruttò a Britten l’«Aspen Award», conferito negli Stati Uniti «agli individui che ovunque nel mondo hanno dato il massimo contributo al progresso dell’umanesimo». In quell’occasione egli inviò un discorso dedicato all’importanza della composizione musicale per la collettività umana: l’autore a cui si tributava il massimo apprezzamento era proprio Šostakovič, meritevole di aver eretto con la Sinfonia «Leningrado» un «monumento ai suoi concittadini, un’espressione esplicita della loro tenacia e del loro eroismo». In altre parole, Britten riconosceva nell’amico russo un’incarnazione del proprio credo estetico: «Voglio che la mia musica sia utile alla gente, che piaccia, che migliori la loro vita». Più che un’adesione preconcetta ai gusti più tradizionalisti del pubblico, oggi si tende a leggere in queste parole la persuasione di poter meglio assolvere attraverso uno stile piacevole e avvincente alla propria funzione di coscienza critica: senza opporsi frontalmente alle convenzioni dominanti (sociali non meno che musicali) Britten riteneva di poter far sicale. Un’opzione che però a sua volta escludeva il ricorso agli apparati tecnico-teorici delle avanguardie. (Del resto, la perizia di Britten nei generi drammaturgico-musicali è comprovata, ove ce ne fosse bisogno, dal fatto che delle sedici opere da lui composte, almeno cinque sono rimaste stabilmente in repertorio: oltre alle due appena menzionate, Billy Budd, The Turn of the Screw, A Midsummer Night’s Dream. Primato, questo, ineguagliato tra i compositori del secondo Novecento.) In conclusione: le scelte tecnico-compositive dei nostri due autori si configurano, più che come un tributo al tradizionalismo, come la ricerca di un «meta-linguaggio» in cui le opzioni stilistiche e formali della tradizione non sono usate tanto per se stesse, ma in funzione della loro interazione reciproca. Questa scelta, rispetto a quelle operate dalle avanguardie, permetteva un rapporto più immediato con il pubblico ed era quindi il corrispettivo della consapevolezza, vivissima in entrambi, della funzione civile che la musica assumeva in un momento tanto cruciale della storia europea. Non che ciò valga ad annullare ogni controversia critica sulla vita e sull’opera dei due: ché criptotesti e messaggi subliminali non sono necessariamente veicoli di comunicazione più efficaci di testi e messaggi espliciti; né le testimonianze private sul tormento di Šostakovič cancellano la sua avversione ufficiale per i dissidenti. Solo, si approssima forse il momento in cui si dovranno ripensare le contrapposizioni che hanno agitato la vita musicale nei decenni attorno alla metà del secolo scorso. E chissà che, come nel 1933 Schönberg ribattezzò Brahms «il progressivo», non sorga presto il giorno in cui si debbano ribattezzare Šostakovič e Britten come «gli avanguardisti». ◼ speciale Durante gli anni del conflitto mondiale, sull’onda del tentativo di Stalin di coinvolgere anche gli intellettuali nella propaganda del regime, la censura allentò alquanto la sua morsa, e la carriera di Šostakovič attraversò una nuova fase di successi ufficiali. Ne fu espressione, ad esempio, la Sinfonia n. 7 «Leningrado», eseguita nel 1942, che ritraeva descrittivamente l’invasione della Russia da parte delle truppe tedesche e la loro disfatta. Ma all’inizio della guerra fredda il potente Andrej Ždanov, principale responsabile per il controllo delle arti nell’Urss, rinfocolò la vecchia polemica antiformalista e Šostakovič fu nuovamente costretto a fare pubblica ammenda. Nel ’53 il compositore celebrò la morte di Stalin con la Sinfonia n. 10, ricevendone in cambio il titolo di «Artista del popolo», la più alta onorificenza dell’Unione Sovietica. Sopraggiunse poi la decadenza fisica: dal 1967 in poi una malattia dei nervi gli procurò una paralisi alla mano destra, che gli impedì di suonare. Grazie a un’incrollabile forza di volontà, però, egli riuscì a comporre sin quasi alla morte, nel 1975. Tra le opere dell’ultimo periodo spiccano due meditazioni sul tema della morte: il Quartetto per archi n. 14 (1973) e la Sinfonia n. 14 (1969). Questa Sinfonia con soli, su testi di García Lorca, Apollinaire, Rilke, Kjuchel’beker, in undici movimenti, fu dedicata proprio a Benjamin Britten. Nel nono movimento un testo del poeta russo Kjuchel’beker diventa veicolo per un messaggio diretto e complice all’amico britannico: «Che importa la persecuzione?... Imprese ispirate e dolci canti son pari agli Eterni». L’opera costituisce un seguito ideale al War Requiem dell’inglese (1962). Il profondo spirito pacifista che pervade questo Oratorio risente fortemente delle convinzioni politiche dell’autore, 5 — speciale novecento / parte prima La calda voce del jazz sitore creolo di New Orleans, aveva fatto stampare sul suo biglietto da visita la qualifica di «originator of jazz», e basterebbe questo a dirla lunga sulle rapidissime fortune del genere, che attorno agli anni venti era praticamente conosciuto, se non effettivamente diffuso, pressoché in tutto il mondo, e che un musicista nato appena nel 1890 poteva pretendere di avere «inventato». La smargiassata aveva infatti un fondo di verità: la musica che il giovanissimo Morton aveva cominciato a suonare attorno al 1905 era qualcosa che nessuno si sarebbe preoccupato di chiamare jazz ancora per parecchio tempo, ma Jelly Roll Morton che come tale era già da diversi anni in stato nascente. Le conseguenze della fine dello città è il vero e proprio luogo di nascita del jazz, quello in cui Louis Armstrong emergerà attorno al 1920 come il primo musicista che svilupperà il virtuosismo solistico: e ispirazione non secondaria sarà il repertorio dell’opera italiana, ampiamente diffuso anche tra gli strati più bassi della popolazione nella città del Delta. La novità dell’improvvisazione non è un tratto che compare repentinamente, e d’altronde per diverso tempo influenza anche generi che non la contemplano. Si pensi all’orchestra ragtime di James Reese Europe, che di fatto introduce il neonato jazz nella cultura metropolitana. L’orchestra di Europe, che non è una piccola formazione come quelle di New Orleans, ma un’imponente banda militare, non suona musica improvvisata ma il suo stile «hot» è largamente influenzato dagli accenti del jazz, ed è la prima formazione afroamericana che si esibisce, nel 1912, in una sala prestigiosa come la Carnegie Hall di New York. Nel contempo diviene l’orchestra che accompagna la coppia di ballerini schiavismo producevano infatti, negli ultimi anni dell’Ottocento, il maturarsi di un lungo processo di appropriazione che il gruppo etnico afroamericano aveva avviato da almeno un secolo nei confronti delle musiche sia colte sia popolari di estrazione europea e in cui poteva riconoscere una propria, forte identità culturale. Si era a quel punto prodotta una notevole varietà di pratiche musicali, da quelle formalizzate ma non scritte come il blues e lo spiritual, a quelle del tutto formali e precisamente notate come il ragtime, le cui notevoli fortune, all’alba del XX secolo, erano legate essenzialmente alla circolazione degli spartiti. Il jazz, che evolveva da queste forme, portava con sé la novità dell’importanza accordata all’improvvisazione estemporanea in un contesto di esecuzione collettiva come quello titpico delle bande di ottoni e percussioni di New Orleans. Questa alla moda formata da Vernon e Irene Castle, che «inventano» e insegnano al mondo il fox-trot. Sono questi gli avvii spettacolari di una storia affascinante e contraddittoria, in cui la forza propulsiva che erompe da un insieme di musiche del tutto nuove è a stento trattenuta da pesanti barriere razziali e sociali nonché dal pregiudizio morale che a lungo continuerà a bollare la musica dei neri come «musica del diavolo», mentre contemporaneamente l’industria dell’intrattenimento si sta apprestando letteralmente a rigenerarsi attingendo a piene mani dalla cultura degli afroamericani. Un’altra caratteristica notevole del jazz, infatti, è quella di nascere nel momento in cui l’industria del suono riprodotto ha avviato un’irreversibile trasformazione del modo di ascoltare e di vivere la musica. Edison inventa la riproduzione meccanica del suono (su cilindro) nel 1877, Berliner la perfeziona con il disco dieci anni dopo, e già attorno al 1900 nel mondo si vendono cilindri e dischi nell’ordine di milioni di copie. Il primo disco di «black music» sarà, nel 1913, proprio un ragtime dell’orchestra di Europe, impegnato a costruire la rispettabilità della cultura nera presso i ceti colti dell’America metropolitana, mentre il primo disco di jazz sarà inciso nel 1917 da una formazione interamente bianca, la Original Dixieland Jass Band dell’italiano Nick La Rocca, che però dello stile delle formazioni nere riprende i modi e gli effetti più facili e ammiccanti. Ciò fa sì che il jazz si affermi contemporaneamente come musica tradizionale, comunitaria, etnicamente connotata e insieme, almeno potenzialmente, come prodotto d’in- j di Veniero Rizzardi speciale eLLY roLL morTon, il pianista e compo- Charlie Parker speciale — 5 novecento / parte prima logica di un sostanziale razzismo «scopre» con entusiasmo il jazz come «fenomeno importantissimo della storia musicale» ma anche come «immenso progresso compiuto nella musica di tipo leggero e popolare» e «potentissimo strumento educatore per le masse», esaltando la positiva ambiguità di una musica che a suo vedere superava di slancio la dicotomia tra intrattenimento e valore estetico. Questa fase di perfetto equilibrio è splendidamente esemplificata dalla stagione delle grandi orchestre, Duke Ellington, Jimmie Lunceford, Cab Calloway, Chick Webb, Count Basie, la cui popolarità verso la fine degli anni trenta venne superata dalle formazioni bianche di Benny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey e Glenn Miller, in cui prevaleva la funzione di puro intrattenimento legata al ballo. Era il preludio a una storia del tutto nuova, quella che nasce all’inizio degli anni quaranta nelle jam sessions dei locali della 52. strada a Manhattan, dove si formerà il bebop, un approccio del tutto nuovo alle strutture del blues e della canzone, trasfigurate da un’improvvisazione virtuosistica su tempi rapidissimi, e solisti, e inventando così una delle sonorità più caratteristiche della musica del Novecento. Sono anche gli anni in cui i compositori, anche al di qua dell’Oceano, scoprono il jazz manifestando una partecipazione e un desiderio di assimilazione cui la critica terrà dietro molto malvolentieri. Il rivolgimento nei linguaggi artistici in Europa negli anni cataclismatici della prima guerra mondiale apre infatti la musica alle più disparate suggestioni, dal rumore dei futuristi ai ritmi delle musiche non europee. Così nella Parigi di Cocteau, di Stravinsky e dei Ballets Russes si scopre la musica «negra», un’influenza che durerà a lungo – Parigi, del resto, sarà fino agli anni sessanta la capitale europea del jazz, prima e a volte unica tappa di tutti i più importanti jazzisti di ogni generazione, da Armstrong in avanti fino a Charlie Parker, Miles Davis, Charles Mingus, l’Art Ensemble of Chicago… Ma, ritornando all’incontro dei compositori con il jazz, non vi è personalità di spicco che operi nel corso degli anni venti e trenta che non introduca elementi di jazz nel suo linguaggio: Ravel, Sostakovic, Hindemith, Stravinskij, Berg, Krenek che scrive nel 1927 un’«opera jazz», Jonny Spielt Auf, e figure magari più defilate come il ceco Erwin Schulhoff che reimposta del tutto il suo stile a partire dal jazz. Gli anni trenta del cosiddetto «neoclassicismo» o del «ritorno all’ordine» sono in realtà un momento di forte recupero comunicativo all’indomani dei fuochi delle avanguardie, e in questo senso il jazz gioca un ruolo di grande importanza. La situazione è ben compresa da Alfredo Casella che nel 1929, pur attraverso la lente ideo- su una maggiore complessità armonica dei modelli di partenza. È questo il momento in cui il jazz diventa una musica di puro ascolto e, negli anni cinquanta, rientra persino in contatto con le avanguardie della composizione. Ma ancora una volta il discorso critico mancherà di comprendere, o vorrà fraintendere, la complessità, l’originalità, l’intrinseca propulsione evolutiva del jazz, che ha tuttavia abbandonato la sua veste «popolare». In questo senso il discorso si è aperto soltanto di recente ma, al di là di un’eccellente, agguerrita musicologia specifica, non ha ancora prodotto una comprensione veramente integrata del jazz alla modernità musicale. ◼ speciale trattenimento di massa. Un’altra notevole conseguenza è il fatto che la trasmissione del jazz tra musicisti avvenga già molto presto per imitazione a distanza attraverso il disco, piuttosto che per assimilazione diretta in un contesto di prossimità e condivisione: in quel di Davenport, Iowa, difficilmente Bix Beiderbecke avrebbe potuto ascoltare jazz dal vivo e divenire il grande cornettista che ha segnato, anche se solo come una meteora, la storia del jazz classico. Per diversi anni l’industria del disco funzionerà secondo un principio di vera e propria segregazione: nel corso degli anni venti e trenta una musica specializzata circolerà su etichette specializzate per un pubblico esclusivamente di colore, ma presto i race records cominciano a finire sempre più spesso nelle mani di bianchi, mentre l’atmosfera eccitante dei club di Harlem attrae sempre più pubblico proveniente dalla borghesia colta in cerca di divertimento esotico. Sono gli anni in cui Duke Ellington si afferma come originale e raffinato bandleader, scrivendo in funzione Duke Ellington delle speciali «voci» strumentali dei suoi Louis Armstrong 6 — speciale novecento / parte prima La musica per film da, in alcuni casi radicale, di alcuni linguaggi espressivi che nei tre secoli precedenti avevano conosciuto un’evoluzione possente e tempestosa, giungendo in taluni casi ad autentiche «esplosioni» nel campo della produzione di senso (la musica, la letteratura); ma si caratterizza soprattutto per la nascita – avvenuta, tecnicamente parlando, in realtà alla fine dell’800 – di un linguaggio totalmente nuovo, avveniristico, destinato di lì a poco a influenzare profondamente tutti gli altri, e in qualche caso a inglobarli. Il cinema. Il cinema appare, in un arco di tempo straordinariamente breve, in grado di bruciare tappe evolutive che ad altre forme d’arte hanno richiesto decenni, se non secoli; in poco, pochissimo tempo diventa, da fotografia in movimento, strumento di racconto, di trasfigurazione del reale, forma d’avanguardia e nello stesso tempo redditizia attività industriale, opera d’arte e prodotto di consumo. Di più. Il cinema, che muove i Alfred Hitchcock primi passi ad appena un quindicennio dalla scomparsa di Richard Wagner, sembra vera- dimento sostanzialmente artificiale e illusorio, che forza a convivere tra loro linguaggi inconciliabili sul piano meramente «naturalistico». Nasce di qui una delle prime e più forti diffidenze che la musicologia «purista» ha sempre riservato nei confronti della musica cinematografica: il rimprovero, cioè, di un peccato originale che consisterebbe nell’essere musica «su committenza», ma non solo; musica «a metraggio», condannata unicamente a un ruolo ancillare e descrittivistico nei confronti delle immagini, dei dialoghi, cioè di ritmi a essa intimamente estranei, decisi «altrove» e dalla musica medesima, in quel caso subiti (è celebre la paradossale battuta di Stravinskij secondo il quale la miglior musica da film è quella che non si sente. Facile osservare che analoga obiezione potrebbe essere mossa verso i due terzi della musica cosiddetta «colta», anch’essa nata su committenza di re, principi, signorotti, gran dame e dittatori, e anch’essa spesso (occorre citare il caso dell’opera e del balletto, o del «poema sinfonico a programma»?) indirizzata a mettere insieme forme espressive reciprocamente impermeabili e innaturali (nessuno di noi nella vita quotidiana si esprime cantando o danzando, il vento non soffia secondo scale cromatiche, i tuoni non hanno il timbro dei timpani ecc.) in nome di una «sintesi» artificiale superiore rappresentata, appunto, dall’intuizione del compositore. mente realizzare la concretizzazione della Gesamtkunstwerk, dell’opera d’arte totale vagheggiata e in larga parte costruita dall’autore del «Ring»: l’occasione, il contenitore linguistico, la scatola cinese semantica che può contenere e assorbire, e nei casi migliori interagire con, tutti gli altri: letteratura, teatro, pittura, danza. E musica. Nasce cioè la forma di espressione dell’ingegno umano che più di qualunque altra mette in campo il concetto di sinestesia, cioè quel tipo di metafora che associa termini appartenenti a sfere sensoriali diverse. Ma, come osserva Sergio Miceli, lo studioso che ha dedicato a questi problemi, e in generale alla musica «applicata» (al cinema in primis), le analisi più complesse, lucide ed esaurienti, se in letteratura la sinestesia è comunque riconducibile alla sfera verbale (Miceli cita il celebre verso montaliano, fredde luci parlano, cfr. Musica e cinema nella cultura del Novecenlano to, Sansoni 2000, pp. 7-8), nel cinema le cose to sono complicate dalla presenza simultanea di elementi percettivi appartenenti a dimensioni diverse, che oltre a coinvolgere i nostri due sensi principali, vista e udito, mettono in moto una serie di variabili comportamentali psicologiche (eccitazione, paura, commozione, repulsione, ilarità) attraverso un proce- Al netto allora da questo paradossale equivoco di matrice idealistica, ciò che allora rimane è l‘insorgenza di un nuovo genere musicale, che transita lungo tutto il Novecento carico delle esperienze del passato ma pronto anche ad assimilare il nuovo, che produce generazioni di compositori specializzati, in alcuni casi in esclusiva in altri no, nella musica per lo schermo, studi e dipartimenti preposti al settore, orchestre e direttori qualificati, apparati tecnologici, repertori, prassi concertistiche ed esecutive (nei casi più «nobili», e raramente in Italia). Questo genere è appunto la musica «per» o «da» film. Non ne esiste ancora una storia compiuta e cronologicamente ordinata, vista la smisurata vastità del campo (non più vasto, comunque della storia stessa del cinema…), e chi si accingesse all’improbo compito di delinearla si troverebbe a fare i conti innanzitutto con una vertiginosa quantità di scuole nazionali, di stili, di applicazioni, e di influssi reciproci fra il neo-genere e generi preesistenti: dall’opera al jazz, dal sinfonismo puro, al rock & pop, dal camerismo all’elettronica. La musica cinematografica infatti, che in quanto tale (cioè in quanto musica di commento appositamente composta e costruita sul materiale girato per accompagnare con pertinenza la «produzione di senso» del racconto), nasce solo dopo l’avvento del sonoro (1929) negli Stati Uniti e si suole datare dal King Kong di Ernst B. Schoedsack e Merian C. Cooper (1933) con la partitura di Max Steiner, si muove trasversalmente rispetto agli altri generi e non segue le evoluzioni linguistiche del Novecento musicale, spesso addirittura contraddicendo le spinte innovative del cinema cui si applica. Per fare esempi concreti, in Italia sino a tutti gli anni cinquanta ed oltre, i musicisti cinematografici sono ancora i di Roberto Pugliese speciale L noVeCenTo Si caratterizza per la trasformazione profon- Ludovico Einaudi speciale — 6 novecento / parte prima no fatto il proprio ingresso con decenni di ritardo nelle partiture cinematografiche (peraltro, nel secondo caso, oggi dilagando in assoluta e generica banalità e sbrigatività), spesso con valenza descrittiva apertamente negativa o demonizzante, forse in risposta alle intransigenti posizioni teoriche sull’argomento di Adorno nonché alla «provocazione» pratica di Schoenberg con la sua ipotetica «Musica d’accompagnamento per una scena di film» op.34, oggetto a posteriori e molti decenni dopo la sua composizione di un cortometraggio sperimentale di JeanMarie Straub. In realtà la «modernità» della musica cinematografica non va tanto ricercata nelle collaborazioni eccellenti tra Autori sommi e Compositori colti (Fellini-Rota, Ejzenstein-Prokofiev i casi più noti) ma viceversa nella capacità di molti musicisti specializzati di attraversare i generi, i codici, gli schemi innovando continuamente il linguaggio, elaborando incessantemente i materiali, scavando e scarnificando gli stereotipi, e senza mai fermarsi alla soglia del «commento» sottolineatorio o per contro antitetico. La figura di riferimento in cui tutti questi sforzi si condensano è senz’altro avanguardie europee, e spesso provenienti dal Vecchio Continente (come l’ungherese Miklòs Ròzsa, il tedesco Franz Waxman, l’austriaco Max Steiner, il russo Dimitri Tiomkin) la musica cinematografica americana si rivelò avamposto di ricerche, sperimentazioni e tensioni linguistiche sconosciute a quella europea, che per contrasto assorbì invece moltissimo dal jazz e che a differenza di quella statunitense non ha mai sviluppato un profilo omogeneo, unificante, ma ha seguito piuttosto le indoli e gli influssi dei singoli compositori: il francese Georges Delerue, impressionista e neoclassico, l’inglese John Barry, proveniente dagli ambienti della swinging London ma sinfonista sublime e bruckneriano, il nostro Morricone, miracoloso mago di alchimie fra avanguardia radicale e lirismo estenuato, per non citare che i principali. Così accadeva che Hollywood incamerava, attraverso i compositori principali delle vecchie majors e poi figure di spicco come John Williams e soprattutto Jerry Goldsmith (il vero pioniere dell’avant-garde in questo genere), le ansie più febbrili di adeguamento della musica da film da retaggio servile del cinema muto a linguaggio capace di interagire fieramente sia con il racconto per immagini che con l’evoluzione stessa della musica novecentesca. È abbastanza ovvio che su questo terreno si sia celebrato uno scontro permanente fra compositori, produttori e spesso registi: le ultime due categorie poco inclini a concedere alla musica cinematografica e ai suoi protagonisti l’indipendenza necessaria per sviluppare un percorso autonomo. Ed è altrettanto ovvio che ciò che a noi appare naturale, ormai storicizzato nella storia della musica colta dello scorso secolo, come ad esempio la tecnica dodecafonica o l’elaborazione dell’elettronica, abbia- Bernard Herrmann (1911-1975), vero musicista «totale», artefice sonoro dei massimi capolavori di Hitchcock dopo esserlo stato di Quarto potere di Orson Welles ma soprattutto – insieme, agli antipodi geografici e produttivi, a Dimitri Shostakovich – strenuo sostenitore e geniale costruttore della musica da film come «nuovo genere» musicale del Novecento. Un genere più che paritario rispetto ad altri, magari declinanti (l’opera) o ingoiati dai riflussi delle post-neo-transavanguardie o mescolati dall’apparente e illusoria caduta delle barriere fra «colto» e «popolare» (esemplificata da musicisti come Philip Glass, Michael Nyman o in Italia Ludovico Einaudi e Giovanni Allevi): un genere che in realtà è ormai divenuto lessico universale, koinè diffusa della postmodernità, ma che ha sempre ottenuto i propri risultati più avanzati quando, con umiltà, fedeltà e rigore, ha affiancato l’immagine in movimento nella piena consapevolezza di esserne non la schiava ma a volte l’ispiratrice, la dimensione parallela, la traduzione più indicibile. E in molte occasioni la vera, unica anima. ◼ speciale idealmente eredi e depositari dell’operismo ottocentesco (verista in particolare), e proprio il Neorealismo, stagione di rifioritura e rinnovamento etico ed estetico del cinema italiano, si avvale di partiture convenzionali e nazionalpopolari «indietro» nei codici linguistici di almeno quarant’anni. Ci vorranno gli anni sessanta e la nascita dei «generi» (commedia, western, il peplum) perché compositori come Giovanni Fusco, Mario Nascimbene e poi Ennio Morricone smontino dall’interno questo meccanismo cominciando a manipolare il suono, a lavorare sulle «distanze» invece che sulle mimesi onomatopeiche, sull’orizzontalità della musica invece che sul suo spezzettamento, insomma sulla sua modernizzazione. Potrà apparire paradossale, ma il luogo ove il dialogo fra le pulsioni dell’avanguardia storica musicale (sempre rimasta alla larga dal cinema, si pensi ai casi di Schoenberg, Stravinskij, Berg) di marca europea e la musica per film si è fatto più intenso è stata la Hollywood del periodo che va dagli anni quaranta a buoBernard Hermann na parte dei sessanta. Qui, grazie anche a figure di compositori fortemente impregnati del clima delle Orson Welles 6 — speciale novecento / parte prima Due rivoluzioni del pensiero musicale Edgard Varèse – Frank Zappa: The Present-day Composer(s) Refuses to Die Le analogie che legano i due (non soltanto dettate dalla passione zappiana per quel «gray-frizzy-hair-mad-scientist» la cui Ionisation lo sconvolse ancora quasi bambino) sono in certi casi sorprendenti e ci porterebbero a considerarle come vere rivoluzioni del pensiero musicale contemporaneo per certi versi con esiti ancora inesplorati. Vediamo perché. iL ConCeTTo Di mUSiCa Consideriamo come Varèse e Zappa abbiano in alcuni casi rifondato alcuni parametri musicali generali al di là della loro tradizionale concezione. iL ConTaTTo Il concetto stesso di musica è continuamente sottoposto aro SiG. ZaPPa mi dispiace di non poter accogliere la sua a problematici interrogativi: in Varèse addirittura si risolve richiesta. Partirò per l’Europa la prossima settimana e sain suo stesso scavalcamento e nella ridefinizione di «suorò di ritorno la prossima primavera. Spero di vederla al mio no organizzato»: ritorno. Poiché il termine «musica» sembra essersi progressivamente ridotto Con i migliori auguri fino a significare molto meno di quel che dovrebbe, preferisco ricorrere E.Varèse all’espressione «suono organizzato», così da evitare la tediosa questioUniversalmente note agli zappiani sono ne: «ma è musica?» queste famose righe scritte da Varèse in riAnche in Zappa il concetto ultimo di musposta ad una lettera che Zappa ragazzino sica si riduce a quello di organizzazione, un Edgard Varèse mandò al suo mito bizzarro nelle quali con atteggiamento creativo del pensiero in una Parigi, 22 dicembre 1883 gentilezza il vecchio maestro rimanda un de-ristrutturazione di materiali disparati New York, 6 novembre 1965 incontro poi mai avvenuto. sempre all’insegna del motto: Ma quella che forse pochissimi conoscoAnything Anytime Anyplace for No Reason At Frank Zappa no è proprio la lettera (rimasta inedita fino All Baltimora, 21 dicembre 1940 al 2006) che Zappa (dopo una famosa teleaddirittura superando quel «tabù» della Los Angeles, 4 dicembre 1993 fonata) spedì a Varèse: non necessità del fenomeno acustico alla di Giovanni Mancuso speciale C «I have been composing for two years now, utilizing a strict twelve-tone technique, producing effects that are reminiscent of Anton Webern Webern. […] I became more and more interested in you and your music. I began to go to the library and take out books on modern music, to learn all I could about Edgard Varèse. It got to be my best subject (your life) and I began to writing my reports and term papers on you at school. At one time when my history teacher asked us to write about an American that has really done something for the Usa, I wrote on you and the Pan American Composers League [sic] and the New Symphony. I failed. The teacher had never heard of you and said I made the whole thing up. Silly but true. That was in my Sophomore year at school school». Quell’incontro non avvenne mai, ma il giovane Zappa continuò a sviluppare, nel suo caleidoscopico universo creativo, alcune intuizioni e speranze varesiane all’insegna di una originale fusione di utopia e concretezza. Edgard Varèse definizione di musica: …estendendo il concetto fino a comprendere la luce, il comportamento, fattori climatici e qualsiasi altra cosa […], tutto può essere consumato come musica. La ComPoSiZione Di conseguenza anche il concetto di composizione musicale viene ripensato: sia in Varèse che in Zappa compare spesso il termine Progetto, sintomatico di quell’avvicinamento razionale alle discipline scientifiche: Una composizione non è altro che un progetto, un tracciato in attesa dei mezzi meccanici per la sua realizzazione sonora. In Zappa si ritrova esattamente la stessa idea di Progetto anche se la fattività zappiana non dimentica che il fine ultimo è comunque la produzione di un «Oggetto»: Progetto/Oggetto è un termine che ho adoperato per descrivere il concetto generale della mia opera in campi diversi. Ogni progetto (a qualsiasi campo appartenga) e intervista legata ad esso fanno parte di un oggetto più vasto che non ha un termine tecnico. Correndo poi attraverso le trame dei parametri musicali più particolari, le analogie si moltiplicano e le utopie varesiane troveranno in Zappa singolari realizzazioni (in particolar modo intorno all’idea del ritmo e della sovrapposizione di tempi irrelati). mUSiCa e TeCnoLoGia – mUSiCa e SCienZa Un altro affascinante punto di contatto è rappresentato dal rapporto tra musica e scienza o tra musica e tecnologia. speciale — 6 novecento / parte prima UToPia e ProGeTTi inComPiUTi speciale E ancora, la dimensione utopica e l’urgenza di oltrepassare i limiti della tradizionale catena: idea-composizioneesecuzione-ascolto fu terreno condiviso dai due. Si pensi a Le citazioni sono tratte da: Frank Zappa, Peter Occhiogrosso: Autobiografia, Arcana, Roma 2003 Edgard Varèse: Il suono organizzato – Scritti sulla musica, Ricordi-Unicopli, Milano 1985 Za ppa Quasi tutte le mie composizioni odierne sono scritte con o suonate da una macchina, un computer che è uno strumento musicale chiamato SYNCLAVIER. […] Nel Synclavier è possibile inserire qualsiasi cosa che vi venga in mente di suonare o provare. […] Il compositore può presentare la propria idea nella sua forma più pura, permettendo al pubblico di ascoltare LA MUSICA invece dei problemi di ego di un gruppo di musicisti a cui non frega un cazzo della composizione. Espace di Varèse, grandioso progetto rimasto ad una fase di studio o l’abbozzo dell’opera L’Astronome in collaborazione con Antonin Artaud e da parte zappiana agli innumerevoli progetti di invenzioni, progetti commerciali o politici oltre naturalmente a quelli spettacolari come quel delirante Dio Fa proposto al Comune di Milano in occasione dei mondiali di calcio del 1990. È questo senso di incompiutezza, di apertura massima verso ogni possibile sviluppo di un’idea, di utopica attesa di nuove concretizzazioni che mi porta a considerare Edgard Varèse e Frank Zappa, fin troppo osservati esclusivamente nella loro individuale unicità di enfants terribles terribles, non solo come due tra i grandi compositori del Novecento ma come rarissimi inventori di possibilità. Quando i compositori ricominceranno a pensare al futuro? ◼ Fra nk In Varèse questa tematica diviene ben presto una frustrante separazione tra il tempo delle intuizioni e quello della tecnologia: molte opere rimasero incompiute ed altre attesero anni prima di trovare i mezzi tecnici adeguati a realizzarle. Sono certo che arriverà un giorno in cui il compositore dopo aver realizzato graficamente la propria partitura la vedrà trasferirsi automaticamente in una macchina che ne trasmetterà fedelmente all’ascoltatore il contenuto musicale. Queste ipotesi sulla futura possibilità di utilizzare «macchine» destinate alla produzione musicale ci conduce direttamente ad un preciso e sorprendente parallelo. All’inizio degli anni ’80, Zappa, già campione assoluto dell’utilizzo delle tecnologie di registrazione e di montaggio, scoprì e iniziò ad usare il «synclavier», macchina esattamente corrispondente alle speranze di Varese: Nelle strisce fotografiche, ripetute sequenzialmente, la cronologia iconologica e parziale del Novecento, prima parte. Monarchi, rivoluzionari, dittatori e presidenti. Nelle pagine pari, in sequenza: Vittorio Emanuele III di Savoia (1869 – 1947); Francisco Pancho Villa, pseudonimo di Doroteo Arango Arámbula (1878 – 1923) con Emiliano Zapata (1879 – 1919); Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria (1830 – 1916) ultimo imperatore d’Austria; Nicola II Romanov (1868 – 1918) ultimo imperatore di Russia; Nikolaj Lenin pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov (1870 – 1924); Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg (1847 – 1934) ultimo presidente del Reich; Aisin Gioro Pu Yi (1906 – 1967) ultimo imperatore della Cina; nelle pagine dispari, in sequenza: Chiang Kai-shek (1887 – 1975); Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883 – 1945); Adolf Hitler (1889 – 1945); Imperatore Showa nato Hirohito (1901 – 1989); Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938); Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948) ; Josif Vissarionovi� D�ugašvili detto Stalin (1878 – 1953) ; Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (1874 – 1965); Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945); Mao Zedong (1893 – 1976). Il secolo delle grandi conquiste. Nelle pagine pari, in sequenza: 1901 i fratelli Wright, Orville e Wilbur fanno volare il primo aereo; 1914 con due anni di anticipo sul previsto si conclude il taglio del canale di Panama; 1922 produzione industriale di tubi catodici (nella foto 1932: Allen B. Du Mont l’inventore della televisione come oggi la conosciamo); 1926 Robert Goddard lancia il primo razzo a propellente liquido; 1927 Charles A. Lindbergh sorvola l’Atlantico; 1931 s’inaugura l’Empire State Building, l’edificio più alto del mondo (fino al 1974); 1938 viene brevettato in Inghilterra il primo radar; nelle pagine dispari, in sequenza: 1939 i fisici tedeschi Otto Hahn, Lise Meitner and Fritz Strassman sperimentano in laboratorio la fissione nucleare; 1940 funziona il primo computer elettronico digitale, inventato (nel 1939) da John Vincent Atanasoff e Clifford Berry; 1942 attivato il Chicago Pile-1 primo reattore nucleare a fissione controllata ideato da Enrico Fermi (nel disegno a colori); 1943 per scoprire i codici segreti dei nazisti in Inghilterra funziona Colussus, il primo computer elettronico digitale programmabile; 1943 parte il primo programma sul computer ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) il primo computer elettronico digitale programmabile generico che può essere programmato per qualsiasi calcolo; nel dopoguerra inizia la corsa allo spazio: usando una V2 preda bellica negli Stati Uniti si lanciano nel 1947 i primi animali nello spazio sub-orbitale (moscerini della frutta, cui seguiranno le scimmie). Scienziati. Nelle pagine pari, in sequenza: 1907 Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970) logica; Sigmund Freud (1856 – 1939) psicologia; Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 – 1947) teoria dei quanti; Carl Gustav Jung (1875 – 1961) psicologia; Guglielmo Marconi (1874 - 1937) radio; Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857 – 1935) teoria del volo spaziale; Jules Henri Poincaré (1854 – 1912) matematica; William Bateson (1861 – 1926) genetica; Albert Einstein (1879 – 1955) teoria della relatività; Karl Landsteiner (1868 – 1943) gruppi sanguigni; nelle pagine dispari, in sequenza: Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887 – 1961) fisica; Thomas Hunt Morgan (1866 – 1945) correla i geni ai cromosomi; Ernest Rutherford (1871 – 1937) teoria orbitale dell’atomo, raggi X; Alfred Lothar Wegener (1880 – 1930) deriva dei continenti; Niels Henrik David Bohr (1885 – 1962) teoria quantistica dell’atomo; Sir Frederick Grant Banting (1891 – 1941) medicina, scoperta dell’insulina; Edwin Powell Hubble (1889 – 1953) astro- nomia, scopre altre galassie; Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976) fisica; Sir Alexander Fleming (1881 – 1955) medicina, penicillina; Alan Mathison Turing (1912 – 1954) matematica teoria dell’elaborazione; Enrico Fermi (1901 – 1954) fisica. Invenzioni per le masse. Nelle pagine pari, in sequenza: 1900 Kodak lancia sul mercato americano Brownie, fotocamera compatta per tutti a 1 dollaro. 1901 Victrola, il primo grammofono a dischi sul mercato; 1905 Walter Griffiths inventa l’aspirapolvere domestico; 1906 Lee DeForest inventa il triodo amplificatore termoionico e l’elettronica diventa tecnica comune; 1908 il Modello T di Henry Ford è l’automobile più venduta al mondo; 1910 Willis Carrier inventa il condizionatore d’aria; 1917 nasce la cerneria lampo; nelle pagine dispari, in sequenza: 1925 in Inghilterra John Logie Baird inventa la televisione (otticomeccanica); 1926 Don Juan è il primo film con colonna sonora, le folle applaudono; 1927 The jazz singer (il bianco pitturato Al Jolson) nel primo film parzialmente sonoro; 1928 Luci di New York primo film interamente sonoro; 1929 Su il sipario! primo film interamente sonoro interamente in technicolor; 1930 a Ringfield, in Massachesetts, nascono i cibi surgelati; 1930 in Inghilterra la BBC inizia le trasmissioni radiofoniche regolari quotidiane; 1939 la Wolkswagen costruisce l’automobile del popolo; 1940 il laboratori Bell costruiscono il primo CNC (Calcolatore a Numeri Complessi). Guerre, solo le due guerre mondiali: nelle pagine pari, 1914 – 1918 Prima guerra mondiale (Grande Guerra); 28 giugno 1914 lo studente nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip assassina l’erede al trono dell’Impero Austro-Ungarico, arciduca Francesco Ferdinando (e la moglie), il 28 luglio 1914 inizia il conflitto; si conclude l’11 novembre 1918. Da una parte gli Imperi Centrali (Austria, Germania, Ottomani) dall’altra Inghilterra, Francia, Russia Stati Uniti, e Italia. La guerra è di posizione e logoramento, in trincea (foto), condotta sul numero dei soldati mandati all’attacco. Impiego di rudimentali ma devastanti strumenti di sterminio di massa: gas, mitragliatrici, aerei, mine, sommergibili e generali inetti. Il 28 giugno 1919, con oltre 21 milioni di morti militari e civili, apparentemente soddisfatti, il primi ministri David Lloyd George (Inghilterra) Vittorio Emanuele Orlando (Italia), Georges Clemenceau (Francia) e il presidente Woodrow Wilson (Usa) firmano il Trattato di Versailles. Pesanti sanzioni per gli sconfitti; nelle pagine dispari: 1939 – 1945 Seconda guerra mondiale: il 1° settembre 1939, dopo prove generali in altre parti d’Europa (Sudeti, Austria) i nazisti invadono la Polonia (nella foto Benito Mussolini e Adolf Hitler): è la guerra lampo (blitzkrieg) (nella foto a colori l’invasione tedesca della Russia, 1942) meccanizzata, veloce, spietata. Galvanizzati dai successi nazisti, Italia e Giappone entrano in guerra a fianco della Germania (1940 e 1941, nella foto l’attacco nipponico a Pearl Harbour) è l’Asse d’Acciaio. Il conflitto si estende in tutto il mondo con rapide vittorie dell’Asse (nella foto, prigionieri inglesi a Dunkerque, Francia, 1940). Le azioni sono condotte non solo sui campi di battaglia ma sistematicamente contro le popolazioni, da tutte le parti in guerra. Stati Uniti, Inghilterra, Unione Sovietica (e Francia) ribaltano le sorti del conflitto (nelle foto: Iwo Jima, 1945; Berlino, 1945). Evoluzione tecnica del massacro: battaglie e bombardamenti aerei, razzi, sottomarini, armi automatiche, bombe incendiarie, radar, campi di sterminio, bomba atomica (nella foto; Nagasaki, 9 agosto 1945). Il 2 settembre 1945, con venti milioni di morti militari e quaranta di morti civili le potenze vincitrici disegnano un nuovo mondo e danno inizio alla Guerra Fredda (nella foto, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Josif Stalin a Yalta, 4 febbraio 1945). a cura di Luca Colferai
Scaricare