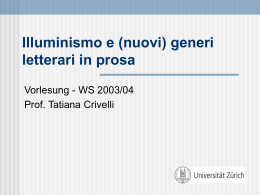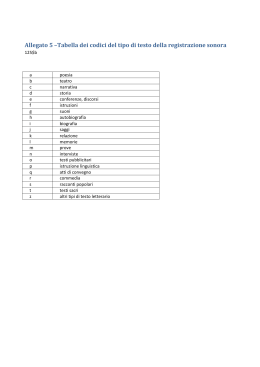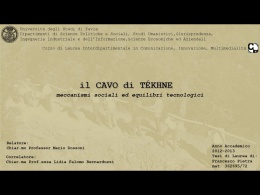MARZIANO GUGLIELMINETTI, Memoria e scrittura. L’autobiografia da Dante a Cellini, Torino, Einaudi, 1977 Marziano Guglielminetti (1937-2006) è stato docente di Letteratura italiana presso l’Università di Torino. Durante la sua lunga carriera di studi ha dedicato le proprie ricerche in particolare alla letteratura fra tardo Cinquecento e Seicento. Tra i suoi lavori sono da ricordare l’edizione dei Novellieri del Cinquecento per la collana «I classici Ricciardi» e di Viaggiatori del Seicento per la collana «Classici italiani» della Utet. In Memoria e scrittura, saggio lungo e talvolta molto complesso, egli sceglie di esulare dai secoli della letteratura a lui più cari per ricercare nel mare magnum della letteratura italiana medievale e rinascimentale i testi rappresentanti del lungo iter di formazione del genere dell’autobiografia, di cui – tesi sottesa ai primi quattro capitoli del libro – non esisteva coscienza almeno fino al XVI secolo. Nella ragionatissima Introduzione (pp. VII-XX) l’autore indica le linee metodologiche della sua ricerca, in parte esplicitamente mutuate dal lavoro di Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, dove lo studioso francese afferma che è possibile parlare di autobiografia solo quando l’identità del nome citato nel testo coincide con quella dell’autore. Data questa fondamentale premessa, che si rivelerà nel corso della trattazione il principale criterio di selezione adoperato da Guglielminetti per la scelta dei testi da includere, viene però mossa una critica allo stesso Lejeune, il quale vedeva solo nell’età moderna la nascita del genere autobiografico – che anzi egli considerava irradiante verso altri generi, come il saggio e l’autoritratto – escludendo in toto l’età medievale. Guglielminetti, al contrario, oppone a questa tesi l’idea che proprio durante la media aetas si stesse calcificando l’ossatura dell’autobiografia, processo che in questa sede tenta di indagare. Il primo capitolo Alle origini dell’autobiografia (pp. 3-41) presenta un testo che sarà più volte ripreso nel corso del saggio, le Confessioni di Sant’Agostino, considerate il punto di riferimento più saldo per gli scrittori dei secoli successivi che avrebbero voluto narrare di sé. Uno dei passi che Guglielminetti prende maggiormente in esame è l’incipit del libro X, subito successivo al racconto della morte della madre Monica. Il santo qui afferma che una sola è la via per la conoscenza di Dio: affidare attraverso la scrittura i propri ricordi alla memoria, unico strumento capace di sottrarre gli uomini alle debolezze della contingenza della vita materiale. In questo modo la misura del tempo diventa tutta interiore, subordinata all’esame della propria coscienza, dove non è la cronologia degli eventi a ordinare i propri ricordi, al contrario è l’animo umano che dilata o contrae gli eventi del proprio vissuto a seconda della profondità che essi hanno rivestito nella formazione della propria moralità. Sempre al mondo interiore, seppur in toni drasticamente diversi, si rivolgono i testi presi successivamente in esame, le due laude Omo, mittite a ppensare e O vita penosa, continua bataglia di Iacopone da Todi, entrambe modellate sullo schema esistenziale-ascetico ripreso dal libro biblico di Giobbe e dal De contemptu mundi di Innocenzo III. Iacopone, nel voler presentare le cause e le caratteristiche della propria tensione morale nei confronti del mondo esteriore, tenta una scrittura in prima persona, che Guglielminetti considera spontanea solo in minima parte. Tutti gli avvenimenti della sua vita sono infatti continuamente rapportati all’agiografia cristologica, mai per proporre una identificazione con le azioni compiute dal figlio di Dio, piuttosto per dimostrare di continuo la propria nullità di uomo nei confronti della divinità. Scrittura più schiettamente autobiografica è invece individuata nella Cronica di Salimbene de Adam, composta in latino fra il 1280 e il 1290. Ritroviamo nel testo una forte concentrazione sull’io dell’autore, ravvisata da Guglielminetti in almeno due elementi, l’uso della prima persona singolare e non plurale, con il conseguente distacco dalla tradizione latina del pluralis maiestatis, e la scelta di rivolgere il racconto ad un lettore ideale che immagina membro della propria famiglia. La narrazione delle vicende accorse collettivamente a sé e ai propri parenti occupa la prima parte del testo; al contrario nella seconda l’autore concentra maggiormente l’attenzione sulla propria persona, narrando l’origine del suo nome, gli sforzi del padre per distoglierlo dalla scelta di diventare frate, il colloquio chiarificatore con il genitore ed infine alcuni episodi avvenuti nel convento. Il tono autobiografico muta però nella conclusione della Cronica, dove Salimbene si sposta sempre più verso il genere dell’agiografia, trasformando il racconto delle proprie vicende esistenziali in un tipico fioretto medievale. Il secondo capitolo è interamente dedicato a Dante Alighieri (Dante e il recupero del «parlare di se medesimo», pp. 42-100). L’incipit della Vita nova, dove Dante definisce il libello «libro de la mia memoria», svela la cosciente ripresa del concetto agostiniano di memoria, interpretato da Dante come l’affidamento alla scrittura di pochi e funzionali eventi, allo scopo di ricostruire la propria storia d’amore giovanile. Naturalmente la memoria e la scrittura rivestono due ruoli complementari: compito della memoria è la selezione dei ricordi, poi ripensati e narrati, grazie alla capacità della scrittura, rivestiti degli schemi descrittivi biblici. Emblematica in tal senso l’apparizione di Amore che afferma di essere ormai il padrone della persona stessa dell’innamorato («Ego dominum tuum» dice Amore rivolgendosi a Dante), episodio evidentemente modellato sui racconti delle visioni trascendenti contenuti nella Bibbia e nelle agiografie. Gli eventi narrati, quindi, non rappresentano le tappe di una storia d’amore vissuta o da viversi, sono invece corollari di una epifania interiore, che non riesce completamente a compiersi fino all’ascensione finale, momento in cui Dante è condotto da Beatrice alla visione di Dio. Il modello agostiniano fu ugualmente seguito da Francesco Petrarca, di cui Guglielminetti si occupa nel terzo capitolo (Petrarca, dall’autoconoscenza al racconto di sé, pp. 101-158). La figura di Agostino è interpretata da Petrarca in senso notevolmente differente rispetto a Dante: se quest’ultimo vedeva nel santo un punto di riferimento moralistico-didattico, Petrarca privilegiava l’aspetto ascetico-penitenziale presente nelle opere agostiniane, specchio del tormento interiore vissuto da Agostino, che sentiva come una figura a sé vicina, ugualmente provato nel proprio animo a causa di un dissidio tra beni terreni e beni spirituali che mai il poeta di Laura riuscirà a risolvere. Nei passi petrarcheschi in cui Agostino è citato esplicitamente, come la notissima epistola sull’ascesa al Monte Ventoso (Fam. IV 1), Guglielminetti nota però che la narrazione non sfocia mai in autobiografia: Petrarca, pur prendendo le mosse da un personale esame interiore, non approda a un vero racconto di sé, quanto ad una sublimazione del modello agostiniano e degli eventi della vita del santo che sente di rivivere (sul monte Petrarca era stato indotto alla riflessione a partire dalla lettura bibliomantica delle Confessioni, come Agostino sulla spiaggia aveva sfogliato la Vita Antonii di Atanasio). Neanche nel Secretum lo studioso intravede tracce di autobiografia: il dialogo con Agostino diventa un dibattito intellettuale, che si mantiene sempre nei limiti di una discussione colta, mai davvero sincera e scevra da reminiscenze letterarie. Più proficua la ricerca di tracce di autobiografia nelle postille al Vat. lat. 3196, il codice degli abbozzi dei Rerum vulgarium fragmenta, continuamente annotato dal Petrarca lungo l’amplissimo arco di tempo della stesura e sistemazione dei suoi componimenti lirici, nella convinzione che ogni fatto biografico fosse importante per comprendere ciascuna poesia, addirittura il momento della giornata in cui le componeva. Un solo luogo è invece latore di riferimenti esplicitamente autobiografici di Giovanni Boccaccio (cap. IV, L’apologia del letterato. Boccaccio e gli umanisti, pp. 159-225), il proemio al XV libro delle Genealogiae deorum gentilium. In questa sede il certaldese si difende dalle accuse di aver scritto un compendio di poesia per soli poeti, allargando poi il campo delle argomentazioni in propria difesa ricordando il periodo della vita in cui si affacciò per la prima volta all’attività poetica, vantandosi poi di aver saputo unire nella propria opera la cultura latina e medievale. Egli è inoltre il primo a segnare un netto distacco dalla tradizione religiosa patristica, tanto da ammettere nel medesimo luogo di aver dedicato molto poco tempo alla lettura dei sacra volumina. Particolarmente originale nel panorama umanistico è il racconto di sé che Pio II opera nei Commentarii rerum memorabilium, composti tra il 1462 e il 1463. A rendere ingegnosa l’opera è il ricorso ad un modello mai prima considerato nella narrazione, i commentari di Giulio Cesare, scelti dal Piccolomini per il loro carattere concreto e diretto. Nota la descrizione del conclave in cui fu eletto papa, a scapito del cardinale francese Rouen. Pio II, sulla scorta della contrapposizione dei personaggi di Cesare e Pompeo presente nel De bello civili, costruisce due figure antitetiche, l’una, se stesso, incarnazione della dignità e della vera grandezza tipica di un uomo che dalla letteratura ha ricavato una formazione etica inattaccabile, la seconda, il prelato francese suo avversario, emblema della rozzezza e della trivialità. Una voce più schiettamente autobiografica si ritrova nelle Satire di Ariosto, dove il poeta ferrarese esprime tutto il suo rammarico per l’impossibilità di vivere come la precedente generazione di umanisti, stimati dai signori presso cui operavano e spesso figure centrali nelle missioni diplomatiche. Gli intellettuali della sua epoca, invece, sono descritti come degenerazione dei veri letterati – nell’Orlando furioso li definirà cicale – solo alla ricerca della protezione dei principi italiani. Il suo ideale di vita è opposto: nella prima e nella terza satira, ad esempio, descrive orazianamente la quiete letteraria che gli piacerebbe concretizzare, una vita in campagna, seppur frugale, dedicata esclusivamente alla poesia. Da segnalare anche la satira quarta, dove ricorda i luoghi ameni della propria infanzia vissuta nei dintorni di Reggio. Ad un genere paraletterario è dedicato il cap. V, I ricordi degli scrittori mercanti e politici (pp. 226-291) in cui spiccano le analisi del Libro segreto di Goro Dati e dei Ricordi di Lorenzo il Magnifico. Il primo ci offre uno spaccato della vita di un mercante fiorentino del XV secolo, in un’opera che non mira ad essere un racconto autobiografico, quanto un taccuino di appunti, strumento essenziale per la classe mercantile dell’epoca. Nel libretto Goro Dati segna notazioni anagrafiche, ma anche proponimenti edificanti per il futuro: visitare i luoghi santi, mantenersi in castità il venerdì, compiere opere di pietà. Al medesimo genere di libro di mercanti si ispirano i Ricordi di Lorenzo de’ Medici, dove, però, alla ragion di mercatura è ovviamente sostituita la ragion di stato come criterio di analisi del reale e della propria esistenza. L’evento descritto con particolare partecipazione emotiva è rappresentato dalla morte e dai funerali di Cosimo, suo nonno, che meritò gli onori di tutti gli altri signori d’Italia, insieme al re di Francia. Lorenzo descrive il suo antenato come un nuovo Augusto, pater patriae, capostipite di una nuova dinastia principesca. Nell’ultimo capitolo, La Vita di Cellini e le memorie degli artisti (pp. 292-386) viene posta l’attenzione su quella che Guglielminetti considera la vera prima autobiografia della nostra letteratura, la Vita di Benvenuto Cellini. Lo scarto rispetto al passato consiste nella considerazione e nella descrizione che l’autore fornisce di se stesso non più solo come artista, ma come uomo a tutto tondo, immerso nella realtà contingente nella quale vive ma contemporaneamente capace di operare riflessioni morali valide al di là della propria vicenda e del proprio tempo. Questa caratteristica della scrittura del Cellini si riscontra già nei Sonetti, composti in carcere nel 1456, dove era stato rinchiuso per accuse di sodomia. Le riflessioni dell’artista comprendono il proprio rapporto con Dio, il ruolo della fortuna nell’esistenza umana, affrontate sempre con un tono mai cronachistico o anagrafico, ma sempre tendente al sublime. In modo specifico nella Vita l’aspetto religioso e morale innerva ogni evento: Benvenuto si presenta come il nuovo Giovanni Battista nel racconto della propria nascita, a cui prendono parte molte persone, tra cui i suoi nonni presenti in casa e descritti con un atteggiamento da patriarchi biblici, intenti ad aiutare la figlia Elisabetta – non a caso omonima della mamma del Battista – durante il parto, poiché reduce da vari aborti. Il nonno di Benvenuto è ancora protagonista di un altro episodio della sua infanzia, quando vede il giovane nipote uccidere un serpente che aveva tra le mani, anch’esso prodigio interpretato alla luce del Vangelo di Luca, dove si narra che Gesù aveva dato il potere ai discepoli di uccidere anche i serpenti (Luca 10.19). A partire dal racconto dell’età adulta la Vita si lega maggiormente agli eventi storici che l’artista visse alla corte di papa Clemente VII, presso cui era orafo ufficiale. Elogia le proprie opere artistiche di pregio, dimostrando coscienza della netta superiorità della propria professionalità rispetto a molti colleghi. Il conflitto fra il papa Clemente VII e Carlo V influì però anche sulla sua carriera, poiché alla corte del papa fu reimpiegato come bombardiere. Partendo da un tono fondamentalmente escatologico, la Vita passa dunque ad un racconto sempre più lineare, attraverso cui scopriamo raffinati ritratti dei personaggi storici del tempo che Benvenuto conobbe personalmente, tra cui il re Francesco I di Francia. Mongelli Michele
Scaricare