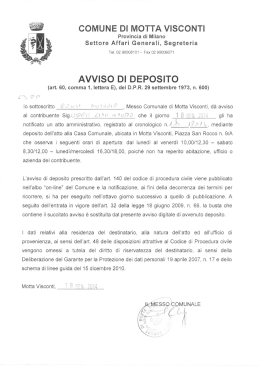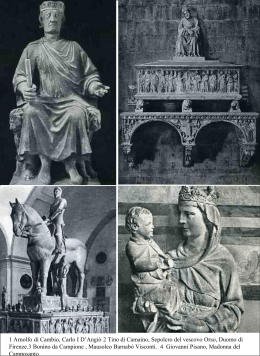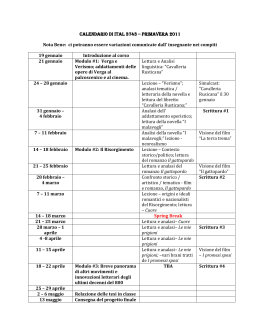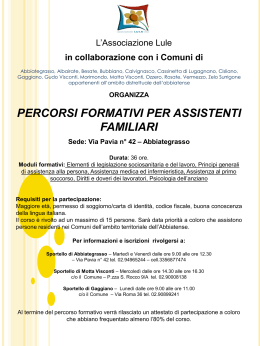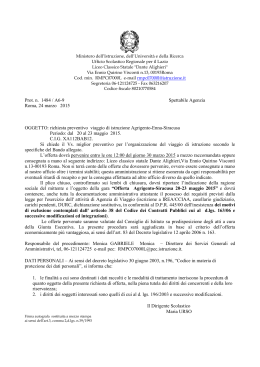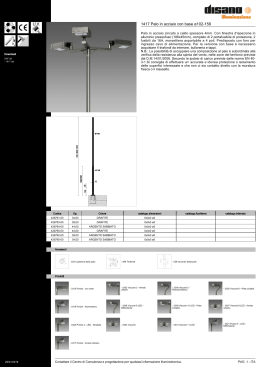Cineteca di Bologna Circuito Cinema presentano Il Cinema Ritrovato. Al cinema Classici restaurati in prima visione dal 28 ottobre Il Gattopardo di Luchino Visconti versione restaurata Italia-Francia, 1963 durata: 185’ Soggetto: dal romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Sceneggiatura: Luchino Visconti, Suso Cecchi d’Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli Fotografia: Giuseppe Rotunno Montaggio: Mario Serandrei Musica: Nino Rota Interpreti: Burt Lancaster (Don Fabrizio, Principe di Salina), Alain Delon (Tancredi Falconeri, nipote del Principe), Claudia Cardinale (Angelica Sedara), Romolo Valli (padre Pirrone), Paolo Stoppa (don Calogero Sedara), Serge Reggiani (don Ciccio Tumeo), Rina Morelli (Maria Stella, moglie del Principe), Lucilla Morlacchi (Concetta), Leslie French (Chevalley), Pierre Clementi (Francesco Paolo), Ivo Garrani (colonnello Pallavicino), Giuliano Gemma (generale garibaldino), Mario Girotti (conte Cavriaghi), Anna Maria Bottini (la governante, M.lle Dombreuil), Lola Braccini (donna Margherita), Olimpia Cavalli (Mariannina), Ottavia Piccolo (Caterina) Restauro promosso da Cineteca di Bologna, Titanus, The Film Foundation, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux, Twentieth Century Fox e CSC-Cineteca Nazionale, con il sostegno di Gucci e The Film Foundation, realizzato al laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2010. Il film è preceduto da I due Gattopardi di Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice (Italia, 2013) 13’ Il Cinema Ritrovato. Al cinema settembre 2013 – giugno 2014 ogni lunedì e martedì del mese trenta sale in tutta Italia Ufficio stampa Cineteca di Bologna Materiali stampa Andrea Ravagnan www.cinetecadibologna.it/areastampa (+39) 0512194833 www.ilcinemaritrovato.it (+39) 3358300839 [email protected] I due Gattopardi diretto da Alberto Anile scritto da Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice Italia, 2013 durata: 13’ Il nuovo Gattopardo è preceduto dal documentario I due Gattopardi. Il filmato ripercorre le complesse vicende che portarono alla realizzazione del capolavoro di Luchino Visconti a partire dalle traversie subite dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uscito postumo dopo il rifiuto di due grandi editori. Nel raffronto fra libro e film, I due Gattopardi racconta la tempesta di critiche che il romanzo suscitò, l’attenzione del Partito Comunista per la trasposizione in pellicola, il lungo e difficile lavoro di scrittura prima di arrivare a una sceneggiatura che soddisfacesse le diverse esigenze artistiche, ideologiche e produttive, le magnifiche infedeltà a cui Visconti piegò il romanzo di Lampedusa. Parte sostanziale del documentario sono le scene inedite, ritrovate da Anile e Giannice, tagliate da Visconti dopo alcuni mesi di regolare distribuzione in sala e da allora dimenticate e mai più viste. Il documentario è stato realizzato da Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice, giornalisti e scrittori, autori del libro, Operazione Gattopardo – Come Luchino Visconti trasformò un romanzo di “destra” in un successo di “sinistra” (Le Mani, 2013, premio Efebo/SNGCI come miglior libro di cinema del 2013). I due Gattopardi accompagnerà la versione restaurata del film in tutte le sale. Vivo con questo film ogni giorno della mia vita. Martin Scorsese Il romanzo Dopo essere stato rifiutato da numerosi editori, il romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) fu pubblicato postumo grazie a Giorgio Bassani presso Feltrinelli nel 1958 (l’anno successivo vinse il Premio Strega). Il libro fu meditato a lungo dall’autore, un aristocratico siciliano che lo scrisse fra il 1954 e il 1957, fino ai suoi ultimi giorni. Ambientato in Sicilia ai tempi dello sbarco di Garibaldi a Marsala, il romanzo era imperniato sul bisnonno paterno di Lampedusa e scandito in episodi dotati ciascuno di una certa autonomia. “Lo straordinario interesse del romanzo non sta tanto nella trama, quanto piuttosto nel ricco e sottile gioco della complicata realtà interiore del protagonista che nell’arte di Lampedusa trova una limpida e balenante rappresentazione. Don Fabrizio, singolare temperamento, nel quale l’orgoglio e l’intellettualismo ereditati dalla madre si scontrano perpetuamente con la sensualità e la fiacchezza ricevute in eredità dal padre, assiste inerte alla rovina del proprio ceto e al sorgere di una nuova classe sociale e, quel che è più, allo sfaldamento del suo patrimonio a vantaggio di quel Calogero Sedara, contadino senza scrupoli divenuto milionario, e, in seguito, senatore, la cui bellissima figlia Angelica, alle ricchezze paterne, aggiunge il titolo di principessa per aver sposato il nobile e spiantato Tancredi Falconeri, nipote di Don Fabrizio. La coerenza fantastica del romanzo va ricercata nel motivo lirico della morte, o meglio, nel desolato motivo d’origine esistenziale dell’essere per la morte. Dalla coscienza di tale condizione umana scaturisce l’immobile scetticismo del protagonista” (Furio Felcini). I primi progetti sul film Il produttore Goffredo Lombardo, patron della Titanus, acquistò i diritti del romanzo nel novembre 1958, quando Il Gattopardo stava riscuotendo un grande successo editoriale. La regia del progetto cinematografico viene affidata inizialmente a Mario Soldati, che, nonostante fosse entusiasta del libro, decise di rinunciarvi perché temeva di non conoscere abbastanza a fondo l’universo siciliano. La Titanus quindi siglò un contratto con Ettore Giannini, l’autore del bellissimo e sfortunato Carosello napoletano, ma questi fu successivamente estromesso. La scelta di Visconti Alla fine del 1960 il progetto passò a Luchino Visconti, reduce dal primo, autentico successo di pubblico della sua carriera di regista cinematografico, Rocco e i suoi fratelli (anch’esso prodotto e distribuito dalla Titanus). Oltre che dalla lettura del romanzo, Visconti era rimasto colpito anche dalla visione di un documentario televisivo di Ugo Gregoretti, La Sicilia del Gattopardo (1960), girato proprio nei luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e di Don Fabrizio Salina. Così si espresse il regista sulla propria visione del romanzo: “Nel Gattopardo si racconta la storia di un contratto matrimoniale. La bellezza di Angelica data in pasto alla voracità di Tancredi. Ma Angelica non è soltanto bella; ella sa bene di che pasta è fatto un tale contratto di matrimonio, e l’accetta, anche se quello che a prima vista sembra dominare è soltanto un purissimo sentimento d’amore. E anche Tancredi non è soltanto cinico e vorace: riverberano in lui, già all’inizio della deformazione e della corruzione, quei lumi di civiltà, di nobiltà e di virilità che l’immobilità feudale ha cristallizzato e cicatrizzato senza speranza di futuro nella persona del principe Fabrizio. Dietro il contratto matrimoniale di Angelica e Tancredi si aprono altre prospettive: quella dello Stato Piemontese, che nella persona di Chevalley viene quasi a far da notaio e a mettere il sigillo al contratto; quella della nuova borghesia terriera, che nella persona di don Calogero Sedara richiama il duplice conflitto dei sentimenti e degli interessi quale Verga lo delineò in modo memorabile in Mastro Don Gesualdo, ch’io considero il più autentico progenitore del sindaco di Donnafugata; quello dei contadini, oscuri protagonisti subalterni e quasi senza volto, ma non per tanto meno presenti; quella della sopravvivenza contaminata, anacronistica, ma cionondimeno ancora operante, delle strutture e del fasto feudali, colti a mezzo tra la stagione della loro inarrestabile decadenza e l’intromissione nel loro tessuto di corpi estranei (don Calogero, gli ufficiali piemontesi, gli stessi garibaldini) che, ieri respinti, vengono oggi sopportati e assimilati. Di questa impostazione del romanzo di Lampedusa non abbiamo sottaciuto un solo momento o aspetto o dialogo decisivo; in più abbiamo dato corpo ad alcuni motivi che nel romanzo sono presenti in accenni informativi. Prima di tutto la rivoluzione palermitana, le battaglie garibaldine, il linciaggio degli sbirri borbonici: tutto questo era necessario per spiegare la potenza dirompente della congiuntura storica e il rischio reale che Tancredi accetta di correre, per inseguire il suo deliberato disegno di essere alla testa dei fatti per dominare i fatti stessi. In secondo luogo il rapporto tra don Calogero e i contadini (cui più volte si accenna nei dialoghi del libro), per rendere evidente una delle componenti del prezzo e della posta in gioco nel contratto di matrimonio fra Tancredi e Angelica. In terzo luogo le conseguenze della disperata impresa di Aspromonte. Alcuni disertori dell’esercito regio che nel 1862 obbedirono all’appello di Garibaldi per seguirlo ad Aspromonte furono fucilati come disertori. Naturalmente non ci siamo presi la libertà di introdurre questo episodio nel film; ma è una realtà che echeggia nel ballo, e della quale Fabrizio è ben consapevole. Alla fine della festa infatti, come in un commiato solenne e amaro allo stesso tempo, le carrozze degli invitati tornano alle loro case alle prime luci dell’alba, mentre il principe Fabrizio si avvia solo per le vie della vecchia città, in un tormentoso e struggente colloquio con la luce della stessa mattutina... Se qualcuno dicesse che in Lampedusa i modi particolari di affrontare i temi della vita sociale e dell’esistenza che furono del realismo verghiano e della ‘memoria’ di Proust trovano un loro punto di incontro e di sutura, mi dichiarerei d’accordo con lui. È sotto questa suggestione che ho riletto il romanzo le mille volte, e che ho realizzato il film. Sarebbe la mia ambizione più sentita quella di aver fatto ricordare in Tancredi e Angelica la notte del ballo in casa Ponteleone, Odette e Swann, e in don Calogero Sedàra nei suoi rapporti coi contadini e nella notte del Plebiscito, Mastro don Gesualdo. E in tutta la pesante coltre funebre che grava sui personaggi del film, sin da quando la lapide del “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” è stata dettata, lo stesso senso di morte e di amore-odio verso un mondo destinato a perire tra splendori abbaglianti che Lampedusa ha certo assimilato, sia dalla immortale intuizione verghiana del fato dei siciliani, sia delle luci e delle ombre della Recherche du temps perdu. Del resto, il tema centrale del Gattopardo – “perché tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi” – non mi ha interessato soltanto sotto la critica spietata al trasformismo che pesa come una cappa di piombo sul nostro paese e che gli ha impedito di cambiare davvero fino ad oggi, ma sotto l’aspetto più universale, e purtroppo attualissimo, di piegare la spinta del mondo verso il nuovo alle regole del vecchio, facendo ambiguamente e ipocritamente sovraneggiare quelle da queste” (Antonello Trombadori, Dialogo con Visconti, in Il film ‘Il Gattopardo’ e la regia di Luchino Visconti, a cura di Suso Cecchi d’Amico, Bologna, Cappelli, 1963, pp. 28-30). La scelta di Burt Lancaster Visconti lavorò quindi all’adattamento con i suoi collaboratori di fiducia, Suso Cecchi d’Amico e Enrico Medioli, cui si unirono due sceneggiatori della Titanus, Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa (che avevano già partecipato a Rocco e i suoi fratelli). I problemi con la produzione insorsero quando fu stilato il preventivo che raggiunse una cifra enorme. La formula della coproduzione con la Francia (già adottata per Rocco) stavolta non era sufficiente e Lombardo si orientò a cercare interlocutori statunitensi. Fu così che si profilò l’esigenza di affidare la parte del Principe ad un grande divo americano e fu lo stesso produttore a pensare a Burt Lancaster. Visconti, che avrebbe voluto Laurence Olivier, inizialmente rifiutò questa scelta ma in seguito cambiò idea, tant’è vero che avrebbe chiamato nuovamente Lancaster ad interpretare il ruolo del protagonista in Gruppo di famiglia in un interno (1974). I cantieri per le location Nell’autunno del 1961 il regista effettuò i sopralluoghi in Sicilia, con lo scenografo Mario Garbuglia e l’organizzatore generale Pietro Notarianni, accompagnati da Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa. Il 14 maggio 1962 iniziarono le riprese. “Nelle settimane che precedettero immediatamente l’inizio delle riprese, Garbuglia si trovò a dirigere contemporaneamente cinque cantieri diversi per le costruzioni delle scene dell’ingresso dei garibaldini a Palermo, mentre allo stesso tempo si lavorava freneticamente alla casa del principe a Boscogrande, alla sua residenza estiva di Donnafugata, a Ciminna, e alla costruzione dell’osservatorio, su di una terrazza con vista panoramica su Palermo. Le centinaia di saracinesche da sostituire con le persiane, la pavimentazione di asfalto da occultare con la terra battuta, i fili della luce e del telefono e le antenne della televisione da eliminare in quartieri di Palermo, non rappresentarono che le difficoltà più risibili. Le costruzioni di Palermo, fra cui quella della Porta attraverso la quale fanno irruzione le Camicie Rosse, furono realizzate in quindici giorni. In ventiquattro giorni vennero portati a termine i lavori alla villa Boscogrande: e per i restauri di questa villa si era dovuto impiantare un vero e proprio laboratorio di falegnameria, e far venire da Roma un esercito di stuccatori e decoratori. Infatti tutti gli infissi, i pavimenti, i soffitti furono rimessi a nuovo; la facciata venne completamente restaurata, si ridipinsero i muri, si affrescarono e tappezzarono le pareti. Una ventina di pittori racimolati fra Palermo e Roma dipinsero l’affresco descritto nel libro sul soffitto del salone centrale, portando a termine l’opera (duecento metri quadrati) nel tempo record di quindici giorni”. «Ma questo è niente in confronto a quello che abbiamo fatto a Ciminna», prosegue Garbuglia. «Il paese era stato scelto perché la sua piazza, con la chiesa in fondo, corrispondeva “quasi” in tutto a quella dell’immaginaria Donnafugata, quel “quasi” sta per l’assenza di un piccolo particolare: mancava infatti il palazzo del principe di Salina. E il palazzo l’abbiamo fatto noi». A un metro di distanza dagli edifici più o meno moderni che sorgono di fianco alla chiesa fu innalzata la facciata del palazzo principesco, secondo il progetto di Garbuglia. Ci vollero quarantacinque giorni di lavoro, in mezzo a difficoltà di ogni genere, prima fra tutte la mancanza di materiali. Si dovettero trasportare a Ciminna chilometri di tubo Innocenti, e colossali carichi di gesso dalla lontana Messina; perché il gesso era indispensabile per i getti dei modelli, e quello locale si rivelò restio a solidificare. Garbuglia era andato in Sicilia con quattro capisquadra e sei operai specializzati; gli altri operai furono reclutati fra i contadini, e bisognò insegnar loro i rudimenti del mestiere; non è escluso che in seguito si siano rivelati utili per loro. Anche la piazza di Ciminna andava rifatta; bisognava cioè liberarla dall’asfalto moderno e riportarla a una pavimentazione più primitiva. Il lavoro degli arredatori incominciò molti mesi prima dell’inizio del film, e consistette in un primo tempo in un accurato lavoro di ricerca di mobili, quadri, tappezzerie dell’epoca. Il risultato di questa indagine su vasta scala venne esposto in numerosissimi album di fotografie, che erano via via sottoposti al regista per una prima scelta. Una volta scelti gli ambienti in cui si dovevano girare le scene, si studiava la disposizione dei mobili, e si preparavano le tavole su cui venivano appuntati i campioni di stoffa selezionati per le tende e la tappezzeria, quelli della moquettes, ecc. Le tavole dei campioni venivano ancora sottoposte e discusse con il regista prima di passare alla realizzazione. Tutta l’isola venne perlustrata per requisire il maggior numero possibile di carrozze d’epoca, alcune delle quali furono trovate ancora in funzione presso delle imprese di pompe funebri, altre nelle stalle delle antiche ville o nei paesi dov’erano adibite agli usi più impensati. Tutte queste carrozze dovettero naturalmente essere restaurate, imbottite e riverniciate. Sugli chassis vennero dipinti gli stemmi di famiglia. Per tutto quello che riguarda l’arredamento fu prezioso l’aiuto della famiglia Lanza di Mazzarino, uno dei cui esponenti, Gioacchino, è il figlio adottivo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, duca di Palma, ed erede del titolo del romanziere. Dalle favolose collezioni di palazzo Mazzarino proviene appunto una grandissima parte dei mobili, dei letti, degli arazzi, dei lampadari, delle moquettes che arredano gli ambienti dove sono state girate le scene del film; e molti dei servizi di piatti, posate, cristallerie che rifulgono nella scena del ballo. Gioacchino Lanza di Mazzarino fu un valido collaboratore degli arredamenti: esperto conoscitore della materia, egli rappresentò una guida ideale per la ricostruzione della Sicilia scomparsa. Come abbiamo detto, tutto il film venne girato in Sicilia, ad eccezione però delle scene dell’interno del palazzo di Donnafugata, che furono ricostruite nelle sale di palazzo Chigi all’Ariccia” (Tommaso M. Cima, La realizzazione in Il film ‘Il Gattopardo’ e la regia di Luchino Visconti, a cura di Suso Cecchi d’Amico, Cappelli Editore, Rocca San Casciano 1963, pp. 158ss.). Le riprese Le riprese ebbero luogo solo in tre dei quattro set che erano stati predisposti: “In piazza San Giovanni Decollato (quattro giorni di riprese: la fucilazione dei picciotti e la reazione delle donne scatenate); in Piazza della Vittoria allo Spasimo (quattro giorni di riprese: la carica della cavalleria borbonica); in piazza Sant’Euno (due giorni di riprese), dove fu sostituita l’antica porta d’accesso alla città attraverso la quale fanno irruzione i garibaldini” (Caterina d’Amico, La bottega del Gattopardo, in Il Gattopardo, a cura di Lino Miccichè, Electa Napoli – Centro Sperimentale di Cinematografia, Napoli 1996, p. 270). La sequenza della presa di Palermo fu girata in dieci giorni, quindi fu realizzata la scena iniziale del film, la recita del Rosario, “ambientando” Villa Salina nella villa Boscogrande, alle porte di Palermo. Furono necessari ventiquattro giorni di lavoro per rifare pareti, pavimenti, infissi, soffitti, stucchi esterni e interni, decorazioni e affreschi mentre la facciata venne ripristinata. Gli arredatori erano due debuttanti, Giorgio Pes e la principessa Laudomia Hercolani del Drago. Alla fine di giugno, le riprese si spostarono a Ciminna che, come narrato da Garbuglia, “diventò” la Donnafugata del romanzo, nome immaginario dietro cui si cela Palma di Montechiaro. La celebre sequenza del ballo fu girata, di notte, a Palazzo Gangi di Palermo, che era in buono stato di conservazione e richiese solo pochi interventi scenografici. “Visconti e Rotunno [direttore della fotografia del film] cercarono di ricreare la luce delle candele. Si cercò di simulare con poca illuminazione artificiale e migliaia di candele quella che doveva essere stata un’illuminazione interamente naturale” (Caterina d’Amico, La bottega del Gattopardo, op. cit.). I costumi Per quanto riguarda i costumi, Piero Tosi, uno dei più grandi collaboratori di Visconti, aveva iniziato il lavoro di documentazione fin dall’inverno del 1961. Tosi racconta: “Per le divise borboniche e quelle del raffazzonato esercito dei Mille, mi ero ferreamente documentato al Museo Risorgimentale di Palermo, che conservava anche un pantalone azzurro di Garibaldi: tale e quale nel taglio, a un jeans d’oggi. Le camicie rosse nelle bacheche di quel museo: che poesia di taschini, di asole, di centine, di colletti... Mi accorsi che avevano una poesia del fatto in casa, la perfezione amorevole dell’ago e del filo familiari. I Mille erano volontari. Ognuno arrivava con la sua uniforme tagliata e cucita dalle mamme, dalle nonne, dalle fidanzate. Non c’era una camicia rossa uguale all’altra nella truppa di Garibaldi, non c’era un pantalone uguale all’altro. E non dovevano esserci camicie e pantaloni in serie nel film. Quando si legge un romanzo, una sceneggiatura, la nostra personale fantasia trova sempre qualcos’altro fra le righe, negli ‘spazi’ della narrazione. Io, fra quei paesani dai modesti panni, dagli scuri fustagni, immaginai una ragazza vestita di bianco. Senza sapere chi l’avrebbe indossato, curai in modo particolare quell’abito, campionando stoffe, torturando la sartoria e Tirelli perché quel bianco lo volevo di un certo tipo, un bianco per un abito borghese non troppo elegante. Lo feci di étamine bianco grezzo, con un’applicazione di un soutache a disegno geometrico, guarnizione tipica del Secondo Impero. Il tormentone fu l’abito di Claudia Cardinale. Nel romanzo, Tomasi la veste di rosa, con i guanti lunghi. Tutto sbagliato per quel che riguarda la storia del costume. Oltretutto, Claudia, in rosa, sembrava proprio una bambola, anche se non era affatto grassa. Era la fotografia a dilatarla, a renderla più rotonda” (Piero Tosi. Costumi e scenografie, a cura di Caterina d’Amico de Carvalho e Guido Vergani, Milano, Leonardo Arte, 1997, pp. 46-47). “L’assurdo dell’assurdo” Goffredo Lombardo racconta: “Lavorare con Visconti significava avere completa fiducia in lui – come del resto non si poteva non avere – e disponibilità a tutto quello che voleva perché tanto non c’era niente da fare... Prendiamo Il Gattopardo, uno dei tanti overbudget della Titanus: questo non dipese da Il Gattopardo in quanto tale ma dal fatto che Visconti, innamoratosi di questo film, volle l’assurdo dell’assurdo. Girando in Sicilia, e non dico sulle Alpi ma in Sicilia, pretese che gli arrivassero con l’aereo da San Remo quintali e quintali di fiori freschi ogni giorno per abbellire determinate scene. In quella famosa del ballo volle tutti i numerosi lampadari della sala illuminati con le candele vere. Naturalmente queste candele si squagliavano e di conseguenza, oltre al trambusto iniziale per accenderle, c’era quella di interrompere la lavorazione ogni ora, prendere di nuovo le scale di legno, cambiare le candele, a centinaia, e riaccenderle. Sempre nella scena del ballo, tutti gli uomini portavano i guanti bianchi. Dato il caldo e l’inevitabile bagno di sudore i guanti dopo alcune ore si ombravano. Nessuno lo avrebbe notato e tanto meno la macchina da presa, ma Visconti sì, e pretese che impiantassimo sul luogo una lavanderia con una cinquantina di donne addette a lavarli perché non poteva girare se i guanti non erano proprio immacolati! E questo solo per citare qualche esempio, tanto per far capire quanto la lavorazione continuò a dilatarsi oltre il previsto. Insomma con il film in costume avemmo un sacco di problemi con Visconti – forse anche perché l’ambientazione aristocratica lo faceva tornare alle sue origini, o forse più semplicemente perché era un perfezionista con tutte le fisime dei perfezionisti – mentre non ne avemmo alcuno per un film moderno come Rocco, che girò con delle esigenze e con un ritmo normali, anche se non certo in economia” (Goffredo Lombardo, in L’avventurosa storia del cinema italiano – 1960-1969, a cura di Franca Faldini e Goffredo Fofi, Milano, Feltrinelli, 1981, p. 257). La musica Per la musica, come già aveva fatto per Rocco e i suoi fratelli, Visconti scelse Nino Rota: “Nel caso del Gattopardo, il regista non ha chiesto a Rota una musica di commento, una musica “cinematografica”, ma una sinfonia originale che contenesse i temi principali del film. Rota avrebbe dovuto comporre, nelle intenzioni di Visconti, una Sinfonia del Gattopardo, senza pensare al film, alle scene, all’adattamento. Composta la sinfonia, sarebbe stata adeguata successivamente al film, così come era avvenuto a proposito dell’adattamento della Settima di Bruckner per Senso. Questa sinfonia, comunque, non “usciva”. “Un giorno – ha raccontato Rota – ci siamo messi in casa di Luchino a cercare tra le mie passate composizioni e tra i miei temi. Luchino mi diceva anche dei temi che si avvicinavano alla sua idea. Mi ricordo che ho suonato dei brani del Faust di Gounod, dei temi di Massenet, dei temi di Wagner. Ad un certo punto, distrattamente, per associazioni di idee, ho cominciato a suonare – come se fosse un brano di altri compositori – l’Adagio, il terzo tempo di una sinfonia che avevo scritto nel 194647. Visconti ne fu entusiasta e disse che quella era la musica de Il Gattopardo. Non solo. Dopo che gli feci ascoltare il quarto tempo, Allegro molto agitato, vi individuò immediatamente le caratteristiche adeguate per la lunga sequenza del Viaggio a Donnafugata”. Era la La Sinfonia sopra una canzone d’amore, il cui primo tempo era già stato utilizzato – lo si è detto – come colonna sonora del film La montagna di cristallo di Cass. Anche i ballabili (mazurka, controdanza, polka, quadriglia, galop, valzer del commiato), suonati dall’orchestrina durante la festa a palazzo Ponteleone – una sequenza della durata di ben tre quarti d’ora – furono scritti da Rota prima dell’inizio della lavorazione del film. Questi ballabili furono registrati in precedenza ed in maniera alquanto fortunosa a Palermo, da una formazione strumentale raccolta all’ultimo momento. Tra l’altro si era in piena estate, la temperatura era di 40° all’ombra e fu deciso di effettuare la registrazione alle sette del mattino. D’altra parte, nelle intenzioni dei responsabili, questa registrazione era considerata un provino da sottoporre al regista. Quando Visconti ascoltò le musiche gli piacque in modo particolare il modo un po’ trasandato dell’esecuzione. Egli riteneva che, trattandosi di una festa che si svolgeva in una casa privata, ed essendo l’orchestrina in campo, la non perfetta esecuzione conferisse alla scena un sapore più reale. Così la registrazione fu approvata e passò senza alcuna modifica nella colonna musicale del film. Il Valzer brillante Il motivo centrale della sequenza del ballo di Il Gattopardo è costituito dalla partitura inedita di un Valzer brillante di Verdi. Si tratta di un valzer a suo tempo dedicato da Verdi alla contessa Maffei, il cui manoscritto originale era stato acquistato presso una libreria antiquaria romana da Mario Serandrei, montatore del film e amico sia di Visconti che di Rota, e regalato a Visconti. La partitura per pianoforte è stata orchestrata successivamente da Rota per piccolo ensemble e utilizzata per le evoluzioni in a solo di Fabrizio e Angelica. I Ballabili Se sul Valzer brillante Nino Rota ha agito come orchestratore, sui rimanenti Ballabili, forse con la stessa complicità di Visconti e a totale insaputa della critica cinematografica e musicale anche più avvertita, ha agito secondo una delle sue solite operazioni di recupero. Quei ballabili, infatti, orchestrati nello stesso modo, non appartengono originariamente a Il Gattopardo, ma al film Appassionatamente (1954) di Giacomo Gentilomo di cui Nino Rota aveva firmato la colonna sonora. Addirittura, nel film di Gentilomo venivano a inserirsi in una analoga lunga sequenza di un ballo dell’alta aristocrazia tardo-ottocentesca, durante il quale Amedeo Nazzari e Myriam Bru erano i protagonisti di una memorabile esibizione sulle note del futuro “valzer del Gattopardo”. La festa, in Appassionatamente, procedeva persino secondo gli identici cerimoniali di quella del Gattopardo, con tanto di mazurke, polke, quadriglie; per cui la “citazione viscontiana” di un film dimenticato non ha affatto colto di sorpresa Rota che ha, molto discretamente, citato se stesso. Curiosità a parte, resta quanto meno da soffermarsi sul fatto – per Visconti eccezionale – che l’autore del Gattopardo ha girato l’intera sequenza del ballo sulla musica e senza avere preventivamente approvato i ballabili scritti da Rota. “Direi – ha commentato il musicista – che questo è l’unico caso di mia esperienza in cui la musica incisa prima è stata conservata per intero nel film. Tutte le volte, infatti, che ho inciso dei play-back, anche per film con coreografie e montaggi studiati, ho dovuto reincidere la musica, perché le scene girate non corrispondevano più al play-back. Questo è avvenuto, per esempio, per Guerra e pace, per La montagna di cristallo, per Sunset Sunsrise di Kurohara” (da La musica di Nino Rota, a cura di Pier Marco De Santi, Bari, Laterza, 1983). La prima versione “integrale” La prima del film ebbe luogo al Cinema Barberini di Roma il 27 marzo 1963, in una versione più lunga di quella distribuita successivamente, come hanno scoperto Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. “L’edizione restaurata del Gattopardo, quella festeggiata nei più prestigiosi festival internazionali, non è la stessa che venne proiettata al Barberini il 27 marzo 1963. Rispetto a quella dell’anteprima, che potremmo definire la versione integrale, alla edizione oggi disponibile manca almeno una decina di minuti di film. […] L’intera questione è rimasta per cinquant’anni avvolta nel mistero. […]. Ma alcuni tagli riemergono. Nella versione francese del film, dentro il trailer, perfino all’interno della tagliatissima edizione americana ci sono scene o inquadrature assenti nella versione italiana oggi disponibile. Chi le ha tagliate, quando, per quale motivo? Cosa, di preciso, è stato eliminato? E perché nessuno ne parla? […] E’ comprensibile che Visconti, dopo le prime settimane di programmazione in Italia, abbia deciso di sveltire lo spettacolo eliminando qualche momento meno riuscito che rischiava di incrinare la grazia dell’insieme; ha evidentemente tenuto conto di tanti recensori a proposito dell’eccessiva durata del film, della convenzionalità della scena del sogno, del profilo didascalico di altri brani. […]. A dispetto della promessa fatta a Cannes che l’edizione italiana sarebbe rimasta quella integrale, l’unico Gattopardo diffuso e autorizzato sarebbe diventato quello ridotto, mentre la versione originaria scivolò lentamente nel dimenticatoio. […] Stilisticamente congrui e apprezzabili, i tagli che Visconti decise di apportare spostano un poco più a destra la barra ideologica del film. Il regista tolse qualcosa che, oltre a non appartenere al romanzo, non apparteneva forse davvero nemmeno a lui. […] I recensori di sinistra usciti perplessi dalla visione della versione integrale sarebbero stati ancora più delusi dell’edizione tagliata, e avrebbero fatto obiezioni molto più serie delle timide rampogne opposte da un Aristarco comunque condiscendente. Per questo la curiosa uscita del Gattopardo in doppia versione, e l’assordante silenzio che l’ha sempre accompagnata, sembra un consapevole compromesso perché Visconti ottenesse i suoi scopi senza scontentare troppo il partito di riferimento. Mentre dava in pasto alla critica, marxista e non, la versione integrale uscita in sala a marzo, Visconti modificava la pellicola in sordina in vista di Cannes e dei posteri.” (da Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice, Operazione Gattopardo, Le Mani, Genova 2013). Il successo di pubblico e le difficoltà della Titanus Il film ebbe un clamoroso successo di pubblico ma i suoi costi si aggiravano “intorno ai tre miliardi di lire: Lombardo aveva tuttavia avuto dalla Fox un’anticipazione di un miliardo e mezzo. Problemi d’altro genere hanno accompagnato anche l’uscita del film: all’estero viene considerato troppo lungo; in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la Fox lo distribuisce in un’edizione rimaneggiata da Sidney Pollack e Burt Lancaster, senza il controllo di Visconti, abbreviata di 40 minuti e per di più stampata sulla base di un controtipo per il sistema Cinemascope e in Deluxe Color anziché in Technicolor, come nella versione italiana e francese. Anche l’edizione francese viene mutilata di circa 250 metri. Ma Il Gattopardo ottiene subito un grande successo, di critica e di pubblico. Vince la Palma d’Oro al Festival di Cannes 1963, tre Nastri d’argento, il David di Donatello a Lombardo per la miglior produzione – nel mercato italiano raggiunge il primo posto assoluto nella graduatoria della stagione 1962/63 con 774 milioni di lire; ridistribuito nella stagione successiva, il film ottiene il secondo posto con 347 milioni, e buoni incassi otterrà anche nelle periodiche riprese che la Titanus ne farà fino alla stagione 1982/83. Buoni risultati l’uscita del film registra anche in Gran Bretagna, in Belgio, negli Stati Uniti, in Spagna, nell’America Latina e nei Paesi scandinavi. Grazie al Gattopardo, nella stagione 1962/63 la Titanus è in Italia la prima società di distribuzione, con un incasso globale di 2.204 milioni di lire, ottenuto con 18 film nazionali e 6 stranieri. Ma i rientri sono forse troppo scaglionati nel tempo perché la Titanus possa subito risentire dei benefici” (Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli, Un secolo di cinema e di televisione Titanus, vol. I – Il cinema, Roma, Titanus 2004, pp. 224ss). Infatti, nello stesso periodo la Titanus doveva controbilanciare anche le considerevoli spese sostenute per la produzione di Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich (uscito il 4 ottobre del 1962) e di un altro film costoso e dall’esito comemrciale deludente, I sequestrati di Altona di De Sica (30 ottobre 1962). Lombardo ha così rievocato queste difficoltà e i problemi insorti con i distributori statunitensi: “Non ebbi la minima discussione con Visconti, ma con Zanuck, per fare l’esempio del Gattopardo, fu dura. Dopo una settimana di riprese, la Fox, visionate alcune foto di scena, mandò un telegramma chiedendo di rigirare tutto, perché Burt Lancaster con i baffi era praticamente irriconoscibile per gli spettatori americani. Poi, quando videro il film ultimato, gli americani si arrabbiarono moltissimo perché lo trovavano troppo lungo. Pretesero addirittura che venisse rimontata tutta la scena della battaglia, come se lo scontro tra Garibaldini e Borboni dovesse essere inserito in un film western. C’era un’altra mentalità. Su Sodoma e Gomorra si accumularono le perdite di tanti film giovani e lo sforzo sostenuto per Il Gattopardo che era andato fuori di due miliardi. Mancarono dei successi che coprissero le perdite e, quindi, le riserve si esaurirono. (Goffredo Lombardo, da Modi di produzione del cinema italiano – La Titanus, a cura di Guido Barlozzetti, Stefania Parigi, Angela Prudenzi, Claver Salizzato, Roma, Di Giacomo Editore, 1986, pp. 30-31). In un’altra testimonianza, Lombardo aggiunse: “I due film che avviarono la Titanus verso la débacle furono Il Gattopardo e Sodoma e Gomorra. Con questi due film perdemmo, a quell’epoca, più di cinque miliardi. Eppure, io non rimpiango di avere fatto nessun film. Mi piacciono tutti, indistintamente, anche perché bene o male che siano andati, ci ho creduto. Però è vero che i Pane e amore sono il mio fiore all’occhiello e Il Gattopardo lo adoro, anche se mi ha dato tante preoccupazioni e tante noie... Poi adoro Rocco e i film di Valerio Zurlini. Gli altri li amo lo stesso, però, certo, questi che ho citato rappresentano le mie creature predilette. E sono uscito pulito dalla débacle, questo sì. Del resto, data l’educazione che ho avuto, dato il patrimonio morale che mi ha lasciato mio padre, non poteva essere altrimenti, certi principi restano dentro indelebili. Ci sono riuscito con tanta volontà di lavorare, di ricominciare praticamente da capo. Mi sono dibattuto in difficoltà enormi, da principio chi mi affidava un film in distribuzione non sapeva quale solidità avesse questa nuova organizzazione, poi piano piano siamo andati avanti, con caparbietà, malgrado fosse iniziata una ennesima crisi del cinema italiano.” (da L’avventurosa storia del cinema italiano – 1960-1969, op. cit., p. 261) Di diverso parere la co-sceneggiatrice del film, Suso Cecchi d’Amico: “Sul fatto che i film di Luchino Visconti costano troppo, i produttori ci hanno sempre marciato, soprattutto Lombardo il cui vero disastro fu Sodoma e Gomorra e non certo Il Gattopardo su cui ha rimesso pochissimo e forse niente, mentre Sodoma e Gomorra fu un vero disastro, ma per lui era molto più nobile dire che il suo disastro dipendeva da Visconti e Il Gattopardo” (da L’avventurosa storia del cinema italiano – 1960-1969, op. cit., pp. 260-61). Antologia critica «Trasferendo in stupende, affascinanti e languide immagini Il Gattopardo, Luchino Visconti è stato sostanzialmente fedele al romanzo. Ma, fedele soprattutto a se stesso, ne ha approfittato per riprendere il discorso interrotto da Senso. Sebbene anche Senso sia un’opera memorabile, ci pare di poter dire che il discorso intrapreso nel Gattopardo è più limpido e coerente. Le immagini, il colore, i paesaggi, gli episodi gustosi e persino qualche macchietta (come quella disegnata con gusto da Romolo Valli nella parte del gesuita amico di casa Salina) non hanno indotto in tentazione il regista. La linea del racconto si spezza nelle varie vicende, si frantuma in contrasti dialettici, nell’esposizione dei piccoli fatti dell’esperienza di ogni giorno; ma la linea ideologica è inflessibile, acuta come punta di diamante, limpida come una notte di stelle. I problemi dell’Unità nazionale, la difficile saldatura tra il Settentrione di aspirazione e tono europei, il Centro di civilissima ma appartata provincia (basta pensare alle idee politiche del Grande Gioacchino Belli!) e il Mezzogiorno depresso sono affiorati in questo dopoguerra con nuova vivezza. In cento anni molti problemi sono stati elusi; eppure ce li siamo portati dietro (cosa andava a cercare in Africa il siciliano e garibaldino Crispi?) come il cane che si porta dietro la coda. Il merito ideologico ed artistico del Gattopardo visconteo consiste nell’aver cercato le radici del nostro malessere nazionale senza insistere in prevaricazioni predicatorie. Le idee camminano, la diplomazia cavouriana dà scacco matto alla storia, ma la gente del Risorgimento fa fatica a seguire l’impulso dato da quei tre tipi straordinari. Mazzini muore in disparte, Garibaldi si ritira a Caprera, e Cavour si spegne troppo presto. È assai singolare la riuscita di un film, dovete convenirlo, che è anche un’opera di storia demistificatrice. Il Gattopardo ha l’andamento di una vicenda dal corso fatale: è un Via col vento di linea italiana, più modulato, più geniale, più autentico, ma altrettanto grato allo spettatore comune di quello hollywoodiano. Luchino Visconti s’è, in un certo senso, sdoppiato: da una parte troviamo un intellettuale rigoroso, che riflette da artista sugli ultimi cento anni del proprio Paese: dall’altra, appare come un omologo lombardo del Principe di Salina. Un aristocratico che sta dalla parte della gente nuova perché sente che questo è giusto, che tale è il senso della storia, ma non può dimenticare la dolcezza irrevocabile di un certo passato, le maniere cortesi di una volta, quel vivere sereno, in civili agi e intelligenti cortesie, in un privilegio che parecchio sapeva farsi perdonare, perché non si dimenticava della carità e della cultura, almeno nei suoi migliori esemplari. È l’elegia di una civiltà morta; con aggiunto il disagio che ogni persona bennata prova nell’avvertire la rozzezza, il cinismo, la brutalità dei “parvenus”». Pietro Bianchi, È meglio di Via col vento’, “Il Giorno”, 29 marzo 1963 «Dategli la Sicilia, tre miliardi o quattro da spendere, e lasciatelo sfogare; ne deriverà, come qui, l’ottava meraviglia cinematografica. Osservate. Ecco, dall’esterno, la villa del Principe nell’ora in cui, prima di cena, la famiglia raccolta nel salone come in un quadro antico, smozzica il rosario: nei grandi balconi, sulla facciata d’oro sonnolento, impolverato, le tende si gonfiano di tepida brezza...e con uno di questi refoli, per così dire, entriamo. La preghiera è macchiata da lontani clamori; il biglietto di un parente informa Salina che la rivolta è scoppiata; il rosso malpelo di Genova è sceso a Marsala con i suoi mille pezzenti (fate la carità di un’Italia unita... ci raccomandiamo, o siciliani, al vostro buon cuore), e l’emblematico alano di casa fiuta negli accorrenti aliti marini ai quali ho accennato un aroma di sangue che lo agita. “È Bendicò!”, strillò trionfalmente una elegante mia vicina di posto; mi rammaricai di non poterla contraddire, ed ecco la sciagura del boom librario: quella di appaiarvi a qualsiasi chioccia di luoghi comuni e idee ricevute, livellandovi come una pialla, anzi come, salute a noi, la morte. Il Principe ordina la carrozza e va a dare un’occhiata a Palermo. Il fatto è che le stragi e l’amore (quello fomentato dalle ghiandole) si chiamano per misteriose vie; il Principe ha voglia di una calda meretrice che gli offra le sue gioie rozze ma totali come il formaggio e le pere divorati nel pagliaio senza mediazione di tovaglia e di posate. Qui l’obbedienza di Luchino al sobrio Tomasi diventa cilicio: non vediamo che un braccio tondo e bianco cingere il collo di Salina e non udiamo che un “Uh, principone mio...”, poi le tenebre di un’eroica dissolvenza inghiottono la scena, e addio. Soppresso (e mi duole) il fatto che all’alba il Principe, tuttora smosso, anzi arato, dall’avventura notturna, si pappi anche la principessa: non è un male che le gentildonne sappiano quanto debbono, talora, alle sgualdrine. Lodai mentalmente il regista per quei mattoni esausti che paiono ansiosi di sbriciolarsi: i palazzetti diventano polvere che s’innalza, neutra polvere, lunga polvere, disperati memoriali di polvere che l’indifferente cielo respinge (come farà nel 1944, d’altronde, e la ragione è sempre quella), mentre gli uomini stramazzano sul proprio grido e stanno. Ma in quale brano di questo Gattopardo, Visconti non eccelle? Il viaggio a Donnafugata, quelle campagne viziose, onanistiche, di una morbida carnalità, nei sobbalzi delle carrozze, o levigate dai vapori meridiani intorno alla colazione imbandita sull’erba. La sosta nell’alberghetto mangiato dal sole, con le pareti che sembrano di pomice e danno l’impressione di incrostarsi dei fiati degli ospiti. L’ineguagliabile panoramica, in mezzo primo piano, dei Salina allineati negli scanni di gala della chiesa, durante il Te Deum di benvenuto. Il plebiscito, quei sì appuntati ai cappelli, non meno trascinati e fittizi del motivetto della Gigogin...la proclamazione del favorevolissimo risultato è e non è parodistica, avendo i connotati di una prassi tutt’altro che abbandonata, in democrazia. Le partenze all’aurora per la caccia, quando l’imminente supplizio della luce si annunzia invece come un ristoro, come un beneficio. Gli andirivieni astratti, magici, di Tancredi e Angelica nella parte negletta o addirittura sconosciuta dell’immensa villa, quei tuffi nel passato mentre in ogni vena di entrambi, col desiderio che a quando a quando li sconvolge, batte il futuro... è più ed è meglio che possedersi... è una gioia rarissima e invidiabile che mi rincresce di non aver mai provato, accidenti a me. Infine, il ballo. Sì, è una sequenza magari eccessivamente protratta, ma formidabile, eccelsa. La virtù di Luchino si sfolgora; è mezzogiorno, qui, per il suo talento. Inchiniamoci... quando ci vuole ci vuole. Tagliare, sveltire, ha sentenziato più d’uno. Il diavolo che vi porti: ma se contemporaneamente al ballo il regista ha sulle braccia il declino morale e fisico del Principe, che nel romanzo occupa quasi trent’anni! Dobbiamo vederlo, il Salina, uscire dal palazzo Ponteleone col gusto delle proprie ceneri sulla punta della lingua! E Visconti riesce, contrapponendo iteratamente il protagonista e lo sfondo, a ottenere l’ardua sintesi che gli preme». Giuseppe Marotta, Tardivi inchini alla spossante bravura di Luchino Visconti, “L’Europeo”, n. 15, 14 aprile 1963 «È stato spesso sottolineato che i pescatori de La terra trema esprimono una lentezza, una ieraticità rivelatrici di un’aristocrazia naturale, opposta ai nuovi ricchi; se il tentativo dei pescatori fallisce, non è solo a causa dei grossisti di pesce, ma del peso di un passato arcaico che fa sì che la loro impresa avvenga già troppo tardi. Anche Rocco non è soltanto un “santo”, è un aristocratico per natura, nella sua famiglia di poveri contadini: ma troppo tardi per ritornare al paese, perché la città ha già corrotto tutto, perché tutto è diventato opaco e perché la Storia ha già fatto cambiare il paese... Ci sembra tuttavia che con il Gattopardo Visconti arrivi alla piena padronanza e all’armonia dei suoi quattro elementi. Il troppo-tardi lancinante diventa altrettanto intenso del Nevermore di Edgar Poe; chiarisce anche in quale direzione Visconti avrebbe potuto tradurre Proust. E non si può ridurre il rammarico di Visconti al suo apparente pessimismo aristocratico: l’opera d’arte sarà fatta di questo rammarico come i dolori e le sofferenze da cui traiamo una statua. Il troppo-tardi condiziona l’opera d’arte e ne condiziona la riuscita, perché l’unità sensibile e sensuale tra Natura e uomo è per eccellenza l’essenza dell’arte, in quanto a lei tocca d’arrivare troppo tardi a tutti gli altri sguardi tranne appunto che a quello: il tempo ritrovato». Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 1985, pp. 111-112 «Anche nel cuore delle sue operazioni più masochistiche e autodistruttive, il cinema viscontiano sapeva aprirsi a momenti di contagiosa effusione formalistica, di grande e commovente amore per la propria vocazione estetica tradita. Sono momenti che rientrano di diritto in quello che Most, citando ancora Kant, definisce il Sublime dei Moderni, l’unico possibile dopo che Baudelaire ha saldato con una congiunzione non più eliminabile i concetti di “ridicolo” e di “sublime”: “È un piacere che sorge solo indirettamente, e cioè viene prodotto dal senso di un momentaneo impedimento, seguito da una più forte effusione delle forze vitali”. C’è un esempio perfetto proprio nel Gattopardo, una splendida e incongrua panoramica sui tetti di Donnafugata che non si giustifica narrativamente e non è prevista nella sceneggiatura del film. Siamo sulla terrazza antistante la villa dei Salina, mentre Tancredi e Angelica stanno esplorando le soffitte disabitate ed esplode la loro sensualità prudentemente tenuta a freno in attesa delle nozze. I bambini più piccoli del Principe stanno giocando con mademoiselle, Concetta la figlia maggiore – invano innamorata di Tancredi ed esclusa dal cerchio magico di quella esplosione amorosa che si respira all’interno della villa – presta scarsa attenzione al suo beneducato e noioso corteggiatore, il conte Cavriaghi, che le ha donato le poesie dell’Aleardi. Intanto Francesco Paolo, l’altro figlio grande, è andato a prendere l’ospite piemontese e lo sta portando alla villa. “Ah guardi, ecco l’ospite!”, dice Cavriaghi, seduto sul muretto della terrazza con il suo inutile libretto di poesie. Ritta sotto l’ombrellino, al centro dell’inquadratura, Concetta guarda il fratello e il visitatore, che stanno entrando nel palazzo; poi sembra avvicinarsi al giovane immobile sulla destra, ma la m.d.p. La oltrepassa, la immobilizza a sua volta e va al di là del suo sguardo in una lunga e struggente visione del paese che chiude la sequenza in una vera e propria effusione lirica, sottolineata dalla musica a piena orchestra. Non si tratta di una soggettiva, che fra l’altro non potrebbe attribuirsi a nessuno dei personaggi principali; e nemmeno forse a un intervento “autoriale”, che non avrebbe alcuna giustificazione sul piano della storia o del discorso. Forse è un modo di alludere a un altro film, a un film sulla “bellezza” di una Sicilia perduta che deve invece rimanere implicito o rigorosamente racchiuso fra virgolette; e si pensa alle illuminanti osservazioni di Harold Bloom sulla Verneinung freudiana, la “negazione” con cui il poeta, esprimendo idee e sensazioni precedentemente represse, riesce a difendersi contro le sue stesse immagini sconfessandole: una difesa del non nominare, del non-mostrare, che può essere la radice di tanti problemi linguistici e psicoanalitici oltre a valere come sola definizione possibile del Sublime letterario (che è sempre, per Bloom, un Sublime negativo). E la storia del cinema italiano è intessuta di sconfessioni e di rimozioni, in cui Luchino Visconti è, ancora una volta, un protagonista e un maestro». Guido Fink, Visconti: la bellezza inaccessibile, “Cinema & Cinema”, 45, giugno 1986, pp. 29-32 «Il Gattopardo ha finalmente mostrato Visconti, a molti che rifiutavano la cosa, nella sua vera luce di personaggio composito. Infatti, gli elementi che in questo film diventano conclusivi, sono stati sempre presenti, e vivi in varia misura, nell’opera precedente. Ne voglio citare alcuni: 1. la mancata e impossibile rinuncia dell’autore alla sua condizione di aristocratico; 2. l’elemento funesto, decadente – il tema morte – sempre presente, fin da Ossessione; 3. la posizione pre-religiosa; 4. la concezione del futuro come un passato da riconquistare, mescolata a quella di un nuovo tempo da costruire; ecc. il mio proposito, in queste note, sarà, dunque, un po’ partigiano, per cercare di mettere in luce il Visconti troppo dimenticato: cioè l’autore che ha sempre avuto caratteri capaci di modificare, per una via estetica, l’intenzione ideologica. Il Gattopardo è una più accentuata regressione di Visconti verso la sua educazione aristocratica, religiosa e decadente. Ma non è detto che ogni regressione sia un fatto negativo in sé: a volte, come liberazione psicologica di componenti ancestrali, è un fatto positivo. Inoltre ogni regressione si scontra con un mondo intanto mutato: quindi può avviare una dialettica verso valori nuovi, può suggerire nuove sintesi. La conclusione del film di Visconti parrebbe una regressione al tema decadente della morte, che distrugge la Storia, dopo l’impostazione iniziale di stampo marxista. Ma potrebbe anche essere l’avvio di una nuova problematica tra il marxismo e i temi del dolore, della tragedia e della morte, raccolti nel momento in cui diventa assurdo considerarli come “colpe della borghesia” (senza, per questo, rinunciare a combattere la borghesia). Del resto, la storia procede anche per linee interne. L’arte è uno degli strumenti che permette di rivelare queste linee interne. Se oggi assistiamo a fenomeni di decadentismo come cavalli di ritorno di una vecchia cultura, ciò significa che la nuova cultura non li ha ancora superati; anzi, essa stessa li ripropone per trovare nuove soluzioni». Renzo Renzi, Visconti segreto, Bari, Laterza, 1994 «Visconti, si sa, non era un regista “fedele” ai testi letterari cui s’ispirava. Non quando li teneva presente solo indirettamente, come accadde in 3 fra i suoi 18 titoli filmografici; ma neppure quando vi si ispirava direttamente, come accadde in ben 9 dei restanti. Trattava quasi sempre le fonti letterarie come semplici canovacci, di cui spesso usava situazioni, dialoghi e personaggi, ma allontanandosene poi radicalmente in quanto a struttura e senso, sì da potersi permettere, in qualche caso (v. Ossessione, La terra trema, Il lavoro) di non citarli neppure nei titoli di testa. E non solo per una questione di “diritti”. La verità è che il più “letterato” fra i nostri registi aveva, di fronte ai testi letterari, lo stesso atteggiamento che adottava di fronte alla concreta realtà socioantropologica: come i dati della oggettiva realtà effettuale, anche quelli della fittizia “realtà letteraria” costituivano lo spunto iniziale, il punto di partenza, cui spesso liberamente, e a piene mani, attingeva; ma poi gli uni e gli altri venivano sottoposti a radicali mutamenti di senso, a mescolanze che ne trasfiguravano le valenze originarie, a veri e propri processi di reinvenzione che ne cambiavano funzioni e significato. È proprio alla luce di questa “norma” del rapporto viscontiano con la letteratura che il caso de Il Gattopardo appare significativamente eccezionale, se non del tutto straordinario, nella filmografia viscontiana. Non che anche qui Visconti non operi scelte significativamente selettive e modificative nei confronti del testo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che, ai tempi dei primi sopralluoghi palermitani per il film (autunno 1961) è uscito da appena tre anni (autunno 1958). Basti pensare alla sostanziale eliminazione del capitolo V del romanzo (la visita di Don Pirrone a S. Cono), sintetizzato nelle quattro inquadrature (171/174) della seq. XVIII, in cui il prelato spiega la differenza tra i “signori” e gli uomini normali, che il Tomasi aveva posto nel primo paragrafo del capitolo. E, ancor più, basti tenere presente la eliminazione secca dei capp. VII (“La morte del Principe”) e VIII (“La fine di tutto”), il cui dettagliato senso di morte è peraltro sintetizzato nella macrosequenza del ballo. Ma si pensi, appunto, anche al diverso peso che l’episodio del ballo ha nell’economia del racconto letterario (dove occupa meno di un decimo delle pagine) e in quella del racconto cinematografico (dove conta ben 178 delle 725 inquadrature del film, e occupa quasi un quarto del running time. O alla sostanziale diversità d’avvio dei due racconti: quello letterario, che dalla conclusione del Rosario e dal rientro del tutto “nell’ordine, del disordine, consueto”, con il Principe che ricorda “il cadavere di un giovane del quinto Battaglione Cacciatori”, ritrovato un mese prima nel giardino della Villa; e quello cinematografico, che recupera il Rosario sino dal finale della magnifica sequenza (inqq. 1/11) di avvicinamento a Villa Salina – vero e proprio preludio (extradiegetico o prediegetico, almeno fino all’inq. 9) del film – , compatta il tutto nelle iniziali sequenze (tra le inqq. 1/46), mettendo fra le primissime inquadrature (inqq. 23/28) anche la lettura del giornale e del biglietto inviati dal Principe al Duca Malvica, che nel romanzo chiudono il primo capitolo, venendo dopo la gita notturna a Palermo, la conversione con Tancredi e i rimbrotti di Padre Pirrone per la scorribanda erotica palermitana, e precedendo l’estrema conclusione, in Ringkomposition, con un nuovo Rosario (S’inginocchiò: “Salve Regina, Mater misericordiae”, pag. 63). La questione è che mai come nel Gattopardo Visconti sposa il punto di vista del protagonista letterario e adotta la sua centralità narrativa». Lino Micciché, Il Principe e il Conte, in Il Gattopardo, a cura di Lino Miccichè, Napoli-Roma, Electa – Centro Sperimentale di Cinematografia, 1996, p. 9 Il produttore, il regista e gli attori Goffredo Lombardo e la Titanus È l’unica società cinematografica esistente da oltre un secolo. Nel 1904, il napoletano Gustavo Lombardo (1885-1951) fondò una società, “Monopolio”, che sarebbe successivamente diventata “Lombardo Film”, quindi “Titanus”, per distribuire film a Napoli e nel Sud Italia. Nel 1909 Lombardo dà inizio all’attività distributiva di film della Gaumont, Eclair, Vitagraph e nel 1911 acquista i diritti della distribuzione dell’Inferno di Bertolini e Padovan, quindi, dimostrando non poco coraggio, distribuisce anche i film futuristi. All’inizio degli anni Trenta, dopo il trasferimento a Roma, decide di intraprendere anche la produzione dei film (nel 1932 con Venere di F. N. Neroni, seguito nel 1935 da Passaporto rosso di Guido Brignone) e, dal 1936, sarà affiancato dal figlio Goffredo (Napoli 1920-Roma 2005), che aveva avuto dalla moglie, l’attrice Leda Gys. In quel periodo, il produttore napoletano intuì anche le eccezionali qualità artistiche di Totò, che esordì proprio in una film prodotto e distribuito dalla Titanus (Fermo con le mani, 1937, di Gero Zambuto) Il periodo di più intensa attività nella produzione si colloca fra il 1945 e il 1964 quando la Titanus produce e distribuisce quasi cento film. Nel 1949 inaugura il filone dei popolari mélo diretti da Raffaello Matarazzo (Catene, 1949; Tormento, 1950; I figli di nessuno, 1951), nel 1953 scopre il filone del “neorealismo rosa” con Pane amore e fantasia di Luigi Comencini, cui fa seguito nel 1956 l’altro fortunatissimo filone dei Poveri ma belli diretto da Dino Risi. In quello stesso periodo la Titanus produsse una dozzina di titoli interpretati da Totò. Ma fin dall’inizio degli anni Cinquanta sostenne anche il cinema d’autore, producendo titoli quali Roma ore 11 (1951) e Uomini e lupi (1956) di Giuseppe De Santis, Il cappotto (1952), La spiaggia (1953), Dolci inganni (1960) di Alberto Lattuada, Il bidone (1955) di Federico Fellini, Il tetto (1956) di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, Policarpo ufficiale di scrittura (1958) di Mario Soldati, I magliari (1959) di Francesco Rosi, Rocco e i suoi fratelli (1960) e Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti, La viaccia (1961) di Mauro Bolognini, Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy. Tenne a “battesimo” alcuni fra i più importanti giovani autori del cinema italiano degli anni Sessanta, come Valerio Zurlini – di cui produsse, in quel periodo, Estate violenta (1959), La ragazza con la valigia (1961) e Cronaca familiare (1962) –, Elio Petri – L’assassino (1961) e I giorni contati (1962) –, Franco Brusati – Il disordine (1961) –, Ermanno Olmi – I fidanzati (1963) – e altri. È intensa anche la serie di coproduzioni con la Francia, da Labbra proibite (Quand tu liras cette lettre, 1953), il primo film di Jean-Pierre Melville distribuito in Italia, a Il mondo del silenzio di Jacques-Yves Cousteau e Louis Malle, da A doppia mandata (A double tour, 1959) di Claude Chabrol, a Il buco (Le Trou, 1960) di Jacques Becker e In pieno sole (Plein soleil, 1960) di René Clément. In quel periodo la società amplia e sviluppa i teatri di posa della Farnesina, acquisisce gli stabilimenti dell’ex Scalera e arricchisce anche i laboratori di doppiaggio e di edizione. Nel luglio del 1961, la Titanus organizza un convegno a Milano, intitolato Per un nuovo corso del cinema italiano, cui partecipano Visconti, De Sica, Monicelli, Bolognini, Lattuada, Brusati, Zurlini, Comencini e altri, che costituisce un ulteriore sintomo della grande affermazione artistica e commerciale che il cinema della penisola sta vivendo in quegli anni. Nel 1962-1963 il disastro finanziario di Sodoma e Gomorra (1962) di Robert Aldrich, costringe Lombardo a ridurre drasticamente l'attività produttiva (che continuerà nel 1963 e nel 1964 con pochi titolo per poi cessare del tutto fino al 1971). La società continua però un’intensa e fortunata attività distributiva che proseguirà fino al 1994, detenendo per almeno vent’anni il ruolo della società italiana più importante e diversificando le proprie scelte in un ampio ventaglio di generi (commedia, poliziesco, avventuroso, cappa e spada etc) ma senza trascurare anche il cinema d’autore: Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Comizi d’amore (1964) di Pier Paolo Pasolini, Il buono, il brutto, il cattivo (1966) e C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone, Il profeta (1967), Vedo nudo (1969), Telefoni bianchi (1976), La stanza del vescovo (1977), Scemo di guerra (1985) di Dino Risi, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (1968), Il commissario Pepe (1969), Dramma della gelosia tutti i particolari in cronaca (1970), Ballando ballando (1983) di Ettore Scola, L’uccello dalle piume di cristallo (1970), Il gatto a nove code (1971), Tenebre (1982) e Phenomena (1985) di Dario Argento, Metello (1970), Bubù (1971), L'eredità Ferramonti (1976) e La venexiana (1986) di Mauro Bolognini, Monsieur Hulot nel caos del traffico (1971) di Jacques Tati, La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini, Unico indizio: una sciarpa gialla (1973) e Baby Sitter (1975) di René Clément, La proprietà non è più un furto (1973) di Elio Petri, Il Casanova di Fellini (1976) di Federico Fellini, Caccia sadica (1970) e Mr. Klein (1976) di Joseph Losey, Buffalo Bill e gli indiani (1976) di Robert Altman, L'immagine allo specchio (1976), L’uovo del serpente (1977) e Un mondo di marionette (1980) di Ingmar Bergman, Lucky Luciano (1973) e Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Francesco Rosi, L'armata Brancaleone (1966), Brancaleone alle crociate (1970), Camera d’albergo (1981) di Mario Monicelli, I nuovi mostri (1977) di Dino Risi, Monicelli e Scola, L’ingorgo (1978) di Luigi Comencini, Storie di ordinaria follia (1981) di Marco Ferreri, Lola (1981) di Rainer Werner Fassbinder, La messa è finita (1985) e Palombella rossa (1989) di Nanni Moretti e numerosi altri. Nel 1995 Goffredo Lombardo ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, mentre nel 2010 Giuseppe Tornatore gli ha dedicato il documentario L’ultimo Gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo. Dalla metà degli anni Novanta la Titanus svolge attività di produzione televisiva, diretta da Guido Lombardo, figlio di Goffredo e nipote di Gustavo. Luchino Visconti Discendente da una delle famiglie più prestigiose dell’aristocrazia lombarda, Luchino Visconti è nato a Milano il 2 novembre 1976. Suo padre è il duca Giuseppe Visconti di Modrone e la madre Carla Erba, appartenente ad una facoltosa famiglia borghese. La sua formazione avviene più nell’ambito della ricca cultura cosmopolita familiare che non nelle aule scolastiche (frequentate solo sporadicamente). Da adolescente, possiede già una vasta cultura letteraria, teatrale e musicale e nei primi anni della giovinezza si dedica all’allevamento dei cavalli, non senza tentare qualche prova letteraria che rimane inedita (il romanzo Angelo). Negli anni Trenta si avvicina al cinema e si stabilisce a Parigi dove ha modo di diventare collaboratore di Jean Renoir (è assistente di La scampagnata / Une Partie de campagne, 1936 e di Tosca, 1940, che il regista francese inizia a girare in Italia). Nella sua formazione di cineasta è fondamentale l’impatto con il Realismo poetico come, sul piano ideologico, quello con il Front Populaire e il Partito Comunista. A Roma frequenta gli intellettuali antifascisti della rivista “Cinema” e li coinvolge nella preparazione del suo primo lungometraggio, Ossessione (1943), liberamente ispirato al romanzo Il postino suona sempre due volte di James Cain (il legame con la letteratura dominerà l’intera opera cinematografica viscontiana). Il film segna una importante rottura estetica, narrativa e tematica con il cinema italiano dell’epoca e anticipa il fenomeno del Neorealismo. L’anno della Liberazione, partecipa al documentario collettivo Giorni di gloria e inizia un’importante attività di regista di prosa e lirica che lo renderà uno dei protagonisti del rinnovamento delle scene italiane del dopoguerra. Le sue regie di prosa comprendono Parenti terribili e La macchina da scrivere di Jean Cocteau (1945), Quinta colonna di Ernest Hemingway (1945), Antigone di Jean Anouilh (1945), A porte chiuse di Jean-Paul Sartre (1945), Adamo di Marcel Achard (1945), La via del tabacco di John Kirkland (da Erskine Caldwell) (1945), Il matrimonio di Figaro di Pierre Augustin Caron De Beaumarchais (1946), Delitto e castigo di Gaston Bary (da Fedor Michajlovic Dostoevskij) (1946), Zoo di vetro di Tennessee Williams (1946), Euridice di Jean Anouilh (1947), Rosalinda o Come vi piace di William Shakespeare (1948), Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams (1949), Oreste di Vittorio Alfieri (1949), Troilo e Cressida di William Shakespeare (1949), Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller (1951), Il seduttore di Diego Fabbri (1951), La locandiera di Carlo Goldoni (1952), Tre sorelle di Anton Čechov (1952), Il tabacco fa male di Anton Čechov (1953), Medea di Euripide (1953), Come le foglie di Giuseppe Giacosa (1954), Il Crogiuolo di Arthur Miller (1955), Zio Vania di Anton Čechov (1955), Contessina Giulia di August Strindberg (1957), L'impresario delle Smirne di Carlo Goldoni (1957), Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller (1958), Immagini e tempi di Eleonora Duse (1958), Veglia la mia casa, angelo di Ketti Frings (da Thomas Wolfe) (1958), Deux sur la balançoire di William Gibson (1958), I ragazzi della signora Gibbons di Will Glickman e Joseph Stein (1958), Figli d'arte di Diego Fabbri (1959), L'Arialda di Giovanni Testori (1960), Dommage qu'elle soit une p... di John Ford (1961), Il tredicesimo albero di André Gide (1963), Après la chute di Arthur Miller (1965), Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov (1965), Egmont di Wolfgang Goethe (1967), La monaca di Monza di Giovanni Testori (1967), L’inserzione di Natalia Ginzburg (1969) e Tanto tempo fa di Harold Pinter (1973). Le sue regie liriche: La Vestale di Gaspare Spontini (1954), La sonnambula di Vincenzo Bellini (1955), La traviata di Giuseppe Verdi (1955, 1963 e 1967), Anna Bolena di Gaetano Donizetti (1957), Ifigenia in Tauride di Christoph Willibald Gluck (1957), Don Carlos di Giuseppe Verdi (1958), Macbeth di Giuseppe Verdi (1958), Il Duca d'Alba di Gaetano Donizetti (1959), Salomè di Richard Strauss (1961), Il diavolo in giardino di Franco Mannino su libretto di Visconti, Filippo Sanjust e Enrico Medioli (1963), Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart (1964), Il trovatore di Giuseppe Verdi (1964), Don Carlos di Giuseppe Verdi (1965), Falstaff di Giuseppe Verdi (1966), Der Rosenkavalier di Richard Strauss (1966), Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi (1969) e Manon Lescaut di Giacomo Puccini (1973). Parallelamente prosegue un’intensa e straordinaria attività di regista cinematografico, realizzando un capolavoro come La terra trema (1948), quindi Bellissima (1951), film realistico sulla società dello spettacolo che offre un grande ruolo ad Anna Magnani (protagonista anche dell’episodio viscontiano di Siamo donne, 1953), il sontuoso affresco Senso (1954), da Camillo Boito, grande mélo risorgimentale, Le notti bianche (1957), raffinato film “da studio” ispirato a Dostoevskij, il potente dramma realistico Rocco e i suoi fratelli (1960), che costituisce anche il primo di una lunga serie di successi di pubblico. Dopo il sarcastico episodio Il lavoro (di Boccaccio ’70, 1962), realizza Il Gattopardo (1963), che ottiene la Palma d’Oro a Cannes, e un crudele film “da camera” come Vaghe stelle dell’Orsa (1965), quindi l’episodio La strega bruciata viva (di Le streghe, 1967, tagliato dalla produzione), il travagliato adattamento da Camus Lo straniero (1967), il sulfureo mélo ambientato negli anni dell’ascesa di Hitler La caduta degli dei (1969), uno dei maggiori successi della stagione 1969/70, che apre la Trilogia tedesca, costituita anche da Morte a Venezia (1971) da Thomas Mann e Ludwig (1973). Alla fine delle riprese di questo film, Visconti viene colpito da ictus ma riesce ancora a realizzare due film, Gruppo di famiglia in un interno (1974) e L’innocente (1976), da D’Annunzio. Muore a Roma il 17 marzo del 1976, mentre il suo ultimo film è in fase di doppiaggio. Burt Lancaster Della sua interpretazione nel ruolo del principe Fabrizio di Salina, Visconti disse: “Penso che Lancaster abbia dato, non soltanto con le sue eccezionali doti naturali e di mestiere, ma con un serio impegno di studio e approfondimento tanto del suo ruolo quanto del testo di Lampedusa e della letteratura storica che ad esso può introdurre, un contributo personale decisivo alla realizzazione del personaggio. È entrato nella parte via via che il film si inoltrava nel suo contesto, e lo si vedrà crescere sullo schermo secondo questo ritmo. E poiché il momento di maggiore altezza umana e drammatica del principe di Salina coincide a mio avviso proprio col punto culminante del ballo in casa Ponteleone, l’interpretazione di Lancaster si è avvantaggiata anche del suo stesso graduale e sofferto sviluppo” (Dialogo con Visconti, in Il film Il Gattopardo e la regia di Luchino Visconti, op. cit.). All’anagrafe Burton Stephen Lancaster, nacque ad Harlem il 2 novembre 1913 da un impiegato postale di origini irlandesi. Intraprese inizialmente una fortunata carriera di acrobata in circhi e night club formando con il fratello il duo “Lang & Cravat”, quindi nel 1945, dopo che un incidente gli aveva impedito di continuare le acrobazie, fu notato da un agente teatrale che lo fece esordire a Broadway. Rivelò subito una naturale predisposizione alla recitazione tanto che il passo al cinema fu breve: nel 1946 esordì nel bel film noir di Robert Siodmak I gangsters (The Killers, 1946) e nel secondo film, il carcerario Forza bruta (Brute Force, 1947) di Jules Dassin, ottenne già il ruolo di protagonista. La sua prima, immediata, affermazione fu quindi legata al cinema noir: in questo genere, in Le vie della città (I Walk Alone, 1949) di Byron Haskin, condivise la scena con un altro divo della sua generazione, Kirk Douglas. Se appartengono ancora al genere noir i vigorosi Il terrore corre sul filo (Sorry, Wrong Number, 1948) di Anatole Litvak e Doppio gioco (Criss Cross, 1949) di Robert Siodmak, negli avventurosi La leggenda dell’arciere di fuoco (The Flame and the Arrow, 1950) di Jacques Tourneur e Il corsaro dell’isola verde (The Crimson Pirate, 1951) di Siodmak, rivela anche doti ironiche. Intanto ha dimostrato una notevole versatilità drammatica con Erano tutti miei figli (All My Sons, 1948) di Irving Reis, da Arthur Miller, confermata da Torna, piccola Sheba (Come Back, Little Sheba, 1952) di Daniel Mann, Da qui all’eternità (From Here to Eternity, 1953) di Fred Zinnemann, L’ultimo Apache (Apache, 1954), regia di Robert Aldrich, dove impersona un pellerossa che esce dagli schemi del western convenzionale, Vera Cruz (Id., 1954), ancora di Aldrich (1954). All’inizio degli anni Cinquanta Lancaster è uno dei divi più importanti e anticonvenzionali di Hollywood, dalle idee sempre più dichiaratamente progressiste, e crea una società di produzione con Ben Hecht. Esordisce nella regia con Il vagabondo delle frontiere (The Kentuckian, 1955) e si misura con Anna Magnani in La rosa tatuata (The Rose Tattoo, 1955) di Daniel Mann, mentre in Trapezio (Trapeze, 1956) di Carol Reed, rievoca i suoi trascorsi di acrobata. Cambia i generi sempre confermando le qualità di una recitazione vigorosa e intensa e dimostrando una particolare sensibilità (come attore e produttore) alle problematiche sociali, dal western – Sfida all’O.K. Corral (Gunfight at the O.K. Corral, 1957) di John Sturges, Gli inesorabili (The Unforgiven, 1960) di John Huston – al dramma di denuncia, Piombo rovente (Sweet Smell of Success, 1957) di Alexander Mackendrick, dove è straordinario nella parte sgradevole di un giornalista senza scrupoli, al dramma psicologico, Tavole separate (Separate Tables, 1958) di Delbert Mann, al film avventuroso in costume, Il discepolo del diavolo (The Devil's Disciple, 1959) di Guy Hamilton, dove recita con Kirk Douglas e Laurence Olivier. Negli anni Sessanta, diversificò ulteriormente la gamma di ruoli, impersonando il mistificatore protagonista di Il figlio di Giuda (Elmer Gantry, 1960) di Richard Brooks (che gli valse un Oscar), Il giardino della violenza (The Young Savages, 1961) di John Frankenheimer, un anziano giudice compromesso col nazismo in Vincitori e vinti (Judgement at Nuremberg, 1961) di Stanley Kramer (1961), un ergastolano in L’uomo di Alcatraz (Birdman of Alcatraz, 1962) di Frankenheimer (per cui ottenne la Coppa Volpi a Venezia), Gli esclusi (A Child Is Waiting, 1963), uno dei primi film di John Cassavetes, di cui Lancaster fu anche produttore. Seguirono quindi la straordinaria prova mimetica di Il Gattopardo di Visconti, il ruolo difficile di un generale reazionario in 7 giorni a maggio (Seven Days in May, 1964) di Frankenheimer e l’eroe del bellico Il treno (The train, 1965) ancora di Frankenheimer. Con la maturità continuò a scegliere con intelligenza i registi, affidandosi alla regia di alcuni dei più interessanti cineasti statunitensi della seconda metà degli anni Sessanta, come Sydney Pollack (Joe Bass l’implacabile / The Scalphunters, 1968; Ardenne ’44, un inferno / Castle Keep, 1969), Frank Perry (Un uomo a nudo / The Swimmer, 1968, uno dei film più audaci della sua carriera, ma che venne bocciato dal pubblico), ancora Frankenheimer (I temerari / The Gypsy Moths, 1970), Aldrich (Nessuna pietà per Ulzana / Ulzana’s Raid, 1972). Ritornò alla regia con il vigoroso L’uomo di mezzanotte (The Midnight Man, 1974) e ritrovò, dopo dieci anni dal Gattopardo, Alain Delon nel film di spionaggio Scorpio (1973) di Michael Winner e la regia di Visconti in Gruppo di famiglia in un interno (1974). Nella seconda metà degli anni Settanta sperimentò nuove esperienze, come l’incontro con Robert Altman per lo sfortunato Buffalo Bill e gli indiani (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson, 1976) e con Bernardo Bertolucci per l’affresco di Novecento (1976), quindi ritrovò Aldrich nel notevole Ultimi bagliori di un crepuscolo (Twilight’s Last Gleaming, 1976) e continuò a privilegiare registi europei, come l’inglese Doulas Hickox (Zulu Dawn, 1979), il francese Louis Malle (Atlantic City, USA, 1980, uno dei più importanti film della maturità di Lancaster), l’italiana Liliana Cavani (La pelle, 1981), l’inglese Bill Forsyth (Local Hero, 1983). Negli ultimi anni, alternò cinema e televisione, sempre con intatto carisma e fra le ultime interpretazioni forse la più memorabile è, curiosamente, quella del diabolico capo della CIA nell’ultimo film di Sam Peckinpah, il travagliato Osterman Weekend (The Osterman Weekend, 1983). Nel 1991 fu colpito da ictus e costretto all’inattività. Morì a Century City il 20 dicembre del 1994. Alain Delon Della regia di Visconti nel Gattopardo, Alain Delon dichiarò che “il mio ruolo, quello di Tancredi, aveva una funzione storica e politica molto precisa: Garibaldi, le mutazioni dell’Italia... Me ne ha parlato relativamente poco ma con precisione. Si è soprattutto concentrato sul Principe Salina che interpretava Burt Lancaster. Lui stesso avrebbe dovuto recitare il ruolo, e noi tutti l’abbiamo incoraggiato a farlo. Alla fine non ha osato ed è stato senza dubbio meglio così. Il Principe era lui. Il film è la sua autobiografia. Ogni gesto che fa Lancaster, è lui, Visconti. Era un uomo molto duro con tutti e soprattutto con se stesso. Poteva rimanere al lavoro quattordici ore di fila, dalle sei di sera alle otto del mattino, con meno dieci gradi a Milano. E nessuno avrebbe potuto rifiutarsi di rimanere. Era la sua intransigenza ma aveva sempre uno scopo, una funzione” (Entretien avec Alain Delon, a cura di Olivier Dazat e Jacques Fieschi, “Cinématographe”, n. 103, settembre-ottobre 1984). Nato a Sceaux l’8 novembre del 1935, ebbe un’infanzia infelice e un’adolescenza irrequieta tanto che a diciassette anni decise di arruolarsi nella Legione straniera in Indocina e partecipò anche all’assedio di Dien-Bien-Phu. Ritornato in Francia, visse alla giornata finché fu notato dal regista Yves Allégret che gli assegnò la parte di un giovane criminale al servizio di Jean Servais in Godot (Quand la femme s’en mêle, 1957). Fin dal 1959 aveva già una fama notevole anche grazie alla relazione con Romy Schneider. Il primo film importante della sua carriera, che lo rese una star internazionale, fu Delitto al sole (Plein soleil, 1960) di René Clément, dove impersonò magistralmente il diabolico Tom Ripley di Patricia Highsmith. Seguì la piena consacrazione di Rocco e i suoi fratelli (1960) di Visconti, che nel 1961 lo volle anche a teatro, accanto a Romy Schneider nella tragedia elisabettiana Dommage qu’elle soit une p... di John Ford. Clément e Visconti, soprattutto quest’ultimo, furono i maestri che formarono Delon come attore, proprio mentre esplodeva il fenomeno della Nouvelle Vague, cui il giovane attore (ormai diventato un divo popolarissimo in tutta Europa e in Asia) rimase sempre estraneo. Sotto la regia di Clèment interpretò altri tre film di genere completamente differente: la singolare e estrosa commedia all’italiana Che gioia vivere (Quelle joie de vivre, 1961), il magistrale noir Crisantemi per un delitto (Les Félins, 1964) e la rievocazione storica della Liberazione in chiave gaullista di Parigi brucia? (Paris brûle-t-il?, 1966). Fondamentale fu anche l’incontro, sempre in Italia, con Michelangelo Antonioni per L’eclisse (1962), dove Delon impersonò un dinamico e cinico agente di borsa, cui seguì una fortunatissima incursione nel noir (genere successivamente prediletto da Delon), Colpo grosso al casinò (Mélodie en sous-sol, 1963) di Henri Verneuil, dove ricevette una sorta di investitura dal glorioso co-protagonista Jean Gabin. Dopo l’ultimo incontro con Visconti per Il Gattopardo, l’attore si cimentò con successo nel genere cappa e spada in Il Tulipano nero (La Tulipe noire, 1964) di Christian-Jaque e subì invece una delusione all’esordio come produttore del pur notevole Il ribelle di Algeri (L’Insoumis, 1964) di Alain Cavalier. Seguì una poco significativa parentesi hollywoodiana e un nuovo, importante sodalizio artistico, stavolta con Jean-Pierre Melville, che lo scelse come protagonista di tre classici del noir, Frank Costello faccia d’angelo (Le Samouraï, 1967), I senza nome (Le Cercle rouge, 1970) e Notte sulla città (Un Flic, 1972). Nella seconda metà degli anni Sessanta, Delon diventò uno degli attori europei più popolari in assoluto e, quando venne coinvolto in uno scandalo legato all’assassinio della sua guardia del corpo, la sua fama aumentò anziché esserne intaccata, tanto che fu anche uno dei produttori indipendenti più potenti (con la società Adel, poi Leda). Fino al 1977 alternò con esiti spesso felici film d’autore a film noir. Se nei primi cambiò spesso registro, nei secondi creò un personaggio che divenne presto mitologico. Fra i film d’autore, ricordiamo L’assassinio di Trotsky (L’Assassinat de Trotsky, 1972) e lo splendido Mr. Klein (1976) di Joseph Losey, un altro incontro fondamentale per Delon, e La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini. Fra i noir, La piscina (La Piscine, 1968) di Jacques Deray, regista che ritrovò, fra l’altro, in Borsalino (1970) e Flic Story (Id., 1975), inoltre Il clan dei siciliani (Le Clan des siciliens, 1969) di Verneuil, L’evaso (La Veuve Couderc, 1971) di Pierre Granier-Deferre, Due contro la città (Deux hommes dans la ville, 1973), ultimo incontro con Gabin, e Lo Zingaro (Le Gitan, 1975) di José Giovanni, Morte di una carogna (Mort d’un pourri, 1977) di Georges Lautner, eccellente thriller politico. Dalla fine degli anni Settanta tende a privilegiare ruoli più stereotipati, perlopiù in polizieschi (anche se rivela una certa autoironia in Per la pelle di un poliziotto / Pour la peau d’un flic, 1981, che dirige, produce e interpreta). Fanno eccezione solo il ruolo dello Charlus proustiano in Un amore di Swann (Un Amour de Swann, 1984), l’ubriacone di Notre histoire (1984, inedito in Italia) di Bertrand Blier e soprattutto il doppio del magnifico Nouvelle Vague (1990) di Jean-Luc Godard. Dalla fine degli anni Novanta si ritira quasi completamente dal cinema per dedicarsi, con successo, al teatro e alla televisione. Claudia Cardinale Nelle sue memorie, Claudia Cardinale ricorda con particolare intensità il nuovo incontro con Visconti (che l’aveva già diretta in un ruolo minore in Rocco e i suoi fratelli) per Il Gattopardo: “Sotto i merletti, le sete, i pizzi, i punti di Venezia o d’Aleçon, di Bruxelles o di Inghilterra, sotto quei bianchi leggeri come la spuma delle onde, o trasparenti come la bruma sulla laguna, ero compressa in un corsetto d’epoca, di una crudeltà implacabile. Quella era la magia del cinema, con Visconti. Sotto l’apparente facilità, sotto l’eleganza naturale, si celava la sofferenza. Come il mio corpo serrato in quella morsa, noi attori eravamo una materia plasmabile tra le mani del nostro grande demiurgo. A lungo, di quel corsetto mi è rimasto un segno attorno alla vita che mi ricordava la ferita che avevo sopportato senza dire niente, e quasi senza soffrire, tanto ero trascinata dall’entusiasmo, la certezza di partecipare a un’opera eterna, la consapevolezza della bellezza che ci circondava. Quel film ha cambiato la mia vita, aprendo la mia carriera al cinema internazionale. Ma più ancora, dopo quelle riprese, non fui più la stessa” (Claudia Cardinale, Le stelle della mia vita, Piemme, 2006, p. 93). Nata a Tunisi da genitori italiani il 15 aprile del 1938, Claudia Cardinale recitò quasi casualmente in un cortometraggio di René Vautier, Anneaux d’or (1957) che le valse un piccolo ruolo in I giorni dell’amore (Goha, 1957) di Jacques Baratier (1958). Di lì a poco vinse un concorso di bellezza e si trasferì nella penisola, frequentò i corsi di recitazione del Centro Sperimentale e venne scelta da Mario Monicelli per la parte della bellissima Carmelina, tenuta segregata in casa dal fratello in I soliti ignoti (1958). Il film fu un trionfo che rese famosa anche la giovanissima attrice, cui fu offerto un contratto in esclusiva dal produttore Franco Cristaldi (suo futuro marito) della VIDES. I film successivi aumentarono la sua popolarità, in particolare Il magistrato (1959) di Luigi Zampa, La prima notte (1959) di Alberto Cavalcanti e soprattutto Un maledetto imbroglio (1959) di Pietro Germi, Il bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini, La battaglia di Austerlitz (Austerlitz, 1960) di Abel Gance, Audace colpo dei soliti ignoti (1960) di Nanni Loy (seguito del film di Monicelli), Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti, I delfini (1960) di Francesco Maselli, La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini, la sua prima, importante prova di attrice drammatica e La viaccia (1961) di Mauro Bolognini. All’inizio degli anni Sessanta diviene una diva di prima grandezza, sullo stesso piano di Sofia Loren e Gina Lollobrigida e, come loro, intraprende una fortunatissima carriera internazionale: Cartouche (1962) di Philippe de Broca, Senilità (1962) di Mauro Bolognini, 8½ (1963) di Federico Fellini (dove interpreta pressoché il ruolo di se stessa), Il Gattopardo (1963) di Visconti, La Pantera Rosa (The Pink Panther, 1963) di Blake Edwards, La ragazza di Bube (1963) di Luigi Comencini, Gli indifferenti (1964) di Francesco Maselli, un’altra notevole prova drammatica, Il circo e la sua grande avventura (Circus World, 1964) di Henry Hathaway, accanto a John Wayne, Il magnifico cornuto (1964) di Antonio Pietrangeli, con Ugo Tognazzi, Vaghe stelle dell’Orsa... (1965) di Luchino Visconti, Né onore né gloria (Lost Command, 1966) di Mark Robson, con Anthony Quinn e Alain Delon, I professionisti (The Professionals, 1966) di Richard Brooks, con Burt Lancaster, Piano, piano non t’agitare! (Don’t Make Waves, 1967) di Alexander Mackendrick, Il giorno della civetta (1968) di Damiano Damiani, C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone, con Henry Fonda e Charles Bronson, Nell’anno del Signore (1969) di Luigi Magni, con Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, Le avventure di Gerard (The Adventures of Gerard, 1970) di Jerzy Skolimowski, Le pistolere (Les pétroleuses, 1971) di Christian-Jaque, con Brigitte Bardot, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (1971) di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, L’udienza (1972) di Marco Ferreri, Il clan dei marsigliesi (La Scoumoune, 1972) di José Giovanni, con Jean-Paul Belmondo, I guappi (1974) di Pasquale Squitieri, Gruppo di famiglia in un interno (1974) di Luchino Visconti, dove fa un’intensa apparizione, Libera, amore mio! (1975) di Bolognini. Dalla fine degli anni Settanta viene spesso diretta dal marito Pasquale Squitieri (Il prefetto di ferro, 1977; Corleone, 1978; Claretta, 1984; Atto di dolore, 1990; Il giorno della Shoah, 2010) e continua una variegata carriera internazionale, con film quali Goodbye & Amen (1977) di Damiano Damiani, Una donna due passioni (La Part du feu, 1978) di Étienne Périer, con Michel Piccoli, L’amante proibita (La Petite fille en velours bleu, 1978) di Alan Bridges, La pelle (1981) di Liliana Cavani, con Marcello Mastroianni e Burt Lancaster, Fitzcarraldo (1982) di Werner Herzog con Klaus Kinski, Una cascata d’oro (Le Ruffian, 1983) di José Giovanni, con Lino Ventura, Enrico IV (1984) di Marco Bellocchio, con Mastroianni, La Storia (1986) di Luigi Comencini, And Now... Ladies and Gentlemen (2002) di Claude Lelouch, Le Démon de midi (2005, inedito in Italia) di Marie-Pascale Osterrieth, Cherche fiancé tous frais payés (2007, inedito in Italia) di Aline Issermann (2007), Gebo e l’ombra (Gebo et l’ombre, 2012) di Manoel de Oliveira, con Jeanne Moreau, El artista y la modelo (2012, inedito in Italia) di Fernando Trueba, The Third Person (2013) di Paul Haggis. Il restauro Cosa fai quando il mondo che ti circonda sta cambiando, quando hai la sensazione che tutto ciò che conosci e ami lascerà il posto a un nuovo ordine? Ti opponi? Lo accetti? E come lo accetti? Con risentimento? Con grazia? Forse con tutt’e due. Chi può lasciarsi alle spalle il mondo che lo ha formato senza addolorarsi per il tempo che passa? Queste domande, queste sensazioni che sono alla base della condizione umana si ritrovano in ogni inquadratura del Gattopardo, il magnifico adattamento di Luchino Visconti del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa su un principe siciliano al tempo del Risorgimento, il quale si rende conto che il suo ruolo storico, e quello della sua intera classe sociale, è di ritirarsi nell’ombra. Visconti, che discendeva egli stesso da una delle famiglie aristocratiche più antiche d’Europa, passò molti anni a tentare un adattamento di Proust per il grande schermo. In un certo senso ci riuscì con questo stupefacente arazzo cinematografico in cui ogni gesto, ogni parola, la disposizione di ogni oggetto in ciascuna stanza richiama in vita un mondo perduto. Il Gattopardo è un’epica del tempo, e la sua lentezza, che culmina in un maestoso crescendo nella lunga sequenza del gran ballo, è governata dai ritmi di vita dell’aristocrazia fondiaria siciliana, con i suoi costumi e abitudini, la sua coltivazione dell’agio e della riflessione, i suoi viaggi stagionali. È un’epica della storia, in cui assistiamo con i nostri occhi alle trame del cambiamento: sui campi di battaglia, nelle vie e nei salotti dove i notabili si riuniscono per decidere chi muoverà i fili del potere. È anche il ritratto di un uomo, il Principe di Salina, interpretato da Burt Lancaster. All’epoca della lavorazione del film ci fu chi mise in dubbio questa scelta di cast, ma dopo aver visto Il Gattopardo risulta impossibile immaginare qualcun altro nei panni del Principe. Lancaster conferisce al personaggio forza e autorità ma anche intelligenza e grazia, e il suo senso di finezza aristocratica è straordinario. È un’interpretazione eccezionale, profondamente toccante. In definitiva, Il Gattopardo è un grande inno sinfonico alla Sicilia, al suo popolo, ai suoi profumi e al suo paesaggio, alla sua bellezza e alla sua violenza. Il film di Visconti è una delle più grandi esperienze visive della storia del cinema, e nel corso degli anni i restauri si sono rivelati estremamente difficili. Sono molto felice che la Film Foundation, con il sostegno finanziario di Gucci, abbia contribuito a rendere possibile questo straordinario restauro. Ci è stato così restituito uno dei nostri tesori più preziosi, in tutta la sua gloria. Martin Scorsese, Fondatore e Presidente di The Film Foundation “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.” Benché Tancredi stia parlando del futuro dell’aristocrazia italiana, la sua descrizione si applica bene anche al restauro dei film. Nel corso degli anni la tecnologia cinematografica è radicalmente cambiata, e una delle principali sfide del restauro è tentare di ricreare l’impossibile esperienza della visione del film così come fu originariamente presentato. Oggi potenti strumenti digitali ci consentono una libertà quasi illimitata nella manipolazione delle immagini e nella correzione del colore. È così possibile cancellare quasi completamente le devastazioni del tempo e rendere i risultati artistici e tecnici originali de Il Gattopardo più fedelmente di quanto fosse possibile in passato con l’impiego delle tecniche fotochimiche tradizionali. Il Gattopardo fu fotografato con un processo chiamato Technirama, nel quale le immagini vengono impressionate su pellicola 35mm in senso orizzontale anziché verticale. L’immagine anamorfica risultante, che ha il doppio delle dimensioni di un fotogramma 35mm, è eccezionalmente nitida e ricca di dettagli. Il negativo originale del 1963 è ormai sbiadito e mostra molti dei problemi comuni ai film della sua epoca. Un aspetto interessante, tuttavia, è che a causa del processo fotografico i graffi e lo sporco scorrono lungo il fotogramma in orizzontale anziché in verticale. Per questo nuovo restauro i negativi originali in Technirama sono stati scansionati a 8K (8000 linee di risoluzione orizzontale) producendo ventuno terabyte di dati. È stato scansionato anche un interpositivo 35mm per recuperare sezioni necessarie a sostituire materiale assente nei negativi originali. Dopo la scansione tutti i file sono stati convertiti a 4K, e il restauro interamente digitale è stato eseguito a questa risoluzione. In 12.000 ore di restauro manuale sono stati eliminati quarantasette anni di sporco, graffi e altre anomalie fisiche. Anche la colonna sonora monoaurale originale è stata sottoposta a un accurato restauro, usando un magnetico 35mm acquisito ed elaborato digitalmente per eliminare schiocchi, scatti e rumori mantenendo al contempo le caratteristiche dell’originale. Schawn Belston, Film Preservation, Twentieth Century Fox Il Cinema Ritrovato. Al cinema Classici restaurati in prima visione da lunedì 28 ottobre Il Gattopardo di Luchino Visconti versione restaurata www.cinetecadibologna.it www.ilcinemaritrovato.it
Scaricare