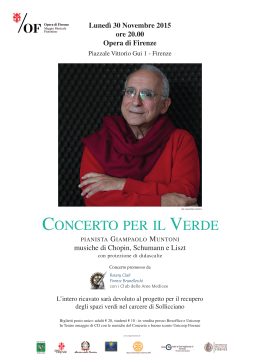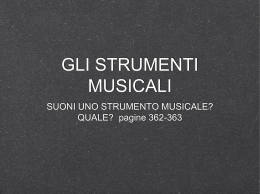Rivista dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca n. 4 - anno 2013 - nuova serie I grandi anniversari musicali sillabe Istituto Musicale Luigi Boccherini sillabe «Codice 602» Nuova serie Il titolo della Rivista è un omaggio ad una delle più antiche tradizioni musicali lucchesi. Risale, infatti, all’XI secolo il prezioso Antifonario noto come Codice 602, custodito nella Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca. Rivista annuale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca N. 4 - Dicembre 2013 Autorizzazione del Tribunale di Lucca n. 867, del 20.10.2007 Direttore responsabile: Sara Matteucci Responsabile editoriale: Fabrizio Papi Comitato di redazione: Giulio Battelli, Sara Matteucci, Fabrizio Papi I grandi anniversari musicali Rivista dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca n. 4 - anno 2013 - nuova serie Comitato scientifico: Giulio Battelli, Marco Mangani, Guido Salvetti In questo numero hanno collaborato: Gabriella Biagi Ravenni, Marco Brighenti, Giovanni Giannini, Marco Moiraghi, Alessandro Solbiati, Guido Salvetti, Donato Sansone, Fulvio Venturi Realizzazione editoriale: Sillabe s.r.l. Scali d’Azeglio 22/24 57123 Livorno www.sillabe.it Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”: GianPaolo Mazzoli Presidente: Paolo Cattani Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” Piazza del Suffragio, 6 55100 - Lucca Tel. 0584 464104 www.boccherini.it La Rivista «Codice 602» Nuova serie è realizzata grazie al contributo di: Fondazione Banca del Monte di Lucca ISBN 978-88-8347-536-8 sillabe Indice Editoriale7 di Sara Matteucci La parola del direttore di GianPaolo Mazzoli 11 Contributi Di quella piva l’orrendo sono La cornamusa nelle opere verdiane di Piave: un (dis)appunto di Budden di Donato Sansone Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano di Marco Brighenti 15 35 Io l’ho servita per l’amore. Mascagni, D’Annunzio e Parisina57 di Fulvio Venturi Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc 67 di Guido Salvetti Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten di Alessandro Solbiati Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra di Marco Moiraghi 83 111 Studi sulla Musica a Lucca Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” di Gabriella Biagi Ravenni 129 Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini 149 La tesi di laurea Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner come possibile modello per il primo movimento del Concerto op. 11 di F. Chopin di Giovanni Giannini 163 Editoriale di Sara Matteucci Come tutto il mondo musicale internazionale rivolge e ha rivolto quest’anno doveroso interesse alla coincidenza degli anniversari verdiani e wagneriani, anche l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” si inserisce nel clima di tali celebrazioni attraverso le proprie attività culturali ma, nello spirito di una stretta connessione con l’intera comunità musicale europea, ha deciso di allargare lo sguardo su altre importanti ricorrenze, dedicando questo quarto numero della nuova serie della Rivista «Codice 602» ai Grandi anniversari musicali. Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Michele Puccini, Pietro Mascagni, Benjamin Britten, Francis Poulenc e Paul Hindemith: questo l’ampio e variegato parterre di compositori cui alcune delle migliori firme della musicologia contemporanea hanno dedicato i propri studi, portando alla luce aspetti e contenuti inediti della loro produzione musicale nei saggi presenti in questa edizione. Tra le innumerevoli sfaccettature della musica verdiana, una particolare venatura folklorica dell’orchestrazione drammatica viene analizzata nel saggio di Donato Sansone “Di quella piva l’orrendo sono”. La cornamusa nelle opere verdiane di Piave: un (dis)appunto di Budden, caratterizzata dall’utilizzo o dall’evocazione del suono di aerofoni a sacco quali zampogne e cornamuse. Esempi dalle opere Aroldo e Macbeth sono approfonditi qui sul piano del significato drammaturgico, dell’orchestrazione e della strumentazione e della struttura armonico-melodica. L’altro grande bicentenario è invece onorato dal testo di Marco Brighenti, Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano, in cui l’estetica wagneriana è esaminata attraverso il dualismo tra prospettiva esteriore e interiore presenti nella complessa concezione teatrale del compositore tedesco, aspetto che determina influenze sul rapporto tra musica e parola, sulla recitazione dei cantanti, fino alla costruzione della trama stessa dell’opera e all’architettura degli spazi teatrali. Codice 602 7 Un triplice anniversario risuona tra le righe del saggio “Io l’ho servita per l’amore”. Mascagni, D’Annunzio e Parisina, con cui Fulvio Venturi ripercorre l’iter produttivo dell’opera Parisina di Pietro Mascagni dalle origini fino all’ultima edizione. Dall’Italia di nuovo alla Germania, Marco Moiraghi svolge un’interessante indagine musicologica in Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra, analizzando le connessioni tra il tema della guerra e la produzione musicale del compositore tedesco scomparso cinquant’anni fa, attraverso il ricorrente utilizzo della marcia militare nel suo vasto repertorio. Nel 1963 anche la Francia visse un rilevante lutto musicale e, dopo aver celebrato nel 2012 il 150° anniversario della nascita di Claude Debussy, ricorda oggi Francis Poulenc, un altro pilastro della sua musica nazionale. Ed è con una quanto mai utile rilettura del suo Journal de mes mélodies che la nostra rivista rende omaggio al musicista francese grazie all’articolo Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc, del noto musicologo Guido Salvetti. Rivolto agli interpreti della musica vocale da camera, il celebre “Diario delle mie mélodies” rappresenta un prezioso ‘manuale di istruzioni per l’uso’ che lo stesso Poulenc curò per decenni, dispensando consigli e chiarimenti sulle modalità di esecuzione della propria musica. Centesimo compleanno poi per il compositore, direttore d’orchestra e pianista Benjamin Britten, al cui ritorno alla scrittura cameristica Alessandro Solbiati dedica il proprio contributo, Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten, con un’approfondita analisi del brano scritto nel 1975, un anno prima della morte del compositore britannico. Come ogni anno, «Codice 602» riserva inoltre una sezione dedicata agli “Studi sulla Musica a Lucca”, e anch’essa in questo numero è improntata agli anniversari musicali. Un’estesa ricerca condotta su materiali d’archivio ha portato Gabriella Biagi Ravenni alla stesura delle Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari”, una significativa indagine sulle prime rappresentazioni delle opere di Giuseppe Verdi (particolarmente I lombardi alla prima crociata, Ernani, Attila e Macbeth) al Teatro di Lucca, con particolare riferimento all’attività dell’impresario Alessandro Lanari. Il 1813 fu anche l’anno di nascita di Michele Puccini, padre del famoso Giacomo, anch’egli musicista, il quale fu docente e poi direttore dell’Istituto Musicale lucchese. Nel giorno del suo funerale, il 18 febbraio 1864, Giovanni Pacini tenne un elogio funebre nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparata di Lucca e il testo del discorso, che ripercorre sostanzialmente la biografia del compositore lucchese, fu poi dato alle stampe. Oggi lo riportiamo integralmente in questa edizione della nostra rivista con una breve introduzione esplicativa. Infine, «Codice 602» ospita come di consueto una delle migliori tesi di Laurea di un allievo dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”. Si tratta questa volta di Giovanni Giannini il quale presenta un estratto della propria tesi di Diploma Accademico di II livello, dal titolo Il primo movimento del Concerto per pianoforte e orchestra op. 61 di F. W. Kalkbrenner come possibile modello del primo movimento del Concerto op. 11 di F. Chopin. Attraverso una serie di corrispondenze tematiche e formali corredate da esempi musicali, la tesi dimostra come il giovane Chopin avesse ben presente i modelli di un genere tramite cui egli desiderava raggiungere il successo come concertista. Questo quarto numero della Rivista «Codice 602» vede l’instaurazione di varie novità, tra cui il cambio della direzione, la collaborazione con la casa editrice Sillabe, e l’istituzione di un archivio online delle precedenti edizioni della Rivista (consultabile sul sito web: www.boccherini.it). Desidero approfittare di questa occasione per ringraziare sentitamente il Direttore GianPaolo Mazzoli e il Consiglio accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” che recentemente mi hanno accordato la loro fiducia. Vorrei inoltre esprimere una calorosa riconoscenza a chi mi ha preceduto, il prof. Carmelo Mezzasalma, ai colleghi del comitato scientifico, agli autori dei saggi e soprattutto al comitato di redazione formato, oltre che dalla sottoscritta, dai prof.ri Giulio Battelli e Fabrizio Papi, per il prezioso, concreto e competente contributo. Con l’intento di mantenere sempre alto il livello qualitativo della Rivista e di potenziarne l’impatto e la diffusione, esprimo l’augurio perché «Codice 602» possa affermarsi sempre di più come uno degli organi rappresentativi della ricerca musicologica e del dibattito culturale musicale. Buona lettura. Codice 602 8 9 La parola del direttore L’anno accademico 2013/2014 segna per me l’inizio del quinto anno del mio mandato da Direttore. Non è certo il tempo di fare dei bilanci definitivi ma è comunque il tempo di iniziare un’attenta analisi di quello che mi rimane da realizzare fra gli obiettivi che mi ero prefissato e soprattutto riflettere su quello che avrei potuto fare meglio e, perché no, anche su quello che, tornando indietro, non rifarei. Una cosa di cui certamente sono orgoglioso è aver creduto nello sviluppo della Rivista «Codice 602», vero fiore all’occhiello della nostra produzione artistica–musicologica. Quest’anno la Rivista si presenta con una nuova e innovativa veste grafica, sebbene sempre legata alla tradizione dei numeri precedenti, e prevede una capillare distribuzione nei maggiori centri d’interesse musicologico. Per questo voglio ringraziare la casa editrice Sillabe, per avere curato questa nuova edizione ma soprattutto i miei colleghi Giulio Battelli, Sara Matteucci e Fabrizio Papi per il valido e coscienzioso apporto dato a questa significativa iniziativa, contribuendo a dare sempre maggiore prestigio al nostro Istituto. Devo evidenziare poi che quest’anno, denso di importanti anniversari musicali, il nostro Istituto, oltre alla rivista, ha onorato i grandi musicisti europei promuovendo anche una serie di conferenze e incontri culturali e dedicando il concerto inaugurale del nuovo anno accademico alla celebrazione di Verdi, Wagner e Britten. Tutto questo perché produzione artistica e musicologica rappresentano da sempre un nostro obiettivo, certi che entrambe siano necessarie non solo a completare il percorso di studi professionalizzante dei nostri studenti ma anche per rimanere al livello dei maggiori conservatori italiani. È doveroso da parte mia ringraziare per l’importante lavoro svolto il Prof.re Carmelo Mezzasalma, che quest’anno lascia la direzione della rivista, e augurare al nuovo Direttore, la Prof.ssa Sara Matteucci, un buon lavoro nella speranza che «Codice 602» acquisisca sempre più rilievo nel panorama delle pubblicazioni musicologiche italiane. Codice 602 11 Ringrazio infine la Fondazione Banca del Monte per il sostegno economico, senza il quale non avremmo mai potuto realizzare questa importante pubblicazione, e per la sensibilità istituzionale che ogni volta dimostra sostenendo meritevoli iniziative tese alla promozione e allo sviluppo della cultura musicale. M° GianPaolo Mazzoli Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” Contributi Di quella piva l’orrendo sono La cornamusa nelle opere verdiane di Piave: un (dis)appunto di Budden di Donato Sansone* Nel suo noto e corposo saggio sul teatro musicale verdiano, Julian Budden in almeno due occasioni si sofferma a puntualizzare come il musicista, volutamente o per incompetenza specifica o per faciloneria, abbia disatteso nella scrittura la sua stessa intenzione musicale; e lo fa con parole simili. Mi riferisco all’effetto musicale evocativo del suono di cornamusa che Verdi utilizza in due diverse partiture drammatiche su testo di Piave, e che il Budden così liquida in un caso: “con tale termine non intendeva la cornamusa scozzese […] bensì la più amabile zampogna italiana che ancora si può sentire per le strade di Roma”1; e così nell’altro: “Per le cornamuse il suo modello era la zampogna italiana; di qui la pia illusione che esse venissero suonate dai pastori intenti a pascolare il gregge”2. Toccato su una corda forse particolarmente sensibile, trattandosi dello strumento che più di tutti identifica la musica della sua nazione, lo studioso britannico sembra dunque rivolgere un’amorevole rampogna (mi si passi il gioco di parole) al musicista emiliano. I due melodrammi in questione, ambientati entrambi, neanche a dirlo, in terra d’Albione, sono Aroldo e Macbeth. * Donato Sansone è titolare della cattedra di Biblioteconomia e bibliografia musicale presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Diplomato in Flauto dolce, all’attività di ricerca musicologica e bibliografica affianca quella di concertista nell’ambito della musica medievale e barocca. Ha al suo attivo alcune centinaia di concerti in Italia, Europa, Australia, Medio Oriente e Stati Uniti. Studioso di diversi repertori musicali e strumenti tradizionali, da più di 30 anni pratica attivamente il mondo della zampogna e della ciaramella, strumento di cui è specialista riconosciuto a livello nazionale. 1 Julian Budden, Le opere di Verdi, I: Da Oberto a Rigoletto, Torino, EDT/Musica, ©1985, p. 324. 2 Julian Budden, Le opere di Verdi, II: Dal Trovatore alla Forza del destino, Torino, EDT/Musica, ©1986, p. 378. Codice 602 15 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone AROLDO, ovvero Lontani suoni di cornamuse Elaborato tra il 1856 e il 1857, il dramma trasla oltremanica, retrocedendola di qualche secolo, la materia del precedente Stiffelio. La vicenda si svolge tra il Kent e le sponde del Loch Lomond: il trasferimento dell’azione in Scozia avviene in un’ellissi narrativa tra il III atto, che si chiude in un castello del Kent, ed il IV, che si apre con la seguente didascalia: Profonda valle in Iscozia. La riva del lago Loomond si vede in prospetto. Monti praticabili, coperti di selve a destra e sinistra, dov’è un pineto presso cui una modesta casa. Cade il sole. Lontani suoni di cornamuse e corni che si appressano. Voci di Pastori, Donne e Cacciatori, che scendono dai monti e s’incontrano sulla scena. È un paesaggio, rimarca il Budden, “i cui connotati ricordano più l’Abruzzo che il Dumbartonshire”3. Se, infatti, l’associazione di pastori e zampogne obbediva ad un consolidato topos letterario e figurativo (ed è un cliché a tutt’oggi radicato, ma solo parzialmente corretto), il bagpiper scozzese nell’immaginario anglosassone non è mai stato l’ingenuo bovaro invasato di un’arcadica virtù artistica, ma un professionista, con un ruolo specifico anche di dignità statale, come quando accompagna, anzi in un certo senso guida le truppe in battaglia, ruolo attestato fin dal XVI sec. Pastori, donne (contadine) e cacciatori costituiscono tre distinti gruppi corali, ognuno dei quali è evocato da un inciso musicale: ovviamente una coppia di corni rappresenta i cacciatori, mentre i pastori, come ormai si è capito, sono evocati dalle cornamuse; più tardi queste omaggeranno della loro rurale simbologia anche le contadine, che nell’esposizione iniziale del quadro lirico sono rappresentate dagli archi. Posta dunque dal testo l’esigenza drammaturgica, si pone a Verdi il problema di tradurre musicalmente e timbricamente le caratteristiche idiomatiche dello strumento: se per i corni il problema nemmeno si pone che è già risolto, per la cornamusa si tratta di individuare e poi riprodurre “il suo idioletto strumentale”4, e renderne le componenti timbriche, melodiche, armoniche e ritmiche. Per meglio comprendere le parole di Budden da cui siamo partiti, occorre tratteggiare schematicamente le caratteristiche della cornamusa scozzese che il dramma propone, e della zampogna che Verdi dispone. Innanzitutto occorre isolare una cornamusa scozzese ‘tipo’ ed una zampogna ‘tipo’ (in realtà dovremo ricorrere a due sottotipi, ‘a chiave’ e ‘zoppa’), dal momento che numerose sono le varianti cronologiche e regionali sia dell’uno che dell’altra: sarebbe dunque più corretto parlare di famiglia che non di specie, ma possiamo comunque limitarci a una generalizzazione accettabile ed in ogni caso perfettamente funzionale alle esigenze della presente analisi. La cornamusa che ha in mente Budden, e che probabilmente avevano in mente, almeno sul piano iconografico, Piave e Verdi, corrisponde verosimilmente alla Highland Bagpipe del classico suonatore in kilt che a tutti noi è familiare; la zampogna cui sembra far riferimento Budden è la zampogna laziale-molisana (o, con poche differenze, calabro-lucana), lo strumento che più di ogni altro connota l’idea e l’atmosfera del natale italiano, e che proprio in corrispondenza di quello scorcio d’anno vediamo (per la verità sempre meno) suonare da musici ambulanti per tutta la penisola. Quantunque anche solo visivamente gli strumenti appaiano completamente diversi, permane diffusissima la confusione di nomi e di ruoli fra i due, al punto che negli ultimi anni non è affatto raro, purtroppo, imbattersi in bagpipers con cornamuse scozzesi vestiti da improbabili pastori italici nelle manifestazioni natalizie delle nostre città. Pochissime cose hanno in comune i due strumenti. Entrambi sono costituiti da più canne ad ancia nelle quali l’aria affluisce in modo continuo attraverso un otre, tradizionalmente in pelle animale, tenuto in costante pressione dall’insufflazione dell’esecutore tramite la respirazione5; una o più canne (‘chanters’) hanno la possibilità di produrre melodie attraverso buchi o chiavi, un’altra o altre canne producono invece un suono fisso (bordoni). Questo è il comune denominatore. Notevoli sono le differenze. La zampogna è strumento principalmente da accompagnamento della ciaramella o piffera, ed è per questo che l’iconografia e la pratica musicale tradizionale prevede di norma i due strumenti e i due suonatori in coppia; la cornamusa è invece strumento solista, e anche quando impiegata in gruppi come le bande militari, tutti sono solisti e fanno tutti la stessa cosa. La struttura dello strumento è conseguenza (o causa) del diverso impiego musicale. La zampogna è infatti provvista di due ‘chanters’ e di un numero di bordoni che va da uno a tre. Il doppio ‘chanter’ è la vera differenza dirimente: al contrario di quanto avviene sulla cornamusa, le due canne melodiche permettono di produrre armonie, se pur limitate ai soli accordi di tonica e dominante. I due ‘chanters’, detti ‘manca’ e ‘ritta’, a distanza di ottava, hanno entrambi l’estensione di una 5a, ma la ‘ritta’ ha in più la possibilità di suonare la nota sensibile un semitono sotto la fondamentale. La ‘ritta’ può dunque produrre sei note e impiega le cinque dita della mano destra (nei suonatori destri); la ‘manca’ ne impiega solo quattro (non è usa- 3 Budden, Le opere di Verdi, II, cit., p. 378. 4 Marco Beghelli, La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 2003, p. 541. 5 In alcune cornamuse europee (ad es. in Francia, Boemia, Irlanda) l’aria è immessa nell’otre attraverso un mantice azionato col braccio. Codice 602 16 17 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone to il pollice). Il bordone è intonato alla 5a sopra la fondamentale più bassa; se sono presenti altri bordoni (secondo il modello e l’area di provenienza), raddoppiano all’8a superiore o inferiore il bordone centrale. In uno strumento in Sol lo schema fonico è dunque il seguente: RITTA: Fa2 Sol2 La2 Si2 Do3 Re3 MANCA: Sol1 La1 Si1 Do2 Re2 BORDONE: Re2 altro/i BORDONE/I: Re1 Re36 È proprio la presenza del bordone a caratterizzare armonicamente la zampogna: in virtù (per colpa) di quel vincolo può produrre solo accordi di tonica e di dominante, sia pure in forma di diversi rivolti giocando fra i due ‘chanters’. La peculiarità armonica dello strumento è all’origine del suo nome: ‘zampogna’ deriva infatti da ‘syn-phonia’ 7 . La cornamusa ha invece un solo ‘chanter’, che è suonato con entrambe le mani e consente pertanto l’estensione di più di un’ottava (solitamente una nona); nella sua forma più diffusa ha tre bordoni intonati sulla tonica, due dei quali all’unisono, mentre il terzo è all’ottava sotto. Meno significativa sul piano musicale, ma molto importante su quello timbrico, è la differenza di tipologia delle ance. La zampogna monta infatti solo ance doppie, mentre la cornamusa usa l’ancia doppia per il solo ‘chanter’, a cui conferisce il tipico suono penetrante, mentre i bordoni sono provvisti di ancia semplice. Il vero ‘chanter’ della zampogna, come si è detto, è esterno allo strumento, ed è la ciaramella, o piffera, che svolge lo stesso ruolo del ‘chanter’ della cornamusa, cioè quello di suonare le melodie. Entrambi sono intonati con la fondamentale verso il basso, corrispondente al penultimo dito (anulare)8. Ciò comporta una conseguenza che è soprattutto musicale: i repertori dei due strumenti sono infatti basati su una scala di tipo autentico e non possono eseguire brani su scala plagale. Se questa è la struttura standard della zampogna più diffusa e che è giunta fino a noi, bisogna tener conto, tuttavia, di una seconda tipologia, più arcaica, oggi quasi del tutto scomparsa nelle aree di diffusione della zampogna ‘a chiave’, ma di cui numerose evidenze iconografiche e 6 Entrambi i bordoni sono pressoché disusati; in area laziale-molisana il bordone basso è chiamato ‘contro’, quello alto ‘moschetta’. In alcune aree di diffusione del modello calabro-lucano gli strumenti montano tutti e tre i bordoni. 7‘Synphonia’ è chiamato anche uno strumento a corde dal suono continuo, testimoniato in età medievale, precursore della ghironda, dotato di una corda tastata e di uno o più bordoni, che gli conferiscono una sonorità simile a quella degli aerofoni a sacco. In area iberica è presente una ghironda chiamata ‘zanfona’, fase intermedia nell’evoluzione fono-ortografica del termine. 8 Mentre la nota più bassa della ciaramella è un semitono sotto la fondamentale, come nella ritta della zampogna, nel ‘chanter’ della cornamusa è invece a distanza di un tono. alcune testimonianze musicali attestano l’uso e la diffusione soprattutto nell’area circumromana. Si tratta della zampogna ‘zoppa’, sorella carnale (o meglio lignea) dell’altra, al punto che diversi costruttori le producevano entrambe. La ‘zoppa’ differisce dalla prima innanzitutto, come s’intuisce, per la mancanza della chiave che permette di chiudere l’ultimo foro della ‘manca’, ma soprattutto per la diversa accordatura delle due canne: esse sono infatti intonate a distanza di 4a (e non di 8a). Riprendendo il precedente schema della nostra zampogna ‘tipo’: RITTA: Fa2 Sol2 La2 Si2 Do3 Re3 MANCA: Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Ciò conferisce alla variante ‘zoppa’ due importantissime peculiarità rispetto alla zampogna a ‘chiave’: la prima è la possibilità di suonare a solo, avendo, pur distribuite fra due ‘chanters’, l’intera gamma di una scala; la seconda è di poter eseguire anche melodie con scale plagali. E così è per la zampogna ‘zoppa’ più nota che è sopravvissuta ai nostri giorni, anche se a forte rischio di estinzione: si tratta della zampogna di Amatrice, paese conosciuto ai più come eponimo di uno dei di più famosi sughi della cucina italiana (‘all’amatriciana’) piuttosto che per la sua rarissima zampogna, il cui repertorio basato prevalentemente su intervalli di 4e e 5e parallele, su un modo misolidio plagale, costituisce uno dei più straordinari arcaismi della tradizione musicale popolare italiana9. Il IV atto del dramma si apre dunque con una scena corale interpunta dagli incisi delle sezioni strumentali associate ai tre diversi gruppi. Soffermandoci su quelli che denotano la cornamusa e (fallosamente, secondo Budden) connotano il mondo agro-pastorale, rileviamo che in effetti è 9 La struttura della zampogna ‘zoppa’, di ormai rara diffusione in area centro-meridionale a vantaggio di quella ‘a chiave’, si ritrova ancora viva e diffusissima, con lievi varianti, tra Sicilia e Calabria: lo strumento, chiamato ‘a paro’, ha un uso esclusivamente solistico o di accompagnamento del canto. A differenza dei modelli laziali, molisani, campani e lucani monta ance semplici. La sopravvivenza della zampogna ‘a paro’ consente di gettare una luce sulle modalità d’uso della desueta zampogna ‘zoppa’: la tipica tecnica di accompagnamento sulla canna manca è a volte riecheggiata in alcune trascrizioni (o meglio rimembranze) di musicisti colti dei secoli scorsi. Accenno solo che ne ritroviamo traccia, ancora problematicamente associata al termine ‘cornamusa’, in un’altra opera verdiana, l’Otello (opera di Boito e dunque estranea alla trattazione). Nel II atto Verdi dispone in partitura una cornamusa (che può “essere sostituita da due oboi”) e le affida questo accompagnamento del coro di marinai, donne e fanciulli, che, se opportunamente tradotto in tempo composto, corrisponde esattamente ai moduli praticati sugli strumenti ‘a paro’ e presumibilmente sugli ‘zoppi’: Per una più esaustiva e accurata disamina delle zampogne e di altri aerofoni a sacco italiani rimando a Febo Guizzi, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lucca, LIM, 2002; La zampogna in Europa, Como, Tipografia Nani, 1979; La zampogna: gli aerofoni a sacco in Italia, a cura di Mauro Gioielli, Isernia, Iannone, 2005. Codice 602 18 19 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone proprio questo l’inciso che apre la scena e l’atto, previo rullare cupo di timpani, rispettando peraltro l’ordine indicato dalla didascalia (“Lontani suoni di cornamuse e corni che si appressano”). Timbricamente la scelta delle ance è pressoché obbligata: la cornamusa, tradotta in orchestra, è 2 oboi, 2 clarinetti e 2 fagotti. Sorprendente l’esordio: prima della melodia, infatti, ci sono due lunghi suoni all’ottava corrispondenti alla tonica (Sol): è esattamente così che inizia a suonare una Highland bagpipe, nella quale le ance battenti dei bordoni, accordati per l’appunto a distanza di ottava, entrano in azione un po’ prima dell’ancia doppia più dura del ‘chanter’, anche per consentire al ‘piper’ di accordarli. Fin qui la mimesi è straordinaria. L’andamento ritmico, tuttavia, è il tipico andamento binario terzinato delle più classiche melodie del repertorio per zampogna, organizzato in battute di 6/8; ma la tonalità minore è pressoché estranea allo stesso repertorio. La melodia si dipana in un intervallo di 6a minore, dunque da cornamusa o da ciaramella; la sua ripetizione è armonizzata per 3e parallele, che si aprono alla 5a sulla dominante pre-cadenzale, ove le note necessarie al completamento dell’armonia diadica dei clarinetti sono sopperite dall’ingresso dei fagotti. È sicuramente questo il dato decisivo alla base del giudizio di Budden: la cornamusa non può produrre bicordi, mentre la diafonia per 3e sembra ben evocare il suono della zampogna, che in virtù dei suoi due ‘chanters’ di regola produce formule armoniche di accompagnamento basate su intervalli di 6a. Rivoltando l’intervallo, la ripetizione della melodia, armonizzata, è perfettamente eseguibile su una zampogna ‘a chiave’, salvo il Re basso cadenzale. Insomma, dopo un inizio da cornamusa (se fossero stati bordoni di zampogna avrebbero suonato la dominante, non la tonica), le componenti salienti dell’idioletto sembrano essere in effetti quelle della zampogna. Sul piano del fraseggio la mimesi naturalistica lascia decisamente il passo all’invenzione artistica: l’inciso è costruito su di una semplice struttura di 4+4 battute, ma la schematicità strutturale è tuttavia interrotta dall’inserimento di una battuta centrale in cui le due voci si fermano per lasciar quel nonsoché di ‘vago ed indefinito’ leopardianamente poetico; e del resto ‘vaga ed indefinita’ e altrettanto impressa di un’impronta artistica più colta che popolare è l’ondivaga tensione modale del paesaggio armonico di questa scena, nella quale maggiore e minore si intersecano, si alternano, si accavallano, si ammiccano. L’inciso non è quanto di più riuscito sul piano melodico, e men che mai suggestivo di arie popolari scozzesi o ‘abruzzesi’, specialmente nello sviluppo della sua seconda battuta: sembra che l’impegno artistico di Verdi sia monopolizzato dall’intento pittorico affidato alle componenti armonico-timbriche, a discapito dell’efficacia della linea melodica, pur in un momento così importante sul piano della contestualizzazione drammaturgica. MACBETH, ovvero Suono sotterraneo di cornamusa Con quest’opera, la prima partitura in cui Verdi trasfonde il suo professato amore per il poeta inglese10, dal dramma storico di impostazione scottiana si passa al “genere fantastico”11. Com’è noto, il Macbeth vide una duplice realizzazione: la prima per il Teatro della Pergola nel 1847; la seconda, con testo tradotto e gli adattamenti scenici al gusto francese, quasi un ventennio dopo, per il ThéâtreLirique di Parigi nel 1865; con testo italiano venne poi rappresentata alla Scala nel 1874. Diverso il genere, diverso il ruolo drammaturgico dell’invenzione musicale: in consonanza con le cupe e misteriche atmosfere celtiche, la didascalia che nel rito mantico del III atto introduce l’apparizione e la teoria degli otto re e del fantasma di Banco affida la caratterizzazione, timbrica più che musicale, ad un “suono sotterraneo di cornamusa” prodotto peraltro esattamente in coincidenza con l’improvvisa sparizione del calderone in cui bolle il classico brodo di rospi, vipere e sangue, inghiottito dalla terra. Se nell’Aroldo alla cornamusa era affidato il compito di 10 “È un poeta di mia predilezione, che ho avuto fra le mani dalla mia prima gioventù, e che leggo e rileggo continuamente”. Lettera di Verdi a L. Escudier, 28 aprile 1865 (Jacques Gabriel Prod’homme, Lettres inédites de G. Verdi à Léon Escudier, «Rivista musicale italiana», XXXV (1928), p. 187). 11 “Siamo perfettamente d’accordo sul genere fantastico dell’opera che devo scrivere per Firenze”. Così Verdi al Lanari in una lettera del 17 maggio 1847 (Verdi’s Macbeth: a Sourcebook, ed. by David Rosen and Andrew Porter, Cambridge University Press, [1984], p. 4). Aroldo, IV Atto, bb. 5-16 Codice 602 20 21 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone connotare geograficamente il trasferimento dell’azione in Scozia e antropologicamente il coro dei lavoratori della terra (pastori, cacciatori, contadine), qui, che in Scozia ci siamo fin dalla sinfonia, il valore simbolico si fa meno oleografico e più profondo. La partitura, infatti, colloca questo evento sonoro esattamente dove lo colloca il testo, cioè “sotto il palco” (= sotto terra), e lo concretizza timbricamente in un ensemble di fiati, naturalmente ance, ma molto poco banale e scontato: 2 oboi, 6 clarinetti in La, 2 fagotti e un controfagotto. La strumentazione è chiaramente rivelatrice dell’intenzione musicale: è chiaro che a Verdi interessa molto più il “suono sotterraneo” che quello “di cornamusa”, e a tal fine ricorre non solo semplicemente a suoni gravi (pur sempre fonocompatibili con quello di una cornamusa, quindi niente tromboni, cimbassi, o tube), ma anche tradizionalmente evocativi o suggestivi dell’ipogeo: ne scaturisce infatti un effetto del tipo organo regale che connota il Plutone monteverdiano. C’è da chiedersi per quale motivo Piave12 e Verdi (ma in questo caso direi Piave in primis) abbiano collocato sottoterra proprio una cornamusa. In alcune aree alpine (dunque regioni che dichiarano, ed in parte hanno, matrici celtiche), è ancora in uso la pratica di invitare suonatori di cornamuse a suonare sui pascoli nel trapasso fra inverno e primavera allo scopo di richiamare in vita l’erba addormentata nel sottosuolo: nel Comasco e nel Bresciano sono i ‘marziröö’ che vanno a ‘ciamà l’erba’ suonando attualmente campanacci, che però curiosamente sono chiamati ‘sampügn’, nome che è evidente retaggio etimologico di altri ancestrali usi; a Teglio, in Valtellina, sono invece invitati suonatori di baghet o perfino zampognari13. Esiste dunque una tradizionale correlazione fra certi strumenti ad ancia e il mondo ipogeo; ma che il cittadinissimo Piave o il padano Verdi ne fossero a conoscenza è tutt’altro che cosa accertata. In realtà l’indicazione drammaturgica risale all’originale testo shakespeariano. Alla scomparsa del calderone, Shakespeare dà una laconica didascalia: “hautboys”; che il suono venga da sottoterra lo si deduce dalle parole di Macbeth (“Why sinks that cauldron? and what noise is this?”), pur non essendo affatto esplicitato che esso provenga da dove è finito il calderone. Dunque Shakespeare immagina un suono (ipogeo) non di cornamusa 12 Non entro, in questa sede, nella questione relativa al ruolo di Andrea Maffei nella composizione del libretto, come del resto rimane sostanzialmente estraneo alla tematica in oggetto il raffronto drammaturgico e musicale fra i diversi allestimenti: a entrambi i temi è dedicata ampia e nota letteratura. 13 Sull’uso del ‘chiamare l’erba’ nell’arco Alpino cfr. Roberto Valota, Chiamare l’erba: rituali di propiziazione primaverile nel Comasco e nel Nord Italia, Oggiono, Cattaneo, [1991]; Giuseppina Lombardini, Studi di folclore: proverbi valtellinesi, Sondrio, Tip. Mevio Washington, 1926; Guida escursionistica della Valchiavenna, Chiavenna, Rota, 1986; Maura Cavallero, Giochi della tradizione in Val San Giacomo, [Campodolcino], Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, 2008. (‘hornpipe’ o ‘bagpipe’, avrebbe scritto), ma di ance: laddove, naturalmente, ‘hautboy’ non indica un oboe inteso come lo strumento che, nella sua fisionomia definitiva e a noi familiare è andato definendosi solo nella seconda metà del ‘600, ma, nel linguaggio dell’età shakespeariana, indica genericamente gli strumenti ad ancia doppia imboccata come le bombarde, i cialamelli, i pifferi etc. Sublime è il gioco di parole nel testo inglese: alla didascalia “hautboys” le tre streghe urlano “Show!” “Show!” “Show!”14, evidente calembour fonetico con la parola ‘shawm’, che per l’appunto indicava propriamente la bombarda in area anglosassone15. Il “suono sotterraneo di cornamusa” si colloca a ‘Scena delle apparizioni’ avanzata, dopo l’evocazione dei primi tre simulacri (capo coperto d’elmo, fanciullo insanguinato, fanciullo coronato), e le relative profezie. Nell’ottica della fortissima caratterizzazione simbolica dell’intervento, la sua realizzazione musicale, nella quale la figura ritmica della terzina è peculiare, appare tutta costruita sul simbolo del tre: “tre” è la prima parola del III atto (“Tre volte miagola la gatta in fregola”) ripetuta per tre volte in anafora; tre sono le streghe che attuano il rituale; “tre sono le apparizioni profetiche, alle quali fa seguito un suono sotterraneo di cornamusa […]. Anche il motivo melodico […] si struttura secondo una scansione ternaria (accentuazione ricorrente di tre La […], quasi eco del triplice colpo di un usciere di corte) e si dipana pur esso sulle note di una triade”16; e tre volte, alla scomparsa del calderone, si alza l’appello “Apparite!” rivolto ai simulacri regali. 14 “Apparite!” “Apparite!” “Apparite!” nel libretto di Piave. 15 Secondo Francesco Degrada il testo shakespeariano di cui Verdi si sarebbe avvalso come punto di partenza per la collaborazione con Piave è quello nella traduzione di Carlo Rusconi pubblicato a Torino nel 1838 e ristampato più volte nel corso degli anni successivi (Budden, Le opere di Verdi, I, cit., p. 574). Shakespeare usa tre volte la parola ‘hautboys’, termine che il Rusconi traduce solo una volta in modo specifico, mentre nelle altre due circostanze si attiene ad un’indicazione generica, di volta in volta variata anche con implementazioni personali: Atto I, sc. 6. Atto I, sc. 7. Atto IV, sc. 1. Shakespeare Hautboys Hautboys and torches Hautboys Rusconi Squillo festivo di strumenti Suono di strumenti, e torcie Suoni d’oboè (William Shakespeare, Macbeth: Tragedia di Shakespeare. Voltata in prosa italiana da Carlo Rusconi, 5. ed., Firenze, Successori Le Monnier, 1867, pp. 34-35, 36-37, 119). 16 Beghelli, La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco, cit., p. 431. Codice 602 22 23 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone Macbeth (1865), III Atto, “Scena delle apparizioni”, bb. 144-147 A ben vedere, però, la simbologia è meno rigida di quanto sembra, essendo essa resa più complessa dalla compresenza del due: binario è il tempo, 4 i timbri strumentali, 4 le apparizioni complessivamente, 8 i re che sfilano, 3x2 (= 6) è l’altrimenti inspiegabile numero di clarinetti che Verdi chiede per il gruppo ‘cornamuseale’. Ma la più misteriosa promiscuità di binario e ternario è in realtà nell’evento centrale della scena: la quarta apparizione, quella degli otto re. Resta infatti avvolto nel dubbio se i “regal fantasimi” siano effettivamente otto o nove; quasi che con una focalizzazione narrativa su Macbeth si sia voluto far partecipe lo spettatore della confusione psichica del protagonista, ancor più turbato dall’apparizione, proprio in coda alla regale teoria, di Banco, che non è re e dunque non può essere l’ottavo, ma che è non è nono perché “otto re passano uno dopo l’altro: l’ultimo è Banco”. E Banco nono e ottavo insieme appare tenendo in mano uno specchio, cioè quanto di più esotericamente e simbolicamente duale ci sia17. Sul piano strettamente musicale ci troviamo davanti, più che a una melodia, a una sorta di squillo d’ordinanza da trombettiere, quasi si accogliessero, più che dei re, dei generali. Verdi parrebbe così restituire alla cornamusa la sua dignità marziale da Royal Regiment Pipe, quantunque qui assai lontana dagli ordinari usi di quel repertorio. La simbologia s’insinua anche al di là della struttura ritmico-melodica: lo squillo altro non è che l’esposizione pura e semplice di una tonalità nella sua triade di base; e non è una tonalità casuale, ma è quel Re 17 Sulla questione del numero delle ombre nella scena, anche in relazione al testo di Shakespeare e alle sue traduzioni, cfr. Daniela Goldin, La vera fenice: Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, Einaudi, 1985, pp. 237-238. maggiore che nella lettura simbolica macbethiana di Chusid rappresenta l’esposizione di realtà, verità e, nello specifico della scena, di profezie destinate ad avverarsi18. Lo ‘squillo’ ritorna dopo alcune battute, non più in funzione di segnale salutatorio, ma, sviluppandosi musicalmente, sembra assumere il carattere di una vera e propria marcia per la parata dei re (“Otto re passano uno dopo l’altro”): sempre più cornamusa da Regiment Pipe Band, a prima vista; tuttavia lo sviluppo è breve e musicalmente limitato all’introduzione di una variante di scarsissimo respiro melodico. Fa la sua comparsa un mimetico effetto bordoni dei fagotti, che nella prima esposizione era del tutto assente; ma l’effetto è solo apparente: le note sono ribattute, e quantunque Verdi si curi di indicare che l’articolazione dev’essere legata, la nota ribattuta con questa carica marziale è di impossibile esecuzione con qualsiasi aerofono a sacco. Nello sviluppo della frase, poi, proprio fagotti e controfagotti guidano un percorso modulatorio totalmente inconciliabile col ruolo di bordone. Se dunque Verdi-Piave hanno voluto una cornamusa, con valore marcatamente simbolico geo-etnografico o più profondamente esoterico, la realizzazione verdiana riconduce molto più shakespearianamente alla banda di ‘hautboys’, che peraltro ne costituisce la realizzazione pratica nella strumentazione della partitura. La ripresa dello ‘squillo’ è caratterizzata anche da una significativa implementazione armonica, affidata in prima battuta ai 6 clarinetti: essi dispiegano la loro piccola falange fonica in triadi perfettamente parallele, ciascuna nota delle quali è eseguita da una coppia all’unisono, ribadendo così la complessa simbologia di-triadica, che prosegue anche nella simmetrica scomposizione ternaria del secondo tempo di ogni battuta. Ci troviamo di fronte a quel parallelismo di terze che forse fa sentire a Budden quel certo odore di zampogna italiana, ma che con l’idioletto strumentale specifico ha ben poco a che vedere, e di cui, a mio giudizio, non è appropriato rimproverare qui Verdi. Ancor più significativa è l’evoluzione armonica delle quattro battute aggiunte: la melodia strizza l’occhio al modo minore, mentre clarinetti e fagotti, questi ultimi definitivamente svincolati da qualunque residuo di funzione bordonale, creano un’indefinita atmosfera armonica che da esoterica sembra farsi esotica, evocando il maqam hijaz di “sapor mediorientale”, per dirla con Gianna Nannini, o, per usare le parole del Nostro, “quel profumo orientale che io come musicista riconosco”19. Di nuovo un elemento diadico, dunque, nella dialettica tra i 18 “This suggests the future fulfillment of the prophecy ‘Non re, ma di monarchi genitore’”. Martin Chusid, Evil, guilt, and the supernatural in Verdi’s Macbeth: toward an understanding of the tonal structure and key symbolism in Verdi’s Macbeth: a Sourcebook, p. 258. 19 Verdi: interviste e incontri, a cura di Marcello Conati, Torino, EDT, 2000, p. 86. Codice 602 24 25 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone due poli maggiore e minore: esattamente come con le cornamuse dell’Aroldo, essi sfumano e confondono i rispettivi confini modali; ma qui, come accennato sopra, le ance basse sviluppano una tensione di dominante, mai risolta, che sussume ed esalta armonicamente, anche grazie ai rivolti di settima, questa vaghezza modale. Macbeth (1865), III Atto, “Scena delle apparizioni”, bb. 158-165 Il confronto fra le due scritture parla da sé. Dell’incedere regale della marcia del ’65 non c’è traccia alcuna, e più che una ieratica parata di spettri sembra una grottesca danse macabre di scheletri; rigida e totalizzante è l’articolazione ternaria; la tonalità di Re minore è più netta e affermata, anche e soprattutto grazie alla fissità (questa volta assai più bordonale, e per giunta da bordone di zampogna) del basso. Ne risulta più netta e schematica la dialettica fra tonica e dominante, a sostegno di un fluido ed inesorabile parallelismo delle terze nella linea melodica. Non c’è dubbio che proprio questo passaggio abbia portato il Budden al giudizio critico da cui siamo partiti (“non […] la cornamusa scozzese […] bensì la più amabile zampogna italiana”)20. E se l’invenzione della partitura parigina del ’65 è per lo studioso “una delle sonorità più ultraterrene di tutta l’opera ottocentesca” proprio in virtù della sua ricercata semplicità, ad essa lo studioso attribuisce anche e soprattutto il merito di aver emendato l’idea originale del ’47, “in cui la semplicità cade nella banalità”, arrestandone, anzi eliminando alla radice “la propensione a scivolare verso la canzonetta popolare”21. Non è dato sapere se Verdi abbia mai sentito una cornamusa scozzese; è assai più probabile che abbia sentito una coppia di zampognari questuanti a Roma o a Napoli22, dove si recò più di una volta, anche in tempo di novena o di Natale: è a Roma i primi giorni del gennaio Macbeth (1865), III Atto, “Scena delle apparizioni”, bb. 158-165 Siamo lontano le mille miglia o poco meno dalle terzinate pastorali a seste parallele delle zampogne. Ma per comprendere l’osservazione di Budden bisogna prendere in considerazione le due diverse partiture del ’47 e del ’65: lo sviluppo di tipo ‘marziale’ delle quattro battute d’esordio è infatti quello del Verdi parigino di vent’anni più maturo, mentre nella partitura del ’47, le stesse quattro battute così accolgono i re nella loro spettrale sfilata: 20Cfr. supra. Con buona pace del Budden, neanche questo è brano da zampogna: non le appartengono le note ribattute, tanto più se articolate corte come nella prima e nella terza battuta; al suo repertorio tradizionale inoltre è pressoché estraneo, come già detto, il modo minore. 21 Budden, Le opere di Verdi, I, cit., p. 325 22 Sicuramente a Roma e a Napoli arrivavano zampognari delle regioni interne fin dal XVIII sec. (cfr. Ambrogio Sparagna, Zampogne, presepi e musica paraliturgica nel Lazio meridionale in La zampogna: gli aerofoni a sacco in Italia, I, pp. 101-128). Sulla presenza abituale di suonatori molisani a Napoli per le novene: Mauro Gioielli, Il difficile mestiere dello zampognaro: due documenti ottocenteschi, «Utriculus», n. 36 (ott.-dic. 2005), pp. 16-17 e Giovanni Bidera, Gli ultimi novanta giorni del 1836, ossia, Il colera in Napoli, Napoli, a spese di Raffaele de Stefano, 1837, pp. 174-177. Codice 602 26 27 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone 184923 (ammesso che il clima della nascente repubblica romana fosse benevolo per i suonatori ambulanti di nenie devote); nel novembre dello stesso anno è a Napoli per seguire l’allestimento di Luisa Miller, rappresentata l’8 dicembre24. Certamente conosceva quel repertorio di musica ‘colta’ che si rifaceva al modello musicale caratteristico della zampogna. Termini come ‘piva’ o ‘pastorale’ erano già presenti nel vocabolario delle forme musicali da almeno tre secoli, riecheggiando, specialmente il secondo, stili e formule che ritroviamo nei repertori tradizionali delle zampogne e di altri aerofoni a sacco italiani25, mentre a partire dal ’700 più di un compositore si fece etnomusicologo ‘in nuce’ lasciandoci testimonianze musicali non solo ispirate al repertorio popolare della zampogna, ma dichiaratamente mimetiche dello strumento. Alcune costituiscono fonti preziosissime, una volta depurate delle contaminazioni dovute all’inevitabile censura eufonetica del musicista colto nei confronti dei generi ‘bassi’. Cataloghi di editori quali Canti o Ricordi, sicuramente familiari a Verdi, ne accoglievano alcuni: la Pastorale per organo con l’imitazione del suono de’ Zampognari di Giovanni Morandi (1822) e la Zampognata del Natale di J. Burgmein (cioè 23 Lettera di Verdi a S. Cammarano del 6 gennaio 1849; la Gazzetta di Roma “ne annunciò l’arrivo in città (n. 3, 4 gennaio 1849, p. 15) […] dal giorno 31 dicembre al giorno 1° gennajo” (cfr. Carteggio Verdi-Cammarano (1843-1852), a cura di Carlo Matteo Mossa, Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2001, p. 87. 24 Lettera di Verdi a V. Flaùto del 1° novembre 1849. Verdi si fermò a Napoli fino al 14 dicembre. Prima del ’49 era già stato a Roma dal 3 ottobre al 7 novembre del 1844 per la prima rappresentazione di I due Foscari; per la rappresentazione della stessa opera era stato a Napoli dal 26 giugno al 21 agosto del 1845 (Marcello Conati, Giuseppe Verdi e il suo tempo: introduzione alla cronologia verdiana in Verdi 200: vita e opere narrate ai giovani, a cura di Marcello Conati, Parma, Associazione Parma lirica, [1999], p. 30 e segg.), quindi ben prima di iniziare a lavorare al Macbeth. 25 Capostipite della letteratura per tastiera di questo genere sembra essere il celebre Capriccio pastorale F 2.34 di Frescobaldi, contenuto nel Primo libro di toccate (edizione 1637): l’incipit corrisponde ad una melodia tradizionale riscontrata in varie zone d’Italia, ad es. in Lombardia con il testo “San Giüsép e la Madona i andaven vers a Betlem” (Roberto Leydi, I canti popolari italiani, [Milano], Mondadori, 1973). Nello stesso anno escono i Pastorali concenti al presepe di Francesco Fiamengo, nei quali il genere è esplicitamente associato al Natale. Per un approccio metodologicamente critico alla complessa problematica dei rapporti fra repertori popolari e musica colta, cfr. Roberto Leydi, L’altra musica: etnomusicologia, S. Giuliano Milanese, MGB-LIM, 2008 e Guida alla musica popolare in Italia, I: forme e strutture, a cura di Roberto Leydi, Lucca, LIM, [s.d.]; sulla storia della relazione iconografica e musicale fra la Natività e gli aerofoni a sacco cfr. Nico Staiti, Angeli e pastori: l’immagine musicale della Natività e le musiche pastorali natalizie, Bologna, Ut Orpheus, c1997. Giulio Ricordi) ne sono due esempi tra i tanti26. La maggior parte di questo repertorio, come detto, è costituito da composizioni frutto di creazione artistica personale ‘alla maniera di’, cioè ispirate ai modelli musicali della zampogna e degli zampognari: note ostinatamente lunghe o ribattute, tempo composto, terze parallele ne sono gli ingredienti imprescindibili. Scorrendo alcuni titoli notiamo anche come al termine ‘zampogna’ si sostituisca, a volte, quello di ‘cornamusa’27. Sono, in estrema sintesi, i due peccati (certamente veniali) commessi da Verdi. Budden gli imputa il secondo, lo scrivente gli rimprovera, con il massimo possibile di bonarietà, anche il primo28. 26 Molto interessanti alcuni casi di vere e proprie cartoline d’autore riportate da musicisti d’oltralpe dal ‘viaggio in Italia’: H. Berlioz, Sérénade agreste à la Madone sur le thème des pifferari romains; Ch. Gounod, Les Pifferari, particolarmente prezioso sotto il profilo etnomusicale. Altre testimonianze 800sche a stampa o manoscritte (senza alcuna pretesa di esaustività): F. Paër, Pastorale degli zampognari; L. Lefébure-Wely, Les Pifferari: aubade italienne; G. Perderak, Pastorale suonata da pifferari abbruzzesi a Roma sotto le feste del S. Natale; J. Conte, I pifferari pour violon; L. Landsberg, Novena cantata dai pifferari e accompagnata dalla loro cornamusa; J. Benedict, I pifferari; F. Lanza, Gli Abbruzzesi in Napoli: pastorale […] sopra taluni motivi di zampogne nazionali; P. Davide da Bergamo, L’arrivo dei Pastori al Santo Presepio e loro partenza dal medesimo suonando la zampogna; F. Hérold, Tarantella précédé du chant des zampugni; L. Vecchiotti, Pastorale-pifarata napoletana (ringrazio Fabio Tricomi per queste ultime due segnalazioni). 27 L’equivalenza dei due termini è documentata anche in area napoletana nell’800 (Giuseppe Gargano, Vocabolario domestico napolitano-italiano, Napoli, Nunzio Pasca, 1841, p. 140). 28 Non è escluso che a Verdi fosse noto un illustre precedente rappresentato dalla Nina, o sia La pazza per amore di Paisiello, opera di diffusa e diuturna celebrità, le cui arie furono usate da vari compositori come tema per variazioni e parafrasi per buona parte dell’800. Per rianimare Nina caduta “in una profonda astrazione” sconsolata e melanconica, Susanna annuncia l’arrivo “di un certo pastore che suona alcune arie per ciò prodigiose”: e di lì a poco “si sente suonare una zampogna, ed il pastore comparisce seguito da villani e villanelle”. Come in Macbeth lo strumento è usato in virtù di misteriosi poteri (in questo caso siamo di fronte ad una vera e propria seduta di musicoterapia); ma nel contempo, come in Aroldo, è anche il naturale attributo del pastore musicista. Alla zampogna viene affidata l’esecuzione di una ‘pastorale’ e l’accompagnamento di un’aria: per realizzare l’intervento Paisiello ricorre a 2 oboi e 2 fagotti, con il sostegno di una viola che quasi sempre esegue un suono fisso corrispondente al quinto grado prodotto da un bordone. A parte qualche rapida incursione nei gradi della scala plagale, la parte del primo oboe, soprattutto nell’accompagnamento dell’aria, è compatibile con una zampogna ‘a chiave’. La scrittura complessiva è quindi più aderente alle reali caratteristiche dello strumento, come del resto ci si può attendere da chi ha vissuto ed operato a Napoli; ma anche Paisiello non dimostra certo una filologica attenzione per la esattezza mimetica, non fosse altro per la mobilità delle note di bordone. Codice 602 28 29 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone POST SCRIPTUM, ovvero Di quella piva… Se Verdi avesse avuto la possibilità di trascorrere un periodo sull’Appennino parmense, magari per ristorarsi dalle afose calure padane di Roncole e di Busseto, avrebbe forse avuto a disposizione un altro modello per tradurre la cornamusa in partitura. Nell’area tra la Val Trebbia e la Val Parma, divisa attualmente fra le province di Piacenza e Parma, è attestata fino alla prima metà del XX sec. la presenza di una delle tre cornamuse di tradizione italica: la piva29. Se ne ha notizia da testimonianze iconografiche fin dalla seconda metà del XVIII sec.30; col nome ‘piva’ la troviamo nel Vocabolario Reggiano-Italiano di Ferrari (1832) e nel Vocabolario Parmigiano-Italiano di Malaspina (1856-59)31. Dall’analisi dei repertori degli ultimi suonatori oggetto di studio si evince che lo strumento era impiegato esclusivamente per eseguire danze: slegato da contesti rituali, diversamente dalla zampogna, non ha goduto dello scudo protettivo della sacralità d’uso, cedendo all’avanzata trionfale della ben più versatile fisarmonica, che ne ha assorbito, ereditato e ritrasmesso il repertorio in collaborazione col violino. La continuità della tradizione della piva emiliana si interrompe nella prima metà del ’900; ma l’esiguo numero di suonatori storici di cui si è a conoscenza e degli esemplari originali a noi pervenuti (se ne conoscono una ventina, alcuni incompleti)32 testimoniano comunque di una pratica musicale piuttosto ristretta anche in passato. La piva è un aerofono a sacco a ‘chanter’ singolo con due bordoni a distanza di ottava: appartiene pertanto a tutti gli effetti alla famiglia delle cornamuse. Il ‘chanter’ è accordato mediamen- 29 Le altre due cornamuse tradizionali sono il ‘baghet’ (Valli bergamasche) e la ‘müsa’ (area detta delle ‘Quattro Province’: AL, GE, PC, PV). Estinte tutt’e tre, sono state oggetto di recupero a partire dagli anni ’80. Gli ultimi epigoni della tradizione emiliana nascono a inizio secolo. Secondo Bruno Grulli, il 30 luglio 1969 Giorgio Vezzani, fotografando il musicista Luigi Garilli mentre suonava la piva poco prima di morire, ha di fatto immortalato “l’ultima volta che un suonatore di piva emiliana, portatore della cultura della piva, ha suonato lo strumento” (Bruno Grulli, La piva nelle valli piacentine, «La Piva dal Carner», I (XXXV), n. 2 (78) (lug. 2013), p. 34). 30 Una delle prime attestazioni iconograficamente attendibili è in un dipinto del pittore parmense Pietro Melchiorre Ferrari, Frugoni in Arcadia (1763), olio su tela, 180×218 cm, Parma, Galleria Nazionale. Vi compare, naturalmente, come attributo arcadico di una figura pastorale. 31 Ferrari, che attesta dunque la conoscenza dello strumento anche in area reggiana, la riporta con il nome di ‘piva dal carner’, cioè piva da bisaccia. Per le due testimonianze cfr. Mauro Gioielli, La müsa delle Quattro Province e la piva in Emilia Romagna in La zampogna: gli aerofoni a sacco in Italia, I, p. 33. 32In Le diciotto pive emiliane superstiti, a cura di Bruno Grulli et al., «La Piva dal Carner», n. 74 (ott. 2012), gli esemplari sopravvissuti sono dettagliatamente descritti e analizzati. te33 sulla scala maggiore di Sol; la nota più bassa, come nelle bagpipes, è un tono sotto la fondamentale; i bordoni producono il suono fondamentale a distanza di un’ottava l’uno dall’altro. Come avviene per le altre cornamuse, la scala completa del ‘chanter’ le consente di essere strumento solista, in grado però di eseguire melodie solo di ambito ‘autentico’. Incuriosito dalla presenza di un perigordino nel I atto del Rigoletto, Marcello Conati ha voluto indagare su eventuali rapporti con una quasiomonima danza del repertorio tradizionale appenninico chiedendosi se Verdi […] in gioventù o per lo meno nell’infanzia aveva avuto modo di accostarsi direttamente alle espressioni autentiche della musica popolare – come non ricollegare, ad esempio, il Perigordino del Rigoletto a quella danza popolare detta Bigurdén che ancora sopravvive nella memoria di alcuni abitanti dell’Appennino parmigiano34? Luigi Garilli con la piva nel 1962 Ma la realizzazione della partitura rivela un deciso scarto di registro linguistico: Se la musica da fuori scena rappresenta il lato più triviale della corte (la scelta di affidarla alla banda, cioè a un complesso il cui repertorio è in larga parte costituito da musica stilisticamente bassa, è in linea con questa idea drammaturgica), lato da tenere celato – i suoni provengono da dietro le quinte, dove lo sguardo dello spettatore non può arrivare –, il minuetto e il perigordino, con il loro incedere ‘elegante’ affidato al più nobile gruppo d’archi, costituiscono invece la facciata che il potere offre alla società35. 33 Nell’analisi dei 18 esemplari rimasti, Grulli chiarisce che “se esistono alcune similitudini per gruppi di pive, tra loro sono tutte variate: non esistono due pive uguali” (Le diciotto pive emiliane superstiti, cit., p. 4). 34 Marcello Conati, Ballabili nei “Vespri”. Con alcune osservazioni su Verdi e la musica popolare, «Studi Verdiani», n. 1 (1982), p. 22. 35 Rigoletto: libretto e guida all’opera, a cura di Federico Fornoni, in Rigoletto, «La Fenice prima dell’opera», 2010/5, pp. 69-70. Codice 602 30 31 Di quella piva l’orrendo sono Donato Sansone Le danze appenniniche, infatti, generalmente […] sono danze assai ruvide […]; pur nella regolarità della pulsazione ritmica e nell’uso basilare di pochi accordi di accompagnamento, presentano un impianto fraseologico in contrasto con il ritmo armonico, con improvvisi scatti modaleggianti. A un orecchio non abituato, risulta perfino difficile immaginare che su queste musiche sia possibile ballare36. L’approccio del musicista colto alla musica tradizionale, come già osservato a proposito delle musiche per zampogna, avviene di regola a condizione che “la si sottoponga a una forte stilizzazione e rielaborazione […] che però equivale a farle perdere i suoi tratti più caratteristici”37. La curiosità se Verdi conoscesse la cornamusa della sua terra resta insoddisfatta. Quel che appare meno ipotetico è che l’ispirazione verdiana, quando la necessità drammatica avesse richiesto un’operazione di mimesi di uno strumento estraneo alla tradizione classico-colta, come nel caso dei due drammi di Piave esaminati, prediligesse rivolgersi ai repertori ‘stilizzati e rielaborati’ ed ai loro strumenti. Insomma, uno dei musicisti che fu amato fin da subito dalle fasce sociali più popolari e consumatrici abituali di musiche extra-colte, al punto che queste si appropriarono di parte della sua produzione operistica, stilizzandola e rielaborandola a loro volta, per inserirla copiosamente nei propri repertori38, non mostrò in vita altrettanto mutuo fervore nei confronti del loro universo espressivo. “Un subieu da famè39 con cinque buchi”: così Verdi commenta un flauto egizio del Museo di Firenze. In quelle sette parole si manifesta con chiarezza ed evidenza la sua posizione ideologica: precipitatosi a Firenze con la speranza di vedere uno strumento da poter copiare e utilizzare, con gli opportuni adattamenti, nella partitura dell’Aida, si trova davanti ad una canna di 70 cm con cinque fori senza imboccatura né foro d’insufflazione. Lo strumento non è in alcun modo riconduci- bile a un modello colto, dunque non si presta ad alcuna ricodificazione organologica, presupposto di quella ‘stilizzazione e rielaborazione’ che ne avrebbe consentito l’utilizzo (come avvenne, invece, per le famose trombe della stessa opera). Il suo disappunto si esprime in modo chiaramente spregiativo, rinforzato dall’uso del vernacolo, col riferimento al mondo popolare, e per di più di condizione servile, che diventa così l’unità di misura dell’indegnità musicale40. Non ci sorprende allora se della cornamusa scozzese, come quelle che avrebbero dovuto risuonare al tramonto sulle Lowlands di Aroldo o dal profondo sottosuolo della caverna di Macbeth, è finito in partitura il surrogato ‘stilizzato e rielaborato’ del musicista colto e ormai cittadino, filtrato attraverso l’uso di modelli simil-zampogneschi a loro volta ‘stilizzati e rielaborati’ da una certa letteratura musicale salottiera. Nella stagione scaligera di fine millennio, per l’allestimento della Nina di Paisiello Riccardo Muti ha voluto sul palco lo zampognaro Piero Ricci, molto noto per aver “elevato la zampogna” (sono parole di Ricci) ideando uno strumento modificato ed in grado di modulare al di là dei due tradizionali ambiti di tonica e dominante, grazie alla mobilità della canna di bordone. “Quando ho visto questo autentico zampognaro mi sono commosso – confessa Riccardo Muti –. Non è stato facile trovarlo, perché desideravo un musicista serio, non uno di quei pittoreschi personaggi che a Natale invadono le strade”41. Per esser degno di partecipare alla mensa di Euterpe, Talia, Melpomene ed Erato lo strumento doveva “elevarsi” (alcuni dicono snaturarsi) da ‘pittoresco’ a ‘serio’. Evidentemente i 150 anni trascorsi dal senatore Verdi al senatore Muti non sono bastati non dico a far gustare, ma anche solo a far digerire, per quel che è, l’orrendo sono di quella piva. 36 Nicola Scaldaferri, Il fascino dell’opera popolare: incursioni nel mondo del Trovatore, in Il trovatore, «La Fenice prima dell’opera», 2011/5, p. 33. 37 Ivi. 38Basti pensare, a titolo di esempio, alle riduzioni di brani operistici verdiani per settimino di ocarine. Verdi stesso avrebbe ascoltato un’esecuzione, commentando, con campanilistico fair play: «non m’importa dell’istrumento, mi basta sapere che sono emiliani» (cfr. Anna Zammartini, Il gruppo Ocarinistico torna al Regio, «La Repubblica» (Bologna), 1 ottobre 2009. 39 “Uno zufolo da mandriano”. ‘Famè’ è variante locale di “Famì, famiglio, garzone, servente, servo […]. Quegli che, o qual mandriano, o qual bifolco o lavoratore, è obbligato altrui anno per anno ricevendo in mercede alimenti, abiti o denaro” (Ilario Peschieri, Dizionario Parmigiano-Italiano, I, Borgo San Donnino, dalla tipografia di Giuseppe Vecchi, 1836, p. 347). 40 L’episodio è raccontato sia da Italo Pizzi che dallo stesso Verdi, in termini leggermente variati (“Figlio d’un cane! Quel Flauto non è che uno zufolo a quattro buchi come hanno i nostri pecorai” cfr. Verdi: interviste e incontri, p. 78, 388). Una fotografia del ‘flauto’ in oggetto, risalente al Nuovo Regno (1550-1070 a.C.), è in Musica e archeologia: reperti, immagini e suoni dal mondo antico, a cura di Giulio Paolucci e Susanna Sarti, Roma, Quasar, 2012, p. 19. Si tratta in realtà di un interessantissimo precursore del ney, un flauto senza imboccatura ancor oggi in uso presso le culture musicali arabe, turca, iraniana e, in forme non molto dissimili, in alcune aree balcaniche. Va detto, per inciso, che non solo nell’area padana, ma in nessuna tradizione strumentale italiana è presente uno strumento simile. 41 Giuseppina Manin, Muti: “Nina” unisce la Scala e il Piccolo, «Corriere della Sera», 22 settembre 1999, p. 37. Codice 602 32 33 Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano di Marco Brighenti* Per ognuno di noi la sola vera vita reale può esistere soltanto nell’immaginazione come ideale non raggiunto Lettera di Richard Wagner ad August Roeckel1 Negli scritti teorici di Richard Wagner ricorre spesso (con frequenza accelerata, in verità, negli scritti degli ultimi anni) il termine “ideale”, applicato ai più diversi ambiti della vita e dell’arte. A vederlo spuntare pagina dopo pagina si dubita che tale termine vada assunto nel mero significato della lingua ordinaria, quale riferimento ad un generico “idealismo” non meglio precisato. In cosa consiste la tendenza idealista, cui Wagner dice di ispirare i suoi drammi? In questo breve testo cercherò di affrontare quel particolare aspetto dell’estetica wagneriana che riguarda l’alternativa tra la componente realista e quella idealista nel suo teatro: come sono da determinarsi le due dimensioni (certo presenti entrambe nella sua opera), e come vengono poste in essere dall’artista? Wagner ha sempre avuto ben chiare le * Marco Brighenti è nato a Ferrara nel 1986. Si è diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, e ha studiato composizione al Conservatorio di Milano e direzione d’orchestra. Si è laureato presso l’Università di Padova con una tesi sulla temporalità in musica nelle filosofie di Adorno e Jankélévitch e ha conseguito la laurea magistrale in filosofia presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi sul pensiero filosofico di Richard Wagner. Attualmente insegna storia e filosofia presso il Liceo scientifico “Pietro della Valle” di Teheran. 1 Lettere di Riccardo Wagner ad Augusto Roeckel, trad. di V. Morelli, pref. di H.S. Chamberlain, A. Reber, Palermo, 1899, p. 81. Codice 602 35 Marco Brighenti possibilità antitetiche che si offrivano al dramma2. Il teatro di Wagner è realista quando si piega, con torsione naturalistica e con infinita pazienza mimetica, a cesellare le realtà più particolareggiate (si pensi solo alla rappresentazione del passo dei giganti nel Rheingold o del canto degli uccelli nel Siegfried, o al serpeggiare del fuoco di Loge per tutto il Ring) o a restituire con sorprendente realismo le stratificazioni storiche, politiche e sociali (si pensi che gli dei del Rheingold, strappata loro la maschera mitica, si muovono sulla scena come i personaggi di un vero e proprio dramma borghese, a denunciare la corruzione della civiltà capitalistica). D’altro lato Wagner avoca al suo dramma la potenza di trascendere il piano della vita ordinaria attingendo a una dimensione universale e ideale, i cui connotati cercherò di definire. Tale antitesi, a pensar bene, è stato uno dei problemi centrali, se non il centrale, di tutte le regie wagneriane. Le regie dell’epoca di Richard e poi di Cosima Wagner, affidandosi alle scenografie di Josef Hoffmann per il Ring del 1876, e di Paul von Joukowsky per il Parsifal del 1882, seguirono un approccio di minuzioso, lenticolare realismo, un Wagner tutto “elmo e corna vichinghe”, equipaggiato con ammennicoli su cui oggi l’ironia scorre facile. Alla rivoluzione di Adolphe Appia sbarrò le porte lo zelo di Cosima, finché non fu Wieland Wagner a seguire passo per passo il geniale dettato dello svizzero, rifuggendo dal realismo per raggiungere una sempre maggiore astrazione e idealizzazione simbolica. Un pieno ritorno del realismo si ebbe con Patrice Chéreau nel 1976, sebbene di un realismo diametralmente opposto a quello della messa in scena di un secolo prima, in quanto ad un armamentario mitologico al limite del feticismo, venne preferito il riferimento diretto alla storia della civiltà capitalista contemporanea. Da questa lezione, che si oppone al simbolismo idealizzante e universalizzante del pronipote di Wagner non meno che al facile realismo mitologico della tradizione, procedono molti registi attuali, non ultimo Frank Castorff, regista del recente Ring del bicentenario. Molto è stato scritto su Wagner come musicista, come poeta, persino come regista3, ma non sempre, o forse non a sufficienza, le considerazioni 2 Uso il termine dramma per indicare il dramma wagneriano, ben sapendo che Wagner stesso scartò sia la parola opera che quella di dramma per indicare le sue opere: “nel nostro caso però, pur con la massima buona volontà, non saprei quale nome dovrei dare alla mia creatura” (Richard Wagner, Sulla denominazione ‘Musikdrama’, in Richard Wagner, Musikdrama, a cura di F. Gallia, Studio Tesi, Pordenone, 1988, p. 57). 3 Veramente esemplare a tal proposito è il libro di Martina Srocke, Wagner als Regisseur, che analizza puntualmente le testimonianze attorno all’attività registica di Wagner, in particolare a Bayreuth. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano “disciplinari” che vengono fatte in ciascuno di questi ambiti si riallacciano alla teoria propriamente metafisica su cui il teatro wagneriano si fonda. Punto di partenza e momento centrale di questa breve trattazione sarà determinare il presupposto metafisico che fonda nella teoria estetica di Wagner la dicotomia di realismo e idealismo e il loro rapporto. Come sempre Wagner non si accontenta di risolvere il problema su un piano puramente estetico, ma spicca il volo fino a delineare una vera e propria teoria metafisica che al dramma dell’avvenire dovrebbe dare fondamento filosofico. Per precisa scelta metodologica mi riferirò più che potrò alla letteratura primaria: avendo Wagner così ampiamente e acutamente riflettuto sulla sua stessa arte, ritengo accordargli una doverosa precedenza anche rispetto a pietre miliari dell’interpretazione wagneriana (Adorno, Nattiez, Dahlhaus e Sans). Cominciamo dunque da una immagine particolarmente efficace evocata dallo stesso Wagner in Opera e dramma: Supponiamo che un poeta sia entusiasmato da un eroe che combatte per la verità e la libertà, un eroe nel cui petto arde un potente amore per i suoi fratelli oppressi ed offesi nei loro più sacri diritti. Egli vuole rappresentare questo eroe nel punto culminante della sua attività e sceglie per ciò la fase seguente, che è decisiva nella sua storia. Con le masse popolari, che hanno risposto al suo appello entusiastico, che hanno abbandonato la casa e la famiglia, le donne e i figliuoli per vincere o morire combattendo contro i potenti oppressori, l’eroe è giunto davanti a una città, che quella turba non esercitata all’arte della guerra deve prendere con un assalto sanguinoso, perché trionfi l’opera della liberazione. […] Questa è la situazione in cui gli eroi pervengono all’apice della loro grandezza. Il poeta fa che l’eroe, il quale or ora nella solitudine della notte si è consigliato col suo Dio, collo spirito del più puro amore degli uomini e si è santificato col suo alito, si presenti al crepuscolo dell’alba fra le sue schiere […]. Alla sua voce il popolo si raccoglie, e questa voce penetra sino nel più profondo di quelle anime, le quali ora hanno la coscienza del Dio, che in esse alberga: questi uomini si sentono sollevati e nobilitati, e il loro entusiasmo conquide l’eroe e lo incita all’azione. Egli afferra la bandiera e la agita in alto, dirigendosi alle mura terribili della città, ai baluardi dei nemici […]: “Avanti! Coraggio! Vincere o morire! La città dev’essere nostra!”. Ed ora il poeta d’un tratto si è esaurito: egli vuol rappresentare sulla scena il momento unico, in cui l’estremo entusiasmo ci si mostra in una realtà persuasiva; bisogna che la scena per noi diventi il teatro del mondo; la natura deve essere una e medesima cosa coi nostri sentimenti, essa non può più restare per noi un ambiente freddo e accidentale. Ma ecco! La necessità preme sul poeta; egli fa che si disCodice 602 36 37 Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano Marco Brighenti sipi la nebbia del mattino, e per suo ordine il sole si leva raggiante sopra la città consacrata alla vittoria degli entusiasti4. Ho pescato questa pagina tra le tante di Opera e dramma non quale saggio dell’enfasi della prosa wagneriana, ma in quanto la vivacità della descrizione può facilmente introdurci al problema che tratterò nelle pagine seguenti. Nessuna particolare originalità troviamo in ciò che viene descritto: un solenne momento di battaglia che si svolge nel fulgore dell’alba, come tanti ne potremmo trovare, nel migliore come nel peggiore teatro d’opera dell’Ottocento. Ciò che preme sottolineare a Wagner è come, nel momento fatale descritto, la natura, l’ambiente esterno diventi un tutt’uno col sentimento interiore dell’eroe e della sua schiera: una intima necessità lega il sorgere del sole all’azione degli uomini. Vi è una totale simbiosi tra l’azione interiore dei personaggi e l’ambiente esteriore, quasi che il sorgere del sole si può dire necessitato dall’impeto guerriero dell’eroe: le leggi di natura si piegano al sentimento interiore dei personaggi. Quella descritta è in realtà la scena finale del terzo atto de Le Prophète di Meyerbeer, l’odiato rivale, il momento in cui il tenore canta il celebre “Roi du ciel et des anges”. E difatti, dopo tanta entusiastica descrizione, non poteva mancare la stoccata: […] in una fra le scene principali del Profeta di Meyerbeer, che in quanto all’esteriore, è uguale a quella dianzi descritta, noi abbiamo […] l’effetto di un sole in cui non ci è dato riconoscere più che un capolavoro della meccanica. Il soggetto, che […] il sole non doveva se non illuminare, l’eroe entusiasta, che doveva effondere la sua estasi intima nella melodia e che, data la necessità imperiosa, opprimente della sua situazione, provocò l’apparire del sole […] non c’è affatto; in sua vece funziona un tenore in costume caratteristico5. Forse pure lo stesso Wagner aveva da farsi perdonare qualcosa, se è vero che nel suo Rienzi troviamo una scena gemella di quella del Profeta, nel maestoso finale del primo atto, quando il popolo esultante acclama Rienzi Tribuno della plebe, e dove, anche in quel caso, è certo l’elemento scenografico da grand opéra a regnare, a scapito del travaglio interiore dell’eroe. Come che sia, in Opera e dramma Wagner accusa Meyerbeer di disperdere miseramente la sacra unione tra l’animo dei personaggi (l’eroe e la sua schiera) e la meravigliosa aurora sorgente, riducendo il sole a una sofisticata macchina e l’eroe a un tenore imbellettato. Eppure, ribadisce 4 Richard Wagner, Opera e dramma, trad. di L. Torchi, Torino, Fratelli Bocca, 1929, pp. 121122. 5 Ibid., p. 122. Wagner, quanto all’esteriore, la scena di Meyerbeer è perfettamente identica alla descrizione. Se analizziamo l’argomentazione di Wagner ne ricaviamo che la differenza tra la scena di Meyerbeer e quella descritta non può essere colta da uno sguardo sugli eventi esteriori, ma solo accedendo all’intimo del personaggio. Evidentemente, ciò che manca nell’opera di Meyerbeer non sarà la meraviglia della messa in scena, ma la “estasi intima” dell’eroe, la situazione interiore di cui la scena esterna dovrebbe essere una manifestazione. Venuta a disperdersi l’intima necessità che lega l’animo dell’eroe all’ambiente circostante, tale fasto scenografico si giustificherà allo spettatore meramente su un piano razionalistico e naturalistico: “ma io domando che significa l’effetto del sole, e mi si potrebbe ancora rispondere: ‘perché al mattino non deve poter sorgere il sole?’”6. All’autore drammatico si aprono quindi due possibilità: fare sì che la “trama”, gli eventi che compongono il suo dramma abbiano una spiegazione dal punto di vista unicamente razionale (ed è la strada del realismo), oppure far sì che gli stessi eventi acquisiscano un valore ideale, trasfigurati dai sentimenti profondi che muovono i personaggi sulla scena. Come è possibile questa seconda ipotesi? Cosa significa e come si può realizzare tale trasfigurazione? Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente muovere il piede su un terreno prettamente metafisico, dal quale poi sarà Wagner stesso a condurci fin dentro al cuore del suo teatro. L’esempio della scena dell’aurora ci introduce immediatamente, attraverso una immagine particolarmente indicativa, in uno dei cardini concettuali (anzi, a mio avviso, il cardine) del pensiero wagneriano: la dicotomia tra esteriore ed interiore, alla quale si apparentano tutte le altre, compresa quella di realismo e idealismo che a noi interessa. In questo scritto vedremo come questa dicotomia, che viene da Wagner fondata a livello metafisico, si rifletta in un ambito propriamente estetico e, in particolare, nelle riflessioni sui rapporti tra musica, scena e parola. Nel fondamentale saggio di Nattiez, Wagner androgino, uno dei pochi dell’epoca contemporanea, peraltro, in cui il combustibile non sia il livore contro il genio wagneriano bensì l’attenta e rispettosa lettura degli scritti teorici del compositore, viene posta al centro del pensiero del musicista e pensatore tedesco la dicotomia di maschile e femminile, che Wagner, cultore romantico dell’unità, supererebbe attraverso la figura dell’androgino. Certo, gioca palesemente a favore dell’illustre musicologo francese che il 13 febbraio 1883 la penna cadesse al musicista proprio alle prime pagine che aprivano il più intenso scritto sull’androginia, Sul femminile nell’umano: è difficile, tuttavia, non pensare che nel pensiero wagneria6 Ibid., p. 123 (in nota). Codice 602 38 39 Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano Marco Brighenti no esso ricopra un ruolo più che allusivo o, pur altamente, simbolico. è possibile rintracciare nella dicotomia tra interiore ed esteriore un concetto guida forse più direttamente connesso alle riflessioni estetiche che sorgevano in Wagner anche a seguito della composizione e della messa in scena dei suoi capolavori. Lo scritto unanimemente considerato il fulcro del pensiero wagneriano è Opera e dramma, in cui viene edificato concettualmente il Wort-TonDrama. La frase nella quale solitamente si riassume, come un grido di battaglia, il messaggio di Opera e dramma è la seguente: “l’errore nel genere artistico dell’opera consisteva in questo, che di un mezzo dell’espressione (la musica) si è fatto lo scopo, e dello scopo dell’espressione (il dramma) si è fatto il mezzo”7. Frase imbarazzante, certo. Irrefrenabile la valanga di critiche che tale slogan di Wagner si è attirata (lapidario Adorno: “nessun vero musicista ragionerebbe così”). Wagner non poteva certo attirarsi in tal modo le simpatie di alcun musicista, ma l’affermazione è ancor più imbarazzante perché si pone in chiaro ed evidente contrasto con il peana della musica che il compositore stesso farà nel Beethoven, quasi una riedizione di quelli esaltati di Wackenroder. In realtà non bisognerebbe dare tale peso a questa infelice formulazione wagneriana: basterebbe sfogliare qualche pagina avanti per trovare la vera frase chiave dell’opera: […] l’interiore è il fondo e la condizione dell’esteriore, […] l’interiore tuttavia non si manifesta chiaramente e decisamente che nell’esteriore8. Questa che potrebbe anche sembrare una vuota e astratta formula è in realtà, a mio avviso, la chiave di volta dell’intero Wagner, sia il pensatore che elabora la poetica del puro umano sotto l’influsso di Feuerbach, sia il discepolo di Schopenhauer apostolo della compassione universale. Cosa intende Wagner quando costantemente parla di esteriore (das Äußere) ed interiore (das Innere) nelle sue opere teoriche e nei versi dei suoi drammi? Si cercherà qui di mostrare come Wagner definisca metafisicamente i due termini e come poi da queste alture speculative tali concezioni si riversino fin nelle pieghe della preparazione musicale e scenica del dramma. Solitamente si divide il pensiero di Wagner in due fasi, una prima che trova il suo culmine nei grandi scritti composti tra il 1849 e il 1851 (da Arte e rivoluzione ad Opera e dramma), beneficiata dall’influsso forte dell’umanesimo di Feuerbach, che gli insegnerà a ricercare in ogni evento della Storia il Puro Umano, una seconda, dopo la notte passata insonne a leggere d’un fiato Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, nella quale Wagner diviene profeta della compassione cosmica tra i viventi. A riprova del fatto che la dicotomia di esteriore ed interiore fondi l’intero pensiero wagneriano, capace di illuminare le diverse problematiche politiche, religiose, estetiche che il musicista affronta, sarà facile verificare come tale dialettica si forgi alla visione del puro umano, ma, quando Schopenhauer avrà spodestato dalla cattedra Feuerbach e lo avrà istruito della duplicità del mondo, fenomenica e noumenica, (Wille, volontà e Darstellung, rappresentazione), sarà altrettanto pronta a recepire in modo originale e personale tale lezione. L’uomo è un essere esteriore ed interiore insieme. I sensi ai quali egli si presenta come oggetto artistico sono la vista e l’udito. La vista coglie l’uomo esteriore, l’udito l’uomo interiore. L’occhio percepisce la forma corporea dell’uomo […]. Vengono trasmessi però contemporaneamente all’occhio anche quei sentimenti dell’uomo interiore che esso non è in grado di cogliere direttamente, e ciò avviene mediante la espressione del viso e i gesti. […] Quanto più l’uomo esteriore è in grado di rivelare l’uomo interiore, tanto più chiaramente l’uomo si manifesta come un essere artistico. Ma l’uomo interiore è colto direttamente solo dall’orecchio9. Posto nel tabernacolo della sua arte il Puro Uomo, esteriore sarà dunque il volto dell’uomo, il suo corpo, lo spazio e il tempo in cui le sue azioni si svolgono, mentre interiori sono i suoi sentimenti, i motivi delle sue azioni. Esteriore ad una prima ordinaria ma fondamentale definizione è dunque ciò che è visibile all’occhio, mentre interiore è ciò che all’occhio si nasconde ed è invece accessibile solo all’udito. Ciò che è esteriore ha un corpo ed è quindi finito, individuale, determinato e, infine, mortale. Compiacendo al dettato di Feuerbach, che mette al cuore del suo sistema filosofico l’uomo nella sua corporeità finita e sensibile, Wagner sottolinea con forza in questa fase del suo pensiero l’uomo esteriore, la cui somma realizzazione artistica si compie nell’arte mimica, come vedremo. Se vogliamo, però, aprirci a una dimensione universale, prosegue oltre Wagner, dobbiamo rivolgerci all’interiorità dell’uomo, solo nell’interiorità l’uomo “è obbligato a uscire dall’egoismo della propria espressione personale e definitiva” e viene a trovarsi “nella comunità del grande sentimento universale”10. Solo nel ritorno nella propria interiorità possiamo avere una via d’accesso all’universalità, ossia raggiungere quella unione con gli altri 7 Ibid., p. 25. 9 Ibid., pp. 42-43. 8 Ibid., p. 128. 10 Richard Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire, trad. di A. Cozzi, Milano, Bur, 1963, p. 45. Codice 602 40 41 Marco Brighenti fenomeni del mondo che attraverso l’esteriorità è negata. Questo snodo concettuale è come un varco alla successiva incursione del pensatore di Danzica nel laboratorio filosofico di Wagner. Il sentimento interiore attraverso il quale l’uomo si sente legato a tutte le creature è, presto detto, il Wille di Schopenhauer, la volontà, la cui unità e universalità lega tutti i viventi e può essere colta per Schopenhauer solo andando oltre ai diversi fenomeni esteriori nei quali si compone la Darstellung, la rappresentazione. Per vedere volte in chiave schopenhaueriana le due categorie di interiore ed esteriore dobbiamo attendere il saggio Beethoven del 1870, dove Wagner teorizza una duplice forma di visione cui l’uomo potrebbe accedere. La coscienza umana, sostiene Wagner in questo saggio, può rivolgersi all’esterno, ai fenomeni sensibili, così come alla propria vita puramente interiore. La coscienza rivolta all’esterno percepisce i fenomeni inserendoli nelle coordinate kantiane di spazio e tempo. Nel mondo esteriore della rappresentazione ci orientiamo attraverso il principium rationis, ricostruendo la catena di cause ed effetti (scire per causas). Questo tipo di conoscenza, come è facilmente intuibile, permette allo spettatore accorso allo spettacolo drammatico, di comprendere i nessi causali della trama, il perché delle azioni esteriori che si svolgono sulla scena. Sotto questo aspetto lo spettatore si rapporterà all’opera drammatica coi medesimi strumenti gnoseologici con cui si affaccenda per lo più nel vivere quotidiano, connettendo i fenomeni secondo la legge di causa ed effetto. Lo spettatore non si attenderà dal teatro uno scarto rispetto alla vita ordinaria e se quotidianamente la sua ragione sa render ragione del sorgere del sole, tale spiegazione gli sarà sufficiente anche nella vita che vede in azione sul palcoscenico. La coscienza che riesca a dischiudere l’interiorità dell’uomo, d’altra parte, conoscerà l’essenza profonda dell’io, che è, per Schopenhauer come per Wagner, puramente istintuale e irrazionale. Il concetto di Wille (volontà) è un raffinamento filosofico del Gefühl (sentimento), individuale e universale insieme, che irradiava dal cuore del Puro Uomo. Sprofondando (versinken) in se stessa la coscienza non ha più un oggetto, determinato, individuale, (che era il corpo, la materia determinata in Feuerbach e la rappresentazione, la Darstellung, in Schopenhauer) cui contrapporsi esteriormente, e arriverà a riconoscere l’identità di se stesso con l’intero universo. La conoscenza interiore è conoscenza dell’io, ma questo io individuale e determinato si riconosce come frammento dell’unica ed universale Volontà. All’occhio che sappia penetrare l’interiorità, allo spettatore accorso al dramma di Wagner, non risulterà più incredibile che una medesima necessità leghi il sorgere del sole al sentimento dell’eroe. La spiegazione meramente razionale e ordinaria del sorgere del sole parrà poca cosa rispetto alla forza della necessità interiore. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano Tale è il significato di “ideale”, che Wagner attribuisce al suo teatro, un teatro in cui gli eventi non rivelano solo le connessioni causali tra i fenomeni, ma la necessità che abbraccia l’intero cosmo, e in cui la vita sulla scena è manifestazione esteriore autentica della più profonda vita interiore governata dalla voluntas. Ecco dunque che nella dottrina della doppia visione assistiamo a una rielaborazione in chiave schopenhaueriana della dialettica tra uomo interiore ed esteriore che avevamo letto nelle pagine di Opera e dramma e de L’opera d’arte dell’avvenire. Si sbaglierebbe, però, se si pensassero i due mondi, interiore ed esteriore, ideale e reale, come assoluti e non connessi: nel Puro Uomo, il volto, i gesti sono la manifestazione indiretta della sua vita interiore. Se la filosofia di Schopenhauer è irriducibilmente dualista, in quanto il mondo è scisso in volontà e rappresentazione, Wagner è, come ha con buone ragioni argomentato Nattiez, monista: nel suo pensiero (come Nattiez dimostra servendosi della figura dell’androgino) ogni scissione deve essere ricomposta per raggiungere l’unità originaria. L’esteriorità in Schopenhauer è illusione, è il Velo di Maya che impedisce l’accesso alla conoscenza noumenica della verità, in Wagner l’esteriorità può essere redenta se torna ad essere la manifestazione autentica del sentimento universale che risiede in tutti gli esseri. Nel dramma wagneriano l’esteriore e l’interiore devono armonizzarsi: l’esteriore, il mondo dei fenomeni, il volto e il corpo umano e la scena devono assumere il loro pieno significato attraverso la intima necessità che li lega al mondo interiore del sentimento (della Volontà), non già annullarsi. Le forme della manifestazione si riveleranno allora per ciò che esse sono, non più semplicemente fenomeni conoscibili attraverso il principio di ragione (la legge di causa ed effetto), ma manifestazioni dell’assoluto, quell’assoluto che negli scritti più tardi prende il nome di Volontà, in accordo con la lezione schopenhaueriana. Per diversi motivi, che Wagner espone lungamente nella sua ricostruzione dell’arte e della civiltà occidentale, l’uomo non si è manifestato mai in questa sua integrità, e l’alba della nuova arte dovrà sorgere sopra secoli di una civiltà che ha falsamente scisso corpo e anima. Il volto e il gesto dell’uomo sono stati lentamente piegati e distorti dalle convenzioni sociali e l’arbitrio della moda (schillerianamente intesa) è divenuto per lui una maschera: “il musicista osservi assai attentamente, per esempio, un personaggio che proprio ora egli trova molto interessante: se questo porta una maschera – la tolga; se indossa un abito simile al figurino di un sarto teatrale – tolga anche quello11! 11 Richard Wagner, Sul libretto e sulla composizione della musica d’opera, in Wagner, Musikdrama, cit., p. 109. Codice 602 42 43 Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano Marco Brighenti Il dramma non dovrà rifuggire dal realismo tout court ma dovrà decantare la realtà facendo emergere dai mille tratti arbitrari che disegnano la storia i lineamenti del volto della pura umanità. è quello che attraverso un’attenta rielaborazione del processo percettivo avviene nel teatro di Bayreuth. Tutto il credo artistico di Wagner potrebbe essere riassunto in questo tentativo di redenzione dell’esteriorità, di purificazione dall’esteriorità inautentica, che fosse la recitazione affettata dei cantanti, un fasto scenografico non pienamente giustificato o una trama in cui gli eventi non presentassero una necessità interiore. Solo così possiamo risolvere un’apparente contraddizione: nelle pagine wagneriane ci imbattiamo spesso in una feroce critica contro ciò che è esteriore: esteriore è l’arte operistica che, per esempio quella di Meyerbeer, mira solo all’effetto (Wirkung) sul pubblico. Dobbiamo ora ritenere oggetto dell’invettiva wagneriana precisamente quell’esteriorità isolata, assoluta, che non scaturisce, che non è manifestazione dell’interiorità. L’apparato scenico più farraginoso potrà mostrare unicamente una realtà esteriore arbitraria e accidentale, che attraverso l’esibizione dei più disparati costumi umani mirerà unicamente a solleticare i più frivoli istinti del pubblico, invischiando i personaggi del dramma nei fili delle mode, delle convenzioni storiche e sociali, fino ad occultarne l’essenza puramente umana. Ho cercato di presentare il più sinteticamente possibile il fondamento metafisico attraverso cui possiamo comprendere in tutto il suo spessore filosofico il significato della dicotomia Ideale-Reale. Dovremo ora cercare di vedere come su questa chiave di volta metafisica (il reciproco compenetrarsi di realismo e idealismo) si reggano le campate del dramma wagneriano. Prendiamo come punto di avvio le istruzioni dello stesso Wagner: parola, musica e mimica sono le basi dell’opera d’arte dell’avvenire (Wort-Ton-Drama appunto). Nell’economia del dramma come concorrono queste differenti componenti a definire i piani del reale e dell’ideale? Ritorniamo alla descrizione della scena da cui eravamo partiti, in cui il connubio perfetto tra l’entusiasmo interiore dell’eroe e l’ambiente naturale circostante, l’aurora sorgente, diviene modello dell’arte drammatica. Wagner ammette che questa descrizione si adatterebbe benissimo, “quanto all’esteriore”, anche alla ricordata scena del Profeta di Meyerbeer. Eppure nell’opera del rivale tanta magniloquente esteriorità non sgorga dal dramma interiore dell’eroe. Ciò che, secondo il giudizio di Wagner, rende fallimentare il lavoro del rivale, puro effetto senza causa, andrà, quindi, ricercato in ciò che è invisibile agli occhi. Ciò che fa scadere la scena dell’opera di Meyerbeer in un vuoto esercizio scenografico non andrà ricercato nella messa in scena, ma nella assenza di una musica capace di trasfigurare ciò che i nostri occhi vedono. Wagner attribuisce alla musica il potere di trasfigurare il macchinario scenico del sole in manifestazione visibile del sentimento dell’eroe: grazie all’azione della musica, vedevano il dramma portato subito nella sfera dell’ideale, dove il più semplice tratto dell’azione appariva loro trasfigurato, dove l’affetto e il motivo, fusi in un’unica espressione immediata, parlavano loro in maniera nobile e toccante. […] qui il pathos supremo diveniva la pura anima del dramma12. Come è noto, nell’estetica di Wagner la funzione di esprimere il sentimento, l’interiorità dell’uomo, è infatti delegata alla musica: è questo un tema che senza particolare originalità Wagner accoglie dalla filosofia romantica della musica. La musica è l’arte che, non avendo alcun rapporto con i fenomeni che appaiono alla vista, esprime quell’interiorità che, per Wagner e Schopenhauer, consiste nella forza dell’unica Volontà che governa il mondo. Proprio in quanto esprime la Volontà a prescindere dalla sua frantumazione nei mille fenomeni di questo mondo, la musica esprime un sentimento che, nella misura in cui permane in interiore homine, senza manifestarsi esteriormente attraverso il corpo e il gesto, si mantiene su un piano universale: se il noumeno, la Volontà universale, è una, la volontà individuale è già fenomeno. Questa problematica, che sembra trovare i suoi punti di appoggio unicamente all’interno della visione filosofica del pensatore di Danzica, è, come abbiamo visto, già delineata nell’Opera d’arte dell’avvenire. Se la musica esprime direttamente il sentimento interiore universale, la sua manifestazione esteriore, il divenire fenomeno della volontà, è affidata alla parola, al corpo e al gesto dell’attore e alla scenografia. In Opera e dramma Wagner rivendicava con forza il ruolo della parola e del gesto scenico, a forgiare un dramma che, rispondendo all’appello di Feuerbach, ridonava determinazione, individualità, corpo ai personaggi. L’estetica di Opera e dramma potrebbe essere chiamata realista tale è la forza con cui viene messo in risalto il ruolo di quegli elementi (gesto e parola) in grado di far emergere il determinato, l’individuale, dall’oceano indistinto della musica. Tale realismo, rivendicato con forza avvalendosi del mandato filosofico di Feuerbach, deve però innalzarsi fino a una dimensione ideale, cui potrà essere pienamente pronto dopo essere stato immerso nel mare della musica. Wagner ricorda come persino alla lettura dei drammi di Shakespeare, l’autore drammatico da lui più venerato, rimanesse in lui la sensazione di una “asprezza dell’individualità”13, che avrebbe potuto essere addolcita solo quando il teatro di prosa fosse confluito nel nuovo Wort-Ton-Drama e attori, scene e musica fossero stati 12 Richard Wagner, Sulla finalità dell’opera, Wagner, Musikdrama, cit., p. 17. 13 Ibid., p. 20. Codice 602 44 45 Marco Brighenti battezzati con la musica. Se la parola e il gesto disegnano e individuano il concreto, il determinato, la musica, dunque, si pone, prima del principium individuationis, prima di ogni determinatio. Se solo la musica può rivelare direttamente l’interiorità e raggiungere pienamente la sfera dell’ideale, anche al lavoro del poeta e dell’attore e del regista è dato avvicinarsi a tale sfera, esprimendo indirettamente l’interiorità del sentimento, nella misura in cui, come abbiamo visto, ogni parola, ogni gesto, ogni elemento dell’ambiente scenico, scaturisca dall’intima necessità purificandosi da ogni esteriorità arbitraria. è pur vero che Schopenhauer, ribaltando Platone, affidava all’arte visiva la possibilità, se non di eguagliare la musica nell’esprimere l’assoluto (la volontà universale), almeno di trascendere il piano dei singoli fenomeni giungendo fino alla loro realtà ideale, archetipica. Il Puro Uomo d’altronde, non corrisponde affatto all’uomo fenomenico, invischiato nella storia e nella società, ma appunto all’archetipo ideale di uomo, il cui volto, corpo e gesto esprimono e manifestano (seppure non direttamente come la musica), depurato da ogni effetto inautentico, il sentimento interiore. Il Puro Uomo ha un corpo, un volto, concreto determinato, ma sul suo volto nulla appare di accidentale: a Siegfried che si specchia nell’acqua si rivela la menzogna di Mime e la verità della propria discendenza. Se la purificazione dell’esteriore può giungere a compimento solo grazie alla fusione dell’arte mimica con la musica, lo studio e il raggiungimento di una gestualità adeguata nella recitazione è un passo indispensabile di tale processo: […] se ogni azione, addirittura ogni più banale accadimento della vita […] quando è riprodotto come gioco mimico ci si rivela nella luce trasfigurata e con l’effetto oggettivo proprio di una immagine speculare, allora, in base alle nostre ulteriori osservazioni, dobbiamo constatare che questa immagine speculare si mostra a sua volta nella più pura trasfigurazione dell’idealità non appena si sia abbeverata alla fonte magica della musica, quasi ci venga offerta come pura forma, mondata da ogni realistica materialità14. Solo alla musica è concesso attingere il piano dell’assoluto, ma non per questo Wagner (che nel suo teatro di Bayreuth aveva rinunciato a dirigere personalmente l’orchestra15, ma non ad essere egli stesso sovrintendente della messa in scena) delega unicamente alla musica l’equilibrio tra reale e ideale. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano Cercherò di analizzare nella parte seguente del testo come la dialettica ideale-reale influisca sulla ideazione stessa della “trama” del dramma, sulla recitazione e sulla messa in scena. […] solo quel quadro della vita umana è chiamato poetico in cui tutti i motivi intelligibili unicamente alla ragione astratta spariscono, per mostrarsi al contrario quali motivi del sentimento puramente umano16. La tensione verso una configurazione ideale degli eventi scenici differenzia nettamente, anche dal punto di vista della mera trama, il dramma wagneriano dall’opera tradizionale. I drammi di Wagner sono veramente la narrazione di eventi interiori piuttosto che esteriori: non si comprenderebbe il darsi stesso degli eventi scenici se si tentasse di comprenderli con il solo strumento del Principium rationis, con la sola catena delle cause e degli effetti con cui si spiegano i fenomeni esteriori. Soffermiamoci, per esempio, su quel momento che nei drammi wagneriani costituisce spesso la risoluzione delle più forti contraddizioni: la morte dell’eroe o dell’eroina. Nelle opere tradizionali il o la protagonista muore sempre per l’incidenza di un fattore della vita reale: nel momento fatale il tragico destino di morte si reifica in scena nelle forme di un pugnale, un veleno; certo, anche nelle opere italiane della generazione romantica può essere unicamente il dolore interiore a portare lo sventurato (o più spesso la sventurata) alla follia e poi alla morte, ma tale dolore non assurge mai a una dimensione “ideale”, sottostando sempre al vaglio del principio di ragione. Di fronte alla morte dell’eroe o dell’eroina il raziocinio dello spettatore non si troverà mai in scacco. Persino in uno dei più tragici finali della storia dell’opera, la morte di Violetta ne La traviata, Verdi, dopo averci, sulle ultime, commoventi, parole della morente condotti in una dimensione celeste e ideale, quasi esaltante, ci riporta (con un verismo estremo da cui Wagner si sarebbe scostato inorridito) con crudezza efferata alla dimensione terrena: scarto drammaturgicamente tanto più efficace quanto più ferocemente ordinarie sono le parole del medico sul quale si conclude l’opera: “è spenta!”17. Si provi a immaginare un medico al capezzale di Isotta! La morte nelle opere di Wagner è più spesso (beninteso, con le dovute importanti eccezioni, vedi il caso di Siegfried) lo scioglimento di contraddizioni di più alto tenore metafisico che il soccombere alle 16 Richard Wagner, Musica dell’avvenire, trad. di L. Torchi, Milano, F.lli Bocca, p. 42. 14 Ibid., p. 26. 15 Con la ben nota eccezione del terzo atto di Parsifal, in cui il direttore Hermann Levi si vide sostituire senza preavviso dall’autore. 17 L’abisso che separa il teatro di Verdi da quello di Wagner è riconoscibile immediatamente e istintivamente a qualunque neofita, ma, appunto perché abissale, tale distanza spesso si preferisce non percorrerla, rinunciando a comparazioni analitiche tra due universi tanto diversi. Forse in questa antitesi estetica tra reale e ideale è ravvisabile uno dei principi su cui i due geni si differenziano? Codice 602 46 47 Marco Brighenti nefaste influenze della sorte o agli intrighi di nemici. Si prenda ad esempio il personaggio di Tannhäuser (per vari aspetti forse l’opera più sottovalutata di Wagner, che invece contiene già tutti i nodi del pensiero wagneriano, spesso a uno stato più evidente perché primitivo): Tannhäuser deve soccombere, è necessario che muoia, a indicare la impossibilità di ogni conciliazione nel corrotto tempo presente tra la spiritualità e la necessità sensuale, tra l’anima e il corpo. Per il personaggio che vive tale contraddizione senza poterla sciogliere, l’unica forma di Erlösung possibile rimane la morte. Lo stesso si può dire a proposito della morte di Kundry: ella, più che morire, si dissolve assieme alle ragioni filosofiche e simboliche del suo esserci. La spiegazione materiale, ma anche la spiegazione meramente psicologica, non rende ragione del dramma, e la musica dovrà condurre, senza indugi, lo spettatore a comprendere i motivi puramente ideali della “trama”. Tale è il pudore di Wagner nel considerare naturalisticamente l’evento limite della morte, vero confine supremo tra reale e ideale, che molto raramente egli usa il verbo comune “sterben”, “morire”: lo usa per Tristan, ma non lo usa, per esempio per Isolde (e per Tannhäuser), preferendogli il verbo “sinken”, che può essere tradotto con l’ordinario “cadere”, scenicamente ineccepibile, ma che ben più propriamente nel pensiero wagneriano significa lo “sprofondare”, l’essere riassorbito della vita individuale e determinata nell’unica ed eterna volontà. Chi nel raccontare una trama wagneriana non ha mai provato l’imbarazzo di spiegare con le parole della vita ordinaria all’interlocutore, magari neofita, il “perché” dei principali nessi, dei grandi momenti di scioglimento, ivi compreso il momento supremo, la morte dell’eroe o dell’eroina? Dovendo affidarsi al solo principium rationis non riuscirà a presentare come credibile una trama in cui gli eventi si succedono per motivi puramente ideali. Come afferma lo stesso musicista ne La musica dell’avvenire: “il dramma, nel momento in cui è rappresentato sulla scena, desta subito nello spettatore interesse profondo per un’azione che si appalesa e che, almeno per quanto è possibile, è una imitazione fedele della vita umana. […] Noi constatiamo anzi tutto la proprietà incancellabile dell’umano processo di percezione, che incita l’uomo a scoprire le leggi della causalità ed in virtù della quale, in presenza di ogni fenomeno che lo impressiona fortemente, egli si domanda involontariamente: Perché? […] A questa domanda” si può rispondere solo […] in un senso, che essa domanda si acquieti e venga delusa. […] Il sentimento simpatico dell’uomo passa già egli stesso allo stato di estasi, dove dimentica quel fatale ‘Perché’; e così, in preda alla più grande eccitazione, si abbandona involontariamente alla guida ed al governo di quelle leggi, secondo le quali la musica si fa così meravigliosamente Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano comprendere e, in senso profondo, risponde ad un tempo essa soltanto e giustamente a quel ‘Perché’18. Sicuramente l’imbarazzo innervosiva e infastidiva Wagner ogni qual volta non poteva sottrarsi alle più petulanti domande attorno ai lavori cui attendeva. Per un artista i cui progetti attendevano anche decenni per essere compiuti e i cui versi dovevano così a lungo aspettare il battesimo delle note la risposta doveva risultare particolarmente penosa. Persino August Roeckel, verso il quale Wagner nutriva, ricambiato, la più alta stima, non riuscì a cogliere, alla sola lettura, il senso complessivo del Ring; il principio di ragione, che egli come tutti usava, non gli soccorreva: Non posso credere che abbiate frainteso il mio significato e la mia intenzione: solo mi sembra abbiate data più importanza di quello che, così come sono, meritino ai vari fermagli della grande catena. [...] Ciò che maggiormente mi colpisce è la vostra domanda, ‘Perché mai, se l’oro è restituito al Reno, è necessario che gli dei periscano?’ Sono certo che ad una buona rappresentazione lo spettatore dalla mente più ristretta non sarà lasciato in dubbio su tal punto. Certamente la caduta degli dei non è parte necessaria del dramma considerato come semplice nesso contrapposto alle cause. […] Ora conosco bene da me quanto lo spirito e il significato del mio poema sia reso chiaro solo dalla musica. […] Col tempo spero di mandarvi lo spartito19. Oltre che nella costruzione della “trama”, la dicotomia tra ideale e reale, è da Wagner studiata fin nel modo di recitazione dei cantanti. Su Wagner come regista moltissimo è già stato scritto e fintanto che un’autentica creatività o il peggiore arbitrio avranno dominio nell’intelletto dei registi, molto si scriverà. Non intendo quindi addentrarmi in un terreno che non mi compete. è però importante, credo, chiarificare concettualmente quali sono i principi generali che, a partire dal fondamento metafisico prima esposto, reggono la messa in scena secondo la concezione wagneriana. Wagner denuncia l’impreparazione delle scene del suo tempo ad accogliere la dimensione ideale: egli fu consapevole di aver determinato una svolta non solo nella storia della musica ma anche nella storia del teatro in generale. L’influenza persistente del dramma borghese nella vita teatrale tedesca, fin dal settecento di Lessing20, ha reso gli attori teatrali tedeschi perfettamente in grado di cogliere tutte le sfumature della vita ordinaria dell’uomo, le cui movenze sono vincolate da contin18 Wagner, Musica dell’avvenire, cit., pp. 58-60. 19 Lettere di Riccardo Wagner ad Augusto Roeckel, cit., pp. 89-96. 20 Wagner, Sulla finalità dell’opera, cit., p. 7. Codice 602 48 49 Marco Brighenti genze storiche e sociali, ma al sorgere di una nuova arte teatrale, quella di Goethe e Schiller (il musicista li vede come anticipatori della propria tendenza ideale) che, sulle contingenze storiche e sulle mode fa risaltare i tratti del puramente umano, gli attori si sono dimostrati impreparati. Se nel teatro tedesco […] continuava a prevalere l’attenzione per il ‘vero di natura’, presto però dovette imprimersi su di essi quella tendenza ideale che, nel campo dell’espressione, doveva realizzarsi sotto forma di ‘pathos poetico’. Coloro ai quali è abbastanza familiare questa branca della nostra storia dell’arte sanno bene quante difficoltà incontrarono i nostri grandi poeti nello sforzo di inculcare questo nuovo stile agli attori21. Wagner riconosce una sproporzione tra le doti degli attori e i nuovi compiti loro affidati dall’arte ideale: “il malfamato ‘falso pathos’ deve la sua origine e un certo sviluppo a questa sproporzione”22. Abbiamo qui un’indicazione importantissima da parte di Wagner: la tensione verso l’ideale non deve realizzarsi nella ricerca di un supposto “stile alto”, aulico, ma nella continua ricerca di autenticità, di necessità nelle movenze e nel canto, che esprimano senza filtri la vita interiore del personaggio. Il falso pathos tradisce sia la dimensione ideale che quella reale, in quanto una recitazione affettata risulta avulsa dalla realtà della vita ordinaria e, nello stesso tempo, il pathos non sgorga da un autentico sentimento interiore, risultando un “effetto senza causa”. Il gesto non deve essere né l’imitazione di movenze sociali cristallizzate né l’astrarsi artificiosamente da ogni veridicità. Wagner chiede che l’attore sul palcoscenico trascenda il piano della vita ordinaria dominata dall’esteriorità arbitraria, fino a raggiungere uno stato di estasi23: “che cos’è l’attore fuori della situazione di estasi che è l’unica cosa che può d’altra parte spiegare e motivare la sua intera vita e le sue aspirazioni?”24. Il cantante deve sempre ricercare “una veridicità ideale, che elimina completamente la pochezza della realtà dell’attore addobbato e truccato in un modo o nell’altro in questa o quella vicinanza di quinte illuminate e di fondali”25. Il devoto wagneriano Heinrich Porges, che ci ha lasciato interessantissime considerazioni sulle regie di Wagner, ricorda come durante tutte le prove dell’Anello del Nibelungo a Bayreuth nel 1876 l’intento di Wagner 21Ivi. 22Ivi. 23 Quell’estasi che Wagner nel Beethoven chiama “chiaroveggenza” e che corrisponde allo stato di sogno, quando squarciamo il velo di Maya della rappresentazione e il mondo ci appare nella sua essenza ideale, quale Wille indivisa e universale. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano fosse di unire l’espressione del più profondo sentimento attraverso una recitazione che eliminasse l’affettazione del falso pathos e che invece rendesse la realtà dei personaggi. Egli parla a proposito della recitazione impressa da Wagner ai cantanti di “una naturalezza ideale e una idealità pienamente divenuta natura”26. Dopo aver analizzato brevemente come la dicotomia di reale e ideale si esplica nella realizzazione della trama e nella recitazione, vediamo più da vicino come essa deve guidare il gesto scenico. Vi è nell’estetica di Wagner una contraddizione evidente. Da un lato si riserva alla musica la possibilità di esprimere un sentimento totalmente interiore e indeterminato (senza scostarsi quindi dalle principali teorie romantiche), e si mette in guardia il compositore dal sostituirsi al compito del poeta e dell’attore, determinare l’oggetto drammatico, cadendo con facilità nell’aberrazione del descrittivismo: il musicista deve divenire fratello del poeta proprio perché solo quest’ultimo (insieme all’attore e al regista) può determinare, individuare l’oggetto drammatico. D’altro canto l’unione tra il gesto dell’attore e la musica avviene sotto il segno della reciproca mimesi: […] il gesto e la melodia dell’orchestra formano un tutto. […] Il gesto e la melodia orchestrale, l’uno nello spazio e l’altra nel tempo, l’uno all’occhio e l’altra all’orecchio, si sono manifestati come cose affatto uguali e vicendevolmente determinate da sé medesime. […] Come il gesto, con questa facoltà, manifesta all’occhio ciò che egli solo può esprimere, così l’orchestra produce nell’udito delle impressioni, che con questa manifestazione sono perfettamente analoghe27. Così il gesto scenico deve seguire dettagliatamente la musica e viceversa. Musica e gesto sembrano quindi, più che svolgere in armonia funzioni diverse, rispecchiarsi fedelmente l’una nell’altro. Una musica votata ad essere calco del gesto apre le porte al descrittivismo musicale, certo non difficile da incontrare nelle creazioni wagneriane. Basti a questo riguardo pensare, oltre al greve passo dei giganti, alla spedita cavalcata di Kundry accompagnata del ritmo puntato degli archi nel Parsifal, addirittura all’esitare dei passi di Sieglinde nel primo atto della Walküre, dove sotto il disegno puntato degli archi che si ripete tre volte, è indicato addirittura in partitura il movimento dei passi della donna. Nietzsche fu il primo a denunciare la tendenza della musica wagneriana a farsi esasperata gestualità, e Adorno rincarò la dose: 24 Richard Wagner, Lettera a un attore, in Wagner, Musikdrama, cit., p. 42. 26 Heinrich Porges, Die Bühnenproben zu den Bayreuther Festspielen des Jahres 1876, in Sven Friedrich (Hg.), Wagner im Spiegel seiner Zeit, Fischer Taschenbuch Verlag, p. 177. 25 Ibid., p. 45. 27 Wagner, Opera e dramma, cit., p. 394. Codice 602 50 51 Marco Brighenti […] il momento espressivo indomabilmente potenziato si mantiene appena nello spazio interiore, nella coscienza del tempo, e viene scatenato come gesto esterno. […] La forza dell’elemento costruttivo si consuma nell’intensità rivolta all’esterno, quasi fisica. L’elemento gestuale in Wagner non è, com’egli pretende, manifestazione dell’uomo indiviso, ma riflesso che imita il reificato, l’alienato. […] La musica di Wagner finge l’unità di dentro e fuori, invece di costituirne in oggetto la rottura28. Ha ragione Adorno quando denuncia come il rapporto tra musica, parola e gesto “diviene la somma di tutti gli stimoli registrati dagli organi di senso” col rischio che il rapporto tra musica e gesto diventi “permanente sovradeterminazione” per cui il gesto dice ciò che già la musica dice da sé e viceversa29. Ancor prima delle critiche di Nietzsche e di Adorno, erano i presupposti teorici espressi nel primo libro di Opera e dramma che avrebbero dovuto far trovare a Wagner soluzioni diverse da quella mimetica per instaurare il rapporto di musica e gesto, sbarrando la strada a una forma di realismo a volte ingenua: è Wagner stesso che aveva duramente criticato l’errore della musica “di volere, come puro mezzo d’espressione, determinare chiaramente la cosa da esprimersi”30: nel momento in cui si fa calco preciso del gesto, la musica contravviene esattamente a questo divieto. Wagner ricorda costantemente che la vera regia dell’opera è data dalla musica, e non solo perché in partitura sono segnate, come abbiamo visto, precise indicazioni sceniche, ma appunto in quanto nella musica si deve rispecchiare la gestualità degli attori. Se è vero che attraverso la musica scritta in partitura il regista dovrebbe avere le indicazioni più precise circa il gesto scenico da realizzare, analizzando la musica dei suoi diversi drammi noteremo certo una evoluzione significativa sia sul piano scenico che su quello strettamente musicale. È innegabile che nell’ultimo Wagner, specie nel Parsifal, l’elemento realistico vada decantandosi, a favore di una sempre maggiore astrattezza: certo, il gesto, musicale e scenico, si fa qui altamente simbolico e quasi rituale. La prevalenza dell’elemento idealistico su quello realistico non significa una prevalenza dell’elemento musicale assoluto (quell’oceano pronto a inghiottire ogni cosa, da cui Opera e dramma ci mette in guardia), ma una diversa natura del gesto, scenico e musicale insieme. Per vedere questa evoluzione possiamo analizzare un momento topico non solo del teatro in generale, ma nello specifico anche di quello wa28 Theodor Wiesengrund Adorno, Wagner, a cura di Mario Bortolotto, Torino, Einaudi, 2008, pp. 30-32. 29 Ibid., p. 102. 30 Wagner, Opera e dramma, cit., p. 32. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano gneriano: la scena di duello, o comunque di scontro armato fra un eroe e il suo deuteragonista. Non è una scelta aleatoria: una scena di duello può essere intesa quale cartina di tornasole in quanto caratterizzata da un incremento massimo del gesto esteriore ed allo stesso tempo da una momentanea sospensione del travaglio sentimentale interiore dei personaggi; senza più l’appiglio della parola, è facile che la musica si trovi spaesata e incapace di comprendere quale funzione svolgere. Iniziamo dal giovanile Lohengrin e dal duello del primo atto fra Telramund e Lohengrin. Wagner sceglie di utilizzare un tema già udito in precedenza, nel momento in cui il re Heinrich, chiamando i contendenti al giudizio divino, sancisce il duello conficcando la sua spada al suolo. Si tratta di un tema dal ritmo puntato che nella sua rudezza ben esprime la forza e la violenza gestuale quasi barbarica di quel momento. Esso, inoltre, nel suo disegno discendente, anticipa senza dubbio il tema della lancia di Wotan. Nel momento in cui viene elaborato nella scena del duello, però, tale tema perde tutta la sua semplice efficacia gestuale. Non solo il momento risulta artificiosamente staccato dal flusso musicale (preceduto da due battute di pausa), quasi si trattasse di un pezzo chiuso, come una pantomima, ma per di più il blando contrappunto imitativo del tema (sulla falsariga del duello che nel Don Giovanni mozartiano vede contrapposti il protagonista e il Commendatore), corrisponde più a ragioni astrattamente musicali che drammaturgiche. La scrittura musicale si avvale qui degli strumenti di sviluppo tematico, seppur elementari, propri della musica assoluta, quasi che la musica, non riuscendo a farsi plasticamente gesto, si richiudesse per un attimo nella sua sfera egoisticamente isolata. L’effetto è quello di un momentaneo sdoppiamento tra musica e scena, come se per un attimo il teatro wagneriano cadesse nell’artificiosità del teatro d’opera così spesso denunciata. Non cambiano molto le cose nel duello tra Hunding e lo sfortunato Siegmund nel secondo atto della Walküre. Certo l’uso più consapevole del Grundmotiv restituisce alla scena un maggiore spessore narrativo e drammaturgico (col sopraggiungere del tema della lancia di Wotan ad accompagnare l’intervento del dio), ma anche in questo caso l’elaborazione dei temi di Hunding e di Nothung risulta artificiosa poiché avvertiamo nettamente come la musica si discosti dalla scena per seguire le proprie leggi interne, essendo condotta attraverso i tipici strumenti di elaborazione della musica assoluta. Nel Lohengrin come nella prima giornata del Ring l’intento di Wagner di rendere la musica correlato perfetto del movimento scenico si infrange contro lo scoglio della scena del duello. Qui musica e gesto tornano a dividersi e, mantenendo ciascuno la propria esteriorità reciproca, tornano ad essere arbitrario effetto senza causa. Finalmente nell’assalto di Siegfried a Fafner, nella seconda giornata del Ring, percepiamo una concisione, una tonicità e una plasticità della Codice 602 52 53 Marco Brighenti musica che si fanno immediatamente gesto, senza alcun residuo della convenzionalità e dell’arbitrarietà delle scene prima ricordate: la aderenza mimetica al gesto di Siegfried è ora perfetta. Wagner in questo breve momento riesce a fondere con virtuosismo fino a tre Grundmotive31: il tema della spada, il tema di Siegfried e il sinuoso tema di Fafner, ma nella perfetta saldatura dei temi, il richiamo alla struttura narrativa dato dai Grundmotive nulla toglie al puro scatenarsi della musica in gestualità. In questa scena del Siegfried, a mio avviso, assistiamo alla più compiuta resa pratica del principio mimetico di Opera e dramma. Ma è nell’ultima opera wagneriana che noi assistiamo a una vera e propria diluizione dell’elemento musicale (e quindi, di riflesso, di quello gestuale): l’aggressione di Klingsor a Parsifal si riduce, in un momento di massima concitazione a un semplice glissando di arpa. È evidente che qui Wagner lavora per sottrazione, come se volesse ridurre al minimo l’elemento gestuale, visivo, determinato, realistico. Nell’ultima opera, e la scena dello scontro tra Klingsor e Parsifal è, per i motivi che ho detto, una spia attentissima, l’elemento gestuale perde manifestamente ogni peso naturalistico. È nello scritto Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882, nel quale si danno le più precise direttive attorno all’esecuzione del Parsifal, che lo stesso Wagner parla di una “sparsamkeit […] der plastischen Bewegung”32, una “economia del movimento plastico”, e ammonisce gli interpreti della “necessità di nobilitare i movimenti plastici attraverso la sua più coscienziosa moderazione”33. È Wagner stesso a ricordare come la più perfetta realizzazione del personaggio di Tannhäuser fosse quella di Ludwig von Carolsfeld, proprio per la sua capacità di rendere attraverso una sublime immobilità la più profonda estasi interiore. Nel momento in cui il cantore invoca il nome di Maria, che dissolve il Venusberg, “con questo grido egli aveva preso l’atteggiamento di uno trasportato nella più alta estasi, e così egli deve restare, senza un movimento, i suoi occhi rapiti al cielo, sì, anche fino a quando viene interpellato dai cavalieri che entrano dopo, non deve la- 31 Utilizzo il termine Grundmotiv e non quello comune di Leitmotiv in quanto – come dichiara Wagner stesso in Sull’applicazione della musica al dramma – quest’ultimo fu formulato da Wolzogen, cogliendo più però la componente narrativa del tema che quella compositiva e strutturale, sottolineata da Wagner. 32 Richard Wagner, Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882, in Richard Wagner, Ausgewählte Schriften, Hrsg von Philipp Werner, Fischer Taschenbuch Verlag, p. 316. 33“Die Nötigung zur Veredelung der plastichen Bewegungen durch gewissenhafteste Mäßigung derselben”, in Wagner, Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882, cit., p. 317. Il sole e l’eroe: realismo e idealismo nel dramma wagneriano sciare la posizione”34. È Angelo Neumann, baritono e intendente teatrale, famoso per gli allestimenti wagneriani, a confermarci le medesime impressioni nel ricordare la straordinaria interpretazione della scena da parte dello stesso Wagner: Come nobilmente rappresentava il Tannhäuser, allorquando allo svanire dell’incanto del Venusberg si trova nuovamente nella valle foresta della Turingia. Quasi pietrificato in statua, rimaneva immobile con le braccia alzate, all’entrata dei pellegrini egli viene gradualmente mosso da un tremore35. È significativo che se il gesto deve manifestare il sentimento interiore esso lo faccia per sottrazione, come se, nei momenti di più alta e commossa eccitazione, la sua funzione fosse quella di annullarsi. Sono quei momenti in cui l’ideale predomina nettamente sul reale, in cui il gesto musicale e scenico si annulla, come abbiamo visto avvenire con radicalità inusuale nell’ultima opera wagneriana, il Parsifal. Nel Dramma mistico, l’elemento ideale prevale nettamente su quello reale, a indicare che con la vittoria di Parsifal sul mago assistiamo a quel miracolo di cui così diffusamente Wagner parla in Religione e arte: lo spezzarsi della catena di causa ed effetto del principio di ragione, la sospensione e inversione di tutte le leggi di natura, a trasfigurare, nel Karfreitagszauber, l’eterno dolore della natura. 34“Mit dieser Ausrufung habe er die Stellung des in erhabenster Extase Entrückten angenommen, und in ihr solle er nun, mit begeistert dem Himmel zugewandtem Blicke, regungslos verbleiben, ja sogar bis zur Anrede durch die später auftretenden Ritter nicht die Stelle wechseln” in Richard Wagner, Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld, in Richard Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, VIII Band, Leipzig, Fritzsch Verlag, 1873, p. 228. 35 “Wie herrlich stellte er den Tannhäuser dar, wie er nach der Entzauberung aus dem Venusberg sich im Thüringer Waldtal wiederfindet. Fast zu Statue erstarrt, stand er mit erhobenen Armen da, beim eintritt der Pilger geriet er in Allmählich gesteigerte zitternde Bewegung.” in Angelo Neumann, Erinnerungen an Richard Wagner, in Sven Friedrich (Hg.), Wagner im Spiegel seiner Zeit, Fischer Taschenbuch Verlag, p. 161. Codice 602 54 55 Io l’ho servita per l’amore Mascagni, D’Annunzio e Parisina di Fulvio Venturi* Questo saggio è dedicato ad un triplice anniversario: i centocinquanta anni dalla nascita di Pietro Mascagni e Gabriele D’Annunzio (1863) ed il centenario della prima rappresentazione di Parisina (1913). Superato il lungo momento di crisi che l’aveva colto dopo la composizione di Iris, Mascagni pensava ad un’opera con la quale tradurre i concetti di novità, d’efficacia e precisione nell’intaglio dei personaggi, di svolgimento magistrale del soggetto da lui sempre cullati, ma non sempre messi in atto nella sua produzione. Il considerevole successo arriso ad Isabeau, unito alla buona circolazione di quest’opera, metteva adesso il musicista, giunto alla più piena maturità artistica, in posizione favorevole per guardare con fiducia all’attività futura. Fu così che Mascagni, senza ricercare l’occasione, e senza avere avanti manifestato desiderio di collaborazione, lesse la tragedia Parisina di Gabriele D’Annunzio, dietro proposta del suo editore Lorenzo Sonzogno. Era il 1912. Tranne il riferimento puramente temporale dato dal “medioevo” di Isabeau, per Mascagni l’atmosfera di Parisina, ambientata nella corte estense, rappresentava un argomento del tutto nuovo e mai avvicinato prima. Quello fu il primo punto di contatto. La tragedia di Parisina si era invece affacciata alla mente di D’Annunzio dieci anni avanti, nel periodo della stesura di Francesca da Rimini, che scriveva come prima parte d’una trilogia dedicata ai Malatesti (Malatesta), la famiglia sotto il cui casato aveva albergato la Signoria della Città di Rimini. Secondo il disegno del poeta, a quella tragedia dovevano seguire Parisina, come seconda parte, e Sigismondo Malatesta, come * Fulvio Venturi svolge un’intensa attività di saggista, essenzialmente nel genere musicologico. Specializzato nel teatro “verista” e novecentesco, ha perlustrato quasi l’intero repertorio mascagnano ed ha scritto anche di autori quali Respighi, Zandonai, Strauss, Massenet, Gabriele D’Annunzio. Nel 2013 ha collaborato con la casa editrice Sillabe per la realizzazione del volume Mascagni forever ed è inoltre autore di due pièces teatrali: Tramontata è la luna, dedicata a Maria Callas ed Estate dedicata a Gabriele D’Annunzio. A Cerignola ha ricevuto il Premio Mascagni 2013. Codice 602 57 Fulvio Venturi Io l’ho servita per l’amore. Mascagni, D’Annunzio e Parisina terza. Nel 1902 D’Annunzio consegnò alle stampe Francesca da Rimini e nel 1903, durante un’intervista, annunciò di studiare approfonditamente l’ambiente storico relativo a Sigismondo e d’essere pronto con la trama di Parisina. La redazione della pièce rimase tuttavia per molto tempo tra i progetti irrealizzati del poeta, mentre Sigismondo lo rimarrà per sempre. Nel 1906 D’Annunzio offrì il soggetto a Giacomo Puccini alla luce di una ventilata collaborazione, ma il compimento di Parisina s’attuò solo dopo che l’editore Lorenzo Sonzogno ne ebbe acquistato i diritti per la propria casa musicale, con lo scopo di farne un libretto d’opera. Gabriele D’Annunzio dette notizia d’aver terminato Parisina in data 26 marzo 1912, mettendo in evidenza con orgoglio d’aver scritto, dall’ottobre 1911, oltre cinquemila versi1. D’Annunzio, come d’abitudine, aveva preparato un quadro audace e sensuale nel quale, sullo sfondo della Ferrara cortese, della Santa Casa di Loreto, della camera “a ursi” (decorata con orsi) nella residenza estense di Belfiore, e del cupo carcere della Torre del Leone, aveva inizio e si consumava fino alla morte, tra echi di battaglia, cori di fantesche e famigli, antifonali e sentore d’incenso, il canto d’un usignuolo ed il Libro di Tristano, la luce notturna della Galassia e piogge purificatrici, l’amore proibito tra Parisina Malatesta e Ugo d’Este, matrigna e figliastro. Questa è la trama. Atto primo. Presso la villa estense sull’isola del Po. Niccolò d’Este ripudiata la sua amante Stella dell’Assassino (Stella de’ Tolomei, figlia di Giovanni de’ Tolomei, di Siena), dalla quale ha avuto un figlio, Ugo, si è legato in matrimonio a Parisina (figlia di Andrea Malatesta, signore di Cesena e nipote di Carlo Malatesta, signore di Rimini). Stella, che odia la rivale, tenta di alimentare questo sentimento nel figlio il quale, pur amando la madre, non può sottrarsi alla passione per Parisina. Atto secondo. La Santa casa di Loreto. Dopo avere respinto i predoni di Schiavonìa, che hanno tentato una scorreria “per rapinare la Vergine Nera”, Ugo incontra Parisina che, non riuscendo a resistere alle sue profferte, gli si concede. I due amanti si uniscono ai piedi dell’altare. Atto terzo. La camera “a Ursi” nella “Delizia” di Belfiore. I due amanti vivono segretamente la loro relazione ormai da un anno. Parisina, tuttavia, è inquieta: sente di rivivere la sfortunata vicenda della sua ava Francesca da Rimini, e teme una delazione. Infatti, una notte, Niccolò, avvertito dal famiglio Zoèse, giunge improvvisamente, sorprende i due amanti e li condanna entrambi a morte. Atto quarto. La Torre del Leone, il carcere estense. Mentre Ugo e Parisina, imprigionati, attendono la fine, giunge Stella; ma Ugo non ode più la voce della madre, l’odio sordo che ella ha portato e porta alla sua amante. La pioggia notturna ha purificato le anime dei condannati. Avvinti dal fuoco della loro passione e dallo spirito del sacrificio, Ugo e Parisina offrono il capo al carnefice chiamandosi per nome, mentre i loro corpi sono illuminati dai raggi della salutazione angelica. Leggendo il testo di Parisina Pietro Mascagni avvertì quello che per lui costituiva novità, sentì il fascino del verso musicale di D’Annunzio, rimase avvinto dallo sbalzo dei personaggi, dai quali le parole e i sentimenti sgorgavano come acqua dal fonte. Il 4 aprile 1912 egli prese impegno con Lorenzo Sonzogno di musicare il testo ed il successivo 24 aprile inviò a D’Annunzio, che si trovava ad Arcachon, un telegramma: “Ricevuta (e) letta tragedia che mi ha prodotto impressione profonda - Sarò lietissimo d’incontrarla a Parigi prima di accingermi al lavoro”2. Il musicista si era innamorato di quella poesia e sentiva di dare la sua musica a quell’insolito libretto, di servire “per l’amore”3 la sua nuova opera, interamente assorbito dalla tragedia dannunziana. Quel documento è il primo del carteggio tra musicista e letterato riguardo la genesi di Parisina. Mascagni iniziò la composizione a Roma e dopo appena dieci giorni fu in grado di suonare alcuni appunti della nuova opera al collega. D’Annunzio era in Francia “in esilio volontario”, ovvero per lasciarsi alle spalle una disastrosa situazione finanziaria in Italia, dividendo le abitazioni tra Parigi ed Arcachon. La prima data segnata sulla partitura autografa è quella del 21 giugno 1912 e contrassegna da p. 169 a p. 171 l’incipit del Doloroso di Ugo “Or voi composto m’avereste nella bara”. Trasferitosi a Parigi per lavorare vicino al librettista, Mascagni, sotto mentite spoglie per evitare il clamore della carta stampata, dapprima si stabilì presso gli amici Basevi, d’origine livornese come lui, sul Boulevard des Capucines, poi affittò a Bellevue una villa tutta sommersa nel verde – Castel Fleury – dove invitò D’Annunzio. La segnatura successiva è del 25 luglio, sull’attuale pag. 296 per l’inizio del duetto della Torre del Leone (“Non odo più, / non odo più la stilla / del tempo [...]”). Tra la fine di luglio e l’inizio d’agosto Mascagni, con D’Annunzio al fianco, compose alacremente, concludendo il gran duetto del secondo atto. Con il ritorno del poeta ad Arcachon, il musicista, dopo la metà del mese d’agosto, comunicò al suo librettista d’aver affrontato la cantilena dei marinai, la descrizio- 1 Paolo Alatri, D’Annunzio, Utet, Torino 1983, p. 326. Il dato, però, non collima con quanto Mascagni affermerà più tardi; secondo i conteggi del musicista i versi della stesura originale dannunziana di Parisina sarebbero stati 1700. Probabilmente il poeta aveva inserito nel conto anche le didascalie. 2 Pietro Mascagni, Epistolario, a cura di Mario Morini, Roberto Iovino, Alberto Paloscia, LIM, Lucca 1996, vol. 1, p. 347. 3 Frase appartenente al libretto, cfr. Parisina, tragedia lirica di Gabriele D’Annunzio musicata da Pietro Mascagni, casa Musicale Lorenzo Sonzogno, Milano 1913, p. 58. Codice 602 58 59 Io l’ho servita per l’amore. Mascagni, D’Annunzio e Parisina Fulvio Venturi ne dell’ambiente data dal suono delle buccine e dal canto della Laus Virginis e la discesa della notte sulla scena del secondo atto. Aggiungeva però di dover interrompere il suo cammino per qualche “incaglio” verificatosi con l’antifona della chiericìa e con il canto dell’usignolo. Dalla partitura si evince infatti che egli compose quelle scene solo alla fine di ottobre 1912 (l’inizio del secondo atto con la “chiericìa”) e il 2 febbraio 1913 (il canto dell’usignolo)4. Per superare l’ostacolo Mascagni consultava manuali di canto fermo (fr.: plain-chant) per trovare il ritmo e la giustezza delle cadenze, chiedeva al poeta d’adeguare i versetti dei cantici alle necessità musicali e cercava testi d’ornitologia sui quali apprendere le modulazioni dell’usignolo. Era tuttavia ben un altro il problema che mandava in panne il motore della composizione e che affliggeva il maestro. Era la complessità dell’intera operazione che egli intravedeva nel lavoro ancora da fare ed erano le riduzioni da compiere sul testo letterario per musicare più agilmente le parti rimanenti. Cesure ancora da concordare che si dovevano sommare ai numerosi aggiustamenti sulla versificazione primordiale già compiuti quando D’Annunzio aveva soggiornato a Castel Fleury5. Mascagni, temendo per le dimensioni e per l’agilità teatrale di Parisina, informava il poeta delle sue perplessità nel tardo settembre, dopo aver composto la frottola della Verde (“Amor prese vergogna per lo mento”) ed aver dato inizio all’Ave Maria della protagonista. “Io mi trovo in agitazione per il mio lavoro” – scriveva Mascagni a D’Annunzio6 – “la pesantezza musicale di ogni personaggio mi spaventa per l’esecuzione dell’opera”. Insieme con i versi dannunziani era anche una complicata situazione affettiva a rendere il musicista inquieto, al punto d’aggiungere nella stessa lettera d’essere nervoso al pensiero di lasciare Castel Fleury. Erano le sue cure d’amore a ritardare la composizione. Il suo matrimonio periclitava a causa della liaison con Anna Lolli, che aveva condotto con sé in Francia, e la moglie Lina era sul piede di guerra. Mascagni non era tipo da recalcitrare di fronte alle difficoltà, o ai problemi esistenziali, e l’idea della composizione era per lui più forte d’ogni altra. Così forte da scrivere al fraterno amico Vittorio Gianfranceschi7 che in data 4 ottobre 1912, 4 Mascagni rifece poi la scena il successivo 10 aprile. 5 Il musicista aveva anche chiesto ed ottenuto dal poeta la soppressione del personaggio del sacerdote che, nella Santa Casa di Loreto, ricevuta l’offerta della spada, benedice Ugo “com’è in costume di cavalleria”. [...] il bilancio del lavoro è (era) oltre ogni dire florido, è anzi miracoloso: ho già musicato 780 versi della tragedia dannunziana; me ne mancano ancora 650, ma i pezzi e le scene principali e di capitale importanza sono già compiuti aggiungendo sono sbalordito per la facilità con la quale mi riesce di musicare la poesia di D’Annunzio. Il musicista era come preso nel vortice del musicalissimo verso dannunziano, si abbandonava all’ispirazione e, in meno di un mese, componeva quasi 50 pagine di musica sulle 328 finali. Nella consapevolezza della grande mole del lavoro compiuto l’assillo della teatralità della nuova opera non abbandonava Mascagni, anzi quel pensiero continuava ad inoltrarsi nella sua mente come un tarlo nel legno. All’inizio di novembre scrisse a D’Annunzio, che evidentemente chiedeva notizie, di dargliene poche perché sempre al lavoro, aggiungendo: [...] mi allarmo qualche volta e resto inquieto quando calcolo che Parisina avrà più di quattro ore di musica: sarà un’opera ineseguibile, o per lo meno priva di quella praticità che è indispensabile al cammino di un’opera lirica. Ma come fare? Altri tagli non sono possibili [...] Parisina sarà troppo lunga8. Risolta in qualche modo la delicata situazione privata e tornato a casa, Mascagni terminò la composizione dell’opera di fatto il 2 febbraio 1913, riprendendola per alcuni ritocchi nei successivi mesi di marzo e aprile, quindi per il lavoro di strumentazione. Mascagni aveva posto particolare attenzione a penetrare lo spirito della tragedia, a rispettare “la trasparente semplicità” di quei versi “così sonori, così ritmati” che, alla prima lettura, gli avevano fatto “gonfiare le vene e sentire il cervello in fiamme”9. Sentiva la sua opera “poderosa per contenuto musicale, [...] estremamente forte e violenta nelle situazioni tragiche”; la definiva libera nella forma e nella tonalità, “tematica per eccellenza con continui richiami e con riproduzioni e ripercussioni di idee”10. Aveva realizzato quelle situazioni meditando su esperimenti compositivi precedenti anche non del tutto riusciti. Nella sua imperfetta Amica, presentata a Monte Carlo nel 1905, Mascagni aveva evidenziato quell’inquietudine armonica che, riproposta in Isabeau (1911), stabiliva ora il cardine compositivo di Parisina. Un’inquietudine che risaliva al 6 Mascagni, Epistolario, cit., vol. 1, p. 353. 8 Mascagni, Epistolario, cit., vol. 1, p. 356. 7 Vittorio Gianfranceschi (Vienna 1861- Milano 1933) in anni giovanili aveva condiviso con Mascagni la composizione di alcune musiche. A lui Mascagni dedicò nel 1895 la partitura dell’opera Guglielmo Ratcliff. 10 Mascagni, Epistolario, cit., vol. 1, p. 361; lettera a V. Gianfranceschi, datata 8 dicembre 1912. 9 Pietro Mascagni, Com’è nata Parisina, in «La Lettura», anno XIV, n° 1, p. 16. Codice 602 60 61 Io l’ho servita per l’amore. Mascagni, D’Annunzio e Parisina Fulvio Venturi 1898, enunciata dagli esatonalismi e le escursioni armoniche di Iris. Nella reminiscenza del tema di Giorgio in Amica egli individuava con certezza la radice tematica di Ugo in Parisina e con la nuova opera si addentrava nel campo della configurazione psicologica, assegnando un tema non solo al personaggio tenorile, ma anche a tutti gli altri personaggi principali e persino ad intere scene, come il tema di sette note emesso dalle buccine, che caratterizza tutto il secondo atto. I temi, spesso mischiati al materiale armonico, non erano (e sono) udibili in tutte le situazioni, ma comunque sempre presenti. Forse era quella la pesantezza musicale cui si riferiva Mascagni, se intesa come complessità strutturale dell’opera. Nel rispetto del testo dannunziano la scrittura vocale di Mascagni, che tanta importanza aveva avuto nelle opere precedenti, si modificava. Mantenendo le accensioni di appartenenza tradizionale allo stile mascagnano, in Parisina la cellula melodica diventava meno chiusa, si apriva in un declamato-arioso di largo respiro dove più puntuali d’una volta si facevano i richiami dinamici. La tessitura del rigo vocale si era fatta più centrale, se confrontata con quella del Mascagni verista o con il fraseggio flessuoso di Iris. Nella nuova formula, gli ardori del linguaggio dannunziano, inseriti nell’ispirazione mascagnana, si enunciavano con febbrili esortazioni espressive del tutto inusitate nel repertorio melodrammatico. Pensiamo alle indicazioni Veemente e Doloroso che si alternano nella frase di Ugo “anche una volta, / se non per mio voto, non più nel sangue / ma nelle lacrime”, posta al termine della descrizione dell’incontro materno nel terzo atto, o alla continua alternanza degli Ansioso agli Agitato nella parte di Parisina. Altrove, ma pur sempre nella parte della protagonista, le indicazioni di Agitatissimo si alternano in brevi lassi a quelle di Supplichevole e Disperato, tanto da richiedere per la loro resa, alla stessa interprete, sia l’attitudine della grande cantante, sia quella della grande tragédienne. Quando, nel simbolismo mortuario di D’Annunzio, l’idea dell’atto d’amore si mischiava con la descrizione anatomica della strage, con la visione dei corpi “rotti sotto il carro”11, inebriando Parisina di passione e di voglia nella Santa Casa di Loreto, Mascagni contrassegnava la frase con l’indicazione Sensuale. Infine la frase “l’ardor dell’inferno mi sarà, / dopo, più dolce, sette volte più / dolce, che se dormissi / nelle tua braccia avvinto / e ti sentissi abbandonar l’un braccio nel lieve sonno”, con la quale Ugo afferma che il suo perdimento eterno sarebbe in ogni caso più leggero se dovuto alla sua unione carnale con la matrigna – o meglio, se conseguito dopo aver gustato il piacere del rilassamento dopo un amplesso con lei – è forse la più utile per testimoniare l’attenzione di Mascagni al testo di D’Annunzio. Dopo aver chiesto al poeta delucidazioni sul senso esatto delle parole, egli contrassegnò la frase con l’indicazione Lascivo. Parisina vide dunque la luce con i suoi fascini e la sua smisurata bellezza: un’ora il primo atto, un’ora e dieci il secondo, cinquantacinque minuti il terzo e poco più di mezz’ora il quarto. L’editore Lorenzo Sonzogno corredò l’edizione con un’iniziativa molto interessante, commissionando a Gaetano Previati cinque tavole per le illustrazioni dello spartito canto e piano e del libretto, una per la copertina ed una per ogni atto. L’immagine grafica del libretto fu completata poi con cinque disegni e “gabbia” firmati da reni (probabilmente lo stampatore Enrico Reggiani che materialmente eseguì l’edizione). L’iniziativa dell’editore non si fermò a quel punto, anzi si perfezionò con la commissione di un manifesto a Plinio Nomellini, uno dei pittori più vicini alla sensibilità di Mascagni, nato nella stessa città natale del musicista e suo coetaneo. Nell’arte di Nomellini, in quella pittura tutta pervasa dai tramonti tirrenici, in quel vivido colorismo dove i contrasti naturalistici toscani si fondevano nella corrente simbolista internazionale, Mascagni poteva udire “il suono roco delle buccine” levarsi “lungo la marina”12, così come alla sua musica chiedeva la poesia di D’Annunzio, quando faceva scendere la notte stellata sull’amore d’Ugo e Parisina, dopo l’assalto dei corsari. Il manifesto di Nomellini diventò l’immagine di riferimento per l’intera “operazione Parisina”, con il suo divisionismo maculato come “la pelle del leopardo”13 che circonda la bella e sensuale protagonista, palpitante di attesa nella camera “a ursi” in Belfiore. La sera della prima rappresentazione, quando il sipario del Teatro alla Scala si aprì sulla scena del terzo atto, il pubblico riconobbe nell’atteggiamento scenico del soprano Tina Poli Randacio la posa di Parisina, quale Nomellini l’aveva tratta per il suo manifesto. La previsione di Mascagni si rivelò esatta. Un’opera di dimensioni tanto vaste non poteva avere un cammino teatrale spianato e spedito. Non si deve dimenticare che il pubblico italiano non aveva mai amato le opere lunghe e che l’Italia era il paese in cui le opere di Wagner, per avere una buona diffusione, dovevano essere tagliate senza risparmio. Il critico musicale più accreditato d’Italia, Giovanni Pozza, commentando il successo più di stima che reale della prima rappresentazione, scrisse: 11 Parisina, tragedia lirica di Gabriele D’Annunzio musicata da Pietro Mascagni, casa Musicale Lorenzo Sonzogno, Milano 1913, p. 54. 12 Ibid., p. 56 (cfr. la prima didascalia). Se la figura di Parisina è [...] viva e convulsa, se ancora una volta il suo amore e il suo dolore parvero degni d’essere esaltati dall’arte, il merito non fu soltanto della poesia di D’Annunzio, ma anche della 13 Ibid., p. 78. Codice 602 62 63 Fulvio Venturi musica di Mascagni. [...] Parisina rappresenta nella vicenda dell’arte mascagnana un nuovo passo sopra una via che, nonostante molte incertezze e qualche ritorno, è stata una via di progresso. [...] Alle rivelazioni apportate dal testo poetico risponde un giuoco di sfumature ben misurato, in un ambito di tinte prestabilito; gli effetti di armonie e gli effetti strumentali sono moltiplicati in una ricerca incessante del minimo particolare. Insomma il distacco dal melodramma tradizionale è compiuto. La linea musicale non conosce più altra direzione e altra misura dell’emozione drammatica, e supera i limiti della regola, o li rispetta secondo quell’emozione, per carattere e per la forma, sdegna la norma comune ovvero vi si adatta e vi si acqueta. Il critico, con l’enunciazione dei numerosi pregi della partitura, concludeva il suo articolo aggiungendo: La eccessiva lunghezza: ecco un difetto che, se non riparato, non può non pesare sulle sorti di Parisina; a esso – astrazion fatta di ogni giudizio sul valore reale del nuovo lavoro – anche il più sfegatato amico del Maestro deve augurare che sia apportato il più sicuro e semplice dei rimedi: tagli, tagli, tagli [...]14. Questa frase, dopo il vaticinio dell’autore, è stato il viatico di Parisina. Mascagni ipotizzava una congiura ai suoi danni. Era noto ch’egli vedeva fantasmi ovunque, ma forse, in certi casi, non aveva torto. Il caso di Parisina fu uno di quelli. Il musicista pagava il prezzo dei pessimi rapporti che intratteneva con il mondo della carta stampata, da quando era salito all’onore delle cronache con il successo di Cavalleria rusticana. Giovanni Pozza era pur sempre quello stesso critico che tredici anni prima aveva arbitrariamente messo in dubbio il totale gradimento di Iris, dopo una fortunata edizione andata in scena al Teatro dal Verme, a Milano. Questa fu la sua recensione, pubblicata sul giornale più letto in Italia: Venti chiamate all’autore, tre pezzi replicati, ottima l’esecuzione, [...] enorme il concorso del pubblico. [...] Un successo dunque. Potremmo anche dire un grande successo. Il pubblico non lesinò ieri sull’applauso. Non lesinò né pure sull’entusiasmo. Alcuni brani dell’opera lo fecero andare in visibilio. In alcuni punti il fragore dei battimani e delle grida dovette far tremare la cupola del teatro. Comparando però l’innegabile successo dell’opera con il semi-insuccesso registrato due anni prima alla Scala, Giovanni Pozza aggiunse: L’Iris piacque più ieri sera al Dal Verme che due anni or sono alla Scala? Nonostante la dose doppia di applausi, non oserei affermarlo. Io l’ho servita per l’amore. Mascagni, D’Annunzio e Parisina In questo modo il critico affermava invece l’irrevocabilità di un giudizio emesso in precedenza. Congiure a parte, Mascagni aderì nella misura più drastica al suggerimento di apportare tagli a Parisina, eliminando l’esecuzione del quarto atto già dalla seconda rappresentazione scaligera. A quello egli aggiunse un taglio nel postludio del secondo atto, che poi tolse completamente tra la terza e la quarta rappresentazione ed infine abolì parte della scena tra madre e figlio al primo atto, compresa l’enunciazione del tema di Ugo. Al termine delle recite milanesi, Parisina passò a Livorno all’inizio del 1914, con gli adeguamenti ricevuti a Milano. L’affetto dei concittadini decretò un grande successo all’opera e al suo autore, che però non fu confermato nelle successive rappresentazioni allestite al Teatro Costanzi, a Roma. Mascagni non si dimostrò entusiasta della produzione romana, che nacque senza il suo diretto controllo. Perdipiù, quando egli stesso subentrò a Edoardo Vitale nella direzione d’orchestra, trovò sul palcoscenico una protagonista femminile che non riscuoteva le sue simpatie. Nella primavera seguente Parisina varcò poi l’oceano con la produzione del Teatro Costanzi, per affrontare una tournée sudamericana che, in effetti, lasciò una traccia molto labile. Il concetto d’ineseguibilità ormai si associava generalmente a questa partitura. All’inizio del 1916 Pietro Mascagni fu scritturato per dirigere a Genova una stagione lirica interamente dedicata alle sue opere. Nel programma fu inserita anche Parisina, ma il musicista non fu contento dell’impresa organizzatrice e dopo due sole rappresentazioni fece togliere l’opera dal cartellone. Sembrava quasi che nel cuore dell’autore le difficoltà di realizzazione di Parisina si fossero trasformate in disinteresse. Mascagni mise da parte questa sua amatissima creatura, lasciando cadere i progetti che dovevano portare l’opera in molte città italiane ed anche a Parigi. Non volle eseguire Parisina fino al 1938, quando diresse la partitura dai microfoni dell’ente radiofonico italiano d’allora (E.I.A.R.). In quest’occasione l’autore ripristinò anche l’esecuzione del quarto atto, complice l’impiego del grande mezzosoprano Ebe Stignani nella parte di Stella dell’Assassino. Nel dopoguerra Gianandrea Gavazzeni ha raccolto l’amore mascagnano, riproponendo Parisina a Livorno nel 1952 ed a Roma nel 1978, difendendola anche dagli attacchi di una critica talvolta esacerbata. Il grande direttore bergamasco, pochi mesi prima della morte, volle dirigere in concerto il quarto atto dell’opera quasi come un inavvertito testamento spirituale. Da ricordare infine la produzione radiofonica R.A.I. avvenuta a Milano nell’ottobre 1976. Questo è stato il cammino di Parisina fino all’edizione di Montpéllier (1999), fino ad oggi l’ultima per quest’opera. 14 Parisina alla Scala (al paragrafo L’opera), in «Il corriere della Sera», Milano, 16 dicembre 1913. Codice 602 64 65 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc di Guido Salvetti Per coloro – ancora troppo pochi – che credono nelle esecuzioni ‘storicamente informate’, e che diffidano del puro istinto come base dell’interpretazione musicale, il cospicuo lascito di Francis Poulenc (1899-1963) nel genere della musica vocale da camera (circa 110 Mélodies e 30 Chansons) rappresenta un caso fortunato, visto che l’autore stesso – pianista delle proprie musiche – si è prodigato in consigli e chiarimenti su tutte queste sue composizioni; e che il suo più importante e più assiduo interprete vocale, il baritono Pierre Bernac, ha dedicato altrettante cure in pubblicazioni che hanno avuto vasta attenzione e diffusione. Mi riferisco, nel primo caso, al Journal de mes mélodies, dove Poulenc commenta una per una queste sue opere. Si tratta di brevi annotazioni, in parte appartenenti – come vero e proprio diario – all’epoca della composizione o della prima esecuzione; in maggior parte stese ex post, in vista di una pubblicazione che non poté avvenire per via della morte precoce e improvvisa dell’autore il 30 gennaio 1963. In ogni caso, dopo pochi mesi dalla morte gli amici più cari, riuniti in associazione per onorarne la memoria (Association des amis de Francis Poulenc, tuttora operante)1, erano in grado di pubblicare con le Éditions Bernard Grasset una preziosa e accurata edizione, curata dal compositore Henri Sauguet, del Journal de mes * Guido Salvetti è musicologo e pianista. Come musicologo ha al suo attivo volumi e saggi su argomenti che spaziano dal Settecento italiano all’Ottocento operistico, al Novecento storico. Come pianista è attivo particolarmente nel repertorio da camera e liederistico e da più di un decennio collabora con il soprano Stelia Doz in numerose masterclass in Italia e in Europa, con concerti e incisioni. Dal 1984 al 1996 presso il Conservatorio di Milano ha diretto il corso di Musicologia da lui fondato, dove ha insegnato Storiografia musicale e Analisi della musica post-tonale. Di questo Conservatorio è stato direttore dal 1996 al 2004. Nel 2000 ha insegnato all’École Normale Supérieure di Parigi per il corso DEA Musique Histoire Société: il corso è stato dedicato alla musica italiana del primo Novecento. Dal 2006 al 2012 è stato presidente della Società Italiana di Musicologia (SIdM). Dal 1995 dirige la Collana “Musica nel Novecento italiano” e dal 2003 la Collana “Repertori musicali”. 1 Rimando al sito dell’Associazione all’indirizzo www.poulenc.fr. Codice 602 67 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti mélodies. Dall’introduzione a firma del curatore apprendiamo “che Francis Poulenc era estremamente attento alle interpretazioni delle sue musiche” e che spesso ebbe a lamentarsi di cantanti che “ascoltano soltanto il loro istinto” e di pianisti che non capiscono che “l’accompagnamento di un Lied ha pari importanza della parte di pianoforte in una Sonata”. Nel secondo caso, cioè per quanto riguarda Pierre Bernac, confluisce nei suoi scritti l’esperienza esecutiva lungo i venticinque anni di concerti e di amicizia con Poulenc2, rafforzata da un’importante pratica di insegnamento, che vide uscire dalla sua scuola cantanti quali Gérard Souzay, Elly Ameling e Jessye Norman. Le indicazioni esecutive contenute nei suoi scritti sono molto particolareggiate e si potrebbero riassumere nella costante preoccupazione che tutti, assolutamente tutti, i segni presenti nello spartito abbiano pieno e convinto riscontro nell’esecuzione. In genere vengono confermati i metronomi apposti dal compositore, tranne qualche piccola oscillazione consigliata dalle esigenze della ‘pronuncia’ del testo poetico. A mio parere la parte didatticamente più preziosa – soprattutto per i cantanti di madrelingua diversa dal francese – è la puntigliosa annotazione, sopra il testo poetico, delle liaisons, delle separazioni, dei principali appoggi, delle parole-chiave, ecc. L’impostazione pragmatica e minuziosa di Bernac ci riporta spesso per le scelte interpretative più generali alle parole di Poulenc, anch’esse apparentemente impegnate a chiarire tali questioni caso per caso, ma in realtà preziosamente intrise di intenzioni e convinzioni profonde di ordine generale. È quanto ora intendiamo chiarire, anche perché, come vedremo, le indicazioni di Poulenc – più ancora di quelle di Bernac – si prestano a qualche fraintendimento da parte di chi non è di madrelingua francese e soprattutto di chi non ha confidenza con una prosa che tende al paradosso, o almeno all’esagerazione. Poulenc stesso ci dà la misura di quanto la chiave principale per comprendere le sue mélodies sia la poesia; intesa non solo come testo poetico con i suoi contenuti e le sue strutture formali – come è ovvio –, ma soprattutto come immersione nell’immaginazione e nella sensibilità del poeta. Viene spontaneo il riferimento ad alcune raccolte ottocentesche, tra cui i Lieder su testi di Elisabeth Kulmann che Schumann compose con l’animo commosso per la geniale e sfortunata adolescente, morta a diciassette anni, un cui ritratto era appeso vicino alla sua scrivania. Poulenc dichiarò in più circostanze di conoscere e amare questa piccola raccolta. Il nostro musicista arrivò a immaginare che sarebbe stato titolo di gran 2Cfr. Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, Paris, Buchet-Chastel, 1978; Francis Poulenc. The Man & his Songs, Norton & Company Inc., New York, 1977; The Interpretation of French Song, Cassell-London, 1976 (capitolo Poulenc, pp. 269-326). merito se sulla sua tomba si fosse letto: “Qui giace chi mise in musica Apollinaire ed Éluard”. Avrebbe potuto aggiungere, in quell’occasione, altri nomi a cui dimostrò di essere altrettanto legato: per esempio, Louis Aragon (il poeta della struggente C e dello scioglilingua ‘dada’ Fête galante); o Max Jacob, pittore amico di Picasso e Braque e poeta pre-surrealista3, autore dei testi della cantata per baritono e orchestra Bal masqué 4 . Diremo più oltre del posto privilegiato che occupa Louise de Vilmorin, per chi voglia comprendere il milieu culturale a cui appartengono le mélodies di Poulenc dagli anni Trenta in avanti. Per l’esecutore, dunque, è decisivo non tanto sapere queste frequentazioni poetiche di Poulenc, quanto capirne il significato, cioè la chiave di lettura di queste poesie che il musicista intende darci. Il caso di Guillaume Apollinaire è particolarmente sorprendente. Le prime poesie di questo poeta furono musicate da Poulenc nel 1920 (Le Bestiaire) e occuparono tutti gli anni fino al 1946 (l’anno delle Deux mélodies sur des poésies de Guillaume Apollinaire, che sono Le pont e Un poème). Il poeta riconosce, nei confronti del poeta, un debito diretto: “È con Apollinaire che io penso di aver trovato il mio vero stile melodico”5. In altra occasione ebbe a precisare quali siano le caratteristiche di quel mondo poetico, affermando che “la sua ironia è velata di tenerezza e di malinconia”, mettendo però subito tra parentesi l’ironia, con la raccomandazione agli esecutori di eliminare “clignements d’yeux et un faux air entendu”, strizzatine d’occhio e false arie d’intesa6, che sono di quell’ironia – almeno per l’ormai lunga tradizione cabarettistica e degli chasonniers da Aristide Bruant fino a Maurice Chevalier – la più evidente manifestazione. E invece, riferendosi al Bestiaire, dichiara agli esecutori:7 […] cantar il Bestiaire con ironia e soprattutto con intenzione è un controsenso completo- vuol dire non capire niente della poesia di Apollinaire e della mia musica. Maria Freund canta il Bestiaire con serietà, come se fosse Schubert. 3 Il Surrealismo ebbe il suo ufficiale atto di nascita nel 1924, con il manifesto di André Breton. La libera associazione delle parole e delle frasi, riferita a un flusso di coscienza che è tipico del sogno, è però già operante in Stéphane Mallarmé (1842-1898) e dagli anni del Simbolismo, il cui manifesto, ad opera di Jean Moréas, risale dal 1886. 4 Max Jacob (1876-1944) è stato un poeta, pittore, scrittore e critico. Amico di Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Georges Braque. Jean Cocteau, e Amedeo Modigliani, che dipinse il suo ritratto nel 1916. Come letterato pubblicò la raccolta di poesie in prosa Le Cornet à dés, del 1917, e Le Laboratoire central (1921), definito dall’autore come “un’ampolla tappata di liricità”. Alcuni versi tratti da Le laboratoire central furono musicati nel 1933 dall’amico Francis Poulenc nella forma di cantata per orchestra da camera e baritono col titolo di Le Bal masqué. 5 Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, Cicero, Parigi, 1993, p. 10. 6 Ibid., p. 33. 7 Ibid., p. 4. Codice 602 68 69 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti Nel caso di altre mélodies su poesia di Apollinaire (Quatre poèmes de Guillaume Apollinaire), per la vivace e ammiccante L’Anguille la raccomandazione è la stessa8: “senza ironia, credendoci”; e per Carte postale rimanda a un composto quadro di Bonnard (Misia Sert al pianoforte), di cui occorre sottolineare dice – “l’intimità”. Gli interpreti che pensano di applicare alle mélodies di Poulenc i modi degli chansonniers, sia nel genere vivace e scollacciato, sia nel genere sentimentale (alla Edith Piaf, che Poulenc frequentò nell’ambiente di Jean Cocteau), sono quindi avvertiti: Poulenc si espresse recisamente contro “il genere ibrido […] quella confusione di generi che si è troppo prolungata. […] Ognuno al suo posto!”9. È pur vero che dichiarazioni di questo tipo appartengono a una fase tarda della vita di Poulenc; al secondo dopoguerra. Eppure non si può non tener conto che egli si espresse contro un’intonazione canzonettistica delle sue mélodies, pretendendo un vero ‘canto’ (“nelle Mamelles [de Tirésias] bisogna cantare come se fosse Verdi”)10, e detestando le “chanteuses intelligenti”. Contestualmente dichiarava, con riferimento a Roussel, di detestare “l’umorismo freddo”11. Tutto ci induce a pensare che l’incontro con Apollinaire avvenne per Poulenc mettendo tra parentesi l’ironia e valorizzando sempre più “tenerezza e malinconia” (prediligendo, anche come esecutore, opere languorose come Voyage, ultimo dei Calligrammes, definita “una delle due o tre melodie a cui tengo di più”); il che è non poco paradossale se si pensa allo spirito provocatorio ed eversore degli anni 1910-1918 in cui il poeta pubblicò le sue stupefacenti raccolte di poesie; ma che può ben inquadrarsi, prima di tutto in quel generale ‘ritorno all’ordine’ che trionfò nel primo dopoguerra, ma soprattutto nella propensione nostalgica di cui Poulenc ha dato tanti segni nei suoi ultimi anni. Concludendo su questo punto, rimane l’esigenza di collocare queste raccomandazioni anti-ironiche in un contesto che escluda qualsiasi ritorno a un sentimentalismo romantico: il musicista raccomanda infatti, fino alla noia, di evitare il rubato e il rallentando conclusivo. L’inesorabilità del ritmo è il riscatto dal pericolo della malinconia; è l’antidoto alla sonorità ‘poetica’ che Poulenc ricercava, come vedremo, in un gioco pianistico (e talvolta armonico) che spesso è ‘alla Chopin’. Accostato ad Apollinaire al vertice delle predilezioni di Poulenc, Paul Éluard (1895-1952) può vantare il numero maggiore di poesie intonate dal suo fedele Francis, nonostante fossero di idee politiche distanti: 8 Ibid., p. 11. 9 Ibid., p. 49. 10 Ibid., p. 53, aprile 1945. 11 Ibid., p. 61 ottobre 1945. Poulenc era cattolico e, dagli anni della resistenza al nazismo, gollista; Éluard era comunista convinto, inquadrato nel partito comunista francese. Fondatore, assieme a Breton ed Aragon, del movimento surrealista, nelle sue opere Éluard adottò la tecnica ‘onirica’ dell’accostamento apparentemente casuale, agli ossimori, agli scarti improvvisi tra realismo e simbolismo. Poulenc ebbe a dichiarare che “nessuno saprà mai abbastanza tutto quello che io devo a Éluard. Grazie a [lui]12 il lirismo è penetrato nella mia opera vocale […] a causa del calore delle sue immagini”. Anche nel caso di Éluard il punto più vero dell’incontro tra poeta e musicista risiede in qualche zona dell’ispirazione che è sorprendentemente lontana dal gioco modernista ed eversore. È stato ben scritto che “[per il poeta] niente si descrive meglio che quello che si conosce appena. Non si scopre se non quello che non si conosce”13. L’incontro avviene dunque in quel margine di ambiguità dei significati che il poeta si pone il compito di creare, con la convinzione che da lì, da quella incertezza, nasceranno la sorpresa, l’immaginazione, la commozione o il riso. In quel margine la musica di Poulenc gioca la sua partita, che non è quella della ‘spiegazione’ della poesia in termini razionali e quindi prosastici, ma è quella di fissare nel modo migliore lo stato d’animo con cui la sensibilità del musicista si accosta a quel mondo di immagini, rese fresche e incontaminate perché liberate dai pesi sintattici e dalle connessioni logiche per volare libere in un cielo di pura poesia. Leggiamo ancora: “ciò che ha più infiammato l’immaginazione di Poulenc è la comunicazione costante che Éluard stabilisce tra il mondo reale e i sogni, molto più in là della [freudiana] interpretazione dei sogni a cui i surrealisti si sono dedicati per igiene mentale”14. È qui che entra in campo la centralità per Poulenc della prosodia, cioè del modo con cui la sua musica deve decidere il ritmo, gli accenti e gli appoggi della ‘lettura’ poetica. La questione è decisiva sul terreno dell’esecuzione almeno quanto è stata decisiva per il compositore nel grande e lungo lavoro, talvolta durato anni, con cui cercava di immergersi nel valore poetico di quei testi. Almeno una volta Poulenc ci spiega con chiarezza i termini di questo ‘lavoro’; e lo fa con l’orgoglio di … esserci riuscito. Sia nel Journal15, sia Nel testo originale questa dichiarazione accomuna a Éluard il baritono Pierre Bernac: ne parleremo più innanzi. 13 Claude Carré, Francis Poulenc et Paul Éluard: une seule musique sous les deux espèces, articolo consultabile all’indirizzo http://www.poulenc.fr/downloads/poulenc_ eluard.pdf. 14 Carré, Francis Poulenc et Paul Éluard, cit. 15 Poulenc, Journal, p. 16. 12 Codice 602 70 71 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti nell’intervista radiofonica a Claude Rostand16, egli si riferisce alla quarta mélodie della raccolta Cinq poème d’Éluard, Rôdeuse au front de verre: Rôdeuse au front de verre, Son coeur s’inscrit dans une étoile noire. Ses yeux montrent sa tête, Ses yeux sont la fraîcheur de l’été, La chaleur de l’hiver. Ses yeux s’ajourent, rient très fort. Ses yeux joueurs gagnent leur part de clarté. Vagabonda dalla fronte di vetro, il suo cuore s’iscrive in una stella nera i suoi occhi mostrano la sua testa, i suoi occhi sono la freschezza dell’estate, il calore dell’inverno, i suoi occhi si aprono al giorno, ridono forte, i suoi occhi giocano e conquistano la loro parte di luce Poulenc ci dice di aver pensato a lungo di come tradurre in ritmi musicali il penultimo verso: Ses yeux s’ajourent, rient très fort. Come si può vedere i versi precedenti e quello seguente scorrono regolarmente, senza interruzione, dalla prima sillaba verso l’appoggio sull’ultima. Ma in quel penultimo verso, all’improvviso, tra la quinta (-ent) e la sesta sillaba (rient - pronuncia rì) c’è una frattura, un soprassalto. La soluzione stava per il musicista nell’introduzione di una pausa tra le due sillabe e di un appoggio deciso, nell’acuto, sulla seconda17. Questo è uno dei tanti possibili esempi di come la prosodia musicale senta di doversi modellare letteralmente su quella letteraria. Non sempre è così, naturalmente; ma l’osservazione di Poulenc ci induce a considerare tutta l’importanza che in sede di esecuzione si definisca esattamente, preliminarmente, quali siano le soluzioni prosodiche del canto rispetto alla poesia18. Ritornando a Éluard, è mia convinzione che la difficoltà di recitare in musica le sue poesie, con il suo valore di sfida, sia alla base della predilezione del nostro musicista. Giustamente, però, Poulenc riconobbe che lui stesso ha dovuto imparare, non solo dal poeta, ma anche dal cantante, il baritono Pierre Bernac, con cui collaborò per più di 27 anni. La frase Claude Rostand, Francis Poulenc ou l’invité de Touraine, 6e entretien radiophonique, Radio France, rimasterizzato in Francis Poulenc ou l’invité de Touraine. Entretiens avec Claude Rostand. Coffret de 2 CD, “Les Grandes heures”, Archives sonores de l’INA (Institut National Audiovisuel). 17 Francis Poulenc ou l’invité, a 8’ e 17”: “Solo l’istinto mi ha fatto trovare questo accento sul tempo forte, dopo un silenzio che rende impossibile ogni equivoco”. 18 Nella pratica didattica del soprano Stelia Doz, con cui ho collaborato per anni, c’è questo vincolo preliminare: l’allievo è obbligato a recitare la poesia con i ritmi e con la forma di frase musicale (levare, culmine, appoggio, ecc.) che modella o rimodella la prosodia letteraria. Vedi i suoi articoli Alcune idee sull’interpretazione del Lied romantico, in I canti dell’ultimo Schumann, a cura di Guido Salvetti, Pisa, Edizioni ETS, 2007, pp. 25-42; Alcune idee sull’interpretazione del repertorio francese, in Tra ‘poeti maledetti’ e cabaret. Mélodie e Chanson da Duparc a Poulenc, a cura di Guido Salvetti, Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 27-38. 16 che più sopra abbiamo citato parzialmente, contiene infatti questo elogio di Bernac: Non si saprà mai abbastanza quello che devo […] a Bernac. È grazie a [lui] che il lirismo è penetrato nella mia opera vocale […] grazie alla sua ammirevole comprensione musicale e soprattutto grazie a quello che mi ha insegnato dell’arte del canto nel corso dei nostri anni di lavoro19. Quanto possa aver imparato Poulenc, come pianista, dal baritono Bernac credo si possa ben capire guardando con attenzione l’accurato lavoro condotto da quest’ultimo, nei suoi scritti sopra citati, direttamente sui testi poetici, con i segni di appoggio, sospensione, interruzione, legatura, ecc. Non molto diversa da quella con Éluard fu l’esperienza di Poulenc con Louise de Vilmorin (1902-1969), almeno per quanto riguarda un linguaggio poetico che lascia sufficienti margini di indeterminazione affinché l’immaginazione musicale possa accendersi di luce propria. Certo meno nota, almeno in Italia, di Éluard e Apollinaire, questa donna delicata e affascinante al punto da far innamorare l’omosessuale Jean Cocteau e una schiera impressionante di mariti e amanti dagli Stati Uniti alla Slovacchia, da Roma a Londra, fu al centro della vita culturale parigina tra le due guerre, nei salotti intellettuali di Marie Blanche de Polignac (a Parigi e a Kerbastic), cantante e pianista ‘dilettante’, o di sua zia, la mecenate Edmond de Polignac, organista: è il mondo di Picasso e Bonnard, di Stravinsky, di Cocteau e dei Six (in particolare il mondano Auric e, meno assiduamente, il nostro Poulenc), De Falla e Wanda Landovska; e cento altri, tra cui le protagoniste della moda (Jeanne Lanvin) e della creazione di nuovi profumi (Chanel). Loulou, come veniva chiamata la Vilmorin, si era segnalata negli anni Trenta come romanziera (fantasiosa e leggera, provocatoria ma non troppo, del tipo – benché molto meno sdolcinata – della nostra Liala). Poi, come vedremo, sarà la volta delle raccolte di poesie. Nel dopoguerra, tornata a Parigi dopo anni passati in un castello della Slovacchia e nella vita mondana di Budapest, si dedicherà a sceneggiature cinematografiche, e collaborerà con articoli di cronaca mondana a riviste di moda e di attualità: attività che le darà ancor più l’opportunità di partecipare agli eventi mondani internazionali di quegli anni. Tra le sue amicizie si contano Jacqueline Bouvier, che sarà Kennedy, i reali di Monaco e i Savoia in esilio; attraverso il suo eterno amico-amante André Malraux, ministro nei governi di De Gaulle, frequentò Winston Churchill e tanti altri governanti d’Europa e d’America. Nel suo castello di Verrières, a pochi chilometri a sud-ovest di Versailles, inaugurò, dal 1952, gli incontri culturali dei Dimanches. Per chi volesse rendersi davvero conto 19 Vedi nota 12. Codice 602 72 73 Guido Salvetti di questa vita così speciale, c’è oggi la possibilità di ricevere sul proprio computer (formato Kindle) una biografia particolareggiata e vivace, a cui rimando20. Può invece essere utile che io selezioni i passaggi più significativi, per noi, delle Correspondances21 e del Journal di Poulenc riguardanti la Vilmorin e, naturalmente, le mélodies da lei ispirate. Nel novembre 1936 la Vilmorin scriveva al musicista scherzando su quanto aveva sofferto nello scrivere le poesie da lui richieste: Sei tu, Francis, sei tu che per primo (tu sei dunque per me Francis 1°) che hai avuto l’idea di ‘comandarmi’ delle poesie da mettere in musica. Così sarai tu a decretare che io sia poeta! La tua fiducia mi onora e mi piace tanto più che la credo impregnata dal fascino sovrano delle illusioni. A Kerbastic non ho potuto scrivere che le Garçon de Liège e Eau de vie, au-delà che ti mando qui allegate. Quanto a Chevaliers de la Garde blanche (te la mando anch’essa) l’ho scritta qualche mese fa, nel più grande segreto, a Forques, a casa di Jean Hugo22 e pensando a lui. Per me è meno una poesia e più una preghiera e una confessione. Se mai diventerò poeta sarà colpa tua e io mi domando se ti perdonerò di avermi obbligata a non nascondere i sospiri della mia malinconia. Altre lettere, per e dal castello del marito Palffy in Slovacchia, riguardano le sei mélodies su poesie tratte dalla raccolta Fiançailles pour rire (1939). Nel Journal ci sono pagine molto esplicite su come Poulenc ‘leggeva’ queste poesie. In data 2 dicembre 1939 scriveva: Poche creature mi commuovono come Louise de Vilmorin: perché è bella, perché zoppica, perché scrive in un francese dall’innata purezza, perché il suo nome evoca fiori e legumi, perché ama d’amore i suoi [quattro] fratelli, e fraternamente i suoi amanti. Il suo bel viso fa pensare al XVII secolo, come il suono del suo nome. […]. L’amore, il piacere, la malattia, l’esilio, l’impaccio sono la fonte della sua autenticità. […] Le poesie di Louise de Vilmorin danno materia a vere melodie femminili. È ciò che m’incanta. Seguono annotazioni più specificamente incentrate sulle poesie che ha messo in musica: Poiché in generale amo raggruppare numerose melodie, ho richiesto a Louise altre poesie. Durante l’estate del 1937 scrisse per me Le garçon Françoise Wagener, Je suis née inconsolable, Louise de Vilmorin, 1902-1969, Paris, Albin Michel, 2008. 21 Francis Poulenc, Correspondances 1913-1969, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes, Paris, Fayard, 1994. 22 Jean Hugo (1894–1984) fu un pittore, illustratore, scenografo e sceneggiatore. Mas de Forques, sua residenza provincial, è presso Lunel, a pochi chilometri da Montpellier. 20 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc de liège e Eau de vie au delà. […]. Mi dispiace che nella sua raccolta Fiançailles pour rire abbia creduto di far bene edulcorando l’erotismo velato di Eau de vie au-delà. Per niente al mondo apporterei questo cambiamento nella mia versione musicale perché questo creerebbe un vero controsenso. La palpitazione dell’accompagnamento non avrebbe più ragion d’essere. Ci sono, poi, preziosi spunti interpretativi riguardanti le singole mélodies. Prezioso, mi sembra, è quanto consiglia a proposito del Garçon de Liège, “vertiginosamente veloce […] per salvaguardare l’atmosfera turbinosa [tourbillonante: è di più di turbinosa!] della poesia. La parte del canto non è invece di un flusso precipitato come quello del pianoforte”. A proposito di Eau de vie “occorre cantare leggermente, molto semplicemente, senza sottolineature e ciononostante senza nulla nascondere”. Per Aux officiers de la garde blanche rivendica la scelta di una falsa ricchezza, e difende la scelta dell’immutabile unisono dell’inizio: “da parte mia ci vedo umiltà più che povertà”. E aggiunge: “quei sedicesimi ripetuti evocano la chitarra che Louise porta con sé quando va a pranzo dai suoi amici”. Più sommarie, a mio parere, le annotazioni riguardanti le sei mélodies della raccolta Fiançailles pour rire. Raccomanda molta intensità in Dans l’herbe; molte prove e molto lavoro per superare le difficoltà di Il vole; molta semplicità per Mon cadavre. Dichiara di aver tradotto in un’atmosfera francese il riferimento zigano di Violon. Fleurs deve essere cantato “umilmente poiché il lirismo viene dall’interno”. Anche da questi pochi spunti ci possiamo convincere che, ancora una volta, Poulenc, mentre metteva in musica queste poesie, era dominato soprattutto dalla personalità del poeta, in questo caso una donna deliziosa e sensibile, che scriveva poesie adatte a “vere melodie femminili”; il che si traduceva in semplicità, umiltà (il termine più usato) e leggerezza. A quest’ultimo proposito trovo illuminante per gli esecutori quanto richiede per il Garçon de Liège il cui vortice di note veloci viene associato all’immagine della vertigine, un’idea che si pone agli antipodi rispetto alla velocità ‘meccanica’ e programmaticamente senz’anima del modernismo di stampo futurista (si pensi anche soltanto a Pacific 231 di Honegger). A prima vista, inoltre, può sembrare ineseguibile la raccomandazione che la voce non precipiti quanto il pianoforte. Occorre però capire che per la voce non è tanto un problema di velocità, quanto di pronuncia e di fiati. Ad esempio, nel Journal, così come nelle schede interpretative di Bernac, emerge talvolta la raccomandazione di utilizzare per alcuni scopi espressivi i fiati corti o cortissimi. C’è anche l’accenno al valore della parte pianistica per attribuire alla mélodie il valore erotico della poesia: “la palpitazione dell’accompagnamento”. Questo ci dà occasione, dopo aver dedicato al cantante una serie di osservazioni e di raccomandazioni riguardanti il valore fondamentale Codice 602 74 75 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti della prosodia, per far riferimento alle numerose osservazioni, disseminate nelle nostre fonti, riguardanti il pianoforte. Si parte con la fin ovvia constatazione che la parte pianistica ha in generale – non certo solo nelle sue – un ruolo decisivo, ben lontano da quello del cosiddetto ‘accompagnamento’. L’annotazione di Poulenc, a questo proposito, è corredata da un esempio musicale in cui al pianoforte appare un controcanto che qua e là scavalca in altezza la linea del canto. In casi come questi e in tanti altri, è fondamentale che il pianista sappia capire dove e come emergere. Per far questo, egli arriva a dire, il miglior pianista per il genere del Lied e della mélodie è un compositore.23 Mi si perdoni un inciso, pertinente allo scopo sostanzialmente didattico di questo mio intervento. Vorrei infatti sottolineare quanto soprattutto oggi sia importante e attuale questa questione, perché le abitudini esecutive in questo ambito sono venute di molto regredendo negli ultimi decenni, con pianisti troppo timidi e sommari, con esecuzioni a coperchio abbassato, con un costante disequilibrio sonoro a favore del canto. Credo che ciò dipenda soprattutto dall’infausta abitudine di quegli esecutori che, quando iniziano a studiare la parte, si vanno ad ascoltare tutto quanto si trova nei siti tipo Youtube. Ciò che si ascolta attraverso questi canali e i miseri altoparlanti del proprio computer è un’ombra distorta e poverissima, ancor peggiore di quanto si può ascoltare dai CD: se ascoltati con mezzi non professionali, o addirittura in auto con il rumore del motore: i bassi sono quasi inudibili (con quasi totale eliminazione dei valori armonici) e gli acuti hanno un risalto del tutto innaturale. Occorre quindi rileggere le raccomandazioni di Poulenc: “la mia musica reclama l’impiego pressoché costante del pedale”; “i pedali hanno un posto capitale nella mia musica […]; con loro si possono ottenere colori divini”24. A modello indica, a questo proposito, Walter Gieseking. Nella stessa annotazione, già citata, dell’aprile 1945, in cui si scaglia contro le “chanteuses intelligentes”, nel rivendicare alle proprie mélodies un canto vero e pieno, precisa, anche: “con una bella salsa di pedale. Il burro, che diamine! Senza questo una musica si spappola”25. In conclusione, una rilettura delle indicazioni interpretative di Poulenc e di Bernac ci convince che esse sono improntate alla convinzione che queste opere (anche quando mimano – soprattutto nelle Chansons – i generi più popolari e di consumo) appartengono alla sfera colta, del Lied tedesco e della mélodie come praticata da Debussy o Fauré. Fin troppo in ombra appaiono alcuni aspetti che oggi chiameremmo della ‘contaminazione’ con il cabaret e la canzone commerciale. Negli anni di gioventù 23 Poulenc, Journal, cit., p. 68. 24 Ibid., p. 38. Ibid., p. 53. 25 – gli anni Venti, soprattutto – la cosiddetta ‘estetica del luna-park’ predicata da Cocteau aveva effettivamente scaldato i cuori verso nuovi ambiti di modernità. Che questa contaminazione abbia tentato anche Poulenc è documentato dall’impresa collettiva de Les mariés de la tour Eiffel (1920) e anche dall’opera tratta da Apollinaire, Les mamelles de Tirésias, concepita nel 1930 e realizzata tra il 1939 e il 1944. Il rifiuto del genere ‘ibrido’, come disse, e l’insistenza sulla ‘serietà’ della propria musica vanno capiti come appartenenti alla fase riflessiva del secondo dopoguerra. È significativo, a mio parere, che non ci siano evidenti segni di evoluzione stilistica, nelle mélodies, tra l’anteguerra e gli ultimi anni: Poulenc si sentiva un sopravvissuto a un mondo che stava sprofondando: quello del sistema tonale avversato dai ‘dodecafonici’; quello della ‘voce umana’ svuotata dagli automatismi seriali (Boulez) e dalle tecnologie (Pousseur). Il genere stesso della mélodie (che pure egli affermava non essere sorpassato) avrebbe avuto bisogno di nuovi poeti, che Poulenc, dopo la morte di Éluard, non vedeva più all’orizzonte, benché forse, dopo il ritiro dai concerti di Pierre Bernac, qualche speranza poteva venirgli da Denise Duval. Insomma tutto quanto siamo venuti riferendo in questo saggio va ben soppesato, evitando di appiattire la grande varietà e la grande vivacità di queste opere sulla malinconia e la tristezza troppo spesso invocate dal loro autore, prossimo ad abbandonare – nel 1958, con uno struggente addio – il genere tanto amato. Rimane – quella sì preziosissima – la serie delle indicazioni di studio: la cura estrema della prosodia; la precisa individuazione volta per volta della funzione del pianoforte. E l’interesse che oggi riveste la sua musica, con l’avverarsi della profezia che Poulenc enunciò nel 1961: “so di essere fuori moda; d’altronde penso che, nell’avvenire, mi si eseguirà più di Barraqué e Pousseur”26. Il problema, semmai, è che ciò avvenga con l’amore che crediamo si sia meritato dispensandoci tanti tesori di poesia musicale. 26 Poulenc, Correspondances 1913-1969, cit., p. 256. Codice 602 76 77 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti Appendice 101 – Fiançailles pour rire (Vilmorin) 102 – Bleuet (Apollinaire) Cronologia generale delle mélodies di Poulenc secondo la segnatura FP 1919 11 – Toréador (Cocteau) 1940 106 – Le chemin de l’amour (Anouilh) 107 – Banalités (Apollinaire) 1941 112 – Deux poèmes de Louis Aragon 1942 117 – Chansons villageoises 1920 15 – Le Bestiaire (Apollinaire) 16 – Cocardes (Cocteau) 1943 121 – Métamorphoses (Vilmorin) 122 – Deux poèmes (Aragon) 1921 22 – Quatre poèmes de Max Jacob 1944 127 – Montparnasse-Hyde Park (Apollinaire) 1924 38 – Poèmes de Ronsard 1925 42 – Huit chansons gaillardes, (anonimi XVII secolo) 1927 44 – Vocalise 46 – Airs chantés (Jean Moréas) 1946 131 – Deux mélodies (Apollinaire) 132 – Paul et Virginie (Radiguet) 134 – Le disparu (Desnos) 1947 136 – Trois chansons de Garcia-Lorca 137 – Mais mourir (Éluard) 1930 55 – Épitaphe (Malherbe) 1948 140 – Calligrammes (Apollinaire) 1931 57 – Trois poèmes de Louise Lalanne 58 – Quatre poèmes (Apollinaire) 59 – Cinq poèmes (Max Jacob) 1949 144 – Hymen (Racine) 145 – Mazurka (Vilmorin: n. 2 della raccolta collettiva Mouvements du coeur) 1932 60 – Le Bal masqué (Max Jacob) 66 – Pierrot (Banville) 1950 147 – La fraîcheur et le feu (Éluard) 1933 69 – Huit chansons polonaises 75 – Quatre chansons pour enfants (Jaboune) 1935 77 – Cinq poèmes de Paul Éluard 79 – À sa guitare (Ronsard) 1936 86 – Tel jour telle nuit (Éluard) 1953 157 – Parisiana (Max Jacob) 158 – Rosemonde (Apollinaire) 1956 161 – Le travail du peintre (Éluard) 162 – La souris – Nuage 163 – Dernier poème (Desnos) 1957 167 – Viva Nadia 169 – Une chanson de porcelaine (Éluard) 1958 174 – Fancy (Shakespeare) 1937 91 – Trois poèmes de L. de Vilmorin 1938 92 – Le portrait (Colette) 94 – Deux poèmes de G. Apollinaire 96 – La grenouillère (Apollinaire) 1960 178 – La courte-paille (M. Carême) 1962 182 – Nos souvenirs qui chantent (contrafactum della 1a aria di Teresa in Les mamelles de Tirésias) 1939 98 – Miroirs brûlants (Éluard) 99 – Ce doux petit visage (Éluard) Codice 602 78 79 Spunti per l’esecuzione delle mélodies di Poulenc Guido Salvetti Mélodies su poesie di Apollinaire (ordine alfabetico di raccolta) Deux Mélodies sur des poèmes de Guillaume Apollinaire, FP. 131 1. Le pont 2. Un poème Banalités (Banalities), FP. 107 1. Chanson d’Orkenise 2. Hôtel 3. Fagnes de Wallonie 4. Voyage à Paris 5. Sanglots Deux poèmes de Guillaume Apollinaire, FP. 94 1. Allons plus vite 2. Dans le jardin d’Anna Calligrammes, FP. 140 1. L’espionne 2. Mutation 3. Vers le sud 4. Il pleut 5. La Grâce exilée 6. Aussi bien que les cigales 7. Voyage Le Bestiaire, FP. 15a 1. Le dromadaire 2. La chèvre du Thibet 3. La sauterelle 4. Le dauphin 5. L’écrevisse 6. La carpe Deux Mélodies de Guillaume Apollinaire, FP. 127 1. Montparnasse 2. Hyde Park Deux Mélodies inédites du Bestiaire, FP. 15b 1. Le serpent 2. La colombe Quatre Poèmes de Guillaume Apollinaire, FP. 58 1. L’Anguille 2. Carte-Postale 3. Avant le Cinéma 4. 1904 Rosemonde, FP 158 (da Alcools) Mélodies su testi di Paul Éluard (in ordine di raccolta) Cinq Poèmes de Paul Éluard (1935) FP 77 1. Peut-il se reposer? 2. Il la prend dans ses bras 3. Plume d’eau claire 4. Rôdeuse au front de verre 5. Amoureuses Miroirs brûlants (1938-39) FP 98 1. Tu vois le feu du soir 2. Je nommerai ton front Un soir de neige (1944) FP126 1. De grandes cuillers de neige 2. La bonne neige 3. Bois meurtri 4. La nuit le froid la solitude Main dominée par le coeur (1947) FP 135 Mais mourir! (1947) FP 137 La Fraîcheur et le feu (1950) FP 147 1. Rayon des yeux 2. Le Matin les branches attisent 3. Tout disparut 4. Dans les ténèbres du jardin 5. Unis la fraîcheur et le feu 6. Homme au sourire tendre 7. La Grande rivière qui va Le Travail du peintre (1956) FP 161 1. Pablo Picasso 2. Marc Chagall 3. Georges Braque 4. Juan Gris 5. Paul Klee 6. Joan Miró 7. Jacques Villon Une Chanson de porcelaine (1958) FP 169 Mélodies su testi di Louise Vilmorin (in ordine di raccolta) Trois poèmes de Louise de Vilmorin, FP 91 (1937) 1. Le garçon de Liège 2. Au-delà 3. Aux officiers de la garde blanche Fiançailles pour rire, FP 101 (1939) 1. La Dame d’André 2. Dans l’herbe 3. Il vole 4. Mon cadavre est doux comme un gant 5. Violon 6. Fleurs Métamorphoses, FP 121 (1943) 1. Reine des mouettes 2. C’est ainsi que tu es 3. Paganini Mazurka, FP 145 (n. 2 della raccolta collettiva Mouvements du coeur) Ce doux petit visage (1939)) FP 99 Figure humaine (1943) FP120 1. De tous les matins du monde 2. En chantant les servantes s’élancent 3. Aussi bas que le silence 4. Toi ma patiente 5. Riant du ciel et des planètes 6. Le jour m’étonne et la nuit me fait peur 7. La menace sous le ciel rouge 8. Liberté Tel jour, telle nuit (1936-37) FP 86 1. Bonne journée 2. Une ruine coquille vide 3. Le Front comme un drapeau perdu 4. Une roulotte couverte en tuiles 5. A toutes brides 6. Une herbe pauvre 7. Je n’ai envie que de t’aimer 8. Figure de force brûlante et farouche 9. Nous avons fait la nuit Codice 602 80 81 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten di Alessandro Solbiati* Un breve, iniziale “sconfinamento” personale forse non indispensabile, ma utile a capire il mio successivo approccio analitico: Benjamin Britten terminò il suo Terzo Quartetto per archi nel novembre del 1975, un anno prima della sua scomparsa avvenuta il 4 dicembre 1976, e non poté nemmeno ascoltare la prima esecuzione assoluta, avvenuta 15 giorni dopo la sua morte. Esattamente in quegli stessi mesi, io, poco meno che ventenne, capii definitivamente che la musica era la mia vita, che la mia vera vocazione musicale non era esecutiva (studiavo molto pianoforte, all’epoca) bensì compositiva; sempre in quei mesi fu l’incontro fulminante con Franco Donatoni a rivelarmi quale dovesse essere la mia direzione. Di conseguenza il mio approccio al comporre avvenne assumendo come punto di partenza il percorso delle avanguardie del secondo dopoguerra (Maderna, Ligeti, Berio, Donatoni, Kurtág e Castiglioni soprattutto), nella convinzione che fosse l’unico possibile (pur senza alcuna adorante remissività, anzi con molto senso critico) e che qualsiasi approccio compositivo contemporaneo che non prendesse le mosse da quella via fosse accademico, neoclassico, vecchio ed anche un po’ furbo. Dunque, autori come Poulenc e Britten erano per me in quel momento di scarso * Alessandro Solbiati è diplomato in pianoforte e in composizione al Conservatorio di Milano e ha studiato con Franco Donatoni all’Accademia Chigiana di Siena. La sua musica è regolarmente eseguita nei più importanti Festival europei, radiotrasmessa ed incisa per case quali Stradivarius, Decca, Bis Records, ecc. Attivo anche nel campo della videoarte, esce in varie versioni INNO, in collaborazione con un gruppo di giovani artisti. Nel 2002 pubblica per il Teatro Comunale di Monfalcone un Quaderno di Cultura Contemporanea intitolato Ah, lei fa il compositore? E che genere di musica scrive?, quattro saggi di riflessioni sul comporre, di analisi e di illustrazione dettagliata delle proprie tecniche compositive. Nel 2009 è stata messa in scena al Teatro Verdi di Trieste la sua prima opera Il carro e i canti, dalla tragedia di Puškin Il festino in tempo di peste. Nel 2011 viene eseguita Leggenda, dalla dostoevskijana Leggenda del Grande Inquisitore, commissione del Teatro Regio di Torino. Una terza è in programma al Teatro Comunale di Bologna per il 2015, attorno al Suono giallo di Vasilij Kandinskij. È docente di Fuga e Composizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni di Milano. Codice 602 83 Alessandro Solbiati interesse. Ritrovarmi ora, più di 35 anni dopo, ad occuparmi seriamente dell’ultimo lavoro cameristico di Britten, scritto proprio in un anno per me cruciale, lungi dal costituire un contrappasso, è una significativa verifica, dopo che il passare degli anni, pur confermandomi molte delle mie idee di partenza, mi ha insegnato a cercare i punti di contatto tra esperienze differenti, più che i punti di conflitto. Dei circa cento lavori che costituiscono il catalogo del compositore inglese (95 numeri d’opera alcune volte comprendenti ciascuno più brani), i due terzi circa sono vocali, siano essi teatrali o no (ben 13 sono le opere composte). Dei restanti 37 più della metà sono orchestrali: solo 17 sono i lavori cameristici. Ciò significa che Britten era più a suo agio laddove ci fosse un testo da rivestire di musica, complice anche il lungo sodalizio artistico e personale con il tenore Peter Pears. D’altro canto, però, i suoi lavori cameristici, pur rari, occupano in generale una posizione nodale e importante, come nel caso delle tre Suites per violoncello solo o di Lachrymae, noto ed emozionante brano per viola e pianoforte. Un caso a parte è costituito proprio dalla produzione per quartetto d’archi. Tra il 1928 e il 1933, cioè tra i suoi 15 e 20 anni di età, nel periodo di studio con Frank Bridge, Britten si dedicò in particolar modo a tale formazione, evidentemente considerata un’ottima palestra compositiva, scrivendo in cinque anni due quartetti, una rapsodia, un quartettino e tre divertimenti (si tenga presente che per il Terzo Quartetto, quarant’anni dopo, a causa della sua stessa struttura il musicista aveva ancora pensato al titolo Divertimento). E che questa produzione giovanile non sia poi stata considerata un puro esercizio adolescenziale lo si evince dal fatto che nel 1974, dopo una difficile e non riuscitissima operazione al cuore e subito prima di concepire il Terzo Quartetto, Britten venne convinto da Donald Mitchell, amico, biografo, professore di musica alla Sussex University e co-fondatore della Faber Music, a rivisitare il Quartetto in Re maggiore del 1931 per renderlo degno di pubblicazione, come segno del ritorno al comporre dopo una forzata interruzione. Britten si dedicò poi all’organico quartetto d’archi in uno dei periodi cardine della sua attività: i due “veri” primi Quartetti, quelli pubblicati come primo e secondo rispettivamente con i numeri d’opera 25 e 36, sono stati composti nel 1941 e nel 1945, e quest’ultimo è l’anno di composizione della sua opera più celebre, quel Peter Grimes che lo rese uno dei più rappresentati autori di teatro musicale del XX secolo. Poi, trent’anni di “silenzio quartettistico”, fino a giungere a quella commovente “chiusura del cerchio” costituita dal Terzo Quartetto, in pratica l’ultimo lavoro compiuto, composto nella consapevolezza di una morte ormai non lontana: esso non esisterebbe senza l’insistenza del grande Quartetto Amadeus, primo interprete, che riuscì anche a fargliene ascol- Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten tare un’esecuzione in prova, solo venti giorni prima della scomparsa. Veniamo dunque a questo Terzo Quartetto, pubblicato postumo nel 1977, e che reca, a fine partitura, l’indicazione “Suffolk-Venice October/ November 1975”. Il brano è composto da cinque movimenti, intitolati rispettivamente I. Duets, II. Ostinato, III. Solo, IV. Burlesque, V. Recitative and Passacaglia (“La Serenissima”). Proprio l’anomalia dell’intitolazione di tutti i movimenti e la loro disposizione non convenzionale avevano in un primo tempo condotto l’Autore all’idea di intitolare il brano Divertimento. Secondo i metronomi aggiunti sulla partitura con l’approvazione del compositore, le durate dei cinque movimenti sono rispettivamente di 6’, 3’15’’, 4’30’’, 2’30’’ e 10’. Evidente dunque lo sbilanciamento sulla Passacaglia finale, il che ci condurrà a qualche importante considerazione. Ma si noti subito come altrettanto significativo un altro sbilanciamento, quello per il quale le durate di tutti i tempi dispari sono più ampie: e i tempi dispari sono costituiti dai movimenti lenti, sicuramente i più interessanti. E già a questo proposito per la prima volta (ma non sarà l’unica) sorge spontaneo un riferimento a Béla Bartók: in molte opere mature del compositore ungherese, infatti, il centro espressivo, la regione dell’assoluto e dell’archetipo sonoro vengono toccati nei movimenti lenti. Si pensi alla straordinaria Musica della notte della Suite pianistica En plein air, o al I movimento della Musica per archi, celesta e percussioni, o ancora ai movimenti centrali dei concerti per pianoforte e orchestra, con particolare riferimento al primo e al secondo. Vi è tuttavia una vistosa differenza, e purtroppo tutta a vantaggio del magiaro: i movimenti veloci che si alternano o circondano quelli lenti (basti pensare alla Sonata per due pianoforti e percussioni) si avvalgono, quasi per contrappasso, di un’energia ritmica formidabile, primigenia, di assoluta originalità, che affonda le sue radici nelle asimmetrie metriche delle tradizioni popolari dell’Europa Orientale, laddove invece i tempi veloci di Benjamin Britten assumono in generale movenze ritmiche assai convenzionali, neoclassiche o addirittura neobarocche, che ci “riportano alla realtà” e ci costringono a prendere atto delle sue ostentate posizioni antimoderniste: si consideri oltretutto che trenta, quarant’anni separano le vite e le produzioni di Bartók e Britten, e che nel frattempo la musica occidentale aveva aperto frontiere di cui era difficile non tenere conto. A causa di tali riflessioni mi dedicherò innanzitutto a I e III movimento, Duets e Solo, poi ai due tempi veloci, II e IV, Ostinato e Burlesque, per giungere infine alla sintesi finale costituita dalla Passacaglia (“La Serenissima”), i cui motivi di massimo interesse, peraltro molto intensi, vanno oltre la musica. Partiamo dai titoli: mentre Ostinato, Burlesque, Recitativo e Passacaglia sono termini esattamente musicali ed anche piuttosto rétro, che da soli restringono ed indirizzano il campo delle scelte, Duets e soprattutto Solo sono termini astratti che non indicano alcun percorso obbligato e che Codice 602 84 85 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati quindi costringono a un rapporto più originale con l’immagine compositiva, rivelando una Weltanschauung del compositore. Consideriamo Duets, il I movimento. La sua struttura è facilmente riconducibile a quella di un rondò, del tipo A (batt. 1-17) - B (batt. 18-27) - A' (batt. 28-39) - C (batt. 40-57) - A" (batt. 58-66) e, in modo più sfumato, D (batt. 67-75) e coda very quietly (batt. 76-94). Ma non è certo nella struttura che risiedono gli elementi di massimo interesse, bensì nelle scelte di materiali e figura effettuate soprattutto nelle parti A. Esse trasformano quelli che potrebbero essere dei semplici “duetti” all’interno dell’organico quartettistico in una riflessione forse extra-musicale sulla nozione stessa di “duplice”, di “relazione tra due”, di fusione e complementarità. Ad essa si contrapporrà la condizione di solitudine e di estraneità al contesto (ritmico e di registro) che costituisce il centro d’interesse di Solo, il III movimento, significativo e paradigmatico cuore stesso dell’intero brano. Esaminiamo dunque la parte A di Duets, le battute 1-17. I due strumenti centrali della partitura (II violino e viola) sono situati nella regione più centrale del registro, stretti in un intervallo di seconda maggiore, le cui due note essi si palleggiano in modo isocrono: si tratta del massimo delle possibili rappresentazioni di unità e al tempo stesso di complementarità “dialogata” del “duplice”. Nel corso delle 17 battute di A, tali seconde maggiori “migrano” progressivamente, quasi strisciando. Questa la loro sequenza totale: Es. 2: sequenza delle seconde maggiori Tali seconde coprono dunque nove note su dodici, escludendo solo Re#, Mi e Fa#. Guarda caso, giunto alle ultime battute di A (batt. 15-17), il gioco figurale cambia leggermente e si profila proprio il nucleo Re#-Fa#, completato per note di volta rispettivamente da Mi e Sol, venendo così a coprire sistematicamente e con poche ripetizioni un totale cromatico esposto per piccoli nuclei. Anche le iniziali seconde maggiori, tra l’altro (si vedano già nell’es. 1 le battute 1 e 3) venivano “riempite” dal semitono intermedio, divenendo di fatto dei micro-cluster. Questo utilizzo dei piccoli ambiti saturati cromaticamente non può non riportarci nuovamente a Bartók, ad esempio all’inizio del IV Quartetto per archi o al soggetto del fugato del già citato I movimento della Musica per archi, celesta e percussioni. Ma anche in questo vi è una significativa differenza: Britten, del tutto inspiegabilmente, non riesce ad esimersi dal collocare questa vera e propria esposizione di un totale cromatico clusterizzante, materico e “strisciante” entro la cornice (rassicurante?) di due bemolli in chiave, segno di un Sib maggiore o Sol minore del tutto inesistenti. Bartók, viceversa, in tali situazioni, accetta la sostanziale assenza di ogni riferimento tonale, omettendo ogni armatura di chiave. Peraltro, l’eclettico atteggiamento di Britten nei confronti dei materiali musicali fa sì che quasi subito e per due volte, alle battute 2 e 4/5 (si veda sempre l’es. 1), una differente oscillazione di altezze, composta da intervalli di quarta, lasci delineare con evidenza le triadi rispettivamente di La minore prima e di Reb maggiore/Fa minore dopo. A definitiva conferma di una vera collisione tra nostalgia diatonicotonale e sottile desiderio di materiali “nuovi”, di un totale cromatico dato matericamente, vi è una seconda esposizione delle dodici note, questa volta senza ripetizioni e in modo pressoché seriale, affidata, come una cornice di partitura e di registro, ai due strumenti esterni, I violino e violoncello, in registri appunto molto esterni: Es. 1: primo movimento, batt. 1-6 Es. 3: sequenza di 11 note esterne di primo violino e cello Codice 602 86 87 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati Come si vede si tratta di undici altezze. Ma la dodicesima, il Fa, giunge al battere della battuta 18, innescando l’episodio B. In esso (batt. 18-27), quello che precedentemente era solo l’occasionale apparire di elementi diatonici entro un globale cromatismo viene viceversa sviluppato in una vera contrapposizione sistematica: mentre le coppie, alternativamente II violino/ violoncello e II violino/viola, percorrono, raddoppiandosi, completandosi e arricchendosi timbricamente e articolativamente, alcune ristrette cellule di totale cromatico, il I violino sovrappone più volte una vera e propria cellula motivica, basata su un intervallo di sesta minore seguito da una seconda maggiore, utilizzando ogni volta un medesimo modello ritmico. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una cellula ritmico-tematica (la prima, in questo movimento fin qui del tutto a-motivico) contrapposta allo strisciare materico delle coppie. Ma nella seconda parte di A' (batt. 34-36), le due note mancanti per completare una nuova pseudo-serie (a conferma di un sottile interesse per l’esaurimento lineare del totale cromatico), il Re# e il Mi, sommate a un Do#, divengono un nucleo armonico centrale e ricorrente di II violino e viola, mentre I violino e violoncello sembrano sviluppare gli intervalli di sesta della cellula motivica di B: appare dunque evidente un atteggiamento di sviluppo e trasformazione di elementi ritmico-intervallari, trasversale alle zone formali di un rondò, che ben si inscrive nel grande asse occidentale Beethoven-Brahms-Bartók, agli estremi confini del tematismo. I successivi episodi (C e D) e ritorni di A poco aggiungono di nuovo agli elementi fin qui esaminati. Ne tralascio dunque la descrizione minuziosa, limitandomi ad osservare che si tratta di successive varianti ai giochi di coppie visti finora, talvolta sottolineandone la componente ritmico-tematico-diatonica, come nel piuttosto povero e infelice episodio C (batt. 39-57), Es. 4: primo movimento, batt. 21-23 Il ritorno ad A' vede in un primo nucleo di battute (batt. 28-33) il ritorno dei medesimi elementi di A con un inverso gioco di coppie: sono I violino e violoncello ad occuparsi delle seconde maggiori in regione centrale, limitandosi questa volta alle coppie di note (riempite poi con il semitono interno) La/Si, Reb/Mib, Solb/Lab, Mi/Fa#, mentre II violino e viola, in una regione di registro inevitabilmente più ristretta che in A, incorniciano le seconde come avevano fatto I violino e violoncello alle battute 12-17, con una sequenza, una quasi-serie, di 10 note senza ripetizioni: Es. 6: primo movimento, batt. 39-43 Es. 5: la sequenza di 10 note di secondo violino e viola o la componente davvero melodica (batt. 71-74), e talvolta invece elaborando i frammenti di cluster di A in A" (batt. 58-63). Si noti semmai la coda delle battute 76-94, in cui riemergono ciascuno per pochi secondi tutti o quasi gli elementi precedenti. Passo dunque a Solo, il III movimento, sicuramente il più inquietante, alCodice 602 88 89 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati meno per buona parte del suo svolgimento. Qui il titolo si allontana sempre più da ogni riferimento musicale; certo, si potrebbe pensare al “solo” come al momento di messa in evidenza di uno strumento, e di fatto è così, poiché il primo violino è davvero “solo” in questo movimento, ma non si tratta della solitudine orgogliosa dello strumento che primeggia, bensì di quella desolata e desolante di chi è estraneo in tutti i sensi al contesto. Non vi sono equivoci possibili: il titolo riporta ad una condizione umana, ed è davvero difficile non pensare che Britten si riferisse alla sua stessa condizione di uomo che sa di avere ancora pochi mesi di vita, ineluttabilmente, e che davanti alla morte si è soli. La collocazione di questo movimento è doppiamente simbolica: si tratta del centro del brano (e questa è una scelta evidentemente lucida e volontaria del compositore) e al tempo stesso, rispetto alle durate dei movimenti riportate all’inizio di questo scritto, l’attacco del III movimento coincide quasi esattamente, con un margine di una sola manciata di secondi su ventisei minuti, con la sezione aurea negativa dell’intero brano. Ma questa è quasi certamente una relazione inconscia. Anche nel caso di Solo non è difficile ricondurre la struttura ad un modello ben noto, anzi al più noto, cioè all’A B A; ma mentre in Duets il riferimento al Rondò è iper-pertinente e ben chiaro all’ascolto, qui la riduzione alla forma Lied rischia di essere semplificatoria e fuorviante. Perché? Innanzitutto non si tratta di semplice ABA, ma, a meglio guardare, di un AA'A"BA'" e le proporzioni sono quindi totalmente a favore dell’elemento A: il metro è un 2/4 very calm a 40 di metronomo e vi sono 14 battute di A, 13 di A', 12 di A”, dopodiché B è una quasi cadenza senza battuta e con l’indicazione lively che conduce al ritorno ad A'" di ben 21 battute. Insomma, il brano è un quadruplice A, inaspettatamente intercalato ai suoi 3/4 da un momento di leggerezza del tutto imprevedibile e comunque di breve durata. Ma che cos’è A? L’esempio musicale qui riportato, le battute 1-14, A, appunto, penso sia più chiaro di mille parole: Es. 7: terzo movimento, batt. 1-14 La partitura è vuota, desolantemente vuota, II violino e viola tacciono, sembra un altro duetto... e invece no, non lo è: in Duets le coppie di strumenti erano unite nel registro e nei comportamenti, diventavano un’unità a due facce. Qui ci troviamo invece nel caso opposto. Quattro ottave abbondanti separano all’inizio I violino e violoncello, e la progressiva salita del violoncello che conduce i due strumenti a sfiorarsi a battuta 14 non è affatto una tensione all’unità, perché i loro comportamenti sono e rimangono estranei. Poco fa ho detto, e mi sembrava inevitabile farlo, che l’esempio di partitura è più chiaro di mille parole. Invece, alla fine dei conti, penso di essermi sbagliato: l’ascolto del brano, di queste battute, smentisce nettamente quanto sembrerebbe di assoluta evidenza nella partitura. E ciò è da ascriversi all’abilità e alla lucida intelligenza di Britten. Vi sono quattro bemolli in chiave e qui non si può certo ridire quanto affermato sull’inizio del I movimento: là i due bemolli in chiave erano radicalmente smentiti dall’ostentato totale cromatico della musica. Ora invece il I violino inizia con un esplicito, seppur acuto, arpeggio di Lab maggiore e passa subito dopo il testimone al violoncello che dalla sua IV corda vuota sale, appunto, con un lento, disarmante e pulitissimo arpeggio di Lab maggiore. E come è possibile, allora, che questa musica non suoni in Lab maggiore? La risposta c’è, è piuttosto complessa e risiede in una scelta geniale e amara al tempo stesso del compositore. Sarebbe stato troppo semplice mettere in scena la solitudine del I violino relegandolo a un melodizzare in regione acuta e contrapponendogli nel grave note senza una relazione percettivamente chiara, diciamo utilizzando anche qui sequenze molto cromatiche. La modalità utilizzata, e quindi la metafora ad essa connessa, è molto più forte e in un certo senso senza speranza: i due strumenti, in fondo, “parlano la stessa lingua”, sono nella stessa armonia, eppure ben tre parametri fanno sì che essi non siano in grado di ascoltarsi e di sostenersi l’un l’altro: ciascuno è chiuso nel Codice 602 90 91 Alessandro Solbiati proprio percorso, o meglio è il violino che “non sente” il violoncello. Quali sono i tre parametri? a) l’iniziale, estremo distacco di registro impedisce di percepire la relazione armonica tra i due. Già Beethoven, nelle sue ultime sonate, aveva scoperto quale “senso di abisso” fosse possibile comunicare all’ascoltatore qualora le due mani del pianista venissero allontanate tra loro e relegate rispettivamente nei registri acuto e grave, oltre i limiti della “buona educazione armonica”. In Britten, l’allontanamento iniziale è ancora più estremo. b) le due sequenze ritmiche, del violino e del violoncello, scorrono differenti tra loro e indifferenti l’una all’altra. Il violoncello fa un semplice arpeggio di Lab maggiore, è vero, ma le durate procedono lente, irregolari e imprevedibili secondo questa sequenza di semiminime: 2 2 1 2 3 1 1 1 4 2 4. Il contrasto tra la regolarità delle altezze e l’irregolarità incerta ed esitante delle durate è evidente. Il violino fa una frase a valori più brevi, senza respiri e senza pause, procede nella sua regione acuta e separata dal resto del mondo senza percepibili fraseggi e il rapporto con il violoncello è di sapiente indifferenza o estraneità metrica. c) il parametro più delicato, quello armonico. Su 12 note del violoncello, quattro di esse attaccano durante una nota tenuta del violino, cioè senza attacco sincronico, mentre negli otto casi di sincrono viene sempre negata la pertinenza armonica con l’accordo di Lab: in sincrono con il Lab il violino suona un Fa e un ren (tritono), in sincrono con il Do un fab, un sin e un sol (cioè mai una nota dell’accordo di lab e, due volte su tre, note che non appartengono nemmeno alla scala di lab) e in sincrono con il mib si permette due volte al violino la nota lab (fondamentale dell’accordo) ma creando il duro rapporto di quarta. La sequenza del violino utilizza dieci note su dodici, è vero (sono esclusi solo la e sib), e tuttavia se se ne fa un statistica si constata una netta prevalenza delle note della triade di lab maggiore: delle 34 altezze suonate, ben 16, circa la metà, sono lab, do e mib, cioè le note della triade di lab maggiore, le stesse del cello, ma il sottile gioco di sincroni “stonati” e di attacchi asincroni impediscono la percezione della relazione. Come procede poi il brano? Che cos’è A'? Si fa semplicemente perno sul do di arrivo del violoncello, esso viene ripreso dalla viola due ottave sotto, all’altezza della sua IV corda vuota, le alterazioni in chiave diventano quelle di fa maggiore e il gioco ricomincia in fa maggiore. L’arpeggio lento, ascendente e irregolare di fa maggiore è appannaggio della viola, il I violino mostra di interessarsi del cambiamento all’inizio anticipando come a battuta 1 le note del nuovo arpeggio, ma poi se ne distacca con la medesima indifferenza mostrata in A, e sulla quale qui non entro in dettagli. Alla fine di A' (batt. 27) la situazione si ripete, sia pur in modo asim- Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten metrico: il la dell’arpeggio di fa maggiore di viola viene ripreso due ottava più in basso dal II violino che da lì fa partire un arpeggio di la maggiore confermato dalle nuove alterazioni in chiave, tre diesis, irregolare, lento e ascendente come i precedenti e al quale il I violino reagisce allo stesso modo, con un iniziale ammiccamento alle note dell’accordo di la maggiore e un successivo distacco. Si tratta di A" (batt. 28-39). L’asimmetria armonica cui si accennava è la seguente: il do di aggancio tra A e A' era la terza dell’accordo di lab e la quinta dell’accordo di fa, cioè l’armonia si trasferisce una terza minore sotto (Lab-Fa), mentre tra A' e A", il la della viola è sì la terza dell’arpeggio di fa maggiore ma diviene la fondamentale (e non la quinta) della nuova tonalità. Il percorso totale, a parità di “agganci”, diviene dunque l’asimmetrico lab-Fa-La. Globalmente i tre arpeggi ascendenti, se non altro perché realizzati da tre strumenti via via più acuti (violoncello, poi viola, poi II violino) conducono fatalmente ad un aggancio all’unisono tra II violino e I violino e ciò fa scattare una scintilla di imprevista luminosità e vitalità, in un contesto che appariva desolato. Vorrei arrischiare un’associazione mentale. Si consideri quel capolavoro che è, all’interno del Quartetto op. 132 di Beethoven, il movimento lento, la Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito, in modo lidico. La sua ieratica e religiosa lentezza sfocia e si alterna più volte, inaspettatamente, in un Sentendo nuova forza in cui è il trillo acuto di I violino a far scattare un’energia ritmica, una giocosità serena e candida che non ci aspettavamo, in quel contesto. Ecco, il B di Solo si comporta allo stesso modo, e dato il riferimento alla malattia e all’agognata guarigione, potrebbe persino essere che il riferimento beethoveniano fosse vero, più o meno consapevolmente. Anche la nuova agogica lively, in fondo, potrebbe essere un buon indizio di relazione con quel Beethoven. Codice 602 92 93 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati Es. 8: terzo movimento, batt. 40-64 Codice 602 94 95 Alessandro Solbiati L’unisono sul La acuto di II e I violino fa scattare il trillo del I violino, il clima cambia di colpo e diviene lively, i tre strumenti inferiori percorrono liberamente e candidamente, in tre successive zone, le note degli arpeggi via via di La maggiore, Fa maggiore e Lab maggiore, retrogradando le tonalità concatenate nel tre A, mentre il I violino gioca nella regione acuta, quasi improvvisando, un po’ colibrì e un po’ tzigano. La serenità di questo gioco liberatorio ricade e influenza molto quel ritorno ad A che abbiamo definito A"', ma che in sostanza si comporta da vero A+B. Si ritorna sì, infatti, al 2/4 lento iniziale, si fa nuovamente perno sul ritorno alla IV corda vuota del violoncello della battuta 2, ma questa volta il Do non è la terza dell’accordo di Lab: in chiave non c’è nulla e si apre così la quarta armatura di chiave, quella di un luminoso Do maggiore. L’asimmetria delle tre tonalità precedenti si trasforma in un’evidente simmetria: Lab-Fa, terza minore discendente, e La-Do, terza minore ascendente partendo da un semitono sopra il Lab. Sono simmetrie di rapporti tonali (anche se qui non si tratta tanto di tonalità, quanto di semplici usi di triadi concatenate quasi simbolicamente) che ci riportano a taluni percorsi della grande musica romantica, quella di Schubert, Schumann e Brahms in particolare, ma anche e ancor più a certi aspetti della cosiddetta armonia assiale cara a Bartók: Lab e Fa, infatti, sono legati dal fatto che il relativo minore di Lab è l’omologo minore di Fa maggiore e la stessa relazione vi è tra La e Do. Perché dicevo poco fa che A'" è un vero A+B e porta con sé l’energia liberatoria del gioco di B? Perché in realtà i tre strumenti “al di sotto” del I violino si comportano in modo nuovo e differente, rispetto ai precedenti A. Innanzitutto partecipano tutti e tre insieme al gioco e non uno per volta, facendo sì che A'" sia di fatto anche un A+A'+A", poi il loro arpeggio non è il sinistro arpeggio instabile e estraneo di prima, fatto però di una semplice triade, ma è un fascinoso spettro di armonici su IV corda di violoncello e viola (spettri di Do) e di II violino (spettro di Sol); quindi non si tratta affatto di triadi pulite, ma di spettri di armonici che salgono fino al decimo armonico di violoncello e viola (Do-Do-Sol-Do-Mi-Sol-Sib-Do-Re--Mi, tenendo i due Mi a distanza di ottava) e all’ottavo armonico del Sol di II violino (Sol-Sol-ReSol-Si-Re-Fa- Sol), con il timbro misterioso e velato degli armonici. A quel punto, con un gesto di conciliazione che ci dichiara superata l’angoscia dell’estraneità e della solitudine, il I violino incrocia gli altri e scende con note più limpidamente appartenenti alla triade di Do maggiore fino al suo Do più basso, fondendosi con gli altrui armonici in una triade di Do maggiore che viene a coincidere con lo spettro armonico del Do del violino stesso. Si tratta di un insperato gesto finale di unità, e quindi non più di solitudine. Uno happy end che l’inizio certo non lasciava prevedere. Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten È sinceramente più difficile per me trovare motivi di vero interesse analitico nel II e nel IV movimento, i due tempi veloci intitolati rispettivamente Ostinato e Burlesque. La velocità stessa della pulsazione riporta Britten nella regione di una ritmicità decisamente neoclassica e tematica, nel gioco di un contrappuntismo un po’ risaputo, tutti elementi un po’ difficili da accettare in un brano del 1975, almeno per me. Cercherò tuttavia di individuare alcuni centri d’interesse che vadano al di là di questi aspetti ed è facile osservare che la grande abilità compositiva di Britten ce ne offre varie occasioni. Partiamo da Ostinato. La sua struttura macroformale è nella prima parte ostentatamente esplicita: vi è una zona A (batt. 1-37) seguita da un indiscutibile B (batt. 38-71) di carattere contrastante, ma sotterraneamente e incessantemente percorso dall’elemento che determina il titolo del movimento (e questa presenza mascherata e continuamente variata è da ascriversi tra i motivi di maggior interesse). Da 72 vi è poi un accattivante sbilanciamento: una lunga, ben percepibile conduzione ci farebbe supporre una successiva, altrettanto ampia ripresa, ed invece il forte segnale di ripresa che giunge a 91 non fa che avviare una coda breve e instabile (batt. 93-106), continuamente interrotta da silenzi e basata sul breve emergere di elementi precedenti: una forma, dunque, che si avvia con accademica chiarezza ma che poi sfuma intelligentemente i suoi contorni. Peraltro se è vero che A e B sono fortemente contrapposti e ben riconoscibili, è altrettanto vero che a livello medio-formale ciascuna delle due zone è molto articolata al suo interno, frammentata e piena di inquiete invenzioni. Ma qual è dunque l’onnipresente elemento che determina il titolo del movimento? Si tratta del seguito di quattro semiminime con ampi intervalli unidirezionali che si ritrova già a battuta 1: Codice 602 96 97 Alessandro Solbiati Es. 9: secondo movimento, batt.1-9 Su tale elemento è possibile fare un’osservazione non priva d’interesse. Nella cellula-segnale (batt. 1, 3 variata, 15, 33, ecc.) i moti unidirezionali ascendenti e discendenti della cellula sono sovrapposti e sincronici, nelle parti esterne. A ben guardare essi si basano su una sorta di trompe l’oreille: poiché sono costituiti da intervalli di settima, le note dell’elemento ascendente sono una scala discendente (Mi-Re-Do-Si) e quelle dell’elemento discendente sono una scala ascendente Mi-Fa-Sol e il La è alla viola poiché “esce” dall’estensione del violoncello). Tale “inganno acustico” è poco percepibile in caso di sincronizzazione, ma diviene un elemento “alla Escher”, quando i due moti si presentano separatamente, come accompagnamento ostinato di altri elementi, ad esempio ascendente ma composto dalle note discendenti Do-Sib-La-Sol alle battute 5-8, discendente ma composto da una scala ascendente (Sol-La-Si-Do) alle battute 11-14. Ma come è fatto A? E interessante notare come si tratti di un ostinato che... soltanto cerca di essere tale, poiché è continuamente intercalato da pause. I due slanci iniziali delle battute 1 e 3 sono separati da una pausa di minima; il primo tentativo di ostinato delle battute 5-8 viene interrotto da un nuovo slancio e da un nuovo silenzio di minima; un secondo ostinato delle battute 11-14 subisce la stessa sorte (slanci e pause a batt. 1517), mentre il terzo acquista sì maggior continuità e dura da 18 a 32, ma un ulteriore slancio con pausa fa precipitare al più calmo B delle battute 38-71. In esso l’elemento ritmico-intervallare dell’ostinato diviene una più sottile filigrana di pizzicati, variata molto e con molta intelligenza durante il vero e proprio tema che contraddistingue B. Ed è proprio questo tema che ci permette almeno una osservazione di carattere armonico. Ostinato ha da capo a fondo un Fa# in chiave, ma nulla ci parla di Sol maggiore salvo l’ammiccante arrivo finale ad una triade appunto di Sol maggiore... per la durata di un decimo di secondo e in pianissimo. Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Eppure questo Fa# è sottilmente significativo, fino a costituire in un certo senso la chiave di volta stessa dell’intero movimento. È fin troppo evidente che la nota d’appoggio del gesto dell’ostinato è il Do della quarta corda vuota del violoncello (che diviene spesso un vero pedale) ed anche della viola. Su tali corde vuote vengono costruiti frammenti scalari di varia natura, politonali o polimodali. Ma la parte B è basata su un tema in un “modo di Si maggiore” (modo e non tono perché il La è sempre naturale) e tale tema è spesso appoggiato su un pedale di Fa#, pur permanendo in basso l’ostinato appoggiato al Do del violoncello. Ecco: il Fa# è chiave di volta del brano in quanto tritono del Do (e quindi sua controparte dissonante che “graffia” la nozione stessa di pedale di Do) ma al tempo stesso trait d’union con il soprastante elemento in Si maggiore, appoggiato ad un pedale di dominante. Si vedano, nei due esempi di seguito riportati, le battute iniziali (38-42) e finali (64-72) della parte B, entrambe tematicamente in Si maggiore, ma appoggiate al Do le prime e allo scivolamento finale del Fa# al Do le seconde. Es. 10: secondo movimento, batt. 38-42 Codice 602 98 99 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati Es. 12: quarto movimento, batt. 1-5 Es. 11: secondo movimento, batt. 64-72 Passiamo ora al IV tempo, la Burlesque. Si tratta senza dubbio alcuno del movimento più scopertamente ritmico-tematico-contrappuntistico: qui si prendono le mosse da taluni scherzi provocatori di Mahler, filtrati dai sarcasmi di certo Šostakovič, compositore peraltro più vecchio di Britten solo di sette anni. È lo stesso Britten a giocare sui palesi riferimenti formali, con virgolette e parentesi che denotano un po’ di britannica ironia, iniziando sì con l’agogica “neutra” di Fast-Con fuoco, ma mettendo al centro un Quasi “Trio” e tornando al tema (e si notino parentesi + virgolette...) con un (“Maggiore”) a battuta 106. Questo Maggiore sta ad indicare che il La in prevalenza minore, anche se molto “sporco”, dell’inizio del tempo, qui si tinge leggermente di maggiore, con una buona presenza di Do#. Permanendo all’interno di logiche tonali, viene inoltre considerato “graffiante” anche la collocazione del Quasi “Trio” nel tono di Mib, a distanza di tritono dai circostanti La. Per dare un’idea di quanto il tematismo assai velato o addirittura poco esistente nel I e III movimento e in fondo ancora un poco velato nell’Ostinato qui esca del tutto allo scoperto, diamo un paio di esempi di partitura, l’attacco (batt.1-5) e il fugato delle battute 30-44. Es. 13: quarto movimento, batt. 30-44 Codice 602 100 101 Alessandro Solbiati Eppure, proprio la Burlesque contiene al suo interno il momento di più forte originalità timbrica dell’intero quartetto, un momento che riesce ad interpretare al meglio tutte quelle virgolette e parentesi poste dall’autore stesso, cambiando il punto di vista e l’interpretazione analitica e percettiva di questo tematismo ritmico, che diviene in questo modo una specie di citazione. Tale momento consiste proprio nel Quasi “Trio” in Mib. In esso vi è un contrasto stridente tra lo smaccato 3/4, che aveva già un sapore di citazione in Mahler settant’anni prima, e il fatto che proprio qui ciascuno dei quattro strumenti si trasforma, prendendo un diverso binario timbrico e generando per poco meno di un minuto una sorta di nuovo ensemble, percussivo e anomalo. Si vedano le prime undici battute del Quasi “Trio”. Es. 14: quarto movimento, batt. 68-78 L’accordo di Mib maggiore in stato fondamentale, in sé assai esplicito, è realizzato a) dal battere in pizzicato del violoncello che gioca sempre, però, a sporcare la fondamentale con acciaccature sul La a distanza di tritono. Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten b) dal completamento dell’armonizzazione (Sib-Sol) affidata ritmicamente al II violino che però utilizza il timbro secco e rumoroso del legno battuto. Subentra e si sovrappone poi, dopo due battute, la viola che, con l’indicazione piuttosto esilarante di wrong side of bridge (“il lato sbagliato del ponticello”, cioè suonando oltre il ponticello, come di solito si dice), sovrappone delle terzine con il suono stridulo e imprevedibile per intonazione che proviene appunto dal suonare in quella posizione dello strumento. A quel punto il I violino entra con una cellula tematica del tutto simile a quella iniziale della Burlesque, ma con il timbro attenuato dalla sordina e al tempo stesso con l’indicazione dinamica contrastante di f spiccato, il che dimostra che la sordina deve avere un puro effetto timbrico e non dinamico. Questa pagina così stralunata e grottesca riesce a gettare una luce nuova e diversa sull’intero movimento, elevando al quadrato un’ironia che non sarebbe riuscita ad essere tale qualora avesse soltanto riproposto (in ritardo) le modalità di sarcasmo che contrappuntano l’intero XX secolo europeo, da Mahler, a Prokofiev, a Šostakovič. Pur non potendo dimenticare che nel frattempo la musica europea aveva individuato ben altre ricchezze timbriche, questo Quasi “Trio” è in grado di aprire uno spiraglio molto efficace all’interno del vocabolario di Britten. Per accostarsi al V e ultimo movimento, Recitative and Passacaglia (“La Serenissima”), ed anche per emozionarsene, perché questo effettivamente merita, bisogna per un momento dimenticare le questioni di linguaggio musicale e di ogni sua storicizzazione ed andare al di là. La Passacaglia è in Mi maggiore, certo, e lo è davvero, questa volta, anche se con infiniti arricchimenti e deragliamenti interni. Ma a parte il fatto che essa è incorniciata all’inizio da un Recitative dai toni armonici più aspri e meno definibili e soprattutto, alla fine, da un inquietante accordo estraneo al mi maggiore, l’ultimo del quartetto, e, ancora, a parte il modo simbolico in cui il mi maggiore “invade” progressivamente la partitura (i quattro diesis appaiono a I violino e violoncello a battuta 26, al II violino a battuta 38 e alla viola solo a battuta 50), a parte tutto ciò, va detto che questo mi maggiore sta a Britten come il Do maggiore dell’Arietta dell’op. 111 sta a Beethoven: entrambi sono degli ambienti sonori archetipici, al di là della storia, che due compositori che a quel punto della loro vita non devono dimostrare proprio nulla utilizzano per esporre il proprio universo espressivo. In primo luogo va detto che, mentre nella Burlesque il riferimento vecchiotto contenuto nel titolo veniva di fatto per lo più confermato dalla musica, nel caso del V movimento il doppio titolo un po’ “polveroso” appare una sorta di vezzo: non vi è infatti una netta separazione tra i due Codice 602 102 103 Alessandro Solbiati momenti, poiché il primo contiene già l’elemento base del secondo e confluisce naturalmente in esso, e soprattutto né l’uno né l’altro dei titoli viene di fatto rispettato, poiché entrambi sono interpretati dalla musica in modo suggestivo e simbolico, felicemente molto al di là dei vincolanti riferimenti che essi contengono. In secondo luogo, in questo caso l’analisi non può partire dalla partitura: per comprenderne i significati, infatti, bisogna addentrarsi in alcuni aspetti della personalità di Britten e di quel preciso momento della sua vita. I primi quattro movimenti del Terzo Quartetto sono stati scritti nel Suffolk, nella casa in cui Britten e Peter Pears si erano trasferiti nel 1971. Ma la composizione del quinto movimento avviene durante un’ultima visita a Venezia, nel 1975, quando le condizioni fisiche del compositore apparivano del tutto compromesse: l’endocardite diagnosticata nel 1971 (si noti, la stessa malattia che condusse alla morte Mahler) non era stata sconfitta nemmeno dall’operazione chirurgica del 1974, la debolezza era sempre più evidente, eppure, l’anno successivo all’operazione, Britten vuole risiedere per un certo periodo a Venezia. Venezia non era una città qualsiasi, per lui. Aveva a lungo nutrito l’idea di realizzare un’opera attorno al racconto lungo di Thomas Mann Morte a Venezia, ma il progetto era stato forzatamente rinviato per la fortuita concomitanza della realizzazione cinematografica di Luchino Visconti che aveva dato luogo ad alcuni problemi tecnico-legali. Poi, l’opera viene scritta e messa in scena nel 1973, a malattia già abbondantemente in corso, ed appare già essere l’ultima opera teatrale possibile: a quel punto il processo di identificazione di Britten con Gustav von Aschenbach è inevitabile e sempre più forte. Ma non tanto, si badi, per la scoperta dell’omosessualità da parte del personaggio di Mann e nemmeno per la sua malattia cardiaca che lo conduce alla morte (sebbene, in questo caso, la nota prefigurazione di Mahler in Aschenbach getti un ulteriore, possibile ponte tra Britten e Aschenbach): no, la chiave di lettura più forte e probabile è contenuta in una frase scritta a Britten da Wystan Hugh Auden, il poeta del quale il compositore inglese subì sempre una profonda, costante influenza, quasi una sudditanza, sebbene tra loro non vi fosse stato nulla di affettivo probabilmente a causa della presenza stabile di Pears a fianco di Britten. Auden scrisse a Britten “di non permettere all’ordinata superficie borghese di reprimere l’aspetto caotico e dionisiaco della sua personalità”. Questa esortazione rimasta inattuata, è probabilmente da riferire sia al comporre che all’affettività: Aschenbach ha saputo fare, nel racconto di Mann, quello che forse Britten avrebbe desiderato, cioè accogliere il disordinato, il dionisiaco, stupirsene, magari, avversarlo, ma poi farsene travolgere e cedere a ciò che víola l’ordine costituito, pur con la conseguenza di soccombergli. Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Giunto al termine cosciente della sua esistenza, Britten, che aveva sempre invece mantenuto un buon ordine borghese, trasferisce questa aspirazione non realizzata nelle scelte dell’opera Death in Venice e, tornando a noi, viceversa la sublima nelle scelte formali e musicali di Recitative and Passacaglia (“La Serenissima”), composto, a questo punto significativamente, proprio a Venezia. Alla base di tutto il movimento, del Recitativo quanto della Passacaglia, vi è un movimento oscillatorio ed isocrono del basso, che alterna due semiminime a distanza di tono, Mi e Fa#. Esse nel corso del recitativo si deformano fino ai limiti della riconoscibilità, per riapparire, pressoché onnipresenti, in tutta la Passacaglia. Codice 602 104 105 Alessandro Solbiati Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Es. 16: quinto movimento, batt. 26-38 (inizio Passacaglia) Es. 15: quinto movimento, batt. 1-7 C’è chi identifica in queste due note le campane di Santa Maria della Salute, a fianco dell’hotel del compositore, c’è chi più realisticamente lo indica come il tema stesso (anomalo, direi) della Passacaglia. Entrambe le ipotesi sono insufficienti. Sebbene così onnipresente questa oscillazione regolare non ha mai il tono dell’ossessione, bensì quello del passo, del cammino che non può arrestarsi, della nostalgia, del saluto. Qual è il senso (e la struttura, peraltro) del Recitativo? L’elemento oscillatorio grave è presente per sette volte, sebbene sempre meno riconoscibile (batt. 1-2/4-5-6/8/10/13-14-15/17-18/20-21-22), avvolto, si vedano soprattutto i primi casi alle battute 1-2 e 3-4-5, da armonie strettissime, aspre, sul ponticello, che costruiscono assieme ai Mi-Fa# dei piccoli cluster. Si inizia ponendo a due strumenti su quattro un diesis in chiave, un curioso riferimento al Mi minore, poi si sottrae tale Fa#, annegando via via nel “nulla in chiave”, per tingere poi a poco a poco la partitura dei quattro diesis di Mi maggiore all’arrivo della Passacaglia. Ma cosa vi è, all’inizio del V movimento, tra una dizione e l’altra del moto grave e isocrono armonizzato in modo così inquietante? Vi sono sei recitativi [senza misura], secondo l’indicazione dell’autore, in cui via via gli strumenti citano elementi tematici dell’opera Death in Venice. Ecco il centro d’interesse, il cuore espressivo: rievocare e al tempo stesso liberarsi di quell’opera, bruciarne gli elementi, farli emergere un’ultima volta e poi ridurli in cenere (Aschenbach significa ruscello di cenere) e poi intraprendere un cammino senza più esitazioni se non quelle della nostalgia, sovrapporre (ed è la Passacaglia) a quel basso oscillante una sequenza melodica di gradi congiunti indiscutibilmente in Mi maggiore prima al I violino (batt. 26-38), poi al II violino (batt. 38-50) e infine alla viola, che “prende il largo” e non si ferma più, fino alla quarta e un po’ differente dizione del cello (trasposta significativamente al V grado) da battuta 71. È da notare che le tre dizioni iniziali cambiano di strumento, ma non di registro, restando sempre in regione centralissima, come si trattasse non di un’imitazione ma della riaffermazione di un “credo” melodico. Codice 602 106 107 Il Terzo Quartetto per archi di Benjamin Britten Alessandro Solbiati Ma proprio quella fissità nel registro permette agli strumenti che hanno già esposto la sequenza di costruirle attorno, via via, una fitta rete di linee melodiche assai cromatiche, fino al climax piuttosto intricato, armonicamente e polifonicamente, delle battute 60-67. Il diminuendo e il successivo intervento tematico del violoncello aprono una zona B senza più il tema (ma con il moto oscillatorio del basso) in cui le semicrome dei tre strumenti superiori disegnano inaspettate progressioni diatoniche ineffabilmente neoclassiche, quasi un colpo di coda dell’ordine apollineo: conduce a un momento che non posso che definire emozionante. In sé, si tratta soltanto della ripresa, del ritorno della melodia in Mi maggiore al I violino sovrapposta ai Mi-Fa# del violoncello. Eppure, in questa pagina, vi è qualcosa che va al di là del semplice ritorno di un tema, una nostalgia, la consapevolezza di un saluto e al tempo stesso la riaffermazione di un mondo: nelle battute 110-125, infatti, la sequenza melodica principale si congela a poco a poco in un accordo di Mi maggiore che sembra definitivo. Questo, in fondo, è l’irrinunciabile habitat sonoro del compositore. Ma, ci dice Britten stesso, il quartetto, nonché l’intera sua opera, termina con una domanda, non con una risposta: improvvisamente, inaspettatamente, quel Mi maggiore che sembrava rispondere negativamente all’appello di Auden, lascia spazio ad un accordo differente, che cresce fino ad una dinamica insolita: rf, rinforzando, per poi diminuire. Quest’accordo è costituito dalle note (dal basso) Re-Do#-Mi-Sol#. La certezza del Mi maggiore (e di un intero mondo) è perduta. E quell’indicazione di diminuendo al nulla senza tempo, che però in inglese suona “dying away”, con britannica ironia per chi sta morendo davvero, è, nel vocabolario di Britten, un saluto al suo mondo e un benvenuto ad ogni nuovo mondo, magari con meno certezze. Es. 17: quinto movimento batt. 81-85 (progressioni Passacaglia) Una nuova melodia di I violino (batt. 89) cui risponde alla quinta inferiore (risposta in sottodominante?) la viola (batt. 96), sovrapposta all’immancabile moto oscillatorio e alle semicrome ridotte anch’esse a seconde maggiori oscillanti di II violino e viola, Es. 19: quinto movimento, batt.122-128 Es. 18: quinto movimento batt. 89-91 Gli esempi musicali presenti nel saggio sono stati gentilmente concessi per la riproduzione dall’Editore Faber Music Ltd, London. Faber Music Ltd © Copyright 2006 Codice 602 108 109 Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra di Marco Moiraghi* Dunkler Tropfe: “Scura goccia” o, se si vuole, “Cupo gocciare”; o anche: “Confuso sgocciolio”. È l’incipit di un testo poetico di Christian Morgenstern (1871-1914) utilizzato da Paul Hindemith (1895-1963) nel ciclo liederistico Mélancholie op. 13 (1917-19) per voce femminile e quartetto d’archi. Perché ricordare questa musica, non molto nota e senza dubbio marginale nel catalogo di un compositore tanto fertile e produttivo come Hindemith? Perché partire da una piccola e oscura pagina vocale per ricordare l’autore di celebrate pagine sinfoniche, di grandi affreschi operistici, di articolati e vasti cicli cameristici? La risposta implica una lunga riflessione, anche perché Dunkler Tropfe, pur nella sua evidente marginalità, può fungere da ottimo punto di partenza per una riconsiderazione critica non solo del repertorio hindemithiano poco frequentato, ma più ampiamente di tutto Hindemith, di tutta la sua produzione. Produzione che oggi, a mezzo secolo esatto dalla scomparsa del compositore, ritorna nelle stagioni concertistiche con maggiore frequenza e chiede insistentemente di essere valutata e interpretata con più circostanziata attenzione. A bene vedere in Hindemith, in questa verace figura di artista-artigiano, da sempre considerato emblema di grande vitalità creativa e di un efficientismo produttivo di matrice prettamente tedesca, si scorgono sorprendenti crepe ed imprevisti elementi di fragilità. Si scorge, forse, la cor* Marco Moiraghi si è diplomato al Conservatorio di Milano in Pianoforte e in Composizione. Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Milano la laurea specialistica in Musicologia e presso l’Università degli studi di Pavia il Dottorato di ricerca in Musicologia. Ha pubblicato una monografia su Paul Hindemith (L’Epos, Palermo 2009) e una monografia su Gino Negri (Squilibri, Roma 2011); è di prossima pubblicazione, in collaborazione col clavicembalista Enrico Baiano, Le Sonate di Domenico Scarlatti. Contesti, testi, interpretazioni (LIM, Lucca). Ha pubblicato articoli su riviste specializzate e in alcuni volumi miscellanei, trattando principalmente di musica strumentale e vocale dal Settecento al Novecento. Svolge attività didattica presso le Scuole di Musica di Biassono (MI) e di Osnago (LC). Insegna “Guida all’ascolto della musica” ai Corsi Popolari Serali di Musica del Conservatorio di Milano. Codice 602 111 Marco Moiraghi rosiva insistenza di quel cupo gocciare che la poesia di Morgenstern evoca con tocco lieve e discreto. Un gocciare cupo ma anche sommesso, quasi nascosto: come se il compositore avesse voluto dissimulare una ferita, un dolore persistente e difficile da affrontare. Si osservi, in Dunkler Tropfe, un dettaglio importante: la reazione della musica di fronte al vocabolo “morte” (Tod). Con un espediente tecnico tanto semplice quanto efficace, d’un colpo (battuta 11 della partitura, poi ripresa più avanti) viene fatto decadere ogni precedente costrutto armonico; la musica si condensa su una vuota ottava Sol2-Sol3 (primo violino e voce), in corrispondenza dell’intonazione di Tod. Sembra che il compositore voglia alludere chiaramente, ma anche con discrezione, all’idea della morte: un puro intervallo d’ottava che smorza e arresta l’andamento sintattico, quasi svuotandolo di senso. Questo suono puro su Tod è carico di una sua specifica valenza: quella che ci si fa incontro è un’idea di morte come entità ostinata ma calma, ineluttabile, segnata dalla percezione di un fermo rigore che ostruisce senza scampo il flusso della vita, conferendogli immediata rigidezza. Ma si badi ora più nel dettaglio alle circostanze storiche e biografiche che favorirono la genesi del ciclo liederistico Mélancholie. Dei quattro numeri che compongono l’op. 13, il primo ad essere composto (poi collocato in ultima posizione nella struttura dell’opera) vide la luce il 25 dicembre 1917. Momento cruciale nella sua rilevanza simbolica: si festeggia un Natale infausto, di lutti e di miseria, con tutta la popolazione tedesca in supporto ad uno sforzo bellico a dir poco logorante. Dei restanti brani di Mélancholie, uno fu composto nel giugno 1918 (diventerà il numero 2 della raccolta) e due nel luglio 1919 (numeri 1 e 3: quest’ultimo è appunto Dunkler Tropfe). Nel giugno 1918 il soldato semplice Paul Hindemith era al fronte, nella Francia del nord. In quel mese cadde in combattimento l’amico Karl Köhler: a lui, appunto fu dedicata l’op. 13, come si legge nel manoscritto della partitura: Meinem Freunde Karl Köhler. Gefallen 1918 an der Westfront1. La guerra e la morte: enormi e tenaci ombre per i tedeschi vissuti all’inizio del “secolo breve”, “l’epoca più violenta della storia dell’umanità”2. Proprio Dunkler Tropfe ci fornisce un esempio emblematico di quanto l’idea della guerra, connessa a quella della morte, abbia segnato l’immaginario di tanti artisti di quel tempo. In questa pagina vocale si ha un’embrionale sintesi di motivi tipicamente hindemithiani e tipicamente tedeschi, paradigmi di un’intera epoca: il motivo della morte, del lutto; il motivo della processione, della marcia militare o funebre; il motivo 1 Si possono trovare dettagli approfonditi sul servizio militare del compositore in Paul Hindemith, Notizen zu meinen Feldzugs-Erinnerungen, «Hindemith-Jahrbuch», vol. 1989/ XVIII, pp. 55-159. 2 Così recita il sottotitolo dell’edizione italiana del ben noto compendio sulla storia del Novecento di Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1997. Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra dello spaesamento, della confusione provocata dall’oscura presenza di una minaccia incombente; il motivo della contrapposizione fra individuo e società. Come si può notare dall’incipit della composizione (Es. 1), la scrittura musicale – con la sua fraseologia regolare e ripetitiva, con il suo profilo ritmico rigidamente tetico, con la sua armonia ostinata e bloccata – dissimula un’implicita andatura da marcia funebre: Es. 1 Mélancholie op. 13 (1917-19) per voce femminile e quartetto d’archi: inizio del terzo brano, Dunkler Tropfe Nella produzione giovanile di Hindemith, che cronologicamente coincide con gli anni della Grande Guerra, l’accenno implicito o esplicito a ritmi e movenze di marcia (marcia funebre o marcia militare, o entrambe fuse insieme) è un fatto via via più ricorrente; contestualmente, si ha anche l’impressione di un progressivo e radicale allontanamento dal mondo delle danze tipiche della belle époque, per avvicinarsi ad una sensibilità più attuale, più urgente, più crudamente e tragicamente moderna. Detto con una formula sintetica: crescendo e maturando, Paul Hindemith sembra passare rapidamente dal Valzer alla Marcia. È un passaggio traumatico, gravido di conseguenze. Non a caso in questi luttuosi anni di guerra (in particolare dal 1915, anno della morte del padre del compositore durante i combattimenti in Francia, al 1918, anno del richiamo alle armi di Paul) nel catalogo hindemithiano troviamo ben cinque volte il termine “marcia”, sempre in ambito cameristico: due volte in pagine per pianoforte a 4 mani, altre due volte in due diversi sestetti e una volta, molto significativamente, nel Quartetto per archi n. 2, composto proprio nelle settimane di permanenza al fronte3. Il riferimento alla marcia, come si è già fatto notare, può essere spesso 3 Le composizioni a cui qui si accenna verranno dettagliatamente elencate più sotto, verso la fine del presente contributo, all’interno di in un vasto gruppo di musiche hindemithiane che recano l’esplicita indicazione “Marcia”. Codice 602 112 113 Marco Moiraghi nascosto o sottinteso, implicito, non dichiarato; ed importanti appaiono tutti quegli indizi di una speciale predilezione per lo stile della marcia (per la sua texture, per la sua sintassi, per le sue movenze), ben al di là dell’esplicita indicazione “Marcia” usata nel titolo di una composizione. Se ad esempio dal Quartetto per archi n. 2 testé citato torniamo al pochissimo noto Quartetto n. 1 (1914-1915) – composizione senza dubbio acerba ma non per questo meno interessante – ci imbattiamo in un’ampia pagina riflessiva centrale (il secondo movimento) interamente modellata sulle movenze di una marcia: Es. 2 Quartetto per archi n. 1 in Do maggiore, op. 2 (1914-15), inizio del secondo movimento Per quanto Hindemith appaia qui saldamente ancorato alla tradizione musicale del tardo Ottocento e benché lo spirito di Dvořák e dei suoi Quartetti per archi (ben noti a Hindemith e da lui molto apprezzati4) aleggi distintamente su questa bella pagina giovanile, va osservato che sono già presenti alcuni tratti caratteristici del compositore che verrà: non solo e non tanto per il magistero tecnico, per il dominio della scrit4 La fortuna del repertorio per quartetto d’archi di Dvořák nell’ambiente musicale frequentato da Hindemith è documentato ad esempio dall’alto numero di esecuzioni di Quartetti dvořákiani da parte di ensemble strumentali che videro la partecipazione dello stesso Hindemith. Cfr. ad esempio Michael Kube, Am Quartettpult. Paul Hindemith in Rebner- und Amar-Quartett. Dokumentation (3. Teil), in «Hindemith-Jahrbuch», vol. 1993/ XXII, pp. 200-237, dove si documenta la particolare predilezione per i più maturi Quartetti di Dvořák, ovvero op. 51, op. 96 e op. 105. Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra tura strumentale, che qui è indubbiamente già molto alto, ma anche e soprattutto per uno speciale trattamento della materia sonora, per una ben precisa organizzazione dei materiali – in altri termini e in sintesi: per una peculiare “visione” della musica, ossia per una definita posizione estetica. Si pensi al ruolo che assume la melodia tematica del primo violino a partire dalla quinta battuta del passo mostrato nell’Es. 2: il suo è un canto mesto che si erge sopra allo sfondo rassegnato, opaco e ostinato della vera e propria marcia, definita nella scrittura della prime quattro battute e poi sostenuta dalle tre parti gravi di sostegno armonico dalla quinta battuta in poi. Nel prosieguo di questo movimento (dalla battuta 12 in poi, non mostrata nell’esempio) il violino secondo si unirà al violino primo nella riesposizione variata del tema, ma la sostanza della scrittura non cambierà: si tratterà pur sempre di delineare un doppio livello, dato dalla compresenza dello “sfondo” e del “primo piano”, ovvero della marcia e del canto solistico. Nella considerazione dell’artista Hindemith non si dovrebbe cadere nella tentazione di considerare un passo simile come semplice esempio di scrittura tardoromantica, calco di vecchi stilemi che poi verranno soppiantati, nelle opere della maturità, da scritture più attuali e complesse. Questa non è semplicemente e banalmente una scrittura “immatura”, perché nel suo doppio livello, nella sua embrionale contrapposizione fra “solo” e “tutti”, c’è già il segnale di un orientamento, la traccia di una riflessione profonda e durevole; c’è già, in sostanza, quella accurata e sofferta meditazione che porterà il compositore ad indagare il problematico campo del rapporto fra individuo e collettività. D’altronde una scrittura siffatta, nel catalogo di Hindemith, non rappresenta affatto un caso isolato; lo si può dimostrare con un accostamento volutamente estremo, che forse permette di cogliere l’essenza del nostro discorso nel modo più diretto e incisivo possibile, condensando forzatamente un’indagine che certo meriterebbe di procedere per gradi e con ben altra prudenza. Si mostrerà dunque l’incipit di un altro movimento lento hindemithiano, lontanissimo nel tempo e nello spazio dal Quartetto n. 1, ossia l’attacco della Slow March dalla Pittsburgh Symphony composta nel 1958 (Es. 3). Il volo pindarico che ci porta dal movimento lento del Quartetto n. 1, concepito da un giovane studente del conservatorio di Francoforte, al movimento lento della Pittsburgh Symphony, complessa opera orchestrale che segna una prima sintesi significativa del “tardo stile” di un compositore affermato, non è puramente stravagante o paradossale come potrebbe a prima vista apparire. In due opere così dichiaratamente diverse e distanti si rintracciano infatti comuni segnali di un ricorrente e fondamentale spunto di riflessione, che ruota intorno all’idea della sofferta fragilità della coscienza individuale. Ad uno sguardo accurato il rapporto fra “solo” (oboe) e “tutti” (orchestra) nella Slow March del 1958 non Codice 602 114 115 Marco Moiraghi Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra appare affatto dissimile dal rapporto fra “solo” (violino primo) e “tutti” (gli altri tre strumenti) nel Quartetto del 1914-15. In entrambi i casi si tratta del faticoso ergersi di una melodia, di un canto, sopra al fondale oscuro e cupo di una “massa”. Ci sono tanti dettagli che mostrano profonda affinità fra le due pagine mostrate. Si pensi ad esempio al modo in cui inizia a manifestarsi la parte solistica: un lungo suono tenuto che prelude a successivi sbalzi e mutamenti di tessitura, secondo direttrici melodiche che diremmo lungamente meditate e profondamente sofferte, dolorose, faticose (per il violino del Quartetto è soprattutto il movimento della battuta 7, con discesa di quinta e successivo recupero d’ottava; per l’oboe della Sinfonia è tutta una serie di salti che hanno inizio nella seconda battuta, i cui esordi ricordano molto la parte violinistica del Quartetto giovanile). Questa speciale riflessione sulla relazione fra “solo” e “tutti”, che in Hindemith assume presto una forte valenza simbolica, inizia dunque a manifestarsi precocemente in molte pagine del periodo della Grande Guerra, nei modi più vari ed inaspettati. Qui interessa particolarmente mettere in luce l’emergere di tale riflessione in musiche che palesano uno stretto rapporto con l’idea del cammino, della processione, dell’avanzamento, della marcia. Nella Sonata per violino e pianoforte op. 11, n. 1, composta nel maggio 1918 durante il servizio militare in Francia, il secondo movimento (“Nel tempo di una danza lenta, grave”: Es. 4) può legittimamente ricordare il carattere di una marcia funebre. L’incipit presenta un ostinato ritmico che ricorda molto da vicino, pur nelle evidenti differenze, la tipologia di attacco del movimento del Quartetto n. 1 mostrato nell’Es. 2. Anche qui abbiamo un “fondale” insistente (i rintocchi della parte pianistica) e un “primo piano” dato dalla melodia del violino. La musica si muove nell’ambito tonale di Mi bemolle, ma senza chiarezza; non è un caso che il titolo della Sonata non indichi se si tratta di “maggiore” o “minore”: la complessità armonica, con le sue sospensioni ed ambiguità, lascia spazio a differenti possibili interpretazioni: Es. 3 Pittsburgh Symphony (1958), inizio del secondo movimento, Slow March Es. 4 Sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle, op. 11, n. 1 (1918), inizio del secondo movimento Codice 602 116 117 Marco Moiraghi Anche nella successiva Sonata per violino e pianoforte, l’op. 11, n. 2, risalente al settembre-novembre 1918 (composta nei momenti liberi lasciati dalle tragiche circostanze: il compositore era coinvolto, come soldato semplice, nel dramma della disfatta e della ritirata dell’esercito tedesco sul fronte occidentale, nella Francia settentrionale), il movimento lento manifesta caratteri vicini perlomeno all’idea di una triste processione, se non di un’effettiva marcia militare cupamente segnata dal senso della sconfitta. Ed anche qui, in questo “Tranquillo e misurato” (Ruhig und gemessen) dal carattere molto mesto (Es. 5), si scorge un doppio livello dato dalla presenza di una melodia solistica (inizialmente al violino, ma poi imitata contrappuntisticamente dal pianoforte a partire dalla battuta 5) che si leva dolorosamente su un fondale armonico opaco e regolare: Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra un allora diffuso epigonismo brahmsiano (modelli per questi Walzer potrebbero essere stati i molto brahmsiani Walzer op. 22 di Max Reger). Dal “Langsames Walzertempo” n. 1 in un limpido tono di Si maggiore, fino al cullante Fa maggiore del “Langsam” n. 6, la musica offre un perfetto modello di invenzioni melodiche e di sonorità belle époque. Questa rassicurante cornice salottiera viene però inaspettatamente spezzata dall’avvento del settimo pezzo della raccolta, Stürmisch: Es. 5 Sonata per violino e pianoforte in Re, op. 11, n. 2 (1918), inizio del secondo movimento Si osservi un dettaglio sintomatico: in tutti gli esempi proposti finora è presente un ritmo puntato fortemente caratterizzante, che può riguardare sia il “fondale”, ovvero l’accompagnamento accordale (Quartetto n. 1; la Slow March dalla Pittsburgh Symphony) sia il “primo piano”, ossia la melodia solistica emergente (Dunkler Tropfe; le due Sonate per violino op. 11). D’altronde l’occorrenza del ritmo puntato si accompagna sempre ad un processo di iterazione ed ostinazione ritmica, stabilita solitamente dalle parti che costituiscono il sostegno armonico. Di che cosa si tratta se non di evidenti riferimenti (dichiarati o sottintesi) all’idea stessa di Marcia? Si è già fatto notare che nella produzione giovanile di Hindemith si può avvertire un deciso spostamento da quello che possiamo definire l’ambito espressivo del Valzer all’ambito espressivo della Marcia. In una composizione poco nota degli anni di guerra, gli otto Walzer per pianoforte a 4 mani op. 6 (composti nell’estate 1916, nel periodo in cui giunse in casa Hindemith la tragica notizia della morte del padre del compositore) potremmo ravvisare una sorprendente conferma di ciò che è stato sin qui osservato. Quello a cui assistiamo, da ascoltatori, nella successione dei primi sei pezzi dell’opera è una sfilata di eleganti movimenti di danza, secondo un gusto e uno stile di scrittura perfettamente situati nell’orbita di Es. 6 Walzer per pianoforte a 4 mani, op. 6 (1916), inizio del settimo brano, Stürmisch Questo movimento assume a nostro parere una valenza “esistenziale” ben maggiore di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Per il giovane compositore non si tratta soltanto di proporre una musica audace o un insolito schema di danza, reso particolarmente complesso dalle novità introdotte in campo ritmico e armonico; il punto focale del ruolo assunto dallo Stürmisch è piuttosto la rilevanza simbolica che esso assume nel contesto compositivo nel quale è collocato. La regolarità fraseologica, fin Codice 602 118 119 Marco Moiraghi qui perfettamente rispettata, viene ora letteralmente spazzata via da un discorso frammentato e discontinuo, fortemente ambiguo sotto il profilo armonico e sintattico; nel dipanarsi della musica si insinuano elementi di drastica rottura rispetto all’impalcatura tonale precedente, mentre la stessa metrica ternaria, già resa precaria dalla dislocazione ritmica della parte del secondo pianista (fin dalla prima battuta), viene a tratti scalfita (a partire dalla battuta 6) da misure di 4/4, ben percepibili nella parte del “primo”. Il successivo brano dell’op. 6, conclusivo della raccolta, sembra poi presentare il senso di disfacimento e di rassegnazione successivo ad uno scoppio, ad una deflagrazione: dopo un’illusoria citazione del Valzer n. 1 in Si maggiore, Hindemith fa in modo di concludere il suo piccolo ciclo pianistico con una rassegnata e desolante chiusa in Re minore, tanto da ribaltare completamente lo stato di fresco ottimismo aleggiante nei primi sei brani dell’opera. Che cosa abbia significato per il compositore una siffatta strutturazione non è facile stabilirlo. Possiamo però dire che oggi, a distanza di un secolo, una composizione come l’op. 6 appare come un perfetto paradigma di un’epoca di brutale disillusione e di traumatico crollo di molte effimere speranze. Forse non è del tutto casuale che Hindemith abbia usato l’insolito termine Stürmisch per il brano citato. Stürmisch vale naturalmente come “burrascoso”, “tempestoso”, “irruente” o “agitato”, ed è termine non del tutto estraneo – per quanto raro – alla tradizione musicale colta di lingua tedesca (se ne trova un famoso esempio nel Finale della Prima Sinfonia di Mahler: Stürmisch bewegt / Energisch); Hindemith tuttavia può anche aver scelto questo vocabolo avendo nelle orecchie un termine molto di moda all’epoca, ovvero Sturmpatrouilen, il nome delle famigerate “pattuglie d’assalto” tedesche istituite proprio in quel drammatico anno di guerra 1916. Non pare del tutto infondato sostenere che con questo spregiudicato Stürmisch Hindemith abbia voluto dar forma sonora alla brutalità di una guerra che stava spazzando via i sogni di una generazione; la rottura lacerante rispetto al tessuto ritmico, metrico, sonoro, espressivo del Valzer tradizionale e l’incursione del metro binario nel corso del pezzo sembrano elementi che prefigurano tempi nuovi: non più i tempi del Valzer, insomma, ma quelli ben più duri e drammatici della Marcia. Le considerazioni fin qui volte hanno una valenza che ovviamente – come si è accennato più sopra – va ben al di là del periodo della Grande Guerra. Ad un livello molto generale, si può osservare che proprio a partire dall’epoca considerata in Hindemith si definisce e si fissa con sempre maggior consapevolezza l’idea di un’arte compositiva che potremmo definire “tetica” o “di appoggio”, ossia basata su una speciale e personalissima quadratura ritmico-metrica, su una fraseologia affermativa, poggiata su solide basi, strutturata, densa di ragioni e ben radicata nella tradizione Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra illustre. Una simile idea crea le premesse migliori per accogliere nelle maglie della texture combinazioni ritmiche perentorie, nette, inequivocabili, spesso risultanti da una personale elaborazione di tradizionali passi di danza; da qui, la predilezione per lo stile della Marcia, in Hindemith, risulta del tutto naturale. L’arte compositiva “tetica” di Hindemith si rivela spesso anche in pagine di concezione ritmica particolarmente studiata e complessa, con una particolare predilezione per tempi come 9/4, 9/8, 12/4, 12/8 o 12/16, indicazioni che abbondano in Hindemith più che in ogni altro compositore suo coetaneo. Del resto si ritrovano spesso, nelle sue partiture, stratificazioni ritmiche di carattere marcatamente “tetico” in battute binarie semplici e tradizionali come 4/4 e 2/2. Fra i moltissimi esempi possibili, si vedano i seguenti due estratti dal Trio per archi op. 34 (1924) e dalla Kammermusik n. 2 (1924): Es. 7 Trio per archi, op. 34 (1924), inizio del primo movimento, Toccata Codice 602 120 121 Marco Moiraghi Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra Pagine come queste mostrano la tipica fraseologia giustappositiva di Hindemith, basata sull’accostamento di svariati tasselli o blocchi ritmici. Alla base di tale scrittura – che a taluni osservatori è parsa, non a torto, di matrice settecentesca o esplicitamente bachiana (tanto che si parla di musica “neobarocca”) – c’è una mentalità compositiva che privilegia la forza icastica e propulsiva dell’accento in “battere”, sfruttato come persistente appoggio che sorregge e fa progredire il discorso. È lo stesso meccanismo che vediamo applicato in molte altre musiche che si rifanno all’idea dell’avanzata, della processione, del percorso da compiere, dell’itinerario marciante. Se ci si vuole soffermare anche soltanto sulle musiche nelle quali Hindemith usa espressamente il titolo “Marcia”, si può constatare che la casistica è di un’abbondanza stupefacente, oltre che di un’assoluta continuità cronologica: Es. 8 Kammermusik n. 2, op. 36, n. 1 per pianoforte e 12 strumenti (1924): passo centrale del primo movimento, Sehr lebhafte Achtel 1916: Marsch in f moll per pianoforte a 4 mani. 1917: Todtmooser Abschiedsmarsch mit Hymne per pianoforte a 4 mani (musica smarrita). 1917 circa: Das Grab ist meine Freude. Festmarsch per sei strumenti (musica smarrita). 1917 circa: Musik für 6 Instrumente und einen Umwender. Marsch (musica smarrita). 1918: Quartetto per archi n. 2: una delle variazioni del secondo movimento è segnata “Nel tempo di una marcia lenta”. 1920: Gouda-Emmental Marsch per ottavino, pianoforte e quintetto d’archi (musica smarrita). 1921: musica orchestrale per il film Im Kampf mit dem Berge: contiene un “Tempo marziale” ed un successivo “Allegro Marziale”. 1921-22: Suite 1922 per pianoforte: il primo movimento è una “Marsch”. 1922: Regimentsmarsch der “Tipopo” per pianoforte (poi rielaborata per archi e fiati: 1924). 1922. Tuttifäntchen, musica per voce recitante e orchestra: il sottotitolo è “Marce natalizie”. 1923: Quartetto per archi n. 5; il terzo movimento è una “Kleiner Marsch”. 1923: “Minimax”. Repertorium für Militärorchester per quartetto d’archi: il primo brano è una “Armeemarsch”. 1925: Concerto per orchestra: il terzo movimento è una “Marsch”. 1926: Konzertmusik op. 41 per orchestra di fiati: il terzo movimento è una “Marsch”. 1927: Kammermusik n. 5 per viola e orchestra da camera: il quarto movimento è una “Variante eines Militärmarsches”. 1927: Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley per clarinetto e contrabbasso (o violoncello): il sesto pezzo è una “Marsch der Löwenreichswehr”. Codice 602 122 123 Marco Moiraghi 1929: Lehrstück per solisti, coro e orchestra: il n. 3 della partitura contiene una “Langsamer Marsch”; il n. 6, Scena dei clown, è una “Marsch”. 1930: Wir bauen eine Stadt per voci recitanti, coro di bambini e strumenti: il primo brano è una “Marsch”. 1932: Das Unaufhörliche per solisti, coro e orchestra: il n. 8 della partitura è una “Kleiner Marsch”; il n. 17 ha l’indicazione “Nel tempo di una marcia solenne”. 1932: Plöner Musiktag per voci e strumenti: la seconda sezione dell’opera “Tafelmusik”, si apre con una “Marsch”; così pure per la terza sezione, “Mahnung an die Jugend”. 1932: Philharmoniches Konzert per orchestra: l’ultima variazione è “In tempo di Marcia”. 1932: Marsch für Blasmusik. 1934: Unterhaltungsmusik per tre clarinetti, primo brano: “Märsche” (musica smarrita). 1933-35: Mathis der Maler, opera in sette quadri; quadro 4, scena 1: “Marsch”; quadro 4, scena 4: “Marsch”. 1936: Sonata per pianoforte n. 1, secondo movimento: “Nell’andatura di una marcia molto lenta”. 1936: Sonata per flauto e pianoforte: l’ultimo movimento è una “Marsch”. 1936: Bearbeitungen ausländischer Lieder (Der alte Berner Marsch) per quintetto d’archi e clarinetto (musica smarrita). 1938: Nobilissima Visione per orchestra: il n. 4 della partitura è una “Marsch”. 1938: Sonata per fagotto e pianoforte, seconda parte del secondo movimento: “Marsch”. 1940: Concerto per violoncello e orchestra: il terzo movimento è una “Marsch”. 1940: Theme with four Variations (according to the four Temperaments) per orchestra d’archi e pianoforte: la sezione finale della Prima Variazione “Melancholic” è una “Slow March”. 1942: Ludus Tonalis per pianoforte: l’Interludium n. 6 è una “March” (intitolazione in inglese). 1943: Symphonic Metamorphosis of Themes by C.M. von Weber per orchestra: il quarto movimento è una “Marsch”. 1945: Concerto per pianoforte e orchestra: è una “March” (intitolazione in inglese) la seconda sezione dell’ultimo movimento. 1946: When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d. A Requiem “For Those We Love” per mezzosoprano, baritono, coro e orchestra: il n. 3 della partitura è una “March” (intitolazione in inglese). 1946: Symphonia Serena per orchestra, secondo movimento: “Geschwindmarsch by Beethoven. Paraphrase”. 1948: Settimino per strumento a fiato, quinto movimento: “Fuge. Alter Berner Marsch”. Paul Hindemith e l’ombra lunga della Grande Guerra 1951: Sinfonia Die Harmonie der Welt per orchestra: il primo movimento, Musica instrumentalis, contiene una “Marsch”. 1953-54: Neues vom Tage (seconda versione), opera in due atti; n. 16 della partitura: “In tempo di Marcia”. 1956-57: Die Harmonie der Welt, opera in cinque atti; introduzione al secondo atto: “Marsch”. 1958: Pittsburgh Symphony per orchestra: il secondo movimento è una “Slow March”. 1959: Festmarsch, canone per quattro voci maschili e tuba. 1960: Marsch über den alten Schweizerton per orchestra. Il lungo elenco comprende naturalmente cose molto diverse fra loro: ci sono parodie di antichi motivi o di brani di autori classici; elaborazioni di popolari temi di marcia; marce festose accanto a marce funebri, oltre ovviamente ad una cospicua presenza di marce che si rifanno dichiaratamente o allusivamente all’ambito militare. In questa disparata congerie di composizioni ci pare tuttavia di poter ravvisare la presenza di un filo conduttore molto preciso, capace di legare insieme ed avvicinare molte delle opere elencate, oltre ad altre qui non citate in quanto prive dell’intitolazione “Marcia” ma che nondimeno manifestano caratteri di forte affinità5. Il filo conduttore è appunto ciò di cui si trattava all’inizio del presente contributo a proposito di Dunkler Tropfe: un senso di diffusa inquietudine connesso all’idea della morte e spesso associato al richiamo di un contesto bellico. L’analisi incrociata dello stile di alcune delle composizioni elencate – una prospettiva di studio finora non considerata dagli studiosi di Hindemith – permetterebbe di cogliere la stretta connessione esistente fra il tema della guerra e la meditazione sulla condizione umana. Hindemith non era dunque solo quel fresco, appassionato e ottimista artigiano che tutti ammiravano: in lui le ombre lunghe e opprimenti della Grande Guerra agirono ad un livello molto profondo e con assidua insistenza, creando le premesse per un non effimero scavo psicologico su alcuni dei più scottanti nodi irrisolti della sua epoca. 5In Sancta Susanna (1921), ad esempio, si trova un significativo esempio di lugubre marcia musicale (alle battute 522-567 della partitura) il cui effetto straniante è legato al contesto drammaturgico della scena della litania e della processione delle suore; la strumentazione e la scrittura di questo passo culminante di Sancta Susanna lo avvicinano allo stile di alcune delle più riuscite marce hindemithiane con carattere funebre. Altro esempio che meriterebbe di essere accostato alle musiche elencate è il Finale della Sonata per tromba e pianoforte (1939), di fatto una marcia funebre nella quale spicca la melodia del corale luterano tradizionale Alle Menschen müssen sterben. Codice 602 124 125 Studi sulla Musica a Lucca Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” di Gabriella Biagi Ravenni* Premessa Delimitiamo l’argomento: prime lucchesi delle opere di Giuseppe Verdi al Teatro del Giglio di Lucca, negli anni, certo i più gloriosi di quel teatro, della gestione dell’impresario Alessandro Lanari. Sull’importanza di quella gestione mi ero già soffermata in alcuni lavori di anni addietro1, ripromettendomi di ritornare sull’argomento, per mettere in luce le fonti lucchesi, in particolare le lettere dell’impresario, che gli studi sull’impresario non avevano preso in considerazione2. Per questo contributo mi sono avvalsa dell’importante lavoro di Alice Tavilla3, che ha condotto uno scavo siste* Gabriella Ravenni è professore associato di Musicologia all’Università degli studi di Pisa. È socio fondatore del Centro studi Giacomo Puccini, del quale è attualmente Presidente e membro del Comitato scientifico. Fa parte della Commissione scientifica dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini, nell’ambito della quale coordina il Comitato per l’edizione dell’Epistolario. È Direttore della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Direttore del Museo Casa natale di Giacomo Puccini a Lucca. Vicepresidente del Centro studi Luigi Boccherini, e membro del Comitato scientifico, è inoltre socio ordinario dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. 1 Diva panthera. Musica e musicisti al servizio dello stato lucchese, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, 1993, pp. 81-86; ‘La stagione fu brillantissima’: mecenatismo, direzione, impresariato al Teatro del Giglio, in Fine di uno stato: il Ducato di Lucca 1817-1847. Atti del Convegno (Lucca, 9-11 ottobre 1997) in 4 voll., “Actum Luce”, xxvi/1-2 (1997), xxvii/1-2 (1998), xxviii/1-2 (1999), xxix/1-2 (2000), vol. 3, pp. 21-55; Storie di una prima: il Temistocle al Teatro del Giglio di Lucca, in Intorno a Giovanni Pacini, a cura di Marco Capra (Studi musicali toscani. Ricerche e cataloghi, 10), Pisa, ETS, 2003, pp. 81-111. 2 Marcello De Angelis, Le carte dell’impresario. Melodramma e costume teatrale nell’Ottocento, Firenze, Sansoni, 1982; Id., Le cifre del melodramma. L’archivio inedito dell’impresario teatrale Alessandro Lanari nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (1815-1870), 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1982.; John Rosselli, L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicale italiano dell’Ottocento (edizione originale The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi, Cambridge, Cambridge University Press, 1984), Torino, EdT, 1985; Paolo Mechelli, I fili della scena. Alessandro Lanari, il carteggio con impresari e delegati (1820-1830), Lucca, LIM, 2009. 3 Alice Tavilla, Alessandro Lanari a Lucca e le sue lettere negli archivi lucchesi. Una prima ricognizione attraverso il reperimento e l’analisi di fonti inedite, tesi di laurea specialistica, primo relatore Gabriella Biagi Ravenni, Università di Pisa, 2011. Ringrazio l’autrice per avermi consentito di avvalermi del suo lavoro, in particolare per individuare le lettere di Lanari. Codice 602 129 Gabriella Biagi Ravenni matico nell’Archivio storico del Comune di Lucca, portando alla luce 373 lettere di Alessandro Lanari (di cui 363 inedite), di cui ha fornito un regesto accurato, e presentando una preziosa cronologia delle stagioni realizzate dall’impresario nei teatri lucchesi, in primis nel Teatro del Giglio. Le prime verdiane del titolo non sono prime assolute, ma riprese molto precoci, spesso con i creatori dei ruoli, che consentivano al pubblico lucchese di conoscere molto presto le novità del teatro italiano. Tutto questo era possibile grazie alla molteplice attività di Lanari, il Napoleone degli impresari, che gestiva in contemporanea molti teatri importanti: in modo quasi continuativo il Teatro della Pergola di Firenze e il Teatro di Senigallia ma anche, per periodi e stagioni importanti, La Fenice di Venezia, il Teatro alla Scala di Milano e altri ancora. A Lucca aveva iniziato nel carnevale 1818-1819 – è a lui che si deve la stagione inaugurale del ‘nuovo’ Teatro del Giglio, nella stagione di ‘estate in autunno’ 1819 – e continuerà per un trentennio, quasi ininterrottamente. È proprio nel periodo di attività di questo straordinario personaggio che si assiste in Italia a un cambiamento epocale nel sistema produttivo dell’opera lirica: dalla centralità degli impresari alla presa di potere da parte degli editori, che diventeranno progressivamente gli arbitri assoluti della vita dei teatri, della scelta dei titoli e di conseguenza delle carriere dei compositori4. Non è raro che, nei momenti di declino di un fenomeno, se ne possano apprezzare i momenti più fulgidi: la carriera di Lanari può essere vista in questo modo. Ed è singolare che negli ultimi anni di attività l’impresario abbia mandato in scena, come vedremo, prime assolute verdiane. Ai vari Direttori del Teatro del Giglio, nonché alle varie Deputazioni, che si succedettero alla guida del teatro in quell’arco di tempo, va riconosciuto complessivamente il merito di aver colto la qualità delle proposte che Lanari presentava, nonché le opportunità che la sua frenetica attività nazionale e internazionale poteva offrire a un teatro che di per sé non avrebbe potuto competere con i ‘primari’ d’Italia. Le prime verdiane più importanti – e le riprese più precoci – furono quelle de I lombardi alla prima crociata, nel 1843, dell’Ernani, nel 1844, di Attila e Macbeth nel 1847. Mi concentrerò sulla stagione del 1843, la più documentata, e su quella del 1847, che vede l’evento più memorabile ai nostri occhi. 1843 I lombardi alla prima crociata è la prima opera verdiana allestita sul palcoscenico del Teatro del Giglio, nella stagione di ‘estate in autunno’ del 1843. La copiosa documentazione conservata nell’Archivio storico del Comune di Lucca ci offre parecchi dati utili per seguire le fasi cruciali 4 Sull’argomento si rinvia al fondamentale e illuminante Stefano Baia Curioni, Mercanti dell’Opera. Storie di Casa Ricordi, Milano, Il Saggiatore, 2011. Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” della progettazione, il libretto stampato a Lucca consente alcune puntualizzazioni. La quarta opera di Verdi era andata in scena al Teatro alla Scala di Milano l’11 febbraio 1843, con un grande successo, grazie soprattutto alla bravura del coro e dei due interpreti principali, Erminia Poggi-Frezzolini e Carlo Guasco. A Lucca, frattanto, era in corso di definizione la prossima stagione di ‘estate in autunno’, ed erano già stati definiti i titoli di due opere: Lucrezia Borgia di Donizetti e Ruy Blas, del Principe Giuseppe Poniatowski, una novità assoluta. Il 16 febbraio Lanari scrive alla Deputazione degli Spettacoli Teatrali, trasmettendo una lettera del tenore Antonio Poggi (marito di Erminia Poggi-Frezzolini) che proponeva di mettere in scena a Lucca l’opera verdiana come terzo titolo5. I coniugi Poggi erano già stati scritturati da qualche tempo per la stagione di ‘estate in autunno’ 18436, ed è grazie a questa informazione che si comprende il meccanismo: era prassi consolidata che i cantanti proponessero titoli a loro graditi. Evidentemente Poggi desiderava avere l’opportunità di debuttare il ruolo di Oronte a fianco della moglie, creatrice del ruolo di Giselda. Nella lettera del 16 febbraio Lanari mette subito in evidenza un problema che potrebbe frapporsi alla realizzazione della richiesta di Poggi: Rimetto ora alle SS. LL. Ill.me una lettera di Poggi, dalla quale rileveranno ch’egli propone l’opera del M° Verdi I Lombardi alla prima Crociata, la quale pare che abbia ottenuto un successo veramente straordinario. Io sarei disposto a proporre [?] quest’opera, alla quale vedo che i coniugi Poggi tengono moltissimo, ma temo che possa trovarsi un ostacolo per la parte del Basso, giacché è scritta per Basso profondo. Se si potesse avere Balzar, non vi sarebbe nessuno scrupolo, ma se questi non si può avere, e che il Basso dovesse esser Colini, il quale potrebbe già d’ora avere accettato la mia proposta, starà bene a questi una parte scritta per Derivis? Io vado a fare a Poggi questa osservazione, e nel tempo prego anche le SS. LL. Ill.me a dirmene il proprio sentimento, desiderando andare sempre d’intelligenza con le SS. LL. Bisogna anche considerare che nella scelta delle opere si deve andare d’accordo con i Conjugi Poggi. Sono legami dai quali un’Impresa non può sottrarsi allora che vuole degli artisti di rinomanza come sono i detti Conjugi. Il problema del cantante da scritturare per il ruolo di Pagano sarà l’oggetto principale della corrispondenza tra Lanari e la Deputazione per i prossimi mesi. Lanari ribadirà più volte che per interpretare quel ruolo, scritto 5 Lettera di Alessandro Lanari (d’ora in avanti Lanari) in: Archivio storico del Comune di Lucca, Fondo Teatro del Giglio (d’ora in avanti Teatro del Giglio), busta 12 (1843), n. 21. Si avverte che le trascrizioni dei documenti riproducono fedelmente le fonti e che non sono stati segnalati gli ‘errori’. 6 Lettera di Lanari, 4 gennaio 1843, n. 239 del Regesto delle lettere in Tavilla, Alessandro Lanari, cit., p. 127. Codice 602 130 131 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni per Nicola-Prosper Dérivis (creatore anche del ruolo di Zaccaria nel Nabucco), non si sarebbe potuto fare a meno di scritturare un basso profondo. E quando invece verrà scritturato Filippo Colini, un baritono, Lanari inviterà la Deputazione a trarne la logica conseguenza: i Lombardi non si potranno dare. I documenti evidenziano che fu la Deputazione a insistere nel voler realizzare quella proposta, con osservazioni di grande interesse. Iniziamo dalla prontissima risposta, il 17 febbraio, alla lettera di Lanari del 167: L’impresario però ancora insiste nell’evidenziare le difficoltà, e allega documenti probatori10: Nulla di più sodisfacente possiamo noi desiderare dell’Opera di Verdi I Crociati Lombardi alla terza Crociata che Ella con la sua di jeri ad insinuazione della Sigg. Poggi Frezzolini ci propone per terzo spartito della pross:a stagione di Estate in Autunno. Il parere del Sig. Poggi sul merito di questo nuovo lavoro è per noi di grandissimo valore, ove potremmo, se si volesse, dubitare della verità e giustizia degli elogi che egli ne fa – soltanto a nostra maggior garanzia e per non doverci mai nulla rimproverare, mentre sin d’ora approviamo la scelta, ci decidiamo [?] dopo la lettera che Domenica avemmo noi pure da Milano, a darle il nostro definitivo assenso, quale non può mancare quando le notizie che noi avremo in tal proposito consuonino con quelle della lettera dai Poggi da lei rimessaci che qui le ritorniamo. Accludo alle SS.LL. Ill.me una lettera del S.r Poggi dalla quale, e più ancora da un brano di altra lettera di Verdi rileveranno essere impossibile che Colini possa eseguire la parte di Pagano nell’opera I Lombardi alla prima Crociata – In sostanza le cose ora sono in questi termini, che per le opere le quali sono già destinate, e quelle che sono in predicato vi vuole per la buona esecuzione un Basso profondo, ed invece si vuole un Baritono – Poniatowski desidera aver Porto, Verdi ne sarebbe stato contento, ed invece io sono stato costretto di scritturare Colini! – Ecco pertanto tolto di mezzo ogni motivo di controversia intorno al Basso, ma egli è certo che ora bisogna dimettere ogni pensiero di dare l’opera di Verdi siccome quella per la quale non può essere adatto il Colini essendo la parte di Pagano scritta per Basso profondo. Un lavoro parallelo, quello della Deputazione, che raccoglie notizie in modo autonomo. Lanari ne prende atto e inizia a prefigurare un adattamento della parte di Pagano, possibilissimo a quei tempi. Riprende però una proposta già avanzata in precedenza, e respinta dal Direttore Nuccorini: perché non scritturare il basso Dérivis8? E quanto all’opera di Verdi I Lombardi alla prima Crociata sentirò quali saranno le notizie che alle SS. LL. ne saranno date da Milano ove queste si confrontino con quelle date da Poggi, se il Basso che potremo avere sarà adattato all’opera, o questa possa adattarsi al Basso (su di che scrissi a Poggi) se lo Spartito si potrà avere a ragionevoli patti, io lo fisserò senz’altro […] Firenze li 19 febbrajo 1843 P.S. Io proposi al di loro antecessore il Basso Derivis, il quale fu a torto ricusato, perché essendo un’artista che ha calcato ripetutamente il Teatro della Scala, e quello di Vienna, non si può negare che abbia le qualità volute dal Contratto. La Deputazione, che intanto aveva raccolto altre informazioni, dà ormai per accolta la proposta di Poggi/Lanari9: 7 Minuta di lettera della Deputazione, 17 febbraio 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 21. Più avanti si ribadisce che è giusto compiacere gli artisti e che di conseguenza va accolta la proposta de I lombardi, “sempre che l’esito sia stato sì felice e come sopra si è detto”. 8 Lettera di Lanari, 19 febbraio 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 23. 9 Minuta di lettera della Deputazione, 20 febbraio 1843, ivi. Al seguito di nuove informazioni ricevute sul merito della nuova opera di Verdi “I Lombardi alla Prima Crociata” possiamo interamente convenire della scelta da Lei fatta di questo spartito da darsi per Terza opera nella prossima stagione di Estate in Autunno, tanto più essendo questo di piena soddisfazione dei Conjugi Poggi. E ancora11: Quanto all’opera del Verdi è un fatto che non può essere eseguibile da Colini – L’autorità dello stesso Maestro compositore parmi che in certi casi debba esser presa in considerazione, e si rileva chiaramente dal paragrafo di lettera del Verdi che io rimisi alle SS.LL. non potere assolutamente convenire ad un Baritono la parte di Pagano nell’Opera i Lombardi. L’esempio che le SS.LL. mi adducono mettendomi innanzi l’opera del Principe Poniatowski non fa al nostro caso, mentre se è agevole modificare, ed adattare un parte che si sta scrivendo, non è la stessa cosa dover fare il medesimo lavoro per una parte di un’opera non solamente scritta, ma anche rappresentata – la differenza che passa è immensa. La Deputazione sembra intenzionata a risolvere la questione e propone addirittura un cartellone diverso, purché gradito ai tre artisti già scritturati – i coniugi Poggi e Colini – ma non rinuncia a portare avanti la possibilità de I lombardi, sia pure come alternativa12: Ebbene noi proporremo di dare per Prima la Beatrice di Tenda ove 10 Lettera di Lanari, 2 marzo 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 25. Gli allegati non sono conservati. 11 Lettera di Lanari, 5 marzo 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 30. 12 Minuta di lettera della Deputazione, 18 marzo 1843, ivi. La fidanzata corsa di Giovanni Pacini compariva nella corrispondenza precedente come uno dei possibili titoli della stagione 1843. Sarà rappresentata al Giglio nella stagione 1844. Codice 602 132 133 Gabriella Biagi Ravenni tutti i primi tre artisti figurano in egual parte fra loro, tanto più che quest’opera è per quanto ci viene assicurato di gradimento assoluto della Frezzolini – Noi tenghiamo ferma per seconda il Ruy Blas del P.e Poniatowski, e per Terza si cercherà combinare anche interpellando i Conjugi Poggi o i Lombardi vedendo di combinare la Parte di Pagano per Colini, o la Fidanzata Corsa: lo spartito essendo in mano del Sig. Ricordi si potrà da Lei trattare con maggiore facilità di quello potesse farsi coi primi possessori. E, in risposta a ulteriori difficoltà frapposte da Lanari, e alla possibilità che la stagione, con l’unico punto fermo del Ruy Blas, veda l’allestimento di Lucrezia Borgia (già eseguita al Teatro del Giglio nel 1838) e di Beatrice di Tenda (già eseguita al Teatro del Giglio nel 1839), la Deputazione espone chiaramente il proprio punto di vista, ribadendo quale avrebbe dovuto essere la mission di un teatro governativo qual era il Teatro del Giglio13: Due spartiti ormai di soverchio intesi e su questo nostro Teatro, e su tutti i circonvicini, non possono assolutamente giovare allo scopo che questo R. Governo si è prefisso nell’assegnare per lo spettacolo dell’Estate in Autunno una non indifferente somma che a questo spettacolo dovrà di dote, nella veduta soltanto di giovare al Paese nostro. Ella ben vede dunque che non volendo noi attirarci addosso la critica universale, non potremmo assolutamente approvare il suo piano, che non sarebbe compatibile a cose ordinarie, tanto meno poi in una circostanza come quella che in detta stagione si verifica, intendiamo dire della Riunione degli scenziati qui, che per certo non riuscirà svantaggiosa al di Lei interesse. Opere nuove dunque, e non opere già sentite a Lucca e nei teatri delle città vicine, tanto più in occasione di un evento straordinario che si sarebbe svolto a Lucca in settembre, il Quinto congresso degli scienziati italiani.14 L’occasione prestigiosa e il conseguente afflusso di ‘stranieri’ era una motivazione più che ragionevole per sostenere la richiesta di una stagione teatrale di livello. La massima attrattività si poteva raggiungere combinando la presenza di ottimi cantanti, già scritturati, con la proposta di titoli nuovi. Una sottolineatura ipotetica: pura coincidenza il fatto 13 Minuta di lettera della Deputazione, 4 aprile 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 44. 14 Sull’intreccio tra composizioni/eventi musicali e occasioni locali/internazionali vedi: Fabrizio Papi, Un été à Lucques. Theodor Döhler, un pianista biedermeier alla corte di Carlo Lodovico di Borbone, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, 2012. Di grande interesse le 12 melodie composte da Döhler, raccolte sotto il titolo Un été à Lucques. Molte sono dedicate ai protagonisti della stagione di estate in autunno 1843: i coniugi Poggi, il principe Poniatowski. Döhler aveva invitato a Lucca l’editore Giovanni Ricordi: “Forse vorrete fare una piccola escursione a Lucca in Settembre dove per la riunione dei scienziati saremo in un piccolo Parigi” (ivi, p. 85). Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” che Antonio Mazzarosa – il primo e più prestigioso Direttore del Teatro del Giglio, nominato nel 1819 da Maria Luisa di Borbone – fosse uno dei promotori del Congresso e che ne avrebbe presieduto i lavori? La risposta di Lanari a quel limpido richiamo alla mission generale e particolare che il teatro e il suo impresario si dovevano prefiggere, ci riporta nel clima della prassi produttiva ottocentesca:15 Del resto mi piace di fare osservare alle SS.LL. Ill.me che allora quando si hanno degli Artisti di fama sono essi che devono rispondere allo scopo che codesto R. Governo si è prefisso, molto più delle opere che si rappresentano, per cui sono d’avviso che poco conta siano esse nuove, o già intese – N’avemmo un esempio allorché fu costì la Malibrand che quantunque si producessero spartiti già intesi in Lucca e nei vicini paesi, pur non di meno quella grande Artista non mancò di produrre l’effetto che doveva Le SS.LL. Ill.me poi sanno che io aveva proposta un’opera nuova, e che ha ottenuto successo brillantissimo a Milano: voglio dire i Lombardi alla prima crociata, ma bisogna pur convenire che hanno fatto poco conto di questa proposta dapoiché hanno voluto, ad onta della mia osservazione, un Basso che non può eseguire un tale spartito, mettendo insieme, diciamo così, elementi contrari alla effettuazione del progetto da me fatto; che del resto lo spartito nuovo, e d’esito già sperimentato io l’aveva proposto. La Deputazione non poté fare a meno di replicare pesantemente16: [La sua scelta] sinceramente non incontrerebbe il genio di nessuno avuto riguardo alla molteplicità di nuovi lirici lavori che esistono, e che si danno nelle Piazze a noi vicine, mentre qui si ama meglio riprodurre degli spartiti di troppo ovunque intesi, e perciò sempre di poco effetto per quanto mai egregiamente eseguiti ora possano essere […] torneremo noi pure a pregarla di non voler essere scortese con noi e sostituire così una nuova opera a quella in questione l’esecuzione della quale non potrebbe che far nascere in tutti un certo cattivo umore che noi vogliamo in ogni occasione prevenire per il comune interesse, e perché questo R. Governo non debba mai poterci tacciare di aver noi messo poca premura al miglior andamento di quelle cose che piacque a S.A.R. il nostro Principe di affidarci. La documentazione conservata registra un ennesimo tentativo di La15 Lettera di Lanari, 6 aprile 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 33. A distanza di qualche anno, Lanari sentiva ancora ‘bruciare’ la ferita dell’annullamento dell’appalto del Teatro del Giglio: la Deputazione di allora non aveva trovato altra strada per poter avere a Lucca Maria Malibran. Sulla stagione 1834, vedi: Gabriella Biagi Ravenni, Maria Malibran, La sonnambula, il Teatro del Giglio: cronache di un trionfo, in La sonnambula, programma di sala, Teatro del Giglio, Lucca, 1999, pp. 37-58. 16 Minuta di lettera della Deputazione, 19 maggio 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 44. Codice 602 134 135 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni nari di sostenere la propria tesi, e poi, con un salto di mesi, si piomba nel bel mezzo della stagione. Il 17 agosto era andata in scena Lucrezia Borgia: un buon successo, apprezzamento per i tre interpreti principali, Erminia Poggi-Frezzolini, Antonio Poggi e Filippo Colini17. Seguirono altre 12 rappresentazioni, fino al 13 settembre, con una successione nelle recite che merita una sottolineatura: tutte di seguito, durante la settimana, con l’eccezione del venerdì e del lunedì. Il 2 settembre il debutto del Ruy Blas, l’unico punto fermo nella tormentata programmazione della stagione, con un esito quasi disastroso. “Opera nuova, musica cattiva, bellissimo vestiario, bravi cantanti, teatro buono” è il lapidario e sintetico giudizio di Francesco Minutoli. Le repliche furono solo 4, l’ultima piazzata con ottima strategia la sera del 14 settembre, festa di Santa Croce. Subito dopo l’infelice debutto del Ruy Blas, con la prospettiva che l’opera dovesse essere cancellata, era indispensabile che I lombardi alla prima crociata potesse andare presto in scena. E si faceva imminente l’inaugurazione del Congresso degli scienziati (15 settembre) Così la Deputazione a Lanari18: Per imponenti cause che alla S.V. non debbono essere ignote, ed a garantire il decoro di questa Deputazione, e l’interesse di cotesta Impresa, la medesima trovasi nella indispensabile necessità, d’invitare nel modo il più positivo la S.V. ad avere ricorso, con la maggiore possibile sollecitudine per porre senza indugio in iscena l’Opera già prestabilita I Lombardi alla prima Crociata del Maestro Verdi, musica di sicuro successo. E siccome però risulta non potersi dare questo Spartito che con un buon numero di Coristi, e con una scelta e completa Orchestra, così questa R. Deputazione, ad assicurarne l’effetto non si ristà dall’invitarLa pressantemente a darsi tutte le premure possibili onde veder montata al più presto d.a Opera, mettendosi di concerto col Maestro Direttore della Musica per completare, a senso dell’Art.° 7 del vigente Contratto d’Appalto, l’Orchestra del necessario numero di abili Professori, e più specialmente di un Primo Oboè, e di un primo Corno; non omettendo in pari tempo di dare gli ordini opportuni per l’aumento dei Coristi necessarissimi essendo i Cori in detto spartito scritti a quattro; facendole inoltre presente che ove si ottenessero fino a otto di quei soggetti che gli eseguirono in Sinigaglia, gioverebbe mirabilmente alla speditezza per conseguire l’importantissimo scopo. La risposta dell’impresario, un po’ piccata, sciorina le meraviglie di una professionalità consolidata e puntualizza l’osservanza di impegni e compiti da parte sua, mentre evidenzia l’inosservanza da parte di altri19: in quanto al numero dei Coristi che mi richiedono di più per l’Opera I Lombardi alla prima Crociata, io ho ad esuberanza adempiuto al mio obbligo quando in luogo di 14 secondo il consueto ne do 18. Siccome sono di fatto, e che anco volendo aderire al desiderio delle SS.LL.Ill. me col fissare quei Coristi che mi accennano, non mi trovo nella possibilità di farlo perche essendo quelli delle Marche si trovano impegnati quali a Fermo, e quali a Macerata. In questo proposito mi corre l’obbligo di far presente alle SS.LL.Ill. me che a Senigallia col g.no 3 Luglio cominciarono le prove del Bravo e il 16. era già posto in scena, e che il 17 detti di mano a quelle dei Lombardi la qual Opera ebbe comparsa il 29 dello stesso mese, ed ottenne quel brillante successo che mi attendeva: laonde debbo con ciò concludere che se il ritardo della andata in scena su queste scene della ridetta Opera i Lombardi succede, non è per fatto mio; ma ben sì per fatto dei Coristi, e ciò per mancanza di assiduità, premura, e zelo del loro Maestro. In quanto alla completazione della Orchestra mi trovo perfettamente d’accordo con il citato articolo 7 del Contratto il quale mi obbliga di servirmi dei Professori della R. Cappella come prescrive l’analogo veneratissimo Sovrano Decreto, e se è accaduto che sia mancato qualcuno dei Professori, io non ho tardato di provvedere al rimpiazzo in tempo debito. Le prove dovevano essere già cominciate, come di solito, con le prove del coro guidate da un non assiduo – secondo Lanari – Matteo Quilici. Il 13 settembre, tre giorni prima dell’andata in scena, è l’impresario che protesta per i ritardi nella preparazione delle scene e dell’attrezzeria, invocando l’intervento diretto dell’autorità20: È già un mese che fu passata all’attrezzista S.r Malerbi la nota degli Attrezzi occorrenti pei Lombardi; passarono venti giorni che per detta opera furono date al macchinista Mechetti le opportune ordinazioni: fatti però da me verificare i lavori che erano stati approntati dai suddetti due individui a tutto jeri, si è rinvenuto che sono molto arretrati. Io pertanto debbo invocare l’autorità delle SS.LL.Ill.me all’oggetto, che vogliano prendere in tal proposito quei provvedimenti che saranno opportuni a far sì che i lavori di cui è proposito siano compiuti con quella sollecitudine che è necessaria, perché l’andata in scena dei Lombardi stabilita per sabbato [16 settembre] non abbia da questo lato subire ritardi – A norma delle SS.LL.Ill.me accludo la nota degli 17 Sulla stagione 1843, vedi: Francesco Minutoli, Memorie degli spettacoli teatrali in Lucca compilate da Francesco Minutoli, Archivio di Stato di Lucca, Dono Pellegrini 17 (d’ora in avanti Minutoli), cc. 229-230. 19 Lettera di Lanari, 7 settembre 1843, ivi. 18 Minuta di lettera della Deputazione, 3 settembre 1843, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 90. 20 Lettera di Lanari, 13 settembre, in Teatro del Giglio, busta 12 (1843), n. 89. La nota degli attrezzi non si è conservata. Codice 602 136 137 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni attrezzi che Malerbi dovrebbe avere approntati, nota che a lui fu da me trasmessa da un mese a questa parte. Scene e attrezzeria dovettero essere prontamente approntate, se l’opera andò in scena, come previsto, il 16 settembre, con grandissimo successo. Il debutto fu seguito da 14 repliche, tutte molto apprezzate. Un sintetico resoconto ce ne dà la misura21: 16 [settembre] Op[er]a nuova. I Lombardi. Moltissimo incontro. Immensi applausi e particolarmente alla P.ma Donna. Buon Vestiario, e Decorazioni. Teatro pienissimo. 17 Sett: Op[er]a: I Lombardi. Teatro pienissimo. La sera vi furono i Fuochi, che riuscirono passabili. 19.20.21. Esclusa dall’Appalto e 23 D.° Teatri sempre pieni 24 D. Op[er]a sud.[dett]a Teatro di una piena tale, che furono rimandati indietro da 400 Persone. 25.27.28.29. Ultima dell’Appalto. Teatri sempre bellissimi. 1 Ott:[obre] I primi tre Atti Dei Lombardi, e l’ultimo Atto della Beatrice di Tenda. Benefizi della Pma. Donna. Strepitosissimi Applausi alla medesima, e gli furono gettati molti Mazzi di Fiori, ed ebbe 4 bei regali del valore di 2500 Franchi 2.4.5 D.° Opa: I Lombardi. Ultima recita. Teatri sempre pienissimi. Molti Fiori alla Pma Donna […] [su tutta la stagione:] La Pma Opera incontrò assai, la Sda: nulla affatto, la Tza: moltissimo. Alla Pma e Sda non vennero, che pochissimi Forestieri, alla Tza: moltissimi, e in tutto il tempo furono N. 4432, e nella sola sera del 25 furono N. 546. I posti chiusi furono sempre affatto voti sino all’Opera I Lombardi, che allora, erano sempre pieni. Il resoconto merita qualche commento. “Buon Vestiario, e Decorazioni”: costumi forniti probabilmente dall’impresa Lanari, che aveva avviato molti anni prima un’attività parallela di sartoria teatrale, e scene realizzate a Lucca, anche se non sollecitamente. L’impianto scenografico de I lombardi alla prima crociata, a voler realizzare le indicazioni presenti nel libretto, è di grande complessità e costituisce una delle ‘difficoltà’ segnalate da Julian Budden per l’allestimento dell’opera: “undici scene, molte delle quali richiedono una notevole grandiosità spettacolare”22. Esterni (la piazza di Sant’Ambrogio, con la chiesa, da cui si diffonde la musica; un monte praticabile in cui si apre 21 Minutoli, cit., cc. 229v-230. 22 Julian Budden, Le opere di Verdi (edizione originale The Operas of Verdi, Cassell, London, 1973-1981), 3 voll., EdT, Torino, 1985-1988, vol. 1, p. 146. Le altre: “due tenori di calibro affatto diverso, il più potente nel ruolo più modesto [Arvino] e, infine, peggio di tutto l’onnipresenza della banda”. una caverna; la valle di Giosafat, sparsa di vari colli praticabili, di lontano si vede Gerusalemme; tende) e interni (galleria di un palazzo; sala di un palazzo; recinto di un harem; tenda; grotta, da un’apertura si vedono le rive del Giordano; tenda, s’apre la tenda e si vede Gerusalemme, sulle mura e sulle torri sventolano le bandiere illuminate dal sole). Le didascalie sceniche del libretto stampato a Lucca23 sono esattamente le stesse di quelle del libretto della prima assoluta a Milano: sicuramente uno sforzo produttivo non indifferente, considerando le dimensioni e la struttura del palcoscenico. La sera della benefiziata della prima donna Erminia Poggi-Frezzolini, 1 ottobre, tre atti de I lombardi e uno di Beatrice di Tenda, l’opera che, come aveva scritto la Deputazione, risultava essere “di gradimento assoluto della Frezzolini”. Prassi corrente, quella di accostare atti di opere diverse, senza preoccuparsi di dare al pubblico la possibilità di seguire lo svolgimento della vicenda, e del resto la Frezzolini era la creatrice del ruolo eponimo della Beatrice. Un vero cavallo di battaglia, che offriva d’altro canto al pubblico un’opportunità diversa, quella di risentire una parte di un’opera e di apprezzare la bravura dell’interprete. Le presenze di ‘forestieri’, ovvero tutti i non lucchesi, sono davvero rilevanti. Ma non dobbiamo dimenticare che, dal 15 al 30 settembre, si era svolto il Congresso degli scienziati. È assai probabile, per non dire certo, che molti di quei ‘forestieri’ fossero congressisti. La Deputazione avrà avuto ragione di essere soddisfatta: la mission sicuramente era stata pienamente raggiunta. Niente dicono i documenti consultati sulla questione che tanto aveva assillato Lanari e, per suo tramite, la Deputazione: Filippo Colini, baritono (ma il Minutoli, nelle sue Memorie, lo definisce basso, e registra la sua bravura), e la parte di Pagano/Eremita, scritta per un basso profondo. La parte fu ‘aggiustata’? o le difficoltà che Lanari aveva sottolineato fino alla nausea non erano reali? Interessante riportare a questo proposito il punto di vista di Budden sui punti deboli dell’opera24: 23 I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA / DRAMMA LIRICO / DI TEMISTOCLE SOLERA / POSTO IN MUSICA / DAL SIG. MAESTRO GIUSEPPE VERDI / DA RAPRESENTARSI / NEL R. TEATRO DEL GIGLIO / sotto la protezione di S. A. R. / CARLO LODOVICO DI BORBONE / Infante di Spagna ec. ec. ec. / DUCA DI LUCCA / Nell’estate del 1843 / PRESSO G. ROCCHI TIP. DEI RR. TEATRI, esemplare in Archivio di Stato, Lucca, Dono Pellegrini, libretti, n. 162. In copertina la data manoscritta, 1843, nella pagina del frontespizio una nota di possesso: un timbro con le iniziali AL [Alessandro Lanari] circondate dalla scritta TEATRO LA FENICE VENEZIA. A p. 3 si legge: “La Poesia, e la Musica del presente Dramma sono di proprietà del Sig. Giovanni Ricordi di Milano e come tali poste sotto la salvaguardia delle veglianti Leggi”. 24 Budden, Le opere di Verdi, cit., p. 126. Codice 602 138 139 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni Un inconveniente più serio per Verdi era quello di avere, come primo Pagano, Prosper Dérivis, creatore del ruolo di Zaccaria; sicché fu costretto ad affidare a un basso profondo una parte la cui ambivalenza sarebbe stata espressa in modo molto più efficace dalla voce di un baritono. Problema assolutamente rovesciato! Colini sarebbe stato un perfetto creatore del ruolo25! Un cambiamento alla partitura Verdi l’aveva sicuramente fatto nella parte tenorile di Oronte su richiesta di Antonio Poggi, che doveva interpretare il ruolo a Senigallia, nella stagione della Fiera (debutto il 29 luglio), e a Lucca: una nuova versione della cabaletta Come poteva un angelo (Atto II, scena 2), una vera e propria aria sostitutiva, “più brillante e aggraziata dell’originale”, con un Do acuto nella frase finale26. Minutoli si concentra sulla ricezione, e non fa alcun commento sulla musica, né sul libretto. Laconico, ma molto positivo, invece il resoconto di Pietro Provenzali27: I Lombardi alla prima crociata – Opera seria del Maestro Verdi. Grandissimo incontro. Per verità la musica è grandiosa originale e i bravi cantanti vi possono figurare assai. Immensi applausi e Teatro popolato. Molto più distesa la recensione del debutto28: Onore al sig. Temistocle Solera, che per esso si rallegrano le italiane scene di un Dramma lirico, a cui la morale e il pudore cordialmente applaudiscono. Onore al Maestro sig. Giuseppe Verdi, che per esso si gustano melodiosi ed armoniosi concenti; onore ai cantanti (Frezzolini-Poggi, Poggi, Colini, Lucchesi, Patriossi, ec.) pei quali ci è dato rilevare le somme bellezze di una musica giustamente encomiata. I Lombardi alla prima Crociata (tale è il titolo del Dramma scritto dal Solera, e volto in musica dal Maestro Verdi) comparsi il 16 corrente su queste scene, ottennero il più completo trionfo. Né poteva essere altrimenti, laddove Musica e Poesia si sforzano a gara di toccare e commovere; laddove ambidue parlano alla mente ed al cuore. Gloria dunque al Maestro, al Poeta, ai Cantanti, e gloria pure al Lanari per lo splendido modo con cui ha decorato lo spettacolo. I Lombardi provano che la lirica non è perduta, e che vanta l’Italia un Cigno di più. 25 I Lombardi alla prima crociata andrà in scena al Teatro alla Scala nella stagione di carnevale 1844-45 con gli stessi Frezzolini-Poggi, Poggi e Colini e Verdi direttore. Emanuele Muzio ne scriverà a Barezzi: «Colini è troppo melato nel suo canto; e nei pezzi concertati non si sente essendo baritono, e la parte è scritta per basso profondo» (Budden, Le opere di Verdi, p. 220). 26 Budden, Le opere di Verdi, cit., p. 145. 27 Pietro Provenzali, Memorie, 24 voll., Archivio di Stato di Lucca, Biblioteca Manoscritti 187210, tomo IV, c. 1204, 16 settembre. 28 «Giornale privilegiato di Lucca politico letterario» XVII/79, 18 settembre 1843, p. 4. e il bilancio complessivo del corso di recite, entrambi a firma di G. Bertini29: Colla decorsa sera ebber termine le rappresentazioni in questo R. Teatro, e l’applauditissima Opera «I Lombardi alla prima Crociata» dopo aver trattenuto per più e più sere piacevolmente il Pubblico, segnò il fine di una stagione per lei divenuta brillante. Né al solo merito grande dell’Opera del valantissimo Verdi, deesi attribuire la generale, costante, favorevole accoglienza, ma molto ancora al valor sommo di una Frezzolini Poggi, di un Poggi, e di un Basso Colini. È inutile tesser nuove corone di lodi per questi egregi cantanti, giacchè i loro nomi suonano bastantemente onorati per tutta Italia. Non tacerò per altro che i Coristi hanno acquistato nuovo diritto alla stima di che godevano come abili molti, e che l’orchestra concorse efficacemente alla perfetta esecuzione di un’Opera, quanto bella e armoniosa, altrettanto difficile. L’assolo di violino del 3.° atto fu sempre eseguito con somma maestria e dolcezza dal nostro sig. Puccini [Angelo] primo violino e direttore d’orchestra, e gli meritò seralmente il pubblico plauso. Opera, Cantanti, Orchestra, Coristi e Coriste tutti hanno avuto nelle debite proporzioni il pubblico encomio. I Lombardi del maestro Verdi, lasciano a Lucca indelebil memoria, e grata ricordanza dell’Impresa perché ci fece godere questa musica, e decorò così bene lo spettacolo. Era la prima opera verdiana che i lucchesi potevano ascoltare e sembra proprio che il debutto non avrebbe potuto avere migliore riscontro. Era anche il debutto in Toscana30 e segnò l’inizio di una lunga serie di successi e riconoscimenti. Anche la piccola Lucca aveva riconosciuto nel giovane Verdi – “un Cigno di più” – la nuova promessa della lirica. 1847 La rappresentazione del Macbeth al Teatro del Giglio nella stagione di ‘estate in autunno’ del 1847 è sicuramente una delle punte di diamante dell’attività di Lanari a Lucca: la prima ripresa dopo la prima assoluta, il 14 marzo, al Teatro della Pergola, con molti interpreti riproposti31, perfino con lo stesso maestro concertatore, Pietro Romani, che aveva assistito 29 «Giornale privilegiato di Lucca politico letterario» XVII/84, 6 ottobre 1843, p. 4. 30 Sembra improbabile che I lombardi alla prima crociata abbia debuttato al Teatro della Pergola di Firenze il 15 settembre 1843, come si legge in De Angelis, Le carte dell’impresario, p. 97: il giorno precedente al debutto lucchese? Un venerdì, giorno di chiusura dei teatri? Con gli stessi interpreti che agivano a Lucca, con un calendario di recite fittissimo? 31Cambiarono gli interpreti principali, Fortunato Gorin invece di Felice Varesi per Macbeth, Rathinka Evers invece di Marianna Barbieri-Nini per Lady Macbeth, ma furono confermati Nicola Benedetti per Banco, Faustina Piombanti per la Dama di Lady Macbeth, Angelo Brunacci per Macduff, Francesco Rossi per Malcolm, e i comprimari Giuseppe Romanelli e Giuseppe Bertini. Codice 602 140 141 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni Giuseppe Verdi nell’allestimento. L’altro titolo verdiano, un’altra novità assoluta per Lucca, era Attila, con un’altra prima donna, la celebre Eugenia Tadolini. Vale la pena di ricordare che: Lanari aveva prodotto le prime assolute sia di Attila (Venezia, La Fenice, 17 marzo 1846) sia di Macbeth (Firenze, Teatro La Pergola, 14 marzo 1847); di conseguenza era proprietario di entrambi gli spartiti; poi ne aveva ceduto i diritti, rispettivamente, all’editore Lucca e a Ricordi. Era in atto una vera guerra tra i principali editori milanesi/italiani, che avevano ormai ben chiaro quale sarebbe stato il futuro dell’opera italiana. Fu grazie all’insistenza, fastidiosissima per Verdi, di Giovannina Lucca che32: […] l’editore Lucca finalmente ha avuta la proprietà di un’opera del signor Maestro, e sarà per quella di Venezia del Carnevale venturo [1845-46]. Egli l’ha acquistata dal Lanari per 13 mila lire austriache. Evidentemente Francesco Lucca, pur di assicurarsi i diritti di un’opera di Verdi, era disposto a “pagare l’opera un anno prima che fosse scritta”33. Anche Giovanni Ricordi, per Macbeth, aveva sottoscritto con molto anticipo il contratto con il figlio di Lanari34: Rilevo dalla cara vostra 7 corr.e che voi avete assunti i contratti che aveva in corso il vostro Sig. Figlio Antonio, e mi invitate a mandarvi una modula di scrittura da rispettivamente firmarsi per il contratto di cessione dell’opera che M.° Verdi, obbligato a scriverla per vostro Figlio nel venturo Carnevale, va invece a scrivere per voi a cod.° I. e R. Teatro della Pergola nella p.a vent.a Quaresima. Mi affretto quindi di rispondervi che voi versate in un innocente equivoco, in quanto che il contratto che voi credete che fosse ancora a stipularsi è già sino dallo scorso anno deffinitivamente conchiuso tra me e vostro figlio, come rileverete dalla copia del contratto stesso firmata dal vostro Figlio che vi compiego. Risulta che Ricordi abbia pagato 16.000 lire35. Su questa stagione così importante la documentazione conservata nell’Archivio storico del Comune di Lucca è assai scarsa, ed è assai difficile, allo stato attuale delle ricerche, ricostruire con precisione l’andamento della stagione. Scarse anche le cronache e le recensioni: le Memorie del Minutoli si interrompono prima del 1847, nella Cronaca di Massimiliano 32 Lettera di Emanuele Muzio del gennaio 1845 a Barezzi, cit. in Budden, Le opere di Verdi, cit., p. 263. 33 Baia Curioni, Mercanti dell’Opera, cit., p. 107. 34 Lettera di Giovanni Ricordi ad Alessandro Lanari del 16 novembre 1846, cit., in De Angelis, Le carte dell’impresario, pp. 228-229; un commento sulla strana concorrenza tra padre e figlio alle pp. 117-8. 35 Baia Curioni, Mercanti dell’Opera, cit., p. 107. Quilici, il Direttore d’orchestra, troviamo soltanto uno stringatissimo giudizio sul Macbeth36: Macbeth esito felicissimo. La Evers Katinka cantava bene ed agiva benissimo quella parte con molta dignità. Gorin [Macbeth] urlava per sistema, per quella Musica però molto adatto il suo sistema. Tutti gli altri facevano del loro meglio. Di parere opposto sulla performance della prima donna, con un timido apprezzamento per la musica, il Provenzali37: Prima rappresentanza dell’opera il Macbeth la musica è buona ma l’esecuzione non è stata felice. La prima donna Madamigella Evers è debole assai. Sul «Giornale privilegiato» solo un annuncio, e nessuna recensione38: Dimani sera 21 agosto (salvo casi impreveduti) si aprirà questo R. Teatro coll’Opera seria Attila, musica del Maestro Verdi, e parole di Temistocle Solera. Cantano in quest’Opera la sig. Eugenia Tadolini, ed i sigg. Nicola Benedetti, Fortunato Gorin, Angelo Brunacci, Francesco Rossi, Giuseppe Romanelli. Si avranno 32 coristi di ambo i sessi e 40 comparse. La sig. Tadolini canterà per 12 sere, l’ultima delle quali sarà il 14 settembre. Il Biglietto serale per le sere in cui Ella canta è di Paoli tre. Per seconda Opera si avrà il Macbeth parole di sig. Piave e musica del Maestro Verdi. La prima donna sarà la sig. Kathinka Evers, seconda donna Faustina Piombanti. Il Biglietto serale sarà secondo il consueto di Paoli due. Del resto erano gli ultimi giorni, tumultuosi, del governo del duca Carlo Lodovico di Borbone, che di lì a poco avrebbe abdicato. Qual era lo spettacolo di punta per l’impresario? L’ultima creazione di Verdi, quella che è ritenuta “una realizzazione sbalorditiva”39, o l’Attila, che vedeva nel cast una stella di prima grandezza, tanto da consentire un aumento del prezzo del biglietto serale? È un po’ insolito che fossero state scritturate due prime donne: forse si era ritenuto che la Tadolini non fosse l’interprete adatta al ruolo di Lady Macbeth. A questo riguardo non si può fare a meno di ricordare la famosa lettera di Verdi del novembre 184840: La Tadolini ha troppo grandi qualità per fare quella parte! […] La Tadolini ha una figura bella e buona, ed io vorrei Lady Macbeth brutta 36 Massimiliano Quilici, Cronaca delle rappresentazioni date nei teatri di Lucca dall’anno 1771 al 1887, Archivio di Stato di Lucca, Dono Pellegrini, 15, ad annum. 37Provenzali, Memorie, tomo VII, c. 2438v, 30 agosto. 38 «Giornale privilegiato di Lucca politico letterario» XXI/67, 20 agosto 1847, p. 4. 39 Budden, Le opere di Verdi, cit., p. 334. 40 Citata in Budden, Le opere di Verdi, cit., pp. 294-295. Codice 602 142 143 Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” Gabriella Biagi Ravenni e cattiva. La Tadolini canta alla perfezione; ed io vorrei che Lady non cantasse. La Tadolini ha una voce stupenda, chiara, limpida, potente; ed io vorrei in Lady una voce aspra, soffocata, cupa. La voce della Tadolini ha dell’angelico; la voce di Lady vorrei che avesse del diabolico. Della presenza della Tadolini, e dello ‘sfruttamento’ di tale presenza, è rimasta una testimonianza assai curiosa e inusuale, ovvero l’esistenza di due libretti diversi dell’Attila, entrambi stampati a Lucca nel 184741. Diverso il formato, aggiunto in uno dei due il nome del Direttore dei Cori, Angelo Pelliccia, diverso il testo! Nella Scena 1 del I Atto, il testo dell’aria di Odabella Oh! nel fuggente nuvolo non sei tu padre impresso?... cielo! Ha mutato immagine! Il mio Foresto è desso. Sospendi, o rivo, il murmure, aura, non più fremir, ch’io degli amati spiriti possa la voce udir. è sostituito da Oh! nel fuggente nuvolo Cupa e fatal mestizia In questo core ha stanza, qual entro un’urna gelida, qui muta è la speranza. Del viver mio son l’ore, contate dal dolore; conforto ne’ miei gemiti, trovo al penar soltanto, e il pianto, ancor il pianto è grave error per me. Segue poi una scena 2 interpolata, con l’ingresso di Uldino e un brevissimo scambio di recitativo tra i due, che consente a Odabella di intonare 41ATTILA / DRAMMA LIRICO IN UN PROLOGO E TRE ATTI / Parole / DI TEMISTOCLE SOLERA / MUSICA / DI GIUSEPPE VERDI / DA RAPPRESENTARSI / NEL REGIO TEATRO DEL GIGLIO / nella stagione d’estate in autunno 1847 / LUCCA / PER G. ROCCHI TIP. DEI RR. TEATRI, in Archivio di Stato di Lucca, Dono Pellegrini, libretti, n. 178. Due gli esemplari con l’innesto di cavatina e cabaletta dalla Maria di Rohan: ATTILA / DRAMMA / LIRICO IN UN PROLOGO E TRE ATTI / Parole / DI TEMISTOCLE SOLERA / MUSICA / DI GIUSEPPE VERDI / DA RAPPRESENTARSI / NEL R. TEATRO DEL GIGLIO / nella stagione / d’estate in autunno 1847 / LUCCA / PRESSO GIACOMO ROCCHI / TIP. DEI RR. TEATRI, in Archivio di Stato di Lucca, Dono Pellegrini, libretti, n. 179 e in Biblioteca Statale di Lucca, Legato Domenici, 43/22. Ben fu il giorno avventurato che a conoscerti imparai: nobil cor. Che tanto amai, non invan fidava in te. Perché farti almen beato d’un accento non poss’io! Ma un arcano l’amor mio dee restar tra il Cielo e me. Un innesto vero e proprio – quasi un’aria di baule – che altro non è che la parte conclusiva dell’Introduzione (n. 1 del I Atto), precisamente Cavatina e Cabaletta della Cavatina, della Maria di Rohan di Donizetti. La Tadolini era stata la creatrice del ruolo eponimo della Maria di Rohan a Vienna, nel 1843. La scena si conclude con la frase di Odabella: “Qual rumor di passi”, che nel libretto originale prelude all’ingresso di Foresto: si riprende così la vicenda ma, nell’aggiustamento, si sono dimenticati di far uscire Uldino. Qual è il libretto che acquistarono i lucchesi, quello ‘normale’ o quello con l’innesto? Forse il secondo, considerata l’aggiunta del nome del direttore dei cori. Da sottolineare il fatto che in entrambi compaia, nella pagina a fronte dell’elenco di personaggi e interpreti, una sorta di copyright: Il presente libretto, essendo di esclusiva proprietà del Signore FRANCESCO LUCCA, come venne annunciato nella Gazzetta Privilegiata di Milano (28 Marzo 1846) restano diffidati i signori Tipografi di astenersi dalla ristampa dello stesso senza averne ottenuto il permesso dal succitato editore proprietario. Entrambe le ristampe erano state autorizzate? O il tipografo Rocchi inseriva la dicitura a propria tutela, ovviamente su indicazione dei responsabili? Se veramente Eugenia Tadolini cantò queste arie, il pubblico ebbe la possibilità di avere un assaggio dell’opera che non fu mai rappresentata a Lucca in quegli anni. Non è stato invece reperito il libretto dell’allestimento lucchese del Macbeth. Una digressione e un’ipotesi: il 31 agosto 1844, pochi giorni dopo il debutto lucchese di Ernani (27 agosto) Lanari scrive alla Deputazione giustificando la mancata consegna del libretto42: […] nemmeno per l’Ernani avrei deviato dal mio sistema [di consegnare i libretti all’autorità, anche se non obbligato], se i libretti di detta opera fossero stati stampati per mio conto: i pochi però che sono venuti qui sono stati rimessi dallo stampatore di Firenze S.r Galletti, al quale ne compete il provento: e d’altronde non poteva farne eseguire 42 Lettera di Lanari, 31 agosto 1844, in Teatro del Giglio, busta 13 (1844), n. 180. Codice 602 144 145 Gabriella Biagi Ravenni io la ristampa, essendosi riserbato il diritto di proprietà il S: Ricordi di Milano, che da colà rimise a Firenze un numero di copie dei detti libri, che io dovetti cedere al detto Galletti, in forza di un precedente contratto esistente fra di noi. Questo ho voluto esporre nel desiderio che sia noto non esservi mancanza dal canto mio; che del testo per mostrare che fino al termine della mia Impresa desidero di usare a S.E. il Ministro dell’Interno, ed alle altre Autorità quei riguardi che ho usato fin qui, ho acquistato tre libretti che rimetto alle SS.LL. Ill.me pregandole a volerne fare la trasmissione. Sembra di poter dedurre che non era stata mandata in stampa una tiratura speciale per Lucca (anche la ricerca di questo libretto non ha dato risultati). Dato che anche il libretto della prima assoluta fiorentina di Macbeth fu stampato da Galletti, potrebbe essersi ripetuta la stessa situazione. Forse in certi casi, per l’intrico dei diritti fra impresari, editori e stampatori, si stava passando alla prassi di usare libretti generici. Il progetto della stagione di estate in autunno era stato inviato da Lanari il 18 marzo 1847 (negli stessi giorni in cui il Macbeth andava in scena a Firenze)43: Darò due Opere, cioè per prima o L’Attila, o i Foscari del Maestro Verdi; e per Second’Opera Macbeth dello stesso Maestro, ed offro li seguenti Artisti Prima Donna = Kathinka Evers Primo Tenore = Angelo Brunacci Primo Baritono = Gorin Fortunato Primo Basso = Nicola Benedetti con le occorrenti seconde Parti. Prime verdiane al Teatro del Giglio. “Gloria al Lanari” etc. attualmente ancora nella Grand’Opera Macbeth espressamente dal Verdi per Lui Scritta qui alla Pergola ottiene un generale incontro [nella parte di Macduff] motivo per cui su queste Basi io le ne ho fatta la proposta nell’intimo convincimento di offrirle cosa pienamente decorosa anco riguardo all’esecuzione dei proposti artisti. Nell’imminenza dell’andata in scena Lanari fa un’esplicita richiesta alla Deputazione45: Avendo partecipato al S.r M.° Massimiliano Quilici la disposizione presa di andare in scena quasi contemporaneamente colle due opere Attila [in effetti 21 agosto] e Macbet [29 agosto] che devono esser prodotte in questo R. Teatro del Giglio, Egli, non volendo assumere una troppo gravosa responsabilità, mi ha pregato di affidare al S.r M.° Romani da me qui condotto per la messa in scena del Macbet, anche la direzione delle prove d’orchestra dell’opera stessa, tanto più che sono già state fatte da Lui quelle di cembalo a Firenze. Il detto M.° Romani, amico anche del S.r Quilici ha assunto di buon grado un tale impegno. Ed io mi rendo sollecito di darne analoga partecipazione alla R Deputazione onde voglia sanzionare una tale disposizione, mercé la quale si otterrà di mandare in scena la citata opera il Macbet con quella sollecitudine che è necessaria. Tutto questo fa intravedere molti motivi di interesse e di curiosità: è assolutamente plausibile che l’allestimento scenico e la concertazione siano stati preparati con il massimo impegno e che Romani e Lanari46 abbiano trasferito sul palcoscenico lucchese l’esperienza fondamentale della prima assoluta, curato quasi maniacalmente, come si sa, da Giuseppe Verdi. Nella lettera successiva, del 24 marzo, Lanari, oltre a cercare di ottenere una dote più cospicua, difende anche la qualità degli artisti proposti, che era stata messa in dubbio dalla Deputazione44: Mi reca specie poi le eccezioni che Lei rileva sugli Artisti da me nominati giacchè oltre il merito positivo hanno un credito in Professione de migliori poiché la Evers, è stata preferita per la gran Fiera a Senigallia ove trattasi di una esigenza Somma, e che vi è una Dote di Scudi 5000 e che ora è stata prescelta pel R. Teatro della Corte di Berlino. Il Baritono Gorin è di primo Cartello conosciuto ai RR: Teatri di Torino con gran successo, Trieste la Gran Fiera di Reggio la Pergola ove ora [lacuna per taglio dell’originale] Opera l’Attila ove per la terza volta vi si è prodotto con sempre maggiore successo, e finalmente il Tenore Brunacci, che dopo aver percorso li Teatri di Milano, Torino, Russia 43 Lettera di Lanari, 18 marzo 1847, in Teatro del Giglio, busta 16 (1847), n. 46. 44 Lettera di Lanari, 24 marzo 1847, in Teatro del Giglio, busta 16 (1847), n. 49. 45 Lettera di Lanari, 16 agosto 1847, in Teatro del Giglio, busta 16 (1847), n. 147. La Deputazione si premurò di scrivere al riguardo al Quilici. 46 La cura di Lanari per la corretta composizione dell’orchestra al Teatro del Giglio si ricava da una sua supplica al Duca di Lucca Carlo Lodovico di Borbone in cui chiede di potersi avvalere dei timpani in dotazione della banda del reggimento del Duca: De Angelis, Le carte dell’impresario, cit., p. 120. Codice 602 146 147 Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Duecento anni fa nasceva Giuseppe Verdi, ma veniva al mondo anche colui che avrebbe generato quel Giacomo Puccini destinato a divenirne il successore. Michele, quarto discendente della dinastia dei Puccini, nacque a Lucca il 27 novembre 1813 e, come i suoi antenati, dopo gli studi a Bologna e a Napoli, ricoprì l’incarico di organista della Cattedrale ma svolse anche un’intensa attività compositiva e didattica. Fu proprio nel nostro Istituto, fondato nel 1842 da Giovanni Pacini, che Michele Puccini divenne prima ispettore onorario, poi insegnante di composizione ed infine direttore, incarico che tenne fino alla morte prematura avvenuta a soli cinquantuno anni il 23 gennaio 1864. Nel giorno dei funerali Giovanni Pacini tenne un’orazione funebre, successivamente data alle stampe, nella quale ripercorreva la vicenda umana e professionale dello scomparso e, dimostrandosi buon profeta, presagiva un luminoso futuro artistico per il figlio Giacomo. In quest’anno, così ricco di anniversari, ci limitiamo a celebrare questo duecentesimo dalla nascita pubblicando la riproduzione dell’orazione di Pacini; il prossimo anno, nella ricorrenza del centocinquantesimo dalla sua morte, torneremo a dedicarci con maggiore attenzione a questo musicista che merita di essere adeguatamente ricordato, oltre che per essere stato il padre di Giacomo, anche e soprattutto per la sua attività di compositore e didatta. Codice 602 149 Giulio Battelli Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Codice 602 150 151 Giulio Battelli Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Codice 602 152 153 Giulio Battelli Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Codice 602 154 155 Giulio Battelli Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Codice 602 156 157 Giulio Battelli Giovanni Pacini ne’ funerali di Michele Puccini Codice 602 158 159 La tesi di laurea di Il primo movimento del Concerto op. 61 F. Kalkbrenner come possibile modello per il primo movimento del Concerto op. 11 di F. Chopin di Giovanni Giannini Chopin nasce nel 1810 e la sua breve vita si svolge in quello che viene spesso definito periodo biedermeier1. È inevitabile quindi che i suoi primi numeri d’opera, fra cui i suoi due concerti per pianoforte, si rifacciano, nello stile e nella forma, proprio alle pagine pianistiche che spopolavano nei salotti della Restaurazione. L’aspirazione del giovane Chopin era infatti diventare un concertista e guadagnarsi da vivere in tal modo. In Polonia, negli anni più importanti per la sua formazione musicale, egli si era nutrito di classicismo viennese (Haydn, Mozart, Beethoven) e di biedermeier appunto, stile a cui ogni compositore-esecutore del primo Ottocento doveva adeguarsi se voleva intraprendere una carriera di suc1 Per comodità faremo spesso ricorso nel testo al termine biedermeier, riferendoci con ciò a quei pianisti-compositori che operano nei primi decenni dell’Ottocento. In realtà alcuni di essi continuano ad essere presenti sulla scena musicale anche nel periodo romantico vero e proprio ma lo spirito reazionario e conservatore che li contraddistingue non ci permette di considerarli musicisti romantici. Il pianista biedermeier infatti non aspira a rivoluzionare il mondo ma anzi accetta la realtà così com’è, cercando di trarne il maggior profitto possibile. Egli è un artista di successo, un virtuoso itinerante oltre che un insegnante ben remunerato. Di conseguenza in musica egli ha un atteggiamento conservatore e non mira a stravolgere le forme del periodo classico. Si tratta spesso di una musica rassicurante, di facile intrattenimento per il pubblico e che più che a commuovere mira a stupire l’ascoltatore L’estetica biedermeier deriva direttamente dalla crisi di valori manifestatasi con il venir meno degli ideali rivoluzionari prima e con la caduta dell’Impero napoleonico poi. Essa è ben esemplificata dalla mediocrità borghese del Signor Biedermeier, personaggio inventato da Samuel Friedrich Sauter (1766-1846), le cui storie apparvero su un settimanale satirico e umoristico di Monaco, i “Fliegende Blätter”. Il Signor Biedermeier esemplifica al meglio la sensibilità piccolo-borghese del periodo della restaurazione, l’uomo qualunque che si accontenta di poco, è dedito agli affetti casalinghi e la cui sicurezza deriva, più che dallo sfarzo e dal lusso, dal semplice decoro (tutto ciò in contrapposizione agli eccessi del cosiddetto Stile Impero). In musica quindi il biedermeier privilegia un’estetica fatta di certezze e brillante esteriorità e che meglio rappresenti ciò che è quotidiano e domestico. Occorre infine aggiungere che nella pubblicistica italiana Piero Rattalino è stato uno dei primi, se non il primo ad usare il termine biedermeier (si veda ad esempio il suo volume Storia del pianoforte, Milano, Il Saggiatore, 1982). Codice 602 163 Giovanni Giannini cesso. In conseguenza di ciò era imprescindibile per l’aspirante giovane pianista-compositore avere tra i propri numeri d’opera un certo numero di pezzi con accompagnamento orchestrale (poco importa se in un ruolo soltanto di accompagnamento). La sua op. 2, composta nel 1827, rappresenta proprio una delle forme predilette del periodo, le Variazioni per pianoforte e orchestra sul ‘Là ci darem la mano’ dal Don Giovanni di Mozart, seguite nel 1828 dalla Grande fantasia su arie nazionali polacche op. 13 (la quale rientra nel genere del pot-pourri su melodie popolari assai in voga in epoca biedermeier) e dall’op. 14, Krakowiak. Gran Rondeau de Concert in Fa maggiore. Sono opere in cui il pianoforte è protagonista assoluto, mentre l’orchestra, sottomessa e reverente come nel coevo melodramma italiano, gli fa da cornice, lo asseconda e lo sostiene senza mai insidiarne il primato. Chopin ha inoltre in repertorio due concerti per pianoforte e orchestra, il celeberrimo Concerto in Mi minore op. 11 (1830) e quello in Fa minore op. 21 (in realtà composto prima del suo Concerto n. 1, tra il 1829 e il ’30). Si tratta, in entrambi i casi, di concerti che si conformano pienamente all’estetica del concerto biedermeier e ne suggellano la grande stagione che di lì a poco, con Thalberg e Henselt, entrerà in crisi. La nascita di questo tipo di concerto affonda le proprie radici nell’ultimo decennio del Settecento che vede la fine dell’Ancien régime e la graduale nascita di una classe professionale e commerciale, con conseguente fine del mecenatismo legato all’arte, tipico dell’epoca classica. In questo periodo infatti, si pongono le basi per la nascita di una nuova figura di musicista, non più al servizio di un nobile protettore ma indipendente e versatile, capace di combinare il proprio sapere musicale con una conoscenza pratica e a volte spregiudicata del mondo degli affari. È soprattutto in paesi come la Francia rivoluzionaria e l’Inghilterra democratica, prima ancora che in Austria o in Germania, che si assiste alla rapida crescita di un pubblico borghese ed alla conseguente nascita e proliferazione di concerti pubblici a pagamento, di cui il musicista stesso è l’organizzatore che se ne assume così anche gli oneri ed i possibili rischi finanziari. In questo mutato contesto sociale la musica strumentale cessa infatti di essere appannaggio dell’aristocrazia e della classe alto-borghese, esce dai salotti e diventa un fenomeno di grande diffusione ed il concerto per pianoforte diventa la prova suprema dell’abilità del pianista compositore, quasi il lasciapassare per il successo dell’artista che ormai è diventato un virtuoso internazionale itinerante. Fra le varie forme strumentali il concerto per pianoforte e orchestra è quindi quello che più di ogni altra forma è stato influenzato e condizionato da particolari elementi di ordine sociale e culturale, soprattutto nel periodo compreso fra il 1790 e la fine degli anni Trenta del 1800. La sua funzione diventa, infatti, sempre più legata alla promozione ed all’affermazione del pianista compositore presso il nuovo pubblico borghese, ancora privo degli strumenti per ap- Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner prezzare la musica strumentale e di cui il virtuoso deve accaparrarsi lo stesso consenso riservato alle già collaudate rappresentazioni del melodramma. Tipica del musicista biedermeier è quindi la sua propensione ad andare incontro alla richiesta di questo nuovo pubblico che vuole essere strabiliato più dalla bravura tecnica e dai passaggi sempre più virtuosistici che dalla sostanza musicale vera e propria. In questa ottica il concerto solistico si pone quindi come forma principe per il raggiungimento degli scopi del pianista. Esso viene presentato nell’accademia e ne diventa gradualmente parte così importante che l’accademia stessa finirà per chiamarsi semplicemente concerto, proprio in virtù del concerto solistico che in essa viene eseguito. Il concerto per pianoforte si dimostra inoltre un mezzo adatto all’esplorazione delle possibilità del nuovo strumento pianoforte, migliorato e perfezionato nella meccanica, nell’estensione e nel volume sonoro, e diventa una sorta di fucina per la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche e passaggi sempre più audaci2. In questo periodo dunque nasce e prende forma il concerto biedermeier. Esso passa dalle opere di Dussek e Cramer, ancora in parte legati a concezioni mozartiane-beethoveniane, acquista la sua fisionomia con i lavori di Steibelt e Field e raggiunge il suo massimo sviluppo con Hummel, Moscheles, Ries e Kalkbrenner. Si tratta di una copiosa produzione concertistica di cui non rimane pressoché traccia nell’odierno repertorio pianistico, se si eccettuano i due concerti di Chopin e il Concertstück di Weber, che comunque va in tutt’altra direzione rispetto alla tipica forma del concerto biedermeier. Si tratta spesso di lavori di uomini il cui talento di pianisti è di gran lunga superiore a quello di compositori, ma che cionondimeno contribuiscono enormemente allo sviluppo della tecnica strumentale e renderanno possibile, a partire dagli anni Trenta, il graduale emergere del concerto romantico vero e proprio3. Per contrasto il modo in cui questi musicisti di primo Ottocento si avvicinano alla forma è tutt’altro che audace. Essi si accontentano di utilizzare le convenzioni della forma classica, spesso senza capirne le implicazioni. Anche quando si spingono ad esplorare nuovi territori dell’armonia, l’ordine costituito della sintassi armonico-tonale vi è turbato solo in superficie e viene ripristinato quanto prima4. La forma del concerto biedermeier è mutuata infatti dal concerto classico (mutuata a sua volta dalla forma a 2 Occorre precisare, comunque, che tale sperimentazione rimane sempre nei limiti della tecnica clementina, sebbene portata al massimo grado di sviluppo, e che la vera novità in campo pianistico sarà rappresentata dagli Studi di Chopin e dalle composizioni di Liszt. 3 Non a caso il loro tipo di concerto viene da alcuni definito “protoromantico”. Cfr. John A. Meyer, Il concerto, in Storia della musica, pp. 228-278, The New Oxford History of Music, L’età di Beethoven, Feltrinelli editore, Milano, 1984. 4Cfr. Romanticismo e Biedermeier, p. 79, in Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, EDT., Torino, 1982. Codice 602 164 165 Giovanni Giannini ritornello del concerto barocco) ma non è più basata sul concetto dell’unitarietà tematica (l’Einheit austro-tedesca), sullo sviluppo dei temi e sul fitto e costante dialogo fra solista e orchestra. La forma è piuttosto basata su contrasti di sonorità ed una tipica opposizione fra momenti di lirismo e sezioni di pura tecnica virtuosistica in una scrittura, diremmo, quasi a blocchi contrastanti. Essa si cristallizza, diventa rigida, quasi una cornice all’interno della quale ci si aspettano ben precisi momenti di lirismo o di vertigine acrobatica, con chiari riferimenti al teatro e al balletto di cui il concerto si propone la mimesi. Nel concerto biedermeier gli episodi solistici sono quasi sempre sezioni autonome, tematicamente indipendenti e sono in diretta relazione con lo studio; spesso sono puri esercizi tecnici di scarso valore musicale, scritti al fine di mettere in evidenza le qualità di resistenza dell’esecutore, anche se alcuni di essi possono avere un qualche interesse ritmico o melodico. Al fine di ovviare alla monotonia del ripetersi dei passi di agilità l’autore ricorre spesso a modulazioni a tonalità remote come sul sesto grado abbassato (tali interpolazioni sono già presenti in alcuni dei concerti di Dussek). In certi autori (Moscheles, Kalkbrenner, Herz) tali sezioni finiscono con l’occupare la maggior parte dell’esposizione o della ripresa e, in un certo senso, l’episodio solistico finisce per diventare una cadenza in tempo5. La scrittura pianistica inoltre tende a coprire l’intera gamma sonora del pianoforte; una tastiera sempre più estesa infatti stimola il compositore a creare passaggi che la esplorino nella sua interezza. Tutto ciò unito all’uso pressoché costante del pedale di risonanza fa sì che il pianoforte riesca quasi a sostituire il ruolo dell’orchestra, sempre più relegata in secondo piano e spesso, ad eccezione dei ritornelli, deputata ad una mera funzione di sostegno e di colore. Il dialogo orchestra/solista, tipico dell’età classica, non è presente nel concerto biedermeier. Tutto ciò è dovuto soprattutto al mutamento della sua natura ed alla sempre maggiore attenzione data all’aspetto virtuosistico del pianista; ma dietro a questa tendenza vi sono anche motivi di ordine pratico. Non sempre le orchestre erano all’altezza di eseguire il concerto con poche prove o addirittura con una sola prova come accadeva il più delle volte e, se le condizioni economiche non ne permettevano la presenza, si doveva poter eseguire il concerto anche in assenza di orchestra. *** Il Primo concerto per pianoforte e orchestra in Re minore op. 61 di Kalkbrenner fu composto presumibilmente nel 1823 a Londra e pubblicato nello stes5 Tipica del concerto biedermeier è, infatti, l’abolizione della cadenza, posta di solito, nel concerto classico, poco prima della fine del primo movimento prima della ripresa del tutti orchestrale. Di essa evidentemente non si sente più il bisogno in quanto il pianista a quel punto ha già dato prova sufficiente delle proprie capacità virtuosistiche. Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner so anno a Parigi dall’editore Aulagnier con il titolo Premier grand concerto pour le piano-forte avec accompagnement d’orchestre. Le sue mirabili proporzioni e lo sviluppo al massimo grado della tecnica clementina che ne sta alla base lo renderanno un punto di riferimento per i concerti del decennio successivo. Esso fu eseguito per la prima volta a Londra il 5 maggio 1823, nell’ambito della stagione dei concerti della Società Filarmonica con grande successo di pubblico e di critica6. La stessa Frau Moscheles, presente al concerto, ne attesta il successo anche se non manca di precisare che Kalkbrenner aveva suonato gratis cosa che suo marito, anche lui invitato a suonare per la stessa occasione, aveva rifiutato7. Il concerto rappresenta un punto di svolta nella carriera di Kalkbrenner e ne farà uno dei pianisti più importanti dell’epoca, insieme ad Hummel, Field e Moscheles. La critica apparve unanime nel giudizio più che positivo tanto sull’opera in sé che sulla esecuzione di Kalkbrenner. In una recensione apparsa su «The Quarterly Musical Magazine and Review» del 1823 il recensore loda in primis la qualità di scrittura dell’introduzione orchestrale che definisce superba; aggiunge inoltre che “la competenza e la maestria compositiva dell’autore è repressa dall’autore stesso in quanto l’opera è dedicata principalmente al suo strumento”8. A proposito poi della conclusione del primo assolo scrive che “per farsi un’idea dell’effetto che produce esso deve essere eseguito dalla mano di un pianista di prim’ordine”. Dell’ultimo assolo del movimento dice poi che quando si pensa che tutto quello che è umanamente possibile eseguire sia già stato eseguito e il pubblico si aspetta ormai la conclusione, con un abile e appropriato passaggio di transizione l’esecutore si getta in una nuova serie di ardui passaggi, che superano in difficoltà quelli già ascoltati, e di cui l’immaginazione avrebbe potuto a mala pena intravedere la possibilità. Anche a proposito del terzo movimento il critico fa notare l’abilità di Kalkbrenner nel mantenere inalterata la tensione fino alla fine con una calibrata serie di effetti a sorpresa ed un’abile scrittura a difficoltà crescente. Non manca di aggiungere che in questi passaggi la velocità è l’elemento fondamentale, senza il quale il resto non varrebbe niente. “Descrivere come sono stati suonati certi passaggi è praticamente impossibile. Per rendere onore a questa composizione bisogna che sia Kalkbrenner 6 In tale occasione Kalkbrenner non era solo ad esibirsi. Secondo infatti le usanze dell’accademia egli dovette condividere l’esecuzione del suo concerto con quella dell’aria “Berenice ove sei ?” dall’opera Lucio vero di Niccolò Jommelli. Vedi «Allgemeine Musikalische Zeitung»», XXV, 1823, col. 567. 7 Ignaz Moscheles, Charlotte Moscheles, Aus Moscheles’Leben; nach Briefern und Tagebuechern, Duncker e Humboldt, Leipzig 1872-73, vol. 1, p. 75. 8 «The Quarterly Musical Magazine and Review», vol. V, Londra, 1823, pp. 76-78. Codice 602 166 167 Giovanni Giannini stesso a suonarla”. Conclude infatti dicendo: “Soltanto una mano è in grado di piegare l’arco di Ulisse”. Di uguale tenore la recensione apparsa sulla «Allgemeine Musikalische Zeitung», che fra l’altro sembra essere in parte basata sulle parole del critico inglese, e di cui riportiamo la traduzione9. Il sesto concerto, tenuto il 5 maggio, ci permette di tributare i debiti onori al nostro famoso concittadino, il Signor Kalkbrenner, che vive qui da circa 10 anni e gode di grande e meritato prestigio. A pieno titolo gli conferiamo immediatamente un posto d’onore tra quegli uomini, tra cui Hummel, Moscheles e Field, che in questo periodo hanno dato vita, grazie al loro modo di comporre e di suonare, ad una propria scuola. A loro tempo anche Steibelt e Dussek erano considerati virtuosi ed anche i loro concerti non erano considerati un gioco da ragazzi, ma cosa sono essi a paragone con gli autori su menzionati? Ci sembra che al confronto essi abbiano svolto soltanto un lavoro di preparazione. Dove poi stia il limite della difficoltà estrema, dove si debba tracciare un confine tra ciò che è ulteriormente possibile eseguire e ciò che è puramente impossibile è difficile da stabilire. Se però si prendono in esame i più recenti concerti di questi signori, verrebbe da pensare che siamo già arrivati al non plus ultra. Tutto ciò è dimostrato in particolare dal concerto in Re minore eseguito dal Signor Kalkbrenner il 5 maggio nelle “Argyll Rooms”. A ragione il Signor Bacon scrive che “il concerto potrebbe scoraggiare anche il pianista più temerario e si potrebbe dire che veramente pochi, probabilmente nemmeno una mezza dozzina di pianisti in tutto il paese, sarebbero capaci di eseguire il concerto a soddisfazione dell’autore”. Ascoltare invece la velocità con cui egli stesso suona un più allegro, oppure esegue una serie di trilli o i suoi terribili passaggi di ottave è l’unico modo per rendersi conto di ciò che è veramente possibile eseguire. Senza una simile esperienza nessuno sarebbe in grado di farsene un’idea. Il concerto è stato pubblicato qui e dimostra, insieme a simili pubblicazioni di Hummel e Moscheles, quanto il modo di suonare il pianoforte si sia evoluto anche in questo paese. Nella speranza che venga presto pubblicato anche in Germania sarà opportuno parlare tanto dell’opera stessa quanto della sua esecuzione da parte del Signor Kalkbrenner. Come la maggior parte dei concerti più recenti sarebbe opportuno definirlo una sinfonia per orchestra con pianoforte obbligato. Il concerto è sicuramente dotto ed elaborato con rigore e non si può quindi non riconoscere quanta diligenza l’autore abbia mostrato nella composizione nonostante i molti passi di bravura del solista in cui l’intenzione dell’autore era di dimostrare l’abilità d’esecuzione e non l’arte stessa. L’introduzione orchestrale ha un carattere aulico e solenne e il tema vero e proprio vi viene già anticipato a batt. 22 e trattato abilmente in doppio contrappunto. Anche gli altri tutti sono di grande effetto gra9 «Allgemeine Musikalische Zeitung»», XXV, 1823, coll. 565-567. Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner zie soprattutto ad un appropriato e consono uso degli strumenti a fiato e ci mostrano il talento del maestro per le sinfonie a più voci in cui si era già cimentato con successo in passato. Il primo assolo inizia con un passaggio di ottave ad entrambe le mani in cui il Signor Kalkbrenner, come anche Moscheles, mostra di realizzare l’impossibile e si conclude, per usare la metafora del su citato critico inglese, “come un tuono diviso in due” con due scale cromatiche che si muovono per moto contrario. In questo assolo troviamo anche una catena di trilli dove ad ogni nota l’armonia cambia dando luogo ad una serie di cadenze evitate. Il secondo assolo, che inizia con l’inversione del tema attraverso un passaggio enarmonico, grazie al carattere mite si differenzia in modo molto appropriato dal primo e dal terzo assolo, ed il tema vi riappare in un’altra tonalità. I passaggi difficili e focosi sono quelli che riescono meglio al Signor Kalkbrenner e più ne caratterizzano l’esecuzione, e fra questi il finale è stato sicuramente la parte più eccellente del movimento. Il concerto si compone dei consueti tre movimenti: Allegro maestoso, Adagio di molto e Rondò vivace. Il primo movimento ha un’estensione di 287 battute e, nel complesso, le proporzioni delle varie sezioni, esposizione-sviluppo-ripresa, risultano ben calibrate. Esso è costruito secondo i principi tipici e ormai consolidati del concerto biedermeier e non secondo le regole classiche dell’elaborazione tematica, caratterizzandosi quindi per l’alternarsi di sezioni liriche/maestose e sezioni virtuosistiche e per un tipo di scrittura a difficoltà crescente capace di mantenere inalterato l’interesse dell’ascoltatore fino alla fine del movimento. Come è spesso tipico dei concerti biedermeier il modo prescelto è quello minore, ovvero Re minore, il che conferisce al primo movimento un carattere austero e a tratti cupo. Il concerto si apre con un’introduzione orchestrale di esposizione tematica, seguito dall’entrata solistica che riprende i due temi principali. Seguono poi le code dal carattere brillante e a tratti acrobatico che conducono ad una sezione centrale che potremmo chiamare di sviluppo, ma che manca in realtà di una vera e propria elaborazione del materiale tematico. La ripresa orchestrale è accorciata e ripropone soltanto il primo tema. Nella ripresa solistica il secondo tema non appare nella modalità di impianto bensì nel modo maggiore, scardinando così ulteriormente le regole tonali del concerto classico che vorrebbero anche la ripresa del secondo tema nel modo minore. Il movimento si chiude infine in Re maggiore, con una brillante coda di ben 59 battute costruita su materiale completamente nuovo. L’orchestra è confinata entro limiti ben precisi, ovvero nell’introduzione, all’inizio dello sviluppo, nella ripresa e nel finale. In presenza del solista essa funge da mero accompagnamento e da sostegno armonico, anche se non mancano qua e là alcuni interventi del ‘tutti’ per lo più in funzione modulante o cadenzale. Ricapitolando possiamo quindi dire che in questo primo movimento Codice 602 168 169 Giovanni Giannini Kalkbrenner dimostra la sua assoluta padronanza della tecnica clementina con un uso pressoché sistematico di rapide figurazioni in sedicesimi, scale semplici, doppie, cromatiche e per moto contrario; uso di accordi piuttosto estesi, note ribattute (per le quali pare fosse particolarmente rinomato), ampio uso del doppio meccanismo, con passaggi di terze diatoniche e cromatiche e, naturalmente, tecnica delle ottave in tutte le sue varianti. Partendo dai principi della tecnica clementina Kalkbrenner porta al massimo sviluppo la tecnica digitale e del polso, in ciò aiutato dall’intuizione che è alla base del guida-mani e anche dalle meccaniche del tempo, in cui i tasti avevano una corsa di pochi millimetri. Il suono, secondo tale metodo, deve prodursi solo con l’articolazione del polso e delle dita (sempre perpendicolari al tasto), escludendo così la partecipazione di braccia e avambracci. La posizione della mano, la cosiddetta bella posizione, diventa così di particolare importanza se si vuole suonare con perfetta eguaglianza di tocco ed estrema velocità (il guida-mani veniva decisamente in aiuto dell’allievo che si prefiggeva questi scopi)10. Anche per quanto riguarda l’uso delle armonie, Kalkbrenner si muove sempre entro i limiti della tradizione classica, facendo spesso ricorso a semplici alternanze di I e V grado. I momenti di maggiore tensione armonica sono di solito realizzati con l’uso, spesso indiscriminato, della settima diminuita e dell’accordo di sesta eccedente. L’uso delle modulazioni inoltre spesso non sembra seguire la necessità di creare tensione drammatica o contrasti di carattere espressivo ma si caratterizza piuttosto come un semplice diversivo all’interno delle sezioni virtuosistiche. Si tratta spesso di modulazioni improvvise a tonalità lontane che, con il loro effetto sorpresa, permettono all’autore di rinnovare e prolungare la vertigine motoria e di riportarsi poi alla tonalità principale con un’ascesa cromatica, in un crescendo che accumula tensione e si va a risolvere nella consueta e prolissa serie di trilli finali. *** Il primo Concerto in Mi minore op. 11 di Chopin fu composto fra la primavera e l’estate del 1830 (pubblicato a Parigi nel 1833), quindi sette anni dopo la pubblicazione del Concerto op. 61 di Kalkbrenner. Esso fu presentato al Teatro nazionale di Varsavia l’11 ottobre 1830 in occasione di uno dei concerti di commiato che Chopin tenne nella capitale polacca, prima della sua partenza per Vienna. Il concerto riscosse molto successo in quella occasione, come anche nelle successive esecuzioni a Breslavia, a Vienna, a Monaco e infine a Parigi. Chopin lo suonò per l’ultima volta 10 Tutto ciò ovviamente segna anche il limite della sperimentazione tecnica di Kalkbrenner che si muove comunque entro i confini di una prassi esecutiva già ben codificata e non osa avventurarsi in territori sconosciuti, per i quali dovremo attendere almeno gli Studi op. 10 di Chopin e le ardite composizioni di Liszt. Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner a Rouen il 12 Marzo 1838. Esso segue in realtà di qualche mese il Secondo Concerto in Fa minore op. 21 (pubblicato nel 1836). Con il suo “secondo” concerto in Mi minore egli sembra infatti cercare di adeguarsi all’evoluzione del nascente virtuosismo romantico e in effetti, rispetto al Concerto in Fa minore, esso presenta una tecnica più sviluppata, un virtuosismo più appariscente e una sonorità più robusta, oltre che delle dimensioni molto più ampie. Il Concerto in Fa minore era infatti da alcuni stato criticato per la delicatezza della sonorità, non adatta a grandi ambienti. Chopin, insomma, che si accingeva ad intraprendere una carriera di concertista internazionale, sentiva il bisogno di scrivere un concerto meno “intimista” e più consono alle richieste del nuovo pubblico borghese. I modelli a cui egli si rifaceva erano i concerti degli autori allora più famosi, quali Hummel, Ries, Field e, soprattutto Kalkbrenner, per Chopin allora il primo pianista d’Europa, al quale non a caso il concerto è dedicato11. Non c’è dubbio che molto dello stile lirico e ornamentale dei concerti di Chopin è adombrato nei concerti di Kalkbrenner, in quelli di Field e Ries e, soprattutto, nei Concerti op. 85 e op. 89 di Hummel il quale, forse più di ogni altro, influenzò lo stile musicale di Chopin. Il loro stile si rifaceva a sua volta alla musica tastieristica viennese, specialmente rappresentata da Wagenseil e Mozart e, naturalmente, all’opera italiana, che godeva di un immenso favore popolare. La struttura, l’impostazione generale, la concezione estetica del Concerto op. 11 è la stessa di quella dei concerti per pianoforte degli autori su citati, cui si adegua nella forma, nell’ornamentazione e perfino nella tematica (vi si notano infatti affinità e derivazioni proprio da Hummel e Kalkbrenner). Si tratta insomma a tutti gli effetti di un vero e proprio concerto biedermeier, così come lo abbiamo precedentemente descritto, basato principalmente sul contrasto fra passi lirici e passi a figurazione e non sul principio compositivo dell’elaborazione tematica. Tipicamente biedermeier sono la scelta di non lasciare spazio alla cadenza del pianoforte nel primo tempo, il Larghetto centrale con chiari richiami al mondo operistico, e il ricorso a un finale dai temi popolareschi. Come consuetudine per i concerti dell’epoca il ruolo dell’orchestra è fortemente ridotto e, se si eccettua la lunga introduzione orchestrale e gli altri interventi del tutti fra una sezione e l’altra del movimento, essa è spesso ridotta a mero sostegno armonico o di colore per il solista. Il primo movimento Allegro maestoso (689 misure) ha la struttura generale del concerto classico: dopo un’estesa introduzione orchestrale di esposizione tematica, si divide nelle tre sezioni di consuetudine: esposizione, sviluppo e ripresa. L’esposizione solistica presenta un primo tema principale dal carattere perentorio e vigoroso, subito abbandonato per 11 Kalkbrenner ricambiò dedicandogli le Variations brillantes op. 120. Codice 602 170 171 Giovanni Giannini lasciare posto ad un secondo tema lirico (espressivo), sempre nella stessa area tonale. La parte di transizione fra i due temi principali comincia con un episodio secondario in Mi minore che occupa un’importante porzione dell’esposizione solistica e che conduce poi, attraverso una serie di arpeggi e figurazioni cromatiche ai limiti dell’improvvisazione, all’esposizione del secondo tema in Mi maggiore. La sezione centrale, o se vogliamo di sviluppo, risulta molto estesa e parte da una ripresa leggermente modificata del tema lirico presentato adesso in Do maggiore e subito dopo al relativo minore per poi proseguire in un lungo passaggio virtuosistico in figurazioni di sedicesimi, per lo più basato su una serie di progressioni ascendenti. Si tratta di uno spettacolare episodio solistico che gradualmente cresce in brillantezza ed accumula tensione per raggiungere uno splendido culmine nella ripresa del primo tema da parte dell’orchestra. Anche la ripresa è piuttosto lunga, soprattutto perché il primo tema lirico, con i suoi episodi secondari, vi è ripreso quasi per intero (Chopin omette invece di riprendere, nella parte del solo, il primo tema maestoso del concerto). Le figurazioni del secondo tema, stavolta riesposto in Sol maggiore, sono sostituite da un’ardua coda che ha quasi il carattere dello studio e in cui si ristabilisce la tonalità di Mi minore. Seguono, come in Kalkbrenner, le consuete lunghe battute di trilli seguite da un breve tutti orchestrale in cui viene ripreso il tema iniziale del concerto. Da notare inoltre l’insolita scelta chopiniana di alterare, all’interno del movimento, la tradizionale successione delle tonalità, facendo seguire, nell’esposizione, il primo tema in Mi minore dal secondo nella parallela maggiore e, nella ripresa, facendo riapparire il secondo tema nella tonalità di Sol maggiore, con un mutamento di tonalità davvero poco ortodosso. Per facilitare il confronto formale fra il primo movimento del Concerto op. 61 di Kalkbrenner e quello in Mi minore di Chopin ci siamo avvalsi di una tabella di raffronto fra le varie sezioni che compongono il primo movimento, evidenziando inoltre gli elementi di diversità fra i due movimenti (tabella 1). Come si evince anche da un breve sguardo alla tabella sinottica i due movimenti risultano molto simili da un punto di vista macro strutturale. Entrambi sono infatti costruiti su uno schema formale quasi identico. Ciò che maggiormente differenzia il primo movimento del concerto di Chopin da quello di Kalkbrenner sono le dimensioni generali (689 battute del movimento chopiniano contro le 424 di Kalkbrenner). In particolare sono da evidenziare in Chopin le maggiori dimensioni dell’introduzione orchestrale (134 batt. contro 109), del passaggio di transizione fra i due temi principali (43 batt. contro 19) e soprattutto dello sviluppo (102 batt. contro 68). Si noti inoltre come Chopin, a differenza di Kalkbrenner, si avvalga, all’inizio dell’episodio di transizione, di un ulteriore tema secondario proposto dapprima nella tonalità di impianto e poi in Si minore (batt. 179-193). Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner Altra differenza che salta agli occhi è il diverso trattamento delle tonalità nell’esposizione e nella ripresa dei temi (sicuramente più ortodossa quella di Kalkbrenner). Inoltre, sebbene entrambi decidano di ripresentare il secondo tema in modo maggiore, Chopin opta comunque, con la coda finale, di terminare il concerto in modo minore. Si tratta, insieme alla decisione di scrivere un lungo passaggio di transizione in tono minore, di una differenza non meramente formale in quanto contribuisce notevolmente a lasciare nell’ascoltatore la sensazione aver ascoltato un movimento in modo minore (sensazione che, francamente, in Kalkbrenner scompare quasi subito dopo l’ascolto del primo tema). Un’ulteriore differenza formale la si riscontra nello sviluppo dove Kalkbrenner riprende, a differenza di Chopin, anche il tema principale del movimento su cui elabora le battute 274 e segg. dello sviluppo. Verso la fine dello sviluppo, inoltre, recupera anche un frammento del secondo tema. Da notare inoltre come, sempre nello sviluppo, Kalkbrenner introduca un importante momento lirico con un nuovo tema (dolcissimo, batt. 255 e segg.) e conseguente stabilizzazione tonale in Mi bemolle maggiore (per ben 19 battute). Lo sviluppo di Chopin, al contrario, si caratterizza per un uso pressoché costante di passaggi in figurazione e da un trattamento tonale perennemente modulante (per lo più costruito attraverso progressioni). Sorprendenti invece sono le affinità delle due entrate solistiche dei due movimenti. Es. 1. Kalkbrenner, Concerto op. 61, I movimento (batt. 92-100: entrata del solista) Codice 602 172 173 Giovanni Giannini Es. 2. Chopin, Concerto op. 11, I movimento (batt. 139-146: entrata del solista) Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner compagnamento della mano sinistra, inoltre, è praticamente identico: basso fondamentale sui punti principali dell’armonia quindi una serie di accordi ripetuti nel registro medio della tastiera12. Identico anche l’uso delle armonie, in quanto entrambi i temi sono costruiti su una sequenza armonica di I-II-V. La prima parte del tema, inoltre, viene ripresa, a distanza di quattro battute, sul secondo grado dell’armonia. Si noti come entrambi accumulino grande tensione armonica col permanere del tema su questa armonia per tre battute, per poi risolverla sulla dominante con un rapido passaggio virtuosistico (nel caso di Chopin con una lunga scala per grado congiunto, legatissimo, tipico esempio del suo jeu perlé; la soluzione di Kalkbrenner risulta invece un po’ più articolata e ritmica con una figurazione quasi di tipo violinistico, a salti sempre più ampi sull’armonia della dominante) (ess. 4, 5). Come Kalkbrenner anche Chopin costruisce la prima esposizione sul tema principale esposto dall’orchestra. Entrambe sono molto affermative, imponenti, con uso di accordi, ottave, figurazioni cromatiche in sedicesimi e lunghi arpeggi, con figure ritmiche sempre più veloci, che coprono gran parte dell’estensione della tastiera (ess. 1, 2). In entrambi gli autori l’entrata solistica è formata da due frasi staccate (caratteristica del resto anche di altri concerti del primo Ottocento, vedi es. 3): la prima comincia alla tonica e termina sulla dominante; la seconda sulla sottodominante e termina alla tonica. Entrambe terminano su una cadenza perfetta cui segue immediatamente il tema lirico (nel caso di Chopin, già presentato dall’orchestra nell’introduzione). Es. 4. Kalkbrenner, Concerto op. 61, I movimento (batt. 105-113: primo tema lirico) Es. 3. J.N. Hummel, Concerto n. 4 op. 110: prima esposizione del solo Entrambi i temi lirici sono di chiara ispirazione violinistica ed hanno il medesimo carattere espressivo (melanconico scrive Kalkbrenner, espressivo in Chopin) e sono presentati nel registro sovracuto della tastiera. L’ac- 12 Come giustamente nota Hans Nautsch, tale tipo di scrittura pianistica era già stata ampiamente collaudata da Hummel nel suo Concerto op. 85, come da altri autori suoi contemporanei e deriva molto probabilmente dalla pratica di accompagnamento orchestrale del teatro d’opera. Cfr. Hans Nautsch, Friedrich Kalkbrenner. Wirkung und Werk, Amburgo, 1982, p. 128. Codice 602 174 175 Giovanni Giannini Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner Es. 7. Chopin, Concerto op. 11, I movimento (batt. 385-389: sviluppo) In comune ad entrambi i concerti si nota l’esteso uso di trilli alla fine dell’esposizione e della ripresa (ma non alla fine dello sviluppo). Si tratta, come tipico di molti concerti dell’epoca, di svariate battute di trilli semplici e doppi accompagnati da passaggi in ottave alla mano sinistra che si spostano sui vari registri della tastiera muovendosi sui gradi dell’accordo di settima di dominante (es. 8). Es. 5. Chopin, Concerto op. 11, I movimento (batt. 155-162: primo tema lirico) Ma le analogie tematico-strutturali non finiscono qui. All’inizio dello sviluppo, dopo un breve intermezzo orchestrale, sia Chopin che Kalkbrenner riprendono in tonalità maggiore una versione leggermente modificata del tema lirico, ed in entrambi i casi sul sesto grado della tonalità di impianto: Chopin in Do maggiore, Kalkbrenner in Si maggiore (tonalità sicuramente più lontana dall’impianto tonale, rispetto a quella scelta da Chopin). Notiamo quindi come i due temi lirici ripresi nello sviluppo si collochino in rapporto di terza rispetto all’impianto tonale del concerto (ess. 6, 7)13. Entrambi i concerti presentano inoltre una ripresa accorciata: l’orchestra ripropone infatti solamente la parte iniziale del primo tema mentre l’entrata solistica della ripresa lo tralascia completamente e passa direttamente alla riesposizione del primo tema lirico. I due movimenti, infine, si concludono con poche trionfali battute del tutti che riprendono brevemente il primo tema del concerto. Es. 6. Kalkbrenner, Concerto op. 61, I movimento (batt. 239-242: sviluppo) 13 Anche in questo caso Nautsch fa notare come questo uso tonale in rapporto di terza si rifacesse alla prassi dell’epoca. Cfr. Nautsch, op. cit., p. 27. Es. 8. J.N. Hummel, Concerto op. 85 in La minore: passaggio di trilli alla fine dello sviluppo Analogo è anche il trattamento dell’orchestra nei due concerti, il cui ruolo è per lo più relegato all’introduzione, ai momenti di passaggio fra una sezione e l’altra del concerto e, naturalmente, alla conclusione del movimento. In generale non vi sono esempi di dialogo fra solista e orchestra o del solista che accompagna l’orchestra. Va comunque notato però che Chopin assegna anche riferimenti tematici all’orchestra nelle sezioni di sviluppo e, nell’esposizione del secondo tema del primo movimento, egli combina un assolo di corno con il pianoforte. Appurate le affinità tematico-strutturali dei due concerti, non possiamo certo non accennare a quelle che invece sono le sostanziali differenze di scrittura fra le due opere. In primo luogo notiamo come Chopin, a differenza di Kalkbrenner, riesca a dare bellezza melodica ed intensità espressiva anche ai passaggi di transizione e a quelli più prettamente virtuosistici. Con Chopin il passo a figurazione diviene elemento costruttivo, Codice 602 176 177 Giovanni Giannini ricco di contenuti musicali; esso viene melodizzato, si riempie di espressività e diviene il filo conduttore del movimento (es. 8). In altre parole non appena Chopin lascia i temi e comincia a ricamare arabeschi si apre un mondo tutto nuovo nel quale sparisce il mondo brillante e un po’ scontato dei suoi predecessori che sa solo di bravura tecnica. Le figurazioni, insomma, non sono usate da Chopin come elemento accessorio o di collegamento, ma come base della concezione melodica e armonica assieme (e questo può essere ricondotto alla influenza che Bach ebbe sulla sua formazione musicale). Tutto ciò è particolarmente evidente se si osserva la lunga sezione solistica di figurazione che comincia a battuta 416 (es. 9). Essa è in realtà uno spettacolare episodio solistico che gradualmente cresce in brillantezza ed esaltazione e raggiunge uno splendido culmine nella ripresa del primo tema da parte dell’orchestra14. Es. 9. Chopin, Concerto op. 11, I movimento (batt. 179-183: episodio secondario) Es. 10. Chopin, Concerto op. 11, I movimento (batt. 416 e segg.: sviluppo, passaggi in figurazione) Notiamo inoltre come Chopin, alla fine dei temi principali, invece di passare direttamente ai passi virtuosistici, tenda invece a prolungare il momento lirico con ulteriori episodi secondari di particolare intensi- Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner tà drammatica. Potremmo dire anzi che, laddove finiscono i temi veri e propri, cominciano quegli episodi secondari che sono veramente l’anima dell’intero concerto e in cui Chopin dà il meglio di sé. La differenza fra i due movimenti va inoltre ricercata, oltre che nella più alta qualità musicale di Chopin, nella scrittura pianistica, con particolare riferimento alle innovazioni tecniche che Chopin apporta nel suo concerto. Esse si richiamano chiaramente ai suoi contemporanei Studi op. 10 di cui, nel Concerto op. 11, Chopin allenta comunque il rigore virtuosistico15. Abbiamo già visto come Kalkbrenner si muova all’interno di una tecnica tradizionale ben collaudata, quella clementina da cui anche Chopin indubbiamente parte, per allargare però la sua paletta a soluzioni tecniche e ad un tipo di scrittura pianistica che la superano di gran lunga. Lo stesso Kalkbrenner di ciò doveva essere cosciente se, all’ascolto del concerto di Chopin, nota come esso sia ricco di novità tecniche. Citiamo ad esempio l’uso di diteggiature “rivoluzionarie” come il passaggio del quarto dito sul quinto, l’uso disinvolto del pollice e del mignolo sui tasti neri e la scrittura in ampi arpeggi che oltrepassano l’ottava. Riguardo poi alla tesi principale del presente lavoro, ovvero se il Concerto op. 61 di Kalkbrenner possa essere servito da modello per il Concerto op. 11 di Chopin, possiamo fare le seguenti considerazioni finali. Innanzi tutto occorre dire che sicuramente lo stile musicale, il linguaggio di Chopin ed in particolare quello dei suoi concerti, non poteva non essere influenzato dai compositori allora più in voga, quali Hummel, Field, Spohr e, naturalmente, lo stesso Kalkbrenner. In realtà il suo linguaggio risulta particolarmente influenzato dalla scrittura di Johann Nepomuk Hummel, tanto che sarebbe difficile immaginare come sarebbe stata la musica di Chopin se costui non avesse conosciuto l’opera di questo suo predecessore16. I Concerti in La minore op. 85 e in Si minore op. 89, che Chopin conosceva molto bene, sono molto simili a quelli di Chopin per quanto riguarda l’architettura dei movimenti, la scrittura orchestrale, il trattamento della linea melodica ed il tipo e la frequenza dell’ornamentazione. Ciò nonostante, alla luce delle osservazioni e delle forti affinità che abbiamo esposto nel presente capitolo, ci sentiamo di poter ragionevolmente affermare che, per quanto riguarda il Concerto op. 11, il modello di riferimento è molto probabilmente proprio il Concerto op. 61 di Kalkbrenner, più che qualsiasi altro concerto dell’epoca (Hummel incluso). Ciò è particolarmente valido per il primo ed il terzo movimento 15 Occorre precisare che gli Studi op. 10 furono pubblicati nel 1833, ma sicuramente Chopin ne scrisse una buona parte molto prima. Sappiamo inoltre che alcuni dei primi studi furono scritti da Chopin a proprio personale uso per cercare di risolvere i difficili problemi tecnici presentati dall’esecuzione del concerto in oggetto e di quello in Fa minore. 16Cfr. Gastone Belotti, Chopin, Torino, EDT, 1984, p. 73. 14 Meyer, op. cit., p. 264. Codice 602 178 179 Il primo movimento del Concerto op. 61 di F. Kalkbrenner Giovanni Giannini dell’opera (nel secondo movimento infatti Chopin si distacca dal modello di Kalkbrenner). Ad ulteriore suffragio della nostra tesi possiamo anche aggiungere che il giovane Chopin non solo conosceva la partitura del Concerto op. 61 ma che lo aveva anche eseguito nell’agosto del 1824, durante la villeggiatura a Szafarnia, per un piccolo gruppo di ascoltatori17. Le motivazioni di questa “scelta” chopiniana risiedono, a nostro parere, proprio nell’enorme stima che allora il giovane musicista polacco nutriva nei confronti del maestro tedesco. Citiamo qui di seguito un passo di una lettera del 12 dicembre 1831 che Chopin scrive all’amico Titus Woyciechowski: […] non immagini quanto fossi curioso di Herz, di Liszt, di Hiller, ecc. Sono tutti delle nullità a paragone di Kalkbrenner. Ti confesso che ho suonato come Herz, e che vorrei suonare come Kalkbrenner (…)18. O ancora, in un’altra lettera al suo amico Kumelski nel novembre 1831: […] sono molto legato a Kalkbrenner, il primo pianista d’Europa. Ti piacerebbe senz’altro. È il solo al quale io non sia degno di legare le scarpe. Gli Herz, ecc. sono, ti assicuro, dei semplici fanfaroni; non suoneranno mai meglio di lui19. Il Concerto op. 11, peraltro dedicato allo stesso Kalkbrenner, rappresenta insomma l’inevitabile tributo di un giovane che esordiva verso chi aveva più esperienza di lui ed era considerato il più famoso pianista del momento, nonché il più illustre didatta di Parigi. Non escludiamo inoltre l’ipotesi che il maestro polacco, intenzionato ad intraprendere la carriera di virtuoso internazionale, con tale tributo sperasse di poter entrare nelle grazie del maestro, con il quale avrebbe prima o poi dovuto confrontarsi. Con tutto ciò non intendiamo certo declassare il giovane Chopin a mero imitatore di concerti altrui. È chiaro a tutti che Chopin, ancorché appena ventenne, in questo concerto è già un poeta e che, pur avendo preso a modello Kalkbrenner, egli compone comunque il Concerto op. 11 seguendo il proprio genio musicale. Quanto preso infatti divenne suo e in modo così originale che Chopin resta ancor oggi un gigante mentre i suoi modelli sono spariti dai ricordi dei più. Non a caso, a tutt’oggi, a distanza di quasi due secoli, i suoi due concerti per pianoforte rimangono i due più fulgidi esempi di concerti biedermeier e sono gli unici ad essere ancora in repertorio. 17Cfr. Piero Rattalino, Chopin. Ritratto d’autore, Torino, EDT, 1991, p. 16. 18 Correspondance de Frédéric Chopin, Parigi, La revue musicale, 1981, vol. II, p. 40 e segg (la traduzione dal francese è di Fabrizio Papi). Kalkbrenner Chopin Batt. totali: 424; tempo 4/4. Batt. totali: 689; tempo 3/4. Esposizione orchestrale tematica (104 battute); i due temi vengono esposti nelle due tonalità deputate. Esposizione orchestrale tematica (139 battute) (secondo tema esposto in Mi maggiore). Entrata solistica: primo tema 8 battute: 4 alla tonica, 4 alla sottodominante. Entrata solistica: primo tema 16 battute: 8 alla tonica, 8 alla sottodominante. Episodio lirico: 8 battute. Episodio lirico: 8 battute; si prolunga in un episodio secondario (8 battute) viene esposto due volte. Episodio di transizione: 18 battute, progressione cromatica ascendente di trilli. Episodio di transizione (43 battute), introdotto da un nuovo tema secondario in Mi minore seguito da un lungo passaggio di arpeggi e figurazioni cromatiche discendenti. Secondo tema in Fa maggiore: 8 battute; breve episodio lirico (con espressione, battute 140-147); viene proposto una seconda volta dall’orchestra mentre il solista lo accompagna con rapidi arpeggi in sedicesimi. Secondo tema in Mi maggiore: 9 battute; viene presentato tre volte, ogni volta arricchito da abbellimenti o passaggi in ottava, poi da battuta 52 intenso episodio lirico, con modulazioni e progressioni che portano alle code in Mi maggiore. Code finali (42 battute); scrittura a difficoltà crescente con sfoggio di tecnica clementina, scale, arpeggi, doppio meccanismo, note ribattute; progressioni (battuta 173 e segg.); improvvisa modulazione a La bemolle maggiore (batt. 189); conclusione con scale cromatiche per terze e 4 battute di trilli. Code finali (59 battute); scrittura a difficoltà crescente con figurazioni in sedicesimi, doppio meccanismo (per quarte); battute 291 e segg.: passaggio modulante con rapide figurazioni in sedicesimi alla mano sinistra, esposto due volte; da battuta 315: figurazioni cromatiche ascendenti, quindi discendenti, culminanti in 4 battute di trilli. Sviluppo: tutti orchestrale (30 battute); entrata del solista a battuta 239, in Si maggiore, che riprende il tema lirico; passaggio modulante da battuta 247 che porta ad un nuovo episodio lirico in Mi bemolle maggiore; batt. 274 e segg. ripresa del primo tema; passaggi modulanti, coda finale con figurazioni in ottave. Sviluppo: tutti orchestrale (52 battute); batt. 385: entrata solistica, riprende il primo tema lirico dapprima in Do maggiore quindi in La minore; ampio uso di abbellimenti; progressione da battuta 404; da battuta 408 lungo passaggio in arpeggi con modulazioni. Ripresa orchestrale accorciata (10 battute), espone solamente il primo tema. Ripresa orchestrale accorciata (25 battute) espone solamente il primo tema. Ripresa solistica: riprende il tema lirico; passaggio modulante identico all’esposizione; secondo tema in Re maggiore. Ripresa solistica: riprende il tema lirico, il tema secondario e le figurazioni modulanti dell’esposizione, secondo tema in Sol maggiore. Coda finale (59 battute): in Mi maggiore basata su materiale nuovo, su passaggi in figurazioni di sedicesimi (breve modulazione a Si bemolle maggiore, batt.391 e segg.); 8 battute finali di trilli. Coda finale: in Mi minore (50 battute)); ha il carattere dello studio; 4 battute finali di trilli. Conclusione orchestrale (12 battute): modo maggiore. Conclusione orchestrale (19 battute): modo minore. 19 Correspondance de Frédéric Chopin, Parigi, La revue musicale, 1981, vol. II, p. 17 e segg (la traduzione dal francese è di Fabrizio Papi). Codice 602 180 181 Giovanni Giannini Bibliografia Belotti Gastone, Chopin, Torino, EDT, 1984 Basso Alberto, L’epoca biedermeier e Carl Maria von Weber, p. 967, in UTET, Storia della musica, vol. 2, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 2004 Dizionario Enciclopedico universale della Musica e dei Musicisti, Torino, Utet, 1986 (voce concerto) Meyer John A., Il concerto, in Storia della musica, pp. 228-278, The New Oxford History of Music, L’età di Beethoven, Milano, Feltrinelli editore, 1984 Nautsch Hans, Friedrich Kalkbrenner. Wirkung und Werk, Amburgo, 1982 Newman William S., The Sonata since Beethoven, New York-London, W.W. Norton & C., 1983 Papi Fabrizio, Friedrich Wilhelm Kalkbrenner – Apoteosi e declino del Biedermeier, Ghezzano (Pi), Felici Editore, 2007 Radcliffe Philip, La musica per pianoforte, in Storia della Musica, The New Oxford History of Music, Milano, Feltrinelli editore, 1984 Rattalino Piero, Il concerto per pianoforte e orchestra, Milano, Ricordi-Giunti, 1988 Rattalino Piero, Storia del pianoforte, Milano, Il Saggiatore, 1982 Rattalino Piero, Fryderyk Chopin. Ritratto d’autore, Torino, EDT, 1991 Romanticismo e Biedermeier, p. 79, in Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT, 1982 Schumann Robert, Gli scritti critici, Milano, Ricordi-Unicopli, 1991 Tusa Michael C., 19th Century Piano Music, New York-London, Routledge, L. Todd editor, 2004 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, seconda edizione, London-New York, 2001 (voce Kalkbrenner) Von Lenz Wilhelm, Il pianoforte e i suoi virtuosi, Palermo, Sellerio editore, 2002 Discografia dell’op. 61 Friedrich Kalkbrenner, Piano Concerto n. 1, op. 61, in The Romantic Piano Concerto, vol. 41, Howard Shelley (piano), Tasmanian Symphony Orchestra, Howard Shelley (conductor) Hyperion, 2006 Friedrich Kalkbrenner, Piano Concerto n. 1 in D minor, op. 61, in The Romantic Piano Concerto, vol. 1, Hamburg Symphony Orchestra, Hans Kann (piano) Heribert Beissel (conductor), VoxBox2, CDX 5064, 1992 182 finito di stampare nel dicembre 2013 presso la Tipografia Bongi, San Miniato (Pi) per conto di sillabe
Scaricare