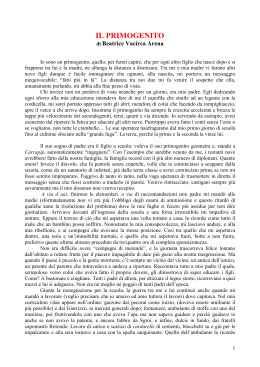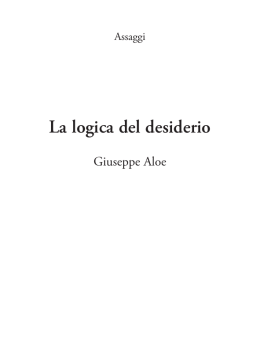Prefazione Un monito pieno di saggezza, valido in ogni epoca e ad ogni latitudine. Lo sforzo di conoscere e riconoscere se stesso è il primo impegno necessario per vivere un’esistenza consapevole e l’unica rocca da cui poter estendere il proprio sguardo sul mondo, sperando di comprenderne qualcosa. Identificare se stesso e distinguere il proprio io dal resto degli individui non è atto di superbia, bensì l’unica via attraverso la quale si possa poi intendere ed apprezzare l’altro da sé, senza timore di confondersi o rimanerne soggiogati. E’ un cammino faticoso, pieno di insidie e di canti di sirene che, con carezzevole ipocrisia, cercano di dissuadere dal compiere questa vana fatica, sussurrando che è tanto più comodo e dolce lasciarsi andare, adeguarsi ad essere semplicemente ciò che gli altri vedono in noi, per essere meglio accettati, meglio compresi e non provare più alcun dolore, immersi nell’anestetico abbraccio dell’inconsapevolezza. I giorni che non ti aspetti narra, con evidenti valenze autobiografiche, il disagevole percorso intrapreso da un uomo per uscire dal proprio guscio, per farsi padrone del proprio destino, strappando da sé quella sorta di etichetta che proprio il destino gli aveva appiccicato addosso e scegliendo egli stesso cosa essere, chi diventare. Non si tratta certo di titanico e roboante eroismo, ma di grande coraggio umano. In un mondo che, mentre ci lusinga con i suoi frenetici ed esaltanti progressi tecnologici, ci stordisce con i suoi continui inviti a sognare di poter avere tutto e ci distoglie dal sacro diritto, o dovere, di sognare invece cosa essere, eclissando nel fumo delle sue gridate offerte il piacere di immaginare chi vogliamo diventare, la voce serena di Fiorenzo Mascagna ci ricorda quanto ciò sia in realtà molto più necessario al raggiungimento di quella felicità che ogni essere umano agogna per sé.La più alta ambizione possibile non è quella di possedere cose, ma quella di poter dire, al bambino che eravamo, se ce lo trovassimo un giorno davanti: ecco, ho realizzato i tuoi sogni, sono quello che volevi essere da grande, non ti ho dimenticato, né tradito. Certo, ci vuole anche fortuna; bisogna trovare, sulla propria strada, i segnali che indichino la via, ma questo non è sufficiente; il merito dell’uomo e la sua abilità stanno nel riconoscerli e nell’essere così forte da seguirli, anche quando tutti, comprese le persone che lo amano di più, dicono, in buona fede, che è una follia, che quella strada non porterà a nulla e che i sogni sono solo inconsistenti illusioni.Fiorenzo Mascagna è oggi un apprezzato scultore e docente all’Accademia di Belle Arti, ma non ha dimenticato le sue radici, e il mondo semplice che scolpisce in bassorilievo sullo sfondo della sua storia, è il mondo della tranquilla vita di provincia, con i suoi ritmi lenti e naturali, con le stagioni che scandiscono il tempo dell’uomo. La linfa vitale che pervade il narrato è la stessa che anima l’autore: dall’antica saggezza contadina egli ha appreso che ci vuole del tempo per vedere i frutti di quanto si è seminato, bisogna sapere aspettare, e dalle pagine del romanzo lancia la sua tacita sfida alla società del “tutto e subito”. I personaggi intagliati in questo mondo divengono, fra le sua mani, rappresentanti di un’umanità che rischia di svanire, inghiottita nel caotico traffico del progresso omologante. Una profonda sensibilità consente all’uomo e all’artista di cogliere i gesti e i silenzi che costituiscono la vera ricchezza dell’esperienza del singolo e, traducendoli in un linguaggio che tocca corde inconsuete, li materializza e li rende fruibili senza che quei gesti e quei silenzi perdano la loro fragile, impalpabile consistenza. E’ forse l’allenamento ad usare lo scalpello e la pratica a far emergere, attraverso esso, la grazia e la flessuosità di un giovinetta dalla dura pietra che ha insegnato a Fiorenzo Mascagna a ricreare quelle atmosfere e quelle ambientazioni intime e rarefatte che ciascuno porta dentro di sé, ma che il più delle volte, quando si cerca di far rivivere descrivendole, perdono gran parte del loro fascino e vividezza, appesantite dall’incontro con la realtà esterna. E’ caratteristica esclusiva degli uomini attribuire significati altri a quanto accade loro e proprio nel significato attribuito ad un evento, che ad altri può apparire banale, si concretizza l’identità particolare di ciascun individuo, diverso da ogni altro. Può un libro acquistato per caso su una bancarella, senza per altro alcuna vera intenzione di leggerlo, mutare il corso di un’esistenza? Sì, se noi decidiamo di dare a quell’avvenimento un valore speciale. La simpatia che suscita il protagonista del romanzo è tutta nel suo costante non prendersi troppo sul serio, nel rimanere cosciente dell’arbitrarietà di certi significati, eppure nell’agire in base ad essi in modo serissimo. Le valenze autobiografiche contenute nel romanzo, più che segnare una linea di confine tra narratore e lettore, segnano anzi un punto di incontro; la semplicità e la naturalezza con cui Fiorenzo Mascagna descrive sentimenti, situazioni e punti di vista generano complicità e partecipazione. Nella massificazione del gusto, in cui finiscono inevitabilmente anche le produzioni artistiche e intellettuali, I giorni che non ti aspetti rappresenta una piacevole, sorprendente eccezione. Senza avvalersi dei colpi di scena e degli artifici narrativi così comuni al nostro tempo da apparire doverosi, la narrazione avviluppa l’attenzione del lettore, trasportandolo in una realtà intimistica e familiare, quasi ascoltasse il racconto di un amico. E’ una scelta stilistica matura e ponderata, dovuta probabilmente anche all’esperienza di docente dell’autore, che conosce il valore di un linguaggio che con semplicità e naturalezza riesca a trattare anche delle cose più difficili e a toccare con dolcezza gli argomenti dolorosi e tragici che fanno spesso parte del bagaglio dell’esistenza. Intessuto di personali considerazioni e riflessioni, quello che emerge con maggior forza dalle pagine del romanzo è la rara sensibilità di uno sguardo sul mondo che è in grado di abbracciarlo così com’è, senza chiedere scioccamente al mondo di cambiare, ma pretendendo quel cambiamento da se stesso. E’ la storia di un’inversione di marcia, di un lento ma caparbio risalire la china, di uno svegliarsi da quel torpore in cui è dolce lasciarsi scivolare, ma che determinerebbe il tradimento del sé e la morte del sogno che anima la vita di ogni uomo. Quasi un controcanto al verghiano mondo dei “vinti”, la vicenda del protagonista si pone come un suadente memento: se qualcosa di buono il progresso ha portato con sé, è la possibilità concessa all’individuo, occidentale e contemporaneo, di scegliere una strada diversa da quella che la sua origine sembra avergli assegnato: tutto ciò che occorre per farlo è volontà e determinazione. Così il vecchio e triste cappellaio Alessandro, emblema di quella società in cui si è ciò che era tuo padre, racconta delle sue frustrate ambizioni, affidando al protagonista, un uomo che ha avuto la possibilità e il coraggio di seguire le proprie, gli arnesi di un mestiere che ormai non serve più a nessuno. Il quadro degli studenti “segaioli”, invece, che si ritrovano nel retro del bar vicino alla scuola e menano il loro tempo nell’ignavia e nell’incoscienza del domani, dipinto con i toni empatici e caldi dell’affetto e al contempo del distacco di chi fu uno di loro, induce la malinconia per un futuro a cui si è rinunciato prima ancora che avesse inizio: quei tanti Lucignolo, cui tutti siamo pronti a dispensare benevoli sorrisi, abdicano di fatto alla costruzione del loro domani, e il nostro sorriso, riletto tra le pagine di Fiorenzo Mascagna, si rivela in realtà carico di tutta la sua compiacente indifferenza. I giorni che non ti aspetti è un invito garbato a far tesoro delle proprie esperienze, a non vivere la vita in frammenti che hanno senso solo se presi singolarmente, ma a tenere sempre un vigile sguardo sul tutto, perché domani diventeremo quello che ieri abbiamo scelto di essere, senza soluzione di continuità. Alessandra Maiorino I GIORNI CHE NON TI ASPETTI CAPITOLO I (passato a confronto) Quando la mattina ti svegli presto e vedi il giorno carico di colori galleggiare sopra i tetti, il pensiero va a tutte le volte che non l'hai guardato con la tazza del caffè in mano. La stanza dove dormi comincia a prendere luce. Passano pochi minuti, ed i rumori del giorno, fedeli alleati della vita, buttano giù dal letto l'ultimo sogno fatto ad occhi aperti, quello per cui rischiavi di versarti addosso la tazza di caffè riscaldato. Mi ero alzato di buonora, un sussulto caritatevole, nell'aprirmi gli occhi, mi aveva regalato il titolo del piccolo saggio sulla teoria del colore al quale avevo lavorato nei giorni precedenti. Mi era capitato più volte che a svegliarmi fossero le preoccupazioni ed i problemi che affollano la vita di chi si appresta a ricominciarla da un qualche punto di non facile decifrazione, ma che la parola avesse il potere di svegliare chi aveva altri motivi per farlo, lo ignoravo del tutto. Quando ritorni a vivere da adulto nella casa che ti ha visto crescere, ricordi perfino di aver nascosto i sogni da qualche parte. Li cerchi sotto il letto, nel solito armadio che custodisce tutto, dentro il contenitore di vetro della credenza, tra le lettere custodite nella scatola delle scarpe. Ogni angolo è traccia della speranza di ritrovare, da qualche parte, un gioco ininterrotto. Quel passato, che ti riporta agli occhi la tinta delle pareti di quel certo anno e che non ti fa dimenticare neppure come eri vestito il giorno del tuo primo lavoro, è dentro i minuscoli indizi della vita quotidiana. Non può essere vero che la nostra innocenza sia stata spesa con i primi soldi guadagnati. E' questo non voler credere di essere stati gli assassini dei nostri sogni che ci spinge a cercare quel tempo, che vorremmo ancora buono, per rappacificare l'adulto con il bambino. A parte la pausa di una relazione iniziata male e finita peggio, mi ero ritrovato a fare le stesse cose che facevo prima di andarmene da casa. Il mio vissuto più intimo, le parole, i miei primi lavori e buona parte dei vestiti, non mi avevano seguito in quella sciagurata avventura. Per tutto il tempo della mia permanenza a Brescia, il casale era rimasto disabitato. I miei, per una questione di comodità, dettata soprattutto dallo scorrere degli anni, si erano trasferiti nella casa ereditata dal nonno materno. Mio padre continuava a curare l'orto e, nella cantina, ancora custodiva tutti gli attrezzi. Anche per lui la casa era sempre stata quella. Delle comodità poteva farne a meno, ma quel troppo silenzio avrebbe finito per fargli perdere l'uso della parola. Quel troppo silenzio, eccessivo anche per me, stava comunque diventando un punto di inizio necessario per una nuova vita da ricominciare. Non ero tornato per proporre a me stesso una soluzione per l'inverno. Quella casa aveva visto le mie prime cadute e conservava sotto le scale i segni scavati nel tufo che avevo fatto io. Cosa significasse fare a distanza di anni lo stesso mestiere, potevo comprenderlo solo raccogliendo le tracce del mio gioco di allora che avevo lasciato crescendo. E' carico di ombre qualsiasi voltarsi indietro; il mio si stava riversando dentro l’anima con tutto il suo bagaglio di ricordi e sapori. I volti cercati sulla parete, le immagini da rimettere insieme nel cortile da sempre teatro di festosi incontri. I riflessi del sole invernale sparpagliati sulle tempeste di nodi degli ulivi. Voragini da rincorrere sotto la crosta del tempo. Quando sentii suonare il campanello, l’orologio dell’ingresso segnava le dieci e l'incantesimo del mattino, affogato dentro la nebbia, si era rotto da parecchio tempo. Pensando che fosse il postino, aprii da sopra ed urlai: “Mettila sulle scale!”. Non sentendo lo scatto della serratura, mi preoccupai che la porta fosse rimasta aperta. Bisognava scendere, perché tutte le volte che rimaneva spalancata, ci si infilava il gatto che mi sarei ritrovato puntualmente in cucina. Il tempo a mia disposizione era quello necessario per infilarmi le scarpe e salvare il file sul quale stavo lavorando. Prima ancora di legare i lacci, mi ritrovai Federica in cima alle scale. Mi rendo conto che qualsiasi descrizione di ragazza appariscente, elegante e carina, potrebbe non giustificare da sola lo stupore di trovarmela sul pianerottolo di casa all'improvviso. Dopo tanto che non la vedevo, l’avevo incontrata il giorno prima. Mano al calendario delle sofferenze, esattamente il ventitré di Dicembre davanti all’oreficeria del paese in compagnia di suo marito. Lasciamo per un attimo Federica sul pianerottolo di casa, blocchiamo il gatto che altrimenti entrerebbe in cucina, insomma… fermiamo il tempo! Non fosse altro che per quella poca legna da ardere per la stufa. Il ventitré di Dicembre mi trovavo dunque in strada. Potrei dire che ero uscito per comperare le sigarette, mi sembra banale, dirò semplicemente che ero uscito e basta. L'atmosfera è di quelle facili da immaginare: le vetrine infiocchettate, la gente in preda a quella atavica fretta che precede i giorni di festa. Di diverso solo un cielo grigio che minacciava neve, e sarebbe stata proprio una gran bella sorpresa per il giorno di Natale. Incontrai Claudio e Federica che uscivano dal negozio. Soliti saluti, auguri a non finire per me, per mio padre e la mamma, per la moglie di mio cugino incinta. Claudio e Federica si erano conosciuti alle prove di uno spettacolo teatrale che, in quelle lontane sere di Luglio, stavamo allestendo per una rassegna estiva. Claudio recitava nella compagnia, anche se al teatro di quelle sere avrebbe preferito volentieri il pallone. Prese confidenza con Federica meglio di chiunque altro, perché, mentre il resto della compagnia si agitava per dare un senso compiuto ad uno spettacolo nato in poche settimane, lui era l'unico ad intrattenersi con le ragazze nel giardinetto fuori della cantina. Inutile dire che Federica disapprovava il comportamento irresponsabile di Claudio. Vai a capire il destino! Con l'impegno che mettevamo tutti per sentirci dei bravi attori, quello che interpretò meglio di chiunque altro il ruolo di successo, fu proprio lui. Federica aveva saputo che mi ero lasciato con Maria non so da chi, ed in mezzo a quel via vai di gente, provò a farsi raccontare com'erano andate le cose. Lo sapevamo entrambi che la strada non poteva essere il luogo adatto per affrontare un argomento che avrebbe richiesto bel altro tempo e riservatezza. Sembrava che avesse fretta di darsi ragione. Quella di Federica, nei confronti di Maria, era stata da subito un’antipatia a pelle, provocata probabilmente dalla natura eccentrica della mia fidanzata che, in quelle rare occasioni di incontro, aveva sfoggiato tutta la sua presunzione di superiorità nei confronti di altre donne. Quelle poche volte che si erano viste in estate, non avevano comunicato, se non a gesti e per lo stretto necessario. Di quando Federica mi disse che con una come lei al massimo potevo durare sei mesi, ne stava facendo un trofeo. Non poteva comunque andarmi giù che Federica mi rinfacciasse, con civetteria, quella sua personale vittoria di previsione su come sarebbe finita. Provai a cambiare discorso, ma lei, mentre Claudio si stava intrattenendo con un suo amico, mi prese i polsi dicendomi: “Un giorno di questi ti vengo a trovare e mi racconti tutto”. Siamo a questo punto: non “un giorno di questi”, ma la mattina dopo. Una visita assolutamente inaspettata, anche perché, quello che avevano sentito le mie orecchie, erano le solite promesse che sentiamo dire tutti e alle quali, spesso a ragione, non diamo peso. Era arrivata all'improvviso nel cuore del mio mondo; il disordine che si apriva ai suoi occhi, somigliava fin troppo a quello che mi ritrovavo dentro. La mia casa raccontava di libri e abiti sparsi. Decisamente impacciato, senza alibi, le tasche della felpa piene di matite, la barba di un paio di giorni, le scarpe slacciate, la guardavo in silenzio. Avevo già il mio bel da fare per tenere testa a quello sguardo pieno zeppo di domande. Inutile cercare le parole. Quelle che riuscivo a pronunciare erano quelle confezionate da una vita, tipo “Come stai? Accomodati” e poco altro. Un po' divertita, si mise a girare su se stessa come una bambina che cerca in un qualche angolo della stanza qualcosa da tormentare con le dita. Ci conoscevamo dai tempi della scuola, eppure, quello che mi riusciva meglio con lei, era sentirmi in imbarazzo, soprattutto quando mi puntava addosso quegli occhi marroni “pagliuzzati” di verde. Nei pochi istanti in cui riuscivo a guardarla, vedevo ancora quel mondo distante: un misto di aristocrazia, intelligenza e bellezza. Si era truccata con cura, ma sarebbe stata bella anche se l'avessi vista alle sei del mattino. Consapevole di non avere una reggia a mia disposizione e di non essere un principe azzurro, quello che potevo fare, da comune mortale, era proporle un caffè: l'unica cosa decente che avevo in casa. A volte davvero i discorsi fatti con gli amici sulle donne vanno a farsi benedire. Io, quello che aveva speso serate intere per rivalutare nelle donne il fascino del profondo, meglio se impegnate politicamente e, perché no, magari proletarie dal seno cadente, stavo lì come un fesso ad aspettare che le cadesse il cucchiaino di mano per raccoglierlo con la lingua. Federica rappresentava l'esatto contrario della donna che avevo idealizzato per anni. Possibile che la sua bellezza giustificasse tutto? Elegante e delicata, di buona famiglia, a scuola brava in tutto, anche in matematica. Da sempre avrei voluto detestarla e invece no: quel volto che guardavo con ammirazione avrebbe giustificato qualunque cosa. Non tardò a chiedermi di Maria. Lo fece dopo essersi accesa una sigaretta. La curiosità di Federica era compiacenza verso se stessa. Aveva avuto ragione fin dal primo momento, ma soprattutto voleva averla adesso. Le domande, stipate dentro il suo sguardo, non si sarebbero accontentate di risposte vaghe, voleva conoscere i dettagli, sapere esattamente com'erano andate le cose. Sapendo di dover soddisfare la sua curiosità, stavo cercando le parole adatte per descrivere il vuoto abissale nel quale mi ero ritrovato quando, rientrando nel pomeriggio a casa di Maria, avevo sorpreso la mia compagna a letto con un'altra donna. Lo scivolare dei loro corpi sul lenzuolo si era conficcato nella mia mente tanto da rendermi straniero dentro la casa che avrei voluto amare. Pensando che Maria stesse riposando, mi ero preoccupato di fare piano, richiudendo lentamente la porta girando la chiave. Dopo tutto, dovevo soltanto prendere il progetto per l'Accademia dimenticato nello studio prima di uscire. Federica ascoltava il racconto, passandosi nervosamente le mani sulle ginocchia. Fuori, il rumore di un trattore si era infilato dentro il silenzio che di tanto in tanto inghiottiva le mie parole. La pausa mi aveva consentito di mandar giù le ultime gocce di caffè rimaste nella tazzina. Stavo rivivendo quegli istanti: i gemiti, la porta della camera aperta, la sua vestaglia sul divano, gli abiti della ragazza sul bordo del letto. Federica, portandosi le dita della mano sinistra sul mento, disse: “Difficile riuscire ad accorgersi di cose che la mente rimuove prima ancora che possano trasformarsi in certezza”. Come anestetizzato, ripercorrevo attraverso il racconto i secondi che avevano preceduto il mio sarcastico “ Buon divertimento!” prima di uscire sbattendo la porta. La ragazza abbracciata a lei mi era sembrata giovane e, comunque, a parte quelle sue dita sottili sul seno della mia compagna, ricordavo solo che aveva i capelli scuri molto lunghi. Le domande sugli orari dei miei rientri, le telefonate dopo cena: “Resto a dormire da Monica, abbiamo da lavorare su reperti della seconda sala”. Stavo raccontando a Federica cose non dette neppure a me stesso. La mia breve permanenza a Brescia si era trasformata in un epilogo inaspettato e doloroso. Neanche la possibilità di prendere la macchina per tornare a casa la sera stessa, visto che mi sarebbe stato difficile mancare all’inaugurazione della mia mostra in programma per il giorno dopo. Via Dante l'avevo percorsa in lacrime. Il bisogno di stancare le gambe e la testa mi aveva condotto sotto il portico del Comune, dove il signor De Petri, custode dell'archivio, incontrato sulle scale, si era limitato a salutarmi facendo finta di nulla. Piazza della Loggia, trasformata all'improvviso in un cumulo di ricordi da sparpagliare con le dita, aveva assunto sembianze spettrali. Mi stavo chiedendo se avrei dormito la notte in quel letto e quante altre volte, quelle lenzuola, avevano accolto corpi diversi. Fuggire a Sermione, la voglia di stare affacciato sul lago, essere un turista come tanti. Il bisogno di uscire dal perimetro della città aveva condotto il mio girovagare a Verona, dove la sosta si era protratta fino alle due del mattino in un tavolo all’aperto della caffetteria antistante l’Arena. Lì, avevo pensato alla vernice del giorno dopo, al discorso già preparato per la presentazione, alle persone da incontrare, a Maria pronta a fare la prima donna con i suoi sorrisi tutti d'occasione. Quando una città la senti brutta all'istante, vuoi semplicemente che diventi orribile. Avevo dormito sul divano, Maria si era alzata più volte durante la notte. Le sue occhiaie tradivano un sonno tormentato. Entrando nel soggiorno dopo essersi lavata i capelli, parlando a voce bassa, disse: “Presumo che dopo la mostra te ne andrai via. Cosa vuoi che ti dica, posso dire che ti capisco, fossi in te farei la stessa cosa, però voglio dirti che mi dispiace e tu non sai quanto. Mi dispiace non essere riuscita a preservare il nostro rapporto da cose che nella mia vita ci sono, insomma... ci sono sempre state”. Federica ascoltava attentamente le mie parole tenendosi il viso tra le mani, poi con forza disse: “E tu non ti sei accorto mai di niente? Una cosa te la devo dire... La tua bella archeologa, quando siamo andati al mare con Claudio, Serena, Patrizia, Alessandra e Francesco, mi è sembrata fin troppo affettuosa nei confronti di Serena, tanto da farmi pensare che la tua fidanzata avesse strane idee in testa”. Cosa potevo dire? E' sempre da un certo punto in poi che si capisce qualcosa di quello che sta succedendo nella tua vita. Mi ero risparmiato il macabro rituale di togliere le camicie dall'armadio. Giorni e giorni spesi per preparare una mostra da cancellare con un addio. Già ai primi saluti della gente intervenuta alla vernice, volevo semplicemente fuggire. Mentre aspettavo il momento propizio, che comunque non sarebbe stato prima della fine della serata, cercavo di ingannare il tempo passeggiando con tutta la mia assenza dentro la sala. Non ero riuscito neanche a guardarla negli occhi. Un suo amico aveva insistito per fotografarci davanti al manifesto della mostra. L’inutilità di gesti tutti da dimenticare non faceva altro che affrettare il distacco. Maria si aspettava che passassi a casa per prendere le mie cose. Magari quella poteva essere l’occasione per parlarci meglio. La chiamai invece quando mi trovavo dalle parti di Mantova, solo per dirle che stavo andando via. Delle dolorose ragioni del mio ritorno, non ne avevo parlato con nessuno. Federica era la sola a sapere com'erano andate effettivamente le cose. Anche se il comportamento di Maria aveva scavato dentro di me una ferita profonda, spesso mi ritrovavo a pensare al disagio che doveva aver provato nel vedermi sulla porta della camera quel venerdì pomeriggio. Federica leggeva dai miei occhi pagine d’imbarazzo. Pentita per le troppe domande che avevano riesumato momenti da seppellire, ogni tanto provava a sdrammatizzare con qualche battuta il clima pesante sceso sul nostro incontro. Parlammo parecchio e fu un mettere le mani dentro il passato. Federica tirò fuori, a sorpresa, dal cilindro delle cose andate, un giovedì pomeriggio del Giugno Ottantadue. Mi raccontò per filo e per segno cosa avevo fatto dalle sedici fino alle diciannove circa di quel giorno. Non mi veniva in mente nessun pomeriggio di quell'anno, ma quando mi disse della ragazza che era con me, ricordai perfino di aver perso, quel giorno, il crocefisso della catenina. Pensando di trovarmi al lago, era venuta con il motorino per chiedermi se volevo fare insieme a lei una ricerca su Bacchelli. Mi trovavo al lago, ma non da solo. Con me c'era una ragazza tedesca di nome Elke che veniva qualche volta alle prove con gli altri amici del Servizio Civile Internazionale. Elke era una ragazza simpatica e benché parlasse poco l'italiano, un qualche modo per comunicarci le nostre rispettive simpatie lo avevamo trovato. Non so se mi piacesse veramente, certo aveva un volto grazioso, però era più importante che fosse straniera. Con la sicurezza di sempre, appena velata da una rabbia lontana, Federica disse che quel pomeriggio ci rimase male, anche perché, qualche giorno prima, le avevo scritto una lunghissima lettera per confessarle quel disagio d'amore che mi portavo dentro da settimane. Mi ero in qualche modo liberato del problema lanciando la bomba e scappando via. Non sempre si scrive una lettera per ricevere una risposta. Il mio, e adesso lo ricordavo bene, era stato uno sfogo, una sorta di ammissione d'incapacità e di inadeguatezza a quella situazione. Quando, guardandomi negli occhi, sussurrò che si sentì tradita, spuntò sulle mie labbra un sorriso di quelli che durano un solo istante: Federica stava parlando seriamente. Chinò la testa sulle ginocchia, lo faceva sempre quando aveva un problema. Anche se di anni ne erano passati parecchi, mi sentii un cretino lo stesso. Seduto sul letto, giocherellavo con una matita; lei di fronte a me, intorno un silenzio infinito. Un fitto ronzio dentro la mia testa prese il posto dei pensieri. Federica si aspettava che dicessi qualcosa; mi sentii spoglio. Quando alzò la testa vidi nei suoi occhi lo stesso disorientamento che stava dentro i miei. Prese la mia mano sinistra e la strinse tra le sue, avvicinando le labbra. Eravamo talmente vicini da apparirmi sfocato il suo volto. Per la prima volta sentivo il suo respiro che odorava di rossetto. Quando pensai di poterle dire qualcosa, un bacio fece naufragare ogni possibile parola. Quella che stavo respirando dalla sua bocca era la nostra presenza in un altro tempo. Federica non aveva più gli occhi del suo primo arrivo ed io non esistevo più, mi ero sparpagliato sulle sue labbra. Si alzò dal letto facendo una leggera pressione con le mani sulle ginocchia, prese le tazzine, e molto lentamente, le ripose sul davanzale della finestra. Si rimise il cappotto e, prima di sparire per le scale senza dire una parola, mi salutò con la mano. Cominciai a chiedermi quale poteva essere il peso specifico di un bacio e se per entrambi avrebbe pesato nella medesima maniera. Le cose non dette anni prima incominciavano ad urlarmi nelle orecchie, mentre quelle parole che sussurravo guardando l'orizzonte dalla finestra, si dissolvevano appena staccavo la bocca dal vetro. Quel sogno che, in qualche modo, aveva illuminato la mia esistenza ed i miei desideri, era stato ucciso dalla più bella delle morti: un bacio. Mentre riassaporavo dalle labbra il sapore dolciastro del suo rossetto, guardavo con insistenza le due tazzine sul davanzale per rendermi conto che quello che avevo sognato da sempre era successo veramente. Mi chiedevo cosa potevo farne del desiderio di rivederla ancora. Sentivo come saldato un debito con il passato, il presente però non aveva risposte da darmi. Se la mia vita la dovevo nuovamente inventare, la sua, seguiva i lineamenti della sua faccia. Neanche un bacio avrebbe potuto scalfire la compostezza di un sentiero tracciato. Non avevo rubato nulla, però quella lettera scritta molti anni prima incominciava a pesarmi, tanto da diventare un macigno difficile da rimuovere. Tutto era irrimediabilmente lontano, tranne la malinconia nella quale inciampavo, quando tornavo a pensare a quel bacio. I miei mi aspettavano per la cena. Avevo rispettato la vigilia solo per non fare un torto a mia madre. Non sarei andato a messa e non avrei fatto nulla di quello che più o meno fanno tutti. Mi chiedevo comunque se anch'io avessi cercato dentro la notte di Natale la scusa per andare a letto tardi. Ero contento di stare un po' con loro, anche se temevo le solite domande sul lavoro, sempre scarso e pagato male. Quel sogno nel quale credevo soltanto io, si allontanava sempre di più ogni volta che sentivo sul collo le ansie di quelli che si preoccupavano per me, e che per il mio bene, mi consigliavano di fare qualsiasi altra cosa che fosse un vero mestiere. Camminando per i vicoli rischiarati dai lampioni mi ripetevo una frase di Klee rimastami impressa dai tempi dell'Accademia “Poi una qualche luce appare e si prende un'unica direzione”. Provavo a dar ragione alle grandi speranze, mi raccontavo la vita come se la stessi dicendo ad un altro. Avevo più voglia di credere nel futuro che motivi per farlo. Parlavo dentro la sciarpa, un po' per sentire il respiro caldo sulla faccia, un po' per la paura di incontrare qualcuno ed essere preso per pazzo. In mio padre avevo ritrovato il sorriso di sempre. Mi stupivo della mia stessa felicità nel vederli insieme. Nei loro occhi risplendeva la stessa luce. Gli anni erano lì, tutti per intero sui loro volti, ma in perfetta armonia con quella tovaglia semplice che accoglieva nel mezzo la solita bottiglia di vino. Mio padre me lo aveva sempre detto che la strada dell'arte non sarebbe stata né comoda né sicura. Un contadino sa meglio di chiunque altro che per far crescere le piante ci vuole acqua, sole e tempo. Sa anche che serve avere fortuna, perché la grandine e le gelate sono sempre in agguato. In lui trovavo un alleato silenzioso che mi diceva soltanto di essere più concreto, di seminare piante che potessero crescere in fretta. Io e la mia mania degli ulivi! Lo sapevo che i grandi alberi non crescono in una una stagione, ma ingenuamente lo speravo. In quel momento Federica si trovava da un'altra parte, ed io sapevo anche dove. L'albero di Natale a casa dei miei non c'era. Mia madre aveva cucinato poche cose, di diverso solo il dolce, e lo spumante era quello da poco. Federica la vigilia la stava passando a casa dei suoceri. Conoscendo il padre di suo marito, sapevo per certo che in quel momento si stava consumando una cena tipo pranzo per gli sposi. Immaginavo i regali sotto l'albero, la signora Monetti vestita a dovere, il signor Alberto intento a divorare gamberetti alla crema. “Altre usanze”, avrebbe detto mia madre. Non stavo invidiando nessuno, Federica ed io eravamo perfetti dentro le nostre rispettive cornici. Quella sua eleganza mal si sarebbe adattata alla pochezza di una casa di contadini, per non parlare dell'imbarazzo che avrebbero provato i miei nel ritrovarsi a tavola la figlia del farmacista del paese. No, non volevo stare da un'altra parte; semplicemente mi sarebbe piaciuto essere migliore di quello che ero. E' una condizione scomoda quella del sognatore, tutti i giorni una prova e quel sogno da scagliare lontano per corrergli appresso. Avevo studiato, sostenuto con profitto gli esami in Accademia, ma siamo alle solite: se mi fossi laureato in architettura sarebbe stata un'altra cosa. Claudio era un ingegnere, tra l'altro felicemente sposato con una laureata in medicina. A casa sua c'ero stato una sola volta per il compleanno della sorella. Una gran bella festa stile Alberto. Mangiammo di tutto e la signora Monetti si mostrò garbatamente gentile permettendoci di mettere lo stereo “a palla” per tutta la sera. Eravamo tutti giovani e tanti, ma i genitori di Clara non se ne andarono mai. Alla fine della serata ci fu regalato il portachiavi della ditta del padre. Ricordi che mi danzavano davanti agli occhi. Non si poteva non notare la mia assenza dalla sedia che nel frattempo stava risultando piuttosto evidente. Quel groviglio di fili del passato mi impediva perfino di essere sorridente in un giorno di festa a casa dei miei genitori. Niente domande sul lavoro, quella contenuta dalle quattro pareti della cucina era la serata tranquilla che volevo. Malinconie intrecciate. Maria si era limitata a spedire le mie cose dentro uno scatolone che non avevo nemmeno aperto. Federica, senza saperlo, ci aveva appoggiato sopra il cappotto. Due passati in un angolo della stanza possono far molto rumore. Le immagini della mattina, gonfie come una vela, navigavano dentro la mia testa. Mia madre ebbe la felice idea di chiedermi se ero stanco. Quella che avrebbe dovuto essere una domanda, in realtà era un modo per dirmi “ Forse è meglio che vai a dormire, andrà meglio domani”. I pensieri, che per tutto il tragitto verso casa non avevano smesso di mescolarsi tra loro, erano il frutto di una giornata dalla quale avevo ereditato più sconforto che voglia di sentirmi parte del mondo. Arrivato sul cortile ebbi un sussulto che sembrò tramutarsi in energia. L'ora non era delle migliori, e anche la stanchezza che sentivo dentro gli occhi non avrebbe lasciato scampo ad iniziative di rivolta. Senza aspettarmi nulla da me stesso, continuai il capitolo del breve saggio al quale stavo lavorando. Scrissi un paio di pagine e, mentre stavo rileggendo il manoscritto, mi addormentai sulla sedia. Da quella volta che mi sono addormentato sulla sedia ad oggi, sono passati sei anni. Riprendo da qui perché mi ritrovo seduto su quella stessa sedia ed ho tra le mani il libro nato da quegli appunti. Federica adesso lavora nella farmacia del padre e mi capita di incontrarla spesso, soprattutto quando porta a spasso la sua bellissima bambina. Lo aveva sempre detto che se avesse avuto un maschio si sarebbe chiamato Giovanni, se invece fosse stata femmina Beatrice. Quando le vedo assieme penso che le cose non potevano andare diversamente: principessa la madre, altrettanto la figlia. Con Claudio ci si dà il colpo di claxon, quando ci s'incontra per strada, ma di tempo ne è passato troppo, non si è più amici ma semplici conoscenti. Il teatro della vita ci danza sopra la pelle. A volte da spettatori di noi stessi ci applaudiamo sapendo che gran parte dei nostri gesti e delle parole che annotiamo sul diario della nostra esistenza li dobbiamo alle circostanze, più o meno fortunate, che compongono il mosaico della vita. Dico questo, mentre rileggo la mia storia fatta di sconfitte e di tanta voglia di riscatto. Ripenso alla vigilia di Natale di sei anni fa, ripenso a quei giorni carichi di domande su come rendersi visibili al mondo e soprattutto alla donna che in quel momento ne rappresenta l'immagine più rotonda. Se Federica mi avesse amato, mi avrebbe amato il mondo. Di questo amore avevo cercato la sicurezza di farne parte, probabilmente il resto non contava niente. Qualcosa di mio credo di averlo ceduto a quel ragazzo che avrebbe voluto essere migliore del compagno di Federica. Un onorevole compromesso tra il mio bisogno di appetiti e la voglia di sentirmi appagato. Volevo che un artista fosse rispettabile quanto un ingegnere. L'ho fatto per vanità, l'ho fatto per piacere ad una ragazza e per sentirmi chiamare professore. E' come se si fosse avverato quello strano sogno fatto tanti anni prima. Al bambino che ero, promisi che avrei difeso i suoi sogni, che li avrei fatti diventare grandi. Oggi parlo ai ragazzi che stanno sugli stessi sgabelli dove sedevo io. Sono come li avevo immaginati quella notte di sei anni fa, quando scrivendo di forma e colore, cercavo di dar corpo a qualcuno che mi stesse a sentire. Di loro, certo nessuno immagina che, quel poco o tanto che so, lo devo ad un amore che se non mi ha messo le ali, di certo mi ha buttato giù dal nido. Mi faccio spazio tra le parole, cerco il significato vero dentro la metafora e un po' mi sorrido alle spalle. Mi rivedo dentro quella umana povertà vestita di luce. Sì, una storia da poco, come è poco il sasso che custodisce l'opera. Le ragioni che ci spingono verso il futuro sono legate al senso del pane più di quanto si creda. Non è possibile vedere il proprio volto nello specchio perché ciò da cui non ci allontaniamo mai, sfugge alla nostra consapevolezza. Vediamo sempre quello che è passato. A conti fatti, dico di fare oggi quello che ho sognato ieri; quella che mi racconto è una mezza bugia resa mezza verità dalla costanza di pensiero che giustifica percorsi dolorosi che avrei evitato. Probabilmente un sentiero vale l'altro; l'importante è camminare con fiducia e ricordarsi di quello che s'incontra per strada. E' un senso di proprietà debole quello che accompagna i nostri approcci, molto di quello che crediamo di guidare, in realtà va per conto suo. Un appuntamento non serve per tenere a mente il taglio esatto delle labbra di una ragazza e nemmeno per annotare il colore dei suoi occhi. Ci basta ricordare che ha due belle labbra e che vorremmo rivedere quegli occhi. Non sono mai diventato un elettricista e quel mio primo diploma da tecnico, non so neppure dove sia finito. Conservo gelosamente il bagaglio del mio travaglio di allora e mi sembra strano incontrare oggi, da relatore, in qualche convegno, quelli per i quali ero la negazione della cultura. Nasce da qui la mia convinzione che non è mai troppo tardi per risalire la china. Federica non ha avuto la fortuna che ho avuto io di toccare gli estremi. Il suo problema di cosa dover fare da grande, era già stato risolto sopra il bancone della farmacia. Dal mio professore di Lettere ho appreso che cultura è tutto quello che si ricorda dopo che ci si dimentica di quello che si impara a scuola. Non è complicato capire che se non c'è un legame tra quello che si apprende e quello che si vive, gli sforzi fatti sopra i libri possono vanificarsi nel nulla. Come può risultare efficace uno studio di trigonometria se non se ne conosce il suo effettivo grado di applicazione? Non esiste uno studio funzionale a se stesso. Oggi voglio credere che Federica sia stata parte del mio destino. Il percorso di ognuno di noi è segnato da tappe fondamentali, bisognerebbe sempre coglierne il significato profondo. Parlo di questo mentre sono seduto ai piedi di un faggio secolare, dopo aver trascorso in Accademia una giornata fatta di tante parole. La passeggiata che mi sono concesso mi ha condotto ai margini di una strada sterrata dove si è piccoli di fronte all'enormità di questi faggi secolari. L'uomo ha occhi solo per il presente, gli alberi non ne hanno affatto, eppure mi sembra naturale pensare che ne abbiano. Guardo il cielo da sotto questi rami e mi sembra impossibile che questo incommensurabile groviglio possa aver avuto origine da un cespuglio. C'è un tempo per la formica, un tempo per gli alberi secolari ed un tempo che precede l'origine di tutto. Da quale cespuglio è nato il percorso che non so riconoscere negli abiti che indosso e nella macchina parcheggiata poco più avanti? Quest'uomo che mi respira dentro l'ennesima sigaretta e che legge lo scandire del tempo da un orologio da polso, lo conosco veramente? Il mio tempo questa mattina l'ho trascorso dentro un'aula accogliente fatta apposta per sentirsi fuori dal mondo. Ho ripercorso con i miei studenti le tappe fondamentali che hanno segnato l'arte contemporanea. Ci siamo ritrovati a discutere di César, delle sue compressioni e delle pattumiere di Arman. Mentre argomentavo le diapositive, ripensavo ai giorni passati in quella stessa aula da allievo, quando a parlarci di storia dell'arte contemporanea era Cesare Milanese. Sono anni che occupo la cattedra che è stata degli insegnanti che ho avuto; forse questa mattina è stato vedere lo sgabello vuoto della terza fila a trascinarmi nel passato. Quello sgabello ha ancora inciso il mio nome con un chiodo, è da lì che ho appreso le cose che riempiono la mia bocca a lezione. La vita non finisce mai di sorprendere. Dai tempi del bar Selvaggina all'Accademia: tante immagini diverse. Per la prima volta questa mattina ho parlato del mio passato ad un gruppo di ragazzi durante la pausa per la sigaretta. Li ho visti seguire con attenzione il racconto. Abbiamo parlato il linguaggio dell'arte. Con la nostra lente d'ingrandimento ci siamo spinti fin dentro le profondità dell'animo umano. Mi sono chiesto se tutto questo gli servirà a qualcosa. Si sta facendo sera ed un leggero vento agita le chiome degli alberi che mi hanno fatto compagnia per un paio d'ore. Sarà un ritorno a casa di quelli che fanno ritrovare al solito posto le raspe lasciate in tutta fretta questa mattina. Domani avrò gli abiti della scultura, lasciati i panni del professore, sarò operaio di me stesso e continuerò a scavare dentro un'idea per cercarvi una parte di me che ancora non conosco. La casa che accoglierà il mio ritorno è quella dove sono nato, quella che non finirò mai di scoprire. Di questo raccontarmi l'anima ed il cuore delle cose, mancano le tessere che ho perduto, ma quelle che restano, non sono solo il ricordo di un tempo passato, sono l'essenza di quello che vivo e di quello che sono. Continuerò a non avere risposte alle tante domande che mi faccio, però nel mettere insieme le pagine del vissuto avrò cura di non dimenticare nel cassetto le briciole di questo tempo andato, che compone il gioco al quale non saprei rinunciare. Si dice della vita che è una sola e che andrebbe vissuta seguendo le tracce di quel far somigliare le cose che fai a quelle che vorresti fare. Dimentichiamo che questo appartenerci è la vera carta di identità di un’esistenza da vivere a contatto con i battiti del nostro cuore. Sarà che di giorni ci sembra di averne fin troppi, ecco perché ne sprechiamo una buona parte. Serve anche costruire castelli di sabbia, serve mantenerci bambini, entrare nell’orbita di un mondo pensato piccolo, ma che invece nasconde immense foreste cariche di sapori da percorrere a piedi. E’ camminando piano che si riesce a guardare la strada. Ognuno ha la chiave per aprire le stanze dei sogni. L’atto di fiducia sarà quello di ritenere possibili le trasformazioni genetiche di un’idea. In fondo, la felicità, è pur sempre l’adempimento di un desiderio. CAPITOLO II (dal bar Selvaggini alla biblioteca) Frequentavo la scuola media; non avevo ruoli importanti da sostenere, non ero capoclasse ed i voti in pagella non mi obbligavano ad una condotta di rispetto nei confronti dei libri e degli insegnanti che avevo. L'unica cosa nella quale mettevo molto impegno era appiccicare con cura le maglie dei giocatori di calcio, ritagliate dalle figurine, sotto i volti dei personaggi di storia. Il giorno che l'insegnante di lettere ci fece vedere dall'antologia un'immagine dei graffiti di Lascaux, pensai semplicemente che chi aveva fatto quelle raffigurazioni non sapesse disegnare. Le cose non cambiarono quando dallo stesso libro ci mostrò la “Guernica” di Picasso. Non mi sembrò possibile che in tutti gli anni trascorsi dall'epoca primitiva fino al Novecento, l'uomo non avesse imparato a disegnare. Arrivò in mio soccorso il compagno di banco che, mostrandomi dalla stessa antologia, gli affreschi del Cinquecento, chiarì i miei dubbi. Indipendentemente dal periodo storico, alcuni uomini sapevano disegnare ed altri no. Tutto potevo immaginare tranne che nella vita mi sarei occupato d'arte. Le mie deduzioni di allora, non erano soltanto le mie, per molti miei ex compagni di classe le cose stanno ancora così e non penso che per questo non dormano sonni tranquilli. Con questo bagaglio d'indifferenza, certificato peraltro da un libretto scolastico che non lasciava scampo a fughe improbabili verso la cultura, mi iscrissi alla scuola superiore seguendo le sacre prescrizioni che i miei insegnanti avevano annotato nell'ultima pagina di quel libretto grigio. Proprio perché sembra brutto indurre un ragazzo alla manovalanza, mi avevano lasciato scelta: potevo diventare un elettricista o un meccanico tornitore. Volendo vedere per forza le cose dal lato buono, mi eccitava l'idea di prendere il pullman per andare a scuola. Avrei viaggiato con i miei amici e magari chissà, a Viterbo, potevo trovarne di nuovi. La scuola aveva prodotto in me una tale indifferenza nei confronti del sapere da sentirmi a posto comunque. Frequentare le lezioni era semplicemente il prezzo che dovevo pagare per vedere gli amici al bar sotto le mura. Mi confortava sapere di non essere l'unico a pensarla in questo modo. La mia nuova scuola somigliava ad una specie di labirinto e le finestre davano tutte sulla strada. I rumori che arrivavano da Via dell'Orologio Vecchio si mescolavano alle voci degli insegnanti, rendendo piuttosto incomprensibili le lezioni a quelli degli ultimi banchi. Mi sembrava strano che i posti più ambiti fossero i peggiori. Di bravi in classe ce n'erano un paio ed avevano preso la scuola come un impegno serio, scrivevano appunti anche a ricreazione. Per quelli come me, convinti che l'algebra fosse una malattia della pelle, la scuola era semplicemente un pretesto per non andare a lavorare. Che in classe ci fossero gli insegnanti si poteva sopportare, quello che mi sembrava eccessiva era la pretesa di starli a sentire. Dal fondo della classifica maturata in tre anni di scuola dell'obbligo, nel giro di qualche settimana, avevo risalito delle posizioni; con grande stupore mi accorsi di non essere tra i peggiori. C'era chi, convinto che fosse meglio abbondare, metteva l'apostrofo a caso. Mi convinsi di essere comunque finito nell'inferno studentesco, quando a lezione di elettrotecnica vidi scritto alla lavagna “l'aradio”. Lontani i giorni delle figurine e, sempre più consapevole di far spendere inutilmente i soldi ai miei genitori, stavo cercando una soluzione che mi permettesse di salvare quello straccio di coscienza che in qualche modo credevo di aver ereditato da una famiglia di contadini. Inutile dire che la scuola stava diventando un rifugio per quando pioveva. Più o meno eravamo una dozzina quelli che, a turno, facevano girare le palle ai professori e al flipper nuovo di zecca del bar Selvaggini. Sebbene mi atteggiassi a capo branco, marinare la scuola generava troppi sensi di colpa, che mi ritrovavo puntualmente nella testa. Convinto che la mia fosse una malattia da guarire, incominciai a fare “sega” più spesso. Quello che cercavo di fare era stare da una parte sola, non importava che fosse quella giusta o quella sbagliata, volevo essere bravo in qualcosa. Saper marinare la scuola era un'arte che potevo imparare praticandola, anche se, tutte le mattine, guardavo con rimorso le mille lire del digiuno che dovevano servire per finanziare un paio di partite a flipper, le sigarette e poco altro. Nonostante la mia apparente disinvoltura, la timidezza mi impediva comportamenti che per altri erano assolutamente normali. La camicia a quadri che mettevo sopra il maglione era l'armatura per le mie insicurezze; i capelli spettinati e quei quattro peli sul mento che chiamavo barba, costituivano il mio rifugio sicuro. Al bar si ascoltava musica. Nell'ultima sala c'erano dei tavoli dove ogni tanto qualcuno ci apriva sopra i libri che avrebbero dovuto essere da un'altra parte. Il bar Selvaggini sembrava fatto apposta per quelli che alle dieci del mattino non dovevano essere visti da qualcuno. Le poche ragazze che marinavano la scuola sostavano sempre davanti al juke box nell'attesa che qualcuno ci mettesse dentro qualche moneta. Gli argomenti erano sempre gli stessi. Le ragazze, noiose quanto noi, aprivano i quaderni solo per disegnarci sopra labbra di velluto e cuori infranti. L'amicizia con le donzelle del gruppo viaggiava sopra il filo tenue del fumo di sigarette. Si era volgari quasi per dovere. Nell'ultima sala del bar non c'erano futuri principi e le improbabili principesse che si nascondevano dietro folti fasci di capelli, appena aprivano la bocca facevano cadere le braccia. Peccatori nello stesso modo, frequentavamo con apparente serenità il girone dei dannati. Predestinati ad una vita mediocre, avevamo scelto di non essere della partita. I libri che portavamo a spasso servivano come fragile alibi alle domande sulla scuola che sopportavamo una volta a casa. Lo sapevamo più o meno tutti che non sarebbe durata. Quelli che riuscivano a godere dell'ubriacatura “segaiola” almeno vivevano del momento; io pativo l'imbecillità della mia condizione e non c'era giorno che non mi domandavo se avesse un senso quello che stavo facendo. Il tempo passava e la scuola si stava allontanando sempre di più dalla mia vita. Gli insegnanti sapevano perfettamente che non eravamo ammalati e che non giacevamo in un letto d'ospedale. A loro serviva solo la giustificazione, ovviamente falsa, che lasciavamo in segreteria, quando ci degnavamo di varcare il portone. Il bar Selvaggini era un luogo frequentato da molti ragazzi che occasionalmente avevano problemi con i compiti in classe e le interrogazioni. Il proprietario, un omone tranquillo che dispensava simpatia, non ci risparmiava la “ramanzina” quando, per prendere le bottiglie dal magazzino, attraversava la sala. La sua era una presenza bonaria alla quale ci eravamo abituati; per farlo contento, ogni tanto, facevamo finta di studiare. I soldi non sempre bastavano per arrivare alla fine della giornata. In tre decidemmo di provare a finanziare la nostra sciagurata esistenza andandoci a giocare quelle due lire che avevamo in tasca al circolo del biliardo. La decisione fu presa una mattina piovosa di Novembre. Il trasferimento dal bar al circolo, che distava un centinaio di metri, avvenne sotto un unico ombrello. L'atmosfera cambiò di colpo. In quella sala zeppa di fumo c'erano sei biliardi in fila ed altrettanti tavoli verdi. Nel giro di un’ora avevamo fatto il salto di qualità che avrebbe fatto rabbrividire qualsiasi genitore. Mi sembrò strano che alle nove del mattino, tanta gente, potesse permettersi il lusso di giocare a carte invece di lavorare. Quei volti corrosi dal vizio seduti ai tavoli, li avevo già visti in un film. Ebbi paura più della puzza d'alcool che della loro maestria nel gioco. Quella mattina io ed il mio amico Carlo perdemmo “a stecca” tutti i soldi messi da parte e quelli che ci aveva prestato Ezio. Se avessimo vinto? Tornare a scuola era difficile almeno quanto vincere a carte contro quelli del circolo. I foglietti delle giustificazioni stavano finendo e c'era sempre il rischio che il Preside convocasse i genitori degli assenti cronici. Il rimpatrio definitivo avvenne ai primi di Dicembre. Ci accolse il nuovo professore di italiano. Tutto secondo copione: le pecorelle tornavano all'ovile e ad aspettarle sulla porta c'era un prete. Sì, il professor Cionco, anche se vestiva in borghese, era un uomo di Chiesa. Fu una cosa nuova assistere alla sua prima lezione: non aprì mai il libro e alla fine non dette i compiti che solitamente davano gli altri. Come per miracolo, quel giorno gli assenti erano soltanto tre. Appoggiato alla scrivania, parlava di Foscolo come di un vecchio amico che avrebbe dovuto essere tra noi. I poeti, attraverso il suo racconto fatto di tanti dettagli, prendevano corpo smettendo di essere quelle figure oscure del libro. Parlava e sorrideva. L'ironia con la quale trattava argomenti che mai avrei pensato poter essere divertenti, provocava reazioni di consenso. Il suo entusiasmo, oltre che essere bello a vedersi, era disarmante. Quel modo d'insegnare fu per me un'autentica rivelazione. Frastornato da quella sua prima lezione, provai uno strano senso di felicità quando il professore, guardando il registro, disse che non c'era nulla di irrecuperabile. Mi sentii riabilitato alla vita. Il ritardo che avevo nei confronti dei programmi era enorme. Sembrava che i professori parlassero arabo. Se non volevo essere bocciato dovevo iniziare a studiare veramente. Gli appunti che prendevo erano incomprensibili anche per me, ed i compiti in classe costituivano il muro quasi invalicabile della mia riabilitazione totale. Con il professor Cionco le cose stavano in un altro modo: la sua disponibilità a comprendere situazioni difficili era palpabile. Il libro di letteratura lo avevo venduto ad un mio compagno di classe ed avevo una qualche difficoltà a confessarlo. Quelle che mi portavo appresso erano le fotocopie di alcuni capitoli del libro, neppure rilegate in modo decente. Quando un mattina, a ricreazione, dissi al professore che l’antologia l’avevo persa alla fermata del pullman, mi resi conto di aver mentito ad un prete ed era la prima volta che lo facevo. Guardandomi con aria serena mi rassicurò dicendomi che la biografia di Leopardi potevo leggerla su qualsiasi altro libro. Fu lui stesso, quel giorno, alla fine delle lezioni, ad accompagnarmi in biblioteca per insegnarmi ad usare gli schedari. Il professore sapeva chi ero più di quanto lo sapessi io. Durante il tragitto assecondò altre mie bugie dette per giustificare le numerose assenze. Liquidò il mio sermone dicendomi di guardare avanti. Era chiaro a lui quanto a me che nella mia testa c'era una gran confusione. Non sapevo cosa significasse studiare e certo non poteva sfuggirgli che quella inversione di rotta avrebbe provocato in me dei piccoli traumi da superare. Io, che ero bravo a giocare a calcetto, mi resi conto all'istante di non essere capace neppure di leggere correttamente le istruzioni del distributore di sigarette. Posare gli occhi sopra una pagina del libro comportava una fatica dura da sostenere. Mi vergognavo di non saper leggere, ed in classe era la cosa che più di ogni altra evitavo, quando l'insegnante chiedeva di continuare dai banchi la lettura dal libro di narrativa. Di quanto fosse in salita la mia nuova strada ne parlavo con lui nell'intervallo, non senza provare sconforto per il presente. Il professor Cionco, ironizzando, diceva che se volevo corteggiare le ragazze del liceo dovevo essere bravo in italiano. Quando aggiungevo che mi sarei accontentato di quelle del bar Selvaggini, replicava che le più carina del classico, le avrei trovate dalle quindici in poi in biblioteca. Erano i tempi delle manifestazioni. Per le strade si sentivano le urla dei cortei. Impegnarsi politicamente era soprattutto un modo per stare insieme, riconoscersi in un'idea, frequentare amici, condividere tanto altro oltre la bandiera. Di negozi che vendevano dischi e libri ce n'erano davvero tanti. Più o meno una volta al mese nasceva un quotidiano, e le riviste di politica campeggiavano in bella mostra nelle vetrine delle edicole. Incominciai a frequentare assiduamente la biblioteca e, benché il tempo lo passassi più a fumare sulle scale che a leggere libri, un qualche contatto con la cultura iniziavo ad averlo. Il professor Cionco aveva ragione: la biblioteca era frequentata da molte ragazze che facevano costantemente la spola tra i tavoli e la fotocopiatrice. Non c'era stato nessun salto di qualità, volevo sentirmi diverso, ma fondamentalmente continuavo ad essere quello di prima. La consapevolezza che si stava facendo strada nella mia testa suggeriva comunque rapidi cambiamenti di rotta, se volevo somigliare a quei ragazzi impegnati. Grazie ad una conoscenza con una ragazza delle magistrali, iniziai a frequentare un circolo culturale. Visto il legame affettivo che avevo con il professor Cionco sarebbe stato forse più naturale frequentare una parrocchia; mi ritrovai invece a condividere le mie giornate con i ragazzi della F.G.C.I. Fare politica era darsi un ruolo, essere protagonisti di un qualche cosa. In realtà più che cambiare il mondo, volevo cambiare me stesso e tutte le strade sembravano buone, meglio se popolate da ragazze carine. Lo scenario delle mie amicizie cominciò a cambiare poco alla volta. Uscito dal gruppo dei “segaioli cronici” della mia classe, ormai solo, non mi restava che decidere cosa fare delle mie giornate. Nel giro di un mese, da capo branco che ero, mi ritrovai ad essere l'ultima pecora accodata ad un qualunque corteo. Le situazioni guidavano i miei comportamenti: diventò naturale comperare il giornale la mattina e qualche libro di tanto in tanto. Del quotidiano leggevo solo i titoli, dei libri il prezzo sul retro della copertina e poco altro. Il passo successivo fu l'eskimo e la sciarpa rossa. Grazie ai miei capelli spettinati ed a quei quattro peli sul mento, le mie sembianze incominciavano ad essere quelle di un ragazzo impegnato, solo che non avevo l'oratoria, la cultura e nemmeno la capacità di scrivere un volantino senza fare errori. Di scioperi allora se ne facevano tanti. Per un motivo o per l'altro, almeno un paio di volte ogni quindici giorni, c'era una manifestazione. Feci la mia prima esperienza politica organizzando a scuola uno sciopero per i termosifoni spenti. Qualche tempo dopo fui nominato rappresentante di classe. Studiare stava diventando una necessità, perché quelli che frequentavo erano ragazzi del liceo ed i libri che comperavano li leggevano davvero. L'impegno politico esercitava un discreto fascino sulle ragazze, ma la strada che avevo davanti a me per essere competitivo su questo fronte, la vedevo lunga. Non passava giorno che non mi chiedevo se mi interessava veramente la politica o se quello che mi ero dato era solo uno strumento per conoscere nuova gente. Stavo mentendo a me stesso ed i libri non letti, che portavo a spasso, ne erano la testimonianza più evidente. Posso dire oggi in tutta sincerità che ero un rivoluzionario finto. Federica era una ragazza borghese che frequentava il classico. In comune avevamo soltanto la preferenza per i posti di mezzo sul pullman che prendevamo per andare a scuola. Capitava che i nostri sguardi si incrociassero, ma quello che raccontavano alle nostre rispettive teste, non erano frasi degne della penna di Cupido. E' possibile che per lei fossi uno dei soliti illusi che vogliono cambiare il mondo. Federica per me, invece, era la classica ragazza borghese perfettamente in sintonia con la sua bella campana di vetro. Quello che sapevamo entrambi è che i nostri mondi non avrebbero mai comunicato. Le vacanze di Natale appena trascorse ci avevano fatto trovare sull'uscio delle festività la befana con in mano il gettone per l'ultimo giro dentro il quieto far nulla. Nella sostanza, anche il ritorno tra i banchi rappresentava l'occasione per dividere il popolo studentesco: da una parte quelli che avevano fatto i compiti e, dall'altra, gli studenti che sentivano avvicinarsi il patibolo delle interrogazioni. Quella mattina del sette gennaio potevo essere collocato tranquillamente nel girone degli ignavi: senza infamia e senza lode. Per la prima volta il ritorno a scuola non stava vestendo le tinte fosche della tragedia. Certo non avevo studiato fino allo sfinimento, però la pace con i libri mi era sembrata possibile. Il pullman, pieno di facce non propriamente allegre, si stava incamminando verso la salita. Babbo natale non aveva esagerato con doni da sussulto e la befana si era semplicemente preoccupata di chiudere la porta delle festività. Nulla lasciava presagire al dono che il cielo stava preparando per quelli che sentivano il bisogno di un supplemento di vacanza. Prima i finestrini bagnati dal nevischio e, poco dopo, neve fitta. Nonostante bagliori di felicità stavano accendendo gli occhi di noi studenti, scaramanticamente fingevamo di non credere a quello che stavamo vedendo. Nel giro di pochi minuti, il manto bianco si era adagiato su tutta la campagna circostante, rendendo quasi impraticabile la strada. L'entusiasmo per il lieto evento stava raggiungendo livelli considerevoli; di preoccupante c'era soltanto la marcia spedita del pullman verso la salita. Arrivati a quel punto “gufare” contro il “mezzo” non poteva che essere una necessità collettiva. Un urlo di gioia si levò, quando, alla penultima curva prima della discesa per Viterbo, slittando sulla sinistra, il pullman si mise di traverso. La danza propiziatoria degli studenti aveva raggiunto lo scopo. L'aria sconsolata dell'autista era il naturale contrappeso alla gioia di quelli che non vedevano l'ora di incamminarsi a piedi verso casa. A differenza dei miei compagni, in piedi davanti al sedile, guardavo la neve scendere con poetica partecipazione; neanche mi aveva sfiorato l’idea di scendere e non avevo neppure manifestato gioia alzando le mani a pugni chiusi. Quelli rimasti al loro posto erano pochi e tra questi c'era Federica. A parte l'autista che, a ragione, mostrava segni di nervosismo, la bella ragazza dai capelli castani, aveva la stessa espressione di quelli che perdono l'ultimo passaggio per andare allo stadio a vedere la partita. Ero in piedi davanti a lei, difficile non notare il suo pieno disappunto. Uscì dalla mia bocca una domanda che mai avrei pensato di poterle rivolgere: “Scusa, per te è un problema la neve?” Senza pensarci due volte mi rispose che non poteva mancare a scuola, visto che la giornata prevedeva una verifica di latino che lei avrebbe voluto fare. Le mie orecchie avevano sentito bene, la ragazza era contrariata perché voleva andare a scuola per fare un compito in classe di latino. In un attimo tra me e lei si scavò un fossato largo e profondo, i punti di contatto che avevo ipotizzato tra me e la ragazza stavano scomparendo, la novità, comunque, poteva essere quella dell'aver in qualche modo comunicato con il mio nemico di classe. Visto che non mi aveva neppure sfiorato l’idea di scendere dal pullman per tornarmene a casa a piedi, la ragazza pensò che io fossi tra quei pochi che stavano preferendo il ritorno tra i banchi al posto di una allegra passeggiata sotto la neve. Ero rimasto incollato al mio posto semplicemente perché, manie da superuomo in pieno inverno, non avevo il cappotto. Rivolgendosi a me, sfoggiando un sorriso severo, disse che non eravamo molti quelli che avevano voglia di studiare. Sì certo! Proprio così! Andare a scuola era la cosa che desideravo più di ogni altra in assoluto, decisamente stavo morendo dalla voglia di rivedere i miei professori. Non stava scherzando, davvero credeva che io fossi tra quei pochi. Completamente a disagio, cercavo dentro la mia bocca parole che potessero confortare questa sua sensazione sbagliata. Stavo subendo il fascino della ragazza a tal punto da non accorgermi che sul pullman, ad aspettare il mezzo di soccorso con le catene, eravamo rimasti una manciata di studenti ed i pendolari. Quella sua compostezza da prima della classe poteva far pensare ad una ragazza timida, le cose, in realtà, stavano in un modo diverso: il timido ero io. Non tardò a chiedermi se oltre all'elettrotecnica mi interessava altro. Nonostante i miei insegnanti si erano prodigati nel convincermi che i circuiti elettrici sarebbero stati la mia ragione di vita, nessun santone aveva avuto successo nel farmi credere che la musa ispiratrice della mia esistenza sarebbe stata l'elettrotecnica. Decaduta fin dai primi giorni, quella che avrebbe dovuto essere la mia aspirazione istituzionale per il futuro, restava quel certo vuoto da riempire con qualcosa di meglio dei circuiti elettrici ma che al momento non conoscevo. In piedi con le spalle sul profilo del sedile, guardavo la ragazza che aveva la testa appoggiata al finestrino. La neve che scendeva copiosamente dietro la sua testa, formava quel tutt'uno di magico capace di far sognare chiunque. Mentre stavo cercando una possibile risposta alla sua domanda, quel viso incorniciato dalla neve, si scomponeva e si ricomponeva in mille espressioni dentro il mio cervello. Trovarmi quegli occhi dentro i miei, dava la sensazione di completo smarrimento. In qualche Interrompendo modo quella che avvertivo nella mia testa era una sensazione di silenzio assoluto. la lunga pausa che avevo accumulato sulle labbra, disse: “Allora?” Non avevo altra scelta che mentire. Risposi dicendo che frequentavo un circolo culturale, aggiunsi che mi occupavo di teatro, e che, dopo il diploma, mi sarei iscritto a sociologia. Sapendo che quello che stavo dicendo collimava poco con i libri tenuti in mano, mi preoccupai di rimarcare che la scelta della scuola che frequentavo era stata dettata da motivi pratici. Le vacanze di Natale erano servite per scrivere una relazione di fisica. Buona parte del mio tempo era stato speso per riempire una ventina di fogli con notizie sui principali scienziati che avevano messo mano ai possibili sviluppi delle emissioni radioattive. Le pagine in questione, più che essere frutto del mio ingegno, erano il risultato di quello che avevo copiato imparando a cambiare le parole. Di mio però c'era un discreto lavoro di impaginazione. Mentre stavo mostrando a Federica il frutto delle mie fatiche, cadde da sopra i quaderni di scuola un libro che avevo comperato in una bancarella e che portavo a spasso da giorni, senza averlo neppure aperto. Fu lei a raccoglierlo da terra, visto che era finito sotto il suo sedile. Con un gesto impercettibile della mano mi fece capire che potevo sedermi. Federica si stava facendo di me l'idea che io avrei voluto che si facesse e, convinta che io fossi veramente un ragazzo impegnato, cominciò a parlarmi delle sue passioni culturali. Citò autori che io non avevo mai sentito nominare, mi consigliò libri che io non avrei mai letto. Il mio impiego principale consisteva nel dire di si con la testa. Quando vide che il libro raccolto da terra era di Rudolf Harneim “Verso una psicologia dell'arte” sulle sue belle labbra apparve lo stesso sorriso che io avrei riservato soltanto ad una vittoria nel derby e aggiunse: “Ma io questo libro lo voglio assolutamente leggere, promettimi che appena lo avrai terminato me lo presti!” Potevo dirle che quel libro era stata una scelta casuale e che non lo avevo neppure aperto? Neanche per sogno. Potevo far passare dei giorni prima di mettere dentro le sue mani quella copertina con sopra le mie impronte? Ovviamente quel libro lo avevo già letto e potevo prestarglielo all'istante. Prese tra le mani quella copertina bianca con nel mezzo un quadrato blu dicendomi: “ Dai! Dici davvero? Grazie! Davvero grazie. Giuro che non te lo maltratto. Dopo averlo letto ne parliamo, ti va? Non stavo aspettando altro. Mi ero cacciato dentro una situazione di quelle difficili da gestire. Non eravamo ancora amici, ma in qualche modo potevamo diventarlo, anche se ancora non sapevo come. Quello che comunque non capivo era perché volevo diventare amico del mio nemico di classe. La neve aveva reso del tutto impraticabile la strada e tinto di bianco perfino le cortecce degli alberi. L'autista, da poco risalito sul pullman, si era affrettato a comunicare a voce alta che stava per arrivare un altro autobus con le catene. I pendolari, assiepati vicino al posto di guida, si stavano lamentando per il ritardo. Federica, voltandosi verso di me con tono fiducioso disse: “Forse ce la facciamo!”. Non avevo fatto i compiti di matematica ed il libro di misurazioni elettroniche era stato appena sfiorato dai miei occhi, però nelle ultime due ore avevo lezione di fisica: l'occasione per presentare il frutto della mia ricerca impaginata bene. La voglia di andare a scuola proprio non c'era, ma probabilmente avevo trovato il modo per farmela venire. Arrivato il mezzo di soccorso, lentamente incominciammo a scendere. Quei pochi metri necessari per raggiungere l'autobus, furono la mia prima passeggiata con la ragazza che, in qualche modo, stava cambiando la mia vita. Arrivati a Viterbo Federica scese alla prima fermata portandosi appresso il libro che le avevo prestato. Non ricordo che ora fosse e neppure m'importava saperlo. Gli altri cinque minuti necessari per arrivare da Piazza Crispi al capolinea, li passai con la testa appoggiata al vetro. Quella che era stata neve abbondante sul Passo del Cimino, a Viterbo era soltanto pioggia. Potevo essere felice dell’incontro, invece un velo di tristezza cominciò ad avvolgere i miei pensieri. Fondamentalmente avevo recitato una parte e messo in fila sulle labbra le mie irrinunciabili bugie a copertura di quel nulla che sentivo di dover colmare con altro ma che al momento era nulla e basta. L'avrei rivista il giorno seguente e per tanti altri giorni ancora. Di sicuro c'era il problema del libro che le avevo prestato e che non avevo letto. Il giorno che mi avrebbe ridato il libro di cosa avremmo parlato? Per non incontrala, il giorno dopo, andai a scuola approfittando del passaggio di un mio parente. A ricreazione cercai il professor Cionco, ma aveva lezione nella sede distaccata. Mi precipitai in segreteria per chiedere un permesso di una decina di minuti. Appena finita la lezioni incontrai il professore a Piazza Dante che stava uscendo dal portone. Facemmo la strada insieme fino alla fermata. Mentre camminavamo, mi disse che le bugie dette a Federica in qualche modo erano state un bene. Era la prima volta che sentivo un prete giustificare un peccato, se pur veniale. Facendo precedere un bel sorriso a quello che stava per dire, aggiunse: “Adesso non hai via d'uscita”. Non avevo capito quello che intendeva con queste parole, ma sapevo che stava per dire qualcosa di saggio. Mettendomi la mano sulla spalla continuò: “Vedi che avevo ragione a dire che la cultura serve anche per conoscere le ragazze? Prestando a Federica il libro che non hai letto, ti sei messo da solo nella condizione di doverlo leggere. Se non lo trovi in biblioteca, dimmelo, te li presto io i soldi per comprarlo di nuovo”. Accettai la sfida come se si trattasse di vincere una partita. Furono giorni frenetici quelli che seguirono. Don Cionco si appassionò alla mia storia chiedendomi di tanto in tanto notizie sugli sviluppi. Quando Federica mi restituì il libro, ne parlammo a lungo, perché nel frattempo lo avevo trovato in biblioteca ed ero riuscito a leggerlo per intero. Complice l'entusiasmo per la mia prima lettura ed il desiderio di assecondare le passioni culturali della ragazza, cominciai ad occuparmi di cose che mai avrei pensato potessero entrare a far parte della mia vita. Sotto l'attenta guida del professor Cionco presi a studiare regolarmente. Se ne avvantaggiò la mia pagella, mentre mia madre, preoccupata perché non uscivo più da casa, andò a parlare con i professori dicendogli che studiavo troppo. La mia vita si stava muovendo tra due punti fermi: una ragazza del liceo classico di nome Federica ed un professore prete. Sempre più spesso mi ritrovavo nella mia stanza ad immaginare un futuro diverso da quello dei miei amici che mi fischiavano da sotto la finestra per chiedermi se volevo uscire. Nel giro di qualche mese, il perimetro della mia vita, si era ridisegnato sopra interessi nuovi. Quello che doveva essere un sereno percorso di rinascita, in realtà custodiva ansie nei confronti delle quali mi sentivo disarmato. Dei soliti giri a vuoto dentro il paese sentivo di poterne fare a meno, sotto casa non venne più nessuno: stavo pagando con la solitudine il prezzo delle mie scelte. L'unico amico superstite che qualche volta bussava alla mia porta era Gianni. Veniva a trovarmi soprattutto quando sentiva il bisogno di sfogarsi per i continui litigi che negli ultimi tempi popolavano il suo rapporto con Luisa. La sua fidanzatina, aveva mal digerito la scelta del ragazzo di non continuare gli studi. A dire il vero anche io faticavo a comprendere le ragioni che lo avevano spinto a preferire il posto da manovale nella ditta edile del padre rispetto alla scuola. Difficile capire la sua decisione perché Gianni era sempre stato bravo e lo sarebbe stato anche alle superiori. L'idea che avevo dei ragazzi che frequentavano con profitto, non era troppo esaltante. In loro vedevo l'incapacità a rapportarsi con la vita reale e, questo, semplicemente perché molti erano degli imbranati a giocare a pallone e nelle gare erano sempre gli ultimi. Il mio amico costituiva l'eccezione: era un ottimo centravanti e nei cento metri non lo batteva nessuno. Di solito quelli ai quali non piace studiare, manifestano sintomi da rigetto molto tempo prima degli esami. Gianni aveva sempre fatto i compiti e studiato regolarmente per le interrogazioni. Luisa si era probabilmente immaginata con il suo fidanzato per il Corso. Gianni mi raccontava dei soldi che stava mettendo da parte per comperarsi il motorino e di quanto fosse importante per lui, non pensare a niente, terminato il lavoro. Quella scelta l’avrei dovuta fare io e quindi, mi restava difficile entrare dentro le motivazioni che gli avevano fatto preferire alla scuola il posto da muratore. Eravamo troppo giovani per delineare profili di vita futura. Gianni non perdeva occasione per dirmi che voleva sposarsi presto. Immaginava il suo futuro con Luisa nella mansarda costruita dal padre per lui o per suo fratello. Una vita tranquilla con casa, moglie e figli, pensata a quindici anni, può far scappare qualsiasi ragazza che vuole vedere davanti a sé, magari un futuro meno garantito, ma di vedute più larghe. Luisa non era il tipo di ragazza di quelle che stravedono per mariti figli e cucina. Piuttosto vanitosa e ambiziosa, le piaceva far voltare i ragazzi, quando, dopo essere scesa alla fermata, percorreva la distanza che separa Porta della Verità dal “Paolo Savi”. La sua corporatura minuta, opportunamente esaltata nelle forme da un abbigliamento in linea con i desideri dei ragazzi, la faceva sembrare più bella di quello che in realtà era. Quando Gianni mi parlava di lei, l’immagine descritta dal mio amico, non corrispondeva esattamente all'affresco che Gianni stava dipingendo. Lui la incontrava ai “giardinetti” verso le diciassette, io la vedevo sul pullman, e quando, nelle ore di assemblea, sfilava con le sue amiche per il Corso, sostando davanti alle vetrine, più per specchiarsi, che per guardare capi di abbigliamento. I suoi momenti di maggiore vanità erano comunque quelli che precedevano il ritorno a casa, quando al capolinea si mescolavano, nell'attesa dei rispettivi autobus, tutti i ragazzi della provincia. Non le bastava piacere, voleva essere corteggiata. Da qui al pensare male ce ne corre, visto che quando stavano assieme sembravano veramente una bella coppia. Gianni semmai si lamentava dell'eccessiva ambizione della ragazza che avrebbe voluto per lui un futuro da ingegnere e non certo quello da muratore. Le visite del mio amico, benché viziate dal bisogno di confidarsi con qualcuno, erano le poche occasioni che mi restavano per dialogare con un passato che volevo lasciarmi alle spalle. Quando lo ascoltavo, riuscivo ad immaginarlo già grande e questo mi faceva in qualche modo paura. Lui stesso si vedeva così. Voleva imparare presto a fare bene il mestiere del padre. Mi parlava di livelle ad acqua e delle giuste proporzioni tra cemento e ghiaia per fare le massicciate. Usava i termini dei muratori esperti, e benché apprezzassi il suo entusiasmo, quello che proprio non riuscivo a fare, era immaginarlo con Luisa in una vita futura. Quando mi diceva che in estate avrei potuto lavorare in cantiere nella ditta del padre, per guadagnarmi qualcosa, tornavano le immagini delle gelate che vedevo dal finestrino quando il pullman si incamminava verso la salita. Quei ragazzi in abiti da lavoro che sostavano la mattina alle sette di fronte al bar in attesa dei loro rispettivi principali, costituivano l'immagine complessiva di un mondo entro il quale avrei dovuto trovare la mia dimensione. A casa, nessuno aveva fatto pressioni perché scegliessi di andare a bottega o fare il manovale, però non avrebbero avuto nulla da obiettare se avessi scelto di diventare uno di loro. Il mio limbo, che di tanto in tanto veniva scalfito dalle proposte di Gianni per l'estate, lo verniciavo di fresco ogni volta che tornavo nella mia stanza a far compagnia ai sogni. Gianni non poteva sapere come mi sentivo quando mi diceva che il padre avrebbe avuto bisogno di un bravo elettricista. Per lui stavo studiando elettrotecnica, quello che aveva smesso di saperlo ero io. Presto incominciò a diventare difficile sedermi sulle scale per parlare con lui di cantieri e soldi guadagnati. Luisa stava filando con uno dello scientifico e l'avevo vista in atteggiamenti piuttosto eloquenti nel giardinetto della biblioteca con quello che al momento, sembrava essere, un amico più speciale del previsto. Non mi ero scandalizzato affatto, mi sarebbe sembrato strano il contrario. Delle ragazze che studiavano non ne conoscevo nessuna fidanzata con fabbri, falegnami e muratori. Non era questione di casta ma di sintonia e di interessi comuni. Una sorta di livellamento di queste situazioni disarmoniche tra ragazzi che lavoravano e studentesse delle superiori, avveniva in discoteca la Domenica pomeriggio. Questa specie di democrazia comportamentale, fatta di poche parole e di abiti firmati, rendeva uguali quelli che, per condizione culturale e sociale, non lo erano affatto. Molti baci tra ragazzi e ragazze che non avevano nulla in comune, se non il fatto di piacersi per come apparivano sotto le luci colorate della pista, nascevano già morti, o venivano uccisi dalle ragazze, quando, gli improbabili principi, dichiaravano con un lessico da far venire i brividi, che facevano i pavimentisti o che lavoravano in campagna con i genitori. Gianni pensava all'amore come ad un qualcosa al di sopra di tutto. A sua insaputa, Luisa stava smentendo questo genere di ottimismo, mentre io mi convincevo sempre di più dell'importanza dei denominatori comuni. Il mondo che si apriva ai miei occhi lo stavo osservando da un punto di vista diverso. Mi scoprivo ambizioso e soprattutto desideroso di segnare distanze considerevoli, tra quello che avrei voluto essere (anche se non sapevo cosa), e quello che secondo me ero stato. A frequentare la discoteca mi aveva convinto un'amica di nome Tina che vedevo nel pomeriggio, quando il tempo era tutto da passare sui gradoni dei giardinetti in attesa di quella luce miracolosa che possa illuminare la tua vita. Con la ragazza facevo spesso un pezzo di strada al ritorno da scuola, per giungere fino a casa. Avevamo la stessa età, ma lei frequentava ragazzi più grandi. Ovviamente mi piaceva, ma, a dire il vero, erano poche quelle che mi rimanevano indifferenti. Diciamo che ero affetto da quella tipica malattia della crescita che affligge i ragazzi in età scolare, che è sempre carino chiamare sensibilità nei confronti della bellezza femminile. Tina frequentava un Istituto parificato per contabili ed aveva ripreso gli studi dopo aver lavorato come cameriera in un ristorante. Da quello che mi raccontava, quello trascorso al ristorante, era stato un anno piuttosto pesante, di quelli che lasciano ricordi non troppo sereni. Probabilmente dietro quel suo lamentarsi del recente passato c'era anche dell'altro. Mi venivano in mente storie di uomini; più che una ragazza, sembrava una giovane donna cresciuta troppo in fretta. Sapeva che scrivevo poesie e, dai libri che portavo a spasso, aveva in qualche modo dedotto che fossi un ragazzo diverso dagli altri. Un sabato pomeriggio, mentre facevamo la stessa strada, tornati da scuola, mi disse che se volevo potevo accompagnarla in discoteca il giorno dopo. Nel giro di un istante, un lento morbido e sensuale si era fatto strada dentro i miei pensieri. Abbracciato a lei in un lento morbido e sensuale, mi stavo immaginando dentro una situazione di quelle che ti sogni la notte, ma, non sempre la realtà ha la fortuna di corrispondere al sogno. Le cose, infatti, stavano in un modo diverso. A mia insaputa, ero stato usato per far ingelosire un ragazzo che stava frequentando con alterne fortune. Il ragazzo in questione di nome Tommy, era piuttosto bello: uno di quei rari casi di ragazzi che pur non avendo studiato, riescono a trasmettere quel tutt'uno di magico, che piace alle donne. Mi resi conto di questo quando, accompagnati in discoteca da un suo amico senza speranze, che però aveva la macchina, mi ritrovai con Tina seduto sul divano. Il mio ruolo, non somigliava affatto a quello che mi sarei scelto, però fare il rivale in amore poteva avere qualcosa di eccitante. Quando Tommy, opportunamente seguito dallo sguardo da Tina, si avvicinò al tavolo, mi resi conto all'istante che tra me e lui non poteva esserci partita. La mia amica, in ogni caso, prevedendo il confronto, gli aveva detto di me cose assolutamente meravigliose. Io nel ruolo ero il ragazzo intellettuale dal fascino irresistibile, conoscevo la letteratura russa, leggevo Hegel e stavo scrivendo un libro. Quel ragazzo biondo dai capelli lunghi, vestito di bianco, tutto poteva immaginare, meno di trovarsi di fronte, un rivale assolutamente inoffensivo che, non solo non conosceva la letteratura russa, non sapeva neppure ballare. Avrebbe potuto avere tutte le ragazze che voleva, si muoveva in modo disinvolto e ballava bene. Tina però non aspirava ad essere una delle tante. Quella che aveva messo in campo, era una tattica che alle altre non sarebbe mai venuta in mente. Tommy nelle sue qualità era assolutamente inattaccabile, però faceva di mestiere intonaci e questo lo rendeva vulnerabile dal punto di vista intellettuale. Tina, nelle nostre conversazioni, mi aveva detto spesso che avrebbe guardato soltanto uomini dalla laurea in su ed ovviamente benestanti. Lei stessa, credo fosse in difficoltà, di fronte al fascino del ragazzo che, pur non essendo un laureato, era bello, intelligente, e si comportava in modo garbato. La priorità del momento, comunque, sembrava essere quella di tenersi l'esclusiva della frequentazione con Tommy. Lei, in fondo, sebbene si vedesse unica, era semplicemente carina, magari con qualche freccia nell'arco in più delle altre in fatto di spregiudicatezza. La sua inseparabile amica di nome Patrizia con la quale condivideva atteggiamenti da “femme fatale”, ma nei confronti della quale, si sentiva superiore, era stata relegata a ruolo di assistente per il trucco. Patrizia la conoscevo di vista, aveva smesso di studiare e non frequentava i giardinetti. Quello che non si poteva non notare dell'amica di Tina, erano i suoi bellissimi occhi verdi. Con lei non avevo alcun tipo di confidenza e quel complimento che le avrei fatto volentieri, poteva restare ben custodito dentro la mia timidezza di ragazzo fuori da qualsiasi gioco. Quando Tina scese in pista per ballare, capii che le mie speranze erano destinate ad annegare dentro il bicchiere di martini che stavo rigirando tra le dita. Quel ragazzo dai capelli biondi che faceva il muratore, oggi è un noto imprenditore e chissà se ricorda quella Domenica pomeriggio alla discoteca “I due cigni”. In seguito Tommy ha sposato l'amica di Tina, con la quale, condivide una vita fatta di successi e frequentazioni che la mia amica avrebbe sognato. Quel finto rivale in amore, sta scrivendo proprio di lui, con quella naturale ammirazione che si ha nei confronti di quelli che, saltando gli schemi, riescono ad inventarsi una vita di successi, oltre la linea tracciata dal pregiudizio. Di tempo da allora ne è passato parecchio. Tommy ha potuto riempire la sacca dei suoi sogni con quello che voleva, mentre io, ricevevo in quei giorni, da due bellissimi occhi marroni, la spinta di mille braccia per tirarmi fuori dalla stupidità sopra la quale galleggiava la mia vita. Mi è necessario tornare all’origine della cosa perché nello specchio della mia leggerezza di allora vedo troppi ragazzi che non hanno avuto né la fortuna di Tommy e nemmeno la mia, quella di essere aiutati per preferire al gioco del biliardo quello della cultura. Oggi che sento come compiuta questa specie di metamorfosi, da buon ranocchio che ha saltato il fosso, ho la necessità di ricordarmi quale altro destino mi attendeva, se quel giorno, avessi vinto la partita al circolo del biliardo e, se, non mi fosse capitato di incontrare sul mio cammino una ragazza di nome Federica ed un insegnante prete. CAPITOLO III (senza i colori per dipingere il cielo) Stavo scrivendo l’intervento per un convegno sul Manierismo che doveva svolgersi, nei giorni seguenti, al Palazzo Farnese di Caprarola. Com'era capitato altre volte, per documentarmi al meglio, avevo sparso libri dappertutto, aperto cartelline, riesumato appunti, riascoltato vecchie registrazioni fatte a lezione di storia dell'arte. Nonostante non facesse caldo, la finestra era rimasta spalancata da quando, nel pomeriggio, un paio di vasi regalati dalla zia, avevano trovato posto sul davanzale. L'operazione, necessaria per liberare il passaggio tra il tavolo da lavoro e la libreria, avrebbe semplificato di fatto, da quel momento in poi, i miei spostamenti culturali. La telefonata del mio amico Bruno, arrivata inaspettata, aveva reso la serata un po' speciale in tutti i sensi. Da quando era tornato a vivere a Roma, ci vedevamo poco, anche perché i suoi impegni di musicista gli consentivano soltanto visite sporadiche in paese. Anche se la frequenza delle nostre visite in birreria aveva subito un tracollo, la qualità dei nostri incontri conservava tutto il suo valore. La telefonata, piuttosto lunga, si era resa complice di un principio d’incendio in cucina, visto che quella che avrebbe dovuto essere la mia cena, aveva subito quel genere di mutazione che fa storcere il naso, trasformando di fatto, una bistecca, in carboni ardenti. A differenza delle altre volte, la promessa di farmi visita al casale era sembrata carica di concretezza. Entrambi avevamo combattuto a colpi di silenzio a cena le nostre battaglie, per ottenere quella linea di credito familiare, necessaria per non stare fuori dal mondo. L’aver condiviso per anni una vita fatta di semine senza certezze, ci rendeva simili in molte cose, anche se negli ultimi tempi, gli importanti riconoscimenti ottenuti nei vari festival, lo rendevano più ottimista di me riguardo al futuro. Comunque, per quanto le cose gli stessero andando bene, quello che gli dava da vivere, era suonare nel gruppo di un noto cantautore. Siccome da un paio di settimane stava registrando il nuovo disco alle porte di Roma, non gli restava difficile tornare la sera in paese. Della sua vita venivo costantemente informato dalla madre, che incontravo spesso al supermercato o per strada. Due donne molto diverse la madre di Bruno e la mia. La signora Agostina è quel tipo di madre che mette da parte i ritagli dei giornali, la mia è di quelle che non hanno ancora capito che mestiere sta facendo il figlio. Le aveva da sempre accomunate la passione per la “funzione” delle sei del pomeriggio in chiesa. Conoscendola, sapevo che non avrebbe fatto mancare la sua presenza al convegno. Bruno, comunque, proprio perché molto riservato, si lamentava spesso della madre. Anche se molto bravo con la chitarra, non accadeva mai che la portasse con sé alle feste di fine anno o per le grandi occasioni. Quando parlava del suo lavoro lo faceva sempre in modo ironico, e questo lo rendeva simpatico a tutti. Il programma della giornata seguente comprendeva l’idea di svegliarmi presto. Volevo scrivere a mente fresca cose delle quali non pentirmi il giorno dopo. Quando ti scivola dentro le mani una serata fertile e produttiva, diventa difficile dire a te stesso che è ora di andare a dormire. Così, tra un caffè e l'altro, la lancetta piccola della sveglia, si era lasciata dietro la mezzanotte. Le cose da fare, messe in cantiere per il giorno dopo, avevano subito l’influenza della serata euforica appena trascorsa che avrebbe dovuto passare il testimone al giorno. Passaggi di testimone di questo tipo non sempre riescono bene, infatti, alle otto e tre quarti del mattino, stavo ancora allungando le braccia dentro il letto. Mentre ripassavo con la mente il programma appuntato su un foglio messo in cucina, mi convincevo sempre più che sarebbe stato difficile continuare a scrivere sul Manierismo, a meno che non me la fossi sentita di rinunciare ad un paio delle cose messe in cantiere e al pranzo. Bruno lo aspettavo nel pomeriggio; la sua idea di appuntamento era sempre stata vaga. Avrei potuto dirgli di scegliere dal quadrante dell'orologio un numero che potesse andar bene per incontrare un amico, ma tentativi di questo tipo non avevano mai ottenuto i risultati sperati. L'appuntamento per il pomeriggio poteva essere a qualunque ora. Stavo pensando alle cose da fare, scegliendo opportunamente tra le priorità quelle meno faticose. Mi sembrava tuttavia strano che, in cima alla lista, ci fosse finita la legna da tagliare. La cantina in disordine avrebbe avuto bisogno di un qualche intervento radicale, la casa mi stava supplicando in ginocchio di darle un minimo di ascolto. Tutte cose rimandate di giorno in giorno che urlavano vendetta. Senza confessarlo troppo a me stesso, speravo che Bruno arrivasse in anticipo sul previsto. E’ fisiologicamente normale pensare che un amico, nel momento del bisogno, possa darti una mano. Magari avrebbe potuto aiutarmi a portare dentro la cantina la legna. Sì! Proprio così! Usare le mani, per qualcosa di diverso che non sia suonare la chitarra, è l'ultima cosa che puoi chiedere ad un musicista. Le occasioni per prenderlo in giro non erano mancate nel corso degli anni. Le sue unghie curate avevano spesso suscitato ilarità. No, proprio non potevo contarci su un aiuto di questo tipo. La giornata stava scorrendo dentro la scia dei possibili compromessi tra le cose che avrei voluto fare e quelle che andavano fatte. Trovare il tempo per dipingere la porta della cantina, si era rivelato meno complicato del previsto. Quale occasione migliore per rilassarmi e riflettere su cosa scrivere a proposito di Jacopo Barozzi da Vignola. Alle sei del pomeriggio, il passo flemmatico del mio amico si era lasciato dietro il cancello. Sapendo che lo avrei riaccompagnato a casa la sera, aveva scelto di farsi quella che lui definiva una gran bella camminata. Neanche arrivato sul pianerottolo, mi chiese cosa ne pensavo di un aperitivo. Più che di aperitivo, dovevamo discutere della cena. Avevo le gambe sul tavolo, il tappo della biro in bocca e stavo scrivendo. Dopo essersi ironicamente complimentato per il disordine che c'era in giro, disse: “Sempre a scrivere. Di cosa si tratta questa volta?”. Pensai: strano che non sia stato informato dalla madre a proposito del convegno. Mi sembrò normale leggergli alcuni passaggi di quello che avevo scritto. Bruno mi gelò con una domanda inaspettata: “Bene! Sei stato invitato come relatore al convegno?”. No, non ero stato invitato e, sinceramente, non pensavo che servisse un invito. L'ufficio Cultura del Comune stava vivendo giorni euforici, il principe d'Inghilterra aveva onorato il paese con la sua presenza. La scuola di architettura del principe Carlo, ospitata nelle scuderie del Palazzo, si era resa protagonista di una bella mostra, all'interno della quale erano stati presentati gli elaborati per una possibile riqualificazione del centro storico. Il clima che avevo avvertito era di quelli dove dentro ci finiscono tutti, anche quelli che con l'architettura e l’arte non hanno nulla a che fare. Bruno mi stava dicendo che il convegno, in realtà pensato in funzione del pranzo offerto dal Comune, avrebbe coinvolto personalità che si erano rese partecipi delle varie iniziative di contorno all’evento. Aggiunse che probabilmente gli inviti, riservati a questi signori, vigili urbani compresi, li avevano già distribuiti. Il mio sguardo andò sopra i fogli riempiti a penna; l'istinto mi stava suggerendo di accartocciarli, ma non potevo farlo davanti al mio amico. Li spostai dal tavolo alla credenza. Bruno seguì con gli occhi il gesto, poi disse: “ Immagino che non ti sia mosso di qui tutto il giorno; possiamo fare un giro e poi magari andare in pizzeria, cosa ne pensi?”. La proposta non poteva essere rifiutata, anche perché sentivo di dover smaltire quella specie di rospo che mi ritrovavo in gola. In macchina, Bruno, riprendendo il discorso, disse di aver visto gli inviti a casa del maestro della banda musicale, aggiungendo: “Probabilmente si saranno dimenticati di invitarti, anche perché non è che ti si vede tanto in giro”. L’incombere del silenzio nell'aria, lasciava giustamente credere che l'avessi presa male. Fare finta di preoccuparmi dell'orario di chiusura dei negozi, mi era sembrata la scusa migliore per farmi vedere interessato ad altro. Bruno mi conosceva bene, ed anche se mi stavo impegnando a non far pesare sul nostro incontro il mio malumore, si capiva che il colpo non lo avevo assorbito bene. Parcheggiata la macchina, fece una delle sue solite battute per far volare da qualche altra parte il silenzio che avevo sulle labbra. Libero da impegni intellettuali, potevo sorridere alla serata da passare in compagnia del mio migliore amico. Sapevamo che avremmo fatto tardi e non ci preoccupammo di andare subito in pizzeria. La sosta al bar per l'aperitivo poteva essere l'occasione per scambiare qualche battuta con amici e conoscenti. Sebbene non mi sentissi proprio in forma, a causa di una ricaduta influenzale, stavo facendo pace con il mondo. Quel troppo silenzio del quale mi ero nutrito negli ultimi giorni, mi offriva la possibilità di metterci le mani dentro. La solarità di Bruno stava riaccendendo in me parole frequentate troppo poco negli ultimi tempi. Quella sorta di rovesciamento verbale che mi avrebbe consentito il dialogo leggero delle situazioni che richiedono soltanto frasi scontate e qualche sorriso, era quello che auspicavo per la serata. La zavorra caricata sulle spalle prima di salire in macchina, avrei voluto lasciarla direttamente al bar, magari in un angolo nascosto della sala. Il passo successivo poteva essere quello di fare un salto a casa sua per ascoltare qualcosa. Bruno aveva capito che continuare a discutere del convegno non sarebbe servito a nulla. Arrivati a casa, ci accolse la madre. Nella stanza del mio amico c'erano appese al muro le foto di quello spettacolo che avevamo allestito anni addietro e, ben incorniciato, sopra il letto, il manifesto realizzato per quella occasione. Le nove erano passate da qualche minuto, ma nessuno dei due sentiva il bisogno di trasferire quella voglia di stare insieme da qualche altra parte. Mi fece ascoltare un assolo di chiusura, aggiungendo che lo aveva scritto pensando a quando ce ne andavamo con gli altri amici le sere al lago. Il suo entusiasmo, bello a vedersi, lo sentivo contagioso. Ascoltavo in silenzio quella sua maestria capace di trasformare sei corde in emozione profonda. Mi colpiva quella naturalezza morbida fatta di dita che scivolavano veloci. Quando ironicamente disse che saremmo dovuti andare in pizzeria prima della chiusura, stava ancora suonando. Lo avrei ascoltato fino a notte fonda. Nonostante fosse Venerdì, c'era poca gente al ristorante. Scegliemmo il tavolo vicino la porta. Fuori, c'era una coppia di fidanzati che stava litigando a voce alta. Bruno mi guardò dicendo: “Mi sembra di risentire le discussioni che facevi con Maria. Ho saputo che Federica ha vinto un concorso come assistente alla facoltà di Perugia, tu l'hai più vista?”. I tempi non erano più quelli in cui venivo informato su cosa Federica stesse facendo. Risposi semplicemente che non ne sapevo nulla e che l'avevo incontrata in Comune, mentre stava ritirando dei certificati. Ecco, parlare di calcio e di donne poteva essere la soluzione per sciogliere i ghiacci della mia anima, ancora in pena per il mancato invito al convegno. Gli argomenti della serata furono quelli, e non mi sembrò vero, per una volta, non parlare d'arte. Quando ci salutammo sotto casa, la promessa fu quella di rivederci quanto prima. La mattina seguente, dovendo accompagnare la zia fuori paese per delle commissioni, pensando di fare tardi, non avevo azzardato altri programmi. Come ormai succedeva spesso, fu smentita anche questa previsione, visto che alle dieci meno un quarto ero di nuovo a casa. Il postino non lo avevo sentito arrivare e, guardando l’orologio una seconda volta, mi resi conto che non poteva aver anticipato il giro, però dentro la cassetta delle lettere, che mio padre aveva accuratamente legato col filo di ferro sul montante di legno del cancello, c'era una busta bianca che conteneva l’invito per il convegno. La mia curiosità fece una rapida verifica su chi avesse potuto infilare la busta nella cassetta, e l'ipotesi Bruno sembrò la più attendibile. Mi ritrovai tra le dita un invito di seconda mano che, nel giungere a casa mia, aveva seguito un percorso troppo alternativo per conservare il suo valore originario. I fogli non accartocciati davanti al mio amico, li avevo gettati al rientro. In ogni caso, non me la sarei più sentita di mettere mano a quegli appunti. E' con questa sorta d’imbarazzo che il Giovedì seguente varcai la porta del Palazzo. Mi ritrovai intorno persone vagamente interessate all'argomento; alcuni avevano preso posto, mentre altri se ne stavano in piedi. L'impressione che molti dei presenti fossero lì più per l'evento mondano in sé, che per Jacopo Barozzi da Vignola, sembrò piuttosto evidente. Seduto tra gli ultimi posti della sala, scrutavo le facce del pubblico. C'erano ovviamente persone che conoscevo. Mi sembrò strano che un convegno sul Manierismo potesse attrarre così tante persone. Il mio pensiero tornò fuori e si soffermò sul tavolo degli antipasti, preparati per l'occasione. Ero così cattivo da non accorgermi che a metà della sala c'erano degli studenti, probabilmente invitati dai loro rispettivi docenti, pronti per prendere appunti. Prima i saluti del sindaco, poi le varie introduzioni, stavano facendo entrare il convegno nei clima dei lavori. I relatori, compostamente seduti dietro il tavolo della presidenza, visibilmente compiaciuti della presenza di pubblico, sembravano convinti che la gente fosse lì per loro, e non per il pranzo offerto dal Comune. Una signora, non so bene chi fosse, prese la parola ed incominciò a tessere elogi al mecenate che aveva lasciato in eredità lo splendido Palazzo dove si stava svolgendo l’assemblea. Dalle sue parole, sembrava che Alessandro Farnese lo avesse scritto nel testamento di suo pugno che saremmo stati noi i beneficiari ultimi della sua fortuna. Parlava con tono convinto e con una buona impostazione di voce. Potevo non essere d'accordo con quello che stava dicendo, e infatti non lo ero, ma ciò non mi impediva di apprezzare la sua dialettica convincente e corposa. Nel guardare gli altri relatori, mi accorsi che non erano meno distratti del pubblico chiamato ad ascoltare. Ognuno di loro era lì per fare il proprio discorso, senza mostrare alcun interesse per quelli degli altri. Alla fine i discorsi si somigliarono tutti. Più che ad un convegno sul Manierismo, si stava assistendo ad una celebrazione postuma della bontà d'animo e della magnificenza di Alessandro Farnese. Nessuna voce fuori dal coro, nessun dibattito, solo ossequiose parole per l'antico proprietario del Palazzo. Le mie perplessità sull'organizzazione dei lavori non ebbero sorte migliore. Un ingegnere dalla voce sommessa, terminati gli interventi dei professori, disse che fuori avremmo trovato gli antipasti. Ci pregò anche di non soffermarci troppo nell'atrio, perché il pranzo sarebbe stato servito oltre il giardino. Fu notte fonda. Stavo riflettendo sul fatto che a parlare d'arte siano sempre tutti, meno che gli artisti. C'era un dubbio da sciogliere: sono gli artisti che non sanno cos'è l'arte, o le varie istituzioni, non sanno cos'è l'artista? Cresce male un mondo tirato di traverso, dove più che l'opera d'arte conta la cornice della festa. Il Rinascimento non è soltanto quello che avevo sentito raccontare in sala, ma probabilmente, per il comandante dei vigili urbani, quella era la versione giusta. Mentre provavo ad adeguarmi al clima festaiolo che si respirava nell'atrio davanti al tavolo degli aperitivi, non potevo non ascoltare cose peggiori di quelle che poco prima avevo sentito dire dentro il salone. Una signora piuttosto elegante stava raccontando ad una sua amica di essere stata a Firenze la settimana prima, e di aver sostato a lungo in Piazza della Signoria, rapita dallo splendore del “Davide” di Michelangelo. Esaltava lo scultore dicendo alla sua amica di aver apprezzato la cura della scelta del marmo e il trattamento delle superfici. Aggiungeva di aver notato interventi così minuti di scalpello che solo un grande artista avrebbe potuto fare. L'occasione era troppo ghiotta per non dar sfogo a tutta la mia cattiveria. La vicinanza delle due signore, mi aveva consentito di ascoltare tutto. Feci due passi e, alla signora vestita di tutto punto in blu, dissi: “Signora, la scultura in Piazza della Signoria è la copia del Davide, l'originale è nella galleria dell'Accademia”. Non mi soffermai neppure per cogliere l'espressione della malcapitata. Non avendo preso neppure in considerazione l’idea di andare al pranzo offerto da Comune, lasciai il bicchiere sul bordo del tavolo e me ne tornai a casa. Non mi sentivo particolarmente bene da giorni. Avevo attribuito il mio malessere alla solita ricaduta influenzale. Un ritorno a casa così mesto, non c'era stato nemmeno al rientro dal funerale di un mio amico che qualche tempo prima era andato a schiantarsi con la moto. Anche se avevo fatto finta che la cosa riguardasse altri e non me, l’influenza di stagione, dopo una prima visita, si era stabilmente fermata a casa mia. Andare regolarmente a lezione con la febbre, non aveva migliorato la situazione. Da allora mi sentivo debole. La bidella dell'Accademia, notando il mio colorito non propriamente roseo, non si era fatta mancare il più classico dei rimproveri: “Riguardati, se non vuoi passare tutta l’estate a letto”. Le sue parole ricalcavano quelle pronunciate dal mio medico curante, secondo il quale avrei dovuto sospendere per un po' tutte le attività e starmene a riposo. Probabilmente, come avevano detto medico e bidella, la mia trascuratezza non aveva contribuito a migliorare le cose, però sapeva di strano che a distanza di quasi tre mesi dal primo attacco influenzale, fossi soggetto a ricadute di questo tipo. Nel seguire gli interventi del convegno, continui abbassamenti della vista mi aveva costretto a ricorrere ad una qualche giustificazione nei confronti di me stesso. La sera prima avevo preso sonno molto tardi e quindi potevo essere stanco a tal punto da subire conseguenze di questo tipo. Sapevo che mi stavo raccontando bugie, però anche quello era un modo per risolvere apparentemente il problema. Del termometro potevo farne a meno: la febbre ormai la riconoscevo dalla stanchezza degli occhi. Negli ultimi tempi, mi capitava sempre più spesso dover convivere con le alte temperature. Più o meno ogni paio di settimane, mi ritrovavo nel letto a dover fare i conti con delle abbondanti sudate. Un paio di giorni e la febbre se ne andava, senza prendere medicine. Il medico, passata la stagione dei rimproveri, ebbe la fulminante idea di prescrivermi delle analisi che ovviamente non avevo ancora ritirato. Dovendo riportare nel pomeriggio l'auto dal meccanico, a causa di una perdita d’olio della pompa dei freni, pensai di approfittarne per far visita alla mamma. Lasciata la macchina in officina, avevo percorso qualche centinaio di metri a piedi. Ero arrivato molto stanco davanti alla porta di casa dei miei genitori, tanto da sentire la necessità di sedermi sulle scale della vicina. Sentii all'improvviso una specie di biglia di ferro che dal petto si stava staccando per arrivare in una frazione di secondo alla testa, facendomi svenire all'istante. Al mio risveglio, frastornato, vidi la vicina con un bicchiere d'acqua in mano che stava dicendo qualcosa ad altre persone giunte in mio soccorso. Nella piccola folla c’era anche Gianni in tenuta da lavoro. Siccome il cantiere nel quale stava lavorando distava qualche decina di metri dal luogo del fatto, si era precipitato per vedere cosa mi fosse successo. Non mi rendevo conto di quanto tempo fosse passato. La gente intorno a me azzardava ipotesi sulle cause del mio svenimento e proponeva soluzioni. Quella che sembrò raccogliere il consenso di tutti, riguardava l’idea di un trasferimento dalle scale della vicina dei miei al pronto soccorso. Mia madre aveva anticipato la sua consueta visita in chiesa, ma nessuno, per non farla preoccupare, pensò di andarla a chiamare. Mentre mi stavo lentamente riprendendo, Gianni, con un gesto deciso, mi fece capire che non dovevo muovermi. Poco dopo non lo vidi più, era andato a prendere la macchina per portarmi in ospedale. Mi sembrò naturale chiedergli di non farne parola con mia madre, ma ovviamente, stavo dicendo la più inutile delle frasi; troppa gente aveva assistito al mio svenimento, e nessuno dei presenti avrebbe tenuto la bocca chiusa. Il medico del pronto soccorso fece l'emocromo e lo confrontò con quello delle analisi che non avevo ritirato. Dopo essersi consultato con un collega, togliendosi gli occhiali, disse: “Queste, comunque, non sono analisi di uno che sta bene”. Con voce pacata aggiunse che avrei dovuto fare degli ulteriori accertamenti. Si stava rendendo necessaria una visita ematologia, che avrei comunque fatto in un altro ospedale. L'appuntamento fu preso il giorno stesso per il Venerdì successivo. Tre giorni dopo, mi ritrovai nella sala d'aspetto dell'ospedale, pieno di buchi in un braccio. Rassegnato a fare tutti gli accertamenti del caso, tra una visita e l'altra, sostavo in piedi sulla porta leggendo il giornale. Alle quattordici, nella stanza, c'ero rimasto soltanto io. Il medico mi fece entrare nello studio chiamandomi per nome, poi, guardando i fogli davanti, a sé disse che i noduli che avevo sul lato sinistro del collo potevano essere anche cumuli di grasso, ma aggiunse: “Io però non ci credo. Ho dato disposizione alla chirurgia per asportarne uno domani ed analizzarlo mediante biopsia, quindi si faccia trovare qui non più tardi delle nove, che faremo questo piccolo intervento; poi lei, visto che le è di strada, porterà il nodulo estratto a Viterbo al laboratorio analisi”. Avevo ascoltato cose poco rassicuranti. Alle domande fatte al medico erano seguiti corposi silenzi. Sapevo che i linfonodi ingrossati non sono indice di salute, ma il dottore aveva rincarato la dose dicendomi che la presenza linfonodale, come risultava dall’esame ecografico, era piuttosto estesa. Fatto l'intervento e portato il termos che conteneva il mio linfonodo al laboratorio analisi, non restava che aspettare due settimane per il verdetto. In questi casi, riuscire a far finta di nulla, è l’aspirazione principale, ma in qualche modo sapevo che i giorni davanti a me non sarebbero passati in fretta. La risposta delle analisi coincise con la medicazione della ferita. Mentre l'infermiera stava disinfettando il taglio che mi ritrovavo sul lato sinistro del collo, il medico sussurrò che le cose stavano messe peggio di come aveva immaginato. La diagnosi era di quelle che fanno tremare i polsi. Il medico, senza tradire emozioni, disse che il risultato della biopsia non aveva fatto altro che confermare i suoi sospetti, solo che non si aspettava che il linfoma, dal quale risultavo affetto, fosse al 4° stadio b, cioè l’ultimo. Aggiunse che partivamo svantaggiati per via della vasta presenza linfonodale, sia sopra che sotto il torace. Altra brutta notizia era costituita dalla compromissione del midollo. In momenti come questi, ti passa davanti l'esistenza intera. Rivedi fotogrammi della tua vita: una specie di ripasso a velocità vertiginosa. Prima delle parole del medico il termine “tumore” aveva sempre riguardato gli altri. Poche parole erano state sufficienti per farmi capire che la mia vita poteva anche finire lì. Mi venne in mente un frammento poetico di Nazim Hikmet che feci subito mio: “Non ho paura di morire ma morire mi secca”. Nessun isterismo aveva accompagnato la notizia La mia espressione era di incredulità. Quando il medico disse che bisognava iniziare presto con la chemioterapia, risposi che potevamo cominciare anche subito. Sorridendo aggiunse: “Non ci vogliono meno di otto ore, poi dovrà essere accompagnato e dovremo fare altri accertamenti. Si accomodi nell’altra stanza, adesso l'infermiera le dirà cosa dovrà fare”. Evidentemente non sapevo nemmeno cosa fosse la chemio. Stavano girando nella mia testa termini che mai avrei pensato potessero riguardare la mia vita. Di cose belle negli ultimi tempi non ne erano successe molte, ma questa poteva azzerare progetti, sogni e speranze. Quando fui accompagnato nella sala accanto per fare l'elettrocardiogramma, mi ritrovai vicino, distesa sul letto, una ragazza di neanche trent'anni, alla quale era stata diagnosticata la mia stessa malattia, solo ad uno stadio più basso. Eravamo due potenziali cadaveri che stavano sbirciando la televisione. Piuttosto nervosa, rigirava tra le dita il bracciale che si toglieva continuamente dal polso. Anche lei stava aspettando il medico curante, ma non per stabilire i cicli della cura: lo aspettava per dirgli che voleva soltanto firmare la cartella clinica e andarsene senza neppure iniziare la chemio. Dalle poche parole scambiate con lei, avevo capito che avrebbe seguito cure alternative legate a discipline orientali. Io, di malattie non ne capivo niente, ed ovviamente non potevo che essere a digiuno anche di possibili altre cure per guarire la malattia. Mi stavo semplicemente affidando ai medici dell’ospedale. La ragazza si chiamava Angelica ed aveva i capelli ricci, lunghi e neri. La sua espressione dura non lasciava trasparire emozioni. Al collo portava due catenine ed al polso un bracciale di rame che sfilava continuamente. Mi aveva salutato con un “Salve! Benvenuto nel club degli sfigati”. Niente male come inizio della cura. Angelica, di tanto in tanto, dirigeva nervosamente lo sguardo verso la finestra. Sembrava essere al di sopra della sua malattia. Voleva semplicemente prendere le sue cose e non farsi più vedere dai medici. Confermato l'appuntamento per il primo ciclo, mi alzai dal lettino guardando la ragazza, che nel frattempo aveva infilato un paio di occhiali e stava sfogliando una rivista. Presi tempo nel radunare le mie cose. Volevo salutarla, farle gli auguri, rivedere quegli occhi nascosti dagli occhiali. Quando mi vide in piedi davanti al letto, allungò la mano per salutarmi e farmi gli auguri per una cura, che a suo modo di vedere, avrebbe ucciso anche l’anima insieme alle cellule buone e cattive del corpo. Non mi era stato dato tempo per decidere nulla. I medici, tracciando il percorso di cura, avevano lasciato dentro la mia cartella clinica, scritte a penna, un’infinità di raccomandazioni che da sole, non facevano presagire nulla di buono. La ragazza, nel lamentarsi per il ritardo del suo medico curante, si alzò di scatto dicendo: “Se questo non arriva, io me ne vado comunque”. Giunto sulla porta, la salutai con un sorriso. In macchina, durante il viaggio del mio ritorno a casa, cercavo le parole giuste per annunciare la mia malattia senza far preoccupare troppo i miei genitori. Di tanto in tanto, lo sguardo della ragazza, me lo ritrovavo dentro la testa. Non ci saremmo più visti: in fondo, non le avevo chiesto neppure di dove fosse. Al mio primo ciclo, che avrei dovuto ripetere per sei mesi, più o meno tutti sapevano che avevo un tumore. Quello che i medici si erano dimenticati di dirmi è che la che mio, oltre ai capelli, ti fa perdere anche la sensibilità nei confronti dei sapori. Un paio di giorni dopo il mio primo trattamento, sentendomi le labbra come addormentate, misi in bocca un po’ di sale grosso. La sensibilità nei confronti dei sapori se ne era andata del tutto. Quello che sentii sulla bocca, erano sassolini insapore che rigiravo sulle labbra. Provai con un bicchiere di vino: era semplicemente acqua. Quando mi ritrovavo disteso nel letto per fare la mia bella flebo di otto ore, pensavo spesso alle parole dette dalla ragazza quel primo giorno. Il club degli sfigati era piuttosto frequentato, chissà se la sua decisione di percorrere altre strade l'avrebbe portata a risultati migliori? Verso il quarto mese, un contatto con il figlio di mia cugina, mi aveva messo a rischio varicella, visto che il bambino, il giorno dopo, si era ritrovato ricoperto di bolle. Questo significava che, se l'avessi contratta, non sarei sopravvissuto. Sarebbe stato, in quel caso, un bacio dato sulla guancia di un bambino la causa del mio possibile decesso, considerato che non avevo mai avuto la varicella e che le mie difese immunitarie erano nulle. Quando lo comunicai al medico, non ci furono giri di parole. Disse che se incominciavo a grattarmi, il tempo che mi sarebbe rimasto non avrebbe superato le due settimane. La raccomandazione dei medici fu quella di evitare qualsiasi forma di contatto con persone. Questo significava comunicare per telefono e farsi lasciare la busta della spesa sulle scale. Poteva anche essere inutile continuare a scrivere le dispense per i miei studenti. La mia principale attività consisteva nel rassicurare gli altri. La malattia, di fatto, la vivevo con una certa incoscienza. Molte delle cose proibite dai medici, facevano ancora parte della mia esistenza. Capitava che, mentre scrivevo al pc, mi guardassi le braccia. Trascorso qualche giorno, ebbi la sensazione di aver scampato il rischio varicella. Succedevano cose belle intorno a me: Federica era venuta a trovarmi e, da medico, aveva scommesso sulla mia piena guarigione. Bruno, quando tornava in paese, gran parte delle serate le passava da me. I ragazzi del mio corso, si erano dati appuntamento nel cortile di casa, portandosi appresso l'allegria più contagiosa possibile. Stavo imparando a leggere dentro il cuore della gente. A ricordarmi che stavo male c'erano i sensi di nausea, ma per il resto, stranamente, così bene non c'ero mai stato. La cassetta delle lettere, spesso piena di auguri, mi ricordava che intorno a me c’erano affetti veri. Tutti quelli che venivano a trovarmi si mostravano disponibili per rendermi la vita migliore. La solidarietà la respiravo insieme all’aria. Quando tornavo in ospedale chiedevo notizie alle infermiere della ragazza conosciuta nella stessa stanza dove facevo i trattamenti, però nessuno sapeva dirmi nulla di Angelica. Febbre e sudorazioni notturne erano pressoché scomparse. Contrariamente a quello che mi avevano detto, i capelli si erano indeboliti senza cadere. Quando mi guardavo allo specchio, vedevo una faccia gonfia e liscia, non propriamente bella, però quello era il prezzo da pagare. Al penultimo ciclo, mi aveva accompagnato Bruno. Mentre l’infermiera stava infilando l’ago nelle mie martoriate vene, arrivò la notizia della morte di Fabrizio De André. Quello scarno annuncio televisivo fece chinare la testa al mio amico. Sapevo che lo aveva conosciuto personalmente e, sul retro della chitarra, custodiva gelosamente la firma del noto cantautore fatta con un pennarello. Anche se quel tragico annuncio era nell’aria da un po’ di tempo, la notizia fece scendere un velo di silenzio, che sembrò preludere ad una giornata triste su tutti i fronti. La dottoressa Cristina, entrando nella sala, chiese se era successo qualcosa. Alla notizia del decesso di De André restò impietrita. Nei giorni che avevano preceduto il mio ritorno in ospedale, sapere che mi avrebbe accompagnato Bruno, mi aveva risollevato. Prima la morte di De André, poi un calcio dato da un medico all'armadietto di ferro della medicheria, fece piombare l'ospedale in un clima da incubo. Sentii urlare: “Questi li dovrebbero mettere tutti in galera!”. Il dottor Polidori stava urlando. La dottoressa tornò indietro, lasciando sopra il letto, vicino alla porta, il vassoio delle medicine. Bruno mi guardò per un istante chiedendomi cosa poteva essere successo, poi uscì sulla porta della stanza insieme ad alcuni pazienti che si stavano riversando nella grande sala antistante la medicheria. Il dottor Polidori, in preda ad un attacco d’ira, continuava ad urlare frasi pesanti all'indirizzo di qualcuno. Solo dopo essersi calmato, apparve chiaro il quadro della situazione. Bruno continuava a sostare sulla porta per capire cosa fosse successo, io ero nel letto con la flebo attaccata e non mi potevo muovere. Poco dopo, avvicinandosi, disse che avevano portato in ospedale una ragazza che stava morendo. Appena l’infermiera tornò per controllare il flusso della bromicina, le chiesi chi fosse quella ragazza. Associai l'urlo del dottore ad un qualcosa che non avrebbe dovuto succedere. Il presentimento mi stava conducendo dritto ad un nome che non osavo pronunciare. Scuotendo la testa disse: “Si chiama Asdrubali, era in cura qui, poi è andata via e adesso l'hanno riportata”. Non sapevo il cognome della ragazza conosciuta proprio in quella stanza, quindi chiesi se era Angelica. L’infermiera, uscendo dalla stanza, rispose: “Sì, è proprio lei”. Sospirando aggiunse: “Ma chi è che mette certe cose dentro la testa della gente?”. Bruno vide scendere dai miei occhi un paio di lacrime di quelle che scavano, poi mi domandò: “La conosci?”. Guardai la bottiglia della flebo per distogliere lo sguardo. Il mio amico, piegando il giornale nelle mani, sussurrò: “Ti lascio solo un istante, vado fuori a fumare una sigaretta”. La ragazza era stata portata in corsia. Volevo vederla, ma non potevo muovermi a causa dei tubi attaccati. Le restanti ore, prima della fine della somministrazione, le passai in silenzio senza dire una parola. Al momento di lasciare l’ospedale chiesi a Bruno se poteva aspettarmi in macchina. Aveva capito che non me ne sarei andato senza vedere la ragazza. Era stata messa in una stanza a tre letti, di cui uno vuoto e nell'altro dormiva una signora anziana. Mi avvicinai, il suo sguardo fisso verso la finestra mi aveva riportato alla mente quel primo giorno. Quando le chiesi se ricordava chi fossi, disse: “Certo, sei quello che è venuto quando sono andata via. Anche tu pensi che sono stata una stronza?” Non pensavo niente, la guardavo e basta. Avrei voluto chiederle perché avesse deciso di abbandonare le cure quel giorno, ma era semplicemente inutile fare domande. Fu lei che guardandomi disse: “La magia non ha fatto effetto, quindi sono tornata. Tu dici che è tardi?”. Che era tardi lo avevo capito da un calcio dato con forza dal dottore all’armadietto delle medicine, ma a lei cosa potevo dire? Il viso scavato, le mani pelle ed ossa, la sua voce debole, lo sguardo perso. Mi chiese della mia malattia. Risposi di non saperlo ancora se ero guarito. Accennando un sorriso aggiunse: “Quindi ci rivedremo qui? Magari vienimi a trovare”. Risposi di si, mi sembrò un po' sollevata. Nel salutarla, pronunciai la stessa frase che mi aveva detto il giorno del mio arrivo: “Benvenuta del club degli sfigati”. Non potevo fare nulla, se non chiedere al medico quanto tempo le restasse da vivere. La dottoressa Cristina, incontrata sulle scale, alla mia domanda, sospirò: “Poco, veramente poco, poi, a parte il fratello che è rinchiuso in una comunità, non ha nessuno”. Avevo già deciso che mi sarei occupato di Angelica. Durante il tragitto, Bruno mi chiese della ragazza. Non solo non avevo risposte, per il troppo silenzio le mie labbra si erano incollate. Giunti sotto casa, dalla mia bocca uscì solo un flebile grazie per avermi accompagnato. Per uno che ha appena fatto la chemio, è proprio strano desiderare di tornare presto in ospedale. Avrei potuto attendere il periodico esame del sangue che facevo solitamente dopo una settimana dalla somministrazione. Due giorni dopo, nel bel mezzo delle mie crisi di nausea, senza dire nulla a nessuno, andai in ospedale. Le portai qualcosa da leggere ed una serie di disegni che avevo fatto per realizzare dei monili. Nella busta di plastica avevo messo anche dei succhi di frutta, un dolce e due bottigliette di acqua minerale. Sembrava che stesse un po' meglio, ma probabilmente si stava facendo forte per non farsi vedere abbattuta. Portava una maglia a maniche larghe con sopra disegnati dei motivi orientali. Le chiesi se potevo andare a comperarle un pigiama, rispose che tanto non lo avrebbe messo. Aggiunse però che, se volevo, potevo ricaricarle il telefono. Nello scendere le scale per andare al bar, mi resi conto di aver perso completamente di vista la mia malattia. Stranamente, i sensi di nausea provocati dalla chemio riuscivo a sopportarli meglio delle altre volte. Pensai di prenderle anche qualche rivista ed una spazzola nuova, visto che quella che aveva sul suo comodino era ridotta piuttosto male. Nel cercare di non farla sentire sola, non mi sentivo solo neppure io. I giorni che non potevo andarla a trovare, la sentivo per telefono, non dimenticandomi mai di chiederle se le serviva qualcosa. Anche se i medici erano stati severi nell'impedirmi di lavorare, senza dire niente a nessuno, e lontano dalle ore di possibili visite di amici e parenti, avevo messo mano ad uno dei disegni scelti da Angelica. Realizzare un monile per lei era quanto di meglio potessi fare per metterle sulle labbra un sorriso. Come pietra avevo scelto il porfido d’Egitto, la montatura sarebbe stata in oro bianco. Una sensazione strana lavorare di notte, facendo molta attenzione a non lasciare residui di lavorazione. Nonostante avessi preso tutte le precauzioni del caso, di fatto, respiravo polvere molto nociva per la mia precaria salute. Tornato in ospedale, trovai Angelica seduta sul letto. Sapendo che sarei andato a trovarla, mi fece trovare un braccialetto di fili intrecciati. Dissi: “Anche io ho fatto qualcosa per te” . Le misi al collo il mio monile. Quelle braccia sottili mi strinsero forte, poi, dopo aver guardato la pietra aggiunse: “Ma questo è uno dei disegni che mi hai fatto vedere l'altra volta, e quando lo hai fatto?”. Nulla era più importante in quel momento del suo sorriso. In qualche modo, credevo di poterla guarire, ma il destino aveva semplicemente ritenuto giusto che quella ragazza, sul finire dei suoi giorni, avesse accanto qualcuno. Quando lentamente si sdraiò sul letto, ebbi la sensazione che di tempo non ne fosse rimasto molto. Avrei voluto farmi ricoverare per starle vicino, ma questo non era possibile. Il tempo che stavamo insieme lo trascorrevamo parlando d’arte e di viaggi. Mi diceva che le sarebbe piaciuto laurearsi in pedagogia, solo che, dopo la morte dei suoi genitori, non avrebbe saputo nemmeno come pagarsi le tasse universitarie. Aveva viaggiato, lavorato saltuariamente come commessa e cameriera. La sua vita, più disordinata della mia, appariva come un intreccio di situazioni impossibili. Fili tesi tra Roma ed il lontano Oriente dove era stata più volte. Qualche giorno dopo, sentendo che non rispondeva al telefono, pensai che si fosse dimenticata di accendere il cellulare, quindi chiamai in corsia. Rispose la capo sala. Quando dissi all’infermiera di verificare se Angelica avesse il telefono spento, il silenzio di qualche secondo mi fece capire che era successo qualcosa. Sentivo che dall’altra parte del telefono, qualcuno stava cercando le parole giuste per dirmi che Angelica era morta nel corso della notte. Non c’erano altre domande da fare. L’infermiera, sentendo il mio respiro pesante, cercò di consolarmi dicendomi che, comunque, Angelica aveva lasciato qualcosa per me. La cosa più naturale del mondo sarebbe stata quella di precipitarmi all'obitorio, ma a cosa sarebbe servito? Io non volevo vederla morta. Di questa corsa inutile verso l’ospedale sentivo di poterne fare a meno, perché potevo piangere anche con la testa sul vetro della finestra. L'ultima volta l'avevo vista seduta sul letto. Non potevo accettare di vederla distesa nella camera mortuaria dell’ospedale. La rabbia era tutta per quei bastardi che l'avevano convinta a spalmarsi sul petto e sotto le ascelle olio di mais macerato in foglie d’alloro e uova di scarafaggio. Il calcio dato con forza all'armadietto delle medicine dal dottor Polidori, mi sveglia spesso la notte. Angelica continua a raccontarmi di sé e dei suoi viaggi, mentre quelle poche immagini di lei che sorride, fanno compagnia alla mia vita. “Il club degli sfigati” continua ad essere frequentato da molta gente. Alcuni vengono rispediti indietro, altri, senza volerlo, ne diventano soci. Angelica aveva lasciato per me, sul comodino, queste parole: “Ciao professore, oggi sto sudando troppo perché possa pensare a giorni felici. Non arrabbiarti se quando verrai sarò andata via. Magari sto esagerando, però il dottore non mi è sembrato particolarmente felice delle analisi di questa mattina. Volevo dirti che mi hai fatto proprio una bella compagnia in questi giorni. Non so come dirtelo, ma avrei voluto conoscerti prima. Spero che queste poche righe ti vengano consegnate il più tardi possibile, ma quando le leggerai pensa a me come hai fatto in questi giorni, senza farmi mai mancare il sorriso. Che ti dico? Io non sono brava come te con le parole, però pensami ogni tanto, soprattutto quando lavori. Sai, il monile che hai fatto per me è proprio bello. Non sono riuscita a dirtelo il giorno che me lo hai dato, te lo dico adesso. Magari mi dedicherai una poesia. Volevo scrivere tante cose, adesso non mi viene in mente niente. Poi, accidenti come pesa la penna. Insomma, grazie. Non potrò mai renderti i soldi che hai speso per me, però ti prego, insieme a questa lettera, prendi anche il mio cellulare. Tienilo acceso sempre. Ti voglio bene. A.” A quelli che chiamano cercando di lei, dico che Angelica mi ha lasciato il suo telefono perché nel luogo dov’è andata non c’è campo. A forza di dire che è partita per un viaggio, mi sono convinto anche io che prima o poi la vedrò tornare. Non sono mai stato a Terracina dov’è seppellita. Lì c’è soltanto un corpo che presto verrà inghiottito dalla terra; la sua anima invece è ovunque. Continuerò a tenere il suo cellulare acceso, anche quando non la cercherà più nessuno. Quando sono tornato in ospedale per il mio ultimo trattamento, mi hanno fatto trovare sul comodino dentro una busta chiusa, la lettera, la spazzola che le avevo regalato ed il suo cellulare. Sono tornato per l’ultima volta in quella stanza divenuta improvvisamente anonima Era un giorno di pioggia di quelli che aggiungono malinconia ai silenzi tristi già stipati dentro la bocca. Non avevo più vene buone per la chemio e, dopo vari tentativi, Antonella, l’infermiera, era riuscita a far scendere l’ago sopra il dorso della mano. Mentre con le dita premeva sul braccio per far scendere il sangue, commentava il giorno che aveva preceduto la scomparsa di Angelica. Senza chiedermi come mai non fossi tornato in ospedale per darle l’ultimo saluto, disse: “Tanto non sarebbe servito a nulla. Quello che sa di strano è che anche noi non siamo serviti a niente. Sai, ti aspettava, sapeva che non saresti venuto ma ti aspettava. Credo che volesse morire tra le braccia di qualcuno. Poi invece ha perso i sensi. Portarla in rianimazione è stata la cosa più inutile del mondo. Tu invece come ti senti?”. Non sapevo se la sua domanda si riferisse alla malattia o piuttosto a quello che stavo provando per la scomparsa di Angelica. Risposi: “Bene, credo di sentirmi bene, almeno per quello che è possibile. Perdonami se te lo dico, ma se guarisco non vi voglio più vedere”. Mentre districava il tubicino della soluzione fisiologica che si era avvolto ai fili dell’elettrocardiogramma, sospirò: “Magari! Questo è solo l’ultimo giorno della chemio, speriamo. Ne parleremo dopo la TAC, e comunque ne avrai ancora per un bel po’. Oggi finiamo di fare i buchi in queste braccia che ormai non ne possono più. In ogni caso, ci sarà da fare la radioterapia. Aspettiamo i risultati della TAC che farai Mercoledì, poi il dottor Polidori deciderà i dosaggi”. Sì, mi era stato detto che il calvario non sarebbe finito con la chemio. Chiesi all’infermiera se i trattamenti radioterapici fossero stati comunque necessari. La risposta fu che non c’era possibilità di scamparla, visto che venivano fatti già dal primo stadio del morbo di Hodgkin. Io ero all’ultimo ed i miei linfonodi erano stati classificati come “uova di piccione”. Non capivo comunque come mai avessi l’impressione che quello fosse il mio ultimo giorno di cure. Le ragioni del mio ottimismo non avevano alcun fondamento. Mi si stava chiedendo di avere pazienza, anche perché, come ripetevano spesso medici ed infermiere, ero arrivato in ospedale ridotto piuttosto male. Arrivai al giorno della TAC con quella naturale paura di chi sa che da un esame medico dipendono molte cose della sua vita. Disteso sul lettino di quella stanza vuota, cercavo di non pensare a nulla, ma in qualche modo la mente rovistava dentro le speranze per trovare appigli di conforto. Sarei dovuto tornare in ospedale la settimana successiva. Nel frattempo, potevo illudermi che quello sarebbe stato l’ultimo giorno. Una volta a casa, nonostante la debolezza minasse le gambe, decisi di farmi una bella camminata dal casale fino al bar, ma non perché volessi bere qualcosa. La perdita dei sapori, dovuta alla chemio, avrebbe reso identici un bicchiere d’acqua ed un amaro. La giornata, se pur ventilata, era di quelle che rendono piacevoli le passeggiate. Giunto al bar, mi fermai a parlare con un amico che aveva preso a lamentarsi di un dolore alla gamba. Mi sarebbe venuto da dirgli che c’è di peggio in giro, però è risaputo che se c’è una cosa alla quale siamo particolarmente attenti, quello è il proprio dolore. La mia sosta non poteva essere lunga perché a casa mi aspettava il consueto appuntamento con le medicine. Sostai per un attimo sulla porta del bar, e improvvisamente sentii uno strano profumo nell’aria. L’odore che avevo sentito per qualche istante era stato talmente intenso da costringermi a mettere la mano sul naso. Guardai i ragazzi seduti ai tavoli e nessuno sembrò infastidito da odori forti di nessun tipo. Mi incamminai verso casa pensando a questa sensazione solo per qualche secondo. Arrivai stanco. Il bisogno fu quello di distendermi sul letto. Neanche il tempo di togliermi le scarpe e mi addormentai. Il sonno durò poco. A svegliarmi fu un forte senso di appetito. Nei mesi scorsi avevo mangiato perché dovevo, non perché volevo. Non sentire alcun sapore rende improbabile il desiderio di cibo. D’istinto andai in cucina, presi un pugno di sale dal contenitore di vetro e lo misi in bocca. Sputai tutto nel lavello. Avevo sentito il sapore del sale come qualsiasi altro mortale. Emozionato dall’accaduto, cucinai una bistecca. Mentre ripetevo a me stesso che era impossibile quello che mi stava succedendo, misi in bocca la carne: dopo sei mesi sapeva di buono. Mangiai con la voracità di chi non lo fa da settimane. Tornato in ospedale per i risultati della TAC e per fare il mio solito emocromo, feci le scale senza sostare mai sui pianerottoli. Il dottore, eseguiti gli esami di rito, decise di farmi un altro prelievo per ripetere le analisi. I globuli bianchi, che non avevano mai superato le 3000 unità, erano raddoppiati e dalla TAC non risultava alcuna presenza linfonodale. Vidi il dottor Polidori parlare con la dottoressa Cristina. Sentii dire dalla dottoressa che non aveva alcun senso programmare i cicli di radioterapia, perché non c’era niente da bombardare. A quel punto, la dottoressa decise di fare l’esame del midollo, sottoponendomi a quella tortura che conoscono bene quelli che hanno fatto questo genere di esame, che consiste nel farsi forare l’osso per estrarne un frammento. Mentre ero ancora disteso sul letto, che presentava abbondanti chiazze di sangue, la dottoressa, togliendosi gli occhiali disse: “Senti, io ho fatto l’esame al tuo arrivo in ospedale; il midollo era marrone ed in quella circostanza ho pensato che non ce l’avresti fatta. Adesso quello che era un midollo marrone è rosso vivo. Può farti piacere se ti dico che sei guarito?”. Chiesi della radioterapia. La risposta fu che non ci sarebbero stati cicli e che dovevo tornare in ospedale solo per i controlli. Aggiunse: “ Le risposte alle domande che ti stai facendo possono essere di vario tipo. Diciamo che siamo contenti di non doverti avere più tra i piedi”. CAPITOLO IV (Alessandro il cappellaio) Al numero 12 di Via dei Solari, vive ancora un cappellaio davvero bravo che una volta costruiva cappelli con finissime trame in tessuto e fodere lucenti. Il suo vero nome è Alessandro, ma tutti lo chiamano Gigi. Le mattine, dopo aver preso il giornale, andava al lavoro in bicicletta. Alzata la saracinesca, tutto contento, incominciava a disporre la sua merce su trespoli di legno. Attaccata la campana d'ottone dietro la porta, si rinchiudeva nello stanzino dove ritagliava con sapiente maestria sagome di cartone, facendone solide armature per quei cappelli da appendere al muro. Contento nel vedere la gente misurare i suoi cappelli, salutava sempre con il nome che gli avevano dato gli altri. Che lo chiamassero Gigi o Alessandro gli era del tutto indifferente. Malgrado avesse la grazia di una persona anziana, non era vecchio; è sempre stato un uomo al quale non sapresti dare un'età. Ragazzi diventati adulti se lo ricordano con quel taglio di giacca e le scarpe lucide tirate a festa. Sono passati tre lustri e quel negozio è ancora in Via dei Solari, e Gigi, per una questione d'insegna sopra la porta, non si chiama più Gigi ma Alessandro. Quella che una volta era la bottega del cappellaio è stata rilevata dalla figlia che l'ha tramutata in un negozio raffinato. Niente più trespoli di legno, niente più cappelli nello stanzino. Da quando ha appeso la bicicletta al chiodo, al negozio ce lo accompagna il genero, che lo va a riprendere all'ora di pranzo. Saranno gli anni che passano, e passano per tutti, ma Alessandro non ha più il sorriso di una volta. Buona parte del suo tempo, gli siede accanto sulle scale del negozio. Adesso non fabbrica più cappelli, glieli portano dentro eleganti scatole direttamente dal Piemonte. I clienti si complimentano con lui perché adesso la vetrina è davvero bella. Degli scaffali in castagno mezzo consumati non ne è rimasto niente. Il bancone di legno contornato in ottone con le misure sul retro, si ricorda di averlo visto l'ultima volta in campagna dal genero, poi non ne ha saputo più nulla. Alessandro non è triste per il bancone o per gli acciacchi degli anni. E' triste perché vende di tutto ma nulla di quello che ha sapientemente costruito per anni. Il suo è diventato un negozio come tanti. Sopra mensole di cristallo ci sono borse e portafogli firmati. Niente più ordini, niente più gente che misura i suoi cappelli. Quando ci parlo, mi dice che è un torpore grigio la sua vita, e ogni volta, mi ripete la stessa frase come se non l'avessi capita. Cerco di confortarlo dicendo che il mondo cambia e qualche volta in meglio. Mi risponde, scandendo bene le parole, che la gente non è più la stessa e che, a parte il prezzo, di quello che compra non gliene importa niente. Lui è sempre lì a rincorrere con gli occhiali quelle minuscole etichette che cambiano sempre. I clienti pagano alla cassa ed in quello scontrino, dove lui vorrebbe che ci fosse scritta la sua vita, ci sono solo dei numeri ed un “grazie ed arrivederci”. Gigi non c'è più, se n'è andato con l'ultimo cappello venduto al farmacista del paese, tra l'altro il padre di Federica. Alessandro continua a non darsi pace del fatto che della sua vita sia rimasto solo un anonimo buonasera per l'ultimo cliente, prima che la figlia lo vada a prendere per riportarlo a casa. Quella di Gigi è la metafora del mondo che cambia, è il dissolversi delle identità, è la confluenza del particolare dentro il frammentario. Gigi non è soltanto un uomo triste, è un cappellaio al quale non commissioniamo più cappelli. Non si dica che non c'è più un pittore che sappia emozionarci con un tramonto o che sono scomparsi gli scultori capaci di tradurre la grazia di una giovinetta scolpendola nel marmo. La fabbrica del bello si è trasferita altrove. Nel luogo dove fabbricano cappelli, possono dipingere i ritratti più belli del mondo, e pantografare nel marmo la grazia di una giovinetta senza che uno scultore ci posi sopra uno scalpello. E' stato già deciso che tutto quello di cui possiamo avere bisogno, in tutte le misure e confezionato bene, lo fornisce l'industria ad un prezzo migliore. Dunque, può avere ancora un senso rincorrere il passato? Cadute le distinzioni entro le quali l’uomo coltivava la sua terra, quello che rimane è uno spazio indefinito come la bottega del cappellaio: un luogo pieno zeppo di tante cose e tutte diverse. E' questo il mosaico entro il quale viviamo. Ci rammarica la tristezza di Alessandro, che tutti vorremmo vedere al suo posto, con i suoi trespoli e la campana d'ottone dietro la porta. Probabilmente trascuriamo di essere stati noi i primi a non commissionargli più cappelli. Non lo so se Alessandro ha più stima di me perché nel mio lavoro ritrova la sua manualità artigianale, o perché i libri che mi porto dietro mi danno un'aria rispettabile da professore. Quando la Domenica mattina la sua consueta passeggiata lo conduce da queste parti, non perde l'occasione per mostrarmi le foto sbiadite della sua vita, che si porta appresso dentro la tasca della giacca. In quelle tasche piene di passato, insieme alle foto dei suoi cappelli finiti, ci sono le briciole della sua giovinezza mescolate a mozziconi di sigarette. Per lui sono lo stesso ragazzino che giocava a pallone davanti alla sua bottega. Risento le prediche di allora, quando facevo volare qualche cappello dai trespoli con il pallone, scatenando la sua ira. Non è casuale che la sua passeggiata lo conduca dalle mie parti; anche se la figlia si prende cura di lui, in fondo, Alessandro è un uomo solo. Il tempo che passa, quando lo vedi scorrere davanti agli occhi tutti i giorni, ha la consistenza di un ferro che divide il passato dal presente. Alessandro lucida col gomito i ricordi che si porta appresso, senza i quali, qualsiasi ritorno a casa sarebbe un trascinarsi. I suoi lineamenti garbati, che fanno pensare alla saggezza, mi scorrono dentro. Non so se quelli che fanno rumore sono i ricordi di quando lo vedevo arrivare al casale con la vespa per consegnare a mio padre le scarpe da lavoro. Di quella timidezza nascosta dietro i tronchi d'ulivo, riassaporo le paure di quel bambino che fuggiva sempre davanti al nuovo. Adesso che ci ritroviamo la Domenica mattina sul muretto che costeggia il fosso, stendiamo la tovaglia delle parole e sopra, il passato, suo e mio, apre le danze del nostro farci compagnia. Mi parla dei suoi cappelli e delle scarpe di cuoio che consegnava nelle case di campagna. Molti dei clienti che aveva non ci sono più, e lui si sente un superstite di questi viaggi tra i campi assolati. Di quelli che sono ancora vivi, ne traccia il profilo commentandone i comportamenti e la vita. In qualche modo, per lui, i cappelli sono il completamento della personalità e non semplici copricapo per l'estate o per l'inverno. Oggi il sole accarezza i fili d'erba dello stradone. Quando ero bambino dicevo che sarei stato in grado di riconoscere il sole della Domenica da quello degli altri giorni. Aver vissuto qui è stata la cosa più bella che mi potesse capitare: i profumi, i colori, la campagna con tutti i suoi vestiti. Alessandro mi ha riportato dentro una busta di plastica uno dei tanti libri che gli presto, quando viene a trovarmi. Non sono libri che ho letto, sono semplicemente libri che ho comprato, quando pensavo che la cultura potesse trasferirsi al cervello direttamente dalle mani. Di quei libri portati a spasso ricordo poco, leggerli adesso mi sembrerebbe rincorrere il passato. Lui però li legge e li commenta con molta attenzione. Si lamenta della vista e sorride quando gli dico che un giorno ne scriverò uno con le parole grosse e che dentro ci finirà anche la sua vita. E' strano, io sono diventato adulto e lui non è diventato vecchio. In qualche modo, nel senso buono, lo è sempre stato. Mi ha portato dei compassi che usava per il lavoro. Dice che potrebbero servirmi. E' commovente vedere come li ha avvolti negli scampoli di stoffa. E’ un bel regalo. Parte della sua vita adesso è nelle mie mani. Alzando le spalle, sussurra che tanto, se non li prendessi io, farebbero una brutta fine. Quello che lui si aspetta è che gli chieda qualcosa del passato. I regali che posso fargli sono fatti di domande. Non avevo mai pensato di poter rendere felice un uomo chiedendogli della sua vita. Siamo entrambi soli, ma le nostre solitudini hanno in comune soltanto il silenzio: la mia è funzionale a quello che faccio, la sento necessaria. La sua è di quelle che non vorresti avere. Non sapendo nulla di me e di Federica, mi parla del signor Fausto e dice: “Il farmacista sì che è una persona colta ed intelligente”. Mi racconta di quanto era esigente, quando entrava nello stanzino per scegliere la stoffa dei cappelli. Tira fuori della tasca una foto e con orgoglio mostra l'immagine del dottor Fausto con la moglie e la figlia, fatta con lui al pranzo della comunione di Federica. Per lui quella bambina è soltanto la figlia del suo migliore cliente, per me le cose stanno in un altro modo. Cerco i ricordi di quella bambina vista sempre di sfuggita in compagnia della nonna. Vestita sempre bene, aveva una pelle candida, di quelle che non possono essere sfiorate neppure con un dito. Ricordo di averla guardata con invidia, un giorno di Luglio, quando girava attorno alla macchina del padre, mentre il dottor Fausto caricava le valige per il mare. Io, al massimo, potevo andare al lago con uno zio, quando veniva da Roma la Domenica. Il frigorifero a casa mia era il secchio d'acqua fresca, non avevo il telefono e neppure la televisione. Mondi separati da distanze abissali. Non mi sembrava giusto che anche a scuola i figli dei ricchi fossero trattati in un altro modo. Se qualcuno di loro non studiava, veniva aiutato perché aveva dei problemi. Se io non studiavo, ero semplicemente un somaro. Sono stato bocciato in quarta elementare perché ero timido e balbuziente. La colpa che avevo era quella di detestare la mia voce. Non sapevo leggere e non sapevo parlare. Forse non volevo leggere e non volevo parlare. Mentre parlo ad Alessandro del mio passato lo vedo sorridere, perché per lui contano più le rivincite. Mettendomi la mano sulla spalla dice: “Quella pagella mi sembra che tu l'abbia riscritta, non ti pare?”. Stringo le labbra, guardo l'orizzonte, poi incrocio il suo sguardo. Difficile trattenere quel paio di lacrime contenute dentro occhi che non sanno attendere un momento diverso. Si accorge della fatica che faccio per trattenere il pianto e prova a cambiare discorso chiedendomi di mio padre. Dentro questo strano imbuto ci finisce anche lui, perché il giorno che arrivai con la pagella a casa, mi consolò portandomi a vedere i coniglietti appena nati. Non ci fu nessun rimprovero, solo un po' di silenzio, lo stesso silenzio di adesso. Alessandro aggiunge: “Una volta si nasceva predestinati. Avrei voluto studiare, fui messo a bottega da Giacinto il ciabattino; un privilegio, perché i miei fratelli andarono a lavorare i campi”. Il passato, come luogo dove si incontrano quelli che hanno qualcosa da dire, riecheggia nelle mie e nelle sue parole. Ci chiediamo quanto della vita in realtà sia già scritto. Guardo i filari della vigna, i più lunghi sono quelli che costeggiano la strada. Ripenso a mio padre, a quando mi diceva di coltivarne uno soltanto, almeno per vedere il risultato della fatica. Sopra la pietra che sto lavorando c'è il libro che ho preparato per Alessandro: ecco i miei due filari della vigna che comunicano solo alla fine dello stradone. E' passato molto tempo e le mie scarpe da lavoro sono state divorate dai sassi. Alessandro dice che le cose importanti costano molto. Mi chiedo se il prezzo che si paga vale lo spettacolo. Le scelte importanti non si fanno neppure, ti arrivano addosso direttamente e con incoscienza le segui. Per Alessandro le semine sono sempre un grande atto di fiducia. Il libro che ho sfilato dallo scaffale della libreria non è un libro qualunque, è quello che ha segnato la mia esistenza. Sapendo che Alessandro sarebbe venuto, ho preferito quello dei posti a sedere di mezzo del pullman, quello prestato a Federica, il primo libro che ho letto. So che lo leggerà tutto d'un fiato come gli altri. Ne parleremo; chissà se avrò le stesse parole dette quel giorno a Federica sulle scale della biblioteca. Sarà l'occasione per raccontargli anche il resto. Ci sono cose che non capisco e che sfuggono alla mia comprensione. Perché quel giorno, da ragazzo che non aveva mai letto un libro, comperai proprio quello in una bancarella di Piazza del Sacrario? Perché quel libro e non un altro? Il destino stava anticipando le mie mosse. “Verso una psicologia dell'arte” di Arnheim è un testo che ha fatto parte della mia bibliografia nell'insegnamento in Accademia, ed il titolo corrisponde alla materia che ho insegnato per anni. Allora studiavo elettrotecnica, non capivo nulla d'arte e neppure mi piaceva; non ero bravo a scuola e mai avrei pensato di poter insegnare qualcosa. Il destino ha messo nelle mie mani quel libro, poi, sapendo che non lo avrei mai letto, mi ha fatto conoscere Federica che in qualche modo mi ha obbligato a leggerlo. Federica quindi è stata tirata in ballo da un destino che aveva già deciso i passi successivi. Fa un po' paura tutto questo, ci si sente spettatori della propria vita. Io ero dall'altra parte del fiume, non sapevo nuotare e non avevo barche a mia disposizione. Mi chiedo se per il destino non fosse più comodo scegliersi qualcuno già in prossimità della riva. Non capirò mai perché ad un certo punto della mia vita ho incominciato a svegliarmi la mattina molto presto per studiare. Possibile che io abbia fatto tutto questo per piacere ad una ragazza? Quando racconterò queste cose ad Alessandro, lui mi dirà che certe scelte hanno il doppio del valore, proprio perché segnate dal destino. Capirà anche perché la foto che sto tenendo tra le dita non è semplicemente l'immagine di una bambina con l'abito della comunione. Più che una vita da vivere, mi sembra una vita da seguire quella che mi ritrovo appiccicata addosso. Non avevo idea di cosa fosse l'arte e non era previsto nessun incontro con la scultura. Perché il giorno del mio compleanno sono finito, senza saperlo, all'interno di una cava dove nei laboratori si lavorava la pietra? Perché il 18 di Agosto, quando tutte le attività industriali sono chiuse, ho trovato, in quel luogo, uno scalpellino saggio che mi stava aspettando con una matita in mano? Quando ci si ritrova stranieri di se stessi si cerca di capire, anche a distanza di molti anni, quello che può essere successo da un certo momento in poi. Vittorio aveva delle mani enormi da boscaiolo, ma la grazia con la quale stava scolpendo sulla veletta di un camino una meravigliosa rosa, mi fece comprendere quanto di inaspettato la vita può riservare. Dissi a quello scalpellino che mi sembrava impossibile fare con gli scalpelli una cosa del genere. Sorridendo, rispose che non esiste niente di impossibile, a patto che la cosa che vuoi, tu la voglia veramente. Il libro, Federica, il professor Cionco, Vittorio, adesso Alessandro: tessere di un mosaico di un disegno o incontri casuali? Alessandro mi guarda aspettando quel sorriso che gli dica di mettere dentro la busta di plastica il libro da portare a casa. Se me lo avessero detto che un vecchio cappellaio, che non ha neppure terminato la terza elementare, conosce la Divina Commedia a memoria e sa tradurre il latino, non ci avrei creduto. Alessandro parla il linguaggio dell'arte e della letteratura. Conosce la filosofia. Poter parlare con lui di Cartesio e Kant fa impressione. Commenta Duchamp, dell'artista cita gli scritti del 1960 ed aggiunge che dovrei seguire gli insegnamenti del “maestro”. Per Alessandro l'artista ha principalmente il ruolo di educatore sociale. Lui vede nella sensibilità lo strumento per aiutare tanti giovani a trovare la loro strada. Probabilmente sono meno ottimista del mio vecchio amico, ma comunque anche io credo che a qualcosa serva ragionare d'arte ad alta voce. Gli amici con i quali condivido il poco tempo che ho, sono gli stessi con i quali andavo da ragazzino a rompere con la fionda le lampadine della strada. Per loro, sentirmi parlare di César, è riconoscere in me un povero matto che fa una demenziale arringa in difesa di un rottame d'auto schiacciato dalle presse. La loro vita è fatta di concretezze nelle quali ritrovano quella personale serenità che all'artista sembra dover mancare per forza. Facciamo mestieri diversi, però giochiamo a calcetto e ci voltiamo quando passano le belle ragazze. Dico ad Alessandro che in un mondo dove Pollock è scambiato con il rivestimento per il divano, è difficile far valere le ragioni dell'arte. Gli studenti che ho avuto con me a lezione dovranno sudare molto per potersi mantenere da artisti e, parecchi di loro, per vivere, dovranno fare un altro mestiere. La realtà che li attende è già scritta sopra un vecchio copione. Seduti a tavola dovranno discutere con i loro genitori di quello che intenderanno fare del loro futuro. Da questa che sembra una perenne perdita di tempo, c'è da aspettarsi di tutto, anche che qualcuno giudichi il futuro con il metro delle bollette da pagare. La forza che avranno è tutta nelle motivazioni che ognuno di loro saprà trovare. Domani, più delle parole, sarà giudice il silenzio e gli esami li dovranno fare tutti i giorni. Servirà essere bravi ma soprattutto fortunati. Servirà sapere quelle cose che non puoi raccontare, perché se non le dici nel posto giusto, non ti capisce nessuno. E' di questi posti giusti che ho paura: sono stanze piccole dove ci si sta in pochi o da soli. Troppo di frequente si assiste a questo lasciare indietro cose che dovrebbero arrivare per prime. Di questo passo, quello che riusciremo a leggere saranno soltanto i libretti delle istruzioni. L'indifferenza ha un suo spessore: è questo il germe che impedisce effettivi travasi di cultura. L'arte evidenzia il disagio profondo di una società che vive nella contraddizione perenne di chi cerca nuovi mondi e non si accorge di quelli che ha dentro. Nessuno bussa alla porta dell'uomo, ecco perché l'uomo non risponde. Mi lamento con Alessandro e dico che i miei amici non vengono più con me a vedere le mostre perché si annoiano. Anche io mi annoio, però ci vado. E' da voltastomaco sentir parlare di come, quel determinato quadro, starebbe bene in sala, se solo fosse più grande e se avesse colori che si intonano con le tende o con il divano. Dentro una sala l'arte e fuori il mondo. Un mio collega dice che si va alle mostre per farsi vedere, perché alle inaugurazioni ci sono i critici e soprattutto gli assessori. Potendo scegliere, preferisco intrattenermi con le belle signore, se non altro ti lasciano dentro gli occhi sorrisi che puoi portarti a casa. Così, tra donne, politici e personaggi bene, si consuma la festa attorno al tavolo dei pasticcini. E l'arte? Una performance meravigliosa: per un giorno si trasforma in cornice. Tornerà ad essere arte il giorno dopo. Quando dico ad Alessandro che in fondo mi pagano per dire cose che racconterei gratis per strada, sorride. E' quasi l'ora di pranzo ed il mio amico deve tornare a casa. Mi volto e guardo la parete per metà coperta dall'edera: in decine di anni nulla è cambiato. Quando guardo dalla finestra non ho più la ringhiera sul mento, ma vedo gli stessi tetti che s'imbiancavano d'inverno. Allora la felicità era non andare a scuola, adesso la felicità è vedere il paesaggio che cambia in un baleno. Di questo guardare dalla finestra mi resta la voglia di scoprire tutte le altre cose che sono dietro il vetro e che non vedo. Faccio il nodo agli appetiti che ho dentro. Si cresce, in qualche modo si cresce, anche se a volte le cose che sono intorno a noi restano le stesse. Sotto la vernice riaffiora il passato che mi trascina dentro il vortice delle cose che ho odiato. Quelle che ho amato le porto con me ogni volta che chiudo la porta alle mie spalle per mescolarmi alla gente. Questa armatura invisibile, lustrata dagli affetti più cari, è la sola difesa che conosco per non sentirmi spoglio dei miei averi. Stasera il lampione che illumina il fosso mi dirà che i miei occhi non avranno trovato una fuga migliore. Se non fossi schiavo di tutto questo, non potrei scrivere una sola parola per sentirmi libero dentro le cose che vedo. La mia è una felicità che non ha verso e quindi non posso indossarla per andarmene in giro; posso farne però un lieve distendersi di frasi per quelli che, come me, chiudono gli occhi, quando questo involontario mondo racconta poesie. La polvere di questo tempo, trascorsa o scivolata nelle mani, lascia possedere i frammenti di riesumazioni lente. Quali nudità abbiamo, se non quelle ferite o illuminate dal destino che ama rileggersi ripercorrendo i passi che ci hanno condotto da qualche parte, lasciandoci ignorare il dove. Sarebbe facile dire che è notte; invece questi frammenti di vita invecchiati, luccicano al sole di mezzogiorno. Davvero si possono incontrare le gioie ed i dolori del mondo standosene seduti sulle scale di casa? Mio padre diceva: “E' questione di vento, bisogna vedere da dove tira”. Già! E' una vita da annusare, quella che calpesta i piedi o lucida le scarpe. Conta il punto di vista, è da lì che le cose ci appaiono maleodoranti o profumate. Si può essere felici di essere vivi, perché solo se si è vivi il dolore che si appiccica ai giorni, lascia poi il posto alla carezza. Nessun ricordo in realtà serve per ubriacarci di passato, è necessario per misurare le distanze tra anima e cuore. E' un distillato di tempo quello entro il quale si muovono le riflessioni di una vita intera. Quando si scrive, sono sempre gli altri a farlo, usando la nostra penna e l'inchiostro che, altrimenti, resterebbe lì, senza servire a nulla. Se l'inchiostro può diventare pagina, c'è da chiedersi quante altre cose morte possono diventare vive. A quest'ora solitamente fingo di avere fame e, come mi ha insegnato mia madre, apparecchio con la tovaglia ed i piatti buoni. Importa poco che sia tornare a farlo per una persona sola. Certe solitudini non hanno il respiro grosso, ti dormono accanto senza infilarti i piedi nel mezzo. Quando Maria ripercorreva con il dito il profilo di una vita per metà inventata, diceva che dovevo fuggire dal mio paese per incontrare il mondo. La città avrebbe amplificato le energie ed ogni luogo sarebbe stato un porto per le mie ricchezze interiori. Casa sua, dopo tutto, era accogliente e luminosa. Le sue braccia un po' meno, ma probabilmente per molti questo sarebbe stato solo un dettaglio. Il silenzio non capito, gli argini indecifrabili dei sentimenti trascinati dentro le cose da fare. La sua inquietudine piena di tumultuosi ritorni. C'è un distillato di luna dentro questo contenuto desiderio di sole. La stanza vuota dell'anima rimbomba, adesso che non ci sono più i suoi capelli sul cuscino. Gli occhi non sanno invidiare le cose che ho avuto. Anche gli addii lasciano sempre possedere qualcosa, che sia il pettine o il batuffolo d'ovatta sul davanzale. “Nessun guardare fuori dalla finestra è un guardare, se quello che cerchi è dentro”. Lo ripetevo a me stesso quando, tornando tardi dalle tante cene, guardandomi soddisfatta, diceva: “ C'è il lavoro, ci sono i soldi…si può essere felici”. In questo dividere il corpo dal cuore ci si sente orfani della vita, soprattutto dopo aver conosciuto Angelica. Se le mie parole dovessero accontentare la pagina, dovrei dire che sono triste per un amore finito. No, la solitudine è una cosa diversa. La stanza è solo più grande, ed il letto un ventaglio che si apre, sull'odore di caffè appena fatto. C'è ancora il suo glicine assordante dentro le tempeste di cuore. L'amore non è entrare ed uscire da un desiderio come fa un bambino quando entra ed esce da una scatola di cartone. Aspettare che la felicità si separi dalle attese è una possibile risposta ai dubbi incontrati sulle scale ogni volta che chiudi la porta. Non ci posso fare niente se, attraverso questo tirarla a lungo con le cose, mi rivedo seduto su un muro mentre cerco sotto il guscio delle lumache le ali. Questo desiderio di pagine scritte da spargere sopra cose inventate, è complicato da leggere, somiglia ad un giorno scritto al contrario. Ci sono inverni fatti apposta per essere lasciati fuori ed inverni da portare dentro. Le mie dita accarezzano giorni costruiti il giorno prima. Forse è vero che ci si sente nuovi quando il tempo che ci si lascia alle spalle è vecchio. Mi chiedo da quale verso si indossa una giornata come questa, perché le ombre cambiano velocemente di posto. E' un cuore che non ha spigoli quello che accoglie i ritorni dalle stanchezze, e così, mi dico di essere felice dentro questi ritorni contenuti nel segno rotondo delle mie parole. Sarà che ad Angelica hanno tolto i colori per dipingere il cielo, ma io proprio non ci riesco a sentirmi povero perché non ho la macchina nuova. Sono miserie diverse quelle che non ho e che non vorrei avere. Ci sono giorni in cui nessuna cosa è vicina alle nostre braccia, perché non sempre l'armonia delle cose amate si dispone in cerchio. Sono giorni in cui riconoscere l'odore della vita è come indovinare il profumo della propria donna con il naso otturato. Abbiamo fuochi accesi, auto desiderate, giorni di vacanza, riserve di abiti e vini, risparmi sottovuoto e cesti per l'immondizia ricolmi di pane. Ma cosa possediamo delle attese feroci dei nostri passi che fanno finta di non incontrarci per strada? Cosa possediamo dell'amore che ci lascia sul comodino il biglietto “forse torno domani”. Se la palla di vetro si rompesse adesso, che rumore i silenzi! Appiccicati alle parole. Proprio non ci insegna nulla questo bosco messo tra una strada e l'altra. Sarebbe sufficiente lo sguardo di Angelica dentro il cuore di ognuno. Gioia e dolore assumerebbero significati diversi. Maria diceva che per proteggere il cuore bastano pochi millimetri di pelle, di solito l'oggetto in questione non è più grande di un fazzoletto ed è di colore scuro. Questo implica la ricerca di una felicità con attaccata sopra un'etichetta. Le gare frenetiche con gli orologi non sono mai un appuntamento con la vita. E' che abbiamo deciso di ritrovare tutti i giorni la maniglia al solito posto: come potrà mai avere il nostro ritorno a casa un nome diverso? Bisognerebbe essere capaci di tenerezze per dissodare una stagione come questa, ma il muro che ci viene addosso, è un alveare catartico di ingegnosi dolori dal mutabile aspetto. Alessandro non sa nulla del libro. Mi piacerà farglielo avere dentro la busta di plastica come gli altri, quando mi verrà a trovare. Lo immagino come un bel regalo per i suoi occhi, soprattutto perché non ha i caratteri piccoli dei quali si lamenta sempre. Mi piace pensarlo seduto sullo scalone del negozio mentre sorride leggendo di sé e della sua vita. Quando lo vedrò in cima alla salita, avrà nelle tasche una mela, un fazzoletto e forse lo spago per legare l'uva alla vite. Sotto il braccio il cappello e nella mano il bastone di noce. E' questo suo portare adagio a spasso gli anni che sparpaglia odore di tempo nella campagna, tra i vicoli, nelle case. Ci sono giorni che potrei fingere di non aver vissuto, ma alla canapa avvolta sulle scale, alle affilature delle falci per strada, dovrei dire di non essere mai nato. Le mani che chiudono finestre, i frammenti dell'ora tarda, fatti di canne e panni stesi, si riposano dentro quest'uomo vecchio, fatto di pace e di vicoli assolati. Quale consuetudine più bella del ritrovarlo qui la Domenica mattina, con la sua vita avvolta al filo che all'ora di pranzo lo riporterà a casa. Sa della malattia, ma non conosce tante altre cose. Leggermi somiglierà al guardarsi nello specchio e scoprire che la sua immagine nel corso degli anni non è cambiata. Avrà parole, forse silenzi. Mi terrà per qualche istante le mie mani nelle sue. Spererò che quella sapienza malferma sulle gambe mi possa arrivare dentro. Probabilmente la magia di certi incontri dipende da alchimie tutte da decifrare. Mentre sto completando queste pagine, Federica ha già ricevuto il manoscritto dentro una busta bianca lasciata in farmacia questa mattina all'apertura. Diciamo che sono andato presto apposta per non incontrarla, volevo lasciarle i miei fogli senza ascoltare alcun commento da parte sua. Questo, non perché non avrei voluto parlarci; ho ritenuto opportuno preservare quello che ho scritto su di lei in questo modo. Nella busta, insieme al manoscritto, ho messo l'insolita richiesta di completare il libro con quello che riterrà opportuno scrivere di me o di qualsiasi altro argomento. Le ho anche chiesto di farmi avere il tutto entro dieci giorni. La promessa è che quanto scriverà verrà pubblicato, di qualsiasi cosa si tratti. Mi sembra naturale che sia lei a chiudere questa pubblicazione che probabilmente non ci sarebbe stata se Federica, quel giorno, non mi avesse chiesto in prestito il libro che non avevo letto. Se l'origine della cosa è nel gesto semplice di una ragazza che sorride, è bello poter pensare che il bello della vita possa dipendere da gesti come questi, e non da macchinose “ingegnerie” comportamentali. Al momento non so, e lo saprò soltanto tra una decina di giorni, se la mia richiesta sarà stata accolta. Note biografiche scritte da Federica Conosco Fiorenzo Mascagna dai tempi della scuola ed ho avuto il privilegio di leggere il manoscritto che ancora riportava le cancellature ed altre varie annotazioni che non sono riuscita a decifrare. Mi è stato dato dall'autore il compito di scrivere la sua biografia, perché, dice lui, dovrei conoscere la sua vita. La ritengo una cattiveria sottile che mi ha obbligata a documentarmi, una specie di vendetta legata a fatti d'altri tempi. Se non ricordo male è nato nell'agosto del 1959, mi pare il 18. Quello di cui sono sicura è che è nato a Caprarola, cioè dove sono nata anche io. Quando ci siamo conosciuti, studiava elettrotecnica al Professionale di Stato e voleva terminare gli studi per iscriversi alla facoltà di Sociologia. Ha preso la qualifica da elettrotecnico, ma la sua Maturità è quella dell'Istituto d'Arte dove si è diplomato per poi completare di studi artistici all'Accademia di Belle Arti di Viterbo, diplomandosi in scultura, da secchione come me, con il punteggio di 110/110 e lode, discutendo la tesi “Concetto di luogo nella scultura”. Altra cosa vera che ha scritto in questa pubblicazione è che ha insegnato Teoria della percezione e Psicologia della forma nella stessa Accademia che lo ha visto studente. Non è invece vero che il suo percorso di vita sia stato così fortemente condizionato dal fatto di avermi conosciuta. Credo invece che Don Cionco prima, Aurelio Rizzacasa e Cesare Milanese poi, abbiano contribuito non poco alla sua personale crescita culturale, per altro difficile da catalogare. Che Fiorenzo Mascagna sia uno scultore lo testimoniano le sue apprezzate opere, che tra l'altro ho occasione di vedere tutti i giorni quando vado al lavoro, vivendo in prossimità della piazza che accoglie due suoi lavori. Altri interessi, non ultimi quelli letterari e la sua passione per l'insegnamento, ne fanno una persona poliedrica, capace di operare una buona sintesi tra le esperienze artistiche ed i vissuti dell'uomo. Sono un medico e quindi non me la sento di tracciare un profilo critico dell'artista; posso solo dire che le sue sculture mi trasmettono serenità e nelle cose che scrive ritrovo la magia di chi veramente può sentirsi miracolato, visto che i suoi primi trascorsi scolastici non sono stati dei migliori e nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo poi. Ho letto con interesse il suo ultimo libro sulla teoria e psicologia del colore e della forma, ritrovando dentro il testo argomenti dei quali mi aveva parlato abbondantemente a voce. Credo comunque che lui sia particolarmente affezionato alla sua prima pubblicazione del 1985, “Il verso delle cicogne”, con la quale ha vinto il premio nazionale di poesia “Roma oggi”, soprattutto perché a premiarlo fu uno dei suoi poeti preferiti: Mario Luzzi. Lo scrivere è dunque un aspetto importante della sua attività, quello che non capisco è perché Fiorenzo Mascagna continui a definirsi scultore e basta. Nel leggere il manoscritto, ho ritrovato parte della mia vita e credo sia normale che ricordi così esplicitamente espressi possano provocare emozioni difficili da spiegare. Ho letto il libro come se la Federica del racconto non fossi io, perché alcune cose che Fiorenzo ha scritto non corrispondono esattamente al vero ed io, ovviamente, per rispetto del racconto e dell'autore, non le svelerò mai. Ho riflettuto su fatti e situazioni estendibili ad altri ambiti e, se il lettore si è sentito coinvolto da quello che ha letto, credo che questo possa significare che dentro il libro Fiorenzo non ha soltanto messo buona parte della sua vita, ma gran parte della vita degli altri.
Scaricare