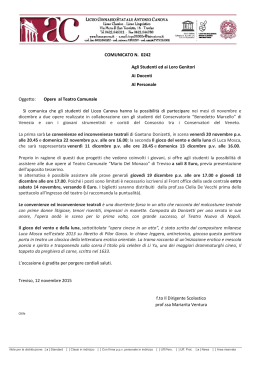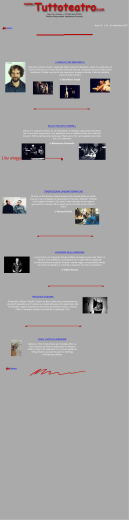TheRope 2/3 NEOFIGURATIVO Il piacere della forma – Quattro cavalieri contro l’apocalisse: Rodriguez, Tarantino, Snyder, Zhang Yimou – Il teatro assoluto del Pop Live – Da Barbie a Pamela Anderson (fotografate da LaChapelle): l’aura è solo riproducibile – Corpi reali, cyborg e virtuali per una nuova iconologia del mito. Premio “The Rope” a Martin Scorsese e Mick Jagger Grafie dello Spettacolo e Pratiche dell’immaginario EDIZIONI FALSOPIANO TheRope 2/3 Neofigurativo Il piacere della forma – Quattro cavalieri contro l’apocalisse: Rodriguez, Tarantino, Snyder, Zhang Yimou – Il teatro assoluto del Pop Live – Da Barbie a Pamela Anderson (fotografate da LaChapelle): l’aura è solo riproducibile – Corpi reali, cyborg e virtuali per una nuova iconologia del mito. Premio “The Rope” a Martin Scorsese e Mick Jagger. Grafie dello Spettacolo e Pratiche dell’Immaginario TheRope Grafie dello Spettacolo e Pratiche dell’Immaginario Direttivo: Andrea Caramanna, Maria Angela D’Agostaro, Elisabetta Di Stefano, Giuseppe Pernice †, Daria Parisi, Rino Schembri (vicedirettore), Barbara Tomasino, Renato Tomasino (direttore responsabile) Redazione: Giulia Raciti N u m er o d u e / t r e Rivista semestrale, marzo/ottobre 2008 Registrazione presso il Tribunale di Palermo, nr.14 08/05/2007; Ricerche finanziate con Ex Quota R.S. 60% 2005/2006 Redazione e amministrazione: LUM Michele Mancini Università degli Studi di Palermo Palazzo dei Principi Aragona Cutò, 90011 Bagheria (Pa) Tell. +39.091.9290611 Web: www.lummichelemancini.net Mail: [email protected] © Edizioni Falsopiano-2009 Via Baggiolini, 3 15100-Alessandria http://www.falsopiano.com Per le immagini, copyright dei relativi detentori Progetto grafico e impaginazione: Daniele Allegri Stampa: Impressioni Grafiche S.C.S a.r.l. – Acqui Terme Prima edizione: Gennaio 2009 SOMMARIO Neofigurativo 2/3 Neofigurativo p. 7 Sul neofigurativo cinematografico Rino Schembri p. 9 Corpi e spazi iperreali nella cinematografia di Zhang Yimou Maria Angela D’Agostaro p. 26 B-movie e/o exploitation e/o supergenere? Andrea Caramanna p. 39 Eroi della strada e grafie metropolitane in Walter Hill Maria Angela D’Agostaro p. 44 I segni della neofiguratività. I comics come linguaggio della visione Giorgio Cappello p. 50 LaChapelle tra forma e gioco Giulia Raciti p. 55 Non c’è altro. La Salomè cinematografica di Carmelo Bene Saverio Zumbo p. 71 Corpi concavi e convessi in “Cremaster cycle” di Matthew Barney Davide Gambino p. 88 Robert Lepage - Il teatro ad orologeria Roberto Giambrone p. 101 Madonna: la star della visual performance Alessandra Costanza p. 119 Live: Iconologia della star Renato Tomasino p. 122 Per un’estetica dell’immagine multimediale Elisabetta Di Stefano p. 214 Neofigurativismo segno di un tempo di rinnovamento radicale e… digitale Enzo Li Mandri p. 221 Oltre il corpo Alessandro Cappabianca p. 225 Scritture Stanislavskij e Mejerchol’d: la regia operistica tra naturalismo e rivoluzione teatrale Daria Parisi p. 232 Visioni Across the universe Piera Gemelli p. 245 Speed Racer Piera Gemelli p. 246 Too Human – Quando l’impostazione cinematografica diviene inopportuna Sergio Nuzzo p. 248 Premio Cinematografico “The Rope” p. 255 Iconosaggi Fotogrammi tratti dal film The Adventures of Prince Achmed di Charlotte Reiniger 1926 p. 18 Tagli e Feticci p. 63 Icone Pop p. 111 Icone strip p. 136 Catastrofi p. 162 Mitologie p. 180 Contorni p. 207 6 NEOFIGURATIVO Estetica della forma digitale Al cinema, come nella vita, non comprendo il plot, i rapporti di parentela, i nomi e l’identità stessa dei personaggi. Comprendo appena il tempo dei suoni, la grana della voce, il movimento dei corpi. Michele Mancini Incanto del 10-XII-2001 Neofigurativo •Nasce in seno all’iperrealismo e alle declinazioni del Pop. •È la forma che prevale sul contenuto. •È puro scintillio della forma. •I contenuti sono sempre a livello di forme archetipiche. •È piacere delle visione, pulsione e dissipazione. •È estetica della visione > Questa visione orgasmica degli occhi conduce alla catarsi. •È gioco di cosmos e caos. •È gusto delle pratiche alte e basse. •È il tacco a spillo in ferro che ticchetta come un chiodo sul marmo. •Si aggancia alle arti figurative > Di nuovo Ragghianti? •Si aggancia alle arti della visione > Pop, Rock, Clip, Fumetto, Spot, Videogame. •Il teatro nelle sue spettacolarizzazioni live. •È corpo che è contorno e pura perimetrazione. •Insegue un’idea di bellezza assoluta che è forma. •Insegue un’idea di bellezza assoluta che è mito, teriomorfismo, androginia, totalità primordiale. •È corpo che è dato come cancellazione del volume. •È corpo grafema che scrive lo spazio. •Topoi neobarocchi che traghettano nel neofigurativo: il piacere dell’ornamento, citazionismo, intertestualità, plurilinguismo, pluristilismo, coinciden- 7 za degli opposti, pluri-totalità. •È il corpo postumano, che non necessariamente si fa attraversare dalla tecnologia ma che comunque rimane tecnologico per estrema sapienza di pratiche. È postumano perché si lascia plasmare dalla tecnologia, anche dalla plastica e dal bit. •Recupera le cromie accese del Pop. •Ha a che fare con l’androginia, intesa come pienezza, come circolarità, perché il corpo neofigurativo attiva tutti i processi della baudrillardiana seduzione. •È il sublime del trash televisivo > simulacri che puntano al nulla. •È Rita Hayworth/Gilda con il fallo. •Il corpo neofigurativo è torturabile, vivisezionabile, spezzettabile ma invincibile, perché mitico (Roland Barthes) e quindi invulnerabile, replicabile; attiva un gioco sadico. •È il supereroe del fumetto e il fumetto è il linguaggio trainante del Neofigurarivo. •Sono registi neofigurativi: Walter Hill, Ridley Scott, Tony Scott, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, George Lucas, Stanley Kubrick, Peter Greeneway, Wong Kar Wai, Park Chan Wook, Zhang Yimou, Wachowski Bros, Zack Snyder... Visconti, Rossellini, Godard, Antonioni, Wenders. •Registi teatrali neofigurativi: Robert Lepage, La Fura dels Bauls, Krypton del tempo che fu, Bob Wilson, Le Cirque du Soleil, Momix, Bartabas ... •Star neofigurative: Matthew Barney, Madonna, Shakira, Christina Aguilera, Britney Spears, David Bowie, Michael Jackson, Mariko Mori, Cindy Sherman, Queen, Nancy Sinatra, Pamela Anderson, Gong Li, Riccardo Schcchi, Beyoncé, Amy Whinehouse, Mick Jagger, Mariah Carey, Dita Von Teese. •E La Chapelle? Aggiungiamo anche lui! The Rope 8 Sul neofigurativo cinematografico di Rino Schembri Una luminosità fuori da ogni rapporto con la realtà, sovrannaturale, abbagliante per la sua luminescenza “acida” ultravioletta, cosparge il corpo di un uomo a torso nudo e inonda uniformemente il ristretto ambiente. È questo l’incipit di Gomorra (M. Garrone, 2008). Ed è evidente che la figura immersa in una siffatta atmosfera non possa che presentarsi con gli attributi di ordine soprannaturale e non certo di soggetto somigliante all’esistente quotidiano. Che le figure rappresentate in modo da non prendere luce da una fonte ben determinata, nelle quali tutto appare uniformemente chiaro a causa di una luminescenza diffusa e da un irraggiamento invisibile, si elevassero sin dal periodo paleocristiano a creature divine è noto; così come è noto che sin dagli anni Venti i cineoperatori si indirizzarono alla ricerca di una resa fotografica in cui la figura del divo sullo schermo fosse in grado di richiamare l’immagine sacra e superumana proprio perché si tratta di “creature che partecipano contemporaneamente dell’umano e del divino, simili sotto un certo aspetto agli eroi della mitologia e agli dei dell’Olimpo, in quanto suscitano un culto o addirittura una sorta di religione”1. E se in Gomorra la luce tonale violetta (che successivamente scopriamo provenire da una lampada del solarium in cui è collocata la scena) sottende una regalità fatta di ricchezze materiali e illecite, antitetica alla ricchezza spirituale che avvolge il volto dei santi e quindi portatrice di morte, allora non c’è dubbio che dal punto di vista figurativo questa inquadratura crei allo spettatore uno shock emotivo che mortifica i pregiudizi cumulati sul cinema italiano contemporaneo. Sì, perché procedere con l’illuminazione totale e tonale, nel cinema, così come nell’arte figurativa, vuol dire rendere incorporee le figure sulla scena, sublimarle, mitizzarle, rendere universale il mondo rappresentato. Incollati sulle poltrone, sull’orlo di un precipizio abissale in cui intuiamo che potremmo confluire noi, le nostre idee e la nostra insoddisfazione dell’esserci sbagliati a definire meramente contenutistici gli elogi dei nostri critici e di quelli d’oltralpe al film di Garrone; nel buio della sala cerchiamo il volto di chi ci sta accanto, per carpirne gli umori, percepirne le sensazioni e, quasi increduli, attendiamo che l’arte si manifesti nella sua totalità linguistica e paradigmatica. Luce tonale, dicevamo, ovvero intensità del chiaroscuro comprensiva del colore in genere, così come nell’accezione data da Francesco Milizia nel suo Dizionario delle Belle Arti e del Disegno 2. Rimanendo nel panorama artistico italiano, non c’è dubbio che alcuni film possano essere raggruppati per il 9 tono della luce dominante che li accomuna. Allo stesso modo in cui alcuni film del periodo fascista denominati dei “telefoni bianchi”, sottovalutati dalla critica militante, e pervasi dal tono “alto” della luce per come esigeva il genere della commedia, esprimono un sentire vicino all’anima pagana di quella Grecia antica che viveva la gioia del vedere, e attraverso il vedere quella del bello e dell’arte; anche alcune opere di un fotografo come Cavalli, che prediligono il “tono alto”, la luce che trabocca, ricercano analoga via per raggiungere l’arte. L’arte dunque come pura visione. Che sia questa raggiunta attraverso l’alternarsi armonico di toni di colore (300 di Z. Snyder, 2007), o tramite il predominio dei grafemi sul “tutto tondo” alla maniera fumettistica (Sin City di R. Rodriguez, 2005), o attraverso l’epifania simultanea di tutti i colori (Across the Universe, J. Taymor, 2007), o tramite il patchwork di generi cinematografici, compreso l’animazione giapponese, in cui i personaggi passano dall’universo realistico a quello del cinema - più vero di quello reale e dunque iperrealistico (Kill Bill Vol. 1 e 2, Q. Tarantino, 2003-2004) - o ancora attraverso le asimmetrie temporali tra musica e immagine nelle splendide sequenze della “danza dei fagioli” e della lotta con gli uomini volanti nella foresta di bambù in La foresta dei pugnali volanti (Z. Yimou, 2004), è la visione (Significante senza Contenuto) che si pone come puro valore assoluto. E il Referente? Questo a volte si svuota dal peso materiale e diviene pura luce, sequenza di bit generati al computer, corpo senza materia capace di sovvertire le leggi della fisica o corpo materico a-storico (in quanto suscettibile di operazioni di morphing che ne esaltano la sua plasmabilità) e corpo a-temporale (in quanto oggetto di operazioni di compositing che gli conferiscono poteri di telepresenza). Tralasciando in questa sede le questioni teoriche inerenti la nozione di “fotogenia” e le qualità estetiche del primo piano - poste da Delluc a partire dal concetto di “cinematografabilità” di Ricciotto Canudo e riprese da Epstein dobbiamo andare a Raggianti, ai volumi Cinema arte figurativa e ad Arti della visione in cui il critico passa in rassegna temi quali lo statuto dell’immagine, spazialità e temporalità, etc., per rintracciare la rivendicazione del diritto di ascrivere il cinema alle arti figurative e da lì legittimare l’attuale tendenza del predominio del figurativo nell’arte cinematografica come specificità del postmoderno tecnologico volto a costruire il piacere della visione 3. Ragghianti, nel saggio Cinematografo rigoroso 4, pone l’accento sullo svolgimento di valori formali nel tempo come peculiarità del cinema, avvalendosi di strumenti critici e di indagine assai fini. Come ben si sa, spazio e tempo, fin dall’innatismo leibnitziano, e poi soprattutto nel celebre Laocoonte del Lessing 5, erano concetti che erano stati usati per la contrapposizione fra arti figurative e poesia. Avverte Ragghianti che il termine “figuratif”, che distingue 10 le arti della visione rispetto alle altre arti come la poesia e la musica, non è originale della cultura artistica francese né di quella italiana, ma discende da Lessing ed è sinonimo di forma o di linguaggio formale e non contenutistico 6. È questione di forma, dunque. Siamo perciò lontani da certo atteggiamento critico di tipo sociologico che disprezza il cinema – e tutte le arti dello spettacolo – privo di contenuti e che non veicola “messaggi” (concordiamo invece con Mc Luhan quando sostiene che “il messaggio è il mezzo”). Evidentemente, per un malintesa interpretazione della cultura, ciò che è forma imbarazza, e la distinzione tra “alto” e “basso” passa attraverso il grimaldello del Contenuto. Siamo di fronte ad una esplicita forma di relativismo culturale nelle cui pieghe dell’abisso scavato dal pensiero dominante s’intralciano e sprofondano gli stessi sostenitori. Ma da cosa proviene questo fascino della forma che è alla base del piacere della visione che instrada al bello e quindi all’arte? Ci sovviene una sequenza di un film, non molto recente, ma sicuramente tra i più contigui predecessori di quel neofigurativismo cinematografico che è oggetto del nostro breve saggio. È la sequenza musicale di Un sogno lungo un giorno (F. F. Coppola, 1982), nella quale il protagonista Hank e Leila (un’acrobata di circo) si incontrano dopo essersi dati appuntamento. Qui il regista “gioca con i valori di scala, mettendo un Hank piccolissimo sormontato dal gigantesco primo piano di Leila, e lavorando soprattutto sui primissimi piani dei personaggi intarsiati da sfondi colorati e luminosi, effetti, cambi di colore, in un caleidoscopio dove le varie fonti vanno e vengono in un fluido magma” 7. In questa sequenza sono presenti almeno tre caratteristiche formali che stanno alla base del neofigurativismo cinematografico volto ad esaltare la forma rispetto al contenuto: l’intarsio (inteso nell’accezione di profilazione che è all’origine della figura silhouette, ma anche come tecnica compositiva specifica del cinema elettronico e del digitale); l’epifania simultanea di tutti i colori (quella Poikilìa che Tomasino in questo volume assume come una delle specificità dell’evento live rock e pop); l’ibridismo dei generi e delle pratiche in una prospettiva di esaltazione della cultura pop (specialmente quella fumettistica). In questo flusso di colori al neon che disegnano geometrie sfavillanti avviene la metamorfosi del volto di Laila: il tre quarti di lei dissolve nel segno grafico al neon corrispondente e il referente reale lascia il posto al grafema, all’icona/neon che ne costituisce il suo simulacro pop. Questo viso reale, che si fa profilazione e quindi sua stessa rappresentazione, si rigenera e fa dunque perdere la nozione di ciò che è reale e di ciò che è rappresentato. L’alternanza di vero/falso del resto è presente in tutta la sequenza attraverso il continuo ricorso a quella forma di intarsio elettronico che è il chroma-key, 11 tecnica che rende possibile lo scambio continuo dei valori di scala o l’inserimento dei volti reali in un tripudio di colori al neon che si fa décor tanto onirico quanto realistico (sia per Las Vegas che per la tradizione del musical). Più avanti le pratiche circensi della donna si mescolano alla performance di un Hank improvvisato direttore di una orchestra composta da carcasse di vecchie auto: di profilo, sospesa su un filo e rivestita da un ridotto tutù che esalta le tornite cosce nella cui sommità il reggicalze non mostra timore ad esibirsi, la donna procede in avanti stagliandosi contro i colori della sera. È qui che il corpo di Laila si fa pura visione in tutta la sua portata realistica in contrapposizione al suo simulacro, e cioè alla sagoma illuminata che raffigura un’altrettanto sensuale forma di donna che la donna si lascia alle spalle mentre cammina. La graficità delle forme, o l’evidenziazione dell’artificialità della messa in scena, producono un tipo di immaginario che spesso – come in questo caso - sconfina con il mondo del fumetto e del cartoon. Vero e falso, reale e virtuale, sono dicotomie che sovrintendono tutto il costrutto filmico di Un sogno lungo un giorno e sono al servizio della messa in forma figurativa sin dalla sequenza di incipit, nella quale l’ostensione della forma passa attraverso il ricorso al cartoon. Se alla base della cinematografia che esalta la graficità delle forme è il fumetto (e il cartoon), allora non sembrerà strano indicare ne I guerrieri della notte (W. Hill, 1979) un’ulteriore opera che prefigura l’attuale tendenza neofigurativa. Prima ancora della doppia prova di Linklater dell’uso del rotoscoping in Waking Life (2001) e in A scanner darkly (2006), è Walter Hill a darci un saggio magistrale della possibilità di graficizzazione del profilmico che fa sembrare cartoon ciò che viene ripreso dal vero, generando un processo di osmosi totale fra l’immagine dal vero e il suo simulacro. E in questi tre film citati, gli attori e tutto il profilmico diventano ombre, tracce che, come osserva Amaducci a proposito dei film di Linklater, “sono solo punti di partenza che sono serviti per costruire una realtà dissociata” 8. Analogamente ombre, tracce, punti di partenza, possono essere definiti gli attori che prostituiscono il loro corpo (in quanto dispensatori di Grazia, osserverebbe il compianto Michele Mancini) alle tecniche di motion capture per dare origine a personaggi che hanno sì un referente reale ma il cui Significante coincide con il suo stesso simulacro. Corpi fantasmatici, dunque, facilmente manipolabili, tanto da rendere credibili – in quanto verosimili – mostri d’ogni genere: dall’automobile-ballerina di una nota réclame di una casa automobilistica, agli organismi teriomorfi presenti nella trilogia de Il signore degli anelli (P. Jackson, 2002-2004), e in 300 (Z. Snyder, 2007). Qui l’artista, il computer animator, per raggiungere l’epifania della forma della sua opera mette in campo l’aristotelica téchne e, avendo a che fare con materie già formate, si carica del compito di annullare il reale corporeo dell’Altro 12 per fare uscire una nuova corporeità il cui grado di formalità raggiunge l’iperrealtà. Così come i personaggi generati con tecniche di motion capture possono muoversi all’interno di ambienti reali; specularmene - con tecniche di compositing - gli attori reali possono recitare all’interno di ambienti sintetici. L’uso della composizione digitale per creare spazi continui in cui interagiscono diversi elementi può essere considerato un esempio di estetica anti montaggio che contraddistingue il cinema neofigurativo. Mentre la logica del montaggio filmico tradizionale privilegia il montaggio temporale rispetto al montaggio interno ad una scena, la composizione li pone sullo stesso piano. La nuova logica dell’immagine digitale in movimento insita nell’operazione di compositing, per certi versi, va contro l’estetica di Ejzenstejn. La composizione digitale rende le dimensioni dello spazio e della cornice importanti quanto il tempo (non va dimenticato che lo spazio composito risulta dall’assemblaggio di porzioni di spazio opportunamente stratificati in livelli). Questa tipologia di montaggio – denominata da Manovich “montaggio spaziale” 9 – può dare esito a due differenti risultanti figurative: la prima non tiene conto dei confini che separano i diversi mondi rappresentati; la seconda fa sì che i diversi spazi si omologhino nella prospettiva, nei valori di scala e nella luminosità, formando dunque un solo universo percettivo. Il primo caso è quello che abbiamo precedentemente individuato nella sequenza di Un sogno lungo un giorno ed è attualmente alla base della costruzione filmica dei videoclip musicali o di sequenze onirico-musicali in lungometraggi a soggetto come quella delle fragole inchiodate al muro sulle note di Strawberry Fields Forever nel recente e bello Across the Universe. In questa sequenza, che magistralmente richiama certe operazioni artistiche della Pop-Art, l’intarsio e la sovrapposizione di immagini dei protagonisti che infilzano fragole e immagini di bombe del Vietnam che esplodono spruzzando sangue rosso-fragola, unite ad una sinfonia di colori che si intreccia in un tutt’uno con la struttura delle immagini, crea uno stimolo sensoriale sinestetico totalizzante. La seconda tipologia di “montaggio spaziale”, quella che determina uno spazio virtuale integrato e verosimile, è alla base di quelle opere filmiche realizzate per la massima parte in green screen e che occupano un posto di massima autorevolezza nel limbo del cinema neofigurativo. A questa tipologia va ascritta la costruzione formale di 300, per il quale non sono mancate improbabili letture allegorico-contenutistiche che hanno visto nella lotta tra persiani e spartani il fantasma dello scontro di civiltà tra Oriente e Occidente, sorvolando sulle specificità estetiche e linguistiche del film. Altre letture ne hanno sottolineato il dato tecnologico - ma solo per paragonarlo allusivamente ai prodotti del cosiddetto cinema mainstream – e 13 cioè evidenziando che l’opera di Snyder è stata realizzata prevalentemente con fondali sintetici generati al computer, con la quasi totale abolizione del profilmico (come se il ricorrere a questa modalità della messa in scena costituisse una forma di denigrazione dell’arte cinematografica). Del resto, si sa, i trucchi impercettibili sono un inganno al servizio del piacere della visione dello spettatore: rialzare un attore più basso rispetto alla sua partner e farli sembrare di uguali altezza mentre si baciano appassionatamente, utilizzare controfigure per girare azioni troppo pericolose o difficili da compiere per l’attore, sono espedienti che hanno fatto la storia del cinema. Ma a differenza dei trucchi cinematografici “in camera”, la postproduzione digitale si avvale di quella proprietà “scalare” e modulare dell’immagine pixellizzata che fa sì che gli elementi che la compongono (e che per tutto il processo di produzione hanno mantenuto le loro identità separate), possano essere invece facilmente ridotti, aumentati, sostituiti, cancellati, al fine di configurare un “flusso” unico, i cui singoli elementi non sono più accessibili. Così è in 300, nel quale l’aura è accresciuta dalla sua stessa riproducibilità seriale (sia in quanto prodotto finito replicabile in innumerevoli copie, sia come risultato della combinazione di serie distinte di elementi replicabili opportunamente collegati tra di loro). Non va dimenticato che 300, con le sue tinte desaturate e a toni dominanti ora bronzo, ora verde rame, ora ciano, si fa metafora e metalinguaggio, richiamando l’attenzione sulla sua totale appartenenza a quella genìa del prodotto artistico riproducibile tecnicamente. In più il colore di 300 è un colore simbolico (il colore opaco degli spartani che però scolpisce la forma o il colore iridescente dei persiani), lo è perfino il colore del sangue che mentre fuoriesce dai corpi rimane quasi galleggiante nell’aria, finchè arrivando a terra non lascia traccia (perché il rosso del sangue non è raffigurazione della violenza ma pura rappresentazione). Per analogia, il colore del sangue che sgorga dai corpi dei protagonisti di Sin City (corpi che mostrano una straordinaria resistenza alla morte e una malleabilità liquida) è bianco, nonostante l’uso selettivo del rosso in varie inquadrature del film. Il rosso infatti è associato alla violenza della passione, al pendolo tra Eros e Thanatos, e ha una funzione “cosmetica” in quanto rende l’immagine più allettante. Incastonato dentro il bianco e nero, il rosso amplifica il suo potere deduttivo: non è un colore straripante, ma lucidato, tenuto a freno nella sua carica erotica e perciò disponibile, pronto ad essere consumato. Rosso è infatti il colore del drappo che avvolge il corpo di Goldie nella scena della notte d’amore con Marv. Rosso perché Goldie è la “Donna perfetta”: con il suo viso circondato da un’aureola di capelli d’oro esaltati dal controluce sembra una dea, una santa pronta all’estasi del sacrificio, un’icona/silhouette pronta ad offrirsi alla nostra pulsione scopica che eccitata dal 14 rosso divora il suo oggetto che si offre inerme al centro del letto/altare sacrificale. Dicevamo che alla logica della sequenzialità e orizzontalità, tipica del cinema narrativo che fa uso del montaggio temporale, il compositing oppone una logica di tipo ipetertestuale e verticale che da vita a stratificazioni dell’immagine basate su livelli che possono essere di numero infinito e che possono contenere “ritagli” di oggetti, tracce grafiche e altro. È questa l’essenza stessa dell’immagine simulacrale del cinema digitale: la possibilità di costruire immagini complesse a partire dalla selezione e ricomposizione di porzioni di immagini semplici, scalabili e replicabili, secondo le modalità di quell’operazione che abbiamo definito simile alla tecnica dell’intarsio; tecnica che dunque porta all’estremo - in quanto la comprende - la serialità che caratterizza l’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica. In una siffatta tipologia dei modi di produzione, per la quale la diegesi filmica diviene la risultante di operazioni di intarsio a livello sintagmatico, assume valore fondamentale il concetto di silhouette. Qui entra in gioco la perimetrazione della figura (reale e virtuale) attraverso l’uso del controluce che caratterizza alcuni dei film già elencati. Ci siamo già riferiti alla silhouette richiamando la scena della notte d’amore tra Goldie e Marv in Sin City; Rodriguez, Tarantino, Snyder, Yimou, ne fanno pieno uso. Sin City ha il pregio di insistere sulla piattezza della traccia grafica e di ridurre il segno iconico a grafema (come nel caso del cane stilizzato in un bianco e nero in negativo o delle ombre di personaggi che si stagliano contro le pareti) riuscendo in questo modo a fornire con un minimo di informazione, un massimo di riconoscibilità; Kill Bill vol. 1 utilizza le silhouette dei cartoon per raccontare la storia di O-Ren – inizialmente androgina per far sì che i nemici abbassino la guardia ma poi più stemperata fino a sembrare una bambola giapponese - e rendere dunque la deriva verso il male come un qualcosa di irreale; 300 enfatizza la figura in rapporto allo sfondo mediante sapiente uso del compositing; La città proibita (2007) perimetra e penetra gli scenari di tragica solitudine, spietata ambizione, bramosie di vendetta, percorrendo gli sfarzosi corridoi della corte imperiale con magistrali carrellate d’inesorabile lentezza e bellezza che perpetuano la finezza artistica di Yjmou. Zhang Yjmou. Il regista che riesce a inventare nel rispetto della verosimiglianza: perduto irrimediabilmente il passato cui la rappresentazione dovrebbe rimandare (rimozione alla quale ha contribuito la Rivoluzione culturale cinese), sceglie il suo sostituto, la rappresentazione stessa, rendendolo autonomo dal suo referente proprio attraverso l’ostentazione della sua natura fittizia. Emblematica è la sequenza de La foresta dei pugnali volanti nella quale la ballerina cieca deve eseguire il “passo dell’eco danzante” seguendo la traiettoria e il tempo dei fagioli scagliati contro tamburi. Vestita di seta sui toni 15 del rosa e dell’oro, la danzatrice/guerriera cieca usa le lunghe maniche svolazzanti come protesi per battere i roboanti tamburi. La performance quasi onirica dell’attrice (Zhang Ziyi che per quel film ha sostituito Gong Li come musa del regista) disvela l’incerto statuto fisico dei corpi “naturali” che si curvano e volteggiano per offrire il piacere massimo della visione allo spettatore. Ricorrendo ad una temporalità doppiamente dilatata (per l’uso del ralenti, per il contrasto con la fissità della posa assunta in alcuni momenti dal corpo della donna), l’agile macchina da presa segue la traiettoria di ogni fagiolo lanciato contro i tamburi come se seguisse un proiettile. E il completamento di ogni gesto o di ogni azione è atteso a lungo dallo spettatore che, in questa durata abnorme, riflette più del consueto sui motivi e sulle conseguenze possibili di quel gesto, drammatizzandolo in un ventaglio d’ipotesi tanto che, per dirla con Epstein, “il surrealismo bruto dell’insolito si carica di un senso drammatico” 10. Talvolta il rumore, reso nella sua durata realistica dell’esecuzione, si scontra con la realtà dilatata delle immagini e riconduce l’attenzione sul mondo del fittizio; altre volte in analogia con esse, viene dilatato, riverberato e, poiché fa sentire una polifonia di suoni nuovi e strani che danno così vita a meravigliose “silhouette sonore”, emoziona in modo analogo a quello in cui la surrealizzazione delle immagini commuove lo spettatore. Si tratta di un “meraviglioso” – nella qualità di categoria del neofigurativo - che può dirsi verosimile, perché ottenuto digitalmente a partire proprio da quegli elementi naturali e concreti che costituiscono per noi il mondo reale, oggettivo e vero. Epilogo Luce. Scorrono i titoli di coda. L’immagine di una ruspa protesa verso l’alto mentre scompare all’orizzonte con dentro i corpi esangui di due giovani malavitosi segna l’epilogo di Gomorra. Gli esiti figurativi conseguenti a quella luce al neon ad incipit del film ormai ci sembrano lontani, quasi rimossi, forse perché non avvalorati da un complessivo progetto registico scandito da coerenza di linguaggio lungo tutta la linea temporale del film. Perfino l’identificazione con qualcuno dei personaggi è un processo che ci è venuto a mancare. Scorrono i titoli di coda. Ci risolleviamo facilmente da quella poltrona/abisso nella quale sembrava potevamo sprofondare. Dov’è l’alternarsi simbolico e corretto dei toni di colore? Dov’è l’epifania simultanea di tutti i colori? Dov’è il predominio dei grafemi sul “tutto tondo”? Dove sono le asimmetrie temporali tra musica e immagine? Non ci conforta per nulla l’idea che molto cinema italiano contemporaneo – da Moretti a Garrone, passando per Sorrentino - continui ad esser lungi dall’avvicinarsi a quel modello artistico che ci piace denominare “neofigurativo”. 16 1 E. Morin, I divi, tr. it. Garzanti, Milano 1977, cit. p. 8. F. Milizia, Dizionario delle Belle Arti del Disegno, 2 voll., Remondini, Bassano, 1797. 2 Si veda: C. L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1952 e (idem) Arti della visione, 2 voll., Einaudi, Torino 1975. “Fotogenia” è un termine chiave in tutta l’opera di Epstein. Il termine viene applicato al cinema per indicare una gamma di significati che vanno dalle qualità specifiche della luce e composizione dell’immagine cinematografica alle caratteristiche che un attore deve avere per rendere al meglio nella pellicola. Louis Delluc è stato tra i primi a parlare, a proposito della fotogenia, della specificità del cinema. Su queste questioni si veda: L. Delluc, Fotogenia [1920], in A. Barbera, R. Turigliatto (a cura di), Leggere il cinema, Mondatori, Milano 1978; J. Epstein, Alcol e cinema, tr. it. Il Principe Costante, Pozzuolo del Friuli 2002. Sulle specificità “fotogeniche” del primo piano si veda (idem), Bonjour Cinema, tr. it. Fahrenheit 451, Roma 2000. In tempi più recenti la questione è stata affrontata da E. Morin, Il cinema o l’uomo immaginario, tr. it. Feltrinelli, Milano 1982. 3 4 Il saggio, scritto nel 1932, è contenuto in Arti della visione, vol. I, op. cit., pp. 5- 37. 5 G. E. Lessing, Lacoonte, tr. it., Aestethica, Palermo 2000. 6 Ibidem, p. 257. 7 A. Amaducci, Anno zero. Il cinema nell’era digitale, Lindau, Torino 2007, cit. p. 36. 8 Ibidem, cit. p. 206. 9 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, tr. it. Olivares, Milano 2002, p. 202. 10 J. Epstein, Alcol e cinema, cit. p. 99. 17 Fotogrammi tratti dal film The Adventures of Prince Achmed di Charlotte Reiniger, 1926 18 19 20 21 22 23 24 25 Corpi e spazi iperreali nella cinematografia di Zhang Yimou di Maria Angela D’Agostaro Nel panorama del cinema postmoderno di questi ultimi decenni, gran parte della narrazione filmica opera la destrutturazione dei modelli e dei codici, prevale l’ibridismo e la frammentazione, si ha la tendenza a giocare, a manipolare il processo narrativo grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie; si creano nuove forme, o si attuano dei procedimenti di rivisitazione “cannibalizzando” le vecchie 1. Vi è una innumerevole produzione filmica in cui l’iperrealismo della forma prende il sopravvento, sbriciola ulteriormente i linguaggi, i saperi e punta tutto sulle arti della visione vampirizzando le pratiche della pop-art, del clip, del fumetto, del videogame e dello spot. Ed ecco apparire in questo orizzonte lo stile di registi come Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, George Lucas, Steven Spielberg, e pochi altri che delineano, con la loro filmografia, una nuova estetica della forma in cui prevale il piacere dell’ornamento, il citazionismo di figure archetipiche, che animano il mondo del fumetto e non solo, in cui il corpo soprattutto femminile assurge a segno, e si riappropria di tutto un immaginario che stimola la pulsione scopica del desiderio. In questo contesto occupa un posto particolare Zhang Yimou, il quale guarda allo splendore della forma e mentre essa si impregna di significato simbolico, si stratifica assorbendolo, conferendo ad ogni livello il sublime sicché anche il “residuo” partecipa della contemplazione. Il regista offre, allo sguardo attento dello spettatore, alle volte uno spaccato culturale di una Cina piena di contraddizioni, realizzando film in cui le storie attingono a piene mani alla quotidianità rurale ricca di tradizioni, valori, semplice e composita al pari della natura che l’avvolge; essa è contrapposta a quella cittadina ove i ritmi sono più incalzanti e i corpi si disperdono senza un’apparente identità. È un mondo in cui i personaggi, spesso femminili, cercano un loro spazio, oltrepassano coraggiosamente e con tenace testardaggine tutti gli ostacoli presenti nella loro vita, con un linguaggio che ci riporta ai fasti del codice del neorealismo italiano; le inquadrature e le sequenze mostrano rigore nella fotografia e nella composizione dell’immagine, tutto si impregna di valore estetico e simbolico, nulla è lasciato al caso. Queste sono le caratteristiche che ad esempio si possono riscontrare in La storia di Qui Ju del 1992, Non uno di meno del 1999 2. In altre regie, invece, Zhang Yimou lascia che lo sguardo venga trascinato dalla grazia delle immagini spettacolari ritraenti luoghi ove i codici percettivi sono calcolati e offrono soglie di stimolazione, ove il simbolico stratificato della forma fa da padrone, allora le figure si muovono come ombre cine26 si o grafie che si confondono con i paesaggi così sublimi da andare al di là della rappresentazione del reale: è la vertigine della iperrealtà, è la fascinazione spaziodinamica, è l’estasi della negazione dell’esser-ci che si disperde e rinasce in ogni rituale, che si consuma nella narrazione di vicende cha vanno dal melodramma al gangster movie fino al rinnovato wuxiapian. Nell’immaginario composito di Yimou ritroviamo la transitorietà del tempo, l’inquietudine, le passioni, la pulsione della natura, i corpi di donne schiacciati dall’inesorabilità del destino, donne combattive nella tragicità della loro esistenza, belle, sensuali, dai tratti così perfetti da tradurre l’anima dell’estremo sacrificio, i corpi di eroi che recuperano nell’essenza della “virtù” il potere del non-luogo della mente, metafora della “grazia”. Sono tutte immagini che fluttuano nel rigore degli spazi testimoniandone l’esistenza grazie ad una esteriorità affabulante e inarrivabile in cui risiede il loro principio interno. Questo universo tematico è legato da un doppio filo: l’uso simbolico del colore e il protagonismo dell’icona del Sol Levante, il volto di tante pellicole, Gong Li. Wassily Kandinsky a proposito del rapporto che intercorre tra la forma ed il colore precisa che essa si esplicita in un numero infinito di combinazioni e di effetti: questi si intersecano, dialogano, attestano l’uno l’esistenza dell’altra. Il pittore inoltre scrive: “la forma, in senso stretto, è il confine fra una superficie e un’altra. Questa è la sua definizione esteriore. Siccome però tutto ciò che è esteriore racchiude necessariamente in sé un’interiorità (più o meno palese), ogni forma ha un contenuto interiore. La forma dunque è l’espressione del contenuto interiore… È chiaro che l’armonia delle forme è fondata su un principio: l’efficace contatto con l’anima” 3. Allora la forma non è sospesa in una zona astratta, al di là della terra o al di sopra dell’uomo, “essa si mescola alla vita traducendo nello spazio alcuni movimenti del pensiero” 4, ne è la visione speculare che si riflette in una topologia complessa legata alla potenza della materia. Non è il ritorno dell’antica antinomia tra materia e forma che tanto dibattito ha suscitato nei territori dell’Estetica, in quanto nello stile di Zhang Yimou questa questione trova una pacificazione sfaccettata, avvalorata da una figurazione archetipica che sta alla base della composizione delle immagini, della filosofia, della cultura orientale e non solo: il Tao, ovvero il principio cosmico, che permea e trascende tutti gli aspetti della creazione e infonde in essi vitalità, è l’Uno in cui i molti vivono in armonia, è la “Via” in cui l’eroe trova il respiro, l’essenza e lo spirito 5. L’artisticità di Zhang Yimou si nutre allora di questa simbologia figurativa e la infonde a vari livelli, dal sottotesto al testo, già a partire dal primo film che dirige nel 1987, Sorgo rosso. Un primo piano di un volto coperto da un velo trasparente rosso appare allo sguardo dello spettatore ipnotizzato dalla sago27 ma d’icona di una fanciulla certamente incantevole, Nove Fiori impersonata da una giovane Gong Li. Il rosso cinabro è una delle cifre stilistiche del regista, in esso si racchiude un mondo di simbologie rituali legate alla memoria orientale impregnata di alto e immanente spiritualismo; è un colore che irretisce la percezione visiva, è passione e sensualità, è la metafora virginale di una futura sposa, il sigillo del matrimonio, è indice di fedeltà e sincerità, è il sedimento dei terreni ferrosi coltivati di sorgo in cui si svolge la vicenda, è segno di Eros e Thanatos. Ogni sequenza è cadenzata da una simbologia rivelatrice atta ad interpretare il reale in una stratificazione altalenante tra alto e basso, tra materiale e spirituale, tra rito e usanza in una visione che confluisce nell’Uno e nella perdita generatrice. Il rosso lega emozionalmente tutte le vicende che colpiscono Nove Fiori, è il colore del vestito e del tessuto della portantina che la condurrà dallo sposo, è il segno del suo cambiamento, della sensualità che attrarrà il suo vero amore, il virile Yu; la loro passione si consumerà tra le piante di sorgo, in un cerchio rituale fatto di fogliame che accoglierà i corpi nudi annodati in un amplesso, e le onde della piantagione sfiorate dal vento ne significheranno il movimento rimandando l’estasi sopraggiunta alla grafia dei colori vividi di un tramonto che saluta la perdita. È rosso il colore della distilleria e dell’acqua che usa Nove Fiori per pulire e propiziare alla prosperità la casa dove abiterà; infine, è ancora una volta un rosso confuso nelle sfumature delle atmosfere del tramonto che rende il cielo muto testimone dell’uccisione della protagonista. Questo colore si sposa bene con la geometria degli spazi che accolgono le azioni dei protagonisti. La vita e la morte, nella loro ciclicità inarrestabile coesistono in un unico luogo: i verdi campi del sorgo, teatro di trasgressione, di passione, di rapimenti, di uccisione, i cui sentieri che lo attraversano formano un crocevia che fa incontrare-scontrare le forze di una natura libera, indomabile, agendo come specchio dell’anima più intima dei protagonisti, in una visione quasi panteistica. Gli altri luoghi: la distilleria, la casa del padre di Nove Fiori, appaiono come bui, asfissianti, soggiogati da un rituale che si esaurisce in una quotidianità apparentemente tranquilla e rassicurante. Lo spirito della femminilità della giovane Gong Li governa incontrastato per tutta la durata del film e si offre completa la sua semplice flagrante seduttività. Il colore rosso ritorna in un’altra pellicola di Zhang Yimou Lanterne rosse, 1991; ritroviamo Gong Li che interpreta il ruolo di una fanciulla, Soglian, che per vicissitudini economiche è costretta ad abbandonare i suoi studi e sposare Chen, un ricco proprietario terriero. La povera ragazza si ritroverà in un ambiente ove si scontrerà con le altre tre mogli e sarà costretta a sottomettersi ai rituali che ritmano la giornata dell’aristocratica casa. 28 Il titolo del film esplicita la simbologia forte che assumeranno le lanterne nel corso della narrazione. Le lanterne rosse assurgono a marchio della filosofia di vita che si svolge nella casa, segno del potere maschile, presagio del desiderio: esse, infatti, vengono adagiate sulla parte alta del telaio della porta e in ogni punto dell’appartamento della prescelta, rimarranno accese e presenti finchè il signore vi soggiornerà. La loro forma ovale, bombata, rimanda alla fertilità del ventre, o ad un morbido seno, ai punti erotici di un corpo femminile che si abbandonerà nella culla del piacere. Il loro colore significherà una serie di privilegi e piccoli rituali di preparazione a cui ha diritto la favorita: ad esempio, una serva eseguirà un massaggio ai piedi della prescelta con delle piccole bacchette, dalla punta ricurva arrotondata, che oltre ad alleviare la stanchezza al corpo, sollecita l’apertura dei chacra e libera quindi le energie benefiche confluenti nella libido e nell’erotismo. I rituali, che scandiscono la narrazione filmica, sono sottolineati da precise scelte formali utilizzate dal regista e sembrano tradurre le tre unità di aristotelica memoria: il luogo è sempre uguale, la casa, il tempo scorre con il contrappunto delle lanterne e si diluisce nell’azione che ha un compimento tragico. Lo sguardo scivola nella stasi contemplativa dei cerimoniali di ogni scena, ed i personaggi sembrano incasellati nelle geometrie degli spazi, la loro andatura lenta segue quasi una composizione pittorica che va per sovrapposizione, in cui la profondità si fonde in un continuum indivisibile che dal piano frontale porta al fondo e viceversa. Domina quindi una figurazione in cui il corpo si staglia in maniera perimetrale e si colora di tinte a cui metaforicamente corrispondono un ventaglio di sentimenti: smarrimento, rabbia, paura, falsità, tristezza. Il ritratto del “potere” regola la geometria dell’anima che si rispecchia nelle relazioni umane della casa: si offre visivamente in una struttura piramidale mobile al cui vertice c’è il padrone, poi la prescelta e per emanazione le altre tre mogli che esercitano nei loro spazi una propria forza. Il mondo femminile è mostrato nelle quattro età della vita: l’adolescente, la ragazza, la donna matura, l’anziana, ciascuna è sottomessa al rigore formale, ogni personalità è annullata anche nel nome, e apparentemente esse, nello scorrere dell’impietoso e indolente tempo, varcano la spettrale e simulacrale soglia della seduzione nello spazio concesso. Le inquadrature spesso dall’alto rendono inesorabile il tragico destino della protagonista. Ella alla fine rimane intrappolata dallo spazio, incorniciata da una scenografia in cui le pareti, le mura della casa diventano possenti, alte e si scontornano nel cielo che le sovrasta partecipando di questa atmosfera opprimente. Nella fotografia il viraggio straripa di grigio metallico e plumbeo tingendo ogni cosa, una morsa asfissiante accerchierà e cancellerà il corpo 29 che si contorce di Sonlian trascinato a forza nella torretta degli orrori, rimarrà allo sguardo un segno tremante di una sottile pennellata ed il suono interiore, straziante che ne scaturisce. Sul volto e sul corpo di Gong Li Zhang Yimou disegna la cifra della seduzione simbolica dell’universo femminile, al di là della credibilità della recitazione eleva l’attrice a diva, ella è “il ricettacolo immediato dello sguardo dello spettatore” 6. Gong Li è l’icona, un segno visivo, che con la sola presenza satura l’immagine, sia che il regista la ritragga in un primo piano o in un totale, la sua silhouette nel suo incedere ondulatorio, o sicuro, o nella stasi della sola presenza-assenza si irradierà sempre e comunque di luce divina. Queste qualità sono ben evidenziate in La triade di Shangai, del 1995. In questo gangstermovie l’attrice interpreta Bijou un’affascinante vedette di un night club, pupa del vecchio e potente boss Tang. Nella progressione narrativa la sua apparizione è folgorante: è viziosa, altezzosa, è la regina fuori e dentro il palcoscenico, è ipostatizzata in una gestualità, in una cosmesi ed in un look che la rende immediatamente riconoscibile come una vera dea. Come non identificare nel personaggio di Bijou alcune caratteristiche di LolaLola protagonista dell’Angelo azzurro di Joseph Von Sternberg: “Essa è il peccato. È la mala sorte. È la vendicatrice della sua razza. È l’Eva del serpente rinata da Versailles” 7. È nel night-club, o nella camera da letto o ancora, nei paesaggi notturni, selvaggi e rurali dell’isolotto, che si dispiega un’iconografia di grande forza espressiva e seduttiva che va dal fascino della dark lady, all’ingenuità della fanciulla perseguitata, alla “bella sconosciuta” che possiede la grazia irresistibile dell’avventura nell’ignoto, fino alla stereotipo della femme fatale protagonista di tanta letteratura anche fumettistica 8. In questo ultimo modello Bijou appare come una creatura capace di agitare i sentimenti, vittima designata, incapace di gestire gli eventi ed allontanare quei segni che già sono scritti sulle morbide curve di un corpo, e sui lineamenti di un volto di una bellezza funerea illuminato da due occhi a mandorla che si perdono nei meandri del sentire, e sulle labbra piccole rosse come ciliegie da assaggiare; ogni centimetro di pelle traducono una malia d’amore maledetta. Questa maledizione non colpisce solo coloro che sono attratti dalle spire della seduzione, ma si riversa su colei che è lo scrigno della bellezza fatale, disarmandola e conducendola verso un fato inclemente. L’iconografia proposta dal personaggio di Bijou è incorniciata e marcata ora dalle luci brillanti del palcoscenico, o dalle piume e paillette degli abiti occidentali in perfetto stile anni trenta, dalle sete trasparenti che drappeggiano i tagli vertiginosi del negligé, ora da una figuratività opposta che ha come 30 oggetto la purezza della donna angelicata, una peccatrice redenta che sprigiona sguardi di innocenza suscitando la stupita ammirazione femminile: allora le rendono omaggio i colori freddi e notturni di una natura incontaminata, ultimo teatro del Thanatos. L’icona di Bijou regala una bellezza rituale, esoterica ed iniziatica, in quanto nel suo corpo è custodito il segreto della seduzione scritto esternamente dalla levità dei segni dell’artificio; ogni accessorio, gioiello, taglio dei vestiti, la cosmesi mette in atto l’arte della simulazione: il rosso accesso che copre le labbra rimanda immediatamente al sangue, alla morte, alla perdita, il suo volto porcellanato non è il riflesso della sua anima, è l’espressione di una maschera così perfetta ove lo sguardo è estatico, il sorriso traduce una smorfia che si disperde in una fascinazione sacrificale. Così nella parte finale del film, il primo piano di Bijou si staglia in un freddo blu notte, la pioggia incessante la bagna e ogni goccia che si adagia sul volto lo restituisce bello, perfetto tanto da sembrare plastificato, simulacro dell’assenza. Il turbinio sfavillante di immagini spettacolari, che stratificano la forma, è protagonista della trilogia che Zhang Yimou dedica al wuxiapian: qui la funzione dell’archetipo si nutre da un lato delle “virtù dell’eroe” e dall’altro del potere dell’energia spirituale. Apre la trilogia del genere Hero 2002, un vero e proprio kolossal ambientato nella Cina del III sec. a. C.: il re di Qin vuole diventare il primo imperatore ed unire sotto un unico cielo i sette regni in cui è diviso il territorio. Yimou indaga con perizia le sfaccettature del “potere” e lo compone offrendolo allo sguardo dello spettatore, simile ad un prisma in cui si riflettono i differenti livelli della narrazione che avanzano in un continuum di flashback. Ogni frammento del racconto è connotato dalla dominanza cromatica: grigio metallico, rosso, azzurro, verde, a chiusura il bianco. È l’epopea della bellezza e del dolore, del fascino e dell’intrigo, dell’Io dell’imperatore che si riflette a specchio in quello dell’antagonista Senza Nome; è un viaggio interiore in cui il colore assurge a simbolo dei livelli dell’anima, è la “via” da percorrere per appropriarsi della verità: gli ostacoli sono le menzogne, ma ogni qual volta si dis-velano il “potere” si riverbera e rinasce in un’altra forma fino a rifluire nella circolarità cristallina del ch’i primordiale 9. Il flashback allora è la metafora di una memoria che sfoglia le pagine colorate del potere dell’io-guerriero: se è grigio metallico siamo attirati in caosstatico ove il movimento ondulatorio della luce delle candele, poste su diverse file alla base del trono ove è seduto il re di Qin, sollecita un cammino virtuoso. I colori e l’atmosfera di questa scena rimandano in maniera sinestetica alle gocce d’acqua che rimbalzano dalle canalette e dalle grondaie degli edifici che circondano un atrio interno, luogo deputato al primo scontro tra Senza Nome e Spada Spezzata. I corpi dei due valorosi guerrieri leggeri 31 come le gocce d’acqua, si librano nell’aria, fendendola con la maestria delle armi, ogni colpo, ogni movimento è sottolineato grazie alla slow motion, ed incorniciato con inquadrature che visualizzano la poesia del dettaglio. Il primo piano della lancia, lo scintillio dell’incrocio delle spade, si configura come una successione di non luoghi, una sospensione scandita dal tempo simbolico della mente, al ritmo di uno strumento a corde: ricordiamo che musica ed arti marziali condividono lo stesso scopo, il raggiungimento di uno stato di coscienza superiore. Per confermare come sia netta la differenza tra la dimensione del palazzo e la transitorietà degli altri spazi coinvolti, si procede nella sublimazione dell’astrazione del rosso che, a questo livello della narrazione, significa il potere della calligrafia al pari delle arti marziali. Spada Spezzata usa la virtù della spada per muovere abilmente il grande pennello intinto nella pittura rossa con cui inciderà la parola “spada” sul grande foglio che verrà donato al re perché “calligrafia e arte della spada si somigliano, nascono dall’armonia tra la forza del polso ed il sentimento del cuore”. Vi è un crescendo nella geometria dei combattimenti che sollecita tutti i sensi e il rosso sprigiona energia invadendo lo spazio in ogni direzione. La forza espansiva di questa tinta inebria gli sguardi avviluppandoli in movimenti ondulati, centrifughi che traducono la sensualità dei colpi inferti da due fate, Luna e Neve che Vola, che duellando danzano fino all’ultimo battito d’ali, in una foresta ove il giallo delle foglie da lì a poco si tingerà del sangue sacrificale della perdente. Altro momento ieratico è rappresentato dal duello tutto mentale che Senza Nome e Spada Spezzata eseguono sopra un lago; i corpi sospesi in aria eseguono mirabolanti piroette e voli iperbolici sfiorando con le spade e con passo leggero il grande specchio d’acqua. La levità dei movimenti si staglia in un paesaggio ritratto da una fotografia ove il viraggio predominante è il blu che gli conferisce un’aura di impalpabile bellezza. I due valorosi guerrieri squarciano l’aere come una leggera brezza e l’estaticità dell’immagine conduce la sguardo a vivere la pausa della contemplazione nel flusso e riflusso che spinge a rimirar la quiete del sentire. Il valore del re Qin come guerriero è contrassegnato dal verde che colora i drappi che cascano dalle volte del palazzo ed ornano la sala del trono; è il ricordo dell’incontro-scontro tra il sovrano e i suoi nemici Spada Spezzata e Neve che Vola; è un faccia a faccia che coinvolge nella coreografia del duello i paramenti che, squarciati, scivolano leggeri come foglie sul pavimento, o come pennellate sottolineate dai primi piani e dall’uso mirabolante della steadicam. La contesa si chiude con il ritiro del nemico che rinuncia ad uccidere il sovrano. Il colore verde, dato lo svolgimento dell’azione, non fa altro che suggellare il valore e la virtù del guerriero; togliere la mano dalla spada 32 e abbandonare lo spazio del combattimento non è indice di codardia, ma è saper ascoltare quelle vibrazioni che provengono da anahata, varcare quindi la soglia del corpo fisico e sentire quello astrale stabilizzando questo passaggio nel centro del cuore. Il verde allora è l’intendimento, la penetrazione dell’anima. Il colore bianco identifica l’ultimo flashback. Siamo giunti alla fine del cammino, è il momento dello smascheramento, tutti i personaggi hanno raggiunto la pace dello spirito purificato, ciascuno secondo la propria intima essenza: infatti, Neve che Vola placherà la sua rabbia e comprenderà l’anima del suo amante Spada Spezzata solo dopo un estenuante e mortale duello che li vedrà coinvolti, i loro corpi inginocchiati l’uno avvinghiato all’altro troveranno l’estasi della morte guardando l’infinità di una natura desertica; il caos ha dato origine ad un nuovo ordine, è la quiete della ragione che si è nutrita di sentimento e spiritualità. Il viaggio interiore del re è giunto alla fine, il potere è rischiarato dalla luce della verità che sublima se stessa; mira la parola “spada” che campeggia rossa sullo sfondo bianco della carta di riso e comprende che il nemico ha penetrato il suo intento, in quel segno è racchiusa la natura e la virtù del guerriero: “la conquista dell’arte della spada è l’assenza della spada nella mano e nel cuore, la mente aperta contiene tutto. L’uomo di spada è in pace con il mondo, egli non uccide e porta la pace all’umanità.” Materia ed energia sono le realtà di un’unica forma, coesistono in una pacificata armonia. L’impalpabile velo della poesia d’amore muove l’azione dei combattimenti che si susseguono nella Foresta dei pugnali volanti del 2004. Il regista si misura ancora una volta con il “cappa e spada” cinese narrando il destino e la passione del soldato Jin, interpretato dall’idolo del cinema asiatico Takeshi Keneshiro, per una rivoluzionaria Mei, dà vita a questo personaggio Zhang Ziyi, astro nascente della cinematografia cinese, una bellezza più sottile e adolescenziale rispetto all’icona di Gong Li, che sembra dire a baluardo della sua seduzione: “Io non sono una donna, sono un universo” 10. I due giovani si innamorano durante la sanguinosa guerra tra l’esercito della dinastia Thang, ormai in declino, e una alleanza clandestina denominata “I Pugnali volanti.” Un fascino emozionale intenso connota la scena che si svolge nel “Padiglione delle Peonie” una casa di piacere adibita come è tradizione a sala da te, in cui per la prima volta si incontrano i protagonisti: Jin che si finge un cliente e Mei che assume l’identità di una danzatrice cieca. Zhang Yimou cura con attenzione maniacale ogni dettaglio, dalla scenografia alle luci, all’arredo fino ai costumi che devono rispecchiare filologicamente l’epoca ritratta. Il valore attribuito alle forme e ai colori hanno contribuito alla meravigliosa alchimia della visione della danza “dell’eco danzante”. 33 I colori pastello variano dall’azzurro al rosa ed invadono il salone del “Padiglione”, luogo deputato alla performance della leggiadra fanciulla, la cui circolarità è perimetrata dai tamburi che riprendono il motivo dell’ornamento centrale: una peonia. I musicisti si dispongono ai lati su una doppia fila, ogni cosa è geometricamente posta, e la danza segue delle traiettorie precise indicate dal rintocco dei fagioli scagliati contro i tamburi. Il corpo di Mei definisce lo spazio con i movimenti cromatici delle maniche del suo vestito, è il tripudio di effetti visuali policromi, è una fantasmagoria ottica e figurativa, è un susseguirsi di inquadrature che indugiano dal dettaglio al primo piano fino a inseguire con puntualità i movimenti di piroette e volteggi in aria che si chiudono in pose graziose che rimarcano un equilibrio extraquotidiano. Un altro rintocco dei fagioli e la danza ricomincia spendendosi in movimenti ampi, acrobatici, salti aerei. Lo sguardo dello spettatore è rapito da questa visione dinamica e trova quiete nell’ennesima pausa: questa volta la danzatrice sembra un magnifico uccello in equilibrio su di una gamba, pronto per essere risvegliato e volare. La vorticosa danza è puntellata da un montaggio veloce: il corpo si abbandona al ritmo incalzante dei tamburi, è un susseguirsi di grafie che si espandono nell’aria esaltando le dinamiche dell’attrazione sensuale e desiderante. L’ipnosi cromatica sollecitata in questa scena attua una retorica del reale sfociante in una rappresentazione che imprigiona la pura ripetizione dei gesti che si frammentano in uno spazio, ove la metafora e la metonimia non hanno ragion d’essere, lo sguardo si inerpica nella vertigine di una simulazione realistica 11 e l’effetto speciale dei fagioli sospende una realtà avvalorandola più del reale. Le sinfonie visive ritmano il crescendo della narrazione; alla fuga nella foresta, o ai combattimenti sempre più ardimentosi si alternano pause di raccoglimento dove fanno da sfondo panorami mozzafiato in cui il punto di fuga è appiattito, macchie di vivida natura incorniciano i piccoli gesti d’amore fatti di sguardi rubati, di promesse che non si possono mantenere, di versi, di mani che si sfiorano, di labbra che ardono per assaporarsi. Il manto accogliente dell’amore accompagna i passi dei protagonisti che tornano a misurarsi in nuovi combattimenti; ogni azione è percossa dal brivido del Thanatos. È nella foresta di bambù, teatro tradizionale dei combattimenti nel cinema cinese di arti marziali, che le acrobazie, i voli e gli abissi offrono coreografie scenografiche. Gli inseguitori scendono giù dagli alberi come se la forza di gravità fosse annullata, leggeri come le mortali lance che lanciano per catturare i due innamorati. La foresta nella sua significativa stratificazione delle tonalità del verde si rivela il luogo ove si smascherano le identità, si sciolgono gli inganni, si dipanano gli intrighi, è un susseguirsi di eventi spettacolari dove gli effetti speciali sono orpelli che dinamizzano l’azione 34 e la scenografia. L’amore rimane il motore principale della storia, ossessiona e tormenta i protagonisti, nutre il corpo e la mente fino a spingerli all’estremo sacrificio. È questo tema che accompagna lo sguardo attonito e sedotto dello spettatore verso un finale lungo, disseminato di tutti quegli elementi caratterizzanti il genere wuxiapian che danzano lenti in mirabili visioni epiche: l’amicizia, il valore del guerriero, l’amore, il sacrificio, la rinuncia, la lotta fiaccante che riesce ad avere un controllo sui corpi con la forza dell’energia spirituale, la marmoreità delle azioni morali sono condotti fino alla morte; sono queste qualità che animano i fendenti decisivi inferti nel duello di Jin e Leo. La contesa sembra attraversare il lirismo di tutte le stagioni così il tempo della rappresentazione diventa meta-temporale come il codice virtuoso del vero guerriero. Chiude questa trilogia dedicata al wuxiapian La città proibita 2007, che nel suo impianto narrativo più che un omaggio alle arti marziali si configura come una tragedia sheakespiriana dalle tinte forti e sanguinarie. È la celebrazione da un lato della bellezza di Gong Li che ritorna con questa pellicola ad essere diretta da Yimou, e dall’altro del “potere” della materia e dello spirito, nella sua accezione negativa e positiva. Come gli altri film anche questo presuppone una funzione simbolica del visivo per differenti livelli. È il viaggio in un periodo storico quello medievale in cui la dinastia Tang era al suo massimo splendore, ove l’ostentazione dominante dello sfarzo, tinto da un accecante giallo oro, nasconde una realtà oscura, fatta di intrighi di corte, di giochi di potere, di segreti; sarà ancora una volta il sacrificio, la perdita a suggellare le azioni dei protagonisti. Apre la narrazione la serialità dei cerimoniali e dei riti che conducono immediatamente lo sguardo dello spettatore a celebrare una visione ieratica del meraviglioso involucro del palazzo imperiale e dei suoi componenti, che si sta apprestando ad accogliere l’autorità assoluta della famiglia reale: l’imperatore. La figuratività del tragico accompagna la malinconica solennità del primo piano sul volto di Gong Li-l’Imperatrice; le gocce di sudore che imperlano la sua fronte incorniciata dalla chioma corvina acconciata da spilli elaborati in oro, lo sguardo pietrificato e dolorante, la mano tremante che sceglie altri gioielli d’appuntare, annunciano già da un lato la nefas e il fatum, e dall’altro l’espiazione e il sacrificio dell’eroina. Ella è vittima ma allo stesso tempo è sulla sua gestualità tremante, sui suoi sontuosi abiti, nel suo maquillage e nel suo incedere formale nei corridoi del palazzo imperiale che ritroviamo disseminate le tracce di una storia che la condurrà alla rivolta. Poche sequenze e subito Zhang Yimou ha rappresentato con l’ausilio di pennellate digitali, e una sapiente giustapposizione di colori caldi e freddi, 35 ambienti così belli da sembrare iperreali in cui i protagonisti si muoveranno come presenze spettrali; i loro corpi, resi perimetrali da una luce vivida, sveleranno l’assenza che si satura di un conflitto tragico senza via d’uscita se non quella della solitudine, partner segreto, sornione, carica di quella pietas che conduce alla morte metaforica dell’Io che si nutre si sangue, ferite, sentenze, rabbia, dolore. Tutti i personaggi di questa scintillante tragedia familiare vivono un segreto nella loro desertica solitudine: l’Imperatrice combatte l’oppressione, l’aridità interiore, consapevole che non potrà mai liberarsi dalle catene della vessazione, beve il “rimedio” quotidianamente, medicina dell’agonia e della prigione dello spirito, spera di cambiare una sorte predestinata; l’Imperatore pater familias, riflette il potere del sistema feudale, ha rinunciato al suo vero amore, ha il dovere di dettare le leggi, ogni sua azione anche la più efferata è giustificata dal machiavellico il “fine giustifica i mezzi”, il dolore straziante della sua anima troverà il suo acme quando assassinerà il figlio minore: ogni colpo inferto con il suo cinturone di un giallo-oro accecante sarà carico di pathos, la lunga chioma scarmigliata coprirà il suo volto accompagnando la tragicità del crudele gesto fino ad accarezzare le umane lacrime che scorreranno lente confondendosi con un urlo che riecheggerà nella sala reale sollecitando una visione sinestetica. Il primo genito ha un carattere gentile e debole, insegue l’amore vero, custodisce il segreto di una relazione pregressa con la matrigna, ed un innamoramento per la figlia del medico di corte; su costui si abbatterà la furia di una cocente verità: la donna che ama e con cui ha consumato notti di passione non è altro che la sorellastra. Questo episodio traduce una delle dialettiche delle vere pene della tragedia secondo cui il dolore tragico risiede nell’innocenza della colpa 12. Il secondo genito è un guerriero generoso e virtuoso, incarna un dilemma storico nella cultura cinese: l’impresa impossibile condotta da un solitario eroe che va avanti, giunge al martirio sacrificandosi per ciò che ritiene giusto. Il più piccolo dei fratelli è il ricettacolo di tutti i segreti che si vivono nel palazzo, la sua vista si è nutrita di odio e rabbia, la sua presenza in ogni sequenza è connotata da una gestualità titubante, o da apparizioni repentine che sembrano confondersi con le pareti dei lunghi corridoi o delle stanze, un oggetto tra gli oggetti. I tre geniti incarnano con gradiente differente l’amore filiale e le loro azioni saranno regolate proprio dall’ubbidienza e dal rispetto familiare. Il climax realizzato è atto a creare visioni catartiche in un processo cadenzato da una polimorfia sensibile che conferisce ad ogni sequenza un’aura di sacralità dilatata, trabordante negli spazi che puntualmente si offrono allo sguardo come dispositivi celebrativi, di autocontemplazione, immagine simbolica del cosmo, basti ricordare la magnifica terrazza del crisantemo che si erge nella sconfinata piazza antistante al palazzo, punto di riunione della 36 famiglia reale: “La terrazza è rotonda, la tavola è quadrata come il cielo è rotondo e la terra è quadrata. Le leggi del cielo regolano la vita terrena. Sotto il cerchio dentro il quadrato ognuno ha un suo ruolo, imperatore, cortigiano, padre, figlio, lealtà dell’amore filiale, ritualità e giustizia. Le relazioni obbediscono alla legge della natura.” Sono ancora gli spazi della grande piazza inondati dall’oro dei crisantemi ad essere il teatro della sanguinosa vendetta che ricongiunge il passato ed il presente di questa famiglia patriarcale: due eserciti si scontreranno in una geometria di azioni che come onde si infrangeranno in un mare di sangue: il grigio plumbeo e luccicante ingoierà il giallo lasciando immense chiazze di rosso. Il film si dispiega come una collana di perle e ciascuna di essa vive la catarsi del sacrificio, della contemplazione e dell’estasi mistica della visione: è lo scontro tra due titani, due numi immortali: il dragone e la fenice. Il primo incarna la forza vitale e benefica della natura, rappresenta il sole e la vita, la seconda per la sua divina bellezza è la Gemma Originaria, la progressione che anela all’immortalità con il consenso del Cielo e la Terra 13. Imperatore ed Imperatrice avvolti dai loro reali paramenti dorati hanno un portamento luminoso e solenne, ogni gesto anche il più tragico non eclissa la perfezione della loro bellezza. Una disperazione errante, livida percorre comunque tutta la narrazione; i conflitti tra i personaggi troveranno soluzione solo in un susseguirsi di eventi anche spettacolari, di tableaux vivants che sembrano essere ritagli di iconicità bizantina, o di battaglie appartenenti alla migliore tradizione della mitologia ellenica, archetipi di luoghi e corpi che vivono un “tempo in movimento”, incesellati nel grande mandala del “crisantemo”. In queste ultime fatiche Zhang Yimau ha celebrato e raggiunto in maniera sistemica la sofisticazione delle apparenze che sono andate al di là di una realtà riproducibile dall’occhio della cinepresa, i corpi e gli spazi hanno sfidato l’irreale sconfinando nell’iperrealtà, sono assurti a segni, effigi di un rituale senza tempo, soggetti di produzione ma anche oggetti di culto, artifici incantatori del desiderio dell’Altro. Cfr. G. Canova, L’alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo, Studi Bompiani, Milano, 2004 1 Cfr. F. Richard, Qiu Ju, une femme chinoise: Voyage en Chine, «Positif”, n. 382, dicembre 1992, pp.32-33; Marc-André Brouillard, Pas un de moins: rat des villes et rat des champs, «Séquences”, n. 209, settembre-ottobre 2000, p.40 2 37 W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, a cura di Elena Pontiggia, Se, Milano, 2005, p. 49 3 4 «Elles se mèlent à la vie, d’où elles viennent, traduisant dans l’espase certains mouvements de l’esprit” H. Focillon, Vie des formes, Quadrige Puf, Paris, 1996 5 L. Mulvey, Visual and Other Pleasures, Macmillan, London, p.22 6 Cfr. M. A. D’Agostaro, Lola Montez, vita, scena, set, mito, Contesti, Ribera, 2007 Cfr. S. Sinisi, Cantami o diva. I percorsi del femminile nell’immaginario di fine secolo, Avagliano editore, Cava de’ Tirreni, 1999; J. Baudrillard, Della Seduzione, Se, Milano, 1997 7 8 Cfr. J. O. More, Capire il taoismo, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2007 9 G. Flaubert, Les tentations de Saint Antoine, Paris, p.41 Cfr. J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Universale Economica Feltrinelli, Milano, III ed. 2002 10 11 Cfr. R. Tomasino, Storia del teatro e dello spettacolo, Palumbo, Palermo, 2001 12 Cfr. J. O. More, Capire il taoismo, op. cit. 38 B-movie e/o exploitation e/o supergenere? di Andrea Caramanna Domanda sibillina, retorica. Perché provare a distinguere tra il budget alto e basso, tra estetiche di genere, quando ormai l’avvento delle nuove tecnologie di ripresa, davvero low budget, ha coinvolto e fuso la produzione mondiale di immaginar? Cinema, Pubblicità, Televisione, Internet. Fare una pagina web è una questione tecnica che costa davvero poco, però i content manager delle pagine on line sono ormai obbligati a utilizzare tutto il “peggio” della comunicazione. Soprattutto violenze, nudità, scandali e scandaletti, spesso soltanto false notizie, futili indiscrezioni, morbosità d’ogni genere (e già ne avevamo parlato nel numero scorso di The Rope a proposito dei “Beautiful Agony”, gli orgasmi messi in scena dalla webcam fissa su un territorio domestico qualunque). Dove inizia tutto questo? Sicuramente nella cultura popolare, che poi diventa estetica pulp. E c’è tutta una cultura prodotta dalla comunicazione mass mediale che però è filtrata dai codici di autoregolamentazione, dai poteri e dalla censura. Così già nella Hollywood degli anni dieci mentre è un fiorire di comitati contro i contenuti scabrosi nei film, ed è un moltiplicarsi di produttori di film che mostrano il “peggio” del mondo. Una parte di questi film ha per giustificazione il puro intento educativo. Tuttavia i film per metter in allarme contro le malattie veneree finiscono per stimolare gli istinti più voyeur del pubblico. Che è attratto da queste pellicole ad un livello viscerale. E soltanto questi film riescono ad attrarre in modo trasversale tutte le fasce di pubblico. Altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno dei b-movies. Perché hanno rappresentato il lato oscuro dell’anima umana o se vogliamo la fantasia, confermando una volta per tutte che tra i vari teorici Edgar Morin aveva più ragione di altri. Basti pensare a quei generi divenuti importanti e fondamentali negli anni Quaranta e Cinquanta, ovvero il noir e la fantascienza. Quindi, se è prevalsa definitivamente la produzione low budget significa automaticamente che il novanta per cento della produzione mondiale di immagini ha caratteristiche exploitation? Pensiamo di sì. Anzi dovremmo riflettere sulla caratteristica pulp che investe la nostra intera cultura. Anche politicamente, la globalizzazione non si configura forse come esplosione di tutti i localismi per riconfigurarli come forme massmediali tout court, dalla nuova leggibilità e interpretazione? Quello che alcuni studiosi come Tom Gunning hanno indicato quale cinema delle attrazioni, includendo Méliès ed Eisenstein, si sta moltiplicando abbracciando molti media contemporaneamente, tutti con la stessa modalità di espressione: colpire gli istinti, accendere le sensazioni più viscerali. L’estetica 39 exploitation costruita e propagata con il sistema low budget solca i giornali, le radio, i videogame, la televisione, internet, il cinema, la pubblicità, ma anche gli spettacoli e le arti più tradizionali, magari con più difficoltà: il teatro, la pittura, la scultura, la musica (la lo-fi, cioè la bassa fedeltà ha prodotto i più interessanti fermenti degli ultimi decenni). Per non divagare, soffermiamoci sul cinema. Diciamo subito che il cinema è senz’altro indietro ad altre forme di comunicazione. In due casi il cinema mostra di essere totalmente consapevole delle nuove estetiche dominanti del ventunesimo secolo: 300 di Zack Snyder e Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Sono anche due esempi tra loro molto lontani perché in generale si può dire che mentre il film di Tarantino e Rodriguez rimane un film intellettuale pur travestendosi da exploitation, dall’altra parte 300, apparendo quale blockbuster, in realtà contiene e rappresenta un’estetica pulp. Basterebbe considerare la quantità impressionante nei due film di parti del corpo mozzate. Ed oltre a questo dato comune il pulp si mostra attraverso una cornice decisamente fantastica orrorifica che rende i personaggi dilatabili e interscambiabili, dei puri attanti che si scontrano l’un l’altro fino al climax, che può essere un groviglio di corpi o di ferraglia (le automobili o le armi, gli scudi, le spade, gli elmi, le pistole o le mitragliatrici). Certo Tarantino e Robert Rodriguez fanno un film doppio (altro riferimento ai due spettacoli a forfait, con lo sconto, dove uno è omaggio, dei drive in, ai tempi d’oro dei b-movies) contenente davvero tutto l’immaginabile del viscerale e la propagazione di un virus letale è perfetta per sintonizzare vecchie paure con angosce contemporanee. Insomma, entrambi i film scuotono lo spettatore, costringendolo a fare i conti con uno spettacolo ripugnante. Ma come tutti i mostri, a guardarli si prova repulsione ed attrazione. Altro film esemplare è The Blair Witch Project di Daniel Myrick, Eduardo Sánchez , la cui legittima prosecuzione potremmo considerare il fantascientifico horror Cloverfield di Matt Reeves. In entrambi i casi è innegabile l’aspetto di cortocircuitare ancor prima del film le aspettative, gli istinti, le curiosità, le indiscrezioni, le morbosità per qualcosa che alla fine è molto deludente. Perché nei due casi la messa in scena è ridotta a una camera a mano che gira vorticosamente, compie ogni tipo di movimenti obliqui o dall’alto verso il basso e viceversa. Ed alla fine l’unico risultato è di oscurare ancora il visibile, ma perché quest’ultimo non costituisce attrazione in sé. L’attrazione stava solo nell’attesa, nella pulsione che spingeva lo spettatore a guardare da una parte, a supporre qualcosa, un elemento. Mentre poi il primo è un film low budget, curiosamente il secondo è un film high budget che si traveste “low”. E questo indica senza ombra di dubbio che la estetica bassa, l’exploitation è definitivamente prevalsa su tutte le estetiche. Attraverso questa breve analisi dei quattro film si può dedurre che l’exploi40 tation contemporaneo conosce benissimo gli strumenti per ottenere lo stesso risultato, vale a dire l’attenzione del pubblico. Il resto conta poco ed è trascurabile affermare che mentre i primi due titoli sono capaci di una messa in scena articolata e complessa, i secondi invece si limitano a poco. Certo nel caso di Cloverfield gli effetti speciali ci sono, ma la cosa sorprendente è che, per ostentare un’estetica da low budget, sono posti in secondo piano, mentre di solito i trucchi dei b-movies sono mostrati come risorsa da ostentare, quasi una prova della sufficiente bontà del film. Per esempio molti trucchi del cinema italiano di serie B negli anni settanta erano fatti da abili artigiani, e non aveva proprio senso nasconderli. Ricordiamo ad esempio un film dalla realizzazione quasi impossibile per le scene sottomarine, L’isola degli uomini pesce di Sergio Martino (che ha appena rifatto L’allenatore nel pallone con Lino Banfi!), laddove la scenografia e i costumi furono brillantemente creati e risolti da Massimo Antonello Geleng. La superiorità “intellettuale” del B-movie La fine del film d’autore è stata decretata dalla superiorità “intellettuale” del B-movie, laddove quest’ultimo non ha nessuna pretesa d’arte o qualcos’altro mentre il primo di pretese di solito ne ha tantissime. Tanto per fare un nome, ci ricordiamo vivamente la preoccupazione di Bernardo Bertolucci, il quale sospettava che la parodia del suo Ultimo tango a Parigi, vale a dire Ultimo tango a Zagarol di Nando Cicero, fosse nettamente superiore. Una prova luminosa dello sprofondamento delle cosiddette estetiche “alte”. Anche Ciro Ascione nel saggio “Bidoni e Filmacci” in Fino all’ultimo film. L’evoluzione dei generi del cinema a cura di Gino Frezza, sconfessava alcuni presunti capi d’opera: “è probabile che per far colpo sulla tipa che era con voi durante la proiezione di The piano (Lezioni di piano) di Jane Campion, abbiate detto tutto il possibile della protagonista, mentre la vostra coscienza vi gridava che la Hunter era un’acidona e che se Sam Neill le tagliava un dito non aveva tutti i torti. Mettetevi nei panni di un possidente neozelandese della fine dell’Ottocento, e poi chiedetevi come vi sareste comportati con una moglie isterica che 1) ha già una figlia, saccente e insopportabile, 2) vi nega i piaceri del talamo, 3) si rifiuta di rivolgervi la parola, 4) pensa solo al suo pianoforte, 5) vi fa le corna con un maori. Forse la pensava così anche la vostra compagna, ma non ha osato parlare. Non sono i contenuti indifendibili a rendere Lezioni di piano un bidone... Lezioni di piano è un bidone perché Jane Campion noleggia un bravo direttore della fotografia e gli fa filmare tante belle cartoline di tramonti, tutte al servizio di un apologo femminista. Kiarostami in Ta’m e guilass (Il sapore della ciliegia) affligge lo spettato41 re con sciattissimi piani sequenza dove per dieci minuti non vedi altro che la nuca di un automobilista... Prova a dire che Madadayo di Kurosawa è una sfilata di vecchi rincoglioniti che predicano ovvietà da dopolavoro ferroviario, e tutti ti guarderanno come se avessi ruttato in cattedrale”. Certo Ascione scopre l’acqua calda, ma è vero che l’approccio ad un autore porta spesso alla sopravvalutazione. Woody Allen potrebbe benissimo rappresentare l’autocapitolazione dei cineasti rispetto al passato cinematografico. Troppo ingombrante la storia del cinema per pensare ancora di avere slanci artistici, ormai conta solo rimpastare gli immaginari e quindi i generi. Allen negli ultimi suoi film, per di più uno all’anno a ritmo di exploitation, si limita a rifare il grande cinema, parodiandolo, citandolo, alla stregua di Tarantino. Se siamo arrivati a questo punto è perché messi in campo alcuni elementi ci rendiamo conto che il canone cinematografico attuale sembra un rimpasto di tutto ciò che è stato filmato. Ma rifare è proprio una caratteristica del B-movie, dell’exploitation, che ha il solo scopo di ottenere audience. E non essendoci più il problema di realizzazione di film, perché anche gli effetti speciali costano poco, grazie all’uso massiccio delle tecnologie digitali di ripresa e postproduzione, neanche ci sarà il pericolo di creare scene improbabili come quelle indimenticabili di Ed Wood in cui gli attori inciampavano su cavi nel set o lottavano con inverosimili mostri che si muovevano soltanto con la spinta degli stessi interpreti come Bela Lugosi. Oppure la palestra spacciata per astronave in Bestia nello Spazio di Alfonso Brescia. E perché no, l’orgasmo dell’asino finto che raglia, inquadrato con il primo piano dell’occhio in Ramba sfida la bestia, pornazzo di Salvo & Martin con Marina Frajese. L’avvento del supergenere Il rapido cambiamento e l’ibridazione dei generi è avvenuto soprattutto negli anni novanta. Affermano Luca Aimeri e Giampiero Frasca in Manuale dei generi cinematografici. Hollywood dalle origini ad oggi: “Nel 1990, in quella vetrina delle tendenze del cinema USA che è il Festival di Cannes, la Palma d’oro va, non senza polemiche, a Cuore selvaggio di David Lynch, un film che bene sintetizza il processo di deriva dei generi rappresentandone un punto estremo e paradigmatico e che al contempo è un film apripista rispetto al decennio su cui si affaccia, contenendone più che i semplici semi”. Oltre alla contaminazione, l’effetto che più ci interessa nella nostra analisi è quello della fetazione di un unico supergenere. Nel 2002 forse Frasca e Aimeri non erano ancora tanto sicuri di questa conclusione però chiudevano la loro analisi sul film di Lynch con questa rilevante osservazione citando Genere e Supergenere di 42 Roberto Nepoti: “se da un lato Cuore selvaggio rappresenta il punto estremo della deriva dei generi, dall’altro con l’elaborata struttura narrativa a puzzle, il suo impianto a toni contrastanti tra noir e commedia, lo humour nero, il campionamento pop, l’uso della soundtrack ecc., preannuncia la stagione black/crime-comedy degli anni Novanta che vedrà il suo campione in Tarantino. Cuore selvaggio come i lavori di Tarantino sono esemplari di un cinema che vive di cinema, frutto della metamorfosi che, dagli anni Settanta in avanti, ha praticamente trasformato tutto il cinema di Hollywood in un unico testo metacinematografico ultracosciente di sé. Il corpo del cinema è diventato un deposito, un magazzino culturale, un paradigma disponibile all’uso da cui ritagliare elementi già insediati nell’immaginario collettivo assemblandoli liberamente”. Se oggi si può essere solo di serie B, oppure se non ha senso parlare di differenze tra budget, che cosa è rimasto dei generi, o meglio, si può ancora parlare di classicità a proposito di Clint Eastwood che poi fa film normalissimi e noiosi oppure dell’ipocrisia militante di Ken Loach, che ci rifila di tutto, fuorché quel briciolo di gran cinema che sgorga in appena 2 secondi dalla regia di un qualunque Tony Scott o Robert Rodriguez (era lui guarda caso il regista dell’assoluto low budget El mariachi)? Non è rimasto niente dei generi (Aimeri e Frasca dicevano che se non erano proprio morti, erano in stand by) e a parte alcuni capolavori del passato ancora riconosciuti della storia del cinema (ma presto saranno altri... ), rimangono migliaia e migliaia di altri film, forse ancora tutti da scoprire. E l’unico cineasta che l’ha capito perfettamente è Tim Burton, elaborando un cinema B-movie tout court. I suoi titoli, come Ed Wood, Mars Attacks!, sono il più splendido omaggio! Bibliografia (a cura di) Gino Frezza, Fino all’ultimo film. L’evoluzione dei generi del cinema, King Kong, Editori Riuniti, Roma, 2001 Luca Aimeri, Giampiero Frasca, Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini ad oggi, Utet, Torino, 2002 (a cura di) Franco La Polla, Poetiche del cinema hollywoodiano contemporaneo, Lindau, 1997 Eric Shaefer, Bold! Daring! Shocking! True!A History of Exploitation Films, 1919-1959, Duke University Press Durham & London, 1999 Jonathan Ross, L’incredibile storia del cinema spazzatura, Ubulibri, Milano, 1996 43 Eroi della strada e grafie metropolitane in Walter Hill di Maria Angela D’Agostaro Una carriera complessa quella del noto cineasta americano Walter Hill, aspirante giornalista entrato nel mondo del cinema quasi per caso. La sua vasta produzione filmica è certamente influenzata da quelle passioni che lo hanno accompagnato e formato fin da ragazzo: i libri di avventura di Wells a Stevenson, e tutta la grande letteratura del XIX secolo e del XX, fino ad arrivare ai fumetti, quelli della EC (Educational Comics) che vantavano una produzione suddivisa in generi quali l’orrore, la fantascienza, il thriller, il western e che gli hanno ispirato la produzione di una serie televisiva, Tales from the Crypt. Nel bagaglio dell’immaginario di Hill non mancano altri classici del mondo dei fumetti, quelli della DC Comics che hanno generato eroi per molte generazioni di lettori, da Flash, a Wonder Woman, da Batman a Superman 1. Il suo immaginario filmico invece, si nutre del western: High Sierra di Raul Walsh, la filmografia del maestro del genere Jhon Ford, o ancora Award Hawks, Robert Aldrich, Don Siegel, passando infine per lo stile barocco e sentimentale di Peckinpah, il quale a sua volta ha un grosso debito nei confronti del grande Kurosawa. Walter Hill è sceneggiatore, regista, produttore e nella sua filmografia ripercorre i topoi del suo ricco immaginario, così che i suoi eroi sembrano grafemi alle volte impalpabili, ingoiati dai campi lunghissimi o da panoramiche che compongono le immagini. Ha fatto dunque tesoro del cinema classico hollywoodiano, ma il suo compiacimento formale non è qualcosa di stantio; il suo stile si riscontra in una inquadratura pulita, ben composta, armonica, scolpita, ove il movimento è esaltato nella sua forma motoria, inserito in uno sviluppo diegetico in cui vengono spezzati gli assi temporali, in cui si procede per accumulo o per giustapposizione, così ogni gesto è una performance, ogni azione è l’esibizione di corpi che si danno nella loro flagranza fino a scomparire, alle volte, nella loro essenza perimetrale. L’opera prima di Hill è Hard Times (L’eroe della strada) del 1975 di cui scrive anche la sceneggiatura che sarà interpretato da Charles Bronson e James Coburn. Già dalla scelta degli attori lo spettatore sa che da un lato si troverà davanti la faccia di Bronson metallica, scolpita quasi da un ghigno, con un fare pronto all’azione e dall’altro ci sarà un rivale che in questo caso avrà una grande capacità di parola. Sono però entrambi corpi a perdere di personaggi anonimi che si muovono nella notte: da un lato un lottatore di box a mani nude 44 e dall’altro un giocatore d’azzardo. In questo esordio “nelle scene d’azione Hill non è interessato tanto allo spettacolo della violenza fisica, quanto ai processi mentali di valutazione dell’avversario e di costruzione di una strategia” 2. La storia che si dipana nella notte è puntellata da piani lenti, che trascinano lo sguardo dello spettatore nei meandri della solitudine, nel sudore speso dai protagonisti, nel silenzio di Bronson e nel suo ghigno che, come in un eroe da mito, nella sequenza finale svanisce alla ricerca di un oltre, forse di nuove avventure. Del 1978 è la seconda fatica, The Driver (Driver L’imprendibile), con Ryan O’Neal e la splendida Isabelle Adjani, un film che non ha successo in America né di pubblico né di critica, ma che ciò nonostante rimane un grande esercizio di stile per il regista. Spettacolari sono i duelli e gli inseguimenti sulle strade, sequenze che ancora una volta vanno al di là della realtà. L’azione che si spende alla caccia del dannato Rain O’Neal sembra seguire un tracciato metafisico. Le figure umane sono immerse spesso in scenari suburbani desolati, la macchina da presa insegue le forme con il solo intento di illustrare come in una striscia di un fumetto e ciò provoca una sorta di straniamento dell’immagine stessa. In maniera inconsapevole Hill si accosta con questo film alla pittura di uno dei maggiori rappresentanti del realismo americano tra le due guerre, Edward Hopper. Già in questi primi due film Hill ha indicato indubbiamente il suo marchio stilistico, vuole tracciare una mitologia ove lo spettatore riconosca degli archetipi: eroi dai mille volti che percorrono strade sterrate o d’asfalto, guerrieri molte volte solitari, sagome che si aggirano in paesaggi spesso notturni, grafemi che scintillano nella loro forma 3. La sua filmografia successiva è una galleria di personaggi che non si perdono in inutili psicologismi, molte volte si muovono al limite dell’abisso, o disegnano traiettorie che vanno al di là della realtà approdando in un’iperrealtà atemporale, o altre volte vengono plasmati crudelmente dal regista che non vuole certamente dare degli insegnamenti morali ma offrire allo spettatore delle “visioni”. Spesso il paesaggio, che sia suburbano o metropolitano, è notturno, partecipa, avvolge la vita dei personaggi rappresentandone o ingoiandone le forme; un paesaggio che di solito è illuminato da neon lividi o con un viraggio che ci riporta alle grafie dell’arte pop (grazie a Andreiw Lazlo), così nei I guerrieri della Notte del 1979, o in Strade di Fuoco 1984, una favola rock che travolge lo sguardo altalenando i registri del musical, del western, della commedia, in cui l’estetica della forma si crogiola nelle intime fantasie della performance della rockstar protagonista, Diane Lane sexy come l’eroina di un fumetto, o nel valore dell’eroe che la libera da un sadico capobanda. In altri film il viraggio che dà scintillio alla fotografia è operato su tinte scure 45 nelle varianti del blu o del marroncino presenti ad esempio in 48 ore del 1982, o in Danko del 1988. Altre volte Hill passa da topoi paesaggistici ampi, ove la natura si offre nella sua naturale, incontaminata, sinistra, bellezza diventando presagio di morte per i I Guerrieri della palude silenziosa del 1981, all’atmosfera asfissiante e crudele, che si tinge di quelle tinte fosche che caratterizzano il noir, come in Jonnhy il Bello del 1989 in cui impone al protagonista, interpretato da Mickey Rourke, una maschera crudele di bellezza. In quest’ultima pellicola il regista gioca sul doppio, sullo specchio, sull’altro che non è che la materializzazione nell’Io del subconscio che vuole disfarsi del deforme; il meccanismo diegetico del film alla fine paradossalmente sottolinea la forza di un estetica del brutto. Sul contorno del volto di Rourke si plasma la storia, nel destino di questo eroe si traccia una percorso ben preciso, un modello di vita convenzionale da vivere, ma solo attraversandolo il protagonista ne vedrà il reale abisso: il cammino è costellato da prove da superare per assurgere e bere alla fonte di una verità che è già disegnata nel suo volto deforme. Con I cavalieri delle lunghe ombre del 1980, Mississipi Adventure del 1986, Ricercati: ufficialmente morti del 1987 e Geronimo del 1993 lo stile di Hill celebra i luoghi del western, omaggia l’arte di Peckinpah, e propone una classicità postmoderna che in alcune occasioni sfocia nel neofigurativismo. Sono dei film, quest’ultimi, in cui il segno è la ridondanza, la poetica iconica, la proposizione di spazi che appaiono non luoghi proprio perché manieristici, perchè si offrono allo sguardo incantato nella loro immensità, sicchè la vita del singolo eroe, che con il proprio cavallo o sul treno attraversa le praterie, o le montagne rocciose, o i ruscelli, o i deserti e la loro desolata flora, si disperde. La forza dello spazio ritorna preponderante anche quando l’accecante sole scolpisce i corpi dei cavalieri erranti che nell’azione trovano la loro consistenza quasi bidimensionale. Lo spazio infinito allora si dispiega accogliendo questi corpi eroici e sacrificali che si abbatto al suolo come manichini senz’anima, corpi che vengono colpiti e cascano come statue di sale. Il film cult della prestigiosa carriera di Hill che anticipa il tratto del neofigurativismo della filmografia che transita sul grande schermo in questo nuovo millennio, è certamente I guerrieri della notte. Negli anni settanta vi era un sottofilone prolifico che vedeva protagoniste le gang urbane; Hill con I guerrieri certamente non voleva animare un dibattito sociale, è determinato semplicemente a creare una storia dalla forte componente fumettistica. Infatti, va oltre il romanzo di Sol Yurick e si ispira alle strisce dei comics che raccontavano le vicende dell’Anabasi di Senofonte, storia di eroi in fuga attraverso un inospitale territorio, ma ambientato in un mondo futuristico. La gang protagonista della narrazione doveva avere un tratto eroico nell’accezione clas46 sica del termine; in ogni sequenza vi è la costante dimostrazione che ogni azione prende vita dalle strip di un fumetto, tutto è strutturato in modo da ricordare che ci troviamo di fronte ad “una striscia disegnata filmicamente”. Il tempo che marchia il film è un ipotetico “domani”, l’atmosfera è tetra e fantastica, reale e stilizzata allo stesso tempo grazie al lavoro del direttore della fotografia Andrew Laszlo, ed ogni inquadratura ha una chiusura simile a quello di una vignetta. Il film si apre con un piano totale su di una ruota che con i colori liquidi e traslucidi, illumina la notte seducendo e ipnotizzando lo sguardo, è un cerchio, una forma scintillante che ci accompagna ad entrare di getto nella trama. Le luci circolari rincorrono quelle orizzontali che poco dopo attraversano lo schermo fino a scoprire che sono quelle della metropolitana. La striscia di luci si alterna a primi piani o a totali che presentano i personaggi della vicenda; ogni gang sfila come in un rituale al nostro sguardo segnata da un colore che assurge a simbolo di riconoscimento: il rosso, il nero, il giallo oro, l’argento, e va a confondersi con la planimetria della metropolitana. Un montaggio veloce graffiato dalle luci ci accompagna al luogo della riunione delle gang di New Jork: nel Bronks. È un tripudio di colori, di sagome che ascoltano il fautore dell’insolito raduno all’insegna della tregua. Cyrus, come un altro eroe di Senofonte, è il capo dei capi, l’incarnazione di un nuovo ordine da imporre ad una città che è suddivisa in tanti piccoli feudi, ognuno dominato da clan. Egli si propone come il “Padre”, elemento totemico da adorare, ogni sua parola è sottolineata da una gestualità eclatante. Ma, mentre alza le braccia al cielo, un membro dei Rouges mira al petto con una pistola, e lo colpisce. La folla delle gang si disperde, le volanti della polizia entrano in azione. Inizia così il viaggio di ritorno a Coney Island dei Guerrieri, ignari di essere incolpati dell’omicidio e che già un membro del loro clan è sacrificato ingiustamente, come non vedere in questo la mitologia biblica dell’agnello? È una marcia che incede nella notte della metropoli con andatura tagliente, violenta, carica di una morte che è in agguato, di uno scontro da superare, di un addio prossimo agli altri compagni di ventura. Il corpo dei guerrieri è messo a rischio e lo sguardo ipervisivo di ogni inquadratura, grazie al viraggio e alla surreale illuminazione eseguita sapientemente da Laszlo 4, ne restituisce l’adrenalina, il dolore, la perdita fatale. Il film è visionario, astratto e mescola frammenti di western, basti pensare ai continui duelli cui sono sottoposti i guerrieri; esemplare è la sequenza ed il patteggiamento per attraversare la zona degli orfani, o ancora lo scontro con la gang Baseball Furies che nel loro abbigliamento ci ricordano i protagonisti di Arancia Meccanica. Hill segue alle volte l’azione nella notte urbana attingendo al linguaggio del 47 videoclip, basti pensare alle inquadrature ritmate e alternate dai primi piani di una bocca che parla al microfono di una radio narrando le perdite subite dai clan e lanciando la musica che commenta il film. Questo tratto neofigurativo ci fa anche ricordare le opere di Lichtenstein Roy noto pittore della pop art americana. Tutto il film è per altro carico di atmosfere pop, proponendoci una cultura visiva “alta” che si disperde piacevolmente in una forma “bassa” di subcultura quale è definita quella del fumetto. Anche le figure femminili presenti nella narrazione si caricano di particolari tinte brillanti, basti pensare appunto alla bocca rossa della spiker che sembra appena uscita dalle pagine di un rotocalco reclamizzante un rossetto o un dentifricio; sono donne che si offrono come silhouettes seducenti, non a caso l’unica protagonista femminile apparentemente sembra sciatta, ma il suo incedere sui tacchi nella notte, lo spacco della gonna, quella maglietta rosa che le disegna il seno assurgono a simbolo di una carnalità che è il marchio di una sensualità selvaggia e di una perdita. Così le componenti dell’unico clan di donne, pur essendo avvolte in abiti ordinari accendono i fuochi della passione di tre dei guerrieri attirandoli in una trappola ove il sesso è solo apparentemente a portata di mano: giocano, seducono, danzano strusciando i loro corpi di donna, offrendo bocche socchiuse per poi rivelarsi come Arpie pronte a cibarsi dei loro prigionieri. Un cono di luce siderale avvolge tutto il film, l’urbe, gli anfratti della metropolitana, i vicoli, le strade che luccicano iperreali fino ad arrivare alla sequenza finale a Coney Island in cui la notte lascia spazio all’alba, presagio che gli eroi finalmente potranno riposare solo dopo aver combattuto per l’ultima volta con i Rouges che li hanno accusati ingiustamente. La pacifica alba di una lunga notte appena conclusa trascina con sé ancora il rumore delle gomme della macchina dei “cattivi” che scorre lenta sull’asfalto, e il tintinnio snervante di tre bottiglie mosse dalle dita della mano del capo dei Rouges che si accompagna con la sua voce stridula, beffarda e ripetitiva: Guerrieriiii! È la spiaggia il teatro dell’ultimo scontro ed è l’heppy end, i Guerrieri vincono, e i clan accorsi in quel luogo riconoscono il loro valore perché apprendono finalmente dal coraggio qual è la verità. Le sagome dei guerrieri si allontanano in un alba liquida, malinconica, iperreale come il light motiv dello stile neofigurativo di Hill. 1 Cfr. D’Agnolo Vallan, Walter Hill, Grafica Ferriere, Bottigliera Alta, Torino, 2005 2 Dave Keher in D’Agnolo Vallan, Walter Hill, op., cit., p.159 48 Cfr. Camphell J., L’eroe dei mille volti, Ugo Guanta Editore, Parma, 2000; Prop V., Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 1971; Vogler C., Il viaggio dell’eroe, la struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e cinema, Dino Audino Editore, Roma 1992 3 4 In un intervista Laszlo dichiara che nei Guerrieri ha utilizzato la tecnica per una “fotografia imperfetta”: “ho esasperato i colori già esistenti, o persino inserire nell’inquadratura luci in punti anomali, bagnare la strada in modo da creare riflessi di luci e colori. Nessuno di questi stratagemmi ricade sotto la categoria del “realistico”, ma apporterà uno stile particolare alle inquadrature del film”. Utilizzando svariate gelatine, luci con temperature differenti ha evidenziato come “la realtà di una situazione deve essere sfumata nell’irrealtà” … Tutto questo fa sì che la fotografia risulti stilizzata ed assume in tratto di un fumetto. D’Agnolo Vallan, Walter Hill, op. cit., p. 94 49 I segni della neofiguratività. I comics come linguaggio della visione di Giorgio Cappello Esiste una frase di Moebius che dice: “Una storia non deve avere per forza la forma di una casa, con una porta per entrare, delle finestre per guardare e un camino per il fumo. Si può benissimo immaginare una storia a forma d’elefante, di campo di grano o di fiammella di cerino….” Iniziava così uno degli eventi cruciali nella storia dei comics (userò poco o niente il termine italiano chiaramente dispregiativo fumetto): la rivoluzione figurativa, ovvero la dichiarazione d’indipendenza della grafica dalle regole imposte dalla trama, dagli editori, dal genere trattato. Di qui la totale libertà dei creativi il dominio della visionarietà sulla trama. Un capovolgimento se pensiamo che all’inizio l’illustrazione veniva utilizzata solo come commento grafico alla storia, che era tra l’altro narrata in prosa e non attraverso i Baloon. Fino a quel momento i disegnatori avevano dovuto seguire regole precise e limitare le loro capacità al gusto dell’epoca. Nel 1975 accadde qualcosa di straordinario, che partì ovviamente dalla Francia con Moebius: il fumetto cominciò a capire che avrebbe potuto rendere molto di più, che avrebbe potuto essere considerato, se non un’arte, almeno un suo simile. Soprattutto, iniziò la scoperta di nuovi mondi. Iniziò la Sperimentazione, ovvero la presa di coscienza “delle potenzialià intrinseche di un linguaggio che aveva sempre vissuto col complesso di colpa di non essere un altro” (D. Barbieri). Iniziò con Jean Giraud. Autore di un fumetto di successo di stampo classico (il famoso cowboy francese Blueberry), scelse di cambiare registro, scelse di prendere il treno dei comics e trasformarlo in un aereo, di deragliarle dai binari sicuri sul quale viaggiava e di farlo decollare, nel cielo dove non si trovano binari, dove non c’è un inizio, né una fine, dove non ci sono limiti (e la scelta del nome Moebius conferma tale ambizione). Moebius è l’inizio e l’apice del nostro percorso, e il suo discorso è semplice: trascinare il lettore nelle sue visioni. Basta guardare Arzach per capire: innanzitutto, via i baloon, via le didascalie che tolgono attenzione a chi legge (anzi a chi guarda). Moebius libera così la potenza delle immagini, che spaziano dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, senza alcuna regola. Il risultato è che chi guarda (anzi chi vede) la tavola, può farsi travolgere da questa esperienza, senza dover fermarsi a riflettere sulla trama o dover adeguare la visione al ritmo del racconto. Il taglio cinematografico delle inquadrature, poi, riesce anche a fendere quella bidimensionalità, che solitamente ci protegge dall’ondata visionaria, e 50 a dare corpo alla profondità in cui rischiamo di cadere. Moebius così consente un totale trasporto in qualcosa che non abbia limiti, in qualcosa che sembra addirittura evadere qualunque regola e qualunque limite, è il sognatore totale, il fautore e il primo figlio della Rivoluzione Figurativa. Frank Miller è uno degli ultimi figli di questa rivoluzione, ma è anche colui che di questo fantomatico volo intrapreso dal comic traccia una rotta. È uno dei maestri insuperabili del fumetto, capace di piegare la trama alle esigenze della visione e rendere la prima non meno credibile. C’è una costante nelle storie di Miller, che lega storie come 300 a The Dark Knight o a Sin City: lo scontro, la battaglia aperta tra lo Stato e l’individuo. Lo scontro dalla trama si estende anche al disegno, dove Miller è maestro di visioni, e i suoi accorgimenti per cercare di evidenziare la spaccatura tra la società e l’uomo che vi dimora sono simboli evidenti dell’affascinante ma pericolosa bascula dei nostri tempi. La visione dei personaggi di Miller non può perciò che essere di stampo conservatrice, con i suoi “o bianco o nero”, e le titaniche figure che si ergono a contrasto netto con l’ambiente, come il messaggio è in netto contrasto con il mondo in cui il lettore si trova. E allora tutto è estremo: le pose dei personaggi, la bellezza o la bruttezza, le azioni o le conseguenze sono sempre brutali. Gli eroi sono tutti di un pezzo, non c’è spazio per i dubbi nel loro modo di agire. Ogni movimento è fluido e perfetto, ogni gesto assoluto. I Villain (Come re Serse, come il Senatore Roark o i vari criminali di Gotham City) invece sono astuti, ciarlieri, sempre pronti a confondere e a ingannare con le loro parole. Ma è sempre l’ambiente, lo stato, le istituzioni che permettono loro di rimanere impuniti. Così arriviamo a Sin City, e al suo gioco di Bianchi e Neri: l’ambiente modella le figure in modo che non vi sia più una contrapposizione tra figura e sfondo ma uno definisce l’altra: il corpo viene definito dall’ambiente circostante, che gli da forma e sostanza. In più le forme sembrano stringersi addosso ai corpi e a tentare di invadere la figura, allo scopo di creare delle zone di grigio, di inquinarle come ha già fatto con tutto il resto. Ma alla resa dei conti, è proprio contro queste zone di grigio che gli eroi dei suoi comics si battono, contro la corruzione che imperversa. I corpi di Dwight, di Marv o di Hatigan si muovono in questo nero mare, lo attraversano e lo fendono come lame di luce. Non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. Quando Miller non mostra questi assolutismi con i colori, li fa vedere nelle forme dei corpi: prediamo ad esempio Batman, The Dark Knight, dove la figura di Barman è perfetta, il fisico poderoso, il costume che spazza via gli anni e gli acciacchi di un uomo che fino a quel momento dimostrava alme51 no 70 anni. Di contro, le figure del sindaco, dei vari piccoli criminali e degli abitanti di Gotham, sono grottesche, macchiette, dal loro sguardo si capisce immediatamente che la corruzione li ha segnati e non daranno segni di ribellione. 300 è uno dei simboli del comic contemporaneo, per tematiche e per montaggio delle immagini, ma è soprattutto puro spettacolo visivo. Diverso sia da Sin City che da The Dark Knight, esso è all’insegna del titanismo: anche qui, la storia si ripete, ma Miller si diverte molto di più a disegnare. È uno spettacolo quasi di danza. La danza tra bene e male, tra purezza e corruzione. Il corpo degli spartani, gli ultimi Greci veramente liberi, si articola in pose aggraziate nonostante i corpi muscolosi, con assoluta sincronia rispetto agli altri, si ergono come colonne, sempre in perfetto ordine geometrico. Il tocco seducente e velenoso dei persiani invece tradisce i loro passi, il loro avanzare ammassati e senza regole. I Persiani sono lo sfondo, l’ambiente che corrode. Gli Spartani invece, sono la giustizia. Lo sfondo qui si piega docilmente ai movimenti dei corpi che circonda. Non importa se le posture siano innaturali, o se la prospettiva non viene rispettata in pieno. Il fumetto è segno, al servizio di chi vuole comunicare. Non importa che le vesti o i volti siano stilizzati. Quello che ci arriva è l’immagine di una perfetta macchina da guerra. Le didascalie distanziate ci danno il tempo di rimirare l’impeto e la perfezione della falange laconica. In questo Miller esprime quello che è una delle due polarità che imperversano nelle scene (in tutte le scene, comprese quelle cinematografiche e disegnate). La tematica del corpo, con i Persiani “Corpo-ambiente” che ospita l’azione e che incornicia la perfezione dello spettacolo del Corpo Assoluto, quello degli Spartani di Leonida. Titanico il campo di battaglia, Titanico l’esercito del Dio-Re Serse, Titanica anche la bruttezza di Efialte, lo “Spartano Mancato”, il quale come un moderno Tersite ci riconduce alla Kalokagatia greca, che Miller utilizza a più riprese nelle sue opere. Il brutto qui, è anche cattivo, e debole. I buoni invece, sono forti, e soprattutto sono cristallini, limpidi. L’univocità del messaggio buono=bello cattivo=brutto è una costante del fumetto sin dai suoi albori: essendo il fumetto principalmente sintesi, il lettore doveva immediatamente capire il carattere dei personaggi dai volti e dai costumi. Da qui il supereroe bello e dotato di colori solari, e i cattivi sempre caricaturali e con costumi di colore nero o verde. Miller però dà un altro senso a questa concezione, perché il comic va incontro al giudizio critico del lettore e così anche le trappole metaforiche che l’autore ha piazzato, mentre i primi fumetti supereroistici cercavano solo l’approvazione passiva di chi legge. Con la perdita del messaggio unico che la società contemporanea manifesta, Miller recupera questa concezione e la plasma per fare vedere realmente cosa si annida nell’ombra, cosa si cela dietro la faccia del perbenismo. 52 Il Se Miller è il portatore della Tematica del corpo nel comic, un altro dei cinque autori maximi del fumetto è l’araldo del crollo delle ideologie occidentali (e con largo anticipo, prevede una catastrofe a New York negli anni 80!): Alan Moore, autore di Watchmen, V for Vendetta, The League of Extraordinary Gentlemen. Iniziamo dicendo che Moore non è un disegnatore. È uno scrittore, uno sceneggiatore di comics. Quindi le visioni nelle sue opere non gli appartengono? Tutto l’opposto. Il compito di uno sceneggiatore, in generale, è descrivere al disegnatore le visioni che ha, in modo che quest’ultimo possa metterle su carta, fondendo la propria visione a quella dello sceneggiatore. Il potere visivo dello sceneggiatore deve essere più forte, perché deve comunicare agli altri una visione senza usare il linguaggio delle immagini. E le visioni di Alan Moore sono qualcosa in cui il lettore si potrebbe perdere, non per il tratto o lo stile del disegno usato, ma per la complessità nella costruzione della vignetta. Moore vuole farci partecipi del Caos che è la sua e la nostra mente, della complessità dell’animo che ci unisce. E chi cerca di esplorare questo caos che è il suo comic, scopre qualcosa di straordinario, se non è distratto dall’aspetto puramente visivo delle immagini: che il suo Caos è sistematico, che la vera visione non si trova nel segno grafico, ma nell’inquadratura, nella posizione delle vignette e dei personaggi all’interno di esse. Perché la visione in Moore non si trova solo negli ipertrofici scenari in cui i personaggi si muovono (come la Londra di “League of Extraordinary Gentlemen”, o quella di stampo espressionista di “V for Vendetta”) ma anche nei minuziosi campi medi dove i personaggi discutono, nelle inquadrature ingannevoli di specchi e fumo che rovesciano le sensazioni e che confondono, e allontanano lo spettatore dalla rivelazione. È un sadico, Alan Moore: ci dà tutte le informazioni che ci servono e magari ci dà anche la soluzione dell’enigma attraverso le sue tavole, ma ci inonda anche di visioni incidentali e trasversali che non ci permettono una lettura lineare dell’opera. Così arriviamo alla fine del racconto, ci viene rivelata la verità, e dobbiamo tornare indietro per scoprire che quella verità ci aveva accompagnato dall’inizio, ma che noi siamo stati risucchiati in una miriade di altre sensazioni, e non l’abbiamo vista. E allora capiamo che ogni atomo nella visione di moore è dove dovrebbe essere, e che anche la variabile di disturbo,è stata calcolata al millesimo di secondo. Succede così in Watchmen, manifesto dell’avvento del Caos e del crollod delle ideologie (fu scritto nel periodo della Guerra Fredda, ma trova straordinari echi nell’epoca che stiamo vivendo). È una storia dove il vero protagonista, il Comico, muore subito, e tutto è giocato sull’assenza. Assenza di linearità, rappresentata dallo 53 spostarsi avanti e indietro nel tempo del Dr. Manhattan, con vignette che si ripetono identiche a distanza di 20 pagine; assenza di motivazioni, con la crisi del supereroe, assenza di lieto fine, assenza di certezze. Tutto il fumetto può essere riassunto nella celebre inquadratura del dialogo dello specchio, dove sembra che i personaggi siano inquadrati e altri fuori campo stiano parlando, per poi scoprire che i personaggi inquadrati e quelli che parlavano erano effettivamente gli stessi, e la vignetta era solo l’inquadratura di uno specchio. È tutto cangiante, privo di appigli per la ragione, è la maschera di Roscharch, uno dei Watchmen. Chi legge (o chi Vede) può solo lasciarsi andare, senza opporre resistenza, e assisterà a cose che lo segneranno. Altro dunque da Miller, sebbene la linea di confine tra questi due sciamani dei comics sia sempre sottile. La differenza tra Moore e Miller è nella lettura e nel ritmo della storia. Le opere di Miller hanno una lettura veloce, facile, basata sulla visione diretta. Moore invece tiene un ritmo più lento, più attento, più cervellotico. Se Miller sterza sull’univocità del messaggio e nel tratto stilizzato, Moore e i suoi artisti (non dobbiamo dimenticarli) invece si divertono a dipingere diversi punti di fuga e molteplici particolari, cosicché ogni lettura della stessa vignetta non potrà mai essere la stessa. Due modi quello del disegnatore e dello sceneggiatore che tendono sempre verso espressioni nuove, verso porti e mari ancora sconosciuti. Mentre l’illustrazione partiva come commento del testo scritto ora si è arrivati all’esplosione della figuratività. Tutto è al servizio della visione, il disegno ora domina e la parola deve con umiltà porgersi accanto. E allora poche parole, unite al segno grafico, riescono a evocare qualcosa che rende il comic un linguaggio, forse il Linguaggio adatto alla neofiguratività che ha la fortuna o la maledizione di esprimere la fine di un’epoca e il vuoto che ci accompagna nella successiva. 54 LaChapelle tra forma e gioco di Giulia Raciti Sovreccitate confezioni di set fanno precipitare lo sguardo nella vertigine del favoloso mondo di LaChapelle, dove tutto si gioca entro le voragini superficiali delle apparenze. Qui i grafemi neofigurativi si scrivono come sfavillanti involucri di incrocio, su cui i segni danzano in combinatorie mobili, per aizzare l’orgasmo visivo che riluce nello scintillio della forma. Un universo fluorescente modulato da distonie cromatiche esplose in orge di colore ipercarico; atmosfere sature e acide plasmano cornici baroccheggianti, dominate dall’horror vacui e dall’effetto di decorazione 1. Poetica dell’affastellamento dunque, per l’ultrapatinato fotografo statunitense, che ripercorre trasversalmente le teche della storia dell’arte, vampirizzando e fagocitando la tradizione figurativa, le Avanguardie Storiche, la Pop Art e l’Iperrealismo nelle sue molteplici declinazioni. Costruzioni di set presentati come “irreality show”, mutuano i maestri dell’onirico: da Salvator Dalì, agli accostamenti improbabili di esplicito retrogusto magrittiano, che sono altresì l’espressione di una sensibilità smaccatamente dadaista, distinta per l’ironia mordace e dissacrante, la decontestualizzazione dell’oggetto-feticcio, l’elogio del banale. Simili caratteri raccordano Duchamp allo spirito della Factory di Warhol, il papà della facciata americana della Pop Art, grazie al quale il giovane LaChapelle è immesso nei circuiti artistici internazionali. Il fotografo del Connecticut si ispira al suo mentore per le accese cromie e l’immagine seriale, ma se ne discosta nei processi di deificazione dell’icona, in quanto sostituisce l’astrazione di tratti sintetici e graffianti a un piacere dell’accumulo, che richiama la vivacità dei Combine Paintings Neodada. E ancora opere marchiate da tendenze iperrealiste, in cui, evocato soltanto in qualità di simulacro, l’oggetto scompare per overdose di visibilità. Con tali ancoraggi l’apostolo pop istituisce la sintassi delle nuove famiglie dell’immagine: glamour, fashion, glitter, fetish, cool, erette all’insegna del Kitsch, la categoria della citazione, funzionale ad attivare nello spettatore un effetto di continuo déjà-vu. Reclamato dal nostro autore come cifra stilistica consapevole, tale da trascendere la riduttiva definizione di paccottiglia, il Kitsch è spettacolarizzazione dei miti della cultura di massa, estetizzati come espressione ludica del gusto e del (dis)gusto del sentire comune 2. Ma il kitsch è anche epopea della riproducibilità tecnica 3, che celebra il potere totemico dei prodotti di consumo fabbricati in serie. Feticismo delle merci quindi, officiato da una moltitudine smarrita nella ricerca convulsa di una forma identitaria residuale, riconosciuta nei beni seriali, il veicolo del mana, ovvero “lo spirito delle cose” 4, la forza magica sovrasensibile di cui è necessario impossessarsi a ogni costo. Siamo 55 dinnanzi a un’inedita idolatria dell’oggetto, divenuto tempio dell’impero dei sensi, per il godimento orgasmico e il piacere materico sottesi al nuovo sex appeal dell’inorganico 5. È la rivelazione di una singolare sensibilità estetica, che impone con veemenza il gusto per la cosa, paradigma neutro di sessualità; sintomo di quel processo di disumanizzazione, già denunciato nel 1925 da Josè Ortega y Gasset 6, il quale rileva la de-soggettivazione dell’arte, che liquida l’umano e introduce l’avvento del postumano. Così, riflessi nello specchio di una bidimensionalità illusoria, Dorian Gray postumani si riverberano come membrane di pura superficie, sagome di sola perimetrazione, proiettate nella cultura edonistica della simulazione delle forme. È la galleria dei divi dello Star System messa in immagine da LaChapelle. Nell’inesauribile schiera di ritratti, Uma Thurman, Naomi Campbell, Leonardo Di Caprio, Angelina Jolie, Shakira, Paris Hilton, etc. si incidono al pari di tableaux vivants, disvelati da una patina glamour, tinta con i colori e le luci della plastica, il materiale connotativo del XX sec. Rivestire di sensualità ogni minimo elemento di immagine, questo l’imperativo categorico delle messe in scena lachapelliane, poiché, conformemente alla lezione del maestro Andy Warhol, “la sessualità è la cosa”. Siamo nuovamente nel raggio di quel sex appeal dell’inorganico che amalgama insieme soggetto e oggetto, tale da poter qui delineare un parallelo fra l’artista Jeff Koons, che si serve della donna alla maniera di un ready-made duchampiano, e il nostro fotografo, il quale riduce i modelli del Fashion System alla stregua di cose, forme neutre senza attributi propri, tautologicamente definiti dagli accessori e dagli indumenti 7. È un archivio umano di corpi reificati, oggetti fra le cose, eternati in uno scenario di cartone, epifania di quella Nausea sartriana, che è vertigine di inesistenza, percezione del mondo come puro apparire 8. Siamo infatti nell’orizzonte sacro delle apparenze, luogo dove non vi è dialettica fra gli opposti ma solo reversibilità, poiché, parafrasando Baudrillard, è qui che confluisce il gioco complice e duale dello scambio simbolico, è qui che opera la seduzione, per deviare i segni dal loro valore e volgerli verso libere commutazioni 9. Strategia di spostamento quindi, in cui tutte le forme possono scambiarsi: ibridare l’umano, l’inumano, l’animale e il divino, perché il corpo è una figura da sedurre, da sviare, da fuorviare. E allora dipingere, mascherare, bardare, torturare, per sedurre con la superficie del corpo, una parure che fà e disfà le apparenze e le fà risplendere nella pienezza della forma e nel brivido del gioco, ovvero la pratica liminare a fondamento di ogni ipotesi fictionale, che è ordita e tessuta nella quadruplice trama di competizione (agon), azzardo (alea), maschera e vertigine 10. Non stupisce dunque che nel paese delle meraviglie di LaChapelle Pamela 56 Anderson sia un bell’anatroccolo venuto fuori da un uovo, Naomi Campbell la venere nera del latte, Madonna un’effige devozionale, in quanto è proprio quest’inversione allegorica a marchiare lo stile autoriale. Una poetica della sostituzione, in cui travestitismo e fascinazione teriomorfica sono i mezzi impiegati per disegnare immagini in “trans”; transiti segnici ovviamente, capaci di generare quelle sdefinizioni, per dirla con Francesca Alfano Miglietti, che guardano al corpo come un contenitore di lavoro sul vecchio mito delle Metamorfosi 11, in un incessante Ri-Divenire 12, che è messa in gioco dell’essere come nuova ontologia. Così, davanti allo specchio i narcisi di LaChapelle celebrano il piacere della simulazione, esibendosi nelle pieghe metaforiche di una drammaturgia essenziale data entro la trama del Simbolico, luogo di erranza assoluta, deputato allo scambio del valore 13: il Ketchup come il sangue, la carne da fastfood come gli organi sessuali, il latte come lo sperma, l’oro come l’urina, l’ebano come la merda. Un’apoteosi del corpo a perdere scritta mediante paradossi visivi, ovvero linguaggio scompaginato, da sempre espressione del desiderio. In breve pura sollecitazione vouyeristica, pompata al massimo attraverso la messa in gioco del mana, il sintomo capace di tutte le commutazioni della catena simbolica 14. Ma l’ambivalenza costitutiva del Simbolico è da ricercare altresì in quella fluttuazione sessuale già dichiarata da Platone nel Simposio: “Ciascun uomo è la metà che cerca l’altra metà, il simbolo corrispondente” 15. Seduzione androgina insomma, forma di totalità primordiale, di reversibilità in atto sempre ammiccata da LaChapelle; non è infatti un caso che tra le sue muse predilette si annoveri l’indossatrice trasngender Amanda Lepore. Dunque mito, teriomorfismo e androginia, per cantare le fiabe visive di LaChapelle, impeccabilmente erette all’insegna del culto estremo per l’edonismo formale. L’impianto compositivo veicola infatti un’idea di Bello reso mediante i dettami della Grande Teoria dell’estetica europea 16. Armonia, rispetto per i rapporti numerici e simmetria, percorrono il filo rosso che attraversa Policleto, Vitruvio, Leonardo Da Vinci, fino al Modulor di Le Corbusier, per plasmare corpi conformi alla sezione aurea, racchiusi in insiemi di proporzione e abbacinante splendore. Ma la scrupolosa osservanza dei principi della forma classica non salva la materia dalla deformità! Nessuna vaghezza dei contorni 17, nessuna mancanza di misura, eppure, al di là di ogni precostituito topos sulla discordanza, nelle foto di LaChapelle il Brutto si insinua surrettiziamente, in qualità di esasperazione parossistica dei canoni costitutivi del Bello. Shakira è infatti ritratta mentre riposa nell’infiorescenza di una “Venere acchiappamosche” (Shakira: Venus Fly Trap, 2001), una versione neobaroc57 ca dell’Olympia di Manet, in cui il nostro autore mette in campo gli usuali significanti dell’erotismo femminile: capo reclinato, occhi rivolti all’insù, labbra truccate e dischiuse, capelli lunghi e scomposti, abito semiaperto, per far insinuare l’Eros fin oltre le fenditure 18. Il potenziale sessuale della diva è teso in un’iperbole apicale, che rivela l’ambivalenza della popstar dalla carnale presenza scenica, ovvero prosopopea di un fiore di acchiappamosche pronto a cibarsi delle sue prede irretite. Sono pertanto ritratti di persona quelli di LaChapelle, intesi nell’accezione latina di maschera, nei quali il Bello è sterile celebrazione della forma perfetta, è plastica, artificio e falsità, oltremodo lontano dal concetto di kalokagathia, ossia corrispondenza tra sfera etica ed estetica. Nella sovversione della triade platonica di bello, buono e vero, è proprio il Brutto, al contrario, ad assolvere alla funzione di verità, in quanto porta allo scoperto il principio di rappresentazione, reso attraverso l’enfasi esacerbata dei caratteri, che deborda nel grottesco sino a evolversi in mordace parodia, puro show del cliché, funzionale a rivelare l’icona. Il Brutto diviene quindi una forma di metalinguaggio, che, al pari dei personaggi straniati di Bertold Brecht, esibisce soggetti i quali recitano, mostrando di recitare, quasi fossero tableau vivants bloccati in un fermo immagine in cui si condensa, scompaginata, l’intera struttura narrativa. È il collasso di ogni logica consequenziale, teso oltre il limite nei frammenti di storie implose all’interno delle opere lachapelliane dal titolo Disastri. Sono porzioni di cosmo perturbato da eventi incoerenti e arcani, incisi nello stridente contrasto che omogeneizza vedute apocalittiche alla statuaria impassibilità di modelli elegantemente disordinati. E ancora, capolavori raccolti sotto l’etichetta Awakened, ci parlano di corpi in stato vegetativo, cullati dall’onda dell’acqua, simbolo del materno liquido amniotico che protegge l’involucro della carne in attesa di risveglio. Ma la forza rigeneratrice e distruttrice di un simile elemento archetipico si manifesta in tutta la sua veemenza nella serie Diluvi, ispirata alla michelangiolesca Cappella Sistina. Insomma, i recenti lavori del cantore di immagini posseggono la forza epica di incubi d’autore, uno specchio anamorfico della crisi di significanti propria della contemporaneità. Ecco dunque che dinnanzi a una simile catastrofe del Simbolico la Società dello Spettacolo mette in scena la sua distruzione, per recuperare quel sentimento del tragico e quella dimensione del dolore tematizzati come nucleo ontologicamente costitutivo di ogni umanesimo 19. Nelle fotografie di LaChapelle perciò, spirito apollineo e dionisiaco danzano all’unisono per manifestare la “forza plasmatrice del mondo” 20 e dare forma quel bisogno di pericolo che ravvisa nel Sublime la moderna categoria estetica deputata a esperire piacere dal dolore 21. È qui possibile delineare un parallelo con i dettami enunciati nell’aristotelica teoria della tragedia, secondo cui pietà e ter58 rore sono mezzi funzionali al fruitore per conseguire la catarsi 22, quell’esperienza estetica assimilabile alla figura di un naufragio osservato da terra, in quanto passioni, paura e dolore attraversano lo spettatore ma non lo sovrastano, perché slittati sul piano della finzione. E se il sublime è la tonalità emotiva che permette di consumare lo shock a distanza, allora, ecco che le catastrofi di LaChapelle elevano la tragedia a dimensione del Simbolico, divengono un poltàc spettacolare, cioè sontuosa distruzione dell’eccedenza, pratica di sacrificio di corpi e oggetti, data nei termini di puro potere della perdita, quindi rituale finalizzato a esorcizzare quella parte maledetta 23 che fa dell’uomo un servo della cosa 24. Così, denotative del sistema degli oggetti, svettano illese e affastellate, sullo sfondo di paesaggi devastati e corredati da enfatici e statuari modelli, le insegne Gucci, Cæsar Palace, Burger-King, omogeneizzate da dispositivi di spettacolarizzazione che fondono e confondono in un’unica amalgama “nobile semplicità e quieta grandezza” 25 e horror vacui, generando un cortocircuito tra la statica teatralità neoclassica e l’allegoresi barocca. E se LaChapelle nei suoi set mette in immagine le ossessioni del nostro tempo, allora la rivisitazione del Diluvio Universale non solo pone l’accento sulla catastrofe, tema ampiamente indagato dal fotografo, ma diviene una vera e propria proclamazione di poetica da parte dell’autore, il quale dichiara: “Michelangelo, lui è l’artista pop, perché è conosciuto in tutto il mondo” 26. Da una simile prospettiva finanche la Cappella Sistina diviene brand del made in italy, marchio popular di adorazione che gioca in totale dispendio segnico con le iconografie tipiche della Pop Art. Gesù Cristo è difatti trasformato in un supereroe che irrora, con un espediente riecheggiante Rebrant, un’aura di luce conforme ai dettami classici di rappresentazione, ma al contempo, si mimetizza però fra gli astanti di una folla anonima, con modalità che rinviano agli attori alienati de L’entrata di Cristo a Bruxelles di James Ensor, in un’epopea di desacralizzazione per ogni fede di esplicita matrice Pop. Reale, irreale e iperreale, precipitano quindi insieme nelle fiabe e catastrofi di quella baudrillardiana Disneyland Universale, confezionata dal nostro Fellini della fotografia, che rivela con i suoi processi di eccitazione ottica il bisogno di allestire la scena, perché quando c’è scena, c’è sguardo, gioco e alterità e tutto è perciò metaforizzato. Tali esibizioni di set raccordano LaChapelle ad altri esponenti della staged photography, quali Cindy Shermann, Jeff Wall o il fotografo Gregory Crewdson, per i suoi “single frame movie”, i quali, quasi fossero delle novellizzazioni cinematografiche, condensano in una singola inquadratura l’ampiezza potenziale di un intero testo filmico. Siamo già nell’immagine-movimento, per dirla con Deleuze, all’interno della 59 quale LaChapelle scrive la sua firma. Infatti il passaggio dal medium dello spazio a quello del tempo è siglato da documentari del calibro di Rize (2005), nonché da videoclip di celebri rockstar, tra cui Britney Spears, Jennifer Lopez, Christina Aguilera e ancora da spot promozionali d’autore. Insomma forme audiovisive brevi, per un cinema lachapelliano che guarda alla pubblicità come la nuova ammaliatrice dell’oggi, capace di condensare, stratificata per livelli e citazioni, il patrimonio culturale degli “Ismi” del Novecento, esprimibile nell’assioma secondo cui le avanguardie storiche vincono laddove hanno perso, o perdono laddove hanno vinto, cioè diventando patrimonio delle masse 27. 1 Cfr. Omar Calabrese, L’età neobarocca, Laterza, Bari 1987. Per una più approfondita trattazione sul kitsch Cfr. Alberto Abbruzzese, Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma 2003; Gillo Dorfles, Il Kitsch: antologia del cattivo gusto, trad. it, Mazzotta, Malno 1976. 2 In merito al concetto di riproducibilità tecnica Cfr. Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it, Einaudi, Torino 1974. 3 Cfr. Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, trad. it, in Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1965. 4 5 Cfr. Mario Perniola Il sex appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino 1994. Cfr. Josè Ortega y Gasset, La disumanizzazione dell’arte, trad. it, Luca Sossella Editore, Roma 2005, cit. p. 27. 6 7 Cfr. Roland Barthes, Sistema della moda trad. it, Einaudi, Torino 1970. 8 Cfr. Jean Paul Sartre, La Nausea, trad. it. Torino Einaudi, 1947. Cfr. Jean Baudrillard, Della seduzione, trad. it, SE, Milano 1997; Jean Baudrillard, Parole chiave, trad. it, Armando, Roma 2002. 9 Cfr. Roger Caillos, I giochi e gli uomini: la maschera e la vertigine, trad. it, FabbriBompiani-Sonzogno-ETAS, Milano 1981. 10 60 Francesca Alfano Miglietti FAM), Nessun tempo, nessun corpo: arte, azioni, reazioni e conversazioni, Skira, Milano 2002. 11 Alessandro Cappabianca, Il tempo delle parole e l’istante delle immagini, in Filmcritica – Anno LVI- n 563 2006, Editrice Le Balze, Siena, cit. p. 102. 12 13 Jean Baudrillard, Parole chiave, op. cit. 14 Cfr. Renato Tomasino, op. cit. Platone, Simposio, a cura di Mario Vitali, Gruppo Editoriale Colonna, Milano 1998, cit. 189 d. -193-d. 15 Cfr. Wladyslaw Tatarkiewicz, Storia di sei idee, trad. it, Aesthetica, Palermo 1997, cit. p.139. 16 17 Karl Rosenkranz, Estetica del brutto, trad. it, Olivares, Milano 1994. Rainer Crone, Inscenare il perturbante Ombre della bellezza nei ritratti di celebrità, in Gianni Mercurio, Fred Torres, David LaChapelle, Giunti Editore, Firenze 2007. 18 Mario Costa, La disumanizzazione tecnologica, il destino dell’arte nell’epoca delle nuove tecnologie, Costa & Nolan, Milano 2007. 19 Cfr. Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, trad. it, Sonzogno, Milano 1924. 20 In merito alla concettualizazione del Sublime si veda: Pseudo Longino, Il Sublime, trad. it, Aesthetica, Palermo 1987; Edmund Burke, Inchiesta sul bello e sublime, trad.it, Aesthetica, Palermo 1998; Mario Costa, Il sublime tecnologico, Edisud, Salerno 1990. 21 22 Cfr. Aristotele, La poetica, a cura di Giuseppe Saitta, G. C. Sansoni, Firenze 1960. 23 Cfr. Georges Bataille, La parte Maledetta, trad. it, Bertoni, Verona, 1972. 24 Cfr. Umberto Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2003. 61 Cfr. Johann Joachim Winckelmann, Pensieri sull’imitazione, trad. it, Aesthetica, Palermo 1992. 25 26 Cfr. Gianni Mercurio, Fred Torres, op. cit. 27 Cfr. Renato Tomasino, I Cavalieri del Caos, L’Epos, Palermo, 2004. 62 Tagli e Feticci 1. Stefan Sagmeister, Hurry, poster per l’AIGA, 1997. 2. Stefan Sagmeister, Sagmeister, poster per l’AIGA, 1999. Elaborazioni dagli originali di David LaChapelle 3. Feticcio 1 > Uma Thurman 4. Feticcio 2 > Diluvio 5. Feticcio 3 > Pamela Anderson 6. Feticcio 4 > Kylie Minogue 7. Feticcio 5 > Shakira 63 64 65 66 67 68 69 70 Non c’è altro. La Salomè cinematografica di Carmelo Bene di Saverio Zumbo “il cinema come immagine acustica = in-con-sequenza delle riprese e indisciplina chirurgica del montaggio”. Sono queste le sole parole che Carmelo Bene dedica alla propria esperienza cinematografica nell’introduzione alle Opere 1. Se non è opportuno, almeno in questa sede, interrogarsi sulla nonchalance con cui l’artista guarda a tale esperienza 2, non ci si può astenere dal rilevare l’obiettiva sproporzione tra la sua rilevanza e l’interesse critico da essa suscitato. L’interesse c’è stato, è vero, da parte di uno sparuto manipolo di studiosi cui il cinema di Bene ha ispirato analisi e notazioni talvolta acute, alcune delle quali avremo modo di ricordare nel corso di questo studio su Salomè (1972), ma ciò che è lungi dall’essere sanato è il misconoscimento (o più semplicemente, l’“ignoranza”, etimologicamente parlando) del posto che esso occupa nella storia del cinema italiano e del cinema tout court. Si pensi soltanto, al riguardo, che c’è mancato un soffio che il ventesimo secolo si chiudesse senza che alla produzione cinematografica fosse dedicata alcuna monografia 3. Occuparsi di un film squisitamente cinematografico come Salomè pare, dunque, tanto più “urgente” quanto più il cinema attuale cosiddetto “d’autore”, con rare eccezioni, sembra aver smarrito il gusto, e la necessità etica, di interrogarsi su se stesso e di interrogare il mondo. Immiserendo l’“autorialità” a feticcio intellettuale contraddistinto da stilemi ereditati dal passato, svuotati della loro necessità storica e carica innovativa, ed a criteri di esteriore eleganza o di facile effettismo. Riducendosi così, spesso, genere tra i generi, ad una sorta di prodotto griffato. Ma veniamo a noi, rimandando ad altra occasione temi che richiederebbero una trattazione di ben più ampia portata. I titoli di testa sono “ritagliati” su superfici monocrome, che lasciano intravedere porzioni di profilmico vivacemente colorate. Questa soluzione era stata adottata da Antonioni per i titoli di testa di Blow up (1966). Anche il valore concettuale dell’operazione è affatto analogo: marcare il carattere artificiale, linguistico, “discorsivo” della diegesi 4. Ai titoli di testa sono inframezzate inquadrature di sederi femminili scudisciati con variopinti orpelli piumati, del boia che maneggia con voluttà la sua mannaia, ed immagini di un cartone animato in cui un cammello, sul cui fianco è disegnata una borsa di denari, fa il salto ad ostacoli attraverso crune di aghi, strizzando, infine, l’occhio allo spettatore. Il trasparente sbeffeggiamento della parabola evangelica allude alla condizione “regale” di Erode/Bene, 71 a quella sorta di Eden, di paradiso in terra che è, o che dovrebbe essere, la sua vita di lussi e dissipatezze. Il cammello non entra, ma è, in virtù della ricchezza, in paradiso. L’utilizzo di un cartone animato che, in apertura, accompagna i titoli di testa, è inoltre spiazzante in quanto si trattava di un uso non infrequente in film commedia, spesso estremamente “popolari” (e la realizzazione rudimentale, in netto contrasto col contesto in cui si inserisce, rimanda a quell’ambito), che non ci si aspetterebbe certo in un film “d’autore”. Appare quindi programmatico rispetto alla commistione di registri stilistici che seguirà. La flagellazione/vellicamento di deretani muliebri, che, assurdamente, appaiono effettivamente escoriati, segna d’altronde una dichiarazione di intenti: una presa di posizione antinaturalistca, sintomatica, peraltro, della compresenza di pathos decadente e straniamento, una dimensione in cui l’artificio culturale (la perversione delle passioni) conserva tutto il suo valore di fondamentale nucleo tematico nonostante il sabotaggio operato dall’artificio strutturale. Subito dopo l’ammiccamento del cammello un’inquadratura del sole riempe lo schermo, ponendosi così in simmetria col chiarore abbacinante del finale. Ma è, da subito, la luna ad imporsi come presenza ossessiva. Una luna inizialmente presentata con precisione “astronomica”, con una immagine di assoluto realismo fotografico; in netto contrasto, dunque, con la spropositata mole di significati simbolici di cui è caricata da parte di alcuni personaggi. Una luna che, come dirà Erodiade, “Assomiglia alla luna e basta!” I colori, che appaiono, in queste prime sequenze come nel resto del film, vividi, senza sfumature, richiamano la Pop Art, che costituisce l’impronta figurativa più ricorrente, insieme ad un certo decorativismo bizzantineggiante. Il montaggio è estremamente frammentario, brusco, con scarti sensibilissimi quanto a dimensione dei piani, come rispetto al loro stesso valore narrativo. Si potrebbe pensare a più situazioni presentate contemporaneamente, se non fosse che è lo statuto stesso della “situazione” e della “narrazione” a risultare sgretolato da una siffatta pratica registica. Difficile dire, infatti, con che “realtà” si abbia a che fare, venendo meno i requisiti di un coerente spazio diegetico, e con che “storia”, lo statuto narrativo delle immagini che scorrono essendo sommamente incerto ed ambiguo 5. Uno spazio caratterizzato da marcati caratteri di irrealtà (o meglio di inverosimiglianza, che possiamo intendere come “spazio”, e “realtà”, dell’immaginario, della psiche, del mito etc.) si combina ad un tempo impiegato strumentalmente (ossia espressiva72 mente) che ignora la consequenzialità narrativa improntata al nesso causaeffetto (ecco allora quella in-con-sequenza delle riprese, nella frase citata in apertura) 6. L’esempio più lampante, e programmaticamente provocatorio, è il passaggio in cui Bene dice “Ah, sono scivolato!” prima di scivolare nel sangue. Ne risulta una produzione di senso che, prodiga di ogni illusione, si accanisce nel negare allo spettatore, spietatamente, proprio l’illusione che egli si aspetta e pretende, quella detta “di realtà”. È poi interessante notare come tutto ciò sia suscettibile di effetti molto pratici fuori dal testo, nel mondo. Ecco allora il pubblico che, alla prima di Salomè, nell’ambito della Mostra di Venezia del 1972, cerca di linciare il regista. Inferocito non certo per ragioni “religiose”, e tanto meno “morali”. Ma perché, semplicemente, non tutti accettano con fair play di vedersi sottrarre la terra da sotto i piedi. L’episodio dell’“ultima cena”, con un Cristo non meno inquietante di quello de La via lattea (non pensare a Buñuel è davvero impossibile7) che, pronunciata la fatidica frase “uno di voi mi tradirà”, scatena una baraonda tra gli apostoli che fanno a gara a candidarsi gridando “io! io! io!...”, è il momento in cui, figurativamente, più forte si fa la tensione verso l’informale. I personaggi, nelle loro variopinte vesti, vengono a comporre macchie di colore che si confondono con quelle dipinte sullo sfondo. La “corruzione” del referente pittorico, della sua agiografica classicità, sembra alludere alla corruzione a venire (ma già presente, in qualche modo, data l’atemporalità cui il film è improntato) del potere istituzionale cui sarà subordinato il mondo cristiano. Il Cenacolo diviene allora un’orgia di pulsioni e tornaconti personali non dissimile da quella praticata nella reggia di Erode. La bellezza classica appare allora “disfatta”, degradata nell’estetizzazione. Gli sculacciamenti iper-decadenti dell’inizio balenano in montaggio parallelo. L’archetipo del potere accomuna epoche diverse sotto l’emblema dell’ “homo homini lupus” (gli apostoli che assaltano un gregge di agnelli per sbranarlo vivo). Trova una spiegazione, in questo senso, anche il Cristo dai lunghi canini di vampiro che apparecchia un pranzo regale nella dimora del re pagano: il potere di ogni tempo che consuma i suoi osceni banchetti sotto la copertura di una legittimazione divina. La canzoncina canticchiata dal vampiro, Vipera, vera chicca di misogina naï73 veté, rimanda con acre ironia al tema centrale del rapporto col femminile. Lo stesso, dopo aver ripiegato i veli che serviranno per la “danza” finale, raccoglie il cadavere di una giovane donna e va a collocarlo accanto al tetrarca, dove da adesso continueremo a vederlo. Se ha forse ragione Grande nello scorgere una simbologia anti-cattolica nella donna cadavere 8, pure occorre sottolineare che la sessuofobia è presente, nel film, non tanto come dato culturale e religioso, ma soprattutto come carattere strutturante del personaggio principale. La donna è “morta” per Erode/Bene in quanto non è per lui persona, ente, ma mera materialità, puro e vuoto oggetto del desiderio, inanimato elemento del décor, dello sfarzoso ciarpame di cui si circonda. Oggetto di lusso, prezioso e inutile, e non propriamente di lussuria, se non a livello affatto fantasmatico e regressivo, la pratica stessa dell’erotismo implicando una partecipazione di cui Erode non è capace. Non sarà un caso se, al di fuori dell’ossessivo e patetico appello rivolto alla figliastra, non lo vediamo mai in atteggiamenti che denotino un coinvolgimento erotico, o che si ostini ad imputare alla moglie una sterilità smentita dai fatti. In tutto il film, del resto, a dispetto dell’esibizione fino alla nausea di nudità, di genitali femminili visti in dettaglio, non vi è mai accenno all’espletamento di un sano, o foss’anche insano, atto di commercio carnale. Il sesso come scambio, a qualsiasi livello, è assente. Erode farà la fine che vedremo, il giovane siriaco è costantemente ripreso nell’atto di masturbarsi forsennatamente nel fuoricampo, Tigellino fa uso delle cortigiane soltanto per mangiare, tra le loro natiche, dell’uva. Per quel che servono a lui, come lussuoso vasellame, come oggetto di lusso, appunto, e non di libidine, potrebbero essere anch’esse morte. Siamo in presenza di un punto nodale del film, che ci si sforzerà di chiarire nel prosieguo dell’analisi. Per ora ci si limiterà a dire che, se la donna è “cosa morta” per Erode, ciò non è certo dovuto all’epifania di un cattolico disgusto della carne, ma semmai ad un suo particolare paganesimo. In quest’ottica, che il cadavere della femminilità sia recato da quello che chiameremo, con Maurizio Grande 9, Cristo-Istituzione, può essere messo in conto, anziché ad una opposizione tra costui e il tetrarca, alla analogia, di cui si è detto poco sopra, tra i mondi da essi incarnati. Ovvero al fatto che il primo rappresenti, in qualche modo, un aspetto del secondo. La scena orgiastica, se così possiamo definirla, in cui Bene, assalito da un nugolo di ragazze nude “guarnite” con cappelli a cilindro di vari colori, vagola confuso e stordito e sembra infine venire meno, appare paradigmatica dell’uso che nel film si fa dei codici espressivi. Il montaggio rutilante, la disorganizzazione dei punti di vista, i movimenti di macchina e dei personaggi concorrono ad una figurazione caleidoscopica, mentre una cacofonia di 74 musiche e urletti occupa la colonna sonora. Compare inoltre, a lampi, il cartoon del cammello salterino che, nuovamente, ammicca; come a commentare, sarcasticamente, il dubbio “bengodi” di Erode. Si tratta di un montaggio (inteso anche come montaggio sonoro, e come montaggio “verticale” di suoni e immagini) dirompente, che porta violentemente in primo piano l’istanza enunciativa, studiatissimo e calcolatissimo, in perfetta corrispondenza con la strenua, maniacale cura riservata all’aspetto iconico, alla cura per la composizione dell’immagine, ossia per quello che possiamo intendere, secondo la lezione di Ejzenstejn, come “montaggio interno” all’inquadratura. L’operazione che Bene pone in essere prevede la liberazione degli elementi del significante dalla loro “schiavitù” nei confronti della finzione naturalistica. Le voci, le musiche, i rumori, le forme, i colori, il ritmo del montaggio e dei movimenti in scena, compongono un ideale palinsesto di codici che, sottraendosi alla loro funzione “naturale” di subordinazione alla costruzione di una realtà diegetica coerente, si combinano incessantemente per creare effetti espressivi in cui, di volta in volta, l’aspetto sensoriale, emotivo, estetico e concettuale acquistano un peso ed un valore variabile per ogni occorrenza. Si tratta, se vogliamo, di una radicalizzazione e di un ampliamento del concetto ejzenstejniano di “montaggio intellettuale”. A ciò si aggiunga che, come avremo ancora modo di notare, la modalità del “palinsesto” attiene anche alla combinazione di sottocodici di uno stesso codice (la parola, la musica, il rumore, le cui varianti diegetiche ed extradiegetiche, “in” e “off”, sono suscettibili di sovrapposizione) o anche dello stesso sottocodice (combinazione di più voci, eloqui, o musiche, o rumori ed effetti sonori aventi lo stesso rapporto col “campo” e lo stesso statuto di diegeticità, le combinazioni cromatiche ottenute tramite l’utilizzo, nel profilmico, di superfici colorate trasparenti, etc.). Al dialogo tra il paggio di Erodiade ed il giovane siriaco, ad esempio, sono sovrapposte voci “fuoricampo”. Sulla base del testo teatrale le possiamo interpretare come commenti di soldati. Ciò che percepisce lo spettatore cinematografico, tuttavia, è una partitura di parole e suoni, senza che gli sia dato il minimo indizio riguardo all’appartenenza delle frasi che provengono dal fuoricampo. E proverranno, poi, davvero dal fuoricampo (saranno, ovvero voci “off” in senso proprio), o non saranno piuttosto fuori-scena, fuori dalla situazione diegetica visualizzata (e quindi voci “over”)? Il quesito non soltanto è irresolubile, ma è minato nella sua stessa essenza da una prassi rappresentativa (o forse meglio: anti-rappresentativa) che rifiuta il realismo illusionistico della scena e la “verosimiglianza” delle situazioni. Una prassi rispetto alla quale è l’idea stessa di diegesi (intesa correttamente, non come sinonimo di “narrazione”, ma come insieme degli elementi costituenti la realtà fittizia del 75 film) a risultare, se non proprio liquidata e resa inservibile (siamo comunque in grado di dire, seppure molto approssimativamente, “cosa succede”), di certo fortemente indebolita e relativizzata. Questa sorta di palinsesto dialogico è d’altronde da inquadrare in un particolare atteggiamento posto in essere rispetto al testo di Wilde, o, più precisamente, rispetto alla sua sostanza letteraria. Essa viene spesso lavorata con un procedimento di questo tipo: le frasi vengono fedelmente riprodotte, operando, però, tagli e sovrapposizioni delle voci recitanti, e giungendo così al limite dell’inintelligibilità. Il rispetto “alla lettera” del testo coincide dunque, paradossalmente, con la sua negazione. Che corrisponde, evidentemente, alla negazione della possibilità di una sua rappresentazione, allo sbeffeggiamento dell’aborrita idea della “messa in scena”. Il testo, insomma, non è e non può essere teatro (né cinema) ma semmai materiale teatrale (o cinematografico). Il manifestarsi del personaggio di Erodiade ci dà modo di rilevare un’ulteriore contravvenzione di un codice rappresentativo: quello che implica la corrispondenza univoca tra attore e personaggio 10. La moglie del Tetrarca è infatti interpretata da due attori, sdoppiandosi così in una donna piagnucolosa, dotata di grandi ali d’angelo, ed un ladrone da favola con grandi baffoni, che insieme depredano il palazzo reale. Un’ “anomalia” ben più pesante di quella inerente i due Cristi (che possono essere interpretati come personaggi differenti, come due diversi Cristi; ed essendo comunque entrambi uomini, sono, quanto a ciò, naturalisticamente plausibili se considerati separatamente), e quindi, rispetto a questi ultimi, uno scatto ulteriore in direzione antinaturalistica. I velenosi commenti di Erodiade vengono proferiti, insieme, da Lydia Mancinelli con fare sottomesso e da Alfiero Vincenti con piglio autoritario e voce baritonale. Quest’ultimo rappresentando la vera anima di Erodiade, o più precisamente, in termini junghiani, l’“animus” che la agisce. Giovanni è rappresentato come un mingherlino meridionale, rozzo e incolto. Nella prima scena in cui compare lo vediamo attorniato dalla eccentrica corte di Erode, picchiato e, nello stesso tempo accarezzato. Il bailamme della colonna sonora cessa, qui, a favore di un completo silenzio, una sorta di vuoto allucinante in cui risuonano i sonori schiaffoni che vengono assestati sul viso del Battista. La soluzione espressiva è di grande efficacia; Il silenzio calato all’improvviso risulta, per contrasto, assordante, stordente, in sintonia con quello che si suppone essere lo stato psichico-percettivo del personaggio. Egli ha lo sguardo fisso, stralunato, si guarda infine intorno, completamente spaesato, in una muta, lunga inquadratura. Da ultimo, con una lieve oscillazione della testa, sembra voler dire “che trattamento!”. L’effetto ottenuto col silenzio risulta ulteriormente amplificato dalla continuità e dalla durata del76 l’inquadratura, una sorta di silenzio del montaggio che esaspera l’atmosfera straniante. Il fattore di estraniazione dalla realtà è, qui, paradossalmente, l’improvvisa e inattesa adozione del “tempo reale”. Quanto all’alternanza di ceffoni e carezze possiamo pensare alla messa in caricatura del destino terreno del Battista, e dei santi martiri in generale: adorazione e supplizio. Giovanni viene poi gettano dal boia dentro una cisterna, dove, successivamente, viene lasciato cadere un libro. Il santo, da quel momento, prende a recitare, con accento meridionale, brani delle Scritture comicamente storpiati. Cosa che continuerà a fare, tra sproloqui vari 11, quando, su insistenza di Salomè, viene fatto emergere dalla sua angusta prigione. È ora vestito da “azzurro” della nazionale di calcio (l’idea del campione di calcio come prototipo del personaggio carismatico e ignorante poteva essere, alcuni anni fa, abbastanza veritiera...). Al suo comparire attacca la canzonetta che recita: “se vuoi vivere senza pensieri dalle donne ti devi guardar sono vipere dagli occhi neri (...)”. Il tema misogino viene nuovamente veicolato dalle note svagate di una canzone. Non sembra peraltro casuale che si riaffacci il tema-luogo comune della “vipera”, se si considera l’impatto visivo della Salomè impersonata da Donyale Luna: magrezza patologica 12, cranio rasato, sguardo vitreo, ha realmente un aspetto da rettile, attraente ma, allo stesso tempo, inquietante, disturbante. Né sarà un caso che il profeta, da lei tentato, sia intento a mangiare una mela durante tutto il suo delirio. Il rapporto tra Johanaan e Salomè, a ben guardare, è in effetti molto diverso rispetto a quello, di netta opposizione (desiderio della seconda contro rifiuto sdegnoso del primo), previsto dal testo wildiano. Giovanni esordisce con un pesante apprezzamento, che sa di deprivazione sottoproletaria 13: “Bella, figghia ri puttanuna!” Dirà poi: “Chi è questa donna che mi guarda; non voglio che mi guarda (...) ditelo che se ne vada; non sto con lei; puttana!” Seguirà un’altro insulto, in cui, però, l’uso del vezzeggiativo tradisce l’ambivalenza: 77 “figghiuzza ri puttana!” Il profeta finisce per accettare la donna che gli si offre, ma lo fa con la violenta misoginia tipica della più radicale, disperata inibizione: “Allora vieni cu mia, brutta scornacchiata!” Ma è la principessa, a questo punto, a esprimere un rifiuto. Guardandolo, fa no con l’indice della mano destra. Giovanni non sembra neppure accorgersene, perso nella sua inane fantasia erotica: “Chiappi ri culu, chiappi r’oru...” Poi, colpito per l’ennesima volta sul capo da un pesante librone (le Scritture, si suppone, che, più che “entrargli in testa”, gli sono “arrivate in testa”), erompe: “Indietro figghia ri puttana, figghia ri Babbilionia”! Infine conclude: “Non ti guarderò più. Mangio la mela. Addio, Salomè; tu sei maledetta”. Questo addio conferma il contenuto pesante, “tragico”, di questo passaggio, e di questo film, che si manifesta oltre il tono di farsa e attraverso esso. “Mangio la mela” (con tanto di inquadratura in dettaglio del frutto in questione) rimarca l’ambivalenza; il fatto che Giovanni, benché non abbia strumenti per comprendere la situazione, e tanto meno per gestirla, ha ceduto anch’egli al potere seduttivo della principessa. “Addio, Salomè; tu sei maledetta” esprime un senso di scoramento nell’atto astioso della rinuncia, e nel dolore dell’impotenza. “Non ti guarderò più” rimanda al tema dello sguardo, che risulterà cruciale, come vedremo, nella sequenza finale e nell’intera nella struttura del film. Alla singolare dialettica di pathos e straniamento è da mettere in conto anche il pianto palesemente artificiale del paggio di Erodiade che lamenta la morte del giovane siriaco: lo vediamo irrorarsi gli occhi di collirio, i cui rivoli gli solcheranno poi il volto. Alla programmatica ambiguità tra voce “in”, “off” e “over” possiamo invece ascrivere un particolare effetto. Più volte la voce in di Erode diventa improvvisamente over. Inizialmente le sue labbra si muovono in sincrono, (per la verità approssimativo, volutamente) con le parole, poi queste ultime conti78 nuano mentre lui tiene la bocca chiusa, o magari mangia. Anche la sincronizzazione (apparentemente “sbagliata”) viene dunque usata non come espediente naturalistico, ma espressivo. Lo sfasamento, o meglio, la relativa indipendenza tra banda visiva e banda sonora sfocia in un momento comico quando, inquadrate le labbra in movimento di un asino, sembra sia lui a dire, con la voce di Erodiade: “Lasci insultare tua moglie?” L’asincrono, tuttavia, è generalmente funzionale al clima di alterazione cui concorre, massicciamente, anche l’impiego di voci e rumori distorti (la non comprensibilità della natura di un rumore è, praticamente, la norma, ma anche la distorsione delle parole, talvolta, oltrepassa il limite dell’intelligibilità). Un clima allucinato e “allucinogeno”. L’esaltazione estetica simbolista trova qui un correlato nella cosiddetta “cultura psichedelica”, improntata agli effetti “estetici” ed alle implicazioni metafisiche ed esistenziali connesse all’uso delle droghe omonime. E “psichedelico” è forse il termine che meglio può valere a definire questo film (si tenga conto che attorno a quegli anni vedevano la luce opere cinematografiche come Easy Rider di Hopper, The Trip di Corman, Magical Mystery Tour dei Beatles; per non parlare della produzione underground del “new american cinema”, i cui rapporti col cinema di Bene meriterebbero una trattazione a parte). Pare significativo, al riguardo, che l’espressione “tetrarca”, con cui si concludono regolarmente le risposte di Salomè alle richieste di Erode, suoni piuttosto, storpiata con accento americano, come “di droga”. Erode, ogni volta che chiede a Salomè di danzare, la vede riflessa nel suo piccolo specchio 14 che utilizza, anche, come cucchiaio (più volte lo usa per portarsi alla bocca della frutta che poi risputa sopra esso dopo averla masticata). È più che probabile un riferimento alle nozioni freudiane di “narcisismo primario” e di “fase orale”. Come fissato in fase orale Erode non sembra distinguere il sé dall’altro da sé, ed è quindi impossibilitato a venirvi a patti. Patologicamente chiuso in se stesso, risulta incapace, in particolare, di gestire una relazione, un “rapporto d’oggetto”, con la donna che suscita la sua passione erotica. Ecco allora la supplica tragicomica rivolta più volte alla figliastra nell’agghiacciante sequenza finale: “Salomè restiamo amici, restiamo amici...” Ed in questo senso, come “acque amniotiche”, sono simbolicamente interpre79 tabili le acque nere, oscure da cui è circondata la reggia. Una dimora nella quale è dato scorgere una rifrazione del disordine mentale del protagonista, uno stile di vita che rimanda alla sua patologia. L’infermità allucinata del tetrarca si riverbera nel bric-à-brac circostante, e la componente mitologica, il simbolismo malato che tutto pervade, la foresta di simboli in cui egli si agita, è in relazione con la sua psiche dissestata, nella quale i contenuti dell’inconscio hanno invaso inflattivamente la sfera cosciente15. Gli stessi personaggi riflettono Erode, in quanto portatori di problematiche ad esso inerenti. Il Cristo-Vampiro e Tigellino, di cui si è detto. Il giovane masturbatore siriaco, identificato, già da Wilde, con Narciso; di cui qui non vediamo il gesto di impugnare la spada per suicidarsi, ma soltanto quello di portarsi alla fronte la mano insanguinata, quella mano perennemente impegnata nell’atto onanistico, quasi si fosse evirato a forza di masturbarsi. Giovanni, il cui non-rapporto con Salomè prefigura quello del re. L’altro Cristo, il cui auto-supplizio è accomunato a quello di Erode attraverso il montaggio parallelo; un altro “re” che si immola in un martirio narcisistico. Sul versante opposto, quello femminile, troviamo, oltre a Salomè, la morta congerie di corpi-materia inerte (“sarebbe terribile”, riflette Erode-Bene con solenne gravità, “se i morti rivivessero”) e la doppia Erodiade, intenta, oltre che a depredare e a ingiungere al marito di non guardare la figlia, ad arrotolare una gran quantità di filo spinato: corone di spine a volontà per tutti i “poveri cristi” del caso. Non è una danza ma una sorta di martirio ciò che Salomè mette in atto ai danni di un Erode in preda al panico. Un martirio che è anche il martirio del Battista, della cui decapitazione, con cui culmina la tragedia wildiana, non vi è traccia, se non nell’immagine beffardamente allusiva di un’anguria aperta in due dalla mannaia del boia (né vi è traccia, significativamente, dell’uccisione di Salomè). Un martirio che coinvolge, come ulteriore alter ego, la figura cristologica la cui auto-crocifissione abortisce miseramente nel momento in cui, inchiodata una mano, diventa impossibile inchiodare l’altra. All’invasato non resta, allora, che prendersi a martellate in testa. Salomè non danza, ed i veli sono quelli che essa toglie di dosso, uno ad uno, ad Erode. Quest’ultimo viene perciò “disvelato”, messo a nudo sotto la luce accecante della realtà, contrapposta dialetticamente al buio amniotico della reggia. Un’opposizione, questa, cui ne viene associata un’altra, secondo una logica di ulteriore opposizione espressiva, di “opposizione di opposizioni”: al buio della dimora reale conferisce un senso di calore estremo le presenza di fiamme che bruciano incessantemente, mentre, nel chiarore abbacinante che caratterizza il calvario di Erode, lo vediamo, immerso in un ambiente deser80 tico, annaspare tra ghiaccio e sangue . Dal calore d’inferno della passione malata al gelo di morte dell’impotenza. Dopo che brividi di freddo, a mo’ di presagio, si erano impossessati del tetrarca in alternanza con insostenibili accessi di caldo. Erode cerca disperatamente di opporre la propria chiusura narcisistica: “Eh taci, non sto parlando con te! Eh non rivolgermi più la parola! Suvvia, Salomè, restiamo amici...”, dice comicamente alla carnefice sorda alle sue suppliche. Una strategia cui, prima della svolta traumatica, faceva ricorso per ricavarne un benessere fragile e illusorio: “Non c’è nulla al mondo che possa turbare la mia felicità” e poi “Stasera sono felice, sono molto felice; non sono mai stato così felice” (proferito con aria mesta: ancora dei codici, quello linguistico e quello recitativo, “sfasati” e dialetticamente sovrapposti). Sotto i veli, suscettibili della doppia valenza simbolica di placenta e di sudario, il feto-cadavere Bene mostra i denti in un ghigno mortuario. La principessa asporta facilmente con le dita la pelle della sua vittima. Scena ad un tempo antinaturalistica ed agghiacciante. Salomè, mentre la sua voce scorre in asincrono, incombe sul tetrarca mimando l’atto di mordere. Erode è violentato e come fagocitato da questa figura archetipica di femmina divorante. Egli, che aveva incautamente promesso ogni cosa alla figliastra, giurando “...sulla mia vita, sulla mia corona, sulle mie idee”, viene dunque spossessato della sua stessa identità. In montaggio parallelo vediamo, oltre alla scena della crocefissione, la doppia Erodiade che, a dorso d’asino, si dirige verso la luna. Udiamo le note della canzoncina che fa: “Abat-jour che soffondi la luce blu, di lassù tu sospiri chissà perché”. Un accostamento che, in contrapposizione alle proiezioni mitologizzanti di cui la luna è fatta oggetto, la riconduce ad una dimensione di svenevole ele81 mento decorativo. Erodiade si accinge ora ad accaparrarsela, come già ha fatto con le preziose cianfrusaglie della reggia. D’altra parte, è ravvisabile una luttuosa sottolineatura della tragedia in atto: “Abat-jour mentre spandi la luce blu, ahi che tu cerchi forse chi non c’è più”. Mentre il tetrarca offre in cambio della salvezza una congerie di oggetti preziosi e squisiti dalle magiche qualità, cercando così inutilmente conforto nell’enumerazione delle mirabilia che componevano il suo universo simbolico andato in pezzi, il volume della musica, in contravvenzione alle convenzioni cinematografiche correnti, cresce gradualmente sino a coprire e rendere incomprensibile il suo vano monologare. Un ulteriore esempio di combinazione “inaudita” di codici. L’ultimo disperato grido di Erode suona così: “Chi ha preso il mio anello, chi ha bevuto il mio vino... spegnete le torce, non voglio vedere più nulla, non voglio che niente mi riguardi... spegnete le torce, cancellate il sole, nascondete la luna, nascondete le stelle... comincio ad avere paura!” “Il mio anello” e “il mio vino”, ovvero, metonimicamente, gli oggetti numinosi e l’esaltazione patologica dell’io che gli conferivano sicurezza e garantivano la sua identità16. “Riguardare”, con sottile gioco linguistico, sta, oltre che per “concernere”, per “guardare di nuovo”, “ricambiare lo sguardo”. Guardare il re è un gesto insolente, che lo rende umano, vulnerabile. Il re di un regno infero, uterino, vede così perforato l’involucro del proprio isolamento narcisistico, e la propria esistenza messa in pericolo. E comincia, comprensibilmente, ad avere paura. Doveva finire così, lo lasciava presagire la visione che Erode ha, all’inizio del film, guardandosi nel suo cucchiaio-specchio. Prende quindi forma una sequenza ispirata ad un’altra opera di Wilde, il dramma incompiuto La santa cortigiana. Al personaggio interpretato da Bene appare, infrangendo una lastra di ghiaccio nell’emergere dalle acque, una giovane donna dalla prorompente femminilità 17, nuda e coperta di gioielli. Lui la scruta dal basso, come inebetito; anche la donna lo osserva. Udiamo la voce di Bene proferire una frase, che ripeterà poi tre volte, accorciandola ad ogni ripetizione. “Non c’è altro amore che l’amore di Dio” ci rimanda all’alter ego che tenta di crocifiggersi da solo. La figura cristologica che un esasperato narcisismo, ovvero la pretesa di essere Dio, conduce al supplizio di sé. 82 “Non c’è altro amore che l’amore” suggerisce una modalità di amore autoreferenziale, quella dell’io che si ama narcisisticamente. “Non c’è altro amore” è riferibile alla deprivazione del protagonista, alla sua radicale incapacità relazionale. “Non c’è altro” suggella la patologia del tetrarca, il mancato riconoscimento dell’altro come soggetto. Stordito dall’epifania Erode, o meglio il suo doppio “en abîme”, si ritrova poi immerso nelle acque notturne. Si carica infine, con tremendo sforzo, un enorme masso imbrillantinato sulle spalle, procede a fatica, incespica e ricade in acqua. Incapace di reggere un simile peso. C. Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995, p. XIII. I corsivi, ed il capoverso con la minuscola, sono nell’originale. 1 Assai significative, riguardo a tale nonchalance, sono le pagine dedicate al cinema nel libro-intervista realizzato con Giancarlo Dotto.(C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998, pp. 263-309) 2 È del 1999, infatti, il “castorino” di Cosetta G. Saba (Carmelo Bene, Milano, Editrice Il Castoro). 3 4 “[Quanto agli] atipici titoli di testa (...) noteremo che essi si discostano alquanto dalla loro funzione istituzionale: marche di enunciazione che, paradossalmente, proprio perché inducono lo spettatore ad accettare il film come discorso, gli danno modo di fruirlo in quanto storia. Qui si tratta di frammenti diegetici e, nel contempo, di lettere, di parole. Una sorta di ‘diegesi scritta’ (...) Siamo già di fronte ad una riflessione su come l’immagine fotografica, nella fotografia e nel cinema, si fa senso, ad una rivendicazione del carattere di linguaggio, di discorso, che è proprio del cinema, in virtù del quale fare cinema significa costruire delle proposizioni, e non ‘penetrare la realtà’. Così questi ‘pezzi di Londra’, usati a mo’ di unità grafiche, ven83 gono a comporre il discorso dei titoli di testa, quel discorso che ci parla della produzione del film e del film come prodotto. Diegesi e titoli di testa, vale a dire, sono fatti della stessa sostanza. Non si intende, in conclusione, esorcizzare l’origine discorsiva della storia, ma chiamarla, da subito, risolutamente in causa”. (S. Zumbo, Antonioni. Lo spazio dell’immagine, Salerno, Ripostes, 1995, pp. 49-50). 5 Alcune pagine importanti per comprendere la poetica cinematografica di Bene, contenute ne L’orecchio mancante (Milano, Feltrinelli, 1970), sono state curiosamente espunte dall’edizione delle Opere (cit.). L’autore, tra l’altro, vi afferma : “Perché si impolverano soprammobili noleggiati, avendo a solo scopo dell’operazione la ingenuità di attribuirsi un passato? Perché ogni realtà ‘interna’ al cinema deve essere a tutta forza giustificata dalla sua equivalenza ad una realtà esterna? Perché la capacità di un attore è riposta soltanto nella sua facoltà di imitazione? Perché lo spazio deve essere paesaggio e basta? Perché il ‘colorÈ è obbligato ad uniformarsi alla stupidità della natura? Perché mai la sequenza è solo ‘logica’? Perché l’arte deve essere la vita? Chi lo ha detto che la vita deve essere ‘questa vita?’ (...) Come mai in tutte le altre ‘speculazioni artistiche’ la vecchia polemica naturalistica si è spenta, schiantata da evidenze arcinote, e solamente nel cinema la si continua a portare avanti con una ostinazione asinina, sorda muta e cieca a tutto danno dell’ ‘ORA’ e del ‘SEMPRE’, con la meschineria dell’alibi della FRUIZIONE?” (p. 47). Cfr. M. Grande, Salomè o la fine del mito, in “Bianco e Nero”, n.11-12, 1973: “I temi, i tempi, i procedimenti e i materiali vengono drasticamente bloccati non appena stanno per passare dalla ‘apparizione’ alla ‘permanenza’ (nel tempo e negli spazi). Il montaggio porta alla rarefazione del collegamento o delle giunture ‘naturalistici’ (in senso temporale, spaziale e gestuale-comportamentale) tra atti e risultato: si procede per un movimento sintattico di ‘accenni’ di gesti, di movimenti e di eventi (...)”. (p. 135) “[Carmelo Bene] vuole ridurre la selettività del tempo e degli spazi per approdare ad una forma rappresentativa sovra-temporale ed extra-spaziale; per approdare all’impossibile della trasformazione del tempo da legge della successione a compresenza e simultaneità; all’impossibile della trasformazione dello spazio in totalità onnicomprensiva di una pluralità di eventi e di forme (...) Questo atteggiamento è verificabile considerando la tecnica di ripresa che unifica sostanzialmente - nei ‘valori espressivi’ primi piani e campi lunghi, particolari e visioni di insieme, dettagli e totali. Allo stesso modo il montaggio, ritmato secondo 6 84 cadenze particolarissime e molto rapide (con spezzatura di movimenti e della continuità stessa delle azioni e dei gesti), tenta di cogliere la compresenza spaziale di più movimenti/gesti insieme, invece di segnare le azioni una per una e di catalogare i gesti, combinandoli poi insieme a livello di scansione spazio-temporale che rispetti il decorso logico del succedersi degli eventi. Qui è come se le azioni e i tempi fossero combinati ‘a priori’ secondo una legge della non-temporalità e della non-contiguità della successione e della non-spazialità degli intervalli. Il che conferisce al film (e ai suoi procedimenti) il carattere di una ricerca condotta sino alle estreme conseguenze nella strutturazione di un complesso di segni e di riferimenti (un senso) basata sulla dilatazione dei piani e dei quadri e su di una frammentazione del tempo stesso. Dilatazione e frammentazione che suggeriscono l’idea di un rapporto che nega il riferimento monocentrico dei piani e la scansione delle sequenze, per approdare invece ad un rapporto equivalente della multiplanarità ed alla rappresentazione (e messa in scena) della simultaneità di frammenti dissociati di una realtà in decomposizione”. (pp. 150-151) Oltre a La via lattea non può non tornare in mente, ovviamente, il beffardo cenacolo di Viridiana. 7 8 “La critica spietata che Carmelo Bene fa della Religione (in questo caso la religione cattolica e la ‘superstizione’ italiana) si appunta sui caratteri fondamentali che questa ha assunto (assolvendo i suoi compiti di oggettiva repressione culturale e materiale) di negazione dell’umanità, di uccisione del terreno. Una morte che compare nelle forme di una giovane fanciulla nuda e morta portata tra le braccia dal Cristo-Istituzione o Cristo-Vampiro e che resterà per tutta la durata del festino di Erode (e del film) dietro le spalle di Erode; con tutta la evidenza oggettuale di una nudità morta, di una umanità negata, dei valori terreni rifiutati e negati dalla religio del celeste e del divino, e intesi come totalmente separati dalle più genuine qualità e dalle pulsioni più esplicite dell’uomo terra”. (M. Grande, cit., p. 139) 9 Grande oppone questo “Cristo-Istituzione” o “Cristo-Vampiro” all’atra figura cristologica che appare nel film, quella che suona un tamburello e cammina sull’acqua, e che tenterà, infine, di auto-crocifiggersi (M. Grande, cit.): “Mito istituzionalizzato e codificato secondo leggi e canoni, dottrine e dogmi, fantasie divenute legge: aspetto ‘storico’-ufficiale del Mito del Dio-Uomo rappresentato, in Salomè, dalla figura del Cristo-Vampiro (già anticipata nelle prime sequenze) che si oppone a quella dell’uomo crocifisso per la fede di un idea, per la sua testimonianza e la sua diffusione-predicazione”. (pp. 138-139) 85 “Un Cristo-Uomo che si uccide, che sopprime la propria umanità festosa (era giunto ridente dall’acqua in una tunica bianca suonando allegro un tamburello) per divenire, suo malgrado e contro il suo sacrificio, il suo doppio storico: il Cristo della storia, delle Istituzioni religiose, della Iconografia ecclesiale, del potere liturgico”. (p. 149) Bene è in ampio anticipo, questa volta, sul Buñuel di Quell’oscuro oggetto del desiderio. 10 11 Gustosa, al riguardo, una notazione di Franco Pecori: “(...) la battuta ‘Avanti popolo, a riscuotere’, detta da una figura di contadino-bracciante-calciatore della nazionale, è la frase politicamente più micidiale di tutto il cinema italiano, perché sono le parole di uno schiavo che non sa di essere schiavo, ma anzi è stato convinto di essere un rivoluzionario e per questo è disposto a prendersi tanti schiaffi, anche se non sa perché glieli danno, con tanto fervore”. (F. Pecori, I veli di Salomè in “Filmcritica”, n. 231, 1973, p. 29) 12 La modella di colore Donyale Luna era, effettivamente, affetta da anoressia. 13 Nell’intuizione beniana che informa questo frammento è dato scorgere, in nuce, buona parte della produzione audiovisiva di Ciprì e Maresco. 14 Fernando Trebbi individua, opportunamente, il valore metacinematografico di questa configurazione: “(...) mentre lo specchio cucchiaio si espone ad una nuova metamorfosi oggettuale: quella dello specchio-schermo. Tra le mani di Erode infatti, il piccolo specchio rotondo dall’impugnatura finemente lavorata, strumento per eccellenza della toletta e del boudoir, si trasforma in una sorta di piccolo schermo sul quale scorrono in proiezione privatissima le immagini di un film che ha per soggetto il corpo di Salomè”. (F. Trebbi, Il bianco medaglione degli Endimioni: “surface” e “profondeur” nella “Salomè” di Carmelo Bene in “Nuova corrente”, n. 70, 1976, p. 83) 15 Anche il “disordine” del linguaggio cinematografico è, in qualche modo, da considerarsi in relazione al protagonista. Il che può ricordare la “soggettiva libera indiretta” teorizzata da Pasolini (P. P. Pasolini, Il cinema di poesia in “Filmcritica”, n. 156, 1965). 16 L’anello, nel testo di Wilde, è l’“anello della morte”, che deve passare dal tetrar- 86 ca al boia affinché quest’ultimo sia autorizzato ad uccidere. Assume, qui, un diverso significato in quanto decontestualizzato, astratto dalla logica drammaturgica. Analogamente, nel testo della tragedia, è ad Erodiade che Erode intima di tacere, dicendole che non sta parlando con lei. L’ingiunzione, dislocata nel dialogo-monologo finale, risulta apparentemente assurda, ma è significativa ad un livello più profondo. 17 Si tratta di Verushka, celeberrima modella degli anni Sessanta. Bibliografia E. Baiardo, F. De Lucis, La moralità dei sette veli. La Salomè di Carmelo Bene, Genova, Erga edizioni, 1997 C. Bene, L’orecchio mancante, Milano, Feltrinelli, 1970 C. Bene, Salomè (cartella informativa), Ufficio Stampa dell’Italnoleggio Cinematografico, Roma, 1972 C. Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995 C. Bene, G. Dotto, Il cinema in C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998 A. Bertani, Salomè in “Cineforum”, n. 377, 1998 T. Caputo, Il montaggio diabolico in “Cinema Sessanta”, n. 91-92, 1973 A. Farassino, I sette veli di Salomè in Riminicinema, Catalogo ’93 E. Ghezzi, Prima di Salomè, in E. Ghezzi, Cose (mai) dette, Milano, Bompiani, 1996 M. Grande, Salomè, mito ed esistenza in “Filmcritica”, n. 231, 1973 M. Grande, Salomè o la fine del mito in “Bianco e Nero”, n.11-12, 1973 F. Pecori, I veli di Salomè in “Filmcritica”, n. 231, 1973 G. Saba, Carmelo Bene, Milano, Editrice Il Castoro, 1999 N. Simsolo, Carmelo Bene o della responsabilità di un’arte critica in “Zoom”, n. 1, 1972 C. Tirso, Il cinema di Carmelo Bene o l’estasi convulsa dell’immaginario in “CloseUp”, n. 7, 1999 F. Trebbi, Il bianco medaglione degli Endimioni: “surface” e “profondeur” nella “Salomè” di Carmelo Bene in “Nuova corrente”, n. 70, 1976 87 Corpi concavi e convessi in “Cremaster cycle” di Matthew Barney di Davide Gambino Forma come unione di significato e significante va sempre più allontanandosi con grande velocità di fuga dai segni dei nostri tempi e della nostra cultura. Ciò catalizza fenomeni di catalogazione e di definizioni prefissali o suffissali, proprio perchè amorfo e colmo di ambiguità è il tempo in cui ci troviamo ad agire, cosicchè le definizioni (che in realtà dovrebbero definire un ambito) risultano composizioni di preconoscenze e particelle da posporre o anteporre. Da i “Francofortesi”, da Lyotard e da vari ambiti artistici e socioculturali ci giungono tali convinzioni riguardo l’incertezza caratterizzante la nostra epoca. Come inscrivere in questa nebulosa la rappresentazione di ciò che siamo, di ciò che è il nostro “io”? Come definire “la macchina” che ci ha permesso e ci permette tutt’ora di essere? Come determinare il nostro corpo? Da Artaud, dalla body-art, dal cinema, dalla sociologia, dalla filosofia della scienza, dalle nuove tecnologie e da molteplici fattori culturali agenti nel nostro villaggio globale, giungono a noi mappature, ridisegnature e descrizioni del sistema corpo. In tale magmatico panorama negli ultimi quattordici anni si è stagliata una figura. Ora pensate ad un personaggio fuori dal normale. Un uomo sulla quarantina, ex modello, ex giocatore di football, ora regista tra i più accreditati sulla scena dell’arte contemporanea. Quest’uomo si chiama Matthew Barney, autore del monumentale progetto di “Cremaster” (1994); ed è un vero e proprio mostro divoratore di qualsiasi forma di produzione culturale che sia mai stata ideata dall’uomo. Dalle incisioni rupestri sulle pareti di una caverna neanderthaliana, alla realizzazione di futuristiche installazioni d’ingegneria edile nelle metropoli contemporanee, il suo bestiale appetito passa per la via principale della mitologia culturale americana per eccellenza: il cinema contemporaneo. Dotato di una fame insaziabile che ingurgita e sintetizza lavori altrettanto visionari (da Lynch a Cronenberg, da Clive Barker a Romero, da Coppola a Kubrick) e che una volta digeriti, ritraduce in scioccanti immagini, allusioni visive, metafore palesi ma criptiche allo stesso tempo. Barney preannuncia di segnare un passo significativo nel mondo dell’arte. Arte che nel mondo di oggi vuol dire più che mai “prodotto di fattura umana avente valore culturale” data la difficoltà enorme della differenziazione fra media, ambiti artistici, supporti e contesti di fruizione. Tutto ciò è incredibilmente condensato in “Cremaster” opera in cui convergono sculture, installazioni, performance, musica, video-arte; opera che è fruibile nei musei, su uno schermo cinematografico, su uno schermo di un normale personal computer e chissà che in futuro non giunga fino in televisione. Opera che è deposita88 ria di tutta quella sintassi che definisce la cultura postmoderna. Ci si chiede quindi se è l’arte ad utilizzare i media, oppure se quest’ultimi diverranno siti dove nasceranno e per mezzo dei quali verranno proposti i prodotti degli artisti. Ed è qui che il lavoro di Barney trova la sua unicità. Il ciclo “Cremaster” parte dallo sviluppo dell’embrione per inoltrarsi lungo la differenziazione cromosomica, una sorta di radiografia anatomica che sconfina verso il territorio del meraviglioso e dell’ibridazione. Già la trama suggerisce tutto ciò: un viaggio che porta alla distinzione sessuale, passando da luoghi fantastici a reali, da orifizi e portali, per una distinzione che avviene fra arte e realtà, fra mondo e pensiero, nella quale Barney si autocolloca nel mezzo. Di straordinaria efficacia e di estrema complessità appare essere l’operazione meta-artistica e meta-culturale dell’artista statunitense. Pensando all’informe come aspetto caratterizzante del nostro tempo, mi ha catturato il rapporto fra ossessione della forma in Matthew Barney e la mutevolezza del corpo in “Cremaster”; e ciò che mi appresto a compiere è inabissarmi in questo mondo da lui creato, cercando di sviscerare e leggere attraverso alcune commistioni la mitologia e la fenomenologia della scrittura del corpo nella saga. Sin dai suoi esordi sulla scena artistica newyorkese nel 1991, Matthew Barney è stato elogiato in quanto uno degli artisti più interessanti della sua generazione. I suoi primi lavori come “Blind perineum”1 (in cui in 87 minuti di video mostra come il performer si muova su alcune pareti di una galleria aggrappandosi a viti di titanio ghiacciato fino a giungere dentro ad un enorme congelatore in cui era stata posizionata una panca per esercizi ginnici interamente coperta di vaselina) oppure come “Drawing Restraint 7”2 (installazione presentata alla biennale di Whitney del 1993 in cui fra sculture di vaselina, rappresentanti corna di arieti, posiziona tre monitor retti da un tubo in cui si vedono lotte fra 2 attori travestiti da satiri) sono esplicitamente incentrati sul corpo e sull’atletismo. Il mondo viene percepito attraverso il corpo, il quale in “Cremaster” viene messo in scena con un linguaggio cinematografico algido, congelato, misuratissimo, immaginandone una mutazione tra il fiabesco e l’allucinato. Cremaster è il nome del misconosciuto muscolo (in italiano muscolo cremasterio) che regola lo spostamento in alto o in basso dei testicoli in risposta a determinati stimoli, quali il freddo o il caldo, al fine di proteggere la formazione degli spermatozoi. Cremaster rimanda all’unico muscolo che un atleta non può controllare, il solo dal movimento involontario dunque escluso dai sogni di virilità dell’uomo yankee contemporaneo, ossessionato dal controllo e dalla “costruzione” del corpo. Segno di impotenza trasformato da Barney in segno di potenza infinita. Il richiamo a questa parte dell’organismo maschile sovrintende ad un’opera visionaria, in cui si mescolano cinema e 89 videoarte, installazioni e scultura, opera che ci parla del processo di differenziazione sessuale subita dall’organismo nelle prime sei settimane seguenti alla concezione. Cremaster catalizza un nuovo dualismo cartesiano, una dialettica fra muscoli involontari, fra muscoli autoreferenziali cioè la contrapposizione cuore/muscolo cremasterio codificando un’ opposizione fra produzione sentimental/emotiva e produzione sessual/generativa. Cremaster vuol dire, per prossimità, gonadi, riproduzione, caratteri sessuali primari e secondari: ma l’interesse di Matthew Barney non riposa nella dimensione erotica, quanto invece nel sesso come forza generativa del divenire e delle differenze. Il sesso è sviluppo progressivo del corpo, superamento di quel primo stadio in cui l’embrione non ha ancora deciso manifestamente se diventare maschio o femmina. Quest’idea guida, a volte, si manifesta fino a mimare l’amplesso, ma più spesso scorre sotto le cose, trasfigurata, accennata, simboleggiata. Questa metamorfosi che il futuro soggetto subisce, divenendo uomo o donna, vale per Barney come una grande metafora che richiama il processo creativo, ogni forma di creazione e in particolare quella artistica. I film, con le loro immagini estremamente fantasiose, gli scenari sontuosi, illustrano dapprima come un’idea si formi nella mente del creatore, poi come insorgano i dubbi sulla sua validità e la necessità di respingerla, in seguito come l’idea si imponga, quasi in un delirio di onnipotenza, nella mente dell’artista. Poi per contrasto arrivano altre incertezze, accentuate dalla consapevolezza che l’idea deve alla fine trasformarsi in un’opera nuova e compiuta, deve definirsi. Da “Cremaster” si evince come la dialettica in cui l’artista si dibatte sia nella volontà di sempre procrastinare il momento della definizione finale, dell’identità precisata e dell’amorfismo resosi forma. Secondo Barney l’opera d’arte tende a sfuggire a questo destino, cioè tende a non assumere un’identità, perchè una volta giunta a questo stadio l’idea, realizzata e ormai esterna al suo creatore, muore. La fase processuale, per Barney, rappresenta il momento di massima potenzialità. Ed è proprio il concentrarsi sul mantenimento di tale stato di potenzialità ad essere al centro delle complesse trame simboliche-narrative dei cinque “Cremaster”. “Non ho fatto altro che reinterpretare a modo mio il processo vitale che, in ognuno di noi, porta necessariamente una trasformazione - dice Barney. Racconto il modo in cui una forma combatte per trovare una propria definizione” 3. Un’ossessione per la fisicità che, a suo modo, è molto americana e persino pop: “È vero, ‘Cremaster’ potrebbe essere letto anche come distorsione della mania non più solo americana, ma universale, per il corpo perfetto. Sono stato atleta, e nel mio lavoro d’artista c’è qualcosa che rimane di quell’esperienza: la possibilità di dare una forma al corpo, la fatica, la resistenza portata al limite. Di questo sistema, mi interessa ciò che si nasconde dietro l’apparenza: come la volontà, messa a dura prova, possa produrre effetti anche 90 sui muscoli; come credere con forza in qualcosa che possa produrre trasformazioni sul corpo umano” 4. Dunque perché non viaggiare attraverso la scrittura del corpo in “Cremaster” per comprendere profondamente cosa si esplicita nell’identità fra questo muscolo ed il corpo? Il corpo nella saga si fa amplificazione costante di ciò che è entrinsecamente rapportabile al muscolo cremasterio inteso da Barney cioè ibridazione generativa, inafferrabile mutevolezza e camaleontismo artistico. Esso infatti si rende amplificazione o sineddoche dell’architettura, si incunea nella performance e si presenta come contenitore dell’Altro attraverso la mitologia. Meraviglioso sincretismo corpo-architettura si rivela essere l’ambientazione di “Cremaster 4”, ovvero il primo episodio della saga, ambientato nell’ Isle of Man (un’isola senza tempo, eterna e misteriosa le cui rovine sono di grande attrazione e nascondono molti segreti legati alla magia) nel mar d’Irlanda fra Scozia, Inghilterra, Galles ed Irlanda; luogo che già dal suo nome rimanda al corpo, in quanto l’uomo è “separato”, è insulare per natura, proprio a causa della sua forma definita dalla struttura corporea. L’isola è ricca di leggende, miti e folklore. A tale proposito si narra che, essendovi una montagna risalente ad un’era geologica antichissima (come l’intera isola d’altronde) formata da infinite valli e crepe, tra le sue alture vi sia il “Picco Isolato” un complesso di rocce aguzze dalla forma di denti affilati, luogo in cui le fate (secondo il mito viventi sull’isola) manifestano il loro potere; si tramanda inoltre vi sia una piccola isola di pietra e roccia (cosiddetta “Isola incantata”) che nasconde al suo interno l’ingresso al regno delle fate 5. Mosso dal fascino incantato dell’isola, Barney scelse questo luogo da cui far iniziare la sua saga mitica. Nel film l’isola diviene un vero proprio surrogato del corpo del performer che danza metaforicamente sulle estremità di essa (nella costruzione alla fine del pontile), che vi cammina sotto (quando si trova sott’acqua), vi striscia attraverso (quando nella faticosa performance si trova a serpeggiare in un tunnel impantanato di vaselina). Quando Barney è nell’isola, come quando è nel tunnel, è anche in un corpo, il suo corpo (la sua isola di un uomo). La sequenza in cui striscia attraverso il tunnel (che Bruce Springsteen, altro grande mito contemporaneo stelle e strisce, chiamerebbe “Tunnel of love”) 6 suggerisce la nascita; in realtà, per Barney, suggerisce la rinascita dato che attraverso il percorso iniziatico si giunge alla consapevolezza del limite perenne, dello scacco del desiderio. Ferma e decisa è l’intenzione di Barney di sprofondare lì dove l’informità sta per partorire la forma, lì dove un corpo si prepara a nascere. Cosa nasce dunque? Nella sua operazione meta-artistica, nel suo tentativo di afferrare la creatività, Barney non vi pone massima attenzione; noi potremmo invece supporre (da buoni occidentali non possiamo far altro che ricercare linearità narrative ovunque) che stia per avere inizio il processo generativo di un corpo femminile, cioè quello della fanciulla 91 chiamata Good Year protagonista del Cremaster successivo (“Cremaster 1”). Barney ha infatti voluto che gli episodi non rispettassero l’uscita della loro progressione numerica, ma seguissero invece il seguente ordine: “Cremaster 4” (1994), “Cremaster 1” (1995), “Cremaster 5” (1997), “Cremaster 2” (1999), “Cremaster 3” (2002). Certo non casualmente, dato che la sequenza numerica 4-1-5-2-3 contiene un’evidente simmetria costruita attorno al numero cinque in posizione centrale, numero che risulta, inoltre, anche dalla somma delle coppie numeriche alla sua destra e sinistra. Ma il gioco delle combinazioni può ancora continuare ritrovando alchimie del numero 3 e del numero 5, che oltretutto corrisponde alla classica pentapartizione in atti delle antiche tragedie greche, oltre ad essere anche il numero delle discipline olimpiche nei giochi ateniesi. Nel secondo “Cremaster” (il numero 1) si passa dalla messa in scena degli organi riproduttivi maschili del quarto alla luccicante e coreografica messa in scena di quelli femminili. Anche qui l’architettura è rifrazione del corpo e ad esso rimanda. Lo stadio di football presente nel film, caratterizzato dalla presenza di due aerostati legati a uno dei pali della porta del campo da gioco, risulta essere lo stadio della città natale dell’artista (Boise, Idaho). Qui lo stadio si fa sineddoche della città natale, intesa come luogo uterino per il corpo dell’artista. Infatti anche gli aerostati evocano l’ascesa delle ovaie e dentro ogni dirigibile presenziano quattro “hostess” vestite in uniformi vagamente anni ’30 (disegnate dallo stilista Isaac Mizrahi) 7, che prima sono sedute silenziosamente intorno ad una tavola che regge una scultura di vaselina somigliante ad un modello schematico dell’utero e poi la circondano ed adornano di uva rossa e verde. In “Cremaster 5” il rapporto corpo-architettura è strettamente correlato alla città di Budapest di fine ’800 e alla sua architettura; basti notare come il teatro (nel caso particolare l’Opera di Budapest) luogo dell’illusorio e del mutevole oppure le strutture architettoniche, quali le terme dello storico Hotel Gellert o il Lànchìd hid che rimandano all’acqua, simbolo del divenire e del “panta rei” eracliteo, si facciano amplificazione delle metamorfosi corporali dei personaggi. Tema questo tipicamente postmoderno, tema che riguarda la mutazione e la simbiosi fra corpo e architettura della metropoli o fra corpo e metropoli stessa; innesti della metropoli sul corpo che ossessionano Shinja Tsukamoto autore nipponico di “Tetsuo-The iron man” 8 o Katsuhiro Otomo autore del manga “Akira” 9. Corpo che si vede mutare in funzione dell’ambiente in cui vive, che vede la macchina “toccare la pelle” ed entrarvi. Da Ballard fino a Cronenberg, dai tecnomutanti degli States fino al cyberpunk dell’estremo oriente, Barney fagocita tutto e lo trasforma attraverso la sua eclettica cultura. Nel Wortondrama, unione indivisibile delle arti, sogno di Wagner ma anche di tutti gli artisti romantici, allestito dall’artista stelle e strisce, l’azione perfor92 mativa risuona come aspetto caratterizzante, come scrittura dello spazio e del tempo, del divenire e del confine. Il corpo esibito da Barney è un corpo che, seppure dal fascino glaciale, conferisce qualità organica all’immagine video, è un corpo che si contorce, si muove, muta e stravolge se stesso, che vive. L’espressione corporea dei suoi personaggi viene ulteriormente a spiccare a causa della loro mancata complessità psicologica; essi si muovono nell’autoreferenzialità delle loro azioni, delle loro reiterate performance destinate ad essere fatalmente irrisolte. Negli atti performativi Barney sembra voler definire i limiti corporei con estenuanti prove fisiche, e mostrare il mutamento dopo essere entrato in attrito con la resistenza. La forma è definita dalla volontà, così Barney rintraccia un’identità fra l’aspirazione alla forma e la sua identità d’artista, così come la trovava fra i suoi muscoli e la volontà d’atleta (non con l’identità d’atleta, dato che essa è connessa allo sport in questione e non è direttamente legata alla creatività come per l’artista). La performance diviene in “Cremaster” luogo di evasione dal corpo attraverso il corpo stesso. Così agisce il mago Houdini che in “Cremaster 5” agisce sul crinale fra libertà e morte attraverso il suo unico strumento: il corpo. Con esso scende a patti, in esso e su di esso inscena la lotta imperitura fra natura e cultura, i due valori, le due variabili che esplicano la funzione algebrica del nostro tempo. Queste e tante altre sono le domande che Barney ci riconsegna. Cos’è il desiderio? Come si caratterizza? Da cosa è costituito il puro significante che ha investito ed investe il reale? Natura o cultura? Marchesini afferma come l’uomo sia contenitore di entrambi, e come sia la cultura a definire la mancanza, come sia essa a definire le ibridazioni con l’alterità (uomo-macchina) 10. Quali i nuovi piani d’esistenza? Certo è che in feroci dibattiti fra evoluzionisti, post-evoluzionisti fra tecnofili e tecnofobi si cercano di analizzare a fondo questioni quali la fine dell’antropocentrismo, la post-umanità (tecnoscienza e fine umanesimo), l’iper-umanità (proiezione estensiva dell’uomo), ma il dibattito certamente a lungo risulterà laborioso. Houdini-performer incarna lo show su se stesso, attira lo sguardo sul corpo, vede in esso lo strumento per seguire la propria mente, per seguire “l’idea” e nello stesso tempo si rende conto che l’unica soluzione per giungere al fine sia disfarsene, sia andare verso “l’ oltre”. Case il cow-boy del cyberspazio di “Neuromante” che subisce la menomazione del restare ancorato al suo corpo reale, sarebbe fondamentalmente d’accordo. “L’anatomia è il destino” affermava Freud; “in realtà non è più così, essa è una scelta, è possibilità modificabile” 11 - dichiara Madame Orlan intervistata da Francesca Alfano Miglietti - e dunque sono modificabili anche destino, identità ed alterità. L’anatomia ormai è pura possibilità, collage e puzzle di eterogenei frammenti . Così come l’arte ormai anche il corpo si articola per frammenti. L’estetica del frammento presente nei fenomeni artistici e nelle opere sopracitate vive un caloroso fermento ed 93 una appassionata celebrazione da circa due secoli, cioè da quando il romanticismo tedesco ha rintracciato la discontinuità, l’incoerenza, la schisi del soggetto e la multiformità dell’esperienza moderna nella forma dello smembramento e del frammento separato dal tutto. Il frammento è chiaramente legato al “non finito”, in storia dell’arte identificato con l’ultimo periodo michelangiolesco; concetto che è centrale anche in Barney dato che per lui il “nonfinito” rappresenta il massimo momento di potenzialità e, di conseguenza, anche di creatività. Per lui la performance risulta essere infinita tensione, infinita resistenza, infinite possibilità. Etimologicamente infatti infinito è equivalente a non-finito. L’ “opera d’arte frammento” infatti non si caratterizza come incompleta, bensì come impossibile a compiersi. Comprensibile quindi risulta essere l’enorme importanza gnoseologica attribuitagli dai fratelli Schlegel, da Novalis, da Schleiermacher 12 e da tutti i protoromantici tedeschi che rinvennero nel frammento non il rapporto con il tutto, bensì la rottura con esso, la piena autarchia e lo svincolarsi dal “differente”. Tutto ciò che esso è, risulta essere la piena individuazione, contenendo la massima euforia e vivacità creativa e non la nostalgia della separazione ed il dolore per la perdita della totalità. Ne consegue che il frammento per i romantici è un’entità creatrice, un puro significante che trascende il tutto, che vive in un’autocomprensione che lo porta a negare l’alterità. Allo stesso modo altrettanto fuorviante è poter pensare all’ “opera d’arte frammento” creata dall’artista, in quanto l’opera d’arte si inserisce in un disegno artistico del soggetto che tutto è tranne che cieca casualità autodeterminante (i romantici credono nel fondamento del frammento su stesso e nella sua continua autodimostrazione, il soggetto invece si confronta costantemente con l’alterità). Ciò costituisce un paradosso irrisolvibile. Barney, invece, sembra volersi inserire lì dove l’opera d’arte non è ancora compiuta, lì dove lo scontro fra forze misteriose (il salire, lo scendere) è irrisolto, egli è interessato ai sistemi continui, evolventi, irresoluti. Basti pensare a quella esemplare sequenza di “Drawing Restraint 7” in cui Barney (satiro/ariete) insegue invano la propria coda. Se la catturasse sarebbe la fine della storia. Così il tragitto della corsa motociclistica presente in “Cremaster 4” traccia i diagrammi che muovono tutta l’azione, mostrando l’insolubilità del sistema (il percorso compiuto dai sidecar è circolare). Egli si insedia lì dove il paradosso non sussiste, lì dove la bellezza e la creatività consistono nella pura possibilità. Ed è così che nelle sue performance sembra volersi destreggiare in territori sconosciuti, vischiosi come il tunnel di “Cremaster 4”, che si trova ad attraversare nelle sembianze del satiro-Loughton (questo è il nome dell’unica specie di pecora che vive nell’Isle of Man), uomo capra dal naso camuso e dai capelli rossi. Satiro che cerca di ricongiungersi nella sua unità, che possiede come contrassegni dell’Assenza le cavità per le “corna mancanti”, e che cerca superare ciò che si è imposto come prova iniziatica, 94 essendo comunque consapevole di dipendere da altre variabili performative, nella fattispecie i due side-car (uno giallo, l’altro blu). Mezzi di locomozione scelti, non casualmente, da Barney poiché nel 1907 l’Isola di Man è stata scenario per il Tourist Trophy (“La coppa del turista” di cui alcuni dicono sia stata la prima corsa di motocicletta al mondo): un 33 miglia e mezzo di circuito intorno ed attraverso il cuore dell’isola. Il corpo che si fa performance è protagonista anche dell’ultimo episodio cioè “Cremaster 3”. Qui esso vive l’impossibilità ad essere come stabile ed unico; esso vive la frustrazione del riconoscimento del riuscire a superare la serie di ostacoli lungo il percorso che porta verso l’Altro, vedendosi però distrutto dalla natura o dall’opera da lui stesso creata. L’Apprendista, infatti, deve superare una serie di prove, rese metafora nella straordinaria struttura a spirale del Guggenheim Museum di New York. Alla fine, di nuovo sul Chrysler, il pre-finale edipico in cui l’Apprendista ha la meglio sull’Architetto, uccidendolo, lascerà campo al finale frankesteiniano in cui il grattacielo ucciderà l’Apprendista. Il corpo va si oltre la performance, modellandosi attraverso lo sforzo, ma non oltre ciò che crea. Le attività performative rivelano lo scontro tra differenti forze della natura, volontà e resistenza. Forze impersonate metateatralmente dai personaggi interpretati da Richard Serra e da Barney stesso. Inoltre ancora una volta lo spazio in cui il film è ambientato manifesta esso stesso una volontà propria, e diventa a sua volta un personaggio. L’opera creata è più potente del creatore, e il grattacielo sceglie piuttosto di rimanere incompiuto che tollerare la hybris dei suoi artefici. Il sistema resta incompiuto nell’utopia barneyana, poiché esso non tollera il prevalere di una spinta sull’altra. L’artista si fa ulteriormente demiurgo poichè fonda una sua natura basata sull’informità che riesce a raggiungere un’utopica stabilità. L’ultimo capitolo è finito, ma il Ciclo è un cerchio, e non ha termine, quindi una coda racconta la leggenda di Finn McCooll 13 e della formazione dell’Isola di Man, là dove prende le mosse il Quarto Cremaster, il primo ad essere girato. Fra le concavità e le convessità del corpo mitologico cremasteriano si insediano mitologie celtiche, mitologia greca, fiabe con i suoi animali sapienti e realtà trasfigurate. Così come ogni uomo che si trova a brancolare in “territori sconosciuti”, così come un Minotauro a guardia del labirinto del desiderio, Barney traspone e reinventa miti, disegna figure mitologiche e si fa guidare nel “meraviglioso” dal suo sconfinato immaginario. In “Cremaster 5” la magnificenza visiva e cromatica, tipica del barocco, non può che essere speculare a figure quali gli elfi marini delle terme Gellert, non dissimili dagli elfi dei boschi che popolano la shakespeariana “Sogno di una notte di mezz’estate” oppure a figure quale il Gigante-Nettuno, topos della tradizione piscatoria e protagonista di molte grandi favole d’ambientazione marina (la “scena di mare” costituiva una delle sei canoniche della scenotecnica barocca euro95 pea) 14 e Dio della mutevolezza e dell’eterno divenire. Figura mitologica rappresentata iconograficamente, infatti, da un busto umano e da estremità inferiori marine. In “Cremaster 3” si manifestano mitologiche rifrazioni fra l’ambientazione (prologo e conclusione in terre celtiche) ed alcuni personaggi. Basti pensare che The Entered Apprentice, dopo che “l’architetto (Serra), grazie ad un allucinante intervento chirurgico, gli innesta nella bocca delle lamiere contorte, viene tramutato in una figura nibelungica con tartan 15 e copricapo rosa”. Figura mitologica riconducibile al gigante ermafrodita Ymir, che vive al principio della cosmologia norrena, le cui membra si uniscono in modo vario; oppure Siegfried, figlio di Siegmund e nipote di Odino, il quale diventa invulnerabile nel momento in cui assaggia il sangue del drago da lui ucciso. Siegfried, che compirà numerose fatiche dopo l’acquisita invulnerabilità ma che perisce sotto la lancia del nano Hagen, dopo aver riconquistato l’amore della Walkiria Brunnhilde16. Inoltre vi sono anche rimandi impliciti al mito biblico come nel caso di Hiram Abiff o a miti più moderni come quello della creatura che si ribella al suo creatore Frankenstein, mito prometeico dei giorni nostri, che ha stimolato una lunga fenomenologia: dall’automa Maria di “Metropolis”17, al mito del Golem (in ebraico “informe”), messo su celluloide da Paul Wegener 18 fino ai Nexus 6 di “Blade Runner”19. Le stesse rifrazioni mito/ambiente sono presenti in “Cremaster 4” dove, sempre legate a mitologie norrene, co-protagoniste sono le fate ermafrodite dell’Isola di Man. Le fate sono degli esseri soprannaturali minori, intriganti e che presiedono al destino umano (corrispondenti alle Moire greche o alle Parche latine). Fate chiamate da Barney nel primo Cremaster con l’appellativo di Faeries. Nel Vecchio francese, la parola faerie è collegata al “fatum” latino, cioè il destino o il significato del destino. In “Cremaster 4” le Faeries sono tutt’altro che incantevoli, a differenza di come sono nel nostro immaginario; sono, infatti, impersonate da tre body-builders che hanno modellato i loro corpi a proprio piacimento. Spesso appaiono nude, inoltre, finché i titoli di coda non lo svelano, non si può essere interamente sicuri che siano donne, data l’acconciatura androgina ed i genitali coperti dal trucco e da dispositivi protesici. Ma ognuno delle tre risulta distinguibile dalle altre. Infatti, è vero che hanno gli stessi capelli luminosi rossi come il candidato Loughton, ma una, la più femminile delle tre, ha due chignon sulla testa a simbolizzare le ovaie che ascendono su per il corpo; la più maschile, ha due chignon che giungono fino alla nuca, simbolizzando la discesa dei testicoli, mentre la Loughton Faerie mostra la dialettica non risolta nella presenza androgina, avendo due chignon sulla cima e due alla base della testa. Le Faeries inoltre appaiono nelle parti di “Cremaster 4” in diversi aspetti: spogliate, indossanti vestiti durante il pic-nic e nelle tute attillate da membri dell’equipaggio di un 96 pit-stop-team. Così Barney esplicita nel corpo mitologico la fenomenologia della sessualità: androginia, femminilità e mascolinità. Ma ancora più importante, in questo episodio del 1994, risulta essere il corpo mitologico del satiro Candidato-Loughton impersonato da Barney in persona, ricordando il suo precedente lavoro 20. Il nome attribuito dall’artista al satiro svela una duplice spiegazione. Innanzitutto, come ho prima affermato, la pecora Loughton è l’unica specie indigena dell’Isle of Man , ma non è tutto, poiché essa è anche l’unica specie dell’intero Regno Britannico a possedere due diverse paia di corna, un grande paio di corna verso l’alto ed uno più piccolo verso il basso. Ciò rappresenta, nell’immaginario barneyano, l’esistenza di un sistema riproduttivo maschile (discendente) ed uno femminile (ascendente). L’uso della definizione “Candidato”, invece, sottolinea, come afferma anche il celebre dizionario inglese Webster’s Third, come il satiro aspiri ad una definizione, ad un “non so che”, ad una “non differenziazione”, ad una duplicità androgina conseguibile con l’acquisizione delle due paia di corna che mostra di non avere e di volere proprio nelle inquadrature iniziali del quarto “Cremaster”. Inquadrature in cui le mani del satiro si muovono curiose sul capo, richiamando le pratiche autoerotiche di un bambino che vuole scoprire la propria sessualità, ricercando corrispondenze con l’alterità (cioè le corna della pecora Loughton), con cui si troverà in perfetta simmetria verticale alla fine dell’opera. La figura mitologica del satiro, mezzo uomo e mezzo capra, sgorga da quell’inesauribile serbatoio di miti, che è la civiltà greca, culla della civiltà occidentale; e Barney, conscio di tutto ciò, e figlio di quella terra che oggi è cristallizzata nelle nostre menti come la capitale dell’Occidente, incarna e ripropone nelle sue performance questo esemplare corpo mitologico. L’animale ha un rapporto millenario con l’uomo che, dalla mimesi prima, dall’animalità totemica (esplicitata nel prevalere di Gilmore sul toro in “Cremaster 2”), dalle divinità animali (Anubis, Api, la vacca per gli indiani), dalle filosofie ad essi collegate (Cinismo) 21 fino al teriomorfismo più moderno, traccia dei percorsi incidenti con esso. La figura del satiro nasce dalle processioni ditirambiche della Grecia arcaica e dalla persistenza in tali riti del capro come animale totemico, rievocato da danze e travestimenti e poi probabilmente ivi sacrificato. Da tali riti sacrificali si è fatta etimologicamente 22 risalire la tragedia, che poi avrebbe avuto la sua divisione in tre sottogeneri successivi: tragedia, commedia e dramma satiresco. Protagonista di quest’ultimo è appunto il satiro, figura dalla barba ispida, dal naso camuso, portatore di ferina sessualità, di lascivia ed irruenta follia animalesca. “Per Nietzsche essi raffigurano addirittura la nostalgia di una vitalità primordiale, un’irrefrenabile accordo delle pulsioni con il ciclo della natura, e perciò una perduta condizione animalesca e insieme superumana” così dichiara Renato Tomasino 23. Barney personifica nel satiro questo superomismo e questa forza 97 primigenia: sessualità neutra che si fa forza creativa. Né uomo, né donna; né uomo, né animale. La sua sessualità è puro significante non trova significazione altra. Esso è pura potenza. La mitologia è “il luogo del far credere vero ciò che, forse, vero non è ”. Così come si propone l’illusionista oppure cosi come fa il cinema. Barney sintetizza un po’ tutto ciò modellando il medium che conosce bene: il corpo. Corpo che attraverso la mitologia (il luogo della realtà/credenza) fluttua fra metamorfosi continue rigenerandosi nel suo eterno divenire, ponendosi la domanda: chi sono prima di essere? “Cremaster” diventa allora l’epico racconto dell’interstizio fra le convessità del principio di realtà e le concavità del principio di piacere. Desiderio incarnato nella mutevolezza del corpo come in una scultura di Henry Moore, fra concavità e convessità. Quest’ultimo si identifica nella ricerca di uno stadio intermedio fra indifferenziato e differenziato, in uno sforzo utopico di creare una identità mutante, in continua mutazione, in metamorfosi. I corpi dei protagonisti dei cinque film assumono spesso queste caratteristiche, accentuate da un trucco tanto delirante quanto sapiente, e si impegnano in azioni atte a ritardare il più possibile il momento dell’assunzione di identità mescolandosi con l’architettura, ridisegnandosi con il mito e mutando nello sforzo performativo. “Cremaster” è il corpo prima che esso diventi tale. Ed è in questo paradosso formale che si cela l’informità del desiderio. 1 http://artpost.info/speedpost/detail.asp?news_id=75 2 http://dinamico.unibg.it/cav/elephantandcastle/doc_articoli%5Cbelpoliti.pdf Cremaster Cycle - A Conversation with Matthew Barney - Interview at Guggenheim Museum 3 4 Valentini, Valentina, Le pratiche del video, Bulzoni, Roma 2003 (pp. 109-112) 5 www.wikipedia.org 6 Springsteen, Bruce, Tunnel of love, CBS record 1987 7 http://magazine.libero.it/cinema/bd/schedafilm.php?sch=44168 8 Tsukamoto, Shnja, Tetsuo - The iron man, Giappone 1989, b/n 67’ 98 9 Otomo, Katsuhiro, Akira, Giappone 1989, animazione col 124’ Marchesini, Roberto, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Boringhieri, Torino 2002, (pag. 577) 10 Alfano Miglietti, Francesca, Identità mutanti, Costa & Nolan, Genova 1997 (pag.114) op. cit. pag. 12 12 Abbagnano Nicola – Fornero, Giovanni, Protagonisti e testi della filosofia, vol. C (pp. 12 - 15 e pag 37) 11 13 Finn McCool (Fionn MacCumhail in gaelico) era un gigante. Finn McCool sconfisse un gigante Scozzese lanciandogli negli occhi un pezzo di terra. Il luogo dove il pezzo di terreno atterrò è proprio al centro del mare irlandese in mezzo all’Irlanda e l’Inghilterra, ed è adesso l’Isola di Man. Ogni volta che Finn desiderava risolvere dei problemi si portava il pollicione in bocca per ciucciarlo e sapeva come reagire poichè li aveva acquisito secondo il mito tutte le conoscenze possibili. http://pronunciationkey.blogosfere.it/ Tomasino, Renato, Storia del teatro e dello spettacolo, Palumbo 2001 (pag. 394) op. cit. pag. 14 14 Un tartan è un particolare disegno realizzato con fili di tessuto colorato intrecciati tra di loro a formare geometrie caratterizzate da bande alternate di colori diversi che si intrecciano ad angolo retto. Il tartan nell’era moderna è associato alla Scozia ed in particolare ai clan scozzesi: ogni clan ha il proprio disegno che lo contraddistingue. Il Kilt il tipico gonnellino scozzese, è infatti quasi sempre realizzato in tartan. http://it.wikipedia.org/wiki/Tartan 15 16 Panini, Giorgio, Atlante di mitologia, Mondadori, Milano 1994 (pag. 64) 17 Lang , Fritz, Metropolis, Germania 1926, b/n 87’ 18 Wegener, Paul - Boese, Carl, Il golem, Germania 1920, b/n 76’ 19 Scott, Ridley, Blade Runner, Usa 1982, col 124’ 20 “Drawing Restraint 7” 99 21 Cinismo da greco kunòs = cane 22 Tragon odè = canto dei capri Tomasino, Renato, Storia del teatro e dello spettacolo, Palumbo 2001 (pag. 138) op. cit. pag 14 e 25 23 100 Robert Lepage: il teatro ad orologeria di Roberto Giambrone Autore, attore, produttore, scenografo, regista cinematografico e teatrale, Robert Lepage è probabilmente il massimo rappresentante di quel teatro totale che in Italia – dopo la promettente ma breve stagione del “teatro immagine” – stenta a maturare e che altrove, in Europa e oltreoceano, sta dando i suoi migliori frutti. Nel segno di una drammaturgia della scena non più incentrata sulla supremazia del testo letterario, autori come Robert Wilson, Peter Greenaway, Jan Fabre, Christophe Marthaler, Philip Glass tra gli altri, non a caso impegnati sui diversi e complementari fronti delle arti visuali e sceniche (dal cinema alla videoarte, dalla danza alla performance e alle installazioni), si sono distinti nell’ultimo ventennio per aver saputo sovvertire il canone occidentale del teatro a senso unico e a prospettiva centrale. Le loro opere, inglobando e riformulando l’estetica del postmoderno, attraverso la compresenza di linguaggi diversi, le pratiche della citazione, del remake, del bricolage – spesso e volentieri in senso meta linguistico – ma soprattutto attraverso l’uso di nuove tecnologie, meccaniche e digitali, hanno contribuito alla diffusione di nuovi regimi scopici e, conseguentemente, di una nuova sensibilità percettiva nello spettatore di fine millennio. Il caso di Robert Lepage è esemplare. Nato a Quebec City nel 1957, dopo un’infanzia difficile e tormentata, Lepage manifesta un precoce interesse per la geografia ma è la passione per l’arte a spingerlo verso il teatro. A 17 anni inizia gli studi, come attore, al Conservatoire d’art dramatique di Quebec City e, dopo uno stage a Parigi, comincia a collaborare con diverse produzioni in qualità di attore, drammaturgo e regista prima di entrare, nel 1982, nella compagnia di ricerca del Théâtre Repère, con la quale realizza Circulations, che ottiene il premio come migliore produzione canadese in occasione della Quinzaine Internationale de Théâtre de Québec. Ma la svolta avviene nel 1985 con La Trilogie des Dragons, uno spettacolo epico, che ripercorre la storia di tre generazioni di immigrati cinesi nelle Chinatown di Québec City, Toronto e Vancouver. Il multiculturalismo dispiegato nella traccia narrativa dello spettacolo (dove si parlano tre lingue e si intrecciano i destini di diverse etnie) riflette il métissage scenico, che fa largo uso di azioni fisiche, prospettive multiple, giochi di luci e di ombre, mentre la drammaturgia procede rapsodicamente per ellissi e flashback, in una scrittura di impianto cinematografico, “un fluire di magiche immagini cariche di forza che mescolano l’esperienza occidentale a un punto di vista orientale” 1. Altra caratteristica di questo spettacolo – come di altre sue opere che avranno più edizioni, anche 101 cinematografiche – è la sua forma aperta e in progress, che vedrà ben tre successive versioni di durate progressivamente crescenti, da un’ora e mezza ad oltre sei ore. Il passo successivo nella costruzione di questo théâtre visual, un magico teatro di superfici, dove l’immagine si fa racconto e seduzione pura, sostituendosi al “gioco delle parti” della polverosa scena tardoborghese 2, è Vinci (1986), nel quale la fascinazione delle macchine è accentuata dalla presenza in scena di un solo interprete: lo stesso Lepage. Per rendere omaggio al genio di Leonardo, Lepage realizza una vera e propria fantasmagoria di luci colorate, proiezioni, scritte luminose, suoni e musica. Un’opera di pura visibilità, dove il testo è sostituito da una partitura di immagini che prolifera rizomaticamente grazie a un montaggio ancora una volta di tipo cinematografico. Tuttavia – e qui sta l’originalità del lavoro di Lepage, che non esclude l’epos dalla scena – Vinci non è un astratto caleidoscopio. Vi si racconta, per suoni, didascalie e immagini, la storia di un giovane fotografo canadese (Lepage sceglie non a caso un voyeur di professione) che giunge a Firenze in cerca di affermazione e, come in un viaggio di formazione, scopre il senso dell’arte e della vita attraverso le opere di Leonardo. E certo non deve essere casuale l’interesse di Lepage per l’architetto-artista italiano se, come afferma Jean Collet, Leonardo da Vinci sarebbe stato “il vero inventore della cinepresa” 3, oltre che un abile manipolatore di corpi e specchi 4, proprio come l’artista canadese. Vinci è dunque un omaggio all’artista-genio che ha saputo guardare oltre i canoni consacrati dell’arte e della scienza sollecitando nuovi punti di vista: “Il teatro in questo senso produce un nuovo sguardo, un’inedita “esperienza” visiva” 5. Lepage si spinge ancora più avanti in questa ricerca, ad un tempo rigorosa e ludica, di eccentrici regimi scopici e di una nuova machinerie dell’immaginario, con lo spettacolo Le Polygraphe (1987), che avrà anche un’edizione italiana (tradotta da Franco Quadri nel 2000) e una cinematografica (1996). Prendendo spunto da una tragica vicenda autobiografica (l’omicidio di una cara amica), il regista coniuga ancora una volta cinema e teatro per realizzare un thriller utilizzando i flashback, le dissolvenze, i piani di ripresa e le tecniche di montaggio dei classici hollywoodiani, fino a includere i titoli di coda. Il polygraphe è la macchina della verità a cui è sottoposto il principale indiziato dell’omicidio, che si trova al centro di una vicenda torbida e intricata con tutti gli ingredienti del noir classico. Il fondo scena è delimitato da un grande muro dove gli attori, sfidando la legge di gravità, si muovono, passeggiano o cascano dando l’impressione di una ripresa dall’alto. Il virtuosismo, non solo tecnologico ma soprattutto recitativo, arriva al punto da simulare l’avanzamento veloce del videotape. Ciò che colpisce maggiormente in questo spettacolo è la mise en abîme del teatro stesso, il rispecchiamento 102 continuo di questo nel cinema e viceversa: “[…] nella pièce si fa del teatro nel teatro, ma si gira anche un film sul delitto che è alla base del giallo. Ed è la relatività rappresentata da questi vari piani che si intersecano a dare a quest’opera realmente poligrafica il suo senso” 6. Questa sovrapposizione di piani e discorsi – che diverrà una cifra distintiva di tutto il teatro di Lepage – costringe lo spettatore ad una lettura non univoca dell’opera, attivando sensi e ragionamenti diversi: “Tutto ciò decostruisce la convenzione scenica e induce nello spettatore un sottile senso di disagio, una sorta di lieve strasbismo” 7. L’anno prima dell’edizione cinematografica di Le Polygraphe, Lepage aveva diretto per il cinema Le confessional, cui faranno seguito i film No (1998), liberamente ispirato allo spettacolo teatrale Les sept branches de la rivière Ota, Possible worlds (2000) e La face cachée de la lune (2003), tratto da un altro suo spettacolo, a riprova del medesimo e sovrapposto interesse che il regista dimostra per i due media, ai quali si aggiunge la televisione, per la quale cura un adattamento de Les sept branches… (1996). Il successivo, complesso spettacolo teatrale di Lepage è Les plaques tectoniques (1991, dopo una prima versione in progress del 1988), che utilizza la metafora delle placche tettoniche in movimento, ora catastrofico ora di assestamento, per incrociare le storie di alcuni personaggi inquieti alla ricerca di un’identità tra vecchio e nuovo continente. La scena accoglie al suo centro una grande piscina, che per incantesimo (tutto tecnologico di luci, proiezioni e ingegnosa attrezzeria) si trasforma nella laguna veneziana, nello skyline newyorkese, nel cimitero parigino di Père Lachaise, dopo esser stata un moderno centro universitario di Montréal. Proprio qui comincia l’intricata storia di una studentessa innamorata del suo professore di storia dell’arte, che però ama un bibliotecario muto e sparisce per anni, mentre la ragazza cerca di dimenticarlo partendo per l’Italia dove si innamora di una tossicodipendente, inseguita dal padre con il quale ha una relazione incestuosa. La complessità della vicenda, che incrocia storie, identità e situazioni limite, riflette l’articolata architettura drammaturgia, che moltiplica i punti vista, sovrappone i piani narrativi e scardina le regole spazio-temporali, proiettando i personaggi da un luogo all’altro dei due continenti in epoche diverse, riportando in vita finanche Chopin. “I nessi appaiono obliqui, ma il ritmo e la forma che emergono nel corso delle tre ore di spettacolo, gran parte del quale si svolge a mollo nell’acqua, sono stimolantissimi” 8 scrive il critico dell’Observer Michael Coveney, che definisce lo spettacolo un evento “esotico e mesmerico”. Ed effettivamente gli spettacoli di Lepage, con la loro fantasmagoria tecnologica e la sapiente texture drammaturgia, producono un effetto incantatorio nel pubblico, un coinvolgimento sensoriale prossimo al rapimento estatico o al “viaggio allucinogeno” 9. 103 E guarda caso, lo spettacolo successivo, Les Aiguilles et l’Opium (1991), parte proprio dalle allucinazioni di Miles Davis e Jean Cocteau per indagare sul tormento e l’estasi del genio dedito al consumo di sostanze oppiacee. Sospesa al centro della scena è una grande lavagna mobile che fa da schermo sul quale si avvicendano, in dissolvenza o in montaggio alternato, immagini da Ascenseur pour l’échafaud di Louis Malle, con la colonna sonora di Miles Davis, primi piani di oggetti (il grande telefono è un omaggio a La Voix Humaine) e dettagli corporei, la copertina di “Life” con il ritratto di Cocteau, l’etichetta di un vinile d’epoca. Questa “magica membrana estensibile” 10, al centro della quale è sospeso il corpo dell’unico attore (Lepage stesso e, successivamente, Marc Labrèche nella prima ripresa e Nestor Saied nell’edizione italiana del 1997 tradotta da Franco Quadri), dichiara la sua funzione soprattutto quando diventa una spirale bianca su fondo nero che ruota con effetti ipnotici. Il bricolage è, anche in questo caso, la cifra distintiva dello spettacolo, costruito per accostamenti paratattici, visuali e sonori: frammenti dalle biografie dei due artisti, testi di Cocteau, conversazioni telefoniche, musiche di Davis e Satie. Dopo Les Aiguilles Lepage avvia un intenso periodo di lavoro: dall’89 al ’93 è direttore artistico del Théâtre Français du Centre National des Arts di Ottawa e nel ’92 mette in cantiere Le cycle Shakespeare, che vedrà la realizzazione di Macbeth, Coriolan e La tempête (1992-1994) nel discusso adattamento, basato sul dialetto québécoise, di Michel Garneau. Anche se questo approccio a Shakespeare non aderisce del tutto alla poetica visionaria e travolgente di Lepage, è utile per rintracciare alcuni elementi di ricerca che il regista innesta nella sua sperimentazione sulle ibridazioni, come l’uso del frame, una cornice che delimita lo spazio come fosse uno schermo cinematografico o televisivo, utile a creare primi piani e isolare dettagli. Inoltre, la ricerca linguistica di Garneau ammicca al linguaggio delle soap televisive, col preciso intento politico di smitizzare la sacralità del testo riportando l’attenzione al linguaggio comune e preservando, in tal modo, le tradizioni linguistiche delle minoranze. Contigua a Le cycle è la messa in scena di A midsummer night’s dream (1992), che lo battezza il primo nordamericano a dirigere Shakespeare al Royal National Theatre di Londra. Lepage tornerà a occuparsi, come vedremo, dell’universo shakespeariano con esiti diversi e più significativi per il nostro discorso. Ma nel frattempo arriva un altro monumentale spettacolo: Les Sept Branches de la Rivière Ôta (1994), prima produzione della neonata struttura multidisciplinare “Ex Machina” di cui assume la direzione artistica. Questa nuova formazione presenterà, in rapida successione, alcuni dei più importanti lavori di Lepage, tra cui i più significativi saranno, oltre a Les Sept Branches…, il monologo Elseneur (1995) dall’Amleto di Shakespeare, La Géométrie des Miracles (1998), La Célestine di Fernando de Rojas (1996), Zulu Time (1999), La face 104 cachée de la lune (2000), Apasionada (Que viva Frida), basato sugli scritti di Frida Kahlo (2001), The Busker’s Opera dalla Beggar’s Opera di John Gay (2001), l’opera in musica 1984, tratta dal romanzo di Orwell e diretta da Lorin Maazel (2005), Le Projet Andersen (2005) e Lipsynch (2007), nonché diverse riprese dei precedenti spettacoli ormai entrati nel repertorio della compagnia e che, dal 1997, Lepage mette in prova e realizza nel centro di produzione pluridisciplinare “La Caserne” (una ex caserma dei vigili del fuoco). Prima di analizzare alcune di queste fondamentali produzioni, è necessario ricordare che Lepage affronta, nel frattempo, anche nuovi territori dello spettacolo dal vivo come l’opera lirica e la musica pop: è del 1991 la messa in scena de Le Château de Barbe-bleu di Bartók ed Erwartung di Schönberg, mentre due anni dopo firma la regia per The Secret World Tour di Peter Gabriel, col quale collaborerà anche nel 2002 per la tournèe Growing Up Live. Ritorna al teatro lirico con La damnation de Faust di Berlioz, in Giappone nel 1999 quindi a Parigi nel 2001, e nel 2007 con The Rake’s Progress di Stravinsky. Ed è fatale che Lepage, nel suo inquieto ma giocoso girovagare tra generi e dispositivi della scena, incontri anche il nuovo circo del Cirque du Soleil, firmando l’ideazione e la regia di KÀ (2005). Torniamo a Les Sept Branches…, che debutta a Edimburgo nel ’94 e che crescerà in fasi successive fino ad una versione di otto ore del ’96 e una di sette dell’anno successivo. Come ne Les plaques tectoniques lo spettacolo segue, nell’arco di cinquant’anni, i destini di diversi personaggi legati in qualche modo alla tragedia di Hiroshima. Filo conduttore dello spettacolo è la fotografia, cioè l’immagine, il suo potere evocativo (è attraverso una fotografia che i personaggi scoprono i loro legami familiari) e distruttivo: “La bomba atomica equivale a un flash fotografico. La fotografia diventa metafora della distruzione e della memoria: le ombre dei corpi impresse sui muri delle abitazioni, a causa dell’esplosione, diventano segno tangibile e indelebile della distruzione e della tragedia” 11. Un sistema di pannelli, che richiama le abitazioni tradizionali giapponesi, serve a Lepage per tessere la sua partitura di immagini, sfruttando ingegnosamente luci e ombre. Come nei teatri orientali, ma grazie a sofisticati dispositivi di videoproiezione, “[…] l’immagine si declina in ombre, riflessi, documenti d’archivio, film, cabine fotografiche, diapositive, video, testi composti al computer, lumakee, immagini di sintesi” 12. Ormai lo stile di Lepage è maturo e il regista non ha più dubbi sulla strada da seguire. I suoi spettacoli sono delle macchine ad orologeria, fantastici carillon che dispensano suoni e immagini come moderne lanterne magiche. È tempo di tornare a Shakespeare con le idee più chiare e un più sofisticato bagaglio tecnologico a disposizione. Intitolando Elseneur (1995) il suo Amleto, Lepage dichiara il proprio interes105 se più per lo spazio che per il personaggio 13. Protagonista dello spettacolo è infatti il set, al centro del quale, come ne Les aiguilles…, si innesta l’attore Lepage, che in un virtuosistico e straordinario gioco di trasformazioni e illusioni interpreta tutti i personaggi. Le sorprendenti moltiplicazioni prospettiche sono possibili grazie ad un complesso macchinario scenico al centro del quale vi è un monolite mobile che contiene a sua volta un cerchio rotante. “Dentro” e intorno a questa macchina l’attore interagisce con le immagini proiettate sullo stesso monolite e su due schermi che delimitano ai lati la scena. Nonostante le rotazioni del cerchio e le inclinazioni del piano, egli è perfettamente a suo agio pur sfidando la forza di gravità. L’effetto sul pubblico è stupefacente e incantatorio. Pare che Lepage si sia ispirato alla sequenza di Steamboat Bill Jr. nella quale Buster Keaton rimane impassibile e incolume mentre la facciata di un edificio gli cade addosso all’altezza di una finestra aperta14. Al cinema, ancora una volta, è rivolto l’omaggio più evidente, a partire dai titoli di testa proiettati sullo schermo centrale. Ma Elseneur fa i conti anche con la pittura (Delacroix), con la scienza leonardesca e con gli esperimenti foto-dinamici di Muybridge15. Un altro aspetto che ha spinto Lepage a sperimentare in Elseneur nuove possibilità espressive, attraverso l’uso di sistemi tecnologici, è la convinzione che nel testo di Shakespeare la musicalità sia un elemento primario. Con la collaborazione del musicista Robert Caux, il regista ha individuato la specifica musicalità di ogni passaggio del testo: “Lavoriamo con una macchina che riconosce i differenti tipi di sillabe pronunciate e associa a ogni sillaba una musica particolare. Quando si passa il testo di Amleto attraverso questo filtro, il senso emerge con una modalità assolutamente nuova”16. L’esecuzione musicale è affidata a una macchina che reagisce alla sonorità del testo pronunciato dall’attore; in tal modo, lo spettacolo subisce piccole modificazioni ad ogni recita e non è mai lo stesso. L’anno seguente Lepage dedica La géométrie des miracles (1996) a Frank Lloyd Wright e al suo incontro con il filosofo e mistico armeno Georges Gurdjieff. L’architettura è per Lepage una questione strettamente legata allo spirito e alla rappresentazione. Tutto il suo teatro è una gigantesca architettura in movimento, un corpo organico come quelli immaginati da Wright e per esemplificarlo il regista immagina un tavolo da disegno che si trasforma di volta in volta negli oggetti funzionali al racconto, mentre tutt’intorno luci e proiezioni restituiscono immagini di città e progetti architettonici. Architetture che si moltiplicano, oltre che nelle immagini, anche nelle coreografie sincronizzate. Per lo spettacolo multimediale Zulu time (1999), ambientato in un supertecnologico scenario aeroportuale, Lepage ha chiamato a raccolta diversi artisti esperti in tecnologie dell’immagine e del suono e l’amico Peter Gabriel per 106 le musiche. Zulu time è puro godimento sensoriale, un mix di immagini, visioni, corpi reali e virtuali, che ha una funzione catartica e ludica allo stesso tempo. “Il significante celebra i suoi fasti”17, per usare un’espressione formulata a proposito del cinema illusionistico di Méliès, col quale il teatro di Lepage ha non poche parentele. Come nel caso del pioniere del cinema, anche nell’opera di Lepage “il viaggio […] nel paese delle meraviglie non comporta nessuno through the Looking Glass. La meraviglia non è al di là dello specchio, è nello specchio. La magia […] non è al di là dello schermo, è al di qua di esso, nel dispositivo che la produce” 18. E ha tutto il sapore dell’omaggio a Méliès La face cachée de la lune (2000, che avrà una versione cinematografica nel 2003), una ironica, poetica e surreale celebrazione dei viaggi spaziali, reali e metaforici. Inizialmente interpretato (a solo) dallo stesso Lepage, lo spettacolo racconta di due fratelli che si ritrovano dopo la morte della madre per rievocare il loro passato in un racconto parallelo alle esplorazioni spaziali. Il trasformista Lepage interagisce con i video, gli oggetti e le marionette, e con le musiche di Laurie Anderson a supporto di una narrazione eccentrica che si sviluppa per flashback. L’anno successivo il regista si misura nuovamente con la pittura, come a voler rimarcare il suo interesse predominante per gli aspetti visuali del teatro, realizzando lo spettacolo su Frida Kahlo Apasionada (Que viva Frida) (2001) di Sophie Faucher, poi intitolato La casa Azul. Un sipario trasparente, illuminato da una fluorescente luce blu, divide la scena in due porzioni consentendo agli attori che agiscono sul fondo di interagire con le immagini proiettate sul sipario frontale in un gioco di dissolvenze incrociate. La protagonista – interpretata dalla stessa Faucher, che aveva scritto e interpretato per Lepage anche La géométrie des miracles – racconta in prima persona gli episodi salienti della vita di Frida, in un confronto serrato con le immagini: i dipinti naturalmente, ma anche i murales di Diego Rivera, i filmati in bianco e nero dell’America degli anni Trenta e Quaranta, le lettere e le pagine del diario della Kahlo, il volto di Mae West, definita da Frida la più straordinaria machine a vivre. Dopo The Busker’s Opera da John Gay (2001) e la trasposizione in opera lirica del 1984 di Orwell (2005), il lavoro più significativo di Lepage è Le projet Andersen, commissionato nel 2005 dal governo danese per celebrare il bicentenario della nascita di Hans Christian Andersen. Lepage è nuovamente solo in scena ad interpretare diversi personaggi che ruotano intorno a quello principale, chiaramente autobiografico: un giovane canadese che si ritrova a Parigi per realizzare, su commissione dell’Opéra, un libretto per bambini basato sulle fiabeLa driade e L’ombra di Andersen. Al frenetico susseguirsi di situazioni, personaggi, ambienti metropolitani (i telefoni pubblici, l’Opéra Garnier, i vagoni di un treno, il Bois de Boulogne, le salette di un “peep show”, l’Esposizione Universale del 1867, una discoteca, una stanza da 107 letto) e piani temporali, fa da sfondo il tema della solitudine, che adombra l’inappagamento sessuale del protagonista. Tuttavia lo spettacolo è divertente e ironico e dispensa una gustosa satira al sistema dello spettacolo. Gli elementi di maggiore interesse sono ancora una volta scenografici, a supporto di una performance attorale che ricalca l’automatismo della macchina scenica. “Spettacolo divertente e malinconico, fra soap opera, cabaret, coreografia, immagini virtuali, installazioni. Come in tutti i lavori di Lepage, ritroviamo lo spazio sempre in movimento, il tempo che va avanti e indietro, il delirio tecnologico, gli effetti visivi e sonori, la babele di lingue e le contaminazioni musicali” 19. I più recenti progetti teatrali di Robert Lepage, con la compagnia Ex Machina, sono Lipsynch (avviato nel 2007 con una prima rappresentazione ma ancora in progress) e The Blue Dragon (2008). Il primo è un’indagine sulla voce, considerata basilare nella comunicazione umana ma spesso confusa con il linguaggio tout court, che il regista esplora in diverse manifestazioni, dal pianto di un bambino alle voci registrate ed elaborate al computer. Il lavoro prende spunto dalle vicende di diversi personaggi, che si intersecano – come spesso avviene nelle opere di Lepage – mentre le rispettive voci sembrano voler ricercare la propria identità all’interno di una storia collettiva. The Blue Dragon, invece, si riallaccia idealmente a La Trilogie des Dragons, la qual cosa ci spinge ad immaginare l’insieme dell’opera di Lepage come un grande organismo sincronico. Col pretesto di seguire, vent’anni dopo, uno dei personaggi del precedente spettacolo, ci viene mostrata un Cina contemporanea molto high-tech, dove la sensualità di una danza dal sapore antico si staglia su luminescenti sfondi digitali. Mentre Lepage è impegnato a riprendere, ciclicamente, diversi spettacoli del proprio repertorio, il suo ingegno trova altre declinazioni nella musica, nel cinema (come interprete), nel circo e ultimamente anche nella danza: con la danzatrice Sylvie Guillem e i coreografi Russell Maliphant e Akram Khan sta lavorando al progetto Eonnagata (di cui esiste già un video), che unisce suggestioni europee e orientali e che vedrà i risultati nel febbraio 2009. Ma prima di allora, la notte del solstizio d’estate del 2008, per celebrare il 400esimo anniversario di Québec City, avrà luogo The Image Mill, una delle più imponenti spettacolarizzazioni ambientali mai realizzate, di cui Lepage sarà regista. A ridosso della chiusa del Bassin Louise, sull’enorme facciata del Bunge Grain Elevators, saranno proiettate immagini in tre dimensioni sul passato, il presente e il futuro del capoluogo del Québec. Sarà uno spettacolo di luci che unirà le suggestioni dello skyline a quelle della light-art 20. Sarebbe riduttivo trovare una formula per definire un lavoro così complesso e “fluido” come quello di Robert Lepage. Certamente si tratta di un teatro che ha saputo cogliere e declinare la complessità del contemporaneo guardando, 108 foucaultianamente, ad un archivio-laboratorio dei saperi e delle forme che sarebbe piaciuto anche a Benjamin. L’attenzione per il frammento, il focus sui dettagli, lo sguardo eccentrico e la commistione dei generi che abolisce qualunque gerarchia delle arti e dei saperi, ma soprattutto il ritrovato piacere dell’immagine per l’immagine, sono i fondamenti di questo lavoro. Tra uno spettacolo e l’altro, nel 2000 Lepage è stato chiamato ad allestire la singolare mostra Métissages presso il Musée de la Civilisation di Quebec City. Quella mostra – dove confluivano suggestioni diverse, dalle Wunderkammer al pre-cinema – sembra restituire, più di qualunque sfuggente descrizione, il senso profondo dell’opera di Lepage. Una grande installazione accessibile ai visitatori, dove si intrecciavano arte, filosofia e scienza a dimostrazione che non esiste uno specifico dell’arte e dei linguaggi, una presunta purezza delle forme. Lo spettatore si avventurava all’interno di una grande Torre di Babele con tante finestre aperte su altrettanti teatrini dell’immaginario, al sommo della quale si trovava una piscina a forma di cuore, dopo avere incrociato un tappeto di sacche di sangue, una tecnologica foresta luminescente, un teatro anatomico e un immenso Cabinet de Curiosités. La mostra – una sorta di archeologia vivente dell’immaginario occidentale – provocava al visitatore una sensazione di spaesamento, che suscitava allo stesso tempo l’inquietudine del perturbante di freudiana memoria e il fremito irresistibile del sublime. 1 I. Wardle, “The Times”, 29 luglio 1987. Cfr. C. Hébert, I. Perelli-Contos, L’écran de la pensée ou les écrans dans le théâtre de Robert Lepage in B. Picon-Vallin (a cura di), Les écrans sur la scène, L’Âge d’homme, Lausanne 1998, p. 175: “Il théâtre visuel tenta di fare dell’immagine il medium determinante, che permette di “accedere” a un mondo invisibile dove la parola non è più attuale, ossia ad un mondo del pensiero sensibile che non si carica del peso del logos né del cogito cartesiano”. 2 J. Collet, Caméra in AA.VV., Lectures du film, Albatros, Paris 1975 [ed. italiana : J. Collet, Attraverso il cinema, Longanesi, Milano 1981, p. 31]. 3 4 Cfr.: R. Tomasino, I cavalieri del caos, L’Epos, Palermo 2004, pp. 108, 134. 5 A. M. Monteverdi, Il teatro di Robert Lepage, BFS edizioni, Pisa 2004, p. 45. 6 F. Quadri, Il Patalogo 23, Ubulibri, Milano 2000, p. 101. 109 7 U. Volli, “la Repubblica”, 5 marzo 2000. 8 M. Coveney, “The Observer”, 9 dicembre 1990. 9 F. Quadri, Il Patalogo 14, Ubulibri, Milano 1991, p. 251. 10 J. St-Hilaire, “Le Soleil”, 17 ottobre 1991. 11 A. M. Monteverdi, Il teatro di Robert Lepage, cit., p. 57. B. Picon-Vallin, Hybridation spatiale, registres de présence in B. Picon-Vallin (a cura di), Les écrans sur la scène, cit., p. 26. 12 Cfr.: A. Lavender, Hamlet in Pieces. Shakespeare reworked by Peter Brook, Robert Lepage, Robert Wilson, Continuum, New York-London 2001, p. 95 e sgg. 13 14 Ibidem, p. 104. Cfr. F. Quadri, Robert Lepage: Elsinore al computer in Il Patalogo 19, Ubulibri, Milano 1996, p. 183: “Fratta e ricongiunta nell’immagine riflessa di un muro di mattoni, la scenografia si rinnova così continuamente, dall’astrazione all’estrema concretezza, dalla citazione di Delacroix alla vetrata d’epoca, con effetti luministici rubati alla pittura seicentesca, mentre agli enormi ingrandimenti dei personaggi risponde lo stagliarsi dell’uomo rinascimentale di Leonardo o di quello contemporaneo in movimento fissato dall’obiettivo di Muybridge: un effetto di profondità e di spazio degno del “mondo fuor di sesto” di cui si cerca il senso”. 15 R. Lepage in R. Charest, Quelques zones de liberté, L’instant même/Ex Machina, Québec 1995, p. 205. 16 A. Costa, La morale del giocattolo. Saggio su Georges Méliès, Clueb, Bologna 1989, p. 102. 17 18 Idem. 19 P. Cervone, “Corriere della Sera”, 11 febbraio 2006. 20 Cfr. R. Tomasino, I cavalieri del caos, cit., pp. 25 e sgg. e pp. 144 e sgg. 110 Mitologie Pop 1. Idoli afro-dadaisti 2. L’ascensione di Mercury 3. Rock Hamlet (il duca bianco) 4. “Voltificazione” cartoon (Nina Hagen) 5. Leonessa teriomorfa (Tina!...) 6. Scalarità della luce: gocce di lacrime e sudore 7. Scalarità delle nebbie: exitus con sigaretta (Zappa) 111 112 113 114 115 116 117 118 Madonna : La star della visual performance di Alessandra Costanza Louise Veronica Ciccone nasce a Bay City nel Michigan il 16 agosto 1958.Il padre Tony Ciccone è di origine italiana,mentre la madre, Madonna Louisa Fortin ,era franco-canadese.All’età di 6 anni, Louise Veronica perde la madre. Questo evento ha avuto un grande impatto nella sua vita ed è spesso citato nelle sue canzoni. Lo sconfinato affetto che Louise aveva nei confronti della madre la spinge a portare il suo stesso nome: Madonna. La stessa artista,in seguito dichiarerà su quel triste episodio della sua vita: “ Quel periodo mi ha lasciato la fortissima sensazione di vuoto da colmare.” Così Madonna Louisa Veronica Ciccone diviene cantante, attrice e produttrice discografica.Con oltre 280 milioni di dischi venduti, è ritenuta l’artista femminile di maggior successo nella storia della musica. È stata, ed è tuttora in grado di influenzare (ma anche di creare) le nuove tendenze musicali, tanto da essere soprannominata la “Regina del Pop”. Inoltre, i suoi innovativi quanto provocatori video musicali, la rendono l’artista più quotata su MTV. Alla carriera di cantante, Madonna, ha affiancato quella del cinema, prendendo parte a diversi film e quella del teatro. Nel 1992 ha fondato la casa di produzione Maverick Records, con cui ha prodotto i lavori di artisti quali Alanise Morissette, Michelle Branch e i Def notes. Nel 2003 ha scritto una collana di libri per bambini.Autentica superstar di una categoria a sé, Madonna ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo con la sua camaleontica capacità di trasformarsi continuamente. Si è imposta come la “Madre della Reinvenzione” Esaminando la sua carriera artistica si può notare la sua evoluzione di visual performer in ogni aspetto dell’arte e della vita, seguendo il percorso dall’esplosivo look streat punk degli esordi al controverso mix di immaginario erotico e religioso, fino all’uso pionieristico del video e di Internet e alle produzioni colorite e sofisticate che oggi sono il suo forte. Il particolare fascino di Madonna deriva da una combinazione programmata nel minimo dettaglio, tra musica, movimento e abbigliamento sia sul palcoscenico che nel videoclip. L’artista gioca con i tabù ed i cliché più comuni, presentando il suo corpo come qualcosa di estremamente “sessualizzato” e nello stesso tempo costruito. Quel corpo non è “naturalmente femminile”, ma è il risultato di aerobica, body building, danza e diete: tutto questo non viene nascosto ma messo in mostra. Madonna, infatti, meglio di qualunque altra star, impersonificava il credo anni Ottanta secondo cui era possibile modellarsi e diventare ciò che si voleva; che le diete, il culturismo ed altre forme di esercizio fisico fossero i mezzi idonei per arrivare alla meta: raggiungere un “io” ideale, 119 che significava un corpo ideale.Ma un corpo, anche se ideale, non basta a creare una buona performance. IL vestito appare dunque il carattere necessario,una pelle simbolica,che rende il corpo del performer un “corpo rivestito”.Il trucco, la maschera, l’abito sono rimedi al vuoto che abita il soggetto,sono veli rispetto al reale, alla morte, alla castrazione.Contrariamente agli altri show business, Madonna non si identificò mai con una determinata immagine, ma l’assumere sempre nuovi e sorprendenti ruoli diventò il suo marchio. IL corpo della star assume così un alone simbolico,la sua figura si carica di eccesso di significazione,una potenzialità connotativa che diviene veicolo di seduzione irresistibile,dando avvio a forme rinnovate di feticismo. Il processo di costruzione dell’immagine di star di Madonna si serve del videoclip come mezzo primario ma ha il cinema come modello. Sfruttando l’appeal e la pervasività del videoclip, la performer nel suo divenire icona musicale assume un carattere fortemente mitico, dunque sostanzialmente narrativo. Madonna ha fondato buona parte del suo successo artistico e commerciale sulla commistione di realtà e finzione, sulla costruzione della propria storia di artista, sul backstage di una carriera rapidamente trasfigurata in leggenda.Attraverso questo lungo ed intenso lavoro di costruzione del personaggio e continuo processo di manipolazione fisica e tecnologica, Madonna diviene una star: la star della visual performance. Come ogni diva che si rispetti, il suo corpo non abita nessun tempo e nessun luogo: la sua immagine è l’assoluto. È un’icona sacra, un’immagine trionfante, simile a quella delle icone bizantine, lei è ciò che il suo look manifesta, una sciamana per eccellenza, lei è Dea di Bontempelli e cambia personalità a seconda dell’abito che indossa, è la prostituta e la santa, è il ricordo di sua madre, è il “manque“, il desiderio inappagato, inconfessabile ed inappagabile, è Grimilde, la matrigna di Biancaneve e lo schermo è il suo specchio, attraverso il quale incontra, incita, richiama lo sguardo di uno spettatore voyeristico che serva al suo riconoscimento desiderato. È la paura angosciosa dell’assenza senza fine, è la sublime volgarità di un’esibita e sfacciata divaricazione del décor e del corpo, ma è anche, soprattutto, una merce. Non esiste centimetro del suo corpo, fibra della sua anima, ricordo della sua vita, che non possa essere messo sul mercato. È una merce totale: la merce tipo del grande capitalismo e quindi gli enormi investimenti, le tecniche industriali di realizzazione e di standardizzazione del sistema ne fanno un prodotto destinato al consumo di massa. Madonna ha tutti i pregi del prodotto di serie adottato dal mercato mondiale come il chewin-gum, il frigorifero, il sapone da bucato e così via. La diffusine di massa è assicurata dai più grandi moltiplicatori delmondo moderno: stampa, radio, TV, videoclip e naturalmente cinema.Il critico rock Piero Scaruffi così sintetizza il fenomeno 120 Madonna: “È una delle ultime grandi performer in cui arte e vita si fondono e confondono. Il piglio sarcastico e nichilista del suo rhythm and blues, benché sposato ad arrangiamenti tecnologici e produzioni miliardarie, riflette l’atteggiamento casual e amorale di tanta gioventù bruciata dei ghetti intellettuali, facile tanto alla vita di strada quanto al glamour del successo.La sua - continua Scaruffi - è una personalità drammatica, che è cinica e distaccata secondo i nuovi costumi giovanili, forte di un retroterra di promiscuità sessuale e di precoce indipendenza. Nato all’incrocio fra civiltà punk e civiltà disco, e testimone della rivoluzione del costume degli adolescenti, il mito di Madonna non è che un aggiornamento della figura dell’eroina romantica e fatalista”. 121 Live: iconologia della star 1 di Renato Tomasino 1. L’attesa Lì sul palco, in controluce, le sagome nere degli strumenti musicali e dell’apparato tecnologico sembrano un’istallazione dada o cubista. C’è infatti il sortilegio che promana dagli idoli africani in questo profilo di sottili, acuminati ritagli fallici in nero; tutta l’avanguardista scomposizione dei volumi nel décalage tra i diversi profili; ma per una visione postmoderna potrebbe anche trattarsi di sagome di robot o cyborg, in ogni caso di epifanie post-umane “senza organi” sorprese in momentaneo riposo. L’attesa freme nei cori del pubblico, nei fischi, nei battiti delle mani e delle file di talloni sulla platea che ritmano l’invocazione tellurica, ctonia, di un’oltranza. È già rito. È già spettacolo. Quello stesso profilo frastagliato dell’accumulo tecnologico è già spettacolo. Ora, altre nere sagome appaiono umane e, sortite dalle quinte, vanno a posizionarsi ognuna presso un ritaglio di quello apparato strumentale, ognuna elabora con quello delle nuove e difformi creature in cui si traduce nella forma un’ipotizzabile sintesi di biologico, meccanico ed elettronico. Non diversamente, lo show ha già avuto inizio, è già lì da sempre, nei Sei personaggi pirandelliani, o in un happening del Living o dell’Open che nasce non si sa come dal training, insomma in ogni pratica che ritorni al rito ed ai suoi accoliti officianti. Infatti, nella controluce, rulla il suono sempre più forte come accadeva ai tamburi delle consorterie esoteriche, e con quello s’accresce il battito delle mani e dei piedi. E tra i battiti crescenti, l’innesco di un riff ben noto scatena deliranti ovazioni in un mix di frastuono parossistico. Ed eccola apparire la star, lei in silhouette!...Si staglia nella sua piena perfezione di contorno riconoscibile, come evocata e costretta ad apparire da quel prolungato frastuono inaugurale della platea, da quei rullii del palco. L’ovazione esplode allora istericamente, come da una folla di posseduti. Di contro, un ritardo nell’apparizione provoca improvvisi silenzi ed istanti di sgomento, l’imbarazzante sensazione del vuoto; ma se l’attesa per un qualsiasi motivo si prolunga, ecco che riprendono i battiti delle mani e dei piedi ma accompagnati da fischi e motteggi, e perfino insulti alla star assente...nel tentativo di esorcizzare il mancato effetto augurale dei segni d’attesa, lo spezzarsi del circolo propiziatorio. Non diversamente Amaterasu, il sole, invocata, insultata, derisa, dal fondo della sua caverna apparve alla danzante Uzume ed agli altri dei shintoisti nello spettacolo delle origini. Eccola dunque. Nella persistente controluce dell’antro scenico, della star non si distinguono i tratti né il volume, ma solo la chiusura infallibile del suo contorno, quel suo disporsi tutta nella superficie che la rende incorruttibile e 122 immortale. Appare dal fondo, salendo dai gradini del retropalco, prima la testa..., oppure emerge da una botola...Si erige infine sul limitare più interno del palco, là dove il virtuale punto di fuga tende a innalzarsi, occupando la posizione dunque dell’oggetto del desiderio, il lacaniano oggetto d’appoggio (cfr. Seminario libro XI) alla traiettoria della pulsione scopica: è l’oggetto del piacere della visione che rilancia quella traiettoria verso un’oltranza che tende a collocarsi sempre più in fondo, un’ oltranza metafisica dietro la scena e matrice della scena. Quella silhouette, allora, attira e rinvia alla trascendenza da cui la scena origina e per cui la scena è il cosmo stesso, ed alle conseguenti liturgie di un rituale epifanico. Quella silhouette infatti non può darsi senza un alone che si staglia nell’ombra: emerge dal nero e sul nero si ritaglia nel suo contorno alonato di luce. Ha a che fare, perciò, con lo zombi, il “non morto”, con l’antenato che ritorna minaccioso ed insieme benevolo, ma reincarnato nel giovane eroe; è l’emersione da un’oscurità generatrice, dal buio in cui tutto può accadere e da cui tutto può ri-nascere. È inaugurazione di un teatro delle ombre che costringe allo sguardo frontale e nega allo sguardo profano il retroscena, la “cucina” del sacro di barthesiana memoria (cfr. Sur Racine); teatro delle ombre che tuttavia a quel retroscena rinvia, là dove l’eroe ha avuto commercio con il Dio Padre e, da inanimato che era, è ritornato da lui segnato alla vita, a questa vita di pura sagoma senza volume. Non diversamente appare la silhouette di Gilda, emergendo dall’ombra, stagliandosi nel cerchio di luce di un “occhio di bue” in apertura che dall’ombra la estrae al leit-motiv di Amado mio. Così la silhouette, originata dall’ombra, va incontro alla luce del mito, per sempre, sottraendosi al destino della corruttibilità. È noto che da allora in poi Gilda e Rita hanno intrapreso strade diverse; ma, come potè testimoniare il medesimo soggetto reso ormai duale, alla moltitudine planetaria dei fedeli non importava nulla di Rita, di un preteso “reale che ritorna sempre al proprio posto”, ma importava solo di Gilda, dell’immaginario, quindi di ciò che non ha bisogno di tornare perché assolutamente è, di ciò che del preteso “reale” fa niente altro che lo sfondo, e la controluce, la drammaturgia implicita che gli consente di vincere sul volume per stagliarsi soltanto nell’erezione della sua silhouette. Così, nel live rock e pop emergere dall’ombra è una costante. I Led Zepppelin facevano sempre ricorso a questa tecnica per iscriversi perentoriamente nel mito all’inizio di ogni loro apparizione, in tal modo metaforizzando nel contrasto luce-ombra che definisce le loro sagome il tripudio superumano del manifestarsi delle loro tecnologie e delle loro energie. 123 2. La silhouette È estrema la silhouette, spudorata, d’altra parte si installa sulla scena come erezione fallica della pulsione scopica, ovvero come anamorfosi causata dalla tensione desiderante (cfr. di Lacan La significazione del fallo e molto altro); in sostanza tout court come prospettiva, da sé sola, anche in assenza di qualsiasi elaborazione prospettica dello spazio circostante. Se è “maschile” si modellerà nell’estensione delle spalle, nel rigonfio delle cosce, nella quasi decapitazione di una testa che si raccorcerà tutta a culmine convesso della possanza del tronco, in una erezione piramidale strutturata e gerarchica. Se invece è “femminile” si volgerà lentamente dal fronte a clessidra fino al profilo o al semiprofilo sinuoso, e viceversa – a volte posando in una immobilità marmorea grazie ad una piattaforma girevole - e perciò disegnerà una dinamica “esse” indecorosa; una “esse” che offrirà le sue accentuate nuances innaturali come feticci, molteplici e opposti sostituti fallici di quell’unica erezione totalitaria ed ortopedica che è in vece la silhouette “maschile”. Di tal fatta appaiono nella performance le silhouette sinuose, ed insieme piene di sé per estrema tensione, di Shakira e Beyoncé non a caso insieme in un clip speculare, elaborato secondo strategie analitiche che lo hanno predisposto al trionfo planetario: Beatiful Liar (2007). Ma nell’uno e nell’altro caso, il “maschile” e il “femminile”, la silhouette appare come definita artificialmente, come manipolata dalla visione in un formato “scope” cui ci si è dimenticati d’applicare la lente di compressione. Il suo respiro poggia sul generoso mantice del petto, il suo plesso è incavato ma palpitante e turgido, i gomiti piegano le braccia all’indietro ed estendono la complessione delle spalle, i pugni si chiudono energici ma dietro le voluttuose linee della figura...e il primo passo allunga la gamba come fanno i felini: la silhouette “sa” nella sua pratica tutti i possibili manuali di Delsarte e di Decroux le significazioni energetico-simboliche del corpo. Tutto lo spazio, infatti, si trasforma e si riorganizza in virtù della sua apparizione, e assume una splendente evidenza che è articolata dalla pulsante tensione perimetrale di lei, dal suo movimento esatto, dal suo gesto preciso. Di conseguenza dal dinamico gioco perimetrale della silhouette si dipartono anche i tracciati di ogni comunicazione e di ogni empatia con il pubblicovoyeur secondo un rigore geometrico e matematico che esteriorizza ogni interiorità e ne fa “scena”. Ma c’è una fondamentale differenza tra siffatta epifania e quelle postulate dalla tradizione teatrale colta che va dalla “supermarionetta” alla Craig ai bioritmi di Majerchol’d al marionettismo cubo-futurista ed al geometrismo schlemmeriano, fino per l’appunto al “mino astratto”di Decroux. E la differenza non consiste nel rigore e nel training. egualmente ardui e mirabili, ma nello spostamento del baricentro più in basso, dal tronco al “plesso solare”; con la qual cosa la silhouette del live pop recupe124 ra, rende vistose ed amplifica nello spazio le pulsazioni dell’Eros e dell’assolutezza totalizzante ed androgina del femminile, e con questa un’implicita ritualità propiziatrice e rigeneratrice in quei citati maestri del tutto assente, e infine riattiva un’orgasmica “estetica del piacere” altrettanto rigorosa quanto quella del “dispiacere” che è stata instaurata, nell’ambito del persistente vittorianesimo, dal maschilismo alla Craig. L’umanità del pop è fatta solo da “uomini da salone”, secondo la definizione di Decroux. e quindi da dei, eroi mitologici ed aristocratici in posa, mai da manovali della fatica o da schiavi (della regìa) alle quali si sottintendono appartenere le altre categorie mimico-umane (sempre di Decroux). E se c’è dell’esibizione di fatica, essa produce il sudore divino di Ercole e, insieme, essa parte dal lavoro incessante e scabroso del plesso di Afrodite, con ciò risarcendo il femminile come assoluto scenico (anche quando si tratti di un uomo o presunto tale) e contrapponendosi, rivoluzionariamente, al conservatorismo maschilista delle avanguardie e dei professori che se ne occupano. Logico che l’approdo non sia, alla fine il “corpo senza organi” di ArtaudDeleuze, ma il corpo che si esteriorizza soltanto nella piega, che si svolge graficamente nella “piega di pieghe” di Leibniz-Deleuze; ovvero si svolge in quel femminile esibito e disciolto che è ogni barocchismo, e di fronte al quale la nostra visione non può che essere una deriva, un’improduttiva dissipazione del piacere e di piacere sul leit-motiv del Thanatos, di un “oltre” inesplorato del soggetto scopico (si veda, ovviamente, il freudiano Aldilà del principio di piacere e i commenti di Lacan). Spesso accade che la silhouette “maschile”, quella “femminile”, si evolvano l’una nell’altra nella dinamica dei loro tagli in controluce, e dunque si femminilizzino o si virilizzino attingendo a quella indecidibilità che è data – insegna Platone (Simposio) – dalla loro stessa pienezza. Ma anche quando ciò non accade, è a tutti evidente che la silhouette maschile reclama il sacrificio attraverso la violenza imposta dalla moltitudine dei fedeli, lo smembramento di Dioniso o di Osiride, la brutalità sodomita che spezza la purezza come nei torreggianti giovani marinai di Kenneth Anger, bianchi e lattiginosi. Ed è evidente che la silhouette femminile, per quanto di per sé scissa e dispiegata nelle sue nuances in pubblico offerta – nuances sorrette da un Dio padre sadico al bando d’asta della sacra prostituzione – proprio per questa costrizione alla “volgarità” può pericolosamente aggredire con quelle stesse nuances, sfiancare, possedere senza posa con la virilità più oltraggiosa. Insomma, in un modo o nell’altro, in definitiva è l’androgino sempre di scena; l’androgino che si autogenera in perpetuo, che si soddisfa da sé, ma scatenando ogni perversione del desiderio in quell’alterità - con la “a” minuscola – che è il pubblico; usando di questa per-versione - “Version vers le Père” diceva infatti Lacan – suscitata per compiacere il piacere di se stesso, 125 cioè proprio quel commercio con l’Altro, - stavolta con la “A” maiuscola – che lo traccia nella sua piena androginia. Di tal natura è la silhouette: regale. Del resto essa fu vanamente tentata quando le rane vollero un re, ed una di esse si gonfiò a tal punto – per assumere la dignità incorruttibile e piena di sé della natura regale - da scoppiarne. Ma un attimo prima della deflagrazione del corpo in mille elementi, elementi eterogenei di pelle lacerata, nervi, scheletro, sangue, interiora, cibo ed escrementi, tracciati di organi interni, epiteli e mucose in un caos della corporeità tornata alle origini, un attimo prima l’esito perfetto era stato raggiunto, ed era il cosmo. Se solo la rana avesse saputo fermarsi in quel punto miracoloso della tensione estrema possibile, impossibile, la stessa tensione dei palloncini ossessi di Marco Ferreri!...Su quel bilico, là dove una “e” la separa dall’orrore primigenio, dal caos del corpo spezzettato, si tende la silhouette. La favoletta, vera e terrificante come tutte le favole, ci dice che è facile attingere alla tesa, compatta perfezione della silhouette, e che pressocchè impossibile è riuscire a farla durare. Occorre uno snervante addestramento, presupposto indispensabile di una maestria sublime – insomma quel che le nuove avanguardie fisico-gestuali, hanno chiamato il “training”, un training sia corporeo che psichico – perché si ottenga quell’esito in maniera così salda da poterlo ripetutamente incarnare ed esibire all’adorazione di un pubblico di fedeli. Molte volte, quando si dispregiano degli spettacoli perché privi di contenuti o messaggi, o perché pur nel proporli si mostrano “politicamente scorretti”, oppure – motivazione più colta e insidiosa – perché non manifestano un qualsivoglia “costrutto dell’arte”, un’elaborazione del linguaggio specifico...beh, molte volte si trascura proprio che in quegli spettacoli, così dispregiati dai critici e dai pedagoghi addetti ai lavori, è la silhouette ad essere trionfante e a costituirne l’unica vera motivazione o quasi...Se consideriamo la maestria che ha dovuto incarnare la star. nel corpo e nella mente, per raggiungere quel perfetto esito di tragica precarietà ma di mitica valenza – e ciò grazie al suo crudele lavoro sacrificale o a quello del regista su di lei esercitato sadicamente – bene, allora, dobbiamo concludere che anche quel dispregiato spettacolo può attingere al sublime. Se non lo si riconosce è per autoritarismo pedagogico e moralista, è per la famigerata pruderie che impone il principio dello “utile dulci”; è perché la forma pura è sempre spudorata nella sua imperiosa domanda di riconoscimento e d’adorazione senza contropartita: si impone con la volgarità dell’evidenza, imbarazza e inquieta, seduce e incatena a sé come ad un fantasma dell’ossessione; e dunque la forma pura non rafforza il soggetto dell’ossesso con alcuna protesi che tenda ad una valorizzazione sociale del soggetto medesimo, piuttosto lo consegna alla deriva della sua dissipazione, la deriva 126 stessa della “libido”, dopo essere passata per gli occhi ed avere travolto il regime della vista da oggetto insopprimibile della “pulsione scopica”. Per questo motivo di interessato utilitarismo economico-sociale, di economia del soggetto intesa come eugenetica del soggetto, la seduzione – ha osservato Baudrillard – subisce nella nostra epoca, pure assai “permissiva” in funzione del marketing globale, il più radicale e generalizzato degli interdetti, il silenzio sprezzante o l’aggressione parossistica degli esperti, dei media, del costume sociale, perfino delle pianificate strategie della moda, e diremmo anche degli artisti ed intellettuali (se non dovessimo fare delle cospicue eccezioni che, per esempio, vanno da Ado Kirou a Baudrillard, da Jesus Franco a Tarantino, da Warhol a Lachapelle, da Lepage a Madonna...). Si tratta, essenzialmente, di aggressione o spregio verso la volgarità “banale”, ovvero “balenante”, della silhouette, verso la seduzione spudorata della forma senza principi. Molta “spazzatura” la dichiareremo, per converso, sublime. Non segnaleremo opere d’arte riconosciute universalmente per alte strategie di contenuti e di linguaggio, le quali tuttavia elaborino secondo noi soprattutto procedimenti seduttivi della forma pura; ci limitiamo al momento ad esempi di sublimità-trash. Primo premio assoluto a Critos en la noce di Jesus Franco (1961) per le sue donnine equivoche “belle époque” tutte décolletés turgidi in offerta, vitini di vespa, fianchi rotondi fasciati dalle grinze luminose e fruscianti del satin troppo aderente, ed allusive bocche a ventosa lucide di lacca; donnine cui il solito sadico sottrae alla lettera la pelle con il suo bisturi lucente...cui dunque sottrae proprio la tensione compatta della superficie, la forma spudorata e colpevole...sicché, alla fine, con la lama affilata prende ad incidere tra pelle e carne, ovvero superficie e volume, della stessa eroina. Questa è, naturalmente, una brava ragazza che per smascherarlo si è agghindata da equivoca – duro training... - ovvero da silhouette, la sinuosa “esse” del femminile, la sinuosa “esse” tesa androginicamente dai sostituti fallici esibiti dalla sua nuova configurazione. Punizione perfetta, dunque, per una brava ragazza che, avendo attinto volontariamente alla forma spudorata, avendo fatto di sé l’oggetto scopico, ha sollecitato insieme gli immaginari codificati della “fanciulla perseguitata” e della “femmina perduta”; immaginari, d’altronde, dalla stessa vistosa vittima già teorizzati con le parole della sceneggiatura ed i comportamenti nel plot. Finisce come doveva inesorabilmente finire: l’amoroso di turno salva la procace ma virginale fanciulla, cui forse della brutta avventura resterà solo quella piccola cicatrice di bisturi sul viso da puttana santa – un vero peccato, comunque...- che si può esserne certi, si rimarginerà. Poiché l’immaginario sadico – lo ha spiegato Barthes – e di tal natura che pretende la rigenerazione della vittima bella, intatta da lacrime e perdite, disordini e sciupii, in sostanza la ricomposizione della forma fino alla spu127 dorata perfezione, fino a quell’imbarazzante esibizione di sé che sollecita di nuovo il castigo e i tormenti, nel gioco senza soluzione tra Eros e Thanatos. Ripescato dal trash, Critos en la noce è dunque un capolavoro, dato che realizza per il puro piacere della vista un manuale analitico di quel che andiamo qui esplorando: il rapporto tra lo spettatore e la “sua” silhouette, “sua” in quanto appartiene ad una mania collettiva che è solo “sua”. Venga espresso dal plot, come accade nel “capolavoro” di Jesus Franco, oppure resti del tutto implicito in sintomi evidenti della relazione tra lo spettatore e la sua visione, questo pendolo tra Eros e Thanatos, forma e distruzione, è quel che in ogni caso il potere della silhouette alimenta. Gli esempi filmici potrebbero essere infiniti, a partire proprio dai quattro cavalieri dell’Apocalisse in questo numero di The Rope assunti a nucleo rovente del tema tendenzioso della “nuova figuralità”: Rodriguez, Tarantino, Snider, Miller. Fino a retrocedere con la memoria alla sinuosa Gilda, che esibisce nella sua danza lasciva la condanna inflittale dal sadico Glen Ford ai bollori roventi della castità forzata; al mitico efebo Marlon Brando sconciato da una virile teppa brutale in Fronte del porto, Il selvaggio, La caccia (dove la teppa è per giunta borghese e custode dell’ordine morale); più indietro, alla giovane madre di Eizenstejn – dalla camicia di velo latteo, gonna e giacchino di nero merletto – che nello spasmo della morte preme le mani alla fibbia della preziosa cintura in filigrana che le serra il vitino, e deforma nella “o” allusiva della fellazio le turgide labbra laccate di rosso. Ma queste, si dirà, sono opere d’arte e per ben altri motivi. Forse lo si potrà dire ancora per La legge di Dassin (1958), dove la procace Lollo è legata su di un tavolo da cicina e meritatamente scudisciata da rustiche megere invidiose sui culmini troppo volgari della sua palpitante silhouette. Con qualche sforzo si potrà dire ancora per la virginale principessa Liana Orfei, “giustamente” sottoposta in una stalla alle voglie della soldataglia mongola dato che le ogive dei suoi seni protendevano la sua mise aristocratica in un décolleté davvero svergognato, ammesso che I Tartari (1961) sia di Richard Thorpe o addirittura di Welles e non, come forse è, di un qualsiasi Ferdinando Baldi; lo si potrà dire per il pestaggio meticoloso e progressivo, protratto nel tempo da un gangster sadico, del viso da Barbie viziosa di Patricia Arquette, colpevole inoltre di indossare una microgonna leopardata aderente come una buccia, ammesso che Una vita al massimo (1993) sia dello sceneggiatore Quentin Tarantino e non dello spregiato “pubblicitario” Tony Scott. Ma lo si potrà dire ancora quando in Teseo contro il Minotauro (1960), dello sconosciuto Silvio Amadio, una mitologica casta Arianna – alias Rosanna Schiaffino – ansimando forte, sicchè i capezzoli bruni sembrano sul punto di perforare la seta del chitone, vede pericolosamente avvicinarsi alla guancia di raso il ferro rovente con cui sta per sfigurarla la malvagia gemella? ... Questa, per 128 licenza mitologica, è una sorta di Messalina che vuole ben a ragione restare l’unica proprietaria di un simile viso libidinoso, di certo non adatto ad una vergine... Ma rinunciamo volentieri pure al plot, oltre che all’arte, quando è di scena sua maestà la silhouette: in cento spregiate commediole all’italiana, il breve “giro di vita” di Giovanna Ralli – o chi per lei tra le “maggiorate” - turba ancora oggi i sogni spettatoriali ad ogni riproposta d’archivio, strizzato come è da un’alta e sgrigliante cintura di pelle lucida nera, torturato dalla grande fibbia metallica sul tenero plesso; non v’è chi non vorrebbe serrarla tra le sue carezze quella piccola circonferenza ...e, al tempo stesso, sformarla, slargarla, per sciupare l’effetto di tanta oltraggiosa procacità che da lì si disegna. Se si aggiunge la cotonatura che fa della chioma una pagoda, il profilo in allarme dei seni, la gonnellina così stretta da costringere a piccoli passi da geisha ancheggiante, è da filmetti italici come questi che la latina Amy Winehouse ha elaborato il suo look, molto più che da Hollywood; un look che ha trionfato nel 2008 attribuendo aura romantica, tenera e sacrificale alla bellissima star del pop-blues. Bene, inneggiamo allora a Tempo di villeggiatura (1956) di tal Racioppi e ad altre derive di siffatti “capolavori”, misconosciuti ma al servizio dell’immaginario... E, scendendo ancora più in basso, fino al famigerato trash comico-erotico anni settanta, chi non ricorda nel pasticcio lubrico di Nello Rossati lo chemisier di lino verde chiaro de La Infermiera (1975), alias Ursula Andress, così aderente da fare grinze prossime allo strappo nel sottolineare le forme generose; così sbottonato da fare emergere ad ogni passo cosce muscolose e, sopra, le dolci colline; così bollente da rendere liso il tessuto sotto le braccia in quei piccoli aloni violacei di bagnato evocanti un fantasma di perdita; sicchè l’algida nascita di Venere, dalla stessa Andress personificata in Licenza d’uccidere, impallidisce davvero al confronto. Qui non basterebbe lo scudiscio della Lollo per ridurre a brandelli l’attillato chemisier sanitario, per punire come si merita quella bambola impudica che con le sue procacità è impegnata a dare l’assalto al patrimonio di un vecchio riccastro da uccidere con eccessi d’amore...e, insieme, non basterebbero le mani per carezzarne tutti i contorni: ci vorrebbero la vista, l’olfatto, l’udito, il gusto, tutti i sensi in polimorfia...come accade agli eroi secondo Starobinski (L’occhio vivente), “tragici” solo perché pazzi di desiderio. Già, il mostro e la bella: un tema necessario all’erezione della silhouette e sempre sotteso! In quei trash anni ’70 i nostri comici strabuzzano occhi da polipo, profferiscono battutacce scatologiche, scorreggiano, defecano, burattini impazziti e grotteschi attorno alla bellona di turno che sembra non darsene per inteso, incontaminata. Così, già nella commedia dell’Arte la maschera, irrompendo dagli inferi, si dispiegava e spezzettava tutta in cento lazzi 129 osceni e andava a imbrattare di mille schizzi di vergogna la silhouette principesca dell’attrice che appariva lei sola senza maschera, altera e ignara, immobile e piena della sua grazia, mostrata dalle dinamiche scaltre tra posa e posa...La poverina, casta ancorchè appariscente, del tutto ingenua, avrebbe visto così rovinata la sua reputazione tra i crescenti schiamazzi del pubblico...non si sarebbe potuta mai più onestamente sposare, sarebbe stata costretta nella vita reale al degradante lavoro del marciapiede...ma il sacrificio della degradazione, la Servetta o la Colombina di turno in realtà lo compiva ogni sera e, per questo, accortamente s’agghindava per ore, provava e riprovava, ci dava sotto di cosmesi, profumi e coiffeur, per rendersi così sfacciatamente bella da meritare il sacrificio nell’immaginario spettatoriale. E di conseguenza si cominciava ad immaginare della sua vita privata sempre più lubrica, si tesseva la leggenda dell’equazione tra artista e femmina di malaffare da adorare e insieme da perseguire a norma di legge e di ogni morale. E dunque, ha radici antiche il gossip mediale di oggi sui vip, starlette e dive del pop, antiche e necessarie. Non si comportano dunque diversamente dai guitti d’allora i mostri alla Alvaro Vitali, il nano felliliano, e tutti coloro che l’avanspettacolo ha vomitato nel cinema: in Pierino contro tutti (1981, del “maestro” Marino Girolami) il finto bimbo Vitali giunge perfino a urinare facendosi reggere il membro da una bambola di maestrina che si chiama Michela Miti, del tutto inconsapevole, ma colpevole d’indossare una gonnnellina strecht e la blusa due misure sotto il necessario. Peggio per lei! E l’immaginario spicca il volo... maschilista, politicamente scorretto...poichè non si può davvero chiedere la “correttezza” all’immaginario. Ci mancano Michele Miti e tutte le sue simili, inghiottite dall’oblio dopo essere state marchiate a fuoco dai critici; oggi non più rigenerabili in assenza di maschere-mostri e di pratiche “basse” dalla commedia dell’arte, del varietà, dell’avanspettacolo, dell’alta professionalità della Cinecittà più povera, strafottente, oziosa e goliardica di allora...sotto la pratica di prestigio dei pochi autori e della “Dolce vita”!... Michela e le sue cugine erano le principali autrici dei loro piccoli capolavori, capolavori della corporeità figurale, dell’esserci, in cui riuscivano a trasformare nell’immagine un fatto di corpo; capolavori, dunque, non certo di cinema-film. ma di cinema-cinema. 3. Il corpo “figurale” tra le Arti Può apparire strano che sullo schermo possa avvenire un siffatto trasferimento della corporeità, ma non lo è più tanto se si pensa che la corporeità figurale del teatro – ciò che chiamiamo la flagranza - ha sempre aspirato alla bidimensionalità delle figura ed alla cancellazione del volume, della sua interiorità e delle sue viscere. La pornografia, invece, è volume, più precisamente rappresentazione della 130 bucalità del volume; e come la pornografia, lo è l’opera carica di contenuti e di messaggio. Ma non furono mai pornografiche la commediante Isabella Andreini nelle sue Follie in strip-tease o la bellissima prostituta-soprano Angela Veglia detta la Giorgina – che fu costretta in clausura solo per la sua esagerata beltà -, le avventuriere Lady Hamilton (alias Michèle Mercìer per Christian–Jaque) e Lola Montez (si veda la stupenda biografia della D’Agostaro sulla scia di Ophüls e di Martine), la flamenchista Otero e la chanteuse Lina Cavalieri (per noi ancora e sempre la Lollo di Leonard, più che mai silhouette), la spogliarellista Gipsy Lee Rose e l’eccelsa mima masochista Rita Renoir la figlia di Artaud, i cui tormenti sessuali immaginari sulla scena farebbero impallidire ancora oggi quelli fisici di una Orlan e di una Abramovic. Né lo furono mai, pornografiche, le loro eredi nell’arte del corpo che si fa immagine, filmica finalmente, e tesa nella bidimensionalità perfino nelle dinamiche,quali la ricordata Gilda fasciata di luce dal satin nero; Marilyn fasciata dal satin rosa della “material girl” scintillante, meretrice che si dichiara dietro ad un luccicorio come una gazza ladra; B.B. dalla mise da squinzia metropolitana, le labbra spropositate in una attitudine equivoca, la ruscellante chioma scarmigliata senza decoro e la fronte bassa, qualità della depravazione femminile già follemente agognate da Calderón de La Barca e dai pittori controriformati delle Maddalene. Fu allora infatti, nel ‘600, che si dette inizio ai nostri giorni borghesi di adesso, i giorni repressivi dei contenuti didattici, della pornografia e, per l’appunto, della messa al bando della seduzione, per una economica messa in valore sia dell’etica che dello spettacolo. Al contrario, tutte le creature di scena e di set sù ricordate, e molte altre ancora, erano inarrivabili nel tendere la corporeità al suo massimo effetto figurale, conoscendo le pose, la gestica e l’allure che fa del corpo sempre una figura in posa, sia statica che ancor più dinamica: Sapevano infatti l’arte di erigersi nella bidimensionalità del vuoto simulacro, sullo schermo dell’immaginario, oscuro boccascena teatrale o latteo telone filmico che fosse, superficie di seduzione in cui sempre possono disegnarsi in erezione anamorfica profondità insondabili. Conoscevano tutte costoro l’arte della replica perfetta, dimentica di tutta la carne del mondo e soddisfatta della sua capacità di sublime offerta seriale alla reiterazione del desiderio. Tutte costoro, dunque, furono di un “e” più accorte della famigerata rana, e si fissarono nella gloria, malgrado i loro tristi o avventurosi destini, e anzi grazie a quelli. Da questo punto di vista, poteva esserci a volte della gloria – sia pure dispersa al minimale, ed al netto delle pratiche di scena assenti – anche nei sodi glutei in tanga di veline e vallette del trash televisivo ai tempi del Biscione, nei loro seni a palla serrati dagli strapuntini a balconcino, nelle loro bocche laccate...L’affermazione oggi dello schermo piatto formato 16/9 – formato 131 che nessuno si cura di mutare quando si trasmettono vecchi film o show – rafforza quell’effetto iconico dilatando la zona toracica del protagonista di turno, star, show girl o anchor man che sia, schiaccia la testa e fa di ogni immagine l’icona di se stessa, rendendo il mezzo televisivo quello ideale per il voyeurista maniaco della silhouette. Così veline, starlette ed intrattenitori nel mercimonio TV di immagini mitiche evocano una qualche eco dell’antico sacrificio che fa del corpo un’immagine ed alimentano lo zapping come desiderio di accumulo di immagini sacrificali, collezione inesausta di santi; insomma mantengono un’eco di quella forma che è sapiente offerta masochista al sadismo dello spettatore. Ma è intervednuto l’interdetto eticosocio-didattico e queste qualità proprie in definitiva di ogni scena sono, invece, quasi del tutto assenti dagli odierni pornografici spettacoli tesi alla trasmissione edificante di messaggi e valori, gli spettacoli etici egemoni adesso sui Network e nella rete globale, ma già inventati dai philosophes illuministi e della rivoluzione borghese. Sia chiaro che non ce l’abbiamo però con il porno; notiamo che è semplicemente un’altra cosa. Ciò non vuol dire che la pornografia, come qualsiasi altro tipo di rappresentazione, non possa far ricorso alle pratiche figurali della seduzione, magari proprio per indurre il pubblico a scivolare nella “bucalità” che è il suo obiettivo. Può sedurre perfino il politico, il sociologo, il pedagogo e il prete, nel suo sanculotto talk-show etico-didattico, figuriamoci se non può farlo la star della pornografia quando sia veramente tale. Il fatto è che le star non si inventano; di dotate del massacrante training adeguato, anche solo del miracolo del naturale talento, ce n’è veramente poche: le Traci Lord – adolescente troppo procace dalla rigonfia boccuccia imbronciata e gli occhi a mandorla, sotto una chioma che sfida B.B. – non nascono come i funghi. E se Victoria Paris sarà ormai quasi vecchia, Jeanna Jameson rischia già di invecchiare. E oggi, poi, quella stagione hardcore di Beverly Hills sembra finita, così come sono finiti i registi sacrificanti sul set, da Stagliano a Damiano al partenopeo Salieri...Finita appare, d’altronde, nell’orgia trionfante di una pressappochista e laidamente accettabile lap dance universale, anche l’arte che pure riluceva ancora nei sordidi teatrini a luce rossa di Riccardo Schicchi, quando Eva Henger o Ilona Staller potevano a tratti apparire una Rita Renoir rediviva, splendendo di forma e di calcolata offerta di distruzione della forma, tra bave senili, turistici flash giapponesi e siparietti unti e sdrusciti. E di nuovo erano queste le belle tra i mostri. Avviandoci a concludere questa digressione sulle proprietà della “bella forma”, è comunque evidente che il cinema ha catturato e reso sincretiche le funzioni ostensive della pittura e delle arti figurative, poi quelle della “posa” fotografica, estendendole alla dimensione letteraria della narratività, dunque 132 trasformando la stessa narratività in una dinamica figurale in atto. Assumendo anche i corpi del teatro, il cinema ne ha realizzato l’aspirazione più antica e inaugurale, l’aspirazione alla ostensività; non a caso il processo ricorrente nel set va dai corpi alla loro lavorazione nell’immagine alla loro sublimazione nella dimensione epifanica del mito. E su ciò Michele Mancini ha lasciato analisi memorabili, come quella di Santi, Martiri e Registi. Ecco perché gli esempi addotti, che premono nell’immaginario in maniera del tutto faziosa, non possono che essere in gran parte di genere cinematografico. Questi esempi costituiscono, nel nostro caso, la bussola anche per il linguaggio e le pratiche del teatro, aiutandoci a distinguere da un lato il corpovolume pornografico e con esso il corpo-parola etico e psicologico, e dall’altro il corpo di pura ostensione, teso nell’armonia della bidimensionalità e tutto in epifanica offerta alla funzione scopica ed all’iscrizione mitica. Ed è questo ultima accezione inaugurale del corpo teatrale, e non altra, proprio la pratica privilegiata della pop-star, la sua fragilità sadomasochista e al tempo stesso la sua grandezza mitica esibite intenzionalmente allo spettatore. Non si può tacere, tuttavia, della funzione leader assunta in questi ultimi decenni dal fumetto, nel senso che questo linguaggio ha costituito il principale riferimento nell’aspirazione filmica alla ostensione della forma – per citazioni e rielaborazioni dirette, ma anche latenti e indirette – ed un ruolo di linguaggio specifico guida e di transito in ogni operazione di sincretismo tra le arti che sia tesa alla figuralità. Così, al di là del genere artistico in questione, ogni volta che si tenda a questo scopo, si potranno rinvenire strategie e componenti del fumetto nel plot, nei tagli di luce, nel décor, nel processo ostensivo di eroi ed antieroi, nel costume, nella composizione del quadro scenico, nelle dinamiche innaturali, nelle sonorità e nella lingua... Allora, se il wrestling privilegerà del fumetto le maschere e il costume o certe abnormi sonorità, la pubblicità i procedimenti ostensivi, e così via...E non è qui il caso, dato che ci porterebbe troppo lontano, di esaminare i molteplici rapporti, anche in termini di soluzioni tecnologiche e stilistiche, tra fumetto e cinema, dai diversi e più innovativi procedimenti di animazione alle estetiche degli “effetti speciali” fino alle contaminazioni in ogni genere cinematografico, anche il più tradizionale. Queste considerazioni sono comprovate dal ruolo che il fumetto ha assunto nella pop-art degli anni ’60 e ’70; ruolo esplorato e insieme teorizzato, per la ragione che per sua intrinseca filosofia la pop-art ha mirato a procedimenti figurali ostensivi e, al tempo stesso, alla serialità di quei procedimenti. Questo ruolo non è stato dismesso con l’avvento dell’iperrealismo e di ogni derivato della Pop-Art. Né va trascurato, nel nostro caso, che la pop-musica ed i suoi eventi discendono dalla medesima galassia “pop”, sia pure una galassia assai diversificata nelle sue lontane costellazioni. Negli eventi pop, dunque, potremo trovare esattamente tutte le 133 contaminazioni sù accennate. Quanto alla leadership assunta dal fumetto tra le strategie della figuralità, occorre mettere in conto alcune motivazioni congenite alla specificità di questo linguaggio: la progressione per “piani” spinge a configurare la composizione e l’equilibrio interno di ogni piano secondo evidenti funzioni ostensive; lo sviluppo del plot è dato da una dinamica di rapporti tra piano e piano, dunque tra le successive funzioni ostensive e ciò, inoltre, sollecita la propensione verso quel campo diegetico mitico-eroico che è proprio di ogni favola; il disegno – e così anche il colore del tutto arbitrario e simbolico che ad ogni disegno si può sovrapporre – non soffre i limiti del reale e dell’utilizzo di quanto effettivamente esiste nel mondo, se non per criteri assai lati di pura riconoscibilità dell’immagine offerti comunque al fruitore. Per questa libertà nel conseguire soluzioni figurali estreme il fumetto è stato saccheggiato dal cartoon classico e dall’animazione digitale, così come dalle elaborazioni dell’immagine pubblicitaria – che non a caso ha codificato il procedimento dello story-board inaugurato da geni del cinema come Eizenstejn – offrendo sempre soluzioni figurali avanzate ed ogni prefigurazione, infine, del linguaggio tecnologico della “Realtà Virtuale”. È ovvio che siffatte considerazioni sono tanto più valide quando la scansione del plot fumettistico avviene per piani che sintetizzano nella figuralità della singola posa una “grande sintagmatica narrativa”, collegandosi ai piani contigui per grandi stacchi spazio-temporali; come per esempio proprio nel Frank Miller che in queste pagine di The Rope è in questione di solito, meno ostensivo è l’effetto figurale quando i “piani” si raccordino analiticamente sia rispetto all’azione che al discorso; può accadere allora che perfino il fumetto perda molto della sua figuralità e si faccia “filosofico”, anche etico-psicologico-didattico e per questa via, perché no, perfino pornografico nella sua ricerca di restituzione di un volume da “bucare”! Dopo tutto, si tratta di un linguaggio complesso, che ha conseguito tale complessità non solo per l’avere intersecato le altre arti, ma per la sua stessa lunga travagliata gestazione. Ne ritroviamo i progenitori nelle serie sacre bizantine e gotiche – queste perfino dotate di cartigli in cui si iscrivono parole o pensieri di santi, uomini ed anche animali umanizzati - poi con le agiografiche apoteosi figurali che ornano le corti e i pubblici edifici dei signori del Rinascimento; così come negli analoghi procedimenti rivolti al sacro e perfino teorizzati dalla Controriforma, e poi diffusi nelle grandi opere basilicali e nell’effimero festivo, giù giù fino alle agiografie dei santi illustrate serialmente per i più grazie ai nuovi procedimenti della riproducibilità tecnica. Sacro e profano: dai santi alle vessate eroine del feuilleton e del romanzo d’appendice illustrato sette-ottocentesco non ci corre poi molto, tanto che alcune leggende di martirio e ricomposizione nella gloria, come quella di 134 Santa Genoveffa o Santa Uliva, spettacolarizzate già dal ‘500, sono state in seguito del tutto ambivalenti dalla sacra rappresentazione al feuilleton avventuroso-eroico; e questo era sempre accompagnato da frequenti illustrazioni riproducenti le eroine scarmigliate, lacrimanti a mani giunte, legate nude ad un tronco silvestre o in catene in una cella, torturate e sconciate nel loro fulgore biondo-ceruleo da brutti ceffi o megere, insidiate lubricamente da vecchi o da deformi, infine di nuovo fulgide nella loro gloria e magari abbacinanti nel candore sacro di un abito da sposa regale. Non appena codificato dagli standard della grande diffusione, superati gli esordi in spazi deputati sugli organi di stampa e conquistati negli anni ’30 del secolo scorso i più vari formati di albi esclusivi, il fumetto alimenta dei sottogeneri e dei generi apparentati; il più illustre dei quali è di certo il fotoromanzo: non offre la libertà inventiva dell’immagine disegnata, ma ha il vantaggio – nell’era dello immaginario cinematografico - di “ripresentificare” l’icona del divo quale è stata formulata dallo schema filmico e non un suo surrogato. E con il fotoromanzo, una serie ibridata di altri procedimenti illustrati e verbalizzati che oggi costituiscono tutto il vasto campo che gli addetti ai lavori, come il nostro Umberto Cantone, indagano come quello dei “paratesti”. 4. Confessione e anamnesi Confesso che il mio personale addestramento al piacere della silhouette, all’esercizio della seducente altalena tra Eros e Thanatos, si è verificato proprio grazie al fumetto negli anni lontani del dopoguerra, da quando ricevetti in dono da mio padre – guarda caso – il mitico albo n.1 di Pecos Bill. Riuscii a non perdere un solo numero di quel meraviglioso dono settimanale dove il biondo eroe del West dal ciuffo nero – che modernità da rock-star! – aveva una fidanzatina adolescente dal nome dolce e dal cognome mieloso ma vagamente allusivo: Sue Sluefoot detta la “piccola Sue”. Questa esibiva una lunga capigliatura bionda ondulanta dalla permanente alla Veronica Lake, tratti da santa e la sinuosa silhouette a metà tra l’acerbità da cerbiatta e la pin up alla Vargas, e per di più, da eroina del West, indossava un’aderente mini jeans – ben prima di Mary Quant – stivaletti col tacco, camicetta rosa sbottonata sulle dolci colline, un vezzoso foulard al collo dono del suo cow-boy. Non basta: la stupenda creatura era sempre concupita e calunniata dal cattivo di turno, rapita dai banditi, legata sulla soffice prateria ai piedi e ai polsi delicati tirati dietro la schiena – con l’effetto sulla silhouette che si può immaginare – oppure legata al totem dai pellerossa, sempre ferocemente antifemministi, e magari pure minacciata dalle loro laide 135 Icone Strip 1. La chimera: Pecos e Turbine 2. S.S.S. – Sue Sluefoot Silhouette 3. Il teriomorfismo: il gran capo Malji Hoo 4. La Silhouette nella mandorla lunare. 5. Jane- Calamity- Russel “Il mio corpo ti scalderà”… 6. Sacra mandorla carnivora 7. Estasi della beata Sue 136 137 138 139 140 141 142 squaw; e perfino, di rado, subiva – che momenti attesi e sublimi!... – appena l’inizio di pr ogrammate sevizie, i primi “contrassegni di morte”sulla figura intatta, per fortuna poi sempre riparabili: fosse il graffio della punta rovente d’una lancia, l’avvinghiarsi di un fiore carnivoro in un giardino esoterico di loschi trafficanti cinesi, una prima staffilata sul colmo della camicetta… Ma non correva alcun rischio la “piccola Sue”; ci si poteva scommettere che nell’istante estremo, prima dello sciupío irreparabile, sarebbe arrivato lui, l’aitante ragazzone dal ciuffo nero!... Più tardi subentrò una rivale di Sue, la fuorilegge Calamity Jane – alias il nuovo mito Jane Russel fatto fumetto – ed era aggressiva, maliarda, fosca e correva gli stessi rischi dell’altra, poi sempre salvata in extremis da un Pecos Bill mosso dal solo generoso intento di redimerla dalla sua vita perduta, e non certo dall’intenzione di tradire la piccola Sue!... Così le silhouette si caricavano anche del plot del mélo, dove sottesi al vorticare delle avventure vi erano amori gelosi, amori infelici, impossibili, sent-sentimenti, vendette e rinunce generose: un valore aggiunto che caricava di un più di pulsionalità ogni attentato alla bella silhouette. Inoltre Calamity Jane era ovviamente in travesti – attillati jeans e giubbotto di daino, sombrero, il cinturone della colt attorno ai fianchi rotondi – e ciò si appellava, anche se allora non lo sapevo, ad una pratica dello spettacolo d’ogni tempo, quello dell’avventuriera in abiti maschili, la qualcosa ben si addiceva al carattere irruento dell’eroina dai capelli corvini. Non è qui il caso di ripercorrere le tappe dello spettacolo femminile in “travesti”, a volte perfino gloriose giungendo alle eroine di Shakespeare, Calderón, Tirso, per non parlare ovviamente dell’Arte, del Variété o, ancor di più del Burlesque e del Cabaret fino a lambire mostri sacri dello star system quali la Garbo e la Dietrich. Quanto poi, di conseguenza, conti il travestimento sessuale tra le pratiche dello spettacolo pop è cosa nota, costituendo al tempo stesso rituale trasgressivo, bandiera ideologica, raddoppio del desiderio, incubo allo specchio, sciamanesimo e chissà quanto altro da Bowie a Mercury, da George Michael a Madonna; e con il travestimento, ovviamente il feticismo della mise di scena e di vita, con tutto il suo armamentario simbolico. Mantenni comunque saldo il mio fervore per la piccola santa, la “piccola Sue”, contro l’intrusa vampira, e pensavo che dovesse durare in eterno...quando apparve all’improvviso la mitica serie di soli 33 numeri di un altro albo, quell’Oklaoma! che prendeva il titolo da un noto musical e si ambientava in un romantico Sud da Via col Vento! ; del resto, a causa delle “inique sanzioni” e della guerra, solo tra gli anni ’40 e ’50 potevamo finalmente verificare tanto agognato ed affabulato cinema di Hollywood. L’eroina di Oklaoma! era una delicata fanciulla creola ribelle al dominio di un Nord incolto, affarista e sfruttatore; costei riceveva dallo spirito del fratello, l’ufficiale Raphael De Soto morto in battaglia, e dalle onde del Padre il sacro 143 fiume Mississipi, il suo costume da vendicatrice. Si era liberata pertanto del décolleté di veli turchini e dell’ampia gonna a volants ed era riapparsa in jans un po’ troppo attillati e stivali sadici alla coscia, unica concessione al suo stato d’origine da creola: la nera chioma fluente fino alle reni e una romantica camelia tra i capelli. Fu un colpo di fulmine, anche perché la indomita Belle-Star – guarda un po’, così si chiamava – se le andava a cercare di cotte e di crude tra soldataglie nordiste, banditi, Ku Klux Klan, pirati, indiani e carcerieri corrotti e sadici- più di quanto sia riuscito ad enunciare lo strutturalista Veselavskij nella sua Favola della fanciulla perseguita- riuscendo solo al trentatreesimo albo, per me tristissimo, vincitrice e del tutto intatta...e di nuovo pacificata nei suoi svolazzanti veli turchesi da fanciulla del Sud. Allora non capivo, né potevo confessare a me stesso, che parte di quella nuova fascinazione era dovuta ai meccanismi innescati da un fantasma di ambiguità sessuale. Finchè dovetti ammettere che anche le larghe spalle, la nuca taurina e lo stretto bacino di eroi come Pecos Bill o Tex, agghindati nei loro aderenti costumi messicani da battaglia, mi sollecitavano pulsioni desideranti una vaga soddisfazione, in qualche modo momentaneamente appagata quando essi venivano feriti, catturati, legati, sottoposti a torture alle quali reagivano con l’imperturbabilità dell’icona del coraggio. Ci fu un film rivelatore, lo splendido Scaramouche (1952) dove non solo la sontuosa maschera di cui al titolo – calzamaglia a righe bianco-nere, stivali, camicia candida sbuffante, mascherina nera... - forniva un’aura, come dire, d’irresistibile virilità femminea all’eroe Stewart Granger, ma anche il cattivo, ambiguamente, si ritagliava il suo magnifico spazio di fascinazione nel luogo finale di quel che decretai “il più bel duello della storia del cinema”: E il cattivo era uno stupendo Mel Ferrer in parrucca di boccoli bianchi, inguainato nella sua mise di seta nera da cavaliere settecentesco, le fruscianti maniche della camicia lattea ed il ruscellante jabot aristocratico che sgorgavano dall’aderente giustacuore a replicare, ma con più femminea civetteria, la sinfonia in bianco e nero dell’eroe positivo. Nell’interminabile sequenza, elegantemente ballettata alla maniera impareggiabile di George Sidney, quel magnifico cattivo riceveva per punizione dalla lama del vendicatore le stimmate sottili dei “contrassegni di morte”...prima in un braccio, poi sull’altro, poi sul giustacuore, stimmate segnalate dalle macchie rosse sul candore della camicia e dal bell’ansare di lui madido di giovanile sudore sacrificale: sangue e sudore, due perdite corporee a minaccia della totalità della figura. E qui si aveva la rivelazione finale, che legava il plot del feuilleton filmico al rito iniziatico: il fratello non avrebbe mai potuto uccidere il fratello!... Come per tutta la mia generazione, anni dopo, da adolescente, fu la volta del fumetto erotico all’italiana; Jolanda de Almaviva la corsara, Zora la spudorata vampira, la spadaccina Isabella duchessa dei diavoli - a proposito, dove 144 è finito? Al macero?...Quel gioiello di Corbucci, dove Brigitte Skay, polposa B.B. dei poveri, subiva una sublime fustigazione sulle punte erogene e sporgenti della sua silhouette -, poi le impudiche squaw Vartán e Walhalla; ma, soprattutto, l’ariostesca principessa del Catai Angelica – frangetta alla Cleopatra, viso parigino, body striminzito di cuoio – capace di subire indenne gli oltraggi più vergognosi da orde di musulmani e tartari, sotto lo sguardo disperato del suo promesso sposo il paladino Orlando. Più avanti ancora fu la volta dei michelangioleschi super-eroi made in USA, e soprattutto delle anabolizzate quanto flessuose super eroine Cat-women, Wonder-women e quante altre; ma già quasi a recupero intellettuale di una maniera, come consapevole operazione di cultura, sia pure pop. Ma Barbarella - il film, non il fumetto di Forrest – mi fece ripiombare per qualche tempo tra i sadici e desideranti fantasmi infantili. Allora, signori critici, è o no Vadim – Vadim che non vi piace, che non è nouvelle vague, che è commerciale e “cip” – un grande artista? Certo, concediamo – bello sforzo! – che anche Godard e Truffaut lo siano! Ma Vadim è Vadim: quello che ha saputo fare con Jane Fonda in Barbarella e con B.B. in Et Dieu créa la femme, solo lui sapeva farlo!...Vadim l’ossessionato, che ha inseguito sempre un folle amore per una sola identica silhouette: Jane, Brigitte, Catherine o Annette Strayberg che fosse la creatura in carne ed ossa di turno. Quanto infine al rapporto con il fumetto tecnologico di oggi, o simulante la tecnologia con artigianato magistrale, qui non procedo, pensando che altri su queste pagine potrebbero occuparsene con più affinità generazionale e competenza. Tanto basti. A seguire le piste dell’immaginario verso la messinscena del potere e del dramma della silhouette, iscritta nella sua pienezza splendente, non si finirebbe mai di rivisitare linguaggi e pratiche. Basti sapere che tutto ciò è implicito ogni volta che “il principe splendente”, la silhouette appare e seduce. Ed intendere che solo un interprete formidabile può incarnare un tale “principe splendente”. 5. La silhouette scienza esatta Da quel che è emerso è chiaro che la nostra questione ha a che fare con la psicanalisi; inoltre – in quanto si tratta dell’elaborazione simbolica di una pratica di linguaggio, sia pure radicata nell’immaginario – è plausibile coinvolgere le analisi della semiologia e dell’antropologia, le scienze per l’appunto del Simbolico, trovandosi la questione al nodo in cui in queste prospettive si intrecciano ed offrono i loro esiti alla “analisi del profondo”. Quanto alla definizione di forme e condizioni dell’iconicità, tutto ciò ha dato i suoi frutti con quella “nouvelle critique” che ha percorso la parabola dai Seminari post-freudiani di Lacan – la formulazione della forma nella specularità dell’Immaginario – al “superamento di Freud” proclamato soprattutto 145 dalla “Teoria dei simulacri” di Baudrillard per un verso, e per un altro dagli anti-edipici approdi di Deleuze fino ai saggi di Millepiani, tutti informati alla crisi del classico rapporto edipico e speculare tra soggetto e immagine. Ma dello stesso Deleuze va considerata l’investigazione sulla “piega barocca”, i cui sviluppi ci sembrano tuttavia neo-freudiani e neo-strutturali. E tralasciamo qui molte altre cose. come l’analisi di forme e fratture scritturali secondo Derrida, quella sulle grafie dei “mitemi” di Morin a ridosso di Barthes, il fantasma del “corps morcelé” di Mannoni, etc. Non dimentichiamo, tuttavia, che il percorso che ci consente di interrogarci con incroci interdisciplinari sulle proprietà dell’icona parte da Warburg e da quel “ritorno al paganesimo” che, attraverso molti esponenti di genio, ha regalato al Novecento l’Iconologia come scienza. Che tutto ciò sia in questione traspare probabilmente da ogni riga di questo nostro approccio, dunque non ne faremo oggetto di metadiscorso. Merita invece una riflessione un altro punto di vista scientifico – ammesso che quelli di prima istituiscano davvero delle “scienze” – il punto di vista che nelle metodologie d’analisi tiene conto di certi esiti delle scienze cosiddette esatte, ed in particolare delle cosiddette “matematiche del caos”, le quali poi si risolvono nel loro apparente contrario: matematiche della forma e relative topologie. Torniamo alla rana che ha cercato di conseguire con un esito tragi-comico la sua forma regale: è evidente che lì sono in questione le teorie della “tensione superficiale”, infatti se la povera rana avesse saputo calcolare con esattezza il momento ottimale di tensione della propria pelle non sarebbe andata incontro al proverbiale disastro. Non voglio sostenere che sarebbero capaci di un simile calcolo i tanti performer che trionfano apparendo nella silhouette e che in essa danno testimonianza di sé come immagine più che come corpo...ma intendo dire che il loro calcolo è implicito nel duro training psichico e corporeo, nell’esito raggiunto...Certo, alla fine per talentuosa intuizione!...Ma un’intuizione che è carica di lavoro sperimentale addirittura sacrificale e che in tal modo si è sostanziata di un calcolo esatto, che resta implicito nella prassi. Non diversamente per ogni matematico, ad esempio, l’impostazione di un integrale è un’intuizione di calcolo più che un’operazione analiticamente esplicitata, eppure quell’intuizione i matematici se la portano appresso nelle elaborazioni di calcolo le più sofisticate...Architetti come Sarfatti o Gehry partono nel loro lavoro al computer dalla “ di forme le più gradevoli” e dei loro dinamismi e alla fine hanno sempre ragione nei progetti conseguenti; ma sono poi altri, il loro staff di matematici e telematici, a rendere conto degli algoritmi sottesi a quelle elaborazioni formali. Il performer lavora esattamente allo stesso modo: training fino al massacro, cumulo d’esperienza, rischiosi tentativi, infine l’esito figurale...lasciando ad altri il 146 compito di spiegare la magia della tecnica sottesa: nel loro specifico Beyoncé o Shakira (per esempio nel citato clip a due Beatiful Liar) valgono Gehry e Sarfati, sono architetti della propria figuralità, così come lo furono nel ‘500 Isabella Andreini e nel ‘900 Rita Renoir, e tutte le fulgide epifanie dello show di ogni tempo. Un bel libro di Luciano Emmer (Bolle di sapone) sviluppa una questione matematica in maniera del tutto trasversale, procedendo dalle teorie matematiche pure – in particolare proprio quelle sulla tensione superficiale – all’analisi delle strutture naturali e biologiche, infine alle elaborazioni degli artefatti umani: espone infatti la questione di una matematica specifica applicandola alle forme sferoidi liquide, alle minerali ed alle protozoiche, poi a molti esempi delle arti figurative carichi di tutte le valenze simboliche che la cultura ha attribuito alle bolle nei secoli, fino alle applicazioni della stessa teoria matematica alla prassi dell’architettura postmoderna. Non abbiamo dubbi che la trattazione avrebbe potuto toccare anche la performance e la risoluzione della corporeità performativa nell’immagine, tecnologica e/o tradizionale. Dunque, sia in natura che negli artefatti l’elaborazione di “bolle” dipende da condizioni strutturali che l’analisi può matematizzare secondo i medesimi principi che assicurano all’oggetto in questione la tensione superficiale ottimale, la sua straordinaria stabilità in quella condizione, ed insieme la precarietà determinata dalla consistenza di parametri che non debbono variare di un “e”, pena il disfacimento della bolla ed il repentino passaggio dalla forma all’informe, e perciò ad una situazione caotica. Ora, la straordinaria stabilità della forma ottimale – quella che esteticamente appercepiamo come la “forma perfetta” – ed al tempo stesso la sua precarietà sono qualità che corrispondono non solo all’esito del lavoro del performer, ad un training che ha incorporato nella sua pratica la tecnica derivata dall’esattezza del calcolo, ma anche al pendolo dell’immaginario spettatoriale tra forma ed informe, cosmo e caos, Eros e Thanatos. Il timore della distruzione è implicito al piacere dell’appercezione della “forma perfetta”, ne costituisce una condizione ineliminabile al punto da offrirsi come l’attesa ed il piacere di questo timore; perciò occorre che l’immaginario, lavorando sull’esattezza di una matematica inconscia, possa sempre tentare la distruzione della bella forma, ma anche che la possa di continuo ritentare dato che questa possibilità permanente di “attentato alla bella forma” è condizione necessaria del piacere della bella forma. E ne sanno qualcosa, per l’appunto, i bambini quando giocano alle “bolle di sapone”. Ci sentiamo, allora, un po’ più sollevati nei riguardi dell’anamnesi “perversa” cui ci siamo abbandonati con la deriva delle pagine precedenti: sollevati nel senso che almeno le condizioni generali di quella perversità ci appaiono ora normali. E se ciò è acca147 duto, la “matematica delle bolle” sembra averne un qualche merito nei suoi principi esatti di spiegazione!...In psicanalisi la questione è direttamente quella del sistema energetico come circuito del desiderio dal funzionamento alternante. Lacan la pone come alternanza della “Epifania” e della “Aphanisis”, apparizione e cancellazione del meta libidinale; alternanza che, nella sua permanente virtualità, legittima proprio l’immagine speculare come oggetto di desiderio (voyeurista). Quando parliamo di un repentino passaggio dalla forma al caos, e viceversa, attraverso il discrimine infinitesimale di una “soglia”, è implicito che ciò avvenga in relazione ad un punto di vista, una “singolarità” – così si definisce in topologia un punto attrattore di un campo e dunque di uno stato di sistema – singolarità che nel nostro caso può anche tenere esattamente il luogo dello spettatore. E sia pure questo lo spettatore virtuale supposto come assoluto, come accadeva nelle architetture e scenografie rinascimentali che venivano elaborate per intero a partire da quella singolarità del punto di vista che era dato dal luogo virtuale del principe. Dunque, per ottenere l’esibizione di una figuralità scenica si passa da uno stato dell’intero sistema architettonico e scenografico ad un altro, e viceversa. Sempre, infatti, questi ribaltamenti di stato sistemico giocano attraverso la relazione tra una “singolarità” e la sua soglia. Ora, c’è un settore della topologia matematica che si occupa esattamente di questo, ed è la “Teoria delle Catastrofi” di René Thom. Applicata inizialmente al comportamento caotico di certe dinamiche di sistemi gassosi, che repentinamente si ribaltano da uno stato ad un altro completamente differente, la “teoria delle catastrofi”, come ha dichiarato il suo stesso autore, può trovare applicazione nello spiegare tutti i sistemi naturali ed articiali che appaiano di comportamento caotico: perfino la configurazione dei ritagli tettonici di strati della crosta terrestre o quella che il reticolo dei pori dà alla pelle umana, ed ancora le reazioni vegetali, animali ed umane rispetto a determinati stimoli – per esempio i comportamenti di paura/attacco delle bestie – e infine le dinamiche delle relazioni sociali, economiche ed estetico-artistiche. Dunque, è del tutto plausibile l’analisi del comportamento del performer – proprio nella sua attivazione della dialettica tra caos e figuralità – mediante questa teoria matematica. Tanto più per il fatto che lo stesso studioso ci ha lasciato un prezioso saggio su una materia davvero contigua alla nostra, quello su I contorni della pittura. Quel che lì si afferma rispetto alla possibilità di configurare topologicamente, ed analizzare e matematizzare secondo “le catastrofi”, i rapporti tra figura e sfondo, tra dinamiche e spazio, tensioni perimetrali e ribaltamenti, è illuminante per capire la nostra questione e come il lavoro di performer si rapporti proprio ai parametri “di superficie” delle arti figurative (e soprattutto, come abbiamo visto, del fumetto). 148 Le catastrofi elementari secondo Thom sono sette: la piega, la cuspide, la coda di rondine, l’ombelico iperbolico, l’ombelico ellittico, la farfalla, l’ombelico parabolico. Ognuna di esse costituisce una topologia dinamica di innegabile bellezza, collocando nella dinamica stessa del sistema osservato – e non nel taglio sincronico di una sua virtuale stasi – il principio di elaborazione delle forme. Queste, e le loro complicazioni in catastrofi complesse generate da ibridazioni sistemiche, dipendono da un’infinità di variabili che, nel caso dei comportamenti umani hanno in larga parte a che fare con le dinamiche storiche, economiche e culturali. Per questo abbiamo potuto affermare che c’è sempre una relazione tra gli studi matematici, la Weltanshauung epocale data dal nostro habitat culturale – non ultimo l’habitat architettonico–urbanistico – ed il nostro lavoro cosiddetto artistico (si veda I cavalieri del Caos). Sicchè ad esempio – confortati dalla possibilità d’intendere l’arte barocca a partire dalla mirabile Piega del Leibinz deleuziano – abbiamo potuto riscontrare che le elaborazioni dinamico-formali degli studi sulle ellissoidi, discendenti dalle proprietà delle sezioni di figure coniche, si applicano alle architetture ed alle dinamiche pittoriche manieriste-barocche, - come nel lampante esempio del Tintoretto- ed egualmente al comportamento scenico delle maschere dell’ “Arte” impegnate nei loro lazzi. Tali studi, infatti, ripresi grazie agli umanisti ed ai pittoriarchitetti come Raffaello Sanzio dalle matematiche ellenistiche di Apollonio Pergeo o di Archimede, erano tornati in auge nel ‘500 e saranno rielaborati in seguito da Galileo fino a Leibniz come supporto topologico necessaro per sviluppare con nuovi calcoli ad andamento infinitesimale le teorie relative alle funzioni ed ai fasci di funzioni. Non a caso proprio il Leibniz è considerato l’inventore della moderna topologia matematica; mentre Galileo aveva ripreso da Archimede e da altri ellenistici la possibilità di lavorare alle funzioni con quelle numerazioni complesse che saranno fondamentali per lo sviluppo della odierna algoritmica e delle sue applicazioni telematiche. Non ci pare azzardato, allora, che le dinamiche formali delle sette catastrofi, e le loro ibridazioni, possano costituire oggi il côté topologico-matematico per spiegare il nostro habitat socio-economico, e quello figurale dalle nuove arti visive alla performance. Del resto, tale correlazione tra scienze, comportamenti ed arti sembra tanto più appariscente nelle epoche di generale dislocazione dello sviluppo storico: così nel ‘600 e così adesso. Non a caso Calabrese (L’età neobarocca) ed altri hanno ben per tempo messo in campo i principi estetici del cosiddetto neo-barocco. Nel condurre la nostra disamina sulle condizioni della performance come epifania figurale, possiamo dunque ipotizzare con qualche fondamento un principio che può trovare applicazioni analitiche: quando il pop-performer appare e si configura epifanicamente nella sua silhouette, e quando poi 149 prende a muoversi e danzare – peraltro correlando alla propria immagine dinamica complessi di danzatori o di acrobati – e quando prende a saltare sul palco (ad esempio come James Brown), a correre spinto dall’attacco del riff lungo tutta la ribalta (come ha sempre fatto da maestro Mick Jagger), a prostrarsi sul proscenio di fronte al pubblico per suscitare un effetto di coinvolgente intimità che si muta subito in applauso (ad esempio, Madonna supina e palpitante nell’abito da sposa di Like a Virgin o nel satin rosa di Material Girl), in tutte queste dinamiche che inanellano pose passando dialetticamente dall’una all’altra, questo performer non fa che riprodurre esattamente le topologie individuate dalla “Teoria delle Catastrofi”. Basta condurre sui filmati dei rilievi di pose, di tracciati scenici, di ritmiche per rendersene conto. Il performer probabilmente non ne possiede analitica coscienza matematica, tuttavia la sua pratica magistrale sta mettendo in forma il caos secondo precise topologie che si mutano repentinamente l’una nell’altra in maniera meravigliosa. Ed a ciò deve quell’effetto di spettacolarità che risulta così trascinante per un’immediata percezione empatica che pone tutti i sensi dello spettatore in stato di polimorfia. Così la pulsione scopica travolge con le sue elaborazioni fantasmiche, reificate nelle flagranti topologie, sia la funzione acustica fin lì dominante – ma che ora, nella performance, viene subordinata ad una musicalità e ritmica visuali – sia l’odorato, il gusto, il tatto riattivati da una flagranza visuale che si fa ravvicinata…che addirittura ci sconvolge nella sua dinamica formale costituendo noi stessi a momenti fondanti delle “singolarità” di elaborazione del campo topologico. Ogni dettaglio sensoriale diviene in tal modo indispensabile ed esatto nel momento stesso in cui si pone nel registro del visibile: il vellicante fruscio di satin troppo aderente in cui Mariah Carey in soirée rinserra le sinuose volute della sua silhouette; l’odore del sudore abbondante di Elvis che i fan più prossimi conoscono bene in quel mix in dissipazione di alcool, anfetamine e giovinezza; la rubata carezza sulla pelle di raso delle lucide cosce di Shakira che supina va sussultando di ventre e di seni; il visibile gusto di fragola delle rosse labbra da pin-up anni ’40 di Christina Aguilera in Candyman…inoltre tutto il seduttivo repertorio feticista è nell’ordine necessario di quel visibile che costruisce la sua miracolosa e fragile perfezione mediante l’impiego simultaneo di piccole catastrofi scopico-sensoriali e relative “singolarità” e “soglie di campo”. Ci sono tuttavia comportamenti unificanti nelle topologie che qui andiamo esaminando. Sia le matematiche delle bolle che quelle delle catastrofi, in quanto elaborazioni algoritmiche di topologie sottoposte a tensioni dinamiche, acquisiscono tutte le peculiarità fondamentali enunciate dalla “teoria dei frattali”; ovvero dal nuovo orizzonte, esplorato da Mandelbrot, del rapporto regolare fra numeralità e figura nell’era della complessità caotica. Pertanto, a 150 queste stesse peculiarità delle immagini frattali corrispondono tutte le forme dinamiche che nelle suddette elaborazioni algoritmiche trovano l’istanza di una loro possibile analiticità. Ora, le peculiarità unificanti di ogni tipo di frattale vengono riconosciute essenzialmente nella “regolarità”, nella “scalarità” e nella “autosomiglianza”, tre comportamenti che in realtà si presuppongono a vicenda e si sostengono l’un l’altro senza soluzione di continuità che si possano nettamente delimitare. Per noi, in un campo che potremmo definire in senso lato come “estetico”, la “regolarità” comporta che in qualche modo l’evoluzione della performance sia sempre prevedibile, sia a livello di segmenti testuali che macrotestuali (ovvero relativi a più performance e magari eterogenee per linguaggi specifici); e che di questa evoluzione siano prevedibili anche gli effetti di shock e di sorpresa, che risulteranno tanto più efficaci quanto più saranno riconoscibili ed in qualche modo attesi. D’altronde, fin da Aristotele, è questo della sorpresa un espediente consueto di ogni pratica di spettacolo che nell’accadimento live ponga il centro del suo interesse. Il comportamento della “scalarità” fa sì che si manifestino analogie morfologiche e dinamiche tra segmentazioni di scala diverse, sempre più piccole o sempre più grandi, delle topologie osservate; la quale proprietà si traduce nel nostro campo anche nella diffusa affermazione di una qualità stilistica omogenea, fino al limite dell’appercezione di uno stile degli stessi momenti di frattura e di contraddizione dinamica e/o figurale. Infine, il comportamento della “autosomiglianza” riassume e riqualifica gli altri due – regolarità e scalarità – evidenziando come ogni topologia somigli a se stessa nelle sue parti e nel suo divenire possibile. I nervi ed i fasci muscolari tesi e pulsanti di Madonna in Confessions Tour (2006) hanno dunque configurazione, ritmo, dinamiche somiglianti a configurazione, ritmo, dinamiche della sua intera figura muscolosa e spettinata, impegnata nella dura danza metropolitana – il mondo del “krump” e le “Battles” - del suo costume fatto di body sgambato, sudore, stivaletti, orpelli luccicosi scarni e taglienti, della acrobatica figuralità danzante dei suoi boys, della fantasmagoria taglieggiante dei fasci di luce. E, magari, tutto questo complesso di autosomiglianze scalari entra in contrasto – efficacemente stilistico quanto più netto – con la linea musicale-vocale che la star mantiene legata e sinuosa secondo infinite proliferazioni; un legamento sonoro mollemente islamizzante, nostalgico, offerto a sostegno di fratture incomponibili che si susseguono come piccole e continue catastrofi. Ma non è che un esempio. Se Michael Jackson sul palco cammina senza spostarsi di un passo, queste “lisciate” dinamiche riproducono quella scandalosa, ma stilistica, della sua mano sul sesso evidenziato dai jeans di pelle lucida, e riproducono anche l’attitudine ondulatoria e lisciante di tutta la sua figura dinoccolata; laddove, magari, l’elemento di frattura è qui costituito dal sincopare netto, spi151 goloso della linea musicale rock rispetto alle ondulazioni di flagranze visuali prive di soluzione di continuità (soluzioni che poi, però, si recuperano come catastrofi acrobatiche nelle scansioni nette dei sintagmi più ampi e che pertanto riagganciano ad un’omogeneità stilistica il ritmo sincopato della musica rock). Ma il passo “lisciato” di Michael Jackson è poi quello di Cab Callowey, peraltro un vecchio espediente del cabaret black…e poi è anche quello del dondolante tricheco dei cartoons di Minnie the moocher (1932). Così, i raffronti intertestuali ci portano ad individuare “autosomiglianze” di livello micro e macrotestuale. Nello spettacolo questo riconoscimento di livello macrotestuale da testo a testo si chiama “stereotipo”. Lo spettacolo lo riconosce infallibilmente, facendo agio su una memoria sommersa; e pertanto; sia pure senza averne la chiara coscienza, lo attende, ne gode al suo puntuale e desiderato verificarsi, ne sposta ed arricchisce il senso, i riferimenti, l’appercezione ad ogni riaccadimento. Per quanto si tratti di una pratica dettata da una strategia economica, per l’appunto quella del rispondere alle attese del desiderio spettatoriale e dunque facilitare il consumo del prodotto-spettacolo, in virtù del suo ri-proporsi ogni riaccadi mento è una ripetizione che in realtà non ripete proprio nulla, che sposta oltre tutti i riferimenti di quel che accade. Non c’è arte della performance senza arte dello stereotipo. E non se ne tesse mai abbastanza l’elogio: non c’è infatti evoluzione senza ripetizione, diversità senza la riproposta dell’identico, sviluppo senza quel raddoppio che è il principio di ogni infinita serialità; così come in poesia l’ambiguità del senso, di ogni senso, origina dalla ripetizione della “rosa”. Ed è questo il punto che molti non hanno compreso – artisti ed intellettuali alla Adorno – che non c’è arte che non divori i proprio stereotipi. Non fosse che per questo, dispiegare l’analisi come “regolarità”, “scalarità” ed “autosomiglianza” è una bella intrapresa che ci è consentita dall’adozione di riscontri con i comportamenti topologici della “teoria dei frattali”. L’intera organizzazione della pop performance segue dunque un’articolazione stereotipica che, magari, pesca nel macrotesto di altre pratiche live, affini o fondanti. In questo senso la constatazione più evidente mostra la filiazione della intera diegèsi della pop performance dal Grand Variété otto-novecentesco, pur rielaborato dalle nuove tecnologie audio-visive-illuminotecniche digitali. Abbiamo così le inderogabili scansioni date dalla “Entrée”, nella quale per la prima volta il pubblico subisce lo choc atteso dell’apparizione della vedette; dalle sequenze dei numeri delle diverse pratiche codificate - la scena d’approccio comico e coinvolgente, l’illusionismo in tutte le sue forme, il virtuosismo di giocoleria e/o acrobatismo che dall’agilità e dall’eleganza giunge, attraverso l’esibizione valorizzata dello sforzo e della sofferenza, al 152 “tu per tu” con la morte, il “fine dicitore” e/o il confidenziale crooner, i song sia noti che nuovi, la provocazione erotica fino al degrado ed alla offerta di prostituzione e lo strip-tease – poi arriva al centro dello show il numero “clou” della vedette, riconoscibile ed atteso quanto subissato dalle ovazioni; segue la ripresa dei numeri di genere - per lo più, adesso, in una chiave esotica che piega all’orientalismo o al tribalismo selvaggio la futurologia astratta della prima parte - e infine il gran finale che riesibisce in maniera rutilante la vedette ed il collettivo nella riproposizione veloce del meglio delle loro abilità. Che poi questo schema si apparenti anche con quello del circo, e con altro ancora, è evidente. Il fatto che, a differenza del Grand Variété di un secolo fa, la pop performance sia quasi sempre un one-man-show non sposta nulla, semmai gli conferisce anche le stereotipie dello spettacolo di Entertainment tipico del cabaret anglosassone. In più, l’one-man-show potenzia l’esibizione di virtuosismo della vedette, la popstar, la quale si fa la principale interprete di tutte quelle scansioni stereotipiche – comicità, entertainment, strip, acrobatismo e magia compresi – che il Grand Variété affidava ad artisti di diversa specializzazione. Non c’è praticamente grande evento pop che non segua – con le opportune varianti specificate sul luogo, sul pubblico e sul performer – questo schema generale: dai primi tour di Michael Jekson o di Madonna alle Destiny’s Child at Atlanta (2006) ed oltre, lo schema è puntualmente riverificato nella sua eterogenea ma calibratissima efficacia, e costituisce soprattutto l’offerta che i fan inderogabilmente si attendono, pena la mancata soddisfazione, la percezione di un live inconcluso. Ma come è possibile che in questa testualità e macro-testualità della performance, già di per sé tanto eterogenea, si trovino strutturali analogie di comportamento con le infinite eterogeneità del micro-testo a qualsiasi livello analizzato? Come è possibile quella magia detta stile, quell’aura impalpabile eppure chiaramente appercepita, che rende di una medesima epifania e di una medesima evoluzione il cristallo sfaccettato della goccia di sudore e quello dello show tutto intero? La risposta sta nella “forma”, cioè proprio nelle configurazioni topologiche: solo la forma può rendere analoghe le pretese sostanze più diverse, poiché la forma prefigura tutte quelle sostanze e ci chiarisce che di per sé esse non sarebbero per noi in alcun modo significanti. Magari sarebbero reali, ma non significanti. Ed il visibile, l’oggetto della pulsione scopica, è fatto di Significante, non di Reale. Tutta la Topologia – scienza fondata nel ‘700 da Leibniz ed Eulero con il nome di “Analysis Situs” - si basa infatti sulla convinzione che un principio di organizzazione formale fonda l’universo e la sua evoluzione, per quanto di complessa e polivalente operatività possa essere questo principio. Infatti, di questa singolare disciplina matematica si potrebbe dare la seguente defi153 nizione, secondo la quale essa “analizza quelle proprietà delle figure geometriche che risultano invarianti per quanto si sottopongano a trasformazioni continue quelle stesse figure”. Alcuni di questi casi sono di immediata intuizione. Per esempio è evidente che per quanto una figura si metamorfizzi, a meno che non si compia una frattura di campo (catastrofe) sarà sempre possibile perimetrarla, e dunque stabilire un suo interno ed un esterno. È del pari evidente che se tracciamo una linea che congiunge un punto interno di quella figura con un punto esterno, essa attraverserà il perimetro in almeno un punto d’intersezione. Inoltre, se i punti di intersezione con la linea perimetrale dovessero essere più d’uno, saranno comunque di numero dispari, poiché se fossero pari avremmo congiunto un punto interno con un altro punto interno. Questi semplici principi topologici risultano di fondamentale importanza per la nostra questione della formulazione della silhouette, il valore del suo contorno e delle sue relazioni dinamiche con lo spazio attraverso il tempo. Ma quel che il performer verifica con la pratica non corrisponde a pure immaginazioni di una scienza priva di applicazioni, dato che la Topologia traduce graficamente l’impostazione di equazioni algebriche a due o “n” variabili, e pertanto è indispensabile – come abbiamo detto – all’analisi di funzioni e fasci di funzioni. Ma la Topologia è divenuta più complessa con l’introduzione di figure risultanti dalla programmata coordinazione in sviluppo continuo di campi originariamente opposti, come il famoso “Toro”, non a caso figura di pregnante simbolismo totemico fin dalle civiltà arcaiche dell’Egeo. In questi casi è possibile tracciare linee di congiunzione tra punti di opposti campi interni ed esterni e che tuttavia non attraversano alcuna delimitazione. Simili proprietà si sono chiarite con la scoperta da parte di Moebius della esistenza di figure dalle “superfici bilaterali” – cioè “interne” ed al tempo stesso “esterne” – come appunto il Nastro di Moebius” e la “Bottiglia di Klein”, figure dalle proprietà del tutto differenti da quelle dotate di superfici “unilaterali”, come per esempio un piano delimitato (potrebbe essere un foglio di carta), o un cilindro o una sfera. In questi casi i principi topologici di cui sopra non solo vengono smentiti, ma non sussistono nemmeno, non essendo possibile definire campi interni ed esterni alla figura. Tuttavia una superficie unilaterale resterà sempre tale quali che siano le metamorfosi continue della figura cui appartiene, e così una superficie bilaterale. Solo le metamorfosi che traducono l’una nell’altra, producendo un ribaltamento della loro definizione (catastrofi), possono modificare queste qualità. (Esperienza che fanno pure i bambini, quando creano un Nastro di Moebius incollando gli estremi di una striscia di carta dopo averne rovesciato uno). Ora, abbiamo l’impressione che il performer 154 sappia da sempre praticare questi principi ed anche le loro catastrofi nel suo rapporto con il suo stesso corpo, lo spazio, il tempo, i corpi coreografici, scenografici ed illuminotecnici con cui si relaziona. Ma c’è di più, quando la Topologia passa ad analizzare le proprietà di “figure connesse” – cioè che passano dall’una all’altra – ed addirittura di “reti di figure connesse”, o quando a queste reti di figure si arreca una modificazione di discontinuità per sottrazione di un lato, ottenendo quella che si definisce come una “struttura ad albero”, in questi casi si giunge ad ipotizzare e calcolare un numero di dimensioni superiore rispetto alle quattro conosciute della nostra esperienza quotidiana e non rappresentabili graficamente. I calcoli relativi appaiono così complessi da costituire dei veri e propri “giochi matematici”, alcuni dei quali non hanno ancora offerto soluzione e costituiscono il rovello, ed anche lo spasso, delle menti scientifiche più ingegnose . Archimede nel suo Stomáchion (alla lettera “indigestione”, “mal di pancia”) elabora i quiz relativi alla composizione con il sistema del puzzle di quadrati e di cubi, con combinazioni ed elementi ben più complessi del gioco oggi in vendita planetaria, il Tangram. La virtualità degli “ipercubi” non aveva per lui segreti. Questa possibilità di lavorare con matematiche non convenzionali su figure n-dimensionali è per altro alla base del quiz del famoso oracolo di Delo: costruire un’ara cubica del volume di un terzo esatto rispetto al cubo dato dalla cella del tempio. La soluzione è da matematica infinitesimale ed ha a che fare con la quadratura del cerchio!…Ma, per esempio, un altro di questi problemi consiste nel vedere come si possano sciogliere i famosi tre anelli intrecciati senza fare passare un anello attraverso le linee che definiscono gli altri. Un problema che si presenta insolubile alla matematica, e che tuttavia maghi ed illusionisti risolvono ogni giorno sui palcoscenici di tutto il mondo! Ancora un’osservazione: val la pena di ricordare che la Topologia e le sue proprietà – con attinenza a superfici bilaterali ed unilaterali, figure connesse, reti e quanto altro – è stata usata dal genio di Jacques Lacan per rendere conto delle n-possibilità dell’economia psichica che formula il Soggetto, e dei suoi mutamenti. Così il nastro di Moebius, la bottiglia di Klein, il nodo dei tre anelli non hanno per lui segreti quanto alla loro applicazione alle articolazioni ed all’economia della Psiche. C’è comunque, un’altra, un’ultima teoria fisico-matematica in grado di unificare nei loro principi tutte le analisi topologiche – dalle bolle alle catastrofi e ai frattali – e si tratta della cosiddetta “Teoria delle Stringhe”(Edward Witten, Brian Green ed altri). Questa traduce ogni “forza” in “forma”, ipotizzando un livello sub-quantistico di elementi costitutivi del tutto immateriali, dunque precedenti ed anzi fondanti lo stesso “principio di indeterminazione”. Siffatti elementi – che nemmeno a rigore potremmo definire tali – sarebbero degli incorporei filamenti energetici detti per l’appunto “Stringhe”, tutti assoluta155 mente identici nella loro incorporeità e nella loro qualità soltanto vibratile di energia pura. La vibratilità perpetua di cui le stringhe sarebbero dotate – non rilevabile peraltro da alcuna macchina di laboratorio ma solo ipotizzabile dall’induzione matematica – le porterebbe a differenti ed infinite configurazioni di campo, un campo non materico, e solo virtualmente topologico. Le stringhe verrebbero pertanto a costituire filamenti, anelli, spirali, parabole e altre configurazioni elementari di pura vibrazione energetica. La loro aggregazione, sempre diversa, nei fotoni e nei “quanta” consentirebbe il passaggio “catastrofico” alla materia, segnato a questo punto dalla primaria ambivalenza materia-energia osservabile in laboratorio; e poi, via via crescendo di scala, l’aggregazione consentirebbe le configurazioni delle diverse sostanze materiali e dei corpi in evoluzione. Come dire, che a fondamento del cosmo, della stessa realtà subatomica, ci sarebbe solo e soltanto la forma, le infinite ma regolari configurazioni della forma segnalata solo da manifestazioni di energia. Infatti, queste originarie “particelle S” – le stringhe - vengono così definite per la loro funzione primaria di assicurare la “Supersimmetria” in tutto l’universo e tra microcosmo e macrocosmo, aggregandosi almeno secondo undici dimensioni, una sola delle quali, quella organizzata dai principi gravitazionali, sarebbe comune e dominante rispetto alle altre. Ogni aggregazione stabile di più dimensioni viene a costituire una cosiddetta “membrana”, cioè una sorta di cosmo le cui peculiarità sono determinate da una complessiva tensione formale organizzata dalle dimensioni costituenti. Nel nostro cosmo, ovviamente, si tratta del’organizzazione determinata dalle tre dimensioni spaziali e da quella temporale, e siffatta organizzazione costituisce la nostra “membrana”. Ma ogni “membrana” – ovverosia ogni “universo parallelo”, posto che a quanto pare l’intero universo sarebbe fatto da tensioni superficiali – risulta però sottoposta agli stessi principi gravitazionali che regolano tutte le altre. Le stringhe non farebbero altro che costituire in definitiva i segmenti minimi di un alfabeto cosmico i quali, aggregandosi tra loro in infiniti modi diversi, ma secondo regolarità statistiche, darebbero luogo alle diverse lettere di questo alfabeto, a loro volta suscettibili di organizzarsi in dimensioni e “membrane”. Ed è davvero il caso di dire che darebbero “luogo”, dato che si tratta soltanto di organizzazione formale dello spazio che viene diversamente orientato dalle aggregazioni di queste manifestazioni energetiche minimali, le “particelle della Superimmetria” per l’appunto. Qualcosa di simile era già stato ipotizzato dalla filosofia in ambito democriteo e pitagorico, poi di nuovo e con maggiore precisione nell’età barocca grazie alla matematica filosofica di Leibniz: le sue monadi incorporee, prive di “porte” e “finestre”, attive in una costante dispiegamento delle loro poten156 zialità e quindi delle loro aggregazioni, finiscono alla fine con il tracciare secondo molteplici punti di organizzazione del campo, ovvero “singolarità”, quelle “scenografie del mondo” che lo stesso Leibniz ha così definito, ed ha anche analizzato con le nuove e adeguate matematiche infinitesimali della “analysis situs”. Anche per questa via relativa alla congetturazione scientificofilosofica, il parallelo tra l’ellenismo, il barocco ed il neobarocco postmoderno sembra mostrare delle fertili motivazioni. Ma quel che ci interessa è il fatto che se ne può dedurre che, come accade per la natura, qualsiasi artista per raggiungere il livello di un’epifania della forma nella sua opera deve fare ricorso all’elaborazione ed alla sperimentata amministrazione di un’energia formante che costituisce comunque il principio del suo lavoro. E così come la natura non ha nessuna auto-coscienza delle operazioni di alta matematica che mette di fatto in opera, pur possedendone una sapienza assoluta acquisita nell’immensità dei tempi, allo stesso modo non ne possiede auto-coscienza alcuna l’artista che però, di fatto, attraverso prove, errori e rischi individuali e trans-individuali, diacronici e sincronici, ha acquisito di fatto, nella sua pratica sempre in via di ottimizzazione, una sapienza tecnica non concessa ad altri mortali. Ma, siccome l’artista ha a che fare con materie già formate, ecco che nel suo lavoro acquisisce un ruolo fondamentale ciò che Aristotele definiva come téchne, cioè il modo specifico di elaborazione e amministrazione della sua energia formativa ma coordinata alla specifica forma della materia assunta ed alle specifiche finalità del suo progetto. E queste modalità variano da caso a caso, a seconda della materia e del progetto, e perché siano efficacemente utilizzate richiedono per l’appunto una scienza che attraverso il cumulo di sperimentazioni si faccia organica e poi pratica. Una scienza della téchne specifica, in sostanza (secondo le modalità che rapportano la Poetica alla Fisica). Ed è questo che all’artista si richiede, piuttosto che una scienza analitica e meta-teorica. Nel nostro caso, quello del performer, la materia già formata, che viene assunta dall’elaborazione ed amministrazione dell’energia formante secondo modalità specifiche, è in primo luogo il proprio stesso corpo. E ciò comporta quel tipo di esperienza che, ad esempio, denunziano i danzatori, o gli acrobati, o gli atleti della ginnastica o del pattinaggio artistici, quando riferiscono di sentirsi divenire, nel momento della performance, altri da quel che normalmente sono, come liberi dalla corporeità intesa come peso e gravità persistenti, pura energia, elettricità, corpo allo stato elettrico!...Con queste parole di auto-confessione Billy Elliot, il giovane eroe del bel film di Daldry (2000), convince del suo talento l’alta Commissione dell’Accademia di danza. Il performer governa, dunque, l’infinità delle “stringhe” energetiche che hanno formato il suo corpo, ai fini di una rielaborazione complessiva del suo 157 stesso corpo verso un più alto grado di formalità non concessa all’altrui comune esperienza. Possiamo anche ipotizzare, poiché si tratta di “uscire dal corpo”, attingere ad una “corporeià altra” fatta di energia e non di peso, che il performer riesca a lavorare sulle unità di energia fondamentali rispetto alle dimensioni del proprio universo o “membrana”, unità elaborate dalle aggregazioni delle “stringhe” ovvero le unità gravitazionali minime – i cosiddetti “gravitoni” – proprio quelle unità energetiche che sarebbero le uniche comuni alle più diverse dimensioni cosmiche parallele. Infatti, come abbiamo già detto, tutte le dimensioni parallele del cosmo, obbedirebbero soltanto ad un principio universale, quello newtoniano della gravità, sicchè le stringhe, non appena aggregate nelle entità elementari di una certa dimensione, si metterebbero in ogni caso ad obbedire alle leggi della gravitazione universale. Ora, possiamo ipotizzare che il performer, grazie al training massacrante elaborato da una téchne specifica, riesca a rimettere in gioco – in vibrazione è il caso di dire – questa energia formante che trova in sé allo stato ancora di beanza caotica, allo stato della potenzialità e delle scelte. E per conseguenza che riesca a porsi nella sua esperienza live non come oggetto ma come soggetto dei principi di gravità, come signore ed artefice della loro formazione e del loro orientamento. Ed è questo che il performer denuncia nel dichiarare di sentirsi non più corporeo, ma “elettrico”!... Come che sia, si tratta sempre di una questione di forma e di tensione (superficiale): anche chi lavora sulle miriadi di vibrazioni delle “stringhe”, chi signoreggia il caos e le sue forme possibili, lavora su quei principi di tensione che gli fanno correre i drammatici rischi della rana di La Fontaine... Signoreggiando sui principi della gravità, il performer inoltre apre e chiude le porte degli universi paralleli, riuscendo probabilmente a “vivere” la sua esibizione aderendo alle dimensioni che caratterizzano “membrane” differenti. Questa sua esperienza di pratica vissuta, che dichiara per l’appunto come “elettricità”, come “fluidità energetica” capace di scorrere tra esperienze simultanee annullando il reale corporeo, non può esserci né comunicata né esplicitata, poiché a nessuno è consentita la libera uscita dalle nostre quattro dimensioni, e nemmeno al performer stesso se si pensa ad un’esperienza gnoseologico-analitica; tuttavia la percepiamo così come si percepisce in letteratura quell’energia figurale che costituisce la metafora, ovvero l’energia che si forma mediante la sincreticità e il passaggio da uno stato all’altro nella medesima immagine. Allo stesso modo intuiamo che il corpo del performer è insieme reale e virtuale: della sua virtualità costitutiva non ne decifriamo con analiticità le dimensioni, ma ne percepiamo sincreticamente, per sinestesie polimorfe che dai sensi giungono a colpire catastroficamente l’intelletto, il fascino di una esperienza e di una forma dell’oltre, il dominio di un’oltranza inimmaginabile. Ed è per questo che il corpo del performer è virtualità 158 senza l’uso delle tecnologie del virtuale, anzi prefigurazione di quelle tecnologie e istanza di necessità del loro linguaggio. Quando il procedimento che va dalle vibrazioni energetiche minimali o “stringhe” fino alla epifania della forma è compiuto e sperimentato al punto da costituire, più che una seconda natura , la vera natura del performer, allora possiamo dire che egli ha attinto alla qualità consustanziale, strutturale, della Morfogenia: la felice disposizione a darsi come forma. Abbiamo visto, tuttavia, come la forma sia sempre perimetrata, dunque non relazionata ad un esterno che non sia esso stesso forma, almeno in quanto di necessità relato con la forma. Questa qualità di auto-perimetrazione è definita da Lacan come “compacité” ed è raffigurata nelle due forme complementari, ma separate da delimitazioni precise, degli organi sessuali impegnati nell’atto erotico (Encore, seminario XX). La conclusione dello psicanalista è che, in realtà, si ama solo se stessi, cioè il fantasma posto dal proprio immaginario, dato che alla base si sente solo se stessi, la propria tensione superficiale compatta, e di questa ci si eccita. Allo stesso modo l’icona, anche quella del performer, si autodelimita e si autosoddisfa. Magari chi la rimira, e se ne entusiasma, crede di influire su di essa e di perturbarla, ma essa, la figuralità iconica, non sente che se stessa e di se stessa, come Narciso, si turba per amore e desiderio. E, naturalmente, accoglie in questo atto tutto ciò che la pressa dall’esterno, ma come proprio e fatto proprio nella sua stessa forma. La topologia matematica e quella psicanalitica spiegano dunque le motivazioni vere della teoria della Gestalt, la “teoria della buona forma”, ed anche di ciò che precede la Gestalt, come le “sezioni auree”, le “intenzioni più gradevoli” e tutti quei principi psico-geometrici che da sempre presiedono alle Arti. Così chiarita la questione della Morfogenia, questa, nelle sue specificazioni di tecnica specifica - tanto per proseguire sul crinale attualissimo di Aristotele – sarà per il teatro e per ogni tipo di ribalta live l’attitudine alla Fanogenia, cioè l’attitudine epifanica che estrae dal nulla e dall’oscurità la flagranza figurale; per la ritrattistica di ogni tipo sarà la Iconogenia che essenzialmente si manifesta nella felicità di omologazione formativa del tutto e delle parti, dunque nei dettagli, gli accessori, le tonalità, nella potenzialità catastrofiche dei contorni, nel processo di “voltificazione” che riconduce all’epifania del volto ogni altra articolazione figurale, etc.; sarà la Fotogenia nel caso della Fotografia, dove – dato che ogni specificità sussume comunque tutte le altre – tutto quanto detto contribuisce ad elaborare la flagranza live della posa, la sua capacità di darsi epifanicamente, qui ed ora, al di là dei tempi e degli spazi reali dello scatto (si veda, ad esempio, la proverbiale fotogenia di molte star, come la Bernhardt, quale si ammira nel Panthéon di Nadar, James Dean, Marilyn…); sarà ancora nel caso del cinema la 159 Cinegenia, per esempio nella capacità, divenuta istinto, di essere sempre a fuoco in tutti i propri movimenti (come dicono accadesse a Marilyn, per questo ammirata da Cartier-Bresson…), o nella capacità di sezionare il piano secondo “campi aurei”dal punto di vista geometrico, o ancora di sezionare dinamicamente lo stesso set dandone armoniose geometrie in evoluzione, e perfino la capacità di uscire ed entrare dal preciso dettaglio del fuoco giocando tra “epifania” ed “aphanisis” – cancellazione, sparizione – un gioco drammatico e coinvolgente. Insomma le eterogenee semiotiche dell’ostensione si configurano in gerarchie sempre diverse a seconda del medium in questione, ma sempre come semiotiche intransitive (non comunicazionali), di riferimento a loro stesso complesso gerarchico, al testo-icona che si produce come autoreferenziale e metatesto. (Si veda, sulla scia di Hjelmslev, il classico Progetto di Semiotica di Garroni). Dicono che anche le bestie posseggano naturalmente almeno alcune di quelle prerogative morfogenetiche – potrebbe sottoscriverlo Bazin – ed è sicuramente vero: è difficile, in effetti, che un animale sbagli interpretazione. Ma se è così accade per l’appunto per la “naturale” qualità epifanica dell’animale che è della stessa natura della qualità epifanica del cosmo e delle sue diverse dimensioni; un’epifania come natura costitutiva, istinto, non come pratica, téchne, natura acquisita fino alla laboriosa connaturazione nel sé di quella qualità. Ora all’uomo, angelo caduto, questa naturalità senza studio, senza sacrificio di sé, sembra negata. Ma lo è poi sempre? Nei casi più splendenti le due modalità epifaniche – la naturale e la studiata – della complessiva Morfogenia sembrano congiungersi in una sola: Marilyn, ad esempio, era di questa qualità della “genia” nelle sue diverse accezioni, ed è per questo che di lei si può dire che era “piena di Grazia”, e che come tale potrà sfidare il tempo dei tempi nella vita di immortale oltranza dell’Icona. Peraltro sulle sorprendenti affinità tra la morfogenia dell’animale e quella delle star autenticamente tali dovremo ritornare: è un tratto distintivo affascinante, e che sembra davvero rinviare, rispetto all’umano, alla manifestazione di una qualche comune oltranza. Un’ultima constatazione sulla correlazione di tutta questa tematica figurale con le scienze: prima di passare alla civiltà bizantina con connotati ierofanici, il termine “epifania” era stato coniato dai matematici ellenistici e designava l’apparizione alla vista “da sopra”, ovvero ortogonale ed “a piombo”, di figure complesse che in tal modo si manifestavano come superfici definite. L’epifania era in sostanza la trascrizione visiva della n-dimensionalità nella dispiegata bidimensionalità della superficie, operazione corrente ed istintiva, dunque pulsionale, per chiunque guardi qualcosa su uno schermo o su una virtuale parete da boccascena teatrale. Allo stesso modo le “stimmate”, prima 160 di caratterizzare il soggetto ierofanico, indicavano i punti geometrici, tra campo dello spettatore e campo della figura, da porre in relazione dialettica per determinare mutamenti di “epifanie”. Qualcosa, dunque, di molto simile alle “singolarità” delle “Catastrofi”. 6. Fiat Lux Dunque, giungendo ora all’acme del nostro “détour”, la star appare. Ed ecco le prime note musicali; a volte solo vocali per ottenere un effetto di riconoscimento e insieme di differimento dell’immagine; asincronismo-voce-suono che esalta la drammaticità sottolineando il rischio del salto solitario della star nell’orgia dell’esultanza collettiva. Qualche istante…e la illuminotecnica gioca il suo grande ruolo da protagonista: il palco si infiamma di tutti i colori – laser, fari diacroici, gelatine, sagomatori, schermi fumogeni, multischermi impazziti, lampade multiple e cristalli Swarovski rotanti, o tutte queste cose insieme – e l’incendio, calcolato e gestito al computer, aspira al caos della poikilía. Questa – come ben sapevano i Greci – è la manifestazione simultanea di tutti i colori dell’Iride per annunciare l’accesso della divinità alla vista ed alla mente dei fedeli, con una progressione che induce invasamento, possessione, libidine insana, follia. Tant’è vero che poikíle è la Menade invasata e danzante, poikílos è il folle ovvero l’uomo devastato dalle Furie; e però lo è anche ciò che appare splendidamente bello, ciò che miracolosamente, divinamente, muta ed appare cangiante. In definitiva in questa esplosiva accensione cromatica si pone un’immediata relazione tra l’epifania splendente del sacro ed il soggetto spettatoriale che ne risulta sconvolto e scisso nel caos delle sue parti: la vista colpisce la mente, e la mente delira. Delira, la mente, perduta in quel labirinto del sé che offre ed arrende la sua inestricabile oscurità all’epifania della luce divina. Singole parti ed oggetti di scena possono rilucere di questa improvvisa illuminazione, proponendosi a segni moltiplicativi della divinità: capita spesso a strumenti musicali solitari che si mutano dalla scura sagoma della controluce nell’epifania di una fulgida stella , grazie alla stretta relazione che notoriamente intrattengono con le abilità virtuosistiche della star. Prince, ad esempio, suole fare ricorso ad un simile effetto. Ma la luce può anche essere rinviata e come rigenerata da elementi minimali che, d’improvviso, prendono a splendere di luminosità propria: le gocce di sudore sulle membra ambrate di Tina Turner risplendevano come perle...come cristalli possono rilucere filamenti di saliva tra le labbra e la lingua, magari moltiplicati ingigantiti dai rimandi delle installazioni multi-schermo. Sono parti di un sacro reliquiario feticista che nel loro potere seduttivo rinviano nella luce alla gloria dell’intero. Dal particolare allo universale: il sipario di luce artificiale – poikílos – come 161 Catastrofi 1. Modelli a cuspide 2. Modelli a cuspide 3. Modelli a cuspide 4. Modelli a cuspide 5. parabola semicubica 6. l’ombelico iperbolico 7. effetto farfalla 162 163 164 165 166 167 168 il “velo di Maya” nel Teatro classico indiano si dispiega a rappresentare il cosmo, nel momento di acme in cui questo disvela e insieme signoreggia il caos. Ne hanno fatto uso in tanti, dai Genesis, ai Queen; ed è frequente anche l’effetto di un improvviso sfondamento luminoso nell’antro scenico oscuro, di una controprospettiva dalla quale un dio guarda lo spettatore, come ha fatto ad esempio Peter Cox. Il sipario di luce può poi riproporsi in più momenti di acme emotiva e sensoriale dello show, di solito coincidendo con accensioni musicali-strumentali di particolare veemenza. La combinazione diviene pressocché indispensabile per avviare il pubblico al folle invasamento che si fa possessione e trance. Questa può anche essere manifestata fisicamente dalla stessa star che aggancia così il “suo” pubblico, la comunità dei fedeli, in istanti di privilegiata sintonia offerti dal suo deliquio che asseconda passaggi musicali intensi, dalla furia che ne fa esplodere altri; istanti del venir meno e di elargizione della Grazia, pioggia dispensatrice divina. Spesso viene in ausilio il ritornante “muro di chitarre” che nel “progressive” live rock si eleva, dalla preghiera ad un delirio acceso dalla poikilía illuminotecnica, accompagnando la trance dispensatrice del Lou Reed di turno. La poikilía deve la sua sacralità anche al fatto di costituire il momento di esibizione dell’abbondanza, nel senso della Grazia divina che si riversa sulla floridezza economica, sul suo surplus ostentato e dispensato. L’Impianto acustico-illuminotecnico più potente non è soltanto, come è ovvio, quello tecnologicamente più evoluto, ma anche necessariamente quello più costoso e dunque, alla lettera, più “dispendioso”. La dotazione dell’impianto più potente possibile ha costituito per molti anni addirittura il “brand” dei Queen o dei Genesis; naturalmente secondo criteri di totale sostituzione della tecnologia esibita alla tradizionale opulenza scenografica del Grand Variété o del Musical, ma anche in un rapporto di equivalenza con quelle scenografie ora desuete . Potentissimi spot in batterie, attivati ed indirizzati telematicamente, hanno costituito la vera struttura dello sconvolgente live dei Pink Floyd “P.U.L.S.E.” realizzato presso lo Earles Court di Londra nel 1994; in quell’occasione tutto il pubblico venne portato , da quelle sventagliate luminose devastanti l’enorme sala, ad uno stato di esaltazione terrorizzata; come fosse stato rapito nella rete abbagliante di una formazione di astronavi aliene. E, in effetti, come rendere l’epifania di una dimensione altra, non umana, non regolata dai parametri dello spazio-tempo, se non con il ricorso all’apparizione di creature o almeno di segnali provenienti da un mondo alieno? Così, lo sventagliare delle luci sostenuto dal suono evoca spesso, ed intenzionalmente, un effetto-astronave; da questa sembrano essere discesi i Genesis come i Qeen, come gli Iron Maiden, come i Pink Floyd, al loro apparire...oppure ad essa 169 sembrano dover ritornare nel finale. Ma proprio i Genesis scelgono spesso il più sofisticato e filologico labirinto di luce dal quale emergere come “mostri”, celati solitamente nel suo fondo ai comuni mortali ed alla esperienza quotidiana. Altri, facendo direzionare sulle verticali lanci policromi di luce, simulano una più ierofanica e meno fantascientifica ascensione ai cieli, o almeno la nostalgia che potentemente li indirizza al regno del Padre dopo una sacrificale ma momentanea caduta; così Prince il divino, ovviamente, ma anche così Sting. In ogni caso è evidente che l’esibizione dell’apparato tecnologico non coinvolge soltanto la percezione acustica e quella visiva che ad essa si connetta, ma l’intera scenografia dinamica: è conversione polimorfica, sotto i sensi stupiti dello spettatore, del sonoro nel visibile e del visibile nel sonoro; sicchè la luce transita attraverso l’udito così come il suono elaborato elettronicamente si mostra traslucido di luminosità. L’intero apparato multimediale è dunque una scenografia della luce che si rifrange dagli enormi schermi multipli digitali alle tastiere, eletroniche e no, alle consolle ed ai microfoni. Da Live at Pompei in avanti gli eventi del rock e del pop hanno imparato perfino, all’occorrenza, a fare a meno dei teatri grandi o piccoli, a fare a meno delle scene “costruite” per offrire a spettacolo – alla lettera del termine – la luce stessa del quasi incorporeo ma potente apparato multimediale, magari rifrangendola tutta nell’esasperata simbolicità mitica e cosmogonica di un grande disco del sole di rame. Naturalmente esistono numerose pratiche specifiche per giungere a tutto questo, di pre-produzione più che di post-produzione, dato che qui la postproduzione non può esistere e coincide di necessità con il live. Ricordiamo – oltre ovviamente al côté musicale ed elettro-acustico, oltre al côté illuminotecnico-scenografico – la preparazione di immagini e spot da immettere nel live; l’abilità del missaggio in diretta immagini-suono che si incardina in una nuova grande pratica di spettacolo, quella del Vj; le prove e riprove sulle interferenze e sul dialogo live tra la star e le immagini, o tra la star e la sua stessa immagine (come in Live at Atlanta delle Destiny’s Child, fino a giungere addirittura alla composizione davanti agli occhi del pubblico stupefatto di giganteschi effetti-ologramma. In attesa di quelli veri in azione sul palco, nel film Simone abbiamo già visto una creatura reale che appare in uno stadio come una star olografica; per contro, l’ologramma dinamico, alto come un edificio di diversi piani, di Britney Spears appare in Live from Las Vegas (2002), in realtà interamente realizzato per via illuminotecnica e sincronicamente interagente con la star reale. Discendenti da un grande progetto creativo-ingegneristico, a volte da un progetto d’Arte come quello di Wim Wenders per i live degli U-2, alla fine, tutte queste ed infinite altre pratiche della multimedialità conferiscono al prodot170 to live quella incorporeità luminosa, quel consistere in cangianti perimetrazioni della luce che lo assimilano ad un videoclip sintesi di effetti speciali, al film sperimentale n-dimensionale e tutto forme e cromie da “cinemago”, nell’accezione prefigurata da Eizenstejn per il futuro “in diretta” della regia e del cinema. Così, l’unica cosa che si possa dire del davvero sorprendente Confessions Tour di Madonna è che lo show appare come un lungo, interminabile videoclip di alta tecnologica post-produttiva, pur essendo in realtà un prodotto live: la pesantezza dei corpi, della materia, è infranta, dispersa, e resta la leggerezza luminosa delle superfici dinamiche a dare volume traslucido e flagranze al gioco scatenato dei perimetri cangianti. E allora l’esito pieno della figuralità – il sogno di ogni accadimento teatrale – è infine magicamente attinto. Spesso, con le molte migliaia di Watt usati per l’acustica e l’illuminotecnica di un live rock si potrebbe muovere un transatlantico, illuminare una città di medie dimensioni. L’ostentazione della potenza dell’apparato – tutta immateriale, tutta energetica e vibratile – elabora la dimensione adatta al manifestarsi della straordinaria energia della star. Questa – per quanto consumata da stress, alcool, nevrosi, droga, sragione...o forse proprio perché così consumata – si mostra infatti capace di un consumo d’energia sovrumano lungo l’arco delle due o tre ore della performance; d’altra parte è alla star che compete il possesso e l’uso dispensatore del Mana divino, l’energia suprema. Di un siffatto consumo sovrumano si muore, si resta stroncati nel fiore degli anni al fine di consegnarsi giovani all’icona immortale; ma a volte accade l’esatto contrario: l’energia dissipata è come una corrente che fluendo depura, un dono dell’Alterità al suo prediletto, sicchè assicura una vita lunghissima cui arride l’eterna, incontaminata giovinezza. Se alla prima categoria è difficile non associare Elvis, capostipite di tutti i “morti giovani” a venire da Jim Morrison a Sid Vicious, come non ascrivere alla seconda il giovinetto sempiterno Mick Jagger?...La dissipazione energetica della star si manifesta inoltre nel virtuosismo con cui manipola sul palco sport e danze, o loro equivalenti simbolici. Non si tratta, dunque, soltanto di esercitare ai limiti del parossismo la propria vocalità, superando l’umano per approdare al mostruoso, al portento, all’assoluto naturale del ferino o del catastrofico; non si tratta soltanto di assecondare il ritmo strumentale con dinamiche e sudore o di trasalire sui “muri di chitarre”: senza mai perdere il ritmo la star si produrrà nello step e nel rock, nel flamenco e nel caraibico, nella brackdance, nello skettboard, nell’acrobatico, in danze metropolitane e post moderne d’ogni tipo, ma anche nel Wrestling, nelle arti marziali, nella boxe, nel baseball...spesso coadiuvata da eserciti di boys o di girls dei quali, ovviamente, si propone come l’unica étoile in una gara di virtuosismo che li batte sul loro stesso terreno professionale. 171 Tutti ciò non sembri inessenziale per la seriosità di un approccio teatralogico, non sembri “pratica bassa” da confinare nel ciarpame scenico di cui non vale la pena trattare, secondo quanto l’accademia ha già perpetrato nei confronti delle pratiche del Grand Variété o per quelle dello show notturno metropolitano, o come fa oggi nei riguardi del preteso trash televisivo. Tutto ciò comporta in realtà una totale ripresa di pratiche ed insieme l’avvio di una globale rivoluzione scenica che, al contrario, manda nella soffitta dei ricordi polverosi, dei ricordi inattuali destinati a divenire nel tempo il ciarpame della memoria, compagnie di giro e compagnie di Stabili dai trecento borderò trecento, attori dalle pratiche a mezzo busto e preoccupati della futura pensione, pubblici in abbonamento e pubblici scolastici, saggi di accademici e collane editoriali-concorsuali di somari trionfanti, e perfino testi di autori da “nuova drammaturgia” protetta dallo Stato (a meno che, quindi; non siano degli Shakespeare che hanno previsto con la loro scrittura di farsi film, musical, fumetto, pubblicità, installazione, song... e per l’appunto, rock!). I futuristi non immaginavano quanto avessero ragione, dato che il loro profetico manifesto sul “Teatro di Varietà” scaturiva solo da percezioni sinestetiche e da empatie dinamiche; ma un secolo dopo...dopo che tutti abbiamo vissuto per cento anni nel trascinamento di sovrastrutture istituzionali e sottoculturali, quelle del così detto “teatro di prosa”,...siamo in grado di cogliere la portata della rivoluzione scenica prodotta dal live pop e rock. Una per tutte: è tramontata ovviamente l’epoca della scena decorativa, ovvero la “scena del principe” che si elaborava come ammirabile per la sua minuziosa specularità rispetto ad un sovramondo platonico in eterno ipostatizzato; ma è tramontata anche la scena naturalista del “manto di Arlecchino” calato per due terzi sulla verticale del boccascena, la “quarta parete” immaginaria, la visione dal buco della serratura, i mobili impallanti e le quinte lise della carta da parati dei salotti, o lucide della similpelle degli studi, o livide delle vetrate di verande o ancora unte e trasudanti delle piastrelle di cucine e cessi; è stata travolta pure la più recente scena “opera d’arte” da teatro di regia, il manufatto pesante e semovente firmato dallo scenografo, degno piuttosto di una galleria d’arte moderna; e dunque la “scrittura della scena” elaborata dal generoso equivoco di Craig o dei costruttivisti, sui cui declivi impervi l’attore sembrava dover ruzzolare ad ogni istante e, in ogni caso, visibilmente appariva nell’imbarazzo del rischio, nella meccanicità marionettistica di una recitazione costretta tra il sublime piano di regia e l’impraticabilità del monumento artistico. Superando tutto questo, con lo show della poikilía ritorna l’antro scenico degli sciamani, la caverna di platonica memoria, e perciò il teatro come evocazione dell’oltranza, mistero ed epifania. Lo spazio vuoto e oscuro, insondabile, viene esplorato dalla luce e dalla luce riceve forme, dimensioni, diret172 trici e dinamiche infinitamente cangianti; non significanti di un qualche significato, di una somiglianza quale che sia al “Reale”, ma finalmente Significanti puri, in sovrabbondante dispendio rispetto a qualsiasi reale; Mana che manifesta ogni possibile n-dimensionalità e ce ne parla agli occhi ed alla mente. L’eventuale visibilità di ponteggi di luce o praticabili, passerelle, torri di tubolari, ascensori, così come fondali e quinte forniti di traslucidi schermi digitali, non costituiscono la presenza di elementi scenici che per mimetismo o per funzione simbolica si propongano come significanti di una referenza esterna, come accadeva nella scenografia tradizionale, ma strutture di funzionalità agili ed auto-referenti, itinerari alla percorribilità nel labirinto dell’antro. Nemmeno, dunque, congegni materici esibiti, così come avevano intuito e praticato i costruttivisti, ma funzioni del live e della sua potenza. Potremmo dire che con il vuoto insondabile dell’antro-abisso nero verso ogni possibile oltranza e con le scene di luce – in cui appaiono angeli di luce come silhouettes oscure ma aurelate – con questa dicotomia luce-ombra fatta di materia impalpabile e levitante senza peso, di non-materia e di grafie pure, il teatro ritrova la sua necessità originaria, quella del rito e del disvelamento, della comunità inaugurata. Se non fosse anche questa un’affermazione troppo pesante. La necessità di questo odierno teatro, grazie all’abbondanza del Significante esibito come tale, è tutta dell’ordine volatile e cangiante del voluttuario, manifesta la necessità della pulsione come tale, nella sua sacralità priva di qualsiasi reale mediazione sacra, e meno che mai ideologica. Rispondendo all’economia incontrovertibile dell’Io, all’altalena pulsionale, questo teatro si manifesta come originario rispetto alle stesse origini della teatralità: non è sacro ma dà la motivazione perché si elabori il sacro a sua giustificazione, non è rito ma dà la motivazione perché si istituisca il rito. L’antro di luce del pop live rende inattuali d’un sol colpo tremila anni di dispositivi scenici e di configurazione dei teatri; nel senso che ne dichiara la loro ragione ideologica e sovrastrutturale, il loro intento comunque risarcitorio rispetto alle regole del contesto sociale, rispondendo con spudoratezza ingenua solo alle domande di Sua Maestà il Desiderio. Si proclama perciò teatro-teatro, l’unica scena che finalmente vuol risarcire solo se stessa e se stessa pone come valore assoluto: il Significante non ha morale, meno che mai contenuti. Non inganni quanto abbiamo già evidenziato a proposito della percezione, da parte del pubblico, di una “Fabula” perennemente dilacerata tra Eros e Thanatos, nel caso specifico tra ipostasi iconica e minaccia di disfacimento: questa “Fabula” non è proposta dal pop-live secondo una liturgia che ci obbliga ad un contesto di valori altri, quindi alla considerazione ed all’accoglimento di un contenuto che racconta di quei valori. non è una “fabula” trascendentale, ma soltanto trascendente. Qui il valore, se così si può ancora chiamare, è infatti il desiderio di per se stesso e che racconta spudoratamente se 173 stesso; cioè il preteso valore è solo una traccia, quella pulsionale dell’alternanza della libido, grafia del soggetto, traccia tuttavia fondante di ogni elaborazione di valore. Scandalizzarsi perché questa traccia sia sollecitata da interessi economici surrettizi e potenti, ovvero da un gioco di mercato che trascende ogni soggetto e ne fa un oggetto di consumo, è anche questo uno scandalizzarsi moraleggiante e contenutistico, dunque ideologico, poiché ignora che ogni soggetto, il Soggetto, è per l’appunto economia ed è per l’appunto consumo, senza di che non si dà proprio alcun soggetto! Il fattore specifico – poiché, come asseriva il buon vecchio Marx, ogni economia si elabora in maniera specifica in base ad uno specifico bisogno o mancanza – è che in questo caso il bisogno, la mancanza siano riconosciuti ed esibiti di per se stessi, come categoria motrice di ogni economia, e dunque dell’economia primaria e significante, quella psichica. Il pop-live è in definitiva un cinico, interessato, ma spudorato, veritiero bagno nella verità economica del Soggetto, ovvero nella sua spettacolarizzazione. E che sia una spettacolarizzazione interessata, manipolata, strategicamente programmata da potentati, di ciò non ce ne importa proprio nulla, perché non sposta la questione minimamente, non sposta infatti la verità spudorata dell’appello al desiderio...Sarebbe allora come prendersela con il cosmo, poiché anche il cosmo in fin dei conti è un potentato!...Sul piano artistico, ma anche intellettuale, la questione è stata esplicitata una volta per tutte da Andy Warhol: le sue serigrafie iconiche – dalle celeberrime Marilyn ritentate con infinite variazioni per decenni a Liz, a Mao al Ché - nelle quali le star “voltificate” risultano di valore praticamente scambiabile con il primo piano della zuppa Campbell, non denunciano la responsabilità del mercato più di quanto non rinviino al “dispiacere” ideologico del critico, cioè per niente! V’è al contrario in quell’operazione un piacere figurale che si attaglia alle superfici ed alla loro perimetrazione, parallela alla loro possibilità di scambio e di uso gratuito e dissipativo in quella “Disneyland universale” (per dirla con Baudrillard) che è il mondo delle merci simulacrali. Bene inteso, non si intende qui avallare nessun immobilismo e nessuna supina acquiescenza, né attribuita alla pop-art né da parte nostra: la resa consenziente alla verità insopprimibile della pulsione è una scelta; così come una scelta è la propria dislocazione verso un soggetto critico, verso un’attitudine demistificante le proprie stesse relazioni pulsionali rivolte a quell’ideale dell’Io che si configura nella speculare rete desiderante dello sguardo. Si può essere travolti da Eros nella passione di una contemplazione figurale, quella piena di sé come di Grazia della silhouette epifanica; ed al contrario si può rimuovere quella passione dislocandosi nel disincanto, attraversando la lucidità analitica della frustrazione demistificatrice, la quale inevitabilmente ci 174 porterà alla considerazione del “corps morcelé” – non corpo feticistico, ovvero pur sempre correlato alla totalità trionfante del Narciso, ma in dispersione e riappropriazione caotica – al “corpo senza organi”, al mutante sia esso cyborg o “cosa” proteiforme. Naturalmente, la contrapposizione segnala l’accesso a due abiti psichici e a due elaborazioni culturali in antitesi: la figuralità ed il minimalismo, lo show di contro all’estetica del “dispiacere” e – volendo riconoscerci tutti deleuziani – si tratta di scegliere nell’ambivalenza di Deleuze tra l’infinito flusso di fascinazione in svolgimento della “piega barocca” e il nomadismo mutante, anti-speculare, di una corporeità viscerale che non possiamo più nemmeno denominare “corpo”. Il pop-live corrisponde alla prima istanza, cioè all’estetica della piega in svolgimento, e noi con quello. Libero ognuno di storcere il naso di fronte a così sfrontata volgarità di scelta di piacere e di indirizzarsi altrove, verso le raffinate e sublimi mete del “dispiacere”. Troverà alla fine sempre un Sid Vicious, o un ben più ambiguo Marilin Manson che, vellicando la sua anti-figuralità ed anti-specularità, lo trascinerà inconsapevole ben dentro quelle strategie di consumo dei potentati che voleva sfuggire e denunciare. Poiché le due propensioni, in definitiva, ostentano la loro polarità, perché hanno bisogno l’una dell’altra, e di fatto intrattengono scambi continui a reciproco supporto. D’altra parte, la poikilía della scena di luce dimostra d’essere innovatrice rispetto al contesto dei valori costituiti anche sul piano delle sinestesie con altre pratiche artistiche rivoluzionarie o comunque innovative. Quel che abbiamo osservato a proposito della poikilía del pop-live si può affermare allo stesso modo per il complesso di materiali ultraleggeri e trasparenti, le volute parossistiche e cangianti di luce in maniera catastrofica, le policromie azzardate ad esibizioniste di tanti nuovi teatri e centri di cultura di oggi secondo le attuali modalità dell’architettura. Questi luoghi di spettacolo – coerenti alle funzioni e progettazioni delle nuove città-spettacolo – hanno in tal modo superato non solo le istanze delle scene tradizionali – la principesca, la naturalista, quella di regia e d’arte – ma hanno reso obsolete perfino le ricerche sulle molteplici relazioni tra pubblico e scena intraprese da Gropius in poi mediante teatri polivalenti e teatri mutanti: tutto ciò i nuovi dispositivi della cromía luminosa lo hanno fagocitato e rilanciato ad un livello di nuovo estetismo poli-funzionale ed auto-referenziale. Dei tanti esempi, di cui altrove ci siamo occupati (Cavalieri del Caos), basterà qui ricordare il mirabile EMP (Experience Music Project) realizzato a Seattle da Frank Ghery e proprio con destinazione al live pop e rock. Quanto alla funzione scenografica della luce, questa si coordina dichiaratamente alle più aggiornate estetiche della light-architecture, tra le quali quelle strabilianti del “signore della luce” di Las Vegas, l’architetto d’ascendenza pop Jon Jerde. D’altra parte che oggi l’estetica dei teatri e dei musei abbia a che fare con gli 175 hotel-casino, con i “parchi a tema” e con gli “Shopping Center” non è un mistero: le cattedrali delle merci tendono a somigliarsi tutte quante, nell’assetto metropolitano globale, quali che siano le tipologie della merce ritualizzata ed esibita. Il pop-rock, per la sua dichiarata motivazione nel marketing globale, è il primo tra i generi della cultura contemporanea ad avere abbracciato quella stessa estetica nelle sue installazioni live. Ma non è detto che la scena di luce non riesca, se necessario, a fagocitare strategie di significazione che appaiono proprie del minimalismo. Da Laurie Anderson in poi è facile vedere una clamorosa e sfavillante performance rock che si va spegnendo, o si intervalla con inquietudine angosciosa, attraverso l’immersione nel buio...oppure attraverso l’intermittenza di una fonte di luce flebile e a rischio: per esempio una pulsante lampadina rossa esplora la fronte del performer e gli penetra la mente facendogli socchiudere gli occhi, quando l’incendio dell’animo viene scavato e insieme simboleggiato con estrema essenzialità di mezzi... quando poche note ripetute all’infinito quell’incendio lo aizzano, portandolo a divampare verso la più drammatica delle catastrofi...o almeno facendole temere ad un pubblico sospeso sul baratro della più stringente emozione. Siffatte pratiche, che potremmo definire psico-minimali, sono consuete nelle varie forme musicali del cabaret o nelle caves confidenziali o sperimentali, e perciò di solito l’evento pop-rock che vi fa riferimento ne usa ad intermittenza, come di espedienti digetico-drammatici. E il caso, per esempio di Amy Winehouse allo Shepperd’s Bush Empire di Londra (2007), dove è evidente l’intento dell’instaurazione di un clima intellettuale e confidenziale destinato per la sua sofisticazione a pochi eletti – che poi sono i molti che gremiscono il teatro – con i quali si instaura una corrente di intensa emotività nella compartecipazione ad una pratica musicale; e questa si pretende come “alta” per l’originalità e l’irripetibilità che la rendono affine alla Jam-session. Ma poi il grande evento, nel grande spazio del live torna sempre alla luce abbagliante, e riassume la star nel fulgore degli inizi, per esempio con l’irruzione della sfavillante diretta da Los Angeles di conferimento degli awards all’artista in lacrime per la “finta” sorpresa. Discenda da un astronave, come principe splendente degli alieni destinato a profetare e colonizzare sulla terra, Ascenda in levitazione al regno del Padre sulla scala di torrenti di luce, oppure emerga dagli Inferi del sottopalco e si innalzi quale Lucifero abbagliante, sempre in ogni caso la pop-star epifanica si circonda della sua aureola come del suo habitat, anzi si manifesta tutt’una con il fulgore di questo habitat luminoso, dalla quale la individua e ritaglia solo il contorno netto, trionfante, della silhouette. Alle volte l’aureola si materializza in un manufatto traslucido e trasparente – di plastica, acciaio, alluminio, vetro, specchi, garze, sete...- capace di accogliere e rilanciare potenzia176 ta ogni fonte di luce, di far rifulgere al suo interno quella silhouette trionfante, di chiudersi e dischiudersi per consentire l’avvento sulla terra (sul palco), di levitare o discendere sulla verticale del palcoscenico a tutta volta. Si concretizza così scenograficamente, come già negli “ingegni” sacri quattro-cinquecenteschi, , quella simbologia della “mandorla di luce” che attribuisce all’icona della pop-star la stessa sacralità soprannaturale dell’icona sacra. A siffatta “mandorla di luce” ha fatto ricorso, tra i tanti, Madonna in Confessions Tour. Nella tipologia iconica essa include il soggetto che ne è il portatore in una curva ellissoidale di luce raggiata, volendo significare che quello stesso soggetto è irradiatore di luce, anzi è tout court fatto di luce, è un soggetto-cosmo, per la stessa potenza della Grazia soprannaturale che lo ha sostanziato. Questa simbologia proviene da un sostrato culturale indoeuropeo arcaico, ma transita ad oriente e nel culto di Shiva e della sua sposa Parvati, la sua shakti, entrambi divinità cosmogoniche che evidenziano nella loro vicenda l’eterna dialettica tra cosmo e caos. Passa poi al Buddhismo e, come attributo del Buddha, la “mandorla luminosa” si manifesta in tutto l’estremo Oriente. Ad occidente si fa attributo di Dioniso, poi di Cristo (nella tassonomia iconografica della trasfigurazione), della Vergine (nella tassonomia dell’Assunzione), infine degli Angeli di più fulgido splendore. Con il degradare delle gerarchie angeliche e, infine, con i santi, la “mandorla” si ritrae sistematicamente alle dimensioni più o meno vaste del Nimbo, aureo disco di luce raggiata che circonda solo la testa del soggetto portatore. Il Nimbo, tuttavia, si ritrova di frequente a sostituire per ellissi la Mandorla anche nel caso dei soggetti di massima luminosità di cui sopra. Pertanto è attributo delle divinità induiste e, prima ancora, delle egizie e mesopotamiche. In occidente lo si riscontra fin dall’arcaismo come attributo di HeliosApollo (il Sole) nella tassonomia della quadriga che sorge follemente involata dall’impeto dei cavalli bianchi, ed anche di Artemide-Selene (la Luna), poi di Eos (l’Aurora), di Phosphoros (dio tutto luce da cui discende il nostro demone Lucifero), infine degli imperatori romani, prima di passare a contrassegnare i santi della cristianità e poi perfino le stampe delle eroine dei feuilleton, almeno nel fulgore della loro capigliatura e dei loro grandi occhi lacrimanti. Ma spesso l’iconografia, anche fotografica, delle star le ha rappresentate così aureolate dal Nimbo dato dal flou del contesto, in una luce che si trasmette anche ai loro occhi ed al loro sguardo...oppure, di nuovo, ha più semplicemente evocato il Nimbo attraverso il fulgore di una capigliatura ariosa e splendente... In fondo, grazie alle civetteria femminile manipolatrice di ogni cosmesi, lo stesso mito hollywoodiano della star platinata – dalla Harlow a Marilyn alla Novack alla Mansfield alla Basinger... non fa che riprodurre la simbologia ed 177 il potere sovrannaturale del Nimbo. Perciò, appaia o no da una Mandorla, l’icona della pop-star vi fa spesso ricorso; sia per via degli effetti luminosi che aureolano il suo capo sia per il fulgore di una chioma aureolante che accoglie e rilancia la luce. Di tale qualità simbolica appare la leonina, avvolgente, ingovernabile chioma d’oro di Beyoncé in Destiny’s Child at Atlanta. Qualcosa che si era già visto al cinema, d’altronde, con il fulgore di perdizione della chioma incolta di B.B. o con il fulgore da supplizio sacrificale dell’altrettanto incolta chioma di Barbarella–Jane Fonda, incatenata così carica di mana per il pasto rigeneratore dei mostri, degli uccelli, o dei tasti titillanti di un organo “orgasmico”. Le traversie della creatura aureolata non sono che la sintetica ricapitolazione simbolica, offerta al desiderio spettatoriale, di un attraversamento dei quattro stadi percorsi dalla storia dell’umanità nel mito: l’età dell’oro, dell’argento, del bronzo e del ferro; secondo le quali età la vita umana ha avuto inizio nella felicità edenica piena ed incorrotta, ma poi ha affrontato via via il degrado che le ha fatto conoscere malattie e miserie, inganni e delitti, fino all’ineluttabile scoperta della morte e della dissoluzione. Poiché l’ontogenesi è la ricapitolazione della filogenesi, ogni individuo ha compiuto questo percorso dalla beanza degli inizi al disfacimento della propria immagine speculare ed al nulla; ed ogni individuo desidera compiere lo stesso percorso a ritroso, intraprendere secondo un sogno utopico la risalita che lo porterà verso la piena beatitudine. Il Dio che discende tra noi e soffre e muore e ritorna trionfante al Padre, l’Agnello sacrificale, come lo sciamano, o l’eroe di ogni vicenda mitica, simboleggia questa speranza e questa possibilità di risalita che abita nell’immaginario. Alla stessa funzione simbolica ed alla stessa “Fabula” corrisponde la star nell’affrontare le sue traversie, romanzesche, filmiche, sceniche o soltanto iconiche che siano; o anche semplicemente nell’affrontare la fatica, il sudore, la sofferenza, il pathos, il rischio che aggrediscono e pongono in liquefazione la sua immagine nella performance, ma che le danno anche l’opportunità di ricomporla quell’immagine con magistrale destrezza sovrumana, sfidando il destino, oltre ogni destino. Quella ricomposizione iconica è un’assoluta necessità, poiché l’età dell’oro, il Paradiso l’Arcadia, l’Eden sono spazi chiusi e perimetrati nei quali vige la pienezza incorruttibile. Così, anche chi abita lo spazio chiuso della felicità si identifica nell’esatta perimetrazione della sua pienezza. E questa qualità lo rende esattamente iconico. Se si ammettesse una discontinuità del contorno, una falla nella pienezza, ciò equivarrebbe ad introdurre il defluire del tempo in questo “eterno presente”, e dunque significherebbe contaminare la felicità dell’oro con le traversie e i malanni delle altre età degradanti. Questa impossibilità di contaminazione ci dà tutta la misura del sacrificio che la creatura iconica compie quando si decide, o è indotta, a manifestarsi a noi 178 al fine di trascinarci con sé; dunque quando affronta quel degrado al quale tutta la sua natura ripugna. L’aureola che circonda il volto della star nel poplive, la mandorla luminosa da cui la star viene fuori come se discendesse dalla sua astronave aliena, non fanno altro che ricordare questa appartenenza all’età dell’oro, età alla quale il performer dovrà ritornare: la luminosità aurea evoca pienezza, abbondanza, felicità, giovinezza e l’immutabilità nel tempo dei tempi di queste condizioni. 7. Mitologie La condizione della consistenza a-temporale nella piena felicità non ci consente tuttavia di immaginare che nell’età dell’oro ci si possa annoiare, così vari ed infiniti sono i piaceri che essa offre. I cinque sensi sono saturati da un’inesauribile cornucopia di esperienze sublimi, né a tali esperienze fanno difetto la varietà, la sorpresa, la potenzialità di fruirne in maniera piena e di continuo rigenerata. In definitiva, tutti immaginiamo che nell’età dell’oro l’alternanza dell’economia psichica tra Eros e Thanatos abbia cancellato il secondo polo, senza che il primo ne abbia risentito alcuna crisi, magicamente!...Ora, l’iconografia d’ogni tempo, subendo le censure delle contingenze storiche, ha di sovente tradotto siffatto eterno presente del piacere nella rappresentazione del piacere di un solo senso, privilegiato per la immaterialità e dunque per la spiritualità del suo oggetto: tale senso è l’udito, e l’oggetto è la musica. Il felice abitante del luogo ameno – quale che questo sia – e sia egli intento con diletto a rimirare una beltà suprema (magari se stesso), ad amare con ardore, a cibarsi d’ogni delizia e ad avvolgersi nei profumi, sempre nella tradizione iconografica viene rappresentato come ispiratamente intento alla produzione o all’ascolto della musica che, per ellissi polimorfica di un solo senso di riferimento, può simboleggiare e lasciare immaginare tutto il resto. La creatura edenica ha la musica come suo habitat. Ha scritto infatti Jean Starobinski: “il déduit (trastullo) musicale [...] è, insieme, ciò che meglio risponde al principio di pienezza e ciò che non altera in nulla l’integrità dell’eterno” (Le incantatrici, pag. XII). Per questa rispondenza ad una tassonomia della raffigurazione edenica la star della musica, più di ogni altra, si presta in sommo grado ad un’assunzione iconica. Tutti possiamo immaginare che essa, nella sua ipostasi d’oltranza, viva nell’habitat della musica come nel suo elemento consustanziale e che, pertanto, essa ci porti con la performance live il dono inestimabile di quell’oltranza. Ed ecco perché lo strumento del suo virtuosismo viene ritagliato dal controluce, eretto come un fallico scettro, illuminato da una aureola vicaria tutta sua: gli accade quel che accadrebbe esattamente al bastone sciamanico portatore del mana commutatore di tutte le cose, alla bacchetta del mago, al simbolo della croce che infatti nell’iconografia appare spesso 179 Mitologie 1. Il sesso di Dio: Zeus-Artemide insidia Callisto ( Jacopo Amigoni) 2. Artemide/Luna/Cane (Cavalier d’Arpino) 3. Leda con Zeus teriomorfico (Leonardo) 4. Diana-Mandorla lunare ama il sonno eterno di Endimione (Pier Francesco Mola) 5. Nettuno e Anfitride con nimbo aureo 6. Pistrice- Nereide chimera 7. Lo sguardo della Venere pandemia (Boucher) 180 181 182 183 184 185 186 187 aureolata e, nell’oro, portatrice dei monogrammi di un proprio specifico messaggio liturgico. E allora, dalla performance ci si aspetta quello che esattamente Starobinski descrive: “Il tempo dell’infelicità conosce una breve sosta, e questa sosta, ottenuta attraverso la magia di una maschera, vogliono farcela sentire come l’eco di una felicità perduta; vorranno farci ascoltare la musica, con l’intatta durata da essa posta in atto, come un richiamo delle favolose origini” (pag. XIII). Gli apparati tutti che predispongono ed elaborano la “festa” servono congiuntamente ad immergerci in quella “aura” che è il non-tempo della grande “vacanza” originaria, lo spazio dell’infinito piacere dei nostri sensi e dunque della nostra immaginazione, là dove sarà possibile all’oro delle origini abbagliare la nostra vista e renderla traslucida alla visione della silhouette epifanica. E alla musica si affida il compito di trascinarci fuori dal tempo della colpa e della sofferenza, della corruzione e della morte, di accostarci alla comunione con la star che, per amore, si degna di apparirci, e perfino di assumere tragicamente i tratti della nostra stessa corruttibilità. Ma il suo canto, come quello delle sirene, si eleva sulle soglie della morte in un rischio calcolato, un rischio che tanto più la assolve quanto più quella ci seduce, alla lettera ci porta fuori dalla nostra vita, in una ex-sistenza nella quale non possiamo a lungo resistere. Così, di necessità, quel piacere è per noi effimero. Tuttavia, per il tempo che vale, seguire quel canto di sirena, cantare anche noi quel canto, ci trascina nell’esperienza di un oltre dal tempo mortale, di un oltre dall’universo della corruttibilità; all’esperienza, dunque, di un’altra dimensione. Ciò non toglie che tale percorso sia per noi ambivalente e quanto mai rischioso, come, del resto, lo è per la star la cui tragedia non può essere simulata, ma reale!...Se no che valore avrebbe?...Solo che il glorioso destino della star è segnato fin dall’inizio e per sempre nella sua stessa aura luminosa, e il nostro?...Del canto delle Sirene a volte si muore, se non si possiede l’accortezza dolente e cinica di Ulisse, ed è questo che inebria nell’avventura dello show. Il più gran poeta del femminile seduttivo ed inattingibile, del femminile proprio come epifania iconica, ha descritto un live musicale – del resto è l’epoca della Camerata De Bardi e dell’opera musicale nascente – ed è il live della grande ingannatrice, la seduttrice per antonomasia, ma non sposterebbe nulla se la sua maga Armida si chiamasse invece Beyoncé o Mariah Carey emergente alla luce ed al canto: “Così dal palco di notturna scena/o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare./ Questa, benché non sia vera Sirena/ma sia magica larva, una ben pare/di quelle che già presso a la tirrena/piaggia abitàr l’insidioso mare;/né men ch’in viso bella, in suono è dolce/e così canta, è l cielo e l’aura molce” (Gerusalemme liberata, XIV, 61). Il momento dell’ispirazione è senza alcun dubbio fornito al poeta dalla diretta esperienza 188 della performance scenica delle prime divine del teatro lirico nascente in forma di Pastorale. Ma è del pari evidente che il richiamo al mito aureo si fa nel passo da intratestuale – relativo alla tematica stessa dei drammi pastorali – extratestuale, ovvero relativo alla epifania della diva nella rappresentazione. Ora, poiché il credere agli incantesimi manifesta una regressione al pensiero primitivo e, insieme, ai primi sviluppi della vita psichica individuale, queste grandi seduttrici sono la realizzazione del nostro stesso desiderio e, se per qualche verso appaiono pericolose o addirittura mortali, ciò corrisponde al timore della punizione che sempre accompagna il desiderio. Ma è un timore che vale la pena di soffrire, se questo è il prezzo per entrare nel giardino incantato della seduttrice: così come nel melodramma alle sue origini – quando era popolato da eroi e semidei, ninfe e maghe – anche adesso l’apparato dell’opera pop predispone quel giardino incantato, là dove saremo felici, per un tempo che s’invola, con la grande seduttrice che vi abita e che nella sua icona per intero l’incarna... L’esperienza sublime non ha nulla a che fare con quelle che è possibile intrattenere d’ordinario, nella nostra vita reale. Solo colpevolmente una donna del nostro quotidiano può conformarsi all’icona della beltà scenica. Certo, ciò avviene nella nostra società affluente, almeno da quando sono esistite le Marilyn, le B.B., le Gilda imitate dalle moltitudini femminili; ma ciò avviene per l’appunto sotto il segno della colpa che instaura dal modello lo spazio dell’inadeguatezza e, alla lunga, dell’insostenibilità. Infatti, come ha scritto ancora il poeta nell’invettiva contro quel valore dell’onore, controriformato, che è poi il sociale, che è il moderno, che è la frustrazione: “Tu a begli occhi insegnasti/di starne in sé ristretti/ e tener loro bellezze altrui secrete;/tu raccogliesti in rete/le chiome e l’aura sparte;/tu i dolci atti lascivi/festi ritrosi e schivi;/ai detti il fren ponesti, ai passi l’arte” (Aminta, vv. 698-705). E sognava il poeta, dunque, il contrario inattingibile: lo sguardo licenzioso, le parole e i gesti invitanti nella ostentata separazione feticista dal corpo, i capelli sparsi nel caos che paventa la pura perdita, il passo languoroso ed allusivo mosso dal baricentro rovente del plesso solare. Tutto quel che è negato è qui desiderato, nella disperazione d’un desiderio che s’è deviato per il poeta, un giorno, scontrandosi con le perdite d’amore, sicchè ha immaginato, infine, proprio la sua inattingibile e assoluta Shakira. La ninfa Shakira d’ogni tempo che l’ha reso folle. Tornando nel solco di Starobinski, sono dunque tre le tipologie dell’iconismo femminile con attributi di mana sacrale, quali sono state formulate dallo spettacolo a partire dal melodramma e dalla Commedia dell’Arte fino al poplive dei nostri giorni. Tre tipologie talmente codificate da decidere, nel bene e nel male, attraverso la loro solo epifania, delle sorti della rappresentazio189 ne: successo, fascinazione, mitologie del backstage e del post-stage, interdetto morale e/o culturale, censura e persecuzione, ripulse atterrite dal femminile di autocrati della scena (come Craig) o del set (come Cukor nei confronti di Marilyn). E queste tre tipologie sono: la “Armida seduttrice” che instaura il regno delle false apparenze e delle illusioni, e fa del proprio potere del se-ducere lo strumento per smarrire la vista e la mente di chi la rimira nel labirinto di un desiderio inappagabile; la “Poppea incoronata” che rifulge nella gloria della sua beltà trionfante e incorruttibile, ma che tale appare perché così piena di amore sensuoso – in tutti i sensi dell’aggettivo – da farsene provvida dispensatrice, per l’appunto la grande consolatrice d’amore; c’è infine la “Manon suppliziata”, fanciulla portata dal suo stato sociale elevato e dalla sua stessa beltà straordinaria alla frivolezza incosciente, indotta dal libidinoso moralismo borghese alla prostituzione, tradotta in catene senza riguardo per quella sua beltà che non sia lo spettacolo sadico dello sciupío, infine sfinita e languorosa in quel deserto americano che è il deserto dell’anima ed il venir meno del corpo. Ma le tre tipologie – la tassiana, la monteverdiana e quella di PrévostMassenet-Puccini – di sovente si sono tra loro intrecciate in vario modo, determinando drammaturgie, attese spettatoriali, icone viventi e leggendarie; ed in generale si sono manifestate talmente potenti da sostenere nell’immaginario di ogni spettatore una sorta di inconscia equivalenza tra apparizione femminile e spettacolo, istituendo nelle attese di ognuno quell’apparizione come l’essenza stessa di ogni spettacolo possibile, o se si vuole istituendo la condanna dello spettacolo alla funzione voyeuristica che è insita nel suo stesso nome, in barba a tutte le dotte disquisizioni dei critici e di teorici come degli educatori e dei legislatori. Sicché, con buona pace di tutte le estetiche del “minimale” e del “dispiacere”, risulta incrollabile nell’immaginario l’aforisma secondo il quale “la donna è spettacolo”. Ora, dato che il pop ha avuto la spudoratezza di affidarsi a tale aforisma, perseguendolo nello scambio simulacrale planetario, ecco che di necessità è soprattutto di donne che qui ci troviamo ad occuparci; senza con ciò negare che vi siano delle forti tipologie iconiche maschili che possano assurgere alla scambiabilità di merci simulacrali, soprattutto le icone del “machismo” affette da processi di femminilizzazione: dal campionario infinito, nel nostro caso basterà estrarre Elvis e Mick Jagger, Bowie e Michael Jackson... Le tre tipologie “femminili”di cui sopra caratterizzano in ogni caso l’icona come di per se stessa performativa: essa ci racconta un dramma, anche se si materializza nella téchne di un ritratto, di una fotografia, di un manifesto; essa si carica di didascalie diegetiche, a volte effettivamente dette o stampate ma spesso anche soltanto virtuali, e mediante quelle ci cattura nella sua storia implicita, che poi è la storia che l’immaginario vuole sentirsi raccontare. Ed 190 è allora che l’icona assume da un lato il potere sacro del simulacro, evidenziando la pienezza e l’emanazione del mana che la costituisce, e dall’altro si fa merce di scambio nel mercato planetario dell’immaginario, valorizzazione concreta del desiderio per il suo transito fino alla morte. Ogni vera icona, insomma, trasforma gli atelier figurativi ed i set cine-fotografici, ovunque essi siano e di quale natura essi siano, in stage di una performance, ipostasi di un live. Questo interesse per la narrazione “in diretta” con la quale l‘icona sorprende chi la rimiri, una narrazione che, come abbiamo detto, ci pone in connessione con una “oltranza”, è stata usata da ogni strategia di potere - religiosa in passato come economica oggi - fin dagli antichi Egizi; ma più spesso mediante una sapiente commistione delle due finalità: l’economico (nel senso più lato del termine, dunque anche psichico) ed il religioso (dunque anche il trascendente filosofico, ideologico, etc.) hanno fin dall’inizio determinato lo statuto della simulacrità. Da qui l’atteggiamento di venerazione che si confà ancora oggi non solo al frequentatore dei templi, ma anche al visitatore di musei d’ogni tipo. Su siffatta strategia fece già leva Attalo il Grande per inventare nella sua Pergamo del III secolo a C. il dispositivo stesso del Museo: una successione di simulacri offerti alla venerazione ed insieme alla riflessione di un eletto pubblico itinerante, nello spazio sacro adiacente al luogo del culto di Atena. Dal dispositivo del Museo ellenistico origina, come è naturale, il registro di discorso ed il potere della critica d’Arte, già consolidati quando nel III secolo dopo Cristo Filostrato Lemnio inaugurò la scienza iconologica con il suo Eikònes dedicato all’analisi di 64 dipinti di soggetto mitologico campeggianti in un pubblico porticato della sua colta Napoli grecizzante. Fatica cui fece seguito quella dell’omonimo nipote dedicata ad altri 17 soggetti iconici. Nello stesso periodo toccò al giureconsulto Callistrato di manifestare nelle sue Istitutiones le notevoli correlazioni tre le tecniche della Retorica e quella della composizione delle icone: sul perno della Ecfrásis (Descrizione) si veniva così affermando il convincimento della equipollenza tra parola e immagine quanto al loro potere di articolare i contenuti, la comunicazione sia logica che empatica, le conseguenti analisi degli esperti. Non vi è dubbio che l’iconografia cristiana derivi per modalità e per finalità da quella classica. Ma fu solo dopo le lotte sostenute con gli iconoclasti d’oriente – ispirati da un rigorismo monofisita e platonizzante che negava ogni valore alla duplicazione dell’idea trascendente nel concreto materiale della copia – che si affermò il valore dell’icona e la sua equipollenza al testo sacro; principi sanciti da quel II Concilio di Nicea che, confermando il valore di accesso al divino delle immagini sacre, accolse il sostrato culturale della plurisecolare elaborazione neoplatonica, giunta su questo tema specifico 191 fino alle nette affermazioni di valore di Gregorio Magno, Giovanni Damasceno, ed altri esegeti del neoplatonismo in versione cristiana. Non c’è da meravigliarsi che nei nostri principati rinascimentali dalla forte economia mercantile l’idea della sacralità del Museo, e dei simulacri in esso accolti, si sia riversata sul valore estetico degli originali, e delle copie in loro assenza commissionate – ma già la prassi delle “copie” era stata perseguita da Attalo... – e da qui al collezionismo dei principi, inaugurato da Lorenzo il Magnifico; per arrivare ai criteri ed ai dispositivi d’esposizione con il corridoio vasariano, alias Galleria degli Uffizi, di Cosimo I e poi di Francesco. Da Firenze la pratica principesca del Museo dilaga per l’Europa accompagnata a quella dei multipli d’arte a stampa (xiliografia e tanto altro...) per i dotti ed i ricchi. mentre, il discorso sul valore simbolico - quella che abbiamo chiamato “narrazione dell’oltranza” – dell’icona viene ripreso in aurei manualetti xilografati diffusi in tutto il continente, specificati per generi e tematiche, sul modello della Iconologia di Cesare Ripa (1593). La riproducibilità tecnica ha poi fatto il resto, come abbiamo già detto. Né ci addentriamo nella weltanschauung della novecentesca scuola iconologica di Warburg che abbiamo già indicato tra i presupposti epistemologici di questa trattazione. Dunque, la tradizione occidentale dell’icona – oggi globalmente estesa al pianeta – è quella neoplatonica che si radica in dialoghi di particolare spessore del Maestro quali il Timeo, il Fedone, il Simposio. Nel solco di essa i teologi della Imagine hanno offerto ai Padri di Nícea un paradigma condiviso secondo il quale: a) L’icona è “somiglianza dissimile” (homóioma) in quanto duplicazione nel concreto (copia) dell’Ideale trascendente; essa è insieme il Medesimo e l’Altro e a ciò deve il suo valore di evocazione mitica; b) Come tale l’Icona è in primo luogo medium estetico-rappresentativo, per il quale si traduce nello spazio e si offre nella diacronia del tempo l’Assoluto a-spaziale ed a-temporale della Divina Incarnazione. c) L’Icona è il “cronotopo”(paradeígma) che consente di porre in relazione il senso dell’Immagine ed il senso dell’Invisibile, traducendo questo nell’esperienza della Storia, la qualcosa comporta senza dubbio delle pesanti limitazioni rispetto al senso originario, ma anche un innegabile arricchimento che carica di significati l’epifania dell’Invisibile (a questa soluzione si contrappone l’iconologia orientale che, per la sua ascendenza monofisita, vede nell’icona solo una sorta di partenogenesi del divino e come l’invito perché si ascenda ad esso, fuori dalla diacronia storica). d) Il valore simbolico, e da questo anche narrativo ed educativo, che pertanto è da attribuire all’Icona, consistendo in una spazializzazione ed in una temporalità (ritmo) poggia pertanto sul valore estetico: la venustas parietum dei luoghi di culto, giusta la teologia platonica dell’equivalenza tra il Sommo Bene ed il Sommo Bello (non così, ovviamente, nella tradizione orientale dove l’iconismo deve tradurre 192 solo una mistica). e) Non si può avere icona che non sia “in throno sedens”, cioè gloriosa e da noi assunta come tale nel ricordo (come ben sa non solo l’arte cristiana, ma tutto lo star-system dei nostri tempi nei suoi più diversi apparati). f) Il valore dell’Icona si sostiene dunque su una mancanza originaria che ci costituisce e su una reminiscenza dell’Assoluto, dell’adesione alla totalità in cui il nostro Io si dissolve: l’Icona è ricordo, confronto e decifrazione con la memoria, e perciò la ripetizione, la replica s’origina dalla sua stessa natura. g) Per tutti i motivi suddetti l’icona è degna di veneratio: non l’adoratio puramente teologica della tradizione orientale, ma qualcosa che ha a che fare con la devozione alla venustas, con la forma sensibile dell’ultrasensibile, di questo essa è il “ritratto” (ektipoma). h) Ne consegue – con ricco innesto dell’aristotelismo della Poetica e della Retorica nel platonismo – che la simbologia iconica ha tale forza visiva (enérgheia) perché il suo procedimento è metaforico, riuscendo a trasporre nel concreto visibile ciò che è visibile sono nella mente (eidos); ciò fa l’assoluta equipollenza di funzioni della produzione del Visibile e della Scrittura (ed anche la pericolosità del Visibile, come ben sanno i Padri che hanno parlato degli occhi come di finestre sui peccati del mondo!). In conclusione, dopo Nicea, mentre ad Oriente si persegue il mito originario dell’Icona Acheropita (non eseguita da mano umana) ed essa esclude luci, prospettive e forme della “visione binoculare media”, ad occidente si ravvisa il valore del doppio sensibile, fino a riconsiderare la proprietà naturale di cui sono dotati gli esseri sensibili di generare dei doppi nelle ombre, nelle immagini speculari, in silhouette, dal punto di vista di una venustas che è al contempo di valenza empatica, simbolica e conoscitiva. Vero è che per il Maestro il fine di ogni produzione di immagini non è quello di rappresentare ciò che è nella sua essenza, ma solo ciò che appare, così come appare, cioè produrre phantàsmata, sicchè sono ammesse deformazioni geometriche, illusioni ottiche, elaborazioni ritmiche conformi alle aspettative di una vista che si nutre e s’appaga di errori; ma è anche vero che gli eídola che in tal modo si generano trovano nella venustas l’istanza e la reminiscenza dell’oltre da cui pure derivano, sicchè: “Ogni cosa di cui il demiurgo realizzi la forma e la potenza guardando a ciò che si mantiene sempre identico a se stesso e servendosene come modello, riesce necessariamente tutta bella” (Timeo 28 a-b). Ci pare che non ci sia uno solo di questi principi classici e cristiani sulla teofania dell’icona che non si adatti alla nostra questione dell’epifania live della star. E se il criterio caratterizzante questa singolare epistemologia erotica è quella dello della Venustas, converrà, tralasciando per il momento tutte le altre icone mitologiche pure in gioco, soffermarsi un po’ sulle caratteristiche iconiche della dea che della venustas è la titolare, per l’appunto VenereAfrodite. Vedremo quel che la più accreditata tradizione iconografica della 193 dea prescrive e potremo trovare straordinarie persistenze di siffatte codificazioni nella formulazione attuale dell’icona seducente della star. Cominciamo, naturalmente, dagli occhi là dove riluce la massima attrattiva dell’immagine proprio come duplicazione e quindi come specularità: Narciso dovette prima di tutto guardarsi dritto negli occhi, restituirsi il proprio sguardo grazie all’immagine riflessa sullo stagno, per formulare e riconoscere l’insieme del proprio volto e farne l’oggetto del proprio amore; sintomaticamente ci sono dei nevrotici che non possono tollerare di guardarsi dritto negli occhi davanti ad uno specchio, temono infatti di perdersi in abisso sull’asse della vista speculare e dentro il foro senza fondo della loro stessa pupilla riflessa. Queste problematiche da odierna teoria analitica della “pulsione scopica” poggiano ovviamente su profonde intuizioni degli antichi, la cui mitologia è piena di sorprendenti funzioni, legate all’Eros ed alla Soggettività, di specchi, stagni, fonti...Non a caso “pupilla” viene da “pubilla”, cioè pupetta, bambina: essa è l’immagine che scorge sul foro in abisso del proprio stesso sguardo una fanciulla – anche “puella” proviene dallo stesso nucleo eidetico – che si rimiri allo specchio, presumibilmente stupita e colta da autosoddisfazione del desiderio. Non c’è da meravigliarsi che tale proiezione desiderante sia per definizione femminile: anche la storia del desiderio è stata scritta dagli uomini, favolose età matriarcali a parte (di cui nulla sappiamo). E d’altra parte può vedersi in ciò quella tendenza alla femminilizzazione, l’aspirazione alla totalità androginica, che abbiamo vista caratterizzare proprio i soggetti più virili. Insomma, come che sia, l’oggetto della pulsione scopica è donna, è alla lettera una pubilla! Ora, come guarda Venere allo specchio? Ovvero come si manifesta lo sguardo di desiderio di Venere, posto comunque che sempre a tale attitudine desiderante si conformi il suo sguardo data la sua specifica natura divina. La tradizione la vuole straba, paeta, cioè lievemente strabica; chi la rimiri si accorge che i suoi assi visivi non si intersecano nel bel mezzo dell’oggetto cui si rivolge ma divergono leggermente andando ad intersecarsi in un ideale punto retrostante rispetto a quell’oggetto, verso un campo dell’oltre indefinito. È la sensazione che dà lo sguardo dei miopi e delle belle donne; questo sguardo rivolto ad una indefinitezza, che addirittura può apparire metafisica, conferisce un innegabile fascino poiché lascia supporre, a seconda delle circostanze, un atteggiamento di serenità, pensosità, attitudine sognante, malinconia, rimemorazione, rimpianto, in una parola comprensiva di tutto “pateticità”. La Monroe usava coscientemente quest’arma di seduzione e, amabilmente, ci scherzava sopra nella vita privata e nei suoi film (Come sposare un milionario...) La pop-star Anastasia sbandiera seduttiva i suoi occhiali nei live, ma quando se li toglie i suoi magnifici occhi da gazzella non fanno mistero della loro miopia addirittura sensuale. Ecco, possiamo supporre che 194 straba e paeta voglia dire semplicemente “sguardo vago e indefinito da miope”, e che dunque fosse miope Venere ...o che si atteggiasse a tale, come può fare benissimo chiunque si distragga rispetto all’oggetto contemplato. Ma questa è la caratteristica della Venere Urania, la genitrice di tutte le cose cantata da Lucrezio, prima ancora dea celeste scolpita da Prassitele che la vide nascente dalle acque: la Anadiomede che miracolosamente s’era fissata nell’icona aurea, tra lo stupore di tutti, prendendo a pretesto sensibile la cortigiana Frine che inaspettatamente, con serena impudicizia, usciva dal bagno camminando verso la riva. Tale, è ovvio, è anche la Venere del Botticelli. Ma v’è poi un’altra Venere, l’Afrodite Pandemia amica dei Satiri, quella dei suburbi e dei postriboli, la Venere carnale efficacemente scolpita nella “Callipige”: gli assi visivi che originano dalla sue pupille convergono davanti all’oggetto rimirato e non dietro di esso, ne sfiorano appena la superficie, la carezzano lieve e saltellante trasmigrando da superficie a superficie con erratica voluttà, secondo quell’andamento metonimico dello sguardo di piacere, scambiabile e mercenario, che è stato ben illustrato nella festa barocca di Starobinski. I suoi occhi invitano, s’appellano, ammiccano esibendo un vivido desiderio che non avvolge, non incatena, ma promette di esaurirsi nell’attimo del piacere effimero. Questa Venere che giace con Marte, e viene esibita lubricamente nella rete di Vulcano, che seduce mille amanti ed è irrazionalmente sedotta dal suo stesso figlio bendato e armato di arco e faretra, mostra dunque i suoi occhi di nera brace, non più cerulei, come ludibundi, saltantes, micantes (che accendono scintille), morsitantes (proprio in quanto “morsicano”), e perfino marcidi e oculi foediti come i Padri cristiani asserivano essere gli occhi imbellettati e sfrontati delle ragazze del tempo. A questa genia della Venere carnale corrispondono le icone delle Cleopatre, delle Semiramidi, delle Circi e Armide. Nel cinema – fatti salvi gli exploits delle Gloria Swanson, delle Vivienne Romance e delle Mae West – è stata per l’appunto B.B. a scardinar e il canone dello sguardo da Venere celeste imperante da Lillian Gish alla Garbo, dalla Bergman a Michèle Morgan, dalla Turner a Marilyn, e a generalizzare il canone degli oculi morsitantes. Ben inteso, in buona compagnia quando accorreva: Liz in Venere in Visone e come “Maggie la gatta”, Jennifer Jones in Duello al sole, e così via. Oggi quasi tutte le pop-star, così come le topmodel, hanno adottato questo canone più scopertamente libidinoso: sono di solito occhi da “Venere carnale” quelli di Madonna, di Christina Aguilera, di Beyoncé, della Winehouse e quante altre; ma all’occorrenza, da magistrali performer, eccole illanguidirsi – nel blues o nel soul per esempio, o per un intervento estemporaneo evocante un ricordo commosso... – e sapere adottare lo sguardo vago e assorto dell’Afrodite Urania. Torniamo allora a questo ceruleo sguardo celeste, glukumeílichon (dolce 195 come il miele), là dove il gruppo gl assicura la connessione con il cosmo – glauco è l’occhio, ma dallo stesso gruppo consonantico gli Attici coniavano il cielo terso, la brezza di mare, il sorriso, il gioco infantile, la bambola... – per dire che questo sguardo è anche ugrón, cioè umido, tremulo, con una lacrima sempre pronta a fermarsi tra palpebra e palpebra, e perciò trasparente come il cristallo e proprio riflessivo come lo specchio. Questa convenzione, passata alla agiografia delle martiri cristiane, è stata ben nota allo starsystem hollywoodiano che ha abbondantemente usato della glicerina per ottenerne l’effetto nel primissimo piano. Il resto lo facevano la miniaturizzazione dei lineamenti ed il flou aureo del contesto ottenuti dal teleobiettivo, la sapienza delle luci (ma su ciò, e passando poi dai canoni della “voltificazione” a quelli dell’allure, della ritmica del plesso solare, etc., rimandiamo al nostro Figure dell’Immaginario). In definitiva, Platone è transitato fino ad Hollywood: le sue sfere del cosmo iperuranio tremulano nello sguardo delle star. Le loro palpebre socchiuse e vibranti – proprio per reggere la tensione superficiale della lacrima–specchio – contornate dal rigo nero cosmetico fin dalle Egizie – il nero e panoramico “occhio di bove” – danno infallibilmente una conformazione “a mandorla” ad occhi che devono abbracciare il cosmo e non considerare nessuno. Altra connotazione della nostra Dea, connessa alle qualità dello sguardo, la vuole serenamente o maliziosamente sorridente. La “ridente Afrodite”, “l’amica del riso”, “colei che soavemente sorride”, e così parafrasando, la definisce la pseudo–Omero nel suo Inno. Naturalmente la chioma è d’oro e sparsa alla brezza del vento primaverile, d’avorio il collo sinuosamente “a cigno” – a differenza del collo taurino degli eroi – e tutto l’incarnato dal petto alle braccia, rosee le gote, e rosse come il rubino le labbra. Esse devono allontanare il sospetto di una simbolizzazione della torbida fase orale dell’erotismo infantile, tanto più data la costante presenza dell’Amorino sempre avvinghiato alla sua Genitrice, e perciò sono labbra carnose ma minuscole, paragonate a piccoli fiori di campo o ai “rubini” dei colombi in amore (i beccucci rossi) dai barocchi come Góngora e Marino. Ma il tipo “maledetto” della Semiramide o della Maddalena ammette invece la bocca grande, vero accesso dall’esterno all’interno della corporeità e viceversa, vero organo di suzione capace di trasferire, rovesciare, modulare nel ritmo l’interno e l’esterno. Torniamo così alla dicotomia tra le due Veneri, perpetuata ancora oggi. Ma anche in questo caso la rivoluzione rappresentata da B.B. ha rovesciato il canone dominante e non c’è più attrice seducente, top model, pop-star che non mostri temeraria le sue grandi turgide labbra. Queste si aprono in ogni caso su quei filari di piccole perle smaglianti che sono i denti: qualità un tempo favolosa cantata nei miti ed oggi sempre a portata dell’evoluta odontotecnica. E siffatti deliziosi filari hanno la loro parte nel sorridere, morsica196 re, suggere d’intesa con la bocca e con gli occhi. Così come, spudoratamente, la sua parte reclama oggi anche la piccola lingua palpitante, umettante, giocosa tra i traslucidi filari salivari, primissimo piano che nessun cameramen si lascia più sfuggire se ha a che fare con le belle ugole d’oro...rosea, di preferenza, e in bel contrasto innaturale con il rosso delle labbra...ma talora non proprio rosea, evocante nella sua patina intensi e segreti lavori, non più tanto segreti... Un cenno anche per la fronte; essa è la sede del pudore, dei pensieri che si leggono limpidi – “le si legge in fronte”, per l’appunto – e perciò sarà spaziosa e candida, e in essa ci si potrà rispecchiare. Ma nella “altra” Venere, la Pandemia, sarà inverecunda, expudorata, degno coronamento di quel “viso da cagna” con cui Catullo e poi la tarda latinità bollano le meretrici. E da ciò la qualifica di “sfrontata”, ovvero dalla fronte breve, magari perché travolta dal fluire scomposto della chioma e dalle selvagge sopracciglia. C’è bisogno di ripetere che anche in questo caso è il secondo modello quello egemone oggi tra le pop star? Resta da dire dell’allure di Venere, dato che artisti e poeti concordano con quanto icasticamente riuscì ad evocare Virgilio, quando l’affranto figliolo di lei, Enea, la riconobbe d’incanto: “Et vera incessu patuit Dea” (Eneide, lib. I, 405). L’incesso di Venere articola una perfetta distribuzione delle masse muscolari, in equilibrio rispetto alla linea mediana, nel decorrere fluente e ritmico del movimento, le “sincinesie” delle mani, il contraccolpo rotondo delle anche, la stupefacente levità nella fase d’appoggio e di “carico” del piede e dell’avampiede. C’è bisogno di ricordare che l’Allure era attento oggetto di studio per i divi di Hollywood (non, invece, in Italia!)? Questo studio è stato in tutto ereditato dalle passerelle della moda e, da lì, è passato alle pop-star grazie soprattutto all’irruzione del fenomeno Madonna. E dobbiamo anche smentire gli ortopedici: il tacco alto dona e aiuta al conseguimento della perfetta allure. La Venere di Virgilio e di molti altri calzava “alti coturni d’oro” il cui tacco snello, da valutare almeno in cinque o sei centimetri, la aiutava nella corretta levità dell’appoggio. Certo, oggi la popstar arriva come niente ai 14 centimetri di tacco a spillo... bene, ortopedia a parte, l’effetto è tutt’altro che disprezzabile: mentre la levità dell’appoggio diviene massima, quasi come in una danza sulle punte, i roteanti movimenti muscolari di cui sopra si fanno più sinuosamente accentuati, ma l’intera figura tende a spezzare la sua direttrice tra il busto in avanti, le anche all’indietro, le ginocchia lievemente piegate. Ciò riproduce la mitica postura delle divinità indù, e delle Devadasi, detta tribangi, postura che è un’esplicita offerta di sacro erotismo attraverso la messa in evidenza del plesso. E dunque, ben vengano i vertiginosi tacchi a spillo dell’Aguilera e di Tina Turner, scintillanti d’oro o di cristallo come i coturni della Dea. 197 Chiudiamo questa digressione sull’icona di Venere sorprendendola in un vero e proprio live, quale ci viene descritto dalla fantasia di Apuleio ne L’Asino d’oro (lib. X , 31), episodio del Giudizio di Paride. La Dea – come sempre “suave subridens” – per battere la concorrenza di Giunone, “puella vultu honesta”, e di Minerva dagli “oculis in aspectu minacibus”, non esita a lanciare al seducente giovane proprio “occhiate assassine” da Pandemia, ma non si limita a “saltare solis oculis”, perché avvolta da una leggera sopraveste di seta ondeggiante al vento, la chioma aurea sparsa e libera, sugli alti coturni, si esibisce in una performance di canto e danza sostenuta dal coro degli amorini, boys ante litteram. Per non tediare con il latino, riportiamo la famosa traduzione rinascimentale del Firenzuola: “Ma molto maggior soavità era poscia veder Venere muoversi secondo gli accenti di quel lor canto, e quei lascivi e graziosi passi, fra le ondeggianti piume di quei pargoletti camminando, or quelle vive luci in atto mansueto girare, or con benigna ferita e con gentili minacce voltarle, or mostrare che gli occhi stessi saltando, negli altrui cuori ne facesse far pruova quanta dolce forza ha la vista nel bel regno d’Amore”. Si dirà che un tale miracolo di epifania nell’icona s’appartiene a una Dea, non alla genía dei mortali. Il cinema dello star-system, i rotocalchi ed il pop-rock hanno comunque inaugurato innegabilmente una nuova “genía”: da Marilyn a Madonna abbiamo le generazioni delle icone che intenzionalmente, geneticamente, vivono nella coincidenza tra l’essere reale e l’essere-per-lo-spettacolo-planetario, ovvero l’essere per il marketing; la generazione delle star per le quali è impensabile chiedersi, come ci si è chiesto per Gilda, come siano poi davvero: la loro esistenza è l’apparenza fictionale, e l’apparenza fictionale è un valore di borsa nel mercato dell’immaginario. Per questo si tratta di star radicalmente, generazionalmente “pop”. Non a caso, proprio per questa sua spudorata verità nell’apparenza, Cesare Zavattini – il teorico del non-attore e del pedinamento – non aveva difficoltà ad includere Marilyn nel campionario strategico del suo neorealismo, tra i prototipi della “bellezza del vero”, ma in questo caso il vero della finzione che con l’attrice si dà ingenuamente e magistralmente a pubblico spettacolo. Tant’è che la bella baratta la sua stessa beltà con il compenso mercimoniale nel malizioso ma disarmante discorsetto metalinguistico al suocero alla fine de Gli uomini preferiscono le bionde; e lo stesso fa Madonna in Material Girl, metalinguaggio di metalinguaggio, potenza dell’icona al cubo. Infatti le mitologie non sono soltanto quelle del mondo antico o delle sue manifestazioni in chiave iconologica di “rinascita del paganesimo”, ma anche quelle della modernità e della post-modernità, come sostiene Morin; non a caso nell’intitolazione di questo capitolo abbiamo evocato intenzionalmente Barthes. Ieri, le grandi favorite ed avventuriere, le divine della lirica e le étoi198 les della danza, le vedettes del Variété soprattutto...nel Novecento l’Olimpo dello star-system hollywoodiano, poi gli eroi del catch, dello strip-tease, dello sport, della moda, per l’appunto del rock e del pop in tutte le sue varianti, fino ad oggi, fino ai testimonial TV d’ogni tipo. E sono mitologie che si contaminano volentieri, o addirittura che fagocitano se stesse; così se Madonna vampirizza Marilyn c’è chi vampirizza evocando un proprio vicino di pratiche: Bubblé su Sinatra, la Winehouse sulla Holliday, così via. Ma ognuna di queste divinità del nuovo Olimpo – solo in pochi casi davvero immortale, però di sicuro affollatissimo – si articola poi per tipologie molto diverse tra loro, corrispondenti a mitemi della affabulazione immaginaria: lo on the road, il country, il jet-set, l’etnico, il new-age, il techno, ... etc...etc; si potrebbe non chiuderne mai l’enumerazione, comunque tutti mitemi trasversali e contaminanti tra le più lontane regioni della produzione mitologica. Ma di ciò non oltre: non si finirebbe mai l’inventario e l’esemplificazione...e si cadrebbe alla fine nel sociologismo becero degli accademici. C’è comunque una convinzione generalizzata, un dato che da “antropologico” si è fatto “sociologico” per via dei suoi rivoluzionari effetti sull’immaginario planetario: la convinzione della nascita prepotente di una nuova razza umana – la potremmo definire la “razza globale” – che appare privilegiata quanto a capacità di riprodurre la qualità iconica nel live. Cerchiamo di spiegarci. Lo Star-System di Hollywood aveva assegnato la funzione iconica in maniera specifica al tipo anglosassone – dalla Gish e dalla Garbo fino a Kim Basinger, Uma Thurman ed oltre - ed aveva accolto in via subordinata altre possibilità di sacralizzazione iconica sotto la comune categoria dell’esotismo. Per quanto nutrita e variegata fosse questa categoria esotica, essa accoglieva insieme nel suo dominio, offerto all’immaginario delle masse, il “matador” ispano-italo-arabo Valentino così come più tardi il tenore latino Mario Lanza, il “cinese” Richard Barthelmess, la mulatta Dorothy Dandridge come oggi Halle Barry, le sensuali italiche dalle ascelle non rasate quali Sophia Loren e le altre “maggiorate”, le pin-up francesi da cave esistenziale dalla Greco a B.B., e chissà quanto altro...a tale categoria era però negata l’attribuzione dell’aura luminosa ed anche totalizzante, quella delle anglosassoni patinate, ed era invece assegnata una sorta di aura in negativo, segno di un potere degli Inferi e fatta di dissipazione e perdite per un fantasma di erotismo , differente dal salubre erotismo anglosassone, un’aura di luminose tenebre che si diffonde e contagia con il sudore, gli odori, i capelli, i pori di una pelle dal lucore non uranio ma luciferino...De resto, questa categoria era già stata formulata dal live scenico: Josephine Baker e Billy Holliday insegnano, come più di recente Diana Ross e le Supremes. Chi emana “aura esotica”, e dunque ctonia, solo con un duro e lungo dressage può poi trasformarsi ed essere assunto nell’Olimpo auratico, ovvero nel199 l’età dell’oro. È toccato per l’appunto a Sophia che, mutati look e pelle, si è vista aprire le porte dello star-system di Beverly Hills; è toccato a Gina che non a caso in Naked in the World ha visto mutare la sua chioma corvina nel rosso fuoco sacrificale e salvifico di una prostituta d’alto bordo (latina naturalizzata americana); ma ciò non avveniva senza la permanenza di residui, scorie, che segnalavano eroticamente per l’appunto qualcosa di contaminato. Ora, il pop ha travolto queste recinzioni categoriali hollywoodiane, queste utopie razzistiche di splendori incontaminati e separabili dagli altri luciferini, ma per affermare una sorta di razzismo anche più egemone, quello legato per l’appunto all’apparizione di una nuova razza globale che ha le caratteristiche di una super-razza. Questa mescola in varie gradazioni, tutte accettabili, l’aurea chioma anglosassone con le componenti fisiche latine, le portoricane o comunque black, le cinesi e mongoliche, le asiatiche indiane o arabe... Le super-razza che ne scaturisce manifesta una complessione ed un atletismo corporei d’eccezione, una qualità luminosa e tattile della pelle che appare migliore del raso – quasi un rivestimento sintetico sebbene naturale, e di compattezza perimetrale assoluta -, dei lineamenti di sublime perfezione che riescono a coniugare il turgore a bocciolo delle labbra mulatte con nasini francesi miniaturizzati, lunghi occhi a mandorla, zigomi alti, ovali perfetti e crani dolicocefali ariani, un colorito d’ambra dai riflessi d’oro. Alla superrazza globale, l’attuale razza iconica per eccellenza, appartengono senza dubbio Beyoncé e Mariah Carey, Shakira e la Aguilera, e la Winheouse, Rihanna e Leona Lewis ed Alicia Keys, Fergie, Pussycat Dolls ed infinite altre, trovando già per molti versi uno splendente prototipo maschile nell’abbronzato Elvis dagli occhi cerulei in contrasto con il lucido ciuffo nero e il sudore latino della pelle abbronzata. Anche Barack Obama viene fuori da questa super-razza elaborata dalla cultura planetaria pop-rock, tanto che di lui si dice che è vincente perché non è completamente nero, e non è completamente bianco, e che non si sa bene di che razza sia, si sa solo che iconicamente funziona. Non a caso è stato definito come “la rock-star della politica”. C’è stato, per la verità, un progetto di elaborazione sintetica in direzione di questa genia d’eletti, ed è stata quello tentato coraggiosamente e pionieristicamente da Michael Jackson: gli interventi fisiognomici con bisturi, immissioni, sottrazioni, interventi chimici sul colorito della pelle, complesse elaborazioni di look hanno sortito un prototipo di “sintesi” che ha retto per molti anni – senza nulla togliere ai meriti del bagaglio tecnico della talentuosa star – e che ha fatto impallidire le operazioni della mutante Orlan ed i tentativi di pelle sintetica di Stelarc, ponendo il pop di prepotenza nell’ambito della più estrema Body-Art. Per quanto pagata da Michael a caro prezzo sul piano del mito sacrificale e personale, si tratta di una direzione da tenere d’occhio, perché non ce la sentiamo di escludere una sua futura ed esplosiva affer200 mazione nella rete simulacrale a venire che connetterà corpi reali, corpicyborg, immagini di sintesi ed ologrammi virtuali. E d’altra parte, già oggi non possiamo negare elementi di sinteticità, mirabili effetti alla lettera di “plasticità” in star della super-razza come Beyoncé, pur additate come campioni di “naturalità”. È evidente, tirando le somme, che la nuova super-razza deve il suo carisma al fatto di ripresentificare la razza originaria: non già quella indoeuropea alle pretese origini della civiltà e della storia umana, ma quella divina dell’età dell’oro, la razza archetipa comune a tutti gli esseri antropoformi viventi in quell’ideale età; le star di cui sopra ne offrono la reincarnazione, ne sono il live, e per questo il loro live è eminentemente iconico. Tuttavia, la constatazione di questo nuovo primato razziale, la razza globale come divino ritorno degli esseri della razza archetipa, delle creature del “sogno” e dunque, ritualmente, degli antenati, non ci esime da una più analitica considerazione di quella apparente totalità che è l’epifania iconica. A noi qui interessa cogliere i tratti fondanti dell’icona mitologica, la fisionomia dell’oltre che appare rappresentarsi per noi. La sua compattezza e totalità miracolosa non deve trarre in inganno: essa si tende su di una molteplicità di elementi di virtuale separazione – abbiamo visto, ad esempio il ruolo della capigliatura-nembo – ed addirittura disgregazione nei quali è insita la stessa perenne minaccia auto-distruttiva; e chiamiamoli pure, ormai, inesauribili rapporti di scala e/o dispositivi di potenziali catastrofi. Una per tutte: la bella immagine apre sempre alla drammaturgia pubblica e privata di un soggetto “perverso” e “polimorfo”. Queste icone mitologiche, infatti, invertono i sessi, evocano satiriasi e ninfomania, pedofilia e sadomasochismo, schiavitù all’alcool ed alle droghe, violenza e corruzione, follia e predisposizione al crimine, o semplicemente cinismo e avidità dell’ego: a ciascuno il suo; nel supermercato degli orrori ogni mito s’adorna vistosamente del suo ciarpame che dovrebbe restare inconfessabile! Ed è quel ciarpame che ne fa l’aura che rinvia all’Eden dell’eterno piacere. Quanto il satiriaco “macho” Georges Michael si è fatto sorprendere a farsi violentare da canaglie in un cesso pubblico, la sua “aura” non ne ha risentito affatto, anzi si è caricata di quella contraddizione trasformando la polimorfia in una più accesa “poikilía”. Quello stesso ciarpame sovente si materializza, come un mana che si espande, negli oggetti di un reliquario sacro che finisce prima o poi all’asta; ed il ricavato di quella asta finisce magari in opera di bene: per gli orfani, l’ambiente, gli animali, gli ammalati...cosicchè il mercimonio di sé, che sarebbe spregevole per qualcisi mortale, diviene esaltazione del valore quando a vendersi è l’icona mitica nel suo esibito back-stage leggendario, o quando vende i frutti materiali di quella sacra prostituzione, il suo reliquario. Perché tutto 201 ciò possa accadere, occorre che vi siano delle polarità in tensione nell’icona, la possibilità di una moltiplicazione nelle sue parti e quella di una inesauribile dissipazione. Ora, queste polarità in tensione che tracciano la perfezione della silhouette epifanica ci sembrano soprattutto consistere in due diversi processi di elaborazione, contrapposti e pure dialetticamente relati: la “voltificazione” e, di contro, la relazione con l’oggetto privilegiato. La “voltificazione” e una processualità in progress che Morin e Deleuze hanno attribuito all’affermazione dell’icona; essa finisce con l’identificare il totale con quella sua parte che è il volto, e addirittura finisce con il proporre il volto iconico come una sorta di metalinguaggio del volto reale: il volto della star, infinitamente riprodotto, ci evoca nella sua sublimità il volto stesso della star, ne è l’emblema, il brand che ne consente la veicolazione. Dunque, quando poi la star appare nel live, il suo volto rimanda a quello stesso seriale processo di “voltificazione” che si è esercitato sul suo volto, e da tale rinvio nell’immaginario ricava un’aura ancora più potente, proprio in quanto miracolosa incarnazione di un brand. A margine, tiriamo due conclusioni: la prima è che Benjamin aveva davvero torto quanto pensava che la riproducibilità seriale potesse cancellare l’aura dell’opera; la seconda deve constatare che Marilyn è stata l’artefice di Warhol e della sua concettualizzazione “pop” e non viceversa, e l’intelligenza dell’artista è consistita nel limitarsi ad accogliere e manifestare questo dato di fatto nella sua opera seriale. Quanto all’oggetto privilegiato, ne abbiamo già detto, chiarendo che esso origina dal bastone sciamanico, trasposizione del pene corporeo nel fallo simbolico fuori dal corpo, e da lì subendo infinite trasformazioni morfologiche, ma non di funzione. “You are simply the best”, recitava una canzone anni ’80 di Tina Turner, allora dea della relazione tra totale della silhouette e “voltificazione”. Questa è l’esito cui si dedicano schiere di stilisti, di truccatori, di acconciatori, in sostanza di un’operazione di professionalità delle pratiche e di potenza della produzione, per giungere ad un’ipostasi che non può essere modificata senza un tale pubblico trauma da mettere in forse la futura carriera della star. Quando Welles volle distruggere nella moglie l’ipostasi di Gilda, rischiò di rovinare per sempre la carriera a Rita, e probabilmente era un rischio sadicamente calcolato. Quando la Roberts si troncò la chioma da Pretty Women per mutarsi nella piccola fata Campanellino, dovette poi sopportare anni di eclissi hollywoodiana...fino alla ricrescita della chioma. Più intelligentemente , Britney Spears dapprima s’è rapata a zero, alimentando con la follia autodistruttiva l’aura della sua stessa icona compromessa, poi però s’è subito messa addosso un fluente parrucca d’oro, in tutto simile alla chioma di prima, offrendosi come icona restaurata, e dunque rigenerata. Certo, non è più esattamente la stessa cosa, ma è bene che sia così: come abbiamo già 202 detto, una piccola sfasatura dall’icona nascente a quella perdurante, un piccolo décalage di beltà come i capelli un po’ più corti o un po’ meno tempestosi, una piccola cicatrice ricavata in un qualsiasi incidente, una incipiente ruga, qualche etto in più nella sublime silhouette sono cose che il pubblico adora, sono le stimmate dei “contrassegni di morte”, la riprova che la creatura che appartiene all’Oltre si è offerta al nostro libidinoso sadismo. L’importante è che il processo di “voltificazione” giunga a proporci alla lettera il “mostro”, cioè il sacro portento. E non v’è chi non veda della mostruosità nell’assoluta bellezza efebica di Elvis, così come già in quella di Brando o nella innaturale levigatezza da maschera di porcellana di Marilyn. Questa “mostruosità” può poi spingersi a mostrare davvero l’animale, il bestiale che è nell’icona, secondo la sua specificazione di genere. Così quando la bella Tina Turner intonava quel refrain – simply the best ... – non v’era chi non vedesse in lei la belva carnivora, la tigre nella flessuosità della sua silhouette e nella protensione delle grosse labbra da negra laccate di rosso, nel ruggito della loro vorace apertura sulle chiostre scintillanti dei denti candidi: un’apertura da bocca-antro, duplicazione in scala della cavità sciamanica. Ecco, nel pop-rock, non è mai venuta meno la pratica del “teriomorfo”, del simulacro del dio o semi-dio in forma di animale. E, insieme al teriomorfismo, la pratica della “chimera”, ovvero della creatura divina risultante, mostruosamente, dall’assemblaggio dei più diversi animali della più fantasiosa zoologia mitica. C’è chi è magistrale nel “volto-maschera”, nel “volto-cartoon”, esteso in anamorfosi, nel “volto-bestia” (gorilla-leone), come in tutte queste cose lo era, per esempio, Nina Hagen, maestra di mimica, microfisionomia e trucco, o, in maniera più romantica e sensuosa, l’allieva del mimo Lindsay Kemp Kate Bush. C’è chi la “voltificazione” la volge nell’urlo della follia, dell’ira, del male di vivere, o contro la società ( Joe Strummer cantante dei Clash); chi la volge tutta in mimica nel commentare, sorprendersi, ridere, arrossarsi gli occhi d’emozione, in perfetto stile comedy (anche Beyoncé sa farlo). Mick Jagger, dalla sublime silhouette, gioca a partire dalle labbra sulla propria “voltificazione” seducente e lussuriosa, ma la piega anche alla rabbiosa instintualità del teriomorfo, ruggendo, saltando, aggredendo vocalmente e fisiognomicamente; poi si fa essere chimerico assumendo sembianze da clown, da menestrello, da “grillo” gotico di un medioevo fantastico; e infine intraprende anche la concitata relazione con il suo oggetto, un microfono quanto mai strapazzato e asperso di brillante sacra salivazione. Ma c’è chi l’oggetto l’individua nella propria chitarra o in un altro strumento devastato e, alla fine, magari platealmente distrutto o incendiato; chi l’oggetto l’individua nel satin che fa da buccia alle proprie sinuosità, come Mariah dai dolci fianchi e la soirée suo “habitat”; chi, come Amy dal romantico vitino di vespa 203 anni ’50 nel mortale bicchiere di assenzio poggiato per terra, accanto alle scarpette dal tacco a spillo, di continuo preso e vuotato e di continuo riempito da inservienti-aguzzini. Naturalmente pratiche di silhouette, di voltificazione, di relazione con l’oggetto si espandono e replicano dalla star ai suoi accoliti lì sulla scena (ma anche alla moltitudine dei fan in preda al rito del mimetismo). Così boys and girls moltiplicano abbigliamenti feticisti, oggetti apotropaici, atteggiamenti energetici da bestiario e quanto altro. Questi procedimenti costituiscono il sale della scena ed il vero artista ci sguazza, ne fa le metodologie sia del suo professionalissimo rispetto della “scaletta” dello show, precostituita ed infinite volte riprovata insieme a tutte le gag con i fan, i musicisti, i tecnici, il pubblico..., sia della improvvisazione che è sua propria, non simulata, che risponde però ad un proprio ben collaudato repertorio di abilità. Quanto a siffatte capacità di trasformare la “scaletta” in autentica performance, David Bowie ha lasciato, nel ricordo pallidamente fissato in clip e film, eventi luminosi: la scena era il suo “must”. E così Freddie Mercury. E poiché al pubblico piace anche riconoscere , evocare, tra le pieghe della contaminazione, che dire di David Bowie-Amleto, di Freddie Mercury-Nijnski ed, oggi, di Beyoncé-Josephine Baker in gonnellino di banane? Ma, dato che siamo alle pratiche ed all’ensemble, tra voltificazione ed oggetti, che dire – ben prima delle ostentazioni di sacra volgarità hip hop – del sadico rapporto tra il patron Kim Creole e le servizievoli Coconuts?... Lui, discendente con le sue belle da una limousine, con quell’aria da pagliaccio, da clown bianco-domatore, tutto bastone e cilindro e pettacci di frac argentei, il volto da scimmia, e loro in sinuosa silhouette al mercato delle schiave, alla pubblica esposizione del palco. Ma la produzione era potente, e la pratica accurata: dieci soirées dieci, costosissime, erano gli abiti che attendevano le belle dell’harem di re-scimmia, sottoposte dietro le quinte a pratiche di fregolismo anche nel trucco e nelle acconciature. Ma in definitiva è un tratto, un gesto, un particolare, quasi un nulla quello che davvero “sigla” le più amate epifanie, che ne fa una ossessione nei desideri dell’immaginario: la virtuosistica tastiera della partitura gestuale di Mercury, o il suo pugno chiuso di vigore e di rabbia, la disperata sessualità dell’approccio allo strumento musicale di uno Springesteen, Peter Gabriel in “caduta libera” dal palco sul pubblico per infrangere la barriera della ribalta e salvarsi nel mare dell’affetto (pratica divenuta uno stereotipo dei film rockettari di Hollywood), il vocalist Al Jarrea che mima con le dita il suono del flauto mentre canta, o ancora le palme al cielo invocanti la potenza divina come in un gospel (ad esempio, Angus Young) e magari il pubblico che risponde palme al cielo, le vere e proprie interpretazioni microfisiognomiche da “musical comedy” di Cindy Lauper o di Boy George, e – dagli Scorpions 204 agli Stones – il dito puntato sulla platea in un insurrezionale appello diretto: “tu” e “tu” e “tu”..., o invece il dito malizioso tra il mento e l’angolo delle labbra come fa Christina Aguilera sgranando gli occhioni e socchiudendo la bocca, da pin-up anni ’40...ed infiniti altri artifizi di un teatro di pratiche, del “più grande spettacolo del mondo”dove le pratiche fioriscono e riconfluiscono nella prima e genitrice di tutte, la pratica epifanica dell’icona. Ma infine tutto s’avvolge nella coltre di fumo, pareti di fumo colorato da emozioni che sale a sommergere gli dei, che progredisce inesorabile verso l’aphanisis. I Led Zeppelin rafforzavano il momento con la policromia sempre più sfrenata di petardi da fuoco d’artificio tra le nebbie. Fumo che magari si replica in scala nell’accensione di una sigaretta, nel suo rosso brillio sull’ultimo assolo di chitarra, come faceva nell’estasi Lou Reed, o Keith Richiard degli Stones, fumo che sale in una fragile scia che preannuncia il nulla, il fumo del cigarillo di Paco De Lucia che il “tocaor”, spezzato l’ultimo pianto, ha impigliato tra le corde della sua chitarra flamenca, fumo che ancora resiste, si spegne, vibra, resiste, mentre tutto intorno si fa buio. Come nella cave più intimista, così nell’immensità degli stadi. Allo stesso modo, tra cortine di fumo sempre più dense si dissolve il corteggio delle ninfe, e l’oro dei capelli di ogni nostra Shakira viene spento lentamente dalla coltre cinerea: resta lì, stampato sulla cenere, il contorno sinuoso di un’ombra, per un attimo, poi solo il desiderio che ha bruciato l’oro ed il nulla divino. Accogliamo qui la prima parte di Live, la nuova monografia in corso d’opera di Renato Tomasino. 1 205 Contorni: ciò che il desiderio vede (calchi sul monitor) 1. La silhouette di Gilda (1946) ridisegna l’immaginario. 2. Merce simulacrale: cinque silhouettes della “material girl” per sposare un milionario. 3. La “chica caliente” del cha cha danza col plesso e inaugura la silhouette TV. (Abbe Lance in Casa Cugat, 1955, nastro mandato al macero). 4. Chimera, Grillo, Giullare (omaggio a Mick, protagonista del premio The Rope a Martin Scorsese). 5. Le tue labbra sanno di lampone: la Candy Girl Christina Aguilera attiva polimorfie della vista. 6. La silhouette è una “S”: Sacrificio, Sacrilegio, Simulacro. (Madonna - The Confession Tour - 2006). 7. La silhouette sacrificale: Amy Winehouse e il suo assenzio. (At London, 2007). 206 207 208 209 210 211 212 213 Per un’estetica dell’immagine multimediale di Elisabetta Di Stefano Un candido pollo si muove sullo sfondo di un campo. Un’immagine innocua che potrebbe richiamare alla mente certe rappresentazioni realistiche di tardo Ottocento, se non fosse perché non si tratta di una pittura, ma di un poster moderno. Eppure non è una promozione pubblicitaria di qualche azienda alimentare, perché la figura del pollo - contornata da una serie di scritte tracciate a mano - è acefala ed espone provocatoriamente il suo collo mozzato con le carni rosee in netto contrasto col candore delle piume. Si tratta di Hurry!, l’immagine più inquietante e più nota di Stefan Sagmeister, realizzata nel 1997 per la conferenza dell’American Institute of Graphic Arts. Due anni dopo a Detroit, sempre per il convegno dell’Aiga, l’originale quanto discusso designer austriaco torna a turbare lo spettatore con un altro poster di forte impatto emotivo, in cui il busto nudo dello stesso Sagmeister esibisce una composizione testuale realizzata col bisturi, secondo le inquietanti modalità della Body Art. È sicuramente una trovata scioccante sia per l’esibizione del corpo martoriato sia per la provocazione concettuale, poiché al centro campeggia lo slogan di Sagmeister Style=Fart (Stile=Scorreggia). In entrambi i manifesti l’accento verte sul valore emozionale del messaggio e sull’urgenza di “toccare il cuore” del pubblico. Secondo gli organizzatori della conferenza sorprendere era l’imperativo assoluto: il poster, oltre a informare, doveva vibrare un colpo allo stomaco e attirare la gente1. I poster di Stefan Sagmeister fanno luce sulle nuove tendenze del design grafico che, in linea con gli orientamenti dell’arte contemporanea, hanno abbandonato le forme armoniche e le regole codificate per produrre emozioni travolgenti e mirare allo shock estetico 2. Come osserva il filosofo polacco W. Tatarkiewicz: “Oggi ci sono molti artisti, scrittori, musicisti per i quali compito e fine dell’arte non è il suscitare esperienze estetiche, ma emozioni forti, che colpiscano, turbino. Un’opera è ritenuta tale se produce shock. In altre parole: scopo dell’arte non è l’espressione, ma l’impressione, nel significato naturale di questo termine, e cioè impressionare, impressionare fortemente, colpire fortemente il fruitore” 3. In realtà la definizione di arte come veicolo di emozioni risale al Settecento; già il filosofo francese J. B. Du Bos apriva le sue Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura affermando: “Constatiamo quotidianamente che i versi e i quadri provocano un piacere sensibile; ma ciò non rende meno difficile spiegare in che cosa consista questo piacere, che assomiglia spesso all’afflizione e i cui sintomi talvolta sono uguali a quelli del più vivo dolore. L’arte della poesia e l’arte della pittura non sono mai tanto apprezzate come quando riescono ad affliggerci” 4. 214 D’altro canto la ricerca dell’emozione, del turbamento, dell’inquietudine sembra essere il quid oltre che dell’arte, di qualsiasi veicolo comunicativo della società odierna: design, video, cinema, pubblicità. Questi grandi canali, in cui particolarmente incisiva è stata l’applicazione della tecnologia digitale, caratterizzano nei suoi vari livelli la cultura di massa, pertanto l’arte deve fare i conti con queste nuove forme di produzioni di immagini, sperimentando un’osmosi che finisce per rendere labili i confini tra arte e non arte, verità e finzione. Agli esordi della cultura occidentale, Platone poteva ancorarsi al mondo delle idee nella ricerca di una verità che non riscontrava né sulla terra, né tanto meno nelle opere d’arte, oscillanti tra la falsità della riproduzione icastica e l’illusorietà di quella fantastica 5; mentre Aristotele distingueva il vero della storia che descrive i fatti realmente accaduti, dal verisimile della poesia, la quale narra ciò che potrebbe accadere 6, aprendo alle successive generazioni di poeti e artisti la porta della libertà immaginativa. Ma oggi l’evoluzione tecnologica ha conferito alla creazione artistica delle potenzialità altissime grazie all’ausilio di mezzi sofisticati che ci fanno nuovamente precipitare nella platonica spirale di fobie illusionistiche senza neppure la certezza delle verità iperuraniche. Nel nostro mondo le condizioni di vita e di esperienza, mediatizzate dall’immagine, diventano spettacolo. 11 Settembre 2001: l’umanità intera assiste al crollo delle torri gemelle a New York. Il dato storico, l’attentato ad opera degli integralisti islamici al seguito di Bin Laden, diviene secondario, mera didascalia rispetto all’estetizzazione dell’evento. L’immagine delle torri fumanti, dei corpi che si lanciano all’esterno e, infine, il rapido annientamento di uno dei più significativi simboli americani rimbalza sugli schermi televisivi, entra nelle case, annullando le distanze geografiche. È il sublime 7. L’umanità intera prova un’esperienza estetica, già nota nell’antichità, ma più chiaramente teorizzata nel Settecento da Edmund Burke: il delight, il sollievo o “piacere negativo” che ogni individuo, inevitabilmente, prova quando riesce a sfuggire ad un pericolo che minaccia la sua integrità fisica 8. Ma l’esperienza descritta da Burke era in situ e non teneva conto della tecnologia televisiva che moltiplica il fenomeno emotivo toccando anche gli spettatori a distanza. A causa di quella distanza, mediata dallo schermo, il confine tra realtà e finzione diviene più labile, si confonde. La tecnologia produce una distanza estetica – concettuale e morale – che penetra nelle immagini e le riconfigura in chiave artistica; così la cronaca si trasforma in “spettacolo” 9. La dicotomia tra verità e illusione è stata oggetto di riflessione nel campo cinematografico. Gli esempi sono molteplici, per citarne solo uno ricordiamo Simone (USA, 2001) del regista neozelandese Andrew Niccol, il talentuoso sceneggiatore di The Truman Show, altro film incentrato sulla dialettica real215 tà e apparenza. Il film è ambientato nel mondo di Hollywood e racconta la storia di Viktor Taransky (Al Pacino) il quale, con l’ausilio di un software, crea un’attrice virtuale, la bellissima e sensuale Simone, che diventerà in breve tempo una star e sarà creduta da tutti una persona vera. Come nel mito di Pigmalione, il creatore, Taransky, si compiace della sua creatura che ha dato senso, oltre a ricchezza e notorietà, alla sua squallida esistenza di regista di secondo ordine (“Ti ho creato Simone affinché io esista” ripete in uno dei suoi monologhi con la donna di pixel). Ma quando Taransky si rende conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano, è ormai troppo tardi: il pubblico vuole i suoi miti e pur di averli è disposto ad accettare come vero ciò che è solo pura finzione. Oggi viviamo in un universo digitale che comporta una trasformazione profonda della vita umana su tutti i livelli. Come sostiene José Jiménez 10, nell’epoca del multimediale, quando si parla di immagine non bisogna intendere il termine solo in senso visivo, ma anche verbale e sonoro o di integrazione tra i vari piani; per cui se prima si distinguevano generi artistici differenziati (letteratura, pittura scultura, etc.), oggi è più appropriato parlare di immagine artistica in senso lato. Infatti l’espansione della tecnologia ha trasformato la nostra cultura e le nostre forme di vita, le arti non possono ridursi ad un semplice vedere, ma bisogna avvicinarsi all’arte con una mentalità molto più aperta e ricettiva. In questo senso l’estetica, come scienza della conoscenza sensibile, secondo la definizione di Alexander G. Baumgarten 11, riacquista una sua attualità, configurandosi come quella disciplina che, tenendo conto dei nuovi media 12, deve ridisegnare la mappa epistemica del sapere estetologico e recuperare il valore etimologico dell’aisthesis. L’immagine multimediale, infatti, si rivolge al sensibile – si pensi alla ruolo basilare assunto dal corpo in molte istallazioni -, alla sensorialità pura e semplice, attivando contaminazioni e ibridazioni grazie ai media tecnologici. Di conseguenza al predominio dei “significati” si sostituisce quello dei nuovi “significanti” tecnologici: si pensi alla poesia elettronica o alla musica elettronica, o ancora a tanti films pittorici astratti delle avanguardie – V. Eggeling, H. Richter, J. Léger, Man Ray, Werner Graff, Sezenka etc. – che, per le loro sperimentazioni sulle leggi dell’immagine dinamica, si prestano, come ha messo in rilievo Mario Costa, ad una nuova lettura e valorizzazione 13. Il sistema delle Belle Arti di batteuxiana 14 memoria è ormai crollato da tempo, ma lungi dal proclamare l’ennesimo elogio funebre dell’arte 15, bisogna interpretare in modo nuovo le pratiche artistiche, orientandosi verso nuovi orizzonti ermeneutici che tengano conto delle moderne potenzialità espressive. Nella loro configurazione o mediazione tecnologica le immagini implicano procedimenti di integrazione e di sintesi di ogni tipo di supporto e processo di rappresentazione e si trasformano in dispositivi multimediali 16. 216 Ma non è solo l’arte a subire una trasformazione. Dal mito michelangiolesco dell’artista divino che plasma faticosamente con le mani la materia per tirar fuori l’opera d’arte si è passati a quello dell’artista divo, a cui l’aureola della celebrità è conferita, come alle star, secondo meccanismi economici di pubblicità e di mercato 17. Oggi si assiste al declino della techne, della perizia manuale, l’artista opera su immagini già esistenti, modificandole e trasformandole – anche con strumenti informatici -, al fine di conferir loro una forza interrogativa esclusa per principio dal banale utilizzo dell’immagine di massa 18. Le prime opere d’arte costituite dall’assemblaggio di materiali già dati sono i ready made che determinano la perdita della gerarchia tra cultura alta e cultura popolare e minano la concezione tradizionale della creazione artistica col suo background idealistico e religioso. Il ready made è originariamente destinato ad una funzione utilitaristica, da cui si emancipa esteticamente. L’opera d’arte, invece, risulta annullata se, viceversa, viene impiegata come mero oggetto utile, come dimostra Marcel Duchamp con l’esempio famoso del ready made reciproco (usare un Rembrandt come tavolo da stiro). Nell’era dell’immagine, l’arte, per tradizione appartenente alla cultura alta, si introduce sempre di più nella catena della comunicazione di massa. Si pensi alla Gioconda di Leonardo, l’opera più riprodotta del patrimonio artistico occidentale: dagli ironici baffi di Marcel Duchamp alle moltiplicazioni di Andy 221 Wahrol fino alla pubblicità della Ferrarelle. L’immagine si sdoppia, si frammenta, si distorce, e il referente non è più l’opera di Leonardo quanto la riproduzione nei mass-media, quali la stampa e la televisione. Nel 1936, con l’avvento della riproducibilità tecnica, Walter Benjamin 19 lamentava la perdita dell’aura dell’opera d’arte che, riprodotta in serie, perdeva il fascino dell’hic et nunc, ovvero le circostanze uniche e irripetibili che ne avevano determinato l’origine e il valore; oggi l’arte non solo si serializza, ma si trasforma, smette di essere un capolavoro, un oggetto venerabile ma distante, per diventare un’immagine vicina e familiare, grazie alla tecnologia che rende disponibile la riproduzione di massa. Tuttavia questa perdita dell’aureola può essere interpretata sotto un segno positivo. L’intervento di Duchamp sull’immagine di Monna Lisa è possibile solo nell’universo della riproduzione tecnica e della cultura di massa, dove le immagini dell’arte, o di qualsiasi altro segmento della realtà, sono facilmente disponibili, infatti il segno dei baffi sull’originale ne implicherebbe la distruzione. La riproduzione, inoltre, consente di mettere in discussione l’immagine e di sperimentarne la sovrapposizione con altre dimensioni visive o estetiche. Questo implica un’autonomia dell’immagine rispetto ai supporti materici che diviene centrale per la teoria dell’arte nella contemporaneità. L’arte è ormai entrata nel217 l’era della riproduzione tecnologica grazie alla quale le immagini acquistano un diverso valore e l’estetica è chiamata ad affrontare in modo nuovo e con la sensibilità di oggi le problematiche dell’esperienza multimediale. 1 P. Hall, Sagmeister, London, Booth-Clibborn, 2004, p. 165. Cfr. D. Russo, Free graphics. La grafica fuori delle regole nell’era digitale, Milano, Lupetti, 2006, pp. 63-66. 2 W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee, Palermo, Aesthetica, 2004, p. 61. J. B. Du Bos, Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, Palermo, Aesthetica, 2005, p. 37. 3 4 Platone, Sofista, 235d-236c. Come è noto per Platone l’artista si dedica ad un’attività mimetica e illusoria, a differenza del filosofo che tende verso le forme pure, dedicandosi con la ragione alla contemplazione delle idee immutabili ed eterne. Pertanto l’artista è posto da Platone sullo stesso piano dell’indovino e del sofista, poiché la loro arte non si fonda sulla conoscenza (Filebo 44c); infatti il sofista con le parole e l’artista con i colori mirano non alla verità, ma all’apparenza, servendosi di immagini ingannevoli (Sofista, 233c-234c). Sulla dottrina delle idee si veda il saggio di D. Ross, Platone e la teoria delle idee (Oxford, 1951), Bologna, Il Mulino, 1989. 5 Aristotele, Poetica 51b, trad. it. a cura di D. Lanza, Milano, Rizzoli, 1990, p. 147: “Compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verisimiglianza o necessità. Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi […] si distinguono invece in questo: l’uno dice le cose avvenute, l’altro quali possono avvenire. Perciò la poesia è di maggior fondamento teorico e più importante della storia. La poesia dice gli universali, la storia i particolari”. 6 Sul tema del sublime esiste un’ampia letteratura, cfr. in particolare M. Costa, Il sublime tecnologico, Roma, Castelvecchi, 19982. 7 8 E. Burke, Inchiesta sul bello e il sublime, Palermo, Aesthetica, 2002. 9 Il fenomeno della spettacolarizzazione è riscontrabile anche nell’immagine di Bin Laden che rimbalza attraverso gli schermi televisivi e i computer, viene manipolata, valica il confine tra realtà e finzione e assurge a moderna icona del male. Lo spet218 tacolo, i cui principali teorici di riferimento sono Daniel J. Boorstin (The image. A guide to pseudo-events in America, New York, Atheneum, 1978) e Guy Debord (La società dello spettacolo, Firenze, Vallecchi, 19792), mantiene in qualche modo il rapporto tra le immagini e il reale. Per effetto dei media le immagini creano degli “pseudo-eventi” o “pseudo-ambienti”, nei quali la nozione di reale, pur filtrata dalle componenti spettacolari, non si smarrisce del tutto. 10 J. Jiménez, Teoria dell’arte, Palermo, Aesthetica, 2007, p. 17. A. G. Baumgarten, L’estetica, a cura di S. Tedesco, Palermo, Aesthetica, 2000, p. 27. Sulla centralità del sensibile nella riflessione estetica cfr. M. Perniola, Del sentire, Torino, Einaudi, 2002; E. Franzini, Filosofia dei sentimenti, Milano, Bruno Mondadori, 1997. 11 Sull’argomento cfr. A. Tursi, Estetica dei nuovi media. Forme espressive e network society, Milano, Costa & Nolan, 2007. 12 13 Mario Costa si è fatto interprete di un’estetica legata alle nuove tecnologie dell’immagine, del suono, della scrittura e della comunicazione, su cui ha pubblicato diversi lavori, in part. cfr. L’estetica dei media. Avanguardie e tecnologia, Roma, Castelvecchi, 19992; Dall’estetica dell’ornamento alla computer art, Napoli, Tempo Lungo, 2000 e Internet e globalizzazione estetica, Napoli, Tempo Lungo, 2002. Come è noto, nel 1746 Charles Batteux (Le Belle arti ricondotte a unico principio, Palermo, Aesthetica, 2002) conferisce un impianto sistematico, sulla base del principio di imitazione, ai vari tentativi di classificazione delle arti operati nel corso dei secoli, individuando cinque Belle Arti (musica, poesia, danza, scultura, pittura). 14 15 Alle soglie dell’Ottocento, durante le sue lezioni di Estetica, Hegel proclamava la “morte dell’arte”, in quanto, non più passibile, secondo la sua concezione filosofica, di rendersi manifestazione sensibile dell’Idea. In tempi più recenti il tema della “morte dell’arte” è stato ripreso più volte, secondo differenti accezioni, fino alla proposta di Bernard Edelman che, nel suo Addio alle arti (Milano, Medusa, 2001), presenta una rilettura dell’ “affaire Brancusi” e, di conseguenza, dell’arte del Novecento, e al più recente Dimenticare l’arte (Milano, Franco Angeli, 2005) di Mario Costa che individua nuovi orientamenti per l’estetica nell’era tecnologica. 16 J. Jiménez, Teoria dell’arte, cit., p. 11. 219 A. Vettese, Ma questo è un quadro? Il valore nell’arte contemporanea, Roma, Carocci, 2005. 17 18 J. Jiménez, Teoria dell’arte, cit., p. 12. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), Torino, Einaudi, 2000. 19 220 Neofigurativismo segno di un tempo di rinnovamento radicale e … digitale di Enzo Li Mandri Tutto ciò che si oppone al buon senso, fosse pure ai limiti del fastidio del gusto, lascia un segnale che non è detto sia solo frutto di un guizzo banale o estemporaneo. Un segnale esiste in quanto accende la nostra attenzione e, in questo senso, può acquisire il valore, o assumersi il compito, del simbolo. Un simbolo è traccia, e quindi memoria, di una realtà dimenticata o sommersa ad arte, ed ha la forza (o dovrebbe averla) di resuscitare tale realtà nella memoria. Man mano che la società si evolve i simboli diventano oscuri perché figli di un linguaggio obsoleto; allora essi, non potendo più parlare alla mente, parlano al cuore, cercando di evocare sensazioni e sentimenti che “dicano” al di là delle parole. Chi ha “vergato” simboli tenendo conto della loro vulnerabilità espressiva ha preferito incidere nella cera semiperenne dell’immaginario collettivo sensazioni e sentimenti, piuttosto che immagini, con l’auspicio che essi, rievocati, prolificassero in immagini più attuali via via che venivano rimessi in campo. Io credo che tale possa essere il valore oggi di quella corrente artistica che, radicandosi all’inizio del ’900 insieme alle varie correnti neo umanistiche, prende il nome di neofigurativismo, delineata via via dalla scultura dei tratti nell’autoritratto di Lucian Freud, dalla Architettura Organica di Carlo Sarno, cattolico e cavaliere del Sacro Ordine Gerosolimitano, dal cromatismo espressivo del quotidie di Daniela Dalmasso, dalla Arte Sentimentale di Amedeo Lanci, frutto dei suoi “sentimenti” come la definisce Piero Adorno, dai barocchismi surreali, ispirati dalla sua personale visione della natura e del contesto sociale, di Pierluigi Romani, dal Nuovo Umanesimo (Milano 2004) di Pierro Pasquale agito con le tecniche della tassellatura e del mosaico, e le logiche riflettenti del vetro soffiato, per arrivare a Jackson Pollock, inventore di quella che fu definita la Pittura Gestuale, che ha tratto ispirazione sempre da tutto ciò che dalla realtà si distacca, poco o molto, e quindi dai disegni rituali sulla sabbia dei Navajo alle ricerche interiori, alla psicanalisi, passando da Hart bentos, Siqueiros, fino a Pablo Picasso. In questo percorso si innestano le logiche dei nuovi strumenti dell’Arte votata al digitale; esse, proprio perché prive di una sostanza performante reale e contestuale, possono “prendere” a prestito “immagini” o ancora meglio “sensazioni” e “sentimenti” depositati in un immaginario collettivo, che tanto poco si discosta dal bruniano mondo delle idee, restituendo loro forma a guisa di sensazione, la sensazione che l’idea scatena, concretizzata con la sostanza di oggi, carica del vissuto e delle esperienze più recenti. La forma a questo punto si scioglie dal contesto, reinterpretando il rimosso, il deus 221 absconditus dell’Arte, che immagino foriera ancora di iniziatici stimoli al divenire, e abiurando gli dei decaduti, ormai nella polvere, per aver concluso il loro ciclo e aver dato quanto era in loro potere: una forma legata alla sostanza e non all’idea. Allora, per quanto l’animo mio guardi come il gambero al passato, desideroso di veder risollevare dalla polvere e dall’inedia gli antichi monoliti fallici, sacralmente unti dalla cteis, e respirare la parola amata assorbendola dall’ululare delle gole tra le rocce, ecco, devo volgere ancora gli occhi alla materia e parlare di piume, e presunzione. Fu la piuma, o l’amaro nocciolo, il tuo primo strumento, uomo? Fosti prima poeta, o prima mago? La natura ti violò prepotente o tu volesti imporle il seme tuo? Che importa? Oltre il tempo la Fede? Oltre la fede la Scienza! E la Scienza è “in instrumentum”! Perché l’uomo non è fuor di Natura e solo tramite Ella opera. Dicevo della presunzione, ecco, sta proprio in questo: credere d’essere senza di Lei ed Ella senza di noi essere. Dove Natura e Uomo stringono il Patto, sacro agli Dei, e da essi benedetto? Sullo “strumento”! semplice e tenero, come una piuma, ad esser poeta, o flessuoso e amaro, sulle carni, ad esser mago: o il piacere, o il potere; se qualcuno conosce altri Dei me li presenti, io non ne conosco. Avevo 7 anni, e già affidavo a carta e penna sentimenti pesanti come nubi nere; a 13 le mie prime opere teatrali, i miei racconti, le mie lettere d’amore; a 16 i miei primi discorsi sull’Anarchia e il valore dell’opera individuale (e la fuga spaventata delle prime ragazzine!); a 18 i primi articoli su i giornalini e, quando decisi che dovevo spezzare il muro delle consuetudini visive, cercai rifugio in una cinepresa filmando dai tombini della SS 113 le vetture della Targa Florio dal basso; fui uno dei primi a investire un patrimonio sull’impianto stereo per ascoltare la musica nota per nota, sussurro per sussurro, e a registrare su nastro la base degli spettacoli di teatro che io stesso recitavo, o delle trasmissioni in radio (RadioPal e RadioPalermoCentrale); contemporaneamente facevo esperienza sulla “pellicola”, era il tempo dei S8, mi occupai del montaggio e della colonna sonora di un antesignano, il “Boris Vian” di G.M. Costa, insieme ad A. Mirabella; intanto, assunto al Banco di Sicilia, finii ben presto dietro la prima calcolatrice a memoria intelligente, la Audit4, che perforava su un nastro di carta le informazioni contabili secondo un codice binario a 4 bit, e da qui come programmatore al Centro Elettronico; poi la mia prima scheda di Computer Grafica, il primo PC (AT IBM 80286), il primo monitor in RGB e la prima Tavoletta grafica (Benson); erano strumenti che acquistai (carissimi allora) e che finalizzai al lavoro, ovviamente, ma l’obiettivo era altro: essere agevolato nella espressione artistica! Il sogno si dimostrò meno maneggevole del previsto, oggi lo è certamente di più, ma per me il loro messaggio era chiaro fin da allora: strumenti! Sempre più sofisticati, meno comprensibili, più efficienti, meno malleabi222 li, ma strumenti! Preferivo anch’io quelli tradizionali, sarei tornato volentieri alla penna, ma non ne potevo disconoscere l’utilità. Ma insomma, cosa era successo? il computer aveva stravolto il bucolico mondo dell’Arte o un impulso frenetico a vivere oltre ogni tempo aveva partorito il mostro? Come tutte le diatribe che cercano di risalire alle origini, quasi sempre fumose, di un cambiamento radicale, anche questa lascia il tempo che trova; cari detrattori del digitale o meno, ormai il digitale esiste! E col digitale esiste un mondo parallelo che deve la sua “forma” a particelle fatte di materia diversa da quella con la quale siamo abituati a confrontarci; e questa “forma” di questo mondo parallelo prende solo parzialmente (e probabilmente sempre meno) vita da quella “sostanza” che informava e informa ancora il mondo quotidiano e diversamente tangibile; qui si scatena l’urlo! Per chi è assertore della purezza di tale sostanza è “scandalo”, per chi in questa sostanza riconosce la corruzione dall’originario mondo delle idee è “hosannah” al ritorno del divino furore senza veli; se invece si ha la bontà di demistificare tale, sia pur veloce e complesso, cambiamento dello “strumento” e considerare l’importanza innovativa del suo uso e la pur troppo marchingegnosa ancora manovrabilità (è della stessa Margherita Hack la dichiarazione che la ricerca sulle interfacce sia ancora troppo indietro e sottovalutata, e sono proprio le interfacce a consentirci di interagire correttamente e congruamente con lo strumento informatico) ci si rende conto come questo strumento risulti per lo meno indispensabile alla nuova creatività, quando questa decida (e i margini per potere ancora decidere potrebbero restringersi sempre più) di andare verso modi e mondi espressionistici nuovi, che abbiamo etichettato come NeoFigurativismo; nuovi proprio perché nati da una rinnovata e riformata visione della realtà figurativa, frutto di una interpretazione nuova di una sostanza rinnovata, oppure originati dal riscoprimento degli archetipi da un diverso punto di vista, e cioè quello di una umanità che cresce, si rinnova, è indispensabilmente diversa, a dispetto di chi la vorrebbe vedere andare indietro o addirittura essere annichilita e sotterrata dai suoi (purtroppo spesso ineluttabili) errori dati anche dalla ricerca; e costoro, che si rivelano animati sempre da uno spirito da fine del mondo tardo medievale (mille, non più mille), si ritrovano di fatto maldisposti a spendere le proprie energie per uscire da quel cerchio di abitudini che rende la vita sempre comoda e sempre fasulla, e, di conseguenza, a riconoscere due realtà che stanno sotto gli occhi (e le dita) di qualsiasi giocatore di videogame: la realtà materiale nelle sue forme classiche è esplosa e la nuova realtà si nutre di particelle elettroniche generate da un computer. Dietro ovviamente c’è sempre l’uomo! L’uomo di sempre, a meno che, come è già successo, e succederà, esso non abiuri se stesso, riducendosi ad un oggetto schiavo dell’oggetto che ha creato; ma, se siamo in guerra, e per di più per la sopravvivenza dell’umanità, 223 essa va combattuta e farà le sue vittime, come è in ogni epoca di cambiamenti radicali; infatti il ritorno alle forme come espressione pura non si riscontra nella storia dell’Arte (e l’Arte segna le tappe della crescita sociale dell’Umanità) ad ogni cambio di stile, ma quando si rivela è il chiaro segno di un cambiamento radicale, di Kali Yuga, di piedi di argilla (e di argilla è fatto l’uomo cosmico, l’Adam Kadmon, delle sacre scritture), di forme che disconoscono le forme (classicamente intese e riconosciute) per restituire all’idea la freschezza indispensabile a far rinascere la vita, e la vita, come sempre è una sorpresa. 224 Oltre il corpo di Alessandro Cappabianca Il corpo come segno grafico, prodotto di contaminazioni irresistibili, di ibridazioni artificiali totalizzanti. Non risulta del resto il corpo attoriale sempre trascinato dalla forza d’una metafora verso i territori della spettralità, dove finisce per incontrare un fantasma (che non coincide necessariamente con quello del personaggio)? In questo senso, è mai “naturale” il corpo dell’attore? È mai fatto solo di carne, sangue, muscoli e “organi”? Non è sempre (rivolgersi, per questo, a un certo Artaud) corpo spossessato, corpo di dolore, posseduto dagli spiriti? O corpo glorioso, corpo senza organi, consegnato a un destino di trasmutazione alchemica, se e dove questa trasmutazione riesce ad aver luogo? Già storicamente, il corpo dell’attore si pone come corpo travestito, nelle pratiche teatrali antiche (occidentali e orientali), o più recenti, in cui era interdetto l’accesso delle donne al palcoscenico. Ma non è solo una questione di identità sessuale. Non solo il trucco (nel senso di maquillage), non solo la maschera (nel senso greco), non solo il costume, ma la metafora stessa che l’attore incarna (il personaggio che impersona, uomo o donna) , fa sì che il suo corpo, quand’anche si dia nella “naturalezza” del suo essere fisico, acquisti una certa aura di travestimento, quindi di artificio. Corpo sempre in eccesso, perennemente abitato da una quantità di fantasmi. In questo senso, è ancora giusto chiamarlo corpo? Accanto al problema del corpo attoriale, della sua identità, dei suoi fantasmi, si pone dunque la questione del vero e proprio attore artificiale, anche se forse si tratta solo d’un pleonasma. Dell’attore senza corpo, potremmo dire. E specifichiamo, per l’attore cinematografico: senza corpo anche sul set, laddove già si avvia un processo di spettralità. Senza corpo, comunque, con o senza sembianze umane, ma non senza interazione con l’attore “umano”. Pensiamo, per il teatro, a certe sperimentazioni americane di cui riferisce Antonio Pizzo in Verso l’attore artificiale (reperibile in rete al sito www.noemalab.org/sections/ideas/ideas). Pizzo collega storicamente questa tendenza al simbolismo, alla Supermarionetta di Gordon Craig, alla biomeccanica di Mejerchol’d, a certi tentativi futuristi ecc. e, in generale, alla reazione di fastidio che provavano ormai autori e registi, sullo scorcio del primo Novecento, nei confronti dell’istrionismo naturalistico dei “grandi attori” di tradizione ottocentesca. Di qui, per successivi tentativi, si sarebbe arrivati allo sviluppo di una vera e propria “estetica tecnologica”, o perlomeno a una pratica di ibridazione teatrale, attraverso l’utilizzo in scena di proiezioni, diapositive, giochi di luce, cinema, televisione e computer, 225 cosa che, tra l’altro, non avrebbe fatto altro che esaltare (in vista dell’inevitabile coordinamento) il ruolo della regia. Ma cosa accadrebbe, si chiede Pizzo, se l’attore umano potesse essere sostituito da un attore artificiale, senza forma umana, magari fatto solo di luci, schermi e computer grafica, in grado di interagire sulla scena con un attante umano, secondo un programma prefissato, si, ma anche aperto ad alcune variazioni/improvvisazioni? Nell’articolo sono citate, l’abbiamo detto, alcune sperimentazioni dell’ultimo decennio, come lo spettacolo IT/I: An Interactive Theatre Play al MIT di Cambridge (MA), dove I è un attore vestito da clown e It un computer che interagisce sulla scena con lui, o il Virtual Theatre di Barbara Hayes-Roth presso la Stanford University di California, dove, durante uno spettacolo chiamato Cybercafé , venivano organizzate alcune scenette con dialoghi a tre personaggi, due attori umani e un avatar (un computer-actor) in grado di interagire con essi e, entro certi limiti, di improvvisare risposte credibili, fornite di una certa plausibilità. Si tratta di cose minime, certo, che basano la loro efficacia (ci sembra) su un effetto-sorpresa senza molte chances di durare a lungo – a meno che non ci si voglia affidare ad ipotesi decisamente fantascientifiche. Cose minime, soprattutto, rispetto alle invenzioni spettacolari e rutilanti con le quali il cinema degli effetti elettronici è ormai in grado di stordirci. Se pensiamo agli attori artificiali come burattini, marionette, maschere, automi, bambole, ombre, simulacri vari, dobbiamo prendere atto che è possibile ipotizzare addirittura una loro precedenza storica, legata ad origini sacrali, rispetto alle performances con attanti umani 1. E spesso l’attante umano ha reso omaggio a quest’origine camuffandosi da marionetta, automa, maschera ecc. Solo l’assenza di corpo ( o più esattamente, l’assenza di materia) , nell’era del virtuale, segna un discrimine preciso, facendo venir meno quella dialettica tra Dentro e Fuori sulla quale poggia la problematica del Corpo – o meglio, facendo sì che essa cambi natura, ponendosi su basi diverse. Il simil-corpo artificiale, d’altra parte, non deve essere assolutamente pensato come una similitudine o un’imitazione del corpo; esso ne evidenzia ed esalta certe particolarità, deprimendone altre, proprio come, in altri modi, avviene al corpo dell’attore cinematografico nel passaggio dal set all’immagine filmica. In questo senso, ogni messinscena del corpo (corpo/fantasma o corpo/artificiale) costituisce una riflessione sul ruolo del corpo stesso e può assumere anche solo per questo, un’importanza fondamentale. L’attore di cinema, in genere, depone il suo corpo sul set, come un cappotto al guardaroba, e nel film ne rimane solo la traccia: traccia spettrale, almeno secondo Derrida. 226 Si tratta quindi d’un Corpo che diventa inevitabilmente Fantasma – o meglio, di un’Ombra che spesso tenta disperatamente di ritrovare le tracce del Corpo da cui deriva, di attribuirsi uno spessore, un volume, un interno che ha perduto. Ma forse questa perdita è anche la sua fortuna, se è la condizione d’una sorta di trasmutazione, d’un al di là in cui il Corpo non si trova “superato”, ma più prezioso, tessuto della materia raffinata del sogno. Occorre assegnare un valore al Non-Corpo, alla Non-Materia, a ciò la cui referenza non può porsi se non come virtuale, perché virtuale è il luogo dove nasce, incrocio tra set e laboratorio. Fino a ieri, sullo schermo cinematografico, gli attori vedevano ridursi ai minimi termini (rispetto all’esperienza del set) la concretezza del loro corpo, il loro spessore (il loro “dentro”), la possibilità che affiorassero secrezioni prodotte da processi interni, che ne scaturisse il sangue, per qualche ferita o anche solo per una di quelle punture di cui parlava Shylock: negazione del Corpo di Dolore. Era il cruccio, com’è noto, dell’Artaud attore cinematografico, cui non sfuggiva la miseria dello spettacolo d’un Corpo senza Organi ottenuto con così poca fatica. Del Corpo, insomma, rimaneva l’illusione, il ricordo, la suggestione (la traccia spettrale), che i cineasti della flagranza , magari, tentavano disperatamente di potenziare; ma per la maggior parte dei registi questa spettralità non era che una chance , qualcosa di funzionale alla manipolazione d’una creatura artificiale, la creatura cinematografica, corpo di Frankenstein, corps morcelé, assemblato al tavolo di montaggio. C’è (c’era) un cadavere, o perlomeno un corpo perduto, all’origine del corpo filmico. E dunque la produzione dell’immagine analogica (oggi la cosa ci appare più chiara) si pone (si poneva) come pratica di rianimazione, in quanto la sua limitata indipendenza non la esonera(va) dal rapporto col lavoro della morte. Rianimazione dell’Ombra, per ritrovare un simulacro di Corpo. Alla rianimazione si contrappone l’animazione dell’immagine virtuale. Il fenomeno non sarebbe troppo diverso da quello dei cartoons o anime, se non fosse che qui a regnare incontrastata è l’ibridazione, l’incrocio tra corpo e impulso elettronico, tra set e laboratorio. Non a caso, con riferimento alla tecnica di performance capture, adoperata p.e. da Zemeckis in Beowulf, è stata coniata un’espressione (che Lewis Carroll avrebbe classificato tra le parole-baule) come imagemotion: image – motion – emotion, dove l’emozione è legata prima di tutto ai corpi, aspirati nel vortice d’un universo elettronico, veicoli di impulsi luminosi che ne ridisegnano contorni e movimenti. Si prenda un recente esempio orientale, La città proibita (2006) d’un autore 227 come Zhang Yimou, che non per caso in Vivere! (1994) aveva esplorato proprio l’universo del teatro d’ombre. È innegabile, qui, un certo compiacimento decorativo, sostenuto anche dal virtuale, che percorre quasi ogni inquadratura, dagli interni nel palazzo imperiale alle scene di battaglia. In queste ultime, la moltiplicazione elettronica dei guerrieri spicca come un effetto ricercato – ma il culmine della suggestione si raggiunge, ci pare, nelle sequenze dell’inseguimento notturno sui monti, dove i guerrieri sembrano calare volando dal cielo, materializzandosi come angeli neri. Sono scene solo parzialmente elettroniche, a quanto pare, girate da acrobati con l’ausilio di cavi invisibili a cui erano sospesi. Perché ci colpisce la bellezza di questa inesorabile discesa di uomini-ombra? Forse proprio perché si tratta di finti uomini-ombra, o tali almeno della cui esistenza o inesistenza, su un set reale, non possiamo pronunciarci con sicurezza. È un effetto straniante, diverso, tuttavia, da quello di Zemeckis, che invece punta a una radicale ibridazione tra corpi (reali), impulsi elettronici (collegati a varie zone dei corpi stessi) e vere e proprie “pitture elettroniche” (ambienti, paesaggi, creature fantastiche). Ciò che ne deriva, in tutti i casi, è comunque la contaminazione, l’intreccio, l’intarsio del Corpo con una sorta di Super-Corpo smaterializzato (si pensi anche al “corpo vuoto” di Sandman, fatto di sabbia, in Spider-man 3 di S. Raimi). Staccandosi dal Corpo reale (anche solo parzialmente), ponendo soltanto la possibilità tecnica di farne a meno, la cosiddetta “verità del cinema” diventa comunque sempre più indistinguibile dalla finzione – ma si potrebbe anche dire: forse si apre la possibilità di raggiungere, proprio nella finzione, una più profonda verità. Il Corpo, nel film, si stacca da se stesso, non solo (come nella fotografia) in quanto figura, ma in quanto azione; l’attore si vede sullo schermo ripetere gesti e movimenti da gran tempo effettuati, pronunciare parole da gran tempo emesse; o addirittura non può più vedersi (magari perché è morto) e a vederlo siamo noi spettatori. È un distacco effettivo, diverso da quello metaforico del teatro. Il cinema degli effetti elettronici tende a rendere radicale questo distacco, eliminando l’originale, il corpo-carne. Questa sarebbe l’apoteosi del suo compimento, se non fosse che ancora non ci riesce del tutto. Resta che, se l’uomo si riconosce dal suo Corpo di carne, il cinema , come aveva già intuito Bioy Casares immaginando L’invenzione di Morel, costituisce il tentativo più radicale di cambiarne la natura, di portare a compimento cioè il tentativo avviato dalla fotografia (e prima ancora dalla pittura) di sostituire alla carne qualcos’altro. 228 La sembianza (anche “falsa”) del Corpo, nel cinema, ci parla della verità del Corpo stesso, proprio esplorandone i travestimenti - fino al travestimento terminale, che è quello del vero. In Artificial Intelligence, ideato da Kubrick e realizzato dopo molti anni da Spielberg, entrano in gioco soprattutto tre elementi: il corpo (organico); b) il robot quasi-umano (il mecha); c) il simulacro elettronico. Ce ne sarebbero anche altri: la statua (p.e., quella della Fata Turchina); il cartoon (p.e., il mago che risponde alle domande)…Il bambino protagonista (il mecha David) 2, è tuttavia investito soprattutto dall’impatto dei primi due elementi, mentre il terzo, che non riguarda né lui né l’altro mecha , l’adulto Gigolo Giò, viene utilizzato per le creature artificiali meno perfezionate, per l’orsetto Teddy o per gli altri robot di cui bisogna mostrare in diretta la distruzione, durante la flesh fair. Artificial Intelligence è dunque solo secondariamente un film di effetti speciali elettronici (forse Kubrick, per farlo, aspettava che gli sviluppi tecnologici gli permettessero di far interpretare David da un vero robot); ma proprio per questo ci sembra radicale l’interrogativo che pone circa lo statuto del Corpo (e dell’io). È l’umano, in effetti, è il corpo organico di Haley Joel Osment, a imitare il robotico, sia pure un robotico che a sua volta imita l’umano in tutto e per tutto, salvo alcune eccezioni: il bambino-robot non cresce, non invecchia, non “muore” (può solo guastarsi o essere distrutto), non mangia ( si limita a imitare , a tavola, i gesti umani del portare il cibo alla bocca – se davvero lo inghiotte, si guasta), non defeca (non capisce cosa faccia la sua madre adottiva, Monica, seduta sul gabinetto), non dorme…Prova, però, amore, gelosia, paura di quell’abbandono che interverrà nella scena angosciosa nel bosco, ma che è anticipato dall’altrettanto angosciosa scena nella piscina, quando Martin (il “fratello”, munito di un corpo “vero”) viene salvato e lui no: certo, lui non ha bisogno d’essere tirato fuori, non può affogare, ma il suo atteggiamento, con le braccia protese in avanti e l’espressione disperata, sul fondo della piscina, è quello di chi chiede comunque d’essere salvato, anche se non si sa bene da cosa. Nell’arrivo di David in casa di Monica e di suo marito, personalmente trovo una strana affinità con la prima parte del Piccolo Buddha di B. Bertolucci. In fondo, David pone anche lui il problema dell’incarnazione (Buddha, ma anche Cristo, o Pinocchio). In un caso come nell’altro, si aggira per la casa un bambino che è altra cosa (il piccolo Buddha lo diventa quando riceve la visita dei due monaci; David lo è fin dall’inizio). David , come Pinocchio, è un Cristo che vuole incarnarsi, che chiede non al Padre, ma a una figura di Madre (la Fata Turchina) la grazia di incarnarsi, se 229 quella di assumere un corpo di carne è una condizione per essere amati. In fondo, quello che David chiede è di poter crescere e invecchiare, di correre l’avventura di diventare senex, di non vedere Monica invecchiare e morire da una posizione di eterno puer. Sembra sapere oscuramente che invecchiare (e poi sparire) sia la condizione per essere amati: non si ama ciò che ci sopravvive incorrotto in eterno. Ogni favola d’incarnazione pone il problema del corpo doppio, del corpo come involucro di un’altra cosa: anima, imprinting, DNA… E da questo punto di vista, io è sempre un altro. La coincidenza (l’unità, l’identificazione) è sempre frutto di una mescola tra eterogenei, la cui entropia è tendenza alla separazione (la morte). Pensiamo al parassita corporeo di Artaud, alla negatività del corpo cosiddetto “organico”, frutto di una subdola espropriazione, che è il contraltare rovesciato della mancanza di cui soffre David. Vero è che in pellicola e sullo schermo, ciò che risulta è sempre un simulacro. Sullo schermo, a differenza che sul set, non esistono attori “in carne e ossa”, e di ciò si crucciava già il Serafino Gubbio di Pirandello (come più tardi Artaud). Tuttavia, la grandezza del cinema era stata proprio questa: ritrasmutare per miracolo alchemico le ombre in corpi, i mecha in bambini veri. Ci si può chiedere: chi sono i protagonisti d’un film come Grindhouse di Q. Tarantino? Kurt Russel e Zoe Bell? Ma Zoe Bell, per esempio, qui è veramente attrice o solo una stunt-woman che rifà se stessa? Vere protagoniste, dopo tutto, non sono le macchine, le automobili, la Dodge Change modificata dello stuntman assassino, contro la Dodge Challenge già apparsa in Punto zero di Sarafian? E l’azione non consiste soprattutto nello scontro delle auto, nel loro furioso, reciproco tentativo di distruggersi a vicenda, non come fossero permeate dalla rabbia di chi le guida (le guida?), ma fossero esse stesse a condurre verso la catastrofe le protesi-umane che siedono al volante? L’aveva già scritto Ballard, del resto, e ribadito Cronenberg, che tra corpo umano e protesi meccaniche ogni contaminazione è possibile. Ma il pensiero corre anche naturalmente (o innaturalmente?), verso gli scontri tra automobili nel garage sotterraneo del Chrysler Building in Cremaster 3 di Matthew Barney, dove cinque macchine (di mafiosi?) compiono la lenta, metodica distruzione di un’altra macchina, si scagliano a turno contro di essa, fino a ridurla in pezzi – ma non siamo mai in grado di distinguere, nelle inquadrature riprese dall’alto, se al volante delle macchine distruttrici vi sia davvero qualcuno. E pensiamo ancora, per restare a Matthew Barney, ai due sidecar che corrono a tutta velocità in opposte direzioni, condotti da due strane coppie, una in blu, una in arancione, in Cremaster 4 (che poi è il primo dei cinque video 230 della serie, del 1994). Pensiamo allo stesso Barney, che balla il tip tap indossando una maschera lupesca (o da satiro), parrucchino rosso, orecchie flosce. Pensiamo all’atleta paraplegica Aimee Mullins, vivente icona museale, in look leopardato, all’interno del Guggenheim di F. L. Wright, ancora in Cremaster 3 (che invece è l’ultimo, del 2002). Pensiamo alla struttura matematica stessa, sottesa alla numerazione esoterica dei video 4-1-5-2-3, la cui simmetria è basata sulla centralità del cinque. Pensiamo all’uomo-radice della religiosità Candomblé, ibrido tra l’umano e il vegetale, che Barney filma mentre si masturba strofinandosi a un albero-motore, durante il carnevale a Salvador de Bahia (De Lama Lamina, 2004). Pensiamo all’algido cerimoniale scintoista del matrimonio Barney/Björk, celebrato su una baleniera giapponese, in Drawing Restraint 9 (2005), nel corso del quale i corpi diventano strutture astratte, si identificano con i mantelli, con i cappucci, che letteralmente, ricoprendoli, ne prendono il posto Tuttavia, su questi più recenti tentativi, in cui sembra implicata un’istanza di superamento della caducità della carne, di sconfitta del tempo, di aspirazione a un respiro cosmico, di avvicinamento all’imperturbabilità delle strutture “spirituali” dell’Oriente, non solo si allungano ombre oscure, d’ordine mitopoietico, ma anche, bisogna dirlo, un’altra Ombra – la prefigurazione d’un destino di rinuncia, di perdita irrevocabile della fisicità. Non so quanto il simbolo astratto d’una balena, come statua di vasellina (in Drawing Restraint), possa sostituire vantaggiosamente (altro che sul piano ecologico), l’urlo e il furore d’una caccia a Moby Dick… 1 Non è forse superfluo ricordare qui che W. Benjamin trovava singolari corrispondenze tra lo spirito del dramma barocco tedesco, in quanto sede di allegorie luttuose, e il teatro delle marionette: “Persino l’apparizione fisica degli attori, e soprattutto del Re, che si mostra nella sua pompa, poteva assumere un aspetto rigido e burattinesco.” (W. Benjamin – Il dramma barocco tedesco – Einaudi- Torino, 1999 – p.100). 2 Mecha è abbreviazione di mechanism. Ci piace notare una certa assonanza, puramente casuale (in italiano), con il termine me-carne, fondamentale nella semiotica corporea. 231 SCRITTURE Stanislavskij e Mejerchol’d: la regia operistica tra naturalismo e rivoluzione teatrale 1 di Daria Parisi Stanislavskij e Mejerchol’d incarnano convenzionalmente le due estreme concezioni del teatro così come si sono configurate, non solo in Russia ma in tutto il mondo occidentale, nei primi decenni del Novecento: naturalismo e “teatro delle convenzioni”, teatro centrato sull’attore contro teatro centrato sul regista, teatro borghese e teatro rivoluzionario, teatro della parola e teatro del corpo,ecc. Al di là di queste semplificazioni, la parabola teatrale di questi due straordinari innovatori mostra anche dei punti di convergenza, a partire dal noviziato di Mejerchol’d in qualità di attore sotto l’egida del maestro Stanislavskij nei primi anni del Teatro d’Arte di Mosca nell’ultimo decennio dell’Ottocento, all’influenza reciproca nelle produzioni della metà degli anni Venti, fino al riavvicinamento che precede la morte di entrambi a distanza di circa un anno. Il sipario si chiude: Konstantin Sergeevic Stanislavskij muore nel 1938 celebrato come un eroe dal regime, Vsevelod Emilevic Mejerchol’d nel 1939 giustiziato come “non persona” dallo stesso regime. Eppure Stanislavskij era il borghese e Mejerchol’d il rivoluzionario, iscritto al partito, fervido sostenitore del credo... Ma non è oggetto di questo saggio ripercorrere la vita dei due personaggi e i paradossi della storia, i rapporti con il regime, le sue canonizzazioni e gli autodafè, né ripetere le rispettive teorie teatrali e sistemi di training attoriale: voglio invece concentrarmi su un aspetto dell’attività registica di Stanislavskij e di Mejerchol’d, la regia d’opera lirica, attività estremamente rappresentativa delle divergenti concezioni e pratiche teatrali dei due registi e che nelle tortuose vie della storia diventerà, sorprendentemente, la piattaforma d’incontro del maestro e del discepolo. Mejerchol’d si dedica alla regia operistica prima del suo maestro Stanislavskij: tra il 1908 e il 1918 viene assunto come attore e regista dei Teatri imperiali Aleksandriskij e Mariinskij di Pietroburgo, teatro di prosa il primo e d’opera e balletto il secondo. I due teatri imperiali incarnavano il più retrogrado e cimiteriale accademismo, sia nel repertorio tradizionale che nelle pratiche tipicamente ottocentesche di attori “mattatori”e cantanti “divi”. La nomina inattesa di Mejerchol’d, dovuta pare alla pressione dello scenografo Aleksandr Golovin che aveva apprezzato le sue sperimentazioni al Teatro di Vera Kommissarzevskaja, fu accolta dal quasi unanime malcontento di attori 232 e cantanti, specie di quei mattatori e divi poco inclini a piegarsi alla tirannia del teatro di regia. Ma Mejerchol’d agì con magistrale diplomazia e astuzia, adattando la sua sete di sperimentazione al materiale umano: senza sconvolgere le cristallizzate pratiche sceniche, ma proprio attraverso la messa in evidenza del loro convenzionalismo, pose le basi del “teatro delle convenzioni”, della teatralità esasperata e autocelebrativa. Rispettando ed esaltando il primato di attori e cantanti, il regista e lo scenografo Golovin costruiranno intorno a questi una scena fastosa, armonizzata con l’arredamento dei teatri stessi, una degna cornice antiquaria a spettacoli del passato, con l’intento di riportare drammi e opere al loro clima originale 2. Al Mariinskij Mejerchol’d curò la regia di sette opere: (1909) Tristano e Isotta di R. Wagner; (1911) Boris Godunov di B. Mussorgskij e Orfeo e Euridice di C. Gluck; (1913) Electra di R. Strauss; (1917) Il convitato di pietra di A. Dargomyzskij e La fanciulla di neve di N. Rimskij-Korsakov; (1918) L’usignolo di I. Stravinskij. Le regie di Mejerchol’d si inserirono nella tendenza innovatrice assecondata dal teatro, alla ricerca di nuovi mezzi espressivi nella creazione di uno spettacolo che fosse sintesi perfetta non solo di dramma e musica, ma anche di scenografia e coreografia. Negli anni del tramonto del regime zarista collaboravano col Mariinskij, oltre al già citato Aleksandr Golovin, artisti del calibro di Aleksandr Benois, Konstantin Korovin, Valentin Serov ed il grande coreografo Michail Fokin. Le regie operistiche di Mejerchol’d seguono la stessa linea delle regie all’Aleksandriskij: impostazione antiquaria della scena e valorizzazione degli interpreti. In molti allestimenti il regista decise di dividere la scena in due parti, relegando le pitture sul fondo e utilizzando il proscenio come una sorta di piedistallo dell’attore. Se all’Aleksandriskij aveva richiesto agli interpreti di enfatizzare il gelido accademismo, la misura e l’eleganza del gesto, richiese invece ai cantanti una sorta di cantar-danzando, un’interpretazione ritmico-gestuale della partitura che desse risalto alla plasticità del corpo del cantante. L’attività di Mejerchol’d ai Teatri Imperiali rappresenta dunque un momento di stasi nella sperimentazione del regista, sperimentazione che invece aveva libero sfogo nell’attività parallela dello Studio inaugurato nel 1913; ma seppur costretto dai lacci dell’accademismo e del tradizionalismo, Mejerchol’d fu capace di creare allestimenti di grande valore, avvicinando i vetusti Teatri Imperiali al nuovo corso nascente nel teatro russo, agendo sul terreno della stilizzazione che svilupperà parallelamente nello Studio e negli anni successivi. Un valore di prorompente innovazione nel campo della regia operistica possiede invece l’allestimento del 1935 della Dama di picche al Malyj Teatr di Pietroburgo, ritorno di Mejerchol’d all’opera lirica nel periodo di decadenza seguito ai trionfi degli anni Venti. 233 Mi soffermerò su quest’allestimento in seguito, dopo avere introdotto la regia operistica di Stanislavskij. L’attività di regia di opere liriche di Stanislavskij comincia nel 1922, come conseguenza dell’attività di formazione dei cantanti-attori all’Opera Studio del Bol’soj, fondato nel 1921 e ospitato nella casa stessa di Konstantin Sergeevic, direttore dello Studio. La collaborazione con il teatro Bol’soj era cominciata già nel 1918 con alcune lezioni-conversazione tenute ai cantanti del teatro, ma Stanislavskij aveva rifiutato la proposta di curare regie d’opera per l’inadeguatezza della preparazione scenica dei cantanti rispetto ai compiti da lui prefigurati. Su pressione del fratello Vladimir e della sorella Zinajda, che l’accompagneranno quali fedeli collaboratori in questa e altre imprese, Stanislavskij infine accettò di istituire e dirigere lo Studio d’Opera, sperimentando quotidianamente la validità del “sistema” nella formazione del cantante operistico. Avrà probabilmente influito sulla decisione di Stanislavskij l’istituzione dello Studio Musicale del Teatro d’Arte nel 1919 sotto la direzione di V.I. Nemirovic-Dancenko, cofondatore e codirettore del Teatro d’Arte ma con il quale in quegli anni si andava delineando quell’allontanamento che porterà alla rottura negli anni Venti. Lo Studio Musicale di Nemirovic-Dancenko portava anche la dicitura di “Opera Comica”, visto il repertorio verso il quale si rivolgeva: sulla scena del Teatro d’Arte erano state portate le operette La figlia di Madame Angot di Lecocq e La Périchole di Offenbach 3. Tale scelta nei confronti del genere popolare dell’operetta (scelta peraltro osteggiata da molti membri del Teatro d’Arte e che porterà alla separazione e all’istituzione nel 1926 del Teatro Musicale Nemirovic-Dancenko) esprimeva la volontà di Nemirovic-Dancenko di allinearsi con l’estetica del teatro d’avanguardia nella rivisitazione delle pratiche teatrali “basse”. Al contrario Stanislavskij e la sua visione estetica del teatro apparivano quanto mai fuori posto e démodé nel panorama post-rivoluzionario: cosicché, fallito il progetto del “Teatro Panteon”, che avrebbe dovuto essere un punto d’incontro del Teatro D’Arte, i vari studi e altre compagnie, a Konstantin Sergeevic non rimase che rifugiarsi nella torre d’avorio dell’opera lirica, genere alto, non inquinato da fermenti politici e rivoluzionari, reliquia del secolo passato e simbolo di quella società agonizzante alla quale Stanislavskij apparteneva. Così, mentre trionfa l’astro di Tairov, degli allievi Vachtangov e Mejerchol’d, mentre il teatro d’avanguardia scardina la tradizione teatrale perseguendo la nascita di una nuova società e di una nuova teatralità, Stanislavskij riduce notevolmente il suo impegno di regista al Teatro d’Arte 4, dedicandosi sempre di più all’attività pedagogica e alla stesura del “sistema”, sperimentato soprattutto attraverso la formazione dei cantanti-attori. La nuova sfida creati234 va è adesso rappresentata dal rinnovamento scenico dell’opera lirica, rinnovamento che Stanislavskij persegue attraverso la messinscena di quattordici opere: (1922) Evgenij Onegin di Cajkovskij; (1923) Werther di Massenet; (1926) La fidanzata dello Zar’ di Rimskij-Korsakov; (1927) La Bohème di Puccini e Il matrimonio segreto di Cimarosa; (1928) Notte di Maggio di Rimskij Korsakov; (1929) Boris Godunov di Mussorgskij; (1930) La Dama di picche di Cajkovskij; (1932) Il gallo d’oro di Rimskij-Korsakov; (1933) Il barbiere di Siviglia di Rossini; (1935) Carmen di Bizet; (1936) Don Pasquale di Donizetti; (1939) Le gole di Darvaz di Stepanov e Rigoletto di Verdi, messe in scena dopo la morte di Stanislavskij nel 1938 da Mejerchol’d, attenendosi ai suoi piani di regia 5. L’addestramento degli attori precedette e accompagnò l’attività registica di Stanislavskij: per Konstantin Sergeevic, come abbiamo visto, uno spettacolo sarebbe stato inconcepibile senza una preparazione completa dei cantanti. Gli allievi dell’Opera Studio ricevevano un’istruzione completa e articolata: teoria e pratica del “sistema”, ovviamente; ma anche un severo training fisico, basato su una serie di esercizi a suon di musica, pratica completa del ballo (nelle opere messe in scena dallo Studio le danze venivano eseguite dai cantanti stessi) e scherma; a ciò si aggiungevano accurati esercizi di dizione e ortoepìa, perché Stanislavskij era sempre molto esigente sul fatto che le parole cantate fossero chiare e intellegibili al pubblico 6. Gli allestimenti operistici di Stanislavskij erano dunque incentrati sulla “autenticità” e naturalezza della recitazione attoriale, sulla verosimiglianza della espressività emotiva, secondo quella stessa linea che aveva perseguito al Teatro d’Arte. Secondo tale linea, le scene e i costumi dovevano rispecchiare fedelmente, in maniera quasi maniacale, l’epoca di ambientazione dell’opera, senza però schiacciare gli interpreti con l’eccessivo sfarzo. Grande attenzione veniva posta al movimento sulla scena, non solo quello dei protagonisti ma anche quello del coro: ogni singolo cantante, ogni comparsa doveva, secondo il sacro “sistema”, seguire il proprio “superobiettivo” e le proprie profonde e meditate motivazioni sceniche. Inoltre il movimento del cantante, la recitazione e il “movimento interiore” dovevano essere regolati sul tempo-ritmo della musica: il corpo, e l’anima, dovevano seguire, con scioltezza, tale ritmo che costituiva la coincidenza tra il superobiettivo di ogni singolo interprete con il significato dell’opera tutta. Quando Stanislavskij mise in scena la Dama di picche nel 1930 questa rappresentava il risultato di più di dieci anni di lavoro dedicati all’opera lirica e costituisce, come vedremo, una cristallizzazione dei suoi principi registici; al contrario Mejerchol’d, con la messinscena del 1935, ritorna al genere operistico dopo più di quindici anni di lontananza, anni peraltro fecondissimi e prosperi. La sua messinscena della Dama risulta una summa delle sperimen235 tazioni teatrali di quegli anni, un’innovazione totale della regia operistica, una sorta di testamento artistico: insieme a l’omaggio a Cechov Trentatré svenimenti, che riunisce tre vaudevilles (L’Orso, L’anniversario, Una proposta di matrimonio) messo in scena nel marzo dello stesso anno al Teatro Mejerchol’d di Mosca, l’opera di Cajkovskij rappresenta il triste addio di Mejerchol’d alla scena 7. La Dama di picche (Pikovaja Dama) fu composta da P. I Cajkovskij per il Teatro Mariinskij di Pietroburgo, dove fu messa in scena nel 1890; il libretto, di Modest Cajkovskij, fratello del compositore, era tratto dall’omonimo racconto di A. Puskin, del quale nel 1890 ricorrevano i cento anni dalla nascita. Quest’opera rappresenta oggi un classico del teatro musicale russo, l’opera cajkovskiana più rappresentata nei teatri di tutto il mondo; ma nei primi decenni del secolo non era affatto una favorita del repertorio russo 8. L’interesse per la Dama di picche andò di pari passo con l’avvicinarsi dei festeggiamenti per i cento anni dalla morte di Puskin del 1937 e il recupero dell’opera del sommo poeta da parte del regime, secondo quel procedimento di appropriazione dell’arte e della cultura russa prerevoluzionaria attraverso la canonizzazione dei suoi maggiori esponenti, celebrati quali poeti e artisti della nazione e del popolo. Stanislavskij si accostò alla Dama di picche liberamente, non spinto da commissioni da parte del regime, ma inaugurando il clima puskiniano di quegli anni. La preparazione dell’opera era cominciata già nel 1928, in parallelo all’intenso lavoro di allestimento del Boris Godunov di Mussorgskij tratto dall’omonimo dramma puskiniano. Purtroppo il duro lavoro di Stanislavskij e dei suoi collaboratori (B.I. Versilov e P.I. Rumjantsev) non raggiunse i risultati sperati a causa della sfortuna che sembrò perseguitare l’allestimento della Dama: dapprima la malattia di Stanislavskij, che lo costrinse ad andare a curarsi all’estero prima che la messinscena fosse completata, poi la malattia dello scenografo Golovin, che cedette il compito al suo assistente B.E. Zandin 9. Versilov e Rumjantsev si attennero strettamente al piano di regia del maestro, ma la mancanza di Konstantin Sergeevic proprio nel momento finale della produzione influì negativamente sull’esito. La critica si scagliò duramente contro questa messinscena, ma gli attacchi erano dovuti più all’osservanza delle linee culturali del partito e delle sue antipatie (in quegli anni precedenti alla sua “canonizzazione” negli anni Trenta, Stanislavskij attraversava un periodo di disgrazia nelle simpatie del regime) che a critiche fondate 10. In realtà la regia della Dama di picche sembra peccare per una sorta di cristallizzazione di quegli innovativi principi che Stanislavskij aveva sperimentato nelle precedenti messinscene: ove viene a mancare la vitalità della sperimentazione, il principio si traduce inevitabilmente in accademismo 11. Il fatto 236 che, per l’assenza di Konstantin Sergeevic, i due registi Versilov e Rumjantsev abbiano completato il lavoro di allestimento seguendo religiosamente il piano di regia senza adattarlo alle eventuali esigenze contingenti, ha rafforzato senza dubbio il manierismo di questo spettacolo. La messinscena di Stanislavskij era incentrata sul dramma del protagonista, German, e la sua pazzia: tutta la vicenda viene letta in chiave realistica, epurando l’atmosfera fantastica dell’opera e del racconto originale. Contrariamente alla consuetudine operistica, German non viene rappresentato come un eroe romantico ma, più similmente al personaggio del racconto di Puskin, come un uomo mediocre, un ufficiale povero e poco brillante, di aspetto comune, ma animato da un’ambizione e un’avidità smisurate. Anche Liza non è l’elegante fanciulla aristocratica dell’opera, ma la modesta pupilla della vecchia contessa, che vive in una stanzetta nel mezzanino, come nel racconto puskiniano. Per il personaggio della contessa Stanislavskij si ispirò alla figura di una lady centenaria incontrata a Nizza: “Passeggiava ogni giorno in un vestito nero, malgrado il caldo. Era dritta come un bastone, stretta nel corsetto per restare eretta. Non degnava mai nessuno di uno sguardo. A casa, quando era sola, mi immagino che si liberasse del corsetto e tornasse a essere una non entità” 12. Malgrado il racconto di Puskin fosse ambientato nell’epoca contemporanea al poeta, negli anni Trenta dell’Ottocento, nel libretto di Modest Cajkovskij, su diretta richiesta dei dirigenti del Mariinskij, l’azione fu retrodatata al Settecento, al regno di Caterina la Grande: era consuetudine nei teatri di tutto il mondo retrodatare l’ambientazione originale, sia per motivi di censura (si pensi all’ambientazione seicentesca delle prime Traviata) che di spettacolarità. Stanislavskij mantiene l’ambientazione settecentesca, forse proprio per la maggiore spettacolarità, e invita a disegnare scene e costumi A. Ja. Golovin, lo scenografo che aveva collaborato con Mejerchol’d agli storici allestimenti al Mariinskij e all’Aleksandriskij di Pietroburgo, e col quale aveva già lavorato nel Matrimonio di Figaro del 1927, uno strepitoso successo di pubblico e considerato uno dei capolavori di Stanislavskij. Con le scene di Golovin si voleva ricreare quel fasto e quella antiquaria magnificenza tipiche delle messinscene di Mejerchol’d ai Teatri Imperiali, ma l’effetto non fu quello sperato. Zandin, l’aiutante di Golovin che gli successe dopo che questi si ammalò (morirà nel 1930), non fu all’altezza del compito e pur realizzando le scene sui disegni del maestro, non riuscì ad adattarle alle esigenze reali della scena e degli attori: la tanto ricercata magnificenza finì per schiacciare le figure degli interpreti, anziché darvi risalto. La recitazione naturalistica, quella “verità” tanto esaltata da Stanislavskij, risultò inadeguata, soprattutto nelle scene di massa (il Giardino di’Inverno nel primo atto e il ballo nel secondo atto); mentre le scene più riuscite risulta237 rono quelle più raccolte, dove predominavano i toni intimistici (la scena d’amore nella stanzetta di Liza nel primo atto, quella della caserma e del canale nel terzo atto) e il finale nella casa da gioco, dove il dramma focalizzava sulla pazzia di German, interpretata con grande realismo da Jegorov. Laddove invece dominava la teatralità falliva l’estro di Stanislavskij: lo si vede soprattutto nel piano di regia della scena del ballo. In questa scena, dove si incrociano tutti i protagonisti del dramma e si decide del loro destino, di primaria importanza è l’intermezzo pastorale al quale assistono gli invitati. Questa mise en abyme rappresenta una parodia del dramma stesso, ove il dilemma di Cloe divisa tra l’amore per Dafni e il ricco Plutone è il dilemma stesso di German, che preferendo la ricchezza finirà per impazzire e suicidarsi. Stanislavskij non mise in risalto questo aspetto, ma si concentrò su quelle minuzie che erano la sua delizia nelle scene di massa: la delineazione delle motivazioni di tutti i personaggi, inclusi i coristi, e la recitazione attraverso gli sguardi, i gesti, ecc.; i movimenti sulla scena regolati dal realismo drammatico e non dall’effetto visivo; la cura maniacale nei costumi (concepì quattro quadriglie in costume di Cinesi, Samoiedi, Greci antichi e Pastori) e nella scenografia che finirono per risultare meramente decorativi. La scena era composta da una scalinata monumentale che scendeva da una terrazza, e ai suoi piedi una fontana e degli arbusti. In primo piano un prato e delle sedie sulle quali prendevano posto i personaggi guardando la pastorale sulla scalinata. Sul fondo della scena, al di là della terrazza, la sagoma di un ricco palazzo illuminato. Le scene risultarono troppo monumentali per l’esigua grandezza del palcoscenico, e soprattutto la scalinata risultò eccessiva. La scala, dalla quale i personaggi scendevano e salivano, doveva probabilmente mettere in risalto attraverso il suo valore simbolico la smania di ascesa di German, nonché servire a dinamizzare i movimenti sulla scena, ma finì per schiacciare tutta l’azione scenica 13. La messinscena della Dama di picche mostra dunque i limiti della regia stanislavskijana: la difficoltà a conciliare “sistema” e spettacolarità e la tendenza all’accademismo. Del resto in quegli anni il “sistema”, che aveva rivoluzionato la recitazione attoriale e posto le basi di un rinnovamento radicale del teatro, si accingeva a diventare il quinto Veda del teatro sovietico, asservito totalmente al realismo socialista. Nel 1932 Stanislavskij e NemirovicDancenko avevano fatto atto di fede, ricusando il formalismo e proclamando il realismo quale unico approccio sano all’arte 14. A Stanislavskij fu così concesso di trascorrere nell’agio e con relativa serenità i suoi ultimi anni, ormai ridotto al monumento funebre di se stesso e della sua arte. Diverso sarà, come vedremo, il destino di Mejerchol’d, al quale la Dama di picche riuscì fatale. Nel 1934 un’altra Dama lo aveva affascinato, la Dama delle camelie con un 238 allestimento al TIM (Teatro Mejerchol’d) quanto mai lontano da quei tempi travagliati, in un recupero melanconico della tramontata cultura russa vista in chiave europea. La nostalgia di questo stesso passato splendore pervade la Dama di picche, che era stato chiamato a dirigere su iniziativa del direttore del Malegot (Malyj Gosudarstvennyj Opernyj Teatr) di Pietroburgo P.A. Shapiro 15. Nel riaccostarsi al genere operistico Mejerchol’d, apparentemente libero dai lacci che avevano costretto le sue produzioni operistiche ai Teatri Imperiali, lo sovverte praticando una regia rivoluzionaria, che pone sotto la propria egemonia tutte le componenti dello spettacolo. Il regista-tiranno scardina dapprima il testo stesso dell’opera che, con l’aiuto di Stenic nella riscrittura del libretto 16, deve essere riportato all’originale racconto puskiniano intorbidato dal libretto di Modest Cajkovskij: non solo l’ambientazione viene riportata agli anni Trenta dell’Ottocento ma, secondo un procedimento sperimentato nelle produzioni del TIM, una serie di tagli, dislocazioni, inversioni, stravolgono completamente il testo ridonandogli una sorta di verginità drammatica 17. Al centro del dramma Mejerchol’d pone il tema del gioco d’azzardo, cogliendo con acutezza il valore che questo tema ha rivestito per la cultura ottocentesca: espressione del destino, della facile ricchezza e della rovina, della piccolezza dell’esistenza umana, il tema del gioco mostra la fragilità del mito dell’autorealizzazione dell’uomo attraverso il lavoro che domina la letteratura fra Settecento e Ottocento. Lo stesso tema era stato al centro di Maskarad di Lermontov messo in scena all’Aleksandriskij nel febbraio del 1917: German viene rappresentato quasi come un doppio di Arbenin, il protagonista del dramma lermontoviano, un uomo divorato dal demone del gioco, con sguardo allucinato e movimenti convulsi da marionetta 18. L’influenza di Maskarad e delle regie ai Teatri Imperiali è rintracciabile con evidenza anche nella cura antiquaria delle scene e dei costumi, che però non ricadde mai nel décor fine a se stesso dell’allestimento stanislavskiano, ma acquista il valore di mise en relief, di stilizzazione, tipici del procedimento di “teatralizzazione” che domina le produzioni di Mejerchol’d prima della Rivoluzione e che poi diventerà principio del suo “teatro delle convenzioni”. Per le scene Mejerchol’d si avvalse della collaborazione di L.T. Chupiatov: il regista progettò una soluzione visiva generale articolata nella ripetizione della figura geometrica del triangolo, forma carica di valenze mistiche; inoltre utilizzò per molte scene una piattaforma inclinata, ripetizione del triangolo, che dinamizzava la decorazione antiquaria delle scene e il movimento degli interpreti, evocando i set costruttivisti del Magnifico cornuto (1922), La Morte di Tarelkin (1922), Il lago Lyul (1923). Gli amori del passato tornano ancora nella Dama di picche nella veste della 239 Commedia dell’Arte, grande amore dei tempi dello Studio di via Borodinskaja e del “Dottor Dappertutto”, pseudonimo con il quale si firmava nella rivista “L’amore delle tre melarance” : una pantomima “alla maniera di Callot” sostituisce l’intermezzo pastorale della scena del ballo. Abbiamo visto come Stanislavskij fallì nel rappresentare questo momento importantissimo di mise en abyme del dramma; al contrario Mejerchol’d vi riuscì in maniera tanto magistrale quanto originale. Mejerchol’d si era ispirato alle incisioni di Jacques Callot della serie I balli di Sfessania per la pantomima che aveva creato nel 1913 con V. Solovev, Arlecchino sensale di matrimoni; la pantomima della Dama di picche prende invece ispirazione dalle incisioni della serie dei Tre Pantalone: in queste incisioni Callot ricorre a un particolare procedimento compositivo, l’unione nello stesso quadro di due momenti diversi dell’azione. L’eroe principale, Pantalone, è raffigurato due volte: in primo piano, di dimensioni più grandi, così vicino all’orlo del foglio da sembrare sul punto di uscire dal disegno e inchinarsi al pubblico; e sul fondo, di dimensioni più piccole, la sua figura sul palcoscenico. Allo stesso modo viene costruita la messinscena nella Dama di picche: in primo piano gli ospiti, fra i quali la Contessa, Liza e German che le fa scivolare il biglietto fra le mani; in secondo piano, nella pantomima, Smeraldina passa un biglietto a Tartaglia. In tale maniera l’azione principale veniva messa in rilievo, pur venendo meno i riferimenti metatestuali dell’intermezzo pastorale 19. Ma la grande innovazione di questa messinscena consistette soprattutto nella sperimentazione di una nuova recitazione operistica: andando contro al principio della coincidenza del movimento con la musica, quel tempo-ritmo di Stanislavskij che Mejerchol’d aveva già applicato prima di questi alle messinscene al Mariinskij, il regista pone il principio della libertà ritmica dell’attore, il cui movimento e recitazione devono essere sviluppati non come riflesso della musica, ma come suo contrappunto. Il dramma e la musica in tale maniera dovevano coesistere in connessione dinamica, ove il dramma scaturiva comunque dall’espressione musicale, dalla quale Mejerchol’d fece infatti derivare le variazioni imposte al testo dell’opera. La messinscena della Dama di picche rappresenta quindi una condensazione dei procedimenti via via esperiti da Mejerchol’d nel corso del suo percorso artistico: la stilizzazione, la teatralizzazione, il teatro delle convenzioni, il set costruttivista, la decostruzione del testo drammatico, e, in ultimo, l’innovativa recitazione contrappuntistica. In questo continuo rinnovarsi, in questa incessante sperimentazione consiste la rivoluzione teatrale di Mejerchol’d. La Dama di picche ebbe un successo clamoroso di pubblico: nei due anni che restò in repertorio, prima di essere bandita insieme a tutti gli altri allesti240 menti di Mejerchol’d, ebbe più di cento repliche. Gran rumore produsse nel mondo culturale: cinque giorni dopo la prima, si tenne una seduta all’Accademia Nazionale delle Arti esclusivamente dedicata alla messinscena di Mejerchol’d. La maggiorparte dei membri si scagliò contro il formalismo, contro i sacrilegi perpetrati nei confronti dell’opera cajkovskiana, ma alcuni, fra i quali il compositore D. Sostakovic, difesero il diritto del regista a proporre la propria interpretazione e lodarono l’innovativo principio contrappuntistico della recitazione. Ma “la vita nell’arte” di Mejerchol’d era ormai all’epilogo. Ripellino intitola l’ultimo capitolo del suo noto saggio sui maestri del teatro russo del Novecento Ritorno e morte del figliol prodigo 20: quasi in capitulo mortis i due colossi si riavvicinano, proprio sulla scena operistica. Dopo che il TIM era stato chiuso e le sue messinscene bandite da tutti i teatri del regno, nel 1938 Stanislavskij, ormai sul finire dei suoi giorni, chiama l’antico pupillo in disgrazia a lavorare come regista in quel Teatro d’Opera nel quale si era rifugiato negli ultimi travagliati anni. Affida a Mejerchol’d il compito di continuare la messinscena del Rigoletto, che il vecchio maestro non aveva più la forza di seguire. È assai significativo che l’ultima regia di Stanislavskij, alla quale lavorava da anni, e che poi toccò a Mejerchol’d portare sulla scena, fosse proprio una riflessione sul potere, con l’inevitabile sconfitta del giullare... Di lì a poco Stanislavskij muore, e Mejerchol’d, su diretto desiderio di Stanislavskij, diventa il direttore del Teatro d’Opera Stanislavskij. Pochi mesi dopo il Rigoletto, nel giugno del 1939, Mejerchol’d viene arrestato e otto mesi dopo fucilato. Sua moglie, l’attrice Zinaida Raich, viene trovata sgozzata nella sua casa di Mosca due settimane dopo l’arresto del marito. Jean Benedetti, biografo di Stanislavskij, ha suggerito l’ipotesi che il regime si sia mostrato così spietato nei confronti di Mejerchol’d proprio perché rimaneva l’unico erede diretto di Stanislavskij e vitale continuatore di tutta quella tradizione culturale che si era deciso di archiviare, ove fosse inconciliabile con i presupposti del realismo socialista 21. Anche l’esperienza operistica di Stanislavskij viene implacabilmente archiviata dal regime: dopo la rimozione di Mejerchol’d viene nominato direttore del teatro Nemirovic-Dancenko, già direttore del Teatro Musicale che divideva la sede teatrale con quello di Stanislavskij. Nel 1941 i due teatri vengono fusi nel “Teatro Nazionale Musicale e d’Opera intitolato agli artisti nazionali K.S. Stanislavskij e V.I. Dancenko”, nome che porta tuttora. Nel 1943 muore Nemirovic-Dancenko e con lui si chiude definitivamente il capitolo più fecondo e splendido del teatro russo. Si dovranno aspettare gli anni Sessanta e la revisione krusceviana prima che queste pagine siano riaperte, Mejerchol’d riabilitato e la sua opera recuperata. 241 1 2 Proseguiamo lo scandaglio sulla cultura rissa intrapreso con The Rope /1. Cfr. Ripellino, Angelo Maria, Il trucco e l’anima, Torino, Einaudi, 1965, pp. 140-159. 3 Nel 1926 lo Studio Musicale del Teatro d’Arte diventa Teatro Musicale Nemirovicancenko e divide con il Teatro d’Opera Stanislavskij il teatro Dimitrievskij. Nel 1939 incorpora il Balletto d’Arte di Mosca, fondato nel 1929 dalla ballerina Victorina Kriegel sulla scia dei metodi del Teatro d’Arte. 4 Fra il 1920 e il 1938 Stanislavskij firma la regia di undici spettacoli, fra i quali solo due ebbero successo e risonanza e occupano un posto d’onore nella cronaca teatrale di quel tempo e nella carriera artistica del regista: L’ispettore generale di Gogol’ del 1921 e La folle giornata ovvero il matrimonio di Figaro di Beaumarchais del 1927. Spesso però Stanislavskij, così come Nemirovic-Dancenko, fornivano la loro supervisione registica a molti spettacoli, specie quelli sotto la direzione di giovani registi, cosicché quasi ogni messinscena del Teatro d’Arte portava in minore o maggior grado l’impronta, spesso discorde, dei due tirannici direttori, che tra l’altro, secondo lo statuto del teatro, avevano diritto di veto su ogni spettacolo. 5 Nel lavoro di allestimento Stanislavskij, visto l’enorme impegno che la messinscena di un’opera lirica richiede, si faceva coadiuvare da due o più registi: il fratello V. S. Alekseev e Z.S. Sokolov, che firmarono anche la regia indipendente di alcune opere, ma sempre e solo con l’approvazione e la supervisione di Stanislavskij; e in seguito B.M. Suskevic, V.F. Vinogradov, l’ex allievo dell’Opera Studio P. Rumjantsev, e altri. 6 Per un’introduzione alla didattica di Stanislavskij all’Opera Studio si veda l’articolo: Daria Parisi, Ricordo di Stanislavskij: il maestro all’Opera, in “The Rope”, n.1, Palermo, 2007, pp. 109-124. 7 In questi anni imperversa infatti il flagello della repressione stalinista: nel 1934 il realismo socialista era stato decretato l’unica estetica del regime; nel 1937 verrà chiusa il Teatro Mejerchol’d e le sue messinscene bandite da tutti i teatri. 8 È indicativo che la prima opera messa in scena da Stanislavskij con l’Opera Studio sia l’altra opera più nota di Cajkovskij, l’Evgenij Onegin: rispetto alla maggiore spettacolarità della Dama di picche, l’Onegin rappresenta invece un felice esempio di naturalismo, un precursore del teatro di Turgenev e Cechov. A tal proposito si veda il saggio: Daria Parisi, Il teatro di Cechov e l’Onegin di Cajkovskij, 242 “Drammaturgia musicale”, n. 1, Palermo, 2003. Il cast completo della Dama di picche, messa in scena all’allora “Teatro Nazionale dell’Opera intitolato all’artista popolare della repubblica K.S. Stanislavskij” il 30 febbraio 1930: Piano della regia: K.S. Stanislavskij. Registi: B.I. Versilov e P.I. Rumjantsev. Supervisione musicale: V.I. Suk, direttore – B.E. Chajkin. Scenografie e costumi: B.E. Zandin. German - G.A. Egorov, M.B. Sceglov; Tomskij - S.I. Bitelev, P.I. Mokeev; Elezkij - Ju. P. Junizkij, P.I. Rumjantsev; Liza - M.L. Meltzer, O.S. Sobolevskaja; la Contessa - E.A. Romanova, V.D. Dipner; Polina - M.S. Goldina, S.A. Gelikonskaja. 9 10 Le recensioni rendono il polso del tempo. E. Braudo scrisse sulla “Pravda”: “Che astruserie nella Dama di picche,... ma in nessuna maniera è possibile creare una visione coerente e realisticamente sana...La risposta alla domanda, a quale scopo e per quale spettatore è stata messa in scena questa Dama di picche, non siamo riusciti a trovarla nello spettacolo!”. Gli attacchi non risparmiarono neanche Cajkovskij; M. Grinberg scrisse sul “Vecernaja Moskva”: “nella Dama di picche c’è tanto di quel morboso misticismo che non può non risultare ostile alla coscienza contemporanea”. Citate nelle cronache del “Teatro accademico musicale di Mosca intitolato agli artisti nazionali Stanislavskij e Nemirovic-Dancenko” al sito http://www.stanmus.ru/; la traduzione è mia. 11 La stessa sorte aveva avuto la pedissequa applicazione del “sistema” al Teatro d’Arte, e proprio allo scopo di stimolare la sperimentazione Stanislavskij aveva via via fondato i tre Studi del Teatro d’Arte. Allo stesso scopo nel 1935 fondò un nuovo Studio operistico per giovanissimi cantanti. Citato in Pavel Rumjantsev, Stanislavskij i opera, Isskustvo, Moskva, 1969, pp. 416-417. 12 13 In tempi recenti, nell’allestimento del 1992 al Glyndebourne Festival Opera, il regista Graham Vick e lo scenografo Richard Hudson hanno fatto una scelta analoga, ponendo al centro della scena una monumentale scala dorata, sulla quale poi si svolge l’intermezzo pastorale. 14 Il Teatro d’Arte già dal 1931 era sotto il diretto controllo di Stalin, in quanto monumento del teatro nazionale. 243 Shapiro e altri partecipanti alla produzione della Dama condivideranno la triste sorte del regista: Shapiro viene fucilato come “nemico del popolo” nel 1936; lo scrittore e critico V. I. Stenic, che riscrive per Mejerchol’d il libretto della Dama di picche, viene fucilato sul finire degli anni Trenta e stesso destino anche per A. I. Piotrovskij, responsabile letterario del Malegot. Cfr. AA.VV., Mejerchol’d. Pikovaja Dama. Dokumenty i materialy, Kompositor, Sankt-Peterburg, 1994, p.8. 15 16 Di conseguenza la partitura musicale dovette essere adattata alle variazioni del libretto, con alcuni tagli e dislocazioni eseguite da N.G. Shulgin. Un’operazione analoga è quella compiuta da Peter Brook nella Tragédie de Carmen (1983), nella quale però domina la recitazione naturalistica. 17 18 Cfr. Ripellino, op. cit., pp. 394-5. 19 Cfr. AA. VV., Mejerchol’d, cit., p. 21. 20 Ripellino, op.cit. 21 Jean Benedetti, Stanislavskij. La vita e l’arte, Dino Audino Editore, 2007. 244 VISIONI Across the Universe di Piera Gemelli “Is there anybody going to listen to my story?” Across the Universe inizia così, con una richiesta di partecipazione, e sulle note di Girl entriamo nel film attraverso le onde del mare che ci sommergono. Si tratta di un inizio emblematico perché dà figura alla sensazione di immersione che ci accompagnerà per tutto il film, trascinandoci nella vertigine di un bagno visivo-acustico. Davanti alla potenza sensoriale delle immagini la trama passa in secondo piano. Dei giovani, una storia d’amore, il ’68, il rock, il pop, i Beatles. Questi sono gli elementi che compongono la linea narrativa, in cui le canzoni dei Beatles non fanno da accompagnamento sonoro, ma si intrecciano alla storia costituendosi come linfa. La fluidità che troviamo all’interno delle singole scene non attraversa invece omogeneamente il film, che appare come un collage di videoclip. Ogni scena costituisce un quadro musicale a sé e trait d’union tra le varie scene è il costituirsi dell’immagine come pura visione. Across the Universe esibisce come una macchina barocca il suo congegno scenico, il suo artificio, presentando una moltitudine di linguaggi per il raggiungimento dell’intensità sensoriale e della meraviglia. Pensiamo alle solarizzazioni della scena del pullman psichedelico guidato dal Dott. Robert/Bono, che possiamo prendere a metafora del viaggio dello sguardo dello spettatore “with kaleidoscope eyes” all’interno di Across the Universe. E mentre Bono canta I am the Walrus e Lucy in the sky with diamonds, non un unico punto di vista, non una linea retta, ma un continuo muoversi dello sguardo che segue il movimento vorticoso dello spazio che non è superficie piana, ma è dato da un aggrovigliarsi vorticoso della fluida materia digitale. E così l’occhio aiutato dal colore frattale precipita in questi vortici spaziali imbarcandoci nel galeone fluttuante del film, e dalla porosità dello spazio di Lucy in the sky with diamonds passiamo alla bidimensionalità della scena circense di Being for the Benefit of Mr. Kite, che ricorda la “videopittura” di Eve Ramboz e Alain Escalle, per l’ibridazione linguistica. Anche questo rientra in pieno nella macchina barocca di Across the Universe, per la capacità di ricombinare gli elementi visivi in un quadro in movimento. Unendo pittura, disegno, video e ovviamente musica e danza, si ha un’immagine semanticamente ambigua, aperta alla polimorfia, frutto del mutamento di sostanza delle immagini originarie. Come dott. Robert, anche Mr Kite produttore di artifici visibili, di spazi totalmente irreali, guida la macchina della meraviglia, il circo, immagine emblema dello spettacolo. Qui non avremo colori lisergici e spazi 245 vorticosi, ma un collage di sagome, piatti colori primari e corpi tridimensionali, acrobati di carta inconsistenti e leggeri, come fluttuanti e impalpabili sono i corpi diafani di puro movimento nella scena sottacqua di Because. Essi perdono la loro materialità per avvolgerci nel movimento ondulato della fluidità digitale, che permette la fusione tra tempo e spazio e tra ambientescena e azione-corpo, mentre la musica ci immerge nel flusso sonoro, in preda ad una dolce sinestesia. Ma da questo punto di vista la scena che più coinvolge la totalità dei nostri sensi è quella sulle note di Strawberry Fields Forever. Questa sequenza riecheggia il videoclip originale della canzone diretto da Peter Goldmann. Infatti, pur non riferendosi al Vietnam, fa un uso della stessa gamma cromatica basata sul contrasto di qualità tra colori saturi e grigi, in un montaggio serrato di immagini sovraimpresse, mentre i Beatles gettano vernice rossa su un pianoforte. In Across the Universe vediamo Jude inchiodare delle fragole al muro, dal quale inizia a colare il succo rosso evocativo del sangue e al crescere della rabbia in Jude corrisponde lo scoppio delle bombe, mentre il ragazzo scaglia con violenza le fragole sul muro che esplodono in colate rosso sangue. Anche qui si attua una metamorfosi delle forme e dei linguaggi. Così, attraverso l’uso di sovrimpressioni, vediamo fondersi i volti di Maxwell e di Jude insieme alle fragole, al sangue e alla vernice, in un crescendo vorticoso di musica e rumore che termina con il rosso liquido. Questo dilagando invade lo spazio visivo fondendo nella nostra mente tutte le sensazioni precedenti. Possiamo dunque considerare Across the Universe come un’immersione “attraverso l’universo” dei sensi, in quanto bombardandoci di suoni, colori e danze, avvia verso la liberazione di puri stimoli, verso un’esperienza sensoriale immersiva che mira a risucchiare lo spettatore dentro l’universo meraviglioso del film. Speed Racer di Piera Gemelli “Comincia una nuova era […] Ora tutto può cambiare […] anzi è già cambiato”. Speed Racer lontano dall’essere un semplice film sulla passione e il talento di un ragazzo per le corse automobilistiche (tratto da Mach GoGo, un cartone animato giapponese del 1964 di Tatuo Yoshida) si presenta come un lunapark della visione e della sperimentazione tecnologica. La semplicità lineare della trama, in netto contrasto con la struttura estremamente complessa della messa in forma, mi porta a pensare che è in quest’ul246 timo aspetto che dobbiamo cercare la chiave di lettura per interpretare l’ultimo film dei fratelli Wachowski. Innanzitutto la particolarità di Speed Racer è nella messa a fuoco simultanea di tutti i piani, dal dettaglio al campo lunghissimo. Questo è stato reso possibile attraverso una tecnica di ripresa chiamata Bubble Technology che consente una visione degli sfondi a 360°. I vari ambienti vengono infatti ripresi con una tecnologia QuickTime Virtual Reality per poi essere trasformati in un unico ambiente virtuale, su cui vengono incollati i personaggi. Inoltre le macchine con all’interno i personaggi sono sempre ferme e sono invece gli sfondi a muoversi. Di conseguenza avremo una diversa percezione dello spazio: non più un ambiente statico da esplorare, ma uno spazio fluido, uno spazio dinamico che funziona come l’azione di un colpo di frusta. Come i personaggi, anche lo spettatore viene avvolto dalle spire iperboliche dei circuiti automobilistici, dalle cromie acide in vertiginoso movimento. A causa del dinamismo, dato dall’effetto di velocità e dai contrasti dei colori, difficili da sopportare, si crea una tensione che attrae aggressivamente lo sguardo dello spettatore nel campo di forze delle superfici cromatiche, e che dunque fa rimbalzare l’occhio da un punto all’altro dello spazio bidimensionale, sfondandolo. Non a caso per questo film si parla di 2D e mezzo, un misto cioè delle due dimensioni dei cartoni animati e il 3D dell’animazione digitale. Abbiamo così in alcune scene i personaggi fermi, incollati allo sfondo mentre questo si muove, come quando la famiglia Racer visita la Royalton Industries. Essi sono immobili, estasiati, mentre davanti ai loro occhi scorrono le immagini di questa fabbrica tecnologica delle meraviglie, e nel loro stupore ricalcano l’esperienza dello spettatore che, “incollato” sulle poltrone, assiste ai prodigi dei fuochi d’artificio della tecnica. Altre particolarità del film sono le transizioni tra le diverse scene realizzate attraverso lo scorrimento dei volti dei personaggi. Ad esempio quando Speed ricorda il fratello, la scena non viene visualizzata con un flashback ma, dietro il primo piano del protagonista, vediamo muoversi circolarmente lo sfondo, finché seguendo questo movimento rotatorio compaiono le scene del ricordo, mentre in primo piano c’è sempre Speed. Si creano due piani paralleli tra passato e presente, in mezzo ai quali scorre il tempo (compresenza ripresa anche nello stile del film che mescola costumi anni ’60 con macchine dal design iperfuturistico). Inoltre attraverso questo tipo di transizione, il passaggio tra le due dimensioni temporali avviene senza interruzione. Così se prima abbiamo parlato di spazio fluido, possiamo estendere lo stesso discorso anche al tempo. Quello di Speed Racer è uno spazio fluttuante, che supera in una folle corsa campi di attrazione e di repulsione, mulinelli di colore-energia perturbanti lo spazio, e si sviluppa in un flusso ritmico portato da onde elettromagnetiche che comprende anche il tempo. Forse è qui la 247 chiave di lettura di questo bel “giocattolone” rumoroso e sfolgorante: un nuovo modo più intenso di percepire il flusso spazio-temporale. In questo caso Speed Racer sarebbe la sintesi postmoderna del dinamismo che attraversa e incastra i piani del reale e che, per certi aspetti, richiama il Futurismo, in quanto poggia sul concetto di unità spaziale tra oggetto e ambiente e pone lo spettatore all’interno del quadro invitandolo a percepire le correnti sferiche della materia attraverso l’elettromorfismo e il polimaterismo tipici del movimento d’avanguardia, ma che sono qui richiamati con innovativo aspetto ludico. Siamo così investiti dalle giostre di colore psichedelico, abbagliati dai giochi pirotecnici, fusi e confusi nello spazio cromatico, e proiettati verso lo spazio della percezione pura, ovvero quella delle luci cangianti percepite dal vittorioso Speed. Too Human - Quando l’impostazione cinematografica diviene inopportuna di Sergio Nuzzo È luogo comune ritenere che per la creazione di un acclamato successo videoludico debbano essere rispettate tre condizioni: una buona idea, un buon direttore dei lavori e, sempre, un buon quantitativo di denaro. Il progetto qui esaminato si basa su un’idea davvero interessante (la mitologia norrena), è stato sviluppato da Silicon Knights (casa del famoso Metal Gear Solid) e ha avuto a disposizione gli illimitati fondi della Microsoft (il gioco è infatti riservato alla XBox 360)… e tali premesse esigerebbero un risultato a dir poco perfetto, ma la realtà, si sa, è sempre ben distante dalla fantasia. L’eroe che impersoneremo si chiama Baldur, pupillo di Odino, che vive ad Asgard, terra governata da un gruppo di esseri umani ciberneticamente modificati e considerati alla stregua degli dei. Sin dal menu principale ci troviamo faccia a faccia con l’elemento RPG alla base del gameplay, che si concretizza con la scelta di una tra le cinque classi a disposizione: si va dal Bioingeniere (in grado di curarsi), al Defender (molto resistente), al Berseker (forte nella mischia), al Commando (specializzato in armi a distanza), per finire col Champion, perfetto ibrido che mischia combattimenti ravvicinati all’utilizzo di armi da fuoco. Fin dalla prima missione arrivano le delusioni: le atmosfere gotico-fantasy promesse dal titolo e dalla grafica, lasciano il posto a mostri robot che poco hanno a che vedere con Odino e il Valhalla. Interessante, invece, la particolare interfaccia di controllo, la quale prevede l’utilizzo di singoli pulsanti rispetto alle sempre più difficili ‘combo’ proposte da altri titoli: ogni tasto cor248 risponde a un’unica azione, permettendo all’utente un controllo rapido del personaggio, soprattutto durante i combattimenti, consentendo agevolmente di passare dalle pistole alle spade senza troppa confusione. Se questa novità di gioco può far intendere una certa soddisfazione d’acquisto, la realtà è ben differente. In questo gioco è impossibile guardarsi intorno. Fornendo all’utente un’unica prospettiva di visuale, Too Human risulta fastidioso: sappiamo bene che muoversi davanti a uno schermo cinematografico non restituirà alcun cambiamento nell’impostazione prospettica della scena ma non ci aspettiamo la stessa situazione davanti a un videogame. Così il combattimento si affida totalmente al sistema di mira automatica del software, il quale porterà ad attaccare sempre il nemico più vicino, impedendo così qualsiasi schema strategico nel portare avanti gli attacchi. Tutto ciò comporta un ulteriore problema: in questo gioco si muore spesso. Per rimediare al problema gli sviluppatori hanno fatto si che, dopo ogni morte, il personaggio riprendesse la propria avventura dall’ultimo checkpoint visitato, senza alcuna perdita di punti e senza nemmeno resettare la quantità di danni già inflitta ai nemici… in poche parole, ci ritroveremo a valutare la difficoltà d’uccisione d’un ‘boss’ in base al numero di morti che serviranno per abbatterlo. Approfondiamo però la fastidiosa impostazione visuale del gioco: la telecamera virtuale, in nome di velleità cinematografiche di dubbia riuscita, effettuerà costantemente imprevedibili movimenti, cambiando prospettiva anche nei momenti più concitati e senza alcuna speranza di limitarne il libero arbitrio che le è stato attribuito (il tasto LB promette solo a livello formale di riportarla alle spalle di Baldur). Se durante il combattimento normale questo è fastidioso, quando vi ritroverete ad affrontare un boss la situazione si farà spesso insopportabile, facendo rimpiangere di non aver acquistato un dvd piuttosto del gioco. Parte di questi problemi vengono risolti affrontando la campagna in cooperazione con un amico, grazie al supporto Xbox Live: giocare in due rende il caos conseguente più piacevole e permette di attuare qualche manovra tattica con più calma. Purtroppo il gioco non si adatta ai livelli dei giocatori e in caso di un grosso gap tra un partecipante alla partita e l’altro, il livello più alto si troverà ad affrontare da solo quantità di nemici previste per due, mentre il compagno dovrà soltanto pensare a restare vivo. Ad alternare i combattimenti vi sono le visite nel Cyberspazio: un luogo bucolico e luminoso, in totale contrasto con gli ambienti del gioco, dove dovremo risolvere degli enigmi alquanto semplici basati sui tre poteri magici che collezioneremo durante l’avventura (spinta, sollevamento e fuoco). Anche la palette di colori non è sempre delle più azzeccate, per quanto l’atmosfera cyberpunk del gioco potrebbe essere una parziale giustificazione ai 249 volti sin troppo cinerei, dal pericoloso effetto zombie, che caratterizzano i personaggi principali: lo stesso Lord Baldur,nonostante un character design che spicca sicuramente in fermezza rispetto al resto della truppa, non sfoggia nessuna caratteristica (di forma o colore) che lo renda davvero distinguibile. Se abbiamo iniziato parlando del gioco come un RPG facendo riferimento alla possibilità di giocare scegliendo tra cinque tipologie differenti di personaggio, i problemi legati alla modalità di combattimento e l’impossibilità di modificare l’angolazione della telecamera impediscono qualsiasi tipo di personalizzazione: il ricchissimo set di armature e i punti-esperienza spendibili in nuove abilità, essendo il gioco privo di reali possibilità strategiche, risulteranno un poco piacevole specchio per le allodole. Le possibilità di sviluppare la componente ruolistica non sono sviluppate neanche a livello di narrazione: le visite all’affascinante Aesir, capitale di Agsard, durante le quali abbiamo occasione di acquistare armi e armature, non presentano alcuna possibilità di dialogo che vada al di là delle cut-scenes. Laddove lo scopo ultimo delle componenti ruolistiche all’interno di un videogame è quello di aumentare il potenziale d’immersività e immedesimazione, Too Human fallisce su tutta la linea, mettendo il giocatore completamente in disparte quando non si tratta di sterminare interminabili file di goblin tutti uguali. Goblin tutti uguali… già, perché i modelli dei nemici vengono riproposti dall’inizio alla fine del gioco, con solo poche e sporadiche varianti. Anche i fondali dei livelli, per quanto ve ne siano alcuni d’effetto, tendono ad annoiare da metà avventura in poi. Le texture rasentano appena la sufficienza, così come l’effettistica particellare legata alle esplosioni. Il comparto audio vive anch’esso di contraddizioni: un’effettistica tutto sommato piatta si accompagna a una colonna sonora d’autore davvero ben confezionata, con tutti i cori, gli archi e le basi elettroniche che ci si aspettano da un’atmosfera neogotica. Da menzionare il doppiaggio, che presenta una recitazione di buona qualità. Concludendo, il gioco risulta mediocre su tutti gli aspetti: poca immedesimazione, poca interattività, punto focale fastidioso, colorazione aberrante e, soprattutto, ripetitività. Purtroppo gli dei sembrano essere avversi al titolo che parla di loro, lasciando gli appassionati delusi e con un’unica speranza: l’applicazione di parecchie migliorie nei due titoli che completeranno la trilogia di cui Too Human è il capostipite. 250 Hanno collaborato a questo numero: Alessandro Cappabianca Architetto e critico cinematografico di formazione, come suol dirsi, non accademica e militante. Da anni nel direttivo della rivista Filmcritica. L’ultimo suo libro, edito da Costa & Nolan, intitolato L’immagine estrema, approfondisce la rilevanza nel cinema della crudeltà artaudiana. Ha pubblicato monografie prestigiose e centinaia di saggi ed è stato nel Direttivo di Fiction – Cinema e Pratiche dell’Immaginario. Giorgio Cappello Laureato presso il DAMS di Palermo in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo. Diplomato alla Scuola di Fumetto di Palermo, è sceneggiatore di fumetti per l’editore Cronaca di Topolinia, ha scritto anche per la collana Monstars per la Nicola Pesce Editore. Andrea Caramanna Critico cinematografico e docente di Storia del Cinema presso l’Istituto Superiore di Giornalismo di Palermo. In qualità di cultore della materia collabora con i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo, dell’Arte e della Moda dell’Università di Palermo. Redattore delle riviste telematiche ReVision e Expanded Cinemah, collaboratore del magazine on line Sentieri Selvaggi, ha scritto su varie riviste e quotidiani tra cui Cahiers du Cinéma e Cinecritica. Dal 2006 è direttore artistico del cinema Lubitsch. Alessandra Costanza Laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo. Diplomata all’Actor’s Academy di Milano. Giornalista pubblicista di moda e spettacolo, lavora da diversi anni come conduttrice delle TV regionali e come attrice di teatro. Maria Angela D’Agostaro Assegnista di ricerca in Storia, Teorie e Tecniche del Teatro e dello Spettacolo, docente a contratto presso il DAMS (Università di Palermo). Autrice di diversi saggi di cinema e di teatro su miscellanee accademiche e atti di convegno. Ha di recente pubblicato una monografia su Lola Montez. 251 Elisabetta Di Stefano Ricercatrice presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo e docente di Estetica alla Facoltà di Architettura. Ha scritto alcune monografie su temi relativi alla teoria delle arti dal Quattrocento al Seicento, fino alla nascita dell’estetica moderna, esaminando diversi autori significativi, tra cui Leon Battista Alberti, Giovan Pietro Bellori, Gian Lorenzo Bernini. Attualmente si interessa di problematiche relative ai rapporti tra estetica, architettura, design e nuovi media. È socia del Centro Internazionale Studi di Estetica e della Società Italiana d’Estetica. Davide Gambino Laureato presso il DAMS (curriculum Spettacolo) dell’Università degli studi di Palermo. Si è diplomato presso la scuola d’arte audiovisuale Estudio de Cine di Barcellona (Spagna). Ha collaborato con alcune riviste come saggista e ha realizzato numerosi cortometraggi, presentati in diversi festival del cinema, l’ultimo dei quali è stato ora incluso nella selezione preliminare del Festival Internazionale del cinema di San Sebastian 2008. Roberto Giambrone Laureato in Discipline dello Spettacolo all’Università di Bologna, è giornalista professionista e critico di teatro e danza. Collabora con La Repubblica - Palermo e Danza & Danza. Ha curato diverse rassegne e pubblicazioni. Dirige, con Eugenia Casini Ropa, la collana Danza d’autore per la casa editrice L’Epos di Palermo. È autore di Pina Bausch. Le coreografie del viaggio (Edizioni Ephemeria, Macerata 2008). Dirige l’Ufficio Stampa e l’attività editoriale del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Piera Gemelli Laureata in Scienze e Tecnologie dell’Arte, dello Spettacolo e della Moda, con la tesi di Storia e Critica del Cinema Percorsi del colore dal cinema moderno al postmoderno. Critico della rivista cinematografica online CinemaLayers, collabora con l’Associazione Culturale Gianburrasca,e con il LUM Michele Mancini – Università degli Studi di Palermo. Vincenzo Li Mandri Docente a contratto dal 2001 di Elaborazione Immagini e Suoni presso il DAMS, Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. Giornalista pubblicista dal 1989, ha collaborato con L’Ora, Grandevù, La Repubblica, Cantieri Navali, Giornale di Sicilia, Il Mediterraneo, Oggi Nuovo Sicilia. 252 Sergio Nuzzo Giornalista pubblicista dal 2007, lavora come Addetto Stampa per il LUM Michele Mancini (Università degli Studi di Palermo) e come Organizzatore Eventi per diverse aziende (Hasbro, Wizards, Upper Deck, Associazione Gianburrasca). Sua la rivista Card Player’s Magazine (Gedis Srl) e il libro Racconti (Il Filo Edizioni). Daria Parisi Assegnista di ricerca in Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. Insegna Letteratura russa come docente a contratto presso la medesima Facoltà. I suoi ambiti di ricerca e le sue pubblicazioni spaziano dalla letteratura, al teatro russo e operistico in particolare, al cinema. Giulia Raciti Dottoranda di Ricerca in Tecnologie Digitali per lo Spettacolo, presso LaSapienzaRoma. Laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, indirizzo DAMS Arte V.O., ha conseguito un Master in Cinema Promozionale in Digitale, tenutosi nella sede del LUM (Laboratorio Universitario Multimediale). Redattrice della rivista The Rope – Grafie dello Spettacolo e Pratiche dell’Immaginario. Rino Schembri Ricercatore di Cinema, Fotografia e Televisione nel DAMS della la Facoltà di Lettere e Filosofia (Università degli Studi di Palermo), presso la quale insegna Storia e Critica del Cinema e Storia e Tecnica dei Linguaggi Audiovisivi, è anche componente del comitato tecnico-scientifico del LUM. Autore di Lara Croft e le altre (L’Epos, 2003), ha pubblicato diversi saggi in miscellanee accademiche ed è stato anche critico cinematografico e televisivo per i quotidiani Oggi Sicilia e Avanti!. Barbara Tomasino Lavora con Rumore, Marie-Claire, altri organi di stampa e network radiofonici, tra cui la RAI, come critico musicale, cinematografico, di costume e culture giovanili, autrice e conduttrice di format. Ha pubblicato Groupie – Ragazze a perdere (L’Epos, Palermo 2004) e diversi saggi su cataloghi di mostre e rassegne internazionali. Ha collaborato alla realizzazione di crito-video. È tra i fondatori del Laboratorio Creativo A Bout de Clip. 253 Renato Tomasino Ordinario di Storia del Teatro e Presidente del DAMS (Università di Palermo). Ha lavorato con L’Astrolabio, Filmcritica, Fiction, Sipario, Rinascita, Giornale di Sicilia e altri organi di stampa come critico teatrale, cinematografico, opinionista, in alcuni casi come redattore e condirettore. Ha pubblicato la Storia del teatro e dello spettacolo dell’Editrice Palumbo (Palermo 2001) e numerose altre monografie. In atto è direttore responsabile di The Rope e di Letterature e Culture (on-line). Saverio Zumbo Insegna Storia e critica del cinema e Cinema documentario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova. Tra le sue pubblicazioni, volumi dedicati all´opera di Kubrick, di Wenders, di Antonioni, di Hitchcock ed alla trasposizione cinematografica delle commedie del Rinascimento. 254 PREMIO CINEMATOGRAFICO THE ROPE Si costituisce il premio cinematografico The Rope. La giuria è composta da: Umberto Cantone, Andrea Caramanna, Maria Angela D’Agostaro, Elisabetta Di Stefano, Enzo Li Mandri, Daria Parisi, Giulia Raciti, Rino Schembri, Barbara Tomasino, Renato Tomasino. Trattandosi di un premio di tendenza, il riconoscimento consiste solo in un comunicato stampa dedicato annualmente ad un’opera audiovisiva recente che verrà ritenuta il miglior prodotto, senza distinzione di genere, di durata, di distribuzione e di finalità. Premio Cinematografico The Rope 2008 A: Shine a light Decine di cineprese corteggiano un uomo che si muove come un Dio: Mick Jagger, sciamano dalle cento rughe, lampeggia e vortica sulla scena levitando, dominando la gravità e l’accesso alle dimensioni parallele del cosmo. È bestia, è leone che rugge, è grillo, è clown, è chimera nell’estasi... e le cineprese lo stuzzicano, lo aizzano, si piegano ad un montaggio frenetico che è puro ritmo, miracolo di un cinema intimamente musicale come nel Nevskij di Eizenstejn, di grafemi dinamici come nelle operine di Fischinger e Ricthter. Cinema che gareggia col live e lo trascende, mostrandolo da sguardi molteplici in simultanea, sguardo di Dio attorno al figlio in terra, cinema senza valori e messaggi, miracolo tecnico di puro scintillio della performance. A Martin Scorsese, The Rope. Ricerche finanziate con il T.U. 60%. 255 TheRope Grafie dello Spettacolo e Pratiche dell’Immaginario Direttivo: Andrea Caramanna, Maria Angela D’Agostaro, Elisabetta Di Stefano, Giuseppe Pernice †, Daria Parisi, Rino Schembri (vicedirettore), Barbara Tomasino, Renato Tomasino (direttore responsabile) Redazione: Giulia Raciti N u m er o d u e / t r e Rivista semestrale, marzo/ottobre 2008 Registrazione presso il Tribunale di Palermo, nr.14 08/05/2007; Ricerche finanziate con Ex Quota R.S. 60% 2005/2006 Redazione e amministrazione: LUM Michele Mancini Università degli Studi di Palermo Palazzo dei Principi Aragona Cutò, 90011 Bagheria (Pa) Tell. +39.091.9290611 Web: www.lummichelemancini.net Mail: [email protected] © Edizioni Falsopiano-2009 Via Baggiolini, 3 15100-Alessandria http://www.falsopiano.com Per le immagini, copyright dei relativi detentori Progetto grafico e impaginazione: Daniele Allegri Stampa: Impressioni Grafiche S.C.S a.r.l. – Acqui Terme Prima edizione: Gennaio 2009 256
Scarica