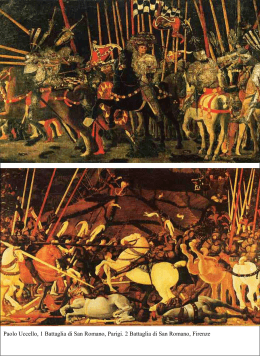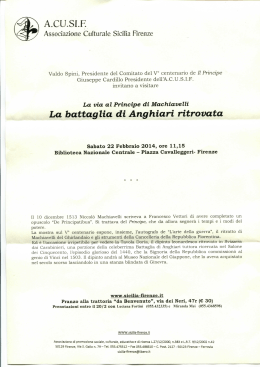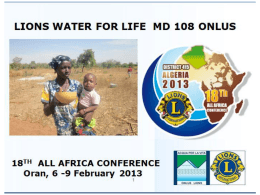Giampaolo Pansa Bella ciao Controstoria della Resistenza saggi Rizzoli Proprietà letteraria riservata © 2014 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-07260-1 Prima edizione: febbraio 2014 Realizzazione editoriale: studio pym / Milano Introduzione Rivoluzione senza onore Il desiderio di scrivere questo libro viene da un tempo per me molto lontano. Era il maggio 1959, avevo ven titré anni e mezzo ed ero uno studente dell’Università di Torino. Stavo per laurearmi in Scienze politiche, con una tesi di dimensioni mostruose, un mattone di otto cento pagine, già consegnata al professor Guido Quaz za, l’incaricato di Storia contemporanea. In quell’epo ca l’argomento era insolito per i lavori da presentare all’esame di laurea: la guerra partigiana nella mia pro vincia, tra Genova e il Po. Nello stesso mese, per l’esattezza il giorno 24, si ten ne a Genova un convegno sulla storiografia della Resi stenza, organizzato dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Il padre di tutti gli Istituti della Resistenza fondati o da fondare nel no stro paese. Il convegno aveva la solennità di una funzione reli giosa. Affidata a due cardinali della ricerca storica sul fascismo e l’antifascismo. La relazione sull’antifascismo sino al 25 luglio 1943 era stata assegnata al cattolico Ga briele De Rosa. L’altra l’aveva scritta Roberto Battaglia. Era l’autore di uno studio imponente, pubblicato da Ei naudi nel 1953: Storia della Resistenza italiana, un tomo di 623 pagine che avevo letto con grande attenzione e molto scetticismo. Oggi può sembrare assurdo che a un convegno di quel rilievo politico e accademico venisse concessa la parola a uno studente neppure laureato. Ma erano tem pi ben più liberali di quelli odierni. E quando alzai la 5 mano per intervenire, il presidente del convegno, Fer ruccio Parri, uno dei leader della Resistenza, mi disse: «Parla pure anche tu». Ne approfittai per dare sfogo alla mia presunzione giovanile. E lo feci con la grinta di chi non esita a be stemmiare in chiesa. Accennerò dopo alla mia requisi toria, sparata contro le rievocazioni della Resistenza. A cominciare da quelle inutili, perché retoriche, faziose o bugiarde, che nel giro di un decennio erano diventa te un’alluvione cartacea in grado di seppellire la verità. Per adesso ricorderò soltanto che suscitai subito molte reazioni negative tra il pubblico. Il più indignato si mostrò Vannuccio Faralli, socia lista, il primo sindaco di Genova nel dopoguerra. Era un signore di 68 anni, ancora di bell’aspetto, la chioma bianca e la cravatta nera a fiocco dei socialisti ottocente schi. Impugnava un prezioso bastone da passeggio e lo agitò in aria, scandendo: «Ma come? Ai convegni sulla storia della Resistenza adesso facciamo parlare anche i giovani fascisti?». Nel sentirmi dare del fascista, rimasi interdetto e mi bloccai. Ma dalla presidenza, Parri mi ordinò: «Vai avanti e di’ quello che ti sembra giusto dire!». Conti nuai con la stessa grinta e conclusi, un po’ ansioso, però non vinto. Quando la prima e unica giornata del con vegno finì, mi sentivo con le pive nel sacco. Non mi re stava che andare in stazione e prendere il treno per ri tornare a casa. Mentre uscivo, Parri mi fermò: «Vieni a sederti accanto a me». Parri aveva 69 anni, capelli e baffi candidi, gli occhia li alzati sulla fronte, un sorriso mite, quasi paterno. Mi chiese: «Come ti senti dopo quello che ha detto Van nuccio?». Risposi crucciato: «Pensavo di aver detto co se utili a chi scrive sulla Resistenza e mi sono preso del fascista!». Lui mi replicò, paziente: «Sono assai più anziano e 6 credo che tu abbia fatto bene a spiegarci come la pen si. Siete voi giovani che dovete tirare i sassi nei vetri. Così, quando i vetri si rompono, noi vecchi ci rendia mo conto che è venuto il momento di sostituirli. Per ringraziarti, mio caro spaccavetri, ti darò una borsa di studio. Non illuderti, è poca cosa, ma sono contento di offrirtela». Trasse dalla tasca interna della giacca un libretto di assegni del Credito italiano. E ne firmò uno da venticin quemila lire. In quel tempo era l’affitto di un mese per un buon bilocale, in un quartiere del centro di Torino. Prima di scrivere Bella ciao ho riletto il testo stenografi co del mio intervento, pubblicato per intero sulla rivista dell’Istituto nazionale della Resistenza. Avevo parlato a braccio e il mio sproloquio occupava ben sette pagine. Con la boria tipica dei giovani, avevo contestato le sto rie generali della guerra di liberazione pubblicate sino a quel momento. E il mio bersaglio numero uno era la storia scritta da Battaglia. Perché tiravo i sassi soprattutto contro di lui? Lo compresi meglio in seguito, con più chiarezza che nel 1959. In realtà Battaglia era soltanto un uomo dello schermo, nel senso che dietro la sua figura, molto ri spettabile, si celava una questione assai più grande e cruciale nella storiografia della Resistenza: il predomi nio assoluto dei memorialisti e degli storici comunisti. A ben guardare, poteva sembrare soltanto il riflesso di un altro dato di fatto: la prevalenza delle formazioni comuniste nei venti mesi di guerra civile. Tuttavia non si trattava di una circostanza dovuta solo a quanto era accaduto tra il 1943 e il 1945. C’era qualcosa di più. Il di più consisteva nel fatto che, subito dopo la fine della guerra civile, il Pci aveva imposto il proprio punto di vista sul nostro conflitto interno. Lo riassumo così: la 7 Resistenza era stata soprattutto comunista, gli altri par titi o le altre posizioni politiche avevano recitato un ruo lo molto secondario o pressoché inesistente. Da questo principio, conclamato di continuo e sem pre ribadito, negli anni successivi sarebbe derivata una serie di conseguenze politiche e culturali. La più impor tante, che ancora oggi si fa sentire nell’atteggiamento degli eredi del Partitone rosso, era di un rigore inflessi bile: chi attacca il Pci attacca la Resistenza, chi sostiene che i comunisti volevano imporre una dittatura popo lare d’impronta sovietica è soltanto un fascista masche rato, chi afferma che pure le Garibaldi avevano i loro scheletri nell’armadio è un falsario. Infine chi rievoca i delitti e le violenze compiute do po il 25 aprile, quasi sempre da partigiani delle Garibal di, è un figuro spregevole che deve essere zittito. Me ne sono reso conto di persona dopo l’uscita del Sangue dei vinti nel 2003 e dei miei libri successivi. Gli antagoni sti rossi mi hanno dato la caccia. E fior di baroni acca demici, gente che si ritiene l’unica titolata a occuparsi di storia della Resistenza, mi hanno messo al bando ac cusandomi di un reato per loro infame: il revisionismo storico. Una colpa ancora più grave perché commessa da chi non appartiene alla loro casta, un giornalista, un bastian contrario, un dilettante della ricerca storica. Nel 1959 sbagliavo a prendermela con Battaglia? Non del tutto. Nato a Roma nel 1913, aveva combattu to nelle formazioni di Giustizia e Libertà, le bande del Partito d’Azione. Era stato un ribelle coraggioso, dap prima in Umbria, poi a Roma e infine in Garfagnana, al le spalle della Linea gotica dei tedeschi, dove gli Allea ti lo avevano lanciato con il paracadute. In seguito era diventato comunista. E aveva scritto la sua Storia della Resistenza italiana, che avevo letto e riletto con la mati ta in mano e un quaderno per prendere appunti. Dopo la stesura del manoscritto, Battaglia lo sotto 8 pose al giudizio di una autorità politica in quel momen to indiscutibile: Luigi Longo, il comandante delle Bri gate d’assalto Garibaldi nell’Italia occupata dai tede schi e diventato il numero due del Pci, accanto a Palmi ro Togliatti. Oggi nessuno scrittore di storia, ancorché dilettante o amatoriale, sottoporrebbe mai un suo ma noscritto a un big della Casta politica. Se a trattenerlo non intervenisse l’amor proprio, lo fermerebbe il timo re di essere sbeffeggiato. Ma nel Partitone rosso, e forse non soltanto nel san tuario delle Botteghe oscure, si usava così. Longo les se il manoscritto di Battaglia, tenendo in mano un lapis ben più appuntito del mio. E lo giudicò ancora troppo viziato dalle origini politiche dell’autore, un tempo mi litante del Partito d’Azione. Per questo gli domandò di modificarlo in più di un punto. Era una richiesta perentoria, come di solito lo erano quelle dei capipartito di un tempo. Ma non so dire se Battaglia l’abbia soddisfatta e in quale misura. A rigor di logica dovrei pensare che qualche correzione l’abbia apportata. Del resto non si presenta un manoscritto ai piani alti del Bottegone, e a un dirigente di ferro come Longo, per poi decidere di non tenere in nessun conto le richieste di pochi o molti ritocchi. Ma nella lontanissima giornata di Genova, le mie inge nue frecciate verbali non furono rivolte soltanto a Bat taglia. Qualcuno oggi sostiene che il Pansa è un autore arrogante, convinto di saperla sempre più lunga degli altri. Se è davvero così, debbo riconoscere che a ven titré anni e mezzo ero già un borioso formidabile, un contestatore tutto sommato cortese nella forma, però furibondo nella sostanza. Per cominciare sostenni che le storie della Resistenza pubblicate sino a quel momento erano tutte da riscrivere. 9 Poiché risultavano zeppe di errori e basate su fonti debo li, per non dire fasulle, o gonfie di propaganda retorica, e perciò inattendibili. Dunque ritenevo necessaria “una prima opera di revisione” di quanto si era scritto sino ad allora. Nel rileggere il testo del mio intervento, oggi mi col pisce l’uso insistito di quel sostantivo e del verbo che ne deriva: “revisione”, “revisionare”. Nelle polemiche sto riografiche di quegli anni non si usava ancora il termine “revisionista”. Né per indicare un testo meritevole di scomunica, e meno che mai, al contrario, per affermare che la storia va sempre riscritta e dunque revisionata. Adesso l’accusa di revisionismo si spreca per tutti i testi che non seguono il codice dei Gendarmi della memoria resistenziale, un’immagine che fa da titolo a un mio libro del 2007. Qualcuno, come il sottoscritto, la considera una bandiera da sventolare con orgoglio. Ma riconosco di essere ancora una mosca bianca. Ho degli amici preoccupati del mio buon nome che mi scongiurano di non dichiarare più di essere un revi sionista. Sempre a Genova spiegai a un pubblico sorpreso, ma tutto sommato tollerante, che la revisione della storio grafia resistenziale era indispensabile per sistemare al cuni conti che non tornavano. E osai fare qualche esem pio che oggi sembra banale. I partigiani erano stati per davvero così tanti, come sostengono le statistiche uffi ciali? Esisteva una storia segreta della Resistenza che i celebranti si rifiutavano di vedere? Per “storia segreta” intendevo i contrasti brutali tra bande di diverso orien tamento politico, i delitti che ne erano derivati, il pro filo vero di certi personaggi e di alcuni eventi troppo mitizzati. Poi aggiunsi: «A questa storia segreta appartengono le pagine meno belle della guerra di liberazione. Per il partito più forte, il Pci, la guerra partigiana è stata anche 10 una rivoluzione. E nessuna rivoluzione è mai all’acqua di rose. Bisogna fermarsi su questi fatti se vogliamo ave re davvero un quadro veritiero e non agiografico della Resistenza». Infine azzardai la provocazione più pesante, se tenia mo conto che mancava un anno all’inizio dei Sessanta. Riguardava la necessità di ricorrere alle fonti fasciste. Dissi: «Gli studi sulla Resistenza sono condotti per il 95 per cento su fonti partigiane o antifasciste e solo per il 5 per cento su fonti della Repubblica sociale e del Par tito fascista repubblicano. È una lacuna grave che ac centua sempre di più il vizio di fondo dei nostri lavori, quello di produrre storie a senso unico. Dove i partigia ni si muovono da soli sulla scena, combattendo contro un nemico invisibile che si rivela soltanto per le conse guenze che la sua fantomatica presenza produce sull’al tra parte». E conclusi: «Quale effetto farebbe una sto ria del Risorgimento che ignorasse del tutto le vicende degli austriaci?». Le mie sassate contro i vetri non passarono inosser vate. Appena dopo la laurea, presa nel luglio 1959, mi cercarono due storici di sinistra, Luigi Cortesi e Stefa no Merli. E mi chiesero di scrivere un articolo sulla sto riografia della Resistenza. Dirigevano un trimestrale, la “Rivista storica del socialismo”, pubblicato a Milano. Accanto a loro c’era Giovanni Pirelli, autore con Pie ro Malvezzi di un libro di culto per la mia generazione: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, stampato da Einaudi nel 1952. Giovanni Pirelli era il tipo d’uomo che s’incontra di rado. Apparteneva alla dinastia dei Pirelli, figlio di Al berto e fratello di Leopoldo, ma aveva scelto di restare fuori dall’ambiente delle grandi imprese. Nato nel 1918, era stato ufficiale degli alpini e poi aveva fatto il parti giano, da comandante e commissario politico nelle Ga ribaldi in val Chiavenna e nell’Oltrepò pavese. Socialista 11
Scaricare