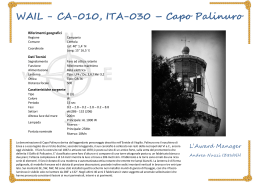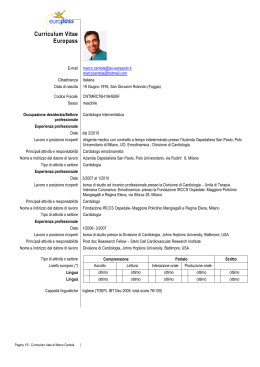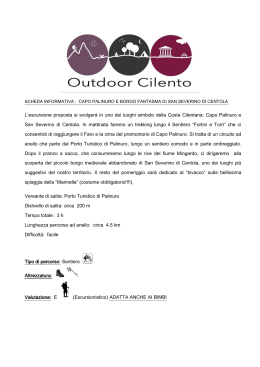PROGETTO CENTOLA Questo libro è stato pubblicato con il patrocinio morale del Comune di Centola e del Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano PREFAZIONE Con la pubblicazione di questo volume “Storie, Aneddoti, Fatti e Misfatti di Centola e delle sue frazioni”, l’Associazione “Progetto Centola” continua a lavorare per ricostruire e valorizzare la memoria storica del nostro territorio. Per espletare il suo intento, ha chiesto la collaborazione dei cittadini e, attraverso una rigorosa analisi basata sullo studio di documenti e fotografie, divulgare la memoria storica, sociale, culturale del nostro paese. È un libro che raccoglie gli scritti pervenuti alla I edizione del concorso di narrativa bandito dall’associazione, mostrando in tal modo che la cultura e la sua diffusione può essere fatta da ognuno di noi. Partecipando, tutti hanno avuto la possibilità di far conoscere i propri ricordi, fatti e aneddoti che, nell’insieme, concorrono a fare la storia di un paese. Con questa iniziativa, l’associazione ha ampliato ed arricchito le sue attività, rendendo note storie e testimonianze dei cittadini protagonisti della vita del Comune, in modo attento e veritiero; un patrimonio di ricordi non più cristallizzato, ma che merita diffusione. Per questo ho accolto con grande interesse l’idea di presentare, anche come Istituzione, il libro; e, proprio il bisogno di tramandare la memoria è il filo conduttore degli scritti. Il lettore apprende vicende personali e familiari impensabili, fatti semplici ed eventi importanti che hanno coinvolto famiglie e comunità, lasciando nella memoria impronte indimenticabili. L’amministrazione Comunale sostiene con convinzione ed interesse queste iniziative perché riconosce quanto sia significativo e importante, per i nostri cittadini, conservare e tramandare la memoria storica e collettiva del paese di appartenenza. Mi auguro che questo libro venga accolto come il risultato di una virtuosa convergenza di intenti e come un contributo alla comprensione della comune identità, alla quale noi leghiamo il nostro futuro. Il sindaco Dott. Carmelo Stanziola INTRODUZIONE L’Associazione Progetto Centola, al fine di serbare la memoria di fatti, vicende, eventi, episodi di vita vissuta e aneddoti, rilevanti dal punto di vista storico, culturale e di costume, che hanno visto il coinvolgimento di personaggi, famiglie e luoghi del comune di Centola, ha promosso, attraverso un pubblico annuncio, la I° EDIZIONE DEL CONCORSO DI NARRATIVA: “Storie, Aneddoti, Fatti e Misfatti di Centola e delle sue Frazioni” Il poster che pubblicizzava l’iniziativa è qui di seguito riportato Il regolamento per la partecipazione al Concorso, così come approvato dal Comitato Direttivo dell’Associazione Progetto Centola, è sotto illustrato Art.1 - E’ prevista una sezione di testi in prosa, in lingua italiana; sta, o consegnare direttamente i loro testi entro il 30 Giugno 2012,ai seguenti indirizzi: Art.2 - La partecipazione è libera e gratuita. Giuseppe Lupo ( Coordinatore del Concorso ), Via Generale Imbriaco 69, Centola. Il tema è “Storie, Aneddoti, Fatti e Misfatti di Centola e delle sue frazioni”. Aceto Rossella, ( Referente per San Severino), San Severino di Centola. L’argomento potrà essere trattato sia sotto forma di narrazione, storicamente fedele, dei fatti accaduti, sia attraverso una rielaborazione fantasiosa e originale degli stessi. Marisa Amendola ( Referente per Palinuro ), Via Indipendenza, Palinuro. Licia Saturno ( Referente per San Nicola ), San Nicola di Centola. Art.3 - Ciascun partecipante potrà presentare anche più di un testo, in cinque copie anonime. Una sesta copia firmata dovrà riportare le generalità complete, l’indirizzo e recapiti telefonici. Il tutto dovrà essere consegnato i busta chiusa, intestata a: Renzo Galietti ( Referente per Foria ), Piazza Galietti, Foria. Art.6 - La Giuria del Concorso, nominata dal Direttivo dell’Associazione “Progetto Centola”, stilerà una graduatoria di merito per le opere classificate ai primi tre posti, a cui saranno assegnati dei premi. Associazione Progetto Centola- ConcorsoStorie e Aneddoti. Data la particolarità dell’argomento, gli autori degli elaborati potranno far riferimento anche alla fonte da cui hanno attinto le notizie oggetto dei loro testi. Ai testi potranno essere allegati foto o documenti storici. A insindacabile giudizio della giuria saranno assegnati altri premi o diplomi con motivazione o eventuali segnalazioni di merito. Art.7 - Un premio speciale sarà assegnato al migliore testo, tra quelli presentati dagli alunni delle scuole del 1° ciclo del Comune di Centola. Art.4 - I testi narrativi non dovranno superare le 5 cartelle. I lavori dovranno essere presentati su fogli in formato standard A 4, scritti al computer in carattere times new roman-12, interlinea 1,5. Art.8 - I nomi dei componenti della Giuria saranno comunicati durante la cerimonia di premiazione. I testi non verranno restitui. Espletato il concorso, tutti i testi ritenuti meritevoli, a insindacabile giudizio della giuria, saranno pubblicati a cura dell’ Associazione “Progetto Centola “. Art.9 - Notizie ed eventuali informazioni sul concorso si potranno rilevare sul sito,www.progettocentola.it. Art.5 - Gli interessati potranno spedire per po- Nel bando era previsto che, espletato il concorso, tutti i testi ritenuti meritevoli, a insindacabile giudizio della giuria, sarebbero stati pubblicati a cura dell’ “Associazione “Progetto Centola”, in un volume a stampa. Il Direttivo dell’Associazione “Progetto Centola” ha provveduto alla nomina della Giuria del Concorso la cui composizione è qui di seguito indicata: Raffaele Luise (Presidente), Pasquale Carelli, Antonio La Gloria, Luigi Leuzzi, Elena Paruolo. La giuria, dopo avere esaminato gli scritti pervenuti (44, da 21 autori diversi ai quali vanno ad aggiungersi i 4 racconti brevi degli alunni della scuola elementare di Foria), ha redatto una classifica di merito, tenendo presente che gli elaborati classificatisi ai primi tre posti saranno premiati nel corso di una manifestazione pubblica durante la quale verrà presentato anche il volume con le opere esaminate. In tale contesto saranno anche premiati gli alunni delle scuole elementari che hanno preso parte al concorso. In relazione a quanto sopra, L’Associazione Progetto Centola, nel tenere fede a quanto programmato, ha provveduto alla preparazione e alla stampa, con il Patrocinio del Comune di Centola e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, del presente volume. L’iniziativa di cui sopra rientra tra le azioni individuate dall’ “l’Associazione Progetto Centola”, costituitasi nel mese di Luglio 2010, la quale essenzialmente si propone di “Ricostruire, attraverso una rigorosa analisi basata sullo studio di documentazioni cartacee e di fotografie, messe a disposizione dalle famiglie, la memoria storica, culturale e sociale di Centola e delle sue frazioni ( Foria, Palinuro, San Nicola e San Severino )”. Nel contesto di cui sopra sono state recuperate, copiate e catalogate in maniera digitale centinaia di fotografie e documenti i cui contenuti, opportunamente analizzati, storicizzati e interpretati, hanno consentito di trarre informazioni utili a tracciare una serie di percorsi finalizzati a testimoniare l’evoluzione paesaggistica, urbanistica, sociale ed economica del territorio e delle famiglie ad esso afferenti. Al fine di conservare questo importante patrimonio di conoscenze e permetterne la fruizione alle presenti e future generazioni l’Associazione Progetto Centola, in stretta collaborazione con il Comune di Centola, intende realizzare in una idonea sede un “MUSEO DELLE TESTIMONIANZE E DELLA MEMORIA DEL COMUNE DI CENTOLA” quale parte di una struttura di più ampio respiro che vada a configurarsi come un vero e proprio “POLO INTEGRATO DELLA CULTURA DEL COMUNE DI CENTOLA. Il presente libro, che raccoglie gli scritti presentati alla I° Edizione del Concorso di Narrativa: “Storie, Aneddoti, Fatti e Misfatti di Centola e delle sue Frazioni” insieme ad altre pubblicazioni (digitali “on line” e cartacee) è parte integrante delle attività dell’Associazione Progetto Centola, finalizzate a tracciare attraverso le memorie private delle famiglie vicende pubbliche di più ampio respiro idonee ad delineare la storia sociale e lo sviluppo del territorio visto nella sua globalità. Ci si augura pertanto, che questa pubblicazione possa rappresentare un elemento propulsivo per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati. Ezio Martuscelli Presidente Associazione Progetto Centola PREAMBOLO “Centola merita”. Esordirei così nel presentare questo splendido volume e il “verbale” della riunione della Commissione, da me presieduta che, nel corso di una lunga discussione decise, la sera del 30 agosto 2012, l’assegnazione dei premi del Concorso di scrittura sulle “memorie” che accomunano le quattro frazioni del Comune di Centola: Palinuro, Foria, San Severino, San Nicola e il Capoluogo. Merita, innanzitutto, per la qualità della gran parte degli scritti, alcuni davvero notevoli, e per la quantità delle composizioni (ben 48, di 25 autori ivi comprese due classi delle elementari ) e dei temi trattati, che trascorrono su un registro molto ampio del patrimonio storico e immaginario del nostro territorio. Particolarmente interessante il criterio di valutazione scelto, che è consistito nel combinare insieme l’esame degli aspetti estetico-formali, del valore storico-locale e dell’originalità dei racconti. Questo metodo ha permesso un esame più accurato e l’individuazione del valore di ciascuno scritto. Messi di fronte a composizioni sovente molto stimolanti, soprattutto quando si sono dovuti valutare i grandi temi del brigantaggio e della guerra o alcuni squarci emozionanti dei riti che hanno scandito per secoli la cultura contadina e l’epica marinara, da sempre attraversati come da una eco di liturgia cosmica, la discussione della Commissione si è fatta a tratti molto appassionata. E non nascondo lo stupore, mio e dei quattro membri della Commissione, di fronte alla capacità di alcuni passaggi dei racconti di cogliere e svelare qua e là la cadenza segreta, i colori e i ritmi dei miti che hanno ispirato la grande civiltà contadina e l’epopea marinaresca di questa parte incantevole di Magna Grecia. E da questo punto di vista sono esemplari i racconti che , nell’ordine, si sono classificati ai primi tre posti: “Il brigante Cola Marino” di Maria Luisa Amendola, “La notte dell’Abate” di Giuseppe Lupo e “La maledizione di zia Clelia” di Filomena Stanziola. Ma potremmo ricordarne molti altri, che lasciamo alla vostra personale scoperta, compresi i quattro racconti della Sezione bambini. Se un appunto però si volesse fare, è che nei racconti di questo concorso si è un po’ perduta proprio la memoria più antica, quella straordinaria della Magna Grecia, che ha tuttavia abitato questi luoghi fino quasi ai nostri giorni sia per mare che per terra, come ad esempio nell“omerica “ vicenda di Marco il Pastore. Ma, questa che auspico come prima edizione dell’excursus nella memoria di quel che ci ha generati e fondati come centolesi, ha aperto un cammino prezioso, che va assolutamente proseguito, alla ricerca appunto delle scaturigini più antiche e segrete, quelle mediterranee di ascendenza fenicia e greca, ma non solo. Vi confido che fino a qualche anno fa condividevo in qualche modo le amare riflessioni del professore Feliciano Speranza, figlio del maestro Gaetano Speranza e docente di Lingua e Letteratura latina all’Università di Messina, con il quale ho intrattenuto una lunga e affettuosa corrispondenza, che era solito parlarmi dei centolesi come di “dormienti”. Un’ affermazione severa , che nessuno che sia intellettual mente onesto e innamorato del proprio luogo natio credo possa mettere in discussione. Ma poi, negli ultimi anni, è sorto il “Progetto Centola”, con le sue numerose , appassionate e intelligenti attività di vario genere e soprattutto con l’ideazione di questo percorso nella memoria, che se sostenuto e continuato, potrà conferire nuova e più forte, più fiera identità alla nostra Comunità. Perché, a ben guardare, la stupefacente magia del mare di Palinuro e l’aspra, impervia bellezza di questa parte di Cilento, con borghi straordinari come quello di San Severino e distese intatte come il Vallo di Diano, sono innanzitutto “paesaggio dell’anima” e non mere località da fruizione turistica “mordi e fuggi”. E’ proprio la densità della memoria ritrovata, il filo di Arianna che da una parte ci consente di vivere il nostro meraviglioso territorio come un paesaggio dell’anima, di grande caratura spirituale e culturale, e che dall’altra ci permette di elaborare un’offerta turistica di alto profilo culturale, capace di attirare per un periodo indefinito tante persone, certo turisti, ma soprattutto viaggiatori capaci di stabilire relazioni di profonda empatia con la nostra terra. Sappiamo bene che il nostro è un territorio ad eminente vocazione turistica, ma dobbiamo riconoscere che è solo un turismo ad alta definizione culturale che ha in sé gli anticorpi per opporsi ad un turismo di puro consumo e anche di rapina ambientale, che, come abbiamo visto dal 1954 ad oggi, deturpa l’immenso tesoro che ci è dato di abitare e di cui dovremmo essere amministratori responsabili e saggi, vanificando in definitiva o riducendo di molto gli stessi benefici economico-sociali che potrebbero derivarne per l’intera Comunità. Senza dimenticare , infine, che è proprio una rinata consapevolezza culturale che consente al Comune di Centola di non essere più solo oggetto passivo dell’interesse di tanta parte d’Italia, ma di poter anche dare avvio ad un rapporto più attivo e creativo, sia sul piano culturale che politico, con l’ambiente più ampio che ci circonda: dal resto del Cilento alla Regione Campania e a Napoli, dall’Italia alla nuova Europa, e perché no al periplo del Mediterraneo. Raffaele Luise Presidente Commissione Giudicatrice del Concorso di Narrativa Roma, 29 Settembre 2012 Anna Maria Amendola CINEMA SOTTO LA LUNA L’operatore prendeva ad armeggiare fin dal primo pomeriggio. Si posizionava davanti alla parete bianca della Chiesa e andava e veniva per calcolare la distanza. Era uno di quelli che sanno tutto. Dava ordini e contrordini ad un giovanotto che scattava. I paesani guardavano a bocca aperta e se ne stavano a debita distanza per non intralciare il lavoro. Dopo il guizzo rosso del tramonto, scendeva azzurra la sera e poi la notte carica di stelle, con la luna piena che sembrava scoppiasse. Era l’ultima sera della festa del patrono, quella dedicata al cinematografo. La pellicola in programma doveva essere bellissima, si capiva dal titolo: I Figli di Nessuno. L’unico manifesto che annunciava il film era attaccato sulla parete della rivendita di tabacchi. Rappresentava una suora con gli occhi persi dietro una figura d’uomo che si allontanava. Sul viso della suora c’erano due lacrime, una a destra e una a sinistra, rotonde e grosse. Penso che tutti noi bambini le toccammo: sembravano vere. Ognuno, a modo suo, per una specie di masochismo collettivo, immaginava una storia triste e bellissima. Fu così che mi feci un’idea sbagliata dell’amore, associandolo al dolore. Immaginai per tutta la prima giovinezza storie eroiche, dove l’amore diventava impossibile. Dovetti, a quei tempi, assumere un atteggiamento angosciato e strano, perché sentivo spesso le zie confortare mammà, preoccupata per il mio colorito olivastro e la mia perenne stanchezza. Dopo una pausa di assoluto silenzio (tutti erano corsi a casa per mangiare un boccone), scoppiava una specie di rivoluzione. Uomini, donne, bambini si riversavano nell’unica strada che finiva in piazza, davanti alla chiesa. Ognuno portava la propria sedia: chi la brandiva, portandola dritta sul capo, chi la trascinava dietro di sé: si andava al cinema! C’era un’agitazione incredibile. Tutti volevano conquistare la prima fila e perciò i tentativi di sorpasso erano continui e con conseguenze immaginabili: le sedie finivano per impigliarsi e allora giù imprecazioni e liti: chi riusciva a passare innanzi, poi di scatto si girava per dire a gesti a quelli che seguivano: dietro al mio culo. Volavano gli insulti e le voci stridule si coprivano l’un l’altra. – Figlio di puttana, và a buttare il sangue! –. Troppo, per un posto al cinema sotto la luna. Intanto la marea avanzava sotto la luna. Ondeggiavano le sedie sbilenghe e brandite, e si individuavano nitide nella luce bianca. Quando alla fine si arrivava in piazza, la prima, la seconda, e anche la terza fila s’erano già formate: c’erano sedute tutte le vecchie del paese. Proprio in prima fila c’erano le più grasse: Maria Sanse10 verinara, Lucia, a Sianese, Filomena chiatta e altre. Si vantavano con un ghigno di soddisfazione di non aver mangiato quella sera per conquistarsi il primo posto. Erano così grasse che sembravano massi di pietra scura: le spalle cadevano sul sedere grosso e la sedia gli scompariva sotto. Qualche bambino cercava di sedersi davanti a loro, ma lo cacciavano urlando e dandogli pugni sulla testa. E quello si vendicava gridando da lontano: – Piscine vecchie! Un compagno a scuola mi aveva detto che le donne hanno in mezzo alle gambe una fornacella scura. Pur non volendo, m’immaginavo quella di Filomena chiatta e provavo un disgusto che quasi mi faceva vomitare. Sistemarsi era un’impresa, bisognava cercare il posto, evitando le teste che ti stavano davanti. Ciò che non si poteva proprio evitare erano gli odori dei vicini, che andavano dall’aglio al vino, nella migliore delle situazioni, dal sudore ai denti marci, nella peggiore. Ma eccolo quel quadrato magico di luce, lì, sull’intonaco della chiesa. La pellicola cominciava a girare tra fischi sottili e lampi di luce e improvvise strisce scure. Poi comparivano le scritte accompagnate dalla musica. In piazza cadeva il silenzio. Credo stessimo tutti a bocca aperta, come ipnotizzati dall’operatore; ma quando l’attenzione era al massimo si spezzava la pellicola. Immediato il boato di protesta. Tra lampi e strisce scure, dopo qualche minuto, ricomparivano le immagini. Si andava avanti così a singhiozzo, finché non compariva la parola fine. Ed era sempre una delusione poiché, anche se l’uomo e la donna erano felici e contenti, noi avremmo voluto vedere come e quanto erano felici e contenti. Di nuovo le sedie che sembravano avanzare da sole nel bianco della luna. Le donne piangevano ancora, e gli uomini parlavano della femmina che era bella e che se fosse capitato a loro avrebbero fatto così e non così. Quel cinema sotto la luna era per tutti l’occasione di una volta all’anno. L’indomani, già prima di sera, ognuno rientrava nella propria pelle. Fuori, era sereno e c’era la luna bianca e saputa come sempre. 11 Anna Maria Amendola I FRANCESI I francesi arrivarono intorno agli anni ’60 e presero posto alle “Saline”, sotto gli ulivi secolari. Sparirono di colpo le vigne, i vecchi casolari, per lasciar posto al Club Med. Fu una corsa all’oro senza pari. E arrivarono i soldi, le femmine in due pezzi e le balere. Sul corso, aprirono i primi negozi dei paesani disposti a tutto, a cambiare nome e lingua pur di ingraziarsi i nuovi venuti: così “da Antonia” diventò “chez Antoinette”. Ebbe inizio l’imbarbarimento. Il prete ebbe bisogno di una chiesa più grande e via, in un colpo solo, la piccola chiesa bianca e la piazzetta. E via, pure i magnifici lastroni di pietra e le scalinate che lasciarono il posto ad una rotabile asfaltata. Così pure la locanda di mattoni rossi col pergolato: al suo posto un casermone di cemento. Erano tutti contenti i paesani perché arricchivano, ancora di più, i francesi che avevano trovato l’Eldorado. Non ci lasciarono niente i francesi. Scandagliarono i fondali e strapparono senza pietà tonnellate di coralli, poi fu la volta dei relitti delle navi greche e romane. Indisturbati, portarono via ogni cosa. Certo ognuno ha migliorato: case, macchine e bomboniere per i matrimoni. Quanto si sia perduto? Nessuno ha fatto ancora i conti. 12 Anna Maria Amendola LA FESTA DI S. PANTALEONE Era la sera del trenta agosto, la sera di Santa Rosa. L’aria era ancora calda e pesante, per l’afa che ci aveva tormentato tutto il giorno. La zia si aggirava per casa inquieta e, senza una ragione, spostava gli oggetti con le sue mani grandi, quasi da uomo. Alla fine sbottò: – È arrivata già la valigetta! –. Mi girai verso il tavolo basso che era vicino alla porta d’ingresso e la vidi: c’era la valigetta di zio Ciccio. Come facesse a farsi precedere dal bagaglio non l’ho mai capito. Certo è che, appena qualche ora dopo l’arrivo della valigetta, compariva anche il proprietario. Zio Ciccio era il marito della zia Rosa. Io, all’epoca, ero una bambina grassoccia, con un viso pallido e inespressivo. L’unica cosa d’eccezionale che possedevo era una lunga treccia di capelli che, tenuta insieme tutta sull’orecchio sinistro, mi costringeva ad assumere un atteggiamento dolente e patetico. Uscimmo di casa che la sera era già tramontata da un pezzo: nell’aria tutti quanti i profumi dell’estate. La strada era bianca, sotto la luna, e le case, l’una dietro l’altra, aprivano finestre e balconi, rettangoli di luce rossastra che versavano fuori un odore di cipolla e basilico, un rumore di posate e di voci confuse. La zia camminava in silenzio imponente e scura (me la ricordo sempre vestita a lutto per le morti dei nonni e dei parenti anziani che avvenivano con puntuale frequenza nel momento che doveva smettere gli abiti neri). Una volta che avevo la febbre alta e la vidi entrare d’improvviso nella camera da letto, la scambiai per Stalin che era morto proprio in quei giorni. Urlai per ore fino a quando la zia indossò una camicia bianca ed io uscii esausta dal delirio. – Hai visto –- disse, interrompendo il silenzio, – ha voluto farmi il regalo di Santa Rosa –. Io rispondevo poco alle sue sfuriate perché non riuscivo a parlar male dello zio. Più tardi, cercai le ragioni dell’uno e dell’altra, inutilmente: ora so di averli amati entrambi. Eravamo quasi arrivate in piazza, quando ci superò una macchina dalla quale scese proprio lo zio Ciccio: – Rosa, Ro, ti ho fatto il regalo di Santa Rosa! Venite a vedere quant’è bella! È un’APPIA. Non ce l’ha nessuno in tutto il comune! –. Intanto apriva le portiere della macchina per farci salire. – E guardate il colore: è finissimo: è grigio perla! –. La zia osservava in silenzio e, poi, prendendomi per mano: – Beh!andiamo a casa! –. Lo zio ci corse dietro e strattonava la moglie per il vestito pregandola: – Ma come, non la vuoi provare? –. Poiché proseguiva convinta, senza rispondere, zio Ciccio afferrò me per il braccio e così tornammo verso la macchina. – È bella? È bellissima! –. Lo zio mi fece leggere la 13 scritta APPIA che era sul davanti in mezzo ai fari su un piccolo dischetto bianco. – È la più bella macchina del comune! Quant’è bella! Com’è bella! È troppo bella! –. Zio Ciccio mi guardava con gli occhi lucidi di felicità, poi si incupì dietro i suoi pensieri e avviò la macchina. Io ero al settimo cielo, persa in un’infinità di sensazioni piacevolissime: l’odore del nuovo, il velluto morbido della tappezzeria, il mare lucido e gli alberi scuri che correvano fuori, le luci dei fari che divoravano la strada. Aveva ragione lo zio Ciccio: quella macchina era proprio grigio-perla, di un colore finissimo. Aveva ragione anche la zia Rosa perché, da quella sera, cominciarono per noi due, a causa della macchina, guai terribili che si protrassero per anni. Zio Ciccio era come impazzito, voleva che tutti, proprio tutti, lo vedessero alla guida di quella meravigliosa utilitaria, ma il fatto è che era un pessimo autista e che, in non poche occasioni, mise a repentaglio la sua e le nostre vite. Il dramma culminava quando il percorso era in salita: la macchina a stento tirava e lo zio dietro al volante cominciava a spingere, piegando ritmicamente le spalle, e la zia: – Spingi, spingi, che fai prima! –, e accompagnava le parole con pugni vigorosi sulle spalle ricurve dell’autista. Ad ogni passaggio a livello che trovavamo chiuso, lo zio chiamava il casellante e faceva alzare le sbarre, la zia mi tirava giù con violenza: – Muori da solo, solo come un cane! –. E poi rimanevamo lì, mentre la macchina sobbalzava fra le rotaie, col cuore in gola, a spiare se per caso non arrivasse il diretto. A piedi, dopo che il treno era passato, attraversavamo le rotaie io e la zia, tenendoci per mano e guardando a destra e sinistra come ladri. Le cose si complicavano davvero il giorno di S. Pantaleone. Lo zio non avrebbe rinunciato per niente al mondo alla festa di S. Pantaleone, che si svolgeva a Vallo della Lucania, dove lui era nato. Passeggiare per il corso, sotto le luminarie colorate, tra me e la zia, con la catena dell’orologio bene in vista sul panciotto scuro e rispondere ai saluti di tanti che, con rispetto, lo chiamavano Don Ciccio, credo sia stata per lui la più grande delle soddisfazioni. La gente diceva che era assai ricco e favoleggiava sulla “pensione americana” che gli veniva pagata in dollari. Durante gli anni della seconda guerra mondiale, era capitato come soldato in America ed era rimasto ferito sul campo da una granata. Lo avevano curato insieme ad altri in un grande ospedale di Boston ed era tornato poi invalido speciale in Italia. Da quel viaggio, aveva portato a casa un orologio a pendolo, le schegge che non erano riusciti a togliergli dalla coscia destra e la sterilità per aver respirato dei gas micidiali per il tempo che rimase sfinito sul campo. In compenso, gli avevano dato la pensione e un abbonamento permanente alla rivista “Legion d’honore”. La gente di Vallo lo salutava con un rispetto solo apparente, in sostanza era invidiato parecchio. Peccato che quella moglie così bella non fosse riuscita a dargli un figlio. La zia, infatti, s’era abbracciata la sua croce e, per rispetto del marito, lasciò intendere a tutti che dei due era lei che non poteva fare figli. E così io, che ero la terza di quattro figlie femmine, una sera, mi ritrovai a dormire nel letto grande degli zii con le lenzuola ruvide che sapevano di bucato. La sera della festa di S. Pantaleone, facevamo in lungo e in largo la piazza con la 14 zia che sbuffava in continuazione e con lo zio che rimandava l’acquisto anche di un pezzo di torrone al prossimo giro, per non spendere una lira. Soffriva, infatti, d’avarizia lo zio Ciccio. Si privava di ogni cosa pur di conservare i soldi. Alla fine, io ero sempre più stanca e assonnata, mi trascinavo a stento. Era un sollievo ritornare dentro la macchina. Quel sedile di velluto grigio valeva mille carezze, ma era una sensazione destinata a durare poco. Man mano che ci allontanavamo dal paese, lievitava l’agitazione della zia, che incitava il marito a fare presto, a spingere di più sull’acceleratore. Attraversavamo un bosco scuro, interrotto nel bel mezzo da una gola stretta e profonda, dove anni addietro si nascondevano i briganti. E di gente che andava e veniva dalle fiere ne era stata uccisa tanta, anche uno dei fratelli Serva, di Foria, era stato ucciso nel vallone di Mezzanotte dai briganti che si erano impossessati del carico di lana e delle mule. Una volta arrivati al famigerato vallone, la zia si abbandonava ad un parossismo furioso: – Cammina ti dico, che i briganti possono prenderci la bambina e facciamo la fine di Lindeberg. – Più di tanto la macchina non va, vuoi stare un po’ zitta? – Disgraziato, incosciente! A passare con la bambina, a quest’ora di notte, per questi posti! –. – Stai zitta! –. E lo zio a spingere con le spalle dietro lo sterzo, con quel suo movimento ritmico, e la zia a scalciare e a urlare e a tirar pugni e di tanto in tanto: – Lindeberg, Lindeberg! Gli occhi mi si spalancavano di botto, gli alberi diventavano una minaccia, l’oscurità della valle un’unica grande mano pronta a rapirmi e a buttarmi chissà dove. Davanti alla macchina, non più la luce dei fari, ma risate sguaiate di bocche spalancate. Le orecchie mi si drizzavano, pronte a cogliere il primo fischio sospetto, confondevo le cose: non c’era più la macchina né gli zii, ero sola: io e la paura. Quando, come Dio voleva, arrivavamo a casa, la zia si chiudeva nel più assoluto silenzio e zio Ciccio ripeteva ad intervalli regolari: – Pazza, questa pazza! –. Io mi infilavo nel letto in mezzo a loro due e ringraziavo Dio che mi aveva liberato dai briganti e da quel Lindeberg, che confondevo, allora, con Hitler o Stalin, ignorando che si trattava della vittima. Mi addormentavo quasi subito per svegliarmi nel cuore della notte, in una conca calda e umida: pisciavo puntualmente nel letto, la notte di S. Pantaleone. La zia mi sgridava solo un po’, poi si metteva in piedi anche lo zio, che mi faceva pena perché sembrava già vecchio e stanco. La zia toglieva via le lenzuola bagnate e rifaceva il letto. Stendevo le mani nel letto che sapeva di bucato e ne mettevo una sotto il cuscino dello zio e una sotto quello della zia. Fortunatamente la festa era passata. Un anno mi senbrava lungo, allora, e il pericolo lontano. 15 Anna Maria Amendola IL TEMPO DELL’INCANTO Ci fu il tempo dell’incanto, del mondo senza fatica, dei pomeriggi lunghi passati a giocare alle comari, dietro il seggiolone della nonna che aveva il sedere grosso. Dicevamo di stare all’ombra del gran pino e inventavamo i giochi, imitando la nonna e le zie. Quando la nonna si alzava, avevamo pronto un piccolo paniere, pieno di carte che legavamo alla cintura del suo grembiule piano piano. La seguivamo ridendo per tutta la casa: il paniere dondolava. Ci nascondevamo dietro le porte delle stanze che si aprivano l’una nell’altra. Quando la nonna se ne accorgeva, chiamava la zia Rosa che, sciogliendo il nodo, ci diceva: – Delinquenti!, – e ci prometteva cose non buone, ma non ne faceva niente. Di queste ed altre cattiverie mi pentivo il giorno del Corpus Domini, quando io e mia sorella piccola vestivamo da angioletti. Ci facevano indossare delle tuniche lunghe, di un rasone pesante, con in vita un cordoncino che faceva da cintura. Sulla testa un diadema di carta stagnola, tenuto fermo da un elastico fastidioso che passava dietro le orecchie. Il peggio erano le ali. Due pezzi di cartone con su incollate tante striscioline di carta velina, tagliuzzate a mo’ di piume. La zia signorina impegnava mesi per prepararle. Mi calavo totalmente nella parte dell’angelo, sicché facevo un sogno che è andato avanti per un pezzo: camminavamo tutta la famiglia, anche i parenti che erano morti, per la strada del porto. Era notte, ma c’era la luna piena che faceva giorno sul mare, sulla strada e sull’erba, lungo la cunetta. Camminavamo senza parlare e cosa strana i nostri piedi sulla strada non facevano rumore. Arrivati alla rotonda, mi staccavo dalla mano della zia Rosa e spiccavo il volo. Muti gli altri, senza spostarsi, alzavano la testa a guardarmi e avevano la bocca aperta e la faccia bianca, come cosparsa di farina. Volavo con un sorrisino leggero, fino a quando, girandomi indietro, non scorgevo sull’asfalto l’ombra lunga di un diavolo nero con la forca a tridente e le corna dritte sulla testa. Precipitavo e mi svegliavo in un bagno di sudore, con la maglia di lana di pecora che mi pizzicava la pelle. La mattina della festa, le donne si alzavano presto per scopare strade e vicoli, poi strappavano dalla collina montagne di felci che disponevano ai lati delle strade e sulle soglie delle porte. Dai balconi cadevano le coperte ricamate. Nell’aria un odore di fiori, perché venivano preparati i cesti di petali versati a pioggia dai balconi quando passava la processione. Io e mia sorella aprivamo il corteo. Le cose andavano bene fino a che sfilavamo per il corso, poi cominciava la sofferenza, perché la processione doveva passare per tutte le strade in 16 salita e in discesa. Il prete cominciava ad andare più svelto, alla fine quasi correva e noi faticavamo a tenergli dietro. La tunica scivolava sotto la cintura e bisognava reggerla con le mani già impegnate dal cestino di petali, per quanto sorretto dal nastro che passava dietro al nostro collo. Il diadema si metteva di traverso e le ali, sbilanciate, si spostavano da un lato. Arrivavamo a casa disfatte. Correvo in cucina a bere direttamente dagli orci pieni d’acqua che torreggiavano sullo scanno di legno, sotto la finestra. Urlavano le zie e la mamma di non bere, che eravamo sudate, che potevamo prendere la bronchite e anche la tubercolosi. Ci lasciavamo investire dall’ombra fresca della casa con i balconi socchiusi. Dopo le festa del Corpus Domini, arrivava l’estate calda, con il sole che batteva sui tetti da mattina a sera e il mare immobile, liscio come l’olio. Andavamo a mare alla Ficocella, una spiaggia piccola che si apriva ad arco sotto uno spuntone d’arenaria, ai piedi del paese. Lì arrivavamo andando giù per una stradina sterrata che, per superare lo strapiombo, si trasformava in una scala ripida tagliata in parte nella roccia. L’andata era un gioco. La mamma, che non sapeva nuotare, ci seguiva in apprensione già da quando uscivamo di casa. Vestiva un prendisole di percalle leggero e si riparava dal sole con un ombrellino blu a disegni rossi. Portava i capelli alzati sulla nuca e fermati alle tempie da due pettini di celluloide. Qualcuno, una volta, le disse che sembrava, a causa della pettinatura, una donna etrusca. Tradussi immediatamente che la mamma era bellissima. Scendevamo le scale di pietra saltando e, arrivate, andavamo dritte in acqua. Era magnifico il mare. Sul fondo si individuavano le pietre, le conchiglie, le erbe una ad una. Andavamo a bere alla fontanella che veniva fuori da due pietre accostate e in un solco di ghiaietta finiva a mare. L’acqua era dolcissima, forse per via del sale che avevamo in bocca. Per arrivare alla piccola sorgente, bisognava camminare sugli scogli che erano ora lisci e piani, ora ruvidi e pungenti. Saltavamo da uno scoglio all’altro e passavamo sotto la parete d’arenaria, dove il sole non arrivava mai. C’era in quel posto un odore di muffa e di sementella, un’erba che, erano sicuri, distruggeva i vermi piccoli e bianchi che affliggevano tutti noi bambini. La sementella veniva messa a bagno per giorni; poi la mamma la faceva passare in un imbuto di latta rivestito con un pezzo di tela. Ne usciva un liquido viscido, di colore giallino, che ci facevano bere a forza, tenendoci ferme le braccia e tappandoci il naso che rimaneva come in una morsa tra il pollice e l’indice della zia Rosa, sicuramente più decisa della mamma. Detestavo lo scoglio all’ombra della Ficocella, ma dovevo passarci per forza di cose. Ogni volta riconquistavo con sollievo la sabbia calda che schiacciavo sotto i piedi per correre di nuovo nell’acqua. Arrivavano altre mamme con i figli. E un giorno arrivò Antoniuccio da solo, perché era già un giovanotto. Mia sorella piccola cominciò a girargli intorno e alla fine sbottò: – Perché non tiri giù le mutande e fai cadere la sabbia che ti è rimasta in mezzo alle gambe? –. Antoniuccio fece finta di non aver sentito, ma mia sorella insisteva petulante. Sapevo che doveva star zitta, ma non sapevo perché. Antoniuccio pensò bene di tuffarsi. Le mamme, non più in imbarazzo, 17 dicevano che era meglio quando la Ficocella era divisa in due, quella degli uomini e quella delle femmine, che era meglio quando i costumi da bagno erano canottiere lunghe al ginocchio, che era meglio, che era meglio…Continuarono così per tutta la mattina. Antoniuccio uscì dall’acqua quando noi eravamo già in cima alla scala di pietra dirette a casa. 18 Anna Maria Amendola I “DON” Nei paesi del Sud, come il mio, gli abitanti si dividevano in due categorie: quelli che avevano il don e quelli che non l’avevano e che si chiamavano semplicemente per nome. A tutti i don erano dovuti rispetto e riverenza, o perché erano signori di nascita o perché lo erano diventati arricchendosi. Vi era poi una terza fascia di don che non potevano vantare né titoli né soldi, ma che svolgevano funzioni importanti e mestieri difficili. Il don era dovuto: al maresciallo, al prete, all’ufficiale di posta, al maestro e a chiunque fosse impiegato dello stato. Mio padre era don Nicola, ufficiale di posta, ma era anche figlio di don Vincenzo, il cavaliere che aveva saputo, dal nulla, mettere su una cianciola e arricchire con la salagione delle alici e il commercio dell’olio e del vino. La piccola società del paese si regolava sui parametri dell’epoca post-fascista, dove il “perbene” e il “signore” era anche il potente. Era quello che capiva, leggeva il giornale e che sapeva sempre cosa fare. A tutti gli altri, volentieri o non, toccava ubbidire. E, come accade ancora, rivalità e inimicizie dividevano spesso le famiglie dei don. Così, il mio maestro, quello che ci bacchettava, tenendo la lingua ricurva tra i denti, disse ai miei compagni, indicandomi: – La vedete quella lì? Il padre è ricchissimo. Pensate solo a quanti soldi fa con la vendita dei francobolli! –. I compagni mi guardarono e io guardai a terra sotto i banchi e vidi i talloni di Felicita che restavano fuori dalle ciabatte americane troppo piccole. Appena a casa, corsi da mio padre e gli chiesi se era vero quello che aveva detto il maestro a scuola. Piegò la testa da un lato e abbozzò uno strano sorriso. Puntò l’indice verso di me e disse sottovoce: – È invidia! – e poi gridando, – è invidia! –. Mi spiegò cosa significasse monopolio di stato. E per la prima volta mi mise al corrente dei sacrifici che facevano tutti in famiglia, da quando il nonno era morto e la cenciola era stata venduta. La domenica successiva, come al solito, la mamma ci fece indossare i vestiti nuovi, ci aggiustò i baschi di feltro sulla testa e ci mandò a messa. Mi accorsi che gli altri bambini non avevano cappello. Rifeci di corsa la strada fino a casa, spalancai la porta e, come una furia, mi tolsi il cappello, lo gettai per terra e ci saltai su con tutti e due i piedi. La mamma e le zie mi guardarono e non dissero una parola. Non ho mai più indossato nessun cappello anche se da tempo il cappello non è più un segno di distinzione. Quando tornai a scuola, le cose erano cambiate: il maestro era un pericoloso nemico; tra me e i miei compagni c’era il disagio che finì per isolarmi e propormi in quei panni che mai avrei voluto indossare. 19 Anna Maria Amendola “U’ PURPU” Quando in napoletano si dice a qualcuno “si nu’ purpu”, è difficile capire tutto intero il significato della parola “purpu”, che risulta, come è ovvio, non traducibile in altra lingua, per l’insieme delle sfumature e delle sottigliezze, dei sapori e dei dissapori che cambiano, adattandosi in maniera diversa a diversa situazione. Insomma, la parola “purpu” è la ‘variabile costante’ di infinite realtà nel molteplice del quotidiano, del perenne divenire, dell’immobilità dell’essere in quanto tale. Oh anima! Che filosofia “pi nu purpu”! Una sera, quando ancora non era notte, Alessandra, che veniva da Eboli, dove per fortuna non si era fermata ma era scesa più a sud, nel Cilento, mentre stavamo in piedi sugli scogli a far niente, mi disse, emozionata più che incuriosita, che proprio lì, vicino ai suoi piedi, c’era una pietra che sembrava avere due occhi. Seppi subito che era un polipo: a) imbecille che in un delirio di onnipotenza ci sfidava b) intelligente che si adattava al colore della pietra per mimetizzarsi c) pavido che atterrito non osava muoversi per sfuggire al pericolo. La seconda volta, il polipo me lo sono trovato proprio di faccia, mentre nuotavo in un mare incredibile, tanto era azzurro e fermo. Capii immediatamente che avevamo paura tutti e due, invece di cercare una via di fuga, che pure era possibile, come sempre accade, ci affrontammo in un duello all’ultimo sangue. Per quelle inspiegabili coincidenze c’era sull’acqua una canna che afferrai subito e cominciai a dar colpi forti sul polpo, spingendolo verso riva. Il polipo si fece duro come un sasso, non l’avrei mai creduto! Per confondermi e confondersi, cominciò a sparare fumo nero che si diffondeva come una piccola e inutile nuvoletta nel grande mare intorno. Irrigidendosi, mi rese facile il compito di spingerlo sulla riva. Seduta sulla sabbia calda, sentivo dietro di me la voce della zia Teresina, la donna più paurosa che abbia mai conosciuto, che nei momenti drammatici mi diceva: – Non aver paura –. A sentir da lei quell’esortazione, diventavo un leone. Accanto al polpo mezzo morto, seduta sulla spiaggia, mi sentivo “un leone”. La terza volta che ho incontrato un polipo è stata quella definitiva che mi ha aperto le porte della conoscenza. Me ne andavo in riva al mare di prima mattina, con la mia tinozza piena di tonni, dritta verso lo scoglio, sul quale ripulivo i tonni della testa e delle interiora per poi lavarli nella conca affianco, dove il mare entrava e usciva, provocandomi a un discorso che in quel momento non avevo né tempo né voglia di fare. Questa volta arrivò da lontano, maestoso nell’apertura dei tentacoli, ed era un polipo di quelli grossi e ve20 raci: era grande e con un mantello rosso, a piccole macchie bianche. Non avrei mai osato afferrarlo con le mani, per le cose brutte che avevo sentito di uomini soffocati da tentacoli. Gli riconobbi immediatamente una forza superiore alla mia e anche il coraggio di avvicinarsi così tanto alla riva. Ma non volevo perderlo. Mi venne subito in mente di afferrare la bacinella, tagliare le teste ai tonni e andargli incontro così protetta da uno scudo appetitoso. Infatti, in men che non si dica, il polipo era dentro. Alzai la bacinella con forza e la poggiai sugli scogli. Ancora una volta l’avevo avuta vinta io, o, almeno, così credevo, impegnata in una lotta senza pietà. Mi portai a casa il polipo vivo nella bacinella e aspettai fino a sera che mio marito rientrasse e calasse nella pentola d’acqua che bolliva il polpo. Fu così che lo vidi, quando, dopo un attimo, lo tirò su con tutti i tentacoli arricciati. E lo vidi di nuovo avanzare maestoso e libero nel mare azzurro. In quel momento stabilii di non usare più astuzia se mai avessi incontrato di nuovo il polpo, ma la coscienza si sa com’è: oggi, decidi e domani, dici di non aver deciso quello che avevi deciso. 21 Immagine di San Pantaleone, in onore del quale a Vallo della Lucania viene organizzata una grande festa popolare. 22 Panorama di Palinuro dal mare, anni 1950s. Palinuro, anni 1950s, la spiaggia della Ficocella. 23 Maria Luisa Amendola NONNO ALFONSO ( metà secolo XIX ) Capitolo I All’alba, più presto delle altre mattine, Alfonso già trafficava nella stalla e parlava con il suo asinello. Gli accarezzava il collo, con mano ferma e, mentre gli metteva il basto, diceva: – Oggi andiamo alle montagne, faremo un bel cammino. Dobbiamo portare i vasetti di alici salate e il tonno; speriamo di avere in cambio i loro buoni salami e le castagne! Eh, che ne dici, Tato? –, e caricava i cesti colmi, sul dorso del povero asino. Legato bene il carico, salì sul muricciolo, che era a lato della stradina e saltò in groppa a Tato, tra le due sporte. Tirò le briglie e urlò alla moglie: – Teré, io vado! –. Teresa, precipitandosi sull’uscio di casa, senza avere ancora raccolto i capelli nel “tuppo”, così lo salutò: – Alfò, stai attento ai briganti. Non tornare di notte! Dio ti accompagni! –. Così, in quella fresca mattina d’autunno, Alfonso intraprese uno dei suoi tanti viaggi d’affari. Era tanto presto che, per le vie del paese, non c’era nessuno. L’asino, trotterellando sulla strada, sollevava la polvere e faceva quel classico, cadenzato rumore di trotto, nel silenzio di un paese ancora addormentato. Percorsa la strada che a quei tempi si chiamava maestra, imboccò il sentiero dell’Acqua del Lauro, stretto ai lati da rovi e lentischi. Il sentiero scendeva lungo la costa della collina di San Paolo, fino a raggiungere il fiume Lambro. Nonno Alfonso, seduto in groppa a Tato, guadò facilmente il fiume, perché conosceva bene i punti dove l’acqua era bassa. In breve, per vie scorciatoie, tra le macchie, arrivò sulla riva dell’altro fiume, il Mingardo, che scorre a poca distanza dal Lambro, in una bellissima valle, stretta fra le colline di Centola e S. Severino, ad ovest, e il monte Bulgheria, ad est. Il sole cominciava ad illuminare le cime dei monti. Un venticello fresco scuoteva i pioppi e gli ontani, lungo il greto del fiume, ripulendo la vallata dagli ultimi lembi di nebbia. Ormai la luce trasparente del mattino aveva inondato tutto, dando risalto ai colori delle rocce e della vegetazione. 24 Nonno Alfonso era un uomo semplice, con la modesta istruzione che aveva ricevuto dalla scuola elementare, ma era molto sensibile al bello. Dalla groppa del suo Tato, godeva intimamente di quello spettacolo, assaporando la quiete del luogo. Intanto, questa sensazione di intimo, singolare godimento era, purtroppo, accompagnata dal timore di qualche sgradevole incontro: i briganti. Spesso, Alfonso li aveva incontrati; ma con le sue buone maniere, con la sua generosità, era sempre riuscito a superare l’ostacolo. Nella valle del Mingardo, lungo la costa delle colline circostanti, nelle grotte del Monte Bulgheria, vivevano, all’epoca, diverse bande di briganti. Alfonso ne conosceva parecchi e, quando li sentiva avvicinare, sapeva contenere l’istintivo, immediato timore; li salutava e offriva loro qualche fiasco di vino, fingendosi, per qualche minuto, anche lui un brigante. Poi, quando arrivava in paese, raccontava, con orgoglio, i suoi incontri, arricchendoli con la fantasia. Provava soddisfazione nel far credere di aver superato prove talvolta drammatiche. Era fiero di mostrare agli amici il suo coraggio e la sua forza d’animo. In realtà, Alfonso non aveva un coraggio da leone: nel suo intimo era un coniglio, ma cercava di reagire. Si sforzava di affrontare quel viaggio nell’entroterra ed il rischio dei briganti, per dimostrare a se stesso e agli altri che non aveva paura. Intanto, nonno Alfonso non sapeva che le cose, nella valle, erano cambiate: le varie bande di briganti erano in conflitto fra loro, per la supremazia sul territorio. Nella valle del Mingardo, detta Valle del Diavolo o dell’Inferno, vivevano, facendo razzie in tutte le campagne, anche i famosi briganti della banda di Zurlo. Questo capo, Zurlo, era un uomo forte, con i capelli crespi, duri come la barba, dal colore rossiccio. Grossi baffi, con le punte alzate verso gli zigomi, gli coprivano totalmente le labbra, mentre, sotto la falda di un cappellaccio, luccicavano due occhietti feroci. Era il terrore della contrada, Zurlo! Al richiamo del suo inconfondibile fischio, venivano giù dalla costa, come diavoli in corsa, i suoi dieci-dodici compagni. Francescantonio poi, detto il Gufo, viveva con la sua banda, sul costone della collina, di fronte a Castelluccio, verso la fine della valle, dove il fiume sfocia ai piedi di Molpa. A metà collina c’era, e ancora c’è, un antro, dall’ingresso circolare, ben visibile dal greto del fiume. In questa grotta vissero, indisturbati per anni, i briganti del Gufo, finché non arrivò Zurlo, dal monte Bulgheria. In una notte di luna piena, sul finire dell’estate, le due bande si affrontarono sulle sponde del Mingardo. Il segnale dell’ora e del luogo dell’incontro, era un falò. Fu puntualmente acceso. 25 Le fiamme lunghe, scoppiettanti, guizzavano nel buio di una notte, apparentemente tranquilla. Ecco le due bande: Zurlo, con i suoi uomini da un lato, il Gufo, con la sua banda, dall’altro. Sembrava che la luna si fosse fermata, immobile, sbalordita, a guardare dall’alto quella singolare battaglia. Si schierarono. Ogni brigante tirò fuori la sua arma: erano coltelli a serramanico, coltellacci da macellaio, accette, spranghe di ferro. Si patteggiò: chi vinceva la sfida, sarebbe entrato in possesso del territorio fino a Molpa e a Trivento, e dell’antro dove aveva sede la banda del Gufo. Altro che valle del diavolo! Quella notte la valle si trasformò in un orribile girone dell’inferno. Avrebbe potuto descriverla bene la penna di Dante! Urla, bestemmie, rumore di armi, lamenti di chi, colpito, moriva. Le fiamme del falò illuminavano la scena e sembrava che mandassero nell’aria un crepitare cattivo. Erano feroci i briganti di Zurlo! Forti, armati meglio di quelli del Gufo: perciò vinsero. Da quella notte Zurlo e i suoi presero possesso della zona e fissarono una loro postazione nella grotta del Gufo, mentre quest’ultimo e i suoi pochi superstiti, sconfitti, cercarono un nuovo riparo, alle falde del monte Bulgheria. Capitolo II Di tutto ciò, il buon nonno Alfonso non sapeva. Si avviò, quindi, tranquillo per il suo viaggio nei paesi dell’entroterra, per il consueto baratto. Ma Teresa, sua moglie, quel mattino, nel fugace saluto, gli aveva gridato: – Attento ai briganti! –. Presentimento? Chissà! Alfonso percorse la via mulattiera lungo il fiume, fino a S. Severino, poi trotterellò per i sentieri della valle del Mingardo, salendo verso Montano Antilia. Arrivò lassù che il sole era già alto. Raggiunse il centro del paese e prese posto, come al solito, all’ombra di un grosso castagno, che saliva dalla scarpata, sotto il muretto che delimitava la piazza. Subito si diffuse la voce: è arrivato Alfonso, il palinurese, che ha portato vasetti di acciughe speciali e tonno. Prima due, poi tre, cinque, tanti acquirenti, “barattanti” soprattutto. Alfonso, per la sua pazienza e affabilità, era diventato quasi un amico per quei montanari che non lo consideravano un qualsiasi commerciante, ma come una persona simpatica, di cui si aspetta la venuta. 26 Gli offrivano di tutto: salumi stagionati, fichi secchi, miele e tante altre cose buone. Non mancava l’invito a pranzo da parte di qualcuno, più amico, per il quale Alfonso aveva un occhio di riguardo. Dopo il pranzo, se era rimasto ancora qualcosa da barattare, Alfonso ritornava in piazza, altrimenti, nel primo pomeriggio, riprendeva la via del ritorno verso Palinuro. Quel giorno di ottobre gli affari erano andati bene, lo scambio delle merci era stato abbastanza veloce, per cui Alfonso decise di accettare l’invito a pranzo dell’amico Menico. Finito il pranzo, andarono in campagna, dove Menico aveva una vigna, carica di uva, come non era mai stata. Tra una chiacchiera e l’altra e i dovuti complimenti per la buona cura delle viti, il tempo passò e nonno Alfonso non considerò che, in autunno, le giornate sono più corte e il buio avrebbe potuto coglierlo per strada. Quella volta, infatti, partì da Montano Antilia più tardi del solito. Di notte, era più probabile l’incontro sgradito, con i briganti... Appena Alfonso si rese conto di aver perduto molto tempo, caricò in fretta quanto aveva avuto in “cambio merce “, montò sul dorso di Tato, lo spronò con decisione e si avviò. Per quanto veloce potesse camminare, Tato non riuscì a raggiungere la Valle del Diavolo, cioè le sponde del Mingardo, prima del tramonto. Man mano che scendeva la sera, il colore degli alberi, da verde, diventava nero; e pure un presentimento nero turbava i pensieri di Alfonso. Il silenzio della campagna, che a lui tanto piaceva, andava diventando un incubo: avanzava la paura! Nonno Alfonso, nella speranza di rendersi invisibile, cercava di rannicchiarsi sull’asino, di farsi piccolo, piegandosi verso il collo dell’animale. Vi si abbracciava quasi e quel calore di Tato, gli dava conforto, compagnia. In cuor suo, forse, anzi sicuramente, nonno Alfonso invocava l’aiuto di Dio e dei morti. Certamente avrebbe avuto meno paura se si fosse trovato al cimitero, sulla tomba dei suoi cari, anziché nella valle del diavolo, al buio, fra due strapiombi di roccia, sotto i ruderi di S. Severino! Col fiato sospeso, appollaiato tra le due sporte, legate al basto, Alfonso era arrivato quasi alla fine della valle, di fronte a Castelluccio. Ad est, sul Bulgheria, era apparso un quarto di luna. Quella tenue luce dava a nonno Alfonso un certo senso di sollievo: gli sembrava che la luna camminasse insieme a lui! Intanto, proprio quando cominciava a sentirsi un tantino più sicuro, perché aveva superato il percorso più buio e pauroso, improvvisamente, dall’alto della costa, sulla destra, udì venire voci minacciose: – Ehi! Tu! Fermati, fermati! –. Povero nonno Alfonso! Sentì raggelarsi il sangue: non v’era dubbio! Erano loro: i briganti! Briganti nuovi, non quelli che conosceva lui: quelli 27 lo avrebbero chiamato per nome. E poi, non era quella la voce del Gufo, non era quello il modo con cui il Gufo era solito farsi sentire. Alfonso tirò le briglie e Tato, ubbidiente, si bloccò. Alfonso e Tato attesero. Dall’antro con l’accesso grande, circolare, si precipitarono una dozzina di uomini: era la feroce banda di Zurlo. Circondarono l’asino, mostrarono le lame dei loro coltelli, mentre Zurlo intimava ad Alfonso: – Scendi, scarica le sporte e dacci tutto! Se non lo fai subito, ti taglierò le orecchie! –. Nonno Alfonso scese in silenzio, fece scivolare le corde dai cesti e li adagiò per terra, mentre i briganti, spavaldi, osservavano. Finita l’operazione di scarico, Alfonso raccolse l’ultima oncia di coraggio che gli restava e, con voce fioca e strozzata dal pianto, implorò: – Fatemi andare! –. Zurlo abbozzò una smorfia che esprimeva una soddisfazione maligna, nel vedere quel malcapitato tremare tanto da non riuscire a raccogliere le corde. Da quella masnada, fece un passo avanti uno di quei ragazzoni, che chiamavano “piccione di brigante” che, rigirando tra le dita, con l’abilità di un giocoliere, il suo coltellaccio, avvicinò il viso a quello di Alfonso e disse: – Sei stato bravo, perciò non tutte e due, ma un orecchio, uno solo devi darmelo! – e, con l’indice, gli toccò l’orecchio destro. Le ginocchia di nonno Alfonso vacillarono, la gola gli si seccò. Dalla bocca semichiusa gli uscì appena un sibilo. Quasi privo di sensi, si appoggiò al suo asinello che, come se avesse capito ciò che stava succedendo, mandò un raglio che fece una lunga eco tra le pareti della valle. Zurlo, volendo dimostrare che era un brigante “d’onore”, un brigante che sta ai patti, fece indietreggiare “il piccione” e gli disse: – Impara ad essere un vero brigante; la parola è parola! Questo, deve andare. Basta! Prendete le sporte e andiamo a mangiare. Capitolo III La banda eseguì gli ordini. Sghignazzando, ridendo, risalì velocemente per la costa e raggiunse la grotta, mentre Alfonso, accanto al suo asino, cercava di riprendere fiato. Era ormai buio. Nella valle, si sentiva solo l’urlo sinistro di qualche uccello notturno e lo scroscio dell’onda del Mingardo, sulle pietre. Nonno Alfonso, più morto che vivo, salì sull’asino. Non aveva il coraggio di sollevare gli occhi dalla testa dell’animale per guardare intorno, né guidava il percorso. 28 Ma Tato conosceva bene la strada, perciò camminò sui ciottoli, lungo il fiume, fino a raggiungere il sentiero dal quale era sceso al mattino, lungo il pendio della collina di San Paolo. Non fu necessario che nonno Alfonso lo spronasse: Tato camminava spedito verso casa. Per tutto il tratto di strada, dopo l’avventura con Zurlo e la sua banda, Alfonso non aveva aperto bocca: respirava piano, tanto piano, mentre il cuore batteva forte, tanto forte che, forse, Tato lo avvertì. Arrivato dove il sentiero si immetteva nella strada grande, in mezzo alle prime case del paese, Alfonso tirò un sospiro di sollievo e cominciò a guardare oltre la testa di Tato. Un raggio silenzioso del faro di Capo Palinuro, strisciando nelle tenebre, gli andò incontro e a nonno Alfonso sembrò che dicesse: “Vieni, vieni, sei arrivato! Ancora una volta ce l’hai fatta!”. 29 Maria Luisa Amendola DON BIAGIO Capitolo 1 Don Biagio, cilentano doc, era un ometto magro, di media statura, intelligente e furbo, gentile ed ironico. Gli piaceva lavorare, ma scherzare pure, combinando equivoci e raccontando cose strane, con tanta convinzione, da dovergli credere per forza. In quell’epoca, in cui non esisteva nessuno dei moderni mezzi di comunicazione e divertimento, si aveva il tempo per stare insieme e raccontare e raccontarsi storielle e bugie, e vivere serenamente, soddisfatti, contenti di poco. Così il simpatico Biagio, per tutti don Biagio – “don” perché sapeva leggere e scrivere, quindi ritenuto più intelligente e attivo – era un punto di riferimento per i suoi compaesani. Facevano capo a lui per incontrarsi e anche per comprare quelle cose indispensabili al vivere quotidiano. Don Biagio, infatti, aveva un negozio – all’epoca unico nel paese - in cui si vendeva di tutto. Innanzi al negozio, don Biagio aveva sistemato due lunghe panche di legno, che erano delle travi di ulivo, appoggiate su due muriccioli e protette, dal caldo del sole, da un enorme pergolato. Lì, si fumava la pipa, si giocava a carte, si beveva anche un buon bicchiere di vino, si chiacchierava, si rideva, come in un ameno salotto a cielo aperto. Sostare all’ombra della pergola di don Biagio, era un piacere quotidiano al quale gli amici difficilmente rinunciavano. C’era un’aria di serenità e di pace in quell’ angolo di terra, perché i frequentatori del rustico salotto erano persone semplici, sincere, pronte anche alla battuta facile, ma senza riserve, senza gelosia l’uno verso l’altro. C’era tra loro quell’agreste cordialità che lascia spazio ad un rapporto buono, buono come il pane integrale appena sfornato, carico di odore e sapore. Tra quella compagnia c’era Tommaso, un uomo estremamente generoso, a cui gli amici avevano dato un compito: portare una pagnotta di pane caldo, ogni volta che la moglie, Mariuccia, lo faceva. Così Tommaso, che abitava vicinissimo “al salotto a cielo aperto”, il sabato di ogni settimana, arrivava con un pezzo di pane caldo che, puntualmente, fregava alla moglie. 30 Mariuccia, donna piccola, tutta pepe, portava sempre un grembiulino legato in vita, un fazzoletto a fiori rossi e gialli, piegato a triangolo sulla testa e al collo una collana di corallo, sbiadito per l’usura e il sudore. Personaggio noto nel vicinato soprattutto per gli improperi e le grida che scaricava sul povero Tommaso, quando si accorgeva che mancava la pagnotta. Ascoltare Mariuccia “benedire” il marito era il divertimento settimanale più ambito dai soliti amici. Perciò, quando il sabato arrivava Tommaso, con la pagnotta nascosta sotto un lembo della giacchetta, tutti lo accoglievano, non solo per il buon pane, ma anche per sentire quello che raccontava. – Ha cominciato ieri sera. – disse Tommaso una mattina, appoggiando sul tavolo la pagnotta. – Ieri sera, Mariuccia mi avvertì: “Se domani manca un’altra volta la panella, povero te! Io le conterò! Ma a chi le porti? Si può sapere? Tieni a cummare, no?”. Mariuccia, non gridare come una cagnetta punta dalle vespe, tu lo sai, io non ho cummari! Se prendo un pezzo di pane, è per farlo assaggiare a quelli della bottega di don Biagio. “E sì, sono gravidi?! Quante volte debbono assaggiare? Tu ti freghi una panella tutte le settimane: loro mangiano e io impasto! Ti sembra bello che io mi alzo alle quattro del mattino, mi spacco “le reni” per impastare e tu fai lo “splendido” e dai, dai...”. E Mariù, finiscila; il pane si dà. Se tu dai, ricevi pure! “Ah! E va bene. Adesso ti faccio vedere io: se pure domani “ti fotti”la panella, io non so che ti faccio!”. Il discorso tra Tommaso e la moglie, riportato nei minimi particolari, fece ridere tutti. Anche don Biagio era molto divertito, e pensò di mandare un ambasciatore da Mariuccia, per continuare il divertimento. Capitolo II Don Biagio fece cenno a Guglielmo di seguirlo e così lo istruì: – Vai da Mariuccia e domandale dov’è il marito. Lei ti dirà che, siccome manca una panella, il marito sarà andato, sicuramente, alla bottega di don Biagio. Tu dirai che non hai visto Tommaso alla bottega: perciò sarebbe opportuno cercarlo e vedere dove si è cacciato stamattina. Mariuccia ti seguirà; tu vieni con lei piano, piano. Trattienila a parlare di qualsiasi cosa, mentre io penso a spedire Tommaso in altra direzione. Guglielmo, lusingato per il delicato incarico, si sentì persona di fiducia di don Biagio e serio, affermò: – Don Bià, fidatevi! A Mariuccia penso io! Ho capito che cosa volete fare: voi sistemate Tommaso verso il Rione dell’Arco, ci siamo capiti! Così 31 quando Mariuccia non troverà il marito alla bottega, penserà che il suo pane lo mangia quell’allegra signora e...sarà una guerra! – Certo, la scena della gatta-tigre che assale quel pover’uomo sarà infernale. Guglielmo, già divertito solo ad immaginare la scena, partì veloce per la casa di Tommaso. Intanto don Biagio preparò un pezzo di formaggio, vi aggiunse parte della pagnotta e pregò Tommaso di fargli il favore di portare quella specialità a Rosina Mirtillo, da parte di don Biagio. Aggiunse sottovoce: – Però, Tommà, ti raccomando; acqua in bocca! Fai in modo che la cosa non venga scoperta da mia moglie! Se Felicia venisse a saperlo, non occorrerà chiamare il medico, dovrete chiamare Ciccio, quello che fa le casse da morto. Scusami, Tommà, io non ho avuto “mai a che fare” con questa Rosina, però sai com’è? Mi dispiace. È vedova: se ne dicono tante... io però penso che abbia veramente bisogno! – State tranquillo, don Biagio, sono uomo anch’io. Ho il cuore pure io e ...mi dispiace. State tranquillo, non dirò niente neppure a Mariuccia! Così dicendo, Tommaso prese il fagottino e si avviò da Rosina. Dopo pochi minuti, arrivarono al negozio Guglielmo e Mariuccia, la quale, non vedendo il marito, si innervosì. Le si accese negli occhi quella luce di rabbia di chi medita una vendetta. Mariuccia, nell’attesa di sapere che fine avesse fatto Tommaso, non stava ferma un minuto: sciupava con le mani quel povero grembiule che le penzolava sul ventre; aggiustava, con gesti nervosi, il fazzoletto che le copriva la testa. Poi cominciò: – Vorrei sapere dove è finito stamattina, se non è qui. E si è presa pure la panella per portarla da don Biagio! Mariuccia, mentre guardava da tutti i lati, non riuscì più a controllarsi: alzò la voce e, presa ormai da una “crisi di gelosia”, ripetè più volte: –Puozzi schiattà! Puozzi crepà, tu e chi te vene appriessu! – e batteva il piedino per terra. Intervenne Alfredo, calmo calmo: – Mariù, non ti preoccupà, Tommaso è qua vicino! Poco fa l’ho visto laggiù, nel rione dell’archetto. – Nel Rione dell’Arco? E che è andato a fare nel Rione dell’Arco? Non finì di pronunciare la parola “arco” che già si era avviata in quella direzione. Prese posto sotto l’arco frapposto tra due case, tirò il fiato schiacciandosi in un cantuccio e restò immobile. Di lì puntava la prima casa del vicoletto, meglio di un cacciatore che punta la tana di una volpe. La tana della volpe era l’uscio di Rosina Mirtillo. Dopo poco, il dubbio di Mariuccia diventò certezza: ecco Tommaso uscire da quella maledetta porta, sorridente, mentre si prendeva gli accorati ringraziamenti di Rosina, per l’ottimo pane e il per il saporito formaggio. 32 Capitolo III Rosina Mirtillo chiuse la porta e Tommaso, soddisfatto, si avviò, a passo svelto, per portare a don Biagio i saluti e i ringraziamenti di Rosina. Non aveva percorso neppure due metri di quell’angusta strada, quando si sentì afferrare per la giacchetta e assestare un colpo secco sulla spalla destra: era una tegola che si frantumò sul selciato, dove Mariuccia l’aveva trovata. Si girò di scatto il povero Tommaso, portandosi la mano sinistra sulla spalla destra, mentre il dolore gli prendeva anche il braccio. Tommaso, nel vedere Mariuccia, non riuscì a parlare: rimase a fissarla per un attimo e poi cercò di evitare i colpi, scaricati a ripetizione, chinandosi ora a destra ora a sinistra, quasi fino a terra. Mariuccia era come impazzita. Non guardava dove colpiva! Mandava pugni in tutte le direzioni, accompagnando il gesto con l’augurio di sempre: – Tié, tié, puozzi crepà! Intanto don Biagio, Guglielmo e gli altri, nascosti dietro la siepe dell’orto di Rosina, si godevano la scena. Smisero di ridere e saltarono fuori, quando videro che la camicetta di Mariuccia era macchiata di sangue. Si fece avanti don Biagio, cercando di fare finalmente la persona seria: – Mariuccia, Mariuccia che fai? Ferma, ferma! Tommaso non ha nessuna colpa; ha fatto un favore a me. Sono stato io a mandarlo da Rosina a portare il formaggio; ti stai sbagliando. Tommaso non ha fatto alcun male, perché debba meritare questa tua feroce reazione. – Ah, sì? – rispose Mariuccia, mentre si tamponava il taglio, sulla mano, che le aveva procurato la tegola rotta addosso al marito. – Sì.. sì... non ha nessuna colpa? E la pagnotta che si frega tutte le settimane, a chi la dà? Finalmente Tommaso trovò la voce per rispondere: – Ora non la darò più a nessuno, perché, con la mano tagliata, non potrai più impastare! 33 Maria Luisa Amendola MEMORIA DEBITORUM Capitolo I C’era una volta, anzi c’è ancora, un simpatico tipo che vive in un paese del Cilento. “C’era “perché, per molti aspetti, è di ieri, c’è e vive con l’intelligenza e la furbizia che occorrono per vivere oggi. Eccolo: è un ometto composto, dall’aspetto serio, con due “scocchette “rosse sul viso, occhietti tondi, chiari, furbi. I capelli rossicci, malamente tinti – anzi stinti – perfettamente pettinati e tirati sul cranio, formano una membrana ben sistemata, come a proteggere ciò che è dentro la testa. Infatti l’intelligenza e l’intuito che producono il cervello di quest’uomo sono da proteggere, anche con i capelli! Da giovanissimo, era un artigiano, che sapeva riparare mobili e finestre; da uomo, è un imprenditore che ha saputo crearsi un piccolo impero: ha messo su un polo commerciale, di notevole dimensione, in cui si vende di tutto, dalle culle al contenitore per l’ultimo viaggio. Matteo Mari, soddisfatto e mai tranquillo, gira nel suo spazio, passando dalla sua scrivania a qualche tavolo dell’ufficio di vendita; va nelle sale attigue, chiamando, impartendo ordini, rispondendo a mille telefonate. E’ sempre indaffarato! Quando entra un cliente, lo accoglie con benevolenza e umiltà, poi, a seconda del soggetto che gli sta davanti, regola il discorso e stabilisce, all’istante, cosa deve dire. Inizia quasi sempre col commiserare se stesso: racconta i suoi problemi, a cui aggiunge anche la descrizione di qualche malanno. Questo forse, per obbedire a un istinto segreto di scongiurare l’eventuale malocchio. Poi, sempre con gentilezza e disponibilità, chiede al probabile cliente, in che cosa può essergli utile. Quando è certo che quella persona non gli farà perdere tempo e che acquisterà qualcosa, passa al momento “soft “, al momento di offrire il caffè e sorridere anche con gli occhietti tondi e celestini. 34 Capitolo II Un giorno, Matteo riceve la visita del dottor Vincenzo Zara, suo compaesano, residente a Napoli, ove svolge, da molti anni, la sua professione. Appena lo vede, attraverso la porta a vetri che, dal suo ufficio, dà direttamente sul piazzale d’ingresso, gli va incontro. E… – Accomodatevi, quale onore, stamattina, avervi qui ! Accomodatevi, entrate, entrate!... – “E’ sempre un piacere rivederti, caro Matteo, – e gli appoggia la mano sinistra sulla spalla, mentre con la destra stringe la destra di Matteo, – Ti vedo in forma: Bravo! Gli affari vanno bene di sicuro, è inutile chiedertelo! – Dottò, non sempre! – risponde, – potrebbero andare meglio, se alla gente funzionasse la memoria… Il dottore, conoscendo il tipo, lo provoca: – Scusa, Mattè, che vuoi dire con questo: “se alla gente funzionasse la memoria”? – Don Vincè, prendiamoci un bel caffè e vi spiego. Voi che siete medico, non potete inventare una cura, che so io? Trovare una medicina da somministrare a qualcuno per rinforzare o, addirittura, ricostruire la memoria ? Il dottor Zara, stando al gioco, così risponde: – Qualcosa c’è per questa facoltà del cervello, ma prima bisogna vedere bene di che si tratta; qual è la causa che ha degenerato la memoria. Matteo, penso che tu lo sappia, c’è la memoria visiva, uditiva, ci sono i ricordi nascosti nel subconscio … – Dottò, non cominciate a parlare difficile, altrimenti non posso seguirvi. La cosa è semplice: ci vuole una medicina potente da distribuirsi gratuitamente, altrimenti non la comprerebbero, che possa curare la memoria! – Capisco, capisco: tu vorresti che a qualche tuo smemorato cliente ritornasse la “MEMORIA DEBITORUM ”. Ma quella, caro mio, non si risveglia con nessun farmaco! … ti assicuro!… Intanto siedono tutti e due, uno di fronte all’altro, nell’ufficio del Mari. Matteo accosta la poltrona vicino alla scrivania e tira fuori un sospiro. Punta il gomito sul piano e appoggia la testa sul palmo della mano. Guarda al di sopra degli occhiali l’amico Zara, e riprende: – Allora, secondo quello che dite, non c’è niente da fare! Debbo rassegnarmi! Debbo chiamare Mario, farmi portare il carro funebre, riempirlo di cambiali e assegni scoperti, e spedire il prezioso carico al cimitero. Lo sapevo che per questa malattia non c’era rimedio, ma ho tentato! … Beh, prendiamola ironicamente, alleggeriamo un po’ il problema! Zara esplode in una gran risata, mentre Matteo, più serio che mai, estrae da un cassetto della scrivania, un fascio di buste, ben ordinate e tenute ferme da un robusto elastico verde. Solleva la testa, all’altezza giusta per guardare l’amico, sempre al disopra degli occhiali, e ricomincia: – Don Vincè, vedete questo mazzo di buste? Queste contengono il “Ricordo debitorum”, sfuggito alla memoria di parecchie persone! 35 Per un attimo tacciono tutti e due. Poi Matteo abbassa lo sguardo sul mazzo di buste e comincia a contare: – Uno, due, tre,. trenta.. cinquanta….dottò, sono più di cento! Ho perduto il conto! Sono anni, anni, non mesi! Alcuni di questi signori debitori sono morti! E Zara: – Perbacco! Ma che dici? È possibile che si faccia passare tanto tempo per pagare un debito? Scusa, eh! Vedo che su ciascuna busta hai scritto qualcosa; forse hai annotato i solleciti che tu hai fatto a questi smemorati? Matteo lo interrompe: – Solleciti? E che debbo sollecitare più? Questi sono sordi oltre a essere smemorati! Non sentono niente! Che si possano…mah, è meglio che non continuo.. Volete sapere che ho scritto su ogni busta? Vi accontento subito. Capitolo III – 1a busta: REQUIESCHIATTA tu, e tutta la tua razza! Sapete perché ho scritto questo? Perché, in questa busta, dorme la nota delle spese fatte da sette nipoti, per l’acquisto di una bara e per il trasporto al cimitero di uno zio, morto senza figli. Ora gli eredi litigano per la divisione dei beni, mentre io aspetto che torni lo zio a pagare l’ultimo suo viaggio, fatto nell’elegante contenitore, scelto dai suoi nipoti, allegramente addolorati. Pausa, – 2a busta: SPACCONE ECCELLENTISSIMO! – e accompagna col giusto improperio: – Ti possano biscottare come una “fresella”. Dottò, questo conto appartiene a Ciccio, il panettiere, e risale a quando c’era la lira. Acquistò i mobili per una cucina, compresi gli elettrodomestici, e se ne andò in Inghilterra, sperando che sua maestà lo assumesse come panettiere di corte. E sì, Elisabetta aspettava lui! Spaccone fradicio! Credeva di essere il primo panettiere del mondo…Intanto io non ho visto finora né lire, né sterline, né euro; anzi si dice che lo cerca la polizia! La moglie piange di gioia per il gradito smarrimento, e intanto si gode la cucina dicendo che non ha soldi per saldare il debito e conclude che del marito non sa niente di niente! Quindi archiviamo anche questa! 3a busta: REVERENDISSIMO BUGIARDO! Questo è un conto che il reverendo don Tonino deve pagare, al più presto, al Padreterno! Conoscete Tonino, il sagrestano, che tutti chiamano “don Tonino” perché si atteggia a prete? Bene, questo signore, un giorno, venne da me, a nome del prete vero che, all’epoca, era don Pietro e mi disse che in sagrestia, occorreva un mobile per conservare i paramenti sacri e aggiunse: “Ha detto don Pietro che, appena può, passerà lui a pagare”. Girò per il negozio e scelse non uno ma due armadietti. Mi insospettii e domandai: “Tonì, ma in quella saletta della sagrestia è possibile mettere due armadi?” Mi rispose: “Sì… sì … se tu sapessi, questo don Pietro è un fanatico, ha rinnovato tutti i paramenti e ne ha comprati tanti che ora non ha dove metterli!..”. Anche se la risposta non mi convinceva, feci caricare sul furgone i due armadi e dissi all’autista di seguire Tonino. Intanto, giunti in parrocchia, il reverendissimo bugiardo ne fece scaricare uno solo; 36 l’altro lo scaricò a casa sua. Dopo qualche giorno venne don Pietro e fu sorpreso nell’apprendere che erano due armadi da pagare, e non uno. Ne pagò uno solo, quello che era stato portato in sagrestia e aggiunse: «Tonino deve imparare… ora basta! Non posso pagare anche il suo armadio con le offerte dei fedeli». Dottò, avete capito che “pesce” è Tonino il sagrestano? Sperava che don Pietro, oltre all’incarico di scegliere, gli avrebbe dato anche quello di pagare la merce, così avrebbe avuto il suo armadietto a costo zero! Il dottor Zara è divertito per l’episodio raccontato con tanta “passione”, ma non può ridere perché Matteo è seriamente arrabbiato, perciò si limita a dire: – Mi dispiace per quanto ti è capitato, ma tu insisti con Tonino perché ti paghi; magari minaccialo! – Minacciarlo? A che servirebbe? Quello non teme nessuno, non ha niente da perdere; e chi non ha niente da perdere è tra i potenti, caro dottore! Questo è un nullatenente, un bugiardo fradicio! Che possa fargliela pagare il Padreterno! Così dicendo, Matteo Mari sistema le buste, una sull’altra, mettendole sempre rigorosamente in ordine, mentre Zara allunga il collo per cercare di leggere qualche altra “epigrafe”. Matteo, vedendo che il dottore sporge il capo in avanti, continua a leggere, busta per busta, senza commentare, ma cadenzando la voce e accompagnandola, con una mimica tale da essere un efficacissimo commento. Il dottor Zara si sforza per trattenere un’abbondante risata e vi riesce fin quando Matteo rallenta la corsa nel leggere, per scandire: – RAFFINATISSIMA VOLPE! MIRACOLO DELLA NATURA! E ci siamo intesi, dottò, questa è la sindachessa! A questo punto, Vincenzo Zara, finalmente, dà sfogo alla sua ilarità, e mentre ride, come poche volte gli era capitato, riesce a dire: – Benissimo; non parlo più! Io ero venuto a chiederti una cosa proprio per il Comune! – No..o..o.., – lo interrompe il Mari, – assolutamente no! Don Vincè, per voi tutto! Per il Comune, pensateci voi! Credo che ci vorrebbe una buona dose di quella medicina… E Zara: – Quale? –E quale medicina??!! Quella per memoria debitorum! 37 Maria Luisa Amendola IL BRIGANTE COLA MARINO Un cane brutto, che rassomigliava ad un orso, infatti lo chiamavano “Ursu”, si aggirava, tanto tempo fa, per il piccolo borgo di Palinuro. Camminava trotterellando, con la lingua di fuori, con le orecchie lunghe e larghe, che gli pendevano avanti agli occhi lucidi e mobili da far paura. Aveva il pelo corto e scuro, gambe corte, una mezza coda. Non si può dire a che razza appartenesse: sicuramente era un bastardo. Era certo un bastardo, diverso da ogni altro cane, perché era l’unico a portare, all’orecchio destro, un vistoso orecchino d’oro. Ma chi poteva essere il suo padrone? Anche il padrone doveva essere un uomo particolare, tanto da aver avuto la geniale idea di mettere al suo cane un orecchino d’oro! La curiosità di sapere chi e perché avesse messo un orecchino così bello ad un cane così brutto, fu soddisfatta quando si scoprì che una donna, Maria Grussolo, era stata uccisa. Maria abitava nel rione “Ncoppa ‘a funtana” – ancora oggi così indicato – ed era l’amante del brigante Cola Marino, uomo particolarmente temuto, per coraggio e ferocia. Con la sua banda, spadroneggiava nel territorio compreso tra la valle del Mingardo e Capo Palinuro, commettendo furti e omicidi, che eseguiva al Palorcio, località che si trova ai piedi della Molpa. Qualcuno fece sapere a Cola Marino che la sua donna lo tradiva. Il brigante non riusciva a credere che Maria avesse potuto fargli questo affronto e decise di accertarsene personalmente. Escogitò un piano. Mandò da Maria uno dei suoi uomini di fiducia, con l’incarico di dirle che Cola Marino era stato ucciso e, prima di morire, gli aveva raccomandato di portare a lei Ursu perché ne avesse cura, ora che il padrone non c’era più. Maria accolse il cane, mentre si asciugava una lacrima con la punta dello scialle, che portava sulle spalle e incrociava sul petto. Richiuse la porta, mentre il messaggero ritornò dal brigante. Cola Marino passò a mettere in atto la seconda fase del piano: si nascose nei pressi Questo racconto si è classificato al primo posto nel concorso di narrativa 2012. 38 della casa di Maria, per spiarne ogni mossa. Da un rudere, poco lontano dalla casa di lei, poteva osservare i movimenti della donna e quale cura avesse del suo Ursu. Il primo giorno, Maria gli diede da mangiare abbondantemente; il secondo, già seccata dalla presenza dell’animale, gli diede poco cibo. Il terzo giorno, tentò di allontanarlo, prendendolo a bastonate. Cola Marino ringhiava dal nascondiglio; ma non uscì allo scoperto. Aspettò la sera. Era quasi notte: la luna piena cominciava a salire nel cielo terso di una serata di marzo. Il brigante pensò che era arrivato il momento di attuare la vendetta. Salì sul muro del rudere e, con un salto, fu dall’altro lato. Bussò con decisione all’uscio della donna che aprì subito. E’ difficile raccontare lo spavento di Maria! – Cola Marino! Sei lo spirito o non sei mai morto? – Lo sguardo del brigante era di fuoco. Sul suo volto si leggeva solo ferocia. Nella sua voce c’era solo ira. Ordinò a Maria di uscire e di seguirlo. La donna, capite immediatamente le intenzioni del brigante, uscì di casa e, correndo, imboccò la strada che va alla Marinella. Cola Marino fece un fischio al cane ed un cenno con la testa. Ursu obbedì al comando del padrone e si lanciò all’inseguimento di Maria. La raggiunse, l’assalì e la fece cadere. Cola Marino, con la calma cattiva di chi medita la vendetta, si accostò alla donna che Ursu teneva a terra e la trafisse con novantanove coltellate più una, la centesima, nel basso ventre, come punizione definitiva del tradimento, di cui il brigante era ormai sicuro. Ne fu certo perché Maria aveva trattato male il suo cane, e così cantò mentre la finiva: – O ronna, ca vattisti lo mio cane, ricisti : puozzi stà senza patrune; nun t’avia levato na’ fedda ri pani, e nun t’avia fattu quarch’ errore. Si tu vulivi bene a lo mio cane, vulivi bene pure a lo patrone. (O donna,che hai percosso il mio cane, hai detto: devi stare senza padrone; eppure non ti aveva sottratto una fetta di pane, né ti aveva fatto qualche sgarbo. Se tu avessi voluto bene al mio cane, avresti amato pure il suo padrone). La bella Maria giacque riversa ai piedi di un grosso ulivo, lungo lo stradone, nei pressi di “Carminella”. Morta Maria, Cola Marino compì l’ultimo rito: si chinò sulla sua vittima, non per baciarla, ma per toglierle un orecchino che infilò all’orecchio destro del cane, rima39 sto a guardare immobile e silenzioso. Il mattino seguente, i pescatori che scendevano alla Marinella, videro sotto l’ulivo, il corpo della donna, barbaramente uccisa. Per lo spavento, non andarono più a pescare, quel giorno; tornarono in paese a raccontare quello che avevano visto. I palinuresi allora seppero, con certezza, che l’assassino di Maria Grussolo era stato Cola Marino, perché il cane del brigante portava quell’orecchino che mancava alla donna. Per catturare Cola Marino, fu inviato a Palinuro un capitano, esperto nel combattere il brigantaggio. La sede dei gendarmi, con i relativi locali adibiti a carceri, era il palazzo vecchio dei Rinaldi di Centola, che si trova nell’attuale piazza Murat. Cola Marino fu avvertito della presenza a Palinuro del nuovo comandante, inviato appositamente per lui. Il brigante non si turbò: pensò di comporre dei versi, di portare una “serenata” al valoroso militare. Era inverno. Il cielo era nero: non c’erano stelle né luna. Un silenzio anch’esso nero, come la notte, avvolgeva alberi, case e stradine. Solo i raggi del faro, silenziosi ed uguali, strisciavano nelle tenebre. Il brigante, fermo sull’ingresso del suo nascondiglio, che era una grotta sul dirupo di Cala Fetente, guardava il mare scuro e ne ascoltava il fragore, mentre ripeteva la serenata che aveva composto. Quando gli parve che i versi andavano bene e che era l’ora giusta per agire, si mosse. Col suo fedele Ursu, strisciando fra rovi e lentischi, scese dal faro verso il centro di Palinuro. Si fermò a poca distanza dal palazzo Rinaldi, sede dei gendarmi e, cantando con tutto il fiato che aveva in petto, così sfidò il capitano: – Vui ‘ca tiniti carta, calamaru e pinna, e siti ‘u cumandante ri ‘sta chiazza, iu tengu purviri e palle al mio comando e sono il re della montagna. (Voi che tenete carta, calamaio e penna, e siete il comandante di questa piazza, io tengo polvere e palle al mio comando, e sono il re della montagna ). 40 Nell’assoluto silenzio, la voce di Cola Marino squillò come quella di un tenore. La riconobbero tutti gli abitanti del rione e ognuno restò immobile nel suo letto, col fiato sospeso. Il capitano uscì dalla caserma con i suoi gendarmi e si recò nella piazza da cui il brigante aveva cantato. Ma Cola Marino, finito di urlare i suoi versi, si era dileguato nelle tenebre, per i sentieri impervi, che solo lui conosceva. Ancora una volta, aveva fatto perdere le sue tracce! Per molto tempo, il brigante continuò a spadroneggiare nella zona finché, malato e stanco, per non cadere nelle mani dei gendarmi borbonici, decise di ritirarsi nella grotta del “Ruvito “, sul Monte Bulgheria. E in quell’antro finì i suoi giorni. 41 S. Severino. Fiume Mingardo: Gola del Diavolo. 42 Fotografie di alcuni famosi briganti che dopo il 1860 operarono in molte regioni del Sud d’Italia. 43 Quattro “briganti” catturati dall’esercito nord-piemontese e da mercenari locali. 44 Anni 1950s, la valle del fiume Lambro. 45 Francesco Ciccarino MORTE DI UN SOLDATO: PIETRO CICCARINO (a cento anni dalla sua morte a Sciara Sciat il 23 ottobre 1911) Cent’anni fa, nella stessa data di oggi, si consumava una pagina triste per l’esercito italiano che coinvolse anche la nostra collettività; e quella fu il primo di tanti lutti di guerra che questo paese ebbe poi a vivere. E in quel giorno, assurgeva alle cronache anche un nostro concittadino: Pietro Ciccarino, bersagliere dell’XI° Reggimento bersaglieri. Egli apriva, così, tragicamente e ufficialmente quello che sarebbe diventato poi il lungo elenco dei caduti in guerra partiti da queste nostre terre: nel 1915-1918, e nel ’40-’45. Quindi il nostro Bersagliere ha avuto il triste primato di primo caduto in guerra di questa comunità. Già da tempo, la famiglia di Pietro Ciccarino aveva in mente di organizzare un degno ricordo nel centenario della morte; i nipoti (i superstiti sono una decina) soprattutto hanno sempre tenuto vivo il ricordo di quello zio perito così giovane. L’anno scorso, l’iniziativa fu fatta propria dal Progetto Centola che coinvolse l’Amministrazione municipale che a sua volta ha contribuito ad organizzare ed ha voluto questa giornata. La famiglia ha apprezzato e pubblicamente ringrazia l’Associazione, l’Amministrazione e tutti i cittadini per aver voluto condividere questo giorno di memoria. Riteniamo che in un’epoca in cui assistiamo ad una vera sovversione della scala dei valori, al di là del fatto contingente, questa celebrazione che stiamo compiendo abbia un’importanza in più; riteniamo che questa giornata faccia bene alla testa e al cuore di questo paese. Pietro nacque il 29 giugno 1888, i suoi genitori erano Giuseppe Ciccarino e Laura Profice. Egli era il quarto, di nove figli: Francesco (n. 4-4-1877), Carmela (n. 11-1-1879), Anna Maria (n. 12-11-1881), Concetta (n. 28-12-1883), Antonio (n. 17-1-1886), Pietro (n. 29-6-1888), Benedetta (n. 19-9-1893), Luigi (n. 10-2-1896) e Rosa (n. 1611-1898). Tutti vissuti e morti a Centola, tranne naturalmente Pietro, e tranne Anna Maria che, emigrata negli Stati Uniti, non fece più ritorno qui. La vicenda di Sciara Sciat è storia nota, riportata da tutti i testi di storia e di guerra. 46 Sciara Sciat era un’oasi libica; là era di stanza l’Esercito Italiano che aveva fatto della Libia uno degli obiettivi espansionistici della scellerata politica giolittiana di quell’epoca. Un giorno, mentre transitava in una specie di gola, quindi in una situazione favorevole ad un agguato o ad un accerchiamento, l’XI° Reggimento Bersaglieri venne appunto accerchiato e decimato. 400 poveri soldati italiani vennero uccisi e scaraventati in un pozzo, morti o feriti che fossero. Quel pozzo diventò la loro fossa comune. Ed è davvero singolare che, a distanza di cento anni, proprio in questi giorni, la Libia stia vivendo un’altra pagina drammatica, dopo 42 anni di dittatura di Gheddafi. La vicenda di Gheddafi non è estranea ai fatti di cui stiamo parlando, perché dovete sapere che poco dopo aver preso il potere in Libia, e dopo aver espulso gli italiani che là erano insediati fin dai tempi dell’epoca coloniale, Gheddafi decise di espellere anche i morti. E tra essi anche i poveri resti dei Bersaglieri di Sciara Sciat. Il fratello di Pietro, Luigi, in occasione dell’espulsione dei morti, scrisse al ministero della difesa, chiedendo di riavere i resti del fratello morto a Sciara Sciat. Siamo all’incirca nel 1970-’71; ebbene il ministero rispose che ciò era impossibile, in quanto i resti facevano parte di una fossa comune, quella del pozzo di Sciara Sciat, appunto. Ma nello stesso tempo il ministero gli comunicava che tali resti avrebbero trovato degna sepoltura al Cimitero dei Caduti d’Oltremare a Bari. Ed è appunto a Bari che egli, oggi, riposa insieme ai suoi compagni di allora. Aneddoti di memoria storica ci raccontano che i richiamati per la campagna di Libia furono poche centinaia in Italia; non sappiamo con quali criteri e con quale logica sia stato formato l’elenco. Fatto sta che, a quanto ho potuto accertare, dall’area del Cilento furono in due ad essere richiamati: Pietro ed un altro giovane di Laurino, Giuseppe Palladino, anch’egli dell’XI° Bersaglieri, anch’egli perito il 23 ottobre 1911, all’età di 22 anni. Sempre aneddoti di memoria orale, pervenutici soprattutto da parte delle sorelle e dei fratelli di Pietro, ci raccontano che già da tempo si sapeva che Pietro sarebbe stato richiamato per la Libia; ed è per questo che la famiglia voleva farlo emigrare per gli Stati Uniti, dove in quegli anni già c’era un buon flusso migratorio da Centola. Tutto fu inutile, perché egli si rifiutò, quasi per una strana attrazione verso il suo destino. Qualche voce attendibile ci ha detto che a Centola c’era una giovane ragazza che contribuì a non farlo emigrare… Ci siamo avvicinati quanto basta, forse già troppo, alla sua vita privata, preferiamo fermarci qui… La vicenda di Sciara Sciat fece molto scalpore in Italia, allora, al punto tale che lo 47 stesso Giolitti, che era il presidente del Consiglio dei Ministri, fece pervenire un telegramma a tutti i sindaci dei caduti. Io ho avuto modo di leggere quello che giunse al Comune di Laurino, a Centola non ho neppure provato a cercarlo. Destò impressione anche a Centola la vicenda di Sciara Sciat, al punto tale che il municipio sentì il bisogno di dedicargli una lapide sul muro della casa di famiglia in piazza. Pietro Ciccarino, figlio di contadini, da Centola, dalla Molpa, all’età di 23 anni, concludeva così la sua breve vita, in un’oasi della Libia, a Sciara Sciat, nello “scatolone di sabbia…” di cui parlava Salvemini. A 23 anni, prendeva posto così nella memoria collettiva di questo paese che oggi lo ha voluto ricordare degnamente. Centola, 23 ottobre 2011 48 Il Bersagliere Pietro Ciccarino, il secondo da sinistra (caduto a Sciara Sciat, Libia, nel 1911). 49 Domenica D’Angelo IL RICORDO E’ ANCORA VIVO Aprile 2012 Sono passati dieci, lunghi anni e il ricordo è ancora vivo. Era il 5 Aprile 2002: una giornata come tante, caratterizzata dalla solita routine, spezzata improvvisamente da una gelida ed inaspettata telefonata, giunta alle ore 14,15. Dall’altra parte del telefono, la voce di mio fratello Antonio, a Centola, invocava il mio aiuto: – Mimma corri, la mamma, il papà, il fuoco! – poi, il silenzio. Sembrava che il mio cuore si fosse fermato, rivolgendomi a mio marito esclamai: – E’ successo qualcosa di brutto ai miei cari. Dopo un iniziale smarrimento, ho ricontattato mio fratello Antonio. Dall’altra parte del telefono, un grande frastuono. Qualcuno poi mi ha rassicurato dicendo che non era successo niente, si trattava solo dell’esplosione di una bombola di gas dei vicini di casa. Ho intuito subito cosa stesse succedendo, perché i miei genitori non erano presenti. Mi sono fatta forza e ho contattato tutti i miei parenti dei paesi limitrofi per sapere cosa esattamente fosse successo. All’oscuro di tutto, sono corsi sul luogo dell’accaduto e mi hanno lasciato intendere ciò che il mio cuore già purtroppo aveva percepito: una terribile tragedia aveva colpito la mia famiglia. I miei genitori, nel tentativo di sedare una lite tra fratelli, vicini di casa, erano rimasti coinvolti nell’incendio appiccato da uno dei litiganti. Non era la prima volta che si verificavano violenti liti in questa famiglia e che i miei genitori si prestavano a correre in aiuto. Nessuno avrebbe però mai immaginato quale sarebbe stato, stavolta, l’esito dell’ennesima lite familiare. Da lì, ha avuto inizio un lungo calvario, durato dal 5 al 25 Aprile. Insieme alle mie sorelle Nicolina e Renata, che da anni abitano a Cremona, decidemmo immediatamente di partire per recarci dai nostri genitori che, nel frattempo, erano stati ricoverati, in gravi condizioni, al più vicino ospedale: Vallo della Lucania. Dopo un lungo viaggio, siamo arrivati al paese dove erano ricoverati i nostri cari. I medici non ci diedero alcuna speranza: il quadro clinico di entrambi era più critico di quanto pensassimo. Erano ricoverati in terapia intensiva, mia madre, Gilda, riportava l’80% di superficie corporea ustionata, così mio padre Carmelo. Nonostante i medici mi avessero sconsigliato di vederli in quelle condizioni, insi50 stetti per dare l’ultimo bacio ai miei adorati genitori. Non so chi mi abbia dato tanta forza e coraggio: il fuoco li aveva resi irriconoscibili. Ancora oggi, mi chiedo il perché di tanta sofferenza. Più le ore passavano più le condizioni cliniche peggioravano. Aggrappati ad una ultima speranza, decidemmo di trasferirli in un centro ustioni. Trovammo un solo posto presso l’ospedale Cardarelli di Napoli per mia madre, per mio padre all’ospedale S. Eugenio di Roma. La situazione si faceva ancora più critica, si viveva in un incubo. Nei giorni seguenti, ci dividemmo tra Napoli e Roma, sperando sia noi figli, sia tutto il paese che avvenisse un miracolo. Più i giorni passavano e più le speranze svanivano. Il cuore di mia mamma Gilda, dopo aver lottato tra la vita e la morte, per sette lunghi giorni, cessò di battere alle ore 7,30, il mattino del 12 Aprile 2002. Seguirono altri sei giorni di agonia per mio padre Carmelo: si spense alle ore 7,00, del mattino del 18 Aprile 2002 e con lui anche la speranza dell’intero paese. Dopo tre anni dalla terribile tragedia, sono riuscita a tornare, a Centola, al mio paese che porto sempre nel cuore, e in quella casa ormai chiusa per sempre, dove vi sono tutti i miei ricordi. Purtroppo, non è più come prima, anche se c’è tanto amore e affetto da parte della gente centolese che, ancora oggi, a distanza di dieci lunghi anni, mantiene vivo il ricordo di Gilda e Carmelo. 51 1985, Gilda Aceto con il marito Carmelo D’angelo. 52 Via Gelso, la casa dei Natale (dove si sviluppò l’incendio che provocò la morte di Gilda Aceto e di Carmelo D’angelo). 53 Aniello Errico PALINURO: COME ERAVAMO LA CHIESETTA DI SANTA MARIA DI LORETO Durante uno dei miei periodi trascorsi a Palinuro, purtroppo non frequenti, abitando nei pressi di Torino da quasi cinquant’anni, un giorno mi sono imbattuto in un gruppo di turisti che nel fotografare il campanile antistante l’attuale chiesa, si interrogavano su chissà quale catastrofico evento avesse potuto radere al suolo l’annessa chiesetta, lasciando in piedi il solo campanile. L’argomento mi incuriosì e mi intromisi nella loro curiosità, spiegando che ciò che stavano ammirando e fotografando non erano le conseguenze di un terremoto o di qualche tromba d’aria, bensì l’inconsulto e sciagurato risultato di un progetto approvato, pianificato e….non completato. Rimasi sorpreso anche dal fatto che, inaspettatamente, al gruppo di turisti, si erano aggiunti dei giovani palinuresi che ascoltavano con molto interesse, tra la curiosità ed il desiderio di saperne di più. Non mi meraviglia che, tra le ultime generazioni di palinuresi, sono quasi sconosciuti i fatti che determinarono la demolizione della vecchia chiesa di Palinuro, lasciando ai posteri quei pochi resti tuttora visibili. La nicchia che si vede attualmente era la nicchia centrale, sull’altare, e vi trovava posto la statua della Madonna di Loreto. La nicchia ed il campanile con la sottostante vecchia sacrestia è tutto ciò che resta della vecchia chiesetta di Palinuro, dopo che una notte iniziarono a demolirla. Non voglio entrare in fatti specifici o spiegare il motivo, anche perché forse…sarei di parte, ma per dare a Palinuro una nuova e più capiente chiesa, in molti hanno sempre sostenuto che non c’era bisogno di demolire quella esistente. Ma se si volessero conoscere i fatti, basterebbe chiedere a coloro che hanno all’incirca la mia età, oppure andare a consultare i documenti presso il Comune e ci si potrebbe fare un’idea non solo di come andarono le cose ma anche del perché siano rimasti quei pochi resti di una splendida, vecchia chiesetta. Ciò che invece vorrei raccontare è com’era fatta questa semplice ma accogliente chiesetta che per tanti anni aveva visto molte generazioni ricevere il battesimo e la cresima; aveva ospitato sposi per la consacrazione dei loro matrimoni; aveva dato il saluto ai palinuresi verso l’ultima dimora, lontano da Palinuro; aveva accolto i fedeli nelle ricorrenze più importanti, nelle feste più sentite e che in una nottata, era stata ridotta ad un cumulo di macerie e lasciata come la si vede adesso. 54 Nella nicchia che si vede ancora, troneggiava, come ho accennato in precedenza, la statua della Madonna di Loreto ai cui piedi si trovava l’altare, che è possibile ammirare ancora oggi nella nuova chiesa. Una balaustra in marmo separava l’altare dall’unica navata. Non c’erano banchi bensì sedie che ogni fedele aveva portato dalla propria abitazione, così com’era tradizione; in tal modo, involontariamente, si venivano a creare spontanei accorpamenti rionali per cui le sedie della zona Ficocella si trovavano accanto a quelle della zona di “Belluvirì”, mentre quelle della zona dell’Acqua dell’Olmo a fianco di quelle di S. Paolo, oppure quelli del rione di Via Aranci vicine a quelle di “Chianufaracchiu”. Le vicinanze erano fittizie, però, per cui spesso bastava spostare due sedia perché una fedele di S.Paolo venisse a trovarsi accanto ad una della strada del porto. Le sedie erano riservate alle donne, mentre gli uomini stavano in piedi, tutti in fondo alla chiesa. L’altare si trovava staccato dalla parete di fondo da un corridoio che andava dalla sacrestia all’abside e sui due lati erano poste le statue della Madonna Assunta e della Madonna Addolorata che venivano così a trovarsi in due nicchie laterali all’altare ma sulla stessa parete della nicchia centrale Sui lati della navata si trovavano quattro nicchie, due sulla destra e due sulla sinistra: entrando, sulla destra, c’era la statua di S. Antonio di Padova e nella nicchia verso l’altare, la statua del Cuore di Gesù. Sul lato sinistro nella nicchia più vicina all’ingresso c’era la statua di San Francesco, mentre nell’altra quella di S. Nicola. Alla base di ogni nicchia, un piccolo altarino consentiva ai fedeli di depositare un mazzo di fiori o appoggiare un pensiero di devozione . All’ingresso della chiesa, si accedeva dalla strada attuale, lato mare, oppure, se vogliamo, lato ovest; due gradini in marmo immettevano su un sacrato che dava accesso alla porta principale. Varcata la soglia della chiesa, si ci trovava sotto un palco in legno che correva da un lato all’altro della navata ed era profondo circa due metri, sorretto verso l’interno da quattro pilastri in legno che poggiavano dentro il pavimento. Questo era lastricato di mattonelle ceramicate di color terra di Siena, mentre sui bordi correva una striscia con altre mattonelle di colore più scuro. Sul lato sinistro dell’ingresso era sistemata una scaletta in legno a chiocciola, piuttosto angusta, con un corrimano alquanto levigato dal tempo, che portava alla parte superiore del soppalco dove era alloggiato l’organo, quello che attualmente è visibile sul lato destro dell’altare della nuova chiesa. Veniva suonato solo nelle festività solenni oppure nelle ricorrenze importanti, ed a suonarlo era solo una persona: il professore Luigi Merola. I ragazzini che frequentavano la parrocchia facevano a gara per tirare il mantice dell’antico organo, e capitava piuttosto spesso che l’arcigno sguardo del professore facesse capire, all’incaricato del mantice, che i giri di manovella non erano sufficienti a diffondere per la chiesa il giusto tono. A volte, prima di aprire alcuni toni, il professore si girava verso l’addetto al mantice 55 e: – Uaglu’ gira chiù fort’ chà già rap’ i toni! –, ed allora si raddoppiavano le forze, si avvicendavano le mani, si intensificavano i giri del mantice, ed il suono delle canne si diffondeva per la navata, riempiendo la chiesa, fondendosi con le vibranti voci dei palinuresi. In talune ricorrenze, poiché lo spazio per gli uomini sotto il soppalco era piuttosto angusto, alcuni salivano sull’organo e non si sottraevano all’incombenza di mantenere il mantice dello strumento sempre gonfio. Era toccante e spettacolare quando, la notte di Natale, il parroco intonava il “Gloria”: dopo un breve silenzio, la possente voce del professore Merola riprendeva la nota per continuarlo con l’accompagnamento, sulle note di “Tu scendi dalle stelle”. La risposta dei fedeli era inebriante, solenne ed impetuosa: non vi era un solo palinurese che non cantasse a squarciagola ma con un’intonazione, un’armonia ed una tonalità che solo i palinuresi sapevano esprimere. Oggi, a ricordare ai più anziani quelle forti emozioni, è rimasto un campanile ed una nicchia….., ai giovani si può solo raccontare, peccato! Palinuro, anni 1960, la chiesetta di Santa Maria di Loreto [prima che fosse inopinatamente abbattuta. 56 Giuseppe Gabriele UN CENTOLESE TRA I 5000 (SU 50.000) NO NEI CAMPI DI PRIGIONIA YANKEE Di recente, Arrigo Petacco, per i tipi della Mondadori, con”Quelli che dissero No”, ha ricostruito, con il rigore della mente e la sensibilità del cuore, la vicenda dei soldati italiani, sconfitti ad El Alamein e prigionieri degli Alleati. Gli Inglesi organizzarono campi in India, Australia, Africa Centrale e Meridionale; gli Americani sfruttarono le aree inospitali dell’immenso territorio statunitense. Nel corso della detenzione, i prigionieri assunsero posizioni diverse: i più accettarono di collaborare, una minoranza negò la firma alla collaborazione: cooperatori e non cooperatori. Per uno storico di professione, trattare questi argomenti è già una sfida. Per un anonimo familiare, la cosa assume risvolti ulteriori, ma soprattutto delicati. Al rischio di fraintendimenti e di gratuiti giudizi sul piano politico, entra in gioco la sfera personale, con ricordi, incomprensioni, emozioni, esperienza vissuta la cui intensità ognuno vuole custodire in se stesso. Dunque, non un intento agiografico, non la rivalutazione di un progetto politico fallimentare (chi scrive si riconosce ancora nella validità di un ritorno alla autentica lezione marxiana, liberandola da tutte le deformazioni marxiste più o meno opportuniste, più o meno barricadiere); solo il necessario ed onesto tributo di un figlio che ha conosciuto pienamente la vicenda politica ed umana del padre solo dopo la sua scomparsa, padre, peraltro, con il quale ha condiviso momenti di gioia familiare, ma anche e soprattutto fasi di disobbedienza e di opposizione. Nonostante le testimonianze numerose di reduci direttamente coinvolti, la vicenda dei prigionieri non collaboratori nella realtà concentrazionaria statunitense risulta ancora oggi evitata e taciuta. Si preferisce affidarla alla estinzione con la morte progressiva dei sopravvissuti. L’aspetto delicato e significativo della questione non è la ricostruzione, certamente importante, della diaspora degli sconfitti di El Alamein né la ricomposizione della ragnatela concentrazionaria in territorio americano o l’applicazione del principio del bastone e della carota anche ai prigionieri di guerra. Occorre, invece, capire le ragioni del no a qualunque costo. Ragioni molteplici, non semplicisticamente riconducibili al fanatismo cocciuto verso il Fascismo. Molti non collaboratori erano fascisti convinti ed irriducibili. 57 Ma, tra i non collaboratori, tanti fascisti non erano mai stati o, strada facendo, non lo saranno più e non lo sarebbero stati al rientro, diventando anche militanti di sinistra. Tutti, però, erano soldati ed essere fascisti per loro significava, innanzitutto, essere italiani. Coerenza militare ed orgoglio nazionale. Obbedienza a valori morali prima ancora che politici. Mio padre, di tanto in tanto, squarciava il suo passato, diceva e non diceva, poi rinunciava, convinto, e non a torto, di non essere adeguatamente creduto. Qualche passaggio è rimasto impresso: le due fettine di pane e carote come razione quotidiana, le randellate a sorpresa anche nel corso della notte, le sfottiture sguaiate nei confronti delle donne di famiglia, l’ultimo periodo più sereno nei campi delle Hawaii, il viaggio di ritorno con una vecchia nave nell’Atlantico, l’arrivo a Napoli ed il congedo con il timbro preclusivo ed ostativo di “non collaboratore”, l’ultimo tratto da Napoli a Centola Scalo, la donna di Centola che lo riconosce alla Giardina e corre ad avvisare i genitori… Nei momenti difficili, diventava ostinato, spesso intrattabile. Non era uno sprovveduto, ma non era un intellettuale, non poteva ragionare sui massimi sistemi ed autocriticamente ravvedersi. Era figlio della medio feudo-borghesia di una lontana provincia; era nato ad inizio Ventennio, si era riconosciuto in quell’entusiasmo fino ad arruolarsi, forse, volontario. Volle sognare, sognò maldestramente, ma sognò. Il dovere del sogno lo condividiamo, il suo sogno lo respingiamo con il nostro sogno. Oggi, non sogna più: riposa nella quiete del cimitero di Terradura; gli è accanto Emilia, irrinunciabile compagna di speranze e delusioni. Si chiamava Gabriele Domenico, era nato a Centola il 2 aprile 1921, morto nella casa di riposo Divino Amore, di Torchiara, il 16 luglio 2010; P.O.W. (prisoner of war) 4WI 17017, come si ricava da una cartolina militare miracolosamente rinvenuta nel disordine della sua vecchia scrivania. 58 Guerra 1940-45, Mimì Gabriele, primo a sinistra, in piedi [fatto prigioniero in Libia, nel corso della ritirata. Passò un periodo in un campo di prigionia USA, alle Haway]. 59 Mimì Gabriele scrive dalla prigionia, da un campo nel Pacifico, alle zie Falcone. Cartolina scritta il 16-01-1944, partita dagli USA nel febbraio del 1945, arrivata a Terradura, il 20 03 1945. 60 Cleonice Gambale IL FANTASMA Nei primi anni del novecento, un signore di Centola, che di mestiere faceva il contadino, si sposò ed andò ad abitare in una casa donatagli dal padre. La casa era in via S. Sebastiano, aveva una stanza, una cucina e una soffitta. Vi portò la sposa, ma già la prima notte di nozze si accorse che qualcosa di strano accadeva in quella casa. Infatti, quando gli sposi si apprestarono ad andare a letto, la candela, che avevano accesa, si spense da sola e, una volta coricati, le coperte gli venivano tolte di dosso. La sposa incominciò ad avere paura e quella notte passò senza che il matrimonio venisse consumato. La notte dopo, successe più o meno la stessa cosa, ma con il passare del tempo gli sposi si abituarono a quella situazione e finalmente riuscirono a coronare il loro sogno d’amore. Gli anni passavano in fretta e tutte le notti e tutti i giorni succedeva qualcosa. La porta, se era aperta, veniva chiusa; la candela, se era spenta, veniva accesa; sulle scale che portavano in soffitta si sentivano passi di qualcuno che saliva o che scendeva. Questo fantasma era anche burlone, perché, se la donna cucinava, le slacciava il grembiule, oppure le spostava i piatti. Passò tanto tempo, la pazienza e lo spirito di sopportazione del contadino si erano esauriti. Una notte non ne poteva più, si mise a sbraitare contro il fantasma e decise di fargli dire una messa. La notte successiva non successe nulla e così i giorni a venire. Finalmente il fantasma era andato via. La storia però non finisce qui perché, dopo qualche mese, il contadino sogna un monaco che gli rivela di essere il fantasma e gli chiede scusa per tutto il disturbo che gli aveva arrecato in quegli anni. Gli spiegò anche che quella era la punizione che gli era stata data per un peccato commesso e che avrebbe trovato pace solo quando un vivente gli avrebbe fatto celebrare una messa. Per farsi perdonare gli rivelò dei numeri da giocare al lotto e la ruota su cui giocarli. 61 In quegli anni, per giocare al lotto, bisognava andare a Salerno poiché in provincia non esistevano ricevitorie. Il contadino aveva un amico che quotidianamente si recava a Salerno per lavoro. A lui chiese il favore di giocargli i numeri e gli diede i soldi della giocata. Purtroppo, però, questo suo amico amava giocare a carte e la sera stessa, invitato da altri amici, andò a giocare. La serata non fu di quelle fortunate e finì per perdere non solo i suoi soldi ma anche quelli che il nostro contadino gli aveva dato per giocare i numeri al lotto. Dopo una settimana il contadino sognò di nuovo il monaco che lo rimproverò dicendogli: – Io ho cercato di sdebitarmi, dandoti dei numeri da giocare al lotto, ma tu non hai saputo approfittare della fortuna. Scoprì così che i suoi numeri erano usciti e anche sulla ruota che gli aveva indicato il fantasma e che però il suo amico non li aveva giocati perché aveva perso i soldi a carte. Finì così una grande amicizia e i due si riappacificarono soltanto dopo che il passare degli anni aveva reso meno dolorosa la delusione per la mancata vincita. La storia è vera, il fantasma non so. Io non ci credo e voi? Centola 2012: Vedute di Via San Sebastiano. 62 Michele Gambardella SFIDO CHIUNQUE! Nell’aria si respirava la pioggia e l’odore dei caminetti. A Centola, come tutti i pomeriggi di sempre, i giovanotti mettevano in pratica l’arte della scopa, briscola e tressette. Il caffè di “zì Vito” era il tempio del gioco delle carte e “zì Vito” il sacerdote. Le regole, le tattiche e le strategie di gioco, tramandati da padre in figlio, si rispettano ancora. E quando vi è un dubbio o una disputa su una giocata, basta dire, oggi come allora: “Lo ha detto zì Vito. Ipse dixit!”. Zì Vito, nonostante la sua non più tenera età, era dinamico e sempre pronto alla battuta. Si considerava il padre putativo di quei ragazzi che lo adoravano. Amava la musica e le opere teatrali. Si vantava di essere stato molte volte al San Carlo quando, da giovane, a Napoli, aveva prestato il servizio militare. A volte, se era felice (spesso capitava dopo una partita vinta o durante una brillante giocata), amava canticchiare a mo’ di sfottò: –…Ridi pagliaccio, sul tuo “onore” infranto! Ridi del duol, che t’avvelena il cor! Naturalmente i ragazzi frequentavano il caffè all’insaputa dei loro genitori, e avevano sempre il timore di essere scoperti, sorpresi con le carte a giocare. La tensione era sempre alta, quasi palpabile, e al solo pensiero che potesse entrare all’improvviso il padre di qualcuno, giocava loro brutti scherzi. Alfredo e Gino lo sapevano bene. Assidui frequentatori, temevano la stessa cosa. *** Il piccolo locale, quattro metri per quattro, aveva due porte. Una che dava su Via Imbriaco e l’altra, spesso utilizzata come via di fuga, per chi in quel posto non voleva farsi trovare, dava su Via Sole. Da una parte il bancone e dall’altra la sala e sulla sua parete, in alto, un poster gigante. E sul poster il busto di un uomo girato di 45°, con cappello a larghe tese in testa e sigaretta tra le labbra. Nel pugno, le carte in evidenza e, sotto, la scritta a caratteri cubitali: Sfido chiunque! Nell’angolo di fianco al bancone, una piccola voliera con un passerotto. 63 La voliera era sempre aperta e il passerotto entrava e usciva a suo piacimento. Quando al mattino zì Vito distribuiva la posta, il passerotto, dall’alto del cielo o sui tetti delle case, lo seguiva passo passo. Bastava un suo fischio per farlo scendere. Zì Vito sapeva ottenere quello che voleva dagli animali e aveva addomesticato quel piccolo uccello che portava sempre con sé, sotto la giacca, nel taschino interno. Nell’altro angolo, l’ultimo ritrovato della tecnica. Una radio a soprammobile. Una Radiola 60 della RCA, 27 valvole. Lussuosissima. Zì Vito ne andava fiero. – Produzione americana! – amava ripetere. Da quelle casse acustiche le partite di calcio illustrate da Niccolò Carosio erano come proiettate. Le immagini si stampavano nella mente ed era come essere lì, allo stadio, ad assistere alle partite. *** La primavera del 1934, tutti i giorni, Alfredo, Gino, gli amici tutti erano lì, in quel caffè, con le orecchie protese all’altoparlante, a fare il tifo per gli undici beniamini che si batterono per il titolo mondiale di calcio, la coppa del mondo Jules Rimet. Il 10 giugno, ci fu grande festa: l’Italia per la prima volta campione del mondo! Zì Vito offrì da bere. Stappò una bottiglia e la mise a disposizione di tutti. Quel giorno ebbe una doppia soddisfazione. La vittoria della Nazionale Italiana, ottenuta con uno strepitoso goal, ai supplementari, di Angelo Schiavio, 2 a 1 contro la Cecoslovacchia, e la ventiduesima edizione del giro d’Italia, vinta dal suo idolo, Learco Guerra, la locomotiva umana. Tutto nello stesso giorno! La sua gioia era incontenibile anche perché lì, tutti gli altri, tifavano per Alfredo Binda. Si abbracciarono e festeggiarono per tutto il pomeriggio. Non si giocò a carte. *** Il pomeriggio del 27 novembre, il piano di Alfredo e Gino era pronto. I loro scherzi erano famosi. Memorabili. Non lasciavano nulla al caso. Pianificavano tutto, anche i minimi dettagli. Era come un’arte. Studiavano l’obiettivo da colpire, scoprivano i punti deboli, i timori, le paure più nascoste. Si prendevano tutto il tempo necessario per ottenere l’effetto desiderato, per scatenare il pandemonio. Questo era il loro segreto. 64 Avevano così individuato l’obiettivo. La vittima sacrificale. Il caffè era in piena attività. I tavolini erano immersi nel fumo delle sigarette che come una gigantesca nube li avvolgeva tutti. Fuori, l’odore amaro del tabacco e quello del caffè appena tostato, il bagliore della luce del sole al crepuscolo si rifletteva, rimbalzando sull’aria umida, la radio in sottofondo cullava la loro serena monotonia … Achille Tognani cantava “…che mai sarà di me? Non domandarlo perché …”. Il momento di agire era arrivato! Lo aspettavano da tempo. Nella loro mente, avevano visto e rivisto la scena mille e mille volte ancora. *** Filippo era un giovane gracile e timido. Loro coetaneo e anche amico. Lo conoscevano bene e soprattutto sapevano benissimo chi temeva più di ogni altro al mondo: aveva una paura fottuta del padre! Temeva di disubbidire alla sua volontà! E lì proprio non ci doveva andare. – Quel posto non fa per te! – glielo aveva raccomandato tante volte. Ma il gioco delle carte gli piaceva proprio. Era uno degli allievi preferiti di zì Vito. Con lui a compagno qualche volta vinceva pure. Perché zì Vito, nonostante la sua chiara competenza, quando giocava con quei ragazzacci, perdeva quasi sempre. Erano d’accordo a farlo perdere, perché godevano nel vedere le sue sfuriate quando il compagno sbagliava. Tutti d’intesa, tre contro uno. Filippo era l’unico del gruppo che non ci stava proprio a perdere. Quando era a compagno con zì Vito, non cedeva quasi mai alla tentazione di sbagliare solo per il gusto di vederlo nelle sue drammatiche e comiche interpretazioni: piroette verbali, acrobazie lessicali! Forse, pure per vendetta Alfredo e Gino avevano strutturato il piano per Filippo. Era il punto debole da colpire. *** Alfredo e Gino avevano tutto l’occorrente per bloccare l’uscita secondaria. Avevano una specie di gancio. Un arnese che avevano costruito da soli, utilizzando due vecchi anelli di ferro, quelli utilizzati per legare i cavalli e gli asini. Se ne erano procurati due: uno più grande e uno più piccolo. I due anelli, tenuti assieme da un pezzo di ferro, formavano lo strumento che i due utilizzarono per bloccare dall’esterno la porta del caffè che dava su Via Sole. 65 L’anello più piccolo serviva per essere agganciato alla maniglia, mentre quello più grande entrava perfettamente nel pomello, sull’anta fissa della porta. Una volta agganciati, pomello e maniglia, diventava impossibile aprire la porta. Le prove erano state fatte. *** Nel caffè, tutti concentrati a giocare, non si sentiva fiatare una mosca. Solo la radio “… come una stella cadrò e forse un dì nel nulla tornerò …”. Gino, si precipitò nel locale e, con la faccia nera di chi porta messaggi di morte, sciagure imminenti, puntò diritto al tavolino, dove zì Vito e Filippo giocavano a compagni. Chinandosi, sussurrò nell’orecchio di Filippo, ma non tanto da non farsi sentire anche dagli altri: – Filì, sta arrivando tuo padre..! Poi, subito, lasciò il caffè dalla porta su via Sole e, appena fuori, agganciò l’arnese infernale al pomello e alla maniglia. Bloccando la porta. Dentro, improvvisamente, non si respirò quasi più. L’aria divenne pesante, come se si fosse fermato il mondo. Gli occhi sgranati, le pupille dilatate, gli sguardi che si incrociavano. Le orecchie tese a percepire il minimo rumore. L’adrenalina a mille! Neanche il tempo di riflettere che, con un sincronismo perfetto, toc toc, si sentì all’altra porta. Tra le quattro mura, centesimi di secondo, il terrore e poi il finimondo. Tutti, fatta eccezione per zì Vito, scattarono in piedi e si precipitarono verso la salvezza. La porta bloccata non resistette all’urto violento di quei ragazzi. Il boato fu enorme. Caddero uno sull’altro, tutti sulla porta divelta. Il caffè sventrato sembrava essere stato visitato da un uragano. I tavolini con le gambe all’aria, le carte disseminate per terra e qualche tazzina di caffè in frantumi. Il passerotto come impazzito si lanciava in picchiata da un lato all’altro del piccolo locale, sbattendo contro le pareti. Alfredo entrò e, candidamente, come chi viene da un altro mondo, rivolgendosi all’uomo, sbalordito nel vederlo, domandò, con l’ingenuità tipica di un bambino: – Ne zì Vì, ma che è succiesu? Fu in quell’attimo, in quel preciso istante, che nella mente dell’uomo si materializzò il brutto tiro che quei due gli avevano giocato! Mentre alla radio “… amor, amor, portami tante rose, scegli le più spinose …”. 66 *** Alfredo e Gino ritornarono al caffè di zì Vito solo a Natale. Con l’aria implorante perdono, dimessi e a capo chino, portarono gli auguri a zì Vito. L’uomo, vedendoli arrivare, si commosse. Allargò le braccia e come se niente fosse successo, li strinse forte al suo petto. Era come il ritorno del figliol prodigo. Il ritrovamento della pecorella smarrita. Li accolse con la consapevolezza del padre che accoglie quel figlio che tanto lo ha fatto soffrire. Con la saggezza del vecchio che sa che quella è solo una stagione della vita e che presto svanirà. In fondo in fondo, anche a lui lo scherzo era piaciuto … 67 Centola, inizio di via Serra, Teresa Greco con il marito Antonio Lupo e Giuseppa Scarpa, innanzi alla bottega di generi alimentari (agosto 1984). Alle spalle di questa bottega era situato il caffè di Vito Serva. 68 Vito Serva “Zì Vitu” (fu anche, per molti anni il postino di Centola). 69 Francesco Guglielmelli … E LA GALLINA PAGÒ IL CONTO Antefatto A Centola, nel dicembre del 1931, muore prematuramente don Carmelo Speranza, figlio unico di don Gioacchino Speranza, lasciando nella disperazione e con una montagna di debiti la moglie Teresina, quattro figli maschi (tra cui Gaetano) e tre femmine (tra cui mia mamma Iolanda). Da bambino, ho vissuto con molte di queste persone, delle altre ho sentito tante storie, zeppe di particolari, al punto che, pur non avendole mai conosciute e viste, è come se con loro avessi mangiato, bevuto e vissuto insieme. Una di queste persone è sicuramente don Gioacchino Speranza. A quell’epoca, già abbastanza anziano, abitava al “Campanaro”, attuale Via Gelso, e veniva dipinto da tutti come un grande fifone, al punto che, quando suonava la campana “a morto”, lui si chiudeva in uno stanzino, serrava tutte le imposte e con le mani si tappava con forza le orecchie, per non sentire i rintocchi. La morte del figlio, poi, aveva accresciuto di molto questa sua paura, al punto che, quando volevano prenderlo in giro, bastava paventare un morto perché lui corresse anzitempo a sigillarsi nel suo stanzino. Si viveva anche di questi scherzi … e non solo. Un esempio piccolo, in questo breve racconto. ***** Eravamo in prossimità della Pasqua del ’32, e, come si sa, i galli erano, come tuttora, i sacrificati principali per il pranzo della festività. Galli e galline, a quei tempi, non si trovavano solo nelle campagne, ma la loro dimora era molto spesso in qualche spazio sotto casa, per cui pascevano liberamente per le vie e dentro casa, beccando a destra e a manca, proprio come fossero di casa. Alla pulizia degli ambienti, specie quelli del piano terra, si provvedeva poi con delle scope di erica, dato che poche abitazioni avevano il pavimento, più spesso avevano un lastricato in calcina o in terra battuta. In questo contesto maturò l’evento che avrò sentito raccontare centinaia di volte, e che, per questo, mi sento quasi in obbligo di tramandare per non farlo morire. Come detto, eravamo sotto Pasqua, e nonna Teresina aveva venduto un gallo per una manciata di centesimi. Donna Maria, sapendo che quei soldi servivano, eccome, s’era affrettata a ripassare per saldare il debito. Non trovando mia nonna, li lasciò a don Gioacchino, che, non sapendo dove metterli, perché i suoi pensieri erano 70 altri, li poggiò sulla “focagna”. Zio Gaetano, che fin da ragazzo era capace di fiutare l’odore del denaro a miglia di distanza, appena vide donna Maria che scendeva le scale, svoltò in un angolo, girò per un altro vicolo e, come un falco, piombò in casa. Poi, senza farsi vedere dal nonno, cosa peraltro molto semplice, rubò i soldi e, con piede felpato, si allontanò. Una mezz’oretta dopo, fischiettando e facendo del tutto per farsi sentire e notare, ritornò verso casa e, prima di salire gli scalini d’ingresso, chiamò a voce alta e con tono allarmato don Gioacchino: – Nonno, nonno la gallina rossa teneva un soldo in bocca! Lo sguardo di don Gioacchino andò subito sulla “focagna”, in cerca dei “suoi” soldi. Non trovandoli, razionalizzò il disastro. Uscì sulla porta e, con le mani alzate come un Cristo, e con tutta la voce che teneva in corpo, tuonò: – Teresina, Teresina la gallina rossa s’è mangiato i soldi che ha portato donna Maria. Prendila subito. Ammazzala! Poi, senza abbassare il tono, girando in tondo, ripeteva senza sosta: – Che disastro … che disastro … che disastro… Nonna Teresina non era molto distante, ma anche se lo fosse stata non avrebbe potuto non sentire quel grido che era imprecazione, disperazione, rabbia, … era tutto un mondo. Così, con calma e con pazienza, e forse inizialmente anche con un po’ di convinzione, acchiappò la gallina rossa, le legò le zampe, mise a bollire l’acqua, e quando tutto fu pronto, fu “sacrificata” pur non avendo nessuna colpa.. Zio Gaetano, ovviamente, partecipava attivamente e con zelo a tutte le macabre operazioni, dispensando anche qualche consiglio e non celando una buona dose di costrizione. Don Gioacchino, al contrario, non volle vedere niente. Disse solo: – Teresina, mi raccomando, i pezzi falli molto piccoli, se no rischiamo di non trovare i soldi. Nonna Teresina non dovette aspettare la fine di quel minuzioso, chirurgico intervento per capire che i soldi non li avrebbe trovati mai. Dopo un primo momento di spontanea ingenuità, aveva capito subito in fondo a quale tasca erano finite le monete, ma il cuore di mamma le suggeriva che doveva far finta di crederci, almeno fino a quando quell’evento “vero” e per certi versi “tragico” poteva essere tranquillamente raccontato durante le fredde sere d’inverno, davanti ad un bel fuoco scoppiettante, in compagnia di una bella “vruula” di castagne. Così lo appresi tanti tanti anni fa, dalla voce carezzevole di mia nonna Teresina, e così lo dono a chiunque crede che quel mondo, per quanto povero, difficile e tragico, merita comunque di non essere dimenticato. 71 Francesco Guglielmelli L’ATTESA Nicola il contadino con la cravatta Seduto sulla parte fuori terra di una contorta radice di un ulivo secolare, Nicola r’Anella attendeva. Al suo fianco, sopra un ciuffo d’erba verde, era poggiato il suo solito grosso bicchiere col manico, non sporco, ma incrostato di una patina color rosso vinaccia. Di fronte, a poca distanza, un vitellone legato ed impastoiato veniva preparato per il macello. Dalle colline di Caprioli, il sole, prossimo al tramonto, gettava gli ultimi raggi sul prospetto retrostante delle case di Via Giardina, laddove un tempo era il campo di pallone di Centola capoluogo. Ad un tratto, la resistenza estrema dell’animale vibrò nell’aria, mentre tre uomini, maneggiando funi e catene, come marinai con i velieri, quando il mare è in tempesta, immobilizzarono la bestia. Una mosca, spostata da tanto impeto, andò a posarsi diritta sul mento di Nicola che si destò. Nicola r’Anella era un uomo sulla sessantina, né alto né basso, magro e asciutto, che non rinunciava mai al cappello, né tanto meno ad una cravatta nera dal nodo consunto, e ad un panciotto, sempre nero, alla cui asola centrale aggrappava un orologio da taschino. Con la mano scacciò la mosca, e con calma prese tabacchiera e cartine, e in religioso silenzio si preparò una sigaretta col “trinciato forte”, l’accese, poi si alzò, si stiracchiò e si aggiustò il cappello, scoprendo di più la fronte pensierosa. Un silenzio improvviso fermò l’aria, e il più anziano dei tre, con colpi e movimenti precisi, come quelli di un chirurgo alle prese con una operazione difficile, mise fine alla vita dell’animale. Un raggio di sole, penetrando i rami, si stampò sull’occhione sinistro del vitello che si velò. Nicola buttò il fiammifero, posò in una nicchia del tronco d’ulivo la sigaretta accesa, si piegò, prese il bicchiere col manico e, senza dire una parola, pose fine all’attesa. Riempì il bicchiere da dove la vita usciva a fiotti e, in piedi, senza alcuna pausa, bevve l’intero calice, quando il tutto era ancora fumante. Poi con calma riprese la sigaretta e, come niente fosse, aspirò lungo e liberò una boccata di fumo con la stessa poesia di un treno a vapore. A Nicola, il contadino con la cravatta, avevano insegnato che il sangue degli animali allunga la vita agli uomini. E ne era fermamente convinto. 72 Francesco Guglielmelli UN VIAGGIO NEI RICORDI Un giro nel Cilento, dove la Campania tocca i monti lucani e si tuffa nel mare di Enea, porta a dover percorrere strade strette e tortuose, fra paesini aggrappati alle rocce e rocce aggrappate ai paesi, dove tutto è abbandono, dove tutto è silenzio … e dov’è pure il mio paese: Centola. Qui, una civiltà, quella contadina, è al tramonto. Qui, un modo di vivere merita memoria. Sudore, lacrime e sacrifici hanno scolpito come pietre “sagome” contadine che, nonostante tutto, cercano di non fermarsi, rendendosi ancora utili nei campi, fino alla meritata pensione, che spesso viene vissuta più come un premio che come un sacrosanto diritto. Il declino dell’agricoltura ha radici lontane. L’emigrazione, prima, l’industrializzazione, dopo, hanno spostato l’interesse delle forze produttive verso mondi nuovi e lavori diversi. L’agricoltura, abbandonata a se stessa, non ha retto e la civiltà ad essa legata è sul viale sbiadito del tramonto. Rafaele, asciutto come una alice salata, ha dedicato tutta la sua vita al lavoro a mezzadria. Non ha mai indossato un cappotto. Passa tutte le sue giornate a coltivare un fazzoletto di terra comprato dopo tanti sacrifici. Appoggiato ad una mazza che usa come bastone, racconta di quando, dopo giornate di duro lavoro, sotto l’acqua o sotto il sole, aspettava come un premio la sera, che passava con gli amici “alla cantina”, a bere, giocare e dimenticare. Dal suo viso scarno e asciutto non esce una parola, ma emerge con chiarezza un monito: “… non avevo nulla, eppure non mi mancava mai niente”. Attraversare, oggi, il Cilento, per arrivare a Centola, è vedere campagne abbandonate, piante secolari aggredite e vinte dai rovi, paesi deserti, spopolati, snaturati da ristrutturazioni senza vita e senza anima. Penetrare queste zone è saper ascoltare il silenzio, è capire quella sottile e lenta agonia che piano piano, adagio adagio si infila in tutte le cose; è non dimenticare. Mauro ha ottantatrè anni, barba lunga e bianca: sembra uscito dalla Bibbia. Vive notte e giorno in campagna, isolato dal mondo, a cui però si collega con una radiolina a “transistor” che gli hanno portato di recente i nipoti dall’America. Viene in paese solo per acquistare le batterie per la radiolina ed i fiammiferi per accendere il fuoco. Non ritira la pensione perché ritiene che non sia sua. Ultimamente parla 73 pochissimo: è depresso: gli è morto l’asino. L’estate a Centola è una esplosione di colori. L’inverno, di contro, induce alla malinconia. I giovani che vivono con apprensione e paura la crisi occupazionale, guardano, oggi, con rinnovato interesse al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, convinti che il turismo sulla costa e l’agricoltura di “nicchia” nell’entroterra potrebbero, coniugandosi, avviare un nuovo processo produttivo capace di dare lavoro e rilanciare l’economia. Michele, giovane neolaureato, coltiva a tempo pieno il vigneto di famiglia, sognando un vino da esportare con una propria etichetta. Chiuso nel suo giubbotto verde scuro, sguardo rivolto al mare dove il sole è prossimo al tramonto, si domanda, quasi socchiudendo gli occhi in una specie di dolce sogno: “L’agricoltura può esistere senza i contadini?”. Poi, accendendosi una sigaretta e riprendendo il filo dei propri pensieri, si chiede ancora: “L’agricoltura può esistere senza la capacità di soffrire, di assecondare i ritmi delle stagioni, senza l’umiltà di ascoltare i vecchi, senza la capacità di sentire i colori e vedere gli odori?”. Il Cilento è tutto questo, ed altro ancora. Il Cilento è … una sfida con se stessi. I giovani potranno vincere se sapranno portare a nuovo giorno la civiltà contadina, ri-scoprendola, ascoltandola, e rinnovandola, senza l’illusione di poterla dimenticare. Resta sempre una civiltà che ha saputo superare momenti storici difficili, puntando non tanto sulla quantità dei propri prodotti, ma sulla profondità dei propri sentimenti. Ormai è sera. Filumena, seduta come sempre davanti alla porta di casa, vede Rafaele che, rientrando con passo stanco verso casa, non porta il solito “panaro” al braccio, ma, stranamente, una sedia nuova di zecca. Filumena lo guarda con sospetto, e lui, senza attendere la domanda, si lascia andare alla risposta: – Serve … serve Filumè. Quando muoio, la gente che viene deve potersi almeno sedere. 74 Francesco Guglielmelli PETALI DI ROSA Con l’introduzione della scuola dell’obbligo (riforma scolastica del 1963), finisce il ciclo della Scuola di Avviamento, ed inizia quello della Scuola Media; finiscono le classi mono-sesso, nascono le classi miste. Inizia dappertutto, quindi anche a Centola, una nuova era, nasce una nuova generazione, quella tecnologica, chiamata a saper interpretare nuove sfide che pongono al centro un “uomo” capace di coniugare ragione e sentimento; capace di navigare verso lo spazio ignoto e allo stesso tempo emozionarsi dinanzi alla luna che si lascia accarezzare dal mare; che sappia guardare senza paura alla propria dimensione interiore, anche quando questa porta in sé dolore, sofferenza, e sembra che tutto intorno crolli e non resta altro che calpestare piccoli, minuscoli, innocui … petali di rose. In questo paesino del Cilento, in una piccola aula posta al secondo piano di un edificio privato, adibito a scuola, Andrea, tredici anni compiuti a marzo, seduto all’ultimo banco di una delle tre file, quella adiacente alla parete d’ingresso, era teso e nervoso, e, con lo sguardo nel vuoto, raccoglieva i suoi pensieri. Fuori, c’era il sole e, nonostante fosse maggio inoltrato, il tepore estivo tardava a venire. Dall’unico balcone, posto al centro della parete frontale all’ingresso, entrava poca luce, e la stanza più che un’aula sembrava la sacrestia di una cappella conventuale. Dentro, comunque, c’era aria di vacanze. Andrea, seduto, con le spalle poggiate al muro, sapendo che certamente sarebbe stato interrogato, si ripassava mentalmente il programma di storia: non era per nulla tranquillo. Nel banco davanti, sedeva Giusy. Giusy, diminutivo di Giuseppina, era fra tutti la più vivace e non perdeva occasione per mettere in evidenza le sue giovani e tenere forme che, anche se acerbe, già lasciavano presagire le delizie della maturazione. Andrea ne era teneramente innamorato, ma non trovando il coraggio di dichiararlo, metteva petali di rosa fra le pagine di un libro che le chiedeva in prestito, per poi restituirlo dopo poco. Quel giorno, non lo fece. Continuava a pensare e a sprofondare nei pensieri della più che probabile interrogazione. Si destò solamente quando il professore di storia lo chiamò alla cattedra, scandendo nome e cognome. Moliere, questo era lo “strano” nome di questo “strano” professore. Minorato sin dalla nascita, aveva delle protesi sia agli arti inferiori che a quelli superiori, tanto che il suo muoversi era simile a quello di un robot. Completava la “figura” un volto butterato 75 nel quale spiccava, come un cattivo presagio, l’occhio sinistro, vitreo. Dei sentimenti nemmeno l’ombra. Andrea si alzò di scatto e, con passo pensieroso e dondolante, raggiunse la cattedra. Pose il fianco ai compagni e fissò la lavagna che teneva di fronte, su cui, della data parzialmente cancellata si leggeva bene solamente l’anno: 1966. Con gli occhi sul professore, cercò il “paterno” che vi era, o meglio che avrebbe dovuto esservi in ogni buon maestro. Addosso avvertiva lo sguardo curioso di Giusy, come di una che vuol capire se quel ragazzino poteva diventare davvero il suo primo bacio. Tre domande, tre trappole, tre pugnalate. Nessuna risposta, nessun aiuto, nessuna carezza. Il professor Moliere si alzò e, col piglio di chi ha vinto disse: – Vai, anzi vieni a settembre! –. Andrea sprofondò. Lasciò il corpo lì, a terra, e portò a sedere i vestiti, in fondo, nell’ultimo banco. Al suono della campanella, tutti si precipitarono fuori. Andrea, triste, si attardò. Dopo un po’ si alzò, prese dalla tasca i petali di rosa, li buttò a terra, li guardò per un attimo, poi, con rabbia, li schiacciò e si decise a scendere lentamente gli scalini contandoli uno ad uno. Alcuni componenti della famiglia Speranza: A sinistra, Gaetano Speranza senior. A destra: I fratelli, Gioacchino (sinistra) e Feliciano Speranza. Feliciano era un famoso pasticciere. 76 Centola, anni 1930, veduta da ovest. Centola, loc. Giardina: Processione della Madonna di Pompei. 77 Vincenzo Lamanna VENTI LIRE Avevo 10 anni. Correvamo scalzi nei vicoli, imitavamo con le braccia aperte il volo delle rondinelle. Le magliette di bianco cotone erano madide di sudore delle corse gioiose. Tutto aveva senso. Le cose erano animate, facevano parte del nostro vivere. Le mura rigate dal nero delle età non erano mute. Conservano ancora gli echi della nostra innocenza di bambini allegri che giocavano a bandiera nella piazza di San Nicola. Era un giorno di ottobre. L’odore del mosto delle cantine lo sentivi frizzare nell’aria e ci rallegrava come il sapore arcigno dei marroni. Mi sentii chiamare da Carmine, detto Minucciu, l’amico della mia infanzia con cui giocavo. Mi ricordò che martedì arrivava in piazza Imbriaco il camion di mattoni della signora Giovanna. Un mese prima, nella bottega di mastro Ciccio , avevo visto, nella vetrina, degli scarponi neri, di pelle morbida e liscia, con una lanugine bianca. Solo a guardarli sentivo un tepore ai piedi. Le nostre scarpe comuni erano cucite a mano, di cuoio traforate. Il freddo lo sentivi pungere con i suoi aghi di gelo, e l’acqua delle pozzanghere facilmente bagnava i calzini rattoppati da nonna Teresa. Quelle scarpe erano il mio sogno. Potevo correre per le vie anguste senza sentire freddo, nell’inverno quasi vicino, ma costavano 200 lire e mio padre non poteva comprarle. Non c’erano soldi a sufficienza, si viveva alla giornata. Mio padre, per guadagnare poche lire, doveva lavorare in campagna e battere il ferro per foggiare gli arnesi del lavoro, con mio nonno, da portare alla Fiera di San Francesco. Nella vetrina erano esposti solo tre modelli di scarpe, fatte a misura per l’età . I colori erano due: il marrone e il nero. Sognavo di averle, ma nello stesso tempo comprendevo la mia illusione di non poterle comprare. Ci rassegnavamo facilmente, bastava il sapore di un chicco d’uva e l’amarezza si stemperava in una corsa o in una “partitella” a calcio. L’illusione la gustavamo come il velo acre della melagrana che racchiude gli arilli rossi. Il giorno dopo, “Minucciu” mi ricordò che l’arrivo dei mattoni era rinviato a venerdì. La settimana passò in fretta e il camion arrivò di pomeriggio. Sembrava un ippogrifo con il suo carico ocra. Eravamo lì, nel piazzale, ad aspettarlo con quell’ansia che ti saliva in gola. Giuseppe, il figlio di Carmelina, fece da capomastro, ci divise in squadre: Aniello, detto “petto d’acciaio” per la sua robustezza, doveva scaricare il ferro e il cemento, noi i mattoni: prima i doppi, poi i singoli. Me lo ricordo tarchiato e buffo, come se mi fosse vicino. Aniello era tutto coperto di polvere grigia, sembrava un pesce infarinato. Sollevava i sacchetti come se fossero pieni di pannocchie, senza 78 gemiti. Poi scaricò il ferro. Toccò a noi scendere i mattoni che ci passavamo in riga, per posarli in pile parallele. La fatica si faceva dura, ma non potevamo lamentarci o andarcene. La padrona, a detta di tutti, pagava bene, ma voleva il servizio completo. Trattenevamo nel cuore il dolore delle ferite dei bordi taglienti dei mattoni. Continuammo a scaricarli e passarli fino a quando, a sera, il camion fu completamente svuotato. La mia schiena era piegata e dolente, nonostante la stanchezza, mascheravamo bene tutto. Ci parlavamo con gli occhi, aspettandoci la nostra paghetta per il lavoro fatto. Ci sentivamo stanchi, ma eravamo soddisfatti del “trasloco”. Ci recammo a casa di Carmela per avere la giusta ricompensa. La vedemmo con il viso torvo, quasi lesinava la nostra paghetta. Pensò di interrompere quell’atmosfera greve e di offrirci un bicchierino di anice. Poi, contrita, mise la mano nella tasca del grembiule a fiori ed estrasse un portafoglio con le borchie dorate. Ci radunò a cerchio e, chiamandoci uno per uno, ci pagò. La mia sorpresa fu di trovare nella mia mano una moneta di 20 lire. Si distingueva per il colore giallo da altre monete. Venti lire, per tutto quel lavoro, non potevo capacitarmi! Rimanemmo tutti mortificati, col capo chino accennammo un breve saluto e uscimmo con la rabbia nel cuore. Pensavo di meritare di più: duecento lire sarebbe stata la paga giusta che mi avrebbe consentito di comprare le scarpe per l’inverno. Le scarpe erano svanite, era rimasta solo la fatica. Col pianto nel cuore ritornai a casa. Il dolore alla schiena si faceva più forte, a stento riuscivo a salire i gradini della piazza. Quando mia madre mi vide, si accorse che camminavo piegato. Senza domandarmi, capì che avevo fatto un grosso sforzo fisico. Ma non immaginava che io avessi potuto, con i miei compagni, scaricare il camion di zì Carmela. Rinunciai al mio breve segreto e le raccontai tutto. Mi accarezzò, dicendo che avrebbe tenuto segreto il mio racconto a mio padre. Mi propose per consolarmi: – Se domani verrai con me a raccogliere le olive in zona Lacci, ti comprerò le scarpe da mastro Ciccio –. Il mio cuore ricominciò a battere di gioia. Ritornai a sperare. Passarono alcuni giorni, non rividi i miei amici. Ormai il camion era solo un lontano ricordo. Le castagne cominciavano a cadere e, le sere, i racconti della nonna avevano cancellato la mia delusione. Mia madre mi ricordò che, il giorno successivo, dovevamo svegliarci presto per raccogliere le olive. Mi alzai alla sua chiamata e ci recammo nella località prescelta, dove gli ulivi erano fissi a schiera, lungo il corso di un piccolo ruscello che mormorava alla terra un tremolio sereno. Cominciammo senza indugio a raccoglierle per terra, nella carraia. Erano nere, grosse, alcune lacerate dai rovi. Riuscimmo, dopo una settimana, a raccogliere venti mastelli. Riempimmo i sacchi umidi e li portammo al frantoio. Mastro Domenico fu sorpreso nel vedermi. Non immaginava che avessi raccolto tutte quelle olive. Quando svuotò i sacchi, mio nonno era lì che rideva, fiero del lavoro del nipote. Mia madre aspettò la ricompensa: duecento lire! Quando vidi quelle monete di color ferro, fui sorpreso dalla grandezza e dal colore scuro. Provai una gioia immensa. Potevo comprare finalmente le scarpe tanto sognate. Non perdemmo tempo, con mia madre andammo da mastro Ciccio. Il negozio era ancora aperto. Le scarpe 79 erano sempre lì, esposte nella vetrina, di color nero. Mia madre chiese il prezzo. Per voi, disse mastro Ciccio, è sempre lo stesso, 200 lire . Le misurai, sentivo il calore della lana, tanto desiderato. Le comprammo. Quando arrivai a casa, sentivo un’aria nuova, ero felice, potevo correre nei vicoli con i miei compagni, saltare i pozzi d’acqua, non avevo più paura del freddo. Avevo finalmente le mie scarpe nuove, l’inverno era arrivato, ma io non sentivo più freddo. 80 Vincenzo Lamanna SCENDI O TAGLIO Era di maggio, il mese delle tredicine. Come era bello il mio paese, agghindato dalle ortensie e dai gerani di colori diversi. Il rosso si abbarbicava al ferro maculato di ruggine, sul balcone di piazza Imbriaco. Nell’aria sentivi il profumo intenso di ginestra che ti portava con la mente all’infiorata del Corpus Domini. I gigli di Sant’Antonio erano ritti come sentinelle degli orti grigi e attiravano con i loro effluvi grevi le api ronzanti nelle tube bianche dei pistilli giallo-arancio. Il ciliegio di zì ‘Ntonio era situato in una località detta “Cavallo valle “che portava ad una valle lussureggiante, con i suoi frutti rossi vermigli che seducevano i bambini del piccolo borgo. Ma era guardato a vista da zì ‘Ntonio che non lo lasciava mai. Chi si avvicinava e cercava di prenderlo in giro riceveva solo improperi. In fondo era bravo e aveva un gran cuore. Quell’albero era come quello del Bene e del Male in un paradiso di primizie di stagioni. Lo potevi ammirare solo da lontano, ma guai a toccare i suoi frutti o salire suoi rami nodosi che davano ombra ai terrazzamenti. Chiunque avesse provato a sfidare la guardia di zì ‘Ntonio non l’avrebbe passata liscia. Era fatto così, non lo potevi cambiare. Ma noi non ci rassegnavamo, eravamo sempre tentati di approfittare di un momento di debolezza o di stanchezza dell’assidua guardia del vecchio, per raccogliere le ciliegie. Erano grandi, si vedevano dal muretto di cinta, piegare con il loro peso i rami. Sono frutti che hanno una vita breve, se non le raccogli subito, cadono nella terra avida e i vermi li divorano in poco tempo. In un certo senso, rassomigliavano ai nostri sogni di allegri ragazzi di campagna. Non facevamo in tempo a costruirli con la fantasia e li vedevi per strada sfumare . Il tempo era quello delle speranze brevi. Il ciliegio era lì, come un re di coppe con il suo guardiano dai lunghi baffi che incuteva paura, al centro dei nostri sguardi torvi. Zì ‘Ntonio era seduto su quel poggio di arenaria, intento a pascolare le pecore e assorto, sul suo bastone di salice a uncino. Nell’apparente dormiveglia, gli occhi semiaperti giravano con sospetto, alla ricerca del piccolo ladro di quei frutti rossi che sorridevano al sole a mezzogiorno. La fame non lo distraeva. Tirava, da un tovagliolo largo piegato a quattro, il pane sovrapposto in due larghe fette, un pezzo di formaggio e di pancetta, accompagnati da una bottiglia di buon vino rosso. Quando lo vedevamo, lo salutavamo con riverenza per accattivarcelo. Ma la sua risposta era breve, quasi indifferente, come un riflesso del suo carattere diffidente. Un giorno, ci riunimmo in un angolo della piazzetta. Pensammo tra di 81 noi: – Ci deve pur essere una via per distrarlo dal ciliegio . Non può stare sempre lì, a guardare nella valle. Si dovrà pure assentare per un bisogno, per un dovere, per una festa –. Sant’Antonio, con la ricorrenza ormai vicina, ci aiutò. Infatti l’indomito guardiano andava a messa solo il giorno del suo onomastico: il 13 giugno, la festa di Sant’Antonio. Infatti, in quel giorno, non andava in campagna, lasciava le pecore nel recinto e andava in chiesa senza pensare al ciliegio. Il giorno della festa tanto atteso venne. Le campane suonavano a festa per annunziare la messa vespertina. Zì ‘Ntonio lo vedemmo uscire di casa nel primo pomeriggio, con il cappellaccio di paglia, comprato alla Fiera di San Luigi, che sventolava di qua e di là per scacciare mosche e zanzare. Si diresse verso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, con il passo sicuro e celere che non tradiva il carattere austero. Quando entrò in chiesa, velocemente prendemmo la strada di Montecitorio che portava alla collina dei ciliegi, da una viottola secondaria. Eravamo liberi, correvamo senza fermarci, il ciliegio era libero dal suo guardiano. Salimmo in modo alacre sui rami che si abbassavano sotto i nostri piedi e mangiammo tante ciliegie come non mai, ridendo della severità del vecchio tradita. Sazi, raccogliemmo le altre ciliegie nelle nostre magliette rigate. Poi scappammo, senza farci vedere, per una scorciatoia posta a lato della strada principale. Ma non vedemmo tornare Andrea che era rimasto indietro, ancora sull’albero a mangiare ciliegie. Intanto la messa era finita, zì ‘Ntonio pensò al ciliegio, il suo perno fisso, avviandosi verso il pendìo. Presagiva dentro di sè, con rumorosi mugugni, che qualcuno avesse approfittato della sua assenza per rubare le ciliegie. La sorpresa fu di trovare Andrea sull’albero che mangiava i suoi frutti, come se nulla fosse successo. Alla vista di zì ‘Ntonio, che gli intimava di scendere, brandendo un bastone di erica in mano, ebbe paura . Diceva ripetendo più volte: – Scendi o taglio –. Aveva preso la scure per tagliare l’albero. Noi eravamo dietro al muretto di cinta, guardavamo la scena divertiti ma, nel contempo, preoccupati per la sorte del nostro amico di avventura. Dopo tanti rimbrotti, il ragazzo non trovò altre scelte, si buttò nell’erba. Zì ‘Ntonio per inseguirlo e sfogare la sua rabbia per essere stato raggirato, inciampò in un poggio d’erba e ruzzolò nell’aia, ferendosi ad una gamba. Non riusciva ad alzarsi, ricadendo a terra. Si procurò una larga ferita da cui usciva sangue e il dolore gli impediva di alzarsi. Andrea aveva raggiunto ormai il paese a gambe levate. Noi, preoccupati della sorte di zì ‘Ntonio, ritornammo indietro e lo soccorremmo. Dopo averlo fasciato con una manica di camicia verde campo, lo mettemmo su una carriola, dove la paglia faceva da cuscino, e lo riportammo a casa. Lui capì la nostra buona azione. Dai suoi occhi arcigni vedevi il luccichio del perdono. Ci ringraziò e lo lasciammo alle cure del suo medico. Dopo quella bravata, il ciliegio di zì ‘Ntonio rimase nei nostri cuori e quel bastone di salice curvo non vibrò più nell’aria. Rimase lì, tra i sassi, dove le lucertole si annidano. Non dimenticammo il suo gesto e quando il treno soffiò l’ultima nuvola prima del sogno svizzero e vidi le fronde d’ulivo piegarsi in un inchino, una lacrima mi rigò l’anima e sorrisi al tempo ormai lontano. (Da un racconto di un anonimo di Foria) 82 Vincenzo Lamanna STRANIERO Avevo circa 25 anni quando partii da Napoli per il Venezuela, con la malinconia del canto di “S. Lucia luntana” nel cuore, c’imbarcammo sulla nave. Sentivo la voce roca delle maree, una nenia di madri che agitavano al cielo i fazzoletti bianchi, il pianto che rigava visi imbruniti dai riflessi del grano. Lungo la rotta, l’orchestrina continuava a suonare le canzoni che ricordavano la mia terra del Sud baciata dal sole, il desìo d’amor del soldato innamorato. Tutto ciò mi rattristava, il mio pensiero era fisso sulle mie cose, le persone care che erano lontane all’orizzonte opaco diventavano punti neri di un foglio infinito. Il canto delle maree non arrivava, rimaneva sulla tartana danzante ai suoni arcani dell’attesa di un’altra terra. Mi apprestavo a conoscere l’America, dove la povertà era un sogno, secondo il racconto dei miei compatrioti. Il Bolivar era forte delle nostre braccia brune al sole, senza mente, il giudizio era sospeso come il gabbiano che incrociava la rotta senza un nome. Il silenzio dominava le nostre coscienze, la ragione era asservita ad altre terre. Ma il cuore era sempre là, integro, schiacciato dal peso delle incudini e dai suoi crogioli. Mi aggiungevo alla lista di emigranti stranieri, con un’unica dote: il mio nome di battesimo, Giovanni. Quando il battello intravide la costa, le case erano quasi simili. I tetti di latta vicini, in lunghe schiere di scaglie di luna. Fuori città, c’era un pezzo dell’Italia nascosto dalla sera. Mio zio era lì, ad aspettarmi. Sentii il calore di quell’abbraccio, del mio Sud lontano. Prese la mia valigia e mi condusse con l’auto a Caracas. Luccicavano le stelle, senza lacrime. Erano scese nelle piccole capanne e vegliavano come tanti lumi sulle nostre speranze di ritornare un giorno nei nostri paesi. Ma non ci accorgevamo che partendo, toglievamo la linfa ai nostri ulivi, lasciavamo le donne sole ad accudire i vecchi e ad affrontare il duro lavoro dei campi. Il mio primo giorno di lavoro fu a Maracaibo. C’era una grande raffineria di petrolio e di gas per rifornire la navi che attraccavano. Sembrava un grande ragno che stendeva i suoi tentacoli in mare: erano tubi di gas e di combustibile che viaggiavano in parallelo. Il mare aveva usurato alcune condotte, e noi dovevamo saldare i buchi o coprirli con resti di copertoni d’auto. Mi accorsi che il gas, passando a metà regime, poteva provocare uno scoppio o un incendio. Il caporale si complimentò per il mio suggerimento. I tubi del gas dovevano essere pieni per rifornire i battelli che quel giorno erano numerosi. La mia proposta passò e la catastrofe di un’esplosione fu evitata, grazie ad un italiano. Il lavoro si faceva precario, pensai di approfittare delle 83 congratulazioni dell’azienda, per proporre al mio direttore di assumermi. Ma questi girandosi verso di me senza pensare, rispondendo di riflesso, altalenando l’indice della mano destra in un diniego, disse: – Tu, no, tu no, tu straniero. Quella parola mi ferì il cuore, il groppo che fermò le foglie, non scese. Rimasi lì, stupito: “straniero” non mi aveva chiamato nessuno. Sulla chiatta mi chiamavano Juan, ma straniero no. Piansi nel cuore, al cielo, senza farmi vedere. Mi soccorse il vespro, come un fiore con le sue corolle arcuate, mi ricordò le ferite della vite che nel silenzio della valle spandeva i suoi arcigni tralci alla terra. Mitigando il dolore, divisi quelle sillabe atre, cancellai nell’animo quell’appellativo salso, non ebbi più vergogna, sognando una nuova aurora, raccolsi il mio cappello e ritornai alla mio favo di latta. (da un racconto di Giovanni Pace) 84 Vincenzo Lamanna VINCENZINO E IL GRANO Quella sera andai a dormire presto. Avevo promesso a mio nonno che l’avrei accompagnato a Lacci. Il grano era maturo e doveva essere raccolto in nottata. Conoscevo il grano solo di nome, ma non sapevo com’era fatto. Ero piccolo, non potevo capire la mietitura. Vivevo la partenza con ansia, avevo solo sette anni e non conoscevo il colore delle spighe. Nello stesso tempo provavo curiosità di sapere come si trebbiava. Così pensando, mi addormentai per poche ore. Sentii il respiro affannoso di mia madre sul mio viso che mi svegliava: – Vicinzì, Vicinzì alzati, devi andare con nonno a mietere. – Era mezzanotte, dovevamo partire presto. Mio nonno aveva già sellato l’asino, che scalpitava in via Sole. Levai le lenzuola sudate, mi lavai con l’acqua fresca del catino, mi vestii in fretta e scesi nella piazza soprana. Mio nonno con mio padre erano pronti con i loro sarmenti. Facevo in fretta a capire, stordito dal sonno che mi mancava. Mi chiedevo per la strada che cos’era il grano e come doveva essere falciato. Per me, erano parole nuove, di un mondo quasi fatato che la mia mente a stento riusciva a capire. Com’era bello il cielo, di un blu intenso che mi ricordava il presepe: la notte dei pastori. Le stelle erano sparse ovunque serene, custodi dei segreti degli uomini. Erano mute e brillavano in modo ineguale quasi a rappresentare il diverso destino della stirpe umana. Le cicale non avevano smesso il loro canto continuo, nei nidi di paglia secca degli ulivi. Di tanto in tanto le raganelle animavano con i loro tremolii le tacite roggie che portavano acqua ai mulini. Dopo un’ora e mezza di cammino, senza sentire una parola, rapiti dall’odore delle felci vergini, arrivammo a Lacci. Ebbi la sensazione di trovarmi in un mare dorato. Sembrava che il sole si fosse adagiato nell’erba e la luna vegliasse le pule dorate, chine come ninfe ad un tiepido zefiro che sussurrava qualcosa di antico e di arcano. Tutto era una meraviglia, la vista di un campo di grano e di ombre che la luna disegnava tra i cespugli. – E’ quello il grano? – chiesi a mio nonno. Con un breve cenno mi disse di sì. Le donne si avvicinarono e si misero in file parallele con i loro falcetti. Gli uomini seguivano a distanza con i forconi che raccoglievano la paglia residua in covoni, separandola dalle pule. Sembrava quasi un gioco di dama dove i cavalieri accompagnavano le dame in un girotondo di colori bianchi e neri, davanti al proprio re: il grano! L’apparente silenzio di favola veniva a tratti interrotto dallo strido del ferro arcuato che tagliava gli steli arcigni: zacate, zacate, za… Poi, le donne cingevano con i lacci di giunco i fasci raccolti. Per lenire la fatica, levavano un 85 canto a Maria. Era di solito un canto di invocazione alla Madonna, di partenza per il Sacro Monte o di mesto addio, di ritorno dopo la venerazione della vergine, con la promessa di una grazia. I nostri padri avevano sul petto i santini della Madonna del Carmelo che li proteggeva dalle malattie e dagli eventi avversi. Avevi la sensazione che il paese si fosse trasferito in campagna con i suoi arnesi, i suoi racconti e i canti che allietavano il cuore. Ci fermammo, stanchi della mietitura, e raccogliemmo il grano in sacchi di iuta. Il colore dei chicchi era dorato come quello dell’oro. Dopo aver avvicinato i sacchi del raccolto, ci sedemmo e tagliammo il pane in pezzi uguali. Profumava di cisto. Mio nonno mi disse: – Stai mangiando, quello che abbiamo raccolto, il grano diventato pane. Hai visto quanta fatica ci vuole, – poi aggiunse: – è un bene prezioso che ci dà sostentamento e va rispettato, ricordalo, non devi mai buttarlo. In guerra era raro trovarlo; c’è il sudore del nostro lavoro, non buttarlo mai! Conservalo sempre! Che meraviglia! Sensazioni mai provate, neanche giocando a bandiera, pensai. Cominciò a farsi giorno, la sera si ritirava, ebbra di luna, nelle sue stanze eteree, con le sue ancelle: le stelle che lasciavano alla terra dorata il sottile lucore di lontani falò. Il campo era diventato di un giallo tenue, nello specchio dell’aurora che conservava i lemori ocra della fatica delle donne e degli uomini. Capii, nello stupore della mia innocenza, che non era una favola ciò che avevo vissuto. Avevo conosciuto il grano, non era più un racconto fantastico di un camino sopito. In fondo era la storia del pane che le mani rigate di mia madre posavano giunte in preghiera sulla tavola, ornata dalla tovaglia di lino, a mezzogiorno, quando la campanella dell’orologio ricordava che il quarto era passato. Dovevamo ringraziare Dio del dono raccolto fatto pane, e sperare in un tempo migliore. Non avevamo paura, bastava poco, forse la meraviglia ci faceva sognare e sperare, nonostante le avversità. Si continuava a vivere di piccole cose che, scambiandole senza inganno in un piccolo baratto amico, ci facevano sentire uniti. In quel campo dove il sole dormiva, dove il suo sangue nutriva le radici della mia infanzia, dove volgo, chiudendo le palpebre, lo sguardo e cerco con le mani adunche di vecchio nella plaga dorata il falcetto solcare, ritrovo Vicenzino, la meraviglia divenuta magia del bambino che non conosceva il grano. (da un racconto di Vincenzo Serva) 86 Vincenzo Lamanna ROSINA E’ TORNATA L’asina di zì Francesco era invecchiata. Le salite erano sempre più difficili da superare. Facilmente inciampava per i carichi di legna nei pendii. Si fermava o si accasciava sotto il peso dei sacchi di olive. Zì Francesco era molto affezionato a lei, scioglieva le funi e la liberava dall’eccessivo carico. Così con un raglio, a fatica, si rialzava e riprendeva lentamente il suo cammino. Il padrone doveva però ridistribuire il carico per farla ripartire. Si perdeva del tempo prezioso, specie d’inverno, quando, facendo buio presto, era difficoltoso ritornare a casa per strade strette, impervie, illuminate dalla luna. Zì Aniello, più volte gli aveva suggerito di venderla alla fiera di San Francesco, a Centola, agli zingari che sapevano come metterla in vendita per lavori meno gravosi. Tutti eravamo legati a Rosina. Vuoi per i lavori che aveva fatto da giovane, vuoi perché era la nostra compagna di gioco. Noi condividevamo il lavoro di campagna con quell’animale così mansueto. Ma ci rendevamo conto che non poteva più affrontare quei pesi così pesanti come un tempo. Mio nonno decise di portarla alla fiera per venderla. Non disse niente. La scelta era ormai fatta: di fiere se ne facevano, a Centola, due all’anno, un’altra a Foria e quella di S. Luigi, a S. Severino. Partì alla volta del mercato e vide un vecchio zingaro che lo contattava per la vendita di asini e di capre. Gli chiese di avvicinarsi e, dopo un abbraccio da vecchi amici, gli presentò l’animale. Compà Raffaele guardò l’asina da sopra a sotto, si accorse che il pelo era bianco. La guardò in bocca e si accorse che i denti erano color ruggine. Controllò le zampe e disse a zì Francesco che l’animale non poteva lavorare più. Aggiunse: – Meno male che l’hai portata in tempo, è vecchia e ha pochi anni di vita –. Zì Francesco si rattristò e la vendette per 2 mila lire. Si salutarono con compà Raffaele e lasciò l’animale alla fiera. Nello stesso mercato, il fratello, zì Aniello, girovagava per acquistare un somaro giovane. Intanto compà Raffaele aveva chiamato i suoi compari, ridendo sotto i baffoni, ordinò di mettere a nuovo l’asina. In un baleno i suoi amici si misero all’opera e la lavarono, le imbiancarono i denti, le misero i ferri agli zoccoli dopo aver tagliato le unghie. Completarono il lavoro togliendo i peli bianchi e la coprirono con una sella bordata da cordoni rossi e verdi. Riacquistò un aspetto giovane e molti compratori si avvicinarono a compà Raffaele con l’intenzione di comprarla. Ma con soddisfazione rinviava le offerte ad un prezzo più vantaggioso. Zì Aniello venne attirato dall’eleganza dell’animale. Aveva comprato solo una paglietta, 87 come tradizione della fiera. Era colpito dall’apparente giovinezza dell’animale che non dimostrava gli anni, scalpitando sul selciato con forza. Chiese al vecchio il costo dell’asina. Era venuto alla fiera per comprarne una giovane come quella che gli veniva proposta, al costo di 10 mila lire. In un primo tempo, zì Aniello rifiutò la cifra proposta, poi si accordò per 8 mila lire. Se la portò nel paese soddisfatto, rilasciando battute a destra e a manca in modo ilare. Camminando, camminando, mentre gli zingari erano scomparsi ridendosela alle spalle del povero malcapitato, si accorse che l’asina camminava con sicurezza come se conoscesse il luogo. Zì Aniello rimase perplesso e cercò delle ragioni per spiegarsi tutto ciò. Si convinse che la giovinezza era la causa della sua destrezza. Ma per la strada fu preso da altri dubbi, quando vide che l’animale conosceva la “Via Serra”. Infatti, dopo un breve tragitto, con lo stupore del padrone, riconobbe la stalla di zì Francesco e vi si allocò come se fosse da tanto tempo la sua dimora. Zì Aniello non trovò altra spiegazione, il dubbio rimaneva: – Come ha fatto a riconoscere la stalla? –. Andò dal fratello per chiedere spiegazioni del fatto così curioso. Il fratello, sentito il racconto, propose di visitare l’asina. Quando scesero nella stalla, i dubbi scemarono e la realtà apparve nella sua interezza. Zì Francesco la guardò in bocca e si accorse che un dente era screziato: era il segno di riconoscimento della sua asina a seguito di una caduta. Zì Francesco gli disse: – Caro fratello, gli zingari ti hanno fatto fesso, questa è la mia asina che ho portato al mercato. E’ Rosina! Zi Aniello non credeva ai suoi occhi, rimase sbalordito al punto che diventò paonazzo dalla rabbia, mentre il fratello ridendo a crepapelle, gli dava dei colpi sulla spalla per consolarlo: – Aniello, aspetta alla fiera di S. Raffaele, la venderai agli zingari per nuova –. Così, tra una risata e un borbottio, si fece sera e Rosina riposò nella vecchia stalla. (Da un racconto di Francesco) 88 Centola-1955, Piazza Imbriaco, già piazza Vecchia, matrimonio di Italia Culetto con Michele Cariello. La trebbiatura sull’aia con buoi nel Cilento. 89 Contadino che torna dai campi con asino e capre. U “trainu” come mezzo di trasporto. 90 Nicola Lamassa SAGGEZZA E GIUSTIZIA Un giorno, si portò a casa di mia nonna paterna una sua amica, austera di carattere e con un senso della giustizia molto marcato. Bisogna premettere che entrambe avevano un linguaggio cadenzato e suadente, da una corposità dialettale chiara, tale da incantare chiunque le ascoltava. L’ospite, rivolgendosi a mia nonna, le denunciò un danno subito nel proprio podere; le disse: – Quel tuo figlio ha tagliato una quercia dal mio querceto e ne ha fatto legna –. Mia nonna, conoscendo l’integerrima onestà del proprio figlio e come questi conoscesse e rispettasse i confini in maniera inderogabile, si meravigliò di ciò che la sua amica le stava facendo osservare. Le fece notare, con sottolineata certezza, la propria perplessità e, pronunziando il nome del proprio figlio, sostenne che non poteva essere stato lui. Al sentir quel nome pronunciato da mia nonna, anche la sua amica istantaneamente si ricredette e anch’ella sottolineò la sua perplessità. Sul figlio di mia nonna non potevano nascere confusioni di sorta. Immediatamente la donna disse: – No, amica mia, io non facevo riferimento a tuo figlio, mi sono espressa con tale termine per riferirmi a quel giovane che abita in casa tua e che appartiene a tua nuora –. A questo punto mia nonna comprese e subito ribadì: – Se trattasi “ri chiddu guaglione”, a cui voglio tanto bene come mio figlio, hai fatto bene a rivolgerti a me. Ti autorizzo ad andare nel mio querceto, scegli la migliore quercia e tagliala a tuo beneficio e piacimento –. La signora all’istante alzò le mani, abbracciò mia nonna e chiamandola per nome rincalzò dicendo: – Con le tue parole mi hai pagato mille volte, tra di noi è come non fosse successo più niente. Dobbiamo volerci soltanto bene –. Le due ricordarono un tizio che al contrario, per una facezie, introdusse una causa che non aveva avuto mai fine, e allora insieme ricordarono un detto: “Arrassu fregnu nunn’accustà cu nszugna, ca la grazia tua binigna mi misca la rugna”. Tradotto in italiano vorrebbe dire: ”Stai lontano, stolto burlone, insulso e venditore di burlonerie, non accostarti a chi è unto di sapienza e diligenza; perché l’insipiente tua beltà imbevuta di furberia danneggia la mia onestà, come la peste danneggia il corpo”. 91 Nicola Lamassa UNA STORIA E UN REDUCE DI GUERRA Mio padre era solito raccontare in famiglia le “malepatenze” sofferte in gioventù, e sovente prevalevano i fatti della prigionia, avvenuti durante la detenzione in Germania (“malepatenze”: espressione dialettale pronunciata da quasi tutti coloro che appartenevano alla sua epoca, per riferire fatti legati ai patimenti del tempo, alle fatiche di cui ognuno doveva farsi carico, per affrontare la fame e la povertà in cui la propria famiglia versava). Mio padre, pur appartenendo alla classe del 1907, fu richiamato con la classe del 1920, partecipando alla II Guerra mondiale. Essendo l’Italia ancora alleata con la Germania, quest’ultima intervenne e combatté contro i Greci, ottenendo la resa che l’Italia non era riuscita ad ottenere. Intanto in Italia, contemporaneamente, gli alleati americani, iniziando dalla Sicilia, avanzavano, liberandola dai tedeschi. In questa nuova condizione, gli Italiani lontani, nella penisola Balcanica, presso Salonicco, ebbero delle sorti terribili. Alcuni, con inganno furono fucilati dai tedeschi, altri, come mio padre, furono deviati in Albania e tradotti in Germania, ammassati su vagoni da bestiame. L’esercito tedesco, in quei frangenti, era come impazzito. L’episodio delle sue sofferte memoriche mio padre raccontava più spesso era il seguente. Egli raccontava come venivano utilizzati i soldati prigionieri, provenienti dall’Italia e da altre nazionalità nemiche della Germania. Per trasportare grossi quantitativi di materiali da un punto all’altro in quel territorio, dovevano spingere a braccia un vagone, su binari disposti lungo un pendio di un colle; una volta bloccato tale mezzo in una parte elevata, i soldati addetti tornavano indietro, verso il luogo di carico stabilito, per rifare la stessa operazione; quindi, attendevano il vagone che ridiscendeva il pendio con la velocità acquisita per inerzia lungo il tragitto. Sul luogo di arrivo il vagone carico veniva frenato da due respingenti dell’ultimo vagone di una serie di altri vagoni giacenti e fermi a valle. I soldati dovevano stare molto accorti nei continui tragitti che i vagoni compivano. I rischi, già molto evidenti, erano presenti volta per volta per cui la prudenza non era mai troppa. Infatti, un giorno, il 17 Maggio 1947, per distrazione, un commilitone di mio padre stava per essere travolto dal vagone di ritorno. Papà, accortosi di quanto stava accadendo, afferrò repentinamente il proprio compagno, scongiurando la sciagura, ma l’azione non fu sufficiente a far rimanere indenni entrambi. Infatti, il gomito del 92 braccio sinistro di mio padre rimase all’interno dei respingenti, schiacciato tra i due vagoni. Ma non finì qui. Nonostante l’atroce dolore che dovette sopportare in quel momento, mio padre venne aggredito ferocemente, con ripetuti schiaffi sul volto, da un giovane ufficiale tedesco che, contrariato per il soccorso prestato, voleva dare un avvertimento esemplare anche agli altri, affinché la cosa non si ripetesse più. Mio padre, esasperato per quel brutale trattamento, reagì, vibrando col braccio destro una ferma gomitata all’altezza dello sterno del giovane ufficiale, rovesciandolo a terra. L’umiliazione subita fece sì che il giovane ufficiale, preso dall’ira, portasse la mano presso la fondina del proprio revolver, per puntarlo verso mio padre. Nel momento in cui stava per sfoderare il ferro, ecco avvicinarsi un anziano ufficiale di alto grado, anch’egli tedesco, pose il suo piede sulla mano che stava brandendo l’arma e disse: – Frena la tua ira, perché con noi gli italiani non sono mai stati così feroci e brutali. In seguito, ricoverato all’ospedale, mio padre fu operato al gomito: gli fu inserito un pezzo di metallo che portò per il resto della sua esistenza. 93 Nicola Lamassa MASTU PANDOLA Calzolaio (scarparu) o ciabattino? Sembra opportuno scrivere una parola sulla differenza dei termini che orbitano intorno a questa attività. Inizierei proprio da “ciabattino”. È un termine che ci riporta alla ciabatta o alla pianella. Infatti quest’ultima è una protezione da camera degli arti inferiori. Però, un pezzo di gomma legata intorno alle dita del piede e sul retro, all’altezza del tallone, realizzava la calzatura dei poveri che portavano in paese e durante il lavoro in campagna. Questo tipo di calzatura era chiamata scarpone o “zammitta”. Come si può notare dalla descrizione, era solo una protezione che rivestiva appena le parti inferiori e laterali del piede, lontana dalla vera calzatura a cui oggi attribuiamo il nome. Possiamo dire che tale oggetto era molto più vicino alle pianelle da camera o alle ciabatte, da cui, io credo, provenga il nome di “ciabattino”. Nei tempi della povertà registrata nel periodo successivo alla II guerra mondiale, un uomo di Centola, nel suo negozietto, sito nella piazzetta del Rosario, ai piedi della scala in pietra, a destra del campanile, svolgeva l’attività di calzolaio per le famiglie signorili e più abbienti, le quali, essendo possessori di carrozze, potevano disporre di più cuoio, finimenti e pezzi di pelli e ottenere più facilmente materiale onde poter ricavare un maggior numero di scarpe. Si racconta un aneddoto intorno a questo ciabattino molto divertente. Antonio Esposito, detto “Mastu Pandola”, essendo presbite, non vedeva da vicino e possedeva occhiali con lenti bi-convesse per regolare la sua presbiopia. La bi-convessità delle sue lenti gli permise di intuire la scoperta del fenomeno che ritroviamo all’interno degli argomenti sulla luce, sull’ottica e le fonti luminose relative alla rifrazione in funzione della concavità e convessità delle lenti, e la variazione del luogo del Fuoco, in fisica. Infatti, l’ingegnoso artigiano, poneva una lente dei suoi occhiali tra la fonte energetica-sole e l’oggetto incendiabile-sigaretta e, mediante la rifrazione del fascio dei raggi del sole, estremamente concentrati all’esterno delle lenti, cioè nel Fuoco, esterno alla lente e opposto al sole, otteneva l’accensione della sigaretta. Il povero ciabattino non aveva fiammiferi o altro mezzo per accendere le sue sigarette ma aveva trovato il suo piccolo ingegno per accenderle e fumare. Non doveva fare altro che applicare il sistema “sole-lenti-sigaretta”. In breve tempo si allenò così bene da riuscire ad accendersi le sigarette ogni volta che lo desiderava. 94 Usciva nella piazzetta del Rosario, alla presenza dei ragazzi incuriositi, accendeva la sigaretta, velocemente la portava in bocca e, aspirandola, iniziava a fumare, tra gli applausi dei ragazzi sempre più affascinati per quelle piccole ma significative “operazioni scientifiche”. Si racconta ancora che “Mastu Pandola”, non avendo la possibilità di dotarsi di due forme per la realizzazione delle scarpe, creò un’unica forma rettangolare come modello base per la coppia di scarpe. Ecco che la povertà aveva aguzzato l’ingegno. Quell’unica forma avrebbe vestito indifferentemente sia il piede sinistro che il piede destro. Lo sfortunato che si trovava ad indossarle, dopo patimenti di vari giorni, poteva vantare delle scarpe rettangolari che, però, di lì a pochi giorni, sarebbero state dei modelli “personalizzati”, perfettamente modellati dalla sagoma del proprio piede! Colui che oggi chiamiamo calzolaio, invece, attraverso il suo lavoro, sin dall’inizio riesce a dare conforto al piede sia nei movimenti di deambulazione come in quelli relativi al moto del piede da fermo, o almeno così dovrebbe essere! (Da un racconto di Ezio Martuscelli) 95 Nicola Lamassa ACCADEVA IN LOCALITA’ GIARDINA L’integerrima integrità di carattere dell’Ing. Antonio Martuscelli Il Prof. Ezio M. è solito trascorre i suoi periodi di riposo prevalentemente a Centola. Una mattina, consumando una breve colazione unita al caffè, sulla pista del “Bar La Pergola”, raccontava, a noi che eravamo seduti presso il suo tavolo, un episodio emblematico dei tempi passati. Quest’immagine mi fa venir in mente l’ingegnere e filosofo De Crescenzo, quando in TV, nelle sue digressioni filosofiche, spiega agli astanti il perché di quell’episodio o il significato etimologico di quel vocabolo greco. Ritornando ai tempi passati, tra gli anni ’40-’50, la località “Giardina” era solo una verdeggiante zona, non ancora infittita dalla densità urbanistica che col tempo si è venuta a formare. Vi era un numero esiguo di abitazioni, per cui intorno si notavano coltivazioni di ortaggi e piccoli allevamenti di bestiame, come pollai e stalle di maiali, per il fabbisogno delle famiglie che abitavano in quelle poche abitazioni. Il Professore, ricordando con nostalgia detto ambiente, riportò un aneddoto relativo a ciò che spesso si ripeteva quando le coltivazioni erano già mature o cominciavano ad esserlo. Gli ortaggi della sua famiglia erano estesi al punto da aver bisogno di un colono, per coltivarne i vari prodotti. Però, sistematicamente, quando questi orti iniziavano a dare i primi frutti, ecco sfuggire, quando ad un pollaio, quando ad un altro, i pennuti di proprietà delle famiglie limitrofe, che non erano sempre gallinelle ma spesso si portavano nell’orto anche tacchini. Insomma, la presenza di queste bestiole era un vero e proprio saccheggio per le coltivazioni. Per cui, non tanto per il gusto di abbattere quegli animali, ma per dare un monito ai padroni affinché tenessero custoditi i loro animali, il papà del professore, volta per volta, effettuava una particolare operazione: imbracciava il suo “dietrocarico”, si portava nel suo orto, abbatteva il pollame che vi si trovava e poi inviava il suo colono dai singoli padroni affinché ne raccogliessero le carcasse. Ovviamente, nelle singole famiglie nasceva un putiferio tra coloro che avvertivano il problema più sensibilmente e coloro che avrebbero dovuto responsabilmente tener custoditi gli animali. 96 Nicola Lamassa senior, nonno di Nicola junior. Centola, loc. Serrone: Antonio Martuscelli (07-09-1950). 97 La piazzetta del Rosario dove, negli anni del secondo dopoguerra, era situata la bottega del ciabattino detto”Mastu Pandola”. Centola, la Giardina come era nel luglio del 1964. 98 Mario Augusto Lorenzini LA PRIMA VOLTA CHE PRESI IL TRENO PER CENTOLA La prima volta che presi il treno per scendere alla stazione di Centola risale all’Anno 1942, un sabato di primavera. Provenivo da Eboli, dove frequentavo la terza ginnasio. I miei genitori erano già in quella stazione da alcuni mesi, provenienti dalla stazione di San Nicola Varco – case sparse del comune di Eboli – sulla linea BattipagliaReggio Calabria. Preferirono lasciarmi a pensione a Eboli, per consentirmi di terminare l’anno scolastico. Il desiderio di vedere la nuova stazione – mio padre era un capostazione – mi spinse a prendere il treno. Come figlio di ferroviere, godevo dei biglietti gratuiti. Dove esattamente fosse Centola non lo sapevo e lo chiesi al ferroviere che era venuto nello scompartimento a controllare il biglietto. – C’è una galleria lunga alcuni chilometri e poi c’è la stazione di Centola – mi disse. Stetti attento durante il percorso. Ecco Paestum con i suoi templi, Agropoli dove ero andato a fare il bagno, poi Torchiara, Rutino, Vallo della Lucania e di nuovo il mare, a Pisciotta, San Mauro La Bruca ed ecco la lunga galleria. Il treno rallentò, mi affacciai al finestrino, vidi la stazione “Centola” e mio padre con il berretto rosso e la paletta verde in mano. – Babbo! – gridai e scesi. – Sei venuto a vedere dove siamo? Hai fatto bene. Il treno ripartì e mi guardai d’intorno. Il Bulgheria con i suoi quasi mille metri di altezza mi impressionò. Ero abituato a vedere l’orizzonte quasi all’infinito e questa montagna limitava il mio orizzonte. La stazione, una strada, tre case, un paese abbarbicato sulla collina, un fiume che scorreva lento nei pressi, sotto un ponte ardito chc recava una data ANNO VI. Il mare? E’ un po’ lontano, – disse mio padre. Mia madre non mi aspettava e rimase sorpresa. Ci abbracciammo senza dire una parola. Il momento era difficile per tutti. 99 C’era la guerra, c’era da tirare la cinghia, come si diceva allora. Noi eravamo toscani, in Toscana avevamo lasciato i nonni materni e paterni. E per loro stavamo in ansia. Domenica mattina, chiesi di andare alla Messa. – E’ lassù, – e mia madre indicò un gruppo di case (ma forse era eccessivo definirle case) abbarbicate sulla collina. San Severino sembrava un presepio. La strada era approssimativa. Non ero solo, c’erano alcune ragazze più grandi e alcune vecchiette che facevano la stessa strada. Mi accodai. Ecco il paese piuttosto malandato e, in fondo, la chiesetta da cui si dominava la vallata dove scorreva il fiume che sfociava al mare. Mi misi in fondo alla chiesa. Non passai inosservato. Le ragazze mi guardavano e sorridevano. All’uscita, una si avvicinò. – Tu sei il figlio del capo? – Sì! – risposi. – Mi chiamo Carmela. – E io Mario. 19 giugno 1946 A Mario Ultimo giorno di scuola per te, sì, proprio ultimo, lasci ormai i banchi per dedicarti a cose ben superiori. Ma un giorno, forse lontano, scorgerai, fra i tuoi tanti, il rosso libretto. Un palpito, un ricordo commovente e fra le tante firme scorgerai anche la mia. Rivedrai un pezzo del tuo passato, una tua amica, gli oscuri monti di San Severino. E allora…..ti giunga il mio ricordo affettuoso, accompagnato da un caldo augurio di rosea vita. Carmela 100 Mario Augusto Lorenzini RICORDI DI UN FIGLIO DELCAPOSTAZIONE DI CENTOLA (1943 e 1946) QUELL’ESTATE CALDA DEL ‘43 A giugno, avevo concluso il Ginnasio, con il saggio ginnico al Timpone, campo sportivo (si fa per dire) di Sapri. Calzoncini neri e maglietta bianca a mezze maniche, sul petto una vistosa M nera. Fu quella l’ultima occasione di una parata fascista. Avevo quindici anni, ero balilla moschettiere, l’anno dopo sarei diventato avanguardista ma non ci fu, per quell’occasione, l’anno dopo. L’Italia era in guerra da tre anni ed era ormai allo stremo. Gli alleati martellavano con le fortezze volanti ogni notte la Sicilia e Napoli e si apprestavano a sbarcare in Sicilia. Quando, dopo il saggio ginnico, ci fu il “rompete le righe”, ognuno di noi della quinta ginnasio sperò di ritrovarsi, per continuare il Liceo, qualche mese dopo. Io abitavo alla stazione di Centola, nel Cilento, quattro case dintorno, un ponte ferroviario piuttosto ardito, opera del regime (su un pilone il fascio ANNO VI). Sotto il ponte, scorreva il fiume Mingardo che di fatto somigliava ad un ruscello: non l’ho mai visto scorrere per tutto il letto negli anni in cui ho abitato nel Cilento. L’estate non era, per me, sinonimo di vacanza, anzi mi annoiavo parecchio. Roberto, figlio anch’egli di un capostazione, abitava alla stazione di san Mauro La Bruca, al di là di una galleria lunga cinque km; Francesco abitava alla stazione di Torre Orsaia; Ugo abitava a Sapri, aveva la fortuna di fare i bagni. Mio padre mi fece l’abbonamento per andare a fare i bagni a Pisciotta e ci andavo con il treno del pomeriggio, con un capostazione più giovane, pisano, emerito aeronautico che mi costruì un aquilone. La radio trasmetteva bollettini di guerra nient’affatto rassicuranti. I miei genitori erano preoccupati. Temevano di restare isolati, di non poter ritornare in Toscana, dove c’erano i nonni. La posta non arrivava o arrivava in ritardo anche se usufruivamo della posta militare in quanto mio padre era stato militarizzato. Il 25 luglio, la radio trasmise il comunicato che il re Vittorio Emanuele III aveva 101 accolto le dimissioni del cavaliere Benito Mussolini. Tutti avvertimmo l’incertezza del domani. E ora che facciamo? Intanto, i treni continuavano a correre sui binari ma erano treni carichi di soldati tedeschi. A Centola, c’era un comando di Battaglione italiano, con ufficiali piemontesi che spesso parlavano in dialetto con mio padre, nativo di Saluzzo. Incominciarono subito a disfarsi del materiale e vendevano tutto: divise, vettovaglie, scatolette, coperte di lana. Un tenente aveva fatto venire dal Piemonte la moglie in attesa di un figlio. Si trovò senza niente, il giorno della nascita di un bel bambino, e mia madre rovistò nel baule per trovare qualche indumento che aveva conservato come ricordo. Ma quel giorno davvero la vita cambiò. L’epilogo fu l’8 settembre, quando la radio annunciò l’armistizio. I treni non circolarono più e lungo i binari una fila ininterrotta di soldati che a piedi, dalla Sicilia e dalla Calabria, ritornavano a casa, verso il Nord. E nel golfo di Salerno, l’8 settembre, gli alleati sbarcarono con tutte le loro forze. I tedeschi della divisione Goering cercarono di inchiodarli sulla spiaggia di Paestum, poi si ritirarono. E furono davvero mesi difficili. La lira non valeva niente e ricordo di aver comprato la Divina Commedia con cinque chili di farina. Poi, a gennaio, ritornai a scuola, a Sapri, a frequentare la prima liceo. L’Italia era davvero diversa. QUELL’ESTATE DEL 1946 Il 2 giugno, non andai a votare per il referendum Monarchia o Repubblica. Non avevo ancora compiuto diciotto anni. Faceva caldo quella domenica. Io rimasi a casa mentre i miei genitori, a piedi, fecero 18 km per andare a votare nell’ultimo seggio a Centola, Comune del Cilento. Mio padre era il capostazione e la stazione distava nove km dal capoluogo. Non c’era alcun servizio pubblico nei giorni festivi e i seggi erano ubicati solo nel capoluogo. Ricordo che insieme ad altri elettori della piccola frazione intorno alla stazione – San Severino di Centola – camminarono di buon mattino e, solo nel pomeriggio, fecero ritorno, soddisfatti di aver adempiuto, per la prima volta nella loro vita, il dovere di votare. Non ho mai chiesto per chi avessero votato. Io, se avessi votato, forse avrei votato per la Monarchia, perché non avevo alcun riferimento storico della Repubblica, se non quella di Salò, ma solo per sentito dire 102 in quanto, vivendo nel Sud da oltre cinque anni, ero ormai sensibile più al Sud che al Nord. Ricordo che quella domenica, dopo la Messa, ripresi a studiare perché gli esami di maturità erano alle porte e sicuramente dall’esito del referendum sarebbe “uscita” la traccia del tema di italiano. Vinse la Repubblica e allora fu tutta una ricerca storica di “pensieri” degli autori repubblicani, cominciando da Mazzini. Il Liceo classico di Sapri, istituito dopo la fine della guerra, affrontava per la prima volta gli esami di maturità e noi eravamo i primi studenti a chiedere il “pass” per il nostro futuro che era veramente ricco di incognite. L’Italia cominciava a riprendersi, con tanti problemi da risolvere, cominciando dai trasporti e per il Sud erano essenziali. La commissione era interna, solo il presidente era esterno, si chiamava Nicola Sensale che avevo avuto come preside al Ginnasio Matteo Ripa di Eboli alcuni anni prima: glielo ricordai quando mi passò accanto nella sorveglianza alla prova scritta di Italiano. Ricordo alcuni docenti: Giuseppe Reale di Italiano, Leonzio Speranza di Storia e Filosofia che in quella classe trovò la compagna della sua vita. Il tema era scontato, fu imperniato su un pensiero del Mazzini. E scrissi quanto ero riuscito a conoscere attraverso i pochi testi in possesso. Non c’era da scialare in quei tempi. Una biblioteca non sapevo neppure che cosa fosse, i giornali erano pochi e con poche pagine, i libri nuovi erano ancora da scrivere. La maturità era, allora, un esame serio, con tre prove: Italiano, Latino e Greco e tutte le altre materie agli orali. Altri tempi. 103 Mario Augusto Lorenzini GLI OSCURI MONTI DI SAN SEVERINO “………Un giorno, forse lontano, scoprirai, fra i tuoi scritti questo libretto rosso. Un palpito, un ricordo commovente e fra tante firme scorgerai anche la mia. Rivedrai un pezzo del tuo passato, una tua amica, gli oscuri monti di San Severino. E allora…..” Ho ritrovato il rosso libretto dove, nel giugno del 1946, i compagni di scuola maturi del Liceo Classico Carlo Pisacane, di Sapri, vollero scrivere il loro ricordo. Melina scrisse il suo ricordo che ho voluto riportare all’inizio. Melina aveva un anno più di me ed era stata promossa alla terza liceo. Abitava in una casa su un poggio, a due passi dalla stazione ferroviaria di Centola, dove io ero arrivato, nel 1942, con mio padre, capostazione titolare, e mia madre. Provenivamo dalla stazione di San Nicola Varco, a due passi da Battipaglia e da Eboli dove avevo frequentato la terza ginnasio. In quella casa, Melina abitava con i genitori e altre quattro sorelle, l’ultima delle quali si chiamava, se non erro, Nietta. Melina era una bella ragazza. dai capelli neri e dal volto sempre sorridente. Fu per me la prima “fiamma”, diciamo il primo amore. Insieme andavamo a Sapri con il treno e quando attraversavamo la galleria di Torre Orsaia ci prendevamo per la mano. Oggi, alla veneranda età di ultraottantenne, mi commuovo ancora, scrivendo questo ricordo. La guerra, le tradotte tedesche dirette verso la Sicilia, lo sbarco alleato nel golfo di Salerno, l’Italia divisa in due, la fame, la disfatta del nostro esercito, la linea ferroviaria interrotta e utilizzata dai militari abbandonati per rientrare a casa. – A San Severino – come ha raccontato Don Giovanni Cammarano – c’era, durante la guerra, un Battaglione di Alpini piemontesi che si sciolse come neve al sole e si disfece di tutto il materiale da caserma, per racimolare qualche soldo. Il tenente Mesini, piemontese, aveva con sé la moglie e un bambino di pochi mesi. Si trovò senza casa e senza un soldo. Mio padre, che era nato a Saluzzo, sentì il bisogno di aiutarlo e si dette daffare per procurargli un alloggio e un piatto di minestra, chiedendo ai sindaci (ex podestà) viveri di ogni genere, mentre mia madre e la moglie dell’altro capo stazione toscano, Cosetta Liberali, cercarono nei loro armadi cappottini e vestitini in disuso, miei e di Sandro che cresceva a vista d’occhio 104 (Sandro, ormai giornalista di grido in pensione, l’ho ritrovato in occasione della presentazione del mio libro, ha scritto l’introduzione “Una giovinezza nelle stazioni ferroviarie”). Ho ricordato Don Cammarano e come non ricordare che, nell’inverno del 1943, questo sacerdote riunì alcuni studenti del liceo che attendevano di riprendere gli studi e impartì loro le prime lezioni di greco e della Divina Commedia, in una stanzetta non ricordo dove ma non nella chiesa nel paese antico. La ferrovia riprese a funzionare con un treno al giorno e, solo nel 1946, quando l’Italia fu tutta liberata e si apprestava a votare per la prima volta, si poteva guardare con fiducia al futuro. L’otto giugno, non andai a votare perché non avevo ancora l’età e i miei andarono a piedi a Centola, per assolvere al dovere di cittadini. Il 16 giugno, la prova scritta di Italiano alla maturità, con il tema da uno scritto di Mazzini. Alla stazione, ripresero ad arrivare le corriere da Camerota e da Centola mentre, da Montano Antilia, i muli arrivavano carichi di tronchi d’albero da spedire a Napoli. Ricordo le “pesciaiole” di Camerota che al mattino arrivavano con la cesta di pesce fresco sulla testa. Io intanto, dopo la maturità, mi ero iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Napoli ma non frequentai alcuna lezione. A luglio 1947, mio padre fu trasferito in Toscana, alla stazione di Calenzano, vicino a Firenze. Due carri con le nostre masserizie furono agganciate ad un treno derrate diretto a Milano. Si rientrava in Toscana, con tante incognite e preoccupazioni. Quando il treno si mosse e imboccò la galleria della Spina, mi si strinse il cuore, chiusi gli occhi e pregai. Addio a Melina che era andata sposa ad un capo stazione. Addio a tanti sogni. Addio al figlio del capo. 105 Foto riguardanti la famiglia Lorenzini e la stazione di Centola. Queste foto sono state scattate nel periodo che va dal 1940 al 1947. La chiesetta del borgo antico di San Severino (anni 1940s). 106 Gli oscuri monti di San Severino. 107 Maurina Luise A MIO PADRE Ho voluto parlare di mio padre per lasciare ai suoi nipoti e a coloro che lo conoscevano un ricordo di un uomo semplice, il cui cuore non è stato indurito nemmeno dagli orrori della guerra, sempre convinto che l’unica via da percorrere è quella del perdono e della comprensione. Mio padre non potrà leggere questo scritto ma, sono certa, che nel mondo senza tempo nel quale si trova, apprezzerà questo mio piccolo gesto. I nonni paterni, Gerardo Luise e Maria Raffaella D’Angelo, si sono sposati all’inizio del 1900. Dal loro matrimonio sono venuti al mondo 6 figli: Raffaele, Giuseppe, Domenica, Antonia, Nicola e Concetta. Nicola, mio padre, è nato il 14 Novembre 1913, a Centola. Lo stesso giorno del 1947, ha sposato Maria Ciccariello (nata a Centola il 2 Giugno). Hanno avuto due figli, Gerardo e Maurina, ed il nipote che porta il nome del nonno è nato il 13 Giugno 1979. Mio padre parte per il servizio militare, il 19 Giugno 1934. Nel 1936, è collocato in congedo per essere richiamato il 4 Giugno 1940. L’8 Giugno, è imbarcato a Napoli, con destinazione: Libia. Il 10 Giugno, giunge a Tripoli, con la XX Compagnia Sussistenza Tripoli. Viene catturato e dichiarato prigioniero di guerra, nel Maggio 1942, per mano degli inglesi e vi rimane fino al 20 Giugno 1946. Molte volte, il mese di Giugno ricorre nella vita di mio padre, soprattutto nel periodo di guerra. E’ ancora vivo per me il ricordo della sua voce che mi racconta degli accadimenti che ha vissuto tra il ‘40 ed il ’46: delle umiliazioni subite, delle sofferenze, della fame; dell’inaspettata gioia che provò, quando, durante la prigionia, a Tripoli, tra i catturati dagli inglesi, vide scendere da un camion suo fratello, zio Peppino, che non vedeva da tempo. Spesso raccontava un episodio: Si trovava con alcuni suoi commilitoni nel deserto libico. I loro spostamenti erano lenti e rischiosi. Un giorno, dopo lunghe ore di marcia, giunsero di fronte ad una stretta gola e vari elementi facevano supporre che fosse minata. Non sapendo come procedere, decisero di far passare il cammello che utilizzavano per il trasporto delle 108 loro suppellettili, per sondare il terreno. Fortunatamente, il paventato pericolo risultò infondato. Ma l’esistenza dell’animale doveva comunque avere un triste epilogo. Infatti, a distanza di qualche settimana, i commilitoni si ritrovarono in mezzo al deserto ed a corto di viveri. Resistettero diversi giorni ed alla fine furono costretti a prendere una drastica e dolorosa decisione: uccidere l’animale. Affidarono alla sorte la scelta di chi avrebbe dovuto sparargli, poi, decisero di cucinarlo in un bidone che avevano al seguito. Solo dopo la cottura, però, si resero conto che il bidone era stato precedentemente utilizzato come contenitore della nafta e, non essendo stato lavato bene, il carburante residuo era diventato insolito condimento per la carne del cammello. Ma i giovani soldati non poterono permettersi il lusso di non mangiarlo, e probabilmente tale pensiero non sfiorò nemmeno la loro mente. Ne agguantarono un pezzo ciascuno e lo divorarono come il più prelibato dei cibi, conservando il resto per il prosieguo del viaggio. Un pezzo di carne al giorno li aiutò a resistere fino a quando raggiunsero la base italiana. A sentire questi racconti, oggi, viene quasi da sorridere, ma credo che la brutalità cui una guerra sottopone l’uomo; l’umiliazione cui viene costretta la dignità umana; la sofferenza fisica e morale che deve subire un soldato dilaniano a tal punto l’anima da restare indelebili cicatrici che mai potranno essere sanate. Mio padre era una persona umile. La sofferenza vissuta in guerra l’aveva certamente segnato, e questo lo leggevo, a tratti, nei suoi occhi, e nel suo tono di voce, ma non aveva intaccato la semplicità del suo cuore. Forse, proprio la crudeltà della guerra lo ha portato, in seguito, a riflettere sui veri valori della vita e ad essere sempre disponibile con tutti e pronto a perdonare anche le offese più gravi, senza serbare rancore. Di lui mi resterà sempre il suo sorriso, la sua voglia di scherzare e la sua spontanea dolcezza. Tra le storie che mio padre mi narrava da bambina, quella che non mi stancavo mai di ascoltare è la storia del “Purcidduzzu ri Sant’Antonio” (il maialino di Sant’Antonio). Il periodo era quello della II Guerra mondiale. Mio padre e mio zio erano a Tripoli. I miei nonni, dal fronte, avevano ricevuto notizie da Peppino ma non sapevano nulla di Nicola (mio padre). Questa situazione li faceva vivere nell’angoscia. La nonna, in particolare, era invasa da una profonda tristezza. Le sue giornate trascorrevano nell’attesa, tra speranza e cattivi presagi. Nella sua mente e nel suo cuore albergava solo una preghiera a Sant’Antonio, affinché ricevesse notizie del figlio. Una notte, la sua supplica fu esaudita: sognò il Santo di Padova che la rassicurava, dicendole: “I tuoi figli sono vivi. Sono prigionieri ma stanno bene e tra qualche 109 giorno arriverà una lettera”. Il mattino successivo, svegliandosi di buon’ora, la nonna ricordò il sogno e sentì formarsi in lei una nuova speranza. Lo raccontò al marito ed alla figlia Concetta che viveva con loro e, piena di fiducia e di riconoscenza a S. Antonio che aveva compreso il dolore di una madre, si avviò, come ogni giorno, in campagna. Uscendo di casa, sullo stipite della porta, notò una falena, che noi centolesi chiamiamo “Purcidduzzu ri Sant’Antoniu”. La nonna la guardò e, con un sorriso appena accennato, uscì per affrontare l’ennesima giornata di lavoro nei campi. I giorni passavano e la falena continuava a stare sullo stipite, facendo compagnia alla seppur alleggerita sofferenza dei nonni, e partecipando alla loro umile quotidianità. Era trascorsa una settimana dal sogno, la nonna, uscendo, notò che la falena non c’era più. Senza porsi troppe domande si recò in campagna. Verso sera, rincasando, trovò una lettera sotto la porta. Il cuore cominciò a batterle forte e lei, che non era abituata ad esternare l’emozione, avvertì un forte fremito, che le scosse tutto il corpo. Nel riconoscere la grafia sulla busta, non riuscì a frenare le lacrime: strinse la lettera forte al petto e, spontaneo, dall’angolo più profondo del suo cuore, appena percepibile all’esterno, alzando gli occhi al cielo, le uscì un: ”Grazie”. Ripensò alla falena e capì che quella mattina non era più al suo posto perché aveva compiuto la sua missione ed era, forse, volata verso una casa, dove un’altra madre era in attesa di una speranza da custodire nel proprio cuore. La nonna, con le mani tremanti, porse la lettera a Concetta. Appresero così che mio padre e mio zio erano prigionieri ma che stavano bene. Da quel giorno, nella nostra famiglia, il “purcidduzzu ri Sant’Antoniu” è portatore di buone notizie. Negli ultimi tempi, le vicende di guerra in Libia, che hanno riempito i telegiornali, mi hanno fatto ricordare di quando mio padre mi parlava di Tripoli, di Tobruch, di El Alamein e dei bombardamenti; della commozione provata quando, deportato in Inghilterra, su una nave, credette di vedere la costa di Palinuro. Mi parlava di Oxford, Manchester e poi aggiungeva: – Un giorno, tornerò in Libia e in Inghilterra per rivedere quei luoghi da uomo libero. Ma il destino aveva disegnato altri scenari per la vita di mio padre. P.S. Mio padre e suo fratello Giuseppe hanno dato alla Patria parte della loro vita e della loro libertà. Il fratello di mia madre, zio Domenico, ha perso la vita, a soli 22 anni, nella II guerra mondiale. Grazie, zii. Grazie, papà. Con la collaborazione nella stesura di Maria Rosaria Lo Schiavo 110 Guerra 1940-45, i fratelli Giuseppe e Nicola Luise, da Centola, si incontrano per caso a Tripoli ( 1941 ). Entrambi furono fatti prigionieri. Paga per il lavoro effettuato durante la prigionia in Inghilterra dal prigioniero Nicola Luise. 111 Nicola Luise, marito di Maria Ciccariello (1913-1988). 112 Giuseppe Lupo LA NOTTE DELL’ABATE La Badia dominava possente la collina di San Leonardo, a un chilometro circa dal centro abitato di Centola. Circondata da una cinta di mura, aveva una serie di porticati ad arco che abbellivano l’insieme della struttura, che raggiungeva il suo massimo splendore nella chiesa abbaziale, a tre navate, una centrale e due laterali. Altri locali erano utilizzati per l’appartamento dell’abate, le celle dei monaci, depositi per i raccolti delle terre che erano di proprietà dell’abbazia, la foresteria che serviva per accogliere gli ospiti occasionali che di tanto in tanto facevano visita all’abate. Il quindici agosto del 1293, così come era tradizione, era ospite dell’abate di Centola, il governatore di San Severino. La giornata era splendida, la badia era stata costruita in una posizione fantastica, circondata da alberi secolari e un venticello alleviava la calura del mese di agosto. Le celle, che ospitavano i frati, abbracciavano con la vista la valle del fiume Lambro, i paesi dislocati sulle pendici del monte Gelbison e del maestoso Cervati; dall’altro lato impreziosiva il tutto il mare di Palinuro. Il governatore si era fatto accompagnare, nella consueta visita all’abate, dalla moglie e da quattro uomini di scorta. La mattinata era stata splendida, l’abate con grande cortesia, aveva accompagnato gli ospiti a visitare il grande giardino alberato e poi la chiesa . Come gli altri anni, anche questa volta il governatore e sua moglie erano stati affascinati dall’immensità dell’abside larga tredici metri e delle tre navate, che naturalmente erano ancora più ampie. L’amenità del posto aveva fatto il resto e l’ora del pranzo non tardò ad arrivare. Si sedettero a tavola l’abate, il governatore, la moglie, i quattro uomini di scorta e gli altri monaci dell’abbazia. Il pranzo fu abbondante e ottimo. La badia di Centola era molto ricca, i suoi possedimenti producevano olio, vino, ortaggi e frutta in abbondanza. Tra un bicchiere di vino e una deliziosa portata uscita dalla cucina dell’abbazia, il clima era allegro e spensierato. L’abate era particolarmente brillante. Questo racconto si è classificato al secondo posto nel concorso di narrativa 2012. 113 Affascinato dalle grazie della moglie del governatore, faceva sfoggio di tutta la sua cultura, facendo spesso riferimento a ciò che aveva appreso leggendo i preziosi manoscritti che erano custoditi presso l’abbazia. Gli ospiti, incuriositi, si erano fatti promettere, dopo pranzo, una visita alla biblioteca. Niente lasciava prevedere quello che di lì a poco sarebbe accaduto. I Commensali si erano da poco alzati da tavola e stavano riprendendosi dalle fatiche del pranzo, quando si scatenò il finimondo. Tuoni, lampi, scrosci violenti di pioggia si abbatterono sulla badia e su tutto il territorio circostante. Era arrivata una tipica tempesta pomeridiana estiva, conosciuta con il nome di “trupia”. La tempesta era talmente violenta che il governatore e i suoi accompagnatori non poterono lasciare la badia nell’ora convenuta. Avvicinandosi la sera, il temporale si era un po’ attenuato, ma continuava a piovere e nel cielo ancora saettavano fulmini. Il governatore pensò perciò di ritornare al Castello di San Severino con tre guardie del suo seguito, decidendo nel contempo di lasciar pernottare alla badia di Centola la giovane moglie. Il tempo infatti era ancora brutto, si avvicinava la notte e niente consigliava di fare affrontare il viaggio ad una giovane donna. Per maggiore sicurezza aveva deciso di lasciare in compagnia della signora una delle sue guardie. Partito il governatore, l’abate intensificò ancora di più le sue premure verso la moglie. Già durante la giornata non aveva tralasciato di essere gentile e cortese con lei, non facendo niente per nascondere la sua ammirazione, pur nel rispetto della presenza del marito. La signora infatti era un bella donna e l’abate non era insensibile al fascino femminile. Inoltre non gli sembrava vero che il temporale gli avesse offerto la splendida e insperata opportunità di avere ospite la donna senza la presenza del marito. Trascorse perciò la serata sempre accanto a lei, manifestando una premura financo esagerata, che la donna però mostrava elegantemente di gradire. Venuto il momento di andare a letto, fu talmente premuroso da fare una cosa che di solito lui, abate, lasciava fare agli altri monaci dell’abbadia. Infatti, accompagnò personalmente la moglie del governatore alla foresteria, nel locale che le era stato riservato per trascorrere la notte. La stessa cosa fece con la guardia, accompagnandolo alla sua stanza. Finalmente si ritirò nel suo appartamento. Provò a dire le preghiere, che di solito recitava prima di addormentarsi, ma la cosa 114 fu per lui molto faticosa perché il pensiero correva sempre a quella bella donna che riposava, sola, poco lontano da lui. Cercò di imporsi un comportamento da abate, tentando di prendere sonno. Niente da fare, il pensiero di quella donna era diventata ormai un’ossessione. Si girava e rigirava nel letto, cambiava posizione, chiudeva gli occhi, ma il sonno non arrivava. Intanto, le ore passavano e il desiderio aumentava sempre di più. Era talmente eccitato che niente gli sembrava potesse impedirgli di appagare quella passione che così violentemente si era impadronita di lui. E allora ruppe gli indugi, prese un lume ad olio, uscì dalla sua cella e si avviò verso la foresteria, dove riposava la donna. L’emozione lo prendeva alla gola, le gambe gli tremavano, a stento riusciva a tenere fermo nella sua mano il lume, aprì, piano e senza fare rumore, la porta e si avvicinò al letto. Tremante, emozionato ma terribilmente eccitato, allungò la mano per accarezzare la deliziosa testa della donna. Ma non appena sentì il tocco della sua mano, la persona che riposava in quel letto, sobbalzò e si alzò immediatamente. Era la guardia, che aveva scambiato stanza con la sua padrona. Lei, infatti, insospettita da tutte le attenzioni dell’abate, dopo la partenza del marito, aveva temuto, a ragione, che durante la nottata l’abate potesse provarci. Aveva perciò chiesto alla sua guardia di cambiare stanza. L’abate ci mise un po’ di tempo per capire la situazione; già si vedeva tra le braccia della bella e giovane donna in una notte di fuoco e si ritrovò ad accarezzare quella guardia pelosa e muscolosa. La vergogna fu enorme, scappò nella sua cella, si chiuse dentro e vi restò anche la mattinata successiva. Quando la moglie del governatore si svegliò, scese nel refettorio per la colazione e chiese naturalmente dell’abate. Le sembrava poco cortese iniziare la colazione senza attendere il suo ospite. Intanto era scesa anche la guardia. Ma arrivò un monaco che, su incarico dell’abate, le riferì che poteva tranquillamente fare colazione perché l’abate era indisposto, colpito da un malessere improvviso e non poteva farle compagnia. Mortificato, si scusava con lei. La vergogna era tale che non aveva il coraggio di comparire al cospetto dei due. Mentre facevano colazione, la guardia raccontò alla donna quanto era accaduto durante la notte, svelandole così la natura del suo malessere e complimentandosi con lei dell’intuito che aveva avuto nel prevedere il comportamento dell’abate. I due risero a crepapelle, era troppo divertente immaginare la sorpresa e la delusione dell’abate nel constatare lo scambio di persona. I monaci presenti non capivano e non si spiegavano perché la malattia del loro abate 115 provocasse nei due tanta ilarità. Naturalmente, il marito non seppe mai del fallito tentativo dell’abate. La donna preferì tacere per evitare di rovinare i rapporti tra l’abate di Centola e il Governatore di San Severino. La guardia fece lo stesso. Forse. 116 Giuseppe Lupo LA FESTA DI PASCUCCIO Avevo dieci anni, stavo andando a scuola. Ricordo che la mia classe era situata al primo piano del Convento, nell’ ultima stanza, a destra di chi guarda . L’insegnante era la sig.ra Anna Marotta, di cui ho un ricordo bellissimo. Severa e al tempo stesso affettuosissima con noi ragazzi. Come al solito, ero abbastanza contento di andare a scuola; le tasche piene di fichi secchi, che allora erano la nostra merendina; i compagni che man mano aumentavano di numero via via che dalla Serra arrivavamo nella Piazza Vecchia e poi lungo la discesa che ci avrebbe portato alla Giardina e quindi al Convento. Allora non c’era lo scuolabus, ma questo non ci pesava; fare tutta quella strada insieme agli altri bambini per noi era una festa. Era il 21 novembre e, arrivati all’altezza della “fontana vecchia “, all’improvviso scoppiò un violento temporale. Fulmini saettavano nel cielo, il vento agitava i rami del grande albero che era proprio accanto alla fontana, una pioggia violenta e insistente incominciò a venire giù. Trovammo rifugio nei locali della falegnameria di Gerardo Mangia, che era lì, nei pressi. Una persona anziana che si era fermata, come noi, per trovare riparo dalla pioggia, rivolta a noi bambini, disse: – Non vi meravigliate, oggi è “a festa ri Pascucciu” –, oggi è la festa di Pascuccio. Il falegname lo guardò e annuì, ma noi bambini, naturalmente, non capimmo cosa l’uomo volesse dire, e scorgendo una momentanea tregua della pioggia, scappammo di corsa verso la scuola. La giornata scolastica passò via normalmente, fuori continuava a piovere, ma noi al sicuro seguivamo la lezione della nostra maestra. Non è che l’aula fosse particolarmente confortevole, il riscaldamento non sapevamo neppure cosa fosse, spifferi entravano dalle finestre malmesse, ma almeno non ci pioveva. Durante la mattinata, mi ritornò più volte in mente la frase che aveva pronunciato quel signore, ma non osai chiedere spiegazioni alla maestra . Quando fui a casa, la curiosità divenne più forte, anche perché continuava a piovere e non capivo cosa avesse a che fare il cattivo tempo con la “festa di Pascuccio” di 117 cui aveva parlato quel vecchio. Con la speranza di saperne qualcosa di più, raccontai l’episodio a mio padre. Lui mi guardò incuriosito e, allo stesso tempo, divertito. Voleva saperne di più, mi chiese notizie di quel signore che avevo incontrato nella falegnameria; ma io non fui in grado di aggiungere altro. E allora incominciò a raccontare . Viveva a Centola un sacerdote che si chiamava don Gaetano Pascuccio . Non provava molta simpatia per i Borboni che ancora regnavano nell’Italia Meridionale e meno ancora amava i briganti. In quegli anni nella zona di Centola imperversava la banda di Nicola Marino e frequenti erano le colleganze tra la politica e la delinquenza. Spesso i briganti venivano utilizzati e strumentalizzati per i giochi della politica, nella lotta tra filoborbonici e liberali. Don Gaetano aveva un fondo in località Lacci, in posizione molto amena: ricca di alberi da frutta, di ulivi, di un magnifico vigneto, di pascoli e impreziosito dalla presenza di un piccolo specchio d’acqua, alimentato, oltre che dall’acqua piovana, da una ricca sorgente. Sulle rive di quello specchio d’acqua, don Gaetano aveva fatto costruire un fabbricato rurale, che egli utilizzava come ricovero per sé, per i suoi attrezzi, per la campagna e per il raccolto delle sue coltivazioni. Presso quel piccolo lago, varie specie di uccelli migratori si fermavano per riposarsi delle fatiche del loro lungo viaggio. E don Gaetano non disdegnava di sparare qualche colpo con il suo fucile da caccia, per puro divertimento, più che per procurarsi del cibo. Ogni mattina il sacerdote, dopo aver celebrato la messa, prendeva la sua mula e si recava a “Lacci”. Quel posto era per lui un angolo di paradiso, dove poter tranquillamente coltivare la sua terra e meditare sulle vicende politiche che tanto lo appassionavano. Era infatti un convinto liberale. Anche quel giorno, il 21 novembre del 1855, don Gaetano, dopo la messa, prese la mula e raggiunse la sua campagna. Di lì a poco, si scatenò una grande tempesta: tuoni, fulmini, pioggia in abbondanza. Don Gaetano si rifugiò nel suo “malazzeno” e paziente si mise ad attendere che il cattivo tempo passasse. Trascorse il tempo un po’ leggendo il suo breviario, un pò pregando, un po’ guardando dalla finestra il vento che increspava le acque del suo lago. Intanto, le ore passavano e la tempesta non accennava a cessare. Incominciò allora a preoccuparsi, ma non per sé. Lui lì stava bene, si sentiva in pace con sé stesso e con il buon Dio. Incominciò però a pensare ai suoi familiari che, a Centola, in via Serra, sicuramente 118 erano preoccupati sapendo il loro congiunto in campagna e con quel terribile temporale che sembrava voler aumentare di intensità sempre di più. Nel frattempo, era già il tramonto. Decise allora di affrontare la tempesta e di far ritorno a casa. Prese la sua mula, la preparò, si coprì ben bene con una mantella che, durante i mesi invernali, portava sempre con sé, poggiò un piede sulla staffa e si accinse a salire sul dorso dell’animale. All’improvviso, alcuni colpi di fucile si confusero con il rumore dei tuoni, don Gaetano cadde a terra morto. A Centola, intanto, i suoi familiari si preoccupavano sempre di più, non vedendo arrivare il loro congiunto. Si erano già fatte le otto di sera, quando sentirono un forte colpo alla porta, si alzarono, veloci, dagli scanni su cui erano seduti e accorsero all’uscio di casa. Aprirono e videro la mula di don Gaetano che con la testa premeva contro la porta. Di don Gaetano nessuna traccia. I familiari sapevano delle simpatie politiche del loro familiare e dei rapporti non buoni con i briganti e pensarono subito al peggio. Diedero l’allarme e tutti si diressero in località Lacci, dove trovarono il corpo di don Gaetano, vittima di ignoti, nel posto che forse egli amava di più. Da allora, la pietà popolare ricorda il 21 novembre come la “festa di Pascuccio” e ogni anno, in quel giorno, si scatena un terribile temporale, esattamente come accadde nel giorno in cui fu ucciso il sacerdote nemico dei Borboni e dei briganti. E quello specchio d’acqua a Lacci, incastonato nel fondo tanto amato da don Gaetano, è diventato per tutti “il lago di Pascuccio”. . 119 Centola, loc. Giardina: “a funtana vecchia”. 120 Centola, cartolina che riproduce il convento dei Cappucini del XVII sec. 121 Anna Natale ARRIVANO I FRANCESI I sabato di luglio e d’agosto rappresentavano per noi bambini della piazza e del vicolo una scadenza da segnare sul calendario, un appuntamento a cui non poter mancare… Come accadeva da qualche anno, avremmo assistito al passaggio delle corriere che portavano i turisti francesi al Club Méditerranée. Il Club costituiva un fiore all’occhiello per il nostro comune. Un turismo, quello francese, che portava sulle spiagge tantissime persone disposte a spendere, a divertirsi e a far divertire. Venivano numerosi e di tutte le età, intere famiglie e comitive di giovanotti e ragazze. Soprattutto ragazze. I gruppi s’avvicendavano con cadenza settimanale. Mentre il pullman del ritorno passava alle prime luci dell’alba, quello dell’arrivo era solito arrivare a metà del pomeriggio. Noi bambini, già dopo pranzo, ci mettevamo lungo la strada ad aspettare, ma non mancavano neanche gli adulti, specialmente i ragazzi in cerca d’avventura. Ricordo che l’autista suonava ripetutamente il clacson, non appena arrivava nella stretta e ripida salita prima della piazza. Ci alzavamo di scatto dal muretto e iniziavamo a salutare: – Ciao Francesi, ciao! – urlavamo a squarciagola. Il momento più emozionante era quando la grande corriera colore blu marino ci passava davanti. Procedeva con un andamento leggero, lento così che noi potevamo respirare il profumo che il vento portava fuori dai finestrini. I Francesi rispondevano con enfasi ai saluti, sventolavano i fazzoletti e sorridevano divertiti. Fra tanti arrivi, ce ne fu uno indimenticabile. Il pullman, nella salita, rimase bloccato per il sopraggiungere, sul lato sinistro, di un altro mezzo pesante. Furono necessarie parecchie manovre e quindi fu deciso di far scendere i passeggeri. Non credevamo ai nostri occhi. I Francesi, anche se solo per pochi minuti, sarebbero stati in mezzo a noi. Avremmo potuto ammirarli in tutta l’interezza del corpo e avremmo potuto respirare da vicino il sentore della loro pelle. A noi, quegli stranieri sembravano di una bellezza straordinaria. Ci incutevano cu122 riosità ed allo stesso tempo timore e, se ripenso a quei momenti, mi sovviene l’immagine vista nei libri di storia dei marinai di Colombo tra gli Indio. Erano quasi tutti biondi, alti, poco vestiti, con gli occhiali da sole e, ai piedi, i sandali infradito. Cingeva il collo di grandi e piccini, di uomini e donne una collana formata da tante palline di legno, variamente colorate. Quel vezzo suscitò in noi una grande invidia. Avrei dato in cambio il cerchio dell’hula hop pur di averne una… Dispensarono sorrisi cordiali e, quando ripartirono, dal finestrino, ci mandarono i baci con le mani. – Beati loro che sono Francesi! – dissi ad alta voce; lo sguardo deluso dei miei amici lasciava capire che erano della mia stessa opinione. Così, già dalla domenica, aspettavamo l’arrivo successivo e si studiava il posto migliore per riuscire a vedere il mezzo da quando giungeva nella salita fino alla curva delle “Pietre Rosse”. L’ultimo passaggio coincideva con l’ultima settimana d’agosto. Quello era un appuntamento triste perché dopo non ce ne sarebbero stati altri e, di lì a poco, il mare, e noi con lui, sarebbe rimasto nuovamente solo. 123 Anna Natale LA VENDITRICE D’ABITI USATI Veniva ad ogni cambio di stagione. Scendeva lentamente dalla corriera che, alla fermata convenuta, sostava più del solito per permetterle di scaricare i bagagli. Eh sì, lei aveva tanti bagagli, ma non borse o valigie come si può pensare, bensì fagottoni di stoffa. Uno, due, tre… tanti fagotti legati stringendo i quattro angoli in un unico grosso nodo centrale. Così era tutte le volte. Una proprietaria tra i suoi averi. Quando, infine, il marciapiede appariva tappezzato di rosso, di marrone, di giallo, di nero e la corriera riprendeva la corsa, iniziava la fatica. Lei trasportava tutto quanto sotto il terrazzo di casa mia: lì, proprio in piazza. Conoscevo così bene le sue abitudini che col pensiero la precedevo nei gesti. Mi incuriosiva guardarla attraverso la tendina della finestra. Non ho mai saputo darle un’età. Non ho mai saputo il suo nome. La chiamavo semplicemente “Signora Minù”, per la somiglianza con la protagonista di un omonimo cartone animato. So di certo che veniva da Napoli: acquistava abiti usati ai mercatini rionali, gli stessi abiti di cui erano colmi i suoi fagotti e che andava vendendo nei paesi del Cilento. Si fermava solitamente una decina di giorni. Lì, proprio sotto il mio terrazzo… La osservavo mentre disfaceva gli involucri e pazientemente cercava di dare un ordine logico agli indumenti: per uomo, per donna, per bambino… giacche, pantaloni, gonne… Ed eccola, poi, piegare, tagliare, intrecciare e, con ago, filo e ditale, rammendare. Con la Signora Minù aveva in comune la corporatura grassottella, il naso sempre rosso, una grossa crocchia sul capo, ma soprattutto gli occhi vispi e attenti a che nessuno rubasse i suoi tesori. Sulle spalle (d’inverno e d’estate), un vecchio scialle nero dalle frange sempre più rade. Mi sarebbe piaciuto molto parlarle, ma mia madre non mi permise mai di scendere per andare a rovistare tra gli abiti esposti in quella vetrina a cielo aperto. Una vicina di casa, sua cliente, mi confidò che la “pannazzara”, come la chiamavano in paese, era una vera affarista: comprava gli indumenti a peso, li sistemava alla meglio e poi 124 li rivendeva singolarmente. Un vero guadagno. Si sussurrava anche che avesse tanti soldi da parte e una bella casa. Aveva ereditato quel lavoro dalla madre che, come lei, aveva dormito sotto le stelle, usando, come materasso, morbidi, colorati cenci. 125 Anna Natale QUANDO IL DIVERTIMENTO CI VENIVA A CERCARE C’erano degli arrivi che periodicamente venivano a sconvolgere la tranquilla vita di paese e, in particolare, di noi che abitavamo intorno alla piazza. Eravamo invidiati da tutti. A noi bastava aprire i finestrini per assistere agli arrivi, ai preparativi, alle prove, agli spettacoli all’aperto e, ahimè, alla partenza degli “ospiti”. Alle mie compagne, a mia sorella ed a me piaceva soprattutto la giostra. Sotto un finto cielo blu cobalto, tempestato di stelle e lune, bellissimi cavalli dagli occhi grandi e dolci si rincorrevano in un girotondo che speravamo non finisse mai. Noi, giovani Amazzoni, regalavamo le nostre trecce al vento… I giovanotti, ma anche i babbi e qualche nonno, amavano il teatro. Tra i protagonisti del teatro viaggiante, c’era sempre una bella ragazza disposta a fare un malizioso spogliarello sulle note di “E levate ‘a cammisella”. Il tutto avveniva tra urla deliranti, seguiti da fischi di delusione, quando lo spogliarello finiva sul più bello… Era super emozionante vedere dal vivo un pezzetto di televisione. Attori, attricette dai capelli gialli come il sole, truccatori, maschere facevano parte di un mondo magico, lontano anni luce dal nostro quotidiano. Per la vigilia della festa dedicata alla Madonna di Pompei, se le offerte erano state generose, potevamo assistere alla proiezione di un film!!! “Stasera cinema all’aperto”, si leggeva sui manifesti attaccati sulle mura della chiesa e della tabaccheria. Uno spaghetti western ci avrebbe proiettato nella rivoluzione messicana. Un bel film mitologico ci avrebbe fatto sudare con Ercole o con Maciste. Con largo anticipo sull’orario d’inizio, la piazza si riempiva di spettatori d’ogni età e, quando finalmente si spegnevano le luci, anche i piccioni se ne stavano in silenzio nella colombaia… Il più gran successo spettava senza dubbio al circo. Puntuale tutti gli anni tornava… “AL CIRCO DI SCARPACOTTA”. C’era tutto un mondo da vedere e da scoprire, sotto quel tendone a strisce variopinte e nella carovana di roulotte colorate. 126 Mi sconvolgeva il numero della contorsionista. Infilava il corpo seminudo tra le sbarre delle sedie, proprio come un bruco che esce ed entra in una mela. La invidiavo, così agile, così magra e poi poteva girare per l’Italia. Mi chiedevo se era già stata a Roma o a Firenze. Forse aveva visto la torre di Pisa e il Duomo di Milano!!! Il proprietario, Scarpacotta, era un mago- pagliaccio destinato a far ridere tra schianti e finte magie. Urlava e piangeva. Cadeva e si rialzava. Aveva una straordinaria mimica facciale. Faceva finta di mangiare le mosche con l’enorme bocca rossa sotto l’immancabile naso a ciliegia. Ai piedi, delle enormi scarpe, esageratamente lunghe, ma non “cotte” come diceva il suo nome. Alla fine dello spettacolo, seguito dal cane, un bastardino bianco e nero di nome Mordillo, passava fra il pubblico con un cappello in mano. Così, fra il tintinnio delle monetine da cinque, dieci e venti lire, si spegnevano le luci e il silenzio avvolgeva la piazza. Quando la famiglia degli artisti andava via, lasciava un vuoto dentro di noi, proprio come quando finivano le vacanze di Natale e la mamma metteva in soffitta le statuine del presepe. 127 Anna Natale ROSSO POMODORO Il vicolo viveva giornate particolari quando i pomodori, ben maturi, erano pronti per essere trasformati in passata o, secondo il bisogno o il gusto, in pelati. Un vero e proprio rito o meglio una tradizione a cadenza fissa (la seconda metà di luglio), che vedeva coinvolti grandi e piccini. Le donne “matriarche” ne parlavano tra loro già dall’inizio del mese e stabilivano i turni in modo da potersi aiutare reciprocamente. Ricordo che mi piaceva in modo particolare andare dalla comare Pinuccia. Lei di passata ne faceva davvero tanta, visto che le doveva servire anche per i clienti che ospitava nel suo piccolo ristorante e che ritornavano puntuali ad ogni estate. Le casse colme di pomodori maturi arrivavano in casa con un paio di giorni d’anticipo e venivano ammonticchiate a mo’ di letto a castello. Era poi necessario lavare le bottiglie e i barattoli di vetro che avremmo riempito nel giorno tanto atteso. Di solito, s’iniziava di buon’ora e noi bambini ci alzavamo all’alba come i grandi. Indossato il grembiule, iniziavamo. Ci venivano dati i pomodori tagliati a metà e dovevamo metterli nei vasi, uno sopra l’altro, intervallando qua e là con qualche foglia di basilico: era accattivante guardare attraverso il vetro e veder crescere quel mucchietto rosso macchiato di verde fresco. Intanto, i piedi e i sandali si riempivano di semi e si sporcavano. Alle donne (tra queste mia madre) spettava un incarico più gravoso e certo meno divertente. Si organizzavano come una catena di montaggio e raramente sbagliavano i modi e i tempi di lavoro: chi spaccava i pomodori, chi con mano leggera estraeva i semi, chi manovrava la macchinetta, chi riempiva le bottiglie e infine c’era chi le tappava. Era una vera e propria festa! Il tutto avveniva tra racconti, barzellette, canti e, perché no, qualche litigata. – Comare Pinuccia, Titina ha nascosto il basilico. – Uffa! Elena mi prende in giro e mi schizza. Così, si andava avanti fino a che tutti i pomodori, nella nuova veste, non erano stati intrappolati nei contenitori. A quel punto, ci si concedeva una meritata pausa e una genuina merenda. Parte dei semi andava a ricoprire le lunghe e alte fette di pane che la padrona di casa aveva disposto come petali di fiore nei vassoi di ceramica. Olio, aglio, sale e origano contribuivano a fare di quel semplice cibo una vera ambrosia. 128 “Haggio schiattato quatte pummarole ‘ngopp ‘a ‘nu cuzzitiello re pane re grano: ‘na punta r’aglio, nu filillo r’uoglio, ‘nu pizzico r’ariemu e de sale” Recitava la padrona di casa mentre, sul grande tavolo di legno, disponeva rosse fette di cocomero per togliere la sete. – Tornate nel pomeriggio, – raccomandava poi a noi bambini, – ci sarà un ghiacciolo per tutti. Prima che il sole raggiungesse il punto del vicolo destinato alla bollitura, sui sassi inceneriti veniva posizionato il treppiede e quindi il grosso calderone. Quel recipiente era un punto in comune per le famiglie del vicinato. Qualcuno lo aveva comprato, ma poi era diventato di tutti… Concetta, che aveva le braccia lunghe, mimando un esercizio ginnico, andava in su e giù e posizionava le bottiglie prima e i barattoli poi, nella grande bocca nera. Il tutto veniva coperto d’acqua e protetto con sacchi di iuta fermati da piccoli sassi. Finalmente, si poteva accendere il fuoco e dare il via alla cottura che non doveva mai essere veloce, altrimenti il vetro si sarebbe rotto. Era un autentico spettacolo e perciò non mancavano gli spettatori. Il muretto in pietra diventava un salotto all’aperto; gli occhi rimanevano puntati su quelle fiamme che come in un film di streghe e stregoni erano indispensabili per la buona riuscita del prodotto finale Intanto, il sole si era alzato nel cielo e distribuiva le nostre ombre sull’acciottolato. Era l’ora in cui tutti si sarebbero ritirati in casa per il pranzo e il meritato riposo pomeridiano. In giornate come quelle, il sonno giungeva facilmente, ma noi bambini rimanevamo ugualmente svegli e fuori di casa, con la scusa di fare da guardiani al calderone. Le nostre guance diventavano rosse, mentre impazienti aspettavamo che nel pomeriggio la comare Pinuccia offrisse ai grandi il caffè e a noi bambini l’agognato ghiacciolo. Quel ghiacciolo lei lo faceva in casa con le formine riempite di succo di limone, di arancia e di menta. Al resto pensava il freezer. Sul bastoncino di legno non c’era scritta nessuna marca. Eppure il sapore era ugualmente buono ed io, se chiudo gli occhi, lo sento ancora, forse perché i bei ricordi e i buoni sapori vanno oltre le cose che passano. 129 Cartolina che riproduce una vista del Club Méditerranée di Palinuro. Antica cartolina di Palinuro del 1941. 130 Giovanni Profice ACCADDE E ACCADE ANCORA Tra i tanti episodi ascoltati in famiglia, quello che ha toccato di più la mia sensibilità è stato quello legato ad un giovane rimasto vittima della simpatia mostrata nei confronti di una giovane del suo paese. Tale assurdo delitto ebbe origine da una battuta scambiata tra Valente Giuseppe e Stanziola Raffaele, padri rispettivamente di Raffaella e Lorenzo. – Tuo figlio si merita di essere ucciso! – fu l’esclamazione del padre di Raffaella, avendo saputo da un “amico” che il diciassettenne Lorenzo, più di una volta, aveva rivolto le sue attenzioni alla figlia. Raffaele, di rimando, convinto che il suo interlocutore avrebbe afferrato l’ironia della risposta, disse: – Uccidilo tu! E quello lo fece davvero! Non ho conosciuto questo mio parente, ma io e quelli della mia età conoscevamo bene il fratello più giovane: un carattere allegro che riusciva ad esprimere un umorismo vivo e gioioso, non privo di una fine intelligenza. Mi sono spesso chiesto se il “DNA” dei due fratelli contenesse gli stessi caratteri. Probabilmente, se i tratti genetici del fratello maggiore fossero stati più simili al minore, avremmo avuto un’altro tipo di famiglia. Purtroppo, qualche anno in più d’età, la ristrettezza culturale e la legge meno restrittiva che rendeva legale la “vendetta d’onore” hanno dato al fratello maggiore facoltà di credere di agire per il meglio. Quelle rivolte alla giovane erano solo delle innocenti espressioni di simpatia. Frasi scherzose ed ironiche ma che i tempi e la società dell’epoca non potevano comprendere. Non reagire ad un fatto del genere, non rispondere in modo deciso significava dimostrarsi deboli, essere persone senza onore. La società di oggi avrebbe certo considerato i due giovani aperti ed intelligenti. Ho anche pensato che tale fatto è forse stato letto come una forma di stalking. Poi, mi son detto che lo stalking è più legato ad una società in cui vige l’indifferenza, cosa che all’epoca era inconcepibile, il paese era molto più piccolo e le famiglie erano più unite da affetto sincero e leale. Forse è per questo che, oggi, non si concepisce la giustificazione per i “delitti d’onore”, anche se, per mezzo dei mass media, siamo sopraffatti quotidianamente da fatti di sangue versato per motivi ancor più gravi e mostruosi. 131 Giuseppina Raimondo UNA STORIA DI CASA NOSTRA Maria si era alzata molto presto, in quella tiepida mattina di primavera, e, con la quarta in testa e il secchio con i panni, si era avviata alla fontana vecchia. Il sole illuminava appena le colline ad est del piccolo borgo marinaro ancora immerso nel torpore. Solo il respiro del mare si effondeva tra le case e per le viuzze costeggiate di fichidindia. Alcuni gozzi remavano verso il porto con il magro ricavato di una notte di pesca: qualche chilo di triglie o di seppie. Maria, con l’agilità dei suoi diciassette anni, risale una via acciottolata fiancheggiata da orti profumati di zagara e, attraversata l’unica via asfaltata che porta alla piazzetta, dove sorge il campanile e la chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, giunge alla fontana vecchia, a monte di essa. Non c’è ancora nessuno, a quell’ora. Di solito, verso le sette, una schiera di donne, ciascuna con la propria quarta, vi si raduna per attingere acqua. La fontana vecchia è il luogo di ritrovo quotidiano, dove vengono diffusi e commentati tutti i fatti del paese: i fidanzamenti, gli imminenti matrimoni, i bisticci e i tradimenti, le nascite e le morti. Per fare la provvista quotidiana, le donne devono fare parecchi viaggi alla fontana, portando sulla testa l’apposito recipiente di terracotta di venti litri, la quarta appunto, perché a Palinuro, nei primi anni cinquanta, nelle povere case dai muri screpolati e cotti dal sole non c’è acqua corrente: l’unica riserva d’acqua per le necessità quotidiane è costituita da due o tre quarte che troneggiano su un apposito rialzo della cucina. I bagni poi sono un lusso, sconosciuto anche ai ricchi. Maria, svelta, sciacqua i panni, non molti perché, appena una settimana prima, la mamma aveva fatto la colata. Sbattendoli sul lavatoio, canta, pensando di non essere ascoltata ed ha quasi finito quando sopraggiungono altre ragazze che, avendola sentita cantare, scherzano sul motivo della sua presunta allegria. Ma Maria ribatte: – Altro che allegria! Uccello in gabbia o canta per amore o per rabbia. Negli ultimi mesi, infatti, la sua vita è stata sconvolta: suo padre, partito per l’America in cerca di fortuna, non dà più notizie di sé, non manda una lira, non si sa se è morto o se è vivo. Le donne, che conoscono tutta la vicenda, le rivolgono parole di conforto, invitandola a confidare in Sant’Antonio del Porto che è tanto miracoloso. 132 – L’avissa fa’ puri pe’ mme nu mmiraculo S. Antonio, – aggiunge Maria, – com’ha fatto pe’ marinari ‘a notte ra tempesta, o’ 25 settembre: avissa fa’ torna’ a patrimo ra l’America. Rosetta, una ragazzetta a cui piace molto chiacchierare, in attesa di riempire la quarta, a tal proposito porta la notizia che i marinai, scampati alla tempesta, hanno deciso di fare una grande festa di ringraziamento in onore di S. Antonio del Porto: ogni anno, il 25 settembre, porteranno la statua miracolosa del Santo in processione sul mare. Zì Giorgio, inoltre, farà una questua per il paese, per la manutenzione della chiesetta del Porto. Maria non partecipa ai pettegolezzi, non le interessa più niente; in quel periodo si sente abbandonata, la sua famiglia vive un momento di grande incertezza e ristrettezza economica. Ma c’è qualcuno che pensa notte e giorno a lei e che quando la vede non ragiona più: è Totonno, il giovane marinaio che abita con i suoi alla Ficocella, in una casetta di appena due vani, circondata da gerani e rosmarino. Il giovane le ha messo gli occhi addosso da tempo e il suo cuore palpita al solo pensiero di lei. Sogna di sposarla, non gli importa che è povera e non ha dote, penserà lui a tutto: lavorerà notte e giorno, se necessario. Maria, in realtà, è di una bellezza che non passa inosservata, nonostante la modestia del suo vestire: gambe lunghe e ben tornite, figura slanciata dalle forme armoniose di giovane donna, e un viso roseo e fresco ancora di bambina, contornato da una massa di capelli neri raccolti in una lunga treccia. Quella mattina, Totonno, di ritorno dal porto, con la sporta quasi vuota di pesce, dopo essersi accomiatato dal suo amico Vincenzo, con la scusa di farsi una bevuta d’acqua fresca, sale verso la fontana, deciso a fermare Maria, qualora l’avesse incontrata. Ella aveva appena intrapreso la via del ritorno con la quarta piena e il secchio dei panni sotto il braccio, quando Totonno, vedendola da lontano, la raggiunge e la ferma. Il giovane pescatore semianalfabeta è paralizzato dalla timidezza, ma trova il coraggio di dichiararle i suoi sentimenti, con le parole di un’antica canzone cilentana: “Sia biniritto chi criavo lu munno ca lu sapette tanto bello fare. Criavo la notte e po’ criao lu juorno e po’ nce criavo li stelle pe meravigliari. Criao lu mare e po’ criao l’onna E po’ la varca pe nce navigari. Poi nce criao a ti, bella figliola, ca ‘o cori mi fai sempe sparpitari.” – Ma che dici? Fussi asciuto pacciu stammatina? – dice Maria, mostrandosi risentita, ma in cuor suo compiaciuta dell’attenzione di Totonno. Ella, in un primo momento, teme che Totonno voglia prenderla in giro ma poi, dato che da qualche 133 tempo anche lei prova una forte simpatia per questo giovane forte, prestante e dallo sguardo onesto, confessa di non essere indifferente ai suoi sentimenti e di amarlo nel segreto del suo cuore. Maria torna a casa con le gote in fiamme e il cuore colmo di speranza, mentre Totonno sente esplodere dentro di sé una gioia incontenibile che vorrebbe gridare al mondo intero. Con quattro salti egli si trova sulla Ficocella per dare la notizia ai suoi e per sollecitarli ad andare a portare la “mmasciata”, la richiesta ufficiale della mano di Maria, a sua madre. A casa, Maria non trova sua madre ma sa già dove potrebbe essere andata. Tresina, quella mattina, era andata dalla comare Assunta per chiederle un piacere: – Ne cumm’Assu’, scrivitimmilla ‘na littri a maritimo Minicuccio, a Merica, ca i’ nun sacciu scrivi –. Le aveva portato in dono tre pezzi di sapone che lei stessa aveva fatto qualche giorno prima, cosa che Assunta aveva molto gradito. Assunta è una donna sui quarant’anni, nubile e molto religiosa, che insegna a ricamare alle ragazze che si preparano il corredo. Una decina di ragazze, tutti i pomeriggi, siede sulla sua terrazza che guarda il mare, protetta da un muretto ornato di vasi di gerani rossi; esse ridono e scherzano, mentre l’ago sale e scende nella tela tesa sul telaio, sognando un bel giovane in divisa, un carabiniere o un finanziere, che le sposi e le porti a vivere in città, in una casa dove c’è l’acqua e il bagno. Spesso si divertono a prendere in giro zia Filuccia, sorella più anziana di Assunta, che è analfabeta e un po’ tarda a comprendere l’argomento di cui si parla o capisce fischi per fiaschi. Assunta, oltre ad insegnare l’arte del ricamo, dà loro consigli e ammonimenti e le esorta a confidare nella Madonna. A metà pomeriggio, infatti, soprattutto nel mese di maggio, si smette di scherzare per recitare il rosario. Tresina, non essendoci le ragazze, la mattina, prima di scrivere la lettera, si sfoga con Assunta, lamentandosi della sua vita di stenti: d’inverno deve andare a raccogliere ulivi a tierzo e a fare legna, d’estate deve fare la colata e trasportare acqua per la gente, salare pesce per mandarlo a vendere, andare a giornata nei campi. E’disperata non solo perché il marito non dà più notizie da mesi, ma perché anche il figlio vuole partire per l’America. In tal modo, verrà a mancare quel minimo sostegno economico che egli le dà, andando a pescare e a vendere il pesce nei paesi dell’interno. Ha anche una figlia da marito: e chi se la sposa senza dote e senza corredo, dato che non le ha potuto comprare neanche uno straccio? Assunta, però, la consola, esortandola ad aver fede nella Provvidenza che, secondo lei, è intervenuta proprio a proposito, visto che un uomo del paese, Gaetano, detto Viluozzo, ha messo gli occhi su Maria e le vuole fare la “mmasciata”. Certo è un po’ più maturo rispetto a lei, e anche un po’ guercio, ma sta bene economicamente, possiede una casa a Pianofaracchio, terre alla Portigliola e si vuole sistemare. Se Maria lo sposasse, farebbe la sua fortuna, potrebbe fare la signora. Tresina non è del tutto contenta di questo pretendente ma, si sa, la povera gente non 134 può permettersi il lusso di scegliere, bisogna che si accontenti. Calmatasi un poco a questa notizia, detta la lettera per il marito, mettendoci tutta l’anima e la speranza che essa vada a buon fine, che arrivi a Minicuccio suo, con l’aiuto di sant’Antonio del Porto. Avevano appena conclusa la lettera, quando Maria sopraggiunge in cerca della madre che non aveva trovata a casa. Le due donne colgono l’occasione per dare a Maria la notizia della richiesta di matrimonio da parte di Gaetano, soprannominato Viluozzo. – Ma site asciute re capo? I’ m’avisse spusa’ du viecchiu ‘nzallanuto? – grida Maria su tutte le furie, – mi voglio more re fame, me ne vavo a fa’ monaca, ma a chiddu ca ricite vui i’ nu m’’o spuso. Si ‘o vulite proprio sapi’, u nnammurato mio è … – Chi è? – la interrompono ansiose le due donne. – E’ Totonno, u marinaro ca stai ncopp’ ‘a Ficucella! Tresina accoglie la notizia con una certa preoccupazione perché Totonno è tanto un bravo giovane ma è povero, mentre Viluozzo, sebbene più attempato e meno attraente, avrebbe assicurato un prospero avvenire alla figlia. Ma non si può avere tutto dalla vita! I due giovani però, nonostante l’intenso sentimento che li unisce, sanno che non sarà facile coronare il loro sogno d’amore. Soprattutto Maria è consapevole che in questo paese non si può vivere solo di pesca: il mare è avaro e amaro. Lo sa bene lei che ha visto emigrare il padre, stanco di passare la vita a bordo di una cianciola, senza poter portare a casa quel tanto per dare alla famiglia una vita dignitosa. Tante volte Totonno, parlando con l’amico Vincenzo, fratello di Maria, delle difficoltà economiche che impediscono ai giovani del paese di realizzare i loro sogni e di fare progetti per il futuro, ha dovuto riconoscere che ci vorrebbe un cambiamento che ponesse fine a tanta miseria e desse a tutti la speranza di una vita migliore. La voglia di lavorare c’è ma ci vorrebbe un’opportunità. Non è giusto, egli sostiene, che i giovani debbano lasciare la propria casa, emigrare tra gente sconosciuta di cui non comprendono né la lingua e né le usanze. Ma il sole, il mare, le bellezze naturali di questa terra incantevole e difficile contribuiscono solo a rendere più dolorosa la partenza. Ora però Totonno, sostenuto dall’amore di Maria, non si scoraggia: guarda al futuro con maggiore fiducia; è deciso a restare, non lo spaventano i sacrifici che dovrà affrontare. Forse quell’opportunità che aspetta potrebbe anche capitare. Vincenzo, invece, vuole partire per l’America sia per cercare il padre e sia per tentare quella fortuna che egli non ha avuto. L’anno successivo, in una luminosa mattina di Aprile, finalmente Totonno e Maria si sposano. Dopo la cerimonia religiosa, il corteo nuziale di parenti e amici, al suono di un organetto, giunge alla Ficocella, nello spiazzo antistante la casa di Totonno, dove è stato preparato un semplice rinfresco di dolci e liquori fatti in casa. 135 Durante il percorso, gli sposi sono festeggiati con lancio di confetti che i ragazzi si precipitano a raccogliere dal suolo, rischiando di travolgere la sposa. Mentre si offrono i dolci, a turno, gli amici rivolgono parole augurali agli sposi. Inizia per primo il testimone di nozze, compare Mauro, detto Ciccolatera: – Nobili sposi, a voi rivolgo il canto, Vi vengo a dare il meritato onore, Voi siete degni di sublime avanto, Di bellezza, d’amor voi siete il fiore. Tenga il ciel da voi lontano il pianto, Renda felici i vostri giorni ed ore. Dopo nove mesi un figlio a lato Dio gli mandi sapienza infinita e amore. Poi tocca a a Liugi ‘o Ndringhete: – Zita galante, zita galante, che puozzi sta’ sempe cuntenta. L’aniello ca v’ha rato il vostro amante Mittitivillo vui, stella lucente, mittitivillo a lo ireto galante, chiù se rimira e chiù porta splendente. Tant’anni puozzi sta’ co’ lo tuo amante Pe’ quante foglie tocula lu viento. Fino a sera si balla la tarantella e si cantano stornelli cilentani accompagnati dall’organetto di masto Ciccio. Poi la festa finisce, ed anche la breve luna di miele, e la dura realtà quotidiana prende il sopravvento. Nel 1954, l’anno delle nozze, i Francesi del Club Méditerranée scoprono Palinuro e vi costruiscono il primo villaggio turistico della costa tirrenica. Una distesa di ulivi centenari, che si affaccia su un mare limpido e incontaminato, si trasforma in breve in un villaggio di capanne di paglia, dalle stradine delimitate da aiuole fiorite, nato per il divertimento e il benessere di turisti d’oltrape. Vengono assunti molti operai locali, prima, per la costruzione dei bungalow e di tutte le strutture del villaggio, poi, per i servizi di ristorazione, di manutenzione e giardinaggio. Grazie alla raccomandazione di Antonio, detto “ru campo” per essere stato uno dei primi operai, vengono assunti anche Totonno e Vincenzo, che in tal modo rinuncia a partire per l’America. Anche Maria viene assunta, insieme a tante altre donne del paese: chi lavora in lavanderia, chi nelle cucine e chi serve in tavola. Finalmente, quel cambiamento tanto atteso sembra essere una realtà: grazie ad una natura generosa che ha dotato questa terra di un paesaggio incantevole, di una bellezza estasiante, per esprimere la quale Omero non trovò di meglio che il mito delle Sirene ammaliatrici, Palinuro si trasforma, in pochi anni, da paese di pescatori in un centro turistico di fama internazionale. La presenza del Club Méditerranée è quell’opportunità tanto sperata e desiderata! 136 Esso costituisce un richiamo per milioni di turisti da ogni parte del mondo. Nascono alberghi, ristoranti, negozi e quelli che un tempo erano poveri pescatori e operai si trasformano in piccoli imprenditori, investendo i risparmi di una vita in un’attività turistica. Anche Totonno e Maria, con grandi sacrifici, mentre fanno studiare Teresa, la loro unica figlia, investono i loro risparmi nella costruzione di un ristorante, che sorge al posto del giardino, a ridosso della loro casa sulla Ficocella. Il ristorante “Da Totonno”, a conduzione familiare, va bene fino agli anni ottanta: Totonno si procura la fama di ottimo cuoco, bravo soprattutto nel preparare pranzi a base di pesce fresco, pescato spesso da lui stesso. Maria gli dà una mano e la clientela non manca. La difficoltà maggiore la incontrano nel servire i clienti stranieri ma Totonno non si perde d’animo e, con la gestualità e un’innata simpatia, si fa capire dai turisti di lingua francese e inglese e anche dai tedeschi. Quando non riesce a districarsi, si rivolge a Teresa, che studia lingue all’università. Alla fine degli anni ottanta, il Club Méditerranée smobilita: le autorità competenti non prendono gli opportuni provvedimenti per trattenere i Francesi a Palinuro e, per i palinuresi, è l’inizio di una crisi che andrà sempre peggiorando. Totonno e Maria rimpiangono i tempi in cui il loro ristorante era pieno di turisti di varia nazionalità, ora devono ringraziare Dio se il sabato e la domenica arriva qualche napoletano buongustaio. Ma Totonno, nonostante la sua ignoranza, ha capito che ormai non si può vivere di rimpianti, ci si deve rimboccare le maniche e iniziare un nuovo percorso. Ha capito anche che i tempi sono cambiati e non ci si può più improvvisare operatori turistici: ci vogliono competenze e idee nuove per sfruttare al meglio le risorse che la natura ha elargito a piene mani. Loro hanno fatto fin troppo, il loro progresso lo hanno fatto: erano pescatori, contadini, braccianti, alcuni solo con la terza elementare, poi sono diventati piccoli imprenditori. Ora tocca ai giovani che, come Teresa, grazie alla cultura e alla voglia di lavorare, devono produrre idee e progetti, senza i quali non potrà esservi ulteriore progresso. 137 Donne di Palinuro che attingono l’acqua dalla vecchia fontana. Donne palinuresi con la tipica “quarta”, portata in equilibrio sulla testa (anni 1950). 138 La Santa Messa presso la cappella di S. Antonio del porto protettore dei marinai a Palinuro. Sinistra:Palinuro le statue di S. Antonio e della Madonna dell’Assunta vengono portate in processione (anni 1950). Destra: La statua miracolosa di Sant’Antonio del Porto di Palinuro. 139 Gruppo di ragazze palinuresi che ricama. Una immagine del ClubMed, a Palinuro (1950-1960). 140 Domenico Zavaglia e Maura Raimondo tra i primi operai del Club Med poi emigrati in Venezuela. 141 Palinuro, anni 1960: Caratteristica passeggiata con gli asini. Sullo sfondo, l’ingresso originario del Club e la prima recinzione con filo di ferro e canne. 142 Raffaele Riccio I MAIALI IN UDIENZA Tra le tante cause strane, che sono state dibattute negli anni passati, nelle Preture del Cilento, una merita particolare attenzione. Il dibattimento in questione ebbe a che vedere con un incidente, accaduto a due maiali o, meglio, ad un verro e ad una giovane scrofa (o porcella, che dir si voglia). La causa venne dibattuta con tanto di avvocati, testimoni, attori e convenuti, convocati dal Pretore di Vallo della Lucania, in udienza. La memoria accusatoria, stilata dall’avvocato del proprietario del verro, recitava: “Il giorno 3 di maggio dell’anno 18… il Signor Don G. De .. stava conducendo al pascolo nel demanio comunale del Comune di M., un suo verro di 110 kg e di pregiata razza senese, al fine di nutrirlo con le erbe abbondanti, rinvigorite dalle recenti piogge. Nel contempo procedeva, in senso inverso, anche la contadina A. M. del medesimo Comune, la quale conduceva al pascolo, del tutto libera e senza riguardo alcuno, una sua giovane scrofa, alias porcella, di razza comune e di minor pregio. Il possente verro del mio cliente, annusando l’odore della porcella, che libera e senza freno alcuno, andava girando e grugnendo per il suolo pubblico e, provocato dai grugniti della stessa, con la furia tipica di tali animali eccitati, si precipitava addosso alla porcella per farla sua. Durante la corsa frenetica, a causa di alcuni tronchi di vecchi alberi, che gli sbarravano il cammino, il verro è inciampato, rompendosi la zampa posteriore destra. Ora, il medesimo verro, essendo inabile all’accoppiamento ed alla progenie, deve essere abbattuto. Tutto ciò determina un ingente danno per il proprietario dell’animale, che qui accusa A. M., proprietaria della suina, di non aver custodito, con la cura dovuta, la sua porcella. Si richiedono pertanto il sequestro della medesima, causa dell’incidente, ed i danni per il mancato guadagno che poteva derivare al proprietario dalle future monte del verro. Tali danni vengono quantificati per un ammontare di £ 50, più si richiede il pagamento delle spese processuali. Firmato Avv. D. G”. La lettura della memoria accusatoria aveva già provocato parecchia ilarità, tra i banchi della Pretura, quella mattina stranamente affollati, ma ancora di più ne provocarono le parole di A. M., la proprietaria della giovane scrofa. Questa era una donna di buon senso, che non poteva permettersi di pagare £ 50 e, 143 di perdere il suo maiale. Alla richiesta del Pretore, riguardo all’accusa, guardò il giudice e si rivolse a lui direttamente: – Scusate Vossignoria, pe’ spiegà i cose come su’ gghiute ve voglio fà nu paragone. Facimu ca ‘i su ‘u vierro e Vui, cù rispetto parlanno, site a purcedda… Scusasse sembe Vossignoria, … ma se iu mi jetto ‘nguoddu a Vossignoria e mi ruppu ‘na coscia, … che n’ce trase, Vossignoria, ca se stai facennu i fatti suoi … eh … a mi me pare, ca iè accussì.. a culpa è a mia ca su ‘u vierru, e me voglio ittà nguoddu a Vossignoria ca i’è a purcedda …, nun’è certo ri Vossignoria, cha se stai quieto a nu pentuno…. L’ilarità generale, dopo questa apologia della porcella, scoppiò per la sala ed anche il Pretore fece fatica a trattenere il riso. Intervenne subito l’avvocato del signorotto: – Ma, Vossignoria, il discorso di questa contadina … non ha fondamento … la sua porcella ha causato il danno del verro, perché ne ha attivato i desideri e, per conseguenza, ne ha determinato la caduta e la rottura della zampa posteriore … questo esempio non ha senso …. A. M., per nulla preoccupata, dall’intervento dell’avvocato e dagli occhiacci del proprietario del verro, rimise in campo la sua logica stringente: – Scusasse sembe Vossignoria, … ma se iu su ‘u vierro e io mi jetto ‘nguoddu a Vossignoria, cha iè a purcedda, e io mi ruppu ‘na coscia, … che n’ce trase Vossignoria ca se stai facennu i fatti suoi … tanta bella e ‘ngrazia re Dio ... eh … eh … a culpa è a mia, cha me voglio ittà ‘nguoddu a Vossignoria e no de’ Vossignoria …. In Pretura ormai tutti ridevano, e la sala delle udienze si era riempita di tutti gli avvocati presenti. Alla fine, venne emessa la sentenza che fu … a favore di A. M. e della “purcedda”, con danno e scorno del verro azzoppato e del suo proprietario. (Da un racconto di Carmela Forte, di Foria di Centola) 144 Scrofa Nera. Verro di cinta senese. 145 Antonio Stanziola LA CALCOLATRICE MANUALE Riporterò un aneddoto che un mio antenato, analfabeta, utilizzava per fare i calcoli matematici, necessari per svolgere la sua professione di apprezzatore. Il nonno di mio nonno, “Vavo ‘Ndonio” faceva l’apprezzatore di terreni, cioè attribuiva un valore monetario ai terreni. Vavo ‘Ndonio però era analfabeta e quindi non sapeva né leggere né scrivere. Questa sua condizione di ignoranza gli poteva rendere difficile l’esercizio della professione ma, come vedremo, non fu così. Un primo ostacolo era dovuto alla scrittura dei numeri. Non sapendo scrivere, per fare i conti si serviva di bastoncini. Aveva a disposizione diversi gruppi di bastoncini, e ognuno di essi ne contava nove. C’era quello per indicare le unità, quello per le decine, per le centinaia, per le migliaia e così via. Ma la cosa più geniale riguardava le operazioni matematiche. Vavo ‘Ndonio sapeva fare l’addizione e la sottrazione, tuttavia quando si trovava di fronte alle moltiplicazioni aveva dei problemi. In particolare, entrava in confusione quando si trattava di moltiplicare tra loro due numeri maggiori di cinque, come per esempio 7×8. Riporterò ora il metodo che egli utilizzava quando si trovava di fronte a queste situazioni. Si parte tenendo entrambi le mani chiuse. Una volta definita la moltiplicazione, (es. 7×8), ognuna delle mani conta i fattori moltiplicativi non partendo dal numero 1 bensì dal 6. Pertanto, la nostra moltiplicazione verrà calcolata tenendo in una mano due dita aperte (per indicare il 7) e tre nell’altra (per indicare l’8). Considerando entrambi le mani, le dita aperte contano le decine, mentre quelle chiuse si moltiplicano tra loro e si sommano alle precedenti. Dunque, ritornando al nostro esempio, le dita aperte sono 5 (2 in una mano e 3 nell’altra) e, dato che esse contano le decine, siamo a 50. Le dita chiuse, rispettivamente 3 e 2, si moltiplicano tra loro e dunque 3×2=6. A questo punto, non resta che fare la somma: 50+6=56, e ottenere così il risultato della nostra moltiplicazione: 7×8=56! Al fine di prendere familiarità col metodo, riportiamo un altro esempio: moltiplicazione 9×9. Dato che le mani iniziano a contare da 6, la moltiplicazione 9×9 prevede che in entrambi le mani il numero di dita aperte sia 4, per un totale di 8 dita aperte. Queste contano le decine e dunque siamo ad 80. Le dita chiuse, 1 in una mano e 146 1 nell’altra, si moltiplicano tra loro (1×1=1) e si sommano alle decine. Pertanto, 80+1=81 che è il risultato della nostra moltiplicazione: 9×9=81. Chi effettivamente sia stato l’inventore di questo metodo resta un mistero. Ad oggi, non si sa se sia stato lo stesso Vavo ‘Ndonio che ingegnandosi l’abbia prodotto, o se gli fosse stato insegnato da qualcun altro. 147 Filomena Stanziola LA MALEDIZIONE DI ZIA CLELIA Correva l’anno 1960, l’estate era vicina e nell’aria c’era un effluvio di profumi e odori davvero straordinario. I colori erano intensi e meravigliosi. Le ginestre erano in fiore e il profumo che emanavano riempiva l’aria già satura di tutto ciò che la natura in quel periodo dell’anno donava. I campi erano già arsi dal sole, il grano era stato già mietuto e le mani nodose e sapienti dei contadini ammucchiavano i covoni in attesa della trebbiatrice. Tutto faceva presagire che l’estate sarebbe stata lunga e calda. Il mare era di un blu cobalto intenso e limpido. Sulle coste incominciavano ad arrivare turisti stranieri e privilegiati di poter godere di tanto splendore. Zia Clelia era scesa al fiume, come era solita fare tutti i giorni. Aveva una cesta piena di indumenti da lavare. Era bella, giovane, solare e si avviava solerte al suo posto sulla riva ignara della sorte che l’attendeva. Zia Clelia era alta e magra, lunghi capelli incorniciavano il suo viso. Occhi grandi e orgogliosi, procedeva con passo sicuro, senza nessun timore. In paese era conosciuta come una giovane donna, seria e dedita al lavoro. Era stata già promessa a un lontano parente un po’ più vecchio, ma di buone maniere. Vigilava su di lei suo fratello Giovanni, uomo austero e di poche parole. A volte impulsivo e di facile collera e, purtroppo, molto geloso della sorella Clelia. L’occhio sempre attento e indagatore non rendeva la vita facile alla nostra bella fanciulla. Quel maledetto giorno, Clelia indossava un vestito leggero e un po’ più scollato del solito. Era bella e sorridente e la scollatura metteva in evidenza i suoi bei seni di giovane donna. Spesso, mentre lavava i panni, Clelia canticchiava qualche motivo popolare e, a volte, la sua voce diveniva una dolce nenia. Il fratello vigilava poco distante, in groppa a un somaro mansueto e avanti con gli anni. Al fiume, c’erano altre donne e le loro voci si univano ai suoni della natura. Mentre le donne erano dedite al loro lavoro, si avvicinò un signore giovane e di aspetto piacevole, un cultore del luogo, un amante del mare, e con assoluta naturalezza si rivolse a Clelia, chiedendo un’informazione riguardo a un posto da raggiungere. La ragazza si ritrasse un po’ spaventata, convinta che quel posto fosse frequentato soltanto dalle donne del paese. Dopo l’iniziale sorpresa, Clelia rispose e indicò al giovane la strada da imboccare per raggiungere la meta. La giovane donna si comportò da persona educata e gentile e non le sembrò strano dare un’indicazione a uno sconosciuto. Ma purtroppo, da lì a breve, dovette ricredersi. La scena venne seguita Questo racconto si è classificato al terzo posto nel concorso di narrativa 2012. 148 a distanza dal fratello Giovanni, il quale si era fatto un’opinione dell’accaduto completamente diversa da quella della sorella. Scese dal somaro, lo legò ad un albero e si avvicinò al fiume, con fare deciso e minaccioso. Arrivò trafelato e, con gli occhi iniettati di sangue, andò dalla sorella e la sottopose al terzo grado, urlando che non avrebbe dovuto rivolgere la parola ad uno sconosciuto, che lei era già promessa sposa, che il suo vestito era troppo indecente e la scollatura troppo vistosa, sgarbata e un invito al peccato. Le vomitò addosso tutta la sua gelosia. Le altre donne assistettero impotenti a tale attacco e, spaventate, riempirono le loro ceste di indumenti lavati e leste se ne andarono. Nel frattempo, la rabbia di Giovanni aumentava e, non contento delle ingiurie e delle minacce rivolte alla sorella, passò ai fatti e, con un guizzo da animale, afferrò una pietra di notevoli dimensioni, sul greto del fiume, e, con una forza brutale, la scaraventò addosso alla ragazza. Clelia fu lesta a pararsi il viso, si voltò e la furia disumana arrivò tutta sulla sua spalla sinistra e il dolore straziante e intenso le fece perdere i sensi. Si svegliò dolorante e completamente confusa nel suo letto. L’aveva condotta lì forse il fratello o forse qualcuno che l’aveva trovata priva di sensi. Da quel momento, la sua vita mutò radicalmente. Accusò per giorni, mesi, dolori indicibili alle spalle, alla schiena, non riuscì più a respirare con naturalezza, il suo polmone sinistro fu compromesso per sempre e, ad ogni colpo di tosse, sputava sangue. La furia omicida del fratello le aveva perforato il polmone e compromesso l’esistenza. I mesi che seguirono furono mesi di rancore, di odio verso Giovanni: Clelia rifiutò qualsiasi chiarimento e confronto con lui. Di ogni foto che ritraeva loro due, insieme al resto della famiglia, Clelia provvedeva subito a strappare il volto del fratello, con determinazione e con odio profondo. Da quel maledetto giorno i due non si parlarono mai più, neanche un cenno di saluto. Lui venne tormentato per tutta la vita dal rimorso e, per espiare il suo peccato, si chiuse in un mutismo ostinato e colpevole e vestì sempre di nero, quasi a voler dimostrare il suo stato di lutto perenne. Clelia lo odiò fino alla morte che sopraggiunse dopo atroci dolori e patimenti. La sua giovane vita venne stroncata da una gelosia bieca e crudele. 149 Quando le nostre nonne lavavano i panni nel fiume. La Ginestra, tipico arbusto della macchia mediterranea caratterizzata da bellissimi fiori di colore giallo. 150 Centola. Un contadino, separa il grano dalla pula. Palinuro, la spiaggia della Ficocella e delle Saline, anni 1950. 151 152 Concorso “Storie, Aneddoti, Fatti e Misfatti di Centola e delle sue Frazioni” I Edizione SEZIONE ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO Partecipanti al concorso: alunni delle classi IV e V Elementare di Foria di Centola. Insegnante: Antonietta Saulle 153 Rosa Maria Scianni I BRIGANTI Subito dopo l’Unità d’Italia (anche un po’ prima) nel nostro Cilento era diffuso il fenomeno del Brigantaggio. Nel 1869, nei pressi di Foria di Centola, accadde questo fatto. Dei signori molto ricchi, durante una sera tranquilla e stellata, tornavano a casa da un lungo viaggio. All’improvviso la carrozza fu assalita da un gruppo di briganti, questi derubarono i signori e fuggirono in cerca di un nascondiglio . I briganti videro un “malazzeno”, un posto dove stanno gli animali e le provviste. Questo abitacolo campestre apparteneva a un certo Domenico, egli stava accudendo le bestie per la notte, quando arrivarono i Briganti che gli chiesero qualcosa da mangiare e un giaciglio per riposare . Domenico, per paura che lo uccidessero, accettò di dar loro ciò che chiedevano. All’alba, mentre tornava in paese, incontrò i gendarmi che gli chiesero se per caso avesse incontrato i briganti. Domenico non voleva passare guai con la legge, così come non aveva voluto passarli con i fuorilegge, e allora pensò di cavarsela così: – Sì, l’aggiu ncuntrati, l’aggiu rati a mangià e l’aggiu fatti arripusà n’da l’asticu mio. I gendarmi pensarono che scherzasse e si misero a ridere e si allontanarono . Domenico pensò di essersela cavata, e in fondo aveva detto la verità . 154 Scuola Primaria di Foria, Classe IV LA TESTIMONE Molto tempo fa, i contadini di Foria, durante la mietitura, quando finivano il lavoro, a sera, non tornavano a casa, ma restavano tutta la notte a guardia dei covoni, e nelle terre portavano tutta la famiglia, in paese non restava quasi nessuno, solo qualche vecchietto . Una volta, accadde che, durante una di queste sere, venne rubato il corredo di una ragazza . La futura sposa piangeva, disperata, senza corredo non poteva esserci matrimonio, allora la famiglia denunciò il furto e la cosa arrivò alla Pretura di Pisciotta. Il giudice chiamò alcuni testimoni e tra questi anche una certa zia Betta, vecchia e sorda. Questo l’interrogatorio: – Cara signora lei ha sentito o visto qualcosa? Risposta: – No, nunnaggio visto nienti. Il giudice ribatteva: – Cara signora, forse se lei ci pensa un po’ su, ricorderà qualcosa. Zia Betta: – Endrangheta nunn’ aggiu vistu nienti. E così continuò, senza che il giudice cavasse qualcosa da quella donna . Per fortuna, il corredo fu ritrovato e la promessa sposa coronò il suo sogno, ma zia Betta e il suo “Endrangheta “non fu dimenticato. 155 Scuola Primaria di Foria, Classe V IL CANCELLIERE Nelle sue giornate un po’ noiose, il vecchio cancelliere della Pretura di Pisciotta, per scacciare i tristi pensieri dalla sua mente, si ricordava dell’episodio accadutogli con un suo “collega” . Questi i fatti : due contadini di Foria erano sempre in lite tra loro per una vecchia disputa di confine, uno dei due, stanco, decise di discutere la faccenda in pretura. Chiese ad un amico e compare, un certo Pasquale C., di fargli da testimone, questi accettò. Ma, come raccontano a Foria, il signor Pasquale, il giorno prima dell’incontro in Pretura non se la passò bene . Era un tipo timido e l’ansia non lo fece dormire per tutta la notte. Il giorno fatidico, si vestì di nuovo, con cappello e cravattino e col suo asinello partì verso Pisciotta, viaggiando attraverso i poderi di S. Nicola di Centola. In pretura, c’era il nostro buon vecchio cancelliere che, chiamato il testimone, cominciò con le rituali domande: nome, cognome, data di nascita e mestiere . Pasquale rispose, disse il nome e il resto e come mestiere pronunciò queste parole: – Di mestiere faccio il “cancelliere”. Al che il funzionario rispose: – Sono ben felice di parlare con un collega. E Pasquale calmo, calmo ribattè: – Eccellenza, ma cosa avete capito? Io faccio i cancieddi pi li ciucci! Rise tutta la Pretura, la battuta portava allegria in un luogo ritenuto severo e, diciamo la verità, un po’ angusto. Per giorni, a Foria, Pasquale C. fu al centro dell’attenzione e il fatterello accaduto più di cento anni fa è stato tramandato fino a noi, facendo ridere anche noi, figli di un tempo così diverso. 156 Maria Beatrice Napolitano U’ STIRNICCHIATORE Una mattina, di buon’ora, partiva da Foria, per andare alla stazione di Centola e prendere il treno per Sapri . Si respirava bene a quell’ora e la giornata prometteva bene . Sul marciapiede della stazione non c’era quasi nessuno e … guardava i binari, due bei ferri dritti, dritti che portavano in qualunque luogo. Il treno arrivò col solito ritardo e… salì per andarsi a sistemare tranquillo in un posticino in terza classe. Niente da fare, quel treno era strapieno. Si stancò a percorrerlo più volte, quando, per stendere un po’ le braccia affaticate, si appese con forza ad una specie di manubrio situato all’altezza della carrozza. Soddisfatto, fece anche un bello sbadiglio, ma all’improvviso per poco non cadeva all’indietro, il treno che andava veloce (veloce per modo di dire) arrestò la sua corsa con uno strattone e si fermò. – Gesù! – pensò, – e adesso che succede? Ma meraviglia delle meraviglie, verso di lui vide arrivare conduttore e controllore un po’ nervosetti. Il conduttore gli chiese: – Per quale motivo lei ha tirato il freno di emergenza? Rispose tranquillo: – Ma quale, quel coso lì? E io pensavo che fosse uno stirnicchiatore!!! Questa è una divertente ma verissima storiella di Foria di Centola. 157 INDICE Prefazione pag. 3 pag. 4 pag. 8 Introduzione Prologo Racconti e Aneddoti Anna Maria Amendola CINEMA SOTTO LA LUNA pag. 10 Anna Maria Amendola I FRANCESI pag. 12 Anna Maria Amendola LA FESTA DI S. PANTALEONE pag. 13 Anna Maria Amendola IL TEMPO DELL’INCANTO pag. 16 Anna Maria Amendola I “DON” pag. 19 Anna Maria Amendola “U’ PURPU” pag. 20 Maria Luisa Amendola NONNO ALFONSO pag. 24 Maria Luisa Amendola DON BIAGIO pag. 30 Maria Luisa Amendola MEMORIA DEBITORUM pag. 34 Maria Luisa Amendola IL BRIGANTE COLA MARINO pag. 38 Francesco Ciccarino MORTE DI UN SOLDATO: PIETRO CICCARINO pag. 46 Domenica D’Angelo IL RICORDO E’ ANCORA VIVO pag. 50 Aniello Errico PALINURO: COME ERAVAMO - LA CHIESETTA DI SANTA MARIA DI LORETO pag. 54 Giuseppe Gabriele UN CENTOLESE TRA 1 5000 (SU 50000) NO DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO YANKEE pag. 57 Cleonice Gambale IL FANTASMA pag. 61 Michele Gambardella SFIDO CHIUNQUE! pag. 63 Francesco Guglielmelli ... E LA GALLINA PAGÒ IL CONTO pag. 70 Francesco Guglielmelli L’ATTESA pag. 72 Francesco Guglielmelli UN VIAGGIO NEI RICORDI pag. 73 Francesco Guglielmelli PETALI DI ROSA pag. 75 Vincenzo Lamanna VENTI LIRE pag.78 Vincenzo Lamanna SCENDI O TAGLIO pag. 81 Vincenzo Lamanna STRANIERO pag. 83 Vincenzo Lamanna VINCENZINO E IL GRANO pag. 85 158 Vincenzo Lamanna ROSINA E’ TORNATA Nicola Lamassa SAGGEZZA E GIUSTIZIA Nicola Lamassa UNA STORIA E UN REDUCE DI GUERRA Nicola Lamassa MASTU PANDOLA Nicola Lamassa ACCADEVA IN LOCALITA’ GIARDINA Mario Augusto Lorenzini LA PRIMA VOLTA CHE PRESI IL TRENO PER CENTOLA Mario Augusto Lorenzini RICORDI DI UN FIGLIO DEL CAPOSTAZIONE DI CENTOLA (1943 e 1946) Mario Augusto Lorenzini GLI OSCURI MONTI DI SAN SEVERINO Maurina Luise A MIO PADRE Giuseppe Lupo LA NOTTE DELL’ABATE Giuseppe Lupo LA FESTA DI PASCUCCIO Anna Natale ARRIVANO I FRANCESI Anna Natale LA VENDITRICE D’ABITI USATI Anna Natale QUANDO IL DIVERTIMENTO CI VENIVA A CERCARE Anna Natale ROSSO POMODORO Giovani Profice ACCADDE E ACCADE ANCORA Giuseppina Raimondo UNA STORIA DI CASA NOSTRA Raffaele Riccio I MAIALI IN UDIENZA Antonio Stanziola LA CALCOLATRICE MANUALE Filomena Stanziola LA MALEDIZIONE DI ZIA CLELIA Sezione Alunni delle scuole primarie di primo grado Rosa Maria Scianni I BRIGANTI Classe IV, Scuola Elementare di Foria LA TESTIMONE Classe V, Scuola Elementare di Foria IL CANCELIERE Maria Beatrice Napolitano U’ STIRNICCHIATORE 159 pag. 87 pag. 91 pag. 92 pag. 94 pag. 96 pag. 99 pag. 101 Pag. 104 pag. 108 pag. 113 pag. 117 pag. 122 pag. 124 pag. 126 pag. 128 pag. 131 pag. 132 pag. 143 pag. 146 pag. 148 pag. 154 pag. 155 pag. 156 pag. 157 Stampa Litografia IP - Firenze Febbraio 2012
Scaricare