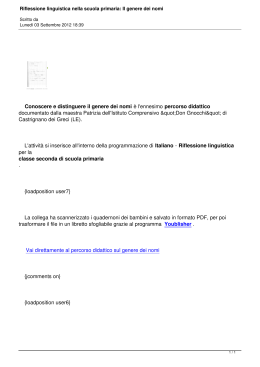Maurizio Gnerre La saggezza dei fiumi Miti, nomi e figure dei corsi d’acqua amazzonici Copyright © 2003 Meltemi editore srl, Roma È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, non autorizzata. Meltemi editore via dell’Olmata, 30 – 00184 Roma tel. 06 4741063 – fax 06 4741407 [email protected] www.meltemieditore.it MELTEMI Indice p. 7 10 Introduzione Prime parole Capitolo primo Dal Rio-mare alle cascate, dai discorsi ai nomi Controcorrente Xíbaros Dai discorsi ai nomi Il gioco dei fraintendimenti Federazione Discorsi e “forza” Significati nascosti 34 Capitolo secondo Trasformazioni e metamorfosi La storia di Tsunki Acqua e terra Indeterminatezza e definizione Rarefazioni e addensamenti Inversioni e trasformazioni Posizioni del corpo e posizioni di ruolo Parole chiave e suoni Nomi 69 Capitolo terzo Spazi e luoghi Territori e viaggi L’apprendimento Storia dei fiumi e dei loro nomi Nomi dei fiumi Contiguità concettuali Statuto referenziale, trasparenza e focalità dei nomi 94 Capitolo quarto Le ragioni nascoste dei nomi Introduzione Prime parole Voci, suoni e silenzi Parsimonia semiotica Parole, verità e “forza” Esistenza del referente e statuto referenziale dei nomi La “onomatizzazione” del mondo Da nomi di luogo a toponimi, da luoghi a non-luoghi Discontinuità percettiva Statuto referenziale di un nome Motivazione e focalità 127 Capitolo quinto La “scarsità vitale” e la referenzialità dei nomi L’osservabile L’interpretabile Referenza e predazione Genere dei wakán’ e dei nomi dei fiumi Scarsità vitale e animismo predatorio Sui nomi dei luoghi e dei fiumi 143 Capitolo sesto Come so quello che ho scritto Sentieri e fiumi Voci e letture Achuar Nomi di luoghi L’ascolto marginale Domande e sogni 155 Appendice Alcune parole shuar usate nel testo 159 Bibliografia Una popolazione amazzonica, gli shuar, un mito “fluviale” che essi narrano e i fiumi, dove si sedimentano conoscenze e nomi. I fiumi sono vissuti di vite nascoste. Le loro acque sono state maschili e femminili, ma ora, da tempo, sembrano essere solo femminili. I loro abitanti sono umani e non umani, vivi e vivi solo un po’, come i tronchi degli alberi che giacciono nella corrente; essi sembrano privi di vita, ma spesso, anche se sono già decomposti, racchiudono invece manifestazioni o ipostasi di spiriti arútam. I nomi si aggirano fra i morti e i vivi, persone, esseri, spiriti, e fiumi. Sono i wakán’ gli spiriti che, forse, li fanno vagare. I nomi sono parole e queste aderiscono alle non-parole, al resto del mondo, se usate negli involucri acustici, come i canti degli ánent, che le rendono attive. Altrimenti, fra le parole e le non-parole c’è una schermatura che attutisce l’aderenza delle prime a tutto il resto, le non-parole. L’Amazzonia esiste ancora. Se non era il paradiso terrestre, la morte e l’abbandono hanno trasformato già da tempo molte immense regioni della sua foresta in un “inferno verde”. Ora tante altre parti sono divenute un “deserto rosso”, di terre oramai dilavate di ogni vita organica, lasciate bruciare al sole. L’Amazzonia sopravvive a tanto accanimento, a tanta cieca cupidigia, e anche, ferita quasi mortale, alla scomparsa di tante voci che le infondevano forza vitale. Erano le voci dei canti, dei flauti, delle risate argentine 8 MAURIZIO GNERRE lungo i fiumi, nei pomeriggi dorati. Tante popolazioni si sono disperse. Dove vivevano è tornata la foresta; chi è ancora vivo è andato altrove, ma non canta più. Gli shuar sono tanti, forse quarantacinquemila; molti oramai si vergognano di quello che erano o erano stati i loro padri; vivono braccati dall’incubo di quello che gli altri, i non-shuar, pensano di loro. Altri sono ancora fieri del proprio mondo, così come ora se lo rappresentano, dopo tante vessazioni. Anche se non cantano più, raccontano ancora per ore e ore le loro storie. Altre storie non le raccontano a nessuno e vanno a cercare la loro verità nei sogni. Sei capitoli e altrettante figure. Alla fine del percorso sono raccolte le parole shuar che ricorrono spesso nel testo. Spero che le pagine del libro, quasi tutte, possano essere lette in maniera scorrevole; altre, lo so, richiedono un po’ d’attenzione, ma spero anche che siano pochi i lettori che desisteranno di fronte a qualche piccolo ostacolo che, forse senza desiderarlo, ho infrapposto. La “saggezza”, come quella dei fiumi, sta nella temperanza, nella costanza e nel ritorno. Chi trova oscure le mie parole, o vuole chiedere per sapere altro, può usare la scrittura: [email protected] Pújunua ha seguito i miei percorsi e atteso i miei ritorni. Senza Taririri non avrei scritto queste pagine, che sono sue. Vorrei tanto che potessero leggerle Payáshnia e Aíjiu Juánk, ma essi potranno solo udire il mio ánent e cantare con me le sue parole: Tachátniuna wétatjai Kashíninki wétatjai PRIME PAROLE 9 Chiave di lettura dello shuar Adotto qui la resa grafica usata dalla Federazione shuar e achuar e dal Sistema di educazione interculturale bilingue shuar in tutte le pubblicazioni in quelle due lingue: e: vocale alta, centrale-posteriore, non arrotondata, non troppo distante dalla pronuncia della vocale nella parola inglese bit; ch: affricata palatale sorda; la stessa pronuncia di ch in spagnolo e di ci in italiano standard; dopo nasale n, diviene sonora, con una pronuncia prossima a quella di gi in italiano standard; ts: affricata alveolare sorda; la stessa pronuncia di z in italiano standard zia; dopo nasale n, diviene sonora, con una pronuncia prossima a quella di z in lazo/’laddzo/, in italiano standard; j: fricativa glottidale; simile alla pronuncia toscana di c di casa. Per ulteriori ragguagli sulla fonologia dello shuar e su alcuni dei suoi condizionamenti fonologici si veda il terzo capitolo di Gnerre 1999. Abbreviazioni utilizzate nei capitoli 3 e 4 n: nome comune; N: nome proprio; Ne: nome etnico; Nf: nome di fiume; Nl: nome di luogo; Np: nome di persona; Nf I a: nome di fiume costituito da un nome comune o da un nome di persona; Nf I b: nome di fiume costituito da un nome comune o da un nome di persona seguiti da una terminazione interpretabile come “acqua o fiume”; Nf II: nome di fiume costituito da due nomi comuni, di cui il secondo è “acqua o fiume”; er: etero-referenziale; ir: intrinsecamente-referenziale. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI Capitolo primo Dal Rio-mare alle cascate, dai discorsi ai nomi Controcorrente Chi dall’oceano entri navigando nella foce del Rio Mare, risalendo la corrente lenta di uno dei suoi rami, non vede nulla che gli ricordi un fiume, e le ragioni di quel nome, Fiume-Mare divengono evidenti. Solo qualche frammento di una sottile striscia di terra all’orizzonte traccia l’unico confine fra i colori, senza contrasti, delle acque e del cielo. A chi la cerchi con lo sguardo, quella striscia suggerisce la presenza di qualche isola, bassa e piana. Dove essa sembra più continua e meno interrotta, consente al navigante l’illusione di riconoscere le sponde del fiume. L’isola più grande del Rio Mare, Marajó, la si vede a lungo all’orizzonte. I segni dell’uomo sono pochi: imbarcazioni e piccole barche lontane. Saremo alleviati quando riconosceremo, sulla sponda più meridionale, il profilo degli edifici di Belém do Pará, la grande città che raccoglie assieme alle loro acque tanti segreti di centinaia di fiumi, come il Tocantins, il più vicino fra tutti. Entriamo così nel mondo dei mondi possibili, delle visioni e dei sogni. Le illusioni narrative e forse ottiche dei primi viaggiatori europei, li indussero a intravedere, fra gli abitanti del grande fiume, anche quelle donne guerriere e arciere “prive di un seno”, le Amazzoni. Tale fu la certezza di quelle illusioni che fu un frate scrivano, e non un avventuriero scriteriato, a denominare il fiume che navigava, il più immenso fra tutti, con il loro nome: Rio de las Amazonas. 11 Fra’ Gaspar de Carvajal, nella Relazione del primo viaggio lungo quel fiume (1541-1542), descrisse una vera battaglia fra gli spagnoli naviganti e le guerriere: Si sappia che essi [gli indigeni] sono soggetti alle Amazzoni e loro tributari e, a conoscenza del nostro arrivo, andarono da loro a chiedere aiuto. (…) Queste donne sono molto bianche e alte e hanno i capelli molto lunghi e intrecciati attorno alla testa; hanno un corpo vigoroso e vanno nude, con le sole vergogne coperte, combattendo con archi e frecce nelle mani, ognuna come dieci indios. (…) una di queste donne conficcò un palmo di freccia in uno dei brigantini e altre fecero poco meno, sicché i nostri brigantini sembravano dei porcospini (Carvajal 1986, trad. it. da Peloso 1988, p. 51). Se risaliremo allora, giorno dopo giorno, le correnti meno impetuose, nascoste fra le tante isole fluviali, vedremo in alcune parti sponde a noi più vicine; apparirà allora qualche povera capanna di caboclos e poi, di nuovo, lontane, sottili strisce scure fra acque e cielo. Passeremo per alcune strettoie, la più celebre fra tutte quella di Óbidos, dove le acque sono costrette, da un enorme macigno di pietra, a scavare in profondità il loro letto per poter superare l’ostacolo. A nord potremo vedere, lontani, i profili di alcune alture e poi, ancora, altre sponde, altri orizzonti di acqua, e ancora tante sottili strisce di foresta. Acque più scure, che arrivano da latitudini equatoriali, lambiranno il nostro scafo preannunciandoci l’immenso Fiume Nero, il Rio Negro, e con esso l’avvistamento del profilo della città più grande di tutto il corso del fiume delle Amazzoni, Manaus. Il suo nome evoca una popolazione scomparsa e Manoa, la città dell’Eldorado, dalle colline dorate. Altri sogni, altre visioni, altri colori e altre sponde ci diranno che, anche se siamo ancora sulle medesime acque del grande fiume, il suo nome ora è diverso: Solimões. Ancora molto dobbiamo navigare contro la corrente che diventa ogni giorno più forte. Oltrepasseremo, senza accorgercene, le foci di decine di fiumi. Altri volti si avvicinano a noi nelle canoe, con altri gesti e altre parole. Non più so- 12 MAURIZIO GNERRE lo i volti dei caboclos del fiume, i meticci con le loro voci di parole portoghesi impastate con altre, portate fin qui dagli schiavi africani e con quelle indigene della “buona lingua” tupì, il nheêngatú. Ora al nostro scafo si avvicina anche gente indigena tikuna che, numerosa, vive non lontano dalle sponde del grande fiume. Sappiamo così che stiamo lasciando il territorio brasiliano; siamo oramai nella parte del fiume di cui cominciamo a vedere, sempre più nitide, le sponde. Con esse e con i loro profili distinguiamo altre decine di corsi d’acqua che nel grande fiume si immettono, talvolta impetuosi e carichi di detriti. Il fiume da qui verso le Ande è conosciuto con un altro nome ancora, Marañón; questo è il suo nome più antico che ci ricorda quello dell’immensa isola che ci ha accolto alla foce, Marajó. Le sponde sono ancora più vicine a noi e le canoe e i battelli sembrano più numerosi, perché a noi più visibili. La terza città del fiume, Iquitos, allineata sulle sue sponde alte, ci sfila davanti. Anche il nome di questa città fluviale ricorda una popolazione indigena oramai agonizzante o già dissolta nel mondo meticcio. Vediamo entrare nel Marañón altri fiumi, l’Ucayali e il Huallaga da sud, il Corrientes, il Pastaza, il Morona da nord. Oramai la corrente che solchiamo è rapida. Le sponde divengono più alte e intravediamo colline coperte di foresta che scendono ripide alle acque, trasformandosi spesso in scarpate di terra rossa e gialla. Il fiume vi passa nel mezzo, attraverso una strettoia tortuosa in cui le acque corrono più vive che mai. Lo chiamano il “pongo”, la “porta” nella lingua delle Ande, il quechua, parlata da molte popolazioni della regione. Si intuisce che non siamo troppo lontani dallo svelare il segreto dell’immenso fiume che abbiamo percorso, il più importante fra tutti, quello a cui tutti gli altri versano i loro tributi. Abbiamo scritto tre dei nomi con cui viene chiamato. Ma quelli sono solo i nomi “ufficiali” che compaiono scritti, anno dopo anno, nelle tante mappe preparate fra il Cinquecento e il Settecento, fino al 1704, quando fu stampata la più ambiziosa fra tutte, opera del gesuita Samuel Fritz. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 13 Ciascuna delle popolazioni che abitano nella regione e quelle, moltissime, che si sono estinte, fanno o facevano risuonare, nelle loro parole o nei loro canti, tanti altri nomi per parlare del fiume più grande. Voci oramai scomparse ci fanno pensare a ciò che è avvenuto quasi dovunque in Amazzonia nel corso dell’ultimo secolo: troviamo, nella sua immensa estensione, storie di relazioni, di amori, di abbandoni e di oblii. Forse, come un’archeologa suggerisce, attraverso i secoli tutto si è trasformato “da un Paradiso fittizio a un Inferno verde”. Le storie dei fiumi, veri protagonisti dell’Amazzonia, sono emblematiche e talvolta sembra di ascoltare storie di vite umane. A volte dei fiumi sono stati dimenticati, insieme alle loro storie, altre volte sono stati “riscoperti” e denominati di nuovo da chi non poteva conoscere i loro nomi antichi. Altre storie sono state narrate. Da luoghi di tante passioni e di tanta vita, molti fiumi, le cui anse erano un tempo conosciute nei dettagli, sono divenuti acque che scorrono, quasi ostili agli umani, anzi, ostacoli da superare. La famosa ferrovia “del diavolo” che univa Guajará-Mirim sul fiume Mamoré al fiume della Madeira (“del legname”) è un emblematico concentrato di morte. Nella sua costruzione, all’inizio del Novecento, morirono decine di migliaia di lavoratori semi-schiavi, cinesi, indios, avanzi di galera, caboclos cacciati dai latifondi del caucciù. Lo scopo era quello di superare con trasporto ferroviario le rapide del primo dei due fiumi, che impedivano la navigazione. A monte c’erano ricche riserve di caucciù e la bramosia di ricchezza dei signori dell’epoca richiedeva quella ferrovia, a qualsiasi costo. Poi tutto fu abbandonato alla corrosione della ruggine e le rapide insidiose furono di nuovo percorse, per necessità e con pericolo, con le canoe e le piccole imbarcazioni delle rade popolazioni delle sponde dell’indomito fiume. Settant’anni dopo, la costruzione della strada transamazzonica ha trasformato in ostacoli da superare con ponti e traghetti innumerevoli fiumi, un tempo vie maestre della 14 MAURIZIO GNERRE selva, e ha trasformato, soprattutto, innumerevoli vite umane, che prima punteggiavano della loro presenza i corsi di quei fiumi. Lungo la strada si è andata concentrando, trovando luoghi di attrazione vicino ai ponti sui fiumi, un’umanità di mercanti e cercatori d’oro, indigeni e negri, predicatori e contrabbandieri, caboclos e asiatici, ruffiani e brunite fanciulle adolescenti. Erano in tanti, spuntati da corsi d’acqua remoti e da luoghi assai distanti dai fiumi; prima reciprocamente ignari della loro esistenza, si erano incontrati, uccisi, truffati, amati, plagiati lungo quella strada. Tutta la mappa era cambiata. I fiumi erano oramai sbiaditi. Segnata in rosso era solo la grande strada, e ai suoi lati crescevano caoticamente agglomerati di baracche e villaggi dalle vie fangose brulicanti di quella nuova umanità, sorpresa della sua stessa esistenza. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI Quei fiumi, sia l’Upano che il Zamora, ma come essi tanti altri, come il Pastaza, sono formati da innumerevoli ruscelli e torrenti che scendono dalla parte orientale della cordigliera andina coronata, a pochi gradi a sud dell’Equatore, da grandi vulcani bianchi. Alcuni, come il Tungurahua e il Sangay sono attivi e minacciosi, e fanno sentire di tanto in tanto, con sbuf- Xíbaros Se passiamo il Pongo, se riusciamo a risalire le sue strettoie impetuose, possiamo allora lasciare alle nostre spalle le acque del Marañón, il “serpente d’oro” che scende dalle cordigliere del Perù e risalire, volgendo la prua verso nord, il fiume Santiago. Ascolteremo altre voci, indigene, e vedremo altri volti, alcuni dipinti, talvolta, con strisce rosse. Sempre più vicine, le due sponde sono oramai alte, e verso occidente, vediamo le colline che annunciano i versanti orientali della Cordigliera del Condor. Il sole tramonta presto dietro le sue foreste. Passeremo il territorio degli aguaruna e degli huambisa. Quando avremo risalito tutto il fiume Santiago e raggiunto il Namangosa, dovremo decidere se continuare la nostra navigazione verso nord, sull’Upano, oppure ripiegare verso sud, sul fiume Zamora. Qualunque sia la scelta che faremo, percorreremo le terre abitate dalle popolazioni che si auto-denominano, aents, oppure shuar. Xíbaros le chiamavano nel Cinquecento, e quel nome atterriva chi lo udiva. Ancora oggi, altrove nell’Ecuador e nel Perù sono conosciute come jívaro. 15 Fig. 1: Distribuzione geografica dei gruppi jívaro (Gnerre 1999). 16 MAURIZIO GNERRE fate e scrolloni, la loro robusta presenza; altri, come il Cotopaxi e il Chimborazo, sono spenti e rassicuranti e si lasciano ammirare, immensi, spesso sfumati fra le nuvole bianche. Dalle pendici di questi vulcani e di altre montagne scendono, prima allo scoperto, ben visibili fra le pietraie e la rada vegetazione e poi, presto nascoste dalla boscaglia di altura, le acque che, unendosi via via, trovano i loro percorsi in torrenti tortuosi e tumultuosi. Strette dapprima fra rocce e precipizi raggiungono la quiete quando vengono chiamate con i nomi di Pastaza, Palora, Upano, e, più a sud, Morona, Santiago, Gualaquiza e Zamora. In questa vasta regione dell’alta Amazzonia vivono gli shuar. Un tempo il loro ambiente era quello scosceso e pietroso segnato dalle cascate in cui quei torrenti andini si trasformano quando devono affrontare i precipizi oltre ai quali si guadagneranno percorsi via via più ampi. Da secoli gli shuar hanno occupato spazi meno scoscesi e più pianeggianti, nelle valli dei fiumi Zamora e Upano e ancora oltre; i limiti dei loro territori si sono estesi fino alle ultime cordigliere orientali del Cutucù e del Condor, coperte da selve fittissime. Oltre quelle alture si apre l’immensa pianura che concede alle acque, che numerose la percorrono, solo qualche modesto dislivello prima che giungano nel Marañón, a poche decine di metri sopra il livello dell’oceano, ma da questo lontane ancora migliaia di chilometri. Fra foreste scoscese e cascate incontrò gli shuar, nel 1549, il primo conquistador spagnolo, Hernando de Benavente, che, baldanzoso e incauto, era sceso dalle Ande, alla ricerca di chissà quali glorie e ricchezze. Il percorso, impervio e nascosto, glielo avevano indicato altri indigeni, forse desiderosi di lasciare ai loro temuti vicini della selva il privilegio di vendicare i soprusi che gli spagnoli non avevano certo lesinato a tante popolazioni pacifiche. Il conquistador ne uscì in breve tempo, malconcio e infuriato, accompagnato oramai solo dai pochi uomini sopravvissuti all’avventura visionaria in cui li aveva trascinati. Scrisse al suo imperatore Carlo una lettera desolata e irosa, in cui affermava di aver incontrato la “gente più barbara mai trovata in tutta la mia conquista delle Indie”. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 17 Gli indigeni che, falsi alleati, lo avevano accompagnato verso la catastrofe, chiamavano quella gente barbara shiwar “nostri nemici”. Questo fu il nome, scritto xíbaro nella grafia spagnola del Cinquecento, con cui la fama di quella gente refrattaria alla “conquista” si sparse nell’impero spagnolo. Testardi, poveri, avidi e febbricitanti, pochi anni dopo quella catastrofe gli avventurieri ispanici, visionari smemorati, tentarono di nuovo l’avventura della “conquista”. Alcuni piccoli avamposti furono stabiliti nelle terre impervie degli xíbaros. Ostinatamente immemori, per boria e presunzione, della rovina di Benavente, piccoli condottieri, hidalgos e adelantados che guidavano gruppi raccogliticci di disperati, tenuti coesi solo dall’avidità di ciascuno, cercavano, con imprese sempre più estreme e senza ritorno, di rifarsi delle frustrazioni dei loro sogni subite altrove nelle “Indie”. Volevano tentare di estrarre dalle acque dei torrenti che scendevano fragorosi verso oriente, scarse tracce di quell’oro che, anni prima, durante la conquista del Perù, avevano concupito, luccicante in statue e monili, senza riuscire nell’intento di farne un bottino personale. Solo per pochi anni, hidalgos e adelantados, divenuti encomenderos, potettero trarre vantaggio delle loro piccole, coraggiose e miserabili colonie minerarie, ratificate da pompose concessioni imperiali e, ancora di più, da nomi roboanti che coronavano fangosi agglomerati di capanne: Santiago de las Montañas, Sevilla del Oro, Logroño de los Caballeros, Nuestra Señora de los Dolores de Macas. Nel 1599, un anno prima dello scadere del secolo della grande “conquista” continentale, che aveva visto devastati e umiliati territori immensi e innumerevoli popoli, dalle Antille a Panama, dal Messico al Guatemala, dal Perù al Cile, quasi per scandire con una emblematica vendetta tanti soprusi e tanta distruzione, solo gli shuar e, molto più a sud, gli araucani del Cile, spazzarono via i barbuti visionari. Secondo quel che sappiamo da incerte e contraddittorie relazioni, le poche decine di spagnoli degli avamposti furono uccisi o messi in fuga. Gli shuar agirono con la velocità che caratterizza le loro azioni di guerra e con una ferocia reciproca e simmetrica a quella subita in nome di Dio e dell’imperatore. 18 MAURIZIO GNERRE Emblematica è la storia del “governatore” spagnolo di Logroño de los Caballeros, giustiziato con una colata dell’oro raccolto dai suoi sparuti uomini, fuso e versato nella bocca tenutagli spalancata. Il terrore provocato dalla fama di tale impresa, in realtà un topos rappresentativo della ferocia degli indigeni, già narrato trent’anni prima dal milanese Gerolamo Benzoni, si sparse con il nome di chi l’aveva compiuta. Fu così che xíbaro (e poi jívaro) divenne un antonomastico per “selvaggio, barbaro”. Poi, con i secoli, insieme alla memoria di quell’impresa terribile e memorabile, la forza minacciosa di quel nome si stemperò, fino a che restò in uso solo per denominare tranquilli contadini portoricani e un sonnolento porticciolo cubano. Ma i tenaci spagnoli, certi della loro missione imperialdivina, certezza in cui risiedeva la loro forza, non abbandonarono del tutto i loro avamposti. Protetti già da anni dalla presenza di una Madonna miracolosa, la cui immagine era stata trovata in una caverna sulle rive scoscese del fiume Upano, i pochi abitanti del villaggio di Sevilla del Oro, al momento del bisogno, furono coadiuvati dalla loro Vergine: a un ennesimo attacco degli indigeni infedeli e feroci essa comparve per atterrirli, e non solo li mise in fuga, ma li dissuase una volta per tutte dal minacciare gli intrepidi barbuti. Costoro ricostituirono il loro villaggio dall’altro lato del fiume, dove già era esistita (Nuestra Señora de los Dolores de) Macas. Per secoli fu questo l’unico avamposto di cristiani sudditi del re di Spagna, incastonato in mezzo alle selve degli xíbaros, a tre settimane di penosa ascesa fino oltre le pendici del vulcano Sangay. Tale era infatti il tempo necessario per raggiungere il primo villaggio andino (non lontano da Riobamba) sotto sicuro controllo degli amministratori di sua maestà cattolica. Per quasi tre secoli solo qualche missionario che agognava il martirio, come il gesuita Juan Lorenzo Lucero, o qualche avventuriero che immaginava ricchezze nascoste osò far capolino nelle terre degli xíbaros. Tante sono le descrizioni, concise e quasi sempre stereotipate, degli xíbaros visitati da missionari in brevi incursioni apostoliche, fra il Seicento e la DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 19 prima metà dell’Ottocento. Una delle ultime fra queste, tipica nella sua presentazioni di topoi ritenuti indizi sicuri di “selvaggia ferocia”, la dobbiamo al frate missionario ligure Castrucci da Vernazza (1854). Egli aveva raggiunto gli xíbaros del Pastaza nel 1848 e aveva scritto in italiano una relazione del suo viaggio. Trascrivo un passo del suo capitolo sulla Missione ai Givari; già dal titolo vediamo che l’insulto etnonimico (ratificato da Colini trent’anni dopo) non solo non scompariva, ma veniva ulteriormente rafforzato nella resa italiana del nome spagnolo: Fig. 2. Indi chivari (Castrucci da Vernazza 1854). 20 MAURIZIO GNERRE Ne’ giorni loro d’allegria si dipingono con molto studio, poi si danno allo stravizzo [sic], e a bevere sì smodatamente da perdere i sensi. Intorno al primo che s’ubriachi fanno cose da stolti; lo trasportano a processione come un morto, gli ballano attorno, gli si genuflettono, e fanno altre loro pazzie; e in questo le donne mescono e porgono il liquore agli astanti, quindi a compimento festivo traggono i teschi di coloro ch’ebbero ucciso, conficcati nella punta delle loro lance. Bagordi e feste degni di lor selvaggia ferocia! (Castrucci da Vernazza 1854, pp. 40-41). Ma non solo come “stolti” e “pazzi” erano descritti. A volte veniva sottolineata la loro sagacia e la loro curiosità. In una spedizione alla regione shuar del Rio Zamora, compiuta nel 1785, lo scrivano che redigeva il diario-relazione notava: Una sera, uno degli Xíbaros infedeli, che avevamo denominato Manuel, stanco di rispondere alle molte domande che il Comandante Capo gli poneva, e mentre osservava attentamente il modo in cui Don Juan Nepomuceno de Vibanco prendeva nota delle sue risposte, smise di rispondere e ammirato della novità della scrittura, cominciò a chiederci di quella nostra abilità, [la scrittura] che gli era sconosciuta; mentre così ripeteva a voce alta i nomi delle persone che erano presenti, egli bagnava il suo dito con la saliva e, usando il suo scudo tondo a modo di lavagna, attuava come se stesse scrivendo tutti quei nomi (Jijón y Caamaño 1919, p. 385). Troviamo in questo episodio due temi su cui ritorneremo nel capitolo seguente: la scrittura e i nomi propri. Teste secche L’attribuzione agli shuar di una certa intelligenza andò aumentando, come ovvio, quando notizie più dettagliate su di essi e sulle loro abilità divennero via via più accessibili al mondo esterno. Solo dalla seconda metà dell’Ottocento si formarono in alcune delle regioni a sud di Macas, abitate dagli shuar, alcuni sparuti villaggi di poveri coloni andini. Pressati dalla miseria e dai latifondisti, essi lasciavano alle spalle la sicura scarsità a cui erano condannati nelle loro regioni di origine, quelle di Cuenca e di Loja per tentare la via di un’in- DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 21 certa abbondanza nelle valli dei fiumi Gualaquiza e Zamora. Gli shuar erano ancora gli xíbaros dei racconti come quello del nostro missionario ligure: terrificanti e, ancora peggio, irrazionali, “stolti” e “pazzi”, sempre più conosciuti come i “cacciatori di teste” dell’Amazzonia. Anzi, la fama dei loro “feroci” costumi veniva alimentata e diffusa da pratiche commerciali ciniche e fiorenti, e del tutto “civilizzate”. Infatti, sui mercati nordamericani ed europei cominciarono a comparire alcune teste-trofeo, le tsantsa, tanto sinistre quanto fascinose. Brune e minuscole fattezze di pelle secca e durissima, lunghi capelli neri luccicanti, labbra trafitte da spine di legno di palma, le piccole teste erano oggetto di dotte disquisizioni fra coloro che potevano ammirarle, con distaccata brama di esotismi estremi, in una biblioteca dagli odori antichi o in un gabinetto di rarità conservate tra canfore e formaline. I più importanti musei etnografici dell’emisfero settentrionale se le contesero e presto, per soddisfare le richieste di un mercato crescente, stretto fra solleticazioni lombrosiane e sinistri esotismi, cominciarono ad arrivare, forse da Panama, dei falsi: teste umane rattrappite, che nulla però avevano a che fare né per forma né, tanto meno, per i pensieri che quelle teste, in vita, potevano aver contenuto, con quelle degli xíbaros, autori garantiti del costoso prodotto. A essi, oramai, era attribuita, fuori d’ogni dubbio, una perversa intelligenza. Mentre al di qua dell’oceano giungevano teste rattrappite, autentiche o false che fossero, fra gli xíbaros giungevano missionari rigorosamente autentici che, nel loro anelito cristianizzatore e civilizzatore, volevano modificare le teste e i pensieri (i “cuori” e le “anime”) dei feroci selvaggi. Le terre dove vivevano gli shuar furono divise con alterne vicende in province missionarie assegnate a ordini diversi: a gesuiti, domenicani, francescani e, con maggiore esito e durata fra tutti, all’allora nuovo ordine dei salesiani. Perfino l’Unione evangelica, tirata a cimento da tanta sfida civilizzatrice, inviò a Macas la volonterosa famigliola cristiana di un pastore con moglie, esempio di monogamiche virtù. Tutti schierarono personalità spesso uniche e notevoli nel loro genere, di zelanti e irrefrenabili convertitori e battezzatori. 22 MAURIZIO GNERRE Fu in quell’epoca, oramai tra gli ultimi due decenni dell’Ottocento e i primi del secolo che iniziava, che, al seguito delle teste secche, cominciarono a giungere in Europa e negli Stati Uniti anche notizie degli xíbaros; negli scritti più illuminati, come quello di Colini (1882-83) essi assumevano, oltre alla perversa intelligenza già loro assegnata, qualche spiraglio di comportamento umano. Alcuni di quegli scritti erano assai accurati, altri meno, ma, comunque, gli xíbaros poco alla volta divenivano avvicinabili. Nel giro di pochi anni, sulla scia delle teste rattrappite che oramai abbondavano nei musei, e dei missionari, essi stessi cacciatori di teste-anime, giunsero fra gli shuar letterati, viaggiatori-scrittori e perfino studiosi di etnologia. Tra i primi, alcuni, come gli ecuadoriani Juan León Mera (1891) ed Enrique Vacas Galindo (1895), si accontentavano di elaborare versioni romanzate che includevano descrizioni più o meno stereotipate o fantasiose; tra gli altri, il piemontese Enrico Festa (1909) manteneva un certo sobrio distacco nei confronti dei tratti più sinistri che i missionari salesiani sottoponevano al suo apprezzamento. Altri ancora, come il nordamericano Fritz Up de Graff, scrissero libri di relativo successo, dai titoli sinistri come Head-Hunters of the Upper Amazon (1923); tra gli etnologi, infine, dobbiamo menzionarne due, autori di scritti di valore diverso: il futuro fondatore del Museé de l’Homme, Paul Rivet (1907-1908) e il giovane missionario Michele Allioni (1910). Ma il richiamo evocativo alla “caccia alle teste” fu ancora accolto e riproposto in un trattato di valore, come quello scritto dall’etnologo finlandese-svedese Rafael Karsten The Head-Hunters of theWestern Amazonas (1935). Come abbiamo visto, molto è stato scritto sugli shuar, e parte di quest’attività scrittoria è stata motivata, per lo meno inizialmente, da quell’immagine tenebrosa di essi (e degli altri jívaro) che fin dal secolo XIX si era diffusa in Europa e negli Stati Uniti, rafforzata da scarse notizie e da numerose teste rattrappite. La storia di quell’immagine è lunga, e a volte anche esilarante. Taylor (1985, pp. 255-256) sintetizza bene quell’alone che si era costruito attorno agli jívaro: DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 23 Poche società amazzoniche hanno provocato l’immaginazione occidentale come quella degli jívaros e nessuna, forse, è stata assunta con tanta costanza come l’immagine al negativo delle forme di vita sociale che l’Occidente considera prototipiche della civiltà e, in una certa misura, della natura umana. Nel corso di più di tre secoli di contatti con i bianchi (iniziati, ricordiamolo, per lo meno “ufficialmente” nel 1549) gli jívaro provavano in definitiva che lo stato di natura, lungi dall’essere un semplice orizzonte filosofico o uno stato fittizio, non soltanto esisteva e si riproduceva identico a se stesso, ma era anche capace, aggiungendo l’insulto militare allo scandalo filosofico, di infliggere ignominiosi rovesci ai soldati di Dio e dell’impero. Dai discorsi ai nomi Lentamente, anche la difficile lingua shuar veniva esplorata, per tentativi, da qualche missionario, coadiuvato dai meticci di Macas che parlavano con gli indigeni in una versione semplificata della loro lingua. Uno degli aspetti apprezzabili, anche da chi non dominava la lingua indigena, erano le spettacolari attuazioni retoriche degli shuar. Il domenicano Enrique Vacas Galindo, in un’opera letteraria (1895) il cui protagonista era un uomo dal nome guerriero di Nankijúkima, “agitatore della lancia”, tratteggiava con queste parole il modo di parlare e la retorica che gli shuar dispiegavano nel corso delle loro conversazioni cerimoniali diadiche (pp. 80-81): si stabilisce fra i due un dialogo indescrivibile, improvvisato, ma condotto con grande pathos. Lo spettatore crede a volte di udire uomini posseduti dal demonio, a causa dell’agitazione e della veemenza e della voce tonante con cui parlano: altre volte sembra di assistere a una disputa accaloratissima, nella quale ciascuno dei due contendenti dispiega una ricchezza di erudizione e 24 MAURIZIO GNERRE di eloquenza che egli stesso non può contenere. Non sono uomini, lettore, quelli che ti presento, sono leoni! Mentre uno declama, l’altro ripete: “Sì! No! E che? Che altro? Bene! Così è!…” fino a che l’altro non abbia terminato. E questi allora prende la parola, mentre il primo si mette a ripetere “Sì! No! Che?” e altro. Però la cosa più notevole è che parlano con tale precipitazione e rapidità, che appena si riesce ad afferrare qualche sillaba, fra quelle pronunciate con maggiore accentuazione. (…) Circa mezz’ora dura questo dialogo. Dopo conversano con naturalezza, e in modi intelligibili e anche scherzosi (…). D’altro lato, l’idea preconcetta di una “povertà” lessicale e categoriale che doveva necessariamente corrispondere alla barbarie o alla “stolidità” dei parlanti dello shuar, se da un lato costituiva un deterrente a uno studio serio della lingua e faceva ritenere adeguata e sufficiente la sua versione semplificata, dall’altro riservava sorprese insospettate ai pochi che invece la affrontavano con impegno, pur senza disporre delle categorie analitiche adeguate. Porta la data del 1890 una lettera scritta ai superiori da un altro missionario dell’epoca, Alberto Delgado, che esprimeva in modo quasi coraggioso contro i luoghi comuni del suo ambiente, tutto lo stupore provato nell’incontro ravvicinato con quella lingua “selvaggia”: che opinione diversa ho adesso della lingua jívara (…). Oh! È una lingua perfetta, filosofica, sentimentale, e vorrei perfino dire, più ricca forse dello spagnolo e di altre lingue europee per quel che riguarda la parte zoologica e botanica. Fin la più piccola pianta, fin il più minuscolo insetto, fra tutti gli infiniti alberi e animali che popolano queste selve, ha un nome. Hanno mille esclamazioni. L’ausiliare essere entra nella formazione di tutti i verbi, così come le desinenze del nome latino nella formazione dei suoi casi. Che combinazioni energiche e concise! Mi trovo ora a scrivere un vocabolario; con esso e con l’esercizio sono sicuro che saprò capire gli Jívaros, però dubito che qualcuno riuscirà mai a parlare come loro (Magalli 1890). Gli entusiasmi dei due autori si manifestano su aspetti diversi della lingua shuar: il primo, che pure conosceva per lo meno la sua versione “semplificata”, coglieva la straordi- DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 25 naria forza retorico-espressiva dei generi di conversazione shuar. Il secondo, in una visione più analitica, si concentrava su alcune caratteristiche più precise, e lo stupore di fronte agli insospettati dettagli referenziali e potenzialità espressive si trasformava in entusiasmo e, forse, nel sospetto della presenza di capacità intellettuali nascoste in quelle teste dai lunghi capelli neri luccicanti decorati di piume. Ben pochi dei suoi contemporanei, inclusi fra questi diversi linguisti europei e nordamericani, da Schleicher a Brinton, sarebbero stati disposti a concedere a quei “selvaggi” una qualche sofisticazione intellettuale. C’è però una dimensione forse più nascosta, e quasi intermedia, fra quelle che i due osservatori allora potevano cogliere. Sia il dettaglio nella denominazione di moltissimi referenti del mondo naturale, sia la forza retorica, osservabile non solo nel torrente di parole, esclamate e urlate in un flusso ritmico e prosodico incomprensibile all’osservatore, ma anche nelle posizioni assunte dal corpo e nelle espressioni facciali che le accompagnavano, erano riflessi osservabili di una concezione del linguaggio, della sua referenzialità, del suo uso e della sua efficacia, presenti, come vedremo, ancora oggi. Il gioco dei fraintendimenti Gli studiosi più attenti, come alcuni fra gli etnologi e i missionari che certo oramai sospettavano la complessità del mondo linguistico-culturale degli jíbaros, erano tenute lontane dal cogliere tanti aspetti della lingua e, ancora di più, della ricchezza semantica nascosta al suo interno. Erano portati, infatti, dagli stessi indigeni, ad avvalersi della versione semplificata, pidginizzata e forse quasi creolizzata della lingua in uso, forse da secoli, nell’avamposto meticcio e cristiano di Macas. Fu in questa varietà che il primo missionario citato, quello che con tanta efficacia descriveva l’attuazione retorica degli shuar, scrisse e fece stampare in quegli stessi anni anche un libretto, il primo in quella lingua, intitolato, non a caso, Catón en lengua Jíbara (Anoni- 26 MAURIZIO GNERRE mo 1891), una specie di catechismo “per la missione di Macas”. Anni dopo fu stampata anche una traduzione del Vangelo di san Luca prodotta da quei coniugi evangelici distaccati a Macas fin dal 1902. Viaggiatori e missionari prima, etnologi e antropologi poi (ma, come visto già dall’inizio del secolo XX) hanno potuto fornire descrizioni relativamente accurate di ciò che era per essi osservabile. Quando però cercavano di ottenere, tramite conversazioni, qualche spiegazione ed esemplificazioni di concetti come wakán’, arútam, e simili, erano frustrati dall’assenza (per loro) di una qualche coerenza. Spesso, come ho mostrato per il primo di quegli etnologi, il finlandese Karsten (Gnerre 1984), c’erano problemi linguistici seri che facevano naufragare ogni speranza di “comprensione”, visto che egli (e altri) si avvalevano dello shuar pidginizzato. Quella lingua semplificata era un’altra forma di resistenza, questa volta “passiva”, messa in pratica dagli shuar verso coloro che volevano conquistare le loro anime e i loro cuori? Il fatto è che solo dagli anni Venti in poi si raggiunse una prima approssimazione alla comprensione più articolata delle forme della loro lingua. Non venivano ancora usati i registratori, strumenti allora ingombranti presenti solo in alcuni musei etnografici e università nordamericane ed europee. Per i pochi interessati alla lingua degli shuar, per lo più missionari, non c’era altra strada che quella di chiedere agli indigeni che volevano rispondere e collaborare alla conoscenza altrui delle proprie cose, parole fuori dal contesto, paradigmi verbali e poco altro. Mediante le annotazioni sui loro quaderni mettevano insieme frammenti della lingua e solo attraverso questi cercavano di comprendere le conversazioni e le narrazioni degli indigeni. Talvolta si facevano dettare alcuni testi narrativi e comunque, anche se lo facevano, ottenevano sempre, come era avvenuto all’etnologo finlandese Karsten, testi semplificati, perché prodotti nella lingua semplificata. Indipendentemente dai problemi linguistici, però, c’era l’elaborazione discorsiva degli shuar e la loro volontà a rispondere in modo utile (per lo meno dal loro punto di vista) alle domande che venivano loro poste. La riservatezza DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 27 e la segretezza erano deterrenti forti ad ogni resa considerata appagante delle curiosità interpretative occidentali. Anche se diversi studiosi e pensatori oramai riflettevano, altrove, sulle forme culturali di tante popolazioni lontane, l’interpretazione delle categorie e delle forme linguistiche era ancora un percorso lungo, iniziato, in modi diversi da Sapir (1921) e da Malinowski (1923). Per chi, come molti etnologi e missionari, non era consapevole di quelle riflessioni, la lingua shuar costituiva uno sbarramento insormontabile per una comprensione dei significati che attraverso essa i suoi parlanti convogliavano. I limiti interpretativi del “significato nelle lingue primitive” (Malinowski 1923) erano ancora una barriera assai ardua alla comprensione. Incomprensioni Ma oltre quello che la lingua nascondeva, vi erano altre dimensioni che si intrecciavano con la percezione shuar della persona. Pochi fra i missionari cattolici che cercavano di “ridurre” i bambini e i giovani shuar alla vita dei collegi missionari, o internati, si rendevano conto che l’ostacolo principale consisteva proprio nel tentativo di una “reductio ad unum” delle abissali differenze individuali che si celavano dietro volti e sguardi che sembravano spesso simili l’uno all’altro. Ciascuno di quei giovani aveva avuto storie diverse, soprattutto visioni diverse; nelle capanne solenni, lontane l’una dall’altra nella foresta, da cui convergevano alla grande missione bianca, avevano forse visto e udito cose simili, ma non lo avrebbero ammesso mai. I missionari tentavano quindi di costruire un’omogeneità cristiana su una diversità individuale, non casuale, ma voluta e coltivata, in cui non aveva spazio l’idea di una società organicamente coordinata. Erano i missionari che pensavano tutti quei bambini e quegli adolescenti come “jívaros”, giovani individui di un’unica popolazione. Certo, erano individui che a volte facevano o dicevano cose simili per scelta propria, e mai perché convinti da qualcuno che il mondo dovesse essere in un certo modo perché così era stato deciso. 28 MAURIZIO GNERRE Quello che poteva governare i loro destini era il loro arútam, se mai lo avessero incontrato un giorno, nei sogni o, terrificati, in un soffio di vento nella foresta. La refrattarietà che gli shuar opponevano (e, oserei dire, oppongono) ai tentativi di cristianizzazione non era quasi mai violenta, anzi, spesso, essi tenevano un atteggiamento esteriore, o di facciata, che schermava la loro fierezza e si avvicinava a una mansuetudine per essi inusuale; facevano credere in tal modo che qualcosa fra tutto quello che i missionari ripetevano era entrata nelle loro menti. Tuttavia, il loro modo di agire e alcune delle loro parole rivelavano, a chi li voleva osservare e ascoltare, che le loro menti percorrevano altri sentieri. Fu così che negli anni Trenta, dopo circa quarant’anni di azione missionaria dei salesiani (preceduti in luoghi diversi della regione, o affiancati, da domenicani, gesuiti e francescani) un vescovo, mons. Comín disse al papa Pio X, facendo riferimento alla missione fra gli shuar “Santità, innaffiamo un tronco secco”. Quando poi negli anni Cinquanta iniziò l’azione, assai controversa, che tendeva a far convergere i bambini e gli adolescenti (ancora “rami freschi”, forse modellabili nella loro crescita) nei grandi internati maschili e femminili che missionari e suore avevano istituito, le resistenze delle famiglie all’“internamento” dei loro bambini erano fortissime. Leggiamo qui quanto scriveva uno shuar di grande valore, Ricardo Tankámash’, che conobbi bene e che concluse la sua vita ucciso per motivi oscuri ai più. La sua testimonianza illustra, meglio di ogni spiegazione o interpretazione, la repressione culturale e la pressione psicologica a cui sono state sottoposte alcune generazioni di shuar. All’inizio degli anni Settanta Ricardo raccontava (Münzel, Kroeger 1981, pp. 217-218): Io non volevo andare all’internato però mia madre diceva: “Devi farlo, devi imparare lo spagnolo, devi civilizzarti!”. Alcune volte sono scappato dall’internato e sono tornato a casa, e mia madre sempre mi riportava indietro. Mi trascinava dietro di lei. Io gridavo. Nell’internato i missionari mi dicevano: “Vuoi vivere DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 29 nel sudiciume invece che nell’internato, perché vuoi vivere con i tuoi, dove tutti dormono ammassati, uno sull’altro”. Nemmeno mio padre voleva che andassi dai missionari. Diceva sempre: “È meglio uccidere i missionari, allora vivremo in pace”. Però mia madre gli rispondeva: “No, nostro figlio deve civilizzarsi”. E così andai dai missionari. Mio padre non voleva venire a visitarmi là; però mia madre veniva. Una volta al mese ricevevamo le visite, e lei mi portava frutta e manioca. Però a volte non mi consentivano di vederla, perché ero stato disubbidiente o non avevo detto bene le orazioni, o perché avevo parlato in shuar e non in spagnolo con altri bambini. In quei casi i missionari mi portavano la frutta e la manioca di mia mamma, però lei doveva andarsene senza che avesse potuto vedermi. I missionari le spiegavano: “Tuo figlio ha parlato shuar, per questo non puoi vederlo oggi. Però se per tutto il mese parlerà in spagnolo, potrai vederlo la prossima volta”. Durante le vacanze potevamo andare a casa. Però allora, poco prima delle vacanze c’era scritto col gesso sulla lavagna: “Sono amico del diavolo se nelle vacanze vado a casa con gli shuar!”. Noi bambini dicevamo fra di noi: “Ah! Gli amici del diavolo sono quelli che vanno a casa!”. E nessuno voleva essere amico del diavolo. Tutti volevano essere amici di Dio. Così la maggior parte di noi, volontariamente, restava all’internato e lavoravamo durante le vacanze per la missione, dall’alba al tramonto. Federazione Nel 1962 fu fondata l’associazione dei centri (villaggi) shuar di Sucúa. In seguito furono fondate altre associazioni e, nel 1968, quelle allora esistenti si unirono in una Federazione. La sede prescelta fu il paese meticcio di Sucúa, e ciò tanto per la sua posizione centrale nella valle dell’Upano, a sud di Macas, quanto per il fatto che in quella regione fosse sorta la prima associazione di villaggi. Fin dai primi anni la Federazione dispose di una radio che trasmetteva in shuar e in spagnolo durante molte ore al giorno. Durante le ore mattutine i programmi erano rivolti alle scuole dei villaggi, dove operavano tanti giovani indi- 30 MAURIZIO GNERRE geni che, usciti dagli internati missionari, avevano ricevuto una certa preparazione come maestri elementari, in grado di coordinare le lezioni radiofoniche con l’attuazione pedagogica diretta. Furono chiamati “tele-maestri”. La radio, ascoltata in una grande parte del territorio shuar, svolse per decenni un ruolo fondamentale nella costruzione di una certa identità unitaria e di una comprensione del ruolo dell’organizzazione stessa. I gruppi locali shuar divenivano lentamente parte del “popolo shuar”. Fig. 3. Bandierina celebrativa dei primi quindici anni della radio della Federazione shuar. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 31 Discorsi e “forza” Nell’ambito dei cambiamenti residenziali e dell’organizzazione politica che gli shuar si sono dati nel corso degli ultimi quarant’anni, è cresciuta molto, e su solide basi, un’abilità di discorso pubblico e di costruzione retorica praticata da molti uomini e da pochissime donne. La forza dei loro antichi dialoghi, descritti nel passo riportato sopra (“non sono uomini… sono leoni”) è stata sostituita da un altro tipo di forza retorica. La radio della Federazione è stata uno strumento assai efficace di diffusione e di rafforzamento non solo della nuova coesione etnico-identitaria, ma anche, insieme a tante altre abilità e conoscenze, di nuove forme retoriche. I primi dirigenti della Federazione e i primi “tele-maestri” provenivano quasi tutti dalla valle dell’Upano: fu dunque la varietà di shuar che essi parlavano che con il tempo si è consolidata come quella di maggiore prestigio, e quindi imitata da quasi tutti gli altri. Con la nuova retorica sono emerse tante forme che consentono di convogliare in shuar, evitando di fare ricorso allo spagnolo, moltissimi concetti nuovi; ad esempio, quello di “federazione” è stato reso con irúntramu, una forma nominalizzata dal lessema verbale irú-r- “riunire, raccogliere”, quindi qualcosa come “riunione, raccolta”. Ma, oltre a tante forme nuove, diversi costrutti sintattici sono emersi a discapito di altri e, aspetto molto importante nella costruzione dei nuovi e spesso lunghissimi discorsi sono comparse forme di concatenazione fra gli enunciati. Una di queste, tuma asamtai “così essendo” è, insieme ad altre forme, oramai frequente; tutte consentono di costruire concatenazioni, collegando cioè il contenuto di un enunciato a quello dell’enunciato precedente, e di formare quindi discorsi, spesso assai lunghi e retoricamente assai efficaci. Le assemblee dei “centri” (villaggi), quelle delle “associazioni” regionali di “centri”, quella della “Federazione” tenuta annualmente a Sucúa, sono, accanto alla pratica quotidiana delle trasmissioni radiofoniche shuar, i 32 MAURIZIO GNERRE luoghi in cui viene praticata, e raffinata, quest’arte retorica contemporanea (Hendricks 1986). Gli episodi e gli esempi di tale arte sono oramai innumerevoli, e anche i loro effetti politici e sociali lo sono. Uno, assai famoso, ebbe luogo nel 1993-94: in quegli anni la Federazione fu percorsa da un conflitto interno di una complessità e gravità mai sperimentate nei trent’anni intercorsi dalla sua fondazione; il presidente e alcuni dei suoi collaboratori furono calunniati. In particolare sul primo si concentrarono sospetti di traffico di cocaina e di adulterio. Altri, a lui vicini, furono accusati di aver ucciso degli shuar e achuar per tagliare loro la testa e farne delle tsantsa, le teste trofeo rattrappite, per venderle a caro prezzo a cinici compratori stranieri. All’assemblea generale della Federazione, che si tenne a Sucúa nel febbraio del 1994, il presidente parlò ai seicento delegati, inviati dalle associazioni e da ogni singolo “centro”, e li convinse della falsità di tutte quelle accuse infamanti. L’opinione generale fu che aveva parlato in modo “forte” (kakáram): non solo aveva parlato “bene”, ma aveva posto nel suo discorso dimensioni, per noi spesso insondabili, di un “forza” personale, non facilmente riconducibile a una abile personalità comunicativa. Probabilmente aveva un arútam forte. Perché sono gli arútam gli spiriti che infondono la “forza”. Le acquisizioni e le perdite di questa “forza” individuale, specialmente quella maschile, sono presenti nel mondo shuar attuale in modo forse ancora maggiore che nel passato. In molti casi credo che oramai, dal momento che altre manifestazioni di forza, come l’uccisione di un nemico poderoso, non sono più praticabili, esse siano divenute per molti uomini un’ossessione. Oggi, a differenza di un tempo, tanti uomini si trovano a vivere vicini, nei villaggi, e sanno di far parte di una vasta organizzazione politica dove esiste una competizione per il potere, per “mettersi in luce”. Páant è la voce più spesso usata per esprimere questo concetto; il suo significato è quello di un modificatore avverbiale: “chiaramente, con voce forte e nitida, in modo evidente e aperto”. Su tali valori di “forza” e di “chiara apparenza” si concentrano in molti, ma purtroppo, sembra che oramai gli arútam scarseggino. DAL RIO-MARE ALLE CASCATE, DAI DISCORSI AI NOMI 33 Significati nascosti Nelle pagine che seguono procederemo scavando all’interno di alcune dimensioni dei significati nascosti nella lingua shuar e nei suoi usi. Parleremo della relazione con l’ambiente in cui gli umani vivono e di alcune mie interpretazioni delle rappresentazioni shuar di esso. Sono queste le dimensioni, sospese fra il linguistico e il retorico, che ci consentono di muovere i primi passi verso ciò che racchiude la semantica dei nomi comuni delle piante, degli animali e dei nomi propri delle persone e dei corsi d’acqua. Questi ultimi nomi assumono valenze che “ricaricano” il valore semantico dei nomi comuni corrispondenti, in una costante circolazione di rinvii. Nei nomi dei corsi d’acqua si sedimenta una ricchezza conoscitiva che non è solo quella, innegabile, della conoscenza dell’ambiente che tanto stupiva il missionario Delgado; si tratta di altro, di un tipo di retorica, se possiamo usare questa parola, diversa anche da quella che stupiva Vacas Galindo. È una retorica intrisa nella semantica stessa dei nomi, che si vanno arricchendo di sedimentazioni referenziali. Questa è la saggezza che i nomi dei fiumi racchiudono. Cercheremo di svelarla, iniziando il percorso dai meandri di una narrazione.
Scaricare