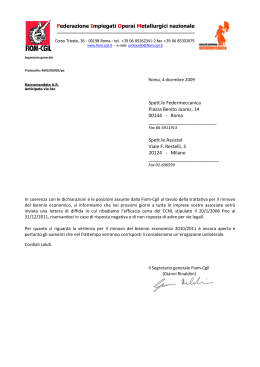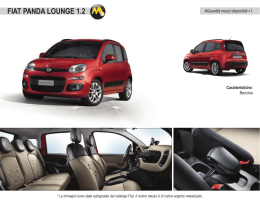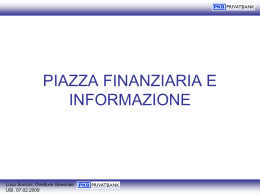Manifesto – 20.10.12 Fiat, punto. A chi parla la sentenza – Loris Campetti Ieri Antonio compiva gli anni, voleva festeggiare ma non ci riusciva perché «ho un magone», diceva agli amici che lo chiamavano per fargli gli auguri. Quel magone aveva un nome, era l'attesa trepidante di una sentenza. Antonio è un operaio giovane e ottimista, sennò non avrebbe tre figli ai quali, da quando è in cassa integrazione perché è marchiato a sangue con la sua tessera Fiom in tasca, fatica a garantire il pranzo e la cena. A metà mattinata ad Antonio sono arrivati gli auguri più attesi: la magistratura ha detto la sua e anche in appello ha confermato che la Fiat ha discriminato gli operai di Pomigliano iscritti alla Fiom, al punto che nessuno dei 2.150 assunti - dei cinquemila che avrebbero dovuto essere - ha quel marchio incompatibile con l'idea d'impresa e di democrazia che ha Sergio Marchionne. Che ora dovrà assumerne 145, tutti iscritti alla Fiom, è costretto ad aprire i cancelli della fabbrica al demonio, un demonio assetato di giustizia. Ma la giustizia è compatibile con i progetti di Marchionne? La giustizia è compatibile con le ricette della coppia Monti-Fornero, ai quali va stretta persino la pratica novecentesca di rappresentanza e democrazia sindacale? Marchionne, Monti e Fornero pensano che i diritti acquisiti - a un lavoro dignitoso e non costretto da ricatti, a una vita non precaria, a una liquidazione e a una pensione certe e non da fame - siano un lusso che non possiamo più permetterci. Perciò hanno usato Marchionne come grimaldello per riportare i rapporti di forza e le relazioni sociali a prima dell'autunno caldo del '69, cancellando leggi giuste e promulgandone di odiose. Antonio non è un lupo solitario, è un animale metropolitano, come lui a Pomigliano ce ne sono tanti che ieri hanno pianto di gioia dopo aver troppo a lungo pianto di rabbia, espulsi dalla loro fabbrica, umiliati, evitati dai compagni che hanno scambiato la dignità con una promessa, che sempre più appare falsa, di lavoro e di futuro. In tanti ieri hanno festeggiato con Antonio e come Antonio: secondo la giustizia non è lecito discriminare gli operai sulla base del colore della tessera che hanno in tasca, e per il rifiuto a sottostare al diktat di Marchionne: ti farò lavorare solo se ti presenterai nudo davanti ai cancelli, spogliandoti di ogni diritto e dignità. Loro, Antonio e tante sue compagne e compagni hanno detto no, facendo storcere il naso a politici, sindaci e sindacalisti perbene e permale, imprenditori democratici in giacca, cravatta e scarpe autofirmate e non in pullover, quelli che avevano ordinato, da molti inascoltati, di dire sì al ricatto padronale e dopo il vulnus alla democrazia di Marchionne li avevano ancora insultati: se siete fuori dal lavoro, industriale e sindacale, è colpa vostra, colpa della vostra dissennata presunzione. La sentenza di ieri che respinge il ricorso della Fiat parla a tutti, persone perbene e permale. Parla agli operai che non avevano ceduto e a quelli che invece avevano sperato di cavarsela con il cappello in mano, quelli che cominciano a capire che in una fabbrica senza diritti, e senza Fiom, non si campa. La sentenza parla alla politica, alla sinistra in primo luogo, sia quella che ha votato la cancellazione dell'art.18 voluta dal governo Monti-Fornero sia a quella che raccoglie le firme per un referendum che ripristini una giustizia non dettata dal capitale. Se il lavoro non rientra nell'agenda politica, se non torna a prenderne la testa di lista, la testimonianza straordinaria degli operai di Pomigliano e persino il sussulto di dignità della magistratura resteranno soltanto resistenze di una cultura democratica in via di rottamazione. La sentenza parla anche alla Cgil che oggi chiama in piazza i lavoratori delle fabbriche in crisi per rivendicare una risposta alla crisi di natura opposta a quella dominante in Italia e in Europa. La forza del sindacato guidato da Susanna Camusso sta in tutti gli Antonio di Pomigliano che non si sono spogliati davanti al padrone. Prima ancora che la Fiom sono questi operai ad aver vinto la partita davanti al giudice e al paese. È ora che la Cgil ne prenda atto, accettando finalmente l'idea che la Fiom è una risorsa, non un problema. I problemi stanno altrove, e siedono al tavolo di una trattativa impossibile con il governo e la Confindustria che usano la crisi del paese allo stesso modo in cui Marchionne usa la crisi dell'auto e della Fiat. Diciamolo con chiarezza, almeno noi: siamo tutti Antonio, siamo tutti operai di Pomigliano. «Tanta gioia, ma testa fredda» - Franca Pinna NAPOLI - Vittoria, gioia, mente fredda. Il giudice ha ancora una volta dato ragione alla Fiom, ma non c'è mai da fidarsi troppo, con la Fiat. Un rischio concreto è che gli operai una volta rientrati possano passare direttamente dalla cig «per cessata attività» alla cassa ordinaria, senza varcare il parcheggio dell'ex Alfa. «Non sarebbe un problema perché una cosa è la discriminazione un'altra la gestione della crisi. Abbiamo fatto diverse proposte dai contratti di solidarietà alla cassa a rotazione, per arrivare alla riduzione dell'orario di lavoro in una logica di giustizia e equilibro. L'importante ora è solo che ci vengano riconosciuti i nostri diritti». A pensarla così è Mario Di Costanzo, iscritto alla Fiom, assunto nel '99 e addetto alla carrozzeria. Teme che la sentenza possa non trovare applicazione: «Anche quella di primo grado era esecutiva e non è stata messa in pratica. Secondo me ci vuole un intervento della politica. Sono sicuro che tra poco verremo attaccati dagli altri sindacati. Già nei mesi scorsi Fim e Uilm ci hanno messo alla gogna come se avessimo cercato una via preferenziale, non capendo che in gioco è la democrazia e le garanzie dei lavoratori che riguardano non solo la fabbrica, ma a mio avviso il paese intero». Antonio Di Luca, operaio a Pomigliano dal 1989, non sta nella pelle dalla gioia. Ascolta le parole della sentenza, annuisce, metabolizza il successo cercando di non farsi sfuggire nemmeno un passaggio. Di Luca, per esempio, non è pienamente d'accordo nel chiamarle «assunzioni» visto che per il Lingotto lavorerebbe già da 23 anni e dunque perché essere definito un «riassunto» nella nuova compagnia, meglio salutare l'evento come un ritorno al proprio posto, sempre che la sentenza venga applicata. «Comunque andranno le cose - spiega - credo che la decisione della Corte sia un grande successo per tutti i lavoratori Fiat e non solo, perché da questo momento rappresenta un precedente e ogni singolo lavoratore può sentirsi più tranquillo e avere meno paura di essere discriminato». Certo è presto per cantare vittoria, Sergio Marchionne, si sa, è un osso duro, l'azienda ha già annunciato che ricorrerà in cassazione. «Non ci preoccupa, credo che la decisione dei giudici di Roma difficilmente potrà essere ribaltata - continua Antonio, che ora fa parte anche del direttivo provinciale Fiom - Oggi bisogna pensare positivo, è un giorno di festa perché la Costituzione è rientrata in fabbrica. Ed è la quarta volta in due anni che l'azienda viene condannata per discriminazione. Prima il giudice Ciocchetti aveva stabilito la condotta antisindacale per discriminazione, poi il 21 giugno sono stati condannati a riassumerci tutti, mentre lo scorso agosto il ricorso di sospensione è stato rigettato. Stanno girando in tondo, devono farci tornare dentro, non hanno scelta». La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dietro i cancelli e i lavoratori della Fip che attendono i 147 compagni commentano non senza qualche timore: «Marchionne ora prenderà tempo - dice una tuta bianca del nuovo stabilimento - per dimostrare che è lui il più forte, e farà di tutto per metterci gli uni contro gli altri in una guerra di poveri». L'animosità verso un'azienda che fa di tutto per alzare il livello di tensione si percepisce perfino nelle parole di alcuni addetti alla lastratura: «Adesso cercheranno di cacciarne 145 già assunti per ribadire che è tutta colpa della Fiom già lo hanno fatto in questi mesi, e sappiamo di un ex delegato Fiom che ora non dorme più per i sensi di colpa. Ma non è così, le cose sono diverse, in quanto lo Stato ha dato troppo potere a Fiat, che ora si sente in diritto di vietare l'ingresso agli iscritti ad un sindacato. Marchionne - dicono - fa tutto quello che vuole, ormai si sostituisce anche allo Stato». E se da un lato l'astio per i vertici è difficile da smussare alla fine arriva un grande messaggio di solidarietà che abbraccia tutti e 5mila operai, di cui 2750 ancora fuori dallo stabilimento: «Quelli della Fiom dovevano entrare anche se la magistratura avesse dato ragione al Lingotto, perché non è pensabile che un lavoratore non sia libero di iscriversi al sindacato che vuole . E la nostra impressione è che la Fiat abbia marchiato quelli della Fiom come si faceva con gli ebrei». Marchionne «prende atto» ma insiste: non c'è posto per tutti Prevedibile un ricorso alla Cassazione. Prevedibile che la sentenza della corte d'appello di Roma verrà usata dalla Fiat per provare a dividere ancora i lavoratori di Pomigliano, dove si produce la Fiat Panda. In un comunicato, il Lingotto «prende atto» e accenna a «potenziali conseguenze», non specificate ma che si rifanno a quanto annunciato il 30 giugno scorso, dopo la sentenza di primo grado che imponeva la riassunzione di 145 operai iscritti alla Fiom causa discriminazione. Allora, l'amministratore delegato Sergio Marchionne fece sapere che, per assumere nuovi operai, avrebbe dovuto licenziarne altrettanti. Perché di Panda non c'è richiesta sui mercati che giustifichi altra gente al lavoro, nonostante la promessa - nei giorni brucianti del referendum sul nuovo contratto di lavoro - che la Fiat avrebbe riassunto tutti i circa 4.000 dipendenti della vecchia Pomigliano. Un ricatto mai finito, nemmeno di fronte a due sentenze giudiziarie. «Le considerazioni di allora - si legge ancora nel comunicato - risultano ancor più valide oggi, alla luce del fatto che l'azienda è già stata costretta a far ricorso negli ultimi mesi alla cassa integrazione per un totale di 20 giorni lavorativi, a causa della situazione del mercato automobilistico Europeo». Dunque, la linea del licenziamento resta valida. E altra cassa integrazione potrebbe aggiungersi per chi rimane, visto che i mercati continuano a scendere in modo pesante per il gruppo, -20% in Italia e -18,5% in Europa in settembre. La sentenza arriva alla vigilia del piano (al Lingotto preferiscono parlare di aggiornamento degli obiettivi) che il prossimo 30 ottobre Marchionne illustrerà agli analisti, al termine del consiglio di amministrazione sul bilancio del terzo trimestre. L'amministratore delegato ci lavorerà fino all'ultimo minuto. Non è previsto il lancio di nuovi modelli - il manager sostiene, in solitudine mondiale, che è inutile in tempi di crisi di mercato - ma un programma di export di auto del gruppo dagli stabilimenti italiani all'estero. Unico modo, dice ancora Marchionne, per far fronte alla grave sottoutilizzazione degli impianti del nostro paese, che porteranno la Fiat a perdere 700 milioni di euro nel 2012. Per questa operazione, la Fiat ha chiesto al governo Monti agevolazioni fiscali all'export, sulle quali un gruppo congiunto sta lavorando al ministero dello Sviluppo. Ma è chiaro che, se si arrivasse a delle soluzioni, le norme dovrebbero valere per tutte le imprese e non solo per Fiat. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, piuttosto critico con Marchionne, sta lì con il fucile puntato. Oltre a commentare la sentenza della corte di appello di Roma, il Lingotto ha smentito seccamente un articolo del Messaggero in cui si attribuiscono a Marchionne una serie di decisioni su prodotti e produzione nei vari siti italiani in vista dell'appuntamento del 30 ottobre. La direzione della comunicazione Fiat smentisce anche un articolo di Bloomberg e ripubblicato dal Detroit News in cui si parla, tra le altre cose, di portare la produzione della Dodge Dart (gruppo Chrysler, controllato da Fiat) nella fabbrica di Cassino, dove si costruisce l'Alfa Romeo Giulietta che condivide con la Dart il pianale meccanico. Ipotesi compatibile tecnicamente, ma improbabile politicamente, considerando che il sindacato dei metalmeccanici americani Uaw ha dato moltissimo a Marchionne nel 2009, ha ottenuto molte riassunzioni ma non sembra disposto a farsi portare via produzioni. Nemmeno di un modello come la Dart, per ora un flop di vendite sul mercato nordamericano. Per il lavoro prima di tutto – Luca Fazio Non è un corteo, forse è qualcosa di più. E non è solo questione di numeri o di masse oceaniche che sfilano. «Dobbiamo dare voce al mondo del lavoro che appare invisibile, costretto a mettere a rischio se stesso perché il governo lo ignora», dice Susanna Camusso per spiegare le ragioni di questo strano happening che per tutta la giornata trasformerà piazza San Giovanni in un luogo aperto dove il lavoro cercherà di tornare protagonista (ore 10,30-17,30). Sul palco, prima e dopo l'intervento del segretario generale della Cgil (alle 16), si alternano delegati sindacali, attori, lavoratori, precari e artisti, tra cui Eugenio Finardi; a rappresentare il «villaggio del lavoro», tutt'intorno sono stati allestiti trenta stand regionali per evidenziare come la crisi abbia già lacerato il tessuto produttivo del paese (e troverete anche un banchetto de il manifesto). L'obiettivo dell'happening è rivoluzionario: «Cambiare da subito l'agenda Monti, che ci sta portando al disastro». Ma come? Protagoniste sono le persone che stanno lottando per non perdere il lavoro, i casi più conosciuti - Irisbus, Vynils, Carbosulcis, Alcoa... - ma anche storie che non vengono raccontate. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, visto che ci sono voluti due anni per tornare in piazza San Giovanni, dopo la manifestazione Cgil del novembre 2010 contro il governo Berlusconi. A proposito di voci inascoltate - e un pensiero non può non andare a Florin Damian, il disoccupato che giovedì si è dato fuoco per protesta davanti al Quirinale qualcuno ha idea di quanto forte sarebbe l'urlo dei lavoratori delle 30 mila imprese scomparse nel triennio 2008-2010? O di quel mezzo milione di persone in cassa integrazione che sopravvive con stipendi al di sotto della soglia di povertà? (dal 2008 ad oggi, 4 miliardi di ore di cassa integrazione). Non un settore produttivo è stato risparmiato dalla crisi più sconvolgente. La meccanica del dopo Marchionne. Le aziende metalmeccaniche del comparto auto, ferroviario e navale registrano le maggiori richieste di cassa integrazione. Sul totale delle ore di cassa, la meccanica pesa per 253.714.842 di ore coinvolgendo 162.638 lavoratori (e anche la cassa integrazione ordinaria è aumentata del 47% rispetto all'anno precedente). Al centro della crisi, ovviamente, la Fiat, e di conseguenza molte aziende dell'indotto come la Pcma Magneti Marelli di Napoli, la Irisbus di Avellino (658 lavoratori di cui 190 «esodati») e la Om carrelli elevatori che ha trasferito ad Amburgo la produzione. Per il settore ferroviario la «preoccupazione» si chiama Finmeccanica, con l'annunciato piano di dismissione che prevede la vendita di Ansaldo Breda ed Sts (un colpo per la Liguria dove Finmeccanica dà lavoro a 7.400 lavoratori, senza contare i 5.000 dell'indotto). Ma a risentire del piano di dismissione ci sono decine di aziende sparse in tutta Italia. Il crollo di ordini e di forza lavoro coinvolge anche la cantieristica navale, con piani industriali «lacrime e sangue» che stanno falcidiando realtà produttive a Castellammare di Stabia e Sestri Ponente (solo per il ridimensionamento di Riva Trigoso è stato fatto un accordo nazionale separato, non firmato dalla Fiom, che prevede due anni di cassa per 3.650 lavoratori). Si spengono gli elettrodomestici. Sono a rischio chiusura stabilimenti storici come Indesit, Merloni, Electrolux (i produttori delocalizzano in Polonia e Turchia). La Indesit ha già chiuso tre stabilimenti, in bilico ci sono 360 lavoratori in cassa con stipendi ridotti del 30%. La Electrolux ha annunciato 841 esuberi e le vertenze sono ancora aperte. La Merloni ha ceduto tre stabilimenti alla Qs Group, che solo in seguito a un «bonus» statale di 35 milioni di euro si è impegnata a riassumere 700 lavoratori. L'edilizia è ridotta in briciole. Il settore delle costruzioni, dall'inizio della crisi, ha perso circa 325mila posti di lavoro (500mila se si considerano i settori collegati). Scrive la Fillea Cgil: «Stiamo assistendo alla morte del settore delle costruzioni, fino ad oggi sono sparite 20 Ilva, 100 Termini Imerese e 200 Alcoa». Da nord a sud, impossibile quantificare i nuovi disoccupati. Stessa situazione per il settore delle piastrelle e delle ceramiche (Modena, Imola e Faenza), con la storica azienda Richard Ginori che dopo 277 ha chiuso i battenti. Il calo di turismo e commercio. Ci sono più di 250 vertenze aperte sul territorio nazionale: solo nel periodo tra gennaio e giugno 2012 sono stati coinvolti oltre 20 mila lavoratori nel terziario e 5 mila nel turismo. Qualche caso eclatante: la catena alberghiera NhHotel che vuole licenziare 400 persone, e la catena francese Fnac che rischia di chiudere tutti i punti vendita lasciando a casa 600 commessi. L'agroindustria è alla frutta. La situazione è drammatica anche nel settore della forestazione che in Italia occupa circa 60 mila persone (il 93% concentrate al sud): in Campania, solo per fare un esempio, ci sono 4 mila lavoratori che non prendono lo stipendio da 15 mesi... Per completare il quadro della crisi (ma non basterebbero dieci pagine per elencare chiusure e dismissioni), bisognerebbe aggiungere altri settori strategici dell'economia telecomunicazioni, banche (i dipendenti), elettronica, siderurgia, energia, chimica, farmaceutica, tessile e moda, trasporti... Milioni di vite in bilico. Non ci stanno tutte in piazza San Giovanni, ma visto che hanno le stesse esigenze da qualche parte bisognerà pure indirizzarle. Il titolo dell'happening é: «Prima di tutto il lavoro». I fantasmi dei call center – Riccardo Chiagi Per conquistare un nuovo contratto di lavoro, che metta nero su bianco le clausole sociali in caso di appalti ed esternalizzazioni, hanno scioperato in blocco. Con una adesione stimata almeno al 75%, molto alta in un comparto dove per legge devono essere garantiti alcuni servizi di assistenza tecnica e di rete. Ad incrociare le braccia, per la seconda volta in soli trenta giorni, sono stati tutti i sindacati delle telecomunicazioni, dai confederali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil ai basisti dell'Flmu Cub e Cobas Lavoro Privato. Hanno manifestato a Roma più di cinquemila lavoratori arrivati da mezza Italia, con un indicativo corteo unitario confederale e di base nel centro storico, da piazza Repubblica a piazza Santissimi Apostoli. Sono scesi in piazza anche a Palermo, lì dove la vertenza tocca la vita di almeno seimila ragazzi che tirano avanti nei call center, con contratti part-time e di solidarietà da poche centinaia di euro al mese. E ancora a Torino, dove sono diventati «notizia curiosa» alcuni giovani addetti dei locali call center che si sono vestiti da fantasmi per manifestare in piazza. «Da operatori fantasma - hanno specificato - perché già siamo precari e sottopagati. E ora, con il mancato rinnovo del contratto e con i ricatti delle imprese sui diritti, diventeremo una specie in via di estinzione a causa delle delocalizzazioni». Hanno scioperato anche quelli dell'Ugl, che hanno sfilato in solitaria alla periferia della capitale. Le controparti sono imprese che si chiamano Telecom, Vodafone Omnitel, H3G, Tiscali, Almaviva, BT Italia, Colt, Comdata, Fastweb e Sky. Giganti delle telecomunicazioni, che nel devastante quadro generale resta uno dei settori in cui l'impatto della crisi, in termini di ricavi, si è fatto sentire meno. Eppure, riunite nella confindustriale Asstel, stanno chiudendo le porte a qualsiasi ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro che, grazie alle clausole sociali, tenga ferma la salvaguardia dell'occupazione. Alla Slc Cgil raccontano che perfino il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi si è spazientito, osservando che una posizione così intransigente sulle clausole sociali «mal si adatta all'attuale momento economico e sociale del paese». Come malissimo si adattano gli obiettivi generali delle imprese, tendenti a favorire le delocalizzazioni del lavoro all'estero; rendere la gestione degli appalti una ulteriore concorrenza al ribasso sui costi; e ridurre per l'ennesima volta i diritti dei lavoratori. Anche con la richiesta di un contratto ad hoc per gli operatori dei call center, l'anello più debole della catena. «Non è ammissibile - replica Massimo Cestaro, segretario generale della Slc - che questo settore strategico per il paese si regga su simili forme di deregolamentazione dei rapporti di lavoro». Non solo la Cgil ma i sindacati nel loro complesso osservano che in tutte le realtà aziendali la battaglia sul rinnovo del contratto viene considerata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori come giusta, condivisibile, ed essenziale per il futuro dell'intero comparto. «La libertà di impresa - ricorda Michele Azzola, anche lui segretario Slc - non può essere esercitata a scapito di altri diritti, e soprattutto del diritto alla salvaguardia dell'occupazione. È necessario che il contratto disciplini le procedure nell'ambito dei cambi di appalto, per evitare di creare disoccupazione quando si assumono nuovi lavoratori con gli incentivi statali». Perché non è un certo un mistero che tanti call center hanno aperto e fallito nel tempo strettamente necessario per prendere i finanziamenti pubblici. Oppure hanno spostato le attività nel sud della penisola per ottenere sgravi fiscali, e ora puntano a delocalizzare all'estero per abbassare ulteriormente il costo del lavoro. E la mancata volontà di rinnovare il contratto, denunciano le organizzazioni sindacali, indica la volontà di avere mano libera nelle riorganizzazioni, nella gestione delle commesse e degli appalti, e nelle esternalizzazioni di nuovi, ulteriori rami di azienda. «Fino a quando l'unico modello a cui le aziende si attengono è quello di tagliare il costo del lavoro - tira le somme Azzola - concetti come qualità, produttività ed eccellenza restano solo parole che vengono usate nei convegni». In piazza con il drago della finanza che ha divorato vite e speranze – Mauro Ravarino TORINO - Correva l'anno 2008, fine settembre, e per le vie di Torino sfilavano i lavoratori con le bandiere rosse della Cgil: «La crisi non è vicina, la stiamo già vivendo», dicevano. In testa al corteo c'era un drago, quello che aveva divorato in meno di un anno 362 euro dalle tasche di ognuno di loro. Quattro anni dopo, la crisi si è fatta epoca, e l'enorme drago - metafora della finanza che si mangia il lavoro - verrà portato in piazza San Giovanni a Roma dalla Cgil di Torino. La coda è diventata lunghissima, 25 metri sui quali sono elencate le cifre drammatiche della cassa integrazione, dei lavoratori in mobilità, della disoccupazione giovanile (35% a Torino, più alta della media nazionale). Sono oltre mille i lavoratori in arrivo dal Piemonte con treni speciali e autobus. Qualcuno arriva da Mirafiori, altri dall'ex Bertone, due realtà che hanno numeri record per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria. Ma l'estremo Nord-Ovest non è solo Fiat e indotto, è anche un insieme di centinaia di vertenze ancora senza soluzione. La Cgil propone di unificarle, di aprire un dialogo e un'azione comune tra tutti i soggetti. Evitare l'isolamento. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate nei primi nove mesi del 2009 erano 50 milioni (a fine anno, 70 mln), da gennaio a settembre 2012 sono 21 milioni e 500 mila. «La cassa cala ma non perché i problemi siano superati, ma perché la maggior parte delle imprese hanno raggiunto il limite massimo di possibile utilizzo (12 mesi nel biennio)». Al 30 settembre scorso risultavano fare ricorso alla cigs 345 unità produttive (26 mila lavoratori coinvolti). Dai dati emerge, però, come oltre 5.500 persone risultino ancora formalmente in forza, ma in situazioni che solo in pochissimi casi potranno vedere un effettivo rientro al lavoro (procedure concorsuali e cessazione di attività). La Cgil denuncia una recente norma inserita nel «decreto sviluppo» secondo cui «la cassa straordinaria potrà essere riconosciuta solo nei casi in cui vi sia una prospettiva di continuazione o ripresa dell'attività produttiva, rischiano dunque di rimanere scoperti i lavoratori dei numerosi casi di fallimento». Il ricorso massiccio alla cassa non è stato sufficiente a impedire un'impennata dei licenziamenti (al primo ottobre per la provincia di Torino risultavano iscritti nelle liste di mobilità 25.178 disoccupati). Calano inoltre i contratti a tempo indeterminato, aumenta il lavoro intermittente. A Roma ci saranno anche gli operai della Fiom con un po' di amarezza per un'iniziativa in qualche modo considerata insufficiente. «La manifestazione - spiega Federico Bellono, segretario provinciale Fiom - è sicuramente positiva per dare dignità a tante situazioni di crisi nel nostro Paese. Ma non c'è dubbio che continui a esserci un'attesa per ora vana di una iniziativa più forte. Parlo dello sciopero generale. È dalla scorsa primavera che lo chiediamo. Il tempo sta per finire». Le tute blu portano a Roma il racconto di una crisi pesante e senza uscita. Fiat, De Tomaso, Viberti, Romi ex Sandretto. Se il gigante Mirafiori arrugginisce, l'indotto soccombe vittima delle scelte e dei ritardi di Marchionne. Chi si è sganciato dal Lingotto, lavorando per francesi o tedeschi ora soffre per il rallentamento del mercato. In casa Fiat si attende il fatidico 30 ottobre, quando il Lingotto dovrebbe sciogliere le riserve sul nuovo piano. Martedì sono andati sotto il palazzo della Giunta regionale (ieri c'erano vestiti da fantasmi i lavoratori del collettivo Comdata, colosso dei call center) i dipendenti della De Tomaso e della Romi ex Sandretto: due vicende emblematiche che coinvolgono 1500 lavoratori. La prima è finita tra i fascicoli della magistratura (lunedì arrestato il figlio di Rossignolo), nella seconda gli attuali proprietari brasiliani hanno annunciato di voler cessare la produzione. Ma la lista si allunga: in bilico i lavoratori, un centinaio, della storica ex Viberti di Nichelino, saliti recentemente sul tetto della fabbrica; aria di tagli alle Acciaierie Beltrame di San Didero; pagamenti in ritardo alla Celltel di Scarmagno; delocalizzazione paventata alla Dayco di Ivrea. Un topolino senz'anima – Livio Pepino La montagna ha partorito il topolino. Non senza qualche inganno. Un secolo fa le indagini di Mani pulite sembravano avere «girato l'Italia come un calzino». Ma, nonostante le inchieste, gli arresti, i dibattimenti, le condanne, la mobilitazione della piazza e della stampa, i processi di allora non hanno lasciato tracce durature nel sistema. A poco a poco, i fattori extragiudiziari che avevano favorito inchieste e processi si sono modificati e i promessi interventi istituzionali tesi a prevenire e disincentivare la corruzione sono come evaporati. Alla fine, il cuneo aperto con Mani pulite si è rinchiuso confermando la regola secondo cui la giustizia può colpire alcuni forti ma alla lunga, senza cambiamento politico, è impotente di fronte alla categoria dei forti complessivamente considerati. Accade così che, a pochi lustri dai processi per la Tangentopoli milanese, due loro protagonisti concludano amaramente che «Mani pulite è stata inutile, ma anche controproducente: inutile perché non mi pare che abbia causato un contenimento della corruzione; controproducente perché ha confermato il senso di impunità che già prima accompagnava questo tipo di reati» (Gherardo Colombo) e che «per l'attività di contrasto alla corruzione in Italia potrebbe rivelarsi addirittura profetico quanto Joseph Roth scriveva a proposito della protagonista di uno dei suoi racconti: "Nessuno aveva desiderato che restasse in vita e perciò era morta"» (Piercamillo Davigo). È in questo contesto che si colloca l'approvazione del disegno di legge sulla corruzione. Per valutarlo è necessario confrontarlo con le esigenze emerse nei processi degli ultimi anni. Cosa hanno insegnato quei processi? In breve e limitandosi al settore penale: per arginare le diverse forme di corruzione è necessario, per quando riguarda l'aspetto penale, precisarne e ampliarne le ipotesi, rendere punibili alcune condotte ad esse prodromiche, potenziare gli strumenti di accertamento, prevedere tempi di prescrizione commisurati alle difficoltà di accertamento (per evitare la regola del proscioglimento per estinzione del reato che caratterizza gran parte dei relativi processi). Sembra incredibile ma il disegno di legge approvato dal Senato non dà risposta soddisfacente a nessuna di queste esigenze, nonostante le aspettative che lo hanno accompagnato. Il ministro della giustizia definisce «grilli parlanti» i critici della sua creatura. Ma i fatti hanno la testa dura e dicono cose diverse. Manca, nel testo approvato dal Senato, ogni cenno al falso in bilancio, al cosiddetto "autoriciclaggio" e allo scambio elettorale in cui il corrispettivo del voto sia una utilità diversa dal denaro (per esempio un impiego...), che continueranno, dunque, a restare impuniti. Il più grave tra i reati dei pubblici ufficiali, la concussione (consistente nel procurarsi denaro o altre utilità abusando della propria funzione), viene depotenziato in maniera significativa: l'ipotesi più frequente, quella della cosiddetta concussione per induzione, viene configurata come reato autonomo con consistente riduzione di pena. I reati introdotti ex novo - il traffico di influenze e la corruzione tra privati sono caratterizzati da pene ridotte o da un'ampia punibilità a querela, che ne renderanno residuale la concreta applicazione. Gli strumenti di accertamento a disposizione della magistratura sono limitati (nelle indagini per traffico di influenze, per esempio, non sono consentite le intercettazioni telefoniche) e talora addirittura diminuiti (come nella concussione per induzione in cui, essendo prevista la punibilità anche del concusso, saranno limitatissime le denunce e le collaborazioni). I meccanismi della prescrizione restano invariati e comporteranno talora - grazie, per esempio, alla diminuzione della pena per la concussione per induzione - tempi ancora più brevi (realizzando così un salvacondotto per alcuni imputati di processi in corso, tra i quali Filippo Penati e Clemente Mastella). C'è quanto basta per concludere che i dati negativi prevalgono su quelli positivi e che siamo di fronte a una operazione tutta mediatica che, al di là delle apparenze, non renderà certamente più efficace il contrasto alla corruzione. Altro miracolo del governo dei tecnici! Per il lavoro, new deal verde e meno orario - Lia Fubini Il drammatico aumento della disoccupazione manifestatosi con la recessione che ha investito i paesi industrializzati è certamente causato da insufficienza di domanda. Non è però questa una spiegazione esaustiva, la disoccupazione era in crescita già prima dello scoppio della crisi e la causa va ricercata in larga misura nella ristrutturazione produttiva e nel cambiamento tecnologico che ha causato l'espulsione dal processo produttivo di molti lavoratori non specializzati o con qualificazioni obsolete. Non sempre e non necessariamente l'innovazione tecnologica comporta un aumento della disoccupazione. In certe fasi proprio grazie all'evoluzione della tecnologia nascono opportunità legate a nuove produzioni e vengono creati posti di lavoro. Ma in altre fasi l'introduzione di tecnologie labour saving e il ridimensionamento di attività caratterizzate da un calo della domanda dovuto a saturazione dei bisogni comportano un processo di distruzione di posti di lavoro. Nel processo dinamico di creazione e distruzione di posti di lavoro il saldo occupazionale può dunque risultare negativo specie quando le innovazioni di processo risultano più massicce e importanti delle innovazioni di prodotto; tale processo è particolarmente evidente nei momenti di crisi e di stagnazione. In un recente articolo su sbilanciamoci.info, Laura Balbo evidenzia la necessità di prendere coscienza delle conseguenze dell'introduzione di tecnologie a risparmio di lavoro, che hanno comportato una disoccupazione crescente non solo in Italia. Si apre dunque il problema di come fare fronte alla situazione senza ricorrere a soluzioni drammatiche - in passato spesso la mobilitazione per una guerra è stata il fattore risolutivo delle crisi occupazionali. Anche oggi c'è una guerra da combattere, ed è quella per la salvezza dell'ambiente. Con la crisi il problema ambientale è anche una grande opportunità per creare occupazione e crescita sostenibile. (...) Se con la crisi e l'avvento di nuove tecnologie non c'è lavoro per tutti non sarebbe il caso di riprendere la proposta della riduzione dell'orario di lavoro? Si tratta di una proposta controcorrente: oggi ci si indirizza nella direzione opposta (allungamento dell'età pensionabile, eliminazione di alcune festività, ecc.) e la conseguenza è un drammatico aumento della disoccupazione (...) Invece si dovrebbe pensare a una riduzione dei tempi di lavoro tale da soddisfare le esigenze produttive e al contempo migliorare la qualità della vita dei lavoratori. (...) Un movimento per la riduzione del tempo di lavoro, il rilancio dello slogan "lavorare meno per lavorare tutti" costituirebbe una svolta culturale degna di nota. Certamente esiste il problema dell'aggravio di costi e quindi dei finanziamenti necessari per sostenere la proposta. Almeno per i salari medi e bassi, infatti, si deve pensare a una riduzione di orario a parità di salario evitando così di alimentare l'esercito dei working poors. Dato il momento di difficoltà per le imprese il processo di riduzione del tempo di lavoro dovrebbe essere portato avanti con finanziamenti statali. Non è facile in questo momento, ma si deve tenere conto che l'aumento dell'occupazione sarebbe in grado di generare comunque un maggior gettito fiscale, permetterebbe di risparmiare sugli ammortizzatori sociali, costituirebbe un rilancio della domanda aggregata con effetti positivi sull'economia e sui conti pubblici. Il testo completo dell'articolo è su www.sbilanciamoci.info I Paesi baschi oltre l'autonomia - Jacopo Rosatelli La crisi economica e la cessazione definitiva della lotta armata dell'Eta. Questi sono i due elementi-chiave che definiscono il contesto nel quale si svolgeranno domani le elezioni regionali nei Paesi baschi. Un appuntamento cruciale, che inciderà molto non solo sul futuro della Comunidad autónoma vasca, ma sull'intero quadro politico spagnolo. Dall'esito delle urne si capirà se anche questo territorio seguirà l'esempio catalano, innescando di fatto un negoziato con lo Stato centrale per un diverso assetto di autogoverno. È un esito quasi certo. A porsi l'obiettivo di «un nuovo modello di relazione con lo Stato» è la forza che, secondo i sondaggi, otterrà il maggior numero di consensi: il Partido nacionalista vasco (Pnv), di centrodestra, legato alla borghesia industriale. Esplicitamente indipendentista è la coalizione Euskal Herria Bildu, di sinistra, vicina ai movimenti sociali e al mondo delle cooperative, che le inchieste d'opinione danno al secondo posto. La maggioranza degli eletti sarà dunque, salvo sorprese, favorevole ad andare oltre l'autonomia attuale. Il Pnv, esistente sin dagli albori del nazionalismo basco a fine Ottocento, è la formazione che ha sempre governato la regione, salvo nell'ultima legislatura. Il suo leader, Iñigo Urkullu, sarà con ogni il prossimo governatore (lehendakari, in basco). Euskal Herria Bildu è invece una sigla nuova, ma che non nasce dal niente: in essa è confluita essenzialmente l'area della sinistra abertzale, tradizionalmente considerata il braccio politico dell'Eta. Ma non solo. Ne fanno parte anche Eusko Alkartasuna, frutto di una scissione dal Pnv negli anni Ottanta, Alternatiba, un gruppo staccatosi da Izquierda Unida (Iu), e infine Aralar, formata un decennio fa da militanti della sinistra abertzale critici nei confronti dell'Eta. Un soggetto plurale, dunque, che nella sua natura rispecchia la vivacità della politica basca. Malgrado il nome della coalizione sia nuovo, è un'esperienza che esiste già da un paio d'anni. Da quando, cioè, la sinistra abertzale ha potuto tornare ad agire politicamente nella piena legalità, dopo la messa fuori legge di Batasuna, nel 2002. Proprio la strategia di unione alle altre forze - perfettamente legali per l'ordinamento spagnolo - ha consentito alla sinistra abertzale di partecipare alle elezioni comunali del maggio 2011 e alle politiche dello scorso novembre, mandando nel Parlamento statale una pattuglia di sette deputati sotto le insegne della lista Amaiur (vedi intervista in questa pagina, ndr). Sono sviluppi che non si capiscono se non li si lega al cambiamento maturato in seno alla sinistra abertzale dopo il fallimento dell'ultima trattativa fra l'Eta e il Governo di Madrid nel 2008. Archiviata la speranza di una soluzione negoziata al conflitto, dirigenti autorevoli come Arnaldo Otegi e Rafa Díez Usabiaga decisero che era venuto il momento di dichiarare esaurito il ruolo storico della lotta armata, scommettendo esclusivamente sulla via politica. Dopo una lunga fase di discussione interna, il mondo della sinistra nazionalista aderì alle loro tesi. Culmine di questo percorso, l'annuncio di «cessazione dell'attività armata» da parte dell'Eta, esattamente un anno fa. Da allora, la situazione nei Paesi baschi può dirsi normalizzata. O quasi. Resta infatti ancora da chiarire il destino dei militanti dell'organizzazione armata - non ancora formalmente disciolta - in carcere e in clandestinità. E soprattutto la sorte del leader della sinistra abertzale, Otegi, che sta scontando una pena a sei anni e mezzo di prigione per aver tentato di ricostituire la disciolta Batasuna. Una situazione che - al di là di ogni altra considerazione - è assurda proprio perché si deve anche al suo impegno diretto la fine del terrorismo. L'ottimo risultato che i sondaggi attribuiscono a Euskal Herria Bildu (intorno al 25%) dipende da una sorta di «effetto-premio»: larghe fasce della cittadinanza, al di là dei tradizionali sostenitori della vecchia Batasuna, vogliono mostrare di sostenere il nuovo corso non-violento. Inoltre, sul versante economico la coalizione della sinistra indipendentista è molto netta nell'opporsi alle politiche del Governo di Mariano Rajoy, oggi particolarmente impopolari. E qui c'è un oggettiva affinità con le altre due forze progressiste in campo: il Partito socialista (Psoe) e Iu. Ma a dividerle è la «questione nazionale». Che nei Paesi baschi pesa di più della «questione sociale». I socialisti hanno governato nell'ultima legislatura regionale, grazie all'appoggio esterno del Partido Popular (Pp): un'insolita coalizione costruita proprio sulla distinzione fra nazionalisti e non-nazionalisti. Un'alleanza che ha retto tre anni ed è saltata quando il governatore uscente Patxi López si è rifiutato di applicare i tagli decisi dall'esecutivo conservatore di Rajoy sotto dettatura di Francoforte e Bruxelles. Proprio questa «insubordinazione» è la carta che il Psoe si gioca nelle elezioni di domenica, potendo anche esibire il fatto che questa regione è quella economicamente più in salute di tutta la Spagna. Dal canto suo, Izquierda Unida cerca di raccogliere il voto indignado e offre una sponda alle altre sinistre, invitandole ad anteporre i temi sociali alle controversie «nazionali». Perché, almeno sulla carta, dalle urne potrebbe uscire una maggioranza progressista. Ma forse è ancora lontano il tempo in cui il «fattore nazionale» smetta di essere quello decisivo. A rimetterci è la Spagna - Anna Maria Merlo PARIGI - Compromesso minimo al Consiglio europeo, Hollande e Merkel salvano la faccia, ma a rimetterci nell'immediato è la Spagna. La supervisione bancaria, che la Francia, con Italia e Spagna, voleva in tempi rapidi, avrà effettivamente un quadro legale entro fine anno. Ma, come chiedeva la Germania, prima di diventare operativa dovrà passare del tempo, forse non prima del 2014, cioè a elezioni tedesche passate. La Germania accetta che la supervisione, controllata dalla Bce assieme alle autorità nazionali, riguarderà 6mila banche europee, ivi comprese le sue Landesbanken, le banche regionali che Berlino avrebbe voluto tener fuori dalla vista dei partner. La supervisione «avrà luogo nel 2013, ma quando non lo sappiamo ancora» ha riassunto Mario Monti. La Spagna ha fatto la figura di spettatore. La ricapitalizzazione diretta delle banche, di cui la Spagna ha immediato bisogno, non potrà avvenire in tempi brevi, non prima della fine del prossimo anno, inizio 2014. Nel frattempo, toccherà allo stato spagnolo intervenire, aggravando il debito pubblico. La supervisione bancaria è difatti condizione preliminare per la ricapitalizzazione diretta delle banche in crisi da parte del Mes, il nuovo meccanismo di aiuti, per evitare che la crisi bancaria si traduca in un aggravamento della crisi del debito. Mariano Rajoy incassa la sconfitta, fa buon viso a cattivo gioco, afferma che la ricapitalizzazione delle banche rappresenta «soltanto» il 4% del pil spagnolo (40 miliardi di euro): «Possiamo gestirlo senza problemi», dichiara, mentre la popolazione è in rivolta. Ma Rajoy spera ancora che qualche accelerazione del calendario venga strappata all'Eurogruppo, incaricato di entrare nei dettagli tecnici del compromesso raggiunto nella notte tra giovedì a venerdì. La Spagna preme anche perché il Mes si faccia carico almeno di parte del debito passato, mentre per la Germania dovrà occuparsi solo del presente e del futuro. Hollande si è rallegrato sui «tempi ancora più rapidi» di quelli previsti a giugno per la messa in atto della supervisione. Hannes Swoboda, presidente del gruppo S&D all'europarlamento, «deplora la mancanza di un calendario preciso» e il comportamento di Merkel, che «frena». In realtà, l'unico punto favorevole per Hollande è che il primo passo dell'Unione bancaria è sui binari. E che la discussione sul bilancio è stata rimandata di un po': a Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo, è stato affidato il compito di fare proposte per il vertice di dicembre. Messa da parte, per il momento, la questione dei super-poteri al commissario agli affari economici, a cui Merkel voleva affidare il diritto di veto sui bilanci nazionali che non rispettano i diktat del Fiscal Compact. Per Hollande «ci vuole un altro trattato» per questo e quindi si rischia di andare alle calende greche, visto che la Francia non ha nessuna intenzione di indire un referendum sull'Europa. Merkel ha commentato, soddisfatta, che la Germania aveva «sempre detto che bisognava privilegiare la qualità alla rapidità» ed è stata accontentata: non dovrà andare di nuovo di fronte al Bundestag a chiedere altri soldi per la Spagna. Se a dicembre verrà stipulato il quadro giuridico della supervisione bancaria, primo passo per l'Unione bancaria, potrà allora venire formalizzata anche l'Europa a più velocità, con la creazione di un «nocciolo duro» della zona euro, che permetterà, per Hollande già da gennaio, di istituire la tassa sulle transazioni finanziarie (nei 10 paesi che l'accettano). La Gran Bretagna ha già messo le mani avanti e preso le prime misure di progressivo allentamento dei legami (ha annunciato l'opt out dalle politiche interne e di giustizia). A sorpresa, mentre si lascia affondare la Spagna, la Grecia, già quasi annegata, riceve congratulazioni per «i progressi» fatti per attuare «il programma di aggiustamento»: tradotto in soldoni, Atene avrà a novembre la tranche di 31,5 miliardi del programma di aiuti, di cui ha assolutamente bisogno. P.S. Per fortuna, il ridicolo non uccide: a ritirare il Nobel per la pace a Oslo, il 10 dicembre, l'Ue sarà rappresentata da (almeno) 30 persone: van Rompuy, Barroso e Schultz, per Consiglio, Commissione e Parlamento, più i 27 capi di stato e di governo e, se lo desiderano, altre personalità. Merkel e Hollande hanno fatto sapere che saranno presenti. Hollande ha detto proprio «riformatorio» - Marco d’Eramo «L'Europa non può essere un riformatorio». Nessun giornale italiano ha ripreso - et pour cause - quest'affermazione che il presidente francese François Hollande ha pronunciato in un'intervista concessa a sei importanti quotidiani europei (tra cui La Stampa). Eppure lo spagnolo El Pais proprio questa frase usava come titolo, e a ragione, perché il termine «riformatorio» centra il nocciolo del problema e riassume in sé la natura foucaultiana, panottica, disciplinare, che la gestione della crisi dell'euro sta assumendo. Quel che Bruxelles, la Troika, la Banca centrale europea (Bce) e il governo tedesco infliggono da quasi tre anni alla Grecia è una limpida illustrazione di quella tecnica - comune a eserciti, carceri, ospedali, scuole e fabbriche, cioè a tutti gli apparati «disciplinari» - che Foucault chiamava «ortopedia» e che raffigurava con le grucce serrate attorno a un alberello per «raddrizzarlo». Foucault si meravigliava che a un certo punto della storia gli umani non si fossero più limitati a punire i criminali e i delinquenti, ma considerarono che si poteva nello stesso tempo punirli e redimerli, castigarli e rieducarli, che disciplina e penitenza avessero un potere catartico. L'ultima proposta della cancelliera tedesca Angela Merkel - «commissariare» tutti i bilanci degli stati membri - realizza infine la versione finanziaria del panopticum di Bentham (quel modello di carcere in cui i detenuti vivono 24 ore su 24 sotto gli occhi di un sguardo invisibile). E la natura ortopedico-benthamiana di questa proposta risulta ancora più chiara se si pensa che in Germania, pur una repubblica federale, per i Länder non c'è nessun commissariamento da parte del governo centrale e il raggiungimento del patto di stabilità è fissato per il 2020, e con le dovute eccezioni: e se uno stato sovrano non commissaria le sue regioni, perché mai dovrebbe farlo l'Europa (che di uno stato non ha né la legittimità, né l'omogeneità istituzionale) nei confronti dei paesi membri? Il fatto è che, a differenza dei Länder, i paesi del Sud Europa sono «criminali minorili» che vanno riformati e puniti con tanta severità «che si ricordino la lezione». Questo spiega anche perché nessun giornale italiano, nemmeno quelli che hanno più o meno appoggiato Hollande, abbia ripreso questa frase. Semplicemente perché con il nostro premier Mario Monti (sostenuto da una maggioranza che comprende il Partito democratico) l'Italia ha «patteggiato la condanna» a condizione di autoinfliggersi autonomamente la punizione e di sottoporsi di propria spontanea volontà a un trattamento di rieducazione (non si sa quanto sincero o quanto solo di facciata: una nazione di furbetti non può redimersi tutto d'un botto e di colpo diventare puritana). Poi ci si meraviglia che in Italia (ma anche in Spagna, Portogallo, non parliamo della Grecia) l'Europa sia sempre più impopolare. Come dice sempre Hollande, non si può «imporre la catena perpetua a paesi che hanno preso decisioni difficili». La nave pacifista Estelle verso le coste di Gaza - Michele Giorgio Urne aperte per i palestinesi della Cisgiordania chiamati oggi, dopo sette anni, a rinnovare consigli comunali e locali. Con il risultato del voto scontato - vincerà Fatah, il partito del presidente dell'Anp Abu Mazen, poichè Hamas e il Jihad islami boicottano il voto - l'attenzione di molti palestinesi dei Territori occupati (e di tanti attivisti internazionali) è rivolta alle acque di Gaza. È previsto nelle prossime ore l'arrivo della nave pacifista svedese Estelle, ossia l'ultima missione della Freedom Flotilla3 volta a rompere il blocco navale di Gaza attuato da Israele. Tuttavia le possibilità che l'imbarcazione, un veliero con a bordo una ventina di passeggeri (incluso un italiano) e aiuti per la popolazione palestinese, riesca a raggiungere il porto di Gaza city sono scarse. Israele non ha fatto mistero di voler fermare, anche con la forza, la nave del movimento internazionale che si batte per porre fine al blocco della Striscia e che lo scorso 6 ottobre ha lasciato Napoli, dopo tre giorni di iniziative a favore della popolazione di Gaza, alle quali ha partecipato anche il sindaco Luigi De Magistris. Qualche giorno fa, con una lettera inviata al Segretario generale dell'Onu Ban Ki Moon, Israele ha chiesto che le Nazioni Unite intervengano per la navigazione della Estelle, altrimenti, ha avvertito, passerà all'azione, come avvenuto negli anni passati in altre missioni della Freedom Flotilla. È ancora vivo il ricordo dell'incursione di commando israeliani sul traghetto turco Mavi Marmara, alla fine di maggio del 2010, sfociata nell'uccisione di nove passeggeri. «È la Siria ad aver bisogno di aiuti», ha scritto nella lettera l'ambasciatore israeliano Dan Prosor all'Onu definendo la Estelle una «provocazione». «Voglio sottolineare - ha affermato Prosor - che Israele non vuole un confronto ma è determinata a far bloccare la nave». Ebrei contro l'occupazione a bordo. È ampio il sostegno a questa nuova missione della Freedom Flotilla. In Italia ha raccolto l'appoggio di decine di associazioni e organizzazioni e anche quello di 12 fra deputati e senatori (dell'Idv e del Pd) che hanno sottoscritto (insieme a decine di altri parlamentari europei) l'appello internazionale «Fine del blocco di Gaza subito!». Ben diverso è l'atteggiamento della Farnesina che, rispondendo alla comunicazione che a bordo di Estelle si trova anche il cittadino italiano Marco Ramazzotti Stockel, ha fatto sapere che «sconsiglia» di recarsi a Gaza a causa degli «obiettivi rischi che i nostri connazionali potrebbero correre nel caso intendano recarsi via mare verso tale area», ricordando che «l'ingresso via mare nella Striscia comporta, come noto, una violazione della vigente normativa israeliana». La «normativa», ossia il blocco navale, è quella di una potenza occupante ma questo «particolare» appare del tutto irrilevante al nostro ministero degli esteri. Marco Ramazzotti Stockel è un ebreo. «Non dimenticate di scrivere Stockel quando riportate il mio nome - dice l'attivista imbarcato sulla Estelle - così capiscono che sono ebreo e che se lotto contro l'occupazione è proprio per gli ebrei, è a loro che fa male, oltre che ai palestinesi, l'occupazione». Con un passato politico nel Pci e nella Cgil, iscritto a ECO-Ebrei contro l'Occupazione, laureato in Diritto internazionale, Ramazzotti Stockel ha già partecipato alla Freedom Flotilla lo scorso anno. «È un sogno quello di andare a Gaza per testimoniare da ebreo che siamo fratelli e che Israele deve trovare altre politiche che non siano quelle militaristiche per risolvere il contenzioso tra i due popoli», spiega l'attivista. Sul terreno però le cose vanno nella direzione opposta da quella auspicata da Marco Ramazzotti Stockel. Chi vive a Gaza deve pagare ogni giorno un conto altissimo, specie se è un giovane. È notizia di questa settimana la decisione degli Stati Uniti di sospendere, di fatto su pressione di Israele, 30 borse di studio per studenti meritevoli della Striscia. Si tratta di un progetto lanciato due anni fa, dallo stesso Segretario di stato Hillary Clinton. Prevede che gli studenti di Gaza vadano nelle meglio attrezzate università della Cisgiordania. Secondo Israele invece gli atenei palestinesi sarebbero luoghi usati da Hamas per trovare nuovi seguaci. «Hamas lavora molto sulla ricerca di nuovo affiliati all'infrastruttura terroristica da Gaza alla Cisgiordania - ha detto Guy Inbar, portavoce dell'esercito - e sul trasferimento di conoscenze per rafforzare la struttura in Cisgiordania». Gli studenti di Gaza perciò non saranno autorizzati ad andare in Cisgiordania e gli Stati Uniti hanno subito abbozzato: le 30 borse di studio sono state date ad altri. Una notizia che si abbina ad documento del 2008 reso noto, grazie a una petizione dell'associazione israeliana per i diritti umani «Gisha», che descrive come i vertici del ministero della difesa dello Stato ebraico avessero fissato in 2.279 le calorie al giorno che poteva ricevere un abitante della Striscia: un numero di calorie che evitava critiche internazionali e teneva allo stesso tempo sotto pressione la popolazione civile. In tutto 107 camion di aiuti al giorno, cinque giorni alla settimana, per rifornire quel milione e mezzo di persone di palestinesi che vive nella prigione più grande del mondo. Autobomba fa strage a Beirut – Giuliana Sgrena Tra le otto vittime (il bilancio è provvisorio) dell'autobomba esplosa ieri nel centro di Beirut vi è Wissam al Hassan, un alto ufficiale della sicurezza libanese, vicino all'opposizione guidata da Saad Hariri. Lo scoppio, che ha provocato anche un'ottantina di feriti, alcuni molto gravi, è avvenuto nel quartiere di Ashrafiyeh zona abitata soprattutto da cristiani e in un momento di grande traffico. Immediatamente sono state dispiegate ingenti forze di sicurezza, perché poco lontano dallo scoppio si trova anche l'ufficio del Partito cristiano falangista, ostile al regime di Damasco. La tensione in Libano sta salendo per effetto del conflitto siriano, del resto la politica dei due paesi è sempre stata estremamente intrecciata e non solo durante il periodo in cui le truppe siriane controllavano il paese vicino. Le prime accuse per l'attentato (finora non rivendicato) sono subito cadute sul regime di Assad che però, tramite il ministro dell'informazione Omran al Zoubi, ha definito l'attacco «un atto codardo di terrorismo». Il primo ministro libanese Najib Mikati ha detto che il governo sta cercando di scoprire l'identità degli attentatori e che saranno puniti. Non sarà facile scoprire gli attentatori nella giungla terroristica libanese, anche se i legami con il conflitto siriano sono sempre più evidenti. Wissan al Hassan si può considerare un obiettivo di alto profilo visto che aveva avuto un ruolo chiave nel perseguire i killer di Rafiq Hariri, e più recentemente era riuscito a catturare e arrestare Michel Samaha, implicato in un traffico di esplosivi. Samaha è un personaggio politico ambiguo, che ha cambiato spesso schieramento: ministro dell'informazione con Hariri ora fa parte di un raggruppamento pro-siriano. Anti-siriano e impegnato a sostegno dell'opposizione armata ad Assad era invece Wissan al Hassan. Lakhdar Brahimi, inviato dell'Onu in Siria, che ha tentato di ottenere una tregua almeno nei giorni dell'Aid (festa musulmana), proprio due giorni fa aveva avvertito che «non si ci può aspettare che la crisi resti dentro le frontiere siriane». Anche perché il governo alawita di Assad è l'anello di congiunzione tra il regime di Ahmadinejad in Iran, quello iracheno di al Maliki e l'Hezbollah libanese. Saltando Assad salta questo fragile equilibrio basato su regimi dittatoriali (al Maliki viene chiamato il nuovo dittatore iracheno). E ieri a Beirut sembra essere arrivata subito la risposta a Lakdar Brahimi. Quindi l'internazionalizzazione del conflitto è inevitabile e che questo stia già avvenendo è evidente (e non solo per la presenza di combattenti stranieri) in Libano, per gli scontri tra la Siria e la Turchia e anche per le ultime mosse di Nour al Maliki. Il nuovo "dittatore" iracheno si è recentemente recato a Mosca per discutere con Putin di forniture di armamenti, di petrolio (la Gazprom potrebbe sostituire la Exxon che ha fatto accordi con il governo kurdo mandando su tutte le furie Baghdad), ma anche di Siria. Se la Turchia è il gendarme della Nato nell'area, la Russia è ben posizionata con i suoi alleati. Anche se Siria e filosiriani e anti-siriani hanno un problema in comune: la questione kurda e i movimenti indipendentisti kurdi potrebbero approfittare della situazione. Fatto Quotidiano – 20.10.12 Erosa da Grillo, esclusa dal Pd e spaccata all’interno. Dove va l’Idv di Di Pietro Luca De Carolis L’Italia dei Valori vive giorni a dir poco complicati, stretta tra casi giudiziari, difficoltà politiche, sondaggi non proprio ottimistici e la possibile esclusione dalla coalizione di centrosinistra. Sullo sfondo le forti tensioni interne al partito. Abbiamo chiesto a due rappresentati del movimento di Antonio Di Pietro di raccontare cosa sta succedendo. Per il senatore Luigi Li Gotti, dipietrista doc (“ma credo convintamente nel partito”), sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi, Di Pietro non è all’angolo e l’Idv non è spaccata. Nelle ultimi riunioni abbiamo votato all’unanimità”. Li Gotti è ottimista: “L’alleanza con il Pd ci sarà, senza di noi non vincono”. Più critico Massimo Donadi, capogruppo alla Camera ma sempre più in rotta con il segretario. La frattura nel gruppo dirigente dell’Idv – dice – c’è stata, ed è stata anche profonda. Ma ora siamo uniti sull’adesione al centrosinistra, e Di Pietro rimane il nostro leader”. Donadi è fermo nel volere l’alleanza con il Pd. E annuncia: “Voterò Bersani alle primarie”. In diverse regioni piovono ombre su vostri dirigenti. Per voi è un momento complicato. Sì. Casi come quello di Vincenzo Maruccio (ex capogruppo in Regione Lazio, accusato di peculato, ndr) per noi sono ferite. Anche se i suoi avvocati ci hanno assicurato che proverà la sua estraneità. Ma dobbiamo rimanere diversi dagli altri partiti. Molti hanno detto: il solito problema dell’Idv, Di Pietro seleziona male i dirigenti. Al suo posto, avrei fatto molti più errori. Dovremo ripartire da controlli più rigidi e da un diverso metodo di selezione. Un metodo più democratico? È chiaro che un collettivo vede meglio di una sola persona. Da qui, si passa al tema dell’Idv personalistico, dove Di Pietro decide quasi tutto… Di Pietro è un politico sopraffino, sa che il modello del partito personalistico non funziona più. Ha già annunciato che dopo le elezioni toglierà il suo nome dal simbolo. Sulla linea politica però vi siete scontrati. Lui voleva rompere con il Pd, lei no. All’interno del partito c’è stata forte discussione tra chi riteneva di rompere con il centrosinistra e chi invece voleva restare in coalizione. Ora Di Pietro, con la sottoscrizione della carta d’intenti del centrosinistra, ha chiarito il percorso. Intanto Bersani vi ha escluso. Perché? Noi, e dico tutti noi, siamo fortemente all’opposizione del governo Monti, perché ha ridato smalto all’immagine dell’Italia sulla pelle della povera gente. Quello che ci ha diviso dal Pd è l’eccesso di foga nel criticare il governo e chi lo sosteneva. Ma ora l’Idv ha offerto il ramoscello d’ulivo: credo che i democratici ci stiano ripensando. Ha avuto contatti che lo confermano? No, ma i numeri sono chiari: senza l’Idv il centrosinistra non può essere maggioranza e non può governare. L’alternativa è la conferma di Monti, per cui spingono in tanti: qualcuno anche nel Pd. Quindi è ottimista. Credo che il riavvicinamento ci sarà. L’Espresso scrive di comitati dell’Idv per Bersani, e la descrive come uno dei più favorevoli alla cosa. Favole: andrò “solo” a votare per Bersani alle primarie, e cercherò di convincere altri a farlo. Lui può essere l’unificatore del centrosinistra. Renzi? Mi pare una candidatura che rompe anziché unire. Senatore, l’Idv pare soffrire il caso Maruccio. Stiamo affrontando un momento di grande sofferenza, per episodi gravissimi. Ma ora è il tempo della reazione e dell’orgoglio . Dobbiamo ripartire, con misure ancora più severe per tutelare il nostro partito. Ma il problema della selezione dei dirigenti c’è. Premesso che la presunzione di innocenza vale per tutti, il fatto è che in pochi anni siamo passati dal 2% al 7-8%. Una crescita così rapida rende difficile controllare tutto, verificare anche a livello locale. E comunque, noi non voltiamo le spalle di fronte a casi del genere, come fanno altri partiti. Lei parla di percentuali. Gli ultimi sondaggi danno l’Idv al 6% (Ipsos), e c’è chi la dà al 4,3% (Swg). Preoccupato? No, siamo comunque sopra al 4% delle scorse politiche. La contrazione può esserci rispetto ad europee e regionali, che sono un’altra cosa. E poi la tendenza è attorno al 6%, che mi pare un dato importante. Grillo ha tolto tanti voti all’Idv: vero o falso? C’è affinità tra i nostri elettori, è vero. Lui porta avanti un discorso di protesta, noi lavoriamo di più all’alternativa, alla proposta. Intanto però Bersani vi ha escluso dall’alleanza. Di Pietro è rimasto all’angolo? No, affatto. Lui, assieme a tutta l’Idv, lavora per una coalizione di centrosinistra, quella che ha vinto le amministrative. La nostra opposizione al governo Monti, e a suoi provvedimenti votati anche dal Pd, ha creato un problema di rapporti, contingente. Ora bisogna partire dal programma: i nostri punti fermi, dalla giustizia alla solidarietà e al lavoro, non sono diversi da quelli del Pd e di Sel. Soprattutto, l’agenda Monti non compare nella carta d’intenti. Nel vostro gruppo dirigente sono volati stracci. Ci siamo solo confrontati. E nelle ultime riunioni tutti i documenti sono stati votati all’unanimità. Lavoriamo uniti a un’alternativa di governo. Crede che la coalizione si ricompatterà? Senza l’Idv il centrosinistra non può arrivare al 40% e al premio di maggioranza, quindi non può governare. Non vedo come possa fare a meno di noi. Un consiglio che darebbe a Di Pietro? Lui è molto esplicito nei giudizi, non fa calcoli. Può essere un difetto, ma in fondo è anche un pregio. Lavoro, manifestazione Cgil a Roma. Bonanni: “Dove? Non ho visto nessuno” La Cgil ritorna a piazza San Giovanni per una manifestazione dedicata al lavoro, dopo due anni dall’ultima iniziativa nel luogo simbolo anche della storia sindacale. Nessun corteo, ma una piazza trasformata in un “agorà del lavoro” considerato l’unica chiave per uscire dalla crisi. Trenta stand, ventuno regionali e gli altri di categoria, riempiono la piazza, dominata dal palco su cui si alterneranno musica (Casa del Vento, Tosca, Eugenio Finardi) e storie e testimonianze di lavoratori, concluderà la manifestazione l’intervento, previsto per le 16-16,30, del segretario generale Susanna Camusso. Si tratta quindi di una no stop per il lavoro, partita adesso e che proseguirà fino alle 17,30. L’obiettivo della Cgil “è ricordare al Governo di mettere il ‘lavoro prima di tutto’”, lo slogan dell’iniziativa. La manifestazione è così anche l’occasione per dare voce e riunire le centinaia di vertenze. Bonanni: “Manifestazione? Non ho visto nessuno”. Landini: “Chi si è accorto nel Paese che c’è Bonanni?”. Ma è l’occasione per riaprire una polemica tra la Cgil e il segretario della Cisl Raffaele Bonanni. Quest’ultimo, infatti, ha risposto ai cronisti: “Manifestazione? Non ho visto nessuno, non me ne sono accorto”. Parole che hanno irritato i vertici della Cgil e a rispondere è stato il segretario della Fiom Maurizio Landini: “E chi è Bonanni, chi si è accorto che c’è lui in questo Paese?”. ”Al di là delle battute – ha aggiunto Landini – se ci sono salari bassi e crescente precarietà penso che un sindacalista debba preoccuparsi e pensare ad azioni da mettere in campo”. Bonanni alla fine ha cercato di aggiustare il tiro: “Rispetto chiunque manifesti le proprie opinioni. Così come chiedo rispetto per le mie manifestazioni rispetto quelle degli altri”. E precisa: “Non c’era alcuna venatura polemica nelle mie parole. Ho solo detto di non avere incrociato per le strade di Roma nessuna manifestazione nel recarmi ad un’altra iniziativa dove peraltro era previsto l’intervento del segretario della Cgil Camusso, punto. Ognuno di protestare in questo paese. Poi se c’è qualcuno che cerca pubblicità o vuole rinfocolare polemiche gratuite ha sbagliato persona”. Passera: “Pronti a modificare la legge sulla stabilità”. Stesso atteggiamento è quello del governo: “Rispetto tutte le opinioni – dice il ministro del Lavoro Elsa Fornero - Ho rispetto per la manifestazione dei lavoratori. Lavoratori e sindacati, tutti coloro che vogliono parlare sanno che non mi sono mai tirata indietro. Il lavoro è la mia prima preoccupazione”. Tutto questo nel giorno in cui anche il ministro dello Sviluppo Corrado Passera, dopo le aperture del presidente Monti e del ministro dell’Economia Vittorio Grilli, fa capire che potrebbero esserci possibilità di modificare il testo del disegno di legge sulla stabilità. “Se il Parlamento vorrà modificare” il ddl, spiega Passera, “a saldi invariati siamo disponibili a modifiche, come ha già detto Monti”. D’altra parte la necessità di modifica la legge che il governo ha presentato e che dovrà essere approvato dal Parlamento è stata auspicata da molte parti, da sinistra a destra. In piazza chimici, artigiani, edili, metalmeccanici. Dai chimici agli artigiani, dai lavoratori nel campo dell’edilizia ai metalmeccanici fino ad arrivare ai professionisti. A piazza San Giovanni ci sono migliaia di lavoratori. In mezzo alla piazza la Flc Cgil di Potenza ha tra l’altro costruito una “ruota della sfiga” con le immagini del presidente del Consiglio Mario Monti, del ministro della Pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi, dell’ad della Fiat, Sergio Marchionne, ma anche dei leader di Cisl, Raffaele Bonanni, e di Uil, Luigi Angeletti, raffigurati come il gatto e la volpe. Così Camusso esortata dai lavoratori ha anche lei fatto girare la ruota, che si è fermata su Patroni Griffi, rappresentato come “tagliatore di teste”. Nella piazza, tra le decine di palloncini rossi e bandiere del sindacato, campeggia un palco sul quale si alternano, musicisti, attori, artisti e lavoratori. Tra i numerosi stand, divisi per categorie del sindacato e per regioni, uno è stato adibito a “panetteria”, dove su un vero e proprio forno a legna si legge “Rivendichiamo lavoro e salario… per il momento offriamo il pane”. Tanti i gadget e le magliette con slogan come “giovani non più disposti a tutto”. Polemica all’interno della protesta: “Dov’è la protesta? Sembra una sagra”. Non tutto sembra però soddisfare i lavoratori presenti alla manifestazione: “Ma dov’è la protesta contro il governo? Qui sembra una festa di paese, si mangia e basta”. Serpeggia un po’ di delusione a piazza San Giovanni a Roma tra molti operai e lavoratori venuti oggi per “rivendicare lavoro e salario”. Disoccupati, cassintegrati o in mobilità non ci stanno a ridurre “l’indignazione ad una sagra di paese dove gli stand delle categorie sono ridotti a punti ristoro con i prodotti regionali”. In effetti le file agli stand che danno vino e panini sono lunghe, complice anche l’ora di pranzo. In pochi azzardano però una lettura diversa. “Solo un anno fa questa piazza era teatro di scontri tra i black bloc e le forze dell’ordine – spiegano alcuni professionisti arrivati da Bari – Oggi qui c’è una festa assolutamente pacifica che allo stesso modo dice di ‘no’ alle manovre del governo contro il lavoro”. Bersani: “La Cgil ha buone ragioni per stare in piazza”. L’iniziativa del sindacato, tuttavia, viene sposata non solo dalla “sinistra sinistra”, ma anche dal segretario del Pd Pierluigi Bersani: “La Cgil ha buone ragioni per scendere in piazza. Quando sento obiezioni rispetto al fatto che si vada in piazza non sono d’accordo perché penso che anche la sofferenza e il disagio debbono essere raffigurati e avere momenti di interpretazione”. Bersani ha sottolineato di non essere mai preoccupato “quando c’è una manifestazione ordinata e dice le cose che la gente vuole dire”. “Non è un caso se oggi e domani ho scelto per la campagna per le primarie di essere in Sardegna – ha detto il leader di Sinistra Ecologia e Libertà Nichi Vendola – E’ uno dei simboli drammatici in cui versa il mondo del lavoro nel nostro Paese. E è anche il mio modo simbolico per aderire e per sostenere le mille ragioni che hanno portato oggi la Cgil in piazza a Roma”. Sostegno alla manifestazione anche dal leader dell’Italia dei Valori Antonio Di Pietro: “C’è bisogno di una politica che difenda le fasce deboli. Idv contesta questa ingiusta redistribuzione della ricchezza che sta venendo avanti con il governo Monti. Contestiamo anche il fatto che Monti abbia creato una nuova e più grande divaricazione sociale”. ”Il governo, privo di una vera politica industriale, ha progressivamente tolto diritti ai lavoratori – dichiara il segretario dei Comunisti Italiani Oliviero Diliberto – scaricando su di loro i costi della crisi in modo inaccettabile, aggravando il problema. Generazioni di giovani non possono e non devono rassegnarsi alla precarietà: lavoro e saperi devono essere i due pilastri dell’Italia di domani”. Ddl anticorruzione, pioggia di stroncature. Csm all’attacco, l’Anm: “Deludente” Mario Portanova Due anni e mezzo di discussione, un cammino parlamentare non ancora concluso, una contrattazione estenuante tra i “tecnici” del governo Monti e i colonnelli del Pdl di Silvio Berlusconi. Ora, sul disegno di legge anticorruzione approvato ieri in Senato (con uno dei voti di fiducia più “bassi” mai registrati da questo esecutivo) piovono critiche pesantissime, soprattutto da chi è impegnato sul fronte della lotta al sistema delle tangenti. “L’elenco di quello che manca è infinito”, dice a Il Fatto Quotidiano Piercamillo Davigo, consigliere di Cassazione e membro negli anni Novanta del pool milanese di Mani pulite. Davigo mette sul tavolo i nodi più contestati, dalla mancata “ripenalizzazione” del falso in bilancio alla riduzione di fatto delle pene per la concussione. E’ la cosiddetta norma “salva Ruby“, ma in realtà anche con la nuova formulazione il processo in corso a Milano contro Silvio Berlusconi vedrebbe come limite temporale massimo il lontano 2020. Dice la stessa cosa, in termini più drastici, Antonio Di Pietro: il ddl “favorisce i corrotti”, oltre a introdurre una “finta” incandidabilità dei condannati. Perché chi si è visto infliggere una pena inferiore a tre anni potrà ripresentarsi agli elettori, a meno che il reato contestato non sia di mafia o contro la pubblica amministrazione. E manca il reato di autoriciclaggio, cioè la ripulitura in proprio dei profitti illeciti, una delle richieste più pressanti dei magistrati antimafia: oggi, infatti, sono punibili solo i riciclatori di denari altrui. E poi c’è il fronte della magistratura. “Chi credesse che questa legge segni una svolta epocale nella lotta alla corruzione resterebbe deluso”, attacca Rodolfo Sabelli, segretario dell’Associazione nazionale magistrati. “L’intervento non è stato cosi determinato come ci si aspettava, può essere considerato un primo passo”. Perché intanto la corruzione in Italia “è diventata sistemica e pervasiva, e penetra la pubblica amministrazione in modo diffuso. Questo – conclude il segretario dell’Anm- dovrebbe determinare una reazione forte”. Intanto il Csm ha pronta una bozza di parere che è una netta stroncatura del provvedimento, anticipa Repubblica. Invece di reprimere più duramente una piaga che caccia l’Italia nelle peggiori posizioni delle classifiche internazionali sul tema, il disegno di legge “rischia di far lavorare a vuoto il sistema”. Il nodo è sempre quello, la prescrizione. L’effetto combinato di pene lievi e processi lunghi, secondo l’organo di autogoverno di giudici, continuerà a produrre il doppio danno di un numero basso di corrotti puniti e di spese alte per dibattimenti inutili. Il Corriere della Sera fa il punto sui processi in corso che rischiano di saltare per la nuova separazione tra concussione per costrizione (il raro caso in cui il pubblico ufficiale obblighi un cittadino a pagare una tangente) e concussione per induzione (il frequente caso in cui la tangente sia semplicemente richiesta). L’abbassamento delle pene per questa seconda ipotesi (da 4-12 anni a 3-8) anni) determina una riduzione dei tempi di prescrizione. Così, riporta il Corriere, solo a Milano diventerebbero a rischio 66 processi, un dato indicativo del pesante impatto che la nuova norma avrebbe a livello nazionale. “Sulla concussione c’è un’amnistia mascherata“, arriva a dire Alberto Vannucci, docente di scienze politiche e direttore del Master su mafia e corruzione dell’Università di Pisa. “Il reato è stato scientificamente smantellato, perché la fattispecie più diffusa è sicuramente quella per induzione. Con la nuova legge rubare un’autoradio sarà più rischioso che chiedere una tangente. Per non parlare”, continua, “dei nuovi reati di corruzione tra privati e traffico d’influenze: in base alla pena si prescrivono in sei anni, che è giusto la durata media di un processo in Italia”. Sempre lì si torna, sulla prescrizione, “una patologia italiana che non è stata toccata”. Una delle questioni sollevate è che nel nostro ordinamento il tempo che cancella ogni responsabilità comincia a scorrere dalla data in cui il reato è stato commesso, e non da quella in cui è stato scoperto. E raramente i reati contro la pubblica amministrazione sono scoperti in flagrante, a meno che qualcuno non avverta i carabinieri prima della consegna della mazzetta. Un’altra autorevole contestazione arriva dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che pur definendo il testo “un buon successo per il governo dei tecnici”, sottolinea che “forse bisognava reinserire il reato di falso in bilancio e magari fare un bel reato di falsa fatturazione”, ha affermato intervenendo all’inaugurazione del Corso di alta formazione per amministratori di beni confiscati dell’Università Cattolica di Milano. “Questa legge – ha continuato – è dovuta passare dalla quadratura del cerchio a cui il governo ha dovuto sottoporla per trovare un testo equilibrato che potesse essere approvato dalle diverse forze parlamentari”. A proposito dell’approvazione da parte delle “diverse forze parlamentari”, ai massimi livelli politici nessuno accusa apertamente il Pdl, ma la cronaca di quest’ultimo anno dimostra la sua tenace resistenza a ogni inasprimento di pene e reati per i protagonisti di cricche e “sistemi” vari. Per quieto vivere, lo stesso presidente del consiglio Mario Monti si è limitato a dire che “il governo avrebbe voluto fare di più” e a parlare di generiche “resistenze dei partiti” finalmente superate, su un provvedimento per il quale “inizialmente non c’era grande entusiasmo”. Così a difendere un testo che probabilmente lei stessa avrebbe voluto diverso è rimasto soprattutto il ministro della Giustizia Paola Severino. ”Un buon disegno di legge che si possa poi completare nel tempo è un segno comunque importante”, ha affermato a Otto e mezzo su La7. Sul falso in bilancio, “uno dei reati spia della corruzione”, esistono comunque “disegni di legge anche in fase avanzata” . Anche sulla prescrizione “si potrà tornare con provvedimenti separati”. A patto, naturalmente, di superare le “resistenze dei partiti”. La Stampa – 20.10.12 Il veliero Estelle bloccato da Israele Il veliero Estelle con a bordo attivisti filo-palestinesi diretti a Gaza è stato ’’circondato da unità della Marina israeliana che lo hanno abbordato’’. E’ quanto si legge in un comunicato di Freedom Flotilla Italia. Alle 10,20, spiegano gli attivisti, il veliero partito dalla Svezia è stato circondato e abbordato da unità israeliane 17 miglia nautiche a nord della località egiziana di Arish.’. ’Denunciamo l’ennesimo crimine di guerra del governo israeliano nei confronti di popolazione civile prosegue la nota -. A nome delle migliaia di persone a bordo di Estelle, chiediamo la fine dell’assedio illegale di Gaza subito e per sempre e il rilascio immediato di tutti i pacifisti prelevati da Estelle con la forza e attualmente ostaggi delle autorità israeliane. Gli attivisti a bordo di Estelle sono ora impossibilitati a continuare la loro missione, in quanto prelevati contro la loro volontà da Estelle e probabilmente condotti in centri di detenzione in Israele’’. Il portavoce dell’esercito israeliano ha confermato l’avvenuto abbordaggio della nave Estelle. «Operazione avvenuta in accordo con le leggi internazionali e con le direttive del governo israeliano dopo aver effettuato ogni tentativo di prevenire la nave dal raggiungere la Striscia di Gaza», recita una nota. «L’abbordaggio - ha spiegato il portavoce militare - è stato effettuato solo dopo numerosi richiami ai passeggeri a bordo; vista la loro volontà di non cooperare e dopo aver ignorato appelli a cambiare rotta, è stata presa la decisione di abbordare la nave e condurla nel porto di Ashdod». «I marinai israeliani hanno operato come stabilito e hanno preso ogni precauzione - ha proseguito il portavoce - per garantire la sicurezza dei passeggeri. Dopo l’abbordaggio da parte dei soldati, che non hanno avuto bisogno di usare la forza, i passeggeri sono stati accuditi e a loro sono stati offerti cibi e bevande». «Dopo l’arrivo nel porto di Ashdod, i passeggeri saranno trasferiti alla custodia della polizia israeliana e delle autorità di immigrazione del ministro dell’interno». «Su istruzioni del ministro Giulio Terzi, l’ambasciata italiana a Tel Aviv si è immediatamente attivata e, in raccordo con la Farnesina, segue costantemente l’evolversi della situazione per assicurare ogni assistenza affinché venga garantita l’incolumità del nostro connazionale che risulta imbarcato sulla Flotilla». Lo afferma una nota della Farnesina dopo l’abbordaggio della Estelle da parte della Marina israeliana. Russia, esce il “manuale per immigrati”. Gli stranieri raffigurati come utensili Anna Zafesova Una scopetta, un rullo per verniciare, un pennello e una cazzuola, sorridenti al loro arrivo in Russia in attesa di cominciare una nuova vita. Questi quattro personaggi del “Manuale dell’immigrato per lavoro” stanno diventando in Russia un caso politico. Pubblicato dal comune di Pietroburgo, il manualetto - stampato anche in altre lingue, tagiko e kirghizo tra gli altri, per essere compreso anche dai potenziali immigrati - vorrebbe facilitare l’inserimento in Russia ai nuovi arrivati. Una serie di fumetti nella stilistica dei cartoni animati sovietici mostra i quattro attrezzo sbarcare all’aeroporto, registrarsi alla polizia, fare la visita medica e il test per l’Aids (“ricordate, a casa aspettano che tornate in salute”, ammonisce il dottore). Alla prevenzione dell’Aids (incluso il consiglio di “restare fedeli” accompagnato dalla vignetta di scopetta e rullo che si baciano) è dedicato un buon terzo del libretto, che ricorda agli stranieri che in caso risultino positivi al test devono lasciare immediatamente la Russia. Sbrigate le pratiche poliziesche, si tratta di imparare come comportarsi. Il manualetto insegna a scopetta e soci l’educazione, pubblicando una serie di frasi di prima necessità - “Mi scusi”, “Per cortesia”, “Potrebbe gentilmente aiutarmi” - con le quali già un autoctono spesso viene respinto con perdite se si rivolge al prossimo. Figuriamoci un immigrato con la pelle di un colore diverso da quello abituale sulle rive del Golfo Finnico. Dove, ricordano gli autori del libretto, vigono ancora le regole della “capitale culturale della Russia”: “A Pietroburgo si usa essere puliti e ordinati nel vestire, educati, e cedere il posto nei mezzi alle donne, agli anziani e ai diversamente abili”. Agli stranieri poi viene consigliato di visitare l’Ermitage, il museo della Kunstkamera e una serie di altri enti culturali. Poi, potranno tornare a lavorare con la scopetta e il pennello, ma senza disturbare troppo: tra le regole consigliate c’è quella di non fare rumore, non sputare e gettare rifiuti, non parlare a voce troppo alta. Fin qui regole di buona educazione, uguali per tutti, immigrati e non. Ma ci sono anche i consigli per “integrarsi” meglio: “Non uscite di casa con la vestaglia o la tuta sportiva, soprattutto abbinata a scarpe classiche”, “Non stare per strada accovacciati sui talloni”, «Non cucinare sui balconi e per strada”, e “Non indossare sempre abiti nazionali, in quanto attirano molta attenzione, e non sempre è utile”. Non si capisce se questo ultimo consiglio voleva essere premurosamente destinato a proteggere gli immigrati asiatici da attacchi razzisti per i quali la città è tristemente famosa (decine negli ultimi anni, incluso l’omicidio di una bambina tagika da parte di una banda di nazionalisti). Ma i solitamente silenziosi tagiki si sono infuriati. Karomat Sharipov, presidente dell’associazione degli immigrati tagiki, vuole andare in tribunale: “Ci hanno paragonati ad attrezzi da lavoro, e questo nonostante la metà dei nostri siano laureati”. Forse è per questo che la scopetta nel manualetto indossa un paio di occhialini. L’editore del manualetto, commissionato dal comune di Pietroburgo (città già al centro di polemiche per numerose iniziative controverse, come la legge contro “la propaganda dell’omosessualità” che di fatto bandisce ogni manifestazione di amore “irregolare”), non ci vede nulla di male: “Tra i vari personaggi proposti dal disegnatore c’erano la chiave inglese, il cacciavite, il martello e tanti altri, ma abbiamo scelto questi quattro”, dice l’autore dei testi Andrey Khmyrov, apparentemente senza rendersi conto che tutti i personaggi russi dei disegni - il medico, il poliziotto, l’insegnante - hanno invece una forma perfettamente umana. Che numerosi russi abbiano sempre nutrito un profondo disprezzo verso i “neri”, come chiamano i non slavi, considerato in particolare gli asiatici alla stregua di ritardati mentali, non era una novità già all’epoca dell’Urss. A questi pregiudizi si sono poi aggiunte le fobie moderne, dall’Aids al fondamentalismo islamico. Ma stavolta gli immigrati, che arrivano in Russia dai loro Paesi spesso dilaniati da guerre e sprofondati nella miseria, e che svolgono i lavori più umili e pesanti, spesso senza venire regolarizzati e costretti a dormire nei cantieri dove lavorano , si sono ribellati. Anche la comunità uzbeka prepara una denuncia, mentre Sharipov vuole agire anche contro i governi dei Paesi di provenienza degli stranieri: “Se accettano questa umiliazione allora farebbero prima a cancellare dai nostri passaporti lo stemma nazionale e mettere il simbolo di quello che ci considerano, scopette e cazzuole”. L’indignazione è stata tale che la procura di Pietroburgo sta svolgendo una verifica per capire se nel “Manuale” ci sono gli estremi di istigazione all’odio e discriminazione razziale. Nel finale del manualetto, scopetta, pennello e compagni lasciano la Russia, ringraziati dai loro clienti ai quali “hanno fatto dei gran lavori in casa”, come a dire che l’integrazione e la visita ai musei comunque non significano che gli asiatici - ex cittadini dello stesso Paese nell’Urss - possono restare, una volta finito il loro compito di “attrezzi”. Donne uccise un dramma della modernità - Mariella Gramaglia Carmela Petrucci, liceale, diciassette anni, palermitana, si frappone fra la sorella e il suo omicida di 22 anni. Cerca di salvarla dal furore dell’ex fidanzato respinto. Le hanno trovate una accanto all’altra, le ragazze, riverse nell’androne di casa al ritorno da scuola. E’ la centounesima vittima di femminicidio nell’Italia del 2012. Femminicidio, parola una volta lontana, usata per le feroci esecuzioni di donne da parte dei trafficanti di droga messicani di Ciudad Juarez, è oggi entrata nel nostro lessico di europei sempre più incerti di noi stessi e della forza dei nostri valori. Non è accaduto per bizzarria ed esotismo, ma per dolore, per sdegno, per sottolineare che viene un momento in cui ciò che non si voleva guardare diventa un’ossessione della coscienza, che ciò che ad alcuni pareva sopportabile – uno dei tanti dolorosi dettagli della cronaca – prende il corpo di un’emergenza democratica, di una ferita al patto sociale che ci unisce. Infatti, molto spesso, non è di arretratezza che si tratta. La storia delle due sorelle palermitane somiglia da vicino, non solo geograficamente, a quella della catanese Stefania Noce morta il 27 dicembre 2011. Ventiquattro anni, brillante studentessa di Psicologia, femminista militante, battagliera nel movimento degli studenti. Il ragazzo che la uccise, dopo un amore finito, non seppe dire altro che una frase pesante come un macigno: «L’amavo più della sua vita». E’ la contiguità, l’ossessione del possesso, la perversione blasfema dell’amore a fare di un uomo un assassino. Raramente si uccide una sconosciuta. Su una donna un uomo, un particolare uomo, proietta ciò che ha deciso di non essere: è da lei che pretende e si aspetta l’assoluta dedizione. Che può andare oltre la vita dell’altra, come racconta il dialogo teatrale di Cristina Comencini, che prende le mosse proprio dal grande vuoto che buca l’anima di molti ragazzi e che a Torino di recente, alle Officine Grandi Riparazioni, ha commosso tanti spettatori. I dati, le statistiche sono arnesi difficili da maneggiare. Tuttavia non credo ci sia un caso italiano, una ferita che riguarda solo noi, o principalmente noi. E’ un dramma della modernità, però, non dell’arretratezza, o meglio non solo dell’arretratezza. Su questo non possiamo darci consolazioni facili. Una zona buia dell’anima convive con l’epoca delle Cancelliere e delle Segretarie di Stato donna: sembra ignorarle e affondare nella preistoria. Nel 2009 in Finlandia, Danimarca e Norvegia ci sono state in media sette donne uccise ogni milione di cittadine. Un po’ di più che in Italia: da noi 6,57. Forse alcolismo e solitudine sono più potenti dell’emancipazione. Negli anni fulgenti del primo Zapatero in Spagna (2004-2005) ci fu, invece, un calo significativo della violenza contro le donne: lui ci aveva creduto, aveva speso denari ed energie per la prevenzione, l’educazione, la promozione brillante di quel tipo di autorevolezza femminile che crede nel sostegno alle altre e che sola può far da argine al peggio. Dunque la politica non è impotente. Se vuole. Le volontarie del «Telefono rosa», esaminando un campione di mille e cinquecento telefonate, hanno scoperto che il novanta per cento delle donne che le chiamano perché già colpite, picchiate, a rischio di vita, non denunciano il loro persecutore. I tempi del procedimento sono troppo lunghi, durano in media cinque anni, e nel frattempo la protezione per loro e per i loro bambini non è tale da rassicurarle. Qualcosa potrebbe essere cambiato. I centri di sostegno contro la violenza potrebbero essere rafforzati e infittiti. E’ quello su cui preme anche la comunità internazionale, con la Convenzione di Istanbul che impone agli Stati più protezione per le vittime, sanzioni penali per i matrimoni forzati, robuste strategie di prevenzione. La nostra ministra delle Pari opportunità Elsa Fornero l’ha firmata il 27 settembre scorso. Peccato che nella seduta del 20 settembre, in cui il Senato avrebbe dovuto dare solennità al suo mandato, la discussione fu sospesa alla maniera di una riunione di condominio: il vicepresidente Domenico Nania era sparito, Rosi Mauro non poteva perdere un aereo e il presidente Schifani tardava a farsi vivo in aula. Non era mai accaduto nella storia della Repubblica. Brutto segno di un brutto Parlamento. Fornero è decisa a tornare alla carica il venticinque novembre prossimo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Intende chiedere la ratifica della Convenzione e presentare il suo programma in materia di violenza sulle donne. Non disperiamo. La politica qualche volta può anche essere una cosa seria. l’Unità – 20.10.12 L’Europa ha fatto un passo indietro – Paolo Soldini L’Unione bancaria? Calma, signori. Mario Monti sembrava contento, ieri, mentre raccontava ai giornalisti gli esiti del Consiglio europeo e intanto, secondo l’eterno copione dei vertici dell’Unione, tutti – più o meno – si dicevano soddisfatti. Ma non ce n’è motivo. A leggere i testi nero su bianco, ci si accorge che su quello che dovrebbe essere il primo, essenziale passo verso il riequilibrio dei rapporti tra la politica e il mondo finanziario, l’Unione bancaria appunto, s’è fatto un bel passo indietro. A fine giugno s’era deciso che la supervisione unica da parte della Bce di tutti gli istituti finanziari europei sarebbe partita all’inizio del 2013. Le cose stavano ancora così nella bozza con cui i 27 leader della Ue giovedì sera sono entrati al Justus Lipsius di Bruxelles, ma quando ne sono usciti ieri mattina s’è scoperto che la maratona finita alle 5 di notte aveva partorito meno che il classico topolino. Entro il 1° gennaio dell’anno prossimo dovranno essere messe in opera le strutture e le procedure dell’Ub – recita il comunicato finale – ma poi servirà tutto l’anno per farle davvero funzionare. Fino all’inizio del 2014 sarà tutta teoria. Sistemati gli entusiasmi, anche italiani, della fine di giugno. Perché il passo indietro? Nel settembre o nell’ottobre del 2013 si voterà per il Bundestag tedesco e la cancelliera Merkel non ha la minima intenzione di arrivare alle elezioni con impegni che potrebbero piacere molto poco ai suoi connazionali. Un po’ perché il riassetto dei rapporti con le banche, che significa inevitabilmente capitalizzazioni da parte dei fondi di stabilità e quindi soldi da sborsare, rischia di essere molto impopolare presso l’opinione pubblica tedesca, come già si è visto dopo la decisione (per ora tutta teorica) di mettere 100 miliardi a disposizione delle disastratissime banche spagnole. Un po’ perché il governo di Berlino ha il suo bel daffare anche per superare il boicottaggio delle Casse di Risparmio e delle banche centrali dei Länder, le quali temono di vedersi strappare dalla centralizzazione a Francoforte la rete intessuta con i rapporti e gli interessi locali: il principio del «qui decidiamo noi». Ancora una volta, insomma, gli interessi elettorali del centro-destra di Berlino danno il la alla strategia europea contro la crisi. Francois Hollande, arrivando a Bruxelles, lo aveva detto fuori dai denti, ma poi l’ipocrisia della diplomazia ha prevalso. Tutti lo sanno, nessuno lo dice. Ma siamo poi sicuri che l’Unione bancaria, se e quando si farà sul serio, funzionerà davvero? Certo, l’europeizzazione della vigilanza è un passo avanti rispetto al caos attuale che significa, quasi sempre, impossibilità d’ogni controllo serio. Ma è soltanto una delle tante misure che dovrebbero essere adottate per arrivare a una vera ed efficace regolamentazione dei mercati finanziari. Nonostante il segnale positivo dato recentemente con la decisione di 11 paesi di procedere con la cooperazione rafforzata per applicare la tassa sulle transazioni finanziarie, l’Unione europea pare ancora molto, molto restìa a percorrere seriamente quella strada. L’elenco del «non fatto» da parte dei governi e delle istituzioni europee in materia di misure anti-speculazione comincia con la commistione tra banche d’affari e banche commerciali, alla quale (nonostante le battaglie di alcuni partiti di sinistra, a cominciare dal Labour e dalla Spd) pare che nessuno voglia porre rimedio e continua con una lista che riempirebbe un elenco del telefono: dalle vendite allo scoperto, oggetto di incredibili tira-e-molla delle autorità di Borsa nazionali, ai derivati usati come vere e proprie assicurazioni per le speculazioni sui titoli di stato agli ostacoli ai controlli sui consigli di amministrazione anche quando viene erogato denaro pubblico alla scandalosa incapacità di limitare, almeno, retribuzioni d’oro e dividendi. Si sa che questa inerzia è il frutto di anni di monetarismo e neoliberismo, di una egemonia culturale instaurata da quelli che Jacques Delors chiamava negli anni ‘80 «gli ayatollah neoliberisti» e di cui l’Europa, e purtroppo anche buone quote della sinistra, continua ancor oggi a subire l’influenza. Ma i disastri provocati dal laissez-faire verso la finanza e le rigide austerità di bilancio imposte agli stati diventano sempre più evidenti e stanno accumulando contraddizioni esplosive. La strategia anti-crisi attuale si scontra contro il muro delle recessioni che travolgono un’economia dopo l’altra. Bisognerà aspettare che anche la Germania cominci a soffrirne (e le esportazioni ne risentono già) perché anche il governo di Berlino cambi atteggiamento? In difesa de l’Unità - Claudio Sardo Ora Matteo Renzi vuole chiudere l’unità perché l’Unità dà conto della battaglia delle primarie senza edulcorare i termini della competizione politica nel Pd. Non gli fa onore, perché un leader democratico che si candida a guidare il Paese dovrebbe sempre avere una cura speciale della libertà di stampa e coltivare il pluralismo come una ricchezza, anche quando esso risulta scomodo. Il casus belli è un articolo di Michele Prospero in cui si definisce «fascistoide» la parola rottamazione. L’Unità, i lettori lo sanno bene, non ha mai sostenuto che Renzi è un «fascistoide». L’intervento di Prospero contestava la cultura della rottamazione, attribuendo ad essa una matrice violenta e autoritaria. Ma quello scritto era opposto nello stesso numero del giornale ad uno di Roberto Weber, che sosteneva invece la necessità vitale di «facce nuove», pena l’esaurimento del progetto del Pd. Cosa avremmo dovuto fare? Cestinare gli articoli e assicurare i lettori che si sta svolgendo nel Pd un «dibattito franco e vivace»? Ogni giorno su l’Unità parlano i sostenitori di Renzi e si confrontano con quelli degli altri candidati alle primarie. Ieri abbiamo pubblicato due interviste, a Giorgio Gori e a Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia, uno dei più autorevoli dirigenti Pd schierati a fianco del sindaco di Firenze. E in passato abbiamo dato grande rilievo, come è ovvio per un giornale, alle critiche e agli attacchi sferrati dal fronte renziano contro Bersani e la sua segreteria. Ricordo che non sono neppure mancati i paragoni con «Ceausescu» oppure la previsione di un esito «totalitario» del Pd se non fossero state accolte determinate richieste sulle regole delle primarie. L’Unità avrebbe dovuto censurare anche questo? Avrebbe dovuto censurare lo scontro sulla ricandidatura di D’Alema, compreso il dissidio tra D’Alema e Bersani? E dovrebbe ora censurare la polemica sulla cena per la raccolta fondi di Renzi, organizzata da un finanziere che ha costituito la propria società nelle isole Cayman? Ieri Renzi ha reso omaggio alla tomba di don Giovanni Minzoni, martire di un fascismo che stava sradicando con la violenza la fragile democrazia italiana. Eravamo con lui, siamo con lui. Se il nostro scontro è servito a regalare al sindaco di Firenze e a tutti noi quella pausa di riflessione sulla tomba del parroco di Argenta, cattolico interventista, appassionato, democratico, penso che sia un bel segno. Don Minzoni è stato ucciso dall’ignoranza e dalla barbarie di un gerarca, o di un comitato fascista, che voleva negargli la libertà di costituire un gruppo scout, di educare i giovani secondo valori diversi da quelli del regime nascente, di dare forma insomma a quel pluralismo sociale e delle idee che è incompatibile sia con i regimi autoritari che con il servilismo alle ideologie dominanti. Ma tornando alla disputa di oggi, Renzi dice che non ha senso destinare i fondi pubblici dell’editoria a un giornale come il nostro, che poi li usa «per insultare qualcuno che non la pensa come te». Ecco, viene da dubitare che a questo punto il sindaco di Firenze sia stato davvero cosciente dell’enormità di questa affermazione. La questione non è l’insulto (che a mio giudizio non c’è stato ma che assumo come la percezione di un’offesa e come tale mi dispiace e mi ferisce). La questione è condizionare un fondo pubblico per l’editoria a un determinato comportamento o gradimento politico. Se fosse così saremmo pericolosamente fuori da un canone accettabile di libertà. Sono parole gravi, che l’ira può spiegare ma non giustificare. Tanti avversari de l’Unità hanno nel tempo sperato che l’Unità chiudesse. Oggi le distorsioni del mercato editoriale e la crisi generale costituiscono purtroppo una gravissima minaccia per i giornali di idee e per i quotidiani di medie dimensioni a diffusione nazionale. Il fondo dell’editoria non è una mancia. Deve servire per favorire un risanamento aziendale e un adeguamento strutturale alle nuove condizioni del mercato, senza però disperdere quel patrimonio di pluralismo e di libertà che esprimono i giornali di chi «non la pensa come te». Lo stesso fondo, ahinoi, è minacciato. Dalla contrazione del bilancio pubblico e dalla pigrizia politica e intellettuale di certi benpensanti ai quali non dispiacerebbe un taglio alla libertà di stampa. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze a chi vuole ridurre gli spazi di libertà. E speriamo, anzi siamo convinti, che Renzi sarà dalla nostra parte sia che vinca le primarie del centrosinistra, sia che le perda. Quanto all’invettiva di ieri contro l’Unità, forse è giusto considerarla come la rabbia di un momento. Chi si ferma in silenzio e in preghiera davanti alla tomba di don Minzoni non può che combattere per avere più libertà, non può avere paura delle differenze e del valore democratico del confronto e del dissenso. E la chiamano democrazia… - Moni Ovadia Nell’agosto del 1968 gli eserciti del Patto di Varsavia, invasero la Cecoslovacchia, schiacciando il sogno del socialismo dal volto umano promosso dal segretario del partito comunista di Alexander Dubcek e misero fine alla primavera di Praga. Lo studente Jan Palach, per protestare contro l’invasione e la brutale repressione della libertà del suo popolo, si cosparse di benzina e si dette fuoco in piazza San Venceslao sulla gradinata dell’Università della Capitale. Quel gesto fu un lucido atto consapevole contro la tirannia, ispirato, come lo stesso Palach ebbe a dire nei tre giorni della sua agonia prima di spegnersi, al martirio dei monaci buddisti contro il crudele regime sud Vietnamita del dittatore Diem. Jan Palach fu un eroe ma, come sempre accade, sul suo corpo martoriato si esercitò, per scopi strumentali di propaganda, tutta la retorica occidentale della sedicente democrazia. Giovedì un lavoratore rumeno, rimasto senza lavoro e senza sostentamento per la propria famiglia si è dato fuoco davanti al Quirinale riducendosi in fin di vita. Cosa diremo di lui? Che è uno squilibrato? Che era esaurito? Non è anche lui a suo modo un martire, vittima di un regime che continuiamo ipocritamente a chiamare democrazia? Possiamo chiamare democrazia un sistema politico che si accanisce contro i più deboli e gli ultimi, che porta alla disperazione i suoi cittadini lavoratori, i suoi studenti, che precarizza i giovani che entrano nel tempo produttivo e rende obsoleti donne e uomini nel pieno della loro maturità, mentre consente sconci privilegi di casta e di censo? Possiamo parlare di libertà in un Paese che fa scempio sistematico della sua legge fondativa solo perché ciclicamente si ripete, sempre più spento e svuotato di senso, un rito elettorale che manda a governare il Paese una sorta di mandarinato, di potere sottratto al controllo dei cittadini in un quadro di leggi artatamente costruite perché i politici capaci e galantuomini siano costretti all’impotenza? Dove sono finiti i valori costitutivi dell’Italia repubblicana? Li ricordo. Art.2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art.4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Se questi diritti vengono calpestati non c’è vera democrazia. Repubblica – 20.10.12 Rise del terremoto all'Aquila, ora racconta: "Io, dissanguato dalle tangenti per il Palazzo" – Corrado Zunino ROMA - Dall'ex rudere recuperato, i fari interrati che segnano il percorso fra gli ulivi, la piscina di fronte alla camera da letto, si vede l'Isola di Giannutri. A nord la Costa Concordia spanciata di fronte al porto del Giglio. Sul terrapieno in ghiaia, seicento metri sopra il mare, ci sono i resti dell'elicottero con cui Francesco Maria De Vito Piscicelli, il padrone del rudere riattato a resort, portava l'anziana madre a pranzo sulla spiaggia di Ansedonia. Gliel'hanno bruciato 1 alle otto di sera del primo ottobre. L'attentato dopo cinque minacce. Il 29 febbraio scorso l'avevano aggredito in due, scesi dallo scooter mentre Piscicelli camminava telefonando ai Parioli, a Roma. Poi gli hanno spedito in villa all'Argentario tre proiettili, avvolti in un giornale. E l'hanno bloccato mentre saliva in auto lungo la mulattiera sterrata che porta al resort sul Promontorio: "Perché continui a parlare, perché vuoi mettere in crisi il sistema che ti ha sfamato?", gli hanno sibilato scoprendo sotto il maglione le beretta parabellum. "Fermati o facciamo fuori te e la tua famiglia". Le sue denunce sono tutte alla caserma dei carabinieri di Orbetello. Francesco Maria De Vito Piscicelli, due mesi di carcere, undici giorni ai domiciliari, è l'imprenditore edile consegnato all'opinione pubblica, "per sempre", dall'intercettazione telefonica in cui ride con il cognato del terremoto dell'Aquila 4, discorrendo con lui dei nuovi lavori che porterà la futura ricostruzione. Francesco Piscicelli, 50 anni, napoletano alto borghese, vicino ad Alleanza nazionale, è stato uno dei quindici costruttori scelti dalla cricca della Ferratella per lavorare al soldo della Protezione civile di Bertolaso. È diventato un collaboratore di giustizia. In otto interrogatori, assistito dall'avvocato Giampietro Anello, ha consegnato alla Procura di Roma il racconto della corruzione pubblica italiana dal 2000 al 2010. Giovedì scorso, ha accettato di parlare con "Repubblica". "Il sistema Protezione civile, la deroga assoluta per ogni appalto pubblico, inizia con il Giubileo del Duemila, l'incontro fra il sindaco di Roma Francesco Rutelli, il provveditore alle Opere pubbliche del Lazio Angelo Balducci e il capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Nelle intenzioni pubbliche si doveva creare una macchina che riuscisse a costruire opere in un paese in cui la burocrazia e i veti bloccano tutto, ma nel corso delle stagioni le missioni diventano un sistema di arricchimento personale. Famelico, sfruttato a sinistra e a destra. L'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto dall'interno: una montagna di denaro pubblico per dieci stagioni è stata messa a bilancio per realizzare auditorium, stadi, caserme, svincoli e e in percentuale è stata trasferita a parlamentari, ministri, sottosegretari, magistrati contabili, funzionari della Protezione civile, alti dirigenti delle Opere pubbliche. Nessuna istituzione, nessun partito, tutto ad personam". Lei è accusato di corruzione, Piscicelli. Insieme ai costruttori fiorentini della Btp per l'appalto della scuola dei marescialli e dei brigadieri a Firenze. "Io ho pagato solo per lavorare, se non lo facevo chiudevo l'azienda che avevo ereditato da mio padre e che sempre ha lavorato con lo Stato. A Firenze ho fatto da intermediario tra il gruppo presieduto da Riccardo Fusi e l'ingegner Angelo Balducci, il grande capo del mattone pubblico italiano. Quelli della Btp, provinciali, rozzi, non riuscivano ad arrivare a Balducci perché il direttore dell'edilizia di Stato, Celestino Lops, li ostacolava, favoriva la Astaldi. Con una telefonata organizzai l'incontro, rimasero stupefatti. Sono stato io a presentare Denis Verdini, coordinatore del Pdl, a Balducci. Fusi trattava Verdini come fosse il suo straccio e usava la banca di Verdini come il suo bancomat". Lei ha pagato Balducci per far entrare nell'appalto Marescialli la Btp? "Ho fatto da intermediario ottenendo da Fusi, in cambio, un prestito da 700 mila euro". Quando ha versato tangenti in proprio, Piscicelli? Denaro suo per opere sue. "Lavoro con Balducci dal 2004. Nei primi cinque anni ho partecipato a trecento bandi pubblici per ottenere due lavori: la scuola di polizia di Nettuno e la caserma della guardia di finanza di Oristano. Per i Mondiali di nuoto di Roma, quelli del 2009, ho partecipato alle cinque gare pubbliche, ho speso 700 mila euro in progettazione e ho vinto Valco San Paolo: avevo preparato un progetto unico in Europa, con luci a soffitto lunghe sessanta metri, e firmato un ribasso del 16,5 per cento. I cinque appalti erano tutti assegnati prima dell'apertura delle buste. Nelle gare bandite dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, e in particolare quelle della Protezione civile, non c'era notaio, non c'erano vincoli. Tutto nella discrezione del presidente Balducci: poteva assegnare ottanta punti al progetto che voleva spingere. Mi obbligò a chiedere un disegno anche al professor Giampaolo Imbrighi, suo caro amico. Mi costò 50 mila euro. Voleva che partecipassi per forza alla gara per lo stadio del tennis: un finto concorrente della Cosport di Murino e Anemone, destinati alla vittoria. Sulla carta erano gare europee, ma tutti gli appalti erano pilotati da Balducci, il Consiglio superiore ratificava silenzioso". Lei chi pagò e quanto? "Per le piscine di San Paolo, 14 milioni di base d'asta, ho versato tre tangenti. Me ne avevano chieste quattro. Il collettore di denaro per conto della squadra di Balducci, l'ingegner Enrico Bentivoglio, dopo la mia vittoria volle 50 mila euro, il 3 per cento. "Sai, c'è bisogno di accontentare molte persone". Ventimila furono per la funzionaria Maria Pia Forleo, "ci eravamo sbagliati, serve di più". Mi spiegavano tutto, si fidavano di me. Poi subentrò Claudio Rinaldi, nuovo commissario ai Mondiali. E senza ritegno pretese 100 mila euro. Glie li portai all'Hotel de Russie, in via del Babuino. All'interno di un sacchetto di una boutique romana. Mi feci accompagnare dal ragioniere, ha visto tutto. Rinaldi mi disse: "Questo è un acconto, al collaudo mi devi dà dù piotte e mezzo". Duecentocinquanta, queste non le ho pagate". Lei ha ottenuto l'appalto per una struttura, Valco San Paolo, bandita per 14 milioni, costata 34 e dopo trentanove mesi chiusa e con un pilone fratturato. "Mi sono disinteressato del destino della piscina. Io ho visto solo nove milioni, altri otto e mezzo me li hanno truffati quelli della Ferratella, i ragazzi di Balducci. Il pilone è solo un assestamento, ma tutta l'opera è stata una corsa folla. Abbiamo dovuto rifare i progetti dell'architetto Renato Papagni, un amico del presidente della Federazione nuoto Paolo Barelli. Carta straccia, un copia e incolla fatto male, le ipotesi di rimozione terra redatte senza criterio. Per dieci mesi abbiamo lavorato 24 ore al giorno e ho dovuto chiedere l'intervento della segretaria particolare di Alemanno per farmi pagare il milione e mezzo di stato di avanzamento lavori. Il Comune di Roma è un casino pazzesco, venirne fuori è stato un miracolo. Durante i lavori, poi, mi si è messo contro il presidente Barelli, il senatore del Pdl. Era furioso perché avrebbe voluto far lavorare aziende vicine in almeno due lotti, Balducci non gli diede nulla. Per ritorsione, ci bocciò il tetto in acciaio e ce lo impose in cemento armato. Diceva che con i vapori caldi delle piscine l'acciaio si sarebbe corroso. Abbiamo dovuto stravolgere il progetto, rifare i calcoli, sovradimensionare i pilastri, comprare altro ferro per armarli. Costi e ritardi. E poi Barelli ci obbligò a lavorare con le aziende specializzate che indicava, costavano il 30 per cento in più. Se non ubbidivamo, minacciava il blocco dei lavori. Mandava avanti il suo ragioniere, Maurizio Colaiacomo. Gli impianti di filtraggio, per dire, li ha fatti tutti la Culligan, a prezzi fuori mercato". Al Comune di Roma solo confusione? "Della Giovampaola mi chiese di portare l'imprenditore fiorentino Valerio Carducci dal sindaco Alemanno. L'appalto per il nuovo palazzo Istat. Non se n'è fatto nulla". Angelo Balducci imponeva i suoi uomini? "Lui imponeva tutto, era il dominus. Non avido, ma corrotto mentalmente, un affascinante gesuita innamorato del potere. In cinque mesi di carcere sono andati a trovarlo settanta parlamentari, una processione. Se parla viene giù tutta la Prima Repubblica e pure mezzo Vaticano. Balducci voleva accontentare tutti, e soprattutto la classe politica. A me ha imposto la ditta che doveva fare gli scavi archeologici, quella per lo sminamento. E pure tre tecnici tra cui lo strutturista Fabio Frasca, figlio di una dirigente del ministero delle Infrastrutture. Frasca ha sbagliato i calcoli per Valco San Paolo, ha preso una normativa vecchia". Il rapporto tra Balducci e Anemone? "Diego Anemone non esiste. È un ex falegname inventato dal capo. Quando scoprite un'impresa di Diego Anemone in un appalto pubblico, vuol dire che sta lavorando direttamente Angelo Balducci. Faceva cassa così, mettendo Anemone dovunque. E affidandogli la gestione del denaro da destinare ai politici". Che significa, Piscicelli? "A Natale, Pasqua e Ferragosto la classe politica italiana batte cassa. Un assedio, spegnevo il telefonino. Ascolti. Mi chiama Anemone, mi dice che devo versare 150 mila euro, siamo alla vigilia delle feste natalizie. Balducci conferma: "Sì, devi farlo, servono ai parlamentari". Anemone insiste perché vada da lui, ha l'ufficio in una traversa di via Nomentana. Stanze di pessimo gusto. Spinge una porta scorrevole e alla vista si rivela un tavolo lungo due metri e quaranta, largo uno. Sopra, un covone di banconote. Quasi tutti tagli da cinquecento. Milioni di euro, mai visto nulla di simile. Con i miei 150 mila nella giacca mi sono sentito un morto di fame, me ne sono tenuti cinquemila. Anemone ha comprato la casa al Colosseo dell'ex ministro Claudio Scajola con un po' del denaro prelevato da quel tavolo". Continua a girarci intorno: parla di tangenti e di politici. Che cosa ha detto ai magistrati? "Tutto quello che so, che ho visto, che posso certificare. Ho fatto il nome di otto politici di primo piano che hanno preso soldi e servizi dal sistema Balducci". E chi sono? "Non vorrei violare il segreto istruttorio". Fino a prova contraria il corruttore è lei. "Otto dicembre 2007, l'Immacolata, le racconto. Sono con mia moglie e mia figlia al ristorante Nino di via Borgognona: arriva una telefonata, è Mauro Della Giovampaola, funzionario della Protezione civile. "Devi venire alla Ferratella, immediatamente". Era sbrigativo Della Giovampaola, lasciai la mia famiglia sul flan di spinaci. Gli uffici erano chiusi, ma lui aveva le chiavi. Mi disse categorico: "Devi dirmi che ribasso hai fatto per l'Auditorium di Firenze". Chiesi perché. "Così vuole il capo". Se lo diceva Balducci si ubbidiva. Chiamai i miei soci fiorentini, Fusi e Di Nardo, li obbligai a rivelarmelo. Telefonai a Mauro, comunicai il ribasso e gli chiesi perché era necessario. Mi disse: "L'appalto dell'Auditorium deve andare al costruttore Cerasi, lo vuole Veltroni". Emiliano Cerasi con la Sac e Bruno Ciolfi con l'Igt presero l'Auditorium. Il 17 febbraio 2010, chiamato in causa da un'intercettazione tra l'architetto Casamonti e il costruttore Di Nardo, Walter Veltroni assicurò: "Come ha già detto il sindaco Domenici, non ho mai esercitato alcun tipo di pressione né su di lui né su altri per qualsivoglia gara". Piscicelli, lei partecipò al bando per la realizzazione dell'Auditorium di Isernia, costi lievitati da 5 a 55 milioni, segnalato in rosso dall'Authority dei contratti pubblici. "A Isernia avevo vinto. Ricordo il giorno in cui, nel teatro di via della Ferratella, si stavano aprendo le buste. Trentun dicembre 2007, le gare truccate si indicono l'ultimo dell'anno, quando gli altri non ci sono. Chiama al telefono il funzionario Bentivoglio. Salgo al piano, mi dice: "Hai fatto un progetto bellissimo, l'appalto è tuo". Torno in teatro, l'atmosfera è già cambiata. Commissari che si chiamano da parte. Il presidente del concorso dichiara il vincitore: è un'associazione temporanea di imprese guidata dalla molisana Rocco Lupo. Sono secondo. Cerco Bentivoglio, è pallido, ha paura. Riesce a dirmi: "Bertolaso ha chiamato Balducci, Di Pietro ha imposto Lupo, mi dispiace"". Già chiamato in causa sull'Auditorium di Isernia, Di Pietro il 4 giugno 2010 rispose: "Non sono stato sponsor dell'opera, non so neppure se poi l'abbiano davvero costruita". Chi è Guido Bertolaso, un capro espiatorio? "E' un megalomane con il complesso di far del bene. Per le responsabilità che ha avuto, la fama che si è creato, non avrebbe mai dovuto vendersi per 50 mila euro. Quella era la sua tariffa: 50 mila euro, per volta. Suo cognato, Francesco Piermarini, con i soldi pubblici destinati al G8 si comprò una barca, "Il lumacone", per la pesca d'altura con l'abbattitore per il pesce crudo". A Carlo Malinconico ha pagato le vacanze all'Hotel Pellicano di Porto Ercole. "E' un uomo di Balducci. Da sottosegretario della presidenza del Consiglio del governo Prodi ha firmato qualsiasi progetto il capo gli portasse, qualsiasi missione, qualsiasi deroga. A occhi chiusi. Balducci nel 2006 mi chiese di occuparmi di lui: "Ci serve come il pane, dobbiamo curarlo in tutto e per tutto", mi disse durante un aperitivo in piazza San Silvestro. Malinconico voleva uno dei rustici che stavo ristrutturando qui all'Argentario, gli piaceva la vecchia Villa Feltrinelli. Lo accompagnai due volte, ma in cuor mio sapevo che non gli avrei mai regalato un immobile da un milione e due. Per fortuna aveva fretta, l'estate stava arrivando e allora Balducci mi chiese di ospitarlo a spese mie al Pellicano. Malinconico e la sua compagna dal 2006 al 2007ci hanno fatto sei vacanze. Milleottocento a notte, colazione esclusa. Ho pagato fino a quando il figlio del magistrato Toro non ci rivelò che la procura di Firenze stava indagando sulla cricca. "Chiudi il conto, chiudi il conto". Raggiunsi il Pellicano, saldai 25.600 euro e dissi a Roberto Sciò, il titolare: "D'ora in avanti Malinconico si paga il soggiorno". Quando la direzione dell'albergo glie lo comunicò, il sottosegretario andò su tutte le furie. Preparò la valigia il pomeriggio stesso e lasciò l'Argentario millantando una nuova nomina. Gli ho chiesto indietro il denaro, mi ha fatto rispondere dagli avvocati: "Piuttosto li do in beneficenza". Facile fare beneficenza con i soldi miei. Il governo Monti continua a dare incarichi a Malinconico, l'ultimo è arrivato dal ministro Passera". Lei ha denunciato anche il magistrato della Corte dei Conti Antonello Colosimo, già capo di gabinetto del ministro dell'Agricoltura Catania. "Credevo fosse un amico, mi ha taglieggiato dal 2004 al 2008. Ha sempre preteso una tangente, a volte anche del 15%, su tutti i lavori pubblici che facevo e questo perché è stato lui a presentarmi Angelo Balducci. Per anni gli ho pagato auto, autista, l'affitto dell'ufficio in via Margutta. Quando ho smesso mi ha scatenato contro la finanza. Nel 1992 la politica chiedeva agli imprenditori soldi, ma dava benefici. Oggi la politica, e alcuni funzionari potenti, ti chiedono soldi per non farti male. Alla Ferratella c'è un'impiegata che solo per mandare tre righe di giustificazioni della spesa in Banca d'Italia chiede a ogni imprenditore una tangente di 1.000 euro. Tre righe digitate al computer, mille euro". Quanti imprenditori hanno lavorato con la banda Balducci. "Eravamo in quindici, affidabili. Oggi tra gli emergenti c'è il romano Paolo Marziali, quello che ha realizzato il polo natatorio di Ostia". Che resta della banda Balducci? "Lui lavora ancora, governa ancora. Non credo si salverà dai tre processi che ha in corso, ma fin qui non ha aperto bocca. È tornato a vivere a Roma, in via Appia Pignatelli, e i suoi uomini, Rinaldi, Bentivoglio, Zini, la Forleo, sono ancora al loro posto. Ai magistrati ho raccontato di nuovi funzionari corrotti fin qui non sfiorati". E degli otto politici di primo piano, che ha detto? "Che prendevano soldi, tanti soldi. Non credo, quando tutto diventerà pubblico, e accadrà presto, potranno continuare a far politica. Io ho pagato un milione di tangenti e adesso sono con il culo per terra". Venerdì sera l'avvocato Giampiero Anello ha confermato che tutto ciò che l'imprenditore Piscicelli, suo assistito, ha detto in questa intervista è già stato riferito ai magistrati della Procura di Roma. Corsera – 20.10.12 Tanto semplice che non si farà - Giovanni Sartori La vicenda dei nostri sistemi elettorali spiega, o comunque concorre a spiegare, il fallimentare andazzo della politica italiana. Nel mio ultimo pezzo (Il Porcellum e i Porcellini di domenica scorsa) concludevo dicendo che un modo non corruttibile di consentire all'elettore di esprimere le sue preferenze sui candidati esiste. Ma non lo indicavo. È che il mio spazio era finito, e anche che volevo mettere assieme e ricordare quante leggi elettorali sbagliate, e quindi dannose, abbiamo accumulato negli ultimi decenni. Ricordare gli sbagli serve ad evitarli? In Italia no. Non mi illudo, ma provo lo stesso. Nel dopoguerra, e dopo l'esperienza del fascismo, era normale adottare un normale sistema proporzionale. Che funzionò senza proliferare partitini perché la paura del Pci portava a concentrare il grosso dei voti sulla Dc. Così fu il Partito comunista che, senza volere, fece funzionare un «bipartitismo imperfetto» che, per quanto imperfetto, ricostruì il Paese e produsse il miracolo economico del nostro dopoguerra. La Francia, con un Pcf molto meno forte, restò invece impantanata in una «repubblica dei deputati» che era poi un parlamentarismo anarchico. Però anche noi, tra gli anni 50 e 60, abbiamo avuto un Gianburrasca, per l'esattezza Marco Giacinto Pannella, che si impadronì dal 1967 in poi, e oramai si direbbe a vita, del Partito radicale e che affascinò, tra i tanti, anche Mariotto Segni. Pannella riuscì a persuadere Segni (e molti altri, si intende) che l'Italia doveva adottare un sistema maggioritario secco (puro e semplice) che avrebbe immancabilmente prodotto un sistema bipartitico all'inglese. Mai tesi fu più campata in aria. Ho scritto e riscritto senza sosta, nei decenni, che Pannella e i suoi si sbagliavano di grosso. E per decenni ho sostenuto che mentre il maggioritario a un turno avrebbe frantumato il nostro sistema partitico, era invece il maggioritario a due turni che ci avrebbe avvicinati al bipartitismo. Ma come resistere alla prepotenza e ai digiuni di Pannella? Vinse anche la viltà della Dc che, sfaldandosi, preferì il meno pericoloso (ritenne) Mattarellum , un sistema misto, maggioritario secco per tre quarti e proporzionale per un quarto. Con il Mattarellum cominciò così la nostra scivolata elettorale verso il peggio e la ingovernabilità. L'alibi invocato dai difensori del Mattarellum è di addebitare la moltiplicazione dei partiti al quarto proporzionale di quella legge. Ridicolo. Quella moltiplicazione fu dovuta alle «desistenze»: i partitini che non potevano vincere nella contesa uninominale ricattavano i partiti maggiori chiedendo in cambio dei loro voti una serie di collegi sicuri per sé. Grazie al Mattarellum siamo così arrivati alla frantumazione partitica che si è conclusa nella grande ammucchiata del secondo governo Prodi. E il rimedio fu ancora peggiore del male che si doveva curare, fu l'ancor vigente legge Calderoli, il Porcellum. Nel frattempo erano tornate alla ribalta le preferenze che poco più di 20 anni prima avevamo ripudiato a furor di popolo. Fortuna vuole che ora si scopra che i voti di preferenza si comprano anche a Milano. Aggiungi che le preferenze ricreano i partiti di corrente, o di fazioni, addetti appunto a catturare le preferenze che poi, in realtà, il popolo non sa dare o a chi dare. Eppure un sistema che consente e anzi produce una genuina espressione delle preferenze degli elettori esiste: è il maggioritario a doppio turno. L'ho proposto più volte. Ma no; i nostri legislatori non lo vogliono. Né vogliono capire che il doppio turno è anche un indicatore di preferenze. Lo debbo rispiegare? Per amor di patria (si dice ancora?) forse sì. Comincio dal ricordare che il sistema maggioritario a doppio turno (che funziona bene da sempre nella V Repubblica francese) è, al primo turno, come un sistema proporzionale: ogni elettore esprime liberamente la sua prima preferenza e, così facendo, immette la sua scelta nel meccanismo elettorale. Meccanismo che conta i voti, che scarta le preferenze dei meno, e che ovviamente non è comprabile. Supponiamo, per esempio, che la mia prima preferenza sia Marco Giacinto Pannella. So benissimo che il mio sarà un voto perduto. Ma lo voto lo stesso e nessuno potrà dire che non mi è stata data la libertà di preferire e di scegliere. Al secondo turno, la seconda volta, mi toccherà invece scegliere un candidato di mia seconda preferenza, o anche il meno sgradito. Ma anche questa è una scelta mia, non del partito o della mafia. In nessun caso sono mai un sovrano spodestato. Dunque, se le preferenze si vogliono le possiamo avere così. Ma il maggioritario a doppio turno (proposto, ma a sprazzi e senza troppa convinzione, soltanto dal Pd) non piace a nessun altro. Forse per ignoranza, non infrequente nei nostri legislatori; ma soprattutto, sospetto, perché manderebbe troppa gente a casa. Siccome non sono cattivo come ho la fama di essere, anni fa proposi un addolcimento. In primo luogo il passaggio al secondo turno sarebbe consentito ai primi quattro. Dopodiché, al secondo turno i due partiti minori (dei quattro) hanno la scelta di ritirarsi e così di fruire di un «premio di tribuna», mettiamo, del 20 per cento dei seggi; oppure di combattere le elezioni, perderle, ma così facendo perdendo anche il proprio premio di tribuna. Questa, oso dire, è una proposta «pulita», tanto più che oggi come oggi è difficile prevedere chi se ne avvantaggerebbe; siamo troppo nel caos (con Grillo, Renzi, i non votanti e una valanga di incerti) per indovinare. Per una volta sarebbe facile fare il bene del Paese. Invece appena presentata in Aula la proposta della commissione Affari Costituzionali del Senato, viene ricevuta da 222 emendamenti. Troppa grazia Sant'Antonio.
Scarica