SUPPLEMENTO SETTIMANALE DE «IL MANIFESTO» GLI SCRITTI INEDITI SUL FASCISMO TRA LE OPERE IN VIA DI PUBBLICAZIONE SCOPERTE NEL LABIRINTO DEI MATERIALI DEL GRANDE SCRITTORE PORTOGHESE PRIMATISTA MONDIALE DI ALIAS - CHE APPLICÒ ALL’EUROPA CONTRO ARMI ED ESERCITI, SILURI E SOTTOMARINI, IL CONCETTO DI IMPERIALISMO CULTURALE a o se s F n a n re do P SABATO 16 OTTOBRE 2010 ANNO 13 - N. 41 IN QUESTO NUMERO ULTRAVISTA: ANTONIO RUSSO • LE NUOVE LONELY PLANET • ULTRASUONI: JIMI & MILES • MALCOLM X & ALBERT AYLER • TALPALIBRI: EISNER • TRASFERTE: SHANGHAI • FUSINI • PS. SHAKESPEARE • STASIUK • P. ROTH • MAGRELLI • RITAGLI: AFFINATI • VIGEVANI Il Portogallo è ospite d’onore al Pisa Book Festival che inizia il 22 ottobre con la presenza dei più famosi scrittori contemporanei. Accanto a questi ricordiamo Fernando Pessoa le cui opere sono considerate tesoro nazionale e che sono ora sottoposte a un lavoro di riscoperta e catalogazione di Gianluca Pulsoni L’ opera di Fernando Pessoa è più che mai un labirinto pieno di misteri. Come per certi grandi poeti è ancora poco quello che si conosce del suo lavoro e ancora è minima, rispetto alla qualità dell’opera, la percezione della sua importanza nella storia dei campi del sapere che attraversa. A cercare però di scoprire e dare ordine alle carte sconosciute del poeta, nel modo più filologicamente scrupoloso e con una serie di lavori di diverso indirizzo, ci sono da alcuni anni tre studiosi universitari, non lusitani d’origine, ma residenti ed operativi a Lisbona. Uno di questi è italiano e si chiama Antonio Cardiello. Studioso di letteratura e filosofia, laureato a Padova con una tesi su Pessoa, vive da sei anni nella capitale portoghese. Qui è borsista universitario con un lavoro che interseca filosofia e letteratura nell’opera del grande lusitano. L’abbiamo incontrato per parlarci del lavoro critico e filologico obiettivamente rivoluzionario che lui e gli altri due ricercatori stanno compiendo sul poeta portoghese. Puoi farci una introduzione al tuo lavoro su Pessoa? In questi cinque e sei anni sto provando a portar a conclusione una tesi di dottorato e l’asse portante è l’opera del poeta in relazione a certe altre importanti ricerche e correnti filosofiche, come una prosecuzione del lavoro di tesi già svolto, ma avendo l’ausilio dei testi originali. Scrivo però con una certa lentezza perché ci sono altri lavori su Pessoa in cui sono entrato. Il tutto, se vuoi, è nato con l’esperienza iniziata proprio qui con i suoi testi, con la digitalizzazione delle sue carte. Un iniziativa il cui merito va in grande misura a Jerónimo Pizarro. Chi è Jerónimo Pizarro? Jerónimo Pizzarro è un ricercatore di origine colombiana, adesso con doppia cittadinanza (è anche portoghese), che già dal 2001 ha cominciato a frequentare assiduamente gli ambienti accademici portoghesi ed è oggi un grande specialista dell’opera di Pessoa: infatti, nonostante abbia una età piuttosto giovane, poco più che trentenne, ha già vari titoli tra cui una laurea ad Harvard relativa alle pratiche d’edizione e impaginazione. Gli ultimi 8-9 anni li ha spesi documentandosi con una precisione ed assiduità unica nel panorama internazionale proprio sull’ «archivio» di Pessoa. Dunque ha lavorato giornalmente studiando i manoscritti, i dattiloscritti e possiede perciò una visione d’insieme dell’opera del poeta assolutamente senza pari. Ha già ripubblicato moltissimi testi del poeta, raccolti e trascritti; ha portato alla luce molti scritti che erano inediti fino al suo intervento e con questa base ha ideato un progetto rivoluzionario o quanto meno originale, ovvero organizzare una équipe che digitalizzasse tutta la biblioteca personale di Pessoa che è stanziata nella casa museo omonima. Naturalmente abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni del caso, dato che la casa non è accessibile a chiunque, abbiamo stipulato un accordo/protocollo con la «Casa Pessoa» e con Patricio Ferrari – ricercatore argentino con passaporto italiano, a mio modesto parere il più grande specialista della storia della biblioteca personale di Pessoa (che ha una storia molto complessa, contorta) – s’è pensato di creare, e insieme coordinare, questo gruppo di volontari-studiosi che, senza prendere un euro dalla «Casa Pessoa» o dal Municipio di Lisbona, si sono dedicati per più di un anno a questa fatica che iniziammo nella primavera del 2008, terminando in Giugno del 2009. Quanti eravate a lavorare alla digitalizzazione? Non sempre era possibile avere un numero di collaboratori tali da potere avanzare con una certa rapidità, perché alla fine le persone veramente interessate erano 5 o 6, oltre Pizarro, Ferrari e me. Noi abbiamo anche chiesto ad amici e parenti, alle volte, di darci una mano, proprio perché mancava del personale. Una cosa artigianale che perciò potrebbe anche far pensare a un lavoro mal fatto, invece no: perché è stato a tutti gli effetti un lavoro inecce- 2) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 pibile. Tanto ineccepibile che sarà, finalmente, disponibile on-line. Quando, in quale piattaforma? La Casa Pessoa aveva un sito un po’ precario, ma con l’aiuto di esperti informatici, tecnici anche del Municipio di Lisbona, è stato ristrutturato. E qui ci sarà un ampio spazio dedicato alla biblioteca del poeta: tutte le pagine della maggioranza dei libri conservati saranno disponibili on-line. Secondo le ultime informazioni che ho, tra un paio di mesi tutto sarà disponibile, ma in queste cose purtroppo gli imprevisti burocratici fanno sempre capolino. Sarà comunque possibile visionare le sue carte e vedere cose importanti come i suoi marginalia, perché Pessoa aveva un modo tutto suo di scriverli. Comunque stiamo parlando di più di 1300 titoli e come sai un titolo può corrispondere anche a più volumi. E’ perciò qualcosa di monumentale. A livello pratico, l’operazione di rendere digitale le carte del poeta, oltre al senso anche di salvaguardia del carattere finito del materiale, è stata fatto per qualcosa di mirato? Effettivamente ce ne sono diversi di scopi. Il primo è sicuramente la fruizione per i molti ricercatori sparsi per il mondo che non potrebbero accedere alle carte. Quindi diciamo che questo è proprio lo scopo accademico. Il secondo scopo è sicuramente culturale o etico, perché l’opera di Pessoa, in alcuni momenti della Storia, ha rischiato di essere dispersa. Come mai? Da quello che so l’opera di Pessoa è stata per alcune situazioni un caso clamoroso. L’archivio si compone di circa 28.000 scritti, ma alcuni degli scritti che facevano parte di questa «mitica» arca non sono nella Bi- blioteca Nazionale, che raccoglierebbe tutti gli scritti che la famiglia ha venduto o concesso, mentre la «Casa Pessoa» ha comprato dalla famiglia circa il 90% dei libri che erano appartenuti a Pessoa, solo che quando hanno acquistato i libri pensavano fosse il 100% dei volumi a lui appartenuti! Quindi dal 1993 che la «Casa Pessoa» ha acquisito i libri e la maggioranza della scomparsa degli stessi è avvenuta proprio dal 1993 ad oggi. Ora, non voglio accusare nessuno ma una ventina di anni fa era anche molto più facile accedere ai libri di Pessoa perché c’erano meno controlli. Oggi invece tutto giustamente è complesso, anche perché l’opera di Pessoa, dal 2009, è considerata «tesoro nazionale», ciò significa che la famiglia non può vendere a suo piacimento originali del poeta a privati o in aste pubbliche senza prima d’aver sentito lo Stato Portoghese che diventa il loro primo interlocutore. Va da sé però che l’atteggiamento degli eredi, con la questione delle scomparse misteriose di alcuni libri è stato quantomeno dubbio. Anche perché poi Pessoa ha sempre lasciato delle tracce, delle piste, dei cammini per capire quali potessero essere i suoi progetti futuri. Uno di questi è il dossier Crowley. Aleister Crowley era un mago ambiguo, scrittore di opere filosofiche ed illusionista. Abile provocatore e per alcuni una spia inglese, famosissimo in patria. Ha vissuto in Portogallo? No ma qui incontrò Pessoa. Ci sono dei libri che testimoniano questo incontro e questo «dossier» – serie di composizioni, scritti su Crowley – ma questo libro non fa parte dell’archivio (anche se una parte dello spoglio contiene documenti che gli sono complementari). Battuto all’asta il giorno 11 novembre 2008 per 50.000 euro, è stato venduto all’estero: Ma sappiamo che si trova probabilmente negli Stati Uniti, quindi non in Portogallo, acquistato da un privato. È un lavoro molto importante. Siete riusciti a sapere i contenuti del libro, o almeno lo scheletro? Gran parte del materiale che è stato messo all’asta dalla famiglia è già nel volume Encontro Magik, pubblicato nel 2001 da Miguel Roza – erede legale di Fernando Pessoa – e rieditato quest’anno dalla casa editrice Assírio & Alvim. Quindi, per grandi linee, sappiamo di cosa tratta. Rimane però il problema che sarebbe indispensabile consultarlo nella sua totalità perché è un libro fondamentale per la ricostruzione della biografia di Pessoa uomo oltre che per Crowley. L’occasione del «dossier» è l’incontro tra i due, il 2 settembre 1930 a Lisbona. Pessoa si dilettava anche di astrologia, era diventato un grande conoscitore dei processi astrologici e questa abilità l’aveva portato a comporre anche gli oroscopi dei famosi eteronimi e a motivare le abilità letterarie di ognuno di essi partendo dalle caratteristiche astrologiche, per arrivare poi a formarne le estetiche. Pessoa aveva letto in una rivista dell’epoca un oroscopo fatto da Crowley su di sé e Pessoa gli aveva scritto una lettera dicendogli che s’era sbagliato! Naturalmente Pessoa manda a Crowely un oroscopo più dettagliato e più giusto. Figuriamoci allora che Crowley, di fronte a una situazione del genere, decide di conoscere di persona Pessoa e viene in Portogallo. Crowley era un personaggio oscuro e l’episodio dell’incontro è abbastanza noto, ciò che si sa meno però è che la Cia lo pedinava e lui per far perdere le sue tracce inscena un clamoroso falso suicidio, dopo l’incontro con Pessoa, che venne coinvolto e presumibilmente spiato dalla stessa Cia che lo interrogò per sapere cosa aveva fatto in quei giorni Crowley. Lui tenne il gioco del mago e mentì. Torniamo al progetto. Vorrei sapere da te se ci può descrivere il panorama della produzione di Pessoa da scoprire e riscoprire e cosa avete fatto e farete dopo il lavoro della digitalizzazione delle carte. Lo spoglio di Fernando Pessoa è ancora ben lungi dal poter essere divulgato nella sua veste integrale. Ad oggi, infatti, «solamente» il 50% del suo totale è stato pubblicato. Il recente proliferare di nuove edizioni di testi pessoani, spesso curate da giovani filologi e letterati dediti a rigorosi lavori di trascrizione secondo le più moderne e apprezzate tecniche della critica testuale fa ben sperare e, su tutte, merita una segnalazione speciale la neonata edizione portoghese del Libro dell'Inquietudine, frutto del minuzioso lavoro di raccolta e catalogazione di frammenti compiuti da Jerónimo Pizarro: Fernando Pessoa, Livro do Desasocego, Edição Crítica de Fernando Pessoa, Série Maior, volume XII. Edição de Jerónimo Pizarro, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 2010. Poi, al di là delle pagine inedite su vari argomenti e sul teatro e al di là delle pagine di estetica già esistenti attribuite al Pessoa ortonimo, si aggiungeranno altre antologie, la cui paternità interessa almeno due degli eteronimi principali. Inoltre, vi sono all’incirca 500 documenti di contenuto religioso e filosofico che non hanno ancora visto la luce del giorno. ■ CONVERSAZIONE ■ ANTONIO CARDIELLO ■ Labirinto Pessoa Per gli amanti della poesia invece, le attese più febbrili riguardano vaste sezioni di componimenti elaborati in inglese e francese. Ritornando a noi invece posso dirti che dopo la digitalizzazione c’è stato un catalogo, J. Pizarro, P. Ferrari & A. Cardiello, A biblioteca particular de Fernando Pessoa – Acervo Casa Fernando Pessoa, Dom Quixote, Lisboa, vol. I, 2010 che riunisce tutta l’informazione legata alla biblioteca personale in modo da comporre però anche un’opera apprezzabile dal punto di vista estetico. In ogni pagina c’è la copertina a colori di ogni libro del poeta e una nota bibliografica relativa, ci sono poi sezioni dedicati ad alcuni esempi di marginalia con l’immagine digitale e la loro trascrizione e inoltre presentiamo, sempre nel catalogo, esempi dei «marginalia silenziosi», cioè quei passi sottolineati a margine di alcuni libri che abbiano un riscontro diretto con certi sviluppi teorici delle opere del poeta. Il filo conduttore tra Pessoa lettore e Pessoa scrittore, il quale come tutti i grandi poeti, come Leopardi, presenta sempre un’opera polimorfa che attinge a più interessi e campi del sapere. Come si fa perciò a trovare la strada dentro questo labirinto? E qual è la chiave per uscirne? La risposta l’ha data forse già Mazzino Montinari, parlando della sua grande opera di filologo su Nietzsche, con questa affermazione: «la biblioteca non rappresenta soltanto una porta privilegiata per entrare nel mondo dell’autore, ma anche un cammino per uscirne». Foto di Fernando Pessoa (1888-1935). A destra in una immagine a firma Muniz Martinez ■ DOCUMENTI ■ Due testi inediti su fascismo e oltre a cura di Antonio Cardiello* Q Il Manifesto Il Manifesto DIRETTORE DIRETTORE RESPONSABILE RESPONSABILE Norma Norma Rangeri Rangeri VICEDIRETTORE VICEDIRETTORE uesti due documenti dattiloscritti che pubblichiamo qui di seguito dovrebbero risalire alla seconda metà degli anni 20 e integrano una serie di testi dal tratto smaccatamente antifascista, alcuni di essi ancora inediti persino in Portogallo, alla cui stesura Pessoa si dedicò fino agli ultimi mesi della sua vita. Il primo dei due frammenti è incompiuto. L'autore, dopo aver toccato il tema per linee generali, si sofferma sulla valutazione dei progressi materiali introdotti in Italia dall'avvento del Fascismo, operando un raffronto con il saldo negativo pagato dal nostro paese in termini di manisfestazioni di libertà e di reale progresso civile. Il secondo segue somiglianti posture mordaci, configurandosi come un'acuta satira rivolta ai limiti linguistici del duce che, in un certo senso, si riflettono nei limiti di reazione di un popolo italiano in grado di subire gli schiaffi inferti senza ostentare apparentemente alcuna sorta di resistenza o opposizione. Angelo Angelo Mastrandrea Mastrandrea Alias Roberto Roberto Silvestri Silvestri Francesco Francesco Adinolfi Adinolfi (Ultrasuoni), (Ultrasuoni), Federico Federico De Melis, De Melis, Roberto Roberto Andreotti Andreotti (Talpalibri) (Talpalibri) Con Con Massimo Massimo De Feo, De Feo, Roberto Roberto Peciola, Peciola, Silvana Silvana Silvestri Silvestri REDAZIONEREDAZIONE via A.viaBargoni, A. Bargoni, 8 8 0015300153 - Roma - Roma Info: Info: ULTRAVISTA ULTRAVISTA fax 0668719573 fax 0668719573 ULTRASUONI ULTRASUONI fax 0668719573 fax 0668719573 TALPA LIBRI TALPA LIBRI tel. 0668719549 tel. 0668719549 e 0668719545 e 0668719545 EMAIL Due scritti inediti a cui il poeta lavorò negli ultimi mesi della sua vita: nel primo si parla del tributo salato pagato dall’Italia, nel secondo la satira colpisce Mussolini e la sua scarsa conoscenza della lingua inglese e anche gli italiani disponibili a farsi schiaffeggiare da destra e da sinistra TESTO 1 Mathew Arnold, che fu (nonostante qui non si sappia, il che equivale semplicemente a dire che non si sa) uno dei grandi poeti del diciannovesimo secolo, definì, in una frase che divenne celebre, la nullità intima della civilizzazione puramente materiale: «A cosa ti serve un treno che ti porta in un quarto d’ora da Camberwell fino a Islington, se ti porta da una vita miserabile e stupida a Camberwell a una vita miserabile e stupida a Islington?» In effetti, rappresentando appena delle facilitazioni funzionali a una vita che dovrebbe avere fini più alti, le conquiste materiali non significano nulla di per sé, se non quando dalle loro applicazioni realmente scaturisce qualcosa relativa a questi alti fini. Sulla natura di quegli alti fini possiamo opinare: per alcuni potrebbero essere semplicemente la grandezza nazionale (è un concetto limitato, ma è, per la maggioranza degli uomini, l’unica cosa che veramente li trascina fuori dal loro egoismo naturale, e così rende possibile che costoro facciano qualcosa in più rispetto al vegetare attivamente); per altri consisterebbero nella felicità umana (che è un concetto parimenti riduttivo, in quanto cani e gatti, se fossero capaci di concetti sociologici, non ne avrebbero un altro differente); per alcuni si tradurrebbero in determinati obiettivi religiosi; per altri (tra i quali io stesso mi includo) nella creazione di valori civilizzazionali – valori artistici, scientifici, filosofici – che servano da stimolo e da consolazione per gli uomini futuri. In se stessa la civiltà materiale non è affatto una civilizzazione, ma semplicemente un perfezionamento. Migliorano le condizioni in cui gli uomini vivono; gli uomini possono o meno migliorare. È risaputo da tutti i sociologi che le condizioni climatiche estremamente benevoli tendano a disturbare il progresso e la civilizzazione del popolo che ne è soggetto, per lo stesso motivo per cui non suscitano opposizione, facendo vivere la volontà, non producono difficoltà alla vita, destando l’emozione, non creano problemi di vita, svegliando l’intelligenza. Quando, poi, in opposizione a argomenti, come quelli che da ogni parte – escludendo le parti democratiche e radicali che attaccano per una questione di fanatismo politico – si ergono contro il fascismo, si risponde con la regolarizzazione dell’orario dei treni, con il miglioramento del valore della lira, e, perfino, con la stabilizzazione dell’ordine pubblico (supponendo che la pace varsaviana sia un ordine) non si sta ri- SEGUE A PAG 4 Alias A CURA DI A CURA DI EMAIL [email protected] [email protected] WEB: WEB: http://www.ilmanifesto.it IMPAGINAZIONE IMPAGINAZIONE ab&c - ab&c Roma- Roma tel. 0668308613 tel. 0668308613 RICERCA RICERCA ICONOGRAFICA ICONOGRAFICA il manifesto il manifesto CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA DI DI PUBBLICITÁ PUBBLICITÁ Poster PosterPubblicità Pubblicitàs.r.l. s.r.l. SEDE LEGALE SEDE LEGALE via A.viaBargoni, A. Bargoni, 8 8 tel. 0668896911 tel. 0668896911 fax 0658179764 fax 0658179764 e-mail e-mail [email protected] [email protected] sede Milano sede Milano via Pindemonte via Pindemonte 2 2 2012920129 MilanoMilano tel. 02 tel.76016293 02 76016293 fax 02 fax76312360 02 76312360 TARIFFE TARIFFE IN EURO IN EURO DELLEDELLE INSERZIONI INSERZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICITARIE Pagina Pagina 21.000,00 21.000,00 (279 (279 x 433) x 433) MezzaMezza paginapagina 11.600,00 11.600,00 (279 (279 x 213) x 213) Colonna Colonna 8.200,00 8.200,00 (90 (90 x 433) x 433) MezzaMezza colonna colonna 4.700,00 4.700,00 (90 (90 x 213) x 213) Piede Piededidipagina paginagrande grande 8.200,00 8.200,00 (279 (279 x 141) x 141) Piede Piededidipagina paginapiccolo piccolo 5.800,00 5.800,00 (279(279 x 93) x 93) Quarto Quarto di pagina di pagina 6.300,00 6.300,00 (137 (137 x 213) x 213) Quadrotto Quadrotto 2.300,00 2.300,00 (90 x(90 93)x 93) POSIZIONI POSIZIONI SPECIALI SPECIALI Coppia Coppia manchettes manchettes prima prima paginapagina 3.500,00 3.500,00 (60 (60 x 40) x 40) Finestra Finestra di sezione di sezione 3.200,00 3.200,00 (90 (90 x 93) x 93) IV copertina IV copertina 22.800,00 22.800,00(279 (279x x433) 433) STAMPA STAMPA Sigraf s.p.a. Sigraf s.p.a. via Redipuglia, via Redipuglia, 77 77 Treviglio Treviglio (Bg) (Bg) tel. 0363300330 tel. 0363300330 Diffusione Diffusionee econtabilità contabilità Rivendite Rivendite ee abbonamenti abbonamenti REDS REDS ReteRete Europea Europea Distribuzione Distribuzionee eservizi servizi viale Bastioni viale Bastioni Michelangelo Michelangelo 5/a 5/a 00192 00192 Roma Roma tel. 0639745482 tel. 0639745482 Fax. Fax. 0639762130 0639762130 ABBONAMENTO ABBONAMENTO AD ALIAS AD ALIAS euro euro 70,00 70,00 annuale annuale versamenti versamenti sul c/cn.708016 sul c/cn.708016 intestato intestatoa aIlIlManifesto Manifesto via A.viaBargoni, A. Bargoni, 8 8 00153 00153 Roma Roma specificando specificandolalacausale causale In copertina una foto di Fernando Pessoa da bambino ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (3 In alto immagine da una copertina, a destra foto di Fernando Pessoa. sotto da un murales di Lisbona SEGUE DA PAG 3 -spondendo con niente: ci si riferisce semplicemente ad una cosa differente e che non si attiene al caso. Uccidere, torturare, ingiuriare, non sono fenomeni necessariamente coinvolti nella produzione del buon funzionamento dei treni. Non è inconcepibile che si possa migliorare la lira senza bruciare biblioteche private e imporre sulla stampa una censura di carattere fisico. La medesima manutenzione dell’ordine [...] Pubblicato nel nº 163 del Jornal i il 12/11/2009 TESTO 2 Lo zio Mussolini, come qualsiasi inglese con ragione di lamentela, scrisse una lettera al Times. Il duce non sa l’inglese, né, da quello che sembra, ha trovato qualcuno capace di saperlo responsabilmente tra i quaranta milioni di persone che compongono la sua patria virtuale e i tre milioni che, nel computo effettivo, formano la sua patria reale. La lettera è notevole, non per le affermazioni – che sono del genere di quelle che potrebbe fare il Sr. Lloyd George, o il Sr. Briand, o qualunque altro Afonso Costa – ma per l’impiego palese della parola whereof, che vuole dire «di che». Di memorabile non dice nient’altro il littore. Il problema rappresentato dal fascismo è molto semplice, e, nella sua essenza, non è, a noi portoghesi, sconosciuto. Il popolo italiano – c’è da supporre che sia tale e non fascista o comunista – ha ricevuto qualche anno addietro, sul lato destro del viso, un ceffone dal comunismo. Il fascismo, per raddrizzarlo, gli ha dato un ceffone, leggermente più forte, sul lato sinistro. Non sappiamo, né abbiamo modo di sapere, se il popolo italiano gradisca di più essere rimasto diritto o nuovamente storto, o se preferisce gli svantaggi facciali del processo innescato. Ed è tutto da scoprire, riguardo a questa faccenda – dato che ogni nuovo ceffone, per raddrizzare le sorti, è sempre più forte di quello anteriore – in che momento è che termina la terapia equilibratrice, e in che stato si ritrovi l’equilibrato quando il Destino, alla fine, si stanca del trattamento. Whereof... Pubblicato in Fernando Pessoa, De República (1930-1935), Lisboa, Ática, 1979, pp. 357-358. *note e traduzione di A. C. 4) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 di Roberto Ciccarelli «O dio quell'immagine perché è falsa». Aimé Césaire, nell'ultimo atto della sua Tempesta, dramma shakespeariano che celebra la vittoria nella guerra civile anti-francese in Algeria, rompe il gioco degli specchi che lega il servo colonizzato Calibano a Prospero, il padrone colonizzatore. È il momento della catarsi in cui Calibano, il simbolo dei colonizzati e della negritudine, rifiuta di riconoscersi nel modello culturale europeo e impara a vivere sui margini senza vivere una vita marginale. Se è questa l'immagine che i colonizzati hanno elaborato durante la storia delle lotte anti-coloniali, meno chiara è l'immagine che i colonizzatori hanno creato per se stessi quando i complessi giochi di imitazione tra centro e periferia tra il XIX e il XX secolo hanno lasciato spazio alle più recenti pratiche neo-coloniali. Nel denso saggio iniziale pubblicato nel volume Atlantico periferico. Il postcolonialismo portoghese e il sistema mondiale (Diabasis, pp. 209, euro 13), il sociologo e teorico del diritto Bonaventura de Sousa Santos ricostruisce il percorso che tra il Brasile e l'Africa ha calibanizzato il Prospero portoghese esportandone la malinconia ancestrale, quella di non trovarsi mai a proprio agio nello spazio culturale stabilito dagli imperialismi vincenti. Il ciclo coloniale portoghese è stato il più lungo della storia europea, ha preceduto di tre secoli il colonialismo capitalista del XIX secolo. A differenza di quello anglo-sassone, che costituisce la norma fondamentale del colonialismo moderno, quello portoghese è fondato sullo squilibrio tra un eccesso di colonialismo e una mancanza di capitalismo. La perifericità di questo paese rispetto alla creazione del sistema-mondo è dovuta alla sua dipendenza rispetto all'Inghilterra al punto che, in alcuni momenti, il Portogallo è stato una colonia informale dell'impero britannico. Rispetto alla norma imposta dal colonialismo inglese, quello portoghese rappresenta il colonizzatore come un colonizzato, una rappresentazione che conferma la subalternità dei dominanti rispetto alla cultura imperialista egemonica. «Gli uomini portoghesi – scrisse Lord Byron – sono senza dubbio la razza più brutta d'Europa». Sentenza senza appello che spinse la cultura dei dominanti ad interiorizzare il razzismo anti-lusitano dell'imperialismo britannico. Il Prospero portoghese era caotico ed assenteista, crudele come i suoi cugini d'oltremanica, ma sempre più simile al Calibano che avrebbe dovuto dominare. Le «classi dirigenti» lusitane, subalterne alla cultura letteraria inglese di cui impararono lingua e costumi, interiorizzarono questa norma e, come ha mostrato Manoel De Oliveira in molti dei suoi film più glaciali e ironici, la trasformarono in farsa. Quando l'egemonia britannica declinò, lasciando a quella americana lo spazio per affermarsi nel sistema-mondo, Fernando Pessoa formulò il desiderio di un nuovo ruolo per la cultura nazionale portoghese. Nel suo contributo al libro Maria Ramalho ricorda come nell'immagine finale della prima poesia di Mensagem, pungente elegia della decadenza imperiale, Pessoa immagina il Portogallo come il «volto» dell'Europa che fissa la sponda statunitense al di là dell'Atlantico. In un frammento programmaticamente intitolato «Manifesto» il Portogallo viene celebrato in maniera paradossale: da un lato, esso rappresenta il «poter essere» di una cultura nazionale capace di guidare con la poesia la nuova missione civilizzatrice dell'Occidente e, dall'altro lato, è cosciente del sottosviluppo e la dipendenza, la decadenza e la futilità dell'impero portoghese. Periferia europea con diritto all'immaginazione del centro, sospesa tra l'ambizione di creare una nuova centralità della periferia e la realtà di una periferia atlantica sempre meno centrale, il Prospero calibanizzato portoghese vive in una misteriosa sospensione del tempo, o anacronia, che ha impregnato la socialità e l'identità tra colonizzati e colonizzatori durante il fascismo salazariano. La progressiva confusione tra l'identità del colonizzatore con quella del colonizzato venne definita «luso-tropicalismo» e diventò pane quotidiano per l'appetito identitario del regime che provò a ridurre l'indecisione originaria dell'identità portoghese all'apologia della cultura meticcia e fluida. Il meticciato è, al contrario, una merce simbolica il cui valore cambia in base all'esito delle lotte coloniali. Può essere lo stigma che perseguitò i colonizzatori portoghesi nei salotti europei, ma è anche lo strumento che giustifica la disuguaglianza sociale razzista. «È negro perché è povero», oppure «È povero perchè è negro», sono le frasi standard con le quali il discorso sul meticciato permette al colonialismo di negare la propria responsabilità nella produzione delle iniquità sociali tanto al centro, quanto nelle periferie. Forzati a giocare il gioco dei binarismi moderni, il Prospero portoghese confonde la linea del colore che rappresenta la soglia invalicabile che divide i dominanti dai subalterni per gli studi postcoloniali maturati in ambito anglosassone. Prima e dopo la decolonizzazione del 1974, questa identità vive a cavallo della linea, anche se non sa mai su quale lato si trova. Né Prospero, né Calibano, ma unione di contrari, a questa periferia atlantica resta la liminalità e la frontiera, l'inter-identità come identità originaria. ■ SAGGI ■ BONAVENTURA DE SOUSA SANTOS ■ Atlantico periferico Fernando Pessoa immagina il Portogallo come volto dell’Europa che fissa la sponda statunitense al di là dell’Atlantico, periferia europea con diritto all’immaginazione nuova centralità della periferia Le nuove guide. Sotto: Scorsese a Houston Street sul set di «Raging Bull» CULT INSOSTENIBILE LETALE RIVOLTANTE ■ GUIDE DI VIAGGIO ■ LONELY PLANET ■ SOPORIFERO COSI’ COSI’ BELLO Una New York d’autore di Luciano Del Sette MAGICO CLASSICO BURIED SEPOLTO DI RODRIGO CORTÉS; CON ROBERT PATERSON, RYAN REYNOLDS. SPAGNA 2010 0 Il camionista Paul si trova rinchiuso in una cassa di legno 3 metri sotto terra con in tasca un cellulare, un coltello e un accendino, e con questi oggetti deve cercare di liberarsi da una situazione di cui non ricorda assolutamente nulla. Produzione indipendente spagnola presentata con successo al Sundance. CATTIVISSIMO ME DI CHRIS RENAUD, PIERRE COFFIN, ANIMAZIONE. USA 2010 0 In un ridente quartiere fuori città si trova il rifugio segreto di Gru che con un esercito di schiavi progetta di rubare la luna. Ma i suoi piani cambiano quando tre orfanelle vedono il rcondato da steccati bianchi e cespugli di rose in fiore, sin lui un potenziale papà. Nella versione originale la voce di Gru è Steve Carell, nella versione italiana è doppiato da Max Giusti. MISS ADÈLE E L'ENIGMA DEL FARAONE DI LUC BESSON; CON GILLES LELLOUCHE, LOUISE BOURGOIN. FRANCIA 2010 0 1912. Mentre la crittrice di romanzi d’appendice Adèle Blanc-Sec si trova in Egitto per recuperare il sarcofago del medico di un faraone, nel frattempo Parigi è in preda al panico per uno pterodattilo uscito dal guscio nel museo di storia naturale più totale: l’ucello di 136 milioni di anni terrorizza la città. Dal fumetto Belle Époque di Jacques Tardi. IL RAGAZZO CHE ABITAVA IN FONDO AL MARE DI MARCO SANTOCCHIO; CON CRISTINA CAPPELLI, DANIELE FERRARI. ITALIA 2010 0 La giornalista Nicole riceve tre videocassette per posta. Non c’è il mittente ma capisce che si tratta di un video-diario che racconta gli ultimi giorni di vita di un ragazzo. Nicole comincia ad indagare. SEGUE A PAG 10 F acile profezia: il pubblico si dividerà tra entusiasti e scettici, progressisti e conservatori, partigiani sul fronte del sì e su quello del no. Succede quasi sempre al cospetto di una novità. Tanto più quando rompe una tradizione consolidata, quando irrompe in un mondo da decenni rassicurante. Quel mondo, nel caso specifico, è il mondo delle guide di viaggio. Anzi, delle guide di viaggio per eccellenza. Le più celebri. Le più vendute sul nostro pianeta. Le Lonely Planet, figlie, ormai più che trentenni, di Maureen e Tony Wheeler. Centinaia di titoli che continuano a fare da bussola, tutto sommato ancora abbastanza precisa, ai vacanzieri autogestiti di ogni nazione. La novità, che fa la sua comparsa sul mercato italiano in questo mese di ottobre, è una collana parallela, rivolta, almeno per ora, esclusivamente alle grandi città. Si chiama «Itinerari d’autore» e con le Lonely Planet classiche ha in comune soltanto il marchio, chiuso in un rettangolo blu, in alto a sinistra sulla copertina. Per il resto, dimenticate l’impaginazione spartana come le cartine in bianco e nero, i lunghi e minuziosi elenchi di alberghi e ristoranti, le centinaia di informazioni pratiche, le descrizioni fitte dei luoghi e degli spostamenti, cui da sempre vi hanno abituato le Lonely. In questa collana si respira, appunto, aria d’autore, sia nei testi che nell’iconografia. L’idea, nata dall’accordo con l’editore franco-belga Casterman, Groupe Flammarion, autorità indiscussa nel campo del fumetto (pubblica, tra gli altri, Tintin e Corto Maltese) è quella di proporre, con occhi particolarmente attenti al pubblico più giovane, una serie di manuali di viaggio urbano agili ed eleganti, divisi per itinerari scritti dagli autori delle guide tradizionali e raccontati attraverso le immagini di grandi firme dell’illustrazione e della strip. Carta patinata ma non troppo, grafica impeccabile e accattivante, precise mappe a colori, fanno il resto. L’idea è piaciuta alla Edt di Torino, che traduce e pubblica in Italia le Lonely, e anche in questo caso l’accordo è stato raggiunto. Tra ottobre e novembre usciranno sul nostro mercato New York, Bruxelles, Roma, Marrakech, Firenze, città fortemente evocative, in grado di offrire al turista percorsi fuori dall’ordinario, amplificati dai colori e dalle atmosfere dei disegni. Prendiamo, allora, la guida di New York e apriamola, immaginando la bocca dei ‘lonelisty’ conservatori atteggiarsi a una smorfia di sdegno, e quella dei ‘lonelisty’ progressisti spalancarsi in un sorriso a trentadue denti. Le pagine, circa 180, portano la firma di Vincent Rea per i testi, e di Myles Hayman per le illustrazioni. Il primo ha lavorato a lungo come caposervizio della rivista Geo ed è oggi giornalista free lance; il secondo ha lavorato con molti quotidiani americani e vari edito- Esce in edizione italiana (Edt) una nuova collana con il marchio «Lonely Planet», dedicata alle grandi città, eleganti manuali di viaggio illustrati da grandi firme: New York, Bruxelles, Roma, Marrakech, Firenze ri di libri. Che la parte visiva reciti, ma senza arroganza, la parte del leone, si capisce fin dalle otto pagine introduttive, dove ciò che nella Grande Mela non bisogna perdere (i panorami, la città nei film, la cucina, i musei, le atmosfere di strada…) è proposto da un’illustrazione sotto la quale sono allineate brevi didascalie. Ognuno dei dieci itinerari è introdotto da una tavola su doppia pagina. La mano di Hayman, lungo tutto il percorso della guida, lascia un’impronta splendida; il suo occhio sa catturare e restituire alla mano il dettaglio e l’insieme, differenziando le atmosfere senza rinunciare mai all’unità e alla coerenza dello stile. E questo si apprezza ancor di più nell’iconografia di minori dimensioni che accompagna il testo: i ritratti di attori e registi sui luoghi dei loro film; gli artisti, i bar, i mercati, la musica dell’East Side; la gente, presenza forte in ciascuno di dieci itinerari, che costruisce il babelico melting pot di Ny; il viaggio in bus attraverso Brooklyn, o in treno lungo il corso del fiume Hudson. Le facce, le case, i grattacieli, i marciapiedi, i monumenti, il verde, le strade, gli interni dei bar, le barche, le auto, pur essendo interpretazioni nate dalla sensibilità di Hyaman, infondono la certezza che li incontreremo camminando, e non saranno molto diversi da come ci appaiono sulla carta prima di partire, mentre stiamo ancora sognando. Adesso la parola passa ai testi di Vincent Rea, cui va riconosciuto il merito di essere riuscito a conciliare molto bene le misure «strette» con la qualità dei contenuti. Detto ciò, occorre lanciare un avvertimento: chi cerca una guida approfondita e minuziosa, certamente non la troverà nel lavoro di Rea. Gli intenti della collana sono altri e di- versi: offrire spunti curiosi, notizie particolari, chiavi di lettura delle realtà, giochi di temi e connessioni, a chi (soprattutto i giovani citati all’inizio) vuole vivere un viaggio a New York con intelligente leggerezza, stimolato alla scoperta personale da segnali e suggerimenti scelti con molta cura. A chiusura del volume, il repertorio informativo. Riguarda solamente, altro segnale preciso di differenza dalle Lonely storiche, notizie su visto, valuta, cambio, fuso orario, mance, e quant’altro; indirizzi e orari dei luoghi da visitare; microschede su ristoranti, locali, negozi dello shopping, per ciascun itinerario. A completamento, un breve capitolo dedicato ai voli internazionali e ai mezzi di trasporto locali. Promette bene, per le pagine che abbiamo potuto vedere, Bruxelles, titolo che conferma il successo turistico crescente di una città fino a pochi anni fa considerata noiosa e senza attrattive. Promettono bene i disegni a proposito di Marrakech, mondo magnifico nonostante la barbarica invasione degli stilisti e delle Marte Marzotte. La sfida vera, in Italia, arriverà, però, dalle guide dedicate a Firenze e Roma. Le firme hanno nomi stranieri, questo sì come da tradizione Lonely. Se testi e disegni non saranno all’altezza delle attese, chi potrà impedire ai ‘lonelisty’ conservatori di sfoderare un sorriso beffardo, accompagnato da un «Ve lo avevo detto!», pronunciato neppure troppo a bassa voce? ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (5 Una cooperativa per l’affitto delle biciclette, due palazzine trasformate in altrettante comuni, un mercatino per distribuire, una volta alla settimana, la frutta e verdura coltivata negli orti creati sui tetti e curati dagli inquilini di un grande palazzo. O addirittura i commessi messi in comune tra panettieri, drogherie e lavanderie. Se il comunismo è morto, il collettivismo pare invece godere di ottima salute. Quantomeno per le vie di Bushwick, uno dei tanti quartieri di Brooklyn, dove da qualche tempo è scoppiata la moda di distribuire e condividere proprietà, servizi e consumi. Dalla spesa, garantita dagli anarchici di «Food not Bomb», fino alla pulizia di materassi e divani alla caccia delle «bed bugs», le terribili cimici che dall’anno scorso hanno invaso New York. Certo, stiamo parlando di un luogo molto particolare, diventato in poco tempo un rifugio per i giovani scacciati dagli affitti stellari di Manhattan o di Williamsburg (un’altra zona di Brooklyn, ormai troppo «in», e quindi carissima), dove fioriscono gli studi, anche loro collettivi, di pittori o di gruppi musicali. Ma in realtà non è detto che l’esperimento sia poi così isolato. Ne’ negli Stati uniti ne’ in tante altre parti del mondo, come raccontano Rachel Botsman e Roo Rogers nel loro What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption, ovvero «Ciò che è mio è tuo, la crescita del consumo cooperativo». Appena uscito nelle librerie di New York, il libro analizza per l’appunto il crescere delle cooperative di consumo e di quelle di produzione, sostenendo, con un tocco di ottimismo, che questo potrebbe essere il futuro che ci aspetta. Per rispondere alla crisi economica che continua a divampare, ma anche per scoprire un modo per usare, non solo per giocarci, il grande boom dei social network. Perché, dice Rachel Botsman, «Facebook e le bancarelle dei piccoli coltivatori hanno molto in comune, entrambi raccontano la riscoperta della vita comunitaria, nel mondo virtuale e in quello reale». Anzi l’uno può aiutare concretamente l’altro. Visto che tanti piccoli produttori, di cibo ma perché no anche di oggetti e tessuti artigianali come quelli targati Etsy Lab (siamo di nuovo a Brooklyn, questa volta a Dumbo forse il più trendy dei quartieri newyorkesi), vivono e sopravvivono spesso proprio grazie all’esistenza della rete. La passione per la vita comunitaria, quantomeno negli Usa, non è una novità. Anche se noi continuiamo troppo spesso a vedere l’America solo come la patria dell’individualismo, qui il condividere buona parte della vita quotidiana e l’associarsi è una realtà che esiste da tempo, cresciuta lungo tutto il ‘900. E se dieci anni fa, nel suo «Bowling alone», il sociologo Robert Putnam lamentava la crisi di quelle strutture collettive, e paventava addirittura la fine di quello che lui chiamava il «capitale sociale», i fatti lo hanno poi smentito. Costringendolo a tornare sui suoi passi in un altro libro, Better together, proprio perché attorno a lui in realtà stavavano crescendo le nuove, oggi sia reali che virtuali, comunità americane. 6) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 Un freelance davvero free: faceva il muratore per finanziare una rivista di filosofia e diventò editore, non era giornalista professionista e arrivava dove erano in atto feroci genocidi senza partecipare ai viaggi organizzati della stampa di guerra, ma facendosi ospitare dalla gente del posto. La sua morte resta misteriosa di Ada Pagliarulo e Paolo Martini * L o hanno trovato sul ciglio di una strada, a pochi chilometri da Tbilisi, con il torace fracassato. Antonio Russo, quarant’anni, inviato di Radio Radicale, si trovava in Georgia per tentare di documentare la guerra dei russi contro la Cecenia, dove era già stato l’anno prima. Questa volta non era riuscito ad arrivare sui luoghi del conflitto: aveva tentato più di una volta di raggiungerli, utilizzando una rete di contatti tra i guerriglieri ceceni, ma il controllo era diventato ormai serratissimo. Spariti computer e telefonino. Pare abbia dato a qualcuno di cui si fidava nuovo materiale su quella guerra. Nelle sue intenzioni, quella documentazione avrebbe dovuto comporsi in un dossier da consegnare nelle mani dell’alto commissario Onu per i diritti umani, Mary Robinson. Antonio non piaceva ai russi, irritati per l’ingerenza nei loro affari interni di tutti quei rompiballe collegati ai radicali, che erano arrivati addirittura a far parlare, dalla Commissione diritti umani a Ginevra, un parlamentare ceceno. Antonio era lì perchè non era tipo da scrivania. Dopo due o tre mesi di vita cittadina, scalpitava per andare altrove. Era sempre di passaggio. In Ruanda e Burundi durante i massacri hutu e tutsi; in Algeria, quando uomini, donne e bambine venivano sgozzati; a Sarajevo, quando i cecchini freddavano i civili al mercato. Mai un recapito telefonico d’albergo. Ha sempre scelto di mescolarsi. «Sono a casa di amici, mi ospitano finchè possono». A volte al buio, come accadde a Prishtina: in tutto il Kossovo non c’era più un solo giornalista occidentale. Si era nascosto in una casa privata: i serbi sapevano di lui, ma non riuscivano a trovarlo. Tra un rastrellamento e l’altro, riuscì a scappare mescolandosi a una colonna di profughi kossovari, saltò su un treno e arrivò in Macedonia. Ma per lui, quella non poteva restare soltanto un’esperienza professionale: non ha mai voluto vendere il materiale che aveva raccolto e consegnato al Tribunale ad hoc sulla ex-Jugoslavia, per documentare la pulizia etnica dei generali di Milosevic. Antonio Russo non apparteneva all’ordine dei giornalisti: era un free-lance. Molto free. Il suo linguaggio scarno e crudo lo teneva lontano da ogni compiacimento: non c’era alchimia, non c’era narcisismo. Orgoglio sì, e tanto. «Senti, Mentana, adesso m’hai rotto il cazzo!. Pronunciò questa frase il giorno che era circondato dai cronisti di mezzo mondo che gli chiedevano, a Skopje, l’ennesimo racconto di quella fuga «rocambolesca» – così scrivevano - da Prishtina. C’era poco di rocambolesco, aveva paura e basta. La sera prima di sparire sul treno aveva parlato in diretta alla radio per due ore. E aveva esordito così: «qui è un casino». Non gli piace- ■ ANNIVERSARI ■ A DIECI ANNI DALLA MORTE ■ Un silenzio assordante vano gli alberghi internazionali per cronisti. Li considerava parte di una specie di circuito turistico ad hoc dedicato alla stampa di guerra. Antonio li chiamava «i viaggi organizzati». Lui cercava una casa per ospitare amici, gente del posto che fosse disposta a raccontare. Per loro e con loro cucinava e beveva. «Na sdarovie», alla salute di quei disperati. A Prishtina è stato così, a Tblisi era così. Cercava di sbarazzarsi al più presto degli interpreti e dell’inglese standard da inviato, per assimilare e assimilarsi agli interlocutori del luogo. I «grandi» cronisti storcevano il naso ascoltando il suo raccontare naif, e alzavano le sopracciglia ostentando perplessità sulle sue «fonti». Ma è al «gazetari italian Antonio Russo» e alla sua morte che il quotidiano kossovaro Koha Ditore ha subito dedicato un articolo. Con foto di lui, felice di essere al centro della polveriera, accanto a un kossovaro in divisa. I due si guardano negli occhi, confusi tra una folla di profughi. Il «gazetari» ride, la distanza è annullata. Lui era stato capace, la notte del capodanno 2000, di raccontare i festeggiamenti da un villaggio al confine tra la Georgia e la Cecenia, nell’area di Pankisi. Il capodanno dal Caucaso, con tre ore di anticipo rispetto al nostro. Non era uno scoop particolare, ma in radio «funzionò» meglio di qualsiasi altra trasmissione fatta da Radio Radicale a quell’ora. Quando tornò dal Kossovo, gli chiesero di scrivere un libro. Lo fece, ma non sappiamo cosa ne sia stato. Volevano girare un film su di lui, e un giorno arrivò in radio un tale con un soggetto scritto - disse - «da un certo Aurelio Grimaldi». Era esattamente come uno si aspetta che sia un film di Grimaldi: un cronista che ha visto gli orrori delle guerre, che si ubriaca e chiama di notte la sua compagna dicendo: «stanotte voglio scopare». Più o meno così. Non crediamo che Antonio si riconoscesse nel personaggio. Chissà se nel film ci sarà la storia dell’anellone che aveva al dito, quello che fu costretto a tagliare al ritorno dalla Bosnia. Una ferita da nulla, che non aveva potuto mai disinfettare a fondo, gli aveva provocato una infezione sotto l’anello. Non riusciva più a sfilarlo. «L’ho segato via», disse. Si è invece sempre rifiutato di tagliare il lungo codino un pò fuori moda che gli scendeva sulle spalle. E che lo rendeva così pericolosamente riconoscibile. «Antò, mo che torni in Cecenia tagliati quel codino…». Tre, quattro, cinque premi: giornalista dell’anno a Ischia, premio Andrea Barbato, premio Ilaria Alpi. Spesso preferiva far parlare le fotografie, le riprese amatoriali che poi faceva circolare in Rete. Era l’evidenza cruda della guerra in Cecenia: prove, andava alla ricerca delle prove di un genocidio quando ancora le cronache dei giornali parlavano solo di «ceceni mafiosi». Che il suo omicidio abbia ragioni politiche è probabile. Ma certa è la determinazione con cui ha inseguito, cercato le notizie in situazioni di totale, assoluto e controllato black-out dell’informazione. Dove cercarle imponeva il contatto con persone che avrebbero messo a rischio la sua incolumità. Paesi in cui chi ti fa fuori è sicuro che non sarà facile capire se sei stato ammazzato per i dollari che hai in tasca o per quello che hai visto e raccontato. * www.radioradicale.it/ antonio-russo/ common license UN REPORTER Chi era Antonio Russo? Cosa è rimasto di lui nella memoria del nostro Paese? Probabilmente poco. Era un giornalista. Un reporter. Ucciso mentre svolgeva il proprio lavoro in Cecenia, dieci anni fa. Vale per lui l’assurdo adagio del nemo propheta in patria. Era inviato di Radio radicale. I suoi reportage erano scomodi. Tutti i paesi occidentali, avevano interesse a coprire i crimini del potere russo. Un potere che ha un triste primato: duecento giornalisti uccisi. È lungo l’elenco dei nomi. Nell’elenco non compare mai lui. Eppure fu il primo a denunciare quei crimini. In Italia, poi, il silenzio nei suoi confronti è assordante. Fa male sapere che mentre il suo Paese lo dimentica, a Washington è stato premiato con il titolo di eroe di guerra. Un’onorificenza conferita a pochissimi giornalisti. (c.a.) aveva scoperto. Io certamente non ti so dire di chi possa essere la responsabilità della sua morte. Ognuno ha la sua versione e credo che il film abbia fatto bene a lasciare una serie di dubbi che possono essere legati a tante situazioni. Il film non ha scavato neppure nella cronaca spicciola delle ultime ore. Perché troppe cose mancano nel film. Dalla telefonata a sua madre a tantissime altre, che sono successe poco prima che lui morisse. di Carmelo Albanese I l film su Antonio Russo, con la sceneggiatura di Aurelio Grimaldi e con Gian Marco Tognazzi nel ruolo principale, si fece. Cecenia è il titolo. Dire che sia stato ignorato dalla distribuzione è dir poco. Non bisognava parlare di lui. Non era tanto importante come se ne sarebbe parlato. Non bisognava parlarne, punto. Il film provò a rompere il silenzio. Ne venne realizzato anche un altro sulla morte di Antonio. Il titolo è significativo: L’inquilino di via Shevarnadze. Dal nome della via dove si trovava la casa di Antonio e dove andarono ad ucciderlo. Ignorato anche questo film. Facciamo a Gian Marco Tognazzi alcune domande sul film Cecenia e su Antonio Russo Perché hai scelto di rappresentare Antonio? Mi sono innamorato letteralmente di Antonio. Ho cercato tutti i video in cui compariva. Ho visto le sue fotografie. Ho sentito i racconti di chi lo conosceva. Ho ■ INTERVISTA ■ GIAN MARCO TOGNAZZI ■ Il film vietato a tutti L’attore ci parla di «Cecenia» il film di Antonello Grimaldi da lui interpretato boicottato dalla distribuzione. Ci parla anche di memoria e di cultura che nel nostro paese pare siano estremamente sconvenienti ascoltato praticamente tutte le sue testimonianze per radio radicale che inviava dai territori di guerra. Ho studiato moltissimo per rappresentarlo al meglio. Antonio Russo era un uomo molto particolare. Non era un giornalista nel senso canonico…Era unico e irripetibile proprio perché era un autodidatta. Perché era uno che faceva il muratore per mantenere una rivista di filosofia. Era un uomo che non incontri facilmente in giro per strada. Un uomo con una sensibilità quadrupla, quintupla. Maschile e femminile allo stesso tempo. Testardo, da buon abruzzese quale era. Poi era uno che si faceva deportare per testimoniare la deportazione dall’interno. Non è un caso che è uno degli unici ad avere il riconoscimento a Washington come eroe di guerra. Ci sarà un motivo no? A Washington è ricordato, ma in Italia no. In Italia essere profeti in patria è quasi impossibile. Anche perché c’è questo atteggiamento di vergogna nei confronti del nazionalismo che io proprio non capisco. Come se fosse una vergogna o fosse indice di appartenenza ad uno schieramento politico di un certo tipo, rivendicare l’appartenenza al proprio paese. Ti sei fatto un’idea su chi possa essere stato ad uccidere Antonio? La realtà dei fatti non la sa nessuno. O meglio sicuramente qualcuno la sa. Però non è detto che la sappiano in Italia, non è detto che la sappiano tutta e non è detto che tutto venga detto…il fatto che sia stato trovato morto a seicento metri da un check point russo, non vuol dire nulla. Può essere stato tradito dai ceceni stessi, dai partigiani. Può essere stato vittima di un problema internazionale tra Italia e Russia. È vero però, che gli era stata promessa la morte in un congresso. Lì, gli era stata già comunicata la sentenza di morte. Gli era stato detto «non ti ripresentare che la prossima volta non te ne vai». Può essere legato a quello che Quanto pensi che farebbe bene, al nostro paese, il ricordo di Antonio Russo? Secondo me fa bene tutto quello che è memoria, fa bene tutto quello che è cultura, Anche se ormai queste due parole vengono demonizzate. In questo siamo ridicoli. Potrebbe essere la soluzione economica per il nostro paese. Abbiamo il 70 per cento del patrimonio culturale del mondo. È come avere il 70 per cento del petrolio…Io non credo che chi ha il 70 per cento di una ricchezza possa basare la sua economia su qualcos’altro. Noi dovremmo puntare tutto sulla memoria…Vale per la scienza, per il cinema, per il giornalismo, per i reporter, per Antonio Russo…Quando ci fu quella polemica con me per il fatto di mio padre. Se era ricordato, se non era ricordato. Tutti pensarono che era un fatto personale. È chiaro, era mio padre, stava a casa mia. Poi ti accorgi però che non è un fatto singolo. È un atteggiamento generico, di mancanza di riconoscimento per la propria storia…Perché il fatto di non avere un ricordo di quanto di buono si è fatto nel tuo Paese è deprimente. Non solo per Antonio Russo, ma proprio in generale. Quando Ada Pagliarulo e Paolo Martini scrivono che Antonio Russo era un free-lance molto free, colgono un punto centrale della sua personalità. Il suo impegno civile e la sua passione politica precedono e accompagnano il suo lavoro di giornalista. Durante il 1990 partecipò al movimento studentesco della Pantera, contrastando le politiche liberiste che si stavano affermando dopo il crollo del muro. L’ingresso dei privati nelle università e la mortificazione del diritto allo studio. Antonio Russo (terzo da sinistra) in cattedra all’Università nei giorni della Pantera LA MEMORIA «…Le testimonianze dei miei reportage radiofonici sono state conservate nell’archivio della radio e sono state anche trasferite via Web. Questo è a mio avviso importante per due motivi. Il primo consiste nel fatto che bisogna comunque possedere una memoria storica. Questo è un dato che un po’ la tecnologia trascura. L’informazione valida è quella che abbia la possibilità di essere reperita storicamente. «Laudatur tempores acti» diceva Dante, si lodino i tempi passati, in quanto ‘exempla’ di un’esperienza. Gli esempi storici si traducono nella capacità di analizzare il presente e prevedere il futuro con un fondamento abbastanza solido…» «In secondo luogo penso che la quotidianità dell’informazione che ha luogo attraverso la testimonianza diretta abbia un valore perché fa capire cosa realmente è in atto. C’è ancora parecchia confusione sull’informazione che stiamo portando avanti sul Kossovo. La possibilità di reperire i miei reportage e risentirli via Web aiuta la gente ad avere un’immagine più precisa degli eventi in corso. Fondamentalmente noi dobbiamo ricordarci che l’informazione è un veicolo diretto all’utente, non è un soliloquio da parte del giornalista. Bisogna tenere sempre presente che chi è dall’altra parte del microfono deve poter comprendere una realtà in cui non è presente. Questo, penso, è il massimo sforzo che i giornalisti devono compiere». (Antonio Russo) Quando vennero disoccupate le facoltà, continuò il suo impegno politico. Fondò una casa editrice «Antonio Russo editore», che pubblicò diversi volumi. In uno Lineamenti di una teoria dell’etnocidio di Rodolfo Calpini, cominciò ad interessarsi alle tematiche del genocidio. Il tema dei genocidi divenne il suo interesse principale. Appena sentiva di un luogo del mondo dove un intero popolo rischiava di essere sterminato da nuove forme di imperialismo, si precipitava lì. Aveva bisogno di raccontare. Non importava il rischio. Prendeva la telecamera e partiva. Se nessun media gli dava spazio, era pronto a mettere le sue testimonianze, scritte, parlate, o video, sulla rete. Anche in questo era un antesignano. Nell’uso giornalistico della rete. Nel 1998 non c’erano i social network per come oggi li conosciamo. Tutto era straordinariamente nuovo. Lui però ne aveva già recepito l’importanza. Aveva messo in pratica un altro tema del movimento studentesco cui aveva partecipato. La possibilità di utilizzare la rete come libero mezzo di divulgazione delle notizie. ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (7 ■ DISINTERMEDIARE LA CULTURA ■ Faremo senza copyright di Alessandro Delfanti L a Sgae o Sociedad General de Autores y Editores è l'equivalente spagnolo della Siae, la Società Italiana Autori ed Editori. Mentre eXgae, come dice il nome, è un gruppo basato a Barcellona che lotta contro l'entità che gestisce i diritti d'autore e ne chiede la chiusura o quantomeno una riforma radicale. eXgae è uno degli esperimenti più avanzati del fronte per la liberazione della produzione culturale dai lacci imposti dal copyright, che sostieQuando è nata eXgae e da ne le grandi aziende e i dinosauri chi è formata? della cultura alla faccia delle traeXgae è nata nel 2008 e ha una sformazioni causate dall'avvento struttura completamente rizomatidi Internet. Poche settimane fa la ca: non c’è un inizio o una fine. Sgae ha fatto pervenire a eXgae C’è invece un nucleo di affinità, un una lettera in cui intimava di non gruppo di persone a Barcellona usare più quel nome (che richiache però lavora costantemente in ma troppo da vicino il loro) e di rete con altri gruppi e singoli. Abcessare le sue attività. Simona Lebiamo reti molto grandi sia a Mavi vive a Barcellona ed è una delle drid che in generale in Spagna. principali animatrici di eXgae. Le Barcellona rappresenta solo il 25 abbiamo chiesto di spiegarci cosa per cento di eXgae. La rete è formafa eXgae, quali saranno le conseta sia da artisti che da hacker, proguenze di un'eventuale causa fessori, persone che hanno negozi contro di loro, e cosa accadrà se e di informatica, e gestori di spazi quando (perlomeno in Spagna) viculturali che pagano canoni per la vremo in un mondo ex-Sgae. diffusione di musica. Per questo 8) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 eXgae è un gruppo spagnolo che lotta contro la Sgae, la Siae iberica, per un’arte libera e aggiornata alle dinamiche di Internet. Intervista con Simona Levi abbiamo i piedi per terra, dobbiamo rispondere a bisogni reali di chi fa cultura, suona, scrive o semplicemente vuole trasmettere musica nel suo bar e non vuole più sottostare alle gabelle della Sgae. Perché avete scelto la Sgae come bersaglio? La Sgae è il «braccio armato» dell’industria discografica e finanzia le lobby più retrograde della produzione culturale. In un anno la società ha ricevuto 164 milioni di euro che poi non ha ridistribuito. Pigliano i soldi da chi non è iscritto e non li restituiscono. Scrivono il tuo nome sbagliato e i tuoi soldi spariscono... Qali sono l vostre attività principali? L’idea principale è che è molto facile vivere senza Sgae, basta cambiare le proprie abitudini. Ci sono cittadini che hanno bisogno di strumenti per risolvere problemi legati a Internet e alla proprietà intellettuale, e noi cerchiamo di consigliarli. Se invece c’è bisogno di un avvocato, invitiamo le persone a rivolgersi a legali esterni, che non sono legati a noi. Facciamo in media 1.400 consulenze all'anno e di queste solo una ventina hanno davvero bisogno di avvocati. La nostra pagina web ha 10.000 visite al mese e lì si possono trovare tutti gli strumenti legali per emanci- parsi dalla Sgae. Perché in realtà la produzione di cultura senza bisogno di un intermediario è facile, può farlo chiunque. Per esempio? Per esempio, se sei un artista o hai una sala che fa concerti, il contratto per un concerto solitamente recita: «i diritti d'autore saranno liquidati attraverso la corrispondente entità di gestione» ma in realtà questo non è obbligatorio e si fa solo per un’abitudine sbagliata. Inoltre spesso gli artisti non sono iscritti: sono solo soldi regalati alla Sgae. E poi quando un agente Sgae entra in un bar la gente si spaventa perché pensa sia un poliziotto, invece è un agente di una compagnia privata e non è obbligatorio firmare nulla... Noi suggeriamo soluzioni diverse per i contratti e suggeriamo per esempio di mettere musica copyleft, non soggetta a Sgae. Infine cerchiamo di analizzare la situazione legale e facciamo proposte per l’era digitale. Siamo una specie di think tank su questi temi, come nel caso del Forum della cultura libera che si terrà a Barcellona dal 28 al 31 ottobre (articolo a fianco). Come vedete il vostro ruolo negli scontri sul copyright? L’EVENTO Per noi, in fondo, si tratta di «normalizzare» la situazione. Nel paradigma digitale in cui viviamo grazie a Internet, produttore e consumatore si confondono e condividere liberamente cultura (per esempio scaricando e diffondendo film e musica) è semplicemente la norma. Ma dal punto di vista legale vige ancora il vecchio paradigma, mentre noi invece facciamo eventi per normalizzare la cultura (come gli oXcars, il gran galà della cultura libera e no-copyright che si terrà il 28 ottobre durante il Forum della Cultura Libera) secondo i canoni del mondo in cui tutti noi viviamo. Fate anche azioni diverse da quelle legali? Facciamo comunicazione, video, grafiche anonime... aiutiamo i movimenti con una produzione artistica virale che permette loro di manifestarsi in forma pubblica. Il ministro della Cultura Cesar Antonio Molina ha fatto entrare le società di gestione a parlare di pirateria nelle scuole materne, per cui il 19 gennaio 2009 abbiamo lanciato il concorso Molina Pirate (gioco di parole tra «pirata» e «vattene» in spagnolo, ndr.) in cui bisognava trovare uno slogan per mandarlo via. Da questa campagna è nato un video e dopo un mese Molina in un rimpasto di governo è sparito. Quale sarà l’effetto della lettera degli avvocati della Sgae? Vi aspettate un processo? Ci basiamo sulla frase di Gandhi: prima ti ignorano, poi ridono di te, poi ti attaccano, poi tu vinci. Dopo che il nostro sito, grazie a loro, ha avuto 110.000 visite in un giorno... pensiamo che il loro atteggiamento sia cambiato. Noi abbiamo sem- Perché nessuna forza politica propone una seria riforma di quelle agenzie? Purtroppo in Spagna tutti odiano la Sgae ma c’è un tabù per la sinistra a opporvisi seriamente, anche se sappiamo che dietro le quinte lo fanno. La Sgae infatti è appoggiata da molti artisti importanti legati alla fine della dittatura. A destra invece non c’è questo problema, e il Partido Popular è più veloce e intelligente su questi temi e tende un po’ a capitalizzare il nostro lavoro. Spesso dicono: «Visto? È una lotta di destra», e noi dobbiamo continuare a ripetere che siamo di sinistra, così come gli artisti che ci appoggiano. Come immaginate il futuro? Io vorrei fosse senza Sgae. Però siamo disposti anche (se ci fosse una riforma seria) a prevedere una Sgae come ente privato che un artista può contattare se ha molti introiti, che si occupa dei suoi iscritti ma non di altri diritti obbligatori. Un di Bruno Di Marino Ramblas del Copyleft pre invitato la Sgae a tutti i dibattiti, siamo sempre stati disposti a lavorare dialetticamente con tutti, ma loro non sono mai venuti e non hanno mai risposto. Comunque se decideranno di farci la guerra non faranno altro che accelerare la loro scomparsa. La società civile stavolta non li appoggerà. Nessuno ci considera malvagi, abbiamo appoggi politici, mentre loro stanno usando il copyright come mezzo contro la libertà di espressione. di A. D. P ente privato in cui non sono rappresentati autori ed editori insieme. Oggi sfruttato e sfruttatore sono rappresentati dallo stesso cartello e questo non ha senso. Cosa diresti a un artista o una band che vuole iscriversi alla Siae? In certe situazioni lavorative è impossibile non essere soci di un’entità di gestione (per esempio per chi lavora in Tv). Infatti i precari dell'industria culturale sono pagati solo via royalties, ed eliminarle sarebbe un duro colpo per loro. Però li invitiamo a essere sempre padroni della propria vita: se non è necessario che qualcuno gestisca le tue cose, se suoni live o se distribuisci la tua musica online, la Siae non ti serve. Ma se devi essere dentro al sistema almeno cerca di aiutarci a cambiarlo da dentro. www.effecinque.org er il secondo anno consecutivo a Barcellona dal 28 al 31 ottobre si terrà il Forum della Cultura Libera organizzato da eXgae. L'anno scorso le decine di attivisti anticopyright, hacker, ricercatori e associazioni per la cultura libera che hanno partecipato al forum hanno scritto insieme la Carta di Barcellona, un manifesto della cultura libera che fissa le principali richieste per un'industria finalmente adatta alle trasformazioni che la creazione e l’utilizzo di contenuti hanno attraversato con l'avvento di Internet. Quest'anno il tema è invece l'economia della cultura libera. Come far crescere e difendere dalle lobby della proprietà intellettuale i nuovi scenari, anche di business, che stanno emergendo dal web? La risposta del Forum verrà condensata in una guida, un «manuale per la sostenibilità dei nuovi modelli economici nell'era digitale». Basandosi sugli esempi forniti dal free software, dalle tecnologie peer-to-peer e su un diverso modello di giustizia legato alla circolazione dei saperi, a Barcellona verranno proposte forme di reddito per i lavoratori creativi che siano slegate dal «modello unico» rappresentato dal diritto d'autore. Al centro dell'incontro ci saranno sia le questioni legate alle infrastrutture tecnologiche necessarie per la creazione di cultura in rete, sia i problemi politici e legali che dovremo affrontare per favorirne la crescita. La lista degli invitati è impressionante. Si va da Nick Ashton-Hart, direttore della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'istituzione che gestisce i domini internet e assegna i nomi dei siti a Eddan Katz della Electronic Frontier Foundation, da sempre in prima linea in difesa dei diritti dei netizens, i cittadini della rete. Ci saranno Michel Bauwens della Peer to Peer Foundation con le sue idee di estensione del modello peer-to-peer alla produzione collaborativa online e offline; e Magnus Eriksson, uno dei membri del Pirate Bureau, il think tank della pirateria legato al Pirate Party svedese; ma anche Benjamin Mako Hill, hacker famoso e teorico del free software. Parteciperà pure Yann Moulier Boutang, economista francese noto per i suoi saggi sul capitalismo cognitivo e per essere una delle menti dietro al nuovo partito verde di Cohn-Bendit. Insieme a loro decine di artisti, produttori e attivisti da tutto il mondo si riuniranno per immaginare un mondo in cui la produzione di cultura in forma libera venga riconosciuta come un modello sostenibile e proficuo. Questo non avverrà senza abbattere almeno in parte le recinzioni alla circolazione di saperi e informazioni costruite tramite il diritto d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale. Il programma sarà diviso in diverse parti. Ci saranno per esempio discussioni sull'uso di strumenti open nel settore pubblico, contro il dazio pagato alle multinazionali del software. Una sessione sarà dedicata a fornire strumenti a chi vuole partecipare alla riforma del sistema e vuole saperne di più sul «come sì» invece che sul «perché no». La relazione tra cittadini e legislatori è modificata dalla rete, e nuovi soggetti possono partecipare direttamente a una riforma. Per esempio associazioni e attivisti possono usare gli strumenti di comunicazione e sfruttare il fatto che i processi legislativi sono sempre più spesso disponibili in rete e trasparenti per fare crowdsourcing: spingere masse di cittadini a sviluppare soluzioni legislative collaborando in rete e quindi influenzando l'agenda dei politici. Le sessioni sulla sostenibilità dei modelli open saranno divise tra la presentazione di progetti concreti e la discussione della cornice economica e politica in cui questi possono crescere e mettere radici. Invece del modello copyright, che nutre le grandi industrie culturali monopolistiche ma taglia fuori microimprese e agenti autonomi, si discuteranno modelli aperti e misti, in cui le royalties non sono l'unica forma di guadagno di un artista o di una persona che produce cultura. I costi di produzione e distribuzione dell'informazione sono scesi drasticamente – ognuno può girare, montare e distribuire un film se ha una telecamera, un computer e un accesso a Internet. Gli intermediari rappresentati da agenti e case di produzione – per tacere delle società di gestione del diritto d'autore, vedi l'intervista a fianco – non sono più indispensabili e fondano la loro esistenza su un modello vecchio perlomeno di vent'anni. UMBRELLA BEACH Usa, 2010, 3’30”, musica: Owl City, regia: Alexander Brown, fonte: MTV Brand New 7 L’ ambientazione è un paese sulla costa. Un ragazzino, che ha la verve del geniale inventore, costruisce una macchina volante con la quale si appresta a lanciarsi dalla scogliera. Seguiamo le fasi di progettazione e di assemblaggio dei vari materiali, in montaggio alternato con la solitudine di una donna dentro la sua casa che ripete catatonicamente gli stessi gesti e con un uomo che, sul tetto di una casa, scruta l’orizzonte con il suo cannocchiale. Cosa è successo? Il ragazzo si è schiantato con il suo artigianale velivolo gettando nella disperazione e nella follia il padre e la madre (ipotesi realista), oppure ha effettivamente spiccato il volo sparendo per sempre e i genitori attendono il suo ritorno (ipotesi surreale)? In entrambi i casi le immagini del giovane protagonista sono flash-back rievocati dagli adulti. Sta al pubblico interpretarli. Videoclip di discreta fattura, Umbrella Beach è tratto dall’album Oceaneyes, come l’altro singolo Fireflies, forse più originale. ÇA M’ENERVE Francia, 2009, 5’, musica: Helmut Fritz, regia: autore ignoto, fonte: MTV Pulse 6 Strano tipo questo cantante francese al secolo Eric Greff, che ha scalato le classifiche con il martellante Ça m’emerve. E tutto quello che fa incazzare l’amico Fritz, ovvero un tedesco (da qui il forte accento teutonico) che sbarca a Parigi, è una sfilza di cose, dalle commesse dei negozi alla gente che beve champagne, dalle ragazze che portano la frangetta alla Kathe Moss ai buttafuori delle discoteche. Nel clip Greff – circondato da cimeli del passato e in abiti da dandy – si scontra con le situazioni quotidiane attraverso continui sketch e gag. Il montaggio è costellato da effetti strobo e rapide zoomate che simulano la vibrazione delle casse audio. Niente male. YOU DON’T UNDERSTAND ME Svezia, 1995, 4’30”, musica: Roxette, regia: Greg Masuak, fonte: Youtube.com 7 Il pensiero corre immediatamente a Bergman e al suo immaginario, dall’ambientazione generale del video, con la compagnia di attori itineranti provvista di un piccolo palco mobile (Il volto) all’immagine finale con le sagome dei personaggi ripresi in campo lungo sulla montagna (l’ultima inquadratura de Il settimo sigillo). Del resto chi meglio della formazione svedese poteva permettersi un omaggio al grande maestro? Masuak costruisce il clip di You don’t understand me su eleganti, surreali e struggenti immagini in bianco e nero, senza definire situazioni narrative ma con una buona capacità visionaria. Molto forte la presenza, bionda, di Marie Fredriksson. JUST UK, 1995, 4’10”, musica: Radiohead, regia: Jamie Thraves, fonte: Youtube.com 8 Nel vedere un singolare clip come Just la mente corre a Buñuel e Lynch con le loro opere visionarie. Mentre Yorke, accompagnato dalla band, canta il brano producendosi in smorfie eccessive fin quasi all’epilessia, giù in strada un signore si distende sul marciapiede e fa inciampare un altro tizio; ne nasce un diverbio, con l’uomo accasciato che intima all’altro di lasciarlo in pace. Chi è questo enigmatico personaggio? Un folle o una presenza soprannaturale? Ben presto la scena attira l’attenzione degli altri passanti e anche di un poliziotto: finiranno tutti – in un’inquadratura finale ripresa dall’alto – distesi per terra sul marciapiede come prigionieri di uno strano incantesimo (L’angelo sterminatore). Per tutto il clip si svolge un livello narrativo autonomo al testo della canzone, con i dialoghi che scorrono in sovrimpressione. E ciò si spiega con il fatto che originariamente questo lavoro era un corto trasformato poi in un video. La fotografia è di Alex Melman. ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (9 DI ANTONIO CAPUANO; CON GABRIELE AGRO, VALERIA GOLINO. ITALIA 2010 8 Un incipit vorticoso, una violenza e lo stile del film e la vita di un ragazzo cambia, rinchiuso nel carcere minorile. Due realtà socali che non possono entrare in contatto, la classe alta e la bassa, l’organizzazione meticolosa del futuro e la creatività anarchica. Uno dei migliori film presenti alla mostra di Venezia (Giornate degli autori) per sincerità di inspirazione e stile. (s.s.c.) BENVENUTI AL SUD DI LUCA MINIERO; CON CLAUDIO BISIO, ALESSANDRO SIANI. ITALIA 2020 7 Divertente remake di Bienvenue chez les Ch’tis di Dany Boon che prendeva in giro i criptici abitanti del nord della Francia. Qui un direttore delle poste in Brianza per punizione è mandato al sud dove incontra una umanità e un modo di vivere completamente diverso da quello che immagina. Angela Finocchiaro è la moglie, Valentina Lodovini la bella impiegata, con Nando Paone e Giacomo Rizzo. Film che arriva in contemporanea alle spiritosaggini dei leghisti, come a smussare una realtà conflittuale e mostra come chi va, vede. Venduto in Francia e negli Usa, risponde alla regola universale che (attenzione) c’è sempre un altro nord e i lumbard sono sempre il sud profondo dell’Europa. (s.s.c.) L’ESTATE D’INVERNO DI DAVIDE SIBALDI; CON PIA LANCIOTTI, FAUSTO CABRA. ITALIA 2007 6 In un motel di Copenaghen Christian, ragazzo diciannovenne, chiede alla prostituta che aveva portato in camera di restare ancora e la paga perché parli con lui. Nel chiuso della stanza emergono via via esperienze e ricordi del passato, con qualche brivido creato dalla suspense delle possibilità di sviluppo del racconto, con una certa abilità da parte degli interpreti nel tenere desto l’interesse del pubblico. (s.s.c.) GORBACIOF DI STEFANO INCERTI; CON TONI SERVOLLO, MI YANG. ITALIA 2010 6 Lo chiamano Gorbaciòf per la voglia sulla fronte, è il contabile del carcere di Poggioreale a Napoli ed ha la passione del gioco d’azzardo. Anche il padrone del ristorante cinese dove si trova la bisca, padre della ragazza di cui è innamorato, gioca, e perde al di sopra delle sue possibilità. Gorbaciof comincia a sottrarre banconote dalla cassaforte del carcere. Il film sembra pensato sull’icona Servillo, così come si è venuta formando, come a connotarne gli aspetti più inquietanti, con l’inedito innesto di influenze di cinema far east. Il risultato è un po’ statico, con la figura di Servillo prepotentemente in primo piano e tutto il resto a fare da sfondo. (s.s.c.) LA HORDE DI YANNICK DAHAN E BENJAMIN ROCHER, CON ERIQ EBOUANNEY, AURÉLIEN RECOING. FRANCIA 2009 5 L'idea in sé poteva essere esplosiva: partire da una situazione «realistica» per finire nella metafora sanguinaria più pura. Ovvero: mettiamo che un gruppetto di poliziotti corrotti e ipermaneschi organizzino una spedizione punitiva contro i criminali che ne hanno ammazzato uno (realismo). Siamo nella banlieu parigina, i poliziotti assaltano i «nemici» rischiano di rimanerci, e ecco che la situazione si ribalta e le due parti sono costrette a una alleanze. L'edificio infatti si riempie di zombie ferocissimi che non fanno distinzioni quando si tratta di ingoiare sangue... Il problema è che le intenzioni non si fanno realta, o meglio cinema. E così l'ideuzza iniziale finisce col produrre l'effetto opposto: sbadiglio invece che terrore. (c.pi.) 10) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 HAI PAURA DEL BUIO DI MASSIMO COPPOLA; CON ALEXANDRA PIRICI, ERICA FONTANA. ITALIA 2010 6 Scelto dalla Settimana della critica come film italiano, ha un grandioso incipit in una fabbrica di Bucarest dove Eva ha finito il suo contratto. Parte per l’Italia con destinazione Melfi, è ospitata da una coetanea, Anna, una giovane operaia della Fiat e si presta a fare da badante alla nonna in ospedale. Il rapporto speculare tra le due ragazze si sviluppa in direzioni imprevedibili mostrando due tipi di caratteri simili per durezza, in un’astrazione di racconto che è la nota dominante del film. (c.pi.) IL FILM LO ZIO BOONMEE CHE SI RICORDA LE VITE PRECEDENTI DI APICHATPONG WEERASETHAKUL. CON THANAPAT SAISAYMAR, JENJIRA PONGPAS. THAILANDIA 2010 Un piccolo grande film inatteso, capace di toccare i gangli nervosi più oscuri del nostro «vedere il mondo», Zio Boonmee ha la rara capacità di connettere cinque o sei culture estreme dell'immagine. Palma d’oro a Cannes, film impuro, politico in senso pieno e traslato, che fa della coesistenza pacifica la chiave per raccontarci due o tre cose su vita, morte e metempsicosi nella buddista Thailandia senza scatenare letture banali o la censura di militari (18 colpi di stato). Fiaba e cronaca vera, fumetto pulp e antica arte dell'incisione, feuilleton e storia, horror e fantascienza, allucinazione e magia, il trash e il lisergico cromatico: lo zio Boonmee, dal feroce passato anticomunista, malato di insufficienza renale, attende la morte, tra la campagna, la foresta, le grotte e la città, assistito in dialisi da una infermiera fantasma (lo spettro della moglie morta), sullo sfondo di una repressione armata che gli uccise il figlio. (r.s.) LA RASSEGNA LONDON RIVER NIHON EIGA DI RACHID BOUCHAREB; CON BRENDA BLETTYN, CINECLUB DETOUR (VIA URBANA 107) SOTIGUI KOUYATÉ. ALGERIA FRANCIA 2009 28 OTTOBRE - 23 GIUGNO 2011 6 Nihon Eiga, ovvero «La storia del cinema Giapponese» è una rassegna della cinematografia dal 1970 al 2010 a cura di Enrico Azzano, Raffaele Meale e Riccardo Rosati per iniziativa dell’associazione culturale Cinema Senza Frontiere. Dopo l’inaugurazione del 14 ottobre all’Istituto giapponese di cultura, un calendario con cadenza quindicinale è in programma al cineclub Detour con serate dedicate a cineasti o a particolari generi, presentati dai curatori e da studiosi: Yukio Mishima (il 28), Wakamatsu (11 novembre), Shinya Tsukamoto, Takeshi Kitano, Hayao Miyazaki, Takashi Miike, Nagisa Oshima, Shuji Terayama. Fra gli appuntamenti da non perdere: Millennium Actress di Satoshi Kon, il regista di anime scomparso nell’agosto scorso. Per l’occasione è stato edito il volume «Nihon Eiga, Storia del Cinema Giapponese dal 1970 al 2010» raccolta di saggi, riflessioni e recensioni sui film in programma. (s.s.c.) L'attore maliano Sotigui Kouyaté (tra i più intensi e «tecnici» performer di Peter Brook) è stato premiato alla Berlinale per questa smagliante interpretazione di un padre alla ricerca della verità sulla morte del figlio «immigrato» al Nord, disperso in occasione di un devastante attentato terroristico. Il regista, il «beur» francese di origine algerina Rachid Bouchareb, è arrivato a maneggiare i grossi budget come per questa fiaba semi-etica a partire da un drammatico fatto di cronaca, film molto ben modulato e diretto in modo da non cedere al sentimentalismo. (r.s.) MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE DI WERNER HERZOG; CON BRAD DOURIF, WILLEM DAFOE. USA 2009 7 Cromatismi messicani, fantarealismo, magie, alterazioni psichiche, un nano che misteriosamente attraversa il set... Un po’ il (cattivo) tenente Colombo, un po’ Twin Peaks, un po’ i fratelli Coen con il killer robotico e visionario in missione per conto di Dio, il film si apre su una fiammeggiante San Diego con il taccuino squadernato del detective Willem Dafoe che da solo basta a suscitare grandi passioni per il caso di un ragazzone suonato, barricato in casa dopo l’assassinio di sua madre. David Lynch (più che produttore) ha stregato Herzog, ma non gli ha rivelato i suoi segreti. (c.pi.) PASSIONE DI CARLO MAZZACURATI; CON SILVIO ORLANDO, GIUSEPPE BATTISTON. ITALIA 20120 6 Un regista-autore (il monodico e attonito Silvio Orlando) disilluso e annoiato, fugge... verso il cielo. Via dai lavori immaginari forzati di Cinecittà alla volta di un’improbabile rappresentazione popolare paesana, una «Passione» in Toscana, che pur essendo un accrocco ridicolo finirà, grazie a un paio di galeotti, per commuovere tutti. Meno il film, che ha il difetto di spalmar commedia all’italiana su tragedia pasoliniano-ispanica, in cerca di una scorciatoia populista. Magnifico Corrado Guzzanti nella parte del mattore di provincia. (r.s.) LA PECORA NERA DI ASCANIO CELESTINI; CON ASCANIO CELESTINI, GIORGIO TIRABASSI, MAYA SANSA. ITALIA 2010 8 Un film sul manicomio inusuale e «unico» nella sua forma ossessiva e disperata, partitura musicale «a cappella» per attori e voce recitante che svela, con la stessa bruciante verità e doppiezza di una testimonianza autobiografica, ora leggera, ora tragica, ora lucida ora infantile, L’ANIMAZIONE DOK LEIPZIG FESTIVAL DI CINEMA DOCUMENTARIO ora comicissima e ora insostenibile, i sogni, gli orrori, gli incubi e le allucinazioni di Nicola, un ragazzo nato «nei favolosi anni Sessanta», che passa 35 anni, per schizofrenia, in un «manicomio elettrico». Celestini penetra l'ordine del discorso lecito e lo mette a soqquadro con ironia e profondità, dando voce ai senza voce. (r.s.) QUELLA SERA DORATA DI JAMES IVORY; CON ALEXANDRA MARIA LARA, ANTHONY HOPKINS. USA 2009 7 Film elegante per un romanzo, di Peter Cameron (Adelphi) elegante. Un giovane professore Omar Razaghi (Omar Metvally), poco dotato per l'insegnamento e in crisi professionale e sentimentale ha una fidanzata (Alexandra Maria Lara) molto determinata. Lei è brillante e lanciata nella carriera universitaria e lo spinge a partire per l'Uruguay a conoscere la famiglia di Jules Gund, lo scrittore su cui il ragazzo sta lavorando. Gund si è suicidato, lui vorrebbe scrivere la sua biografia, gli eredi si oppongono ma per Omar il progetto è determinante ai fini del suo futuro ... Nella vecchia villa, sontuosa e molto «vecchio stile», il giovane conosce il fratello gay dello scrittore (Hopkins). Intorno si muove una fauna abbastanza classica di esiliati d'oro, anch'essi icone di un altrove, la «vecchia Europa». (c.pi.) LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI DI SAVERIO COSTANZO; CPN ALBA ROHRWACHER, LUCA MARINELLI. ITALIA FRANCIA GERMANIA 2010 7 Tratto dal best seller di Paolo Giordano ha una sua bellezza visionaria, è fatto di particelle di cinema sconnesso, ma azzarda, ha un’atmosfera speciale nell’inseguire i due protagonisti, Alice (Alba Rohrwacher) e Mattia (Luca Marinelli) in vent’anni di solitudine. Congelato nell’autismo dell’infelicità fatica a estrarre dai personaggi il dolore dei traumi infantili. Alba Rohrwacher è impressionante nella sua performance di anoressica, Filippo Timi di clown crudele. (m.c.) E D’ANIMAZIONE. LIPSIA 18-24 OTTOBRE Edizione 53 del festival più longevo dell’Europa orientale, con numeri in crescita. In programma 346 film di cui 223 documentari da 58 paesi, a forte impatto politico trattando di guerra, crisi economica e ambientale, le difficoltà della democrazia, le questioni di genere. Fra i tanti registi presenti Susanna de Sousa Dias, Marcin Koszalka, Jaques Perrin, Bill Plympton. Riflettore acceso sulle nuove immagini di mascolinità, in società e famiglia. Per la prima volta c’è la competizione internazionale per corti documentari, oltre a quelle per doc lunghi, animazione, giovani talenti, Generation Dok, nazionali complessivi 71mila euro in palio. Debutto del premio della fondazione per la Pacifica Rivoluzione per doc artistici impegnati su democrazia e diritti umani. Punto di forza da 14 anni la sezione Animadoc, avamposto sui doc animati. Programmi speciali su Caucaso oggi, denaro (Money Matters), l’animatrice lettone in New York Signe Baumane e omaggio al documentarista 80enne Klaus Wildenhahn. (th.m.) IL DOCUMENTARIO LE CITTÀ SLOW DI PIERO CANNIZZARO THE TOWN DI E CON BEN AFFLECK; REBECCA HALL. USA 2009 7 Il set, «the town», è Charlestown, periferia di Boston che si dispiega sensuale nelle sue case di mattoni rossi, i monumenti all'Indipendenza, gli alberi, l'oceano. Fuggire da Charlestown, covo malfamato, è l'obiettivo del malinconico Doug MacCray (Affleck), padre carcerato, madre tossica e suicida, irlandese subalterno alla mafia italiana. Rapine, inseguimenti e colpi di mitra servono solo a declamare la storia d'amore del bandito con la direttrice della banca (Rebecca Hall), presa in ostaggio e poi corteggiata. Il film è lontano da Mystic River, ma che una direttrice di banca sia dalla parte del «nato per rubare», non è male. (m.c.) L’ULTIMO DOMINATORE DELL’ARIA DI M. NIGHT SHYAMALAN, CON NOAH RINGER, TORINO, SALONE DEL GUSTO 22 OTTOBRE DEV PATEL, USA 2010 Otto città con il gusto del buon vivere e del tempo disteso come filosofia di vita sono raccontate in «Le città slow» l’ultimo lavoro di Piero Cannizzaro. Venerdì 22 ottobre presenta uno di questi lavori a a Torino al Salone del gusto (21 - 25 ottobre): Città slow Pollica per ricordare il sindaco Angelo Vassallo (foto) ucciso il 5 settembre, già vicepresidente di Cittàslow e ispiratore della serie. Attraverso i luoghi e i volti incontrati nelle cittadine Cannizzaro racconta con il suo stile poetico e incisivo il rispetto della salute, della solidarietà e della spontaneità del vivere insieme: Orvieto, Pollica, Bra, Cisternino, Levanto, Greve in Chianti, Massa Marittima e Amelia fanno parte di questo ciclo di documentari. Si incontrano non solo luoghi e coltivazioni, ma anche personaggi e testimonianze di vita, quasi un obbligato punto di arrivo dopo il «Cibo dell’anima», la serie dei suoi documentari dove si raccontava il cibo legato alle diverse religioni. (s.s.c.) 4 Avatar ha aperto i suoi cantieri celesti e sedotto il regista di origine indiana Shyamalan, che dalla trascendenza di Il sesto senso è passato alla grande saga fantasy. Film d’iniziazione che non ha nulla dell’acidità infantile di Nel paese delle creature selvagge di Jonze. Nessun detour emozionale spezza la monotonia delle immagini, sfigurate da un 3D posticcio. Inutilmente Shyamalan cita Miyazaki con il suo gatto-autobus volante a sei zampe o tenta il miracolo digitale in una gigantesca onda sospesa. Il film è un disastro produttivo, un innesto non riuscito tra il visionario cacciatore di spettri e i piani milionari degli executives. (m.c.) OSTIENE GAMER di Carlo Avondola A L’AMORE BUIO filippo brunamonti a. catacchio mariuccia ciotta giulia d’agnolo vallan cristina piccino roberto silvestri s.s. collins S SEGUE DA PAG 5 SINTONIE Lord Zombie. Accantonato non si sa quanto definitivamente il progetto Tyrannosaurus Rex, e sfumata inoltre l’ipotesi di un successivo remake (dopo quello ibrido e concettuale firmato Chuck Russell) di The Blob, Rob Zombie annuncia il suo titolo cinematografico del 2011: The Lords of Salem, in realtà una sua canzone, ma anche uno script tenuto nel cassetto su una Salem contemporanea i cui abitanti si trovano a fronteggiare la demoniaca presenza di un manipolo di fattucchiere vissute trecento anni prima. A convincere il regista della Casa del diavolo sarebbe stata la garanzia da parte della produzione (la stessa di Paranormal Activity) sul controllo totale di sceneggiatura, casting e montaggio, diversamente da quanto accaduto con i due – pur meravigliosi – Halloween (2007 e 2009), una esperienza che gli avrebbe lasciato l’amaro in bocca distogliendolo dal piacere di immaginare nuovi rifacimenti. Ma un sogno proibito – per uno dei pochi talenti Usa attualmente in circolazione – si aggiunge qui: chi se non Zombie potrebbe rifare il dimenticato capolavoro L’etrusco uccide ancora (Crispino 1971), magari con un cameo speciale di Samantha Eggar? La casa di Waris. Ancora un giorno (chiude il 17 ottobre) per visitare a New York un singolare mercatino, ospitato nei pressi della High Line di Chelsea e organizzato dalla fervida mente di Waris Ahluwalia, artista filantropo, creatore di gioielli e attore (era il capotreno del Darjeeling Limited di Wes Anderson e il Mr. Kubelkian di Io sono l’amore). Il progetto-installazione – che richiama il suo sofisticato brand – si intitola House of Waris Tea Room, e accumula in prospettiva nonprofit un bel po’ di mercanzia upper, dalle invenzioni della stilista sonica Cynthia Rowley alle borsette iperreali di Olympia Le-Tan, le creazioni delle fashion sisters Kate e Laura Mulleavy di Rodarte ispirate da A bout de souffle insieme alle opere di Eric Anderson, non dimenticando di offrire una selezione di tè direttamente proveniente dalle altitudini dell’Himalaya. Cinema permanente a Lisbona. La Cinemateca Portuguesa di Lisbona (39, Rua Barata Salgueiro) con la sua sezione fissa di proiezioni Historia Permanente do Cinema moltiplica – per accostamenti trasversali e benemeriti dissotterramenti – il godimento della visione retrospettiva, tumultuosamente disancorata dal peso dei sensi unici di giudizio. Così come accade nella seconda metà di ottobre: il prossimo 23 ad esempio arde luminosamente con The Revolt of Mamie Stover (Femmina ribelle, 1956) di Raoul Walsh, con Jane Russell donna di vita a Honolulu dopo Pearl Harbor in lotta contro pregiudizio e sentimentalismo (oltre che a confronto diretto con la leggendaria Agnes Moorehead), insieme al curioso e sconosciuto Das Madchen Von Gestern Nacht (1938, di Peter Paul Brauer con Willy Fritsch, ovvero il romanticismo secondo il canone del Terzo Reich) e a tre corti di raro pregio marginale, il classico Rabbit’s moon di Kenneth Anger (’50), Song of Hollywood del venezuelano Temistocles Lopez (’70) e Sex Garage (’73, di anonimo), coito filmato e non interrotto tra umani e motociclette. ■ STORIE ■ COSA CI FACEVA QUARANT’ANNI FA MILES AL FUNERALE DI JIMI? ■ Insieme sul pianeta nero La tromba di Miles Davis; la Hofner Club 60, tra le prime chitarre acquistate da Jimi. La copertina del disco «mai nato» di Jimi, Davis e Gil Evans; Miles al funerale di Hendrix di Alberto Piccinini L’ unico funerale al quale Miles Davis partecipò, a parte il proprio, fu quello di Jimi Hendrix. Scese vestito di nero da una delle 24 limousine parcheggiate in fila di fronte alla Dunlap Baptist Church di Seattle, il primo ottobre 1970. Il manager di Hendrix, l’inglese Mike Jeffreys, aveva organizzato tutto. Pagati i voli da New York, Los Angeles, Londra, per musicisti, giornalisti, roadie, impresari. Pagate le stanze all’Holiday Inn dell’aeroporto, dove si svolse quello che il giornalista Al Aronowitz descrisse come «un baccanale sulla tomba di Jimi». Il trombettista aveva viaggiato sul volo da New York. Mai a suo agio tra più di dieci persone, divorato dalla solita ossessione per la coolness, aveva preferito scendere in una suite del Plaza. Col parrucchiere Vinnie, giusto per capire il tipo, e una momentanea fidanzata: Jacki, casualmente conosciuta all’aeroporto. L'anno prima Davis aveva interrotto il breve matrimonio con la 24enne modella e cantante Betty Mabry, la «ragazza del Kilimanjiaro» che aveva dato il suo volto alla copertina dell’ultimo album jazz ortodosso della sua lunga carriera, e che – soprattutto - lo aveva introdotto nel giro dei rocker neri più radicali: Sly Stone e Jimi Hendrix. Era stata la gelosia per Betty a spingerlo verso Hendrix. Una specie di crisi di mezza età, forse la chiacchierata storiella tra il chitarrista più bravo di tutti e la sua bellissima moglie coll’ afro sulla testa, una dea del black power. Nel 1975, nelle vesti di cantante sexy-funk lei aveva inciso un pezzo «femminista» intito- nare la strada che l’aveva portato al successo (e molti videro in questo durissimo scontro uno dei motivi della sua misteriosa fine). Viveva sempre più come un limite il suo essere autodidatta. Marionetta di un ingranaggio (bianco) che non poteva controllare. I tempi stavano cambiando. Le Black Panther venivano a trovarlo in camerino dopo i concerti, chiedendogli di sostenere le loro attività. E nell’estate del 1969, a cavallo dell’esibizione di Woodstock, Hendrix si trasferì in una casa-comune da quelle parti.. Liquidato il trio con Mitch Mitchell e Noel Redding, prese a frequentare musicisti afroamericani di esperienza jazzistica, come Roland Kirk, Sam Rivers, il pianista Mike Ephron. Suonava notte e giorno con loro, lato He was a big freak, ridicolizzanin lunghe jam di alcune delle quali do il suo uomo che amava farsi fruneppure è rimasta traccia registrastare con una cinta turchese. Qualta. Aveva battezzato la sua comune cuno ci aveva visto un ritratto non creativa Sky Church, chiesa del cieproprio lusinghiero di Miles Davis. lo. Con alcuni dei suoi nuovi comIl jazzista, che teneva alla sua repupagni di viaggio salì sul palco di tazione quanto alla sua leggendaria Woodstock: il bassista Billy Cox, il collezione di occhiali scuri, ribattè chitarrista Larry Lee, i percussionipiccato che Betty, semmai, si riferisti Gerry Velez e Juma Sultan (queva a Hendrix. st’ultimo veniva dal giro del sassoTutto il breve rapporto tra il 46enfonista free Archie Sheep). Solo per ne Davis, che già allora poteva riemuna suprema quando involontaria pire due capitoli di un qualsiasi licattiveria la rudimentale registrabro di storia della musica, e il 27enzione dell’esibizione di Woodstock ne Hendrix, nuovo sciamano elettri– una delle più celebri, quella che co piovuto da marte (dissero di lui: termina con la devastazione dell’in«sarebbe diventato il Miles Davis no americano – ha fatto scomparidella sua generazione») fu costellare nel silenzio il tappeto percussivo to da piccole cattiverie. Come la voldi tutta la Band of Gypsys, come fu ta che il trombettista non si presenbattezzato il gruppo, salvo la battetò a un affollato party nella sua casa di New York,, lasciando a Hendrix un bigliettino con sopra scritto un tema musicale. Il chitarrista, che non sapeva leggere la musica, ne era rimasto costernato. Tra il 1969 e il 1970 Davis e Hendrix entrarono nello stesso giro di bella gente, musicisti radicali afroamericani, a New York. Frequentavano le stesse feste, si trovavano a cena assieme, bazzicavano la stessa boutique del Lower East Side. Giubbotti, cinture, pantaloni. Rigorosamente in pelle. La boutique era della moglie di Alan Douglas, produttore delle riprese di Woodstock, che ebbe la parte principale nel tentare uno di quelle leggende incompiute che ancora aleggiano sulla storia della musica del secolo scorso: la collaborazione discografica tra Miles Davis e Jimi Hendrix. In generale Hendrix cominciava a sentirsi strette, anche un po’ cialtrone, le sue esibizioni in trio con gli Experience. Il chitarrista era pressato in tutti in modi dal manager Mike Jeffreys per non abbando- La collaborazione tra Hendrix e Davis è una favola incompiuta della cultura radicale nera anni ’70. Si erano frequentati a New York: uno cercava un maestro, l’altro un nuovo mondo sonoro. Del disco mai inciso resta solo la copertina ria di Mitch Mitchell. Alan Douglas, trovata l’idea di una collaborazione con Miles Davis, aveva fatto le cose per bene. Aveva convinto Gil Evans – arrangiatore di alcuni dei capolavori di Davis – a curare la regia della cosa, anche per smussare eventuali problemi di ego in sala di registrazione. Evans, come tanti altri jazzisti, teneva in grande considerazione Hendrix. Lo stesso Hendrix aveva dichiarato più volte che nella sua nuova vita avrebbe voluto imparare a leggere la musica per lavorare su partiture più complesse. L’idea che aveva del jazz discendeva ancora dal suono delle big band degli anni ’40, ascoltate con suo padre: che tra le sordine di Ellington e il wah wah sulla Fender si possa tracciare un filo rosso è ipotesi non troppo peregrina. Senonchè Davis ci mise, ancora una volta, qualcosa del suo. Il giorno prima della prima session Douglas riceve una telefonata del manager del trombettista: «Mi dispiace dirtelo, Alan, ma Miles vuole 50.000 dollari prima di andare in studio». Douglas allora chiama Davis: «Miles che succede?», gli chiede. «Dai, so che ce la puoi fare», ammicca ikl trombettista. «No che non posso», insiste Douglas. Hendrix, che è lì presente, capisce l’antifona, e bofonchia qualcosa tipo «Vabbè andiamocene a mangiare». Allora chiama il giovane batterista di Davis, Tony Williams. E' infuriato: «Ho saputo che dai 50.000 dollari a Miles!». Tony Willams, 24 anni, aveva partecipato nell'aprile 1969 alle session di In a silent way, l’annuncio della svolta elettrica di Miles Davis coi pianisti Joe Zawinul e Chick Corea, che avevano circondato come gli indiani il povero Herbie Hanckock, e con un giovane chitarrista inglese, John Mc Laughlin. Ancora McLaughlin compare qualche mese dopo nelle session di Bitches Brew, il doppio e definitivo album del Davis elettrico, uscito giusto quarant’anni fa. Bitches Brew è già l’alfa e l’omega di tutto: l’esplorazione di un nuovo pianeta, il vero disco «hendrixiano» di Miles Davis; ma anche la nascita della fusion e del jazzrock, l’idioma multinazionale e spesso pletorico del decennio che viene. Ha raccontato una volta Robert Wyatt di aver assistito in quel periodo a una jam session a New York, accanto a Jimi Hendrix. Sale dul palco il chitarrista «fusion» Larry Corryel e macina dieci minuti di scale velocissime. Sale Hendrix, subito dopo, e attacca: «Bam-wahwah-waah!». «Con quattro note – ricordava ridendo Wyatt – Jimi lo ha cancellato!». Ma Hendrix sentiva il bisogno di un maestro, e quello avrebbe potuto essere Miles Davis. Davis, a sua volta, aveva bisogno di uscire dalla claustrofobia del jazz. Aveva voglia di stupire tutti di nuovo, abbandonando al proprio destino il jazz modale, il free jazz, Coltrane e Coleman. La sera che Douglas lo portò a vedere Hendrix, in un club di New York, rimase a bocca aperta. Disse soltanto: «Che sta facendo? Che cazzo sta facendo?». L’impressione, riascoltando le incisioni dei due musicisti in quel periodo, è che qualcosa li stesse spingendo verso lo stesso pianeta. Third stone from the sun, come quel pezzo di Hendrix..O un Pianeta Nero (come un titolo dei Public Enemy) rarefatto, funky, sexy, infestato da misteriose elettriche presenze. Davis attaccò un wah wah alla tromba.. Hendrix fece suonare la sua chitarra come la tromba di Davis. E Davis uscì dal jazz, per entrare in un mondo che rimase soltanto suo. Hendrix uscì dal mondo e basta così. Del progetto discografico con Gil Evans resta la copertina disegnata dell’artista pop-surrealista Mati Klarvein, che immaginò per primo il Black Planet dov’era riuscito a sbarcare Davis – sua è pure la copertina di Bitches Brew. E mentre Gil Evans arrangiò e incise alcuni pezzi celebri di Hendrix, a Davis scappò l’ultima cattiveria. Accettò nuovamente di partecipare alle session messe in piedi da Alan Douglas. Che sarebbero dovute iniziare pochi giorni dopo che Hendrix fu trovato cadavere a Londra.. Così non gli restò che andare al suo funerale. Col cuore spezzato, dissero. ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (11 di Luigi Onori I l jazz italiano di avanguardia si interroga e celebra Albert Ayler e Malcolm X, alla ricerca di un’eredità viva - sia sonora che politica - mentre in Italia soffia forte il vento del razzismo, dell’intolleranza, dell’incultura. Non è un caso che il polistrumentista Paolo Botti e il sassofonista-clarinettista Francesco Bearzatti attingano l’uno al repertorio di Ayler per riproporlo in una chiave nuova che mantiene il nucleo emotivo della musica e la sua urgenza politica (come spiegano in questa pagina Flavio Massarutto e lo stesso Botti) e l’altro alla figura scomoda di Malcolm X e al suo lucido radicalismo. Entrambe le operazioni mettono l’accento sulla matrice afroamericana del jazz e sulla connessione forte e inscindibile tra l’espressione sonora di una comunità e la sua travagliata storia, sul valore identitario e oppositivo - seppur non apocalittico sempre e dovunque - del jazz. Sono messaggi non scontati in stagioni di «fine dell’ideologia» e non perché ci sia bisogno di integralismi razziali e sonori al contrario (il jazz è solo nero). È però necessario (far) conoscere la storia e sapersi ispirare creativamente e non mimeticamente ai suoi protagonisti, come fanno Botti e Bearzatti. Siamo in una fase in cui si tende a fare del jazz un fenomeno di glamour, di tendenza modaiola, colonna sonora ideale per gli happy hour; a quest’uso decorativo si affianca, in un significativo parallelo, un’idea del jazz che lo riduce - mitizzandolo - ai decenni ’40-’60, in un arco stilistico che comprende, bebop, hardbop e modalismo, senza nulla prima o dopo. Albert Ayler e Malcolm X non rientrano in queste fuorvianti o utilitaristiche semplificazioni e le fanno esplodere. Archie Shepp incise in quartetto il 9 marzo del 1965 (a due settimane dall’omicidio del leader nero all’Audubon Ballroom di Harlem) lo struggente Malcolm, Malcolm-Semper Malcolm (pubblicato in Fire Music, Impulse) e da allora tante sono state le rievocazioni in jazz. Il Poem for Malcolm (Byg) registrato ancora da Shepp a Parigi nell’infuocato 1969; la colonna sonora di un documentario sul leader nero - Malcolm X, Warner - uscito nel 1972 con brani di Duke Ellington, Billie Holiday e Last Poets; Colloquio con Malcolm X (Pdu) di Giorgio Gaslini, una musical-action del 1973-’74 con cantanti lirici, voci recitanti, coro, big-band, solisti quali lo stesso autore, Gianni Bedori, Bruno Tommaso, Franco Tonani e testi di Ettore Capriolo; negli anni ’80 si registrano Season of Renewal (Jmt) del sassofonista Greg Osby e X-The Life and Times of Malcolm X (Gramavision) del pianista e compositore Anthony Davis, autore nel 1986 di un’opera lirica in tre atti scritta per undici voci su libretto della poetessa e scrittrice Thulani Davis; negli anni ’90 ecco MX-Dedicated to the Memory of Malcolm X (Red Baron, 1992) del sassofonista David Murray ed i cd legati al film di Spike Lee: la colonna sonora di Terence Blachard (Columbia) e la raccolta dei brani di repertorio usati nel film del 1992 (QWest/Reprise). Ben venga, quindi, il crudo e intenso - dal tragico e epico Prologue/ Hard Times fino all’(Epilogue) rappato con dura fierezza/consapevolezza da Napoleon Maddox - album di Francesco Bearzatti. Sassofonista, clarinettista, compositore, da sempre jazzista eterodosso e molto noto in Francia, ha puntato la sua attenzione su uno dei leader neroamericani più controversamente amati con il cd X (Suite for Malcolm), edito di recente dalla Parco della musica records. Attorno a Bearzatti una delle più belle formazioni del jazz europeo, il Tinissima quartet. L’album è illustrato dalle tavole scure e dense di Francesco Chiacchio (il design è di Marco Sauro). Ne abbiamo parlato con il leader-sassofonista mentre, dopo qualche concerto estivo si annuncia un tour autunnale di presentazione che dopo Barcellona (Barcelona Jazz Festival) toccherà Gioia del Colle (Ba; Ueffilo Jazz Club, 24/10), Bisceglie (Ba; cinema comunale, 26/10), Bacoli (Na; biblioteca comunale, 28/10), Napoli (29/10), Castellanza (VA; università, 5/11), Bologna (Bravo Caffè, 10/11), Parigi (Triton Jazz Club, 11/11), Cagliari (European Jazz Expo, 19/11), Brescia (teatro Eden, 14/12). però nel suo caso con una motivanamori del jazz e, quindi, ami la culC’è un legame tra il precedenzione talmente forte da azzerarsi tura afroamericana, ovviamente ad te album dedicato a Tina Moquasi completamente, soprattutto un certo punto lo porta ad imbatterdotti (sempre Parco della muquando lavorava per Soccorso rossi anche in Malcolm X. Quando avesica) e questo nuovo, a parte so. Partendo da quell’esperienza ho vo letto l’autobiografia da ragazzo l’utilizzazione del medesimo deciso di tenere unito il gruppo in ero rimasto molto colpito e quando organico? onore suo (Tinissima è il superlaticercavo un personaggio da celebraIl gruppo si chiama ancora Tinissivo di Tina), un gruppo combat che re mi veniva in mente lui, mi rivenima quartet, per me è importantissisi occupa di personaggi che sono va, però quel continuo «aspetta, è mo… vado un po’ indietro. Il lavoro stati molto importanti però tendopericoloso, non è cosa nostra…», per la Modotti è nato da un amore no a essere accantonati proprio per perché, sai come è, Malcolm è intocsviscerato che ho avuto e ho nei la loro pericolosità nei confronti del cabile. suoi confronti; ero molto ispirato, potere. A me interessa portare, inveho letto moltissimo, ho cercato (e vice, alla ribalta questo tipo di persoI jazzisti, però, lo hanno spessionato) tutto, dai fumetti alle bionaggi e ciò, tra l’altro, mi aiuta nelso celebrato. grafie varie, a internet e ho sentito l’ispirazione. Non c’era bisogno di Però per un bianco della provincia molto forte la sua presenza umana, me per far conoscere Tina Modotti italiana sembrava un po’ complicapolitica, sociale ed artistica. Tutte ma devo dire che - attraverso il dito. Poi, in realtà, seguendo bene la ciò mi ha fatto partire per quel viagsco che ha venduto moltissimo e i fase finale della sua esistenza, dopo gio sonoro. Se ci si imbatte in Tina numerosi concerti - tanta gente mi il viaggio a La Mecca quando pratiModotti - a parte le sue foto che soha scritto o detto di aver scoperto la camente supera la barriera razziale no già di per sé un viaggio (vedere il Modotti... e scopre che ci sono dei bianchi che passaggio dai primi scatti alle foto non sono «teste di cazzo», da lì il leadi denuncia) -, quando leggi la sua Per il nuovo progetto su Malder neoramericano diventa veravicenda è una cosa da rimanerne colm X - «X (Suite for Malmente pericoloso. Io sono partito folgorati: una persona straordinacolm)» - come hai lavorato e proprio da quel punto e a ritroso, coria, con un’umanità incredibile. Mi da quali fonti sei partito? me per Tina Modotti, sono andato ha sempre colpito l’interesse che Essendoci meno fonti - a parte l’aualla sua infanzia e ho cercato - sinaveva per gli altri senza un credo retobiografia - ho lavorato in maniera tentizzandoli - di ricostruire i pasligioso, che io rispetto tantissimo, molto emotiva. Il fatto che uno si insaggi esistenziali fondamentali. Due splendidi «cattivi maestri» e due artisti italiani che ne rileggono il ruolo all’interno della comunità nera e oltre. Musiche e visioni politiche in netta opposizione al tentativo di ridurre il jazz a un genere sempre più «di moda», preda di bar e insipidi happy hour ■ ICONE/1 ■ FRANCESCO BEARZATTI RACCONTA IL CD-TRIBUTO AL LEADER NERO ■ Solo Malcolm X 12) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 La «X (Suite for Malcolm)» ha una sua precisa struttura. L’ho costruita in maniera che i movimenti, scritti con i numeri romani, arrivassero fino al decimo, alla X. Sono partito da un prologo: a un certo punto era minacciato dai suoi stessi compagni di lotta, dall’organizzazione (Nation of Islam di Elijah Muhammad, ndr) che lui stesso aveva contribuito a far diventare importantissima. Hai presente quella foto famosa di Malcolm X con il mitra, dietro la finestra? Io sono partito da lì e ho scritto un prologo, tragico, per poi andare indietro, quando la sua abitazione viene bruciata dal Kkk, ho ricostruito i viaggi e i lavori al tempo in cui Malcolm cercava ancora di integrarsi e quindi si stirava i capelli… Ho messo anche un momento ludico che si chiama Cotton Club però non ho scritto un pezzo di lindy hop ma disco anni ’70, la musica da ballo di quando ero ragazzo, e mi sono permesso questo trasporto temporale. Ho cercato di rendere nel miglior modo possibile il momento in cui lui, con il crimine e la droga, è arrivato al carcere, poi la scoperta e la conversione all’Islam, il fatto che è diventato - poco alla volta - un grandissimo leader di riferimento per la comunità afroamericana, il viaggio a La Mecca e la morte. C’è un epilogo che è il prologo messo in forma di rap e lì ho chiamato come ospite un collaboratore di Archie Shepp che si chiama Napoleon Maddox e fa beat box: ha scritto un testo che ha rappato (Malcolm, Enough). Ho voluto aggiungere una postilla sonora - sono sempre stato grande ammiratore anche di Muhammad Alì - che si richiama al combattimento di Kinshasa, una ghost track. Secondo te ha una particolare valenza tornare a parlare di Malcolm X nel momento in cui c’è Barak Obama alla presidenza degli Usa? Sì ma nel mio caso è casuale, perché sono amori (Malcolm X e Muhammad Alì) che ho sempre avuto; vedo anch’io una sorta di continuità, mi fa piacere, ma è del tutto casuale. (si ringrazia Marco De Persio) ■ ICONE/2 ■ UNA VITA BREVE E TRAGICA ■ La sua influenza è stata enorme. Sperimentò la conduzione multidirezionale del gruppo e approfondì temi etnici distanti dalla tradizione afroamericana. Quando si spostò sul soul in molti pensarono che si fosse perso. Ancora oggi lo «spirito santo» fa scuola Albert Ayler, l’uragano col sorriso dolce di Flavio Massarutto I di F. Mas. Paolo Botti è uno dei più interessanti musicisti del nuovo jazz italiano. Specialista di uno strumento poco frequentato come la viola, il quarantenne musicista romano - milanese d’adozione - dopo aver pubblicato per l’etichetta Caligola Records i bellissimi Viola Trio (2005) e Looking Back (2007) ha fatto da poco uscire, sempre per la medesima casa discografica, un tributo ad Albert Ayler. Angels and Ghosts. The Ayler Tapes è un notevole lavoro registrato in completa solitudine nel quale Botti alterna alla viola anche banjo, dobro e mandolino. Tutto rigorosamente senza sovraincisioni. Lo abbiamo intervistato. Come mai hai pensato ad un intero lavoro dedicato ad Albert Ayler? Ayler è un po’ un universo a sé nel panorama delle avanguar- l 25 novembre 1970 il corpo di Albert Ayler fu ripescato dall’East River, a Brooklyn. La causa del decesso: annegamento. Immediatamente cominciarono a fiorire le più svariate ipotesi sulla sua morte. Il mistero che avvolgeva i suoi ultimi giorni e il clima di tensione e violenza di quegli anni fecero sì che si pensasse a una causa violenta, affari di mafia o droga, o a un complotto dell’ F.b.i. Teorie che continuano ancora oggi a circolare nonostante le memorie, rese pubbliche da tempo, della sua ultima compagna, Mary Parks, che testimoniano la depressione e i problemi psichici del sassofonista afroamericano. Sta di fatto che è più comodo e intrigante mantenere l’aura dell’eroe tragico da collocare bene in vista nella folta galleria dei Martiri del Jazz. Il sublime distruttore di note, lo spirito santo del free jazz (il padre era John Coltrane e il figlio Pharoah Sanders), l’uragano dal sorriso dolce. Nella sua Qui sopra Davide breve vita conclusa tragicamente a soli trentaquattro anni Ayler aveva impresToffolo ritrae Albert so una fulminante accelerazione al movimento che stava trasformando il Ayler (dal fumetto jazz e andava sotto i nomi di new thing e free jazz. Dapprima con l’influente «Visioni»); a sinistra Spiritual Unity (Esp, 1964) insieme al contrabbassista Gary Peacock e al batteMalcolm X rista Sonny Murray aveva sperimentato la conduzione multidirezionale del (di Francesco Kiakkio) gruppo, facendo in modo, cioè, che ogni musicista seguisse una propria e audal libretto del cd «X tonoma linea ritmica e melodica. Poi aveva approfondito l’utilizzo di temi di (Suite for Malcolm)» stampo folclorico, anche estranei alla tradizione afroamericana, secondo un’ottica che anticipava di decenni l’inebriante girandola di citazioni e cortocircuiti culturali che saranno dominanti (Spirits Rejoice, Esp, 1965 e Live in Greenwich Village, Impulse, 1965/67 ). Infine nell’ultimo periodo si era gettato nella ricerca di fusioni inedite tra strumenti (come la cornamusa) e stili scandalosamente eretici per la chiesa del jazz, persino per quella riformata del free tanto da meritarsi all’uscita del controverso New Grass (Impulse, 1968) la presa di distanza di Amiri Baraka, un tempo suo fervido sostenitore, che allora disse laconicamente: «Il fratello Albert si è perso». In realtà Ayler, refrattario a qualsivoglia ortodossia, aveva più volte dimostrato di essere interessato alla sua personale ricerca e di essere fedele solo a quella. Le accuse di deriva commerciale gli furono gettate addosso come a un altro grande inquieto, quel Miles Davis che faceva di tutto per immergersi nella black music e per sfruttare le opportunità offerte dagli strumenti elettrici. Anche altri esponenti dell’avanguardia come Archie Shepp avevano, pur da una prospettiva esplicitamente politica, incrociato la loro musica con il soul, il rhythm’n blues e il funk. Certa critica, però, priva degli strumenti analitici che solo anni più tardi le sarebbero derivati dalle teorie del signyifing e del black Atlantic, non comprese o non volle comprendere. Oggi possiamo con maggior equilibrio leggere quelle ultime incisioni al di là della loro riuscita come passi di una ricerca, prematuramente interrotta, coerente con una visione che attraversa tutta la sua opera. Ancora oggi l’influenza di Albert Ayler sullo sviluppo del jazz e sul linguaggio sassofonistico è stata enorme a partire dalla scena dei Loft degli anni ’70 - il sassofonista David Murray gli dedicherà lo splendido Flowers for Albert - fino alla musica improvviPAOLO BOTTI/ INTERVISTA sata europea. Negli anni ’90 Giorgio Gaslini fece un’attenta opera di trascrizione di temi e brani ayleriari dando vita ad Ayler’s Wings (Soul Note), molto apprezzato dalla critica e die jazzistiche, è un musicista attraverso tutta la sua produzione, dal pubblico. Tra i tanti tributi a lui che ho sempre apprezzato ma anche quella degli ultimi, controdedicati si consiglia caldamente il di cui non avevo più di tanto versi, dischi… turgido Healing Force. The Songs of approfondito il linguaggio. NeHo cercato di prendere in esaAlbert Ayler (Cuneiform Rune, 2007) gli ultimi anni - grazie anche me tutta la discografia di Ayler, ad opera di un settetto guidato dal alla vicinanza con amici musicidalle primissime testimonianze chitarrista Henry Kaiser e tutto insti come Edoardo Marraffa e scandinave (con il classico Mocentrato sugli ultimi due album. Filippo Monico, da sempre deanin’ di Bobby Timmons), alle Nel 2004 la Revenant gli ha dedivoti al grande sassofonista di ultime produzioni elettriche. cato un ricco cofanetto con preziosi Cleveland - ho avuto modo di Indubbiamente per chi ha in memorabilia, un libro di più di dueindagare e approfondire le molmente e nel cuore il suono di cento pagine e nove cd, più un bote implicazioni e contraddizioni Ayler accompagnato da ritminus, di registrazioni rare e inedite della sua arte che è emblematiche fluide come quella esem(Holy Ghost, 2004). Un vero tesoro ca rispetto a un tema che mi plare di Sunny Murray e Gary che ha tra i suoi gioielli il commosta molto a cuore in questo periPeacock può risultare frustranvente concerto tenuto ai funerali di odo: il legame tra avanguardie te l’ascolto di quei lavori basati John Coltrane e i demo dell’album e sperimentazione con le origisu semplici ostinati rhythm New Grass. ni del suono afroamericano, and blues, ma per altri versi è con il folklore, con il blues, con stata proprio questa vicinanza la musica di New Orleans ecc. al linguaggio del blues più geSicuramente è questo legame nuino e meno astratto a renderAl centro Ayler da ragazzo, a destra quello che mi ha spinto a dedili utili alla mia ricerca. tre dischi: Love Cry (Ayler), Angels care un lavoro alla sua figura. & Ghosts (Botti), Music is the Healing Tu sei noto come un ottimo violiForce of the Universe (Ayler) Colpisce il fatto che hai spaziato sta ma qui suoni anche, e soprat- Le avanguardie del folk tutto, banjo, dobro e mandolino. È solo un episodio o ti ascolteremo ancora come polistrumentista? Negli ultimi anni ho dedicato molto tempo e energie ad approfondire lo studio di questi strumenti che mi appassionano tanto, e sicuramente si tratta di un percorso che continuerà. Il banjo in particolare rappresenta ai miei occhi un emblema della musica afroamericana avendo la sua origine proprio negli strumenti che gli schiavi avevano portato con loro dall’Africa ibridandosi poi con gli strumenti a corde europei. Nel jazz è stato un’insostituibile parte della sezione ritmica fino all’avvento della chitarra elettrica, ed è stato poi relegato a un ruolo revivalistico, quasi esclusivamente nel dixieland. Oggi assistiamo a un rinato interesse per questo strumento anche sulla spinta di alcuni importanti musicisti di estrazione blues che lo hanno riproposto con forza come Taj Mahal e più recentemente Otis Taylor. Tutto il tuo disco ha un preciso profilo estetico. Puoi parlarcene? Non ti nascondo che questo lavoro ha rappresentato per me un azzardo: svuotando i semplici temi di Ayler dalla visceralità del suo suono sassofonistico si potrebbe finire col banalizzarli o peggio normalizzarli. Per evitare questo rischio ho cercato di esaltare la materialità del suono degli strumenti che ho scelto, materialità certo molto diversa dall’originale, ma proprio per questo stimolante. Da un lato questo lavoro mi ha portato a compiere il processo inverso a quello di Ayler. Cioè riportare alla loro dimensione folklorica i suoi temi, ma ho sempre cercato di non limitarmi a questo aggiungendo ogni volta qualcosa di mio e di originale. Il risultato è un disco che non so se è più jazz o più folk, più d’avanguardia o più di revival, più di Albert Ayler o più di Paolo Botti… ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (13 Geoff Farina + Chris Brokaw ON THE ROAD New Model Army Nella musica dello storico gruppo britannico si mischiano il punk e il pop, con uno spiccato senso melodico. Un tour per festeggiare i trent'anni di carriera e per salutare definitivamente il loro pubblico. ROMA SABATO 16 OTTOBRE (CIRCOLO DEGLI ARTISTI) Anti-Flag Vengono da Pittsburgh, suonano punk e condiscono i loro testi di uno spirito ipercritico nei confronti della società americana e dei suoi «poteri». Nella stessa serata anche i Pulled Apart by Horses e Swellers. MILANO GIOVEDI' 21 OTTOBRE (TUNNEL) Beautiful La nuova band che mette insieme i tre Marlene Kuntz (Cristiano Godano, Riccardo Tesio, Luca Bergia) l'ex Csi Gianni Maroccolo e il dj e producer inglese Howie B ha appena pubblicato l'album d'esordio, omonimo, e parte per una tournée italiana. Insieme l'ex leader dei Karate e l'ex membro dei Codeine. VARESE SABATO 16 OTTOBRE (TWIGGY) FIRENZE DOMENICA 17 OTTOBRE (SALA VANNI) ROMA GIOVEDI' 21 OTTOBRE (BLACKOUT) SCHIO (VI) VENERDI' 22 OTTOBRE (MAC2) COLLE VAL D'ELSA (SI) SABATO 23 OTTOBRE (SONAR) Magic Arm Sonorità che mettono insieme il folk, il rock e l'elettronica per l'artista inglese Marc Rigelsford, alias Magic Arm. FAENZA (RA) SABATO 16 OTTOBRE (CLANDESTINO) Half Seas Over Il duo angloamericano propone un pop-folk-blues delicato e sofisticato. BOLZANO MARTEDI' 19 OTTOBRE (VINTOLA) FIDENZA (PR) SABATO 23 OTTOBRE (TAUN) 14) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 MILANO SABATO 16 OTTOBRE (TUNNEL) La band britannica neo-progressive rock fa parte della scuderia di Steven Wilson. Supertramp ROZZANO (MI) DOMENICA 17 OTTOBRE (SPAZIO AURORA) La storica band inglese di Breakfast in America (disco del 1979) è tornata. TORINO SABATO 23 OTTOBRE (PALAOLIMPICO ISOZAKI) Tweak Bird Una data per i fratelli Bird, chitarra baritono e batteria, e per il loro stoner rock venato di psichedelia. TRIESTE DOMENICA 17 OTTOBRE (TETRIS) Allan Holdsworth Uno dei più apprezzati chitarristi della scena internazionale. FOGGIA MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (MOODY JAZZ CAFFE') ROCCAFORZATA (TA) GIOVEDI' 21 OTTOBRE (GO WEST SALOON) CIVITANOVA MARCHE (MC) VENERDI' 22 OTTOBRE (MAGGA) ROMA SABATO 23 OTTOBRE (JAILBREAK) Avenged Sevenfold Puro heavy metal per la formazione californiana. Songs with Other Strangers La storia del punk inglese. African rap’n’folk da Bamako, prodotti da Manu Chao. The Pineapple Thief We Have Band The Damned Smod Sono in giro dalla fine degli anni Ottanta e hanno un grosso seguito tra gli amanti dell’hardcore e dell’indie rock. Sul palco anche i Madball. CONEGLIANO VENETO (TV) MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (RADIO GOLDEN) MILANO GIOVEDI' 21 OTTOBRE (PALASHARP) ROMA MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (CIRCOLO DEGLI ARTISTI) BRESCIA GIOVEDI' 21 OTTOBRE (VINILE 42) Sick of It All Torna in Italia la band di Lol Tolhurst e Michael Dempsey, membri della prima formazione dei Cure. ROMA MARTEDI' 19 OTTOBRE (INIT) TANETO DI GATTATICO (RE) SABATO 16 OTTOBRE (FUORI ORARIO) L'elettronica del giovane trio londinese. Levinhurst Il progetto di Marta Collica dal vivo mette insieme Manuel Agnelli, Cesare Basile, Stef Kamil Carlens, John Parish, Giorgia Poli, Hugo Race, Jean Marc Butty, Steve Wynn e Rodrigo D'Erasmo. RAVENNA MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (TEATRO RASI) TORINO VENERDI' 22 OTTOBRE (HIROSHIMA MON AMOUR) FIRENZE SABATO 23 OTTOBRE (PIAZZA DELLA SIGNORIA-FESTIVAL DELLA CREATIVITA') Front Line Assembly L'electro-industrial della band canadese. SAN DONA' DI PIAVE (VE) SABATO 23 OTTOBRE (REVOLVER) Linea 77 La band piemontese torna in tour per presentare il nuovo lavoro intitolato 10. ERBA (CO) GIOVEDI' 21 OTTOBRE (AMERICAN ROAD) VICENZA VENERDI' 22 OTTOBRE (PEOPLE) BRESCIA SABATO 23 OTTOBRE (LATTE+) Apocalyptica La band metal finlandese. MILANO DOMENICA 17 OTTOBRE (ALCATRAZ) Pain of Salvation Una metal band scandinava attiva da oltre vent’anni. MILANO VENERDI' 22 OTTOBRE (ALCATRAZ) Sharon Jones & The Dap-Kings Una sola data per la band statunitense che accompagna da anni Amy Winehouse. MEZZAGO (MI) SABATO 23 OTTOBRE (BLOOM) Yuppicide In concerto la band hardcore di Boston. MEZZAGO (MI) VENERDI' 22 OTTOBRE (BLOOM) Laetitia Sadier La cantante degli Stereolab in versione solista. A Torino con Mice Parade e Siljie Nes. TORINO GIOVEDI' 21 OTTOBRE (SPAZIO 211) ROMA VENERDI' 22 OTTOBRE (INIT) BOLOGNA SABATO 23 OTTOBRE (LOCOMOTIV) Hayseed Dixie La band arriva dai Monti Appalachi, negli Stati Uniti, e ripropone in chiave bluegrass i grandi successi del pop e del rock... MEZZAGO (MI) SABATO 16 OTTOBRE (BLOOM) Mafalda Arnauth In Italia una delle più interessanti fadiste venute alla ribalta negli ultimi anni. ROMA SABATO 16 OTTOBRE (AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA) Tito & Tarantula Il latin rock di Tito Larriva ha conosciuto un momento di grande fama con la colonna sonora del film Dal tramonto all’alba. RONCADE (TV) VENERDI' 22 OTTOBRE (NEW AGE) TORINO SABATO 23 OTTOBRE (LAPSUS) RONCADE (TV) SABATO 16 OTTOBRE (NEW AGE) ROMA DOMENICA 17 OTTOBRE (ALPHEUS) Anaïs Mitchell Alt-folk sullo stile di Ani DiFranco. ROMA SABATO 16 OTTOBRE (ANGELO MAI) Statuto La ska band torinese torna sul palco. MODENA SABATO 16 OTTOBRE (LEFT VIBRA) BOLOGNA SABATO 23 OTTOBRE (ESTRAGON) SETTIMO TORINESE (TO) SABATO 23 OTTOBRE (LA SUONERIA) 99 Posse Tonino Carotone Il ritorno della formazione hip hop partenopea. L'istrionico artista di Pamplona, teorico di un «mondo difficile». COLLE VAL D'ELSA (SI) SABATO 16 OTTOBRE (SONAR) Oregon Inizia il 22 ottobre 2010, per concludersi il 21 marzo 2011, la nuova e nutrita stagione di Linguaggi Jazz, organizzata dal Centro Jazz Torino. In cartellone - con il loro 40˚ Anniversary Tour - gli Oregon: Paul McCandless (oboe, sax soprano), Ralph Towner (chitarra e piano), Glen Moore (contrabbasso e piano), Mark Walker (batteria e percussioni). TORINO VENERDI' 22 OTTOBRE (CONSERVATORIO G. VERDI) Matt Elliott Dai trascorsi elettronici con i Third Eye Foundation, l'inglese Matt Elliott è passato al folk contemporaneo. SAN COSTANZO (PU) SABATO 16 OTTOBRE (TEATRO DELLA CONCORDIA) CARPI (MO) DOMENICA 17 OTTOBRE (MATTATOIO) Dillinger Escape Plan Arriva nel nostro paese il mathcore della band statunitense. SAN VITTORE DI CESENA (FC) SABATO 16 OTTOBRE (VIDIA) Remo Anzovino Il pianista-compositore in tour per presentare l'album Igloo. BARLETTA SABATO 16 OTTOBRE (TEATRO CURCI) PIAN DI SORRENTO (NA) DOMENICA 17 OTTOBRE (MARIANIELLO JAZZ CAFFE') Immanuel Casto Il trasgressivo artista coon il suo porn groove in una tappa dell'Adult Music Tour. MILANO SABATO 16 OTTOBRE (MAGAZZINI GENERALI) ROMA VENERDI' 22 OTTOBRE (CIRCOLO DEGLI ARTISTI) ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) SABATO 23 OTTOBRE (OASI SAN MARTINO) FIRENZE SABATO 16 OTTOBRE (FLOG) Jeff Mills Uno dei maggiori esponenti della elettronica, padre della «real techno». ROMA SABATO 23 OTTOBRE (CS BRANCALEONE) Dalle nuove musiche al suono mondiale La stagione autunnale della rassegna di Musica 90 prende il via al Museo Regionale di Scienze naturali con lo spettacolo del coreografo Marco Santi, Verkorperte Spiegel (oggi), si prosegue il 19 con il duo tra Carla Bozulich (Evangelista) e il bassista degli Zu Massimo Pupillo e ( r ), progetto solista di Fabrizio Modonese Palumbo, il 20 tocca invece alla violoncellista islandese (e vocalist dei Múm) Hildur Guonadottir, entrambi allo Youth Museum. TORINO SABATO 16, MARTEDI' 19 E MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (VARIE SEDI) Musiche Migranti Per la trentacinquesima edizione del festival Musica dei Popoli in programma la Grande Orchestra di Tango di Juan José Mosalini (oggi) e il progetto Mare Nostrum di Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren (il 23). FIRENZE SABATO 16 E SABATO 23 OTTOBRE (FLOG) Casa del Jazz Sempre bilanciata tra recital e iniziative divulgative, la struttura capitolina propone la presentazione libraria del volume di Enzo Gentile Jimi santo subito! (ShaKe edizioni) seguita dal concerto Around Jimi del gruppo di Giovanni Falzone Mosche Elettriche (Valerio Scrignoli, Michele Tacchi e Riccardo Tosi). A seguire il gruppo Italuba del batterista Horacio «El Negro» Hernandez (Amik Guerra, Ivan Bridon e Luis Manresa), e la guida all’ascolto curata da Gerlando Gatto su Il sound atipico del jazz. La dolcezza del violoncello con ospite Paolo Damiani. ROMA DA LUNEDI' 18 A MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (CASA DEL JAZZ) Alexanderplatz Il club romano dedica una tre giorni al gruppo Riccardo Del Frà-Maurizio Giammarco Rendez Vous (21-23, con il pianista Bruno Ruder e il batterista Marcello Di Leonardo). Nei giorni precedenti recital delle formazioni guidate rispettivamente da Marco Zurzolo, Alice Ricciardi, Enrico Bracco, Pietro Lussu e Antonella Vitale (con Francesco Puglisi, Domenico Sanna, E. Bracco e Alessandro Marzi). ROMA DA SABATO 16 A SABATO 23 OTTOBRE (ALEXANDERPLATZ) Tra jazz e nuove musiche Prosegue la rassegna dedicata in gran parte alla musica afroamericana dalla Radio della Svizzera Italiana. Di scena la Tetraband, quartetto guidato dal pianista e tastierista di Belgrado Bojan Z (Zulfikarpasic) con Josh Roseman al trombone, Ruth Goller al basso e Seb Rochford alla batteria. LUGANO (CH) GIOVEDI' 21 OTTOBRE (RSI, STUDIO 2) Jazz & Wine of Peace Festival L’originale (nella formula e nelle scelte artistiche) rassegna propone più artisti per ciascuna giornata. Per il 22 sono in programma il trio Depart guidato dal sassofonista viennese Harry Sokal (con Heiri Känzig e Ales Deutsch), il Tomasz Stanko Quintet (il leader alla tromba più Alexi Tuomarila, Jakob Bro, Anders Christensen e Olavi Louhivuori). Il 23 si prevede il duo Klaus Paier/Asja Valcic (ore 11 chiesa di s. Giovanni), Jack DeJohnette & The Ripple Effect con ospiti le ance di John Surman e la voce con percussioni di Marlui Miranda (nel gruppo anche Jerome Harris e Ben Surman; ore 18.30 Teatro Comunale) e l’orchestra free Ken Vandermark’s Resonance (un tentetto con, tra gli altri, Magnus Broo, Steve Swell e Dave Rempis; il recital verrà trasmesso da Rai Radio3). La manifestazione si conclude il 25 ottobre. CORMONS (UD) VENERDI' 22 E SABATO 23 OTTOBRE (VARIE SEDI) acura diRoberto Peciola con Luigi Onori (jazz) (segnalazioni:[email protected]) Eventualivariazioni di datee luoghi sono indipendentidalla nostra volontà. AFRICA UNITE Un’immagine degli Africa Unite di Grazia Rita Di Florio S e la musica avesse un potere rivoluzionario il mondo sarebbe già cambiato, si pensi ai vari Bob Marley, Fela Kuti o James Brown, tanto per citare tre grandi icone vissute in contesti storici alquanto rappresentativi sul piano delle contraddizioni sociali e dell’arretratezza sociale e politica ma si potrebbero menzionare anche Bob Dylan, John Lennon e i Clash che puntarono con il punk (come con il reggae) a una radicalizzazione dello scontro politico impensabile ai giorni nostri, non fosse altro perché il punk maturò in un periodo molto favorevole dal punto di vista mediatico. Le stesse motivazioni storiche consentirono a Fela Kuti di autoproclamarsi The Black President della Repubblica di Kalakuta o a James Brown di sedare le rivolte nere dopo l’assassinio di Martin Luther King, così come a Bob Marley di guidare la rabbia di rude boys e emarginati dei ghetti giamaicani divenendo al contempo la prima stella planetaria del Terzo Mondo. «Ciò accadeva quando il musicista era un icona, oggi questo non succede più, è più famosa la tipa che ha vinto La Supersecchiona che una band come la nostra e questo è il sintomo dell’epoca in cui vi- viamo, massmedializzata, addormentata e poco ricettiva a qualsiasi input o sollecitazione. Il nostro impegno come musicisti, oggi, è semplicemente l’obbiettività, raccontare ciò che succede intorno a noi fornendo il nostro punto di vista sulla realtà». Parola di Madaski, leader, dub master, tastierista e cantante di Africa Unite, una della band più longeve del panorama reggae italiano. Le sue parole si colorano di toni taglienti, spietati, non hanno mezzi termini e mezze misure, sono poco concilianti quanto il messaggio profuso con il loro nuovo disco, Rootz; uno sguardo disincantato e disilluso sulle piaghe che affliggono i nostri tempi, la questione ambientale, il controllo mediatico, il ritardo culturale, quanto lucido e distaccato su ombre e penombre della musica reggae, dal rastafarianesimo all’omofobia, argomenti trattati e fatti a pezzi rispettivamente nelle tracce Mr. Time e Così sia. «Un’aperta condanna all’omofobia - dice Madaski - che non fa sconti a nessuno e sebbene chiami per nome alcuni personaggi della musica reggae giamaicana, è rivolto a tutti i fautori di questa idiozia, e a coloro che in Italia tendono a tollerare e giustificare una simile aberrazione, per pigrizia o noncuranza, avallando o cercando giustificazioni a una teoria di morte, come quella dei nazisti che scioglievano ebrei e rom nei forni crematori ■ INCONTRI ■ UN DISCO CONTRO MITI E STEREOTIPI GIAMAICANI ■ Trecce tricolori La band pubblica «Rootz» e torna al reggae delle origini. «I gruppi nostrani non sanno discernere, avallano un genere spesso omofobico. Bisogna stare in guardia. Noi raccontiamo il paese in cui viviamo, la nostra quotidianità» senza distinzione tra vecchi, donne e bambine; perciò ’brucia chi vuole bruciare’, il nostro messaggio è di fuoco. Giustificare una cultura di violenza arroccandosi dietro il pretesto delle radici culturali è la classica posizione del terzomondismo spicciolo». «L’immaginario del reggae è legato agli stereotipi giamaicani - interviene Bunna (voce, chitarra) che i gruppi reggae italiani tendono ad abbracciare senza discernere, noi abbiamo sempre cercato di rifuggire da atteggiamenti che non ci appartengono essendo italiani e fautori di una cultura alternativa, perciò abbiamo sentito il bisogno di esprimere una condanna diretta dell’omofobia. Per noi è importante raccontare la nostra quotidianità che è nettamente diversa da quella giamaicana, scimmiottare ciò non ci appartiene, che non ci ha mai interessato; noi ci siamo proposti come band che voleva portare avanti una propria visione delle cose. In tema di discriminazioni - siano esse razziali, di classe o sessuali - sentiamo di dover esprimere la nostra indignazione». Il discorso va verso il circuito del reggae italiano e a questo punto Madaski sbotta: «Io non credo esista un circuito del reggae italiano, personalmente non sono collegato col circuito del reggae in generale, faccio le mie cose per conto mio perché riesco ad esprimermi attraverso questo genere musicale: fra l’altro il reggae ha fatto parte della mia formazione musicale di adolescente, perciò l’ho prediletto come veicolo di espressione artistica ma non frequento concerti reggae». «Io invece - continua Bunna ho un ottimo rapporto con la scena reggae italiana anche se non posso fare a meno di notare che c’è in generale un atteggiamento un po’ troppo superficiale rispetto ad alcuni temi scottanti, e anche una certa ipocrisia che tende a giustificare alcuni aspetti del reggae giamaicano da cui io ho sempre preso le dovute distanze. Non so come gli attori della scena reggae italiana abbiano accolto un brano come Così sia, forse con stupore o con scetticismo, ma non è questo il problema che ci siamo posti. In generale ritengo che ci sia una tendenza a fare finta che vada tutto bene; il mondo va a rotoli e la gente corre a casa a guardarsi il Grande fratello, o si gasa perché è uscito l’ultimo modello di iPod o iPad». Autonomia è la parola d’ordine degli Africa Unite, una band sulla breccia da circa 30 anni forgiata sulla forte personalità dei due leader; Madaski si autodefinisce un nichilista, e non per niente il suo primo gruppo formato in età adolescenziale, in piena fase dark, si chiamava Suicide Dada. Un approccio filosofico-esistenziale che traspare in Mr. Time «un brano molto ’forte’ - spiega lo stesso Madaski - che sta andando molto bene. Volevo sfatare anche l’altro lato oscuro, a mio avviso, del reggae che è il rastafarianesimo, in pratica un’invenzione storica in cui lo stesso Hailè Selassiè non ha mai creduto, il quale peraltro è stato un dittatore sanguinario. Niente è così distante da me come queste filosofie tanto fasulle quanto pericolose». Il lato più solare è rappresentato da Bunna, la cui voce luminosa e splendente si contrappone a quella cavernicola, alla tonalità cupa di Madaski; e forse proprio le due personalità speculari, e complementari, individualmente distintive, costituiscono uno degli ingredienti vincenti della band. «Io e Bunna siamo molto sciolti - puntualizza Madaski - anche nel comporre lavoriamo molto individualmente, poi ci confrontiamo in studio e assembliamo ciò che ci pare più riuscito, più conforme al nostro sound che è un suono prestabilito. Per esempio per questo album abbiamo lavorato a quattro mani molto più che nel precedente disco Controlli che si avvaleva della collaborazione di Paolo Baldini per le basi. Però sempre seguendo questo metodo di lavoro individuale». E ancora: «Ciò che caratterizza il sound di Africa Unite è l’approccio che abbiamo con la musica che riflette la nostra visione della vita, più che la caratterizzazione del suono in sé e per sé. A livello di sound sicuramente ci sono alcuni miei interventi personali più cupi che si rifanno alla scena new wave e ad altre esperienze musicali che vanno al di là del reggae». Su questo punto i due sono in piena sintonia perché anche Bunna sostiene che «l’approccio ai testi, ciò che ci premeva dire con la nostra musica è l’elemento caratterizzante sin dagli esordi; credo che un nostro brano sia riconoscibile sin dai primi dieci secondi più per i temi che per il sound». Rootz è un disco accuratamente messo a fuoco sulla tradizione, sul reggae delle origini, con una massiccia sezione di fiati, il cui filo conduttore rimane il messaggio, pur con la piena consapevolezza che «la nostra musica non può mica cambiare il mondo!». Ciò vuol dire rinunciare al grande potere della parola? «No affatto, chi vuole intendere intenda», precisa Madaski che vive l’arte/la musica come una sorta di esplorazione psichedelica della coscienza che può risvegliare le menti dallo stato di narcolessia attuale. Bunna, invece, evoca una presa di coscienza radicata nel messaggio di Marley: «Solo consapevolezza e impegno possono cambiare la realtà; apri gli occhi, vivi, cercala, rincorrila, difendila la nostra libertà…» (da Cosa resta). ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (15 ULTRASUONATI THE BLACK ANGELS PHOSPHENE DREAM (Blue Horizon/Audioglobe) 7 Vengono da Austin, Texas. Il loro nome è preso in prestito dalla celebre canzone dei Velvet Underground e la loro anima è cupa e acida come nelle migliori tradizioni d’oltreoceano. Ma per questo terzo album, uscito per la rediviva Blue Horizon di Mike Vernon, i Black Angels abbandonano in parte le spirali voodoo del validissimo Direction to See a Ghost, per abbracciare una psichedelia più californiana, più Sixties e (vagamente) più solare. Reminiscenze dei Nuggets maggiormente elettrici (Sunday Afternoon, Telephone), s’incrociano a riffoni stoner (Bad Vibration), andamenti alla Jefferson Airplane (True Believers) e sali e scendi lisergici di floydiana memoria (Yellow Elevator #2). Un album da non scambiare per derivativo, Phosphene Dream. Perché, anche stavolta, i Black Angels dimostrano un’anima genuinamente psichedelica. Pepita rara, che li conferma come una delle migliori band uscite negli ultimi cinque anni. (c.col.) RAFFAELE CASARANO ARGENTO (Tuk Music) 7 La giovane etichetta discografica fondata da Paolo Fresu ha scelto di lavorare sulla qualità, più che sulla quantità: troppi i cd in circolazione, pochi acquirenti, meglio allora prendere bene la mira, sulle uscite. Se la prima pubblicazione era riservata, com’è ovvio, al nuovo doppio del trombettista sardo, questa porta alla ribalta un contraltista (anche assai abile nel maneggiare l’elettronica) dalle idee decise, e un orizzonte musicale ben più ampio del jazz «canonico». Dalla sua Casarano ha una voce intensamente lirica, ma è interessante che tanta poetica struttura sia messa al servizio di un flusso sonoro che incorpora echi di flamenco e di tango, imprevedibili sciabolate rock, canzone, ritmiche elettroniche e «glitch». Ospiti, tra gli altri, Daniele Di Bonaventura e Vertere String Quartet. (g.fe.) SCOTT COLLEY EMPIRE (CamJazz) 6 Il titolo del cd si riferisce a una località del Kansas che il contrabbassista Colley dovrebbe aver scelto come luogo remoto ispiratore di musiche dell’«America profonda». Un jazz che ha qua e là colorature vagamente country (la chitarra di Bill Frisell ha in questo, ovviamente, la sua parte principale, e si tratta di un girovagare musicale piuttosto sterile), un jazz raffinato, molto scritto, di tono sognante e lirico. Colley ha un suono magnifico e una musicalità calda davvero ammirevole. Dieci brani-miniature che diventano sostanziosi quando nel gruppo, che comprende Ralph Alessi alla tromba e Brian Blade alla batteria, il pianista Craig Taborn sostituisce Frisell. È in una veste più intimista di quella solita, ma la sua delicata felicità inventiva si fa apprezzare. (m.ga.) MASSIMO DE MATTIA - DENIS BIASON/M. DE MATTIA ATTO DI DOLORE - DUEL2 (www.setoladimaiale.net) 7 Il flautista e il chitarrista friulano compaiono in entrambi gli album e la loro dialettica strumentale - serrata e vertiginosa - ne è ingrediente comune. Da anni De Mattia elabora linguaggi sperimentali e di incrocio con altre forme artistiche, indirizzando la sua eccellenza strumentale verso terreni non virtuosistici né convenzionali. Radicalissimo il primo album che ricerca una nuova spiritualità prendendo le distanze dalla «religiosità corrotta, becera», cercando attraverso la musica una sorta di assoluto pio e trascendentale. Arricchiscono di altre inquietudini sonore i cinque brani il piano di Bruno Cesselli e le percussioni di Zlatko Kaucic. In Duel2 chitarra e flauto sono uno di fronte all'altra, quasi in una sfida inventiva e propongono una serie di undici, brevi, quadri sonori, esplorando aree sonore e dimensioni espressive con abbandono creativo e lucida progettualità. (l.o.) EELS TOMORROW MORNING (Eworks/V2-Cooperative Music) 7 Tomorrow Morning, «domani mattina»! Come in pochi mesi può cambiare tutto, anzi come da un giorno all’altro può cambiare tutto. Appena in gennaio avevamo parlato di un disco dall’humus cupo e disperato per la fine di un amore. Oggi quel «lutto» è stato metabolizzato e ecco di nuovo E (Mark Oliver Everett) in versione ottimistica. «Domani è un altro giorno» diceva Rossella O’Hara (Vivien Leigh) in Via col vento, e domani può succedere qualsiasi cosa, questa la filosofia che lo ha accompagnato per la sua nona opera, capitolo finale di un trittico iniziato un annetto fa con Hombre lobo e proseguito col già citato End Times. Abbandonato quasi totalmente il mood acustico, spazio all’elettronica e a quel suo modo così particolare di scrivere canzoni, modo che lo ha reso uno dei personaggi più intriganti della scena alternativa statunitense (e quindi mondiale). Non siamo ancora ai livelli del capolavoro Blinking Lights and Other Revelations ma Tomorrow Morning è un ottimo album, davvero. (r.pe.) 16) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 ❙ ❙ BOOK NOTE ❙ ❙ MANHATTAN BRASS Don Backy e Sanremo. Il tragitto impenitente del folksinger toscano 7 NEW YORK NOW (Enja) Il quintetto con R.J. Kelley, Mike Seltzer, Wayne du Maine, Dave Taylor, Lew Soloff suona di tutto, dal barocco al contemporaneo: qui rende omaggio alla cultura newyorkese anzitutto con la suite di West Side Story di Bernstein arrangiata da Jack Gale, proseguendo con partiture recenti da Euphoria che il sassofonista Daniel Schnyder ha scritto per sé e il gruppo, fino alle Four Songs di Paquito d‘Rivera e a Spiritual & Blues di Wynton Marsalis: musiche tra loro differenti, ma tenute assieme dall’amore per la Grande Mela e dal perfetto equilibrio tra colore jazz e pagina scritta. (g.mic.) Guido Michelone In parallelo all’uscita del nuovo album, Il mestiere delle canzoni (etichetta Ciliegia Bianca) in cui Don Backy (al secolo Aldo Caponi) riflette sulla propria realtà umana e artistica, con un occhio al passato (glorioso) e l’altro al presente (incerto), l’impenitente folksinger toscano, oggi settantenne, dà alle stampe Storia di altre storie. Memorie di un juke box ’70-’80 (edizioni L’Isola che c’è, Bagno a Ripoli, 2010, pagine 288, euro 30,00), secondo volume, dopo Questa è la storia... (Coniglio, Roma 2007) di un ampio progetto autobiografico, che raccoglie pensieri, aneddoti, raccontini in una sorta di album di famiglia, suddiviso per decenni: entrambi sono grossi volumi, illustrati da foto, schizzi, disegni, riflessioni che il protagonista ha gelosamente custodito negli anni, grazie alle immancabili agende in similpelle (riprodotte tra l’altro in diverse pagine) che le banche regalavano ai clienti. Il periodo di Storia di altre storie vede un Don Backy quasi come Janus Bifronte, che reitera, alla propria maniera, i postumi di una contestazione acerrima: era lui, per chi non lo sapesse, a finire su tutti i giornali, attorno al Sessantotto, non solo per belle canzoni come L’immensità, Canzone, Casa bianca o il testo di Pregherò, ma per aver sfidato il Clan di Celentano, di cui da un lustro era una colonna portante, secondo solo al Molleggiato. È proprio quest’ultimo a decretarne l’ostracismo, con tanto di azioni legali, che non intaccano la risolutezza di Don Backy, il quale non rinuncia a una carriera in fondo speculare a quella dell’ex amico Adriano. Come Celentano, infatti, anch’egli prosegue lungo i Seventies in SANTANA GUITAR HEAVEN (Arista/Sony) 5 una duplice felice carriera, la canzone e il cinema, aggiungendone una terza e una quarta, legate alle arti visive - il fumetto e la pittura - con mostre di quadri e libri di graphic novel ante litteram. È comunque ancora nella musica che conferma una notevole verve popolaresca che spazia tra lirismo intimista, derive autoriali à la page e un po’ di strapaese; per contro, davanti alla macchina da presa l’attore si sdoppia ulteriormente: le doti interpretative vengono perpetuate fino alla chiamata di Bernardo Bertolucci per La tragedia di un uomo ridicolo del 1980. Dall’altro queste stesse qualità attoriali risultano svilite in ruoli goliardici nel cosiddetto filone boccaccesco, le commedie sexy liberamente ispirate al Decameron dopo l’exploit della pellicola seria di Pier Paolo Pasolini. Al di là dei risultati, in un decennio-chiave per la fortuna critica, la vicenda di Don Backy resta una storia tipicamente italiana, come quella della più famosa kermesse sonora, stando almeno a quanto espresso da Paolo Iachia e Francesco Patacchini in Nonostante Sanremo. 1958-2008: arte e canzone al Festival (Coniglio, Roma 2010, pagine 271, euro 14,50), che affronta il tema in una prospettiva insolita, spiegando la gara alla luce della partecipazione dei grandi cantautori da Modugno alla Consoli. In questo libro, tra l’altro, Don Backy è citato una sola volta, per la cover de L’immensità dei Negramaro, mentre abbondano i vari Mina, Battisti, Milva, Dalla, Ron, Fossati, Vasco, Paoli, segno che - al di là del gran rifiuto di Guccini, De André, De Gregori e pochi altri - la Città dei Fiori continua a esercitare, tra i musicisti, una sorta di amore/odio verso un’attrattiva nazional-popolare, sempre più carrozzone mediatico e sempre meno veicolo promozionale per la buona canzone. GIOVANNI FALZONE HJALTALIN MOSCHE ELETTRICHE (CamJazz) TERMINAL (Borgin/Goodfellas) 7 Finiranno mai di sorprenderci questi islandesi? Gli Hjaltalin in patria sono già una realtà nonostante abbiano all’attivo un solo disco, Sleepdrunk Seasons, uscito tre anni fa, ma nel resto d’Europa sono degli emeriti sconosciuti. La band scandinava rilascia un disco pop orchestrale che ha in sé i prodromi di una bomba a orologeria. Brani che strizzano l’occhio anche al soul come la title track o l’intrigante Feels Like Sugar danno quel tocco di imprevedibilità e di freschezza a un album che, se ben supportato in sede di promozione, può davvero risultare vincente. E se a tutto questo si aggiungono le voci - una maschile e una femminile - di Hogni Egilsson e Sigridur Thorlacius che sembrano arrivare direttamente da Manchester, beh, il gioco è fatto. (r.pe.) Il sottotitolo del cd è Around Jimi e quindi il programma si spiega: il bravissimo trombettista Falzone dedica un intero capitolo della sua attività odierna alla musica di Hendrix. Però non si limita a creare suoi brani sulle tracce di Purple Haze, Fire, Manic Depression e Foxy Lady ma inserisce tracce proprie e di Miles Davis (Solar e So What combinata con Foxy Lady). Tutto è una nuova riflessione sulle possibilità di percorrere con originalità le strade del jazz associato alle esperienze della musica elettrica, rock. Falzone ha sonorità limpidissima (molto personale con sordina in Fire) e un fraseggio tra il nervoso e il razionalista. In quasi tutto il lavoro, pur nel contesto di una band tipicamente rock, sembra attirato dalle reminiscenze hard-bop (piuttosto ingombranti, come si sa, per via dell’inflazione). Ma niente maniera. (m.ga.) BEN FOLDS/NICK HORNBY LONELY AVENUE (Nosuch/Warner) 8 No, no: non avete letto male. La strana coppia del titolo è proprio quella formata dall'eclettico pop writer Usa e il vulcanico scrittore britannico che insieme - via e-mail - hanno dato vita alla raccolta di canzoni pop rock più intriganti di questi ultimi dodici mesi. Hornby spediva un testo la mattina e Folds lo musicava nel pomeriggio, totale undici pezzi plasmati su diversi registri; da quello comico di Levi Johnston's Blues, dove un ragazzotto di provincia scopre di stare con la figlia di Sarah Palin, a un altro più malinconico, Picture Window, un capodanno vissuto dietro le finestre di un ospedale. E ancora Doc Pomus, dedicata al paroliere di Presley. Magnifico, e se non vi basta, è disponibile una versione de-luxe dove l'aggiunta non sono canzoni, bensì quattro racconti inediti di Hornby. (s.cr.) FRANCESCO GIAMPAOLI A CASO (Sidecar/Brutture Moderne) 7 Il ravennate Giampaoli è musicista eclettico e decisamente insofferente alle definizioni che infilzano le note in categorie troppo limitanti. Di formazione è bassista, ma alle quattro corde affianca tastiere, percussioni, vibrafono, chitarra, mandolino: tutti strumenti presenti in questo viaggio in venti tappe, dal taglio molto vario e cinematografico. Tra oasi di riflessione e punte di concitazione, il disco (con molti eccellenti ospiti) potrebbe piacere anche a chi ama certe scabre, sentite atmosfere del cosiddetto post rock: ma le definizioni, s’è detto, qui vanno molto strette. (g.fe.) LEGENDA 8 Il sottotitolo di questa ennesima fatica del sessantaseienne chitarrista è The greatest guitar classics of all time. Insomma, una raccolta di cover con il comune denominatore di chitarre e assoli, struttura portante del disco. Ma la ricetta è cucinata come fosse l'ennesimo tentativo di ripercorrere le fortunatissima strada di Supernatural, il mega hit mondiale del 1999. Altri tempi, anche perché l'operazione è realizzata con poco cuore è troppa tecnica: si parte bene con Chris Cornell perfetto su Whole Lotta Love degli Zeppelin, ma While My Guitar Gently Weeps con India. Arie & Yo-Yo Mama rischia di far rivoltare nella tomba il povero George (Harrison). E poi: a che pro rivisitare Back in Black degli Ac/Dc in chiave hip hop? (s.cr.) EMILIANA TORRINI RARITIES (One Little Indian/Goodfellas) 7 Il titolo è poco originale quanto esplicativo. Si tratta di un doppio cd per la cantante e autrice islandese (padre italiano, ovvio) che contiene ben ventotto tracce per un totale di undici brani, alcuni già editi e qui proposti in versioni alternative o remixate altri mai apparsi su album. Molti dei pezzi sono tratti da Love in the Time of Science, quello prodotto da Roland Orzabal dei Tears for Fears, disco molto lontano stilisticamente parlando - dalla strada che l’artista ha poi intrapreso. Tra i titoli: Dead Things, To Be Free, la bellissima Baby Blue, Easy, Unemployed in Summertime e Tuna Fish. Un album per completisti ma che non aggiunge molto, come normale per questo tipo di operazioni, a quanto di lei già si conosce e apprezza. (r.pe.) TROMBONE SHORTY BACKATOWN (Verve Forecast) 8 Con Amanda Shaw e Irvin Mayfield è il presente e il futuro di New Orleans. Classe 1986, Troy Andrews arriva da una famiglia di musicisti. Valente polistrumentista, il suo acme lo dà ai fiati (trombone, tromba) e come vocalist. Carismatico e padrone del palco, assieme alla sua formazione che consta di sei musicisti anche questi tanto giovani quanto talentuosi, Shorty firma il suo miglior lavoro. Vero Nowlins sound del 2010, mescolato con identità difformi. Ma tutte ovviamente rintracciabili sia nel French Quarter che nei sobborghi. Second-line, tradizione funk e elementi free (Hurricane Season, Horn Jam, Quiet as Kept, In the 6th, Right to Complain), arrangiamenti che sanno di grunge e Seattle (Suburbia, The Cure), e metriche r'n'b in cui si palesa Kravitz (Something Beautiful). È il migliore e probabilmente lo sarà a lungo. Fatelo vostro. (g.di.) UOCHI TOKI CUORE AMORE ERRORE DISINTEGRAZIONE (La Tempesta Dischi/Venus) 6 Nome di grido tra i dj newyorkesi, Danny Krivit remixa brani pescati nel suo immenso archivio. Disco e funk sono insaporiti da ingredienti latini, afro e soul. Una raccolta d'autore che catapulta su una pista da ballo a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta ma col sostegno dei groove di Krivit, che, caricando la ritmica a dovere, rendono lo scenario nostro contemporaneo. Orge ritmiche in nome della black music con il marchio Strut a rassicurare i più rigidi riguardo la concezione di fruibilità musicale. Follow the Wind dei Midnight Movers convincerà anche i più scettici. (l.gr.) Dire che gli Uochi Toki hanno stancato causa ripetizione della formula sarebbe negare la loro musica, fondata su una reiterazione tanto ipnotica quanto straziante. Hanno stancato al sesto disco? Allora avevano già stancato all’esordio perché la loro musica è una continua dichiarazione d’identità senza concessioni all’ascoltatore. Il tono dei rap di Napo sembra derisorio, come a voler calcare la mano sul rapporto impari fra artista e ascoltatore, e il flusso verbale straripante e lynchiano combinato con la musica di Rico, piena di caos urbano, sottolinea quanto sia perdente tentare di decifrare; meglio un’interpretazione personale che viaggi a suggestioni, col rischio dell’autocompiacimento. E pensare che il duo qui parla di amore… o quanto meno lo usa come concetto di partenza. (l.gr.) LINKIN PARK THE VASELINES MEETING OF A THOUSAND SUNS (Warner Bros) SEX WITH AN X (Sub Pop/Audioglobe) 3 Tutto è (ri)cominciato nel 2008, con uno show di beneficenza nella loro Glasgow. Da vent’anni band di culto nel giro indipendente - non senza l’aiuto del fan celebre Cobain, che li aveva coverizzati - i Vaselines di Eugene Kelly e Frances McKee si cimentano, poi, in qualche live negli States. Il feeling è quello giusto. E la tentazione di una reunion diventa realtà. L’esperienza concisa (un paio di ep e un album, tra l’87 e l’89), la rivalutazione di massa e l’indie pop, il basso profilo, la leggerezza squisitamente Eighties che tornano, come se il tempo si fosse fermato. Sex with an X è (ancora) l’immediatezza dei due accordi, i cori irresistibili della McKee e le melodie catchy che si memorizzano in un instante. Nelle registrazioni sono stati coinvolti i Belle and Sebastian e il 1990s Michael McGaughrin. Praticamente, le uniche novità in questo ritorno... (c.col.) DANNY KRIVIT EDITS BY MR.K VOL.2: MUSIC OF THE EARTH (Strut/Audioglobe) 7 L’unico brano degno di menzione - senza enfasi - è When They Come for Me, una specie di hip hop su una ritmica quasi tribale. Il resto è melassa! Stucchevole rock pop (e rap) in salsa «fm» Usa. La banalità, la - diciamolo pure - inutilità di questo disco appare in tutta la sua chiarezza già al primo ascolto, e più si va avanti, più lo si ascolta e più questo rockettino adolescenziale rischia di uccidere le nostre povere orecchie «adulte», e non basta certo il tentativo di imitazione - aiuto!! - dei Nine Inch Nails di Blackout a migliorare la storia, anzi... Non che i Linkin Park, arrivati al successo con un genere già in agonia come il nu-metal, siano mai stati nei nostri cuori - pur se qualche canzone ascoltabile in passato l’avevano messa su - ma oggi dio ce ne scampi e liberi. Sembrava si fossero sciolti, ma perché ripensarci? (b.mo.) 6 chiara colli stefano crippa gianluca diana guido festinese luca gricinella mario gamba guido michelone brian morden luigi onori roberto peciola «Aurora» (1927) di Friedrich Wilhelm Murnau; in piccolo, il regista sul set di «Tabù» (1929-’31) ■ IL SAGGIO DI LOTTE H. EISNER SUL REGISTA ESPRESSIONISTA ■ Archeologia di Murnau di Barbara Cinelli M urnau di Lotte Eisner fu pubblicato da Le Terrain vague a Parigi nel 1964. Per una edizione tedesca Eisner lavorò successivamente a un testo ampliato, che venne considerato troppo impegnativo per il pubblico della Germania: pesantemente rimaneggiato e abbreviato sarà pubblicato nel 1967 con una introduzione di Robert Herlth, Hermann Warm e Arno Richter; seguirà poi un’edizione londinese nel 1973. La copia dell’originale tedesco, amorosamente conservata, e che non corrispondeva a nessuno dei testi fin’allora editi, era stata nel frattempo amputata di cinque capitoli su dodici, sottratti da un amico appassionato di cinema, ma anche cleptomane, ed Eisner, partendo dall’edizione francese e recuperando da quella inglese i capitoli sugli ultimi tre film girati in Germania (Der letze Mann, Herr Tartüff e Faust), allestì finalmente l’editio princeps, pubblicata a Francoforte nel 1979, l’unica che l’autrice considera davvero rispettosa della sua prima volontà, ricomposta con una dedizione che rivela la centralità attribuita a questo saggio: non solo un libro su Murnau, ma un libro di Lotte Eisner, o, ancora più precisamente, la testimonianza dell’incontro tra un’archeologa e il cinema di un appassionato di arte, che anima le forme attraverso la macchina da presa. È questo il testo che ora appare in una meritoria traduzione italiana, priva peraltro di utili precisazioni in merito a un’intricata vi- cenda editoriale: Lotte H. Eisner, Murnau Vita e opere di un genio del cinema tedesco, Alet edizioni, pp. 288, € 18.00) Eisner aveva compiuto studi di archeologia e storia dell’arte con Heinrich Wölfflin, conclusi nel 1924 con un dottorato sullo sviluppo della composizione nella decorazione dei vasi greci. Prima di diventare critico cinematografico per «Filmkuriers» di Hans Feld nel 1927, passerà un biennio in Italia lavorando nei siti di scavo: il suo sguardo conserverà l’acume indagatore dell’archeologo, attento alla valorizzazione dell’oggetto come documento, alla scrupolosa valutazione di ogni traccia lasciata dalla storia, e sembra predestinarla alla passione di una vita, che inizia in Francia quando nel 1933, ebrea, è costretta a lasciare la Germania di Hitler. A Parigi lavora con Langlois per recuperare i film salvati dalle distruzioni del nazismo, e dal 1945 sarà la conservatrice della Cinémathèque française. La formazione da archeologa e storica dell’arte (così la definiva l’estensore del necrologio sul Times ricordando le sue recensioni cinematografiche) rendono Eisner perfettamente organica all’attività di archivista, e allontanano dalla sua scrittura non solo ogni cedimento a quelle analisi sociopsicologiche che hanno determinato negli studi sul cinema tedesco tra le due guerre la fortuna del testo di Siegfried Kracauer, ma soprattutto ogni facile compiacimento a giudizi superficiali, dettati da riferimenti a film che sono stati frettolosamente visti, o peggio ancora, mai conosciuti direttamente; e di questa precisa etica nella ricerca Murnau offre una splendida testimonianza. Eisner aveva conosciuto Lang, cui aveva dedicato una fondamentale monografia, ma non aveva mai incontrato Murnau, partito per gli Stati Uniti nel 1927, proprio quando lei aveva cominciato a occuparsi sistematicamente di cinema. E anche se dal Faust in poi aveva sempre visto in prima visione tutti i film del regista, questo era accaduto «molto tempo fa», come lei stessa ricorda nell’Introduzione all’edizione inglese di Murnau. I ricordi lontani non sono documenti, sembra metterci in guardia Lotte, e chissà che non potremmo ancora utilmente riflettere su una fragile custode della memoria che non credeva nei libri fatti in fretta, e dedicò sette anni sette a questa monografia su Murnau, vedendo e rivedendo – «again and again» –, grazie a Langlois e alla Cinémathèque Française, tutte le copie e le versioni che poteva trovare. Per dichiarare poi, alla fine di questa «archeological pursuit», che altri comunque, dopo di lei, avrebbero certo potuto individuare ancora altri interessanti argomenti per definire lo stile di Murnau. Alcuni temi mi sembrano straordinariamente e amaramente attuali in questa vicenda editoriale. Il rispetto dell’oggetto e della sua storia, la considerazione della deperibiltà delle testimonianze materiali come un dato ineliminabile di questa storia, e la consapevolezza dello storico di essere comunque un anello della lunga catena che si snoda, attraverso il tempo, attorno all’oggetto dell’indagine: si riporta alla luce una complessa vicenda, ma soprattutto si offre con rigore filologico, a chi verrà dopo di noi, un materiale da cui ripartire, senza competizioni per narcisistiche primogeniture nella scoperta di favolosi inediti. Così Eisner, a fronte dell’alone leggendario che avvolge la figura di Murnau, decide di costruire il suo libro come un’indagine serrata che risulta da più voci; intervista i suoi collaboratori ancora in vita: scenografi, operatori, sceneggiatori; incrocia queste fonti orali con appunti di Murnau stesso e con i ricordi del fratello e della madre; le confronta con le recensioni apparse sui periodici tedeschi e poi americani in occasione delle prime dei film. Nulla tralascia, dunque, per richiamare in vita chi non poteva più parlare con lei dei metodi di costruzione del proprio linguaggio visivo. Con rigore e sistematicità di analisi Eisner intercetta nella documentazione di cui dispone gli elementi che permettono di definire lo stile, passando dalla biografia alle riflessioni sul linguaggio specifico della disciplina, sempre conservando per il lettore tutto il fascino del personaggio. I preziosi aneddoti non sono mai esornativi, ma assolutamente funzionali a questo duplice registro di ricerca e di cifra comunicativa. L’esasperazione di Jannings, protagonista del Faust, e di tutta la troupe, coperta di sudore e coi nervi a pezzi per la insistita ripetizione della scena del volo sulla città, attraverso i miasmi della pestilenza, visivamente resi con fuliggine soffiata da un’elica, si contrappone all’imperturbabile certezza del regista: «sorridendo porse il suo camice bianco ormai sporco al trovarobe e lo fece sostituire con uno pulito, poi disse laconico: "Se non lo sopportate, non venite"». Eisner discute la questione di una lettura realista di Murnau, che potrebbe sorgere di fronte a questi episodi, ma ci offre una chiave di lettura che sopravanza di molto le facili etichette, e che ben si accorda a un giudizio espresso nel 1921, una delle tante preziose perle che questo libro ci consegna: per il giovane appena assunto alla Bioscop come regista si parlava di «essenziale, nobile oggettività», «avversione per ogni tipo di facili espedienti». Ben consapevole, per averli vissuti, di quanto gli anni di Weimar fossero ricchi di umori contrastanti, e di quanto complesso fosse il rapporto tra gli artisti, l’eredità dell’espressionismo e l’incalzare delle nuove ricerche della Sachlichkeit, in bilico tra registrazione e allucinazione della realtà, Eisner riporta la cura di Murnau per i particolari a un’esigenza di stile, applicata parimente a invenzioni comiche o a narrazioni oniriche. Il filtro della lente ottica, che consentiva la lettura delle forme in segmenti corrispondenti alle inquadrature, diviene la misura di ciò che entrerà o uscirà dalla costruzione del film: come un architetto della visione, il regista sacrificava all’incrollabile esigenza di qualità che lo sosteneva ogni elemento accessorio, per puntare decisamente a una sintassi visiva di massima eloquenza, tanto da desiderare film privi di didascalie e considerare l’avvento del sonoro troppo precoce rispetto all’esplorazione ancora in corso e non completata delle potenzialità espressive della macchina da presa. È un fatto singolare come Eisner sia riuscita ad eguagliare Murnau nella serietà e nella responsabilità verso il proprio oggetto di ricerca, tanto da rendere il suo testo doppiamente prezioso: come contributo alla storia delle arti, e come esempio di metodo. Nella breve prefazione a L’ecran démoniaque (1952) Eisner aveva dichiarato di voler discutere solo quei film «di cui conserviamo un ricordo preciso, o che abbiamo avuto occasione di rivedere nel corso di recenti rassegne retrospettive»; e in contrapposizione alla disinvoltura della scrittura sul cinema diffusa in quella sua epoca invocava l’esempio di questo metodo, definendolo tipico della storia dell’arte (che non è più quella di un tempo, cara Lotte). Consiglio finale: forse un pellegrinaggio sull’esempio di Herzog, non tanto per tenere in vita Lotte, ché i suoi libri assolvono egregiamente a questo compito, quanto per resuscitare anche per la storia dell’arte un modello lineare, retto e coerente. In questo formidabile «scavo» del 1964 l’allieva di Wölfflin (e Langlois) si cala nella sostanza formale («nobile oggettività») di un’opera troppo segnata dalla lettura sociologica di Kracauer ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (17 TRASFERTE Expo di Shangai: il «modellino» del padiglione rumeno e (in piccolo) di quello italiano «Better city, better life» è il tema dell’esposizione universale: in realtà in questo enorme catino illusionistico, con pochi visitatori occidentali e un fiume da tutte le parti della Cina, la città del futuro è un nuovo inferno ■ UN REPORTAGE DALL’EXPO 2010: PERPLESSITÀ SU UN GIGANTISMO VUOTO ■ Entropia calda a Shanghai di Daniele Balicco SHANGHAI S e osservato dall’esterno, il padiglione italiano all’Expo di Shanghai presenta un profilo stranamente sobrio, mentale, quasi austero. La forma è semplice, squadrata, per quanto mossa lateralmente da feritoie diagonali e da una vasta vetrata a inserzione che si apre sull’ingresso principale. Il movimento interno dei volumi dovrebbe ricordare, al visitatore che lo attraversa, la sovrapposizione scomposta e casuale delle bacchette di legno dello Shanghai, il noto gioco per bambini. Anche il materiale con cui la struttura è costruita è poco appariscente, così come il suo tono cromatico dominante: il grigio chiaro. In realtà, come ci spiegano, si tratta di un materiale innovativo, un nuovo tipo di cemento trasparente che filtra e armonizza all’interno del padiglione la luce bianca lattiginosa proveniente dall’esterno. Nell’infinita area espositiva che lo circonda, afflitta da spazi fuori misura e da profili surreali, seducenti e aggressivi come tropicali piante carnivore, la forma del padiglione italiano progettata da Giuseppe Imbrighi esibisce quasi un silenzioso gesto oppositivo. Basti pensare che, solo per restare nel settore europeo, a pochi metri di distanza da quello italiano, il padiglione inglese ostinatamente interroga la curiosità di chi passa mostrandosi nell’incomprensibile nuvola di spilli acrilici disegnata da Thomas Heatherwick. Poco più in là, un complicato gioco di case sospese mostra le acrobazie estetiche (e finanziarie) della ricchissima Olanda. Una mela verde morsicata è la Romania; una tazza bianca smaltata, galleggiante su un tranquillo lago artificiale ricoperto 18) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 da ciottoli di fiume, è la Finlandia. Ogni paese – o forse meglio la specifica forma del suo capitalismo – proietta qui, nello spazio ordinato e gerarchico dell’Expo, la propria auto-rappresentazione simbolica, la proiezione immaginaria del posto preteso all’interno della nuova geografia economica mondiale. Case degli spettri, giostre delle meraviglie, colonie extra-terrestri, isole misteriose, tranne poche eccezioni – Cina, Stati Uniti, Germania, Canada, Italia – la dominante estetica dei padiglioni della fiera internazionale (ancora fino al 31 ottobre) mostra, potenziata fino alla vertigine e allo smarrimento, la proiezione inconscia di un mondo reale divenuto inabitabile. «Il tema – mancato – dell’Expo dovrebbe essere niente meno che il futuro delle nuove città. Better city, better life, come ossessivamente è ripetuto ovunque: su pupazzi, magliette, poster, cartelloni, penne a sfera, orologi. Eppure nella maggior parte dei padiglioni visitati, io e Fabio abbiamo cercato invano prototipi che quanto meno ci mostrassero sogni e illusioni di un futuro sostenibile che non sarà. Nel migliore dei casi, abbiamo assistito invece a continue variazioni su tema di un’esasperata combinazione di tecnologia e distrazione regressiva. Più spesso, esposizioni intelligenti, o bizzarre, di normalissimi prodotti commerciali, come i telefonini Nokia all’interno del padiglione finlandese. I visitatori occidentali sono pochi, la stragrande maggioranza è cinese. Fiumi infiniti di persone, migliaia e migliaia, provenienti da ogni parte della Cina, ma apparentemente sempre più americanizzate, si riversano senza pace in questo enorme catino illusionistico. I cinesi sono disposti a fare code di ore, sotto un sole infuocato e un’umidità quasi del 100%, pur di vedere piccoli pezzi camuffati di mondo. Soprattutto a Fabio, che è da e piena di rifiuti. Una piccola alto, biondo, riccio e per di più discarica a cielo aperto. Ed è l’encon gli occhi celesti, i ragazzi cinenesima ferita al nostro senso di si di continuo chiedono fotografie: appartenenza perennemente gli mettono i propri figli piccoli sulumiliato. Una volta entrati nel pale spalle, lo abbracciano sorridendiglione, troviamo quello che spedo. È un’attrazione da fotografare. ravamo di non trovare: una serie Per il signore anziano dello Yuscomposta di stereotipi e di granan, per la bellissima studentessa tuite follie. Quello che l’Italia di chimica dell’università di Chenespone per il futuro possibile del gdon, per l’adolescente omosesvivere urbano sono anzitutto suale della periferia di Shanghai, macchine e moto (e non certo vestito male come molti giovani ecosostenibili); lussuosi mobili di italiani, tutto attillato, con enormi design, scarpe, vestiti e pasta. Del occhiali neri e capelli cotonati in resto, accanto a una Ferrari fiammodo improbabile, per tutti loro, meggiante i cinesi si mettono in fiio e Fabio, davvero, arriviamo dalla per fare una foto. In un’altra sala Luna. Gli occidentali incuriosila, imprigionate in una teca di vescono quasi più delle bizzarre fortro, due artigiane del legno inme dei padiglioni dell’Expo, quasi comprensibilmente scolpiscono si rendessero conto, i visitatori cipinocchi. Poco più in là, un video nesi che qui vengono portati a veincomprensibile sul ponte di Mesdere il mondo, che l’esotico lì mosina (proposto come esempio di strato è solo, marxianamente, la genio italico e altissima tecnolorappresentazione camuffata di un gia in una città come Shanghai equivalente generale. che viaggia con treni a lievitazioLa coda per entrare al padiglione magnetica e che ha saputo cone italiano è lunga, non lunghissistruire 9 linee della metropolitama come invece sarà quella per na in 4 anni; siamo davvero al ridila Germania, l’Arabia Saudita, il colo) divide a metà una sala occuGiappone o la Corea del Sud. A pata da videoinstallazioni della ridifferenza di molti altri spazi vista «Abitare» che mostrano stralespositivi, l’Italia non prevede ci di vita quotidiana di una nazioprotezioni per il sole e il caldo sofne improbabile, smarrita, senza focante. Un’ora di coda è semplicemente una tortura. Ci ritroviamo così subito a casa, messi per l’ennesima volta di fronte all’incapacità tutta nostrana di occuparsi realmente delle persone comuni, privi di pass, tesserini o di conoscenze capaci di vanificare, con un colpo di mano, ore di fila. Siamo come su un tram di Roma, d’estate. Su un tram rovente, affollato e senz’aria. Quella che dovrebbe essere una vasca d’acqua alla fine del padiglione, sul lato sinistro della coda, invece di mostrarsi come traccia e richiamo culturale di una lunga tradizione magnifica di fontane e giochi acquatici, i nostri parchi storici, i giardini all’italiana, Villa d’Este, è un impressionante ritorno del rimosso della nostra contemporaneità offesa. Una vasca di cemento, con poca acqua putri- bussola. Perfino la luce delle foto ci tradisce. Un unico prototipo di abitazione ecosostenibile è nascosto in un lato della sala centrale; lo si nota per caso, attraversando il bel gioco di volumi costruiti per proteggere l’esposizione del nulla. Saliti al piano superiore si passa attraverso una sala che malamente riproduce con due videoinstallazioni il labirinto di strade e di piazze proprio dell’urbanistica italiana; poco oltre la mostra di una regione, nel nostro caso la Puglia, per fortuna parzialmente centrata, oltre che sul turismo, sullo sviluppo delle energie rinnovabili: solare ed eolico. Tiriamo, almeno per un attimo, un sospiro di sollievo. I due ristoranti di cucina italiana all’interno del padiglione sono gestiti solo da cinesi; se si chiede il timbro italiano per il gioco del passaporto che appassiona tutti i visitatori dell’Expo, ci viene risposto che l’Italia non lo fa. Cerchiamo infine qualche rimando all’Expo di Milano 2015 e lo troviamo nascosto in un piccola stanza. Ed è un paese governato ormai quasi esclusivamente da venditori di eventi e improbabili esperti di marketing. Così se la bella struttura architettonica mo- stra all’esterno, anche nel confronto con gli altri padiglioni, solidità, eleganza e intelligenza creativa; l’interno violentemente sprofonda nel trionfo del nulla culturale di questa nostra patetica italietta berlusconiana. Degli altri padiglioni che abbiamo visitato, gli unici veramente emblematici per capire fino in fondo il gioco di specchi auto-rappresentativo dell’Expo, sono, ovviamente, Stati Uniti e Cina. L’involucro di quello statunitense nasconde al suo interno tre enormi sale cinematografiche. A differenza della maggior parte degli altri spazi espositivi, il visitatore qui non può muoversi liberamente; deve sedersi e vedere in ogni sala un filmato. Entrano trecento visitatori per volta. Si spengono le luci. Inizia la narrazione degli States, superpotenza ormai capace solo di narrare il sogno di se stessa. Nel primo filmato, l’ambasciatore americano saluta in cinese i visitatori che immediatamente vanno in visibilio; poi una maestra si muove per Central Park cercando di insegnare una piccola frase di mandarino a simpatici, piacenti, atletici e snobissimi giovani newyorkesi. Nella seconda sala, Hillary Clinton spiega, sempre in mandarino, che gli Stati Uniti sono una terra di immigrati, e quindi naturalmente anche di cinesi. Poi una maestra, questa volta americana, mostra la propria classe di bambini di tutte le etnie del mondo mentre discute i loro progetti per un futuro migliore: better city, better life. Conclude Obama, con il suo bel sorrisone, salutando SEGUE A PAGINA 20 Eugène Delacroix, «Amleto scorge lo spettro del padre», Cracovia, Museo Jagellonico FUSINI ■ «DI VITA SI MUORE»: UN SAGGIO DI NADIA FUSINI ■ thing of nothing», «il re è una cosa fatta di nulla». Non più creatura, perché il Creatore, come il Re, è andato «a cena dai vermi» – osserva Amleto –, la Via Crucis dell’uomo come cosa-insé, l’uomo come res, insieme cogitans e patiens, cosa-che-pensa e cosa-che-sente, non può essere se non un viaggio all’inferno. L’uomo, res cogitans e res patiens (Cartesio e Spinoza sono a più riprese evocati), già abbandonato da Dio, e ora anche senza la salvezza della ragione (il dubbio metodico cartesiano) e nemmeno della politica geta, che ripete, ripercorre e con(il comunitarismo dell’amor intelfligge con il Testo. Eppure, la riaplectualis spinoziano), l’uomo penpropriazione che il Teatro opera sa e patisce come l’attore, evacuasulla Scrittura, non essendo proto fuori da se stesso. prietà naturale, bensì usurpazioSi comprende così il titolo, strane – quanti re usurpatori e scorotegicamente interlocutorio e dunnati nel dramma shakespeariano! que tanto più soppesato, del libro – resta insanabile lacerazione, fadi Fusini: le «passioni» sono quelglia abissale, ferita aperta, ed è, lo che non è la Passione di Cristo, appunto, in quella piaga, è dentro sono la «carne», la sarx di Paolo quella macchia rossa – come la senza lo spirito, il «piccolo residuo macchia di Lady Macbeth – in cui sporco» (anche Lacan con Freud Fusini – il lettore-attore e il lettore permea più d’una di queste pagiesegeta – vuole e insieme non ne), sono la pulsione coatta della può non abitare. Allora, qualcosa macchina desiderante (Deleuzedi essenziale si fa chiaro: che, Guattari) senza altra meta che la cioè, il teatro di Shakespeare è la morte. «Di vita si muore», appunscena della Dannazione e che Futo, intitola Fusini, ovvero, come disini ha pensato il suo libro in cince Amleto, «il sole genera vermi que atti non solo come tragedia nella carcassa di un cane», perché shakespeariana, ma come Via «sono le carogne a dare frutti». Di Crucis del Dannato, non più del vita si muore: le passioni, le emoSalvatore, non più di Cristo, ma zioni, sono le pustole della natura, dell’uomo come cosa-in-sé: lo diil resto intossicato e soprattutto ince chiaramente Lear a Edgar, sensatamente persistente (è parola «Thou art the thing itself», «tu sei chiave di Fusini) d’una malediziola cosa stessa»; lo dice chiaramenSEGUE A PAGINA 22 te Amleto del re «The king is a Leggere Shakespeare all’ultimo respiro di Massimo Stella L a scrittura della critica, quando è critica di rango, s’intende, è una questione di metodo: ci sono libri scritti a una distanza siderale dall’atto di lettura che, necessariamente, presuppongono. E ci sono poi libri che, invece, riducono quella distanza all’ultimo respiro, sospendendola nell’aria, davanti a noi, come un delicatissimo interim. Questo, appunto, è il caso del libro, interamente shakespeariano, di Nadia Fusini: Di vita si muore Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare (Mondadori, pp. 495, € 22,00). È una questione di metodo, si diceva, che dipende da che cosa si vorrebbe capire di un certo oggetto e da come lo si vorrebbe capire: qui si tratta di teatro e, specificamente, del teatro di Shakespeare. Che cosa, dunque, e come scrivere, sul teatro e su Shakespeare, al di là delle sue potenzialmente infinite messe in scena, per un verso, e senza trasformarlo, per l’altro, in letteratura o in (ri)costruzione ideologica? Fusini risponde con un libro in cui il corpo visibile della scrittura critica aderisce quasi millimetricamente – lo scarto, l’interim, è metodico – al corpo invisibile, perché presupposto, perché precedente, perché perduto, della lettura: il suo libro è una vera e propria scena di lettura. La lettura come azione, innanzitutto. Fusini legge nella posizione dell’attore, nella posizione cioè di chi parla e agisce, restituendo così la dimensione squisitamente drammaturgica del testo: «l’attore è un critico del dramma», diceva acutamente Oscar Wilde ne Il critico come artista. E infatti la drammaturgia, in sé, è un puro, purissimo problema di tempi, cioè di parole-azioni: se si scrive di teatro non si può prescinderne. Da qui, dunque, la meditata struttura, sino al più sottile dettaglio, del libro, suddiviso in cinque atti-capitoli (come risulta almeno oggi una tragedia shakespeariana), dedicati ognuno a un dramma: I Giulio Cesare, II Amleto, III Otello, IV Lear, V Macbeth, preceduti da un Prologo, pausati tra il II e il III atto da un Intermezzo (Misura per misura), alla maniera elisabettiana dell’induction o del play-within-the-play, lo spettacolo nello spettacolo, e chiusi infine da un Congedo. E, tra un atto e l’altro, brevi istanti, poche pagine di scrittura corsiva, in cui si pronuncia il tema dell’atto imminente o vi si allude per uno scorcio di prospettiva o lo si lega e riporta a quelli precedenti, in un gioco di rimandi, con lo scopo di ricordarci che, in cornice, fuori e oltre il libro, esiste, è esistito, il lettore all’opera. Ciascun atto-capitolo, infine, ripercorre la tragedia cui è dedicato seguendo il tempo dettato dal drammaturgo: dal primo al quinto atto, appunto, dal primo all’ultimo minuto, in modo da sentire l’attimo che passa, l’inseguirsi delle parole e dei gesti, pur se non si rinuncia a far scorrere la spola avanti e indietro per il testo, in nome di quella reversibilità che, se non è del tempo fisico, è tuttavia della memoria di chi sta assistendo allo spettacolo. Ma, alla lettura come azione, che ci ridona la drammaturgia senza svuotarla della sua energia di movimento, si intreccia un’altra forma di lettura: la lettura come pratica sapienziale. E il teatro di Shakespeare assurge allora dal rango di scrittura a quello di Scrittura: la Scrittura ebraico-cristiana della tradizione mediterranea antica e tardo-antica fino al suo punto di rottura con Lutero, più semplicemente, quella che noi chiamiamo Bibbia. Il teatro di Shakespeare non è Testamento, né Legge, certo, ma, secondo Fusini, con l’autorevolezza del Testamento e della Legge esso compete, antagonisticamente, e ne rioccupa lo spazio carismatico che, in quel momento, nell’Europa tra Cinque e Seicento, rivelava, ormai per sempre, la sua perdita d’aureola. Il lettore-attore diventa allora Rabbino, Padre della Chiesa, Monaco e Semplice Cristiano che rivendica la propria libertà interpretativa (Lutero), diventa cioè lettore-ese- Scena di lettura in cinque atti (Giulio Cesare, Amleto, Otello, Lear, Macbeth), questo libro «pratica» il teatro shakespeariano come azione e orizzonte agonistico moderno della Scrittura sacra S H A K BERSAGLI E S P E A R E Cardenio e la novella che sfida gli anglisti di Viola Papetti Il canone shakespeariano (CWWS The Complete Works of William Shakespeare) subisce periodicamente drastiche cure da parte degli accaniti studiosi: ingrassa, dimagrisce o addirittura perde la testa. Shakespeare è troppo Shakespeare per essere un semplice «attore di Stratford», una cittadina sull’Avon, che a Londra fece fortuna scrivendo mirabile poesy – allora per poesy si intendeva sia la poesia che il teatro. La sua authorship è stata ancora una volta messa in dubbio dagli storici che hanno contribuito alla collectanea, Shakespeare and his Authors, curata da William Lehary, e severamente stroncata da Stanley Wells («TLS», 13 agosto 2010), grande e riconosciuto esperto del Bardo. Invece è stato ben accolto da Peter Holland (ivi), altro più giovane ma anche lui eccellente studioso, l’originalissimo Phenomenal Shakespeare di Bruce R. Smith che bisogna assolutamente leggere come esempio entusiasmante per la nostra individuale scoperta di uno Shakespeare fenomenologico. Quei testi sepolti sotto la coltre di una critica di secoli ci appariranno in una nuova luce che ci sorprenderà. Basta provare. Dal discutibile Shakespeare Only di Jeffrey Knapp apprendiamo che l’autore singolo – che sarebbe il caso del Bardo impegnato per anni con la stessa compagnia di cui era anche azionista – o l’autore in collaborazione con un altro autore erano casi frequenti. La doppia paternità si poteva districare solo al momento della stampa del testo poiché nelle locandine non figurò il nome dell’autore o degli autori fin verso il 1700, quando Dryden notò con sorpresa che il nome di Congreve era apparso appunto in locandina. In quella situazione i falsi potevano proliferare e inventare anche i loro doppi, bugiardi ma pretenziosi, attirando verso il corpo delle opere shakespeariane (CWWS) gli sguardi mai soddisfatti dei posteri. Nella seconda edizione di The Oxford Shakespeare. The Complete Works (2007), curato da Stanley Wells e Gary Taylor, su Cardenio si può trovare «Un breve resoconto», anzi brevissimo, e non il testo che sarebbe di Fletcher e Shakespeare però scomparso negli incendi del Globe prima, e del museo del Covent Garden poi. Cardenio è un personaggio della prima parte del Don Chisciotte, pubblicato in inglese da Thomas Shelton nel 1612. The History of Cardenio, con la doppia paternità, è registrato dal libraio-editore Humphrey Moseley nello Stationer Register del 1653 – ma poco ci si può fidare di Moseley che usò il nome del Bardo falsamente in altre circostanze. Tuttavia pagamenti per la rappresentazione di un dramma Cardenno o Cardenna figurano tra i documenti dei King’s Men. Nel Settecento, il secolo neoclassico in cui si passò dalla imitatio alla audace creatività del falso che rivendica la sua autenticità, Lewis Theobald pubblicò Double Falsehood, or the Distrest Lovers, ora tradotta per la prima volta in italiano da Thomas Fazi e Enrico Bistazzoni, Doppia menzogna ovvero gli amanti afflitti (con prefazione di Roberto Bertinetti, testo originale a fronte, Fazi Editore, pp. 200, € 16,00). La tragicommedia, tratta dalla novella sentimentale di Cardenio e Lucinda (Don Quixote, I, 36-7), è stata accettata nella autorevole collana Arden Shakespeare come tardivo frutto della penna del Bardo e inserita, di fatto se non di diritto, nel canone. «Tutti i falsi sono fatti allo scopo di passare per autentici. Di conseguenza debbono essere imitazioni ben fatte, quasi perfette in modo da entrare nel canone che intendono forgiare senza destare sospetti» (Innocenti). A teatro i testi erano e sono tuttora sottoposti a trasformazioni, adattamenti, tagli e lo scritto ha la stessa non finitezza di uno spartito musicale, la stessa possibilità di inverarsi in una esecuzione ogni volta diversa. Shakespeare era già merce, e secondo l’opinione comune un falso era una pugnalata al commercio (Holliday) o il risultato illegittimo di un adulterio (Boswell). Il Copyright Act del 1709 confermava l’arte come proprietà intellettuale e inimitabile del suo autore. Lewis Theobald aveva pubblicato una buona edizione completa delle opere di Shakespeare, senza includervi The Double Falsehood, che invece pubblicò a parte nel 1728 come frutto della collaborazione del Bardo, in tarda età, con John Fletcher, prolifico giovane drammaturgo. Dichiarò di possedere il manoscritto seicentesco che aveva revisionato e adattato per la scena con grande fatica. Ma non lo esibì mai. Pope, anche lui curatore meno attendibile di Theobald di un’edizione completa dell’opera shakespeariana, lo attaccò furiosamente, in special modo per The Double Falsehood, che nel titolo sembra ammiccare ironicamente alla sua natura di falso che si impone come vero, a dispetto di quello originario. E come tale ebbe un certo successo e fu rappresentata nel 1727 e ben sei volte fino al 1847. La traduzione di Fazi e Bistazzoni tralascia i tenui barocchismi dell’inglese e decisamente punta all’ammodernamento del testo in vista di una eventuale rappresentazione italiana. Gli anatemi di Pope contro Theobald nella New Dunciad non ebbero grande effetto. E ancor oggi Cardenio lancia la sua sfida. L’anglista di fama mondiale Stephen Greenblatt – di cui uscirà in dicembre Shakespeare’s Freedom – in collaborazione con Charles Mee ha scritto in Italia il suo Cardenio, ambientato in Umbria tra un gruppo di americani in viaggio di nozze, che ha già iniziato il suo percorso teatrale come esempio di «mobilità di materiali da un autore o da una tradizione a un’altra» (Greenblatt). Ma c’entra davvero Shakespeare? A mio pare il testo di Theobald è un’esangue brutta copia del Sogno di una notte di mezza estate, spogliato del fantastico intreccio tra il mondo feerico e gli artigiani per esser ridotto all’unità neoclassica del plot, spenta la luminosa poesy dell’«artigiano» di Stratford – così lo chiamò Kipling. ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (19 STASIUK TRASFERTE DA PAGINA 18 tutti in mandarino. Il pubblico ci nese applaude, commosso e felice. Nel terzo cinema, infine, viene proiettata una piccola fiction. Una bambina americana vuole trasformare in un giardino lo spazio degradato che si apre all’incrocio di due strade, proprio di fronte alla sua finestra. Dopo una serie di ostacoli e di conflitti, una donna cinese, un giardiniere africano, e altri insopportabili abitanti del quartiere, aiutano la bambina a realizzare il suo incantevole giardino pubblico aperto a tutti. Non basta. Nel finale un uomo elegante, con gli occhiali, che ha osservato a distanza tutta la scena seduto su una panchina, mentre leggeva il Financial Times, di fronte a una richiesta d’aiuto della nostra piccola urbanista, si toglie giacca e cravatta e solleva, muscoloso e aitante, l’ultimo pezzo di cemento che deve essere spostato. Si accendono le luci e si esce dal padiglione. Nessun prodotto americano esposto, nessun progetto: solo tre film. Diametralmente opposto è il padiglione cinese che giganteggia rosso fuoco su tutta l’Expo. Nessun altro edificio dell’intera fiera può superarlo in altezza. All’interno c’è tutta quanta la Cina di oggi, stipata in una specie di enorme aeroporto dove si soffoca per la quantità di persone e per l’abbondanza senza fine di prodotti, filmati, riproduzioni esposte, per quanto organizzati e divisi per regioni e città. L’unica cosa possibile è contemplare stupefatti, e un po’ atterriti, questa immane esibizione di potenza di una nazione economicamente trionfante su un pianeta morente. Altro che better city, better life. In qualunque padiglione regionale si entri, si vedono oltre a mille prodotti diversi e ai soliti reperti archeologici, soprattutto filmati di città trasformate, di aeroporti, di enormi impianti industriali, di sistemi di trasporto integrato. Tutto è stato trasformato e modernizzato. Non a caso è un paese guidato da più di vent’anni da una classe dirigente di ingegneri e di tecnocrati che non prevedono mai che, prima o poi, gli equilibri naturali ci chiederanno il conto. Nei sei giorni passati a Pechino, favolosa città della mente, non abbiamo mai visto il sole. Una luce bianca spettrale continua, impastata di umidità e di smog, la avvolge come un mantello di disperazione. Il cielo è riapparso, solo lasciando la città in aereo e solo dopo mezz’ora dal decollo. Better city, better life. Pubblicando il proprio diario personale scritto nel 1958, durante il suo primo soggiorno in quella che fu la Cina di Mao, Edoarda Masi, nell’introduzione del 1993, scriveva: «A lungo mi sono rifiutata di tornare in Cina. Ma la città perduta era Pechino, non Shanghai. Come è perduta Roma, dove non riconosco i luoghi che sono stati i miei. E quasi non capisco perché questa sarebbe la mia patria più di qualsiasi altro luogo d’Europa. In questi ultimi anni è stato creato un mondo intero di “emarginati”. Non sarà senza conseguenze. Da più parti e con ogni mezzo si è annullata la possibilità dell’opposizione orientata ad un fine, regolata da una guida e animata dalla speranza. In un sistema che genera distruzione, i subalterni vengono privati di ogni capacità che non sia pura distruzione. La Cina di oggi è paurosa perché sta per essere trascinata in questo». 20) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 Un ritratto dello scrittore polacco Andrzej Stasiuk Il cinquantenne romanziere polacco torna in quella regione frontaliera dei Carpazi, tra le più dimenticate d’Europa, che gli dà modo di animare gli elementi e di sperimentare una particolarissima scrittura atmosferica: non narrativa ■ «IL MONDO DIETRO DUKLA» DI ANDRZEJ STASIUK ■ dei Carpazi occidentali. Una delle aree più selvagge d’Europa, descritta in un momento storico preciso (gli anni successivi alla caduta del comunismo) ma che resta ostinatamente fuori dal tempo, resistendo tanto ai cambiamenti politici quanto alle definizioni razionali che cercano di individuare il genius loci e di afferrare lo spirito profondo di un luogo. La ricerca di luoghi al margine per Stasiuk è più che altro un elementare impulso estetico, il bisogno di trovare posti dove la storia e la bellezza non schiaccino mente non mancano nella sua l’immaginazione, come invece gli prosa gli elementi tipici dell’autopuò accadere a Parigi o Venezia, re ribelle, come si vede nel romandove non è mai stato e dove dice zo Corvo bianco (sempre tradotto che non sarebbe mai in grado di in Italia da Bompiani), storia di scrivere. Ancora una volta però, una gita tra amici d’infanzia in fusarebbe riduttivo fermarsi alla suga dalle proprie disillusioni che aspremazia del luogo sull’intreccio, sume i contorni di una disperata soprattutto se non ci accontentialotta per la sopravvivenza, tra le mo di stantie tassonomie letteranevi, ancora una volta, dei Carparie che prevedono quello sfuggenzi. Ma è nel suo carattere descrittite sottogenere letterario, buono vo che la prosa di Stasiuk, alle presolo per disporre i volumi nelle se con la natura, gli elementi, lo grandi librerie, che prende il nospazio circostante, rivela il suo me di «letteratura di viaggio» e tratto più ispirato e interessante, che ha ingabbiato per anni persiquello che permea i racconti conno un grande scrittore come Katenuti in Il mondo dietro Dukla, puscinski. Nel caso di Stasiuk afsorta di quadri indipendenti legafiorerebbe un dubbio: i luoghi a ti a un luogo concreto e uniti dal cui egli è così tenacemente legato filo sottile della memoria visiva. e a cui tendono le proprie ossesAfose domeniche estive con rari sioni biografiche e letterarie riealberi a fare ombra, rane che anscono a tramutarsi in veri «luoghi nunciano la fine dell’inverno, indell’anima», in grandi metafore verni in cui la neve «sfavilla democome la Sicilia di Sciascia o, per ciniaca», vagabondaggi, vodka e un tare un altro grande polacco, la amore adolescenziale per una vilDrohobycz di Bruno Schulz? La leggiante il cui viso, nell’emoziomediazione letteraria riesce cioè ne, sembra sempre sfuggire al trea fare di un luogo concreto, in dicenne protagonista. Non si tratquesto caso sperduto ai margini ta però di bozzetti di colore o di dell’Europa centro-orientale, uno una fuga nell’esotismo, e nemmescenario universale, il teatro del no di una trita riflessione su fronmondo che ogni grande classico tiere antiche e moderne, visibili e mette in scena? invisibili. Anche nei Racconti galiUn libro come Il mondo dietro ziani, un volume anche questo anDukla indica che forse l’obiettivo cora inedito da noi, la prosa di Stadi Stasiuk,e il suo lato più interessiuk rincorre luoghi (e mondi) posante, è di altro genere, e si lega alco battuti sia dall’attualità della lo stile e all’uso della lingua, una cronaca che dall’inattualità della scrittura evocativa (pienamente letteratura: la catena montuosa restituita dall’impeccabile tradudei Beskidy, estrema propaggine zione italiana) che guarda alla po- Descrivere la luce, forse non è possibile di Francesco Groggia «S e desidero un’acqua d’Europa, è la pozzanghera/ Nera e gelida…» scriveva Rimbaud nel Bateau Ivre. Andrzej Stasiuk la sua pozzanghera europea, di certo avvolta nel gelo, l’ha trovata in quella regione dei Carpazi al confine tra Polonia, Slovacchia e Ucraina in cui si svolgono molti dei suoi racconti, tra cui Il mondo dietro Dukla (Bompiani, traduzione di Alessandro Amenta e Laura Quercioli Mincer, pp. 171, € 16,00). Dukla è appunto il piccolo centro attorno a cui ruotano le storie che compongono il libro, un luogo situato una zona tra le più periferiche e dimenticate d’Europa, dove la meraviglia della natura contrasta con i tratti a volte dimessi e squallidi di una presenza umana comunque ostinata, fatta di migliaia di corpi e anime che tentano «ognuno a modo suo di spuntarla sul giorno». La scelta della regione (in cui lo scrittore abita in una sorta di apparente, volontario isolamento) è per Stasiuk allo stesso tempo poetica ed esistenziale, ed è legata a una caratteristica essenziale del luogo: la sua marginalità, sia geografica sia letteraria, il fatto cioè di essere priva di mitologie preesistenti, requisito indispensabile per fabbricarne di nuove. La stessa biografia dell’autore sembra accompagnare questo processo: nato a Varsavia nel 1960, arrestato appena maggiorenne per diserzione e condannato a un anno e mezzo di carcere (un’esperienza che rievocherà nel suo primo libro Le mura di Hebron, ancora inedito in Italia), oppositore al regime comunista, attivista in un movimento pacifista (il WiP), a partire dagli anni novanta diventa uno scrittore di successo, appartato e indipendente. Con racconti e romanzi anche di ambientazione metropolitana, come Il cielo sopra Varsavia e Nove (il primo pubblicato da Bompiani, il secondo ancora inedito in Italia), che uniscono la gangster story con una riflessione esistenziale sempre inquieta, negli anni Stasiuk ha soprattutto coltivato e rivendicato la propria autonomia, ostentando noncuranza per mode e ambienti letterari fino a fondare, con la moglie Monika Sznajderman, una propria casa editrice, la Czarne, che pubblica principalmente scrittori dell’Europa centro-orientale. Se scrivesse in inglese o in francese, se fosse cioè inserito in una tradizione letteraria «forte», di quelle che coltivano una venerazione particolare per la figura dello scrittore «maledetto», in una linea ideale che attraverso l’oceano va da Rimbaud a Kerouac, Stasiuk sarebbe un autore di culto anche al di fuori della Polonia. E certa- esia e cerca di avvicinarne il ritmo. A questo proposito, in una conversazione con il critico Stanislaw Beres contenuta in una storia della letteratura polacca attraverso i colloqui con gli scrittori (idea interessante e magari esportabile), Stasiuk cita come propri modelli quasi esclusivamente poeti, e non solo polacchi (c’è anche, guarda caso, Rimbaud). La lingua poetica di Stasiuk cela un’ossessione che in Il mondo dietro Dukla, pieno di abbozzi di storie e meravigliose descrizioni, è dichiarata esplicitamente, più volte, come affermazione di una personale poetica che predilige l’essere al divenire: «Da molto tempo mi sembra che l’unica cosa che valga la pena descrivere sia la luce, le sue trasformazioni e la sua eternità. Le azioni mi interessano in misura decisamente minore. (…) Gli eventi e gli oggetti o finiscono o muoiono o vanno in pezzi sotto il proprio peso e quando li guardo e li descrivo lo faccio solo perché rifrangono la luce, la modellano e le danno una forma che siamo in grado di capire». Si potrebbe aprire il tema, già classico, sui limiti e le possibilità del linguaggio, sulla sua capacità di descrivere la realtà, ma Stasiuk, troppo sanguigno o troppo saggio per affondare in questioni di pura speculazione, sa che l’equilibrio precario tra intuizione e fallimento, tra ambizione e limite è un tratto costitutivo dell’affabulazione letteraria. Se il linguaggio è inadatto a descrivere il mondo come si vorrebbe e se ogni libro rappresenta una temporanea sconfitta, non arrendersi, libro dopo libro, diventa un atto, questo sì, ribelle, e allo stesso tempo molto umano, perché carico di una speranza forse insensata. «Non è possibile descrivere la luce, al massimo la si può immaginare, cominciando sempre da capo». PHILIP ROTH di Francesca Borrelli M i chiamo Nathan Zuckerman e non ho un Io: questa, al fondo di tutta la sua esibita perentorietà, è l’unica vera certezza del più famoso personaggio della letteratura americana degli ultimi cinquant’anni, l’ebreo di Newark figlio di un podologo, la cui comparsa sulla scena del romanzo è datata 1979 e il cui luogo di nascita si trova fra le pagine di un libro di Philip Roth, Lo scrittore fantasma. Da allora, Zuckerman ha recitato nel ruolo di protagonista una decina di volte, finché il suo creatore ne ha decretato la fine orsono tre anni fa, in un libro eloquentemente titolato Il fantasma esce di scena: dopo quasi trent’anni di remunerativi servizi resi in qualità di principale alter ego dello scrittore americano, una sentenza davvero crudele, che i lettori di tutto il mondo si augurano reversibile. È vero, però, che segnali di insofferenza verso il suo personaggio Philip Roth li aveva già maturati da tempo, probabilmente a partire dallo sforzo costatogli nel ritagliare a Nathan Zuckerman il più complesso e il più schizoide dei suoi ruoli in quello che resta l’intreccio più elaborato tra i molti dell’autore americano: titolato La controvita, è un romanzo del 1986, già pubblicato da Bompiani e ora ritradotto da Vincenzo Mantovani per Einaudi («Supercoralli», pp. 393, € 21,00). «Essere Zuckerman è una lunga recita – si lamenta l’illustre protagonista del libro – esattamente l’opposto di ciò che si intende con l’espressione essere se stessi». Lo dice a quella che è al medesimo tempo la sua giovane moglie e la principale comparsa femminile del romanzo che sta scrivendo, perché Zuckerman è – per le cronache letterarie – il celebre autore di un libro fortunato, al tempo stesso viatico della sua fama presso un vasto pubblico e responsabile della sua disgrazia presso la famiglia dalla quale proviene, i cui componenti ha ridicolizzato in impietose descrizioni esemplificative di tutte le nefandezze attribuibili agli ebrei. La controvita è dunque, nella più banale e nella meno esaustiva delle letture possibili, un metaromanzo, ossia un libro in cui Roth ospita gli appunti preparatori del testo al quale immagina stia lavorando Nathan Zuckerman; ma ciò che più impegna l’attenzione del lettore è la quantità dei punti di vista adottati dalla narrazione, dove una voce onnisciente si alterna alla presa di parola in prima persona dei protagonisti. E, al tempo stesso, lo sguardo su di sé che ogni personaggio rivendica come veritiero, si contrappone al ritratto stravolto che Nathan ne restituisce tra le pagine del suo romanzo, il quale evidentemente si avvantaggia della trasformazione di persone ordinarie in godibili caricature. «Uomini e donne – riflette – non si consegnano agli scrittori come personaggi letterari a tutto tondo: generalmente ti offrono assai poco su cui lavorare e, dopo l’impatto della prima impressione, non ti aiutano quasi più». Non esistono verità, sembra dire nietzscheanamente Zuckerman, esistono solo interpretazioni. Ma, a sua volta, questa arrendevolezza più che sottintendere una apologia dell’ermeneutica indica quanto sia illusoria la velleità di «bersi senza fiatare la maschera della naturalezza». Tutto deve aspettarsi il lettore fuorché una vicenda ricostruibile secondo il prima e il poi, in questa Controvita di Roth dove fabula e intreccio non coincidono mai, mentre si moltiplicano le prospettive e si incrociano i punti di vista, sia che li si intenda nella loro valenza di pareri su una stessa questione, quella ebraica prima di tutto, sia che li si assuma come dispositivi della narrazione attivati da uno scrittore magnificamente padrone di tut- Alla sua quarta apparizione sulla scena del romanzo americano, il più celebre alter ego di Philip Roth si esibisce in acrobatici sdoppiamenti di ruolo, mentre il suo autore si diverte a tessergli intorno una mirabile rete romanzesca «Conversations» di Ben Shahn, 1958, New York, Whitney ■ «LA CONTROVITA», UN ROMANZO DELL’86 RITRADOTTO ■ Ora Zuckerman recita a soggetto te le possibili strategie romanzesche. Forse, per orientarsi, si potrebbero isolare come momenti cruciali dell’intreccio i funerali dei due fratelli Zuckerman, perché sono queste le occasioni migliori per ricapitolare le vite dei personaggi. Poiché l’incipit del romanzo è fresco della morte di Henry, causata da una operazione di bypass che avrebbe dovuto emanciparlo dai farmaci assunti per la sua cardiopatia, farmaci a loro volta responsabili di averlo ridotto all’impotenza sessuale, il lettore è legittimato a pensare che questo fratello minore dedito alla professione di dentista muoia prima di Nathan, il famoso romanziere. Ma con il passare delle pagine apprenderà che non è così, e che il destino di Henry varia a seconda del ruolo assegnatogli dalla voce narrante, ovvero a seconda del fatto che egli figuri come un personaggio messo in campo dal narratore al quale Roth affida la storia, o come il protagonista del romanzo che Nathan sta scrivendo, grazie alle confidenze realmente ricevute dal fratello ma del tutto mendacemente riportate. Lo stesso Henry, infatti, leggerà di sé cose mai accadute, quando dopo i funerali di Nathan, al quale è dunque sopravvissuto, si introdurrà nella casa del fratello, e frugando nei suoi schedari troverà appunti compromettenti che lo riguardano, nonché la stesura del romanzo di Nathan, saturo di aneddoti familiari riportati con il consueto sarcasmo. Da quelle pagine apprenderà la disponibiltà del fratello a usare per i propri scopi narrativi il segreto che a suo tempo gli rivelò circa le sue relazioni extraconiugali, ma anche la spregiudicatezza di Nathan nell’inventare di sana pianta alcuni fatti di cui si sarebbe reso protagonista, per esempio un viaggio in Israele che lo avrebbe ridicolmente guadagnato all’ortodossia ebraica, lui che non pensava ad altro se non a eseguire con meticolosa precisione la sua professione di dentista. Pagina dopo pagina, Henry scorre incredulo gli appunti di quel roman- zo che il lettore già conosce per averne appreso la traccia nei precedenti capitoli raccontati in prima persona da Nathan, di cui non è mai dato sapere, se non a posteriori, di quale vita viva: se di quella che lo vede protagonista del romanzo al quale sta lavorando o di quella che gli dispensa il narratore: entrambe per gentile concessione di Roth, naturalmente, unico artefice e sommo giudice – è bene ricordarlo a chi condividesse romantiche illusioni sulla autonomia dei personaggi – di tutto ciò che si svolge in questo strabiliante romanzo. Dove la complessa costruzione della tessitura sembra fatta apposta, tra l’altro, per consentire a Philip Roth l’apertura di lunghe parentesi narrative in cui sfogare la sua passione dialogica, che estende dal ragionamento più pacato all’invettiva, passando per dialoghi la cui potenza argomentativa è tanto più magistralmente resa quanto più la rincorsa della verità coincide con l’approdo dei personaggi al puro e semplice delirio paranoico. Anche qui, come in altri romanzi dell’autore americano, fra le comparse più articolate figurano almeno tre fanatici: uno di nome Shuskin, che vuole propagandare l’invenzione di un metodo di congelamento delle cellule in grado di rimandare la morte per almeno un paio di secoli; un altro di nome Jimmy che, ispirato dai libri di Nathan, vorrebbe coinvolgerlo nel dirottamento di un aereo come gesto esemplare per diffondere il suo nuovo verbo, ossia la necessità di emancipare gli ebrei dal loro passato, cancellando dalla memoria collettiva tutte le persecuzioni subite; e un terzo di nome Lippman, fondamentalista israeliano la cui logica non lo rende meno pericoloso di un folle, che gira armato predicando la disobbedienza civile e la fondazione illegale di ulteriori insediamenti nei territori arabi. Sia chiaro, però, che solo a Nathan Zuckerman è concessa la spietata quanto crudele messa a fuoco delle possibili derive della mentalità ebraica, sia che essa si esprima nella ristrettezza delle vedute piccolo borghesi a lui più familiari, sia che approdi alla cecità del fanatismo. Quando è Nathan a fiutare odore di discriminazione, vera o presunta, ecco allora che Roth regala al suo alter ego tutti i più convincenti argomenti a carico dei pregiudizi secolari coltivati dai gentili. E tra loro mette la figura forse più magistrale della Controvita, la moglie di Nathan Zuckerman destinata a sopravvivergli, dotata di un virtuosismo argomentativo all’altezza delle sue snobsitiche esigenze intellettuali, anche lei proiettata a viva forza nel romanzo del marito, dal quale tenta tuttavia di uscire in un estremo sforzo di ribellione. Pallida illusione di un povero personaggio: ma non lo sa Maria che ogni sua mossa soggiace alla violenza autoriale di colui che l’ha inventata? Eppure anche Nathan appare in difficoltà, ossessionato com’è dall’incubo che i suoi personaggi reclamino il controllo della situazione e, sottraendosi alla sua volontà, gli rovinino la vita. La sua vita che altro non è se non un romanzo di Philip Roth. DECOUPAGE MATVEJEVIC E IL PANE, DAI CIELI ALLA TERRA Padre nostro, prefazione di Enzo Bianchi e postfazione di Erri de Luca (Garzanti, pp. 231, € 18,60), è il titolo che Pedrag Matvejevic ha voluto per il suo recente libro dedicato al più antico e prezioso alimento degli umani: quella manna dei cieli che, come raccontano le Scritture, «saziò» il popolo semita nel deserto. Quel pane nato in Mesapotamia dalle spighe di grano la cui la simmetria «stupì» i nostri antenati, è da millenni sigillo della cultura nella società umana, e oggetto di un’infinità di libri (fra i quali per l’originale argomentazione sul tema della terra e del modo di coltivarla, Il pane selvaggio di Piero Camporesi). La «fantasia dell’uomo – come scrive Bianchi – ha saputo dare forme e consistenze sempre diverse a quell’alimento così da renderlo appetibile e accessibile nelle situazioni più disparate». LUCIANO CANFORA: COME PENSIAMO I FATTI STORICI? «Perché ci siamo scannati senza interruzioni a partire dal primo concilio di Nicea?», scriveva Voltaire alla voce «Tolleranza» nel Dizionario filosofico: una domanda alla quale Luciano Canfora azzarda una risposta con un procedimento analogico sulla conoscenza della storia nel saggio L’uso politico dei paradigmi storici (Laterza, pp. 117, € 16,00), versione aggiornata di Analogia e storia uscito trent’anni fa. Allora come oggi Canfora affronta, da un lato la questione «dell‘alternativa tra la illuministica “tolleranza” e la giacobina “virtù”»; dall’altro, la questione di metodo inerente al nostro «pensare i fatti storici inestricabile da quella forma a priori, per dirla in termini kantiani, che è l’analogia»: quel procedimento tucidideo, ricorda l’autore, che è alla base della ricostruzione del più remoto passato. FABIO STASSI E I PERSONAGGI DI CARTA Quando aveva cominciato «a viaggiare su una linea lenta e annosa – scrive Fabio Stassi nel suo terzo o quarto libro Holden, Lolita, Zivago e gli altri (minimum fax, pp. 332, € 12,50) – non sapevo quale insolita compagnia avrei avuto». Ma là fuori dai finestrini del treno c’erano pur sempre Spoon River e l’universale commedia umana di una popolazione immaginaria a riempire lo scompartimento, uomini e donne da lui già frequentati nei libri, che non avevano perciò né pelle né sangue né carne, solo sostanza di parole, ma con i quali – come ha scritto Primo Levi – puoi intrattenerti; insomma tanti Capitano Mac Whirr, del quale Conrad diceva: anche se mai aveva camminato o respirato su questa terra, tuttavia era autentico. Come e quanto lo sono i duecento ritratti e comprimari dei maggiori romanzi italiani e stranieri, che leggiamo in questo felice libro di rimembranze letterarie. a cura di Romano Costa ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (21 FUSINI DA PAGINA 19 ne che insiste anche quando Dio se n’è andato. E l’uomo-attore se ne rimane lì, «ombra che cammina» con il suo «racconto idiota» tra le mani «pieno di grida e di rumore» (Macbeth), pieno di immagini di Dio infrante, lascito beffardo di una eredità avvelenata: l’Ecce homo, la Passione, il Rito di Comunione, la Discesa di Cristo agli Inferi, il Figlio icona del Padre, la caduta di Lucifero, l’Apocalisse, sono gli spettri con cui l’attore, l’eroe di Shakespeare, lotta. Mentre il diavolo, e con lui la folla dei torturatori di Cristo sotto la Croce, ritratti da Grünewald e messi in scena dai Mystery Plays medievali, ridono e rumoreggiano: il mondo è un puttanaio a cielo aperto, un postribolo dove si festeggia l’«incesto universale» (Misura per misura), è un manicomio (Lear), è una «prigione» e un «cimitero» (Amleto), è l’Inferno (Macbeth). Sono lì a mostrarlo la Vienna di Isabella e il «convento» (nunnery) di Ofelia, la folle landa deserta di Lear con il suo carrozzone di freaks, il palazzo di Elsinore e il caposanto di Yorick, il castello di Inverness. Ma Fusini non dimentica mai la Storia per la Scrittura. Quel mondo-bordello, quel mondoinferno, quella casa di matti, è pensata e percorsa sul filo della Londra popolare che sta entrando nella piena modernità: la Londra storica dei bassifondi e dei teatri, degli ospedali-galera, delle gilde di accattoni, la Londra delle professioni, dei predicatori, dei medici e dei trattatisti, delle corti di giustizia, del mercato librario (la futura Londra di Dickens), ricreata per tutto il corso del libro, come un fil rouge, senza che la profonda conoscenza documentaria pesi sulla lettura (lo stesso vale per le diverse considerazioni filologiche, puntualmente avanzate quando necessario). È importante questa attenzione alla storia, perché il teatro di Shakespeare non sarebbe tale se non vi si avvertisse, in corso, la genesi del mostro metropolitano, testa del nascente Leviatano-Stato (Hobbes). Così come costante è l’attenzione per l’orizzonte politico della drammaturgia shakespeariana: da un lato, Fusini libera (finalmente!) il campo dalla sovranità secondo Kantorowicz, perché il «doppio corpo del re» risulta sì presente in scena, ma equivale ai residui della Scrittura e non è ciò di cui Shakespeare vuole parlare; dall’altro, accentra la sua attenzione sul vero problema, la possibilità di una «ragione politica» (Giulio Cesare), per rivelarci tuttavia che la ragione politica di Bruto, intrinsecamente avvelenata dall’immaginazione (phantasia), «traffica in spettri» e consegna quindi le proprie vittime (Cesare-Cristo) alla menzogna (di Antonio – di Elisabetta, di Giacomo e dei loro Consigli di Stato). Di questo mondo e di questo teatro, restano lì, in piena luce, impiccate, strozzate, annegate, stuprate a morte, le spose e le figlie: Desdemona, Ofelia, Cordelia. Fusini è delicatissima con loro, quasi a proteggerne la millenaria memoria e la storia straziate. Di loro, Fusini non vuole rivelare troppo. Ma sappiamo chi sono: sono il lato buono di Cristo, l’Anima torturata (Psiche) – le fanciulle perseguitate della fiaba – che quel mondo e quel teatro, ma come fosse da sempre, non può lasciar sopravvivere. 22) ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 di Niccolò Scaffai L’ anatomia dell’esperienza è al centro dell’opera di Valerio Magrelli fin dagli esordi, ma negli ultimi suoi libri il metodo è esercitato in maniera più estroversa. In La vicevita (Laterza 2009) e nel recentissimo Addio al calcio (Torino, Einaudi «Supercoralli», pp. 114, € 17,00), l’attitudine a scomporre le funzioni del soggetto, facendone l’oggetto di un’osservazione raziocinante, si applica infatti a un personaggio in situazione, i cui gesti aderiscono a quelli di una comunità che officia un rito quotidiano: il viaggio del pendolare, nel volumetto laterziano dell’anno scorso; il calcio, nel nuovo libro, più impegnativo e forse piú riuscito del precedente. Addio al calcio è un macrotesto scandito in due tempi, ciascuno composto da 45 scritti brevi in prosa. O piuttosto in prosa poetica, dal momento che nei brani sono abbastanza frequenti le cellule metriche, talvolta concatenate in sequenze di versi regolari e rime vere o per l’occhio (quanto basta a fugare i sospetti di un arbitrario ‘ritaglio’ da parte del lettore stilisticamente fazioso: «vetri molati e legno alle pareti, camerieri vetusti e gran gelati. L’hanno spazzato via quel vecchio bar, con le ruspe, il tritolo, i caterpillar»). Queste caratteristiche strutturali rendono incerto lo statuto di genere letterario e sconsigliano perciò di distinguere troppo rigidamente tra il Magrelli in versi e quello in prosa (come indurrebbero a fare invece le diverse vesti e collocazioni editoriali dei suoi libri: da un lato la ‘bianca’, dall’altro i ‘supercoralli’ einaudiani, per esempio), e di conseguenza tra una vena tutta scientifico-sperimentale nel primo e una – diciamo – tutta socio- logico-aneddotica nel secondo. Eppure uno scarto c’è, ma riguarda soprattutto le dimensioni nelle quali si sviluppa la scrittura: se per le raccolte di poesia tout court è stato possibile parlare di una magrelliana «vocazione cartografica», per Addio al calcio è necessario considerare anche la coordinata temporale. Tempo inteso sia come formula di ripartizione interna, basata appunto sull’allusione alla durata di una partita di calcio; sia, soprattutto, come profondità storica e linea di collegamento tra le generazioni. Il punto di vista che attrae anche lo sport nell’orbita di una fisicità patologica («Allora, per guarirlo da quella brutta malattia, me lo mettevo davanti, sull’attenti, e cominciavo con i cataplasmi. (…) Erano gocce, medicamenti per prepararlo al gioco del calcio, e agivano pian piano come vitamine»; «sentii lo scatto secco del menisco spezzato») rimane quello già tipico del primo Magrelli – è vero – ma conta di più la facilità con la quale il calcio può essere messo in racconto e per così dire epicizzato: l’«energia ridicola e insopprimibile» che trasforma lo sport in «un ininterrotto commento, un’estenuata tela di Penelope». E dell’epica, talvolta, la retorica del calcio assume le movenze, per esempio attribuendo agli atleti soprannomi ‘formulaici’, seppure dissacranti: la scriminatura tra i capelli rossi valse a Odoacre Chierico – ricorda per esempio Magrelli – il nomignolo di ‘gettone’. Quasi ininterrotto è anche il filo che lega i brani, connessi l’uno all’altro da una serie di richiami tematici e lessicali tipologicamente non diversi da quelli che cuciono insieme le stanze di una canzone (o le poesie di un canzoniere). I nessi, oltre a incrementare il tasso di poematicità del libro (anche per questo complesso e felicemente indefinibile), funzionano come altrettante sinapsi che facilitano il flusso della memoria personale, l’andirivieni dal passato al presente e viceversa. Non sembrano pertinenti i confronti con quegli autori italiani, da Saba a Sereni a Buffoni, che hanno fatto occasionalmente del calcio materia di (ottima) poesia. A Magrelli non interessa trasformare lo sport in letteratura, né sciogliere un peana all’atletica vitalità. La sua scommessa è piuttosto quella di parlare dell’argomento mantenendosi in equilibrio tra due opposti snobismi: quello dell’intellettuale ‘apocalittico’ che assolutamente non segue il calcio, o se lo fa è solo per deprecarne futilità e corruzione; e quello dell’‘integrato’, che idealizza e nobilita il pallone, anche attraverso funambolici preziosismi lessicali (da Magrelli del tutto evitati: nessuno si aspetti Gianni Brera, insomma, nel bene e nel male). Per inciso, la scelta di non premere sul pedale della critica morale spiega un brano come il seguente, in effetti di primo acchito un poco scandaloso: «non posso tacere l’atto più grave che, a mio Una squadra di Subbuteo, il calcio «a punta di dito» esploso in Italia negli anni settanta ed entrato nell’immaginario del libro di Magrelli parere, sia mai accaduto su un campo di calcio. Non parlo di giocatori sudamericani uccisi a rivoltellate, né di falli vigliacchi o di aggressioni, bensì (…) di un’omissione», cioè quella – prosegue Magrelli – di un calciatore che non aveva restituito agli avversari una palla volontariamente mandata in fallo laterale per far soccorrere un infortunato. Il punto non è la minore o maggiore gravità del gesto, ma la presenza dell’accaduto nell’orizzonte dell’esperienza personale del narratore, nel campo visivo dei suoi ricordi. L’orrore, per esempio, penetra sì nelle pagine, ma solo attraverso una privata memoria visuale, quella di un’installazione alla Biennale di Venezia: «a Belgrado, sullo sfondo dell’ex quartiere generale dell’esercito serbo ridotto a imponente rovina, un ragazzino palleggia con un cranio umano». Oltre a ricondurre Addio al calcio alla via maestra della poetica di Magrelli, quest’aspetto permette di inquadrare entro il tema della visione anche un motivo caratteristico del libro, quello del ‘miracolo’, di un’improvvisa manifestazione appunto visiva, valida in sé innanzitutto come fenomeno, in seguito e incidentalmente come simbolo: «Eravamo a metà partita, in un campetto sul lungofiume, quando dal cielo ■ «ADDIO AL CALCIO», PROSA POETICA DI VALERIO MAGRELLI ■ Un occhio raziocinante tra due opposti snobismi piomba in mezzo all’erba un pesce gigantesco, un pesce sacro»; «Passato un quarto d’ora, ecco il prodigio. Uno per uno, innumerevoli sportelli si sollevarono da terra»; «Solo una notte assistemmo al miracolo. (…) Ci sporgemmo tutti quanti da una specie di feritoia orizzontale, e finalmente vedemmo…»; «Dovemmo apparire loro come un miraggio, una fata morgana a cui non si presta fede»; «il pallone non era neanche pesante, ma bastò per raggiungere il miracolo». Il valore peculiare del calcio sta nella fruizione plurale, collettiva di quelle epifanie: da parte della squadra, certo, ma anche da parte della coppia padre-figlio che è la vera protagonista del libro. Il narratore, grazie alle oscillazioni tra passato e presente, si ritrae ora nel ruolo del figlio («Giocare da soli col padre è un momento struggente, insostenibile»; «Mento in fuori, braccia ad anfora, e la sfera di cuoio sotto il piede: mio padre diventava Mussolini e insieme Piola»), ora in quello del padre, che vede avvicinarsi la fine del rito non solo per via dell’età e del fisico, ma anche per colpa dell’allucinazione, del mero inganno ottico che ha preso il posto del miracolo: «E invece per mio figlio il gioco significa ormai quasi soltanto PlayStation. (…) Così lui gioca partite fantasma, contro squadre fantasma, con risultati fantasma. Da solo, immerso ore e ore in una sorta di allucinazione». Si consuma così l’addio al calcio, senza traumi, ma in un’indefinita e quasi leopardiana sospensione nel silenzio che fa balenare un senso ulteriore, esistenziale, come quando ci si avviava a recuperare la palla finita fuori dal campo e si indugiava qualche istante prima di tornare a giocare, «dimenticando quello spazio muto che ci avvolgeva, al di là del muretto». Un felice libretto dall’incerto statuto che fa della passione per il calcio padre-figlio un set di analisi dei costumi e dei ricordi: lontano dal moralismo e dall’epica P BERSAGLI O E S I A ALBERTO VIGEVANI, IL DESIDERIO DELL’UOMO PROBO di Andrea Molesini di Giulio Ferroni H ■ «PEREGRIN D’AMORE», VIAGGI NEI LUOGHI DEGLI SCRITTORI ITALIANI ■ Tenzoni di Affinati o sempre pensato che Eraldo Affinati scriva e legga in movimento, sentendo la propria attività come un percorso nel mondo, percorso tra costipati quartieri cittadini carichi di prelia): luoghi toccati e attraversati senze e di oggetti, o tra spazi distedai maggiori scrittori italiani e dalsi e lontani, centri monumentali e le loro opere, cruciali per la loro periferie slabbrate, stazioni e cimiesistenza o per le loro opere; luoteri, cattedrali affollate e piccole ghi di oggi anche lontani e talvolcappelle solitarie, territori induta a essi ignoti, a cui i testi vengostriali e campagne dagli orizzonti no imprevedibilmente ad assosconfinati. I suoi libri sono semciarsi e combinarsi. pre quelli di un pellegrino, che Tanti viaggi: per ognuno dei nel toccare e guardare i luoghi ne quaranta scrittori, da Francesco percepisce la densità morale, ne d’Assisi a Pasolini (con Prologo a estrae il carico di umanità, di deCastel del Monte), due capitoletti terminazione vitale, di memoria e centrati su due diversi luoghi, uno di oblio, di lacerazione e di ricompiù breve (in prima persona) e posizione, come una sorta di specuno più ampio (in seconda persochio spirituale, che riflette la conona, con voce che direttamente si riscenza di sé e del mondo. Pellegrivolge al viaggiatore e ci dice quello no medievale, romeo o bordone che vede e che fa), e altri luoghi che si confronta col fitto presente che capita variamente di evocare. del mondo, egli sente i luoghi, le «Stazioni» del pellegrinaggio, incose e le persone che li abitano somma, davanti ai quali, pur se con il proprio stesso corpo, con la tanto mutati, risuonano le pagine propria andatura, con la fisicità celebri e amate, si ritrova il senso del proprio percorrerli, sia che usi di tante letture, dell’entusiasmo i più diversi mezzi di locomoziodel lettore, del volto d’Italia passane, sia che lo faccia a piedi: può to e presente. Opere essenziali delusare ogni mezzo possibile, dalla nostra letteratura si fissano così l’aereo alla motocicletta, ma ciò in una serie di situazioni emblemache davvero conta per lui è posatiche, di caratteri morali e spirituare i piedi per terra, misurare lo li, di occasioni personali, che il spazio camminandoci, anche viaggiatore percepisce in una sorquando si tratti di spazi in cui è dita di elevazione eroica. Per Affinati sagevole o addirittura pericoloso tutta la letteratura, quella che per camminare. Questo viandante lui conta, è come una sfida, nel sempre sostenuto dalla letteratuquadro di una lotta entro la durezra, e specialmente dalla letteratuza dell’esperienza, di un difficile ra che più si è confrontata con il implicarsi dell’umano nel mondo: dolore, con la lotta, con il destino entro una singolare mitologia deldel mondo, con Peregrin d’amola guerra, è «veglia d’armi» che egli re (Mondadori «Sis», pp. 415, € vive come un «soldato», fraterno 20,00) percorre una serie di luocon tutti coloro che hanno percepighi in cui cerca il senso e il valore to l’esistenza come impegno, batdella letteratura italiana (sottotitotaglia severa e difficile per un valolo Sotto il cielo degli scrittori d’Itare di senso e di libertà. Allora l’Italia che il pellegrino ritrova in questi viaggi letterari è un’Italia eroica, un’Italia che dal suo passato (l’«umile Italia» di Dante e Pasolini?) si proietta verso l’attuale eroismo degli immigrati, verso un nuovo, contraddittorio orizzonte, che si riconosce nella loro presenza seria e discreta, umile e umiliata, nella dignità silenziosa che in quasi tutti i luoghi toccati si manifesta nei loro volti e nei loro gesti. Essi sono presenti quasi in ogni pezzo del libro: e si può vedere come l’Orlando furioso ci porti qui nell’isola di Lampedusa (dove nel poema dell’Ariosto avviene l’ultimo duello tra cristiani e saraceni, tre contro tre), con gli immigrati clandestini che lì approdano e con un singolare personaggio che sembra reincarnare lo stesso eroe Orlando, eroe ora non dello scontro ma della solidarietà: questi accoglie e protegge un gruppo di immigrati, somministrando un pasto con francescana religiosità. Come questo Orlando redivivo, altri fantasmi si affacciano in altri luoghi del pellegrinaggio e ad essi il pellegrino dà direttamente voce: così un povero giardiniere di un ristorante tra le ville del Chianti parla con la lingua di Niccolò Machiavelli, esprimendo la propria ansia sullo stato contraddittorio del mondo; così la ricerca che Eraldo fa a Londra dei luoghi dell’esilio di Ugo Foscolo viene narrata (nella seconda persona di cui si è detto) dalla voce stessa del poeta, che egli ha appassionatamente amato e sentito come un «unico faro» di vita, fin dal Luca Capuano, Castel del Monte, da «Il paesaggio descritto», luoghi italiani patrimonio Unesco, Logos tempo delle lezioni universitarie di Walter Binni; così al centro del libro, davanti al monumento di Giuseppe Gioachino Belli all’ingresso di Trastevere, egli ascolta la voce, in romanesco, del proprio padre che nel mondo di là si trova proprio a contatto col Belli. Molto varie sono peraltro le modalità con cui Affinati presenta i diversi luoghi e i diversi scrittori, con un gioco di variazioni, che può passare dall’incontro, sul Lido di Dante presso Ravenna, con un professore in pensione assistito da una badante ucraina, con cui egli dialoga sulla propria passione per la Commedia, a quello con uno studioso giapponese nella chiesa di Santa Maria Novella, dove si incontrarono i narratori del Decameron al tempo della peste di Firenze, al ricordo del fenomeno della vaiolance sotto la statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, a quello degli incontri personali con Mario Rigoni Stern a proposito delle guerre da lui vissute, ecc. I più vari dati di cultura e di passione, dal cinema alla musica allo sport, vengono a sostenere questi viaggi nella letteratura italiana, con molteplici coincidenze che sembrano rivelare l’inafferrabile mistero che anima un’adesione appunto «eroica» alla realtà, anche ai suoi lati più duri e oscuri, al «lavoro» che essa richiede: con la testarda volontà di far giocare la letteratura nel presente, come segno di vita, che può Quaranta «siti», da San Francesco a Pasolini, su e giù per lo Stivale, con l’idea di verificare un personale canone italiano a contatto con vestigia storiche e degradi dell’oggi: alla fine, una specie di duello eroico con testi, personaggi e situazioni persistere a rivelare il mondo, anche quando sembra schiacciata e marginalizzata da tutti gli scarti e le brutture che il mondo trascina con sé. Del resto Affinati è molto attento agli scarti e alle lacerazioni degli ambienti attraversati, si ferma più volte a notare la degradazione dei luoghi, l’accumulo di rovine che su di essi si è caricato dai tempi delle voci originarie di cui egli segue le tracce: ma di fronte a tutto egli è come salvaguardato dalla sicurezza del suo sguardo e della sua passione «eroica», dalla armatura agonistica e a volte ieratica che si trova ad assumere. Nella sua deliberata lontananza da ogni prospettiva accademica, anche chi come me è colpevole di frequentazioni accademiche cerca di perdonargli alcune coquilles, magari imputabili alla redazione forse affrettata, male ormai della grande editoria (ma non si può perdonare p. 67, dove si dice che Masaccio sarebbe morto vent’anni prima della stesura del Decameron!). Certo dal libro risulta un vero e proprio canone personale (molto fitto nella zona novecentesca), che predilige gli autori che esibiscono il conflitto o che comunque tende a mettere in evidenza gli aspetti agonistici anche di autori non leggibili in chiave «eroica»: ne risultano messi ai margini gli ambiti del comico, dell’eros più sensuale, del melodramma, che pure costituiscono linee essenziali della nostra letteratura (ci sono un Boccaccio e un Ariosto molto diversi da quelli su cui Affinati richiama l’attenzione, ci sono almeno un Metastasio, un Verdi, un Don Giovanni mozartiano che a loro modo hanno avuto un rilievo essenziale nella costruzione dell’anima italiana). Forse la poesia è nata per dire lo stupore panico del cacciatore che nella foresta, sotto una luna immensa, per la prima volta vedeva il leone. Ma cosa resta, oggi, di quell’oscuro turbamento? Le nostre città – bolgie di auto, passanti, luci e manifesti che invitano a comprare l’utile e l’inutile – hanno bandito ogni traccia del sacro, ed è difficile meravigliarsi di qualcosa. Alla contemplazione appassionata – il territorio della poesia – non restano che fuggevoli immagini, strappate al frastuono della strada. «Di là dalla vetrata / sembra la rondine / si sia involata / più rapida ancora / della sua ombra. // Così noi: col peso / del nostro passato / ombre sempre più lente / siamo nel volo / rapido del presente». Di Alberto Vigevani (Milano 1918-1999), narratore e poeta, librario ed editore di cose rare, esce, nella «Bianca» di Einaudi, L’esistenza Tutte le poesie 1980-1992 (pp.194, € 14,50), a cura di Enrico Testa. L’intrecciarsi di quinari e settenari, di rime saltuarie, sempre cariche di senso, si sposa con il tema del tempo – la materia di cui siamo fatti – e della memoria, impegnata in una visionarietà melanconica, che non cede mai, però, alla lacrima, e nemmeno a una mestizia crepuscolare. Sono versi dal lessico semplice, e il fraseggio schietto, quelli di Vigevani, abitati da una pietas vigorosa e innamorata di «un mondo inesistente / se l’esistere fosse / più certo del niente». Molte poesie finiscono con la parola «niente», o propongono rime dalla forte carica semantica come «giorno/ritorno», «foglie/soglie». E poi c’è la riflessione sulla vecchiaia – la più grande sorpresa nella vita di un uomo, scriveva Tolstoj – che si beffa ogni giorno di quello che ci sentiamo bruciare dentro: «Quello che ci stupisce / e gli altri non sanno / è come siamo giovani, / dentro, giovani ancora / nei corpi invecchiati, / e delicati e fragili / come quei fiori / che basta soffiare / per farli di colpo / morire». Quasi a ogni pagina, il lettore viene sorpreso dagli scarti ironici, dai guizzi fanciulleschi del pensiero: «Gli angeli li incontro di rado / non so perché sempre in tram». E così Vigevani descrive i suoi antenati ebrei: «Pastori, carovanieri, vignaiuoli / idolatri e fornicatori ma, après coup, / amanti del Verbo, assetati di giustizia». Siamo nati per trascorrere, non per mettere radici, e solo l’immaginazione ricorda la verità: «Immagino talora l’ignoto / che abitò queste stanze / e l’ignoto che le abiterà». C’è l’eterno desiderio dell’uomo probo in queste poesie, la sua voglia di vivere con semplicità nella ricerca della conoscenza, anche se questo impone il dolore rigoroso del tramandare: «Un riverbero intravidi / del volto del Dio creduto morto / ardere nei grandi occhi atterriti / del ragazzetto ebreo che una nera / coperta sulle spalle i neri sfiora / vagoni del treno per Treblinka». Perché, dopo Auschwitz, dell’innominabile creatore si può pensare solo «che esista e dorma / fuori dal tempo / mentre noi lo invochiamo / da dentro». ALIAS N. 41 - 16 OTTOBRE 2010 (23
Scaricare

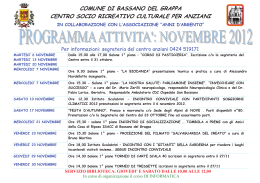



![[c-bo - 24] carlino/giornale/var/20 16/05](http://s2.diazilla.com/store/data/000984718_1-e9c413592e5cb01d1ec232d1850910b7-260x520.png)

