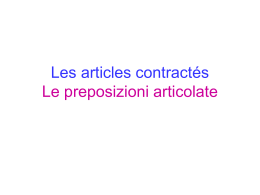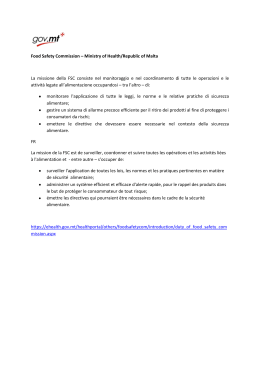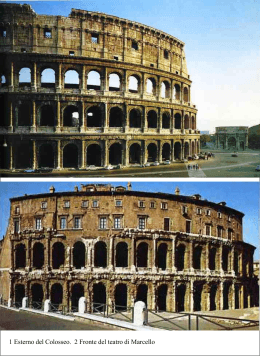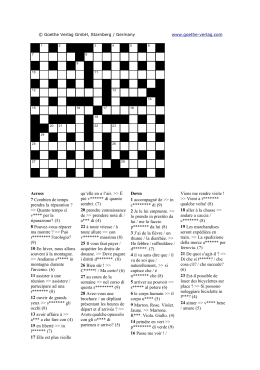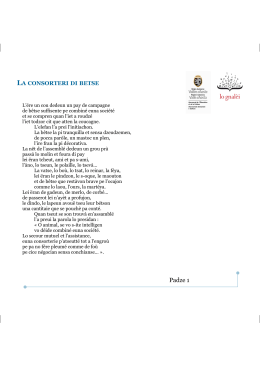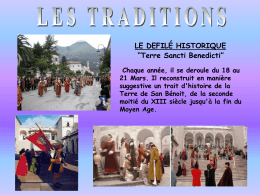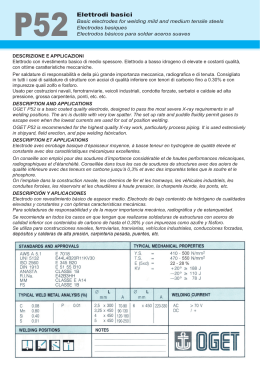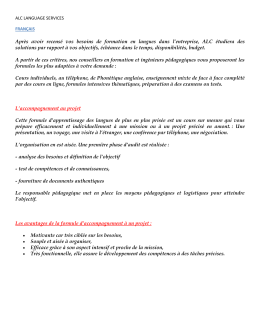“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna Tesi di dottorato in Letterature Francofone XVII° ciclo L-LIN/03 Anno accademico 2004-2005 Fractures Dramatiques dalla scena al testo: fondazione dello spazio teatrale Storia del teatro dell’Oceano Indiano Madagascar, Maurice, Réunion Coordinatore del Dottorato Chiarissima, prof. Carminella Biondi Candidata Maria Clara Pellegrini Relatore Chiarissima, prof. Anna Paola Mossetto Correlatore Emerito, prof. Bernard Mouralis I Fractures Dramatique: dalla scena al testo: fondazione dello spazio drammatico Storia del teatro dell’Oceano Indiano: Madagascar, Maurice, Réunion Introduzione Teatro, un patto sociale.................................................................................................. V CAPITOLO PRIMO ..........................................................................................................................16 Schiavitù, marronnage, ..................................................................................................................42 Rivoluzione francese e secessione .................................................................................................58 Madagascar indipendente,..............................................................................................................67 Le incerte declinazioni della libertà, ..............................................................................................79 CAPITOLO SECONDO ..................................................................................................................120 Sezione 1: Madagascar Teatro malgascio, tra classicismo e sperimentazione ............................120 Storia e mito .............................................................................................................................143 Mito e realtà.............................................................................................................................165 Teatro e società: riflessione morale tra satira politica e engagement .......................................... David Jaomanoro, Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Henri Rakotontrasoa, Narcisse Randriamirado .........................................................................................................................178 Teatro del silenzio, tra sperimentazione linguistica e minimalismo narrativo.............................. Fidy Randriamirado, David Jaomanoro, Michèle Rakotoson, Jean-Luc Raharimanana .........199 Sezione 2: Maurice............................................................................................................................. Riflessione storica sul teatro mauriziano. Politica e misticismo, le due anime del teatro mauriziano....................................................................................................................................234 _Toc132035177 Dal neoclassicismo al romanticismo .......................................................................................246 Hortense de Céré-Barbé, Léoville L’Homme, Arthur Martial, Raoul Ollivry ........................246 Verso il teatro sperimentale........................................................................................................... dal dramma morale Robert-Edward Hart, Loys Masson al teatro profetico di Malcolm de Chazal.......................................................................................................................................266 _Toc132035182 L’io frammentato, tra espressionismo e psicodramma............................................................291 André Masson, Regis Fanchette...............................................................................................291 Teatro e Società .......................................................................................................................305 Jean-Norbert Augustin, René Noyau, Dayachand Napal.........................................................305 Teatro politico..........................................................................................................................305 II Dev Virahsawmy, Azize Asgarally..........................................................................................305 Sezione 3: Réunion ............................................................................................................................ Quale teatro reunionese? Esegesi di una drammaturgia discontinua................................................. 1868 e 1963, la Réunion tra mimesi ed evasione, 1970-2000, multietnicità e sperimentazione 337 _Toc132035193 Dramma romantico e scuola del buonsenso .................................................................................. 1800, il teatro reunionese tra mélo e vaudeville ......................................................................347 1960 I camerieri sapenti di Félix Dorwling-Carter ................................................................364 ........................................................................................................................................................ Teatro totale.............................................................................................................................368 tra scrittura e rappresentazione: il testo moltiplicato ...............................................................368 1970-2000 Dal neorealismo al teatro epico l’invenzione della Storia e della Società.............395 Teatro del Oprimido....................................................................................................................... per una drammaturgia della coscienza civile e costruzione del mito reunionese: ......................... Emmanuel Genvrin, Jean-Louis Rivière..................................................................................425 Lieux théâtraux – théâtre des lieux ..................................................................................................448 Drammaturgie dell’Oceano Indiano.................................................................................................448 Schema Diacronico ..........................................................................................................................453 Approccio tematico ..........................................................................................................................461 Bibliografia ......................................................................................................................................511 III ai miei genitori e alla piccola Antonella IV Introduzione Teatro, un patto sociale La crisi in cui versa il teatro occidentale contemporaneo non è certamente d’aiuto alla diffusione della produzione teatrale di aree emergenti e generalmente poco conosciute come l’Oceano Indiano. Nonostante i tentativi dei drammaturghi e dei registi europei del secondo dopoguerra di dare nuovo impulso alla drammaturgia (minacciata dalla popolarità del mezzo televisivo), il teatro è rimasto un evento culturale accessibile a pochi: una manifestazione per lo più borghese e intellettuale, verso la quale il pubblico si rivolge con sospetto sempre maggiore. Il successo nei primi anni 60 del TNP di Vilar, la partecipazione corale nel 68 al teatro di contestazione non hanno trovato conferma nella sperimentazione degli anni 80, dove, contrariamente alle premesse e ai casi isolati di Boal in Brasile e in Francia, ci si è avviati a una normalizzazione dell’evento teatrale. Perfino la moltiplicazione di teatri e di compagnie nelle periferie, la promozione di festival non sembrano aver favorito, come rileva Bernard Dort1, la democratizzazione della macchina e della letteratura drammatiche, dimostrandosi incapaci di reintegrare il teatro dentro il corpo sociale a dispetto della diffusione capillare degli eventi. La diffidenza maturata negli ultimi anni dal pubblico e dai critici verso la drammaturgia è, probabilmente, da imputare anche alla difficoltà di definire un genere soggetto a continue rivisitazioni da parte di specialisti e degli addetti ai lavori, in cui sembra essere venuto meno il margine tra scrittore e regista, tra autore e fruitore per una ipertrofizzazione, nei casi estremi del Living e dello Happening, della creazione estemporanea fino al recupero dell’orale sullo scritto2. L’urgenza in cui versa la produzione occidentale è evidente se confrontata all’esuberanza dell’attività teatrale dei paesi africani dove, malgrado la precarietà delle strutture e le difficoltà politiche, il teatro è tra i generi più fiorenti del continente, al punto che dal dopoguerra, accanto ai festival promossi dalle nazioni occidentali, come il concorso di Radio France Internationale, sono numerose le nazioni africane che si sono dedicate all’organizzazione di concorsi per la promozione del teatro locale. 1 Bernard Dort, L’Âge de la Représentation, in Le Théâtre en France II. De la Révolution à nos jours, Jacqueline de Jomaron (sous la direction), Paris, Armand Colin, 1989, pp. 528-534. 2 La teoria condivisa di un teatro come norma sociale e dell’azione drammatica come gesto rituale hanno spostato l’interesse dal teatro letterario al teatro spettacolo, allargando la definizione di “rappresentazione teatrale” a performances generiche, come letture pubbliche, e alle manifestazioni tradizionali. V È il caso dell’isola di Maurice dove negli anni 50 è stato istituito il Festival di Drammaturgia in lingua inglese, oltremodo popolare tra gli scrittori di origine indiana e creola. Anche se i festival europei restano l’occasione più importante e il momento di maggiore visibilità offerto agli scrittori delle ex-colonie, la cui produzione letteraria e drammaturgica rimane in molti casi inesplorata, negli ultimi anni gli intellettuali e gli artisti dei paesi emergenti hanno, nondimeno, cominciato a maturare una coscienza critica e un certo riserbo nei confronti dei concorsi internazionali indetti dalle istituzioni estere, laddove la promozione teatrale sembra essere riservata soprattutto a quelle opere che rispondono ai canoni specificatamente occidentali, facilmente accessibili al pubblico europeo. Pur illustrando i benefici derivati dalla promozione dei festival europei, Ganaba Abdoulaye3 nel 1976 e Rogo Koffi Fiangor4 nel 2002 non mancano di rivelare la parzialità di un mezzo che, anche indirettamente, impone all’Occidente una certa visione della produzione drammatica dei paesi emergenti. Censendo le opere presentate al concorso tra il 1967e il 1973, Ganaba Abdoulaye pone l’accento sulla ricorrenza di soggetti e contesti, talvolta folcloristici, atti a identificare geograficamente e culturalmente il teatro delle ex-colonie, prodotti di una manifestazione teatrale che dei testi sembra sottolineare e apprezzare anzitutto il valore etnico prima che il talento letterario, insistendo su rappresentazioni che attingono alle credenze popolari, e su racconti ispirati ai «mœurs divers» attraverso le quali rievocare le usanze tradizionali in fatto di fidanzamento, matrimonio, prove di iniziazione. I temi trattati fanno luce, quindi, sulla settorialità di un festival che nasce anzitutto come concorso africano e che non sempre è stato in grado di integrare le altre aree della francofonia5. L’approssimazione con la quale ci si rivolge al teatro africano dacché i concorsi, come fanno notare Abdoulaye e Fiangor, sembrano orientare la produzione dell’area verso alcuni soggetti più popolari, viene esasperata dalla mancanza di dati certi e di documenti per le isole dell’Oceano Indiano dove la promozione teatrale è un fatto recente e per lo più vincolata, come nel caso del Madagascar e dell’isola di Maurice, a festival teatrali istituiti per il vicino continente africano, o ancora circoscritta a un fenomeno locale come per la Réunion. Dallo studio di Abdoulaye emerge, di conseguenza, la difficoltà delle isole di imporsi in un sistema che sembra privilegiare la produzione africana rispetto alle altre letterature francofone, 3 Ganaba Abdoulaye, Analyse thématique et sociologique du Concours Théâtral de 1967 à 1973, Thèse de Doctorat, oct. 1976. 4 Rogo Koffi Fiangor, Le théâtre africain francophone, Paris, l’Harmattan, 2002. 5 «[…] un certain nombre de Mauriciens se seraient découragés estimant avoir peu de chance dans un concours particulièrement africain.», Ganaba Abdoulaye, Analyse thématique et sociologique du Concours Théâtral de 1967 à 1973, op. cit., p. 59. VI quasi mai premiate nei diversi concorsi. Dall’istituzione del premio di Radio France Internationale, nel 1966 Concours Théâtral Inter-Africain, solo due autori malgasci sono stati insigniti del premio e pubblicati nel 1979 e nel 1990, Michèle Rakotoson, attualmente responsabile del concorso, e il giovane Jean-Luc Raharimanana, tra gli scrittori mauriziani pochi sono, invece, riusciti a superare le pre-selezioni. Per quanto ricco ed eterogeneo il teatro dell’Oceano Indiano è, ancora oggi, ignorato nonostante critici e scrittori abbiano da tempo dimostrato interesse per la produzione letteraria, in prosa e in poesia, delle tre isole. Numerose sono le sezioni di antologie e storie delle letterature francesi riservate a scrittori dell’Oceano Indiano come Leconte de Lisle per la Réunion e Malcolm de Chazal e Jean-Marie Le Clézio per l’isola di Maurice. Senghor ha consacrato buona parte della sua antologia6 sulla letteratura nera d’espressione francese all’esegesi degli scrittori malagasci Rabearivelo, Rabemananjara, Ranaivo (la prima antologia del suo genere a rivendicare lo statuto della francofonia per gli autori delle ex-colonie). Le stesse monografie dedicate ai poeti e agli intellettuali più rappresentativi dell’area dell’Oceano Indiano, Chazal des antipodes di Camille de Rauville7, l’antologia di Senghor, se non trascurano del tutto, si soffermano fugacemente sull’analisi della produzione teatrale degli scrittori mauriziani o malgasci. Paradossalmente, la notorietà dei poeti e dei romanzieri malgasci, Jean-Joseph Rabearivelo e Jacques Rabemananjara, degli scrittori reunionesi, Leconte de Lisle e Parny, mauriziani, Malcolm de Chazal e Jean-Georges Prosper, unita al fermento del teatro africano sembrano aver oscurato la produzione teatrale dell’area, considerata dai critici di poco interesse e di scarso rilievo rispetto alle altre manifestazioni letterarie dell’Arcipelago. Tra le recenti antologie e storie della letteratura dell’Oceano Indiano, quella del poeta JeanGeorges Prosper8 per la letteratura mauriziana, e di Camille de Rauville9 per l’intera area, solo JeanLouis Joubert10 ha cercato di restituire uno sguardo d’insieme, seppur lacunoso, della produzione delle varie isole, integrando gli studi e le analisi, già copiosi sugli scrittori maggiori, con riferimenti alla drammaturgia in lingua francese e creola delle voci più rappresentative. Per quanto sintetico, il manuale di Joubert rimane un punto di riferimento per quanti si avvicinano al teatro dell’Oceano Indiano, soprattutto se integrato con la bibliografia curata dal 6 Léopold Sedar Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, Paris, P.U.F., 1948. Camille de Rauville, Chazal des antipodes, Paris, NEA, 1974. 8 Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, Île Maurice, éd. de l’Océan Indien, Mila, 1978. 9 Camille de Rauville, Littératures francophones de l’Océan Indien, Saint-Denis, éd. Du Tramail, 1990. 10 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, EDICEF, 1991. 7 VII critico e pubblicata su «Notre Librairie»11, nella quale sono censite le opere delle tre isole, Madagascar, Maurice e Réunion, edite da case editrici locali e francesi, in raccolte o su riviste, dalla fine del 1800 al 1994. Il testo si rivela essere di fondamentale importanza per gli specialisti dell’area nella misura in cui, contrariamente a un’opinione consolidata che relega la produzione dell’Oceano Indiano al ruolo di sorella minore della letteratura francese (con il surrealismo), africana (con la Negritude) o antillana (con la créolité), Joubert restituisce l’immagine di un’area produttiva e originale finalmente emancipata dal peso della tradizione francese, ma soprattutto dalle influenze del teatro africano contemporaneo. Ancorché pionieristico, il lavoro dello studioso francese dimostra, non diversamente dagli studi precedenti, un interesse solo parziale per la letteratura drammatica delle isole, integrata nel discorso critico dei vari autori a completamento dell’interpretazione delle poetiche e dei diversi movimenti letterari. Alla luce della povertà dei mezzi e dei documenti che si offrono per lo studio della drammaturgia del Madagascar, dell’isola di Maurice e della Réunion, dell’attenzione discontinua e sommaria riservata dai critici e dagli studiosi alle tre isole, ci si può domandare in quale misura si possa e si debba parlare di teatro dell’Oceano Indiano, e interrogare sulla legittimità di un metodo di indagine volto ad analizzare la drammaturgia dell’area come un fatto a sé, distinto dalla produzione africana, quando proprio i concorsi africani rimangono i canali privilegiati per la promozione degli autori malgasci e degli scrittori mauriziani. Ci si chiede altresì come procedere per la messa a punto di una Storia del Teatro dell’Oceano Indiano, quale peso dare alla tradizione francese o africana per restituire una lettura conforme alle specificità delle tre isole ma non viziata da posizioni troppo definitive, considerato che la frammentarietà degli studi critici non viene incontro a una ricerca che si propone di offrire una visione quanto più esaustiva e completa della produzione dell’area e che il silenzio, spesso ingombrante e non sempre giustificato dei critici ha valore di censura per un fenomeno letterario la cui legittimazione all’interno della produzione teatrale francofona e la cui diffusione fuori del sistema insulare dipendono, in modo sostanziale, dal riconoscimento degli addetti ai lavori. La pubblicazione delle pièces di Rabemananjara su Présence Africane e di Michèle Rakotoson su Théâtre Sud rimangono rare eccezioni nella vasta produzione drammaturgica dell’Oceano Indiano: un centinaio di opere prodotte dal 1809, molte delle quali ancora inedite o non più edite, pubblicate a compte d’auteur o su piccole case editrici del luogo. 11 2000 titres de littérature de l’Océan Indien. Océan Indien, Mauritius, la Réunion, Comores, Seychelles, «Notre Librairie», n. 116, (janvier - mars 1994). VIII La limitata attenzione riservata alla produzione teatrale si riflette, allora, nella distribuzione non omogenea dei testi: concentrati in biblioteche specialistiche, confinati tra i libri rari, talvolta difficilmente reperibili o andati persi nel caso delle pièces inedite scritte a ridosso dei due conflitti. Lo scarso interesse delle case editrici francesi e dei critici d’oltreoceano si ripercuote sulla diversa cura riservata alle opere, la maggioranza delle quali sono occasionalmente introdotte da rapidi cenni biografici, quasi mai da indicazioni storico-critiche sul testo e sull’autore, fino al caso estremo delle opere inviate al concorso di R.F.I. poveramente rilegate, ai cui margini sono ancora presenti le timide correzioni degli scrittori. Come conciliare, allora, lo studio e la messa a punto di una Storia del Teatro dell’Oceano Indiano con l’evidente frammentarietà di un repertorio teatrale e critico che, a tutt’oggi rimane, per lo più, inesplorato. Paradossalmente, mentre l’attenzione crescente degli ultimi decenni per espressioni drammatiche tradizionali ha spostato l’interesse dei critici verso un teatro di produzione orale, favorendo il moltiplicarsi di riflessioni critiche su letterature drammatiche finora trascurate, come il kabary, l’hira gasy per il Madagascar, è, invece, venuto meno il confronto con le drammaturgie in lingua francese delle ex-colonie che, in qualche modo, non sembrano manifestare delle identità autonome e definite rispetto al teatro occidentale. Al rinnovarsi degli studi sempre più documentati sul teatro tradizionale malgascio12 risponde, allora, la disomogeneità delle analisi sul teatro francofono dell’area, molte delle quali, pubblicate tra gli anni 60 e 80, restituiscono solo una visione parziale del fenomeno, troppo sommaria se confrontata alle recenti osservazioni sul teatro francese o africano degli stessi anni. Per quanto la popolarità di alcuni scrittori, Michèle Rakotoson, Jean-Luc Raharimanana, Malcolm de Chazal o Emmanuel Genvrin13, abbia richiamato l’interesse della critica e degli specialisti verso la produzione dell’area, gli studi sul teatro locale sono rimasti confinati all’analisi dei drammaturghi più popolari trascurando gli altri, numerosissimi, autori di teatro delle isole14. Quanti intendono intraprendere una riflessione sul teatro dell’Oceano Indiano si trovano, di conseguenza, di fronte a una geografia letteraria e critica che potremmo definire “a macchia di leopardo”: dove ai periodi di intensa attività corrisponde la maggiore attenzione della critica verso 12 Mauro Didier, Madagascar, le Théatre du peuple: l’art du hira gasy entre rebellion et tradition, thèse, 2000. Andriantsilaniarivo Édouard, Le théâtre malgache, in Le théâtre dans les pays où le français est langue nationale officielle, de culture et d’usage, «Culture Française», n. 3/4 (1982) e n. 1 (1983). Ramiandrasoa Jean-Irénée, Le théâtre malgache classique: 1922-1945, «Notre Librairie», n. 109 (avril - juin 1992). 13 Rimandiamo alla bibliografia. 14 Il nostro studio sul Teatro dell’Oceano Indiano, per quanto circostanziato, ha dovuto confrontarsi con la vastità di una produzione che per varie ragioni, come abbiamo detto, rende difforme l’analisi e la concezione del teatro locale. Tutt’altro che esaustivo, il nostro lavoro si propone di tracciare dei percorsi di indagine e di riflessione aprendosi a ulteriori approfondimenti e a eventuali successive integrazioni nel tentativo di compensare la frammentarietà delle notizie ancora considerevoli allo stato attuale. IX la drammaturgia delle isole (anche se limitata ad alcuni autori) e la conseguente possibilità di reperire i testi nelle biblioteche specialistiche. Questi passaggi brevi, ma significativi e fondanti per la ricostruzione della storia del teatro locale, si alternano a lunghi silenzi, in modo particolare per la drammaturgia del passato, a riprova di come lo studio sul teatro dell’area sia ancora agli inizi, riflesso, soprattutto, delle avanzate ricerche sul teatro africano, e sulla drammaturgia tradizionale. Canale privilegiato per la diffusione delle opere delle ex-colonie, la Francia rimane il punto di riferimento per gli scrittori francofoni che ambiscono ad uscire dalle chiuse maglie del mercato interno, minacciato dall’analfabetismo e dalla censura politica, per accedere, attraverso i concorsi teatrali, al mercato europeo. Le biblioteche collegate al premio di R.F.I. sono riuscite negli anni a costituire un fondo prezioso di documentazione sul teatro in francese delle ex-colonie africane, tra le quali sono annoverate il Madagascar e l’isola di Maurice. Come Limoges, così la biblioteca Gaston Baty di Parigi III15 si offre come meta privilegiata per la ricerca di testi teatrali e tesi di dottorato sulla drammaturgia post-coloniale dei paesi partecipanti al Concorso di R.F.I. Diversamente dalle ex-colonie malgascia e mauriziana, la Réunion ha, invece, mantenuto, in quanto DOM, i legami diretti con la Francia, potendo usufruire come dipartimento, dei fondi stanziati dal governo per la cultura. L’assenza degli scrittori reunionesi alle manifestazioni teatrali di R.F.I. è compensata dagli investimenti del Ministero che, negli ultimi anni, hanno favorito la nascita di compagnie locali come il Vollard e il C.R.A.C. e di case editrici come l’ADER, l’UDIR, Les Chemins de la Liberté, le Editions Grand Océan particolarmente attive nella promozione della letteratura insulare, non soltanto reunionese. I recenti festival teatrali e la successiva fase di catalogazione delle opere in concorso possono essere considerati, per alcuni versi, l’evoluzione del sistema di raccolta e selezione di testi, letterari o scientifici, di autori coloniali da parte del governo francese in vigore fino al dopoguerra. I testi custoditi nella Biblioteca Nazionale di Francia16 e Richelieu sono edizioni rare: pièces edite da case editrici reunionesi o mauriziane, pubblicate in folio, viceversa rilegate con ricche copertine. L’efficienza di una struttura che mirava al censimento, quindi al collezionismo, della produzione coloniale ha reso possibile la conservazione di testi reunionesi, mauriziani e malgasce risalenti anche al 1800. 15 I testi di selezione e preselezione di R.F.I. sono custoditi nel fondo Scherer: specialista di teatro e membro permanente della commissione il critico è stato uno degli animatori del Concorso Interafricano del 1966. http://bucensier.univ-paris3.fr/ 16 http://www.bnf.fr/ X L’indagine ha portato alla scoperta di due pièces malgasce degli inizi del Novecento, ignorate dalle bibliografie17, una delle quali, anonima, ha reso necessarie ulteriori indagini per la determinazione della data di pubblicazione18. Se la partecipazione degli scrittori mauriziani al concorso per le drammaturgie francofone indetto da R.F.I. è giustificata dall’allargamento al festival anche alle realtà non specificatamente africane, stupisce, invece, la presenza imponente nelle biblioteche parigine di pièces mauriziane in lingua francese, edite dalla metà dell’Ottocento agli anni 60, quando l’isola era ormai di dominio inglese. Il caso mauriziano mette in luce la particolarità e la diversità della storia letteraria delle tre isole la cui evoluzione sembra dipendere dalla trasformazione, nei secoli, dei rapporti tra la Francia e le colonie dell’Oceano Indiano. Rispetto ai manuali di letteratura di Joubert o di Camille de Rauville, abbiamo, quindi, ritenuto necessario introdurre la tesi con un ampio capitolo sulla storia delle tre isole laddove è parso evidente come le relazioni tra la Metropoli e le colonie e le ex-colonie abbiano influito sullo sviluppo della letteratura drammatica e dell’attività teatrale nell’Arcipelago indiano. A una premessa generale e cronologica della storia dei territori dell’Oceano Indiano, dalla colonizzazione all’indipendenza, segue l’analisi approfondita di alcuni eventi e/o questioni storiche che a nostro avviso hanno contribuito all’evoluzione culturale e politica delle tre isole, e di cui, direttamente o indirettamente, ritorna la cronaca nei testi teatrali: la rivoluzione malgascia del 1947, la richiesta di dipartimentalizzazione reunionese del 1946, e, andando indietro nel tempo, il colonialismo e la de-colonizzazione, il marronnage come lotta politica prima e memoria collettiva poi. Lo studio della corposa produzione ha, altresì, rilevato una certa continuità tematica tra i vari testi teatrali, suggerendo, pertanto, l’elaborazione di una Storia del Teatro dell’Oceano Indiano che alla neutra successione diacronica di testi e autori preferisse la divisione per argomenti, a partire dai quali definire il clima politico e culturale in cui operano i diversi autori. Sebbene nelle tre aree il teatro si sia sviluppato in tempi diversi e con modalità differenti, agli inizi dell’Ottocento a Maurice, verso la fine del XIX secolo alla Réunion e nella seconda metà del Novecento nel Madagascar, gli scrittori delle isole, manifestamente engagés o viceversa apparentemente lontani da un teatro di contestazione, condividono la medesima concezione politica 17 La bibliografia di Jean-Louis Joubert si è rilevata incompleta in modo particolare per le pièces edite prima del Novecento e dopo il 1990. Soprattutto, è stato necessario integrare lo studio del critico francese con i riferimenti ai testi di teatro del concorso di R.F.I. che Joubert non sembra aver preso in considerazione. 18 Un Malgache, Rêve Mortel, «Revue Nouvelle», 15 juin 1904, Tome XXVIII (mai – juin 1904). XI del teatro, attribuendo alla rappresentazione drammatica la stessa funzione sociale di costruzione della coscienza civile. Il teatro politico è stato assunto come discrimine per tracciare l’evoluzione della complessa e contrastata drammaturgia del Madagascar, dell’isola di Maurice e della Réunion, per circoscrivere e definire i topoi generali di una poetica drammatica a cui fanno riferimento gli scrittori dell’Oceano Indiano: teatro etnologico e dei mœurs divers, teatro del conflitto morale, teatro storico, teatro epico-poetico, teatro sperimentale, diversamente interpretati dagli autori delle tre isole, laddove le varie drammaturgie sono il riflesso di situazioni socio-politiche e di periodi storici differenti. Il confronto con il teatro africano degli anni 60/70 ha permesso di definire la produzione teatrale malgascia come essenzialmente etnologica e sperimentale, moralista con il recupero e la critica del mondo antico e la silenziosa denuncia della realtà e della società post-coloniale, ma scarsamente interessata alla rappresentazione storica. L’assenza del teatro storico è la conseguenza di un processo di negazione dei luoghi della memoria, di un passato profondamente doloroso e irrisolto: segnato dalle guerre etniche precoloniali, dalla colonizzazione merina con la quale iniziò la tratta degli schiavi malgasci, dalle divisioni religiose (tra quella cattolica e protestante), quindi dalla colonizzazione europea, che, seppur contrastata, perdurò sull’isola fino al 1960. L’impossibilità di elaborare un passato comune si riflette nel rifiuto della lingua malgascia per la narrazione teatrale e nella destrutturazione del linguaggio francese che i drammaturghi dei nostri tempi contaminano con lo slang, i ritmi dei proverbi popolari e dello hira gasy, e nella mancanza di una coscienza etnica laddove tutt’ora il teatro contemporaneo si sottrae al confronto con la problematica razziale, con la multirazzialità conflittuale delle tre isole. Nato a ridosso della caduta dell’impero napoleonico e della cessione della colonia francese all’Inghilterra, il teatro di Maurice di fine Ottocento inizio Novecento può, invece, essere definito patriottico, e politico nella misura in cui la rappresentazione è assunta dagli scrittori del tempo come il mezzo per manifestare la propria opposizione culturale al colonizzatore inglese. I generi a cui si fa riferimento sono soprattutto tragedie ispirate ai classici francesi del Seicento, o drammi pervasi dai medesimi trasalimenti romantici di Musset o Hugo. La secessione, il distacco dalla realtà politica vissuto attraverso la poesia e l’arte si acuisce nella prima metà del Novecento, dominato dai drammi esistenziali di Hart o Loys Masson, dalle esplorazioni della psiche di Régis Fanchette, dalla sperimentazione tardo simbolista di Chazal, o espressionista di André Masson. XII Questa prima, lunga produzione tipicamente francese, dominata dal rifiuto della realtà (sostenuta dagli eredi dei primi coloni francesi contro, o in risposta alla politica inglese) viene meno all’indomani dell’indipendenza mauriziana, quando, in risposta all’egemonia culturale francese e come gesto di condanna per la politica antisociale dell’isola, si avvicinano alla produzione teatrale i figli degli schiavi e degli engagés indiani e cinesi, sindacalisti ed esponenti della politica, che approfittano della visibilità internazionale offerta dal concorso di R.F.I. per portare alla luce il contrastato presente multietnico dell’isola. Diversamente dall’isola di Maurice dove gli scrittori hanno sin dall’inizio dimostrato una forte consapevolezza del genere teatrale, e dal Madagascar dove il teatro, benché recente, si distingua per la sua forte originalità, la Réunion, dove già nella seconda metà del Settecento i cittadini improvvisavano piccole rappresentazioni nei magazzini del porto di Saint-Denis, si è avvicinata al teatro con una certa diffidenza, preferendo la prosa e la poesia alla drammaturgia. Nonostante già nel 1863 Auguste de Vinson, Émile Bellier fossero stati tentati dal genere teatrale, le poche opere reunionesi messe in scena tra il 1863 e il 1963, dimostrano lo scarso interesse degli scrittori locali verso il teatro. Il radicarsi del linguaggio teatrale sull’isola si deve probabilmente al fallimento delle aspettative dipartimentali, in risposta al quale il teatro, come strumento di lotta sociale, si è fatto interprete di una coscienza civile e regionale sempre più forte in opposizione all’evidente disinteresse della Metropoli. Come esperienza recente, la produzione drammatica reunionese si distingue, quindi, dal teatro mauriziano per i toni e per un uso soprattutto realistico del mezzo, laddove il linguaggio teatrale è usato dai drammaturghi anzitutto come strumento di educazione sociale Dalle prime opere incentrate sull’analisi della realtà locale di Kichenapanaïdou, si passa alla ricostruzione di intere pagine della storia reunionese di Genvrin, che, memore dell’esperienza del TNP di Vilar, da circa trent’anni opera nel contesto insulare combattendo il fatalismo della politica reunionese per mezzo di un teatro di coscientizzazione. L’eterogeneità delle esperienze storiche e culturali, la vastità dell’area e del periodo temporale preso in considerazione (dal 1800 ai giorni nostri), la diversità dei linguaggi teatrali ove spesso si intersecano le problematiche linguistiche, malgasce e creole, hanno costretto la riflessione a modificare di volta in volta i punti di riferimento critici, integrando gli studi sul teatro di Bernard Dort, di Patrice Pavis, di Jean-Pierre Ryngaert e di Anne Ubersfeld, per citarne alcuni, i manuali di drammaturgia di Silvio d’Amico, Michel Corvin, David Bradby, con saggi sul teatro politico di XIII Brecht e Piscator19, con le teorie di Augusto Boal sul teatro degli oppressi, con i saggi di antropologia teatrale di Turner. Per ciascun soggetto e per ogni autore sono stati, quindi, impiegati più strumenti di lettura in merito alle questioni sollevate di volta in volta dal testo teatrale. Se per l’esegesi delle pièces etnologiche sono stati privilegiati gli studi sulle tradizioni e i miti locali, per il teatro politico è valso il confronto con la tradizione satirica e con il teatro epico brechtiano; per i testi sperimentali, travagliati nei contenuti e nel linguaggio, sono state prese soprattutto in considerazione le teorie sul teatro postmoderno, così come per lo psicodramma si è fatto anzitutto riferimento alle recenti riflessioni sull’identità frammentata dell’uomo post-coloniale. Laddove per il teatro mauriziano e reunionese dell’Ottocento e della prima metà del Novecento sono evidenti i riferimenti ai classici della letteratura drammatica francese, Molière, Corneille, al vaudeville di Scribe, e al teatro metafisico di Claudel, le contaminazioni del teatro sperimentale, l’apertura alle esperienze drammatiche dei paesi orientali rendono, invece, più articolata l’esegesi delle pièces contemporanee, con riferimenti a diverse discipline: dal teatro con la definizione del dramma postmoderno e del dramma metateatrale, all’antropologia per la concezione di teatro rituale e teatro come norma sociale, alla storia come processo di creazione collettiva e di costruzione identitaria. Colonizzato nel 1896, il Madagascar, allo stesso modo delle colonie africane, ha usato il linguaggio teatrale come strumento di emancipazione politica e culturale dal retaggio coloniale, cominciando a produrre per il teatro solo dopo il 1960. Il sospetto nutrito verso un genere estraneo, ereditato dal periodo coloniale si riflette in una drammaturgia che gli scrittori malgasci cercano di nazionalizzare, riconoscendo nelle manifestazioni tradizionali dello hira gasy delle forme embrionali del teatro occidentale. L’appropriazione del teatro da parte degli scrittori malgasci rivela l’intento di ricostruire l’identità collettiva a partire dalle eredità coloniali rielaborate dai drammaturghi sulle leggende tradizionali, sulla narrazione moraleggiante delle canzoni popolari, sul ritmo della frase malgascia che frantuma e ricrea la sintassi francese. I numerosi studi sulla drammaturgia africana divengono strumenti utili per la comprensione di un teatro raramente studiato nel suo complesso, per l’analisi delle pièces e degli autori che, per varie ragioni, sono rimasti sconosciuti, laddove è possibile rintracciare un’affinità tra l’esperienza teatrale malgascia e africana, entrambe caratterizzate da un processo evolutivo similare: dal teatro etnologico degli anni 60/70, alla satira politica degli anni 70/80, alla sperimentazione degli anni 80/90. 19 Massimo Castri, Per un teatro politico, Piscator, Brecht, Artaud, Torino, Einaudi, 1973. XIV Dal confronto con i testi critici e i manuali sul teatro africano è emersa l’urgenza e l’utilità di un’esposizione didascalica capace di integrare l’analisi critica alla documentazione. La recente storia sul teatro africano francofono di Fiangor, la tesi di Abdoulaye e l’enciclopedia del teatro nero di Waters sono, quindi, state prese come riferimento per la messa a punto della Storia del Teatro dell’Oceano Indiano, per l’organizzazione delle varie sezioni. Come il testo di Fiangor e di Waters, alla prima parte storico-critica segue la parte documentaria in cui sono riportati in sintesi i dati principali del teatro delle tre isole: uno schema diacronicosincronico atto a confrontare l’evoluzione del teatro delle diverse aree, un’appendice tematica, infine i riassunti delle pièces analizzate nel secondo capitolo. Teatro storico, teatro politico, teatro etnico, teatro morale? Molteplici come le lingue e le razze che popolano le isole, le drammaturgie dell’Oceano Indiano danno conto di un’attività teatrale discontinua e diversificata ove emerge la frattura piuttosto che la continuità, nell’evoluzione del teatro di ciascuna area, più volte costretto al silenzio, nella diversa destinazione dello spazio teatrale indifferentemente luogo di intrattenimento e luogo di lotta sociale. XV CAPITOLO PRIMO Sur la route des Indes Stretti a Oriente dall’Australia, spinti a Occidente dall’istmo di Suez, i confini dell’Oceano Indiano si stendono irregolari tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, chiusi in una sorta di bacino dove a un tempo si disegnano i rilievi africani, la striscia Mediorientale, la penisola indiana, la costa cinese, l’Indonesia e ancora l’Australia. Benché la via delle indie fosse tra le più percorse dai mercanti di spezie e di tessuti mediaevali, i paesi che si affacciavano sull’Oceano Indiano, rimasti per lo più inesplorati ancora nel 1400, sarebbero stati destinati all’oblio dopo la scoperta delle Americhe: terre sconfinate e vergini che sembravano offrirsi alla rapida invasione dell’Europeo con la promessa di favolose ricchezze. Solo la brama di conquista che scosse l’Europa nel XVII secolo spinse nuovamente gli Europei, Francesi, Inglesi, Olandesi e Portoghesi, verso Est, portando alla colonizzazione di aree di cui solo antiche leggende e racconti esotici serbavano memoria. 16 Come per le Americhe con Colombo, così, solo dopo l’impresa di Vasco de Gama1, si aprì ai conquistatori occidentali il mondo ignorato di intere zone dell’Oceano Indiano, che portavano i nomi arabi: Bouki, Quanbalu o Komr per Madagascar, Dina magarbim o l’isola a ovest, a indicare la Réunion, Dina mozare, o l’isola a est, per Maurice2, avendo gli Arabi preceduto gli Occidentali nell’esplorazione dei mari orientali. Proprio agli Arabi si devono le prime indicazioni dettagliate sull’esistenza di isole abitate come il Madagascar o disabitate come la Réunion e Maurice. Sebbene aperte a qualsiasi conquista, le Mascarene (il complesso di isole che comprende la Réunion, Maurice e Rodrigues) non sedussero gli arabi plausibilmente a causa della scarsità di porti naturali (soprattutto la Réunion), delle correnti stagionali, ma soprattutto per la mancanza di suolo disponibile a futuri impieghi. A esse furono preferite le Comores che divennero una vera e propria colonia islamica, e lo stesso Madagascar con il quale dal XII secolo gli arabi intrattennero regolarmente scambi commerciali. Ai commercianti arabi siamo debitori delle uniche, più antiche informazioni su un popolo rimasto tuttora un mistero per gli antropologi. Se le cronache di Édrisi (XII secolo) fanno luce sui traffici via terra del popolo malgascio con i mercanti di Java (con i quali, aggiunge Édrisi, il popolo malgascio condivide la stessa lingua)3, i frequenti contatti e gli scambi reiterati tra le popolazioni malgasce e gli arabi, portarono all’assimilazione culturale e linguistica di etnie locali, come gli Antemoro e gli Zafi-Ramina, al mondo islamico, favorendo la nascita di una tradizione letteraria scritta in lingua araba oltre alla già fiorente produzione orale4. 1 Ricordiamo che nel 1498 il Portogallo, grazie all’audacia di Vasco de Gama, raggiunse per primo l’India via mare doppiando il capo di Buona Speranza. 2 Il nome Madagascar con cui è designata l’isola deve essere attribuito a Marco Polo che, insieme a Zanzibar e Socotra, cita erroneamente l’isola di «Madeigascar o Mogelasio», «dont les habitants sont musulmans et commerçants. Il y a là plus d’éléphants que nulle part ailleurs, et aussi des chameaux, des léopards, des ours et des lions», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, Paris, Berger & Levrault, 1972, p. 60. È chiaro che Marco Polo aveva confuso il Mozambico con il Madagascar, causa l’errata traduzione del termine arabo Djézireh che precisamente significa “penisola, costa”. Eppure, dopo il 1498, nonostante l’assidua frequentazione del Mar di Eritrea (parte dell’Oceano Indiano dove sono locate le isole suddette), gli europei preferirono continuare a designare l’isola con il nome Madagascar. Il termine arabo Bouki derivava, invece, dall’esigenza da parte degli arabi di distinguere la popolazione malgascia (bouques) dalla popolazione africana. Interessante notare che al tempo dei contatti con gli arabi, pare che gli abitanti dell’isola non avessero un nome che indicasse la loro patria. Il termine Quanbalu o Waqwaq è riportato in alcuni racconti arabi stando ad Auguste Toussaint, Histoire de l’Océan Indien, Paris, P.U.F., 1961, p. 54. 3 «Les gens de Madagascar ne possèdent pas de bateaux pour les traversées maritimes. Il leur en vient d’Oman et d’ailleurs. Ceux-ci continuent vers les îles de Djavaga qui constituent une partie de l’archipel indien. Les marins étrangers échangent leurs marchandises de ceux de Madagascar parce qu’ils parlent la même langue.», Ibid., p. 55. 4 «[…] la caste noble du peuple Antanosi […] se réclame d’une origine arabe […]. Ramina […] on le fait venir de la Mecque. […] Un autre groupe islamisé est celui des Antemoro […]. C’est surtout chez eux qu’on trouve les Sorabe (grande écriture, cf., arabe surat), écrits dans leur dialecte malgache, mais en caractères arabes.”, Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., pp. 50-52. Il passaggio dai caratteri arabi a quelli latini è opera del re Radama XIX secolo che primo intuì la necessità di avviare la giovane popolazione malgascia verso una massiccia scolarizzazione che in quegli anni era opera dei missionari, nonché alla conoscenza della tecnica e della scienza occidentali: «Au début du XIX siècle, le roi Radama I, qui a appris à lire et à écrire en français […], fait mettre au point un alphabet en caractères 17 L’impresa di Vasco de Gama del 1498 avviò l’area dell’Oceano Indiano a una vera e propria trasformazione geo-politica e socio-economica, non solo perché le sue popolazioni si trovarono bruscamente coinvolte negli eventi della storia occidentale, ma soprattutto perché questi territori furono iniziati a quella dolorosa lottizzazione, a quel triste commercio di schiavi di cui qualche anno prima erano state testimoni le Americhe. La frenesia con la quale Portoghesi, Olandesi, finanche Danesi si spinsero alla conquista e al controllo di intere zone dell’Oceano Indiano si spiega con il desiderio lungamente coltivato di controllare l’area nonché il traffico sì fruttuoso di spezie, tessuti, monili di cui sempre l’Oriente era stato generoso (la scoperta e la conquista del Nuovo Continente ebbe origine proprio dalle iniziali mire commerciali degli europei in Oriente). I primi, tra gli Europei, a valersi dell’esperienza di Vasco de Gama furono proprio i Portoghesi che, subito, si spinsero alla conoscenza delle coste e delle isole dell’Oceano Indiano. Come già gli Arabi, i Portoghesi disdegnarono le poco accessibili Mascarene (al condottiero Pero Mascarenhas si deve il nome dell’arcipelago) preferendo la costa africana del Mozambico, insalubre e insidiata a sud dal deserto e il Madagascar di cui tentarono, invano, più volte la conquista. Vista l’impossibilità di assoggettare un popolo che si era dimostrato capace di resistere e di organizzare vere controffensive agli eserciti reali, ai Portoghesi rimase la via del commercio e delle alleanze (nel diventare protetti della corona portoghese, i figli dei capi tribù ricevevano in Portogallo un’educazione militare e religiosa) nella speranza che, la progressiva apertura al mondo e alla cultura occidentali anche per mezzo di opere missionarie, potessero favorire la futura conquista dell’isola. Delle imprese portoghesi, rimangono una conoscenza maggiore dei mari orientali, la documentazione di paesi rimasti inesplorati, come le Chagos, Rogrigues, Carajos e Agaléga, che, nelle nuove carte nautiche portoghesi, finalmente apparivano accanto alle già note Maurice, ora Cirne (isola dei cigni), Réunion (Santa Apolonia) e Madagascar (Saõ Lourenço). A differenza dei loro predecessori, e contrariamente ai Danesi che si erano limitati a saccheggiare le foreste di Cirne ricche di pregiato legname per imbarcazioni, gli Olandesi intuirono le potenzialità militari dell’isola posta strategicamente al centro dei traffici commerciali con l’Oriente. Benché avesse preso possesso dell’isola nel 1598, ribattezzandola Maurice in onore del principe Maurizio di Nassau (Réunion non aveva prodotto lo stesso interesse), solo nel 1638, la Oost-Indische Compagnie decise di installare una colonia, formata da ex-galeotti, per scoraggiare i tentativi inglesi di rivendicare la proprietà su Maurice. I primi anni furono interessati da uno sfruttamento irrazionale delle risorse del luogo con successivo disboscamento di intere aree, nonché l’estinzione dei rarissimi dodo, i cui esemplari popolavano la sola Maurice. Nonostante gli Olandesi avessero più volte mutato latins pour écrire la langue malgache.», Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océn Indien, Vanves, EDICEF, 1991, p. 28. 18 le strategie di impiego del territorio, inviando di quando in quando nuovi e più illuminati amministratori, nel 1710 decisero di abbandonare definitivamente l’isola per il più lucroso Capo. Per quanto riguarda il Madagascar, gli Olandesi ne fecero soprattutto il partner commerciale privilegiato della colonia Maurice. Nel 1663 Frédéric de Houtman redasse il primo dizionario malgascio-malese. Gli Inglesi, futuri padroni del mare, detentori delle principali aree strategiche dell’Oceano Indiano, si interessarono, invece, anzitutto a Madagascar, descritta al tempo di Carlo I (1636) come nuova Eldorado5: paradiso terrestre i cui abitanti dovevano vivere nell’abbondanza di ogni ricchezza. Organizzata una spedizione nel 1644, gli Inglesi dovettero subito ricredersi dell’ospitalità dei Malgasci e delle favolose ricchezze di un territorio che, contrariamente alle aspettative, si rivelò «stérile, le climat malsain, les mines illusoires»6, per convincersi dei superiori vantaggi offerti dalla conquista dell’India. 5 «Un long poème épique célébra les exploits futurs du «premier souverain de l’île d’or». (…). En 1640 Walter Hamond publiait Un paradoxe prouvant que les habitants de Madagascar sont (dans les choses temporelles) les plus heureux du monde. C’était une exaltation de la vie naturelle du bon sauvage pourvue d’or, d’argent de perles et de pierres précieuses. », Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 66. 6 Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 66. 19 Da Quanbalu a Madagascar Combien en avons-nous sur les routes australes /côtoyé tour à tour les étrangers splendeurs (…) Ah! Dieux des mes Aïeux! S’en venir de si loin!... / Avoir troqué sans retour la robe blanche du doux foyer maternel / Contre le manteau rude de l’errance / sur le parcours des trois mers!7 L’origine della popolazione malgascia rimane per gli antropologi ancora avvolta nella leggenda. Le numerose congetture, più o meno composite, più o meno suggestive, che si sono susseguite dalla metà del secolo scorso, mancano tutte di documenti validi e definitivi che le possano convalidare. L’assenza di reperti fossili apprezzabili8 fa anzitutto escludere l’ipotesi di una razza oriunda, sviluppatasi sul luogo sin dalle ere più antiche. Come spiegare, allora, l’esistenza di una popolazione così vicina alla costa africana che, pure, rimane aliena alle tradizioni e ai suoni di paesi ad essa tanto prossimi, e che, invece, sembra condividere con alcune etnie asiatiche non solo i tratti somatici, ma la lingua e le usanze popolari? Benché fossero parse evidenti ai primi esploratori le affinità tra la lingua malgascia e le lingue indonesiane, e la struttura delle società riproducesse l’organizzazione clanica di alcune etnie orientali fondate su un rigido sistema autarchico senza distinzione di classe tra gli appartenenti, e in seno al quale «l’égalité des conditions matérielles est quasi totale»9, nondimeno la popolazione malgascia si è, comunque, sottratta a ogni classificazione, oscillando tra Africa e Indonesia in «[…] une juxtaposition ou un métissage des deux, un peuple originale et d’une grande variété.»10. Si suppone che l’incontro tra i migranti indonesiani e i popoli africani costieri sia avvenuto in epoca remota (intorno al 500 d.c.) dando origine a una popolazione che solo in un secondo tempo si sarebbe spostata sull’isola per mantenere inalterate nei secoli: la lingua, la cultura e i tratti somatici nel più totale isolamento (complici le correnti oceaniche e i rilievi aspri del territorio malagscio11). Altre ondate indonesiane verso l’Africa si sarebbero susseguite fino al XIII secolo per poi arrestarsi 7 Jacques Rabemananjara, Les Boutriers de l’Aurore, Paris, Présence Africaine, 1957, pp. 15-16. «Or, […], Madagascar n’a révélé, du moins jusqu’ici, ni ossements d’hommes fossiles, ni gisements de pierres taillées ou polies, ni bronze. Deux cailloux grossièrement taillés en herminettes de type indonésien ont été trouvés posés sur le sol en deux points des plaines de l’ouest. […].», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 13. 9 Ibid., p. 141. 10 Ibid., p. 19. 11 «L’hypothèse la plus ingénieuse paraît être celle de l’ethnologue américain Linton (1943) dont voici l’essentiel: les aborigènes de Madagascar seraient des négroïdes datant de la préhistoire. Aux premiers siècles de l’ère chrétienne, un courant d’émigration venu de l’Indonésie traversa l’Océan Indien jusqu’à la côte des Somalis d’où, quelques générations plus tard, ces émigrants, mélangés d’Africains, se rendirent à Madagascar. », Auguste Toussaint, Histoire de l’Océan Indien, op. cit., pp. 54-55. 8 20 in seguito alla completa islamizzazione dell’Indonesia, per la quale il Madagascar rimaneva, tuttavia, un importante nodo strategico verso le coste africane12. Gli studiosi sono concordi nel circoscrivere i primi insediamenti malgasci (dei Protomalgasci) nel nord dell’isola, quando la popolazione degli Antalaotra di lingua swahili (gente di mare) si sarebbe spostata dall’Africa passando per le Comores (rimaste per i Malgasci, anche successivamente, una delle mete privilegiate dei loro saccheggi). A questo primo nucleo si sarebbero, successivamente, aggiunti nuove ondate migratorie che avrebbero occupato il resto della costa: a ovest gli Africani, a nord-est gli Iraniani, a sud-est gli Antemoro e i Zafi-Ramina (XIII-XVI d.c.). Già islamizzate, le popolazioni del sud-est si sarebbero poi spostate verso l’entroterra dando origine alle società complesse dei Sakalava (sulla costa occidentale), dei Betsileo (nell’altopiano centrale), dei Bara (a sud), dei Merina13 (al centro). Tra il 1500 e il 1810 molte delle comunità malgasce subirono un cambiamento radicale nella concezione della struttura sociale: dall’iniziale regime chiuso del clan si passò a un sistema piramidale (aperto) più articolato, retto sul regime feudale, sul prestigio religioso del re e delle famiglie nobili. Con il rafforzarsi del potere centrale mutarono anche le prospettive delle comunità concentrate ora sulla conquista dell’intero territorio insulare, intenzionate ad assoggettare quei clan non avvezzi alle alleanze e per questo facile preda delle popolazioni più forti e organizzate militarmente. Nel XVII secolo si distinsero, in modo particolare, i Sakalava, primi ad aver manifestato l’intento di riunire il Madagascar sotto un solo regno (occuparono un terzo dell’isola), primi ad aver unito alla strategia militare l’uso di armi occidentali, di cui la maggior parte delle tribù locali ignoravano l’esistenza14. Le continue ribellioni delle popolazioni assoggettate sancirono la fine dell’impero Sakalava, a cui subentrò nei secoli successivi la potenza merina. La storia dei Merina ebbe inizio nel XVI secolo da un primo insediamento nella spianata centrale originariamente occupata dai Vazimba. L’ascesa del popolo Merina alla guida del Madagascar 12 «Madagascar était une sorte d’annexe (un peu sauvage) du trafic indonésien, qui s’étendait de l’Afrique à la Chine, en passant par l’Inde, avec des antennes vers l’Arabie.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 43. 13 Il popolo Merina si sarebbe formato dall’emigrazione delle popolazioni del sud-est verso l’entroterra. Il suffisso Andriana usato per la classe nobile si ritrova in tutti quei nuclei malgasci costituitesi nel primo millennio, come i Betsileo, i cui capi erano di origine iraniana, indiana o indonesiana. La casta nobile dei Merina, gli Hova, deriva presumibilmente: Houa, capi delle isole Tonga, Ova, libero, infine Mahova, gente dalla pelle chiara, a distinguere l’origine lontana e nobile di tale stirpe rispetto quella più recente africana. Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 56 nota (1). 14 La rivoluzione culturale operata dal popolo Sakalava deve la sua riuscita alla tratta degli schiavi. Tra il XVII e il XVIII secolo, le coste malgasce erano la meta principale delle imbarcazioni europee alla ricerca di mano d’opera da sfruttare a beneficio delle colonie. Il commercio schiavista divenne per i Sakalava prima, per i Merina dopo, la maggiore fonte di armi e polvere da sparo, grazie alle quali fu possibile la conquista del Madagascar: «L’incroyable facilité avec laquelle elle (la conquête Sakalava) semble s’être opérée s’explique sans doute par le prestige des rois, soigneusement organisé, la croyance à leurs pouvoirs magiques, le culte des anciens rois, des conceptions politiques plus étendues, l’abondance des fusils et des munitions que procurait le commerce avec les Européens (…).», Ibid., p. 103. 21 raggiunse il suo apice tra il XVIII e il XIX secolo. Anche se Ralambo diede l’impulso a un’espansione verso est (il grande re Merina deve anche essere ricordato come il fautore del consolidamento del potere centrale), il vero padre della nazione malgascia è considerato Andriamasinavalona, il quale non solo riuscì a espandere i confini dell’antico regno su gran parte del territorio malgascio15, ma riformò e unificò i costumi della popolazione Merina, e dei popoli ad essa sottomessi. La morte del re, la conseguente suddivisione del regno tra i quattro figli, ritardò tuttavia di altri decenni la definitiva unificazione del Madagascar (nel caso specifico, venne favorito l’insorgere e il rafforzamento della guerriglia di quei clan che malvolentieri si erano assoggettati ad Andriamasinavalona, offrendo alle nazioni europee ampie giustificazioni alle loro mire espansionistiche sull’isola). Il controllo dell’Oceano Indiano, da parte delle potenze occidentali, si era risolto nella conquista di alcuni punti strategicamente collocati sulla via delle Indie. La conquista francese del Madagascar iniziò nel 1642 quando Rigault della Società delle Indie decise di stanziare alcuni insediamenti sull’isola per il controllo dei mari e dei traffici. Dopo la l’installazione di una prima comunità a Fort-Dauphin, sud dell’isola (in onore del futuro sovrano Luigi XIV) nel 1643, il comandante Pronis iniziò una serie di alleanze con le etnie vicine nel tentativo di rinsaldare i legami, anche commerciali, con le popolazioni del luogo (i Betsileo del sud vennero aiutati nella guerra contro i Bestileo del nord). Subentrato Flacourt nel 1648 (rimase fino al 1665)16, il forte ricevette una nuova organizzazione, nuove direttive militari che fecero sperare in una fortunata e veloce espansione francese verso l’interno dell’isola. Abbandonato a se stesso (durante il periodo della Fronda), morto Flacourt, il forte riportò grosse perdite in ragione delle quali, la Francia concluse la sua spedizione con una colonizzazione solo nominale dell’isola nel 1665, convincendosi dell’impossibilità di soggiogare con la forza le popolazioni locali. La guerra tra Francia e Inghilterra costrinse i Francesi delle Mascarene a intensificare i rapporti commerciali con il Madagascar. I nuovi legami instaurati con l’isola (sotto il profilo commerciale e non coloniale) aiutarono il rinsaldarsi delle alleanze tra il popolo malgascio e i coloni degli insediamenti francesi preesistenti (nel 1750 era stata ceduta anche l’isola di Sainte-Marie alla 15 Il re viene anche ricordato come il primo che istituì il rito del Kabary, dell’incontro domenicale con il popolo durante il quale il re faceva partecipe la popolazione delle sue decisioni politiche: «Andriamasinavalona s’empara du trône, non sans avoir dû promettre au peuple de le consulter désormais: «Tsy adidiko Izaho ierey, fa Izaho sy hianareo» (ce n’est pas moi qui décide seul, mais moi et vous).», Ibid., p. 118. 16 A Étienne de Flacourt si deve uno dei primi studi sulle popolazioni malgasce, Histoire de la Grande Ile Madagascar (1658), rimasta punto di riferimento per gli studiosi di antropologia e storia malgascia fino al secolo scorso. Un aneddoto narra che il comandante nell’abbandonare l’isola lasciasse ai futuri visitatori del Madagascar il monito di diffidare degli abitanti: «En décembre 1653 Flacourt, ayant fait construire une barque, essaya de regagner la France. Il dressa sur le rivale une stèle trouvée dans l’île des Portugais et y fit graver cette inscription: O advena, lege monita nostra, tibi tuis vitaeque tuae profitura: Cave ab incolis. Vale / O toi qui arrives, lis notre conseil; il sera utile pour toi, pour les tiens et pour ta vie: méfie toi des habitants.», Hubert Deschamp, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 71. 22 Francia), nonché l’espansione degli stessi verso il centro, a Tamatave, dove già vivevano numerosi Creoli. Negli stessi anni in cui la Francia rinsaldava i legami con le popolazioni locali, si consolidava il potere Merina. Il re Nampoina (il desiderato) si mostrò capace di pacificare i clan vicini stringendo finanche alleanze con il popolo Sakalava da sempre ostile a qualsiasi assoggettamento. Regnante illuminato, studiò la possibilità di sfruttare le dighe per aiutare lo sviluppo della risicoltura, convinto del fatto che il benessere dovesse essere equamente diviso fra tutta la popolazione17. L’ascesa al trono di Radama I coincise con l’espansione del regno malgascio e con il consolidamento della potenza inglese nell’Oceano Indiano. Nel 1810 dalla flotta inglese erano, infatti, state sottratte alla Francia Maurice e la Réunion (quest’ultima recuperata dai Francesi solo nel 1815). La Francia si vide costretta a riconfermare i suoi possedimenti malgasci, solleticata (e sollecitata dai coloni reunionesi) dall’idea di potersi espandere sull’intero territorio. Proprio i complessi equilibri orientali, la perdita delle colonie americane per gli Inglesi, di Santo Domingo per i Francesi, l’intensificarsi dei saccheggi dei pirati venuti dalle Antille, prima, dei corsari poi, il perdurare della tratta schiavista (nonostante l’abolizione risalisse al 180718), avevano eletto il Madagascar a nuovo centro di interesse inglese e francese. Di questa situazione ne approfittò il nuovo re Radama I che, forte di una serie di trattati stipulati con l’Inghilterra19, riuscì nell’impresa iniziata da Andriamasinavalona di unificare la nazione. Tra il 1817 e il 1824, i Merina si spostarono dal centro fino a sud sottraendo Fort-Dauphin ai Francesi e assoggettando l’impero Sakalava. Radama, conosciuto come il Carlo Magno malgascio, si avvalse della collaborazione straniera per accelerare lo sviluppo culturale ed economico del Madagascar. Ingegneri francesi e i missionari ammodernarono una nazione avviandola al progresso tecnologico, con l’istallazione di mulini a vento, l’instaurazione di scuole grazie alle quali diffondere, ovunque nel regno, la conoscenza della lingua malgascia. A questo periodo di intensi stravolgimenti politici, di grossi fermenti culturali seguì un’epoca di isolamento e di dura reazione alle influenze esterne. Ranavalona I, figlia di Radama, sollecitata 17 «A certains égards le régime d’ Andriampoinimerina était un socialisme autoritaire. «Ahy ny tany» déclarait-il, la terre est à moi. Il la redistribuait à chaque famille en quantité suffisante «pour assurer la faim de son ventre»; chacun devait lui payer en échange trois vata de ris […] «La famine est mon ennemie», «le riz et moi ne sommes qu’un», […] «la mer est la limite de ma rizière» étaient ses formules ordinaires.», Ibid., pp. 124-125. 18 «La même commission dénonce le maintient de la traite négrière interdite en Angleterre en 1907.», Jean-Pierre Durand et J., L’île Maurice et ses populations, Bruxelles, éd. Complexes, 1978, p. 39. 19 Il governatore di Maurice, Farquhar, intenzionato a ridimensionare la potenza francese nell’Oceano Indiano avvia una serie, di trattati con il re Radama, i quali prevedevano la cessazione di qualsiasi tratta di schiavi (di cui i malgasci erano i maggiori fornitori), a indennizzo della quale: nel 1817 veniva riconosciuto formalmente dal governo inglese il regno di Madagascar, lo stato Merina avrebbe ricevuto armi, munizioni, e 1000 dollari d’oro e d’argento (per inadempienza delle parti al trattato del 1817, seguì quello del 1820). Ibid., pp. 151-159. 23 dell’aristocrazia Hova, decise di chiudere qualsiasi contatto con le potenze straniere, i missionari e la popolazione malgascia cristianizzata furono duramente perseguitati. Grazie alle conoscenze tecniche di Le Gaston Jean Laborde fu possibile sostenere il progetto di un governo autarchico (nel 1832 furono create anche le fabbriche di armi da fuoco), che comprendeva la nascita e lo sviluppo di un produttivo centro agricolo in cui iniziare la coltivazione della canna da zucchero. Se Ranavalona non riuscì a espandere ulteriormente il territorio sottomesso (circa due terzi dell’isola), fece comunque in modo che le popolazioni più organizzate militarmente, come i Betsileo o i Sakalava, le rimanessero fedeli. Negli ultimi anni del suo regno, su suggerimento di Laborde, Ranavalona riaprì il Madagascar al commercio estero, soprattutto francese. Al governo di Ranavalona, seguì il breve regno di Radama II (1861 - 1863), vittima della politica nazionale dell’aristocrazia: «chef capable (…) il ne l’était pas; mais jamais un chef plus humain n’a porté une couronne»20. L’estrema disponibilità verso le potenze occidentali di Radama, che aveva aperto i porti del Madagascar agli stranieri (nel 1862 venne stipulato un patto con i Francesi nel quale fu loro garantita la possibilità di acquistare terra in Madagascar, di avviare attività commerciali sul luogo), non accolse, infatti, consensi da parte dell’oligarchia malgascia che invece vedeva l’influenza europea come una minaccia per la conservazione del grande potere raggiunto sotto Ranavalona I. Prendendo spunto da un’epidemia abbattutasi sull’isola, Raharo, primo ministro, raccolse i militari per attuare un colpo di stato ai danni del re21. L’era dei grandi re Merina era terminata, a questi seguirono una serie di governi fantoccio retti dal primo ministro. Nonostante la promulgazione nel 1881 del “codice dei 305 articoli” (con le riforme nel campo del diritto civile, penale venivano create le basi per uno stato moderno), ormai la disgregazione politica del regno avvantaggiava il radicarsi della cultura occidentale a danno delle tradizioni antiche (nel 1869, il Madagascar divenne definitivamente cattolico). Alla morte di Laborde nel 1881, la Francia vide profilarsi le condizioni per mettere in atto una serie di rivendicazioni sul suolo malgascio avanzando le ragioni di gravi malversazioni perpetrate contro gli eredi del console francese. Approfittando dello stato di confusione politica in cui da tempo versava il governo Merina, la Francia considerò opportuno appoggiare le richieste indipendentiste dei Sakalava, perché i coloni dei fortini di Tamatave e di Fort-Dauphin potessero prendere nuovamente possesso dei vecchi possedimenti. La convinzione di una rapida soluzione dell’iniziativa bellica contro la nazione malgascia veniva dal riconoscimento inglese del protettorato francese sull’isola stipulato nel 1885, dalla certezza che gli Inglesi non avrebbero ostacolato le mire espansionistiche della Francia su un territorio che non destava più il loro interesse. 20 Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 174. Il culto del re esecrava qualsiasi atto di violenza sui membri della famiglia reale. L’undici marzo del 1863, Radama II venne strangolato con una stoffa di seta perché il suo sangue non fosse sparso. 21 24 Dopo un ultimatum, le truppe francesi sbarcano sulle coste malgasce che capitolarono solo dopo la conquista di Tananarive, capitale del regno Merina. Le popolazioni assoggettate al governo approfittarono dello stato di deterioramento del potere centrale per ribellarsi, da qui la decisione finale da parte francese di occupare tutto il Madagascar (anche le zone rimaste indipendenti sotto i Merina), di passare il Madagascar sotto la tutela degli Affari Esteri e delle Colonie, quindi di destituire i regnanti Merina dal potere (6 agosto 1896)22. I governatori che si succedettero sull’isola tentarono di arginare i fenomeni di ribellione con il vecchio sistema delle alleanze che, a conquista ultimata, si risolveva nell’assimilazione del potere locale, dell’oligarchia merina nell’amministrazione coloniale, con l’abolizione del sistema feudale in favore di uno Stato moderno e, apparentemente, sociale. Le riforme attuate da Gallieni prevedevano l’istituzione dell’assistenza medica (gestita prima dai medici francesi poi allargata ai nuovi laureati malgasci), il ripristino dell’obbligatorietà scolastica (venuta meno sotto Ranavalona I) con l’adozione di testi in lingua francese accanto ai testi in lingua malgascia, la creazione di un organo preposto alla cura e al rispetto della giustizia indigena (distinta dalla giustizia occidentale applicata specificatamente agli europei). Alla modernizzazione dell’isola, delle vie di comunicazione, all’allargamento della scolarizzazione non seguì, tuttavia, la capitolazione del popolo malgascio che, contrariamente a quanto sperato dai Francesi, fino al 1947 tentò a più riprese di riconquistare la propria indipendenza23. Alla società segreta V.V.S., fondata nel 1915, i cui trecento membri, pure nella completa disorganizzazione, professavano la libertà del popolo malgascio, seguì nel 1934 il partito politico La Nation Malgache dell’intellettuale Ralaimongo che promuoveva la trasformazione della colonia del Madagascar in dipartimento. Lo scoppio della seconda guerra mondiale, che costrinse le potenze europee a trasferire gli interessi fuori delle colonie alle rovine del Vecchio Continente, diede nuovo impulso e nuova forza ai movimenti nazionalisti delle isole dell’Oceano Indiano. L’invasione inglese in pieno conflitto mondiale (1942) pose la popolazione malgascia di fronte all’evidenza di un esercito francese ormai allo stremo delle sue forze facendo nascere la speranza che gli Anglo-Americani avrebbero potuto appoggiare le ambizioni indipendentiste della maggioranza dei Malgasci (non ultime quelle delle frange Hova che avevano perso il loro peso politico durante la colonizzazione). La legittimità dell’autodeterminazione di tutti i popoli confermata dalla carta di San Francisco firmata anche dalla 22 La regina Ranavalona III fu esiliata dapprima alla Réunion per poi finire i suoi giorni in Algeria. Le spoglie sarebbero state riportate in patria solo nel 1939. 23 «Mais ce qui a le plus manqué c’est une idée directrice; on a hésité entre une colonie de peuplement du type des Antilles et une entreprise commerciale. Les deux ont échoué; la première faute d’une politique de cultures bien adaptées et d’une fusion progressive avec les Malgaches, la seconde faute de produits riches. », Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 76. 25 Francia nel 1945, aveva accresciuto la convinzione che il Madagascar dovesse e potesse finalmente sottrarsi al giogo francese. L’illusione francese, che la creazione di un Consiglio Rappresentativo avrebbe fatto definitivamente tacere le rivendicazioni malgasce, dovette scontrasi con il successo riportato alle elezioni amministrative dal movimento M.D.R.M (Movimento Democratico per il Rinnovamento Malgascio) di cui alcuni deputati malgasci (appena eletti nel Consiglio Rappresentativo) facevano parte. Al M.D.R.M si oppose un organo supportato dal governo francese, lo P.A.D.E.S.M. (Partito dei Diseredati del Madagascar) che riuniva i popoli della costa anticamente assoggettati dai Merina. I brogli perpetrati del governo francese nelle ultime elezioni del 1947, nuovamente vinte dal M.D.R.M., convinsero il popolo malgascio a unirsi in rivolta. Asintomatica, la rivolta del 1947 scoppiò in diverse circoscrizioni dell’isola. In pochi mesi, le frange estremiste riuscirono a occupare un ottavo del territorio, soprattutto la zona a est. Se l’effetto sorpresa e l’inverno frenarono inizialmente l’offensiva francese, con il nuovo anno, il governo decise di intraprendere una dura repressione. Nel 1948 i maggiori esponenti del M.D.R.M. furono arrestati e condannati a morte o al carcere a vita. Il Ministero Mendès decise per un’amnistia totale dei prigionieri politici e intellettuali importanti come Rabemananjara vennero graziati. Nel 1956 fu votata una legge quadro che prevedeva, per i territori d’Oltre Mare, la costituzione di un’Assemblea nazionale nonché la predisposizione di un organo che valesse come Potere Esecutivo. Il periodo di transizione dal protettorato al governo autogestito malgascio, fu sfruttato dal governo francese per creare un corpo politico insulare a lui favorevole, agevolando l’ascesa di figure neutrali, come Tsiranana (ex esponente dello P.A.D.E.S.M., presidente del partito P.S.D.), che garantissero una continuità politica tra il vecchio e nuovo governo, nonché il controllo su un’area importante e strategica come quella dell’Oceano indiano. Redatta la costituzione nel 1959, nel 1960 il Madagascar venne proclamato stato indipendente e sovrano, con Tsiranana presidente. La connivenza del governo di Tsiranana con la ex-potenza coloniale (la Francia manteneva le sue basi militari sul suolo malgascio, la responsabilità dell’esercito rimaneva alla Francia, le scuole secondarie venivano gestite dal ministero francese, allo stesso modo dell’economia malgascia) fu alla base di nuove manifestazioni popolari scoppiate nel 1972. Allo sciopero degli studenti di medicina si unì la protesta dei contadini (che da tempo combattevano con l’inquinamento delle falde causato dalle industrie francesi). La malattia di Tsiranana e la defezione francese offrirono, quindi, nuove occasioni di insurrezioni popolari che coinvolsero tutte le classi sociali. Le nuove elezioni del 1972, vistosamente manipolate a vantaggio di Tsiranana, portarono allo scioglimento del governo, quindi a una provvisoria dittatura militare. Il generale Ramanantsoa eletto capo ad interim, in attesa 26 di nuove candidature, avviò il Madagascar verso nuove riforme nel segno della malgascizzazione (allontanamento delle forze straniere, riconversione dell’educazione scolastica, trasformazione dell’economia verso un socialismo populista, creazione dei fokon’olona24). Il colpo di stato, che portò all’assassinio del nuovo presidente Ratsimandrava, trascinò il Madagascar verso la nuova, rovinosa era della dittatura militare di Ratsiraka convinto assertore di una politica socialista rivoluzionaria. Il 21 dicembre del 1975, un referendum sanciva la legittimità della rivoluzione proclamando Ratsiraka nuovo presidente della Seconda Repubblica malgascia. Tolta la breve parentesi del governo di Albert Zafi (1991 – 1996, presidente della terza Repubblica), la dittatura di Ratsiraka si sarebbe protratta fino al 2002. Motivo di nuovi scontri furono le elezioni presidenziali del 2001. La disposizione di un secondo turno delle elezioni presidenziali da parte dell’Alta Corte scatenò le proteste dei sostenitori del sindaco di Tananarive, Marc Ravalomanana, vincitore al primo turno con il 46, 21%. Alla minaccia dello sciopero generale e illimitato indetto dal sindaco di Tananarive, i fedeli di Ratsiraka si organizzarono per bloccare i collegamenti tra la capitale e il porto Toamasina (roccaforte di Ratsiraka) al fine di mettere Tatanarive sotto assedio. Lo scontro tra i due candidati e i loro sostenitori si risolse solo nel febbraio del 2002 allorché Marc Ravalomanana si autoproclamò presidente del Madagascar. Né la partenza di Ratsiraka, né i tentativi di reprimere le contestazioni dei sostenitori del presidente uscente ristabilirono, però, l’ordine nel Madagascar, solo il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del nuovo mandato presidenziale nel giugno del 2002 sancì la definitiva uscita della Repubblica malgascia dalla dittatura militare. Les îles-sœurs25 24 Unità minima autogestita, responsabile del proprio sostentamento. 27 Ancorché morfologicamente diverse26, sebbene divise dalla Storia e da diversi percorsi sociopolitici, Maurice e la Réunion sono conosciute come le isole-sorelle. Certamente la vicinanza e l’appartenenza a uno stesso Arcipelago (l’Arcipelago delle Mascarene) hanno favorito il mito della loro sorellanza; ancora, l’essere rimaste deserte per lunghi secoli prima della definitiva conquista francese, a cui è seguito un analogo sviluppo demografico (prodotto della deportazione degli schiavi e dell’immigrazione indiana e cinese), hanno assecondato la leggenda di una medesima origine dall’antica Lemuria27. Ciononostante nulla sembra veramente accomunare le due isole, se non meno di un secolo di storia (dal 1735 al 1815) che ha visto, fatalmente, suddita l’una all’altra: la Réunion all’isola di Maurice. La Réunion: isola consacrata alla Francia C’è da chiedersi come è possibile che la Réunion sia rimasta disabitata fino al 1663, se i racconti di quanti, Portoghesi e Olandesi, ebbero modo di esplorarla nel XVI secolo, furono unanimi nel descriverla come una sorta di Paradiso Terrestre, dal clima ospitale e salubre, dalla vegetazione florida, dispensatrice di cibo di ogni genere: 25 La formula per designare le isole francesi dell’Oceano Indiano, Réunion e Maurice, è tratta dal titolo dell’opera di Marius Leblond, Les iles soeurs ou le paradis retrouvé. La Réunion – Maurice, Eden de la Mer des Indes, Paris, Alsatia, 1946. 26 «Les îles-sœurs ne se ressemblent pas. A 231 kilomètres de distance l’une de l’autre, leur contraste est saisissant. La Réunion est dominée par un volcan toujours en activité. Son relief est rude et élevé. Elle offre de piètres rades à la navigation. Maurice, elle aussi, est une terre volcanique, mais plus ancienne. Elle aurait été formée il y a 70 millions d’années. L’érosion a fait son œuvre. Depuis un million d’années toute activité volcanique a cessé. D’où son relief beaucoup plus paisible et des cimes qui n’atteignent pas 850 mètres. Ses rades naturelles pouvaient recevoir les grands voiliers à Mahébourg et à Port-Louis. », Bernard Lehembre, L’île Maurice, Paris, Karthala, 1984, p. 14. 27 L’ipotesi dell’esistenza di un’unica terra originaria, madre di tutti i popoli e di tutte le culture, scomparsa in seguito alla deriva dei continenti è stata riproposta e difesa dallo scrittore reunionese Jules Hermann. Secondo il letterato, le isole dell’Oceano Indiano, la Réunion e Maurice, sarebbero i frammenti del continente primigenio, isola di giganti le cui testimonianze sarebbero rimaste inscritte sul dorso collinare di Maurice (per Malcolm de Chazal), o sulle montagne reunionesi. «Au point de départ, il y a une rêverie sur l’existence d’un continent primitif, la Lémurie, berceau de toute civilisation, mais aujourd'hui englouti après une immense catastrophe cosmique. Les îles actuelles de l’Océan Indien en sont de rares survivances émergées. Cette rêverie s’appuie sur des observations géologiques et s’apparente à la théorie de la dérive des continents, que les savants commencent à échafauder au début du siècle. […] lire les divers accidents du paysage réunionnais comme les traces laissées par de prodigeux géants, sculpteurs des montagnes.», Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 227. 28 « “une grande quantité d’oiseaux, petits et grands, tourterelles, […] une grosse espèce de volailles de la taille d’un dindon […]” […]. Ils décrivaient ces ramiers aux ailes bleues qui se laissent prendre à la main […] la beauté des cascades […], la grosseur des anguilles, le fourmillement des tortues à la chair 28 délicate.» . Lo scarso interesse dimostrato dai colonizzatori e la distratta attenzione della Francia riguardo alla giovane colonia rivelano, piuttosto, il ruolo secondario assegnato alla Réunion dagli Europei rispetto alla vicina Maurice e al Madagascar, laddove l’isola, con i suoi rilievi e la scarsità di porti naturali ostacolava i progetti commerciali e militari della corona francese. «C’est que les conditions naturelles de la Réunion sont beaucoup moins favorables à la vie de l’homme qu’il ne paraît à première vue. Cette île qui, par sa position géographique, devrait être une escale sur la route des Indes se trouve en fait dehors des grandes voies maritimes, car la route de Mozambique fut toujours plus fréquentée que la route des îles. Les quelques bateaux qui empruntaient cette dernière ne s’arrêtaient d’ailleurs guère à Bourbon, lui préférant l’Île de France avec ses deux ports naturels. Car la côte de la Réunion est particulièrement inhospitalière et il n’existe aucun port (…).»29 Il territorio ruvido dell’isola si risolve in una superficie di 2512 Km² dalla singolare forma conica, assediata da tre imponenti massicci (che raggiungono i 3000 metri) e percossa da un vulcano tuttora attivo (Piton de la Fournaise). I rilievi, che dividono climaticamente l’isola da una zona a vento, più umida, da una sotto vento, più secca, rendono difficile ancora oggi la comunicazione e il commercio tra le varie regioni della Réunion. Nonostante l’esuberanza della vegetazione, la Réunion non ha mai presentato delle grosse riserve idriche, il suolo coltivabile è stato, a fatica, sottratto al mare e alle foreste (al tempo del colonialismo, le aree coltivate si presentavano come delle fasce strette che si allungano verso l’interno), per essere nuovamente inghiottito dagli uragani che di quando in quando visitano le coste30. Nel 1642 la Compagnia delle Indie francese prese formalmente possesso di Mascarin (come veniva chiamata l’isola) senza però manifestare alcuna intenzione di colonizzarla, servendo piuttosto come terra d’esilio per quanti si ribellavano ai governatori delle colonie, come accadde per alcuni dissidenti della colonia malgascia nel 1646. Recuperati i proscritti qualche tempo dopo, la Compagnia ne approfittò per ribadire il suo dominio sull’isola che, in onore del re, prese il nome 28 André Scherer, Histoire de la Réunion, Paris, P.U.F., 1965, p. 10. André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 6. 30 «Aussi l’historien est-il surpris, […] d’avoir à constater que l’île resta déserte jusqu’à 1663 et que depuis trois siècles, la population qui y vécut ne connut guère qu’une trentaine d’années de semi-prospérité, le marasme, la pauvreté étant pour elle l’habitude. », Ibid., p. 6. 29 29 Bourbon. Intanto nel 1654 un nuovo gruppo di rivoltosi fu esiliato a Bourbon insieme a sei schiavi neri, con un piccolo rifornimento di semi e qualche animale da gregge nella speranza che il piccolo esperimento avrebbe dato ragione di un futuro insediamento. Accresciuto nel 1663 di due Francesi e dodici Malgasci, tra i quali si potevano contare alcune donne, questo primo nucleo costituì la sola società civile dell’isola fino al 1666. L’iniziale disinteresse della Francia verso la giovane colonia favorì la costituzione di una società multirazziale, ove, diversamente dalle altre colonie, erano permessi i legami misti, tra Malgasci e Francesi, tra Neri ed Europei. Ricorda André Scherer: «À cette époque les habitants de Bourbon étaient d’origine fort diverse. Ils étaient Français pour la plupart (…) mais il y avait aussi des Italiens, des Suisses, (…), des Hollandais, des Indiens. (…) Quant aux femmes, elles furent, pendant les dix premières années de la colonisation, surtout d’origine indienne ou malgache. (…) Ils vivaient de cueillette, de pêche et de chasse (…).»31. Il fallimento dell’iniziativa coloniale sul Madagascar, fu all’origine dell’improvviso interesse per Bourbon da parte della Compagnia delle Indie. Scoperta una qualità locale di caffé (avendo al tempo il caffé un potere di acquisto notevole), si decise di avviare la coltura di una varietà Bourbon e della varietà arabica nel 1715. La facilità con la quale poteva essere esportato il caffé dell’isola rispetto alle lontane Antille, la notevole quantità prodotta, senza che fossero richieste cure particolari da parte della popolazione, procurò a Bourbon una relativa e quanto mai improvvisa prosperità (con la conseguente ondata di nuovi immigrati francesi con schiavi al seguito). La conquista dell’Île de France nel 1715 mutò drasticamente le sorti della Réunion. Il nuovo governatore delle Mascarene, Flacourt (rimasto in carica dal 1735 fino al 1746), forte dell’inasprirsi del conflitto con l’Inghilterra, decise, infatti, di spostare la sede amministrativa da Bourbon alla vecchia Maurice, facendo di quest’ultima la base delle operazioni militari, e lo scalo privilegiato dei commerci con le Indie, per riadattare Bourbon alla sola attività agricola. La seconda metà del XVIII secolo vide quindi un ridimensionarsi dell’importanza strategica dell’isola di Bourbon rispetto ai possedimenti antillani e alle ultime conquiste indiane. Le epidemie che nella seconda metà del secolo colpirono le piante di caffè, il diminuire della richiesta da parte del mercato (vista la facilità con la quale il prodotto poteva deteriorarsi) costrinsero la popolazione a una riconversione della produzione. I tentativi di fare delle spezie e delle essenze (soprattutto il garofano) i prodotti principe dell’isola si scontrarono, però, con i costi nettamente inferiori e la qualità superiore dei prodotti indiani. 31 «(il y avait en 1674, 58 Blancs et 70 Esclaves et en 1713, 538 Blancs et 633 Esclaves) […].», Ibid., pp. 14-15. 30 L’economia dell’isola andò, quindi, via via peggiorando, con il conseguente impoverimento di gran parte della popolazione bianca32. Di contro, la richiesta sempre maggiore di schiavi aveva mutato totalmente l’aspetto dell’isola, trasformatasi ora in una colonia a tutti gli effetti, la cui economia era basata essenzialmente sulla forza lavoro degli schiavi. Il progressivo impoverimento di Bourbon, costrinse a uno sfruttamento irrazionale della popolazione nera, che, mal nutrita e trattata disumanamente, decise, tra il 1735 e la fine del settecento, di ribellarsi al sistema schiavista. Per arrestare il fenomeno del marronnage, delle fughe degli schiavi dalle piantagioni33, l’amministrazione coloniale non vide altra soluzione che l’attuazione rigorosa del Code Noir34 e la costituzione di un corpo di una polizia etnica. L’acuirsi delle ostilità con la monarchia inglese tra il 1742 e il 176335, il potere crescente della Compagnia delle Indie, arricchitasi con le speculazioni perpetrate ai danni dei coloni di Bourbon36, convinsero la corona francese a destituire la Compagnia dal governo delle Mascarene, per divenire unica amministratrice dell’isola, che, tuttavia, non riuscì ad avvantaggiarsi del cambio di regime a causa dell’improvviso scoppio della guerra contro l’Inghilterra. Solo la notizia dello scoppio della Rivoluzione in Francia, nel 1790, sembrò offrire alla popolazione l’occasione di poter mettere fine alle speculazioni economiche della Compagnia delle Indie e dei nuovi messi del re. A differenza dell’Île de France, dove il movimento rivoluzionario era partito dall’esterno e aveva coinvolto le classi meno abbienti, la rivoluzione di Bourbon coinvolse solo le classi più elevate, quei magistrati dell’isola che intuirono la possibilità di acquisire maggiore autonomia dal potere 32 «La seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe furent marquées à Bourbon, malgré la relative prospérité de l’île à cette époque, par l’appauvrissement progressif d’une partie croissante de la population blanche. Il y avait toujours eu des habitants pauvres […] la Coutume […] qui partageait les héritages entre tous les enfants, amena à une miniaturisation des concessions existantes […]. De telles lanières de terre étaient proprement inexploitables d’autant plus que l’esprit individualiste du Créole empêchait tout groupement des propriétés en vue d’exploitation.», André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., pp. 37 - 38. 33 «Les marrons, ces esclaves en fuite qui ont refusé le système servile en se réfugiant dans les montagnes de l’île dès le début de la colonisation, représentent encore un mystère pour les chercheurs de la Réunion. », Sudel Fuma, L’esclavage et le marronnage à la Réunion, «Peuples & Sociologie» (1 décembre 2002). 34 Con l’avallo giuridico del sistema schiavista fu necessario mettere a punto un codice che definisse oneri e doveri delle parti (padrone schiavo). Se inizialmente il codice aveva come scopo quello di limitare gli abusi dei padroni sui loro schiavi, si trasformò, successivamente, in un sistema per giustificare e regolamentare la tratta agli occhi della Chiesa e dei filosofi. Il “Codice Nero” consta di due versioni: la prima redatta dal ministro Colbert e promulgata da Luigi XVI nel 1685, la seconda emanata da Luigi XV nel 1725. 35 «Le duel franco-anglais au XVIII siècle comporte cinq phases bien distinctes: 1) Guerre de la Succession d’Autriche (1740 - 1748); 2) Guerre de Sept ans (1756 – 1763); 3) Guerre de l’Indépendance américaine (1778 – 1783); 4) Guerres de la Révolution (1793 – 1802); 5) Guerres de l’Empire (1803 – 1815).», Auguste Toussaint, Histoire de l’Océan Indien, op. cit., p. 159. 36 « […] la Compagnie avait le monopole de l’introduction des marchandises à Bourbon et elle revendait aux habitants des produits manufacturés, souvent défectueux, avec le bénéfice de 100% pour les articles d’Europe et de 50% pour ceux provenant de l’Inde. Exploités par la Compagnie, les habitants étaient dans l’incapacité de lui rembourser les sommes qu’elle leur avait initialement prêtées. Cet entendement devait par la suite devenir chronique. », André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., pp. 16 – 17. 31 centrale attraverso la gestione di Assemblee popolari che sostituivano le communes37 organizzate precedentemente dai governatori del re. Tra i principali decreti della nuova costituzione rivoluzionaria, l’abolizione della schiavitù produsse la netta opposizione dei coloni. Favorevoli piuttosto a modificare parte del Code Noir38, gli abitanti di Bourbon ingaggiarono una vera e propria protesta contro la Francia: tra il 1798 e il 1802 Bourbon, ora Réunion, chiuse i suoi porti agli ambasciatori francesi, decisa ad avviarsi verso la secessione. Nel 1803, alla decisione del governo napoleonico di mantenere in vigore il regime schiavista, la rivolta reunionese si chiuse senza contestazioni e senza morti, decretando la fine del solo breve periodo rivoluzionario della storia dell’isola, e il definitivo assoggettamento politico, economico e culturale alla Francia. Tra il 1803 e il 1807, Bourbon fu teatro di una serie di catastrofi naturali che compromisero la capacità produttiva dell’isola. Appena tornata alla Francia, Bourbon fu occupata nel 1810 dagli inglesi nel corso della guerra “degli Imperi” (durante il governo inglese si registrò la sola rivolta degli schiavi che abbia mai avuto luogo a Bourbon nel 1811). Restaurata la monarchia borbonica, la Réunion fu restituita alla Francia. La perdita di Santo Domingo nel 1804, indusse il governo francese a impiegare il suolo reunionese per la produzione di zucchero al fine di compensare la flessione dell’esportazione antillana. La trasformazione dell’economia, produsse un’alterazione dello stesso assetto sociale. Per via dell’ingente richiesta di manodopera, la condizione degli schiavi andò esasperandosi (si preferiva reclutare i nuovi arrivati, il cui costo di mantenimento si presentava inferiore a quello degli schiavi da tempo presenti sull’isola); cominciò, inoltre, la lenta e costante immigrazione di salariati indiani, la distribuzione delle terre cambiò, favorendo la nascita dei grandi proprietari terrieri (la difficoltà nei collegamenti costringeva ciascun coltivatore di canna a impiantare sulla sua proprietà anche un mulino per la trasformazione della stessa in zucchero). Nonostante anche nell’inglese Maurice la coltivazione della canna da zucchero avesse ritardato l’emancipazione degli schiavi, nel 1848, il governo della Seconda Repubblica ritenne ormai maturi i 37 «Au Port-Louis, le mouvement révolutionnaire prend un caractère populaire qui menace un moment de déborder ses premiers instigateurs (venus de l’extérieur), les notables, tout autant que les administrateurs. […] À Bourbon, la situation est très différente comme le souligne bien Cossigny: ce ne sont pas des étrangers à la colonie qui prônent l’insurrection, “c’est au contraire toute la magistrature qui s’est mise à sa tête”.», Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, Thèse, Université de Provence, 1978, Marseille, Lafitte, 1980, pp. 275 – 276. 38 La formulazione di un Codice Reunionese più rispettoso della dignità di essere umano degli schiavi avrebbe dovuto mitigare le posizioni dei riformisti e di molti intellettuali del luogo (Parny e il francese Bernardin de Saint-Pierre) forti oppositori del regime schiavista: «On peut même dire que, conformément à l’esprit des premières instructions de Poivre, les administrateurs encouragent à «dédommager» les esclaves de la perte de leur liberté. Il y a en particulier une sorte de paternalisme officiel qui se manifeste par la distributions de distinctions et de gratifications aux esclaves méritants. Mais c’est surtout par le biais militaire qu s’effectue une espèce d’intégration […] des esclaves au monde de leurs maîtres. », Ibid., p. 206. 32 tempi per la definitiva abolizione della schiavitù. Nell’ottobre dello stesso anno fu inviato alla Réunion il governatore Sarda Garriga perché attuasse la transizione dal regime schiavista al sistema di ingaggio salariato. Il 20 dicembre del 1848 la Réunion equiparò lo status degli uomini di colore allo stato civile della popolazione bianca. Abolita la schiavitù, i vantaggi economici offerti dall’ingaggio della mano d’opera indiana rispetto a quella dei liberi del luogo (bianchi e neri) acuirono il fenomeno di impoverimento dei due terzi della popolazione, capace a stento di sopravvivere dei frutti della terra degli altipiani (creando tra l’altro quella divisione sociale ancora presente sull’isola tra latifondisti e proletariato39). Degli anni di prosperità (dal 1850 al 1860) godettero, in realtà, solo pochi individui. Nonostante il potenziamento delle infrastrutture, con la ristrutturazione del porto di Saint-Pierre, la realizzazione di nuove strade (a sud, venne perforata la montagna di Saint-Denis), e delle istituzioni locali (nel 1856 la Réunion fu premiata a Parigi come migliore colonia dell’anno), la forte concorrenza delle Antille, il decrescere della produzione reunionese, l’apertura del canale di Suez, il mutato interesse della Metropoli, ora impegnata nella conquista del Madagascar, trascinarono nel 1870 l’isola verso un nuova crisi economica. Della lottizzazione delle grosse proprietà terriere si avvantaggiarono soprattutto gli Indiani che, da tempo sull’isola, erano riusciti ad acquistare gli appezzamenti a poco prezzo (nacque, così, una nuova classe di ricchi). Il prolungarsi della situazione di indigenza per la maggioranza della popolazione, il disinteresse della “madrepatria francese” riguardo la crisi economica della colonia, portarono l’isola al caos completo, ma soprattutto iniziarono la cittadinanza a quella diffidenza verso le istituzioni, a quella pratica della corruzione politica, che alla Réunion sembra endemica40. Il forte sentimento di appartenenza alla patria francese spinse molti abitanti a partecipare al primo conflitto mondiale. Questo spirito patriottico dovette commuovere la Francia che rispose al gesto con una serie di misure a beneficio della produzione reunionese rispetto a quella delle altre colonie francesi. Il relativo benessere, che ne seguì, fu alla base di un nuovo movimento popolare costituitosi verso la metà degli anni trenta. Nel 1936, Léon de Lepervanche e Raymond Vergès41 39 «Surtout cette prospérité de la Réunion n’était celle que de quelques gros propriétaires. Les 121 sucreries avec leurs 25000 travailleurs possédaient la moitié des ressources de l’île. La nécessité de la grande propriété faisait la misère d’une foule de petits producteurs. L’économie de l’île, de type capitaliste, style Second Empire, engendrait le paupérisme: tout un prolétariat urbain et rural, les Petits Blancs et les nouveaux Affranchis, végétait à l’ombre des cheminées d’usine.», André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 77. 40 «Le Créole adore la France, mais déteste la métropole. […] À leur sens, l’État doit tout organiser: éducation professionnelle, pêche, pots […], chemin de fer, électricité. […] Une telle mentalité de mendicité générale remplace celle de l’effort général. L’Etat doit tout, il ne fait rien, et le Réunionnais est une victime. », Jean Defos Du Rau, L’île de la Réunion, Étude de géographie humaine, Bordeaux, Institut de Géographie, 1960. p. 513. 41 L’attività politica di Léon de Lépervanche e di Raymond Vergès si intensificò durante gli anni della dittatura di Vichy. L’amministrazione reunionese, connivente con il regime francese, si adoperò perché fossero attuate una serie di riforme restrittive, come la cesura o la persecuzione di minoranze etniche. Si fece in modo di fiaccare l’attività di tutte 33 presero spunto dagli scontenti e dall’arretratezza delle istituzioni del luogo per dare vita al partito comunista reunionese. Prima della guerra i due politici, alla testa di uno sciopero generale, ottennero il riconoscimento di alcuni dei fondamentali diritti del lavoro, al tempo ancora ignorati alla Réunion. Lo scoppio della seconda guerra mondiale, gli anni della dittatura di Vichy, l’isolamento che seguì al blocco anglo-americano portarono l’isola al collasso. Terminata la guerra, i nuovi equilibri internazionali, le nuove politiche, il mutare delle richieste del mercato obbligarono la Metropoli francese, come anche l’impero britannico a riconsiderare i possedimenti coloniali. Nel 1946, la Réunion, la Martinica e la Guadalupa presentarono, tramite ambasciatori quali Aimé Césaire, Léon de Lepervanche, Raymond Vergès, la richiesta di Départementalisation. I primi effetti della departimentalizzazione furono la nascita di una nuova classe sociale, gli “z’oreilles”, ovvero i colletti bianchi, quella classe dirigente francese, ben pagata, non direttamente coinvolta nei problemi socio-economici della Réunion. Il ritardo con il quale furono portate a compimento le riforme istituzionali (equiparazione dei salari locali con quelli della Metropoli, miglioramento della sanità locale e della scolarizzazione) risvegliò quei sentimenti indipendentisti sopiti dal lontano 1798. Nel 1959 Il partito comunista, e in modo particolare Paul Vergès che ne era il coordinatore, si fece portavoce della rivendicazione di autonomia dell’isola dalla Metropoli (è da ricordare che in quegli stessi anni il Madagascar era diventato stato sovrano e Maurice si avviava verso l’indipendenza, la Réunion sembrava ancora una volta relegata a ruoli secondari rispetto alle isole sorelle42). Dal 1960 al 1976 furono avviate una serie di opere di ammodernamento delle infrastrutture: apertura della litoranea Saint-Denis, La Possession, installazione di una fabbrica per l’energia idroelettrica a Takamaka, intensificazione dei collegamenti aerei con la Francia. Allo stesso tempo, si intensificano le rimostranze popolari e dei partiti di sinistra e dei movimenti cattolici verso alcuni problemi del paese, come la smilitarizzazione dell’isola e il diritto all’autodeterminazione. Nel 1973 la ripresa degli scioperi nel quartiere Chaudron fu motivo di disordini, incendi, attentati alla chiesa di Tan-Rouge e della Saline. quelle cellule difficili da controllare, come ad esempio quella delle società segrete (la SFIO, cellula del porto di cui Lépervanche era a capo). 42 «Du pessimisme de la Démocratie à l’enthousiasme de Témoignages, l’affectivité annihile bien des capacités d’analyse et laisse apparaître le plus grand personnage de l’histoire réunionnaise: la peur. Une peur qui procède d’un profond sentiment de dépendance, obligeant le Réunionnais, à droite comme à gauche, à se situer par rapport aux autres […]. Départementalisation et indépendance ne sont plus […] que les manifestations politiques, au niveau du statut, de cette grande peur.», Hubert Gerbeau et Edmond Maestri, Colonie décolonisée et «colonie colonisatrice»: Les échos de l’indépendance de Madagascar à la Réunion, in L’Afrique noire française: l’heure des indépendances, sotto la direzione di Charles-Robert Ageron e Marc Michel, Paris, CNR, 1992, p. 617. 34 Nel 1978 su proposta della Francia, la Réunion entrò a far parte della comunità economica ZEE (Zone Economique Exclusive) e nel 1980 nel SADC, la Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe, con Maurice e le Seychelles. La fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta furono segnati dall’incertezza politica. La paura del largage ovvero del crollo dell’interesse da parte delle istituzioni, piegò l’elettorato di sinistra pur di non cedere alle lusinghe di una destra e di un centro più solidi: «L’élection présidentielle de mai 1974 rend manifeste une seconde transformation du paysage politique. Elle marque la manifestation du centrisme politique. (…) Le 10 mai 1981, (…) le candidat de la gauche réalise un mauvais score avec 36, 8%. A l’évidence, la peur du «largage» a joué. Cette alternance politique nationale ouvre une nouvelle période de l’histoire réunionnaise.»43. Nel 1981, il governo di Pierre Mauroy avviò l’isola alla decentralizzazione e alla regionalizzazione. Tacciata di incostituzionalità, la legge fu osteggiata da numerosi membri del governo, che intrapresero, senza fortuna, una campagna denominata “île morte”: nel 1983, con un primo scrutinio, la Réunion venne proclamata regione. Nonostante, nuovi aiuti fossero venuti dalla legge Pons del 1986 sulla defiscalizzazione, totale o parziale, degli investimenti effettuati nei DOM, nonostante l’aumento della produzione avesse avviato l’isola verso un nuovo progresso economico, la Réunion permaneva, come al tempo della Compagnia delle Indie, in un regime di completa sudditanza al potere centrale (alla Francia era ed è demandata la risoluzione dei gravi problemi sociali dell’isola, come la crescita dei settori in sciopero). Se gli scontenti popolari nel 1994 hanno favorito nuovamente l’insediamento della sinistra al governo dell’isola, la proposta di votazione della legge di bidepartimentalizzazione, tra il 2000 e il 2001, ha, invece, portato al crollo della coalizione di sinistra, socialista e comunista, in tutti i dipartimenti dell’isola, tanto che alle elezioni del 2001, solo un seggio è stato riservato alla lista PCR – PS di Paul Vergès. 43 Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, Paris, Nathan, 2002, p. 144. 35 Il paradosso mauriziano Per comprendere l’evoluzione della storia mauriziana è necessario ricordare che l’isola comprende tre possedimenti distaccati, le Chagos, le Cargados Carajos e Agaléga44, negli anni più recenti al centro di eventi storici importanti. Quando nel 1710 gli Olandesi abbandonarono Maurice, la popolazione nera, i meticci e i ribelli, rimasti sull’isola, decisero di dare vita a una piccola comunità alle porte della foresta, punto di riferimento, negli anni a seguire, per tutti gli schiavi ribelli che, deportati a Maurice o nelle isole vicine, si opponevano allo sfruttamento schiavista. Conquistata nel 1722 dalla Compagnia delle Indie, l’isola Maurice, che sotto i Francesi prese il nome di Île de France, divenne uno dei maggiori nodi militari ed economici dell’Oceano Indiano grazie all’abilità e all’intraprendenza del governatore Mahé de Labourdonnais (1735 – 1746). Labourdonnais promosse l’Île de France a centro strategico dell’Oceano Indiano completando il trasferimento dell’amministrazione della Compagnia delle Indie da Bourbon. L’isola divenne base logistica delle operazioni militari nell’Oceano tanto da disporre di un esercito e di una “marina navale delle isole”, mentre Bourbon fu relegata a ruolo di granaio dell’Arcipelago; fu potenziata la vocazione mercantile dell’isola e rispetto alla produzione agricola (da qui, la nascita di una borghesia legata al commercio). Già prima di Labourdonnais, i tentativi messi in atto per coltivare un qualsiasi prodotto esportabile, dal caffè alle spezie, si erano rivelati un fallimento. La posizione e l’organizzazione dell’Île de France, Stella Clavisque Maris Indici, si rivelarono fondamentali a Labourdonnais durante la guerra d’Austria allorché il comandante mosse, proprio, dall’isola per vincere gli Inglesi a Madras (nel 1746). Il rifiuto di distruggere l’ex possedimento inglese, rese ostile la figura di Labourdonnais alla Compagnia delle Indie che decise di destituirlo dal suo incarico nelle Mascarene. 44 «The Chagos archipelago is 1900 km to the north-east of Mauritius […]. A Mauritian-Seychellois copra company exploited the Chagos islands under a system that had hardly changed since the days of slavery. Displaced from the sugar plantations in Mauritius by the arrival of the Indians, some ex-slaves were taken to the smaller island dependencies to work on coconut plantations. Some of these workers stayed on the island and in time formed the permanent population of the Chagos. », Jean Houbert, Creolisation and Decolonisation in the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shihan de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), Asmara, Africa World Press, 2003, p. 156. «Cargados Carajos […] n’est qu’une corruption de Coroa dos Garajaos, ou «banc des garajaos» […] une variété d’oiseaux de mer. Les Cargados comprennent un groupe de 20 îlots situés à environ 250 milles au nord-est de Maurice […] connu sous le nom d’îles Saint Brandon. […] exclusivement station de pêche et centre de ramassage de guano. […] Il en est autrement à Agalega […] qui comprend, en réalité, deux îles reliées par un haut-fond […]. C’est aujourd’hui un établissement florissant comptant environ 300 habitants, que Dussercle appelle «la perle des îles à huile», l’huile en question étant l’huile de coco. », Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, Paris, P.U.F., 1971, p. 13. 36 I governatori che succedettero al Bretone, continuarono l’opera di sviluppo intrapresa dal loro predecessore: fu sperimentata la coltivazione della canna da zucchero e fu avviata la creazione di uno stabilimento metallurgico. Queste opere di miglioria, aumentarono la richiesta di mano d’opera, intensificando il commercio degli schiavi, del resto già precedentemente appoggiato e regolamentato da Labourdonnais. Rimossa, nel 1767, la Compagnia delle Indie dal suo incarico, successero al comando dell’isola i delegati del re Desroches e l’intendente Poivre. Se la liberalizzazione del commercio (erano stati aboliti i privilegi della Compagnia delle Indie) aveva avviato alla supremazia economica dell’isola sulle altre colonie francesi dell’Oceano Indiano, le campagne militari di Suffren, la dichiarata connivenza del governo francese con i pirati del luogo (con i corsari poi) a danno dell’impero inglese, aumentarono il prestigio anche militare dell’Île de France. Come alla Réunion, così gli abitanti dell’Île de France vennero a conoscenza della rivoluzione solo nel 1790. Come a Bourbon, l’oligarchia del luogo pianificò una dura opposizione alle pretese riformiste del nuovo governo repubblicano45. Due avversi schieramenti divisero l’isola, una fazione reazionaria, rappresentata dai grandi proprietari terrieri, e un gruppo rivoluzionario, la Société de la Chaumière, di aspirazioni giacobine (gli appartenenti erano additati come sans-culottes) che invece difendevano le idee rivoluzionarie, ma soprattutto sostenevano la necessità dell’abolizione della schiavitù. Tra il 1794 e il 1803, forte dell’esempio reunionese, anche l’Île de France decise di sottrarsi al giogo francese (sperando con ciò di mettere fine ai soprusi perpetrati dai rappresentanti della corona). Salito al trono Bonaparte, fu infine ristabilito, ma soprattutto ripristinata la legalità dell’ordine colonialista sull’isola. Colonia tra le più ricche dell’Oceano Indiano, a capo di una potente flotta mercantile (la borghesia dell’isola gestiva i traffici delle guerre corsare che infestavano l’area dell’Oceano Indiano), l’Île de France passava definitivamente sotto il controllo della colonia inglese nel 1815 con il trattato di Parigi. Il passaggio dall’amministrazione francese al governo inglese non fu accolto dalla popolazione, senza proteste. Soprattutto la classe della borghesia mercantile venne completamente a scomparire sotto gli Inglesi. Sulla base della necessità di limitare i legami tra l’isola e le altre colonie francesi, tra Maurice e la vecchia madre Francia, si vide indispensabile trasformare l’economia dell’isola da commerciale ad agricola. La riconversione di Maurice in colonia agricola portò a una radicale trasformazione del territorio, ferito dai disboscamenti, che dovevano favorire la coltivazione intensa 45 L’episodio certamente più cruento fu l’uccisione del comandante delle truppe francesi Macnamara che, ostile alle idee rivoluzionarie, aveva tentato di ostacolare la diffusione dei principi riformisti. 37 della canna da zucchero (causa plausibile della diffusione della malaria46), a un’esasperazione del fenomeno della schiavitù, laddove il sistema di sfruttamento venne allargato anche alle fasce dei salariati indiani47. Di fronte alle difficoltà che poneva una tale trasformazione, Farquhar, primo governatore inglese dell’isola, decise di mantenere inalterati gli equilibri precedenti alla colonizzazione, conservando l’organizzazione schiavista (contrastata dall’Inghilterra già agli inizi del secolo), adoperandosi perché la lingua e i privilegi della popolazione francese del luogo non fossero aboliti48. A dispetto della disponibilità inglese, la popolazione francese dell’isola, senza distinzione di classe e razza, ingaggiò contro il governo britannico una lunga battaglia politica e culturale che sarebbe terminata solo nel 1968 all’indomani della dichiarazione di indipendenza. Rimangono a testimonianza dell’opposizione Franco-creola le due riviste fondate nel 1832 e nel 1843, Le Cernéen di Adrien d’Epinay, difensore dei diritti dell’oligarchia francese, La Sentinelle, di Rémy Ollier, pubblicista di colore, voce dei Creoli mauriziani liberi, che si adoperò perché la schiavitù fosse finalmente abolita e i diritti dei lavoratori riconosciuti. L’abolizione della schiavitù nel 1835 avviò l’isola a un netto cambiamento della popolazione. Preferendo la mano d’opera indiana, sottopagata, agli schiavi neri liberati, i proprietari terrieri favorirono l’ingresso di un numero vieppiù crescente di manodopera che, di anno in anno, subentrava, prima agli schiavi, poi agli engagés non più produttivi. Obbligati a rimanere a servizio per cinque anni, i salariati indiani venivano, successivamente, rimpiazzati da nuova mano d’opera. Maurice divenne per i 2/3 indiana, relegando l’originario nucleo francese e creolo alla minoranza. Si venne così a creare quel paradosso di cui l’isola vive ancora oggi: colonia inglese, soggetta all’oligarchia francese49 la popolazione dell’isola è per la maggior parte indiana. All’improvvisa prosperità economica, di benessere generale dell’isola nella seconda metà dell’Ottocento, seguirono anni in cui si alternarono catastrofi naturali a violente epidemie di 46 «L’irruption de la malaria dans la vie sociale mauricienne a coïncidé, tout le porte à croire, avec la rupture d’un équilibre écologique qui avait régné jusque-là. Le déboisement intensif entrepris depuis le début du coolie trade pour reconvertir les arpents forestiers en culture de la canne à sucre […] “Le développement des fièvres a été favorisé par le déboisement inconsidéré des forêts qui renfermaient beaucoup d’arbres dont l’écorce possédait des propriétés fébrifuges”.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 67. 47 «Le développement de l’industrie sucrière, sous l’administration britannique, a retardé d’un quart de siècle l’abolition de l’esclavage dans cette colonie et a nécessité des apports massifs des travailleurs recrutés en Inde.», Ibid., p. 57. 48 «Le Colonial Office, lui-même, ne semble pas avoir été partisan convaincu de l’anglicisation. Il se contenta d’imposer, en 1845, l’usage exclusif de l’anglais dans les cours supérieurs, ce qui n’alla pas, d’ailleurs, sans soulever de vives protestations, mais le français demeura quand même la langue principale de l’île.», Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p. 88. 49 «L’importance de la ligne régulière des Messageries dans l’histoire de Maurice est capitale. “Rien ne peut suppléer l’influence d’une ligne régulière de navigation, pas même la domination politique.” […] C’est incontestablement dans le fait que les communications avec l’ancienne métropole ont été assurées depuis 1864 par une ligne française qu’il faut chercher le facteur principal du maintien de la présence française sur l’île.», Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p. 96. 38 malaria50, che, dopo il 1866, e il 1868, costrinsero i proprietari terrieri ad abbandonare le coste per l’entroterra collinare più salubre. La certezza che il focolaio delle infezioni (non ultimo il colera) avesse origine dagli immigrati indiani, reclutati e trasportati come animali senza che fosse su di essi eseguito nessun controllo medico, indusse il governo locale a pensare nuove e più severe misure di polizia: potevano lavorare solo coloro che erano provvisti di un documento di lavoro, mentre coloro che ne fossero stati sprovvisti, sarebbero stati immediatamente rimpatriati (in questi anni si manifestarono i primi sentimenti razziali nei confronti della comunità indiana). La legge causò non pochi disordini tra il 1870 e il 1871 tra i lavoratori indiani, le cui rivendicazioni erano appoggiate dal proprietario terriero Von Plevitz. Organizzata una commissione d’inchiesta, furono fissate le basi per una futura riforma della Costituzione. Per fare fronte al malcontento generale, nonché alla richiesta di una democratizzazione del sistema politico locale, nel 1885 vennero indette le prime elezioni. Nonostante il tentativo di apertura mostrato dal governo inglese, le votazioni, basate sul censo, favorirono il rafforzamento del potere dell’oligarchia francese dell’isola. L’introduzione del sistema di mezzadria ridistribuì il benessere sull’isola, permettendo ai salariati, soprattutto indiani, di avvalersi di un contratto che li proteggeva da qualsiasi sopruso, offrendo loro l’opportunità di acquistare, in seguito, il terreno o parte del terreno, di diventare, quindi, a loro volta dei piccoli proprietari terrieri. Rispetto alla popolazione creola e meticcia, l’etnia indiana, forse per i lunghi anni che la legavano al regime inglese, forse grazie a personalità influenti come Gandhi che visitarono l’isola, fu in grado di lottare per la propria comunità. Nel 1936, proprio su iniziativa della comunità induista, venne fondato il Labour Party. Il boom economico che accompagnò gli anni della prima guerra mondiale (1914 - 1930) riaccese le aspirazioni separatiste della popolazione francese. Prendendo spunto dal Trattato di Versailles (1918), l’oligarchia e la comunità creola rivendicarono il loro diritto all’autodeterminazione, si batterono perché Maurice tornasse alla Francia. A seguito dei dissensi politici, delle divisioni sociali tra proprietari francesi e maggioranza indù, nel 1937 gli Indiani decisero di promuovere una serie di scioperi generali in difesa dei diritti dei lavoratori. 50 «De toutes les situations difficiles, ils sortaient vainqueurs. Leur outrecuidance était leur légitimité, leur légitimité, la loi. Jusqu’à l’aube du vingtième siècle, les barons ont gardé la maîtrise du flux d’immigrants comme ils avaient eu barre sur la flotte négrière. Le volume de la population indo-mauricienne n’évoluera guère de 1881 à 1944. […] L’accroissement naturel resta faible dans cette période pour les raisons suivantes: forte mortalité, faible natalité. […]. Rien de sérieux ne fut entrepris tant que le pouvoir politique et sanitaire resta entre les mains des Oligarques. N’étaitelle (la malaria) pas, cette fièvre mortelle […] un facteur naturel de limitation de la population? », Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., pp. 57 - 69. 39 Abolito il diritto di censo, alle nuove elezioni del 1947 il Labour Party ottenne la maggioranza dei seggi. L’oligarchia fece in modo di arginare il fenomeno, sgomenta di fronte al pericolo che avrebbe significato una possibile futura indipendenza51. Come era accaduto per la Francia, anche l’Inghilterra si vide costretta a riorganizzare il suo impero, ridimensionando i suoi possedimenti d’oltremare. Vista la maturità politica di cui aveva dato prova la società mauriziana, il governo decise di avviare l’isola verso l’indipendenza. I proprietari terrieri che fino ad allora avevano governato l’isola, nonostante rappresentassero l’interesse di pochi, avvertirono la minaccia di una prossima estromissione dagli affari politici ed economici di Maurice. Rivendicando il diritto di proprietà su un’isola che era stata barbaramente sottratta alla Francia dagli Inglesi, l’oligarchia francese decise di organizzarsi politicamente per fronteggiare l’avanzata del Labour Party, e quindi della comunità indiana. Alla fine degli anni 50 nascevano il P.M.S.D. (che riuniva oltre ai dirigenti francesi, i Creoli, i Franco-Mauriziani, i mussulmani, i Cinesi e gli Indiani tamoul), e il C.A.M. (Comunità di Azione Mussulmana). Preferendo appoggiare le manifestazioni etniche piuttosto che cercare di livellare le differenze culturali, la politica inglese aveva in realtà frenato l’insorgere di qualsiasi spirito comunitario. La politica dell’isola sarebbe stata pertanto destinata alla celebrazione delle differenze, al riconoscimento della separazione: al corporativismo etnico del Communalism impedendo la nascita di uno stato mauriziano unito nella multirazzialità. Il 12 marzo del 1968 Maurice, con presidente Seewosagur Ramgoolam, fu dichiarata indipendente, a eccezione delle Chagos che, precedentemente possedimento mauriziano, rimasero sotto la tutela inglese. I nuovi equilibri politici prevedevano la possibilità di usare alcune zone strategiche a scopo militare. Le Chagos, fino ad allora abitate da un gruppo di ex-Mauriziani, dichiarate invece disabitate, furono evacuate. La popolazione, senza casa, senza patria, si ritrovò a Maurice senza che mai il risarcimento promesso dal governo inglese le fosse rimesso52. I tafferugli causati dalla costituzione di un governo per la maggioranza indiana di confessione hindou, richiesero ancora una volta l’intervento inglese, che sciolto il governo diede i poteri al P.M.S.D. 51 «L’instauration du suffrage universel était […] une calamité. L’oligarchie sucrière brandissait dans toutes les couches de la population catholique le spectre de l’ “hégémonie hindoue”. », Ibid., p. 74. 52 «The Chagos and the other smaller dependencies (Agalega, Saint Brandon) were marginal in the sugar economy of Mauritius. Altogether these dependencies had less than 2000 inhabitants. The style of life of these islands had more in common with Seychelles – were coconut plantations were the mainstay of the economy […]. The Indian politicians considered that the excision of some poor, illiterate, black Creoles a small price to pay for state power in decolonisation with British support. […] The 1500 Zilois of the Chagos were deported to Mauritius without their consent […]. Diego belongs to Mauritius; there is no disagreement about that… L’île est à l’île Maurice; l’usufruct est à la Grand Bretagne.», Jean Houbert, Creolisation and Decolonisation in the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shihan de S. Jayasuriya & Richard Pankurst (a cura di), op.cit., p. 157. 40 Il ristagno dell’economia e la stasi delle riforme politiche convinsero parte degli studenti a dare vita a un movimento politico socialista specificatamente mauriziano, M.M.M. (Movimento Militante Mauriziano). I larghi consensi riscossi da parte della popolazione, la capacità organizzativa di cui diede prova con l’istituzione del GWF (General Work Federation) convinsero il Labour Party e il P.M.S.D. ad allearsi. La serie di scioperi che seguirono provocarono una dura reazione da parte del governo che rispose alla protesta con la restaurazione della censura, e la persecuzione degli esponenti del M.M.M.. Nonostante la pressione a cui fu sottomesso, il partito studentesco diede prova, negli anni seguenti, di sapersi riorganizzare vincendo le elezioni del 1976 con un programma certamente audace, una politica terzomondista capace però di conciliare il pubblico con il potere, per un’isola retta nei secoli da un sistema colonialista. Le elezioni del 1982 portarono al governo la coalizione multipartitica di sinistra (R.P.L., Ressemblement pour le Progrès de la Liberté, O.R.P., Organisation du Peuple Rodriguais, M.M.M. e il P.S.M.) con il 63,7% dei voti, e 62 seggi. Ad avere ragione su un’alleanza così eterogenea fu ancora una volta la destra subentrata, nel 1983, alla caduta del governo, per terminare il suo mandato nel 1986. Pur rimanendo nel Commonwealth, nel 1992, l’isola fu proclamata ufficialmente una Repubblica e Cassam Uteem eletto presidente. Nel 1995 le nuove elezioni portano al potere l’erede spirituale della patria mauriziana, Navim Ramgoolam, eletto Primo ministro per la coalizione del Partito dei Lavoratori e del Movimento Militante Mauriziano. Nonostante il boom economico degli anni Novanta, Maurice è ancora contrassegnata da forti squilibri politici. Nel 1999, la morte del cantante creolo Kaya divenne l’occasione di rimostranze creole contro una politica dominata dalla supremazia indiana. Le rivolte di Port-Louis misero a nudo il risentimento della minoranza Creola estromessa, ancora alla fine del XX secolo, dal potere politico ed economico del paese. La resistenza del presidente e del primo ministro in carica, Amerood Jugnauth, alla ratifica di nuove leggi contro il terrorismo portò alla caduta del governo con la nomina nel 2002 del nuovo presidente Karl Offman e vicepresidente Raouf Bundhun alla guida della Repubblica mauriziana. 41 Schiavitù, marronnage, dall’istituzione all’abolizione della tratta schiavista. Mais sur cet affligeant tableau / Qu’à regret ma main continue, Ami, n’arrêtons point la vue, Et tirons un épais rideau. Laissons le nègre malheureux / Crier sous la verge docile, Et son maître plus ennuyeux / Compter les coups d’un air tranquille: C’est trop longtemps m’occuper d’eux.53 Come altre realtà coloniali, così la storia delle isole dell’Oceano Indiano è stata profondamente segnata dalla tratta schiavista, dal commercio costante, e dalla successiva dissoluzione, di intere comunità africane e asiatiche. A differenza delle Antille, dove la presa di coscienza e la denuncia dell’alienazione dal territorio e dalla cultura africana d’origine è stata oggetto di commenti e rappresentazioni già dalla prima metà del Novecento, nell’area indiana, gli studiosi si sono interrogati solo recentemente sul fenomeno della diaspora del popolo nero, tentando di definire l’impatto emotivo di un simile evento sulla popolazione, nonché la dimensione socio-culturale che, in passato, tale fenomeno aveva assunto nell’area. Se la multirazzialità delle Masacarene è la traccia evidente della deportazione consumatasi fino al secolo scorso, ugualmente, il tempo sembra aver lavorato perché il ricordo e le rovine della schiavitù fossero rimossi dalla memoria collettiva54. Non solo una documentazione povera e lacunosa ha sinora costretto gli storici a ridimensionare il fenomeno della diaspora africana relegandolo al margine delle altre complesse vicende dell’Oceano Indiano, ma pure la discordanza delle fonti a disposizione ha acuito quel sentimento di disagio di fronte a un evento storico finora trascurato. Persino sulle fasi dello sviluppo del fenomeno della schiavitù nelle Mascarene, gli studiosi sono costretti a dichiarare il loro scetticismo, vista la nebulosità dei dati a disposizione (1674 0 1690 per l’inizio, 1848 per la fine?). 53 Évariste Parny, lettre à Bertin in Barquissau, janvier 1775, tratta da Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 208. 54 «Autant il est aisé pour l’historien d’aborder l’histoire politique de la Réunion au XVIIIème et XIXème siècles, autant il est difficile de manipuler les sources d’archives quand on veut étudier la question de l’esclavage et notamment du marronnage. La première difficulté réside dans l’insuffisance de sources documentaires concernant la question de l’esclavage. En effet, l’administration coloniale s’est soit désintéressée de l’existence des esclaves, soit n’a pas voulu laisser des traces pour ne pas être jugée par l’Histoire.», Sudel Fuma, L’esclavage et le marronnage à la Réunion, op. cit. 42 A spiegare simile debolezza di testimonianze è il modo in cui si è sviluppato ed è emerso il fenomeno della deportazione nell’area dell’Oceano Indiano, in particolar modo: la dimensione storica quindi culturale che siffatto evento aveva assunto nell’area già in tempi remoti (tra gli Egizi, come è noto, era in uso la pratica della schiavitù), infine, l’estraneità iniziale delle colonie dell’Arcipelago agli episodi della tratta dei Neri. Nell’Oceano Indiano, infatti, il commercio degli schiavi, avviato dagli Europei, si installava all’interno di un redditizio traffico di uomini amministrato precedentemente dagli Arabi e dai Malgasci: «À partir du VIIIe siècle, les Arabes y [sur la côte africaine] avaient fondé des comptoirs [d’esclaves]. Au XIVe et au XVe siècles, aux dires de Ibn Battouta et des voyageurs chinois, ces villes arabes avaient été prospères. Au XVIe siècle les Portugais désorganisèrent ce commerce (…). Les comptoirs de Mozambique et de Sofala étaient les points principaux de cette “Contra Costa” portugaise. (…) Les premiers contact des Français auprès des comptoir arabes paraissent dater de la décennie 1750. En fait, le trafic systématique commença après la fin du monopole de la Compagnie des Indes: les négociants des Mascareignes se rendaient alors indifféremment chez les Portugais et chez les Arabes.»55. A differenza delle Antille, estranee al fenomeno della tratta prima dell’avvento degli Europei, in Oriente, per Jean Houbert: «The European colonisers did not invent slavery; it was endemic in Africa and in Madagascar. The Europeans articulated this indigenous institution with mercantile capitalism, which gave rise to a massive movement of populations over long distances. »56. Le stesse monarchie Sakalava o Merina si servirono del commercio degli schiavi come fonte principale per l’acquisizione di armi e polvere da sparo a sostegno delle loro ambizioni espansionistiche e per la creazione del nuovo regno malgascio, per la cui costituzione si attingeva alla manodopera delle coste africane e dalle Comores: «They exported some Malgasy slaves, bought from the independent Sakalava chieftaincies to the south, as engagé labour to the French, while buying slaves from eastern Africa for service in the Merina kingdom. »57. 55 Jean-Michel Filliot, La Traite Africaine vers les Mascareignes, in Mouvements de populations dans l’Océan Indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, Paris, Champion, 1979, pp. 235 – 240. 56 Jean Houbert, Creolisation and Decolonisation in the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shian de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), op. cit., p. 129. 57 Malyn Newitt, Madagascar and the African Diaspora, Ibid., p. 91. Come conferma Jean-Claude Hébert, un tale costume era così radicato nella società malgascia da interessare tutte le comunità dell’isola con una solida 43 Quantunque nell’Oceano Indiano la schiavitù fosse considerata una vecchia istituzione, le isole Mascarene non conobbero la tratta che nel 1729, molto dopo la loro conquista, giacché, diversamente dalle Antille, la Réunion e Maurice non erano nate come colonie di sfruttamento ma, inizialmente, come basi militari per il controllo dei mari orientali. Occupata nel 1642, solo nel 1717 la Réunion fu avviata dalla Compagnia delle Indie alla produzione intensiva del caffè. Trasformata in colonia agricola, la virtuosa comunità agreste imparava alla luce dei profitti i vantaggi di una rigida struttura gerarchica costruita sulla forza lavoro poco costosa (soprattutto sempre rinnovabile) degli schiavi. Citando dal testo di Edmond Maestri: «En colonisant Bourbon, le roi de France ne peut nourrir d’autre ambition que d’y voir naître une société paysanne traditionnelle bâtie sur le model français. », ancora dopo la prima fase della colonizzazione, « […] Tous les paysans utilisent des esclaves pour travailler la terre, mais parmi le plus petits d’entre eux beaucoup sont obligés de manier aussi la pioche avec l’aide de leurs femmes et de leurs enfants.»58. Proprio quando, nella seconda metà del XVIII secolo, nei territori atlantici il colonialismo e la schiavitù si avviavano alla decadenza (l’indipendenza degli Stati Uniti e la rivolta degli schiavi a Santo Domingo ne furono la massima testimonianza), alla Réunion e a Maurice, da poco colonie (fondate rispettivamente nel 1642 e nel 1722, per diventare produttive nel 1729 e nel 1735), questo stesso fenomeno andava, invece, consolidandosi59. La condizione endemica, secolare dello sfruttamento schiavista nel mondo orientale, ma soprattutto l’appoggio dello stato francese che aveva contribuito e sostenuto il cambiamento delle colonie verso il regime schiavista («les colons n’ont point créé l’esclavage, ils l’ont subi: la propriété des esclaves, créée, favorisée, encouragée par le gouvernement, est sacrée comme toutes les autres»60) impedirono certamente, qui rispetto alle Antille, l’emergere di una percezione e di un’analisi critica del fenomeno. organizzazione politica: « […] l’expansion des razzias malgaches perpétrées dans l’Archipel des Comores et jusqu’en Afrique, le butin d’esclaves ramené compensant à peine les pertes éprouvées. », Jean Claude Hébert, Les remous du bouillonnement révolutionnaire sur nos postes de traite à Madagascar, 1792 – 1803, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 180. 58 Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit, pp. 28 – 29. 59 «Dans l’histoire des îles à sucre, Bourbon et Maurice représentent un cas paradoxal: alors qu’aux Antilles la traite des Noirs et la canne à sucre avaient prospéré de concert au XVIIIe siècle, les Mascareignes s’orientent vers une monoculture et une industrie réputées dévoreuses d’esclaves au moment précis où la traite est interdite et l’esclavage lui-même semble menacé. », Hubert Gerbeau, Quelques aspects de la traite illégale des esclaves à l’île Bourbon au XIXe siècle, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 274. 60 Più sotto: «L’esclavage enfanté par l’Etat français, avait autorisé et encouragé les colons à placer leurs capitaux dans l’achat des esclaves. », Sudel Fuma, L’idéal républicain à la Réunion, de la Monarchie de Juillet à l’abolition de l’esclavage, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 380. 44 Le idee riformiste e umaniste di Montesquieu, di Voltaire61, verso le quali pure le isole dell’Oceano Indiano si erano mostrate sensibili, anziché promuovere l’emancipazione dal giogo schiavista, agirono, piuttosto, nella coscienza della popolazione reunionese e mauriziana da inibitori della memoria, perché alla luce degli orrori perpetrati ai danni delle comunità più deboli, la verità storica e la conoscenza della realtà schiavista fosse taciuta alle nuove generazioni: «un drame passé [celui de l’esclavage] enfoui le cœur du drame réunionnais, souvent parce que ressenti comme honteux ou humiliant […].»62. * Sebbene alla Réunion la schiavitù fosse stata ufficialmente ratificata nel 1690, l’istituzione della manodopera servile è fatta risalire al 1674 quando La Haye, con l’appoggio del governatore Orgeret, vietando i matrimoni misti (fino ad allora praticati dai reunionesi senza riserve), iniziò l’isola alla selezione etnica prima, e alla suddivisione in classi poi. Nonostante agli inizi del 1700 La Haye si fosse fatto promotore di una politica schiavista, alla fine del XVIII secolo alla Réunion il rapporto numerico tra Bianchi liberi e schiavi era ancora di 226 su 113. Solo la trasformazione dell’isola in colonia agricola, produsse un reale e definitivo cambiamento nella struttura sociale e politica delle città reunionesi, invase da un numero sempre maggiori di schiavi sfruttati nelle piantagioni del caffè63,. In queste piccole e, per la maggior parte, modeste società (quella reunionese e mauriziana) formate originariamente da cittadini francesi alla ricerca di fortuna e di prestigio64, minacciate, ora, 61 «Il est symptomatique que les items les plus fréquemment cités dans ces inventaires de bibliothèques soient d’une part les Œuvres de Voltaire […], d’autre part le célèbre ouvrage de l’abbé Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. […] On peut au demeurant s’étonner du succès de l’ouvrage de Raynal (auquel collaborèrent Diderot et d’Holbach), auprès des colons, car si le contenu pouvait leur en convenir par certain côtés, ce texte n’en fut pas moins la “bible de l’anticolonialisme” au XVIIIe siècle. », Olivier Caudron, Livre, lecture et Révolution aux Mascareignes: Quelques pistes de recherches, ibid., p. 151. 62 Agnès Antoir, «Le théâtre Vollard à la Réunion”, Notre Librairie n. 102 (juillet – août 1990), p. 83. 63 «Les esclaves créoles étant 1.503, la classe servie atteignait la chiffre de 6.573 contre seulement 1.716 Européens. Ces derniers, dont le nombre a pourtant triplé depuis 1714, ne font plus que 21% du total de la population (8.289 habitants) et les Noirs sont 79%.», R. P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, in La Traite Africaine vers les Mascareignes, in Mouvements de populations dans l’Océan Indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 245 64 «[…] mutins, aventuriers, débauchés, bref tous “gens sans aveu”.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 18., Gli abitanti di Maurice vengono così descritti: «L’île apparaît à ses habitants non comme une terre d’établissement, mais comme un lieu de passage inévitablement placé sous le signe du provisoire. Ce contexte incertain a des effets démobilisateurs: il incite les colons à conserver une mentalité d’exilés et à tout sacrifier au profit immédiat, puisque, même s’ils y sont nés, ils voient leur avenir à l’extérieur de l’île. […] les Créoles de l’Ile de France ne sont pas de vrais Créoles, puisque rien ne les distingue des aventuriers de passage: pas de projet à longue terme, pas de sentiment d’appartenance à une communauté de la terre. », Jean-Michel Racault, Pastorale ou “Dégénération”: l’image des populations créoles des Mascareignes à travers les récits de voyages dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 77 – 78. 45 dalle nuove teorie libertarie, la difesa del sistema schiavista si impose come necessità, incoraggiando la riesumazione di antiche, ormai desuete convinzioni, che documentassero e legalizzassero la tratta, naturalizzando, in definitiva, la condizione servile: «Je certifie que le nommé Ferdinand Jean-Baptiste, ancien enclave de ma famille, a toujours continué, contrairement à l’usage adopté par les affranchis de l’infernale et maudite année 1848, à travailler au service de ses anciens maîtres. Je certifie (…) qu’il reconnaît (…) qu’un Blanc est plus que lui.»65. L’incoraggiamento della Compagnia delle Indie a un migliore utilizzo del territorio assieme alla promulgazione del nuovo Codice Nero voluto da Luigi XV (che coincideva con l’inizio dell’impresa coloniale delle Mascarene), rendevano di fatto lecito il ricorso alla manodopera servile. Nonostante, quindi, già dai primi anni del 700, la Compagnia avesse decretato l’illegalità della tratta e del sistema schiavista66, la mutata economia delle isole costringeva i coloni reunionesi e mauriziani a un inasprimento del ruolo maître/esclave e alla riabilitazione, in pieno illuminismo, di vecchie teorie che giustificassero lo sfruttamento inumano degli schiavi: «Humilier et accabler de mépris cette race destinée à l’esclavage; camper en regard la race des Blancs, race supérieure, sacrée, tabou et dresser entre ces groupes une frontière infranchissable […]. Accréditer ainsi l’opinion qu’il existe aux colonies deux «espèces» d’hommes «en quelque sorte de nature différente»: la classe de couleur et la classe blanche. La première vouée à la servitude de tous temps, chez laquelle, par la suite, la liberté est chose «adventice, précaire, révocable au moindre délit: un faveur». Enfin, «conférer un sens, une portée raciale, ontologique, de droit, à la classification libres/esclaves établie par le code: ressusciter la théorie d’Aristote.»67 Stando al Codice Nero: «[…] l’esclave est un «meuble», une chose qui peut être vendu, acheté; voire un immeuble et il est vendu avec le terrain. Il ne peut rien posséder. Sa situation économique est ainsi définie: “Les esclaves ne peuvent Di contro la Réunion: «la population qui y vécut [à la Réunion] ne connut guère que une trentaine d’années de semi prospérité, le marasme, la pauvreté étant pour elle l’habitude. », André Scherer, L’histoire de la Réunion, op. cit., p. 6. 65 Sudel Fuma, L’idéal républicain à la Réunion, de la Monarchie de Juillet à l’abolition de l’esclavage, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 384. I coloni mauriziani e reunionesi giustificavano lo sfruttamento della manodopera nera con la naturale resistenza delle popolazioni africane al clima tropicale, a cui l’europeo non era, invece, avvezzo: “Les colons […] plaidaient que seuls les Noirs pouvaient travailler la terre en climat tropical […].», André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 67. 66 «Jean de la Roque écrit en 1709: «tout travail de la campagne se fait par les esclaves, les habitants travaillent fort rarement». De leurs rapports avec Fort-Dauphin [à Madagascar], les gens de Bourbon ont retenu le principe de l’esclavage. Il est vieux comme Bourbon. Il est officiellement interdit par la Compagnie, mais les gouverneurs euxmêmes le pratiquent, comprenant que sans les esclaves l’île ne produira rien. », Jean Defos Du Rau, L’île de la Réunion, Etude de géographie humaine, op. cit., p. 137. 67 Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 26. Il corsivo è mio. 46 rien avoir qui ne soit de leur maîtres, et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, est acquis en pleine propriété à leurs maîtres.” […].»68. Ma da dove attingevano le Mascarene la loro forza lavoro? Come accennato in precedenza, Portoghesi e Arabi detenevano il monopolio della tratta schiavista. Mentre i Portoghesi avevano fatto della costa orientale africana (il Mozambigo) il centro del loro commercio, gli Arabi, da tempo in contatto con le popolazioni africane, erano il tramite privilegiato dei compratori europei con le etnie del luogo. Gli insediamenti europei (francesi) su molte coste dell’Oceano Indiano, ebbero un ruolo altrettanto importante nella selezione della manodopera servile; i primi a garantire la continuità del flusso migratorio, ovvero dell’esodo massiccio di forza lavoro. La base di Fort-Dauphin, fondata nel 1643, iniziò le isole Mascarene al duraturo commercio di uomini e viveri con il Madagascar. I primi abitanti69, e i primi schiavi delle isole appartenevano, di fatto, all’etnia malgascia: «[…] les vaisseaux de la Compagnie des Indes n’effectuaient de telles opérations [de traite] pour le compte des Mascareignes qu’à Madagascar. »70. Solo successivamente, vista la natura indomita dei Malgasci, considerata la modesta materia prima (forza lavoro) che il Madagascar riusciva a procurare, le colonie orientarono la loro domanda verso l’Africa. Nel 1810 potevano essere censiti sul territorio delle Mascarene: «À partir des rapports de traite conservés […] nous savons qu’au moins 160 000 esclaves furent introduits aux Mascareignes jusqu’à 1810. 45% des captifs étaient originaires de Madagascar, 40% du Mozambique, 13% de l’Inde et 2% d’Afrique d’Ouest. […]. Toussaint, de son côté, a recensé 142 expéditions de traite en Afrique portugaise, de 1773 à 1810, rapportant 64000 esclaves.»71 La crescita esponenziale di deportati, schiavi, a cui furono sottoposte Maurice e la Réunion dopo il 1720, rese opportuno l’osservanza o meglio la messa a punto di una legislazione che regolasse il rapporto maître/esclave. Quantunque le colonie atlantiche facessero riferimento al Codice Nero promulgato nel 1685 (modificato in parte nel 1725), le Mascarene, soprattutto la Réunion videro necessario l’attuazione di una normativa specifica per le isole, il Code de l’Isle de Bourbon del 1767, che rispondesse alle particolari condizioni politiche ed economiche della popolazione del luogo. La preparazione d’un 68 Ibid., p. 24. «Les Malgaches étaient les premiers occupants à Maurice comme à la Réunion. […] Il n’empêche que les Noirs marrons furent les maîtres de l’île après son évacuation par les Hollandais. », Ibid., pp. 16 – 17. 70 Ibid., p. 20. 71 Spiega lo storico: «Le mérite de Labourdonnais […] a été de développer et de rationaliser les opérations de traite afin d’assurer, tant à son administration qu’aux colons, un nombre suffisant d’esclaves. […] L’un d’ordre de police qui visait à ne sélectionner que des groupes d’esclaves dociles, l’autre d’ordre économique, afin de les acquérir au moindre prix.», Ibid., pp. 20 - 21. 69 47 tale codice è certamente all’origine del malinteso e dell’omertà sulla condizione giuridica degli schiavi alla Réunion e a Maurice. Rispetto al codice in uso nelle Antille, il codice reunionese dava, infatti, prova di maggiore apertura e disponibilità nei confronti degli schiavi. Se, in generale, era loro proibito detenere armi, nelle isole dell’Oceano Indiano, non era raro imbattersi in schiavi che erano stati promossi a marinai o a soldati72. Il Codice promuoveva oltretutto la liberazione, l’affranchissement, degli schiavi meritevoli: «Promotion sociale réservée aux Noirs, […] les affranchissements octroyés seraient constatés d’une manière certaine et légale.»73. La normativa vigente nelle Mascarene, punendo energicamente i maltrattamenti, incoraggiava i coloni reunionesi a intrattenere un rapporto paternalistico con il proprio schiavo (al contrario di quanto era in uso nelle colonie antillane): On peut même dire que conformément à l’esprit des premières instructions de Poivre, les administrateurs encouragent à «dédommager» les esclaves de la perte de leur liberté. Il y a une sorte de paternalisme officiel qui se manifeste par la distribution de distinctions et de gratifications aux esclaves méritants. Più avanti: «[…] il faut aussi prévenir le mal, donc humaniser – si cela est possible – l’esclavage et éviter les motifs de conflits. «de s’occuper sans cesse de moiens d’affaiblir les préjugés contre les noirs et les gens de couleur […].»74 Se da un lato, i testi ufficiali sembrano smentire l’esistenza alla Réunion o a Maurice di un regime schiavista disumano quanto quello delle colonie atlantiche, le testimonianze di scrittori del tempo come Bernardin de Saint-Pierre (che soggiornò a Maurice un anno), Parny o Lacaussade (poeta che visse da meticcio la discriminazione razziale alla Réunion75), le denuncie frammentate 72 «Il est bien probable que l’interdiction faite aux Blancs de confier leur fusil, même désarmé, ait toujours été observé.», R.P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p.379. «[…] surtout dans le biais militaire s’effectue une espèce d’intégration – si le terme n’est pas trop fort – des esclaves au monde de leurs maîtres. Les esclaves cafres forment ainsi l’effectif le plus important des marins embarqués sur les corsaires durant la guerre d’indépendance américaine […].»,Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 206. 73 Bernatd Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 25. 74 Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 206 e p. 199. 75 «Je ne saurais me plaire d’un pays où mes regards ne peuvent tomber que sur le spectacle de la servitude, où le bruit des chaînes étourdit mon oreille et retentit dans mon cœur […]. On trouve toujours un homme cotre un cheval […]. Il faut avouer que les nègres sont moins maltraités ici que dans nos autres colonies […] mais ils sont esclaves mon ami.», Évariste Parny, Lettre à Bertin in Barquissau, Tratto Claude Wanquet, Ibid., p. 212. 48 dei giornali, soprattutto la scelta estrema della morte o del marronnage da parte di molti deportati neri sembrano gridare all’ipocrisia dell’uomo bianco. Come lo scrittore francese del Voyage à l’Ile de France (del 1773) così altri memorialisti lasciano intravedere le ombre del sistema schiavista reunionese, complice, invece, di un atteggiamento ingiustamente crudele: «Il est certain que nous ne pouvons nous celer à nous mêmes que les cruautés ont été portés dans ces isles à des excès révoltants et punissables» […] écrivent Souillac et Chevreau en mettant bien en lumière la barbarie qui naît de l’ivresse de la puissance de certains «hommes de notre couleur […]» […]. Ils soulignent aussi combien il est possible de prouver l’existence de cruautés domestiques car elles «se consomment dans 76 une retraite impénétrable à tous les autres qu’aux exécutants et aux patients.» . Seppure molti Reunionesi condividevano la stessa situazione di miseria dei loro servi77, non è giustificabile per lo studioso Sudel Fuma, L’idéal républicain à la Réunion, de la Monarchie de Juillet à l’abolition de l’esclavage78, l’indolenza e il disinteresse con il quale veniva trattato il caso umano dei deportati neri: schiavi malnutriti, lasciati morire privati delle cure necessarie, puniti per una vendita poco vantaggiosa (ricordiamo che molti schiavi erano impiegati nel commercio di prodotti dell’azienda), costretti a vivere in stabili umidi e malsani, obbligati a spendere i pochi guadagni nelle rivendite dei padroni allestite all’interno della proprietà: «La veuve Charles Lenoir, maîtresse de 186 esclaves, […] fait régner la terreur dans son atelier et n’hésite pas à recourir à la prison ou aux sévices corporels pour rentabiliser ses activités. […] L’esclave travaille tous les dimanches et les jours de fête. […] Les cases sont basses, humides et les esclaves y vivent avec des animaux dans des conditions d’hygiène exécrables. Or la grande majorité des propriétaires s’opposent à toute amélioration du logement de leur travailleurs. […] les esclaves doivent rechercher leur nourriture par leurs propres moyens ou ne reçoivent que des racines alimentaires en quantité insuffisante pour satisfaire leurs besoins.»79. Di fronte al diffondersi del marronnage80 tra il 1730 e il 1750, alla pianificazione della rivolta degli schiavi nel 1779, le effimere motivazioni invocate dai padroni sembrano perdere di validità: 76 Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 209. «Nous avons déjà dit que les administrateurs se plaignent […] de trop de laxisme de la part des maîtres […]. Une certaine misère partagée rapproche aussi quelquefois maîtres et esclaves.», Ibid, p. 210. 78 Sudel Fuma, L’idéal républicain à la Réunion, de la Monarchie de Juillet à l’abolition de l’esclavage, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., 79 Ibid., p. 375. 80 «Marron, marrone, d’après le dictionnaire Larousse, (de l’espagnol cimarron) se disait d’un enclave qui s’était enfui […].», R.P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p.357. 77 49 «[…] les esclaves n’aiment pas être enfermés et refusent tout abri décent qu’on leur propose […] ne souhaitent pas avoir des cases […] le Noir s’attache à la glèbe, il travaille sans réfléchir. Il n’a guère des pensées que dans les besoins physiques. Le noir s’engraisse, s’apprivoise dans l’esclavage. […] si on les laisse libres, ils ne font rien et leur vie devient alors un long repos […].»81 Già dai primi anni di schiavitù, i Malgasci si mostrarono individui difficili da assoggettare. Questo popolo dalle forti tradizioni culturali non riuscì ad adeguarsi alla nuova condizione di sfruttamento servile. Durante la colonizzazione olandese, i Malgasci impiantati a Maurice avevano dato vita a una prima comunità dissidente, faro di quanti, schiavi, avrebbero deciso di ribellarsi all’oppressione politica ed economica dei coloni francesi. La richiesta di nuova manodopera, come conseguenza della trasformazione dell’economia agricola delle isole, significò l’introduzione massiccia e senza regole di schiavi (provenienti stavolta da diverse regioni dell’Africa e dell’Asia). Conseguenze dell’imponente immigrazione furono l’abbassamento del valore di mercato dello schiavo, e il seguente peggioramento del livello di vita della manodopera che a lungo andare aveva perduto le poche concessioni garantite agli inizi del XVIII secolo. La vicinanza con le coste malgasce, la conformazione delle isole, soprattutto della Réunion, convinse, quindi, gli schiavi a cercare la libertà dal giogo servile nel mare o nell’entroterra insulare. Tra il 1730 e il 1770 i padroni delle aziende agricole assistettero a un vero e proprio dissanguamento di manodopera che, complice la notte, prendeva il largo su barche di fortuna o fuggiva tra la malsicura boscaglia delle montagne reunionesi: «En effet, partout où l’esclavage colonial a sévi […] il y a eu des Noirs fugitifs, que ce soit la Guyane, aux Antilles, à l’île Maurice […]. A l’île de Bourbon, il y eut également des marrons […] le marronnage a connu au XVIIIe siècle […] un degré d’intensité, une extension qui n’ont rien de semblable ailleurs […]: La proximité de Madagascar […] fait que le naturel de ce païs est toujours flatté de rejoindre sa patrie […] les Malgaches amenés dans les Îles de France et de Bourbon savaient que la terre natale n’était pas si loin: ils furent les instigateurs de ces fuites.»82. 81 Sudel Fuma, L’idéal républicain à la Réunion, de la Monarchie de Juillet à l’abolition de l’esclavage, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 375 – 383. Studi più recenti fanno luce sulla resistenza prolungata e silenziosa dei proprietari terrieri riguardo l’attuazione di alcune norme previste dal Codice reunionese, tra le quali era l’obbligo di educare i lavoranti a servizio alla religione cristiana. All’origine di una tale inerzia sicuramente il timore che alcuni sacerdoti progressisti, nell’alfabetizzare gli schiavi, li avrebbero certamente iniziati alla conoscenza e alla difesa dei diritti civili, Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., pp. 52 – 53. 82 «D’où, de nombreux vols de canots, en vue de rejoindre la Grande Île, et quelques évasions spectaculaires, comme celle du 8 juin 1733, où 12 Noirs de la Compagnie gagnèrent à la nage de nuit, une pirogue ancrée en pleine rade de Saint-Paul.», R.P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les 50 Di questo intenso, prolungato (fino al 1848), periodo di rocamboleschi ammutinamenti resta ben poco nelle Mascarene, qualche documento giudiziario, rari nomi di luoghi che evocano leggendari re marroni come Mafate o Dimitil: «La tradition rapporte à tort ou à raison que Cimadef, Anchaing, Dimitil, sont des noms de chefs marrons; des mots tels que Salazes, Cilaos, Tevelave, sont d’origine malgache. Dimitil est resté célèbre; il menait avec sa «smala» une vie de nomade perpétuellement traqué, changeant de camp et de région.»83. Come nelle altre colonie, così a Maurice e alla Réunion gli schiavi ribelli si organizzarono in comunità, dando vita a delle piccole società rette da una rigida gerarchia (una riconferma della tradizionale organizzazione malgascia), e difese da un organizzato cordone militare. Come nelle Antille, gli schiavi marroni reunionesi e mauriziani passarono alla storia per le loro invettive contro i Bianchi84. L’esperienza maturata nell’Oceano Atlantico, indusse gli abitanti delle Mascarene a tentare di arginare il fenomeno al suo intensificarsi. Già con Labourdonnais nel 1735, la popolazione reunionese e mauriziana rispose con la costituzione di una polizia etnica il cui compito era quello di proteggere dagli attacchi e di frenare la diffusione del marronnage tra gli altri schiavi: «Pacifier l’île était une des tâches que les syndics avaient confiées à Labourdonnais. […] Pour vaincre les marrons, il créa un corps de soldats africains. Son génie tactique reposait sur le principe suivant: substituer à la guerre des Blancs contre des Noirs, celle des Noirs contre des Noirs.»85. A questo primo corpo di polizia (una miliza di Saint-Denis e Sainte-Suzanne, una milizia per Saint-Paul) vennero affiancati numerosi distaccamenti, «toutes personnes portant les armes, depuis l’âge de quinze ans […].»86, che comprendevano una grossa parte della popolazione creola. Proprio i Creoli87 furono i maggiori persecutori degli schiavi ribelli. origines jusqu’en 1848, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 360. 83 Jean Defos Du Rau, L’île de la Réunion, Etude de géographie humaine, op. cit., p. 144. 84 La sterilità degli altipiani aveva indotto, infatti, queste piccole comunità (alcune contavano appena dieci individui) a trovare la maggiore fonte di sostentamento negli assalti alle città, ma soprattutto alle aziende agricole dalle quali sottraevano viveri, capi di bestiame, indumenti e all’occorrenza armi. Ulteriori dettagli nel citato saggio di Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, po. cit., pp. 357 – 391. 85 «Je trouvai le secret de les détruire, confia-t-il, en armant Noirs contre Noirs, et en formant une maréchaussée de Nègres de Madagascar, qui parvirent enfin à purger l’île de la plupart de ses brigands.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 19 86 R.P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 369. 87 «François Caron appartenait à la première génération créole. La seconde produisit deux grands chausseurs: François Mussard au Sud, et Jean Dugain au Nord.», Ibid., p. 379. Per Creolo si itende il nativo di una colonia le cui origini sono legate ad altri luoghi geografici: «’Creolisation’ is derived from the word ‘Creole’ which in the original Spanish, criollo, was used for: ‘committed setter…or native to the settlement though not ancestrally indigenous to it. […] Creolisation will thus be taken to mean a variant to settler 51 Quella che inizialmente era stata pensata come un’organizzazione per salvaguardare la popolazione, si rivelò successivamente un sistema efficace per dare sfogo a quel represso odio razziale che, nelle società insulari, Bianchi e Creoli covavano da tempo. Se il Codice nero prevedeva un compenso per ogni schiavo nero catturato, la caccia ai marrons si trasformò in un vero e proprio massacro, la mano sinistra del rivoltoso essendo ora sufficiente a testimoniare l’avvenuta eliminazione88. Nel 1779 ci fu l’ultimo grande tentativo da parte degli schiavi di ribellarsi alla dittatura bianca. Il giorno di Pentecoste alcune bande armate presero d’assalto i quartieri di Saint-André e SainteSuzanne con l’intento di massacrare la popolazione «[…] ils assassinent de plusieurs coups de couteaux un noir gardien poulailler qu’ils soupçonnent “être dans le cas de donner avis du complot” […] “profiter de l’instant où on serait à la messe et commercer par poignarder les fidèles pendant qu’ils seraient à l’église”.»89. Nonostante nell’Arcipelago il fenomeno del marronnage avesse assunto, più che nell’Oceano Atlantico, dimensioni allarmanti, si dissolse alla fine del XVIII secolo senza lasciare tracce evidenti della sua esistenza, laddove i documenti storici, gli atti dei tribunali, censurati dalla memoria collettiva e dagli studiosi dell’area, raccontano del rapporto conflittuale degli storici dell’area con il fenomeno schiavista90. Il forte individualismo malgascio e la vicinanza della terra natale non assecondarono il sodalizio tra le varie comunità di rivoltosi, impedendo che si venisse a formare un importante nucleo di opposizione politica e culturale come nelle Antille (nelle Mascarene non si verificarono mai rivolte significative come a Santo Domingo): colonisation. The originality of this variant of settler colonisation was that the most of the immigrants were slaves of various non-European origins who were brought together by Europeans and regimented in work on plantations in uninhabited oceanic island.», Jean Houbert, Creolisation and Decolonisation in the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shihan de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), op. cit., p. 123. 88 «Les détachements pourraient «aller dans le bois quand ils le jugeront à propos» avec l’agrément préalable du Commandant de quartier. «Pour augmenter l’émulation et récompenser les détachements à proportion des captures qu’ils feront, il leur sera délivré par la Compagnie, aux frais de la Commune, sur le pied du tarif, autant de Noirs e de négresses qu’ils en tueront dans le bois, dont suivant l’usage, ils seront tenus de porter la main gauche.», R.P. Jean Barassin, La révolte des esclaves à l’île Bourbon (Réunion) au XVIIIe siècle, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., pp. 357 – 391. 89 Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 198. 90 R. P. Jean Barassin, Aperçu général sur l’évolution des groupes ethniques à l’île Bourbon depuis les origines jusqu’en 1848, in La Traire Africaine vers les Mascareignes, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., pp. . 245 52 «Attachment to their native land was not a mere sentiment; it was incorporated with, and formed part of, their religious belief. They believed that when the soul quitted the body it returned not to God, but to the place of their birth […].»91 Convinti che solo la morte avrebbe potuto restituire loro la libertà, i marroni mauriziani e reunionesi non ritennero necessario elaborare una propria coscienza identitaria forte della memoria del mondo ancestrale, da cui erano stati sottratti, per sopravvivere all’oppressione anche culturale del colonizzatore europeo. La spinta disgregazionista che caratterizzò la comunità creola delle isole dell’Oceano Indiano rispetto alle Antille avrebbe impedito nella seconda metà del Novecento l’affermarsi di una società politica creola alternativa alla comunità europea ma soprattutto a quelle comunità indiana e cinese stabilitesi sulle isole solo alla fine dell’Ottocento. * La liberté du travailleur – hors de l’atelier – ne nuit pas au travail. Les soins, l’école, l’habitat, les enfants à nourrir coûtent cher (en aparté)…je vous file un tuyau, Prosper, faites venir des engagés de la côte des Malabars. Ils travaillent dur et ne font pas d’histoires. 92 Il 20 dicembre del 1848 alla Réunion venne definitivamente sancita l’abolizione della schiavitù (Maurice aveva decretato l’illegalità del sistema schiavista già dal 1833). Nonostante i numerosi tentativi della borghesia terriera di opporsi all’inevitabile (la pervicace resistenza reunionese era stata in grado di rinviare per più di mezzo secolo l’applicazione del primo decreto del 1794), la Seconda Repubblica, nelle veci del governatore Sarda Garriga era riuscita dove la prima repubblica e il governo di Luigi Filippo avevano fallito. Al di là di ogni aspettativa e contrariamente a quanto accaduto nel 1794, la notizia dell’abolizione non sembrò in un primo momento allarmare eccessivamente la popolazione reunionese. Probabilmente, rimaneva la convinzione che il nuovo governo avrebbe concesso del tempo per attuare la riforma93, ma soprattutto che, come alla fine del 700, anch’esso si sarebbe persuaso della necessità del sistema schiavista. La mancanza di un esercito organizzato capace di 91 Edward Alpers, The african diaspora in the Indian Ocean, a comparative perspective, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shihan de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), op. cit., p. 38. 92 Emmanuel Genvrin, Jean-Luc Trules, Marie Dessembre, La Possession, Théâtre Vollard, 1987, p. 23. 93 I tentativi delle varie delegazioni di Francs-maçons di entrare in contatto con Garriga fallirono. Era loro convinzione che il decreto repubblicano dovesse essere adattato al contesto reunionese. Era necessario oltretutto che prima dell’abolizione fosse data alla popolazione l’opportunità di creare un’Assemblea coloniale perché potesse essere arginata l’invasione dei nuovi liberi, quindi dei nuovi possibili elettori. 53 respingere le navi francesi, e, in particolar modo, le precarie condizioni economiche in cui versava l’isola dopo la serie di catastrofi naturali che si erano abbattute dal 1803 al 1829 (che rendevano improbabile qualsiasi minaccia di una nuova secessione) dovettero convincere la popolazione dei grandi e dei piccoli proprietari dell’improrogabilità della resa: «[…] toutes les classes de la population doivent savoir qu’il n’appartient à aucune d’elles de devancer ce que voudra faire, pour régler leur avenir, le pouvoir qui sortira du pays […]. Il faut que les populations des colonies attendent avec calme et confiance, la solution que le gouvernement définitif ne peut manquer d donner à l’abolition de l’esclavage. Solution qui sera conciliée avec les droits acquis.»94. Negli anni che precedettero l’abolizione della schiavitù, la minaccia, sempre incombente, della definitiva abrogazione della tratta e del sistema servile, persuasero il Consiglio Generale della Réunion (costituito per la maggioranza dai grossi proprietari terrieri) della necessità di intervenire perché fossero attuate delle riforme in favore di un miglioramento della condizione degli schiavi95, e del reclutamento di manodopera salariata. Dal 1827 e fino al 1832 gli engagés indiani, introdotti sull’isola (una media di 1100 per anno), furono affiancati agli schiavi da tempo presenti nell’azienda agricola. Quello che la borghesia terriera considerava come una fase di transizione indispensabile per abituare i salariati al nuovo regime di lavoro (a cui erano abituati gli schiavi), e al mondo culturale e linguistico (quello francese) a cui erano estranei, si rivelò fallimentare96. Altrettanto funesta fu la risposta dei nuovi liberi, gli affranchis, che, memori della condizione passata, preferirono il vagabondaggio o le privazioni degli altipiani alla nuova schiavitù del salariato: 94 Antoine Roussin, Album de l’Ile de la Réunion, Saint-André, Océan éd., 1991, p. VII. Il corsivo è mio. Jackie Ryckebusch, L’asssociation des Francs-Créoles, 1830 – 1833, Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 365. 96 «Ils essayèrent de trouver, dès avant 1830, une main-d’œuvre libre qui put prendre peu à peu aux champs la place des esclaves au fur et à mesure de l’extinction naturelle de la classe servile. Dès décembre 1827, ils firent […] recruter dans l’Inde des travailleurs libres. […] les rapatriement furent plus nombreux si bien qu’en 1843 il n’y avait plus que 884 engagés dans l’île. […] La cause de celui-ci est que, sauf les plus riches, les propriétaires n’avaient pas de liquidité monétaires pour payer leur main-d’œuvre […]. Une autre cause de cet échec fut certainemt l’impossibilité qu’il y avait de faire travailler côte à côte des esclaves et des hommes libres.» André Scherer, L’histoire de la Réunion, op. cit., p. 68. L’identured labour o lavoro salariato era regolato da una normativa molto restrittiva. Il salariato era reclutato per mezzo di un contratto dalla durata di cinque anni senza il quale non era permesso il soggiorno nelle isole. Alla scadenza del contratto il datore di lavoro si impegnava a far tornare l’impiegato in patria (molti padroni detraeva questa spesa direttamente dallo stipendio), altrimenti questi avrebbe dovuto cercare un altro lavoro (la legge puniva il vagabondaggio). La soppressione delle boutiques all’interno proprietà, dichiarate illegali solo nel 1875, permise ai salariati maggiori risparmi, Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., pp. 46 – 47. 95 54 «L’affranchi avait horreur de la tache régulière imposée, signe de servitude. […] Dans un mémoire, Patu de Rosemont signale que le Ier janvier 1848, 1706 propriétaires avaient 45 698 esclaves et qu’au Ier janvier 1852 ces mêmes propriétaires n’avaient plus que 15843 affranchis travaillant sur les mêmes terres.»97. Pure indennizzata dal Governo repubblicano per la perdita degli schiavi, la borghesia reunionese rimaneva, dopo il 1848, convinta assertrice dell’economia schiavista, considerando la manodopera salariata una rovina certa per il sistema produttivo e imprenditoriale dell’isola (già duramente provata da anni di calamità naturali). Il nuovo apparato poneva infatti non pochi problemi, molti dei quali sperimentati proprio negli anni antecedenti l’abrogazione della schiavitù. I decenni immediatamente successivi al decreto di abolizione, furono, pertanto, segnati dalla ripresa della tratta negriera. Appoggiata dalla maggior parte della popolazione renionese («le commerce de la Traite des Noirs est protegé par la majorité des habitants de cette Colonie»98), la tratta clandestina attingeva dal commercio mai estinto dei Portoghesi e degli Arabi99. Il rischio legato a un tale mercato (per sfuggire al controllo inglese e mauriziano si arrivò a trasportare i deportati in piroghe), procurò all’isola non pochi problemi molti dei quali di ordine pubblico. Non solo le sanzioni o i sequestri del carico di uomini potevano costituire una perdita economica per i tenutari reunionesi, ma gli schiavi si rivelarono sempre più spesso un cattivo acquisto: «Ainsi, la traite destinée à souvenir les îles et à nourrir l’esclavage arriverait paradoxalement à provoquer la ruine à tous deux.»100. Le dinamiche del traffico di immigrati indiani si rivelarono a lungo andare non molto diverse dall’antica tratta negriera. Non solo la manodopera era spesso reclutata con la forza dal paese d’origine, ma le stesse precarie condizioni del trasporto ricordavano il periodo preabolizionista101. 97 Jean Defos du Rau, L’île de la Réunion, Etude de géographie humaine, op. cit., pp. 152 – 155. Proprio per evitare lo spopolamento delle campagne il decreto emanato da Sarda Garriga prevedeva che gli schiavi liberati mantenessero il loro posto di lavoro come affrancati: « “La liberté c’est le premier des besoins de l’humanité, oui, mais ce suprême bienfait impose d’autres obligation. La liberté élève le travail à la hauteur du devoir. Être libre, ce n’est pas avoir la faculté de rien faire, de déserter les champs […]”. […] Afin d’éviter la désorganisation du travail et de protéger la population affranchie, il exige que les futurs citoyens soient pourvus d’un contrat d’engagement d’un an au moins […].», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., 62. 98 Hubert Gerbeau, Quelques aspects de la traite illégale des esclaves à l’île Bourbon au XIXe siècle, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 384. 99 «Le Portugais ont jusqu’en 1869 des esclaves dans leurs colonies. Malgré leur refus de céder ces travailleurs, les Réunionnais s’en procurent avec la complicité de traitants arabes négriers […]. La réprobation qui s’attache à ce nouveau trafic d’hommes frappe aussi bien la zone de Zanzibar que celle des possessions portugaises.», Hubert Gerbeau, Quelques aspects de la traite illégale des esclaves à l’île Bourbon au XIXe siècle, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 295. 100 Hubert Gerbeau, Quelques aspects de la traite illégale des esclaves à l’île Bourbon au XIXe siècle, in Mouvements de populations dans l’océan indien, actes du IVe Congrès de l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien, op. cit., p. 285. 101 «Afin de contenir le engagés et leurs revendications salariées et nouveaux immigrants salariés, ceux-ci importaient de nouveaux immigrants qui acceptaient les gages qu’on leur proposait.”, Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 55 L’esodo indiano sancì alla Réunion la continuazione della schiavitù nella misura in cui ritardò la riorganizzazione del sistema di lavoro e di ingaggio sull’isola da parte della borghesia terriera. Questa nuova e sempre rinnovabile manodopera offerta dal mare, alla ricerca di un riscatto dal proprio passato di paria, si concedeva, infatti, copiosa al banchetto del vecchio sistema schiavista, rassicurando il potere locale dell’inevitabilità di un’economia basata sul lavoro servile102. I salariati indiani, sottopagati come gli schiavi del XVIII secolo, abbassarono ulteriormente il costo del lavoro103, costringendo i nuovi liberi alla fuga verso gli altipiani104. Quantunque il flusso di immigrati indiani fosse destinato a mantenersi costante e significativo fino al 1906, nondimeno i Reunionesi considerarono opportuno rinsaldare i loro antichi legami con l’Africa. Gli engagés indiani, infatti, come cittadini britannici, rappresentavano comunque una minaccia per l’equilibrio politico dell’isola, i salariati di origine africana si rivelarono, invece, il giusto compromesso tra il vecchio sistema schiavista e il lavoro salariato105. Sebbene la schiavitù fosse stata abolita nel 1833 a Maurice e nel 1848 alla Réunion, nel 1912, le Mascarene sono ancora testimoni di fenomeni schiavisti. Seppure le prime manifestazioni di lavoratori (indiani) risalissero al 1867, solo nel 1937, contemporaneamente alla Réunion e a Maurice, sotto la minaccia di scioperi ad oltranza, furono attuate delle riforme radicali e strutturali che avrebbero tutelato il lavoro dell’impiegato reunionese o mauriziano equiparandolo nella retribuzione, negli orari di lavoro, nelle coperture, a quello della Metropoli: 46. Ancora Combeau e Maestri: «Ayant accès à cette nouvelle source de main-d’œuvre bon marché, les grands propriétaires utilisent pratiquement les mêmes circuits de recrutement des négriers pour s’approvisionner en travailleurs.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. p. 67. Per una stima del flusso cfr. Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 50. 102 «L’immigration indienne à Maurice ne se serait pas produite avec une telle ampleur s’il n’y avait pas eu en Inde de sérieux incitants au départ. Un état de misère avait été crée par la colonisation. […] Leur engagement outre-mer […] leur offrait l’opportunité donc un moyen d’échapper au système […] des castes.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 43. Come sottolinea lo storico Hazareesingh, queste motivazioni sociali trovavano di fatto terreno fertile nel vecchio sistema schiavista: «Les immigrants indiens, arrivant juste après l’abolition d’un système qui avait été sanctionné par le temps, ne pouvaient éviter de passer par les mêmes épreuves, ou presque.», K. Hazareesingh, Histoire des Indiens à l’île Maurice, Paris, Librairie d'Amérique et d’Orient, 1973, p. 49. 103 «Or le prix d’achat d’un enclave avant 1848 est trois fois plus élevé que le coût de cession d’un contrat de travail. Même si le contrat d’engagement varie entre cinq et dix ans, selon l’origine ethnique de l’engagé, le nouveau système offre des avantages substantiels aux grands propriétaires de l’île.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. 67. 104 «Des villages d’affranchis se formèrent dans certaines régions de l’île tel que celui du Chaudron sur la propriété de Charles Desbassayns.», Ibid., p. 66. 105 «Protégés par leur pseudo-citoyenneté britannique, ils ne sont liés que pour cinq ans et peuvent réclamer le rapatriement à la fin de leur contrat, alors que l’Africain doit à son propriétaire dix ans de travail. L’Indien peut aussi faire appel à un protecteur, le syndic des immigrants, chargé de surveiller l’application de la législation du travail des engagés.», Ibid., p. 68. 56 «En 1912, le journal Le peuple dénonce les relents de l’esclavage qui continuent à régir les rapports des employeurs et des salaries. «Ces deux classes sont séparées […] par un abîme de mépris. L’une exploite l’autre sans vergogne et exige d’elle reconnaissance, génuflexion et servage.»106. La silenziosa deportazione del popolo nero, l’imbarazzante presente di una realtà sociale inascoltata, omessa nelle carte giudiziarie, eppure in rivolta fino alla prima metà del XX secolo, raccontano di una storia sostanzialmente francese. Se le Antille poterono e possonono rivendicare l’esistenza di due civiltà (quella istituzionale, francese, e quella periferica, africana), l’Oceano Indiano, soprattutto la Réunion, rimane, a tutt’oggi vincolata al mondo culturale francese. Certamente il passato schiavista dell’area, non ha aiutato le popolazioni deportate a sottrarsi culturalmente e spiritualmente a un tale sistema. Soprattutto la convinzione che la schiavitù fosse solo una condizione transitoria, un esilio che mai avrebbe potuto sottrarre del tutto dalla terra natia, ha ostacolato lo sviluppo di un sistema identitario e culturale forte e alternativo a quello francese, assecondando di contro la rimozione del passato schiavista dalla memoria collettiva: «In a democratic political system qualified by ethic communalism, the black Creoles of Mauritius have neither the economic clout nor the numerical strength and political organisation to effectively challenge the Indians state power. […] By way of contrast, decolonisation through integration in French republic decreolises Réunion to the extent to becoming integrally French the Réunionnais are becoming less Creoles.»107. 106 Eve Prosper, Le sens de la notion d’égalité à la Réunion à la veille de la Première Guerre mondiale, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 406. 107 Jean Houbert, Creolisation and Decolonisation in the Changing Geopolitics of the Indian Ocean, in The African Diaspora in the Indian Ocean, Shihan de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), op. cit., pp. 178 – 179. 57 Rivoluzione francese e secessione Le repubbliche di Maurice e della Réunion Nel novembre del 1799, al levarsi del sipario su L’honnête criminel108 di Fenouillot de Falbaire de Quingey, il popolo di Saint-Denis, raccolto nella platea, proruppe in un unico spontaneo plauso acclamando «à l’unisson pendant un quart d’heure Vive le Roi». Il dissenso lungamente represso nei confronti della neonata Repubblica esplose incontenibile nelle strade per diffondersi in tutti i comuni reunionesi. La Réunion si avviava alla secessione con la condanna della vicina Île de France, decisa a chiedere l’aiuto della sempre nemica Inghilterra in difesa della propria libertà di autodeterminazione. Pure lontana da Santo Domingo, la Réunion ne sperimentava, quasi negli stessi anni, le passioni rivoluzionarie. Quale indipendenza reclamavano i Reunionesi, quali ideali ne muovevano le azioni? * La notizia della destituzione di Luigi XVI e della nascita della Repubblica francese giunse nell’Arcipelago delle Mascarene nel dicembre del 1789. Le îles–sœurs, Maurice e la Réunion risposero prontamente all’invito dell’Assemblea Costituente di organizzare delle sedute di quartiere in segno di adesione al movimento rivoluzionario. Già dal maggio del 1790 l’Assemblea Generale eletta dalle colonie, aveva avviato le riforme necessarie perché le isole potessero dotarsi di un governo autonomo e democratico109 capace di provvedere ai bisogni specifici di ciascuna comunità: «Vous êtes mêmes autorisés…de décréter toutes les lois intérieures qui peuvent convénir à la localité et elles auront leur exécution provisoire avec la simple sanction du gouverneur. »110. 108 Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey, L’honnête criminel, Yverdon, Fortuné-Barthélemy de Felice, 1767. Nato a Salins nel 1730, consacrò tutta la sua vita alla letteratura. Collaboratore dell’Encyclopédie, per la quale scrisse numerosi articoli, viene ricordato per il dramma storico L’honnête criminel, scritto a soli 27 anni, e rappresentato a Parigi verso la fine del secolo. Autore di altre opere teatrali (per il Teatro Francese e il Teatro Italiano), fu celebrato soprattutto per la commedia Les deux avares allestita nel 1770. Morì il 28 ottobre del 1800, a Saintes-Menehould dove si era ritirato alcuni anni prima. 109 «La nomination d’un gouverneur civil, Tirol, chargé de réformer le régime de Bourbon a pour effet de terriblement réduire les prérogatives du gouverneur- L’Assemblée coloniale composée de députés élus par les citoyens actifs, au moins âgés de vingt-cinq ans et domiciliés depuis deux ans dans la colonie, dispose d’un pouvoir réel. Le régime mis en place est celui de l’autonomie.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. 11. 110 Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 312. Tra le varie riforme proposte colpiscono l’allargamento del censo, la legittimazione dello stato di uomo libre/affranchi i cui diritti vennero equiparati a quello del cittadino francese, l’abolizione della nobiltà ereditaria: «[…] ainsi l’accès des non catholiques à toutes les fonctions, […] ou encore celui du 8 décembre 1790 qui abolit la noblesse héréditaire et le port des titres nobiliaires […].», Ibid. 58 Se non stupisce il fervore rivoluzionario delle colonie atlantiche (confinanti con gli Stati Uniti da poco indipendenti), lascia perplessa la partecipazione dei cittadini delle Mascarene, manifestamente fedeli a una politica reazionaria. Vicine alla tradizione francese, nonostante l’indifferenza della Madrepatria, le comunità reunionese e maurizana si mostrarono cultrici e attente depositarie della letteratura e della produzione artistica della Metropoli. Anche prima dell’epoca rivoluzionaria, non era difficile trovare sulle isole testi di Montesquieu o di Voltaire, libri di storia e di arte, l’Encyclopédie di Diderot e d’Alambert, diffusi tra i ricchi feudatari e tra i mercanti, nelle numerose biblioteche pubbliche e private111. Per quanto complete delle recenti teorie filosofiche e scientifiche, «ces bibliothèques de l’époque révolutionnaire nous apparaissent […] comme des bibliothèques d’Ancien Régime»112, vista l’assenza sugli scaffali dei testi di storia contemporanea, incentrati sulla Rivoluzione, e dei dispacci o delle riviste che si erano fatti promotori e testimoni dei tumulti del 1789. Per la rarità dei contatti con la Metropoli francese, i cittadini dell’Arcipelago colsero dei fermenti rivoluzionari il solo carattere astorico (di puro pensiero), che pure dovette renderli ricettivi verso le istituzioni democratiche. La notizia della sollevazione popolare in Francia, dell’avvenuta elezione di un governo repubblicano arrivava, così, in un contesto non solo edotto sui nuovi saperi e sulle ultime filosofie politiche, soprattutto occupato, già prima del 1790, nella realizzazione di cellule ispirate ai principi illuministi. La rivoluzione trovava organizzazioni massoniche in pieno fermento, delle comunità politiche parastatali che parteciparono attivamente alla costituzione delle nuove isole repubblicane, tra le quali, La parfaite armonie, principale loggia massonica di Saint-Denis e la società della Chaumière, a l’Île de France113. La risposta eterogenea dei cittadini delle Mascarene al movimento rivoluzionario (aderirono all’invito repubblicano, non solo intellettuali e studenti ma anche proprietari terrieri, liberi professionisti, e nulla tenenti) fa luce sull’esistenza di diverse società massoniche in contrasto: tanto «La Révolution a favorisé les affranchissements, de même qu’elle a aboli toute distinction entre les blancs et les “libres”.», Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., pp. 67 – 68. Maestri aggiunge: «Maîtres de la situation, les sans-culottes réunionnais mènent une politique active reposant sur l’adoption de tous les symboles révolutionnaires: port de la cocarde tricolore, tutoiement, plantation d’arbres de la liberté, organisation de cérémonies patriotiques. La vie se démocratise avec la participation des gens de condition sociale modeste et même de “petits créoles”.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. 12. 111 Olivier Caudron, Livre, lecture et Révolution aux Mascareignes: Quelques pistes de recherches, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 149 – 151. 112 Ibid., p. 152. 113 Claude Wanquet, Le débuts de la franc-maçonneire à la Réunion, in Problèmes réligieux et minorités en Océan Indien, Table Ronde de l’IHPOM, Sénanque, 1980, p. 37. 59 rivoluzionarie quanto reazionarie114. Questo abbozzo di sistema bipartitico è ravvisabile in entrambe le isole, e caratterizzò, in modo particolare, alcuni quartieri della Réunion (la zona a vento, nord conservatore, e la zona sottovento, sud progressista), inesorabili antagoniste negli anni repubblicani. Non solo gli ideali rivoluzionari aiutarono la popolazione tutta a prendere coscienza del nuovo ruolo di cives, persuasero, anzitutto, le isole che il cambio di rotta politico avrebbe reso possibile la fine di decenni (per l’île de France) e del secolo (per la Réunion), di soprusi e speculazioni perpetrati dalla Compagnia delle Indie e dagli emissari regi. Gli storici Toussaint e Scherer sono concordi in proposito: «Ils espéraient en effet obtenir que fut mis fin aux abus hérités du monopole de la Compagnie des Indes et souvent maintenus par les agents du roi, à la politique économique incohérente de ceux-ci […].»115. Di fatto, il nuovo governo sembrava appoggiare e sostenere i particolarismi, o meglio un tipo di organizzazione politica solidamente radicata nel territorio (nei due territori insulari) il cui successo poggiava sull’adesione e sulla complicità piena dei comuni che dividevano le isole. A un tipo di struttura centrale, vecchio regime, approssimativamente rappresentata sulle isole da un governatore cui facevano capo sedi distaccate delle divisioni militari dei quartieri piccoli e grandi (confusi politicamente con le amministrazioni parrocchiali), subentrò il governo di un’Assemblea Generale cui facevano riferimento due assemblee per i distretti a vento e sottovento (per la Réunion), ciascuno dei quali diviso in municipi (la Réunion passò da nove comuni a sei municipi). Rispetto alla riforma del 1767, questo sistema promosso dai repubblicani incoraggiava la partecipazione politica di tutti i cittadini che fossero maggiorenni e di cittadinanza francese116. 114 «Surtout, à partir de 1793, l’opinion publique se cliva en clubs rivaux: le 5 juin à Saint-Pierre, le 14 août à SaintDenis furent fondées des sociétés des «Amis de la Liberté et de l’Egalité», puis la «Société des Vrais Patriotes», toutes associations qui se mirent en relation avec la «Chaumière» de l’Île de France.», André Scherer, L’histoire de la Réunion, op. cit., p. 44. In accordo con Scherer, Edmond Maestri e Yvan Combeau, accennano all’esistenza di “la société des amis de l’ordre, qui a bientôt des ramifications à Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-André. La faction contre-révolutionnaire de Saint-André a l’appui du gouverneur Duplessis.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. 11. « […] au XVIIIe siècle, les premières loges maçonniques de l’Île, tout comme les consœurs mauriciennes, étaient d’obédience écossaise. La laïcité n’était pas à l’ordre du jour; ces loges étaient déistes. Rapidement et parallèlement à l’installation du régime napoléonien, la maçonnerie française se fit plus influente. », Henry Ravelojaona, Le rôle de la Franc-maçonnerie dans l’implantation de l’idée républicaine à Saint-Denis de la Réunion, 1867 – 1905, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 391. 115 André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 40. Auguste Toussaint in Histoire de l’île Maurice, si esprime con parole molto simili, op. cit., p. 61. 116 Urbain Lartin, L’institution des municipalités à l’île Bourbon sous la révolution, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 130. Questa nuova struttura, privilegiava la partecipazione collettiva alla politica delle isole a detrimento di un’amministrazione incentrata sul potere decisionale del singolo governatore: «Un gouverneur et un ordonnateur nommés par la Métropole administrent la colonie, mais leurs pouvoirs sont de plus en plus réduits.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., 11. 60 Se le scarse conoscenze del territorio dell’Oceano Indiano (ancora nel XX secolo, il Ministero delle Colonie avrebbe confuso la Réunion con una delle isole delle Antille) avevano costretto il nuovo governo a trattare le due isole come un’unica entità, la Réunion, dal canto suo, vedeva offrirsi, con il nuovo sistema politico, la possibilità di riscattarsi dall’indifferenza dei governi passati, nonché dalla sudditanza secolare dall’Île de France. Il commissario Bertrand, rappresentante creolo eletto dal popolo reunionese, si fece animatore e difensore in Francia della nuova Bourbon (Réunion nel 1793): colonia colonizzatrice (prima, della vecchia Île de France, come poi successivamente, del Madagascar117), regione distaccata della Francia, divulgatrice degli ideali rivoluzionari in Oriente118: […] c’est là une importante victoire pour Bourbon […]. Il [Bertrand] lutte en particulier pour maintenir la parité entre la représentation de son île et celle de l’Île de France. Non sans mal, tant la position subalterne de Bourbon dans l’ensemble insulaire des Mascareignes apparaît comme une sorte de postulat. «J’ai dû insister, écrit-il, pour que l’isle de Bourbon, dont la population blanche et noire et l’étendue du territoire excèdent beaucoup celles de l’isle de France, ait autant de députés que cette colonie.» […].119. Come fa, però, notare Toussaint, il sentimento rivoluzionario delle Mascarene, sebbene trincerato dietro gli ideali repubblicani, era piuttosto un tentativo di manovra politica per riorganizzare gli equilibri economici tra le colonie e la madrepatria120. L’episodio sanguinario di Macnamara, l’esilio forzato di Duplessis121, per quanto clamorosi, raccontano della breve storia del giacobinismo mauriziano e reunionese, che non riuscì mai 117 «Peupler l’Île de France était une nécessité […] le Conseil supérieur de Bourbon décida d’assigner à résidence dans la nouvelle colonie la plupart de ses indésirables […].», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 18. Così Maestri e Combeau raccontano delle aspirazioni colonialiste della Réunion, soprattutto le convinzioni dei Reunionesi di essere gli unici interpreti, gli unici detentori, tra le colonie francesi, dello spirito libertario e innovatore della Metropoli: «Elle dévient très vite une colonie qui défend la politique coloniale de la France, une colonie colonisatrice. Bourbon n’a pas encore commencé à structurer son économie qu’elle participe à la prise de possession définitive de l’île Maurice au nom du roi de France […]. Pendant la période révolutionnaire, les Réunionnais contribuent au peuplement des Seychelles. […] Sous la Restauration, Bourbon devient le centre de coordination des efforts de pénétration politique de la France à Madagascar. », Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., pp. 30 – 31. Per ulteriori notizie sulla conquista di Madagascar, Hubert Gerbeau et Edmond Maestri, Colonie décolonisée et «colonie colonisatrice»: Les échos de l’indépendance de Madagascar à la Réunion, in L’Afrique noire française: l’heure des indépendances, a cura di Charles-Robert Ageron e Marc Michel, op. cit., p. 609. 118 «Parmi toutes ces îles seule Bourbon fait figure de colonie européenne, bien que la peuplade disparate qui l’habite alors ne rappelle que d’assez loin l’Europe. », Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p.33. 119 Claude Wanquet, La première députation de la Réunion à l’Assemblée nationale, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 119. 120 «Quelques «jacobins» réunis en «clubs» ou «chaumière» essayèrent bien d’amorcer un mouvement «sans culottiste», mais ils ne furent pas suivis, la majorité des colons ayant des vues bien arrêtés sur le genre de liberté et d’égalité qu’on pouvait tolérer dans les îles esclavagistes. », Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p. 62. Il corsivo è mio. 121 Gli storici di Maurice sono concordi nel ritenere l’uccisione del governatore Macnamara la vicenda più grave della rivoluzione giacobina sulle isole Mascarene. Il governatore Conway (irlandese), d’accordo con il comandante della stazione navale Macnamara (irlandese) tentò di ostacolare la diffusione del movimento rivoluzionario organizzando una contro-rivoluzione: «les troupes ayant fait cause commune avec la majorité des colons, il dut s’avouer vaincu et quitter 61 veramente a radicarsi nella popolazione, perché di fatto marginale rispetto al potere e alla tradizione conservatrice locale. Nonostante all’Île de France la rivoluzione avesse assunto un carattere popolare, come la vicina Rèunion, si mostrò refrattaria alla promozione di quelle riforme che ne avrebbero minato la solida gerarchia dell’isola: «Au Port-Louis, le mouvement révolutionnaire prend un caractère populaire qui menace un moment de déborder ses premiers instigateurs, les notables, tout autant que les administrateurs. […] A Bourbon, la situation est très différente comme le souligne bien Cossigny: ce ne sont pas des étrangers à la colonie qui prônent l’insurrection, “ c’est au contraire toute la magistrature qui s’est mise à sa tête”.»122. A differenza di quanto accadeva alle Antille, il movimento giacobino delle Mascarene (più moderato che rivoluzionario), cercò sempre di mediare gli ideali repubblicani, la spinta rivoluzionaria e riformatrice di un Danton o di Marat, con la realtà politica ed economica delle isole. I giacobini delle isole combattevano piuttosto per un ridimensionamento del potere dei grandi proprietari, per un allargamento dei benefici economici, per una modernizzazione della politica e per la difesa dei diritti umani, la cui lotta per il miglioramento della condizione degli schiavi123 non doveva, in ogni modo, compromettere i fondamenti della società costituita. Seppure le notizie del movimento dei Franco-Creoli si hanno nella prima metà del XIX secolo, è lecito ritenere, quindi, che già alla fine del 700 l’organizzazione massonica che presiedeva le isole fosse mossa e strutturata sui medesimi ideali, fosse ugualmente ferma nell’osteggiare l’abolizione della schiavitù: l’île de France. Macnamara, quant à lui, fut massacré par les soldats. La «furie révolutionnaire» s’arrêta là, heureusement. » Ibid., p. 61. Duplessis, governatore reazionario, fu esiliato all’Île de France dai rappresentanti dell’Assemblea coloniale, per la maggior parte ancora giacobina: «cette dernière faction, contre-révolutionnaire, avait l’appui plus ou moins discret du gouverneur Duplessis, du commandant des Volontaires de Bourbon et de l’amiral Saint-Félix, ancien commandant en chef de l’escadre française de la mer des Indes. En avril 1794, La Chaumière de l’île de France obtint du gouverneur général Malartic l’arrestation et le transfert à l’île de France de Duplessis, du commandant […]. Accusés de royalisme, ils furent déférés à la Convention (ils furent plus tard acquittés par le Comité de Salut public). », André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., pp. 44 – 45. 122 Claude Wanquet, Histoire d’une Révolution: La Réunion, op. cit., p. 275. 123 Jackie Ryckebusch accenna a sua volta ai principi che vigilavano alla fondazione e all’organizzazione di ciascuna loggia, a solo uso della classe media che, contrariamente alla casta degli imprenditori terrieri, lottava per la difesa del diritto di autodeterminazione dei popoli, «il faut mettre en dehors des droits politiques les propriétaires et les trop petits propriétaires et neutraliser l’influence des grands […]», Jackie Ryckebusch, L’asssociation des Francs-Créoles, 1830 – 1833, Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 365. 62 «Par ailleurs le Franc-Créole considère l’esclavage comme un fait que le temps seul et les causes morales peuvent améliorer…(art. 10) / Toute loi ou règlement favorable à l’abolition serait dangereuse et “contraire à l’intérêt bien entendu des esclaves”.»124. Il perdurare del potere reazionario nell’indifferenza del Governo Repubblicano (impegnata a consolidare le conquiste politiche in Europa) fu, quindi, all’origine di gravi disordini, sedati per la maggior parte con il sangue. Lo sradicamento dell’albero della pace nella notte del 1794 a Saint-André (distretto conservatore) offrì l’occasione all’Assemblea coloniale di adoperarsi perché sull’isola i fenomeni di insofferenza e di insubordinazione dei conservatori fossero definitivamente arginati: il comune di Saint-André fu soppresso dopo che già la chiesa e il campanile erano stati distrutti125. * Motivo dell’inasprirsi della lotta tra conservatori e giacobini fu l’emanazione del decreto di abolizione della schiavitù promosso da Danton nel 1794. Le notizie allarmanti provenienti dalle Antille (dove la nuova risoluzione aveva dato origine a dure rivolte da parte degli schiavi), suggerirono al governatore Malartic di seguire un atteggiamento più prudente nelle isole dell’Oceano Indiano. Per non esasperare il già teso confronto civile, le isole sospesero ogni giudizio in merito al decreto, decidendo di ritardare l’attuazione del decreto per evitare qualsiasi reazione da parte francese e degli abitanti delle isole126. La convinzione che il governo repubblicano avesse dato maggiori poteri decisionali alle colonie, confortava i residenti della possibilità di protestare contro un decreto che avrebbe sancito la loro rovina. Un tale rigore non si faceva solo l’interprete delle paure di una parte della borghesia delle Mascarene (soprattutto i piccoli proprietari), manifestava piuttosto il dissenso delle isole verso un governo che, come i precedenti, si era macchiato di negligenza e di disinteresse nei confronti dei problemi economici e politici delle popolazioni locali che, invece, gli eventi del 1789, sembravano porre in maggiore evidenza e chiedere un’urgente risoluzione. Allo scoppio della rivoluzione francese, la monarchia inglese aveva, infatti, deciso di intensificare i suoi controlli nelle aree strategiche condivise con la Francia al fine di minarne la stabilità, costringendo, nel 1794, la Réunion e Maurice a decretare lo stato di assedio127. 124 Ibid. Il corsivo è mio. Urbain Lartin, L’institution des municipalités à l’île Bourbon sous la révolution, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 134. 126 André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., pp. 45 – 46. 127 «La présence de la flotte anglaise à proximité de l’île avait conduit l’Assemblée coloniale à proclamer l’état de siège le 7 mai 1794 et à décider les réquisitions d’armes, de vivres et d’hommes valides – tant les Blancs que les affranchis -, d’esclaves pour l’entretien des chemins et la construction de réduits sur les hauteurs pour servir de refuge aux femmes, 125 63 Le isole dovettero sperimentare in pochi anni gli effetti disastrosi del blocco navale: crisi della produzione, razionamento dei viveri esasperavano una già precaria condizione economica, per amplificare i dissensi popolari e le rivendicazioni giacobine. L’ostinazione della Metropoli nel voler attuato il decreto di abolizione e l’indifferenza da questa mostrata nei confronti dell’emergenza inglese nell’Oceano Indiano deteriorarono i rapporti tra la repubblica francese e i coloni delle Mascarene, che, nel 1796, disposero la chiusura dei porti agli emissari francesi, decretando di fatto la secessione delle isole dalla Francia128. La linea dura proclamata dalle isole non aiutò il governo giacobino della Réunion e di Maurice, minacciato, a un tempo, dagli Inglesi ma anche dal potere conservatore. Approfittando della visita del monarchico Jacob Cordemoy, nuovo commissario delle isole, il movimento reazionario del nord riuscì a destabilizzare l’influenza giacobina sull’isola della Réunion. Il terrore bianco, che seguì alla soppressione delle società popolari e alla persecuzione dei sanculotti, non solo ostacolava nuove manovre rivoluzionarie, vigilava soprattutto sull’eventualità che il fenomeno repubblicano fomentasse la rivolta degli schiavi come stava accadendo nelle Antille (ricordiamo che proprio in quegli anni nelle isole l’Assemblea era stata sostituita da un Direttorio). Nonostante le misure restrittive nei riguardi delle società riformiste, la crisi internazionale non favorì la politica dei conservatori, turbata dall’inasprimento dei contributi fiscali (come il decreto sulla confisca dei beni in caso di insolvenza), dall’ascesa al potere del generale Bonaparte (sicuro fautore di una linea oltranzista sull’abolizione della schiavitù), non ultimo dalla permanenza inglese sull’isola. Il 30 marzo del 1798, prendendo spunto dallo sbarco degli Inglesi sulle coste reunionesi, i distretti della regione sotto vento (da Saint-Pierre a Saint-Louis), notoriamente giacobini, insorsero contro il governo francese (accusato di aver venduto l’isola all’Inghilterra) e contro l’oligarchia dell’isola (colpevole di aver dilapidato i fondi). I tentativi di sedare la rivolta fallirono di fronte alla determinazione degli agitatori sudisti di destabilizzare il governo locale, roccaforte del potere monarchico reazionario129, forti del fatto che e aux enfants et aux vieillards.», Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, sous la direction d’Yvan Combeau et Edmond Maestri, op. cit., p. 12. 128 «Deux agents de la Convention, Baco et Brunel, envoyés en 1796 à l’île de France pour faire entendre raison aux “déviationnistes”, furent chassés ignominieusement. Malartic, impuissant, ne put intervenir. Bourbon – que la Convention avait rebaptisée île de la Réunion en 1793 – approuva sans réserves cette expulsion. Dès lors les îles se trouvèrent en rébellion ouverte contre la France. », Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p. 63. 129 «Le 25 pluviôse an VIII (13 février 1799) les habitants de Saint-Louis et de Saint-Paul essayèrent de provoquer un mouvement insurrectionnel parmi la garde nationale de Saint-Denis dans le but d’obtenir la dissolution de l’Assemblée coloniale formée à cette époque en grande partie de contre-révolutionnaires.», André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., pp. 47 – 48. Gli abolizionisti in realtà sono dei contro-reazionari convinti che poco ci fosse da fare contro il sistema schiavista, assertori a loro volta della necessità nelle isole Mascarene di un’economia basata sul lavoro coatto. Jackie Ryckebusch, L’association des Francs-Créoles, 1830 – 1833, Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 361 – 371. 64 nessuno sforzo era stato fatto e sarebbe stato fatto per cacciare gli Inglesi dall’isola. Sebbene i rivoltosi non avessero incontrato resistenze da parte della popolazione, ma al contrario si fossero convinti della possibilità di un coinvolgimento del nord conservatore alla guerra contro l’Inghilterra, nel 1799 subirono la rappresaglia del potere reazionario che, complice l’esercito, mise fine a un decennio di lotte intestine. Con l’esilio dei maggiori membri della società della Chaumière reunionese veniva rescisso l’ultimo legame con il governo francese (la rottura delineata nel 1796 diveniva in questo modo insanabile), soprattutto veniva rivendicata e sancita l’autonomia della Réunion dalla sudditanza secolare dall’Île de France. * Il periodo secessionista della Réunion viene generalmente illustrato dagli storici in poche righe. Al cospicuo numero di testi dedicati all’età rivoluzionaria (citati ripetutamente lungo tutto il nostro lavoro), risponde l’esigua traccia di una sterile cronologia di fatti e personaggi che non riescono ad emanciparsi dal racconto aneddotico. Nonostante nessun altro governo dell’isola si sarebbe mai più esposto a un tale atto di forza, la rivolta reunionese rimane per gli studiosi priva di attrattive e gli anni che vanno dal 1799 al 1802 l’ambizione di pochi Reunionesi130. Dopo la rivolta del sud, il partito conservatore si convinse che solo una separazione dalla Francia avrebbe salvaguardato l’isola da nuove minacce abolizioniste. Già dal 1798, la fazione dei conservatori si era fatta promotrice dell’indipendenza dalla Metropoli a prezzo del possibile assoggettamento alla nazione inglese: « “en cas d’insuccès appeler les Anglais pour s’assurer leur protection au prix même de leur domination”.»131. L’Île de France, dal canto suo, incredula di fronte la posizione della vicina Réunion, rinnovò, con poco successo (3 dicembre 1799, 23 gennaio 1800, 28 luglio 1800), i suoi tentativi di far rientrare la protesta dei conservatori in favore del ripristino di un governo repubblicano sull’isola. Nonostante il parere sfavorevole dell’Assemblea coloniale, malgrado le pressioni di Malartic, rappresentate della repubblica dell’Île de France, la Réunion, per voce del governatore Jacob, presentava nel marzo del 1800 la sua istanza di separazione dalla Francia. Simpatizzante della monarchia, Malartic non poteva non giudicare con inquietudine la conclusione del periodo repubblicano reunionese convinto che l’iniziativa separatista avrebbe 130 Se nel 1946 di fronte la possibilità di chiedere la separazione dalla Francia Lepervenche e Vergès si fecero sostenitori della departimentalizzazione, pochi anni dopo, 1959, il Partito Comunista Reunionese si sarebbe fatto promotore di una campagna in difesa dell’autonomia reunionese. 131 André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 47. Negli anni successivi al blocco, gli Inglesi si erano rivelati degli avversari tutt’altro che da disprezzare. Avevano dato più volte prova di un grosso senso dell’onore, comportandosi nei confronti dei militari reunionesi catturati nel pieno rispetto delle norme militari. 65 provocato la vendetta della Francia, governata ora dall’irruente Bonaparte, e attirato le mire inglesi in vista conflitto franco-americano132, allontanando la Réunion definitivamente dalla Francia. Nel 1801, la Commissione rappresentativa della Réunion abbandonava l’Assemblea coloniale dichiarando di fatto la sua disponibilità al governo francese: «L’Assemblée déclare que la volonté de la colonie est de point rompre les liens que, jusqu’à ce jour, l’ont inviolablement attachée à la France; mais elle déclare en même temps qu’elle n’adoptera jamais le décret du 16 pluviôse an II…et qu’elle repoussera tous les moyens.»133. Il breve periodo rivoluzionario separatista inaugurato dai Reunionesi nel XIX secolo sembra smentire qualsiasi familiarità con la rivolta di Santo Domingo, essendosi imposta, nell’Oceano Indiano, piuttosto come una sorta di controrivoluzione repubblicana. Non solo e non tanto per l’approccio e la realizzazione incerta dell’evento (la Réunion crollò alle insistenze della vicina Île de France solo dopo tre anni), quanto per lo spirito che mosse la rivoluzione. La secessione reunionese, come è stato accennato in precedenza, è figlia degli ideali repubblicani nella misura in cui questi furono orchestrati, negli anni rivoluzionari, dalla classe dirigente e dalla media borghesia (ovvero dalle classi conservatrici). Se nelle Antille gli ideali repubblicani mossero le coscienze e le azioni delle classi più deboli, come gli schiavi, alla Réunion non si registrarono fenomeni preoccupanti di marronnage, né tanto meno gli schiavi furono resi partecipi del cambiamento politico in atto. L’insurrezione reunionese può essere a pieno diritto considerata una rivoluzione dall’alto. Probabilmente, l’imbarazzo degli storici nell’affrontare un periodo così controverso e ambiguo deriva dalla difficoltà di riconoscere nella risoluzione politica della Réunion un atto secessionista. L’autodeterminazione sanciva l’intenzione della Réunion di veder riconosciuto e legittimato dalla Francia il ruolo politico esercitato nell’Oceano Indiano. La Réunion non si faceva, allora, promotrice dell’indipendenza dei popoli come i rivoltosi di Santo Domingo. Conscia della crisi tra Francia e Inghilterra che si andava consumando anche nei mari orientali, fiera detentrice del pensiero e del passato francese, agiva, piuttosto, secondo una precisa linea politica: costringere la Francia ad abbandonare la linea abolizionista. Nel 1803, Bonaparte, eletto imperatore di Francia, ristabilendo gli antichi privilegi coloniali, pose fine a qualsiasi timore delle isole di un’imminente e definitiva emancipazione degli schiavi e al ricatto separatista della Réunion. 132 Il 13 febbraio del 1800, Malartic venne a conoscenza della dichiarazione di guerra degli Stati Uniti in merito al controllo del territorio americano. Gli Stati Uniti essendo stati i maggiori sostenitori dell’economia delle Mascarene durante gli anni della rivoluzione francese e del blocco inglese, si imponeva una decisione: mettersi contro la Francia, o al contrario retrocedere dalle proprie posizioni e appoggiare il governo francese contro gli Americani. 133 André Scherer, Histoire de la Réunion, op. cit., p. 48. 66 Madagascar indipendente, l’insurrezione del 1947 «Attaque générale de Madagascar dans la nuit 29 au 30 mars – stop – Toutes précautions prises.»134 Il protettorato francese, rinnovato nel 1890, costringeva il Madagascar a capitolare. L’isolamento forzato a cui la Francia costringeva l’isola con il rafforzamento del blocco navale non poteva che indebolire ulteriormente l’economia del paese (incentrata negli ultimi tempi sul commercio con le potenze straniere), e rafforzare i dissensi delle popolazioni costiere, ora che l’Inghilterra, tacitamente consenziente alle mire espansionistiche francesi, non si faceva più garante della libertà del popolo malgascio, e in particolar modo della sovranità del governo Merina sulle altre etnie (il commercio e successivamente la diplomazia inglese avevano favorito l’emergere della potenza Merina alla fine del XVIII secolo). La conquista del Madagascar, consumatasi nel 1896 con il beneplacito delle nazioni europee, consacrata dalla neutralità inglese (che non considerava più la presenza francese una minaccia nell’Oceano Indiano), si affermava come un unicum rispetto alle imprese coloniali precedenti. Nonostante la Francia avesse mobilitato l’opinione pubblica in favore della colonizzazione, reclamando da un lato la necessità di sottrarre le popolazioni malgasce alla dittatura Merina e dall’altra avanzando la santità degli ideali repubblicani (che imponevano una campagna civilizzatrice sulla nazione malgascia per alcuni versi ancora primitiva), ugualmente l’impresa francese rimaneva una violazione del diritto internazionale, il Madagascar essendo stato riconosciuta una nazione libera e sovrana dalle maggiori potenze europee già nella seconda metà dell’Ottocento. Nel 1895, all’inizio della spedizione coloniale, i Francesi non potevano, quindi, che apparire agli occhi dei Malgasci degli usurpatori; così, l’esule regina del Madagascar, Ranavalona III esordì nel 1890: «Les Français devaient nous protéger, ils n’ont fait que nous piller.»135. Nulla fecero i Francesi per attirarsi i consensi della popolazione, soprattutto di quelle etnie che erano state liberate dal giogo Merina. La brama di veder assoggettata un’isola che dal XVII secolo si era sottratta al suo dominio, il bisogno di risollevare gli animi di una Nazione depredata 134 Jacques Tronchon, L’insurrection malgache de 1947, essai d’interprétation historique, Efa, Fianarantspa, 1982, p. 39 135 Jacques Tronchon, La Révolution française et Madagascar: arguments ou oripeaux d’une conquête, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p.481. 67 dell’Alsazia-Lorena, la sete di revanscismo136, dovettero convincere il governo francese della necessità di un intervento radicale, che, al compromesso di Gallieni137, favorisse la realizzazione di politica accentratrice, perché la società malgascia fosse sottratta alla sua storia per essere posta definitivamente sotto il controllo politico e culturale francese. I tentativi di assoggettare il popolo malgascio al potere francese, alienandolo dalla cultura e dalle tradizioni ancestrali, si rivelò fallimentare di fronte a una società che aveva negli anni maturato un profondo sentimento nazionale. Non solo, dalla sua fondazione, l’isola possedeva una lingua orale comune, condivisa da tutte le etnie nonostante le differenze dialettali, ma, dal XIX secolo, grazie alla riforma linguistica e scolare di Radama I, e all’installazione di una tipografia, l’isola aveva avviato una copiosa produzione di testi scritti e di riviste, consacrando così la tradizione orale di alcune etnie all’eternità della memoria collettiva. Gli ideali rivoluzionari del 1789, di cui la Francia si faceva promotrice con la sua conquista, erano oltretutto penetrati e si erano diffusi in Madagascar già nella seconda metà del XIX secolo per mezzo di Laborde, consigliere del giovane re Radama II. Non solo il Codice dei 305 articoli redatto nel 1894138, che riformava e informava la società malgascia su regole civili e penali, era direttamente ispirato al Codice Napoleonico, soprattutto la presenza sull’isola di diverse società segrete, laiche e religiose, di discendenza massonica139 136 «En 1895 la campagne de Madagascar fut, à l’encontre des autres guerres coloniales, extrêmement populaire […] le corps expéditionnaire avait la mission de délivrer des populations asservies. L’expédition avait donc pour but non plus la mainmise de la France sur l’Île, mais la libération des Malgaches opprimés. […] Souvent décrite comme un Eden ou un Eldorado, elle est en vertu des «droits historiques» qui remontent à Louis XIV, la «France Orientale», province ultramarine qu’il faut non pas conquérir mais reconquérir. […] Et surtout, prétendre à la fois apporter la liberté et appliquer le droit, n’est-ce pas conforter singulièrement la thèse classique d’une mission civilisatrice […]? […] L’obsession de la Revanche est alors si forte dans l’inconscient collectif qu’elle rend les représentations plus complexes et plus floues.», Guy Jacob, La campagne de Madagascar et l’image de la France libératrice, Ibid., p. 455. Soprattutto i Reunionesi incoraggiavano la conquista del Madagascar da parte francese al fine di consolidare le colonie già istituite sull’isola. Per buona parte del XVIII secolo, la popolazione Merina, il regno di Radama I, e di Ranavalona I, avevano rappresentato una minaccia per il commercio dei coloni francesi (per lo più creoli reunionesi), era necessario, quindi, arginare la potenza Merina a vantaggio di una espansione franco-reunionese sul Madagascar: «L’île tente de résoudre de graves problèmes d’alimentation en viande, en céréales; la croissance de la grande propriété sucrière condamne les petits exploitants. Les tensions sociales sont, dès 1863, particulièrement angoissantes. Aussi propose-t-on aux jeunes Créoles «un nouveau monde à exploiter» sous l’égide de «Christophe Colomb et Vasco de Gama» […] trouveront les perspectives de ces grandes fortunes si faciles à réaliser dans les pays vierges”.». Françoise RaisonJourde, La rumeur lointaine de l’événement…La Révolution Française comme référence et comme métaphore pour l’interprétation du XXe siècle Merina, 1810 – 1865, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 451. 137 «Gallieni avait indiqué deux directions possibles: 1- la “politique des races” et des protectorats intérieurs, au moins dans le premier stade; 2- la politique d’assimilation pour l’avenir, au mois pour le Merina. La première tomba rapidement en ruines: la centralisation, manie française, fit de Tananarive le centre unique de la vie administrative […]. Quant à l’assimilation, il ne fut fait de pas en ce sens que par la reconnaissance […] d’accession des Malgaches aux droits des citoyens sur la demande individuelle.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., pp. 259 – 260. 138 «Dès 1868 parut le Code des 101 articles, puis, en 1881, le Code de 305 articles, législation novatrice, touchant à la fois le droit civil, le droit pénal, la procédure.», Ibid., p. 179. 139 «À Madagascar, au cours de la période ici étudiée, existent deux loges rattachées à la Grande Loge de France, «l’Imerina» à Tananarive, fondée en 1890, et «Les Trois Frères» à Majunga, fondée en 1910 […].», Daniel Ligou, Dictionnaire Universel de la Franc-maçonnerie, seconde édition, Paris, PUF, 1913, p. 1312. C’è da dire che dopo la 68 dimostravano, e avrebbero dimostrato nei primi decenni del Novecento, la partecipazione sollecita dei Malgasci alla modernizzazione e alla difesa della loro patria: l’esistenza di una coscienza civile140. La conquista francese, che chiudeva una serie di trattati e di protettorati nonché anni in cui si erano succedute alle lotte intestine, l’autarchia e le persecuzioni di Ranavalona I, apriva, ora, poco più di un secolo di rivolte e di contestazioni placatesi solo con l’indipendenza del 1960. L’accentramento del potere amministrativo e istituzionale verso la capitale aveva favorito la modernizzazione di Tananarive e delle città a lei prossime, sottraendo le popolazioni delle zone periferiche del Madagascar allo sviluppo. La realtà coloniale si presentava così non molto diversa dal precedente governo Merina. Come al tempo di Radama I e II, il centro si mostrava sensibile alle mode e alle tradizioni occidentali, mentre le zone costiere e il sud si chiudevano vieppiù nella difesa delle loro tradizioni ancestrali. A dispetto di una politica razziale, che avrebbe dovuto avvantaggiare l’etnia Betsileo o Sakalava rispetto alla Merina141, gli Hova, la classe dirigente Merina come agli inizi dell’Ottocento, continuarono a ricoprire anche sotto il regime francese le cariche di alcuni uffici amministrativi facendosi mediatori tra il colonizzatore straniero e le popolazioni malgasce142. Le popolazioni periferiche, che gli illuminati politici francesi avevano indicato come il motivo di una guerra civilizzatrice, non beneficiarono, invece, della conquista interpretando l’invasione francese come la punizione degli avi verso una nazione143 che, da tempo, aveva venduto le memorie conquista francese, le logge massoniche si divisero in due grossi blocchi, quelle frequentate dai grandi funzionari legati al regime coloniale, quelle sostenute da piccoli burocrati e, in generale, da una parte della popolazione malgascia. 140 «The French brought in a series of law […] a blanket interdiction of all discussion of local politics; and the banning of meetings other than family and traditional gathering […]. These laws made a constitution of openly political organizations […]. The movements also used non-political organizations as vehicles, and the French suspicion that the Protestant parishes were hotbeds of ‘subversion’ had considerable basis in fact. », Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, London, Frances Printer, 1987, p. 23. 141 Guy Jacob, La campagne de Madagascar et l’image de la France libératrice, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 456 – 458. 142 «Or si l’on confronte le mythe à la réalité des faits, on ne peut que constater que la «caste Hova» dont il est question s’empresse de donner à l’occupant des gages de fidélité dès que l’insurrection éclate. Cette attitude n’est pas nouvelle. Nous la trouvons déjà en 1896 lorsque Rasanjy, qui a derrière lui une grande partie des hautes classes merina, propose ses services à l’occupant. […] A partir de 1909, beaucoup de “Hova”, […] donnent leur caution au système colonial en adoptant la citoyenneté française. En définitive si la France parvient à s’installer durablement à Madagascar, elle le doit en partie à la collaboration de la plupart de ces “Hova”.», Jacques Tronchon, L’insurrection malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., pp. 87 - 88. « […] le programme de l’ A.C.F.O.M. se situe en marge du mouvement de libération nationale. En réalité, du fait qu’elle constitue alors la seule association malgache, légalement reconnue, bien organisée et agissante dans le domaine politique, l’A.C.F.O.M. est souvent amenée à jouer le rôle de trait d’union entre l’occupant français et les patriotes malgaches.», Ibid., p. 26. 143 «De ceux-ci l’identité associe l’attachement à la terre des ancêtres (le tanindrazana) — et à la grande famille — aux représentations d’un passé insulaire — historique et mythique — et la solidarité face à l’étranger […]. Entre “patriotisme” et “attachement au tanindrazana”, dont les Européens tendent à faire des synonymes, la distance est en réalité celle, non seulement de deux passés, mais de deux visions du monde, car “patriotisme” renvoie les Français à une nation idéalisée, symbolisée par un drapeau et la Marianne, vague déité sans culte véritable dont l’image est vulgarisée, et tanindrazana à des réalités quotidiennes.», Yvan G. Paillard, Les avatars de la “Grande Nation” à 69 di un popolo antico ai Vazaha, agli stranieri. Non solo i popoli ostili al governo Merina, fino a tutto il 1904, si mostrarono indomiti verso il governo francese, ma grossa parte delle popolazioni assoggettate si chiuse all’assimilazione culturale del colonizzatore, mostrandosi con l’inerzia e la passività, da subito, contraria all’attuazione di qualsiasi nuova riforma che andasse a inficiare le tradizioni e leggi degli antichi: «At the village level there was both tacit and overt resistance to intrusions of state power, while the cities, and particularly among the educated, there were demands first for inclusion in the state power to Malagasy hands. (…) The role of inertia as passive resistance, the role of maintaining newly illegal traditional practices such as cattle-raiding and tanety culture, and the retreat into the cult of ancestors all had an element of resistance to them.»144. Se le cronache di inizio secolo raccontano di un Madagascar facilmente assoggettato e sostanzialmente amichevole, documenti recenti provano come i Francesi dovettero confrontarsi con una nazione ripetutamente in rivolta. Lo scarto tra le condizioni della popolazione e degli amministratori e coloni francesi, la disparità negli insegnamenti scolastici e nell’accesso alle cariche di governo dovette aggravare il risentimento e la disapprovazione verso il governo invasore. Nel 1915 un gruppo di studenti in medicina, istitutori e membri delle missioni fondava la società segreta V.V.S (Vy Vato sakelika, ovvero Divisione Fer Pierre) perché attraverso la propaganda della rivolta la popolazione potesse armarsi per un Madagascar libero. Nonostante la società fosse dissolta dal governo un anno dopo la sua fondazione145, essa aveva rappresentato, per il popolo malgascio, la nascita verso un pensiero politico affrancato dall’indottrinamento coloniale. Pochi anni dopo, Jean Ralaimongo, fondatore nel 1924 della Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar aux droits de citoyens français, nel farsi promotore della departimentalizzazione del Madagascar, denunciava gli abusi dei coloni e dell’amministrazione francese nell’espropriazione delle terre malgasce. La rivista, L’Opinion, di cui Ralaimongo era responsabile, offrì, ancora una volta, l’occasione a comunisti come Vittori e Planque di dare vita a un movimento contestatario i cui ideali avrebbero preso forma nella manifestazione del 1929. La dura reazione del governo francese, convinta che fosse possibile arginare il nascente fenomeno politico e rivoluzionario malgascio con arresti e punizioni esemplari, ebbe come effetto l’inasprirsi della lotta e delle posizioni politiche: nessun altro partito fondato dopo il 1929 avrebbe più barattato la libertà con la dipatimentalizzazione: «Les groupements de gauche locaux réclamaient la Madagascar de 1895 à 1914, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 468. 144 Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 22. 145 «L’opinion européenne n’en fut pas moins affolée; on parlait d’un complot à direction allemande, de tonneaux de poison et de poudres découverts pour tuer tous les Européens. On réclamait l’état de siège et des sanctions exemplaires.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p 259. 70 suppression de l’indigénat, l’application intégrale des lois françaises, l’accession de tous aux droits de citoyens», consci del fatto che un consistente movimento popolare e operaio si andava formando nelle città. Il Secondo Conflitto Mondiale doveva però sospendere questo movimento riformatore che, animato da un acerbo eppure già vivace dibattito politico, era riuscito nel 1939 a indire le prime elezioni pubbliche di un rappresentate malgascio al Consiglio Superiore delle Colonie. * Come la Réunion, il Madagascar non fu inizialmente coinvolto nel Conflitto. La partecipazione dell’isola si era limitata al reclutamento di soldati e al contributo sostanzioso in generi alimentari. Il cambiamento al vertice del 1940, l’instaurazione del regime di Vichy doveva però sottrarre i Malgasci dal loro precario equilibrio, spingendoli negli austeri e difficili anni dell’isolamento: del blocco delle esportazioni e delle importazioni, delle ristrettezze economiche, del razionamento dei viveri. Se il perdurare della tradizione fahaleovan – tena 146, dell’autosostentamento147, aveva in un primo tempo aiutato le popolazioni del luogo a sopravvivere a una tale situazione, le misure prese dalla Francia Libera nel 1943 precipitarono, invece, il Madagascar in una reale depressione finanziaria, con la costituzione de l’Office du Riz, preposto al controllo e alla distribuzione del riso, che avvantaggiava le industrie risiere ai danni della popolazione, costretta a cedere all’ufficio l’intero raccolto. La difficoltà di riacquistare la stessa materia prima sul mercato, favorì la diffusione dei traffici illeciti, per lo più gestiti dagli stranieri, con la conseguenza di un impoverimento ulteriore della società malgascia. Il continuo stato di incertezza che ispirava la guerra, inasprì la posizione francese verso gli indigeni. L’apparente distensione raggiunta nel 1939 fu velocemente abbandonata per paura di nuove insurrezioni, ora difficilmente arginabili. Non solo fu ripristinato e rafforzato il regime di indigenato, ma le città furono poste sotto assedio, la popolazione costretta a orari lavorativi logoranti, che l’emergenza del conflitto non giustificava: «[…] véritablement arrachés à leurs terres, beaucoup des paysans ne trouvent plus la possibilité de les cultiver et sont alors dans l’obligation paradoxale d’acheter le quota de riz requis par l’administration.»148. 146 « […] fokon’olona (conseil de village) en favorisant l’autonomie (fahaleovan – tena); les villages étaient encouragés à conclure des conventions (fanakena) pour assurer la police, l’hygiène et l’assistance sociale.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 180. 147 « […] le pays vivait sur lui-même, non sans difficultés du fait de l’arrêt des importations et du manque d’essence pour les communications intérieures. Deux circonstances le sauvèrent de l’asphyxie totale: 1° les avances sur les stocks de produits d’exportation consenties par les banques avec garantie de l’Etat; la survivance des habitudes d’économie traditionnelle […]; chaque famille recommença ou continua à fabriquer ses habits et ses ustensiles et à produire son alimentation.», Ibid., p. 263. 148 Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., p. 123. 71 L’istituzione dell’Office du Riz, il ripristino delle corvée, la dichiarata speculazione perpetrata da entrambe ai danni della popolazione risvegliarono il malcontento e le rivendicazioni sopiti dal 1939. Le aspirazioni indipendentiste e revansciste delle popolazioni malgasce sembravano trovare terreno fertile nelle circostanze storiche venutesi a creare dopo il 1942, allorché gli Inglesi, con il pretesto di bloccare le operazioni giapponesi nell’Oceano Indiano, presero possesso dell’isola dichiarando Tananarive città aperta nel 1943 (anche durante la rivoluzione del 1947 i Malgasci non avrebbero smesso di credere nell’aiuto americano o inglese per sottrarsi dal giogo francese). Pur non avendo mutato gli equilibri politici dell’area orientale (l’isola fu riconsegnata al Governo provvisorio di De Gaulle nei mesi successivi), la vittoria inglese sui Francesi aveva avuto il merito di risvegliare la coscienza politica e combattente di una popolazione che, pur restia alla sottomissione, dopo il 1910, sembrava essersi convinta della superiorità militare del colonizzatore. Nel 1943 a Tamatave riprendeva, così, la propaganda della società segreta PA.NA.MA. (Partito Nazionalsocialista Malgascio, fondato nel 1941 da Lucien Andriamiseza) contro il regime coloniale francese. Convinti sostenitori della lotta armata, gli associati del PA.NA.MA. avevano approfittato degli anni della dittatura di Vichy per diffondere, nella clandestinità, il loro messaggio rivoluzionario, perché i giovani di tutte le etnie e di tutte le regioni malgasce potessero essere formati «idéologiquement […], les organiser et les entrainer à la lutte politique»149. Nel 1943 riprendeva anche la pubblicazione di riviste e saggi di matrice politicoinsurrezionalista. «Mafohaza (Réveillez Vous)», «Kofehy Volamena» (Fil d’Or), «La Nation Malgache», incoraggiati dalla presenza inglese, ma soprattutto dal nuovo governo francese appena installato sull’isola e già sostenitore di un nuovo corso storico franco-malgascio150, promuovevano infaticabili il recupero della cultura e dell’identità malgascia fin nelle lontane campagne, per riunire in un unico appello rivoluzionario anche quei Malgasci esiliati, o semplici studenti, nelle recondite regioni francesi. La certezza che i tempi fossero maturi per una radicale trasformazione dei rapporti con la potenza francese sembrava suffragata dal nuovo orientamento politico internazionale. Nel 1941 con la Carta Atlantica e poi nel 1946 a Los Angeles le potenze mondiali, tra cui la Francia, ratificavano e sottoscrivevano un documento nel quale era garantita a tutti i popoli la libertà di Di seguito: «Les malversations de l’Office du Riz sont un aspect du marché noir pratiqué alors dans toutes les régions de Madagascar, et à tous les échelons de la société coloniale. Depuis 1943, les cotonnades sont à nouveaux utilisés comme moyen de troc par les compagnies d’import-export. Les marges bénéficiaires sur ces articles sont portées à 22%. […] Bref, alors que la masse s’appauvrit de manière accélérée, certains trafiquants, le plus souvent étrangers, bâtissent en quelques années des fortunes aussi artificielles qu’exorbitants.», Ibid., pp. 124 – 125. 149 Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., pp. 23 – 24. 150 «Le malentendu commende avec le voyage de René Pléven en décembre 1943 à Tananarive. Le délégué de la France Libre a choisi l’enceinte sacrée de Mahamasina […] pour annoncer à la foule […] qu’une ère nouvelle allait être inaugurée par la France. La «commission mixte franco-malgache» mise en place aussitôt après son passage fut comprise par les membres malgaches comme une table ronde où serait élaboré le futur statut de Madagascar.», Ibid, p. 125, 72 autodeterminazione: «Les Nations-Unies reconnaissent l’égalité de droit de tous les hommes et acceptent d’assurer leur bien. […] Elles reconnaissent la nécessité de donner l’indépendance aux peuples qui sont capables de se gouverner eux-mêmes. […].»151. La dichiarazione di Los Angeles sembrava trovare conferma nell’accordo Sainteny stipulato agli inizi del 1946 tra Francia e Indocina, per una liberazione pacifica del Vietnam, a cui si aggiungevano le parole incoraggianti dell’Assemblea costituente152 che aprivano nuove prospettive per la situazione malgascia: «L’accord Sainteny – Ho-Chi-Minh conclu le 6 mars 1946 apparaît comme un premier acte de libération pacifique du Vietnam, et prend une valeur exemplaire pour les députes malgaches. Ceux-ci déposent peu après sur le bureau de l’Assemblée, leur projet de loi en vue de l’indépendance malgache. »153. L’attesa, già vibrante, trascese al ritorno dei soldati magasci dal fronte. Accolti dai connazionali come eroi, i militari rappresentavano per i coloni francesi una minaccia154. Non solo la partecipazione alla guerra con uomini e viveri avrebbe potuto dare diritto al Madagascar di rivendicare, come indennizzo del suo intervento coatto, la definitiva liberazione dalla servitù coloniale, soprattutto, il ritorno in patria di quanti avevano avuto modo di avvicinarsi alle teorie radicali del Comunismo sovietico faceva paventare agli amministratori francesi il pericolo di una rivoluzione rossa. La disponibilità palesata dal Governo provvisorio venne meno, quindi, nel 1946, alla fine del conflitto. Le difficoltà economiche unite all’urgenza di ricostruire la Nazione francese, sia fisicamente che politicamente, costringevano la Metropoli a sospendere gli accordi del 1939, facendo piombare l’isola nel collasso delle infrastrutture155, mentre, i nuovi equilibri internazionali convincevano buona parte degli amministratori e dell’opinione pubblica francese residente in Madagascar della necessità di promuovere nuovamente una politica autoritaria: «Mécontents des libertés reconnues aux Malgaches par la IV République, beaucoup de colons souhaitaient le rétablissement d’un régime fort qui, selon certains, ne pouvait échoir qu’à un militaire. Les proconsulats du général Gallieni et, plus récemment, du général Legentilhomme […] étaient présentés comme des modèles à suivre. »156. 151 Ibid., p. 134. «C’est l’heure de la décision: ou nous donnerons satisfaction aux aspirations légitimes de ces populations (d’outremer) ou il faudra nous résigner à les voir s’éloigner. », Ibid., p. 127. 153 Ibid. 154 «Ce que je sais bien, c’est le sentiment, nouveau alors, que j’ai éprouvé à la vue de ces troupes à leur débarquement: la haine, le mépris, la détermination transpiraient de tout leur être. Visiblement, ils n’attendaient que le signal de “l’heure H”.», Ibid. p. 121, nota 5. 155 «Les travaux publics, les routes, les plantations étaient désorganisés par le manque de main-d’œuvre. Les colons français se plaignaient d’être abandonnés et prédisaient les catastrophes. », Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p 265. 156 Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., p. 111, nota 51. 152 73 La reazione di chiusura dimostrata dalla IV Repubblica doveva apparire alla popolazione malgascia come l’implicita dichiarazione francese di mantenere sull’isola il regime coloniale157. I sentimenti traditi del popolo malgascio esplosero, allora, in nuove più energiche proteste nel 1946158, l’insuccesso delle quali ribadì la necessità di un’azione politica estesa su tutto il territorio la cui lotta contro il conquistatore si concretasse nella realizzazione di un programma di ricostruzione della nazione e dell’identità malgascia e si facesse promotrice di una politica direttamente ispirata all’antica tradizione fokon’olona159. Il M.D.M.R. (Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache), il PA.DES.M. (Parti des Déshérités de Madagascar), il P.D.M. (Parti Démocratique Malgache) movimento politico di matrice borghese protestante, il M.S.M (Mouvement Social malgache) di ispirazione cattolica furono costituiti nel 1946 sulla base e sull’impulso di queste nuove aspirazioni. A differenza del PA.DES.M. e del M.D.R.M., i due partiti di matrice confessionale rimasero in minoranza non essendo riusciti a riscuotere grandi consensi da parte della popolazione. La rivolta malgascia, che la colonizzazione dell’isola non era riuscita a fiaccare, prendeva nuovo impulso dalla difesa della tradizione nutrendosi di un passato, ormai mitizzato: del glorioso e illuminato regno Merina, dell’indomita fierezza dei Sakalava, della conciliante saggezza dei Betsileo e nel rifiuto della cultura occidentale; viveva nella legge della comunità, fokon’olona, del Kabary, confidava nell’autorità degli antichi. Fondato da Raseta e Ravoahangy, con il concorso ideologico del sacerdote Dunan, di RaymondWilliam Rabemananjara e dell’intellettuale Jacques Rabemananjara, il partito di rinnovazione malgascia si fece subito promotore di un’azione mirata alla risoluzione dei problemi del Madagascar del dopoguerra. Questi combattenti ritenevano fondamentale unire la rivendicazione del Madagascar libero a una riorganizzazione politica, civile, culturale ed economica del territorio. Come ebbe a dire Raymond-William Rabemananjara, «Le M.D.R.M. n’avait rien d’un parti dans la nation, c’était la nation elle-même, tout le pays réel.»160. Dal 1946, il M.D.M.R. si impose come organo sostitutivo dei sindacati, impegnato a realizzare e gestire cooperative, a collocare manodopera, a farsi mediatore tra la classe dirigente e i lavoratori, 157 .«Si la France de la Libération a admis le principe du dialogue avec les Malgaches, celle de la IV République se voit contrainte de privilégier d’autres impératifs: les intérêts de ses colons […], le maintient stratégique de Madagascar dans le camp occidental […], et d’une manière générale la détermination de certains milieux français, militaire ou hommes d’affaires, à garantir leur situation privilégiée dans cette zone de l’Océan Indien. », Ibid., pp. 30 – 31. 158 «L’arrivée massive en août, de près de 8000 tirailleurs provoqua chez l’occupant une réaction de peur et donna lieu à de graves incidents. Des rixes éclatèrent ici et là prenant parfois l’allure […] de véritables pogroms. […] les soldats eurent la désagréable surprise d’être renvoyés discrètement dans leurs foyers, avec une prime de démobilisation dérisoire. », Ibid., pp. 121 – 122. 159 Cfr. p. 9 presente testo. 160 Ibid., p. 30. 74 tanto da costringere la stessa amministrazione coloniale a negoziare con gli aderenti al partito per disporre di operai all’epoca della ricostruzione del Madagascar. Di tutt’altro contenuto il ruolo svolto dal PA.DES.M. La convinzione che il movimento di rinnovazione malgascia fosse animato dagli eredi della casta Merina, portò alcuni rappresentanti delle etnie costiere ad unirsi in vista di una nuova possibile affermazione del popolo Merina sulle altre minoranze malgasce. Contro il mito dei re Merina, i diseredati del Madagascar, discendenti di quei popoli assoggettati e resi schiavi dagli Hova, rivendicavano, ora, una partecipazione al governo della colonia malgascia, offrendosi, quindi, al colonizzatore come il giusto mediatore tra una politica radicale sovversiva come quella del M.D.M.R., e un’amministrazione conservatrice auspicata dai coloni francesi. Dopo la deposizione nel 1946 della richiesta di liberazione del Madagascar, sulla base della convenzione ratificata a san Francisco, «Etat libre, ayant son gouvenement, son parlement, son armée, ses finances au sein de l’Union française»161, a vent’anni di distanza dalla proposta di Jean Ralaimongo, la IV Repubblica decise di dotare il Madagascar di uno statuto speciale all’interno del territorio francese. Le cinque province in cui veniva ora divisa l’isola permettevano alla popolazione malgascia di eleggere i propri rappresentanti all’Assemblea rappresentativa di Tananarive, nonché di disporre di un piano finanziario, di gestire finanziamenti mirati alla risoluzione di problemi specifici del territorio. Alle prime elezioni, la coalizione di Raseta e Ravoahangy ottenne la maggioranza dei seggi, Rabemananjara fu eletto per la costa est, Raseta per la costa ovest. L’appoggio del governo francese al PA.DES.M. si mostrò in tutta evidenza alle elezioni provinciali del gennaio del 1947, quando in seguito alla schiacciante vittoria conseguita dal movimento di Raseta (che all’occasione riportò la totalità dei seggi), gli esponenti del governo francese decisero di modificare in extremis il sistema elettorale dall’unico al doppio turno; la sollecita correzione del sistema avrebbe permesso ai candidati del PA.DES.M., che concorrevano con i deputati europei, di ridurre in minoranza il M.D.R.M. almeno in tre dipartimenti su cinque. Questo ultimo atto intimidatorio della Francia nei confronti della libera nazione del Madagascar riportò alla luce allo stesso tempo i rancori della popolazione malgascia e i sentimenti di rivolta delle società segrete PA.NA.MA e Jina. La contestazione raggiunse, a un tempo, gli organi di stampa ufficiale del M.D.R.M. istigatori della ribellione e la redazione del PA.DES.M. promotrice, invece, della guerra civile. In aggiunta, le parole feroci contro l’invasore francese gridate da Rabemananjara alla sua presentazione ufficiale nel distretto est, persuasero le società segrete dell’appoggio politico del M.D.M.R. per qualsiasi iniziativa insurrezionale. 161 Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 265. 75 La notte tra il 29 e il 30 marzo del 1947 vari centri del Madagascar si univano alla rivolta contro i Vazaha (gli stranieri) francesi. * Garder calme et sang-froid absolu devant les manœuvres et provocations de toute nature destinées à provoquer troubles dans sein population malgache et à saboter la politique pacifique M.D.M.R.162. Nonostante il 27 marzo con un comunicato, i membri del movimento di rinnovazione malgascia avessero manifestato le loro riserve su una possibile sommossa armata, la rivolta doveva comunque scoppiare nei giorni successivi. Per quanto tutto facesse temere un’insurrezione coordinata dei cinque distretti malgasci, nei fatti, solo la zona est del Madagascar insorse. I territori conquistati e consolidati servirono come basi per espandersi verso le altre regioni. Con il supporto e la preparazione dei generali, in pochi mesi, la costa est era stata dotata di diversi governi provvisori ispirati alla tradizione malgascia, tra i quali si distinsero, Victorien Razafindrabe a nord, Michel Radaoroson a sud. Per un maggiore e decisivo successo delle operazioni i ribelli posero il Madagascar sotto assedio. Bloccati i porti, recisi i fili del telefono, rese impraticabili le vie di comunicazione interne, l’isola chiudeva i pochi Francesi accorsi a sedare la rivolta in una trincea difficilmente espugnabile163. Nonostante dal 1946 il governo avesse temuto rappresaglie da parte dei Malgasci, e dal 46 avesse predisposto un consolidamento militare delle zone più a rischio164, come Tananarive, i Francesi si mostrarono comunque impreparati, soprattutto incapaci di reagire e di soffocare prontamente la rivolta. Approfittando dell’arrivo della stagione delle piogge, e quindi della difficoltà dell’esercito francese di sferrare il contrattacco, i rivoluzionari riuscirono a mantenere le loro posizioni fino al 1948. Causa la scarsità dei moderni mezzi di comunicazione a disposizione, per le asperità del territorio ricco di vegetazione, che rendeva malagevoli i collegamenti tra le varie basi, soprattutto 162 Ibid., p. 267 «Lorsqu’il s’agit de pousser les incursions en forêt, les troupes se déplacent difficilement, et le moral des soldats est rapidement atteint. Les contraintes climatiques viennent ajouter aux difficultés du terrain et au qui-vive incessant suscité par l’adversaire. En outre, la résistance physique des soldats est diminuée par le paludisme, la dysenterie, les maladies vénériennes […] qui sévissent dans ces régions à l’état endémique. […] Contrairement aux prévisions initiales des autorités françaises, la répression militaire de l’insurrection malgache se révèle longue et coûteuse. […].», Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., pp. 61 – 63. 164 «Dès la fin de novembre 1946, celles-ci se trouvent sur le qui-vive. A plusieurs reprises, des forces de l’ordre sont sévèrement molestées par la population. Le 29 novembre 1946, entre Ifanadiana et Androrangavola, le 31 janvier à Marolambo, l’incident tourne à l’émeute. Le chef de district de Mahanoro estime qu’il s’agit là d’une «rébellion (qui) semble avoir éclaté prématurément […].».”, Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., p. 37. 163 76 per la presenza del blocco navale a paralizzare e nullificare qualsiasi contatto con le nazioni esterne (ad esempio gli Stati Uniti) i ribelli si trovarono, però, non solo nell’impossibilità di estendere le loro conquiste ma soprattutto nell’incapacità successiva di difendersi contro i potenziati reparti militari francesi, al punto che il ritorno della stagione secca invertì, difatti, le sorti della lotta armata. Con l’ausilio dei reparti senegalesi, i Francesi in pochi mesi respinsero i rivoltosi verso le fitte boscaglie per lasciarli morire, braccati, di stenti o per le ferite riportate. Nel dicembre del 1948 la rivolta definitivamente sedata e gli ultimi gruppi di insorti finalmente dispersi lasciava sul territorio malgascio 11200 morti, tra vittime dell’insurrezione e della repressione, accanto ai quali si levavano numerosi i morti francesi, soldati vittime della malaria e civili martiri dell’esaltazione sanguinaria dei ribelli:«le Bas-Faraony et la région d’Ambilo sont embrasés par la guerre, avec son cortège de violences habituelles: meurtres, pillages, incendies.»165. Capri espiatori dell’insurrezione divennero i rappresentanti del M.D.M.R.. Nonostante Raseta si trovasse all’estero e gli altri avessero dimostrato la loro estraneità agli eventi con il telegramma del 27 marzo, il governo francese approfittò della situazione per sciogliere il partito e perseguitare, arrestare, condannare a morte o all’ergastolo gli aderenti al movimento di rinnovazione malgascia, ben prima che l’insurrezione fosse sedata166. Non solo la collaborazione alle operazioni militari di alcuni seguaci di Raseta rafforzava la tesi della compromissione del partito con le frange estremiste dello PA.NA.MA. e dello Jina, soprattutto la convinzione che gli aderenti al partito fossero simpatizzanti o discendenti Hova (ricordiamo invece che molti degli esponenti appartenevano all’etnia Betsileo) sembrava avvalorare in modo incontrovertibile la teoria del tentato sabotaggio della politica francese da parte dei nostalgici Merina. Già agli inizi della rivolta, nel 1947, dopo le rappresaglie del governo francese, il movimento di rinnovazione malgascia veniva smembrato per diventare il B.M.T.T. (Bureau des Patriotes Malgaches), perché la politica meno estremista del nuovo movimento potesse convincere i Francesi della neutralità del partito nei confronti degli eventi rivoluzionari. Ciò non di meno, l’atteggiamento del M.D.R.M. rimase ambiguo se non di adesione, certamente non di aperta condanna all’insurrezione, facendo supporre che ci fosse in realtà l’implicito accordo dei parlamentari e dei membri del partito perché il loro coinvolgimento con le società segrete potesse legittimare la lotta armata: « Ce qui importe, c’est de faire fonctionner notre mouvement d’une façon parfaite, car il a été le premier fondé […]. Ce que nous pouvons faire en pénétrant des partis politiques, c’est de 165 Ibid., p. 42. «Le lendemain, 1 avril, le Haut-commissaire reçoit Ravoahangy, Rabemananjara et Raherivelo. […] Leur démarche est même jugée suspecte et incongrue. Pour l’occupant, l’arrêt de mort du M.D.M.R. est virtuellement signé. […] Il faut proclamer l’état de siège et procéder aussitôt à des exécutions exemplaires. […] Effectivement, depuis le 1 avril, la Justice a ouvert une instruction judiciaire sous l’inculpation de complot contre la sûreté de l’Etat, et ordonne l’arrestation des militants M.D.M.R. les plus influents. […] Les inculpés sont entassés sans ménagement dans des prisons trop exiguës, quand ce n’est pas de véritables camps de concentration […].», Ibid., pp. 55 - 57. 166 77 cacher le travail de notre propre mouvement […]. C’est définir clairement l’utilisation des structures politiques existantes pour assurer la clandestinité du mouvement de préparation de l’insurrection.»167. Per i 11200 Malgasci che avevano partecipato all’insurrezione tra il marzo del 1947 e il dicembre del 1948 la lotta per la liberazione del Madagascar era assurta a «guerre sainte, guerre patriotique, guerre d’indépendance.» 168. «Mais je vous parle à vous qui demeurez au combat et qui surveillez les campagnes, à vous auxquels on ne peut pas faire faire le demi-tour et qu’il ne pas facile de décourager quand il s’agit de défendre la patrie (…). Confiance, courage, n’ayez pas peur. Ayez la patience, car le matin d’un jour nouveau est près de paraître, et alors Madagascar sera libre. Longue vie à vous. Longue vie à Madagascar notre patrie»169 167 Ibid., p. 93. Jacques Tronchon, La Révolution malgache de 1947, essai d’interprétation historique, op. cit., p. 159. 169 Archivio militare (circolare n. 1432 del B.D.N.) tradotto dal malgascio, citato da Jacques Tronchon, Ibid., pp. 160 – 162. 168 78 Le incerte declinazioni della libertà, 1946, 1960, 1968 la Réunion, il Madagascar e Maurice tra indipendenza e departimentalizzazione Le mot de nos désirs!/ Le mot de notre chaîne!/ Le mot de notre deuil!/ Il brille/ Dans les larmes des veuves,/ Dans les larmes de la mère/ Et des fiers orphelins. […]/ Île des mes Ancêtres,/ Ce mot, c’est mon salut./ Ce mot, c’est mon message. […]/ Siffle/ Aux oreilles de quatre espaces:/ Liberté! Liberté! Liberté! Liberté!170 L’era nucleare, inaugurata alla fine del secondo conflitto, ripensava gli antichi imperi ottocenteschi alla luce dei nuovi e più flessibili equilibri economici. I territori africani, americani e orientali che, fino a tutta la prima metà del Novecento, erano l’assicurazione e la testimonianza del prestigio delle nazioni europee, si rivelarono, dopo il 1946, per lo più scomode e onerose acquisizioni da cui, ora, le ingenti spese della ricostruzione, non meno il profilarsi della guerra fredda, suggerivano di abbandonare a vantaggio di relazioni politiche più distese, inserite nel progetto della costituzione di un blocco occidentale antisovietico. Se, nel 1947, la richiesta di autonomia del Madagascar era stata ignorata, poi osteggiata dalla Francia a prezzo di pene capitali, arresti e confini, l’indipendenza offerta pacificamente all’Indocina dal governo francese nel 1946 con l’accordo Sainteny, anticipava «l’ora delle indipendenze»171 che si sarebbe abbattuta sui vecchi imperi negli anni 60. Solo nel 1960, il Madagascar avrebbe, difatti, conquistato, con l’avallo francese, la libertà per la quale le popolazioni locali avevano combattuto dal 1896. Maurice, dal canto suo, sarebbe diventato uno stato autonomo in seno al Commonwealth nel 1968 nonostante il dissenso e la resistenza politica della popolazione franco-creola dell’isola, e prima di aver sconfessato le previsioni apocalittiche di un collasso economico avanzate dalla classe dirigente bianca. Ai fasti della liberazione, propagatisi per i numerosi stati africani e nelle grandi e piccole isole dell’Oceano Indiano, unica, si sottrasse la Réunion che, nel 1946 e ancora nel 1959, oscillò ambigua tra il sentimento di fedeltà alla Francia, terra d’origine, e la sfiducia nell’amministrazione per alcuni versi coloniale della Metropoli. 170 Jacques Rabemananjara, Antsa, Paris, Présence Africane, 1956. Citazione da, L’Afrique noire française : l'heure de indépendances : actes du Colloque La France et les indépendances des pays d’Afrique noire et de Madagascar, organisé par l’Institut d’histoire des pays d’outre-mer et l’Institut d’histoire du temps présent, Aix-en-Provence, 26-29 avril 1990, sous la direction de Charles-Robert Ageron et Marc Michel; preface de Francois Bedarida, Paris, CNRS, 1992. 171 79 Quale indipendenza, quante indipendenze e quali governi si sono profilati dopo il secondo conflitto mondiale nell’area dell’Oceano Indiano? * Madagascar, 1960 - 1972 Dal neocolonialismo della Prima Repubblica all’indipendenza culturale e politica degli anni della Malgascizzazione Il rapido, feroce blitz francese del 1948, il silenzio americano e inglese, in risposta all’intervento atteso dai ribelli malgasci, si abbatterono sull’isola a spegnere gli ultimi focolai sovversivi, ma soprattutto a disgregare, ad annichilire la coscienza sociale e politica di un popolo rimasto fedele all’ideale della sovranità della Nazione Malgascia dal 1896. Tradita e disorientata dalla sconfitta dell’organizzazione politica dei partiti merina e dalla connivenza con il governo coloniale francese dei rappresentanti dei côtiers, la popolazione si era chiusa nella celebrazione del lutto dei martiri del 47: «L’échec de la rébellion et de la disparition du parti d’indépendance laissèrent les Malgaches désorientés et divisés. En nombre de points de la Côte Est les indigènes chassèrent les Mérinas, accusés de les avoir trompés. Le P.A.DES.M luimême éclata en partis régionaux.»172 Alla repressione, e al gelo istituzionale che ne seguì, non riuscirono a sopravvivere nemmeno i maggiori partiti dell’isola, il M.D.M.R., il PA.DES.M. (inizialmente supportato dalla Metropoli), quei partiti la cui attività si era sviluppata e radicata nella collettività a ridosso della rivoluzione del 47, e proprio in prospettiva di un’eventuale, prossima emancipazione politica del Madagascar dall’autorità francese. Dispersi, perseguitati i leaders del movimento di rinnovazione malgascia, scacciato il fantasma della propaganda nazionalistica dei gruppi più facinorosi, dissolte finanche le voci delle organizzazioni moderate, la Francia ritornava dominatrice indiscussa sull’isola173, non meno allarmata, ciononostante, dallo spirito sovversivo, dalla capacità di organizzazione militare e politica dimostrata dal popolo malgascio dopo il 46. Si imponeva al governo francese, quindi, una riforma degli accordi franco-malgasci che, in previsione dell’emancipazione dell’isola, consentissero comunque alla Francia un controllo indiretto, militare e politico, sui mari dell’Oceano Indiano onde arginare l’espansione sovietica e cinese. 172 Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 270. «Devant la passivité politique qui avait succédé au grand choc, l’administration retrouvait un pouvoir sans partage, mais aussi sans horizon.», Ibid. 173 80 Il decennale collasso che seguì alla rivoluzione del 47, servì alla Francia, quindi, come fase di transizione necessaria per il trasferimento definitivo dei poteri dal governo francese al popolo malgascio, in vista della formazione di una futura Repubblica del Madagascar filoccidentale: «Quant à la France, aussi bien la conjoncture internationale que les pressions locales (sans omettre les idées cartiéristes) la poussent à avancer vers l’octroi des indépendances aux TOM. Soutenir [une politique modérée] contre les nationalistes tananariviens irréductibles, dont certains sont proches à Moscou, n’est-ce pas la solution idéale? »174. Perché sull’isola si ponessero le basi per un governo filofrancese (soprattutto dopo la dura repressione del 1947 e del 1948), era necessario che la Francia recuperasse agli occhi dei Malgasci la sua immagine di nazione foriera di ideali libertari, progressisti e umanitari. Non stupisce, quindi, che le prime misure adottate dal governo mirassero alla ricostruzione e alla modernizzazione delle industrie e delle infrastrutture della colonia madecassa. Se l’amministratore del Madagascar De Chévigné riaprì i termini del confronto sul diritto di autodeterminazione dei popoli175, Bargues, che gli succedette, si impegnò perché l’economia, le condizioni sociali e culturali del Madagascar potessero riscattarsi dagli anni bui della guerra e dal disfacimento del successivo periodo rivoluzionario. Accanto alla coltivazione e all’esportazione del caffè, fu incentivata la creazione di imprese e la costituzione di nuove strutture, come la rete idrica di Alaotra. La strategia adottata dalla Francia di avviare l’isola all’indipendenza tramite la realizzazione di riforme graduali, di piccole, misurate concessioni, nel decennio tra il 48 e il 58, rispondeva alla necessità di inibire nell’animo della popolazione malgascia la nascita del sentimento patriottico, perché la libertà non fosse sentita come la sconfitta della politica imperialista, ma al contrario fosse riconosciuta come l’esito necessario dello stesso percorso coloniale: la Francia doveva rimanere per i Malgasci «son père et sa mère»176: «In the period immediately after 1947, the colonial power concentrated on building up local support. Development funds were channelled increasingly to series of reorganisations of village level government 174 Lucile Rabearimanana, Les Tananariviens face à la proclamation de l’indépendance de Madagascar (26 juin – 31 juillet 1960), in Charles-Robert Ageron e Marc Michel (sous la direction de), L’Afrique Noire Française: L’heure des Indépendances, op. cit., p. 579. 175 «La France sait et comprend que le peuple malgache, qui veut conserver son âme et son caractère malgache souhaite survivre à ses côtés une route paisible et droite, qui seule peut le mener au but qu’il ambitionne très légitimement: celui d’État librement associé avec tous les autres états membres de la grande communauté de l’Union française.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., pp. 270 - 271. 176 Lucile Rabearimanana, Les Tananariviens face à la proclamation de l’indépendance de Madagascar (26 juin – 31 juillet 1960), in Charles-Robert Ageron e Marc Michel (sous la direction de), L’Afrique Noire Française: L’heure des Indépendances, op. cit., p. 579. 81 reinforced the links between local administrators, village notables whose selection was ratified by the administrators […].»177. Sul piano politico, si fece in modo, quindi, che l’ecumenismo di cui era stato promotore e catalizzatore il M.D.M.R. (espressione del profondo sentimento nazionalistico della popolazione), si disperdesse in assemblee regionali agricole, lontane dalla sovversiva capitale, vicine al mondo conservatore dell’amministrazione, e certamente più controllabili dal punto di vista della pubblica sicurezza. Nel 1948 furono create da Bargues le comunità agricole del C.A.R. e del C.R.A.M., perché la promozione di un’amministrazione territoriale malgascia, nel favorire la nascita di un’economia privata e quindi di una politica individualista, demonizzasse l’istinto associazionista comune ai popoli occupati. Come fanno notare alcuni studiosi del Madagascar, la scarsità degli eventi elettorali regionali, negli anni che seguirono la disfatta del 47, si accompagnava, invece, a nuovi sistemi di propaganda volti a enfatizzare quei sentimenti particolaristici ed etnici cui il Madagascar non era estraneo. Ricorda Maureen: «Elections continued to be held, but candidates concentrated on local issues and ran as sans partis. There were no national elections, and even in elections to the French Assembly, […] candidates ran as individuals supported by their own personalistic election committees. »178. Non solo come dice Maureen, la politica regionalista supportata dal governo francese aveva il duplice scopo di riavvicinare gli amministratori coloniali ai notables (leader della città) e di testare la temperatura della popolazione, piuttosto riproponeva la strategia, già sperimentata prima del 47, di favorire i movimenti costieri, marginali, a danno delle organizzazioni centrali coordinate dai Merina179. La capitale, Tananarive, per quanto legata alla cultura occidentale, si era già rivelata sotto i Francesi una città indipendente dal controllo coloniale: fucina delle prime riviste contro il regime, quando il Madagascar era ancora lontano dall’acquisizione dei diritti fondamentali, laboratorio dei primi movimenti sindacali malgasci. Educata agli ideali libertari dei movimenti rivoluzionari europei e americani, Tananarive doveva di fatto ricompensare la sua assenza ai moti del 47 adoperandosi, dopo il 1953 (data della dichiarazione di legittimità dell’autonomia da parte dei 177 Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 29. Il corsivo è mio. Ibid. 179 «The Malagasy levels of the administration were also the object of some attention. A post-1947 ordinance allowed Malagasy administrators to be fired for ‘suspected bad moral character’. This provided the basis for a purge of administrators suspected of unreliability and their replacement by more certain supporters of regime.», Ibid., pp. 29 – 30. 178 82 vescovi cattolici), per la costituzione di movimenti in difesa della sovranità malgascia e della liberazione dei prigionieri politici della rivoluzione di marzo180. Come nel 1946, così dopo il 53, si delinearono nel Madagascar due correnti distinte: da una parte i sindacati e gli eredi del M.D.M.R. (scissosi nel U.P.M., Union du Peuple Malgache, e nell’U.N.A.M., per un’intesa con i côtiers), vicini alla politica riformista, dall’altra i partiti costieri, discendenti delil PA.DES.M., l’ U.D.S.M. di Zafimahova, antimerina e filofrancese, e il P.S.D. di Tsiranana, più moderato e aperto a un’intesa con l’aristocrazia merina. Due voci del Madagascar, una attiva nella capitale, l’altra diffusa frammentariamente sul resto del territorio. Favorire l’avanzata e il consolidamento dei distretti periferici rispetto alla capitale181, richiedeva, da parte dell’amministrazione francese, l’attuazione di una serie di innovazioni in seno allo statuto coloniale, la prima e la maggiore delle quali fu l’introduzione del suffragio universale nel 1956. Contro poco più di un milione di Merina, guadagnavano l’ammissione al voto sei milioni di Malgasci, per lo più successori di quelle etnie soggiogate dal potere centrale della casta Merina nel 1800. L’istituzione delle associazioni agricole, le rinnovate profferte di cooperazione con l’amministrazione francese, quindi la posizione più morbida dimostrata nei confronti dei fatti del 47 (di cui l’amnistia dei prigionieri politici nel 1954 fu la manifestazione più vistosa) dovettero certamente persuadere la popolazione del nuovo percorso intrapreso dalla Francia verso un reale affrancamento del Madagascar dalla servitù coloniale, a vantaggio della politica filofrancese e moderata dei côtiers, e a detrimento delle incerte teorie riformiste socialiste dei seguaci del M.D.M.R. (molti dei quali, ancora nel 1957 dalla lontana Francia, incitavano alla lotta e alla ribellione182). Nonostante i nazionalisti rinnovassero le loro denuncie nei confronti dell’amministrazione coloniale, dipinta come un lupo dalla pelle di agnello, (non ultima l’applicazione della legge-quadro 180 «Tananarive, capitale du royaume de Madagascar, constitue dès le XIXe siècle, un centre de diffusion de la culture occidentale […]. C’est de ce milieu qu’est issu le personnel politique du nationalisme juste dans les années 60. […] A une période où les Malgaches sont dépourvus de tout droit politique, Tananarive constitue aussi le lieu de parution et le principal centre de diffusion d’une presse d’opinion poursuivie sans relâche par l’administration coloniale. […] mais c’est surtout pendant la période consécutive à l’insurrection de 1947 que Tananarive témoigne de son rôle de porteflambeau des revendications d’indépendance. Journalistes nationalistes progressistes et communisants militant dans des sections de la CGT et dans le Comité de solidarité de Madagascar poursuivent courageusement la lutte pour l’amnistie des condamnés politiques de 1947 […].», Lucile Rabearimanana, Les Tananariviens face à la proclamation de l’indépendance de Madagascar (26 juin – 31 juillet 1960), in Charles-Robert Ageron e Marc Michel (sous la direction de), L’Afrique Noire Française: L’heure des Indépendances, op. cit., pp. 576 - 577. 181 « […] le moyen de cette politique, c’est l’appui inconditionnel sur la France – à laquelle est dévolu le double rôle de garante de la non-domination de l’élite merina et de la formation des élites côtières.», Gérard Roy, Contribution à l’histoire des indépendances malgaches (1959 – 1960 – 1972) , «Études malgaches», cahiers III, ORSTOM, coll. Travaux et documents microédités, p. 47. 182 «Le 29 mars 1957, au cours d’une réunion organisée à Paris pour le dixième anniversaire de la rébellion, Jacques Rabemananjara exhorte les résistants à «lutter jusqu’à leur dernier souffle pour l’indépendance totale de l’île» […].», Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1972, p. 221. 83 del 56 che arricchiva le sei Assemblee del potere esecutivo rinominata «loi-gadra (chaîne)»183), le elezioni del 1957 si chiusero con il trionfo del P.S.D. di Tsiranana. Come temuto dall’opposizione, il successo riportato alle amministrative dall’ala moderata campeggiava in realtà come la vittoria indiscussa della strategia politica attuata dal governo francese negli anni postrivoluzionari. Ridotti in minoranza all’Assemblea Rappresentativa, ai partiti di opposizione non restava che allearsi contro il P.S.D., nemico interno comune, per presentare, nel 1958, a un anno dalla proposta di Tsiranana, e solo a seguito della prospettiva del referendum sul nuovo statuto dell’isola, una nuova bozza di legge che prevedeva l’accesso a una legittima, pacifica autonomia del Madagascar con il sostegno francese184. Già nel 1957, e in qualità di Vicepresidente del Consiglio, Tsiranana aveva, però, richiamato l’attenzione del governo francese sulla necessità di abrogare il decreto di annessione del 1896 in sostituzione del quale venivano accettate le convenzioni già adottate in Camerun e nel Togo. Contro il progetto di Tsiranana, che faceva eco al disegno di legge di De Gaulle di una comunità francese di stati africani, i riformisti uniti nell’A.K.F.M.185 (Congresso Indipendente del Partito del Madagascar) si mobilitarono perché l’opinione pubblica fosse informata sull’evidente atto di usurpazione della sovranità del popolo malgascio che la Francia si preparava a compiere con il beneplacito dei moderati al governo: «“Demain vous serez de nouveau un État, comme vous l’étiez lorsque ce Palais était habité”. Cette seule petite phrase qui n’avait certainement pas la même résonance pour l’orateur (De Gaulle) et ses auditeurs permettra aux partisans du Oui de l’emporter à 77% sur les partisans du Non qui se méfient à juste de l’incompatibilité entre l’appartenance à la Communauté et l’Indépendance.»186. Nel 1959, sotto il governo provvisorio di Tsiranana187, il Madagascar accedeva allo status di Repubblica indipendente. Nello stesso anno, in assenza dei partiti riformisti188, veniva votata la 183 Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 272. «La loi-cadre n’a pas supprimé la «provincialisation» de l’île, jugée néfaste à juste titre par les nationalistes malgaches, et les élections du 31 mars 1957 doivent aboutir à la constitution de six Assemblées provinciales […] et non pas d’une assemblée territoriale comme en Afrique noire. », Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p. 220. 184 «En mai 1958 se réunissant à Tamatave un «Congrès de l’Indépendance» […] il préconisait l’indépendance par voie pacifique, une République unitaire, de libres négociations avec la France, et créait une délégation permanente. », Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p 273. 185 «The AKFM […] was the result of a congress held in Toamasina in 1958 to unite parties opposed to a ‘yes’ vote in the referendum on the French Fifth Republic constitution. (Rejection of the constitution would mean immediate independence). After the referendum, in which, not surprisingly, the ‘yes’ vote supported by the PSD and the administration won, several of the parties united to form AKFM.», Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 31. 186 . Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p.221. 187 Nel decennio che precedette l’indipendenza, Philibert Tsiranana si rivelò il candidato più qualificato come successore alla guida di un Madagascar libero e filofrancese. Non solo Tsiranana era stato anzitempo cofondatore del 84 Costituzione della nuova nazione malgascia: uno stato unito nelle sue differenze etniche, una corporazione di province non federate, uno stato bilingue francomalgascio, le cui direttrici principali erano riassunte in «Fahafahana, Tanindrazana, Fandrosoana (Liberté, Terre des Ancêtres, Progrès)»189. Conscio tuttavia dell’ideologia filofrancese che guidava la nuova costituzione, delle certe opposizioni che questa avrebbe scatenato tra le file nazionaliste del AKFM, Tsiranana, sull’esempio del presidente del Mali, «se fait accorder les pleins pouvoirs le 16 janvier 1960 par l’Assemblée Malgache et engagé le 11 février des négociations à Matignon. Le 2 avril 1960, les accords de coopérations franco-malgaches sont signés et le 26 juin 1960 l’indépendance de Madagascar est solennellement proclamée.»190. * I dodici anni di impero indiscusso di Tsiranana si conclusero improvvisamente nel maggio del 1972, scalzati dalla rivoluzione socialista di Ratsiraka al grido di malgascizzazione191. PA.DES.M. e si trovava attualmente a capo del P.S.D., ma si era dimostrato negli anni sostenitore fedele della politica coloniale. Prima della rivoluzione del 47, studente in Francia, si era fatto promotore di un’organizzazione «were the côtiers would feel more at home», in risposta alle frange nazionaliste studentesche malgasce, “too Merina”, dove militavano noti intellettuali come Jacques Rabemananjara. Rimasto in Francia durante la rivolta, «so he could not be accused of personal involvement in the repression and therefore would not be totally unacceptable to nationalistic elements», una volta tornato in patria, era divenuto membro del partito socialista (lo stesso partito del governatore del Madagascar). Contro la linea intransigente e sovversiva dei nazionalisti, Tsiranana si era dimostrato convinto assertore di una strategia della prudenza, «was opposed to immediate independence as contrary to the interests of the coastal populations and had proposed twenty – to thirty – year transition period was taken as further evidence of his willingness to maintain a close connection with France». Il P.S.D., dopo le elezioni del 1957, non era stato il solo partito capace di espandere il proprio messaggio sull’intero territorio malgascio raccogliendo consensi ben oltre il nord-est del Madagascar (dove era stato eletto Tsiranana). Ponendosi a capo dei sindacati, la Confederazione dei Lavoratori del Madagascar e delle Comores, e dell’informazione con un quotidiano franco-malgascio, il P.S.D. era divenuto per la popolazione tutta, come già il M.D.M.R., simbolo della Nazione malgascia libera: «Seul le parti di Philibert Tsiranana prend en 1957 des dimensions nationales, s’impalnte solidement surtout dans le Nord-Ouest et pourra faire état en dicembre 1957 de quatre fédérations et 28 sections, d’une presse en pleine expansion en langue malgache et française, et d’une section sindacale associée, la Confédération des Travailleurs de Madagascar et des Comores, C.T.M.C., créée en octobre 1957 et affiliée directement à la C.I.S.L. ». Tutte le notizie sono state tratte da Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 30, Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p. 220. 188 «Le Conseil du Gouvernement, sous la Présidence de Tsiranana, devenait le Gouvernement provisoire. Une Assemblée constituante composée de 90 membres, allait être élue par le Congrès dans son sein, en respectant la proportion des six provinces. Les partisans du «non» en furent éliminés.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 274. 189 «Les provinces, dotées de Conseils provinciaux, avaient à leur tête un secrétaire d’Etat délégué par le gouvernement. Donc un provincialisme, mais pas de fédéralisme. Le texte faisait référence à Dieu et aux ancêtres, à la famille et à la propriété. […]. Le malgache et le français sont également langues officielles […].», Ibid., p. 275. 190 Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p.222. 191 «The slogan of the uprising, ‘Malagachization’ had originally been a demand for an education in the national language reflecting the national culture, but in the course of the uprising its meaning widened to include the ouster of the French technical assistants, and then the real departure of the French and the regime they had installed: a second independence and the vindication of the sacrifices of the martyrs of 1947.», Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., pp. 45 - 46. 85 Sostenuto dal consenso popolare e dal governo francese, Tsiranana era stato proclamato padre della patria libera del Madagascar nel 1960192. Se fin dall’inizio l’opposizione del AKFM e del Monima doveva manifestare il dissenso di una parte della popolazione, non di meno, il neopresidente credette possibile una ricostruzione della nazione e dell’identità malgascia in seno alla cultura francese. La rivoluzione di maggio fu, quindi, l’esito di aspettative tradite: la denuncia aperta della connivenza col potere francese perpetuata dal presidente al di là delle reali necessità dell’isola, ma soprattutto la reazione all’affermazione del regime neocoloniale a cui la politica filofrancese di Tsiranana aveva dato libero corso. Di fronte al sistema economico ancora sottosviluppato e all’infuriare di una serie di cicloni che si erano abbattuti sull’isola tra il 1958 e il 1960, Tsiranana rivendicava la necessità dell’appoggio francese per un’isola ancora lontana dal progresso democratico, facile preda delle pressioni filosovietiche dei nazionalisti AKFM (che a quel tempo, avrebbero certamente significato il collasso del Madagascar). L’elezione, tutt’altro che simbolica193, del francese Paul Longuet a Ministro delle Finanze fu, tuttavia, per l’opposizione la prova evidente del perdurare di una situazione di assoggettamento e del controllo politico, economico, militare, finanche culturale, francese sull’isola. Il trattato francomalgascio stipulato nel 1960 faceva, infatti, dell’isola una zona franca per le attività commerciali (che tuttavia rimanevano prevalentemente sotto il controllo delle principali imprese francesi), per la scolarizzazione (effettuata nelle due lingue, ma comunque di stretto dominio francese dalle classi superiori194), per l’esercito (la cui preparazione e il cui mantenimento erano peraltro un’esplicita incombenza francese): «[…] defence, foreign policy, economic policy and education. The defence agreement provided for close integration between Malagasy and French forces. The new Malagasy army, to be formed on the base provided by Malagasies serving in the French army would continue to be trained and equipped by France and would be subsidized by the French budget. […] French forces could use Malagasy territory […]. Madagascar would remain a franc zone. Similarly close links prevailed in education., particularly at the post-secondary level which was to be financed by France […]. The defence agreements allowed France to maintain its military presence on the island as if independence had never occurred, while foreign policy agreements 192 Ibid., p. 32. «Aux finances il nomme le Français Paul Longuet, son deuxième souci étant, semble-t-il, de conserver l’amitié de la communauté française et de rassurer les capitaux étrangers et son troisième souci […] étant de lutter contre “la menace communiste russe et chinoise”.», Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p 349. 194 «When the professor was French and the student was Malagasy the relationship reproduced the colonial era […]. Degrees given by the university were French degrees and the research and teaching of the university reproduced that of a French establishment. […] Again, the point was clear: it was through learning about France, not Madagascar, that one had to pass to aspire to even subordinate position in the system for which the Malagasies were destined.», Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 37. 193 86 ensured that the diplomatic activity of the new nation would be acceptable to France. The monetary and ‘assimilated nationality’ accords allowed both large French companies and small settlers to operate as they had before independence, while the education agreements were signed to perpetuate the whole system by ensuring the future elites would be Francophone and imbued with French culture and values.»195 A dispetto delle rassicurazioni di Tsiranana che non mancava di celebrare la memoria dei martiri del 47 (con l’elezione di Rabemananjara e Ravoahangy, rispettivamente a Ministro dell’Economia e della Salute pubblica196), dell’orientamento socialista197 dell’economia ispirato al sistema tradizionale dei foko’olona, l’amministrazione del P.S.D. tradiva agli occhi dell’opinione pubblica malgascia le sue origini europee (Tsiranana appartenendo a quell’elite politica formatasi nelle scuole francesi198). Gli anni della presidenza di Tsiranana si mutarono nel triste copione già rappresentato da altre neorepubbliche africane: paesi disabituati alla libertà, caduti nel piège neocolonialista degli imperialismi economici dei paesi occidentali, fragili democrazie prede della corruzione e del clientelismo: «One result of this strategy was an explosion in the size of administrators, which grew from 32,476 in 1958 to 50,344 in 1960. Another was the nature if the party itself: a loose collection of regional barons at the top and local notables at the bottom, firmly identified with state power […].» di seguito «The Malagasies did get rich under the system, but mainly through their role in the civil service or political sphere. […] Corruption was not the major issue in the 1972 revolt, but the fact that Resampa (the right-hand man of Tsiranana) could become the largest landowner in Madagascar […] is perhaps a comment on the activities of his fellows ministers. The politico-economic system of the First republic provided the basis for the formation of a privileged Malagasy class that cut across the Merina-côtier division […].»199. 195 . Ibid., p. 33. «Le 19 juillet 1960, le Président, fidèle à sa promesse, ramène de Paris J. Ravoahangy, J. Rabemananjara et J. Raseta et déclare: «Mon premier souci est l’unité nationale.». […] Tsiranana fait entrer dans son gouvernement J. Ravoahangy (Santé) et J. Rabemananjara (Économie Nationale).», Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p 349. 197 «Le programme du P.S.D. comportait la diffusion de l’instruction et le progrès de l’économie par l’amélioration du paysannat et la création d’industries légères. Tsiranana annonçait vouloir pratiquer un socialisme «à ras du sol», sans bousculer les habitudes et sans contrainte totalitaire. “Socialisme”, déclarait-il, “signifie démocratie, communisme signifie dictature.”.», Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 279. 198 Come esposto nello studio di Raymond Delval Cheam, (La formation des cadres de la République malgache à l’Institut des Hautes Études d’Outre-Mer (1958 – 1966), in Charles-Robert Ageron e Marc Michel (sous la direction de), L’Afrique Noire Française: L’heure des Indépendances, op. cit., pp. 593 – 608), la Francia, negli anni che precedettero l’indipendenza del Madagascar, si adoperò perché fosse creata l’elite dei funzionari malgasci che avrebbero sostituito i Francesi nella gestione della futura Repubblica. Interesse della Francia era non solo sensibilizzare i Malgasci agli ideali democratici occidentali (contro il pericolo di una sovietizzazione delle ex-colonie), ma soprattutto educare i futuri rappresentanti a una conduzione dello stato sul modello francese. 199 Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 31, pp. 34 - 35. 196 87 L’opposizione delineatasi dopo il 1953 tra i due movimenti politici del P.S.D. e dell’A.K.F.M. andò sfumando negli anni, tale che Andriamanjato, capo del movimento nazionalista, avrebbe potuto dichiarare nel 1967 che l’«A.K.F.M and P.S.D. were 80 per cent in agreement». Sorto dall’unione di vari partiti oltranzisti nella difesa della libertà della nazione e dell’identità malgascia, probabilmente il messaggio ambiguo di cui si faceva promotore (i membri, per lo più appartenenti all’alta borghesia Merina, predicavano un avvicinamento al Comunismo sovietico200), l’A.K.F.M. non era riuscito, come il P.S.D., a organizzare una rete di consensi popolari. Una volta al governo, il partito sembrò accontentarsi del ruolo di oppositore ufficiale, nella speranza che di lì a qualche anno questo si sarebbe tradotto in una maggiore partecipazione al governo del paese accanto al P.S.D: «The P.S.D. never agreed to these proposals, but never decisively rejected them either.». Maggiore severità di giudizio nei confronti della politica di Tsiranana la mostrò il MONIMA (Mouvement National pour l’Independance de Madagascar) fondato del 1958 da Moja Joana. Braccato dalle truppe del potere ufficiale, per il ruolo destabilizzante da questo esercitato su uno stato da poco indipendente, il MONIMA proclamava la rigida restaurazione della tradizioni economiche e culturali della società malgascia, quindi la decentralizzazione del potere amministrativo (il fokol’ona) contro la statalizzazione socialista praticata da Tsiranana. Il MONIMA, però, rimase la manifestazione isolata di alcuni rappresentanti della classe media (sfruttati sotto la Francia e sotto la nuova repubblica, nostalgici del mondo dei notables e dei burocrati merina), spesso alieni alle teorie politiche leniniste. Il dominio, anche politico, del P.S.D. perdurò fino al 1969, quando alle proteste degli intellettuali universitari in difesa della cultura e della scolarizzazione malgascia, a una situazione economica nazionale già poco sviluppata, si unirono vari fattori: la crisi politica del 68 in Francia (quindi la momentanea sospensione degli aiuti alla ex-colonia), la chiusura del canale di Suez, il susseguirsi di una serie di cicloni che avvilirono ulteriormente la situazione sociale dell’isola201. Nel 1969, veniva fondato dal sociologo Manadafy Rakotinirina il partito, Madagascar pour les Malgaches. Incentrato sulla lotta di classe, in opposizione all’imperialismo dei paesi occidentali e in favore di una linea politica ed economica terzomondista, il partito riuniva a sé le nuove generazioni di studenti, di medici che, cresciuti all’ombra della cultura francese elevavano, ora, contro il palazzo 200 «The party recruited from non-Catholic nationalist groups throughout the island, with its of greatest strength being Antseranana and the plateaux from Antananarivo to Fianarantsoa. The party’s top leadership was Antananarivo based, divided into ‘pure nationalist’ and ‘scientific socialist’ wings with the President, Richard Andriamanjato, playing a mediating role between them. He was himself from a noble Merina family pastor of one of the capital’s most fashionable churches […]. Andriamanjato was representative of the ambiguity of the party, which recruited from conservative bourgeois and petit-bourgeois circles of Antananarivo with revolutionary rhetoric that attacked imperialism and advocated state socialism. », Ibid, p. 31. 201 «By 1970, Tsiranana regime had turned to crisis. The economy was suffering from events such as the 1967 closure of the Suez Canal, the French strikes of 1968 and a series of cyclones in 1969.», Ibid, p.43. 88 del potere il “libretto rosso” della Malgachisation sull’esempio delle rivoluzioni cinese e sudamericane. Presupposto per l’infuriare dei disordini nell’isola, fu l’improvvisa malattia di Tsiranana, colto nel 1970 da un ictus durante la riunione dell’OCAM202. Al decennio di relativa calma sotto il regno del leader del P.S.D., seguirono due anni di confusione politica, segnati da maldestri tentativi di Resampa (braccio destro del presidente) di impossessarsi del potere un volta Tsiranana fuori dal governo203. In risposta alla crisi politica ed economica del paese, nel marzo del 1971 gli universitari si unirono agli studenti delle classi superiori per promuovere uno sciopero degli atenei in vista di una riforma radicale del sistema scolastico (ancora gestito dai Francesi). Nonostante l’intenzione dimostrata dal governo di esaminare le rivendicazioni degli studenti malgasci, nell’aprile dello stesso anno, la protesta dilagò nel sud del Madagascar. Gli agricoltori e gli allevatori antandroy manifestarono il loro dissenso contro la politica vessatoria del governo, che non solo tiranneggiava un settore fondamentale al sostentamento della maggioranza della popolazione, ma permetteva da parte delle industrie (straniere) l’inquinamento delle falde e dei terreni causando l’avvelenamento di un sempre maggior numero di capi di bestiame204. Appoggiato dal MONIMA, il movimento fu prontamente sedato dalla polizia (fonti non ufficiali denunciarono almeno mille morti). La repressione, usata dal regime soprattutto per dissolvere il gruppo dissidente di Monja Joana, faceva luce su un aspetto che si sarebbe rivelato decisivo per il futuro esito della rivoluzione di maggio: l’esistenza di una doppia forza militare, di una polizia malgascia (FRS) dipendente dal governo (che aveva partecipato alle rappresaglie del 1971), di un esercito, al contrario, svincolato dal potere centrale (che si era astenuto da qualsivoglia azione militare nel 71). Mentre l’AKFM dava rassicurazioni al governo, sconfessando i motivi e la condotta dei manifestanti, mentre Resampa (in quanto rappresentante del sud) veniva esiliato sull’isola di Santa Maria, con l’accusa di complotto ai danni di Tsiranana, lo stato si preparava alle 202 L’Organizzazione Comune Africana e Malgascia (OCAM) fu istituita nel 1965 ad Antanarivo per volontà del presidente malgascio Tsiranana. Ratificata dai Ministri degli Affari Esteri di quattordici stati della nuova Africa francofona, l’organizzazione si differenziava dall’OUA (Organizzazione dell’Unità Africana) per la priorità data alla risoluzione dei problemi economici degli stati africani. L’intento principale di Tsiranana era di fatto spostare le proprie alleanze fuori dal contesto europeo/francese a vantaggio di nuovi accordi con partners ugualmente forti come il Sudafrica (sebbene inglese), e le ex-colonie francesi come il Sénégal, a riparo, oltretutto, di eventuali minacce comuniste che venivano dall’Oriente. Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., p. 43. 203 «The main contender for the succession was André Resampa, who made no secret of his belief that he should have the presidency. During the Tsiranana’s illness Resampa began to consolidate his position with the reorganization of the P.S.D.», Ibid., p. 44. 204 «Always governed more or less as an occupied territory, the south had been suffering since the late 1960s from drought, and since 1969 from an outbreak of cattle anthrax.», Ibid., p. 44. «Les Antandroy, demeurés fidèles à un mode de vie pastoral et nomade, se révoltent […] irrités par les exactions d’administrateurs peu scrupuleux qui leur réclament des impôts trop lourds.», Marianne Cornevin, Histoire de l’Afrique contemporaine (de la seconde guerre mondiale à nos jours), op. cit., p. 351. 89 nuove, anticipate elezioni del 1972 che vedevano ancora una volta Tsiranana candidarsi alla presidenza dello stato malgascio. I brogli evidenti che dominarono l’orientamento delle votazioni (Tsiranana, unico candidato, veniva esaltato come designato da Dio) vinte dall’ex-presidente con il 99,7% dei consensi, portarono al definitivo collasso del regime di Tsiranana, sopraffatto dal fervore nazionalista della rivoluzione di maggio. Partita nuovamente dagli ambienti universitari (dalla scuola di medicina di Befelatanana, che rivendicava l’equiparazione dei diplomi malgasci a quelli francesi), in pochi mesi la rivolta si propagò tra la classe operaia, tra i precari e i disoccupati (riuniti nel Zoam), compatti nell’assedio del palazzo presidenziale. L’offensiva del FRS, le intimidazioni di Tsiranana non riuscirono, comunque, a disperdere la folla che, al contrario, raggiunse nei giorni successivi le 100.000 unità. Dopo una serie di smentite, il 17 maggio del 1972, su pressione popolare, il governo militare ad interim di Ramanantsoa decretava la fine del regno di Tsiranana, padre della nazione malgascia205. Rivoluzione popolare, rivoluzione politica, rivoluzione culturale? La malgascizzazione, propugnata dai ribelli di maggio, nata nel contesto universitario e a ridosso di rivendicazioni prettamente accademiche (la difesa di una scolarizzazione che mettesse come priorità l’insegnamento in malgascio rispetto al francese, in difesa di una pari dignità lavorativa dei Malgasci rispetto ai Francesi206), divenne lo slogan, un programma politico per una riforma completa dello stato malgascio che con l’istruzione si impegnava a malgascizzare l’economia e la politica. Contro il regime statalista e filofrancese di Tsiranana, furono intraprese delle azioni radicali nel segno di una restituzione della terra malgascia ai Malgasci. I tre Ministri che affiancarono Ramanantsoa, Ratsiraka, Ministro degli Esteri, Ratsimandrava, Ministro degli Interni e Rabetafika si occuparono ciascuno di un settore dell’economia e della politica malgascia. Ratsiraka rinegoziò gli accordi con la Francia in favore di nuove alleanze con i paesi socialisti dell’Africa e con la 205 «The French command at Ivato refused to send troops to guard government buildings, and on 17 May the French embassy announced that French forces would intervene only to protect French lives and property. […] By mid-May it was clear that the choice facing the French government was not between Tsiranana and an anti-French government but between continued chaos under Tsiranana that might lead to a serious revolution, and a more nationalistic but still ‘reasonable’ military government. […] The FRS were recruited from such a narrow regional and political base that this act was not really equivalent to the declaration of the Merina-côtier civil war, but rather revealed that the regime could only depend on the support of […] a group of mercenaries. It was the gendarmerie that was the alternative force to FRS, and it was their refusal to defend the regime that was crucial.», Covell Maureen, Madagascar. Politics, Economics and Society, op. cit., pp. 48 – 49. 206 «The original demand of the students, for an expansion of the education system that would make it easier for them to acquire the degrees that were their passports to administrate posts, and the eviction of the French from those posts presupposed the maintenance of state power and social hierarchy. The Zoam themselves alternated between rejecting the system of privilege and protesting their exclusion from that system […].», Ibid., pp. 49 - 50 90 Russia. Rabetafika si impegnò a bonificare il territorio malgascio dalle compagnie straniere207. Ratsimandrava dal canto suo, nell’interpretare con rigore il motto di malgascizzazione, insisté per un adattamento dell’organizzazione statale socialista al modello fokon’olona tradizionale: un socialismo che, fondato sull’equa distribuzione delle risorse, rifiutava, tuttavia, l’assolutismo statalista sovietico e cinese, a vantaggio di una decentralizzazione del potere: «the reform developed into a radical vision of rural autonomy and urban populism aimed at the destruction of the state apparatus and the creation of ‘popular control of development’.»208. Quella che si era prospettata come la vittoria di un popolo, da sempre libero, ora, definitivamente, liberato dal giogo coloniale si rivelò nei fatti un’esperienza disastrosa, forse più dello steso colonialismo, per un’intera generazione di Malgasci. Telle qu’elle [la malgachisation] a été faite à Madagascar, ça a été une très mauvaise chose, à la limite une malgachisation fascisante, de prise de pouvoir. Il y avait dans la malgachisation une ouverture possible à la culture malgache (…); il y avait des moyens pour donner aux artistes malgaches pour qu’ils sortent leur identité (…) En quoi consistait cette malgachisation? Le système scolaire a été changé, tout l’enseignement était fait en malgache. (…)Toute une génération s’est retrouvée sans livres, sans bibliothèques, sans réels outils de réflexion. Maintenant ils remplacent la catastrophe par une autre: du jour au lendemain, ils décident qu’ils vont faire tout en français, alors qu’il n’y a plus de professeurs capablesde parler cette langue.(…) La malgachisation, il fallait la faire, mais pas comme elle a été faite.209 Diaspora etnica e communalismo 207 «As interpreted by Rabetafika and his assistants it included moving Malagasies into positions occupied by foreigners, and attempting to assert national control over the levers of the economy. In the general the regime’s economic policy followed the pattern of creating state enterprises to drive out local non-Malagasy entrepreneurs in areas like the commercialization of rice, and the participation in and indigenization of French-owned enterprises. », Ibid., p. 53. 208 Ibid., p. 54. 209 Taina Tervonen, Entretien avec Michèle Rakotoson, «Afrikultures» (juin 1998). 91 la de-costruzione della repubblica mauriziana I disordini che seguirono alla proclamazione dell’indipendenza nel 1968, i tentativi di sabotaggio del nuovo governo mauriziano da parte dell’oligarchia francese dell’isola, le divisioni etniche celebrate da partiti politici chiusi al dialogo, come caste, misero a nudo, nella seconda metà del Novecento, l’esistenza di due nazioni mauriziane. Uno stato indiano, figlio dell’immigrazione, riscattatosi economicamente e politicamente dai vincoli servili, sostenitore di una politica progressista; una nazione franco-mauriziana, custode nostalgica dei privilegi razziali e schiavisti, esule in patria dal 1810 (all’indomani della conquista inglese), ostile all’indipendenza perché di fatto diretta minaccia a quel mondo economico e culturale ereditato dall’imperialismo francese, sopravvissuto, per oltre un secolo, al governo liberale inglese nonché alle ripetute invasioni degli immigrati indiani. Eppure, come ebbero a dire i rappresentanti dell’imponente comunità indiana, solo con l’indipendenza i Franco-Mauriziani avrebbero potuto sperare di riallacciare i legami con la madrepatria, solo la costituzione di uno stato autonomo avrebbe dato motivo alla Francia di intraprendere nuove relazioni politiche ed economiche con l’antica Île de France. Quali allora le ragioni di una così viva opposizione da parte dei coloni francesi alla liberazione del suolo mauriziano dal dominio inglese? Nell’intricata spartizione degli equilibri economici e politici dei territori extraeuropei, Maurice ha rappresentato dal 1810 un caso limite. Dipendente dalla corona inglese, per tutto l’Ottocento e per la prima parte del Novecento rimase sotto il dominio culturale e amministrativo dell’oligarchia francese presente sull’isola in evidente minoranza rispetto al numero imponente di immigrati indiani di nuova e vecchia generazione in attesa di cittadinanza. L’assoggettamento di un’isola che era rimasta sotto l’egida francese per un secolo, sviluppatasi intorno a un primo nucleo di coloni bretoni e normanni che l’avevano popolata (ricordiamo, all’inizio in numero superiore rispetto agli stessi schiavi), imponeva certamente una cautela nel trasferimento dei poteri dall’amministrazione francese al nuovo governo inglese. Non stupisce, quindi, che i governatori dell’isola, primi fra tutti Farquhar, cercassero nelle vecchie istituzioni franco-creole, nelle potenti famiglie mauriziane, dei collaboratori per il governo di Maurice. La connivenza tra potere economico franco-creolo e l’autorità politica inglese fu all’origine del paradosso mauriziano nella misura in cui la scelta inglese di praticare sull’isola un imperialismo 92 passivo210 asserragliò la popolazione francese sulle sue prerogative elitarie di fondatori della patria, della storia, della società e della cultura dell’Île de France (convinzione avallata oltretutto dal documento ratificato nel 1810 secondo il quale gli Inglesi riconoscevano alla popolazione del luogo il diritto di conservare le proprie tradizioni, la propria cultura e la propria lingua211 nonostante il mutato regime). Se la cooperazione con le popolazioni assoggettate non era un fatto nuovo per i colonizzatori inglesi che, a differenza di loro vicini Francesi, erano conviti della necessità di avvantaggiarsi delle conoscenze e delle esperienze degli indigeni per fare della colonia un ambiente produttivo, la colonizzazione dell’antica Île de France, maturata in pieno clima di ostilità e di conflitti anglofrancesi, non solo non riuscì negli anni ad attenuare le differenze e le divisioni culturali tra i due popoli, ma ebbe l’esito di incrementare il sentimento di revanscismo, poi di isolamento da parte della popolazione franco-creola212 dell’isola. Nonostante Maurice avesse goduto di un trattamento particolare all’atto dell’abolizione della schiavitù (attuata previo indennizzo solo nel 1833 anziché nel 1807, come nelle altre colonie britanniche), nonostante la promozione dell’engagismo indiano, l’abbassamento delle tasse doganali in pieno spirito economico liberista, avessero avvantaggiato i grandi proprietari terrieri, l’isola barricava le sue chiese cattoliche contro l’assalto dei protestanti anglicani. Le chiese213, assieme alle scuole da queste gestite, furono erette a baluardo della cultura e della lingua francese, soprattutto dopo che, contro un certo lassismo che aveva interessato i primi decenni della colonizzazione, nel 1850, il governo inglese decise di intraprendere una serie di riforme riguardanti proprio la regolamentazione dell’uso della lingua francese nell’allora colonia britannica214. 210 «En fait, les Britanniques n’ont jamais pu développer une politique linguistique cohérente. Auguste Toussaint parle d’impérialisme passif dans le domaine linguistique mais il faut se demander s’ils avaient les moyens disponibles pour être agressifs dans une ancienne colonie française où la préservation de la langue et de la culture française était considérée comme un devoir sacré.», Musleem Jumeer, Les véritables enjeux des premières élections législatives à l’île Maurice (1886), in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 421. 211 « […] des Britanniques qui purent ainsi s’imposer en maîtres absolus avec une contrainte de faille toutefois du fait que leurs démarches étaient limitées par la concession des Actes de Capitulation de 1810, qui garantissaient aux Français le respect de leurs traditions, langue, religion, culture et institutions.», Ibid., p. 419. 212 « […] il s’agit d’une ancienne colonie passe sous l’administration anglaise mais dont le peuplement reste française […]. Une situation pareille donne lieu nécessairement à des conflits de toutes sortes d’autant plus qu’elle se place dans le contexte de rivalité franco-britannique du XIXe siècle.», Musleem Jumeer, Les véritables enjeux des premières élections législatives à l’île Maurice (1886), in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 419. 213 «Sur le plan religieux, le monopole que l’Eglise catholique exerce depuis la prise de possession à travers les Lettres Patentes de 1723 disparaît et d’autres églises chrétiennes de tendance réformiste apparaissent – les Anglicans, les Presbytériens, les Méthodistes, etc – […]. Ces églises bénéficiaient en outre du service d’un secrétariat tandis que l’Eglise catholique avait du mal à financier ses services sociaux et éducatifs. Bien vite, cet antagonisme entre les deux églises déborde sur la question linguistique […]. L’Eglise catholique devenait non seulement une véritable institution française, mais aussi un rempart imprenable de la langue française tandis que les autres églises chrétiennes devenaient le cheval de Troie de la langue anglaise. », Ibid., pp. 421 – 422. 214 «Pour […] la population blanche et la couche supérieure de la population de couleur […] les Anglais ont manqué à leur parole donnée en 1810 et des efforts constant ont été entrepris pour angliciser tout le train de vie quotidien de l’Ile 93 Avvilita dai conflitti anglo-francesi, dai blocchi navali ripristinati nei primi decenni della colonizzazione, ferita dall’abolizione della schiavitù, ridotta in minoranza dal flusso migratorio asiatico (per la maggior parte proveniente da colonie britanniche), la popolazione franco-creola, piccolo Québec dell’Oceano Indiano215, rifiutava i nuovi decreti come una provocazione culturale che avrebbe reso sensibile la comunità alla minaccia della popolazione indiana. L’esigua ma potente società franco-creola rivendicava non solo il diritto di autodeterminazione ma, ancora una volta come nel 1810, il diritto di proprietà – priorità sul suolo Mauriziano216, che a prescindere dai nuovi occupanti era chiaro dovesse rimanere patrimonio ideale e sentimentale della nazione francese. Il confronto tra riformisti (Franco-Mauriziani) e democratici (Inglesi e meticci) alle prime elezioni legislative del 1886217 fu il primo atto, britannico, di legittimazione delle due Maurices, francese e indiana: l’Île de France settecentesca Stella maris clavisque, le nuove Mauritius, terra promessa dei diseredati, dei paria; l’una francese, l’altra inglese, l’una cattolica, l’altra protestante, politeista, entrambe esiliate, entrambe in cerca di riscatto. Nel riconoscere, da una parte, il peso politico, il potere economico dei Creoli francesi (il cui conservatorismo era avallato dallo stesso governo inglese), nel sostenere, dall’altra, il progressismo della popolazione di colore, l’Inghilterra dava libero corso al separatismo etnico. Le elezioni legislative del 1886, confermarono, oltretutto, con l’estensione del censo, il mutato assetto politico di Maurice che, pure, ferma al conservatorismo dei Franco-Mauriziani218, ammiccava speranzosa al […]. Entretemps tout le système de l’éducation secondaire était tombé aux main des anglais. L’anglais devint la langue principale d’instruction. […] l’essentiel de la transmission de la langue et de la culture françaises se faisait à la maison où, malgré les directives administratives, le français était beaucoup plus usité que l’anglais […].», Ibid., p. 421. 215 « […] sous le regard des nouveaux maîtres de Madagascar, les Mauriciens sont d’abord des Créoles et de plus, des sujets britanniques […] en accentuant l’antagonisme avec les Anglais. C’est ainsi que les Franco-Mauriciens se comparent aux Canadiens, et mieux encore aux Alsaciens-Lorrains.», Dominique Bois, Les Franco-Mauriciens face à la conquête de Madagascar: l’invention d’un territoire français, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 443. 216 «Ce groupe se considère comme le premier occupant du sol, et par conséquent référence incontournable à toute identité mauricienne. Cependant il ne faut pas limiter les Franco-Mauriciens à ce noyau primitif: tout au long du XIXe siècle, l’Ile n’a cessé d’accueillir des migrants européens, le plus souvent français, qui, quoique d’une origine sociale moins prestigieuse, ont pu, par fortune, s’agréger au milieu originel.», Ibid., p. 435. 217 «Après la conquête de 1810, le gouverneur fut le seul responsable de l’administration avec l’assentiment du Colonial office de Londres. En 1825, un Conseil d’administration de cinq membres, tous britanniques, fut constitué pour conseiller le gouverneur. En 1831, ce nombre passa à quatorze et un habitant local, Adrien d’Epinay, fut nommé par le gouverneur pour y siéger. », Musleem Jumeer, Les véritables enjeux des premières élections législatives à l’île Maurice (1886), in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 419, nota 2. Come fa notare Jean-Pierre Durand: «Grâce à ses représentants au Conseil du Gouvernement, l’oligarchie sucrière – française – peut participer depuis 1832 à la gestion des affaires intérieures de l’île. Cette participation est renforcée à partir de 1885 […].», Jean-Pierre Durand et J., L’Île Maurice et ses populations, op.cit., p. 42. 218 «Ces “Réformistes” sont donc amenés, par ces liens économiques solides tissés avec les investisseurs anglais, à prôner une politique essentiellement conservatrice et modératrice malgré les griefs qu’ils pouvaient entretenir contre l’administration anglaise de l’île. », più oltre «L’administration britannique ne pouvait accéder de son coté à leurs requêtes, ses intérêts étant trop liés à ceux de la couche supérieure de la société pour la prospérité et la tranquillité de l’île. », Musleem Jumeer, Les véritables enjeux des premières élections législatives à l’île Maurice (1886), in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., p. 422, p. 424. 94 nuovo mondo219, come strumento per arginare, quindi assimilare, il potere dei Francesi dell’isola. Nonostante, quindi, nei fatti le elezioni del 1886 fossero state la celebrazione del potere francomauriziano, ugualmente quest’ultimo si convinse della necessità di tentare la conquista di nuove realtà territoriali al fine di sfuggire al declino inevitabile, non solo politico ma anche culturale, a cui l’amministrazione inglese, complici le radicali trasformazioni della società, l’avrebbe certamente trascinata. Se il fascino di terre inesplorate rimaneva vagheggiamento di tempi lontani (per la maggior parte conquistate, divise tra le grandi potenze europee), lontana appariva la Francia, resa inaccessibile dalle ragioni storico-politiche che avevano mutato i Franco-Mauriziani in sudditi britannici (quindi, con molta probabilità, sospetti agli occhi del governo francese). Il Madagascar, poco distante da Maurice, con un paesaggio e un clima che in alcuni tratti e in alcune stagioni dell’anno poteva ricordare l’Île de France, si offrì, in questa fine d’Ottocento, ai Creoli mauriziani come la terra promessa220. Non solo, infatti, dal XVIII secolo l’isola ospitava un nutrito gruppo di coloni delle Mascarene (ricordiamo gli insediamenti attorno a Tananarive e a Fort-Dauphin), ma dopo il 1871, in concomitanza con le manifestazioni degli engagés indiani, le rinnovate mire espansionistiche francesi sul Madagascar si presentarono agli esuli mauriziani come l’insperata occasione di ricongiungersi alla patria221. L’istituzione della Société Mauricienne de Colonisation de Madagascar e della Société Française d’Assistance de Port-Louis (sorte tra il 1885 e il 1896) fu, quindi, l’affermazione di quel sentimento di perdita dell’origine, di esplorazione del metafisico che sarebbe stato poi tema, orientamento ricorrente di tutta la politica interna dei Franco-Mauriziani negli anni delle importanti riforme istituzionali, nel decennio che precedette e che seguì l’indipendenza222. * 219 All’etnia indiana, proveniente da colonia inglese, che unica avrebbe potuto far fronte allo strapotere dei FrancoMauriziani. 220 «L’image de Madagascar se charpente à partir d’une double thématique: d’une part, une terre remplie de richesses qui n’attendent qu’une population active et éclairée pour la mettre en valeur et d’autre part, une terre d’élection pour les Mauriciens, chassés d’une île qui ne peut pas les nourrir. », Dominique Bois, Les Franco-Mauriciens face à la conquête de Madagascar: l’invention d’un territoire français, in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit.,. p. 441. 221 «Lorsque l’image de l’Eldorado est prise en défaut, elle est recouverte par une autre, celle de la Terre Promise; comme cette dernière en effet, elle est tout à la fois, terre de salut et terre de rencontre, celle de l’ancienne mère patrie retrouvée. […] Du point de vue mauricien donc, Madagascar permet de conjuguer identité créole et identité française.», Ibid, pp. 442 - 443. 222 Non ci dilungheremo nel testo sull’analisi dei numerosi tentativi dell’elite franco-mauriziana di abbandonare l’isola nei momenti politicamente più critici. Se il Madagascar rappresentò il fallimento, dal 1966 fino al 1968 molti esponenti dell’alta borghesia bianca mauriziana chiesero asilo politico all’Australia prima e al Sudafrica poi (estremamente severo sulla questione delle razze). Lo storico Lehembre (op. cit., pp. 145 – 155) descrive con dovizia di particolari questa fuga da Maurice come l’ultimo canto di libertà di un popolo esule dalla patria (Francia), esule in patria (Île de France), indicativo l’eco di Duval a quanti abbandonavano Maurice di «rester dans une île Maurice détruite que de vivre dans un pays comme des sémy-esclaves.”, Ibid., p. 148. Esodo che non era il rifiuto di Maurice, ma la difesa del sogno tacitamente coltivato della Francia «nation légendaire, intemporelle», Ibid., p. 156. 95 Il fallimento delle società coloniali, quindi delle speranze di un ricongiungimento alla Francia, e in particolar modo, la grave crisi economica sopraggiunta dopo il 1870 interruppero il confronto democratico intentato con la riforma dello statuto coloniale dall’amministrazione inglese nella seconda metà dell’Ottocento. La tregua sulle riforme istituzionali (a dispetto delle proteste dei lavoratori indiani manifestatesi proprio nel 1871), che ne era seguita, aveva, senza fallo, nuovamente avvantaggiato la politica dei grandi produttori, favoriti, tra l’altro, dalla modifica costituzionale del 1886, a partire dalla quale era loro stato possibile accedere alle cariche amministrative di Maurice. L’arretratezza della struttura socio-economica e politica dell’isola (improntata ancora su un sistema di produzione e su rapporti lavorativi non dissimili da quelli del periodo schiavista) si palesò in tutta evidenza negli anni Venti, allorché l’improvviso benessere, che aveva colto i produttori Franco-Mauriziani, nel periodo a ridosso della Prima Guerra Mondiale223, fu doppiato da un’altrettanto inaspettata e quanto mai esponenziale crescita demografica della popolazione indiana. Se i farmaci antimalarici avevano ridotto la mortalità tra gli engagés indiani, i prudenti investimenti da questi realizzati, durante la crisi produttiva dell’Ottocento, avevano valso loro l’acquisizione di terreni costieri, quindi, la partecipazione, in questo primo Novecento, al boom economico che aveva interessato i grandi proprietari Franco-Mauriziani. Il basso livello di vita nel quale la minoranza dei possidenti sperava di mantenere la popolazione indiana (i cui salari non erano stati certamente adeguati all’inflazione seguita al boom economico) anche (o soprattutto) in questa fase di straordinaria produttività, si scontrò, invece, con una rinnovata consapevolezza politica della classe lavoratrice, quindi, con una maggiore conoscenza dei diritti giuridici da parte della popolazione indiana. A differenza della comunità africana e malgascia, gli Indiani, nonostante lo sfruttamento subito per oltre un secolo sul suolo mauriziano non conobbero mai l’umiliazione della schiavitù; ingaggiati sin dall’inizio come salariati, in virtù della loro cittadinanza inglese, beneficiarono di più accettabili accordi lavorativi rispetto agli altri operai creoli224. La consapevolezza politica e giuridica della loro classe, concretizzatasi in questa prima metà del Novecento che non coinvolse, invece, i lavoratori di colore, derivava, pertanto, dalla diversa posizione sociale, ancorché inferiore, che gli Indiani ricoprivano nell’isola grazie alla loro diretta dipendenza dall’amministrazione inglese. Indiane furono le proteste del 1871 contro i trattamenti iniqui riservati dai proprietari terrieri; all’intraprendenza e alla risolutezza dei lavoratori indiani si dovette lo sciopero generale del 1937, 223 «Après la Première Guerre mondiale, la pénurie mondiale de sucre crée une hausse vertigineuse des cours causant un gonflement sans précédent de la masse monétaire de l’île Maurice. Celle-ci entraîne l’accroissement rapide du coût de la vie, tandis que les sucriers refusent toute augmentation des salaires […].», Jean-Pierre Durand et J., L’Île Maurice et ses populations, op. cit., p. 42. 224 Rimandiamo alle pp. 40-43 del testo. 96 quindi la formazione del primo sindacato dei lavoratori (associations d’ouvriers)225 pochi anni dopo l’indagine aperta dalla Commissione inglese sullo sciopero226. La consapevolezza di appartenere a un distinto gruppo etnico, da tutelare sul suolo straniero227, dovette incoraggiare la comunità indiana ad approfondire l’analisi sulle dinamiche sociali, con la conseguente istituzione del primo partito politico mauriziano, il P.L., il Partito dei Lavoratori. Benché i Franco-Mauriziani e i deportati malgasci e africani fossero stati i primi abitanti dell’isola, queste collettività non sembravano aver maturato, fino agli inizi del Novecento, alcun sentimento politico; i particolarismi etnici, doppiati dal senso di casta, avevano certamente frenato la spinta all’aggregazione politica, animatasi solo dopo il 36 in risposta al P.L. indiano (promotore nel 37 dello sciopero generale); su sollecitazione dei possidenti terrieri nasceva agli inizi degli anni Quaranta il Ralliement Mauricien, schieramento politico dichiaratamente francofilo e conservatore. La partecipazione delle colonie alla Seconda Guerra Mondiale, l’emergere di una consapevolezza nazionale e di partiti in difesa dell’autodeterminazione dei popoli sul suolo mauriziano spinsero il governo inglese a ripensare la carta costituzionale dell’isola Mascarena, rimasta invariata dal 1885. Nel 1947228 con l’allargamento del suffragio a quanti sapevano scrivere, fece il suo ingresso nell’Assemblea coloniale il P.L., ovvero il partito della comunità indiana (da sempre estromessa dall’amministrazione dell’isola non solo per ragioni di censo, ma soprattutto per via della politica discriminatoria dei Franco-Mauriziani, contrari all’assimilazione dell’etnia indiana nell’originaria comunità francese, contrari, di conseguenza, al conferimento agli Indiani della stessa cittadinanza mauriziana229). La sconfitta del Ralliement Mauricien si collocava all’interno di un mutato contesto sociale nel quale la popolazione indiana, di etnia indù, non solo contava ormai 332 851 unità contro i 229 255 225 «Depuis la grève générale de 1937 les uns et les autres s’organisaient pour améliorer leurs conditions de travail sur les plantations et leurs niveaux de vie. », Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 95. 226 L’indagine si rivelò successivamente un’inchiesta sull’operato dell’amministrazione locale (per lo più franco-creola), da sempre ostile al colonizzatore inglese, ma soprattutto all’apertura democratica da questo professata. Ricordiamo che le conquiste democratiche (l’abolizione della schiavitù, l’allargamento del censo, i movimenti sindacalisti) della popolazione maurizana ebbero luogo dopo il 1810 sotto l’amministrazione coloniale inglese. Non stupisce che i Franco-creoli dell’isola associassero la perdita dei loro benefici all’invasione britannica (nonostante la vicina Réunion, sotto il governo francese, subisse la stessa spinta al rinnovamento democratico). 227 « […] la crise sociale couve, renforcée par la prise de conscience par les Indiens de leur identité culturelle lors des festivités du Centenaire de l’Immigration (1935). Cette conjonction des revendications culturelles et sociales aboutit à la création du Parti Travailliste en 1936, puis aux grèves violentes de 1937 et de 1938. », Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, Paris, J. A., 1986, p. 68. 228 Jean-Pierre Durand et J., L’Île Maurice et ses populations, op. cit., p. 43. 229 «Par ailleurs, toute l’ambiguïté de la position des «Démocrates» devint apparente quand ils furent amenés à définir les termes «démocrates» et «peuples» par rapport aux immigrants indiens […] D’après leur approche de cette question, tous les Asiatiques ne devaient pas être considérés comme des citoyens et ils les excluaient de leur conception sociologique de la société mauricienne […].», Musleem Jumeer, Les véritables enjeux des premières élections législatives à l’île Maurice (1886), in Révolution française et Océan Indien, prémisses, paroxysmes, héritages et déviances, (a cura di) Claude Wanquet et Benoît Jullien, op. cit., pp. 424. 97 cristiani, tra Bianchi e Creoli230, ma, si era fatta partecipe, allo stesso modo dei grandi imprenditori Franco-Mauriziani, dello sviluppo economico dell’isola, non più e non unicamente come forza lavoro. Il potenziamento delle infrastrutture, delle reti idriche e ferroviarie, la ristrutturazione dei porti si accompagnò, allora, in questa seconda metà del Novecento a un altrettanto sistematico processo di democratizzazione che avrebbe condotto nel 1958 al suffragio universale, di conseguenza, al consolidamento del potere politico degli Indiani, rappresentati dal P.L.231. Di fatto, all’allargamento del suffragio, paventato dai riformisti democratici sin dal 1885, alla vocazione progressista della comunità indiana (affine ai fermenti indipendentisti che, in quegli anni, movevano gli animi di molti popoli colonizzati) si deve il sovvertimento della politica mauriziana, da una gestione paternalista della colonia, alla piena autonomia del self-government. L’invito più volte rinnovato alle potenze imperialiste europee da parte degli Stati Uniti di riconvertire la vecchia politica coloniale in favore di nuovi e paritetici rapporti economici e politici con le nazioni assoggettate, la costituzione di nuovi mercati, come il MEC, in favore di una politica comunitaria europea, rendevano certamente obsolete le ottocentesche monarchie imperialiste. Oltretutto, l’equilibrato dibattito politico, la matura gestione dello stato dimostrata dai partiti mauriziani, convinse l’Inghilterra ad avviare le pratiche di trasformazione della colonia in libera Repubblica in seno al Commonwealth. Nel 1965 sarebbe stata votata e siglata dalla Conferenza Istituzionale e dal futuro presidente mauriziano Ramgoolam l’indipendenza di Maurice232. Se, alla lettura degli ultimi eventi storici e sulla base di quanto ratificato a Los Angeles, la popolazione indiana dell’isola interpretava l’indipendenza (quindi la costituzione di uno stato libero e autonomo) come l’esito naturale del lungo periodo coloniale, i Franco-Mauriziani, rappresentati dal P.M.S.D. (prima Ralliement Mauricien), condannarono l’episodio come tradimento del governo britannico che, coinvolgendo alla stipula dei nuovi accordi le sole rappresentanze politiche di maggioranza (ovvero il Partito dei Lavoratori indiano), aveva volontariamente trascurato le voci, pure minoritarie ma economicamente influenti, degli altri abitanti mauriziani. Il dissenso dei Franco-Mauriziani non tardò a manifestarsi, nel sud dell’isola, dove scoppiarono gravi disordini. L’opposizione dell’oligarchia francese a un’indipendenza che nei fatti costringeva l’ex-colonia a intrattenere dei rapporti privilegiati con la vecchia potenza coloniale, che decurtava 230 Auguste Toussaint, Histoire de l’île Maurice, op. cit., p. 121. «Les Anglais désiraient faciliter l’accès à l’indépendance de la Colonie. Pour mener à bien les changements constitutionnels nécessaires, ils s’appuyèrent de plus en plus sur les leaders du parti travailliste mauricien, nouvellement élus au Conseil exécutif. […] L’instauration du suffrage universel était, il va sans dire, une calamité. L’oligarchie sucrière brandissait dans toutes les couches de la population catholique le spectre de l’ “hégémonie hindoue”. », Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 74. 232 «La Conférence constitutionnelle qui se tint en septembre 1965 à Londres accorda l’indépendance à l’île Maurice. C’était l’aboutissement d’un long processus de désengagement des Britanniques aux Mascareignes. Au terme de cette conférence un accord était signé entre le secrétaire d’Etat aux Colonies, M. Anthony Greenwood, et le premier ministre mauricien, Sir Seewoosagur Ramgoolam, reconnaissant la souveraineté du Parlement de l’île.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p., p. 135. 231 98 Maurice delle Chagos e di Agalega233, dove pure viveva un grossa comunità mauriziana, taceva, in realtà, la preoccupazione di un radicale spostamento a sinistra del futuro governo repubblicano, di cui si faceva promotore il Partito dei Lavoratori (che già, si poteva indovinare, avrebbe governato in maggioranza). Lo scandalo delle Chagos, quindi le dimissioni dei ministri del Partito Mauriziano, portarono alla caduta del governo e al bando di nuove elezioni. La campagna per le elezioni legislative, apertasi alla fine del 1966 e protrattasi fino al 1968, si trasformò sotto la propaganda sferzante dei vari partiti politici in una campagna referendaria234 sull’accettazione o sull’abrogazione dell’indipendenza concessa dall’Inghilterra nel 1965. Con il periodo preelettorale del 1966/1968 veniva, tra l’altro, inaugurata una nuova fase della politica mauriziana, orientata, con l’istituzione del Block Vote, alla consacrazione delle divisioni etniche. La convinzione inglese che la disgregazione della comunità mauriziana fosse la miglior strategia per la realizzazione un buon governo, portò alla formulazione del Block Vote, ovvero d’un sistema che obbligava ogni partito, quindi ogni cittadino a denunciare pubblicamente la sua provenienza etnica al momento della sua candidatura alle elezioni: «L’incursion communaliste dans la vie politique avait été consacrée par l’institution du «Block Vote» qui mettait claque citoyen mauricien dans l’obligation de déclarer avant l’élection à quelle communauté il appartient (…). «Il s’agissait d’opérer la conciliation assez délicate de deux impératifs: représenter équitablement les communautés sans les consacrer officiellement; leur permettre de participer à égalité, mais sans encourager les manifestations communalistes».235 233 Il paradosso (quello di un’indipendenza segnata dalla sudditanza economica all’Inghilterra «Sans indépendance économique, à quoi ça sert, l’indépendance politique? », Ibid. 137) denunciato dalla classe politica franco-mauriziana metteva a nudo il dramma di una parte della società dell’isola che con l’indipendenza, perdeva, di fatto, alcune libertà politiche: i Franco-Mauriziani privati del potere dagli Indiani, ma soprattutto gli abitanti delle Chagos e di Agalega testimoni di un vero e proprio sopruso. Conditio sine qua non per il conseguimento dell’indipendenza era la cessione delle isole da sempre appartenute a Maurice. L’interesse che l’Inghilterra nutriva verso tali possedimenti era di natura strettamente militare. Dopo aver dichiarato le isole deserte davanti alla commissione dell’ONU, l’Inghilterra, complici gli Stati Uniti, si apprestava a far evacuare la popolazione. Nonostante anche l’India avesse denunciato la nazione britannica (più preoccupata in realtà degli armamenti che sarebbero stati sistemati davanti al suo territorio), dello scandalo delle Chagos si venne a conoscenza solo grazie alla protesta delle donne del luogo. Mentre Duval accusava l’amministrazione di aver svenduto le Chagos per l’Indipendenza (quando valevano molto di più), è fatto noto che gli abitanti delle isole non sarebbero mai stati risarciti per il danno subito (i soldi essendo stati prelevati dal governo mauriziano). Per maggiori dettagli rimandiamo al testo di Lehembre pp. 139–140, e a The African Diaspora in the Indian Ocean, Shian de S. Jayasuriya & Richard Pankhurst (a cura di), op. cit., pp. 153 – 161. 234 «En 1965, l’Angleterre considère que l’île est mûre pour l’indépendance: lors du scrutin de 1967, les forces politiques s’organisent autour de deux camps que l’on croit irrémédiablement opposés: pour ou contre l’indépendance. Le Parti de l’Indépendance qui ressemble le Parti Travailliste, le Comité d’Action Musulman et l’Indépendant Forward Block bat le Parti Mauricien Social Démocrate (P.M.S.D.) représentant des intérêts sucriers. », Jean-Pierre Durand et J., L’Île Maurice et ses populations, op. cit., p. 43. 235 Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 142. 99 La pratica del Block Vote sembrava imprescindibile dal proposito di formare un governo che riflettesse la multirazzialità dell’isola e che a partire dal principio del best loser236 considerasse una priorità quella di offrire anche ai gruppi etnici numericamente limitati l’occasione di essere rappresentati in parlamento. Si delineava, così, nel biennio 66/68, lo spettro del communalism237 – che «envenime toute vie politique et masque les problèmes de fond pour leur substituer un discours devenu rapidement raciste» — che subito trasformò il Partito dei Lavoratori, inizialmente riformista e di opposizione, nel “parti des Hindous”238. Tra il 1967 e il 1968 si delinearono due schieramenti politici, il partito dell’Indipendenza nato dall’intesa del Partito dei Lavoratori, e del C.A.M. (Comitato d’Azione Mussulmana, fondato nel 1958), e il P.M.S.D., che vedeva riuniti Creoli e Franco-Mauriziani in difesa della departimentalizzazione239 (della vicina Réunion) contro l’infido compromesso indipendentista siglato dai rappresentanti Indiani. L’inevitabile, attesa vittoria del Partito dell’Indipendenza scatenò la controffensiva dell’oligarchia francese dell’isola, certa che una sommossa popolare, un principio di guerra civile, avrebbe convinto il governo britannico a bloccare il processo di democratizzazione in favore di una diversa, più moderata linea politica. Nel 1968, al termine dello scrutinio dei voti, alcuni facinorosi Mussulmani attaccarono i Creoli cattolici installati nella colonia mussulmana. La rivolta, arrestatasi solo di fronte ai numerosi feriti mussulmani e creoli, si rivelò il maldestro tentativo del P.M.S.D. di ostacolare l’attuazione del programma socialista del nuovo governo laburista mauriziano240 (il cui progetto di statalizzazione minacciava direttamente gli interessi economici dell’oligarchia terriera). 236 «Par ailleurs, le communalisme, introduit depuis 1948 afin de diviser pour mieux régner, restait le principe politique principal. Il est même inscrit d’une certaine manière dans la Constitution à propos de l’élection de l’Assemblée législative. Celle-ci prévoit la nomination par la commission électorale de huit députés parmi les best losers (meilleurs perdants) afin de rétablir l’importance relative des différentes communautés. », Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, op. cit., p. 69. 237 «Le parti de Duval faisait flèche de tout bois, ne reculant devant aucun excès. […] Monté sur un podium place du Quai, à Port-Louis, […] Duval encourageait ses supporters à semer la terreur: “Il faut désinfecter la place du microbe communaliste”. Le microbe était bien entendu, l’Indien, depuis le jour où il avait manifesté le désir de participer à la vie politique de l’île.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 141. 238 Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, op. cit., p. 69. Come fa notare lo storico Lehembre, la nascita del P.M.S.D. era diretta conseguenza dell’evoluzione del movimento operaio indiano in partito politico. La vittoria del P.L. alle elezioni del 1947, riconfermata nel 1958, metteva la borghesia francese dell’isola di fronte la necessità di spostare il nuovo dibattito dai problemi della nazione mauriziana, una questione di ordine religioso,più che etnico, in modo da arginare il fenomeno indiano, indù, la cui popolazione prevaleva numericamente su tutte le altre etnie dell’isola: «Le nouveau système électoral obligeait la caste blanche à s’allier à tout non-Indien. Pour faciliter un plus vaste rassemblement, il sentait la nécessité de glisser du racial au plan religieux, cette opération lui permettant de retrancher de la masse indo-mauricienne la population musulmane. », o ancora «Il fallait exacerber les différences religieuses […]. Il fallait exacerber les différences entre hindous et musulmans, entre hindous et hindous-tamouls […]. De là l’insistance avec laquelle les oligarques dénonçaient le danger de «l’hégémonie hindoue» plutôt que celui de l’hégémonie indienne.», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 87, p. 78. 239 «A plus d’un titre le programme politique du P.M.S.D. était calqué sur celui des départementalistes réunionnais. L’intégration défendue par Duval n’était rien d’autre que le statut de département appliqué à la Réunion depuis la fin de la guerre. », Ibid., p. 159. 240 «La cause de ces désordres était d’ordre racial: des bandes de Musulmans, armés de sabres, s’étaient attaqués à des groupes de Créoles catholiques […] provoquant le déménagement des familles créoles qui vivaient dans les quartiers musulmans, et, réciproquement, la fuite des familles indo-musulmanes des quartiers créoles. […]. Dès l’éclatement des 100 Lo stato di urgenza in cui versava l’isola dopo i disordini del 1968, il ristagno della produzione, la neutralità dimostrata dal governo inglese riguardo alla risoluzione dei numerosi problemi del nuovo stato repubblicano, non ultima l’imponente crescita demografica a fronte di una già precaria situazione economica241, non aiutarono la nuova coalizione ad avviare le radicali riforme strutturali messe in luce nel programma elettorale. Nonostante il Partito dei Lavoratori avesse raggiunto la maggioranza alle legislative del 1967, paradossalmente il 1969 vide il ritorno trionfale del P.M.S.D. (della borghesia franco-mauriziana) al governo. La difficile situazione politica ed economica che lasciava l’Inghilterra convinse il governo di Ramgoolam a tentare una riconciliazione con la Francia: non era difatti l’indipendenza l’unica via perché la Francia potesse ritornare da partner economico sul suolo mauriziano? La promessa del Ministro francese Debré che l’antica patria avrebbe sostenuto il nuovo governo a patto che alcuni ministeri fossero ceduti ai rappresentanti del P.M.S.D., la spuntò sulle ritrosie della coalizione di sinistra e sui dubbi della destra franco-mauriziana e franco-creola, fino ad allora spronata da Duval ad opporsi a qualsiasi compromesso con il governo di Ramgoolam242: il pragmatismo: «[…] des “magnats sucriers” veillait à ce que leur opposition à la bourgeoisie indo-mauricienne qui animait le parti travailliste, n’aboutit pas à une rupture qui eut été irrémissible. […]. Aussi les détenteurs du pouvoir économique offrirent-ils à Sir Seewoosagur Ramgoolam de contribuer à l’élaboration d’une nouvelle premières vagues de violence dans l’est de l’île, il apparut que les affrontements avaient lieu dans les anciens rangs du P.M.S.D.. la découverte d’importants stocks d’armes de toute sorte […] incita les autorités à penser qu’un coup de main avait sans doute été envisagé contre le régime instauré par Sir Seewoosagur Ramgoolam. », Ibid., p. 143. 241 Subito dopo l’accordo siglato nel 1965 con l’Inghilterra, il presidente Ramgoolam aveva compreso la necessità e l’urgenza di stringere un intensa rete di legami con le potenze straniere, oltre l’Inghilterra, per far fronte ai gravi problemi in cui versava l’isola. La Francia, in tal senso, fondatrice della colonia originaria di Maurice, si offriva alla futura Repubblica come il deus ex machina di un melodramma lungamente recitato sul suolo Mauriziano, ricongiungendo le due maggiori anime dell’isola, quella indiana (inglese), quella franco-mauriziana, nel segno di una sottomissione ideale alla Francia stessa: «Apparemment, à l’instar des chefs d’Etat de l’Afrique francophone, ils (Ramgoolam et Duval) venaient chercher dans la capitale française une légitimité qui les confortait […]. […] Quoiqu’il en fut […]: Paris tenait entre ses mains l’avenir économique de l’île Maurice. […] Les dirigeants travaillistes avaient acquis, malgré tout, la certitude que seule l’Indépendance créait les conditions d’une politique de l’aide et de coopération de la France à l’égard de leur île. […] A l’époque où Michel Debré cherchait à accélérer le flux migratoire réunionnais, G. Duval et ses amis réclamaient, sans aucune chance de succès, […] la création par le Colonial Office d’un Bumidom britannique. Et quand Londres dissipa […] cet espoir, le mimétisme produit par l’exemple réunionnais […] entretint le rêve que Paris absorberait l’émigration mauricienne […].», Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., pp. 157 - 160. Non migliorava frattanto la situazione occupazionale con un aumento dei cassintegrati e degli scioperi, «La question du chômage se posait au gouvernement avec acuité. […] Une estimation, faite à cette époque, indiquait que le chômage réel touchait cent mille hommes.», Ibid, p. 173. 242 «L’attitude des deux grands partis déconcerta un très grand nombre de leurs partisans. De part et d’autre, on accepta difficilement l’union sacrée proclamée à haut lieu. […] La coalition entama également une part du prestige de G. Duval. (…] Ses appels au peuple, chaque fois que la négociation achoppait, dans l’espoir de forcer la main du premier ministre, les avait accoutumés à répéter “coalition = trahison”. Aussi quelle fut la surprise d’apprendre un soir devant leur poste de télévision de sa bouche même que la coalition “c’était la foi dans l’avenir”.», Ibid., pp. 166 – 168. 101 politique de développement de l’île s’il renonçait à appliquer le programme socialiste […] notamment à nationaliser les banques, les dock set les propriétés sucrières.»243. Nel 1969, agli occhi delle minoranze etniche che avevano votato per la realizzazione di uno stato socialista e garantista, si inaugurava con il nuovo governo di coalizione (P.M.S.D. e Partito dei Lavoratori) una politica decisamente liberista: partigiana, ancora una volta, degli interessi capitalistici della borghesia francese. La scelta di un sì radicale liberismo in campo economico e sociale sembrava, però, trovare ragioni negli annosi problemi della colonia ora repubblica mauriziana, a cui nemmeno il governo inglese era stato capace di trovare una reale soluzione. Maurice rimaneva in questa seconda metà del Novecento un’isola fortemente sovrappopolata (più della vicina Réunion che pure poteva contare su un’estensione territoriale maggiore), con una disoccupazione crescente. Era necessario dunque fare dell’isola una sorta di paradiso industriale e fiscale, agevolando l’investimento di capitali stranieri244. Divenuta zona franca, potendo contare su un livello infimo di retribuzione degli operai, l’isola conobbe un periodo iniziale di boom economico: «Se refusant [le gouvernement de coalition]à intervenir dans les affaires du secteur sucrier, il lassait libre cours à l’exploitation de plus de la moitié de la population active.[…] Pour attirer les investisseurs le gouvernement de coalition avait crée en 1970 une zone manufacturière d’exportation, encore dénommée zone franche de transformation industrielle […] . De fait les salaires pratiqués sur la zone franche […] étaient «de 25 dollars à Maurice en 1974, alors qu’ils étaient de 111 dollars au Sénégal, de 74,5 dollars en Corée et de 99 dollars à Singapour».245. Dall’altra parte, il governo pensò di risolvere il problema della sovrappopolazione e della crescente disoccupazione incentivando l’emigrazione di forza lavoro specializzata verso le nazioni europee246. Di fronte all’effettiva crescita economica di cui erano riuscite ad avvantaggiarsi solo alcune categorie, al perdurare di una situazione sociale e lavorativa critica, quindi dinanzi al ristagnare 243 Ibid., p. 167. «La création d’une zone franche, le développement de l’industrie touristique et un plan d’émigration constituaient les volets du triptyque gouvernemental pour la résorption du chômage. Pour atteindre cet objectif, les postes-clés avaient été confiés aux ministres PMSD capables, pensait-on dans l’entourage du premier ministre, d’encourager le concours d’investisseurs privés. », Ibid., p. 173. 245 Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 170 – 175. 246 «L’agitation sociale de plus en plus virulente parmi les travailleurs de la relève […] avait réalisé un consensus au sein de la classe politique qui donna le feu vert à […] Duval. Le 6 mars, Alex Rima soumettait à l’approbation du Conseil des ministres un plan qui modifiait la tactique du gouvernement pour faire «émigrer les travailleurs» […] orientés vers les secteurs privés des pays intéressés. », Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, op. cit., p. 177; Dai dati forniti dallo storico Lehembre, relativi all’immigrazione, si evince che le nazioni straniere agevolavano l’immigrazione clandestina rispetto a quella regolare in quanto meno onerosa per gli stati e le industrie europee, Bernard Lehembre, L’île Maurice, op. cit., p. 181. 244 102 dell’economia non certo aiutata dalla fuga di personale qualificato verso l’estero, la classe operaia, ormai convinta della faziosità delle scelte politiche di governo, decise, nel 1970, di manifestare il proprio malcontento: «Ce gouvernement de coalition n’entame aucune des réformes indispensables à la survie de l’île face à la démographie galopante. L’industrialisation autocentrée, la diversification agricole, la réforme agraire ou toute modification dans les institutions scolaires en particulier remettent trop d’intérêts en jeu d’être amorcée. »247. Protesta, che gridava il profondo dissenso verso un governo che, tradendo la sua prima linea politica, aveva certamente rivelato i limiti se non le falle del sistema communalista, etnocentrista, inaugurando, con i compromessi politici, la corruzione del potere fin nelle più alte sfere248. In piena crisi politica, nel 1969 nasceva per iniziativa studentesca il M.M.M., ovvero il Mouvement Militant Mauricien (presentato al pubblico in occasione della visita della principessa Alexandra), di ispirazione socialista e chiaro oppositore del communalismo. Il socialismo radicale professato dai membri del M.M.M. unito a una fede politica aconfessionale (estranea a qualsiasi divisione etnica), il rigore politico e la capacità organizzativa mostrata in pochi anni trasformarono il movimento nel primo (e unico) partito di opposizione, attivamente sostenuto dalla popolazione, fautore nel 1971 di un imponente sciopero249. Il communalismo, di cui anzitempo Duval aveva preannunciato e denunciato le conseguenze funeste, per poi, una volta al governo, sfruttarne il principio disgregatore “pour mieux régner”, veniva duramente criticato e osteggiato dai membri del M.M.M.. Rivendicando la priorità dell’azione politica su qualsiasi campanilismo etnico, il movimento studentesco si opponeva al sistema communalista in quanto retaggio della cultura coloniale, prima francese (eredità una gestione economica classista dell’isola perdurata fino al 1968), poi inglese (lascito dell’amministrazione britannica). I larghi consensi riscossi dal M.M.M impartivano una dura lezione storica250, prima che politica, alla coalizione di governo che si convinse della necessità di intervenire con ogni mezzo per sradicare il neonato sentimento nazionalista mauriziano. Allo sciopero del 1971, quindi alle elezioni 247 Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, op. cit., p. 69. «Il existait ainsi […] une couche d’hommes politiques entièrement corrompus qui s’accrochaient au pouvoir, et qui pour conserver leurs privilèges étaient prêts à toutes les compromissions […] couche qui, à la fois, maintenait la domination de l’oligarchie sucrière et se maintenait grâce à elle. », Ibid., pp. 170 – 172. 249 «Le mouvement militant mauricien (M.M.M.), né de la contestation étudiante, remporte dès 1970 une élection partielle à Triolet Pampeloussess. Ce nouveau parti qui rejette le jeu communaliste, acquiert une très large audience à un rythme qui étonne jusqu’à ses dirigeants. Il s’implante dans le monde du travail en créant la ‘General Workers’ Federation (GWF), qui supplante bientôt la centrale syndicale travailliste. », Ibid., pp. 69 – 70. 250 Il M.M.M. si proclamava anzitutto come movimento volto alla tutela dell’identità mauriziana. 248 103 del 1972 seguirono quattro anni di persecuzioni, censure, arresti indiscriminati ai membri del M.M.M., a fronte di nuove e più intense alleanze tra il Partito dei Lavoratori e il P.M.S.D. di Duval: «À la fin de 1973, S. Ramgoolam remercie G. Duval, dirigeant du P.M.S.D.. Six députés de ce parti l’abandonnent pour rejoindre le Parti Travailliste; ils recevront en récompense quelques postes administratifs de haut rang […]. C’est le début d’un long processus de détérioration des mœurs politiques où se multiplient transfuges et privilèges au profit de la classe politique. »251. Nonostante le rappresaglie del governo avessero inizialmente disorientato il movimento studentesco, il M.M.M. riuscì a riorganizzarsi per candidarsi alle elezioni del 1976, poi ancora del 1982, con un programma certamente meno estremista, nondimeno fedele a una linea politica terzomondista: «à la fois éloignée du capitalisme et de tout ce qui a trait aux socialismes soviétique et chinois. »252. L’originalità del programma politico presentato dal movimento studentesco, sopravvissuto al ripetuto boicottaggio della coalizione di governo, fu premiato alle elezioni del 1982 allorché il M.M.M., corso alle elezioni con il P.S.M. (sorto in seguito alla fuga di alcuni esponenti dal P.L.) con il R.P.L. (Riunione per il Progresso della Libertà) e l’O.R.P. (Organizzazione del Popolo Rodrighese), conquistò la totalità dei seggi in parlamento253. In opposizione alla politica duvalista dell’emigrazione (in risposta al dilagare degli scioperi, alla mancanza di offerta lavoro, e all’aumento della popolazione), i nuovi esponenti del governo si lanciarono in una radicale statalizzazione dell’economia con l’espropriazione di numerosi zuccherifici e di terreni ai privati, con il controllo sulle esportazioni della produzione locale, con la nazionalizzazione della sanità con la creazione di agenzie di collocamento (allocation-chômage)254. Il grosso disavanzo che il governo precedente lasciava in eredità al nuovo insediamento, la crisi economica internazionale aggravata dal superdollaro e dall’aumento del greggio, non crearono, però, le condizioni necessarie perché potessero essere attuate le riforme previste dal M.M.M., caduto dopo soli sei mesi sotto i colpi di nuove intese, coordinate, ancora una volta, dal P.M.S.D. Nonostante sin dal 1790 i Mauriziani avessero dato prova di un profondo senso politico e nazionale, e ancora nel 1871, primi fra i coloni dell’Oceano Indiano, si fossero fatti promotori di 251 Jean-Pierre Durand, L’Île Maurice aujourd’hui, op. cit., p. 71. Idid., p. 72. 253 «Les résultats du scrutin de juin 1982 […] constituent une «première mondiale» dans un pays démocratique, selon les mots d’un dirigeant MMM. Avec 63,7 % des suffrages, la coalition de gauche remporte la totalité des soixante sièges de députés. Elle s’érige de facto en parti unique. », Ibid. 254 Ibid., p. 73. 252 104 embrionali movimenti operai, le comunità che popolano l’antica isola dei Cigni, unitamente divise, sembrano essere difficilmente sopravvissute ai fantasmi delle patrie perdute. Questa ipertrofizzazione del metafisico che tanto ha nutrito la letteratura mauriziana, vive di paesi eternati in villaggi indiani o bretoni meticolosamente ricostruiti su una terra tanto lontana dalla Francia come dall’India, di patrie ritrovate soprattutto nell’infaticabile verbalizzazione del lessico familiare. Utopia coloniale in epoca postcoloniale. Réunion-département, l’insostenibile esercizio della libertà Alla fine degli anni Sessanta, le giovani nazioni africane e asiatiche, sorte dalle ceneri dei vecchi imperi coloniali, crollavano sotto il peso della crescente instabilità politica. Schiacciate dal passato ingombrante della schiavitù, della deportazione, dell’assoggettamento, quindi dell’alienazione culturale, insidiate, nella seconda metà del XX secolo, dai totalitarismi, le ex-colonie esibivano le fragili, illusorie, libertà che erano state loro più o meno benevolmente concesse dalle potenze europee. Come fa notare Edmond Maestri, nonostante le pressioni statunitensi per una sollecita liquidazione delle antiche colonie, Francia e Inghilterra, con il pretesto della minaccia sovietica, optarono per un sistema di stati federati (vincolati al governo centrale) che conciliasse le libertà democratiche con il regime coloniale: «Le Togo, le Cameroun sous la tutelle de l’ONU constituent les territoires associés, le Viêt-Nam, le Laos et la Cambodge représentent des États associés. Le fédéralisme est donc un trompe l’œil. La monstruosité juridique sécrétée par la troisième République perdure puisque l’Algérie dépend toujours du Ministère de l’Intérieur, les DOM et les TOM du Ministère des Colonies devenue Ministère de la France d’Outre-mer […].»255 Il testo della Conferenza di Brazaville del 1943 – 1944256 (una controproposta alla precedente Carta Atlantica del 1941), se non negava in assoluto la possibilità d’indipendenza dei popoli 255 Edmond Maestri, L’année 1946, in 1946: La Réunion, Département. Regards sur la Réunion contemporaine. Actes du Colloque de Saint-Denis de La Réunion organisé par l’Université de La Réunion en collaboration avec le Conseil Général de La Réunion, 6 – 10 octobre 1996, op.cit., p. 33. Il corsivo è mio. 256 «A la Conférence de San Francisco, Georges Bidault, alors Ministre des Affaires Étrangères dénonçait «une campagne d’ignorance et de calomnie» contre l’empire colonial de la France. […] Toutes ces menaces sur le sort de l’Empire après-guerre on pesé sur la décision […] d’organiser la Conférence africaine française de Brazaville. […] dans les colonies françaises il n’y avait pas de peules à «affranchir», […] leurs populations ne voulaient pas d’autre 105 colonizzati, rivendicava comunque la legittimità della politica coloniale come strumento civilizzatore per quelle nazioni non avvezze ai principi democratici, carenti, ancora a Novecento inoltrato, nelle infrastrutture e aliene, infine, ai progressi della tecnica257. Lo statuto di dipartimentalizzazione del 1946 – promosso congiuntamente dalla Guadalupa, dalla Martinica, dalla Guiana e dalla Réunion, accordato senza riserve dalla Francia – si collocava evidentemente all’interno di questa nuova fase coloniale. Già nel lontano 1800, sull’esempio dei rivoltosi haitiani, la Réunion aveva tentato, con esiti incerti e una trascurabile partecipazione popolare, la via della secessione, sospesasi solo di fronte alla rimessa in vigore dello schiavismo e dopo, nel 1848, di fronte all’assicurazione da parte francese di un’estensione del suffragio. Benché gli episodi della storia francese confessino senza fallo il poco interesse dei Reunionesi al conseguimento di un’indipendenza economica e politica dalla madrepatria, nondimeno lo storico Prosper avanza la tesi che, già agli inizi del Novecento, le riforme doganali intraprese dalla Francia nel 1892258 avessero suscitato un acceso dibattito politico sulla modifica dello statuto della colonia in dipartimento assimilato alla Metropoli, o viceversa in stato autonomo e sovrano, in seno a una federazione di stati francesi: «La bataille engagée par les parlementaires réunionnais à la fin du XIXe siècle contre la centralisation, trouve un relais au Conseil général à partir de 1901. Une commission est nommée pour étudier un projet de réforme du système politique. Deux groupes s’affrontent. Le premier, majoritaire à l’Assemblée, menée par Jules Hermann, notaire à Saint-Pierre, veut que la Colonie soit dotée d’une Constitution qui lui accorderait l’autonomie politique et financière au sien de la République française. […] Le deuxième groupe, représenté au Conseil général par Paul Dussac, propose l’assimilation de la Colonie à un département français.»259 indépendance «que celle de la France» […] Les fins de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de l’empire: la constitution éventuelle même lointaine de self-gouvernements dans les colonies est à écarter.», Oruno D. Lara, Nelly Schmidt, Colonisation et assimilation aux Caraïbes et à la Réunion. Origines et responsabilités politiques de la loi du 19 mars 1946, Ibid., pp. 126 - 127. 257 «La France entend aider au bien-être national des populations de son empire colonial. Elle fait de plus son possible pour les amener peu à peu à un stade supérieur de civilisation qui lui permettra d’augmenter les libertés dont elles disposent.», Yvan Combeau, La Réunion – la France (1945 – 1916), Ibid., p. 115. 258 «La Réunion-département est un vieux désir des républicains réunionnais. Ils l’affirment nettement à la fin du XIXe siècle, quand la loi du 11 janvier 1892 vient assimile cette Colonie à la Métropole quant au régime douanier et l’obliger à acheter en France un outillage et des denrées qu’elle pourrait trouver à meilleur compte à l’étranger. Le poids de l’administration parisienne est alors vivement dénoncé.», Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), in 1946: La Réunion, Département. Regards sur la Réunion contemporaine. Actes du Colloque de Saint-Denis de La Réunion organisé par l’Université de La Réunion en collaboration avec le Conseil Général de La Réunion, 6 – 10 octobre 1996, textes réunis par Edmond Maestri, op. cit., p. 137. 259 Ibid., p. 138. 106 I brogli elettorali, la corruzione politica radicata nella società reunionese, quindi la minaccia ricorrente della revoca del suffragio da parte del governo francese, il disinteresse mostrato della popolazione creola, degli engagés e degli ex-sciavi, verso le questioni amministrative dell’isola260, non impedirono, tuttavia, che l’ambizione lungamente carezzata da pochi politici della Réuniondépartement divenisse nel 1936 la divisa dei ferrovieri e degli scaricatori di porto in sciopero261. Se agli inizi dell’Ottocento le istanze indipendentiste erano state promosse da una classe dirigente per niente favorevole alle riforme progressiste della neonata repubblica francese, in questa prima metà del Novecento il modello dipartimentalista diventava, al contrario, il vessillo dei sindacalisti reunionesi, promotori di una linea politica riformista che, plasmata sulla legislazione francese, affrancasse la Réunion dal retaggio di un’economia schiavista e colonialista. Con i sindacalisti del CGT e i militanti della SFIO, Lépervanche giudicava la dipartimentalizzazione come l’unica via praticabile dalla società civile reunionese per accedere agli stessi benefici, alle medesime conquiste in campo pubblico e privato, di cui già godevano gli operai francesi: «Par la voix de ses représentants, la majorité de la population exigeait une intégration accrue au sein de la démocratie française. Sa revendication portait sur l’égalité sociale entre habitants des Vieilles Colonies et habitants de la France métropolitaine.»262. 260 Le votazioni, pilotate fino ai primi del Novecento dall’oligarchia terriera, furono la causa della disaffezione del popolo reunionese alla politica. Il perdurare del malcostume nell’amministrazione convinceva la maggioranza dell’elettorato, costituito per lo più da ex-schiavi (chiamati citoyens), dell’elitarietà delle questioni politiche, un affare dei Bianchi per i Bianchi. Per maggior dettagli rimandiamo al testo di Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., pp. 73 – 75. 261 «Lors d’une manifestation organisée le 11 novembre 1936 à Saint-Denis par la jeune Fédération Réunionnaise du Travail (FRT) – affiliée à la Confédération Générale du Travail (CGT) – qui regroupe les syndicats de cheminots, de dockers, de haleurs de pioche, La Réunion-département Français apparaît sur les banderoles et devient un slogan des travailleurs.», Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), Ibid., p. 141. Con la SFIO (Section Française de l’Internationale Socialiste) già attiva nel porto, nasceva nel 1930 il CPR (Chemin de Fer et Port de la Réunion). Fondatore e attivista di questo movimento sindacale, alla testa dello sciopero del 1936, Léon de Lépervanche. Contro il perdurare dell’oppressione della classe operaia (a dispetto delle ottime prospettive economiche di cui riuscirono a godere i pochi grandi industriali dell’isola durante e dopo la Prima Guerra mondiale), i sindacalisti rivendicavano orari di lavoro e una retribuzione pari a quella dell’operaio francese: «C’est au port, ville symbole de modernité, d’industrialisation, par les quais qui avancent vers l’Océan et le monde, et par le chemin de fer qui y possède son siège, que commencent les grèves de 1936: en août, des dockers, des matelots, des employés du CPR cessent le travail pour l’obtention de la journée de 8 heures. […] devant le scepticisme et l’hostilité des forces politiques radicales ou socialistes et des milieux des notables (pourtant humanistes), les élections municipales partielles du Port permettent l’arrivée à la scène politique des premiers élus communistes: Lépervanche, Roufli, Malet. L’affaire est d’importance, car désormais est née une opposition effectivement «radicale», l’amorce d’une stratégie de rupture […].», Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., pp. 102 – 103. 262 Françoise Vergès, Égalité républicaine et réalité (post) coloniale, in 1946: La Réunion, Département. Regards sur la Réunion contemporaine. Actes du Colloque de Saint-Denis de La Réunion organisé par l’Université de La Réunion en collaboration avec le Conseil Général de La Réunion, 6 – 10 octobre 1996, textes réunis par Edmond Maestri, op. cit., p. 236. 107 Il progetto franco-reunionese, avviato nel 1936, di eseguire interventi più ampi e radicali in merito all’equiparazione dei salari, al risanamento generale dell’economia insulare, fu bruscamente interrotto dallo scoppio della Seconda Guerra mondiale, per arrestarsi definitivamente nel 1940 negli anni della dittatura di Vichy. La nuova linea politica tracciata dal governo filofascista di Pétain: «Travail, Famille, Patrie», orientata nella difesa della tradizione cattolica e conservatrice di alcune classi (ancora nostalgiche del regime schiavista), si mostrava favorevole al mantenimento dello status quo coloniale retto sul potere dell’oligarchia imprenditoriale del luogo, ridimensionando la minaccia, prospettatasi nel 1936, di una rivoluzione reunionbolscevica. Come in Francia, così alla Réunion le riforme varate dal nuovo governo avevano come obiettivo principale quello di fiaccare l’opposizione a vantaggio di un consenso universale costruito sulla retorica e sulla propaganda fascista263. La morsa ideologica messa in atto dalla politica di Pétain (incapace di fronteggiare la crisi economica internazionale sopraggiunta con la guerra ed esasperata sull’isola dal blocco inglese) ebbe l’unico effetto di piegare le nascenti posizioni nazionaliste in favore di un orientamento filocoloniale. L’evidente compromissione della classe dirigente reazionaria con il governo di Pétain, l’appoggio manifesto della Chiesa e di una parte della popolazione reunionese al Fascismo264 anche dopo il 1944, costringevano la Réunion, provata, ora, economicamente e smarrita politicamente, per alcuni versi invisa anche al governo della quarta Repubblica per il suo appoggio alla dittatura fascista, ad assestarsi sulla linea politica più moderata, certamente anti-indipendentista, della dipartimentalizzazione. * «Art.1 – Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français. Art. 2 – Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront avant le 1er janvier 1947 l’objet de décrets d’application à ces 265 nouveaux départements.» 263 Rimandiamo al testo, Évelyne Combeau-Mari, Edmond Maestri (sous la direction), Le régime de Vichy dans l’Océan Indien, Madagascar et la Réunion (1940 – 1942), CRESOI, Sedes, 2002. 264 «Le 18 juillet [1940], le «loyalisme réunionnais» est réaffirmé. Il entre dans la thématique plus large du loyalisme des colonies que la presse de Vichy ne cesse de reprendre.», Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., p. 102. Le testimonianze del tempo, però, non sollevano la Réunion dalla responsabilità di adesione a Vichy come hanno fatto Maestri e Combeau. L’appoggio reunionese sembra essere stato molto più che formale o una diretta imposizione del governatore del Madagascar. La popolazione dell’isola (soprattutto l’oligarchia e la massa meno abbiente), difatti, considera molti provvedimenti restrittivi di Vichy come necessari per il risanamento dell’economia, dell’educazione scolastica («Travail, Famille, Patrie») ma soprattutto per la bonifica della politica, minacciata dal Comunismo nascente. «Alla Réunion non ci si oppone al governatore», «la France, c’est Pétain», sono i motti che meglio raccontano il clima, il coinvolgimento emotivo e politico dei Reunionesi al Fascismo di quegli anni. 265 Oruno D. Lara, Nelly Schmidt, Colonisation et assimilation aux Caraïbes et à la Réunion. Origines et responsabilités politiques de la loi du 19 mars 1946, Ibid., p. 124. 108 Il 15 marzo del 1946 veniva votata dall’Assemblea Costituente la legge di dipartimentalizzazione precedentemente depositata dai rappresentati della Guadalupa, della Martinica, della Guiana e della Réunion. Rimasto invariato dal 1825, lo status coloniale si rivelava anacronistico in questa metà del Novecento devastata da due guerre mondiali, sopravvissuta alle dittature e alla minaccia della bomba atomica, assediata dai movimenti indipendentisti e dalle nuove dottrine comuniste. Il dibattito aperto nel 1902, continuato nel 1936, su un’eventuale assimilazione delle vecchie colonie al governo francese trovava, alla fine della guerra, il consenso della stessa Francia. Contrariamente a quanto sarebbe accaduto al Madagascar negli anni che precedettero la rivoluzione del 1947266, il nuovo governo francese non si oppose alla richiesta di dipartimentalizzazione promossa dalle colonie antillane e dalla colonia reunionese, al contrario ne sollecitò l’attuazione in tempi brevi (dalla fine della guerra nel 1945 trascorse un solo anno dalla firma). La variante andava in contro ad alcuni punti del programma politico espresso dalla coalizione di sinistra che, al tempo, presiedeva la quarta Repubblica267, alineandosi ai principi enunciati nella Carta di Los Angeles: alla difesa del diritto di autodeterminazione dei popoli (promossa dagli Stati Uniti), senza per questo negare alla Francia la prerogativa di continuare a esercitare il proprio potere sulle antiche colonie. Già nel 1945 durante i lavori dell’Assemblea Costituente, la partecipazione di sessantaquattro membri dei territori d’Oltre-mare (tra cui spiccavano anche i deputati africani), aveva rinnovato il patto di fedeltà tra le colonie e la Francia, delineando il programma politico di un governo che si dichiarava disponibile a mettere fine al vecchio impero in favore di una nuova intesa federale che avrebbe coinvolto le vecchie colonie: «La Constituante compte 64 élus d’Outre-mer […]. Elle donne vite le sentiment de vouloir […] mettre fin au vieux système impérial, et de souhaiter la définition d’un lien nouveau […] par un dosage subtil d’assimilation et d’adhésion libre de type fédéral»268. 266 Già nel 1939, poi nel 1946 le rivendicazioni malgasce della soppressione del regime di indignato, dell’applicazione della legislazione francese sul suolo malgascio, infine del riconoscimento della cittadinanza francese alla popolazione malgascia rivelavano il tentativo della popolazione di accedere allo statuto dipartimentalista. Solo nel 1946, poco prima dello scoppio della rivoluzione, la Francia concesse lo statuto di Territoire de la République Française estendendo la cittadinanza francese a tutti i Malgasci. Hubert Deschamps, Histoire de Madagascar, op. cit., p. 261, p. 265. 267 «Le PCF avec plus de 5 000 000 de suffrages sur 20 000 000 d’électeurs obtient le 26% des exprimés […] et dévient le premier parti de France. […] Cette suprématie de la gauche française est un moment unique de la vie politique française. […] Cette situation politique (accord entre «les représentants des anciennes colonies» et le gouvernement) conduit au vote du 14 mars et à la loi du 19 mars.», Yvan Combeau, La Réunion – la France (1945 – 1916), op. cit., p. 112. 268 Edmond Maestri, L’année 1946, op. cit., p. 31. 109 La revoca, lo stesso anno, del regime di indigenato (che faceva dei popoli colonizzati degli individui senza diritti) era un chiaro riconoscimento, l’estensione, da parte dell’autorità parigina, della cittadinanza francese a tutti gli abitanti delle colonie del quadrilatero. Come fa notare Yvan Combeau, la dipartimentalizzazione del 1946 era, quindi, frutto di un’unità di intenti, di una medesima linea politica che, dopo il 1944, Francia e Réunion (e le altre colonie d’Oltre-mare), per una rinascita dalla dittatura di Vichy, per via delle precarie condizioni economiche, si trovavano eccezionalmente a difendere. Alla fine del 1944, le poche infrastrutture di cui poteva vantare l’isola, risalenti per lo più all’Ottocento269, divenivano il simbolo di una Réunion, sottosviluppata, con una popolazione in forte crescita, affamata dalla mancanza di materie prime disponibili, esasperata dall’involuzione sociale a cui gli anni della dittatura di Vichy l’avevano condotta, privata di certezze occupazionali, che pure guardava alle nuove, libere elezioni del 1945 come la via del rinnovamento, avviato, ma non concluso, nel 1936. Il CRADS (Comitato Repubblicano d’Azione Democratica e Sociale)270, fondato nel 1945 per iniziativa del repubblicano Raymond Vergès e del comunista Léon Lépervanche (attivo nella SFIO nel 1936), si fece portavoce di questa spinta al rinnovamento e alla tutela del cittadino reunionese in ambito civile e lavorativo: «de sortir d’une situation d’inégalité et d’injustice flagrantes […] de lutter efficacement contre le paludisme, de faire reculer la mortalité infantile et l’analphabétisme.»271. Il grave stato di arretratezza in cui versava l’isola esigeva, secondo i teorici del CRADS, che venissero attuate delle drastiche riforme in campo economico perché il lavoratore 269 «au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation économique est catastrophique. L’Île possède toutes les caractériqstiques d’un pays sous développé. La ration alimentaire (viande et poisson) annuelle par habitant chute de 14,9 Kilos (1938) à 9 Kilos en 1945. L’agriculture se trouve dans une situation désespérée.», Yvan Combeau, La Réunion – la France (1945 – 1916), Ibid., p. 110. Ancora Maestri, Combeau: «En 1943, La Réunion, qui compte 225000 habitants, évite la catastrophe alimentaire grâce à l’arrivée de plusieurs milliers de tonnes de riz et de légumes. […] la quantité des marchandises débarquées sur l’île est inférieure de plus de 60% à la situation d’avant-guerre. […] Globalement la pénurie caractérise l’économie de l’île. Trois cyclones (avril 1944, janvier et avril 1945) détruisent les cultures et ralentissent considérablement le retour à la normale. […] Au lendemain de la guerre, les infrastructures de l’île sont également dans un état pitoyable, qu’il s’agisse des installation hydrauliques et thermiques ou du réseau routier.», Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., pp. 113 - 114. 270 Già CARDS (Comitato d’Azione Repubblicana Democratica e Sociale) nato nel 1928 dal Comitato Repubblicano reunionese, da cui si distingue per la linea moderata. Tra i fondatori Raymond Vergès che del CRADS sarebbe stato, nel 1945, il principale animatore. «Dès à présent, il convient de souligner que le CRADS n’est pas un parti politique mais un front de classe dans lequel les communistes ont joué un rôle particulièrement dynamique. En raison de l’existence d’un prolétariat important, ils sont déjà solidement implantés dans l’île à la Libération bien que la Fédération réunionnaise du PCF n’ait été officiellement créée que le 30 novembre 1947 à l’initiative de Raymond Vergès», André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais de 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, in 1946: La Réunion, Département. Regards sur la Réunion contemporaine. Actes du Colloque de Saint-Denis de La Réunion organisé par l’Université de La Réunion en collaboration avec le Conseil Général de La Réunion, 6 – 10 octobre 1996, textes réunis par Edmond Maestri, op. cit., p. 252. Il corsivo è mio. 271 Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), Ibid., p. 142. 110 fosse finalmente riscattato da una condizione paragonabile alla servitù di secolare memoria. Riforme che solo per mezzo della dipartimentalizzazione (che prometteva la messa in opera della legislazione francese su suolo reunionese) e della nazionalizzazione dell’economia272 (con una ridistribuzione delle risorse del territorio fino ad allora gestite da pochi oligarchi) sarebbe stato possibile avviare. Per un’isola uscita malconcia dal conflitto, resa incline a una politica reazionaria dalle frequenti carestie, dalle cicliche calamità, dall’incontrollata autarchia dei possidenti terrieri (non appena la Metropoli si mostrava meno attenta ai problemi della Réunion), le posizioni del CRADS in materia economica e politica dovettero assumere (per la classe dominante) la medesima portata rivoluzionaria del decreto abolizionista del 1794. Contro i cradisti di Raymond Vergès, i conservatori si riunirono nel Movimento dei Repubblicani Popolari coordinato da Alexis de Villeneuve273. Sostenitore di una politica della terra, della tradizione cattolica e dell’identità francese del popolo reunionese, Villeneuve si proponeva di difendere gli inalienabili diritti degli imprenditori terrieri contro le rivendicazioni della nascente classe dei funzionari statali. Scettica verso il programma dipartimentalista di Vergès-Lépervanche, consapevole, tuttavia, della popolarità che avrebbe riscosso la nazionalizzazione dell’economia, la destra spostò il dibattito elettorale sul piano emotivo, riducendo le votazioni a una questione di lotta di classe/casta (in occasione delle votazioni che si tennero tra il 1945 e il 1946 per le elezioni cantonali, le elezioni dell’Assemblea Costituente e le elezioni legislative). Il malcostume elettorale radicato nella cultura politica reunionese, avvezza alla corruzione dei candidati e degli elettori (era uso offrire rum durante le votazioni), ai brogli elettorali, e alle violenze perpetrate a danno delle coalizioni politiche, si piegò di fronte all’alto valore civile, all’accezione referendaria che avevano assunto le votazioni del 1945 (pro o contro la dipartimentalizzazione, pro o contro l’estensione dei diritti dei lavoratori francesi ai Reunionesi). Sotto l’attenta supervisione del CRADS274, per la prima volta dal 1848, le consultazioni si svolsero 272 «Le programme des deux candidats cradistes, Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, comporte un axe économique dont un plan, de nationalisation des grandes industries et des grands domaines fonciers, est propre à affoler les grands propriétaires terriers et les usiniers, et un axe social qui vise à changer radicalement la vie des couches populaires. Mais leur réforme maîtresse reste la transformation de la Colonie en un département français. Les électeurs saisissent que sans cette mutation, rien ne sera vraiment possible tant sur le plan social qu’économique.», Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), op. cit., p. 142. 273 «Ce dernier [Alexis de Villeneuve], représentant du Mouvement des républicains populaires, directeur du journal Le Planteur, met en avant le triptyque «l’ordre, la paix, le travail» et condamne la “démagogie politique”.», Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., p. 117. 274 «Enfin cette volonté politique se manifeste dans un climat électoral particulièrement différent de celui que connaît la IIIe République depuis 1973. Ces décennies marquées par le sceau de la fraude et de l’abstention. C’est une troisième naissance pour l’histoire du suffrage universel à al Réunion. La note du 17 mai du Comité républicain d’action démocrate et sociale au gouverneur souligne l’existence d’une rupture avec les comportements politiques passés: 111 nella piena legalità con il trionfo della coalizione di sinistra: maggioritaria in quasi tutti i cantoni (i cradisti avevano conquistato 31 seggi su 36 nella vecchia Assemblea Coloniale), presente finanche in Francia all’Assemblea Costituente con due dei suoi maggiori rappresentanti politici, Raymond Vergès e Lépervanche. Il protrarsi dello stato di indigenza di gran parte della popolazione, lo scarto intollerabile che ancora la divideva dai vecchi e potenti imprenditori per nulla prostrati dagli anni di dittatura, la lentezza dei lavori della costituente conclusisi nel 1946 con la ratifica della dipartimentalizzazione (osteggiata dalla sinistra più riformista, come anche dalla classe meno abbiente) offrirono il pretesto ai conservatori-gaullisti di riorganizzarsi contro la coalizione cradista (di cui facevano parte il P.C.F e il SFIO). Lo scontro verbale tra la sinistra e la destra rinnovatosi all’indomani delle legislative del 1946 restituiva la Réunion all’antico, usato clima elettorale dominato dalla violenza, dagli abusi e dalla corruzione ma soprattutto dal forte astensionismo popolare. La morte di Villeneuve, ucciso durante la manifestazione dei militanti di sinistra a cui si erano arbitrariamente uniti i sostenitori della destra nell’ottobre del 1946275, chiuse la breve parentesi cradista in favore di una linea politica più moderata, gaullista (avallata dalla stessa Metropoli) di cui i Repubblicani Popolari si facevano promotori. Il presunto coinvolgimento di Paul Vergès (leader del Partito Comunista reunionese) all’assassinio di Villeneuve, tradottosi nell’immediato arresto dell’erede del Docteur Raymond durante la campagna elettorale delle municipali del 1947, avrebbe inevitabilmente portato alla dissoluzione della coalizione di sinistra, quindi alla vittoria del programma conservatore della destra. Ma a cosa aspiravano le vecchie colonie con la richiesta di dipartimentalizzazione? Accedere allo statuto di dipartimento significava, per le settler colonies come la Réunion, vedere riconosciuto il ruolo militare ed economico svolto accanto alla Francia dal 1642; significava, in altre parole, vedere affermata l’appartenenza alla nazione francese non come soggetti deboli ma come partner attivi che, nei secoli, avevano contribuito alla crescita della Metropoli stessa: essere légalité des listes électorales; interdiction de toute distribution de rhum ou argent; […] interdiction de transports massifs d’électeurs par camion […].», Yvan Combeau, La Réunion – la France (1945 – 1916), op. cit., p. 111. 275 La ratifica del nuovo statuto dipartimentalista gettò la Réunion nel caos, soprattutto in previsione delle elezioni legislative che si sarebbero tenute nel giugno di quell’anno nelle quali si erano candidati per la circoscrizione di SaintDenis Raymond Vergès e Alexis de Villeneuve. Da un lato la necessità di riconfermare la vittoria del 1945, dall’altra l’esigenza di impedire la definitiva presa di potere da parte della sinistra, sembrò giustificare il ritorno a una pratica poco ortodossa della campagna elettorale: pressioni, minacce, denunce, intimidazioni, ma soprattutto i prodromi di una guerriglia urbana misero a ferro e fuoco l’isola. Nonostante la firma di un accordo di non belligeranza, nell’ottobre del 1946, facinorosi della destra si unirono alla manifestazione della sinistra. Nel trambusto della lotta, Villeneuve fu colpito da uno sparo. Se la destra accusava apertamente del delitto Paul Vergès, la sinistra, decapitata del suo leader, continuava a professare l’innocenza del politico rimandando le responsabilità alla destra, colpevole di aver ordito la caccia alle streghe contro Vergès per avvantaggiarsene durante le elezioni. 112 riconosciuti come cittadini francesi a tutti gli effetti, destinatari delle medesime conquiste democratiche. Dal 1945, si fece, tuttavia, evidente il diverso significato attribuito dalle colonie e dalla madrepatria allo stato giuridico della dipartimentalizzazione. Mentre Césaire (come teorico e rappresentante martinicano all’Assemblea Costituente) difendeva il concetto di dipartimento in quanto organismo dotato di un governo locale e di un’amministrazione indigena, la Francia riconosceva nella dipartimentalizzazione la possibilità di assimilare, quindi di vincolare le vecchie colonie al potere centrale: «“Aller en France et demander la transformation de la Martinique en département français”. Césaire distingue la “départementalisation”, concept “purement technique” de l’ “assimilation” qui peut “être interprétée comme une aliénation”»276. Per quanto i Réunionesi riconoscessero alla dipartimentalizzazione la possibilità di favorire il processo democratico sull’isola (quel processo da sempre ostacolato dallo statuto coloniale, dal regime di indigenato e dal potere esercitato dall’oligarchia terriera), Vergès e soprattutto Lépervanche si facevano sostenitori del progetto assimilazionista che, invece, Césaire rifiutava come limite all’autodeterminazione delle ex-colonie. Incredula277 di fronte alla risoluzione della Francia di accordare il nuovo statuto alla Réunion, la destra si trincerò dietro la cieca difesa della linea colonialista. La dipartimentalizzazione, difatti, poneva non pochi problemi a un’isola dall’economia instabile, sottosviluppata, sopravvissuta a stento al secondo conflitto. Non solo l’introduzione di una nuova moneta avrebbe causato il deprezzamento della valuta reunionese, quindi il crollo dell’economia interna, ma la prospettiva di un’equiparazione alla Metropoli, anche dal punto di vista fiscale, faceva prevedere l’introduzione, sull’isola, di un sistema tributario del tutto estraneo alla popolazione del luogo fino al 1946 (ai Reunionesi era stato sempre applicato un sistema di tassazione indiretta sulle merci importate ed esportate). 276 Oruno D. Lara, Nelly Schmidt, Colonisation et assimilation aux Caraïbes et à la Réunion. Origines et responsabilités politiques de la loi du 19 mars 1946, op. cit., p. 122. «Franz Fanon, l’un des théoricien les plus connus de cette rupture, insista sur la nécessité de briser les liens qui ne pouvaient que freiner le colonisé dans leur mouvement d’émancipation. Ainsi fut instauré un véritable modèle de décolonisation […]. Avec son discours d’assimilation, son aspiration à l’intégration dans la nation française, le moment de 1946 ne pouvait représenter qu’une forme de renoncement. La «colonisation fraternelle», déclara Edouard Glissant, «est aussi déracinante que la paternelle» […].», Françoise Vergès, Égalité républicaine et réalité (post) coloniale, Ibid., pp.234 – 235. 277 «Les «anti-cradistes» tiennent cette solution pour si peu réaliste et si peu réalisable qu’il ne la commentent même pas durant la campagne électorale de l’année 1945, celle des municipales. […] Certains «anticradistes» frustrés de ne pas avoir été à l’origine de cette initiative tirent argument de la lenteur de l’action parlementaire […] d’autres les font pour des menteurs et des incompétents [Vergès et Lépervanche]. », Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), Ibid., pp. 142 - 143. 113 Contro la promessa di una migliore distribuzione delle risorse economiche tra tutta la popolazione, la destra prospettava, invece, il sicuro impoverimento dell’isola incapace di competere con la situazione economica e sociale dei dipartimenti francesi metropolitani278. La minaccia rappresentata dai funzionari, che avrebbero mutato l’isola in un paradiso amministrativo, a detrimento della ricchezza dell’isola tradizionalmente individuata nella terra, si accompagnava alla denuncia delle difficoltà che la Réunion, come dipartimento, avrebbe incontrato nell’attuazione di qualsiasi nuovo cambiamento. Come ricorda nel 1946 «Le Progrès», mentre al tempo dello statuto coloniale, la Réunion poteva considerarsi un dipartimento di fatto, potendo contare su un’amministrazione locale (l’Assemblea Coloniale) solo indirettamente soggetta alla Metropoli, la nuova legge di dipartimentalizzazione costringeva, iniquamente, il povero e sottosviluppato stato della Réunion a sottostare alle medesime leggi fiscali, ma soprattutto a soccombere alle maglie di un’amministrazione centrale. La burocrazia si sarebbe certamente mostrata d’intralcio all’attuazione delle riforme, all’erogazione dei fondi (di cui al tempo l’isola aveva un impellente bisogno). Inverosimilmente, però, la dipartimentalizzazione non trovò l’accordo di tutti i rappresentanti di sinistra. Contro lo spettro dell’assimilazione, gli oltranzisti di sinistra rivendicavano il diritto all’autodeterminazione del popolo reunionese, respingendo lo statuto come illegale da un punto di vista giuridico (vedi carta di Los Angeles) e ipocrita nell’autorizzare implicitamente il perdurare della vecchia situazione coloniale: «Pour commercer, on se permettra de penser que la date de 1946 n’a pas représenté une décolonisation. Dans la seconde partie du siècle, décolonisation signifie rupture, construction d’un État-Nation, constitution d’une souveraineté.»279. * L’inerzia mostrata dalla Francia280 nell’attuare le riforme e gli investimenti necessari per fare dell’isola un dipartimento materializzò i dubbi espressi dalla destra nel 1946. 278 Eve Prosper nel citato saggio dà un sunto delle posizioni difese dalla destra, delle argomentazioni invocate dai giornali, L’Avenir du Sud, La Démocratie, Le Progrès, unanimi nel dubitare dello statuto dipartimentale come il solo sistema per risanare la situazione politica, economica e sociale dell’isola. Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), op. cit., pp. 148 – 150, p. 152. 279 Françoise Vergès, Égalité républicaine et réalité (post) coloniale, op. cit., p. 236. 280 «Par ailleurs, le retard de la France dans la mise en œuvre effective de la départementalisation Outre-mer peut objectivement s’expliquer. De 1946 à 1959, le gouvernement de Paris peut en effet invoquer à sa décharge le fait qu’il avait à faire face à l’époque à des problèmes considérables et urgents comme la reconstruction du pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation de son empire multiséculaire, la guerre d’Indochine de 1945 à 1954, puis la guerre d’Algérie de 1954 à 1962 ou encore la mise en place des nouvelles institutions de la Ve République après le retour au pouvoir du général de Gaulle.», André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais de 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, Ibid., p. 254. 114 Di fronte a un’economia francese in crescita a dispetto dell’insicurezza politica del periodo postbellico, le condizioni dell’isola rimanevano precarie. Mentre la Réunion ristagnava nelle sue antiquate vie di comunicazione, nei suoi apparati industriali risalenti agli inizi del secolo, la popolazione, in forte crescita, vedeva sfumare, con il tempo, le possibilità di impiego, naturale e attesa conclusione del nuovo statuto. La carenza di medici e di strutture sanitarie, ripetutamente denunciate da Vergès, il livello della scolarizzazione tra i più bassi del mondo, i salari al limite della sopravvivenza, l’agricoltura messa in pericolo dai cicloni281, la difficoltà di reperire fondi nonostante l’istituzione del credito FIDES e malgrado la Réunion facesse ora parte dell’Europa, convincevano la coalizione di sinistra, sostenitrice del progetto di dipartimentalizzazione, della malafede con cui la Francia, l’antica potenza colonizzatrice, aveva intrapreso la ratifica del nuovo statuto. I risultati apparivano oltremodo negativi se confrontati con il positivo decennio 50 - 60 dominato dai fermenti indipendentisti di numerosi stati africani, tra cui l’Algeria e il Madagascar. L’indipendenza del Madagascar, e gli anni che precedettero la sua emancipazione dal regime coloniale, segnarono profondamente la coscienza della popolazione reunionese che si vedeva privata dalla Francia di un territorio che l’opinione comune considerava proprietà d’elezione: una propiété dyonisienne282. I benefici di cui aveva goduto la colonia malgascia, tra il 1947 e il 1957, gli aiuti economici e gli importanti interventi strutturali del governo su una nazione che rimaneva una colonia acuirono, oltretutto, il risentimento verso la Madrepatria, che ignorava i bisogni del proprio popolo, dimenticato, esiliato nella lontana isola, a vantaggio di etnie da secoli ridotte in schiavitù. Per arginare il fenomeno della sovrappopolazione e i problemi occupazionali, si ipotizzò, sulla base del progetto Sakay, di avviare lo stanziamento di una colonia reunionese a est di Tananarive da sempre partener privilegiato della Réunion. Se il Madagascar rimaneva il maggiore fornitore di generi di prima necessità dell’isola Mascarena (bestiame e culture varie), gli introiti più rilevanti della Réunion (esclusa la vendita dei prodotti della canna da zucchero) derivavano dalla vendita di acqua e carbone al Madagascar. L’indipendenza della Grande Isola costringeva la Réunion a 281 «À ces délais s’ajoutent les effets dévastateurs des cyclones. Ils sont destructeurs […] pour une île qui commence à peine à sortir de la pénurie. En 1948, un article de Notes et études documentaires […] évoque: “le cyclone qui dévasta les cultures, détruisit les maisons et bouleversa l’économie.” (28 mars 1949).», Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., pp.123 – 124. 282 «En 1885, les conseillers généraux de la Réunion envoyaient une adresse à Paris, dans laquelle ils déclaraient: “L’île de Madagascar nous appartient: nous vous demandons d’occuper définitivement ce pays qui est à nous, qui est notre bien, le bien de toute la France.”. Une telle conviction, qui révèle d’un mythe dont Paris vit parfois le danger, explique partiellement le caractère passionnel des prises de position de la presse réunionnaise à propos de la décolonisation de Madagascar.», Hubert Gerbeau, Edmond Maestri, Colonie décolonisée et «colonie colonisatrice»: Les échos de l’indépendance de Madagascar à la Réunion, in L’Afrique noire française : l'heure des indépendances : actes du Colloque La France et les indépendances des pays d’Afrique noire et de Madagascar, organisé par l’Institut d’histoire des pays d’outre-mer et l’Institut d’histoire du temps présent, Aix-en-Provence, 26-29 avril 1990, sous la direction de Charles-Robert Ageron et Marc Michel; préface de Francois Bedarida, op. cit., p. 616. 115 confrontarsi nuovamente con la sindrome, con il demone della sudditanza283: subordinazione alla Francia rinnovata con la dipartimentalizzazione, dipendenza da Maurice nel lontano XVIII secolo, dal Madagascar nel 1924 e ancora nel 1960, allorché l’isola, diversamente dalla Réunion, si era mostrata determinata nel rivendicare l’autonomia in soccorso della propria identità. Altrettanto edificante l’esempio algerino, paese capace di emanciparsi dalla colonizzazione, poi dalla dipartimentalizzazione, per conquistare con il sangue la propria indipendenza284. Nell’ “ora delle indipendenze”, la sinistra reunionese sconfessava l’esperienza dipartimentale come iniziativa della media borghesia, che lontana dallo lo spirito rivoluzionario della lotta operaia, aveva riconfermato la vecchia oligarchia terriera al potere285. La richiesta di autonomia della vecchia colonia venne, tra l’altro, a coincidere con la nascita del Partito Comunista Reunionese, fondato su iniziativa di Paul Vergès nel 1959. Legato a una politica terzomondista, il nuovo movimento politico si difendeva dalla linea moderata del vecchio CRADS fautore di una dipartimentalizzazione realizzata solo sulla carta286. La richiesta di autonomia politica ed economica per l’isola della Réunion da parte del Partito Comunista, si collocava all’interno di innovatori fermenti culturali, di una diversa interpretazione della storia coloniale. Con la conquista dell’indipendenza, con la lotta per la libertà dei popoli africani, asiatici e latinoamericani si era fatto definitivamente luce sul periodo coloniale, della deportazione e della schiavitù. Accanto alla storia delle potenze colonizzatrici, emergeva la storia non ufficiale dei diseredati: la storia di popolazioni mutilate, quella del popolo africano, quella degli Indios. Si affermava, viceversa, l’assenza di una storia e di una identità reunionesi. 283 «[…] l’affectivité annihile bien des capacité d’analyse et laisse apparaître le plus grand personnage de l’histoire réunionnaise: la peur. Une peur qui procède d’un profond sentiment de dépendance, obligeant le Réunionnais, à droite comme à gauche, à se situer par rapport aux autres, à se rattacher à des appuis extérieurs. Départementalisation et dépendance ne sont plus, dans ces conditions, que les manifestations politiques, au niveau de statut, de cette grande peur.», Hubert Gerbeau, Edmond Maestri, Colonie décolonisée et «colonie colonisatrice»: Les échos de l’indépendance de Madagascar à la Réunion, op. cit., p. 617. 284 «L’année 1954 est celle où débute l’insurrection algérienne, celle où le Viêt-Nam devient indépendant. L’Océan Indien va-t-il rester à l’écart d’un ébranlement planétaire?», Ibid., p. 612. 285 «L’esprit rentier, propre aux colonies, trouva un nouvel essor avec cette forme d’assimilation. La France, mèrepatrie, garantissait protection et rente aux grands propriétaires et aux capitalistes locaux. L’esprit d’entreprise ne fut pas encouragé alors que la mentalité de rentier le fut. La répression politique renforça la peur et le conformisme social […]. L’anticommunisme radicalisa la politique et fit régresser le débat des années à venir.», Françoise Vergès, Égalité républicaine et réalité (post) coloniale, op. cit., p. 243. 286 «De 1946 à 1959, la départementalisation – qui implique notamment l’égalité sociale – est bien instituée sur le plan formel. Mais elle n’est pas réellement mise en œuvre. Très rapidement, les communistes insulaires vont alors tirer de plus en plus souvent et de plus en plus fort le signal d’alarme. Ils vont plus précisément mettre en garde le gouvernement de Paris contre son inaction dans le DOM en général et à la Réunion en particulier.», André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais d 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, Ibid., p. 253. In definitiva, dopo il 1946, visti i ritardi del governo francese nell’attuazione delle riforme sociali, la destra, da detrattrice, era divenuta la maggiore sostenitrice della dipartimentalizzazione. 116 «Le déni de la formation historique de ce métissage (esclavage, colonialisme, créolisation) transforme le métissage réunionnais en identité dépolitisée, ahistorique et donc finalement inoffensive pour le discours unitaire français.»287. L’autonomia rivendicata dai militanti del PCR, tra il 1959 e il 1981 non implicava né reclamava l’indipendenza totale dalla Metropoli, pure difendendo il diritto del popolo reunionese all’autogoverno. Il documento stilato a Morne Rouge (Martinica) nel 1971 tra i rappresentanti comunisti, i progressisti delle vecchie colonie, ora DOM, definiva «le cadre juridique d’un État Autonome», precisandone i «moyens institutionnels et financiers ainsi que son programme économique, social et culturel»288. Partendo dall’istituzione di un suffragio universale effettivo289, e solo dopo aver educato il popolo reunionese a una corretta e attiva partecipazione alla vita politica dell’isola, la dichiarazione di Morne Rouge prevedeva l’indipendenza interna dei DOM dalla Francia, ovverosia la possibilità di gestire gli affari politici ed economici interni in piena autonomia dal controllo esercitato dai vecchi funzionari francesi. I DOM rimanevano però vincolati al potere centrale in politica estera, per «monnaie, diplomatie, défense». Come nel 1946 per la dipartimentalizzazione, così nel 1971, la Réunion e la Martinica si mostrarono ancora discordanti in merito alla definizione del concetto di autonomia. Consapevole dei gravi problemi economici e sociali che, a dispetto delle riforme attuate nell’ultimo decennio290, facevano della Réunion un’isola ancora sottosviluppata nel contesto dell’Oceano Indiano291 e 287 Françoise Vergès, Égalité républicaine et réalité (post) coloniale, Ibid., p. 242 André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais de 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, Ibid., p. 257. 289 Ibid. 290 «[…] 1963 […] nous sommes alors dans le contexte très proche de la guerre d’Algérie […]. La France est malade de son Empire colonial, de ce qu’il a été, de ce qu’il lui a coûté et de ce qui en reste. […] À la Réunion, comme aux Antilles, la situation était au même moment délicate à gérer pour le pouvoir central déjà accusé d’avoir «bradé l’Empire». À partir de 1957 l’idée d’une revendication de gestion autonome s’imposait de plus en plus au sein des départements d’Outre-mer.», Gilles Gauvin, Michel Debré et la départementalisation, Ibid., p. 558. L’elezione del vecchio primo Ministro francese Michel Debré a sindaco di Saint-Denis nel 1959 avrebbe mutato la rotta e le rivendicazioni dei comunisti reunionesi. Consapevole di quanto i ritardi nell’attuazione delle riforme dipartimentali avessero pesato sulle nuove proposte indipendentiste, Debré concentrò gli sforzi per un rapido sviluppo dell’isola in campo economico, sanitario e della scolarizzazione nel decennio 1959 – 1970. Allontanati i politici che avrebbero potuto rappresentare una minaccia all’attuazione dei suoi propositi (Vergès fu allontanato dalla Réunion nel 1960 con l’ordinanza Debré, Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., p. 134), forte del sostegno della destra reunionese, Debrés inizò le sue opere di ammodernamento delle infrastrutture, Ibid., pp. 138 – 140. 291 Nonostante la Réunion potesse vantare dei salari e uno standard di vita più alto rispetto alle vicine nazioni africane, come pure del Madagascar e di Maurice, rimaneva ciononostante un’isola economicamente dipendente dalla Francia. Mentre Maurice era riuscita a diversificare la produzione investendo sull’industria manifatturiera oltre che sul vecchio capitale della canna da zucchero, la Réunion aveva fatto prosperare il terziario, a detrimento di qualsiasi altro settore, soprattutto quello industriale dei cui prodotti restava la maggiore importatrice. Rimandiamo al saggio di William Miles, Relations étrangères dans le cadre d’un département d’Outre-mer: les rapports la Réunion – Maurice, in 1946: La Réunion, Département. Regards sur la Réunion contemporaine. Actes du Colloque de Saint-Denis de La Réunion organisé par l’Université de La Réunion en collaboration avec le Conseil Général de La Réunion, 6 – 10 octobre 1996, textes réunis par Edmond Maestri, op. cit., pp. 431 – 440. 288 117 mondiale, il Partito Comunista Reunionese non assimilò mai il concetto di autonomia a quello di entità nazionale riconosciuta e giuridicamente sovrana292. Le perplessità mostrate dal PCR nella rivendicazione dell’autonomia interna della Réunion si rifletterono nei rapporti con gli altri schieramenti politici. Laddove la destra bocciava l’emendamento come incostituzionale293 e pregiudizievole per l’economia reunionese che sarebbe certamente collassata sotto il peso delle selvagge nazionalizzazioni («indépendance, totalitarisme, appauvrissement»), gli oltranzisti dell’OCMLR rifiutavano l’accordo come nuova dimostrazione della complicità del PCR con il potere borghese: «L’OCMLR accuse notamment le PCR de vouloir remplacer la lutte des classes par une collaboration des classe set de trahir ainsi la classe ouvrière dans la mesure où la proportionnelle permettrait à la bourgeoisie […] de maintenir ses privilèges.»294. Temendo, che la ratifica del documento di Morne Rouge sarebbe stata interpretata dagli Antillani come un chiaro segno di resa sul piano dell’indipendenza295, la Francia si oppose fermamente alla sua realizzazione. Unica volta in tutta la storia della Réunion colonia e dipartimento, gli agricoltori manifestarono a Saint-Louis contro lo stato francese e i funzionari dislocati sull’isola: «Le 6 février, une simple manifestation de protestation des planteurs à Saint-Louis, soutenue en outre par le maire de la ville, se transformant en une «revolte contre le Préfet, les gendarmes et les zoreilles: c’est l’État français qui est mis en accusation […]. Mais surtout le drapeau tricolore est arraché, pétiné, 296 déchiré…et c’est la première fois que cela se passe à Bourbon.» 292 «L’indépendance, même formelle, suppose une souveraineté interne et externe, reconnue sur le plan international, une armée, une diplomatie […], et cela ne correspondait pas à la revendication d’autonomie interne. Il faut peut-être voir dans ces lectures différentes du mot d’ordre d’autonomie une divergence d’intérêts entre le PCF, dont la politique Outre-mer était alors fonction d’une politique internationale orchestrée par l’URSS, et les dirigeants du PCR qui recherchaient avant tout de défendre ce qu’ils estimaient être, dans le cadre d’un modèle de développement socialiste, les intérêts d’un «peuple réunionnais» toujours très attaché en grande majorité à la France.», Gilles Gauvin, Michel Debré et la départementalisation, Ibid., p. 559. 293 «Pour le Recteur Jean-Claude Maestre, «le droit de sécession ne peut appartenir qu’aux TOM car il serait difficile d’accorder le droit d’autodétermination et de sécession aux départements d’Outre-mer à moins de l’admettre également au profit des départements métropolitains», ce qui reviendrait à admettre une «sorte de droit permanent et général d’insurrection». Cependant, si le droit de sécession n’appartient pas aux DOM et si le principe d’indivisibilité de la République […] leur est applicable, comment expliquer, selon Paul Vergès, que les départements d’Algérie aient pu accéder à l’indépendance à la suite d’un scrutin d’autodétermination du 1er Juillet 1962.», André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais d 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, Ibid., p. 261 294 André Oraison, L’attitude des communistes réunionnais d 1946 à 1996: Qui est le responsable de la départementalisation sur le plan politique?, op. cit., p. 264. 295 «L’État français s’est en tout cas opposé clairement à toute forme d’autonomie, car ce statut aurait pu faciliter la transition vers l’indépendance, en particulier aux Antilles où le caractère nationaliste de la revendication était, du fait de l’environnement géopolitique et de l’impact d’intellectuels comme Aimé Césaire, bien plus affirmé qu’à la Réunion. Dès 1927, il existait en effet un mouvement pannègre réclamant l’indépendance d’Haïti, de la Dominique, de la Martinique, de la Guadeloupe et des îles avoisinantes au sein d’une Confédération des Indes Occidentales.», Gilles Gauvin, Michel Debré et la départementalisation, Ibid., p. 559. 296 Ibid. 118 La Réunion «pays bâtard au statut introuvable»297, incapace di sottrarsi al suo passato coloniale, e in particolar modo all’egemonia culturale e politica della Francia, debole alle lusinghe del padre tutelare ma soprattutto dubbiosa sulle prospettive realmente offerte dall’indipendenza298, solo negli ultimi anni e con la proposta di bidipartimentalizzazione299 sembra essersi riconciliata con il controverso passato dipartimentalista del 1946; sembra cioè aver definitivamente riconosciuto l’importante conquista civile ma anche nazionale che la dipartimentalizzazione significò per la popolazione reunionese tutta, «Le statut de département appliqué à la Réunion en 1946 est le fruit d’une longue conquête du monde du travail. Avant la concrétisation de ce projet, les hommes politiques et les possédants sont peu nombreux à la soutenir. […]. Au lendemain de son adoption par l’Assemblée Constituante le 16 mars 1946, le camp des opposants ne désarme pas.»300 297 Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), Ibid., p. 140. «L’intelligence politique de Michel Debré fut peut-être de jouer sur ce ressort […]: «Tous ces États [ceux qui ont accédé à l’autonomie] connaissent de très grandes difficultés. Plusieurs d’entre eux ont été agités par des révolutions et par des coups d’État. La plupart d’entre eux, pour ne pas dire tous, souffrent d’un très bas niveau de vie […]. Face à ces États, la Réunion est l’image de la stabilité. […] la liberté de presse, la liberté d’opinion, la liberté de religion sont assurées et respectées.». […] Ainsi, ombre tutélaire, père lointain, celui qui avait assumé la décolonisation […] était honoré dans sa double paternité: aux enfants restés les plus étrangers, l’offre de la séparation, aux enfants d’élection, ceux de la «vieille colonie» le privilège d’une assimilation complète.», Hubert Gerbeau, Edmond Maestri, Colonie décolonisée et «colonie colonisatrice»: Les échos de l’indépendance de Madagascar à la Réunion, op. cit., p. 617. 299 Alla fine degli anni Novanta venne presentata dalla sinistra di Vergès la proposta di legge di bidipartimentalizzazione. Contestata dalla destra e da parte della popolazione, il 1 gennaio del 2001 la Réunion modifica il suo statuto regionale in bidipartimentale (?). Per maggiori dettagli rimandiamo al testo, Yvan Combeau, Edmond Maestri (sous la direction), Histoire de la Réunion, de la colonie à la région, op. cit., p. 159. 300 Eve Prosper, Les premiers contestataires de la départementalisation à la Réunion (1892 – 1946), op. cit., p. 152. 298 119 Capitolo Secondo Sezione 1: Madagascar Teatro malgascio, tra classicismo e sperimentazione Il teatro malgascio dalle origini al 1945: Evoluzione di un genere tradizionale o interferenza coloniale? Fra i generi letterari, il teatro è attualmente quello più dibattuto dagli autori e dai critici contemporanei delle ex-colonie. Gli studi antropologici le teorie avanguardistiche di Artaud, di Turner hanno contribuito a problematizzare una forma in principio considerata principalmente da un punto di vista estetico-letterario, prima che storico- sociologico. Il modello avanzato da Artaud di un teatro-rito, che il teatro occidentale derivi dai riti dionisiaci nel IV secolo A.C.1, ha, di fatto, esteso la definizione di rappresentazione teatrale o prototeatrale anche alle manifestazioni rituali dei paesi africani e orientali. Se è possibile ritrovare la fluidità della prosa, l’incedere ritmico, la qualità sintetica ed evocativa della poesia nelle narrazioni dei griot, non è altrettanto evidente e scontata la parentela tra il racconto orale e il teatro, tra il rito e la rappresentazione perché i paesi africani potessero, e possano tutt’ora, vantare l’esistenza di una forma autoctona equivalente al teatro occidentale. Il rito, in quanto manifestazione di un prototeatro, viene, quindi, in soccorso di una terra che, schiava per troppo tempo al colonizzatore, vuole rivendicare la propria indipendenza anche culturale dall’imperialismo occidentale. 1 «Nella sua essenza, il teatro greco era una forma di celebrazione religiosa: la sua originaria connessione con il culto di Dioniso era ancora assai forte nel 4° secolo, quando peraltro le rappresentazioni teatrali, nate e sviluppatesi ad Atene, erano divenute già un uso panellenico, e s’erano qua e là legate al culto di altre divinità. Ad Atene, commedie e tragedie erano rappresentate nel corso delle quattro grandi feste dionisiache.», Dizionario Enciclopedico Treccani, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1970, p. 15. L’ipotesi di una relazione tra riti dionisiaci e nascita della tragedia è risolutamente confutata da Schechner, e successivamente da Luigi Squarzia, per i quali non esistono documenti certi che diano testimonianza di una tale filiazione. I due specialisti del teatro vanno oltre, facendo notare che la tesi sostenuta dalla scuola di Cambridge non sarebbe altro che il riflesso della filosofia nietzschiana in netta opposizione alle precedenti teorie estetich rinascimentali: «Nella nascita della tragedia dallo spirito della musica Nietzsche, per primo, volle vedere nella tragedia un frutto delle danze dionisiache che nel ditirambo pongono l’umanità a contatto con le sorgenti oscure, tremende ed esaltanti della natura e della vita; egli capovolse così l’interpretazione della trattatistica rinascimentale, che aveva concepito la tragedia in termini razionali ed estremamente civilizzati, indicando in essa al contrario l’esperienza estrema e magica delle volontà individuali che si pongono a contatto con la schopenhaueriana Volontà del Mondo.», Luigi Squarzia, Da Dioniso a Brecht, Bologna, Mulino, 1988, pp. 27-28. 120 Antico e intellettualmente vivace già prima della colonizzazione europea, la produzione letteraria malgascia non potrà prescindere, a proposito del genere teatrale, dalle resistenze e dalle contraddizioni di cui è stato oggetto la definizione del teatro africano, contemporaneo e postcoloniale. Permanendo la cultura e l’eredità coloniale il termine di paragone per un’elaborazione teorica di un teatro malgascio tradizionale, ne segue che nessuna teoria (a favore o contro l’idea di un teatro autoctono) potrà prescindere da una dichiarazione politica di base: pro o contro la colonizzazione, per un riconoscimento dell’eredità storico-culturale del periodo coloniale o per la sua negazione categorica.2. Se il dibattito africano intorno alla genesi del teatro e dello spettacolo teatrale nel continente è un fatto relativamente recente comunque sofferto, il discorso malgascio sul teatro sembra essersi, invece, esaurito molto prima del 60: prima della fine dell’era coloniale, prima che sull’isola l’attività teatrale si fosse realmente radicata nella cultura del luogo, nella coscienza collettiva, ma, soprattutto prima che l’esistenza e lo sviluppo della produzione teatrale in francese ponesse il problema di un chiarimento sulle origini del teatro malgascio (come di fatto avvenuto per il teatro africano). Lo studio che seguirà sarà la messa a punto di una serie di ricerche e riflessioni sul teatro malgascio in lingua francese dalle origini ai nostri giorni. All’introduzione seguiranno tre sezioni: una dedicata al teatro storico e mitologico con una diversa declinazione del mito dall’epopea di Rabemananjara alle leggende e alle superstizioni di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato; nella seconda sezione considereremo soprattutto la produzione teatrale orientata sulla denuncia dei problemi della realtà contemporanea, a partire dall’analisi delle opere, cercheremo di chiarire il rapporto istituito da alcuni drammaturghi malgasci contemporanei tra teatro naturalistico e lotta per una coscientizzazione politica e sociale del pubblico malgascio; la terza parte infine si occuperà approfonditamente dell’avanguardia teatrale malgascia, di quel teatro sperimentale di cui Michèle Rakotoson, David Jaomanoro, Jean-Luc Raharimanana sono i rappresentanti più noti. * 2 L’affermazione dell’esistenza o dell’assenza di una forma teatrale autoctona nel Madagascar è stata oggetto di rivendicazioni anche politiche, dato che la malgascizzazione del 72, e il periodo post-coloniale si sono adoperati per una difesa del teatro tradizionale contro il teatro di eredità occidentale, contro il pericolo soprattutto di una monopolizzazione eurocentrica della produzione artistica e della critica letteraria in generale. 121 Già prima della colonizzazione del 1895 e anteriormente alle relazioni economiche instaurate con i paesi occidentali, il Madagascar poteva vantare una corposa produzione letteraria orale e scritta, e di cui gli ohabolana (i proverbi), il kabary3 (l’eloquenza), lo angano (il racconto) erano i generi più popolari. La riforma grafica del 1828 (che aveva favorito l’unificazione linguistica dell’isola), la diffusione della carta stampata qualche anno dopo (con la seguente fondazione di riviste e case di edizione), avevano, di fatto, stimolato la pratica letteraria da tempo radicata nella cultura malgascia. Tale diffusione non si era limitata alla traduzione e alla divulgazione della Bibbia, come accaduto per le altre colonie africane, al contrario rivelava, da parte del Malgascio, l’innata passione per l’improvvisazione poetica e per l’attività artistica in generale. Molto tempo prima di Jean Paulhan in Francia (1939), un pastore protestante pubblicava nella seconda metà dell’Ottocento a Tananarive un’edizione in malgascio degli hain teny. La stessa cura era stata riservata ai romanzi sentimentali del pastore Rabary editi dalla rivista Ny Mpanolotsaina (La guida spirituale) alla fine del 1877. Quale ruolo aveva il teatro nella società malgascia prima e subito dopo la colonizzazione? Era possibile affermare, contro l’egemonia culturale occidentale, l’esistenza di una forma teatrale tradizionale, come già era possibile fare per la poesia e per il romanzo? Nella seconda metà del Novecento, Flavien Ranaivo, poeta incluso da Senghor nell’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache del 1948 come massimo interprete della trascrizione poetica degli hain-teny, rivendicava l’autenticità dello hira gasy4, in uso sugli altipiani del Madagascar già a partire dal XVIII secolo, come forma teatrale precoloniale malgascia. Intervistato nel 1969 per Jeune Afrique 5, il poeta riconosceva nei riti ancestrali, nelle cerimonie iniziatiche malgasce una forma prototeatrale non dissimile dai rituali dell’antica Grecia 3 Il Kabary era il discorso ufficiale pronunciato dal re o dal suo mandatario (ma anche dal signore di una città) per tenere al corrente la popolazione di quanto accadeva all’interno del palazzo (riforme, corvées), di conseguenza nasceva come discorso politico-amministrativo della piazza. Con la presa del potere dei Merina, il Kabary divenne un appuntamento domenicale: un rito che univa agli originari propositi politici la sacralità delle feste, delle réjouissances della comunità,come matrimoni, circoncisioni e funerali. Henri Rnjeva, Le Kabary, Entretien avec Honoré Rakotoandrianoela, mpikabary (orateur), «Notre Librairie», n. 109, (avril – juin 1992), pp. 29 – 30. 4 «Dans le hira gasy elles [les sain tehaka ou prélude aux applaudissement] ouvrent le spectacle; puis vient le “reni hira”, ou chanson chef qui se répétera en leitmotiv tout au long du spectacle; enfin le kabary […]. Là le chef de troupe explique sa conception de la vie […] agit comme un chef de communauté. Après le kabary, vient l’épilogue ou “fanarana” qui tire la morale du spectacle. […] cette commémoration des fastes de la cour royale est le fait de gens qui n’en furent que les serviteurs. […] le hira gasy a été structuré par des musiciens razziés sur la côte est, souvent dans la tribu des antemoro.», Michèle Rakotoson, Le Hira Gasy, discours paysan ou rituel des rois, Théatre Sud n. 3, Paris, L’Harmattan, 1990, pp. 13 – 14. 5 Jérôme Equer, Propos recueillis par Jérôme Equer, «Jeune Afrique» (19 – 25 aout 1969), pp. 46 -47. 122 «C’est au XVIII siècle que cette forme de théâtre populaire est apparue dans les villages des hauts plateaux. De nos jours encore, ces manifestations demeurent. À l’occasion de quelque fête ou réjouissance, deux troupes de comédiens-paysans (que lorsqu’ils acquièrent une solide notoriété parviennent à devenir des professionnels) se trouvent confrontées.»6. Con molta probabilità, l’assunto di Ranaivo si ispirava allo studio del professore Andriantsilaniarivo7 edito nel 19478. In merito alla questione dell’esistenza di un teatro autoctono nel Madagascar, il professore difendeva la possibilità di mettere a confronto le gare canore malgasce (improntate su un rigido rituale, e organizzate a partire da una divisione temporale rigorosa) e la struttura teatrale occidentale, l’esemplarità degli attanti9 (il cui cerimoniale era la narrazione, la messinscena della morale collettiva), e la performance degli attori di teatro (la cui recitazione sembrava voler essere la realizzazione del rituale collettivo). Come nel teatro greco delle origini, si poteva ravvisare, nella competizione, una struttura ben precisa: una divisione in tre tempi (o atti), riassumibili in un discorso preliminare o kabary nel quale veniva definito il tema della disputa, l’avvio della competizione canora, le danze a cui seguiva la proclamazione del vincitore10; una drammaticità, quindi, non del tutto dissimile a quella della scuola occidentale. L’improvvisazione degli attanti malgasci (mpilalao), pure molto vicina, nella tecnica, alla Commedia dell’Arte, il rito, che si vuole all’origine della forma teatrale in generale, del teatro malgascio allo stesso modo del teatro europeo, non giustificano e non soddisfano però, a nostro avviso, l’assunto di una conformità della rappresentazione malgascia ai canoni teatrali occidentali. Nonostante la critica del Novecento abbia esteso il campo semantico dell’azione teatrale, di “cosa sia teatro”, aprendo la prospettiva per una sperimentazione e una nuova concezione del testo e della rappresentazione teatrale, ugualmente il Teatro, l’espressione teatrale, anche nelle forme contestatarie, sembra, comunque, misurarsi con una struttura da tutti condivisa che non può prescindere dalla definizione di: scena, come luogo fisico e luogo della narrazione, di testo 6 Ibid. Il corsivo è mio. E. Andriantsilaniarivo, Professore alla Scuola Nazionale della Francia d’Oltre-Mare pubblicò nel numero di aprile luglio del 1947 un articolo, Le Théâtre malgache, su la «Revue de Madagascar». 8 Data evocativa per chiunque conosce la storia del Madagascar. 9 Facciamo riferimento alla definizione di Anne Uberfeld: «Un attante non è una sostanza o un essere, è un elemento di una relazione.», Anne Ubersfeld, Théatrikon, Roma, 1984, p. 64. 10 «Jadis, dans les villages malgaches, tandis que les enfants se réunissaient au clair de lune […], les grandes personnes formaient le cercle de l’autre côté de la place et là se livraient à leur passe-temps collectif habituel: mampiady karajia. Un homme se lève et commence un kabary sur un sujet pris en déhors des préoccupations actuelles du fokolona. Il accomplit ainsi une sorte d’entraînement oratoire, en même temps qu’il invite ses auditeurs, […], à s’évader de leurs soucis quotidiens et des angoisses de la vie.. Mais bientôt surgit le contradicteur, puis un second […], les répliques fusent de tous côtés, ponctuées par les applaudissements de l’élément féminin, muet mais non indifférent spectateur de ce théâtre improvisé.», Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, Paris, Le Livre Africain, 1970, pp. 264 - 265. 7 123 (principalmente scritto, il testo è l’insieme della fabula, dell’azione e dell’intrigo, narrazione complessa non riducibile a un susseguirsi di citazioni morali o di proverbi), della distinzione tra attore e spettatore, separazione rappresentata fisicamente dal sipario, che, nel teatro all’italiana, distingue due spazi, due realtà distinte, quella della finzione e quella della realtà, quella dell’azione e quella della ricezione. A partire da questo assunto, si impone, allora, una distinzione tra la definizione di teatro occidentale e lo spettacolo malgascio dello hira gasy. Nei cerimoniali degli altipiani, lo spettatore non assumeva mai un ruolo totalmente passivo, viceversa era invitato dagli attori a manifestare le proprie opinioni nel corso della rappresentazione. L’auditorio, proprio perché testimone di quanto si stava rappresentando, aveva il dovere di mostrare il proprio consenso o il proprio dissenso, era quindi attore nella misura in cui, con l’espressione del suo giudizio, faceva rispettare dagli attanti il codice tradizionale11. «Claude-Marie Lorin et Albert Rakoto Ratsimamanga n’hésitent pas à affirmer que “le théâtre n’est pas un genre national” [à Madagascar]». C’est qu’il y a théâtre et théâtre. Les spectacles traditionnels n’avaient ni local ni scène, et leur fonction n’était pas esthétique au sens kantien du terme il s’agissait pourtant bien de simulacres dramatiques, tout proches de leurs racines sociales et religieuses.»12. Già all’inizio degli anni Trenta, contestando le teorie avallate da molti contemporanei, JeanJoseph Rabearivelo, assertore dell’interferenza (avversario del concetto più rassicurante di métissange), difendeva, invece, l’idea dell’assoluta estraneità del genere teatrale alla cultura malgascia. Per Rabearivelo13, la sensibilità poetica del popolo malgascio, l’uso particolare della parola e della metafora, la mancanza di sintesi tra idea e azione, negava di fatto che il Madagascar si fosse potuto far promotore di una tale produzione artistica: «“Il faut d’abord se rappeler que le théâtre est étranger chez nous; les Anciens malgaches n’avaient rien qui lui ressemblât, même de loin. […]” de fait le théâtre se définit “comme une expression synthétique de l’acte et de l’idée, de l’écriture et de la parole” n’existait pas à Madagascar avant l’arrivée des Européens.»14. 11 Anche le forme teatrali di confine come lo happening che hanno tentato di sottrarre lo spettatore alla platea per integrarlo alla scena (perché divenisse soggetto attivo, attante e attore, della e nella rappresentazione), lo spazio tra scena e auditorio fa fatica a scomparire. Inconsapevole del ruolo che sta assumendo, lo spettatore rimane comunque esterno alla rappresentazione, agente passivo di quanto si sta svolgendo. Nella rappresentazione malgascia, invece, lo spettatore assume coscientemente e totalmente il ruolo già prima che abbia luogo la rappresentazione. 12 Albert Gérard, Essais d’Histoire Littéraire Africaine, Sherbrooke, éd. Naaman, 1984, p 122. 13 Jean-Joseph Rabearivelo, Le nouveau progrès, «Ny Fandrosoam-baovao», n. 110, 25 octobre 1933. 14 Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, «Notre Librairie» n. 109, avril – juin 1992, p. 71. 124 Il procedere ancora primitivo, metonimico del pensiero malgascio risponde, piuttosto, a un uso simbolico del linguaggio. Come per la parola ebraica15, il discorso malgascio priva la realtà della precarietà della contingenza per ricondurla all’unità, all’inalterabile verità del detto antico. Alla parola e ad essa sola, in quanto genesi e ordinamento del mondo, non agli uomini, è accordata la possibilità dell’azione sul reale: «[…] l’emploi particulier de la métaphore, l’utilisation constante de l’image concrète chargée de signification [peut être défini] l’orientalisme malgache. […] Il est le fruit de l’aversion ou de l’incapacité des esprits simples pour l’expression abstraite. Toute idée se traduit aussitôt par une de ses représentations matérielles possibles et les suites d’idées deviennent de ce fait une succession d’images dont la complexité paraît […] friser l’incohérence»16 La breve sintesi del funzionamento del pensiero malgascio mostra in tutta evidenza il diverso movimento che presiede la costruzione del discorso poetico: chiaramente inverso a quello del discorso teatrale teso, invece, all’esteriorizzazione del reale17. Ugualmente fuorviante e priva di fondamento la tesi difesa da numerosi teorici del teatro africano contemporaneo secondo cui la negazione dell’esistenza di un teatro autoctono sarebbe da imputare piuttosto all’inadeguatezza della definizione, certamente riduttiva, del teatro, incentrata su una concezione eurocentrica dello stesso. C’è da chiedersi, infatti, come mai nel Madagascar di fine Ottocento, all’epoca del maggiore sviluppo della produzione teatrale in lingua malgascia, i drammaturghi facessero comunque riferimento alla terminologia francese, alla divisione in atti e scene, per ripartire i propri testi. C’è da chiedersi come mai la produzione malgascia facesse mostra di una eterogeneità di stili e generi che non aveva eguali in Europa, di una diversa qualità del materiale, che non sempre dava prova di una raggiunta maturità estetica. La produzione teatrale malgascia è generalmente distinta in due periodi: una prima fase che va dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento, dominata soprattutto da un 15 Il confronto che Corvin instaura tra la religione islamica e quella cristiana, ci sembra pertinente per la religione ebraica, ma soprattutto per la cultura malgascia legata, come tutte le popolazioni da una lunga tradizione orale, alla parola come trasmissione prima che del sapere, dell’identità, quindi della realtà «L’Islam […] religion du livre, il n’est pas religion de la scène, alors que le christianisme insiste beaucoup auprès des catéchumènes sur la représentation figurée des scènes extraites de la Bible.», Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Larousse, 1998, p. 15. 16 E. Andriantsilaniarivo e Charles-Elie Abraham, La littérature malgache, «La Revue de Madagascar», n. 26 (juillet), 1946, p. 16. 17 «En Afrique, tout commence, tout finit par la parole et tout en procède. Tout acte social trace et reproduit cette parole initiale attribuée à l’ancêtre fondateur puis léguée à la postérité comme idéal culturel du groupe. Depuis,la parole rituelle libère, réconcilie, resocialise.», Marie-José Hourantier, Du rituel au théâtre rituel, Paris, l’Harmattan, 1984, p. 130. 125 teatro in lingua malgascia (di cui le prove in francese di Jean-Joseph Raberaivelo e Jacques Rabemananjara sono una riuscita eccezione); un secondo periodo che ha visto il declino della produzione locale a vantaggio di un teatro di espressione francese. Senza escludere l’esistenza di una rappresentazione tradizionale malgascia, lo hira gasy, definiremo teatro malgascio precoloniale, quel teatro che, estraneo inizialmente alla cultura indigena, avrebbe avuto origine dal felice incontro di due civiltà quella malgascia e quella europea18 (e in particolar modo dal contatto con i missionari protestanti inglesi stanziatisi nel Madagascar nella seconda metà del 180019): «Il [le théâtre] est sans contredit l’exemple le plus typique de cette littérature nouvelle. Il illustre de façon péremptoire la faculté adaptatrice et transformatrice de l’esprit malgache. Ayant reçu de l’extérieur un cadre entièrement nouveau pour lui, il a réussi à y loger une matière toute personnelle, originale et riche.»20. Uno spettacolo come quello dello hira gasy, dominato dalla tematica erotico amorosa21, dovette certamente offendere il rigore dei padri protestanti, i primi a capire la necessità e in particolar modo l’utilità di introdurre nel Madagscar il teatro per diffondere la morale cristiana. Coniugato all’esperienza dei cerimoniali locali (diffusi capillarmente in tutto il territorio e prodotti da e per il bene della comunità), il teatro occidentale offriva ai missionari la possibilità di agire in modo concreto sulla cultura malgascia epurandola dalle sue discutibili eredità pagane. L’intervento dei missionari protestanti sulle rappresentazioni tradizionali portò alla nascita di due generi: lo ansto simile al Nô giapponese riservato al canto e alla formazione dei cantanti professionisti, lo tsindrindrina (arte dell’Unione) nel quale il repertorio tradizionale dei proverbi e il dramma a sfondo amoroso trovavano una precisa collocazione scenica, un’elaborazione scritta, nonché una prima separazione della scena dagli uditori. Non più modulata sui ritmi certi dei detti antichi, la realtà si scopriva diversa: esperienza del singolo individuo (non più del gruppo) di cui l’attore diveniva il depositario: «Robinary décrit ce dialogue d’une jeune fille avec elle-même:“C’est une représentation où elle improvise la scène, les tableaux, l’intrigue, les situations et le dénouement. Elle trace sur le sol le schéma des 18 «La littérature malgache […] est le résultat du contact de deux civilisations différentes mais facilement complémentaires, qui s’interpénètrent d’ailleurs plutôt qu’elles ne se fondent […].», Ibid. 19 Nonostante le relazioni con gli europei risalissero al XVII secolo, il governo malgascio si piegò al mondo europeo solo dopo il 1869, qando il cristianesimo divenne religione di stato. 20 Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., p. 264. 21 «C’est toujours un thème d’amour, souvent érotique, pour l’édification de tous ceux qui aiment et viennent voir comment on aime et comment on exalte l’amour», Ibid., p. 266 (Michel-François Robinary, En regardant les “Mpilalao”, «Bulletin de Madagascar», n. 16 (1 septembre 1950), pp.19 – 21). «A cause de ses aspects érotiques, le théâtre des mpilalao n’était guère apprécié par les missionnaires, qui s’efforcèrent d’orienter le goût dramatique des Malgaches dans des directions plus acceptables en leur proposant les classiques de l’Occident.», Albert Gérard, Essais d’Histoire Littéraire Africaine, op. cit., p. 118. 126 lieux où va se jouer le spectacle. Elle utilise comme personnages soit des poupées soit des cailloux […] Il y a un personnage de vaudeville qui se lève et qui s’assoit tour à tour et pose à lui-même des questions pour y répondre lui-même” […] elle découvre son âme; elle indique son idéal de vie, l’amour selon son cœur […].»22. Proprio perché rimaneva desto nello spettatore il ricordo dello hira gasy ancestrale, allo stesso modo delle cerimonie popolari, i due generi non sembravano poter prescindere dalla partecipazione del pubblico, i tentativi dei missionari inglesi di spostare l’interesse della popolazione da generi comunque tradizionali verso generi più europei (il teatro elisabettiano) si rivelarono, quindi, fallimentari. Poco avvezzi agli involuti silenzi dei personaggi shakespeariani, gli Hova continuavano a identificare il tormento amoroso con il suono della melodia e del canto. Il kaonseritra, poi doppiato dal vaudeville di tradizione francese, dovette sembrare ai protestanti il giusto, nonché ultimo, compromesso tra la morale europea e il gusto per la danza e il canto malgascio. Supponendo che la componente sociale del hira gasy tradizionale non dovette passare inosservata ai colonizzatori francesi, è possibile dedurre, quantomeno ritenere che il teatro funzionò, per i Francesi, come il cavallo di Troia per i Greci, favorendo la conquista di uno spirito, come quello malgascio, diffidente verso lo straniero, pregiudizialmente chiuso al nuovo; reso sensibile, attraverso il genere teatrale, ai costumi e quindi alla cultura occidentale, il Malgascio fu progressivamente per alcuni versi alienato, come dimostreremo, al proprio patrimonio avito. Gallieni comprese la necessità, l’urgenza di attuare due diversi tipi di innovazioni una volta stanziato il potere francese sulla nuova colonia: da un lato, una riforma scolastica nella quale era prevista l’introduzione della lingua e della letteratura francese nelle scuole (con l’insegnamento dei classici del teatro del Seicento come Racine e Corneille), dall’altro mantenere viva la tradizione del teatro precoloniale sotto il controllo vigile delle autorità (venne così istituita una festa nazionale, La Fête des Enfants, retaggio dei riti pagani del tempo precoloniale, di cui gli mpilalao, attori dello hira gasy, presero successivamente possesso per farne luogo privilegiato della libertà di espressione, anche politica, del popolo malgascio). L’intervento lento ma radicale del colonizzatore francese si rifletté direttamente sui gusti teatrali dei Malgasci del tempo sempre più orientati verso un tipo di concezione occidentale del teatro. 22 Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., pp. 266 – 267. Riallacciandosi all’analisi di Cornevin, Gérard aggiunge: «Les Hovas n’ont pas attendu le général Gallieni pour entrer en relations avec Thalie ou Melpomène. Ils avaient connu le théâtre par la Mission de Londres. Les grands auteurs anglais, Shakespeare en particulier, étaient commentés à l’Université anglaise de Tananarive bien avant la présence française.», Albert Gérard, Essais d’histoire LittéraireAfricaine, op. cit., p. 118. 127 In primo luogo, la richiesta vieppiù frequente di compagnie teatrali francesi23 che rappresentassero i testi della tradizione occidentale, e in modo particolare le operette, dovette indurre a una graduale selezione della platea, costringendo il pubblico a spostarsi dalle campagne alla città24. Precisamente, il trasferimento dello spettacolo nei luoghi chiusi dei teatri all’europea e la metamorfosi dello spazio scenico dal cerchio dalla comunità alla sala divisa da un sipario25 (che costringeva lo spettatore ad assumere un atteggiamento passivo verso quanto rappresentato), precludeva necessariamente la rappresentazione a un uditorio che non fosse culturalmente elevato, edotto sulle usanze europee. La prima forma di teatro locale, il teatro dei precursori (Théâtre des Précurseurs) 26 o fananarana, in lingua malgascia, su modello e temi di gusto occidentale, si rivolgeva, quindi, anzitutto a un pubblico scelto: l’aristocrazia e l’alta borghesia. Il fananarana voleva essere come la sintesi tra l’operetta (soggetti amorosi vivificati dal canto) e la rigida morale protestante (diffusa soprattutto tra le classi elevate). Allo stesso tempo, gli autori, dando prova di una buona conoscenza del canone occidentale, dimostravano di appartenere necessariamente a una classe sociale privilegiata, non solo vicina agli ambienti culturali francesi, soprattutto politicamente legata alle missioni protestanti e cattoliche da poco stanziatesi sul luogo. Se si scorrono i nomi e le biografie di alcuni degli scrittori e attori di teatro non si rimane stupiti che Dondavitra (pseudonimo di Charles-Aubert Razafimahefa, 1880 – 1936), Alexis Rakotobe (di formazione cattolica), Jasmina Ratsirmuseta (1890 – 1946), Justin Rainizanabololona (1861 – 1938), infine Tselatra Rajoaonah (1863 – 1931) avessero tutti frequentato le scuole gestite dalle missioni europee e tutti ricoprissero le più alte cariche istituzionali. Proprio il coinvolgimento degli autori con la politica coloniale e con gli organi di stampa malgasci27 fu all’origine della cessazione improvvisa dell’attività teatrale nel 1915. Accusati 23 «Des troupes théâtrales arrivaient de France à chaque saison. Les impresarii avaient pour office d’initier les Hovas aux secrets de l’art.», Ibid. 24 «[…] l’inauguration du Théâtre de Tananarive le 14 septembre 1899 marque véritablement la naissance du théâtre à Madagascar.», Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, op. cit., p. 78. 25 «Elle [l’école de spectacles dramatiques] a adopté la structure aussi bien externe – découpage du texte en actes et en scènes, ouverture suivie de dialogue entrecoupé de chant et chœur final à l’image de l’opérette – qu’interne – exposition, nœud, dénouement - de la pièce occidentale.» Ibid. 26 Ibid., p. 71. «La combinaison subtile de l’opérette française et du moralisme missionnaire catholique et protestant aboutit donc en une synthèse curieuse de chansons d’amour et de sermon (fananarana).». Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., p. 269. 27 «[…] Justin Rainizanabololona […] faisait partie d’une ambassade envoyée à Paris par la reine Ranavalona III, et, par la suite, dirigea plusieurs journaux. […] Tselatra Rajaonah […] était membre du gouvernement de Rainlaiarivony […].», Albert Gérard, Essais d’Histoire Littéraire Africaine, op. cit., p. 119. 128 di complicità nei fatti del V.V.S28 i maestri del fananarana vennero costretti all’esilio, quindi al silenzio29. Solo Rodlish, (pseudonimo di Arthur Razakarivony, 1897) formatosi in gioventù nella scuola del fananarana, di ritorno dall’esilio in Madagascar nel 1926, decise di rifondare il teatro malgascio traghettando così la prima generazione di drammaturghi verso una nuova fase della composizione teatrale. Rodlish e Rakoto di Montplaisir si prefissero l’obiettivo di sistematizzare i generi teatrali della tradizione per dare vita a una sola forma drammatica nazionale, specificatamente malgascia, il Teatro Classico Malgascio (1922 – 1945). Le caratteristiche principali del teatro classico malgascio possono riassumersi in una commistione del cantato e del recitato. Come lo hira gasy, e il fananarana, questo teatro si divideva in tre tempi (tre atti), più un coro d’entrata e coro finale30 e come le forme che lo avevano preceduto, anche questo tipo di produzione teatrale non poteva prescindere dalla morale, che nelle vicende amorose si riassumeva nell’esaltazione delle virtù individuali contro le prerogative della casta31. Interprete fedele del reale, il teatro classico malgascio rifuggiva i personaggi stereotipati del teatro occidentali per sostituire alle categorie della vittima e del carnefice, del buono e del cattivo, prediligendo figure complesse che si potevano rivelare buoni o cattivi, comici o tragici in base alle differenti situazioni che venivano a vivere sulla scena: «quoique artificiel, l’univers scénique veut être une image fidèle de l’univers […], l'œuvre dramatique une restitution du monde réel […] “le bemiray consiste à mélanger la tragédie, la comédie, le drame” […]. Le héros classique malgache est à la fois lâche et courageux, avare et généreux, méchant et bon […]. Le théâtre malgache classique intéresse […] car il met l’individu en présence non de l’Homme, mais de l’Humain.»32. Rimaneva del gusto popolare, non solo la predilezione per le parti cantate che, in alcune opere, tendeva a prevalere sul recitato33, ma, in particolare, l’idea che il pubblico dovesse avere una parte 28 Rimandiamo a p. 8 e p. 42 del Capitolo precedente. «L’affaire V.V.S. de 1915 marque le déclin de ce Théâtre des Précurseurs strictement réservé au public aristocratique et à la haute bourgeoisie […]», Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, op. cit., p. 71. 30 «Dans son ensemble, la représentation classique est structurée de la manière suivante: elle débute par un Chœur d’Ouverture dont les paroles annoncent le thème moral qui va être développé par la pièce. Ensuite, la représentation de la pièce proprement dite – découpée généralement en trois actes marquant les changements de lieux – alterne dialogues et chants.[…] avant l’ultime baisser du rideau, tous les acteurs se retrouvent sur la scène pour entonner un chœur final», Ibid., p. 72. 31 «Comme l’ont observé Claude-Marie Lorin et Albert Rakoto Ratsimamanga, “l’exaltation de la morale individuelle au détriment des mérites conférés par la caste est le thème habituel des écrivains appartenant à la classe des hommes libres (bourgeoisie)”», Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., p. 272. 32 Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, op. cit., p. 74 – 79. 33 La preminenza del cantato sul recitato (modulato anch’esso sugli accordi vocali) era evidente di fronte al sempre maggiore numero di canzoni che scandivano i drammi (si potevano contare più di venti parti cantate a una o più voci). Testimonianze del tempo riferiscono di pièces apprezzate solo per la ricchezza dei canti che potevano esibire, di un 29 129 attiva nella realizzazione dell’opera stessa. Perché l’opera risultasse gradita anzitutto all’auditorio, incontrasse i gusti del pubblico, ineluttabilmente legato a un’immagine corale, collettiva della rappresentazione, il testo doveva riflettere la sensibilità tutta malgascia verso le tematiche morali e politiche. Come nello hira gasy34, nel teatro classico, lo spettatore era ancora una volta chiamato a esprimere il suo consenso. L’incapacità della sintesi tra atto e parola, quindi della distinzione tra finzione e realtà35 che dominava la creazione del teatro classico malgascio dovette certamente apparire agli Occidentali un arrangiamento naïve, certamente folcloristico, del teatro occidentale: un’illusione che, al pari del sogno, difendeva la propria verità sul reale «qui fonde l’authentique sur la convention, le réel sur l’imaginaire et qui marie le naturel à la fiction.»36. Il mondo ideale, irreale delle pièces malgasce, misurate sul discorso morale, costruite sulle verità dei proverbi ancestrali, rivelava l’intenzione dei drammaturghi locali di emancipare il neonato teatro malgascio dalle influenze del teatro occidentale, rivendicando l’autonomia politica e culturale dal mondo francese. Gli Hova che avevano mantenuto le alte cariche istituzionali non erano solo i fruitori di tale teatro, ma anche i produttori. Non fu un caso che solo dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto dopo i fatti del 47 nel Madagascar, al declino della produzione in malgascio, potesse seguire il timido inizio di una produzione in francese. 1947 – 1997. Mito, storia, superstizione. Abulia, violenza verbale, autismo della memoria: Le esacromie del teatro malgascio moderno e contemporaneo La seconda guerra mondiale arrivò a disperdere in pochi anni gli ultimi esponenti della scuola teatrale malgascia, la cui attività era stata possibile soprattutto perché la formazione di questa prima generazione di drammaturghi aveva di fatto preceduto la riforma scolastica del 1895. Le difficoltà economiche, seguite al conflitto, la comparsa di un nuovo gruppo di letterati, prodotto della riforma di Gallieni, dovettero certamente ostacolare lo sviluppo di una produzione teatrale tradizionale da sempre invisa al colonizzatore. Le nuove leve, digiune della produzione pubblico ancora una volta sensibile più alla qualità, alla varietà dei cantanti e delle melodie che non alla credibilità del plot drammatico. «[…] le public africain est très indiscipliné. Le théâtre lui apparaît mois comme un spectacle qu’il convient de regarder en silence que comme un moyen d’extérioriser ses propres sentiments; les spectateurs africains, non seulement rient, crient, manifestent, mais également parlent, communiquent leurs impressions à leurs voisins […]», Jacques Scherer, Le théâtre en Afrique noire, in Le théâtre moderne II depuis la deuxième guerre mondiale, études réunies par Jean Jacquot, Paris, CNRS, 1967, p. 104. 34 «Le caractère essentiel du théâtre malgache classique dans ses trois composants – l’auteur, l’acteur, le spectateur.», Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, op. cit., p. 78. 35 Secondo alcune testimonianze del tempo: «À Madagascar, la notion de vraisemblance est associée au sens commun et à la vérité pragmatique fondée sur l’expérience et le réel.», Ibid., p. 76. 36 Ibid., p. 78. 130 letteraria malgascia37, si rivelarono, come era facile prevedere, sensibili al fascino della letteratura francese che, per il fatto di essere riconosciuta internazionalmente, affiancata da un corposo apparato storico-critico, si rivelava, di fatto, l’occasione per tanti giovani intellettuali di uscire dagli angusti, costretti spazi di un’isola colonizzata: «Nous avons quelques poètes comme Ny Avana Raanantoanima…Rabearivelo, Razanadrasoa, mais ce ne sont pas des auteurs connus du monde entier. Avec les auteurs français nous avons eu la possibilité […] de connaître des auteurs comme Lamartine, Baudelaire, Victor Hugo: on se sent tout de suite au diapason du monde entier.»38. Il declino del teatro classico malgascio, ritenuta la sola manifestazione teatrale del luogo prima degli anni 70, ha portato a credere che, fatta eccezione per Jean-Joseph Rabearivelo nel 1936 e di Jacques Rabemananjara nel 1947, il teatro fosse stato completamente trascurato dall’intellighenzia del luogo per quasi un trentennio a vantaggio della poesia e del romanzo. La presenza di una fiorente attività editoriale per le altre forme letterarie e per il teatro in lingua nazionale39, sembrava confutare l’esistenza di un teatro malgascio in lingua francese prima della seconda metà del Novecento, portando così i critici, se non all’esclusione della presenza di tale produzione sul suolo malgascio, quantomeno all’idea che tale teatro non dovesse essere esemplare o significativo rispetto agli altri generi summenzionati. Lascia di fatto perplessi come una produzione, apprezzata dalla cultura madecassa per i riferimenti all’esperienza comunitaria, avesse improvvisamente perso di attrattiva per gli scrittori, ma soprattutto agli occhi del pubblico stesso. Alla luce di studi più recenti, non soddisfano più le argomentazioni inizialmente sostenute da Odeam Rakoto e da Raymond Ermantier nel 196340. L’assenza di un repertorio malgascio in lingua francese, sarebbe da imputare secondo i due critici all’incapacità dei drammaturghi locali di riuscire a emulare il genere occidentale sfuggendo alla tentazione di coniugare la tradizione dello hira gasy (il gusto malgascio per l’artificio) alla rigida poetica aristotelica. Le prove sostenute dai primi imitatori del teatro in francese si risolverebbero, 37 Per l’insita oscurità della lingua malgascia, come pure per la frammentarietà di cui aveva dato prova lo studio della produzione letteraria. 38 Jean-Luc Raharimanana, Jacques Rabemananjara, poète et dramaturge, «Notre Librairie», n. 110, (juillet – septembre 1992), p. 23. 39 Nonostante già dagli anni Trenta più di un Malgascio si fosse cimentato nei difficili versi mallarmeani, nelle vaghezze del simbolismo francese; benché nel Madagascar, al tempo, si potessero contare già numerosi epigoni del romanzo esotico e del romanzo naturalista, pure, il teatro della metropoli non raccolse tra gli scrittori più giovani gli stessi consensi, il medesimo successo della generazione precedente. Tra gli anni Venti e gli anni Trenta, Raberivelo aveva concluso la sua intensa e corposa produzione in prosa teatro e poesia. Nel 1932 era stato pubblicato il romanzo di Edouard Bezoro, La soeur inconnue, incentrato sull’abolizione della schiavitù al tempo della colonizzazione francese. Jean-Louis Joubert, Panorama de la Littérature malgache, «Interculturel Francophonies», n. 1, Lecce, Argo, 2001, pp. 15 – 19. 40 «Cela vivait, cela s’agitait, cela brûlait les planches mais l’ensemble du spectacle réalisé au mépris des règles les plus simples manquait de tenue», Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., p. 277. 131 quindi, in una prosa barocca41 nella quale lo spirito nazionalistico, che pure muoveva questi seguaci del francese, cedeva ai verbosi slanci sentimentali42. L’insuccesso di tale teatro, del resto già per la sua scarsa maturità destinato all’oblio, sembra oltretutto imputabile, secondo i due studiosi, al pubblico malgascio insospettito e indispettito da una rappresentazione, che, riproducendo servilmente i canoni occidentali (dimostrandosi assoggettato anche culturalmente del colonizzatore), andava, di fatto, contro il gusto popolare. Il rinvenimento di due esili opere in francese, due testimonianze appena percettibili del teatro in lingua, ci hanno fatto protendere per l’idea che, già prima degli anni 70, più di un autore del Madagascar ne aveva tentato l’imitazione con discreto successo: Rêve mortel43, un atto in versi, e L’Occasion44, commedia in un atto in prosa di Martin e de Busschère. Il fatto che non esista una cronaca in merito alle due opere, o ad altre affini di cui si è persa finanche la testimonianza, è presumibilmente ascrivibile al fatto che il genere era principalmente rivolto all’intrattenimento del pubblico europeo. Di conseguenza, le case editrici del luogo non dovettero preoccuparsi della loro pubblicazione, come accadeva, invece, per le opere teatrali in malgascio. Le due pièces sono state edite rispettivamente sulla rivista «Revue Nouvelle» nel 1904, e da una casa editrice presumibilmente francese, Julien Général, nel 1905. Facciamo notare che la prima opera, quella del 1904, anonima, è stata pubblicata con lo pseudonimo, di Un Malgache, il che fa presumere, anche alla luce del testo, a una nascosta dichiarazione politica da parte dell’autore. Al di là di quelle che potrebbero essere le qualità estetiche di entrambe, o la particolare originalità della struttura rispetto alle opere francesi, europee del tempo, difendiamo la maturità stilistica di cui ambedue danno prova, l’una in versi l’altra in prosa, a negare la tesi di Odeam Rakoto e di Raymond Ermantier di un teatro barocco, goffamente impreziosito da uno stile artefatto e desueto. Aggiungiamo che gli slanci lirici dal gusto seicentesco, della prima opera, non si distinguono dai versi di Rabemananjara apprezzati per il loro alto valore poetico. Ciò che ha oltremodo destato il nostro interesse, visto il breve periodo intercorso tra la pubblicazione delle due opere, è una strana e illuminante complementarità che le distingue: la prima firmata da Un Malgache è una tragedia in versi che racconta dal punto di vista malgascio (i 41 Sorprendentemente, nonostante l’educazione la canto, quindi al ritmo, solo pochi autori riuscirono, con difficoltà, a produrre opere teatrali in versi. Ibid., p. 273. 42 «Comme le dit Randriamarozaka l’auteur se plaît à romancer, à suivre les personnages à travers les péripéties, le temps et l’espace, avant d’arriver au dénouement qui donne toujours leu à une exaltation lyrique des sentiments moraux.», Ibid. 43 Un Malgache, Rêve Mortel, «Revue Nouvelle», 15 juin 1904, Tome XXVIII (mai – juin 1904). Riassunto p. 468. 44 Ed. Martin, H. de Busschère, L’Occasion. Comédie en un acte. Représentée au Théatre Municipale de Tamatave le 16 août 1905, Tamatave, Julien Général éd., 1905. Riassunto p. 468. 132 personaggi sono due indigeni) l’impatto della colonizzazione: l’impossibilità della conciliazione tra la cultura francese e la cultura malgascia, tra dominato e dominatore. Il tema, per alcuni versi simile, è ripreso nel secondo testo: una commedia in prosa che racconta la colonizzazione dal punto di vista del colonizzatore, mettendo in luce i ben noti, e tristi, luoghi comuni della politica dell’occupante Yvonne [tandis qu’ils jouent]: «Qu’est-ce que vous faites…Vous mettez un blanc sur une noire.» Robert: «Oh! Je vous demande pardon…À Madagascar!». come pure l’atteggiamento di sufficienza, di irriverenza, e di scherno verso le colonie: terre selvagge, lontane dalla civiltà e dal mondo civilizzato, popolate da inferiori, o nel caso migliore, come alla Réunion, da coloni dallo spirito semplice nel volersi vantare di possedere gli stessi agi, il medesimo progresso della Metropoli Robert:«Oui, joli pays, la Réunion. Comme qui dirai la Suisse dans l’Océan Indien […] Ainsi à la Réunion tu a les poires comme en France […] Des pommes, des pêches, des letchis […] des pommes de terres nouvelles, un sénat et deux députés.» /Raymond: «Deux députés. Oh! Alors, c’est pas laid Bourbon.»45. L’esempio più significativo, la voce più interessante dei primi anni del Novecento rimane certamente quella di Jean-Joseph Rabearivelo46. Più noto come poeta e romanziere, Jean-Joseph Rabearivelo arrivò tardi al teatro, appena due anni prima della morte. Parimenti, nonostante sia l’autore di solo due opere, Imaitsoanala, fille 45 Ibid., p. 26 e 42. Notare che mentre Robert parla di Réunion, Raymond si riferisce all’isola designandola Bourbon, quello stesso nome che datole all’indomani della conquista le sarebbe stato riassegnato a ogni cambiamento del potere centrale in senso reazionario, così nel 1803, alla nascita dell’impero napoleonico. 46 Nato a Tananarive nel 1901 da famiglia di nobili origini (la madre rivendicava la sua appartenenza alla famiglia di Ralambo, re merina del XVII secolo), caduta in disgrazia in seguito all’abolizione della schiavitù, Jean-Joseph Rabearivelo (pseudonimo per Joseph-Casimir) seguì degli studi discontinui tanto da essere costretto ad apprendere il francese come autodidatta. La sua ambizione letteraria dovette scontrarsi sin dall’inizio con le ristrettezze economiche imposte dalla situazione coloniale, tale da costringerlo sin da giovane a dover conciliare le sue aspirazioni ai lavori più diversi, scarsamente retribuiti: segretario, interprete, bibliotecario, infine correttore di bozze per una casa editrice di Tananarive. I numerosi tentativi di accedere a cariche coloniali che avrebbero permesso a lui e alla sua famiglia una vita più agiata, furono costantemente ostacolati da una rigida burocrazia che tendeva a premiare i Malgasci di estrazione sociale più elevata. L’insuccesso lavorativo si aggiunse alla frustrazione di non vedere il suo lavoro intellettuale riconosciuto dalla Francia, di cui, pure, i suoi componimenti poetici tuttavia celebravano la lingua (Aux portes de la Ville, era stata scritta su commissione per la Grande Esposizione Coloniale del 1931). Nel 1937, proprio quando sperava di poter partecipare all’Esposizione Coloniale si vide rifiutato per un gruppo di artisti locali malgasci, rappresentanti del folclore dell’isola. Si è soliti motivare il suicidio di Rabearivelo con l’improvvisa e inspiegabile morte della figlia Voahangy (1933) da cui, pare, non si sarebbe ripreso. Il fattore economico, la quotidiana mortificazione a cui lo costringeva la condizione da colonizzato, certamente la morte della piccola Voahangy, la frattura mai più sanabile che aveva potuto significare l’assoggettamento di un popolo libero e indomito come quello malgascio, sono attualmente considerati i fattori che hanno spinto un uomo fragile ed esile come Rabearivelo al suicidio nel 1937 per quanto, come ricorda Joseph Boudry, il poeta aveva più volte celebrato il mistero della morte, tanto da programmare fin nei minimi dettagli il suo trapasso come testimonia il diario scritto durante la sua agonia. 133 d’oiseau47 et Aux portes de la ville48, può essere considerato l’antesignano del teatro malgascio contemporaneo in lingua francese. Primo fra i drammaturghi malgasci, Rabearivelo tentò l’interferenza tra le due culture, violando la rigida struttura linguistica francese per mezzo della parola esuberante ed esclusivamente simbolica del racconto malgascio. Anticipando una forma cara a molti autori contemporanei malgasci e africani, Rabearivelo trascrisse per il teatro e in francese le leggende del mondo madecasso. Piegando la tradizione occidentale ai gusti artistici malgasci (la pièce, nel pieno rispetto dello hira gasy, è di fatto una commistione di recitato, cantato e danzato), l’autore gettò le basi per quel rinnovamento della letteratura occidentale che sarebbe arrivato proprio dal métissage e/o interferenza praticata dagli scrittori delle ex-colonie solo agli inizi degli anni 60 e dopo l’avvio del processo di decolonizzazione: «Rabearivelo ne se contente de porter en lui cet amour de la patrie […]. Il met son talent au service de son peuple.»49. Imaitsoanala è la leggenda di una ragazza nata da un uovo, nutrita dall’uccello Vorombe, che di lei si prende cura come una madre. Nonostante il divieto di allontanarsi dal nido, Imaitsoanala decide di seguire l’amore di un principe venuto da un regno lontano. Racconto carico di insegnamenti morali, primo fra tutti l’iniziazione di Imaitsoanala alla vita, la leggenda è annoverata tra i miti fondatori del popolo malgascio. Secondo Paul Ottino50, infatti, il mito sarebbe non solo la narrazione simbolica dell’interdetto della sterilità (con la messinscena dell’opposizione tra la sterilità delle due rivali e della fertilità di Imaitsoanala), ma, stando alla versione tantara, il racconto di Imaitsoanala metterebbe, soprattutto, in scena la nascita della dinastia Merina: Ramaitsoanala, figlia del signore Radiby (Ra/diby, Uomo bestia) sposa di Andriamanaelo sarebbe difatti la madre di Ralambo, primo re merina (come non ricordare che lo stesso Rabearivelo sosteneva di discendere da Ralambo?). Ricordato solo accidentalmente per la sua produzione drammatica, sulle opere di Rabearivelo è stato scritto ben poco, troppo episodiche sono le informazioni per tracciare un profilo adeguato sulla produzione dello scrittore. 47 Jean Joseph Rabearivelo, Imaitsoanala fille d’oiseau, Cantate, Tananarive, Imprimerie Officielle, 1935. Secondo quanto riportato da Paul Ottino, Imaistoanala, come accade anche nei nomi malgasci, sarebbe la contrazione di I, «jeune fille», maitso «la verte en forêt», Vorombe, l’uccello che si prende cura di Imaitsoanala, uccello mostruoso, Vorom/be significherebbe messaggero di Dio. Paul Ottino,L’Etrangère Intime. Essai d’anthropologie de la civilisation de l’ancien Madagascar, Paris, éd. Des Archives Contemporaines, 1986, pp.102-118. 48 Jean Joseph Rabearivelo, Aux portes de la Ville. Imagerie populaire musique de Benoît Rakotomanga sur des paroles et aires anciennes, Tananarive, Imprimerie Officielle, 1936. «Il s’essaya au théâtre en transportant à la scène une sorte de rêve folklorique de la vie et des anciennes mœurs locales, destiné à la propagande de l’Île pour l’Exposition Coloniale de 1931.», Joseph Boudry, Jean-Joseph Rabearivelo et la mort, Paris, Présence Africaine, 1958, p. 42. 49 Joseph Boudry, Jean-Joseph Rabearivelo et la mort, op. cit., p. 64. 50 Paul Ottino, L’Etrangère Intime. Essai d’anthropologie de la civilisation de l’ancien Madagascar, op. cit., pp. 102118. 134 Joseph Boudry ricorda, nel suo saggio su Rabearivelo, che nonostante le due opere di Rabearivelo, allestite a Tananarive con il concorso del comune e del Governo Coloniale, avessero rappresentato un evento per la società malgascia, specialmente Imaitsoanala, nondimeno, o proprio per questo, la loro messa in scena sollevò numerose polemiche, a tal punto che l’autore fu addirittura accusato di plagio: «Un journal lui reprocha d’avoir fait de larges emprunts à un recueil publié par M. Dahle et John Sins sous le titre de Anganon’Ny Ntaolo.»51. Harold H. Waters, dal canto suo, si limita a fornire un veloce e, per alcuni versi, impreciso commetto su Imaitsoanala, riducibile di fatto al riassunto della stessa: «Légende dramatisée. Cantate. La mise en scène indique que la pièce doit être montée sous forme de ballet, et, aussi que le choeur y joue un rôle important. Un oiseau couve Ivorombe. Jeune fille, elle rencontre le roi Andriambahoaka, qui s’énamoure d’elle. Ses femmes sont jalouses, d’autant plus qu’elle est sa fille. Il la mutile mais, miracle, elle est reconstituée et l’épouse.»52 Contro un’interpretazione etnologica del testo, la più recente esegesi di Mathilde Nivoarisoa Rakatozafy reclama, invece, una lettura tutta politica dell’opera sostenendo che la scelta della leggenda popolare di Imaitsoanala non solo voleva essere il recupero della tradizione malgascia, ignorata dai colonizzatori, ma la dimostrazione dell’assurdità delle divisioni politiche (pro o contro la colonizzazione) che smembravano il popolo a tutto vantaggio del colonizzatore. Insomma l’unione tentata dal poeta della parola antica in un linguaggio nuovo (quello francese) era soprattutto una prova di fede al popolo malgascio: «Mais qu’advient-il losqu’un Jean-Joseph Rabearivelo aussi conscient de ses actes décide de traduire en français des oeuvres littéraires malgaches comme Imaitsoanala, zana-brona? Il ridiculise les colons qui croient avoir à faire avec des sauvages […] sans traditions qui gagneraient à être civilisés […]. Jean-Joseph Rabearivelo est en train de mener une lutte pour la reconnaissance d’une identité culturelle qu’on refuse à la nation malgache vaincue par les armes mais militant pour une forme nouvelle d’indépendance. Par ailleurs, en jonglant merveilleusement sur les aptitudes des deux langues en contact, Jean-Joseph Rabearivelo dénonce indirectement l’absurde politique qui tend à privilégier l’appartenance à tel ou te parti, le choix idéologique qui nous emmène à soutenir ou non le régime […] alors qu’au-delà des préjugés […] il existe l’aire linguistique qui ne se définit qu’en fonction d’une narration intégrative […].»53 51 Joseph Boudry, Jean-Joseph Rabearivelo et la mort, op. cit., p. 43. Harold H. Waters, Théâtre Noir, encyclopédie des pièces écrites en français par des auteurs noirs, Washington, Three Continents Press, 1988, pp.68-69. 53 Mathilde Nivoarisoa Rakatozafy, Jean-Joseph Rabearivelo, cet inconnu? In Jean-Joseph Rabearivelo, cet inconnu?, Actes du Colloque International de l’Université de Madagascar pour la célébration du cinquantenaire de la mort (1937-1987), Marseille, Sud, 1989, p. 213. 52 135 Come evidenziato dal caso di Rabearivelo, dalla fine degli anni Trenta fino al decennio che seguì la Seconda Guerra Mondiale, il problema economico, che funestava l’isola, toccò anche le compagnie teatrali, gli stessi edifici adibiti alla rappresentazione. La povertà delle scene (per lo più ingombranti e difficili da cambiare), le sale disadorne e poco accoglienti non dovettero aiutare la crescita del teatro malgascio in lingua francese. Decisivo per il suo momentaneo declino furono la mediocrità delle opere54 sempre più spesso asservite ai gusti del grande pubblico, sempre meno frutto di una moderna sperimentazione. Non meno determinante deve essere considerato il sentimento che abitava lo spettatore malgascio: l’imbarazzo, la sua evidente difficoltà di fare proprio il ruolo pienamente occidentale dello spettatore: una figura sì funzionale allo spettacolo eppure irrevocabilmente esiliato dalla rappresentazione (diversamente dallo hira gasy in cui ricordiamo la comunità fungeva da scena, da interlocutore, da attore, da uditorio, in ultimo da giudice della rappresentazione). Laddove le colonie americane e africane si preparavano all’indipendenza anche con la sagacia della penna, nel Madagascar, il dopoguerra si trascinò, invece, nel silenzio smarrito di un’intera nazione, dei pochi intellettuali sopravvissuti alle carceri. In questo contesto, le pièces di Rabemananjara, e l’attività di Odeam Rakoto dovettero apparire un’eccezione ma anche, il felice preludio55, alla rinascita di un teatro malgascio. * L’attività teatrale subì un’apparente battuta d’arresto durante il decennio della rivoluzione malgascia. Eredità del periodo coloniale: della prevaricazione culturale e dell’intolleranza del colonizzatore, il teatro fu sottoposto negli anni 70 a un vero e proprio processo culturale da parte della popolazione malgascia. La messa in discussione della lingua francese, di un intero sistema culturale condiviso per quasi un secolo, come pure degli anni repubblicani di Tsiranana, in nome dei martiri del 47 produsse uno stato di incertezza generale. Al motto di malgascizzazione si arrischiarono riforme, come l’abolizione del francese e della scolarizzazione su modello occidentale, che nei fatti si tradussero nello scempio del sistema scolastico malgascio, e, per un’intera generazione, nella perdita dei riferimenti culturali sia europei 54 «Le public lettré […] hésite à se rendre au théâtre parce que la qualité des pièces qu’on y joue est douteuse […]. La faiblesse des pièces ne vient pas de l’ignorance ou de la médiocrité des auteurs: il n’est d’excellents, mais ils sont obligés de sacrifier aux goûts de ces spectateurs dont dépend leur pain quotidien. […] Pour lui complaire, l’auteur est obligé d’exploiter certains effets faciles, certains situations, toujours les mêmes, provoquant à coup sûr de bruyantes approbations […].», Robert Cornevin, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, op. cit., p. 274. 55 «Aucun répertoire bien établi, aucun moyen d’expression, aucun budget de fonctionnement: le plus miséreux des baladins du XIIe siècle avait plus d’aisance que ce chef de troupe talentueux, riche d’imagination, mais qui est obligé pour survivre, de prostituer son art, de rabaisser son public. […] Il est contraint à une grande prudence dans l’établissement de son répertoire…s’il innove trop…il perd une partie de ses spectateurs habitués aux formes les plus traditionnelles du théâtre.», Ibid., pp. 278 – 280. 136 che malgasci56. Europei, nella misura in cui la rivoluzione malgascia del 72 si pose come obiettivo quello di reintrodurre la lingua e la letteratura indigena, a riscatto della tradizione, e contro gli anni del dominio culturale francese. Per reazione al totalitarismo di Ratsiraka, gli intellettuali malgasci si opposero a un recupero frammentario e astorico della tradizione saccheggiata a scopi politici e propagandistici. Misconoscere le interferenze coloniali nella cultura malgascia contemporanea, per quanti transitavano dal vecchio regime al socialismo rivoluzionario, voleva dire asservire quella stessa lingua, che nei decenni passati era stata il vessillo della libertà e della disubbidienza del popolo malgascio, a una nuova e più subdola dittatura. La fuga degli intellettuali in dissenso con la «rivoluzione culturale malgascia» ebbe come esito la rinascita della produzione letteraria e, dal 1979, della produzione teatrale in lingua francese. Nel 1979 veniva premiata al concorso di R.F.I Sambany57 di Michèle Rakotoson. L’attività teatrale sembrava riprendere, dopo quasi un trentennio di silenzio, sospinta dall’urgenza della parola di quanti, esuli volontari dal Madagascar, sentivano di dover testimoniare in rispetto del passato taciuto dai colonizzatori e contro i disastri politici e le violazioni umanitarie dei dittatori contemporanei. Per questi autori, il francese, idioma a un tempo estraneo eppure familiare, si prestava, più del malgascio, a un uso analitico e introspettivo del linguaggio, di conseguenza, a una rielaborazione critica del reale. Spogliata di qualsiasi riferimento politico, epurata della memoria coloniale, abitata, occupata come fosse una terra vergine, una «no man’s land», la lingua francese seduceva per il rigore laico per la possibilità offerta allo scrittore di affrancasi dai tabù, dai formalismi della lingua malgascia, per infondere nuovamente nei nomi e nelle cose non solo il meraviglioso malgascio58, ma soprattutto la crudezza della realtà: «Le français, dans ces conditions, est pour Jean-Luc Raharimanana la “langue de la découverte de l’autre”, et non la langue de libération qu’elle est dans nombre de discours francophones. Il continue à se sentir étranger dans la langue française, qu’il utilise avec et à l’esprit de l’imaginaire malgache» e ancora 56 «Telle qu’elle [la malgachisation] a été faite à Madagascar, ça a été une très mauvaise chose, à la limite une malgachisation fascisante, de prise de pouvoir. […] Le système scolaire a été changé, tout l’enseignement a été fait en malgache. […] Toute une génération s’est retrouvée sans livres, sans bibliothèques, sans réels outils de réflexions. […] La malgachisation, il fallait la faire, mais pas comme elle a été faite.», Taina Tervonen, Entretien avec Michèle Rakotoson, op. cit. 57 Michèle Rakotoson, Sambany, pièce inédite, prix RFI 1979. 58 Danielle Nivoelisoa Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, «Notre Librairie» n. 110 op. cit., p. 70. 137 «Jaomanoro franchit de multiples façons les tabous du silence sur les traditions malgaches, le rôle de l’argent, le respect de l’identité, de la femme, de la justice. Par le langage [le français] il ose défier les limites […]»59. Il teatro occidentale, reinterpretato alla luce dell’esempio politico dello hira gasy60 (come rappresentazione della comunità per la comunità), è investito da questi nuovi drammaturghi di un preciso ruolo sociale: rifondare la società malgascia a partire dal recupero della memoria collettiva negata dal colonizzatore e tradita dalla rivoluzione del 1972: «On représente à Madagascar des pièces du corpus occidental, cependant l’essentiel de la vie théâtrale est constitué par la continuation de la forte tradition théâtrale à Madagascar. Les troupes sont itinérantes, et jouent un corpus conservé pour l’activité de celles-ci par la mémoire collective. […] il est absent des programmes d’universités. Cela s’explique aussi, selon Raharimanana, par le mépris des autorités à l’égard de ces formes théâtrales.»61. Se la contestazione si propaga dal teatro sociologico, incentrato sulle piaghe della società contemporanea, il rifiuto è diffuso nelle pièces etnologiche e storiche62 costruite sulla sublimazione di personaggi negletti, come Radama II, sulla celebrazione dei grandi re del passato, quali Andrianampoinimerina (fondatore della dinastia e del regno Merina), o al contrario di dimenticate leggende lacustri, come il lago dei caimani63. Generi differenti che illustrano i due diversi filoni in cui si divide la nuova scuola teatrale: uno neo-classico e uno sperimentale. Se il teatro di Michèle Rakotoson, di David Jaomanoro, Jean-Luc Raharimanana rivendica l’appartenenza all’avanguardia teatrale di Beckett, il teatro storico ed etnologico rimane essenzialmente legato alla scuola naturalistica francese. La corrispondenza tra la logica e le leggende, le superstizioni malgasce, tra l’irrazionalità e la linearità della narrazione produce nel lettore, e poi nello spettatore, un senso di spaesamento, già noto nei racconti di Hoffmann. Lo sguardo paradossale su un presente tecnologico popolato, allo stesso modo dei racconti mitici del passato, di personaggi inconsueti: uomini-caimani, uominiserpenti, principi del lago o sirene che rubano l’anima per giustizia o in cambio della scienza 59 Carole Bougenot, Visite de Jean-Luc Raharimanana, 23 janvier 2003, séminaire commun de DEA; CIEF. Dominique Ranaivoson, David Jaomanoro, un écrivain malgache francophone original, «Notre Librairie», n. 150, (avril – juin 2003), p. 96. 60 «Sambany est un hira gasy. Dans La maison morte, j’ai gardé le rythme de la langue malgache, les ponctuations musicales, qui là sont les chants de la Folle. Un jour ma mémoire est un hira gasy déconstruit. Du hira gasy j’ai gardé les danses, l’occupation circulaire de l’espace, la disposition symbolique et l’interprétation de la musique du texte.», Caya Makhélé, Michèle Rakotoson. Être face à soi, pour mieux aller vers les autres, «Théatre Sud» n. 3, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 38. 61 Carole Bougenot, Visite de Jean-Luc Raharimanana, 23 janvier 2003, op. cit. 62 Danielle Nivoelisoa Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, op. cit., p. 70. 63 Jacques Rabemananjara, Les Dieux malgaches, Paris, Ophris, 1947; Josette Rakotondradany, Le Rebelle, Créteil CERCLEF, 1989; David Jaomanoro, Le Dernier Caïman, 1988. 138 assoluta64, tradisce l’aberrazione del mondo contemporaneo, alla luce, soprattutto, di personaggi umili (che sorprendentemente, come nelle pièces classiche, fanno uso di un linguaggio arcaico, ricercato) «Précision des scènes d’exposition, des didascalies et du dialogue. Unité de temps, de lieu et d’action. L’intrigue se déroule à une époque bien définie. […] L’espace est défini géographiquement. […] Il y a une forte présence d’eau stagnante […].»65. Decisamente di rottura, il teatro di Michèle Rakotoson, di David Jaomanoro, di Jean-Luc Raharimanana. Volutamente provocatorio, questo teatro persegue la contaminazione linguistica (tra genere alto e familiare, tra ricercatezza e trivialità) nel segno dell’incoerenza, quindi della perdita di riferimenti logici: del principio di causa effetto (del resto contestato prima dalla filosofia poi dalla psicologia). Questo teatro dell’inazione (vista l’impossibilità e l’inutilità dell’azione) mette in scena personaggi abulici alle prese con la mise en abîme della negazione: sconfessione della realtà (dello spazio come campo della conoscenza) e della memoria (come esperienza della nominazione di eventi e cose passate). La fauna che popola queste pièces sono i pazzi, i visionari, i ruffiani, i traditori della patria e dell’uomo: anime perse dal potere, dai sogni disattesi, dalla vita ingiusta e inconseguente. Temi, questi, che si rivelano fertile sostrato per l’uomo esiliato dall’Olimpo degli eroi (come accadeva nella tragedia classica)66, nemmeno più uomo, ma collage, somma di bassezze, miserie, stratagemmi abilmente architettati per andare avanti, «l’homme est sans espérance, marqué par l’abandon définitif de l’humanisme que toute relation marquée par la rouerie, la haine, la lutte pour le pouvoir dément.»67. Vittima dello tsiny, e del tody68, la produzione malgascia post-coloniale rifletterebbe l’incapacità del personaggio e delle scrittore di agire positivamente sulle vicende del passato ma anche contemporanee, verso le quali il drammaturgo non sembra essere riuscito a elaborare un pensiero originale, ad assumere una posizione di reale dissenso: 64 Suzanne Ravoaja, Fanano, Créteil, CERCLEF, 1989; Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le Cerveau, Antanarivo, 1997, pièce inédite. 65 Danielle Nivoelisoa Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, cit, p. 71. 66 «S’il se doute que les jeunes écrivains ne disposent pas d’un argumentaire critique suffisamment élaboré, il tempère le constat: “Ils n’ont pas la meme perspective historique que celle qui était proposée à notre génération. Ce qu’ils ont, les jeunes, c’est la conscience du drame.”.», Eugène Ebodé, Jacques Rabemananjara: Le Totem, «Interculturel Francophonies», n. 1, op. cit., p. 84. 67 Dominique Ranaivoson, David Jaomanoro, un écrivain malgache francophone original, «Notre Librairie», n. 150, cit., p. 96. 68 Si definisce, tsiny (del senso di colpa generico, l’angoscia di fronte al mondo), e tody (del senso di colpa particolare). Danielle Nivo Galibert, Histoire, littérature et société. Le silence malgache, «Interculturel Francophonies», n. 1, cit., p. 93. 139 «Les problèmes socio-politiques qui le délimitent ne sont guère évoqués. On en entrevoit quelques-uns ici ou là, timidement ébauchés. Quelques passages suggèrent qu’il existe un problème d’exploitation de la femme sous forme moderne dans les couches moyennes […] et la première pièce de Michèle Rakotoson, Sambany (1978), qui dénonce la pression du groupe sur la femme stérile, fait figure d’exception dans ce discours féminin où la constante est la conformité aux règles sociale. Or, ennemie de la création, reposant sur une doxa, l’écriture conventionnelle est justement une forme de silence.»69. Nonostante, infatti, l’attività teatrale sia andata intensificandosi dagli anni 80 a oggi, non tutti i critici sono concordi, con Liliale Ramarosoa, nel ritenere questa produzione realmente impegnata nella critica al potere centrale. La prima incongruenza messa in risalto da Danielle N. Andrianiafy e da Danielle Nivo Galibert è lo scarto tra produzione teatrale e pubblico. L’uso del francese in qualsiasi forma d’arte (da considerarsi con sospetto soprattutto dopo il 197270), sottintende necessariamente la presenza di una determinata, ristretta nicchia di spettatori: un uditorio colto, con un retroterra culturale affine a quello dell’autore (nel caso di Michèle Rakotoson e Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato l’alta borghesia cresciuta nel clima protestante o nelle scuole cattoliche). Le pièces che presentano e denunciano i problemi della società contemporanea, che, pure, si scontrano con gli orrori della politica, sono, nella realtà, a uso e consumo di pochi: l’alta borghesia di Tananarive e/o in alternanza il pubblico europeo. Se da un lato gli esigui investimenti stanziati dal governo malgascio per la cultura fanno sì che ancora oggi non si sia creato un bacino di utenza sufficientemente largo per un apprezzamento della produzione teatrale autoctona, allo stesso tempo, lo spettatore privilegiato, a cui il testo drammatico sembra rivolgersi, si eclissa di fronte ai temi trattati, non comprendendo (o non condividendo?) appieno il ruolo sociale assunto dal teatro contemporaneo71. Lo scarso interesse dimostrato dai Malgasci riguardo alla produzione in lingua fa sì che il messaggio sociale, politico e umano di questo nuovo teatro rimanga lettera morta, dal momento che la stessa attività dei festival internazionali sembra inadeguata di fronte alla problematicità delle situazioni esposte nelle pièces. 69 Ibid., p. 90. «Elle [la sœur de Michèle Rakotoson] a essayé de monter Un jour ma mémoire mais elle a eu des problèmes et la pièce a été interdite.», Monique Hugon, Entre deux langues, entretien avec Michèle Rakotoson, «Notre Librairie», n. 110, op. cit., p. 78. 71 «Malheureusement, le public malgache n’est presque pas touché par ce théâtre. […] À Madagascar, le théâtre d’expression française est considéré comme un théâtre intellectuel. D’abord, la langue qu’il utilise est le français, une langue savante puisque étrangère dans le contexte malgache actuel. Ensuite, le milieu dans lequel il se développe est celui de l’Université […]. Ce théâtre est presque exclusivement citadin, sinon tananarivien. Petite élite intellectuelle et cultivée, membres des différents centres culturels, ces privilégiés sont en quête d’une certaine ouverture du monde. Cependant ils ne considèrent ce théâtre que comme divertissement […].», Danielle N. Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, op. cit., p. 74. 70 140 Se da un lato si offre allo scrittore malgascio l’occasione unica di farsi apprezzare in Francia e nel resto del mondo, pure, i festival internazionali costringono, di fatto, lo scrittore malgascio all’interno di scomode e ambigue etichettature, come la francofonia, il folclore, non sempre rispondenti all’urgenza sociale o stilistica del momento: «En amont, concourir auprès de RFI suppose une forte “ethnicité” de l’écriture, l’identité recommandée étant avant tout celle d’un peuple ou d’une nation francophone. En aval, les collections telles que “Encres Noirs”, “Lettres Sud”, “Théâtre Sud”, ou même “Littératures d’étranges pays” limitent la réception de l’œuvre au champ des seuls spécialistes francophones.»72. Probabilmente proprio al sempre maggiore successo riscosso dal Concorso Teatrale di R.F.I. nell’ultimo ventennio si deve l’oblio a cui molte pièces malagasce, scritte tra gli anni 60 e 70, sono state costrette. C’è da dire che anche queste stesse pièces sono le prove di preselezione dell’antenato del concorso di R.F.I, il Concours Interafricain, istituito inizialmente tra i paesi africani e il Madagascar, e che fatta eccezione per poche, la maggior parte dimostra una scarsa padronanza del genere. La scoperta di una decina di testi negletti dalla critica, l’essere venuti a conoscenza, grazie al lavoro puntuale di Ganaba Abdoulage73, dell’esistenza di un’attività letteraria, teatrale, sotterranea negli stessi anni in cui si è concordi nel ritenere la produzione malgascia in declino, ha costretto a una riconsiderazione del fenomeno teatrale malgascio, evidentemente soggetto alla popolarità dei concorsi letterari. L’essere venuti a conoscenza di nuove e interessanti prove di concorso, o di antichi testi editi su riviste, ha fornito l’occasione per attenuare alcune, precedenti, affermazioni risultate se non troppo categoriche sicuramente approssimative74 «La participation de ce pays demeure faible […] la majorité des auteurs écrivent plus volontiers dans leur langue nationale […] depuis 1842 ce pays possède une presse écrite [qui lui permet] de se passer de la métropole.»75 72 Danielle Nivo Galibert, Histoire, littérature et société. Le silence malgache, op. cit., p. 95. Ganaba Abdoulage, Analyse thématique et sociologique de pièces du Concours Théâtral Interafricain francophone de 1967/68 à 1973, thèse, 1996. L’autore censisce nel solo periodo tra il 1968 e il 1974 la partecipazione al concorso di almeno 43 pièces. 74 Facciamo riferimento allo studio di Jean-Irénée Ramiandrasoa, Le Théâtre malgache classique: 1922 – 1945, costruito sull’assunto del declino del teatro malgascio classico. Il recente studio di Mauro Didier, Madagascar, le Théatre du peuple: l’art du hira gasy entre rebellion et tradition, thèse, 2000, ipotizza, invece, l’esistenza di un teatro tradizionale ancora fiorente nel Madagascar. Verosimilmente, l’istituzione del concorso teatrale interafricano, che ha proiettato l’interesse occidentale ma anche malgascio verso la produzione in francese, le difficoltà economiche delle case editrici locali, la piaga dell’analfabetazzazione, hanno spostato (riportato) il teatro in malgascio dalla città verso i villaggi, facendo credere alla scomparsa del teatro tradizionale. 75 Ganaba Abdoulage, Analyse thématique et sociologique de pièces du Concours Théâtral Interafricain francophone de 1967/68 à 1973, op. cit., p. 55. 73 141 A dispetto di una produzione così ampia e continua (dalla colonizzazione ai giorni nostri), è un dato di fatto che, a differenza della prosa e della poesia, il teatro rimanga un genere nuovo, poco conosciuto, soprattutto poco frequentato nel Madagascar. Malgrado si possano ritrovare delle affinità con l’antico hira gasy (nonostante proprio lo hira gasy funzioni come mediatore tra la cultura malgascia e la cultura europea), gli scrittori sembrano, nonostante tutto, mantenere delle riserve verso questo genere, forse proprio per lo scarso consenso che trova in patria e all’estero. Il teatro rimane un genere sperimentale nella misura in cui la maggior parte delle opere sono il prodotto di giovani talenti, per lo più trentenni, che, senza reale interesse76, si avvicinano al testo teatrale per l’immediato riscontro di pubblico e critica77 che il genere offre rispetto alla prosa e alla poesia, per l’opportunità offerta dai numerosi Concorsi di valicare i confini di periferie al limite della sussistenza per il miraggio delle Metropoli europee. Scrittori, improvvisati e occasionali, che si sono, comunque, rivelati capaci di dare vita a opere interessanti e artisticamente mature per il forte senso del dramma che da esse traspare, frutto di un’esperienza del reale sempre travagliata, di un’attualità borderline, che vive la maggioranza della popolazione: alle prese con una memoria frammentata, con la fatalità quotidiana. Nato nella sperimentazione del genere occidentale, dall’interferenza tra la politica e la lirica, tra lo hira gasy e le paludate atmosfere raciniane, il teatro malgascio in lingua francese si è evoluto secondo un processo di negazione e di sistematizzazione delle forme ancestrali, di confutazione e di rieinterpretazione della tradizione occidentale, fino alla riscrittura del verbo drammatico in funzione di un gesto teatrale recuperato nella sua coralità. 76 Sono pochi i drammaturghi che hanno prodotto più di un testo teatrale dagli anni 70. «Une centaine de jeunes de 20 à 35 ans […]. L’un est en quête d’un nouveau centre d’intérêt, l’autre d’une nouvelle forme d’expression. Le résultat est le même pour tous: ils se retrouvent happés par la mouvance, emportés par la passion du genre. […] Ses acquis immédiats son multiples et incontestables: c’est la rencontre avec un auteur, avec un personnage et avec un public, bref, la rencontre d’un monde intérieur avec un monde extérieur.», Danielle N. Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, cit, p.74. 77 142 Storia e mito il teatro di Jacques Rabemananjara, di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato e di Clément Rajaonarison Il est vrai qu’au lendemain des Indépendances, une tendance générale engage le théâtre africain du côté de l’histoire.78. Per la definizione e la comprensione del teatro malgascio in lingua francese, il confronto con la produzione africana si è rivelato fondamentale durante tutto il corso della nostra indagine. Nonostante l’isola abbia vissuto meno di un secolo di protettorato francese (1895-1960), ugualmente radicale dovette essere la colonizzazione per i Malgasci come per i popoli africani, parimenti violenta l’alienazione culturale e linguistica che il Madagascar dovette subire in un solo sessantennio di storia coloniale. La convergenza delle due esperienze si rafforza alla luce del precario contesto politico, economico che l’isola e il continente vivono attualmente e che ha sollecitato una risposta praticamente identica da parte delle istituzioni internazionali (soprattutto francesi) per la tutela e la promozione della cultura e della letteratura di entrambi i territori. Come detto in precedenza, il Concorso Interafricano veniva istituito, agli inizi degli anni 60, per diffondere principalmente la produzione teatrale africana e malgascia. Le modalità di recupero del materiale teatrale malgascio, la qualità dei testi, per la maggior parte prove di selezione o preselezione, sono, quindi, del tutto simili a quelle del teatro africano. Le analogie ricorrono, sorprendentemente, anche nella scelta tematica delle opere. Come il teatro africano, così quello malgascio può dividersi in tre produzioni distinte: una etnologica (leggende, racconti, superstizioni), una socio-politica (incentrata sui problemi del Madagascar e del mondo contemporaneo, facendo dell’isola il centro di una rete di strategie economico-politiche internazionali), una storica. L’interesse discontinuo dimostrato dagli autori malgasci verso il teatro ha fatto sì che la produzione teatrale si sviluppasse in periodi molti diversi da quella africana, e che le tematiche scelte riflettessero gusti e inquietudini differenti. Quando già nel 1960, le nazioni africane celebravano l’indipendenza con una serie di drammi storici, con la rinascita della tragedia e degli eroi, il Madagascar si chiudeva al passato e al presente, 78 Sylvie Chalaye, L’Afrique Noire et son Théâtre au tournant du XX siècle, Rennes, P.U.R., 2001, p. 33. 143 restaurando il mondo ideale dei drammi classici malgasci, in cui l’esaltazione del rigore morale lasciava poco spazio alla realtà. Di una trentina di opere analizzate (edite dall’inizio del Novecento) solo tre si sono confrontate direttamente con la storia del Madagascar: Les Dieux Malgaches di Rabemananjara, L’oiseau de proie di Rafenomanjato, Sur les bords de la Sahasinaka di Rajaonarison, nonostante sia evidente nelle altre, o in molte altre, il riferimento problematico, di sicuro emotivamente e ideologicamente irrisolto, ad avvenimenti più o meno recenti del Madagascar di Ratsiraka (così nelle pièces di Michèle Rakotoson e di Henri Rakotondrasoa). Nemmeno è possibile datare la produzione storica del Madagascar in modo definitivo, come nel caso del teatro africano. Piuttosto, un rapido esame delle pièces composte in prossimità dell’Indipendenza malgascia (come quella africana, a ridosso degli anni 60), fa emergere opere di tutt’altro genere come, Agapes de Dieux. Tritriva di Rabemananjara (1962), Lac et fleuve di Rahamefy (1969), Claudia di Razafimandrato (1970). Contrariamente all’evoluzione che sembra inscriversi nella ripartizione della produzione africana (dalla storia locale, anni 60-70, alla storia politica locale contemporanea, anni 80-90, per arrivare alla problematizzazione della condizione umana), la produzione teatrale malgascia non sembra procedere secondo uno schema altrettanto definito, o quantomeno definibile secondo tappe precise. Potremmo dire che l’interesse per la storia, raro e saltuario nel teatro malgascio, stupisce, piuttosto forse, per l’apparente sconfessione di qualsiasi nesso tra il soggetto rappresentato e gli eventi contemporanei. Les Dieux malgaches, furono scritti da Rabemananjara nel 1947, molto prima del 60, ma soprattutto in concomitanza al massacro seguito alla rivoluzione dello stesso anno, così pure L’oiseau de proie, che rievoca la storia del regno di Radama I, è stata concepita da CharlotteArrisoa Rafenomajato a trent’anni dall’Indipendenza (nel 1990). Il teatro malgascio sembra, quindi. sottrarsi ai rapporti di causa-effetto, tra evento storico e produzione teatrale, tra minaccia culturale e difesa identitaria che, secondo gli studiosi della drammaturgia post-coloniale, regolano, invece, la produzione africana: «Enfin dégagée de la censure coloniale, la création théâtrale participe largement à l’entreprise de la réhabilitation de la culture africaine et de ses traditions. Il s’agissait notamment de magnifier de grandes figures historiques autour desquelles la nation noire pourrait galvaniser, retrouver confiance et fierté.»79. Il modesto contributo che gli autori malgasci sembrano offrire alla celebrazione del passato, l’indole complessa, ambigua dei personaggi che popolano le opere storiche (tale da rendere difficile l’identificazione del personaggio principale con l’eroe della tragedia greca, quindi con l’eroe 79 Ibid. 144 nazionale) costringono a rivedere la corrispondenza tra riabilitazione del passato e affermazione dei valori comunitari, dell’identità del popolo pre-coloniale. Il teatro malgascio, anche quello storico, si presenta anzitutto come un refoulement80, o la conseguenza della negazione, della storia passata, come se la frattura prodotta dalla colonizzazione: lo scollamento tra il passato pre-coloniale il presente post-coloniale fosse insanabile e facesse emergere un’interruzione più profonda, tra il periodo pre-merina e post-merina (di cui le opere citate sono un esempio)81. Se il teatro è la messa in scena della trasgressione del tabù, il popolo malgascio, lo scrittore malgascio ha accettato solo in parte di confrontarsi con il silenzio imposto sul suo passato, ed esclusivamente, spostando il racconto storico dalla cronaca alla narrazione mitica, investendo la verità storica con l’ingresso improvviso del paranormale (non identificabile con il fato delle tragedie classiche). Diversamente dal teatro africano degli anni 60, i drammaturghi malgasci non celebrano il mito di eroi collettivi. I personaggi storici rappresentati nelle pièces sono sempre autorità controverse, delle figure scomode per la stessa rievocazione della storia del Madagascar pre-coloniale: Radama I, padre fondatore della nazione malgascia, è considerato da molte etnie del Madagascar come il primo colonizzatore del popolo malgascio, Radama II, succeduto a Ranavalona I, è accusato, invece, di aver agevolato la colonizzazione del Madagascar da parte degli Europei. Ancora una volta, i drammaturghi malgasci prima della frattura82 mettono in scena il trauma, che è a un tempo, assunzione e negazione della storia da parte degli scrittori. Rimane il dubbio che le opere citate vogliano soprattutto mettere in scena una parte della storia malgascia, o al contrario, la storia non sia il pretesto per parlare di qualcosa d’altro: della colonizzazione (ma non in opposizione al periodo pre-coloniale, come per gli autori africani), nei testi di Rabemananjara, della natura umana, nel caso di Rafenomanjato. Il teatro malgascio è la messa in scena del trauma: dell’impossibilità di raccontare la Storia nella sua oggettività. Trincerato nel silenzio83, perduti i riferimenti spaziali e temporali, il passato rappresentato sulla scena è divenuto racconto, mito letterario che trascende il dato reale in leggenda (nel testo i personaggi storici sono affiancati da angeli, demoni, stregoni e fattucchiere). 80 Solo recentemente, e nel romanzo, autori come Charlotte-Arrisoa Rafenomanjatao e Jean-Luc Raharimanana si sono confrontati con il passato coloniale, soprattutto con gli anni bui seguiti al 1947: Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Sang pour Sang, Antananarivo, SME, 2003, Jean-Luc Raharimanana, Nour, 1947, Paris, Serpent à Plumes, 2001. 81 Del resto la stessa guerra tribale, politica di cui abbiamo parlato in precedenza per Rabearivelo. 82 «[…] la colonisation a établi une rupture nette dans l’évolution historique de l’Afrique, et a instauré un conflit entre deux cultures distinctes: la culture africaine et la culture occidentale.», Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le theatre ouest-africain francophone, Paris, l’Harmattan, 1995, p. 5. 83 «Le théâtre, on le sait s’intéresse d’avantage aux ruptures de l’historie qu’à ses continuités.», Ali Baldo Suliman, Dramaturgie du Théâtre négro-africain d’expression française des indépendances à nos jours, thèse, 1982. 145 Anziché offrire alla comunità personaggi esemplari con i quali riconoscersi, e a partire dai quali rifondare la propria identità84, i drammaturghi malgasci si servono delle figure ambigue e irrisolte del passato, che la storia e la memoria non sono riuscite a decifrare: quei personaggi come Radama I e II (per quanto celebrato da Rabemananjara, Radama II de Les Dieux Malgaches non riesce a sottrarsi dalla memoria del deplorato re merina), la cui oscillazione tra Storia e aneddoto, tra realtà e finzione nega la validità del racconto della memoria collettiva. Il teatro storico malgascio è, allora, la decostruzione, più che ricostruzione, del passato per mezzo dell’oblio, che è uno con l’orrore sacro: «L’oralité et la littérature connaissent deux approches bien différentes à l’égard de l’histoire. Dans la logique de l’oral, l’homme cherche à établir un équilibre homéostatique de sa tradition culturelle, de ses souvenirs du passé et de ses pensées sur le présent. L’ “oubli” productif est le résultat d’un processus de triade collectif, opéré sans cesse par nous tous, est un mécanisme fondamental de la pensée orale. Cet oubli n’est pas arbitraire […] il s’agit d’un oubli sanctionné et sacré.»85 Il recupero della tradizione e dell’identità collettiva, non avviene sul piano storico, quanto piuttosto sulla scelta del racconto mitico. Le due modalità di narrazione degli eventi reali, l’una mitologica e/o epica (Rabemananjara, Rafenomanjato, Rajaonarison), l’altra leggendaria, legata alle credenze e alle superstizioni del popolo malgascio (Rafenomanjato, Rasoanasy, Ravoaja) mettono in scena due diverse esperienze del racconto tradizionale: il tantara, o mito fondatore (generalmente unico per tutte le etnie del Madagascar), il tafasiry (o angano) racconto delle leggende (delle varie etnie e, di conseguenza, diverse per ciascuna comunità). Come ricorda Philippe Beaujard86, il mito fondatore assume nella narrazione malgascia un valore strettamente politico, di conseguenza metterà in scena re, principesse in uno «schéma idéologique en compétition». Al contrario, gli angano saranno la manifestazione della memoria collettiva nella misura in cui, attraverso la narrazione dell’interferenza tra mondo soprannaturale e realtà naturale, veicoleranno i tabù, le prescrizioni morali ancestrali nella comunità contemporanea. Foreste, laghi, caimani, serpenti assedieranno una realtà ormai incapace di comprenderne i divieti; e nell’opposizione tra il vecchio mondo pagano e il nuovo discorso razionale si rivelerà, si 84 «Il faut que le théâtre soit un instrument de prise de conscience, d’unité de l’individu et de la société, et soit capable de poser et de diffuser des questions ouvertes qui appellent des réponses […] trouver une parole sur l’histoire qui soit capable d’assumer l’aujourd’hui constitué d’anciens et de nouveaux mythes […].» a cui segue «retrouver son passé pour […] y chercher des modèles exemplaires et formateurs» 85 Werner Glinga, L’histoire dans le théâtre européen et africain, in Théâtres africains, Actes du colloque sur le théâtre africain Ecole Normale Supérieure de Bamako, 14-18 nov. 1988, Paris, Silex, 1990, p. 21. 86 «Le mythe fondateur de la royauté met en scène un pouvoir absolu de la noblesse au sein d’un royaume dont le chef est “dieu sur la terre”. […] Il est clair que les mythes, loin d’être le simple reflet d’une réalité sociale expriment d’abord des schémas idéologiques en compétition […]», Philippe Beaujard, Mythe et société à Madagascar, Paris, l’Harmattan, 1991, pp. I-II. 146 insedierà la frattura storica e culturale, l’interferenza insanabile che più dell’evento storico o di personaggi leggendari ancora una volta sceglie la metafora per rivelare l’impossibilità, o l’incapacità di un popolo di raccontare se stesso. Jacques Rabemananjara il Virgilio malgascio87 Poeta e uomo politico (le due cariche non saranno mai disgiunte), Rabemananjara è stata una delle personalità più autorevoli del Madagascar, una delle voci somme dell’isola: padre fondatore della coscienza del popolo malgascio nei difficili anni della colonizzazione e nel successivo e altrettanto contestato periodo post-coloniale. Rabemananjara è stato il pioniere della rinascita della letteratura del Madagascar (fondatore della «Rivista dei Giovani del Madagascar», collaboratore di «Présence Africaine», teorizzatore, insieme a Senghor e a Césaire, della Négritude) anche e soprattutto per il confronto che ha voluto istituire tra il mondo culturale dell’isola e l’universo letterario francese già a partire dagli anni 40, allorché il sentimento del popolo malgascio verso la colonizzazione era tra i più problematici. Poeta e saggista, Rabemananjarara si è dedicato al teatro tra il 1947 e il 1957: tra gli anni della rivolta (marzo del 47), e il periodo di reclusione. La produzione teatrale circoscritta, conclusasi in 87 Jacques Rabemananjara nasce a Mangabe il 23 giugno del 1913. Proveniente da una famiglia agiata, il padre proprietario d’origine merina, la madre discendente dai notables betsileo, come pochi altri Malgasci della sua epoca può seguire la scuola europea, accanto alla formazione tradizionale (è nella scuola europea che Rabemananjara viene iniziato alla letteratura francese e soprattutto ai grandi classici, i romantici, i parnassiani, i simbolisti). Entrato nell’amministrazione, come funzionario del Servizio di Informazione, si occuperà oltre che dell’organizzazione di un Sindacato Ufficiale per la tutela dei funzionari malgasci, anche della fondazione della «Revue des Jeunes de Madagascar». Sin dall’inizio Rabemananjara cercherà di conciliare la passione politica a quella letteraria. Nel 1946, infatti, come segretario generale del M.D.M.R., sarà eletto deputato del Madagascar all’Assemblea Nazionale Francese. Rabemananjara verrà arrestato nel 1947 con l’accusa di complicità, in quanto rappresentante del M.D.M.R, nella rivolta malgascia nel 29 marzo dello stesso anno. Il poeta sarebbe rimasto in prigione per nove anni condannato ai lavori forzati, ma solo dopo il 1960, l’elezione di Tsiranana metterà fine al suo esilio. Ancora una volta, il poeta concilierà la politica all’arte (negli anni del regime di Tsiranana Rabemananjara ricoprirà alternativamente le cariche di Ministro dell’Agricoltura, degli Affari Sociali, degli Affari Esteri). Costretto nuovamente all’esilio con l’accusa di frode e di illeciti dal regime di Ratsiraka, Rabemananjara non tornerà praticamente più in patria. Il poeta muore il 2 aprile del 2005 a Parigi. 147 dieci anni, consiste di tre tragedie: Les Diex Malgaches88, Les Boutriers de l’Aurore89, Agapes des dieux. Tritriva90. La prima è ispirata alle ultime ore del regno di Radama II; i Boutriers, concepita sul modello epico greco e latino, vuole essere la celebrazione della fondazione del Madagascar; l’ultima, che potremmo definire pièce etnologica, trae ispirazione dalle leggende malgasce sul vulcano Tritriva. Il confronto tra le opere teatrali e i testi poetici fa emergere, come dice Koenig, due diverse personalità dell’autore: una riflessiva, nostalgica, l’altra fiera e violenta. L’aver concentrato l’attività teatrale nel breve periodo della prigionia (il poeta non ha, di fatto, prodotto altro per il teatro), l’evidente discordanza di temi e di atmosfere tra le poesie e le tragedie fa ipotizzare che il poeta si sia rivolto al teatro anzitutto e soprattutto come mezzo di evasione dalla reclusione che viveva ormai da quasi un decennio. «Si dans sa poésie, particulièrement dans celle écrite lors de sa captivité politique, Rabemananjara reste le poète engagé luttant pour l’indépendance de son pays, dans son théâtre, au contraire, la politique ne joue aucun rôle et ne tient aucune part. C’est là toute l’originalité de son œuvre qui nous permet assurément de discerner certains traits de son caractère […].»91 L’ipotesi di Koenig sembra suffragata dai temi, oscuri e affascinanti, di cui Rabemananjara ha fatto il presupposto delle sue tragedie: il passato poco conosciuto del regno di Radama, la nascita ancora pervasa di mistero del popolo malgascio, le leggende altrettanto enigmatiche della tradizione. Il recupero del passato malgascio: della memoria di un passato incorrotto proprio perché mitico, di cui i riti millenari sono custodi, rifletterebbe, allora, secondo Jean-Louis Joubert, come già per Koenig, l’intenzione del drammaturgo di sottrarsi a un presente doloroso, apparentemente senza soluzione (se non quella della morte di cui quotidianamente era minacciato il detenuto): «Le théâtre est apparu à Rabemananjara comme le lieu idéal où ranimer ces ombres du passé que sa nostalgie se plaisait à évoquer. […] Le contexte historique peut rendre compte du pessimisme de ces pièces: la colonisation, d’une manière générale, et le séjour en prison (où les deux dernières sont écrites) n’incitaient 88 Jacques Rabemananjara, Les Dieux Malgaches. Version destinée à la scène, Paris, Ophrys, 1947. Riassunto p. 469. Jacques Rabemananjara, Les Boutriers de l’aurore. Tragédie malgache en trois actes et six tableaux, Paris, Présence Africaine, 1957. Riassunto p. 469. 90 Jacques Rabemananjara, Agapes des Dieux. Tritriva. Tragédie malgache, Paris, Présence Africaine, 1962. Riasunto p. 470. 91 Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, Paris, Présence Africaine, 1989, p. 13. 89 148 pas à juger excellente l’ordonnance du monde. […] On est […] sensibles aujourd’hui à sa charge mythique, à sa méditation sur le passé malgache.»92 L’impressione nostalgica, di un moto di ripiegamento intimistico verso il passato, delle pièces rispetto alle raccolte poetiche, è certamente assecondata dallo stile classico, o meglio neoclassico, di cui fanno mostra le tre opere teatrali rispetto alle liriche. Non solo gli alessandrini di Les Dieux malgaches contribuiscono a istillare nel lettore l’idea di un teatro suranné, per alcuni versi meditativo, persino la prosa di Agapes des dieux, e dei Boutriers de l’Aurore, appesantita dalle involuzioni dell’anima, convince dell’eccezionalità di una tale produzione teatrale, soprattutto se confrontata all’esperienza di altri scrittori francofoni a lui coevi, come Césaire. È certo, come avrebbe riconosciuto lo stesso Rabemananjara, che la formazione nella scuola francese ebbe un ruolo fondamentale nell’assimilazione di archetipi, quindi nella costruzione di modelli, specificatamente occidentali, francesi rispetto a quelli della tradizione letterari malgascia, di cui nulla veniva insegnato; modelli, che avrebbe preso ad esempio non solo per la poesia ma soprattutto per il teatro,e tra i quali figurano i drammaturghi del 600, Corneille e Racine, i romantici, Vigny e Lamartine, non ultimo, il contemporaneo Giraudoux93. Molte volte è stato invocato, in merito alla genesi della prima opera teatrale, l’aneddoto di Rabemananjara studente liceale che, in risposta alla provocazione del professore di letteratura francese, avrebbe voluto dimostrare la sua abilità nell’eguagliare il teatro classico di Racine94 per mezzo di opere altrettanto sublimi Quindi, in ultima analisi, si potrebbe considerare la scelta di tale scuola teatrale, di un teatro della bella forma come sarebbe stato definito dai critici del Novecento, con l’ammissione implicita dell’autore di adesione a un preciso programma stilistico. Allorquando il teatro riscopriva Eschilo e ravvisava in Nietzsche de La nascita della Tragedia il linguaggio profetico per la rigenerazione della tragedia classica, nel medesimo periodo in cui i 92 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 78. «Le théâtre de Rabemananjara reflète beaucoup la formation française de l’écrivain. Grand admirateur du siècle de Louis XIV, et de Racine en particulier, sa première œuvre théâtrale, Les Dieux malgaches, est fortement imprégnée du siècle classique. Il emportera même l’alexandrin dans cette œuvre./Puis une certaine évolution rend place, Les Boutriers de l’aurore ne conserve que certains aspects raciniens. Sa troisième pièce, Agapes des dieux, Tritriva, rompt complètement avec le XVII siècle et subit l’influence de Giraudoux, dont Rabemananjara d’ailleurs goûte beaucoup le style, la fantaisie et l’imagination.», Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, op. cit., p. 65. Lo stesso Rabemananjara, del resto, nel corso di un’intervista riconosceva la sua formazione principalmente occidentale: «Nous avons quelques poètes comme Ny Avana Ramanantoanina…Rbearivelo, Razanandrasoa ec. Mais ce ne sont pas des auteurs connus du monde entier. Avec les auteurs français, nous avons eu la possibilité à l’école puis dans le secondaire, de connaître des auteurs comme Lamartine, Baudelaire, Victor Hugo […].», Jean-Luc Rharimanana, Jaques Rabemananjara, poète et dramaturge, «Notre Librairie» n.110, cit., p. 23. 94 «Je me souviens que nous avons eu un professeur, un père jésuite, qui nous expliquait Racine, Corneille d’une façon vraiment merveilleuse. Nous étions tellement emballés que dans mon enthousiasme, j’ai dit “mon Père, je vais écrire un jour une œuvre comme Racine”. Alors le Père ma regardé avec pitié…», Ibid., p. 27. 93 149 drammaturghi riconoscevano nella frattura, e nella problematicità della forma compiuta, la verità del dramma e dell’esistenza umana, Rabemananjara restava fedele alla tradizione apollinea di Sofocle ed Euripide: «Le retour à la tragédie apporte donc bien une innovation dramaturgique, puisque le modèle eschyléen a été un peu occulté par la tradition classique et néo-classique, qui lui a préféré Sophocle et Euripe, au nom de la mesure et de l’harmonie. [à propos duquel] Claudel observe […] “cette simplicité terrifiante, cette énormité abrupte […] au nom de la primitivité”.»95 La coesistenza del rito tradizionale96 (di cui l’uomo malgascio contemporaneo non ha quasi più memoria), con lo stile del 600, evidentemente arcaico per lo scrittore occidentale, fa del teatro di Rabemananjara un teatro altamente poetico: per la lettura prima che per la scena97 (le pièces si rivelano verbose, l’azione dell’intrigo si risolve tutta della riaffermazione dell’io all’interno del contesto sociale). L’astoricità e l’apoliticità del teatro di Rabemananjara si dimostrerebbe, secondo Koenig, proprio nell’assunzione della tradizione come modello supremo (delle leggende, dei riti, del kabary malgasci, e del teatro classico francese); in particolare, di un tipo di tradizione, sia culturale che letteraria, che non riconosce la possibilità all’uomo di agire sul reale (l’uomo non potendo nulla contro gli dei sia per la legge malgascia che per la poetica raciniana), e che sposta il conflitto dall’esterno del reale nell’anima, nella declinazione inesauribile delle variabili della psiche umana98: «La faiblesse de son caractère [de Radama] est atavique, car Radama est d’abord malgache avant d’être roi. Il lui faut constamment revenir sur lui-même, s’analyser, s’expliquer.»99. Infine, il pessimismo ontologico che regna nelle tre tragedie (pessimismo raciniano, come abbiamo detto, ma anche pessimismo atavico malgascio, pensiamo allo tsiny) trasferirebbe la narrazione, secondo Koenig e Joubert, dal piano della cronaca, quindi dell’assunzione critica del 95 Dominque Combe, La renaissance de la tragédie. Aimé Césaire, Kateb Yacine et Nietzsche, in Le théâtre et le sacré, Actes du Colloque dirigé par Anne Bouvier Cavorat, Mayenne, Klincksieck, 1996, p. 194. 96 «Ainsi la harangue du roi, appelée Kabary dans la langue du pays, était l’événement annuel très cher au coeur du peuple. […] Nous sommes étroitement liés à cette cérémonie royale, à la vie intime des rites qui l’accompagnent et à tout ce qui touche l’étiquette de ces activités où un certain paganisme se mêle à la religion […]. Ces chants et ces danses effectués par le chœur des jeunes gens et des jeunes filles […] sont typiquement malgaches parce qu’ils appartiennent au folklore du pays […].», Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, op. cit., p. 53. Ugualmente le citazioni al riso, alimento fondamentale per la cultura malgascia, Ibid., p. 55, l’aspersione dell’acqua da parte del divino, Ibid., p. 56. 97 «Les trois pièces qu’il a composé sont restées sur le papier, sauf pour quelques représentations anecdotiques.», JeanLouis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 78. La predominanza del testo sul recitato è resa ancora più evidente dalle didascalie che, nel teatro di Rabemananjara, violano la semplice funzione descrittiva per divenire, come, nella prosa, degli approfondimenti, storici, psicologici dell’autore non tanto riguardo al testo quanto al soggetto rappresentato. 98 Jean-Paul Koenig conta ben sei diverse gradazioni dell’amore in Agapes des Dieux. Tritriva: amour-ivresse, amourdouleur, amour-dédain, amor-victime, amour-passion, amour-vertu. Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, op. cit., pp. 43-45. 99 Ibid., p. 21. 150 racconto storico e politico, al piano mitico, dove ogni azione è vana, è sospesa, confermando la tesi di un teatro che rinnega l’engagement dei componimenti poetici in nome di una riflessione generale sull’esistenza umana. Analizziamo ciascuna opera nel dettaglio. Les Dieux Malgaches La scelta di Rabemananjara di far precedere ciascun atto da un titolo: atto I, L’Atmosphère, atto II, Le Conseil, atto III, Le Peuple, atto IV, Le Roi, atto V, La Terre, rivela l’intenzione dell’autore di fondere il rigore della tragedia classica greca e francese, con la divisione in tableaux, più moderna100, facendo sì che ciascuna sezione sia aperta all’altra eppure concettualmente chiusa in sé. Ogni atto infatti introduce un personaggio, rivelandone le caratteristiche salienti, come nel caso del Primo Ministro nel II atto. Dal II al IV atto Rabemananjara mette in scena, ponendole in successione, le tre istituzioni sovrane della società malgascia: il consiglio, detentore della tradizione, costituito dalla classe nobile, il popolo, elettore e alleato privilegiato della monarchia, il re. Proprio il re, l’omicidio del re, in quanto atto di lesa maestà, sposta la tragedia, fino ad allora consumatasi nel palazzo reale, dall’interno verso l’esterno, per coinvolgere nel dramma tutto il popolo malgascio e con esso destabilizzare la Storia stessa della Nazione (la terra essendo anzitutto la culla degli avi). La tragedia lambisce vari piani dell’esistenza: il piano sentimentale, come tragedia amorosa di due amanti la cui passione è ostacolata dal rigido rituale imposto dalla tradizione, quindi dagli avi; il piano politico, mostrando la sete di potere del primo ministro, defraudato del comando prima da Radama e poi dalla presenza sempre più imponente dei funzionari delle nazioni europee; il piano storico con il racconto del transito del popolo malgascio da una condizione di stato libero e sovrano all’assoggettamento politico, culturale francese, aprendo, tra l’altro, nuove interpretazioni sui motivi che portarono all’assoggettamento della nazione malgascia; infine il piano esistenziale, tout court, con il conflitto corneliano tra ragione e sentimento, con l’interrogazione umana sulla vanità dell’agire e la crudeltà del fato, con la messa in causa della legittimità della fede di fronte al disastro di un’intera nazione. Epopea pessimista, le didascalie tradiscono il bisogno dell’autore di fermare nel testo e nella memoria alcune date importanti della storia malgascia come il trattato tra gli europei e il Madagascar che aprì la nazione a una prima colonizzazione culturale: 100 Le esigenze narrative del teatro simbolista ed espressionista sono all’origine del recupero alla fine dell’Ottocento della divisione in tableaux. 151 «La preuve, la voici. Le crime, le voilà:/Ce traité qu’en secret le Roi vient de conclure,/Plaçant tout le pays sous le mandat des Blancs […] Deux hommes d’Occident désormais administrent/ET l’Armée et la Cour et le Royaume entier:/Le forban Jean La borde et le pasteur rentier/Sir John William Ellis.»101 progresso che nel caso della storia malgascia, e delle colonie in generale, sembra ridursi all’introduzione di una nuova, terribile tecnologia: le armi da fuoco Ratsifely: «Frappez! Chargez à la française!/Suivez-moi! Sabre au poing! Baïonnette au canon! […] Nous les tenons/ La poudre par ici sent bon comme la fraise […]/Foncez! Vos compagnons captifs, qu’on les délivre!/ Il me faut à tout prix les gros canons du Fort./Dégagez l’arsenal! Prenez la citadelle!/Marchez.»102 o ancora, nell’improvvisa istituzione di nuovi costumi, di nuove confessioni religiose a scacciare gli dei della tradizione Ratsifely: «Voyez-vous l’incendie illuminer les crêtes?/Les grands destins du monde à cette heure s’arrêtent./Ranavalne revient. Sa grande âme en fureur/Dans les temples des Blancs va semer la terreur. /Elle dispersera leur culte téméraire./Et Radama, tantôt à notre vœu contraire,/Sur les pas des Aïeux ramènera ses pas.»103 L’ideale pacifista e sociale di Radama viene contrapposto dall’autore alla politica utilitaristica dell’Occidente e del primo Ministro; l’apertura a un mondo che generosamente può offrire condizioni migliori per il popolo viene opposta a una lettura ottusa della tradizione Radama: «Me voyons, quels griefs ont-ils contre les Blancs?/D’avoir fait ériger quelques clochers tremblants/que la brise en tous sens agite dans l’espace/est-ce un si grand forfait pour qu’on frappe une race? […] Je respecte ma mère et sa grande mémoire./Je sais de quel éclat brille sur nous sa gloire./Mais dois-je, de son règne admirant le succès, /reproduire à mon tour la faiblesse et les excès? […] Veut-on que je devienne un tyran sanguinaire?»104 Radama, vittima sacrificale delle tragedie classiche, profeta della rigenerazione malgascia, nonpuò che essere trasfigurata, come suo nipote Ratsifely, in Cristo: come lui anima pura per eccellenza, per ciò stesso, pietra della scandalo. «on voit, beau comme un Dieu, transfiguré par on ne sait quel miracle, le prince Ratsifely vêtu d’un riche lamba» 101 Jacques Rabemananjara, Les Dieux malgaches, op. cit., p. 36. Ibid. p. 107. 103 Ibid., p. 53. 104 Ibid., pp. 18-21. 102 152 o ancora, Radama, come Cristo all’orto degli Ulivi: Le Roi: «Hommes qui cherchez-vous?» Brute: «…Je vais dire son fait au Roi!.../Place, place! Faites moi place! » (Il s’ élance, mais rapide comme l’éclair, le lieutenant tire) (Le Brute tombe, […] le roi se précipite comme pour porter son secours […]) Le Roi: «Non! Assez de sang! […] Mon enfant, tu as mal!»105 Les Boutriers de l’Aurore Per ammissione dello stesso autore, l’opera nasce come il tentativo di emulare i grandi aedi del passato, Virgilio sopra tutti che aveva celebrato la fondazione di Roma106. Nonostante la provenienza del popolo malgascio sia tuttora avvolta nel mistero, nessuno prima di Rabemananjara, né dopo, ha tentato, in versi o in prosa, la scrittura del mito dell’origine. Per quanti numerosi possano essere i miti che celano in chiave leggendaria la fondazione di Madagascar, quello di Rasoamor tra gli altri107, nessuno ha mai raccontato l’epopea, né immaginato le traversie, l’esilio (che Rabemananjara fa durare sette anni) del piccolo gruppo di indonesiani salpati dalla lontana penisola con il disegno di raggiungere la terra promessa Ananda: «Ah! Dieux de mes Aïeux! S’en venir de si loin!.../Avoir troqué sans retour la robe blanche/du doux foyer maternel!/Contre le manteau rude de l’errance/Sur le parcours de trois mers!/Bu l’insulte des éléments, l’opprobre des hommes/sans murmure ni révolte, Prince Kashgar,/Connu toutes les affres de l’Angoisse»108 Più avanti Kashgar: 105 Ibid., pp. 117-122. «Une épopée comme l’Enéide me donnait l’idée d’un chant à consacrer à mon pays […] comme mes pièces Les Boutriers de l’Aurore et Agapes des Dieux.», Mukala Kadima-Nzuji et Anselmi Palmiro, Entretien avec Jacques Rabemananjara, écrivain malgache, «Notre Librairie», n. 72, octobre - déc. 1983, p. 80. 107 Paul Ottino nell’L’Etrangère Intime cita il racconto di Flacourt in merito alla leggenda malgascia del principe Rasoamor, mito fondatore dell’isola. Un principe, Rasoamor, figlio unico di un potente e ricco re è follemente innamorato di una principessa che abita su un’isola lontana. Nonostante i tentativi reiterati del padre di sabotare un tale amore (vengono affondate le navi che potrebbero permettere all’innamorato di raggiungere la principessa, vengono chiamate a raccolta le ragazze dei paesi vicini per distogliere il figlio dalla sua ambizione di raggiungere l’amata), il principe si decide a partire, non prima di aver avvertito i genitori che raggiungerà l’amata percorrendo la distanza a nuoto. Raccolto da una balena, Rasoamor giungerà sull’isola dopo tre mesi. Accolto come un figlio dal re del luogo, Rasoamor ritornerà dal padre dopo sei mesi (una volta che l’unione tra i due principi ha avuto luogo) carico di doni e schiavi. Paul Ottino, L’Etrangère Intime. Essai d’anthropologie de la civilisation de l’ancien Madagascar, op. cit., pp. 51-52. 108 Jacques Rabemananjara, Les Boutriers de l’Aurore, op. cit., p. 16. 106 153 «Oh! L’épique traversée!/Une moisson de légende à tous les descendants./ Mais il y avait un double ennemi, Père: […]/le tourment lancinant de nos âmes,/des cœurs en dérive vers l’Exil! […]Sept ans déjà depuis le fameux embarquement» Le Voyant: «Voici l’îlot précurseur, tel/que l’annoncent le prophéties.»109 La dimensione mitica del testo emerge anzitutto dalla divisione in quadri (sei) che pure raggruppati due a due lasciano intravedere una prima ripartizione, essa stessa fondatrice: l’opposizione del femminile e del maschile: atto I quadro I, L’Île, atto I quadro II, La Baie, atto II quadro I, La Femme, atto II quadro II, L’Aveu, atto III quadro I, L’Homme, atto III quadro II, L’Enfant (prime tre parti femminili, le ultime tre maschili). Tutta la pièce gioca del resto sul doppio: Ananda è il doppio dell’isola, per il promesso sposo Kashgar («Tu es l’espoir, tu es l’amour, tu es la vie!/Or l’île que voilà, c’est toi-même Ananda.»110), e della baia, per il fratello di sangue Anjali, di cui Ananda si innamora («Entre vous et la baie des charmes subtils semblaient s’exercer, tisser un lien réciproque d’adoration et d’ineffable communion»111); Kashgar è il doppio (gemello/fratello di sangue) di Anjali, entrambi amati da Ananda. Ora, solo la soppressione, il sacrificio di una delle due parti, permettendo il superamento dell’opposto, sembra concretare l’unione, quindi la riconciliazione dei contrari, e, nel caso della storia narrata, la possibilità dell’effettiva fondazione del Madagascar. La celebrazione del Madagascar mitico è, di fatto, la celebrazione del popolo malgascio la cui genesi misteriosa ne fa di per sé una leggenda. Indonesiano d’origine, africano, arabo, il Malgascio è uno e allo stesso tempo diverso da tutti questi popoli. Rabemananjara esalterà il mistero immaginando la nascita del suo popolo come il frutto di un evento a un tempo naturale, l’incontro di un autoctono con il quale i naufraghi instaurano un patto di sangue, e il sovrannaturale, facendo di Anjali un essere ultraterreno (solo, senza eredi, legato alla terra e alla baia di cui ha fatto la sua sposa). Si insinua però nella riscrittura del mito della fondazione, la sfumatura malinconica della colonizzazione di Mangabé (l’isola di Anjali, che, sorprendentemente, coincide con il paese d’origine dello stesso Rabemananjara). Colonizzazione che sembra prevedere ineluttabilmente la morte dell’autoctono, come a negare la possibilità di qualsiasi unione pure pacifica tra l’indigeno e l’occupante 109 Ibid., pp. 27-29. Ibid., p. 18. 111 Ibid., p. 143. 110 154 Kashgar: «L’étranger, encore une fois, c’est nous […] Du jour au lendemain, nous nous implantons chez lui. Nous fixons tentes et prenons racine sur le sol de ses ancêtres. Nous bouleversons ses habitudes. Nous ne cachons pas la volonté d’imposer nos moeurs. Nous feignons d’ignorer qu’il en a aussi, lui, des coutumes, que c’est bien son droit d’y tenir.»112 Il passaggio dal verso alla prosa, indica il movimento dell’anima, dalla contemplazione lirica, alla tensione psicologica, quindi alla dialettica degli opposti. La celebrazione del mito di Madagascar sarà supportato dal canto, dai versi, a declinare, come in un’orazione, le varie qualità dell’isola: donna/madre («O Nonchalance! O Plénitude/Tout en elle est féminité!»113), isola-deità: «une et sans morceaux», «triple des Puissances irrévocables»114. Sono destinati al verso anche i momenti di più struggente passione (contraddittorio tra Anjali e Ananda, pp. 144-151), il confronto tra i doppi: Madagascar e Mangabé, dell’isola proiettata verso il futuro e della terra simbolo dell’età dell’oro destinata, idealmente, all’estinzione Le prince Anjali (comme en rêve): «Mangabé! Ma terre natale! Orgueil de mes ancêtres!» La princesse Ananda: «La pureté de ce rayon!/Transparence! Rien que Transparence […] /une âme qui s’immole en fins morceaux/pour un festin d’innocence.»115 Tragedia malgascia come prelude il titolo, proprio perché Madagascar nasce dalle ceneri di Mangabé. Tragedia, che è anzitutto la tragedia di tutta l’umanità di fronte al destino: «La chasse aux Dieux, la chasse aux fourmis, voilà la vie. Chasseurs des Dieux, chasseurs des fourmis, double indicatif, deux pôles déterminants de l’homme.»116. All’opposto, la prosa funzionerà come gli adagi in una ripartizione musicale, sarà a un tempo raccordo, spiegazione e anticipazione agli slanci lirici. Agapes des dieux. Tritriva Rabemananjara costruisce la leggenda malgascia dei due amanti infelici, Ratrimo e Hanta, memore certamente della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta, e dell’amore infelice di Ippolito per Aricie. L’autore colloca la tragedia in un tempo imprecisato del Madagascar antico quando i principi, come Ulisse, erano i pastori, quando come nelle pastorali del 600, la purezza dei sentimenti albergava in coloro che più erano a contatto con la natura: ninfe dei boschi, naiadi delle acque, pastori delle greggi. 112 Ibid., pp. 78-79. Ibid., p. 23. 114 Ibid. p. 26. 115 Ibid., p. 137. 116 Ibid., p. 230. 113 155 Il contrasto/lo scontro sarà quindi inevitabile tra l’atemporalità dei sentimenti e il sangue, la legge degli avi, e con essi degli Dei, che parla attraverso la Storia: Hanta: «Tu ne m’aimerais donc, toi, qu’en perspective de l’Histoire? Regarde-moi, Ratrimo […] Je veux être aimée comme me le crie mon sang. Peu me chante l’opinion des contemporains dans leur cupidité […]! L’Histoire, je n’y crois pas.» Ratrimo: «[…] L’Histoire, c’est toi, c’est moi, notre vie, notre mort.»117 Innocenti di fronte al destino118, i personaggi di Rabemananjara accettano senza riserve le dure prove della vita nel rispetto delle tradizioni e della filosofia dello tsiny119: Ratrimo: «Nous sommes des pions dans les mains d’un ordonnateur de jeu invisible. Ce que nous penons pour un élan de tous nos êtres doit faire partie d’un programme établi de toue éternité aux fins d’imprimer un mouvement dramatique à la banalité des faits divers, à la multitude d’aventures humaines de même espèce. […] Mais voici la tragédie: nous formons à la fois et les acteurs et la trame de toute pièce. Notre existence en constitue l’unique intrigue.»120 Accettazione che non è rinuncia, né inerte assoggettamento, ma, al contrario, l’attestazione della dolorosa consapevolezza che solo l’adesione alla vita, permette all’uomo di agire su un ipotetico futuro. L’analisi dell’ultima pièce di Rabemananjara rivela un’inattesa corrispondenza tra quest’opera e la prima. Il binomio Ravao/Reine sembra riproporre, nella scena finale, la coppia Rahaga/Roi. Come Radama, ne Les Dieux Malgaches, la regina morirà soffocata dal lamba, e come l’indovino della prima tragedia, la nutrice si troverà nel dubbio se darsi la morte. L’apocalittico crepuscolo degli dei e degli uomini con il quale si chiudeva Les Dieux Malgaches (di cui il suicidio dell’indovino voleva essere la drammatica rivelazione), già mitigato dall’ironica caccia agli dei e alle formiche dell’innocente Nélumbo ne Les Boutriers de l’Aurore, diviene in Agapes des Dieux. Tritriva la tacita accettazione del destino, l’ammissione della volontà dell’uomo, lui pienamente cosciente, a sopravvivere stoicamente all’insensato banchetto degli dei. Lo stesso Koenig, del resto, riconosce, l’origine della tragedia, nel teatro di Rabemananjara, proprio, nella volontà di affermazione della propria individualità rispetto a leggi ancestrali oramai superate, nel rifiuto della tradizione per il progresso, rigetto di quello stesso passato mitico la cui memoria avrebbe dovuto consolare il recluso Rabemananjara: 117 Jacques Rabemananjara, Agapes des dieux. Tritriva, op. cit., pp. 170-171. «Dieux des Ancêtres! Dieux des étoiles! Dieux justes! Dieux bons! Prenez en pitié les innocents…», Ibid., p. 93. 119 «Devant un cadavre, je me surprend à murmurer le vieux refrain des Ancêtres: “Douce est la vie”.», Ibid., p. 262. 120 Ibid., p. 165. 118 156 «Tant que de tel tabous existent, aucun progrès n’est possible et Rabemananjara s’en rend compte. Il veut rompre avec le monde transcendant des Ancêtres. Toute la nouveauté de son théâtre se trouve dans cette dénonciation du passé, monde idéal certes pour les prédécesseurs de l’homme actuel, mais révolu pour l’homme moderne.» 121 Progresso, di cui l’autore sarebbe oltretutto l’emblema, lui, «voleur de la langue» del colonizzatore: «À l’heure actuelle, au moment où les dirigeantes malgaches semblent désorientés, indécis et mal conseillés quant aux relations à conserver avec la France, Jacques Rabemananjara, en stipulant que c’est grâce au français d’une part qu’il peut non seulement affirmer sa liberté, mais encore l’épanouir et la développer, et d’autre part en proclamant que fructifier le français, “ce n’est pas repousser du pied la pirogue qui l’a aidé à traverser le fleuve”, demeure une fois encore un pionnier.»122 Potremmo allora supporre una simmetrica vocazione politica del teatro rispetto ai testi poetici di Rabemananjara, consapevoli del fatto che, come affermano molti critici contemporanei, la nascita della drammaturgia nel continente africano, originariamente estraneo al genere teatrale, coincide con la volontà degli autori di assumere e testimoniare pienamente il loro ruolo politico attraverso un genere, come il teatro, per eccellenza popolare123. Se il ricorso al mito, alla narrazione leggendaria del passato rivela, come abbiamo detto, un rapporto ambiguo che l’autore malgascio mantiene con la storia, pure, il mito, come riattualizzazione del passato in un contesto meramente presente, rivela l’intenzione del drammaturgo di usare questo stesso passato, esemplare, come specchio, come cassa di risonanza della situazione presente. E il ripetersi quasi ossessivo di alcuni temi, nelle tre opere, sembra avvalorare, anziché smentire, questa nuova ipotesi: «Le recours au passé permet donc de détacher les événements […] du présent, de projeter dans un passé révolu les vices du moment. Le critique nous situe alors dans un temps dramatique qui tient tout à la fois du passé, du présent et du futur.»124 Già Koenig aveva notato ne Les Dieux Malgaches l’introduzione della tematica razziale nel soggetto storico e amoroso nella pièce: l’amore di Radama per Anja è ostacolato dalla legge che 121 Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, op. cit., p. 72. Ibid., p. 96. 123 «Le théâtre africain est un théâtre politique» e più avanti citando Frederick Case: «La littérature négro-africaine est une littérature engagée. L’Africain ou l’Antillais qui écrit un poème, une pièce ou un roman trahit son rôle d’écrivain s’il n’exprime pas — d’une façon ou d’une autre— le vérité de notre condition de colonisés.», Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le théâtre ouest-africain francophone, op. cit., p. 65, p. 263. 124 B. Kotchy, La critique sociale dans l’oeuvre théâtrale de Bernard Dadié, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 147. 122 157 impedisce qualsiasi unione tra i merina e i sakalava, appartenenti alle caste inferiori125. Tuttavia la questione della razza era stata circoscritta alla situazione teatrale, quindi a una questione prettamente malgascia. A nostro avviso, Rabemananjara dimostra di attingere copiosamente dalla realtà coloniale e dalla tragica evidenza dei suoi misfatti: la razza, l’esilio, il problema identitario (con la problematizzazione del passato rispetto al presente, e viceversa, con la conseguente manifestazione del doppio), e che, i poeti della Negritudine (e Rabemananjara insieme a Senghor e Césaire era la voce autorevole della scuola) erano stati i primi a denunciare. Temi, abilmente rovesciati da Rabemananjara, quindi problematizzati rispetto alla posizione assunta dai poeti della Négritude, a spostare gli stessi tabù: dalla relazione di opposizione prettamente esterna (periferico, locale) del contesto della Negritudine (Bianco, colonizzatore, contro Nero, colonizzato) all’ambito tutto interno della cornice malgascia (Malgascio, colonizzatore, Malgascio, colonizzato; Malgascio, sfruttatore, Malgascio sfruttato). L’adesione alla vita e il rigetto ultimo della morte da parte della nutrice (anche lei effigie della tradizione come l’indovino della prima tragedia), alla luce di quanto detto, tradisce, allora, piuttosto l’evoluzione ideologica dell’autore: da un pessimismo metafisico a un pessimismo storico. Evoluzione che, contro ogni aspettativa assunta finora, se per Joubert non è sufficiente a rivelare un engagement politico da parte dell’autore126 pure, a nostro avviso, indica una presa di posizione chiara nei confronti della storia, se non una denuncia, una critica al sistema coloniale, al/ai dogma/dogmi fondanti la colonizzazione: la superiorità della razza e della civiltà occidentale. «N’alléguez pas ici la question de race. Vous moins que personne et aujourd’hui encore moins. Elle se pose, du reste, qu’à quiconque a intérêt à la soulever. Vous l’avez, de plus, constaté de vous-même, nos traditions accusent quantité de points de repères, de rapprochement et de jonction. Là où il y a rencontre de coutumes il y a encore rencontre d’âmes. Les traditions ne sont-elles pas l’expression la plus valable de l’âme d’un peuple […]? Au fond,l’humanité ce sont les ramifications des tiges de la citrouille: creusez le sol, la souche est unique»127 125 «Si l’auteur malgache soulève cette question, c’est parce qu’il se rend compte que cette tare entrave le progrès chez les Malgaches. Il n’a pas hésité à faire de la question raciale le sujet de sa tragédie dont le dénouement manifeste la liberté de l’auteur vis-à-vis de l’histoire.», Jean-Paul Koenig, Le théâtre de Jacques Rabemananjara, op. cit., p. 51. 126 «Le conteste historique peut rendre compte du pessimisme de ces pièces: la colonisation d’une manière générale, et le séjour en prison n’incitaient pas à juger excellente l’ordonnance du monde. Et c’est sans doute cet aspect “politique” qui a retenu les premiers lecteurs. On est peut-être plus sensible aujourd'hui à sa charge mythique à sa méditation sur le passé malgache.», Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 78. 127 Jacques Rabemananjara, Les Boutriers de l’Aurore, op. cit., p. 66. 158 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjatao, Clément Rajaonarison128: Storia di dèi e uomini I due autori di cui tratteremo la produzione storica appartengono alla seconda generazione dei drammaturghi malgasci, ovvero a quel gruppo di scrittori che hanno cominciato a scrivere per il teatro dopo il 1970. Come nel caso della maggior parte dei drammaturghi della seconda metà del Novecento, le opere sono state scritte in occasione del Concorso di R.F.I. Non solo, quindi, tratteremo di due autori i cui testi teatrali non sono mai stati editi (a eccezione di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjatao edita da Bulzoni nel 1987), ma di lavori di selezione o preselezione dattiloscritti con nessuna cura particolare129. Pur rientrando in quella narrazione mitica della storia, di cui abbiamo fatto riferimento nell’introduzione, è evidente una netta differenza tra la visione della storia, quindi della rielaborazione del passato, di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato rispetto a quella di Clément Rajaonarison. Il confronto tra i testi dei due drammaturghi mette in evidenza una sorta di evoluzione, o piuttosto involuzione130, del rapporto tra l’uomo, il cives malgascio, e la storia locale: che parte dal pessimismo metafisico di Rabemananjara, riproposto dall’autrice Rafenomanjato, per arrivare al realismo leggendario di Rajaonarison, conforme piuttosto alla percezione del reale intrisa di fantastico propria della cultura malgascia (e a cui faremo riferimento nel caso del teatro etnico). Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, L’oiseau de proie131 L’autrice apre il testo dichiarando che il racconto esposto è un «fragment d’histoire collé sur un tesson de fiction. Une bouteille à la mer», a porre, sin da subito, una prima distinzione tra una lettura degli eventi fedele alla storia, da cui i personaggi principali sarebbero comunque tratti, e il tessuto narrativo. Estrapolando il materiale storico dal suo contesto, per farne soggetto letterario, il passato, messo in situazione, si rivelerà essere anzitutto la riflessione personale dell’autore sul medesimo evento. 128 Poco conosciamo della vita di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, in quanto, la scrittrice ha preferito scindere la sua attività letteraria dalla vita privata. Nata il 16 marzo del 1966, domiciliata, attualmente, ad Antananarivo, Charlotte Rafenomanjato proviene da una famiglia agiata e “dotata” come ama lei dire, il padre medico stimato , la madre pianista affermata. Sposa a un diplomatico, la scrittrice ha viaggiato molto il che le ha fornito la possibilità, a distanza di tempo, di confrontare i ricordi della sua infanzia con il Madagascar post-rivoluzionario. La prima opera teatrale, Le prix de la paix (1985), nasce come grido disperato a un presente che non riconosce. Arrivata alla scrittura molto tardi (ricordiamo che l’autrice esercita anzitutto il mestiere di puericultrice) e attraverso il teatro. Fino al 1997 è stata presidente della Società degli Scrittori dell’Oceano Indiano (SEROI). Praticamente nulla sappiamo di Clèment Rajaonarison. 129 Facciamo riferimento in particolar modo ai testi di Rajaonarison di cui colpisce la mancanza di corrispondenza tra i nomi. Il lettore rimane stupito dal fatto che rispetto alle didascalie, ad esempio, le lettere che costituiscono il nome di un personaggio possano variare, Nanambola, Mamambola, Lefiraisana. Ugualmente, si può incorrere in aggiunte o elisioni, in note al margine, che fanno pensare a una rilettura successiva del testo, o a probabili correzioni apportate dalla giuria. 130 C’è da dire, infatti, che la produzione di Rajaonarison precede di una decina d’anni quella di Rafenomanjato. 131 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, L’oiseau de proie, Paris, RFI, 1990. Riassunto p. 479. 159 La scrittrice mette in guardia, quindi, su quanto rappresentato, sottolineandone l’aspetto principalmente fictionnel. In quanto ricostruzione letteraria di un frammento di memoria collettiva del popolo malgascio, mai adeguatamente esaminato, il racconto esposto trascende il contesto insulare per divenire una meditazione sul genere umano («une bouteille à la mer»). Charlotte Rafenomanjato sceglie, infatti, di raccontare un momento cruciale della storia malgascia: la nascita della Nazione, del regno di Madagascar per mano di Radama I, facendone il punto nodale per lo svolgersi della storia seguente. Con l’istituzione del regno merina iniziò di fatto la prima colonizzazione del Madagascar, nonché la prima schiavitù di quelle popolazioni malgasce fino ad allora libere. L’uccisione di Rasalimo e dell’erede al trono Raketaka prefigurano la tragica morte di Radama II, quindi la colonizzazione del Madagascar da parte dei Francesi pochi anni dopo. Perché il testo risponda all’esemplarità di cui l’autrice lo vuole fare partecipe, Rafenomanjato, sceglie come tessuto narrativo per la sua pièce la lotta tra il Bene e il Male, riscrivendo la cronaca malgasca dell’anno 1823 alla luce della nozione di destinée humaine. Restituendoci una lettura morale degli eventi del lontano Ottocento, allorché l’unione di un principe merina con una principessa sakalava decise della libertà di un intero popolo, l’autrice ammette l’inanità dell’agire di fronte al destino, vittima di forze superiori che giocano con i sentimenti umani. La vicenda della principessa Rasalimo e la sorte del popolo malgascio perdono la loro tragicità e loro verità storica di fronte a una realtà che due angeli riducono a competizione. Come nell’Iliade, nel testo della drammaturga, la fine del popolo sakalava è frutto di una scommessa tra due angeli A e D, ange e démon, o «déchu» come specifica il drammaturgo, sull’uomo e sul libero arbitrio, quindi sulla capacità dell’individuo di scegliere tra il bene e il male. L’homme en noir: «Ma déchéance est portée par dix victoires: le plaisir, la puissance, la haine, la vengeance, la convoitise, la…» […] «Regarde. Voici une île inconnue où vit un peuple méconnu. Je te propose de nous y rendre. Oserais-tu m’y suivre? Tu choisira l’époque» L’homme en bleu: «Je révèle le défi, immonde tentateur.»132 Come lo spazio scenico, l’agire etico dell’uomo viene diviso in due parti, blu e nero, così la pièce seguirà due movimenti, uno naturale, nella descrizione degli eventi, uno metafisico, nella manifestazione di Principi Universali. La storia della principessa Rasalimo sposa di Radama I, la morte a cui andrà incontro insieme alla figlia Raketaka legittima erede al trono per volere della corte che le preferisce Ranavalona (dal 1823 al 1828), ricostruita in modo naturalistico, è collocata all’interno di una cornice 132 Ibid., p. 1 160 sovrannaturale, in cui dominano gli ideali prima che i personaggi, le luci, blu, sulla destra, e nera, sulla sinistra, a rappresentazione della lotta morale. Riproponendo il pessimismo ontologico dei Dieux malgaches, anche il drammaturgo Rafenomanjato mette in scena il mondo claustrofobico di un palazzo, di una corte corrotta, dove i veggenti sono vittime delle loro stesse divinazioni, sempre infauste e sanguinarie, allorché si trovano a dover decidere il meglio per la Nazione. Sorprendentemente, infatti, se la seconda sezione si apre con il Moasy che ammonisce il re sulle intenzioni ambigue del re merina: «tant que votre règne n’aura pas croisé celui du roi Merina, le royaume sakalava sera préservé de son asservissement.»133, le scene successive ci mostrano il veggente intento a prendere accordi con un soldato merina per la futura unione tra la principessa e il re Radama, contro il volere del sovrano e all’insaputa dello stesso re: «Tu as vu et entendu Ramitraho me charter de bénir l’union de Rasalimo et de Radama.»134. Il mondo che ci propone Charlotte Rafenomanjato è segregato, ancora prima della capitolazione del 1828, nel palazzo del re sakalava Ramitraho: metafora di una chiusura spirituale che vivono tutti i personaggi della pièce. Monadi di una realtà destinata a un tragico epilogo, sin dall’inizio, i protagonisti ingaggiano solo apparentemente un’azione con l’esterno, per mostrare, con l’aggressione (cedere alla tentazione, iniziare la guerra), l’effettiva volontà di affermare, quindi preservare, il proprio mondo dalla realtà esteriore: l’angelo blu accetta la sfida convinto di poter preservare la sua posizione iniziale (p. 1); il re Ramitraho ingaggia la guerra contro i merina per conservare la propria libertà (p. 10); la principessa Rasalimo condanna il padre per amore di Radama (p. 9); Faly rinnega la virtù del fratello in nome della passione e della soddisfazione della carne (pp. 13-14). Per capire l’universo poetico di Rafenomanjato costituito da personaggi monolitici, oppressi dal senso del peccato, prede del conflitto morale tra bene e male, è utile ricordare che un tale mondo è ispirato, si nutre della rigida morale cristiana gesuitica secondo la quale l’autrice è stata educata: «Son univers est profondément chrétien, identique à celui qui a bercé, pendant des années, les spectateurs dans les salles de théâtre d’Antananarivo; son univers est hanté par l’idée du mal qui guette, les personnages demeurent manichéens: une morale rigoureuse permet seule d’échapper à la déchéance et au péché. […] Charlotte n’est pas la seule à s’en être inspirée, les plus grandes pièces du répertoire malgache en sont imprégnées, que ce soit celles de Rabearivelo […] ou tous les artistes qui ont marqué la littérature jusqu’à l’indépendance.» 135 133 Ibid., p. 8. Ibid., p. 20. 135 Françoise Ligier, Charlotte Rafenomanjato, in Théâtre Sud n. 3, Michèle Rakotoson, La Maison morte, Un jour ma mémoire, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 27. 134 161 Rispetto alle altre pièces (che analizzeremo in seguito) ci sembra che L’oiseau de proie sfugga, in parte, a questa divisione manichea dell’universo gesuitico. Il confronto con la tentazione (rappresentata da Ralengo) in questa opera non ha risvolti positivi: nessuno dei personaggi uscirà incolume dalla lotta ingaggiata contro il male, la morte stessa, il sacrificio si rivela gratuito (come del resto lo era stata la scommessa iniziale). Un mondo descrittoci sin dall’inizio come il negativo di se stesso (angelo blu, angelo nero, Levo, Ralengo), è destinato al fallimento, con la confusione di quelli che inizialmente erano i due poli di opposizione, il Bene e il Male: con un angelo blu, che ha ceduto due volte alla tentazione (accettando la sfida del demonio e uccidendo un soldato nella speranza di salvare Rasalimo), e ora, meno innocente di quando è iniziata la tragedia, pure ancora pronto alla sfida lanciatagli dall’angelo nero: uomini e dèi vittime della vanità di affermazione? Clément Rajaonarison, Sur les bords de la Sahasinaka 136 Una diversa atmosfera regna nella pièce di Rajaonarison. La narrazione dell’evento storico è, anzitutto, spostata dal piano metafisico de L’oiseau de proie di Charlote Rafenomanjato al piano fenomenico, concedendo al soprannaturale di interferire, intervenire nella rappresentazione del reale più per conformità a una certa concezione malgascia della realtà che in risposta a un imperativo morale. Nonostante il senso di oppressione aggredisca le prime battute del testo: «tonnerre», «vent» «hurlement des chiens pendant toute la séquence», malgrado, il mistero legato a un amuleto e allo spirito che lo abita, benché, come in Charlotte Rafenomanjato, il racconto sia diviso in due sezioni, presente (dominato dall’ultraterreno) e passato (la repressione del 1947), il drammaturgo non sottrae mai l’evento alla sua evidenza storica, come nel caso della drammaturga, per riconoscere nella manifestazione degli stessi un disegno morale che possa servire da modello per la storia malgascia o per la Storia dell’umanità in generale. L’evento magico è usato non come mezzo di distrazione dei fatti narrati, ma come espediente per riportare alla luce (in una sorta di operazione sciamanica e/o psicanalitica) gli eventi dolorosi del 1947: annunciati frammentariamente di volta in volta, tra la prima e la seconda sequenza, da diversi personaggi (Sanga, Dara e Bana), per essere successivamente portati sulla scena nelle sequenze successive. Il ricorso, nelle prime e nelle ultime battute, a un tipo di narrazione che potremmo definire hoffmanniana per l’inquietudine, il senso di spaesamento e di sopraffazione (un uomo inseguito da 136 Clément Rajaonarison, Sur les bords de la Sahasinaka Paris, R.F.I., 1982. Riassunto p. 473. 162 non si sa chi in una foresta invoca l’aiuto dello spirito) crea, piuttosto, una frattura nel discorso storico, una discontinuità nell’esposizione atta a esorcizzare il racconto stesso di un passato tabù per il popolo malgascio, e la cui memoria in quegli anni era ancora confinata all’oblio. È evidente, anche nell’inserzione dell’elemento magico, la fedeltà a una narrazione cronachistica del passato conseguente soprattutto al bisogno di far dialogare un passato per troppo tempo sconfessato, con il presente. La scena si apre, difatti, su un uomo, Sanga, reduce della repressione del 47, che ha partecipato alla commemorazione delle vittime di quei giorni, a capo, ora,di un nuovo movimento rivoluzionario giovanile (un accenno agli anni della rivoluzione socialista di Ratsiraka?). La rievocazione dei drammatici eventi del 47, offre, ancora, l’opportunità al drammaturgo di mettere in scena le diverse voci del Madagascar di allora, di fare luce sulla situazione complessa e quantomai precaria del dopoguerra, in cui convivevano aspirazioni politiche differenti: quella di Mac Kayna connivente con il colonizzatore, modello del Malgascio oppressore e sfruttatore del suo popolo «Ramassez tous nos morts. Puisque nous avons été obligés de nous déplacer pour prendre nos cadavres, ils ramasseront sur la route les leurs.»137 quella del re Nanambola, scettico sugli esiti positivi della rivolta, sostenitore piuttosto di una cooperazione con le forze straniere certo della possibilità di raggiungere progressivamente e senza spargimento di sangue un’emancipazione definitiva del popolo malgascio dalla colonizzazione «Ajoute plutôt: détruire un ennemi, c’est exposer la vie d’une centaine d’innocents. […] Combien de paysans sont morts, pour votre faute? Deux cents, trois cents […] Des familles de paysans: des hommes, des femmes, des enfants […]»138 quella di Sanga convinto assertore della rivoluzione come unico mezzo per liberare il suolo malgascio dal colonizzatore francese «Ce train dont tu parles […] transportait des tonnes de munitions. Avec elles Mac Kayna aurait pu assurer une meilleure emprise de ton royaume. Certes une paix durable. La soumission totale et l’asservissement du plus faible […] Ces innocents dont tu parles ont sacrifié leur vie pour leur patrie […].»139 137 Ibid., p. 16. Ibid., p. 18. 139 Ibid. 138 163 Soprattutto è l’occasione per rianimare le aspirazioni e i lutti di quei giorni concitati che precedettero la repressione, per denunciare le atrocità subite da un’intera popolazione. Barbarie che assume durante la narrazione il colore e l’odore particolari della guerra civile allorché l’accusato del genocidio non è mai direttamente il colonizzatore francese ma il fiancheggiatore malgascio «Aucun espoir n’était permis. La porte de fer forgé, tiède, était bloquée. […] Les hommes collés contre elle n’étaient plus que des masques carbonisés. Un véritable four crématoire. […] Des cadavres en pleine décomposition […] à cause de l’excessive chaleur […]»140 o ancora «Je revivais cet après-midi de mars 1947. Les mêmes scènes se répétaient à mes yeux. Les mêmes visages livides de cette foule à genoux, attendant en redoutant, les coups de fusil qui mettront fin à la vie […] Le rire sardonique de cet assassin […] le visage calme et détendu de cet homme qui sait qu’il va mourir et qui l’accepte en la [la mort] défiant […].»141 L’evidenza e la rivelazione dei quali se pure legittima, giustifica la rivoluzione presso la storia «moi, j’ai la légalité et la légitimité […] l’histoire vous jugera»142, non fa apparire meno crudele, feroce, abominevole la guerra civile alla luce soprattutto dei nuovi gruppi rivoluzionari: «Je vois ces jeunes révolutionnaires qui comme leurs pères autrefois vivent, sans parfois même comprendre les scènes de violence qui se déroulent devant eux»143 140 Ibid., p. 9. Ibid., pp. 37-38. 142 Ibid., p. 33. 143 Ibid., p. 38. 141 164 Mito e realtà l’esempio di Clément Rajaonarison Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato e di Michèle Rakotoson Partendo dalla somiglianza tra i racconti della tradizione e alcuni testi teatrali malgasci abbiamo considerato la possibilità di istituire un parallelo tra la forma narrativa mitica dei tantara e il teatro storico, gli angano e il teatro cosiddetto etnologico. Il nostro assunto si basa sulla constatazione di una certa corrispondenza tra i protagonisti dei due generi letterari. Nel caso dei tantara, come abbiamo visto, è evidente la comune appartenenza dei personaggi del racconto alla stirpe reale (anche nella tragedia di Clément Rajaonarison, che tratta della repressione del 47, rimane l’opposizione tra il re e la sfera coloniale, e proprio il re è deputato a essere la vittima sacrificale). Storie alla radice vere, i tantara, storie inventate gli angano, questi rappresentavano il genere di racconto familiare da tutti condiviso (al contrario dei tantara la cui narrazione era demandata, come nel caso dei griot africani, a professionisti del genere). Gli angano non avevano, allora, come obiettivo la preservazione della memoria di un popolo, ma la sua educazione, la sua formazione morale attraverso la ratifica delle regole che la comunità non doveva infrangere. I personaggi di questi racconti appartenevano al popolo e alla natura: foreste144, laghi145, fiumi, serpenti146 e sirene, alberi della conoscenza, caimani, morti viventi, streghe, non risparmiano un 144 «[…] la forêt — qui entoure les tombeaux mais qui recouvrait autrefois la majeure partie de la contrée — est le monde des esprit du sol, […] maîtres de la terre; maîtres aussi des sangliers […]. Elle est du monde de l’ailleurs […] sauvage, habité par la mort en même temps source de la vie, où l’on cherche ignames et remèdes.», Philippe Beaujard, Mythe et société à Madagascar, op. cit., pp. 26-27. O ancora Alain Ricard: «Les vagabondages initiatiques dans ces forêts peuplées d’êtres magnifiques […] la route est le symbole de l’accès au royaume des morts, voie le passage vers les “ténèbres mystiques” de la forêt. Elle fisse le réseau social dans lequel une nation moderne se construit au milieu de ses voisins.», Alain Ricard, Théâtre et nationalisme, Paris, Présence Africaine, 1972, p. 111. 145 Ad esempio la leggenda del lago sacro di Anivorano, infestato dai caimani, antichi abitanti del villaggio «Lac situé à Anivorano dans le nord du Madagascar, où, selon la légende, un village a été transformé en lac et les villageois en caïmans par un étranger à qui ils ont refusé l’hospitalité. Depuis, sur les bords du lac, tous les ans, lors d’un culte, les riverains déposent des offrandes.», Lilane Ramarosoa, Anthologie de la littérature malgache d’expression française des années 80, Paris, L’Harmattan, 1994, pp. 247-248. In proposito Danielle N. Andrianjafy sottolinea come nel teatro etnologico la presenza dell’acqua sia dominante, soprattutto l’acqua come elemento degradante, stagnante, per cui lo studioso trova una corrispondenza sia con la tradizione romantica e simbolista francese che con il primitivismo malgascio: «Il y a une forte présence de l’eau stagnante (étang, rizière ou lac) que l’on pourrait rattacher à la tradition très romantique de l’espace circulaire représentatif de l’insuffisance de la condition humaine, aussi bien qu’à la tradition malgache qui aspire au retour à la terre et de ce fait, craint l’eau comme menace de dissolution dans l’espace.», Danielle N. Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, cit., p.p. 71-72. La leggenda è raccontata da David Jaomanoro ne Le dernier Caïman, Paris, RFI, 1988, 146 «Les taňala classent les lolo dans cette catégorie d’esprits, mais emploient par ailleurs l’expression aňaran-lolo pour le “nom donné au souverain après sa mort”. Or, les humours du cadavre et le cercueil royal étaient jadis immergés dans 165 mondo dalle atmosfere per lo più cupe, un mondo lacerato tra ateismo e una superstizione altrettanto cieca. Proprio dalla violazione di uno dei due mondi (generalmente della natura, investita del sopranaturale, da parte dell’uomo) ha origine il dramma, la storia «dangereuse et fatale»147 come ricorda Ottino nel caso dell’angano. Come già negli angano, così nel teatro etnologico ritroviamo la stessa divisione tra mondo naturale e mondo sovrannaturale; allo stesso modo degli angano l’opposizione tra i due mondi si rivela inconciliabile e nefasta, portando se non alla morte di colui che ha violato l’interdetto, certamente alla ricostituzione, stavolta definitiva, della separazione originaria. I due termini a confronto, proprio nell’escludere a priori ogni conciliazione, assumono entrambi delle accezioni negative: uomini impavidi moriranno per non aver creduto nel soprannaturale, la stregoneria è ad uso dei soli malvagi, le credenze antiche celano questioni razziali, come pure la scienza moderna dimostra di essere vittima di pregiudizi e della poco nobile sete per il successo e il denaro. Sostanzialmente morale, il teatro etnologico può essere considerato, in un certo senso, come un’evoluzione moderna dell’angano nella misura in cui il tipo di opposizione che mette in scena ripropone le medesime dinamiche attualizzandole al contesto contemporaneo. L’opposizione in precedenza orizzontale e sincronica, dove mondo reale e mondo sovrannaturale si confrontavano e mettevano a confronto due realtà del medesimo universo sociale, diviene, ora, verticale e diacronica, con il conflitto tra la città e la campagna, tra il mondo antico, rappresentato dalla tradizione148, e la realtà contemporanea, di cui la scienza vuole essere la massima espressione (topos quello dell’opposizione tra città-campagna che sappiamo essere caratteristico della produzione letteraria africana post-coloniale degli anni 60): «Pas de cliché plus fréquent dans la nouvelle littérature africaine que celui du contraste entre la vie 149 urbaine et la vie de la campagne […] “la ville” cruelle qui symbolise la civilisation occidentale […].» des trous d’eau profonde, des rivières Sandraiňanta et Manambondro, où le souverain devenait crocodile ou serpent Fanano», Philippe Beaujard, Mythe et société à Madagascar, op. cit., p. 398. Suzanne Ravoaja mette in scena la leggenda del Fanano con la pièce Fanano, Paris, R.F.I, 1988. 147 Come ricorda Ottino il termine angano, di probabile origine bantu (ngano, racconto, favola), non è solo usato per indicare dei racconti dall’origine antica, ma anche qualcosa di terribile, di fatale. Paul Ottino, L’Etrangère Intime. Essai d’anthropologie de la civilisation de l’ancien Madagascar, op. cit., p. 57. 148 Come metterà in evidenza l’analisi dei testi, il ricorso alla tradizione, come già per la storia, non assume per il Malgascio un valore identitario. Se per il teatro africano post-coloniale il ritorno alle origini «reste un mythe […] destiné à camoufler la rupture historique que doit assumer une Afrique spoliée de son passé» (Sylvie Chalaye, L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XX siècle, op. cit., p. 20), per il teatro malgascio, già prima della decolonizzazione intento alla produzione di un teatro storico ed etnologico, il confronto con la tradizione rimane critico. 149 Alain Ricard, Théâtre et nationalisme, op. cit., p. 110. Sylvie Chalaye fa notare l’esistenza di un décalage tra la prosa e il teatro africano. Se il romanzo di formazione o di apprentissage ha dominato tutta la produzione degli anni 60, sembra che il teatro abbia scoperto questo genere solo negli anni 80. Sylvie Chalaye, L’Afrique Noire et son Théâtre au tournant du XX siècle, op. cit., pp. 33-34. 166 Da questo primo nucleo di racconti angano si sono sviluppati tre generi distinti di produzione teatrale. Un teatro etnico, il cui scopo è rianimare i miti ancestrali in una cultura moderna e cosmopolita, troppo spesso dimentica delle proprie radici (rientrano in questo gruppo i testi di Naïvo Rahamefy150, di Doly Odeamson151, di Vololona Andriamoratsiresy152). Un teatro sociale che, opponendo la realtà alla finzione, il mondo ancestrale al mondo contemporaneo, problematizza la realtà post-coloniale, lacerata tra due universi di cui ne subisce le interferenze senza potersi riconoscere in nessuno. Ritroviamo in questo gruppo Jeanne Rasoanasy153, Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato154, David Jaomanoro e Suzanne Ravoaja (di cui abbiamo parlato avanti). Un teatro d’apprentissage vicino al romanzo di formazione africano, memore del Bildungs roman ottocentesco, attualizzato da Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato155 e Michèle Rakotoson156. Leggende malgasce Come per le favole occidentali, così nelle leggende malgasce si possono riconoscere le medesime dinamiche narrative che procedono dalla definizione iniziale del contesto, la manifestazione dell’elemento drammatico, quindi la soluzione positiva dello stesso157. Dei tre racconti che abbiamo analizzato, il testo di Naïvo Rahamefy158 ci sembra essere quello di maggiore interesse proprio per l’uso personale che fa dei temi della tradizione e del racconto leggendario stesso. La storia, difatti, a differenza degli altri due racconti, non è ispirata direttamente alle leggende della tradizione, ma a un hain-teny ricordato da Jean Paulan nella sua ben nota raccolta; altro fattore importante da considerare è la mancanza di una conclusione felice del racconto, proponendo piuttosto una non-conclusione dell’opposizione originaria, atta a lasciare inquieto lo spettatore (lettore nel nostro caso). 150 Naïvo Rahamefy, Lac et fleuve, 1969. Doly Odeamson, Ikotofetsy et Imahaka, les deux larrons, Paris, R.F.I., 1979. 152 Vololona Andriamoratsiresy, Imaitsoanala, Paris, R.F.I., 1985. 153 Jeanne Rasoanasy, Le monde des vivants, Concours théâtral Interafricain, D.A.E.C coop., 1972, e L’amulette, Paris, R.F.I., 1980. 154 Charlotte- Arrisoa Rafenomanjato, Le Prince de l’Etang, Roma, Bulzoni, 1987, Le Cerveau, inédit. 155 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le Troupeau, Paris, RFI, 1990. 156 Michèle Rakotoson, Sambany, Paris, RFI, 1978, Histoire de Koto, Paria, R.F.I., 1980 157 Doly Odeamson, Ikotofetsy et Imahaka, les deux larrons, op. cit. Riassunto pp. 473-474. Vololona Andriamoratsiresy, Imaitsoanala, op. cit. Riassunto p. 481. 158 Naïvo Rahamefy, Lac et fleuve,op. cit. Riassunto p. 470. 151 167 L’attesa del personaggio, che si rinnova ogni volta che il «colore delle mimose si confonde con quello del cielo», se risponde ai moduli del racconto leggendario, pure, ci previene di un nonsenso inerente all’attesa, dell’attesa come manifestazione della frattura (tra realtà e ideale), nel momento in cui il recitante ci rivela il totale disinteresse del protagonista verso la sua situazione: «Peu lui importait laquelle arriverait, laquelle n’arriverait pas. Il n’attendait personne.»159. Sebbene il drammaturgo dia prova di ispirarsi al mondo ancestrale, sia nei temi che nella scelta del soggetto e della struttura dell’opera160, per manifestare la sua piena aderenza al racconto morale antico da tutti conosciuto e condiviso, nondimeno interrompe la narrazione tradizionale161 introducendo un’atmosfera di incertezza, di inquietudine morale che non apparteneva allo hain teny tramandato dalla popolazione. I temi e i tabù della tradizione, come la sterilità (sterilità della coppia e in particolare della donna), si logorano e si doppiano nel dialogo impersonale tra i due amanti; il lago e il fiume divengono simboli dell’esistenza umana: la manifestazione della scelta dell’individuo di aggredire la realtà per arrivare allo scopo prefisso come il fiume, che «rêve de se jeter à la mer. Il y parvient toujours», o di chiusura all’esterno per proteggere le proprie conquiste e le proprie conoscenze, come il lago che «n’a d’obstacle que lui même […], il est intarissable.»162. La natura, a un tempo preda e cacciatrice, si offre all’uomo come metafora della realtà, che nell’incedere esitante tra la vita e la morte, sintetizza due diversi atteggiamenti dell’individuo verso il reale: l’aggressione, e l’inazione, la scelta del progresso, a dispetto della regola comune, e dell’oblio, conformemente alla sempiterna verità della terra, degli avi, della loro legge. In una leggenda antica, emerge allora una tematica tutta moderna, una parabola che racconta di un’isola impoverita dal protrarsi della colonizzazione, incapace di definirsi ora, all’indomani della decolonizzazione, dopo un troppo lungo periodo di assoggettamento politico e culturale: indecisa, soprattutto pessimista riguardo a qualsiasi tipo di cambiamento. Non stride, allora, all’interno del testo, la parentesi storica, apparentemente fuori contesto, che l’autore introduce per mezzo della serva. Nella seconda parte, in pieno svolgimento di un dramma esistenziale, la serva racconta alla donna, in dubbio se gettarsi nel lago, la storia di un’intera comunità malgascia suicida per non assoggettarsi al dominio merina. Unica superstite di quella tribù, la sola a non aver voluto commettere un gesto a suo avviso insensato, la serva mette in luce la 159 Naïvo Rahamefy, Ibid., p. 29. La figura del recitante è evidentemente ispirata agli ‘mplalao che declamavano gli hain teny, così, la musica tradizionale ad aprire e chiudere ciascuna parte ripropone i ritmi della narrazione dello hira gasy, come pure l’allusione alla simbologia tradizionale legata al lago e al fiume, alla festa degli avi rito pagano della morte e della resurrezione. 161 Ricordiamo che gli hain teny erano dispute amorose che consistevano nel miglior uso dei proverbi locali. Ne segue che i maestri delle dispute erano coloro che riuscivano a concludere il proverbio dell’antagonista con un proverbio analogo od opposto che più gli era conforme. 162 Naïvo Rahamefy, Lac et fleuve,op. cit., p. 22. 160 168 difficile rappresentazione e definizione della libertà per i popoli che hanno conosciuto l’oppressione coloniale «Les soldats mérinas […] nous assiégeaient depuis de long mois. Et pour tromper leurs ennemis […] ils s’appliquaient à chasser les sangliers dans la plaine. Leur roi […] ne savait pas écouter. Il ne pensait en terme de bataille, de vainqueur et de vaincu. […] Nous étions trois mille. Nous n’étions pas trois cents, quand cessèrent les derniers tam-tams. Quant aux autres ils s’étaient précipités dans l’abîme. […] Une tribu s’est suicidée pour être libre. Mais elle n’est pas libre. Elle n’a aucune chance de redevenir: elle est anéantie»163 Tradizione e innovazione, rito antico, culto moderno: il dialogo interrotto Ispirato agli angano tradizionali, il teatro etnologico di Rafenomanjato, di Rakotoson e di Jaomanoro ne ripropone la struttura narrativa costruendo i nucleo drammatico delle pièces sull’opposizione tra la società antica e il mondo moderno, tra una concezione scientifica della realtà e una visione magica del cosmo attraversato dal sovrannaturale. Molto vicino al romanzo di formazione africano, come questo genere, il teatro etnologico mette in scena la profonda solitudine e incomprensione dei personaggi, denunciando, quindi, quella frattura nella storia e nella cultura164 di cui sono testimoni tutti i popoli colonizzati. A differenza del romanzo e teatro africano, e del Bildungs roman ottocentesco, la formazione dell’individuo, nel teatro etnico malgascio, non sembra mai possibile, raggiungibile. Anche lì dove il personaggio dei romanzi e drammi africani è costretto a confrontarsi con la perdita del paradiso originario e del consenso collettivo una volta valicato il confine della città, l’opposizione tra il progresso e la tradizione ridefinisce l’individuo nel recupero nostalgico del mondo antico, dacché, come fa notare Ayayi G. Apedo-Amah, l’analisi del passato rispetto al presente tende a evocare un passato precoloniale idillico165. 163 Ibid., pp. 11-13. «[…] la colonisation a établi une rupture nette dans l’évolution historique de l’Afrique et a instauré un conflit entre deux cultures distinctes: la culture africaine et la culture occidentale.», Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le theatre ouest-africain francophone, op. cit, p. 5. 165 Ayayi G. Apedo-Amah, L’histoire comme source d’inspiration du théâtre populaire négro-africain, Mémoire de maîtrise d’enseignement Paris III, 1976-1977, p. 17. Osservazioni confermate dall’analisi del romanzo: «[…] le roman d’apprentissage qui raconte la formation d’un individu à travers les aventures et les épreuves qu’il affronte. […] En toile de fond au roman de formation, l’affrontement de deux mondes: le village et la ville, la tradition et le modernisme, l’Afrique et l’Europe…Le monde traditionnel incarné par le village […]. C’est ce paradis du temps perdu , univers merveilleux et sans problèmes […]. En face, la grande ville africaine, déjà étrangère, où la France, […] figure un monde de la rupture et du discontinu […] un monde du malheur […] qui s’acharne sur le héros désarmé. Le roman d’apprentissage raconte le passage d’un monde à l’autre, l’arrachement dramatique du monde ancien, dans l’effondrement de toutes les valeurs, la naissance du monde moderne.», J.-L. Joubert, J. Lecarme, E.Tabone, B. Vercier, Les littératures francophones depuis 1945, Paris, Borda, 1986, pp. 35-36. 164 169 Diversamente dal teatro africano, la dialettica tra mondo antico e la modernità non si conclude mai nelle pièces malgasce con la riabilitazione del passato in difesa dell’identità collettiva, lasciando aperto il conflitto tra presente e passato come manifestazione di una realtà post-coloniale ove l’interferenza tra vecchio e nuovo definisce l’identità lacerata delle popolazioni colonizzate: l’impossibile conciliazione tra la memoria precoloniale e universo post-coloniale. Contro il movimento, indice della trasformazione dei punti di riferimento culturali tradizionali, nel teatro africano (rappresentato concretamente nello spostamento dalla campagna alla città, dal paese alla Francia), la narrazione malgascia mette in scena un mondo statico dove il movimento e la dialettica sono solo apparenti, ognuno dei due termini rimanendo chiuso nelle posizioni iniziali che lo definiscono. La mancanza di un reale movimento verso l’esterno che definisca e precisi i termini a confronto, in particolar modo quello d’arrivo che rappresenta il nuovo mondo rispetto all’antico (il tema dei romanzi di formazione è la conoscenza), riflette certamente la diversa prospettiva in cui scrivono i romanzieri africani (anni 60) rispetto ai drammaturghi malgasci (anni 80): gli uni reduci dalla colonizzazione, credono possibile anche se dolorosa la conciliazione degli opposti, lì dove la dialettica è considerata esterna alla società originaria (mondo ancestrale, africano, mondo moderno, occidentale), gli altri, dopo un ventennio di neocolonialismo, mostrano l’impossibilità di una conciliazione ora che l’opposizione si è spostata all’interno del sistema culturale di riferimento, portando gli stessi termini alla degradazione: il culto è divenuto superstizione, la scienza un’utopia. I due mondi conosceranno l’uno l’esistenza dell’altro pur volendone negare la legittimità. Per questo motivo la trasgressione (quindi la punizione del trasgressore) non sarà il prodotto della conoscenza, come nel caso del romanzo, ma dell’ignoranza. Tradizione e progresso sembrano inconciliabili in una terra come quella malgascia dove la modernità è stata guadagnata al prezzo della colonizzazione, e del servaggio non solo politico ma anche culturale. Superstizione e scienza arrivano a un rifiuto reciproco, l’una in nome della sacralità delle tradizioni, l’altra in nome dell’oscurantismo, della mostruosità delle stesse. L’intento morale dello scrittore è evidente: l’interesse riservato alle leggende, non dissimula alcun rimpianto del passato ancestrale quando tutto era luce e armonia, ma è la testimonianza di una confusione culturale che, come aveva previsto Rabearivelo, non è riuscita a superare lo stadio dell’interferenza per il métissage166; confusione di fronte alla quale rimane la sola constatazione dell’orrore e dell’abominio: 166 Questioni politiche e storiche alla base di questa dialettica interrotta. Negli anni coloniali, la resistenza alla cultura europea indicava l’opposizione politica degli intellettuali malgasci contro un sistema coloniale che faceva tabula rasa del mondo tradizionale malgascio. Dopo il 1972 l’opposizione tra il mondo occidentale, imperialista, e il mondo insulare malgascio, socialista, sarebbe stata riattualizzata dalla rivoluzione malgascia di Ratsiraka. 170 «bruits sinistres accompagnés, par intermittences, de reflets de lumière et de tourbillon d’air», «atmosphère surnaturelle»167 Le dinamiche che ripropongono i testi del teatro etnologico sono praticamente le stesse: da un lato il mondo dei vivi che popolano il villaggio, dall’altro il mondo dei morti o degli spiriti, che infestano la foresta168, il lago e il pozzo (privati, nel teatro, delle qualità positive di cui invece erano apportatori nei racconti orali, come nel caso della foresta a un tempo regno dei morti e fonte di vita); da un lato l’uomo moderno, rappresentante dell’autorità scientifica e del potere, come l’ufficiale dell’esercito o capo della polizia169, come lo studente universitario, lo scienziato, dall’altro i personaggi moralmente corrotti come il dahalo170, il ministro del culto antico o i finti detentori del culto171, le streghe, i maghi, gli esseri mitologici dai poteri soprannaturali, metà uomo metà animale, creature malvagie nate dell’interferenza tra il reale e il soprannaturale, sirene incantatrici172, fanano e caimani173, che sfruttano le miserie dell’uomo allo stesso modo dei padroni, dei capitalisti del mondo moderno. La rapida enumerazione dei soggetti trattati nella maggior parte delle pièces etnologiche lascia indovinare l’evidente somiglianza complessiva delle opere analizzate. Alla ricorsività dei temi e delle dinamiche di molti testi presi in esame sembra, però, sfuggire Tsaraheso174 di Clément Rajaonarison. Come le altre opere etnologiche anche la pièce di Rajaonarison è costruita sul confronto tra due termini in opposizione e sulla manifestazione del soprannaturale. Più che nelle altre opere prese in esame, il drammaturgo sembra curare in modo particolare, quasi filologica, la ricostruzione dei riti ancestrali. Vengono così rievocati i riti di iniziazione175, riti per interrare i morti o per fare giustizia176, per guarire i malati177 e gli affetti da follia paranoide178, il rispetto sacro per le pietre e 167 Suzanne Ravoaja, Fanano, op.cit., p. 53. Riassunto p. 483. Jeanne Rasoanasy, Le monde des vivants, op. cit. Riassunto p. 471. 169 Jeanne Rasoanasy, L’amulette, op. cit. Riassunto p. 472. 170 «Initialement, ceux qui s’adonnent au vol rituel des zébus. Aujourd’hui, voleurs de bétail ou voleurs de grandchemin.», Liliale Ramarosoa, Anthologie de la littérature malgache d’expression française des années 80, op. cit., p. 246. 171 Charlotte-Arrisoa Rafenomajato, Le prince de l’étang, op. cit. 172 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le cerveau, op. cit. 173 David Jaomanoro, Le dernier caïman, op. cit. 174 Clément Rajaonarison, Tsaraheso, Paris, Concours Théâtral Interafricain , S.I. D.A.E.C. Coop., 1974. Riassunto pp. 472-473. 175 Le prove che i personaggi devono superare sono tre: l’uccisione del mostro Bevagina, prima sfida alla natura di Tsaraheso, che coincide con la morte dell’innocente Lefiraisana, il passaggio sotto il fuoco delle sagaglie (pp.54-57), seconda sfida di Tsaraheso, il rito iniziatico dell’acqua come forza rigenerante (gli uomini in preda delle acque ingrossate del fiume, «On peut dire que nous revenons de loin», p. 82). 176 Perché un morto potesse varcare la soglia dell’aldilà era necessario, secondo il costume antico, uccidere uno dei vitelli più forti che potesse servire al morto da linceuil per la sua pace eterna (Ibid., p. 42). Prima di uccidere Mamena, gli amici del defunto Loferaisana invocano la giustizia atavica «par la volonté des ancêtres nous allons te tuer» (Ibid., p. 75), quindi il condannato viene legato con un tronco di rafia in equilibrio sul suo ventre. 168 171 per gli avi di cui è rievocato il ruolo centrale nella cultura malgascia tradizionale179. L’idea del soprannaturale, che domina tutto il testo, è certamente rafforzata dall’esistenza di animali leggendari dalle dimensioni insolite (Bevangina è una preda di tre metri), dal susseguirsi di morti misteriose, dalla presenza della magia nera di Mamena, dal potere indiscusso di Tsaraheso capo del villaggio. A differenza delle altre pièces etnologiche, il soprannaturale non è mai identificato in un personaggio, in un essere o in una situazione particolare «Les fétiches protecteurs sont ainsi utilisés, dans la pièce du Malgache Clément Rajaonarison, par tout le village où se situe la scène en commençant par le chef Tsaraheso (un jeune homme de vingt-cinq ans) et son frère Mamena. Le premier s’en sert pour démontrer sa force et sa bravoure; le second pour se rendre invincible.»180 Come per Hoffmann così per Rajaonarison «la “réalité” si quotidienne soit-elle, perd toute unité rassurante pour se voir régulièrement hantée par cela même qu’elle bannit.»181. Ne segue, da parte dell’autore, una ipertrofizzazione dell’opposizione interna che già avevamo notato distinguere la poetica malgascia da quella africana. Il soprannaturale non è esterno e opposto al naturale, ma i due convivono in una fusione, che come abbiamo rivelato nelle altre opere, essere fatale all’uomo. Non si riproporranno nel testo, quindi, le dinamiche tra conoscenza e ignoranza, che avevamo messo in evidenza per i testi analizzati in precedenza, né tanto meno i personaggi saranno classificati secondo le loro qualità morali tra buoni e malvagi. Più vicino al teatro tradizionale malgascio, Rajaonarison, costruisce dei personaggi complessi, buoni e malvagi a un tempo, così Tsaraheso da tutti considerato irreprensibile, si rivela complice 177 Come già aveva notato Jean-Paul Koenig analizzando le tragedie di Rabemananjara, la cultura malgascia si fonda sul rispetto e il mantenimento degli opposti. Perché un uomo possa riacquistare la salute è necessario che si occupi della sua malattia un uomo di una etnia opposta alla sua: «Que ce soit des faits réels ou imaginaires […] il est une chose indéniable, claque fois qu’un Antimoro ou un de ses descendants est malade, on fait appel à un Antamabahoaka qui l’injurie et le miracle: le malade se rétablit. La réciproque est aussi valable dans l’autre sens […]», Ibid., p. 29. Sullo stesso principio della reciprocità si basa il rito quantomai estremo di seppellire vivo il malato perché possa rivivere «Pleurez! Pleurez! Pleurez de joie mes amis! Enfin les ancêtres nous ont exaucés en nous donnant un des nos anciens esclaves à enterrer […]» (Ibid., p. 35). 178 Per far riprendere Vela dallo spavento di aver visto suo marito interrato vivo, lo stregone del villaggio inizia il rito per scacciare lo spirito malvagio dall’animo della giovane donna. Nella ricostruzione di quelli che dovevano essere attimi concitati, il drammaturgo attua una sovrapposizione tra la donna e lo spirito incarnato in un maiale, solo il cui sgozzamento può liberare la donna (Ibid. p. 38). 179 In tutto il testo i personaggi si confrontano con gli avi, che come delle divinità agiscono sul reale mostrando il loro consenso o il loro dissenso, la loro benevolenza o al contrario la loro ostilità verso gli uomini del villaggio. Le figure che si alternano sulla scena fanno tutte mostra di un rapporto di reverenza e di paura verso i defunti. Lofirisana: «[…] Jamais je n’oserai commettre un sacrilège: enlever des pierres d’un “tsamgambato”[…]», Ibid., p. 8; Marolahy: «Qu’ai-je donc fait aux ancêtres pour mériter un tel sort? […] on ne peut rien contre les ancêtres […]», Ibid., p. 42. Così, per scampare alla morte sicura dalle acque del fiume ingrossate dalla tempesta gli uccisori di Mamena invocano la vecchia dama del fiume, Zanahary (Ibid., p. 82) 180 Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., p. 92. 181 Philippe Forget (présentation, traduction et notes), E.T.A. Hoffmann, Tableaux Nocturnes, France, Imprimerie Nationale, 1999, p. 16. 172 della magia nera di Mamena (p. 50); Mamena, da parte sua, presentatoci all’inizio come rivale e provocatore degli dèi, convinto di essere padrone degli uomini e delle cose, apprenderà verso la fine di essere stato usato da Tsaraheso182. Il conflitto interno definito e risolto nell’opposizione tra fratelli (Tsaraheso/Drasika), o fratelli di sangue (Tsaraheso/Mamena) è enfatizzato dal sostrato biblico che si indovina nelle battute dei personaggi: Mamena Lefiraisana, come Caino e Abele183, e nel clima di catastrofe che fa rassomigliare l’uragano che si abbatte sul villaggio al diluvio biblico a mondare la terra dal peccato (Drasika come Noé sarà il profeta inascoltato). Confondendo i termini antagonisti (una volta riconosciuto il mistero come insito nelle cose), facendo venire meno l’opposizione tra il naturale e il soprannaturale, Rajaonarison ha alterato i meccanismi del dramma delle pièces etnologiche, soprattutto ne ha invertito le dinamiche facendo irrompere il reale, elemento estraneo alla pièce, nelle ultime battute di un villaggio votato alla distruzione: «Nous sommes irrémédiablement perdus […] n’espérons aucune aide puisque les ancêtres ont voulu que cela soit […] aujourd’hui 21 mars 1903 nous allons mourir par la volonté des ancêtres, cependant, au cours des ages nous vivrons d’une vie éternelle à travers l’histoire, car l’histoire ce sont les hommes qui la font.»184 Per finire, l’autore sposta il racconto dal piano leggendario, al piano naturale, al piano storico. La catastrofe naturale che si abbatte su un villaggio fino a raderlo al suolo (le nostre ricerche hanno portato alla luce l’esplosione in quegli anni di un’epidemia virale che falcidiò interi paesi malgasci), per la sua portata biblica, potrebbe essere considerata una metafora della storia malgascia, bruscamente interrotta dalla colonizzazione. Emergono dall’omogeneità di cui danno prova la maggior parte dei testi etnologici, nel riproporre una visione uniformemente pessimista della realtà malgascia, le pièces di Michèle Rakososon185, Sambany186 e L’Histoire de Koto187 e di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato Le troupeau188. 182 «Je te hais Tsaraheso, je t’ai toujours haï, c’est par ma sorcellerie que tu jouis de cette puissance. Mais maintenant c’est fini […].», Clément Rajaonarison, Tsaraheso, op. cit., p. 52. 183 Mamena: «Tu me la payera Lefiraisana et pas plus tard qu’aujourd’hui, tout de suite même» (Un léger sifflement se fait entendre, puis tout à coup, les aboiement des chiens se font de plus en plus, galopades, son de cors, cris de joie des chasseurs, cris aigus du sanglier […]) Lefiraisana: «Pourquoi Mamena?» (râle de mourant, Mamena l’étrangle), Ibid., p. 10. 184 Ibid., pp.88-89. 185 Michèle Rakotoson nasce il 14 giugno del 1948. Esercita la professione di insegnante liceale fino al 1983, quando decide di trasferirsi in Francia dove pratica la professione di libera giornalista per R.F.I., France Culture. Più volte insignita del premio di R.F.I. per le sue pièces Sambany (1978) e La maison morte (1989), ha ricevuto il premio del Grand Prix Littéraire de Madagascar per il suo romanzo Dadabe nel 1985. Rimasta in Francia, negli ultimi anni si occupa della direzione del concorso d R.F.I. 173 La storia di Koto e di Faly è molto simile. Koto è un bambino zoppo (come non ricordare che anche Edipo era storpio), Faly è un nano, quindi un ragazzo rimasto bambino e come tale si comporta ed è considerato, che si dedica alla cura del gregge e come il Pan greco ama suonare il flauto. Entrambi sono costretti a fuggire dal paese, gravemente colpito dalla carestia189, perché minacciati: l’uno dalla possibilità di essere ingaggiato come lavorante presso un datore senza scrupoli, l’altro dalla giustizia. La città si offre ad entrambi come il miraggio, l’unica possibilità di salvare se stessi e il paese. Se la storia di Koto si rivela in maggior misura conforme alle modalità della narrazione favolistica (per la scelta del recitante, dei refrain tipici del racconto epico) e iniziatica della tradizione (con l’introduzione di personaggi immaginari come il gallo gigante e parlante Sada, l’orco, l’albero della conoscenza, il banano magico190), il racconto di Faly è invece più vicino a un tipo di narrazione naturalistica, ma non meno simbolica. Come nel romanzo africano, la città si presenterà ai due protagonisti foriera di esperienze negative, entrambi saranno sfruttati per la loro ingenuità, entrambi riusciranno a sfuggire al loro stato solo grazie all’intervento degli abitanti del paese. Tra i due racconti emerge una prima differenza: mentre nella storia di Koto, la dialettica tra la città e la campagna è superata, con la conoscenza, di cui solo la città è depositaria «Et ainsi finit l’histoire/l’histoire de Koto […]/ Ils sont devenus des sages./Ils ont vu les lumières de la ville./ Ils ont vu les mirages de la ville/Et ils sont revenus au village./ Et ils ont fait un village des lumières/avec des arbres, des fruits, des fleurs, de/l’Avenir»191 nel racconto di Rafenomanjato, la dialettica è brutalmente interrotta dal rifiuto del secondo termine (la città) in favore del primo (il villaggio). Senza l’apporto di alcun bene né scienza dalla città, nel paese è tornata insperatamente la pioggia. Nel Troupeau, il movimento viene quindi 186 Michèle Rakotoson, Sambany, op. cit. Riassunto p. 474. Michèle Rakotoson, L’Histoire de Koto, op. cit. Riassunto p. 474. 188 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le troupeau, op. cit. Riassunto p. 480. 189 «La sécheresse se retrouve de deux façons différentes au cœur de plusieurs fables. Parfois elle est abordée comme un simple aléa climatique qui bloque toutes formes de prospérité. D’autres fois, on la présente comme une calamité envoyée par les mauvais esprits pour éprouver les populations. Dans les deux cas, les personnages luttent pour se dérober à ce mal. […] Symbole pour traduire, par la métaphore, l’un de plus grands maux dont souffre le continent africain: la sécheresse mentale et intellectuelle, morale et psychologique, culturelle et éducative, bref, un tarissement de toutes les sources vivifiantes.», Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit, p. 119. 190 «[…] Avec l’extraordinaire aventure d’un garçon, racontée par l’Histoire de Koto, on se rend compte que l’auteur, Rakotoson, n’évoque la sécheresse et la famine que pour bien poser les frontières de la fiction. C’est dans ces frontières que plusieurs faiblesses humaines se déploient. De luttes s’engagent. On aboutit à la victoire des forces du bien sur les forces du mal, après l’intervention des dieux et de la magie. […] Si cette famille a pu vaincre ou venir au bout de la sécheresse […] cela suppose […] que des espoirs existent pour tous les combats.», Ibid. pp. 119-120. 191 Michèle Rakotoson, L’histoire de Koto, op. cit., p. 55. 187 174 inaspettatamente invertito: la città colpita dalla saggezza e dalla bellezza della tradizione di cui il villaggio è depositario sceglie idealmente il regresso: «Ma terre natale mendie un peu d’eau, ici chaque robinet est une source. Nous distribuons gratuitement les galettes, vous, vous les vendez à 50 Francs la pièce. Nous espérons la pluie, vous attendez le bus…pour aller vers quel pâturage? […] Votre argent est un mauvais berger!»192 Rispetto ai due racconti precedenti, Sambany si ispira totalmente allo hira gasy tradizionale. L’opposizione messa in scena non sarà tra la città e la campagna, ma, come nel genere tradizionale, tra l’individuo e la collettività. Il testo sarà, quindi, composto da due parti: uno spazio esterno, in cui agiscono il coro, il capo del coro, ovvero il recitante, il personaggio principale, e l’uditorio; lo spazio interno del racconto, incentrato sulle vicende della narrazione. A seguito di questa iniziale distribuzione dei ruoli, il testo sarà costruito su specifiche regole estetiche che vogliono, non solo l’introduzione della musica tradizionale dello mpihira gasy e del bassessy, ma una ripartizione dello spazio scenico a rappresentare lo scontro tra l’individuo e la collettività. La zona più esterna sarà occupata dal capo del coro, o recitante, mediatore tra il racconto e l’uditorio, di conseguenza, tra le regole della comunità: «Oyez bonnes gens, nous sommes venus de très loin, de là-bas, de notre Ile Rouge au bout du monde. Nous sommes venus bonnes gens pour vous raconter l’histoire d’une femme ni belle ni laide, l’histoire d’une femme comme autant d’autres, l’histoire de Sambany […]»193 lo spettatore, quindi il coro che rappresenta la norma collettiva, la società, infine il personaggio principale che, come nel racconto tradizionale, è, l’eroe tragico, la vittima sacrificale nella misura in cui le sue azioni rappresentano una minaccia per l’equilibrio della collettività: «[…] Sambany, la stérile, la paria, la maudite […] la révoltée. […] Sambany est une femme, bonnes gens,/ comme tant d’autres […] Mais Sambany n’est pas normale, bonnes gens/ Sambany ne vous ressemble pas […]. Si vous la rencontrez/ Ne la regardez as/Fuyez-la, bonnes gens»194 I temi tradizionali ripresi e messi in scena dalla drammaturga per mezzo del personaggio Sambany possono riassumersi nel rispetto della regola comune, nel mantenimento del ruolo suddito della donna in una società patrilineare, nella rappresentazione della sterilità come infrazione 192 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le troupeau, op. cit., p. 25. Michèle Rakotoson, Sambany, op. cit., p. 4. 194 Ibid., p. 4. 193 175 dell’ordine naturale. L’evoluzione della storia di Sambany procede nel confronto scontro tra la realtà interna e la realtà esterna: atto primo, dalla casa al villaggio, Sambany, l’infetta, viola il rito sacro della fecondazione; atto secondo, dal villaggio alla città, Sambany vende il suo corpo; atto terzo, dalla città al paese, Sambany viola l’interdetto di accostarsi agli altri. Lo spostamento che l’autrice mette in atto, solo in apparenza riproduce quello del racconto di formazione africano. Il movimento non è mai circolare, ma sempre ellittico. A differenza di Koto e di Lafy, personaggi leggendari, a causa della mancanza di denaro, Sambany non arriva alla città che si era prefissa (Antananarivo), ma ad Antsirabe. Così, nel movimento inverso, la protagonista non ritorna al suo paese di origine, ma in un paese vicino. L’autrice reinterpreta l’opposizione individuo società, mondo ancestrale mondo moderno alla luce di una visione più politica che morale (come invece accadeva ancora nei due testi di cui abbiamo parlato in precedenza). La colpa di Sambany, prima della sterilità è il suo rifiuto della protagonista di rimettersi al giudizio collettivo: Sambany vuole essere normale, e anche consapevole della sua colpa, vuole continuare a condurre una vita normale195. L’infrazione dell’interdetto, sposta, quindi, la narrazione della vicenda di Sambany dalle convezioni tradizionali, al piano della realtà contemporanea (condizione femminile, rapporti di lavoro, rapporti di sfruttamento). Se molti critici hanno voluto vedere nel personaggio femminile di Sambany, nella lotta alla sua condizione servile, alla sterilità e all’interdetto che questa rappresenta, la condanna dell’autrice al mondo patriarcale ancora attuale in molti paesi africani, quindi una dichiarazione di engagement politico femminista da parte di Michèle Rakotoson, allo stesso tempo, come ricorda Fiangor, il ricorso al tema della sterilità è da ritenersi una circostanza abbastanza diffusa tra i drammaturghi africani contemporanei «En optant pour le recours au thème et à la fable, comme repère des sources d’attente, nous allons juste cibler ce que Shlomith Rimmon-Kenan appelle “le signifié global, homologue du dénominateur structural commun qui émerge sinon du tout, du moins de la plupart des aspects formels de l’œuvre littéraire”./Ainsi en sera-t-il de l’approche du phénomène de la sécheresse; de celui de la lutte pour la liberté et la justice (contre la dictature et la corruption) […]»196 Considerando la donna come una metafora poetica molto comune per indicare la patria, da cui già Rabemananjara aveva tratto ispirazione per Le Boutriers de l’Aurore, e alla luce di quanto osservato da Fiangor, si potrebbe allora interpretare il percorso iniziatico di Sambany, dalla 195 196 «Oui je suis révoltée, oui je suis paria,/mais je veux vivre, je veux être une femme, je veux être moi.», Ibid., p. 15. Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit, p. 118. 176 rivoluzione alla pazzia, alla dissoluzione, come la narrazione simbolica dell’opposizione tra il cittadino e il potere, e per estensione, come la riflessione sulle relazioni economiche e politiche che intercorrono tra i paesi occidentali e i paesi africani: tra le nazioni povere e le nazioni ricche. Chœur: «Stérile, paria, maudite/Sambany a quarante ans/Sambany n’est plus jolie./Samnay est folle.» Chef du Chœur: «Sambany fut une femme/comme une autre, comme tant d’autres/Ni belle ni laide, ni grande ni petite/Une femme/De côte est de notre île.»197 197 Ibid., p. 22. 177 Teatro e società: riflessione morale tra satira politica e engagement David Jaomanoro, Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Henri Rakotondrasoa, Narcisse Randriamirado Se si volesse analizzare il teatro malgascio a partire dagli anni 70, si arriverebbe a distinguere la produzione in due filoni principali: quello etnologico, di cui abbiamo appena parlato, quello politico e sociale. Come aveva già messo in evidenza Ganaba Abdulaye nel suo lavoro di analisi e censimento delle opere in concorso tra 1966 al 1973198 per il Concorso Interafricano, il Madagascar si rivela una voce a se stante nel contesto africano. Nonostante l’isola figuri, insieme all’Africa, tra i partecipanti privilegiati del concorso sin dalla sua costituzione, paradossalmente, e inaspettatamente, il teatro mauriziano si dimostra molto più vicino alle tematiche africane che non quello malgascio. All’eterogeneità del teatro africano, il Madagascar oppone una lettura monotematica della realtà che, come abbiamo visto, difficilmente parte con la riabilitazione della storia locale. A fronte di una produzione mauriziana e africana che nel 1973 copre una varietà stupefacente di temi: da quello storico a quello religioso, da quello etnologico a quello di costume e della realtà sociale, il Madagascar propone nello stesso anno una serie di testi teatrali tutti incentrati sull’analisi e sulla rappresentazione della società malgascia contemporanea199. Le ragioni di una frattura così evidente sono da ricercarsi nella diversa evoluzione del genere teatrale nel Madagascar rispetto all’Africa. La maggior parte delle storie del teatro africano convengono nel far risalire le prime esperienze di teatro africano di ispirazione occidentale alla scuola di William Ponty negli anni Trenta, allorché agli autori delle pièces, tutti liceali, era stato dato il compito di rappresentare e riprodurre attraverso le dinamiche teatrali, la struttura della società e il funzionamento della cultura d’origine. Invece, come abbiamo visto, già alla fine dell’Ottocento, e dopo una lunga evoluzione, il Madagascar era riuscito ad appropriarsi del canone occidentale per dare vita a un genere teatrale specificatamente malgascio, non solo per la lingua usata, ma soprattutto per i temi e per una diversa concezione del teatro che, potremmo definire, totale nell’esigere l’inserimento del canto e della danza a completamento delle parti recitate. 198 Ganaba Abdoulage, Analyse thématique et sociologique de pièces du Concours Théâtral Interafricain francophone de 1967/68 à 1973, op. cit. 199 Ibid., pp. 238-239. 178 Se il teatro africano si sviluppa anche e soprattutto in opposizione a una forma teatrale irreggimentata, manifestazione dell’educazione coloniale, non si può ignorare, invece, che il teatro malgascio moderno sia una continuazione del teatro classico tradizionale. Non stupisce, allora, che contro un’effervescenza di temi che caratterizza il teatro africano degli albori, un teatro «des questions à résoudre, des questions à poser […]. Le théâtre dogmaticien colonial a laissé place à un théâtre militant et réaliste […].»200, il teatro malgascio degli stessi anni sembra esaurire la sua contestazione nella dura censura morale della società malgascia postcoloniale. La componente morale del teatro malgascio non era (non è) solo il retaggio della cultura protestante trasmessa, trasferitasi attraverso i primi lavori teatrali a carattere religioso, soprattutto aveva (ha) origine dal rapporto particolare tra recitante e pubblico istituitosi con lo hira gasy: in cui la parola proferita veniva investita di un forte messaggio politico e morale (nel voler comunicare o riaffermare le leggi della comunità). Come il teatro della Grecia antica, così il teatro malgascio (già alla fine dell’Ottocento) ha un ruolo, anzitutto sociale, di formazione civica, il cui contenuto politico non si definisce a partire dall’opposizione al sistema coloniale: «[…] pour le théâtre et les théâtralisations sociales, l’homme se façonne de lui-même et c’est en ce sens que Schiller pensait que la tragédie grecque avait formé et construit le grec: idéal d’une vie qui ne réalise qu’une partie de ses aspirations, mais trouve dans l’art un accomplissement qui à la longue la transforme»201 quello stesso ruolo politico che sarà rivendicato e riconosciuto al teatro dai drammaturghi africani, invece, solo all’indomani dell’indipendenza proprio in reazione al sistema coloniale in difesa della nuova libertà acquisita e dell’antica sovranità usurpata202: «Dans cette Afrique [années soixante], le théâtre est conçu non seulement comme moyen de susciter chez les Africain une prise de conscience de leur identité en tant que “nation” […] mais aussi comme moyen d’exposer […] la vérité sordide de la colonisation […].»203 200 Koffi Kwahulé, Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain, Paris, L’Harmattan, 1986, p. 271. Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre, Paris, P.U.F., 1965, p. 5. Idea codivisa e ripresa da Michelet come ricorda Kotchy: «Le théâtre est le plus puissant système d’éducation, du rapprochement des hommes. C’est le meilleur espoir de rénovation nationale. Je parle d’un théâtre immensément populaire», B. Kotchy, La critique sociale dans l’œuvre théâtrale de Bernard Dadié, op. cit., p. 14. 202 «La première préoccupation […] du théâtre africain moderne est de s’inscrire dans la lutte d’émancipation de l’Afrique noire.», Bakory Traore, Le théâtre africain, réalités et perspectives, in Théâtre négro-africain, actes du Cololoque d’Abidjan, 1970, Paris, Présence Africaine, 1971, p. 56. 203 Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le théâtre ouest-africain francophone, op. cit., p. 63. 201 179 Le differenti premesse che sono alla base della nascita del teatro in Africa e nel Madagascar hanno sollecitato una diversa evoluzione del tema politico e sociale nei due paesi. Se, quindi, negli stessi anni (dalla metà degli anni 60 alla fine degli anni 80) la produzione malgascia e quella africana condividono il medesimo fine politico e istituzionale, pure dobbiamo riscontrare una diversa interpretazione del tema sociale stesso. Ayayi G. Apedo-Amah distingue tre grandi temi del teatro africano sviluppatisi a ridosso della decolonizzazione: l’anticolonialismo, il panafricanismo e la religione204. L’anticolonialismo si concretizzò con la messa a punto di un teatro storico, che ricostituisse l’identità nazionale a partire dei grandi eroi del passato, e di un teatro sociale incentrato sulla rimozione della figura del Bianco (personificazione del Male), quindi sull’esorcizzazione della cultura e della storia coloniale205. La rimozione terapeutica del trauma della schiavitù avveniva contemporaneamente alla costituzione di nuovi miti: quello della donna, in particolare, moglie e madre che riuniva tutte le accezioni positive della nuova Africa post-coloniale. Infine il tema religioso opponeva all’introduzione, quindi alla dominazione, dell’estraneo cristianesimo, la fede islamica originariamente africana. Divenuto Stato sovrano e Repubblica indipendente nel 1960, come molte altre nazioni africane, il Madagascar non sembra condividerne le frustrazioni, il suo teatro non sembra volerne assecondare la ribellione206. Non verranno mai sviluppati nelle pièces malgasce i soggetti della donna e dell’uomo Bianco, allo stesso modo della tematica religiosa. La madre, fecondatrice e rigeneratrice, sarà la grande assente della produzione degli anni 70. Se è ancora prematuro l’elaborazione del topos della sterilità (sviluppato nel teatro africano e malgascio verso la fine degli anni 80), ugualmente le pièces malgasce del decennio post-coloniale, mettono in scena ragazze adolescenti o che da poco hanno raggiunto la maturità, soprattutto ragazze orfane di madre, seducenti e seduttive come nel caso di Nicole, in Inclinez-vous sombres hypocrites di Fredon Emmanuel Anjararison207. Allo stesso modo, il Bianco, il Francese, è oggetto di ammirazione nella misura in cui la civiltà occidentale, di cui è emblema e propugnatore, si rivela custode della libertà dell’individuo, rispetto 204 Ayayi G. Apedo-Amah, L’histoire comme source d’inspiration du théâtre populaire négro-africain, op. cit., p. 37. «Les Blancs, sont dans plusieurs œuvres, les cibles d’une critique qui reste souvent radicale, qu’elle se présente en bien ou en mal. Partout persiste l’envie ou la nécessité de régler un compte avec de vieux démons […].», più avanti «Plus d’une dizaine de chefs d’inculpation sont alors dressés contre l’Europe par l’Afrique. Cela va de l’esclavage aux essais nucléaires sur le continent noir en passant par la colonisation et les pillages.», Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit, p. 74, p. 88. 206 Dobbiamo ricordare che l’acquisizione della libertà negli anni 60 non fu una conquista per il popolo malgascio, piuttosto la riparazione morale, tardiva, alla repressione del 47, i presupposti della quale implicavano comunque la salita al potere di un uomo di fiducia del governo francese (Tsiranana) che garantisse, in altri termini, il proseguo della colonizzazione nel Madagascar. 207 Fredon Emmanuel Anjararison, Inclinez-vous sombres hypocrites, Concours Théâtral Interafricain, DAEC coop., 1974. Riassunto p. 472. 205 180 a una cultura come quella malgascia che ostacola l’espressione del singolo per favorire quella comunitaria: la voce ancestrale208. A partire dagli anni 80, quando anche per gli stati africani sarà questione di una critica pungente ai costumi e alla politica locali (come prima nel Madagascar), si può constatare un avvicinamento, una convergenza tra i temi e le situazioni messi in scena. Il triste epilogo di un’emancipazione che si era annunciata come la rinascita dei popoli colonizzati (il cui dramma collettivo non poteva essere rappresentato se non dalla tragedia classica in cui il destino avverso nobilitava l’eroe che aveva voluto sfidarlo pur soccombendo209), mostrava, ora, sotto la luce abbagliante di guerre fratricide e di dittature militari, le miserie di intere nazioni che non erano riuscire a conformarsi agli alti modelli degli eroi, dei miti cui, pure, loro stessi avevano dato vita. Riscoperte per il loro ruolo politico, sottratte all’enfasi propagandista dei primi anni 60, le pièces che concorrono per R.F.I tra gli anni 70 e 80 sono tutte accomunate da un forte spirito contestatario, polemico proprio nei riguardi della politica locale, verso quella massa indistinta di presidenti, di ministri, di alti ufficiali idolatri del medesimo vessillo: il potere verde del dollaro. Il ritorno a una descrizione realistica si impone a un teatro che si vuole sostanzialmente impegnato nella riproduzione dell’orrore a cui la realtà contemporanea sembra voler abituare. Questo specchio che i nuovi drammaturghi promènent le long de la route non vuole essere solamente un strumento di riflessione per e sulla società, ma soprattutto un mezzo di autoriflessione210, che cela dietro la vena panflettistica, caustica di molti dialoghi, il serio impegno alla ricostruzione. Per questo motivo, come fa notare Fiangor, molte pièces di quegli anni riproducono il medesimo schema «La prise de conscience de l’existence d’un disfonctionnement, le repérage des éléments défaillants, puis l’engagement vers une forme de responsabilisation qui permette d’agir pour changer, réussir. […] Ce modèle d’implication pour le changement, pour une meilleure gestion de la société a été retenu par certains dramaturges pour présenter leurs pièces.»211 Il drammaturgo, testimone della desolante negoziazione con la vita e la morte, che il nuovo colonizzatore mette in scena alle spese del popolo, userà i suoi testi a un tempo per denunciare e per educare. Perché come dice Bakory Traore, il teatro unica tra le arti ad avere una vocazione 208 Michel Razafimandrato, Claudia, Concours Théâtral Interafricain, DAEC coop., 1970. Riassunto p. 471. Dominique Combe, Dominque Combe, La renaissance de la tragédie. Aimé Césaire, Kateb Yacine et Nietzsche, op. cit., p. 193. 210 «Le théâtre, c’est la vie qui s’analyse elle-même. L’Afrique éprouve non seulement le besoin de vivre, mais de se regarder. Le théâtre fait office de miroir […], donner à voir, […] donner à penser.», Bakory Traore, Le théâtre africain, réalités et perspectives, op. cit., p. 59. 211 Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., p. 72. 209 181 eminentemente sociale, non può prescindere dal ruolo inevitabilmente politico che gioca all’interno della comunità; neppure quel teatro che nega l’impegno politico per la sola aspirazione letteraria212: «Le théâtre africain est un théâtre politique qui vise à sensibiliser les Africains à leur exploitation, d’abord par les colonisateurs et ensuite par les Noirs-Blancs qui ne font que continuer le travail de leurs prédécesseurs.»213 Nata dalla disillusione del decennio post-coloniale214, la produzione teatrale che si profila agli inizi degli anni 80 si caratterizza, allora, per la sua vena fortemente satirica215. Come già aveva messo in luce Aristotele nella Poetica, la differenza tra la tragedia e la commedia risiede nei diversi personaggi di cui sono oggetto: eroi nella tragedia, «personaggi spregevoli»216 nella commedia. Una volta che la storia ha messo in evidenza il fallimento delle aspettative per la costituzione di un’Africa finalmente affrancata dal giogo della schiavitù (politica o economica), il naufragio delle quali era da imputare ai nuovi governanti neri, le qualità che avevano caratterizzato il personaggio bianco, il dileggio di cui era stato fatto oggetto nelle pièces degli anni 60, saranno ascritte al personaggio nero: «Mais dix ans après l’indépendance […] le théâtre ivoirien découvre avec embarras que des cadres du pouvoir colonial a germé un pouvoir autochtone, sorte de bourgeoisie aristocratique avec son cortège de […] corruption. Un changement de centre d’intérêt s’avérait indispensable, d’autant que l’histoire comme source des mythes devenait elle aussi embarrassante […] Avec la disparition progressive du personnage blanc, les Ivoiriens se retrouvaient face à eux-mêmes.»217 L’eroe tragico si scopre, allora, improvvisamente patetico, grottesco nel suo tentativo di sostenere la verità di una tragicità oramai posticcia. Se le qualità che esaltavano i protagonisti delle tragedie storiche, i termini che animavano il dramma animano le pièces naturalistiche degli anni 80, i toni della descrizione sono, invece, mutati. Come in un gioco di specchi, i titoli lusinghieri ed 212 Bakory Traore, Le théâtre africain, réalités et perspectives, op. cit., p. 58. Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le theatre ouest-africain francophone, op. cit., p. 65. 214 «Cependant dix ans après la décolonisation, à la fin des années soixante-dix, commende la désillusion. On découvre qu’en se retirant la colonisation a laissé derrière elle un limon funeste où d’autres tyrannies ont germé faisant le lit de la corruption des malversations en tout genre. Le théâtre se met à dénoncer le népotisme et toutes les perversités des dictatures qui rongent l’Afrique», Sylvie Chalaye, L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XX siècle, op. cit., p. 34. 215 «La satire est une censure indirecte à la quelle tout système culturel […] expose un individu ou un groupe d’individus dont le comportement compromet […] ces valeurs. Cette censure est indirecte dans la mesure où elle se réalise à travers l’ironie verbale et situationnelle, par la description de la réalité qu’on veut critiquer en la renversant.», Ben K’Anene Jukpor, Étude sur la satire dans le theatre ouest-africain francophone, op. cit., p. 38. 216 «La commedia è, come abbiamo detto, imitazione di persone più spregevoli, non però riguardo ad ogni male ma rispetto a quella parte del brutto che è il comico.», Aristotele, Poetica, traduzione di Domenico Pesce, Milano, Bompiani, 2000, p. 65. 217 Koffi Kwahulé, Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain, op. cit., pp. 22-23. 213 182 ispiranti, quali «pères de la nation», vengono ora abilmente rovesciati dai drammaturghi, a denunciare tutta la realtà blasfematoria di tali affermazioni: «Les acceptions qui désignaient les héros historiques […] sont utilisées mais renversées dans leur sens pour les personnages politiques contemporains»218 Come gli scrittori naturalisti dell’Ottocento, la fedeltà alla realtà contemporanea, di cui i drammaturghi della seconda metà del Novecento vogliono dare prova, sarà testimoniata dal ricorso a fatti di cronaca, a episodi della vita quotidiana spesso troppo velocemente accantonati dall’impazienza giornalistica di avere sempre uno sguardo proiettato verso il mondo, ma mai calato nelle cose del mondo. «Quelques exemples suffisent à prouver combien ces dramaturgies sont ancrées dans notre contemporanéité. Ce sont les violences modernes qui secouent ce théâtre, violence urbaine, violence familiale, violence économique, violence médiatique, violence sociale […]. “La tragédie aujourd’hui renaît avec le fait divers” comme l’écrit Alix de Morant à propos de Bintou de Koffi Kwahulé.»219 Sempre affascinato dall’analisi del rapporto tra l’uomo e il cotesto sociale, il teatro malgascio degli anni 80 ne è, quindi, la manifestazione più forte. Possiamo dividere la produzione in tre filoni principali: un primo gruppo di pièces ispirate al teatro morale di cui abbiamo parlato, e in cui ritroviamo Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato220, Narcisse Randriamirado221; un teatro prettamente politico e politico-satirico di Henri Rakotondrasoa222, o drammatico di Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato223; infine un teatro allegorico molto vicino al modello e alle atmosfere dei Morality Plays medievali, in cui si sono cimentati Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato224 e David Jaomanoro225. 218 Ali Baldo Suliman, Dramaturgie du Théâtre négro-africain d’expression française des indépendances à nos jours, op. cit., p. 177. 219 Sylvie Chalaye, L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XX siècle, op. cit., p. 36. 220 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le pain des autres, Paris, R.F.I., 1988, e La Pécheresse, Paris, RFI, 1988. 221 Narcisse Randriamirado, On ne vit que trois fois, Paris, R.F.I., 1988. 222 Henri Rakotondrasoa, Le comptable, Paris, R.F.I., 1985, e À bas l’apartheid, Paris, R.F.I., 1987. 223 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le prix de la paix, Paris, R.F.I., 1985. 224 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La paix du purgatoire, Paris, R.F.I., 1991 225 David Jaomanoro, J’ai marché dessus, Paris, R.F.I. 1988. 183 Prostitute e malfattori La pietas redentrice di Charlotte Rafenomanjato, la farsa irriverente di Narcisse Randriamirado226 Già abbiamo fatto riferimento, nel corso del paragrafo precedente, al contributo fondamentale della dottrina cristiana, della concezione del mondo gesuitica, nell’elaborazione della poetica di Charlotte Rafenomanjato, quindi nell’affermazione di una visione manichea nella censura morale del comportamento del singolo individuo all’interno della società227. Non stupisce, quindi, che in una produzione teatrale tra le più vaste e prolifiche del Madagascar contemporaneo, l’autrice abbia dedicato due opere228 specificatamente all’analisi del dramma morale dell’uomo di fronte alla definizione, redifinizione del peccato in un contesto come quello contemporaneo in cui il denaro sembra aver stabilito dei nuovi rapporti di valore. L’esemplarità dei caratteri che presuppone la rappresentazione della realtà intrisa del dogma cristiano, implicita in un teatro che si vuole anzitutto morale (quindi principalmente formativo per la comunità), si traduce nell’elaborazione di un prodotto teatrale certamente singolare in cui: da un lato è evidente il ricorso al realismo narrativo perché il messaggio possa arrivare allo spettatore icastico e scevro di ambiguità, dall’altro la reinterpretazione in chiave simbolica della realtà, non ultima la scelta di una cornice della vita quotidiana di per sé rappresentativa, come il piccolo appartamento di gente povera ma onesta, o i grandi lussi dei ricchi ma corrotti, denatura la rappresentazione realistica in vista di una messinscena tutta ideologica «Elle parvient à intéresser le public à ses prostituées au grand cœur; elle parvient à rendre attachant des personnages qui pourraient s’enliser dans le flou historique ou le folklore.»229 In una ripresa quasi sistematica delle parabole evangeliche, Rafenomanjato mette in scena il mondo delle prostitute, dei bambini, degli assassini, nel tentativo di riattualizzare il messaggio cristiano alla luce delle nuove esperienze che propone la realtà contemporanea. La pietas cristiana tocca non solo e non tanto prostitute dall’animo nobile, quanto piuttosto coloro che in genere vengono ammirati e emulati dalla società contemporanea per il ruolo che ivi rivestono (i Dahalo ne Le pain des autres, e il ricco ne La pécheresse). 226 Nato il 28 marzo del 1954, esercita l’attività di docente di letteratura francese nella scuola superiore. Autore di teatro e di novelle Dahalo, voleur de zébus, Grand-mère. 227 Françoise Ligier, Charlotte Rafenomanjato, op. cit., p. 27. 228 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le pain des autres, op. cit. Riassunto p. 478. Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La Pécheresse, op. cit. Riassunto pp. 477-478. 229 Françoise Ligier, Charlotte Rafenomanjato, op. cit., p. 28. 184 Rovesciando la morale comune, Rafenomanjato difende il mondo degli umili contro i potenti, portando in scena lo scandalo230 (peccatrici santificate, bambini salvatori degli adulti) come mezzo per attaccare la scala dei valori dell’uomo moderno: mercante di anime, profanatore della dignità umana: «Ce que tu dis est vrai, Luc. Tous les peuples doivent partager leur pain et leur amitié. Mais les malfaiteurs n’appartiennent à aucune nation. Nous devons lutter contre eux, main dans la main»231 La trama non sempre curata nella sua verosimiglianza, piena di improbabili colpi di scena (la morte improvvisa di Faja, a ruota, il decesso fatale del prete che avrebbe dovuto testimoniare in favore di Hanitra, il recupero momentaneo della lucidità di uomo in punto di morte), si rivela, quindi, totalmente asservita al messaggio morale sempre positivo ed edificante. Questo Bildungstheater del XX secolo mette in scena la perdita progressiva dei pregiudizi degli occidentali verso le altre culture ritenute inferiori, verso quei popoli considerati necessariamente dei corrotti perché diversi, ma anche la perdita delle diffidenze dei Malgasci verso gli Occidentali, quindi l’emancipazione di tale popolo dalla sua stessa perdizione (rappresentata dal riscatto morale dei Dahalo). Quindi l’accettazione ultima del concorso di colpa di ogni individuo nel creare una società corrotta, il riconoscimento della responsabilità morale collettiva nella scelta della ricchezza come metro per la disuguaglianza, l’arroganza e l’ipocrisia. «Je suis le seul coupable […] car c’est moi qui ai déclenché par mes provocations ce geste violent. Je croyais que ma position sociale et ma richesse étaient une supériorité et pouvaient m’autoriser à rabaisser des créatures humaines […].»232 Di tutt’altro tono la ricostruzione della realtà, certamente ludica, che mette in scena Narcisse Randriamirado. Da molti considerato teatro dell’assurdo per l’infrazione che l’autore produce nella percezione, quindi nella successiva riorganizzazione logica degli eventi (in Allons z’omelettes233 del 1991 il drammaturgo riproduce il tipico contesto familiare invertendo i ruoli uomo donna; nel caso di On ne vit que trois fois234 si diverte a confondere il sogno con la realtà), da noi è stato posto di seguito al teatro di Rafenomanjato per il medesimo intento morale che accomuna le due produzioni. 230 Dal greco skándalon, pietra di inciampo, insidia. Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le pain des autres, op. cit., p. 21. Riassunto p. 478. 232 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La Pécheresse, op. cit., pp. 48-49. 233 Narcisse Randriamirado, Allons z’omelettes, représentée à Antananarivo, 1991. 234 Narcisse Randriamirado, On ne vit que trois fois, op. cit. Riassunto pp. 481-482. 231 185 Lo sdoppiamento della realtà, come dei personaggi, di cui non si sa quale sia il vero; l’irruzione del reale nel surreale, offre lo spunto per una ricostruzione ironica, beffarda del mondo contemporaneo: Nicolas, angelo dallo sguardo diabolico235, “si prende gioco” alternativamente delle istituzioni e della morale costituita, passando da un incesto (reiterazione in età adulta dell’allattamento materno236), a una violazione dell’ordine gerarchico (la maestra diventa madre, in un’esaltazione mistica del proprio ruolo237), al compimento finale del blasfema da parte e attraverso la madre superiora, laddove Nicolas si rivela alla fine essere lui stesso un rappresentante della chiesa238. La critica, leggera, alle istituzioni, alla Chiesa come alla Scienza239 e alla morale è lungi dal voler assumere i soli colori malgasci. Di qui la decisione di non fornire alcuna indicazione sul tempo e il luogo in cui si svolge l’azione. Pure divertente, e affascinante nel gioco irrispettoso delle parti, il teatro di Randriamirado non si mostra mai così aderente alla realtà da riuscirne a criticare i meccanismi nel profondo. Le scene e i personaggi si susseguono senza che da questo caleidoscopico mondo, sempre scollato, si riesca a trarre un denominatore comune, se non lo spaesamento di cui resta testimonianza nell’ultima battuta, «Ça alors…le voyage dans le futur, c’est du verlan!». La polemica sulla censura praticata dagli uomini occidentali alla cultura e alla storia (p. 2), la critica all’uomo incapace di affrontare e di contrastare il reale, abile nel riesumare di volta in volta «la politique de l’autruche»240, si perde nella farsa finale dove tutto se non spiegato è giustificato. Certamente satirico, irriverente nei confronti della morale comune, Randriamirado costituisce l’ideale trait d’union tra la morale inflessibile di Rafenomanjato e la satira politica dei Henri Randrianierenana. La città del malcostume La parentesi del teatro morale per Rafenomanjato si è risolta in sole due opere, nonostante tutta la produzione dell’autrice sia dominata e orientata da una visione, da un giudizio rigoroso e inflessibile sull’agire umano. Alla base del lento esaurimento del teatro morale, ha certamente 235 Ibid., pp. 18-19. «Que ne ferait pas une mère pour son enfant. Ils ont beau grandir, se marier, gagner leur vie, devenir célèbres…une mère reste toujours une mère.», Ibid., p. 19. 237 «Une institutrice ce n’est pas seulement le participe passé et l’analyse grammaticale des mots soulignés», Ibid., p. 17. 238 «C’est…fascinant. L’extase divine…», Idid., p. 19. Profanazione del sacro che si concretizza nell’assimilazione della suora con la Madonna che allatta Gesù. 239 Serva più di se stessa, che dell’uomo, nell’usare l’individuo come oggetto sperimentale. 240 Ibid., p. 12. 236 186 contribuito sugli autori malgasci la consapevolezza che la società rifiuta e rifugge qualsiasi tipo di critica diretta alla sua condotta. Il giudizio sui mali di cui soffre il mondo contemporaneo, e in particolare la popolazione malgascia, è stato quindi spostato verso la censura politica che in Henri Rakotondrasoa si è risolta nella denuncia feroce dei costumi politici, a colpire gli uomini di governo allo stesso modo dei funzionari statali, senza ignorare il ruolo fondamentale dell’informazione nell’orientare l’opinione pubblica241; in Charlotte Rafenomanjato nella messa in scena del conflitto tra stato e cittadino fornendo le soluzioni per un progresso democratico e pacifico della comunità242. Due esperienze e due risposte divergenti sulla medesima realtà politica: da un lato, quindi, la visione disincantata di Rakotondrasoa, la rappresentazione satirica che restituisce della politica delle nuove dittature socialiste, sembra lasciare un margine insufficiente a offrire delle speranze concrete di cambiamento; dall’altro la riabilitazione del modello tragico tradizionale, con il riconoscimento, quindi, l’elaborazione di nuovi eroi contemporanei, permette, invece, la celebrazione dell’ideale umano e libertario contro la dittatura al potere. Charlotte Rafenomanjato ha vissuto, in poco più di un decennio come tanti altri Malgasci della sua generazione, la rapida metamorfosi del Madagascar da colonia francese, a stato indipendente, ma di fatto ancora assoggettato alla Francia tra il 1960 e il 1972, alla Repubblica socialista e militare di Ratsiraka, fautore di una malgascizzazione totalitaria più che sociale (affine al totalitarismo panafricano che negli stessi anni opprimeva le nazioni del Continente nero). Della sua esperienza di sopravvissuta al massacro freddamente eseguito dall’esercito una mattina del 1991, a danno di una folla pacifica di manifestanti, l’autrice ne ha fatto oggetto di una cronaca puntuale ma non per questo meno struggente nel suo romanzo testimonianza La marche de la liberté243. Ugualmente lucida e intensa la ricostruzione degli anni della dittatura che rivivono nella contestazione di Herinjato Haja244, combattuto tra la scelta della rivoluzione armata per sconfiggere il regime, o seguire la via della lotta pacifica già indicata da Gandhi. 241 Henri Rakotondrasoa, Le comptable, Paris, R.F.I., 1985; À bas l’apartheid, Paris, R.F.I., 1987. Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le prix de la paix, Paris, R.F.I., 1985. 243 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La marche de la liberté: Madagascar à l’aube du XX siècle, à toutes les victimes de la crise malgache, Saint-Denis, Azalées éd., 1992. «Le manifestations quotidiennes à Tananarive organisées depuis juin par l’opposition au régime du Président Didier Tsiranana mobilisent des dizaines des milliers de personnes et culminent le 10 août avec “la marche de la liberté” brutalement réprimée par les autorités. L’accord entre l’opposition et le régime intervient en novembre 1991 et débouche sur la mise en place des institutions provisoires. S’ensuivent le référendum constitutionnel (19 août 1992) et l’élection présidentielle (février 1993, victoire d’Albert Zafy chef de l’opposition).», The LCSH century, New York, Haworth Information Press, 1998. 244 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le prix de la paix, op. cit. 242 187 I riferimenti agli eventi di quegli anni sono a tal punto espliciti che, per sfuggire ad eventuali ritorsioni politiche, l’autrice dichiara, sin dalle prime battute, l’estraneità del testo ai fatti di cronaca. Questa procedura di autocensura, largamente diffusa, come dice Fiangor, tra gli scrittori africani degli anni 80, è la velata risposta alla necessità di un engagement morale e sociale richiesto all’autore da parte di una comunità progressivamente defraudata dei suoi diritti: «D’abord parce que plusieurs dramaturges s’attachent tellement à la réalité que la limite entre la fiction et le réel disparaît aux yeux du lecteur […] d’autres auteurs même dans le monde de la fiction n’hésitent pas à interpeller et à invectiver directement les acteurs d’un univers extra-diégétique nommé ou identifiable.»245 In questo secondo caso, allora, la negazione di ogni corrispondenza tra la finzione e la storia locale vorrebbe essere piuttosto l’affermazione di un preciso impegno politico assunto dallo scrittore proprio attraverso la rappresentazione teatrale (ricordando che il rapido sviluppo del teatro nei paesi africani, la sua sollecita diffusione, è da associarsi proprio al bisogno di partecipazione attiva e di rendere partecipe la popolazione alla politica locale). Il testo di Rafenomanjato si iscrive in questa concezione del teatro formatore dell’uomo animale sociale. Lo sguardo sul mondo contemporaneo, l’enumerazione infaticabile delle sofferenze del popolo non sfociano mai nella contestazione speculativa, fine a se stessa, sono piuttosto il pretesto per una riflessione positiva sull’impegno da assumere: «Certaines pièces […] notamment […] Le prix de la paix s’attellent particulièrement à proposer d’autres attitudes et positions que les œuvres jugent idéales et veulent ainsi aider le peuple à adopter ou au moins les y inciter.»246 Voleurs de la langue e del fuoco come già Prometeo, gli autori del teatro politico degli anni 80, e Rafenomanjato tra essi, hanno sottratto la tragedia agli dèi per consacrarla agli uomini. Perché il teatro potesse e possa tradurre l’ideologia astratta in pratica di vita è necessario che il modello rappresentato sia a un tempo esemplare, per le sue qualità, ma mai distante dall’uomo medio a cui il messaggio è rivolto. I personaggi che mette in scena il drammaturgo appartengono, quindi, a una classe media delusa dal potere e sensibile ai mali del popolo, di padri e madri che come loro vedono minacciato il futuro dei loro figli, quindi, della Nazione. Allo stesso modo, per fugare ogni sospetto ideologico da parte dello spettatore, quindi il suo istintivo rifiuto a proposizioni dogmatiche, il testo, la 245 246 Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., p. 112. Ibid., p. 130. 188 rappresentazione sarà concepita come una simulazione del reale: la tesi non è presentata, ma rappresentata, non è stabilita a priori, ma dimostrata nel corso della sua formazione. Il testo descriverà l’evoluzione politica di Haja che, a partire da una serie di scontri dialettici con i suoi oppositori ideali (Radera247, ricco commerciante alleato del potere e Jao-Hery248 avversario della lotta nella misura in cui favorisce il potere rispetto alle classi meno abbienti; i sostenitori della rivoluzione249) arriverà a rifiutare la lotta armata per una concezione rivoluzionaria che parte dal basso e ivi rimane (il potere non potendo approfittare di alcuna destabilizzazione improvvisa) per tutelare e difendere i più deboli: «Pour effacer la misère résidus de dizaine d’années d’asservissement et d’insécurité, il y a déjà la route tracée. Elle est longue, pacifique et laborieuse. Le travail est le seul levier qui puisse relever le niveau de vie d’une population […] les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, sont connus à toutes les Nations qui ont subis, comme nous, les nuits de la colonisation»250 La morte di uno dei due eroi, Jao-Heri, ucciso dal rivoluzoinario Rojo, la morte ideale dell’altro (reoconfesso di omicidio) se restituiscono gli eroi alla fatalità della tragedia greca, pure sottraggono il destino alla sua forza cieca, attribuendo al sacrificio dei due personaggi un senso: la preservazione del messaggio di pace ultimo atto rivoluzionario contro il potere: «…Avec le théâtre de Charlotte Rafenomanjato, on a l’impression d’entendre les chansons Zanety, l’Oum Khaltoum des haut-Palteaux, ou le Ba Gazy, la rythmique donné au piano instrument indissociable des foyers bourgeois…Et puis le théâtre de Charlotte n’est-il pas toujours un cri, un trop plein de révolte?»251 Il fallimento della rivoluzione socialista di Ratsiraka, l’avvento della dittatura militare, quindi il ripristino delle censura, la repressione ma soprattutto e innanzitutto l’impoverimento graduale del Madagascar, divenuta in soli dieci anni tra le ex-colonie francesi più indigenti, con le sue bidonville 247 «[…] Je crains que pour vous le mot de “Patrie” est vain, dans votre obscurantisme de riche et d’étalages insolents de vos biens […] continuez donc de vivre le chemin que vous appréciez: l’égoïsme face à la pauvreté.», Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, Le prix de la paix, op. cit., p. 9. 248 Haja: «Prenez donc la peine de diriger vos regards vers les troupeaux humains, loqueteux et pitoyables, qui fouillent les détritus pour une pitance indigne d’un être humain! […] Voyez nos paysans. Ils triment depuis l’aube jusqu’au soleil couchant et ont pour nourriture une ration de manioc!» Jao-Heri: «[…] Croyez-vous que la violence sort le chemin indiqué pour concrétiser votre idéal? […] Craignez que le remède ne soit pire que le mal. Cultivez le pragmatisme dans vos sentiments patriotiques […]. La violence ne pourra qu’apporter, sinon le chaos, au moins la recrudescence de la misère. Elle paralysera les forces vives qui travaillent […]. Elle réveillera les bas instincts de certains individus qui profiteront du désordre pour piller, violer […].», Ibid., pp. 1517. 249 «Ce complot, je dois vous le dire, est vaste et bien organisé. Toutes les armes sont prêtes dans des caches secrètes. Des milliers d’hommes et de femmes sont prêts au sacrifice de leur vie, pour une cause qu’ils jugent juste et nécessaire.», Haja, Ibid., p. 32. 250 Jao-Heri, Ibid., p. 38. 251 Françoise Ligier, Charlotte Rafenomanjato, op. cit., p. 28. 189 ad ingrassare i margini delle città di quei Malgasci dei villaggi emigrati nella capitale per trovare lavoro, era (ed è) la realtà post-coloniale con la quale molti scrittori engagés, che pure avevano sperato e sostenuto la rinascita nella Nazione malgascia, dovettero presto confrontarsi dopo gli anni 70. Il teatro di Rakotondrasoa rappresenta la lenta presa di coscienza del nuovo contesto sociale che si andava profilando nel Madagascar post-Tsiranana, dei nuovi assetti, equilibri politici ed economici che si costituivano tra il paese e le altre nazioni, tra i nuovi potenti e la classe operaia; il teatro riflette la graduale evoluzione del rapporto dello scrittore con questa nuova realtà: da una prima constatazione amara degli eventi, Le comptable252, a una successiva presa di posizione contestataria rispetto al mondo contemporaneo, À bas l’apartheid253. I due testi teatrali si rivelano, quindi, molto diversi nelle atmosfere e nel messaggio finale che da essi traspaiono. Da una prima descrizione drammatica degli eventi contemporanei, a manifestare la partecipazione ancora dolorosa, amara, più che disincantata, al contesto malgascio, si arriva, con la seconda pièce, a un’appropriazione del mezzo teatrale come manifesto, come strumento di denuncia per svegliare le coscienze. Per questo motivo, la prima opera sarà ancora conformata ai moduli del dramma naturalista, mettendo in scena un personaggio di estrazione umile (semplice impiegato di un’azienda statale), rappresentante di quella classe sociale che, cresciuta all’ombra del potere, è ignara dei meccanismi che la reggono, pur essendo il prodotto della sua ideologia, che impone il rispetto delle regole comuni per il migliore funzionamento della collettività. Motivo del dramma sarà la presa di coscienza delle dinamiche che reggono il sistema sociale: la frattura tra il mondo astratto della morale, e il mondo reale. Come nel teatro naturalista, il personaggio sarà posto di fronte alla scelta se assecondare la nuova realtà che si è profilata cedendo alle sue proposte lusinghiere, o al contrario condannare la possibilità di qualsiasi compromesso che possa minare l’integrità dell’individuo Harison: «Je ne pourrais jamais faire ça. Ce n’est pas légal.» Rabe: «Puisque c’est le D.G. qui te le demande, ici, la légalité c’est lui, non?»254 Meno idealizzati dei personaggi del teatro naturalista occidentale, le figure che popolano l’universo teatrale di Rakotondrasoa sono, anche se per gradi differenti e per le diverse possibilità che gli sono state offerte, delle anime sempre impure che agiscono per il proprio interesse prima che per la morale. Così, il dilemma di Harison è frutto piuttosto della malcelata delusione che la sua frode non gli arrecherà alcun beneficio 252 Henri Rakotondrasoa, Le comptable, op. cit. Riassunto p. 476. Henri Rakotondrasoa, À bas l’apartheid, op. cit. Riassunto pp. 476-477. 254 Henri Rakotondrasoa, Le comptable, op. cit., p. 16. 253 190 «C’est toujours les petits qu’on fait payer alors que leurs ventres [des politiques] éclatent de vols et de pots de vin.»255 come, pure, la resa è l’esito della meschina eppure consolante valutazione di essere solo una pedina, un esecutore del sistema256. L’idealismo, che resta prerogativa del solo autore si offre come punto di riflessione e opposizione a un sistema dove anche la giustizia è misurata sul denaro257, e dove il pensiero indipendente è denunciato come atto politico sovversivo: «Pour ce qui nous concerne, nous devons admettre que Dieu veille encore sur nous, heureusement aussi, nous sommes toujours vigilants. Et c’est ce que je vous demande maintenant travailler pour que cette société prospère en dépit des saboteurs.»258 Il giudizio assolutamente morale che muoveva la prima opera, frutto di una riflessione esterna alla struttura sociale malgascia, evolve in una satira acuta nel momento in cui l’autore decide di penetrare nel sistema del mondo politico contemporaneo. L’universo manicheo della prima opera, in cui si affrontavano vinti e vincitori, lascia il posto alla realtà più complessa del mondo dell’informazione, e degli equilibri mondiali, a cui la figura del dittatore, pure grottesca e patetica, si rivela sottomessa. Analizzando il regime autocratico nella sua specificità malgascia, poi africana, Rakotondrasoa arriva a riconoscere il fenomeno come la conseguenza del nuovo imperialismo occidentale, frutto di quel perverso equilibrio instauratosi con la guerra fredda in cui le ex-colonie, dopo Cuba, rientravano in una strategia politica che li voleva territori da conquistare ideologicamente contro il capitalismo americano, per i Russi, contro il comunismo sovietico, per gli Statunitensi. Mamadou: «Pourquoi le Président des Etats Unis ne nous aide-t-il pas? Pourquoi ne nous accorde-t-il pas plus d’aides pour surmonter la crise alors qu’il envoi le matériel militaire au Nicaragua par millions de dollars? […] Pourquoi les Présidents du monde capitaliste, la France, ne comprennent-ils pas que le manque d’aide pousserait les gouvernements africains vers la Russie? […] L’impérialisme? Ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement révolutionnaire africain.»259 255 . Ibid., p.17. Ibid., p. 31. 257 Ibid., p. 40. 258 Ibid., p. 79. 259 Henri Rakotondrasoa, À bas l’apartheid, op. cit, p. 35. 256 191 Alla luce di questa amara scoperta, le azioni dei governanti locali se da un lato vengono ridimensionate, manifestate in tutta la loro miseria (da qui la descrizione beffarda di Mamadou260), dall’altro rivelano tutto l’orrore, la meschinità degli stessi presidenti che giocano con il loro popolo261 così come con le instabilità politiche di altri stati, Israele, la Palestina, il Sudafrica262 per aumentare il prezzo del loro silenzio di fronte all’Occidente. Fondamentale per il mantenimento di questi equilibri, l’informazione si rivela alleata indissolubile del potere. Non solo nel testo sarà quindi più volte invocata e ricordata la censura, quindi la propaganda di regime come strumento di informazione, o disinformazione privilegiato da ogni dittatura; l’autore farà altresì riferimento alla responsabilità morale, al ruolo della carta stampata estera nell’incrementare fobie, nel rivelare false o mezze verità sulla politica dei paesi africani, serva essa stessa di una diversa dittatura, quella dei Bianchi excolonizzatori263. Lo sguardo lucido e implacabile su una realtà che sembra sempre uguale a se stessa (perché come ammette Mamadou, i presidenti muoiono ma le idee restano) fino a che le ex-colonie manterranno il loro legame di dipendenza e di sudditanza dai governi occidentali, non viene temperato dalle previsioni ottimistiche che si profilano nelle ultime battute di Djaffar. 260 «Ah, si j’étais Américain, Russe o Français […] mais ici je suis sous-utilisé, sous employé, sous-exploité.», Ibid., p. 42. Facciamo notare l’appropriazione, quindi l’ironica inversione di senso dei termini comunemente usati per definire lo stato sociale ed economico in cui versano le nazioni africane. E più avanti il delirio del dittatore continua: «Valet de l’Impérialisme…Opportuniste…Réactionnaire…Contre-révolutionnaire…Salaud. […] Interdit de séjour tant que je serai au pouvoir, et je suis Président à vie […] et même après moi car après moi, il n’y a que moi parce que ma politique est éternelle: je passe mais mes idées restent.», Ibid., p. 52. 261 Come mostra il drammaturgo, il potere dei dittatori, sostenuto dalle potenze straniere, è soprattutto la conseguenza delle lotte intestine che lacerano il popolo, distraendolo dal problema reale, la dittatura. Mamadou, paladino delle giustizia contro Pretoria, si rivela così ispiratore,istigatore della medesima guerra razziale, interetnica all’interno della sua isola perché possa mantenere il potere: « […] des familles “teint foncé” sont déjà sous la protection des forces de l’ordre dans les camps militaires […]. J’ai donné, personnellement, l’ordre de n’envoyer à Djerba que des soldats “petits oreilles”», Ibid., p. 64. Una politica non così dissimile da quella sudafricana «S’il y a l’apartheid en Afrique du Sud c’est que des capitalistes représentés par la clique de Pieter Botha trouvent dans un racisme déclaré et structuré le cadre de leur exploitations.», Ibid., p. 18. 262 Mamadou:«Le régime raciste de Pretoria agonise; s’il le faut nous enverrons des militaires pour aider le peuple sudafricain à se libérer. C’est notre devoir […]. En ce qui concerne e problème palestinien, notre position est la même: la reconnaissance de l’État palestinien par Israël» Dupont: «Est-ce que vous reconnaissez l’État d’Israël?» Moustafa: «À bas le colonialisme! À bas l’impérialisme! À bas l’apartheid! À bas le sionisme! À bas le capitalisme», Ibid., pp. 24-26. 263 L’autore gioca sulla dialettica tra i giornalisti locali e il giornalista francese, sulla diversa verità che dai loro racconti trapela, soprattutto sulla capacità della stampa estera di rileggere, e in un certo senso colorare, snaturare, i fatti iniziali. Lo sfogo di Abdou contro la censura instaurata dal regime viene così raccontata «Le jeune reporter de la radio — pourtant membre actif du Parti Inique Révolutionnaire du Président Mamadou — s’écria dans une crise de nerfs […] “Ce n’est pas vrai; tout ce qu’il vient de dire n’est que mensonge…Nous, les journalistes, nous sommes censurés, menacés, emprisonnés […]”», Ibid., p. 47. O ancora l’intervista rilasciata da Mamadou e Moustafa (i due Presidenti degli stati Africani in lotta contro Pretoria) si ritrasforma in una minaccia militare contro la politica occidentale: «En quittant les journalistes, le général Moustafa, flaqué du titre délirant de Grand Pionnier de la Révolution Africaine cria avec rage: “Nous n’avons pas peur de l’Impérialisme américain, unissons nos forces pour exterminer les Blancs de l’Afrique du Sud et balayer Israël de la carte politique du Moyen-Orient”.», Ibid., p. 26. 192 Ai dubbi del suo collega riguardo all’effettivo ruolo della stampa nella tutela del libero pensiero nella società contemporanea, una volta che si è scoperto essere un fantoccio del potere, Djaffar rivendica la libertà delle idee, quindi la forza delle parole, nel continuare ad agire anche dietro le formule di regime «Il reste l’espoir de la lutte…crois-moi: on arrive toujours à faire passer des messages aux masses […].»264. Tarda conversione all’ottimismo pronunciata alla fine di una feroce invettiva contro la stessa carta stampata che, di qualsiasi colore, sembra sempre essere al di là della verità. Apparenza e sostanza: il mondo ridotto alla sua essenza. La satira viene quindi in soccorso a un teatro alle prese con una realtà complessa, minacciata da un lato dalla censura, dalla persecuzione politica, dall’altro dalla defezione di quello stesso pubblico che si vuole educare, e che, narcotizzato dagli eventi e da una realtà più terribile di qualsiasi narrazione, è ormai insensibile a un’immagine patetica del proprio mondo. Per denunciare i mali della realtà contemporanea, per mettere la comunità di fronte alla precarietà della sua condizione, gli autori contemporanei reinterpretano la contingenza, le miserie del quotidiano alla luce di problematiche universali. Questo spostamento verso l’esterno è sempre più presente negli autori dell’ultima generazione interessati ai meccanismi della politica mondiale, di cui le ex-colonie, più nel male che nel bene, continuano a essere il riflesso265. Il racconto allegorico266 viene incontro a una rappresentazione morale, moralizzante del reale, da parte soprattutto di quegli autori formatisi all’universo cattolico: «On est ainsi sur le chemin de l’allégorie, et plusieurs auteurs n’hésitent pas à s’y engager plus avant, substituant à l’affrontement dramatique le choc des idées représentées par des personnages abstraits qui les incarnent. Ils retrouveront ainsi la curieuse forme théâtrale qui connut un grand succès en France à la fin du Moyen Age et que on désigne par le terme équivoque de moralité dramatique. Comme le cycle médiéval, le 264 Ibid., p. 69. «[…] l’indépendance est pour l’heure sinon nominale, du moins incomplète et précaire du fait de la structure économique qui a pour base l’économie de la traite […], l’implantation d’une agriculture dominée par des produits d’exporatations peu consommés par les autochtones mais dépendante des prix des pays importateurs.», Ayayi G. Apedo-Amah, L’histoire comme source d’inspiration du théâtre populaire négro-africain, op. cit., p. 24. 266 L’unione, o l’accostamento, di due realtà diverse sappiamo essere specifica di un’altra figura retorica: la metafora e nella sua accezione educativa, morale, l’allegoria. Il mondo dantesco ci ha abituato a una concezione dell’allegoria come «rappresentazione di idee e concetti o atti mediante figure e simboli» (Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli (a cura di), Dizionario etimologico della lingua italiana, Milano, Zanichelli, 1999, p. 84.); l’allegoria, si distingue dalla metafora, di cui pure è considerata l’estensione, per la sua «signification morale, psychologique ou théologique» (Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, P.U.F., 1998, p. 65). 265 193 cycle africain repose sur la volonté de montrer, derrière des personnages incarnés par des auteurs et ayant à dire un texte, des idées abstraites dont est proposé un rapport intellectuel.»267 Presentandosi sotto forma di racconto, l’allegoria nasce come tipo di narrazione semplice, accessibile a tutti nella misura in cui il mondo a cui fa riferimento è da tutti condiviso. Rispetto a un teatro impegnato o sperimentale (non sempre di facile accesso), la rappresentazione allegorica manifesta implicitamente il suo intento didattico nel ricorrere a un linguaggio di cui è in possesso, e di cui è partecipe, la maggior parte della popolazione. I miti, le leggende popolari e la religione, in particolare, la stessa superstizione, in genere, i sistemi culturali a cui tutti fanno riferimento, procedono secondo un meccanismo allegorico. Per quanto il linguaggio allegorico apartenga al sistema narrativo della tradizione (delle leggende attraverso cui veniva veicolato il divieto morale), nondimeno è da considerarsi tra le figure retoriche più apprezzate da quegli autori contemporanei che vogliono fare della rappresentazione teatrale una narrazione epica atta alla realizzazione della distanciation brechiana (fase che permette l’assunzione morale e politica dei mali della società da parte dello spettatore). Come abbiamo visto, gran parte del teatro malgascio è allegorico, soprattutto quel teatro che attinge alle leggende ancestrali di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo. Quello che ci interessa analizzare è il ruolo dell’allegoria nell’elaborazione di nuovi miti, di nuove leggende ispirate alla realtà contemporanea, nelle pièces di Charlotte Rafenomanjato, La paix du purgatoire268 e David Jaomanoro269, J’ai marché dessus270. La paix du purgatoire271 di Charlotte Rafenomanjato trae chiaramente ispirazione dal teatro medievale, di cui l’Everyman anglosassone rimane se non l’unica testimonianza almeno quella più conosciuta. Dobbiamo ricordare che le prime forme rudimentali di teatro occidentale vennero introdotte nel Madagascar proprio dai protestanti inglesi agli inizi del XIX secolo, e che Rafenomanjato, 267 Jacques Scherer, Le Théâtre en Afrique noire francophone, Paris, P.U.F., 1992, p. 98. Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La paix du purgatoire, Paris, R.F.I., 1991. 269 Nato il 30 dicembre del 1953, nel Nord del Madagascar da una famiglia numerosa e di umili origini (padre e madre entrambi agricoltori). Nonostante i suoi successi nello studio, lo scrittore ha dovuto interrompere i suo iter scolastico molto presto per contribuire al ménage familiare, continuando l’università per corrispondenza: «je côtoyais la misère tous les jours», confessa nel corso di un’intervista. La necessità di dover conciliare le sue ambizioni artistiche con i problemi economici si riflettono in una vita dove non mancano i sacrifici (nella stessa intervista racconta della situazione difficile in cui viveva al tempo della gestazione di La Retraite, lui, con la famiglia a dividere una piccola stanza universitaria). Vincitore di un premio letterario nel 1987, Jaomanoro arriva al teatro nel 1988 con una borsa di studio offerta da Limoges. Per la biografia abbiamo fatto riferimento a Liliale Ramarosoa, Anthologie de la littérature malgache d’expression française des années 80, op. cit., p. 238; e Gilles Costaz, Entretien avec David Jaomanoro, in La Retraite, David Jaomanoro, Morlanwelz, éd. Lansman, 1990, pp. 54-57. 270 David Jaomanoro, J’ai marché dessus, Paris, R.F.I. 1988. 271 Charlotte-Arrisoa Rafenomanjato, La paix du purgatoire, op. cit. 268 194 esponente dell’alta borghesia malgascia e formatasi nelle scuole private cattoliche, come pochi altri autori a lei contemporanei, è sicuramente sensibile a quel misticismo e a quel rigore morale caratteristici della narrazione allegorica della Bibbia. Non stupisce, allora, l’interesse degli autori contemporanei per la drammaturgia medievale dei mystery pays, la cui rappresentazione metaforica del vizio, delle passioni e delle degenerazioni umane sembra anticipare il conflitto moderno dell’uomo con se stesso. Diversamente dagli spettacoli medievali, il racconto allegorico della Rafenomananjato non perde mai di riferimento il contesto reale, volendosi sempre aderente alla realtà dell’uomo contemporaneo. I vizi e le virtù di cui narra la scrittrice non sono mai le entità astratte dei dogmi religiosi: l’Avarizia, l’Accidia, la Superbia sono i demoni della quotidianità di cui è possibile trovare traccia nei bambini denutriti e malarici, nei mutilati delle guerre civili, nelle madri dal seno consumato, nei volti consunti che sfilano ogni giorno sulle riviste e sugli schermi televisivi. Le rappresentazioni (della povertà, del malessere) che l’autrice rende problematiche a partire dall’opposizione vizio, virtù, quindi sfruttato, sfruttatore, umile, arrogante, onesto, corrotto, fungono come strumento di coscientizzazione per la collettività. La Voce del Popolo sarà quindi rappresentata come «une femme vêtue d’une longue robe lacérée»272, acompagnata da Monsieur la Faim «compositeur du Tiers Monde […] sa musique […] est pleine des dissonances»273, Madame la Guerre «lesbienne en chaleur accouplée à la mort»274, Monsieur l’Enfance Malheureuse «voix fluette et souffreteuse»275, Monsieur la Maladie «musique chaude et luisante, la fièvre paludéenne»276; il Grand Maître verrà identificato dallo stesso delirante linguaggio dei dittatori di tutti i tempi, di cui i molti presidenti africani sono la triste copia: Le Lecteur: «Je suis votre Guide bien-aimée, inscris-le dans ta mémoire pour les futures générations…et n’espère pas m’enfoncer sournoisement une couronne d’épine sur la tête […] Mes promesses mirifiques éveillent leur fantasmes […] je brille de leurs éclats, je suis soleil…quelle ivresse!»277 Le immagini che nel testo si susseguono mettono il luce i personaggi, a partire dal confronto che istituiscono con La Voce del Popolo (personaggio reietto e perseguitato della pièce): una Giustizia assente di cui ha preso il posto La Repressione; il Lettore: personaggio polivalente e ambiguo, allegoria dell’uomo comune, capace di prendere coscienza della realtà e dei mali perché reso 272 Ibid., p. 8. Ibid. 274 Ibid., p. 10. 275 Ibid., p. 14. 276 Ibid., p. 16. 277 Ibid., p. 6. 273 195 sensibile al Bene dal testo biblico; il Silenzio, alleato della Voce del Popolo nel voler frenare il delirio di onnipotenza del dittatore. Il Silenzio, elevato nel testo a restauratore ultimo della giustizia, è l’evoluzione di quell’ideale di lotta pacifica contro il potere dittatoriale che già ne Le Prix de la Paix, Rafenomanjato aveva proposto come scelta etica. Aiutando a ristabilire la verità dei fatti di fronte l’opinione pubblica (pronta a condannare qualsiasi atto di sovversione), il silenzio può, infatti, essere considerato il vero e unico alleato della rivoluzione, del cambiamento democratico. Se non direttamente ispirato all’universo della morale cristiana, pure, la storia di un piede infetto diventa per David Jaomanoro 278 la chiave di lettura del mondo contemporaneo, a cui far seguire la critica feroce alle iniquità che sempre hanno caratterizzato la condotta umana verso gli esseri più deboli, siano altri uomini o la fauna e la flora terrestre. A partire dalla cronaca che tristemente aggiorna sul traffico dei detriti radioattivi, del commercio di armi chimiche e batteriologice, l’autore mette in scena tre racconti differenti: un prologo fantascientifico; una storia, che seppure ispirata al racconto naturalistico, viola la successione logica degli eventi per mezzo dell’intercalare nervoso di flash back; un epilogo leggendario che racchiude l’insegnamento del testo. I tre universi rappresentati riflettono tre diverse modalità e gradi del racconto allegorico. Il prologo, ispirato al mondo dantesco, e alla legge del contrappasso, investe la scena di un chiaro contenuto morale; i tre personaggi, che si alternano in una realtà indefinita di fronte a un giudice robot, nei loro corpi mutilati279, sono la rappresentazione dei peccati contemporanei, come già i dannati dell’inferno. L’episodio centrale, modulato sulle dinamiche del racconto tradizionale, mette in scena l’opposizione tra la campagna e la città, le norme e le leggende della collettività, come l’acqua purificatrice e fecondatrice280, il sistema di simboli della comunità, probabilmente ispirato ai proverbi degli hain teny281. L’epilogo di cui Rwana è il narratore, è costruito sul modello del mito fondatore, proponendosi come una lettura simbolica della storia attuale282. 278 David, Jaomanoro, J’ai marché dessus, op. cit. Riassunto p. 482. Il primo uomo è rappresentato con una sola metà, senza un braccio, con una sola una gamba e senza una parte del viso: «Tu as vendu les armes chimiques à tes semblables. Tu as fondé ton confort matériel sur l’anéantissement de tes frères de sang.», Ibid., p. 2; Il secondo è privato della bocca: «bandit de la pire espèce. Tu es un vendeur de slogans, un semeur de troubles, un brouilleur de géographies et de couleurs.», Ibid., p. 3; del terzo non resta che un viso putrefatto e delle croste sulla schiena: «déchets atomiques, radioactifs […] tu es trop mauvais […].», Ibid., p. 3. 280 «Qui veut de l’eau?/De l’eau pour féconder les femmes stériles/De l’eau pour stériliser les femmes-lapines.», Ibid., p. 12. 281 Norohasy: «Quelle malédiction s’est abattue sur moi pour que ma poitrine brûle de mon premier homme. Quel méchant sorcier m’a jeté un mauvais sort pour que l’enfant de ma jeunesse devienne un enfant à l’œil unique?», Ibid., p. 18. «ma poitrine brûle» significa nel codice tradizionale, giovane vedova, «un enfant à l’œil unique», bambino orfano di uno dei due genitori. 282 Allo stesso modo dei miti di fondazione, il racconto è incentrato su questioni politiche. I personaggi rappresentati apparterranno tutti alla classe nobile, tre principi, a simboleggiare i tre continenti: l’Africa, l’America, l’Eurasia. 279 196 La seconda parte, che si propone come spiegazione e rappresentazione esemplare (per mezzo di esempio) dei due racconti metaforici ai lati, è quella che desta maggiore interesse. La cronaca della vicenda umana di Rwana, come abbiamo detto, ignora la sequenza logica del racconto tradizionale. La storia del protagonista sarà quindi proposta sulla scena a partire da un alternarsi di sketches slegati temporalmente gli uni dagli altri: quadro uno scena prima, presente, Rwana in ospedale; scena due 1973, Rwana incontra la ricca Bakoule, e regressione in un passato indeterminato in cui Rwana deve fuggire dal villaggio per l’invidia del fratello di Norohasy; scena tre presente, Rwana in fin di vita, nuova regressione in cui Rwana sconfigge in una disputa il fratello di Norohasy; quadro due scena prima Rwana tornato dal ballo si rende conto del suo piede malato; scene seguenti, presente, Rwana curato dalle tre donne si ristabilisce e inizia il suo racconto. La ricostruzione caleidoscopica della storia di Rwana obbedisce all’imperativo del racconto e della memoria, quindi della rimozione dell’interdetto e del riconoscimento del crimine. La regressione iniziale verso il passato dà vita all’alternarsi, quindi al confrontarsi successivo di vari stadi della memoria (il presente con le diverse gradazioni del passato) permettendo la ricostruzione finale del soggetto, quindi, come in una seduta psicanalitica, l’individuazione e la rimozione del problema (nell’ultima scena le tre donne saranno tutte riunite e conciliate accanto a Rwana guarito). Il procedere sconnesso si rivela mezzo per problematizzare i temi della realtà contemporanea e dell’eredità ancestrale, via via affrontati in un discorso iniziato e sempre bruscamente interrotto, perché possano essere restituiti alla scena in tutta la loro allarmante verità. L’autore si serve del testo per suggerire all’uditore delle piste, per lanciargli delle provocazioni, ripescando nelle paure, negli orrori del passato recente della colonizzazione «Ton mal n’est pas le mal des Blancs. Les Blancs ne peuvent rien pour toi, ni contre toi. Ce n’est pas non plus une maladie du pays. Tu n’es pas du pays. Ton mal, c’est le mal de ne pas avoir de pays»283 annunciando nuove catastrofi «[…] au fil des anecdotes politiques et historico-culturelles, au fil de la langue serpentine qui défie en traîtrise l’hameçon enfilé au dedans d’un ver de terre, malgré la clairvoyance de certains dirigeants qui ont prévu et décidé de déféquer leur matière grise polluée sur le terre d’autrui […] le peuple bêtifié n’a pas le droit de refuser sous peine d’expulsion […] par le bas de l’échelle sociale internationale socialiste»284 283 Ibid., p. 21. Come riesumazione in chiave satirica delle perversioni della scienza antropometrica del XX secolo, che stabiliva le tendenze criminali dell’individuo a partire dalla conformazione del cranio. Bakalo giudica il carattere delle persone, quindi delle genti che abitano il nord, il sud, l’est o l’ovest dell’isola, secondo la forma del loro naso, che rivelerebbe la generosità o l’avarizia della persona in base alla larghezza o alla piccolezza delle narici: «Tu devins aussi le caractères des gens en voyant leurs narines?», Ibid., p. 10. 284 Ibid., p. 4. 197 L’apparente happy end che chiude il testo (Rwana ristabilito e fortificato dalla sua esperienza di cui rimane l’unico testimone) è messo in ombra da una profetica ma quanto mai orribile rivelazione, a impedire all’uditorio la realizzazione di qualsivoglia identificazione con il personaggio, quindi la possibilità di qualsiasi procedimento catartico che risolva il conflitto messo in atto: Rwana: «Nous sommes tous victimes de ce marché de crottes qu’on fait au dessus de nos têtes»285 285 Ibid., p. 32. 198 Teatro del silenzio, tra sperimentazione linguistica e minimalismo narrativo Fidy Randriamirado, David Jaomanoro, Michèle Rakotoson, Jean-Luc Raharimanana La costituzione del Concorso Interafricano e poi del Concorso di Radio France Internazionale (R.F.I.), l’istituzione di borse a Limoges per sostenere la produzione teatrale francofona delle excolonie (soprattutto di quei paesi che hanno considerevoli difficoltà nell’investire sulla cultura286) hanno favorito, come abbiamo visto, lo sviluppo in soli pochi decenni di un’intensa attività teatrale nell’area africana e dell’Oceano Indiano (Madagascar e Maurice). La produzione si è distinta in particolar modo per l’eterogeneità dei temi (trattati nei paragrafi precedenti), ma anche per la diversità dei modelli adottati: dal tradizionale al classico francese del sei-ottocento, fino al teatro neoclassico di Giraudoux (al quale si è ispirato Rabemananjara). La possibilità di collocare l’attività letteraria in un periodo definito e il comportamento modulare di tale produzione287 fa pensare che il rapporto tra gli scrittori e il genere teatrale sia stato sempre instaurato in funzione di una risposta anzitutto sociale e sempre nel segno della sperimentazione, nella misura in cui il testo teatrale permette il confronto diretto con il pubblico. Non stupisce, allora, che tra gli anni 80 e la fine degli anni 90, gli stessi autori (Michèle Rakotoson e David Jaomanoro) si siano cimentati in generi diversissimi e per alcuni versi antitetici, come il teatro naturalistico e il teatro sperimentale francese e tedesco degli anni 50. Proprio il ritardo288 (se consideriamo la produzione degli anni 70 come una rinascita del teatro malgascio) con il quale le ex-colonie sono arrivate al teatro, il senso fortemente politico che in queste culture il genere riveste sin dal principio, quindi la necessità di un confronto costante tra la produzione e il mondo esteriore (caratterizzato da una violenza sempre maggiore e da cambiamenti sempre più 286 Nonostante già prima della colonizzazione nel Madagascar ci fosse una fiorente attività editoriale, le difficoltà economiche e politiche seguite alla decolonizzazione, quindi alla rivoluzione di Ratsiraka, hanno prodotto un declino della produzione, in considerazione anche dell’aumento dell’analfabetismo, e della censura che negli ultimi anni ha prodotto una fuga degli intellettuali dall’isola verso i paesi stranieri. 287 Possiamo distinguere due periodi principali: 40-70, dominati da una scarsa attività, anni 80 ai giorni nostri pieni di vivacità creativa. 288 L’apparente ritardo del teatro africano rispetto a quello europeo nell’utilizzo delle risorse del teatro brechtiano e artaudiano, che pure sembravano rispondere all’idea di rappresentazione totale tradizionale, si spiega secondo Thomas Melone a partire dal diverso sviluppo del genere nei due paesi (decisamente recente in Africa e comunque inizialmente ispirato alla tradizione europea del 600), e nel bisogno, nel decennio successivo alla decolonizzazione, di fare riferimento a un genere positivo che «par l’identification et non pas par la distanciation fournit des exemples à imiter […] c’est que le public en Afrique a besoin de s’affirmer, de se connaître et de se reconnaître comme groupe: aussi refuse-t-il d’être divisé, il réclame un théâtre de communion, d’unité idéologique.», Thomas Melone, La vie africaine et le langage théâtrale: Symbole et signification, in Le théâtre négro-africain, actes du colloque d’Abidjan, op. cit., p. 229. 199 rapidi e repentini), giustifica, secondo alcuni critici, la coesistenza di stili tanto diversi nel segno di una sperimentazione rapsodica289 del genere teatrale stesso: «Il n’est plus possible à présent pour le spectateur européen d’envisager le théâtre africain en tant qu’observateur “ethnographe”, amateur d’exotisme, ou sincèrement intéressé par l’étrangeté d’une théâtralité qui appartient à une autre culture […]. Aujourd’hui toute une série de dramaturges africains, revendiquent un théâtre au carrefour des cultures qui les traversent et les influencent […]. Il s’agit d’un théâtre brutalement travaillé par les contradictions du monde contemporain par ses antagonismes et qui provoque autant l’Europe que l’Amérique que l’Afrique.»290 Rivolti entrambi al mondo contemporaneo, il teatro naturalista e il teatro sperimentale rappresentano due versioni della medesima realtà, due visioni dello stesso fenomeno: l’una proiettata verso l’esterno, verso la formazione della coscienza politica del pubblico; l’altra decisamente meditativa, se si considera la scelta del linguaggio sull’azione, come una presa di posizione dell’autore a-ideologica ma ugualmente problematica nei confronti del contesto contemporaneo. La lettura delle pièces malgasce sperimentali mette tra l’altro in evidenza un uso indifferenziato di diversi modelli letterari. Per un lettore occidentale abituato alla classificazione in categorie e generi anche delle scuole poetiche sembra, se non contraddittorio, comunque improbabile, l’accostamento tra Beckett e Brecht, tra Artaud e l’espressionismo, essendo le premesse di ciascuna scuola, e/o stile teatrale che dir si voglia, completamente differenti. Contravvenendo a qualsiasi classificazione, i drammaturghi malgasci sembrano, invece, aver ritrovato all’origine di queste scuole così diverse il medesimo clima politico, non del tutto differente da quello che vivono gli autori contemporanei: periodo post-bellico (nel caso potremmo dire postcoloniale), totalitarismo e rappresaglie militari sulla popolazione (lo stato di guerra è tra l’altro sempre presente nei paesi governati dalle dittature), declino culturale (del mondo tradizionale, ma anche del sapere europeo), incertezza del futuro sia riguardo alle circostanze politiche (nonostante le ripetute manifestazioni, la dittatura di Ratsiraka ha avuto fine solo nel 2002) sia rispetto alla situazione economica e sociale (dettate da un emergenza sempre crescente), infine, l’esilio a cui sono stati costretti molti autori a causa della censura e della persecuzione 289 290 Per usare un termine caro a Jean-Pierre Sarrazac. Sylvie Chalaye, L’Afrique Noire et son Théâtre au tournant du XX siècle, op. cit., p. 35. 200 «C’est ainsi qu’il existe une influence brechtienne; peu nombreux sont ceux qui ont pratiqué le théâtre de Brecht, mais la plupart des autres auteurs ont rencontré les mêmes problèmes, ont utilisé les mêmes instruments de réflexion et sont parvenus à des résultats semblables.»291 Come già ai drammaturghi europei degli anni 50, così agli scrittori malgasci, il mondo appare fuori controllo, privo di senso, in quanto l’uomo ha perso la propria centralità nei confronti di una realtà politica sempre più difficile, che ignora e reprime la volontà popolare, rispetto a un contesto internazionale assente dalla costruzione della vita democratica di una nazione sottomessa, come pure, alla luce delle dinamiche, delle strategie economiche che muovono i consensi dei potenti del globo a dispetto delle ragioni dei singoli individui. Restituito alla fisicità di materia inerte, una volta che il mondo si è rivelato esistente al di là del suo agire, respinto e rifiutato dalla realtà esterna, l’uomo malgascio, non in modo diverso dall’uomo occidentale contemporaneo, si ritrova slegato dal contesto, senza poter più rintracciare, nel movimento delle cose, una logica consequenziale rispondente al rapporto di causa ed effetto (contrariamente alle filosofie ottocentesche per cui l’uomo, come soggetto agente, era unico interprete della realtà, solo legame tra mondo interiore e mondo esteriore). La produzione teatrale che si è andata delineando tra gli anni 80 e la fine degli anni 90 riflette la progressiva presa di coscienza della separazione dell’individuo dal contesto sociale: da un allontanamento volontario a una lacerazione traumatica. Il silenzio a cui è stata sottoposta la storia coloniale e precoloniale malgascia coinvolge, in questa seconda metà del XX secolo, l’attualità politica e la società dell’isola, degradate dalla corruzione morale e da una corruzione intellettuale e fisica conformemente a un analfabetismo in aumento e a una popolazione sempre più bisognosa. Rigettata la società accusata di ipocrisia verso i bisogni dell’essere umano, l’individuo diviene, invece, lui stesso, in un secondo momento, oggetto di rifiuto da parte della realtà esterna. La differente posizione che l’uomo, l’autore, decide di assumere verso la realtà, è all’origine di due espressioni drammatiche diverse: un teatro simbolista e un teatro, come abbiamo detto, rapsodico nella misura in cui è il risultato di teorie teatrali disparate, da quella espressionista a quella dell’assurdo. In base a questi presupposti, in risposta ai movimenti contrari che presiedono all’interpretazione del mondo (di chiusura alla società, da parte dell’uomo, e di negazione dell’uomo da parte della materia), lo spazio e la realtà assumeranno significati differenti. Da un lato, la parola si rivelerà chiusa al mondo per l’incapacità di quest’ultimo di coglierne la verità e la visione profetica, dall’altro, il linguaggio stesso in quanto indice della realtà, si negherà all’uomo che via via perderà finanche la capacità di articolare il discorso. 291 Jacques Scherer, Le théâtre en Afrique noire, op. cit., p. 110. 201 Lo spazio scenico, prodotto del rifiuto del mondo esterno, nel caso della rappresentazione simbolista malgascia, si rivelerà il compromesso tra il teatro naturalista e quello sperimentale, nella misura in cui la definizione e la lettura della realtà esterna rimane ancora dominio dell’individuo. Il mondo frantumato, paradossale delle opere di Michèle Rakotoson e David Jaomanoro, pure successivo a quello di Fidy Randriamirado di soli otto anni, sembra non trovare più i presupposti per un’immagine coerente della realtà; i pazzi di Raharimanana non condividono la volontà unificatrice, il sacrificio eroico del malato di Randriamirado. Le amnesie e la violenza verbale prodotto di uno scenario apocalittico, fanno difficoltà a riconoscersi nelle atmosfere volutamente rarefatte, mistiche, dell’ospedale di Jean. Se l’esteriorità del mondo preclude all’uomo (nel teatro simbolista e in quello dell’assurdo) la capacità di definirsi come soggetto psichico (il teatro naturalista parte dal presupposto che ogni personaggio ha delle caratteristiche peculiari che derivano dalla sua relazione con il mondo), solo nel teatro sperimentale impedirà all’individuo di ricostituirsi come soggetto metafisico. L’essere umano, che nel dramma simbolista di Randriamirado era ancora riconoscibile come eroe (proprio per la sua lotta contro il reale), non sarà più definibile, invece, nel teatro sperimentale, in opposizione al destino, al fato o alla volontà divina che gli è avversa, una volta che il suo agire è stato ridotto a una serie di movimenti slegati dettati dai bisogni primari «Dans une plongée dans une vie réelle, banale, les forces ou les instances naturelles ont remplacé les lois imprescriptibles de la fatalité: l’argent, la sexualité,la mort, la faim ont effacé les motivations nobles et le “regard de Dieu” braqué sur des personnages incapables de transiger avec le monde […]. Il n’affronte plus Dieu, il lutte contre sa misère et ses fantasmes»292 Divenuto cosa tra le cose, macchina ridotta ai suoi istinti, l’uomo messo in scena da Rakotoson, da Jaomanoro e Raharimanana è una creatura post-bellica: un essere informe che con i riferimenti spazio-temporali ha perso la memoria della Storia, di sé e del linguaggio. Se lo spazio è definibile come sistema di relazioni, nel momento in cui viene negata la validità dell’azione, lo spazio, non solo fisico ma anche concettuale, non avrà più nessun presupposto per esistere. Lo spazio diventerà allora il riflesso di un’azione frammentaria (perché incapace di arrivare a compimento) nel tentativo di definirsi e di giustificarsi, quindi di stabilirsi come fondamento. L’eterno ritorno dell’uguale a cui già il teatro di Beckett e di Ionesco avevano abituato con dialoghi presi dai libri stampati (pensiamo alla Cantatrice Chauve scritta prendendo a modello i dialoghi standard delle lezioni di inglese), viene riproposto in modo non del tutto dissimile dagli 292 Jean Duvignaud et Jean Lagoutte, Le théâtre contemporain culture et contre-culture, Paris, Larousse, 1974, pp. 5859. 202 scrittori malgasci nel momento in cui la ripetizione dei gesti e della parola avrà assunto lo stesso valore rituale293, allorché la parola vorrà essere la ricostruzione, la ripetizione di una conoscenza primigenia oramai svuotata di ogni significato. E, come nel rito, la parola avrà più un valore sciamanico che indicativo, sarà proiettata su se stessa piuttosto che verso l’esterno. Non stupisce allora che da una ritualità formale messa in scena da Rakotoson per mezzo di un linguaggio che si ripete nel tentativo di costituirsi memoria, si arriva alla ritualità dionsiaca di Raharimanana dove la parola raggiunge e completa l’azione nella sua violenza (una parola siffatta, sarà allora atto estremo di fondazione o al contrario delirio assoluto della negazione?). Un uomo, un personaggio ridotto a un linguaggio incoerente, vaniloquente nel momento in cui si risolve in un’operazione nevrotica e ossessiva degli stessi gesti, si rifletterà e rifletterà personaggi altrettanto reietti e degradati294. Le pièces saranno quindi popolate da folli295 (Raharimanana), da individui disumani, conseguenza di un lavoro al limite della dignità «fouille-poubelles» (Jaomanoro), da anime perse o corpi senza anima (Rakotoson), alle prese con un dio-drammaturgo, il solo dio rimasto a manovrare i fili dello spettacolo, sadico nella misura in cui mette a nudo tutta la nullità dell’essere, attraverso le gag: scene di violenza gratuita, esse stesse disarticolate dal contesto, all’origine di un riso istintivo (meccanico) e non riflessivo «Le gag implique une manipulation de la réalité qui constitue en fait une analyse de cette réalité bien plus profonde que la présentation des événements politiques et idéologiques. Il s’agit d’une contestation des gestes quotidiens […] dont la désagrégation nous place dans une situation inquiétante, “métaphysique” puisqu’elle met en cause l’ensemble de notre accord avec les modèles établis.»296 293 Nel teatro malgascio assisteremo a una assimilazione del teatro della crudeltà di Artaud al teatro-rito di Genet, nella misura in cui la violenza sanguinaria del rito assurge a metafora dell’assurdità dell’esistenza (Martin Esslin, Théatre de l’absurde, Paris, Buchet/Chastel, 1977, p. 205): «Le rituel sera donc choisi comme esthétique théâtrale au sens d’une forme qui résulte d’une analyse idéologique du vécu. […] Le théâtre-rituel ne sera pas donc en rupture avec la vie sociale mais l’engagera immédiatement. En devenant théâtre, le rituel moderne s’imposera de désacraliser , de démystifier, de montrer la technique.», Marie-José Hourantier, Du rituel au théâtre rituel, op. cit., p. 13. Rituale che però, come nel teatro di Genet, può diventare una messa in scena violenta dell’assurdità dello stesso ripertersi, Martin Esslin, Théatre de l’absurde, op. cit., p. 205. 294 «[…] silenzio, solitudine sono totali. Il risultato è una netta disumanizzazione di P., come in seguito a una regressione nella scala evolutiva dell’homo sapiens […] noto soprattutto per la mancanza di ricordi […].», Cesare Segre, Le strutture e il tempo, Torino, Einaudi, 1974, p. 258. Facciamo notare che la degradazione del personaggio, l’impossibilità di essere definito attraverso la sua azione ma anche attraverso i suoi discorsi, l’assenza quindi di qualsiasi presupposto psicologico a orientare la sua determinazione si riflette nella perdita progressiva del nome (elle, lui in Un Jour ma mémoir di Michèle Rakotoson), o nell’annullamento dello stesso, in favore di una totale identificazione con l’appellativo imposto dall’esterno (ancora una volta l’inversione del ruolo con la realtà che agisce sul personaggio senza che il personaggio possa agire sulla realtà): il profeta, il presidente, nelle pièces di Raharimanana. 295 «Les dramaturges africains, à l’instar de Shakespeare et de plusieurs autres grands auteurs qui ont utilisé à merveille et avec bonheur ces différentes perceptions du fou et de la folie, se sont aussi penché sur cette question.», Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., p. 145. 296 Jean Duvignaud et Jean Lagoutte, Le théâtre contemporain culture et contre-culture, op. cit., p. 42. 203 Se la degradazione fisica e mentale è la manifestazione della degradazione linguistica, la regressione dell’individuo si rifletterà in un linguaggio che ha perso la sua articolazione con il mondo esterno, quindi, sulla scena, in un dialogo interrotto incapace di ricostituirsi a partire dalla somma dei monologhi297. Questo perché, come atto rituale, il linguaggio è divenuto principalmente un atto difensivo prima che propositivo (il rito ha prima di tutto la funzione di conquistare i favori degli dèi) mettendo in scena dei personaggi che hanno scelto il silenzio (nonostante la violenza, la forza di un discorso quasi sempre gridato), che si sono chiusi nei loro monologhi come gli autistici. Nel teatro malgascio, il dialogo realista sarà sostituito dal monologo298, nel caso di Raharimanana, o dal falso dialogo299 in Rakotoson, oppure da una riformulazione in chiave economica300del dialogo originario, nel caso di Jaomanoro. Nel teatro sperimentale sarà, allora, questione di una duplice perdita dello spazio: lo spazio reale, soggetto della pièce e problematizzato sulla scena, e lo spazio teatrale in quanto luogo che riproduce e riflette la realtà esterna, nel momento in cui le parole non ne evocano più l’esistenza301. Questo spostamento dall’azione al linguaggio non presuppone, da parte degli autori malgasci, la possibilità di un’identificazione del personaggio con quanto da lui narrato. Esasperando i principi teorici da cui muovevano i drammaturghi occidentali del dopoguerra, gli autori malgasci costruiscono il loro mondo teatrale a partire da una realtà linguistica ridotta a citazione302 e poi, come atto rituale, all’autocitazione di se stesso. 297 «Peut-être la poussée des monologues dans le théâtre moderne et contemporain, cette tendance du monologue à supplanter le dialogue interpersonnel, n’aura-t-elle été que le symptôme d’un phénomène plus fondamental: reconstruire le dialogue sur la base d’un véritable dialogisme. […] Elargir le théâtre en faisant dialoguer les monologues: “Quand une situation exige un dialogue, notait Koltès, il est la confrontation de deux monologues qui cherchent à cohabiter.”.», Lexique du drame moderne et contemporain, sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac, Belval, Circé/poche, 2005, pp. 71-72. 298 «Un monologue qui ne sert pas, comme dans les dramaturgies classiques, à relancer le dialogue mais bien à le suspendre. Dans ce théâtre à tendance statique — ou statico-dynamique — les conflits sont plus larvés et intrapsychiques que patents et interpersonnels: la solitude soliloquante […] le délire […] la cacophonie […].», Ibid., p. 67. 299 «[…] relancer un discours d’un autre o “dialogue de sourds”, les interlocuteurs se parlent sans s’écouter.», Alain Couprie, Le théâtre, Paris, Nathan, 1995, p. 16. 300 Intendiamo per dialogo economico quel dialogo che ha ragione di esistere solo all’interno di un codice prestabilito e realizzato dagli interlocutori nel tentativo di orientare il discorso. Nel contesto preso in esame, la parola, mai scelta in funzione dell’interlocutore, si rivela un atto solipsistico non rivolto all’altro, alla comunicazione con l’altro, ma alla celebrazione di sé: un atto di comunicazione interrotta. 301 Se partiamo dal presupposto del teatro contemporaneo non è quello di rappresentare ma di presentare, è evidente che il teatro viene reinterpretato come spazio fisico che non riflette il reale, ma riflette sul reale, che non è epifania delle cose, ma del dire, che nell’atto stesso del dirsi si nega: «Dans un univers dépourvu de sens, il est toujours téméraire d’affirmer quelque chose: “ne pas vouloir dire, ne pas vouloir ce qu’on veut”.», Martin Esslin, Théatre de l’absurde, op. cit., p. 78. 302 «La fonction dominante est ici la référencialisation, et la relation entre le texte citant et le texte cité est largement constitutive du conteste global de l'œuvre . C’est notamment le cas du théâtre documentaire qui ramène à une réalité sociale et politique, mais aussi des formes variées de la parodie qui établissent un jeu de parallélismes et de contrastes avec les sources littéraires.», Lexique du drame moderne et contemporain, sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac, op. cit., pp. 45-46. 204 Un linguaggio autoriflessivo, che, come abbiamo detto, prima di dire è un dirsi, esprimerà in modo ancora più prepotente la rottura, la dissociazione con quanto espresso, nel momento in cui sostituirà il segno riconosciuto dalla collettività con un segno straniero ma non del tutto estraneo: la grafia malgascia con quella francese, costringendo la cultura malgascia a riconsiderarsi e a riscriversi attraverso il linguaggio francese, e allo steso tempo, interrompendo la continuità logica tra il referente originario, il significante francese, e il suo significato nella stessa cultura. Un linguaggio usato anzitutto e soprattutto per il suo valore metaforico riflette un tipo di teatro che, pure nello spaesamento di una realtà che si sottrae alla logica303, recupera la parola, finanche il silenzio, come atto di contestazione. Fidy Randrianarivo, Egal des Dieux Fidy Randriamirado rappresenta un’eccezione nel panorama letterario malgascio. Se gli autori, di cui abbiamo trattato finora, si sono ispirati alla cultura occidentale e francese come mezzo per rianimare il mondo ancestrale e dare voce alla sensibilità moderna; hanno sperimentato diversi linguaggi retorici, per appropriarsi definitivamente del teatro con lo scopo di testimoniare il confronto dialettico in atto all’interno dell’ex-colonia, il testo di Randriamirado non sembra partecipare delle medesime inquietudini, rifiutando qualsiasi confronto tra presente e passato, mostrandosi estraneo alle dinamiche, e alle questioni identitarie e politiche sollevate e mai risolte tra il mondo coloniale e precoloniale, avulso, quindi, dall’attualità malgascia come realtà post-coloniale. Sebbene pubblicata presso una casa editrice francese, l’opera del drammaturgo malgascio, Le testament304, non è stata mai fatta oggetto di studio. Se negli ultimi decenni, critici, come Robert Cornevin, Rogo Koffi Fiangor, Liliane Ramarosoa e Nivoelisoa Andrianjafy, si sono preoccupati di mettere a punto una retrospettiva diacronica e sincronica del teatro dell’Africa e del Madagascar, facendo riferimento ad autori come Michèle Rakotoson, o Josette Rakotondradrany (di cui non è stato possibile reperire i testi), in ciascuna delle loro analisi, Randrianarivo (classe 62) rimane 303 Samuel Beckett, Endgame, a play in 1 act, followed by Act without words, a mime for one player, New York, Grove Press, 1958. 304 Fidy Randrianarivo, Le testament. Tragédie en trois actes, Paris, La Pensée Universelle, 1982. Riassunto p. 475. 205 assente. Un rapido accenno gli è stato riservato sull’enciclopedia diretta da Harnold Waters nel 1988305. Partendo dalla premessa che l’autore ha abbandonato il Madascar molto giovane e che i modelli letterari a cui fa riferimento sono unicamente occidentali (Musset, Baudelaire, Maeterlinck), il critico giustifica lo scarso interesse riservato all’opera, da parte degli studiosi, come il risultato di un lavoro senza «classement ni pigmentation»306, difficilmente riconoscibile come malgascio. Ambientato in una casa di cura, i personaggi e lo scenario del testo non fanno riferimento alcuno alla situazione o alla realtà del Madagascar, viceversa, l’uso di nomi tipicamente francesi, come Jean, Pierre, Sylvie, l’atmosfera del dramma rivelano l’intenzione di Randriamirado di uniformarsi ai gusti e ai canoni letterari francesi e occidentali. Lo stesso drammaturgo, nella premessa, fornisce la chiave di lettura del dramma, indicando tra i modelli letterari Steinbeck di La valle dell’Eden, Michaux di Epreuves et exorcismes, e lungo il testo non mancano riferimenti a Chateaubriand, e citazioni musicali tratte da compositori tardo romatici come Wagner e Tchaïcowsky. Il rapporto conflittuale tra l’uomo e la realtà di cui il testo vuole essere la rappresentazione, esplicito nei modelli letterari a cui il drammaturgo si è ispirato, è a nostro avviso indice di quel rifiuto del mondo esterno che sperimentano la maggiorparte degli autori malgasci contemporanei esiliati dal Madagscar. Fidy Randriamirado riflette piuttosto quel sentimento di rifiuto della storia e della cultura non diverso da molte opere della fine degli anni 70 di cui abbiamo trattato nelle sezioni precedenti. Sebbene la pièce sia costruita intorno a personaggi ideali, a pure essenze dello spirito, nel tentativo di sottrarre l’opera al reale, pure, i riferimenti spazio-temporali, che l’autore fornisce all’inizio dell’opera, sono la voce di quel disagio e di quel senso di inadeguatezza, di insoddisfazione per il vecchio e il nuovo, per il presente e il passato specifici di un mondo postcoloniale collassato ancora retto dall’unica coscienza positiva che è l’uomo. In questa fase intermedia di perdita di riferimenti esterni (a causa delle dittature e dei movimenti politici ed economici internazionali), e successivo disconoscimento dell’unità della conoscenza e della memoria, collettiva e individuale, i paesaggi rarefatti di Randrianivo, i silenzi e il mistero dei suoi personaggi non sono il rifiuto della parola generatrice, piuttosto la destituzione di una realtà fallace e menzognera per mezzo dell’unica verità della parola. Pur essendo riconoscibili ed evidenti i riferimenti alla tradizione letteraria tardo romantica e simbolista nell’opposizione tra la parola epifanica e profetica e la contingenza mutevole e tiranna, Randrianivo sembra nondimeno attingere alla sensibilità malgascia nel dare voce e manifestazione a un verbo usato, nel testo, come realtà fondatrice per il fatto di essere segno in cui si riassumono a un 305 Harnold Waters (sous la direction), Théâtre Noir, encyclopédie des pièces écrites en français par des auteurs noirs, Washington, Three Continent Press, 1988. 306 Ibid., p. 69. 206 tempo il simbolo e la cosa, la materia e lo spirito, la rappresentazione del presente e la conoscenza del passato. Rispetto a una parola parmenidea, concreta nella sua perfezione immateriale, sottratta alle dinamiche della contingenza, la frattura tra la realtà e il mondo spirituale è ancora più evidente. Non stupiscono, quindi, nell’introduzione al testo, i riferimenti a Pascal, a Schopenhauer, ma anche a Marx allorché la struttura sociale, le sue convenzioni sono interpretati e denunciati dal poeta come il tentativo grossolano dell’uomo di sottrarsi alla sua realtà di finitezza e miseria «Au Lecteur/ Il y a des misères bienheureuses, celles qui délivrent de l’ennui par leur emprise sur la matière: la guerre, la faim, la maladie…Il en est d’autres […] qui écartèlent l’homme entre la munificence et le néant. Alors, les hommes ont construit le dogme: la société, la religion, la loi, la tradition, la conscience collective. […] Il faudrait que la misère matérielle n’existe pas pour que l’homme se rende compte de ses véritables échecs. […] Cette pièce représente ma vision personnelle de l’opposition évolutive entre la tragédie classique et le drame romantique […] À tous ceux qui ont le malheur d’exister.»307 Se la coscienza e la parola come testimonianza sembrano avere ancora ragione del reale, l’azione (al contrario delle pièces di Rafenomanjato, ma anche della stessa Rakotoson) sul reale soggetta a corruzione, sembra, invece, destinata all’insuccesso, nel momento in cui l’unica soluzione ai mali rimane il suicidio, e ancora prima, il silenzio, la comunicazione interrotta del protagonista con gli altri personaggi. Come nelle pièces di Maeterlinck, o di Strindberg, il testo di Randrinarivo è abitato da un unico personaggio308, definito eroe, di cui gli altri sono la proiezione, il riflesso, perché funzionali alla sua costruzione e alla sua definizione. Le ombre che si alternano intorno al misterioso individuo della camera numero dieci309, sono distinti dall’autore a partire dal ruolo che rivestono in rapporto a Jean: di opposizione, o di integrazione. L’opposizione sarà realizzata da quei personaggi considerati e conosciuti per il ruolo sociale che rivestono: i genitori, i giornalisti, il direttore dell’ospedale Le père: «C’est ça que je n’aime pas chez lui! Il se défie de tout le monde. À croire que la vie n’est pas pour lui qu’un simple jeu où il manipule les êtres avec cruauté» L’agent: «Que c’est beau! Mais qu’est-ce que ça veut dire?» L’infirmière: «[…]. Celui qui le saura le sauvera.» 307 Fidy Randrianarivo, Le testament, op. cit., pp. 11-13. «Au centre, source de toute lumière le héros, qui est le double du poète, autour de lui ses diffractions, les personnages qui émanent directement de lui.», Maurice Gravier, Le héros expressionniste, in Le théâtre moderne, hommes et tendances, études réunies par Jean Jacquot, Paris, CNRS, 1965, p. 123. 309 «Le type du 10», Fidy Randrianarivo, Le testament, op. cit., p. 17. 308 207 Le Directeur: «Mais s’ils n’y parviennent pas, les conséquences peuvent être catastrophiques. Il a déjà cru pouvoir s’en tirer une fois.»310 viceversa, Sylvie e Pierre, incuriositi da Jean, gli si avvicinano come anime alla ricerca del vero, alleggerite dal preconcetto, dal peso dei dogmi e dai rigidi codici sociali Sylvie: «Mais de quoi parle-t-il [le livre]?» Jean: «De la vie […]. Celle de tous les jours, celle dont personne ne parle. De ces événements que l’habitude plonge dans l’anonymat […]. Une version des Mémoires d’Outre Tombe.»311 Il personaggio di Jean si rivela scomodo per la società e per l’ordine costituito, nella misura in cui la lettura che offre della realtà, con il libro Testament (il testo che ha suscitato scalpore tra il pubblico di lettori e che l’autore paragona a Mémoire d’Outre Tombe312), e con le poesie che abbandona tra la sua biancheria come une bouteille à la mer313, è l’occasione per il drammaturgo di far agire nella pièce due diversi approcci alla vita: quello convenzionale e quello problematizzato. Partendo dall’assunto che la realtà manca di unità, per la diffrazione a cui costringono le diverse coscienze, il dramma ci propone due messinscene contrastanti, due differenti rappresentazioni di Jean: una patologica, l’altra profetica, a loro volta testimonianza di due movimenti: uno di repulsione (della società da parte del protagonista), e l’altro di allontanamento, di segregazione (del protagonista da parte della collettività) di Jean, rinchiuso in una casa di cura nella speranza che possa essere salvato dalla sua presunta follia: Jean: «Pourquoi se marier? Est-ce un acte d’amour ou un acte de possession? […] Bas les masques et sus à l’hypocrisie»314 l’altro di avvicinamento, da parte di Pierre, Sylvie e l’infermiera, che si rivelano suoi ideali discepoli Sylvie: «Peut-être a-t-il laissé une parcelle de lui-même en nous. C’est peut-être ça l’immortalité»315 310 Ibid., pp. 30-31, p. 18, p. 28. Ibid., p. 37. O ancora, Pierre: «Tu souffres?» / Jean: «Oui, j’ai vécu.» / Pierre: «C’était beau?» / Jean: «Oui…infiniment beau. Du ciel bleu où les larmes de la douleur se sont noyées à la terre rouge qui perpétue le cruel souvenir du sang versé.», Ibid., p. 57. 312 Ibid., p. 37. 313 Ibid, p. 18, Nuit de septembre; p. 48, Biographie; p. 56, Rêverie; p. 74, Au Hasard des routes; p. 107, Femme de minuit; p. 118, Rêves d’Hiver; p. 123, Egal des Dieux. Citiamo un estratto da Biographie «Un train pour nulle part/ […]/Des gens dans la gare/ Cherchant le chemin de leur vie/ […]/ Nous avons trop peur d’exister.», Ibid., p. 48. 314 Ibid., p. 76, p. 81. 315 Ibid., p. 125. 311 208 Il mondo ridotto ad essenze, l’evidente tentativo del drammaturgo di costituire un pièce totale (al modo dei simbolisti316) che, dando voce all’ignoto, possa denunciare l’insensatezza della realtà, si realizza a partire da un testo il cui misticismo si traduce nella messa in scena di personaggi ricalcati sulle figure del Vangelo. Sebbene, Jean, l’eroe, faccia uso di un lessico simile a quello del Messia «Moi, qui vous ai tous aimés.»317 e sia riconosciuto da Pierre come la reincarnazione ideale di Cristo: Pierre: «Le Christ est né en sachant qu’il ne vivrait pas. Lui mourra en sachant qu’il a vécu.»318 l’identificazione di Jean con il Cristo dei Vangeli (entrambi sobillatori morti a causa della società, l’uno ucciso, l’altro suicida) sarà solo parziale, dando luogo a un personaggio sfuggente perché doppio: a un tempo Cristo e Giovanni (fratello ideale del Cristo morente), vittima ed eroe sacrificale, assertore del mondo (l’uno che non ha vissuto), e negatore della vita (l’altro per aver troppo vissuto). Pierre, come il Pietro dei Vangeli, è il contraddittore, l’«homme sans âme», «un oiseau de passage»319, venuto a contemplare la verità della vita di cui Jean è depositario e testimone. L’infermiera, infine, privata del nome, identificata al ruolo che riveste nella società320, si rivela l’erede ideale del personaggio: «[…] s’assoit à table, prend un papier et un rayon et écrit lentement, en levant de temps en temps la tête, l’air absent. Nul ne bouge, ni ne dit mot. Mais cette musique, ces yeux…Qui sait?»321 316 Alla fine dell’Ottocento, il problema della costituzione di un’arte totale che esprimesse la realtà nella sua essenza venne sentito unitamente da poeti e musicisti. Non solo la parola scelta da Mallarmé doveva rispondere a precisi criteri di musicalità e di tonalità, la collaborazione tra poeti, musicisti e scenografi era sentita come fondamentale per la realizzazione di una ricerca nel senso della verità. Debussy arrangiò l’adattamento musicale de l’Après-midi d’un phaune, negli stessi anni Wagner e Nietzsche teorizzavano il teatro totale: «[…] Richard Wagner, che voleva fare del teatro un’ “opera d’atre totale” in cui confluissero poesia, musica e architettura, disegno che suscitasse esperienze emotive sublimi e illuminazioni profonde, in un pubblico che avrebbe assistitoa qualcosa di simile a un rito religioso; e quella del suo primo amco e poi antagonista Friederich Niezsche, impegnato a ricreare una grande tragedia a partire dallo “spirito della musica” e a propugnare la “rivalutazione di tutti i valori.”.», Martin Esslin, Il teatro moderno (1820-1920), Storia del teatro a cura di John Russell Brown, Bologna, Mulino, 1998, p. 362. La musica, come già gli intermezzi poetici, gioca un ruolo fondamentale nella pièce. Tutt’altro che etnica, i pezzi scelti appartengono alla tradizione musicale tardo romantica, simbolista di Wagner, Tristano e Isotta p. 42 e p. 122 La Morte di Isotta, Tchaïcowsky, Romeo e Giulietta p. 16, Il lago dei Cigni, p. 67, La sinfonia n VI p. 115, La Sinfonia n V p. 119, Debussy L’Après Midi d’un Faune p. 49, Holst I Pianeti p. 97. 317 Fidy Randrianarivo, Le testament, op. cit., p. 122. 318 Ibid., p. 106. 319 Ibid., p. 59, p. 63. 320 « […] Un personnage de comédie classique porte un nom qui quelquefois indique son défaut dominant [Harpagon] […]. Le héros du drame naturaliste est caractérisé par le fait qu’il a un nom et un prénom […] son prénom précise son identité, l’individualise, […] il est déterminé par ses ancêtres et par le milieu. […] Au contraire, pour les expressionnistes [et les symbolistes], un personnage de théâtre est essentiellement une âme. […].», tale che i nomi sono sostituiti da definizioni che indicano la ricerca dell’essere: «Personne», «Nomenlose», «L’Inconnu». Maurice Granire, Le héros exressionniste, in Le théâtre moderne, hommes et tendances, op. cit., pp. 118 – 120. 321 Fidy Randrianarivo, Le testament, op. cit., p. 125. 209 colei che, nonostante non sia personaggio di rilievo nel testo, è stata scelta sin dalle prime battute come depositaria del testamento spirituale del poeta (sarà lei di volta in volta a raccogliere le poesie) proprio perché, senza fare domande, ha accolto, accettato l’immagine dell’eroe per il mistero che incarnava. Opera che si apre sull’abisso delle questioni morali, per riscrivere e metter a nudo la storia dell’angelo caduto dalle ali coperte di fango, grottesco come l’albatros baudeleriano nel suo tentativo di volare e sfuggire al suo destino, il testo di Randrianarivo sembra sigillarsi nel silenzio, incapace di dare una risposta realmente positiva all’orrore dell’esistenza. « […] Et les larmes de Dieu qui frappent le front des êtres de bonne volonté. […] Et la douleur alourdit un cœur qui cherche l’espoir de la fuite. Mais l’ange déchu, qui est aussi tombé du ciel, bat vainement les 322 ailes appesanties par le poisse liquide.» David Jaomanoro, il boia dal volto mano Tra i motivi principali che, negli ultimi anni, concorrono a favorire una produzione sperimentale rispetto alla forma naturalista è certamente l’evoluzione del pubblico malgascio. La rappresentazione di un teatro in francese presuppone una profonda conoscenza della lingua perché l’uditorio possa recepire il messaggio di quanto viene rappresentato. Solo la generazione più giovane e successiva ai primi anni della rivoluzione socialista di Ratsiraka (che aveva bandito l’insegnamento del francese dalle scuole) risponde attualmente a tale caratteristica; si tratta di quello stesso pubblico di giovani che, attraverso le immagini sempre mutevoli dei giornali e della televisione, è avvezzo allo scollamento tra la parola e la sua rappresentazione, una platea ormai diffidente verso un teatro che si pone come raffigurazione oggettiva e totale della realtà esteriore. C’è da dire, oltretutto, che le pièces selezionate per il Concorso di Radio France Internationale sono per lo più rappresentate da troupes di attori e registi (Gérard Probst, Jean-Jacques Bellot, Pierre Forest, Jacques-Henri Delcamp) formatisi nelle scuole del nouveau théâtre ispirate ad Artaud e a Jarry323. 322 Ibid., p. 54. Gli argomenti qui esposti sono stati raccolti da Danielle Nivoelisoa Andrianjafy, Le théâtre. Une aubaine…pour une élite, op. cit. 323 210 A questo si aggiunge la preparazione stessa degli autori, principalmente francese ed europea, sensibile, come il suo pubblico, più della generazione precedente, a un tipo di teatro proiettato all’ascolto (piuttosto che alla rappresentazione) del reale. David Jaomanoro non ha difficoltà, quindi, a enumerare tra i suoi modelli, tra i suoi princìpi ispiratori, il teatro di Beckett. La rielaborazione del canone occidentale del teatro dell’assurdo di Beckett è tale nel teatro di Jaomanoro che a una prima lettura della pièce, La retraite324, si fatica a riconoscerne l’ascendente. La realtà malgascia è indiscutibilmente presente in quest’opera, poiché è riportata dall’autore con una fedeltà quasi cronachistica: le baraccopoli, che da sempre assediano le capitali sudamericane, nel Madagascar degli ultimi anni, si vanno sempre più confondendo con la periferia delle città malgasce; i personaggi di cui narra Jaomanoro esistono certamente in un mondo in cui si sono aggravate le disparità sociali, in una società dove le classi meno protette sono condannate a uno stato di emergenza continua. Certamente non lontana dal vero è la stessa situazione politica che l’autore si diverte a far apparire tra dichiarazioni a bassa voce e smentite dei due personaggi: una realtà corrotta, che vive di slogan e di false promesse elettorali 325 , quindi della disaffezione alle istituzioni del popolo, sempre più abituato a votare per abitudine, per una sorta di rispetto a una tradizione ormai instaurata con gli anni326, e non per fede o convinzione politica. L’apparente vicinanza del testo ai canoni del teatro naturalista, sembra confermata dall’attribuzione di un carattere, di una personalità di cui fanno mostra i vari personaggi. Si potrebbe facilmente considerare Raberaza l’emulo dei grandi truffatori delle pièces del teatro classico, dalla Commedia dell’Arte a Molière (del Tartuffe o del Bourgeois Gentilhomme), come pure si potrebbe ritrovare Ravao, in tutte le figure dei poveri sfruttati e reietti dei romanzi ottocenteschi. Se nel teatro classico, e nei romanzi dickensiani, i ruoli e il giudizio sui personaggi era definito in modo categorico a partire da una morale condivisa, dal momento che la Società, garante delle istituzioni, non era mai confusa con il personaggio negativo, nel teatro di Jaomanoro, l’accusato non 324 David Jaomanoro, La Retraite, op. cit. Bao: «La radio —celle des voisins, bien sûr— a annoncé hier, à la jeunesse intellectuelle, que des emplois seraient créés…» Raberaza: «[…] combien de fois faut-il te répéter que ce genre de chose n’est pas pour nous; c’est pour les autres ça.» Bao: «Mais nous sommes les autres aussi!» Raberaza: «Non, le autres, c’est les Mercedes, les BMW, les Pajero, les Ford, les fous, les grands, les petits-dos (en bondant le ventre), les longs bras, les hauts-chapeaux […]», Ibid., p. 10. Più avanti Raberaza: «J’étais le meilleur à l’école autochtone que je fréquentais, et aussi au concours d’entrée à l’école générale. Mais c’est le fils du chef du village qu’on a envoyé […].» Ibid., p. 29. 326 Raberaza: «Et moi, qu’est-ce que je suis?» Bao: «Un respectable fouille-poubelle qui vote oui tous les sept ans […]», Ibid., p. 10. 325 211 è il ramo secco della società, ma il sistema stesso, in una confusione dei ruoli e dei personaggi che lascia poco spazio all’assoluzione. Jamanoro si appropria di Beckett nel momento in cui, facendo agire le due situazioni al margine di Raberaza e Ravao, rivela l’assurdità non teorica (conseguente a una speculazione filosofica della realtà), ma quotidiana, effettiva dello stato sociale del Madagascar, di per sé disumana e borderline. L’iperbole327, come figura in cui convivono il mondo delle cose e la sua negazione, per eccesso negativo o positivo, di cui troviamo ampie citazioni nei testi di Beckett e Ionesco, nelle pièces di Jaomanoro, si rivela nel gioco stridente di due estremi ugualmente credibili, quello di Raberaza e Ravao, che devono contendersi il controllo dello spazio rispetto alla società. Raberaza e Ravao sono due rappresentanti della classe povera, due reietti dalla società: il primo è un accattone di professione, l’altra una ragazza madre di un bambino avuto da un dahalo. L’assurdo si rivelerà allorché la vita dei due personaggi viene messa a confronto dall’autore, viene fatta camminare in parallelo come in una sorta di esperimento scientifico328. Raberaza e Ravao, pure accomunati dalla medesima sorte, nondimeno sono due esseri opposti: l’uno, che si è conformato al sistema cercando di ricavarne i maggiori benefici con la minore fatica, ha scelto la discarica e la strada come sistema di vita; l’altra non smetterà mai di ricordare e di ricordarsi il proprio spaesamento di fronte a una realtà di cui non comprende i meccanismi, e di cui la strada329, retta continua senza principio ne fine, ripropone la perdita di riferimenti spaziali. Verranno poste due etiche a confronto: quella utilitaristica che si ispira alla morale comune del homo homini lupus 327 «A VENDRE / A ECHANGER CONTRE UNE VOITURE / A ECHANGER CONTE UNE MAISON / A ECHANGER CONTRE DU LINGE / A ECHANGER CONTRE UNE MONTRE… / A ECHANGER CONTRE DES CIGARETTES IMPORTEES.», Ibid., p. 47. 328 «Il n’est pas sans rapport avec le “réalisme élargi” dont parle Brecht ou avec ce que Günther Anders, à propos de Kafka et de Brecht, deux maîtres de la parabole — art du détour par excellence — définit comme un “réalisme expérimental”: “La science moderne de la Nature place son objet, pour sonder les secrets de la réalité, dans une situation artificielle, la situation expérimentale. Elle fabrique une structure, à l’intérieur de laquelle elle place son objet, en le déformant de ce fait même; mais il en résulte le constant de la forme […] Kafka, et Brecht après lui, agencent des situations caricaturales, à l’intérieur desquelles ils placent l’objet de leurs expériences — l’home d’aujourd’hui.”», Du drame moderne et contemporain, sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac, op. cit., pp. 59-60. 329 « […] tout se fait dans la rue: le grand commerce, le petit commerce, les études, les grèves, la messe, l’amour, les accouchements […], les plages, les montagnes, les bains […], les trouvailles, les pertes, les transactions, les révolutions, les religions […] », David Jaomanoro, La Retraite, op. cit., p. 14. A proposito dello spostamento verso l’esterno che suggerisce il testo (dalla casa di Bao alla strada), in n’intervista, Jaomanoro attribuisce il movimento alla particolare situazione di claustrofobia che viveva al tempo: «A l’époque j’avais un sentiment exacerbé d’étouffement. Marié, ère d’un fils, je vivais dans une pièce à la cité universitaire. L’obsession d’un espace plus grand a déclenché La Retraite, qui est un cheminement depuis un espace clos vers un espace ouvert. […] Elle va vers la rue, dans l’attente de voir celle-ci nous mener ailleurs.», Gilles Costaz, Entretien avec David Jaomanoro, op. cit., p. 55. L’interesse riservato alla strada da Jaomanoro, suggerisce diverse e più seducenti interpretazioni. Il movimento verso l’esterno, non solo indica un recupero di una certa tradizione antica, quella degli hain teny, tenute in strada dagli mpilalao, soprattutto fa ritornare alla mente la provocazione del Living theatre, «Il teatro è nella strada» di Julian Beck. Del resto, Jaomanoro, con lo spostamento di Raberaza dalla casa alla strada, dà modo al personaggio di allestire la sua particolare e quotidiana rappresentazione teatrale. 212 Zanety: «Mais papa nous gagnons assez avec le loyer des deux pièces […], pourquoi humilier vos enfants en faisant des travaux malpropres?» Raberaza: «Je me demande bien ce qu’on leur enseigne à l’école. De mon temps on apprendrait à compter, à spéculer…à vivre. Sinon, on serait encore une colonie à l’heure actuelle. Où va notre pays?»330 quella umanitaria (altrettanto condannabile nel suo passivismo) sublimata dalla situazione di emergenza, ascetica nel sostenere l’imperativo morale di difendere la propria e l’altrui dignità, rifuggendo la frode e l’avvilimento dell’essere Rabezara: «[…] Elle était vraiment formidable ton idée de se confier à la rue […] suffit de fermer les yeux pour mieux y voir. Les autres ont les yeux ouverts […] mais ne voient rien […].» Ravao: «Tu es un escroc, un voleur!» Raberaza: «[…] je ne prends rien à personne qu’on me donne. Et puis je ne fais rien que reprendre mon dû. Toute ma vie, j’ai été volé, escroqué, dépouillé, écorché, pompé, sucé […]»331 Jaomanoro, per mezzo dei due personaggi, gioca, quindi, con i luoghi comuni della società: promotrice di una morale individualista quando si asperge il capo di cenere per redimersi dal proprio peccato, sostenitrice di un’etica sociale, che non turbi la sua routine. In questo dedalo di contraddizioni, i confini tra sfruttato e sfruttatore vengono irrimediabilmente confusi, ognuno approfitta dell’altro conscio di essere allo stesso tempo usato, una perversione a partire della quale gli stessi termini tra realtà e surrealtà, tra verità e finzione, vengono riscritti e ridefiniti. Presi di volta in volta come referenti, la società (che sfiora quotidianamente le due esperienze), quindi l’autore che agisce attraverso i suoi personaggi, non ultimo lo spettatore che assiste alla scena, la morale della storia viene costantemente riscritta, riconfermata o smentita dalle diverse prospettive messe in campo, senza che dall’esperienza comune possa emergere una voce unitaria. Il mondo di Raberaza non sembrerà più paradossale di quello di Ravao che, pure incapace di vendere la figlia, decide in ultimo di abbandonarla sul ciglio della strada. Così, se l’atteggiamento di Raberaza è riprovevole e muove la nostra condanna, allo steso tempo sembra essere giustificato dalla situazione di disagio che è costretto a vivere e che è stato obbligato ad accettare a causa del sistema corrotto; ugualmente, la non azione di Ravao, la sua continua provocazione infastidiscono la società in scena non meno del pubblico che è in sala. 330 Ibid., p. 16. Notare il riferimento indiretto al periodo coloniale e al sistema scolastico francese, indicato indirettamente come responsabile della corruzione del pensiero moderno.. 331 Ibid., p. 40. 213 Conformemente a questo gioco di specchi che viene messo in scena da Jaomanoro, a partire dall’indeterminatezza della realtà messa in scena, i personaggi si riveleranno duplici: a un tempo loro stessi e altro (se mai è possibile alla fine definire caratterialmente gli uni rispetto agli altri). Raberaza è se stesso rispetto ai figli (un accattone) ma a un tempo altro («Vous n’êtes pas obligés de dire que vous avez ancore vos parents. Dites que vous êtes orphélins. Marquez “orphélins” dans vos fiches de tous les diables!»332), è quello che la società vuole che lui sia; finge per questo di essere altro recitando la commedia del cieco, ma solo la finzione sembra permettergli di essere veramente se stesso. Parlando a Ravao: Raberaza: «[…] faire le noir autour de soi pour y voir clair. Faire le vide pour être plein…S’anéantir pour mieux être. Se salir salement pour briller. Il faut se salir: la vie n’accepte pas les gens propres […] Les plus grands sont les plus sales de tous. Il faut mentir pour être entendu.» più avanti gridando alla folla: Raberaza:«Moi aussi j’ai fini pour oublier qu’on a bu mon sang, qu’on boit le sang de mes frères tous les jours, sous ce vaste ciel. […] je ferai ces rues les unes après les autres. Et dans ces rues je bâtirai l’avenir de ce peuple. Avec des montagnes de mots. Un océan de pertes. Un floque d’opprobre à la face de l’humanité»333 Le infinite sfumature della parola, si rivelano in questo uso duplice del linguaggio che è sempre al di là di quello che esprime per chi ascolta. Jaomanoro mette in scena tre diversi registri linguistici: 1- una parola-dialogo che è testimonianza e memoria, allorché Raberaza parla con Ravao 2- una parola-dialogo che definiremo grado zero, ché attinge ai luoghi comuni e ai proverbi, tra Raberaza e la moglie Bao 3- una parola-dialogo menzogna, in quanto deformazione della verità, tra Raberaza e la società. Le definizioni ora riportate devono prendere in considerazione che all’atto della loro enunciazione i gesti, quindi il corpo, negano quanto affermato dalle parole. I dialoghi tra Ravao e Raberaza rivelano la sofferenza di un uomo che è stato costretto a scendere a patti con la realtà per sopravvivere, non un cinico, ma una vittima del sistema. Allo stesso tempo, la scelta di scendere in strada per darsi all’accattonaggio smentisce di fatto la sincerità di una confessione appena sussurrata (Bao, rientrando, scopre i due che parlano a voce bassa accanto al 332 333 Ibid., p. 16. Ibid., 40, p. 45. 214 fuoco), tale che, di fronte all’azione, la parola perde il suo aspetto esistenziale per diventare frase fatta: «la vérité, c’est le mensonge»334: Raberaza: «Tu appelles ça ne pas travailler? Sortir vers le milieu de l’après-midi et ne rentrer que très tard dans la soirée; ensuite préparer ce qu’on a trouvé, de manière à le rendre comestible […] Le véritable travail c’est quand les autres se moquent de toi […] Le travail, c’est supporter les autres tout en sachant que les billets qui gonflent leurs poches, c’est sur ton dos qu’ils les prennent […] Pour ton salaire, on t’injurie; on t’apporte, le soir, son caca de la journée bien enveloppé dans du papier journal. Gare au destinataire di colis! Joli cadeau!»335 Così, il dialogo tra Bao e Rabezara, sempre sottolineato dalle gag336, come nel teatro di Ionesco o di Beckett, solo per il fatto di essere assunto a priori a prescindere dall’esperienza dei singoli, è privato di ogni valore referenziale. Bao e Raberaza si esprimono ed esprimono la loro condizione parlando per proverbi e per luoghi comuni: essere sempre più furbi degli altri, sfruttare per non essere sfruttati. In un’inversione postuma del senso comune, la legge non risiede più nella parola scritta che invece smentirà la parola urlata, negherà l’evidenza di quanto detto: il poetico cartoncino di Raberaza «Mes yeux à tout jamais/sont fermés à tes charmes/ O ma rue»337, allo stesso modo degli occhiali neri coprono la verità delle dichiarazioni del finto cieco a rivelare che nemmeno la strada che pure tutti accoglie, nemmeno il linguaggio che pure da tutti è condiviso ha per tutti il medesimo valore: Ravao: «Dire qu’il y a des gens qui se la coulent douce en jouant la comédie…Comme papa Rabe […]. Mais les vrais, les authentiques misérables, est-ce que on les remarque seulement? Je l’entends encore répéter: “La rue ne fait pas de démagogie.”. Mon œil! Même la rue est partiale…»338 334 Ibid., p. 40. Ibid., p. 27. 336 L’assurdo si rivela nella dissonanza di due realtà, in apparenza simili, messe a confronto: grottesca l’una, patetica l’altra. Se uno degli strumenti più usati dai drammaturghi degli anni 50 per esprimere l’assurdo, e per rappresentare la degradazione umana era la gag, Bao e Raberaza ci vengono sempre rappresentati nell’atto di litigare, di insultarsi (Bao che chiama Raberaza «Bakako»), di stuzzicarsi come due fanciulli innamorati tra i rifiuti della discarica. Ravao, al loro opposto, incapace di agire sul reale, sarà la raffigurazione di uno stanco, un esangue patetismo, esso stesso caricaturale, nella misura in cui l’atto di opposizione al reale si risolve in un protesta, il grido in minaccia: «Je ne peux pas souffrir/le contact de nos deux gales réunies/tu pues la gale/et moi la fièvre//La fièvre d’aimer/à en hurler/La fièvre de vivre/à en hurler/Huuuurler», David Jaomanoro, La Retraite, op. cit., p. 35. Più avanti Ravao: «Poussée par la faim, tu le seras toute la vie. Nous autres nous sommes faits pour ça […] Je suis fatiguée de cette lutte que notre race mène depuis toujours…[…] Moi, ce qui me tue, c’est l’inégalité de la lutte. Si seulement nous avions une chance, si seulement je pouvais espérer…», Ibid., p. 50. 337 Ibid., p. 23. 338 Ibid., p. 52. 335 215 Michèle Rakotoson, La storia, la memoria e l’oblio Con Michèle Rakotoson entriamo nel vivo dell’elaborazione e della rappresentazione del teatro sperimentale. Regista e attrice, come molti altri drammaturghi contemporanei, le opere sono frutto di una concezione del teatro, piuttosto recente, per cui il testo scritto non sembra poter prescindere dalla sua messinscena. Non solo la pièce viene, quindi, elaborata a partire da una sintesi ideale tra scritto e rappresentazione, ma in ordine a questa concezione, il testo rimane un sistema aperto, mai concluso, eternamente dialogante con la realtà contemporanea e modificabile secondo le esigenze sceniche. L’elaborazione scritta dei testi di Rakotoson riflette, allora, una sperimentazione che fa riferimento, a un tempo, alla parola come segno/grafema (testo scritto) e alla parola come indice (messinscena). Insieme a Charlotte–Arrisoa Rafenomanjato, Michèle Rakotoson è certamente la più prolifica autrice di teatro malgascio contemporaneo; un teatro che, a parer suo, non può esimersi, come già prima di lei per Rabearivelo, dalla sperimentazione linguistica, riflettendosi di conseguenza in una produzione spesso duplice, prima francese e poi malgascia. La questione del rinnovarsi continuo, della ricostituzione dell’elocuzione, quindi della coincidenza tra significante e significato, tra realtà e segno, è certamente problematica in un paese come il Madagascar soggetto, in passato, a un duplice interdetto linguistico: durante la colonizzazione, con l’inibizione del malgascio in favore del francese, tra gli anni 70 e 80, con il veto dell’uso del francese per una ricostituzione e riabilitazione radicale della cultura ancestrale. Ciò che caratterizza il mondo malgascio coloniale e post-coloniale è, allora, l’essere sempre al di qua della parola proferita, sempre oltre la realtà formulata, nell’enunciazione che è pratica rinnovata della negazione della storia. L’atto linguistico non può prescindere, di conseguenza, nel teatro di Rakotoson, dalla riformulazione del trauma: del passato, quindi della storia malgascia (confermando quanto già osservato nel primo paragrafo), e del presente, allorché la parola negata diventa manifestazione del disagio verso la politica e la società contemporanee. Il percorso teatrale e letterario di Michèle Rakotoson è iniziato, come abbiamo visto, nel 1979, con la premiazione di Sambany al Concorso di R.F.I. La scelta dello hira gasy come luogo di espressione del teatro malgascio, si è andata evolvendo, nelle opere successive, verso la scomposizione di questa particolare forma cantata, recitata e danzata del Madagascar tradizionale. Michèle Rakotoson ha fatto di questa prima esperienza e rielaborazione del teatro etnologico, come abbiamo già analizzato nella sezione precedete, il principio per una reinterpretazione del canone linguistico tradizionale e del canone linguistico e teatrale occidentale. 216 La maison morte339 e Un jour ma mémoire340 si collocano in questa fase di sperimentazione che coinvolge a un tempo la dimensione enunciativa e quella conativa, quella poetica e fatica del linguaggio341, nella misura in cui il teatro di Rakotoson, pure nel silenzio e a partire dalla destabilizzazione, dalla disarticolazione della parola, tenta di ristabilire e di rifondare il legame con il proprio uditorio ancora una volta e unicamente attraverso l’epifania linguistica. Le due pièces, raccolte nel medesimo volume, potrebbero essere considerate due ricostruzioni di uno stesso evento, la rivoluzione, a partire da due prospettive differenti: quella del potere e quella del popolo. Mentre, la rivoluzione è interpretata dal potere centrale come possibilità di un rinnovamento solo nominale dei vertici (nell’affermazione dell’eterno ritorno dell’uguale degli eventi storici), per l’individuo, la presa di coscienza della realtà rappresenta di per sé un atto rivoluzionario. Un jour ma mémoire, come sembra suggerire il titolo, è un’immagine aperta che si propone a un tempo come l’occasione per la memoria ricostituita di ingaggiare la lotta contro il potere (la donna uccide il militare) o, come la manifestazione della sospensione di qualsiasi memoria, di una memoria ancora da ricostruire (la donna che parla con l’uomo ormai diventato scheletro), in una rappresentazione tutta immaginaria di conflitti ancora lontani. L’uso del linguaggio varierà, quindi, nei due testi messi a confronto, in proporzione al valore stesso che l’atto linguistico assume per i personaggi: al linguaggio pieno e metaforico della prima pièce (linguaggio e rappresentazione linguistica del potere), si oppone un linguaggio vuoto, alla ricerca della sua definizione e della sua rifondazione attraverso il gesto, l’atto rituale che precede la parola stessa (il ballo, la simulazione di eventi passati, la soppressione del simbolo del potere). La maison morte, Un jour ma mémoire La pièce, La maison morte, ha un valore immediatamente politico; conformandosi a una tendenza del teatro africano contemporaneo, il testo vuole essere una riflessione, quindi un’analisi e un’accusa alle istituzioni di molti paesi moderni che, invocando il benessere collettivo in nome della rivoluzione e della democrazia, hanno condotto intere nazioni prima alla dittatura poi a uno stato di indigenza vieppiù crescente. La ricostruzione degli episodi di storia attuale parte dall’assunzione di un immaginario collettivo e letterario condiviso e riproposto da numerose opere teatrali degli anni 90, interessato a fornire 339 Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit. Riassunto p. 474. Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit. Riassunto p. 475. 341 Jakobson distingue sei funzioni del codice linguistico: referenziale, conativa, espressiva, metalinguistica, poetica e fatica. Se la dimensione referenziale e quella poetica si riferiscono all’atto linguistico in sé, l’atto conativo e quello fatico prendono in considerazione il legame tra il locutore e il destinatario. «Le conatif est un type de formation verbale propre à exprimer l’effort.», mentre si definisce la funzione fatica come «l’acte de communication qui a pour fin d’assurer ou de maintenir le contact entre le locuteur et le destinatarie.», Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, 1994, p. 106, p. 358. 340 217 un’immagine del dittatore, certamente simbolica, desunta interamente dalla sua attività politica e secondo la quale: alla realtà di un governo corrotto, dispotico corrisponde un personaggio chiuso in una torre342, separato dal mondo esterno di cui rifugge ogni contatto: Radriamabé: «Ce royaume-ci m’apparient, entends-tu, il m’appartient. Je l’ai construit, je me suis battu pendant des années, pour en faire ce qu’il est, et je n’ai pas l’intention de partir ainsi, […]. Pour ce pouvoir-ci, j’ai perdu frères et sœurs, pères et mères, j’ai dû enfermer ma femme pour quelle ne me trahisse pas, je me suis méfié même de mon ombre, porté par une idée, une seule, une obsession: le pouvoir de construire ce pays, mon rêve… Et j’ai construit mon rêve, mon château, ma puissance, mon pays…»343 Ugualmente delirante il programma del militare di Un jour ma mémoire, sulla base del quale, l’autrice sviluppa la sua critica aprendola all’analisi della secolare connivenza della Chiesa con il regime. A partire da un discorso impostato sulla retorica reazionaria dei ben noti messaggi apostolici («se tenir face à l’histoire avec un cœur pur, plein d’amour et désireux de justice et croyant en Dieu.»344), il militare verrà gradualmente assimilato alla figura del religioso (considerando che, secondo la stessa topica cristiana, i fedeli sono identificati ai soldati di Cristo) Lui: «Dieu!!! (il éclate de rire) Je suis mon propre Dieu, mon royaume n’a aucune limite, […] J’irai conquérir les peuples, vaincre les réticences…car j’ai raison, indubitablement, j’ai raison, qui oserai dire le contraire, la raison me fut échue et le pouvoir de décision, […] De ce peuple-ci je suis le Chef, et vous m’obéirez tous…tous ai-je dit, tous…»345 Nell’ottica di una politica dimentica di ogni ideale umanitario, incline alle torture e guerrafondaia, il dittatore non potrà che essere concepito se non come un personaggio disumano, disumanizzato. A una politica vuota e accentratrice seguirà, allora, l’immagine di un dittatore egocentrico, vanesio fino al parossismo, fino alla caricatura Radriambé: «…Toujours à réclamer, à hurler…Que veulent-ils cette fois?» Rabary: «Ils disent qu’ils n’ont pas de travail, ils ont faim.» Radriambé: «Est-ce une raison pour crier de manière hystérique? Ils n’ont qu’à travailler la terre […]» Rabary: «La terre y est stérile.» 342 «Qu’il soit Président, Empereur, Roi ou Chef le personnage du premier responsable d’un pays u d’une communauté bénéficie très rarement d’un éclairage positif dans l’image que les autres donnent de lui. […] Son gouvernement ne s’illustre que dans la barbarie et dans l’inconscience généralisée.», Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., pp. 136-137. 343 Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p. 54. 344 Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit., p. 91. 345 Ibid., p. 92. 218 Radriambé: «Ah! Que tout cela est fatigant.»346 Dal punto di vista di un’analisi del dramma contemporaneo, per una rielaborazione critica del soggetto politico, legittimata dal procedimento dialettico, il personaggio si definirà dalle relazioni di mediazione o di opposizione che instaura con gli altri personaggi347. Ramoana, moglie del dittatore, come suo doppio, sarà la personificazione della sua coscienza348; Ranoro, sua figlia, incarnerà, invece, la voce del popolo349, allora che Rabary, conseguentemente all’idea della ricorsività della storia, sarà a un tempo suo carnefice e suo emulo350. Conformandosi al topos del dittatore, Michèle Rakotoson non solo rievocherà e riproporrà le medesime atmosfere di molte tragedie contemporanee, soprattutto ne sposerà la lettura pessimista riguardo alla possibilità di un cambiamento radicale dei costumi corrotti della politica dei paesi africani. Pessimismo che, tuttavia, potremmo considerare profetico per la storia del Madagascar se pensiamo che, tra il 1991 e il 1996, a un anno dalla pubblicazione del testo, l’isola avrebbe fatto esperienza di una repressione, quindi di un finto processo di rinnovamento. Se da un punto di vista contenutistico, Michèle Rakotoson sembra adeguarsi alla topica ormai classica della nuova autocrazia dal volto democratico e socialista, sia nell’immagine dell’uomo (nevrotico paranoide) che delle atmosfere (negative, minacciate ora dall’umido malsano, ora dalla secchezza, sempre tormentate da uomini il cui stato di precarietà ha trasformato in fantasmi, in zombi351): 346 Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p. 44. Gli esempi della visione isterica e paradossale del dittatore si moltiplicano per tutto il testo. Radriambé considera le proteste del suo popolo un atto di tradimento nei confronti del «padre della nazione» (p. 45), restituendoci di se stesso un’immagine quasi sacrale, di essere superiore e inviolabile «J’ai horreur d’être dérangé. […] J’ai horreur d’attendre.» o ancora «Des armes… (il ricane). Des ce pays-ci, même les femmes savent tirer et c’est moi qui ai ordonné le service militaire obligatoire…Pour défendre le pays…(il hurle au bord de la folie) […] protéger son Président…Et maintenant ils veulent retourner les armes contre moi. Même les enfants. Ingrats,ingrats!», Ibid., p. 47. 347 «Il modello attanziale, dice Greimas, è in primo luogo l’estrapolazione di una struttura sintattica. Un attante si identifica dunque con un elemento (lessicalizzato) che assuma nella frase di base del racconto una funzione sintattica: c’è il soggetto e l’oggetto, il destinatario,l’oppositore e l’aiutante, le cui funzioni sintattiche sono evidenti; […].», Anne Uberfeld, Theatrikón, op. cit., p. 55. 348 Radriambé: «Tais-toi vieille folle, tais-toi, je vais te tuer.» Ramoana: «Me tuer? Comment pourrais-tu me tuer, moi ta jumelle, ton double, ton ombre, et à qui livrerais-tu tes cauchemars, tu as trop besoin de mes remontrances pour vivre. Maintenant, nous sommes liés à jamais.», Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p. 47. 349 «Je suis veuve de mon père, orpheline de mon fils, dépouillée de ma fille…génération sans avenir et sans lendemain. Mon ventre a enfanté la mort et le désespoir, et de mon utérus coule le sang, en permanence. /Femme je suis, paraît-il, mais quelle femme engendre la mort? / Ce sang qui est mien inondera terres et collines, que ne suis-je morte, Seigneur, que ne suis-je morte? Mon ventre n’est plus que souvenir de pourriture et l’odeur de charniers hante toutes mes nuits […].», Ibid., p. 55 350 «Il ne vous faut jamais avoir la mémoire courte, Radriambé, vous avez tué tous ce qui vous craignez, pour vous je n’étais qu’un gamin, un nabot, mais les gamins grandissent un jour…E à force de servir de courber l’échine, ils peuvent se mettre à la place des humiliés…parler comme eux. Vous savez, un peuple est bête, finalement, il ne sait que répéter, il évite de réfléchir, ceux-là ont repris exactement le même trajectoire il y a dix ans, ils répètent les mêmes mots, seul le nom change, ils ne se rendent pas compte qu’ils ont adoré ceux qu’ils renient…», Ibid, p. 62. 351 Ramoana: «Tu as le regard d’un revenant, mon mari, le regard d’un cadavre ou d’un zombi… […].», Ibid. Ramoana: «Ton pays est devenu un pays de morts-vivants mon homme, un pays de morts-vivants […].», Ibid., p. 47. 219 Ramoana: «Les murs de ton château se sont imprégnés d’humidité, et mes vêtements sont pires que les linges des morts, des linceuls pourris qui collent à la peau de ce cadavre que je ne suis même pas…»352 nondimeno l’autrice contribuisce in modo sostanziale all’approfondimento del personaggio e della politica attuale, a partire dalla sperimentazione sul linguaggio di cui i due testi vogliono essere una diversa argomentazione. Dall’analisi del linguaggio e dei temi usati, i due testi sembrano seguire un medesimo schema, teso alla determinazione del rapporto tra l’uomo e la memoria, quindi, alla possibilità dell’elaborazione o rielaborazione della Storia. Le soluzioni, anche linguistiche, saranno differenti per le due opere conformemente alla prospettiva dalla quale la storia stessa (quella della rivoluzione) viene raccontata, quindi ricostruita. Se per entrambi i testi dobbiamo considerare un uso sempre metaforico del linguaggio, nondimeno le due opere si distingueranno per una diversa assunzione dell’evocazione. A un linguaggio pieno del primo testo, farà eco il linguaggio vuoto dell’opera successiva. Alle immagini definite e simbolicamente strutturate di La maison morte, risponderanno delle immagini imprecise di cui i protagonisti confuteranno la validità, nel momento in cui metteranno in dubbio la loro esistenza passata: ponendo il vissuto sotto la minaccia della simulazione, riducendo la realtà, non più a un sogno, ma al gioco perverso della negazione e dell’oblio353. Le due diverse posizioni messe in scena riflettono due modi differenti di considerare la realtà, quindi due soluzioni divergenti di usare e/o considerare il linguaggio per definirla. Posto che, secondo l’immaginario collettivo (a cui l’immagine del tiranno di Rakotoson è conforme), il dittatore è colui che produce la Storia354, e il popolo la subisce, ne seguirà un diverso rapporto con il linguaggio: generativo nel primo caso, frammentario e discontinuo nel secondo (a partire dal grado di coscienza politica dell’individuo stesso). A un linguaggio essenzialmente simbolico del primo testo, seguirà una formulazione dell’atto linguistico soprattutto in senso riflessivo, quindi, metalinguistico. Conformemente al linguaggio 352 Ibid., p. 42 Elle: «L’oubli aussi est une décision comme une autre.», Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit, p. 71 Lui: «Et je veux vivre […], même si vivre c’est oublier les rêves et les illusions, et s’il faut, vivre en minuscule, en rampant, en léchant la paroi des murs […] et oublier, oublier, enlever les fils, se déconnecter et ne plus être histoire, finir en mendiant encore et toujours, mais vivre, vivre, oublier.», Ibid., p.73 Elle: «Il faut que tu oublies maintenant» Lui: «Oublier? Dans ma mémoire et dans mon corps, il y a trop de morts, et ils hurlent. […] Et pour cette volonté de créer et de recomposer à l’infini, combien de temps pour lâcher prise? L’oubli pour la mémoire des ères, l’oubli pour la maturité, pour la sérénité.», Ibid., p. 74. Elle: «Jeu? C’est toi qui triches avec ta mémoire. Tu te mets la tête dans le sable comme une autruche et tu te dis bien: “Tout va bien.”. […] Tu as une excuse maintenant, tu as vécu, tu as souffert, tout t’est dû et l’histoire peut se taire, tu as le silence légitime.», Ibid., p. 88. 354 Elle: «Moi ton maître, j’ai le mot, le verbe, la parole, la puissance, car le monde est ainsi fait, ainsi divisé», Ibid., p. 85. 353 220 politico, che significa sempre altro da ciò che esprime, le immagini, il pesce, le carte, che si susseguono ne La maison morte sono sempre cariche di significati molteplici. Il pesce è alternativamente simbolo del popolo: Radriambé: «Jeune homme, un jour, il faudra que vous regardiez les poissons vivre. Ce sont des animaux fascinants. Celui-ci est un poisson de rivière, et pourtant il a appris à reconnaître ses limites et le sens de l’onde.» di Ramaoana Ramoana: «Je tourne sur moi-même comme la roue de Rasoa la folle […]» e dello stesso dittatore Radriambé: «Du calme jeune homme, du calme, vous finirez par faire peur à mon poisson…suivre le cours de l’onde, suivre le cours de l’eau, respecter l’harmonie en toutes choses, voilà ce que vous devez apprendre si vous voulez survivre […]»355 le carte sono la manifestazione non più del caso, ma dell’abilità strategica dei due giocatori, dei due avversari politici: Radriambé: «Rien ne presse, un peuple a toujours la mémoire lente, ils reviennent toujours au même endroit […] à vous cher cadet. (Rabary abat la carte, Radriambé siffle d’admiration) Bravo Rabary, bravo, vous finirez par devenir un joueur émérite, cela permettra de faire durer cette partie […].»356 Al contrario, in Un jour ma mémoire, le immagini, sempre interrotte, sospese, non riescono a rappresentare ciò che dicono Elle: «Tu sais, j’ai toujours aimé le silence, les après-midi qui se traînent, dans ces après-midi-là, je m’asseyais à ma fenêtre et regardais les couleurs aller et venir, les reflets du soleil et le vent qui change, je mettais de la musique e j’écoutais. / Et dans mon rêve, et dans mon désir se dessinaient des formes, une voix, un geste. Inabouti, peut-être, informel. Il était nuance, il était mouvement, ce frémissement léger du bout des lèvres, des pores de la peau.»357 Per questo motivo, a un testo in cui i riferimenti alla storia locale e alla memoria saranno ricorsivi ma non ossessivi358 (il problema si riduce a come costruire una versione della storia 355 Ibid., p. 41, p. 42, p. 45. Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p. 48. 357 Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit., p. 69. 358 Memoria lunga, memoria lenta, memoria interrotta, ricostruzione della memoria collettiva: 356 221 collettiva che sia accettata e accettabile per la massa359), replica il dramma della memoria come dovere e caso di coscienza nel momento in cui si confronta all’oblio. La narrazione di Un jour ma mémoire si svolge secondo la declinazione successiva delle varie sfumature della memoria: dalla memoria interrotta, alla memoria simulata. Il confronto tra Storia e memoria, tra dimensione collettiva e dimensione individuale, è costante. L’assenza di una narrazione storica riflette l’impossibilità dell’individuo di costituirsi come unità generativa della realtà esterna. Non solo l’uomo si confronta con una memoria disgregata, brisée (Lui: «Ma mémoire s’est brisée. Il faut être vierge pour danser.», Un jour ma mémoire, p. 69), soprattutto con l’impostura della memoria (dal momento che l’essere è ridotto a numero, a cosa che non ha diritti sulla vita, si può presumere che la memoria sia qualcosa di inventato): Lui: « […] nous ne fûmes jamais que des numéros matricules […] Pour cette histoire là, nous n’avions que le droit de nous taire, d’être victimes». Nel testo sarà questione di memoria simulata (facciamo riferimento soprattutto alle pagine 80 e 81), di memoria sbagliata: Lui: « […] Même pour les gestes du quotidien tu te trompes de mémoire.» Elle: «Nous jouons faux, je ne sais quelle mémoire nous avons choisi de revivre»; di memoria rivelata: Lui: «Il faisait toujours beau les jours des manifestations […] nous y croyons alors […] Pour mes compagnons tout était simple […] Ils avaient un monde logique tranché net: eux, nous, les autres, les bons, les méchants, des situations claires […] de mauvais gouvernements, un monde clair…nous, nous partions vaincus d’avance.» 360 ; Ramoana: «Les jours ressemblent aux autres jours dis-tu, et le peuple refait toujours la même histoire…Effectivement il a la mémoire longue.», Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p.42 Radriambé: «Rien ne presse, un peuple a toujours la mémoire lente, ils reviennent toujours au même endroit, il nous suffira d’attendre…», Ibid., p. 48 Rabary: «Il ne leur faudra peut-être pas une heure…Quelquefois l’histoire a des raccourcis…», Ibid., p. 49 Caporal: «Cela dépend pourquoi, en général, j’ai la mémoire sélective…», più avanti: «Alors Rabary…Que disonsnous…(il éclate de rire), moi, j’ai très peu de mémoire, ce n’est pas le cas du magnétophone, vous savez, les impérialistes avec les machines, ils sont assez déroutant, ils prévoient tout […] Mais ne vous affolez pas, je n’ai pas de mémoire, et cet appareil sera remisé en un lieu sûr…Je ne le sortirai qu’en cas de litige…», Ibid., p. 64, p. 67. 359 Rabary: « (en riant) Vous voyez Radriambé, admirez-moi cette mémoire. […] il me faut maintenant trouver les raisons de mon règne…/ (De nouveau il rit…) Trouvé, j’ai trouvé: vu les circonstances dramatiques et les événements terribles qu’a traversés notre pays, j’ai dû m’exécuter et obéir aux injonctions de mon peuple pour sauver la liberté et la démocratie: j’ai dû mettre de côté le despote Radriambé, j’ai sauvé le pays du chaos et de la décadence […] Je suis le sauveur de la Nation…[…] La véritable histoire, jeune homme, celle que je dois raconter à mon peuple.», Ibid., p. 63. 360 Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit., p. 69, p. 70, p. 71, p. 79, 222 o rivissuta tra l’uomo e la donna, tra la donna e il militare, nelle pagine successive, secondo il rito dello psicodramma: Elle: « […] (Elle éclate de rire.) Esclave! Même les tiens te réduisent en esclavage! (Elle prend des habits de fonctionnaire.) Tu as le corps fait pour cela. Tu es la luxure, nègre, tu es la débauche, l’obscurité, la noirceur. Tu es l’enfer, nègre, tous les vices réunis, et l’imbécillité aussi, le sexe fait homme, fait femme. […] Même les tiens […] ils ont appris leur leçon: “Les pays sous-développés sortent des ténèbres”, de la barbarie, il nous faut retrouver nos sources anciennes, nos arbres, nos cocotiers, pour retrouver la pureté originelle, perdue, pour rejoindre le concert des pays riches…car nos richesses sont dans les pulsions de nos corps en détresse, la spontanéité et la joie de vivre des pays sous-développés…Nègre!!!»361 A un diverso uso del linguaggio da parte dei protagonisti, corrisponderà una differente distribuzione della parola all’interno del testo. In La maison morte, la descrizione della realtà è praticamente una prerogativa dei personaggi, le didascalie sono minime e riferiscono anzitutto rapporti di violenza (verbale o fisica) che si consumano tra i personaggi. Al contrario, in Un jour ma mémoire, dove il gesto è divenuto fondante e archetipo della parola, le didascalie forniscono quella conoscenza della realtà di cui mancano i due protagonisti. Il rito della parola messo in atto in entrambi i testi: nella prima opera, con un hira gasy decostruito362, nella seconda, con il tentativo di ricostruire la memoria attraverso il recupero di un lessico che attinga alla memoria dei padri363, produce una differente messinscena del dramma. La scrittrice mette in scena il progressivo denaturamento dell’atto linguistico, subito dai personaggi che la perdita di memoria porta progressivamente all’afasia, prodotto dai protagonisti che attraverso la violenza del rito e la violazione dell’interdetto e del tabù tentano l’epifania di un nuovo linguaggio. Militaire: «Car je suis un dieu jaloux, qui venge la faute des pères sur la tête des enfants […]. Et je n’aurai aucune pitié pour qui me désobéira, car il en va de la vie et du destin révolutionnaire» […] (Elle s’approche de plus en plus, calmement. […] Le militaire s’affole, essaie encore de tirer, le fusil s’enraie. Ils s’affrontent du regard, le militaire semble paralysé. […] Elle se rapproche de lui, et l’etrangle lentement, comme si c’était un rituel […])364 361 Ibid., p. 85. È evidente il riferimento polemico alla malgascizzazione di cui fu vittima il Madagascar nei primi anni 70, come pure la perversione della poetica della Negritudine da parte dalle dittature africane. 362 «Ramoana: […] tu seras toujours, le canard affamé, qui se gorge de sable, fille de Radriambé.». Ranoro: «Oui, mais quand la lune se couche, il est peut-être temps pour l’homme de se coucher.» Ramoana: «Ne sois pas celle qui confond le premier quartier et la pleine lune, tu risques de boire l’eau dans les mains ennemies. Ne te presse pas, le taureau n’attend jamais que l’eau de la fosse sente ranci’.», Michèle Rakotoson, La Maison morte, op. cit., p. 59. 363 Elle: «Essaie de te souvenir.» Lui: «Peut-être dans ta mémoire, une trace, un mot…» Elle: «…La mémoire des pères…», Michèle Rakotoson, Un jour ma mémoire, op. cit., p. 83. 364 Ibid., pp. 92-93. 223 Jean-Luc Raharimanana, de l’autre côté du réel Tra i drammaturghi citati, Jean-Luc Raharimanana365 è il più giovane. Nato alla fine degli anni 60, Raharimanana non ha vissuto né partecipato alla trasformazione del Madagascar da colonia a stato libero e sovrano, non ha sperimentato della decolonizzazione le speranze per una rinascita malgascia, ma solo il silenzio, l’oblio del passato coloniale e precoloniale imposto dalla demagogia socialista di Ratsiraka. L’estro letterario, soprattutto poetico e narrativo, maturato dall’autore fin dalla più giovane età, il salto generazionale che lo divide dagli altri scrittori malgasci contemporanei, presenti sulle scene internazionali fin dagli anni 70, sono i presupposti per una poetica della sperimentazione letteraria oramai imprescindibile per la nuova sensibilità contemporanea. Una visione del mondo nata dal silenzio e dal trauma della parola coloniale e della propaganda della malgascizzazione, non può che ricusare il realismo per riflettersi e ritrovarsi in un linguaggio del rifiuto e della contestazione. La locuzione francese diventa lo strumento di lotta politica contro la politica della malgascizzazione che, facendo tabula rasa del periodo coloniale, ha, di fatto, portato alla degradazione della cultura malgascia366. 365 Nato il 26 giugno del 1967 ad Antananarivo, Raharimanana manifesta sin da giovane una sensibilità spiccata per l’arte, soprattutto per la parola generatrice di mondi, tessitrice della realtà e potente mezzo di contestazione. Premiato nel 1987 al concorso di poesia Jean-Joseph Rabearivelo, nel 1988 gli viene commissionata dall’Alliance Française di Tananarive la creazione di un’opera teatrale, Le prophète et le président. Il soggetto dichiaratamente politico dell’opera, di dissenso verso la dittatura corrotta di Ratsiraka, dà luogo a una reazione del governo contro l’autore, più volte minacciato di arresto. Abbandonato dalla quasi totalità degli attori, come pure dall’Alliance Française (per ragioni di tutela delle relazioni tra Francia e Madagascar), la pièce sarebbe stata pubblicata e premiata solo nel 1990 al Concorso di Radio France Internationale (R.F.I.). La calda accoglienza riservatagli dalla Francia, l’aggravarsi della situazione politica nel Madagascar, convincono il giovane autore a lasciare la patria per installarsi a Parigi. Conseguiti i suoi studi alla Sorbona e il DEA in Letteratura e civilizzazione all’INALCO (Institut des langues orientales), lavora come giornalista e poi come insegnante a Seine-Saint-Denis. Visto sfumare il progetto di costituire una scuola di teatro nel Madagascar a causa dei problemi politici e finanziari del paese, conscio delle difficoltà che attraversano le case di edizione in Madagascar, Raharimanana decide di rimanere in Francia per continuare la sua carriere letteraria di scrittore engagé. A seguito dell’arresto del padre accusato di provocazione e di crimini contro lo stato (professore di storia all’Università di Antananarivo, e cronista alla radio si occupava dei conflitti etnici malgasci precoloniali), Raharimanana lascia la sua attività di insegnante per dedicarsi completamente alla letteratura al fine di restituire, con il racconto, la memoria tradita della storia nazionale. Nonostante la prima raccolta di novelle, Lucarnes (1996), sia stata pubblicata in Francia a sette anni dal suo arrivo, l’isola, il Madagascar, con la sua storia e i suoi racconti orali, la mitologia è ossessivamente presente. Scrittore della violenza, i racconti e il teatro condividono e vivono degli stessi paeseggi, delle medesime realtà: povertà, morte, corruzione fisica e morale di una società che pure affascina per le sue bellezze e la sua sensualità. 366 «Le contexte mis en place par le révolution a créé les conditions d’un analphabétisme généralisé […]. Le regard que Raharimanana porte aujourd’hui sur cette période de sa vie, sur l’enseignement qu’il a reçu, est à la fois amer et ironique: les auteurs du corpus étaient malgaches (lorsque les enseignants ne résistaient pas et persistaient à enseigner des auteurs français), mais si complexes à lire et à comprendre pour les jeunes enfants que l’entreprise […] était d’emblée vouée à l’échec. Dans le même ordre d’idée, les cours de civilisation, dispensés de la même manière sur tout le territoire, au mépris des histoires et des cultures locales, étaient de véritables cours d’ethnologie […]. La langue malgache elle-même, selon Raharimanana est devenue une langue pudique, au point qu’on ne peut même plus nommer le corps, et ceci est l’effet de la malgachisation qui a bridé, formaté, les possibilités de penser et de dire.», Carole Bougenot, Compte rendu de la visite de Jean-Luc Raharimanana le 23 janvier 2003, op. cit. 224 Solo a partire da un’assunzione anche estetica della parola (la scelta del francese riflette il rifiuto di una lingua malgascia ormai snaturata dalla dittatura socialista), sarà, allora, possibile, per lo scrittore, ricostituire e riconoscere la parola nella sua potenzialità etica e politica. Rispetto a una produzione narrativa esuberante, Raharimanana ha creato relativamente poco per il teatro. Nondimeno le sue due opere teatrali, Le prophère et le président367 nel 1990, Le Puits nel 1996368, e, recentemente, un racconto per la scena inedito, danno prova di una conoscenza del genere teatrale, di una sensibilità acuta verso le dinamiche del mezzo, probabilmente risultato di quel senso del dramma (cui già Rabemananjara aveva fatto cenno in un’intervista a Raharimanana369), al quale la cronaca della violenza, insensata e irriducibile, del Madagascar contemponaeo ha tristemente abituato (lo stesso Raharimanana è stato più volte testimone da studente della furia della dittatura, e successivamente, durante la prigionia del padre, delle torture, delle sevizie subite dalla popolazione perché fosse represso ogni tentativo di libertà di espressione). Non stupisce, allora, che il teatro di Raharimanana condivida con la prosa e la poesia, la medesima visione tragica della realtà, partecipi della stessa vocazione politica della parola, che è anzitutto esperienza della violenza, nella misura in cui l’evocazione vuole essere il grido feroce e caustico del dissenso. La violenza di cui pure Jaomanoro e Rakotoson hanno restituito la cronaca nei racconti allegorici di Sambany, di J’ai marché dessus, che hanno reso protagonista nel linguaggio destrutturato di Un jour ma mémoire, o nel delirio della menzogna in La retraite, appartiene all’uomo fintantoché accetta passivamente il suo destino. Come nelle tragedie greche, la violenza che mettono in scena i due autori è, quindi, ancora una volta identificabile al fato: un agente esteriore all’essere umano e che lo obbliga all’azione morale, a riconoscersi animale sociale. L’omicidio che si consuma sulla scena di Un jour ma mémoire è, si vuole, rituale (secondo le indicazioni della stessa autrice), quindi una simulazione destinata alla catarsi; l’esaltazione dionisiaca di cui sono preda i personaggi di Le prophète et le président si risolve, invece, in una strage gratuita, indice della diversa coloritura, della differente rappresentazione, e di un opposto giudizio che Raharimanana ha maturato riguardo alla violenza370. 367 Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, Paris, R.F.I., 1990. Riassunto pp. 484-485. Jean-Luc Raharimanana, Le Puits, Paris, Actes Sud Papiers, Brèves d’ailleurs, 1996. 369 Jean-Luc Raharimanana, Jacques Rabemananjara, poète et dramaturge, op. cit. 370 Riteniamo che la distanza generazionale, che divide Raharimanana dagli autori che hanno vissuto gli anni della decolonizzazione e della successiva dittatura di Ratsiraka, abbia contribuito a far maturare una diversa percezione della violenza e del confronto con la violenza negli autori dell’ultima generazione rispetto a quelli nati negli anni 50. La gratuità di cui è fatto oggetto la violenza (da parte degli scrittori contemporanei) è certamente conseguenza del lavoro di epurazione e di negazione della memoria passata: di annullamento dei riferimenti, quindi dei presupposti storici che danno senso e ragione degli eventi presenti, violenza che è il diretto riflesso della ritrattazione della storia perpetrata negli anni della malgascizzazione. 368 225 La violenza non sarà più esterna all’individuo e al personaggio, un codice assunto e stabilito dall’autore a partire dal quale rivelare l’assurdo371 del reale, ma è la realtà; non è un’operazione estetica ma una constatazione etica, non solo una ricostruzione e non più una rappresentazione ma una presentazione, un riscontro obiettivo e per ciò stesso oggetto di un pessimismo lucido e ateo372. La degradazione dei personaggi non sarà, allora, la conseguenza di un lavoro disonorevole, imposto dalla società, o dai meccanismi politici; non rifletterà, non sarà la testimonianza di un abuso subito, a cui l’individuo non ha potuto sottrarsi; al contrario, apparterà all’uomo come unico lessico rimastogli per comunicare con e sugli altri: non esprimerà una condizione passiva, ma denuncerà una presa di posizione attiva. Coerente con questa visione della realtà intrinsecamente corrotta, Raharimanana ha ambientato il suo primo testo teatrale in un manicomio, nel luogo simbolo, eppure reale, della degenerazione fisica e mentale, costruendo l’opera a partire non più dall’opposizione tra il mondo del sano e del malato (come avveniva ancora nelle opere pirandelliane), ma tra le diverse visioni, declinazioni della malattia. Il dialogo, o meglio, i monologhi si consumeranno, allora, tra due pazzi dell’ospedale psichiatrico: un demente convinto di essere il presidente, un alienato che si dichiara un profeta. Come fa notare Fiangor, la follia è divenuta il luogo privilegiato di molte opere teatrali africane contemporanee. L’assunzione del teatro shakespeariano a modello letterario in quest’ultimo ventennio, nonché la formazione soprattutto romantica (Hugo e Musset) di molti autori ha certamente facilitato la reintroduzione del personaggio del folle, come alter ego dell’autore scacciato dal proprio paese373, nella rappresentazione della realtà contemporanea. Lo scarto tra la contingenza e l’ideale, tra l’agire umano e il modello morale, tra la condizione del singolo e le ragioni della collettività, sembrano oltretutto sottrarre il topos letterario alla sua astrattezza per rivendicarne l’evidenza del quotidiano: «Dans ces pièces où le fou domine ou dirige les situations, nous sommes frappés par la façon dont les auteurs exploitent la folie. Nous sommes en présence de fous qui se mèlent de la vie publique voire politique, de fous-hérauts, bref de fous plus lucides et plus cohérents que les individus dits normaux. Ils portent les révoltes sociales…»374 371 «Le sens premier du mot “absurde” était “inharmonieux” au sens musical, d’où la définition du dictionnaire: en désaccord avec la raison et la bienséance, inconfru, irraisonnable, illogique. […] donc absurde, coupé des raisons, ce qui produit une angoisse métaphysique.», Martin Esslin, Théatre de l’absurde, op. cit., p. 20. 372 Come colui che non crede, il pessimismo di cui dà prova Raharimanana in Le prophète et le président riflette una visione della realtà senza speranza, chiusa a qualsiasi soluzione, o prospettiva futura. 373 Rogo Koffi M. Fiangor, Le théâtre africain francophone, op. cit., p. 145. 374 Ibid., p. 143. 226 La pazzia assume, quindi, nei drammaturghi di ultima generazione, e in Raharimanana di Le prophète et le président, una doppia connotazione: letteraria ed esistenziale (nella misura in cui l’agire umano si caratterizza per la sua inconsequenzialità, per la sua gratuità). Dal punto di vista retorico, la follia è l’erede, l’estremizzazione di quella lettura satirica degli eventi contemporanei e dei personaggi che agiscono nella politica internazionale, messa a punto nel teatro realistico degli anni 80. L’autore ricorre, quindi, alla degradazione mentale come ulteriore disumanizzazione del dittatore, il cui operato sembrava soffrire, già nel teatro di Rakotondrasoa, di un egocentrismo patologico. A differenza di Rakotondrasoa, Raharimanana non sembra più trovare il riscatto dalla realtà nel riso irriverente e pungente della satira. Una volta che la politica, l’agire umano in generale è stato riconosciuto per la sua vanità, allorché della dittatura si sono perse accuse e giustificazioni, e la rabbia è mutata in cinismo, la satira ripiegherà nel grottesco, nei gesti scomposti delle gag (epigoni della follia del buffone medievale), di una comicità violenta e gratuita, somma di citazioni svuotate Rapaoly: «T’es dingue, aussi dingue que ces présidents qui bâtissent ces palais immenses, anti-bombes atomiques […]. Ces pires qu’Hitler et le Diable compris. Hitler, lui, a quand même le mérite d’avoir essayé d’amener son pays à la conquête du monde, tandis que toi […] tu ne nous mènes qu’à la conquête de la misère. Il ne nous reste même pas l’illusion de la lutte. Misère sans fin!»375 Partendo dalla satira realistica del teatro degli anni 80, quando i drammaturghi giocavano sull’ambiguità dei nomi e delle parole per denunciare la terribile e pericolosa megalomania dei dittatori africani (ricordiamo il dittatore Mamadou in A bas l’apartheid, che si effigia del titolo di «padre della nazione», la stessa immagine, padre-figli, è usata da Radriambé in La maison morte di Rakotoson, a testimoniare una topica sfruttata dagli autocrati conformata sul linguaggio della tradizione), Raharimanana mette in scena l’evoluzione di questo personaggio iniziale. Sopravvissuto alle scosse della rivoluzione, alle minacce della destituzione, quindi di un cambiamento di regime, i nuovi dittatori sono un’immagine multimediale: una costruzione artificiale della propaganda e degli slogan; non citano più, quindi, gli eroi e i topoi della cultura ancestrale, ma sono la copia denaturata di altri dittatori: si autocitano. Il presidente di Raharimanana, appena entrato in scena, approfitta del corpo inanime del profeta per improvvisare una serie di pose fotografiche; allo stesso modo, i discorsi si ridurranno a una citazione di dichiarazioni e minacce ben noti a quanti hanno sperimentato, e sperimentano, dittature di ogni tipo: 375 Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, op. cit., p. 20. 227 Le Président: «[…] bloquer l’université»; «censure»; «couvre-feu»; «laissez la rumeur accomplir son travail. Le peuple vous suivra.»; «Rassurez-vous, messieurs les Ministres […] l’économie progresse […] nos dettes extérieures sont livrées. […] [au cadavre de Rapaoly, qu’il vient de tuer] Citoyens, vous êtes tombé sous les coups de la Révolution. Nous trouverons le coupable […]»376. Come già la descrizione satirica dei dittatori africani degli anni 80, così la follia del presidente, permette a Raharimanana di schernire il suo personaggio, reso caricaturale dai gesti già ridondanti e vani in una sala presidenziale, ora grotteschi in un asilo di pazzi. Citazione di se stesso, ridotto a marionetta dall’autore e dal suo stesso agire impersonale (frutto non di una volontà soggettiva ma delle dinamiche internazionali), il presidente verrà ulteriormente disumanizzato nella misura in cui i suoi referenti, i suoi modelli si riveleranno vuoti, senza più alcuna evocazione per l’inerlocutore. Raharimanana si diverte, quindi, nel presentarci un dittatore che si specchia nell’ombra appena delineata sul muro (p. 15), o in uno scheletro (p. 24), che il personaggio prima riconosce come immagine riflessa (confrontandosi con lo scheletro considera che la barba è cresciuta e che è tempo per una nuova dittatura377) poi come suo doppio (allorché Rapaoly getta lo scheletro sulla folla dei matti per rabbonirli). Se Raharimanana tratta il dittatore da alienato, a tal punto che, come nella realtà, la sua follia (politica insensata) gli viene riconosciuta e rinfacciata da terzi (dal guardiano Rapaoly), il profeta, allo stesso modo dei personaggi del teatro classico, assume coscientemente la pazzia come luogo di libertà e verità: Le Prophète: «[…] je suis dingue […] elle [la dinguerie] permet de tout dire […] Je trouble la voie publique? […] La voie publique, ce qu’elle veut, c’est un peu d’asphalte […] dur.»378 Una concezione positiva della follia lascia intendere riferimenti certi alla filosofia greca di Platone e medievale di Erasmo, laddove entrambi ponevano una netta distinzione tra la furia e la mania, moría: tra la pazzia apportatrice di rovina, e la follia manifestazione dell’ingegno e dell’ispirazione divina379. 376 Ibid., p. 16, p. 34, p. 40. «[…] instaurer la dictature, oui, mais avec un nouveau look. La dictature libérale.», Ibid., p. 24. 378 Ibid., p. 6. 379 «Ciò sarebbe detto bene se il delirio fosse invariabilmente un male: ora invece i più grandi doni ci provengono proprio da quello stato di delirio, datoci per dono divino. Perché appunto la profetessa di Delfo, le sacerdotesse di Dodona, proprio in quello stato di esaltazione, hanno ottenuto per la Grecia tanti benefici, sia agli individui che alle comunità; ma quando erano in sé fecero poco o nulla.», Platone, Fedro, Bari, Laterza, 1998, p. 41. O ancora Erasmo: «Due sono le specie di follia: una inviata sulla terra dalle Furie vendicatrici, ogni volta che scatenano i loro serpenti e fanno sorgere nel cuore degli uomini la follia omicida della guerra, o un’estinguibile avidità, o il parricidio, l’incesto, o altri peccati simili […]. Ma assai diversa da questa, c’è anche un’altra specie di follia, dono mio, e secondo me, il migliore di tutti i beni. Esso consiste nel benefico vagabondaggio dello spirito, che libera l’uomo da 377 228 Come riconosce Fiangor, il drammaturgo, allo stesso modo dei giullari medievali, si serve della pazzia, quindi del personaggio del pazzo, per denunciare gli orrori della realtà contemporanea Le Prophète: «Oui, je blasphème…/ ô l’esprit capitaliste/Espérer tout contre si peu de choses […]/Bible! Terreur! Apocalypse, fin du monde […] / moi, qui ne voit pas au-delà de ma chienne existence…/N’y auraitil donc pas une existence plus courte? […]/Priez, faites le chemin de la croix.»380 Mettendo insieme le due immagini della follia, Raharimanana sovrapporrà sulla scena due diverse letture della realtà: quella satirica, passiva e propositiva (nella misura in cui la satira è il prodotto della degradazione di un’immagine originariamente positiva), e quella ironica, attiva e caustica (esito del venir meno di qualsiasi referente dialettico). Appropriandosi del topos letterario del folle veggente, del profeta apocalittico delirante ed esaltato (la greca Cassandra allo stesso modo dell’ebreo Giovanni), Raharimanana investirà la rappresentazione satirica del reale di cui è oggetto il presidente (ereditata dal teatro degli anni 80), dell’urlo irriverente, del riso lugubre381, di una realtà privata dell’illusione. Altrettanto evidenti, saranno, quindi, le citazioni agli angeli caduti di Milton e dei romantici (Hugo), e del decadente Baudelaire. Non più Satana sarà, però, il blasfematore, ma l’uomo: l’individuo in quanto cittadino defraudato dai governi pseudodemocratici dell’utopia libertaria, degli ideali egualitari: Le prophète: «[…] l’Homme a brisé le cœur de Dieu, l’Homme a coupé la queue du Diable. L’Homme serait-il le plus fort? […] Dieu veut devenir homme mais ne peut pas échapper à son éternité, Dieu le triste, l’homme s’amuse malgré la mort […]. La mort serait-elle la condition suprême?» o ancora Le prophète: «[…] l’homme est le produit de Dieu et du Diable. L’homme est le vrai péché de Dieu, son délire, sa folie, son phantasme […].»382 Cittadino che, a differenza dei personaggi di Rakotoson, si sarà impossessato del linguaggio del potere, quindi del linguaggio tout court (come avevamo detto per Un jour ma mémoire) per esporlo alla negazione. Riconosciuti i meccanismi della multimedialità, della propaganda, identificate le paure profonde da cui attinge il codice, l’insubordinazione del profeta, dunque dell’autore, si manifesterà nel rifiuto del linguaggio per mezzo di un uso paradossale dello stesso: ogni cura e da ogni preoccupazione e inonda il suo animo di una multiforme voluttà.», Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, Milano, Mursia, 1966, pp. 75-76. 380 Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, op. cit., pp. 3-4 381 Ibid., p. 48. 382 Ibid., pp. 13-14, p. 31. 229 Le prophète: «Oui, je suis un saint. Un saint moderne. Je m’évaderai d’ici […]. J’atterrerais au Paradis, j’aparadiserais au milieu des anges ébahis […]. Salut Bon Dieu […] Y a déjà eu un accord de ce genre? Merdre, vous ne voulez pas accepter mon contrat! Je veux garder mon corps au Paradis!»383 Tale linguaggio si dimostra oltremodo paradossale nel momento in cui, ispirato alla parola dei Vangeli, rivela tutta la disarmante e triste verità del verbo profetico: Le Prophète: «Vous êtes les fils de l’homme. Vous régnez sur tout ce qui est sur terre. Détruisez tout. Tout. Étalez votre puissance.»384 Il finto dialogo, l’agitato contraddittorio385, a cui l’incontro tra il profeta e il presidente dà vita è l’occasione per il drammaturgo di denunciare le violazioni alle quali l’uomo contemporaneo è ancora soggetto: oltraggio alla persona e alla libertà di espressione, censura fisica (con l’ingiunzione delle torture e arresti, alle quali il presidente maniaco fa costantemente riferimento), censura dell’informazione (allorché la conoscenza è considerata alleata della rivoluzione386), la morte. Di fronte all’evidenza, alla cruda e violenta denuncia della precarietà dell’esistenza umana, il delirante inno alla morte del profeta (doppiato dalle minacce di distruzione del presidente, e dalla strage effettiva che si consuma sulla scena) tradisce il personale orrore del drammaturgo verso la realtà contemporanea, la furia del poeta contro la società: Le prophète: «Chienne! Que crois-tu espérer en aimant encore la vie? Tu seras soumise au pouvoir des hommes dans la vie. Tu seras soumise au pouvoir de l’Etat, des tyrans, des dictateurs […] Tu subiras le sort qu’un Dieu t’a jeté, tu enfanteras dans la douleur et ton Homme vivra dans la sueur de son corps […].»387 383 Ibid., p. 7. Il paradiso non potrebbe essere identificato con qualsiasi nazione occidentale, cui milioni di rifugiati politici, e non, aspirano? Non si potrebbe leggere quindi una critica alla dittatura politica, ma anche economica, in generale ugualmente responsabile della situazione di precarietà in cui vivono molti stati del terzo mondo? 384 Ibid., p. 31. L’inversione messa in atto dal profeta con il paradosso si articola in una serie di immagini che restituiscono una visione incoerente, assurda della realtà: l’opposizione tra un Dio infelice e invidioso dell’uomo perché eterno e un uomo felice perché mortale, un Dio che non è morto ma vuole morire. La citazione reinterpretata in chiave paradossale muta il senso complessivo del messaggio iniziale, allo stesso modo dei singoli termini che compongono la frase. Nel testo evangelico, «figlio dell’Uomo» è Cristo figlio di Dio, redentore dell’umanità. Raharimanana di-verte, sovverte l’immagine iniziale, profanandola: Dio-Uomo, è divenuto uomo-dio flagello dell’umanità. 385 Rapaoly: «Un président et un prophète…d’habitude, ça donne toujours des étincelles» Rapiera: «Non, un roi et un prophète, tu veux dire.» Rapaoly: «Bonnet blanc, blanc bonnet…hé, hé, pouvoir céleste et pouvoir terrestre […].», Ibid., p. 10. 386 La fuga dei matti del manicomio dalle celle viene interpretata dal presidente come un sollevamento popolare (p. 30) per scongiurare il quale è necessario un capro espiatorio: prima Rapaoly, poi lo scheletro, il suo doppio. 387 Ibid., p. 47. In proposito facciamo notare le due differenti versioni, testo scritto e rappresentazione, di cui è stata fatto oggetto l’opera, a riprova del fatto che per tutto il dialogo l’autore si rivolge all’auditorio, quindi per estensione alla società. Nell’esemplare del 1990, la pièce si chiudeva con il profeta che usciva dalla scena minacciando la pazza (la società) con un riso lugubre «Un jour, tu seras à moi.» (p. 48). Nell’ultima rappresentazione la battuta è stata cambiata. All’invito della pazza di andarsene, il profeta risponde «Avec plaisir!». Certamente meno evocativa della precedente, la seconda versione potrebbe intendersi come la dichiarazione definitiva dell’autore se non di rinuncia, quantomeno di rifiuto della situazione malgascia contemporanea, quindi dell’accettazione definitiva dello stato di esiliato in Francia. 230 Il tema letterario della follia, già ricco di evocazioni, costringe oltretutto a un diverso ascolto e a una diversa valutazione della narrazione teatrale. Contro un’esposizione lineare e realistica degli eventi, la rappresentazione della follia, che sempre sottintende due racconti paralleli (quello reale e quello dell’illusione, quello della logica e quello della malattia, dell’irrazionalità), si rivela essere una diversa messa in scena del teatro nel teatro388. Allora che nell’artificio scenico del teatro nel teatro i personaggi sono consci della doppia illusione che si sta creando sulla scena (l’attore recita un personaggio a sua volta coinvolto in una seconda recitazione), nella pazzia, così come nel sogno, il personaggio è privato della propria coscienza. Spostando la valutazione critica di ciò che si sta rappresentando dal personaggio, all’attore, quindi al pubblico, la verità messa in scena (così come vuole Anne Ubersfeld389) sarà dominio del solo spettatore (divenuto per Raharimanana interlocutore privilegiato), una volta integrato al luogo della rappresentazione, come unico testimone e interprete della pazzia dei personaggi. Come nel teatro di Ionesco, la scena, spogliata della sua realtà immediata per significare sempre altro, rispetto a quanto rappresentato, diventerà una no man’s land390 o come dice il drammaturgo rumeno, la ricostruzione di una realtà «à l’envers, de l’autre côté»391. La follia permette allora la dislocazione del reale, dal momento che la rappresentazione della realtà, assunta come veritiera dal folle, risulta essere più vera della realtà esterna, fenomenica e oggettiva392. La rappresentazione considerata sin dall’inizio dallo spettatore come messinscena di una realtà duplice (quella reale e quella dell’illusione), si rivelerà essenzialmente metaforica. Come già per Ionesco, così in Raharimanana, il delirio dei due folli è, di fatto, la negazione della possibilità di raccontare il mondo nella sua oggettività, quindi, la dimostrazione della vanità della stessa rappresentazione come mimesi della realtà. Il discorso, dislocato e sempre metaforico, non 388 Se nel teatro nel teatro, viene attuata la divisione tra attore e personaggio in quanto entrambi recitanti, nel testo di Raharimanana, gli attanti sono a un tempo i pazzi e i pazzi che agiscono in qualità di presidente o di profeta. «Grazie in particolare a Sei personaggi, il “teatro nel teatro” divenne uno dei tratti distintivi del dramma moderno, anche se solo Pirandello a questa risorsa per esprimere temi di elevato contenuto filosofico.», Christopher Innes, Il teatro dopo le due guerre mondiali, in Storia del teatro, op. cit., p. 416. 389 «L’importance de ce clivage de l’espace est double: d’abord il nous permet de ne jamais oublier que nous sommes au théâtre ensuite […] il contraint le spectateur à recevoir non pas directement, mais répercuté par le regard des comédiens tout ce qui apparaît sur le théâtre dans le théâtre. Si nous savons que l’espace scénique est le lieu du non-vrai […], l’espace du théâtre dans le théâtre peut nous apparaître par une sorte de renversement, le lieu de la vérité.», George Banu, Anne Ubersfeld, L’espace théâtral, Clamency, Laballery, 1992, p. 23. 390 Ricordiamo che durante la prima guerra mondiale si definiva no man’s land lo spazio che divideva due trincee nemiche, spazio la cui conquista, nella strategia bellica, assumeva un’importanza assoluta per entrambi i fronti. 391 «À vrai dire, il n’y a pas de véritable frontière entre notre monde et l’autre, tout au plus un no man’s land. Car l’antimonde, en un sens, c’est la projection de notre univers intérieur. […] reconstruire le monde à partir du néant […], mais le reconstruire de l’autre côté, à l’envers […].», Guy Michaud, Ionesco: de la dérision à l’anti-monde, in Le théâtre moderne II depuis la deuxième guerre mondiale, op. cit., p. 42. 392 «[…] pensée prélogique, […] mythes et rêves […], identification du sujet et de l’objet, du symbole et de la réalité, de la parole et de l’idée, aussi bien que, dans certains cas, le divorce du nom e t de la chose signifiée: l’objectivation de la parole […]. Dans le monde de la pensée prélogique […] le langage devient incantation plutôt que communication.», Martin Esslin, Théatre de l’absurde, op. cit., p. 226. 231 sarà pronunciato per narrare gli eventi, ma per citare se stesso (in quanto costruzione logica, da tutti conosciuta e condivisa, che precede e determina la realtà). Riprendendo una struttura cara alla tradizione malgascia (quello dello hira gasy, ma pure dello tsindrindrina in cui i vari personaggi si alternavano sulla scena come su una tribuna393 per esporre diverse posizioni), Raharimanana riproduce il discorso di due folli, due autistici che non si ascoltano, come fossero due monologhi sempre distinti e dissonanti che raccontano di due esperienze: quella del presidente, immagine ed esemplificazione dei mali, quella del profeta personificazione del censore. Un teatro siffatto si rivelerà epico, nella misura in cui l’azione dei vari personaggi è il prodotto del loro racconto: il presidente (il folle che agisce come presidente) è tale perché definito, rappresentato dal linguaggio dell’oppressione, il profeta, privato, già dalla tradizione, delle fattezze terrene, è ridotto a verbo, dal momento che l’opinione comune lo riconosce come intermediario del verbo divino. La messa in scena di un linguaggio dislocato, invertito o pervertito (nel caso della follia) non solo racconta di una realtà che è stata ridotta a metafora, ma di personaggi che sono stati sottratti alla loro umanità per ritornare a essere, come nel teatro classico, delle semplici maschere394. La rappresentazione non sarà più incentrata sui personaggi (i folli, privati dall’autore finanche del nome), ma su ciò che essi comunicano, raffigurano in quanto immagini, topoi: il presidente malvagio, il profeta castigatore395. La ricollocazione delle maschere sullo spazio scenico, la reintegrazione del linguaggio (del messaggio) al centro della scena quindi della narrazione (una volta sottratto il testo all’autorità della 393 «En Afrique la mise en scène est très souvent statique. Les acteurs récitent leur rôle sans songer, ou sans que l’on ait songé pour eux, à de l’animation où à des mouvements. Parfois, certaines scènes font penser à des représentations françaises du XVI ou du XVII siècle, où les acteurs, alignés debout ou assis, sans faire un geste, débitaient leurs tirades.», Jacques Scherer, Le théâtre en Afrique noire, op. cit., p. 105. Il recupero di un teatro declamatorio, da parte di Raharimanana, manifesta l’intenzione dell’autore di sottrarre la rappresentazione all’illusione scenica, allo spazio naturalistico per fare dello spazio il luogo della parola, del rito giuridico. Come nell’agit-prop la scena diventa il luogo privilegiato per resuscitare ed esorcizzare vecchi fantasmi della storia presente: «Il movimento del Prolet-cult fu indirizzato verso l’attività agit-prop, [una finzione attraverso cui si dava vita a] finti processi a personaggi all’epoca ormai impopolari […]. L’agit-prop essenziale nella messa in scena, corrosivo nella satira, era capace di affrontare con immediatezza argomenti di attualità […].», Christopher Innes, Il teatro dopo le due guerre mondiali, op. cit., p. 419. 394 Una seconda differenza tra il testo scritto e quello rappresentato è data dal diverso simbolismo che l’autore mette in scena. Lo scheletro che, nell’opera, è la metafora del dittatore: apportatore di morte, e distruzione, ridotto a cosa indice della sua disumanità nel testo scritto, si mostra, invece, al pubblico coperto da una maschera nella versione orale, a spostare la rappresentazione dal simbolismo alla farsa, a indicare la degradazione del presidente da simbolo del male, a maschera della Commedia. 395 Così nel dialogo insensato che si instaura tra i due protagonisti nel primo quadro è la messinscena del fraintendimeno di due discorsi violenti: uno dettato dal delirio religioso, l’altro dall’aggressività politica (manifesta anche in un atteggiamenti prontamente difensivo): Le prophète: «Toi, tu es une bête impure.» Le prés.: «…des injures?» Le proph.: «Tu pourriras de tes entrailles.» Le prés.: «…des damnations?», Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, op. cit., p. 17. 232 determinazione psichica del personaggio), danno ragione di una parola declamata per la sua emblematicità, quindi di uno spazio ricostituito per la sua ritualità. Ogni volta che la parola viene assunta in funzione della sua evocazione, viene accolta e usata come simbolo, la declamazione diventa un atto rituale. Già in Rakotoson, era parso evidente la ricostituzione dello spazio scenico a spazio rituale, il riferimento alla tragedia greca come luogo in cui la parola e la violenza hanno senso solo nella realizzazione della catarsi. Così, nel secondo quadro de Le prophète et le président, i riferimenti alle Baccanti di Euripide sono chiari, come pure la riedificazione della scena a luogo del sacrificio, del sangue, della morte396 (non a caso il discorso del profeta, l’officiante, sarà un crescendo di invocazioni alla morte fino all’atto finale, al sacrificio collettivo) «Peuple! Le pouvoir suprême appartient à la Mort. Élève ton chant pour adorer ton dieu, la Mort. […] Tu [Dieu] es la Mort que nous, les hommes, serons un jour. Tu es notre Destin, notre Finalité.»397 Partendo dal presupposto che nel meccanismo già citato da Ubersfeld, a proposito del teatro nel teatro, due negativi facciano un positivo, in Raharimanana, dove la parola è anzitutto una finzione (nel momento in cui non appartiene al folle in quanto tale, ma al folle che agisce come presidente o profeta), la violenza, che nell’atto rituale è già simulazione (ricordiamo che Rakotoson, nel parlare del sacrificio del militare da parte della donna, usa l’avverbio come, distinguendo l’azione vera da quella simulata), nel testo si rivelerà fine a se stessa, impedendo l’attuazione di qualsiasi catarsi «On pense ici au potlatch de certaines peuplades primitives qui était à la fois offrande, célébration et destruction. Le théâtre de Genet est un potlatch des représentations que notre société se fait d’elle-même. Et 396 «Genet et Artaud partageaient en effet la même admiration pour le théâtre d’Extrême-Orient […]. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit de rendre à la représentation théâtrale son caractère de cérémonie et d’en faire un acte, de restituer à la scène, ce “lieu voisin de la mort, où toutes les libertés sont possibles”, sa dignité.», Bernad Dort, Genet ou le combat avec le théâtre, in Le théâtre moderne II depuis la deuxième guerre mondiale, op. cit., p. 60. Come è noto, con le Baccanti, Euripide ricostruisce i riti del culto a Dioniso. I riferimenti, o le similitudini tra il testo greco e quello malgascio contemporaneo non si rivelano solamente nella messa in scena della follia omicida da parte delle baccanti, in Euripide, e dei folli in Raharimanana. Le Baccanti così come Le prophète et le président sono due testi incentrati sulla follia (quindi sulla sovrapposizione tra realtà e finzione) come stato di delirio omicida, e illuminazione divina. Il confronto tra i personaggi delle due opere rivela ulteriori parallelismi. Penteo e il presidente sono entrambi pazzi (Tiresia e Cadmo riconoscono la pazzia di Penteo che si rifiuta di osservare i riti, Rapaoly quella del presidente); entrambi personaggi negativi, rappresentano dei governanti che sono venuti meno al loro ruolo istituzionale, che hanno trasgredito le convenzioni sociali. Ambedue i personaggi sono oggetto di satira: Penteo da parte di Dioniso, il presidente da parte del guardiano e dell’autore. Sia il presidente che Penteo sono rappresentati in scena con un doppio e sono uccisi dal doppio che incarnano: Penteo è sacrificato dalla madre Agave che lo ha scambiato per un leone; il presidente è, invece, ucciso dalla folla per ciò che rappresenta, un dittatore assassino. Il profeta di Raharimanana condivide con il Dioniso di Euripide la stessa furia, il medesimo grido di vendetta e rabbia contro i trasgressori, lo stesso linguaggio ingiurioso e violento. Entrambi agiscono come gli officianti del rito, come istigatori della violenza: «Détruisez tout. Tout. Étalez votre puissance.», dice il profeta, «Sconvolgi il suolo di questo paese, sisma divino.», replica Dioniso al coro delle baccanti (Euripide, Baccanti, Milano, Garzanti, 1980, p. 151). Come detto, però, se il sacrificio di Penteo ristabilisce l’ordine delle cose anche per l’apollineo Euripide, il sacrificio del presidente si rivela un atto di pura violenza, una ricostruzione estetica del rito che ha perduto qualsisi presupposto catartico. 397 Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, op. cit., pp. 36-37. 233 la catharsis qu’il nous procure est comme l’envers de la catharsis classique. Après avoir suscité pitié et cruauté, loin d’ “opérer la purgation […]”, elle ouvre au contraire sur la cruauté ou la pitié d’une existence nue […] celle d’un homme dont la vie et la mort ne font qu’un.»398 Nel percorso descritto del teatro malgascio, dalla sua istituzione alle manifestazioni del teatro d’avanguardia di Raharimanana, si è rilevata una vocazione politica della rappresentazione, presente nell’analisi lucida del reale come nella sua trasfigurazione apocalittica. Il pessimismo metafisico di cui dà prova l’ultima generazione e che si rivela nel grido disarticolato e disperato, senza superstiti tra quanti sono stati investiti, i personaggi sulla scena come gli spettatori in sala (poiché, con la battuta finale l’autore sembra voler dichiarare l’abbandono alla terra natale), è certamente sintomo di una critica caustica verso la realtà e verso quelle istituzioni che hanno lavorato perché l’uomo perdesse l’illusione del peso della propria azione sul reale («tu ne nous mènes qu’à la conquête de la misère. Il ne nous reste même pas l’illusion de la lutte. Misère sans fin.»399). Il teatro si rivela quindi soprattutto un’operazione estetica nella misura in cui, privato della realtà allo stesso modo dell’ideale, il drammaturgo, Raharimanana ha deciso di abitare le parole. 398 399 Bernad Dort, Genet ou le combat avec le théâtre, op. cit., p. 68. Jean-Luc Raharimanana, Le Prophète et le Président, op. cit., p. 20. 234 Sezione 2: Maurice Riflessione storica sul teatro mauriziano Politica e misticismo, le due anime del teatro mauriziano La vocazione teatrale dell’Île de France e di Maurice, tra silenzi e rinascite: 1754 – 1938, 1950 – 1970, 1972 – 1998. La documentazione in merito all’origine del teatro rimane ancora oggi insoluta per la maggior parte dei critici e degli studiosi del genere. Se la nascita della poesia e della prosa, anche per le popolazioni con tradizione orale, può essere fissata con una qualche attendibilità, non altrettanto certa sembra essere la datazione delle prime rappresentazioni teatrali, soprattutto, per la difficoltà di arrivare a un giudizio comune su cosa debba intendersi per teatro, per spettacolo teatrale, quindi, per rappresentazione tragica. I dubbi e le incertezze messi in evidenza dalla lunga dissertazione sulla genesi e lo sviluppo del teatro malgascio, rimasti insoluti per tutta la ricostruzione e l’analisi storica del genere, hanno fornito l’occasione per problematizzare, alla luce delle diverse tesi assunte dai critici, la questione intorno al teatro malgascio e delle ex-colonie africane e antillane (posto che nella maggior parte dei compendi, le tre aree sono generalmente raggruppate sotto la medesima formula di teatro negroafricano). Le ex-colonie di fondazione (quei territori inizialmente disabitati di cui gli Europei hanno via via preso possesso lungo i secoli), come l’isola di Maurice e la Réunion, sembrano porre, invece, quesiti diversi agli studiosi di teatro, obbligando lo studio della produzione teatrale del luogo a prendere atto di prospettive inedite e nuove rispetto a quelle delle colonie di stanziamento. Per ciò che concerne il teatro dell’isola di Maurice, anticamente Île de France, non ha senso motivare la fondazione dello spazio teatrale come accade per la drammaturgia africana, ma, anzitutto e specialmente, la sua continuazione. Sarà, pertanto, utile instaurare un confronto con il genere occidentale che dia ragione non delle differenze e delle similitudini con il teatro francese, nella prospettiva di una produzione vieppiù originale, ma problematica nella misura in cui la drammaturgia in lingua francese permane durante l’occupazione inglese e dopo la dichiarazione di indipendenza. Nato come genere di intrattenimento per i coloni stanziatisi sull’isola nei primi anni del XVIII secolo, che, recandosi a teatro, cercavano di conformarsi allo stile di vita della Metropoli, il teatro 234 acquisisce, nel corso dei secoli, una funzione eminentemente politica: di contestazione del Potere centrale, di formazione della coscienza collettiva. «À qui doit être attribué le mérite d’avoir instauré l’art dramatique à l’Isle de France? […] il est permis de penser que ce doit être à Mahé de Labourdonnais, car, dans une lettre en date du 4 novembre 1754 […] il est dit que Labourdonnais avait doté la ville de Port-Louis d’une salle de spectacle et qu’à cette époque (1754), on y jouait la comédie.»1 Come testimonia il documentato testo di Chelin, dalla sua istituzione, l’interesse per il genere drammatico non è mai venuto meno sull’isola, nonostante l’alternarsi delle catastrofi naturali (gli uragani, gli incendi, come pure le devastanti epidemie di vaiolo e colera) abbia costretto a interruzioni forzate per molti decenni. La partecipazione di buona parte della popolazione mauriziana (anche delle classi inferiori) all’evento teatrale conferma il ruolo anzitutto sociale, principalmente di circostanza mondana, che il teatro ricopriva in una società evoluta nei gusti e addentro alle complesse relazioni pubbliche. La cura riservata al genere, dai Mauriziani, si riflette nella programmazione stagionale della piccola sala e poi del teatro costruito da Thuillier2 le cui rappresentazioni, messe in scena dalla seconda metà del Settecento fino a tutto l’Ottocento, fanno riferimento ai grandi spettacoli teatrali della Metropoli (considerando che le troupes ingaggiate erano soprattutto francesi3). Il confronto con Parigi, che si esprime anzitutto con l’emulazione e la ripresa delle opere e i generi più fortunati nella capitale (gli opéras-comiques, le commedie di Molière, le tragedie raciniane e i drammi di nuova concezione borghese, e, nel tardo Ottocento, soprattutto i vaudevilles), può essere interpretato come il tentativo di integrazione di quei coloni alla madrepatria, prima lontana, poi, successivamente negata dall’occupazione inglese. Il teatro si comporta, quindi per l’isola, come un termometro sociale, nel rilevare i cambiamenti e i dissensi al mutamento dell’ordine costituito, lasciando intendere, anche nella sua veste mondana, una vocazione anzitutto politica di difensore: della memoria culturale dei Creoli francesi, e dei privilegi delle classi più elevate, i Mauriziani di origine francese, detentori all’Île de France del potere amministrativo ed economico, e, non ultima, dell’autorità linguistica. 1 Antoine Chelin, Le théâtre à l’Île Maurice, son origine et son développement, Port-Louis, The Mauritius Printing Cy.LTD., 1954, p 1. 2 «Le 4 février 1797, Pierre Etienne Thuillier, […] adressa à l’Assemblée Coloniale une requête pour obtenir la cession du terrain au jardin de la Compagnie. […] Thuillier s’engageait […] à verser à la Commune du Port Nord-Ouest une redevance annuelle de cent piastres effectives et à faire donner tous les ans deux représentations au profit des pauvres […].», Ibid., pp. 10-11. 3 «Il semblait qu’à cette époque les spectacles étaient donnés par des professionnels […]. Les pièces les plus appréciées par le public étaient les opéras-comiques, les drames et les comédies […]. Laglaine arriva à Paris dans un moment propice; la Révolution qui inquiétait tout le monde, faisait chômer les comédiens et il lui fut assez facile de recruter les artistes dont il avait besoin.», Ibid., pp. 4-5. 235 Nonostante le numerose edizioni teatrali risalenti al XVIII secolo diano testimonianza di una ricca produzione drammatica, nondimeno, molti critici ritengono ancora oggi di poter affermare che l’attività teatrale a Maurice sia un fatto recente, circoscritto al periodo postcoloniale. L’alto valore poetico di autori come Chazal e di Prosper, la vocazione romanzesca dell’isola, attestata da Loys Masson, da Le Cézio, e recentemente da Ananda Devy, nell’offuscare un fenomeno teatrale non sempre rilevante, hanno certamente assecondato il radicarsi di tale opinione, per la quale i rari, per lo più irrilevanti, eventi teatrali dell’isola sarebbero la prova dello scarso interesse della popolazione mauriziana verso il genere, confermando l’impossibilità di reclamare l’esistenza di un teatro mauriziano precedente al 19724. Fatta eccezione per Chazal (1950), il cui esibizionismo e singolarità si tradussero in un teatro visionario ed esaltato, nell’impossibilità di attribuire una capacità inventiva, una qualche originalità alle opere di fine Ottocento, inizio Novecento, Decotter preferisce respingere l’idea di un teatro mauriziano anteriore all’indipendenza, piuttosto che ricercare e interrogarsi sulle ragioni di un teatro dell’imitazione, che porterebbero all’elaborazione di una specifica estetica teatrale dell’isola Maurice prima del 1968. Solo nell’ultimo decennio, e in difesa di un’originalità delle opere mauriziane rispetto a quelle teatrali africane (a cui la produzione locale è stata spesso e a torto identificata), studiosi come Vicram hanno avanzato un’esegesi del teatro mauriziano dalle sue prime manifestazioni ai giorni nostri, nel tentativo di restituire, con l’esempio del teatro creolo, una visione obiettiva e completa del panorama letterario dell’isola. Nonostante la prima sala di teatro fosse stata edificata nel 1757, ancorché già dalla seconda metà del XVIII secolo si fosse potuta registrare una discreta partecipazione della popolazione mauriziana agli eventi teatrali, e numerosi cittadini si fossero improvvisati autori di commedie e tragedie per il piacere che tale svago forniva5, solo dopo la conquista inglese del 1810, la produzione del luogo è stata oggetto di uno studio e di un censimento sistematico, a conferma del significato implicitamente politico che il teatro aveva assunto non solo per gli autori, ma per gli stessi lettori e appassionati del genere, Inglesi quanto Francesi. 4 «Dans le domaine de la dramaturgie, les écrivains mauriciens n’ont pas beaucoup produit. Ce fait que parler de dramaturgie mauricienne, c’est restreindre le sujet au présent contexte.», G. André Decotter, Le Plaza. Un demi-siècle de vie théâtrale, Port-Louis, PrecigraphLTD, 1983, p. 75. 5 «Cependant, avant que la salle de spectacle ne fut achevée, de bals et de concerts y furent donnés par la “Société Dramatique et lyrique” formée par des amateurs […].» «En 1825 et 1826 […] Le comité réussit dans sa tache, et une société qui prit le titre de Théâtre de Société, uniquement composée d’amateurs mauriciens, dont Eugène Leclézio était le trésorier, […].»,Antoine Chelin, Le théâtre à l’Île Maurice, son origine et son développement, op. cit., p. 14, p. 31. 236 «Le théâtre était ordinairement le lieu où les sentiments nationaux s’affrontaient.»6 In proposito, Chelin riferisce di due episodi esemplari e chiarificatori del modo in cui veniva vissuto e recepito il teatro (più come tribuna politica che come spazio atto alla rappresentazione) dal Mauriziano di lingua inglese e francese nel XIX secolo. Nel 1811, a un anno dall’occupazione inglese, durante la rappresentazione dell’opera di Dalayrac Azémia ou les sauvages7, la manifestazione patriottica di un marinaio inglese fu l’occasione per il nuovo governo di protestare contro la condotta dissidente dei vecchi coloni francesi, ostinati nel non voler riconoscere la legittimità dell’autorità britannica sull’antica Île de France8. Sebbene il teatro fosse accessibile a tutte le classi, ancora dopo il 1794 (dopo i vari tentativi del governo repubblicano di ratificare la legge sull’abolizione della schiavitù), nel Petit Cercle di PortLouis vigeva una rigida etichetta sull’assegnazione dei posti in sala. La differente realtà delle colonie inglesi, dove il servaggio era stato abolito sin dal 1807 con l’obiettivo di promuovere gli schiavi allo stato di liberi cittadini, fu motivo di nuovi contrasti tra i difensori francesi delle prerogative di casta e i colonizzatori inglesi. Nel 1823, alla prima dell’opera in tre atti Le Déserteur, e del vaudeville Angéline9 un’intera sala fu messa a soqquadro per impedire che un ufficiale di colore inglese prendesse posto nella platea assieme ai suoi compagni d’arme, tra il pubblico della borghesia latifondista dell’isola rigorosamente bianca e francese10. Ma il segno più evidente di dissenso verso l’aggressore britannico si espresse soprattutto nella conservazione della lingua francese nel settore scolastico, e nell’ambito giudiziario per oltre un secolo dalla conquista inglese, opposizione di cui l’attività letteraria divenne catalizzatrice, e il teatro luogo privilegiato della sua spettacolarizzazione. Elevato a strumento politico di difesa dell’identità della comunità Franco-creola dell’isola, il teatro diventa l’eco dei precari equilibri che lacerano le diverse etnie dell’isola: lo spazio ove 6 Ibid., p. 28. Nicolas-Marie Dalayrac (1753-1809), Azémia ou les sauvages, ou Le nouveau Robinson, comédie en trois actes, Paris, Leduc. 1786. 8 «Un soir de mars 1811, où l’on donnait un opéra de Dalayrac: Azémia ou les sauvages […]. Après le premier acte, aussitôt que le rideau fut baissé, […] à ce moment, dans la galerie supérieure, un matelot aviné, un violon à la main, se mit à chanter le God saive the King en s’accompagnant de son instrument criard.», Ibid., p. 16. 9 Le Déserteur, opéra comique en trois actes, paroles de Michel-Jean Sedaine (1719-1797) et musique de PierreAlexandre Monsigny (1729-1817), Paris, Herissaut Claude 1769. Armand d’Atois, Angéline ou La Champenoise, comédie-vaudeville en un acte, imitée de l’allemand, Paris, J. Didot l’ane, 1830. 10 «Le mois de janvier 1823 fut marqué par un incident malheureux […] Charles Letord […] entra au théâtre en compagnie de deux officiers anglais de ce navire. Il s’installèrent au parterre où, d’après l’usage reconnu alors, aucun homme de couleur ne pouvait être admis.», Antoine Chelin, Le théâtre à l’Île Maurice, son origine et son développement, op. cit., pp. 25-26. 7 237 rianimare la resistenza politica e culturale della popolazione mauriziana all’autorità inglese, fiaccata negli anni dal sentimento sempre più acuto dell’esilio e della divisione dalla madrepatria. La progressiva alienazione della comunità francese da una realtà politica e sociale in continua e radicale evoluzione, tra il 1800 e la fine del 1900 (con il passaggio dal governo francese a quello inglese, l’abolizione della schiavitù e l’introduzione degli engagés indiani, l’estensione del diritto di voto alla maggioranza indiana, l’indipendenza e la successiva perdita di potere della vecchia oligarchia francese), si riflette in una produzione teatrale caratterizzata dapprima dall’emulazione dei soggetti e dei generi letterari francesi, per poi risolversi nel collasso della parola e dello spazio teatrale per una successiva rigenerazione del linguaggio, per mezzo di esperienze culturali e sociali nuove (massimamente indiane e cinesi). A partire dalla relazione che è stata istituita tra società e rappresentazione, è possibile dividere la produzione teatrale mauriziana in tre periodi principali11. Il primo periodo, protrattosi per oltre un secolo, dal 1800 al 1950, è dominato da una creazione specificamente in francese. Assunta dai drammaturghi come mezzo per esprimere la propria resistenza verso il nuovo occupante, la scelta della lingua francese vuole essere a un tempo una risoluzione estetica, ma soprattutto un’arma politica anti-inglese e anti-indiana12. Contro uno stile ancora classico, soggiogato da una retorica piatta e sentimentale, l’originalità della produzione si riflette nel significato esclusivamente politico che la lingua francese e i soggetti trattati assumono per gli autori mauriziani in aperto dissenso con una realtà ingannevole e crudele13. La scelta di soggetti storici, come la disfatta francese del 181014, la celebrazione di Napoleone, spirito della rivoluzione e generale liberatore dei popoli oppressi15, la rappresentazione di eventi del passato recente, come la prima guerra mondiale16, sono lo strumento per manifestare la resistenza del popolo mauriziano francese all’invasore inglese. Sono, soprattutto, il mezzo per celebrare e riaffermare, con gli episodi anche dolorosi della memoria collettiva, il legame spirituale con una madrepatria che, pure, negata nella realtà, rivive negli eroi incorrotti, nei martiri del sacrificio: è 11 «De 1800 à 1990, on peut distinguer trois étapes de la littérature mauricienne […]. Du XIX siècle jusqu’à la seconde guerre, le français est un choix linguistique et idéologique […].», Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expréssion française. Essai d’analyse socio-culturelle, Port-Louis, Best GraphicLTD, 1990, p. 16. 12 Ibid., p. 17. 13 Ricordiamo che a partire dalla colonizzazione inglese, i Francesi dell’isola non mancarono di rivendicare i diritto di priorità, quindi proprietà, del suolo Mauriziano, continuando a sperare fino alla seconda guerra mondiale in un tempestivo intervento della Francia a ristabilire la legalità del governo francese sull’isola (ivi, Capitolo I, Le incerte declinazioni della libertà, Diaspora etnica e communalismo, la de-costruzione della Repubblica mauriziana). 14 Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers. Représenté sur le théâtre de Port-Louis le 27 août 1883. Préf. de Henri Sénèque, Port-Louis, The General Printing Company, 1883. 15 «Les artistes réunis donnèrent le 6 mai 1853 une pièce nouvelle d’un de nos compatriotes, Moise Constant, Royalistes et Bonapartistes, épisode en un acte du retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Elle fut bien accueillie par le public qui rendit hommage à l’auteur par d’unanimes applaudissements.», Antoine Chelin, Le théâtre à l’Île Maurice, son origine et son développement, op. cit., p. 68. 16 Clément Charoux, L’Ambulance. Scène patriotique en vers, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1918. Arthur Martial, Amour et Patrie. Pièce patriotique en un acte 14 juillet 1922, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1922,. Raoul Ollivry, La Rencontre. Pièce en un acte et en prose, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1922. 238 l’esaltazione ideale di un mondo che l’esilio ha mutato in terra mitica, la cui sacralità si rivela nell’uso mistico del linguaggio, divenuto atto rituale, nella misura in cui personaggi differenti, e diversi autori ricorrono a espressioni ugualmente enfatiche per designare l’oggetto del desiderio17. L’immagine della Francia e l’universo francese sono consacrati, quindi, dall’ostentazione di una parola e di un’elocuzione volutamente preziose, intenzionalmente sentimentali a mostrare come lo strappo profondo dell’individuo dalla patria di elezione trasformi la mancanza talora in trasporto entusiastico, altre volte in solitaria contemplazione. Dacché i soggetti storici non riescono più a rappresentare il contrasto tra le due ere (pre e postcoloniale) e le due terre mauriziane (l’Île de France e Maurice), e la guerra non nobilita più gli eroi che combattono per la liberazione della patria, i drammaturghi fanno ricorso al simbolo: all’astrazione e allo struggimento dei paesaggi dell’anima per vivificare la memoria di un’irreale e fantastica Île de France in opposizione a una Maurice che si colora di tristi e mortali presagi18, abitata da personaggi ispirati alla mitologia, ora greca ora scozzese, ma mai strettamente mauriziana19. Dove prima tuonava l’onore di una patria ferita, e la sfida individuale era sempre una dichiarazione di guerra, nelle opere degli anni trenta, allorché le speranze di un ricongiungimento alla patria sembrano ormai sconfessate, l’ostilità e il disprezzo degli antichi versi muta in amara riflessione verso un mondo corrotto20. Gli spazi aperti si rinserrano nei dubbi amorosi, in un ascetismo morale la cui fermezza è vuota sterilità, riflesso della mancanza piuttosto che del rigore. Le forze, inglesi e francesi, che si confrontavano apertamente nell’universo manicheo dei testi di fine Ottocento, per contendersi il corpo e l’anima dell’eroe virtuoso, divengono, nelle opere successive, un’astrazione, una mera congettura, per essere solo intuite, nei testi di inizio Novecento, nelle vaghe allusioni, nelle inaspettate coincidenze: talvolta nei nomi dei personaggi21. La rassegnata accettazione dei testi che precedono la seconda guerra mondiale evolve, all’indomani dell’armistizio, in un rifiuto totale della realtà. La rapida ascesa dell’etnia indiana, 17 «Alors la Patrie est en danger […] appelle ses enfants: je suis son fils, il faut partir.», Arthur Martial, Amour et Patrie. Pièce patriotique en un acte 14 juillet 1922, op. cit., 10. «…La France garde la tête des peuples, pour porter haut les idées d’humanité et fraternité…», Raoul Ollivry, La Rencontre. Pièce en un acte et en prose, op. cit., p. 7. 18 Robert-Edward Hart, Le destin de Sapho. Poème dramatique en un prologue et trois actes, Port-Louis, Esclapon, 1923. Robert-Edward Hart, La Tragédie de Déïrdre, Port-Louis, The Standard Printing Establishement, 1938. 19 Il mito della Lemuria, ovvero quel mondo mitico abitato da giganti, antica Atlantide poi scomparsa nelle acque dell’Oceano e di cui a Maurice rimangono i segni nelle montagne, sarebbe stata elaborata da Jules Hermann per poi essere ripresa da Chazal, solo nella prima metà del Novecento. 20 «Oh! Comme tout passe et tout meurt en ce monde!/Les générations changent ainsi que l’onde:/les esprits sont légers, les cœurs sont inconstants./Et les fils font rougir les pères…», Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, op. cit., p. 8. 21 Robert-Edward Hart, L’Egide. Un acte en prose, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1924. Dove il protagonista della storia è Maurice ingannato da Jane (artista inglese), e la scena è ambientata a Versailles. 239 coordinatrice delle forze sindacali e fautrice di un cambiamento in senso democratico e progressista della politica mauriziana, anziché spingere l’oligarchia francese al rinnovamento per un’integrazione delle forze locali, la persuade della necessità e della fatalità dell’esilio22. L’era postbellica, la ridefinizione degli equilibri mondiali e dei diritti dei popoli colonizzati, nel rendere obsoleti i rapporti tra colonizzatore e colonizzato, tra padrone e sottoposto, aprono, a Maurice, nuove prospettive per il riconoscimento e l’attribuzione del potere politico a quelle etnie, indiana e cinese, rimaste sotto l’egida della minoranza francese dal XIX secolo. L’irruzione nel sistema letterario maurziano degli scrittori indiani è sintomo della crisi del sistema culturale e politico che vive la comunità francese di quegli anni. Contro l’aggressione politica e linguistica perpetrata dai coloni francesi a danno delle etnie numericamente predominanti, e in favore del recupero e della promozione della lingua inglese23, gli Indiani, più che istigatori, sono i testimoni dello smarrimento e dell’inquietudine esistenziale, della definitiva risoluzione al silenzio e all’oblio che caratterizza l’ultima produzione teatrale mauriziana in lingua francese. Il teatro diventa, allora, il luogo in cui esacerbare le frustrazioni dell’anima, in cui dare voce e corpo alla propria fuga da un universo paradossale, in cui secoli di storia e di controffensiva politica e linguistica sembrano, d’un tratto, negati. La perdita di riferimenti culturali (ora che l’universo anglofona ha definitivamente estromesso il francofona dalla produzione letteraria locale), si traduce in un teatro rivolto all’analisi dell’individuo, divenuto a un tempo oggetto psicanalitico, e soggetto metafisico. A partire da Chazal, per circa un ventennio, la produzione mauriziana si rivelerà tra le più feconde ed eterogenee del panorama dell’Oceano Indiano, tale che è necessario distinguere le varie esperienze teatrali, prodottesi tra il 1950 e il 1970, come il frutto di differenti sperimentazioni. Gli stessi autori si sono lasciati tentare indistintamente dal teatro espressionista e dal teatro dell’assurdo24; hanno aderito alle provocazioni surrealiste, pur aspirando a un teatro profetico25; 22 Ricordiamo che tra il 1966 e il 1968, molti dei Mauriziani di origine francese decisero di emigrare in Australia e in Sudafrica per manifestare il proprio dissenso alla politica locale (capitolo I, Le incerte declinazioni della libertà, 1946, 1960, 1968, la Réunion, il Madagascar e Maurice tra indipendenza e departimentalizzazione). 23 L’istituzione a Maurice del Festival de Drammaturgie nel 1950, offre l’occasione agli intellettuali indiani di rivendicare la loro appartenenza al mondo culturale inglese. È a partire da quegli anni che gli scrittori indiani si attiveranno per dare vita ad associazioni culturali interessate all’allestimento di opere d’avanguardia e politicamente impegnate, come il teatro di Brecht introdotto nel 1970 da Mohan Maharishi. G. André Decotter, Le Plaza. Un demisiècle de vie théâtrale, op. cit., p. 41, p. 52. In realtà, anche se osteggiata dai Francesi, l’attività teatrale inglese aveva avuto inizio sin dal 1823 con la prima rappresentazione in lingua dell’opera Douglas di Home. Nel corso del 1900, erano stati istituiti numerosi club amatoriali, i quali provvedevano al reclutamento degli attori (gente del luogo) e all’allestimento delle scene. Ibid., p. 14. 24 André Masson, L’Étoile, Port-Louis, Regent Press, 1966, dramma che potremmo definire espressionista, contro una rappresentazione vicina alle atmosfere del teatro dell’assurdo di Beckett di La Verrue. Pièce en trois actes. La conversation. Pièce en un acte, Port-Louis, Regent Press and Stationery, 1971. 25 Malcolm Chazal, Judas, Port-Louis, Esclapon Limited, 1953, e Les Désamorantes. Satire-drame en cinq actes suivi de Le Concile des poètes. Théâtre prophétique en un acte, Port-Louis, The Mauritius Printing Cy limited, C. Marier-d’Unenville, 1954. 240 hanno condiviso i tormenti morali claudeliani per investirli dell’impietosa luce della razionalità psicanalitica26. Ora che l’identità dell’uomo mauriziano è resa incerta dagli eventi presenti, contro il teatro realista e storico di fine Ottocento, i drammaturghi della seconda metà del Novecento negano la possibilità di uno sguardo oggettivo sul reale, proponendo una rappresentazione sempre delirante e simbolica della realtà. In piena adesione al teatro espressionista tedesco, il dramma umano del popolo mauriziano diviso tra due realtà (francese e inglese), nondimeno estraneo ad entrambe, si riflette nella scelta di soggetti biblici, nella glorificazione dei personaggi reietti, colpevoli di fronte all’uomo e a Dio: Erode, Barabba, ma, soprattutto, Gesù e Giuda27. Il destino incompiuto del Creolo francese, una volta che l’esilio ha rotto il corso naturale degli eventi, sostituendo alla durata, la fissità di una condizione sempre uguale a se stessa, allo spazio come movimento, il non luogo dell’incerta nazionalità, trova sua piena rappresentazione nel teatro dell’assurdo di Beckett, nel paradosso delle situazioni kafkiane, dove gli individui sono braccati dalla società e dalle cose28. Anche lì dove si intravede un recupero della narrazione storica con la ricostruzione delle vicende dei primi cristiani29, il tema della persecuzione sembra alludere alla realtà dolorosa di molti Mauriziani di origine francese che, nel 1970, dopo l’indipendenza, si sentivano oppressi come comunità dalle etnie emergenti indiane e cinesi. Se i temi più ricorrenti sono il destino dell’uomo e l’esilio, per ciò che concerne l’elaborazione, la sperimentazione di una nuova estetica del testo teatrale, la progressiva perdita della memoria culturale e linguistica si manifesta in un uso sempre metaletterario della lingua francese. Decontestualizzato rispetto al mondo esteriore, ora che l’inglese è divenuta lingua della comunicazione, il francese si rivelerà e sarà usata come lingua della memoria e della meditazione: parola che cita se stessa nel momento in cui non esiste più una realtà fenomenica o psichica che le corrisponde. Il teatro della contestazione e del rifiuto è definitivamente mutato con André Masson ma anche con Chazal in rifiuto della parola e del gesto teatrale come possibilità della manifestazione e denuncia del disagio sociale. 26 Loys Masson, Christobal de Lugo, Le Pape, La Résurrection des corps, Paris, R. Laffont, 1960. Malcolm Chazal, Iésou, théâtre mythique, Port-Louis, Imprimérie Almadinah, 1950. Malcolm Chazal, Judas, op. cit. André Masson, L’Etoile, op. cit. 28 André Masson, Théâtre: La Verrue. Pièce en trois actes. La conversation, op. cit. 29 Théodore Jean-Gérard, La couronne de gloire, Concours Théâtral interafricain, D.A.E.C. coop, 1972. 27 241 Contro un teatro del silenzio della fine degli anni 60, i drammaturghi di ultima generazione, cresciuti nella lotta sindacale e politica dell’isola pre-indipendentista, hanno voluto ricollocare l’evento teatrale all’interno della società, perché del teatro venisse recuperata e celebrata l’antica vocazione politica. Questa diversa concezione del teatro come strumento di formazione delle coscienze (per un’isola in cui la contestazione non era mai stata concepita come evento sociale ma come esaltazione dell’Ideale) è il prodotto di quel gruppo della società mauriziana (la collettività indiana) che dalla sua installazione sull’isola ha manifestato e lottato per la difesa dei diritti delle comunità minoritarie. Condividendo con il teatro africano postcoloniale il medesimo dissenso riguardo alla politica corrotta e dispotica delle nuove repubbliche indipendenti, la produzione teatrale mauriziana degli ultimi venti anni è certamente più vicina al teatro delle ex-colonie di quanto non fossero le opere precedenti. Con il teatro africano degli anni 80, la produzione mauriziana condivide la medesima concezione didascalica della rappresentazione teatrale, la stessa riabilitazione della narrazione naturalista, nella misura in cui la messinscena, come ricostruzione aderente alla società e alle dinamiche sociali, è riconosciuta quale imitazione oggettiva e veritiera del reale. Il teatro di Dev Virahsawmy, di Issa Asgarally, di Etienne Favory si interroga, allo stesso modo dei drammaturghi africani, sulla realtà per investirla di una denuncia morale che colpisce la collettività e la politica delle istituzioni (dal governo al luogo di lavoro). L’ammissione, nel 1972, dei drammaturghi mauriziani al concorso di R.F.I. ha certamente favorito l’avvicinamento della produzione locale a quella negro-africana essendo stati promossi i contatti tra i drammaturghi mauriziani e gli scrittori delle altre colonie francesi (africane, malgasce e antillane), portando a mutazione radicale della produzione teatrale locale. Laddove il teatro franco-creolo di fine Ottocento e della metà del Novecento, espressione di quei colonizzatori-colonizzati, era profondamente dominato dal recupero dei modelli francesi, il teatro indiano e cinese degli anni 70 è figlio degli schiavi, che condividono con il monde noir l’esperienza della deportazione e dello sfruttamento servile. Come nel teatro africano contemporaneo, il ricorso alla narrazione realistica, talvolta satirica, altre volte tragica del presente, si sposa sempre con la sperimentazione linguistica. Laddove, però, la messinscena africana reinterpreta il teatro e la lingua francese sulla base dei tempi del racconto visionario e simbolico del griot, per un recupero dell’identità altrimenti minacciata dall’eurotropismo, il teatro mauriziano contemporaneo, riformulato dagli autori indiani, 242 considera urgente la sperimentazione linguistica, in creolo30 e francese, nella misura in cui offre l’occasione al drammaturgo, quindi alla collettività di fondare una nuova comunità, né francese, né indiana, ma principalmente mauriziana (violando, in tal modo, la visione sacra del passato propria della tradizione africana). «The main priorities behind their theatre were that it should be an important vehicle for the establishement of a national culture — with goes hand in hand with the recognition and the promotion of a national language — and that it should reach as wide as an audience as possible.»31 Agli occhi degli studiosi della letteratura mauriziana, gli ultimi decenni dell’isola assumono, quindi, un’importanza particolare. Non solo il venir meno, all’indomani dell’indipendenza, di referenti tipicamente francesi nel contesto letterario locale ha lasciato aperti diversi interrogativi, ma soprattutto la scelta degli Indiani e dei Cinesi, rappresentanti ancora oggi delle classi più disagiate e operaie, di appropriarsi della lingua dell’antico oppressore sembra essere un’esplicita dichiarazione politica al vecchio tiranno, moderno capitalista francese. L’allargamento del Concorso Interafricano ad altre aree del panorama francofono, e nel 1972 a Maurice, ha favorito la riabilitazione del francese come lingua della cultura e dell’invenzione letteraria. Il francese scritto e reinterpretato dai discendenti degli schiavi e degli engagés, diventa come il creolo (ugualmente presente nel panorama teatrale degli ultimi decenni) uno strumento di lotta politica e di difesa della memoria collettiva. Nonostante la politica dell’isola sia tutt’ora caratterizzata da una divisione etnica che impedisce l’istituzione di una nazione autenticamente mauriziana, gli scrittori locali, più di un drammaturgo hanno comunque voluto promuovere lo spazio teatrale a luogo di fondazione e di formazione per un’identità dell’isola, finalmente affrancata dalle rivalità etniche. La scelta di numerosi drammaturghi di incoraggiare la produzione in creolo è, quindi, da reputarsi una vera e propria rivoluzione culturale degli ultimi anni, visto che ancora nel XIX secolo e per tutta la metà del Novecento, il creolo era considerato dai Mauriziani come la lingua del servitù e dell’umiliazione, e i pochi schiavi ad aver ottenuto la libertà, i rari meticci ad essere riusciti ad elevarsi socialmente si sottraevano intenzionalmente alle maglie del creolo, sinonimo di un passato oscuro, memoria della deportazione e della perdita del nome. 30 «La production de la littérature en créole est fortement marquée par la présence du théâtre et de la poésie. Ils perpétuent la tradition orale, celle du conte populaire.», Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expréssion française. Essai d’analyse socio-culturelle, op. cit., p. 20. 31 Roshni Mooneeram, Theatre in development in Mauritius, from a theatre of protest to a theatre of cultural miscegenation, in African Theatre in development, ed. Martin Banham, James Gibbs, Femi Osofisam, Oxford, James Currey, 1999, p. 25. 243 Scrittori noti anche in Francia, come Léoville L’Homme rinnegarono la loro origine per riconoscere nel francese l’unico strumento per un’approvazione sociale. Non era raro, al tempo, imbattersi in scrittori o giornalisti che preferivano difendere in lingua francese la sorte di molti loro connazionali sfruttati. Diversamente dai Creoli francesi che avevano tentato il riconoscimento sociale per mezzo dell’assimilazione del linguaggio del potere, gli Indiani, a partire dal 1950, e in risposta all’egemonia politica e culturale francese, si sono, invece, fatti promotori della lingua e della letteratura inglese, fino ad allora ignorata dall’élite locale, nonostante l’isola fosse da tempo una colonia britannica. La scelta del creolo, adottata oggi soprattutto dai drammaturghi di origine indiana come Dev Virahsawmy o Azize Asgarally, è l’assunzione di un impegno sociale e politico da parte degli intellettuali di ultima generazione di dare, o di trovare la voce dell’uomo mauriziano (uno nella sua multietnicità), che divergenze politiche ed economiche hanno sempre impedito di manifestarsi. Il recupero del creolo, difeso per la sua poeticità e per la sua flessibilità contro i puristi della lingua francese, rivela, oltretutto, l’intenzione degli scrittori contemporanei di spostare il teatro dalle sale ingemmate e inospitali dei vecchi teatri all’italiana verso la strada, verso il popolo. Rifacendosi a una concezione antica del teatro come educatore del popolo, formatore della coscienza civile, molti autori hanno scelto di promuovere un teatro in creolo proprio in risposta a un sempre maggiore grado di analfabetizzazione e a una crescente incompetenza della cittadinanza verso quelle lingue, oramai straniere, come l’inglese o il francese, confinate a settori specifici ed elitari della vita sociale, come la sfera politica, economica e letteraria «Pour Virahsawmy, Asgarally et Favory, écrire en créole s’insère dans une politique de la lutte des classes. Le créole […] est revendiqué par le prolétariat, classe exploitée par le bourgeoisie.»32 Distintosi, dalla sua istituzione, per la sua vocazione politica, nonostante le opere socialmente impegnate di ultima generazione, il teatro mauriziano rimane, ancora oggi, luogo deputato al silenzio e all’oblio. Il difficile e contrastato rapporto con il presente, che ha caratterizzato la vita del popolo Mauriziano dalla sua costituzione, ha, di fatto, impedito che ci potesse essere un confronto oggettivo con il passato, ostacolando l’elaborazione di una storia collettiva. Il teatro si è fatto interprete di una rappresentazione del reale sempre ferma all’evento presente, sempre giornalistica nella misura in cui il racconto dell’attualità ha sofferto, dalle prime rappresentazioni, della mancanza dell’interpretazione di molti dolorosi eventi che hanno marcato la 32 Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expréssion française. Essai d’analyse socio-culturelle, op. cit., p. 19. 244 vita mauriziana: come la schiavitù, la deportazione, le guerre religiose ed etniche, i problemi razziali. A differenza di una prosa e di una poesia che hanno tentato di mostrare la complessità del contesto attuale, partendo dalla riflessione sulle ragioni storiche di una collettività multirazziale ancora lacerata dai comunalismi, il teatro, consumato dalle rappresaglie politiche, non si è mai fatto concretamente interprete del reale. Ignorando i contrasti razziali, misconoscendo il passato per l’eterna celebrazione del presente, il teatro mauriziano rimane la cassa di risonanza di un mondo in mutazione di cui condanna i torti e le lacune senza, tuttavia, riuscire ad afferrarne appieno la drammaticità. 245 Dal neoclassicismo al romanticismo Hortense de Céré-Barbé, Léoville L’Homme, Arthur Martial, Raoul Ollivry Tra Corneille e Schiller, fortuna e declino dell’impero francese Il teatro di Mme Hortense de Céré-Barbé. Ad introdurre la prima sezione del paragrafo dedicato al teatro mauriziano è la scrittrice Mme Hortense de Céré-Barbé, figlia del naturalista Céré33. L’interesse che suscita oggi un’opera evidentemente ispirata al genere classico del Seicento, al momento dell’innovazione drammatica, tardo illuminista e preromantica, della Francia repubblicana e napoleonica, può essere spiegato con l’eccezionalità del caso della drammaturga mauriziana. Non solo le esigue notizie intorno alla produzione teatrale dell’isola, della metà del XVIII e del XIX secolo, rendono qualsiasi, pur breve, testimonianza degna di menzione e di studio, soprattutto, il fatto che venga annoverata una donna come prima drammaturga dell’isola è rappresentativo della particolare vocazione letteraria mauriziana nel fare appello al sesso femminile nella spinta al rinnovamento della drammaturgia locale, caso unico nell’Oceano Indiano, ancor più delle origini34. È parso non meno singolare che il primo autore di teatro mauriziano francofono, menzionato negli annali dell’isola, sia il solo drammaturgo ad aver prodotto per il teatro quando l’isola era ancora sotto il dominio francese, dacché tutta la produzione mauriziana successiva al 1814 è segnata dal doppio sentimento di esilio dalla Francia, patria spirituale, e di rifiuto del governo britannico. Il 10 aprile del 1809, Mme Hortense de Céré-Barbé sottoponeva la lettura della tragedia in cinque atti Maximien35 a una commissione francese. La breve introduzione al testo riferisce di una duplice stesura della tragedia conseguente alla prima richiesta da parte del comitato (1809) di modificare il terzo atto ritenuto un plagio 33 Non sono state rinvenute notizie biografiche che possano fornire un quadro esaustivo sulla vita dell’autrice mauriziana. Sappiamo che dopo la caduta di Napoleone, e l’assoggettamento dell’isola da parte degli Inglesi, Mme Hortense de Céré-Barbé continuò a scrivere e dedicare le sue opere, di ispirazione classica, al re di Francia. Un certo interesse sembrano aver sortito le Heures Poétiques et Religeuses (1828), meditazioni di chiara ispirazione romantica nel celebrare il mondo cattolico: le feste religiose, il Diluvio, le Catacombe, l’Apocalisse. Tra le varie composizioni, le è stata attribuita una Ode à la liberté nella quale la poetessa rinnova la sua fedeltà al regno francese: «Par la citoyenne Berbé, née Céré, créole de l’Isle de France.». Le informazioni, qui riportate, sono state tratte da J.J Waslay Ithier, La littérature de langue française à l’Île Maurice, Genève-Paris, Slatkine, 1981, p. 55. 34 Ganaba Abdoulaye fa notare la discreta partecipazione femminile nel concorso teatrale di R.F.I. tra il 1972-1973. Ganaba Abdoluaye, Analyse thématique et sociologique du Concours théâtral de 1967/1973, op. cit., p. 82. 35 Mme Hortense de Céré-Barbé, Maximien. Tragédie en cinq actes en vers, Paris, Germain-Mathiot/Poulet, 1813. Riassunto pp. 485-486. 246 dell’Artaxerce36. Nonostante l’autrice avesse apportato le modifiche alla tragedia del 1809, non acconsentì comunque che l’opera, pubblicata nel 1813, fosse più tardi messa in scena37. Le due versioni di cui ci informa la premessa (1809 e 1813) raccontano di un’opera composta a ridosso di due eventi capitali per l’isola dell’Oceano Indiano: la battaglia del 1810 a seguito della quale Maurice fu occupata dagli Inglesi (penetrati da Cape Malheureux); il Congresso di Parigi del 1814, con il quale si decretò la definitiva cessione dell’isola all’impero britannico. Nonostante, al tempo della stesura e della pubblicazione, l’Île de France dovesse essere ancora considerata una colonia francese, è evidente lo stato di allerta e di incertezza nella quale si trovò a scrivere l’autrice. Il contesto storico e il tema trattato nell’opera (le losche trame ordite da Massimiano per destituire Constantino dal potere) suggeriscono, quindi, un’interpretazione essenzialmente politica della tragedia. A rafforzare l’ipotesi del contenuto storico-politico del testo, è la tendenza generale della produzione drammatica francese del tempo, orientata dal governo soprattutto verso la restaurazione della tragedia classica francese del XVII secolo, di Corneille e Racine, perché la rievocazione della letteratura del Grand Siècle fosse la celebrazione del genio francese ora che l’impero romano era stato audacemente ricostituito da Napoleone. Già negli anni della Rivoluzione, i giacobini, prima, il Direttorio, poi, avevano ravvisato nel teatro un forte strumento di propaganda per la diffusione dei nuovi temi libertari e patriottici. Grande ammiratore del teatro del 600, Napoleone scriveva nel 1806: «La tragedia è la scuola dei grandi uomini, deve diventare la scuola dei re e dei popoli…È dovere dei sovrani incoraggiarla e diffonderla…La tragedia infiamma l’animo, eleva i cuori, può, deve creare degli eroi.»38. 36 Nonostante nella premessa non si faccia riferimento a una versione specifica dell’Artaserse, si può supporre che il testo a cui si fa allusione sia quello di Claude Boyer, Artaxerce, tragédie, Paris, C.Blageart, 1683. Altre versioni teatrali dell’Artaserse, ispirate al racconto di Plutarco delle Vite Parallele, erano state messe in scena tra il 1600 e il 1700. Tra le più interessanti notiamo la commedia musicale di Aurelio Aureli, L’Artaxerse overo l’Ormonda Costante, drama in musica, Venezia, 1666, incentrata sull’amore della moglie di Artaserse, Statira, per Eurimene, amico del re, a sua volta amante di Ormonda. Pietro Metastasio, L’Artaserse su musica del Vinci, rappresentata a Roma nel 1730, Milano, Sonzogno, 1927. nella quale emergono, accanto alla figura di un pallido e debole re, quella eroica di Arbace e spietata di Artabano. Gli storici, Plutarco tra tutti, descrivono Artaserse re di Persia, figlio di Serse, come un re dall’animo generoso e magnanimo, nonostante i numerosi omicidi che gli furono attribuiti (probabilmente sul giudizio dovette influire il confronto con i governi più sanguinari del predecessore Serse e del successore Artaserse Ochos). Dei tre fratelli, Ciro tentò più di una volta di destituirlo dal trono arrivando persino ad allearsi con i nemici Lacedemoni per muovere guerra al re. I brevi riferimenti alla vita di Artaserse sono stati desunti da Plutarque, Vies, tome XV, texte établi et traduit par Robert Flacelière, Paris, Les Belles Lettres, 1979, pp. 15-51. Nel 1810 il giovane drammaturgo Delaville de Mirmont (conosciuto come uno dei rappresentanti della commedia borghese antesignana del vaudeville) pubblicava una nuova versione dell’Artaxerce, a riprova del rinnovato interesse da parte degli scrittori del primo Ottocento per i soggetti classici e per la tragedia corneliana (Louis Allard, La comédie de mœurs en France au Dix-Neuvième siècle, Tome II (1815-1830), Paris, Hachette, 1933, p. 304). 37 «Avertissement: Cette tragédie a été reçue aux Français e 10 avril 1809; le comité chargé de l’examiner avait demandé un changement au troisième acte, y trouvant quelque ressemblance avec l’Artexerce; l’auteur a fait cette correction, mais, par raisons particulières, s’est décidée depuis longtemps à ne pas la faire jouer.», Hortense de CéréBarbé, Maximien. Tragédie en cinq actes en vers, op. cit., p. 4. 38 Federico Doglio, Storia del Teatro, dal Barocco al Simbolismo, Milano, Garzanti, 1990, p. 270. 247 Con la riforma della produzione e dell’attività teatrale francese del 1800, che distingueva due diversi generi di teatro: uno grande e uno piccolo, e secondo la quale solo ai grandi teatri era concessa la licenza di rappresentare le tragedie e le commedie del repertorio classico e moderno, Napoleone entrava prepotentemente nella gestione di una grossa parte della produzione artistica votata al sociale (considerando che proprio alla fine del Settecento e nell’Ottocento il teatro era diventato uno dei luoghi più frequentati dalla popolazione parigina e francese in generale). È chiaro, allora, l’intento dell’autrice mauriziana di conformarsi alla tendenza letteraria del momento emula dei grandi del 600 francese, di cui le tragedie voltairiane erano la più recente trascrizione. In un secolo votato al dramma, Voltaire era stato, infatti, l’unico a tentare la reintroduzione della tragedia antica, convinto che già i Greci avessero riconosciuto al genere la prerogativa di formare ed educare la società civile al bene comune e alle più nobili virtù. Contro le nuove teorie teatrali che cercavano, con il dramma, di sottrarre la scena agli eroi paludati ma pur sempre inumani della tradizione classica per offrirla all’uomo, alla famiglia borghese, agli episodi di ordinaria sofferenza disertati dal Fato, alcuni scrittori riconobbero nell’Ottocento il secolo tragico, nella misura in cui un uomo (fosse anche borghese) si era distinto per la sua eccezionalità. Questi ultimi aedi della tragedia aristocratica (considerando che la tragedia del Novecento può definirsi tale per l’assenza dei grandi eroi) dovettero ravvisare nelle gesta napoleoniche, nel suo breve regno, nella nuova geografia europea che il generale corso era intrepidamente riuscito a disegnare, la personificazione dei grandi modelli, dei grandi Cesari del passato: da Alessandro a Carlo Magno. Accanto agli interni austeri delle case borghesi (in cui la virtù si misurava sulla capacità dei personaggi di resistere alle ingiustizie), risorgevano, allora, le colonne del foro; le tele e il teatro di regime venivano invasi dalla retorica imperiale: dai pepli, dalle tuniche rosse, dalle corone che, già sulle monete, modellavano il profilo del nuovo imperatore francese. Tale retorica doveva tradursi, per l’isola fondata negli anni del regno di Luigi XIV, politicamente ed economicamente conservatrice, nella restaurazione dei classici francesi del 600, dopo che, con il ripristino del vecchio Code Noir nel 1803, Napoleone39 si era mostrato sollecito nel difendere le prerogative del mondo coloniale (fermo, alle soglie della rivoluzione industriale, a una concezione del lavoro non dissimile dal vassallaggio medievale, legata allo sfruttamento intensivo del suolo e della forza umana, e che il decreto abolizionista del 1794 aveva, di fatto, minacciato). 39 L’ostilità verso il colonizzatore inglese si concretò, all’Île de France, con l’elaborazione del mito napoleonico. Per tutto l’Ottocento e ancora agli inizi del Novecento poeti e studiosi mauriziani dedicavano componimenti e monografie all’ultimo imperatore d’Occidente, capace di coniugare (e di incarnare allo stesso tempo) gli ideali rivoluzionari alla grandezza del regno di Luigi XIV. Morto in esilio nel 1821, Napoleone diveniva l’emblema dei popoli diseredati ed esiliati (in cui si riconoscevano i creoli mauriziani di origine francese). Nel 1822 veniva edito in Francia Napoléon poema epico in dieci canti di Lorquet. Il successo del componimento fu tale che Giuseppe Bonaparte si adoperò a farlo pubblicare in America e negli altri stati europei. 248 L’azione riformatrice che caratterizzava il nuovo impero, e che sembrava orientata, soprattutto, verso una sistematizzazione dei poteri costituiti, faceva rassomigliare il regno napoleonico, agli ultimi anni dell’impero romano: all’impero di Bisanzio che aveva coniugato il riordinamento giuridico e sociale augusteo al culto del re. Di fronte a un mondo in rapida ascesa eppure già alla soglia della propria decadenza, la drammaturga mauriziana sceglie gli ori dell’impero d’Oriente, che, al tempo, segnò la fine della grande potenza romana, per rappresentare le glorie del regno napoleonico, la cui stabilità era costantemente minacciata dalla nazione inglese. Le analogie tra il regno di Constantino e quello di Napoleone dovettero, allora, sembrare evidenti alla scrittrice soprattutto sul fronte politico. Come l’imperatore di Bisanzio fu costretto a fronteggiare, in seno al governo, gli avversari anticristiani (come Massimiano) e, all’esterno, le popolazioni barbare organizzate e sempre più potenti, così l’avanzata di Napoleone fu prontamente arrestata dai conservatori francesi ed europei, decisi a riportare i Borboni sul trono di Francia, perché fossero restaurati gli equilibri precedenti alla Rivoluzione Francese. Conscia del morbo che si annidava nell’impero napoleonico, Céré-Barbé dovette cogliere tutta la malinconica grandezza di un regno destinato al crollo. Dimostrando una profonda conoscenza degli scrittori del teatro classico francese, anche del meno conosciuto Boyer, Céré-Barbé tentò la conciliazione tra l’universo corneliano e quello raciniano. Virtù e Fato, onore e sensiblerie sono all’origine di una realtà già nostalgica della fiera incorruttibilità, aristocratica alterigia di Horace o Cinna laddove questi eroi sembrano ormai consapevoli della propria inevitabile corruzione40. L’ideale rinascimentale, dell’uomo artefice della propria fortuna, incarnato dai personaggi di Corneille, convive, nel testo di Céré-Barbé, con l’idea raciniana del destino avverso a cui, anche e soprattutto, gli eroi virtuosi sembrano non potersi sottrarre: Maximien, Constantin, Valérien e Lactance (rispettivamente antico console romano, ultimo imperatore di Roma, ministro dello stesso e filosofo) si contrappongono a Flavius e Faustine, amanti sfortunati, il cui legame non è lontano dal riproporre le unioni incestuose, i morbosi affetti di Phèdre, e di Edipo re: Flavius: «Lorsque tous les deux liés par un nœud solennel/Il me fallut encore conduire à l’autel./Où bientôt, rougissant d’une flamme adultère,/Je n’osais l’appeler du nom chéri de mère;/Alors, plus de repos, et mon cœur s’alarmant/De l’aimer comme fils, ou l’aimer comme amant/Aux plus doux sentiments craignant de faire injurie,/D’outrager à la fois l’amour et la Nature […].»41 40 Quello struggimento dell’anima, quella passione per i periodi di decadenza che, pochi anni dopo, avrebbero distinto la sensibilità romantica. 41 Hortense de Céré-Barbé, Maximien. Tragédie en cinq actes en vers, op. cit., p. 11. 249 Questo diverso e opposto ideale umano (desunto dalla filosofia stoica) dà adito, sulla scena, a due differenti rappresentazioni della virtù: quella dell’azione politica, sempre conforme alla legge morale perché razionale, quella del rifiuto dell’azione, dell’apatia, comunque manifestazione dell’agire etico nella misura in cui è accettazione cosciente del destino. La prima, che nelle tragedie corneliane era ispirazione dell’amor patrio e della difesa della libertà individuale, trova compimento in personaggi esaltati e consunti dal loro stesso ideale, la cui passione, ora che la logica politica corneliana è, di fatto, superata, non riesce più a suscitare l’approvazione del pubblico: Maximien: «Il faut, pour assurer cette foule coupable,/Se montrer le plus fort étant inexorable./Pour moi, qui n’eus jamais que mon ambition/Que la gloire et l’honneur pour seule passion. […]/De mes sauvages mœurs conservant la rudesse […].42» Allo stesso modo, il principio morale che giustificava l’atteggiamento apatico dell’individuo, e che si incarna in figure di eccezionale probità, altrettanto valorose sul campo (come Flavius vincitore sul campo di battaglia), è dominio di quegli eroi, il cui ideale del sacrificio si rivela essere, piuttosto, il frutto dell’incapacità di agire sul reale che non il riconoscimento della volontà (ragione) storica: Flavius: «Ah! la haine d’un père est un poids redoutable […]/Augmente les regrets dont je suis déchiré:/Quand j’invoque la mort pour finir ma misère […]/J’ai cherché dans les camps un remède à mes maux,/J’ai trouvé la victoire, et jamais le repos.»43 I dubbi che tormentano Flavius (sulla liceità del suo amore per la matrigna, sulla necessità dell’esilio per rimanere fedele alla patria e al padre) sono, allora, il segno di un personaggio incompleto, costretto a ricercare la realtà del proprio essere nel confronto dialettico con il filosofo Lactance. Dimostrando, a Flavius, la necessità di dominare le sue passioni, Lactance gli ricorda, anzitutto, di essere un personaggio agente, la cui scelta è in sé principio di grandezza: Lactance: «[…] Par ce faible ennemi si vous êtes vaincu,/C’est pour avoir toujours faiblement combattu./Quand on veut triompher, la victoire est facile»44 L’apologia alla morale stoica di Lactance continua con l’esposizione dei principi fondamentali a cui nessuna condotta umana può sottrarsi: sagesse, devoir, volonté, vertu. 42 Ibid., p. 22. Ibid., p. 33. 44 Ibid., p. 12. Tale che di fonte alla prospettiva dell’esilio Flavius piangerà il suo destino, costruendo versi dalla rima certamente rivelatrice: «devoir/désespoir», «destinée/empoisonnée», «douceur/malheur», «vie/patrie», Ibid., p. 24 43 250 Se nei testi di Corneille, la lotta contro le passioni è ricompensata dal trionfo dell’uomo riconosciuto unanimemente come eroe (anche di fronte all’oltraggio dei legami familiari), nella tragedia di Céré-Barbé l’opposizione manichea tra azione politica e integrità morale, impedisce la soluzione del conflitto tragico. Come rivelato prima da Lactance e poi da Flavius, contro il Fato che gioca con il destino umano, all’individuo non resta che l’esilio45 e la morte46. Contrariamente alle tragedie classiche, il sangue sparso generosamente sulla scena non servirà, quindi, alla celebrazione, e poi, alla consacrazione dell’eroe; orfana di personaggi esemplari, l’opera terminerà sul biasimo collettivo dell’azione umana: Maximien: «C’est toi dont le soupçon/Déshonorant ton fils, déshonorant ta femme, /L’a contrainte à glacer par un triste courroux/Un cœur trop pur […]./De tant des cruautés l’univers s’épouvante […].»47 La discrepanza di cui dà prova il testo, nel voler far coesistere due opposte attitudini verso la realtà: l’una attiva, l’altra passiva, l’una cupida, l’altra rassegnata, è certamente frutto delle diverse fonti a cui sembra aver attinto il drammaturga mauriziana. Laddove per la realizzazione dei caratteri di Constantin e di Maximien, Céré-Barbé si è ispirata alla storia di Artaserse, il Don Carlos48 di Schiller sembra aver fornito lo spunto per l’amore taciuto di Flavius per Faustine, i cui dialoghi danno prova delle più raffinate ricercatezze sentimentali. Se la storia di Artaserse e la vicenda di Massimiano erano state sufficientemente sanguinarie da fornire il nodo centrale della tragedia (l’omicidio di Serse e del fratello Dario), il deforme Don Carlos divenuto, nel dramma di Schiller, l’infelice e generoso amante di Elisabetta, si offriva come l’oppositore ideale del tirannico Filippo di Spagna. Céré-Barbé, che si serve di numerosi brani dell’opera schilleriana per dare corpo ad un intrigo politico-sentimentale, tra l’imperatore di Bisanzio e suo figlio49, è debitrice a Schiller di uno dei personaggi più interessanti della pièce: Costantino ricalcato sul re Filippo schilleriano. Contrariamente a Massimiano, condannato dalla sua stessa condotta amorale ad essere riconosciuto come malvagio, Costantino, come il re Filippo di Schiller, è considerato dai suoi sudditi re giusto e magnanimo, entrambe le opere si aprono, infatti, con gli onori tributati dalle nazioni ai due sovrani. Il pubblico indovina sin dall’inizio che la ferocia e l’autoritarismo di cui lo 45 Ibid., p. 11. Flavius: «Oh dieux qui m’accablez d’une injuste colère,/Impitoyables dieux, armez-vous de tonnerre!/Terminez ma douleur en terminant mon sort […]», Ibid., p. 45. 47 Ibid., p. 93. 48 «L’épisode de l’amour de Flavius, sur la simple vue d’un portrait, est emprunté de Don Carlos […].», Ibid., p. 7. 49 La scena del primo atto, l’introduzione di Lactance ispirata al duca di Posa, l’arresto di Don Carlos sospettato di ordire complotti contro il re. 46 251 accusa Massimiano50 sono il frutto del risentimento di un carattere fiero, e non la lucida valutazione della politica imperiale di Bisanzio. Nondimeno, Constantin non può essere collocato tra i personaggi nobili della pièce. Facendo propria la complessità del carattere di Filippo di Spagna, per nulla generoso ma non per questo inumano, Céré-Barbé sposta la tragedia, dall’eroismo suranné di Flavius51, al dramma politico e umano di Constantin: feroce per non essersi voluto sottrarre all’inganno, tiranno per aver fatto dell’azione politica uno strumento del sospetto52: «[…] la tragedia illuministica contro l’assolutismo ecclesiastico e politico si trasformò in realtà […] nel dramma del re Filippo, ossia nella tragedia della responsabilità politica. […] egli [Schiller] propone la tragedia di un effettivo esponente di classe che fallisce come marito, come padre e come uomo.»53 Come altre tragedie del tempo, non diversamente da molti scrittori europei, che condividevano con l’isola mauriziana54 una storia altrettanto incerta e travagliata, l’autrice si allontana dalla tradizione classica, fondata sull’opposizione tra eroi positivi e negativi, per costruire il suo testo principalmente su due personaggi diversamente negativi: Maximien e Constantin, di cui Flavius e Faustine rappresentano l’ideale tradito, quindi il necessario, futuro fallimento (Faustine, fedele all’immagine di un padre altero ma nobile, preferisce la morte di fronte alla rivelazione della colpa; Flavius sceglie il silenzio, piuttosto che seguire l’imperatore nel suo delirio). Se la figura di Massimiano (Maximien), ricalcata sulle biografie degli storici cristiani (severi nel giudicare uno dei più accaniti persecutori delle prime comunità55), restituisce fedelmente l’immagine di un uomo assetato di gloria e vendicativo, Costantino, che, invece, aveva ottenuto l’approvazione degli storici del tempo, per la sua apertura verso la nuova confessione, sembra ricevere, più di Massimiano (e per bocca di Massimiano), la condanna postuma 50 «De son féroce époux apaisa la colère,/Demandant à genoux la grâce de son père./Mon sang bouillonne encore à m’en ressouvenir./ […] Sa mort doit expier la honte de ma vie,/M’affranchir de l’opprobre et de la tyrannie.», Ibid., p. 20. 51 Maximien: «Ah! Combien ce discours a redoublé ma haine./J’abhorre les vertus de cette âme hautaine.», Ibid., p. 17. 52 «funeste soupçon», Ibid., p. 65. 53 Friedrich Schiller, Teatro, Torino, UTET, 1969, p. XX. 54 Ci è parso interessante il confronto che poteva essere istituito tra il teatro risorgimentale italiano (di Foscolo e non di Alfieri) e l’opera di Céré-Barbé. Nonostante, come abbiamo detto, tra il 1809 e il 1813, l’isola potesse ancora essere considerata francese, è plausibile ipotizzare che, soprattutto dopo il 1810, la tragedia risentisse dell’occupazione inglese. Se la nascita di una coscienza mauriziana anti-inglese può considerarsi prematura (differentemente dal caso italiano), nondimeno Céré-Barbé sembra condividere con il Foscolo, riguardo agli eventi storici, il medesimo pessimismo. 55 «Aurelius Valerius Maximianus, empereur romain, né en Pannonie vers 250, mort en 310 après J.-C. […]. Il conspira bientôt contre [Constantin]; mais il fut trahi par sa fille, obligé de fuir, et, après avoir tenté inutilement de soulever les Gaules, il se donna la mort à Marseille. Maximien fut un des plus ardents persécuteurs des chrétiens, ce qui n’a pas peu contribué à le faire peindre sous des sombres couleurs par les anciens écrivains religieux. Il était du reste d’un caractère altier remuant, ambitieux, et apporta dans sa façon de gouverner toute la rudesse, toute la dureté dont il avait pris l’habitude au milieu des camps.», Alain Rey (sous la direction de), Le Petit Robert des noms propres, Paris, VUEF, 2003, p. 1345. 252 «[…] già nel Tieste del 1797 Foscolo aveva rappresentato la lotta tra due classici antagonisti […]. Anche il Foscolo quindi, di fronte a un pubblico che aveva assistito alle efferatezze della Rivoluzione, sente l’esigenza di potenziare gli effetti orrorosi […]. Nell’Ajace questo si realizza con il raddoppiamento del personaggio negativo: oltre al tiranno Agamennone agisce da protagonista anche Ulisse […].»56 Ricordando che la pièce era stata scritta negli anni dell’impero napoleonico, per celebrare un regno che aveva restituito l’isola al vecchio potere conservatore, perché l’imperatore viene fatto oggetto di tale biasimo? Sarebbe infondato supporre che l’autrice usava il personaggio per manifestare il proprio dissenso verso una politica che aveva, chiaramente, tradito gli ideali rivoluzionari (sebbene non siamo in possesso di documenti che sostengano il contrario). Del resto, come detto, l’imperatore sarà assolto, nel testo, dalla sua colpa, per essere stato vittima di Valérien e della sua passione57. In che misura Costantino poteva raccontare il dramma di Napoleone e Massimiano rappresentare la reazione militare inglese e austriaca58? Il commento politico che offre l’autrice mauriziana agli eventi storici che, ineluttabilmente, portavano alla conclusione disastrosa di un regno, ma, soprattutto, del vecchio impero coloniale francese (nel quale l’Île de France aveva sempre ricoperto un importante ruolo strategico), si rivela di un profondo pessimismo. Costantino, Napoleone non sono più i tiranni, nel momento in cui la sorte e il Fato ne fanno la parabola di un’isola che, non ancora vinta, si preparava, già, al lungo esilio. Amore e patria: revanscismo e retorica nazionale. Léoville L’Homme, Arthur Martial, Raoul Ollivry Le dernier tribut59. Apologia della libertà e costruzione del mito mauriziano. 56 Franceso Spera, Metamorfosi del linguaggio tragico, Rovito, Marra ed., 1990, p. 58. «Non è difficile qui sottintendere il parallelismo con la situazione del principe Napoleone, ammirato e stimato, ma oggetto di condanna […] perché traviato dai cattivi consiglieri.», Ibid., p. 64. 58 Ricordiamo che nel 1810, Napoleone sposava Maria Luisa d’Austria figlia dell’imperatore Francesco I d’Austria, uno dei maggiori alleati inglesi nel combattere la politica napoleonica. 59 Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, représentée sur le Théâtre de Port-Louis le 27 août 1883, Port-Louis, General Stean Team Printing Company, 1883. Riassunto p. 486. 57 253 L’allestimento de Le dernier tribut di Léoville L’Homme60 al teatro di Port-Louis nel 1883 inaugurava una nuova fase dell’attività teatrale mauriziana interessata, soprattutto, alla messa in scena del repertorio francese classico e moderno. Quello che si annunciava come un evento mondano di rara eccezionalità (dacché la maggior parte dei drammaturghi locali disertavano le scene mauriziane per le più fastose ribalte parigine, come nel caso di Céré-Barbé), fu acclamato dalla popolazione, in modo particolare dagli intellettuali, come il segno della (ri)nascita61 della letteratura mauriziana francofona. Il poeta mauriziano Henri Sénèque, a cui fu commissionata l’introduzione al dramma di Léoville L’Homme, si fece interprete del consenso unanime, rivendicando il ruolo fondante di un’opera che, riconosciuta per la sua originalità, riapriva il dibattito sull’eredità francese dei Creoli mauriziani (minacciati, alla fine del XIX secolo, da un governo inglese sempre meno tollerante verso la resistenza civile e culturale ingaggiata dai possidenti locali, e a partire dal 1848, dalla comunità indiana vieppiù organizzata nell’ambito politico e sindacale62): «La représentation de ce petit drame, qui était pour notre pays un événement littéraire, a détruit un préjugé qui tendait à s’enraciner chez nous. Il se confirmait que le goût pour les choses de l’esprit […] était bien peu développé dans notre colonie. […] Si vraiment les préoccupations matérielles remplissent la plus grande part de notre la plus grande part de notre existence, il nous reste toutefois dans l’âme […] et dans l’esprit assez de poésie […].»63 60 Celebrato agli inizi del 900 come il padre della letteratura mauriziana, Léoville L’Homme fu riconosciuto dai suoi contemporanei come uno dei più grandi poeti dell’Oceano Indiano. Nato nel 1857, a pochi anni dalla conquista inglese, Léoville L’Homme, Creolo delle isole (nel senso più specifico del termine nella misura in cui alcuni studiosi intendono per Creolo l’abitante dell’isola nato dalla mescolanza delle comunità locali), poté avvantaggiarsi delle riforme sociali, che promuovevano l’allargamento della scolarizzazione anche alla popolazione non bianca (soprattutto i mulatti). Dopo alcuni anni di praticantato presso «La Sentinelle de Maurice» (rivista che aveva come obiettivo l’emancipazione della popolazione di colore sull’isola, di cui il padre era redattore), Léoville L’Homme pubblicava nel 1882 la sua prima raccolta poetica Pages en vers. Ancora poco conosciuto come poeta, L. L. continua ad esercitare per alcuni anni l’attività di giornalista per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla possibilità di un’estensione del voto agli uomini di colore. Divenuto bibliotecario nel 1902, L. L. poteva dedicarsi liberamente alla sua passione letteraria (facendosi promotore della produzione locale e delle isole attraverso riviste di letteratura come «Mauritiana» e l’«Essor»). Morto nel 1928, il poeta sarebbe stato ricordato ancora per pochi anni, per essere poi ignorato dalle generazioni future. 61 Il fatto che, a partire da Léoville L’Homme, gli scrittori mauriziani abbiano incominciato a rivendicare la loro appartenenza al contesto insulare, quando, ancora agli inizi dell’Ottocento, i pochi scrittori del luogo disertavano l’Île de France per riguadagnare il suolo francese, incoraggia l’ipotesi novecentesca del poeta come padre della letteratura mauriziana: «Son nom, il convient qu’on apprenne à le révérer comme celui d’un précurseur, voire d’un initiateur. N’est-ce pas grâce à lui que son île natale, amoureusement chantée, si bine décrite, est entrée pour la première fois dans l’Histoire de la Poésie française?», Duc de Bauffremont,Une colonie spirituelle. La lointaine île Maurice garde le culte des lettres françaises, «Comedia», 31 août 1930. 62 Ricordiamo che solo in seguito all’imponente sciopero indetto dalla comunità indiana nel 1871, il governo prese provvedimenti per mutare la costituzione e garantire condizioni di lavoro meno pesanti nei campi. 63 Ibid., p. I. 254 Sebbene, sin dagli inizi (e in particolar modo durante il governo Decaen), l’attività teatrale avesse assunto un ruolo centrale nella vita intellettuale dell’isola, al punto da coinvolgere gli Inglesi64 da poco subentrati ai Francesi nel governo di Maurice, nondimeno le improvvisate compagnie e i rari produttori del luogo, sempre alla ricerca di un facile guadagno, si affidavano ancora alla popolarità degli autori europei (particolarmente francesi), conosciuti e apprezzati dalla maggior parte del pubblico locale. Come avrebbe, però, denunciato un giornalista mauriziano, nell’aprile del 1932, alla nutrita programmazione, non corrispondeva, nei fatti, una rappresentazione conforme al testo francese originale: «On sait qu’il y a, à Maurice un théâtre. […] On y jouait le répertoire, les “nouveautés” parisiennes, tout ce qui sort à Paris ce qui est très bien./ Mais on jouait, le plus tranquillement du monde avec des textes et des partitions qui, loin de sortir de chez les éditeurs, étaient tout bonnement copiés et retapés au petit bonheur./ La première conséquence était que les Mauriciens avaient ainsi un théâtre déplorable où tout était dénaturé et falsifié. […] C’est dire la qualité des représentations qu’on offre à nos Mauriciens./ Il y a là, pour la pensée française, un ranger incontestable.»65 La messinscena di opere spesso scadenti rispondeva alle esigenze di una produzione amatoriale, incapace di fare fronte ai diritti d’autore, ma, soprattutto, costretta a confrontarsi con il mercato insulare periodicamente minacciato dalle carestie e dalla crisi economica, quindi, con una popolazione sempre più indigente, che, amante della mondanità e alla ricerca di svago, non voleva rinunciare all’occasione di una serata teatrale. La rappresentazione della pièce di un scrittore mauriziano, ancora sconosciuto alla folla e all’intellighenzia del luogo, era l’indice, quindi, dell’orientamento del teatro dell’isola verso una produzione originale, emancipata dal repertorio francese, ma pur sempre ispirata ai modelli letterari della Metropoli europea66. Il nuovo orientamento (lo spostamento dell’interesse dal repertorio francese a quello mauriziano) rivelava, in modo particolare, il diverso ruolo assunto dalla società intellettuale del luogo: prima emula passiva e occasionale della scuola francese, ora animatrice cosciente di un dibattito letterario, 64 Come abbiamo accennato nell’introduzione, nel 1823 veniva allestita sull’isola la prima opera teatrale inglese. Negli anni successivi, nel 1931, la nascita del club teatrale britannico, impegnato nella diffusione del repertorio classico inglese, offrì l’occasione per la riorganizzazione e la rinascita del teatro mauriziano francofono. 65 Duc de Bauffremont, Le théâtre à l’île Maurice, «Comédia», 1930. 66 Il testo di Léoville L’Homme si apre con una dedica al popolare critico teatrale francese Francisque de Sarcey. Nato nel 1827, incapace di conformarsi alla disciplina scolastica, lascia l’insegnamento in provincia (1851-1858) per tentare la carriera giornalistica a Parigi. Dopo aver firmato i suoi primi articoli con lo pseudonimo di Suttières, diviene critico teatrale per l’«Opinion Nationale» e il «Temps» (1860). Tra le sue opere più conosciute Comédiens et comédiennes (1878-1884) e Quarate ans de Théatre (1900). Muore nel 1899. 255 che, destinato alla rappresentazione dei precari equilibri instauratisi dopo il 1810, rivendicava la propria responsabilità politica. Interprete delle due anime romantiche, Léoville L’Homme fece coesistere le vaghe atmosfere contemplative e squisitamente elleniche delle sue raccolte poetiche con una rappresentazione teatrale (erede del teatro post-rivoluzionario del 700) rivolta al presente e al sociale, che si faceva continuatrice ideale di quella tradizione pamphlettistica che aveva contraddistinto l’autore dei libelli de «La Sentinelle de Maurice». Contro una poesia che rivendicava, allora, l’eredità parnassiana di Leconte de Lisle, che rifuggeva la realtà per l’ideale, la storia locale per il mito greco (e per la quale è conosciuto lo scrittore), il dramma scritto nel 1883 (il solo dramma di Léoville L’Homme) si confrontava, invece, con un episodio decisivo per la storia mauriziana: la battaglia franco-inglese del 1810 per il dominio dell’Oceano Indiano, a seguito della quale la Francia aveva perso la sovranità sull’Île de France. Quello che per la memoria collettiva rappresentava un ricordo doloroso, e ancora troppo recente (dall’invasione inglese erano trascorsi poco più di settant’anni), viene, invece, mutato dal poeta in un giorno di gloria, per quei Francesi e quei Creoli che, a dispetto dell’inferiorità numerica, erano riusciti a disperdere la flotta armata britannica nella battaglia del Vieux Grand Port67. Ispirandosi alle immortali gesta degli eroi omerici, Léoville L’Homme canta l’epopea degli «Atheniens de la Mer des Indes»68: il sacrificio di uomini votati alla patria e all’onore, il cui esempio, non più eguagliato ma tradito dagli avvenimenti successivi, era stato mutato dalla storia in mito. Diversamente dall’Iliade, però, la ricostruzione, anche idealizzata, della battaglia del Vieux Grand Port non diminuiva l’importanza dell’evento documentario, non perdeva agli occhi del drammaturgo la sua connotazione essenzialmente e principalmente storica (Léoville L’Homme fa riferimento ad episodi e luoghi reali, oltre che a personaggi storici che ebbero un ruolo fondamentale nel 1810). 67 La conquista dell’antica Île de France da parte degli Inglesi si è consumata in due momenti: il 23 agosto del 1810 con la battaglia dell’isola de La Passe, in seguito alla quale Francesi inflissero una dura sconfitta alle navi britanniche (la battaglia del Vieux Grand Port venne istoriata sull’Arc de Triomphe), e la successiva penetrazione inglese da Cape Malheureux nel novembre/dicembre dello stesso anno: «This battle was an exception to the rule, that while the British controlled the sea Napoleon Bonaparte won only theland wars. It is the sole Napoleonian naval victory inscribed on the Arc de Triomphe in Paris.» (Sydney Selvon, Historical dictionary of Mauritius, London, The Scarecrow Press, 1991, p. 8). Nell’agosto del 1810, occupata l’isola di La Passe, gli Inglesi, confidando nella loro esperienza e nella loro superiorità numerica, si decisero ad attaccare l’isola di Maurice. Contro ogni aspettativa, i Francesi (la flotta locale costituita nel 700 da Labordonnais) e i corsari abbatterono il nemico fiaccandone le forze con una serie di cannoneggiamenti (su 281 marinai ne morirono e rimasero feriti 229, altrettanti vennero catturati, le navi inglesi che non riuscirono a sottrarsi al fuoco affondarono nei pressi della costa mauriziana). Nel novembre del 1810 12,000 uomini dell’esercito inglese sbarcavano a Cape Malheurex e a ovest di Petite Rivière costringendo Decaen e l’isola alla resa definitiva. 68 Henri Sénèque, Préface, in Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, op. cit., p. I. 256 La scelta poetica di destinare la commemorazione del 23 agosto del 1810 al racconto drammatico (che si distingue dalla più nobile tragedia proprio per un linguaggio intimo che non può prescindere dall’adesione emotiva e affettiva dello spettatore69) rivelava la volontà dell’autore di spostare l’attenzione del pubblico dalla grandiosità dell’evento, all’esemplarità del gesto (considerando che, per raccontare l’imminente occupazione dell’isola, Léoville L’Homme sceglie la sola vittoria marittima dei Francesi sugli Inglesi). Perché la battaglia di La Passe potesse essere indicata dalla comunità come l’evento principale della storia insulare: come il mito fondatore del popolo mauriziano, era necessario che l’azione rappresentata si potesse distinguere, non per il suo eroismo, ma perché edificante. Léoville L’Homme rifugge, quindi, la spettacolarità della guerra, la grandezza impersonale dei personaggi celebrati dalla storia, come Duperré e Willoughby, per trasferire il racconto dal mare alle mura domestiche70. Strappati al corso degli eventi, alla cronaca della Storia universale, l’abitante mauriziano poteva attribuire, agli eventi accorsi nel 1810, un significato anzitutto privato: rivendicare, per la vittoria del 23 agosto e la successiva capitolazione, l’espressione di un dramma nazionale. Per sottrarre la vicenda all’anonimato della Storia, che trascura gli aneddoti per l’oggettività dei numeri71, il drammaturgo anticipa il tempo dell’azione al momento che precede la battaglia, riconducendo, e riducendo, l’episodio bellico alle inquietudini, o alle manifestazioni di coraggio, alle prime reazioni dei cittadini: Guillaume Peyraud: «La bataille/Enfin! Va commencer. La poudre et la mitraille/Vont décider du sort de notre cher pays;/ […] Willoughby va gronder, Duperré va rugir/Mais qui donc peut savoir tout ce qui va surgir/De ce conflit sanglant sur la vague profonde/dans ce coin ignoré du monde?»72 La scelta narrativa si rivela l’espediente stilistico attraverso cui il drammaturgo rende possibile la partecipazione emotiva del pubblico alla vicenda raccontata, nella misura in cui la conclusione, solo immaginata da Guillaume, è, invece, già conosciuta dallo spettatore: 69 «La Tragédie, disait Condorcet […] arrache l’homme à lui-même pour l’occuper des grands intérêts de l’humanité. Le Drame, au contraire, me rapproche de moi-même, me présente le tableau des malheurs où mes passions peuvent me plonger.», Félix Gaiffe, Le Drame en France au XVIII siècle, Paris, Armand Colin, 1971, p. 207. 70 «La Tragédie moderne ne sera donc ni la Tragédie mythologique de la Grèce, ni la Tragédie antique du classicisme, ni la Tragédie héroïque du XVIII siècle, mais selon la formule chère à Diderot, une “Tragédie domestique”, illustrant les inquiétudes familières et les malheurs coutumiers de la vie quotidienne. […] conflits familiaux, drames conjugaux, soucis professionnels […].», Michel Lioure, Le Drame de Diderot à Ionesco, Paris, Armand Colin, 1973, p. 29. 71 Nonostante l’impero avesse voluto celebrare la vittoria del Vieux Grand Port immortalando l’evento sull’Arco di Trionfo, nondimeno la battaglia viene ricordata come del tutto secondaria rispetto ai grandi successi di Napoleone sul campo europeo. La poca importanza attribuita all’esito del conflitto (tra le forze inglesi e quelle francesi), deve essere oltretutto considerata la conseguenza di quell’atteggiamento di successivo rifiuto da parte della Francia di riconoscere e difendere apertamente la popolazione creola francofona del luogo. 72 Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, op. cit., p. 10. 257 Guillaume: «Vaincrons-nous pour jamais l’ennemi redouté […]/Ou bien ce noir combat de l’île de la Passe/Donnera-t-il, après de tant de jours de bonheur,/Le signal infamant de notre déshonneur?»73 L’offensiva politica che anima il testo di Léoville L’Homme si rivela, quindi, inaspettatamente, frutto di un credo patriottico che, per la prima volta nella storia della letteratura dell’isola, attinge a una retorica specificamente insulare e mauriziana, prima che francese: Marie: «Oh! Nous serons vainqueurs […]/Le Créole eut toujours l’âme vaillante et fière […]»74 Léoville L’Homme è l’artefice (o l’esegeta?) di questa retorica nazionale che, attraverso l’esempio del valoroso e onesto corsaro Guillaume, erige la coscienza comune (l’individualità del Creolo mauriziano iscritta nei principi della morale borghese) a partire dall’opposizione al nuovo conquistatore «[…] émotion franche et vraie, la flamme, le souffle, l’enthousiasme jeune,viril, épris des choses vieilles […], des lieux communs littéraires, toujours usés, toujours nouveaux: l’amour, la patrie, la famille.»75 La celebrazione di un avvenimento glorioso, quale fu la vittoria del Vieux Grand Port, è, quindi, l’occasione per porre al confronto due diverse realtà dell’isola, due epoche della storia mauriziana: il passato luminoso, l’età dell’oro, di cui i Francesi erano stati i propugnatori e la comunità creola la premurosa custode; il presente di degrado sociale e ambientale conseguente a uno sfruttamento del suolo e delle risorse umane/indiane (cui, soprattutto, il critico sembra far riferimento)76. Elevando il dramma familiare ad esempio e rappresentazione del dramma storico collettivo, facendo della corruzione dei costumi e della virtù il simbolo della prossima sconfitta, Léoville L’Homme si fa interprete del dissenso anti-inglese che gli esiti di una disastrosa rivalità militare77 avevano mutato nell’animo mauriziano in condanna morale. In opposizione a un’etica tutta protestante del profitto (che nel testo si concretizza soprattutto nella conquista di corpi e delle anime78), il drammaturgo si fa promotore di un ideale dell’onore e del martirio che attinge alla retorica, antica ma non per questo abusata, dell’amore patrio: 73 Ibid. Ibid. 75 Ibid., p. VI. Il corsivo è mio. 76 «Notre développement industriel, qui a atteint aujourd’hui ses dernières limites, ne nous laisse plus qu’une terre dénudée et appauvrie, et nous sommes réduits à aimer la patrie dans le souvenir, non pour qu’elle est mais pour qu’elle fut. […] c’est le déclin de notre age d’or.», Ibid., p. II. 77 Jean: «Car ces Anglais, vraiment, sont des marins superbes/[…] Et ce sont des gaillards portant un tel renom/Qu’ils feraient reculer de peur même un canon!/ […] Je conduirai ce soir au combat infernal/Cinq cents hommes à poigne […]», Ibid., p. 14. 78 Noré incarna questo ideale dell’utile nella misura in cui, come dongiovanni dell’isola, si serve delle sue vittime come fossero materia inerte da conquistare e da espugnare. Ibid., pp. 1-7. 74 258 Guillaume: «[…] Qui fit Athènes grande et plus grande encor Rome:/L’amour du sol natal! […]/ Je serais le martyre/Impassible, qui souffre et reste bouche close.»79 Alla luce di un presente che si contraddistingue per il profondo degrado morale, la logica del martirio è usata, quindi, dall’autore (incarnato da Guillaume) per rendere ancora più evidente e dolorosa la perdita di un passato di onore e virtù, di libertà e di unità civile: Guillaume: «Oh! Comme tout passe et tout meurt en ce monde!/Les générations changent ainsi que l’onde:/Les esprits sont légers, les cœurs sont inconstants./Et les fils font rougir les pères […]/Aujourd’hui le vol, la débauche et le rapt ont du cœur des corsaires/chassé le noble essaim des vertus séculaires.»80 Di fronte a questa nuova e doppia qualificazione del cives mauriziano (l’una rispettosa dell’autorità, l’altra incurante della legge), l’oltraggio al nome (la figlia di Guillaume si concede a un uomo sposato) assume la rivelazione di una crisi politica e istituzionale, che lungi dall’illustrare una circostanza del passato, doveva essere riconosciuta dal pubblico come l’immagine della realtà insulare a lui contemporanea Guillaume: «[…] Noré vient de crier devant tous que ma fille/Est la maîtresse et que tu ne saurais jamais/Lui rendre son honneur compromis désormais/Puisque tu n’es pas libre […]/Je vais vous tuer comme des chiens.»81 Rileggendo un avvenimento della storia nazionale recente con la coscienza dell’uomo moderno, assoggettato allo straniero e da tempo spogliato della patria, l’esaltazione del sacrificio, come pratica etica della rinuncia di sé per il bene comune, è l’eredità morale che il drammaturgo lascia ai suoi connazionali. Nel momento in cui Guillaume sta per levare la scure sul capo di Jean, i rimbombi dei cannoni in lontananza lo richiamano al dovere patrio: Guillaume: «[…] tu leur diras, enfant, ma vengeance entravée,/Que sur ton séducteur ma main s’était levée./Mais que j’ai préféré, quand gronda le canon/L’honneur de mon pays à l’honneur de mon nom…/[…] Je serai le pardon, tu seras la pitié.»82 A fronte degli evidenti limiti stilistici, della grossolanità dei contenuti, l’opera di Léoville L’Homme assumeva un valore inconfutabile per i suoi contemporanei, dacché il drammaturgo si 79 Ibid., p. 11. Ibid., pp. 8-9. 81 Ibid., pp. 24-26. 82 Ibid., p. 29. Ricordiamo che proprio a causa del gesto di rinuncia della vendetta personale, l’opera fu giudicata immorale dai contemporanei, Ibid., pp. VII-VIII. 80 259 faceva animatore di un nuovo ideale dell’attività teatrale. Quella che si proponeva, e voleva essere riconosciuta, come l’opera «d’un poète et d’un patriote»83 orientava, di fatto, la produzione locale verso il recupero di una concezione anzitutto politica del dramma nell’accezione più prossima alla sua etimologia. Nel dare voce al dissenso di quei Mauriziani che si sentivano minacciati dal potere inglese e dalla cultura indiana, Le dernier tribut elaborava una retorica nazionale fondata sulla dicotomia: patria/esilio, virtù/sacrificio, che avrebbe caratterizzato e ispirato tutta la drammaturgia mauriziana del Novecento. Arthur Martial, Raoul Ollivry: il primo dopoguerra Per molti Mauriziani, la guerra del 14-18 era stata l’occasione per manifestare la propria devozione alla nazione francese, di cui gli abitanti dell’isola si sentivano i figli proscritti. Ora che la Francia e l’Inghilterra erano alleate contro un nemico comune, la partecipazione dei Creoli francofoni accanto alle due potenze (intervenuti nel conflitto con un apprezzabile quantitativo di uomini e viveri) sembrava offrire i presupposti per la soluzione del lungo assedio britannico in favore della restituzione dell’isola alla Repubblica francese. La ricchezza accumulata dai possidenti franco-creoli durante la guerra aveva, di fatto, rafforzato le ambizioni nazionaliste creole di riavvicinamento alla Francia, ora che la posizione di benessere acquisita riconfermava l’antica oligarchia al governo dell’isola esorcizzando l’autorità politica inglese e l’emergere della comunità indiana. Come in Europa, così nella piccola isola dell’Oceano Indiano, l’arte, soprattutto il teatro, si fece animatrice di una propaganda politica che incitava alla partecipazione e al sacrificio collettivi per la Patria minacciata dall’invasore. Ricordiamo in proposito l’opera di Clément Charoux, L’ambulance del 1918, scritta a pochi mesi dalla fine della guerra, che prendeva spunto dal massacro dei soldati al fronte per rivendicare il dovere etico e sociale dell’intervento bellico per la difesa della Francia84. 83 Ibid., p. X Clément Charoux, L’Ambulance. Scène patriotique en vers, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1918. «Clément Charoux est comptable de propriété sucrière. […] Poésies, nouvelles, romans, conférences, voilà l’œuvre d’un de plus grands successeurs de Léoville L’Homme. […] La France envahie, meurtrie, endeuillée lui a inspiré de beaux poèmes. […] L’Ambulance […] la scène se passe en France dans un hôpital militaire; les grands blessés sont là sur leurs lits de douleurs; ils donnent leurs opinions sur la guerre et ses conséquences./Certains ne voudraient plus bouger […]. D’autres au contraire, par amour de la patrie, s’inclinent devant le devoir […]. […] La Marseillaise parvient jusqu’aux oreilles des malades; tous se lèvent et courent à la fenêtre […] l’amour de la patrie avait vaincu 84 260 Laddove il vecchio continente elaborava una retorica nazionalistica fondata, anzitutto, sull’esaltazione della guerra come unica condizione per una trasformazione politica, ma anche e soprattutto come metafora di un rinnovamento artistico (pensiamo ai Futuristi in Italia e ai Dadaisti in Francia), l’occupazione della Francia nel 1914, e non la guerra, offriva il pretesto agli scrittori mauriziani per dare voce alle proprie rivendicazioni patriottiche. Testimoniando e reclamando, con la partecipazione alla guerra, l’appartenenza spirituale alla nazione francese, depredata nel 1871 dell’Alsazia e della Lorena, ora occupata dall’esercito teutonico, i Mauriziani si appropriavano dei sentimenti revanscisti del popolo francese contro la nazione tedesca, in un strenuo atto di difesa della propria individualità minacciata dalla potenza inglese e indiana. L’aggressione tedesca veniva, quindi, riconosciuta e confrontata dall’abitante dell’isola, anzitutto alla conquista attuata dagli Inglesi un secolo prima. La Francia del 1914, assediata dalla forze nemiche, diveniva metafora del sacrificio e della consecutiva segregazione subita dal popolo mauriziano nel 1814, e, la rivincita contro i Tedeschi poteva essere assimilata alla successiva e personale riscossa della popolazione creola contro l’invasore britannico. Nel 1922 Arthur Martial85 e Raoul Ollivry86 prendevano spunto dal primo conflitto (l’uno metteva in scena l’entrata in guerra della Francia e l’occupazione tedesca, l’altro, la fine delle ostilità e il ritorno alla vita) per raccontare dell’ardore mai spento del popolo mauriziano verso la patria elettiva, quale veniva considerata la Francia. Raccontando dell’imponente partecipazione della cittadinanza al conflitto, i due drammaturghi davano prova anzitutto del valore e dell’abnegazione di un popolo, che, pure, allontanato dalla terra natia (nella misura in cui i primi ad abitare e colonizzare l’isola erano stati dei Francesi), aveva partecipato alla liberazione della Francia e alla sua ricostruzione, senza lesinare l’azione sul campo, con il sacrificio di vite umane e delle proprie ricchezze. toutes les résistances: “Eh bien, oui, on irait! Et tout droit, jusqu’au bout!/Toujours vaillant, toujors français, toujours debout!”.», J.J Waslay Ithier, La littérature de langue française à l’Île Maurice, op. cit., pp. 99-102. 85 Arthur Martial (1899-1951) fece coesistere la sua attività impiegatizia, lavorava come contabile in una piantagione di canna da zucchero, con la passione letteraria. Autore di numerosi articoli per l’«Essor» (per cui usava lo pseudonimo di Pierre Nobel), è ricordato soprattutto come scrittore di romanzi naturalisti, vicini allo stile di Maupassant, attraverso i quali fu capace di restituire la società mauriziana del tempo. Arthur Martial, Amour et Patrie. Pièce patriotique en un acte 14 juillet 1922, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1922. Riassunto p. 486. 86 Nato nel XIX secolo, Raoul Ollivry può essere ricordato come uno dei più prolifici autori di teatro mauriziani del primo 900, come testimoniano le numerose pièces pubblicate tra il 1800 e gli inizi del XX secolo. Nonostante l’intensa produzione, l’autore è, praticamente, ignorato dalle nuove generazioni. Raoul Ollivry, La Rencontre. Pièce en un acte et en prose, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1922. Riassunto pp. 486-487. 261 Il culto di cui è stata oggetto la Francia all’indomani della conquista inglese, il francotropismo87 che sembra emergere dalle pagine dei drammaturghi di fine Ottocento e inizio Novecento, può, quindi, essere spiegato come il disperato tentativo degli scrittori mauriziani di riaffermare la fede comune in un ideale nazione francese contro gli assalti di un mondo in continua evoluzione (agli inizi del Novecento l’etnia indiana si faceva interprete della lotta politica e dell’emancipazione culturale e sociale della comunità operaia). La guerra era stata vissuta dall’isola, veniva ora celebrata nei drammi, come momento di gloria, di risurrezione e di ricongiungimento per i Creoli francofoni alla terra dei padri, nella misura in cui la Francia, occupata, incarnava la patria anelata, ferita e perseguitata da lunghi anni di occupazione illegittima. Se il dramma, con la sua enfasi volutamente eccessiva talvolta lacrimosa88, veniva in soccorso di una narrazione che doveva fare leva sul sentimento nazionale, la guerra combattuta in Francia era assunta come proiezione del caso mauriziano, nel momento in cui l’ideale patrio e il movente revanscista si risolvevano nel tormento, tutto intimo, dell’esilio e della celebrazione del passato. Come già Léoville L’Homme ne Le dernier tribut, così Arthur Martial in Amour et Patrie89 usa il conflitto bellico come pretesto per elaborare e celebrare una retorica nazionale che ha assunto la Francia e la cultura francese come ideale, proprio a partire dalla dialettica, irrisolvibile, dell’esilio: Le Capitaine: «Notre France en guerre!Ah! l’affreuse vision de deuil et de désolation» e avanti Le Capitaine: «Et la satisfaction sublime du devoir accompli: le devoir plus beau, pour la plus belle patrie»90 Ispirandosi al testo del 1883, Martial identifica il sacrificio e l’onore, che ispirano il culto per la patria francese e il nazionalismo mauriziano, al dramma privato di una ragazza delle isole, al 87 Come fa notare Jean-Louis Joubert (Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 116), Jean-Georges Propser fu primo a usare il termine francotropismo, a proposito di Léoville L’Homme e degli scrittori che a lui si ispirarono, per definire una poetica volta soprattutto al recupero e alla celebrazione della cultura francese in opposizione a quella inglese. In proposito, Joubert racconta l’aneddoto di Léoville L’Homme, le cui spoglie vennero ricoperte di terra francese («un peu de sol gaulois […] /Je l’irai, de ma main, répandre au cimentière/Dans la poudre où j’ai vu coucher mes trépassés.», Ibid., p. 117.) come da lui richiesto nella sua celebre «Lettre à un ami». 88 «[…] quello francese […] stava crescendo sul fertile solco d’un “genere” di teatro popolare quel “melodramma” dei teatri periferici […] che dal Settecento in poi […] aveva riscosso grande e duraturo successo. […] resta il dramma o, se si preferisce, il drammaccio con i suoi effetti a sensazione e gli smaccati colpi di scena: passioni elementari, con briganti e tiranni, madri e mogli colpevoli, orfani sventurati, astuzie e agnizioni, veleni e pugnali: tutto in un linguaggio enfatico e pittoresco…Nel mélo, la virtù lotta contro il vizio, l’innocenza perseguitata trionfa dopo casi impressionanti e paradossali; l’ambientazione è storica o esotica.», Federico Doglio, Storia del Teatro, dal Barocco al Simbolismo, op. cit., p. 364. 89 Arthur Martial, Amour et Patrie. Pièce patriotique en un acte 14 juillet 1922, op. cit. 90 Ibid., p. 7, p. 8. 262 fervore di un soldato esule sull’isola, non più troppo vecchio (come Peyraud) per offrire il proprio aiuto alla patria in pericolo, e all’esaltazione di un giovane, che vuole riconosciuta la sua appartenenza alla nazione francese proprio a partire dall’esperienza del martirio José: «Alors la patrie est en danger: le tocsin sonne […] la France appelle ses enfants: je suis son fils, il faut partir.»91 Diversamente da Léoville L’Homme, il dramma che si consuma sull’isola non è la perdita dell’indipendenza, né il pericolo di una disfatta, ma la constatazione del venir meno di un sentimento nazionale che, più dell’occupazione, minaccia l’identità dei Creoli dell’isola. La deflagrazione della guerra sul continente è motivo, allora, per mettere in scena il dubbio (certamente palesato da più di un Mauriziano al tempo della guerra, come già aveva potuto testimoniare Charoux) sulla legittimità delle rivendicazioni della comunità francofona in merito all’appartenenza al mondo francese, archetipo culturale e modello morale ormai troppo distante dalla realtà mauriziana. Quel mondo, già pervaso nel dramma di Léoville L’Homme di pessimismo e di muta rassegnazione, è, ora, dominato da un sentimento di isolamento che ha pervertito e inaridito la condizione originaria di esilio, nella quale il popolo dell’Île de France si riconosceva. Solo a partire dalla dialettica tra le due rappresentazioni della patria negata (quella della separazione e quella della segregazione, incarnate rispettivamente da Vivette, dal capitano e da José) è possibile sconfessare l’errore, quindi rifondare l’ideale nazionale. L’egoismo di una giovane mauriziana che non accetta la partenza del proprio amato per la lontana Europa, per un conflitto estraneo al mondo della piccola isola dell’Oceano Indiano, è la rappresentazione del dramma di una coscienza, oramai, incapace di cogliere la validità e la legittimità di un’azione, unica nel riaffermare la propria individualità: José: «[…] Avant vous, la Patrie a droit a mes jours» Vivette: «Eh bien! Choisissez, ou mon amour, ou votre patrie.» Le Capitaine: «[…] Vous ne pouvez pas savoir quand on est Français ou fils d’un Français, combien l’on souffre dans la chair même, quand souffre la Patrie […].» Vivette: «France, pardonne-moi. Mes yeux soudain se dessillent et mon crime m’épouvante […]. Allez, courez José, leur crier à tous que vous êtes Français et vous aussi partirez.»92 Come già il corsaro Peyraud, ne Le dernier tribut, rappresentava la coscienza e la memoria del mondo antico: dell’età dell’oro mauriziana (quando l’isola era ancora possedimento francese) 91 92 Ibid., p. 10. Ibid., pp. 11-24. Il corsivo è mio. 263 quindi la censura al mondo moderno, così Martial si serve del capitano, spettatore nostalgico del secolo passato, per narrare dell’esilio che vivono i Mauriziani: Le capitaine: «Vous êtes de braves cœurs, vous autres, enfants de la vieille Île de France […] Île de France, ô cher petit pays où l’exil m’est si doux […].»93 Paventato da Léoville L’Homme, l’esilio diventa per Martial lo spazio esistenziale (ma anche sentimentale) nel quale maturare e difendere il concetto di una patria ormai idealizzata (francese e mauriziana), che prende forza a partire da un’etica della vendetta, della revanche. Ora che l’esilio è riconosciuto da Martial come il solo presupposto per una riflessione, quindi fondazione dell’identità mauriziana, l’opposizione tra passato e presente che nel poeta parnassiano era motivo di condanna per la corruzione del mondo tradizionale, si è risolta (con il capitano) nella sovrapposizione tra la vecchia Île de France e la nuova Maurice, tra il Creolo, erede dei primi coloni francesi, e i nuovi abitanti mauriziani. Il mondo ideale che sostiene la logica dell’esilio (ove il presente è negato per il passato) è alla base di una rappresentazione, se non esotica, certamente bucolica dell’universo agognato. Alla prosa enfatica e militante di Martial, replica, negli stessi anni, il dramma meditativo di Raoul Ollivry94 Mirella: «O merveilleux renouveau de la nature! Quels prodiges vous renfermez!»95 Conformandosi alla retorica nazionalista di Léoville L’Homme, Ollivry prende spunto dalla guerra per celebrare il cives mauriziano, esempio di virtù e abnegazione. A differenza di Martial, però, il drammaturgo non costruisce la sua lode a Maurice a partire dall’esaltazione della Francia. Invertendo uno stereotipo letterario, Ollivry sposta l’azione dall’isola al suolo francese, scegliendo due ragazze francesi come testimoni del valore e della generosità dell’isola: Mirella:«Nos deux villes: Blérancourt et Landifay étalent encore leurs ruines.» Chantal: «Réjouissons-nous, cela va changer […]. Vous avez appris sans doute, qu’un généreux et lointain pays, l’île Maurice, avait proposé à la France de nous adopter […]. L’île Maurice, c’est le pays du soleil et de la nature impassiblement verte […]» Mirella: «Et l’on parle encore notre cher langage…partout où flotta le drapeau de la France, il est resté quelque chose au fond du cœur.»96 93 Ibid., p. 8. Come non ravvisare nella strofa di Martial, l’elogio al Creolo di Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, op. cit., p. 10. 94 Raoul Ollivry, La Rencontre. Pièce en un acte et en prose, op. cit. 95 Ibid., p. 1. 96 Ibid., p. 3. 264 L’esilio che, ancora in Martial, si nutriva dell’aspettativa della prossima rivalsa sul potere inglese, in Ollivry è assurto a condizione esistenziale dalla quale il Mauriziano non può sottrarsi. Come già per Léoville L’Homme, così in Ollivry, la prova della grandezza dell’animo mauriziano risiede nella sua vocazione al sacrificio, che è anzitutto accettazione della storia («Je serai le pardon, tu seras la pitié»97). Prendendo spunto dalla riflessione storica, Ollivry costruisce, allora, il suo dramma sul dialogo tra due realtà politiche ormai distanti che, pure, continuano a condividere un bagaglio culturale e linguistico, un passato familiare, che la lontananza non è riuscito ad intaccare. Il drammaturgo però affrancata la sua meditazione da rivendicazioni locali, per fare partecipi della lode alla Francia, le nazioni tutte: France: «[…] La France garde la tête des peuples, pour porter haut les idées d’humanité et de fraternité […]. Elle court, elle vole au secours des faibles. Et si l’humanité plaint les faibles, c’est que la France a crée le sentiment de solidarité entre les hommes…»98 France, Creolo mauriziano, il cui nome è già segno del tentativo di identificazione spirituale dell’abitante dell’isola al cittadino francese, pur ammettendo il legame affettivo con la terra d’oltralpe non nega, né sembra voler minare, il vincolo politico ed istituzionale con la nazione inglese: Chantal: «Donc sous le glorieux drapeau anglais qui flotte sur vos têtes depuis plus d’un siècle, vous conservez le souvenir de la patrie de vos ancêtres, de la vieille et doulce France» France: «L’Angleterre, c’est notre mère aimée et respectée…mais la France, voyez-vous: oh! La France, c’est: “Maman!”»99 Consapevole di una situazione storica che sarebbe difficilmente mutata, presumibilmente favorevole a una politica della collaborazione tra il potere economico e culturale locale (rappresentato dall’oligarchia creola) e quello inglese (la sola via che avrebbe potuto garantire o ritardare l’avanzata indiana sull’isola), Ollivry si fa interprete di una riflessione e di un’esperienza intima del dramma che avrebbe caratterizzato soprattutto i drammaturghi della seconda metà del Novecento. 97 Léoville L’Homme, Le dernier tribut. Drame en un acte en vers, op. cit., p. 29. Raoul Ollivry, La Rencontre. Pièce en un acte et en prose, op. cit., p. 7. 99 Ibid. 98 265 Verso il teatro sperimentale dal dramma morale Robert-Edward Hart, Loys Masson al teatro profetico di Malcolm de Chazal L’infelice Erato Il pessimismo metafisico di Robert Edward Hart Rifuggendo le attrattive della Parigi degli anni Venti, il dinamismo ottimista e costruttivo del dopoguerra (di cui il fervore sperimentale delle avanguardie era la celebrazione), Robert Edward Hart 100 è stato il preconizzatore di un mondo in decadenza, pervaso dalla consapevolezza della colpa e della perdita dell’innocenza (la cui fine si sarebbe palesata solo negli anni Cinquanta). L’esaltazione marziale dei testi patriottici, di poco anteriori, di Martial e di Charoux (L’Ambulance era stata pubblicata nel 1918) sembra del tutto estranea all’universo intimista, desolatamente sospeso, delle opere drammatiche di Hart, molto più vicine, per ispirazione, agli smarrimenti sentimentali, alla tensione morale goetiana. Inizialmente sedotto dal rigore stilistico dei parnassiani (dai preziosismi leziosi di un mondo greco rievocato come archetipo delle bellezza ideale e formale), lo scrittore, contrariamente alla sensibilità poetica ancora classica dei suoi contemporanei, ha successivamente reclamato la sua appartenenza alla scuola simbolista, facendosi promotore, sull’isola, di un rinnovamento della prosodia in favore dell’introduzione del verso libero101. 100 Nato a Port-Louis nel 1891 da padre inglese (notaio, amante dell’arte) e madre francese (discendente del poeta della Pléiade Pontus de Tyard), manifesta sin dalla più giovane età una sensibilità spiccata per la poesia. Il suo incarico di segretario per un deputato del luogo, gli offre la possibilità di viaggiare in Francia, dove fa la conoscenza di numerosi intellettuali parigini. Nonostante il debito evidente alla letteratura francese (subì le influenze del Parnasse per poi interessarsi alle creazioni simboliste), contrariamente a molti suoi contemporanei, R.E. Hart rifiutò di abbandonare la sua isola per Parigi. Noto soprattutto come romanziere e poeta, Le Cycle de Pierre Fiandre (1928-1936) rimane la sua opera più conosciuta e apprezzata. Il ciclo, che si compone di quattro parti, narra il dramma interiore vissuto da Pierre nel passaggio dalla fanciullezza all’età adulta. La disillusione per una realtà che ha perso il fascino e la magia dell’infanzia si vena di malinconia, spesso di tragico pessimismo, come si evince dalle opere di teatro. Muore sull’isola nel 1954. 101 «Au départ, Hart est un poète formé par le Parnasse […]. Puis il évolue vers une forme moins prisonnière de la raideur de l’alexandrin […]. On reconnaîtra volontiers à Hart d’avoir été l’un de premiers, à la fin des années 20, à introduire dans l’île le vers libre […], non sans réticences de la part de ses collègues.», Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indie n, op. cit., p. 128. 266 Come avrebbe, però, affermato un lettore del tempo102, nonostante il Simbolismo e la drammaturgia di fine ottocento (Yeats103 in modo particolare) avessero esercitato sullo scrittore un indubbio influenza, è difficile ravvisare nei testi di Hart modelli letterari differenti da quelli romantici: un languore nostalgico diverso dal pessimismo cinquecentesco di Du Bellay104 (di cui l’autore rivendicava la discendenza spirituale). Nel poeta e romanziere di inizio Novecento, la contrapposizione tra passato e presente, tra età dell’oro e barbarie, che aveva ispirato i libelli politici dei drammaturghi mauriziani (anche recenti) in funzione di un’analisi della realtà e della società dell’isola volutamente in conflitto con l’occupante inglese, è stata interiorizzata per divenire la manifestazione di un conflitto morale tra l’età dell’innocenza, identificata con l’infanzia105, e la maturità, contraddistinta per la sua incapacità comunicativa106. La nostalgia per un tempo anteriore, il doloroso esilio da un mondo incorrotto e da una natura incontaminata, si richiamano pallidamente al fervore politico di Léoville L’Homme, nella misura in cui, come per il drammaturgo dell’Ottocento, la riflessione malinconica di Hart107 non è mai disgiunta dalla condanna morale verso la rappresentazione della condizione presente, per assurgere a riflessione, anzitutto, esistenziale sulla sorte umana e del singolo. Una lirica che sembrava trarre ispirazione da modelli antichi, trascesi da una civiltà del progresso e della macchina, si dimostra attuale, e assolutamente moderna nel cogliere l’aberrazione del pensiero positivista, il cui meccanicismo respingeva l’uomo sull’abisso di un destino svuotato di qualsiasi finalità. Pur richiamandosi, come parnassiano, al pensiero e alla cultura greca, Hart non riconosce nella tragedia umana la manifestazione di un disegno divino. Come il poeta romantico, Hart canta la perdita della libertà e dell’innocenza, diversamente dai romantici, però, l’esilio e il dolore, che sperimenta l’uomo, non mutano l’individuo in eroe tragico. Una volta che il determinismo ha abolito la scala dei valori (ritenendo infeconda e gratuita la distinzione morale tra buono/cattivo, persecutore/perseguitato), per ricondurre tutto a una 102 «À quelle école appartient ce poète extrêmement subtil, sensible et divers? Tantôt il est romantique et tantôt symbolique. Même il a écrit des vers libres qui pourraient à la rigueur l’apparenter aux plus récents cénacles.», Duc de Bauffremont, Une colonie spirituelle. La lointaine île Maurice garde le culte des lettres françaises, op. cit. 103 L’opera drammatica Déirdré è dedicata al poeta irlandese Yeats, fautore, alla fine dell’Ottocento, di una scuola teatrale che si ispirava ai drammi simbolisti di Maeterlinck. 104 «[…] una vena schietta, mossa da una realtà viva, passa attraverso vari gradi dell’espressione, dal concitato sfogo del cuore […] alla contemplazione del nulla […], dal canto dell’esiliato, […] alla protesta morale.», Giovanni Macchia, La letteratura francese dal tramonto del Medioevo al Rinascimento, Milano, B.U.R., 1992, p. 186. 105 «L’enfance n’est pas un temps particulier, elle est comme un état de grâce, une faille dans l’écoulement du temps, un arrêt dans le glissement vers la mort.», Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 130. 106 «Une intrigue amoureuse se greffe sur cette quête. L’enfant Pierre aimait l’enfant Ariane et tous deux formaient la promesse d’un couple heureux. Mais Pierre en abandonnant l’enfance, s’efface devant Jean, l’ami commun. Incapable d’un amour accompli avec une figure féminine, il préfère le rôle adoptif de l’enfant d’Ariane.», Ibid., p. 130. 107 Robert-Edward Hart, Le destin de Sapho. Poème dramatique en un prologue et trois actes, Port-Louis, Esclapon, 1923. Riassunto p. 487. 267 spiegazione scientifica, l’agire umano si scopre rispondere solo a una cieca necessità, che impedisce all’uomo qualsiasi possibilità di riscatto, anche morale Déïrdré: «Nous ne disons que le mot du destin./ Ma vie est fatidique et mon sort fut écrit,/Dès ma naissance, dans les constellations./Quoique je pense ou que je dise ou que je fasse/Est marqué dans le ciel, de toute éternité.»108 I personaggi di Hart sono tutti uomini sconfitti, spettri che corrono verso le tenebre, spinti da una forza oscura: Roi Conor: « Me voici: roule moi dans ta houle infinie,/Viens, anéantis-moi et que je perde enfin jusqu’au souvenir de la vie»109 Condividendo con lo spiritualismo il recupero problematico dell’individuo e della coscienza di fronte alla realtà, il drammaturgo si fa interprete e continuatore di una poetica del pessimismo metafisico che attinge alla tradizione inglese shakespeariana per ricongiungersi a Schopenhauer110. Alla luce di una speculazione filosofica, a partire da una riflessione soprattutto metafisica sulla condizione umana, i drammi dello scrittore mauriziano mettono in scena la parabola dell’individuo 108 Robert-Edward Hart, La Tragédie de Déïrdre, Port-Louis, The Standard Printing Establishement, 1938, p. 10. Riassunto p. 488. Prima, Lavarcam: «Déïrdré, Déïrdré, ton nom veut dire “alarmes”/Et tu es née sous des étoiles maléfiques.», Ibid., p. 8. 109 Ibid., p. 38. 110 «La houle», a un tempo onda e oscillazione, fa pensare al pendolo di Schopenhauer, il quale identificava l’esistenza umana al movimento di un pendolo che oscillava dalla noia alla disperazione. Il movimento dell’onda, che travolge l’uomo riducendolo a cosa inerte e meschina, può essere assimilato al moto insensato della ruota del tempo che rigenera la realtà per poi annientarla. I romantici, e poi Schopenhauer, avevano ravvisato nella drammaturgia shakespeariana la rappresentazione del dramma collettivo, nella misura in cui, il libero arbitrio, l’agire dell’uomo può essere considerato il frutto del meccanismo culturale, una mera illusione. Come per Amleto, così per Déïrdré la realtà, così come viene rappresentata, è un sogno: «L’âme? O poëte, incurable poëte!/L’âme est un songe des songeurs.», Ibid., p. 8. Laddove l’azione è fortemente determinata dalle circostanze esterne, che rimangono inaccessibili all’individuo, la realtà si manifesterà all’uomo sotto due profili distinti. L’opposizione tra l’infanzia e l’età adulta, la fatale evoluzione verso la maturità, viene rappresentata da Hart per mezzo dell’opposizione temporale, tra mattino, meriggio, sera e notte. Alle diverse fasi corrisponde uno scenario differente che, a fronte di un’interiorizzazione del dramma, manifesta il successivo distacco dell’uomo dalla natura. Le destin de Sapho, mette in scena la progressione dal giorno alla notte, come pure la lenta separazione dell’uomo dal mondo (con il drammatico epilogo) realizzanta per mezzo dell’inascoltato richiamo della poetessa verso l’infanzia (Saffo viene avvicinata dal piccolo Hyacinte, ma l’istinto materno non è sufficientemente forte da trattenerla dal compiere il suo gesto estremo). Il dramma de L’égide si consuma di sera, in una villa alle porte di Versaille. La stasi spazio-temporale si oppone all’evoluzione intima del protagonista che matura il suo definitivo rifiuto della realtà sentimentale fatta di inganni. Per La Tragédie de Déïrdre, Hart si è certamente ispirato alla drammaturgia simbolista. Alla tragicità evocata dalla sera, tipicamente romantica, il poeta ha riconosciuto espressa nell’alba, o meglio nel momento che precede l’alba, la manifestazione dell’ineffabilità del dramma morale. Contrariamente alla prima opera, La Tragédie de Déïrdre, muove dal mattino al crepuscolo dell’aurora. Ai diversi luoghi del dramma (la casa di Déïrdre, la foresta, il palazzo di Conor), corrisponde sempre lo stesso intervallo temporale: il mattino, quando i personaggi attuano il loro destino, come a manifestare l’impossibilità del compiersi naturale del giorno. 268 (molto prossima a quella biblica) costretto ad espiare lo stato di iniziale innocenza con la caduta, che lo porta all’inevitabile perdita di sé. Scritte tra il 1923 e il 1938, le opere teatrali di Hart sono tutte costruite sulla medesima opposizione tra natura111/ spazio interiore (generalmente rappresentato da una casa o da un palazzo), giovinezza/ età adulta, innocenza/ colpa, patria/ esilio, che esemplificano il conflitto morale dell’uomo. Contro qualsiasi soluzione positiva del dramma, gli stadi e gli spazi conflittuali dell’esistenza umana si avvicendano sino a costringere l’individuo a una frattura con la sua primigenia, illusoria, unità. La presa di coscienza del destino si manifesta nella perdita del proprio io, di cui la morte e la fuga dalla realtà sembrano la naturale rappresentazione (a cui nemmeno la creazione poetica sembra poter rifuggire): «Voici la fleur d’un fruit. Je te la livre/Par qu’on n’est jamais sur que la mort/Attendra la maturité du fruit […] Toute œuvre est une instable et fragile victoire/Sur la vie et la mort et sur la solitude»112 Anticipando il motivo che avrebbe ispirato il dramma di transizione di Pierre Fiandre (il protagonista del roman fleuve dello scrittore), Hart prende come metafora della tragedia umana, la perdita della fanciullezza e l’entrata nell’età adulta. Saffo e Déïrdré sono due giovani che rivendicano la propria libertà nella soddisfazione del desiderio: due creature incaute che negano il mondo per le loro chimere: L’Étranger: «Ne raille pas. Je lis au fond de tes prunelles/ la douloureuse erreur de tes ardeurs charnelles […] Que ne t’inclines-tu, Sapho de Mytilène,/Devant la Nature et sa loi?»113 Saffo e Déïrdré sono giudicate colpevoli di fronte agli uomini per averne voluto ignorare la legge: Saffo avendo desiderato d’allontanare da sé lo spettro dell’età matura Sapho: «[…] Chair promise aux tortures/Ne pourrais-tu dompter l’instinct qui t’es si cher/Et, pour dépeupler le monde,/demeurer toujours inféconde?»114 Déïrdré assecondando il proprio destino/istinto contro gli avvertimenti di Lavarcam: Naisi: «Je passais à l’instant devant ta porte ouverte./Je t’ai vue et soudain j’ai reconnu ma destinée.» 111 Nei drammi di Hart, la natura è sempre associata a un’età bucolica. In Saffo, il prologo si apre su una scena campestre che fa da sfondo ai giochi amorosi e ai versi della poetessa e sulle sue compagne, mutate in naiadi dei fiumi. In Déïrdé, l’austerità del palazzo reale si contrappone all’armoniosa natura pagana di una foresta scozzese che i due innamorati hanno scelto come rifugio. 112 Robert-Edward Hart, Offrande à Yeats d’Irlande in La Tragédie de Déïrdre, op. cit., pp. 1-3. 113 Robert-Edward Hart, Le destin de Sapho. Poème dramatique en un prologue et trois actes, op. cit., p. 18. 114 Ibid., p. 21. 269 Lavarcam [il chante ailleurs]: «Mon roi comment as-tu pu croire/Qu’on retient l’or vif du soleil/Dans un flacon où la nuit règne.»115 Nonostante Saffo reclami la supremazia della propria volontà (del proprio spirito assertore di un amore virginale) sulla natura «éternelle inconsciente»116, la poetessa è travolta dal medesimo destino di morte e orrore della leggendaria Déïrdré. Rifacendosi alla tradizione classica che voleva Saffo innamorata delle proprie compagne, Hart identifica la colpa, la condotta innaturale, immorale, della poetessa, nella perversione o falsa rappresentazione della realtà. Volendosi sottrarre alla vita, che è sofferenza e perdita dell’innocenza, i due personaggi sono colpevoli agli occhi del drammaturgo per il loro ostentato disprezzo nei confronti della natura (l’istinto per Saffo, il destino per Déïrdré), che, pure, indovinando gli eventi nefasti, non si è rivelato meno incosciente: Sapho: «Tu connaîtras enfin la fatigue qui ploie/Sous le faix merveilleux des baisers prolongé/ Et […] la folle volupté de ne peser qu’à nous.» E poco più avanti, quando ormai Faone l’ha abbandonata: Sapho: «[…] l’horreur envahit l’être, le cœur est anéanti/ […] le désir et la mort sont d’augustes jumeaux./ […] l’un et l’autre ont le goût de profondes ténèbres […], l’un tue, l’autre sauve.»117 Déïrdré e Saffo vanno incontro alla tragedia per non aver riconosciuto, o più empiamente, per non aver voluto riconoscere la giusta autorità del mondo esterno sull’uomo. Prede delle proprie passioni, Déïrdré della carne, Saffo dello sterile ingegno, il re Conor della sua gelosia, i personaggi di Hart devono espiare la propria colpa, il doloroso errore come dice Apollo a Saffo, con l’annullamento di sé: con la morte suicida, con la rassegnata accettazione della vanità dell’azione. Unico, tra i due drammi, ad offrire un finale positivo, l’Egide118, esorta il pubblico a un’etica del rigore, la cui realizzazione sembra possibile attraverso la graduale abolizione delle passioni. Il rifiuto di Jane, gridato da Maurice, non vuole essere una nuova rinuncia al mondo esterno (come per Saffo e Déïrdré), ma è il raggiungimento della atarassia stoica, il completamento di sé che può essere realizzato solo attraverso la purezza dell’amore filiale: 115 Robert-Edward Hart, La Tragédie de Déïrdre, op. cit., p. 15, p. 16. Robert-Edward Hart, Le destin de Sapho. Poème dramatique en un prologue et trois actes, op. cit.,, p. 18. 117 Ibid., p. 34, p. 45. 118 Robert-Edward Hart, L’Egide. Un acte en prose, Port-Louis, The General Printing and Stationery, 1924. Riassunto p. 487. Insieme a La maison Inquiète, di cui non è possibile rinvenire il documento, i due drammi costituivano il ciclo dell’amore infelice, J.J Waslay Ithier, La littérature de langue française à l’Île Maurice, op.cit.,p. 205. 116 270 Maurice: «[…] et puis maintenant, j’ai changé d’âme…Entre toi et moi, il y a mon fils […], il est comme une égide qui me protège de l’amour, de ses souffrances, de ses lâchetés.»119 Come in Pierre Flandre, così nell’Egide, il difficile rapporto con la donna, il rifiuto della passione, si contrappone all’infanzia ritrovata: Maurice: «[…] c’est à la fois mon enfant, mon compagnon et mon camarade. Nous nous faisons des concessions: il étudie avec moi comme un petit homme, et je joue avec lui comme un grand gosse.»120 Il poeta sembra convincersi, e voler convincere, quindi, di come la vicinanza al mondo dell’infanzia offra all’uomo l’opportunità di uscire dai corrotti meccanismi sociali per recuperare una visione spirituale delle cose, un naturale senso di giustizia congiunta a una chiarezza e fermezza dei gesti (Maurice definisce suo figlio un «Bolchevick»121). La noluntas122 di Maurice è, allora, il frutto di questa lenta sottrazione al mondo della capitalizzazione degli affetti (così può essere caratterizzato il rapporto con Jane123) realizzata per mezzo del fanciullino, che porta all’affermazione della propria libertà sul destino umano (nella misura in cui la conoscenza offre all’uomo la possibilità di sottrarsi all’illusione della felicità) Maurice: «J’étais un père au cœur anesthésié […]. Vous aviez tué en moi jusqu’à l’instinct paternel, et j’ai honte d’y songer.»124 La mitizzazione del mondo dell’infanzia, la perdita dello stesso, si riflette nell’esilio spirituale che vive l’uomo (ora che l’azione umana e il destino sono stati privati di qualsiasi finalità) costretto a rielaborare, qualora possibile, una nuova visione del reale, e rifondare nuovi rapporti umani. La violenta separazione dal mondo a cui si costringono i personaggi, attraverso la morte (Saffo e Déïrdre) e la rinuncia dell’amore (Maurice), è resa ancora più sofferta dalla proscrizione che gli stessi protagonisti assumono in rifiuto d’una patria che non riconoscono più come propria: Mitilene, per Saffo, l’Ultester125 per Déïrdre. 119 Robert-Edward Hart, L’Egide. Un acte en prose, op. cit., p. 26. Ibid., p. 8. 121 Ibid., p. 5. 122 Per Schopenhauer la volontà nello stato di negazione, che ricostituisce l’individuo nella sua unità, contro la molteplicità derivata da una volontà ingannatrice. 123 Jane: «Voyez-vous, ma souffrance je l’avais voulue: la votre était imméritée. Vous étiez, vous êtes le seul homme, qui m’ait aimée pour moi d’abord et non pour lui, le seul qui ne m’ait pas traitée, plus ou moins cyniquement en proie désirable et conquise…et vous êtes celui dont j’ai mutilée la vie, dont j’ai éteint la joie.», Robert-Edward Hart, L’Egide. Un acte en prose, op. cit., p. 14. 124 Ibid., p. 18. 125 Regione dell’Irlanda settentrionale divisa in nove contee, tre appartenenti all’Irlanda, sei al regno Unito ( di cui fa parte l’Irlanda del Nord). La costa si presenta alta e frastagliata. All’interno, i bassi rilievi offrono una natura sempre verdeggiante e un clima temperato. 120 271 Nonostante i testi di Hart rifuggano le atmosfere e i motivi anti-inglesi e anti-indiani dei drammi mauriziani di fine Ottocento e inizio Novecento, per offrire una lettura anzitutto esistenziale del dramma umano, è, comunque, evidente l’intenzione dell’autore di non sottrarsi dal confronto politico allora in atto sull’isola. Per quanto Hart risolva la polemica in poche e rapide battute, nondimeno, a fronte del rilievo che queste assumono nel testo, si può affermare che la performance teatrale viene assunta dallo scrittore anche per il ruolo eminentemente educativo che riveste nella società. Così, l’amore innaturale di Saffo per le sue giovani amiche, suggerisce allo straniero l’opportunità di condannare l’azione perché anzitutto contro la patria. La scelta della poetessa di restare vergine, la sua determinatezza di non istituire legami con il mondo esterno, cela secondo lo straniero, l’istinto egoistico di rifuggire le responsabilità civiche e sociali, di conseguenza la difesa della collettività L’étranger: «Que fais-tu du sol natal?/Pour déserter devant les périls de la vie/Faut-il, à ta chimère immoler la patrie? […]/Il faut que ses fils soient toujours triomphants […]/Afin que, par leur sacrifice,/Elle vive prospère et noble, et que son front/Irradie à jamais cette lumière humaine […]»126 Allo stesso modo la decisione di Saffo di partire dalla città natale ora che «Je ne puis respirer encore l’air de nos îles/J’aime mieux m’en aller vers l’inconnu…là bas.»127, sembra riprodurre fedelmente lo stato emotivo di molti Mauriziani che, di fronte all’avanzata indiana e al silenzio francese, solo pochi anni dopo avrebbero chiesto asilo politico al Sudafrica e all’Australia. La partecipazione del drammaturgo alla vicenda storica mauriziana è ancora più evidente in Déïrdré. Il dramma è, infatti, dedicato a Yeats128, scrittore irlandese della fine dell’Ottocento fondatore della Società Letteraria Irlandese e tra i primi attivisti dell’autonomia irlandese dal governo inglese. Tra i movimenti concitati del primo e del terzo quadro, dove si consumano rispettivamente l’esplosione della crisi e la sua conclusione tragica, Hart inserisce l’intermezzo lirico del secondo quadro che, se non introduce nessun elemento nuovo per l’evoluzione del dramma, pure offre l’occasione allo scrittore per porre al confronto due realtà: quella della patria originaria, inospitale e quella della patria acquisita 126 Robert-Edward Hart, Le destin de Sapho. Poème dramatique en un prologue et trois actes, op. cit., p. 22. Ibid., p. 52. 128 William Buttler Yeats (1865-1939), poeta e drammaturgo inglese, esponente del rinascimento celtico. Nel 1891 inaugura il Teatro Nazionale Irlandese in cui farà rappresentare tutti i suoi drammi. Le opere teatrali coniugano il misticismo teosofico a un forte sentimento nazionalistico. Tra i drammi più noti, la riscrittura del mito celtico della principessa Déïrdré. Verso la fine della sua attività poetica, Yeats superò il simbolismo per concezione vieppiù ermetica del linguaggio. 127 272 Ardann: «[…] Partirons-nous? Quand la patrie est un exil,/C’est bien le pire exil»129 Diversamente da Saffo, i protagonisti del dramma riusciranno a vivere il loro idillio in una terra vergine che, con poveri mezzi, si prende cura di loro. Come in Saffo, però, la scelta di sfuggire ai doveri civili, l’intenzione di negare la condizione storica e politica dell’esilio per non affrontare direttamente ciò che minaccia l’integrità nazionale (quanto era stato auspicato da Appollo), non sembra accettabile per l’autore che vede nella tragedia un giusto castigo divino (laddove la colpa riveste un significato anzitutto morale): Ennil: «[…] Mon petit, souviens-toi que le bonheur s’expie/Dans le sang, et que toute grandeur/Est promise à la haine envieuse des nains.»130 Per quanto Hart possa aver assunto la delicata condizione politica e sociale mauriziana, per quanto possa aver voluto testimoniare, e avere auspicato, la necessità dell’impegno collettivo alla soluzione del problema Creolo, nondimeno il pessimismo che pervade le tre opere, la scelta della stasi (quieta accettazione di Maurice e del Conor) sembrano raccontarci di una realtà mauriziana che è stata capace di rifiutare la convivenza con l’invasore (Maurice scaccia Jane) solo rifugiandosi in un passato idealizzato, che ha fatto della pratica ascetica, dell’esilio spirituale, la nuova patria da abitare. Contro il Dio assente. L’etica della rivolta di Loys Masson Partito da Maurice nel 1939, alla vigilia della Seconda Guerra mondiale, con la determinazione di non fare più ritorno sull’isola, Masson sembra incarnare lo stereotipo del Mauriziano esiliato di inizio Novecento131. 129 Robert-Edward Hart, La Tragédie de Déïrdre, op. cit., p. 23. Ibid. 131 Nato nel 1915, Loys Masson è il primo di una numerosa famiglia franco-mauriziana. Animo eclettico e solitario, da giovane si dedica con la medesima passione alla boxe e ai concorsi letterari. Inizialmente affascinato dalla poesia simbolista, soprattutto Verlaine, nel 1938 Loys Masson pubblica, Les autres nourritures, dichiaratamente ispirate a Les nourritures terrestres di Gide. Su consiglio di alcuni intellettuali francesi, Masson lascia l’arcipelago nel 1939 per la Francia. Contrariamente all’accoglienza sperata, la guerra, appena scoppiata, costringe lo scrittore a una vita di stenti e di fughe continue. Nel 1942 aderisce al Partito Comunista, pubblica numerose raccolte poetiche ispirate al periodo bellico, grazie alla quali, alla fine del conflitto, nel 1945 verrà eletto segretario generale del Comitato Nazionale degli Scrittori. Fervente cattolico, Masson è congedato dal ruolo di redattore della rivista «Les lettres Françaises», della sinistra radicale. Decide quindi di dedicarsi completamente alla carriera letteraria. Muore nel 1969. 130 273 Se il gesto non sembra potersi iscrivere in un preciso disegno politico di condanna al governo inglese, o di rifiuto della nuova comunità indiana, non di meno, rende esplicita la volontà dell’autore di essere riconosciuto unanimemente cittadino francese, prima che mauriziano132. La proscrizione volontaria del poeta (rimasto in Francia nonostante, per lungo tempo, il governo gli rifiutasse la cittadinanza) riflette piuttosto, allora, l’esilio spirituale di un popolo incapace di rinnovarsi e di integrarsi nella nuova realtà multiculturale dell’isola; di un popolo che, rimasto fedele all’immagine di una nazione ideale, la Francia dei lumi e di Napoleone, si sentiva ineluttabilmente rifiutato da una realtà resa complessa e messa continuamente in discussione dal rinnovarsi della politica nazionale francese (i governi che si erano susseguiti tra Ottocento e Novecento, l’avanzata del nuovo potere operaio, le nuove ideologie). Allorché la vita del poeta negli anni della guerra racconta il difficile inserimento di Masson nella collettività francese (quando, inviso dal governo repubblicano prima, di Vichy dopo, a causa della sua cittadinanza inglese fu costretto a vivere e ad aiutare la resistenza senza poter partecipare attivamente alle azioni di rappresaglia), l’ideale umanitario dello scrittore, capace di conciliare una forte religiosità alla fede comunista, in un periodo post-bellico in cui i due termini si volevano irriducibili, impedì, di fatto, il pieno riconoscimento dello scrittore da parte della comunità letteraria francese del tempo, costringendo Masson a una vita intellettuale al margine. Nonostante il suo engagement politico e la produzione poetica rivolta al dramma umano della guerra l’avessero promosso a scrittore nazionale della Francia subito dopo il conflitto (fu eletto segretario del Comitato Nazionale degli Scrittori nel 1946), la concezione cristiana dell’universo umano lo allontanò dopo soli due anni dal mondo intellettuale francese, quello stesso mondo che lo aveva voluto alla direzione del giornale le «Lettres françaises». L’omaggio riservatogli da Aragon e da Mauriac, la celebrazione dello scrittore nella lontana Maurice133 non furono sufficienti, in vita come dopo la morte, a promuovere l’opera del poeta e romanziere rimasto, di fatto, poco noto in patria come in Francia. Reso popolare dalla collaborazione con Seghers, presso il quale pubblicò numerosi versi della resistenza e della lotta antifascista, Notre Dame des Exodes (1940), Délivrez-nous du mal (1942), Masson è ricordato, soprattutto, come autore di romanzi, L’Étoile et la Clef (1945), Le Notaire des noirs (1961), ritenuti i maggiori dello scrittore, certamente i più rappresentativi di una poetica, che Seghers ha definito un’attività di «insurgé permanent»134. 132 Jean-Geoirges Propser definisce l’autore «un écrivain français de nationalité mauricienne», Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, éd. L’Océan Indien, 1978, p. 195. 133 Norbert Benoit, Loys Massson, Île Maurice, éd. Nathan de l’Océan Indien, 1980, pp. 95-96. 134 Ibid. 274 Della numerosa produzione di Masson, il teatro riveste una parte importante anche se marginale (i testi furono inizialmente scritti e pensati per la messa in onda radiofonica o televisiva). Pubblicati tra il 1952 e il 1960, La Résurrection des corps135, Le Pape136, Chrisobal de Lugo137, si allontanano dalla poesia militante degli anni della guerra, pur conservandone il pessimismo e una certa predilezione per le immagini crude, per la presenza ingombrante della morte e del disfacimento. Dei romanzi resta l’eco sfiduciato di una rivolta reiterata ma senza domani, o dal futuro silenzioso e incerto allorché i personaggi sono rappresentati nella loro individualità irriducibile, da cui sembra abolita ogni possibile comunione con gli altri esseri138. Elencando i vari temi della poetica di Loys Masson, Benoit ne rileva quattro, la rivolta, la resistenza, la claustrofobia e la solitudine, il mare139, definibili, secondo il critico, a partire dal ruolo di opposizione o di simmetria con il crimine morale, quale è considerato da Masson l’egoismo. Se l’engagement politico dello scrittore, il fervore cattolico possono essere interpretati come la condanna di Loys Masson al solipsismo verso cui tende il genere umano, sono l’espressione di un severo giudizio contro l’agire individuale e collettivo (di cui l’ultima guerra era stata la manifestazione più tragica), la rivolta, che pure viene rappresentata dallo scrittore come condizione perenne del genere umano, assume per il drammaturgo un ruolo ben diverso dalla resistenza, è investita di un significato morale prima che politico. Contro la poesia e il romanzo, impegnati in un dialogo costante con la realtà esterna e con la storia, le tre opere teatrali, private da Masson di qualsiasi riferimento spaziale e temporale (fatta eccezione per il primo testo ambientato nel 1830), sembrano far opera di astrazione dal contesto bellico e post-bellico per rileggere il dramma umano, di interrogazione e di rifiuto (certamente ascrivibile a una guerra annichilente e disumana che ha messo l’uomo di fronte alla propria solitudine), alla luce di un’etica dell’abbandono e della prova che appartengono al mistero divino. Come per il teatro francese degli anni Cinquanta, così i drammi di Masson devono essere ascritti al processo epifanico delle due guerre, come realtà i cui orrori e la cui carneficina avevano spinto alla messa in discussione tanto della struttura e dell’ordine sociale, favorendo l’esplosione del movimento rivoluzionario sia nella sfera politica che nel mondo artistico (il teatro dell’Assurdo può 135 Loys Masson, La Résurrection des corps. Pièce en six tableaux, «Paris/Théâtre», 1952, Paris, Robert Laffont, 1960. Riassunto pp. 490-491. 136 Loys Masson, Le Pape. Pièce en sept tableaux, Paris, éd. Robert Laffont, 1960, version radiophonique qui a obtenu le prix Carlos-Larronde en 1959. Riassunto p. 491. 137 Loys Masson, Christobal de Lugo. Pièce en deux époques d’après Cervantes, Paris, éd. Robert Laffont, 1960, représenté au Vieux-Colombier, version pour la télévision en 1959. Riassunto p. 492. 138 Nella già citata storia della letteratura dell’Oceano Indiano, Jean-Louis Joubert ipotizza un legame tra il pessimismo di Loys Masson, l’esilio volontario e definitivo del poeta e la storia mauriziana. La lettura de Le Notaire des noirs, sembra mettere in luce, secondo il critico, la critica del romanziere al passato schiavista. Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, op. cit., p. 176. 139 Norbert Benoit, Loys Massson, op. cit., pp. 14-65. 275 essere spiegato solo a partire del secondo conflitto), quanto del senso della realtà (con le sue implicazioni morali e religiose). Se la guerra dà ragione di un teatro pervaso da un cupo pessimismo, se è possibile spiegare il ricorso alla crisi e allo smarrimento dei personaggi come la messinscena del malessere collettivo, ugualmente, Masson spiega l’azione individuale a partire dal rapporto imperscrutabile di Dio con l’uomo, reinterpreta la crisi moderna come la rappresentazione di un confronto sempiterno tra il dubbio e la fede, inserendo il rifiuto del mistero e della razionalità divina nel conflitto tra peccato e redenzione. Come il dramma claudeliano voleva essere la riscrittura e la celebrazione del mistero divino anche attraverso la sofferenza e il dubbio umani, così il teatro di Loys Masson si installa nella tradizione misterica, più medievale che moderna, che racconta le sorti di un’umanità condannata, la cui ricerca della morte fisica è metafora di un tormento spirituale, ora che Dio, come già sul Golgota, sembra lontano, assente dal calvario umano: Perarlta: «De profundis calmavi ad te, Domine…Mais tu es sourd! Tu es sourd — sourd…Tu es le grand bourreau sourd de l’espace…la grande pieuvre sans yeux, sans cœur…Assez!»140 La rivolta permanente che sembra caratterizzare tanto il poeta Masson quanto i suoi personaggi, e che Seghers aveva indicato essere la sintesi di un’anima in cui si fondevano lo sdegno religioso e la lotta politica, è la conseguenza di un’interrogazione tutta umana di fronte a una prova morale che il Verbo divino non rende più intelligibile, di fronte a un linguaggio delle scritture il cui paradosso resta irriducibile. Il silenzio dell’abate Barthélemy, nell’atto di assolvere l’omicida, diventa, così, la metafora dell’impenetrabilità del perdono da parte della comune accezione di giustizia, è la rappresentazione dell’intimo rifiuto della ragione umana del mistero della pietà. Il delitto di Gatien, zio del Papa Domenico Filippi, costretto ad uccidere il nipote e ad accusarsi di crimini che non ha commesso, si iscrive, allora, nel disegno divino141, estraneo all’uomo a cui l’individuo sembra, però, non potersi sottrarre142; la conversione di Lugo è frutto di una scommessa, di uno spergiuro, e la sua santificazione la conseguenza dell’unione con la donna che ha sempre amato. Le tre opere teatrali mettono in scena la parabola umana della caduta e della resurrezione, sono la rappresentazione del lungo cammino dell’umanità dall’abisso del rifiuto, raccontato nel Vecchio Testamento, alla conciliazione finale resa possibile dal sacrificio di Cristo: del dio-uomo. 140 Loys Masson, Christobal de Lugo, op. cit., p. 251. Domenico: «Ma mort est entrée avec toi […] Dieu ne te demande pas cela. Pas à toi! A personne, mai pas à toi…», Loys Masson, Le Pape, op. cit., p. 101. 142 I drammi di Masson, come già le tragedie classiche, sono la messinscena di una rivolta senza libertà: la corsa necessaria verso il compimento della propria dissoluzione. 141 276 I testi seguono allora una struttura tripartita che si apre con la negazione di Dio, allorché l’uomo è posto di fronte a una realtà il cui abominio e il cui peccato gridano l’assenza di Dio, del senso e della finalità del dolore: Domenico: «J’ai été le Père et l’Esprit et me paroles de consécration ont été ta mère…Mais alors dit-moi que tout cela existe. Parle-moi. Donne-moi un signe. Tu m’as envoyé des anges; mais ils étaient trop semblables à moi et je les ai dispersés comme je les avais rêvés.»143 La negazione è frutto della tentazione, della volontà dell’uomo di farsi simile a Dio, di riconoscersi egli stesso Dio nella possibilità che gli è stata offerta di generarlo e di incarnarlo nel momento dell’ufficio apostolico: Domenico: «Je ne ressemble pas: JE SUIS.»144 I personaggi che popolano il teatro di Masson sono abati, papi, frati colti dall’autore nel momento della perdita di ogni certezza: il Papa Domenico, che ha regnato come un sovrano illuminato, nega Dio per sopravvivere a se stesso ora che l’evidenza della grazia fa crollare le false giustificazioni, le menzogne del governo temporale della Chiesa145: Domenico: «J’ai besoin de vous […] Plus que jamais besoin de votre présence, Béatrice…On veut abolir mon visage: mais je le sauvegarderai en vous. On me persécute; et je viens me sauver […].» Béatrice: «Le chemin du défi…»146 La rinuncia dell’abate Barthélemy non è atto di generosità o di onestà nei confronti dei propri parrocchiani, ma la tentazione dello scetticismo (come se la fede avesse bisogno di prove spettacolari147) ora che, contro la superbia dell’uomo, il silenzio di Dio pone l’essere umano di fronte alla povertà e alla propria debolezza Le Père: «Pourquoi vivre? Quand Dieu se détourne, vivre est une agonie…[…] J’ai perdu le droit d’administrer les sacrements […]. Je me suis lucidement condamné […] Si j’étais le fidèle reflet du Christ, je n’aurais qu’à vouloir et l’impossible deviendrait jeu…»148 143 Loys Masson, Le Pape, op. cit., p. 51. Ibid., p. 66. 145 La scelta di personaggi appartenenti alla Chiesa può essere certamente spiegato con il rifiuto e l’accusa del poeta verso un’organizzazione che nel tempo aveva curato più la politica che lo spirito: «Catholique fervent, il épouse la cause des persécutés, des opprimés et comme eux et pour eux, il se révolte non cotre l’église du Christ, mais contre l’église des prêtres.», Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, op. cit., p. 195. 146 Loys Masson, Le Pape, op. cit., p. 33. 147 Domenico: «“S’il est Dieu, qu’il descende de cette croix […] si tu es Dieu, que cette hostie flamboie […]”», Ibid., p. 52. 148 Loys Masson, La Résurrection des corps, op. cit., pp. 129-134. 144 277 La contestazione e il rifiuto sono, invece, totali in Lugo. Se il drammaturgo usa la tentazione come processo attraverso il quale l’uomo compie la sua passione149, quindi la sua redenzione, Lugo è il solo personaggio in cui il percorso salvifico è portato a compimento. La negazione non nasce in Lugo come conseguenza della perdita e della messa in discussione di sé: il rifiuto di Dio è assoluto, la ribellione è radicale, lo smarrimento è frutto di un senso dell’ingiustizia imperioso quanto il bisogno di una giustizia meno fallace di quella umana150. La tentazione, che in Christobal de Lugo si concretizza con la sfida dell’uomo a Dio, non è frutto dello scetticismo, come per Domenico o Barthélemy. Se il Papa e l’abate sono tentati dall’onnipotenza, convinti che la loro posizione garantisca l’esito positivo della loro richiesta151 , Lugo tenta Dio nella speranza che questi possa rispondergli: Lugo: «Oh Dieu! Entends ma parole! Je te défie par le cadavre de Lobillo, je te défie dans cet amour coupable. Voici mes dés — feras-tu attendre ta réponse?»152 La tentazione della morte (omicida e suicida) come unico atto che ristabilisce la libertà dell’uomo di fronte a Dio, come sola azione che può sottrarre l’uomo all’inevitabile dissoluzione delle proprie certezze, è trascesa dalla carità di Cristo (come dice Lugo divenuto Père de la Croix153), è glorificazione della vita allorché la lenta agonia di Lugo, divorato dalla lebbra, è l’accettazione ultima della perdita di sé. La ricerca ossessiva della vita e della salvezza del corpo, mai dell’anima, con cui si aprono, Le Pape e La Résurrection des corps, (l’abate vuole far risorgere la piccola Juliette, gli abitanti del villaggio lottano contro la paura della morte, Beatrice Areggio nel secondo quadro chiede a Domenico di risparmiarla e lo stesso Papa lotta contro la sua follia per restare in vita) cede alle lusinghe della morte: al mantenimento di uno status quo, di una fede professata con indifferenza e tepore, che non è riuscita a riscattare l’uomo dal suo inferno: Le Père: «[…] Je me fais horreur […] Vos péchés vous taraudent: moi c’est mille fois plus qu’un péché, c’est l’agonie de l’enfer…Qui suis-je, mon Dieu, votre prêtre ou Pilate, votre prêtre ou Judas […] Je suis Pilate, Pilate multiplié par des siècles de tiédeur…J’ai voulu occuper la place du Christ, ici, sur cette montagne […] Je suis le sacrilège lui-même.»154 149 La Méditation: «Dans mon indifférence tu étais là. Dans ma haine, ma révolte tu étais là.»/Domenico sourdement: «Dans ma négation.»/La Méditation: «[…] Que savent-ils, Seigneur, que savent-ils de moi? […] Tu adminisres…»/Domenico: «Je fais ma passion», Loys Masson, Le Pape, op. cit., pp. 65-66. 150 Ricordiamo che il testo è ambientato nella Spagna dell’inquisizione. 151 Il Papa nega Dio in virtù di un governo giusto, sempre difensore dei diritti umani, il sacerdote in seguito al venir meno del principio che regge il proprio missione 152 Loys Masson, Christobal de Lugo,op. cit., . 270. 153 Ibid., p. 345. 154 Loys Masson, La Résurrection des corps, op. cit., pp. 155-157. 278 L’abisso di Lugo è tanto più grande quanto più insistente è la morte che lui corteggia. La prima parte di Christobal si apre su una strada, per terminare all’interno di una bettola popolata da spettri più che da uomini, da dannati ingiuriati da un Diogene (Peralta) che ha venduto l’anima al diavolo e che cerca l’impossibile riscatto in un mondo non diverso dall’inferno dantesco. Nonostante l’ultima battuta sia lasciata da Masson alla speranza della carità divina, rimane sulla scena la memoria dei corpi mutilati, l’immagine del demone che si impossessa dell’anima di Gonzalès quasi a escludere la prospettiva di una vera redenzione. Dio, continuamente invocato dai personaggi, si nega alle creature smarrite di Masson, resta assente dalle parole di quanti tentano con il confronto e con l’ingiuria di animare l’Assoluto e l’Eterno per esorcizzare una quotidianità preda della confusione e dell’oscurità. Se in Claudel Dio, come aveva detto Madaule, è il quarto personaggio muto155, per il drammaturgo mauriziano Dio è, invece, lettera vuota. Mentre in Claudel l’assenza di dialogo tra gli uomini è compensata dall’intimo rapporto che i protagonisti intrattengono con una natura permeata dal divino, nel drammaturgo mauriziano, il dialogo interrotto tra i vari personaggi è la rappresentazione di una sorta di soliloquio claustrofobico pervaso dalla negazione di sé e dell’altro: Domenico: «Que feras-tu de ce Pape qui n’a pas la foi en celui qu’il sert — qui a nié, qui nie et qui niera tant qu’il aura le souffle?»156 La scelta (del bene e del male) che si imponeva a Claudel come giusto compimento della volontà divina, ristabilendo la libertà umana, resta incomprensibile ai personaggi di Masson che si muovono nel testo come animali privati del loro libero arbitrio, allorché l’alternativa è ridotta dal drammaturgo alla negazione di Dio o alla sua accettazione passiva (anche Lugo si rimetterà alla disegno di Dio incapace di comprenderne sino in fondo il significato157). Per Masson cristiano e engagè, il mondo da cui è stato bandito il divino e il mistero, preda delle passioni e della superstizione, può essere compreso e rappresentato solo come luogo del peccato e dei peccatori. Il Peccato radicato massimamente nel rifiuto, quindi nella negazione di sé all’altro (identificato con l’egoismo) è sintetizzato da Masson nel dissolvimento della coppia (Domenico e Beatrice, Barthélemy e Cécile, Lugo e Atonia), nella congiunzione inattuabile tra l’uomo e la donna perché 155 «Car tout théâtre de Claudel comporte un quatrième personnage muet, qui est Dieu même, auteur de l’Univers et de l’homme.», Jacques Madaule, Claudel dramaturge, Paris, L’Arche, 1981, p. 148. 156 Loys Masson, Le Pape, op. cit., p. 50. 157 «J’ai reçu une grâce que je ne méritais pas. Le ciel avait peut-être, lui parié contre l’enfer?», Loys Masson, Christobal de Lugo, op. cit., p. 337. 279 sacrilega, per l’uomo che è stato votato al Signore (contrariamente al Père humilié di Claudel dove l’unione tra la ragazza cieca Pensée e il novizio Orian è resa infine possibile). Solo la morte della donna, la cui carnalità è percepita come sorgente del peccato158, la sua soppressione, rappresentata come un atto rituale, invariato per le tre opere, deve essere letta come l’adempimento di un percorso ascetico, che, contro il corpo, dà ragione di un’unione spirituale: Domenico: «Mon amour s’est tu, Seigneur, mais il était un arbre vert. Mon amour était une prairie mouvante, un kaiser de l’été. Reçois-le en toi où je prononce notre durable mariage.»159 ([…] son regard se pose sur l’abbé Barthélemy./Celui-ci, fiévreusement, a défait le corsage de Cécile, mettant à nu la poitrine […] Ses yeux vont à Cécile)160 La Croix: «Antonia, vous m’entendez? Ce sont nos plus douces fiançailles […]. Car c’est dans la bonne et tendre mort que Dieu visite les siens. […] Vous vouliez être ma femme, Antonia, et vous voilà bien plus encore que mon amour: ma douleur. […] Gloire soit au Christ»161 Alla negazione (additata dalla dottrina cristiana come il peccato per eccellenza) rispondono le manifestazioni di un egoismo quotidiano e bieco degli altri personaggi di Masson: il Vescovo Ambrosio, Bénigne o Grégoire, Ganchoso. Gli eroi martirizzati dal proprio rifiuto, i martiri che la negazione ha mutato in eroi tragici del testo, sono circondati da antieroi, da contadini, prostitute, ubriachi, zoppi, da anime perse che sono la rappresentazione, il delirio di una vita per se stessa avara. Il tradimento collettivo degli abitanti di un piccolo villaggio non oltrepassa la forma del pettegolezzo162; la comunità che popola la taverna e che sfila poco dopo nel monastero di Père de la Croix e di Frère Gonzalès, si manifesta ai personaggi, in un corteo di spettri: un’allucinazione blasfema, una parodia della realtà: «Entrent des formes vagues, menées par le démon à tête de chien […]./On reconnaît la Sarrasine, donnant la main à Urraca, le Tavernier, le Bancal, d’autres. En retrait Antonia […] — Vue comme dans un rêve, une tentation […]/ Dans l’obscurité se devinent des démons./Tout cela s’avance dans une sorte de ballet […].»163 158 «Démon, qui t’a menée ici? […] Va-t-en…Ne t’ai-je pas connue le soir où Lobillo s’est tué? […] Je connais ces voix de miel: quand on regarde bien, on y voit le poison. Le ventre tourmenté comme une chienne, voilà ce que vous êtes! Une chienne…», Ibid., pp. 267-269. 159 Loys Masson, Le Pape,op. cit., p. 90. 160 Loys Masson, La Résurrection des corps, op. cit., pp. 236-241. 161 Loys Masson, Christobal de Lugo, op. cit., pp. 332-333. 162 Quasi che il pessimismo di Masson non riuscisse a condannare moralmente dei personaggi così grotteschi. 163 Ibid., pp. 306-307. 280 Nelle due opere più visionarie di Masson, Le Pape e Christobal de Lugo, il dubbio, che nutre il peccato, il tormento procurato dalla paura e dalla solitudine restituiscono un’immagine surreale del mondo, popolato da demoni e voci, da apparizioni, da esseri arcaici: cavalli e uomini dalla testa di cane. Satana, che i personaggi sentono sempre presente, è l’angelo, caduto e decadente, invocato come testimone del proprio rifiuto Antonia: «Sur chaque nuit de ma vie a brillé la lune noire du sacrilège. J’ai communié avec la haine; j’ai souillé mon corps par amour de la souillure […] j’ai été l’épouvantable ostensoir du péché que Satan élevait et abaissait à son gré […] j’appartiens tout entière à l’enfer.»164 è l’essere caprino paventato da uomini dalla fede insicura e dall’inamovibile superstizione Simon: «Tu veux mon avis Jacquin? C’est un coup du démon. A quelques jours de Pâques, dans cette semaine des revenants morts sans confession, foutre! c’est sa main et sa signature […] il y a les prédictions […]»165 è il doppio, il lato oscuro dell’uomo: Giuda e Pilato, la Meditazione che tenta l’uomo, solo come Cristo nel deserto, con la promessa di potere. Giuda il traditore, Pilato, procuratore romano pusillanime, sono invocati alternativamente dai personaggi tentati dall’assoluto. Domenico e Barthélemy accusano se stessi e la Chiesa di aver tradito, come Giuda, lo spirito ecumenico della Chiesa cristiana, e di aver preferito come Pilato il compromesso politico al rigore morale. Come Giuda, Gonzalès vende Père de la Croix per pochi denari. Il tradimento, come atto supremo della negazione, porta alla luce con il peccato, l’estrema solitudine dell’uomo, combattuto tra l’amore e l’odio (come il Giuda di Claudel): il suo tentativo, la tentazione, di rivendicare la propria libertà sul progetto divino: Gonzalès: «[…] tu es la charité même du Christ, et mépris soit sur les autres! […]» La Croix: «Je te l’ai déjà dit: prétendais-tu me remplacer?» Gonzalès: «Eh bien, oui…Pourquoi pas? Etais-je moins honorable? […] Je te hais […] Et pourtant je te panse de mon mieux, et l’instant d’après je t’aime […]. C’est moi. Un portefaix. Le portefaix de la gloire…L’éternel second — l’éternel convers.»166 Di fronte a una realtà scossa dal delirio, i personaggi e la storia perdono di profondità. La ricorsività dei temi (il solipsismo tra ribellione e peccato), dei personaggi (blasfemi e cupidi) e delle 164 Ibid., p. 317. Loys Masson, La Résurrection des corps, op. cit., p. 116. 166 Loys Masson, Christobal de Lugo, op. cit., pp. 341-346. 165 281 atmosfere (notte, crepuscolo, alba) nei testi di Masson raccontano di una concezione del dramma in cui l’immediatezza narrativa della descrizione naturalista, del milieu e dei caratteri, è venuta meno in un universo lacerato dalle contraddizioni e dai demoni del mondo interiore. La mancanza di qualsiasi attenzione per l’illustrazione dei vari personaggi si riflette in una scrittura simbolica, ma non simbolista, intenta nella rappresentazione della difficile pur sempre secolare ricerca di Dio da parte dell’uomo. Il caso Chazal Gnostico, adepto della setta di Swedemborg, surrealista che reclama l’originalità di un’ispirazione africana, Chazal167 è tra gli autori più controversi, la cui poetica si sottrae ancora oggi a qualsiasi classificazione. A dispetto dell’iniziale fascinazione subita da Jean Paulhan, da Breton e da Ponge per il poeta sconosciuto venuto dal lontano arcipelago delle Mascarene, come un aerolite precipitato da un altro pianeta, in conflitto con i connazionali di cui denunciava la scarsa sensibilità, già nel 1950 l’entusiasmo dei surrealisti per il vate mauriziano era pressoché spento. Negli stessi anni, Chazal rivendicava la singolarità della propria invenzione artistica rispetto a un movimento accusato di non essere andato oltre la rivoluzione formale. Questo poeta dal sangue nero, un Nero-Bianco168 come amava definirsi e come era stato giudicato da Senghor (1973), la profondità della cui creazione, riteneva, sarebbe stata colta solo da un pubblico nero o dalla pelle bronzée, aveva ritrovato nella tradizione aforistica europea (della filosofia presocratica e dei moralisti classici) l’espressione del linguaggio originario, vicino alle popolazioni primitive, l’uso icastico di una sintassi che trattava il lessico come gnosi, come realtà rivelata. 167 Nato nel 1902 da una famiglia stanziatasi sull’isola dal 1760, appartenente alla setta di Swedemborg (lo zio era pastore della Nuova Chiesa, e uno degli antenati aveva sostenuto la setta contro i protestanti e i cattolici dell’isola). Da giovane viene inviato negli Stati Uniti per specializzarsi nella coltura e nell’industria della canna da zucchero. Ritornato sull’isola nel 1925 dopo una breve esperienza a Cuba e in Francia, abbandona la canna da zucchero per entrare nelle telecomunicazioni per cui lavorerà fino al pensionamento (1957). Negli anni Trenta pubblica alcuni studi di economia con lo pseudonimo di Médec, a partire dal 1940 dà alle stampe la prima raccolta di aforismi poetici, Pensées. Dal 1945 Chazal irrompe nella vita letteraria dell’isola con una vasta produzione saggistica (studi di cosmogonia), teatrale, poetica e anche figurativa. Il comportamento bizzarro, il sentimento elitario non favorirono i rapporti con i suoi connazionali. Muore sull’isola nel 1981. 168 «…moi, Blanc, je suis un Nègre-Blanc, puisque je ne puis être mulâtre.», Malcolm de Chazal, «Le Mauricien», 30 juin 1958. 282 L’atteggiamento dichiaratamente provocatore dell’artista nei confronti di quanti non sembravano apprezzare il suo estro, primi fra tutti i Mauriziani, l’eccezionalità di una produzione assunta e difesa dall’autore anzitutto per il suo valore profetico, è valso a Malcolm de Chazal l’appellativo di Dalì delle Mascarene. L’improvvisa fortuna del poeta alla fine del 40 e il rifiuto degli intellettuali francesi a pochi anni dalla celebrazione unanime, il tenore sempre illuminato dei versi impediscono di guardare alla produzione di Chazal con imparzialità impediscono di sfuggire alle affrettate interpretazioni dei numerosi esegeti dello scrittore mauriziano che hanno riconosciuto nello scritore ora un epigono dei surrealisti, ora un fanatico della dottrina di Swedemborg. Ciò detto, non è possibile capire il valore della produzione di Chazal se non reinserendo la sua poesia all’interno di una sperimentazione sul linguaggio, di un’interrogazione, di una pratica del ripensamento e di rifondazione dell’arte poetica (Ponge stesso) che aveva caratterizzato il Novecento post-simbolista. Non si afferrano i riferimenti all’arte africana e al pensiero orientale se non ricordando come già all’inizio del XX secolo (nel maggiore sviluppo coloniale) le sculture africane, la tradizione orale del continente nero erano state fatte oggetto di studio da parte delle avanguardie occidentali nel tentativo di assimilare, con la diversa rappresentazione del mondo, un nuovo sistema di simboli. La sensibilità africana rivendicata da Chazal, l’urgenza di una gnosi vicina all’immaginario induista possono essere comprese alla luce del movimento degli scrittori neri e dell’interesse, sempre più diffuso in quegli anni, tra gli intellettuali per la filosofia, l’arte, finanche il teatro orientale (ricordiamo in proposito quanto i viaggi di Claudel e Saint-John Perse avessero contribuito a promuovere in Francia lo studio per una cultura fino ad allora poco conosciuta). Fautore del rinnovamento della produzione letteraria dell’isola, ancora emula, nel Novecento, dei modelli romantici e parnassiani, Chazal è stato pioniere di un movimento poetico specificamente mauriziano che, a partire dal 50, ha cominciato a rivendicare l’originalità della propria creazione rispetto alla scuola francese, facendosi interprete di una concezione multiculturale dell’arte nella quale confluivano indistintamente l’esperienza delle avanguardie, le teorie creazionistiche di inizio Novecento, la metafisica. I brevi studi riservati al teatro dell’Oceano Indiano, in particolar modo mauriziano, sono concordi nel giudicare lo scrittore come il fondatore di un nuovo genere teatrale, la cui azione innovatrice, certamente provocatoria per il contesto insulare, aveva avuto il merito di emancipare definitivamente l’arte drammatica locale dal francotropismo, poco originale, di Charoux, dalle svenevolezze dei vaudevilles, per renderla permeabile alle nuove pratiche teatrali europee, non solo francesi, ma russe e tedesche. 283 Nonostante la curiosità e l’interesse dei Mauriziani per un personaggio singolare noto in Francia e agli scrittori africani, il teatro di Malcolm de Chazal restava sconosciuto, per lo più incompreso dai suoi connazionali. La rappresentazione di Judas nel 1960 incorse nelle critiche dell’autore, contrariato di veder tradita la struttura originaria del testo169, Rompendo con la tradizione naturalistica, la pièce di Chazal si abbatteva sugli spettatori con le sue scene monumentali, per il suo afflato mitico, e l’indecifrabilità di un linguaggio profetico, il cui contenuto metafisico non lasciava spazio all’intrattenimento. L’attenzione riservata, in modo particolare, alla poesia di Chazal, con la riedizione delle raccolte più importanti, Pensées (I, II, II, IV), Sens Plastique, Sens Unique, del «romanzo mitico» Petrusmok, ha adombrato l’esuberanza e l’eclettismo della creatività dell’artista mauriziano, al punto che molta della produzione teatrale dello scrittore è rimasta inedita170, i testi pubblicati, Iésou171, Judas172, Les Désamorantes173 e Le Concile des poètes174, hanno avuto la diffusione di poche centinaia di esemplari. La definizione più felice che è stata data del teatro di Chazal è di Camille de Rauville. Partendo dal confronto con la produzione saggistica e poetica dello scrittore, il critico riconosce, nell’entusiasmo profetico dei testi teatrali, la messa in scena, in modo argomentativo e problematico, delle speculazioni metafisiche esposte nelle opere precedenti. La teatralità dei dialoghi platonici ha certamente ispirato le «logomachies en dialogue» di Malcolm de Chazal: un teatro a tesi in cui l’immagine aveva la funzione di complemento della parola, la rappresentazione dava corpo al linguaggio come logos, razionalità che nel dirsi ordina il reale: «Logomachies en dialogue, les pièces de Chazal tentaient d’illustrer ses théories cosmogoniques ou illuminées des années 50, par des cérémonies littéraires et liturgiques qui célébraient le pontife, le mage foudroyé en holocauste à un triomphe transcendent: projection de l’auteur lui-même sous les incarnations de l’écrivain (Les Désamorantes), du prophète (Le Concile des poètes), du représentant de Dieu (Iésou), et 169 «Tous ceux qui avaient lu cette pièce savaient que c’était aller au-devant de pas mal des difficultés. […] De Chazal se rebiffa de telle manière que les échos se retentirent jusque dans les colonnes des journaux; il proclama que Judas qui allait être joué n’avait rien à voir avec la pièce qu’il avait écrite.», G. André Decotter, Le Plaza. Un demi-siècle de vie théâtrale, op. cit., pp. 32-33. 170 Moïse, Pythagore, Hermès, Bien que la terre, Jésus II, per citarne alcuni, sono rimasti in forma manoscritta. 171 Malcolm de Chazal, Iésou, théâtre mythique en six actes, Port-Louis, Imprimérie Almadinah, 1950. Riassunto p. 488. 172 Malcolm de Chazal, Judas, Port-Louis, Esclapon Limited, 1953. Riassunto p. 489. 173 Malcolm de Chazal, Les Désamorantes.Satire-drame en cinq actes, Port-Louis, The Mauritius Printing Cy limited, C. Marier-d’Unenville, 1954. Riassunto p. 489. 174 Malcolm de Chazal, Le Concile des poètes. Théâtre prophétique en un acte, Port-Louis, The Mauritius Printing Cy limited, C. Marier-d’Unenville, 1954. Riassunto p. 490. 284 même du traître-victime s’immolant pour l’accomplissement de l’ultime sacrifice salvateur du monde (Judas).» 175 Il teatro spogliato dell’azione, chiuso nell’epifania di un pensiero che si confronta con l’origine è assunto da Chazal come luogo di una narrazione recuperata nella sua primitiva funzione conoscitiva. I personaggi, non più ispirati agli eroi classici o al mondo reale, evolvono sulla scena come vettori-verità: sono la manifestazione del pensiero, articolato secondo diverse proposizioni, la cui opposizione, come nel racconto platonico, deve portare all’elaborazione di una tesi finale, riconducibile alla concezione cosmologica dell’autore che molti hanno assimilato a quella di Swedemborg. Il conflitto tra l’uomo e la donna messo in scena ne Les Désamorantes è l’illustrazione dell’autorità funesta esercitata dal sesso femminile sugli spiriti eletti, sintetizzata da Chazal nel noto aforisma «La femme est une trappe pour le génie qui doit l’éviter à tout prix ou n’être rien»176. Lo stile aforistico, che caratterizzava la poesia dello scrittore mauriziano, regola una composizione teatrale volta alla dimostrazione di assunti metafisici, alla rappresentazione di una visione del mondo fondata sulla simmetria tra macrocosmo e microcosmo, sull’accordo tra legge fisica e norma morale. Un teatro che parte dall’uomo per raccontare il divino, che si prefigge l’intento di rendere manifesta la relazione tra naturale e soprannaturale, può essere definito profetico (ed è proclamato tale da Chazal), divinatorio nella misura in cui la parola è manifestata, posta davanti («pro-ferre») allo spettatore come sintesi di un processo conoscitivo, che ha attinto alla Storia (in particolare al mistero cristiano) per riscriverla sulla base di una nuova cosmogonia. L’interesse per i soggetti biblici, in modo particolare per la figura di Cristo e di Giuda, per un dramma di atmosfere e del pensiero negatore della realtà umana, tradisce l’influenza del teatro espressionista, di cui Chazal eredita la sensibilità per i temi religiosi, per la rappresentazione per lo più negativa della donna, per la graduale disincarnazione dei personaggi, ridotti ad archetipo, per la funzione normativa del linguaggio poetico177. Nondimeno, l’uniformità dei soggetti trattati nei saggi, nelle raccolte poetiche e nel teatro rende conto della ricerca di un mezzo espressivo atto alla celebrazione della parola come attività conoscitiva e rivelatrice dell’essenza delle cose, che fa dell’uomo un nuovo Adamo. 175 Camille de Rauville, Chazal des antipodes, Paris, NEA, 1974, p. 18. Citata da Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, op. cit., p 206. 177 «Le théâtre expressionniste présente non pas de caractères, mais des âmes. […] Un dernier aspect de la psychologie du héros expressionniste […] son drame est celui de la faute. Il a peut-être commis une faute et il n’a jamais été capable de définir cette faute et ce fait, il est en proie à des persécutions […]. La femme jouit d’un singulier privilège dans le théâtre expressionniste, celui de n’exister que par la grâce du héros […]. Chez Strindberg, elle doit séduire le héros, le torturer et, en le torturant, l’amener vers le ciel», Maurice Gravier, Le héros expressionniste, in Le théâtre moderne hommes et tendances, études réunis par Jean Jacquot, Pars, CNRS, 1965, pp. 118-124. 176 285 I personaggi di Chazal non sono simboli: sono pure essenze assunte dal drammaturgo perché la loro relazione con una realtà metaforica possa esprimere il disorientamento del poeta di fronte a un mondo che si sottrae a qualsiasi interpretazione178. Giuda, Cristo, Louis Lambert, il profeta testimoniano, al contrario, il possesso della realtà attraverso la parola179. Chazal sceglie di rappresentare la vita di quei personaggi biblici le cui azioni e il cui pensiero, la cui natura mitica (Cristo), la cui condotta ambigua eppure necessaria (Giuda) hanno incarnato il mistero dell’unità dell’umano con il divino. Ricusando l’iconografia romantica di Giuda, vittima del destino e della cieca volontà divina, simbolo di un’umanità tragica i cui ideali politici sono stati traditi, Chazal si ispira al personaggio dei Vangeli, di una tradizione minore risalente ai testi apocrifi dei primi cristiani180 che ha riscattato la figura di Giuda per la sua umanità: Judas: «…Moi Judas Iscariote, fils de Dieu, marchand de nos cités, dans le corps d’un homme, mènerai l’Agneau au Couteau Divin. Je sui s le Désigné pour le crime… Il fallait un bourreau, Seigneur. Je suis là, Tu m’y as préféré, choisi, touché, conditionné…Tu as pris le plus courageux. Tu en as fait le plus souffrant […] je suis libre. Mon œuvre est accomplie.»181 Ne La Tentation de Saint Antoine, già Flaubert aveva acclamato Giuda come lo strumento della redenzione di Cristo182; nel 1914, Léonid Andreev, ne Les sept pendus, rappresentava l’apostolo con attributi di forza e coraggio, in opposizione agli altri discepoli del Messia (descritti come uomini pavidi di fronte al potere romano e al sinedrio). Come in Andreev, nella pièce di Chazal Giuda incarna la forza fisica e la dirittura morale, è presentato sin dalle prime battute come colui che salva Gesù da un primo arresto per portarlo alla redenzione. 178 «La Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent parfois de confuses paroles;/L’homme y passe à travers des forêts de symboles […]», Charles Baudelaire, Correspondances, in Spleen et Idéal, Les Fleurs du Mal, Paris, Gallimard, 1975, p. 11. 179 «L’homme par un langage d’évidence accède par synthèse à un Dieu en qui tout se lie», Malcolm de Chazal, Sens Unique, Port-Louis, Le Chien de Plomb, Regent Press, 1974. 180 «Il tema di Giuda eroe positivo, in qualche caso superiore a Cristo, non è nuovo anche se la sua origine è stata individuata in seno alla tradizione non canonica giudaica […]. Il primo giudizio positivo su Giuda giunse dalla setta dei canditi; secondo gli esponenti di questo gruppo eretico, l’Iscariota fu l’unico tra gli Apostoli ad aver compreso esattamente il ruolo di Gesù. […] Giuda fu considerato buono anche dalla comunità gnostica degli ofiti, presente nel II secolo fino all’alto medioevo in Italia settentrionale e nella Francia meridionale. Secondo gli Ofiti, Giuda era parte integrante del piano salvifico divino, senza il suo tradimento non ci sarebbero state né crocifissione, né redenzione.», Massimo Centini, Giuda Iscariota, Genova, ECIG, 2002, pp. 180-181. 181 Malcolm de Chazal, Judas, op. cit., pp. 63-64. 182 «Gloire à Judas […] et c’est par Judas que Dieu sauva le monde! — Oui, Judas! Sans lui pas de mort et pas de rédemption!», Gustav Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine, Paris, Garnier, 1954, pp. 91-92. 286 Indicato da Cristo come l’eletto, per l’abnegazione del suo sacrificio, Giuda assurge ad alter ego del Messia, a suo doppio183. Judas: «Et moi, Maître, te trahirai-je?» Iésou: «Tu es de ceux qui refuseront par peur de profaner. Deux mille ans après ma mort, paraîtra ton Eglise.»184 Chazal fa di Giuda la figura dominante di molti suoi scritti; non solo le due pièces dedicate al personaggio rivelano il particolare interesse dello scrittore verso il reietto della religione cristiana, anche in Iésou, la figura di Cristo è rappresentata a partire dal binomio con Giuda, e nel saggio teosofico pubblicato nel 1953, Judas ou la trahison d’un prêtre185, l’apostolo è trattato come depositario della vera religione. Il confronto di Iésou e Judas rivela la complementarità dei due testi. Le due pièces sono incentrate sull’episodio della morte di Gesù e il suicidio di Giuda. Non soltanto nelle due opere ritornano i medesimi personaggi, Giuda e Cristo, Lazzaro e Marta, entrambe si aprono con l’interrogazione di Giuda sull’esistenza e sulla necessità dell’azione: Judas: «Tu te trompes. J’agis […] Et vous êtres misérables […] J’irai même jusqu’au Diable pour lui […] jusqu’à l’abolition […].»186 L’Homme: «Le monde? Vil bétail. […] Ah! Faire quelque chose, agir […]»187 Il percorso ascetico di cui si narra nelle due pièces si rivela complementare nella misura in cui le due figure, quella di Gesù e quella di Giuda, si confondono. La morte di Giuda che è sempre rappresentata da Chazal come contemporanea a quella di Cristo188, riferisce di una cosmogonia dove Giuda, agnello sacrificale come Cristo, è divenuto sacerdote di una chiesa che fonda nel sacrificio (dell’uomo-dio per l’umanità e dell’uomo per l’uomo189) la rivelazione del trascendente nella realtà, allorché l’accettazione della morte al di là della comprensione razionale indica l’assunzione del mistero nella sua impenetrabilità: 183 Gérard-Denis Farcy, Le syncophante et le rédimé ou le mythe de Judas, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1999, p. 69. 184 Malcolm de Chazal, Iésou, théâtre mythique en six actes, op. cit., p. 8. 185 Malcolm de Chazal, Judas ou la trahison d’un prêtre, Port-Louis, Popular Printing, 1953. 186 Malcolm de Chazal, Iésou, théâtre mythique, op.cit., pp. 3-4. 187 Malcolm de Chazal, Judas, op. cit., p. 3. 188 «Quand Iésou meurt, Lazare vit, et Judas recouvre son salut.», Malcolm de Chazal, Iésou, théâtre mythique en six actes, op. cit., p. 60. In Judas l’omicidio di Cristo coincide con il suicidio di Giuda. 189 Judas:«Je meurs à cause d’un homme, Lui, il meurt à cause de l’Humanité», Malcolm de Chazal, Iésou, théâtre mythique en six actes, op. cit., p. 52. 287 Marie-Madeleine: «Tu te retrouveras Judas. Alors seulement tu te reconnaîtra.» Judas: «Va, Marie-Madeleine, tu as l’esprit du Christ. Du dehors, tu le vois. Perdu en lui, je ne le comprends plus.» M.M.: «Cesse d’être Judas et tu le comprendras. […] Je vois en toi le dernier accomplissement, la suprême scène, l’ultime mot. Et tu ne peux qu’agir, Judas, poussé par l’Esprit.»190 Come in Iésou, così in Judas, Chazal si concentra sulle sole figure di Cristo e Giuda il cui palesamento è affidato agli altri personaggi Cephas, Marie, Myriam, agli apostoli, André e Pierre, a Clophas e Marie-Madeleine, trattati dal drammaturgo come strumenti atti alla dimostrazione dell’assunto iniziale (Giuda sacerdote della nuova chiesa, Cristo manifestazione del divino), ridotti dal drammaturgo ad anime, a spettri che si dibattono in una Galilea additata come il regno dei morti. Perché i termini della dottrina cristiana, della teosofia di Chazal, possano essere rappresentati ed enucleati è necessario, come aveva rilevato Camille de Rauville, che la scena si offra come lo spazio del confronto dialettico, della logomachia. Pietro, Lazzaro sono, così, mutati da Chazal nel doppio di Giuda e di Cristo, nella misura in cui, avendo sperimentato a loro volta il tradimento e la resurrezione, permettono di amplificare la vicenda, quindi di chiarire il messaggio, dei due personaggi principali: Judas: «Tu seras traître, toi [Simon Pierre], avant que je sois mort»191 Maria Maddalena, Marta e Maria, Myriam la madre di Gesù192, come i successivi personaggi femminili di Les Désamorantes, rappresentano la tentazione del negativo: il peso della carne (contro la leggerezza dello spirito) che, non arrivando a comprendere la pienezza del mistero divino e la natura incorporea del genio, ragionando in termini di possesso e di proprietà: Jeanne: «[…] Ma pâture, tu me fais rire. Toi, si fort, si grand, si noble, mon guide, mon pilote, ma vie,mon amour. Ma chose.»193 190 Malcolm de Chazal, Judas, op. cit., pp. 46-47. Ibid., p. 59. 192 Per la costruzione dei personaggi femminili del vangelo, Chazal fa, evidentemente riferimento, alle teorie gnostiche dei primi secoli. Se per la moglie di Judas, lo scrittore si ispira al quinto frammento dei vangeli apocrifi (una donna insaziabile e avida che ha spinto il marito al tradimento per soldi), anche la confusione tra Maria e Maria di Magdala, la madre di Gesù e altre figure del vangelo sembra procedere dalla lettura dei testi non riconosciuti dei primi cristiani: «la perdita di identità raggiunge proporzioni inattese negli apocrifi: ad esempio nei Vangeli gnostici, Maria di Magdala è addirittura indicata come madre di Cristo […]», Massimo Centini, Giuda Iscariota, op. cit., p. 79. L’unica donna che Chazal sembra riscattare è Maria Maddalena, molto probabilmente perché la tradizione gnostica aveva sublimato la Maddalena nella manifestazione della Conoscenza, della Sophia greca: «In realtà Maria, così come descritta dagli apocrifi e dalla tradizione popolare, risulta un’espressione molto chiara e umana della dottrina gnostica. Nel testo Pistis Sophia appare per settantasette volte ed è indicata, per voce di Cristo, come depositaria della Conoscenza […].», Ibid., p. 78. 193 Malcolm de Chazal, Les Désamorantes, op. cit., p. 25. 191 288 La distruzione e la morte, l’immaginario apocalittico (di esseri ridotti a larve, a un tempo prede e cacciatori) che pervade le prime opere di Chazal si conclude su un diluvio che, come la catastrofe biblica, ha permesso la nascita del nuovo mondo, Malandon, fondato sull’unità e sull’uguaglianza degli esseri. Come Platone nella Repubblica, Chazal contrappone la realtà fallimentare di una società fondata sulla tecnologia (una eco della filosofia heideggeriana?), alla visione di un’umanità governata dai filosofi, la cui ricerca e la cui conoscenza della verità hanno ricondotto l’uomo all’originaria armonia con l’universo: Le Président: «[…] le sens vrai de l’animal retrouvé, le processus de la vie mis a nu, la pensée des plantes révélée, le jeu d’amour universel que nous avions appelé gravitation totalement exposé, le sens même de vivre fut renouvelé.» Le prophète: «L’homme se retrouvera lorsqu’il saura qu’il est le témoin du Cosmos, le prototype, calque et décalque de l’Archétype, et que Dieu est comme l’homme, mais Archétype, et que le vaste Cosmos n’est qu’un Grand Homme, Reflet du Corps de Dieu.»194 L’analisi delle pièces di Chazal mette in luce l’interesse per un mezzo la cui struttura dialogica si offriva naturalmente all’esposizione della complessa teoria cosmogonica dello scrittore. La scelta di dividere i testi nel numero di atti delle tragedie classiche (sei atti per Iésou, cinque per Judas e Les Désamorantes) non impedisce di rinvenire nella struttura aristotelica la traccia di un’argomentazione geometrica, costituita da un assioma iniziale e da una tesi finale (primo e ultimo atto), e da corollari (i restanti atti) la cui funzione è argomentativa e dimostrativa. Il fatto che gli atti delle prime due opere siano introdotti da un titolo, ad indicare la progressione del dramma verso lo sviluppo tragico finale (l’ultimo atto è designato Drame), rivela l’intenzione del drammaturgo di far dialogare la struttura generale con le singole parti del dramma. Come nello stationendrama dove l’evoluzione della situazione tragica è assoggettata alla logica del singolo quadro, così gli atti dei testi chazaliani possono essere colti come unità a sé nella misura in cui ciascuno di essi è la rappresentazione della rivelazione della verità che si cela nella parola. Conformandosi al principio della specularità del macrocosmo e del microcosmo, il testo di Chazal riproduce un organo le cui parti sono a un tempo unite e separate: «La parola diventa sovrana e spicca un salto fuori dalla frase, la frase offusca usurpa il senso della pagina, la pagina prende vita a spese del tutto, — il tutto non è più tutto.»195 194 195 Malcolm de Chazal, Le Concile des poètes, op. cit., pp. 71-75. Friedrich Nietzsche, Il caso Wagner, in Scritti su Wagner, Milano, Adelphi, 1979, p. 180. 289 L’organicismo della parola chazaliana, nel recuperare una certa visualità della poesia simbolista, lascia capire il tentativo dello scrittore di ritrovare disegnata e designata, con il linguaggio, l’essenza delle cose. Questo teatro simbolista (nel lessico e nelle atmosfere), espressionista (nei personaggi e nelle storie), al di là delle intenzioni del drammaturgo, è, allora, la parabola della conoscenza: il Libro mallarmeano finalmente decifrato. Citiamo ad esempio un piccolo passo di Les Désamorantes, in cui Chazal riduce il linguaggio alla rappresentazione degli elementi: «Même décor. Des femmes causent. Eugénie est toujours sur le divan, parmi les coussins rouges [fuoco]. Deux femmes devant elle, l’une est une évaporée [aria], Lucille, et l’autre est grave [terra], Jeanne196» L’aver piegato l’arte drammatica al gioco e alla ricerca intellettuale ha certamente favorito la rottura con la tradizione classica mauriziana, avviando le nuove generazioni verso la sperimentazione europea del teatro post-bellico, per quanto non ancora completamente assunta da Chazal (allorché la novità dei suoi testi era una conseguenza e non la premessa del linguaggio metafisico), di cui lo scrittore aveva indicato in grandi linee i motivi principali: allontanamento dal teatro naturalista per un teatro a tesi, concezione del teatro come manifestazione del dramma esistenziale, spostamento della macchina drammatica dall’azione al linguaggio, disumanizzazione dei personaggi. 196 Malcolm de Chazal, Les Désamorantes, op. cit., p. 8. 290 L’io frammentato, tra espressionismo e psicodramma André Masson, Regis Fanchette 1968, teatro e indipendenza, la riflessione politica di André Masson Il fervore della rivolta, il movente dell’azione e della lotta politica che avevano spinto Loys Masson alla resistenza e alla critica del potere ecclesiastico animano i testi del fratello più giovane André197. La notorietà raggiunta da Loys in Francia, in seguito all’impegno civile assunto durante il conflitto, e per il valore di una poesia intrisa dell’ideale umano, ha probabilmente impedito che la produzione di André Masson potesse emergere ed essere apprezzata dai suoi contemporanei quanto quella del fratello maggiore. Se la guerra aveva elevato la vicenda del poeta Loys Masson a esperienza universale del dolore, della resistenza e della militanza umana contro il cieco destino, l’attività poetica di André rifletteva il difficile periodo di transizione post-bellica: si faceva cassa di risonanza delle antiche paure198 mauriziane, dei timori di una rivoluzione politica, culturale ed economica che alla fine degli anni 50 sembrava inevitabile nella vecchia Île de France. Contro una poetica che si era spogliata dei riferimenti alla terra natale per rivendicare l’adesione all’universo francese199, André Masson si è, invece, fatto interprete del mondo mauriziano nella 197 Nato nell’aprile del 1921, André Masson è il più giovane dei fratelli Masson a dedicarsi alla carriera di scrittore Diversamente dai fratelli Loys e Hervé decide di restare ad esercitare la sua professione di giornalista sull’isola (è redattore dei quotidiani «Le Mauricien» e «Libération»). Entrato molto giovane in seminario per seguire la vocazione religiosa, ne esce dopo qualche tempo per reazione al sistema ecclesiastico. Il primo testo, Le pas de la porte, risente dell’aspirazione mistica e della ricerca di Dio, pur manifestando una certa inquietudine metafisica riguardo al destino dell’uomo. Dopo una serie di romanzi dominati da una visione sempre apocalittica della realtà mauriziana, tra il 1966 e il 1971, pubblica tre pièces teatrali ispirate al modello del teatro dell’assurdo degli anni 50. Il pessimismo e la vena caustica delle sue opere gli valse tra i suoi contemporanei l’appellativo spregiativo di «illuminato». Spinto alla rivolta contro Dio e contro l’uomo, A. Masson può essere considerato un’esistenzialista mauriziano. Muore nel 1988. «En l’île Maurice où je vis, je suis mort plusieurs fois — et chaque fois, dans quelque portrait du monde, ressuscité.», Issa Asgarally, Littérature et révolte, Île Maurice, éd. Le Flamboyant, 1985, p. 31. 198 Sembra certamente un controsenso parlare di “paure ancestrali” per una terra disabitata, colonizzata, nella prima metà del XVIII secolo, da una nazione che negli stessi anni si faceva promotrice del sapere scientifico contro la superstizione. Ciononostante, la repressione sistematica messa in atto dall’oligarchia del luogo, per scongiurare e scoraggiare l’emancipazione della popolazione nera e indiana, aveva mutato il disegno politico (di difesa del potere dell’oligarchia francese) in una caccia alle streghe, la discriminazione in fobia (ricordiamo l’opposizione stolida dei proprietari terrieri di vaccinare la popolazione contro la malaria ancora all’inizio del Novecento). 199 Ricordiamo in proposito che critiche recenti hanno dimostrato come lo scrittore mauriziano, Loys Masson, sia tornato, soprattutto nei romanzi, a raccontare, a confrontarsi con la realtà mauriziana della storia schiavista e dei problemi razziali, ne sono un esempio illustre L’Etoile et la Clef, Le Notaire des Noirs, inserendosi nel ricco filone letterario di Martial e Charoux. 291 misura in cui ha rielaborato l’esperienza delle nuove avanguardie poetiche, l’attività sperimentale degli scrittori del dopoguerra, alla luce del contesto culturale dell’isola, allorché ha riconosciuto nello spaesamento e nel silenzio del teatro degli anni 50 la manifestazione della situazione politica e sociale del popolo mauriziano e, in particolar modo, della comunità franco-creola alle soglie della propria indipendenza. Come Robert-Edward Hart e Malcolm de Chazal, André Masson è rimasto sull’isola a reclamare la pulsione assolutamente mauriziana della sua poetica. Il mondo insulare vive nei testi di A. Masson nella complessità irrisolta e secolare dei conflitti razziali (di cui lo scrittore ha voluto farsi testimone), nell’esuberanza e nella singolarità di una poesia ispirata a una concezione unanimista della realtà che già le parole-cose di Chazal avevano celebrato. La vocazione liturgica della parola, nel ritrasformare ogni volta l’uomo e il poeta in Adamo, pone lo scrittore di fronte alla tentazione del divino, obbligando il narratore a confrontarsi con l’impossibilità di farsi uguale a Dio pur avendone imitato l’atto creativo. Come già Loys, diversamente da Chazal, la poesia e i drammi di André Masson sono pervasi da un profondo pessimismo, da un’angoscia metafisica allorché l’atto di conoscenza tentato dal nuovo Adamo si scontra con il silenzio della materia. La rivolta contro Dio che animava i personaggi di Loys Masson in difesa della libertà e di un’individualità che l’Assoluto sembrava minacciare (rivolta condannata dal drammaturgo come atto egoistico), è sentita dal fratello André come inevitabile laddove la stessa esistenza, come processo che tende a distinguere gli esseri, è percepito di per sé come un atto sovversivo. Di fronte alla storia che ha sopraffatto e disumanizzato l’individuo, sminuendo l’azione del singolo di fronte al processo evolutivo, l’avventura mistica di Prometeo, voleur du feu, è già la promessa della condanna: la certezza del Prometeo incatenato. La rivolta contro il Padre che in Kafka assumeva la doppia valenza religiosa (il Padre della tradizione ebraica) e politica (la Legge che soffoca la libertà del singolo), rivive nei drammi di André Masson che recupera dello scrittore ceco la medesima visione assurda e disperata della realtà. «Si André Masson s’est imposé jusqu’ici comme romancier, il aurait eu, par contre, la main moins heureuse avec ses pièces de théâtre. L’Étoile (1966) a été jouée à l’O.R.T.F. et à la B.B.C., mais personne n’en a voulu pour la scène. Pourquoi? Parce que à gauche, on aurait pris cette pièce pour une pièce de droite et parce qu’à droite, Dieu fait plus peur qu’à gauche.»200 200 Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, op. cit., p. 250. 292 Nel concludere la sezione dedicata ad A. Masson con un giudizio deluso sull’opera drammatica dello scrittore — una prova, secondo il critico, meno riuscita rispetto alla produzione narrativa — Jean-Georges Prosper rilevava l’originalità del teatro massoniano nella complessità e contraddittorietà del tema sociale affrontato, che voleva essere l’affermazione di una rappresentazione problematica della realtà politica mauriziana di fine anni 50. Il contenuto politico dei testi di A. Masson inseriva la produzione dello scrittore nella tradizione teatrale dell’Île Maurice, pensata dalla sua costituzione, come abbiamo visto, in termini di lotta politica, di propaganda e di difesa della cultura della comunità franco-creola minacciata dall’invasione inglese e indiana (ricordiamo velocemente le opere di Leoville L’Homme e di Martial). Il conflitto razziale e politico della vicenda mauriziana assumeva un significato nuovo e terribile alla fine degli anni 50, quando, dopo il secondo conflitto, il vecchio mondo coloniale crollava al grido dei movimenti indipendentisti. I testi teatrali, L’Étoile201, La Verrue202, La Conversation203,di André Masson mettono in scena, allora, l’agonia di una realtà che non vuole riconoscere la propria fine e che ottusamente difende le prerogative di un mondo decaduto; i drammi sono la rappresentazione grottesca della follia, del delirio del potere: Hérode:«L’Orient n’a pas cessé de nous envier! Et voici qu’il invente, pour nous troubler un engin volant! (à part) Il est vrai que l’Occident, lui, il est triste! (aux mages) À cause de vous, Jérusalem s’excite et complote la nouvelle d’un grand événement! Je ne veux pas d’événement! Et s’il existe, je l’étiendrai, votre événement!»204 la messinscena della capacità alienante e massificante delle parole: la constatazione di una perdita: un mort: «[…] Elle est grande la parole. Voyez-moi et voyez mes amis, là-bas, les trépassés. Nous n’avons plus que la parole»205 L’uso allegorico della parola, ispirato al testo biblico, rivendicato da A. Masson poeta e narratore, nutre un teatro che della vicenda politica mauriziana vuole cogliere tutto il dramma esistenziale. Come in Kafka, come nell’esistenzialista Camus, così in A. Masson l’epopea biblica 201 André Masson, L’Etoile, Port-Louis, Regent Press, 1966. Riassunto p. 493. André Masson, Théâtre: La Verrue. Pièce en trois actes, Port-Louis, Regent Press and Stationery, 1971. Riassunto pp. 493-494. L’ultima battuta è lasciata al commissario che a turno si rivolge ora al cadavere di Karlus «qu’est ce que ça pouvait lui faire de se remettre la verrue», a Pilar «[…] le temps vous guérira»,ad Amiel, ormai identificato a Giuda «Bravo,mon garçon.» (p. 47). 203 André Masson, La conversation. Pièce en un acte, Port-Louis, Regent Press and Stationery, 1971. 204 André Masson, L’Étoile, op. cit., p. 14. 205 André Masson, La Verrue, op. cit., p. 33. 202 293 viene riscritta alla luce della prospettiva umana, delle vittime della storia; il suo teatro si fa portavoce di quei personaggi reietti, la cui problematicità è esaltata dalla vanità della propria azione206. La bellezza grottesca e decadente del tragico (Hérode, il vicepresidente Bélar) si unisce, nel drammaturgo mauriziano, a una visione umiliata della rivolta, quasi l’essere umano si trovasse schiacciato tra due poli negativi nessuno dei quali è capace di garantire se non la libertà, la sopravvivenza dell’individuo: Karlus: «Le mot liberté, par exemple? C’est une fleur du désert, la rose des sables […]. C’est moi. Le désert, c’est moi. On appelle cela la mort. Je suis devenu ta mort, ta suprême humiliation.»207 La perdita della libertà, con la quale era costretto a commisurarsi il personaggio delle tragedie classiche, la necessità divina che mutava l’umano in eroe tragico, fa, ora, luce su un uomo reso meschino dalla perdita delle proprie certezze: sospeso tra la rivolta e la tirannia senza riuscire ad attribuire un valore positivo a una delle due scelte politiche (nei testi di André Masson l’assurdità della vicenda sospende qualsiasi giudizio morale sull’azione). Come ne Les Rhinocéros di Ionesco, ne La Peste di Camus, il pericolo della diffusione dell’epidemia (la rinocerite, la peste) era all’origine della psicosi collettiva208, così, il delirio collettivo, in difesa della libertà della maggioranza contro la rivendicazione della libertà individuale, assume i contorni di una vicenda paradossale allorché viene raffigurata da A. Masson 206 L’interesse per i personaggi enigmatici della Bibbia, Giuda, Gesù, Erode, l’assunzione problematica della loro vicenda, all’origine di una riscrittura e di una reinterpretazione della storia biblica stessa, rientra in un processo di creazione letteraria che, come abbiamo visto, era iniziato con il teatro espressionista di inizio Novecento. Il confronto tra il testo di A. Masson e gli esistenzialisti ci è parso particolarmente fruttuoso, dal momento che Camus è l’unico a reinterpretare la vicenda di Cristo alla luce del massacro degli innocenti, l’unico, insieme a Masson, a introdurre la prospettiva umana sull’episodio, per la quale Gesù sarebbe, pure indirettamente, complice e colpevole: «Ci sono sempre ragioni per assassinare un uomo. […] La vera ragione è che lui sapeva di non essere completamente innocente. […] aveva dovuto sentir parlare d’un certo massacro degli innocenti. I bambini di Giudea massacrati mentre i suoi genitori lo portavano al sicuro, perché erano morti, se non per causa sua? […] Quei soldati insanguinati, quei bambini squarciati in due, gli facevano orrore. […] Il lamento saliva nella notte, Rachele chiamava i suoi figli morti per lui e lui era vivo.», Albert Camus, La caduta, l’esilio, il regno, Milano, Bompiani, 1958, p.p. 80-81. Confrontiamo il testo di Masson: Myriam, «La naissance de celui que tu appelles le Messia a été marqué par le carnage! Or, le sang appelle le sang! À cause du sang, moi, je ne crois pas […].», André Masson, L’Etoile, op. cit., p. 54. Figlio dell’usurpatore del trono di David, Erode Antipa, Erode era considerato dagli Ebrei il traditore del popolo a causa di una politica che sembrava favorire l’oppressione romana. L’impopolarità del re nasceva dalle continue infrazioni di Erode alla legge. Il concubinaggio con Erodiade, e il successivo matrimonio con la moglie del fratello, amplificavano il disprezzo per un re che aveva costruito la sua dimora lontano dal popolo, profanando il luogo sacro di un cimitero. La vicenda di Erode è tristemente legata al massacro degli innocenti e all’uccisione di Giovanni Battista. Massimo Centini, Giuda Iscariota, op. cit., pp. 40-41. Sulla lontananza della reggia di Erode dalla città, il drammaturgo costruisce la figura di un personaggio decadente, di un’anima il cui distacco dal mondo ricorda l’Hérodiade di Mallarmé: Antigone, «[…] ton palais est separè de tout ce qui vit et qui aime — un désert! — Trop haut, tu n’entends plus que ta propre voix! On ne parle plus, dans les rues et sur les places que de Dieu qui vient […] On respire Dieu, littérairement — sauf ici on étouffe!», André Masson, L’Étoile, op. cit., pp. 29-30. 207 André Masson, La Verrue, op. cit., p. 40. 208 «[…] société en proie à la psychose à l’image […] de rhinocérité dans Les Rhinocéros de Ionesco.», Issa Asgarally, Littérature et révolte, op. cit., p. 26. 294 come una sorta di reazione pandemica (degli uomini, degli animali e delle cose) all’insubordinazione209. Le tre opere teatrali del drammaturgo, scritte tra il 1966 e il 1971, negli anni più difficili della storia dell’isola quando si decise della sua indipendenza (1968), sono la narrazione del crollo dell’impero franco-creolo. Rappresentando la fine dell’oligarchia terriera come il crepuscolo di un’autorità rimasta indiscussa per secoli, anche sotto il governo inglese, A. Masson mette in scena il disorientamento culturale di una comunità, ritratta cinicamente con le velleità di un dio, di fronte al concretizzarsi di una minaccia paventata dal 1792. La Bibbia con i suoi tiranni sanguinari, la Chiesa come rappresentante del potere spirituale e temporale, si offrono come lo spazio ideale attraverso il quale dare voce a una situazione politica di cui il drammaturgo vuole metter in luce le implicazioni storiche, giuridiche (il tentativo di massificazione culturale e di lotta interetnica210), quindi ritrarre la crisi morale (la corruzione politica) e identitaria, denunciata dai movimenti autonomisti: Hérode: «[…] La peur, c’est de se sentir autre que soi-même, un étranger, qui est moi-meme et qui me bouleverse…Hérode contre Hérode, comme je veux que Dieu soit contre Dieu…le frisson, c’est cette fine ligne de démarcation qui bouge entre le moi et l’autre […]»211 Dominati da un linguaggio che condiziona l’agire umano, lo spazio biblico e il rito liturgico mettono in scena la dittatura della Parola, l’impossibilità della scelta212 umana di fronte al determinismo. Erode e Bélar, Karlus e Myriam non possono agire diversamente dal ruolo che è stato loro imposto, quello del dittatore e quello del rivoltoso; di fronte alla determinazione di Pilar di fermare la rivolta, la decisione di Amiel di salvare Karlus (perché la rivoluzione possa proseguire) palesa la sua vanità, presentando la scelta del dissenso come una mera illusione. Come nei romanzi di Kafka la normalità dell’uomo comune viene messa in discussione dal sopraggiungere di un fatto imprevisto, così i drammi di A. Masson si aprono con i personaggi che scrutano il cielo nel tentativo di decifrare la minaccia che incombe sulle loro teste, che preparano affannosamente le valige nella speranza di poter sfuggire alla persecuzione, tuttavia come nei racconti dello scrittore ceco, il senso, la ragione della minaccia rimane oscura. Se la disgregazione dei personaggi, la loro progressiva semplificazione (il tiranno sanguinario, il ribelle sacrificato), il nonsenso che permea i testi di André Masson sono evidentemente 209 Dopo aver assicurato a Karlus la propria libertà, il commissario termina il suo interrogatorio prevenendo il colpevole di non tentare alcuna fuga visto che l’intera città, topi compresi sono contro di lui. La Verrue, op, cit., p. 18. 210 Hérode: «De toute façon, c’est une étoile juive! Nous allons l’éteindre […].», André Masson, L’Étoile, op. cit., p. 23. 211 Ibid., p. 32. 212 Diversamente, Issa Asgrally riconosce ai personaggi di A. Masson la possibilità della scelta. Secondo il critico, il drammaturgo mauriziano mette in scena un teatro in situazione nella misura in cui questi mostrano «un caractère en train de se faire, c’est-à-dire au moment du choix», Issa Asgarally, Littérature et révolte, op. cit., p. 25. 295 riconducibili al teatro dell’assurdo di Ionesco e Beckett, popolato da uomini ridotti a fantocci, a pagliacci (l’ultimo testo, La Conversation, è certamente ispirato alla Cantatrice Chauve), la problematica esistenziale presente nei drammi soggiogata, in ultimo, dall’orientamento, dall’imperativo politico, spinge a una rielaborazione in chiave espressionista del tema dell’assurdo; quegli stessi drammi espressionisti, da cui l’autore sembra derivare la concezione manichea del mondo, la nozione della libertà e dell’oppressione derivate da un’analisi storico-politica non più metafisica, il tema del doppio (da interpretare in chiave socio-politica213), la rappresentazione allegorica della realtà: Amiel: «[…] Regardez ces fleurs, Madame. Ce ne sont pas de vrais fleurs. Ce sont des idées de fleurs. Comme ce révolver est une idée de revolver. (à Karlus) Moi aussi, je ne suis qu’une idée. Comme la ville […] Comme Mons. Le Président, […] comme la police qui va venir. Oui je pars. Mais les idées restent. Vous sentez? …Les fleurs sont fausses, mais elles embaument…»214 La metafora liturgica suggerita da Kafka, come rappresentazione della Legge e del Padre, che la cultura ha reso tabù inaccessibili all’uomo, è ripresa da A. Masson per la caratterizzazione del potere. Emuli di un dio che l’immaginario collettivo ha mutato in un autocrate vendicativo, Hérode e le Président si appropriano del linguaggio cultuale come strumento normativo: le Président: «Dominus vobiscum» Bélial: «Et cum spiritu tuo»215 La parodia del rito purificatore, la folle perversione di un presidente-re-satana216 a cui vengono attribuiti gli stessi connotati di Dio217, mette in luce il ribaltamento dei rapporti di forza tra la legge 213 Il tema del doppio è ricorrente nei drammi di A. Masson. L’Étoile, La Verrue, La Conversation mettono in scena la deduplicazione dei personaggi: Giuda e Pietro, Amiel e Karlus, M. Dupont e M. Durand. Se nel primo testo il tradimento rendeva simili coloro che l’avevano commesso, Giuda e Pietro, nei drammi successivi, il tema del doppio assume anche una connotazione psicologica oltre che politica e morale. Come la tradizione apocrifa del II secolo d.C. considerava Gesù e Giuda l’uno il doppio dell’altro, al punto che si riteneva che Giuda, confuso con Gesù, fosse stato condannato al posto di Cristo, così nel testo di A. Masson, Amiel (Giuda) suggerisce a Karlus (Gesù) di scambiarsi di abito perché il rivoluzionario possa scampare al linciaggio (La Verrue, p. 42) Il doppio cela la minaccia della massificazione nella misura in cui i personaggi che rappresentano il potere sono privati dal drammaturgo di qualsiasi individualità, ridotti a fantocci di carta, allorché, sulla scena, la perdita della verruca è avvertita come un atto di insubordinazione al sistema generale: «Les six sénateurs, vrais ou signifiés, […] représentés par des personnages découpés en carton, ou si le metteur en scène le préfère, ils seront des comédiens réels […]. Dans le premier cas Bélial s’adressera à eux comme s’ils parlaient […]. Dans le second cas, Bélial entendra de véritables interventions. […] Chaque sénateur pourra porter un petit jouet […] qui signifie sa stupidité», Ibid., p. 20. Durand e Dupont sono l’estremizzazione di questo processo omologante tentato dalla politica (La Democrazia) nella misura in cui le loro azioni sono dei gesti fotocopia, le loro parole, il loro dialogo il frutto di un’inquietante propaganda: Le gendarme: «Peut-être serait-il mieux que vous ne pensiez pas.», André Masson, La Conversation op. cit., p. 67. 214 André Masson, La Verrue, op. cit., p. 11. 215 Ibid., p. 22. 216 «Entre le Président qui porte une couronne. Houppelande noire, genre Satan, doublée de rouge évêque. Il se sert d’un pistolet pour tuer des mouches invisibles.», Ibid., p. 22. 296 e l’individuo nei testi di A. Masson rispetto a Kafka. Il Potere, che nei testi kafkiani era descritto come assoluto e inafferrabile, è evoluto, nei drammi dello scrittore mauriziano, in un personaggio goffo e grottesco, nella misura in cui da cacciatore è divenuto preda dell’ignoto218: Pilar: «[…] Un Dieu de carnaval comique et cynique […] et lâche […]. Mais vous ne vous faites grand que pour dérober votre faiblesse. La loi. L’ordre: vos masques de petit garçon au pouvoir. Vous supprimez Karlus parce qu’il vous dépasse.»219 Se i personaggi kafkiani ispirano la pietà del lettore, un sentimento di condivisione di fonte alla dignità della tragedia umana che suggerisce la loro vicenda, la legge derisa provoca disprezzo, soprattutto alla luce della reazione feroce e senza appello che questa fa seguire per il mantenimento dell’ordine costituito. L’assurdo che nei testi kafkiani è provocato dall’angoscia metafisica generata da una realtà che si rifiuta, nei drammi di Masson è, invece, il frutto dello scarto tra l’azione e la reazione. La circostanza è tanto più paradossale quanto più l’offensiva è sproporzionata alla presunta aggressione: la paura di una cometa è all’origine di un massacro, la decisione di rimuovere una verruca è motivo sufficiente per consumare un omicidio: Le Président: «[…] Quel masque lui [à Karlus]donner, lui qui a choisi de ne plus en porter? […] L’exil, messieurs, à quelque chose de…comment dirais-je?...d’éternel. Ça fait divin […] donc Karlus doit mourir.»220 Traditore della sua gente, Erode lava con il sangue l’affronto di una rivoluzione perché attraverso la Storia lo tramuti in Dio. Il popolo semitico esposto alla persecuzione si offre come metafora alla storia secolare degli schiavi neri e degli engagès indiani mauriziani alla ricerca di un riconoscimento politico sull’isola. La stella venuta da Oriente è la minaccia vieppiù reale di uno stravolgimento degli equilibri politici locali dell’isola. Alleata della forza, la Democrazia viene descritta da A. Masson come il potere oscuro che offre l’illusione della libertà, inibendo di fatto qualsiasi vero cambiamento in favore del bene pubblico. 217 Pilar: «Je vous supplie, comme je l’ai supplié, lui. Mais lui ne peut pas ce que vous pouvez. Vous êtes tout-puissant […] Dieu! Vous êtes Dieu […] À l’école, on nous forçait a répéter que vous êtes le seul grand. On nous faisait apprendre par cœur que votre récompense nous attend. Quand vous demandez l’impossible, c’est un épreuve […].Quand nous refusons votre décision, c’est un péché.», Ibid., pp. 27-29. 218 Hérode: «[…] il ne suffit plus, déjà, de savoir que l’étoile est là! Il faut encore savoir ce qu’elle signifie et savoir le cacher!», André Masson, L’Étoile, op. cit., p. 21. L’evidente ignoranza della realtà sociale da parte del sistema politico è all’origine di un sistema che si ignora, così il commissario di polizia si presenta al colpevole come un individuo, buono a nulla, promosso al suo ruolo per puro caso. André Mason, La Verrue, op. cit., p. 18. 219 Ibid., p. 36. 220 Ibid., p. 22. 297 Nelle parole dei dittatori, Erode e Le Président, la Democrazia è una calamità che porta alla lotta civile, alla guerra fratricida di Erode contro Erode, di Dio contro Dio: Amiel: «[…]. On a frappé, donc ils sont en plusieurs [gendarmes]. C’est la Démocratie. […] Vous parlez de rôle, les rôles qui changent, reprendre votre peau de Karlus etc. etc.. Ce n’est pas un jeu, Mos. Karlus, c’est la réalité […] la sincérité, c’est la Démocratie»221 I pochi anni che separano i due drammi, periodo in cui l’isola era stata dichiarata nazione sovrana e indipendente, danno ragione del diverso clima delle due opere, di un’evoluzione in senso pessimistico del secondo testo. L’accettazione finale di Myriam del passato, nella prospettiva di una futura conciliazione con la Storia, non sembra più possibile ne La verrue. Sebbene entrambi i testi si confrontino con la morte di Cristo e del rivoluzionario, solo L’Étoile sembra riuscire a restituire un senso agli eventi riscattando la morte dalla sua gratuità, allorché Myriam riconosce suo figlio, poi suo fratello infine se stessa nello Straniero. Privato della redenzione, ora che la morte non rientra nel disegno di un progresso della condizione umana, Karlus subisce la condanna della morte senza che nessuno degli altri personaggi assuma l’eredità della rivolta222, come rivela l’uso del verbo al passato di Amiel: Amiel: «Karlus…tu es mort? Karlus, mon camarade…(à Pilar) Vous avez fait mon travail? Il allait vivre, il allait grandir, il allait tout sauver…»223 Régis Fanchette, apologia e declino dell’eroe tragico La ricca produzione teatrale mauriziana francofona termina con il breve testo di Régis Fanchette, Fragments pour un théâtre224, pubblicato nel 1958. Malgrado, le opere di André Masson siano 221 Ibid., pp. 6-7. Karlus: «Mon meilleur ami. Il n’a pas essayé de refaire le monde avec moi, de se revolver lui-aussi. Il m’a seulement aimé.»,. Ibid., p. 44. 223 Ibid., p. 47. 224 Régis Fanchette, Fragment pour un théâtre. Pièce en un acte, Port-Louis, Imprimerie Esclapon, 1958. Riassunto p. 490. 222 298 posteriori all’unico dramma di Fanchette, la prova dello scrittore225 è certamente rappresentativa della fine dell’esperienza del teatro francese sull’isola. Già nel titolo, Fragments, sembra evocata l’impossibilità di una concezione ancora organica del mezzo e del testo teatrale, lascia intuire l’idea di uno spazio drammatico votato al silenzio. Il recupero e la critica dei temi del teatro classico (il conflitto amoroso, l’ideale eroico) si offrono, in aggiunta, come limite tra una tradizione autoreferenziale (quale poteva considerarsi il teatro mauriziano custode del modello francese) e una diversa cultura teatrale che andava maturando con la nuova generazione di scrittori di origine indiana. Il folklore mauriziano, palpabile nelle opere di Chazal e di André Masson, per l’esuberanza di un lessico che tradiva la complessità culturale di un mondo euro-afro-asiatico, nella rappresentazione della realtà storico-politica dell’isola, sembra abolito nel testo di Fanchette che, con molti predecessori e connazionali, condivide l’esperienza di un teatro epurato da ogni riferimento locale, neutro, nella misura in cui si fa l’interprete dei movimenti letterari, francesi ed europei, del secondo dopo-guerra. Il recupero del teatro classico che, nella Francia degli anni 30, aveva avuto uno dei maggiori rappresentati in Giraudoux, alimenta l’esperienza post-bellica del testo teatrale (teatro espressionista, psicodramma, teatro dell’assurdo) di Fanchette che, contro una poetica dello svuotamento dello spazio scenico, rielabora e riattualizza una concezione del teatro come luogo del conflitto delle passioni umane. Le paure, le allucinazioni, gli sdoppiamenti schizofrenici del teatro moderno, come metafora di un mondo interiore che invade e condiziona la scena e il mondo esterno, sono reinterpretati da Régis Fanchette alla luce della rivalità amorosa del dramma classico, in cui due personaggi principali, Jean e Henri, si contendono l’amore della casta Hélène; l’esperienza del nuovo linguaggio psicanalitico, della frantumazione del testo e della rappresentazione si sviluppa su un testo la cui struttura tradisce reminiscenze della tragedia classica. Le cinque scene in cui è diviso il dramma di Fanchette evocano i cinque atti della tragedia. Come il testo classico, le parti che costituiscono Fragments pour un théâtre seguono la logica del racconto: antefatto (nel primo atto Henri confida a Jean l’odio che da sempre nutre verso di lui); esposizione (nel secondo atto il confronto tra Henri e Hélène mette a nudo il motivo dell’odio); intrigo e crisi (nel terzo e quarto atto il contraddittorio tra i personaggi si inasprisce, la notizia della nascita del figlio di Jean sembra acuire l’odio dell’amico-nemico); soluzione (morte di uno dei contendenti). 225 Régis Fanchette è certamente più conosciuto come poeta e narratore che non come drammaturgo. Scrittore bilingue, ha equamente diviso la sua produzione tra una poesia prevalentemente pensata in lingua inglese, e una prosa in francese, incentrata sulla storia e la geografia dell’isola mauriziana. 299 L’odio e l’amore di cui si fanno interpreti i due personaggi tradisce riferimenti a un mondo lontano, cavalleresco, certamente promotore di sentimenti straordinari, assenti in un teatro, come quello moderno, che voleva essere la constatazione della perdita della coscienza individuale tout court: Henri: «Décidément tu deviens grotesque, Jean, ou est-ce l’inconscience qui t’aveugle à ce point? M’ayant demandé de jouer les martyrs, les apôtres au seuil de la Terre promise, tu veux, toi, maintenant jouer au mélodrame! (ironique et amer) Pourquoi pas un duel, après tout, où toi magnanime, tu ne tirerais pas, et où, une fois encore tu te réservera le beau rôle?»226 Il conflitto collettivo, che si consuma sul campo di battaglia di una campagna romana nel 1945, si riflette e si racconta a partire dall’antagonismo di due soli personaggi, Jean e Henri, modellati dall’autore sull’archetipo dell’eroe tragico227. I personaggi, così idealizzati da Fanchette, (la cui psicologia è stata semplificata a vantaggio della rappresentazione di un solo sentimento, l’odio228), si definiscono attraverso un’azione che si afferma come confronto e rievocazione del carattere dei protagonisti delle tragedie classiche. Il moltiplicarsi dei riferimenti all’Otello shakespeariano, all’intrigo amoroso che si consuma tra Iago, Otello e Desdemona, all’Iliade omerica (allorché il personaggio femminile di Fanchette porta il medesimo nome della donna che fu causa della guerra di Troia) rivela, di fatto, il tentativo dei personaggi di sublimare, di nobilitare una natura, altrimenti resa incerta e frammentata dalla crisi del mondo contemporaneo (post-bellico e post-coloniale): Henri: «[…] Ma haine, mesquine jusque-là, s’anoblissait du même coup; devant ce sacrilège, elle devint, en quelque sorte, sacerdotale.!»229 L’impossibilità di restituire un’immagine sensata della realtà (ora che il nesso logico tra causa ed effetto è stato smentito dalla conoscenza moderna), dà vita a una rappresentazione dominata dalla fatalità, dalla convinzione dell’ineluttabilità dei sentimenti e delle azioni attribuibili a dei personaggi esaltati da una volontà, mai agente e sempre sottomessa, come nella tragedia classica greca e del Seicento francese: 226 Régis Fachette, Fragments pour un théâtre, op. cit., p. 20. Jean: «[…] Iago épris de la blanche Desdémone […] le drame atroce de Iago. […] Iago le réfoulé sexuel, le défroqué de l’amour, eut mieux convaincu que cette force abstraite, que cette image désincarnée de mal qu’on en fait.», Ibid., p. 6. 228 «… À Raymond Chasle,/dont l’amitié, vigilante, a nourri/cette pièce sur la haine…», Ibid. 229 Ibid., pp. 7-8.. 227 300 Henri (tristement): «[…] D’ailleurs, cette tragique aventure nous dépasse tous les trois — elle s’est jouée il y a longtemps, très longtemps de cela, dans un passé bien lointain, où les âmes, plus que les corps, étaient désunies et promises à se donner des coups, à se déchirer.»230 Il linguaggio ascritto ai protagonisti, contraddistinto da un realismo ottocentesco che aveva bandito dalla sintassi le metafore barocche, sembra, tuttavia, tradire l’aspirazione al verso, la nostalgia delle figure retoriche che impreziosivano i testi raciniani: Henri: «Elle t’aima et je fus rejeté dans ma nuit. Je te jalousait avant, je te haïssait alors.» Henri: «Et je hais trop cette vie décrochée e son centre vital pour ne pas applaudir au succès de la vôtre, Hélène.»231 Allorché la tragedia classica era la messa in scena della violazione dell’interdetto sociale: la drammatizzazione della norma morale, in seguito al quale lo spazio teatrale veniva mutato, per mezzo del sacrificio, in luogo di purificazione e di riaffermazione della norma collettiva, il testo di Régis Fanchette è la manifestazione, la constatazione del dramma esistenziale, che vivono gli individui tormentati dalla perdita della cognizione di sé. La soppressione dell’antagonista, del singolo (identificato come l’artefice della crisi) che nel teatro classico esprimeva un’operazione morale, diventa la metafora dello smarrimento, dell’inquietudine individuale, di fronte a un’azione, fatale ma pur sempre accidentale, incapace ormai di identificare i personaggi del dramma, come positivi e negativi, come eroi destinati al sacrificio o eroi incarnazione della legalità: Henri: «[…] Car tu m’as tout volé, Jean, et tu le sais: la première place à l’école, le premier prix à la Sorbonne, ton premier livre couronné et que j’avais rêvé d’écrire. (avec un rire creux) Je te dois ma vie ratée, Jean.» più avanti Henri: «En la désagréable compagnie de moi-même, c’est-à-dire ni bonne, ni mauvaise, neutre comme tout ce qui vient de moi…»232 A partire dall’appropriazione dei personaggi classici, Jean e Henri rivelano il proprio disagio a collocarsi nello spazio come individui depositari di un destino esclusivo233, sul piano 230 Ibid., pp. 27-28. Ibid., p. 5, p. 9. 232 Ibid., pp. 3-4, p. 9. 231 301 dell’evoluzione dialettica (come processo che permette la manifestazione e l’affermazione degli opposti) i due antagonisti hanno difficoltà a considerarsi, l’un rispetto all’altro, come due individui autonomi: Jean: «Mais ne penses-tu pas que ton sentiment d’être l’éternel second rejoignait ton désir d’un un autre moi-même en quelque sorte, d’être mon alter ego. Je suis un peu ta création, Henri.» Henri: «[…] Tu as pris conscience de toi-même en prenant conscience de ma haine.»234 Facendo coesistere dei personaggi identici eppure perseguitati dall’immagine degli eroi shakespeariani, Otello e Iago, dei miti biblici Gesù e Giuda235, Fanchette mette in scena l’uno (come atto individuante nel momento in cui si assume la personalità del modello tragico) e il doppio che, il tradimento e l’odio nobilitavano i personaggi capaci di assumere la propria colpa e il proprio destino, Régis Fanchette mette in scena degli eroi impegnati nella difesa del proprio ruolo più per necessità di definire se stessi che in opposizione all’altro. Henri: «Sachez, Hélène, que je ne haïrais pas tellement Jean si je ne vous aimais à ce point.»236 Contrariamente all’odio di Iago, al tradimento di Giuda, l’azione e la passione che muovono i protagonisti di Fanchette non è pura, ma sempre dettata dall’assenza. Le dispute che si consumano tra i personaggi mettono in scena la mancanza fisica e psichica: l’assenza fisica di Hélène nelle scene in cui sono presenti Jean e Henri e, di Jean, tra Hélène e Henri; l’incompiutezza caratteriale dei personaggi, allorché i due protagonisti maschili sono costretti ad accettare l’altro come ideale completamento. La fragilità emotiva dei personaggi, indotta da una realtà complessa che smentisce la rappresentazione manichea degli esseri e del mondo, produce degli individui incapaci di riconoscere nella passione dominante l’elemento classificatore. Ora che la definizione del personaggio non è più legata alla qualità morale, l’odio e l’amore nutrono un individuo che affida all’altro la possibilità della sua rappresentazione: 233 Nel teatro classico, ma anche nel teatro naturalista i personaggi erano pensati come individui esemplari: «Un personnage de comédie classique porte un nom qui inique son défaut dominant [Harpagon] […]. Le héros du drame naturaliste est caractérisé par le fait qu’il a un nome t un prénom […] son prénom précise son identité, l’individualise […] il est déterminé par ses ancêtres et par son milieu […]. Au contraire, pour les expressionnistes […] il faut renoncer à cerner la conscience par une stratégie extérieure […].», Maurice Gravier, Le héros expressionniste, op. cit., p. 118. 234 Régis Fanchette, Fragments pour un théâtre, op. cit., pp. 4-5. 235 Jean: «Jamais je ne t’ai tant aimé qu’en cette heure suprême où tu me trahissais.»/Henri: «Oui, je sais bien; mais dans ta pièce, c’était le Christ qui parlai à Pierre — et nous ne jouons ici, ni l’un ni l’autre, le même rôle, Jean. […] Ne te gène pas. Je lui ressembles d’ailleurs, à Judas, comme un frère, et je ne m’en cache pas […]», Ibid., pp. 16-17. 236 Ibid., p. 29. 302 Jean: «Tu parles de haine, comme une marchande de quatre saisons, mais tu ignores tout de ce sentiment qui peut revêtir une certaine beauté, une certaine grandeur tragique quand elle est nue, froide, sincèrement revendicatrice. Polichinelle! Meurtrier à la manque! Tu ne veux pas m’abattre […] par l’effroi précisément d’aller jusqu’au bout de toi-même […]»237 Come i personaggi, il testo di Fanchette soffre della stessa mancanza di unità. Il doppio che incarnano Jean e Henri, si riflette nella moltiplicazione dello spazio e del tempo. L’alternanza delle scene pari e delle scene dispari è l’occasione per rappresentare i personaggi in luoghi e momenti diversi, Roma nel 1945, la casa di Hélène, nei diversi momenti della confessione e della partenza per il fronte. L’uso del flashback, per mezzo del quale le immagini hanno sostituito le parole (nel teatro tradizionale238) nella narrazione degli eventi passati, realizza e rappresenta la storicizzazione del sentimento. Di fronte a una realtà che è stata privata di senso, sulla quale non è più possibile esprimersi (fare atto di conoscenza), il racconto confessa l’impossibilità dell’analisi dello stato emotivo, riducendo la riflessione sui sentimenti a una constatazione. Come nel teatro epico, dove l’episodio narrato doveva fugare qualsiasi immedesimazione da parte dello spettatore, l’impossibilità della parola e il tentativo di riesumarne il ricordo (quasi attraverso un procedimento psicoterapeutico) messi in scena da Fanchette, agisce sullo spettatore estraniandolo dai luoghi comuni del linguaggio quotidiano239. Jean: «[…] comme le passé, les mots nous échappent, inéluctable, insaisissables...»240 Inserendo la storia di Jean e Henri sul racconto frantumato del dramma classico, privato dell’unità di tempo e di luogo, e sopraffatto da protagonisti che, dimentichi dell’onore antico, denunciano la loro bieca umanità senza valore, il testo di Régis Fanchette mette in scena il personaggio all’atto di interrogarsi sulla propria dimensione di eroe tragico/drammatico. Laddove nelle tragedie classiche l’azione eroica doveva celebrare e affermare la norma sociale, Fanchette assegna la qualifica di eroe a Henri il traditore, il personaggio negativo della pièce. Henri, l’eterno secondo, rigettato da una realtà che celebra il superomismo, contrariamente a Jean critica i valori comuni di un bellicismo che ha legalizzato l’odio, che ha sterilizzato i sentimenti (Jean) e la morte241 per fare dell’uomo uno strumento di lotta razziale: 237 Ibid., pp. 20-21. «La parola collegata all’immagine ha stracciato gli ultimi veli di un impalco tradizionale e proposto un teatrorappresentazione inserito nella storia.», Edoardo Bruno, Dialettica del teatro, Roma , Bulzoni, 1973, p. 118. 239 Henri: «Tu crois en cette soudure autogène, à la veille du combat? […] l’amour sacré de la patrie?...» Jean: «[…] Je crois quand même en une osmose, en la transcendance de l’antagonisme individuel en un.. » Henri: «…Antagonisme général […] la petite guerre des frères ennemis transposée en guerre officielle […].»,Régis Fanchette, Fragments pour un théâtre, op. cit., p. 2 240 Ibid., p. 24. 238 303 Henri: «[…] Quand il vous parle des Boches, on en voit le sang rouge sur leurs grosses pattes velues, et cela fait frémir. La guerre se résume, pour eux, à une ripaille, où le sang doit couler à flot comme du gros vin rouge. Quelle atroce et vulgaire vulgarité!»242 La morte del personaggio negativo, predestinato dalle tragedie antiche al sacrificio per il bene comune, impedisce nel testo di Fanchette che possa compiersi la soluzione del dramma, nel momento in cui Henri è sublimato in eroe dalla sua azione. Il rifiuto della realtà di Henri, in opposizione al compromesso di Jean, chiude il testo, che voleva essere la rappresentazione dell’esperienza della condizione umana come perenne stato di guerra, sulla sospensione di qualsiasi giudizio sul reale. La morte dell’eroe non aiuta quanti sono rimasti, a vivere meglio, la sua scomparsa non ha per la collettività un valore catartico né rifondatore. Il lungo e inquieto silenzio di quanti sono ancora in allerta per il profilarsi di una nuova alba di «tuéries inutiles»243 conclude il dramma della perdita del linguaggio, della parola come strumento fondante la realtà. L’evocazione del passato nella messa in scena di uno psicodramma a tre, si rivela, di fatto, fallimentare allorché i personaggi non riescono a identificare e a superare le proprie posizioni. Il dramma moderno di un individuo costretto a trascinarsi in una vita di cui non accetta più i compromessi morali, si preannuncia l’eco del conflitto locale, proponendosi come metafora della condizione di stallo in cui versa la società mauriziana post-bellica e già all’alba della propria indipendenza: Jean: «[…] C’est nous Boisguillaume, nous qui ne voyons plus où finit la nuit, et cependant, Boisguillaume, il nous faut, nous, continuer à vivre, en attendant l’aube.»244 241 Jean: «Tu sais, de nous deux je crois que c’est toi qui l’as [Hélène] le mieux aimée; je commence à comprendre l’amour encore plus que la haine, de voir Hélène ainsi reflétée dans tes yeux.», Ibid. Jean: «Et cependant ils ont fait de la guerre une chose, mettons plus hygiénique […] mystique humanitaire, notre humanisme bourgeois qui sent la naphtaline, la bombe au napalm.», Ibid., p. 23. 242 Ibid., p. 22. 243 Ibid. p. 1. 244 Ibid., p. 34. 304 Teatro e Società Jean-Norbert Augustin, René Noyau, Dayachand Napal Teatro politico Dev Virahsawmy, Azize Asgarally Il conseguimento dell’indipendenza nel 1968 si offriva agli intellettuali dell’isola come l’opportunità di avviare un processo e una riforma culturale e linguistica, in seno alla produzione artistica, che incoraggiasse la promozione dell’identità mauriziana, contro le divisioni etniche che avevano caratterizzano la realtà insulare dalla sua conquista e, successivamente, negli anni dell’insediamento inglese (1810) e indiano dopo il 1830. La storia del teatro mauriziano messa a punto da Chelin (1954), più recentemente da Decotter (1993), mostra, di fatto, come l’attività drammatica mauriziana si sia sempre palesata come il fenomeno dissociato di due realtà distinte: quella franco-creola e quella inglese, il cui riconoscimento sociale e giuridico era formalizzato dalla costituzione di diverse associazioni teatrali (per lo più amatoriali)245 volte alla diffusione dell’opera e della cultura teatrale dell’una o dell’altra comunità mauriziana. La divisione tra una produzione francofona rappresentata e rappresentante dell’etnia francocreola (degli eredi dei primi Francesi stanziatisi sull’isola e dei discendenti delle unioni miste tra Bianchi e Neri246) e l’esperienza teatrale inglese e anglofona, che, dagli anni 50247 registrava la presenza sempre maggiore degli scrittori indiani, sembra definitivamente superata alla fine degli anni 60. La costituzione nel 1966 dell’OCORA (Concours Théatral Africain et Malgache) e nel 1968 dell’A.C.O.I. (Alliance Culturelle de l’Océan Indien), sanciva la volontà degli scrittori delle excolonie di perseguire un’attività artistica che recuperasse e rifondasse l’identità culturale dei popoli africani e dell’Oceano Indiano a partire da una specificità artistica distinta dal mondo occidentale, 245 La ricostruzione della vicenda teatrale mauriziana dei due storici sembra attribuire dei significati politici all’attività teatrale mauriziana nella misura in cui la costituzione delle prime società drammatiche francesi o inglesi sembra doversi leggere come un primato culturale e politico delle due comunità antagoniste dell’isola. Mentre Decotter ascrive agli Inglesi la fondazione del primo club teatrale nel 1931, avanzando l’ipotesi che la costituzione del club francese fosse di molto posteriore, 1966, e una conseguenza del primo, Chelin rinviene, invece, le tracce delle prime società francesi già agli inizi del 1800, posticipando al 1823 la data di inizio dell’attività inglese sull’isola (considerata dallo storico, comunque, sotterranea e trascurabile rispetto a quella francese). 246 Quando, nel 1829, i mulatti accedono agli stessi diritti riservati ai Bianchi, l’effetto che si produce, in letteratura, è quello di un tentativo di emulazione dei modelli letterari francesi come prova e come riconoscimento della loro appartenenza al mondo culturale dei Bianchi. Contrariamente ai mulatti, invece, gli scrittori indiani si fanno promotori della cultura e della letteratura inglese. Robert Furlong, La littérature mauricienne existe-t-elle?, «Notre Librairie» n. 54-55, juillet-octobre 1980, pp. 73-81. 247 Nel 1950 nasce il primo Festival de Dramaturgie mauriziano di lingua inglese. 305 soprattutto, affrancata dai modelli francesi o inglesi che avevano dominato la produzione del continente africano e delle isole fino alla seconda metà del Novecento. A Maurice dove la corrente communalista esacerbava la spinta centrifuga e separatista della società multirazziale dell’isola, l’apertura degli scrittori indiani e cinesi dal 1970 alla produzione francese rifletteva il tentativo, timidamente sostenuto dal governo (che favoriva una politica di integrazione al contesto economico africano per scongiurare il pericolo di una sottomissione dell’isola al sistema filoamericano o filosovietico), di adesione a un movimento anzitutto culturale di identificazione e di costruzione identitaria (quale identità Mauriziana alla fine dell’impero coloniale britannico?) per le nuove nazioni africane. Quando nel 1972 il concorso teatrale fu allargato anche all’isola anglo-francese, la lunga e sperimentata tradizione teatrale di Maurice si univa a un’attività drammatica africana piuttosto recente (primi anni 60), il cui confronto con il modello occidentale e la realtà culturale e sociopolitica dei nuovi paesi indipendenti aveva favorito l’insorgere di una produzione locale certamente originale. Gli scrittori mauriziani si inserivano in un processo di analisi e critica dei sistemi politici e dei governi indigeni che, pur riferendosi specificamente al contesto africano, quindi allo scontento maturato a dieci anni dall’indipendenza verso una politica che aveva tradito le aspettative della rinascita africana, nondimeno poteva rappresentare la neonata repubblica mauriziana nelle sue connivenze con l’oligarchia imprenditoriale, con una politica economica e sociale non sempre a favore della crescita e dello sviluppo dell’intera nazione. Se la partecipazione massiccia dei Mauriziani al concorso non soddisfaceva sempre i requisiti di originalità dei testi presentati248, le opere mostravano, tuttavia, una continuità con l’attività teatrale precedente, soprattutto con la poetica di quegli autori che avevano unito la sperimentazione del linguaggio drammatico alla condanna sociale. Il forte simbolismo dei testi di André Masson permane nei lavori di Noyau, l’ironia paradossale e una certa facoltà visionaria di Chazal o di Hart si può ritrovare in Augustin e Dayachand. Pur attenta alla realtà sociale, il limite incontestabile di una tale produzione teatrale era la mancanza assoluta di una coscienza sociale, nella misura in cui, rispetto all’esempio africano che si proponeva come strumento di lotta e di formazione delle identità politiche, queste prime tracce di letteratura mauriziana sembravano riproporre una concezione elitaria dell’attività drammatica: nell’uso della lingua francese parlata dalla maggioranza ma conosciuta da una minoranza (di quanti 248 Nel suo studio sui testi proposti al concorso tra il 1968 e il 1973, Ganaba Abdoulaye giudica le opere mauriziane poco rappresentative rispetto a quelle africane, dacchè, secondo il ricercatore, i drammaturghi dell’isola dimostrano ancora di conformarsi ai modelli teatrali del seicento francese. Ganabe Abdoulaye, Analyse thématique et sociologique du Concours Théâtral de 1968 à 1973, op. cit., p. 239. 306 avevano avuto accesso alla scolarizzazione), l’elaborazione di una poetica (ispirata alla sperimentazione espressionista), certamente colta e non accessibile da tutta la popolazione. Di fronte alla ripresa di una produzione letteraria (soprattutto teatrale) in lingua francese, giudicata certamente anacronistica nell’isola mauriziana indipendente (al cui governo risiedevano i rappresentanti della comunità indiana), negli anni 70 si registra il nuovo, inedito fenomeno della letteratura creola. Nonostante la lingua creola non fosse ancora stata codificata, e a tutt’oggi non siano stati identificati dei segni diacritici per la sua trascrizione dall’orale, sebbene il creolo non riscuotesse grandi favori da parte dei frequentatori di teatro, la rinascita del teatro mauriziano è stata ascritta proprio al linguaggio e all’immaginario creolo, di fatto, l’unica lingua uniformemente diffusa sul territorio mauriziano. Contro un teatro in francese, candidato dei concorsi africani (indetti, per lo più, da organi e istituzioni francesi249), Azize Asgarally, Dev Virahasawmy, Etienne Favory si sono fatti promotori di un teatro rigorosamente mauriziano che attingesse alla tradizione culturale, linguistica e storica dell’isola, nella misura in cui il creolo testimoniava del processo storico (dalla schiavitù al sistema di reclutamento dei lavoratori indiani) che aveva portato alla produzione di una società multiculturale e multietnica sul territorio. Il teatro letterario veniva sostituito da un’esperienza teatrale documentarista e democratica: da un teatro del popolo per il popolo250, che si poneva l’obiettivo di istruire sulla storia collettiva e sulla realtà presente, di formare una coscienza sociale e politica. A fronte di una riflessione e di una sperimentazione sempre più feconda sul teatro e sul mezzo teatrale dei drammaturghi africani di nuova generazione (pensiamo a Koffi Kwahulé, Kossi Efoui), il teatro creolo si distingue per la priorità del fine comunicativo. La scelta della lingua e dello stile sono indicativi di un progetto culturale non motivato da rivendicazioni etniche (nessuna etnia in particolare, ma lo spirito di tutte le comunità mauriziane insieme), ma da un principio di lotta politica che si identifica nell’interprete del creolo: l’operaio, l’agricoltore, la classe meno abbiente e culturalmente meno avanzata. 249 «Le concours oriente la production des textes en créant de façon consciente ou inconsciente une batterie de thèmes de prédilection […]», Rogo Koffi Fiangor, Le Théâtre africain francophone, op. cit., p. 45. 250 Ayayi G. Apedo-Amah nel sintetizzare della poetica di Augusto Boal individua tre tipologie di teatro: quella del popolo per il popolo, quella del popolo per un destinatario diverso dal popolo, il teatro che racconta di una realtà diversa da quella popolae per informare il popolo, Ayayi G. Apedo-Amah, L’histoire comme source d’inspiration du théâtre populaire négro-africain, op. cit., pp. 91-92. La funzione educativa del teatro, concretizzatasi a Maurice con l’uso del creolo, si innesca, secondo Roshmi Mooneeram, in quel processo di democratizzazione della cultura promosso dai drammaturghi del XX secolo: «The move away from a theatre relevant exclusively to an English and/or French-speaking elite to theatre in Creole, and the valorizing of previously ignored local material entails a significant ‘democratisation of culture’.», Roshmi Mooneeram, Theatre in development in Mauritius. From a theatre of protest to a theatre of cultural miscegenation, in African Theatre in Development, ed. Martin Banham, James Gibbs, Femi Osofisan, Oxford, James Currey, 1999, p. 26. 307 Contro un teatro sempre più vicino alla poetica brechtiana dell’estraniazione251, Dev Virahsawmy riattualizza l’immedesimazione, che, coinvolgendo emotivamente il pubblico, facilita la partecipazione all’evento narrato, quindi l’illustrazione delle dinamiche sociali all’interno delle quali si muove lo stesso spettatore di teatro, dal momento che, come dice Bernard Dort, nel teatro naturalista il testo preesiste all’azione teatrale, il mondo vi è già codificato in precedenza: «Dans le théâtre naturaliste le sens du texte précède la représentation, il préexiste à l’action, le monde y est codifié et accepté à l’avance.»252 Il confronto con la politica locale e l’analisi del sistema economico e sociale messa a punto da Dev Virahswmy e da Azize Asarally respinge le ambientazioni astratte e le teorie troppo articolate degli autori contemporanei (Michèle Rakotoson, Jean-Luc Raharimanana) per attenersi agli esempi della realtà quotidiana. Rivendicano una funzione civica dell’attività drammatica, gli scrittori mauriziani reinterpretano lo spazio teatrale come luogo deputato all’analisi e alla denuncia della sperequazione, la descrizione realista della quale permette la presa di coscienza, da parte dello spettatore, della necessità della lotta sociale, nella misura in cui la scena è consacrata all’uomo comune posto di fronte alla scelta etica prima che all’eroe (in Li di Dev Virahsawmy l’eroe rivoluzionario è sempre nominato ma, in realtà, non è mai presente fisicamente sulla scena): «Pour Virahsawmy, Asgarally et Favory écrire en créole s’insère dans une politique de lutte de classe exploitée par la bourgeoisie.»253 Il principio educativo rivendicato dai tre autori mauriziani ha portato Favory, come abbiamo già detto nell’introduzione alla sezione, ad abdicare il testo teatrale, l’elaborazione scritta, per la sola manifestazione orale254 del teatro (come recupero della tradizione del racconto declamato in lingua creola). L’impegno sociale assunto da tale generazione di scrittori (alcuni dei quali, come Dev Virahsawmy, sono stati degli attivisti politici, dei rappresentati sindacali e dei partiti rivoluzionari, incarcerati per la loro azione sovversiva) ha fatto sì che la scelta del francese rimanesse un’esperienza accidentale. Contrariamente agli scrittori africani e malgasci per i quali il francese resta la lingua d’elezione, offrendosi come ponte per il mercato occidentale (ne è una testimonianza 251 «[…] l’épique nie “l’imitation” et nie “l’illusion”. Historique par définition, il expose des faits qui se présentent comme passés (alors que le théâtre aristotélicien vise à faire croire la contemporanéité de l’action.», Alain Couprie, Le Théâtre, op. cit., p. 56. 252 Bernard Dort, Le lieu de la représentation épique, «Travail théâtral» n. 27, 1977, p. 37. 253 Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expression créole. Essai d’analyse socio-culturelle, op. cit., p. 19. 254 «La production de la littérature en créole est fortement marquée par la présence du théâtre et de la poésie. Ils perpétuent une tradition orale, celle du conte populaire.», Ibid., p. 20. 308 il rinnovarsi dei concorsi africani promossi dalle istituzioni francesi), Dev Virahsawmy e Azize Asgarallly rivendicano l’autonomia della drammaturgia creola dalla letteratura teatrale europea, difendendo l’originalità di un fenomeno locale, che si propone allo spettatore come esperienza di coesione e di costruzione identitaria: «Li s’insère dans cette tradition de théâtre de contestation […] dénonce le communalisme, s’élève contre l’exploitation de l’homme, […] condamne l’individualisme […].»255 L’opera Li scritta da Dev Virahsawmy nel 1972 è stata pubblicata trilingue solo nel 1979 e ha partecipato al Concorso di R.F.I. solo nel 1981. Di questi scrittori rimane numericamente superiore la produzione in creolo rispetto a quella francese, sempre successiva, mai precedente, al testo in creolo mauriziano. Il teatro rivoluzionario tra pessimismo e censura. Jean-Norbert Augustin e René Noyau Nonostante la consistente adesione di scrittori della neoindipendente isola delle Mauritius al Concorso Interafricano nei primi anni 70 (ricordiamo che Ganaba Abdoulaye ne ha censiti più di ottanta contro la metà dei Malgasci), non restano tracce significative della partecipazione dei Mauriziani alle prove di preselezione e selezione. Se la scarsa originalità dei testi ha contribuito alla loro perdita, nondimeno il ricercatore Ganaba lascia intendere che il poco interessamento della giuria verso le prove teatrali dei Mauriziani potesse essere la conseguenza della maggiore sollecitudine riservata ai testi africani, per i quali la competizione era stata esplicitamente istituita256. I soli due testi, che è possibile consultare, sono le opere di preselezione di Jean-Norbert Augustin, Le syndicat des gens non-nés257, e di René Noyau, La race d’Abel258, di cui sono conservati i manoscritti originali nella Biblioteca Universitaria Baston-Baty, fondo Jacques Scherer, di Paris III. 255 Dev Virahsawmy, Li, Port-Louis, Les chemins de la liberté, 1979. «[…] un certain nombre de Mauriciens se seraient découragés estimant avoir peu de chance dans un concours particulièrement africain.», Ganaba Abdoulaye, Analyse thématique et sociologique du Concours théâtral de 1967 à 1973, op. cit., p. 59. 257 Jean-Norbert Augustin, Le syndicat des gens non-nés, Concours Théâtre Interafricain, D.A.E.C. coop., 1973 (présélection). Riassunto p. 495. 258 René Noyau, La race d’Abel, Concours Interafricain, D.A.E.C. coop. 1973 (présélection). Riassunto p. 495. 256 309 La difficoltà di ricostruire la poetica e la storia del pensiero dei due scrittori mauriziani è, certamente, dovuto alla mancanza di documenti (precedenti o posteriori al concorso) che forniscano maggiori elementi sull’attività artistica dei due autori, di cui le opere su indicate restano l’unico contributo, une bouteille à la mer. Candidati al concorso nel medesimo anno (1973), i due testi prendono in esame lo stesso soggetto, si confrontano con un tema particolarmente attuale negli anni successivi all’indipendenza: la rivolta della società contro il sistema dittatoriale e corrotto, avvalendosi di strumenti retorici e di una concezione del teatro simili, che tradiscono una competenza già formata e ispirata all’esperienza teatrale europea, anche mauriziana, della seconda metà del Novecento. Se la critica al sistema e la satira del mondo politico era un argomento diffuso nella produzione letteraria africana degli anni 70 (soprattutto nel teatro), la celebrazione della lotta sociale a teatro assumeva un’accezione tutt’altro che retorica e teorica a Maurice, dal momento che, l’isola, da pochi anni repubblica indipendente, era reduce da una delle rivolte sindacali più imponenti (1971), a seguito della quale si era proceduto all’arresto di numerosi esponenti del partito di militanza mauriziana (M.M.M., tra i quali figurava Dev Virahsawmy), e all’adozione di sistemi repressivi come la censura e l’inasprimento del controllo militare. Augustin e Noyau raccontano della vicenda mauriziana, e in senso più generale della rivolta dell’uomo contro le ingiustizie e l’oppressione, offrendo prospettive e soluzioni al problema solo apparentemente simili. La necessità di scongiurare le ritorsioni di un sistema, come abbiamo detto, ove era stata ripristinata la censura, ha sollecitato un approccio alla storia locale prettamente metaforico. Entrambi gli scrittori scelgono di restituire una rappresentazione simbolica della realtà nella misura in cui la riduzione a simbolo degli eventi (una simbologia per ovvi motivi condivisa dal pubblico) offre la possibilità di raccontare la realtà, approfondendo l’analisi del fenomeno nella misura in cui il linguaggio metaforico e la struttura narrativa e performativa, che i due scrittori hanno voluto svincolata dal contesto reale, aggiungono al significato immediato (rivolta e repressione) una rosa di suggestioni che aprono nuove chiavi di lettura. La consonanza dei temi e di una certa tecnica narrativa non si accorda alla tesi finale dei testi, profondamente pessimista in Augustin aperta alla possibilità di un riscatto finale dei popoli oppressi in Noyau: 310 Europe: «[…] Je crois que le moment est propice “Indépendance totale, immédiate, inconditionnelle”. C’est lorsque un peuple est seul, quasi-abandonné, qu’il entre dans l’indépendance […]. Elle ne s’acquiert que par les armes […].»259 Per raccontare della nascita e della morte del movimento sindacale, Augustin sceglie la forma del paradosso. Ambientando la storia della lotta in uno spazio indefinito e improbabile, il giardino dei non-nati, il drammaturgo sottrae la descrizione degli eventi da qualsiasi connotazione reale, pur rimanendo i riferimenti ai fatti di cronaca significativi e molteplici. L’analogia tra i rapporti familiari e le relazioni lavorative (la maternità, come il mercato del lavoro, risponde al principio della domanda e dell’offerta) offre l’occasione per denunciare, tra metafore e sottintesi, il sistema politico che non tutela i lavoratori ma solo i potenti. Partendo dall’assunto che la società è un organismo profondamente iniquo, il drammaturgo narra la vicenda di una comunità, oltremodo numerosa, tuttavia considerata inferiore, che, dopo aver preso coscienza del suo potere, lotta per l’affermazione dei propri diritti dovendo alla fine riconoscere la vanità della lotta di fronte a un sistema che difende i poteri costituiti contro qualsiasi aggressione esterna. Il testo descrive la parabola di un movimento sindacale, dalla sua ideazione: Albert: «C’est la révolution qu’il faut […] la solidarité […]. […] n’accepterons de naître que si notre naissance doit s’opérer dans des conditions décentes […].»260 alla sua costituzione giuridica, con relativo codice normativo: Albert: «Premièrement, qu’elles soient dûment mariées/Deuxièment, qu’elles aient atteint une certaine maturité morale, physique, psychique et psychologique./ […] Septièment, qu’elles soient d’un teint reconnu — voire révéré par la société. À la rigueur ce teint devra être un teint admis, toléré par la société.» Suzanne Cœur-de-Vache: «Mais Albert, c’est insensé ce que tu dis là!»261 dalla lotta pacifica: Albert: «La grève, […] pour imposer, pour définir pour parvenir à une démocratie dirigée.»262 alla repressione, quindi allo scioglimento263. 259 Ibid., p. 29. Jean-Norbert Augustin, Le syndicat des gens non-nés, op. cit., pp. 18-19. 261 Ibid., p. 27. 262 Ibid., p. 45. 263 Ibid., pp. 62-68. 260 311 Fuori dal paradosso è chiara l’allusione ai personaggi del mondo reale, evidente l’uso di una metafora che riferisce di un giudizio anzitutto morale portato dall’autore sulla vicenda politica e storica. Gli sfruttati di tutti i tempi: i lavoratori sottopagati, i lavoratori in nero, gli operai sfruttati come gli schiavi di un tempo, sono dei non-nati come coloro che non esistono ancora, degli esseri ideali cui non viene riconosciuta alcuna forma giuridica: Albert: «Ce syndicat aura pour tâche de revendiquer des gens non-nés, afin que notre dignité soit établie, reconnue et respectée […].»264 Privati dei loro diritti, i lavoratori, «gens non-nés», che la Storia ha voluto fossero identificati con la gente di colore, si oppongono a un sistema governato dai Bianchi da cui, di fatto, le minoranze sono state escluse (una critica alla politica del neoeletto presidente Ramgoolam che, pur rappresentando una coalizione di sinistra, si era mostrato connivente con l’oligarchia terriera e capitalista costituita, per la maggioranza, dai Bianchi creoli-francofoni): Albert: «Pas une seule maman noire, pas une seule maman rouge, pas une seule maman jaune.»265 L’immagine dei non-nati, esseri esterni alla società che riflettono sui suoi meccanismi, offre l’occasione per analizzare le forze di potere all’interno della collettività, quindi individuare i principi che reggono gli equilibri politici. In un mondo retto dal denaro, la discriminazione razziale è mutata in contrasto tra gruppi sociali, la lotta razziale in lotta di classe, a cui aderiscono, idealmente e metaforicamente, anche i non-nati come individui che rivendicano il riconoscimento del loro stato di diritto da parte della società: Albert: «[…] l’argent, que je sache, a de tout temps été l’exclusivité des Blancs […]» Philibert Dumollet: «Mais les choses ont commencé à changer maintenant.» Albert: «C’est vrai, mon cher, mais […] l’argent agit comme […] décolorant sur ces gens de couleur et leur fait oublier qu’ils sont essentiellement gens de couleur. […] ça devient une question de classe […].»266 Accanto al soggetto principale, per una maggiore contestualizzazione del fenomeno sociale mauriziano, Augustin accenna alla realtà lavorativa dell’isola dove le aspettative di vita sempre minori hanno incoraggiato l’immigrazione verso paesi più ricchi come la Francia o l’Inghilterra: 264 Ibid., p. 19. Ibid., p. 36. 266 Ibid., pp. 45-46. 265 312 Raymond Salambo: «[…] à quoi bon m’envoyer dans un pays où tout le monde cherche à s’en aller? […] Moi, je trouve qu’il vaut mieux que je parte maintenant même. Envoyez-moi en France, en Angleterre […]. Comme ça, je serais déjà parti — j’aurais déjà émigré.»267 La difficoltà economica dell’isola viene unita alla perdita di moralità della popolazione, causa implicita del venir meno del senso sociale, ora che le persone sono trattate come cose: Albert: «Vous savez, mes amis, comment tout cela se fait? N’importe qui, n’importe quoi — ayant pour seule qualification une petite chose de féminité — va au guichet, se fait remettre un formulaire, le remplit […]. Ces aspirantes mères on les prend comme ça sans imposer des normes, sans fixer des conditions. […] Riches ou pauvres […] et pour comble, voilà que les médecins et les gouvernements sont contre nous!»268 La scelta del suicidio non emerge dal testo come un’affermazione, piuttosto vuole essere una domanda aperta, certamente carica di pessimismo, a una società corrotta che non è stata capace di ascoltare: Albert: «Foutue révolution […] Gandhi — Jésus…John F. Kennedy…Martin Luther King…Ils ont tous essayé […] de remonter le courant. […] Pourrais-je faire exception à la règle?»269 Sfiducia nei confronti della lotta per l’emancipazione civile che René Noyau, invece, non sembra condividere, nel momento in cui ammette la necessità e l’ineluttabilità delle morte e della repressione in un sistema che combatte il progresso democratico: Europe: «Je voue ma vie en échange de la lutte sans relâche de mon peuple, à travers l’union des peuples opprimés […].»270 Se Augustin sposta, sin dall’inizio, il suo racconto su un piano metaforico, René Noyau interseca i due piani, quello dell’esperienza e quello dei simboli, facendo agire nel mondo reale (un atelier dismesso usato come covo dei ribelli e il teatro Plazza) dei personaggi, della cui umanità non è rimasto che il colore della pelle, e anche quello è usato dal drammaturgo come simbolo di una natura ideale che i protagonisti della pièce incarnano. Come nel teatro espressionista i personaggi non sono altro che il loro nome, e la perdita del nome (pensiamo ai personaggi kafkiani di cui non resta che l’iniziale K.) sancisce il venir meno dell’eroe del romanzo, così Noyau fa agire sulla scena dei personaggi vestiti solo del loro nome, 267 Ibid., p. 10. Ibid., p. 16. 269 Ibid., p. 77. 270 René Noyau, La race d’Abel, op. cit., p. 57. 268 313 nella misura in cui questo permette di elevare la condizione esistenziale individuale all’intera collettività. Sulla scena si alternano personaggi biblici dell’Antico Testamento come Abele, Eva, e Caino, martiri della cristianità come Paolo, immagini idealizzate dall’iconografia tradizionale come Europa (una donna bianca, forte e depositaria della giustizia), a cui si contrappone il fratello omonimo, doppiogiochista e nemico della legalità. Sovvertendo il luogo comune, per cui la razza dei diseredati (identificati con la popolazione nera) era associata a Caino, Noyau reinterpeta il mito di Abele e Caino alla luce di una concezione manichea della società, in cui lo sfruttamento perpetrato da pochi (Caino crudele e autoritario), è all’origine delle rivendicazioni di quanti sono considerati giuridicamente più deboli (Abele, il giustio ucciso dal fratello). Eva, con la quale si apre il dramma, introduce lo spettatore al racconto dell’ingiustizia umana, reale e contingente, che i corsi e ricorsi storici hanno mutato in condizione metafisica. Eva, il principio della stirpe umana, madre di Caino e Abele, come un griot narra l’inizio: l’inizio della Storia che è l’inizio e la spiegazione della struttura sociale attuale: Eve: «[…] Il faut savoir qu’Abel et Bella furent les premiers nés sur la terre […] puis vint Caïn séduisant mais autoritaire. Ensuite Donna, bavarde et capricieuse. Et Europe […] rusé et persuasif.»271 La natura ideale dei personaggi, il cui carattere è, come nei drammi medievali e in Molière, sintetizzato nel nome, scelto per i riferimenti morali che in esso si colgono (Misantropo, Caino), si rivela problematica di fronte a una realtà che non accetta più, come nel medioevo e nel 600, l’univocità della conoscenza: Paul: «[…] Cependant je dis que la race de Caïn est celle des tyrans […]. Elle [la race d’Abel] a fini par croire qu’elle est vraiment la race prédestinée des mendiants et des esclaves […].»272 L’unità del personaggio viene ora smentita dal proliferare dei nomi che denotano uno stesso individuo, la complessità della psiche che i realisti avevano tentato di rappresentare per mezzo di un personaggio contraddittorio, pur negata da personaggi monolitici, si ritrova nella moltiplicazione e nell’attribuzione dello stesso nome a personaggi diversi. Pur indicando e definendo il personaggio nella sua essenza, il nome rimane sfuggente, non totalmente confinato al personaggio che indica (oltre ciò che denota). Così, Abel è identificato con 271 272 Ibid., p. 6. Europe al maschile è il fratello di Europe compagna di Abel. Ibid., p. 14. 314 un certo René273 che tutti chiamano anche Mister Black; Europe è nominata indifferentemente Nancy o France (restringendo il continente europeo alle sole due potenze, inglese e francese, che hanno avuto un ruolo importante per l’isola mauriziana); il presidente Caino ha usurpato il nome di Abel, per ottenere consensi da parte della popolazione sfruttata: Paul: «Depuis Constantin et les Barbares, la tactique de l’oppresseur […] a toujours été de SERVIR les esclaves pour rétablir l’esclavage. L’esclavage change de nom mais l’esclavage demeure.»274 L’attribuzione a uno stesso personaggio di una molteplicità di nomi (allo stesso modo di Abel, conosciuto anche come René o M. Black) è evocativa del periodo della schiavitù, quando gli schiavi, la razza di Abele, venivano privati del loro nome d’origine per essere battezzati con un nuovo nome che li identificava e riduceva a proprietà dell’uomo bianco. «C’est interessant, cette multipication des noms…»275, M. Black, René sono alcuni dei tanti nomi attribuiti di volta in volta dai coloni inglesi o dai Francesi agli sfruttati di tutte le razze e di tutti tempi. Potremmo, quindi, rafforzare la tesi di Noyau, secondo cui la schiavitù cambia nome, ma non il sistema di sfruttamento, «L’esclavage change de nom mais l’esclavage demeure.276», affermando che la schiavitù permane proprio perché negli anni ha sostituito il nome: “l’esclavage demeure en changeant de nom.” Persecutore dei diritti umani, usurpatore del nome, Caino è il simbolo degli autocrati, che, nel tempo, hanno cambiato il volto (dai coloni agli industriali, ai presidenti e politici di turno), ma non la sostanza della loro azione volta al controllo e alla repressione dell’iniziativa privata: Speaker: «Attention! Attention! L’ancien pouvoir est tombé. Au micro, LA VOIX DU PEUPLE. Caïn s’était fait passer pour Abel, Caïn n’est plus […] Un gouvernement démocratique populaire est au pouvoir.»277 La scelta di servire i poveri per mantenere lo stato di schiavitù, o come avrebbe detto il Conte Salina del Gattopardo, cambiare tutto perché nulla cambi, racconta di una realtà che è la stessa pur apparendo diversa. Fedele alla storia eternamente uguale a se stessa, per mezzo del nome, Noyau mette in scena il doppio: Europe donna, personaggio positivo, sostenitrice di Abel, e Europe uomo, 273 Certamente non casuale la scelta del nome René come il drammaturgo, come se lo scrittore volesse sottolineare, rivendicandola come proprio, il credo di una rivolta totale. 274 René Noyau, La race d’Abel, op. cit., p. 15. 275 Ibid., p. 9 276 Ibid., p. 15. 277 Ibid., p. 49. 315 «rusé et persuasifs»278, servo della politica e dell’utile, Abel rivoluzionario, Abel popolo e Abel dittatore. Il gioco del doppio viene esasperato con il ricorso all’artificio del teatro nel teatro. La tecnica già ampiamente sfruttata per fini drammatici al tempo di Shakespeare (Hamlet), diventa quasi una rivelazione narrativa per il teatro della prima metà del Novecento (Pirandello), allorché la realtà, con le sue convenzioni, le sue finte verità, con le diverse prospettive sembra potersi raccontare solo come altra da sé, come l’immagine riflessa su uno specchio: Abel: «[…] faire le théâtre. Ils en auront le droit et la liberté.»279 Noyau riserva al teatro non la funzione descrittiva, come in Shakespeare, o analitica di Pirandello, piuttosto, avanza l’idea di un teatro sociale che istruisca la comunità come attraverso un procedimento psicanalitico. La scelta di una rappresentazione, come il living theatre, che coinvolge lo spettatore senza che questo ne abbia piena coscienza280 si riassume, nel testo, nella messinscena di uno psicodramma collettivo, atto a esorcizzare la popolazione dalle paure, liberare la collettività dall’influenza nefasta degli organi preposti al controllo e alla repressione: Paul:«Des fonctionnaires, des soldats, des salariés de l’agression culturelle sous couvert de théâtre.»281 Di fronte alla simulazione dei mali della società (censura, persecuzione) e del delirio collettivo che precede l’atto purificatore (il pubblico adunato nel teatro Plazza si cosparge delle ceneri del defunto Abel), lo stratagemma adottato dal drammaturgo si inserisce nella tradizione teatrale più recente che riconosce nella narrazione e non nella rappresentazione la possibilità della conoscenza reale degli eventi, quindi dell’azione sul reale. Solo il comportamento insensato di personaggi che attraversano la scena declamando massime dell’uomo e della storia, l’uso di un teatro-propaganda (di uno spazio che come nell’agit-prop diventa un’aula di tribunale dove giudicare i colpevoli dei crimini conto l’umanità) può liberare il messaggio rivoluzionario che deve essere raccolto dal pubblico. 278 Ibid., p. 6. Più avanti: Europe: «[je suis] l’homme du milieu […] je regarde ma position par rapport au ballon […]», Ibid., p. 53. 279 Ibid., p. 32. 280 Da pagina 38 a pagina 47, lo spettatore assiste alla messa in scena di un spettacolo living, dove attori che recitano la parte del pubblico vengono coinvolti nella rappresentazione di un dramma, l’arresto di Paul accusato di omicidio dal poliziotto con cui sta parlando, che prelude alla morte di Abel, ucciso da Europe, e di Caïn. La scena delirante che si consuma tra Paul e il sergente offre l’occasione per rappresentare e denunciare lo stato di oppressione esercitato dagli organi militari e dall’informazione, allorché i due accendono la radio per avere notizie sull’omicida (nonostante Paul sia l’accusato) e chi sia la vittima (dal momento che l’esistenza di un morto è solamente presunta). 281 Ibid., p. 43. 316 Diversamente dal teatro tradizionale dove lo spettatore si identificava al personaggio, all’eroe, nel testo di Noyau solo agli spettatori di carta, quelli del testo radunati al Plazza, è dato di riconoscersi (non più immedesimarsi) in Abel282. Allo spettatore reale, testimone di una doppia rappresentazione, è lasciata la morale finale del testo, che, contro l’inconsistenza dei personaggi, l’alterna fortuna degli attori, resta una verità inviolabile: Paul: «Nous ne sommes pas des hommes des îles. Nous sommes de la race des opprimés […]. Je dirai aussi, nous sommes les fils de l’Afrique. Nous avons aujourd’hui renversé le mur de la faim […]. Nous vivons de nos propres ressources […].»283 Nemesi storica e rivoluzione, Napal Dayachand. Nel corso dell’analisi dei testi e degli autori di teatro mauriziano, è stata rilevata l’assenza di opere dedicate alla storia locale. Diversamente dal romanzo e dalla poesia in cui gli scrittori si sono confrontati con episodi tristi e controversi della società mauriziana come il problema razziale, gli anni dello schiavismo, gli abusi, le persecuzioni e la sottomissione economica e culturale subite dalla popolazione di colore, il teatro ha taciuto sul passato dell’isola. Quegli scrittori, come Loys Masson, che, nella prosa, hanno testimoniato il loro biasimo verso un periodo fosco della storia mauriziana come la schiavitù e l’engagismo, non sembrano aver stimato il teatro un mezzo adatto alla narrazione e alla denuncia del passato. Dei pochi drammi consacrati alla storia, Le dernier Tribut di Léoville L’Homme, La rencontre di Raoul Ollivry, Amour et patrie di Arthur Martial, gli episodi narrati si misurano con un periodo del passato recente la cui memoria è così viva da coinvolgere emotivamente il pubblico della sala, ricordando che il testo di L. L’Homme fu rappresentato nel 1883 (la conquista inglese del 1810); si riferiscono, soprattutto, a quegli eventi gloriosi che avevano celebrato la forza e la perseveranza della sola comunità franco-creola, e non di tutto il popolo mauriziano, contro le avversità (gli Inglesi, i Tedeschi). 282 283 Ibid., p. 47. Ibid., pp. 58-59. 317 Il perenne stato di urgenza vissuto dalla popolazione mauriziana, oppressa dal sentimento di aggressione verso gli stranieri venuti dal mare, Inglesi o Indiani, assillata dal revanscismo contro una piccola comunità di potenti, monopolizzatori della cultura e dell’economia, ha impedito che venisse mai avviata una riflessione sulla storia, non corrotta dal dissenso e dalla volontà di rivalsa nei confronti delle altre comunità dell’isola. Il silenzio collettivo sugli eventi di una memoria condivisa (mai esplicitamente evocata nei titoli dei testi citati) denuncia, allora, la presenza ingombrante di una realtà e di un passato che, per non essere mai stato veramente risolto, mai superato criticamente, si protende come un’ombra sul presente. L’impegno educativo, il lavoro di conscientizzazione assunto dagli autori mauriziani che scrivono in creolo, ha spinto Azize Asgarally a interessarsi, primo esempio in teatro, alla storia della schiavitù. Partendo dalla vicenda del principe malgascio ucciso sull’isola mauriziana all’inizio dell’Ottocento per aver fomentato la rivolta degli schiavi, Ratsitatane284, racconta del periodo schiavista: dell’ammutinamento e della repressione militare seguita alla defezione e agli attacchi degli schiavi marroni. Azize Asgarally si confronta con gli eventi lungamente rimossi dell’isola prendendo come riferimento un osservatore esterno, un malgascio di sangue reale esiliato a Maurice per motivi politici (non un uomo comune venduto e deportato sull’isola come schiavo), come se la riflessione e l’analisi del passato collettivo avesse bisogno di una prospettiva estraniante, di un eroe che la storia ha mutato in mito, per potersi raccontare. Il mancato confronto con la storia si manifesta, quindi, nell’uso di espedienti narrativi che, invece di illustrare l’evento, ne simulano la rimozione. Il periodo della schiavitù, la ripercussione economica e sociale prodottasi in seguito all’introduzione degli impiegati indiani nelle piantagioni sono alcuni degli episodi della storia mauriziana che Napal Dayand, ne La ligue des ancêtres trépassés285, riporta alla luce per mezzo del racconto e del ricordo che le anime di uno schiavo, di un engagé indiano, di un amministratore, riemerse dal lontano XIX secolo, si scambiano. In uno spazio irreale, le ombre di tre personaggi recitano a soggetto, proponendo ciascuna un diverso racconto del passato secondo la ricostruzione e la testimonianza della propria vicenda personale: 284 Azize Asgarally, Ratsitatane, Port-Louis, Hart Printing, 1980. «Although Ratsitatane is no more than a dramatized version of historical events, Asgarally gives a voice to the silenced, allowing the prince slave to present a different perspective to the dominant colonial one. Through his right to speak, Ratsitatane holds the power to impose his opinion not only to the audience but also to the colonial authorities within the play; to bring the self and the other face-to-face.», Roshmi Mooneeram, Theatre in development in Mauritius. From a theatre of protest to a theatre of cultural miscegenation, op. cit., p. 27. 285 Dayachand Napal, La Ligue des ancêtres trépassés, Port-Louis, Hart Printing, 1978. Riassunto p. 496. 318 Engagé: «Je me suis débarrassé de cette vie de bête de somme […] la clémence n’existait pas […].» più avanti, lo schiavo rifaccia all’amministratore indifferente gli anni di ingiustizia subiti da lui e dall’engagé indiano: L’Esclave: «Il a été victime de ta méchanceté, l’Administrateur. Comme je l’étais aussi.»286 Come nella Divina Commedia, dove il confronto tra presente e passato si risolve nella condanna morale di Dante verso i personaggi della storia italiana, La ligue des ancêtres trépassés si chiude sulla sentenza infausta dei padri della società mauriziana, testimoni loro malgrado del ritorno ciclico della storia, della mancanza cronica di una giustizia che tuteli la vita e il lavoro di ogni essere umano: L’Esclave: «C’est que le temps a changé et changera bien davantage. C’est toute une évolution. Un genre de table ronde où le premier est le dernier […]. Allons! Tous nos espoirs reposent sur le progrès de nos petits enfants.»287 La considerazione fugace di una nemesi storica che ha ricompensato le sofferenze dello schiavo e le angherie subite dall’operaio indiano nelle piantagioni, con il luminoso presente di due dei loro discendenti (un avvocato e un medico riscattatisi dalla condizione di inferiorità imposta da un regime classista), scolorisce di fronte alla constatazione di una realtà governata da nuove forze di potere che, in modo diverso, continuano a sfruttare la categoria dei lavoratori: Le travailleur: (en larmes) «Laissez-moi aller. Mes enfants vont crever de faim. Vingt sous par personne ? Cela ne suffit pas pour payer le thé et le sucre de la famille […] Entre-temps c’est la misère de la famille. J’ai connu la dernière grève et la misère qu’elle travaille derrière elle [….»288 La storia, quindi, non ha valore in sé, non viene (rap)presentata e rivendicata dal drammaturgo e dai personaggi come spazio, sottratto all’oblio, in cui si dibattono gli episodi di un passato scomodo che ha segnato tutta la collettività mauriziana, quella degli schiavi e quella dei padroni. L’analisi del passato e il confronto tra i tre personaggi offre, evidentemente, l’occasione per mettere in luce le cause che hanno prodotto reazioni estreme come quella del marronnage, per denunciare il sistema folle dello schiavismo e la ritardata emancipazione dei lavoratori con il sopraggiungere degli engagés indiani: 286 Ibid., p. 2, p. 8. Ibid., p. 48. 288 Ibid., pp. 38-39. 287 319 L’Esclave: «Mais nous n’avions plus de maîtres, plus de punitions. En revanche, on nous considérait comme la terreur de nos anciens supérieurs […].»289 Il ricordo e la testimonianza del passato sembra funzionare, nel testo, da deterrente per l’epoca attuale: come modello a partire dal quale analizzare e capire il mondo presente. Il racconto delle esperienze dei tre defunti, le ragioni di un sistema imperialista e gli orrori della struttura economica brutale, da questa promossa290, servono da introduzione critica alla realtà sociale e lavorativa del mondo contemporaneo, certamente più efficiente e apparentemente più umano291, la cui complessità (a seguito dell’introduzione di un terzo elemento, il sindacato, come organo mediatore tra la classe dirigente e quella degli impiegati) lascia però intuire il rischio di degenerazioni non meno pregiudizievoli per una giusta difesa del lavoro dipendente: Le Président: «Un médecin de famille pour chaque travailleur, une augmentation de jours de congé. Contrairement une compensation et gratification en proportion avec le profit de compagnie.» Georges: (choqué) «Mais c’est inconcevable. Pourquoi ne prennent-ils pas toute la propriété?» Le Président: (un rire) «Ne t’en fais pas, ça arrive. Au cas contraire, ils demandent la nationalisation de toutes les propriétés et compagnies privées. […] C’est le communisme qui est leur idéologie.»292 Forte dell’esperienza coloniale, il vecchio amministratore non può che rappresentarsi i risvolti positivi che la recente esplosione demografica (registratasi alla fine degli anni 80 sull’isola di Maurice) può avere sull’economia, sul profitto dei grossi imprenditori: L’Esclave: «L’économie du pays n’a pas changé.» l’Administrateur: «La main d’œuvre a augmenté […].» l’Esclave: «Il y a beaucoup plus qu’il n’en faut.» l’Administrateur: «Cela mène à la concurrence. Une baisse dans le coût de la production […].»293 Mentre lo schiavo non può che prefigurarsi l’evento come un nuovo flagello per la comunità locale: fautore di nuove discriminazioni, di un aumento della povertà a vantaggio delle classi dirigenziali, dei pochi potenti che continuano a governare l’isola: 289 Ibid., p. 6. Nel raccontare la sua epopea, l’engagé ricorda la pressione psicologica esercitata dai battellieri e dai commercianti di schiavi per convincerli ad andare a lavorare sull’isola: le false promesse di un lavoro dignitoso e remunerativo, il trasporto in un battello carico di carne umana, stipata come bestiame, lo sfruttamento nelle piantagioni. Ibid., p.4. 291 Confrontando la sua esperienza con quella dei lavoratori del mondo moderno, lo schiavo può felicitarsi del fatto che la schiavitù non esista più. Ibid., p. 1. 292 Ibid., pp. 31-32. Un riferimento alla politica filosovietica del M.M.M. che aveva organizzato lo sciopero generale nel 1971? 293 Ibid., p. 26. 290 320 L’Esclave: «Avec cette affaire de grève, cette question de riche et de pauvre, le problème reste entier […]. Les problèmes sur terre se détériorent avec le passage du temps. Il y a un fléau nouveau sur terre. Cela s’appelle l’explosion démographique.»294 Il pericolo dell’aumento demografico, a fronte di una politica del guadagno (del denaro295) vieppiù radicata e diffusa tra le classi sociali (da cui restano però esclusi i lavoratori eternamente sfruttati), porta a una degradazione del lavoro: da strumento che permette l’emancipazione dell’uomo (come luogo in cui vengono affermati i diritti umani), a sistema di forze (l’opposizione tra l’istituzione capitalista e la classe operaia) da sfruttare per la scalata al potere individuale: Le Chef syndicaliste: «Si ma popularité continue à monter de ce train, dans quelques années je serais à mon apogée. Les prochaines élections générales me donneront une majorité absolue dans l’assemblée législative.»296 Questa passeggiata rapida sul mondo presente offre, allora, l’opportunità per denunciare le contraddizioni di una realtà lavorativa che ha solamente mutato il sistema di sfruttamento (dall’imperialismo ai sindacati alleati del capitalismo) senza che la categoria dei vessati e le manifestazioni di strapotere siano stati realmente minati. Contro la buonafede dell’uomo comune che si affida al sindacato per migliorare le sue condizioni di vita, si profila l’immagine dei sindacalisti, uomini ricchi e influenti, che, come gli amministratori del tempo schiavista, si avvalgono della forza dei lavoratori per estorcere agli imprenditori e alla classe dirigenziale la promessa di un potere sempre maggiore: Le Directeur: «Comme ils sont pauvres les laboureurs pensent améliorer leur niveau de vie. Ils font confiance aux syndicalistes.» Bob: «Ces syndicalistes se dévorent entre eux-mêmes. C’est un moyen de promouvoir leur popularité dans le domaine politique. Les histoires se répètent […].»297 La corruzione morale di un sistema, che sfrutta la miseria e il risentimento dei poveri, la paura della perdita del patrimonio e l’allarme della minaccia comunista sul mondo capitalista, si mostra ai visitatori dell’altro mondo come la concretizzazione di una più subdola dittatura che ha monetizzato i sentimenti e i principi morali. 294 Ibid., p. 25. Lo schiavo riflette sul fatto che le cose sono cambiate, solo in apparenza nel momento in cui le relazioni sociali sono ancora assoggettate al potere del denaro, dalla cui possibile contrattazione sono esclusi i poveri. Ibid., p. 17. 296 Ibid., p. 44. 297 Ibid., p. 39. 295 321 Come Augustin e Noyau, Dayachand Napal apre il suo testo sulla rivolta dei lavoratori, sullo sciopero generale che ha paralizzato la società mauriziana. Laddove i due drammaturghi precedenti assumevano la prospettiva dei ribelli, tentando di portare sulla scena le ragioni della nascita e gli obiettivi della lotta sindacale, istituendo un confronto tra il potere tiranno e la massa oppressa che mutava quanti combattono per la causa comune in eroi e in martiri del progresso civile, Dayachand resta osservatore esterno (riducendo la rappresentazione a un racconto, a una cronaca degli eventi allorché i tre defunti agiscono come filtro del tempo presente) e disincantato della lotta sindacale. I cinque anni che separano le opere devono aver certamente contribuito a far maturare una visione disillusa verso il sistema economico e politico in generale che, a differenza degli scrittori precedenti, non presuppone più il conflitto tra classi definite (ricchi malvagi, poveri oppressi). Se Noyau e Augustin mettevano in scena una rassicurante visione manichea della società da cui il male, una volta individuato, poteva essere estirpato, Dayachand non può che constatare l’esistenza di una realtà complessa, e denunciare il fenomeno, poco chiaro, di politiche e organismi, il cui ruolo pubblico è stato corrotto da un’azione che ha compromesso e invalidato la lotta sociale. L’entusiasmo rivoluzionario, l’unione spirituale con i grandi personaggi del passato chiamati a sostegno della legittimità298 del conflitto politico come strumento per il progresso sociale, indugia di fronte all’evidenza del rischio della lotta civile ed interetnica che un ostinato individualismo può scatenare in una società stremata da secoli di povertà e di sfruttamento: L’Esclave: «Le fouet a changé de main, c’est vrai. Mais qui vont souffrir? Pas les anciens administrateurs, bien sur! Le chef aura des alliés qui seront ses suivants fermes et les anciens capitalistes. Et quelques hauts fonctionnaires […]. Ce sont les petits qui souffriront. Cette civilisation sera le nouveau barbarisme. Les politiques de parte et d’autre se couperont la gorge.»299 L’avanguardia creola, Dev Virahsawmy, Azize Asgarally. Le opere di Dev Virahsawmy300, pubblicate tra il 1977 e il 1987, sono l’eco della graduale evoluzione dell’opinione pubblica verso una consapevolezza più acuta delle forze politiche, verso una rappresentazione del reale meno edulcorata, non più nobilitata dal fervore ideologico. 298 Pensiamo al dramma di Augustin. Dayachand Napal, La Ligue des ancêtres trépassés, op. cit., p. 47. 300 Nato nel 1942. Dopo aver terminato i suoi studi in Scozia, torna a Maurice dove si mette alla testa del movimento politico anticommunalista mauriziano. Eletto deputato alle elezioni del 1970, viene messo in carcere nel 1971 a seguito 299 322 Come il teatro africano degli anni 80, Dev Virahsawmy mette in scena la disillusione di un popolo che aveva creduto nella possibilità della rinascita sociale, amareggiato di fronte all’evidenza di un male senza volto301 (il Bianco è stato sostituito dal dittatore nero), che sembra vanificare la conquista della libertà, indebolire il progresso civile. Dissidente, sindacalista, fondatore del Movimento Militante Mauriziano, sostenitore della lingua e della cultura creola in difesa dell’idea di una nazione mauriziana unita nella sua multietnicità, lo scrittore di origine indiana ha teorizzato un teatro della protesta302 di diffusione popolare. La scelta di promuovere una produzione nella lingua meno prestigiosa ma più diffusa è assunto come un impegno istituzionale da parte di quegli scrittori mauriziani che hanno partecipato attivamente alla costituzione di una nuova società mauriziana. Sottrarre lo spettacolo e la creazione letteraria al dominio dell’intellighenzia colta, soprattutto Bianca francofona o anglofona, significava restituire il racconto teatrale alle sue originarie aspirazioni sociali e comunitarie: equivaleva a rivendicare per la narrazione la vocazione didattica e rivoluzionaria nella misura in cui lo spettatore si riconosceva il destinatario del messaggio politico di difesa della cultura e dell’identità multirazziale dell’isola. La salvaguardia e la promozione del creolo attraverso l’arte era assunto come un atto provocatore e rivoluzionario che doveva colpire quelle istituzioni politiche che si erano adoperate a mantenere lo status quo precedente all’indipendenza. Come osserva Pierre Benoit, Li era rivoluzionario perché professava la possibilità di riscatto e di avanzamento culturale della società dal suo stato di letargo forzato: «The journalist Pierre Benoit believes that Li was not banned for political reasons since it hardly includes any highly subversive political comments. He suggests, instead, that what frightened the authorities was the idea that “Seki ti feb vin for…”, “those who were weak become strong”, represented through the martyred protagonist.»303 La lotta per l’emancipazione creola propugnata dal drammaturgo mauriziano non era rivolta alla sola classe dei lavoratori contro quella dei padroni304, era soprattutto l’affermazione del superamento delle divisioni etniche che, indebolendo il governo, come in Africa, costringeva la dello sciopero sindacale nazionale dal lui promosso. Continua la sua attività politica fino al 1980, per dedicarsi negli anni successivi all’insegnamento. 301 «[…] le théâtre […] découvre avec embarras que des cadres du pouvoir colonial a germé un pouvoir autochtone, sorte de bourgeoisie aristocrate avec son cortège de corruption […].», Koffi Kwahulé, Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain, op. cit., p. 20. 302 «[…] this article analyses some of the most important repercussions that the very choice of Creole as dramatic language has entailed, before considering the preoccupation and impact of the early theatre of protest.», Roshmi Mooneeram, Theatre in development in Mauritius. From a theatre of protest to a theatre of cultural miscegenation, op. cit., p. 24. 303 Ibid., p. 27. 304 «To write in Creole is also a fundamental step in the political struggle against the class system since Creole is identified with the exploited proletariat.», Ibid.,p. 26 323 neonata repubblica a cedere alle pressioni internazionali (con la pericolosa oscillazione della politica verso il capitalismo americano o il comunismo sovietico) rinviando la promozione di uno stato democratico. Leader del M.M.M. (in seguito Socialista Progressista M.M.M.S.P.), Dev Virahsawmy si è avvicinato al teatro, quando era ancora in carcere tra il 1971 e il 1972 dimostrando la stretta relazione tra l’esperienza politica e la rappresentazione drammatica dell’evento, tra lotta politica e promozione della cultura. La vocazione politica e propagandistica dei testi teatrali è corroborata dalle introduzioni alle opere del drammaturgo, che riprendono quasi indistintamente gli stessi temi (dal 1970 al 1980) di difesa della cultura popolare. In Li, in Les La Po Kabri Gazuyé305, rispondendo a cosa è la letteratura mauriziana, lo scrittore rivendica una letteratura proletaria, che serva il popolo: aperta ai movimenti esterni eppure concentrata sulle manifestazioni delle individualità locali, contraria alla cultura di massa appoggiata dal potere centrale, fautrice, invece, di una promozione culturale che spinga alla comprensione del mondo, all’analisi approfondita dei rapporti umani. In questa operazione di autocoscienza, secondo Dev Virahsawmy, il teatro, come azione rappresentata, è l’unica tra le arti ad educare alla lotta rivoluzionaria per mezzo di esempi concreti e di immani prese dalla vita reale, mantenendo un dialogo aperto e sempre rinnovato con il pubblico: «Le théâtre a été toujours l’avant-garde de cette quête intellectuelle et spirituelle. En effet, le théâtre s’adresse aussi bien à l’émotion qu’à l’intellect.»306 La scelta del creolo, come linguaggio drammatico, è indicativa di un testo la cui priorità è quella della comunicazione. Pensato in funzione della rappresentazione e del pubblico che fruirà dell’opera, il testo teatrale di Dev Virahsawmy rifugge le riflessioni metafisiche di André Masson, la provocazione profetica di Chazal, l’astrattezza di personaggi senza nome di Noyau per riportare la rappresentazione alla linearità discorsiva del naturalismo, ove tutto è culturalmente determinato (milieu, race, moment) e immediatamente riconoscibile. L’assunzione vieppiù cosciente e radicale della scrittura teatrale come azione sociale si rivela in una progressione sempre più marcata dei testi verso la descrizione realista. Se Li dimostra un uso ancora metaforico del linguaggio, e dei personaggi, le opere successive riducono il linguaggio alla sua funzione descrittiva (non più simbolica) e rappresentativa della realtà: 305 306 Dev Virahsawmy, Les La Po Kabri Gazuyé, Port-Louis, Les Chemins de la Liberté, 1980. Dev Virahsawmy, Li, Port-Louis, les Chemins de la Liberté, 1979. Riassunto pp. 496-497. 324 «Virahsawmy’s theatre illustrates that while an intense sense of the place and time allows theatre to be oppositional and relevant to the audience, it need not reduce the appeal of the performance to a minority or limit the performance to a local source.»307 Il diverso valore attribuito al linguaggio308, prima, interprete della pulsione ideologica del drammaturgo, più tardi, eco del disagio collettivo, si riflette in una rappresentazione che si spoglia della tradizione del teatro poetico per farsi teatro testimoniale. Nonostante si possa intuire una ricorsività dei temi nel teatro di Virasahwmy (la lotta operaia, la corruzione e la repressione, la perdita di identità, lo sfruttamento e la discriminazione sessuale), è evidente il diverso clima e il differente procedimento narrativo che lo scrittore adotta per il primo testo drammatico (deduttivo) rispetto ai successivi (induttivo). Mentre in Li309 i personaggi sono funzionali all’esposizione del sistema ideologico: l’estrinsecazione simbolica di un modello della realtà, dominato da forze antagoniste (gli oppressori e gli oppressi), in Bef Bâ Bisab310, e in Linconsing Finalay311 la rappresentazione di un episodio reale (il lavoro in cantiere, i rapporti familiari) offre allo stesso spettatore l’occasione di risalire (di combattere coscientemente) ai principi economici e politici che reggono il sistema (facendo appello a un’azione terapeutica, maieutica del teatro). Li resta, in ogni modo, l’opera più suggestiva di Dev Virahsawmy, la più studiata e commentata. Fortemente evocativa per la spinta all’universale che muove il testo e i personaggi, come le opere contemporanee più controverse, Li ha dato adito a diverse interpretazioni, a ripetute smentite, nel tentativo di rimanere fedele al disegno dell’autore, delineatosi nelle opere posteriori, di fare un teatro di fruizione popolare. Chi è Li? Una prima lettura identifica «Li» al detenuto della cella: il rivoluzionario di cui i carcerieri devono decidere la vita o la morte. Li in creolo mauriziano indica il pronome oggetto della terza persona singolare, la particella “lui” con la quale i personaggi della pièce si riferiscono al prigioniero senza nome. Il testo in creolo, come fa notare Vicram Ramhazai, evidenzia, tuttavia, un uso polisemico della particella, usata, indifferentemente per il pronome soggetto (quando si riferisce 307 Roshmi Mooneeram, Theatre in development in Mauritius. From a theatre of protest to a theatre of cultural miscegenation, op. cit., p. 33. 308 Ricordiamo che i testi a cui si fa riferimento, sono le sole opere tradotte dal creolo mauriziano dal poeta reunionese Carpanin Marimoutou. 309 Dev Virahsawmy, Li, op. cit. 310 Dev Virahsawmy, Bef Bâ Bisab, Port-Louis, Les Chemins de la Liberté, 1980. (Version trilingue, Trad. Française de Carpanin Marimoutou, Chacun pour soi). Riassunto p. 497. 311 Dev Virahasawmy, Linconsing Finalay, Paris, R.F.I., 1987. Riassunto p. 497. 325 al giovane guardiano Arjuna), e come pronome oggetto, infine, in senso spregiativo, per indicare una «non-personne»312. Fisicamente assente, Li monopolizza la scena, costringendo gli altri personaggi a parlare di lui: orientando i discorsi, pervadendo le parole con la sua presenza puramente ideale, come un pensiero scomodo e imbarazzante da sconfessare. La natura quasi fantastica del personaggio di Li (rispetto agli altri personaggi del testo fisicamente e psicologicamente determinati), ha spinto alcuni critici a riconoscere nel protagonista di Virahsawmy, il dio-assente di Beckett di En attendant Godot313. L’assenza di Li, alla quale cinque individui (tre carcerieri, una donna e una sentinella) si confrontano, non sembra, però, essere originata dallo stesso vuoto trascendentale delle opere postbelliche degli anni 50, e Virahsawmy non sembra ascrivere al suo personaggio, le stesse determinazioni metafisiche del Godot di Beckett. Benché Godot e Li figurino nel testo come due sostanze ideali, due realtà puramente linguistiche, l’assenza fisica di Godot è ribadita dall’attesa tradita di Vladimir ed Estragon, laddove Li rivendica la sua presenza attraverso gli altri personaggi che si occupano e si preoccupano di lui; Godot non si sa bene chi sia e perché due personaggi buffi lo stiano ad aspettare in un luogo imprecisato (probabilmente anche sbagliato) spoglio se non fosse per un salice piangente rinsecchito da un lato, Li è il rivoluzionario, accusato di cospirazione contro il governo, internato in un carcere per detenuti politici, occupa una delle celle (non visibili) che il drammaturgo colloca sul lato sinistro della scena. Godot non è un personaggio controverso, motivo di discussione tra i due protagonisti che occupano la scena (Godot è una realtà quasi accidentale nella struttura del testo drammatico), come gli eroi della tragedia classica, Li è lo scandalo che deve essere rifiutato perché la legge e l’ordine costituito possano essere restaurati. L’eroe tragico ormai assente nel teatro contemporaneo, viene, però, recuperato dal drammaturgo come archetipo letterario, come modello dialettico dal cui confronto è possibile caratterizzare gli altri personaggi della pièce: Rwana, il corrotto asservito al sistema314, Mike, l’alienato che decide infine di espiare le sue colpe consegnandosi ai ribelli, 312 Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expression créole. Essai d’analyse socio-culturelle, op. cit., p. 62. «Li ressemble par certains cotés à En attendant Godot. Li et Godot n’apparaissent pas sur la scène. Pourtant on ne cesse de parler d’eux, de s’interroger sur eu. […] En cela, il ressemble à Jésus. […] Une autre lecture de Li se fonde sur les personnages de Rawana d’Arjuna, deux personnages importants de la mythologie hindoue qu’on retrouve dans le Ramayana […] .», Ibid., p. 63. Il confronto tra la pièce di Beckett e quella di Virahsawmy ipotizzata da Vicram Ramhazai, sebbene suggestiva, non sembra del tutto convincente. Waiting for Godot rimane un testo indefinibile, tragicomico, dal momento che per l’intera durata della rappresentazione nulla accade («nothing happens, nobody comes»). Li è un dramma politico che mette in scena l’omicidio politico. 314 Rawana: «Tu comprends le chefs aiment qu’on leur obéisse, qu’on leur exécute les ordres. […] un chef est intelligent. Lui seul sait ce qu’est bon ou pas. Ce qu’il fait, il le fait dans l’intérêt de tous, le tien comme le mien […]. Et puis, un chef est puissant. S’il n’est pas content de ce que tu fais, tu risques de le payer cher.», Dev Virahsawmy, Li, op. cit., pp. 62-63. 313 326 Arjuna, il debole315, Angela, la reietta della società316, Pierre, l’apostolo che cerca di salvare il prigioniero. La posizione che occupano i diversi personaggi nel dramma è rivelatrice della differente opinione, dell’opposta descrizione che questi danno del detenuto. Il dilemma morale esternato da Mike sulla giustezza dell’omicidio e sulla reale colpevolezza del prigioniero si scontra con il calcolato egoismo di Rwana, per cui l’altro, giudicato in ogni caso elemento di disturbo, è considerato solo come fonte di guadagno e di gloria personale: Mike: «Qu’as-tu ressenti quand tu as du tuer un quelqu’un, un être humain comme toi?» Rwana: «[…] un être humain comme toi? Ça ne va pas! Ecoute, c’est un ennemi: Si je ne le tue pas, c’est lui qui me tue […] son sang te libère […].» Mike: «Tu n’as jamais pensé à eux! Aux jeunes, aux pères de famille?» Rwana: «Je fais mon boulot. On me donne l’ordre de tuer, je tue. Plus je tue, plus mes chefs sont contents et me donnent tout: médaille, promotion…»317 Il confronto tra i vari personaggi porta, così, alla declinazione delle diverse accezioni della giustizia. Se la matrice comune delle riflessioni è, come rivela Asgarally, un acuto sentimento egoistico318 che orienta le decisioni di ciascuno, l’azione si distinguerà per il diverso grado di alienazione nei confronti della coscienza morale dimostrata dai protagonisti. L’efferatezza di Rwana, a cui il drammaturgo conferisce delle determinazioni animali: sensualità, forza, irriflessività319, si scontra con l’abulia (l’ignavia dantesca) di Mike, soprattutto di Arjuna: di uomini che rifuggono la scelta e la responsabilità dell’azione, reclamando la loro sottomissione al dovere e alla legge scritta: Arjuna: «Mais c’est contraire au règlement. Je ne peux pas Pierre. Je le voudrais bien. Moi aussi je veux qu’il vive, mais je n’ai pas ce pouvoir.»320 315 Arjuna: «Angela a raison…je n’aurais jamais le courage de faire ce que la conscience m’ordonne.», Ibid., p.100 Rawana: «[…] De comme toi, je eux en avoir mille. Femme, qu’est-ce qe tu vaux…Avec de l’argent, n’importe qui peut s’acheter une femelle.», Ibid., p. 83. Angela: «Ton prisonnier dangereux. Il dit toujours qu’il n’y a pas de bonheur sans liberté. Mais pour une femme, où est la liberté? Notre destin dépend des caprices des hommes.»/Rawana: «devant un sergent, une femme et un soldat, c’est pareil. Même un soldat a plus de pouvoir. C’est un homme lui.», Ibid., p. 88 317 Ibid., pp. 61-62. 318 Issa Asgarally, Littérature et révolte, op. cit., p. 53. Citiamo un passaggio tratto da Li: Pierre: «Non chef. Ce que vous cherchez n’existe pas. Vous ne pensez qu’à vous. Mais pour que votre liberté, votre indépendance, votre bonheur soient réels, il faut que tout le monde soit libre, indépendant, heureux […].», Dev Virahsawmy, Li, op. cit., p. 99. 319 Rawana: «[…] Écoute mon petit, l’indépendance, ça n’existe pas. […] Ferme ton livre, brûle-le. Écoute moi, c’est moi le plus grand livre. Mon livre s’appelle expérience. […] Je serais inspecteur. Pourquoi? Je sais faire plaisir au chef. (Il rit avec satisfaction, se lève, ouvre l’armoire, y prend en révolver et joue avec)/Tu vois ça! L’avenir est là.»., Ibid., p.70. 320 Ibid.,p. 101. 316 327 Il dubbio e la legge (scritta e orale), come spazi che identificano l’uomo messo di fronte alla scelta del bene e del male, spostano la lettura del testo, dal piano delle relazioni politiche a quello esistenziale: Rwana: «[…] C’est le plus fort qui commande. Choisis d’être avec le plus fort […].» Arjuna: «Pour l’instant mon intérêt est faire mon travail […] Faire correctement mon travail.» Rwana: «Faire ce que je te dis de faire.» Arjuna: «Faire ce que le règlement me dit de faire.»321 L’anticamera claustrofobica che divide l’uscita e dalle celle, dove si consuma la tragedia di individui che lottano per la sopravvivenza materiale e spirituale, lo spazio intermedio tra la libertà e il dovere dove si declinano le diverse interpretazioni della legge, come codice scritto o imposizione dei capi (la legge del più forte), mette in scena la relazione dell’uomo al potere: un potere astratto di cui un registro322 e un telefono sono i simboli. L’assenza metafisica, il vuoto istituzionale è rappresentato, quindi, dall’altro elemento presente-assente nel testo: la telefonata, il cui silenzio (o ritardo?) spinge il guardiano a uccidere il detenuto innocente323. La legge, l’ordine sono rappresentati da Virahawmy come elementi repressivi che limitano la libertà umana. Istituita e imposta senza il consenso collettivo, da una minoranza che non ha mai sperimentato il disagio e la misera della maggioranza, conscia, tuttavia, del potere rivoluzionario della massa, la legge si rivela il mezzo più efficace per promuovere un’omologazione capace di soffocare l’iniziativa privata324: 321 Ibid., pp. 75-77. Secondo Vicram, il registro è introdotto da Virahsawmy come strumento atto a produrre un décalage temporale nel testo, quindi a fornire un elemento estraniante per la fruizione del dramma da parte del pubblico. Questo processo di mise en abîme della narrazione con Arjuna, che trascrive sul registro tutto quanto sta accadendo nella cella e fuori, realizza un meta-teatro diviso in due tempi: quello della rappresentazione e quello della narrazione (sempre presunto e mai comunicato al pubblico). Vicram Ramhazai, La littérature mauricienne d’expression créole. Essai d’analyse socioculturelle, op. cit., p. 70. 323 Per tutto il dramma, Rwana è ossessionato dalla telefonata dei superiori, al punto da coinvolgere Arjuna nel fare la guardia a un telefono che resterà muto durante tutto il dramma, anche dopo l’omicidio. Il comunicato di sospensione della condanna è lasciato a Mike, l’altro carceriere, che, però, a causa dello scioper
Scarica