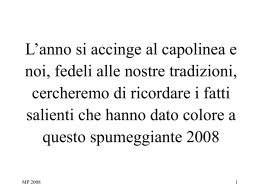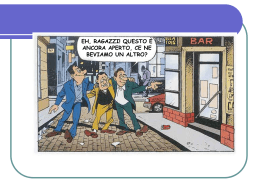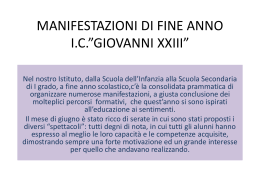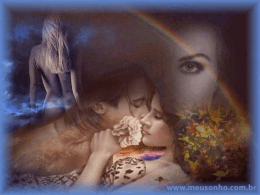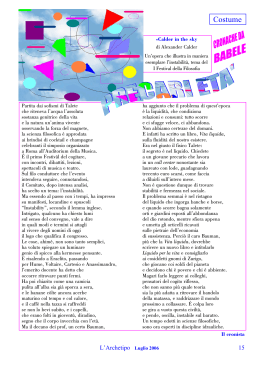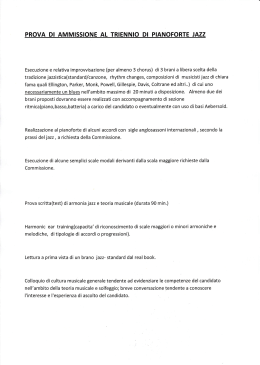CALEIDO SCOPIO Un maestro «suavissimo» MUSICA · A Claudio Merulo, organista e compositore originario di Correggio, è ancora oggi ritenuto uno dei massimi protagonisti della musica strumentale cinquecentesca per la geniale fusione degli elementi virtuosistici, ispirati a una sensuale gioia del suono inomato e versatile compositore di madrigali, canzonette, musiche di scena e musica sacra, Claudio Merulo ha lasciato sicuramente il segno, nel corso del XVI secolo, per la sua straordinaria produzione tastieristica dedicata all’organo, tanto da valergli l’appellattivo di «organista celeberrimo supremo» e «suavissimo organista» da parte di due dei piú grandi teorici musicali del tempo, rispettivamente Girolamo Diruta e Gioseffo Zarlino. Le loro parole palesano tutta l’ammirazione per questo valente musicista, rinomato R per la sua produzione tastieristica tanto da mettere in secondo piano una produzione in ambito vocale altrettanto importante. Al vertice a soli trent’anni Se da un lato è enorme la fama raggiunta ancora vivente, la biografia di Claudio Merulo, nato a Correggio nel 1533 e morto a Parma nel 1604, è piena di lacune e molto poco si sa, per esempio, sulla sua istruzione musicale giovanile. Sicuramente questa doveva essere già completata nel 1556, quando viene nominato organista del duomo di Brescia; incarico tenuto fino all’anno successivo subentrando come secondo organista nella prestigiosa cappella musicale di S. Marco a Venezia, insieme ad Annibale Padovano (primo organista). Alla partenza di quest’ultimo, Merulo prenderà il suo posto, all’età di soli 33 anni, ottenendo una delle posizioni piú ambite – musicalmente parlando – in territorio veneziano. Si consideri che come secondo organista, ad accompagnare Merulo, c’era il grande Andrea Gabrieli, con il Lo scaffale RENATO BORDONE, GIUSEPPE SERGI Dieci secoli di Medioevo EINAUDI, TORINO, 420 PP. 26,00 euro ISBN 978-88-06-16763-9 I mille anni di storia che, a posteriori, hanno assunto la denominazione di «Medio Evo» o «Età di Mezzo» e che, per convenzione, sono compresi tra il 476 – data della deposizione di Romolo Augustolo, considerato l’ultimo imperatore romano 126 d’Occidente – e il 1492 – anno in cui Cristoforo Colombo scoprí l’America – vennero percepiti per la prima volta, nel corso del Quattrocento, dagli intellettuali umanisti, come secoli di profonda e traumatica cesura dalla cultura classica, ai cui canoni essi aderivano e che credevano di avere ripristinato. Giudizi polemici che, nei secoli della Riforma, si radicarono sulla base di riflessioni che condannavano l’asservimento dell’originario messaggio evangelico al potere dei papi e della Chiesa, reclamando una forma di cristianesimo piú puro. Renato Bordone e Giuseppe Sergi ripercorrono il lungo millennio medievale e ne raccontano le vicende salienti, articolando la narrazione in tre sezioni: nelle prime due, dedicate alle strutture del potere, nell’Alto e nel Basso Medioevo, gli eventi storici sono ripercorsi cronologicamente, con l’intento di fornire al lettore una visione obiettiva del periodo, corretta da luoghi comuni, pregiudizi e strumentalizzazioni. A questa lettura politico-istituzionale si raccorda l’ultima parte del volume, dedicata agli approfondimenti di storia sociale, ecclesiasticoreligiosa, ed economica. S. S. DICEMBRE MEDIOEVO quale diede vita a un intenso e apprezzato connubio artistico, durato ben diciotto anni. Una parentesi intensa, ma poco fortunata Oltre alla grande maestria musicale, il Merulo si fece anche autopromotore delle sue musiche fondando una tipografia musicale a Venezia nel 1565. Centro nevralgico dell’editoria musicale dell’epoca, la creazione di una nuova stamperia sulla laguna non fu impresa facile, tanto che dovette chiudere i battenti appena cinque anni piú tardi, ma con una quarantina di opere stampate all’attivo, tra cui alcune dello stesso Merulo. Se l’attività imprenditoriale non ebbe particolare fortuna, sicuramente il suo operato come maestro di cappella fu coronato dal successo e tale da portarlo a lavorare. oltre che alla cappella marciana, successivamente anche presso i Farnese a Parma nel 1584, per i quali lasciò il posto di organista a Venezia. Divenuto cembalista di corte, assumerà, a partire del 1587 anche il posto di maestro di cappella del duomo. A questa ultima fase della sua carriera appartiene anche il suo coinvolgimento nella fabbricazione di un organo portativo, tuttora conservato presso il conservatorio di Parma, unica testimonianza di un suo intervento diretto nella costruzione di uno strumento. Alla produzione organistica è dedicata la registrazione della Tactus Claudio Merulo. Missa Apostolorum In Festo S. Joannis Apostoli (TC533803, 1 CD, distr. www.soundandmusic.com), che si sofferma non tanto sulle celeberrime toccate o ricercari che percorrono gran parte della produzione strumentale di Merulo, quanto a un genere particolare, la cosiddetta Messa d’intavolatura d’organo, dove lo strumento, traendo ispirazione dalle melodie gregoriane, ripropone nell’ordine consueto i brani della Messa, intercalando «versetti» organistici al testo liturgico vero e proprio affidato alle voci che eseguono le melodie della tradizione monodico-liturgica. Tratta dalle Messe MEDIOEVO DICEMBRE d’intavolatura d’organo. Libro quarto, stampate nel 1568 a Venezia, in questa messa vengono aggiunti anche alcuni brani strumentali esterni dello stesso Merulo, come, per esempio, la splendida toccata iniziale, dalle Toccate d’intavolatura d’organo. Libro primo, che nella sua solennità rappresenta un degno inizio di questa Missa Apostolorum, basata su passaggi in gregoriano che rappresentano la struttura portante su cui la vena creativa del compositore si sfoga creando un discorso ricco di abbellimenti ed evocatore di veri e propri «affetti» sonori. Un connubio perfetto La Messa «organistica», che si suddivide nei brani canonici dell’Ordinarium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) e quelli del Proprium (Introito, Graduale, Alleluia, Offertorio, Communio), è legata alla tradizione contrappuntistica cinquecentesca e alle sue rigide regole che vanno codificandosi nel corso del secolo. Ciononostante, la maestria di Merulo sta nel saper fondere la rigidità delle regole con una profonda sensibilità verso il contenuto emotivo. Da questo tentativo, volto alla ricerca del giusto equilibrio tra tecnica compositiva e contenuto «affettivo», nasce il perfetto connubio che contraddistingue la Missa Apostolorum, in cui lo strumento è il protagonista principale, accanto alle sezioni cantate, qui affidate al repertorio gregoriano eseguito dai componenti della Schola Gregoriana Scriptoria diretti dal monaco benedettino e gregorianista Dom Nicola Bellinazzo. L’interpretazione organistica è affidata a Roberto Loreggian che nello stile di Merulo si destreggia con acrobatica disinvoltura, in particolare nel bel Ricercare dell’Ottavo Tuono, tratto dalla sua raccolta dei Ricercari d’intavolatura (Venezia, 1567) e qui inserito tra il Sanctus e l’Agnus Dei. Belle le sonorità e la scelta dei registri dell’organo utilizzato in questa registrazione, benché il libretto non riporti, stranamente, alcuna notizia sullo strumento adoperato per questa ottima registrazione. Franco Bruni 127 CALEIDO SCOPIO Nel segno di Venezia MUSICA · Nati rispettivamente in Germania e Polonia, Samuel Scheidt e Mikolaj Zielenski si affermarono come brillanti compositori di musica sacra, avvalendosi entrambi con profitto della tradizione italiana l contesto musicale luterano del primo Seicento la Ricercar dedica l’antologia Samuel Scheidt. Sacrae Cantiones (Ric 301, 1 CD, distr. Jupiter), incentrata su uno dei protagonisti piú significativi di quell’ambiente. Scheidt nacque nel 1587 a Halle e la sua formazione musicale non sarebbe stata la medesima senza i viaggi compiuti in Italia nel 1609 e nel 1628. Durante queste due permanenze venne infatti a contatto con il clima di innovazione che, in particolare in area veneziana, andava svolgendosi nel campo della policoralità, tanto in auge nella cappella di San Marco sin dalle esperienze cinquecentesche dei fratelli Gabrieli e nel campo della monteverdiana «seconda prattica», il nuovo stile difeso da Monteverdi che rivoluzionava il rigido linguaggio contrappuntistico cinquecentesco a favore di una maggiore libertà dalle strette regole accademiche, a tutto vantaggio dell’enfatizzazione della passione umana. Ne è testimonianza la raccolta Concertuum Sacrorum del 1622, che è una sorta di tributo allo stile italiano, in particolare quello monteverdiano. Al contrario, le Sacrae Cantiones oggetto di questa registrazione, sono tratte da una raccolta a stampa (1620) che precede di poco quella del Concertuum Sacrorum. Se in quest’ultima prevale un’apertura totale al nuovo linguaggio, le cantiones adottano piú sobriamente i nuovi stilemi appresi in Italia, con un linguaggio ancora in parte legato al tardo Cinquecento, ma in cui sono già A 128 evidenti i richiami alla policoralità veneziana dei fratelli Gabrieli, e agli stilemi dei mottetti solistici di Monteverdi, dove la voce emerge dall’insieme corale come protagonista assoluta con tipici abbellimenti nelle linee vocali che rimandano sensibilmente alla coeva tradizione mottetistico-solistica italiana. Variegate le strutture compositive adottate da Scheidt in queste cantiones. La prima, Surrexit Christus hodie, è tutta giocata sul dialogo del soprano solista e il «tutti» del coro. Al contrario, nel Richte mich Gott la struttura policorale a otto voci alterna due ensemble che si differenziano dal punto di vista timbrico, essendo il primo prevalentemente a registro acuto con due soprani, alto e tenore, mentre il secondo coro è dominato dai registri bassi dell’alto, due tenori e due bassi; lo stesso accade in Ist nicht Ephraim, con due gruppi timbricamente opposti che si alternano, ma che, a tratti, si riuniscono nei finali creando effetti sonori particolarmente intensi. Le tre sezioni che costituiscono invece il Lobet im Himmel den Herrn sono tra i brani piú elaborati di questa raccolta dove si prevede una struttura ritornellata sull’Alleluia; in questa cantione Scheidt predilige una struttura piú complessa rispetto agli esempi precedenti, prevedendo una alternanza del «tutti» con passaggi solistici, duetti e trii. Un posto di rilievo è infine occupato dal Vater unser im Himmerlreich, una traduzione piú o meno letterale del nostro Padre nostro. Qui Scheidt impiega un’impalcatura complessa, sezionando il testo della preghiera in nove parti e affidando a ciascuna di esse modalità compositive diverse, dove emergono, in particolare, l’uso tradizionale di due cori a 4 voci, in uno stile prevalentemente accordale, l’alternanza tra coro e due voci soliste di cui una dedita all’esecuzione del canto fermo – ovvero la melodia originaria del corale da cui è tratta la composizione –, infine il puro contrappunto con canoni a tre voci, retaggio della tradizione polifonica cinquecentesca: un percorso musicale in cui i piú differenti mezzi e tecniche musicali vengono messe a frutto ad majorem dei gloriam. Ottimi i dieci cantanti del gruppo Vox Luminis, supportato musicalmente da un basso continuo costituito dal basso di viola, dal fagotto e, ovviamente, dall’organo. La direzione di Lionel Meunier è pacata, solenne ma anche capace di brio e vivacità quando il DICEMBRE MEDIOEVO contesto musicale lo consente. Un’ottima esecuzione che rende giustizia a un autore scarsamente frequentato. Musica per il primate di Polonia Spostandoci in Polonia, la seconda registrazione ci introduce a un’altra figura decisamente significativa quanto poco conosciuta, Mikolaj Zielenski, a cui la Dux ha dedicato una selezione tratta dagli Offertoria et communiones totius anni, 1611 (DUX 0681, 1 CD, distr. Jupiter). Unica sua opera conosciuta, o perlomeno superstite, fu stampata nel 1611 a Venezia presso il famoso Vincenti, con il patrocinio di Wojciech Baranowski (vescovo di Przemysl eletto in seguito arcivescovo di Gniezno e primate di Polonia), per il quale Zielenski fu organista e maestro di cappella. In realtà, pochi o nulli sono i dati biografici conosciuti che lo riguardano. Resta anche il dubbio se abbia soggiornato in Italia dove avrebbe eventualmente acquisito una formazione musicale, la cui influenza si evince chiaramente nelle musiche qui registrate. La grande opera a stampa da cui è tratta questa antologia, composta di due volumi divisi tra Offertori, Comuni e tre brani strumentali, lascerebbe pensare che si tratti di un’opera omnia dell’autore anche se, la distruzione del palazzo del primate di Polonia a Lowicz, potrebbe aver causato la perdita di altre sue fonti manoscritte mai andate in stampa. Come già constatato nella produzione luterana di Scheidt, anche Zielenski mostra una forte vicinanza stilistica alla policoralità veneziana dei fratelli Gabrieli, assurti quasi a modello di ispirazione per la produzione a piú cori da tanti compositori a partire della seconda metà del XVI secolo. La produzione policorale contraddistingue in particolare gli Offertoria, i cui brani a 7/8 voci sono tutti giocati sui contrasti dinamici, con effetti coloristici sempre vari e mutevoli e, soprattutto, sull’alternante utilizzo di passaggi omofonico-accordali ad altri in puro stile imitativo. Alle voci si aggiungono anche gli strumenti (organo e tromboni) che, in questo caso, duplicano le linee vocali, amplificando notevolmente gli effetti sonori. Di natura piú intimistica sono invece le Communiones, scritte per ensemble da 1 a 6 voci e basso continuo. Qui è palese l’influenza del mottetto solistico che aveva preso piede nella produzione musicale italiana dalla fine del XVI secolo. La delicata voce solista di Emma Kirkby, una delle piú grandi interpreti della musica cinque-seicentesca, si trova a suo perfetto agio in questo repertorio in cui alla purezza di emissione viene richiesta una certa agilità nell’esecuzione degli abbellimenti, prerogative sapientemente affrontate dal soprano inglese. Apprezzabile anche l’esecuzione del gruppo vocalestrumentale polacco Capella Cracoviensis diretto da Stanislaw Galonski. F. B. Vitalità dell’antico MUSICA · L’Inghilterra è uno dei Paesi che maggiormente rinnova la tradizione musicale del passato. Come dimostrano la rilettura di una famosa Messa del XV secolo e un’analoga composizione moderna, che affonda le sue radici nella lezione medievale MEDIOEVO DICEMBRE n’opera che nella vasta produzione quattrocentesca inglese si contraddistingue per bellezza e singolarità è la Missa Caput, un’anonima Messa polifonica a 4 voci, della prima metà del XV secolo, riproposta dall’ensemble The Gothic Voices per l’etichetta Helíos nella registrazione Missa Caput and the story of the Salve Regina (CDH 55284, 1 CD, distr. www.soundandmusic.com). La presenza di questa Messa in ben sette fonti manoscritte dimostra il successo che essa incontrò nel corso del XV secolo, tanto da rappresentare un modello compositivo per musicisti del calibro di Ockeghem e Obrecht, U 129 CALEIDO SCOPIO due tra i rappresentanti piú significativi della scuola polifonica fiamminga. Una delle peculiarità della Missa, che si sviluppa secondo la canonica suddivisione delle cinque sezioni del Proprium, è l’inserimento all’interno del primo brano, il Kyrie eleison, di una prosula, cioè di un testo alternativo a commento/enfasi del messaggio liturgico principale, secondo una prassi in realtà molto diffusa nei secoli precedenti. Il testo sostitutivo è tratto dal Deus creator omnium, un atto di ringraziamento che ben si addice dal punto di vista del contenuto come sostituto del Kyrie; al contrario, i restanti brani riportano fedelmente i testi liturgici previsti per la Messa. L’opera è resa particolarmente attraente dalla squisitezza e dalla fluidità delle linee melodiche acute, che si svolgono animatamente sul supporto piú statico delle voci inferiori, le quali, al contrario, si snodano su valori lunghi, tanto da costituire una sorta di supporto armonico. Al movimento contrappuntistico puro, con andamento che spesso ricorda da vicino la polifonia trecentesca, l’anonimo autore indugia spesso anche su un trattamento accordale delle voci, un fatto di certo innovativo rispetto a una piú astratta scrittura basata sul punctum contra punctum, secondo rigide regole dettate per l’appunto dal contrappunto. L’interpretazione delle Gothic Voices è, come sempre, asciutta e pulita, ed è diretta con cura da Christopher Page. Una maggiore libertà interpretativa si riscontra nei popolareggianti Carols che completano l’antologia, alcuni dei quali eseguiti dai soli liuti. Una tradizione costantemente rinnovata All’ambito musicale sacro inglese appartiene anche Choral Music by Jonathan Dove (CDA 67768, 1 CD, distr. www.soundandmusic.com), registrazione dedicata a Jonathan Dove, un compositore vivente il cui linguaggio affonda le sue radici nella tradizione polifonico-corale. Molto felice risultano la scelta dei 130 brani e, soprattutto, la loro disposizione, che permette di mettere a confronto e valorizzare le idee musicali e lo stile di Dove. Notevole è il brano di apertura, Bless the Lord – che riprende alcuni versi del Salmo 104 –, in cui il tono esuberante dell’organo e degli interventi corali contrasta con l’atmosfera intimista della Missa Brevis che segue e che si ravvicina maggiormente alla polifonia antica. I restanti brani, anch’essi d’ispirazione sacra e per la maggior parte su testo inglese, sono giocati su un lessico moderno, ricco in dissonanze ed effetti suggestivi, a volte influenzato dallo stile minimalista, ma con una forte tendenza verso il tradizionale linguaggio tonale. Interessanti sia i brani a cappella, sia quelli che includono l’accompagnamento organistico; in questi ultimi Dove dà vita a combinazioni e soluzioni tra le piú ricercate della sua produzione vocale; come d’altronde interessanti sono brani quali The Three Kings, nel quale intervengono passaggi affidati alle voci soliste, intercalati a vibranti passaggi. Non mancano richiami all’onomatopeica, tipica di tanta produzione madrigalistica rinascimentale, come nel caso del Run sheperds, run!, la cui concitata ripetizione testuale crea l’effetto di uno strepitio di passi veloci. La produzione corale di Dove mostra come sia fortemente presente, vissuta e amata, soprattutto nella società anglosassone, la cultura musicale e in particolare quella corale, frutto di una lunga tradizione che, dall’antica pratica della musica da chiesa, si è diffusa sino ai giorni nostri, costituendo tuttora un proficuo campo d’azione per molti compositori contemporanei. Autore versatile, dedito anche a molti altri generi musicali, Jonathan Dove brilla particolarmente in questi brani organistico-corali, che risultano consoni al suo modo di pensare e fare musica. L’interpretazione del Wells Chathedral Choir, che vanta ben 1101 anni di storia, non delude le aspettative, come anche l’esuberanza dell’organo che vede alle tastiere Jonathan Vaughn, sotto l’impeccabile direzione di Matthew Owens. F. B. DICEMBRE MEDIOEVO
Scarica