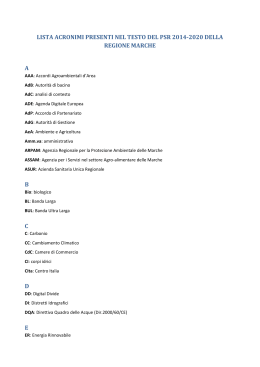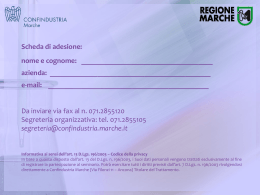1 Sommario Le Cento Città * Direttore Editoriale Mario Canti Comitato Editoriale Fabio Brisighelli Romano Folicaldi Natale G. Frega Giuseppe Oresti Giancarlo Polidori Direzione, redazione, amministrazione Associazione Le Cento Città [email protected] Direttore Responsabile Edoardo Danieli Prezzo a copia Euro 10,00 Abb. a tre numeri annui Euro 25,00 Spedizione in abb. post., 70%. - Filiale di Ancona Reg. del Tribunale di Ancona n. 20 del 10/7/1995 Stampa Errebi Grafiche Ripesi Falconara M.ma Periodico quadrimestrale de Le Cento Città, Associazione per le Marche Sede, Piazza del Senato 9, 60121 Ancona. Tel. 071/2070443, fax 071/205955 [email protected] www.lecentocitta.it * Hanno collaborato a questo numero: MarioCanti,SilviaCecchi,AdrianoCiaffi, Luca Maria Cristini, Giovanni Danieli, Romano Folicaldi, Alfredo Luzi, Giorgio Mangani,CinziaMaroni,AlbertoPellegrino 3Editoriale Ricordo di Enrico Paciaroni di Giovanni Danieli 5Primo Piano L’atleta confiscato di Silvia Cecchi Convegno Padrò e Contadì 9 La terra, tra storia, politica e immaginario di Cinzia Maroni 11 Mezzadria, strumento e fine di Adriano Ciaffi 16 L’addioall’agricolturaelatrasformazionedelpaesaggio di Mario Canti 20 Marche, il giardino fiorito di Giorgio Mangani 25 Portfolio Il mondo fotografico di Adriana Argalia di Alberto Pellegrino 29 Arte LacittàdiAnconaeilMuseoOmerocelebranol’operadi Valeriano Trubbiani con una grande antologica di Luca Maria Cristini 32 Scienza e letteratura Unoscienziatoallospecchio.RenzoTomatiseillaboratorio Bovino di Alfredo Luzi 37 Libri ed Eventi di Alberto Pellegrino 45 Vita dell’Associazione di Giovanni Danieli In copertina Le sorgenti del Nera. Foto Canti Le Cento Città, n. 48 TVS è fermamente convinta dell’importanza di saper riconoscere la bellezza in tutte le sue forme. Per questo, da sempre è impegnata nella produzione di articoli per la cottura che si distinguono per design e funzionalità. Ma l’amore per il bello di TVS si esprime anche nella collezione di opere d’arte, che conta opere di pregio realizzate dai più importanti autori del periodo dal XIV secolo al XIX secolo. L’opera qui presentata ne è solo un esempio. Floriano Bodini, Cavallo e Nudo di donna (Gemonio di Varese 1933 - Milano 2005) www.tvs-spa.it | TVS Spa_Via Galileo Galilei, 2_ Fermignano (PU) Italy AD Amore per il bello, passione per l’utile. Editoriale 3 Ricordo di Enrico Paciaroni di Giovanni Danieli sue numerose iniziative, nessuno di noi ha dimenticato il forum, alle Muse, su La musica nelle Marche, il sistema che non c’è, primo di una serie di incontri sul tema, o i numerosi dibattiti su La Sanità che cambia o il convegno Ambrosetti su La città dei creativi, realizzato con Catervo Cangiotti, convegno che aveva raccolto in rettorato molti dei più prestigiosi capitani d’industria della regione. Poco prima di Natale Enrico Paciaroni ci ha lasciato; il ritorno inaspettato di una malattia che aveva già incontrato e con grande forza di volontà superato, lo ha sottratto definitivamente all’affetto dei familiari, degli allievi e dei suoi tanti amici. Medico, cardiologo, geriatra, era stato il principale artefice, l’anima scientifica, l’animatore culturale di quell’incredibile processo che doveva portare, anno dopo anno, un ospizio per anziani disabili a diventare un centro di ricerca e di cura nel campo geriatrico, punto di riferimento e di coordinamento nazionale. Giunto al pensionamento, aveva continuato instancabile la sua attività di medico e di ricercatore, di promotore di eventi culturali; Il Prof. Enrico Paciaroni. aveva scoperta la felicità di scrivere e negli ultimi Amava il teatro, ed in partitre anni aveva prodotto due vo- colare quello della sua città, Le lumi, uno sulla storia dell’Inrca, Muse, che tuttavia non perceche solo lui poteva scrivere così piva come un’isola felice, ma bene perché solo lui l’aveva così come nodo di una rete regionale intensamente e completamente vissuta, ed uno sulla longevità che avrebbe assicurato a tutti, attiva, nel quale aveva riversato attraverso un miglior utilizzo tutta la sua esperienza e cono- delle risorse disponibili, visibiscenza dei processi di invecchia- lità e attrazione; era Presidente mento e dei comportamenti da degli Amici delle Muse ed anche seguire per restare attivi malgra- in questo ruolo aveva profuso creatività, generosità, genuino do gli anni. entusiasmo. Persona dotata di grande senDella nostra Associazione so civico, interpretava la propria vita come un servizio reso per era stato Presidente negli anni contribuire a risolvere i proble- 2005-2006, realizzando un programma di ampio respiro; tra le mi del territorio. Le Cento Città, n. 48 Dopo il periodo di presidenza, Enrico aveva continuato ad essere sempre attivo nella vita dell’associazione, portando il suo genuino entusiasmo, la freschezza delle sue idee, il suo fervore innovativo; questo anche quando la malattia ne aveva fiaccato il fisico, non certo la progettualità. La sua natura era gentile, affabili i suoi modi, vivo e profondo il suo amore per la medicina, intensa la sua partecipazione alle vicende regionali; non aveva sovrastrutture, era quello che appariva, un uomo ricco di cultura e di entusiasmo, assai legato a moglie e figlie, alle quali ora mancherà moltissimo. Non omnis moriar, aveva scritto Orazio, multaque pars mei vitabit Libitinam: così Enrico non se ne è andato del tutto, molta parte di lui, il suo spirito, è presente tra noi. Silvia Cecchi 4 L’Atleta di Fano attribuito a Lisippo. Le Cento Città, n. 48 Primo piano 5 L’atleta confiscato di Silvia Cecchi La statua attribuita a Lisippo è divenuta italiana per effetto di meccanismi acquisitivi (taluno semplice, altri più complessi) ampiamente dibattuti e avallati da due conformi ordinanze emesse da due diversi Giudici pesaresi (ordinanze 10.2.2010 e 3.5.2012), le quali, accertata la proprietà statuale sul bene, ne dispongono la confisca. La questione dell’‘italianità’del bronzo, contestata a oltranza (attualmente mediante ricorso per Cassazione contro l’ordinanza) dall’attuale detentore (il Paul Getty Trust), presenta dunque un profilo eminentemente giuridico. Come è noto, contemporaneamente alla vicenda dell’esportazione illecita e per le stesse finalità, la statua subì un periodo di clandestinità che va dai sei agli otto anni, dapprima in Italia, in condizioni tali da comprometterne l’integrità di conservazione, ed quindi una (prima) serie di interventi selvaggi di disincrostazione e ‘restauro’ all’estero (in Germania) che le hanno procurato danni gravi, indelebili e irreversibili (né emendati dagli interventi della seconda fase di trattamento): vulnus ampiamente riconosciuto dagli esperti dello stesso museo californiano che acquisì la statua nell’agosto del 1977 dal restauratore-venditore tedesco. Tali danni sono gli effetti di danno ‘secondario’ rispetto alle condotte contestate nel procedimento penale da poco concluso, e l’oggetto diretto e ‘primario’ di altro procedimento penale tuttora pendente presso l’Ufficio della Procura di Pesaro (il reato in questo caso è di natura permanente e come tale imprescrittibile): giacché non vi è dubbio che simili danni sarebbero ben stati impediti dagli organi pubblici italiani preposti alla conservazione e restauro dei beni artistici e del patrimonio arche- Il Pm Silvia Cecchi. ologico, ove il bene non fosse stato sottratto illecitamente alla loro competenza: la circostanza assume un rilievo indiscutibile, di fronte a qualunque obiezione contraria, non solo nel nome del rispetto dovuto alle istituzioni, ma per chiunque condivida comuni sentimenti di responsabilità (di tutela, cura) riguardo ai beni archeologici o di valore artistico. La risonanza della vertenza giudiziaria è stata assai grande, come è noto, e ha suscitato un dibattito tra i sostenitori del ritorno della statua nell’ambiente da cui storicamente proviene e i sostenitori di una indifferenza per il sito (sia pure remoto ed eccentrico) in cui un’opera d’arte finisca per ‘stabilizzarsi’ all’esito di peripezie dettate da illeciti traffici e da condotte censurate dal diritto penale nazionale ed internazionale: indifferenza giustificata nel nome di un quid ‘assoluto’che renderebbe l’opera d’arte per così dire ‘ubiqua’ e affrancata da vincoli di contesto. A questi soli aspetti (culturali ed etici insieme) dedico qui alcune brevi riflessioni, avendo già avvertito che in nessun caso esse potrebbero oscurare il primato giuridico che compete alla vicenda. Le Cento Città, n. 48 1 - Nella relazione inviata al Governo italiano nel 2006 da parte della Direzione del Getty Museum (e poi più volte, successivamente) si sostiene intanto la tesi del ‘legame tenue’ tra la statua e il nostro Paese, con evidente riferimento, per antitesi, al criterio del ‘legame rilevante’ menzionato nella Convenzione Unesco del 2001. Si obiettò in quella circostanza, e già più volte in precedenza, che la statua è di indubbia origine greca e che l’Italia non può rivendicare di essa né un’origine italica o vetero-romana, né l’esistenza di un sito archeologico inscritto con sicurezza nel proprio ambito territoriale. Ma intanto è certo che il collegamento tra la statua e l’Italia non deriva da scavo abusivo o furto in terra greca, non da un bottino di guerra né da un saccheggio, giacché è necessario comunque distinguere, in fatto di trasferimento e provenienza di beni, tra canali commerciali legali e bottini bellici, tra requisizioni di Imperi o di Stati invasori-occupanti e regolari transazioni intercorse tra soggetti privati o pubblici, tra canali neri ed eventi storici in senso lato. Nel nostro caso per vero non sappiamo con certezza neppure quale fosse la direzione della rotta della nave che trasportava la statua di bronzo prima del naufragio, se dalla Grecia all’Italia o viceversa (la seconda ipotesi oggi sembra guadagnare maggiori consensi), né sappiamo con certezza se si tratti davvero di un originale (tesi peraltro assolutamente prevalente) ovvero di copia romana di statua greca. Sappiamo che era consuetudine nel periodo del tardo impero portare in esposizione di luogo in luogo esemplari di particolare pregio di statue greche a guisa di modello da imitare, in varie località dell’Impero, a scopi di pedagogia etico-estetica, Silvia Cecchi 6 Il peschereccio fanese su cui fu imbarcato il Lisippo. per dire così. D’altronde grande fu la notorietà che la statua ebbe nell’antichità (addirittura esiste una copia conservata al museo archeologico di Costantinopoli): ciò che rende ancor più plausibile la congettura che essa abbia svolto il ruolo di modello itinerante in varie località dell’Impero, per la sua straordinaria bellezza: quella levità della figura in rotazione, quel peso ed energia concentrati su un lato della figura ove è una gamba a reggere l’intero peso del corpo e del braccio. Connubio commovente e straordinario tra finitezza ed immortalità, tra caducità dell’attimo e sopravvivenza della materia, sia pure còlti nella bellezza di un giovane corpo di uomo. Dobbiamo però presumere fondatamente che la statua sia stata oggetto di legittima committenza o di altra disposizione di trasferimento che la portò in Italia, ovvero che analoga disposizione ne abbia deliberato il ‘ritorno’ in Grecia o a Costantinopoli, e infine che in entrambi i casi sia naufragata a causa di tempesta marina o avaria della nave che la trasportava. Sappiamo in ogni caso con certezza che il trasferimento era in corso fra due località dell’Impero, in esso essendo ricompresi sia il luogo di destinazione quanto quello di provenienza. Poco più di un secolo dopo la morte di Lisippo, la Grecia, già ‘romana’, diviene governatorato e poi provincia romana: la Grecia era dunque tornata territorio romano, qualora si ritenga che la statua sia opera di discepoli di Lisippo e appartenga al c.d. periodo ellenistico, fin dal momento della sua creazione. D’altronde è pur sempre l’opera del tempo e della storia, così come la profondità della fusione tra civiltà, ad autorizzare espressioni quali ‘civiltà grecoromana’o civiltà ‘romano-bizantina’, e così via. Se così stanno le cose, conosciamo un solo ‘legame forte’: la civiltà greco-romana (ma quando giunse la statua in Italia per la prima volta? durante il primo impero o nella tarda antichità? in periodo bizantino o addirittura in età medievale?). Secondo le congetture più accreditate degli studiosi, la statua avrebbe goduto dunque di una permanenza in Italia variabile fra i due e i dodici secoli: ciò Le Cento Città, n. 48 che significa che “il naufragio è avvenuto quando la lezione (della statua di Lisippo) era così diffusa e radicata nella prassi figurativa (in terra italiana) da non potersi più smarrire”, come sostiene acutamente Paolo Moreno. In altre parole, secondo l’Autore, la lezione era così profondamente metabolizzata in terra italica che ne troviamo dimostrazione in talune pitture pompeiane, in lcune sculture medievali e rinascimentali, e addirittura in figure tratte dagli affreschi michelangioleschi. Non dovremmo allora più dubitare che lo Stato italiano sia davvero il soggetto culturalpolitico erede della civiltà di cui lo splendido esemplare bronzeo attribuito a Lisippo è figlio; in questa prospettiva, l’opera ci si presenta come elemento (chiave di volta, secondo i critici del’arte) di una millenaria e complessa genealogia procedente fino a noi, che di quella civiltà siamo senza dubbio gli eredi. Allora e per converso non vi è alcun dubbio – in ciò consta l’oggetto specifico della vicenda giudiziaria - che nessuna vicenda se non di tipo affaristico- criminale, poté condurre oltre ven- Primo piano ti secoli dopo quella statua sulle coste della California. 2- I pescatori fanesi si trovarono così di fronte ad una res inventa, conservata per quasi due millenni dagli abissi marini, dopo essere naufragata in corso di viaggio. La fortuna la perse e la fortuna la riportò alla luce. Il luogo del rinvenimento è stato individuato con una certa approssimazione ma è possibile asseverare che esso ricada in zona di acque internazionali, secondo la mappatura geo-giuridica delle ‘zone marine’ di cui alle convenzioni internazionali (Convenzioni Unesco - Montego-bay), in una fascia del mare Adriatico al largo di Pedaso, per modo che la nazionalizzazione del bene è l’effetto delle analizzate vicende giuridiche che concorrono univocamente verso tale conclusione. Si tratta certamente di un sito archeologico marino tuttora aperto ed in gran parte ancora inesplorato. Una sorta di sito archeologico ‘di fortuna’, nel senso anche di ‘fortuito’, sottomarino, che attende di essere ulteriormente indagato ed esplorato, ma che non smentisce affatto la pertinenza originaria della statua all’area italico-romana, giacché ogni ipotesi interpretativa sul punto converge sulla conclusione che il reperto non solo gravitava in tale area, ma, fino a prova contraria, vi gravitava e vi si muoveva ‘legalmente’. È dunque in questa area che la statua può essere capita (dirò meglio: può continuare ad essere capita, dato che a tutt’oggi non è completata la sua disamina storica, archeologica ed estetica) e studiata, contestualizzata, comparata e goduta. D’altronde il luogo di un naufragio è spesso l’unica traccia e prova di un itinerario storico interrotto, altrimenti destinato all’oblio. Per questo esso appartiene alla storia. Ben sappiamo quante volte le civiltà abbiano fatto di un approdo di fortuna, di un ‘provvidenziale’ naufragio, il luogo leggendario delle proprie origini, e vi abbiano imbastito il proprio mito di fondazione: è 7 accaduto al grandi città- civiltà (a Roma stessa) come a cittàsantuario sorte dall’approdo fortunoso di una reliquia, dallo sbarco di un santo scampato a peggior fine. Combinazione di storia e destino, d’immaginario e di leggendario, che così spesso alla storia si mescolano: nel nostro caso luogo di eventi storici documentati e ulteriormente documentabili. 3- Ognuno sa quanto l’espressione artistica in generale abbia a che vedere con i dati paesaggistici, con le forme di natura, con gli altri segni dell’uomo e i rispettivi reciproci rinvii (ben sappiamo che non vi sarebbe Raffaello senza la soave dolcezza delle colline urbinati, né Mantegna, Piero o Leonardo senza i metafisici sfondi umbro-toscani, né Vermeer senza il borghese interno borghese-fiammingo, né la Venere di Cranach senza l’allegorismo metafisico germanico, né il fondo-oro di Giotto senza il mistico paesaggio umbro e senza i segni contigui dell’influsso bizantino; si potrebbe proseguire senza fine). Allo stesso proposito, mi viene spontaneo aggiungere quanto scrisse il celebre ‘positivista’ francese Hyppolite Taine: “Anche l’opera d’arte, come i mari, i fiumi, i laghi, si colora del cielo che riflette”: l’affermazione piacque ad Alberto Savinio che così la commenta “sono gli elementi ambientali che finiscono per fare corpo con l’opera d’arte pur restandole esterni”. Meno intuitivo forse è immaginare che anche l’intelligenza di un’opera d’arte, dalla parte di chi la guarda e intenda recuperare il senso di quelle stesse relazioni, implica di veder conservati i medesimi legami con l’ambiente. Nella recisione dei segni contestuali, delle misure e proporzioni reciproche fra un’opera e quanto l’opera circonda, nella recisione della storicità delle tracce del prima e dell’ora, è il vulnus della decontestualizzazione. La lettura integrata, congiunta degli elementi interni ed esterni dell’opera è quel senso intero che l’opera è capace di reLe Cento Città, n. 48 stituire all’osservatore che sappia leggerlo. Ciò è vero per ogni oggetto d’arte. Massimamente però ciò è vero per una statua che, per destinazione e proporzioni, era sicuramente destinata, come nel nostro caso, ad una collocazione in externo, e per di più tendenzialmente fissa: circostanza che impone riflessioni diverse da quelle che competono al rapporto fra un quadro, per esempio, ed il suo ambiente. Che un’opera d’arte muti di fuori del suo ambiente d’origine ben sapeva anche Cicerone, quando rifletteva su come una statua greca già a Roma mutasse di bellezza e di significato (“le statue greche una volta portate a Roma non sono più le stesse”). Se tale perdita oggi si è in un certo senso attenuata, per effetto della dilatata prospettiva storica, nella comparazione tra bene in Grecia e bene in Roma, quello ‘spaesamento’ che già avvertiva Cicerone, siamo però ben in grado di coglierlo noi tra mondo greco-romano e California: e d’altra parte il tema di un’appartenenza culturale, eventualmente condivisa, di quest’opera tra Stato italiano e Stato greco, è aspetto che potrà essere rivalutato, a tempo debito, e ciò a riprova, ancora una volta, che non si tratta di difendere pregiudizi ‘patriottici’ o di campanile, bensì ragioni di diritto e riflessioni implicate nell’intelligenza di un’opera d’arte. Non possiamo non credere che a Malibu si perda irrimediabilmente ogni riferimento, in assenza di qualsiasi modulo esterno di confronto: non una scala di beni contemporanei o prossimi nel tempo, non una stratificazione di testimonianze oggettive storicamente collegabili all’opera, non un universo segnico di contorno e di riferimento che siano in grado di posizionare il bronzo e darne la sua vera misura artistica, senza la quale va perduto proprio quell’ideale umano che la statua esprime ed insegna. Lo sappiamo anche noi, che stupiamo della ‘piccola misura’ di una statua greca confrontata con la grande misura delle statue romane o rinascimentali italiane. Silvia Cecchi Nel momento in cui l’opera nasce e viene posta in un luogo, da quel momento inizia il suo colloquio ininterrotto con il mondo circostante, con l’insieme dei segni in cui è immersa. Vogliamo rivederla anche noi, fin dove possibile, proprio così come la videro con i propri occhi: l’artefice, il committente, i primi e i molti successivi ammiratori, i visitatori, i viandanti, gli oziosi, i viaggiatori, i sedenti. Vogliamo celebrare il rito dell’osservare e dell’ammirare: rito della memoria, della storia, della bellezza, dell’identificazione, della sublimazione. Davanti all’osservatore che voglia immedesimarsi con i suoi predecessori, l’opera avrà il potere di rimettere in vita un organismo vivente storico-culturale e l’universo di relazioni che gli appartiene: potere della forma formante e della fitta rete ‘magica’ dei rinvii che l’oggetto d’arte tesse e l’ambiente conserva (tanto quanto il reato li spezza una volta per sempre, finché non sia riparata l’offesa). 4- Non altro è il senso profondo dei codici deontologici museali e trasfusi nelle convenzioni internazionali, se non quello di impedire che un museo sia ricettacolo di fatti di speculazione finanziaria e di malaffare, l’asilo dato a criminali comuni, anziché il risultato e il vertice di un’operazione culturale. Taluno vorrebbe concedere all’Italia (il Paese fra tutti che più ha fatto le spese delle logiche speculative ed affaristiche dei sodalizi criminali specializzati nel settore) un premio di consolazione: le opere d’arte italiane sono pur un ottimo ‘biglietto da visita’ dell’Italia all’estero. Riflessione piuttosto spicciola e stretta. Prendiamo nondimeno l’argomento per quello che è, pur nel suo modesto pregio: ebbene, non vi è dubbio che la ben nota e invalsa politica degli imprestiti, delle mostre itineranti, delle esposizioni ‘tematiche’ organizzate nelle sedi più disparate del globo, sarebbero state (e sono) il mezzo più adeguato e sufficiente al medesimo scopo, 8 senza alcun bisogno di colludere col (o plaudire al) crimine, nella specie con il contrabbando, l’esportazione illecita delle opere d’arte, la ricettazione, le associazioni per delinquere costituite agli stessi fini, con il reato di interventi abusivi in spregio e a sfregio delle opere dì’arte, condotte la cui mira, come ognuno ben sa, è solo quella di conseguire il maggior lucro possibile e non certo quello a diffondere biglietti da visita dell’arte italiana, anche a costo di danneggiare irreparabilmente (o spezzare nel maggior numero di frammenti autonomamente vendibili) manufatti di inestimabile valore. Vi è da temere d’altra parte che il Grand Tour ricordato da alcuni pubblicisti d’oggi e di cui l’Italia può vantarsi ancor oggi di essere mèta, resterebbe in pochi anni vanificato dalla massiccia evacuazione di opere d’arte avvenuta con il ritmo intensificato degli ultimi decenni e che può anche valersi dell’irresponsabile apologia che si è letta recentemente in alcuni articoli di giornale. Né il prestigio artistico dell’Italia sarebbe mai minorato da un’ampia diffusione di ottime copie, di cui sono ricchi i migliori musei d’Oltralpe e di tutto il mondo. 4bis- Si è molte volte ricordato, nelle sedi in cui il discorso è caduto su questo tema, che difendere la conservazione di un’opera d’arte nei siti di provenienza o di altra appartenenza vuol dire difendere l’identità di un luogo e l’identità culturale e civica della collettività che lo abita: ciò postula l’ampio enunciato dell’art. 9 della Costituzione italiana. La dichiarazione è potente e autoevidente, ma qualche parola dobbiamo pur aggiungere perché ne sia meglio inteso il senso, solo apparentemente semplice. L’identità, declinata in questo caso come consapevolezza di appartenere ad un luogo e come benessere di riconoscersi in esso, è un sentimento che deve molto agli elementi dell’ambiente e soprattutto agli oggetti d’arte che lo abitano e simbolicamente lo Le Cento Città, n. 48 esprimono. L’identità è un’entità dialogica, come il bello estetico. Entrambe richiedono un certo grado di libertà nei collocutori, entrambe esigono la dignità di ciascuno, del soggetto come dell’oggetto: ma la cattività di una statua trafugata è nemica del delicato colloquio che essa instaura tra soggetto ed oggetto. L’offesa (e più che mai l’‘offesa penale’) è sempre nemica del dialogo identitario ed estetico. Importa aggiungere che, tra gli altri compiti, il diritto ha anche il quello assai nobile di restituire dignità a persone e cose. 5-Una parola infine va spesa circa la nozione di “patrimonio dell’umanità” così spesso invocata ma sulla quale non ci si intende bene. Giustamente è stato a questo proposito citato (da Fabio Isman) il grande Quatremère de Quincy, (17551849) laddove il filosofo afferma che un’opera d’arte deriva la sua universalità dal radicamento nelle condizioni originarie. Profonda intuizione di un connubio tra universalità e particolarità, che è il segreto dell’opera d’arte nel suo momento genetico, nel momento del suo linguaggio espressivo (la sua ‘poetica’) e infine nel momento della sua fruizione estetica. Non vi è alcuna antinomia tra i due termini: in quanto patrimonio dell’umanità, tutti hanno l’interesse e il dovere di tutelare il significato dell’opera salvaguardandone le sue radici storico-culturali, all’interno del relativo ambiente. Superfluo aggiungere che il principio di una globalizzazione culturale non significa affatto una perdita di un’identità e di una radice, bensì contiene l’idea di una interconnessione tra identità e realtà culturalmente definite. Un’importante lezione deve essere allora tratta da queste brevi considerazioni: la piena coincidenza tra le conclusioni a cui perviene la cultura giuridica e quelle a cui ci conducono i codici etici e culturali oggi universalmente condivisi. Convegno Padrò e Contadì 9 La terra, tra storia, politica e immaginario di Cinzia Maroni Il convegno Padrò e Contadì è stato organizzato da Le Cento Città che sono una “Associazione per le Marche”. Non poteva mancare allora un nostro contributo ad un fenomeno come quello della mezzadria che è stato uno degli elementi caratterizzanti la nostra regione. A 30 anni dall’abolizione del patto mezzadrile Le Cento Città hanno voluto offrire un contributo riteniamo “originale” all’analisi di questo fenomeno. Il convegno che si è svolto il mese scorso all’Università, organizzato da Annalisa Cegna, ci esime dall’affrontare i temi “classici” della mezzadria e della legge che l’ha abolita, e ci permette di concentrarci su di una serie di questioni particolari, magari meno visitate dalla storiografica ufficiale, ma che sono altrettanto importanti per capire il fenomeno. Il filmato che accompagna le relazioni è un documento che si riferisce al 1964, quando una legge cominciò a smantellare i patti mezzadrili. In esso sono perfettamente riconoscibili i protagonisti del nostro convegno: li padrò e li contadì dell’immaginario collettivo; i cattivi ed i buoni in lotta per la terra. Il rapporto tra queste due figure è stato molto più complesso e complicato e soprattutto “inscindibile” nel senso che i loro destini si sono intrecciati e, come vedremo, la fine della mezzadria ha realizzato un allontanamento di entrambi dal rapporto “diretto” con la terra. La prima cosa da dire e sulla quale tutti gli studiosi sono d’accordo è che la legge del 1982 di abolizione appunto della mezzadria, interveniva in una situazione nella quale “sostanzialmente” la mezzadria non c’era più. La maggior parte dei contadini si era già inurbata e si era da tempo interrotto il loro rapporto diretto e costante con l’attività agricola. Con la legge del 1982 Il tradizionale paesaggio marchigiano. Foto Canti. non si è avuta una inversione del rapporto tra padrò e contadì in quanto questi ultimi non rimasero sulla terra da “padroni”. Che è successo allora? Quali sono stati i veri obiettivi della legge del 1982? Se questa legge era di retroguardia, come dice Sergio Anselmi nel suo bellissimo saggio sulla Storia d’Italia Einaudi relativo alle Marche, cosa c’era dietro? È vero o no, come disse la Corte Costituzionale deliberando su tutta una serie di ricorsi presentati dai padrò (molti sono marchigiani) che accusavano la legge di costituire un vero e proprio “esproprio” delle loro Le Cento Città, n. 48 terre, che l’obiettivo era più che altro ‘politico’, anzi di politica economica, nel senso che venivano puniti i proprietari agrari assenteisti a favore di quei soggetti che invece la terra la lavoravano? Un intervento economico che distrusse la proprietà terriera e cambiò radicalmente anche il volto delle campagne in quanto i contadini “affittuari” se utilizzarono la terra “da padrò”, lo fecero per obiettivi molto diversi da quello di “dare la terra a chi la lavora”. Quindi la prima domanda è questa: dato che la mezzadria era bella che finita all’arrivo Cinzia Maroni della legge del 1982 cosa successe effettivamente nelle campagne con il passagg+io all’affitto? Come sono cambiate le coltivazioni e l’intero paesaggio agrario marchigiano? Questa una delle domande a cui cercheremo di dare risposta. La data del 1982 è solo una data “formale” dalla quale facciamo partire tutta una serie di avvenimenti che invece erano già da tempo presenti nella realtà delle nostre campagne. Era finito quel mondo “agreste”, quel mondo che non ritornerà più dopo la sconfitta dei cosiddetti “padrò”. Non era il patto mezzadrile quello che impediva lo sviluppo dell’agricoltura e la fine della mezzadria ha costituito una forma di ‘liberazione’ anche per i contadini dalla schiavitù della terra. Si era interrotto quel rapporto diretto ed esclusivo a cui li costringeva il patto agrario (se la famiglia mezzadrile voleva “campare” tutto il terreno doveva essere sfruttato e in tutte 10 le forme possibili e tutti i componenti la famiglia dovevano lavorare: da sole a sole tutti i giorni). Con la monetizzazione del rapporto i contadini cominciano ad organizzarsi in altra maniera, magari si associano per comprare i macchinari e sfruttare in maniera intensiva e monoculturale i terreni o lavorando solo part-time la terra. La casa colonica non è più l’abitazione principale ed esclusiva. Si costruiscono case civili vicino a quella o ci si trasferisce in città. Quali sono le conseguenze di questa sorta di “abbandono” delle campagne da parte dei contadini? Ecco un’altra questione centrale. Ne parlano l’on. Adriano Ciaffi che è stato uno dei firmatari di questa legge; l’architetto Mario Canti, studioso del paesaggio marchigiano e Giorgio Mangani, forse lo studioso più sottile ed originale, della cosiddetta “marchigianità”. Con la sua casa editrice e i suoi saggi è l’intellettuale che si è più occu- Le Cento Città, n. 48 pato di “fare le Marche”. Da sempre sostiene che le Marche sono l’Arcadia e quindi nessuno meglio di lui può raccontarci dei rapporti tra l’immagine dell’Arcadia e il paesaggio marchigiano. Era meglio quando era peggio? Certo che no. Le condizioni delle famiglie mezzadrili erano disumane ed era giusto liberare i contadini dal rapporto ‘osmotico’ con la terra. Era giusto quindi eliminare il peggio; ma il meglio? Con la mezzadria sono anche finiti gli “orti fioriti” del paesaggio marchigiano, la cura amorevole del terreno, l’organizzazione scientifica del suo sfruttamento, il regolare deflusso delle acque, la diversificazione delle culture, la scienza delle potature, insomma la grande cultura materiale agraria. Il peggio andava dunque eliminato ma il meglio per la nostra agricoltura non l’abbiamo ancora visto. Convegno Padrò e Contadì 11 Mezzadria, strumento e non fine di Adriano Ciaffi Io ringrazio l’Associazione Le Cento Città perché dopo trent’anni, 1982 e 2012, ci offre l’occasione di una riflessione su un grande fenomeno che ha caratterizzato la trasformazione, forse la più grande nella storia delle Marche e delle regioni italiane agricole; perché nel giro di una generazione è avvenuta una trasformazione enorme, sotto tutti gli aspetti; dalla società rurale si è passati alla società industriale e post-industriale, il tutto in sostanza in mezzo secolo. Se voi prendete un altro mezzo secolo dei millenni della nostra storia, al di là dei cambiamenti politici e di potere, sul piano della trasformazione individuale, culturale e socioeconomica, periodi così brevi e così rivoluzionari è difficile trovarli. Questo per inquadrare la mezzadria, la mezzadria è uno strumento e non un fine, è un contratto e quindi va vista in relazione a fenomeni più grandi di trasformazione economica, dentro cui vi era la società agricola prima e una società postagricola dopo. I contratti sono i legami che più hanno fatto forza in questo processo di trasformazione; secondo quali valori? È chiaro che i cambiamenti nella società hanno sempre dei momenti dialettici, hanno sempre dei momenti di polemica, a volte anche di rottura e quindi i processi, quelli veri, sono quelli riformistici, quelli graduali che maturano processi di trasformazione profonda e la trasformazione della mezzadria, come diceva la nostra Presidente, è uno di questi, non si è risolto con ius o iudicis o per ordine della legge, ma si è realizzato socialmente attraverso tanti fattori, però la politica ha governato queste trasformazioni. Direi che non è neanche un fenomeno dell’ultimo mezzo secolo del novecento, perché in fondo la fine dell’ottocento era caratterizzata con la nascita del movimento operaio, con il movimento agricolo-contadino, sia socialista, sia repubblicano, sia cattolico; le Marche erano rispetto a questo fenomeno un momento di crogiolo pluralistico di queste tendenze che hanno coinvolto, pochi lo sanno, ma anche l’agricoltura. Tutto il movimento murriano, si è caratterizzato popolarmente attraverso l’introduzione dell’associazionismo agricolo, delle università agricole, della cooperazione, fino a far diventare le Marche nel secondo dopoguerra, proprio attraverso le battaglie mezzadrili, la terza regione dopo Veneto, Emilia, come diffusione cooperativa; in specie quella agricola, perché ho ho ricordato l’Emilia, ma in sostanza il processo cooperativo dell’Emilia è fondato nell’associazione per la trasformazione salariale, mentre le Marche come la Toscana, regioni dov’era più diffusa la mezzadria puntano sulla trasformazione della stessa. Quindi questi processi di trasformazione verso una società non più rurale ma urbana, hanno incrociato il divenire dell’istituto mezzadrile, un istituto di progresso, nel senso che la mezzadria è l’origine del medaiage francese, che è poi la mezzadria portata in Italia dai cistercensi benedettini. Ogni nostra vallata fu trasformata da area paludosa in area fertile e agricola, più nei versante adriatico, ma anche in quello tirrenico; poi chi parlerà del paesaggio ci potrà dire qualcosa, attraverso appunto la trasformazione della servitù della gleba in contadini che in una certa misura come si è detto all’inizio partecipavano anche, si è detto in posizioni paritarie, ma la parità è solo nel nome, è solo nella divisione dei prodotti a metà, in realtà poi la direzione d’impresa restava all concedente, tanto che la figura del fattore Le Cento Città, n. 48 è una figura tipica nei rapporti di impresa, un nominato da chi possedeva la proprietà che a volte, senza essere assenteista, pur sempre stava in città e non poteva curare la direzione dell’impresa. Di conseguenza si affidava al il fattore, il che accomunava diversi incarichi e poi svolgeva tutto il rapporto produttivo e mercantile con l’esecuzione, non passiva naturalmente, del mezzadro. Tutte le battaglie di fine secolo, specie in Umbria e nelle Marche sulla mezzadria, leggete il bel volume di Radi sui mezzadri, riguardano il superamento di patti colonici superati, le onoranze agrarie cosiddette, o le corrisposte, le tante uova al mese, i capponi durante le feste, le verdure e così via, le onoranze agrarie che erano delle obbligazioni che si traducevano nel capitolato colonico, che fu sempre ammodernato, fino al capitolato del ’42, e che in sostanza è una forma che gli studiosi di diritto agrario ancora approfondiscono perché si era un po’ perfezionata, ma all’interno di un rapporto, di una cultura, di un tipo di società, ecco il punto. È nel dopoguerra che la controversia proprietari e contadini si fa conflittuale, ancor più di quando si era alla fine del secolo XX e diventa riforma solo per il latifondo; la riforma dei primi governi De Gasperi mise cultura nei nuovi suoli agricoli soprattutto nel sud, perché l’area mezzadrile non aveva latifondi, non tanto in senso tecnico perché le mezzadrie erano all’interno di una proprietà grande, ma erano organizzate autonomamente, ciascun fondo con un mezzadro,nell’Italia Centrale non vi era il latifondo che si era affermato soprattutto nelle regioni del sud. Quindi da noi questa fase sindacale aprì invece la fase sostanziale di trasformazione del contratto. Naturalmente a me ha incu- Adriano Ciaffi 12 Un orto nella campagna marchigiana. Foto Canti. riosito un po’ il padrone e il contadino perché in questa divisione c’è quasi una visione sociologica, non certo romanzata, dei rapporti un po’ di interdipendenza o di insubordinazione del mezzadro rispetto al proprietario; padrò e contadì già ha i sintomi di una caratteristica subesina, cioè Marche basse, perché se andiamo sopra la linea del fiume Esino già parleremmo di contadini e il padron, cioè non c’è la fine con la vocale accentuata, ma c’è la fine con la consonante, questo per dirvi che anche i dialetti si sono formati nel mondo contadino e paesano, non per nulla l’Europa parla di zona rurale, accomunando il piccolo paese e la mezzadria. Ecco approfitto per evidenziare una caratteristica della mezzadria che è quella del rapporto, quasi curtense, fra la produzione e il mercato, il mercato di paese. Quindi, la conformazione degli insediamenti, nonostante le mura che li cingevano e l’essere posti in cima alle colline, in realtà aveva una comunica- zione con la campagna, oltre la pieve, perché i prodotti della campagna venivano in città e la direzione dei campi proveniva dalla città. È questo il quadro di riferimento, allora noi dobbiamo prendere due estremi, due estremi e direi che queste nostre Marche ovviamente come altre regioni, ma forse più delle altre regioni, perché il discorso della caratteristica mezzadrile delle Marche è un discorso da approfondire, anche quando c’è una mezzadria classica che è quella che abbiamo visto in questo film che è un filmato del dopoguerra; in relazione ad un contratto di mezzadria che la legge del 1964 sui contratti agrari, la 756, stabiliva per motivi economici e sociali, valori costituzionali inadeguati e senza tutela giuridica i contratti di mezzadria. E si apre appunto quella tematica un po’ controversa esposta nel film fra chi dice: ‘ma chi l’ha detto, si può sempre fare’, mancava la tutela giuridica con la legge del ‘64. Quali erano Le Cento Città, n. 48 gli sbocchi? Gli sbocchi allora, i pioli del progresso contadino erano prima della proprietà, si partiva dal salariato che nel mondo mezzadrile non era un contratto evoluto, era ancora un contratto di dipendenza rispetto alla mezzadria che veniva ritenuta superiore perché c’era una sorta di compartecipazione almeno sulla divisione degli utili, per capirci del prodotto, anche se non della direzione d’impresa, anche perché non era impresa a volte, perché il più delle volte la proprietà era proprietaria del reddito ma non imprenditrice ;e questa sarà una ragione delle deroghe alla trasformazione quando il proprietario è imprenditore e va a coltivarla direttamente. Poi si è passati alla legge n. 11 dell’affitto che è quella che ha trasformato questo atto, un po’ giovanile che io feci nel 1969, poi trasformata in una proposta di legge del ’70 di trasformare su richiesta il contratto di mezzadria in affitto. L’affitto era il secondo piolo Padrò e Contadì dopo il salariato e il terzo era la proprietà contadina e il quarto era le proprietà contadina associata e la cooperazione. Questi filoni prima che nella legge erano in sviluppo sul piano pratico dell’associazionismo, i contadini erano ancora un soggetto politico, oggi non sono più né un soggetto politico, né culturale, perché il processo di integrazione urbana ha trasformato, ha normalizzato, diciamo così, le diverse culture, mentre la cultura contadina era una cultura, se non la vogliamo considerare subalterna, certo era una cultura diversa da quella urbana, questo è importante. Quando è scomparsa questa cultura subalterna è divenuta importante la memoria e qui divengono importanti’ gli approfondimenti che adesso a distanza si fanno per vedere di salvare questa cultura, che non è solo una cultura di folklore, ma è una cultura profonda, anche economica. Appunto dicevo dagli Spadoni, campagne e campagnoli, questa biblioteca intitolata agli Spadoni, a Bruno Ciaffi, volto agricolo delle Marche, quindi la tecnicità anche dell’organizzazione aziendale, pensate alla casa colonica, pensate alla rotazione delle culture, fino ai laghetti artificiali, fino all’introduzione delle colture specializzate, pensate il ciclo della barbabietola, siamo arrivati ad essere il secondo produttore nazionale, superando anche il Veneto, quando il Veneto cambiava la coltura della bietola in pianura con il granoturco, noi scoprivamo che la gradazione della barbabietola poteva venire anche meglio, anche se era più piccola, più ridotta come peso, nella zona collinare. Sono tutti questi contributi scientifici o tecnici del processo culturale che hanno diradato il panorama delle nostre campagne perché l’introduzione della meccanizzazione ha tagliato tutta la piantagione, quindi è cambiato l’ambiente, diciamo così il paesaggio agricolo, pur tuttavia ha conservato, specie in una zona collinare, come è quel- 13 la marchigiana rispetto a quella veneta dominante o a quella emiliana, una caratteristica tutta sua. Concludo dicendo che dopo che ho dichiarato nullo questo contratto vi è una seconda legge, quella dell’affitto, che ha un po’ esasperato la polemica tra mezzadri e proprietari perché il canone era un canone insufficiente e inadeguato per la limitazione del diritto del proprietario, tanto che la Corte Costituzionale è intervenuta censurando la legge n. 11 e siamo appunto al ‘71 quando già la proposta di legge stava andando avanti, ma poi movimenti anche contrapposti l’hanno un po’ bloccata con manifestazioni sulle piazze, con simulacri di noi protagonisti bruciati sulle piazze, lancio di uova, ecc., una sorta di provinciale, diciamo così, contrasto ma molto profondo perché era in fondo era difficile trovare un professionista o una famiglia borghese della città che non avesse il terrenuccio a mezzadria e viceversa non era facile trovare nelle campagne una mezzadria, però questo fenomeno, al di là di queste leggi, fino ad arrivare al 1982, ecco dal 1960 al 1980 si è sviluppato fino ad arrivare dal 60% di addetti all’agricoltura al 3,5 dell’attuale censimento ancora in corso. Quindi capite che trasformazione, stiamo parlando di 100.000 aziende di cui la mezzadria in fondo aveva solo 1/3, gli altri 2/3 erano di proprieta diretto coltivatrice, la maggior parte a conduzione salariale, per esempio, io mi riferisco alle Marche, intanto siamo ad una superficie, ed ad un numero di contratti superiori a quelli della Toscana, che è rimasta con la fattoria, con la mezzadria classica. L’industrializzazione dell’Emilia e della Toscana, anche nelle province più mezzadrili come Arezzo, Siena, ecc. è precedente agli anni ’50, le Marche hanno avuto una trasformazione più diluita e successiva al processo di trasformazione della mezzadria in queste regioni più pianeggianti. Noi avevamo nel censimento Le Cento Città, n. 48 del ‘70-’71, trentunomila aziende appoderate a mezzadria, a fronte di 61.000, quindi 2/3 di aziende proprietarie, già dieci anni dopo, nel 1981 questa percentuale era diminuita al 7,4% di aziende rispetto all’11% della mezzadria, come superficie, al numero di aziende al 38, ecc., quindi la mezzadria è rimasta con una molteplicità di aziende numerose, ma sempre di meno delle coltivatrici dirette che sono andate sempre aumentando, anche se la dimensione degli 8 ettari dell’azienda mezzadrile è doppia, come media naturalmente, alla dimensione di 4 ettari della mezzadria. Ecco che si arriva a questa legge di cui celebriamo i trenta anni, che questa eredità giacente della legge del ‘64 di contratti non più tutelati dalla legge, dice: chi vuole faccia la domanda e trasforma in affitto, che nel frattempo si era trasformato con un canone, tra l’altro aggiornabile presso l’Ispettorato dell’Agricoltura con la rappresentanza delle parti ogni volta che ci fossero processi di svalutazione o il limite dei prezzi medi dovesse oscillare. Quindi a quel tempo, nel 1982, già eravamo ad un 10-15% di addetti all’agricoltura, quindi immaginate la mezzadria che cosa era rimasto, così è finita la mezzadria per trasformazione, naturalmente ci sono degli esempi interessanti, se ci fosse stato Massi, e concludo con un saluto e un augurio all’amico Massi, perché quando stava alla Commissione Agricoltura si fece questa grande fondazione, la Fondazione Bandini e Roberto Massi è stato il rappresentante, quindi è permanente la sua rappresentanza, degli interessi originari di Giustiniani Bandini, nello statuto misi appunto che due erano, siccome Sigismondo diceva lascio 1.500 ettari se poi ci si aggiunge la fondazione della Sofia a Lanciano, si arriva a 2.000 ettari, sono 55 mezzadri ancora rimasti sui 60-70, perché la conduzione a salariati man mano che vanno via è rimasta, però sono mezzadri che stavano Adriano Ciaffi da centinaia di anni nella proprietà dei Giustiniani-Bandini e si sono perpetuati con i figli e i nipoti ancora tuttora e hanno usufruito della trasformazione della mezzadria in affitto tutti, prima ancora che venisse la legge, 1975 rispetto al 1982, hanno usufruito del premio di rapporto strutturale quando le Marche recepirono le tre direttive comunitarie, la 159, la 160 e la 161 che dava il premio del rapporto strutturale a che trasformasse la mezzadria in affitto perché era individuata dalla vecchia conferenza dell’agricoltura italiana, pensate del 1961, la trasformazione della mezzadria in affitto come la prima fase verso la proprietà associata, ecc. Cioè c’è il lungo percorso della trasformazione dall’azienda in impresa, questo è il punto e allora il mezzadro, che non era imprenditore, e il proprietario il più delle volte assente dalla direzione, è cambiata oggi in un’impresa agricola, oggi si parla di un’impresa agricola al di là del contratto liberamente fatto, perché è caduta anche la proroga legale dei contratti, che era sì questo un provvedimento sociale, la proroga legale dei contratti per mantenere e drenare l’occupazione e l’esodo dalle campagne. Quindi nel celebrare questo trentennio penso che è questo il momento di una riflessione più vera, più insinuante, diciamo così, per capire questo grande processo di trasformazione delle nostre terre, naturalmente alla mezzadria si aggiungono anche i livelli, si aggiungono anche le varie forme di patti agrari appoderati che in ogni regione, dal Lazio alla Sicilia, cambiano rispetto alla mezzadria classica, che a questo punto non considero più toscana, ma umbro pugliese e veneta. Secondo intervento di Adriano Ciaffi in sede di replica. Cercherò di essere breve nel formulare alcune osservazioni che mi sono venute in mente ascoltando le ottime relazione dei colleghi. Sì, la divisione si era verificata nel periodo delle 14 vertenze sindacali che ho precedentemente distinto rispetto al periodo delle riforme. Quindi stiamo prescindendo dalle prime battaglie sindacali della fine dell’ottocento, ho accennato in quel clima alla questione della ripartizione dei prodotti, che interessavano anche piccoli valori, le verdure, il cortile e così via. Il lodo De Gasperi significò l’intervento sui contratti agrari attuato nell’immediato dopoguerra insieme alla riforma agraria, che riguardava la divisione del latifondo ed i primi accenni ala di bonifica. Quindi la attribuzione del 53% del prodotto al mezzadro fu introdotta dal Lodo De Gasperi e su questo riconoscimento del 3% in più si sviluppò il primo contenzioso agrario, con processi esecutivi da una parte e dall’altra e anche con momenti di cripto, di nascondimento, diciamo così, della produzione, come si calcolava, come non si calcolava, se era al netto delle semine, delle scorte di semina che dovevano essere garantite per l’anno successivo. Successivamente si passò al 58% attorno alla fine degli anni cinquanta, attraverso altri provvedimenti che, all’inizio degli anni sessanta, settanta, arrivarono a conferire al mezzadro la quota del 63 %. C’era in sostanza questa tendenza al riequilibrio del contributo del lavoro che sul piano delle prime statistiche agrarie aveva una remunerazione inferiore rispetto alla remunerazione che il lavoratore dipendente aveva in altri settori. Anche allora c’erano le statistiche, c’erano i calcoli del reddito agrario, della distribuzione del reddito agrario complessivo, certo andava in crisi la comunione tacita familiare, che aveva una legislazione ormai secolare ed entrava in vigore la parità fra le unità lavorative, il diritto del giovane ad andare a studiare, perché prima non poteva andare a studiare se sottraeva una unità necessaria a quella comunione tacita familiare che nell’insieme doveva garantire la coltivazione secondo la diligenza a media, Le Cento Città, n. 48 diciamo così, del corrente. Quindi andava in crisi anche la distinzione tra la capacità lavorativa della donna e dell’uomo, che concorrevano con lo 0,60% la donna e l’1% l’uomo a creare quel minimo di unità popolare. Arrivo quindi alla seconda domanda, perché tanta conflittualità. Fin dalle origini c’era e c’è stata fino all’entrata in vigore della legge, perché la pronuncia del superamento del contratto di mezzadria del ‘64-’65, lasciava in vita i contratti dichiarati nulli e superati, tanto che se ne facevano anche altri nelle Marche, nella provincia di Macerata arrivavano anche al 25% quelli che si facevano senza la tutela della legge e quindi i casi di disdetta da parte del proprietario fioccavano con motivazioni, le più diverse, passando attraverso la casistica del proprietario che andava a coltivarlo, del figlio che voleva andare ad insediarsi e di questa conflittualità sulla distribuzione, fino ad arrivare alle norme di legge sui contratti agrari, quindi relativi un po’, siamo già nella legge degli affitti, quindi il 1971 in cui si comincia ad introdurre il concetto che con l’assistenza delle organizzazioni sindacali si fanno i contratti in deroga. Ora, la legge del 1982 prevede appunto, dopo la legge del ‘71 sull’affitto, il perfezionamento di questa possibilità, una volta abolita la proroga legale dei contratti per non poter mandar via il contadino salvo che non dovesse andarci direttamente, a risolvere di comune accordo, con l’assistenza, specie per la parte più debole che era il mezzadro, dei sindacati. Oggi la trasformazione è diventata tale, dicevo nell’ultimo convegno, che la stessa organizzazione sindacale che prima si chiamava Federmezzadri, si chiamavano così tutti i titolari alla difesa del mezzadro, oggi sono organizzazioni che con due timbri assistono sia il concedente, sia l’affittuario, due timbri, due realtà diverse, ma la stessa organizzazione proprio a garanzia che ci sia questa tutela obbligatoria Padrò e Contadì che la legge impone. Concludo dicendo, non abbiamo toccato a proposito della posizione subalterna ai contadini, attenti bene che questo processo di trasformazione che va al di là del superamento della mezzadria, si concretizza anche nell’urbanizzazione delle campagne, cioè fino agli anni del dopoguerra, la casa colonica si riscaldava con il fiato della stalla che stava sotto, oggi sotto c’è il locale per le cene, per gli invitati, la tavernetta, non la cantina, la cantina e la stalla erano tradizionalmente dentro grotta, luoghi più umidi e così via, ma la sostanza è che si riscaldavano con la stalla perché i pavimenti erano mattoni lunghi che da trave a trave poggiavano e creavano diciamo il cosiddetto biancito, bastava sollevare un mattone sopra la stalla e veniva l’aria calda. A questo poi si è sostituita la casa nuova con il cemento, questo lo dico perché se voi andate in tanti ristoranti di agriturismo in genere queste belle stanze con i travi di legno di quercia ben fatti, ecc., corrispondono alla vecchia stalla, ancora con le finestrelle limitate, tanto quanto servisse per far respirare con le finestre di cemento, allora erano fatte di cemento con l’anima di ferro, l’aria perché il respiro, il ruminaggio delle bestie creava un calore e altre cose, creava diciamo così aria calda che serviva a scaldare le famiglie. Da questa fase l’acquedotto, l’elettrodotto, le linee telefoniche, la strada consorziale e poi comunale sono le linee del processo di urbanizzazione, oggi con il valore della distanza che cade rispetto ai computer, rispetto appunto alle linee di comunicazione via radio ecc., questa difficoltà della distanza, del vivere in campagna è stata rovesciata. Oggi si vive meglio in campagna da parte di tutti, perché si ha attraverso la televisione, la radio la comunicazione in tempo reale che hanno tutti quelli della città, ecco perché 15 l’integrazione città - campagna che è storica, che è anche ideologica, pensate alla campagna del mondo, la città, la rivoluzione cinese e così via, oggi in realtà lo spazio è rurale, dice l’Europa, e quindi il piccolo comune è uguale alla campagna, solo che il mercato non è più il mercato delle erbe, struttura tipicamente mezzadrile e contadina, io direi più che mezzadrile contadina, perché la parola contado rende meglio in questo discorso che adesso sto facendo il complesso architettonico della città murata con il contado, la pieve è qualcosa di diverso dalla parrocchia, la pieve era la chiesa che stava fuori porta e che era in fondo il punto di incontro, di ritrovo per tanti motivi della campagna. In fine un accenno all’emigrazione, attenti bene, negli anni ‘70 in parallelo al processo di trasformazione della mezzadria in termini formali di legge, ma anche in termini sostanziali, c’è l’inversione di tendenza della demografia nelle Marche, ricordo ero Presidente della Regione nel ‘77 quando ci fu il primo saldo attivo, quindi il segnale della fine dell’emigrazione biblica degli anni ‘50. Non parlo solo della fine ottocento e dei primi anni dieci del novecento, l’epopea della famosa valigia con lo spago che vedeva i nostri mezzadri, contadini ad andare in Argentina, nel Venezuela, negli Stati Uniti e così via, ma anche dell’altra degli anni del secondo dopoguerra. Ad esempio i nostri emigranti andarono a lavorare anche nelle miniere belghe, la tragedia di Marcinelle ci ricorda 60-65 marchigiani morti nel crollo della miniera; nel ‘75 vi è un inizio di ritorno, di rientro e non dimentichiamo un fenomeno che è stato importante ai fini dei giudizi a volte poco veritieri, poco umani, diciamo così, sulla subcultura contadina, vi era nel mondo contadino una grande cultura, era una cultura di analfabeti, cioè l’analfabetismo che Le Cento Città, n. 48 in campagna aveva anche questi legami che costringevano la mezzadria ad essere subalterna e ad essere arretrata e da superare, ho detto il caso di quanto valeva un giovane che allora la scuola d’obbligo c’era sì e no, non c’erano neanche tutti e cinque gli anni delle elementari, questa è tutta roba del dopoguerra, prima portare un ragazzo fuori dall’azienda significava violazione contrattuale, specie per chi aveva pochi figli. Questa tradizione si è mantenuta anche nel periodo della trasformazione; il concetto del metalmezzadro ha creato un’economia di scala dentro la famiglia numerosa perché insieme alle pensioni dei vecchi, le prime pensione obbligatorie dei vecchi, c’era il salario del figlio che aveva lasciato la campagna ed era andato a lavorare in fabbrica o a fare il commerciante o a fare il dipendente dell’artigianato; artigianato di servizi, pensate alle carrozzerie e pensate alle fabbriche, al servizio che ha dato. Queste 100 mila persone che nel giro di un decennio sono passate all’attività di lavoro autonomo o dell’industria nascente nelle Marche, tra l’altro non è vero che è il fenomeno che ha arricchito la fascia costiera, il progresso di popolazione c’è stato ma non ha evitato di creare per esempio attorno al centro fabrianese la più grossa zona industriale delle Marche, cioè il fenomeno Merloni, il fenomeno Elica, il fenomeno industrie di servizio a queste altre industrie ormai europee, è stato molto maggiore che non ecc. ecc. e quando Ardigò, un sociologo, negli anni ‘70-‘80, parla di capitalismo del sottoscala, si riferisce ad una forma di lavoro autonomo che in tutta la zona calzaturiera, quindi parlo anche dell’entroterra, Montegiorgio, Monte Urano, parlo di Montegranaro, Monte San Giusto, ecc. paesi che non stanno sul mare e, diciamo, neppure nella fascia costiera, che è il risultato dell’emigrazione dalle campagne. Convegno Padrò e Contadì 16 L’addio all’agricoltura e la trasformazione del paesaggio di Mario Canti Dalle cose che ha detto Ciaffi e anche dall’introduzione di Maroni colgo un atteggiamento di fondo espressione di una cultura prevalentemente di carattere politico-sociologico. A mio avviso in quegli anni c’erano anche altri attori, o meglio, altre discipline, in campo, come esperto di pianificazione del territorio in quegli anni ho incrociato più volte il lavoro degli economisti, in particolare mi ricordo che nelle Marche, negli anni precedenti all’istituzione della Regione, esisteva un istituto che si chiamava ISSEM (Istituto per lo Sviluppo Economico delle Marche) che propose un piano di sviluppo agricolo per l’intera regione e arrivò addirittura a redigere dei piani zonali operatici per l’agricoltura. Ricordare quell’approccio che vedeva al lavoro esperti di agricoltura, di economia e di territorio vuol porre in evidenza che dietro a quei cambiamenti che si cercava di proporre, e che si sono poi parzialmente realizzati, sia pure con esiti e attraverso strade diverse da quelle proposte allora, c’era una esigenza economica, oltre a quella sociale e c’era l’aspirazione a realizzare una situazione insediativa ed ambientale sostenibile. Sono d’accordo con Adriano nel riconoscere che la approvazione della legge di cui oggi parliamo è stato un momento importante, che ha concluso un’annosa battaglia condotta dalle forze socialiste e cattoliche per la emancipazione del mezzadro; per portarlo a vivere una situazione diversa da quella del ‘padrò e contadì’. Le cose erano già avvenute prima, diceva giustamente Adriano, e nel seguito si sono completate e verificate al di là delle previsioni della legge e qualche volta anche contro la legge, ed in forme diverse da quelle programmate, perché, per fortuna, anche nel territorio e nell’economia la fantasia, la versatilità esistono e sono attori importanti. Vorrei sottolineare alcuni problemi che la scomparsa della mezzadria ha messo in luce: il primo di questi, al quale è stato già accennato, pone in evidenza come rileggere la mezzadria nella sua struttura insediativa e nella sua organizzazione economica significa sottolineare quanto, sotto questi aspetti,vi fosse in comune tra la stessa e la piccola e media proprietà contadina, l’esodo dalla campagna infatti riguarda il mezzadro come il piccolo proprietario diretto coltivatore; l’uno e l’altro colgono le occasioni offerte dalla motorizzazione e dallo sviluppo dell’industria manifatturiera sui nostri territori; migliori condizioni di vita e libertà nell’agire costituiscono richiami irresistibili per un gruppo sociale che negli anni immediatamente precedenti alla trasformazione socio economica delle Marche cercava di sfuggire alle dure condizioni di vita del contadino anche mediante l’emigrazione. Una quota significativa della popolazione delle Marche scelse allora di partire, di abbandonare la agricoltura ed, in termini generali, l’insediamento rurale per rivolgersi alle attività industriali e alle modalità di vite proprie della città. Bisogna riconoscere che la spinta all’esodo fu sostanzialmente di carattere economico, come dimostrano i forti flussi migratori rivolti anche verso l’estero alla ricerca di lavoro nell’agricoltura ma non solo in questa. Quando io sono venuto a lavorare nelle Marche, sto parlando della metà degli anni sessanta, questa regione era, dopo il Veneto, l’area del Paese con il più alto tasso di emigrazione. Non sto riferendomi solo ai movimenti migratori interni, verso le aree costiere dove Le Cento Città, n. 48 veniva affermandosi lo sviluppo industriale o verso le aree cittadine di maggiore urbanizzazione, ma all’emigrazione rivolta verso altri paesi europei ed anche verso altri continenti. I nostri minatori che estraevano lo zolfo dalle miniere dell’alto pesarese sono andati a lavorare, e talvolta purtroppo a morire, nelle miniere di carbone del Belgio, così come i nostri contadini, mezzadri o no, hanno scelto l’emigrazione in Argentina, verso la quale si è verificato un afflusso formidabile che ha lasciato una eredità di comune sentire tra questi emigrati e i marchigiani residenti. Qualche anno or sono siamo riusciti a stabilire dei rapporti meravigliosi con le associazioni dei marchigiani residenti in Argentina, che talora sono ormai costituite dai figli degli emigranti di allora. A riprova che quella emigrazione era stata ‘subita’ per necessità economiche sta il fatto che questi marchigiani e i loro figli, che vivono oggi a Rosario, a Santa Fè, ed in molti altri paesi agricoli dell’Argentina furono felici per l’essere stati cercati e riconosciuti dalla loro Regione d’origine. Loro erano andati via perché le condizioni di vita non erano così rosee come oggi possono apparire, le condizioni di lavoro erano dure ed anche socialmente, forse, si sentiva la oppressione della famiglia mezzadrile, la costrizione dello stare in quel determinato ambiente per tutta la esistenza; e così sono andati via. Ancora più intensi furono i movimenti migratori all’interno dell’Italia, verso i centri urbani più attrattivi, e, all’interno della regione, verso la costa ed i fondovalle dove veniva affermandosi gradualmente la nuova attività industriale manifatturiera, così in poche decenni la agricoltura marchigiana ha avuto stabilizzato un numero di addetti di livello europeo, certo non Padrò e Contadì per la legge sulla mezzadria, ma per lo sviluppo industriale, per l’emigrazione, la motorizzazione diffusa, e altri fattori di vario genere. Questa profonda trasformazione che ha interessato il mondo rurale marchigiano presenta oggi dei risvolti critici, sia sul piano sociale che su quello ambientale, mi riferisco al mondo dell’agricoltura nel suo complesso perché, a mio avviso, sotto il profilo insediativo e sociale le condizioni della piccola proprietà diretto coltivatrice e quelle della mezzadria non erano poi sostanzialmente diverse: dimensioni ridotte dei poderi, isolamento delle residenze, prevalenza delle culture promiscue, erano fattori costitutivi dell’intero mondo agricolo marchigiano, semmai le differenze erano segnate da fattori geofisici e climatici. Può apparire paradossale ma l’isolamento del podere portava a stabilire forti vincoli di solidarietà e di interdipendenza tra i residenti nelle diverse comunità agrarie: le famiglie mezzadrili intervenivano di comune accordo nella manutenzione dei suoli sotto il profilo idrogeologico (la rete di canali e fossi che oggi rimpiangiamo ad ogni alluvione piccola o grande), per la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, in genere per tutti quegli interventi occasionali che richiedevano forze lavoro superiori per numero ed intensità a quelle normalmente disponibili nell’ambito della famiglia, mezzadrile o coltivatrice che fosse. La solidarietà sorta e sviluppata nell’ambiente rurale resta uno dei patrimoni più preziosi che siano stati tramandati, presenti a lungo nelle Marche, come dimostrano le particolari modalità organizzative che hanno caratterizzato il sorgere e lo sviluppo della piccola impresa manifatturiera: familismo, integrazione delle lavorazioni, rapporti fiduciari tra membri del distretto, questi sono stati i fattori di successo che avevano ed hanno origine dall’ambiente contadino. La scomparsa dell’azienda agricola isolata e delle coltu- 17 L’ordine e il decoro della campagna marchigiana. re promiscue dell’ordinamento agrario mezzadrile, congiunta alla realizzazioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, ha peraltro trasformato in modo significativo il paesaggio stesso della regione. Il mezzadro aveva dalla proprietà una concessione di terreno che ovviamente tentava di sfruttare sotto ogni aspetto, per cui, ad esempio, se c’era una sponda troppo ripida per essere dissodata e coltivata su di essa si faceva crescere il bosco, dal quale veniva ricavato il legname per tutti i bisogni della casa e dell’azienda, se c’era un fiume o una zona palustre andava bene lo stesso, perché da esse si ricavavano le canne e i vimini per tutte le manifatture familiari; di conseguenza non esisteva un pezzo di terra che venisse abbandonato, tutto era coltivato, con tante diverse tipologie di Le Cento Città, n. 48 produzioni perché se bisognava garantire un risultato economico al ‘padrò’, occorreva pure sopperire ai fabbisogni alimentari della famiglia È da questa organizzazione produttiva che nasce il “bel giardino d’Europa”, questo ordinamento produttivo comune a gran parte dell’Italia Centrale rispondeva ad una comune motivazione storico-economica, che poi esprimeva, ovviamente, in forme diverse, il paesaggio, in relazione della diversità: dei luoghi, dei caratteri orografici, del climatici o anche di particolari eventi storici. Personalmente ritengo che certuni caratteri del nostro paesaggio agrario, la sua amenità, il suo equilibrio, quel certo carattere che definirei ‘eleganza’, derivino in larga misura da fattori culturali propri dell’ambiente contadino: la consape- I beni culturali 18 Le Cento Città, n. 46 Padrò e Contadì volezza di appartenenza ad una comunità, di partecipare ad una tradizione ed ad un costume, di possedere ed esercitare saperi specifici ed indispensabili per la vita dei potenti così come degli umili. Con la scomparsa di questo contadino residente sul fondo, che lo gestiva totalmente con gli strumenti di una cultura materiale di antica tradizione , il “bel giardino” è diventato un po’ noioso, non c’è più la varietà degli elementi insediativi e colturali; il paesaggio non è più così bello, movimentato e ricco di occasioni e di osservazioni soggetto come è alle variabili esigenze del mercato che si presentano identiche a se stesse in ogni parte del territorio. Se, per fare un esempio, in un determinato anno il mercato richiede semi di girasole allora tutti si mettono a piantare il girasole, e di conseguenza le colline marchigiane, che di per se restano splendide, divengono un poco noiose, sono tutte verdi prima, gialle dopo e marroni nella fase successiva, quel paesaggio vario ed articolato che era il prodotto di una precisa situazione storica non esiste più. Per conseguenza quando si sente parlare di tutela e conservazione del paesaggio credo sia necessario fare un atto di onestà, e riconoscere che esistono territori sui quali la storia ha creato, anche sul piano naturalistico e paesistico, delle situazioni eccezionali, irripetibili, allora su queste, e solo su queste, bisogna intervenire adottando criteri per la conservazione dello statu quo, il che in agricoltura significa fare “colture di manutenzione” ma non abbandonare il territorio. Il che comporta per la proprietà una riduzione di proventi economici che, in qualche modo ed in una qualche misura, andrebbe risarcita, come avviene (dovrebbe avvenire?) il patrimonio edilizio storico. Per illustrare questa situazione attinente alla conservazione 19 del paesaggio agrario mi riferisco spesso alla Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano conservata agli Uffizi di Firenze, dove al centro è rappresentata la scena sacra e nella parte alta è dipinta la cavalcata dei Magi che si dirigono a Gerusalemme, a fianco di questa cavalcata, nell’angolo alto a sinistra, è dipinta una casa isolata, con il suo recinto che la isola dal contesto, con l’orto, con i campi, con i filari, con la vite maritata e con sul davanti un porticato, vale a dire che il pittore ha rappresentato un tipico insediamento mezzadrile; stiamo parlando di Gentile da Fabriano, quindi nella prima metà del quattrocento quel tipo di insediamento era già codificato, poi con l’espandersi della mezzadria e della piccola proprietà contadina, sarebbe divenuto l’elemento fondante del paesaggio umbro-marchigiano e, in parte, toscano. Due piccole considerazioni aggiuntive; vorrei riprendere l’accenno fatto al senso di solidarietà che pervadeva l’ambiente rurale e confermare che nella prima fase dell’industrializzazione marchigiana viene trasferito nel nuovo ambito operativo, in termini di familismo ambientale, di partecipazione della famiglia all’impresa, di rapporti tra le diverse imprese. Ad esempio nelle aree del calzaturiero si è mantenuto a lungo una organizzazione di fatto che consentiva l’integrazione tra piccole imprese specializzate: quella che faceva la tomaia, quell’altra che produceva i tacchi o le suole, e così via; il tutto connesso sul piano logistico da una motocarrozzetta che correva da un capannone (o da un sottoscala) all’altro. Questa forma di integrazione non richiedeva contratti formali ma intese di fatto che venivano rispettate da tutti, fondate come erano dalla reciproca fiducia e rispetto come era sempre avve- Le Cento Città, n. 48 nuto nel mercato agricolo. Tornando un momento al discorso sul paesaggio vorrei confermare che ritengo che quel “bel paesaggio”, quello del “giardino d’Europa” per intenderci, è irrimidiabilmente condannato a scomparire in quanto prodotto da condizioni economiche e sociali ormai inesistenti; quelle parti dello stesso che si volessero conservare dovrebbero trovare un sostegno, economico e culturale, nell’intervento pubblico, ma del vecchio modello dobbiamo recuperare alcuni valori di fondo: la salvaguardia e la sapiente gestione dei suoli, il contenimento dell’espansione edilizia, l’introduzione di criteri compositivi nel nuovo assetto rurale in analogia con quanto dovrebbe avvenire in ambito urbano. Occorre introdurre anche nella gestione dei territori agricoli obiettivi qualitativi che modifichino gradualmente la tendenza alla valutazione meramente economicistici e di breve periodo che caratterizza i nostri tempi, secondo la quale il valore del costruito si misura in metri cubi cosi come quello dell’agricoltura in quintali; ricordando che l’Europa richiede attenzione e cura per ogni possibile situazione paesaggistica, vedi la Convenzione sul paesaggio adottata nel 2000 a Firenze, recepita dallo Stato italiano nel 2004, ma ancora non operante in molte Regioni comprese le Marche. Ricordando anche che il vecchio piano paesistico adottato dalla nostra regione nel 1984, sulla base della legge nazionale del 1975 (la legge Galasso) è di fatto risultato inattuato perché rinviava ai Comuni la applicazione delle sue norme e questi, posti davanti alla alternativa di far costruire o di rispettare i valori del paesaggio, sia pure in maniera generica, hanno privilegiato, ovviamente, il costruire. Convegno Padrò e Contadì 20 Marche, il giardino fiorito di Giorgio Mangani Vorrei affrontare questo tema dal punto di vista non necessariamente storico; è chiaro in una prospettiva storica, ma più di antropologia culturale, di antropologia geografica. L’Arcadia è il sottotitolo di questo dibattito; la mezzadria è stata sicuramente anche un istituto che potremmo definire antropologico, un istituto di relazione interculturale, perché ha messo storicamente, sociologicamente in relazione il mondo dei proprietari terrieri e il mondo dei contadini; poi magari qualche famiglia proprietaria marchigiana abitava a Roma, ma altre erano di più piccole dimensioni e soffiavano di più sul collo del fattore o direttamente del mezzadro; ma insomma è stata comunque, indipendentemente dalla prossimità, un istituto di relazione antropologica. L’Arcadia mi sembra possa rappresentare bene alcuni argomenti, alcuni ingredienti di questa relazione, che poi è chiaramente anche una relazione servo-padrone, ma è una relazione più complessa di quella diciamo tradizionalmente rappresentata da questo concetto. Intanto cos’è l’Arcadia. L’Arcadia è stata storicamente una metafora all’origine della teorizzazione della vita urbana; l’Arcadia è un altro luogo, più o meno ideale, che viene teorizzato: una regione finta, un po’ teatrale, che viene teorizzata già alla fine della classicità ed è centrale per la storia della cultura romana. L’Arcadia produce per esempio tutta la storia dell’eremitaggio, le forme di eremitaggio che nascono alla fine del mondo antico. Questo tipo di atteggiamento è tipicamente antiurbano, cioè l’eremita, come succede poi anche nell’Arcadia della tarda classicità, rappresenta tutta una serie di valori totalmente antiurbani, è un asociale; ma questi valori vengono rappresentati in un altro luogo per dialogare con il mondo urbano, perché sono talmente il contrario della vita urbana che è evidente che dialogano, devono dialogare con quella. L’Arcadia è anche qualche cosa di più complesso ancora, perché rappresenta un mito fondativo della comunità urbana. È caratterizzata da l’innamoramento, le belle storie dei rapporti d’amore, amore mancato, amore fisico, amore idealizzato, tra le ninfe, i pastori e i satiri e quindi comprende evidentemente tutto il segmento dell’amore carnale, anche dello stupro, perché poi il satiro lega Aminta, nel racconto di Tasso, ad un albero perché la vuole violentare, quindi questo tipo di filone del rapporto fisico, del rapporto violento confrontato invece con il modello dell’amore più sentimentale, più familiare, più alla genesi del rapporto familiare, della nascita della famiglia ai fini della comunità urbana del pastore. Questo comportamento è per esempio centrale per il filone di studi femminista della ‘Gender History’ che ha cercato di spiegare come sia stata fondativa per esempio della storia della città romana. Roma nasce con il famoso ratto delle Sabine; i romani organizzano una rappresentazione teatrale per attirare le Sabine e le rapiscono, e poi c’è, e questo è l’atto fondativo della romanità, del regno romano, insomma della serie dei re, lo stupro, quindi dietro questa Arcadia ci sono anche cose piuttosto oscure, dietro la civiltà si cela un rimosso. L’altro momento, la nascita della Roma repubblicana, invece è ben rappresentato dalla castità. La matrona Lucrezia viene infastidita, diciamo qualcosa di più, da Tarquinio il Superbo e si uccide, un po’ come la nostra santa Maria Goretti. Non è che siamo andati tanto lontani; la vita urbana è fondata su un processo che porta alla valorizzaLe Cento Città, n. 48 zione della castità femminile che è evidentemente la celebrazione del matrimonio, paradigma del nucleo fondativo della città, della comunità urbana, della comunità organizzata rispetto all’amore occasionale e violento. Anche nel mondo greco c’erano storie di questo genere o fondative di questi due modelli, c’erano le ‘Tesmoforie’, le feste che rappresentavano il frumento, la vita agricola, la produzione del grano, legate alla vita familiare, alla celebrazione dei riti della famiglia, e le ‘Adonie’ che duravano una settimana, si facevano dei coccioletti, delle cocciole con dei fiori, i cosiddetti ‘Giardini di Adone’, che erano dei minigiardini che duravano tre giorni, nel corso dei quali c’erano le feste e le cocciole poi, i fiori piantati, non avendo radici, sfiorivano esattamente come sotto metafora gli amori occasionali non infrastrutturati nella relazione coniugale urbana. Dietro la metafora di questo altro luogo idealizzato si agitano modelli culturali, sensazioni, ambizioni, pulsioni molto più complesse di quello che possiamo immaginare. Allora questa Arcadia ha anche qualche cosa a che fare molto strettamente con le Marche, potrei dire, ribaltando il concetto, che forse le Marche hanno qualche cosa a che fare con questa Arcadia, perché in un certo senso hanno contribuito in Italia, nella storia della cultura italiana moderna, a codificare proprio il modello dell’Arcadia come l’abbiamo concepito non solo le Marche, in questa regione questa cosa è molto ben documentata e molto insistita. Intanto ancora il teatro: c’è una grande tradizione da noi, i tanti teatri che non solo dall’Ottocento, ma anche dal Cinquecento vengono costruiti in legno, fatti in casa. Venivano allestiti nelle nostre dimore urbane, per trecento anni vi si pratica il dramma pastorale, nel Padrò e Contadì quale la dimensione dell’Arcadia è quella classica, nella quale i nobili, che recitano per altri nobili di famiglia, si travestono da pastori imitando in qualche maniera il comportamento, il modo di vestire, ovviamente letterario, dei loro mezzadri, dei loro subalterni, di coloro che consentono la sopravvivenza fisica del loro modello di vita. Nello stesso tempo le Marche, l’ha detto Mario Canti molto bene, sono rappresentate come un grande giardino, le Marche sono davvero il giardino d’Italia, ma in una maniera talmente insistita nella documentazione che abbiamo, che la cosa qualche significato deve averlo avuto. Tutti i viaggiatori raccontano che è un grande giardino, pieno di alberi da fiore, da frutto, Michel de Montaigne, Ortensio Lando, tutti quei viaggiatori di cui ha scritto Nando Cecini che anch’io ho pubblicato. Non è probabilmente una sensazione empirica, ma è qualche cosa che loro sentono dire, essendo ospitati nelle famiglie nobili marchigiane, poi c’è la Santa Casa di Nazareth che si sposta in volo, nella narrazione, e va, con una piccola deviazione a Tersatto (che era una specie di città collegata a Recanati, come dire un pieno di benzina, per arrivare nel Laureto di Recanati). E Nazareth vuol dire ‘fiore’ in ebraico. È chiaro che le Marche diventano un giardino fiorito sacro a Maria di Nazareth, perché il giardino è uno degli appellativi classici di Maria e quindi tutto questo filone, i nobili marchigiani, persino gli studiosi di astronomia (perché la casetta è venuta tenuta dagli gli angeli) scrivono poemi sulla Santa Casa di Loreto; lo fa Giulio Aquaticci di Treia che faceva l’astronomo e il matematico, lo fa anche Vincenzo Nolfi di Fano, che aveva anche tradotto il ‘De coelo’ di Aristotele. Insomma c’è tutto un fiorire di interessi, anche seri, per questo rapporto selvagiardino, che nelle Marche è strutturale. Pesaro viene chiamata la ‘città giardino’ e si riempie di ville 21 La grande suggestione della montagna marchigiana. Foto Canti. come quelle famose del Colle San Bartolo, nelle quali la corte, che già si è trasferita da Urbino a Pesaro nei primi decenni del Cinquecento, in maniera protoarcadica, si riunisce. Non più le sale del Palazzo Ducale raccontate da ‘Il cortigiano’, ma le ville del San Bartolo, ‘il ben vive tra i boschi’ dice il cortigiano Ludovico Agostini (sec. XVI), e c’è un fiorire di rappresentazioni fiorite anche nelle decorazioni di quelle ville. Quindi la città giardino, ‘Pesaro giardino’ dice un verso di città del Seicento, e ‘Ancona dal bel porto pellegrino’. Allora tutto questo ci fa arrivare alla fine del Seicento. La regione è stata già ben connotata nella storia della cultura italiana come una regione dal forte ruralismo, ma non solo dal ruralismo che ha studiato Sergio Anselmi in tanti anni, fatto di rendite agricole, di dimensione economica, il granaio di Roma, ma di un ruralismo che è diventato rappresentazione politica, estetica, artistica, teatrale, musicale, sociale, e persino turistica, proto-turistica, quella dei viaggiatori come Montaigne. Allora quando si riuniscono a Roma, nel XVII secolo, i fondatori della Accademia dell’Arcadia, che hanno un obiettivo di tipo letterario, cioè il rinnovamento dello stile e della lingua, l’obiettivo è diventato quasi un modello gramsciano di controlLe Cento Città, n. 48 lo delle coscienze, di controllo degli intellettuali italiani, non solo intellettuali letterati, ma degli scienziati, degli studiosi che si riuniscono a Roma vestiti da pastori, prendono dei nomi arcadici, appunto pastorali. Ancora una volta si crea un altro posto, un altro luogo dove viene sceneggiato un modello che però, invece di essere il modello dell’utopia della società rovesciata, è il modello perfetto della rappresentazione territoriale, sociale marchigiana dello Stato pontificio. Nelle Marche questa cosa è particolarmente evidente, non si può accedere all’Arcadia, quella finta, quella metaforica, senza avere lottizzato un pezzo di territorio, tanto che racconta uno storico dell’Arcadia, poi lo stesso G.M. Crescimbeni, non è bastata l’Arcadia e si è dovuto noleggiare un pezzo della Beozia. C’è una specie di umorismo involontario e si scopre, sotto questo aspetto, che questi fondatori sono quasi tutti marchigiani o comunque una gran parte, e il papa che favorisce questa istituzione è un papa urbinate, papa Clemente Albani, e il Custode, il primo e per tutta la vita dell’Arcadia, è il maceratese Giovanni Maria Crescimbeni, grande proprietario agrario, anche se fa l’avvocato concistoriale. E la seconda colonia fondata dopo Roma è quella di Macerata, che si chiama Elvia, ART - DanielaHaggiag.com MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI SONO DETTAGLIATE NEL “FOGLIO INFORMATIVO” DI CREVAL TIME DEPOSIT DISPONIBILE PRESSO TUTTI I NOSTRI OPERATORI DI SPORTELLO E SUL SITO WWW.CREVAL.IT SEZIONE “TRASPARENZA”. Il tuo valore cresce nel tempo. Con CrevalTimeDeposit, il deposito in euro del Gruppo Creval, custodiamo per te una somma di denaro per un periodo concordato ad un tasso fisso. Alla scadenza, avrai il 100% del capitale e gli interessi maturati nel periodo. Il deposito è garantito dal Fondo Interbancario. www.creval.it Gruppo bancario Credito Valtellinese Padrò e Contadì tre anni dopo; sono sei le colonie in tutto negli anni successivi su un totale di trenta, quaranta, quindi se pensate che sono Cagli, Urbino, Cupramontana rispetto a Volterra e altri posti di questo genere, voi capite che il peso specifico delle Marche è molto alto rispetto al dato generale. Poi confluisce nell’Arcadia tutta l’Accademia reale della regina Cristina di Svezia che era stata nel frattempo fondata anni prima e stava a Palazzo Riario a Roma. La Regina Cristina di Svezia aveva abdicato perché era passata alla religione cattolica dopo essere stata monarca di uno stato protestante, quindi la cosa non poteva funzionare, e viene ospitata a Roma dal papa; però ha un rapporto stretto, particolare, qualcuno dice che sia l’amante, ma è gossip storico, con il cardinale Decio Azzolino di Fermo, potentissimo Segretario di Stato vaticano, e l’Accademia della Regina Cristina di Svezia a Roma era praticamente un po’ come l’Eni di Mattei a Milano, costituita tutta da marchigiani: insomma, il classico tira-tira, il trenino delle relazioni amicali per cui io ho un posto e suggerisco la cosa a un amico; l’Arcadia offre alla regina anche il ruolo di ‘Basilissa’, di presidente onorario dell’Accademia, perché il presidente vero era papa Albani, e il peso specifico dei marchigiani aumenta anche di più. Si potrebbe dire dunque che l’Arcadia, quella vera, quella romana, presenta molte caratteristiche della cultura marchigiana storica e non sceneggia soltanto un modello utopistico, ma in qualche maniera descrive una realtà anche sociale. Allora dietro questa Arcadia ci sono dei valori pan-ruralisti che poi troveremo in tutta la nostra tra- 23 dizione culturale, per esempio papa Albani è all’origine della celebrazione della piccola proprietà terriera che sarà un cardine della cultura politica cattolica moderna. Vedete bene che questo modello pan-ruralista combacia perfettamente sul piano della politica economica pontificia, nel senso che da una parte di celebra la ruralità, la idealità di questa relazione culturalesociale-economica e poi dall’altra si agisce anche sul piano, sulla leva economica, poi questo modello passa al fascismo, arriva fino alla cultura dello Strapaese di cui le Marche, penso a Luigi Bartolini, sono una capitale, dove ancora una volta le donne sono belle perché hanno i fianchi larghi e gli occhi bovini, è evidente che siamo più sul versante ‘Tesmoforie’ che sul versante dei ‘giardini di Adone’, su una relazione familiare fondata sulla fertilità, sulla ‘stabilitas’, cioè la vita residente, la famiglia (poi magari l’amante può anche aiutare alla stabilitas) e tutto questo rappresenta un modello che per noi è rimasto vivo fino ai nostri giorni e che ha contaminato diverse sottoculture. Basta pensare a Paolo Volponi e a tutta la sua celebrazione per l’industria, per la tecnologia, e dall’altra alla sua mitizzazione del mondo rurale. Lui voleva che la tecnologia aiutasse i contadini a non faticare tanto e a non sudare, a non spaccarsi la schiena, ma alla fine della fiera la sua idea non era tanto diversa dal modello di papa Albani; vi striscia anche un atteggiamento in fondo caritativamente antimoderno. Si potrebbe dire: le Marche non è che sono arretrate; le Marche sono contrarie alla modernizzazione, non è neanche una forma di reazionarietà, è una forma di antimodernità Le Cento Città, n. 48 che ci costringe sempre a vivere in una condizione o di arretratezza o di post-modernità; non riusciamo mai a centrare una sana modernizzazione: o siamo la regione della globalizzazione, della internazionalizzazione più vivace, delle aziende che dialogano con i cinesi, oppure siamo contrari statutariamente ad ogni forma di modernità. Questo c’era già, e finisco con questo, c’era già nella tradizione dell’Arcadia, perché era un movimento fondatamente antiborghese, cioè nonostante si valorizzasse la proprietà, era contrario ai processi di laicizzazione che erano anche in corso in quella fine del Seicento, primi del Settecento, tant’è vero che un Arcade qualche decennio dopo, scienziato galileiano come Lorenzo Malagotti (1637-1712) va a fare un viaggio in Inghilterra, partecipa agli esperimenti della Royal Society dove il più modesto era un granduca di qualche cosa e torna scandalizzato dicendo: ma questi fanno esperimenti con l’intenzione di mettere in pratica queste scoperte, esperimenti che potevano consentire la valorizzazione di macchine o di protomacchine, di brevetti, ecc. per i quali la nobiltà anglosassone, come è noto, non aveva la puzza sotto il naso, mentre la nobiltà italiana vedeva come assolutamente indecoroso praticare. Ecco, su questa cosa, sulla mitologia di questa ruralità, del pan-ruralismo marchigiano ci sono tante belle cose, per esempio il nostro paesaggio, che siamo tutti impegnati a conservare e valorizzare, ma dietro il quale si agitano anche pulsioni e repressioni come quelle che tradizionalmente stavano sotto il tappeto, sotto la polvere della tradizione arcadica. Alberto Pellegrino 24 Qui sopra e nelle pagine seguenti l’arte fotografica di Adriana Argalia. Le Cento Città, n. 48 Portfolio 25 Il mondo fotografico di Adriana Argalia di Alberto Pellegrino Adriana Argalia è nata nel 1948 a Jesi, dove ha insegnato materie letterarie nella scuola media superiore e dove vive e lavora, coltivando da sempre una grande passione per la fotografia, che ha praticato con dedizione e tenacia, con impegno culturale e artistico, senza mai trascurare la ricerca tecnica e gli approfondimenti linguistici. Per merito di questo costante e “testardo” impegno artistico, sempre esercitato come Mario Giacomelli nella feconda provincia italiana, l’Argalia ha saputo conquistato una sua precisa collocazione nel panorama italiano della fotografia accanto ad altre fotografe-donne come Letizia Battaglia, Maria Mulas, Elisabetta Catalano, Emanuela Sforza. Ha partecipato a mostre collettive e ha tenuto diverse personali a Roma, Firenze, Bari, Siena, Pesaro, Fermo, Ancona, Spilimbergo, Milano, Trieste, Messico, Parigi, Stoccarda, Francoforte; le sue immagini sono apparse in diverse pubblicazioni e sono entrate in collezioni importanti come la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, l’Ikonos Centre (museo virtuale della fotografia ideato dal Craf), il Fox Talbot Museum in Inghilterra, l’Erich Lessing Culture and Fine Arts Archives di Vienna. La sua prima pubblicazione risale al 1998 ed è intitolata Jesi (Comune di Jesi/Banca Nazionale del Lavoro), seguita poi da Fluisce alla terra il cielo (Banca Marche, 1999), Ritratti. Orizzonti femminili (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, 2005), una m@meil dalla luna (Banca Marche, 2006), Castelbellino (Comune di Castelbellino, 2009). Una raffinata interprete della realtà L’Argalia si è affermata grazie a uno stile personale e libero da schemi, sorretto da un’ottima tecnica fotografica che le ha consentito di raggiungere risultati di grande spessore nel bianco e nero, usato spesso in modo molto intenso secondo la lezione di un maestro come Mario Giacomelli. Un’altra cifra della sua fotografia è la raffinatezza compositiva che diventa espressione di una carica di un lirismo evidenziato dalla scansione poetica delle varie tonalità della scala cromatica che vanno dal nero assoluto al bianco assoluto attraverso le varie gradazioni dei grigi. Molto riservata e mai aggressiva, Argalia ama muoversi con circospezione dentro la realtà quotidiana per osservate persone e cose, per fissare momenti di vita, per cogliere riflessi di luce e frammenti di architetture, per raccontare la città segnata dalla luce solare o immersa nelle ombre artificiali della notte, per “catturare” lo scorrere delle stagioni sopra le variegate modulazioni della campagna marchigiana. Argalia è riuscita negli anni a mettere a punto una personale “poetica del dettaglio”, che nasce da uno speciale culto dei particolari, dalla capacità di cogliere i segnali che arrivano dalle piccole cose: fiori che sbocciano sulla terra o nei vasi, vecchie carte abbandonate e stropicciate, pareti di canne tesi come sipari tra le quinte urbane, panni appesi tra i vicoli, gabbiani in volo o immobili sulla riva del mare, un universo femminile e maschile che ingloba tutte le età e tutte le condizioni sociali, che viene rappresentato con un’intensità psicologica e un’acutezza sociologica che non trascurano mai l’aspetto umano e il risvolto poetico dell’esistenza, in una continua ricerca di libertà espressiva e di esaltazione della fantasia. Dietro questa visione apparentemente “minimalista”, si scopre attraverso un secondo livello di lettura una ricerca più profonda che tende a dare una personale interpretazione di una realtà fatta di ambienti naturali, contesti urbani, oggetti inanimati, presenze umane o animali, a volte Le Cento Città, n. 48 rappresentati attraverso ingrandimenti lenticolari che tendono a scavare nella profondità dei vari soggetti. In questo modo Argalia riesce a provocare un coinvolgimento sentimentale ed estetico che va ben oltre una pur evidente eleganza formale, a trasmettere la consapevolezza di trovarsi di fronte a opere che hanno un loro individuale e preciso significato, ma che nello stesso tempo collegate fra loro da un’evidente unità stilistica e tematica, per cui si possono individuare dei precisi e ben strutturati percorsi narrativi che formano un universo iconografico di grande respiro lirico, all’interno del quale trova una sua collocazione anche il ritratto con una predilezione per il mondo infantile e femminile, riuscendo a cogliere l’esuberanza del gioco, la grazia di un atteggiamento, la dolcezza di uno sguardo, la fluida armonia di un movimento. Una fotografa e il lirismo degli spazi urbani Adriana Argalia è affascinata anche da un’idea di città che ricorda le “città invisibili” di Italo Calvino: “La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere”. L’autrice ama vedere la città attraverso cortine di vetro, tendaggi sinuosi e irreali, terrazze dove il sole scivola sui panni stesi ad asciugare, vicoli e strade segnate dalla luce o immerse nelle ombre della notte, presenze umane quasi mai dichiarate ma spesso ridotte a misteriosi dettagli, foglie e rami di giardini impenetrabili ridotti a ombre appena decifrabili, squarci urbani metaforicamente riflessi nello specchio di una pozzanghera. A questa visionaria rappresentazione della città rientra anche un degrado urbano fatto di vecchie case, palazzi Alberto Pellegrino 26 Le Cento Città, n. 48 Portfolio abbandonati, armature rivestite da cortine di plastica per nascondere un doloroso decadimento, capannoni dismessi e lasciati lì come segni inquietanti di una civiltà del lavoro ormai agonizzante. Siamo di fronte a una sorta di “lirismo degli spazi” che affonda le sue radici in un realismo fiabesco che penetra con pudore nel quotidiano e lo avvolge in un climax di mistero, dove la fantasia si perde nel volo di un gabbiano o nell’inseguire una nuvola che corre libera nel cielo, un lirismo che Italo Zannier così definisce: “Il racconto di Argalia percorre un suo itinerario privato, dettato spesso da fugaci effetti di luce, da presenze misteriose, inquietanti, irripetibili; ombre di maschere naturali create dal Sole, che emergono da un paesaggio dove le architetture sono osservate come totem stagliati nel cielo o appiattiti nella luce abbacinante della strada”. La fotografia teatrale è la sua ultima “avventura” artistica Nel 2005 l’Argalia ha incontrato nel 2005 il Teatro ed è stato un amore a prima vista, una passione che ha portato a un sodalizio artistico con la Fondazione PergolesiSpontini di Jesi per conto della quale ha documentato fotograficamente tutti gli spettacoli di prosa, opera lirica e danza classica che sono andati in scena nel Teatro Pergolesi e nel Sistema di teatri della Vallesina. Diverse di queste fotografie sono servite per realizzare i manifesti delle stagioni di prosa dal 2006 al 2012 e per le campagne di comunicazione promosse dalla Fondazione Pergolesi-Spontini, la quale alla fine del 2012 ha pubblicato, unitamente alla Banca Popolare di Ancona, un’ampia antologia delle immagini scattate dall’Argalia. Il volume di grande formato, che raccoglie numerose immagini in bianconero e a colori, s’intitola Trac! Lo spettacolo cominci, facendo riferimento all’espressione Avoir le trac usata nel gergo teatrale per esprimere l’emozione paralizzante che l’attore prova alcuni istanti prima di entrare in scena. Si tratta di un’opera che segna a pieno diritto l’ingresso dell’Argalia del complesso e difficile mondo della fotografia teatra- 27 le, finora praticata ad alto livello da pochissimi professionisti. L’autrice ha sentito il bisogno di fissare nelle immagini quella straordinaria metafora della vita che è il teatro, un mondo irreale che si trasforma in realtà visiva sulla scena. L’Argalia si propone di trasferire nelle fotografie, che sono di per sé materia inerte, quelle emozioni, quelle sensazioni, quei giochi della fantasia che si materializzano sul palcoscenico e lo fa con un guizzo di colore, un gioco di ombre, lo sfavillio di un velo, la forza cinetica trasmessa da figure in movimento con la consueta eleganza compositiva delle inquadrature, con l’uso funzionale del “mosso” e dello “sfocato”. Lo stesso contenitore teatrale diventa protagonista attraverso la suggestione di una scena o di una platea vuote, il fremito dell’orchestra, la presenza sensibile degli spettatori in un gioco di colori che vanno dal rosso profondo al blu intenso senza mai rinunciare a un’armonica padronanza dei cromatismi. In quest’antologia troviamo l’armonia della danza che spazia dal balletto classico al flamenco; la vivacità delle opere buffe di Pergolesi, Cimarosa e Rossini; il fascino di grandi rappresentazioni teatrali come Gli uccelli di Federico Tiezzi, Anna Karenina di Nekrosius o Giorni felici di Bob Wilson; le magiche atmosfere del melodramma: il Macbeth di Svoboda con le sue maschere inquietanti e violente che emergono dal buio come fantasmi, il supremo sacrificio di Madama Butterfly avvolta nel gelo di un candore lunare; le cupe ombre della follia di Lucia di Lammermoor. Vi sono poi i ritratti in bianco e nero che mettono in risalto l’umanità e la psicologia di attori, cantanti e danzatori, rappresentati con incisività e ironia in una serie d’immagini di grande eleganza compositiva nelle quali sono fissati il significativo movimento di un corpo, l’espressione di un volto, la liberazione di un grido, la smorfia di un dolore, formando quell’affascinante universo che Maurizio Buscarino, indiscusso maestro della fotografia teatrale, ha chiamato il “popolo del teatro”. Le Cento Città, n. 48 I particolari di Tre opere di Adriana Argalia. Luca Maria Cristini 28 Historia pontis a suinis, 2006, bronzo, bronzo ramato. Le Cento Città, n. 48 Arte 29 La città di Ancona e il Museo Omero celebrano l’opera di Valeriano Trubbiani con una grande antologica di Luca Maria Cristini La Mole Vanvitelliana ospita in questi mesi una grande mostra antologica a cura di Enrico Crispolti che la città di Ancona e il Museo Tattile Omero hanno voluto dedicare a Valeriano Trebbiani per celebrarne la lunga vicenda creativa. Per completezza e organicità De rerum fabula supera le pur imponenti mostre Oficina Mundi, organizzata a Macerata nel 1997 (con opere a Palazzo Ricci, nella Chiesa di S. Paolo e nel contesto urbano), Il Mare Scolpito, tenutasi a Jesi nel 2004, e Fabula Terribilis allestita a Roma nel 2006. Sviluppata in diverse grandi sale dell’imponente ex Lazzaretto progettato dell’architetto settecentesco Luigi Vanvitelli, De rerum fabula è una “laica rappresentazione” - così è stata definita - sviluppata in venti scene; un singolare spettacolo teatrale in cui i ruoli si invertono. È infatti lo spettatore che, invece di assistere allo spettacolo nella consueta statica modalità del teatro, percorre e attraversa le scene allestite dagli architetti Massimo Di Matteo e Mauro Tarsetti. Così De rerum fabula documenta un buon mezzo secolo di lavoro di Trubbiani, fra sculture, ambientazioni, disegni e pirografie, dagli anni Sessanta al primo decennio del Duemila, secondo una rigorosa successione cronologica. Come ogni opera teatrale che si richiama alla classicità, la successione delle scene è introdotta da un Prologo e conclusa da un Epilogo, interamente costruiti su testi selezionati a cura di Simone Dubrovic dagli scritti di Trebbiani; altre analoghe citazioni accompagnano lo sviluppo delle scene, caratterizzandole e fornendo spunti allo spettatore per la lettura delle opere. Le venti scene documentano cicli di sculture riproposte per l’occasione in installazione come: “Macchine belliche”, 1965-67; “Aruspici”, 1968-1974; “T’amo pio bove”, 1976-1978; “Putti, giochi di mare, giochi di cielo”, 1980-1982; “Mare, Corazzate, e Federico Fellini”, 1982-2001; “Città, Dimore, Turris”, 1990-1992 e 19992004; “Elmi, caschi, scafandri, borgognotte”, 1993-1998 e 2004. Altre scene propongono vere e proprie installazioni spazialmente reimmaginate per questo nuovo allestimento, come in particolare: “Stato d’assedio”, 1971-72; “Le morte stagioni”, 1973;“Ractus, ractus: stato d’assedio”, 1976-1979; “Il silenzio del giorno”, 1979; “Turrita urbis pugnandi”,1981-1984; “Colosseo”, 1994-1997. Infine alcune altre scene documentano cicli di disegni come quelli per Ciriaco Pizzecolli o di pirografie come quelle celebri ispirate a Leopardi. Il titolo “De rerum fabula” - caro all’autore come i molti latinismi, più o meno filologici, ricorrenti nelle sue intitolazioni - appare quantomai azzeccato in quanto, riassumendo i traguardi maggiori dell’immaginazione dell’artista marchigiano lungo quasi mezzo secolo di lavoro, sottolinea un aspetto che è emerso con particolare chiarezza soprattutto negli ultimi decenni. Ovvero un’affabulazione fiabesca, che sempre più sembra avvolgere la sua dimensione narrativa. L’opera di Trubbiani, secondo Enrico Crispolti - curatore della mostra e del catalogo, e critico che meglio di altri ne conosce la vicenda creativa ha sviluppato sostanzialmente un’affabulatoria dimensione narrativa attraverso l’assemblaggio poetico e sempre rinnovato di icone plastiche, effettuato con rara sapienza di manipolazione metallurgica, nella quale affluiscono, di volta in volta, con Le Cento Città, n. 48 diverso richiamo, componenti da molteplici matrici. Anzitutto l’ancestrale patrimonio di cultura fabrile familiare, originalmente nel tempo elaborato a livello quasi virtuosistico nella modulazione materica e nella combinazione cromatica dei metalli. Proprio in un recente dialogo con Marco Tonelli, che è riportato nel catalogo della mostra, è lo stesso Trubbiani a spiegare questo suo rapporto privilegiato e quasi esclusivo con il metallo: “Credo che ogni scultore abbia un destino materico. Non saprei mai lavorare il legno o il marmo, ma solo i metalli e questo perché ho ereditato la passione per i metalli da mio padre, che era un fabbro ferraio. Quindi ecco il materiale come destino presente e futuro di ogni scultore, il destino prefigurato e delineato dal materiale. Ricordo una bellissima frase di Fellini quando mi disse: mi piace molto il tuo lavoro perché tu hai rispetto per i materiali, non li stravolgi, non li offendi, cerchi di migliorarli, gli togli la pelle, l’epidermide, li metti a nudo”. L’artista nasce a Macerata nel 1937 e il padre è un “fabbro ferraio di macchine agricole e maniscalco”, proprio come il nonno paterno: da essi riceve un bagaglio pratico presto coniugato con eredità prossime di antropologia agraria di questa sua terra marchigiana e di un domestico patrimonio di memorie classiche che derivano da Helvia Recina - colonia romana progenitrice della Villa Potenza dei suoi anni giovanili - e dall’aulica Ancona, coniugata com’è alle imprese oltramarine dell’imperatore Traiano e alle peregrinazioni di Ciriaco Pizzecolli. Dopo gli studi all’istituto d’arte maceratese, Trubbiani ha frequentato l’Accademia di belle arti a Roma e, dal 1968 vive e opera ad Ancona. Nonostante riconosca un importante Luca Maria Cristini 30 Le morte stagioni, part. 03. Turrita urbis pugnandi, part. 01. A destra Colosseo part. 01. Le Cento Città, n. 48 Arte ruolo agli anni che egli stesso ha definito del “dirozzamento romano”, anni di frequentazione di importanti gallerie come la Tartaruga, l’Attico, La Salita e di relazioni con artisti quali Ceroli, Pascali, Marotta, Festa, Angeli, Schifano, è dal serrato dialogo con la terra marchigiana e con la propria città d’elezione che la sua arte trova primario spunto. E la mostra, con un tavolo interattivo posto in chiusura della “laica rappresentazione”, suggerisce un ideale percorso complementare alla grande antologica attraverso i luoghi di Trubbiani nel capoluogo marchigiano. Il visitatore è invitato a percorrere un itinerario esterno alla Mole, fra il gruppo scultoreo Mater amabilis, in Piazza Pertini, il Sipario tagliafuoco nel Teatro delle Muse, il rilievo e la cultura nella Facoltà d’Ingegneria, la Croce del Millenario nella Cattedrale di San Ciriaco, e i componenti plastici realizzati per il presbiterio della Chiesa dei santi Cosma e Damiano. In tutto la grande antologica “De rerum fabula” propone circa 160 opere fra sculture riunite in installazioni o componenti di ambientazioni, pirografie su legno e disegni, fruibili da visitatori vedenti e non. Le opere, infatti, possono essere anche toccate, così come tutte quelle ospitate nella ricca collezione permanente del contiguo Museo Tattile Statale Omero. L’osservazione tattile è infatti il principale canale di conoscenza del museo, fondato nel 1993 ad Ancona per volontà dell’Unione Italiana Ciechi, grazie al 31 Barbuto scafandro ocaiolo, 1993-94, rame bronzo ramato. Comune di Ancona e grazie a un finanziamento della Regione Marche. Istituito con l’intenzione di colmare un vuoto nel panorama dei servizi culturali per disabili visivi, ma anche per permettere a tutti un’esperienza innovativa attraverso suggestioni plurisensoriali extra-visive si è di recente trasferito nella sua Le Cento Città, n. 48 nuova sede proprio all’interno della Mole. La grande antologica su Trubbiani si inserisce nella scia di altre importanti iniziative dedicate negli anni scorsi dal Museo Omero a Francesco Messina, Giacomo Manzù, Loreno Sguanci e Walter Valentini. Scienza e letteratura 32 Uno scienziato allo specchio Renzo Tomatis e il laboratorio Bovino di Alfredo Luzi Nota metodologica L’analisi del rapporto vitaopera e il concetto di Erlebnis (esperienza vissuta) attraversano tutta l’ermeneutica letteraria che da Dilthey giunge fino ad Heidegger, e propongono una metodologia a cui si può riconoscere una qualche valenza euristica. Nel saggio Das Erlebnis und die Dichtung (Lessing – Goethe – Novalis – Hölderlin), (Esperienza vissuta e poesia) pubblicato nel 1922, il filosofo berlinese esplicita la dinamica tra biografia e produzione artistica, evidenziandone, da una parte, le connessioni: “L’opera d’arte non ha l’intenzione di essere espressione o rappresentazione della vita. Essa isola il suo oggetto dal nesso reale della vita e gli dà una totalità in se stessa. […] Essa eleva il sentimento della sua esistenza. […] L’opera d’arte infatti gli schiude la vista di un mondo più alto e più ricco di energia. E mentre gli fa rivivere quel mondo, mette in attività e impegna tutto l’essere del poeta, provocando un’adeguata vicenda di sensazioni psichiche che vanno dalla gioia dell’armonia, del ritmo e della perspicuità intuitiva fino alla comprensione più profonda dei fatti ch’egli rappresenta nei loro rapporti con tutta la vastità della vita” (Dilthey 1999: 198); e dall’altra, il conseguente processo d’interiorizzazione psicologica: “Così, nel substrato della creazione poetica sono contenuti un’interiore esperienza personale, la comprensione di situazioni altrui, l’allargamento e l’approfondimento di esperienze intellettuali. La creazione poetica muove sempre dall’esperienza della vita quale intima esperienza personale o intelligenza di altri uomini, sia presenti che passati, e degli avvenimenti cui essi ebbero parte. Ciascuna delle tante situazioni della vita attraverso le quali passa il poeta può essere psicologicamente definita un’esperienza interiore: Lorenzo Tomatis. un rapporto più profondo con la sua opera di poesia compete però solo a quei momenti della sua esistenza che gli rivelano un aspetto della vita” (Dilthey 1999: 199). A distanza di mezzo secolo, nel 1976, il geografo francese Armand Frémont, d’altro canto, recuperando un concetto filosofico già enucleato da Husserl, quello di Lebenswelt (mondo della vita), ha elaborato l’idea di espace vécu (spazio vissuto). Per Frémont gli uomini non vivono nello spazio così com’è ma nello spazio che essi stessi si autorappresentano e che percepiscono sul piano psicologico. Egli distingue tra spazio di vita (lo spazio euclideo anche estremamente vasto, attraversato materialmente nel corso di un’esistenza, toccato, calpestato, percorso effettivamente nella quotidianità) e spazio sociale (quello più ristretto, che viene elaborato interiormente perché predisposto a farsi assimilare: lo spazio vissuto, capace di fondersi con lo spazio interiore, di coincidere con la sfera dei valori di cui l’individuo è portatore). Egli, sulla base anche delle ricerche degli psicologi Abraham André Moles ed Elisabeth Rohmer, valorizza cioè la percezione, in rapporto ai valori psicologici ad esso attribuiti, del territorio in cui un gruppo Le Cento Città, n. 48 umano si muove ed intrattiene relazioni sociali. In questo spazio l’io scrivente instaura il suo contatto con l’alterità, individuale o collettiva, stabilendo una dialettica interna tra folla e città che proietta la visibilità della sua dimensione umana esterna nel luogo interno psichico, in un continuo gioco tra reale e immaginario. Frémont, sottolinea i rapporti di scala nella padronanza spaziale degli individui e dei gruppi, tanto da parlare di “gusci dell’uomo”, involucri che corrispondono all’ampiezza dello spazio esperito e che si rivelano flessibili in relazione all’età, all’evoluzione lavorativa e sociale degli individui (Frémont 1978: 29-39). È significativo il fatto che il geografo francese, nell’elencare i quattro fattori che costituiscono la percezione dello spazio da parte del soggetto (età, sesso, classe sociale, cultura), illustri la sua tesi attraverso un’originale analisi del romanzo di Flaubert, Madame Bovary, che egli considera una vera e propria rappresentazione della geografia del nostro mondo. Questa prospettiva è tanto più valida se proiettata sulla produzione di Renzo Tomatis, caratterizzata da una linea binaria di interessi, la ricerca di laboratorio sulla cancerogenesi sperimentale e la scrittura letteraria, accentrata sul canone del diario. Questi due campi della conoscenza si incrociano costantemente nella vita dello scienziato-scrittore nato nelle Marche nel 1929, avendo egli la capacità, come ha scritto Claudio Magris nella introduzione al romanzo postumo L’ombra del dubbio, pubblicato da Sironi nel marzo 2008, a sei mesi dalla scomparsa dell’autore avvenuta a Lione il 21 settembre 2007, “di trasformare l’esperienza scientifica, l’ethos della ricerca o la sua violazione, in struttura narrativa, in racconto della vita, delle sue Scienza e letteratura passioni, dei suoi compromessi, dei suoi tradimenti”. Il combinato disposto delle proposte metodologiche di Dilthey e di Frémont sollecita dunque una ulteriore riflessione sul carattere anfibologico del concetto di “autobiografia”. Se sulla scorta del pensiero di Léjeune sulla dinamica del patto autobiografico l’accento è stato posto sulla “scrittura della propria vita” forse potremmo individuare suggestioni efficaci sul piano euristico, in particolare nell’ambito della diaristica di scienziati, se privilegiassimo un ordine inverso degli elementi etimologici interpretando l’”autobiografia” come un modo di “vivere la propria scrittura”, una esperienza vissuta appunto nell’ambito del proprio spazio individuale e sociale che porta luce nella dimensione entropica dell’esistenza così come l’esperimento scientifico ha il fine di espandere le conoscenze. Scrivere, seppur attraverso la finzione narrativa, e condurre ricerche di laboratorio hanno in comune l’“esperire”, cioè una costante attitudine gnoseologica che dà senso alla quotidianità. Ed è forse la dimensione pragmatica della ricerca scientifica a spingere tanti scienziati a registrare nello spazio ristretto delle pagine di diario eventi, incontri, personaggi, successi e insuccessi sperimentali, sensazioni, riflessioni esistenziali, che determinano un reticolato autorappresentativo del proprio io, il cui valore veritativo, soprattutto, come nel caso di Tomatis, in cui questo emerge da un substrato fittizio, è all’incrocio tra proiezione soggettiva del “mirage” e riflessione oggettiva del “miroir”. Attraverso le strategie narrative del racconto in prima persona, che annulla la percezione nel lettore della distanza tra io storico e io narrante, delle effemeridi che ritmano la diacronia biografica e testuale, degli indicatori spaziali e temporali che creano l’epoché entro cui si sviluppa l’insieme narrativo, agisce il meccanismo della identificazione empatica tramite la lettura. Di questo processo di autoriconoscimento 1 33 mascherato è ben consapevole Renzo Tomatis che, nella nota apposta in conclusione del Laboratorio, scrive: Questo libro è frutto dell’elaborazione di mie personali esperienze e, nella sostanza, situazioni e persone sono vere, per quel tanto di verità almeno che io sono riuscito a scorgervi. Ma naturalmente mi sono preso parecchie libertà, e non solo ho usato quasi sempre nomi immaginari, ma ho anche messo una certa cura nell’alterare i rapporti tra persone e situazioni in modo da scoraggiare ogni tentativo di identificazione. Che ciò nonostante qualcuno possa fare degli accostamenti tra quanto è raccontato in queste pagine e sue proprie esperienze personali, può anche essere inevitabile.1 Ritengo che l’effetto di coinvolgimento del lettore e di percezione di realtà, pur nell’occultamento strategico dei dati evenemenziali da parte dell’autore, presente nel canone del diario letterario, abbia spinto Tomatis ad optare per questa forma di narrazione, più o meno romanzata, in tutta la sua produzione letteraria, la cui invariabile tematica resta il rapporto tra ricerca scientifica e società contemporanea. Il laboratorio, pubblicato in prima edizione da Einaudi nel 1965, La ricerca illimitata (Feltrinelli 1974), Visto dall’interno (Garzanti 1976), Storia naturale del ricercatore (Garzanti 1992), La rielezione (Sellerio 1996), Il fuoruscito (Sironi 2005), L’ombra del dubbio (Sironi 2008), sono opere tutte centrate sulle implicazioni tra supposta neutralità della ricerca e interessi economici, tra scienza e medicina, tra responsabilità sociali ed etica individuale, la cui ontogenesi rinvia alla biografia professionale dell’autore, studioso e medico di fama internazionale, noto soprattutto per aver dedicato 26 anni della sua vita alla direzione prima della Unità di Cancerogenesi e poi dell’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) a Lione. E proprio un grande scien- Renzo Tomatis, Il laboratorio, Sellerio, Palermo 1993, p.183 Le Cento Città, n. 48 ziato come Giulio Maccacaro ha saputo individuare in alcune righe della sua introduzione a La ricerca illimitata il gioco di riflessi, diffrazioni, configurazioni dell’immaginario, agnizioni, sdoppiamenti e raddoppiamenti del soggetto, in cui si imbatte il lettore delle opere di Tomatis: Tomatis è uno di quei timidi che han sempre l’aria di voler scomparire ma – assidui testimoni di in apparenti vicende – coltivano l’arte di una vibratile presenza appena defilandosi dietro uno schermo d’occasione o di stile. E lui si faceva schermo di uno specchio: così, chi allunga lo sguardo si ritrova con la propria immagine e con molte altrui, riflesse e rifratte in una luce un po’ scialitica. Questo specchio – dove appaiono molti altri volti ma un solo profilo dell’autore – è il diario che Tomatis tiene da molto tempo e del quale concede rare letture. Breve nota biografica Tomatis è nato a Sassoferrato nelle Marche nel 1929 da padre torinese e madre triestina. Laureatosi in medicina all’università di Torino, nel 1959 si trasferisce a Chicago dove rimane fino al 1967, dedicandosi alla sperimentazione delle culture in vitro e della cancerogenesi chimica. Tornato in Europa, dal 1967 al 1993 lavora a Lione presso l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro ( IARC) da lui diretta negli ultimi dodici anni. Andato in pensione nel dicembre 1993, si stabilisce ad Aurisina, cittadina a due passi da Trieste, città d’origine della madre, ma continua fino alla morte, avvenuta a Lione il 21 settembre 2007, a dedicare la sua competenza e la sua intelligenza ai problemi della prevenzione ambientale e in particolare al rapporto tra salute e società industrializzata. Il laboratorio L’occasione di scrittura del Laboratorio (Einaudi 1965) ha una marca fortemente autobiografica. Si tratta del diario, sotto- Alfredo Luzi posto successivamente a rielaborazione letteraria, tenuto durante un anno (dal 15 ottobre 1962 al 15 ottobre 1963) nel laboratorio di Philippe Shubik presso la Medical School di Chicago. Tomatis vi era approdato fin dal 1959, desideroso di ampliare le proprie opportunità di ricerca entrando a far parte di un gruppo che godeva di una grande reputazione internazionale e consapevole della pigrizia culturale e della povertà etica dell’università italiana, in cui, come egli scrive nel racconto La grande tela, “si sapeva con notevole anticipo chi sarebbe stato il candidato vincente per i posti che si liberavano di anno in anno con il contagocce e anche chi era stato designato come seconda scelta nel caso l’eletto rinunciasse, o che so, morisse improvvisamente”2. Una lettera dattiloscritta, datata 9 giugno 1964, di Italo Calvino, allora consulente editoriale esterno della Einaudi, documenta il parere favorevole dello scrittore alla pubblicazione del Laboratorio nella collana “I coralli” e nello stesso tempo rappresenta una prima puntuale ed esaustiva recensione al libro. Caro Tomatis, ricordo la sera passata insieme a Chicago e con piacere ho letto il tuo Diario di laboratorio. La mia reazione è stata: Finalmente! Finalmente anche la ricerca scientifica ha qualcuno che scrive del proprio lavoro e dei propri problemi, tutte cose di cui si sente parlare continuamente mentre nessuno ne scrive se non in termini generici, nessuno ne scrive in questo modo minuto come fai tu, mostrando gli uomini e le giornate e lo spirito con cui si fanno le cose e le delusioni e i perché. Viviamo in un’epoca in cui tutto viene raccontato, analizzato, seguito in ogni minimo cambiamento: tutto tranne il mondo del laboratorio. Mi pare che il tuo libro venga al momento giusto. La struttura ideale del libro – la sospensione tra le piccole miserie della vita scientifica in Italia e le miserie ingigantite e dorate della 34 vita scientifica in America – prende con forza. Il diario è troppo ricco e minuzioso? No, io credo che deva [sic] agire così, per accumulazione. E il tuo talento è in questa attenzione umana un po’ diffidente, che non lascia mai la preda. Dovrebbe essere un libro che la gente legge. Ma in questo non si può mai essere profeti. Certo, la lettura “a chiave” farà rumore nel mondo accademico: ed era ora. Oltretutto è un bel libro sull’America: l’unico tipo di libro sull’America che può scrivere un europeo senza contar balle: partendo da un’esperienza di lavoro, e poi tutto il resto come contorno […].2 In effetti la dominante della scrittura del Laboratorio, quella che appunto in musica porta un senso di sospensione, è l’idea di dislocazione, in una continua migrazione fisica e intellettuale tra Italia e Stati Uniti, senza nessuna possibilità di un ubi consistam. Il soggetto narrante è costantemente dimidiato tra la nostalgia intesa sul piano etimologico come sofferenza del ritorno e volontà di permanenza, sempre tuttavia revocata in dubbio. La cristallizzazione delle immagini del passato e l’impossibilità di mettere a fuoco lo sguardo sul futuro confliggono e determinano una condizione psicologica di estraneità, di sradicamento, di mancato equilibrio tra spazio vitale e spazio sociale. Proprio nell’imminente ricorrenza delle festività che rappresentano momenti di autoidentificazione collettiva la malinconia e l’incertezza traboccano: 12 dicembre Una di quelle giornate che si disfano senza lasciar niente nelle mani, ci si trova la sera stanchi e irrequieti. Ho traversato il centro per tornare a casa e la gran luminaria natalizia non ha fatto che aumentare la mia inquietudine. Ora ho solo una gran voglia di non esser qui, ma a casa. Nella casa di un tempo, con i rumori che conosco, l’aria di festa, la bella aria del 2 Italo Calvino, I libri degli altri, Einaudi, Torino 1991, p.481 Renzo Tomatis, Il laboratorio, Sellerio, Palermo 1993, pp.46-47. 4 Ivi, p.57 3 Le Cento Città, n. 48 dicembre con la speranza di neve, e fuori le strade nebbiose, piene di incanto. È come una reazione a catena: la voglia di essere a casa e perché mai sono qui; se avevo da venire qui perché ci sono ancora, è davvero valido il motivo che mi ha spinto a venire, e se era valido tre anni fa lo è forse ancora, son davvero convinto di fare delle cose importanti?3 Tomatis dissemina nei frammenti diaristici sciami isotopici della sua condizione di spaesato, trapiantato, sradicato, straniero, migrante. La nostalgia spesso si manifesta con l’irrompere di ricordi sensoriali legati agli odori (“Per qualche attimo sulla soglia di casa ho avuto nel naso odori famigliari, di stufe, di lana strinata, di minestrone” p.71) magari in funzione compensativa dell’aria dell’istituto (“Un’aria che porta con sé odori di muffa, di formalina, di polvere” p.145). Ma quando la nostalgia lo prende alla gola lo scrittore si rifugia nel recupero del rapporto euforico con la natura, il paesaggio: Prima di andare a lavorare sono andato a camminare in riva. Era quasi tiepido, un po’ di foschia, il lago era quieto. La luce, benché il sole fosse già abbastanza alto, pareva venire da qualche punto basso oltre l’orizzonte, illuminava intensamente l’acqua e un tratto di cielo. In alto c’era un grigiore contro cui la luce si smorzava. Una sensazione visiva che suggeriva il silenzio.4 La condizione disforica tra io e spazio collettivo viene compensata da uno spostamento patemico con il ricorso alla dimensione idillica sottolineata dalla adozione di immagini con valenza archetipica e psicoanalitica, come quella della neve: Uscendo, ho trovato la neve, ne era caduta più di dieci centimetri e continuava a venir giù fine fine. A causa del freddo intenso i fiocchi luccicavano come diamanti. Doveva nevicare da parecchie ore. Ma io, chiuso in laboratorio, non me ne ero accorto, durante l’intero pomeriggio non avevo guardato Scienza e letteratura una sola volta fuori dalla finestra. Prima di tornare a casa ho fatto un giro nel parco in riva al lago. La neve era intatta, non c’erano altre orme che le mie. Fatti pochi passi i rumori della strada erano spariti. Si sentiva il vento tra gli alberi e in qualche pausa del vento il picchiettio minuto della neve ghiacciata contro i rami. Sulla riva si erano formate alte dune di ghiaccio, piccoli vortici di vento alzavano la neve a mulinello sulle loro cime.5 Oppure attraverso il ripetersi, in spazi geograficamente diversi, delle stesse condizioni climatiche, che favorisce l’emergere dei ricordi e insieme il conflitto irrisolto tra ieri e oggi: Un pigro lunedì, grigio e caldo. Uno di quei giorni di luglio come ne vengono anche da noi. Nemmeno l’aria condizionata e le finestre sigillate impedivano di sentirlo. Lavorare costa più fatica del solito, bisogna scegliere lavoretti facili, cui non applicarsi troppo. E lasciare che la giornata passi. Ma come amavo queste giornate quand’ero a casa. Non importava se per esse trascuravo il lavoro o lo studio. C’erano dei posti in riva al fiume e in collina dove ogni anno tornavo, e al tramonto passeggiavo per le strade e le piazze della città, da solo o con gli amici mentre le rondini riempivano il cielo con le loro grida.6 Un brano descrittivo d’ambientazione torinese, tra le rondini gozzaniane e i luoghi di Pavese. Una scrittura, quella del Laboratorio, sempre sostenuta da una motivazione analitico-riflessiva, una sorta di critica del giudizio su se stesso e sugli altri che si concretizza nella ricerca delle motivazioni profonde che presiedono all’ethos individuale e collettivo, in una sorta di rigorosa, ma non per questo impietosa, ermeneutica morale. L’uso della prima persona favorisce la dina- 35 mica relazionale tra l’io e gli altri e dilata le capacità autoriflessive del soggetto che si mette in discussione guardando dentro di sé come in uno specchio e nello stesso tempo cercando di far luce nella psicologia dei personaggi che incontra. Così nella pagina si equilibrano, in un suggestivo gioco tra fuori e dentro, la narrazione evenemenziale e realistica e quella dell’introspezione psicologica. Il sentimento prevalente è il pessimismo, generato da una lucida analisi della condizione della ricerca scientifica in Italia e dai timori dell’insuccesso nella sperimentazione di laboratorio. Ne consegue che il ricercatore non riesce mai a liberarsi da una inquietudine che però è l’elemento dinamico della attitudine all’indagine scientifica. Il personaggio Spencer, in un colloquio con l’io narrante sulla possibilità di errore insita in una sperimentazione, ammonisce: “Se vuoi basare la tua felicità o la pace con te stesso sui risultati del tuo lavoro né felicità né pace troverai, mai”.7 Ma, forse in pari dosi, la speranza e la fiducia riescono ad attutire la negatività del pessimismo che rischierebbe di spingere il soggetto verso l’inerzia intellettuale e pragmatica. Tomatis si interroga costantemente sul ruolo dello scienziato nella società contemporanea e sulla efficacia delle ricerche di laboratorio. Preso atto della presenza dell’errore nell’edificio della scienza esatta, come già Max Planck aveva dichiarato nel primo decennio del secolo e come avrebbero confermato le riflessioni di Heisenberg sul principio di indeterminazione, lo scrittore-scienziato si sente inadeguato difronte al compito di collaborare con la propria ricerca a liberare l’uomo dalla sofferenza ma sa che, per avvicinare il mondo della scienza a quello dell’umanità, davanti ad 5 Ivi, p.76 Ivi, p.160 7 Ivi, p.154 8 Ivi, p.160 9 Ivi, pp.112-113 10 Ivi, p.133 11 Ivi, p.149 6 Le Cento Città, n. 48 un insuccesso, si dovrebbe esser capaci di acquistare una certa dose di umiltà nel superare prove del genere. Questa benedetta umiltà che così spesso vorrei predicare agli altri e così raramente trovo in me stesso. […] Il nostro lavoro non può che essere un impegno costante, condotto con precisione e onestà come un’infinità di altri lavori.8 E critica, sul piano etico e sociale, chi, invece di mettere a disposizione della comunità scientifica i propri risultati della ricerca, ne riduce la valenza ermeneutica tenendoli nascosti, come fa il personaggio Flowers: Questo ardito comandante rischia di scambiare per nemico chiunque si avvicini alle sue posizioni, dimentico che altri come lui potrebbero voler solo passargli accanto e procedere oltre nel gran deserto che attende. E di costoro alcuni certamente sono stati fermati nel loro slancio, delusi perché invece di un amico che avrebbe potuto fornire importanti notizie sull’ignoto che attende, hanno trovato un inatteso nemico; di costoro alcuni costruiranno lì accanto altri fortilizi buoni sia all’offesa che alla difesa. E spenderanno il resto della loro esistenza in combattimenti locali finendo di preferire l’inutile lotta contro un nemico noto all’altra contro l’ignoto.9 Tomatis è contrario alla conflittualità che regola, soprattutto negli Stati Uniti, i rapporti tra gruppi di ricerca: Ci sono regole del gioco nel mondo della ricerca che in parte non ho ancora capito, in parte mi rifiuto di capire. Lo spirito di corpo, quello che Stephen ha messo in evidenza l’altro giorno, è una di queste ultime.10 Ma riconosce che “non c’è cosa più stimolante del percepire questa spinta in profondità della ricerca”11, attribuendo così al proprio lavoro una ampia potenzialità euristica. Alfredo Luzi La contestualizzazione storica dell’esperienza autobiografica, sia quella del laboratorio sia quella del diario, è garantita da riferimenti ad eventi che hanno segnato gli anni 60 in Italia e nel mondo. C’è traccia, nelle brevi sequenze narrative conformi alla essenzialità delle note diaristiche, della crisi di Cuba dell’ottobre 1962, del trattato Kruscev – Kennedy sulla riduzione degli armamenti nucleari del 1963, della morte di papa Giovanni XXIII, della morte di Tambroni e delle elezioni politiche in Italia. Ma la dinamica cronotopica del libro ha un duplice andamento che definirei “diasistematico”, muovendosi alternativamente, a livello macrostrutturale, tra Italia e Stati Uniti, messi sempre a confronto sul piano della organizzazione sociale e di quella scientifica, e, a livello microstrutturale, tra lo spazio chiuso del laboratorio e quello collettivo della vita socializzata e del paesaggio. L’ambiente accademico e scientifico italiano, visto da lontano, e dunque in una prospettiva di minor coinvolgimento emotivo, appare dominato da una totale anomia etica, “corroso e corrotto” (sono lemmi utilizzati dall’autore) dalle raccomandazioni, dal baronaggio dei professori universitari, dall’immobilismo scientifico, dalla routine assunta come valore meritocratico. Un sistema sociale e culturale in cui non si fa ricerca ma si è attenti ai meccanismi consolidati ed accettati dalla comunità che permettano di fare carriera, alle camarille, al pettegolezzo. Mi ha scritto anche Git. oggi. Mi dice: “in Italia nulla cambia, non ti muovere da dove sei”. Me ne ero già accorto la scorsa estate in Italia: coloro che più caldamente mi consigliano di restare dove sono, son quelli che mai si sono mossi o che più tenacemente sono attaccatti al cadreghino che occupano.12 36 Certo, negli Stati Uniti, i finanziamenti e le attrezzature disponibili per fare ricerca liberano lo scienziato da quel senso di precarietà che impedisce a chi vuol fare sperimentazione in Italia di programmare il futuro. Ma ciò non vieta a Tomatis di gettare il suo sguardo critico sulle miserie morali che tarlano anche l’efficiente sistema scientifico americano in cui “essenziale è vincere, i mezzi per cui si arriva al successo contano meno”13, e sulla settorialità delle competenze che limita un prospettiva d’insieme delle finalità di un progetto di ricerca, spesso caratterizzato da una “desolante unilateralità di interessi che accomuna la maggioranza dei ricercatori di qui”.14 Sul piano stilistico la condizione di sdoppiamento dell’io narrante che non ha prospettive di carriera in Italia ma nello stesso tempo ha dubbi sulla definitiva permanenza negli Stati Uniti è evidenziata dal ricorrente uso della metafora ossessiva del parlare, del raccontare, che fa da tessuto connettivo alle sequenze che descrivono gli incontri tra italiani. Si realizza così una sorta di mise en abîme, costituita da parole chiave come “racconto, narrare, chiacchiera, parlare, conversare, scrivere una lettera, scrivere un romanzo”, attraverso la quale l’autore esorcizza, con una procedura autoironica di distanza, il potere comunicativo del proprio atto di scrivere. Nel Laboratorio, diario di una ricerca scientifica, è però presente, inattesa per il lettore, anche la letteratura. Il personaggio English traduce Montale, gli studenti dell’ University of Chicago leggono Robbe - Grillet, Beckett, Ferlinghetti, si parla di Pasternak, si fa riferimento ad una visita a Mosca di Carlo Levi, autore di un libro sulla Russia, Il futuro ha un cuore antico, pubblicato in Italia nel 1956, proprio nei giorni in cui esce in traduzione 12 russa Cristo si è fermato a Eboli. Giustamente Paolo Vineis, noto studioso delle connessioni tra ambiente ed elementi cancerogeni, ha scritto: In una concezione a trecentosessanta gradi della cultura, Renzo non faceva una distinzione netta tra scienza e umanesimo: per lui si trattava sempre di attività dell’uomo a servizio dell’uomo.15 A distanza di ventotto anni Il laboratorio conosce una nuova edizione presso Sellerio. E Tomatis riavvia il suo colloquio con il lettore apponendovi una post-fazione dal titolo Trent’anni dopo. Egli osserva che, nonostante le sollecitazioni utopiche del ’68, nell’Italia degli anni novanta nulla è cambiato nella dinamica della ricerca scientifica. Anzi, il sistema si è incancrenito e la scienza è “sempre più centralizzata, sempre più al servizio di interessi accentrati nelle mani di chi tiene i cordoni della borsa. Gli orientamenti della ricerca dipendono pesantemente dai canali di finanziamento”16. Ma nonostante il “pessimismo della ragione” che informa non solo le pagine del Laboratorio ma anche quelle delle successive opere letterarie Tomatis intravvede uno spiraglio di nuova consapevolezza in coloro che dovrebbero sempre tener presente che la scienza, pur nella sua supposta neutralità, deve essere al servizio dell’uomo per aiutarlo a capir eil mondo in cui vive: Rimane da vedere (scrive Tomatis) fino a qual punto i ricercatori che sono attivi oggi e quelli che si stanno formando per esserlo in un prossimo domani, sapranno contrastare una soffocante manipolazione della scienza da parte di chi detiene le fila del potere economico.17 Ivi, p.163 Ivi, p.47 14 Ivi, p.72 15 Paolo Vineis, Un uomo coerente, in Renzo Tomatis, L’ombra del dubbio, cit., pp.14-15 16 Renzo Tomatis, Il laboratorio, cit., p.196 17 Ivi, p.197 13 Le Cento Città, n. 48 Libri ed eventi 37 di Alberto Pellegrino LIBRI Il Romanico nelle Marche La Banca delle Marche ha pubblicato nel dicembre 2012, come strenna natalizia, un bellissimo volume intitolato Il Romanico nelle Marche a cura di Cristiano Cerioni, un ricercatore che ha collaborato con l’Università di Firenze e che ha redatto anche l’Atlante dell’edilizia medioevale nel Montefeltro. Il testo è opera del prof. Paolo Piva, docente di storia dell’arte medioevale presso lì Università di Milano e autore di numerose opere sul Medioevo. Il volume, che è corredato di un apparato fotografico di grande valore, si apre con un saggio intitolato Architettura e integrazioni figurative. Dalla tarda antichità ai secoli del Romanico che presenta gli obiettivi e i confini della ricerca condotta sul territorio, la storiografia e lo stato degli studi, per poi passare all’analisi dei centri paleocristiani marchigiani, prendendo in esame cattedrali, santuari e testimonianze figurative. Successivamente si passa a esaminare l’architettura protoromanica e lo straordinario contributo fornito dall’architettura farfense per arrivare al rinnovamento dell’XI, XII e XIII secolo con la costruzione di cattedrali e chiese urbane. Il saggio si conclude con un’accurata analisi delle tecniche costruttive, delle tipologie degli edifici religiosi e degli edifici annessi, della scultura e della pittura romaniche. Si passa quindi a un esame dettagliato e preciso dell’intera civiltà romanica regionale attraverso una razionale suddivisione del territorio ripartito per le vallate nelle quali sono collocati i vari monumenti: il Montefeltro e la valle del Foglia, le Valli del Metauro, del Cesano, dell’Esino; il percorso s’interrompe per prendere in esame le chiese di Ancona, per poi riprendere con le Valli del Musone e del Potenza, del Chienti, del Tenna, per concludersi infine con le Chiese di Ascoli e Grottamare. Il volume si chiude con un’accurata documentazione iconografica e un aggiornamento storico critico a cura di cristiano Cerioni e con un’ampia bibliografia. Segni di gloria. Una storia del nostro Risorgimento attraverso la satira E’ uscito nel dicembre 2012 un bellissimo volume intitolato Segni di gloria. Storia d’Italia nellastampasatiricadalRisorgimentoallaGrandeGuerra18481918 a cura di Fabio Santilli, presidente del Centro Studi Gabriele Galantara. Si tratta del catalogo che ha accompagnato l’omonima mostra che si tenuta presso il Complesso del Vittoriano a Roma dal 13 dicembre 2012 al 2 febbraio 2013 sempre a cura del Centro Studi di Montelupone e dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. È stato possibile realizzare la mostra e la stampa del volume grazie al contributo del Ministero del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per la Gioventù, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Marche, della Provincia Le Cento Città, n. 48 di Macerata e di numerose altre istituzioni fra cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, le Università di Roma Tre e di Macerata, la Fondazione Carima e Banca delle Marche. Il volume di 400 pagine è caratterizzato da un’accurata analisi storica della satira e da una straordinaria documentazione iconografica a cura di Fabio Santilli ed è suddiviso in tre parti: 1848-1871. Un’espressione geografica: aspirazioni e unificazione con l’introduzione di Mario Belardinelli, docente di Storia contemporanea dell’Università di Roma; 1871-1911. Trasformazioni e trasformismi nell’Italia liberale con l’introduzione di Fulvio Cammarano, docente di Storia contemporanea dell’Università di Bologna; 1911-1918. Deflagrazioni: dal sogno libico alla Grande Guerra con l’introduzione di Paola Magnarelli, docente di storia contemporanea dell’Università di Macerata. Il volume si chiude con un saggio del sociologo Alberto Pellegrino su La stampa satirica e la formazione dell’opinione pubblica. Si prevede che per la prossima estate la mostra sarà trasferita preso il Comune di Montelupone. Lo spettacolo dal vivo nelle Marche Alberto Pellegrino L’11 febbraio presso il ridotto del Teatro delle Muse è stato presentato il volume Lo spettacolo dal vivo nelle Marche (il lavoro editoriale) edito dall’assessorato ai beni e alle Attività Culturali della Regione Marche e dal Consorzio Marche Spettacolo. Si tratta del primo censimento di tutte le attività riguardanti ogni tipo di spettacolo che hanno avuto luogo nella regione nel triennio 20082010 attraverso un lungo lavoro di ricerca coordinato da Renato Pasqualetti e svolto dai borsisti Giorgia Berardinelli e Stefano Silvi. Tutte le informazioni statistiche sono state raccolte in un anno e mezzo di lavoro per mezzo di due schede-questionario rispettivamente indirizzate ai soggetti pubblici e ai soggetti con natura giuridica privata. In questo modo è stato possibile raccogliere tutte le informazioni riguardanti i soggetti che operano nelle Marche, gli eventi dello spettacolo dal vivo, il numero dei lavorati addetti al settore, il bilancio costi e ricavi dei vari soggetti pubblici e privati, il numero di spettatori relativi ai vari comparti dello spettacolo. Sono state predisposte e pubblicate le schede tecniche dei teatri marchigiani operanti nelle cinque provincie con tutti i dati riguardanti ogni singolo teatro che sono finalmente a disposizioni dei vari operatori dello spettacolo; in appendice sono anche elencati in ordine cronologico tutti i teatri storici delle Marche. Nella prima parte del volume si è voluto ricordare con una serie di saggi quanto sia profonda e diffusa la tradizione teatrale nelle Marche: Spettacolo e società nelle Marche tra Seicento e Ottocento di Alberto Pellegrino; Rossini e il Rossini Festival di Gianfranco Mariotti; Giovanni Battista Pergolesi di Giovanni Tangucci; Una voce poco fa (i grandi cantanti lirici) di Gabriele Cesaretti; La tradizione del teatro di prosa nelle marche: autori, attori, esperienze di Pierfrancesco Giannangeli. 38 Un’Antigone marchigiana Da qualche tempo il quotidiano La Repubblica ha varato una collana di libri intitolata “Save the story”, che è considerata “una scialuppa che porta in salvo, nel nostro millennio, qualcosa che sta naufragando nel passato. Gli oggetti che, come questo libro, sono specie in via di estinzione”. L’idea è stata non solo quella di proporre dei volumi a basso costo, rilegati, con un’elegante veste tipografica e delle belle illustrazioni, ma una riduzione di una serie di capolavori della letteratura e del teatro, opportunamente ridotti e “riscritti” con un linguaggio agile e moderno, in modo da richiamare l’attenzione anche di una generazione di lettori più giovani. La riduzione di questi classici (da contenersi entro le cento pagine) è stata affidata a importanti scrittori come Umberto Eco, Stefano Benni, Alessandro Baricco, Andrea Camilleri. Il numero nove della collana è stato affidato alla scrittrice e poetessa scozzese Ali Smith, cui è stato assegnato il compito di riproporre il mito di Antigone, a suo tempo definita la più grande tragedia di tutti i tempi. La vicenda della fanciulla che ha il coraggio di violare la legge dello Stato (che le proibisce si seppellire il corpo del fratello) in nome di una più alta legge morale è presentata attraverso gli occhi di una cornacchia che osserva lo svolgersi degli eventi dall’alto delle mura di Tebe. La cosa che ci riguarda da vicino è che le illustrazioni di Le Cento Città, n. 48 questo libro sono state affidate a Laura Paoletti, una giovanissima artista maceratese laureata in pittura che nel 2012 è stata selezionata a Bologna per la mostra La Grammatica delle Figure e che quest’anno realizza la sua opera prima. Un saggio sulla letteratura italiana al femminile Carla Carotenuto, che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Macerata, ha dato recentemente alle stampe il volume Identità femminile e conflittualità nella relazione madre-figlia. Sondaggi sulla letteratura italiana contemporanea: Durante, Sanvitale e Sereni (Metauro Edizioni, Pesaro, 2012). L’autrice studia alcuni aspetti fondamentali della letteratura al femminile con particolare riferimento alla relazione madre-figlia vista l’importanza che questo rapporto continua ad avere nella narrativa contemporanea prodotta da autrice con opera che sono in grado di richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico e della critica. È opportuno sottolineare che nella seconda meta del Novecento si è registrato un graduale interesse nei confronti delle opere di scrittrici che hanno fornito apporti originali in grado di rinnovare il contesto culturale del paese. Non solo si è proceduto al recupero di scrittrici dimenticate dalla storia ma che hanno avuto una notevole importanza artistica e sociologica, ma vi è stata anche una maggiore attenzione nei confronti della produzione letteraria contemporanea per cui si sono pubblicate molte opere di scrittrici, le cui pagine sono entrare anche nelle antologie scolastiche. Inoltre questi libri sono stati affiancati da saggi, articoli di critica, interviste che hanno risvegliato l’attenzione del pubblico. Oggi, pertanto, il panorama della letteratura femminile si presenta quanto mai vasto, comprendendo fiabe e favole, racconti e romanzi, opere teatrali e raccolte di poesia, sceneggiature cinematografiche e televisive. La Carotenuto, partendo dal Libri ed eventi microcosmo familiare e dall’identità femminile, concentra la sua ricerca sull’incontro critico e spesso conflittuale tra madre e figlia, che implica un confronto tra due femminilità con implicazioni che provocano sofferenza, legami di amore-odio, sensi di colpa e con esiti differenti (subordinazione, simbiosi, identificazione, conflittualità, armonia, nostalgia, rifiuto, ecc.). L’autrice, per esaminare a fondo questo aspetto così problematico della vita familiare, propone un’analisi approfondita delle opere di tre autrici contemporanee (Francesca Duranti, Francesca Sanvitale e Clara Sereni), basandosi su alcuni criteri generali come l’individuazione dei caratteri e della specificità della scrittura femminile, dei legami e dei rapporti tra ragione e sentimenti, l’attenzione ai contributi della psicologia e della psicoanalisi con particolare riferimenti alle opere di Freud e alle teorie di post-freudiani. “Pesaro damare MMXIII” Il fotografo pesarese Luciano Dolcini ha pensato di festeggiare i 45 anni di attività fotografica realizzando una pubblicazione Pesaro damare MMXIII che è riduttivo definire un calendario, perché intorno a questa iniziativa si è riunito un team di notevole valore, formato dalla storica dell’arte Anna Maria Benedetti Pieretti, dal pittore Franco Fiorucci, dal poeta Franco Ampollini, dal grafico Daniele Felicioni, tutti uniti dalla stessa passione per la loro città natale e per il mare su cui essa si affaccia. Sui dodici fogli del calendario si alternano le foto di Dolcini e gli acquarelli di Fiorucci (tutti accompagnati dai testi poetici di Ampollini), due diversi lin- 39 guaggi iconografici che riescono tuttavia a segnare l’avvicendarsi delle stagioni e soprattutto a restituire tutto il fascino del mare che rimane il tema conduttore dell’iniziativa. Abbiamo trovato particolarmente suggestive almeno tre immagini: il mese di aprile esprime una sua forma di elementare lirismo con i rami fioriti di mandorlo che ricorda certe immagini giapponesi; completamente diverso il mese di giugno con le file di ombrelloni schierati come un piccolo esercito un gioco cromatico contrassegnato da un rigoroso geometrismo; infine il mese di agosto con la sua esplosione cromatica di bianchi e di azzurri vuole celebrare tutto il fascino del mare nel trionfo luministico dell’estate. GLI EVENTI La stagione lirica 2013 alle Muse Stagione lirica ridotta ma certamente valida quella proposta nel Teatro delle Muse dal direttore artistico Alessio Vlad che voluto mettere a confronto tre composizioni tutte nate tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento. La prima è la cantata L’enfant prodigue (1884) di Claude Debussy L’autore del libretto Edouard Guinand si è ispirato alla parabola evangelica del Figliol Prodigo, collocando la vicenda in un villaggio nei pressi di Nazareth dal quale il giovane Azael si è allontanato senza dare più notizie al padre (Siméon) e alla madre (Lia), la quale invoca disperata l’aiuto di Dio senza tuttavia perdere la speranza di rivedere il figlio che ritorna povero, lacero, affamato. I genitori lo accolgono felici, lo perdonano e invitano tutto il villaggio a festeggiare la pecorella smarrita. Il francese Arnaud Bernard, che ha curato regia, scenografia e costumi, ha eliminato ogni riferimento religioso e ha messo in scena una pièce laica ambientata nel 1884 con una forte impronta freudiana (siamo nel periodo in cui Freud inizia gli studi di psicanalisi). Le Cento Città, n. 48 All’interno di una camera completamente nera, in un grande letto matrimoniale dorme una coppia borghese e tutto sembra assumere da quel momento le dimensioni del sogno, quando questa giovane madre si sveglia e, avvolta in una bianca camicia da notte, vede materializzarsi davanti a sé il figlio, che ha amato in modo appassionato e morboso; quindi lo abbraccia e lo ascolta rievocare un “tempo per sempre perduto”, un tempo della gioia e della purezza, ma anche il tempo di un impossibile ritorno. Invano trattenuta dalla madre, l’immagine si dissolve e lascia la donna nella disperazione per poi riapparire come un ectoplasma sulla grande parete nera che diventa lo schermo su cui si proiettano sia le pulsioni materne, sia la voglia di pentimento e di riscatto del figlio. Quando però il padre si appresta a festeggiare il ritorno del giovane, tutto sparisce e alla coppia non resta che ritornare nel letto-rifugio dove cercare conforto nel sonno e forse ancora nel sogno. Bernard ha condotto in porto con pieno successo questo progetto di spettacolarizzazione della cantata, grazie anche alla puntuale direzione di Carla Delfrate, cui si aggiunge l’appassionata interpretazione di Elisabetta Martorana bene affiancata dal giovane tenore Davide Giusti. Con un originale accostamento al fianco della cantata viene propostalaCavalleriarusticana (1890) di Pietro Mascagni. Il regista Arnaud Bernard, anche in questo caso, abbandona la strada maestra del Verismo per seguire le vie tortuose della psicanalisi, mettendo in scena una originale e del tutto inedita lettura dell’opera di Mascagni. Il regista ha voluto sottolineare il rapporto viscerale e sensuale che lega la carnalità di un plurimo tradimento alla religiosità della Pasqua-Resurrezione del Cristo e, pur nel rispetto delle unità di luogo, tempo e azione, ha tolto dalla vicenda ogni riferimento alla sicilianità, ai campi dalle spighe d’oro, al sole che acceca e riscalda le menti, Alberto Pellegrino 40 Madama Butterfly, stagione lirica Teatro delle Muse, Ancona, 2013. Le Cento Città, n. 48 Libri ed eventi per trasportare la vicenda in un cupo ambiente claustrofobico, dove l’azione si svolge alla luce delle candele, mentre al centro della scena domina il cero pasquale intorno al quale ruota quasi tutta la vicenda. Egli abbandona il mondo contadino di fine Ottocento per collocare la storia nei primi anni Sessanta più liberi, anche se ancora legati alle tradizioni popolari e al culto dell’onore, indicando come chiave di lettura una commistione di erotismo e sacralità che si manifesta fin dall’inizio con l’amplesso in scena tra Turiddu e Lola, subito seguito dalla presenza di Mamma Lucia che prega con il rosario in mano (elemento ricorrente per tutto lo spettacolo) dinanzi alla fotografia del Crocefisso, la prima di una serie di immagini-metafora che il filo conduttore di tutta la rappresentazione. Sulla scena passano prima una schiera di sacerdoti, poi una lunga fila di donne e uomini, bambine e chierichetti che si apprestano ad arredare la chiesa per i riti della Pasqua con fasci di fiori e bianche lenzuola in un passaggio dall’esterno all’interno segnato dall’immagine del Vangelo con sopra un Crocefisso, mentre alcuni sacerdoti introducono il grande cero pasquale. La scena si trasforma rapidamente nell’osteria di Mamma Lucia che diventa il luogo deputato dell’azione: le donne che fanno i preparativi per la festa, l’arrivo spavaldo di Alfio, i drammatici incontri di Santuzza con Lucia, con Turiddu e infine con Alfio, con i quali si preannuncia la “mala pasqua” sotto una splendida foto di giovane donna che mostra la schiena nuda avvolta in un rosario (Woman with Large Crucifix di Ellen Denuto). Ricca di belle suggestioni è la notturna processione pasquale con ceri e lumini, che conduce all’interno della chiesa con un crescendo luministico che trova la sua centralità nel cero pasquale, mentre all’esterno si consuma la tragedia di Santuzza condannata alla solitudine e all’emarginazione sociale. Da 41 questo momento la scena sarà dominata da due mani di donna intrecciate a un rosario (foto di Stéphane Barthe) in un continuo passaggio dalla sacralità della chiesa al profano dell’osteria, dove fa la sua apparizione la sensuale Lola, si celebra il rito del brindisi e della sfida tra Alfio e Turiddu, si svolge lo struggente addio del figlio a Mamma Lucia. Una folla in chiaroscuro si raduna in attesa per accogliere sbigottita il grido di donna che prorompe dalla platea per annunciare il tragico epilogo del duello, mentre la foto delle mani con il rosario si copre di sangue. Per noi lo spettacolo termina qui, ma il regista ha voluto far morire in scena Turiddu con la bianca camicia coperta di sangue, un tocco di contradditorio realismo in un mondo dominato da una serie di efficaci metafore, unico neo di uno spettacolo che rimane bellissimo per originalità e intensità drammaturgica. La direzione di Carla Delfrate aggiunge spessore drammatico a tutta l’opera nel pieno rispetto di quel dominio della melodia voluto da Mascagni. Di buon livello la prestazione degli interpreti: la dolente presenza di Mamma Lucia (Giovanna Donadini), la sensualità arrogante di Lola (Aliona Staricova), la violenta presenza di Alfio (Gianfranco Montresor), la prorompente e giovanile passionalità di Turiddu (il giovane Kamen Chamev) e, su tutti, la splendida Santuzza di Anna Malavasi che ha saputo esprimere la passione, il dolore, la ribellione e la voglia di vendetta del personaggio. Di un fascino elementare ma efficace è apparsa la seconda opera in cartellone Madama Butterfly (1904) sempre con la messa in scena di Andrea Bernard che ha concentrato la vicenda sopra una piattaforma sospesa sopra una laguna sulla quale galleggiava una distesa di fiori rossi sostituiti nel secondo atto da un mare di bandierine americane a sottolineare l’occidentalizzazione di quella casa, dove anche la protagoLe Cento Città, n. 48 nista veste abiti occidentali. In un complesso alternarsi di luci, si arriva alla drammatica conclusione quando Butterflay riprende gli abiti tradizionali e si genuflette dinanzi alla piccola casa-scrigno, custode delle memorie familiari, prima di porre fine alla sua dolorosa esistenza. Come sempre si è avuto un cast di valore con un ottimo Luciano Ganci (Pinkerton), un convincente Gianfranco Montresor (Sharpless) e una bravissima Elena Popovskaya nei panni di Madama Butterfly. Un testo teatrale di Elsa Morante coprodotto dal TSM Ha debuttato a Torino il 15 gennaio quello che si presenta come uno dei grandi eventi teatrali del 2013: grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile di Torino, l’Associazione Teatro di Roma e il Teatro Stabile delle Marche è stato messo in scena il dramma La serata a Colono, l’unica opera teatrale di Elsa Morante scritta nel 1968 e pubblicata nel volume Il mondo salvato dai ragazzini (ora ripubblicato da Einaudi nella Collezione di teatro). Il testo non è stato mai rappresentato, anche se nel 1970 Carmelo Bene, che considerava questo lavoro “il capolavoro della Morante, vertice della poesia italiana del Novecento”, aveva progettato di farne un film con l’interpretazione di Eduardo De Filippo, ma il progetto non andò in porto. Ora finalmente il testo prende corpo sulla scena con la regia e la scenografia di Mario Martone, al suo terzo incontro con il personaggio di Edipo. Il regista si avvale di un suggestivo progetto luci di Pasquale Mari e delle musiche di Nicola Piovani con un cast particolarmente numeroso nel quale spiccano i nomi di Carlo Cecchi (Edipo), di Antonia Truppo (Antigone) e di Angelica Ippolito (La Suora). In un ospedale fra medici e infermieri arriva, accompagnato dalla figlia, una malato grave che manifesta chiari segni di follia tanto da dover essere legato mani e piedi al letto; egli porta anche una Libri ed eventi 43 benda sugli occhi perché in un impeto di furore si accecato. L’autrice ha voluto trasporre in epoca contemporanea il grande mito di Edipo fornendo come chiave di lettura il sottotiolo del dramma “Parodia”. Infatti, il protagonista ripercorre per tutto lo spettacolo fino alla sua morte con le sue ossessioni, la sua vocazione autolesionistica, il suo mondo diviso tra immaginario e follia, ossessionato da un coro di voci che si ripercuotono ossessivamente nella sua mente. Così Edipo rievoca una vita segnata dal Fato attraverso un linguaggio poetico, ma anche esasperato e ironico, vittima di un destino che è impossibile eludere (“io sono qua, stretto con le corde alla sua croce così che le mie vene s’attorcigliano con le vene di questo legno…Lui, non nato, splende impassibile nell’affermazione della sua morte eterna, mentre io brucio nella mia negazione disperata”). Lo spettacolo sarà al Teatro delle Muse di Ancona dal 4 al 7 aprile 2013. La Fondazione Pergolesi Spontini pubblica le opere pergolesiane Con la pubblicazione de La Salustia si è conclusa la serie dei dvd prodotti dalla Fondazione Pergolesi Spontini e riguardanti i melodrammi messi in scena nel biennio 2010-2011 in occasione del quanto centenario della nascita del grande compositore jesino. La Salustia è la prima opera composta dal Pergolesi nel 1731 e s’ipotizza che il libretto sia un adattamento tratto dall’ Alessandro Severo di Apostolo Zeno scritto probabilmente da Gennaro Antonio Federico che è stato per anni il librettista di fiducia del compositore. Il Cavalleria Rusticana, stagione lirica Teatro delle Muse, Ancona, 2013. primo grande successo di Pergolesi arriva con Il prigioniero superbo (1733) accompagnato dall’intermezzo La serva padrona, destinato in breve tempo a diventare la più celebre opera buffa del Settecento; ambedue i lavori sono stati composti su libretto di Gennaro Antonio Federico. Il successo si rinnova nel 1734 con Adriano in Siria, opera di notevole spessore musicale e sorretta dal libretto del grande Pietro Metastasio; in questo caso l’intermezzo è Livietta e Tracollo ovvero La contadina astuta su libretto di T. Mariani (?). Il quarto e ultimo dvd contiene Il Flaminio (1735), deliziosa opera buffa scritta dal fedele Gennaro Antonio Federico che apre nuove strade nel genere del melodramma comico. La pubblicazione de Le Cento Città avviene grazie al generoso contributo di Bancadell’Adriatico,BancaMarche,Carifano,Carisap,Co.Fer.M., Fox Petroli, Gruppo Pieralisi, Santoni, TVS Le Cento Città, n. 48 Vita dell’Associazione 45 Visite e convegni di Giovanni Danieli 11 febbraio 2013, Offida Carnevale ad Offida Tradizionale appuntamento de Le Cento Città con Offida, in occasione del Canevale. Si è iniziato con la visita di Santa Maria della Rocca, gioiello dell’arte romanico-gotica, cripta d’epoca longobarda con affreschi attribuiti al Maestro di Offida, tanto stupendi quanto insospettati. Poi l’arte del tombolo, ritorno al passato, arte tramandata di generazione in generazione, incontro con Iolanda Ottavi e l’ultima evoluzione del tombolo, il merletto gioiello. Infine, per le strade, contrade in costume, uomini e donne in un camicione, qui chiamato guazzarò, lunghe fascine sulle spalle, i vlurd, accese alle estremità; accumulo di vlurd nel centro della piazza, una delle più belle delle Marche, gran falò, vino, balli, canti. Allegria diffusa nell’aria. Il merletto gioiello di Iolanda Ottavi. 7 dicembre 2012, Macerata Padrò e contadì Nella ricorrenza del trentesimo anniversario dell’approvazione della legge sull’abolizione della mezzadria, il convegno, ideato e realizzato da Cinzia Maroni, ha affrontato una tematica originale: la trasformazione del patto mezzadrile in affitto vista anche dalla proprietà agraria. Una riflessione su come tale trasformazione abbia interrotto per sempre il rapporto tra i proprietari terrieri e la terra, con la conseguente rovina della classe agraria seguita dall’abbandono dei palazzi nobiliari in città e delle residenze in campagna. Dal convegno è emerso che anche per i contadini la trasformazione del patto mezzaLe Cento Città, n. 48 drile in affitto ha comportato la fine del rapporto “totalizzante” con la terra e l’abbandono, anche da parte loro, delle campagne. Si è parlato anche del paesaggio agrario marchigiano, delle trasformazioni radicali che ha subito dopo la fine della mezzadria e della necessità attuale della sua tutela. Relatori Adriano Ciaffi, presentatore della prima legge sull’abolizione del patto mezzadrile, l’editore Giorgio Mangani e l’architetto Mario Canti, moderati da Cinzia Maroni. Un pensiero affettuoso per la socia, ed anche collega mia e degli altri architetti delle Cento Città, Agnese Corallini, che ci ha prematuramente lasciato. Spero, Agnese, di strapparti uno dei tuoi luminosi e indimenticabili sorrisi dicendoti che, lasciandoci nel pieno della tua giovane età, hai ulteriormente innalzato l’età media dei soci de Le Cento Città, che ti ricorderanno sempre. Peppe Oresti Album di Romano Folicaldi 46 7 dicembre 2012, Macerata Convegno Padrò e Contadì In una delle splendide gallerie della Biblioteca Mozzi-Borgetti a Macerata, il convegno Padrò e Contadì, costruito e condotto da Cinzia Maroni, è stata l’occasione per riandare ai tempi in cui l’agricoltura marchigiana aveva visto come struttura sociale ed economica nettamente prevalente la conduzione mezzadrile. I Relatori Adriano Ciaffi, Giorgio Mangani e Mario Canti, hanno svolto riflessioni nei campi ad ognuno di loro più consoni e legati alla loro attività e al loro impegno: un impegno politico e retrospettivamente storico, l’attività culturale nel settore dell’editoria, con un illuminante richiamo all’esperienza dell’Arcadia, l’evoluzione nel modo di osservare il territorio, non come contemplazione estetica del paesaggio, ma come analisi dei cambiamenti che le attività economiche hanno indotto in poco più di mezzo secolo, dalla fine del secondo conflitto mondiale, con una velocità che non ha riscontri nel passato. Sono state riflessioni che pure nella loro rapidità e concisione non potranno non dare adito, in coloro che sono stati presenti, a una maggiore maturità con cui guardare e leggere la realtà odierna. È purtroppo mancato il contributo di Roberto Massi, uno dei testimoni e attori più importanti di quel periodo, scomparso a distanza di pochi giorni. L’incontro si è concluso al Ristorante Il Pozzo per una cena che ha ripercorso alcune delle tradizioni gastronomiche marchigiane reinterpretate alla luce di tempi così differenti dalle epoche in cui sono nate. La Galleria della Biblioteca Mozzi-Borgetti e il ristorante Il Pozzo, a Macerata. Le Cento Città, n. 48 Vita dell’Associazione 47 25 gennaio 2013, Fermo Fermo project A Fermo, gioiello del buon vivere marchigiano, si è svolto il convegno Marche, il centro storico. Fermo project, verso un nuovo modello di sviluppo integrato del territorio e dei borghi, ideato e realizzato da Cecilia Romani Adami. Una scommessa pubblico/privato dalla posta alta: nel centro storico, a portata di piede, centri meeting ed alberghi d’epoca. A tutto vantaggio del turismo, settore economico della massima importanza per l’economia, settore recente nelle Marche rispetto ai grandi distretti industriali, che vede Regione ed Enti locali impegnati per studiare ed implementare un nuovo modello di centro storico e di vita italiana.,. Il convegno si è articolato in due sessioni, la prima delle quali un tavolo di studio coordinato da Cecilia Romani Adami nella sede della Camera di commercio; sono intervenuti l’Assessore Mauro Terzoni e Antonio Minetti, Dirigenti della Regione Marche, Lorenza Mochi Onori, Direttore Sovrintendenza Regionale. Marcolini. I funzionari regionali Mauro Terzoni, Fabio Travagliati, Antonio Minetti, esperti del settore quali Magda Antonioli Corigliano, Sandra Camicia, Mariano Sartore, Claudia Bonanno e i giornalisti Silvia Catalino e Massimo Terracina; in video-conferenza (?) Gianni Carbonaro e Francesca Medda. Nel pomeriggio, nella Sala dei ritratti del Palazzo dei Priori Presentazione alla città e al territorio di Fermo project e dichiarazioni di intenti delle istituzioni, con i Relatori del mattino, esperti e numerosi ospiti. Un convegno di pieno successo, in piena sintonia con la campagna promozionale che la Regione Marche promuove in tutto il mondo. Cecilia Romani Adami, ideatrice del progetto e moderatore. Il pubblico in sala. Pietro Marcolini: Assessore al bilancio e alla cultura. Tavola Rotonda: da sinistra Silvia Catalino, Massimo Terracina, Cecilia Romani Adami, Magda Antonioli. Le Cento Città, n. 48
Scarica