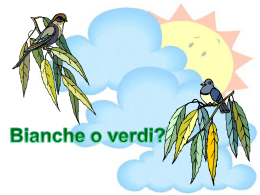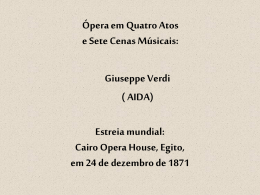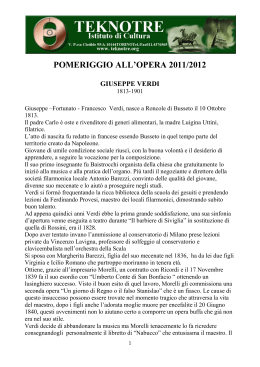È la fine del XIX secolo, nella Bassa del Po. Un ragazzo imbraccia un fucile. Parte un colpo. Una cameriera resta uccisa. H vent'anni. Angiolo, il ragazzo che ha sparato, fugge a casa del nonno, al quale è legato da un affetto profondo. Forse con le sue conoscenze può aiutarlo: si chiama Giuseppe Verdi. Basandosi su documenti, diari e testimonianze autentiche, Maurizio Chierici costruisce un romanzo avvincente e insolito, i cui protagonisti, un politico della sinistra alle prese con la nascita del sindacalismo, e un commissario testardo che combatte perché venga fatta giustizia, si incontrano all'ombra di un Mito e rivelano poco a poco l'altra faccia della sua umanità. Un giallo storico che racconta storie sconosciute di personaggi famosi, e indaga con finezza psicologica tra le pagine private di un Verdi lontano dalla celebrazione retorica che da sempre accompagna il genio. ... Nebbia e nebbia per giorni, ma importa poco a questi che hanno accettato una cattività precoce perché hanno accettato una colpa, ed è essa che li unisce e stringe... Attilio Bertolucci Prefazione Vent'anni fa attraversavo gli archivi della mia città guardando senza devozione le carte che raccontavano del maestro Giuseppe Verdi. Non per mancanza di rispetto; volevo solo disporre in ordine diverso le pagine della storia risaputa. Disordine che suggerisce una specie di melodramma. Inatteso. Perché la benevola situazione di essere nato nella provincia di Verdi annulla gli anticorpi delle interpretazioni senza ossequio. Impossibile limitarsi a ricordarne il genio sfogliando documenti. Bisogna commemorarlo con la solennità dovuta. In piedi e compunti. E mai allungare gli occhi oltre il cliché della tradizione. Come ripete la tenerezza dei libri e degli articoli che ogni giorno accompagnano le opere dell'autore più rappresentato al mondo dopo Shakespeare, Verdi è solo un santo: occhi trasparenti che da ogni cornice osservano benevoli il popolo degli innamorati. Verdi è padrone dal cuore tenero, benefattore dal cuore largo, marito affettuoso e amante discreto sia pure incomparabile. Verdi è agricoltore d'avanguardia, patriota senza paura, politico di ragionata virtù. Ricco come pochi, eppure modesto nelle abitudini. Quasi la perfezione. Ma un signore tanto perbene e così educato avrebbe saputo strappare al suo piano, sinfonie destinate ad attraversare i secoli con una passione che travolge le platee? II dubbio della doppia realtà, schizofrenia mascherata nel teatro del teatro, mi accompagnava sotto le polveri d'archivio durante lo scavo delle carte. E la conclusione sembrava semplice. Il santino distribuito dagli agiografi non avrebbe fatto tremare i cuori. Ma rallegrati sì: valzerini e piccole romanze per le voci bianche delle Tv nella pigrizia delle domeniche pomeriggio, quando piove. Vent'anni fa il diario ritrovato ha suscitato polemiche a volte divertenti. Un sindaco verdiano si è rivolto al presidente Pertini pretendendo mi si togliesse la cittadinanza italiana: «lesa maestà al monumento della patria». Per cancellare la colpa dell'avermi prestato la bella immagine, il fotografo della prima copertina ha giurato che l'immagine era stata rubata. Solo quando gli umori si sono placati, un po' vergognoso chiedeva perdono per aver avuto «un colpo di paura», paura di non poter mai più fotografare qualcosa di Verdi. Mentre Massimo Mila scagliava l'anatema: «Verdi non può essere confuso con Maigret!», la storia dimenticata si rivelava talmente intrigante da accendere un altro tipo di fantasie. Alberto Bevilacqua l'ha ascoltata quando la stavo scrivendo e, per caso, se ne è ricordato (dimenticando la voce narrante) mentre componeva le sue storie. Ma la memoria è tornata: all'improvviso. Tardi, purtroppo: libri già stampati. Ma con la grazia che gli è consueta Bevilacqua ha aggiunto al racconto una bellissima lettera. La conservo fra le cose care: «Ecco chi me ne aveva parlato... Sei un amico troppo importante perché un'ombra ci possa allontanare...». Amicizia da salvare. Soprattutto salvare ad ogni costo un Verdi senza musica, padrone sfiorato da una morte misteriosa mentre infuriano rivolte contadine e congiurano fantasmi borbonici. Con un copione così, chissà quali sinfonie avrebbero incantato il Maestro. Maurizio Chierici Quel delitto in casa Verdi Sabato, 24 settembre 1898 Si volta, e come un serpente polveroso vede alle spalle i cavalleggeri che stanno per raggiungerlo. Ormai è alle prime case di Busseto. Sulla sponda imbiancata della strada, dietro piramidi di fucili appoggiati l'uno contro l'altro come arnesi contadini, un plotone di soldati si è sdraiato per il riposo di mezzogiorno. Da lontano ascolta l'ordine dell'ufficiale e il fruscio degli zoccoli si spegne. Immagina i cavai-leggeri intenti a ricomporsi per l'ingresso in paese dove bisogna camminare a ranghi ordinati, col passo di chi avanza orgoglioso per la forza che rappresenta. Gli uomini rigidi in sella; l'ufficiale e il portabandiera in prima fila. Le divise grigie avrebbero nascosto la stanchezza di un settembre ancora soffocante. Quando il reggimento era uscito di città doveva fare buio, e la nebbia — il viaggiatore lo aveva provato anni prima — intirizziva i cavalli con un brivido che annunciava la fine della stagione. Adesso le strade sono senza fango e il sole scalda la marcia sino a togliere il respiro. Il viaggiatore arriva davanti l'albergo prima dei cavalleggeri e fa in tempo a unirsi agli avventori che hanno abbandonato i tavoli; sono usciti per guardare lo spettacolo delle bestie. I cavalleggeri spuntano in fondo alla strada, disposti nelle file prescritte. Per un attimo l'ufficiale studia l'allineamento, ma deve sentirsi stanco, oppure affamato, perché subito grida «a terra » e, senza osservare la compostezza della manovra, passa il comando a un subalterno. Lega il cavallo poco lontano dagli scariolanti che mangiano uova bollite e lupini. Il viaggiatore osserva con la nostalgia di chi ritrova un po' della propria vita in quei gesti militari. Indossa l'abito scuro di città, ha il naso forte; un cappello di paglia gli rischiara il volto che pare spento dagli anni. Più di sessanta, forse. La valigia che ancora stringe può farlo sembrare un medico, ma sono le mani timorose a renderlo diverso da che si abitua a toccare la gente. Per due volte cerca di attirare l'attenzione della padrona che gira fra i tavoli; la timidezza glielo impedisce, e chissà quanto avrebbe penato se un altro signore, rientrato dal teatro dei soldati, vedendolo sperduto non avesse agitato il tovagliolo bianco e blu prima di sedersi dove sta mangiando. Un piano di legno appartato sul quale subito si apparecchia un altro piatto e un altro bicchiere. Sembra giusto alla padrona, unire nell'angolo silenzioso, dietro il paravento della stufa di maiolica, clienti che si somigliano nella distinzione. Così i signori si conoscono. Il signore spigliato indica con gli occhi la stanza piena di voci. «Una bella confusione... » «Dentro e fuori », sospira l'altro. «Ancora soldati. Sembra di essere in guerra... » «Mi hanno detto che l'aria è di nuovo inquieta. Sono vere le voci di rivolta? » «Ci sono state; si ripeteranno. Dove lo raccontano?» «A Milano, vengo da là. » «A Milano i militari non hanno scherzato: prendere i frati col cannone! Ho letto che Pelloux dirigeva col binocolo l'assalto al convento di Monforte come se stesse sfondando Porta Pia... » ride con la soddisfazione di chi non ama il generale e si diverte a ricordarne le gesta non gloriose sfidando il sentimento di un ascoltatore sconosciuto, ad alta voce, nell'ambiguità di un luogo pubblico. «... hanno fatto prigionieri un po' di cappuccini assieme agli straccioni che mangiavano la minestra. I bersaglieri li hanno trascinati ai piedi del divino Bava Beccaris. Vorrei averlo visto questo spettacolo... » «I giornali hanno esagerato... » Una risposta di cortesia, ma le parole sono fredde. Guarda la valigia e l'abito scuro. « Magari fa il dottore? » « Soltanto agronomo. Vengo a studiare i sistemi di coltura di queste campagne. Bisogna migliorarli... » L'ospite che non ama Pelloux all'improvviso sembra felice. «Me ne sono occupato vent'anni fa. Un incarico di governo. La giunta parlamentare pretendeva un'inchiesta sulle condizioni della classe agricola. Sono avvocato, ma faccio altre cose. Il pubblicista, un po' di politica... » Si alza sulla sedia. L'agronomo allunga la mano attraverso la tavola: « Mi chiamo Gaetano Franzoni ». «Ed io Francesco Barbuti », risponde l'avvocato che, dopo le convenienze, torna a piegarsi per finire la minestra senza accorgersi della malizia che accende gli occhi del compagno. «L'avvocato Barbuti! » ripete, come ricordando, e Barbuti è contento che l'agronomo mostri di conoscere il suo nome. Può sperare abbia letto il libro? Più tardi, nella camera sopra l'osteria, sfogliando le carte che escono dalla valigia, l'agronomo si inquieta per altri pensieri. In un certo senso Barbuti lo riporta alla vecchia curiosità sul mondo contadino, ma una curiosità diversa da quella che l'avvocato si illude di indovinare. Una curiosità che viene da lontano; dal tempo in cui aveva cercato fra le case del maestro Verdi un ragazzo morto o nascosto. Il dubbio lo aveva seguito per anni. Per anni si era immaginato in quale modo il ragazzo sarebbe invecchiato e come avrebbe saputo riconoscerlo col viso coperto di rughe e i capelli radi sulla fronte. Lo ammetteva con se stesso: una ossessione. Ognuno dà uno scopo alla propria vita e lo scopo che affiorava nella sua esistenza disciplinata e solitaria, era soltanto questa ripicca di vecchio deluso. Un giorno, in una strada di Milano, ne sentì chiamare il nome, e si voltò come per aver trovato un amico; ma per quanto la fantasia si fosse sbizzarrita a decomporre e ricostruire l'espressione dello sconosciuto, appena lo vide si arrese all'evidenza: niente, proprio niente, poteva avvicinare lo speziale piccolo e ridanciano al ragazzo del ritratto che la figlia adottiva di Verdi custodiva con amore nella propria casa. Era stato questo amore a eccitarlo. Ed era il modo col quale gli avevano strappato il ragazzo di mano mentre stava per raggiungerlo, a lasciargli dentro un'amarezza che il tempo non aveva addolcito. Ogni persona priva della grandezza del nome o di speciali virtù difende la voglia di legare il proprio destino a destini più fortunati. Da vent'anni Franzoni continuava a chiedersi: il maestro Verdi poteva essere coinvolto nella sparizione del ragazzo? Aveva forse saputo che un poliziotto, travestito da agronomo, stava indagando; e se non lo aveva saputo chi era riuscito a impedirgli con tanta autorità di andare avanti nella ricerca? Ancora un mistero: se il ragazzo era vivo, perché di nascosto non aveva ripreso la strada di casa? Vent'anni prima allorché lo avevano scacciato da Busseto, era tornato a Milano depositando i documenti della ricerca nelle mani di un delegato superiore della questura di piazza San Fedele, ma per quante volte avesse poi tentato di sapere quale interesse era riuscita a suscitare la pratica da lui compilata, gli era stato risposto con un segno vago, come di che ha fretta o argomenti importanti ai quali dedicarsi. Una volta volle controllare nel casellario se altri documenti si fossero aggiunti. Trovò lo scomparto vuoto e un appunto su un foglietto giallo: ricordava l'invio della pratica al ministero. Era successo tempo prima. Non compariva notizia della risposta. Anche l'appunto gli parve singolare: « Rapporto del delegato Franzoni sulla sparizione di un giovane durante i moti contadini ». Il nome di Verdi, scomparso. Anche il censore — dunque — aveva sospettato colpe segrete per il maestro? La stessa idea aveva attraversato due poliziotti... Si era promesso di continuare la ricerca per propria passione, quasi un divertimento dopo il lavoro, ma aveva rimandato, con scuse, creandosi alibi perché (e se ne rendeva conto quando scavava appena sotto la voglia di sapere) quell'ombra imprendibile restava, in fondo, l'unico scopo della vita. Un giorno aveva deciso di rinunciare. Troppo stanco, troppo vecchio, meglio non indagare. E solo quando decise di smettere la ricerca, si accorse di non aver mai superato la rabbia e il desiderio. La sua era rimasta una intenzione. Ormai la carriera finiva, anni lontani dalle prime pagine delle memorie... Dal diario dell'agronomo Forse perché la mia vita è stata avventurosa e disordinata, voglio mettere ordine in questo quaderno di ricordi dove raccolgo, giorno dopo giorno, quanto vidi ed udii... aveva scritto l'agronomo nel diario sepolto alla sua morte in un archivio dove, cercando altre cose, quasi per caso, qualcuno lo avrebbe ritrovato e ricopiato, trascrivendo con difficoltà la scrittura larga, un po' piegata a destra. — Mi chiamo Gaetano Franzoni, sono nato a Piacenza, martedì 3 ottobre 1835. Mio padre era impiegato alla dogana; gli studi furono regolari e mi valsero a diciotto anni l'arruolamento nei servizi ducali. Bisogna sapere che, nei primi tempi del suo impegno davanti alle barriere gialle listate di nero che annunciavano, di là dal fiume, gli stati austriaci, mio padre fece amicizia quotidiana con un capitano della milizia, invecchiato senza migliorare nel grado pur uscendo da famiglia nobile, evidentemente decaduta, non solo nella ricchezza, anche nella considerazione della corte. Più tardi venne a sapere che il figlio del capitano, ormai ritirato, forse morto, era tenuto in grande onore dal nuovo duca, e gli scrisse per chiedergli se mai nell'amministrazione vi fosse posto per il primogenito di un fedele servitore dello Stato. Così, con la protezione del colonnello Luigi Anviti cominciai una carriera che si annunciava di grande fortuna perché sfolgorante sembrava la stella del conte: Carlo III lo aveva nominato ciambellano, commendatore, soprattutto amico. Di lui si fidava non solo per la pignoleria che poneva nella caccia alle teste calde, anche per la magnanimità militaresca delle punizioni. Infatti il duca non amava le pene capitali, così le prigioni erano ricolme. Preferiva bastonare avendo in orrore la forca. Continuava a ripetere che il sangue macchia la storia mentre le nerbate sciolgono i dolori. Non potendo pubblicare un codice di sole nerbate, se la godeva a diradare i galeotti uno alla volta, mettendoli in libertà dopo poca prigione, anziché impiccarli. «La severità del duca è amore. Si è mai visto un padre lasciare che i figli distruggano, con inutili parole, la dignità della famiglia? » Anviti ripeteva simili discorsi orgoglioso che la pena di morte traversasse inutilmente i codici dello Stato. A parte certe rabbie il duca era simpatico. Trascinava Anviti e il conte Bacinetti (l'aiutante preferito) in passeggiate per l'Appennino. Talvolta scendevano al mare. Raccontavano che il sovrano soffrisse nostalgia della spiaggia di Lucca e degli amici di una giovinezza scapigliata. La scapigliatura era rimasta, a giudicare dalla faccia un po' gonfia, con sotto gli occhi borse di stanchezza: ridendo a corte ricordavano le imprese di ogni notte. Mi piaceva il suo amore per le divise, anche se, tornando da ogni viaggio in Europa, scompigliava colori e attribuzioni, modellando la truppa sui grandi esempi d'altrove. Ora le righe larghe, ora le spalline ramate. Copiava le decorazioni da Modena, ma guai a farlo notare: l'ottagono d'argento per i veterani di prima classe e la medaglietta della fidelitas et constantiae in adversis per i piccoli meriti della truppa. Se si lasciava abbagliare da innocenti estetismi nell'organizzazione militare, il sovrano si rivelò condottiero di eccellente preparazione. Previdente, non grandioso come brontolava qualche funzionario scontento. Perché si mormorava di un progetto che voleva gli impiegati dello Stato con indosso una speciale tenuta e, siccome ognuno avrebbe dovuto pagarla da sé, negli uffici bestemmiavano senza pudore per la scontentezza. L'esercito, dicevo. Quando nel 1852 entrai nelle truppe ducali, non sospettavo di trovarvi, in uno Stato tanto piccolo, ottomila uomini sul piede di guerra. C'erano 90 cannoni e 9696 armi da fuoco portatili bene ordinate negli arsenali della Cittadella. Il duca pretendeva soldati sempre pronti alle avversità e le esercitazioni sfiancavano i più giovani; così nei primi mesi la vita non fu facile. Ebbi la tentazione di scappare perché la mia era un'età ancora spensierata dove la volontà è fragile e gli scoramenti distruggono ogni volta il mondo. Anviti mantenne la promessa resa a mio padre. La sua protezione fu preziosa. Mi valse incarichi non banali, come la sorveglianza dell'avvocato Giuseppe Piroli che era stato segretario del governo provvisorio nel '48, allorquando i sovrani furono costretti-a scappare. Cercavo di scoprire con chi discutesse sottovoce negli angoli dei caffè, e quali affari stesse tramando col commerciante di liquori Campolonghi, anche lui liberale. Non per vanto, perché quale significato può avere mai una intuizione sperduta in anni di amarezze, ma la perquisizione che il conte Bacinetti fece nelle loro case, nasceva dai miei rapporti. Anviti era orgoglioso: « Solo un ragazzo, eppure ha capito... » Anche d'inverno l'aria di Parma mi pareva più chiara di quella della mia città. Gente amabile e pigra. Sfuggiva i lavori dí fatica, preferendo il gioco dei commerci o le invenzioni degli atelier. Chiacchieravano volentieri, e fu il primo avviso che mi venne dato: «Non badare alle rivoluzioni promesse a caffè. Se ne scordano camminando verso casa. Sono cicale; vogliono sembrare lupi... » Mi accorgevo come la larghezza del vivere fosse l'impegno dominante della classe appena superiore al popolo. Passeggiando per le strade si aveva l'impressione di abitare in una città dove la prosperità rallegrasse ogni tavolo, ma non era così ed io lo sapevo. I registri della carità pubblica contavano ventidue-mila assistiti su trentottomila persone. Eppure l'imitazione delle mode che arrivavano alle corti dei sovrani con i parenti di Vienna, o i visitatori di Parigi, manifestava una rapidità miracolosa. Un cappello o un ombrello, che la vanità di una marchesa di passaggio o le ordinazioni delle signore vicine alla duchessa richiedevano oltre i confini, pochi giorni dopo giravano nelle piazze, e bastavano due settimane per averne pieni gli occhi. Insomma, le signore spendevano molto più di quanto fosse concesso, e sui soldi che uscivano insospettati correvano malizie: di digiuni o di appuntamenti misteriosi. Anni prima, il ministro Du Tiliot, preoccupato per l'enormità delle spese che grattavano il bilancio con investimenti oltre confine, studiò le voci per capire dove finisse tanto denaro. Finiva nelle case di moda. Allora proibì l'importazione di stoffe francesi. Ma la prima a ribellarsi fu la sua amica, Anna Malaspina di Mulazzo che ogni mese lasciava una fortuna ai sarti d'oltre Po. Tutto ricominciò. Naturalmente c'era un'altra città, più infida, da tenere d'occhio. Donne gonfie di polenta, troppo pallide negli abiti tropo colorati. E, di là dal fiume, uomini alteri. Bevevano e cantavano, ma dovevamo diffidare della loro bonomia. Mi accorgo di ordinare con nostalgia le impressioni lontane di un ragazzo che scopre il mondo nella capitale del proprio Paese, avvicinandosi alle voci di corte e indovinando, sotto l'autorità delle forme, una fragilità che presto lo inquieta. Un giorno, osservando il duca che si esercitava a cavallo, passò un'idea che mi atterri. Possibile che quel giovane uomo, tormentato da troppe debolezze, fosse il custode del potere nel quale speravo di far crescere la mia fortuna? Potrà mai — mi chiedevo — un simile sovrano animare un periodo di storia, non dico così eccellente da meritare il ricordo, ma almeno attraversato da una volontà sulla quale domani sarà possibile discutere l'intelligenza o l'arte scialba? Ero giovane e non rassegnato all'indifferenza. Nell'aria di quel mattino di febbraio, il sole sulla neve, il vento che tagliava l'Appennino, mi accorsi come il duca somigliasse agli uomini che ne drappeggiavano i meriti con abbandono cortigiano. Anche Anviti portava sulla faccia la stessa aria pallida della notte, le stesse ombre negli occhi. Ne imitava i gesti e il portamento: per un momento mi sembrarono parenti anche se la testa contadina faceva ben distinguere il Borbone dal mio conte di Piacenza. I veri maestri della mia formazione erano coloro che vivevano nei corridoi dei palazzi. Non Anviti, che già rappresentava la nobiltà di una guida lontana, bensì i funzionari, i faccendieri, gli indiscreti che il duca incontrava raramente, forse non conosceva neppure, ma per intuizione devota, loro ne interpretavano le ambizioni, anticipandone i desideri per trasmettere a noi che maturavamo, ascoltandoli, un senso profondo di rispetto. Ben presto la corte si disgregò. Il duca venne ucciso due anni dopo. E Anviti cambiò, non l'uso del bastone, ma l'umore. Si trasformò in un comandante che la paura rendeva cupo. Paura dei liberali chiusi nei caffè? Dei muratori o dei calzolai che traversavano i ponti con i punteruoli nascosti sotto il mantello? Ne avevamo riso, mesi prima. Più di questi sospetti dovevano forse inquietarlo gli intrighi di corte ormai a lui sfavorevoli. La Reggente aveva riaperto le porte ai gesuiti, ed erano i preti a fare la legge. L'aprile dell'anno successivo attentarono alla vita del mio colonnello. Un agguato nei borghi. Allora, lo stesso conte nemico della pena capitale, chiese al consiglio di guerra che i sicari venissero fucilati, e salì fino alla villa di Sala dove la duchessa, interrotti i ritiri spirituali, stava meditando la grazia; salì per supplicare che almeno un colpevole — uno, come esempio meritasse la pena. Né la sentenza rappacificò Anviti. La rabbia divenne arroganza, la paura non lo lasciava. Fu il primo a scappare quando, nell'inverno del '59, quaranta ufficiali chiesero alla sovrana di essere tolti, in quel momento solenne, dall'obbligo del giuramento. L'Italia li aspettava. Il regno di Luisa Maria pareva finito. Invece sopravvisse pochi mesi, forse gli ultimi mesi felici della mia giovinezza. Era primavera e il verde degli ippocastani tremava nei viali. Passeggiavo per cercare gli occhi delle ragazze. Attorno ai tavoli dei caffè i soldati cominciavano a mescolarsi al popolo: quando la nave affonda i topi sono i primi a gettarsi in mare, ma non sanno nuotare e il loro destino è ugualmente segnato. La città si preparava al sole dell'estate. Avrei mai ascoltato il silenzio di quell'estate nelle strade della capitale dove avevo cominciato a vivere? Un altro sentimento mi tormentava. Chiuso dentro i pensieri che inseguivano la buona riuscita della carriera e le ambizioni del colonnello Anviti, non mi ero accorto di quanto fosse diverso il mondo. Mi insegnavano a spiarlo senza guardarlo. Cercavo di scoprirne i vizi nascosti scartando le virtù. Per mesi avevano spiegato che nessuna cosa è buona o cattiva in se stessa: la bellezza ingrigisce, la bontà si corrompe. C'è un momento in cui ognuno desidera essere il contrario della persona che per anni ha coltivato; allora basta cogliere questa incertezza per trasformare un cospiratore in un servo segreto del potere. Ci istruivano a rubare le parole sulle labbra, o a indovinare negli occhi di chi incontra un poliziotto la paura per imprese progettate, oppure chiuse nel passato. Un'educazione che aiutava a penetrare il mondo degli altri con un'attenzione che escludeva l'amicizia. Quando mi mescolai ai ragazzi del popolo con l'incarico di scoprire le idee che potevano scaldarli, trovai che i nemici peggiori della legalità non erano gli ignoranti, o i semplici, per quanto crudeli potessero a volte dimostrarsi; i nostri nemici si nascondevano fra gli intelligenti. Sono gli intelligenti che possono corrompersi; così come i ricchi, o gli aspiranti al benessere si mostrano disposti a qualsiasi iniquità pur di non immiserire la fortuna accumulata. La scoperta che mi tormentava era proprio questa: sentivo immiserire i progetti nei quali ero cresciuto, senza immaginare un modo diverso di vivere oltre le mura della Cittadella. Dai miei bastioni ci si abitua a diffidare della gente. Ma quando la malinconia mi spingeva, disarmato, nelle strade, scoprivo che ben altri pericoli infiacchivano la mia carriera di giovane ufficiale ambizioso. Per quanto mi sforzassi di obbedire ai comandamenti del palazzo, guardando le facce, ascoltando le voci mi pareva di non scorgere fra loro nessun nemico. E un poliziotto senza nemici contro chi combatte?... Nello stesso punto, leggendo e rileggendo il diario come esercizio di buona memoria (per nomi, luoghi, occasioni utili alla ricerca), Franzoni pensa, questa sera, come ogni sera, che il fallimento delle ambizioni risiede nel carattere troppo tenero della sua volontà: i nemici vanno coltivati, inventati, scovati; è necessario procurarseli per fortificare la personalità e stimolare l'intelligenza. Valutando la sua missione di poliziotto sperduto fra i braccianti di campagna, nella camera troppo piccola della locanda, riflette sulla sorte che lo spinge ad ascoltare voci senza nome che valgono per ciò che riescono a mettere assieme urlando, quando il senso della ricerca può solo venire dal bisbiglio di un tribuno importante. Perfino Barbuti cade nella rete, vent'anni dopo, quando ormai non conta più. A lui non affidano i protagonisti, preferiscono disperderlo nella folla dei comprimari. Oggi... Eppure una volta, allorché la sorte di fuggiasco lo spinse lontano da Parma, aveva vissuto nel cerchio privilegiato di chi tocca la storia. Piegando gli occhi sul diario, quasi ripetendo a memoria le prime parole, ricomincia a leggere... ... non pensai all'esilio fino a quando il colonnello Davico, comandante militare, solito a vanterie su imprese di cui nessuno ricordava la gloria, mandò a chiamare noi delegati alla sicurezza. La situazione si era aggravata. Dovevamo tenere gli occhi aperti contro i provocatori piemontesi che si nascondevano in città. Non avevo mai visto Davico, se non da lontano. Aveva battuto il pugno, ordinando alla timida giunta rivoluzionaria di sciogliersi e sparire; la giunta si era insediata, nel nome del re sardo, approfittando della lontananza della duchessa. Davico aveva apostrofato gli ufficiali incerti con parole da caporale. Insomma, la legalità ristabilita si doveva a lui che, con onori e feste, organizzò il ritorno della sovrana da un viaggio temuto come una fuga. Adesso la faccia di questo militare senza sfumature pareva rassegnata. Spiegò con la voce di chi riferisce il messaggio di un corrispondente noioso: «Un sedicente generale Ribotti ha invaso Pontremoli guidando un'accozzaglia di carraresi misti a sudditi sardi. Il prefetto ducale, marchese Piombini Appiani, si è dovuto arrendere. Soldati parmigiani e guardie doganali sono prigioniere dei ribelli. Possiamo considerare perduta la provincia oltre l'Appennino. Dio ci aiuti a difendere i territori di pianura... » Per farci intendere quanto grave fosse la situazione, mostrò la lettera che il conte Cavour gli aveva mandato, rispondendo alle proteste del ministro delle armi, marchese Pallavicino. Lettera scritta in francese, perché l'uomo che si diceva paladino dell'Italia, pare non fosse in grado di buttar giù due righe nella nostra lingua. «Le duché de Parme étant la base d'opération de l'armée ennemie, il n'est pas possible d'empécher que, de notre coté aussi, des hostilités n'arrivent pas » Anticipava l'ultima minaccia. La duchessa rimontò in carrozza il 9 giugno. Restammo chiusi in Cittadella. La rabbia e la nostalgia avevano parte uguale nel nostro cuore. Dovevamo lasciare per sempre una città amata dove ognuno si era creato l'angolo di un'amicizia: gli stranieri ne avevano imparato il dialetto che scivolava con smorfie distorte sulle labbra di un ungherese o nelle mani di un napoletano. Scoprimmo di essere divisi nelle idee. Chi voleva difendere la capitale fino all'ultimo sparo, e chi guardava con paura i cannoni già puntati sulle cupole e pronti all'ordine della distruzione. «Fa' che non succeda! » mi dicevo, non perché avessi paura degli scontri; non riuscivo ad immaginare nelle macerie il luogo dove avevo riposto tante speranze. Il dubbio durò fino a sera. Ce ne andammo a mezzanotte. I cannoni vennero caricati a salve e per tre volte avvisarono la truppa in agguato sui ponti: « Abbassate le armi ». In questa città di coraggiosi i colpi vennero scambiati per l'inizio della battaglia. In sei morirono dalla paura. Mi spiace che fra loro vi fosse il professor Corsini, insegnante di inglese, e mio ripetitore di tedesco. Ce ne andammo mentre le campane suonavano a festa. I rintocchi ci inseguirono nel buio, lungo la strada di Mantova, la strada del primo esilio. Al confine coi regni estensi l'esercito si sarebbe sciolto; solo un piccolo gruppo di ufficiali aveva il compito di traversare il Po per consegnare i cannoni alla guarnigione austriaca. Fui ordinato dal generale Crotti (reggitore della Società filarmonica e amico dei musicisti della città) di fare parte del gruppo. L'ultima fortuna, invidiata da quanti ne furono esclusi, perché a Parma la carriera militare era preferita dalla gente umile, classi rurali devote al trono e all'altare, spaventate dalle novità del Savoia che governava in amicizia con i nemici del Santo Padre. Milleottocento e diciannove soldati si accamparono attorno a Gualtieri, un passo dentro il confine estense, aspettando che il piroscafo Vicenza venisse a raccogliere le armi leggere da trasportare a Mantova, mentre sessanta ufficiali e centocinquanta soldati avrebbero fatto scorta ai dieci pezzi di artiglieria di campagna che la duchessa intendeva consegnare all'imperatore. Ci comandava il colonnello Emilio Pizzetti, e con lui era il conte Camillo Zileri Dal Verme che ricordavo sottotenente della guardia del corpo: tre anni prima aveva sposato la sorellastra della duchessa, più giovane, meno tonda. Conoscevo altri cavalieri, come il conte Cesare.Caimi e il capitano Scotti Douglas di Vigoleno, figlio del consigliere della sovrana. Bei giovani che durante la marcia facevano progetti. L'Austria stava per sfidare Napoleone nella pianura di Verona: assieme — ripetevano con sicurezza avremmo piegato i nemici col più forte esercito del mondo. S'infervoravano ad immaginare le vendette da distribuire al ritorno. Intanto, io pensavo, i nostri passi stanno alzando la polvere di chi si ritira, e poi le facce lisce dei patrizi che non davano l'impressione di camminare con gente disposta a sopportare le pene dell'esilio. I giorni che seguirono dovevano confermare questo sentimento. Venduti i cavalli, sessanta ufficiali di Parma chiesero la divisa delle Brigate Estensi; seguendo l'esempio di Pizzetti, fui tra i primi, col grado di capitano-tenente. Dentro il campo trincerato, nelle vicinanze del Palazzo Tè, venni assegnato al battaglione attivo di campagna del corpo d'armata guidato dal principe Eduardo Lichtenstein; ma la specializzazione che mi competeva e la presenza di Anviti, ritrovato dopo mesi senza notizie, fecero in modo che potessi entrare nel corpo di vigilanza del duca Francesco d'Este. Mi parve un sovrano dall'aria malinconica, privo di slanci ma senza vizi. Mantova stava diventando il luogo dove le ultime ambizioni del nostro mondo si raccoglievano dietro le spalle dell'imperatore. Arrivavano truppe da ogni parte, dalla Toscana, da Modena, perfino da Ancona. Gli sbandati, che di nascosto avevano lasciato la Lombardia, si presentavano alle caserme chiedendo ordini e armi; ma se il gesto sembrava commovente, gli sconosciuti venivano respinti perché non si poteva affrontare una battaglia importante col sospetto delle spie sarde nelle nostre file. Un lavoro che rubava le forze. Giorno e notte a interrogare e a capire dove si nascondesse la menzogna. Gli ordini del feldmaresciallo Karl Culoz non ammettevano titubanze: nel dubbio, allontanare i volontari. Il momento dello scontro si avvicinava. La mattina del 18 giugno seguii il duca verso Villafranca, dove l'imperatore aveva stabilito il quartier generale. Era tempo di mietitura, ma non si vedevano contadini. Soldati ovunque. Lungo la via per Castiglione Mantovano costruivano capanne con frasche di pioppo; più avanti, con rami di gelso. Il sole bruciava, e la sete di quelle ore, di attesa e di ansia, asciuga ancora la mia gola. Guardavo con invidia i militari che si bagnavano nei canali. Ridevano, mescolando i dialetti. Erano giovani, dall'aria di paese. Ancora non avevano combattuto e declamavano le promesse che i sovrani, una volta restaurati, si erano impegnati a mantenere con le truppe fedeli: giornate doppie di paga e medaglie. Dopo Mozzecane lo spettacolo cambiò. Non v'era dove tuffarsi, e il caldo aveva sciolto le compagnie nelle ombre dei prati. Dormivano sotto i gelsi, sui mucchi di ghiaia. Il duca si volse a guardarli, mormorando: « Questo sarebbe il grande esercito? » Lo scoramento divenne profondo quando arrivammo, ricoperti di polvere, al comando di Mozzecane. Il generale Wimpffen stava pranzando sotto il portico di una cascina, ma subito venne incontro al duca. Discussero con facce pensierose. Sentii Wimpffen ripetere al sovrano: « Finirà che venderanno la nobile causa per un piatto di lenticchie diplomatiche. Saremo sacrificati... » La stessa tensione a Villafranca. Nel quartiere dell'imperatore scesero dalle carrozze l'arciduca Massimiliano e i figli del granduca di Toscana, Ferdinando e Carlo Salvatore. Rispondevano ai saluti chiusi dentro ai pensieri. Non cercavano di nascondere la pena come se la devozione alle forme che da secoli li accompagnava ormai non contasse; solo l'esito dello scontro li legava alla realtà. Non vidi la battaglia, il posto di un poliziotto è nelle retrovie, ma capii dalla precipitazione con la quale i soldati furono chiamati in avanti che i calcoli dei nostri generali dovevano essere sconvolti. I francesi e i sardi li avevano sorpresi. Nella precipitazione il mio duca fu dimenticato. Era andato a messa nella chiesa di Valeggio, essendo San Giovanni giorno di precetto, e, uscito di chiesa, fece colazione da solo perché il ministro Forni e gli altri ufficiali camminavano dalle sei verso Solferino. Scortai il duca al quartiere generale: i sovrani italiani avevano appuntamento con sua maestà. La sorpresa fu sconcertante. Massimiliano era già partito, mancavano perfino le carrozze: da ore se ne erano andate. Requisii un vecchio calesse di posta e, mentre ancora sottosopra il duca vi stava per salire, ecco spuntare gli arciduchi di Toscana, anche loro frettolosi per il ritardo, anche loro dimenticati e inquieti per la mancanza di notizie. «Quale novità può essere accaduta?» li sentii chiedere mentre si tiravano in là per fare posto al mio sovrano sul legno. Oltre le tende bianche dell'accampamento di quello che era stato annunciato il più potente esercito d'Europa, col cannocchiale vedevo le colline popolate di contadini. Si udivano da lontano i cannoni. Era la mia prima guerra e non capivo cosa stesse succedendo. Non sapevo dove era il nemico. Non immaginavo quale potesse essere la larghezza del Mincio, ultimo baluardo — avevo sentito dire — attorno al quale bisogna resistere ad ogni costo. Arrivò un temporale, portò la grandine. Mi riparai sotto la tettoia che si affaccia sulla strada assieme agli altri sorveglianti militari. Dovevamo vigilare affinché i rifornimenti seguissero l'avanzata; semmai evitare che il panico accompagnasse il ritiro delle truppe. Nessuno pensava alla ritirata. L'uragano fece discutere gli esperti che avevano combattuto altre campagne: « Se stiamo vincendo è una grande sventura... » brontolavano; ma quando il cielo rischiarò in una pioggia sottile verso il Garda, i primi sbandati spuntarono in fondo alla strada. La sorte temuta si stava avverando... Si distrae per una voce. Da qualche parte in fondo alla strada una donna canta. Gli piacciono le donne che cantano quando non cantano per la gente, nei caffè o in teatro: è il pensiero. Subito se ne vergogna perché una cantante una volta gli era piaciuta. Non la sua voce. L'allegria le illuminava gli occhi come adesso la lampada sulle carte del tavolo. Aspettandola preparava in modo speciale la stanza dove abitava. Accostava le tende immergendosi nel piacere dell'oscurità che saliva dagli orti di via Medici. Unica luce il carbone che arrossava la stufa di ghisa. A volte si era chiesto: «Mi sposo? » Aveva respinto questa idea venti, dieci, cinque anni prima, ripetendo: sono troppo insonnolito per rimettermi in cammino. Guardandosi allo specchio si era reso conto del cambiamento. Il grigiore di quella stanza gli era penetrato nella pelle come la polvere nella carne di un minatore. Girava gli occhi attorno. Una stanza impersonale, senza oggetti da ricordare o un profumo sull'altro cuscino per far rivivere qualcosa. Un discorso, un abbandono. « Come mi ricorderà?» pensava guardando la stanza senza disordine. «Una specie di fantasma pulito... » Si erano frequentati a Milano oltre un inverno. Tutti e due un po' si vergognavano che lui fosse poliziotto, ma la tenerezza risultò per lungo tempo più forte di ogni rispetto. Un mezzo soprano non eccellente (l'aveva capito) ma dalla voce corretta e affettuosa. La ascoltava nascosto nel palco dei pubblici funzionari. Poche battute, qualche mezza romanza: non le concedevano di più. Aveva sempre immaginato: «Sta cantando per me... » Nella sua camera arrivava accaldata, mai una volta puntuale. Saliva le scale col passo di chi vuole farsi perdonare il ritardo. Si spogliava in fretta. Lui la guardava. « Sono sicuro che non saprai mai cosa significa essere stanchi... » Continuò a parlare anche quando scoprì di non essere ascoltato. Lei restava con addosso soltanto una camicia leggera. Allora girava la testa: «E tu? » Aspettava sempre e soltanto questa domanda. L'aspettava come un regalo. Il suo vecchio corpo già curvo poteva, dunque, essere ancora desiderato da una donna che chiedeva di scoprirlo? Una sera si lasciò andare e le raccontò del viaggio nella campagna di Verdi quando cercava un ragazzo che sembrava sparito. Qualcuno — lo aveva sospettato — poteva averlo ucciso. « Lo hai conosciuto? » Trasalì. Finalmente veniva presa sul serio l'ansia che lo tormentava... « Il ragazzo?» «Naturalmente non il ragazzo. Parlo di Verdi.,. » «L'ho visto. » « Quando? » «Una volta, in treno. » «E come ti è sembrato? » «Vestito di scuro. Alto il doppio della moglie. Non proprio il doppio... » «Lo sai? Lei faceva la cantante. » «Lo so. » «Sai sempre tutto. » « Di Verdi so tante cose... In fondo alla strada la voce aveva smesso di cantare. Torna al suo diario. ... Non si può capire cos'è la guerra se non guardando i soldati dopo una battaglia. Che l'abbiano vinta o perduta non importa, anche se l'essere battuti aggiunge alla fatica di questo lavoro massacrante la disperazione dell'aver fallito l'impresa, bruciato i calcoli dei protocolli e le ambizioni dei generali. Per ore e ore, fino al mattino, vidi uomini con le uniformi ricoperte di fango e ufficiali dagli occhi vuoti; le sciabole intralciavano gli stivali mentre le nappe delle sciarpe ingrigivano per la polvere e la pioggia. L'ordine delle belle marce era frantumato. Ognuno cercava di sopravvivere un passo dopo l'altro. Il mattino del 25 accompagnai il duca alla stazione dove lo aspettava il treno per Verona. Traversammo una piazza coperta di feriti, stesi come bestie, non fasciati, nessuno a prendersene cura. Non si lamentavano, ormai. Parevano ungheresi. Anche a Verona non ci aspettava la carrozza. Scortai il duca in una tristissima traversata a piedi della città. La gente guardava le divise, sorpresa dallo scoprire gentiluomini abbandonati come fanti alla fatica di una marcia sotto il sole. Fu l'ultima volta che accompagnai il sovrano. La sera raggiunsi il reggimento. Alla malinconia di una situazione che si annunciava di poca fortuna — avrebbe sopportato l'imperatore un esercito di estranei dentro i propri confini? — si aggiungeva il peso di un lavoro senza respiro. Ogni giorno sparivano soldati. Rubavano armi, saccheggiavano i magazzini, riprendevano la strada di casa intuendo la fine di ogni illusione. Dovevamo prevenire, interrogare, vigilare. Il sospetto tornava come abitudine quotidiana. Per ridare unità alle Brigate si inventarono manovre attorno a Villa Bartolomea, un'esercitazione per scaldare la nostalgia. Simulammo l'attacco e la riconquista di Carpi. «Perché proprio Carpi?» volle sapere la truppa. «Perché è la città più importante sulla strada di Modena... » Così si diffusero voci di un colpo di mano oltre il Po. Venni comandato a Sanguinetto, paese di vigne. Abitavamo nel castello, mentre l'appartamento del duca, in visita da Verona, apriva un'ala di palazzo Betti. Si racconta che in questo palazzo avesse soggiornato Francesco Giuseppe e che, proprio qui, seppe d'essere imperatore. Per un attimo la commozione sciolse il protocollo: abbracciò una domestica dimenticando il rigore del principe. Più tardi, allorché la domestica gli rivolse una supplica ricordando l'abbraccio, il sovrano si intenerì concedendo una pensione, modesta perché la commozione era sbiadita: ma bisogna ricordare che, a differenza dei nostri sovrani, i signori di Vienna non sprecano denaro... Fin qui la guerra e il dolore continuano ad essere emozioni lontane (pensò). I morti sono numeri nei bollettini; le sconfitte vogliono dire una marcia verso una certa campagna più a Nord con le facce scontente dei generali, ma ancora nessuna ferita ha intaccato la speranza che il mondo nel quale si è vissuti possa ricomporsi. La fiducia accompagna ogni giorno Franzoni e tanti come lui. Ogni giorno, fino a un certo giorno, che il diario riporta e che egli ora rilegge... ... 10 ottobre, è il ricordo di un giorno di pioggia. L'autunno cominciava. Mentre attraversavo la truppa, sentii il mio nome gridato con gioia, ed ecco spuntare, fra volti sconosciuti, la barba lunga e l'abito civile di chi si è arreso alle fatiche del viaggio. È Giovanni Catellani, giovane tenente col quale avevo diviso a Parma le passeggiate sui rampari che circondano la città abbracciati alle ragazze di una sartoria di strada San Michele. Fu Catellani a darmi la notizia tremenda. Il conte Anviti era stato ucciso. Avevano lapidato anche un altro protagonista dei giochi di corte: Gaetano Buttafuoco, direttore della «Gazzetta ». L'amico, arrivato con fortuna al mio campo, aveva sfiorato la morte. Alla nostra partenza per il fronte di Solferino, Anviti si era fermato a Mantova: assieme ad altri sudditi leali programmava di tenere contatti con i fedeli rimasti nelle città usurpate. Dovevano concordare il piano del ritorno. Anviti andò nelle Romagne in visita ad un amico, Catellani si recò negli Stati Estensi dove certe persone lo aspettavano. Sarebbero tornati di nascosto a Milano per continuare lo spionaggio. Anviti montò sulla carrozza ferroviaria a Bologna; Catellani salì a Reggio, dove si incontrarono. Erano soli nel salottino del vagone e subito chiusero col gancio le porte dell'una e dell'altra parte. Abbassarono le tende di velluto per scambiarsi le informazioni raccolte. «Sembrava soddisfatto », raccontò Catellani. «Un po' inquieto per l'attraversamento del ducato, ma erano passati mesi — gli dissi — e solo la stazione di Parma poteva rappresentare un fastidio: a Piacenza chi si ricordava di lui? Volle la sfortuna che le piogge avessero ingrossato l'Enza, e il ponte, non ancora completato nella costruzione, non dava affidamento ai conduttori. Così ci fecero scendere, attraversare il fiume, per aspettare sull'altra sponda l'arrivo delle carrozze da Parma. Non mi accorsi di sguardi maliziosi. Solo più tardi provai il fastidio di non trovarmi solo, assieme al conte, nel nuovo convoglio. Eravamo in quattro. Due viaggiatori si erano accomodati davanti a noi e non fu possibile fissare i ganci per chiuder di dentro le porte. Appena il treno fermò a Parma, i signori che avevano diviso il breve viaggio, raccolsero i bagagli come se la sola intenzione fosse di scendere. All'improvviso uno di loro afferrò il conte per le braccia e lo tirò a sé, mentre l'altro gli cingeva le spalle gridando verso il marciapiede. «Ecco Anviti; l'è chi, l'è chi... » Dovevano aver telegrafato perché una piccola folla aspettava. Il povero conte si lasciò portare via senza una parola. Tremando, ma con la volontà di seguire da lontano il suo destino, lasciai anch'io la carrozza con l'aria di un passeggero curioso. Tu conosci il conte (si commuove Catellani.) Dopo lo smarrimento si riprese; cercava di discutere con i banditi che lo portavano fuori dalla stazione. Non ebbe verso di convincerli, ma la fortuna sembrò aiutarlo. Al gruppo si avvicinò un maggiore dei carabinieri. « Un ladro? » chiese. Osservando meglio la nobiltà del prigioniero si corresse da solo: «Forse un vecchio cortigiano?... » « Un assassino... » mentì la gente. « Bastonava. Ha fatto uccidere un innocente... » Anviti si rivolse da pari all'ufficiale. «Di qualsiasi fandonia mi si incolpi, ho diritto ad una difesa. La mia vita non può essere affidata a gente da strada. » Allora il maggiore ordinò ai persecutori: «Portatelo in caserma. Provvediamo noi... » « La caserma era a due passi. Quando la porta si rinchiuse alle spalle di Anviti, con un sospiro fui convinto che la vita del nostro colonnello fosse salva. Intanto la voce si era diffusa. I ragazzi la portavano nei borghi e la gente accorreva come al richiamo di uno spettacolo. Il maggiore che aveva ordinato l'arresto di Anviti, vedendo la folla, tornò rapidamente indietro. Lo udii comandare ad un milite senza divisa. "Vai dalla guardia nazionale. Qui i carabinieri sono soltanto cinque, c'è bisogno di rinforzi..." I rinforzi arrivarono. La miseria di dieci volontari senza autorità e coraggio. Intanto la gente si era ammucchiata davanti alla porta. I volontari spingevano, ma con timidezza; agitavano la spada, ma senza vigore, tanto nessuno li guardava. La gente teneva d'occhio l'uscita. Cominciavano le spallate, e i cardini traballavano, gli infissi si piegavano, mentre una voce scandiva le spinte con ordine disumano. Adesso — pensavo — faranno scappare il conte dal vicolo secondario non immaginando che le regole degli invasori non concedessero ai gentiluomini minacciati dalla ferocia alcun privilegio. Arrivarono i facchini, un tronco in spalla. Lo appoggiarono alla porta, la porta saltò. Vidi la folla inghiottire la caserma. Spuntavano facce accese dalle finestre e udivo voci rincorrersi nella ricerca. "Non c'è. Anche qui nessuno..." Poi il grido del trionfo. Si racconta che il conte abbia tentato di coprirsi dietro l'anta di un armadio e che solo per caso, passando e ripassando, un tappezziere abbia scorto il lembo della giacca spuntare dalla fessura. Lo trascinarono in strada e già non parlava. Con i sassi, i bastoni, i piedi e, finalmente, la pietà di un pugnale, lo finirono sul selciato. Avevo gli occhi pieni di lacrime. Scappai per non tradirmi. Mi disse un amico fedele che, dopo aver trascinato il conte per la città, lo portarono nel nostro caffè degli Svizzeri. Prima che il corpo entrasse, un giovane sparò un colpo nel cuore. Sono accadute cose ancora più crudeli. Gli hanno versato in bocca cioccolata calda. "Come mai non bevi, Anviti?..." « Dal retrobottega tirarono fuori una ragazza; la ricorderai, si lasciava corteggiare dagli ufficiali. La fecero stendere sul corpo. "Ecco il comandante dei tuoi amori. Dagli un bacio..." e poiché la poveretta svenne, la buttarono da parte mentre un gaglioffo, con la daga, staccò la testa del nostro colonnello. Allora corsero in strada; tenendola per i cappelli la fecero volare sulla colonna in mezzo alla piazza. Ac-cesero una torcia chiedendo ai soldati della guardia nazionale di vegliare i resti del tiranno. Per fortuna il disgusto sconvolse anche gli usurpatori, che se ne andarono. Ed anch'io sono scappato da una città diversa da quella in cui avevamo vissuto, torva e per sempre perduta... » Non era soltanto il dolore per la morte di una persona che avevo amato; il racconto, tanto preciso nella crudeltà, aveva cancellato ogni tenerezza verso il mio passato, accrescendo i dubbi che già intristivano. Quale vita mi aspettava? Catellani ripeté la sua cronaca al generale comandante che comunicò il lutto a Verona. Il duca inviò un messaggio, ordinando una messa di suffragio, celebrata il 13 ottobre, alle ore nove, con l'intervento dell'ufficialità e i distaccamenti di tutti i corpi militari. Don Cesare Giavarrini , -cappellano maggiore, lesse, al Vangelo, l'ordine del giorno del generale Saccozzi. «Un atroce delitto, non già di un singolo, ma di un intiero partito che si dice avesse una missione civilizzatrice e liberatrice della patria comune, è stato commesso in Parma. Un nostro fratello d'arme, un ufficiale leale, il colonnello parmense conte Anviti, è stato assassinato. » La pioggia bagnava i soldati immobili. Pensavo: cosa faccio qui? «... il governo del sedicente dittatore Farini , che domina pure nello Stato Estense, lasciò che si consumasse tale orrendo assassinio di cui si rese in tal modo vero complice... » Mi domandavo: perché il duca non viene a spiegarci se davvero torneranno, e quando? Ne ricordavo lo smarrimento durante la battaglia: l'imperatore se lo era dimenticato nel giorno importante... La traversata a piedi di Verona, umiliati dal caldo e dal disonore. Nessuno toi na, mi dissi, almeno in divisa. «... siamo poi certi che questo fatto stringerà sempre più i nodi che debbono legare coloro che difendono la buona causa, non solo dell'Italia, anche dell'Europa e della cristianità. L'assassinio del nostro fratello martire ispirerà ai militari d'onore la brama di vendicare la società e le truppe sì gravemente oltraggiate... » Solo parole: mi giravano come una ruota nel petto, ma non le ascoltavo. 1119 dicembre chiesi il pensionamento, indicando il luogo del ritiro nella casa mantovana di un amico. Ma subito andai a Milano per cominciare questa esistenza diversa. Una vita da poliziotto tranquillo. A Parma non sarei più tornato, se non mi avesse richiamato la lettera del colonnello Davico: la famosa storia accaduta nella casa del maestro Verdi... Dalla valigia non esce solo il diario dove ogni sera riassume le giornate usando, più della lettura ragionata di un agronomo, la disciplina di un notaio che non può dimenticare una sola parola della realtà nella quale si mescola. La valigia contiene altre carte. Informazioni. Del resto un poliziotto come potrebbe muoversi senza guida? Cerca tra i fogli il nome di Barbuti, ma la prima nota che prende in mano riguarda una persona che conosce bene: se stesso. Tiene il rapporto per ricordo. Non gli era mai capitato di venir scambiato per spia o malfattore, invece il documento inviato dal questore di Cremona al questore di Milano gli attribuiva «insolite curiosità sulle quali è doveroso vigilare ». Era successo che nel giugno dell'82 era scoppiata una rivolta contadina ad Ognissanti, paese tra Cremona e Casalmaggiore. Per estirpare il lino i braccianti pretendevano « due pesi per loro e tre per il padrone », ma i padroni non ci stavano e si rivolsero all'autorità. Gli venne ordinato di seguire come osservatore gli avvenimenti essendo il centro della rivolta nel podere della famiglia. Soldi, grandi elettori del deputato « massone e anticlericale » Mauro Macchi. «Vada un po' a vedere come i proprietari che esaltano la sinistra se la cavano quando gli agitatori della loro parte politica mettono in testa idee sconvenienti proprio ai loro contadini... » gli aveva detto il capo dell'ufficio col sorriso di chi non condivide l'eccentricità suicida di certi signori. Il nome Soldi gli aveva fermato il cuore. Poi minimizzò la cosa, mettendola nella categoria delle occasioni insensate perché solo la speranza di un sognatore poteva fargli credere che il ragazzo cercato tre anni prima sull'altra sponda del Po, fosse ancora nascosto nella stessa casa. «Una casa dove si facevano pranzi per onorevoli... »: a Sant'Agata gli amici del ragazzo riferivano i suoi racconti. «Una casa di padroni cordiali che si fidano perfino di chi non ha la barba... Una casa che ha un bel nome, Soldi... » Ed il nome era rimasto nel suo diario come curiosità inesplorata. Un giorno, forse, avrebbe compiuto un viaggio. Ecco, il viaggio cominciava. L'occasione non riguardava soltanto le prove da raccogliere; per quanto incredibile possa sembrare, il vedere il ragazzo sparito dai poderi di Verdi, riuscirgli a parlare, oppure semplicemente ascoltare la sua voce, avrebbe contribuito a rinforzare la fiducia ormai vaga nella propria intelligenza. Perché quando aveva cercato il ragazzo con la decisione di trovarlo, la gente attorno a Busseto si era comportata in modo strano. Non che non volesse parlarne. Rispondeva come se il ragazzo non fosse esistito confinando il suo scavare nell'irrealtà. Il segreto della sua aria fanciullesca e furba era rimasto un segreto perfino con la madre. L'agronomo era molto interessato a quanto poteva raccontare la doi.,Ia di un figlio scomparso in modo per niente chiaro: invece si infastidì e non aprì bocca come se avesse paura. «Quando la interrogai sui rapporti con la famiglia del maestro Verdi, addirittura scappò. Come il diario può far fede, la prudenza impedisce perfino a me stesso di precisare l'ipotesi che ho ben salda in testa. Ma questa ipotesi non si arrende. Testarda, aspetta il momento della verità, verità che rallegrerebbe il cuore stanco di un poliziotto ormai negli anni del declino. Dunque, va ad Ognissanti. Arriva la sera del 15 giugno con trenta soldati e sei carabinieri. I militari alloggiano nel granaio della chiesa, lui dorme in casa Soldi. Soldi è anche sindaco del paese. Alla sua tavola siede un deputato. La presenza dell'agronomo dovrebbe riguardare soltanto i discorsi che Soldi, il deputato e «altri caporioni della sinistra» si scambiano nell'imbarazzante situazione del tradire, nella pratica, le belle idee proclamate in piazza. Ma l'agronomo si distrae. «... una cameriera dice di aver sentito parlare di un ragazzo, ma se n'era già andato quando lei arrivò. E quando arrivò?, chiesi. "Tre anni fa." Il giorno seguente mentre i carabinieri portavano via sulla carretta cinque contadini che si erano rifiutati di estirpare il lino al prezzo stabilito dal mio padrone di casa, vidi un prete discorrere con un prigioniero incatenato. "Cos'ha quel prete?" si insospettì un carabiniere. Per mettere calma negli animi seguii in canonica don Gioacchino Bonvicini. Lo scoprii cordiale e per niente riservato. "Sono gli stessi agenti della forza che, a volte, provocano disordini. I deboli hanno sempre torto anche quando avrebbero ragione..." Malgrado simili discorsi pareva tutt'altro che uomo inquieto. "Un ragazzo?" si fermò a pensare allorché affrontai l'argomento che mi stava a cuore. "C'era un ragazzo in casa Soldi. Mi fecero capire che si trattava di un domestico speciale, quasi un ospite accolto per far piacere ad un amico. Non lo vedo da tempo. Domani chiedo dov'è. Devo andare dai Soldi per i contadini arrestati. Povera gente..." » Una volta di più l'agronomo sentì di essere vicino al momento in cui avrebbe potuto guardare in faccia la persona cresciuta in modo spropositato nella sua fantasia; ma ancora una volta l'attesa finì in niente. Qualcosa, nella curiosità del prete, dovette infastidire la famiglia Soldi. Si interrogarono i domestici: il poliziotto venuto da Milano aveva posto le stesse domande? La ragazza raccontò le domande. «Qual è il vero impegno? » chiese il signor Soldi al questore di Cremona. «Tutelare la proprietà in pericolo per pochi sconsiderati o scoprire quali ospiti hanno frequentato la mia casa? » La protesta lasciava intendere la minaccia di uno scandalo per una «perquisizione politica » che gli amici potenti dei Soldi non avrebbero lasciato passare sotto silenzio. Anche il nome di Verdi arrivò al questore. Così il questore prese la penna per compilare il rapporto sfavorevole al delegato Franzoni «più attento alla marginalità di avvenimenti insignificanti che alle idee fomentate in quella casa ». Allora, Barbuti... Sul tavolo insicuro dell'albergo l'agronomo controlla i fogli che escono dalla valigia. Barbuti gli ricorda vagamente il Partito Avanzato e i suoi uomini divisi in confraternite opposte. I moderati, liberali inquieti: farmacisti, medici, avvocati. Sopportano col disagio della borghesia che si annoia nelle abitudini confortevoli le regole della società. Confondono la mediocrità della quale sono portatori, con la struttura dell'ordine del nuovo Stato. Finalmente trova la nota che sapeva di avere con sé. «Elenco dei principali membri del partito repubblicano. Moderati, appartenenti alla società massonica. » Tra l'avvocato Enrico Arisi e il dottor Torquato Ostacchini , ecco Francesco Barbuti. Spiega il foglio della prefettura: «Redattori del "Presente". Colore politico: progressista. Periodicità: quotidiana. Corrispondente esterno il dottor Pietro Cocconi, fondatore... ». « Barbuti ... mi pareva! » L'agronomo sorride della memoria che non lo tradisce. Vi sono altre carte dove torna il nome del compagno d'albergo «... i frequentatori della loggia Giuseppe Mazzini si raccolgono nelle stanze del Comitato di provvedimento per il colera, di fianco al teatro Regio. Qui il 14 luglio 1873 si tenne una riunione particolarmente animata, come ragguaglia un informatore degno della massima fede. L'avvocato Barbuti, e uno dei fratelli Fochi, caffettieri, comunicarono che non sarebbero più intervenuti alle adunanze, non condividendo le congiure internazionali contro il governo di Roma... » In fondo, una nota aggiunge altre informazioni: nel 1880 Barbuti si trasferisce a Roma dove «né il giornalismo, né la politica lo appagano con onore ». «Un sognatore », pensa l'agronomo nel riporre le carte. «Povero idealista dalla mente chiara... » ma il dubbio frena l'ottimismo. «Come mai un sognatore torna in queste campagne mentre la rivolta sta per cominciare?» Al piano di sopra, quasi nella stessa camera dell'albergo Sole, l'avvocato Barbuti sbadiglia davanti al tavolo coperto da fogli bianchi. Vi sono due libri, ma dietro la copertina di tela, un volume non raccoglie pagine stampate, solo articoli, ritagliati ed incollati con accanto appunti che ne ricordano l'occasione. Non ha voglia di scrivere. Gli occhi si perdono nella luce verde del pomeriggio. L'ombra delle piante e le voci che salgono monotone da fuori, fanno crescere la sonnolenza. Uno scariolante si è svegliato e attacca il cavallo. Mastica tabacco, sputa per terra e col calcagno nudo schiaccia nell'erba il resto del sigaro. Barbuti si alza e cammina, due passi in avanti, due indietro nella stanza troppo piccola. Stira le braccia. Non è venuto per capire; non vi sono ragioni nuove, e le torbide ideologie che spaventano i giornali gli sembrano fantasmi di comodo: ogni tanto cambiano nome e colore, ma non la sostanza di una realtà che nessun evento scuote. Questa realtà si chiama fame. Lo sa da anni e lo ha spiegato in un libro. Più vecchio, forse più cinico, adesso torna a ripetere le stesse domande. Si è portato gli articoli di allora, non per la pigrizia del dover riscrivere le stesse parole, ma per il piacere avvilente di controllare, tanto tempo dopo, gli avvertimenti lanciati agli uomini del potere. Sotto la finestra i soldati si preparano a qualcosa. Una ricognizione, una esercitazione. Sellano i cavalli mentre i graduati corrono gridando ordini. Un corriere esce al galoppo verso la città. Un carro di fieno avanza profumando l'aria. La famiglia del bracciante sprofonda nell'erba, donne e bambini, le forche piantate come un trofeo. Barbuti prende il libro degli articoli. Sfoglia anche l'altro con mani annoiate: Monografia dell'agricoltura parmense compilata per incarico della giunta parlamentare, un'inchiesta che gli era piaciuto dedicare «ai signori soci del Comitato Agrario e all'onorevole Camera di Commercio e Arti e a tutti coloro che vollero attribuire un pregio ai poveri risultati di un modesto studio, sperando si tenga conto del desiderio vivissimo di concorrere in qualche modo al miglioramento della classe agricola e alla prosperità economica dei miei cittadini. » 1880: vent'anni dopo nessuna prosperità. Continua la fame, anche i piccoli padroni ormai non ce la fanno. Ma i grandi sono più arroganti, non hanno paura. Confidano nei giovani ufficiali che il naufragio delle imprese africane ha educato a guardare non fuori, ma dentro le frontiere; a cercare i nemici non fra gli eserciti stranieri, ma nelle voci di chi attenta alla tranquillità necessaria ai commerci che prosperano nei palazzi. «Sta per scoppiare una strana guerra », pensa Barbuti. «La borghesia contro gli straccioni. Questa volta non è facile scegliere. Da che parte mi troverò? » Da Roma la miseria delle campagne gli era sembrata di una grandezza tragica; forse perché più quieto, immune dalle passioni della giovinezza, dall'indignazione, dalla rabbia, si era proposto di raccontare questa fame nel colore di una narrazione scientifica, cruda e priva di polemica. Certo, gli viene in mente Zola. Una pagina dopo l'altra rifarà il vecchio cammino. «Vediamo dove posso cominciare... » La curiosità scioglie il torpore. Nei primi fogli c'è una illustrazione che gli ricorda la scoperta del Po: il fumaiolo corto che si alza dal piroscafo Modena, tanti anni fa. Quel fumo apre le sue memorie. Dalle memorie dell'avvocato La prima nave passeggeri la vidi mentre attraversavo il fiume. Doveva essere il '58. Quel traghetto mi portava a Cremona da un cugino di mio padre smanioso di conoscere il «futuro avvocato ». Avevo solo diciassette anni e l'università stava per accogliermi. Pochi mesi prima, nell'età in cui ci si dibatte incerti tra i piaceri e la virtù mi ero deciso di lasciare il seminario di Berceto. Per chi è cresciuto in montagna, già l'attraversare un braccio d'acqua imponente può aver l'aria di un'avventura, allorché dentro questa avventura ingigantì la visione del piroscafo. Si annunciò con la sirena dietro l'ansa del fiume. Lo precedeva un battello con due uomini incaricati di misurare il fondo. Come un arco a prua spuntava l'ancora, e gli stantuffi del motore mi resero sordo. Offrendosi alla nostra invidia, i passeggeri si affacciavano da sotto la tenda tesa sul ponte; c'era anche un salone per i mesi freddi dietro gli oblò. Accanto al nome della nave vidi l'aquila a due teste « Lloyd austriaco — Venezia ». Distolsi gli occhi: mio padre era liberale. Intanto uno dei barcaioli che manovrava il traghetto, informò che il piroscafo veniva dal mare, per salire a Pavia. Partiva alle tre del mattino per arrivare alla sera. Viaggiavano anche navi mercantili, il Verona e il Vicenza. Il barcaiolo ne parlava con l'orgoglio di chi fa sembrare di sua proprietà i monumenti che lo sfiorano ogni giorno. Anni dopo, quando la febbre politica mi spinse ancora sul Po, le navi erano sparite. Gli austriaci le avevano portate via. Forse traversavano il Danubio... Il secondo viaggio viene dal bisogno di capire la miseria dei contadini, nel '78, d'estate e d'inverno. Restano nel quaderno di Barbuti appunti poi riordinati nell'ufficialità del rapporto scritto per il senatore Jacini. Raccoglie informazioni durante i giorni della mietitura. Guarda gli spigolatori che vivono cercando il pane nella polvere dei campi. ... non potevo immaginare mani tanto rapide. Scompaiono fra le zolle, frugano la paglia, aprono il pugno sopra il sacco-grembiule della donna che li segue come una cisterna. Le mani sanguinano, le braccia si coprono di segni che stoppie dure incidono sulla pelle. Il sole accende le ferite. Nessuno parla fino in fondo al campo. Bisogna lavorare di corsa per guadagnare spazio, rubandolo ai più lenti, e scoprendo per primi le spighe dimenticate. Arrivati in fondo ci si alza. Ecco i lamenti. «Quest'anno è magra: l'anno scorso era andata bene... » «Come mai? » «Pochi giorni prima della mietitura il vento aveva piegato mezzo raccolto e la falce non prendeva le spighe. Le abbiamo prese noi. Danno al padrone, ricchezza per tutti. Adesso stanno mietendo che ancora è verde. Per non rischiare... » Il fattore ride sotto il cappello bianco. La sera uscendo dalla cena del mezzadro, traverso la penombra a ridosso dei portici. Sfioro corpi distesi sopra e sotto i carri. Pochi lumi fanno cadere cerchi di luce che rivelano una gamba scarna, una testa piegata nel sonno, un piede scalzo, una gola nuda e protesa nell'abbandono come offerta al coltello. Le donne coperte fino alle spalle. Riposano uno accanto all'altro, posando la testa su tutto ciò che possiedono: il sacco del grano raccolto... Era tornato d'inverno. Aveva visto i braccianti dormire sopra le stalle e scendere nei cortili, ancora notte, con accette e badili: andavano in golena a tagliare i pioppi. Poi li aveva osservati mentre cercavano nella neve. Cosa cercavano? «Le trugne... » non sembrò una risposta. Soltanto un suono. Le trugne sono radici di rovo che sembrano patate legnose sepolte da un velo di sabbia. Gonfiano lo stomaco con nausea dolce; la fame per un po' se ne va. E Barbuti si era chiesto: «La forza dello stare in piedi dove la trovano?» Nella Monografia segue questi fantasmi lungo il Po. ... per arrivare al Po camminano chilometri. Partono che è notte, tornano che l'altra notte comincia. Sulle spalle le fascine, dentro il sacco le radici. Durante il lavoro, qualche volta (poche volte), mangiano accanto al fuoco quando è possibile accendere un fuoco con rami bagnati dalla nebbia. Dall'argine li ho guardati: un cerchio, in silenzio. Lo spiedo sopra il braciere con la polenta che si scalda come fosse carne. Le scarpe dalla suola di legno sprofondano nel fango. Uomini sfiniti. Ore di lavoro per una fascina e un po' di radici. Il freddo taglia le mani; allora le donne preparano catini di acqua calda, uno sulle ginocchia, dove l'uomo immerge le mani, l'altro sulla terra battuta del pavimento, per i piedi. Con i piedi nell'acqua, il capofamiglia si gira verso il tavolo; c'è la minestra. Anche la minestra è qualcosa di più dell'acqua per i piedi. Una volta la settimana le donne comprano due etti di lardo. Lo dividono in sette pezzi lunghi un dito. Ogni mattino ne pestano un po' con l'aglio e le erbe dei fossi. Serve a fare il brodo dove galleggia la polenta. Quando l'inverno brucia gli occhi e rende le mani così dure che è impossibile impugnare gli arnesi, a mezzo pomeriggio gli uomini sono già nel letto: vogliono addormentarsi prima che arrivi la fame. La pena si mescola alla rabbia perché il padrone fa pagare ai derelitti perfino il calore della stalla dove trascorrono i giorni del gelo. Riemergono gialli, senza sangue, quando cominciano i lavori di primavera. Per potersi scaldare accanto alle bestie sono tenuti a tre settimane di fatica non pagata. I ragazzi si scaldano a scuola, dove c'è la scuola: ci vanno solo d'inverno per i geloni. Del resto cosa possono imparare dai maestri che guadagnano 476 lire all'anno e si preoccupano soltanto di sbarcare il lunario con dignità? «476 lire, lei capisce signor prefetto? » Il prefetto ci intratteneva durante un'accademia al Circolo di Conversazione, e la domanda lo sorprese. Dentro la sorpresa passò un piccolo fastidio. Era un prefetto di seconda classe, naturalmente piemontese come lo sono trentadue dei cinquantotto prefetti del regno. « La verità è che i maestri italiani non vogliono lavorare, pensano soltanto a fare la rivoluzione... » Scuoteva con sdegno la bella testa bianca. Guadagnava milletrecento lire al mese... Rileggendo quelle sue vecchie note, Barbuti si accorge come le passioni possano gonfiare in modo esagerato ogni parola. « Derelitti » oggi non lo avrebbe scritto. L'oleografia della spigolatura lo fa sentire a disagio con quelle gole offerte al coltello. Ha bene in mente che piega dare al nuovo rapporto su una campagna ancora più degradata di quella attraversata allora. Vent'anni prima la rabbia faceva ancora sperare, e la sua prosa riusciva a scaldarsi; adesso che le passioni sono finite, l'indagare deve chiudersi in un disegno matematico con effetti che non possono nascere dalla retorica, solo dalla contrapposizione dei documenti. Si sente giovane con davanti un compito inquieto e nuovo. Certo, Zola... Il resto degli appunti accumula le osservazioni frettolose di un cronista che documenta senza tentare il fascino di una ricerca più profonda. Solo qualche storia sopravvive alla noia. «Bisognerà controllare come sono finite. » La prima parla di uno spazzacamino. Alla fine del '68 quando la miseria stava diventando più nera per colpa della tassa sul macinato — ogni bracciante pagato per la fatica con melica e grano, deve lasciare una quota di grano al mugnaio esattore che poi la versa come tassa allo Stato —, Barbuti aveva attraversato la Bassa arrivando a Pieve Ottoville: davanti ai suoi argini giravano cinque mulini. Un viaggio che la curiosità fa uscire dalla carrozzabile per sperderlo nella palude dove si coltiva il riso. Ma si coltiva anche la malaria. Il disagio venne compensato dall'ospitalità che Antonio Marchi gli offrì a Pieve. Era proprietario di una filanda, vecchio appaltatore ducale per la difesa degli argini del Po, raccontatore divertente, signore squisito: forse il miglior possidente incontrato. Un giorno mentre chiacchieravano davanti ad un affresco di Girolamo Magnani, che rappresentava Pieve e la casa dei Marchi, due figure nel dipinto lo incuriosirono. Gentiluomini che intrigano segretamente in un angolo della piazza: chi sono? E Marchi ridendo come sanno ridere i signori corpulenti, rispose: «Questo sono io, l'altro è Frondoni. Stiamo litigando per lo spazzacamino... » «Lo spazzacamino? » «Ogni anno scendono da Tassullo, nelle valli di Trento, gli spazzacamini. Fanno la strada a piedi in compagnia dei ramai. Traversano il Po ma non si spingono fino alle risaie che circondano la città, preferiscono restare sotto gli argini ormai lontani dalla palude », dice Marchi. «Nel fienile dei Maffini, che sono contadini alle dipendenze di Giovanni Frondoni, dormono padre e figlio, il bambino si chiama Pietro Nicolao Menapace e va su e giù per i camini nelle settimane che precedono l'inverno. Casa Frondoni è casa di artisti amici dei Pallavicino, quindi fedeli ai colori del duca. In famiglia sono cresciuti due musicisti, e nel 1833 Angelo Frondoni (poi emigrato a Lisbona) presenta alla Scala un'opera comica, 11 carrozzino da vendere. Suo cugino Giuseppe studia l'organo assieme al maestro Verdi. Raccontano che, sempre nel '33, allorché Verdi cerca sistemazione dovendo maritarsi, ed essendogli preferito dal partito dei codini di Busseto, quale maestro di cappella, Giovanni Ferrari protetto dall'arciprete, se ne va a Monza, ma prova anche a Pieve. Naturalmente si scontra col cugino Frondoni, non solo figlio di notabili, anche propagatore di voci inquietanti sul conto del rivale. "Un liberale irrispettoso, cresciuto alla scuola del maestro Provesi, i cui epigrammi contro la duchessa e contro il papa fanno il giro dello Stato, questo liberale, può mai diventare organista di una chiesa collegiata con trentadue sacerdoti?" «Non lo diventò e vinse Frondoni. «Nell'aia di una casa piena di rispetto per gli onori del mondo, padre e figlio trascorrono la fine dell'autunno e i primi giorni dell'anno nuovo. Dormono nella stalla o nel fienile, dipende dal freddo. Mangiano quando capita: una scodella di minestra nelle fattorie dove scrostano la fuliggine. «Un certo autunno Menapace rispunta pensieroso. Chiede a Maffini: "Non sono io a desiderarlo, lui lo vuole..." indica il ragazzo. "Gli piacerebbe restare qui..." « Risaliti in febbraio sulle montagne pensavano di trovare un bambino nuovo, invece non trovano nessuno. Madre e figlio morti, gli altri sei ragazzi, soli. Menapace prende ancora moglie, e da quel momento Pietro Nicolao perde la parola. Il dispiacere, col tempo passerà. Invece non passa. Ricomincia a parlare, mesi dopo, durante il cammino tra la Val di Non e Pieve. Fanno la strada assieme ai ramai che girano i mercati per stagnare le pentole. Si cammina e si discorre finché la notte chiude gli occhi lungo i fossi. Voci di amici. Pietro Nicolao spiega finalmente la tristezza: non ce la fa a vivere con la matrigna, preferisce i Maffini. I Maffini lo vorranno? Non se ne discute. È già di casa, e due braccia possono servire. «Durante l'inverno Pietro Nicolao aiuta il padre, ma gli altri mesi li trascorre girando la campagna con una cassetta in spalla. Vende aghi e cotone. Non si è mai visto a Pieve un ragazzo così. Si alza che è buio, torna che è notte. Mai fermo. Va e viene da una sponda all'altra del Po. Ha scoperto i traffici che i mulini sciolti nella corrente favoriscono tra il ducato e il dominio dell'Austria. Di là si spende metà per le stoffe; a Parma convengono grano e lupini. Un contrabbando con qualche pericolo, ma i gendarmi sono facili al silenzio. A diciotto anni Pietro Nicolao rinuncia a grattare camini. Si è comprato un carro, vive di commercio. Un gigante dai capelli biondi, ride volentieri e balla come nessuno, neanche a Zibello, sa ballare. «Di là dal cortile, nella casa di mattoni scuri dei Frondoni, vien su una ragazza con l'aria malinconica di chi scopre nelle compagne la bellezza che non le appartiene. L'ovale non incanta, anche se i merletti sono preziosi. Per darsi sicurezza si chiude nell'intimità di un lessico fantastico, nomi storpiati in vezzeggiativi che ricordano fiori e animali, e dentro quel giardino familiare respira sicura. Questa Maria Amalia scopre lo spazzacamino che cerca di capire un libro. Con l'aiuto di monsignor Fontana, dottore in lettere e teologo, impara a leggere e scrivere. Nel giardino dei Frondoni le lezioni continuano mescolandosi ai racconti. Pietro Nicolao le spiega dei ladri incontrati sui mulini o dei vagabondi che fanno ballare i cani nella piazza di Soragna; lei ricorda le storie di casa, come quella del vescovo Sfrondati di Cremona che dormiva proprio nella sua camera quando traversava il Po per andare a Roma. Una volta da Roma non tornò: rimase in San Pietro col nome di Gregorio XIV. Sarà stato il fascino di quel giovanotto diverso, oppure la determinazione che le ragazze timide, non belle ma ricche e ben cresciute, nascondono come un'anima di ferro, fattostà che si innamorano con lo smarrimento che travolge ogni adolescenza. È solo un calcolo che in silenzio tutti e due giocano con identica durezza? Un marito tanto piacevole dove lo trovo? Una moglie così ricca quando mi capiterà? Sfidando le regole decidono di sposarsi. Pietro Nicolao va in pellegrinaggio dai Frondoni. Se il ragazzo non ispirasse simpatia lo avrebbero scacciato, invece frenano le parole e lo trattano da pari. "Per l'ultima volta" ripetono in silenzio. Del resto hanno in mano una carta che sbriciola l'illusione. "Me fióla la gh'a trentamila franc in t'al scosèl..." L'uso contadino pesa la dote senza complimenti. "Mia figlia ha trentamila lire nel grembiule..." Come per dire: con altrettanti soldi è tua. «Restano sorpresi dalla risposta: venendo da un lavoro pagato mezza lira al giorno, lo spazzacamino ha sepolte in qualche posto tremila lire. Frondoni resiste, non bastano. Allora Pietro Nicolao bussa alla porta di Antonio Marchi. Prima gli parla di affari: si libera dell'asino per un cavallo; apre un negozio. "Insomma, fai fortuna!" "Bella fortuna..." Racconta di Maria Amalia. Anche Marchi non sa cosa dire, ma gli cresce un'idea che mescola la simpatia per i due ragazzi al piacere di giocare uno scherzo a Frondoni. Del resto una figlia tanto brutta chi la vorrà? « "Ha detto trentamila? Se bastano trentamila lire, il resto lo presto io." «Due giorni dopo, in un angolo della piazza, Pietro Nicolao affronta il padre riluttante. Adesso Frondoni è nei pasticci. Non può tirarsi indietro, né mandar via lo spazzacamino, perché Marchi, potente e rispettato, fa parte della congiura. Così Maria Amalia e Pietro Nicolao si sposano, salvando un po' le forme. Non nella chiesa dei trentadue preti, ma alle sei del mattino sull'argine della Madonna del Po... » « Sembra un romanzo... » « Lei è qui per scrivere libri », risponde Marchi « ma i romanzi c'è chi li stampa e chi li vive... », ed essendo padrone di casa dall'orecchio educato a cogliere le stonature della retorica, subito aggiunge: «... e chi li dipinge. Questa casa l'ho comperata nel '31. Era in rovina. Per rimetterla a posto ho chiamato Magnani, il pittore dello scenario del Regio. Ha abitato con noi i mesi necessari a stendere gli affreschi. Gli facevo compagnia. La storia dello spazzacamino gli è piaciuta da volerne raffigurare almeno il finale. Frondoni ed io litighiamo in piazza... » Dal diario dell'agronomo Tempo dopo, quasi per caso, anche il delegato Franzoni entra nel racconto di Maria Amalia e Pietro Nicolao. ... quando cercai il ragazzo scomparso dalle proprietà del maestro Verdi con l'animo sereno di chi ha rinunciato all'occasione di un'indagine e distende l'angoscia in un capriccio, mi recai a Pieve Ottoville per soddisfare la curiosità riguardo la storia che aveva per protagonista uno spazzacamino. Questo spazzacamino aveva sposato la figlia di un grande proprietario, non di nascosto: col consenso del padre, nobile e benevolo. Come mai — pensavo — il ragazzo che stavo inseguendo si era rivolto agli amici di Busseto per sapere se è vero che nei paesi vicini succedono miracoli straordinari? Sembrava felice come chi scopre una via d'uscita, e malinconico perché convinto dell'impossibilità del ripetersi dell'occasione. Pretendeva di conoscere, fin nei particolari minuti, come si era comportato lo spazzacamino; le parole usate; le risposte della ragazza. Il padre, potente e severo, era andato in furia? Di nuovo tornò il pensiero alla figlia di Verdi che porta nella sua casa di giovane sposa il ritratto del contadino dai riccioli neri... Quando lo spazzacamino avanzò con la mano tesa e lo sguardo perplesso scoprii di aver sbagliato ogni immaginazione. Era un signore. Alto, gli occhi freddi e le dita morbide di chi, ormai da tempo, trascura la fatica. Fui vago e ripiegai sulle curiosità di un agrimensore che cerca documenti. Ma feci altre domande: «È mai stato nei poderi di Verdi?» C'era stato, prima di aprire il negozio: col carro e il cavallo a vendere mercanzia. Cercammo conoscenti comuni; ne incontrammo pochi. Aveva visto il maestro due volte; la figlia molto di più. E la figlia — domandai — si faceva accompagnare da un amico dai capelli neri? Lo spazzacamino restò soprappensiero. Per un momento immaginai che la risposta avrebbe aperto una strada alla mia ricerca, invece sembrò la scappatoia di chi forse qualcosa sa, ma non intende compromettersi. La prima parola che volle cancellare fu «amico ». «Non conosco gli amici della signora Maria Verdi; so che ha sposato il dottor Carrara... » E con fretta inattesa in un uomo dai gesti pacati, volle cambiare discorso... Dalle memorie dell'avvocato ... in quel vagabondare da una villa ad una cascina lego la barca ai mulini dentro il fiume, spinto dalle voci che girano sulla vita beata di chi macina grano. Incontro quattro persone bianche. Il rumore delle macine impedisce di parlare, ma se le pale non girano si naviga in un silenzio irreale per questi marinai sordi con la farina incrostata nelle orecchie. È la vigilia d'una festa, il giorno in cui il mugnaio fa gli gnocchi. Un pezzo di lardo ed uno gnocco impastato con l'acqua del Po. «Farina buona... » ripetono i saccaroli che scaricano e caricano i carri sull'argine. Avendo attraversato tanta fame non capisco la sottigliezza. «C'è farina cattiva?» « Quella che i padroni pagano ai braccianti. » Mi portano verso i sacchi, esce odore di marcio. «Melica fermentata; se non c'è altro bisogna accontentarsi. » Mi sono ricordato di questa farina il mattino dopo nella cucina di un famiglio da spesa di Sant'Agata: dipende dai fratelli Giuseppe, Giovanni e Gaetano Frati, affittuari del maestro Verdi di un piccolo podere che pagano 3650 lire ogni due anni. Mi mostrano il contratto firmato dal procuratore di Verdi, Paolo Marenghi di Ongina. Alla domenica anche i famigli impastano il pane con la farina pagata per il lavoro. Due pagnotte in mezzo al tavolo come dolci di pasticceria. Aspettano che il lardo si sciolga nell'acqua per intingerlo nel brodo caldo. Non dimenticherò quel pane. Sembra fuliggine. I braccianti seguono i miei occhi, capiscono il disgusto. «Abbiamo protestato, ma il grano non cambia. » Spuntano sopra le scodelle facce gialle per l'ammoniaca dei mesi della stalla. Do loro mezza lira in cambio di una micca. Un prezzo esagerato, ma devo pur fingere di comprarlo per fare la carità senza offenderli. Attraversando il cortile, getto il pane ai cani che mi inseguono furibondi. Lo annusano, lo rifiutano. Un maiale cerca di masticarlo. Lo lascia cadere. Anche a lui non piace il pane di Verdi... Quando rinasce la legge sul macinato, che il duca aveva sepolto, «Il Presente » manda Barbuti a Guastalla. L'immagine che lo accoglie è la strada piena di gente che corre verso la piazza... «Perché in piazza?» «Perché c'è la farina... » Hanno legato due mugnai. Li spingono come sacchi, di qua e di là. Scendo dalla pistoiese. «Cos'hanno fatto?» «Rubano il pane. Inventano un'altra tassa, la verità è che la tassa non esiste. Rivendono la farina ad un panettiere che arriva in barca da Mantova. Carica di notte, nessuno lo vede... » Intanto un ragazzo dà l'allarme: il segretario del comune è scappato verso Suzzara dove si accampa l'esercito di Cadorna. Fra un po' i soldati si metteranno in cammino. Inutile nascondere la farina rubata, frugheranno fin sotto i fienili e l'averla nascosta aggraverà la colpa. La gente si arrabbia scambiandosi la paura. « Mangiamola...! » gridano come ubriachi. Come si fa a mangiare un mulino? «Ecco come si fa... » Portano le caldaie del bucato e la piazza diventa un accampamento. Si rovesciano i sacchi col disprezzo di chi sa di non potere mai più accumulare tanta ricchezza. Le donne impastano. Gli gnocchi sono pronti. Girano bottiglie di vino acido rubate in chissà quale cantina. «Bevi anche tu... » invitano. «È festa! » Bevono e mangiano, ma la montagna dei sacchi non cala. Chi pensa alla punizione comincia a pentirsi. «Il resto portiamolo indietro. » È tardi per tornare sui passi della ragione; questa farina bisogna finirla. Allora il paese della miseria diventa il paese del carnevale. Dalle finestre rovesciano pugni di farina sulla strada. La pazzia contamina la piazza, tutti aprono i sacchi, si sporcano la faccia, imbiancano la chiesa. La farina avvolge nella nebbia muri sgretolati dall'umidità, copre il cielo, arriva fino ai prati oltre i quali si annuncia il rumore degli zoccoli del re. Non so se il capitano che guida la truppa abbia l'animo di un poeta e sappia cogliere il piacere di vivere dentro un sogno nell'estate di un paese coperto di neve. Comincia a piovere; la farina impasta il fango. Nascosti nelle stalle i rivoltosi aspettano. Col vestito della festa, sotto il cappello largo, il giorno dopo li incontro in colonna che marciano fra i cavalli della truppa. Centotrentadue ribelli, le mani legate, verso la città... Posa il foglio. Si è abituato a parlare da solo, sottovoce: « che vergogna... » La luce se ne è andata, il paese si anima dei passi della gente della sera. Ormai traduce con fatica le carte sparse sul tavolo. In tutti questi anni (sta pensando) non ha imparato niente di diverso da ciò che già sapeva, ma il rivivere le vecchie battaglie dà conforto al compito che lo aspetta. Vedrà gli stessi contadini, forse ascolterà gli stessi discorsi. Il mondo non cambia. Versa l'acqua nel catino. Si bagna gli occhi che la lettura ha velato. La penombra li appesantisce con cerchi ancora più scuri. «Ormai non ho l'età per girare da solo negli alberghi. Se mi ammalo?... » Il lavoro disperderà i cattivi pensieri. Deve subito vedere i protagonisti di questo viaggio. Infilandosi la giacca si chiede: «Da chi comincio?» Il tavolo è lo stesso, ma la lampada lo riscalda con una luce che chiude nel cerchio di una intimità imbarazzante i due ospiti. L'agronomo e l'avvocato; un poliziotto e un giornalista. Le carte di uno parlano dell'altro. Franzoni sa, Barbuti non sospetta, e con la voglia di un discorso che allontani, nella penombra quasi fredda, la nostalgia di Roma, lo interroga sulla vita dei campi. «Qui a Busseto c'è un proprietario benemerito, il maestro Verdi... » Franzoni non intende entrare nel labirinto di una scienza sconosciuta. «La parola benemerito può avere sfumature diverse. Benemerito perché compra macchine e spende soldi per far crescere un raccolto più ricco? Le chiedo: la ricchezza sfama la gente che domani dovrà incontrare, oppure rallegra soltanto i discorsi della mensa del padrone? » Barbuti si accende come uno studente dalla testa inquieta. « Guarda, guarda... » pensa l'agronomo, « invecchiando questo radicale diventa socialista... » Coglie nella caparbietà improvvisa con la quale ignora le osservazioni e prosegue il monologo, la durezza che gli ha permesso di sopravvivere dopo le battaglie politiche perdute in modo doloroso. «Deve essere questo filo di ferro a mantenerlo giovane. Forse ottimista... » Quando l'agronomo può rispondere, dice altre cose. «Il suo giudizio è severo. Mi pare che il maestro Verdi si distingua dagli altri proprietari proprio per l'umanità che riversa negli interessi pubblici. Basta pensare all'ospedale di Villa-nova: soldi suoi per curare i poveri... » «È solo una mia idea, ma credo di aver capito perché spende quei soldi. Per risparmiare... » Barbuti pare contento del paradosso. «... Essendo il proprietario più celebrato della regione, ogni malato gli si rivolgeva per una medicina o per una carrozza diretta all'ospedale di Piacenza. Ogni volta, magari con fastidio, non poteva rifiutarsi. Forse l'idea gliela dà un parente... » «Un parente?» « Da parte della moglie. La Strepponi ha giocato perfino al lotto per fare studiare medicina il fratello minore, Davide. Nel '51 Davide incontra una bella donna, Cristina Bel-gioioso. Non so come sia andata, ma Davide e la signora aprono a Locate Trivulzo un asilo per bambini malati. Forse Verdi si è innamorato di questa idea, o forse ha dato ascolto ad un cugino di Piacenza, don Carlo Utini, nipote della madre, prete rosminiano che fonda asili... » Nell'agronomo cresce la perplessità. « Mi pareva che Verdi fosse nato nella casa di contadini bigotti ed ignoranti... » « Lo raccontano: noi sappiamo altre cose. Intanto bigotto è solo il padre, devotissimo, anche per interesse. Dalla curia prendeva in affitto poderi che subaffittava ad altri. Guadagnava discretamente. Sui registri della chiesa della Madonna dei Prati vi è scritto che la nonna del maestro morì serena in una casa dí sua proprietà al centro dei campi che ivi possedeva, forse acquistati all'asta pubblica dalla diocesi di Borgo San Donnino... » La risposta dell'agronomo sembra sarcastica. «Non avrei sospettato il suo interesse per il registro di un parroco di campagna... » «Stavo raccogliendo materiale per il libro... Le dicevo dei genitori di Verdi. Fin da ragazzo si trovò al centro di due schieramenti politici. La madre sposa, sì, un amministratore di preti, ma esce da famiglia di bonapartisti arrabbiati. Lorenzo Utini veste la divisa francese e combatte con Napoleone a Pavia, tant'è che quando gli austriaci ritornano, per cambiare aria gli Utini si rifugiano a Busseto dove fanno gli albergatori all'osteria dell'Angelo. Diventano amici naturali dei Barezzi... » «Naturali... » « Perché nei sospetti che circondano i borghesi compromessi, in quei giorni di restaurazione, Lorenzo Utini ha bisogno della solidarietà di una famiglia di bonapartisti fidati. I Barezzi, appunto. Stefano, fratello di Antonio, l'uomo che si prende cura degli studi di Verdi, era stato suo compagno d'armi: faceva il cartografo al comando di Napoleone. » «Anche lui un artista... » «Un artigiano, ma speciale. Mi pare abbia lavorato al restauro del cenacolo di Leonardo. Come vede, non un circolo di analfabeti. Torniamo all'ospedale pagato da Verdi. Sono pochi letti che gli consentono di condividere la moda filantropica respirata in casa. Forse sto accumulando significati più complessi della realtà; forse a Verdi bastava non avere questuanti davanti il cancello. Adesso l'amministratore risponde: "L'ospizio è vicino, andate". Mi dicono che a Genova, sulla porta di casa Doria, sia appeso un cartello: "Il maestro non può fare beneficenza essendo già impegnato altrove..." » Barbuti parla con un'ironia che indigna l'agronomo. «Lei è ingiusto... » «E lei non conosce questa realtà... » «Ma sto imparando a conoscere lei. Quando è scappato da Parma per andare a Roma è scappato per rabbia. La delusione politica era solo un pretesto. Se ne è andato perché i suoi allarmi non avevano scosso nessuno. E poi c'è la storia del pane di Verdi rifiutato dai maiali. Non deve averle creato molti amici anche nel suo partito... » Adesso Barbuti non ride. Ha perduto la foga del polemista. L'emozione gli fa tremare le mani. Da molte ore si dibatte in una incertezza scoraggiante ed ecco che tutto cambia per una rivelazione. Chi può essere il vecchio commensale, vestito fuori tempo, che troppe cose conosce della sua vita? E dove le ha scoperte con tanta fretta? Si sente scosso ed esitante. Oramai conta poco per tutti, fuori dal gioco politico e dall'ambizione, eppure una strana impressione nello spaventarlo, lo rende felice. Questo compagno insolito non è capitato per caso nel suo albergo; e non si è seduto per sbaglio al suo tavolo. Cercava proprio lui. Ancora un gendarme, come negli anni della giovinezza. Forse sta sbrigliando troppo i pensieri. Colpa del vino... Ma la paura è come la nostalgia: quando arriva, difficile liberarsene. Per non farsi leggere il tormento sfugge lo sguardo dell'agronomo. Risponde alzando gli occhi verso l'inferriata della finestra. L'aria si riempie di farfalle che vengono a morire attorno alla lampada. Anche l'agronomo è in pena: ha confuso le carte della valigia con le parole permesse nella realtà. Un errore che ricorda la malinconia della vecchiaia. Solo gli anni possono aver sfuocato l'attenzione fino a trascinarla, con un gesto d'ira, nella polemica di quel compagno strapazzato dalla vita. Eppure non è scontento. L'albergo profuma di campagna, le voci entrano allegre e l'uomo che sta di fronte restituisce il piacere antico del guardare la gente attraverso uno specchio doppio che lascia invisibili. Di Barbuti conosce i sogni disillusi, ne indovina la lealtà, ne ha seguito l'idealismo da un rapporto all'altro delle prefetture. È proprio di idealisti che comincia ad avere nostalgia. Intanto la voce di Barbuti continua ad arrivargli, da lontano. «... non basta, come lei fa intendere, essere liberali e intelligenti. La ricchezza cambia le persone, le abitua a sentirsi diverse, a soffrire di una miopia che ferma lo sguardo dentro le mura del proprio giardino. Ci si dimentica cos'è la gente ed è per questo che non la si ama più. «Anni fa, mentre cercavo in questa provincia, un impegno uguale al mio venne affidato dal senatore Jacini al conte Romilli: doveva fare le stesse domande nel mantovano, appena di là dal Po. Ho letto le sue note con una pena profonda. Descriveva i contadini come fossero animali, senza anima e senza diritti. "Hanno pelli ruvide — aveva scritto —, la testa piena di bitorzoli, gli occhi instupiditi, la bocca semiaperta, le braccia a penzoloni quando non lavorano. Le donne mostrano seni abbondanti di latte, le anche molto sporgenti; la statura bassa. Sono più atte alle funzioni generatrici delle femmine di altre province. Partoriscono con pochi incomodi, restano meno infiacchite ed hanno un latte sano e pieno di sostanze nutritive..." Sono le stesse creature — mi chiedo — che nei palazzi raccolgono sospiri e ricevono poesie d'amore? Fuori dal nostro perimetro educato non esistono esseri umani, solo animali. Quando ho conosciuto il conte, la rabbia, che i suoi scritti mi avevano suggerito, svanisce nella stupefazione. Un gentiluomo di animo pio, devoto alla chiesa e amoroso verso i contadini. Mi sono domandato se la sua pietà poteva considerarsi rivolta a persone che gli somigliano o era, piuttosto, un sentimento minore destinato ad una specie che pur sempre bisogna compatire... » Barbuti si piega verso l'agronomo e congiungendo le mani, come se stesse pregando, vuole chiudere il discorso: « Lei deve capire questa gente e queste cose prima di giudicare con benevolenza i padroni... » L'agronomo si annoia. I contadini non lo interessano. Ha sempre vissuto fra signori e conosce da tempo le risposte che Barbuti sta sollecitando. Preferisce i ricordi ai problemi di umanità. « Della sparizione di un ragazzo nei poderi di Verdi ha sentito parlare?» «Quando sarebbe successo? Chi era il ragazzo? » « Un contadino. Non lo hanno mai trovato. Mi pare fosse il '79... » « Nel '79... » Barbuti sospira. « Giravo proprio la campagna, ero giovane e stavo scrivendo il primo libro... » « Il secondo che titolo ha? » « Ancora non c'è. Lo saprò alla fine di questo viaggio... » Dall'altra parte del tavolo l'agronomo teme ancora una volta di sperdersi in storie di nessun conto. Guarda l'orologio. «Le dieci, e domani dobbiamo camminare presto. Meglio andare... » Dal diario dell'agronomo Quel '79 — scrive nelle sue carte Franzoni — è l'anno del ritorno. Il colonnello Davico mi manda a chiamare. Senza dubbio non sono più il giovane ufficiale disposto al rischio, e per sempre si è perduto il pallido idealista che svolge con fanatismo missioni delle quali, sovente, non conosce i contorni. Solo la mia faccia non deve essere molto cambiata. Resta la faccia di chi vive in luogo chiuso, liscia come quella di un impiegato; una faccia non segnata dai tormenti di fede, politica o religiosa che sia. Una faccia pronta a ricevere ordini ed a eseguirli senza discutere. La faccia di un conformista che non riesce a sembrare prepotente. Insomma, una faccia che si dimentica; nessuno se la sarebbe ricordata, eppure prendo quel treno con un'angoscia mai conosciuta negli anni di Milano. Torno a Parma, ricomincia l'avventura. Non sono un giramondo infido, ma non appartengo nemmeno alle persone che si ammettono volentieri in una casa perbene. Montando su quel treno mi chiedo: che interessi potranno mai legare la mia sopravvivenza al gruppo dei padroni di un tempo che aspettano a Soragna? In treno, nella poltrona di fronte, una compagna di viaggio si rifugia con accanimento nella lettura. Un pensiero deve tormentarla: cambia libro, apre lettere, tira fuori buste e fogli. Fogli coperti di parole tedesche e offerti ai miei occhi nella convinzione del segreto, non immaginando che il mio professore di Parma, morto per una salva di cannone, aveva sciolto l'ostilità della lingua. La professione mi abitua all'indiscrezione. Deve essere il marito che scrive: «Cara Johanna. Ebbi le tue parole appena partito il mio biglietto postale. Ho saputo che non ti sforzi a piegare la gamba. Non devi abituarti a tenerla tesa. Da principio può essere che si gonfi; con i massaggi passerà. Mi hanno informato della morte del vecchio Spauer. Manda le condoglianze mettendo prima il tuo nome, poi il mio e fai sapere che nel momento in cui ho appreso la disgrazia sono stato addolorato. Scrivi due parole alla cugina Weinkamer. Puoi usare le stesse espressioni, tanto non si frequentano. Hai avuto l'accredito telegrafico? Metà dei soldi devono essere affidati... » La piega impedisce di leggere il resto. Un marito noioso. La signora lascia cadere sul divano l'altro foglio e sprofonda in un libro di Janarius Aloysius MacGahan, reporter del «London Daily News » che ha la vocazione di stupire il mondo. Va in Bulgaria e scopre i massacri dei turchi. Può lo zar delle Russie permettere la fine dei cristiani? Manda le sue truppe dentro l'impero ottomano. I giornalisti viaggiano nelle tende dello zar, ma le cannonate non badano al colore delle tende e MacGahan muore dopo aver inventato la guerra. Sopra il velluto l'altra lettera sembra più tenera. «Mia cara, stamane al comando sono arrivati cinque tuoi messaggi che dopo aver tentato invano di seguirmi in questi piccoli campi di battaglia, si sono rassegnati ad aspettarmi nella vecchia sede di Novi Bazar. Ho toccato le tue lettere prima di aprirle, felice delle cose che stavo per sapere, ma con un senso di dispetto per non averle possedute nei momenti di bisogno. Le ho messe in ordine di data e, mentre un gran senso di pace mi invadeva, le ho lette. Mi hanno reso felice, una felicità sconosciuta nella solitudine in cui mi trovo. Questo posto è la frontiera tra il nostro mondo e il mondo che vorremmo fare nostro, ma è anche una linea tra Serbia e Montenegro, cioè tra popoli che non si amano. Girano bande armate. Attaccano paesi e truppe, puniscono chi si mostra gentile con noi. Dovremmo inseguirli e disperderli, ma come? È pericoloso uscire di città, poi vedessi che città. La traversi nel fango in pochi minuti. Incontri gente che passa ogni giorno confini vecchi e nuovi, vendendo e comprando. Non hanno bottega, né l'abitudine a stendere merci nello stesso luogo: vanno e vengono con l'intuizione miracolosa di offrire oggetti che attirino denaro. Nelle loro borse nascondono informazioni... » Di nuovo è impossibile continuare anche se, questa volta, l'avrei voluto. Chi sarà la signora? Chi ha scritto la lettera dal campo di battaglia? Quando i miei occhi incontrano i suoi, oso soddisfare la curiosità. « MacGahan prendeva soldi dallo zar. Aveva il compito di indignare l'Europa con la storia dei massacri e permettere l'invasione ad eserciti già schierati », indico il libro con l'insicurezza di chi trova banale infrangere con piccoli argomenti le regole del rispetto. «Racconta cose diverse. Non sapeva come sbarcare il lunario. Un girovago senza quattrini... » «Lo pagavano perché sembrasse senza quattrini. Un povero giornalista dalle tasche vuote rivela la crudeltà dei turchi; è la bella storia di un viaggiatore romantico. Il benessere di chi racconta è un privilegio che attenua la commozione del lettore... » «Pare disperato. Bestemmia... » «Le persone perbene non suscitano emozioni. Un baciamano ha mai commosso nessuno? » Siccome non risponde, insisto. «Mi deve scusare, non ho potuto farne a meno. Ho visto la lettera chiusa con la carta grigia dal timbro "verificato per censura". Forse viene dall'Oriente, magari c'entra MacGahan... » «In un certo senso... » Lo dice con serenità. Non deve essere un segreto troppo fondo. Forse un amante di cui gli amici migliori conoscono l'esistenza. «La mia stazione è Borgo San Donnino. » « Allora scendiamo assieme » risponde. « Devo andare a Soragna... » «Sono appena quindici chilometri. Vado a Soragna anch'io. » «Conosce bene la strada... » Ritorna la vecchia paura di essermi in qualche modo rivelato come se il peccato di avere appartenuto ad una polizia scomparsa contasse ancora. «Faccio l'agronomo... » Allorché il treno si ferma, affiora il tormento. «Mi riconosceranno? » Con le valigie sul marciapiede sono inquieto per la vettura promessa che ancora non si vede, quando ecco avvicinarsi la carrozza dove è salita la compagna di viaggio. Il vetturino scende. «È lei quel signore?» Mi levo il cappello per salutare la lettrice di MacGahan. «A Soragna devono aspettarci le stesse persone... » sorride come se avessi cessato di essere soltanto un importuno. Non sono le stesse persone. La viaggiatrice viene accolta come un'amica a lungo attesa, per me c'è solo il colonnello Cesare Davico, più magro, gli occhi febbricitanti, irriconoscibile nell'abito chiaro di campagna. Non dilunga i complimenti. «Venga, la aspettano... » e senza chiedermi del viaggio mi precede attraverso una sala con le pareti coperte da un arazzo trapuntato di perle minute. La sala finisce in un giardino. Per scendere c'è una scala a due rampe. Guardo a sinistra e vedo un lago con un'isola nel mezzo, gli alberi si spogliano nell'acqua coperta di foglie. Davico prende la destra dove certi signori passeggiano nel sole tiepido davanti ad una cafehaus che sembra l'oratorio neoclassico di un cimitero. «Il nostro amico è arrivato... », mi presenta ai signori. Uno lo riconosco, il conte Camillo Zileri, compagno di viaggio nella ritirata verso Mantova. Quando traversammo il Po proprio Camillo faceva progetti di vittoria prevedendo un ritorno fin troppo vicino. Cantava e si manteneva allegro; anche adesso non mi pare immalinconito da nessuna nostalgia perché il Borbone lentamente svanisce, non nell'affetto (Zileri ne è quasi cugino) ma nell'affanno tutt'altro che romantico di questa realtà. I favoriti di Zileri, sempre larghi sul mento, stanno ingrigendo; i capelli che erano folti sono diradati. Di lui mi aveva parlato a Milano il delegato Zaccarelli della prefettura di Parma: il conte era tra i protagonisti di una vicenda che aveva visto il ritorno proibito nei territori parmensi del duca Roberto I. La casa che gli Zileri abitano a Carignano è guardata da un muro simile alla fortificazione di un castello. Abbraccia un parco molto esteso. Il viale attraversa siepi disegnate dal giardiniere di corte e la fila dei pioppi, messi a cannocchiale, fa sembrare le colline azzurre un fondale di teatro. Luogo impenetrabile e ben guardato. Il Borbone lo sceglie per nascondersi al divieto che impedisce il soggiorno dei sovrani nei domini perduti. Vi resta due settimane proprio quando nelle campagne si accende la rivolta del macinato. Un caso? Non si può credere. Un calcolo politico per attizzare il disordine che minaccia le nuove istituzioni. Roberto arriva per la strada che scavalca la Cisa dentro una carrozza a quattro tiri come un viaggiatore senza nome. Nessuno lo riconosce. Viene dalle alture di Camaiore, attorno a Lucca; con la stessa nostalgia del padre sta costruendosi una villa alle Pianore, dirimpetto al mare. A Firenze lo tengono d'occhio e quando il bisbiglio di un cameriere informa che ha lasciato la Toscana, il ministro telegrafa d'urgenza alla prefettura: «Cercate il Borbone ». Il messaggio chiede discrezione. Bisogna allontanarlo, ma non con le truppe, per evitare di trasformarlo in martire agli occhi dei contadini che ogni giorno devono vedersela contro i soldati. Allontanarlo in silenzio, scoraggiando con energia; ma solo dietro le tende di un salotto è possibile umiliarne l'ambizione. Al mattino si preparano sei carrozze con militi e delegati. Zaccarelli guida l'assalto a Carignano. La villa viene circondata, ma quando il delegato incontra Zileri, il conte si meraviglia di tanto allarme. È vero, il duca è passato per un saluto, del resto sono parenti, ma ha preso la strada del mare proprio la mattina. Un caso? Nella polizia vi sono funzionari che mi somigliano, passati da un sovrano all'altro senza danno. Servono con fedeltà il nuovo stato, ma il loro cuore non ha retto all'idea del duca costretto nell'anticamera del prefetto piemontese. Un biglietto precede la sorpresa. L'altra persona alla quale stringo la mano è il conte Alessandro Gigli Cervi: di lui conosco le storie che hanno fatto sorridere la mia giovinezza quando Anviti pretendeva che ordinassimo in cartelle speciali le informazioni sui gentiluomini di corte. L'ironia di un informatore ignoto aveva compilato la seguente scheda: « Fece scarsi studi dei quali approfittò assai poco. Si sposò giovane con la nobildonna Paolina Gaudio, padovana avvenente e desiderosa di adoratori. Alta, carnagione chiara, naso pronunciato. Nella corte fu ben ricevuta. Ella può considerarsi ornamento del circolo ducale e vuolsi che piacesse al duca Carlo tanto che tra il popolo corrono voci non amorevoli anche in considerazione di una caduta da cavallo che pare abbia privato il conte-marito dell'ardore coniugale. In una sera di ricevimento, mentre veniva annunciato il conte Gigli Cervi, sembra che il duca abbia interrotto il servitore con una frase a doppio taglio: "Bisogna dire solo Cervi perché i Gigli da tempo li ha perduti..." E, altra volta, in numerosa brigata di uffiziali, intrecciò insieme i nomi di Gaudio, Cervi e Gigli combinando un bisticcio assai pungente... » La moglie gli favorisce la carriera. Diventa ciambellano, poi incaricato alla beneficenza. Aspira a qualcosa di meglio, ma nessun ministro se la sente di affidargli compiti dove l'intelligenza possa in qualche modo servire. Non avendo perduto né poltrone né onorificenze con l'avvento del regno d'Italia, mi meraviglia trovarlo ancora ligio alla vecchia dinastia. Non so quanto il duca esiliato possa provare orgoglio per la fedeltà di un personaggio tanto scialbo, ma alla causa dei duchisti un contributo pratico può darlo, il denaro, essendo ricco. Per ultimo c'è il conte Dall'Asta: ha organizzato il banchetto nuziale allorché Roberto sposa a Roma una cugina, sorella del re di Napoli, madre dei primi dodici figli dei ventiquattro che il duca mette assieme nei due matrimoni. Non per tutti gli eredi l'intelligenza è un dono. Davico fa segno: bisogna rientrare. «Dobbiamo spiegarle molte cose... » Ci trasferiamo in una sala dove attende una persona che non immaginavo di incontrare: volgare con i deboli, devoto ai potenti. Gaetano Buttafuoco, vecchio direttore della «Gazzetta », si alza dalla poltrona più grasso di come lo ricordavo. Non riesco a nascondere la meraviglia. « Mi avevano detto che era morto il giorno del tumulto per Anviti... » La faccia pallida, le mani flaccide, il respiro che fatica. «Non si sono del tutto sbagliati... » Apre un pacco di carte ed io mi guardo attorno con l'improvvisa nostalgia per gli stucchi e l'aria di un palazzo: nella vita di Milano manca l'occasione del varcare certi portoni. Due disegni sopra il camino segnano il carattere di una mano gentile. Davico si avvicina: «Sono i padroni di casa. Il principe Diofebo e i suoi due fratelli quando erano bambini. Li ha visti così la duchessa Maria Luigia... » E, indicando l'altro quadro, «... quello è di Luisa Maria, l'ultima sovrana. I discorsi che faremo riguardano la nostra lealtà verso la famiglia costretta all'esilio. Buttafuoco spiegherà... » È un po' come trovarsi in sacrestia quando da bambino andavo le prime volte a servire messa; provavo la stessa emozione mentre aspettavo di seguire il prete verso l'altare illuminato dalle candele. Sentivo alle spalle i passi di fedeli che non vedevo. Qui respiro l'ansia di signori che non pronunciano parola ed esitano a guardare il vicino. Buttafuoco allunga i primi fogli con l'aria di una lumaca spaventata. Coglie la mia diffidenza, ma deve ignorarla perché i suoi padroni hanno fiducia in me. Le sue prime parole esprimono una fede che accomuna le poltrone che mi circondano. C'è nostalgia per gli anni del duca non solo per la disperazione dei giorni che attraversiamo, ma per il modello di buon governo che perfino i sovversivi del Partito Avanzato — ripete Buttafuoco — predicano in piazza: « si stava meglio prima... » Nel diario, spunta un filo di scoramento. L'agronomo non se la sente (lo ricorda, rileggendo) di sprofondare in una realtà che ormai non gli appartiene... ... sono un poliziotto educato all'osservanza dei signori che mi ospitano, ma è una obbedienza scaduta; il mio nodo da tempo è sciolto, ora mi lega una lealtà diversa. In questa stanza dove respiro il disfacimento della società che mi ha educato, davanti a nobiluomini carichi di rancore e di denaro, devo decidere se restare con i piedi per terra o scegliere il paradosso. Voglio, soprattutto, fermare le loro parole: «Vi siete sbagliati, non intendo sapere niente altro... » Ma la certezza del mio consenso non li sfiora. Mi sento come un vecchio cameriere che, anni dopo, tornando in visita nella casa dove ha servito con onore, si piega volentieri all'ordine dell'antico padrone anche se niente lo obbliga ad accorrere al suo segno. I cospiratori aggiustano le poltrone attorno alla mia, lasciando Buttafuoco fuori dal cerchio. Finalmente Davico parla: «Non si meravigli se le chiederemo qualcosa sul maestro Verdi. C'è una storia che potrebbe aiutarci... » L'ultimo spazio per uscire dal gioco dei fantasmi sta per chiudersi e la disperazione mi dà il coraggio della disobbedienza. «Voglio essere sincero: vent'anni fa, magari dieci, avrei trovato avvincente ogni proposta che venisse da parte loro. Adesso mi mette paura. Ho paura — aggiungo con un ricordo di lontana cortesia — perché so che potrei lasciarmi convincere ad accettare per entusiasmo, ma, quando si ha la mia età, l'entusiasmo non sempre coincide con la saggezza... » Davico mi guarda sopra gli occhiali. Un'ombra di fastidio. « Con saggezza abbiamo scelto. Lei deve aiutarci... » Domenica, 25 settembre 1898 I primi passi di una ricerca obbediscono all'istinto. Muovono dai ricordi o da frequentazioni assidue; semplicemente dal caso. Forse è il caso che riunisce l'agronomo e Barbuti nella carrozza che corre per la strada di Pieve Otto-ville. Nel sagrato, una folla. La gente si stringe nel cortile. Barbuti ha scelto di cominciare a Pieve per questa gente che conosce. Fra loro si sente sicuro, ed ha bisogno di sentirsi sicuro perché un dubbio lo tormenta da quando è tornato: che senso può avere riscrivere anni dopo lo stesso libro? L'agronomo ha chiesto di accompagnarlo. Un compagno indifferente. Fa domande inutili, gira la testa con l'aria svagata di un gitante senza curiosità. Per fortuna non rimastica discorsi inquieti. Ma è l'indolenza dello strano compagno ad inquietare Barbuti. Quale scienza coltiva? Nella sua indagine non c'è strategia, a meno che, per un disegno strano, non voglia rivelare a nessuno, nemmeno alla persona con la quale ama discorrere, le linee della ricerca. Attraversano la gente che guarda una finestra del primo piano. Un prete e un giovanotto si affacciano. Il giovanotto sta dicendo qualcosa. Arrivano parole come «operai della causa cattolica », e, più avanti, mentre cerca almeno una faccia conosciuta, Barbuti scopre di essere d'accordo con la predica del ragazzo. «... i ricchi si mantengono indifferenti e attendono a sfruttare il lavoro del popolo; vogliono solo guadagnare beatamente guadagni poco sudati. Oh, un po' di socialismo ci vorrebbe davvero, se il socialismo non portasse funeste sciagure! L'anno scorso quando inaugurammo la bandiera dell'Unione Operaia Cattolica di mutuo soccorso, vi indicammo la strada da seguire... » Nell'agronomo l'indolenza sparisce. «Quello, chi è?» «Troppo giovane per i miei ricordi... » «Si informi. Lo chieda... » come se una fretta improvvisa stesse per tormentarlo, «... in fondo al cortile c'è un prete. Conosce tutti. Si rivolga a lui... » Barbuti guarda il prete e ride. « Il prete lo conosco: don Giovanni Fulcini. Belle storie... » «Che tipo di storie? » «Non possono riguardare un agronomo che va a messa. Sembrerebbero irrispettose. Lo hanno sospeso dalla confessione... Attraverso la grata passava poesie alle signore. Una è arrivata fino in città dedicata ad una ragazza nei giorni della villeggiatura: "Mia cara, mai le dissi / e nemmeno le scrissi / una dolce parola / si ricordi di me..."» «Dovevo immaginarlo », si spazientisce l'agronomo, «conosce solo storie di un certo tipo... » Il prete studia con gli occhi liquidi i visitatori sconosciuti. «Chi parla », risponde, «è il dottor Micheli, un cattolico laureato... » Adesso Barbuti ricorda: «Certo, Micheli: la madre è sorella di Mariotti, sindaco quasi socialista della città... » « Uno strano clericale... » L'interesse dell'agronomo si rivela sottile. «... professa le idee di un radicale ed è nipote di un rivoluzionario... » Il ritorno in carrozza è silenzioso, la strada segue l'onda morbida dell'argine. « Oggi il suo libro scopre le parole insolite dei nuovi clericali. Ai nostri tempi erano diversi... Non capisco dove vogliano arrivare. » Barbuti chiude gli appunti sulle ginocchia. «Oramai è difficile capire. » « Le sarebbe piaciuto andare in Parlamento? » « Gli amici della mia parte erano divisi. Chi troppo avanti, chi troppo indietro. E poi servono soldi, non da spendere per convincere gli elettori, ma per educare gli elettori a cancellare un regolamento sbagliato imparando a leggere e a scrivere, e finalmente poter votare. Con diciassette milioni di analfabeti né io, né lei ce la faremo mai! » Per la prima volta le loro impossibilità sembrano mescolarsi. «La politica mi annoia », risponde l'agronomo «ma guardando come lei lavora in questi giorni mi sembra che la mia vita somigli alla sua: le promesse della giovinezza sono subito finite... » Barbuti non coglie la malinconia; la polemica rode ancora. «Non voglio parerle un uomo di cultura vanitoso, ma la legge di questa nazione non tiene conto della "capacità" di chi vota; non si è preoccupata per trent'anni di premiare gli studi, anche avanzati, di gente senza proprietà. Fino a ieri contava solo la proprietà. Gli intellettuali dalle tasche vuote dovevano fare da spettatori alla cattiva commedia che proprietari ignoranti recitavano malvolentieri. Ai ricchi interessano i guadagni che mettono in tasca. Il suo amico Verdi, che lei tanto ammira per le macchine della campagna... » nel fervore non si accorge del sorriso che increspa l'agronomo «... il suo amico Verdi, non si fa mai vedere in Senato. La gente si infuria per non morire di fame e grida attorno al suo giardino, davanti alla sua porta, una disperazione che è la stessa che Verdi mette in musica per storie di secoli fa. Non ascolta le loro voci; preferisce inseguire le maschere, dimenticando i protagonisti in carne ed ossa del tempo che vive. Nel romanzo di Manzoni c'è un dottore che fa un discorso nel palazzo di Don Rodrigo quando esalta il vino del brindisi: "La carestia resti fuori da queste mura". Possono essere le mura di Sant'Agata... » L'agronomo non coglie l'effetto teatrale del vecchio giornalista; segue altri pensieri. «Non sono amico di Verdi e non faccio conti sui suoi guadagni. Ascolto soltanto la sua musica, e la sua musica mi fa piangere anche se preferisco i tempi matematici di Mozart... » La parola « piangere » ha un suono diverso nella bocca dell'agronomo, come una goccia di pioggia su una lastra di vetro. Fa capire una disperazione che subito asciuga. Barbuti risponde. « Quand'ero giovane, a Roma voleva no cantassi qualche romanza, dopo cena, in trattoria. Con la scusa che venivo da Parma dovevo per forza essere un po' tenore. In quei momenti l'ho amato, ma in altri, girando fra le sue ricchezze, scoprendo che appena lasciato il pianoforte non conosce altra vita che i soldi e gli affari — non per nulla ha "sposato" un notaio — mi sono chiesto: quale realtà incredibile si unisce nello stesso personaggio? Fa cantare ai poveri storie che ogni derelitto sparso nel mondo ripete piangendo, poi non vede gli straccioni che faticano dentro i suoi poderi per un po' di farina marcia? » La carrozza si ferma. Il cocchiere scende a rialzare il mantice perché l'aria della sera traversa come un brivido i viaggiatori. Nell'ombra, sotto l'argine, un palazzo galleggia nel Po. L'agronomo si sporge. «Lo vede? Un convento coperto dall'acqua... » « Il fiume lo circonda soltanto nei giorni di piena. Non è un convento, ma la vecchia rocca dei Pallavicino. L'hanno fatta costruire quando pelavano Polesine con le tasse; adesso è in rovina. C'è una fabbrica di pipe di gesso. Nella chiesa si entra in barca sino all'altare. Una volta era un santuario famoso... » Barbuti indica i portici che il fiume ha quasi soffocato. «Un riparo per i pellegrini che si accampavano giorni e giorni aspettando la grazia... » Come un'ombra che all'improvviso ritrova i colori l'agronomo scopre di essere nel luogo dove, per un momento, tempo prima, la solitudine si era slegata dalla sua vita e qualcosa gli aveva dato coraggio confermando la convinzione — sepolta con orgoglio in fondo ai pensieri — di possedere un'intelligenza sciupata, tradita dalla storia, indifferente all'amore. In quel prato, ora coperto d'acqua, aveva osato mostrare in pubblico il suo gusto romantico e affrontare l'esistenza con la semplicità di tutti. Era successo vent'anni fa, sotto quel portico. Dal diario dell'agronomo Nel diario dove meticolosamente annota particolari insignificana; noie c'è spazio per abbandoni. Eppure queste pagine che riportano indietro di vent'anni sono quasi appassionate, percorse da una trepidazione insolita per la prosa senza colore di un funzionario di polizia. ... Sulla spiaggia, davanti al palazzo dove era cresciuta una torre uguale al campanile di Cremona, è stesa una tovaglia e si stappano bottiglie di vino marsala, mentre la servitù apre le scatole dei biscotti e fa uscire dal baule l'armamentario di tazze, piatti e cucchiai per il tè. Guardo la fiamma azzurra dello spirito che fa bollire l'acqua, e malgrado la mia vita sia passata accanto a quella dei signori venuti dalla civiltà degli infusi, non riesco a spiegarmi con quale gusto si possa mandare giù un decotto di cosi scialbo sapore che non ha altro merito se non di favorire l'insonnia. Quando si beve una tazza di tè mi sembra si debba indossare la veste da camera e, con un cerimoniale di starnuti, calarsi in testa un berretto da notte. Invece siamo su un prato, dentro il Po. Le nostre carrozze fanno da paravento tra noi e i pellegrini in fila nei carri tirati dai buoi. Sul fiume risalgono le barche che i barcaioli poveri trainano al posto dei cavalli; con una fascia di tela sul petto e un nastro stretto alla fronte tirano la corda scalzi, la pelle del torace dura da torcere un ago, indosso soltanto un camicione perché l'uscire e il rientrare nell'acqua bagnerebbe le braghe rendendo più difficile una vita già dura. Quando trainano la barca e si piegano in avanti, le signore devono girare gli occhi perché la camicia si rialza scoprendo corpi nudi. Gli occhi della signora che-mi è accanto intristiscono nel guardarli; è la viaggiatrice che amava la guerra contro i turchi combattuta da MacGahan. L'accompagno in questa gita dopo i discorsi nel parco di Soragna. L'ho ritrovata per caso, uscendo con la testa confusa dal colloquio del colonnello Davico. Sola, verso la cafehouse: aspettava l'ora di cena nell'ombra ormai pesante del giardino. Questa di Soragna è una vacanza particolare perché il marito ha lasciato Bolzano per un incarico a Budapest, ma l'incarico — mi è parso — ha l'aria del pretesto che le buone maniere suggeriscono ad un uomo o ad una donna quando cominciano a non sopportarsi, e, pur avendo già deciso, cercano conferma per la scelta da prendere. Dopo quella sera la rivedo quando tiene conversazione, sorridendo con trasporto insolito agli uomini, ai quali poi si nasconde con ironia. Gli incontri avvengono per caso, al ritorno, o al mattino se la missione mi spinge ad uscire presto. Ogni volta che rientro a Soragna mi scopro a pensare che la sala sarebbe stata meno felice senza di lei, e durante la giornata immagino il suo viso un po' duro, i capelli dai riflessi chiari, la luce allegra degli occhi. Un giorno chiede di approfittare della carrozza per visitare un certo mercante di Busseto. Così prende l'abitudine di seguirmi. Non mi interroga sul mio vagabondare da una casa ad un'aia o a un pescatore di Ongina; né, se m'avesse posto domande, avrei saputo dirle la verità. Lentamente m'accorgo che qualcosa ci accomuna. Tutti e due ci sentiamo provvisori e, da principio, non riesco a capire come lei possa esserlo: è questa incertezza a far nascere una confidenza diversa da quella che l'opportunità impone alle forme. Johanna parla, io ascolto volentieri, lasciandomi andare come mai era successo. Racconta di essere cresciuta nella solitudine delle governanti, proteggendo una sorella più bella. Per anni il suo successo, del quale si rallegrava, ha alimentato la sua infelicità. Si sentiva sgraziata; non sapeva dove nascondere le mani e dopo essersi preparata per ore allo specchio, cambiando abiti e pettinatura, restava abbandonata in un angolo della festa provando sollievo per non doversi annoiare con un uomo costretto dall'educazione a farle la corte. Una volta interrompe il racconto osservando che dirigo la carrozza verso un cortile affollato da gente che ci osserva con ostilità. «Cosa vuol sapere da loro... » «Sto cercando le implicazioni di una storia inconsueta... » L'abitudine alla burocrazia annoia il mio linguaggio. «Mi spiace », risponde Johanna, « non capisco la parola... » « Quale parola? » «Implicazioni. » « Umstand... » « Circostanza... » non chiede altro, riprende a parlare. Il marito arriva come una benedizione per la famiglia che cominciava a preoccuparsi. Si preoccupa perché fin da bambina non riuscivano a decifrarne le ambizioni. La gente chiede ai bambini: cosa farai da grande? In biblioteca — non poteva avere più di dodici anni — la governante fece per gioco la domanda ai fratelli. La sorella rispose « la bibliotecaria », i maschi dissero che sarebbero diventati soldati; solo lei si strinse nelle spalle e quasi piangendo confessò di non averci ancora pensato. La mancanza di ambizione diventa anche la mancanza di un obiettivo ed era il motivo che spaventava i genitori. Toccò alla madre sbrigare puntigliosamente la sua vita con l'ansia delle madri del nord che vogliono trasformare le figlie appena cresciute in parenti alle quali si vuole un bene più profondo. La madre organizza la complicità dei complimenti e l'annoia con le raccomandazioni alla pazienza; vuole piegare una ritrosia che non è timidezza, ma disappunto per l'incapacità di sentirsi completamente felice per le attenzioni di un amico senza fantasia. Solo chi vive lontano dai palazzi immagina le donne che vi abitano fragili e senza sangue e non ne sospetta la durezza contadina che, denaro e abitudine al comando, rendono invisibili nell'eleganza. « Una volta sposati », mi dice Johanna con la franchezza di chi sceglie di parlare con un uomo anziché abbandonarsi alle amiche, « ho conosciuto una serenità che scambiavo per qualcosa di più profondo. Cominciavo ad abituarmi alla presenza di un uomo. Ad ascoltarlo, a toccarlo. Prendevo le sue mani e le premevo sulla fronte chiudendo gli occhi serena dentro quel tepore. Mi pareva bastasse; credevo fosse la parte di felicità ctie mi era riservata. Il nostro rapporto si mantenne .garbato e nella noia, rassicurante. Ci piacevano le stesse passeggiate, o i boschi con la neve. Fra noi viveva la tenerezza fraterna di chi si dà pugni sulle spalle per trasmettere l'affetto. Durò tre anni, e dopo tre anni incontrai un'altra persona. Silenzioso, impacciato come chi arriva nelle stanze a noi consuete attraverso scale secondarie. Pareva avesse escluso dalla sua vita la vanità del vestire o il piacere della compagnia. Si rivelò pigro come mai avrei immaginato un uomo nella mia cultura, dove bellezza e forza fisica si confondono in una sola virtù. Un piccolo notaio che riteneva di essere un piccolo ribelle. Bastò discorrere un pomeriggio e capii che dentro mi premeva un'inquietudine fino a quel momento non rivelata. Lui l'aveva sentita; m'avrebbe aiutato a scoprirla. Non nell'indiscrezione di uno scandalo che intorbidisce i discorsi dei pettegoli, ma nella complicità di un dialogo segreto la mia vita cominciò a cambiare per le certezze che ogni giorno riusciva a farmi sentire. Mi si scioglievano le mani e la fantasia. All'improvviso gli uomini scoprirono che ero bella mentre le signore, che mi dimenticavano nel loro parlare, cominciarono a trovarmi intelligente. Il marito si ingelosì: non capiva, e siccome non avevo mai sospettato che qualcuno potesse nutrire per me sentimenti di possesso, questa gelosia divenne un altro piacere dell'ambiguità. Una gelosia assillante. Frugava nei pensieri e nei cassetti estraendo, come un chirurgo scrupoloso, prove che riteneva importanti per un tradimento di cui non riusciva a precisare il sospetto. Un biglietto, un fiore, un regalo sconosciuto lo ossessionavano in mille spiegazioni, mentre erano solo i cascami senza vita di qualcosa che mi aveva stremata in modo diverso. E il fatto che le sue fantasie non arrivassero a penetrare il nocciolo della questione, me lo rese lentamente straniero. Mi legava a lui un sentimento di stima. Anche la stima se ne andava... » La interruppi: «L'altro uomo le scrive da Novi Bazar...» Johanna arrossì. « Quando mi accorsi che lei parlava tedesco mi sono detta: deve aver guardato la lettera. No, quello è mio padre, forse il motivo più profondo del fallimento. L'ho sempre confrontato: l'eleganza, un senso ingombrante di possesso, l'ironia nei dispetti, e da questo paragone usciva un gigante che schiacciava come una ombra senza importanza l'uomo che avrebbe dovuto accompagnare la mia vita. Ma dalle ombre bisogna scappare, eccomi qui... » La sentii incerta: « Qualcosa, qui, non va?» « Il fatto è che ovunque mi trovi provo la stessa inquietudine; ho bisogno di sentirmi, in ogni momento, amata, corteggiata, ammirata. Forse la compensazione in ritardo degli anni tristi... » Le chiesi se l'uomo che le aveva cambiato la vita abitasse il palazzo di Soragna, ma devo averlo chiesto con voce che tremava per un'angoscia nascosta, perché Johanna rispose quasi con affetto: « Qui non c'è nessuno ». Alla sera, ogni sera, ho sempre chiuso nel quaderno le impressioni della giornata, non perché mi illuda di interessare con simili esperienze possibili lettori, ma perché queste esperienze diventano la base scientifica della mia ricerca. Da principio ebbi la tentazione di riportare nel diario i discorsi di Johanna, poi decisi che la smemoratezza, un peccato inconsueto alle mie abitudini, valeva la pena di essere provato almeno una volta. Il giorno del picnic fu il primo giorno in cui figurai suo accompagnatore. Salì sulla mia carrozza, si appoggiò al mio braccio, e la meraviglia fu che nessuno degli ospiti si stupisse di un poliziotto così assiduo ad una signora di un mondo diverso. Fu più tardi, quando i pellegrini ebbero sgomberato, e si poté finalmente visitare i portici, più tardi avvertii in lei un improvviso cambiamento di tensione: come avesse paura di qualcosa. Allora osai guardarla bene in faccia e vidi che stava fissando, sopra la mia testa, un nuovo venuto. Legava il cavallo all'albero prima di voltarsi verso di noi: Gigli Cervi, dunque, il signore senza fantasia che dopo la caduta non sapeva tenere le donne. Lo guardava con un'•espressione che conoscevo bene: disperata, affettuosa, come di chi è lacerato da una speranza morbosa che per un momento aiuta la vita ma la condanna ad atroci malinconie. Ecco il perché del viaggio; ecco spiegata la solitudine. La mia presenza l'aveva soltanto aiutata a riempire le ore in cui Gigli Cervi doveva essere altrove. Mi sentii avvilito come nei giorni più tristi, ma in fondo confortato da una idea che la mia conoscenza aveva sempre individuato: certi confini non devono essere superati, e per fortuna anche questa volta solo una rincorsa silenziosa si era spinta avanti. Le chiesi al ritorno: « Continua a vedere quell'uomo? », avvicinandomi allo scopo principale della domanda col dovuto rispetto ma con l'astuzia che non si lascia ingannare dal sentimento. « La clandestinità fa soffrire », risponde con malinconia. «Prima o poi finirà. Le cose belle se ne vanno se un segno non le concretizza. Un figlio, per esempio... » Era il nono giorno che giravo per la campagna seguendo la traccia del colonnello Davico. Quando l'agronomo supera le ultime parole del racconto di Johanna, stringe l'attenzione come se leggesse, per la prima volta, il diario di un testimone sconosciuto. Da questa pagina in avanti la sua vita cambia. Dopo anni, non ha ancora capito dove l'attenzione si sia distratta e la furbizia, che si nasconde dietro la maschera malinconica di ogni poliziotto, abbia potuto velarsi fino a fargli perdere la partita. E riprende il diario... ... Giorni prima, dopo avermi mostrato lettere e giornali, dopo avermi spiegato come la rivolta per fame possa favorire il ritorno dei legittimi sovrani, Davico fa capire quale inconveniente devo rimuovere affinché il programma vada avanti. L'inconveniente è il maestro Verdi. « Verdi? » Con pazienza, mentre restituisce le carte a Buttafuoco, riprende a spiegare. «Noi riteniamo prossima l'inSurrezione popolare. I contadini, la borghesia e la gente di commercio possono darci una mano. Promettiamo il buon governo che già conoscono, e questa promessa li troverà concordi al nostro fianco. Stavano meglio col duca, perché dovrebbero ostacolarne il ritorno? Per un sentimento patriottico? La patria è la pancia piena e le campagne senza vagabondi. La patria è una paga robusta. Nessun protagonista di questo paese, cosiddetto nuovo, suscita le simpatie della folla. Nessuno, solo Verdi... » Prende fiato. « Solo Verdi. La gente non lo conosce e non può immaginare come egli sia il più duro tra i padroni; la gente canta la sua musica e confonde la musica con l'uomo. L'uomo è senatore: possiede un giornale liberale, soprattutto avversa con tutta l'anima la nostra causa... » Guardai Davico. Aveva l'aria stanca, del resto durante ogni nostro incontro aveva mostrato la stessa faccia infelice. Sembrava una' condizione della sua esistenza. « se mai Verdi ha dato un segno di interesse per la società, questo segno ci condanna al disprezzo... » «In quale modo parla dei sovrani costretti all'esilio?» «Non ne parla, ma avversa il sistema che hanno rappresentato con una violenza insolita in un uomo di cultura. Nei primi mesi del nuovo stato, quando l'assassinio del buon Anviti aveva suscitato un sentimento di orrore in Europa, compresa la Francia alleata al re sardo, Verdi ebbe timore che la restaurazione fosse vicina. Bisognava armare il popolo. Con quali armi? Il podestà di Busseto, Corbellini, gli fece intendere che una specie di guardia nazionale era stata reclutata. Ma cos'è un soldato senza fucile? Servivano 3500 lire per comperare le bocche da fuoco necessarie. "Le casse del comune sono vuote..." "Non importa" risponde Verdi. "Pago io..." Tira fuori le 3500 lire. Fa di più. Scrive all'ambasciatore inglese a Torino, Hudson, che gli suggerisce il nome di un ex bandito di Garibaldi, un sedicente ufficiale di nome Clemente Corte. Corte risponde: ho un arsenale pieno. Verdi ordina cento fucili per Busseto e settantadue per Castel San Giovanni. Ordina e paga anche se — attento al denaro com'è — l'anno dopo pretende di essere risarcito... » « Storie vecchie », lo interrompo, «la gente cambia in vent'anni. Il mondo è pieno di rivoluzionari che la maturità ha reso conservatori; oggi ripudiano le idee per le quali hanno rischiato la vita... » «Non Verdi. È un contadino dalla testa dura. Stia a sentire. Vince ancora l'avarizia e diventa il finanziatore del cannone che Busseto regala al re. Qualche mese prima si era sfogato con gli amici di Milano. "Finalmente questi tedeschi se ne sono andati. Voglia la buona stella allontanarli di più. Oltre l'Alpe vadano a godersi il loro clima e il loro cielo che auguro bello, limpido e splendente più del nostro..." E quando la battaglia combattuta a Custoza minaccia i Savoia, Verdi si spavcnta. Fa sapere a chi amministra i suoi beni: "Me ne andrò, perché la sola idea che gli austriaci possano fare un'apparizione fin qui mi fa correre mille miglia senza prendere fiato soltanto per non vedere quei ceffi. A Rovigo, prima di ritirarsi, hanno incendiato e saccheggiato la città. Incendiare e saccheggiare, ecco la missione civilizzatrice di questa nazione..." Bisognerebbe spiegargli cosa è successo nel Regno di Sicilia: Garibaldi che ruba, i piemontesi che fucilano... Con tanti soldi e una proprietà sterminata non lo capisco. Ha perfino scritto ad un amico: "... per Dio, Garibaldi è un uomo. Veramente da inginocchiarsi davanti..." » Rispunta la vecchia diffidenza. « Come fa a sapere le parole di una lettera spedita da Verdi? » Davico sorride: «Purtroppo non è come crede. Lo ha raccontato il maestro Mariani ad un conoscente di Genova. Non siamo noi ad aprire le buste, adesso... Insomma, non ci ama, ma ci ha amati per convenienza. Conserviamo un biglietto mandato alla duchessa: promette l'omaggio della versione per pianoforte dei Lombardi. E poi accetta una spilla col monogramma degli Asburgo! » Il mio gesto spegne l'entusiasmo. «Solo una risposta gentile: non lo compromette. Un musicista è un uomo pubblico e un uomo pubblico ha obblighi verso il potere dal quale dipende. Pensi alla censura che lo tormenta. L'intendente dei Borboni ha cambiato, a Napoli, duecentonovantasette versi degli ottocento del Ballo in maschera. Per evitare lo scempio, la cortesia resta la resa meno umiliante. Non è la strada giusta di un ricatto... » «Lo sappiamo, ecco perché abbiamo scelto un'altra storia. In un primo tempo avevamo pensato di cercare nella sua vita mettendoci in contatto con i giornalisti della "Rivista Indipendente". Legga! » Dalle mani di Buttafuoco esce un'altra cartella. Davico prende un foglio. « "... Sempre fermi nel proponimento di conservare integra l'Indipendenza del nostro giornale, non indietreggiamo dal compito assuntoci, ma liberi da passioni e scevri di pregiudizi, diremo sempre la verità, anche quando questa verità sia per dispiacere a qualcuno...": è l'impegno del direttore. "... -Nell'albergo di Milano si trovarono colà a dimorare, non sappiamo se a caso o a bello studio, il maestro Verdi, l'autore della Messa da requiem scritta per Manzoni o per chiunque lascerà detto agli eredi che la pagano, e la celebre, secondo lei o secondo lui, Teresa Stolz. Non erano (vedete che personcine a modo) albergate nella stessa locanda, ma ciò non impedì che il maestro Verdi si portasse subito ad onorare di una visita, crediamo platonica, la rotonda di forme e appetitosa soprano. Fu il signor Verdi ricevuto con tutti gli onori e gli oneri inerenti a simili visite, e poco dopo la amorosa coppia si sdraiò, cioè, non si sdraiò, si acconciò, su di un morbido canapè. Quel che facessero su quel canapè, di strano, non lo sappiamo davvero perché erano in camera, e la porta era chiusa. L'avventura sta in questo: senza che la Stolz e Verdi nel calore della mischia si accorgessero di nulla, al Verdi uscì di tasca un portafogli che conteneva lire cinquantamila... Se ne accorse quando tornò in albergo. Incolpò la servitù, ma uno dei camerieri che sapeva dell'amicizia tra Verdi e la Stolz, andò dalla cantante e contrabbandando il nome del maestro ottenne il permesso di ispezionare il pavimento. Sotto il canapè, ecco il portafogli..."» Altri giornali riprendono la chiacchiera. Davico li mostra. «Il Presente » mette due righe: non amano Verdi eppure ne discutono con galanteria. «Non vogliamo sapere quello che capita dietro le porte chiuse, ma riteniamo l'episodio degno di ben altro scandalo solo se fosse dimostrata la notizia di un signore che nei giorni della grande fame, quando i braccianti sfidano i fucili della truppa per pochi centesimi in più, in simili tempi, si andrebbe a spasso con cinquantamila lire in tasca nella condizione di chi mette conto di perderli senza fare troppi drammi... » Il mio buongusto si ribella. La mia occhiata attraversa Buttafuoco, responsabile del dossier. « Un'infamia...! » Adesso è sicuro; me ne andrò. I vecchi signori intristiscono e i loro sogni perdono il senso dell'eleganza e della vita. Ma i vecchi signori sanno essere lettori sottili dei pensieri che suscitano. E Davico, per la terza volta, prende la parola. « Vogliamo piegare Verdi con argomenti meno banali di un pettegolezzo. Condizionarlo, permettendogli, tuttavia, di conservare l'immagine che il mondo gli riconosce. Ecco cosa abbiamo in mente... Lei ci può aiutare... » Buttafuoco tira fuori un quaderno coperto dalla scrittura noiosa di un impiegato; il colonnello lo sfoglia stringendo gli occhi dietro le lenti come chi non riesca a sopportare la stanchezza che porta sulle spalle; Gigli Cervi si alza e se ne va. Solo qualche giorno dopo scoprirò il senso di quella sparizione. «Lei, capitano Franzoni », sta dicendo Davico «conosce bene gli umori di questa pianura. Gode la nostra confidenza, può avere facilmente quella dei contadini che parlano il suo dialetto. Ascoltando, interrogando, cercando di capire, come il mestiere le insegna, e senza suscitare sospetto, deve scoprire se una curiosa testimonianza che abbiamo raccolta possa corrispondere a verità... » Quel « capitano Franzoni » sembra scritto sulla lapide di una persona dimenticata, ma il mistero, che Davico fa balenare, risveglia l'attenzione confusa dai preamboli. «È possibile... di cosa tratta? » «Un ragazzo scomparso. Non possiamo suscitare una indagine ufficiale senza giustificare con i nostri nomi una denunzia che altrimenti nessuno terrebbe in considerazione. La gente scompare di continuo, ma se gente come noi sollecita la ricerca, vi è subito chi nota la stranezza: perché dovrebbe starci a cuore la sorte di un contadino cresciuto nei poderi di Verdi? Perché non guardiamo nei nostri poderi? Perché non contiamo i nostri villani? La gendarmeria non ci sarebbe d'aiuto. Cattive relazioni ci dividono dal potere e i delegati porrebbero subito altre questioni. Alla fine verrebbe fuori la manovra... » Continuo a perdermi nel labirinto. « Chi è il ragazzo? » «Il nome non ha grande significato. Diciassette anni, figlio di un affittuario di nome Scaramuzza. Abita a Roncole, ma da Roncole è sparito nel giugno di tre anni fa. Un bel ragazzo, i capelli ricci, dicono intelligente. Verdi lo vide e chiese ad un artista di copiarne la testa: "Vorrei che un certo tenore gli somigliasse..." Come forse sa, il maestro ha perduto i figli del primo matrimonio, ed ha adottato una bambina nata nella casa di un parente, si chiama Filomena. A Sant'Agata l'hanno battezzata Maria. Ormai non è tanto bambina, l'anno scorso ha sposato il figlio del notaio Carrara, l'uomo che ha in mano gli affari di Verdi. Inutile raccontare il sospetto della gente: il matrimonio è cresciuto su ordine del maestro. Per fare sposare Maria al giovane Carrara, Verdi e il notaio hanno avuto fretta, una fretta improvvisa e ingiustificata. La ragazza si fidanza a diciassette anni ed è maritata in pochi mesi accelerando addirittura gli esami con una dispensa speciale del ministro dell'educazione perché la giovane età le impediva di concludere gli studi al collegio della Regia Opera della Provvidenza di Torino. A nessun amico, fino in fondo, si fece sospettare il fidanzamento, e vi è chi raccoglie a Sant'Agata certi cattivi umori che agitano la casa prima che l'accordo per le nozze fosse rivelato. Questa è la lettera che la mano di un servitore ha fatto uscire dallo scrittoio della signora Verdi. » Un foglio coperto di correzioni. «Una copia...?» «Una brutta copia... » Indirizzata a Milano. «Maria prende marito, sposa il figlio del nostro amico, il dottor Angiolo Carrara, 27 anni, spirito retto, severa onestà, cuore buonissimo. Esso sarà, come suo padre, i suoi zii e tutti di quella famiglia, un eccellente compagno alla moglie di sua scelta e ne sarà certamente corrisposto da Maria che, come sapete, è una creatura d'oro... » Davico mi guarda sopra gli occhiali. «Cosa pensa? » «Non sono uomo di lettere, né studioso del cuore umano, ma ho l'impressione di non assistere ad un amore travolgente. Maria obbedisce e certamente corrisponderà l'affetto del marito essendo una creatura d'oro... Santo cielo, è un contratto, non uno sposalizio. Comincio a capire perché sia stata maritata in fretta... Un altro uomo? » «Un ragazzo. Un compagno di giochi che tornando dal collegio ritrova adulto. Sono storie che succedono, ma a Sant'Agata, come sulla scena, i copioni vengono scritti solo dal padrone di casa e questa passione di adolescenti non è prevista dal programma. Incupisce un'atmosfera già avvelenata dal pettegolezzo della Stolz. A Maria viene proibito di rivedere il figlio del fittavolo, ma, in un modo o nell'altro, il figlio del fittavolo continua a scivolare dentro il giardino. Quando il maestro lo scopre, la sua collera travolge ogni persona. Maria è spedita alle acque di Tabiano, anche se la signora Verdi non avrebbe voglia di accompagnarla perché a Tabiano c'è la Stolz. Poi il collegio: passa un anno e un anno calma la passione, ma non sappiamo se il sogno finisce davvero o impallidisce soltanto, perché a giugno, quando Maria torna, il ragazzo non c'è. Sparisce i primi giorni d'estate, tre anni fa, nel '76. » «Nient'altro? » «Solo questo. Ah, sì, un particolare forse importante. Quando Maria si sposa, porta nella nuova casa, al Paradiso, la testa del ragazzo ordinata da Verdi... » « Posso sapere chi ha raccontato queste cose?» Davico e Buttafuoco si guardano. «Una persona di fiducia... » «Devo capirlo io se merita fiducia. Si tratta di una storia aperta a chissà quali interpretazioni. Magari sotto non c'è niente, ma può nascondere un avvenimento grave; forse è la voce maligna dei contadini che non amano il padrone, forse è il segno di un dramma che si vuole tenere sepolto. Se non so da che bocca esce mi è impossibile prenderla sul serio... » «Allora bisogna dirle di un'altra vicenda. Buttafuoco la conosce meglio di me... » Davico indica a Buttafuoco la poltrona vuota di Gigli Cervi. « Si sieda. Può spiegare al capitano chi ci ha informati. » «Nella corte del conte Barattieri, a San Pietro in Ceno, sulla strada per Cremona », Buttafuoco usa le parole con la cura di chi sceglie dolci alla crema, girando con la mano sopra un vassoio ricolmo, « lavora un falegname che fa carrozze. Nella sua bottega c'è un operaio di quarant'anni. Bisogna dire che non fabbricano carrozze qualsiasi, ma legni per compratori raffinati che pretendono decorazioni di garbo. Ho visto all'opera intagliatori più bravi di certi scultori. Chi ci ha parlato del ragazzo scomparso è appunto l'intagliatore... » « Che interesse ha di mettere in cattiva luce Verdi? » «A sentir lui le ragioni sono tante. Deve sapere che la moglie di Verdi, la Strepponi, è stata in giovinezza una cantante. Rimasta orfana di padre si è sperduta in un mondo dove gli amori sono facili e facili gli abbandoni. Non voglio ripetere la storia dei cantanti e degli impresari che le si accostarono: fatto è che da lunghi o fugaci incontri nascono due figli, forse tre. Verdi è geloso, e non sopporta che la Strepponi continui a girare da un teatro all'altro contornata da uomini. Le fa scenate non solo perché si infastidisce per le voci che arrivano da Firenze o da Trieste dove recita; non accetta di legarsi ad una donna dal passato confuso. Le domanda di cancellare il passato. Pone come condizione alle nozze di "sciogliersi dagli impegni incontrati da nubile perché la Chiesa e la legge danno questo diritto sopra la moglie..." Insomma, rinunciare ai figli. Uno muore presto; l'altro, Camillo, il p,rimogenito, viene lasciato a Firenze, città dove Moriani, forse il padre, si è ritirato. Ormai non canta più. Camillo non va a vivere col genitore che ha famiglia regolare, ma in casa di una nutrice di nome Zanobini. Abbiamo controllato: conferma la storia anche se non può garantire che il falegname di San Pietro sia il bambino da lei cresciuto per incarico della Strepponi. Quando Camillo diventa grande, si provvede alla sua educazione artistica — pare sia un desiderio della signora Verdi — mandandolo nello studio dello scultore Lorenzo Bartolini. Purtroppo Bartolini se ne va presto, e Camillo, dopo aver bussato inutilmente alla porta di Moriani, decide di chiedere aiuto alla madre. Le scrive lettere pretendendo denaro; lettere che addolorano la signora Verdi. Quando esce di collegio, sparisce. Ogni tanto rispunta per battere cassa con la nutrice. Non restituisce niente, ma i vaglia della Strepponi che arrivano a Firenze compensano la Zanobini. Ed eccolo attorno a Sant'Agata con questa storia... » « Uno strano falegname. Vuole soldi? » « Anche... Un po' gliene abbiamo dati, ne avrà ancora se le informazioni sono giuste. Non è il denaro, credo, la sola ambizione. Confusamente intende punire la madre e Verdi che lo hanno rifiutato... » « Potrebbe andare a parlare con loro... » «Ha provato ma senza riuscire a farsi ricevere. Una sua lettera è stata passata a Carrara. Lo hanno minacciato di denuncia per ricatto. » L'agronomo annota sul diario che, pur prevedendo i rischi di una ricerca non ufficiale da parte di un poliziotto inquadrato nelle regole dello stato, ha accettato ugualmente di sapere di più. ... Mi parve un modo per uscire dalla noia delle abitudini milanesi e ritrovare la trepidazione della giovinezza; se fu una scelta sbadata dipese, soprattutto in quel momento, da Johanna Forni. Mi sorprendevo sovente a pensare a lei... Andai in carrozza fino a Busseto e spedii un telegramma a Milano. «Chiedo permesso di fermarmi qualche giorno. Mi si presenta una strana traccia. » Aggiunsi l'indirizzo dell'albergo Sole, dove prenotai una camera domandando di conservarmi ogni messaggio; non volevo mi si sapesse ospite nel palazzo Soragna. Pur disponendo di poche notizie mi parve prematuro attribuire alla sola fantasia di un ricatto l'improbabilità di un legame tra Verdi e la scomparsa del ragazzo. È vero che i protagonisti illustri, sovente sono oggetto di infamie senza radici, ma — pensavo — come mai il notaio non ha denunciato ai gendarmi il falegname arrogante? Forse è davvero figlio della signora Verdi... Allora la storia non è così banale... ... la prima persona che mi venne consigliata di ascoltare fu un inserviente di Sant'Agata, forse l'infedele che aveva raccolto la lettera della signora Verdi per il colonnello Da-vico. Lo incontrai all'osteria di Ongina fra scariolanti che mangiavano trippa. Arrivò in ritardo: «Ho avuto un contrattempo... » si giustificò, e restai sorpreso per il suono della voce calma e nobilmente sonora. La prima domanda di questa inchiesta ebbe un contenuto insolito per un poliziotto che si finge agronomo. « Lei canta?» « Qualche volta, al maestro piace. » «Si trova bene a Sant'Agata? » Nel momento stesso in cui gli rivolsi la domanda, un rossore delicato si diffuse per il volto, quasi fosse una ragazza colta di sorpresa nella stanza da bagno. Del resto la sua pelle non era di contadino. Non bruciata, non tormentata dalle ferite del gelo. Nella casa sbrigava incombenze lievi e solo raramente si scottava al sole. « Dovrei dire bene, perché i tempi sono magri, ma non basta bere e mangiare: c'è dell'altro... » « Mangiare e bere sono abitudini insolite in questa campagna... » Ma il servitore di Sant'Agata sembrò non ascoltarmi. «Da un po' di tempo la casa è diventata un ospizio per matti. Il maestro non rivolge la parola a nessuno; la signora ha perso l'aria felice che ce l'aveva fatta amare. Discutono con voce rabbiosa senza curarsi della nostra presenza. "Tu difendi questi sfaticati, voglio mandarli via..." Lei lo rabbonisce, ma diventa ogni giorno più difficile rabbonirlo... Bastano una finestra aperta o un cavallo che sfiora il giardino per un sentiero vicino ai fiori, e il maestro comincia ad inveire contro di noi. Ha un'idea fissa: spendiamo troppo e rubiamo di continuo. Un altro chiodo: non gli portiamo rispetto così alcuni sbagliano per la paura di figurare male e sbagliando scatenano la sua rabbia. "Non mi prendete in giro con le sdolcinature..." Non si fida del cocchiere. Trova incapace la cuoca. Ha una tale paura dei ladri da inventare porte che si chiudono con aghi di ferro spinti dentro il muro. Da Parigi, una volta ha ordinato a Marenghi, l'uomo di fiducia, di chiudere a chiave il giardino: nessuno avrebbe potuto uscire fino al suo ritorno, meno il cocchiere per tenere in forma i cavalli anche se proprio del cocchiere ha stima meno di tutti e non manca di ricordarlo in pubblico. Marenghi ci radunò per leggere la lettera. Per le settimane che mancavano al ritorno del padrone nessuno avrebbe potuto lasciare la casa: come in prigione. "Se qualcuno sortisse egli deve stare fuori per sempre... Badate non scherzo, intendo essere padrone in casa mia" e padrone lo è davvero. Maltratta ogni giorno Corticelli, l'amministratore nuovo, lavorava in teatro con la signora Strepponi. "Non lasciare che vi siano altri padroni e non fidarti di nessuno..." Lo sgrida davanti a noi che saremmo le persone sospette... » «Perché non se ne va? » «Dove? La paga è buona. Il lavoro sicuro. D'inverno, quando per gli altri è la fame, dentro Sant'Agata non cambia niente. E poi ogni padrone vale l'altro. Non è il paradiso che immaginano i braccianti nelle stalle, ma un inferno sopportabile perché l'inferno fuori è ancora peggio. » « Ha copiato lei la lettera? » «Non capisco... So appena leggere: ho imparato a Sant'Agata... » « Quando ha visto l'ultima volta il ragazzo? » «Tre anni fa, d'estate. Parlava con Filomena... la signora Maria Carrara. Il maestro si affacciò in giardino dallo studio e li scorse lontani, dietro le piante. Chiamò e la signorina venne accaldata per il viale; si trovava al confine del giardino, proprio vicino al cancello che apre sui campi. Poi il signor Verdi domandò di sua moglie e si chiuse con loro nel salotto. Due giorni dopo partivano per Tabiano. Non avevano l'aria di andare in un bel posto quando salirono in carrozza. Erano silenziose; Filomena pallida. » « Il ragazzo non si è più visto? » «Mai più. » « Cosa dice la gente?» «Che era innamorato, ma l'amore di un contadino per la figlia di un signore ha un prezzo. Devono averlo riempito di soldi e spedito via. Forse nelle Svizzere, forse in America. » «E se fosse morto?» Vi fu un silenzio, poi il servitore rise come per uno scherzo: « Perché dovrebbe esserlo? Un ragazzo robusto non si ammala per un viaggio... » « Durante il viaggio potrebbe essergli capitato qualcosa. Di annegare traversando il fiume... » Il sole aveva girato e dentro alla stanza c'era troppa luce in faccia al servitore. Si coprì gli occhi con una mano — pensai — per nascondere l'emozione che il sospetto aveva agitato. Quando si riprese disse quasi sottovoce: «Se è annegato qualcuno lo sa. Venga ». Andammo verso il Po dentro i boschi dei pioppi. Un sentiero accompagna l'Ongina al fiume, ma sulla destra, dentro la golena, prima che la strada finisca, vi sono tre capanni di legno piantati su palafitte per quando il Po si allarga. Una vecchia sedeva appoggiata alla scala con una rete da pesca sulle ginocchia, e lo spago nelle mani. Ci guardava. « Ghé al suplén? » chiese l'uomo di casa Verdi, e non aspettò la risposta perché il becchino era comparso dentro la porta. «Un signore di Soragna vuole sapere una cosa»: il mio accompagnatore continuava a chiedere in dialetto, ma il suplén rispose in una lingua per me piena di ricordi: la parlata dei caporali ungheresi di Parma. Si chiamava Suizzler, veniva da Pest, e quando l'esercito si era sciolto anziché tornare era rimasto a fare il guardacacdia per una confraternita religiosa. Poi il latifondo era stato disperso nelle aste dello Stato e Suizzler viveva pescando i morti nel Po. La corrente trascina su questa sponda i corpi degli annegati per i traghetti che si rovesciano, ma altri corpi arrivano segnati da ferite o, cuciti dentro gli abiti, hanno i messaggi della disperazione di chi esce dal mondo con un salto nell'acqua. Suizzler stende le reti dove la corrente si spande senza forza; quasi mai le riprende vuote. Il municipio gli paga tre lire per ogni morto che porta al cimitero. Nessuno domanda se le tasche del morto sono vuote. «Un ragazzo? » Suizzler sta pensando. «Posso controllare. Ha detto tre anni fa? » Nel registro non vi sono nomi, ma la scrittura aguzza spiega le difficoltà del recupero, se l'annegato è un uomo o una donna e, forse nel geroglifico di un dialetto ad altri incomprensibile, rivela quale tesoro portava addosso. «Tre anni fa, d'estate? Pochi morti, il fiume era in secca. Si fermavano più su... » Continua a guardare. «Non trovo nessun ragazzo... » Alza la faccia appiattita color mattone, il naso schiacciato tra due occhi tranquilli. Il mento gli trema come succede a chi vive dentro l'acqua e quando torna a riva si scalda nel vino. Fa una domanda intelligente: «Lei è troppo indifferente per appartenere alla famiglia del ragazzo. Mi spieghi perché nessuno di loro, in questi anni, è venuto a chiedere notizie? » Una striscia di luce filtra da una fessura dell'imposta. Il legno comincia a marcire quando entro nella cucina degli Scaramuzza. Solo donne. C'è un bambino con le gambe nude, sporco di fango. «Arrivo da Busseto. Ho bisogno di sapere dove posso trovare Lino... » mi rivolgo alla vecchia che ha l'aria della padrona. La domanda ferma i gesti delle ragazze sparse in cucina. Riprendono il lavoro con lentezza per non distrarre, nei rumori, l'attenzione che incuriosisce il colloquio. «Non lo sappiamo. È andato via senza dire niente. Una sera non è tornato, e basta... » «L'avete cercato? » «Dove... » « Qualcuno ha parlato con i carabinieri? » «I carabinieri non danno retta a gente come noi. » «Allora col proprietario del podere, il maestro Verdi. » Nella stanza ogni fruscio si ferma. «Tornerà da solo, se ha voglia di tornare. » Dovevo fare la domanda più difficile. « Crede sia vivo? » Era la madre, ed anche se altri figli lavoravano nei campi, mi aspettavo si sgelasse in una commozione normale. Invece non cambia faccia: «Non so niente, neanche se è vivo ». «Il maestro Verdi ha rinnovato l'affitto? Per quanti anni? » «Deve parlare con mio marito. Lui tratta gli affari:.. » Nella caserma di Busseto il maresciallo cerca di ricordare una storia lontana. Gli pare di aver sentito di un ragazzo scomparso, ma nessuno ha denunciato l'avvenimento, e poi — fa capire — con la rivolta, gli arresti e le nuove paure, cos'è un ragazzo che sparisce di casa? La mattina dopo passo dall'albergo per cercare la risposta al messaggio telegrafico mandato a Milano: trovo un biglietto dei carabinieri che vorrebbero parlarmi, ma non ho tempo perché un impegno mi aspetta. Imprevisto e straordinario. Non riconosco l'ombra che avanza nel buio dell'osteria, poi la faccia mattone e il naso schiacciato entrano nella luce della porta; Suizzler, il becchino del Po. «Nel suo quaderno ha pescato il ragazzo?» « Sono troppo ordinato; nel quaderno vi sono gli stessi nomi di ieri. Ma vorrei farla parlare con la gente che passa il fiume, gente che si ferma nelle osterie e poi viene a bere il mio vino. Ascoltano tante cose. Lei dice che il ragazzo manca da tre anni? Ebbene, lo hanno visto a Sant'Agata poco tempo fa... » L'emozione accelera la domanda che si spegne in modo ridicolo nella serenità di Suizzler. «Chi l'ha visto... » «... per l'amico che me ne ha parlato la storia è senza misteri. Se vuole incontrarlo venga con me. Fa l'aiuto giardiniere. » Mi giro verso la pistoiese, ma Suizzler posa la mano sul braccio. «Lasci perdere, sono due salti. Una carrozza non passa inosservata. Sarebbero in tanti a voler sapere cosa può chiedere a un giardiniere. E si fanno chiacchiere... » Ci aspetta dall'altra parte del paese, ancora un'osteria. Cinque uomini attorno al tavolo: indossano un camicione di tela aperto sul collo, hanno la pelle abbronzata con screpolature appena visibili e i capelli sudati incollati alla fronte, pallida per l'ala del cappello. Uno di loro saluta Suizzler e viene a sedersi con noi. « Lei è il signore di Soragna che cerca Lino? » Faccio segno: sono io. « L'ho incontrato prima della mietitura, in giugno, mi pare...» «Da solo?» «A Sant'Agata gli hanno parlato in tanti, anche la signora Maria. » « La signora non abita al Paradiso, in casa Carrara? » « Di solito vive al Paradiso, però in quei giorni era tornata con Verdi. Sa come sono le donne incinte! Litigava col marito... » «Quanto tempo si sono fermati?» «Il ragazzo o la signora...?» Il giardiniere non capisce. «... a dire il vero, Lino dormiva a Roncole dai suoi, ma veniva a trovarci ogni giorno forse per una settimana, forse di più. La signora... non so, anche lei una settimana, ma lo dico senza fare i conti perché come si può fare i conti dove vanno i padroni? » « Ha raccontato in quale luogo si nasconde? » « Non aveva l'aria di essersi nascosto. Abita sull'altra riva del Po in un paese che si chiama Ognissanti, nella casa di un signore che ha un bel nome: Soldi... Quando i ragazzi tornano da lontano si montano la testa. Mi ha spiegato di un pranzo per un onorevole venuto da Cremona con quattordici carrozze. Lino ha giurato di avere governato cucina e servitù. Quasi un fattore, ma come può essere fattore se ancora non gli è spuntata la barba? Eppure qualcosa di vero c'era nella storia. Aveva vestiti nuovi, perfino le scarpe. Guadagna bene... » «Poi è sparito... » « Sarà tornato dall'altra parte. Forse per una ragazza, ma una ragazza diversa dalle contadine perché faceva domande strane. Mi ha chiesto se è possibile che verso Pieve uno come noi abbia sposato addirittura la padrona. Gli piacevano questi racconti... » «Le è parso contento? » «Contento no. Malgrado i soldi doveva avere un dispiacere. Dispiacere di cuore... » «Non ha salutato nessuno prima di andare via? » Entra un cliente diverso come sono diverso anch'io- fra i tavoli sporchi. Ha la barba curiosamente larga e grigia, un cappello scuro. Sembra ebreo. L'aiuto giardiniere abbassa la voce e guarda l'avventore. Suizzler l'aveva detto: il paese è piccolo, la curiosità pericolosa. «Non ha salutato nessuno... » Quando ritorno a Roncole, dagli Scaramuzza, le donne stanno legando la paglia sotto i portici; gli uomini sono ancora nei campi. «Lei è sfortunato; mio marito non c'è... » Alto, solenne, lento, attraverso l'aia senza che i miei occhi si accorgano del pulviscolo umano che traffica attorno. Fingo di arrabbiarmi per avere ancora una volta sbagliato. Chiedo alla vecchia: « Mi piacerebbe aspettarlo ». «Tornano tardi. Tirano su l'erba perché domani piove... » guarda le nuvole che si accumulano nel tramonto. «Ho saputo che Lino si è fatto vivo pochi mesi fa... » Questo è il momento, mi dico; un segno deve pur uscire dalle rughe della faccia: magari protesta, forse piange. Invece si limita a stupirsi senza cambiare voce, sempre guardandomi negli occhi. «Devono avere fatto male i conti con i mesi. Non lo vediamo da tre anni... » « Mi hanno spiegato che è diventato ricco in una casa di signori, di là dal Po... » « Allora vada da quei signori a cercarlo e gli dica di farsi vedere, magari con i soldi. » Aveva parlato continuando ad asciugarsi le mani nel grembiule che le pendeva davanti. Mentre si gira per tornare fra la paglia mi accorgo che le mani sono secche e nel grembiule non è rimasto nessun segno di sudore. Solo imbarazzo. Per far capire da che parte viene l'informazione e provocare almeno un allarme, chiedo di indicarmi la casa di un parente del servitore che mi ha accompagnato da Suizzler, sul Po. «Fagli vedere », ordina ad un bambino senza voltarsi e senza salutare. Nella strada c'è un'altra carrozza che mi dà il passo lasciandomi uscire per primo dal cortile: dentro, un signore con la barba grigia. Il parente è una donna pallida, invecchiata troppo presto. Si capisce perché guardando i figli che le corrono attorno. Sette bambini: ne manca uno, già nei campi. Nella stanza c'è odore di sudore, una vecchia fa il segno della croce e comincia a recitare il rosario vicino al camino; altre donne che lavorano la seta rispondono continuando a filare. Vedo facce innocenti e facce piene di sonno. Sul pavimento i segni del fango: la pioggia del giorno prima. Fuori qualcuno butta giù il fieno mentre dalla stalla escono i secchi del latte e le bestie si lamentano perché aspettano l'erba. « Vengo per il ragazzo degli Scaramuzza, mi hanno detto che sa dov'è... » « L'ho visto prima dell'estate. Una sera è passato a trovare mio marito che adesso fa la stagione a Diolo. Sembrava avere paura, non perché spaventato da qualcuno; per l'insicurezza, diceva, che stava ricominciando dopo la vita beata: "Non dovevo tornare, ho sbagliato. Sono nei pasticci..." "Corri dai tuoi signori di Cremona", lo abbiamo consigliato. Ma ha risposto che proprio da loro non poteva farsi vivo: un peccato perché stava bene... "Allora vai a casa?" gli ha chiesto mio marito. "È da casa che vengo; per far contenti i miei devo sparire." Ma non si spiegava e non voleva dire di più. La notte l'ha passata nel fienile. È partito che era buio, voleva passare da Sant'Agata. » «L'ha visto ancora? » «Non sappiamo niente. Lino è un tipo che sparisce e ritorna. Non ce ne preoccupiamo... » Cerco di raccogliere l'ultimo filo che sta scappando. «Ne ha parlato con la madre? La vecchia, quella là... » allargo la mano verso la casa da dove sono arrivato. «Una volta, ma ha cambiato discorso come se non fosse suo figlio, forse per il dispiacere di averlo chissà dove. Pensa che tornerà? » Troppe domande hanno scosso l'indifferenza. «Magari torna... » Dallo scrittoio di casa Verdi Dei turbamenti di Maria si era preoccupato anche il Maestro. Nel suo scrittoio sono rimaste due lettere spedite a Piroli, il grande amico. Nella prima annuncia: «Maria è rimasta una ventina di giorni senza marito!!! Cioè: veniva tutti i giorni, e molte volte si fermava qui col pretesto del maltempo! Maria però sta abbastanza bene e si crede che sarà madre verso la fine di luglio o ai primi di agosto... » Nella seconda, del 18 giugno, corregge la cattiva impressione: «Vi ringrazio e rettifico sulla Maria. Mi sono spiegato male. Essa si trova benissimo nella famiglia Carrara. Dissi che la gravidanza era un po' difficile e non si trovava sempre bene. Almeno così volevo dire... E voi, mi dite ancora quando venite qui? Saluti per tutti, addio ». Dal diario dell'agronomo È tardi per arrivare a Soragna. Mi fermo a Busseto, e sulla strada che scende da Roncole faccio i conti della giornata. Il ragazzo è vivo, sta bene, ma si nasconde e a nessuno spiega il perché. Torna disobbedendo alla volontà di tutti e cominciano i guai. Per quale ragione la madre non ammette di averlo visto? Lo nega per proteggerlo o per paura di minacce? Dunque, non è una chiacchiera: il falegname ha detto la verità, almeno quella parte di verità arrivata fino a lui. Domani parlo a Davico, ormai è necessaria una visita a Sant'Agata. Mi lasceranno andare? La donna dei sette figli ha aperto un'altra traccia. «...Lino voleva nascondersi per qualche tempo a San Pietro in Cerro, nella corte dei Barattieri.» Proprio la corte da dove è uscita la voce della scomparsa... Mi sveglio con l'acqua che batte la grondaia: comincia la lunga pioggia sulla pianura. Sembra un brutto giorno, eppure è un bel giorno. La delusione per una donna non adatta alle miserie di un poliziotto rimane come una piaga leggera; anche la guarigione rapida fa parte del carattere aperto alle novità che bruciano il passato. Non si immagina cos'è il piacere di una certezza raggiunta; inseguire un dubbio fino a trovare la chiave che apre il cassetto giusto in una stanza piena di cassetti e scoprirvi che le ipotesi fantasticate esistono davvero. Sotto, nell'osteria, c'è un po' di gente. Il padrone, in piedi da quando faceva buio per servire gli uomini che accendono le lanterne dietro i carri, dorme su una poltrona di vimini. Un'inserviente pulisce il banco con uno straccio. Nell'aria è rimasto l'odore di sigaro e di sonno, di vino mescolato all'orzo caldo. Durerà fino a primavera. « Stanotte sono rientrato tardi. Non ho chiesto se qualcuno ha lasciato un messaggio per me. » La donna scuote il padrone che apre gli occhi smemorati, quasi un nano, pallido e miope. « Qualcuno ha cercato il signore? » Il nano alza lo sguardo velato; il respiro è ancora breve. « Un momento... » Va dietro il banco spingendo da parte la ragazza che ha ripreso la pulizia. La sua bocca cerca un sorriso per sembrare cortese. « Un biglietto... » Apro la busta accanto ai vetri guardando le braccia dei carri lasciati sotto l'acqua con le stanghe per aria. « Devo parlarle, è importante. Si trovi stamattina al palazzo. » Nessuna firma. « Quando lo hanno portato? » Il padrone sta per riaddormentarsi. Spalanca gli occhi con rassegnazione. « Presto; viene da Soragna. » Due ore dopo arrivo davanti al portone. C'è un'altra carrozza a lato del ponte, ma non è alle carrozze che sto pensando. Sono orgoglioso per il racconto che farò al colonnello. Devo soltanto non lasciarmi trascinare dall'entusiasmo e tenere calma la voce per far intendere fino in fondo il valore della scoperta e i dubbi che restano da affrontare. Il guardiano fa strada attraverso il cortile, poi nella sala lunga di Venere e Adone; mi apre senza deferenza dovuta all'ospite conosciuto. Ha fretta. Sul divano, dirimpetto ad una fila di vasi del Giappone raccolti su un legno dorato, ritrovo chi non aspettavo in questo luogo: il signore dalla barba incolta. Lo sguardo distante come due giorni prima all'osteria e nel cortile degli Scaramuzza. C'è un'altra novità: non è il colonnello che mi ha mandato a chiamare, ma Diofebo Soragna, capo della famiglia. Un grande vecchio dalla barba rabbiosa, sempre controcorrente senza mai piegarsi ai tempi e alle idee nuove. I capelli quasi bianchi ricadono sulla destra del viso; baffi lunghi, la barba molto corta. La persona tradisce il vigore che le imprese della sua vita lasciano immaginare. Non mi domanda il nome. Fa solo un gesto, ma è il gesto di chi dà ordini ad un servitore. « Si sieda. » Del resto sono gli stessi modi usati con i sovrani quando non accettavano le sue idee. Con Carlo III, il mio duca assassinato, non si era trovato d'accordo. Gli mandò una lettera dopo appena tre mesi dalla nomina ad Aiutante Generale. La corte era divisa: i Pallavicino sostenevano il partito della duchessa Luisa Maria bigotta e avara nelle spese, mentre i militari e gli amanti della vita allegra avevano scelto la parte del sovrano. Combattendo il frazionismo, Diofebo si era inimicato i due schieramenti. Lo odiavano e sparlavano di lui. «Com'è possibile governare uno stato quando la stessa famiglia si divide in partiti accaniti? » Per Diofebo, che nutriva la curiosità intellettuale sfogliando le pagine degli scrittori reazionari (« furono il pascolo gratuito dell'operosità della mia mente »), l'idea che il potere disceso da Dio si frantumasse in miserie cortigiane lo indignò al punto di fargli scrivere le dimissioni, un documento sul quale avevo meditato quando mettevo ordine negli archivi del palazzo di Parma. Era l'otto marzo 1851. «Altezza Reale, alla vostra bandiera afflitto da tradimento e da ingiusta fortuna, io mi ordinai di obbedirvi per amore e per dovere, perché vi amo, o Signore, prima ancora di conoscervi real discendente di quelli avi alla cui venerazione e riconoscenza fui dai miei cresciuto; vi amo perché voi eravate il legittimo possessore di questa sovranità secondo diritti ai quali devesi fedeltà e operosità... » Una fedeltà al Borbone, faceva capire Diofebo, che negli anni asburgici di Maria Luigia o durante i primi sussulti liberali, sembrava «fatalmente follia ». Ma egli non aveva cambiato bandiera augurandosi la restaurazione, e quando i Borboni eran finalmente tornati e la corte si era ricomposta, quale spettacolo indecoroso avevano offerto gli eredi dei sovrani desiderati! «... A queste impure fonti ora è ridotta, contro sua natura, la posizione che ho l'onore di occupare presso vostra Altezza Reale, mentre significatissimi fatti troppo dicono il vostro cuore alieno da me. Abituato a non indietreggiarmi dal sacrificio ove necessita, trovo così la forza di deporre ai piedi di Vostra Altezza le mie dimissioni... » Più tardi Carlo III viene ucciso e Diofebo diventa presidente del Consiglio di Guerra: pretende di riaprire l'inchiesta sul delitto rimettendo in discussione una sentenza che gli sembra imprecisa e frettolosa. Sospetta un intrigo diverso dentro la corte ma Luisa Maria non gradisce che Diofebo cerchi ancora e lo invita a lasciar perdere. Vuole seppellire la memoria del marito, e quando il principe insiste per andare avanti, gli fa capire di non aver bisogno di lui. Per la seconda volta se ne va, e per la seconda volta si dimette « quale gesto di amore per la giustizia e per il mio duca ». Il suo duca è Roberto, l'esule ancora bambino. Mi siedo. Il principe indica l'ospite dalla barba che come un'ombra aveva attraversato ogni mia curiosità. «Il signor Marco Levi, benefattore di Soragna, è venuto a riferirmi una storia nella quale non avrei voluto nemmeno mischiarmi con le parole, ma che pur da lontano, purtroppo, mi tocca. Mi coinvolge, avendo lei trascorso qualche giorno in questo palazzo, quindi lasciando l'impressione di essere guidato nelle sue ricerche dalla nostra volontà... » Riesce a dare al colloquio l'apparenza della virtù offesa e della rassegnata costrizione alla pena per un imbroglio non pensato. Si rivolge a Levi: « Ecco perché ho voluto parlare di fronte a un galantuomo le cui proprietà confinano con le nostre. Non capisco quale disegno insegua, e non intendo come sia possibile mescolare il nome di un artista amato a sospetti ingiuriosi. Pretendo che il sospetto venga cancellato dalla mia casa. Trovo sgradevole che lei abbia approfittato del decoro che questa ospitalità ha procurato alla sua persona, per scavare nella vita di una persona illustre. La prego di lasciare non solo il palazzo, anche codesto paese... » Un ordine, ma un ordine affrettato che non esprime solo indignazione, anche se l'indignazione del principe mi sembra autentica. Lo hanno tenuto all'oscuro del progetto per l'età avanzata, sicuramente perché la sua dirittura sarebbe stata di ostacolo al ricatto. E quando Levi corre a raccontargli quale tipo di domande pongo ai contadini, Diofebo si agita per due sentimenti: l'impaccio per il dover subire un gioco che non gli appartiene come abitudine, e il timore di finire nell'intrigo. Mi viene in mente che nel cortile non ho incontrato altre carrozze. Guido, fratello del principe, mio colonnello nelle Brigate Estensi, si trova da due giorni nelle proprietà di Cremona; Zileri e Davico in città, Gigli Cervi lontano nell'avventura con Johanna. Come ha potuto Levi intuire il percorso delle mie domande? Dovevo capire che la famiglia del ragazzo non avrebbe taciuto. Levi passava a controllare un tetto in pericolo perché gli accordi con Verdi prevedevano certe ispezioni. Trova le donne spaventate, gli spiegano... Ascolto il principe in silenzio, ma anche il mio silenzio, alla fine, deve intimorirlo; ne coglie l'ironia, capisce la ribellione. «Avanti, dica qualcosa, avrà pure di come giustificarsi! » «La mia spiegazione sarebbe lunga... » Negli occhi del principe vedo la paura. Sono un poliziotto, e i poliziotti quanti giochi possono fingere per raggiungere il loro scopo? Ma la rabbia per la cattiva commedia che stiamo recitando non fa velo alla lucidità. Denunciare il complotto? Quale complotto! La storia di un ricatto immaginario usciva dall'utopia dei poveri congiurati di Soragna; solo nelle loro speranze certi ritorni sono possibili. Indovino il sorriso del superiore intento a valutare l'allarme: la sovversione che esce da un palazzo per conquistare le campagne può sembrare vera a teatro, ma non resiste all'analisi di una intelligenza normale. Nel mio rapporto avrei spiegato che nessun pericolo può venire dalla nostalgia. I problemi sono altrove. Intanto il gioco che sta per finire brucia per sempre ogni dovere verso il mondo nel quale sono cresciuto. Diofebo Soragna non conosce i miei pensieri e resta nel dubbio: se avessi parlato? «... Mi sembra inutile ogni spiegazione. Ringrazio per l'ospitalità e per il cavallo. Qualcuno dovrebbe accompagnarmi a Borgo San Donnino... » Controllo l'orologio. «Alla una passa il treno per Milano. » Ormai non chiedo; pretendo. Non mi scuso di niente, non saluto nessuno. Esco dalla stanza solo con un piccolo segno della testa verso il principe. Gli occhi di Levi girano nel soffitto incantati sulle guance rosa di Giampaolo Meli Lupi, signore del Sacro Romano Impero e grande di Spagna, appeso con la sua parrucca sopra la porta che sto per varcare. Di Levi conosco appena la faccia, non ho mai sentito la voce. Anche per un ricco ebreo di campagna deve essere imbarazzante recitare la parte di chi spegne una cospirazione. Mi informarono, tempo dopo, che l'avermi smascherato rafforzò il suo commercio con Verdi. Ottenne altri compiti e fece buoni affari; in un certo modo diventarono amici, la strana amicizia tra un uomo dolce e un genio brusco con chi lo circonda, forse un po' meno verso coloro che prendono l'abitudine di mandargli fegati d'oca. Levi, appunto. Il cocchiere e un servo di casa devono avere ricevuto l'ordine di vedermi montare sul treno. «Via... andate. » Sono furibondo. La loro presenza in stazione rinnova la rabbia. Non se ne vanno, sembrano gentili, ma la consegna è militare. Vegliano sulla valigia. « Possiamo renderci utili? » chiedono per sciogliere l'imbara77o. Non avevo immaginato che la mia cacciata diventasse un fatto vitale da impegnare due guardiani robusti. Il treno si annuncia. «Mi segua... » ordina il cocchiere sollevando il bagaglio e traversando il marciapiede prima degli altri. Ed io obbedisco, per l'ultima volta obbedisco. L'ultima perché quando mi ritrovo seduto sul divano rosso dello scompartimento, l'assurdo capitolo si chiude per sempre. Riguadagno la mia personalità, torno ad essere un delegato della polizia, la polizia del regno, non quella sepolta del ducato che per nove sciagurati giorni i cospiratori di Soragna avevano tentato di riesumare. Adesso sono io che chiedo, io che comando; un inquisitore che pretende risposte e non deve giustificazioni. Guardo dal finestrino, arrivano altri viaggiatori. Il capo della stazione si volta: aspetta prima di far segno al macchinista. Avanza una signora grassa, vestita di scuro; più indietro, suo marito. Non l'ho mai veduto eppure lo riconosco quando traversa il binario: Verdi... In quel 22 novembre tornano assieme a Milano, lo stesso treno, due vagoni lontani. L'agronomo non sa che il maestro appena seduto tira fuori dalla borsa un fascio di carte e passa il viaggio leggendo il copione che Boito gli aveva spedito attraverso Ricordi. Boito lo ha scritto durante un mal di denti che gli impedisce di dormire per settimane. Verdi non ce l'ha fatta a sfogliarlo a Sant'Agata per la visita di due ospiti francesi che volevano l'Aida per l'Opéra. A Milano, qualche giorno dopo, spiegherà a Ricordi che forse gli piace. « La chiamiamo Il moro di Venezia oppure Otello?» Anche l'agronomo ha qualcosa da fare appena il treno si muove. Deve mantenere la promessa lasciata intendere col telegramma spedito da Busseto all'ufficio di piazza San Fedele: «... ho una curiosa traccia da seguire... » Per farsi perdonare i giorni del mistero intende arrivare col rapporto pronto. « Elenco degli individui appartenenti al partito borbonico-clericale sorvegliati durante un'adunanza tenuta nel palazzo di Soragna... » Racconta di Davico e di Buttafuoco; spiega come possa considerarsi di « nessun pericolo » il conte Zileri dal Verme. Fa sapere che Dall'Asta ha ricevuto un telegramma da Cannes (« Il mio signore », avvertivano dalla Francia, « vi attende senza indugio per lunedì. Firmato commendator Fragola »). Ma Dall'Asta (lo scopre dopo) deve aver respirato l'aria malinconica della congiura fallita perché risponde con un messaggio intercettato: « Chiedo in questa occasione di essere sollevato dall'obbedienza godendo cattiva salute ». Lo stesso avviso era arrivato al rivoltoso più ridicolo, l'inutile Gigli Cervi, subito accorso contento del privilegio. «... È probabile », scrive l'agronomo nel rapporto « si sia recato a Cannes in compagnia della signora Johanna Forni, suddita imperiale, imparentata con l'antico ministro del ducato estense... » Malgrado l'abitudine di seppellire senza rimpianti le illusioni negate, quando scrive il nome di «Johanna », la mano un po' trema... Ma trova ancora la risposta: «Deve essere lo scrollare della ferrovia... » Lunedì, 26 settembre 1898 Lo sveglia il caldo. Fuori piove, comincia la nebbia nei campi. L'abitudine di leggere stando a letto gli fa raccogliere la « Gazzetta » del giorno prima lasciata cadere sul pavimento al momento di spegnere la candela. « ... sarebbe morto l'imperatore di Cina, mancano conferme, le poste di Pechino sono chiuse... » Molossi, il direttore, affronta la grande politica. «... la plebe dei rivoluzionari, le scarpe grosse che si sono lasciate pigliare sulle barricate, la folla dei minchioni che scendono in piazza ad un cenno dei loro capi, non meritano nessuna considerazione. Il solito regime carcerario è giusto quello che ci vuole per essi... » Chissà se ha mai visto mangiare un famiglio da spesa?... Al Reinach Emma Gramatica è la ragazza timida di una commedia di Sardou: «... possiede le doti per diventare una brava attrice, non le resta che affinarle... » Da Chiasso escono gli operai espulsi dalla Svizzera per «comportamento tumultuoso» e appena attraversano il confine vengono arrestati. A Vienna c'è uno scambio di idee fra i gabinetti d'Europa per combattere l'anarchismo «... un'unica strategia renderebbe tutto facile... » Abituato ai giornali di Roma, un attimo e finisce; sono le ultime righe ad incuriosirlo. « Alcuni quotidiani tratti in inganno da poche teste calde avrebbero preteso che il reale vice-console italiano a Trieste, prendendo occasione dei disordini filo-italiani soffocati dalla locale gendarmeria, provocasse addirittura un conflitto fra Italia ed Austria. Di qui il loro annuncio: il ministro Canevaro, malcontento del suo funzionario, aveva deciso per punizione di trasferirlo in Brasile. Non è punto vero! Il ministro degli esteri non si è mai lamentato del marchese Guido di Soragna. Anzi, l'opposto... » Il Brasile; se lo sarebbe meritato! Cavaliere del Duca, colonnello estense, cospiratore borbonico, ed ecco rappresenta i Savoia sia pure nell'angolo dove gli amici di un tempo invecchiano in pace, Trieste. Ma il fastidio che prende Barbuti, nasce da altri pensieri. La sua generazione si è affacciata tardi nella lotta politica; il Risorgimento era quasi finito, restavano da combattere battaglie che sembravano di retroguardia purtroppo contro nemici che non si arrendono. L'ingiustizia dei Borboni avrebbe dovuto svanire nelle promesse dei padri della patria, ma sotto le bandiere, seduti nelle comode poltrone, era successo che i padri avevano dimenticato le vecchie parole. L'ingiustizia cresce, la fame continua. Non serve niente ricordare ai fondatori della nazione i loro giuramenti. «Vuoi dire che stiamo sbagliando?» Quante volte aveva colto il rimprovero nella domanda. «Tu dov'eri quando combattevamo il tiranno?» Adesso non combattono nessuno. Le regole economiche saldano con pazienza i dissapori delle polemiche. Gli antichi e i nuovi padroni sono finalmente d'accordo nel far tacere la protesta di chi ricorda l'impegno dei giorni di guerra. «Tu c'eri quando marciavamo a Solferino? » Non c'era, ed oggi, perduta l'ambizione, fa salti per sbarcare il lunario, mentre, ricco e vecchissimo, Soragna rappresenta l'Italia che mai voleva fosse nata. Dalle memorie dell'avvocato Barbuti aveva incontrato Guido Soragna nella campagna di Diolo, vent'anni prima. Il marchese arrivava in carrozza per parlare al fittavolo. Uno sciopero. Cento famiglie chiuse in un cortile non mangiano fino a quando la paga di quattordici ore di lavoro al giorno non raggiunge le due lire. Si salutano da lontano, toccandosi appena il cappello, nel rispetto degli incontri superficiali di città. Ma il viaggio di Barbuti questa volta ha una meta: a Zibello si inaugura un monumento e gli amici hanno avvisato «Il Presente ». «Andate a vedere, Musini dirà qualcosa... » Musini, il garibaldino. Nella sua casa Barbuti aveva trovato rifugio durante i guai sul macinato. Ormai fa il medico a Zibello. Ha cambiato guerra; il nemico è lo sfinimento dei corpi. Tre chilometri dalla sua casa, sotto l'argine di Polesine, il 35 per cento della popolazione soffre la pellagra. Non dipende dal mangiare solo polenta ma dalla farina marcia che guadagnano come paga; le ultime risaie allargano le febbri... «Una pena che può scoppiare nel furore triviale... », scrive il maresciallo di Zibello al sotto prefetto di Borgo San Donnino. Un tenente viene delegato a trattare con i fittavoli per convincerli a crescere di almeno venti centesimi la paga giornaliera « nell'interesse dell'ordine pubblico ». Barbuti e Musini si riabbracciano in casa di parenti durante una specie di festa. Bevono il vino schiumoso sotto gli affreschi di uno studiolo che mostra Piacenza con ancora i soldati del duca e la piazza di Zibello attraversata da una carrozza che un cavallo bianco e un cavallo nero trascinano verso il grande cappello di una signora. Barbuti fa sapere a Musini che i radicali quieti del « Presente » diffidano delle sue teorie. «Ma noi restiamo amici; tutti dalla stessa parte. Dimmi che è vero?» Si abbracciano senza altri pensieri. « Non è un monumento », scrive Barbuti nel taccuino «solo una lapide sul municipio in memoria di due eroi delle battaglie nazionali. » Quante bandiere! Da ogni parte della provincia accorre la gente semplice delle società operaie. Parlano un oratore di Cremona e il maestro di Polesine; poi tocca a Musini. Non sale sul palco. Con le mani in tasca, il cappello rialzato sulla fronte, avanza da sotto i portici. Un delegato della polizia di Borgo San Donnino tiene la penna ferma sul quaderno. La voce baritonale di Musini riecheggia nella piazza silenziosa. « Siamo qui per glorificare la memoria dei coraggiosi che hanno voluto morire per la patria, ma, lo chiedo a voi che state vivendo in questa patria: è forse la terra amorosa con i propri figli che noi, e loro, avevamo sognato? O non è, piuttosto, una matrigna crudele? La libertà che essi chiedevano era la libertà per tutti, non la libertà dei pochi per opprimere i molti. Pochi ora i fortunati, molti i derelitti. Pochi in alto, tutti in basso. Perché in basso...?» Sta gridando. « Perché siete in ginocchio? Alzatevi e sarete al paro di essi. Ricordatevi che fame e pellagra sono cresciute dopo il '59 quando le vostre condizioni erano sì misere, ma non come oggi... » Immensi applausi. La gente sbalordisce, non è abituata ad ascoltare questo tipo di discorsi. Gli oratori prediligono eleganze che i contadini non capiscono mentre Musini usa le loro parole senza vergognarsi di essere troppo chiaro. Esplode una festa che continuerà dentro la sera. Quando il dottore si siede nel teatrino per assistere ad una rappresentazione, la gente si alza intonando l'Inno a Garibaldi. Tra i presenti vi è il delegato di una società operaia di Pieve d'Olmi, nella sponda cremonese. Invita Musini a tenere un discorso nel suo paese... Barbuti ricorda bene il secondo discorso anche per un viaggio avventuroso: rischiano il naufragio nel Po. Una festa tre volte più grande con reporter venuti da Cremona e da Milano. « Musini usa le parole come fucili e gli avversari ne rimangono incantati. Per controbattere allusioni che ritengono antipatriottiche (« si stava meglio con i vecchi sovrani; il nuovo, purtroppo, è peggiore... ») ricorrono allo scandalo di un garibaldino che ha voltato bandiera. Più di ogni altro si indigna la « Gazzetta ». «Il conferenziere di Pieve d'Olmi, colui che con insulto atroce alla verità della storia non si perita di dire che si stava meglio vent'anni prima (cioè con i tedeschi), colui che tanto fatalmente ha contribuito col suo discorso allo stato di agitazione e di fermento in cui si trovano alcuni comuni della provincia, continua nel suo apostolato fatale con una perseveranza degna di migliore causa... » Cominciano le insinuazioni. « Musini è ricco... Predica bene ma i suoi contadini sono pezzenti... Musini si è macchiato d'infamia in America, altrimenti come spiegare il denaro che gli riempie le tasche al ritorno?... » Si mette in guardia il prefetto. « Sappiamo di un ufficiale sanitario di Zibello che va percorrendo le campagne e promuovendo riunioni... Il triste seme che viene gettato tanto abbondantemente, già comincia a germogliare. In quelle località avvengono tentativi di sciopero; i braccianti vogliono lavoro dai proprietari; comitive girano per le aie chiedendo farina nelle case dei signori, i quali, per la maggior parte, non si attentano di rifiutarla... » Barbuti ordina gli appunti per la Monografia da consegnare al senatore Jacini. «È la fame, ma così disperata da far tremare chi attraversa queste terre... È una fame che fa spettacolo... » Viaggiatori stranieri accorrono per raccontarla. È una fame che affascina la scienza. Un giorno scende a Zibello, da Borgo San Donnino, un professore minuto: mastica caramelle di menta e si fa accompagnare da una signora, larga e austera, sua moglie. Osservano, prendono appunti e se ne vanno in fretta. Si imbarcano verso Cremona per riprendere il cammino sull'altra riva. La barba corta sfiora i fogli sui quali Cesare Lombroso scrive le impressioni. « Incontro in felici simulacri di uomini macilenti, dall'occhio immobile, dalle guancie gialle e allibite, dalle braccia screpolate e piagate come da scottature o per larghe ferite. Ecco, voi li vedete farvisi innanzi, scrollando la testa e barcollando le gambe, come ubriachi, o, quasi spinti da una invisibile forza, cadere di lato; rialzarsi, correre in linea retta come il cane sulla preda e ricadere ancora dando un riso sgangherato che vi fende il cuore, o di pianto, come di bambino. Un pellagroso... » Di là dal fiume Barbuti ascolta storie di briganti che vivono la povertà nello spazio insicuro di una scelta non decisa: di rapina o di carità? Non vagabondi, non ancora banditi. Circondano i paesi, minacciano scempi, ma si accordano per farina e vino. Gandini, prete di Torricella, gli racconta del brigante Cesare Stringhini, mantovano scappato in America mentre i carabinieri stavano per arrestarlo. « Siccome i vagabondi giravano per le campagne in plotoni da sembrare militari senza divisa », dice il prete, «i fittavoli vennero a chiedermi consiglio. Dovevano armarsi per proteggere i beni. Per armarsi era necessario non solo il consenso, anche il denaro del proprietario dimorato in città. "Ci penso io. Forse i fucili non servono..." risposi, e la domenica predicai in chiesa contro chi tradisce il settimo comandamento. "Non rubare, ma rubare non è tutto: si può diventare ladri obbligando col silenzio minaccioso di una masnada di farabutti i proprietari a cedere al ricatto..." Lunedì mattina venne un ragazzo a dirmi che Stringhini e i suoi amici mi aspettavano fuori del paese. Per evitare guai alla popolazione, facendomi accompagnare dal curato Ermenegildo Lodi, mi feci coraggio e imboccai la strada. Mentre ci avvicinavamo udii voci che dicevano "da' una trombonata a quei preti...", ma Stringhini ordinò: "guai a chi li tocca!" Cominciò la discussione. Stringhini si lamentava che l'avevo offeso in chiesa, ed io gli rispondevo di non aver avuto nessuna intenzione di dispiacergli: intendevo solo ammonire le bande di questuanti affinché soddisfacessero la fame con maggiore civiltà. Alla fine ci lasciammo senza danni per me e la popolazione. I briganti si avviarono dalla parte opposta mentre chiedevo a Stringhini: "Posso offrire qualcosa per il tabacco?" Si accontentò di cinque lire.. » «La disperazione », osserva Barbuti «cambia ogni rapporto. Conseguenza dei disumani trattamenti è il turbamento dei contatti tra contadino e padrone. Al sentimento del rispetto necessario a rendere meno tese le relazioni di chi suda dall'alba al tramonto per produrre in favore di colui che raccoglie il beneficio senza fatica, succede l'odio e il livore che avvelenano l'anima del colono. Impreca per il misero stato e non riconosce in chi lo comanda che un nemico. Questo nemico continua ad odiarlo anche la notte quando la fame gli toglie il sonno. Dorme nel fienile fino a quando non ha l'età o ventura di prendere moglie perché il materasso arriva solo come dote della sposa... » «Devo smettere di rileggere il passato », pensa Barbuti poggiando il libro sul tavolo, «altrimenti come riuscirò a capire il presente? » La pioggia continua. Le campane annunciano la messa. Barbuti spinge gli scuri per vedere chi passeggia. Il fondo alla strada l'agronomo sta togliendosi il cappello sulla porta della chiesa. Nell'autunno di quel '79 viaggiatori meno drammatici attraversarono la pianura e proprio davanti all'albergo dove Barbuti e l'agronomo passano la notte quasi vent'anni dopo, la loro carrozza si ferma per chiedere un'informazione: quale strada imboccare per raggiungere la casa del maestro Verdi? Devono essere viaggiatori insicuri e prudenti perché, arrivati al cancello di Sant'Agata, pregano il cocchiere di non scaricare i bagagli: meglio decidere in giardino dopo il colloquio. Ormai il pomeriggio si spegne. Il prossimo treno per Milano ferma a Borgo San Donnino alle 9,30 di sera. «Forse ce la facciamo... se va male. » Uno dei signori si chiama Achille de Lauzières-Thermines, viene da Parigi ed è il critico musicale del « Figaro ». Anche l'altro viaggiatore è di Parigi: rappresenta l'Opéra e la rappresenta da pochi mesi, il 19 luglio ha preso il posto del vecchio sovrintendente Halanzier. Auguste Varcoubeil si è spinto nella pianura del Po con un proposito: strappare a Verdi il contratto (rifiutato ad Halanzier) di rappresentare l'Aida nel suo teatro. Ci sarebbe riuscito? In viaggio ne hanno discusso. L'impresa sembra difficile, forse non impossibile. Il maestro si intestardisce in una polemica (« no, a Parigi no ») che pare incomprensibile, eppure la logica dovrà rassegnarsi al bisbiglio di un diniego; è la ragione che li spinge a trattenere il cocchiere. « Benvenuti amici! » Verdi va incontro a braccia aperte. Senza chiedere parere ordina ai domestici di ritirare le valigie. I parigini non sanno quale vita regola casa Verdi ed è con meraviglia che, appena accomodati nelle camere, sentono bussare: un cameriere avvisa, si sta per andare a cena. «Ma sono appena le sei!... » si lamenta de Lauzières abituato ad altre ore. Alle sei, attorno ad un tavolo dove vini e pietanze intiepidiscono l'imbarazzo, ospiti e padroni fanno chiacchiere di mondo. A dire il vero di un mondo insolito. Verdi parla della campagna. Giuseppina, la moglie, racconta di come si senta sola nella casa troppo grande. «Senatore... », dice Varcoubeil, ma il senatore lo ferma. «Non vado mai a Roma... il senatore non esiste. E poi mi sono offeso quando il protocollo che annunciava l'elezione faceva riferimento solo ai soldi delle tasse come se fosse l'unico merito della preferenza. Diceva: il Senato convalida la nomina avendo accertato che il maestro Verdi versa ogni anno tremila lire di imposte dirette erariali... Altro che tremila... ! » Insomma, per essere Verdi sembra di buon umore. Nei discorsi non troppo prolungati della cena gli ospiti francesi si domandano quale tipo di mondo marito e moglie frequentino fuori dal cancello. Anche perché i loro racconti riflettono una vita chiusa. Verdi gioca a carte, oppure al biliardo, ma solo nelle ore vuote quando il lavoro dei campi lo lascia riposare. Gli piace la fatica del grande fattore. Controlla le semine, l'uso delle macchine, i muratori che risanano le case, gli uomini che saldano gli argini attorno al Po. Oppure i falegnami, i giardinieri che ancora trafficano a Sant'Agata. Questa vita sta per finire, arriva la nebbia e le giornate diventano corte. Fra un po' andranno a svernare a Genova. Se l'impegno è quello del comporre, il maestro si chiude nello studio dove in un angolo, dietro al pianoforte a coda, c'è una spinetta tarlata, i sottotasti neri, i sopratasti gialli: ne11821, su questo arnese, cominciava ad imparare la musica. Gli ospiti ascoltano le spiegazioni e ammirano l'esule per volontà; lo ammirano perché, chiusi in quel giardino che l'autunno comincia a marcire, non riuscirebbero a vivere una settimana. Qualcosa rende sfuggenti i rapporti tra il maestro e la Strepponi. Ne riparleranno nel viaggio di ritorno. Marito e moglie incrociano le parole quasi per convenienza e se non fosse per i visitatori di Parigi forse non avrebbero saputo cosa dirsi. Le voci che girano nei teatri allora sono vere? Per Teresa Stolz, la sua « Aida » ungherese, Verdi ha perfino comperato i gioielli di scena. Le scrive pacchi di lettere; si interessa ai suoi affari al punto di coinvolgere l'amico Piroli in una consulenza sui passaggi di eredità. Scappa da solo, a Milano o a Parigi, quando la Stolz vi canta. A Sant'Agata il cattivo umore non lo lascia per settimane. «Verdi s'irrite pour les intonations de voix trop douces, ou trop vives, de sort que je suis à me demander quel peut étre le juste milieu qui lui convient!... J'ai mal joué à billard et comme il m'a dit quelque chose brusquement, j'ai répondu "As-tu maldormi?" "Qu'ai-je dit hier soir qui méritait tes observations?" Il m'a répondu: "C'est le ton..." Mais au nom de Dieu! Est-ce-que à mon àge je dois parler et me tenir comme une jeune fille! » La Strepponi è sopra i sessant'anni; la Stolz ne ha quaranta. A cena non si parla di Aida e, prima di coricarsi, nello scambiarsi la buona notte, De Lauzières-Thermines e Varcoubeil ripetono « Speriamo! » Certo sono in pensiero. Sui giornali di Parigi hanno pubblicato una lettera di Verdi: non ne vuole sapere dell'Opéra. Sono le 6 del mattino quando De Lauzières sente bussare alla porta. «Le sei... » si avvilisce guardando l'orologio. « Deve essere l'ora fatale della casa. » Da anni non vede il giorno tanto presto. «Sono Verdi... ecco il caffè. » Posa la tazza e aggiunge: «Lo faccio io. Mi dirà se le piace. Oggi la giornata si annuncia bella, non c'è nebbia per essere quasi autunno. L'aspetto in giardino, là parliamo meglio. » «Adesso mi dice che gli dispiace per Aida...» si rattrista il critico uscendo dal torpore. Fin da principio Verdi calcola Aida come fonte di buon denaro. Di soldi non ha bisogno. Sta vincendo la piccola guerra per il riconoscimento dei diritti d'autore e investe con attenzione i capitali che piovono abbondanti. Investe in poderi, case, cartelle della rendita nazionale. Presta denaro garantendosi con contratti che l'amico-notaio Carrara compila con la dovuta cautela. Sant'Agata è una fattoria con attorno duemila biolche. Le prime 350 le ha comperate nel '48 dando in cambio un fondo che valeva 78 mila lire. Poi vengono i campi di Polesine, Ongina: la fila è lunga. Nel solo comune di Villanova paga, nel 1874, 13.3911ire di imposte dirette. Il difficile traguardo delle tremila lire che stabilisce il censo della dignità senatoriale, è quattro volte più piccolo del reddito di una piccola parte della proprietà. Pare che il latifondo si allarghi quando mettono all'asta i beni requisiti alla chiesa. Lo Stato ha fame di soldi perché il suo indebitamento si gonfia in modo forsennato. Svende migliaia di ettari sottocosto. Fino al 1877, solo nella pianura di Verdi, ventunomila biolche di buona terra rendono appena otto milioni. Così i prezzi si abbassano nell'inflazione dell'offerta; gli amministratori del maestro comprano case e poderi con dentro chiese e cimiteri. Il problema dell'investire bene lo ossessiona. Chiede consiglio a tutti e di continuo, ma si rivolge a Piroli (spiato dal giovane poliziotto Frondoni negli anni del ducato: l'« agronomo » provoca una perquisizione nella sua casa) allorché gli affari sembrano consistenti. L'avvocato ha lasciato Parma per Torino: il suo posto in Parlamento si trova accanto a quello sempre vuoto dell'amico. Ed è proprio quando i guadagni diventano importanti per tre opere (Rigoletto , Traviata, Trovatore) che gli viene voglia di una follia; una proprietà diversa dalla solita terra lungo il Po. Mette gli occhi sul Ferlaro, cioè la villa che Maria Luigia aveva fatto costruire nel 1828 per andarvi a passare le vacanze col suo conte Neipperg. Ma Neipperg muore e la duchessa s'immalinconisce: non mette più fretta all'architetto di corte Gazzola. Quando la casa è finita lascia che i figli Albertina e Guglielmo la abitino da soli. Nei registri di corte la costruzione pesa trecentomila lire; trent'anni dopo Verdi si augura che il prezzo ribassi: chi può tirare fuori tanti soldi per un casino di campagna? Prega Piroli di informarsi al Demanio. Piroli non risponde subito perché ha qualche problema con le rivolte del macinato. «Ho sempre dimenticato di scrivervi che, giunto a Firenze, non mancai di prendere informazioni », si giustificò mesi dopo. «Le operazioni di stima sono in corso e tra non molto conoscerò il risultato. Seppi che i periti non danno importanza al valore del casino perché costruito come luogo di delizia ducale. Tenendo conto delle cattive condizioni economiche della nostra provincia, il valore di affezione è scarso... » Un anno più tardi riesce ad essere preciso: vogliono centocinquantamila lire. «Costa troppo », risponde Verdi. «Per guadagnare simile somma bisognerebbe scrivessi un'opera o in Russia o al Cairo, e, a dirvi il vero, ho poca voglia di scrivere, e meno ancora di intraprendere viaggi faticosi... » Ma, più tardi, quando Camille Du Locle, librettista e direttore dell'Opéra-Comique di Parigi, propone qualcosa per l'inaugurazione del nuovo teatro del Cairo, Verdi si lascia convincere. Resiste col viceré d'Egitto fino a quando Du Locle fa balenare un soggetto che gli piace. Deve interessarlo anche il compenso. «Manderò copia dello spartito e lascerò l'assoluta proprietà del libretto e della musica per il solo regno di Egitto [sottolineato], ritenendo per me la proprietà per tutte le altre parti del mondo. Mi si pagherà la somma di centocinquantamila franchi a Parigi, banca Rothschild nel momento in cui verrà consegnato lo spartito... » Centocinquantamila franchi sono un po' di più di centocinquantamila lire, ma in quei giorni è il costo del Ferlaro che fa da unità di misura. Intanto altri diritti continuano a rallegrarlo. Prega Piroli di trovargli poderi a Soragna, a Collecchio o sulla prima collina. Piroli suggerisce, Verdi rapidissimo risponde: «Ma dove è questo Noceto? È un bel sito? Ditemi il biolcatico, la quantità del terreno, lo stato dei fabbricati, il prezzo... » Bisogna consolare anche il povero maestro alla presa con le tasse. «Caro Piroli, ora ho una noia da darvi, ed un consiglio da chiedervi. Mi scrivono da Monticelli per la ricchezza mobile... » Il municipio dove Verdi denuncia il guadagno che non gli viene dai poderi, ma dai diritti della musica, intende sapere se «alle 150 mila lire che dicesi siensi pagate per Aida siano seguiti altri introiti » e «quale somma abbia riscosso dalla ditta Ricordi per l'acquisto dell'opera suddetta ». Rabbioso il maestro annota: «Il contratto dell'Aida è stato fatto a Parigi; a Parigi già furono pagate lire 50 mila con le quali comprai rendita italiana. L'anno scorso mi hanno mandato da Parigi le ultime centomila lire che depositai al Monte di Pietà e che ora impiegherò in un fondo o in una rendita. Domando io: se impiego in fondi pago le contribuzioni; se in rendita pago il 13,20 per cento e le contribuzioni. Devo dunque pagare anche per i denari pagati a Parigi che hanno già pagato il 13,20 per cento?... Se devo dunque pagare per ogni opera che scrivo ogni cinque o sei anni, non posso né devo pagare ogni anno ventimila lire di ricchezza mobile... » Piroli è una specie di fratello al quale si rivolge per questioni minori: un parente di Barezzi vorrebbe la licenza statale per aprire un gioco del lotto; non si potrebbe far nominare a Busseto un certo curato?; un disertore dell'esercito ducale desidera integrarsi in quello italiano: metterà Piroli la buona parola?; la figlia adottiva Maria-Filomena non ha l'età per dare gli esami finali, ma Piroli così bene introdotto a Torino, potrebbe strappare l'eccezione? La parte importante dell'avvocato è quella di consigliere politico. Gli amici che il maestro si fa in Parlamento un po' escono dalle sue mani, mani gentili con i conservatori che fanno da angeli custodi alla poltrona vuota di palazzo Carignano. Posto numero 68; nel 67 abita Piroli, nel 69 Girolamo Cantelli. « II 68 va bene?» scrive d'urgenza l'avvocato. Deve sbrigarsi a rispondere «perché v'è molta ricerca di scranni e tra breve si avrà l'invasione dei napoletani ». A Verdi resta il dubbio: «Ignoro se alla Camera di Torino il posto che prende un deputato abbia significato politico come in Francia... io non voglio essere né bianco né rosso, e desidero restare indipendente nelle mie opinioni. Se voi siete dello stesso colore sarò felicissimo di sedervi vicino ». Subito si entusiasma di un compagno di fila, Quintino Sella, protagonista della destra. «Una testa forte. » Il compito attribuito a Piroli è quello di decifrare, per conto degli esuli pigri di Sant'Agata, la realtà del mondo lontano. Chiede Verdi: «Se le cose continueranno così qualche tempo ancora, noi moriremo di fame. Io non ho mai potuto capire come i nostri uomini di stato cercano di annientare le poche ricchezze che naturalmente abbiamo... E ditemi un po': cosa vuoi dire che quando l'Italia era divisa in tanti piccoli regni, tutti, quassù, avevano le finanze in ottimo stato... » In campagna vive la realtà meglio che Piroli in Parlamento. «... se il Sella va alle finanze so che le condurrà come fosse un carabiniere, ma prima di prendere forti misure mi pare che bisognerebbe studiare quello che è possibile fare. Quando egli metterà imposte che non si potranno pagare, cosa succederà? » Piroli non perde l'ottimismo: «Voi dite: v'è chi grida... e noi moriamo di fame. Queste parole mi hanno colpito perché accennano ad una gravità di situazioni che deve mettere tutti in seria preoccupazione. Ma i lamenti non sarebbero per avventura eccessivi? » Sono giorni in cui prende fuoco la rivolta del macinato. Barbuti e « Il Presente » sfidano il deputato a dare spiegazioni. Piroli nemmeno se ne accorge. Anche il maestro preferisce chiudersi le orecchie: « Non leggo più giornali. Non voglio sentire parlare delle nostre miserie. Non v'è nulla a sperare per noi quando uomini di Stato sono pettegoli e vani... » Ma di andare in parlamento continua a rifiutare. Risponde « non posso » ad ogni sollecito ufficiale. Si scusa allorché lo chiamano per i lavori di una commissione. Sono i mesi in cui progetta il casino di Maria Luigia. Quando la sinistra di De Pretis prende potere, Piroli si arrende: forse le cose stanno declinando. «... se a questo si aggiunge che la nuova scuola, o come già la chiamano, la nuova consorteria progressista si compone in gran parte di gente ignorante che presume progredire senza conoscere il punto di partenza... voi vedete che la prospettiva diventa sempre più scura e incerta. I moderati sono alla Camera pochi in numero e impotenti a far fronte alla corrente... » Rispondono da Sant'Agata che per fare davvero barriera contro il socialismo che dilaga ci vorrebbero preti di campagna meno ignoranti. «... come vi dissi la miseria è molta: è cosa grave e può diventare gravissima, compromettendo anche la sicurezza pubblica. Si tratta di fame!... » Ribatte Piroli: «La vostra carissima ultima annuncia un fatto gravissimo, cioè che la miseria cresce in modo spaventoso... » Gli eletti del Parlamento continuano a vivere come angeli, con i piedi staccati dal mondo. Forse il senatore Verdi potrebbe, meglio dei prefetti, spiegare cosa succede nelle campagne, ma preferisce la vita di Sant'Agata e il lavoro dei campi. « Stamattina ho ricevuto un telegramma dal vice presidente del senato Borgatti che prega vivamente di recarsi il 29 novembre a Roma per leggi urgentissime. Con mio grandissimo dispiacere ho dovuto rispondere che non lo poteva! In verità, per circostanze simili, quando sono costretto a rispondere in tale modo sento vergogna e rimorso...» «... intanto gli scioperi si estendono e ora siamo al punto che nei paesi e campagne vicine (Zibello e Polesine) i contadini giornalieri che devono mietere il frumento (cosa che non ammette ritardo) pretendono condizioni impossibili, e fra queste una enorme: cioè che ciascun mietitore possa prendersi un covone ogni sera, finito il lavoro della giornata! Ma se il covone è prodotto del terreno, e il proprietario paga il lavoro al prezzo convenuto, deve naturalmente al proprietario restare il prodotto. Poi, quale precedente! Perché non potrebbero pretendere l'anno venturo due covoni, poi quattro, poi venti, poi la metà eccetera, eccetera... Il governo che ha lasciato fare, che ha voluto lasciare fare, cosa farà ora se il disordine continua? Reprimerà con la forza? Punire dei poveri contadini ignoranti che non capiscono, né hanno mai capito nulla, perché si sono lasciati sovvertire dai soliti agitatori di reputazione infame che ripongono ogni speranza nel disordine come i borsaiuoli nelle folle?... Il governo doveva mettere un freno ed impedire che questi sovvertitori propalassero massime che tendono a distruggere la società da cima a fondo. Non vale gran cosa questa società, dicono (e lo dicono i più tristi). D'accordo! Ma quella che verrà sarà migliore? Voi, Piroli, che siete a contatto con quei signori al potere, domandategli un po' cosa faranno una volta che i contadini siano in rivolta contro i proprietari? Fino a tanto che disordini consimili nascono in città, non è difficile, in un modo o nell'altro, porvi qualche apparente rimedio, ma nelle campagne, acceso l'incendio, non si spegne più... » Tra i « sobillatori infami » c'è un medico, « figlio del medico Musini, che fa propaganda e che solleva queste campagne. Il male si estenderà certamente, ed è ben naturale dal momento che non si sa né si capisce che vi sia ombra di autorità e di leggi. Brutte cose, ma brutte assai. Peppina vi saluta... » Anche al vecchio amico Opprandino Arrivabene Verdi fa sapere la sua inquietudine. «... hanno scatenato le fiere. Sarà un miracolo se non saremo divorati: i ministri per primi. Intanto questa Lega contro il macinato di Reggio non è tanto bella cosa, soprattutto nei nostri paesi. Io sono vicino di casa e li conosco... I sinistri distruggeranno l'Italia... » Più avanti si preoccupa per la riforma che timidamente allarga il voto a categorie escluse perché senza.proprietà o censo. Siamo lontani dal suffragio universale, ma anche i piccoli cedimenti lo infastidiscono. «... Non ti parlo, ossia non ti rispondo sulla riforma elettorale, sul Senato, sulla Camera, eccetera. Sono cose che fanno venire i brividi. A cosa vuoi sperare?... » È soprattutto con Piroli che Verdi discute con una franchezza sconosciuta ai pochi confidenti, e i motivi sono tanti. La stessa età, tutti e due di Busseto, hanno attraversato assieme il Risorgimento e, per entrambi, la nuova patria riserva un posto di privilegio. Verdi se lo è conquistato commuovendo il mondo; Piroli lo strappa, giorno dopo giorno, nell'esercizio politico. Esercizio che ama, e questo amore lo confessa: « Una volta che vi si è posto il piede in questa via, e ormai sono molti anni che vi sono inoltrato, è assai difficile il ritorno... » Ma la fortuna dell'onorevole Piroli da principio procede incerta. Lo attaccano i radicali; un po' ruvidamente lo insultano dalle logge i repubblicani. La « Gazzetta » non lo difende nel modo dovuto. Non previene i colpi, né ricorre all'esaltazione quotidiana della sua opera, come dovrebbe, tanto che Piroli «tirato per i capelli è costretto ad intervenire di persona in polemiche non gradite ». Se ne lamenta con Verdi: servirebbe un giornale deciso. Una volta, nel '65, non ce la fa ad essere eletto. «Sono rimasto soccombente nella lotta elettorale. Qualche influenza l'avrà certo avuta la slealtà dell'attacco. » Verdi gli risponde: «... I preti hanno saputo maneggiare bene e segretamente... Sono furioso. Addio ». «Voi siete furioso », si immalinconisce Piroli, « ed a ragione, io sono da quattro giorni con la bocca amara per lo stupore. Ecco perché. A Parma tutti mi dicevano, e da Parma tutti scrivevano che la rielezione era sicura. Si tengono riunioni e si conducono le cose in modo che il partito avanzato, anzi avanzatissimo, prenda il sopravvento ed i buoni elettori se ne stanno a casa, sì che il medico Cocconi, già capo dei pugnalatori [del duca], e d'altronde buon medico che sta a Torino da dieci anni, esce con più voti di me ed io sono con lui in ballottaggio domenica prossima. Siccome al partito avanzato si uniranno i clericali sono sicuro di perdere... » E perde, anche perché la ricca borghesia ammessa a votare (solo il due per cento della popolazione nel '76) scopre che le etichette contano sempre meno. Sta nascendo una classe politica omogenea che, con piccoli aggiustamenti, trucca le bandiere permettendo di mantenere la realtà come il censo dei più forti ritiene sia conveniente. Intanto la sinistra avanza. Il parmigiano Girolamo Cantelli, vicino di banco di Verdi a palazzo Carignano e ministro degli interni, ordina retate e riempie le prigioni di intellettuali inquieti. Ma i voti sono voti e quelli dei piccoli proprietari frustrati o dei figli della grande conservazione, seguono la cultura di un'Europa dalle idee aperte. Piroli e lo stesso Cantelli fanno i conti: non solo la destra perde il controllo del governo, ma la loro rielezione corre pericolo. Con la « Gazzetta » sbiadita che non tiene il ritmo battagliero del «Presente », il pericolo è quasi certezza. Nel marzo '76 la destra scivola e De Pretis (mazziniano sceso da Broni) guida la sinistra al potere. Il prefetto di Parma, come tutti gli altri suoi colleghi, dà le dimissioni considerandosi «legato al partito di governo» ora passato in minoranza, ed è nella vigilia afosa del primo autunno che un brivido attraversa i palazzi: ci si prepara a votare. «Le ultime elezioni libere» predicano Sella, Piroli e Visconti Veno-sta agitando lo spettro della fine della civiltà. «Se non vinciamo il paese precipita nella confusione. » Verdi sente l'amico in difficoltà e cerca di prevenire la delusione. «Una fortuna per voi se non sarete deputato... » Ma Piroli non ama questo tipo di fortuna. Corre a Parma per la campagna elettorale. Fa sapere al maestro che andrà a trovarlo a Sant'Agata, deve parlargli di un progetto. A Sant'Agata sono felici di riabbracciarlo. «Tutti desiderano vedervi qui. Peppina dice che portiate un baule grande... » 11 18 settembre una carrozza aspetta l'onorevole alla stazione di Borgo San Donnino. «Finalmente adesso potrete riposarvi... » L'accoglienza è affettuosa. Ma l'avvocato non riposa e resta un ospite di fretta che passeggia nel giardino discorrendo con calore e agitando le mani. Quando se ne va pare contento. Ha ottenuto le cose che si proponeva. Chiede a Verdi i soldi per comperare la «Gazzetta ». Non gradisce solo il denaro necessario a coprire una quota importante; desidera che il nome del maestro possa figurare tra i proprietari. Verdi accetta, si fa intestare un pacchetto di azioni. Gli altri soci sono gli amici che tremano per la destra in pericolo: il ministro Cantelli, il giurista Francesco Bianchi, destinato a diventare senatore. È il sindaco di Parma corso dal prefetto per chiedere «l'ordine della truppa» contro gli affamati in rivolta per la tassa sul macinato. A questo punto serve un direttore da mettere al posto del pallido romanziere Davide Rabbeno che inseguiva le fantasie dei racconti di appendice anziché frustare la sinistra. Qualche mese avanti, il 5 marzo, prima domenica di Quaresima, un giornalista venuto da Napoli — Eugenio Torelli Viollier — aveva fondato a Milano il «Corriere della Sera ». Tre redattori in tutto e uno di loro nasce a Parma: Parmenio Bettoli, critico e scrittore instancabile di commedie senza successo se firmate col proprio nome, ma protagonista di uno scandalo quando, inventando per gioco certi dialoghi, giura all'impresario teatrale di aver scoperto L'egoista per progetto, ultima commedia inedita di Goldoni. Gli credono e scoppia un putiferio. A Bettoli affidano la « Gazzetta » mettendogli accanto Pellegrino Molossi, figlio di Lorenzo che era segretario della Società filarmonica, burocrate pignolo e compilatore di memorie locali, soprattutto amico di Verdi e di Cantelli. Un provinciale colto e perbene, eppure un giorno, negli anni del ducato, si scrolla la timidezza per rivolgere un appello di straordinario coraggio alla sovrana, rischiando la carriera, forse la vita. Succede nel 1856: Carlo III è morto da poco e Molossi avverte Luisa Maria, reggente nel nome di Roberto: «... ho il grave sospetto che Vostra Altezza Reale non sia appieno informata delle sorti attuali del Paese... » E lui la informa confidando che la signora « ... non vorrà disgustarsi dotata com'è di grand'Anima... » Denuncia un ministro intrigante e insaziabile. «La giustizia offesa, la polizia bestiale, la Pubblica Istruzione languente, la Morale del popolo sospirosa ed afflitta, l'esercizio della Sovranità inceppato per le dannose stipulazioni con l'Austria... » L'impero domina la navigazione sul Po, presiede con le truppe la guarnigione di Piacenza, e governa con uomini ombra la polizia del ducato. «A che mai si riduce l'indipendenza di Parma? » Molossi dà consigli: licenziare il direttore di polizia «ed affidare questo geloso ramo di servigio ad Uomo del Paese » buttando fuori lo straniero. Un'utopia politica che spinge a « mondare gli Uffizi di quel mal seme, e disfare la ciurmaglia di guardie» messe assieme da Carlo III e da Anviti. Otto richieste secche e precise colpiscono i potenti dello Stato. Ecco perché rischia davvero e, rischiando, diventa l'amico coraggioso, ammirato da Piroli e Cantelli. Il figlio di Pellegrino comincia a scrivere con l'aureola di un simile passato. Guardando negli anni mostra di non averne avuto bisogno. Il 26 ottobre la « Gazzetta » annuncia di essere proprietà di una società di cittadini. Naturalmente continuerà «a propugnare il programma del partito liberale ». Lo propugna (per usare un verbo amato e tanto usato) con stile nuovo, battagliero e senza tenerezze. Bettoli e Molossi scaldano presto il giornale. «Sul punto di cimentarsi nella lotta a cui chiama l'urna elettorale, reputiamo doveroso far conoscere quali sieno il nostro intimo sentimento riguardo ai partiti e agli uomini che ci proponiamo di combattere. Li distinguiamo in due separate categorie: avversari e nemici... » Tra i nemici c'è la sinistra. «... anelante il potere con l'ansietà di sedici anni di infruttuosi conati... » E, siccome non v'è tempo da perdere, subito attaccano la musica che piace a Piroli e a Verdi. Il primo giorno, il primo numero dell'era appena cominciata, offre questa cronaca da Busseto: «Perché si conosca quale sia l'aura elettorale che spira in questa sezione del collegio, non si esita affermare che esso è in pieno favorevole alla rielezione del commendator Piroli. Vi furono altre corrispondenze mandate al "Presente" nelle quali veniva detto della candidatura, da opporsi a Piroli, del marchese Antonio Pallavicino (proveniente da famiglia di legittimisti, gran nottambulo e, diciamo tutto, anarchico!), sconosciutissimo da tutti e per principi politici e per dottrina. Si parla anche dell'avvocato Amos Ronchey, la cui fermezza, a parte le questioni di meriti col Piroli che non ammette confronti; la cui fermezza, dicevasi, di principi politici... basta, lasciamola lì... » Ogni giorno la « Gazzetta » batte il suo chiodo in favore di uno dei padroni, Piroli, appunto. «... a badare certe voci si direbbe che l'onorevole Piroli fa fatica a star ritto nella pugna elettorale. Mai invece elezione fu più sicura... » Parmerio Bettoli (che è corrispondente del «Corriere ») scrive un articolo per il giornale di Milano e il mattino dopo lo riprende sulla « Gazzetta » senza spiegare che esce dalla sua penna. « Anche il "Corriere della Sera" si occupa del nostro deputato Piroli affermando: "Piroli appartiene a quel numero di illustri che per segnalati servizi alla patria, semplicità di costumi, per scienza ed autorità, un collegio deve gloriarsi di mandare alle Camere, mentre il suo avversario Ronchey non fece mai buona prova quando deputato in questo o quel collegio. È poi disgustoso il vederlo portarsi antagonista del Piroli, suo benefattore..." » Quando il candidato della sinistra Cocconi chiede il suffragio universale la « Gazzetta » si indigna come s'indigna Verdi: «... significa rendere più frequenti i brogli, gli inganni, le frodi, i fallimenti... » Ecco, si vota. Cade la testa di Piroli, ma anche quella del ministro degli esteri Visconti Venosta, appena al di là del Po; Ronchey e Cocconi vanno a Roma. Verdi consola l'amico: «Voi dunque avete ora del tempo da disporre. Meglio, povero Piroli, dopo tanto lavoro in questi ultimi anni! E poi non è bene essere fuori? Vi giuro che sarei infelicissimo se fossi adesso deputato: non amerei vedere lodare, accettare, approvare quanto propone il [nuovo] Ministero, né rassegnarmi a fare da pecorone dicendo sempre di sì... », naturalmente alla sinistra. Anche Verdi viene amaramente sfiorato dalla campagna elettorale che sostiene dietro le quinte, e la « Gazzetta », suo giornale di casa, lo difende. «È penoso constatare a quale sorte di mezzi, nella loro foga, non solo del vincere ma dello stravincere, i nostri avversari abbiano ricorso durante lo scontro elettorale... L'avvocato Amos Ronchey e il marchese Pallavicino si davano le più grandi brighe nella frazione di Busseto. « Presso Busseto, nella villa di Sant'Agata, dimora quel sommo, quella gloria del nome italiano che è il maestro Giuseppe Verdi, del quale tutti conoscono il patriottismo e la stima e l'amicizia che lo legano all'illustre suo compaesano, commendator Piroli. Ebbene, tra il 5 e il 12 corrente, il maestro Verdi ebbe a ricevere una villana lettera anonima, con la quale, assieme a molte ingiurie, lo si minacciava nientemeno che di sputargli in faccia qualora avesse osato rimettere piede a Busseto. Prodezze progressiste!... Di fronte a simili mezzi della codardia, il genio sa sempre installarsi a così eccelsa altezza... » Infatti Verdi spedisce al sindaco la lettera anonima e nella stessa busta infila un altro foglio nel quale spiega di mettere a disposizione 1600 lire in titoli, la cui rendita annua dovrà servire in perpetuo a far studiare un giovane meritevole. Barbuti, che in quei giorni gira la pianura per raccogliere le storie destinate al rapporto Jacini, manda al « Presente » una corrispondenza maligna: «Verdi restituisce il denaro elargitogli dal municipio di Busseto quando aveva bisogno di una rendita per gli studi, ma fa passare questa doverosa restituzione come propria generosità... La sua fortuna permetterebbe di fare ben altro... » Le elezioni tristemente si allontanano. Piroli cerca, e più tardi trova, la strada del Senato. Adesso la « Gazzetta » serve per indignare i lettori raccontando le imprese ladresche di briganti che girano le campagne pretendendo farina e occupando minacciosi le aie di onesti proprietari. Il medico Musini continua ad essere il bersaglio preferito. «... Quando esclama in tono piagnucoloso che il contadino è pagato in ragione di trenta centesimi al giorno dice una solenne bugia per smania di ricavarne effetto dalle sue parole... La paga è di lire 1,30. Esclusa dunque la miseria come fatto principale delle odierne agitazioni, resta l'invidia, questo fertilissimo humus su cui prospera e giganteggia la democrazia. Si soffre che altri stiano meglio, ecco la verità... » Sono le parole in cui Molossi intinge la penna, quasi lo stesso giorno del caffè che Verdi porta in camera ad Achille de Lauzières-Thermines. Quel mattino il critico scende in giardino sconsolato. « Adesso annuncia la sentenza. Aida, addio... » Il suo racconto trova una sorpresa: « Là seduti davanti alla bella grotta tappezzata di verde, cominciamo a parlare di Aida... » Verdi ripete le vecchie parole. Perché rischiare la Francia? Nei teatri italiani lo adorano. I maestri gli obbediscono, gli orchestrali si prostrano ai suoi piedi, il pubblico batte sempre le mani. All'Opéra l'orchestra è quella che è, e poi c'è il palcoscenico troppo largo e gli spettatori diffidenti. Non ha voglia di emozioni. Grazie, no... Peppina va e viene. Ascolta e tace. Forse Varcoubeil, povero intendente di un teatro negato, raccoglie il discorso da dietro le persiane. Verdi alza gli occhi sulla finestra chiusa come per chiedersi: allora si sveglia? Finalmente sveglio, Varcoubeil spunta nel viale con l'aria di chi si prepara a ricevere un rifiuto. « Ehilà! » si interrompe Verdi, « cosa mi consiglia De Lauzières: devo dirgli di sì? » Il critico si sente le ossa pesanti. «Perbacco... » tutto ciò che sa dire. Allora Verdi si alza e va a passi decisi incontro all'ospite che avanza. « Varcoubeil, la notte porta consiglio: vi do Aida...» E Varcoubeil, sconsolato dalle parole che salivano alla sua finestra, getta le braccia al collo del maestro. «E adesso parliamo seriamente », aggiunge Verdi trascinandolo lontano dalla prima colazione di De Lauzières. Anche la Strepponi pare frastornata. Guarda De Lauzières; tutti e due sorridono agitati dalla stessa idea: il maestro ha recitato la parte di un mediatore di campagna che esaspera la richiesta per alzare il prezzo ed ottenere ciò che gli sta a cuore. Qualche tempo dopo il povero critico cascato nella trappola di Verdi, si sfoga sul «Figaro »: «Il secondo centinaio di rappresentazioni di Aida all'Opéra va avanti. Calcolate un po' i diritti d'autore che spettano a Verdi, diritti integrali perché sia il libretto italiano che quello francese gli appartengono per contratto. Non parlo, poi, degli onori. E dire che ho dovuto pregarlo tanto... » Davanti all'albergo Sole c'è un crocevia. Da una parte la strada piega verso Sant'Agata, l'altra si addentra fra i portici per continuare nella campagna che porta a Zibello. La realtà del genio milionario; la lotta del medico socialista che predica in piazza per i pellagrosi. Pochi chilometri le dividono. Ma risalendo dallo stesso incrocio verso la collina si va a Soragna: è la strada percorsa l'ultima volta dall'agronomo quel mattino di pioggia. Forse la carrozza del sovrintendente dell'Opéra e la pistoiese di un poliziotto che correva per riferire dell'indagine ai cospiratori lealisti, si sfiorano nel fango. Franzoni progettava una sorpresa a villa Verdi, ma la sorpresa e ogni altra illusione si sono spente (come sappiamo) sulla poltrona di Soragna. Un discorso che amareggia l'agronomo; per la prima volta nelle abitudini di un uomo pedante questa amarezza gli impedisce di guardare al di sotto dell'apparenza. Avrebbe scoperto una realtà meno svagata di quella descritta nel rapporto. Non inquietante: tutto sommato la diagnosi di non pericolosità risulta giusta, meno giusta è l'impressione che Davico e gli altri duchisti agissero per innocente nostalgia. La cospirazione pensava di essere seria. Studiata altrove, come risulta dalle lettere ancora sepolte nei libri del palazzo. Il giorno in cui Buttafuoco mostrava, per ordine di Davico, carte e giornali all'agronomo, indicando un pacco mai aperto aveva aggiunto: «... La corrispondenza tra il sovrano e il principe Diofebo non è facile. La prefettura ci sorveglia. Sappiamo di nostri messaggi custoditi negli archivi della polizia... » Mostrò un verbale finito per misteriose strade nelle sue mani. «Una lettera proveniente da Roma », era scritto, «fu osservata al di sotto del francobollo e si scoprì un listino di carta contenente varie righe di sottilissima scrittura ed era la parte più segreta di una corrispondenza epistolare che voleva sottrarsi a qualsiasi sorpresa dei funzionari pubblici... » All'agronomo che chiedeva: allora, in quale modo comunicate?, Buttafuoco spiegò che per evitare trappole il duca indirizzava ogni corrispondenza ai Beffa Negrini di Mantova, famiglia dalla quale usciva la moglie del marchese Guido. I Negrini cambiavano busta e spedivano il messaggio del sovrano alle suore del collegio San Carlo di Parma. Quando Diofebo passava ritirava, senza guai, la posta. Forse perché tormentato dall'idea dell'accettare un incarico non gradito, l'agronomo non pensò di chiedere quali misteri nascondessero le lettere: avrebbe scoperto una realtà che poteva cambiare il destino del rapporto cancellato dagli archivi di piazza San Fedele. Cancellato senza suscitare interesse: la risposta del ministero non arrivò mai. Dalla biblioteca di Soragna Le lettere del duca sono il diario di un profugo che sospira nel privilegio: gli onori della corte di Vienna lo raggiungono a Schwàrtzaun nel verde della Stiria. Ricercato ai balli, simpatico alle signore. In Toscana c'è la casa di Camaiore e, appena oltre Cannes i Borboni parenti della moglie (i Napoli, come dicono semplificando fra loro) godono l'aria dolce della Francia. Ma questi privilegi non attenuano il rimpianto che si porta dentro. «... io voglio sempre bene al mio Paese e non l'ho mai nascosto. Ora non mi faccio illusioni: Parma non mi ama. Parma non mi vuole. Abdicare non posso perché: 1) mi è impossibile rifiutare una cosa che non possiedo; 2) la coscienza me lo vieta. Se potessi farlo lo avrei già fatto da più di un anno. Sono disgustato dal dovere, forse un giorno, governare un paese irreligioso che non ha principi e mi respinge. L'ingratitudine è troppo frequente perché ciò meravigli. Che fa la gioventù parmense? Pensa al carnevale mentre il paese è nella miseria; pensando a divertirsi, invece di studiare quando il paese ha bisogno di uomini saldi. La base è guasta, a Parma non vi è ressort, come dicono i francesi... » L'essere dimenticato gli pesa. «...caro principe di Soragna, io sono il solo dei principi italiani che si trova così trascurato dai suoi. Il duca di Modena venne a Roma quest'inverno e nel suo salone ebbe la consolazione di vedere riuniti un centinaio di sudditi. Nessuno vuole invece restare con me. Forse perché ho rimandato a Parma il marchese Mala-spina e il marchese Casati? Non per leggerezza. Il marchese Casati, di cui non avevo avuto che da lodarmi in Germania, dacché era a Roma volle assumere un'aria di padronanza che non potevo tollerare, e, peggio ancora, si pose in vergognose relazioni... » Ma la speranza del duca ha un'anima di ferro. «...questa festa di San Roberto sarà l'ultima che passeremo nelle condizioni presenti? [La "condizione presente" è l'esilio]. Chi lo sa. Io che vedo generalmente l'orizzonte più rosa, lo vedo ora nerissimo, ma dietro quella nube oscura intuisco la luce della speranza che sta per mostrarsi quando la tempesta, che so scoppiare, si scatenerà... In Italia la posizione è più seria perché il governo sta seduto su basi fradicie. Non si regge avanti che con l'aiuto di Napoleone. Questi caduto, Vittorio Emanuele lo segue... quanto a me, come vedo la crisi imminentissima, resto a Roma presso il Santo Padre per venire con lui o per andarmene seco. Il Santo Padre è pieno di fiducia in Dio, vede le cose con molta quiete e spera. Quando sarà passata la crisi e si dovrà riorganizzare l'Italia che si farà mai? Ho sentito molte persone dirmi: Vostra Altezza non tornerà mai più a Parma, sarà sovrano in Italia di uno Stato forse più grande, ma a Parma non deve pensarci... Io non ho mai rinunziato ai miei diritti. Se, senza nuocere a nessun sovrano potrò ingrandire il nostro caro ducato, lo accetterò a condizione che non sia una lesione ai diritti di qualunque altro... Lo accetterò a condizione che resti Ducato di Parma e non pigli altro titolo più pretenzioso...» La malinconia ritorna ogni giorno quando gli arriva non freschissima la « Gazzetta » con novità che non fanno piacere. «... Ho letto ora nell'infiorata "Gazzetta" la notizia della solenne entrata di Umberto a Parma. Anche noi, nel gennaio del 1859, eravamo ricevuti con entusiasmo a Pontremoli: folla, grida, illuminazione. Sono sicuro che anche Umberto avrà giorni di dolore quando saprà che uno straniero avrà dormito nel suo palazzo di Torino. Sarà la ricompensa meritata pel piacere che provai nel leggere i dettagli dell'acconciatura del nostro povero palazzo per l'arrivo di questi ospiti. Margherita ha riposato nella camera di mia madre, ed ambedue hanno ricevuto la gente nel salone del trono! Ben presto questa parola in Italia scomparirà dal vocabolario e ne saranno colpevoli coloro che hanno saputo fare dei troni semplici sgabelli... » Roberto imbuca a Biarritz il 7 novembre '78. «... sono entrato nella trentina e fra breve saranno vent'anni che sono partito da Parma. Solo i vecchi e i poveri si ricordano di me... » «... a Milano l'eccellentissimo "Osservatore Cattolico" che ha il raro talento di essere sulla via diritta, ha fatto una bella campagna contro l'unità d'Italia ed ha vinto la battaglia. Sarebbe possibile avere a Parma un giornale redatto nello stesso modo? » Il 17 novembre '78, sempre da Biarritz. Nelle date c'è un salto. L'ultima corrispondenza risale a gennaio. Il 3 gennaio '79, sul tavolo aperto verso il mare grigio, Roberto ha già « divorato » il primo numero del giornale uscito a Parma il pomeriggio del giorno prima. Nessuna posta è tanto veloce. Forse un corriere speciale. «Caro Principe, ho ricevuto ora "La Luce". Veramente questo giornale mi piace molto. Incoraggi Caricati (buon organizzatore e articolista), lo feliciti di parte mia, e veda che si trovi il modo di impiantarlo bene. Scriverò al conte Dall'Asta per la questione finanziaria, per dare olio alla lampada, lei capisce. Quando c'è l'olio vi è pure una bella luce, e abbonati e corrispondenti si trovano. Mi secca che il buon Buttafuoco non voglia saperne di una fusione: sarebbe una grande economia per Caricati poter stampare "La Luce" nella tipografia Fiaccadori dove si compone "Il veridico..." » Il giornale gli costa ma paga volentieri. Nell'articolo che inaugura « La Luce », Caricati spiega, con l'ipocrisia del giornalista di corte, il suo impegno. «Non abbiamo mecenati. La nostra unica bandiera è quella della verità e della giustizia. Non ci servono i soldi di nessuno perché siamo certi che la nostra battaglia ci procurerà un numero tale di abbonati da sopperire ad ogni spesa. Avremo quattro corrispondenti: a Roma, a Genova, a Parigi e nella Svizzera. Nel 1878 la Rivoluzione è entrata in una fase novella. Essa ha demolito tutto ciò che era necessario al benessere del popolo, ed ora che più nulla le rimane da demolire, ucciderà se stessa. Per ora sembra trionfare, è vero, ma il tempo si annuncia vicino in cui sulle sue rovine la Chiesa scioglierà il canto del ringraziamento... » Una prosa che aveva entusiasmato Diofebo e i lealisti, e l'entusiasmo cresceva ogni mattino, sfogliando il giornale. Non tutte le mattine perché la prefettura interveniva con le manette al gerente (testa di comodo, un vecchio sacrestano) impedendo per qualche tempo che «La Luce » raggiungesse i lettori. Ma l'idea di una rivolta, finalmente possibile, animava i duchisti. Così era cominciato quel '79, anno di intrighi veniali dei quali è sopravvissuta una debole traccia in qualche archivio di campagna e nel quaderno di un ispettore pieno di nostalgia che aveva perso un po' di giorni tra Soragna e Busseto. Lunedì, 26 settembre 1898 Per prima cosa il giornale del mattino. «La verità è che i proprietari hanno speso somme ingentissime per migliorare le case dei contadini. Tutto quello che salta agli occhi a chiunque ricordi come erano vestiti e alloggiati anni orso-no. Nessuno potrà onestamente negarlo: i contadini dormono, vestono e mangiano assai meglio di una volta e c'è da aggiungere che le osterie e gli spacci dei liquori, dal 1859 in poi, si sono purtroppo più che duplicati. Si dice che c'è ancora molta miseria, ci sono pellagra ed emigrazione. Quanto alla miseria è sempre esistita. Il volerla bandire dalla superficie della terra mi pare utopia. La pellagra resta un male gravissimo. Scienziati e filosofi ne studiano accuratamente la natura; in ogni caso non saranno le agitazioni che immiseriscono proprietari e lavoratori a guarirla. Per l'emigrazione ogni parafrasi sembra inutile: in Italia esistono alcuni milioni di bocche in più quindi non vi sarà un rimedio efficace e duraturo alla crisi agricola, ove non si eliminino queste bocche. E il rimedio non può essere uno solo. Lo abbiamo accennato più volte ed ora lo ripetiamo: questo rimedio è l'emigrazione su vastissima scala. Che il governo pensi a trovare una regione propizia all'impianto di una vasta colonia in cui dirigere i braccianti e i piccoli proprietari... » La lettura della « Gazzetta » ringiovanisce Barbuti. Stando a Roma viveva nell'impressione che almeno il buonsenso unisse la grande ricchezza alla gente comune, ed ecco che questa prosa tagliente lo rifà sentire utile. La battaglia resta aperta, c'è ancora posto per lui. Arriva un altro giornale, non lo conosce, «La Cronaca» di Borgo San Donnino. Pare socialista, si racconta del giorno prima a Pieve Ottoville. «... In occasione delle cresime si tenne l'importante manifestazione clericale. Si erano dati convegno, in quella villa simpatica, tutti i capoccia del partito nero, in tricorno e in borghese... » « Devo farlo leggere all'agronomo... », Barbuti sorride alla provocazione verso un compagno imprevedibile e un po' misterioso; tutto sommato — si consola — conversatore intelligente anche se come scienziato non vale granché. Non ha mai parlato di campagna... Forse piove, l'aria calda bagna le mani. L'agronomo spunta da in fondo la strada. « Ancora a Messa! » si meraviglia Barbuti. « Perfino il lunedì... » Glielo chiede senza ironia ma il tono non deve essere giusto perché l'agronomo se ne risente. « Io rispetto il suo sentimento, lei non può burlarsi del mio. È stata solo una visita alla Società Operaia per discutere con braccianti e artigiani. Volevo sentire la loro opinione. » «Ma non sanno niente della coltivazione! Li ha visti? Sembrano bestie da lavoro. Non pensano, perché nessuno li aiuta a leggere e a capire, a non avere, insomma, ore di ozio che non siano anche ore di fame. Come fanno ad intendersi di nuovi sistemi di coltura? Obbediscono agli ordini e basta. I più aperti possono sapere quanto guadagno tocca e quanto il padrone ruba... Ho tenuto per lei questo giornale. » Nel prendere il giornale l'agronomo risponde: « Insomma, giustifica la rivolta... » «Non la giustifico, la capisco. Ha visto le loro facce? Portano la sofferenza di una vita così. Poi i soldati sparano... » « Sparano per evitare un pericolo più grave, e cioè che i signori stanchi della tolleranza decidano di armarsi da soli contro i contadini. Allora meglio armare la truppa. Con un ordine torna in caserma, ma chi farà rientrare le milizie degli agrari?» « La truppa, naturalmente. Non capisco perché debba colpire solo i poveri che disobbediscono a mani vuote e non i padroni che disobbediscono con le armi! » «Un conservatore », pensa Barbuti, «grazie al cielo non fanatico. Riusciamo a discutere ma forse discutiamo, anche se tanto diversi, perché la nostra età spegne gli ardori: vent'anni fa non avremmo certo rispettato con parole quiete le stesse cose. » L'agronomo guarda «La Cronaca» con aria infelice. «Immagino abbia usato altri documenti quando scriveva sulla rivolta per il macinato... » « Ancora... » pensa Barbuti, e si sente trafitto. Come può sapere degli articoli quando i redattori anziani del « Presente » si erano lasciati condannare senza fare il suo nome? Per l'agronomo non esistono angoli nascosti, sa tutto, ha visto tutto. E poi la visita alla Società Operaia! Non si è mai sentito di uno studioso che per prima curiosità vada a mescolarsi agli ignoranti anziché esaminare le colture. La voce di Franzoni lo riscuote; sta facendo un discorso politico come mai gli era capitato di sentire. «... Lei dice, nessuno ascolta i contadini, nessuno li aiuta a capire. Purtroppo (e so quanto lei non ami i socialisti), sono gli apostoli da strapazzo che con la scusa di insegnare a scrivere, distribuiscono la propaganda rivoluzionaria nelle campagne. Specialmente nei giorni di festa, quando i braccianti vengono in villa, li catechizzano con teorie insane e, facendo intravedere miraggi inesistenti, li spingono alla disobbedienza... » Barbuti si arrabbia. Questo modo lo conosce bene, è il linguaggio dei prefetti, il linguaggio di chi possiede. E poi torna la allusione alle sue idee: com'è riuscito ad indovinare quanto abbia lottato nei giorni scorsi a Roma contro i socialisti testardi che attaccavano Rudinì? Lo attaccavano pretendendo l'immediata libertà per gli arrestati delle rivolte di primavera. « Immediato è una parola sconosciuta in politica. » È troppo stanco per farsi ingabbiare da un vecchio gendarme: deve liberarsi di lui. La sua presenza comincia a spaventarlo... Invece trascorrono assieme un'altra giornata, e sono ore che aggravano l'inquietudine. Barbuti fa le sue domande ai braccianti (cosa mangiano, quante ore lavorano, per quanti giorni all'anno, qual è la paga...) e l'agronomo ascolta girando nell'aia occhi svagati. Non apre bocca. Solo verso Polesine, allorché i braccianti rispondono che i preti di città vogliono costituire «la pia opera per il riposo festivo» cioè impegnare i padroni cattolici ad astenersi dal lavoro facendo riposare i braccianti e pagando qualcosa; solo quando cominciano simili discorsi, l'agronomo pare uscire dal torpore. Fa domande, suggerisce risposte. « Domani cambio albergo... » si dice Barbuti. Intanto i contadini raccontano. Tornano che è quasi buio. La pioggia promessa non cade e la carrozza si è ricoperta di polvere. Davanti ai due caffè della strada maestra le contadine offrono trecce di paglia ai compratori arrivati da Cremona per il mercato del lunedì sera. L'agronomo ferma il cocchiere. «Vuole vedere? » chiede a Barbuti. Gli rivolge per la prima volta la parola dopo ore di mutismo. «Finalmente fa il suo mestiere... » Una sorpresa: l'agronomo conosce il mercato e sa la storia della paglia stesa accanto alle lanterne. «Verso la fine di giugno, raccolto il frumento, i proprietari avvisano i braccianti: chi vuole la paglia può accomodarsi. È uno scambio di interessi. I braccianti sfregano le spighe per cavarne il grano, quindi il padrone non spende un soldo per la battitura, ma queste spighe vengono sfregate in un certo modo, tenendole strette in mazzetti e badando a non rompere la cannuccia. Tornano a casa con la paglia. La appendono sotto i portici per farla seccare senza la pioggia. In autunno la intrecciano... » Barbuti lo guarda con un sorriso: «Le sue lezioni sono noiose come i discorsi politici... » Un pensiero prima di immergersi fra i contadini e attraversare i dialetti che si mescolano alle loro spalle. Ma l'aria di festa finisce, un ragazzo arriva di corsa. «I carabinieri hanno preso uno... » La gente lascia perdere la paglia. L'agronomo e Barbuti vanno con la folla che circonda i gendarmi. « Sarà un contadino... » sospira Barbuti, e si sbaglia. Non è un rivoltoso: un giovane signore che tiene gli occhi bassi. « Cos'ha fatto? » «Ha sparato a una ragazza in casa Verdi... » « Morta? » «Morta. » «Verdi... il maestro? » L'agronomo cambia faccia. « Proprio lui . » Allora con una forza insospettata dentro quella giacca vuota, l'agronomo rompe il giro dei curiosi e ferma i carabinieri. «Voglio parlare con l'assassino... » Da quel momento diventa un altro uomo. Lascia perdere l'amico di tante ore, dimentica la borsa preziosa sulla carrozza e pensa soltanto a chinarsi con bisbigli sul giovane che i carabinieri portano via. Si agita nelle domande e cerca di rendere insicure le risposte con una protervia che sgomenta l'avvocato già pronto accanto al ragazzo. «E stata una disgrazia... » « Siamo noi che dobbiamo stabilire se è stata una disgrazia.» L'aria gentile è svanita, gli occhi timidi non ci sono più. Il delegato speciale Gaetano Franzoni comincia l'inchiesta che da anni aspetta nel ricordo di una lontana amarezza. « Per favore, vorrei che lei non aprisse bocca, altrimenti sono costretto a chiederle di andare fuori... » L'avvocato Cesare Sanguinetti sbalordisce: ma il vecchio chi è? Lo stesso tormento di Barbuti. Ha seguito l'agronomo nell'ufficio delle guardie, aspetta in corridoio. Ascolta la sua voce attraverso la porta, dura, senza commozione. Non aveva immaginato che il tono quieto delle sue parole potesse trovare risvolti così taglienti. E poi, perché proprio a lui, studioso bizzarro di terre e concimi, spetta la ventura di pretendere spiegazioni su un delitto? Quando l'agronomo si affaccia nell'andito, Barbuti gli va incontro. « Un poliziotto, allora... » lo chiede e risponde da solo. «Deve capire che fare il poliziotto è difficile. Ci si può mostrare troppo solerti facendo paura alla gente, ma restare uguali alle altre persone è ancora peggio: la diffidenza diventa più forte perché a nessuno piace l'ambiguità... » «Allora... i discorsi con i contadini, i viaggi nella campagna...» «Lasci perdere la campagna... » e per un momento la faccia dell'agronomo torna stanca. Le umiliazioni sono sparite, sembra un gigante: domina il silenzio della stanza dove Angiolo Carrara, 17 anni, figlio di Filomena Verdi e del dottor Alberto Carrara, studente di Liceo, racconta come ha ucciso Giuseppa Belli, domestica, da quattro ore distesa nell'andito di Villa Paradiso, la casa in fondo al paese, dimora del notaio e della sua famiglia. L'agronomo fa domande. Il vicebrigadiere Angelo Gaiba, comandante provvisorio della stazione, trascrive le risposte, mentre il carabiniere Giuseppe Rimondi avrebbe il compito di vegliare sul prigioniero, non si sa mai che voglia scappare, ma il prigioniero sembra uno straccio appeso alla sedia. « Quand'è successo? » chiede l'agronomo. La voce della risposta sembra un filo. «Verso le due, ero tornato da caccia; avevo posato il fucile sul tavolo... » « Carico? » «Lo era... » «Ma non ha l'abitudine di tutti, togliere le cartucce quando entra in casa? » «Di solito succede, ma era rimasto così dal giorno prima... » «Una caccia lunga, senza sparare un colpo... » L'ironia dell'agronomo allarma l'avvocato. Il ragazzo spiega meglio: « Domenica sono andato a ballare ». «Col fucile?» «Col fucile, ma bisogna le faccia capire. Parto venerdì assieme agli amici. Giriamo per due giorni nella campagna. La sera dormo dalla famiglia Persico a Suarzo di Villanova. Sabato torniamo stanchi con quasi niente nel sacco. Sulla porta intendo scaricare: gli altri mi prendono in giro, i nostri fucili restano sempre pronti. Non si sa maí passi qualcosa all'improvviso..., avevano voglia di ridere e pensavano alle ragazze. Sono stato al gioco; poi si è tenuta una festa, e si è ballato anche la domenica. Al lunedì mattina saluto gli ospiti, riprendo il fucile senza guardare se ha le cartucce in canna: la testa ancora confusa... Monto in bicicletta prendendo la strada di Busseto... » «Come portava il fucile? » L'agronomo non riesce a pensare a un'arma carica in bilico su un veicolo dall'equilibrio misterioso. «Ad armacollo... » «Bene, ad armacollo e non le è venuto in mente di controllare la carica? » «Non ci ho pensato. » «Dunque ha viaggiato per dieci chilometri, con l'arma carica su un arnese come la bicicletta... » Il ragazzo fa cenno che è andata così. «A che ora è rientrato?» « Prima di mezzogiorno. » « Dove ha posato il fucile? » « Sul tavolo dell'andito; ma subito, sono tornato via. » «Via, dove?» «Erano tre giorni che non avevo notizie di mio nonno, il maestro Verdi. Sempre in bicicletta sono corso a Sant'Agata a salutarlo... » «Nessuno l'ha visto entrare, uscire, posare il fucile?... » «Nessuno, solo Giuseppa, la Belli. » «A che ora è tornato? » «Stavano pranzando. C'era tutta la famiglia... » Il ragazzo guarda l'avvocato Sanguinetti che gli fa segno di andare avanti. «... Quando mi sono alzato dal tavolo, ho visto in anticamera la Belli che lucidava il pavimento. Le ho detto, spazientito: "Ti avevo chiesto di pulire il fucile!", ma lei ha risposto che ormai aveva cominciato il pavimento, dopo pensava al fucile. » « Era davvero sporco? » «Lo era. Prima nei campi, poi in bicicletta, sono giorni e giorni che non piove. » «Continui; ha preso in mano il fucile... » . «L'ho preso e ho passato lo straccio sull'impugnatura, stringendo con l'altra mano il grilletto. Così è partito il colpo...» «Aveva la canna puntata contro la Belli?» «Me ne sono accorto quando era tardi... » «... e ha sparato. Lo scoppio ha fatto correre i suoi familiari? » «Non c'era di nuovo nessuno. L'unico che ricordo di aver visto è stato il fratello della morta, Alfonso, un altro servitore... » Alfonso siede accanto a Barbuti, gli occhi stanchi, ma non piange. Dal diario dell'agronomo .... verso sera visitai un servitore di Sant'Agata conosciuto anni prima quando cercavo il ragazzo scomparso. Mi spiegò in quale modo il giovane Carrara aveva impegnato le ore vuote dopo lo sparo. Non si era sperduto con la testa confusa sugli argini; si era rifugiato in casa Verdi. Dal giardino di Sant'Agata il mio informatore lo sentì piangere. La voce del padrone consolava e rimproverava. «Possibile abbandonare un fucile carico? Possibile dimenticarsene fino a puntare la canna armata contro la cameriera?» Il ragazzo rispondeva. « Così ha voluto la fatalità... » ma il maestro non se ne dava pace. «Troppe fatalità in questa sventura. » Arrivò la carrozza del dottor Carrara. Le voci si rifecero quiete nella penombra. Un servitore improvvisamente partì sollecitando il cocchiere. Più tardi l'avvocato Sanguinetti attraversò il giardino. La conversazione riprese eccitata. « Conoscevo la ragazza [era la voce del dottor Carrara]; la sua famiglia ci è devota. Non ne ho sentito parlare né bene né male. Insomma, una donna di campagna ancora non sposata: forse perché cresciuta in casa di signori si era abituata ad un gusto diverso e l'amore di un contadino le sembrava indegno. Ho pensato volesse sposare un servitore... » «Non me la ricordo. Era bella? » Verdi voleva sapere. «Bella...? Come posso dire. Non l'ho mai guardata in questo modo. Solo una cameriera gentile... » La curiosità del vecchio sembrava infastidire il notaio come una deviazione non contemplata. « Voglio che risponda Angiolo: era bella? » Verdi batteva testardamente la sua idea. «Non conosco molte ragazze. Sembrava graziosa... » L'imbarazzo di parlare di donne davanti al padre. « Glielo hai mai detto? » L'avvocato Sanguinetti entrava nelle domande. «Una volta... » «E come le hai detto? » Ancora la voce di Verdi. «Che la sua camicia era elegante... » « Cosa aveva di diverso dalla camicia delle altre cameriere?» Sanguinetti cercava di capire. «Non so... Non ricordo. » « Ma qualcosa che ti ha fatto sembrare splendente la sua tela l'avrai pur notato... » Silenzio. Poi la voce del ragazzo Carrara lentamente scandisce le parole. « Era bella perché la portava lei... » Subito la porta finestra si spalancò. Verdi uscì in giardino impugnando il bastone. Chiese al dottor Carrara di tornare al Paradiso; Angiolo sarebbe arrivato più tardi. «Adesso deve parlare da solo con l'avvocato... » Passò un po' di tempo. Il maestro guardava i campi appoggiato al cancello, in fondo al viale. Chiedeva della stagione senza pioggia. «Fa bene all'uva », rispose un contadino. «La nostra uva è poca. Non mi piace la terra secca... » La sbriciolava nella mano. I passi di Sanguinetti sulla ghiaia gli fecero girare la testa. Per un momento sembrò spaventato dalla rivelazione che sentiva inevitabile. «Bisognerà parlare col medico di Busseto. Subito. È importante... » La faccia dell'avvocato non era tranquilla. «Intanto Angiolo torna a casa. Voglio esserci anch'io quando va dai carabinieri. Sa già cosa dire. Arriverò in carrozza per la strada. Lui taglia i campi. Ci troviamo là... » Tutti e due uscirono piegando verso il paese. « Lei è Alfonso Belli? » In caserma, quando l'agronomo comincia a discorrere col cameriere, la sua voce sembra cambiata. È solo un'impressione ma il compagno di albergo sente che una simpatia diversa passa attraverso la porta. Il ragazzo Carrara si mette in fondo al corridoio a discorrere col padre e l'avvocato. «Si è mai visto », riflette Barbuti «un incolpato che può rispondere con l'aiuto dell'avvocato... Il padrone del paese fa proprio quello che gli pare... » Di là ricomincia l'interrogatorio. «Alfonso Belli... » «Sono io. » «È il fratello della morta?» Fa segno di sì. « In quale stanza si trovava quando è partito il colpo? » «Nella stanza vicina. Ho sentito lo sparo e senza sbrigarmi, perché non immaginavo... sono andato a vedere. C'era il signor Angiolo inginocchiato davanti a Giuseppa. Le girava la testa come per svegliarla, ma quando mi sono avvicinato e i piedi si sono trovati accanto ai capelli di mia sorella, il signore si è aggrappato alle gambe gridando: "L'ho uccisa, l'ho uccisa!" Come indemoniato. Poi è scappato in giardino. » « Non l'ha fermato? » «Non pensavo a lui in quel momento. Mi sono messo a correre in cerca di aiuto. Sembrava ancora viva, capisce... » Adesso la voce dell'agronomo arriva come un sussurro alla panca dove siede Barbuti. «Non c'era nessun legame, nessuna simpatia voglio dire, tra Angiolo e la ragazza?» La realtà più complessa intimidisce il contadino. Non risponde, ed è un silenzio che mette a tacere anche l'avvocato e il giovanotto nel corridoio. « Si conoscevano da tanto tempo. Sono cresciuti quasi assieme anche se mia sorella era più grande... » Barbuti nel buio scuote la testa: «Non è una risposta ». Il carabiniere richiama Carrara; solo una formalità per completare il foglio che il brigadiere Gaiba sta riempiendo. «Quando ha lasciato la casa dove è scappato? » «Non lo so, avevo confusione. Sono montato in bicicletta senza scegliere la strada, poi mi sono ritrovato in giardino. C'era mio padre. Nel corridoio il dottore guardava Giuseppa... » «Come mai ci ha messo quattro ore per venire da noi... » «Nessuno sapeva cosa fare. Abbiamo aspettato l'avvocato per un consiglio. » Quando il ragazzo Carrara torna in corridoio, il brigadiere guarda l'agronomo con imbarazzo. « Sono soltanto il sostituto e non capisco se sia il caso di trattenere il figlio del dottor Carrara. Sembra una disgrazia... » « Stanotte la passa in prigione. Domani il pretore deciderà. Lo accompagni. » La voce della risposta è di nuovo opaca. Quando Barbuti e Franzoni camminano con passo stanco nella piazza, le luci del mercato tremano nella nebbia ancora trasparente. Adesso è Barbuti che vorrebbe fare le domande. «Viene in albergo? » Non si spiega la ragione dell'improvvisa timidezza. Chiede, nella speranza di potere camminare un poco col vecchio agronomo ormai perduto. «Ancora non posso, devo vedere una persona. Più tardi, magari: chissà non faccia a tempo per la cena... » Torna ad incupirsi. Gli ultimi passi verso la carrozza sono silenziosi. Dal diario dell'agronomo Nel rapporto inviato al pubblico ministero, avvocato Fermo Benussi, rapporto poi finito nelle carte del presidente del tribunale di Parma, cavalier Annibale Alpi, sul tavolo insicuro della camera di albergo, quella notte l'agronomo elenca senza speranza i sospetti di una storia meno semplice del racconto del ragazzo Carrara. Sia Benussi che il cavalier Alpi ne tengono conto nel dibattito avvenuto un mese dopo, ma, come l'agronomo aveva previsto, nelle «prove» che riflettono la teoria c'è un vuoto troppo importante, e il castello piega le gambe. Un colpo volontario, o un colpo partito per caso? Il dubbio lo accompagna. ... Subito dopo l'interrogatorio del giovane Carrara scrive con linguaggio meno condizionato dalle regole della burocrazia necessarie al rapporto ufficiale — sono andato a fare visita al dottor Alberto Manzi, medico chiamato a compilare l'atto di morte della Belli. L'ufficio dove riceve è una stanza più piccola delle altre, senza strumenti per la medicina, ammobiliata con un tavolo, sedie e scaffali di libri. Sul tavolo, in disordine, si mescolano conti da pagare, lettere e scatole di fiale. Il dottore seduto dall'altra parte della scrivania, dopo aver accennato a qualche discorso di circostanza, rimane immobile, guardandomi con l'aria di chi sta pensando alla cena che raffredda. Gli spiego che mi sarebbe piaciuto leggere il suo rapporto sul delitto. «Non l'ho ancora scritto » risponde «ma posso spiegarle. Ho qui il taccuino... » Il dottore ha trovato la ragazza «con gli abiti composti (una sottana e una camicia bianca), la testa girata da un lato, la base del collo squarciata dal colpo sparato da pochissima distanza, per cui la carica contenuta nell'arma ha fatto palla, distruggendo il midollo spinale e provocando lesioni irrimediabili negli organi della circolazione... » «Vicino quanto? » interrompo. « Molto vicino perché la ferita ha bordi irregolari e bruciacchiati. Il fondo presenta un colore nero carbone... » «Come è larga questa ferita? » «Il mio dito indice vi si è introdotto con facilità... » «Ha visto altre ferite, di questo tipo, provocate da un fucile da caccia manovrato per caso e non da vicino? » Il dottore non sembra contento di dover rispondere. «Non come questa... » « Mi dica allora: cos'ha di particolare? » Non per sfiducia, solo per ignoranza voglio capire in che cosa consiste la differenza tra uno squarcio normale e il colpo che rende incerto il medico. «Ecco... il colpo è partito da vicino. Come posso dirle... » non trova le parole che gli paiono convenienti. Suggerisco qualcosa. « Vorrei solo sapere se può escludere che la canna del fucile sia stata appoggiata al collo della ragazza. » «Proprio appoggiata... » C'è solo una lampada che lascia in ombra gli occhi, ma il disagio si respira anche nel buio. «Comunque molto vicina »: decido di sollevarlo. «Molto vicina... » Me ne vado. È un estraneo che si libera volentieri delle mie domande. Sento che l'accoglienza è quella riservata ad un protagonista occasionale e non gradito, ed io sono sì un poliziotto capitato per caso, ma non capisco come la legge non debba essere bene accetta a chi per dovere sa di legge e di medicina. Paura? Ormai è notte quando busso alla porta dei genitori della ragazza. Una casa di braccianti, il soffitto basso, il pavimento in terra battuta. La mia presenza fa tacere le persone attorno al tavolo, forse parenti col vino e i resti di una cena. Alfonso, il fratello incontrato in caserma, mi riconosce. «È lei... » « Volevo parlarle. » Mi viene incontro per farmi capire che ogni parola può riaprire il dolore un po' sopito dai discorsi e dal bere: meglio discutere camminando sulla strada, che è più alta della porta, quasi un argine dimenticato. Ancora una volta — e quante volte mi è successo nella vita — controllo l'ultima speranza che può farmi intuire dove trovare la verità, se una verità nascosta esiste o se è soltanto la piega di una fantasia esasperata dalla professione e da lontane amarezze. Il cameriere dei Carrara mi segue di un passo: un contadino che serve dentro una casa di signori, quindi bene educato all'uso del rispetto, ma addestrato all'ipocrisia. Mi sembra inutile coprire con parole ambigue una realtà che forse non esiste. Non lo imbroglio. « Le dico il vero, sono venuto a rifare la stessa domanda: tra il ragazzo e sua sorella c'era una storia di tenerezze o di ricatti...? » Camminiamo in silenzio; il silenzio è già una risposta. E quando parla conferma il pensiero inseguito dalla prima rivelazione del delitto. «Non so niente e non capisco nemmeno se quanto sto per dirle possa essere legato alla sua domanda, ma, prima, ho sentito che Giuseppa aspettava un bambino... » «Prima, quando?» «A tavola, se vuole glielo faccio ripetere. » Sono le nove passate. In fondo alla strada il cocchiere aspetta. «Non me l'ha detto in caserma... » «Non lo sapevo. E poi cosa c'entra un bambino col fucile che per caso spara... » Quando torno dal dottor Manzi, il medico ha la lampada accesa e mi apre con la fretta di chi teme l'aggravarsi di un malato, non un poliziotto e le sue domande. Non sembra sorpreso, neanche contento. « Ancora lei... » « Sono venuto a conoscenza di qualcosa che forse cambia il senso dell'incidente. La ragazza era incinta, non so da quanto. Come mai non lo ha scoperto facendo l'autopsia? » Il dottore si piega sul tavolo con la stanchezza di chi deve affrontare una pena diversa. « Non c'è stata autopsia. Questo è il rapporto. L'ho appena terminato e fra un po' vado a dormire... "... La morte è conseguenza esclusiva della lesione stessa, non risultando quindi il concorso di cause preesistenti e sopravvenute. Sono simili ragioni a non farmi ritenere necessario provvedere all'autopsia del cadavere..."» « Una ragione adesso ce l'ha? » «E quale sarebbe questa ragione? » Il dottore riemerge dall'inerzia. La stanchezza sembra essergli passata. «Secondo lei dovrei uscire di casa per ordinare che il corpo di una contadina uccisa in una disgrazia venga portato via dalla casa dove stano vegliando; ordino che venga disteso su un tavolo del cimitero perché il sospetto di un medico chiamato a curare malattie e ferite, getta ombra sui familiari del maestro Verdi. La ragazza aspettava un figlio, dovrei dire. Forse è stato questo figlio a fare esplodere il fucile... Se lei è un bravo poliziotto conosce le furbizie del mondo meglio di un chirurgo di campagna. Mi risponda: quante possibilità ho di riaprire una procedura già conclusa adducendo una malizia che nessuno riuscirà mai a collegare all'incidente di Villa Paradiso? Chi è il padre di questo figlio? La sola persona che avrebbe potuto spiegarlo, non parla: è morta. Lei pretende che io insinui, io fantastichi, io debba mettere sospetti. Sono soltanto un piccolo medico e il ragazzo è soltanto nipote della gloria d'Italia... » Lascio il dottore al suo sonno, licenzio la carrozza. Torno a piedi in albergo per stendere le note che forse potranno illuminare il chiarissimo Accusatore di codesto tribunale. Martedì, 27 settembre 1898 Il carabiniere arriva mentre Barbuti fa colazione. Vuol parlare al delegato Franzoni. Il padrone non sa come dimostrare la gentilezza che riserva ai pochi ospiti diversi dai carrettieri e dalla gente di commercio che dormono nel suo albergo. Lo manda a chiamare con infinite raccomandazioni. «Non svegliarlo di soprassalto... » ma la ragazza già vola per le scale. Deve passare un'ora prima che l'agronomo si affacci. Il milite Rimondi tira fuori di tasca la sentenza del pretore Pessina: «... avendo l'imputato ammesso il reato ascrittogli e non risultando nulla a suo carico nel casellario, se ne ordina la provvisoria scarcerazione. Busseto, 27 settembre 1898, ore 7,45 del mattino ». «Povero pretore, gli hanno dato presto la sveglia. » Restituisce il foglio al carabiniere. «Sto partendo, dica al brigadiere che la missione è finita. » Accanto alla stufa di maiolica Barbuti sfoglia «Il Resto del Carlino ». «... Oggi, alle ore 2 e 15 minuti, nella località Paradiso, lungi cento metri dal paese, il signor Carrara Angelo, di 18 anni, stava ripulendo il proprio fucile da caccia, quando di un tratto, partì un colpo che uccideva la donna dei servizi, certa Bindi Peppina, di anni 23, bussetana. L'infelice fu colpita nella regione sinistra del collo dai grossi quadrettoni che le produssero orribile squarcio, lacerando la carotide. La morte fu istantanea. Il giovane Carrara, accompagnato dal padre Alberto (da lunghi anni agente del maestro Verdi di cui sposò una figlioccia) si è costituito in carcere. Dovrà rispondere di omicidio involontario. Al momento del fatto erano presenti alcuni amici che si erano recati a visitare lo sventurato Carrara. Il maestro Verdi fu subito informato del triste avvenimento e se ne dolse per lo strazio del nipote.. » «Hanno sbagliato anche il nome... » Barbuti passa il giornale all'agronomo che si è seduto al solito posto. « Certa gente ha ancora il diritto ad avere un nome? Povero Carrara, sventurato, straziato... » L'ironia è amara. Con un imbarazzo che Barbuti non avrebbe immaginato l'agronomo gli rivolge la parola. «Devo scusarmi con la sua intelligenza per quanto le ho fatto credere. La mia missione era diversa, lei capisce, non la potevo raccontare. » «Non importa... » « Volevo farle sapere che mi dispiace per certe invenzioni...» «Non si deve scusare. Ci si fa una strana idea dei poliziotti, incolti, violenti: invece possono ascoltare i contadini, magari andare a Messa. » « Guardi che sbaglia ancora. Come tutti gli idealisti ha la virtù di non capire fino in fondo come è complicata la realtà. Neanch'io la capisco, e me ne rassegno... » Quasi rispondendo ad un pensiero, l'agronomo continua. «Ero tornato illudendomi che il passare degli anni avesse cambiato qualcosa. Devo darle ragione: comandano sempre gli stessi...» Monta sulla carrozza che lo porta alla stazione di Borgo San Donnino con l'abito di città e il cappello di paglia che schiarisce la faccia. La valigia a soffietto continua a farlo sembrare un dottore. E il destino non fu crudele... I protagonisti di questo gioco nel melodramma, continuano per qualche tempo ad attraversare altri archivi. Franzoni, per esempio. Forse perché non soddisfatti delle informazioni raccolte sui rivoltosi della bassa del Po, la delegazione politica di piazza San Fedele lo confina nella gabbia dei burocrati a ricopiare pratiche, confidando «nella bella calligrafia e nella chiarezza della scrittura». Di lì a pochi mesi compie 65 anni e sceglie la pensione. Prima di andarsene, con la discrezione che mai lo aveva abbandonato, intende sapere dove poteva essere scomparsa JohannaForni. Un segno leggero, sepolto chissà dove, lo rendeva malinconico. Non è scappata a Cannes. Una lettera indirizzata a Soragna finisce nel sacco della censura, rivelando un destino inatteso. Ancora una volta si era sbagliato. Le ferite dell'adolescenza, così profonde, non erano guarite. Ma Johanna se ne liberava giorno per giorno trasferendole in un quaderno di memorie. E il quaderno era finito nelle mani di un editore furbissimo. L'agronomo non lo sapeva: erano diventati libri che le ragazze di buona famiglia leggevano con commozione. L'agronomo va ad abitare da un nipote che tiene contabilità al numero due di Porta Garibaldi. Nota nelle ultime pagine svogliate del diario «... il mio passato mi ha raggiunto ». Muore nel 1904 senza mai aver lasciato Milano. Ogni storia, per quanto affannata, riserva sorprese sfumate dall'ironia. Il Franzoni che oggi raccoglie le memorie sperdute nei cassetti di questo gentiluomo povero cresciuto nell'amore dei Borboni, vive a Cernusco sul Naviglio e lavora in una fabbrica che stampa tappi di plastica. Naturalmente si interessa di politica anche se la tessera del sindacato piegata nel suo portafogli sarebbe piaciuta più a Barbuti che al delegato Franzoni. In un certo senso lo stesso destino accompagna Barbuti. Non scriverà il libro che aveva sperato sul tavolo dell'albergo Sole. Torna a Roma, si trasferisce a Genova dove viene sepolto nel 1909. Il « Presente » non dedica una parola alla scomparsa, mentre le note dell'ultima inchiesta di questo laico che scherzava con i santi, si conservano nella biblioteca del parroco di San Vitale Baganza, le prime colline di Parma, poco lontano dai boschi della casa di campagna di Maria Luigia, quel villino che Verdi fu lì lì per comperare con i soldi dell'Aida. Le rabbie del timido anticlericale riposano assieme alle storie dei papi perché il nipote più attento alle vicende familiari si chiamava don Riccardo Barbuti, anche lui morto nel '54. Gli ultimi fogli di disperdono nelle soffitte della Curia. Più felice l'avventura di Pellegrino Molossi. Il direttore della «Gazzetta », quel Parmenio Bettoli, pletorico e inquieto, scappato da Milano dopo aver compilato le prime recensioni musicali del « Corriere della Sera », nell'ottanta se ne va anche da Parma: il governo lo manda a Tripoli a « preparare culturalmente l'occupazione italiana ». Così il giornale resta a Molossi. Nell'83 gli viene ceduta la proprietà «fino a quando fosse vissuto », ma negli ultimi giorni dell'84 può far sapere di « aver superato l'anno di prova del rischioso esperimento rinunciando ad ogni aiuto materiale del proprio partito ». La « Gazzetta » è sua per sempre. Scriverà un articolo al giorno fino al 1912, e ogni giorno seguono le polemiche contro la « sovversione », i vecchi editori Piroli, Cantelli, Verdi e Bianchi, ma anche i discendenti dei personaggi minori incontrati da Barbuti e Franzoni nel loro girovagare. I figli dello spazzacamino sanno leggere e scrivere, come si può immaginare. Il nipote, che oggi si diverte a tirare fuori dall'armadio le foto del vecchio Pietro Nicolao Menapace, è tornato a Parma da Roma dopo anni trascorsi alla guida di un ente, con onori e segretari devoti all'ossequio. Per gli scritti di Molossi qualche volta si è arrabbiato Diofebo di Soragna, ma solo qualche volta, perché se è vero che l'ideologia nobilita le lotte della vita, certe esistenze si sentono talmente nobilitate dai titoli e dalle proprietà da poter dimenticare la differenza delle fedi politiche. Il principe non amava l'anticlericalismo sempre più invisibile della «Gazzetta », ma si consolava ogni volta che Molossi se la prendeva con i predicatori del popolo «fonti di calamità e sciagure ». Diofebo muore vecchissimo, nel '97. Scrive da solo l'annuncio funebre, un annuncio che ripete la lealtà al papa e al suo duca, e nel quale chiede che solo quattro preti e nessun amico seguano i funerali. Quando sente che le forze se ne vanno pretende di venir seduto in poltrona. Si fa pettinare la barba e allacciare le pantofole. Morire a letto e in disordine non lo ritiene dignitoso. Per antico risentimento Parmenio Bettoli non gli rende onore. «Visse e morì in un passato ormai sepolto nell'oblio, transitando in mezzo ai tempi nuovi a guisa di statua antica... » Il processo di Angiolo Carrara finisce con una condanna: 38 giorni di prigione, 41 lire di multa, il ritiro del permesso di usare un'arma. Passa un anno e, il primo marzo de11899, la Corte d'appello di Parma riprende in mano la storia lasciando «per primo e per ultimo» la parola all'avvocato Sanguinetti, che con arringa dotta chiede l'« assoluzione completa ». Il presidente (nobile Alessandro Albino Marini), tiene conto delle osservazioni di Franzoni: contesta senza tenerezze lo strano atteggiamento del giovane e la «imprudenza ancora più grave dovuta alla facilità con cui oggi, a differenza di un tempo, si scaricano le armi a retrocarica », imprudenza che il Carrara aggrava andando a spasso in bicicletta col fucile « non prevedendo il pericolo di fare del male ad altri e forse a sé; imprudenza che ancor più esaspera allorché neppure entrando in casa pensa ciò che può accadere e depone il fucile su un tavolo in balia di tutti ». Conclude il nobile Marini: «Mentre le più elementari accortezze consigliano a chi maneggia un'arma da fuoco di non volgerla per qualsiasi motivo contro le persone, egli non bada che le due bocche del fucile guardino da vicino la povera Belli, e se risponde al vero che la colpa sta nell'imprecisione dell'imprevedibile, il Carrara non una ma parecchie occasioni aveva di impedire l'avvenimento... » Per la disperazione dei genitori la condanna viene confermata, ma con una rapidità sconosciuta a quei giorni, dopo una settimana arriva un telegramma da Roma. È il decreto solenne del sovrano che condona l'intera pena di detenzione e la multa di lire quarantuno. Resta il problema del fucile: Angiolo Carrara può riaverlo per tornare a caccia? La regia ordinanza non lo spiega, ma il prefetto misurando la benevolenza sulla rapidità con la quale è arrivata la grazia, interpreta in modo favorevole la « dimenticanza », e restituisce doppietta e licenza. Il ragazzo può sparare. Non vi sono, per il momento, tracce di una corrispondenza tra Barbuti e l'agronomo, tanto vale ormai chiamarlo così. In quel mattino di settembre dovevano essere tutti e due un poco emozionati, e quando arriva la carrozza per Borgo San Donnino, immersi in altri pensieri, non pensano a scambiarsi l'indirizzo. Può succedere quando si ha fretta. ********************************** “…bene il racconto, raccoglie fiumi e viali spogli del nostro inverno, Cronista-narratore educato alla disciplina della scrittura di guerre lontane (vicine), narratore di turbolenze vicine (lontane nel tempo)…” Attilio Bertolucci "... vorrei dire che Chierici è affascinato dal racconto, dai suoi ritardi e tortuosità essenziali, come secondo leggenda lo sono certi animali dall'occhio del serpente. Eccolo, allora, rallentare, godere quelle volute e quegli ipnotismi…” Giuliano Gramigna Maurizio Chierici da trent'anni viaggia per il "Corriere della Sera" e "l'Unità": America Latina, Medio Oriente, Cina e Sud Est Asiatico. Ha scritto vari libri tra cui due romanzi-verità: Malgrado le amorevoli cure (Einaudi) e L'imperatore (Rizzoli). Gli ultimi saggi Lungo viaggio d'addio (Baldini Castoldi Dalai) e La scommessa delle Americhe (Einaudi)
Scarica